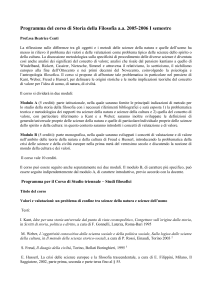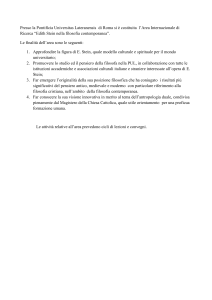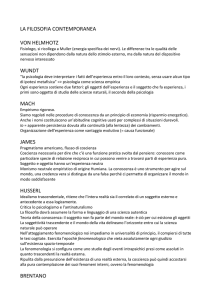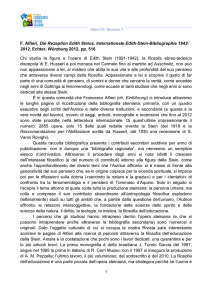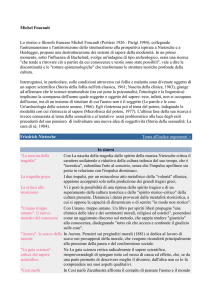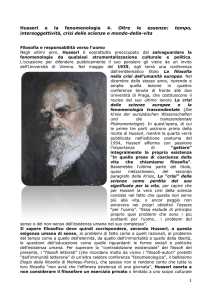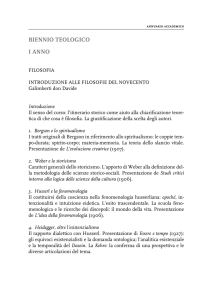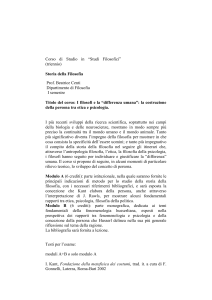RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XIX
NUOVA SERIE - N. 54 - GENNAIO-APRILE 2005
Manni
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce,
e dello stesso Dipartimento.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce),
Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno),
Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo,
Lucia De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia,
Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 294627/8; fax
(0832) 294626. E-mail: [email protected]
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto
I, 51 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto al
n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento
annuo: Italia € 25,00, Estero € 35,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero
Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da
gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo € 10,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nel dicembre 2004 - per conto di Piero Manni s.r.l.
SOMMARIO
5
Marco Salvioli
DERRIDA VERSUS RICOEUR
VARIAZIONI SULLA FENOMENOLOGIA DEL TEMPO
21
Fabio A. Sulpizio
CI DOVREBBE ESSERE UNA ENORME ECLISSI
SACRIFICIO, MORTE E DISSIMULAZIONE IN WILLIAM SHAKESPEARE
41
Francesco Sanguinetti
IL PROBLEMA DELL’APPROCCIO
PREMESSE E PREGIUDIZI COME HABITUS. IL PENSIERO DI XAVIER ZUBIRI
53
Giorgio Rizzo
PROSPETTIVE ANTIREIFICANTI DELLA FENOMENOLOGIA
64
Paolo Zordan
EDITH STEIN E MAX SCHELER
UN CONFRONTO A PARTIRE DALLE ANALISI DEL PROBLEMA DELL’EMPATIA.
79
Pierre Taminiaux
IL FILM D’ARTISTA: UN GENERE METEORICO?
88
Bianca Maria d’Ippolito
SULLE ORIGINI DELLA FILOSOFIA GRECA
94
Girolamo de Liguori
IL CLASSICISTA E LA SCIENZA. NOTA SUL DILETTANTISMO FILOSOFICO
DI SEBASTIANO TIMPANARO
113
Cosimo Caputo
FERRUCCIO ROSSI-LANDI E LA FILOSOFIA ANALITICA
120
Santino Cavaciuti
L’“ATTENZIONE” ALL’“ALTRO”
NELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
123
Virgilio Cesarone
LA PREGHIERA COME EVENTO NELL’ESSERCI.
LINEE ETICHE DI UN ACCADIMENTO RELIGIOSO
3
135
Sandro Ciurlia
“COME LA SPADA DI ODINO…”
LE PERSISTENTI RAGIONI DELLO STORICISMO
142
Giovanni Invitto
IL FEMMINILE TRA ANTROPOLOGIA E CRISTIANESIMO.
LA LETTURA DI ANGELA ALES BELLO
147
Graziella Morselli
PARADISI PERDUTI E DIALOGHI DIFFICILI
154
Recensioni
165
Libri ricevuti
4
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o
Dipartimento di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono
essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà
superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche
su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
DERRIDA VERSUS RICOEUR.
VARIAZIONI SULLA FENOMENOLOGIA DEL TEMPO
Senza ritorno di coscienza, il punto
tra memoria e desiderio si sposta,
è alla deriva di un gorgo.
Passato ed avvenire s’invertono
su di sé si capovolgono, delfini
o tonni nella rete del senso1.
Il problema eminentemente fenomenologico della relazione tra tempo e
intenzionalità è al centro del tentativo husserliano di fondare la logica in
modo non psicologistico. Un tentativo di fondazione siffatto deve affrontare,
tra l’altro, interrogativi che riguardano la capacità di un atto situato nel
tempo di avere come correlati intenzionali contenuti onnitemporali, descrivendo la relazione tra l’éidos intelligibile e il flusso di coscienza 2. Più semplicemente, una fenomenologia della coscienza del tempo deve almeno
mostrare la possibilità di percepire oggetti che si estendono nel tempo,
come ad esempio, una melodia. Se infatti si riuscisse a mostrare che il
tempo come durata si dà all’intuizione, evitando di pensarlo come forma a
priori della sensibilità (Kant) o attraverso un procedimento associativo ricorrendo alla rappresentazione fantastica (Brentano), allora sarebbe possibile
fondare l’analitico sull’estetico e l’evidenza apodittica su quella assertoria,
giungendo all’intuizione eidetica delle essenze, ossia ad una visione concreta degli universali. È infatti nel problema del tempo che si rivela con più
pregnanza il novum della fenomenologia: l’apriori materiale come sintesi
data all’intuizione e non al giudizio 3.
Per l’importanza strategica che rivestono all’interno dell’orizzonte aperto
dalle ricerche husserliane, le Lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo4 costituiscono uno dei “pretesti” più significativi per approfondire
un aspetto del confronto tra Derrida e Ricoeur, pensati come lettori di Husserl5.
Pertanto, confronterò il quinto capitolo de La voce e il fenomeno “Il segno e il
batter d’occhio”6 con il secondo capitolo di Tempo e racconto III: “Tempo intuitivo o tempo invisibile? Husserl di fronte a Kant”7. Le parti in esame verranno
intese come libere variazioni a margine delle analisi del fondatore della fenomenologia. In questo modo, contribuiranno a mostrare come le proposte specifiche di Ricoeur e di Derrida si originano, pur differenziandosi nelle conclusioni, dalle medesime critiche rivolte a Husserl8.
SAGGI
di Marco Salvioli
5
1. Derrida: la generazione del punto-sorgente
6
La posizione di Derrida nei confronti del testo husserliano è eminentemente decostruttiva. In primo luogo, perché, limitando i propri lavori maggiori ad
“introduzioni”, Derrida non accetta la fusione di orizzonti tra il proprio pensiero
e quello di Husserl, ovvero non assume come fatto acquisito la fenomenologia
trascendentale, pur elaborando le proprie domande a partire da questo stile di
pensiero. In secondo luogo, perché Derrida condensa le proprie riflessioni
intorno agli elementi finali (la genesi passiva), marginali (l’origine della geometria) o collaterali (il segno, la voce e la scrittura) del pensiero husserliano.
Se l’analisi fenomenologica può essere praticata propriamente a partire
dalla “conversione”9 consistente nell’epoché, allora tutti i testi di Derrida devono essere considerati come una messa in questione di questa differenziazione dall’atteggiamento naturale e come un problematico indugiare sulla soglia.
Accogliendo la posizione equilibrata di R. Bernet 10, considererò il contributo di
Derrida al movimento fenomenologico come una “philosophie de la répresentation originaire”. Già a partire dalle prime osservazioni svolte da Derrida a
margine del corpus husserliano, dovrebbe essere chiaro che tale interpretazione consiste in una critica della possibilità dell’atto di riduzione fenomenologica proprio sul fondamento della suo carattere temporale 11, dell’essere cioè
inserito in un flusso e contemporaneamente dell’esserne indipendente. In
questo modo, la decostruzione dell’impianto “idealistico” della fenomenologia
trascendentale include il necessario impegno ad esplicitare le implicazioni
della “durata” dell’atto di riduzione fenomenologica. Il tentativo derridiano di
pensare tale estensione, nonostante la richiesta di Husserl che vorrebbe che
la riduzione fosse eseguita «d’un sol colpo»12, mette profondamente in questione il senso stesso della fenomenologia del tempo. In effetti, se l’atto della
riduzione, perché esteso, non si può mai compiere in pienezza, tale conversione –istituendo il campo originariamente rappresentativo della coscienza–
può confermare solamente l’evidenza della contaminazione dell’empirico e
del trascendentale. Pertanto, il nucleo del lavoro di decostruzione operato da
Derrida al livello della temporalità –e cercherò di dimostrarlo sui testi– consiste nel “differire” il compimento dell’epoché. Il significato del temporeggiare13,
infatti, si manifesta nel tentativo di deviare ogni caduta negli esiti della metafisica della presenza, mostrando come lo stesso atto della riduzione segni l’irriducibile ritardo della coscienza sulle “cose stesse”. Si tratterà allora di contestare: da un lato, la “superstizione” del dato immediato e, dall’altro, l’ingenuità della trasparenza che rende accessibile la verità in modo gratuito e
senza possibilità d’errore. L’esitazione che dubita è infatti contrapposta da
Derrida alla “conversione” richiesta dalla riduzione fenomenologica all’evidenza del vissuto di coscienza; se vi è una vena di scetticismo in Derrida, essa è
solamente dettata dalle riserve nei confronti dell’accettazione incondizionata
del «principio di tutti i principi»14.
Questa fondamentale riserva si è concretizzata nel ruolo giocato dal segno
ne La voce e il fenomeno. Poiché Husserl definisce la verità attraverso l’evidenza in quanto presenza immediata alla coscienza, la fenomenologia si
SAGGI
determina nell’esclusione del segno come indice che, per Derrida, prefigura la
riduzione dell’atteggiamento naturale. Avendo fatto epoché della materialità del
segno, Husserl ha dovuto ridurre la differenza temporale –insita nell’atto di rappresentazione di un’alterità– alla puntualità dell’istante dell’intuizione.
L’interpretazione di Derrida conduce, quindi, a ritenere che la riduzione di tale
differenza alla puntualità –così come quella dell’indice all’espressione– sia
dovuta alla decisione husserliana di mantenersi fedele al primato idealistico
dell’intuizione immediata. Conseguentemente la fenomenologia, proprio in
quanto costituisce la critica più sottile alla teoria rappresentativa della conoscenza15, è pensata da Derrida come “il progetto metafisico stesso nel suo
compimento storico e nella purezza solamente restaurata della sua origine”
(VF, 33).
È dunque per questi motivi generali, che Il segno e il batter d’occhio, capitolo dedicato al confronto con la fenomenologia del tempo, inizia addossando
alla puntualità dell’istante la responsabilità di costituire il fondamento della
metafisica, come sapere immediato e assoluto16. Il compito di Derrida consiste,
in ultima analisi, nel mostrare come le stesse descrizioni della fluida continuità
del tempo compiute da Husserl contestano all’origine la conclusione idealistica della puntualità della serie discreta degli istanti. Pertanto, se l’istante fosse
solo il risultato di un’astrazione teoretica, allora verrebbe interdetta la possibilità di operare l’epoché “d’un sol colpo”, ovvero senza alcun passaggio o
mediazione che non siano riducibili –in prospettiva teleologica o asintotica– ad
una coincidenza puntuale. In questo modo, il cammino verso “le cose stesse”
sarebbe indefinitamente reiterato.
La lettura derridiana delle Lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo, pertanto, è costruita essenzialmente intorno all’indecisione di
Husserl tra la fedeltà idealistica all’evidenza del “punto d’origine”17 e la necessità
di affiancare la ritenzione e la protensione18 all’impressione originaria. Le difficoltà insorgono infatti nel momento in cui occorre conciliare l’istantaneità del presente con la possibilità dell’apparizione del fenomeno della durata, in quanto
intuizione del decorso di un oggetto temporale. Posto di fronte a questo enigma,
Husserl deve affrontare il compito della difficile conciliazione di tempo e conoscenza: come intuire la “cosa stessa”, se questa si dà alla coscienza come “sempre altra”, a causa del divenire delle percezioni nel tempo?
Per Derrida, Husserl tenta di dominare il decorso temporale a partire dall’immediatezza dell’impressione originaria: la ritenzione è allora pensata come presenza dell’appena-passato e la protenzione come attesa di ciò che sarà presente. Quindi, la durata temporale, pur distinguendosi dalla successione di istanti
atomici, corrisponde ad una serie di impressioni presenti connesse da un sistema di rinvii. Tali rimandi sono poi costituiti in modo da non mettere mai in discussione l’archi-forma della presenza alla coscienza19. La ritenzione, in effetti, lungi
dall’assumere una connotazione inconscia20 o almeno passiva, rimane la forma
dell’intuizione dell’appena-trascorso che costituisce il senso stesso del “passato”. Così, ciò che comunemente si definisce come il contenuto di un ricordo, si
costituisce attraverso la sovrapposizione di ulteriori ritenzioni che si modificano
reciprocamente secondo una complicata struttura iterativa21.
7
8
Contestando l’auto-interpretazione husserliana di tale descrizione, il principale gesto decostruttivo di Derrida consiste nel far scivolare il concetto di ritenzione come ricordo primario verso la rammemorazione o ricordo secondario. In
questo modo, egli sottomette entrambe le forme della datità del passato alla
nozione di traccia, come elemento non-cosciente chiamato a costituire passivamente la presenza a sé del presente stesso. Lungi dal formare un unità semplice (presente allargato), l’impressione originaria e la ritenzione formano una
unità sintetica attraverso la dialettica di percezione e non-percezione. Tale
gioco di presenza e assenza, evidenziato da Derrida, destabilizza la presunta
continuità intuitiva del presente vivente, mentre ne illustra la costituzione in
senso genetico. Attraverso questa interpretazione, pertanto, la condizione di
possibilità del presente viene a sovrapporsi con quella di impossibilità.
Applicando un tipico movimento del pensiero derridiano più maturo, si può dire
che il presente vivente –sottoposto alla lettura decostruttiva– si manifesta
come il primo e forse più decisivo elemento della serie degli indecidibili22.
Analizziamo ora con cura questo passaggio, che costituisce il centro della
critica di Derrida a Husserl: “la presenza del presente percepito può apparire
come tale solo nella misura in cui essa si compone continuamente con una
non-presenza ed una non-percezione, cioè il ricordo e l’attesa primari (ritenzione e protensione)” (VF, 99-100). In altre parole, il presente, nel momento in cui
è percepito, non è più lo stesso, ma è già altro: è un passato ritenuto, un ricordo primario. La ritenzione, dunque, è presentazione dell’assenza costitutiva
della presenza del presente23. Così, il tempo appare come il continuo trapasso
dall’impressione alla ritenzione, da un’attualità ad una non-attualità. In effetti,
senza il momento “negativo” non si darebbe alcuna percezione del decorso
che decreta la differenza, facendo sorgere sempre nuovi “ora”.
Secondo Derrida, io posso essere cosciente solo di qualcosa che è già passato, cioè di un già dato. Un vissuto è tale, se è ritenuto in quanto non è più
pura impressione originaria, cioè se non è più attuale. È per questo che Derrida
avvicina, pur senza confonderle, ritenzione e rammemorazione: “La differenza
tra la ritenzione e la riproduzione, tra il ricordo primario e il ricordo secondario,
è la differenza, che Husserl vorrebbe radicale, non tra la percezione e la nonpercezione, ma tra due modificazioni della non-percezione” (VF, 101).
Pertanto, la ritenzione e la rimemorazione trovano un terreno comune nella
traccia, nel movimento della différance, in quanto processo e struttura della
ripetizione che costituisce la presenza del presente stesso: “Una tale traccia è,
se si può mantenere questo linguaggio senza contraddirlo e cancellarlo subito, più “originaria” della stessa originarietà fenomenologica. L’idealità della
forma (Form) della presenza implica in effetti che essa possa ri-petersi all’infinito, che il suo ritorno, come ritorno dello stesso, sia all’infinito necessariamente inscritto nella presenza come tale; che il ri-torno sia ritorno di un presente
che si tratterrà in un movimento finito di ritenzione” (VF, 103).
La traccia, col relativo movimento di iterazione, emerge dallo spazio della
non-percezione aperto nel presente vivente dal lavoro necessario della ritenzione. Non coincidendo né con la ritenzione né con la rimemorazione –che
rimangono al livello della coscienza– la traccia allude al momento della gene-
SAGGI
si stessa della presenza del presente, in quanto forma temporale della percezione. Inoltre tale rinvio al movimento di costituzione della coscienza stessa del
presente, movimento localizzabile in un passato che non è mai stato presente, richiama il problema “della storia della ‘vita’ e del divenire-cosciente della
vita” (VF, 103). In questo senso, la nozione quasi-trascendentale di traccia è
utilizzata –nell’orizzonte della Rückfrage– per sondare la scena irrappresentabile del passaggio dal mondo-della-vita (Lebenswelt) al mondo della coscienza. Così, per Derrida, la costituzione del senso del tempo si gioca nella différance tra il “presente vivente” e la “presenza del vissuto”.
Sulla soglia della riduzione fenomenologica, il tempo in quanto temporalizzazione rimanda alla costituzione stessa della coscienza come presenza a sé.
La storia del “divenire-cosciente” coincide con la costituzione della coscienza
del presente, ovvero con il movimento di iterazione proprio dell’auto-affezione
del tempo con se stesso: “Il processo col quale l’adesso vivente, producendosi per generazione spontanea, deve, per essere un adesso, ritenzionalizzarsi
(se retenir) in un altro adesso, intaccare (s’affecter) se stesso, senza ricorso
con una nuova attualità originaria nella quale diverrà non-adesso come adesso pensato, ecc., un tale processo è proprio un’auto-affezione pura nella quale
il medesimo è il medesimo solo facendosi intaccare dall’altro, divenendo l’altro
del medesimo” (VF, 123).
Ritornando su di sé, il tempo produce uno “spaziamento” che è il presente
vivente, pronto ad accogliere il percepito. Se il tempo fosse puro flusso non si
darebbe alcun decorso o durata, ma si avrebbe l’impressione di vivere un eterno presente indifferenziato, in quanto ogni impressione sarebbe assoluta,
senza possibilità di memoria. La percezione della durata presuppone l’abbandono dell’idea di una pura essenza del tempo, per una filosofia dell’iscrizione
originaria dello spazio nel tempo, ovvero per un pensiero della traccia: “la temporalizzazione del senso è fin dall’inizio del gioco ‘spaziatura’. […] Lo spazio è
nel tempo, esso è la pura uscita fuori da sé del tempo, è il fuori-da-sé come
rapporto a sé del tempo” (VF, 124).
Questa spaziatura decreta, pertanto, il fallimento della pretesa husserliana
di pensare il tempo in modo puro e mostra che il campo aperto dalla riduzione
è una scena. In altre parole, anche la fenomenologia induce a rappresentare il
senso dell’oggetto ricercato, invece di intuirlo immediatamente. Pur ricercando
“la cosa stessa” del tempo, per Derrida, Husserl si è trovato a costruire un
eidos: un’immagine statica della temporalità. La scoperta dello statuto differenziale della ritenzione –complicando, in quanto traccia, la semplicità dell’atto di
riduzione iniziale– reintroduce surrettiziamente il tempo del mondo, caratterizzato proprio dalla contaminazione con la dimensione spaziale. In ultima analisi, è tale contaminazione che permette di pensare il ruolo del segno come
“esteriorità costituente” all’interno dell’auto-affezione prodotta dalla voce,
decostruendo la distinzione husserliana tra indice ed espressione.
Questo per quanto riguarda il ruolo giocato dalla fenomenologia del tempo
ne La voce e il fenomeno. L’interpretazione derridiana si è prestata, tuttavia, alle
più forti critiche da parte dell’ortodossia husserliana, specialmente in ambito
anglosassone. Tra le diverse critiche fatte a La voce e il fenomeno, vorrei
9
10
accennare brevemente all’articolo di Natalie Alexander, The Hollow deconstruction of time24. L’articolo sostiene che l’interpretazione di Derrida sia “a weak
misreadings”25, in quanto risulta essere condotta secondo criteri “letterari”.
Secondo la Alexander, Derrida –pensando più come un critico letterario, che
non come un filosofo– ricerca la costruzione retorica di un testo per interpretarla ed eventualmente riprodurla attraverso un procedimento metonimico. Quindi,
l’interpretazione di Derrida non sarebbe argomentata filosoficamente perché
insensibile alla logica sottesa alle analisi husserliane del tempo. Tale logica si
fonda, infatti, sulla teoria husserliana degli interi e delle parti –presentata nella
Terza delle Ricerche logiche– che definisce i rapporti tra elementi indipendenti
e non-indipendenti e, per estensione, le relazioni tra le unità e l’intero flusso
temporale. Non avendo considerato questo fondamentale contesto, la lettura di
Derrida sarebbe filosoficamente delegittimata: “Derrida’s interpretation, trading
on its impossible criterion of presence, assimilates all dependency relations to
grounding relations. By treating the now-phase as an independent foundation,
the Derridian text drives Husserl back toward Brentano, and toward the problem
that a succession of experiences is not an experience of succession, the problem of ‘empirical’ temporal atomism. If the relation between now-phases were
a linear succession of independent instants, then the only relation possible
would be an ‘indicative’ association of independent existences”26.
Ciò che qui è importante discutere, è l’accusa di empirismo nella forma di
un ritorno allo psicologismo brentaniano. Come può, infatti, l’argomentazione
de La voce e il fenomeno –senza riferirsi a Brentano– indurre una studiosa
attenta come la Alexander a questo risultato? Ritengo che la motivazione più
plausibile di questa critica sia da ricercarsi nello stesso “temporeggiare” di
Derrida di fronte alla riduzione fenomenologica. Questa strategia è dovuta, non
tanto ad un presunto fraintendimento, quanto alla scelta di Derrida di evidenziare l’oscillazione più profonda che risiede nello stesso progetto di Husserl:
quella, sottolineata ne Il problema della genesi, tra una fenomenologia statica
ed una genetica. La ricerca derridiana di un sistema d’iterazione delle ritenzioni che precede il darsi del presente è, quindi, da interpretarsi nel solco della
genesi trascendentale e non in quello propria della psicologia empirica.
Nel capitolo dedicato all’analisi delle Lezioni del 1905 Derrida scrive: “Ora,
se si riconosce, come farà Husserl, che l’ ‘ora’ originario non appare che
mediante una sintesi passiva del tempo con se stesso e mediante una ritenzione immediata del passato […], si è in diritto di porre la domanda seguente:
quale discontinuità radicale vi è tra questo passato già costituito e il tempo
obiettivo che mi s’impone, costituito senza alcun intervento da parte mia?
Husserl non porrà questa domanda fondamentale nelle Vorlesungen. Il fatto è
che qui egli rimane a una temporalità noematica, il cui senso è già costituito e
conosciuto”27.
Per Derrida, l’analisi empirica di Brentano è condotta su di un tempo “già
costituito”, così come è già costituito il senso del tempo noematico descritto da
Husserl in seguito alla riduzione del tempo mondano. La riduzione, pertanto,
non porta alla costituzione del tempo mondano sulla base della coscienza
interna del tempo, ma alla costituzione di un tempo ideale che, portato alle
SAGGI
estreme conseguenze, implode sul tempo come forma a priori dell’intuizione
sostenuto da Kant.
La riflessione genetica, suggerita da Derrida, sottolinea la contrapposizione
esistente tra il significato del tempo –guida onnitemporale che costituisce la
condizione di possibilità dell’analisi “statica” condotta da Husserl nelle Lezioni–
e il tempo del significato, attraverso il quale ci si interroga geneticamente sulla
costituzione degli oggetti ideali, anch’essi pensati come prodotti, sebbene né
storicisticamente né psicologisticamente. Ed è al livello di questo tempo costituente l’oggetto ideale “Presente Vivente” come punto-origine (già da sempre
spazializzato e originato) che si devono porre le osservazioni di Derrida sulla
struttura del ritardo e del rinvio come auto-affezione28. Senza considerare il tentativo fatto ne Il problema della genesi di leggere insieme fenomenologia statica e genetica –a partire da una genesi passiva in continuità con la domanda
ontologica– l’interpretazione de La voce e il fenomeno sarebbe da valutare
come totalmente gratuita.
2. Ricoeur: l’aporia dell’apparire del tempo
La lettura delle Lezioni del 1905 di Ricoeur si situa nel progetto complessivo
di “rifigurazione” delle aporie del tempo, riscontrabili nella tradizione filosofica tra
esperienza soggettiva del tempo e tempo cosmologico, attraverso una riconfigurazione narratologica. In tale contesto, Ricoeur considera l’analisi di Husserl
come una descrizione del tempo immanente che, pur nella profondità degli esiti,
risulta inadatta alla spiegazione del tempo fisico. Per questo la descrizione fenomenologica deve essere avvicinata e sostenuta dalla contrapposta spiegazione
kantiana del tempo29. In sintesi, l’intuitività del tempo sostenuta da Husserl, che
esige un presente capace di unire e separare il passato e il futuro, non può
sostenersi senza sottintendere un tempo “invisibile” –perché “non ha punti di riferimento nel presente” (TR III, 91)– quale è quello considerato da Kant.
La necessità del riferimento a Kant costituisce il contenuto della critica di
Ricoeur alla riduzione husserliana del tempo mondano, che apre il campo delle
descrizioni fenomenologiche. Infatti, l’aporia fondamentale risiede già nel ricercare una pura “coscienza interna del tempo” fondata sull’elaborazione di una
descrizione iletica del tempo della coscienza, che si costituirebbe in assenza
di ogni riferimento ad un ordine temporale costituito: “Ora, ci si può chiedere
se tali apprensioni, per strappare l’iletica al silenzio, non devono prendere a
prestito alle determinazioni del tempo obiettivo, conosciute prima della messa
fuori circuito. Parleremmo forse del sentito ‘al medesimo tempo’, se non sapessimo nulla della simultaneità obiettiva, della distanza temporale, se non sapessimo niente dell’uguaglianza obiettiva tra intervalli di tempo?” (TR III, 40).
L’aporia della presupposizione necessaria del tempo mondano –per
Husserl già ridotto– non è, tuttavia, sottolineata da Ricoeur per decretare il fallimento dell’analisi fenomenologica. Tale analisi è solamente limitata ad uno
studio del tempo della coscienza che richiede, come prezzo per la sua audacia e sottigliezza, una certa ambiguità.
11
12
Il commento prosegue indicando le due scoperte principali di Husserl
riguardo al tempo: il fenomeno della ritenzione e della corrispettiva protenzione e la distinzione tra ritenzione (ricordo primario) e la rimemorazione (ricordo secondario). Le suddette innovazioni rappresentano la soluzione posta al
problema dell’intuizione della durata dell’oggetto temporale (ad es. un suono
o una melodia), che Husserl vorrebbe priva di alcuna funzione sintetica
aggiunta.
La ritenzione, in quanto correlata ad una intenzionalità longitudinale, permette la coesistenza dell’impressione originaria e della relativa serie di ritenzioni che rendono conto della continuità e della durata nel mutamento.
Attraverso la ritenzione, infatti, si può rendere conto del fenomeno della durata “nel senso della continuazione del medesimo attraverso la successione di
fasi altre” (TR III, 43). Tale continuità apre dialetticamente alla considerazione
di una identità non logica, ma temporale, che ha il compito di mediare l’identità del presente puntuale e dell’oggetto immanente “non puntuale”, giustificandone la durata percettiva.
Inoltre poiché la relazione tra ritenzione ed impressione originaria è descrivibile come modificazione: Ricoeur “può affermare che il presente e il passato
recente si appartengono reciprocamente, che la ritenzione è un presente allargato che assicura, non solo la continuità del tempo, ma la diffusione progressivamente attenuata dell’intuitività del punto-origine a tutto ciò che l’istante presente ritiene in sé o sotto di sé” (TR III, 48).
Questa comunicazione dell’intuitività al passato rende conto della durata
sotto un duplice aspetto: da un lato, il presente (estendendosi) è modificato in
“presente recente” e, dall’altro, l’impressione originaria passa di ritenzione in
ritenzione defluendo attraverso un adombramento progressivo che spiega la
sensazione del distanziamento temporale. Ogni punto-origine è allora un
cominciare e un continuare che esprime il duplice senso del presente: “punto
d’origine come iniziativa d’una continuità ritenzionale” e “punto-limite, astratto
mediante divisione infinita del continuum temporale” (TR III, 51). Per Ricoeur,
la caratteristica più determinante della ritenzione è quella di esprimere la priorità della modificazione sul momento negativo istituito dalla valorizzazione
della differenza tra l’impressione e la ritenzione. Questa prospettiva è, infatti,
fondata sull’astrazione oggettivante che, fissandosi su un istante, lo pone
come punto-limite (TR III, 50). Conseguentemente, privilegiando la differenza,
ogni istante sarebbe unico e non si potrebbe pensare alcuna forma di continuità tra un punto e un altro del tempo30. Invece, ponendo l’accento sulla modificazione, Ricoeur sottolinea l’anteriorità fondativa del flusso continuo del tempo
su ogni cesura calcolante, interessata a fissare dei punti-origine. La processione dell’impressione originaria e della ritenzione, pertanto, rivela una continuità
vivente che manifesta l’aspetto più originario del tempo, quello indicato dal
ricorso a Kant. In questo senso, tale dimensione originaria sfugge alla fenomenologia della coscienza interna del tempo perché essa viene accettata –e non
intuita– dalla coscienza.
L’altra scoperta essenziale delle Lezioni è quella relativa alla distinzione tra
ritenzione (ricordo primario) e rimemorazione (ricordo secondario). In che cosa
3. Tempo e differenze
Pur non sottovalutando la stratificazione delle osservazioni svolte dai due
autori nei confronti delle Lezioni sulla fenomenologia della coscienza interna
del tempo, ritengo che emergano subito agli occhi del lettore una differenza ed
SAGGI
consiste la differenza tra la ritenzione della melodia che sto udendo e il suo
ricordo, emerso dopo qualche tempo dalla sua esecuzione? Per Ricoeur, la differenza non risiede nel contenuto, ma nel modo di darsi alla coscienza dell’oggetto “melodia”. Nel primo caso, infatti, si ha una percezione, nel secondo una
quasi-percezione perché la melodia non è più data nel modo della “presentazione”, ma in quello della “ri-presentazione”: “Tale differenza sta a significare
che l’‘ora’ puntuale ha il proprio corrispettivo in un quasi-presente che, al di
fuori del suo statuto di ‘come se’, presenta i medesimi aspetti di ritenzione e
protensione, quindi la stessa identità tra l’‘ora’ puntuale e la sequenza di ritenzioni”31.
Pertanto, la differenza tra presentazione e rimemorazione rafforza per contrasto la continuità del flusso temporale, scartando senza appello la possibilità
di una contaminazione tra questi due modi di datità. Quindi per Ricoeur, il ricordo, è una riproduzione costituita analogicamente, che si sovrappone alla continuità originaria del flusso temporale. Il “quasi” che connota la rimemorazione
indica, infatti, che essa può solo riprodurre qualcosa, perché non è un atto
donatore di senso. La costituzione del passato nella rimemorazione avviene,
allora, attraverso il ricorso alla libera variazione. Essa consiste nel: “potere di
ripetere –nel duplice senso di far ritornare e di reiterare– l’esperienza assolutamente primitiva della ritenzione: quest’ultima segue ‘le linee di similarità’ che
rendono possibile la coincidenza successiva tra la medesima successione ritenuta, poi ri-memorata” (TR III, 56).
Questa coincidenza risponde a due problemi: da un lato, compensa la frattura tra la ritenzione e la rimemorazione che non intenziona più un presente
attuale e, dall’altro, introduce alla differenza tra rimemorazione e immaginazione. Infatti, il rimemorare comprende in sé una seconda intenzionalità con valore posizionale (Setzung) “che ne fa una rappresentazione di..., seconda nel
senso che equivale alla replica (Gegenbild) dell’intenzionalità longitudinale
costitutiva della ritenzione e generatrice del tempo-oggetto” (TR III, 57). In questo modo, il rimemorare si rivolge al proprio contenuto e lo pone come ciò che
è stato (presente). Ricoeur ha così dimostrato come la descrizione husserliana riesca a distinguere i piani temporali, rendendo possibile pensare il passato in modo “realistico” attraverso l’analogia con il presente.
L’esposione ricoeuriana prosegue, poi, esplicitando i livelli della costituzione del tempo: obiettivo, obiettivato dagli oggetti temporali e immanente. La
conclusione di Ricoeur consiste nel sostenere che per analizzare il tempo non
è sufficiente ricorrere all’autocostituzione del flusso temporale immanente, ma
occorra riferirsi al tempo come condizione di possibilità dell’esperienza, quale
lo descrive Kant.
13
14
una somiglianza di carattere generale, che possono essere mantenute come
una costante del confronto tra Ricoeur e Derrida. La differenza riguarda l’atteggiamento critico nei confronti di Husserl.
Derrida mira, attraverso una riconsiderazione globale delle diverse fasi
della fenomenologia, a sottolineare i punti controversi che contestano l’autointerpretazione idealistica. Così facendo, egli può far scivolare –secondo una
complessa strategia che porta Husserl contro Husserl– le argomentazioni
fenomenologiche dal costituire un’espressione della metafisica della presenza
compiuta nell’intuizionismo alla base per istituire una fenomenologia della
“contaminazione originaria di empirico e trascendentale”, aperta al confronto
con i momenti non sottoposti al dominio metafisico, presenti nello strutturalismo o nella psicoanalisi. Tra questi emerge l’interpretazione originale della
struttura iterativa delle ritenzioni presente in Husserl, in relazione al concetto di
traccia “inconscia”. Tale interpretazione implica, poi, una traslazione nel significato della “passività” in ambito fenomenologico, verso una concezione più
vicina a quella psicoanalitica. L’uso derridiano, tuttavia, non tende ad una semplice fusione arbitraria dei due registri, ma tenta di pensarne le implicazioni nei
confronti dell’esposizione del movimento della différance.
D’altro canto Ricoeur attinge con più fiducia alle analisi e al metodo presenti nei testi di Husserl, completando le mancanze o incongruenze eventuali
all’interno della propria ermeneutica. Senza doversi vincolare alla totalità della
“lettera” husserliana, Ricoeur ne fa un momento della propria proposta. Ad
esempio, il concetto di iniziativa (TA, 251-267; TRIII, 350-365), elemento fondamentale della riflessione sul presente storico, riceve la sua impronta dal presente allargato, elaborato a partire dalla relazione tra impressione originaria e
ritenzione ottenuta dalla lettura delle Lezioni sulla fenomenologia della
coscienza interna del tempo.
L’analogia consiste nella presa di distanza comune dalla riduzione fenomenologica.
Per Derrida, questo gesto assume le tonalità di un differimento irriducibile rispetto alla presenza a sé di un vissuto immanente. L’immediatezza è il
telos impossibile della stessa riduzione, in quanto questa risulta inseparabile da un atto del soggetto esistente che “converte” il proprio atteggiamento.
Nessuna riduzione, quindi, può comprendere quell’atto che esclude per
definizione come mondano. Pertanto, nell’orizzonte definito da questo limite strutturale si manifesta lo iato tra la sfera ridotta del vissuto e quella
vivente. Il tempo costituito nella coscienza pura, escludendo il tempo noetico nel quale si dà l’atto della riduzione, è così semplice éidos. Esso si risolve in un “tempo formale” segnato, in quanto tale, da una differenza irriducibile rispetto al tempo concreto dell’esistenza. Il tempo, così ridotto, riduce
inevitabilmente la complessità temporale ad un flusso dove “l’attuale adesso è e permane qualcosa di puntuale, una persistente forma per sempre
nuove materie”32.
In continuità con il taglio adottato, la contestazione della riduzione e la contaminazione di empirico e trascendentale vengono a coincidere nella strategia
derridiana. Attraverso tale coincidenza, Derrida tende a far giocare la rigorosa
SAGGI
fedeltà al fenomeno –professata da Husserl– contro la decisione metafisica
della puntualità dell’istante, mantenuta nel “punto sorgente” dell’impressione
originaria. Come deduce la Marrati-Guénon, la scommessa derridiana “sera
alors de montrer que le présent n’est jaimai simple, qu’il est toujour une synthèse originaire et irréductible33.
Pertanto, il ruolo di tale sintesi spezza la purezza della riduzione introducendo un’assenza costitutiva, uno “spaziamento” ed una passività nel bisogno
riscontrato dal presente di ricorrere al supplemento della ritenzione. In questo
senso, è evidente il ricorso al movimento heideggeriano e kantiano dell’autoaffezione34, per cui il presente si produce a partire da un ritorno che, negando
la sua puntualità, lo “pone in essere”. Poiché è tale solo attraverso la riduzione, il sedicente presente di cui si ha coscienza è già da sempre passato.
Dunque, il presente della coscienza è l’effetto prodotto dalla mediazione della
struttura iterativa della traccia ritenzionale: esso è infatti identificabile, in quanto è già da sempre reiterato.
Invece, il rilevamento dell’aporia presente nella riduzione husserliana del
tempo mondano e il necessario completamento con la prospettiva kantiana,
presente in Ricoeur, si spiega con il tentativo di salvaguardare la possibilità
delle Lezioni di descrivere il presente vivente. Questa strategia, infatti, è funzionale al progetto ricoeuriano consistente nell’elaborazione di una ermeneutica della coscienza storica, che “aperta alla ruminazione delle aporie della
fenomenologia del tempo, consiste nel riflettere sul tempo storico tra il tempo
fenomenologico e il tempo che la fenomenologia non riesce a costituire, che
lo si chiami tempo del mondo, tempo obbiettivo o tempo ordinario” (TR III,
159).
Per raggiungere questo scopo, Ricoeur deve pensare il contributo di
Husserl come relativo alla sola coscienza immanente. Allora la riduzione viene
confinata alla costituzione della sola dimensione interna che, come tale, non
può sostenersi se non ricorrendo alla determinazione propriamente kantiana
della “non intuitività” del tempo, in quanto forma a priori della sensibilità. Infatti,
dall’analisi ricoeuriana dello schematismo, che tratta della mediazione operata
dall’immaginazione tra categorie e sensazioni, risulta che “il tempo non potrebbe essere percepito in se stesso, ma che noi ne abbiamo una rappresentazione indiretta, in occasione delle operazioni ad un tempo intellettive ed immaginative applicate a degli oggetti nello spazio” (TR III, 76).
Per Ricoeur, la riduzione impedisce a Husserl di pensare la correlazione tra
tempo ed esistenza mondana. Questa si esprime in Kant attraverso l’argomento dell’auto-affezione come auto-modificazione del soggetto mediante i propri
atti. Ricoeur, qui in continuità con Derrida, trova ciò che manca alla fenomenologia ricorrendo all’auto-affezione declinata esistenzialmente. Tuttavia in
Ricoeur, questo ricorso non comporta alcuna relazione con lo spazio: “Siamo
ben lontani da qualche contaminazione del tempo da parte dello spazio, la
mediazione delle operazioni sullo spazio rivela d’un sol tratto, il legame, nel
vivo dell’esperienza del tempo, della passività e dell’attività: noi siamo segnati
temporalmente nella misura in cui agiamo temporalmente; essere segnati e
produrre costituiscono un solo e unico fenomeno” (TR III, 86).
15
16
La critica a Husserl è, quindi, svolta avendo presente la riflessione kantiana. Per cui, se da un lato, non è possibile accedere alle necessarie acquisizioni husserliane che escludendo la problematica kantiana, dall’altro, si può
descrivere la fenomenologia del tempo solo ricorrendo a “prestiti” nei confronti del tempo obiettivo determinato kantianamente. Pur nella complementarità
delle prospettive, fenomenologia e critica si escludono reciprocamente come la
facce di una stessa medaglia (TR III, 89). In ultima analisi, l’aporia tra tempo
della coscienza e tempo della natura rimane a monte di una certa ricaduta “intimista” delle analisi sviluppatesi in seguito alla riduzione fenomenologica del
tempo mondano.
A partire dalla posizione e dalla declinazione dell’argomento dell’auto-affezione in rapporto alla critica della riduzione husserliana, possiamo ora mettere
in luce una differenza caratteristica nella strategia dei due autori.
Per Derrida, l’auto-affezione come “passività produttiva” è connessa da un
lato alla problematica heideggeriana della differenza ontologica e dall’altro all’incrocio tra segno (Saussure) e inconscio (Freud) determinato dalla traccia35.
Invece Ricoeur, attraverso una connotazione esistenziale dell’auto-affezione kantiana e ricorrendo al tema dell’azione-passione, cerca di attuare il “rinvio della fenomenologia all’ontologia”, nella speranza di dare compimento ai
temi della fenomenologia esistenziale francese36.
L’approfondimento della comune critica alla riduzione husserliana termina
in una divaricazione, in fondo, della passività. Nella prospettiva geneticodecostruttiva di Derrida, la passività esprime una non-presenza che costituisce la coscienza stessa e che non è mai accessibile ad essa; per Ricoeur,
invece, si tratta dell’interpretazione dell’inesauribile opacità di ciò che è
“altro” rispetto alla coscienza e che si dà nell’agire nel mondo-della-vita
(Lebenswelt).
Dopo aver considerato alcune caratteristiche generali del confronto, posso
avviarmi alla conclusione attraverso l’analisi della nota con la quale Ricoeur
considera direttamente la lettura derridiana delle Lezioni del 1905 svolta ne La
voce e il fenomeno37. La nota in questione appare nel momento in cui Ricoeur
presenta la ritenzione come mediazione delle impressioni originarie, che opera
in modo da costituire la durata temporale espressa dall’avverbio “ancora”. La
ritenzione agisce, quindi, in senso chiaramente dialettico: “La funzione della
ritenzione è quella di fissare l’identità del presente puntuale e dell’oggetto
immanente non puntuale. La ritenzione è una sfida alla logica del medesimo e
dell’altro: questa sfida è il tempo […] Durare significa che qualcosa persiste
mutando. L’identità che ne risulta non è più quindi una identità logica, ma precisamente quella di una totalità temporale” (TR III, 46).
È da questa concezione del presente vivente, pensato dialetticamente
attraverso la mediazione della ritenzione, che Ricoeur avvicina la presa di posizione di Derrida. Ricoeur sottolinea che la distinzione tra presente e istante
operata da Husserl nelle Lezioni è una scoperta che va mantenuta: “prescindendo dalla dipendenza della teoria husserliana dell’intuizione” (TR III, 46);
non equiparando “sotto il segno comune dell’alterità” ritenzione e rimemorazione, in quanto la ritenzione continua la percezione.
SAGGI
In questo modo, la posizione di Derrida è ridotta ad una critica dell’identità puntuale o logica che non riesce a superarsi in una identità temporale.
Inoltre, l’adozione della nozione di traccia –alla quale Ricoeur riconosce un
certo merito– non comporta, tuttavia, le osservazioni più radicali di Derrida
sulla costituzione passiva del presente, attraverso il movimento della différance. Se, come vuole Ricoeur, la traccia “si oppone solo ad una fenomenologia che confonda il presente vivo con l’istante puntuale” (TR III, 46), allora
–come è stato precedentemente mostrato– non si sta considerando il testo
di Derrida, o meglio non lo si vuole considerare. E questo perché Ricoeur,
pur presentando tutte le critiche che abbiamo esposto, non vuole accettare
la messa in discussione derridiana del valore della presenza e per questo
–chiaramente contro Derrida– giunge a riportare Husserl ad Agostino:
“Husserl apre la via ad una filosofia della presenza inclusiva dell’alterità sui
generis della ritenzione. […] Husserl non fa altro che affinare la nozione agostiniana del triplice presente e, più precisamente, quella del ‘presente del
passato’” (TR III, 47).
La divergenza tra i due autori si è fatta abissale. Inoltre, alcuni indizi nel
testo di Ricoeur inducono a pensare che tale lettura di Husserl sia impostata, per buona parte, al fine di contrastare la decostruzione derridiana: “le
nozioni di differenza, di alterità, di negatività espresse mediante la formula
‘non...più…’, non sono prime ma derivano dall’astrazione operata sulla continuità mediante uno sguardo che si ferma sull’istante e lo trasforma da
punto d’origine in punto limite. Un aspetto della grammatica del verbo essere conferma questa veduta: è infatti possibile coniugare il verbo essere ad
un tempo passato (e futuro) senza introdurre negazione: ‘è’, ‘era’, ‘sarà’
sono espressioni del tutto positive che indicano nel linguaggio la priorità dell’idea di modificazione rispetto a quella di negazione […] il ricordo primario
è una modificazione positiva dell’impressione, non una differenza” (TR III,
50-51).
In Della grammatologia tuttavia, Derrida sembra anticipare le obiezioni nelle
quali sarebbe incorso da parte dei fenomenologi (G, 98-105). La traccia, infatti, è il nome di una passività in rapporto ad un passato che non si lascia riattivare in alcuna presenza, nemmeno in quella modificata del presente-passato.
In questo modo, Derrida può rimproverare a Husserl (e a Ricoeur) di complicare la struttura del tempo senza mai intaccarne la linearità –se non attraverso “ritorni intenzionali” quali la rimemorazione– per risvegliare qualcosa che, a
ben vedere, è passato solo in potentia. Infatti, la ritenzione e la protensione
“alla lettera”, pur estendendo il presente vivente oltre la puntualità dell’istante,
non ne contestano a fondo la legalità, per cui “decostruire la semplicità della
presenza non porta solamente a tener conto degli orizzonti della presenza
potenziale, o anche di una ‘dialettica’ della protensione e della ritenzione che
si installerebbe nel cuore del presente invece di farglielo abbracciare”38. Per
“abbracciare” il presente, Derrida ritiene necessario ricorrere alla nozione freudiana di effetto a ritardo (nachträglich), abbandonando l’impianto della fenomenologia della coscienza39.
Infine, queste osservazioni ci permettono di mettere a fuoco con più preci-
17
sione la distanza che separa i due pensatori. La lettura di Ricoeur, rifiutando
l’inerenza nel presente allargato di ogni dimensione spaziale e interpretando la
ritenzione come il “terzo” che opera la sintesi, accetta il privilegio delle nozioni
di continuità e di presenza. D’altro canto, Derrida, optando per un pensiero
della différance, indicando nella traccia ritenzionale qualcosa che non “è”, ma
precede e genera.
18
1
M. LUZI, da “Nel corpo oscuro della metamorfosi” in Tutte le poesie I, Garzanti, Milano 1988,
p. 382.
2
Cfr. V. FAGONE S.J., Tempo e intenzionalità, in “Archivio di filosofia”, CEDAM, Padova 1960,
pp. 105-131.
3
Per la spiegazione di quanto, per motivi di spazio, ho potuto soltanto riassumere: E.
MELANDRI, Logica ed esperienza in Husserl, Il Mulino, Bologna 1960, in particolare il II capitolo:
“Eidos. Il problema dello schematismo fenomenologico”. Inoltre: E. FRANZINI, Fenomenologia.
Introduzione tematica al pensiero di Husserl, Franco Angeli, Milano 1991.
4
La cui traduzione italiana è contenuta in E. HUSSERL, Per la fenomenologia della coscienza
interna del tempo (1893-1917), Franco Angeli, Milano 1998.
5
Per l’analisi del confronto da un punto di vista più generale, mi permetto di rinviare a: M.
SALVIOLI, Oltrepassare il segno. Derrida e Ricoeur lettori di Husserl, “Segni e comprensione”, n. 45,
gennaio-aprile 2002, pp. 26-39.
6
J. DERRIDA, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl, PUF, Paris 1967; tr. it. di G. Dalmasso, La voce e il fenomeno [VF], Jaca Book,
Milano 1997.
7
P. RICOEUR, Tempo e racconto III. Il tempo raccontato [TR III], Jaca Book, Milano 1988, pp.
38-68. Ricoeur è ritornato sul tema della fenomenologia del tempo, nella sua ultima opera La
mémoire, l’histoire, l’oubli, Èditions du Seuil, Paris 2000; tr. it. a cura di D. Iannotta, La memoria,
la storia, l’oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003. Tuttavia, per quanto riguarda l’oggetto
della presente ricerca, quest’ultimo volume non sembra portare alcuna innovazione teoreticamente significativa rispetto a quanto sostenuto in Tempo e racconto.
8
Cfr. M. SALVIOLI, Il senso della storia secondo Ricoeur e Derrida, “Sapienza”, 56 (2003), pp.
181-200, dove, tra l’altro, ho cercato di mostrare che –attraverso diverse interpretazioni della traccia, del sedimento e della Rückfrage – Derrida e Ricoeur pensano il movimento della “storicità trascendentale” declinando in senso storico le decisioni teoretiche prese intorno al senso della temporalità e alla temporalità del senso.
9
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it. di E.
Filippini, Est, Milano 1997, p. 166.
10
R. BERNET, La voix de son maître, in La vie du sujet. Recherches sur l’interpretation de
Husserl dans la phénoménologie, PUF, Paris 1994, p. 295.
11
J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (1953-1954), PUF,
Paris 1990; tr. it. di V. Costa, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl [PG], Jaca Book,
Milano 1992, pp. 163-177.
12
E. HUSSERL, La crisi..., cit., p. 178. Dove al § 40 si insiste sul fatto che la riduzione per essere “totale” deve essere eseguita in modo istantaneo evitando il fraintendimento dell’astensione graduale. Derrida, al contrario, sembra optare per questa gradualità che si concretizza nel mostrare
come la pretesa purezza del “campo dell’esperienza trascendentale” sia sempre contaminata da
una passività irriducibile che segna l’impossibilità di una riduzione totale. Se mi è lecito continuare l’allegoria di Bernet, la “voce del maestro” è così continuamente interrotta dal discepolo acuto e
petulante che contesta le premesse della lezione, non permettendo agli altri di apprendere in modo
passivo il contenuto del corso e contendendo al docente il primato.
13
Il rinvio è alla conferenza La différance dove Derrida esplicita la propria strategia condensandola in un segno costruito ad arte per destabilizzare le varie forme della metafisica della pre-
SAGGI
senza: “Differire, in questo senso, è temporeggiare, è ricorrere, coscientemente o incoscientemente, alla mediazione temporale o temporeggiatrice di una deviazione che sospende il compimento
o il riempimento del ‘desiderio’ o della ‘volontà’, e che parimenti li effettua in modo che ne annulla
o tempera l’effetto” (Marges – de la philosophie, Minuit, Paris 1972; tr. it. di M. Iofrida, Margini della
filosofia [M], Einaudi, Torino 1997, p. 34). “Il segno sarebbe dunque la presenza differita. […] Ciò
che descrivo qui per definire, nella banalità dei suoi tratti, la significazione come différance di temporeggiamento, è la struttura del segno determinata in modo classico: essa presuppone che il
segno, differendo la presenza, non sia pensabile che a partire dalla presenza che esso differisce
e in vista della presenza differita di cui si mira a riappropriarsi” (M, p. 36).
14
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tr. it. di E.
Filippini, Einaudi, Torino 1965, § 24, pp. 50-51.
15
E. HUSSERL, § 26 della VI Ricerca logica in Ricerche logiche II, Il Saggiatore, Milano 1968,
pp. 390-393.
16
VF, p. 95: “La punta dell’istante, l’identità del vissuto presente a sé nel medesimo istante
porta dunque tutto il peso di questa dimostrazione. La presenza a sé deve prodursi nell’unità indivisa di un presente temporale”. Questa è l’interpretazione che attraversa anche Ousia e grammé
(M, p. 64) dove Derrida, al fine di confrontarsi decostruttivamente con Heidegger, scrive: “Da
Parmenide a Husserl, il privilegio del presente non è mai stato messo in questione».
17
E. HUSSERL, Per la fenomenologia…, cit., § 11, p. 64.
18
Ibidem.
19
E. HUSSERL, Idee I, cit., § 81, p. 182.
20
Ibidem, p. 144: “È infatti un assurdo parlare di un contenuto ‘inconscio’, che solo in un secondo momento diverrebbe conscio. Coscienza è necessariamente esser-conscio in ciascuna delle
sue fasi. Come la fase ritenzionale ha coscienza della precedente senza farla oggetto, così anche
il dato originario è già conscio – nella peculiare forma dell’‘ora’– senza esser oggettuale”. Questo
passo è interpretato da Derrida come conferma del dominio del presente, a differenza di quanto
pensa Freud (VF, p. 98). A questo riguardo cfr. R. COBB-STEVENS, Derrida and Husserl on the status of retention, “Analecta Husserliana”, XIX, 1985, pp. 367-381, il quale ritiene che il pensiero di
Derrida sovrapponga indebitamente elementi tratti da Saussure, Freud e Nietzsche alla fenomenologia, negando la riduzione attraverso l’interpretazione della ritenzione come traccia inconscia e
spingendosi verso un nuovo naturalismo presentato come empirismo post-trascendentale.
Mostreremo in seguito come il riferimento a PG e al ruolo della sintesi passiva nel pensiero di
Husserl contribuisca a ridurre l’apparente arbitrarietà del gesto derridiano.
21
Cfr. R. BERNET, «La présence du passè», in op. cit., pp. 214-241.
22
J. DERRIDA, La dissemination, Seuil, Paris 1972; tr. it. di S. Petrosino e M. Odorici, La disseminazione [D], Jaca Book, Milano 1989, pp. 240 e ss.
23
Per ricorrere ad una immagine classica: la ritenzione, rispetto all’impressione originaria, è da
pensarsi in analogia con il “vuoto”, rispetto alla brocca. Non si dà nessun recipiente, senza il vuoto
che consente ad un oggetto di contenerne un altro.
24
N. ALEXANDER, “The hollow deconstruction of time” in W. R. MCKENNA e J. C. EVANS (a cura
di), Derrida and phenomenology, Kluwer Academy Publishers, Dordrecht 1995, pp. 121-150.
25
Ivi, p. 150.
26
Ivi, op. cit., p. 129.
27
PG, p. 147. Per il commento dettagliato al problema del tempo in chiave “genetica” tra
Derrida e Husserl, rimando a: V. COSTA, La generazione della forma. La fenomenologia e il problema della genesi in Husserl e in Derrida, Jaca Book, Milano 1996, in particolare il secondo capitolo “La sintesi originaria”, pp. 61-86.
28
Già PG, p. 158, presenta una struttura analoga: “Si tratta di una sintesi ontologica a priori e
nello stesso tempo dialettica. La soggettività è il tempo che si auto-temporalizza. Il tempo è la soggettività che si auto-realizza come soggettività”. In VF, Derrida abbandona il linguaggio ontologico
e dialettico, dettato dalle influenze di Heidegger, per volgersi ad un vocabolario strutturalista,
mutuato dalle riflessioni su de Saussure e Freud. Tuttavia l’apertura filosofica ad un pensiero della
non presenza ai margini della filosofia è dato dalla complicazione originaria di empirico e trascendentale offerta primariamente dalle domande suscitate dal problema della genesi in Husserl.
29
L’interpretazione ricoeuriana è da connettersi all’articolo del 1954-55 “Kant e Husserl” in P.
Ricoeur, A l’école de la phénoménologie [EP], Vrin, Paris 1986, pp. 227-250, secondo cui la feno-
19
20
menologia richiede una fondazione kantiana così come le analisi della Estetica trascendentale
conterrebbero una fenomenologia implicita: “Husserl fait la phénoménologie. Mais Kant la limite et
la fonde” (p. 250).
30
Cfr. P. BOURGEOIS, The instant and the living present. Ricoeur and Derrida reading Husserl,
“Philosophy Today”, n. 37, Spring 1993, pp. 31-37.
31
TR III, p. 53. Questa analogia, sostenuta dal carattere positivo della ritenzione, tra dato ritenuto e dato ri-memorato costituirà la base fenomenologica su cui Ricoeur costituirà l’ermeneutica
della coscienza storica.
32
E. HUSSERL, Idee I, cit., § 81, p. 182.
33
P. MARRATI-GUÉNON, La genèse et la trace. Derrida lecteur de Husserl et Heidegger, Kluwer
Academy Publishers, Dordrecht 1998, p. 85.
34
VF, p. 121: “Ora, dal momento in cui si tiene conto del movimento della temporalizzazione,
come esso è già analizzato nelle Vorlesungen, bisogna utilizzare il concetto di cui si serve
Heidegger, lo si sa, in Kant und das Problem der Metaphysik, precisamente a proposito del tempo”.
Cfr. M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, Laterza, Roma-Bari 1981, § 34 “Il tempo
come autoaffezione pura e il carattere temporale del se-stesso”, pp. 162-168.
35
Cfr. J. DERRIDA, De la grammatologie, Minuit, Paris 1967; tr. it. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi,
G. Contri, G. Dalmasso, A.C. Loaldi, Della Grammatologia [G], Jaca Book, seconda ed. rivista e
aggiornata, Milano 1998, in particolare il secondo capitolo della prima parte “Linguistica e grammatologia”, pp. 49-108, dove Derrida aggiunge il contributo di Nietzsche e soprattutto quello di
Levinas alla costituzione della nozione di traccia.
36
Questo processo è riscontrabile dapprima nella correlazione volontario-involontario che risale alla prima opera autonoma (1950): “Sotto il titolo de Il volontario e l’involontario, le analisi eidetiche, ricche di sottili distinzioni si trovavano ad essere dinamizzate dalla dialettica inglobante dell’attività e della passività […]. Se a Husserl dovevo la metodologia, designata con il termine di analisi eidetica, a Gabriel Marcel dovevo la problematica di un soggetto, a un tempo, incarnato e capace di mettere a distanza i propri desideri e i propri poteri, in breve di un soggetto padrone di sé e
servo di quella necessità, figurata dal carattere, dall’inconscio e dalla vita” (P. RICOEUR, Riflession
fatta. Autobiografia intellettuale, Jaca Book, Milano 1998, p. 34.); quasi a concludere l’itinerario
ricoeuriano ritroviamo questo schema concettuale nel tentativo di pensare il corpo proprio: “Con la
diminuzione del potere di agire, sentita come una diminuzione dello sforzo di esistere, comincia il
regno propriamente detto della sofferenza. […] In questa prospettiva bisognerebbe ripercorrere il
lavoro concettuale fatto a partire dai Trattati classici delle passioni, passando attraverso Maine de
Biran, fino alla meditazione di Gabriel Marcel, di Merleau-Ponty e di Michel Henry, sull’incarnazione, la carne, la situazione affettiva e l’auto-affezione” (P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book,
Milano 1993, pp. 434-435.).
37
TR III, pp. 46-47. Sullo specifico cfr. P. BOURGEOIS, op. cit..
38
G, p. 99. Nel riconoscimento dell’insufficienza dell’interpretazione dialettica del Presente
Vivente dobbiamo leggere anche un superamento di Derrida sulle proprie posizioni rispetto
all’Introduzione a “L’origine della geometria”, dove affermazioni di questo genere: “Mediante la sua
dialetticità stessa, l’originarietà assoluta del Presente Vivente consente la riduzione, senza negazione, di ogni alterità” (“Introduction” a E. Husserl, L’origine de la géométrie, PUF, Paris 1962; tr.
it. di C. di Martino, Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl [IOG], Jaca Book, Milano
1987, p. 140), compaiono più volte.
39
IOG, p. 214: “Il ritardo è qui l’assoluto filosofico […] la Riduzione non è che il pensiero puro
di questo ritardo, il pensiero puro in quanto esso prende coscienza di sé come ritardo in una filosofia”. Questo frammento di IOG potrebbe suggerire di subordinare la derivazione psicoanalitica
della tematica del ritardo originario ad una riflessione autonoma del giovane Derrida sulla dinamica della riduzione fenomenologica stessa.
40
G, p. 100: “proprio qui superiamo il limite della fenomenologia. L’archiscrittura come spaziatura non può darsi come tale, nell’esperienza fenomenologica di una presenza. Essa marca il
tempo morto nella presenza del presente vivente, nella forma generale di ogni presenza”.
CI DOVREBBE ESSERE UNA ENORME ECLISSI.
SACRIFICIO, MORTE E DISSIMULAZIONE
IN WILLIAM SHAKESPEARE
Che Shakespeare fosse molto interessato al tema della sovranità è noto, e
la letteratura sul tema è pressoché sterminata; è noto anche il suo interesse
per la monarchia, in particolare per quella inglese1. D’altra parte, “uno dei più
evidenti e indiscutibili aspetti della visione che Shakespeare aveva della vita è
che la sua concezione della società è strettamente connessa con la sua fede
nella monarchia, in quanto principio di ordine, strumento predestinato di Dio
per mantenere sulla terra un ordine giusto, corrispondente al governo divino
del cosmo”2. Quali siano però le connessioni fra questi due temi, fra di loro solo
parzialmente sovrapponibili, come queste si intreccino con il problema del
potere, della forma di quest’ultimo, delle sue quasi infinite manifestazioni nei
più diversi ambiti della vita dell’uomo, soprattutto dell’uomo che vive in società, è ciò che intendo affrontare. Ovviamente, mi limiterò ad indicare alcuni
momenti topici delle opere shakespeariane, sperando di poter mettere in luce
non tanto Shakespeare, quanto la densità e la problematicità a cui la sua opera
rimanda.
La sovranità era stata definita da Bodin “quel potere assoluto e perpetuo
ch’è proprio dello Stato”3; assoluto e soprattutto perpetuo perché “può succedere infatti che ad una o più persone venga conferito il potere assoluto per un
periodo determinato, scaduto il quale essi ridivengono nient’altro che sudditi;
ora, durante il periodo in cui tengono il potere, non si può dar loro il nome di
prìncipi sovrani, perché di tale potere essi non sono in realtà che custodi e
depositari fino a che al popolo o al principe, che in effetti è sempre rimasto
signore, non piaccia di revocarlo”4. Infatti, “se il potere assoluto concesso al
luogotenente del principe si chiamasse sovranità, egli potrebbe valersene contro il suo principe, che sarebbe ridotto a uno zero”, mentre “per disposizione
della legge, la persona del sovrano è sempre esente da quell’autorità e da quel
potere, qualunque sia, che conferisce ad altri”.5
Sovranità è un concetto chiave per la filosofia e il pensiero politico rinascimentale, anzitutto quello francese, almeno dal momento in cui le lotte civili di
religione, lo stato di guerra di tutti contro tutti divenuto ormai apparentemente
irreversibile, ha fatto comparire sulla scena europea uno stato di follia generalizzata in cui sembra che gli uomini siano “tormentati dalle furie, che si siano
votati anima e corpo al diavolo e a una vita miserabile, e che abbiano solo fretta di morire”6. Questo stato richiedeva urgentemente una rifondazione del potere politico e il fondatore più autorevole della teoria moderna della sovranità è
indiscutibilmente Jean Bodin. Quello di Sovranità è il “concetto centrale della
Republique, com’è stato ripetuto fino a fare dell’affermazione il fondamentale
SAGGI
di Fabio A. Sulpizio
21
22
luogo comune degli studi bodiniani”7. Ora, “tale concetto di sovranità ci appare
in primo luogo da valutarsi sotto due diversi rispetti, verso l’alto e verso il
basso, nei riguardi del potere altrui e nei riguardi dei soggetti, o dei sudditi”8, e
l’aggettivo che sempre in Bodin si accompagna al sostantivo souveraineté è
absolue, assoluta, ossia sciolta e indipendente da ogni altro potere. Il concetto di sovranità “riguarda insomma i rapporti verso l’alto, piuttosto che verso i
soggetti; continua e porta a radicale coerenza il concetto bartoliano del superiorem non recognoscens”9. L’unico superiore che il re riconosce è Dio stesso:
“piuttosto che vassallo, sarebbe esatto dire che per Bodin il re è suddito diretto di Dio, in quanto Dio ha su di lui potere di comando, Dio gli dà la legge cui
egli deve obbedire”10. Essere sudditi diretti di Dio, però, significa in qualche
modo esautorare la Chiesa di Roma, anzi, tutte le chiese, di una delle loro funzioni e, in questa maniera, assumere su di se il duplice ruolo di pontefice e
sovrano. In effetti Bodin, fondando la sovranità assoluta del potere civile, la sua
indivisibilità, il suo promanare da un’unica fonte che la detiene e possiede con
esclusività assoluta e perfetta unicità, “diventa per ciò stesso erede di tutti i
motivi della lotta dell’impero medievale contro le pretese papali”11. Come ricorda Sacerdoti, pubblicati nell’edizione francese nel 1576, Les six livres de la
Republique furono tradotti e pubblicati dieci anni dopo in latino, e in Inghilterra
non c’era persona colta che non avesse nello studio il De Republica di Bodin,
o la Politica di Aristotele esposta dal politique Louis Le Roy. Sacerdoti individua proprio nel pensiero di Bodin una delle chiavi per poter accedere al segreto celato nel Love’s Labour’s Lost di Shakespeare: “Ciò cui abbiamo avuto
l’esclusivo privilegio di assistere è dunque il portentoso spettacolo di una principessa sibi princeps e superiorem non recognoscens che, ‘imperatrice nel suo
regno’, ha appena conquistato la self-sovereignty, la ‘sovranità su se stessa’
–cioè una sovranità ‘assoluta’ e ‘indipendente da ogni altro potere’, specie per
quanto concerne i ‘rapporti verso l’alto’. Ma per essere, appunto, indipendente
nei rapporti verso l’alto la principessa ha dovuto giocoforza riassumere in sé
quelle prerogative che nell’Occidente cristiano erano sempre appartenute a un
sommo sacerdote che perciò stesso pretendeva, come osserva Bodin, ‘la
sovranità non solo spirituale ma temporale su tutti i principi cristiani’. Ed ecco
che la principessa, per ottenere una sovranità autonoma, strappa la prerogativa sacerdotale del sacrificio al sommo sacerdote, lo ‘sottomette’, e diventa
‘signora del suo signore’. Come i Cesari del tardo impero romano cristianizzato, e come gli imperatori bizantini d’Oriente, la principessa della commedia
risulta dunque ‘monarca nel senso letterale della parola, cioè nel senso che è
insieme re e sacerdote’”12.
Fuor di metafora, quindi, il testo di Shakespeare si svelerebbe quale legittimazione, in forma poetica e teatrale, della duplice veste di Elisabetta: Regina
e Sommo pontefice della Chiesa Inglese. Questa duplice funzione, però, non
era soltanto sgradita al Papa, ma anche alla chiesa presbiteriana inglese e, in
generale, alle Chiese Riformate. Per Calvino, ad esempio, “l’autorità è un ordine voluto da Dio, e di conseguenza rispettabile sotto la forma in cui la
Provvidenza si è degnata di trasmettercela. Ma essa è autorità solo nella misura in cui adempie al suo compito, che è quello di organizzare la società, di faci-
Il principio di autorità è stato calpestato; ed ecco, quante tende greche sorgono
concave su questa pianura, altrettante ci sono vacue fazioni. Il comandante supremo non è più come l’alveare a cui debbono far capo tutte le api, e allora che miele
c’è da aspettarsi? Se la gerarchia è travestita, il più indegno può farsi bello sotto
la maschera. i cieli stessi, i pianeti, e questa terra, osservano gerarchia, priorità, e
luogo, stabilità di corso, orbita, proporzione, stagione, forma, funzione e abitudine,
con pieno senso dell’ordine; perciò il glorioso astro Sole troneggia col suo globo in
nobile eminenza fra gli altri corpi celesti. Il suo occhio benefico corregge gli influssi nefasti dei pianeti maligni, e, come un decreto regale, li convoglia direttamente
al bene o al male. Ma immaginiamo che i pianeti mischiandosi malamente si mettano a deviare in disordine: quali sciagure e quali portenti, che rivoluzione cosmica, che maremoti, terremoti, aeromoti, che terrori, mutazioni, orrori possono alterare e spezzare, stracciare e sradicare dalle fondamenta l’unità e il pacifico connubio degli stati dell’universo! Oh, quando è scossa la gerarchia, scala a ogni altro
progetto, l’impresa è malata! Come possono stare al loro giusto posto le comunità, i gradi accademici, e le corporazioni cittadine, il commercio pacifico fra lidi
segnati sulle mappe, la primogenitura e il diritto di nascita, le prerogative dell’età,
le corone, gli scettri, gli allori, se non grazie alla gerarchia? Togli solo la gerarchia,
stona questa corda, e vedrai la discordia che ne segue! Le cose si affrontano in
bruta opposizione: le acque, finora delimitate, solleveranno il loro seno più in alto
delle spiagge riducendo a un pantano tutto questo solido globo; il forte renderà
schiavo il debole, e il figlio violento colpirà a morte il padre; forza sarà diritto; o
peggio, diritto e torto, alla cui eterna dialettica presiede la giustizia, perderanno il
loro nome, e così pure la giustizia. Tutto si risolve nel potere, il potere in egoismo,
l’egoismo in appetito, e l’appetito, lupo universale, doppiamente assecondato dalla
volontà e dal potere, vorrà fare dell’intero universo la sua preda e alla fine divorerà se stesso. Grande Agamennone, quando la gerarchia è soffocata questo è il
caos che segue allo strangolamento. E il disuso della gerarchia è tale che passo
passo si propaga all’indietro, animato dall’ambizione di salire. Il generalissimo è
criticato da chi gli è inferiore di un grado, questi dal precedente, il precedente da
chi gli sta sotto; ogni grado, sull’esempio del primo che è insofferente del superiore, sviluppa una febbre invidiosa di pallida esangue emulazione; ed è questa febbre che tiene in piedi Troia, non il suo proprio nerbo: e per farla finita con un discorso già lungo, Troia si appoggia sulla nostra debolezza, non sulla sua forza15.
Ammettiamo che abbia ragione Jan Kott e che Troia rappresenti la Spagna
e i Greci siano gli Inglesi16, in questo lunghissimo discorso di Ulisse –molto più
che un monologo, un vero e proprio trattato– è evidente il timore che la frantumazione di un potere sovrano comporti la disfatta dell’intero stato e il conflitto
tra le fazioni è il prodromo alla distruzione dell’unità statale: “Quando le fazioni si lanciano troppo in alto, e con troppa violenza, questo è segno della debo-
SAGGI
litare nel suo ambito l’ascesa verso il Padre e la pratica dei suoi insegnamenti. Non soltanto ogni potere deriva da Dio, ma non c’è potere se non per guidare gli uomini secondo Dio: ecco le due tesi capitali dell’Insititution chrétienne”13. In questa prospettiva, il potere politico, deve essere sottomesso a quello religioso, che solo può indicare la strada tracciata da Dio14.
La più rigorosa, puntuale ed affascinante esposizione del principio della
sovranità si trova, in Shakespeare, in quella formidabile commedia nera che è
il Troilus and Cressida; alla domanda di Agamennone del come mai, dopo ben
sette anni di guerra, Troia sia ancora in piedi, Ulisse fornisce un’articolata
risposta:
23
24
lezza dei prìncipi; e con molto danno, sia della loro autorità, sia dei loro affari.
I movimenti delle fazioni, sotto i re, dovrebbero esser simili ai movimenti (come
dicono gli astronomi) delle orbite inferiori; che possono avere i loro propri movimenti, eppure ancora sempre sono tranquillamente trasportate dal movimento
più alto, del primo mobile”17.
Credo che sia il caso, però, di valutare tre elementi prima di prendere troppo sul serio questa apologia della gerarchia: anzitutto, a parlare è Ulisse,
Principe di Itaca, ma notorio bugiardo e, soprattutto, fine politico; che egli creda
veramente in quello che dice è dubbio, ma è importante che gli altri, i più ingenui tra i guerrieri e i soldati (in primis forse, Achille e Aiace), lo credano. Il contesto in cui viene inserito questo lungo discorso di Ulisse è fortemente metateatrale, Agamennone recita la parte del Sovrano assoluto e chiede agli altri
principi e guerrieri di recitare anch’essi il loro ruolo: la politica è teatro.
In secondo luogo, il Troilus and Cressida fu scritto sotto Elisabetta, quando
questa era oggetto più o meno velato di congiure; quando cioè, la storia inglese stava definitivamente passando in una nuova fase, ed era l’età di Astrea, e
la Monarchia si era arrogata il diritto di esercitare anche il potere di re della
chiesa: nella chiesa anglicana i puritani volevano riformare, oltre alla liturgia e
alle vesti, anche l’organizzazione della chiesa. Essi, infatti, rifiutavano “come
retaggio papista la sua stessa struttura gerarchica episcopale, in cui i vescovi
erano nominati dall’alto”18. Effettivamente, la struttura ecclesiastica anglicana
era identica a quella cattolica, salvo per il fatto –assolutamente non secondario– che le nomine dei vescovi erano esclusivo privilegio della regina e non del
papa. “Al posto della struttura episcopale i puritani volevano invece sostituire i
presbyters, cioè il sistema ginevrino di consigli e assemblee di ‘anziani’ che
nominavano dei candidati e li ordinavano”19, mentre il carattere apparentemente democratico della loro organizzazione non era in contraddizione con il fatto
che il loro obiettivo era la creazione di un dispotismo teocratico in cui l’autorità
ecclesiastica si sarebbe sostituita al potere secolare su vasti settori della vita
collettiva. A questo punto, “non è difficile indovinare quanta simpatia potesse
avere la regina per un sistema in cui dei laici appartenenti alla classe media
avrebbero autonomamente espresso un clero che a sua volta aspirava non
meno di quello cattolico alla supremazia sull’autorità civile”20; in questa maniera, effettivamente, si sarebbe venuta a creare una situazione in cui il Principe
altro non sarebbe stato che un semplice membro della Chiesa e non il suo
capo; egli sarebbe stato in obbligo di obbedire ai decreti di quest’ultima e non
certo a proclamarli o a formularli. Quando Giacomo I divenne re d’Inghilterra e
di Scozia si trovò ad affrontare gli stessi problemi di Elisabetta perché, se egli
fosse stato suddito del re della Chiesa, il re della Chiesa sarebbe stato altresì
sovrano dello stesso re. Se, invece, “il re del commonwealth si fosse arrogato
anche il titolo di ‘re della chiesa’, come de facto fecero tanto Elisabetta che
Giacomo, allora nessuna persona o forza in terra avrebbe potuto considerare
il re come un suo suddito, e il re di Scozia o d’Inghilterra, non avendo superiori, avrebbe goduto, all’interno del suo commonwealth, di una superiorità o
sovranità veramente assoluta. Ma che il re avesse il diritto a esercitare il potere di ‘re della chiesa’ era precisamente ciò che veniva negato con vigore sia a
SAGGI
Ginevra che a Roma, e dunque sia Ginevra che Roma erano fatalmente destinate a scontrarsi col re. La summa potestas di Elisabetta”, ma anche di
Giacomo I, “andava difesa tanto dall’unico papa romano, quanto dai molti papi
ginevrini”.21 Ma Giacomo I doveva guardarsi anche dalla nobiltà che risollevava la testa, proprio con l’appoggio, spesso, delle chiese riformate, perché
“all’epoca la nobiltà aveva un rapporto ambiguo con una monarchia la cui
espansione avveniva soprattutto a costo dei suoi diritti politici. Fu perciò di
importanza decisiva per lo sviluppo successivo, anche di quello delle idee politiche, che nell’interesse della sua conservazione la Riforma fosse obbligata ad
allearsi con la nobiltà, riconoscendole un diritto di resistenza che contemporaneamente aveva energicamente vietato ai sudditi in generale e ai contadini in
particolare”22. Del resto, era tutto sommato opinione condivisa da tutti che “una
monarchia, in cui non ci sia affatto nobiltà, è sempre una pura e assoluta tirannia, come quella dei Turchi: perché la nobiltà modera la sovranità e distoglie
un poco gli occhi del popolo dalla famiglia reale”23. Ma era fresca ancora la ferita nobiliare inferta da Essex, e quindi presumibilmente il re Giacomo non era
proprio sicuro che quelle fazioni da cui doveva guardarsi fossero sotto controllo, anche perché “una grande e potente nobiltà aggiunge maestà a un monarca, ma ne diminuisce il potere; e mette vita e spirito nel popolo, ma ne deprime la fortuna”24. I precetti di Francis Bacon in proposito sono una mirabile sintesi di ambiguità istituzionale e di cinismo politico: “è un bene per il sovrano e
per la giustizia che i nobili non siano troppo grandi; e tuttavia mantenuti a tale
altezza, che l’insolenza degli inferiori possa essere spezzata su di essi prima
che s’avvicini troppo alla maestà dei re. Una numerosa nobiltà causa povertà
e incomodo in uno Stato, perché è un sovraccarico di spesa; e inoltre, essendo necessità che molti della nobiltà cadano col tempo in bassa fortuna, ciò produce una specie di sproporzione tra onori e mezzi”25.
Il terzo elemento da tenere presente è che non sempre e non tutti gli autori avevano dato una valutazione così negativa delle fazioni: “io dico che coloro
che dannono i tumulti intra i nobili e la plebe, mi pare che biasimino quelle cose
che furono prima causa del tenere libera Roma; e che considerino più a’ romori ed alle grida che di tali tumulti nascevano, che a’ buoni effetti che quelli partorivano”26. In ogni repubblica, anzi, in ogni stato ci sono “due umori diversi,
quello del popolo e quello de’ grandi; e come tutte le leggi che si fanno in favore della libertà, nascano dalla disunione loro”27, e i desideri “de’ popoli liberi
rade volte sono perniziosi alla libertà, perché e’ nascono, o da essere oppressi, o da suspizione di avere ad essere oppressi”28.
Il sottotesto del discorso di Ulisse, teatralizzato come solo un volpone (‘dogfox’ lo definisce Tersite) sa fare –e del resto non siamo forse personaggi di uno
spettacolo per il divertimento degli dei? Questi “quando sono ormai imbevuti di
nettare e non hanno più voglia di far nulla di serio, prendono posto nella parte
del cielo che si sporge di più verso terra e chinando la testa stanno a vedere
per cosa si dan da fare gli uomini. Per loro è il più dolce degli spettacoli. Dio
immortale, che teatro!”29–, diventa a questo punto: come conciliare libertà e
pace? Sovranità e concordia? E soprattutto cosa succede quando un re cade,
sia pure per mano dei più nobili uomini?
25
26
Rispondere a queste domande è estremamente complesso, ma di fondamentale importanza, perché “i pastori di popoli hanno bisogno di conoscere i
pronostici delle tempeste dello Stato, che sono di solito più grandi quando le
cose progrediscono fino alla parità”30. Qualche anno prima di Troilus and
Cressida, Shakespeare aveva tematizzato proprio questi conflitti nel suo Julius
Caesar: la composizione del dramma risale alla fine degli anni 90 e andò quasi
certamente in scena nel 1599, inaugurando il famoso The Globe, nuovo teatro
della compagnia. Meno di due anni prima, quindi, dell’esecuzione di Essex,
quando però già si avvertiva il pericolo per la corona di Elisabetta. La fonte
principale dell’opera è Plutarco, in particolare la Vita di Cesare, la Vita di Bruto
e la Vita di Antonio; Plutarco era stato tradotto in francese da Jacques Amyot
nel 1559 e questa versione era stata volta in inglese nel 1579 da Thomas
North, sulla cui traduzione lavorò Shakespeare. Credo però che sarebbe sbagliato fermarsi al solo Plutarco, anzitutto perché in quegli anni in Europa infuriava il dibattito sul tirannicidio: il filomonarchico William Barclay nel 1600 definisce monarchomachos tutti quegli autori che si oppongono alla monarchia
nella forma protoassolutistica che stava assumendo in Francia e in Inghilterra;
tra questi autori c’era George Buchanan che nel 1579 aveva dato alle stampe
il De jure regni apud Scotos, dove aveva proclamato che l’insediamento e la
deposizione dei re avvengono da parte del popolo e aveva sostenuto la legittimità del tirannicidio. Qualche anno prima, nel 1574, Théodore de Bèze aveva
pubblicato, anonimo, il Du droit de Magistrats sur leurs subjects, dove veniva
affermato che la signoria è un rapporto fondato sulla reciprocità e che la tirannia è la rottura del contratto di dominazione da parte del signore. I ceti che lo
hanno insediato allora possono deporlo. Se ai ceti viene impedito di riunirsi, i
magistrati, ossia i titolari d’ufficio e l’alta nobiltà, devono avviare la resistenza,
essendo obbligati prima al regno e in seconda istanza al governante.
Soprattutto, vengono pubblicate le Vindiciae contra tyrannos, uscite in latino
nel 1579 e tradotte in francese nel 1581 con il titolo De la puissance legitime
du Prince sur le peuple, et du peuple sur le Prince. Traité tres utile et digne de
lecture en ce temps, escrit en latin par Estienne Iunius Brutus, et nouvellement
traduit en Français31, al culmine delle guerre di religione francesi. Le Vindiciae
aggiungono a quelli del Francogallia di F. Hotman e del Du droit des magistrats
di T. de Bèze nuovi e fondamentali argomenti a favore della resistenza antiassolutista dei militanti calvinisti: “Je savoy bien, Messeigneurs, qu’en publiant
ces questions d’Estienne Iunius Brutus, touchant le vray droit et la puissance
du Prince sur le peuple, et du peuple sur le Prince: il se trouveroit des gens qui
m’en fauroyent mauvais gré. Car elles sont manifestement contraires aux mauvaises pratiques, conseils pernicieux, fausses et pestiferes maximes de
Nicolas Machiavel Florentin, lequel ils ont pour guide au gouvernement des
afaires d’estat”32. La novità del trattato sta nell’uso dell’argomento contrattualista. I sudditi, sia pure non individualmente, ma in quanto costituiti in corpi o in
quanto rappresentati da magistrati, possono, e devono, resistere al sovrano
che ordini di violare la legge di Dio o che violi egli stesso le leggi civili. La legittimità del potere si fonda infatti su un duplice contratto, di cui gli autori delle
Vindiciae (probabilmente Hubert Languet, influenzato da Melantone e tempo-
è impossibile che quelli che in stato privato vivono in una republica, o che per fortuna o per virtù ne diventono principi, se leggessono le istorie, e delle memorie
delle antiche cose facessono capitale, che non volessero quelli tali privati vivere
nella loro patria più tosto Scipioni che Cesari […]: perché vedrebbono questi essere sommamente vituperati, e quelle eccessivamente laudati […]. Né sia alcuno
che s’inganni, per la gloria di Cesare, sentendolo, massime, celebrare dagli scrittori: perché quegli che lo laudano, sono corrotti dalla fortuna sua, e spauriti dalla
lunghezza dello imperio, il quale, reggendosi sotto quel nome, non permetteva che
gli scrittori parlassono liberamente di lui. Ma chi vuole conoscere quello che gli
scrittori liberi ne direbbono, vegga quello che dicono di Catilina. E tanto è più biasimevole Cesare quanto più è da biasimare quello che ha fatto, che quello che ha
voluto fare un male. Vegga ancora con quante laude ei celebrano Bruto; talché,
non potendo biasimare quello per la sua potenza, ei celebravano il nimico suo”37.
Rileggere il Julius Caesar dopo aver letto queste righe di Machiavelli
costringe a ripensare di nuovo l’ossessività con cui Shakespeare insiste sul
nome di Cesare.
Nell’antica Roma Shakespeare, selezionando e ripensando alcune Vite di
Plutarco, cercava conflitti esemplari, di straordinaria portata storica e mitopoietica, che risultavano ancora attuali se rivisitati alla luce di quella crisi che
avvenne tra Cinquecento e Seicento in cui si scontravano un modello simbolico del mondo e un “modello sintagmatico, o relativistico, che si andava formando a causa (fra l’altro) della caduta delle antiche certezze cosmologiche”38. In
termini più schiettamente politici, da un lato sembrava resistere la visione
monarchica, ritualistica, cerimoniale, che reclamava l’investitura divina del
capo, e quindi una sorta di legittimazione metafisica del potere39; dall’altra sembrava, ma solo sembrava, riemergere dalla storia una visione repubblicana e
laica del potere, con legittimazione da parte del popolo e dei suoi rappresentanti. “I due modelli hanno uno statuto radicalmente opposto, in quanto organizzano la realtà, sul piano sia politico che cognitivo, rispettivamente lungo
l’asse verticale e lungo l’asse orizzontale”40. I due modelli riflettono anche due
diverse concezioni del linguaggio in quanto sistema modellizzante primario di
SAGGI
raneamente al servizio della Sassonia, e Philippe Du Plessis Mornay, proveniente dalle fila di Enrico di Navarra) ritengono di trovare menzione nel Vecchio
Testamento. Il primo, che stabilisce l’obbligo della pietà che lega a Dio sia il re
sia il suo popolo e rende ciascuno di questi due ultimi contraenti responsabile
della defezione dell’altro legittimando così il diritto di resistenza. Il secondo, stipulato tra il sovrano e il suo popolo, fondando consensualmente i rapporti di
giustizia tra gli uomini pone un limite al potere regio33. Nella prospettiva delle
Vindiciae, il popolo “come totalità è superiore al re che è solamente il primo
servitore della collettività politica. Anche nell’ambito temporale il re è sottomesso alla legge e il dominio ingiusto legittima perciò anche qui la resistenza, non
però del singolo o della massa disorganizzata del popolo”34, bensì degli uomini che in ogni regno o città rappresentano legittimamente il corpo del popolo,
ossia i titolari di uffici e i ceti. “In caso di bisogno è sufficiente anche una minoranza”35, quella minoranza che in Shakespeare sono Bruto, Cassio e gli altri
congiurati.
Cesare era la figura emblematica del tiranno36 ed
27
28
una cultura: da una parte il linguaggio motivato, dall’altra il linguaggio arbitrario. Di conseguenza, la parola sarà, nel primo modello, una interpretazione,
riservata soprattutto al capo, del senso generale del mondo e dei suoi accadimenti; nel secondo, essa si presenterà come distruzione di tale ermeneutica
simbolica, nel nome di un assetto sociale fondato sul potere di molti, se non
del popolo tutto, e di una visione della storia come dinamica tutta umana degli
eventi, ai quali non sarebbe imposta una forma e una direzione da un qualche
disegno trascendente o provvidenziale. Il mondo rappresentato da Cesare è
un mondo simbolico, o meglio simbolicamente significante e ordinato, fondato
sulla cerimonialità intesa come manifestazione segnica del suo significato
segreto e sacrale. La cerimonialità assume la funzione fondamentale di strumento non solo di celebrazione, ma anche di sussistenza del potere e di collante del popolo di Roma, perché Cesare sapeva che “debbono, adunque, i
principi d’una republica o d’uno regno, i fondamenti della religione che loro tengono, mantenergli; e fatto questo, sarà loro facil cosa mantenere la loro republica religiosa e, per conseguente, buona e unita. E debbono, tutte le cose che
nascano in favore di quella, come che le giudecassono false, favorirle e accrescerle; e tanto più lo debbono fare, quanto più prudenti sono, e quanto più
conoscitori delle cose naturali”41. Anche secondo Bodin il principe deve imporre il rispetto pubblico della religione di Stato e proibire le dispute religiose,
implementando piuttosto il rigoroso rispetto del cerimoniale (“Set on”, dice
Cesare, “and leave non ceremony out”42); del resto, le dispute religiose hanno
il loro fondamento non nelle dimostrazioni razionali, quanto nella pura fede e
sono per questo motivo irresolubili e impenetrabili per la ragione43. Proprio perché la religione, “è il principale vincolo dell’umana società” ed “è una fortuna
quando essa è tenuta insieme col leale vincolo dell’unità”44 bisogna evitare che
le dispute in materia religiosa si diffondano, perché queste sono straordinariamente adatte a scatenare la furia dei forsennati; certo, “le dispute e le divisioni in religione furono mali sconosciuti ai pagani, perché la religione dei pagani
consisteva piuttosto in riti e cerimonie che in una credenza costante”45, ma a
questo punto assolutamente fondamentale risulta il rispetto pedante del cerimoniale. Cesare si pone come il più rispettoso del culto e, in quanto tale, recita il ruolo che ritiene più confacente ai suoi progetti di dominio: quello del principe che, rispettando i riti patrii, si pone come supremo garante della tranquillità e della pace dello stato.
Questa forte tensione verso la comunicazione simbolica del dramma, in
particolare di Cesare, ha permesso agli interpreti del ‘900 di leggere l’opera in
una chiave decisamente attuale ed attualizzante; Joseph Mankiewicz nella sua
versione cinematografica del 1954 si pone, ad esempio, al servizio del testo
con un adattamento intelligente e fedele, proponendolo come una lezione politica sulla dittatura nazifascista, efficacemente riletta nell’autoritarismo di
Cesare, e realizzando così un film assolutamente non banale grazie anche
all’eccellente compagnia di attori tra cui spiccano John Gielgud, James Mason
(nei panni di un rigoroso e tormentato Bruto) e Marlon Brando. L. Calhern, per
parte sua, fornisce il tiranno di sfumature che ricordano i gangsters del cinema
degli anni ‘30. Ma Mankiewicz non è stato certo il primo a fornire una lettura
SAGGI
attualizzante del Julius Caesar, anzi il suo film molto deve ai lavori teatrali che
nel corso degli anni ’30 Orson Welles aveva svolto sul testo di Shakespeare:
“Ho realizzato il dramma in abiti moderni per esaltarne l’interesse contemporaneo, piuttosto che per indicare dettagli attuali. Sto tentando di lasciare che i
versi shakesperiani svolgano il compito di rendere il dramma applicabile alle
tensioni dei nostri giorni. È una tragedia senza tempo sul cesarismo e il collasso di una democrazia sotto il cesarismo”46. E nella rappresentazione del dramma “il taglio degli abiti civili indossati dalla folla romana era dominato da alcuni tratti militari: stivali, spalline e cinture. Casca, Decio Bruto, Legario,
Trebonio, quasi tutti i cospiratori erano ritratti come gangster con il bavero alzato, il cappello nero sulla testa e la tasca rigonfia per la pistola. Sia Marco
Antonio sia Publio, in quanto emissario dello Stato, indossavano divise militari; Bruto, diversamente, era vestito in borghese, con l’abito da cerimonia, che
potrebbe indossare l’invitato a un matrimonio”47. Le foto dello spettacolo riportate in appendice al volume di Casale mostrano un Joseph Holland, nei panni
di Cesare, che veste i panni di Mussolini, e dato che l’allestimento di Welles è
del 1937 risulta chiaro come il richiamo all’attualità della figura e del dramma
sia molto forte. Welles, però, non volle fare del Julius Caesar una semplice
denuncia del regime fascista, ma intese mettere in luce che “Shakespeare
comprese le turbolente e fondamentali forze alla base della tragedia di Giulio
Cesare […]. Nel loro agire egli dimostrò come il problema di questa lotta sia
privo di tempo”48.
Quel che il film di Mankiewicz non mette in risalto, contrariamente alle scelte di Welles, è l’ambiguità delle figure dei congiurati, non soltanto di Cassio, ma
dello stesso Bruto.
Cesare manipola la simbologia non soltanto religiosa di Roma per porre il
proprio nome al di sopra di tutto il genere umano: parla di sé quasi sempre
in terza persona perché Cesare non è più semplicemente un uomo, un condottiero o addirittura un re, ma un ruolo che egli stesso ha forgiato per se
stesso. Alessandro Serpieri nelle sue note al Giulio Cesare coglie questo
aspetto per cui “in quanto uomo politico, egli è il Cosmo Simbolico, il perno
del mondo”49. Anche se gli altri cittadini di Roma non lo hanno ancora compreso, se alcuni lo temono al punto da volerlo abbattere perché “una volta
strappate queste penne crescenti dall’ala di Cesare, egli sarà costretto a
volare a un’altezza normale, che altrimenti si librerebbe oltre la vista degli
uomini e ci terrebbe tutti in una servile soggezione”50, la verità ormai è che
“this man / Is now become a god” (Julius Caesar, I ii) e che “lui sta a cavalcioni di questo stretto mondo come un Colosso, e noi, uomini meschini, ci
muoviamo sotto le sue gambe immense e sbirciamo di qua e di là per trovarci disonorate tombe”51.
Cassio comprende bene la pericolosità del nome di Cesare, ma attacca
l’uomo irridendone le debolezze e mostrando l’invidia che lo spinge contro il
condottiero52, e compie uno smascheramento del falso mito del nome, operando una “decostruzione, effettuata nel segno dell’arbitrario e del convenzionale, della concezione del linguaggio come motivato e simbolico. Non c’è
nulla per Cassio in quel nome che lo predisponga miticamente ad una fun-
29
30
zione di predominio; ed egli fa una sorta di esecuzione comparata di quel
nome, Caesar, e del nome del personaggio che vuol convincere, Brutus: a
livello grafico (Write them), sonoro (Sound them), materico (Weigh them), e
infine magico-esorcistico (Conjure with ‘em). Quei nomi si equivalgono. Non
si dà un destino dell’eroe nel suo nome proprio, nel mito del suo nome.
L’attacco al tiranno deve smantellarne in primo luogo lo statuto simbolico, la
necessità immanente”53. Anzi, in quel momento il nome di Bruto era simbolicamente forse più forte di quello di Cesare, perché era stato un Bruto, un avo
di quel Bruto che restio prestava ascolto a Cassio, a scacciare Tarquinio il
Superbo da Roma.
Quello che Cassio non capisce è che ormai Caesar è già diventato il Nome,
che ha già forgiato un ruolo che, impropriamente, viene ancora chiamato “re”,
ma che è qualcosa di diverso e di cui solo Cesare è consapevole rivestendo
continuamente quel ruolo: “Ma io sono fermo come la stella polare, della quale
non c’è compagna nel firmamento per qualità costantemente fissa e duratura.
I cieli sono dipinti di innumerevoli faville, che sono tutte quante fuoco, ed ognuna risplende; ma ce n’è soltanto una, fra tutte, che tiene il suo posto. E così è
nel mondo: è ben fornito di uomini, e gli uomini sono carne e sangue, e dotati
d’intelletto; e tuttavia in tale numero ne conosco uno soltanto che, inattaccabile, conserva la sua posizione, non scosso da alcun movimento; e che io sia
quello, lasciatevelo mostrare anche in questo”54.
Cesare recita un nuovo ruolo nella commedia del mondo, un ruolo che
porta il suo nome e che egli cerca di rendere grande, non rendendosi conto di
come “la plus part de nos vacations sont farcesques. ‘Mundus universus exercet histrioniam’. Il faut jouer devement nostre rolle, mais comme rolle d’un personnage emprunté. Du masque et de l’apparence il n’en faut pas faire une
essence réelle, ny de l’estranger le propre. Nous ne sçavons pas distinguer la
peau de la chemise. C’est assés de s’enfariner le visage, sans s’enfariner la
poictrine. J’en vois qui se transforment et se transsubstantient en autant de
nouvelles figures et de nouveaux estres qu’ils entreprennent de charges, et qui
se prelatent jusques au foye et aux intestins, et entreinent leur office jusques
en leur garde-robe”55.
Cesare non distingue più tra persona e funzione. Recita continuamente il
suo ruolo e la sua pantomima lo conduce alla morte, una morte che però colpisce soltanto l’uomo e non il ruolo, non la figura, non il nome.
Anche Bruto, però, recita una parte: anche lui vive un ruolo che gli deriva
dal nome che porta, quello del nemico dei tiranni, ruolo che –a differenza di
Cesare– non ha creato ma ereditato dal suo avo. Il suo primo monologo è
quasi un pezzo di oratoria, uno stralcio di un’argomentazione che viene condotta di fronte a un pubblico immaginario ma non per questo meno reale e presente nella mente di Bruto: “It must be by his death” (Julius Caesar, II i). Bruto
non è Cassio, non ha motivazioni personali, non ha l’invidia che lo muove al
tirannicidio, ma soltanto il senso del proprio ruolo di difensore della comunità
(“for my part, / I know no personal cause tu spurn at him, / But for the general”), della libertà dei cittadini di Roma che gli fa vedere il pericolo di concedere il potere di un Cesare a Cesare:
Bruto è assolutamente consapevole del proprio ruolo e della parte che è
chiamato a recitare nella scena della storia, rimproverando i suoi alleati di non
saper scegliere il momento giusto per manifestarsi e in forma non adeguata al
momento (“Oh, cospirazione, ti vergogni a mostrare il tuo minaccioso volto, di
notte, quando più liberi sono i mali? Oh, allora, di giorno, dove troverai una
caverna oscura abbastanza da mascherare il tuo viso mostruoso? Non cercarla, cospirazione; nascondilo sotto sorrisi e affabilità, perché, se procedi
mostrando il tuo vero aspetto, neanche l’Erebo sarebbe buio abbastanza da
nasconderti e non farti scoprire”58).
Bruto e Cesare, però, non sanno “distinguer la peau de la chemise” e “du
masque et de l’apparence” fanno “une essence réelle”, così da confondere due
piani del teatro del mondo, quello pubblico e quello privato, o meglio quello
simbolico del ruolo e quello sintagmatico del discorso. E tale confusione porta
Bruto a riproporre la ritualità e la cerimonialità che erano proprie di Cesare, e
che davano il potere a Cesare, nell’uccisione di Cesare: “Dobbiamo essere
sacrificatori, ma non macellai, Caio. Tutti noi ci leviamo contro lo spirito di
Cesare, e non c’è sangue nello spirito degli uomini. Oh, se potessimo allora
arrivare allo spirito di Cesare, e non smembrare Cesare! Ma, ahimè, Cesare
dovrà sanguinare per questo. E, gentili amici, uccidiamolo coraggiosamente,
ma non rabbiosamente; dobbiamo scalcarlo come un piatto degno degli dèi,
non maciullarlo come una carcassa degna dei cani”59.
Questa insistenza sul rituale tocca il suo culmine nell’uccisione di Cesare e
nella fantastica immagine di Cassio secondo il quale “Per quante epoche future questa nostra scena sublime sarà recitata di nuovo, in nazioni non ancora
nate, e in lingue ancora sconosciute!”60 e Bruto a sua volta: “How many times
shall Caesar bleed in sport” (Julius Caesar, II i), quante volte Cesare sanguinerà per finta! Ma queste riflessioni hanno un qualcosa di perturbante: e
Cassio dà l’avvio a un inquietante circolo ermeneutico “tramandando quella
azione al futuro, e quindi alle possibili rappresentazioni di quell’azione, tra le
quali si impone immediatamente –con clamoroso effetto melodrammatico–
questa tragedia che si autorappresenta mentre rappresenta la tragedia storica.
Questa scena non è altro che una commemorazione della scena originaria,
che è stata l’uccisione di Cesare. Bruto […], rende ancora più esplicito tale
nesso tra rappresentazione e azione. E, allora, ecco affiorare un’altra analogia
simbolica, forse la più rilevante per la segreta immaginazione creativa di
Shakespeare, l’analogia con la celebrazione della messa, nella quale viene
SAGGI
Vorrebbe farsi incoronare: come ciò potrebbe cambiare la sua natura, ecco la
domanda […]. L’incoroniamo, e allora, certo, gli forniamo una punta con cui può a
piacimento procurare danni. L’abuso della grandezza si ha quando essa disgiunge la pietà dal potere; e, a dir la verità di Cesare, non l’ho mai visto governato dalle
passioni più che dalla ragione”56. Abusa di grandezza chi disgiunge la pietà dalla
potenza, Cesare non lo ha ancora fatto, non ha ancora compiuto questo passo,
ma una volta incoronato potrebbe farsi corrompere e allora è necessario fermarlo
prima: “allora, perché non possa, preveniamolo. E poiché l’accusa non trova appigli in quel che egli è ora, mettiamola così: che quel che è ora, crescendo, arriverebbe a questi e questi altri estremi; e perciò pensiamolo come uovo di serpente,
che, covato, diverrebbe malefico, come da sua natura, e uccidiamolo nel guscio57.
31
32
indefinitamente riattualizzato il sacrificio divino”61. Anche, perché, si può
aggiungere, Bruto ha precisato che nelle successive rappresentazioni Cesare
sanguinerà per finta e non realmente, esattamente come per la chiesa riformata inglese l’Eucaristia è un atto simbolico e non c’è transustanziazione.
Torniamo al Love’s Labour’s Lost: lì abbiamo una principessa che mediante
un atto di macelleria, l’uccisione di un povero cervo innocente, si legittima nelle
sue pretese di self-sovereignty, perché così facendo, recitando la parte dell’assassina (“Then, forester, my friend, where is the bush / That we must stand and
play the murdererer in?”, Love’s Labour’s Lost, IV i), essa si arroga il diritto di
celebrare un sacrificio; in questa maniera, la principessa della commedia (ed
Elisabetta nella realtà) non soltanto si poneva nell’assoluta indipendenza dal
Papa di Roma, ma anche in una posizione di dominio nei confronti del clero
inglese in maggioranza calvinista62. Nel Julius Caesar, invece, abbiamo una pluralità di individui che compiono un atto di macelleria uccidendo un uomo secondo un rito ben preciso, come se fosse cibo per gli dèi, per sacrificarlo alla collettività sulla quale egli voleva governare in maniera assoluta e per rivendicare
la libertà contro la tirannide. A suffragare questa sensazione perturbante per cui,
fondamentalmente, qui Bruto e gli altri sembrano riecheggiare la pluralità delle
chiese inglesi che rifiutavano di concedere il potere assoluto ad Elisabetta, pretendendo anzi di esercitare un controllo sulla monarchia, c’è poi la battuta di
Marco Antonio che, vedendo Cesare a terra, lo definisce maestoso cervo
(“hart”), e a questo punto si ritorna di nuovo al Love’s Labour’s Lost e alla sua
caccia al cervo (“deer”), e si ricorda che nel Cantico dei Cantici si parla di un
cervo che nella tradizionale allegoresi veniva identificato con Cristo...
Compiere un sacrificio, però, non è sufficiente. Occorre anche persuadere
il popolo che se ne ha il diritto e che questo sacrificio è opportuno: ma qui il
dramma mostra lo scacco di Bruto e di Cassio; prima ancora del discorso di
Antonio, infatti, Shakespeare insinua il fallimento di Bruto sin dal momento del
suo discorso al popolo: Bruto ha ucciso Cesare non perché non lo amasse ma
perché Cesare era ambizioso e voleva ridurre il popolo di Roma in schiavitù. Il
popolo sembra accettare questa spiegazione ma grida: “Let him be Caesar”
(Julius Caesar, III ii), ‘che sia lui Cesare’! Se Giulio è morto non lo è il suo
nome, il suo ruolo ormai è consolidato ed è stato consolidato proprio dal sacrificio che doveva ucciderne non soltanto il corpo ma soprattutto lo spirito, mentre scalcandolo come un piatto degno degli dèi ne hanno martoriato il primo ed
eternizzato il secondo.
L’errore di Bruto è di non aver compreso la portata dell’innovazione incarnata da Cesare, che rappresenta una ben più radicale mutazione nella storia
del mondo di quanto fosse stato Silla o Tarquinio il Superbo: perché “è vero che
ciò che è stabilito dalla consuetudine, sebbene non sia buono, tuttavia è almeno opportuno. E quelle cose che sono a lungo andate insieme sono come unite
tra loro: mentre le cose nuove non s’accordano altrettanto bene […]. Tutto ciò
sarebbe vero, se il tempo stesse fermo: esso, al contrario, gira tanto, che un
caparbio mantenimento dell’usanza è una cosa tanto turbolenta quanto un’innovazione: e quelli che venerano troppo i tempi antichi, sono soltanto uno
scherno per i nuovi”63.
SAGGI
Questo, invece, non sfugge a Marco Antonio, che con il suo formidabile
discorso, in cui sfoggia una capacità attoriale inarrivabile per chiunque altro,
cambia il corso della storia e fà sì che la mutazione si manifesti in tutta la sua
violenza: “E, ora, che tutto faccia il suo corso. Male, sei scatenato, prendi la
strada che vuoi”64.
Il concetto di mutazione “instaura la logica del tempo su un orizzonte ontologico di spessa materialità […]. E così, se il concetto della mutazione che
subiamo, è iscritto in una logica naturalistica, anche quello della mutazione
sulla quale agiamo, lo sarà. E viceversa, se cambiamo il punto di vista e diamo
alla mutazione sulla quale agiamo una connotazione umanistica, anche la
mutazione che ci domina dovrà mostrare la stessa sostanza. Vale a dire che
natura e prassi si agitano l’una dentro l’altra ed insieme costituiscono il mondo
della vita e l’oggetto della scienza”65. Mutazione è un concetto chiave in
Machiavelli, perché la sua operazione teorica consiste “nel fare della mutazione una struttura globale che è attraversata, in quanto globalità, dall’azione
umana. Ma questa azione è essa stessa strutturale, si estende alla globalità
dell’orizzonte storico, afferra e domina le variazioni del tempo, dando loro
senso e significato”66.
Bruto, filosofo stoico, non coglie pienamente ciò, per quanto ci si avvicini
moltissimo quando afferma che “c’è una marea nelle faccende degli uomini,
che, presa quando è alta, porta alla fortuna; mancata, tutto il viaggio della vita
viene confinato in secche e sciagure”67, ma la sua marea comincia ad avvertire l’effetto della mutazione di Machiavelli per il quale “sendo tutte le cose degli
uomini in moto, e non potendo stare salde, conviene che le salghino o che le
scendino; e a molte cose che la ragione non t’induce, t’induce la necessità”68.
Bruto non avverte questa necessità se non alla fine; fino ad allora egli cerca
di perpetuare lo stato delle cose entro il quale il suo nome e il suo ruolo hanno
un significato, e il problema che egli si pone è quello del passaggio dal pensiero all’azione: “Da quando Cassio mi ha aizzato contro Cesare, non ho dormito. Tra l’attuazione di una cosa terribile e il primo impulso, l’intero intervallo è
come un’allucinazione, o un orribile sogno. Lo spirito e le umane facoltà mortali tengono allora consiglio, e lo stato dell’uomo, come un piccolo regno, subisce allora una sorta di insurrezione”69.
Bruto non riesce a cogliere veramente il suo momento, perché il mondo è
cambiato al punto che ora è il momento di Cesare. Marco Antonio, invece,
coglie il momento giusto per scatenare il popolo contro i congiurati, per scatenare la guerra civile, per poi perderlo all’arrivo di Ottaviano: la fortuna, sembrava avergli dato una chance, per poi travolgerlo; “let me speak, and let me rail
so high, / That the false huswife Fortune break her wheel” (Antony and
Cleopatra, IV xv) è il lamento di Cleopatra, consapevole, però che la ruota della
fortuna non può essere spezzata da nessuno. Chiunque, effettivamente, esamini la vita dei grandi condottieri e dei grandi regnanti non può che constatare
come quelli non “avessino altro da la fortuna che la occasione, la quale dette
loro materia a potere introdurvi dentro quella forma che parse loro: e sanza
quella occasione la virtù dello animo loro si sarebbe spenta, e sanza quella
virtù la occasione sarebbe venuta invano”70.
33
34
L’insonne Bruto, da questo punto di vista, con le sue difficoltà a trasformare il pensiero in azione perché sempre in ritardo sul tempo, con la sua altissima tensione morale nei confronti di una figura ideale a cui riferirsi nella sua
recita del ruolo, l’avo Stefano Giunio Bruto, che aveva liberato Roma dalla
tirannide, si lascia travolgere dalla necessità delle cose esattamente come l’altro grande insonne del teatro shakesperiano, il mostruoso Macbeth, il tiranno
crudele.
Anche in questo caso Orson Welles diede dell’opera un’interpretazione
sconvolgente, amplificando il senso di ineluttabilità che trascina il personaggio
lungo la sua corsa, facendone nella sua interpretazione teatrale una parabola
del fascismo71, inteso come follia del potere per il potere e irrefrenabile sete di
distruzione. Certo, Welles nella sua interpretazione, soprattutto nella versione
cinematografica amplifica il ruolo delle streghe, rendendole le vere artefici del
destino di Macbeth, ma del resto egli lo fa anche sulla scorta dei versi di
Shakespeare: “A Banquo –Non speri che i tuoi figli saranno re, quando coloro
che hanno dato a me la baronia di Cawdor, non promisero ed essi niente di
meno?”72. Nell’interpretazione di Welles, “anche quando Macbeth si ritiene guidato dall’apparizione del pugnale all’assassinio di Duncan, la sua visione è originata dalle streghe”73.
Quale che sia il significato da attribuire alle “Weird Sisters”, come le chiama Shakespeare, non dimentichiamo che il Macbeth fu scritto e rappresentato sotto Giacomo I Stuart, che a quell’epoca credeva ancora alle streghe –o
almeno così sosteneva– e che l’avvento della casa degli Stuart sul trono inglese dopo la morte di Elisabetta era stata avvertita come una mutazione sconvolgente, i cui effetti erano imprevedibili.
Macbeth, però, non è semplicemente lo strumento delle streghe, ma anche
quello della fortuna: “If chance will have me king, why, chance may crown me
/ Without my stir” (Macbeth, I iii); egli, in realtà, è complice della fortuna, non
meno che suo zimbello, al punto da diventare l’emblema di coloro che “per
qualche via scelerata e nefaria” ascendono al “principato”74. Ma Macbeth non
ha sufficiente virtù, come la intenderebbe Machiavelli, per resistere sul trono,
e non ovviamente perché sia traditore, perché la scena del mondo è piena di
traditori, come sa anche un bambino: “Allora i bugiardi e gli spergiuri sono
scemi, perché ce ne sono abbastanza di bugiardi e di spergiuri da battere gli
uomini onesti e impiccarli loro”75, ma piuttosto perché egli non è in grado di
distinguere “le crudeltà male usate o bene usate”, laddove “bene usate si possono chiamare quelle –se del male è lecito dire bene– che si fanno a uno tratto per la necessità dello assicurarsi: e di poi non vi si insiste dentro, ma in convertono in più utilità de’ sudditi che si può. Male usate sono quelle le quali,
ancora che nel principio sieno poche, più tosto col tempo crescono che le si
spenghino. Coloro che osservono el primo modo, possono […] avere allo stato
loro qualche rimedio […] quegli altri è impossibile si mantenghino”76. Ma quello di Macbeth è un mondo in cui “Nulla è stato ottenuto, tutto è stato sprecato,
se il nostro desiderio si compie, ma non si appaga”77; egli non sa condurre il
colpo una volta sola, ma è costretto a ripeterlo un’infinità di volte e ne è consapevole fin dall’inizio (“Se fosse fatto, una volta fatto, allora sarebbe bene che
SAGGI
fosse fatto in fretta. Se l’assassinio potesse pescare il suo risultato e afferrare,
con la sua fine, il successo; se solo questo colpo potessere essere l’esseretutto e il concludere-tutto, qui, qui soltanto, su questo sabbioso banco, su questa secca del tempo, scavalcheremmo la vita del mondo a venire”78). Macbeth
è, machiavellicamente, soltanto ‘lione’ e non ‘golpe’.
Perché? Cosa impedisce a Macbeth di diventare re? Anche in questo caso,
esattamente come per Bruto, il problema è quello dell’interpretazione di un
ruolo: per Bruto, un ruolo ormai fuori dal tempo, per Macbeth, un ruolo che egli
non conosce e non ha il tempo di imparare; Banquo, profeticamente, nota che
“i nuovi onori gli cadono addosso come vestiti mai indossati, che non aderiscono alla forma se non con l’uso”79. Macbeth non riesce a interpretare con la
necessaria naturalezza un ruolo che ha conquistato con la violenza, egli rimane per tutto il dramma l’uomo insanguinato che compare all’inizio della seconda scena, senza quella capacità che deve esser propria del principe di spogliarsi “il principe la persona di principe, e mescolandosi egualmente con i
minori di sé, ben però di modo che possa esser conosciuto, col rifiutar la grandezza piglia un’altra maggior grandezza, che il voler avanzar gli altri non d’autorità ma di virtù, e mostrar che ‘l valor suo non è accresciuto dallo esser principe” (B. Castiglione, Il cortegiano, II xi). Dal momento in cui Macbeth ha ucciso il sonno vive in una veglia che senza soluzione di continuità viene a coincidere con gli incubi dell’inferno, e se il ‘sonno assassino’ aveva lasciato solo
Bruto di fronte allo spettro di Cesare, la veglia prolungata e innaturale lascia
solo Macbeth di fronte al crollo del mondo, negandogli anche il sostegno della
moglie che, almeno, trova rifugio nella follia e nella morte. L’inferno sulla terra
è l’ovvia conseguenza delle guerre civili scatenate a Roma dall’uccisione di
Cesare e in Scozia dall’assassinio di Duncan, e quando la terra non è altro che
un gigantesco cimitero non c’è da stupirsi se anche Macbeth comincia a essere stanco del sole (“I ‘gin to be aweary of the sun, / And wish th’estate o’th’world were now undone”, Macbeth, V v). Essere stanchi del sole, desiderare
che la struttura del mondo si disfaccia, rifiutare una vita che è “a walking shadow, a poor player / That struts and frets his hour upon the stage, / And then
is heard no more. It is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying
nothing” (Macbeth, V v); Macbeth è forse l’unico che ha compreso l’inanità del
suo ruolo, l’inutilità della recita del potere in un mondo che è in disfacimento
perché sottomesso alle bizzarrie della ruota della fortuna. Ma di questo i lettori di Macbeth sono stati informati molto prima, prima ancora che l’omicidio di
Duncan venga compiuto, quando Banquo, all’inizio del secondo atto, chiede
“How goes the night, boy?”, riecheggiando fin troppo chiaramente il biblico
Custos, quid de nocte? (Isaia, 21, 11) che annuncia la distruzione di Babilonia
e la sconfitta dei nemici di Israele, ma che introduce anche gli Oracula de fine
temporum (Isaia, 24). Solo che ad arrivare non è l’esercito di Dio, ma Macbeth
che seguendo il suo pugnale colpisce al cuore il mondo uccidendo Duncan.
A questo punto, il mondo è soltanto la scena di una farsa senza senso, di
un racconto raccontato da un idiota, in cui la fortuna bizzarra e cieca spadroneggia e gli uomini non possono fare altro che scimmiottarsi vicendevolmente
recitando ruoli ingrati a cui non sono preparati; l’unica speranza forse è davve-
35
ro che la struttura del mondo si disfaccia, invocando la distruzione del globo
(“Ci dovrebbe essere una immensa eclisse del sole e della luna, e il globo, spaventato, dovrebbe spalancarsi al mutamento”80), come fa Otello.
Perché sia Macbeth che Otello sono colpevoli del crimine più grave per
chiunque voglia esercitare il potere, sia quello del re sia quello di un cortigiano: essi non sanno recitare e modulare il loro comportamento come richiesto
dalle circostanze. Sono pessimi attori e per entrambi si può dire ciò che l’onesto Jago dice di Otello: ‘egli è quel che è’ e non è capace di essere altrimenti.
Quanto al potere, Bruto, Antonio, Macbeth, persino Cesare, nessuno di
questi aveva compreso quel che invece era ben chiaro a Ulisse (ma anche a
Elisabetta e a Giacomo I), ossia che il vero potere di un re, di uno stato, è nei
suoi segreti e nella sua capacità di sapere tutto dei suoi sudditi senza darlo a
vedere, nel conservare gli arcana imperii e nel renderli così terribili che solo
una penna divina potrebbe svelarli: “The providence that’s in a wactchful state
/ Knows almost every grain of Pluto’s gold, / Finds bottom in the uncomprehensive deeps, / Keeps place with thought, and almost, like the gods, / Does
thoughts unveil in their dumb cradles. / There is a mystery, with whom relation
/ Durst never meddle, in the soul of state; Which hath an operation more divine / Than breath or pen can give expressure to”.
36
1
F. A. YATES, Astrea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century, Routledge & Kegan Paul,
London and Boston, 1975; tr. it., Astrea. L’idea di Impero nel Cinquecento, Einaudi, Torino 1978, p. 91:
“L’interesse di Shakespeare per la monarchia era profondo, specialmente in rapporto con la storia
inglese. Le discussioni intorno alla possibilità di individuare un “tema imperiale”, che attraversi tutto il
tessuto d’immagini dei suoi drammi”, aggiunge però l’autrice, “non hanno tenuto conto del reale tema
imperiale, cui nessuno che vivesse nell’Inghilterra dei Tudor poteva sfuggire”. Questo tema, secondo
la tesi della Yates, è quello di Astrea. Il testo a cui occorre in ogni caso ancora fare
riferimento è G.
2
Wilson Knight, The Imperial Theme, Oxford University Press, Oxford 1931 (1965 ).
2
F. A. YATES, Shakespeare’s Last Plays. A New Approach, Routledge & Kegan Paul, London,
1975; tr. it., Gli ultimi drammi di Shakespeare. Un nuovo tentativo di approccio, Einaudi, Torino
1979, p. 41. “E che l’idea shakespeariana della monarchia, superando i confini meramente nazionali, si dilati in ampie prospettive di un ordine, o disordine, spirituale universale è chiaramente suggerito nelle sue raffigurazioni. È quindi naturale e giusto” parlare di un vero e proprio tema imperiale, che “esamina le raffigurazioni della monarchia usate da Shakespeare, la maestà divina e
cosmica di cui investe la funzione regale, le impressionanti descrizioni del caos e della confusione –tempesta e disordine del cosmo, tempesta e disordine nello Stato– che dilagano quando tale
funzione viene a mancare” (Ibidem)
3
J. BODIN, I sei libri dello stato, a cura di M. Isnardi Parente, UTET, Torino, vol. I, 1964, p. 345.
Per una introduzione a questo tema cfr., J.-F. SPITZ, Bodin et la souveraineté, Paris, Puf, 1998, e
la scelta di testi, J. BODIN, On Sovereignty, edited by J. H. Franklin, Cambridge University Press,
Cambridge 1992.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 346.
6
ERASMO DA ROTTERDAM, I Colloqui, Garzanti, Milano 2000, p. 122.
7
M. ISNARDI PARENTE, Introduzione a JEAN BODIN, I sei libri dello Stato..., cit., p. 28.
8
Ibidem.
9
Ivi, pp. 28-29.
10
Ivi, p. 30.
SAGGI
11
G. SACERDOTI, Sacrificio e sovranità. Teologia e politica nell’Europa di Shakespeare e Bruno,
Einaudi, Torino 2002, p. 59.
12
Ivi, p. 61.
13
P. MESNARD, L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Vrin, Paris 19512; tr. it. Il pensiero politico rinascimentale, 2 voll., a cura di L. Firpo, Laterza, Bari 1963. I, p. 432.
14
W. REINHARD, Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart, Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M Frankfurt a. M., 1996; tr. it. parziale, Il pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna 2000, p. 51: “Lo stato è il custode delle due tavole, ma è al servizio della
chiesa: in ultima instanza esiste per causa sua. così come per Lutero, anche per Calvino lo stato
cristiano può contribuire poco per diritto proprio alla realizzazione della salvezza, perché ciò sarebbe una commistione tra i due governi […]. Mentre in Lutero al servizio della dottrina dei due regni
viene preso l’individuo e solo indirettamente lo stato, Calvino pone l’istituzione direttamente sotto
la legge di Cristo”.
15
W. SHAKESPEARE, Troilus and Cressida, I iii: “The specialty of rule hath been neglected: / And,
look how many Grecian tents do stand / Hollow upon this plain, so many hollow factions. /When
that the general is not like the hive / To whom the foragers shall all repair, / What honey is expected? Degree being vizarded, / The unworthiest shows as fairly in the mask, / The Heavens themselves, the planets, and this centre, / Observe degree, priority, and place / Insisture, course, proportion, season, form, / Office, and custom, in all line of order: / And therefore is the glorious planet Sol / In noble eminence enthroned and sphered / Amidst the other; whose med’cinable eye /
Corrects the ill aspects of planets evil, / And posts like the commandment of a king, / Sans check,
to good and bad. But when the planets / In evil mixture to disorder wander, / What plagues and
what portents, what mutiny, / What raging of the sea, shaking of earth / Commotion in the winds,
frights, changes, horrors, / Divert and crack, rend and deracinate / The unity and married calm of
states / Quite from their fixure! Oh, when degree is shaked, / Which is the ladder to all high designs,
/ The enterprise is sick! How could communities, / Degrees in schools and brotherhoods in cities,
/ Peaceful commerce from dividable shores, / The primogenity and due of birth, / Prerogative of
age, crowns, sceptres, laurels, / but by degree, stand in authentic place? / Take but degree away,
untune that string, / And hark what discord follows. Each thing meets / In mere oppugnancy. The
bounded waters / Should lift their bosoms higher than the shores / And make a sop of all this solid
globe; / Strenght should be lord of imbecility, / And the rude son should strike his father dead; /
Force should be right, or rather, right and wrong, / Between whose endless jar justice resides, /
Should lose their names, and so should justice too. / Then everything includes itself in power, /
Power into will, will into appetite; / And appetite, an universal wolf, / So doubly seconded with will
and power, / Must make perforce an universal prey, / And last eat up himself. Great Agammennon,
/ This chaos, when degree is suffocate, / Follows the choking. / And this neglection of degree it is
/ That by a pace goes backward, with a purpose / It hath to climb. The general’s disdained / By him
one step below; he by the next; / That next by him beneath: so every step, / Exampled by the first
pace that is sick / Of his superior, grows to an envious fever / Of pale and bloodles emulation. /
And ‘tis this fever that keeps Troy on foot, / Not her own sinews. To end a tale of length, / Troy in
our weakness stands, not in her strength”. (W. SHAKESPEARE, Troilo e Cressida, Mondadori, Milano
1996, pp. 43-47; ho leggermente modificato la traduzione di L. Squarzina).
16
Cfr., J. KOTT, Szkice o Szekspirze,, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961; tr.
it., Shakespeare nostro contemporaneo, prefazione di M. Praz, Feltrinelli, Milano 2004, p. 74.
17
F. BACON, Saggi, Tea, Torino 1995, pp. 178-179.
18
G. SACERDOTI, Sacrificio e sovranità..., cit., p. 17.
19
Ibidem.
20
Ivi, p. 18.
21
Ivi, pp. 18-19.
22
W. REINHARD, Il pensiero politico moderno..., cit., p. 53.
23
F. BACON, Saggi..., cit., p. 52.
24
Ivi, pp. 52-53.
25
Ivi, p. 53.
26
N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in N. Machiavelli, Opere politiche,
a cura di M. Puppo, Le Monnier, Firenze 1969, pp. 207-208.
27
Ivi, p. 208.
37
Ivi, p. 209.
ERASMO DA ROTTERDAM, Elogio della follia, Rizzoli, Milano 1996, p. 109.
30
F. BACON, Saggi..., cit., p. 54.
31
Esiste una edizione italiana di quest’opera: STEFANO GIUNIO BRUTO, Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe, a cura di S. Testoni Binetti,
La Rosa, Torino 1994. Per parte mia, ho consultato l’edizione francese del 1581, pubblicato senza
indicazione di luogo e senza editore.
32
S. G. BRUTO, De la puissance legitime..., cit., p. 5.
33
P. MESNARD, Il pensiero politico rinascimentale..., cit., pp. 528-529: “ L’opera si divide in quattro parti principali: 1. se i sudditi sono tenuti ad obbedire ad un principe che ordina di violare la
legge di Dio; 2. se possono resistergli e in che modo; 3. se possono resistere ad un principe che
viola la legge civile; 4. se i principi confinanti hanno, in questi due casi, il diritto o il dovere di intervenire. Essa è arricchita da una prefazione, in cui il Languet […] inveisce copiosamente contro l’avversario […] il Machiavelli, che ha corrotto le menti, e i machiavellici, suoi discepoli che attualmente tentano di ridurre in schiavitù la nobile razza gallica […]: l’autorità dei libri sacri e delle testimonianze storiche fornirà i princìpi da cui il ragionamento deduttivo ricaverà, more geometrico, tutte
le necessarie conclusioni”.
34
W. REINHARD, Il pensiero politico moderno..., cit., p. 58.
35
Ibidem.
36
J. BODIN, I sei libri dello stato..., cit., p. 348: Cesare “fu ucciso perché la dittatura era abolita
espressamente per legge e tuttavia egli aveva usurpato il potere con tale pretesto”. In questa
maniera, Bodin legittima l’operato di Bruto e Cassio.
37
N. MACHIAVELLI, Discorsi..., cit., pp. 232-233.
38
A. SERPIERI, Prefazione a W. Shakespeare, Giulio Cesare, Garzanti, Milano 1998, p. XXXVIII.
39
Su questo tema, cfr., E. H. KANTOROWICZ, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval
Political Theology, Princeton, Princeton University Press, 1957; tr. it., I due corpi del re. L’idea di
regalità nella teologia politica medievale, con introduzione di A. Boureau, Torino, Einaudi, 1989.
40
A. SERPIERI, Prefazione a W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p XXXIX.
41
N. MACHIAVELLI, Discorsi..., cit., p. 240.
42
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, I ii 15 (Giulio Cesare..., cit., p. 12).
43
Cfr., J. BODIN, I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, vol. II, Utet,
Torino 1988, p. 579.
44
F. BACON, Saggi..., cit., p. 17.
45
Ivi, pp. 17-18.
46
Citato in C. CASALE, L’incantesimo è compiuto. Shakespeare secondo Orson Welles, Lindau,
Torino 2001, p. 126.
47
Ivi, pp. 125-126.
48
Citato ivi, p. 129.
49
W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 197, n. 17.
50
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, I i: “These growing feathers plucked from Caesar’s wing /
Will make him fly an ordinary pitch, / Who else would soar above the wiew of men, / And keep us
all in servile fearfulness”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 11).
51
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, I ii: “he doth bestride the narrow world / Like a colossus, and
we petty men / Walk under his hugelegs and peep about / To find ourselves dishonourable graves”.
(W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 21).
52
Cfr., R. GIRARD, A theater of envy: Williams Shakespeare, New York, Oxford, 1991; tr. it.,
Shakespeare. Il teatro dell’invidia, Adelphi, Milano 1998.
53
A. SERPIERI, Prefazione a W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. XL.
54
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, III i: “But I am constant as the nortehrn star, / Of whose truefixed and resting quality / There is no fellow in the firmament. / The skies are painted with unnumbered sparks, / They are all fire, and every one doth shine, / But there’s but one in all doth hold his
place. / So in the world: ‘tis furnished well with men, / And men are flesh and blood, and apprehensive, / Yet in the number I do know but one / That unassailable holds on his rank, / Unshaked of
motion; and that I am he, / Let me a little show it, even in this”. (W. Shakespeare, Giulio Cesare...,
cit., p. 89).
55
M. DE MONTAIGNE, Essais, 3 voll., Garnier-Flammarion, Paris 1979, III, p. 223.
28
29
38
SAGGI
56
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, II i: “He would be crowned: / How that might change his
nature, there’ the question […]. / Crown him that, / And then, I grant, we put a sting in him / That
at this will he may do danger with. / Th’abuse of greatness is when it disjoins / Remorse from
power, and, to speak truth of Caesar, / I have not known when his affections swayed / More than
his reason”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., pp. 45-47).
57
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, II i: “Then, les he may, prevent. And since the quarrel / Will
bear no colour for the thing he eis, / Fashion it thus: that what he is, augmented, /Would run to
these and these extremities; / And therefore think him as a serpent’s egg, / Wich, hatched, would
as his kind grow mischievous, / And kill him in the shell”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p.
47).
58
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, II i: “O conspiracy, / Sham’st thou to show thy dang’rous
brow by night / When evils are most free? O then, by day / Where wilt thou find a cavern dark
enough / To mask thy monstrous visage? Seek none, conspiracy; / Hide it in smiles and affability;
/ For if thou path, thy native semblance on, / Not Erebus itself were dim enough / To hide thee from
prevention”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 51).
59
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, II i: “Let us be sacrificers, but not butchers, Caius. / We all
stan up against the spirit of Caesar, / And in the spirit of men there is no blood. / O that we then
could come by Caesar’s spirit / And dont dismember Caesar! But, alas, / Caesar must bleed for it.
And, gentle friends, / Let’s kill him boldly, but not Wrathfully; / Let’s carve him as a dish fit for the
gods, / Not hew him as a carcass fit for hounds”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 57).
60
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, II i: “How many ages hence / Shall this our lofty scene be acted
over /In states unborn and accents yet unknown!”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 93).
61
A. SERPIERI, ivi, p. 211.
62
Cfr., G. Sacerdoti, Sacrificio e sovranità..., cit.
63
F. BACON, Saggi..., cit., p. 90.
64
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, III ii: “Now let it work! Mischief, thou art afoot, / Take thou
zhat course thou wilt”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 123).
65
A. NEGRI, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, Manifestolibri, Roma
2002, p. 57.
66
Ivi, p. 59.
67
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, IV ii: “There is a tede in the affaire of men / Wich, taken at
the flood, leads on to fortune; / Omitted, all the voyage of their life / Is bound in shallows and in
miseries”. (W. SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 153).
68
N. MACHIAVELLI, Discorsi..., cit., p. 218.
69
W. SHAKESPEARE, Julius Caesar, II i: “Since Cassius first did whet me agains Caesar / I have
not sleep. / Between the acting of a dreadful thing / And the first motion, all the interim is / Like a
phantasmata or a hideous dream. / The genius and the mortal instruments / Are then in council,
and the state of man, / Like to a little kingdom, suffers then / The nature of an insurrection”. (W.
SHAKESPEARE, Giulio Cesare..., cit., p. 49).
70
N. MACHIAVELLI, Il Principe, a cura di G. Inglese, Einaudi, Torino 2004, p. 33.
71
Cfr., J. WILKINSON, The Cripples at the Gate. Orson Welles’s “Voodoo” Macbeth, Bulzoni,
Roma 2004.
72
W. SHAKESPEARE, Macbeth, I iii: “[To Banquo] Do you not hope your children shall be kings, /
When those that gave the Thane of Cawdor to me / Promised no less to them?”. (W. SHAKESPEARE,
Macbeth, a cura di A. Serpieri, Giunti, Firenze 1996, p. 23).
73
G. CASALE, L’incantesimo è compiuto..., cit., p. 199.
74
N. MACHIAVELLI, Il Principe..., cit., p. 54.
75
W. SHAKESPEARE, Macbeth, IV ii: “Then the liars and swearers are fools, for there are liars
and swearers enough to beat the honest men and hang up them”. (W. SHAKESPEARE, Macbeth...,
cit., p. 143).
76
N. MACHIAVELLI, Il Principe..., cit., p. 61.
77
W. SHAKESPEARE, Macbeth, III ii: “Naught’s had, all’s spent, / Where our desire is got without
content”. (W. SHAKESPEARE, Macbeth..., cit., p. 94).
78
W. SHAKESPEARE, Macbeth, I vii: “If it were done when ‘tis done, then ‘twere well / It were done
quickly. If th’assassination / Could trammel up the consequence, and cathch / With his surcease
success; that but this blow / Might be the be-all and the end-all, here, / But here upon this band
39
and shoal of time, / We’d jump the life to come”. (W. SHAKESPEARE, Macbeth..., cit., p. 41).
79
W. SHAKESPEARE, Macbeth, I iii: “New honours come upon him, / Like our strange garments,
cleave not to their mould / But with the aid of use”. (W. SHAKESPEARE, Macbeth..., cit., p. 25).
80
W. SHAKESPEARE, Othello, V ii: “Methinks it should be now a huge eclipse / Of sun and moon,
and that the affrighted globe / Should yawn at alteration” (W. SHAKESPEARE, Rizzoli, Milano 1999,
p. 231. Ho leggermente modificato la traduzione di G. Baldini).
81
W. SHAKESPEARE, Troilus and Cressida, III iii.
40
IL PROBLEMA DELL’APPROCCIO:
PREMESSE E PREGIUDIZI COME HABITUS.
IL PENSIERO DI XAVIER ZUBIRI
È la teoria che decide quanto possiamo osservare
Albert Einstein, citato da Heisenberg, 1971
SAGGI
di Francesco Sanguinetti
Il modo con cui vediamo le cose è influenzato da quanto conosciamo o crediamo
John Berger, 1972.
Ogni forma di sapere razionale, si tratti di conoscenza comune, conoscenza scientifica o filosofica, prende l’avvio e procede da determinate premesse,
cioè viene influenzata, orientata, indirizzata da elementi preesistenti che possono assumere il ruolo di semplici presupposti indicativi o diventare autentici
pregiudizi.
Quale è il peso che questa condizione può esercitare sulle diverse forme di
conoscenza? C. Kordig1 affronta il problema in un lavoro dal titolo significativo:
Il carico teorico dell’osservazione, in cui prende in esame le impostazioni di
alcuni noti filosofi della scienza come Feyerabend (le teorie scientifiche sono
modi di guardare il mondo; la loro adozione influenza le nostre generali credenze ed aspettative e, pure, qualche nostra esperienza), Toulmin (noi vediamo il
mondo attraverso i nostri fondamentali concetti di scienza).
Khun (le teorie scientifiche come paradigmi). Kordig appare piuttosto critico
nei confronti di questa impostazione, tuttavia l’esistenza di un carico teorico è
ovvia: ciascun essere umano guarda il mondo da una particolare prospettiva e
può limitarsi a vedere solo quanto tale prospettiva gli consente di osservare.
Prendiamo come caso esemplare quello della scienza empirica, il cui compito specifico è la conoscenza della realtà materiale, del mondo delle cose che
ci circondano. La moderna scienza empirica nacque con G. Galilei al tempo del
Rinascimento, ma la scienza come conoscenza della realtà materiale era sorta
diversi secoli prima.
Nelle civiltà più antiche, specie in quelle dell’area mesopotamica, la cultura
era dominata dal pensiero magico-animistico, cioè dal pensiero mitopoietico,
nel cui ambito è impossibile lo sviluppo di una scienza oggettiva. I popoli mesopotamici, sumeri, assiri e babilonesi, avevano sviluppato una astronomia piuttosto avanzata, ma essi partivano dal presupposto dell’esistenza di uno stretto legame fra cielo e terra: dallo studio dei cieli era possibile conoscere la
volontà degli dei ivi residenti e trarne oroscopi circa le vicende umane, regolando su tale base l’agire degli uomini, per esempio, se l’oroscopo era infausto
il re non poteva iniziare una campagna militare, ecc. In altri termini la scienza
astronomica era finalizzata non alla conoscenza della natura, ma a quella della
volontà divina2. Tuttavia, i sapienti dell’epoca erano in grado di prevedere feno-
41
meni celesti come le eclissi; ed avevano sviluppato validi strumenti di calcolo.
Presso gli assiri ed i babilonesi l’astrologia era diventata una scienza molto
accurata, fondata su un’osservazione astronomica attenta e precise registrazioni degli eventi celesti con una notevole influenza sulle scelte politiche del
governo. Gli astrologi di corte possedevano e consultavano antichi manuali
astrologici; dal loro studio e dalla registrazione dei fenomeni celesti, traevano
gli opportuni oroscopi; in essi ogni giorno era classificato come favorevole o
nefasto, venivano consigliate o proibite determinate azioni, venivano escogitati speciali interventi per prevenire inconvenienti ecc. La moderna astrologia
non è altro che l’eredità di questa tradizione culturale; solo adesso sappiamo
che tutta questa minuziosa ricerca si basava su un pregiudizio.
La prima conoscenza scientifica degna di questo nome nacque in Grecia in
occasione dello sviluppo della cultura greca e l’avvento del pensiero razionale; tuttavia, la scienza greca o episteme era qualcosa di assai diverso dalla
moderna scienza empirica, come spiega X. Zubiri: ”L’episteme è una forma di
intellezione che risulta determinata dalla visione della struttura interna delle
cose, e che, pertanto, ha in sé i caratteri che le assicurano il possesso effettivo di ciò che esse sono nella loro intima necessità […]. Mentre l’episteme
greca cerca di penetrare nelle cose per spiegarle, la scienza moderna cerca,
in buona misura, di sostituirle con altre più precise”3. Così:
42
Un greco trova il problema del fenomeno in una dimensione differente. Mentre la
scienza considera nel fenomeno, nell’apparire, colui dinanzi al quale appare, il
greco considera nel fenomeno l’apparizione di ciò che appare. Più che gli spettatori, ciò che importa ad un greco sono i personaggi dello spettacolo […]. Nello
stesso modo in cui, quando si trattava del movimento, il greco si interrogava sull’ens mobile, così ora, trattandosi del fenomeno, si interroga sull’ens fenomenale4.
Per la scienza, dunque, la Natura è un sistema di leggi. Per l’episteme, una fondamentazione causale di cose. Una volta di più, la scienza va allo scorrere (al
corso) legale dei fenomeni, l’episteme alla peculiare natura causale delle cose
[…]. Ogni sapere fisico è sapere il perché delle cose […]. In realtà, dietro il perché, la scienza cerca il come, l’episteme cerca il che cosa. Riassumendo, la scienza cerca di accertare dove, quando e come si presentano i fenomeni. l’episteme
cerca di accertare che cosa sono necessariamente le cose che si manifestano in
tal modo nel mondo5.
In sintesi, “l’episteme greca nacque nell’ambito del background culturale del
pensiero mitopoietico, cioè di una forma di pensiero in cui ogni cosa, ogni fenomeno era animato, possedeva una causa interna ed aveva un’individualità. La
scienza moderna si è invece sviluppata nell’ambitodel pensiero cristiano, che
presentava ai credenti un modello di universo regolato da leggi divine. Per
comprendere l’ordine del mondo il greco doveva cercare l’essenza delle cose,
mentre lo scienziato del Rinascimento doveva scoprire le leggi immutabili stabilite dal Creatore”6.
Queste sono le premesse, l’habitat culturale nel cui ambito si è sviluppata
la moderna scienza empirica, una delle più importanti forme di sapere del
momento attuale. Si tratta di un caso esemplare: abbiamo descritto una premessa fondamentale sul piano dell’impostazione, ma ve ne sono altre. Per
Queste sono idee (o atteggiamenti) cui il pensiero greco è rimasto ostinatamente
fedele, quali che fossero le filosofie dalle quali lo deduceva; esso non ha mai voluto
ammettere che l’esattezza possa essere di questo mondo, che la materia di questo
mondo, del mondo nostro proprio, del mondo sublunare possa incarnare gli esseri
matematici (a meno che non vi sia forzata dall’arte). Il pensiero greco ammetteva in
compenso che nei cieli fosse del tutto diverso, che i movimenti assolutamente e perfettamente regolari delle sfere celesti e degli astri fossero conformi alle leggi della
geometria più rigorosa e più rigida. Ma appunto i cieli sono altra cosa dalla terra. E
per questo l’astronomia matematica è possibile, ma la fisica matematica non lo è.
Così la scienza greca ha non soltanto costituito una cinematica celeste, ma ha anche
osservato e misurato il cielo con una pazienza ed un’esattezza sorprendenti, servendosi di calcoli e di strumenti di misura che essa ha ereditato o inventato. In compenso essa non ha mai tentato di matematizzare il movimento terrestre e –con una sola
eccezione– di impiegare sulla terra uno strumento di misura, ed anche di misurare
esattamente una cosa qualunque al di fuori delle distanze. Ora è attraverso lo strumento di misura che l’idea dell’esattezza prende possesso di questo mondo e che il
mondo della precisione arriva a sostituirsi al mondo del pressappoco7.
Non è affatto raro che queste premesse si trasformino da validi presupposti in pregiudizi fuorvianti; di questi pregiudizi si è occupato F.Bacone, quando
tentò di teorizzare il metodo di indagine della moderna scienza empirica, allora agli albori. K. Popper narra il tentativo di Bacone non senza arguzia:
“Secondo Bacone, la natura, al pari di Dio, è presente in tutte le cose, […] ed
il compito della nuova scienza della natura è quello di determinare la natura di
tutte le cose […]. Ciò è possibile perché il Libro della Natura è un libro aperto.
Non dobbiamo fare altro che avvicinarci alla dea Natura con mente pura, libera da pregiudizi, ed essa ci rivelerà prontamente i suoi segreti. Dobbiamo purgare la nostra mente da tutti i pregiudizi, da tutte le idee preconcette, da tutte
le teorie; da tutte quelle superstizioni, o idoli che la religione, la filosofia, l’educazione o la tradizione possono averci tramandati. Quando avremo purgato la
nostra mente da tutti i pregiudizi e le impurità, potremo avvicinare la natura, e
la natura non ci trarrà in inganno”. Questo è l’approccio baconiano alla scienza empirica, definito da Popper come osservazionismo ed è oggi di solo interesse storico; infatti: la regola baconiana: “purgate la mente da tutte le teorie,
può avere un solo risultato: la mente sarà un mente vuota”8.
Queste sono le influenze esercitate sul procedimento della scienza empirica, ma ve ne sono altre più generiche, comuni a tutte le forme di sapere. In
primo luogo abbiamo quelle dipendenti dal linguaggio utilizzato dalla popolazione. Ogni lingua è un ampio sistema di modelli, differente dagli altri, dove
sono naturalmente ordinate le forme e le categorie con le quali ogni persona
non solo comunica, ma anche analizza la natura, accetta o trascura certi tipi di
rapporti e di fenomeni, incanala il suo ragionare e costruisce insomma la dimora della propria coscienza9.
SAGGI
esempio, sono indispensabili strumenti tecnici come la disponibilità di un sistema numerico agibile, quale quello fornito dai numeri arabi, disponibilità che
rende possibile l’esecuzione di calcoli abbastanza complessi con buona precisione. C’è l’ambito culturale, cioè la premessa fornita dalla cultura di base,
come ce la illustra A. Koyré:
43
Le differenti lingue parlate dalle popolazioni umane ancor oggi influenzano il
modo di concepire ed affrontare la realtà. Prendiamo il caso di due lingue di origine comune quali il tedesco e l’inglese: per la prima sapere si traduce con wissen e konnen, mentre la seconda usa per ambedue i sensi to know; le due lingue presentano all’utente due diversi tipi di realtà. Ancora, le più importanti lingue europee utilizzano ambedue i verbi avere ed essere, derivati dai termini latini habere ed esse; tuttavia, lo spagnolo possiede due termini per ciascun verbo
(haber e tener, ser ed estar), mentre il finlandese, che non deriva dal latino, ha
solo il verbo essere (olla) e per dire io ho usa la perifrasi a me è (minulla on).
La lingua come modo di esprimere la realtà presenta notevoli differenze.
E ancora:
44
Noi sezioniamo la natura lungo le linee stabilite dalle nostre lingue materne. Le
categorie e i tipi che isoliamo dal mondo dei fenomeni, non li troviamo là fuori che
se ne stanno a guardare fisso in faccia l’osservatore; ma al contrario, il mondo si
presenta come un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere organizzato in larga misura dal sistema linguistico delle nostre menti. Noi ritagliamo la
natura, la organizziamo in concetti e attribuiamo significati in un dato modo,
soprattutto perché ci troviamo all’interno di una convenzione che la organizza in
quel modo- una convenzione valida per tutta la nostra comunità linguistica e codificata nei modelli della nostra lingua. Si tratta, ovviamente, di una convenzione
implicita e non espressa; ma i suoi termini sono assolutamente obbligatori; ci è
possibile parlare solo in quanto accettiamo l’organizzazione e la classificazione
dei dati stabiliti dalle convenzioni9.
La lingua appare come un importante strumento di differenziazione culturale, come era ben noto anche a X. Zubiri nell’esempio assai noto del significato del di nelle lingue semitiche.
Questa condizione era stata riconosciuta anche da A. Einstein:
L’attenzione dello scienziato è rivolta a quei fenomeni che sono accessibili all’osservazione, alla loro appercezione ed alla loro formulazione concettuale. Nel tentativo di giungere ad una formulazione concettuale dell’insieme enorme e confuso
dei dati d’osservazione, lo scienziato fa uso di un gran numero di concetti assorbiti praticamente con il latte materno e raramente o mai è consapevole del loro
carattere eternamente problematico. Egli usa questo materiale concettuale, o, più
precisamente, questi strumenti concettuali del pensiero, come qualcosa di ovvio,
di immutabilmente dato, qualcosa che che ha un valore oggettivo di verità che non
si deve quasi mai, e in ogni caso non seriamente, mettere in dubbio. Come potrebbe fare altrimenti? Come sarebbe possibile la scalata di una montagna, se l’uso
delle mani, delle gambe e degli strumenti dovessero essere confermati passo per
passo dai principi della scienza meccanica? Eppure nell’interesse della scienza è
necessario impegnarsi ripetutamente nella critica di questi concetti fondamentali in
modo da non esserne dominati inconsciamente10.
Gli esempi citati consentono di abbozzare una classificazione delle premesse della scienza, intese nella loro accezione più ampia, cioè come condizioni
positive o negative al progredire della nostra conoscenza. Distingueremo, allora:
1) premesse tecniche: lo sviluppo corretto ed esaustivo di una teoria scientifica richiede la disponibilità di adeguati strumenti intellettuali, in genere mutuati dalle scienze formali ed astratte quali la matematica e la geometria. Abbiamo
SAGGI
già citato in altra sede gli esempi del calcolo infinitesimale di Newton e quello
della geometria riemanniana di Einstein; un caso più recente è rappresentato
dalla matematica dei frattali per la definizione dei sistemi cosiddetti caotici.
2) premesse culturali distinguibili a loro volta in:
a) premesse ideologiche, quale è il caso ben noto di quei fisici di cultura
marxista che rifiutarono la teoria del big-bang cioè dell’universo in espansione.
b) premesse concettuali: in biologia non mancano pregiudizi del genere,
specie per quanto concerne il momento dell’approccio. Per esempio, il meccanicismo costituisce un grave pregiudizio quando intende ridurre la vita ad una
forma molto complicata di moto della materia, ignorandone il contenuto di natura informatica; del pari il vitalismo diviene un pregiudizio quando invoca la presenza operativa di un’entelechia.
In altra sede ho trattato in modo più approfondito del problema epistemologico concernente le ipotesi di approccio, che precedono nel processo della
scoperta scientifica le ipotesi di lavoro, codificate da K. Popper e ben distinte
dalle prime. Un’ipotesi di approccio non è suscettibile di falsificazione, ma solamente di un giudizio di fertilità; più essa suggerisce sviluppi della conoscenza,
maggiore sarà la sua validità. L’approccio meccanicistico vuole escludere ogni
reazione non riconducibile alle leggi della fisica e della chimica e con tale pregiudizio non può ammettere l’esistenza operativa nella materia vivente dell’informazione genetica; si tratta di un approccio estremamente limitante.
L’approccio vitalista si fonda, invece, su una incomprensione, causata dall’impossibilità di identificare la forza vitale, l’entelechia con l’informazione genetica. Ambedue i pregiudizi sono stati dissolti dalla scoperta della medesima11.
Una posizione lievemente diversa può essere assegnata a due posizioni
filosofiche rivali, il riduzionismo e l’olismo; se le consideriamo alla stregua di
due differenti ipotesi di approccio, risulteranno perfettamente valide ed accettabili, come sostiene Smolin12.
Anche K. Popper, il maggior filosofo della scienza contemporaneo, ha riconosciuto l’esistenza. di queste condizioni preliminari: “Ad ogni istante del
nostro sviluppo pre-scientifico o scientifico viviamo al centro di quello che io
chiamo di solito un orizzonte di aspettative. Con questo intendo la somma totale delle nostre aspettative, sia che siano subconscie sia che siano consce, o
forse anche stabilite esplicitamente in un linguaggio. Gli animali e gli infanti
hanno anche i loro vari e differenti orizzonti di aspettative, sebbene senza dubbio ad un livello di consapevolezza più basso che, ad esempio, uno scienziato il cui orizzonte di aspettative consiste in misura considerevole di teorie o ipotesi formulate linguisticamente”. Questo è un altro aspetto delle premesse del
nostro conoscere, che tuttavia rientra perfettamente nel nostro schema;
Popper prosegue chiarendo ulteriormente: “I vari orizzonti di aspettative differiscono, ovviamente, non solo perché sono più o meno consci, ma anche nel
loro contenuto. Tuttavia, in questi casi l’orizzonte di aspettative gioca la parte
di un quadro di riferimento: solo il loro disporsi in questo quadro conferisce
senso o significato alle nostre esperienze, azioni od osservazioni”13.
Queste premesse culturali potrebbero essere assimilate sul piano conoscitivo
ad un sistema di canali di comunicazione, utilizzati dall’uomo per entrare selettiva-
45
46
mente in contatto con la realtà. Un sistema di canali di comunicazione non è congenito, ma viene acquisito durante lo sviluppo. Un bambino piccolo è molto attento all’ambiente che lo circonda e fissa nella memoria ogni esperienza; crescendo
impara a sviluppare un’attenzione ed una memoria selettive, ad occuparsi solo dei
fenomeni rilevanti, ad aprire verso la realtà determinati canali di comunicazione.
Questo instaurarsi di un sistema di canali di comunicazione consente al soggetto
sia di non rimanere sommerso dagli stimoli, sia di poter esaltare la propria sensibilità, indirizzandola verso i reperti di maggior interesse; vedi l’effetto cocktail-party14.
Procedendo nel proprio sviluppo intellettuale ogni soggetto arricchisce il
proprio sistema di canali di comunicazione, ma può anche correre il rischio di
aprire degli pseudocanali, che non lo possono portare altro che in un vicolo
cieco; questi sono i casi di colui che si fa sviare da un pregiudizio. F. Bacone
aveva perfettamente ragione a combattere i pregiudizi del suo tempo, dominato da un habitat culturale statico e retrivo, tuttavia il suo stesso osservazionismo costituiva un altro pregiudizio in quanto negava l’esistenza di qualsiasi
premessa teorica valida, prova ne sia che egli stesso era, su queste basi, contrario all’ipotesi copernicana.
Dopo questi chiarimenti, riprendiamo in esame le differenze fra l’episteme
e la moderna scienza empirica: per un greco le leggi di natura erano immanenti alla materia stessa e, per comprenderle, era necessario conoscere l’essenza delle cose; per uno scienziato del Rinascimento le leggi di natura erano trascendenti, in quanto imposte al creato dal Creatore, che si faceva garante del
loro funzionamento; in questo ambito era sufficiente studiare il corso legale dei
fenomeni. L’approccio greco, estremamente difficile da realizzare ma coerente
alla mentalità greca molto propensa alla speculazione, non ha avuto successo, mentre quello degli scienziati rinascimentali si è dimostrato valido e, soprattutto, fertile. Gli scienziati attuali considerano le leggi di natura come delle
regolarità constatate nello svolgimento dei fenomeni: agli effetti dell’approccio
è come se fossero leggi trascendenti.
L’approccio rinascimentale, allora possibile solo nell’ambito della cultura cristiana, è uno degli elementi fondanti del successo della moderna scienza
empirica, sorta nell’Europa post-medioevale, non nella Grecia antica, né nella
Cina o nell’India dei quel tempo, certamente più progredite sul piano della tecnologia e del sapere.
Cerchiamo di approfondire questo genere di approccio. X. Zubiri così scrive: ”Esiste un modo primario di confrontarsi con le cose che è l’habitus.
L’habitus, questa voce è un latinismo, in greco si chiama exiV (in italiano i termini abitudine ed abito non corrispondono al significato zubiriano; così preferisco conservare il termine latino habitus con il senso di disposizione o attitudine intellettuale acquisita). L’habitus non è un costume, un abito, ma un modo
di aver a che fare con le cose, οπος εχει, direbbe un greco. Questo modo di
aver a che fare con esse è quello in cui si iscrivono tutti i meccanismi stimolorisposta di un essere vivente15.
Ogni vivente possiede un proprio habitus, tipico di ciascuna specie, un
modo di avvicinarsi alle cose che lo circondano. L’uomo, tuttavia, supera il
semplice livello stimolo-risposta:
Allora, l’uomo, animale di realtà, cioè vivente aperto alla realtà delle cose
che lo circondano, del mondo in cui vive, appare in grado di farsi carico di tale
realtà. Questa essenziale facoltà umana si trova alla base di tutta la storia della
nostra civiltà: l’uomo riconosce le cose come reali, impara ad agire su di esse,
a praticare l’intervento sulla natura, ed a fondare sul possesso operativo di
questa facoltà la propria evoluzione. La possibilità di intervenire sulla natura si
sviluppa ben presto in agire progettuale e con questo l’uomo diviene, in primo
luogo, esigitivo di un’immagine del mondo e, ben presto, di una precisa valutazione della posizione dell’uomo in tale ambito, cioè nell’universo stesso.
Questi sono i due momenti essenziali dell’avventura umana. L’immagine
del mondo sarà prima animistica e magica, il pensiero mitopoietico, gli interventi sulla natura saranno associati a preghiere, offerte propiziatorie, formule
di scongiuro. Con lo sviluppo della civiltà umana avremo poi una scienza
oggettiva e non animistica, una religione monoteista con un dio creatore e trascendente, fino a giungere al momento attuale. In questo ambito l’evoluzione
della specie umana sarà prevalentemente culturale e l’informazione culturale
si trasmetterà con l’apprendimento. Infatti, l’uomo è il primo vivente in cui l’evoluzione culturale è operativa e tale processo appare molto più veloce dell’evoluzione biologica, legata alla generazione. In tale prevalenza svolge un ruolo
essenziale il modo di trasmissione dell’informazione culturale, che sfrutta la
trasmissione per apprendimento.
Come ha luogo questo apprendimento? Dagli etologi sappiamo che il papero riceve, durante le prime ore di vita, l’imprinting della figura materna; se
durante questo tempo viene mantenuto in isolamento perde tale possibilità e
non potrà più recepire tale figura. L’apprendimento elementare presenta tempi
di ricezione ben stabiliti. Del pari sappiamo che, se al gattino neonato vengono mantenute chiuse le palpebre di un occhio per alcune settimane, quell’occhio diventerà operativamente cieco, in quanto le vie neurosensoriali fra organo di senso e corteccia cerebrale non avranno avuto modo di instaurarsi.
Infine, nel caso dell’uomo, se con un intervento chirurgico riusciamo a ridare la
vista ad un cieco nato, entrerà ancora in gioco il fattore tempo: infatti, se l’intervento viene eseguito tardivamente, il paziente riacquisterà la vista, ma non
l’uso della medesima, in quanto avrà già appreso ad entrare in contatto con le
cose che lo circondano tramite il tatto, creandosi un mondo di rapporti tattili e
SAGGI
In questo caso, l’uomo, animale iperformalizzato, esegue un’operazione molto
banale ed elementare, ma nella quale si trova indubbiamente un’innovazione di
grande portata nell’Universo e,precisamente, il farsi carico della realtà […]. Farsi
carico della realtà significa che le cose non sono un mero stimolo. Ma che si presentano come qualcosa di per sé, come non avviene nel caso dell’animale […].
Nel caso dell’uomo le caratteristiche primarie e radicali delle cose sono, appunto,
l’essere realtà […]. Grazie a ciò, l’ambiente diventa qualcosa di completamente
nuovo. L’ambiente non si converte in un insieme di cose, di alcuni sistemi stimolanti, ma in qualcosa di diverso: nell’immenso, indefinito campo di realtà, quello
che chiamiamo mondo. Nel farsi carico della realtà, grazie a questa funzione, le
cose non si presentano all’uomo come parte dell’ambiente, ma del mondo. Questo
significa […] che l’uomo è radicalmente e costitutivamente un’essenza aperta.
Aperta, appunto, al carattere di realtà delle cose […]. L’uomo è strutturalmente un
animale di realtà16.
47
48
non visivi; egli farà molta fatica, se ci riuscirà, a ricostruirsi un’immagine del
mondo visiva.
Queste sono alcune delle premesse neurofisiologiche dell’apprendimento,
che rappresentano un aspetto dell’habitus; a queste si aggiungerà più lentamente l’elemento socio-culturale, quello che più squisitamente viene appreso.
Quindi, in tutte le forme di sapere esistono delle premesse, che possono
esplicarsi in presupposti o pregiudizi, canali di comunicazione verso la verità o
vicoli ciechi. Si tratta, generalmente del contesto dell’approccio ed il criterio
che controlla le ipotesi di approccio, cioè le premesse o i canali di comunicazione, è quello della fertilità, non della veridicità.
Questo habitus, questo schema culturale acquisito, può risultare anche
assai rigido tanto da non consentire l’imbocco di un canale di comunicazione
reale, almeno in prima istanza; è quanto accadde ad Einstein nella sua prima
formulazione della teoria della relatività17. Questo aspetto conservatore di uno
schema culturale acquisito non deve destare meraviglia. Sappiamo che il
nostro S.N.C. possiede una organizzazione strutturale geneticamente determinata, quindi comune a tutti i membri della specie. Tuttavia, questa struttura è
suscettibile di organizzarsi funzionalmente, anzi è esigitiva in quanto a ciò, realizzando determinate acquisizioni come nuovi collegamenti fra i neuroni, le cellule funzionali del S.N.C.. Questi collegamenti interneuronici sono denominati
sinapsi ed ogni neurone ne può avere da qualche decina a diverse migliaia;
essi portano al costituirsi di vere e proprie vie, attraverso le quali vengono trasmessi i diversi impulsi funzionali. Negli animali da laboratorio è stato dimostrato che il numero delle sinapsi è molto più elevato in animali vissuti in gruppo, cioè in un ambiente ricco di stimoli, rispetto a quello rilevabile in animali
allevati in isolamento.
Il S.N.C. umano possiede delle grandi capacità di apprendimento, enormi,
non infinite; deve, quindi, imparare a selezionare le esperienze: a questo servono, appunto, i canali di comunicazione. Questo sistema di canali deriva dall’organizzazione funzionale di una struttura geneticamente determinata. Se,
tuttavia, una struttura di questo genere non viene costantemente utilizzata
attraverso le generazioni, può perdere la protezione della selezione naturale e
rimanere danneggiata.
Tentiamo un chiarimento: sappiamo che la funzione non crea l’organo (concezione di stampo lamarckista), ma contribuisce indirettamente al suo mantenimento. Infatti, è la pressione esercitata dalla selezione naturale sul phylum,
che conserva un organo in piena efficienza operativa, eliminando tutti i casi di
mutazione difettiva a carico del medesimo. Se l’organo non viene utilizzato,
non serve alla sopravvivenza del vivente, perde la protezione del meccanismo
selettivo e lentamente viene sottoposto alla ripetuta azione usurante delle
mutazioni difettive, fino a non essere più operativo. Questo è, probabilmente,
quello che è accaduto alla talpa, che ha perduto il senso della vista perché non
ne ha avuto più bisogno, vivendo nell’oscurità del sottosuolo; il succedersi di
mutazioni difettive a carico dell’occhio, mutazioni che sarebbero risultate letali
per un vivente di superficie, hanno portato alla degenerazione dell’organo della
vista. È noto, infatti, che le mutazioni accidentali dotate di effetto sono la mino-
SAGGI
ranza, ma in esse predominano quelle difettive o svantaggiose, mentre quelle
vantaggiose sono rarissime, eccezionali.
Prendiamo in esame un caso teorico: una mutazione accidentale difettiva
colpisce una funzione sensoriale di un animale superiore; il danno potrà interferire sia con l’organo di senso, sia con l’area cerebrale deputata alla elaborazione dei dati sensoriali, sia con le vie nervose di comunicazione fra l’organo
di senso e l’area cerebrale stessa: si instaurerà un deficit funzionale, ma la sua
efficienza operativa dipenderà dalle condizioni di vita, cioè da come si trova ad
operare la selezione naturale. Per esempio, un deficit visivo risulterà letale ad
un uccello rapace, che si procura il cibo servendosi della vista.
Proseguiamo nella nostra indagine. Il cervello consta di una struttura altamente complessa, in buona parte esigitiva di un’organizzazione funzionale,
cioè dell’instaurarsi di collegamenti interneuronici particolarmente articolati,
dell’apertura di determinate vie, cioè dell’instaurazione di un’organizzazione
funzionale, organizzazione che presenta una certa plasticità di sviluppo e di
area. nonché una specifica sistematizzazione temporale.
Prendiamo, adesso, in esame il caso dell’uomo, l’unico vivente nel quale si
riscontri l’evoluzione dell’informazione culturale, evoluzione che sovrasta per
efficienza e rapidità l’evoluzione dell’informazione genetica. Il cervello è l’organo dal quale dipende l’operatività dell’informazione culturale e che, dai primi
ominidi fino all’uomo attuale, ha più che raddoppiato il proprio volume. La
peculiare caratteristica dell’informazione culturale è la sua trasmissibilità
mediante apprendimento; è questo fattore che rende il relativo processo evolutivo molto più veloce ed efficiente rispetto a quello degli altri viventi, distinzione ben sottolineata da X. Zubiri19.Questa trasmissione si fonda, appunto per
questo, sull’acquisizione da parte dell’uomo dell’uso del linguaggio parlato
prima e della scrittura poi, conquiste che rivestono nella sua storia evolutiva un
ruolo primario ed essenziale.
Tuttavia, dopo queste conquiste, la specie umana si moltiplica, si diffonde
e si disperde, occupando nuove sedi; può così accadere che un popolo rimanga relativamente isolato e si sviluppi in modo autonomo, acquisendo un habitus proprio, specifico, realizzando anche una diversa organizzazione funzionale delle strutture cerebrali.
La conquista della scrittura segue quella del linguaggio parlato con la trasformazione di una sequenza di suoni in una di simboli graficamente espressi,
prima come ideogrammi poi come lettere cioè simboli fonetici. Questi due tipi
di rappresentazione grafica impegnano due distinte parti del cervello. Nella lingua giapponese esistono due distinti tipi di caratteri: i kanji, derivati dalla scrittura cinese, sono ideogrammi senza alcuna relazione sistematica con i corrispondenti suoni del linguaggio parlato, ed i kana, simboli fonetici, ciascuno dei
quali corrisponde ad una sillaba. I morfemi grammaticali vengono scritti solo in
kana, mentre i morfemi lessicali possono essere scritti usando uno o l’altro tipo
di caratteri. Mentre l’elaborazione dei kanji è strettamente associata con l’attivazione di rappresentazioni lessicali-semantiche, l’elaborazione dei kana è
mediata fonologicamente18. Ne consegue che un giapponese impegna nella
scrittura ambedue gli emisferi cerebrali, mentre l’occidentale ne impegna sol-
49
50
tanto uno, lasciando l’altra area libera per altri impegni. Il relativo isolamento
culturale ha portato alla diversificazione di due distinti habitus linguistici.
Prendiamo in esame un altro caso esemplare: i diritti della persona umana
considerati come il problema della schiavitù. Non conosciamo l’organizzazione
sociale dei popoli primitivi, pur ritenendo probabile che vivessero da eguali. Ad
un certo punto della storia dell’umanità vediamo apparire la schiavitù: ogni
popolazione si divide in schiavi e liberi. Questa diffusione della schiavitù non
desta a quel tempo meraviglia alcuna ed appare, anche a menti illuminate,
come un fenomeno del tutto naturale. Sappiamo, infatti, che al mercato degli
schiavi venivano regolarmente portati i prigionieri delle guerre di conquista,
specie ai tempi del fiorire delle civiltà greca e romana. Nella storia dell’impero
romano si legge che quando gli ubii terminarono una faida con i suebi (ambedue popoli germanici) entrambi portarono i loro prigionieri di guerra al più vicino centro commerciale romano per venderli e riscuotere un congruo compenso in argento19; evidentemente i prigionieri facevano parte del bottino di guerra razziato insieme ai capi di bestiame ed a nessuno veniva in mente di liberare i concittadini con uno scambio di prigionieri, certamente meno lucroso. La
parità di diritti fra gli esseri umani venne ripresa e sostenuta dal messaggio cristiano, ma la servitù della gleba è stata abolita in Europa solo nel secolo scorso e la schiavitù esiste ancora nel terzo mondo.
Cerchiamo di inquadrare questi sconcertanti fenomeni dal punto di vista
dell’habitus. Quale può essere il meccanismo operativo da cui dipende l’instaurarsi di un habitus o la sua perdita? Sappiamo che una determinata struttura
cerebrale, esigitiva di un’adeguata organizzazione funzionale, può perdere tale
suscettibilità se questa organizzazione non le viene richiesta dalle circostanze,
in quanto le viene a mancare l’azione protettiva della selezione naturale. Tanto
per fare un esempio, una mutazione accidentale può colpire la struttura in questione ed il difetto non verrà cancellato dalla selezione naturale, ma verrà trasmesso alle generazioni successive e si diffonderà. Se viene a mancare la
consegna alle generazioni successive della citata informazione culturale, l’area
cerebrale deputata alla sua ricezione verrà destinata ad altri compiti, subirà
una differente pressione selettiva e perderà la ricettività sottolineata.
Quale può essere il meccanismo che controlla l’instaurarsi di questi habitus? Sappiamo che, se una determinata struttura cerebrale non subisce,
durante l’opportuno periodo della vita, un’adeguata organizzazione funzionale
per alcune generazioni, tale struttura potrà perdere questa ricettività per una
mutazione difettiva, perdita che, non essendo la funzione operativa, non verrà
protetta dalla selezione naturale, in qualche caso la perdita potrebbe anche
risultare vantaggiosa, lasciando un’area cerebrale dotata di plasticità libera per
altri impegni.. A questo livello l’elemento determinante è la pressione esercitata dalla selezione naturale ed i vantaggi a breve termine di un habitus della
sopraffazione dei più deboli sono indubbi. L’altro elemento in gioco è la trasmissione di questi habitus, la trasmissione di una tradizione culturale, come
Zubiri ci illustra molto chiaramente.
Abbiamo osservato in precedenza che in tutte le forme di sapere si possono riscontrare delle condizioni precostituite, delle premesse; queste possono
Le forme di stare nella realtà sono optative. Appunto per questo, l’uomo, animale
di realtà, quando genera un altro uomo, non solo gli trasmette la vita, cioè non solo
gli trasmette alcuni caratteri psicorganici, bensì inesorabilmente e velis-nolis, lo
installa in un certo modo di stare nella realtà. Non solo gli trasmette caratteri psicorganici, ma gli dà in consegna un modo di stare nella realtà. L’installazione nella
vita umana non è, quindi, solo trasmissione, ma anche consegna. Consegna si
chiama paradosi V, traditio, tradizione. Il processo storico è concretamente tradizione […]. La vita viene trasmessa geneticamente, ma le forme (o i modi) di stare
nella realtà si consegnano mediante tradizione. Appunto per questo, perché c’è
questa tradizione, la vita umana non parte da zero. Essa inizia sempre partendo
da un modo di stare nella realtà che ha ricevuto in consegna. Questo perché […]
l’uomo è un’essenza aperta, e, in casu, aperta alla consegna di modi di stare nella
realtà, ad una tradizione, che appare come tradizione trasmessa20.
Ecco come il filosofo spagnolo rende ragione delle citate premesse: come
essenza aperta l’uomo è in grado e, pure, è necessitato a recepire questo
genere di apprendimento. L’habitus umano, cioè il modo con cui l’uomo affronta il mondo delle cose reali, appare come un insieme di nozioni acquisite dalla
tradizione culturale di base, dall’apprendimento specialistico, da tutte le esperienze accumulate dal soggetto (ma recepite sulla base di tali premesse). Alla
formazione dell’habitus contribuiscono la tradizione culturale familiare, di gruppo sociale, di scuola, di classe, di partito; tale formazione riceve il contributo
delle istituzioni come è liberamente scelta dall’individuo; può, infine, ricevere
influenze determinanti in modo indiretto. Quando Ippocrate di Coo denunciò la
vera natura dell’epilessia, chiamata male sacro perché ritenuta il frutto di una
possessione divina o demoniaca, come un’affezione del S.N.C. non ritrovò
alcun riscontro nei colleghi e la sua geniale intuizione rimase inutilizzata per
millenni. Abbiamo già in precedenza citato quale sia il ruolo svolto dalle premesse quale habitus nel momento dell’approccio, nel primo stadio di ogni processo conoscitivo. L’habitus culturale di ciascuno condiziona in modo rimarchevole questo momento essenziale, come dimostra il già descritto caso della
costante cosmologica di Einstein nelle prima formulazione della relatività.
Sempre dalle opere di Zubiri possiamo trarre un caso positivo: l’uomo considerato come animale di realtà nello studio dell’antropogenesi21 come dell’antropologia culturale, acquisizione basilare per il pensiero zubiriano..
In altri termini, la trasmissione di una tradizione culturale funziona quando
trova la disponibilità a recepirla da parte dell’idonea struttura cerebrale; se questa è andata perduta la trasmissione non diviene più operativa, anche se non
è detto che venga perduta definitivamente, data la notevole plasticità funzionale del cervello umano. Esprimendoci in termini zubiriani diremmo che la consegna non può essere effettuata per mancanza del destinatario.
Siamo partiti dalle premesse per giungere fino all’habitus, un modo di aver
a che fare con le cose ed alla sua importanza nella storia del pensiero umano;
SAGGI
assumere il ruolo di presupposti o pregiudizi, cioè di canali di comunicazione
verso la realtà o di pseudocanali, di vicoli ciechi. X. Zubiri definisce questa condizione come un modo di aver a che fare con le cose come realtà, di farsi carico della stessa in modo optativo, tramite un’opzione:
51
si tratta di un filo diretto che parte dalle prime tappe dell’antropogenesi e giunge fino alla nostra società culturalmente avanzata. L’unitarietà di questo processo è stata chiaramente impostata dal filosofo spagnolo.
52
1
C. R. KORDIG, The Theory-ladenness of observation, “The Review of Metaphysics”,1971,
XXIV, pp. 448-484.
2
G. PETTINATO, La scrittura celeste, Mondadori, Milano 1998.
3
X. ZUBIRI, Scienza e Realtà in Natura, Storia, Dio, Augustinus, Palermo 1985, p. 68.
4
Ivi, p. 72.
5
Ivi, p. 74.
6
F. SANGUINETTI, Xavier Zubiri. Pensiero filosofico e Scienza moderna, La Garangola, Padova1974,
pp. 45-46.
7
A. KOYRÉ, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Torino 1967, p. 91.
8
K. R. POPPER, Scienza e filosofia, Torino 1969, pp. 124-128.
9
L. WHOORF, Language, Thought and Reality, Cambridge, Mass., 1956, p.152., citato da D.
ANTISERI in Le ragioni del pensiero debole, Roma 1993, pp. 40-41.
10
A. EINSTEIN, Premessa, in M. JAMMER, Storia del concetto di spazio, Milano 1963.
11
Cfr. F. SANGUINETTI, Il vitalismo e l’informazione genetica, “Rassegna di scienze filosofiche”,
1969, XII, pp. 221-230; F. SANGUINETTI e M. C. SANGUINETTI, Il problema dell’approccio: libertà di
diagnosi?, Convegno: “Sperimentazione clinica, consenso informato e libertà di terapia”, a cura di
A. Frigerio, Milano, 25 marzo 1998.
12
L. SMOLIN, La vita del cosmo, Einaudi, Torino 1998, p. 36.
13
K. R. POPPER, Conoscenza oggettiva, Roma 1972, pp. 450-451.
14
F. SANGUINETTI, L’umano e le scienze biologiche, in Antropologia e filosofia della religione, v.
I, a cura di A. Babolin, Benucci, Perugia 1982, pp.181-201.
15
X. ZUBIRI, Estructura dinamica de la realidad, Alianza Editorial, Madrid 1989, p.173.
16
Ivi, pp. 205-206.
17
G. S. HAWKING, Dal Big-Bang ai buchi neri, Milano 1988, pp. 174-175.
18
S. Z. RAPCSAK, P. M. BEESON, and A. B. RUBENS, Writing with the Right Hemisphere, Brain
and Language, 1991, 41, pp. 510-530.
19
S. FISCHER-FABIAN, I Germani, Garzanti, Torino 1997, p. 318.
20
X. ZUBIRI, La dimensione historica del ser humano, in Siete ensayos de antropologia filosofica, Bogotà, pp. 127-128.
21
X. ZUBIRI, El origen del hombre, in Siete ensayos de antropologia filosofica, cit., pp. 27-54.
PROSPETTIVE ANTIREIFICANTI
DELLA FENOMENOLOGIA
Intenzione di questo contributo è esplicitare secondo un criterio sincronico di
analisi quei momenti che l’opera husserliana presenta come caratterizzanti in funzione dello scopo che lo stesso contributo si propone di perseguire: ritrovare fra
le righe della complessa produzione husserliana il tema di una proposta che ha
nel rifiuto della reificazione, giocata come vedremo fra più piani, il suo leit-motiv.
L’impiego in questo contributo di una analisi sincronica non è arbitrario, perché motivato da una ipotesi di fondo: che le opere husserliane non semplicemente seguano l’una all’altra, ma siano l’una nell’altra come in un “sistema di
scatole cinesi”; queste sembrano dunque organizzarsi come la partitura complessa di una sinfonia: un tema e le sue costellazioni di motivi presenti in
un’opera degradano lentamente, in un’opera successiva, nella penombra delle
Abschattungen, nel non tematico; richiami ai temi precedenti sono sempre
possibili secondo schematiche di concordanze invariabili.
La sinfonia delle opere husserliane non si ripete mai meccanicamente:
sempre ogni cosa viene ripresa e ri-composta con varianza di temi; questa sinfonia è ritenzione di concordanze già eseguite e protenzione verso nuove.
La fenomenologia è una complessa partitura musicale: come musica è vita
del tempo (temporalità) e nel tempo (temporalizzazione), ovvero Zeitigung.
Si lascerà in questo contributo spesso parlare l’autore pervenendo ad una
chiarificazione e sistematizzazione provvisoria della problematica sopra indicata.
Un ruolo centrale nella articolazione della proposta sopra menzionata è
rivestito dalle Logische Untersuchungen da cui, senza soffermarmi sulla annosa discussione sul rapporto tra psicologia e logica e tra queste due e la fenomenologia, saranno espunti qui di seguito alcuni passaggi che mi sembrano
annunciare a partire da questa opera della giovinezza intellettuale del Nostro
l’orizzonte entro cui elaborare la proposta.
Un primo passo significativo è seguente:
Ogni unità di esperienza come unità empirica della cosa, dell’evento, dell’ordine e
della connessione delle cose, è un’unità fenomenale in virtù dell’inerenza reciproca sensibile degli aspetti e delle parti, che emergono unitariamente, dell’oggettualità che si manifesta.
Nel manifestarsi, una cosa rimanda ad un’altra, secondo un certo ordine ed un
certo rapporto di connessione.
E ciò che è dato singolarmente in questa struttura di rimandi reciproci non è il mero
contenuto vissuto, ma l’oggetto (o una sua parte, una sua proprietà, ecc.) che si
manifesta-e questo oggetto si manifesta per il solo fatto che l’esperienza conferisce ai contenuti un nuovo carattere fenomenologico, in quanto essi non valgono
più per se stessi, ma esibiscono un oggetto da essi differente1.
SAGGI
di Giorgio Rizzo
53
Questo passo tratto dalla Prima Ricerca espone in modo chiaro e netto la
novità assoluta del metodo fenomenologico ed in particolare il suo aspetto antinaturalistico ed antioggettivante. Esaminiamolo più a fondo:
a) L’esperienza nella sua unità è una unità fenomenica: ciò porta già ad
escludere ipostatizzazioni di ogni genere, quelle che Husserl chiamerà
“Seinssetzungen” (posizioni d’ essere), perché queste con la tradizione che si
portano dietro sin da Platone ed Aristotele non riuscirebbero a superare il rigoroso vaglio critico del dubbio introdotto da Cartesio e che Husserl in L’idea
della fenomenologia così sintetizza:
In tutte le sue varie forme la conoscenza è un vissuto psichico: conoscenza del
soggetto conoscente. Di contro ad essa stanno gli oggetti conosciuti. Ma allora
come può la conoscenza divenir certa del suo accordo con gli oggetti conosciuti?
Come può andare oltre se stessa e cogliere attendibilmente i suoi oggetti? La datità degli oggetti di conoscenza nella conoscenza, affatto ovvia per il pensiero naturale, diviene un enigma2.
54
Intendere la esperienza nella sua unità significa per Husserl andare oltre il
pensiero naturale investendo il reale di un indice di enigmaticità gnoseologica:
gli oggetti, qui di fronte a noi, perdono quella statica consistenza di cui il pensiero naturale li ammanta per acquisire una nuova dimensione: lo shock per
una prassi del pensare abituata a vederli inseriti corposamente in un contesto
indubitabile sclerotizzato da certezze incrollabili e relazioni univoche non
potrebbe essere più forte.Se allarghiamo sperimentalmente queste nuova
prassi del pensare anche ad ambiti non intravisti inizialmente da Husserl, si
capisce come l’effetto risultante è ancora più sorprendente: istituzioni, abitudini consolidate da secoli possono essere come soggette ad una operazione di
fluidificazione che le interroghi sulla loro origine e sulla loro legittimità: l’enigmaticità si sostituisce al thaumazein platonico.
b) l’oggetto d’esperienza non è semplicemente (bloss) il contenuto esperito nel vissuto; al contrario perché tale oggetto possa offrirsi, forzando il
passo si potrebbe dire possa aver senso, è necessario che questo stesso
vissuto sia investito di un “carattere fenomenologico”(phaenomenologischen
Charakter).
È banale, ma non troppo, affermare che di questo conferimento
(Verleihung) di carattere non si possa ritenere responsabile l’oggetto stesso a
meno di non cadere in ridicoli paradossi; si richiede dunque l’intervento di un
soggetto che di tale atto si faccia carico.
Viene dunque alla luce quella peculiarità dell’indagine fenomenologica di
essere una “via neutra”, una sorta di “terza via” rispetto a quei due grandi
orientamenti che tradizionalmente la filosofia ha assunto: quello idealistico e
quello realistico.
Il concetto di intenzionalità risolve le aporie di queste due opposte polarità
partendo da una posizione rispetto alle quale queste ultime si mostrano come
non sensi (unsinnig).
Si può ancora di più allargare il discorso facendo parlare il Nostro:
A chi obietta legittimamente che Husserl, distinguendo tra reale ed essere,
apra la porta della dissoluzione del mondo intero, “gettandosi tra le braccia”
dell’idealismo di Berkeley, si può ribattere che il carattere di titolarità della realtà non la stravolge, o tanto meno la nega, ma ne elimina una interpretazione
assurda derivante da una assolutizzazione filosofica del mondo: tale assolutizzazione viene alla luce quando non si osserva che il mondo possiede il suo
essere come un “senso” che presuppone la coscienza come “campo della
significazione”.
In questa prospettiva una nota a piè di pagina inserita nel paragrafo 55
delle Idee da cui è stato espunto il passo sopra, nota nella quale l’autore ci
informa dello “straordinario” ampliamento che il concetto di “senso” qui in
questo contesto assume, ci dà, se analizzata approfonditamente, la possibilità di allargare il quadro di intelligibilità della problematica ivi indagata allo
scopo di dare una veste concreta a quella proposta, la prospettiva antireificanti, da cui ha preso spunto questo contributo: qui si tratta di de-sostanzializzare il mondo e le sue concrezioni ricreando il campo di quelle significazioni operate dalla coscienza: in carne ed ossa, nel loro “presente
vivente”(lebendige Gegenwart).
c) Queste “sostanze” del mondo non valgono più per sé (fuer sich gelten),
ma rinviano ad operazioni della coscienza che ora si tratta di palesare, di far
uscire dalla anonimia della sua funzionalità latente.
Questo “straordinario” allargamento della nozione di senso fornisce un
esempio di come il “ricominciare daccapo” sia molto di più di un mero motto
atto a richiamare alla mente il metodo fenomenologico; al contrario esso è la
linfa vitale, il criterio operativo della fenomenologia stessa come può risultare
da una risemantizzazione di indice superiore della domanda relativa al senso
del mondo così formulabile: e quale è il senso del senso del mondo? Ed ancora se la assolutizzazione del mondo è una interpretazione assurda, ciò significa che ciò che si cerca non è una verità in sé e per sé, ma sempre una interpretazione più sensata, soggetta anch’essa ad adeguamenti successivi, in un
campo di rimandi, di Hin-Rück/weisungen la cui tenuta è assicurata, non per
sempre, dall’orizzonte mondo, orizzonte degli orizzonti.
La filosofia risulta di conseguenza un apprendimento poggiante sulla
spontaneità (Selbsttätigkeit), su “di una riproduzione interiore delle evidenze
SAGGI
Con una certa cautela nell’uso della parola, possiamo anche dire in certo modo
che tutte le unità reali sono “unità di senso”. Ma le unità di senso presuppongono
(e lo ripeto: non già perché lo deduciamo da qualche postulato metafisico, me perché lo possiamo mostrare con un conferimento intuitivo e indubitabile) una
coscienza che conferisca il senso, la quale coscienza poi è assoluta e non a sua
volta dipendente da un conferimento di senso.
Se si ricava il concetto di realtà dalle realtà naturali, dalle unità di una esperienza
possibile, il “mondo” o la “natura” equivalgono alla totalità del reale; ma identificare la totalità del reale con la totalità dell’essere, e quindi assolutizzare il reale, è un
controsenso. Una realtà assoluta vale quanto un quadrato rotondo. Realtà e
mondo sono per noi titoli di determinate unità di “senso”, relative per loro essenza
a determinati nessi significativi della coscienza pura, i quali conferiscono appunto
questo senso e non un altro e ne mostrano la validità3.
55
56
razionali (Vernunfteinsichten) ottenute da spiriti creatori, secondo principi e
conseguenze”4.
Come è già noto sin dai primi anni venti del secolo scorso Husserl si sforza di aprire nuove vie di accesso alle analisi delle costituzioni trascendentali,
ritenendo incompleta ed inadeguata quella “via cartesiana” che sino ad allora
aveva percorso all’insegna del trionfalismo della ragione così come testimoniato da quella sorta di manifesto propagandistico rappresentato da La filosofia
come scienza rigorosa.
Una di queste vie d’accesso è quella costituita dal mondo predato, meglio
conosciuto come Lebenswelt la cui articolazione più esaustiva è realizzata
nella Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale
Phaenomenologie.
Sarebbe tuttavia troppo asfittica una analisi di questa via d’accesso se
non si accennasse al quadro entro cui avviene il passaggio da una concezione statica della fenomenologia ad una genetica, un passaggio reso possibile dalla messa da parte dello schema “apprensione-contenuto apprensionale”5.
Quale è il terreno di cui si alimentano le apprensioni? Quale è la dinamica
di interazione tra queste ed il retroterra storico, filosofico, culturale entro cui i
contenuti della coscienza si articolano?
Queste domande elementari aggiungono per così dire spessore a quella
nozione di intenzionalità sino adesso troppo relegata all’interno di una dimensione puramente ed astrattamente teoretica.
Questa trasformazione dell’orizzonte entro cui la coscienza opera avviene
in seguito al convincimento del Nostro che:
- la fenomenologia non debba essere soltanto una teoria della costituzione
di oggettualità isolate, ma invece una teoria nella quale e mediante la quale le
oggettualità sono poste in relazione ai loro rispettivi orizzonti contenuti tutti nel
mondo quale orizzonte universale;
- un tale allargamento rende possibile il passaggio dalla comprensione statica a quella genetica della fenomenologia.
Questa nuova prospettiva richiede il compito necessario di stabilire “leggi
generali” e “leggi primitive” secondo le quali procede la “formazione” delle
appercezioni a partire da appercezioni “originarie”; tutte le formazioni possibili
devono dunque essere chiarite in base alla loro origine.
Risulta altrettanto chiaro che questa sorta di “storia” della coscienza non
possa essere descritta esplicitando la “genesi effettiva” per le appercezioni di
fatto o i tipi di fatto in un flusso di coscienza fattuale, le Ricerche Logiche sono
oramai un dato acquisito; al contrario ogni forma di appercezioni è una forma
essenziale ed ha la sua genesi secondo leggi essenziali.
La comprensione fenomenologico-eidetica costituisce pur sempre un
baluardo contro le tentazioni di uno psicologismo naturalistico soggetto alle
obiezioni di relativismo e scetticismo; tuttavia questo tipo di comprensione
mostra delle falle nella sua applicazione ad alcune regioni ontologiche: si prenda per esempio il caso delle, idee di “uomo” e “mondo” e lasciamo a proposito parlare lo stesso filosofo:
Non conoscere la monade “uomo” o quella “mondo” in quella “pienezza”
resa possibile solo dall’analisi delle corrispettive “leggi di individuazione” significa in altre parole che queste idee risultano in questo modo inficiate da una
seria “scarsezza”, “rarefazione” di contenuti, e gli studiosi di filosofia sanno fin
troppo bene che quando le cose che ricercano, che indagano risultano troppo
povere di contenuti, risulta più facile “confrontarle”, “omologarle”, “standardizzarle” così come insegnato dal metodo scientifico.
Ciò che dunque conosceremmo di queste monadi sono i loro “abiti”, simili
uno all’altro, abiti facilmente indossabili dal pensiero naturale che ammette
solo taglie standard, prodotte senza previi accertamenti su quali siano le persone che le indosseranno, perché foggiate su modelli pre-fabbricati investiti del
ruolo di persone reificate.
Questa urgenza husserliana di riconsiderare nella “pienezza” le cose del
mondo si impone anch’essa in virtù di una complessa dialettica tra gradi differenti di riduzione: una riduzione prima, quella del mondo della vita, ed una
seconda, trascendentale in cui liberandosi da ogni attualità, da ogni “feticismo”
si realizza la riduzione alla pura soggettività: ma, come osservato acutamente
da E. Paci in Funzione delle scienze e significato dell’uomo7, la riduzione è
“complessa” e appare secondo aspetti differenti, in atti temporali diversi; essa
non è mai definitiva.
La riduzione trascendentale sembra contenere tutte le altre riportandoci ad
una soggettività non mitologica, ma vivente ed orientata verso la verità; questa
si sforza di ritrovare dietro le “maschere”vissute nella quotidianità l’autenticità
di una coscienza non reificata.
A sua volta questa coscienza trascendentale non è una coscienza chiusa,
ma ancora vita, vita che può incorrere nel pericolo di perdersi o di ritrovarsi
ancora una volta.
Scrive E. Paci:
Vita e coscienza trascendentale, io e mondo, non sono assoluti: sono momenti del
perdersi e del riprendersi della vita, del destarsi e dell’obliarsi della vita, della presenza e dell’assenza, della relativa possibilità di risvegliare e di ripresentificare
l’oblio, di ritrovare la presenza nell’assenza.
Questa possibilità di costruire e di conseguenza controllare a priori le
maglie entro cui sistematizzare il mondo e gli uomini non tiene neanche conto
SAGGI
Cerchiamo di studiare la tipica intenzionale che ci è data direttamente attraverso
una comprensione fenomenologico-eidetica delle idee “uomo” e “mondo”, sistematicamente, secondo tutte le connessioni possibili della ragione…e cerchiamo di
raggiungere la loro forma essenziale. Allo stesso modo cerchiamo, nel libero
campo delle possibilità, le strutture essenziali del sistema di leggi formali di una
ragione in generale come ragione logica formale e così via.
[…] con ciò costruiamo, in indistinta generalità, i soggetti di ragione pura e le forme
di attività razionali in cui essi vivono in direzione del vero essere e delle verità, e
allo stesso modo dei veri valori e beni, e li raggiungono. Con tutto ciò, però, non
arriviamo a conoscere come una monade appaia per così dire in pienezza, e quali
possibilità di tali piene individualità monadiche siano predelineate, e attraverso
quali leggi dell’individuazione 6.
57
58
del fatto che ogni attività è motivata, sicché “io, eseguendo l’atto, sono determinato dal fatto che ho già eseguito altri atti”8; alcuni di questi atti hanno poi la
loro genesi nella “sfera della pura passività” nella quale la insonnia strutturale
dell’io cartesiano sembrerebbe ritrovare pause di sana inattività in cui la
coscienza e le sue operazioni assumono l’aspetto dell’abituale.
La introduzione di una dialettica, quella per esempio tra attività e passività,
nella coscienza husserliana ha come sua concausa il superamento di un
modello di riferimento dell’analisi coscienziale costituito dalla sola percezione;
mediante questa i dati iletici offerti dalle sensazioni producono nella coscienza
delle impressioni che solo mediante una successiva operazione di riferimento
e di costituzione, mediante cioè le funzioni della noesi, assumono il carattere
di oggettualità.
Se i dati iletici e le funzioni poietiche sono immanenti alla coscienza, l’oggettuale è invece trascendente rispetto ad essa, ha cioè uno statuto ontologico differente: si pensi alla mera percezione di un rosso che diventa la percezione di un rosso come qualità di un oggetto: questa distinzione tra ciò che è
immanente e ciò che è trascendente rispetto alla coscienza appare però ad
Husserl un residuo di cartesianesimo.
Con la apertura della prospettiva genetica Husserl amplia il quadro entro cui è
svolta quella operazione di riferimento al mondo che precedentemente era riservata solo alle funzioni per così dire superiori della coscienza; un riferimento al mondo
è presente anche nei livelli elementari della attività coscienziale e del vissuto.
Ciò lo porta anche a svincolarsi da quel paradigma kantiano secondo cui da
un lato, nell’ambito della sensibilità, vi sarebbe soltanto mera passività, mentre dall’altro, nell’ambito delle operazioni categoriali superiori, sarebbero effettuate soltanto operazioni attive.
Anche insomma nelle impressioni sensibili più elementari è presente un
momento di attività, significando con ciò che già a questo livello si costituisce
una relazione con il mondo; viceversa anche le funzioni attive sono per così
dire pervase da momenti di passività.
Una analisi statica per esempio della appercezione del mondo e della relativa donazione di senso da parte della coscienza non può fare a meno di una
considerazione genetica in grado di individualizzare la appercezione stessa,
perché risalente ad elementi, quali per esempio quelli affettivi, che nella sfera
attiva sono trascurati.
Solo in questo modo si persegue una “considerazione assoluta” del mondo.
La “individuazione” rimanda alla passività della coscienza singola, ma
anche alla connessione di questa passività con le passività di altre coscienze;
ne deriva una sorta di sistematica passiva mediante cui si spiegano, o meglio
si motivano alcune acquisizioni tipiche quali per esempio quella di mondo fisico, lo stesso, per noi; o quella di tempo oggettivo, lo stesso, per noi.
All’interno di queste analisi viene avanti anche la funzione mediatrice del
corpo in grado di realizzare connessioni entropatiche.
Si delineano in base a quanto detto quelle ipotesi di una teoria della genesi attiva e di una della genesi passiva che saranno alla base della formulazione husserliana della nozione di mondo della vita.
SAGGI
Ecco riassunti in poche parole i momenti fondamentali della genesi passiva::
a) la teoria della costituzione temporale originaria nel presente vivente;
b) la teoria della associazione;
c) l’analisi dei processi cinestetici nella quale si conclude che la percezione
è legata ai movimenti del corpo.
Risulta così fondata quella attribuzione di non dogmaticità rivolta alla fenomenologia che sembra organizzarsi secondo “fili conduttori”9.
Da quanto finora detto se ne potrebbero già delineare tre fondamentali:
a) una ontologia e teleologia corrispondente basata sulla tipica degli oggetti;
b) lo studio della unità di monade come unità di genesi e tipica di monadi
possibili;
c) atteggiamento naturale: concetto di mondo naturale.
Se dunque nella analisi statica le appercezioni risultano già compiute, in
quella genetica se ne ricerca la “storia” come storia delle oggettivazioni possibili; si passa dunque dall’analisi della “struttura” della coscienza a quella delle
“costituzioni” immanenti della stessa.
Simili considerazioni possono valere come parziali risposte a quelle obiezioni (si pensi per esempio a A. Banfi) che hanno insistito sulla presenza nella
fenomenologia husserliana di un fondo dogmatico riconducibile a quel vulnus
rappresentato da una assenza di dialettica nelle acquisizioni della coscienza10.
Più attenzione si deve riservare, ai fini del tema qui trattato, alla teoria della
genesi attiva ove operano quelle che Husserl chiama Urstiftungen, funzioni
costituenti fondamentali la cui natura, quella di essere spontanee e produttive,
è intrisa di passività.
La peculiarità di una Urstiftung è quella, una volta costituita, di venire successivamente “abitualizzata” mediante un processo di sedimentazione nel
corso del quale, la novità rappresentata dall’apertura d’orizzonte di senso, da
parte della Urstiftung stessa, viene progressivamente dimenticata per essere
assorbita nell’orizzonte preesistente che, a sua volta, viene modificato da tale
assorbimento per diventare un nuovo orizzonte.
Per semplificare quanto sopra scritto si pensi per esempio alla costruzione
di un ospedale in una città prima sprovvista dello stesso: in questo caso l’orizzonte oggettuale predato (e presupposto come ovvio e familiare) subisce un
processo di allargamento ad opera di una coscienza che non è quella individuale, ma quella intersoggettivamente strutturata di una comunità linguisticoculturale, coscienza che sintetizza una nuova Urstiftung.
Nel caso qui proposto ci si potrebbe divertire ad immaginare quali conseguenze avrebbe la messa in funzione dell’ospedale sulla dinamica temporale
della coscienza comunitaria: il futuro per esempio avrebbe un minor indice di
negatività rapportato alla considerevole decurtazione dei tempi entro cui un
malato grave può essere trasferito dalla propria casa all’ospedale.
Queste osservazioni conducono quasi naturalmente a quelle riflessioni contenute nella Krisis nelle quali il concetto di Lebenswelt funge da chiave di volta
nella comprensione e nella chiarificazione della grave entropia di senso che
affligge la razionalità moderna del sapere scientifico.
Si capisce in che modo il processo sopra chiarito di costituzione di
59
Urstiftungen possa essere applicato analogicamente a quella Urstiftung operata dalla scienza moderna mediante la quale l’in-sé prodotto dalle idealizzazioni scientifiche, cioè le obiettivazioni del sapere scientifico, supera e trascende
l’orizzonte soggettivo della esperienza quotidiana: questa Urstiftung ha però un
carattere di totalità perché investe la intera sfera d’essere che, idealizzata,
come mondo delle forme oggettive, viene contrapposta come mondo vero al
mondo delle forme soggetto-relative, legate immancabilmente ad accidentalità
prospettiche.
Su questo tema scrive Husserl:
La grande novità è costituita dalla concezione di quest’idea di una totalità infinita
dell’essere e di una scienza razionale che lo domina razionalmente. Questo
mondo infinito, questo mondo di idealità è concepito in modo tale che i suoi oggetti non possono essere attinti singolarmente, imperfettamente e come casualmente dalla nostra conoscenza: esso può essere raggiunto soltanto da un metodo
razionale, sistematicamente unitario nel procedere infinito, infine, di ogni oggetto
verso il suo pieno essere-in-sé 11.
60
La novità dunque del sapere scientifico moderno è che, a differenza di quello antico, fondato su un “a-priori finito e chiuso”, si presenta con la qualità di un
“compito infinito”, con la possibilità cioè di realizzare una teoria sistematica unitaria infinita, che, nonostante la sua infinità, è in sé conclusa.
La totalità dell’essente diviene in virtù della “Mathematisierung” della natura portata a termine da Galilei una “molteplicità matematica” (mathematische
Mannigfaltigkeit).
La prassi del commercio con le cose del mondo è così pervasa dalle acquisizioni teoriche delle scienze matematico-geometriche che non distinguono tra
lo spazio e le figure spaziali di cui parla la geometria e lo spazio e le figure spaziali della realtà sperimentale, come se si trattasse della stessa cosa.
Ma le cose del mondo intuitivo hanno i caratteri della “mera tipicità”, sono
cioè provviste di un indice di “gradualità”, di una maggiore o minore perfezione rispetto alla loro forma ideale; se questa gradualità può soddisfare un interesse pratico, tuttavia è insoddisfacente per quello teoretico che mira ad un
sempre più esteso perfezionamento tecnico nella riproducibilità delle formelimite dello spazio geometrico ideale, consolidando in virtù di questo processo
l’idea che l’orizzonte di perfezionamento sia aperto e vada promosso:
siamo già in grado di comprendere come sulla base della prassi del perfezionamento, nella libera penetrazione negli orizzonti di un perfezionamento pensabile,
nel “sempre di nuovo” (immer wieder), si delineino continuamente, forme-limite,
verso cui tende, come a un polo invariabile e insieme irraggiungibile, qualsiasi
serie di perfezionamenti12.
Se riflettiamo approfonditamente su questi passi tratti dalla Krisis ci rendiamo conto di quali siano i pericoli in cui incorre una razionalità che lascia crescere ipertroficamente la dimensione tecnico-scientifica a danno delle altre:
quello che Husserl chiama “commercio” tra prassi e teoria ci porta a riconsiderare su basi nuove la dialettica tra mondo della vita edil mondo obiettivato della
Wenn wir zwar alltäglich nicht in der Wissenschaft leben, so leben wir doch auch
in einem strengem Sinne vor-und ausserhalb derselben. Oder paradox formuliert:
unsere „Vorwissenschaftlichkeit“ ist bereits durch die Wissenschaft bestimmt, wir
stehen bereits in ihrem objektiven Machtbereich, wenn wir jemals den Versuch
machen, in sie einzudringen. Unser Zugang zur Wissenschaft geschieht nie mehr
ganz von aussen14.
L’ultimo capoverso di questo passo del Fink che sottolinea la impossibilità
di essere completamente al di fuori del mondo obiettivato, dà ragione di quella lettura della dialettica tra i due mondi nel senso di un movimento dalla ragione latente alla ragione rivelata che per Husserl sembra essersi affacciato per
la prima volta in Grecia.
SAGGI
scienza: se con E. Fink possiamo sottolineare la possibilità “auch ohne
Wissenschaft Mensch sein zu können”13 non dobbiamo tuttavia illuderci, come
lo stesso E. Fink ci fa osservare, che sia possibile separare nettamente il
mondo della vita da quello obiettivato delle scienze: noi non possiamo completamente vivere anteriormente o al di fuori del secondo; il mondo oggettivato e
reificato della scienza agisce retroattivamente sul mondo della vita quasi trasfigurandolo.
Non si dovrebbero trascurare neanche le conseguenze apportate da tale
comunicazione di vasi tra i due mondi alla prassi psichica del Dasein contemporaneo, conseguenze che la letteratura, meglio di altre forme culturali, riesce
ad esprimere con estrema chiarezza: si pensi, per esempio, a quella “impazienza” da cui Palomar, il protagonista di un racconto di I. Calvino, è afflitto nel
tentativo di chiudere in una sorta di tipica sistematica le possibilità di accadimento che un evento reale, nel caso del romanzo le onde del mare che si
rifrangono sulla riva, può assumere.
È pur vero che l’attenzione di Palomar è riversata su una singola onda nella
sua specificità, ma l’interesse teoretico investe tale onda di un numero così
considerevole di osservazioni, di analisi, da renderla ingiustificabile nella sua
effettualità, non raffigurabile nella sua genesi, vista la complessità dei fattori
che contribuiscono a crearla; si apre anche in questo caso un orizzonte di possibilità che aumenta, dice ironicamente Calvino, la nevrastenia della quale il
Nostro paradossalmente voleva liberarsi recandosi sulla spiaggia ed osservando quella singola onda.
Quale è il motivo per esempio della scelta di matite con mine di 0,5 mm o
di diametro inferiore così presenti anche in contesti, per esempio un dipartimento di filosofia, le cui Urstiftungen di senso rendono immotivata, ingiustificabile, non concordante una tale scelta?
È solo un interesse pratico quello che spinge uno studente a comprarle? Od
anche uno estetico? Od anche uno teoretico che induce a prediligere queste
mine perché i loro tratti sono più netti, meno imperfetti, più vicini a quell’ideale
di perfettibilità cui sopra si è accennato?
È forse un caso psicanalitico o vi è sotto qualcosa di più?
Le seguenti parole del sopra citato E. Fink sono illuminanti per comprendere quella dialettica di cui sopra:
61
62
Se oggi non è possibile realizzare una vita interamente al di fuori del mondo
reificato ed oggettivato, ciò significa che in questa sorta di interregno l’uomo
deve sforzarsi di disgelare ciò che in lui è “nascosto”: l’uomo autentico, originario il cui senso e telos è stato dimenticato.
Alla ingenuità del razionalismo illuministico che ha creduto di poter fare a
meno nella ricerca filosofica della esistenza, non si può reagire con slanci irrazionalistici, bensì con un autentico razionalismo che fenomenologicamente
tenta di riportare l’uomo alla fondazione di sé, alla costituzione di sé, ponendo
tra parentesi il mondano inteso come il meramente fattuale, il “positivo” del
positivismo, il significato ridotto alla fattualità del discorso, il soggetto ridotto
all’oggetto: oggettività e fattualità sono maschere nelle quali l’uomo nasconde
se stesso e feticizza se stesso.
Il concetto positivistico della scienza è, dice Husserl espressamente, un
Restbegriff, un concetto residuo: esso ha svuotato la metafisica di tutti quei
problemi fondamentali per affrontare la complessità di una indagine sulla esistenza dell’uomo; questi problemi per Husserl sono legati inscindibilmente dal
fatto che sono i problemi della ragione, della ragione in tutte le sue forme particolari, di una ragione non ancora unilateralizzata (einseitig ).
L’antica idea della filosofia, quella nata in Grecia, trovava la sua unità nella
inscindibile unità dell’essere: vi era, dice Husserl, “implicato un ordine di senso
dell’essere e quindi dei problemi dell’essere”; questi problemi travalicano il
mondo in quanto universo di meri fatti, corrispondentemente hanno bisogno di
essere indagati da una ragione non dimidiata, una ragione che, facendo affidamento su se stessa, conferisca un senso al mondo essente, il mondo in quanto essente in virtù della ragione.Superando attraverso il suo radicalismo tutte
le passate ingenuità, questa ragione non pigra può dispiegarsi, motivata da
nuove crisi, verso una idea definitiva di filosofia.
Questa idea definitiva non può essere immobilizzata in un sistema senza
tempo, tanto più che la strada lungo la quale poterla realizzare deve essere
percorsa in prima persona15 con coraggio, visto la insorgenza di domande mai
poste, il mostrarsi di campi di lavoro inesplorati, di correlazioni mai avvertite in
precedenza.
Di fronte a queste urgenze e compiti la filosofia rivela possibilità pratiche,
essa si realizza attraverso l’azione.
E. HUSSERL, Ricerche Logiche, Il Saggiatore, Milano 1968, vol. I, p. 297.
E. HUSSERL, L’idea della fenomenologia, Il Saggiatore, Milano 1981, p. 59. Corsivi miei.
3
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi,
Torino 1965, Libro I, Sezione Seconda, §55, p. 123.
4
E. HUSSERL, La filosofia come scienza rigorosa, Paravia, Torino 1958, p. 3.
5
Cfr. M. SIGNORE (a cura di), “La crisi delle scienze europee” e la responsabilità storica
dell’Europa, F. Angeli, Milano 1985, pp. 264-291. Cfr. anche M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia
della percezione, Bompiani, Milano 2003, p. 219; Merleau Ponty, a proposito dello schema
“apprensione-contenuto apprensionale”, scrive: “Husserl ha definito per molto tempo la coscienza,
o l’imposizione di senso, con lo schema Auffassung-Inhalt (contenuto impressionale) e come
1
2
SAGGI
beseelende Auffassung (apprensione animatrice). Egli fa un passo decisivo riconoscendo, nelle
Vorlesungen, che questa operazione ne presuppone un’altra più profonda, in virtù della quale il
contenuto stesso è preparato a questa apprensione.Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, p.5, nota 1” (M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, cit.,
p.219).
6
E. HUSSERL, Metodo fenomenologico statico e genetico, Il Saggiatore, Milano 2003, p. 58.
Corsivo mio.
7
Cfr. E. PACI, Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 24
e ss.
8
E. HUSSERL, Metodo fenomenologico statico e genetico, cit., p. 59.
9
Cfr. Ivi, pp. 61-63.
10
A tal proposito indicative sono alcune osservazioni contenute in Th. ADORNO, Metacritica
della teoria della conoscenza, Mimesis, Milano 2004; cfr. in particolare il cap. III dal titolo “Sulla dialettica dei concetti gnoseologici”.
11
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore,
Milano 1961, p. 52.
12
E. HUSSERL, op. cit., p. 55.
13
E. FINK, Sein, Wahrheit, Welt.Vor-Fragen zum Problem des Phaenomen-Begriffs, Martinus
Nijhoff, Den Haag, 1958, p. 3.
14
Ivi, p.5.
15
Su questo punto si legga la fine della prima parte della Krisis dove, tra l’altro, Husserl afferma: “Io cercherò di ripercorrere le vie che io stesso ho percorso, non di addottrinare; cercherò semplicemente di rilevare, di descrivere ciò che vedo. Io non ho nessun’altra pretesa se non quella di
poter parlare, innanzitutto di fronte a me stesso e quindi di fronte agli altri, con conoscenza di
causa e in piena coscienza, come uno che ha vissuto in tutta la sua serietà il destino di un’esistenza filosofica” (E. HUSSERL, Crisi, cit., p. 47).
63
EDITH STEIN E MAX SCHELER.
UN CONFRONTO A PARTIRE DALLE ANALISI
DEL PROBLEMA DELL’EMPATIA
di Paolo Zordan
Introduzione
64
Un confronto tra il pensiero di Edith Stein e quello di Max Scheler presenta
senz’altro numerosi motivi d’interesse, dal punto di vista teoretico come da
quello storico filosofico. Abbiamo scelto di accostare tra loro le visioni di questi
autori sulla base della trattazione steiniana del Problema dell’empatia1, poiché
in questo lavoro l’autrice prende posizione sull’opera di Scheler in maniera più
esplicita che in altri testi. Mostreremo come, attraverso le analisi della Stein,
emergano alcuni punti chiave del confronto tra i due pensatori, che prende l’avvio dalla questione dell’esperienza dell’estraneo per investire molti temi cardine della fenomenologia, lasciando intravedere qualcosa della ricchezza e della
vivacità che possedeva il dibattito filosofico nella cerchia dei discepoli di
Husserl attorno alla prima metà degli anni ’10.
Da un punto di vista storico non è arbitrario accostare l’opera di Scheler e
quella di Edith Stein: essi ebbero contatti personali sin dal 1913, quando la giovane fenomenologa, allora ventunenne, iniziò a studiare filosofia all’università di
Gottinga, sotto la guida del professor Husserl. Si era nel pieno di quella “primavera fenomenologica” che coincise con il periodo di insegnamento del filosofo
nella cittadina tedesca: tra il 1905 e il 1914, studenti del calibro di Adolf Reinach,
Hedwig Conrad-Martius, Dietrich von Hildebrand, Roman Ingarden, insieme alla
stessa Edith Stein, appresero il metodo fenomenologico dalla viva voce del suo
scopritore e costituirono quel gruppo che è passato alla storia con il nome di
Circolo di Gottinga. La prima guerra mondiale ed il successivo trasferimento di
Husserl a Friburgo posero fine all’esperienza, straordinariamente feconda, di
questo cenacolo filosofico. Al suo interno, diversi membri avevano progressivamente preso le distanze dall’impostazione del maestro, soprattutto in seguito alla
svolta idealistica che molti ravvisarono dopo la pubblicazione delle Idee I 2.
La figura carismatica e le idee di Max Scheler, che negli anni ’10 entrava
nel periodo della sua maturità filosofica, ebbero un’influenza indiscutibile sui
giovani fenomenologi gottinghesi.
Quando Scheler conobbe Husserl, nel 1901, aveva completato la sua formazione accademica ed era già libero docente a Jena. Colpito da quell’incontro, lesse le Ricerche logiche, che erano state appena pubblicate, e apprese lì
i punti salienti del metodo husserliano. Non sarebbe corretto, tuttavia, inserire
Scheler nel novero dei discepoli del fenomenologo, poiché la sua posizione nei
confronti del metodo fu sin dall’inizio indipendente e la distanza delle sue tesi
da quelle husserliane andò aumentando progressivamente. Di fatto i due
SAGGI
assunsero presto un atteggiamento abbastanza critico l’uno nei confronti dell’altro, arrivando a contendersi la stessa scoperta del metodo fenomenologico.
A partire dal 1910 Scheler si recò diverse volte a Gottinga per tenere privatamente dei seminari, ai quali partecipava la maggior parte degli allievi di
Husserl. Edith Stein prese parte per la prima volta ad una di queste sessioni
alla fine del semestre estivo del 1913 (era arrivata a Gottinga solo pochi mesi
prima) ed in quella occasione incontrò Scheler. Egli discusse la prima parte del
Formalismo nell’etica3, che era stata appena pubblicata nello Jahrbuch für
Philosophie und phänomenologische Forschung, e accennò ad alcuni temi che
aveva affrontato in un’altra sua recente opera, dal titolo Zur Phänomenologie
und Theorie der Sympathiegefühle von Liebe und Hab4. Questi seminari
assunsero un’importanza particolare per Edith Stein, poiché proprio allora ella
cominciava ad occuparsi del tema dell’empatia5.
L’impressione che Scheler suscitò in quell’occasione nella giovane studentessa, tuttavia, come ella stessa ci racconta, non fu del tutto positiva: egli possedeva un’intuito geniale e diffondeva le sue sollecitazioni in modo seducente e
brillante; inoltre “parlava di questioni aderenti alla realtà, che sono importanti per
ognuno e che agitano in particolare l’animo dei giovani, non come Husserl che
trattava di cose astratte e fredde”6; ma c’era qualcosa di quegli incontri che infastidiva la Stein, ed era il modo in cui si parlava di Husserl. Scheler, infatti, scrive ella, “era aspramente contrario alla svolta idealistica e si esprimeva quasi
con atteggiamento di superiorità; alcuni dei giovani si permettevano allora un
tono ironico e ciò mi indignava come una mancanza di rispetto e di gratitudine.
I rapporti tra Husserl e Scheler non erano del tutto sereni. Scheler non perdeva
occasione di ribadire che non era allievo di Husserl, ma aveva trovato personalmente il metodo fenomenologico. Per quanto egli non fosse stato suo allievo,
Husserl era tuttavia convinto della sua dipendenza da lui […]. La facilità con cui
Scheler accoglieva stimoli esterni è nota a tutti coloro che lo hanno conosciuto
o che hanno letto attentamente i suoi libri. Accoglieva da altri delle idee che poi
trovavano sviluppo dentro di lui, senza che lui stesso si accorgesse di essere
stato influenzato. In tutta coscienza poteva affermare che era tutta farina del
suo sacco”7. Da queste poche battute e da altri brevi commenti Edith Stein
appare certamente colpita dalle qualità di Scheler e dalle sue intuizioni, ma persuasa maggiormente dal rigore e dall’onestà intellettuale di Husserl. Vedremo
come a tali impressioni corrisponderanno precise scelte di campo filosofiche: la
Stein accoglierà numerosi spunti dalle analisi scheleriane, sottoponendo però
quelle idee al vaglio rigoroso del metodo fenomenologico così come Husserl lo
aveva elaborato. Ne risulterà una trattazione dei vissuti intersoggettivi assai più
vicina a quella husserliana che a quella scheleriana. Nella prima parte del
nostro lavoro confronteremo le analisi svolte dalla Stein e da Scheler riguardo
la peculiare categoria dei vissuti intersoggettivi alla luce del loro differente
approccio al metodo fenomenologico.
Se torniamo a considerare la testimonianza autobiografica di Edith Stein, vi è
una sezione del Problema dell’empatia a proposito della quale ella dichiara di
essersi ispirata più all’opera di Scheler che a quella di Husserl, ed è la quarta sezione, dedicata all’analisi dell’empatia come comprensione delle persone spirituali:
65
In una prima parte [del Problema dell’Empatia – n.d.a.], ancora sulla scorta di alcuni accenni di Husserl nelle sue lezioni, avevo esaminato l’atto dell’empatia come
un particolare atto della conoscenza. Di lì, tuttavia, ero arrivata ad una cosa che
mi stava particolarmente a cuore e di cui mi sono occupata in tutti i miei scritti successivi: la costruzione della persona umana. Nell’ambito di quel primo lavoro, questo esame era necessario per far capire come la compressione di nessi intellettuali si distinguesse dalla semplice percezione di condizioni psichiche. Riguardo a tali
questioni le conferenze e gli scritti di Max Scheler, come pure le opere di Wilhelm
Dilthey erano state di grande importanza per me8.
Se la presenza di motivi diltheyani nel Problema dell’empatia appare limitata e piuttosto estrinseca, ben più massiccio è l’influsso di Scheler: le posizioni
dell’autrice, nonostante alcune divergenze, risultano significativamente vicine
a quelle del fenomenologo, per di più in relazione ad un argomento che interessava molto ad entrambi, quello della persona umana. Dedicheremo, dunque, la seconda parte delle nostre considerazioni ad un confronto tra la Stein
e Scheler riguardo al tema della persona.
1. Riduzione fenomenologica e vissuti intersoggettivi
66
Le analisi steiniane del Problema dell’empatia richiamano direttamente, per
il loro contenuto e per alcuni riferimenti espliciti, quelle sviluppate da Scheler
nel suo lavoro sulla Fenomenologia e teoria dei sentimenti di simpatia dell’amore e dell’odio. Abbiamo accennato, in precedenza, alle conferenze che
stimolarono Edith Stein alla lettura di quest’opera. Nel lavoro scheleriano è
possibile trovare, inoltre, tracce di un’influenza inversa: nella seconda edizione, pubblicata nel 1923 con il titolo di Essenza e forme della simpatia, Scheler
cita la tesi dottorale di Edith Stein a supporto delle sue considerazioni.
Nonostante tali richiami, nel momento in cui si tenta di stabilire una corrispondenza più precisa tra le analisi contenute nei due testi, si incontrano notevoli
difficoltà. Se ci fermiamo semplicemente a confrontare la classificazione dei
vissuti intersoggettivi elaborata dai due autori ed i corrispettivi apparati terminologici, troviamo numerose ed evidenti discordanze. Per citare un esempio
tra i più significativi, ciò che Edith Stein chiama empatia non corrisponde a ciò
che Scheler intende quando usa lo stesso termine9. Questa sfasatura, ad un
primo impatto, può sconcertare e disorientare. Dobbiamo dubitare della bontà
delle analisi essenziali dei due fenomenologi? O è possibile portare alla luce la
radice da cui hanno origine comune tali discordanze? Questa radice, a nostro
avviso, può essere individuata nel differente atteggiamento metodologico dei
due autori, in particolare nella diversa interpretazione che essi diedero della
riduzione fenomenologica. Mostreremo quindi, a partire dal Problema dell’empatia, come da tale diversità di atteggiamento nei confronti della riduzione scaturisca la critica steiniana a Scheler, nonché la successiva recezione scheleriana di queste analisi della Stein.
Cosa intendevano Edith Stein e Max Scheler per “riduzione fenomenologica”?
Se scorriamo le prime pagine della dissertazione dottorale sull’empatia,
dove la Stein opera un breve chiarimento preliminare riguardo al metodo della
SAGGI
ricerca, appare chiaro come ella intenda qui con “riduzione fenomenologica” in
primo luogo la “riduzione trascendentale”10. La descrizione che l’autrice ci fornisce di questa operazione corrisponde essenzialmente a quella elaborata da
Husserl nelle Idee I: per escludere dalla considerazione fenomenologica tutto
ciò di cui si può in qualche modo dubitare, scrive la Stein, “dovrò mettere fuori
circuito [ausschalten] la posizione di esistenza [Existenzsetzung] e non mi sarà
permesso di farne uso; ciò che invece non posso mettere fuori circuito, ciò che
è indubitabile, è la mia esperienza vissuta [mein Erleben] della cosa […] insieme col suo correlato, ossia il “fenomeno della cosa„ [Dingphänomen] nella sua
pienezza”11. La giovane studentessa di Gottinga sembra essere rimasta fedele, in queste considerazioni metodologiche preliminari, a ciò che aveva appreso dalla viva voce di Husserl: il campo dei fenomeni puri e dei vissuti viene
aperto dalla messa fuori circuito della posizione d’esistenza.
Differente era la posizione di Scheler riguardo alla riduzione fenomenologica12: nella prima fase del suo pensiero, all’interno del saggio Phänomenologie
und Erkenntnistheorie13 (1913), egli fornisce una formulazione apparentemente vicina a quella husserliana delle Idee I, per poi maturare una concezione
sempre più distante nelle opere successive (si confronti in particolare lo scritto sull’Essenza della filosofia14, del 1917). Secondo quanto egli scrive nel saggio del 1913, compiere la “riduzione fenomenologica”, presupposto necessario
di ogni autentica ricerca fenomenologica, significa astrarre da due cose: “anzitutto dal reale compimento dell’atto [realen Aktvollzug] e da tutti quei fenomeni concomitanti che non appartengono al senso e alla direzione intenzionale
dell’atto stesso, così come da tutte le particolari caratteristiche di colui che lo
compie (animale, uomo, Dio). Inoltre da ogni posizione (fede o incredulità) del
particolare coefficiente di realtà con cui il contenuto è “dato” nella visione naturale o scientifica (realtà, parvenza, immaginazione, illusione). Tali coefficienti di
realtà e la loro natura rimangono lì come oggetto di ricerca; non essi vengono
messi fuori circuito [ausgeschaltet], ma la loro posizione in giudizi espressi o
non formulati; e neppure tale posizione è messa fuori circuito come possibilità,
ma solo come posizione di un modo determinato. Solo ciò che noi troviamo ivi
come ancora immediatamente presente, cioè il contenuto di questa essenza
dato nell’esperienza vissuta di essa, è oggetto di ricerca fenomenologica”15.
Sebbene Scheler riprenda in molti punti la terminologia husserliana, egli sembra prospettare la riduzione fenomenologica soprattutto come un metodo per
accedere immediatamente alle essenze, purificando la conoscenza da ogni
contingenza: è necessario prescindere dal reale compimento del singolo atto
poiché si vuole guadagnare una conoscenza che non sia relativa alla struttura
del soggetto conoscente, ma valga in generale per uno spirito appartenente a
qualsiasi mondo possibile; è sospesa la posizione del coefficiente di realtà perché la conoscenza non rimanga legata all’hic et nunc del dato empirico, ma
valga in assoluto per ogni dato dello stesso tipo.
Dobbiamo considerare, inoltre, riguardo al tema della messa fuori circuito
del coefficiente di realtà, che apparentemente richiama la husserliana (e steiniana) Ausschaltung der Existenzsetzung e il momento trascendentale della
riduzione, come Scheler, nelle prosieguo delle sue analisi, metta in stretta
67
68
relazione il fenomeno della realtà, il problema della contingenza della conoscenza e il condizionamento biologico: diviene necessario, secondo il fenomenologo, prescindere dalla posizione di realtà per superare il condizionamento biologico della conoscenza. Il mondo della “realtà” o mondo dell’atteggiamento naturale (natürliche Weltanschauung), infatti, è l’ambiente in cui
viviamo e sbrighiamo i nostri affari secondo le esigenze del nostro stato corporeo. La riduzione, di conseguenza, attraverso cui si attua il passaggio dall’atteggiamento naturale a quello fenomenologico, assumerà per Scheler
sempre più i connotati di una rinuncia al mondo degli impulsi vitali; per Husserl
e per la Stein, al contrario, essa si configura originariamente sul terreno di una
teoria della conoscenza come risposta al problema del dubbio metodico.
Possiamo affermare, in definitiva, che Scheler intende la riduzione fenomenologica sostanzialmente come “riduzione eidetica”, come un metodo per conquistare una visione immediata delle essenze; egli non fa alcun riferimento
specifico al terreno della soggettività pura e non sembra considerare in
maniera adeguata il momento specificamente trascendentale della riduzione,
che dovrebbe permettere l’accesso ad essa.
Prendendo spunto da queste considerazioni, dobbiamo ora esaminare
quei passi del Problema dell’empatia in cui Edith Stein si misura esplicitamente con le analisi scheleriane: in particolare faremo riferimento al paragrafo
sesto della seconda parte, che ella dedica programmaticamente al “confronto
con la teoria di Scheler sull’afferramento della coscienza estranea”. Per lo più
i toni di questo confronto sono critici. La brevissima ricostruzione che abbiamo svolto sul diverso modo in cui i due autori interpretarono la riduzione fenomenologica ci aiuterà ad individuare il nucleo teoretico di tale critica ed a
cogliere i suoi risvolti.
Al centro del confronto sta il problema dell’afferramento della coscienza
estranea. Tale afferramento avviene, secondo la Stein, nel vissuto dell’empatia, che ella ha descritto già nelle sue caratteristiche essenziali: si tratta di un
vissuto sui generis, originario dal lato dell’atto, in quanto è il soggetto empatizzante che compie l’afferramento della coscienza estranea, ma non-originario dal lato del contenuto (non originariamente offerente), poiché il vissuto
empatizzato si dà come scaturente originariamente dall’io estraneo, non da
quello del soggetto che compie il vissuto empatico. In altre parole, l’empatia
non elimina affatto la distinzione tra i soggetti in relazione, anzi la conserva e
la presuppone.
Il vissuto empatico, secondo le analisi steiniane, presenta sempre un certo
grado di mediatezza: alcuni livelli di costituzione dell’io estraneo, infatti, come
il punto zero d’orientamento altrui e l’immagine del mondo che vi è legata,
appaiono solo come modificazioni dei corrispettivi livelli propri in un passaggio
analogante (non sembra valere lo stesso per altri strati costitutivi dell’io estraneo, come quello psichico dei sentimenti, che si danno attraverso l’espressione altrui nell’immediatezza del rapporto simbolico)16. Ora Scheler –scrive la
Stein– metterebbe in discussione proprio questa mediatezza dell’esperienza
dell’estraneo e la permanenza della distinzione tra i soggetti, teorizzando un
“flusso indifferenziato di esperienza vissuta” che precederebbe tale distinzione:
Tutti i nodi della teoria scheleriana vengono esaminati dalla Stein.
Innanzitutto al fenomenologo viene rimproverato di non aver sufficientemente chiarito il concetto di percezione interna. Egli sostiene, infatti, che anche
l’io estraneo sia percepito internamente, come accade per l’io proprio; ma
cosa bisognerebbe intendere, in tale caso, con percezione interna? La Stein
non esplicita qui direttamente la sua posizione (per lei, come per Husserl,
solamente i vissuti propri si danno nella modalità della percezione interna):
ella rileva semplicemente una confusione nel metodo adottato da Scheler per
distinguere i diversi tipi di percezione. Egli non chiarirebbe sufficientemente,
infatti, come si tratti di rintracciare una differenza eidetica della datità e non
di individare tipi differenti di oggetti (lo psichico e il fisico) a cui poi dovrebbe
corrispondere anche, secondo una legge eidetica, una diverso tipo di datità.
In questa circostanza Edith Stein sembra aver presente soprattutto il testo
scheleriano sugli Idoli dell’autoconoscenza18; se riferiamo questa critica, tuttavia, ad alcuni passaggi del lavoro sulla Fenomenologia e teoria dei sentimenti di simpatia dell’amore e dell’odio, in cui viene descritta più chiaramente l’essenza della percezione interna, possiamo constatare la sua cogenza e
la effettiva distanza tra le due posizioni: Scheler, infatti, afferma lì che “la percezione interna appartiene essenzialmente alla concezione dello psichico,
ma è qui del tutto indifferente il fatto che il percipiente percepisca se stesso
o un altro”19.
Il concetto contro cui è rivolta principalmente la critica di Edith Stein, però,
è quello del flusso indifferenziato di esperienza vissuta. L’essenza di questo
flusso viene esposta con chiarezza nello studio sulla Fenomenologia e la teoria dei sentimenti di simpatia dell’amore e dell’odio:
si dà anche il caso che un’esperienza sia semplicemente “data”, senza che la si
debba dare anche come propria o come esperienza di altri – come avviene sempre, ad esempio, quando noi in un primo momento siamo incerti se sia questo o
quell’altro il caso. Ma è questo momento della “datità” che costituisce il comune
punto di partenza per lo sviluppo della graduale, ma sempre più determinata assegnazione a noi stessi e agli altri del materiale esperienziale “dato” in questo modo.
[…] Si tratta piuttosto di un flusso di esperienze, indifferente per rispetto all’io-tu,
che “in un primo tempo” scorre e mantiene di fatto indivisi e commisti l’un nell’altro il proprio e l’estraneo. E in questo flusso si formano, solo gradualmente, vortici più precisamente configurati, che lentamente attraggono nei loro cerchi sempre
nuovi elementi del flusso, e in questo processo vengono associati successivamente e assai gradualmente diversi indivindui20.
SAGGI
Secondo Scheler l’io estraneo viene percepito interiormente [innerlich wahrgenommen] con la sua esperienza vissuta, così come è percepito l’io proprio (non
siamo tenuti ad entrare qui nella sua polemica con la teoria dell’empatia, dato che
essa non è diretta contro ciò che noi chiamiamo empatia). Originariamente sussiste un “flusso indifferenziato di esperienza vissuta” da cui solo un po’ per volta fuoriescono, cristalizzandosi, i vissuti “propri” e quelli “estranei”. A titolo di esempio si
adduce il fatto che noi siamo in grado di vivere un pensiero come proprio, come
estraneo oppure come nessuno dei due; […] e ancora che in un primo tempo viviamo i nostri propri vissuti molto meno di quanto non viviamo quelli derivanti dal
nostro ambiente17.
69
70
Si darebbero originariamente, secondo quanto scrive Scheler, dei vissuti
che non possiedono alcun riferimento all’io proprio né all’io estraneo, che solo
gradualmente sarebbero assegnati a noi stessi o agli altri. In un primo tempo
tali vissuti scorrerebbero in un flusso indifferente rispetto all’io-tu.
Quella del flusso indifferenziato è però, secondo Edith Stein, una rappresentazione assolutamente ineffettuabile: “infatti ogni vissuto, checché se ne dica, è
essenzialmente il vissuto di un io ed ogni vissuto da un punto di vista fenomenico è, in modo assoluto, inscindibile dall’io”21. Perché ai due autori non si dà in
visione intuitiva lo stesso fenomeno? Qual è la radice di questo contrasto? Edith
Stein, proseguendo nella sua analisi della teoria scheleriana, enuncia così il
nucleo della sua critica, mirando dritta al cuore del problema: “è solo per il fatto
che Scheler non conosce l’io puro [c. n.] –e quando dice “io„ intende sempre
“individuo„ psichico– che egli può parlare di un’esperienza vissuta antecedente
alla costituzione degli “ii„. Ovviamente non gli riesce di mostrare una tale esperienza vissuta priva di io. Tutti i casi che egli porta presuppongono tanto l’io proprio quanto l’io estraneo e non valgono affatto come riprova della sua teoria”22. È
impossibile, sostiene la Stein, che si dia un vissuto non appartenente ad un io;
se Scheler può parlare di un’esperienza vissuta antecedente alla costituzione dei
singoli “ii” è solo perché ignora il concetto di io puro. Quando egli parla di “io”
dunque, si riferisce sempre all’individuo psichico, cioè ad un soggetto psichico
sostanziale, fornito di determinate qualità; mai però egli afferra il livello dell’io
puro, cioè dell’io purificato dall’operazione della riduzione trascendentale, nient’altro che il “soggetto dell’esperienza vissuta che vive nell’esperienza vissuta”23.
L’io puro propriamente, scrive la Stein in sostanziale accordo con Husserl, è il
soggetto “privo di qualità e non altrimenti descrivibile [unbeschreibliches qualitätloses Subjekt ]”24; questo io innanzitutto “è “se stesso„ e non un altro [”es selbst”
ist und kein anderes]”25, e tale ipseità [Selbstheit] costituisce la base dell’individualità empirica e di ogni processo di individualizzazione. È evidente l’incompatibilità di questa concezione con la teoria scheleriana del flusso indifferenziato di
esperienza vissuta. Ciò che impedisce a Scheler di giungere alla nozione di io
puro, secondo il punto di vista della Stein, è la mancanza di rigore nell’applicare
la riduzione trascendentale. Se egli intende con “io” un soggetto sostanziale individuale fornito di determinate qualità, si muove ancora su un terreno non completamente ridotto: non ha ancora messo fuori circuito la posizione d’esistenza
di un soggetto empirico che ha un nome, una posizione sociale, delle qualità
reali, del quale si può dubitare che esista veramente poiché appartiene alla sfera
degli oggetti trascendenti. La critica steiniana, sebbene assai sintetica, coglie il
cuore della teoria scheleriana sull’afferramento della coscienza estranea e ci
aiuta a scoprire le differenze esistenti tra tale concezione e quella dell’autrice,
molto vicina alla posizione “trascendentalista” husserliana.
Abbiamo esaminato, partendo da alcune analisi del Problema dell’empatia,
i punti fondamentali della critica di Edith Stein a Scheler: una comprensione
inadeguata della riduzione fenomenologica impedirebbe a Scheler di attingere
al soggetto trascendentale o io puro. Le considerazioni che abbiamo svolte ci
offrono una chiave per interpretare le analisi scheleriane e steiniane sui vissuti intersoggettivi e comprenderne le numerose divergenze.
SAGGI
L’interprete che, sfogliando le pagine del Problema dell’empatia, si sentisse sollecitato a svolgere un’analisi comparativa dei vissuti intersoggettivi
descritti qui con quelli che Scheler analizza nella Fenomenologia e teoria dei
sentimenti di simpatia, si troverebbe con due mappe concettuali assai difficili
da sovrapporre. I due autori, infatti, utilizzano una terminologia molto simile,
ma descrivono atti differenti. Confronteremo qui brevemente le loro considerazioni riguardo tre generi fondamentali di vissuti, l’empatia (Einfühlung), il cosentire (mitfühlen) e l’unipatia (Einsfühlung).
Per Edith Stein il vissuto dell’empatia è senz’altro il più rilevante, dal punto
di vista fenomenologico, tra i vissuti intersoggettivi. È nell’empatia che giunge
a datità per noi l’io estraneo, ed è solo sul fondamento di tale datità che sono
possibili il co-sentire e unipatia. L’empatia, inoltre, ha un ruolo importante nella
costituzione dell’individuo psicofisico proprio, anche se tale contributo ha carattere di necessità solo per quanto riguarda il livello del corpo (Körper)26: più precisamente, nell’empatia reiterata (quando colgo l’altro che empatizza dei miei
vissuti) guadagno per la prima volta la piena costituzione di me stesso come
individuo psicofisico, cioè come individuo costitutivamente fondato sul corpo.
Scheler, al contrario, non riconosce al vissuto dell’Einfühlung tale ruolo di
preminenza, anzi critica, nel suo lavoro sui sentimenti della simpatia, tutte le
precedenti teorie dell’empatia. Anche Edith Stein avrebbe condiviso buona
parte di tali critiche, poiché esse sono rivolte contro le teorie cosiddette
dell’“empatia proiettiva” (in particolare quella di Lipps) e non contro ciò che ella
chiama empatia27. L’empatia steiniana corrisponderebbe invece al vissuto che
Scheler chiama post-sentire (Nachfühlen): la stessa autrice afferma, in una
nota della tesi dottorale, la possibilità di stabilire tale corrispondenza28.
Tenendo fermo questo accostamento, è possibile individuare una delle divergenze più significative tra le analisi di Scheler e quelle della Stein. Il post-sentire, afferma il fenomenologo, deve essere distinto dalla autentica simpatia poiché è un vissuto che resta nella sfera del comportamento conoscitivo del soggetto, e non ha alcuna rilevanza morale, a differenza del mitfühlen (simpatia o
co-sentire). Nel post-sentire vengo solamente a conoscenza dell’esperienza
vissuta di un altro: posso sapere così che l’altro sta vivendo un dolore, ma allo
stesso tempo non provare alcuna compassione per lui. Lo storico, il romanziere o l’artista drammatico, ad esempio, devono possedere in ampia misura il
dono del post-sentire per comprendere la vita emotiva dei personaggi che studiano o rappresentano, ma non hanno alcun bisogno di provare simpatia per
essi. L’autentica simpatia, al contrario, sostiene Scheler, non appartiene alla
categoria degli atti conoscitivi, ma ha una rilevanza morale propria: con-patire
è patire per il dolore dell’altro, in “reazione alla realtà del dolore altrui”29. È chiaro, scrive l’autore, che “ogni genere di con-gioia [Mitfreude] o di compassione
[Mitleid] presuppone una qualche forma di sapere circa i fatti dell’esperienza
altrui. […] Non è solo attraverso la compassione che diventa per me un dato di
fatto il dolore altrui, ma questo dolore deve essere dato già in una qualche
forma perché io, volgendomi ad esso, possa con-patire”30. Le funzioni del capire ciò che l’altro prova e del compatire, tuttavia, “si devono […] distinguere nettamente l’una dall’altra”31. Nell’economia delle analisi scheleriane, dunque, la
71
72
simpatia (o co-sentire) ha un ruolo centrale, poiché essa possiede, insieme al
sentimento, dell’amore una rilevanza morale. Non accade lo stesso nella trattazione della Stein, all’interno della quale l’interesse conoscitivo prevale su
quello morale: la preoccupazione principale dell’autrice sembra essere quella
di mostrare come il co-sentire possa aver luogo solamente sulla base di una
presentificazione empatica. Secondo l’autrice si ha il fenomeno del co-sentire
quando, ad esempio, “accanto alla gioia originaria per la notizia dell’avvenimento che mi fa gioire, continua a persistere l’empatia –cioè il coglimento della
gioia dell’altro– e se, oltre a ciò, l’avvenimento è conosciuto come piacevole
per lui”32. L’analisi steiniana del co-sentire è abbastanza simile a quella scheleriana, ma l’enfasi che i due autori mettono in essa è molto differente. La Stein
sembra considerare il co-sentire, in definitiva, come un caso particolare di
empatia.
Un discorso analogo vale anche riguardo al vissuto dell’unipatia. Nel
Problema dell’empatia l’Einsfühlung viene, per un lato, distinta dal fenomeno
inautentico, teorizzato da Lipps, della identificazione tra io proprio ed io estraneo che avverrebbe nel processo empatico. Tale descrizione è palesemente
falsa, commenta la Stein, poiché i due soggetti conservano sempre la loro
distinzione e non diventano mai un unico io, ma solo stanno l’uno “presso” (bei)
l’altro. Dall’altro lato l’autrice, nel descrivere il fenomeno autentico dell’unipatia, tende a ricondurlo all’originaria datità dell’estraneo che si ha nel fenomeno
dell’empatia:
Un’edizione straordinaria dà notizia che una fortezza è capitolata. La notizia suscita in coloro che l’hanno appresa un sentimento d’entusiasmo, di gioia, d’esultanza. Tutti provano “lo stesso” sentimento. Sono qui crollate le barriere che separano un io dall’altro? […] Nient’affatto! Io provo la mia gioia e colgo, empatizzando,
quella dell’altro e vedo che la gioia è sempre la stessa. Mentre vedo questo, sembra [scheint] sparire quel carattere di non-originarietà della gioia estranea, e che
poco a poco essa, del tutto analoga ad un fantasma, si copra con la mia gioia che
provo in maniera viva ed in carne ed ossa. […] Ciò che gli altri sentono lo ho ora
intuitivamente davanti a me, assume un corpo proprio e vive attraverso il mio sentire; inoltre dall’“io” e dal “tu” emerge ora il “noi” in guisa di un soggetto di grado
più elevato. […] Ma “io”, “tu”, e “lui” vengono conservati nel “noi”, e il soggetto dell’unipatia non è un “io” ma un “noi”. E noi esperiamo gli altri non attraverso l’unipatia, bensì attraverso l’empatia, e questa rende possibile tanto l’unipatia quanto
l’arricchimento della propria esperienza vissuta33.
L’attuazione dell’unipatia appare qui legata al verificarsi di circostanze del
tutto particolari: di fronte ad un medesimo avvenimento io e gli altri soggetti che
lo hanno appreso proviamo uno stesso sentimento. Ciò in virtù del fatto che
l’oggetto e la specie di tale sentimento sono le medesime. Ma non sono sparite affatto le barriere che separano i soggetti: sembra (scheint) che si attui un
coprimento perfetto tra la mia gioia e quella degli altri e che quest’ultima perda
il suo carattere di non-originarietà; ma in realtà posso avere questa gioia “intuitivamente davanti a me” solamente per il fatto che io la vivo in maniera originaria, ed essa assume un corpo proprio grazie al mio avere un corpo proprio.
Ciò che si verifica non è un’identificazione di soggetti singoli, prima separati,
SAGGI
ma la costituzione di un soggetto di grado più elevato come il “noi”. Appare
comunque chiaro che questa particolare formazione soggettiva non elimina,
anzi presuppone i singoli soggetti e la loro separazione, come anche il vissuto
dell’unipatia presuppone la gioia originaria e il coglimento empatico della gioia
dell’altro. Anche l’unipatia, come il co-sentire, appare quindi, in definitiva, fondata sull’empatia.
Altro intende Scheler quando parla dell’unipatia. Egli definisce questo vissuto come una identificazione del proprio io con l’io dell’altro (o viceversa, nel
caso dell’unipatia eteropatica), la quale è tanto involontaria quanto inconscia.
Casi di autentica unipatia si riscontrano, secondo l’autore, nel pensiero e nel
sentimento dei popoli che vivono nello stato di natura, nelle cerimonie degli
antichi misteri religiosi, nella vita psichica infantile, nelle componenti istintive
dell’amore materno e nell’amore sessuale. Questa identificazione non si
compie nella sfera fisica né propriamente in quella psichica, ma può avvenire soltanto in quell’ambito che Scheler chiama livello vitale, cioè “in quel settore mediano [Zwischenreich] della costituzione della nostra essenza umana
che io, distinguendolo nettamente dallo spirito personale e dal corpo materiale, ho chiamato la ‘coscienza vitale’ [“Vitalbewubtsein”] (come correlato
coscienziale sovra- e subcosciente dei processi vitali organici oggettivi)”34. Le
analisi di Edith Stein non contemplano un livello essenzialmente vitale nella
costituzione dell’individuo. Ella tende piuttosto ad interpretare i fenomeni
vitali (i sentimenti comuni, ad esempio) come fenomeni psichici; in particolare non ammette che vi sia un’esperienza vissuta della vita di carattere non
psichico35 (ad esempio, un’esperienza vissuta della vita nella sua ascesa e
nella sua discesa), come Scheler affermava nel suo Versuche einer
Philosophie des Lebens36.
Possiamo comprendere pienamente il peso di queste osservazioni se consideriamo l’importanza del ruolo che svolge la sfera vitale nelle analisi scheleriane
sulla fenomenologia del sentimento della simpatia, importanza che crebbe nella
seconda edizione del 192337. Così come i flussi di coscienza degli individui singoli hanno origine in un flusso iniziale di esperienza vissuta indifferente rispetto
all’io-tu, l’unipatia rende possibile, secondo le leggi di fondazione della simpatia,
tanto il post-sentire quanto la compassione o co-sentire. Tale fondazione riguarda l’ordine atemporale delle funzioni come l’ordine genetico (filo- ed ontogenetico): “è quindi una legge fondamentale di ogni evoluzione del sentimento, sia dal
bambino all’adulto, sia dall’animale all’uomo, sia dal primitivo al civilizzato, il fatto
che nello stadio di sottosviluppo troviamo ancora l’unipatia, mentre negli stadi più
evoluti troviamo il post-sentire”38. Vi è quindi, nelle analisi di Scheler, un momento di fusione unipatica che fonda il successivo differenziarsi dei soggetti. Per
Edith Stein, al contrario, come abbiamo visto, non può esservi coscienza né vissuto senza l’io puro e la sua originaria ipseità; è possibile parlare di un processo
di individualizzazione solo in relazione agli individui empirici.
La comparazione che abbiamo svolto ci sembra confermare l’ipotesi iniziale: all’origine delle divergenze riscontrate nell’analisi dei vissuti intersoggettivi
sta una maniera differente di tematizzare la soggettività, in conseguenza del
modo in cui la Stein e Scheler interpretano la riduzione fenomenologica.
73
2. Le analisi sulla persona
74
Nella sua autobiografia Edith Stein afferma di essersi ispirata alle analisi di
Scheler per la quarta parte del Problema dell’empatia, dedicata al problema
della comprensione delle persone spirituali; ella confessa anche, in una lettera ad Ingarden, che questa sezione è “la sola che abbia svolto con amore”39.
L’interesse per il tema della persona, indubbiamente, è una costante di tutta
la produzione steiniana; è anche evidente l’influenza scheleriana in questa
sezione delle analisi dell’autrice, come tenteremo di mostrare. Nelle opere successive Edith Stein rielaborerà queste influenze in maniera più funzionale alla
sua visione, ed esse diventeranno meno riconoscibili e più difficili da valutare;
infine, a partire dalla metà degli anni ’20, sarà principalmente il pensiero di
Tommaso d’Aquino ad ispirare il pensiero dell’autrice.
Secondo le analisi del Problema dell’empatia, la persona non può costituirsi negli atti teoretici, poiché essi si svolgono sulla superficie dell’io; al contrario
i vissuti del sentire, nei quali è intenzionato il valore, portano contemporaneamente a scoprimento livelli di profondità dell’io. Con ciò è detto anche che tale
io disvelantesi non è l’io puro, il quale è privo di qualsiasi profondità, ma l’io
personale. Viene instaurata così una precisa corrispondenza tra valori (Werte),
che appaiono ordinati secondo una precisa gerarchia, sentimenti assiologici
(Wertgefühle) che intenzionano tali valori e strati dell’io personale che vengono disvelati nei sentimenti assiologici, la quale rende possibile la costituzione
e la comprensione della persona:
Qui si dischiudono dei rapporti essenziali tra la gerarchia dei valori [Rangordnung
der Werte], l’ordinamento in profondità dei sentimenti assiologici [Tiefenordnung
der Wertgefühle] e le stratificazioni della persona [Schichtenordnung der Person]
che si rivelano in essi. Per cui ogni passo avanti nel regno dei valori è simultaneamente una conquista nel regno della propria personalità. Questa correlazione
rende possibile una legalità razionale dei sentimenti [Vernunftgesetzlichkeit der
Gefühle], il loro ancoraggio nell’io e una decisione in quest’ambito tra ciò che è
“giusto” o “sbagliato”40.
Riecheggia chiaramente in questi passaggi la teoria dei valori scheleriana
del Formalismo nell’etica. Del resto la Stein, in nota, rimanda esplicitamente il
lettore al Formalismo per ciò che riguarda il problema della gerarchia dei valori, concetto che ella inserisce senza alcuna riserva critica nel tessuto della sua
argomentazione41. Più distante appare invece la posizione dell’autrice da quella di Husserl, se confrontiamo questi passaggi del Problema dell’empatia con
le pagine della terza sezione delle Idee II, dedicata alla costituzione del mondo
spirituale. Se volessimo abbozzare, in poche righe, un confronto schematico
tra le due posizioni (ricordiamo che la Stein conosceva queste analisi husserliane dai seminari del 1913 su “Natura e spirito”) dovremmo dire che la Stein,
descrivendo la persona come un ricettacolo di valori, costituita sulla base
esclusiva dei vissuti del sentire assiologico, si spinge oltre la posizione di
Husserl, che pure riconosce agli atti valutativi un ruolo fondamentale nella
costituzione dell’io personale42. Non sembra che Husserl arrivi esplicitamente
SAGGI
a stabilire una relazione esclusiva tra la costituzione della persona e il sentire
assiologico; a rigore non è possibile riscontrare neppure nell’opera del fenomenologo il concetto di “profondità” della persona così come è concepito dalla
Stein e da Scheler.
Senz’altro, quindi, possiamo affermare che le analisi scheleriane sulla
persona hanno influenzato la trattazione steiniana in questa ultima parte del
Problema dell’empatia. È chiaro che, se vogliamo valutare il peso di queste
considerazioni sulla persona nel contesto generale della fenomenologia dei
due autori, dobbiamo tenere conto del sostrato assai differente sul quale
esse si sviluppano. Scheler elabora negli anni un’ampia ed originale teoria
fenomenologica della persona. Teoreticamente, il concetto di persona diviene la chiave della sua riflessione antropologica: è a partire da essa che si
può comprendere come sia possibile, al livello essenziale, l’unità di atti
eideticamente differenti. La persona individuale è l’agente unitario cui
appartiene il compimento di tali atti, è “l’unità dell’esperire vissuto immediatamente convissuta”43 che precede e fonda, come tale, la stessa concretezza degli atti; la medesimezza (Dasselbige) della persona, inoltre, secondo
Scheler, “è un idea che in nessun modo è fondata sull’io” 44, piuttosto un
carattere essenziale che le appartiene nella misura in cui essa si costituisce
nel processo di sviluppo dell’individuo verso la piena maturità ( Mündigkeit).
Questo processo di “personalizzazione” è anche ciò che conferisce consistenza individuale agli “Ii” e che fonda l’individualizzazione dei flussi di
coscienza, man mano che si impara a distinguere i vissuti propri da quelli
estranei, come avevamo osservato a proposito della teoria del “flusso indifferenziato di esperienza vissuta”.
Edith Stein non poteva condividere tali presupposti delle analisi di Scheler:
nei suoi primi scritti, più marcatamente fenomenologici, ella seguì con maggiore fedeltà l’impostazione di Husserl, guadagnando l’io puro come polo soggettivo della coscienza ridotta. L’ipseità (Selbstheit) dell’io puro è posta così a fondamento dell’individualità del soggetto empirico. La trattazione della persona
steiniana, pur così vicina per molti aspetti a quella di Scheler, risente necessariamente dei differenti presupposti della ricerca. Anche nel Problema dell’empatia accade, al livello personale o meglio spirituale, una sintesi dei vissuti dell’io; anche qui viene descritto un processo di “personalizzazione”: tale sintesi e
tale personalizzazione, tuttavia, appaiono fondate e costituite sulla originaria
ipseità del soggetto trascendentale.
Quando Edith Stein, in seguito allo studio di Tommaso d’Aquino e della scolastica, tornerà a parlare della persona nelle opere dei primi anni ‘30, ella tenterà di riadattare a tale scopo i concetti della filosofia aristotelico-tomistica, in
particolare quello di sostanza, e riprenderà la definizione di persona data da
Boezio (rationalis naturae individua substantia). Quest’evoluzione allontanerà
ulteriormente il pensiero dell’autrice da quello di Scheler, che aveva criticato in
più di un’occasione il sostanzialismo della filosofia scolastica, e aveva cercato
di sviluppare una antropologia partendo dall’atto personale e dalla persona
come centro di atti, in alternativa alle difficoltà della posizione tradizionale, in
cui egli vedeva il rischio di una reificazione dell’essere umano.
75
76
1
E. STEIN, Zum Problem der Einfühlung, Buckdruckerei des Waisenhauses, Halle 1917, rist.
da Kaffke, München 1980; ed. it. Il problema dell’empatia, Edizioni Studium, Roma 19982.
2
Per una ricostruzione storica di queste vicende cfr. H. SPIEGELBERG, The phenomenological
movement. A historical introduction.Third edition, revised and enlarged, M. Nijhoff, The Hague
1982; cfr. anche il testo autobiografico E. STEIN Aus dem Leben einer jüdischen Familie. Das
Leben Edith Steins: Kindheit und Jugend, Edith Steins Werke, Band VII (d’ora in poi ESW, VII); ed.
it. Storia di una famiglia ebrea. Lineamenti autobiografici: l’infanzia e gli anni giovanili, Città Nuova
Editrice, Roma 19993.
3
M. SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der
Grundlegung eines ethisches Personalismus, in Gesammelte Werke, Band II (d’ora in poi GW, II)
Franke, Bern 19665; ed. it. Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, Nuovo tentativo di
fondazione di un personalismo etico, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1996.
4
M. SCHELER, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle von Liebe und Hab,
Halle, Niemeyer 1913; seconda edizione, notevolmente riveduta e ampliata, Wesen und Formen
der Sympathie, Bonn, Cohen 1923 (ora in GW, VII, Franke, Bern 1973); ed. it. Essenza e forme
della simpatia, Città Nuova Editrice, Roma 1980.
5
Cfr. E. STEIN, Storia di una famiglia ebrea…, cit., pag. 237.
6
Ivi, pag. 236.
7
Ibidem.
8
E. STEIN, Storia di una famiglia ebrea…, cit., pag. 360.
9
Cfr. E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 104 [31].
10
Poniamo l’accento, in questa ricostruzione del pensiero della Stein, sul momento trascendentale della riduzione fenomenologica per esigenze teoretiche e per evidenziare lo specifico della
posizione dell’autrice rispetto a quella di Scheler, il quale, come vedremo, interpreterà la riduzione
sostanzialmente come metodo per attingere alla conoscenza delle essenze. Precisiamo sin d’ora,
però, che, nonostante le differenze, non si tratta qui di una contrapposizione radicale: nel
Problema dell’empatia anche Edith Stein accenna anche al momento eidetico della riduzione (cfr.
E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 68-69 [2]: «Ora, non si tratta di cogliere tali fenomeni
come singoli fenomeni […] bensì di penetrare nella loro essenza»). Vedremo pure come Scheler,
in una prima fase, non si dichiarasse esplicitamente molto distante dalle posizioni steiniane e husserliane (cfr. sotto).
11
E. STEIN, Il Problema dell’empatia, cit., pag. 68 [2].
12
Per questa ricostruzione ci siamo appoggiati a G. FERRETTI, Max Scheler, 2 voll., Vita e
Pensiero, Milano 1972.
13
M. SCHELER, Phänomenologie und Erkenntnistheorie, in GW, X, Schrifte aus dem Nachlab,
Band 1, Zur Ethik und Erkenntnislehre, a cura di Maria Scheler, Franke, Bern – München 19862.
14
M. SCHELER, Von Wesen der Philosophie, in Vom Ewigen in Menschen, GW, V, Franke, Bern
– München 19684; ed. it. L’eterno nell’uomo, Edizioni Logos, Roma 1991.
15
M. SCHELER, Phänomenologie und Erkenntnistheorie, cit., pag. 394.
16
A nostro giudizio, la complessa questione della compresenza di mediatezza e immediatezza nell’esperienza dell’estraneo in Zum Problem der Einfühlung è da comprendere sulla base della
distinzione dei livelli costitutivi della soggettività: nella misura in cui è lo psichico estraneo ad essere empatizzato, questo sembra potersi darsi in maniera diretta, come è evidente nella descrizione
del fenomeno dell’espressione altrui; nella misura in cui è il soggetto trascendentale estraneo ad
essere empatizzato, invece, questo propriamente non si dà alla coscienza ma viene costituito in
analogia al mio io. La critica steiniana a Scheler, come vedremo, può essere letta in questo senso:
Scheler può parlare di una immediata coglibilità dei vissuti estranei proprio perché ignora il concetto di io puro. Per valutare la posizione complessiva di Scheler, tuttavia, è necessario inserire
questa teoria del flusso indifferenziato nel più ampio quadro delle sue analisi sulla persona ed operare anche qui una distinzione di livelli: mentre al livello della coscienza vitale si dà l’esperienza
dell’unipatia e sussiste originariamente una fusione delle coscienze in un flusso indifferenziato
rispetto all’io-tu, così come è possibile un accesso immediato allo psichico estraneo, la sfera per-
SAGGI
sonale altrui è accessibile solo nella misura in cui l’altro decide di rivelarla e il nucleo personale
individuale è, per essenza, inconoscibile.
17
E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 104 [31].
18
M. SCHELER, Die Idole der Selbsterkenntnis, in Vom Umsturz der Werte, GW, III, Franke,
Bern – München 1972.
19
M. SCHELER, Essenza e forme della simpatia, cit., pag. 345 (dove non indichiamo diversamente, il passo citato è rimasto invariato rispetto alla Fenomenologia e teoria dei sentimenti di simpatia dell’amore e dell’odio).
20
M. SCHELER, Essenza e forme della simpatia, cit., pag. 346-347.
21
E. STEIN, Il problema dell’empatia, pag. 105 [31].
22
Ivi, pag. 105 [31-32].
23
Ivi, pag. 106 [32].
24
Ivi, pag. 120 [41].
25
Ibidem.
26
Per quanto riguarda il ruolo dell’empatia nella costituzione del livello psichico dell’individuo
proprio, essa è importante come correttivo per i possibili inganni della percezione, ma non è necessaria, poiché io ho accesso diretto alla sfera dei miei vissuti psichici nella percezione interna (cfr.
E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 192 [101]).
27
A conferma di quanto sosteniamo può essere portato un passo di Essenza e forme della simpatia in cui Scheler cita le analisi di Edith Stein a sostegno della sua critica contro le teorie dell’empatia proiettiva, segno che egli stesso comprendeva la differenza esistente tra le due posizioni (cfr.
M. SCHELER, Essenza e forme della simpatia, cit., pag. 54, nota 4 [aggiunta rispetto alla prima edizione]). Anche Edith Stein, d’altra parte, nel Problema dell’empatia, critica esplicitamente la teoria
di Lipps, ed appare cosciente del fatto che le obbiezioni di Scheler non riguardano in alcun modo
le sue formulazioni (cfr. E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 104 [30]).
28
Cfr. E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 84 [14], nota 8.
29
M. SCHELER, Essenza e forme della simpatia, cit., pag. 60.
30
Ivi, pag. 52.
31
Ivi, pag. 60.
32
E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 84 [14].
33
Ivi, pagg. 88-89 [17-18].
34
M. SCHELER, Essenza e forme della simpatia, cit., pag. 87 (aggiunto rispetto alla prima edizione).
35
Cfr E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 166 [78-79]: «Non esiste un’esperienza vissuta individuale non psichica […] così come non si può separare l’anima dalla vita».
26
Cfr. M. SCHELER, Versuch einer philosophie des Lebens, in GW X, Schrifte aus dem Nachlab,
Band 1, Zur Ethik und Erkenntnislehre, a cura di Maria Scheler, Franke, Bern – München 19862.
37
Nell’edizione del 1923 Scheler aggiunse al suo lavoro sulla simpatia, oltre ai primi due capitoli della parte C, l’analisi del vissuto unipatico contenuta nel punto 4 del capitolo II nella parte A e
la trattazione sulle leggi di fondazione della simpatia al capitolo VI della stessa parte.
38
Ivi, pag. 167.
39
Cfr. E. STEIN, Briefe an Roman Ingarden 1917-1938, ESW XIV, Herder, Freiburg 1991; ed. it.
Lettere a Roman Ingarden 1917-1938, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, pag. 57.
40
E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit., pag. 208 [113].
41
Cfr. Ivi, pag. 208 [113], nota 13.
42
Cfr E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie, zweites Buch, Husserliana IV, M. Nijhoff, The Hague 1952 (ed. it. Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, libro II, Einaudi, Torino 1965), par. 50.
43
M. SCHELER, Il formalismo nell’etica, cit., pag. 458.
44
Ivi, pag. 108, nota 36.
45
G. Ferretti mostra come l’“attualismo” scheleriano si evolva progressivamente e come si
vada attenuando l’opposizione del pensatore al concetto di sostanza, sebbene egli non giunga a
radicare ontologicamente tali sue posizioni (cfr. G. FERRETTI, Max Scheler. vol. 1. Fenomenologia
e antropologia personalisitica, cit., pag. 170 e ss.). Ci sembra che la Stein e Scheler compiano qui,
per molti aspetti, un percorso inverso: Scheler giunge ad attribuire una certa sostanzialità al nucleo
personale individuale sulla scorta di alcune difficoltà che potevano presentarsi sul terreno dell’im-
77
postazione “attualistica” (in particolare riguardo l’individuazione della persona); la Stein, invece, a
partire dalla definizione boeziana della persona come “rationalis naturae individua substantia”, si
interroga, in Essere finito ed essere eterno, sugli attributi di tale sostanza e sull’apertura estática
propria delle persone spirituali.
78
IL FILM D’ARTISTA:
UN GENERE METEORICO?
All’interno di una riflessione attorno alla nozione di genere nel cinema francese, proporrei di affrontare la questione del film d’artista che, in apparenza,
sembra avere un significato relativamente marginale nella storia stessa del
cinema. Tale modalità di espressione filmica oggi sembra essere relegata, in
effetti, al dominio dell’archivio, se non della reliquia, come se il movimento del
mondo (e non solamente del cinema) diretto al perfezionamento incessante
delle tecniche, avesse in qualche modo reso improbabile il rapporto dello spettatore, ma certamente anche del critico, con un insieme di opere che appartengono per la maggior parte al passato dimenticato, o quasi, del cinema.
Parlerei, dunque, qui di un punto di vista quasi- archeologico, tentando di sottolineare ciò che, in questo insieme, rileva un’autentica riflessione sulla modernità e più precisamente sul potere dell’artista (nel senso del pittore o dell’artista di forme plastiche) come uomo di spettacolo e produttore di movimento
all’interno del mondo dell’immagine.
Un primo passo s’impone naturalmente: consiste nel distinguere e simultaneamente classificare differenti forme d’espressione cinematografica; tutte
forme che, poco o tanto, intrattengono una stretta complicità con l’arte moderna ed il suo sviluppo. Intendo, così, per “film d’artista”, essenzialmente, un film
concepito e realizzato da un pittore o da un artista di forme plastiche nel quale
vengono incorporate in modo originale una serie di ricerche estetiche che permettono di mettere in evidenza la “plasticità” dell’immagine cinematografica.
Secondo questa definizione assai stretta il film d’artista, in Francia, sarà apparso soprattutto durante il periodo fra le due guerre, all’epoca dell’eccezionale
effervescenza dell’avanguardia artistica associata al dadaismo, al surrealismo
ed al cubismo. Si pensa immediatamente, a tal riguardo, ai lavori di Man Ray,
Léger e Duchamp1.
Facendo un confronto vorrei in primo luogo distinguere il film d’artista dal
film sull’arte, poi dalla biografia romanzata dell’artista ed infine dal film sperimentale. Qui intendo per film sull’arte il documentario d’ispirazione principalmente didattica s’un artista o s’un particolare movimento, documentario di
struttura realista che nel suo spirito quasi-giornalistico prende spesso in prestito alla televisione i suoi metodi. La biografia romanzata d’artista (non riesco a
trovare un termine migliore per descrivere questo genere, o sottogenere) è
solitamente di natura fittizia e commerciale. Riporta degli avvenimenti biografici legati alla vita di un artista celebre, in particolare alcuni episodi della sua vita
privata. Essa possiede indubbiamente una dimensione narrativa, anche se si
sforza ugualmente di valorizzare alcuni degli aspetti più importanti del proget-
SAGGI
di Pierre Taminiaux
79
80
to artistico del pittore, nella prospettiva di un’esplicita “divulgazione” (pensiamo
al recente Pollock, per esempio, interpretato e realizzato da Ed Harris, d’ispirazione evidentemente holliwoodiana). Infine il film detto sperimentale sfugge
consapevolmente ai tradizionali circuiti della grande diffusione del cinema nella
nostra società di massa e riprende alcuni dei presupposti fortemente formalisti
del film d’artista, preoccupandosi della prospettiva “plastica”. Ma, d’altro canto,
si separa da quest’ultimo nella misura in cui il suo autore non è necessariamente egli stesso un pittore (o un artista, nel senso classico e quasi accademico del termine), anche se s’inscrive in una storia pluri o multidisciplinare dell’avanguardia occidentale di quasi un secolo.
Prima di tutto è necessario far notare che il film d’artista, così come l’ho
appena definito e messo in evidenza nel suo rapporto con diverse produzioni
filmiche affini, si situa evidentemente in un periodo specifico dell’arte francese,
periodo che corre dalla prima alla seconda guerra mondiale. Dopo questo
periodo, in effetti, cioè dopo la fine degli anni quaranta e gli anni cinquanta fino
ai nostri giorni, l’artista moderno (e post-moderno) in Francia avrà poco considerato, se non completamente ignorato, il potere del cinema come modo per
creare immagini originali e radicali.
Se si considera, a tal riguardo, l’astrazione lirica dominante nel mondo dell’arte francese dell’immediato dopoguerra, da Nicolas De Staël a Fautrier, o il
minimalismo di un Yves Klein, che gli succederà agli inizi degli anni sessanta,
si può notare una certa presa di distanza dell’artista nei confronti del cinema.
Si può continuare, nella stessa prospettiva, con la nascita dell’arte concettuale negli anni sessanta e settanta attorno al Fluxus, (e in particolare all’opera di
Robert Filliou) e si vedrà che il desiderio profondo ed incontestabile di ampliare la nozione di espressione artistica al di là della cornice divenuta troppo
ristretta della pittura, non imboccherà necessariamente il cammino del film ma
s’ispirerà piuttosto al nuovo modello dell’installazione e dell’avvenimento collettivo spontaneo. Infine l’arte detta “contemporanea” in Francia, quella, diciamo, di questi ultimi venti o trent’anni (a partire, più o meno, dalla metà degli
anni settanta) avrà ugualmente trascurato il cinema per meglio esplorare la
fotografia, in particolare nel suo significato sia esistenziale che puramente
estetico2. (Qui pensiamo, in particolare, all’opera di Christian Boltanski). In altri
casi il video si sarà sostituito all’immagine filmica propriamente detta come
supporto fondamentale della sperimentazione e della speculazione formale3.
Tutto ciò per affermare che il film d’artista, in apparenza legato alla storia
del cinema francese ma anche a quella dell’arte francese, avrebbe rappresentato un fenomeno effimero. La questione che proporrei, dunque, sarebbe la
seguente: dovremmo noi, per identificare un certo tipo di espressione cinematografica con la nozione di genere, associare necessariamente a questo una
ripetizione nel tempo, o potremmo, al contrario, accettare l’idea stessa di un
genere dalla vita corta e meteorica? Tale questione supera, a mio avviso, di
gran lunga quella della semplice moda di un genere particolare. A tal riguardo,
in effetti, è difficile parlare del film d’artista come di una sorta di giocattolo o
d’oggetto in voga che riflette i gusti popolari della cultura francese degli anni
venti e trenta. La sua natura particolarmente marginale ed oscura (ermetica,
SAGGI
bisognerebbe aggiungere) offre poca credibilità a questa ipotesi.
L’avanguardia (in pittura, letteratura e cinema) di quest’epoca si sarà al contrario costituita in profonda opposizione all’influenza della folla e della massa sul
destino dell’arte nella società moderna.
In questa prospettiva, quella della non-ripetizione del genere in opposizione alla sua possibile perennità, si può considerare l’esempio del burlesco,
genere consacrato dalle storie del cinema. I numerosi film di Laurel e Hardy,
Harold Lloyd, Harry Langdon, Buster Keaton ed anche dei fratelli Marx presero il loro slancio in una certa cultura americana degli anni venti e trenta, e l’approssimarsi della seconda guerra mondiale avrà, in qualche modo, segnato la
fine della “grande epoca” del burlesco. Un genere, dunque, può essere caratterizzato al tempo stesso dalla sua potenza creatrice o dal suo valore artistico
e simultaneamente subire la prova del tempo e declinare durante il suo corso.
In altri termini, ciò che non dura nella realtà concreta può durare molto bene,
nonostante tutto, nel suo spazio mentale e immaginario. Mia intenzione è di
concentrarmi, dunque, essenzialmente sugli scritti di Ferdinand Léger, l’autore
del celebre Balet Mécanique4, perché grazie a questi si può definire, secondo
me, il film d’arte modernista in quanto genere e non soltanto in quanto fenomeno eccentrico confinato al dominio, tutto sommato marginale, della sperimentazione pura e dura.
La sua personalissima riflessione si esprime prima di tutto nell’opera
Fonctions de la peinture5, un insieme di saggi che, malgrado il titolo generico, trattano tanto del cinema, della tecnica, della danza, dell’architettura o
del circo, che della pittura propriamente detta. Qui il postulato di partenza
della pittura è il seguente: la modernità consacra l’intera potenza dello spettacolo divenuto legge e principio assoluto della rappresentazione e della vita
sociale. La quarta parte del libro intitolata Spectacle et cinéma6 afferma più
precisamente la supremazia dell’enorme messa in scena dell’esistenza nell’epoca dell’industria e del commercio. Di fronte a questa evidenza l’artista è
condannato, secondo la sua espressione, ad “inventare costi quel che costi”.
La semplice riproduzione oggettiva del mondo in qualche maniera non è più
sufficiente a garantire il senso dell’arte in un mondo sempre più rapido e
dominato da imperativi materiali crudeli ed alienanti. La durezza e la necessità della vita moderna impongono il bisogno frenetico di distrazione, la cieca
ricerca di entertainment che testimoniano inevitabilmente uno stato di guerra economica permanente tra gli uomini, guerra che non lascia all’uomo alcuna tregua e che, nelle parole di Léger, è “pietosa” (e spietata, andrebbe
aggiunto), quanto la vera guerra. Come egli scrive: “Fintantoché l’evoluzione
economica non avrà dato all’uomo il nuovo sperato equilibrio e questi sarà
vittima della macchina invece che esserne beneficiario, si assisterà ancora a
questo giornaliero fenomeno che vede la gente affrettarsi ed ammassarsi per
andare a lavorare e per mangiare e che la sera si abbandona allo spettacolo in cerca di una distrazione alla stanchezza quotidiana. Ci vanno come le
mosche alla luce, affascinati, una specie di ubriacatura tra quella dei bistrots
e quella degli stupefacenti, spinti come da un oscuro sentimento, poco comprensibile, ma di certo legato ad un bisogno di Bellezza, sul quale presto
81
82
ritornerò”7. Malgrado l’origine negativa di tale desiderio collettivo irreprimibile, l’artista riconosce così l’importanza dei più profondi bisogni dell’uomo,
bisogni non semplicemente consumistici ma anche estetici. L’essere “stupefatto” ed “ubriaco” cerca malgrado tutto, verso e contro tutto, un’espressione
collettiva di nuove forme che potrebbero farlo rinascere invece di riflettere la
sua estraneità a se stesso. Il secondo postulato proposto da Léger è quello
della mobilità fondatrice del mondo moderno. Il mondo, per se stesso ed
ancor prima di fare dello spettacolo, è cinematografico ovvero, nel senso
primo del termine, sta sempre a descrivere un movimento. La capacità d’invenzione dell’artista consisterà, allora, a partire da queste due affermazioni
essenziali, nel creare una scena originale nella (o sulla) quale l’innegabile
plasticità dell’universo verrà particolarmente messa in luce. “Faremo agire gli
oggetti”, egli scrive a tal riguardo volendo sottolineare la natura dinamica del
mondo materiale, natura che fino ad allora era stata, secondo lui, riservata al
soggetto della pittura, della letteratura e del teatro8. Se la nozione di spettacolo meritava di essere presa in considerazione, a dispetto delle sue connotazioni spesso dubbie, era, dunque, un bene perché poteva sfociare in una
serie di immagini uniche situate al di là dell’onnipresenza drammatica del
soggetto imposto da un modello filmico narrativo. (“La figura umana può giocare il suo ruolo, ma la sua espressione è assolutamente nulla sulla scenaspettacolo; fortemente truccata o mascherata, trasformata, il gesto messo a
punto, essa ha il suo spazio nel valore di varietà”, scrive Léger a proposito
del suo progetto di scena interamente plastica9). L’artista criticò, così, con
veemenza, l’ispirazione troppo spesso letteraria del cinema: perché l’arte
divenisse pratica filmica era necessario, prima di tutto, che il film divenisse
una forma inusitata di anti-letteratura. Secondo questa stessa logica egli insisté sul ruolo dominante accordato allo scenario nella concezione dell’opera
cinematografica10.
È chiaro che questo genere esigeva un radicale rigetto delle norme tradizionali della produzione della società capitalista, norme che non concernevano solamente l’industria del cinema. Nel suo saggio Léger criticò severamente l’abituale sottomissione del film agli interessi del mercato e, di conseguenza, il culto del divismo associato generalmente a questi interessi. Egli era persuaso, a torto o a ragione, del fatto che la pittura, malgrado la sua apparente
inesperienza nel dominio strettamente tecnico del cinema, potesse indicare la
via da seguire nell’elaborazione dell’immagine e nella rivelazione del suo potere emozionale direttamente plastico. Per sostenere la sua dimostrazione egli
citò anche gli esempi di Abel Gance ne La Roue, di Jean Epstein in Coeur fidèle, (qui, com’è noto, fu lo stesso Jean Epstein a commentare il lavoro di Lèger),
di Marcel L’Herbier in Galerie de Monstres e in L’Inhumaine ed infine di
Moujoskine in Keim. L’emozione ricercata avrebbe dovuto essere basata,
secondo lui, sulla proiezione simultanea di “frammenti d’immagini” in un ritmo
accelerato11. Ancora oggi si può discutere sulla legittimità estetica di una tale
posizione ed ipotizzare, per esempio, che essa non giunse a realizzare ne
tanto meno ad esaurire tutte le sue promesse formali, ma il punto è che mise
in questione una certa caratterizzazione dei generi che, dagli anni venti riposa-
SAGGI
va nel cinema sulla distinzione fondamentale tra forme differenti di fiction (il
melodramma, il western, la commedia, ecc…).
In più, essa superava la contraddizione essenziale tra documentario e fiction che già a quell’epoca poteva apparire decisiva. Dopotutto il cinema era
nato in quanto documento se si pensa a tutti i primi tentativi dei fratelli
Lumière, e la sua evoluzione verso la fiction, prima nel muto e poi nel sonoro, fu spesso interpretata come il segno della sua maturazione tecnica ed
allo stesso tempo artistica: il superamento d’una certa identità documentaria
fu presentato, dunque, come la prova d’un movimento quasi irreversibile
verso il progresso. Per contrasto il film d’artista non era, in senso stretto, né
una fiction né un documento, e nemmeno l’incrocio dei due. È senza dubbio
questa capacità di modificare i capisaldi più fissi della nozione di genere nel
cinema che costituisce, a nostro avviso, all’inizio del ventunesimo secolo, la
sua più forte ed incontestabile ragion d’essere storica. È evidente che il cubismo, in quanto movimento principalmente legato alla pittura, non ha avuto
bisogno del Ballet mécanique per trovare uno spazio privilegiato nella storia
dell’arte moderna e che l’opera di Lèger, in particolare, avrebbe potuto passare alla posterità anche se non avesse affrontato in modo originale il mezzo
cinematografico.
Questo progetto implicava l’identificazione dello schermo in uno spazio scenico, da una parte, e dall’altra quella dell’oggetto in uno spettacolo. Si potrebbe persino evocare, a tal riguardo, il paradosso dello spettacolo anti-spettacolare. Il carattere antispettacolare ed “anti-spettacoloso”12 di tale impresa derivava senza alcun dubbio dalla povertà di mezzi tecnici messi in gioco, dall’assenza di ogni presunzione drammatica o ancor meno epica, ed ugualmente dalla
dimensione tutta intellettuale ed astratta della forma. Si può affermare, in questo senso, che il film d’artista fu, cronologicamente, nella storia del cinema
francese, e può darsi mondiale, uno dei primi generi a contestare la definizione del cinema come spettacolo popolare, definizione che era apparsa fin dalla
sua nascita alla fine del diciannovesimo secolo e che all’inizio degli anni venti
rimaneva ancora fondamentale. L’eredità dei fratelli Lumière ma anche quella
di Georges Méliès, di Max Linder e di Louis Feuillade avevano chiaramente
stabilito questa identità in un epoca in cui molti osservatori colti esprimevano
ancora un certo scetticismo nei confronti della qualità propriamente artistica
del cinema. Prima di essere accettato ed accolto pienamente come arte il cinema fu, dunque, integrato nell’ordine culturale regnante in quanto “divertissement” di massa, in assenza di una vera e propria cultura della critica, che fu
successiva.
Ma questa distinzione fondamentale tra cinema e spettacolo essenzialmente è il risultato, nel contesto preciso della cultura francese e della sua
storia, di un desiderio di distinzione dall’eredità particolarmente pesante del
teatro. Fino alla nascita del cinema, in effetti (e questa situazione si prolungherà anche per molti anni dopo), la nozione di spettacolo popolare in
Francia fu associata soprattutto all’attività teatrale, particolarmente intensa
attraverso i secoli a partire dalle farse e dalle rappresentazioni sacre del
Medioevo, passando per le commedie di Molière del XVII secolo e per le
83
84
opere storico-romantiche di Victor Hugo e di Alexandre Dumas del XIX
secolo. L’idea di uno spettacolo anti-spettacolare esprimeva, dunque, la
possibilità di uno spettacolo dopo il teatro. (È interessante sottolineare, a tal
riguardo, che gli argomenti di Lèger sullo spettacolo popolare nella Francia
moderna esaltano soprattutto la plasticità del circo e della danza evitando
per la maggior parte del tempo il soggetto del teatro propriamente detto).
L’accento messo da Lèger sull’estrema mobilità delle forme nel film d’artista
traduceva manifestamente il rifiuto della dimensione spesso statica del teatro, dimensione che, a suo dire, era incompatibile con l’evoluzione stessa
d’un mondo sottomesso al potere della tecnica e del movimento meccanico13. Inoltre il teatro non poteva esaurire soltanto in sé stesso la questione
del Bello in arte nella misura in cui tale questione esigeva profondamente il
rapporto privilegiato dello sguardo umano agli oggetti più quotidiani piuttosto che alla voce o al corpo del soggetto. Dal momento che il pittore moderno, secondo lui, aveva “distrutto il soggetto” non poteva accontentarsi di una
disciplina alla quale si era quasi interamente dedicato. Il genere che si sforzava di creare scaturiva, per altro, dal bisogno di organizzare e di assoggettare, in qualche modo, lo spettacolo esterno del mondo allo scopo di produrre un’“architettura policroma” che inglobasse, secondo i suoi stessi termini,
tutte le manifestazioni di pubblicità corrente. Lo spettacolo allo stato puro,
nel suo carattere spontaneo, era ancora troppo caotico ed instabile.
Bisognava, dunque, controllarlo attraverso l’immagine cinematografica e
pervenire, in questo modo, all’avvento “di una società senza frenesia,
calma, ordinata, che sapesse vivere naturalmente nel Bello senza esagerazione né romanticismo”14.
Tale genere potrebbe essere ugualmente definito come un “genere povero”: l’opposizione allo spettacolare, in effetti, esprimeva innanzitutto il rigetto
dell’opulenza e del lusso dei mezzi messi in opera nella creazione, rigetto che
fu anche, nella stessa epoca, alla base dei “ready-made” di Marcel Duchamp.
“Il denaro è contro l’arte, gli eccessi dei mezzi tecnici sono contro l’arte. Il genio
creatore ha bisogno di vivere nella costrizione; la conosce; e generalmente le
migliori opere sono d’origine povera. Tutte le forme di decadenza artistica
hanno l’arricchimento all’origine. Saper far fruttare le costrizioni in mezzo
all’abbondanza, non è da tutti”15. Non si trattava, tuttavia, di opporsi al potere
della tecnica nell’arte, gesto del tutto vano e senza dubbio destinato a fallire in
partenza, ma piuttosto di dimostrare che la tecnica perdeva il suo significato
artistico quando superava i limiti concreti dell’esistenza umana. La tecnica
doveva, dunque, situarsi al livello dell’uomo, né al di sotto né al di sopra, alla
sua altezza propria che era anche quella dell’arte e della vita. La questione
della tecnica diveniva, così, propriamente esistenziale e non soltanto materiale. Riferendosi alla produzione di Ballet mécanique Léger scrive così: “La
donna sull’altalena è la cartolina in movimento. Anche per il materiale ho avuto
delle complicazioni. Molto difficile noleggiare dei cappelli di paglia, delle gambe
artificiali, delle scarpe. I commercianti mi prendevano per pazzo o mattacchione. Avevo messo insieme tutto il mio materiale in un baule. Un mattino m’accorgo che m’avevano ‘sgraffignato’ i miei proiettori: ho dovuto pagarli e allo
SAGGI
stesso tempo comprarne altri”16. Il genere povero mette in evidenza il lavoro di
bricolage dell’artista moderno (dell’artista d’avanguardia) all’interno di una
società dominata da una logica industriale. Ma è anche l’opera di un intenditore che non occupa una posizione d’autorità, di uno che è innamorato di immagini e di oggetti, che non aderisce a nessuna tradizionale struttura di produzione e che s’oppone alla legge della specializzazione delle pratiche e della divisione del lavoro.
È interessante notare che le osservazioni di Léger sul suo film terminano
con un riferimento entusiastico al cartone animato, che, secondo lui, “stimola illimitatamente la nostra fantasia ed il nostro umorismo”17. Egli intravede la
possibilità di una scomparsa del film d’artista, la fine di un’epoca animata
dalla ricerca e dal caso, dove pittori e poeti, usando la sua espressione, si
presero una rivincita sulla macchina commerciale del cinema ed affermarono la sovranità dell’immaginazione in arte. Soltanto il cartone animato gli
sembra in grado di raccogliere la sfida posta dal film d’artista: “ad esso la
parola”, così conclude Léger. Si potrebbe paragonare qui la sua posizione a
quella di Dalì e di Eisenstein, sulla base della medesima espressione, se si
pensa ai rapporti personali, e tutto sommato sorprendenti, che legarono sia
il pittore surrealista che il regista di Corazzata Potemkin a Walt Disney. In
questo senso il genere povero voleva essere quello della libera fantasia e del
gioco, dunque del ritorno allo spirito infantile grazie ad un approccio perfettamente speculativo ed empirico18.
In un altro piccolo saggio intitolato A propos du cinéma19 Léger presentì la
supremazia culturale, attuale o futura, del cinema sul teatro non in funzione di
una qualsiasi superiorità artistica ma piuttosto a partire da un riconoscimento
del suo unico potere d’invenzione e della sua impressionante velocità (velocità di produzione e di diffusione). L’età della macchina, secondo lui, stava trionfando sull’età del cavallo. Pertanto egli non affermò per niente la morte pura e
semplice del teatro la cui più grande forza rimaneva la sua stessa indipendenza nei confronti delle pressioni finanziarie e quindi la sua capacità di assumersi dei rischi senza soccombere ai calcoli strategici e alla legge del profitto.
Infine sognò un film senza precedenti per i suoi tempi: descrivere ventiquattro
ore della vita di una coppia nei minimi dettagli della loro convivenza. Una sorta
di cinema-verità ante litteram dove i personaggi sarebbero stati filmati senza
saperlo e dove l’immagine avrebbe rivelato la piena realtà dell’amore senza
alcun controllo. Pensando alle reazioni che un progetto così audace avrebbe
suscitato all’epoca egli scrisse: “Penso che sarebbe una cosa talmente terribile che il mondo fuggirebbe spaventato, chiedendo soccorso, come davanti ad
una catastrofe mondiale20”. L’insistenza sulla plasticità dell’immagine cinematografica non escludeva, dunque, in nessun caso, l’esaltazione del vero nel
Bello né del Bello nel vero.
Tutto questo per dire che la nozione di genere nel cinema deve essere
affrontata in tutto il suo ibridismo. Il film d’artista nella sua ostinazione a voler
mettere insieme il mondo della pittura moderna e quello del film, pone precisamente una tale questione21. Il carattere ibrido della maggior parte dei generi, nel cinema, permette di affermare la singolarità di un genere letteralmen-
85
86
te sui generis. Tutti i liceali francesi hanno avuto, a loro tempo, il diritto di formarsi sui generi letterari dello stile Lagarde e Michard e dunque sulle distinzioni tutte scolastiche tra poesia, romanzo, teatro e saggio. Ma noi oggi ben
sappiamo che il saggio può nascondere un romanzo, o il contrario, e che il
teatro può fare anche della poesia. L’analisi del film d’artista, in questo
senso, dovrebbe permetterci di cogliere meglio il carattere, direi estrinseco,
della nozione di genere nella misura in cui questa è stata spesso confrontata, nella sua storia, con l’eredità delle discipline artistiche considerate autonome. In quest’ottica il genere non è mai lo stesso ma quasi sempre lo stesso e l’altro, nonostante tutte le dichiarazioni d’intenzione e le semplificazioni
didattiche delle enciclopedie e delle antologie. In questo senso bisognerebbe riscrivere il genere così come si riscrive la storia. In effetti il film d’artista
si può certamente definire come una semplice traccia storica e non come
un’accumulazione o continua superposizione di oggetti cinematografici colti
nella loro pura dimensione quantitativa. La traccia appartiene all’ordine della
singolarità e della finitezza, essa resiste per essenza al potere culturale della
quantità e della ripetizione incessante. Il genere povero che ho affrontato
nella mia esposizione dimostra che si può appartenere alla storia, in questo
caso a quella del cinema, senza detenere necessariamente un reale prolungamento nel tempo. Avere una storia, dunque, senz’averne una propria. La
nozione di genere, così, contiene essa stessa un insieme di contraddizioni
fondamentali che costituiscono la sua ricchezza concettuale e, allo stesso
tempo, i suoi limiti reali.
(traduzione di Donatella Morea)
1
In particolare qui penso a dei cortometraggi come L’Etoile de mer, Le Ballet mécanique e
Anemic Cinéma.
2
Si potrebbe considerare come eccezione che conferma la regola il film di Sophie Calle e Greg
Shepard No Sex last night, sebbene s’inscriva più nel genere del road movie autobiografico che in
quello del film d’artista dalle ossessioni prioritariamente plastiche.
3
Questa presa di distanza dell’arte moderna e contemporanea nei confronti del cinema non si
presenta, per contrasto, nelle altre culture occidentali, se si pensa per esempio ai film sperimentali di Andy Wahrol negli Stati Uniti o ai lavori cinematografici minimalisti di Marcel Broodthaers in
Belgio.
4
Aggiungiamo che Legér è conosciuto anche per il suo lavoro alla scenografia de L’Inhumaine
di Marcel L’Herbier e per aver partecipato al film di Hans Richter Dreams that money can buy.
5
Denoel-Gonthier, Paris, 1965.
6
Ivi., pp. 129-171
7
Ivi, p. 134
8
Ivi, p. 136
9
Ivi, p.137
10
È in questo rifiuto di sottomettere il cinema alle leggi dello scenario, e quindi della scrittura
prestabilita, che il lavoro di Léger si distingue dallo spirito della “politica degli autori” sostenuta negli
anni cinquanta da André Bazin e dalle giovani leve della “nouvelle vague”. Questa, infatti, implicava necessariamente l’identificazione dell’autore col cinema, sia che fosse uno scrittore originale
che un regista propriamente detto.
Ivi, p. 140
Il termine “anti-spettacolare” è da concepirsi come una nozione d’ordine estetico, mentre il
termine “anti-spettacoloso” è di natura più strettamente ideologica.
13
Nella cultura francese questo problema è essenzialmente legato alla preminenza di una tradizione testuale e letteraria del teatro, in opposizione ad una tradizione gestuale e corporale che
costituisce una delle dimensioni fondamentali del teatro in altre culture, come in Asia e soprattutto in Giappone se si pensa, per esempio, al Kabuki.
14
Ivi, p 143
15
Ivi,. p. 165
16
Ivi, p. 167
17
Ivi, p. 167
18
Il cartone animato, nella sua estetica classica, implica un deliberato processo di precipitazione del tempo nell’immagine filmica e l’espressione di un accelerato mondo d’oggetti sottomessi ad
un perpetuo movimento. Il discorso originale di Léger sulla dinamica degli oggetti al cinema presenta, così, numerosi punti di similitudine con una tale prospettiva.
19
In Fondactions de la Peinture, cit., pp. 168-171
20
Ivi, p. 171
21
Ma questa può essere posta attraverso il possibile studio di altri generi cinematografici in
apparenza più classici e popolari. Come si può concepire lo sviluppo del popolare, del film fantastico o di fantascienza, per esempio, senza ricordare le loro indiscutibili origini letterarie?
L’emergere di “feuilletons” polizieschi nella società francese del diciannovesimo secolo può anche
riflettersi nell’opera di Ponson du Terrail, l’ideatore di un eroe popolare come Rocambole, ma
anche in quella di Balzac, di cui si sa che produsse un gran numero di storie per procurarsi da vivere. A di là della Francia lo stesso genere fantastico ottenne i suoi titoli di nobiltà grazie, in particolare, ad Edgar Poe, i cui numerosi racconti ispirarono, sotto molti aspetti, il cinema ad un secolo
di distanza. Quanto alla fantascienza è quasi inutile ricordare come, nella cultura francese, i libri
di Jules Verne contribuirono alla sua diffusione prima che il cinema se ne impadronisse.
11
SAGGI
12
87
SULLE ORIGINI DELLA FILOSOFIA GRECA
di Bianca Maria d’Ippolito
88
“Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?”. Così
scrive Thomas Mann nel Prologo di Le storie di Giacobbe, primo libro della
quadrilogia Giuseppe e i suoi fratelli. E prosegue: “Perché appunto […] avviene che quanto più si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si penetri e cerchi, tanto più i primordi dell’umano, della sua storia, della sua civiltà, si rivelano del tutto insondabili e, pur facendo discendere
a profondità favolose lo scandaglio, via via e sempre più retrocedono verso
abissi senza fondo […] perché l’insondabile si diverte a farsi gioco della nostra
passione indagatrice, le offre mete e punti d’arrivo illusori, dietro cui, appena
raggiunti, si aprono nuove vie del passato, come succede a chi, camminando
lungo le rive del mare, non trova mai termine al suo cammino, perché dietro
ogni sabbiosa quinta di dune, a cui voleva giungere, altre ampie distese lo
attraggono più avanti, verso altre dune” 1.
Giuseppe si confronta con l’immane distesa del tempo, si avvale di uno
strumento sottile eppure infrangibile, il potere dei nomi: “nel nome infatti è sempre insita una misteriosa virtù ed il suo possesso sembra che ci dia una potenza evocatrice”2. Abramo, Eliezer: i nomi risalgono il corso del tempo, ma richiamano l’avo e l’avo dell’avo, ogni abramo è invero soltanto un discendente, e
dietro di lui si avanza l’ombra di un altro, più remoto abramo. E “il giovane
Giuseppe provava un senso di vertigine, come noi quando ci sporgiamo sull’orlo di un pozzo”, perché “ il suo desiderio di dare un principio a quel passato, di cui si sentiva parte, incontrava la stessa difficoltà che sempre incontrano
gli sforzi di tal genere: la difficoltà di risalire alle origini. Non essendo nessuna
cosa nata da sé, ma avendo ognuna un padre, essa ci riporta indietro, in un
fondo più fondo, nelle profondità primordiali e negli abissi del passato”3 Così la
ricerca di un punto fermo cui agganciare la nostra identità umana conduce “ai
sotterranei abisso del passato” ed ogni figura incontrata nel nome induce a
“lasciarci sospingere indietro, di prospettiva in prospettiva, sempre più indietro,
verso una nuova quinta di sabbia, all’infinito”4.
L’esperienza dell’insondabilità del passato è all’origine del lavoro di
Cornford5 nel libro curato da Giuliana Scalera con perizia filologica e attenzione filosofica. “Sulla questione dell’origine –scrive Cornford– nella maggior
parte dei casi la storia ci tradisce”6. Il ‘tradimento’ della storia non è una semplice défaillance, una lacuna colmabile con un sovrappiù di studio e di analisi
dei fatti. Nel ‘tradirci’, in realtà la storia ci offre un’indicazione preziosa: apre
alla coscienza del fatto che c’è un punto, nel nostro incontro con il passato, in
cui ci urtiamo alle stesse dimensioni che sono costitutive dell’umano –lo spa-
NOTTE
zio e il tempo. È il loro carattere costitutivo che, mentre sollecita l’infinito intrattenimento della domanda, ritrova l’esperienza dell’insondabile. Sembra dunque che vi sia una relazione strutturale, un interno rinvio dal problema dell’origine storica ai primordi ‘essenziali’ dell’umano. Su questo confine, metodologicamente ‘incolto’, non dissodato opera Cornford– consapevole di dover tracciare la via.
Il titolo dell’opera: Dalla religione alla filosofia è sottilmente deviante: un
movimento ironico del pensiero, il cui svelamento mostra la modalità intensamente filosofica della riflessione di Cornford. La ‘successione’, infatti, con il suo
peso documentale, è in quest’opera sviluppata ed insieme negata. E rinvio,
persistenza, contraddizione, solidarietà sono fatti valere come momenti che
rimangono interni ad una configurazione unitaria –in cui ‘rotture’, ‘salti’, ‘mutamenti’ si muovono su un fondo impassibile, tempo senza successione, passato senza oblìo.
Possiamo dire che, a ben guardare, il problema dell’origine della speculazione greca si estende e si approfondisce abbandonando il terreno muto della
storia, per raggiungere la soglia dell’interpretazione, dove è in questione la
natura del passato. Sicché, quando Cornford scrive, nella Premessa: “C’è una
continuità di fatto tra la più antica speculazione razionale e la rappresentazione religiosa che giace dietro di essa”7, apre un problema profondo come il
‘pozzo’ manniano del tempo.
Se chiediamo, infatti, che cosa propriamente avviene in questo ‘tra’, ci troviamo di fronte ad una posizione singolare. Tra religione e filosofia vie è ‘solo’
una differenza di linguaggio: tra il linguaggio figurato della religione, fatto di
“simboli poetici e personalità mitiche” e quello astratto della filosofia: “sostanza, causa, materia ecc.”. Ma il linguaggio, per Cornford, è un aspetto puramente estrinseco, e la filosofia non è un ‘evento’, non è una nuova consapevolezza. Le differenze sono soltanto ‘maschere’ di un’identità unica, identica, immobile. Il ‘passaggio’ è la superficie illusoria della ‘permanenza’.
La prima tesi di Cornford è dunque il programma del suo procedimento: “è
possibile risalire in un filo di continuità diretta dalla conquista finale della scienza all’esito finale dell’Olimpismo”8. ‘Risalire’ la corrente del tempo significa qui
sollevare le ‘maschere’ che ricoprono l’identico, mostrare l’inanità del linguaggio, poiché i ‘nomi’ perdono, in questa visione, ogni potere e rapporto con la
‘cosa’.
Ma il cammino è ancora lungo, il filo diretto non conduce soltanto dalla filosofia alla religione, ma a sua volta, la religione attinge “ad uno stadio magico,
più arcaico”9. Nel risalire all’origine, ogni conquista si rivela possesso ingannevole, una ‘duna di sabbia’.
Per la dimostrazione della sua tesi, per seguire il “filo di continuità diretta”,
Cornfornd conduce un’ampia, complessa e suggestiva analisi dei concetti di
“physis” e “moira”. Le categorie filosofiche, legate all’idea di physis dei primi
pensatori greci, che si erano proposti di elaborare concettualmente l’’origine’,
sono ricondotte via via sul sentiero delle dune di sabbia –esse non soltanto
ricevono dalla religione (olimpica) i loro contenuti, ma sono fatte risalire ancor
più indietro, nell’arcaico mondo senza concetto e senza tempo. Scrive
89
90
Cornford: “La filosofia, quando mette da parte i prodotti compiuti della religione e ritorna alla ‘natura delle cose’, regredisce in realtà alla rappresentazione
originaria da cui la stessa mitologia aveva preso forma”10. Forse se Cornford
avesse presente il significato dell’evoluzione della lingua greca in uno studio
filologico raffinato come quello di Bruno Snell –che mostra il parallelo emergere dell’aggettivo neutro sostantivato e del concetto– sarebbe sorpreso o rallentato da un dubbio, nel passo audace di vanificare ciò che Hegel chiamerebbe
“il lavoro del concetto”; –così come potrebbe non dar per scontata l’esteriorità
del nome alla cosa, quando scrive “Ed anche se ora la chiamiamo ‘metafisica’
invece di ‘sovrannaturale’, la cosa in sé non ha cambiato carattere”11.
La seconda tesi di Cornford è resa necessaria dal fatto che il risalire indietro verso le grandi immagini-guida di moira e physis non raggiunge una risposta alla domanda fondamentale. Una volta svelato il ‘che’, la ‘cosa originaria’,
resta ancora la domanda sul ‘perché’. Essa sorge, secondo Cornford, sul
carattere morale attribuito dai primi pensatori greci alla natura. Giustizia, riparazione del torto, reciprocità: sono concetti morali che vengono estesi, contro
ogni esperienza, alla natura. Bisogna dunque chiedersi donde nasca questa
sostanza morale della natura nel pensiero dei Greci.
Ancora una volta, il ‘tradimento’ della storia e le ‘maschere’ della filosofia ci
lasciano senza risposte. La seconda tesi assume che sia necessario cambiare orizzonte, passare ad altro ambito di discorso. Cornford propone di prendere a prestito le categorie elaborate dalla sociologia francese per illuminare il
buio dell’arcaico mondo delle origini greche attraverso un connubio audace,
inusitato, metodologicamente arduo.
Qui, infine, per la prima volta, otteniamo un chiarimento risolutivo. I grandi
temi finora sviluppati in ampia e suggestiva analisi: la Moira come ‘partizione’,
la grande figura che consacra la priorità dell’immaginazione spaziale nella
mente greca e domina da ultimo i pensieri di giustizia e governo –su quella
temporale, orientata al tema dell’anima e dell’interiorità; e la physis, che, come
principio di vita e di movimento orienta il pensiero verso la ‘scienza’; tutto questo si sospende all’ultimo tratto del filo, il tema “la natura è morale”.
L’incrocio con la sociologia –reputata in grado di rispondere alla domanda
sul ‘perché’– inaugura un dialogo produttivo di nuove idee, sulla cui scorta si
disegnano nuovi orizzonti di ricerca. Qui non si può non ricordare che, come
bene ha osservato Nietzsche, il Greco non ‘separa’ natura e morale perché
egli stesso non è ‘separato’, come figura ‘professionale’, e non lo è il poeta né
il fondatore di costituzioni. Scrive Nietzsche: “In altre epoche il filosofo si presenta come un solitario e casuale viandante, il quale, nel più ostile degli
ambienti, cerca di sgattaiolare oppure di farsi strada con la forza dei suoi
pugni. Soltanto presso i Greci il filosofo non è casuale. […] Solo una civiltà
come quella greca […] può giustificare la filosofia in generale, poiché essa
sola sa –e può dimostrare– perché e come il filosofo non sia un qualunque
viandante casuale, sbandato ora in una direzione e ora in un’altra” 12. E come
il filosofo emerge dal cuore del suo mondo civile, così l’uomo greco sta dentro una natura vivente e divina.
In questo pensiero, Nietzsche non era molto distante dalla visione hegelia-
NOTTE
na. Per Hegel, i Greci stanno, tra la “sostanzialità orientale” e “il puro formalismo, il principio astratto del mondo moderno”, nel giusto mezzo, sì che “lo spirito, immerso nella natura, è con essa in unità sostanziale”13.
Nello sviluppo della tematica cornfordiana possiamo in fondo ritrovare due
mosse: 1) il ritorno al ‘più antico’; 2) il ricorso ad altro ambito di discorso. La
seconda tesi ci pone di fronte al concetto etnologico di ‘rappresentazione collettiva’, che proviene dal gruppo sociale, lo identifica e ne esprime la suddivisione e organizzazione originaria. La ‘rappresentazione collettiva’ –essa sola è
in grado di ‘spiegare finalmente l’’origine’. La spiega perché solo dal gruppo
sociale, dal sentimento di appartenenza e dal suo valore vitale può provenire,
secondo l’autore, la tonalità emotiva, la densità morale che ci ha stupiti nell’idea della “natura morale”.
Per ottenere questo risultato, tuttavia, Cornford deve utilizzare i concetti di
‘omologia’ e di ‘proiezione’ –che permangono in una loro ‘ovvietà’ e ‘ingenuità’,
essendo esterne ad entrambi gli ambiti di discorso messi così genialmente in
contatto.
Scrive Cornford: “La segmentazione della tribù è il fatto primario; […] la
struttura segmentata è poi proiettata all’esterno sul resto dell’universo. Il
macrocosmo in un primo momento fu modellato sul microcosmo, e il microcosmo primitivo è la tribù”14. Ma, possiamo chiedere, una tale ‘proiezione’ –prima
di ‘spiegare’ non andrebbe forse spiegata? Da Nietzsche possiamo ancora
apprendere come e perché essa non sia necessaria per intendere il rapporto
dei Greci con la natura: “I Greci […] avevano su questo punto un atteggiamento antitetico a quello di tutti i realisti, poiché essi credevano soltanto nella realtà degli uomini e degli dèi, e consideravano la natura quasi come un travestimento, una maschera, una metamorfosi di questi uomini-dèi”15. Anche Schiller
aveva cantato questa realtà: “Tutto parlava allo sguardo iniziato/tutto era traccia di un dio”16.
Nel passaggio di Cornford al piano socio-etnologico non possiamo non
notare che in fin dei conti le sue due tesi si riconducono ad un’unica. La mitica
ricerca del ‘più antico’, il ‘primitivo’. Così leggiamo: “In effetti, la base e la struttura del politeismo greco è una forma più antica dell’ordinamento che si trova
nella cosmologia di Anassimandro”17, e poi “ci soffermeremo sulla rappresentazione religiosa primitiva […] cercando di risalire […] alla sua origine più remota”18 ed ancora: “e questa concezione non risalga ad una fase ancora più arcaica. […] dobbiamo ricorrere alla nostra conoscenza di altri sistemi religiosi di un
tipo indiscutibilmente più primitivo”19.
Nietzsche (pre)avverte un pericolo nei ragionamenti che ‘spiegano’ col
ricorso al primitivo: “La via che ricerca i primordi conduce sempre verso la barbarie, e chi si occupa dei Greci dovrà sempre tener presente che in ogni tempo
l’incontrollato impulso conoscitivo, come tale, imbarbarisce allo stesso modo
dell’odio per il sapere, e deve ricordarsi che i Greci hanno domato il loro impulso conoscitivo, in sé insaziabile, per un riguardo alla vita, per un bisogno ideale di vita, appunto col tradurre senz’altro in vita ciò che avevano imparato”20.
Al di là della preoccupazione nietzschiana, forse si dovrebbe dire che pensare lo spazio e il tempo significa toccare le coordinate stesse dell’esistenza
91
92
umana. Esse, mentre continuano ad imporsi al pensiero, permangono inesauribili, e la ‘spiegazione’, se vuole colmare il divario metodologico e oggettuale
tra i saperi deve ricorrere allo sguardo divino dell’omologia.
In realtà, per comprendere il significato del libro di Cornford –e la motivazione del suo ‘ritorno’ nella limpida traduzione italiana di Giuliana Scalera,
arricchita da un apparato di indici estremamente utile, è necessario riferirsi alla
contestualizzazione ed all’interpretazione della curatrice.
Nell’introduzione dal bel titolo shakespeariano Della stessa materia dell’anima21, la studiosa osserva: “Per Cornford non si trattava tanto di scoprire,
accanto o contro la ragione, l’irriducibile del biologico e del primitivo, quanto di
decodificare i precedenti magici e primitivi della ragione stessa”22. L’incontro
con i Greci, che non cessa di riproporsi alla coscienza moderna e di suscitarvi
grandiosi conflitti, si rivela qui decisivo per la dimensione antropologica dell’autocomprensione occidentale. La Scalera dà rilievo all’idea di una ragione stratificata, che conserva in sé i momenti del suo opposto, li consuma e ne è pervasa; è quasi una realtà ‘tettonica’, le cui faglie possono distribuirsi in profondità e larghezza, ma anche scontrarsi, spezzarsi, generando eruzioni e terremoti. In un certo senso, si potrebbe dire che Cornford rivela e risolve una ‘rimozione’, mediante cui la ragione ha alienato una parte di sé per poterla negare
o dominare. La riconquista di falde di senso nascoste è l’esito di una dialettica
profonda.
D’altra parte, la studiosa riconosce alla ricerca di Cornford un valore di storia della cultura. In essa vede un tassello importante nello “storico incontro tra
antichisti e antropologi” destinato a “scuotere dalle fondamenta l’ortodossia di
lettura della filosofia pre-socratica”23. Qui Scalera coglie un importante risultato: “Cornford denaturalizzava di fatto la filosofia naturalista “La physis al centro della speculazione antica, per Cornford ha poco a che vedere con la natura […] l’oggetto principale della speculazione greca non è la natura esterna
osservabile, ma una rappresentazione metafisica della realtà”24.
Nella misura in cui raccoglie “la sfida alla filologia lanciata dalla tradizione
filosofica tedesca”, aggiunge Scalera, “Cornford tracciava una linea di discendenza diretta da La nascita della tragedia a Themis”25. Nietzsche per primo,
infatti, aveva colto il tratto non naturalistico della natura dei Greci. Per lui le
modeste osservazioni di Talete non avrebbero mai potuto suscitare la grande
idea di unità che si esprime nel suo detto. “Ciò che spingeva verso una tale
generalizzazione –scrive– era una proposizione metafisica di fede, la cui origine va cercata in un’intuizione mistica”26.
Ma la linea della genealogia nietzschiana tracciata da Cornford si spezza in
un punto, a partir da cui si apre una divergenza decisa. Si tratta proprio
dell’’antinaturalismo’, che nel filosofo tedesco non solo non risucchia la filosofia nell’arcaico, ma ne esalta il novum. Proprio della filosofia è “scegliere e sceverare l’insolito, lo stupefacente, il difficile, il divino”27. In tal modo, infatti “la filosofia stabilisce i suoi confini rispetto alla scienza, allo stesso modo che li stabilisce rispetto all’accortezza con l’accentuare ciò che è inutile. Senza una tale
scelta, senza un gusto raffinato, la scienza si precipita su tutto ciò che è oggetto del sapere, nel cieco desiderio di conoscere a ogni costo tutto quanto; il pen-
1
TH. MANN, Le storie di Giacobbe, trad. it. di B. Arzeni, Intr. di Lea Ritter Santini, Mondadori,
Milano 2001, p. 23.
2
Ivi, p. 24.
3
Ivi, pagg. 31 e 30.
4
Ivi, p. 31.
5
Questo scritto è a proposito di F. MACDONALD CORNFORD, Dalla religione alla filosofia. Uno studio sulle origini della speculazione occidentale, trad. it. intr. e note a cura di G. Scalera McClintock,
Argo, Lecce 2002.
6
Ivi, p. 49.
7
Ivi., p. 43.
8
Ivi., p. 45.
9
Ivi., p. 46.
10
Ivi, p. 47. La sottolineatura è mia.
11
Ibidem.
12
F. NIETZSCHE, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci, tr. it. di G. Colli, Nota introduttiva di G.
Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1991, pp. 146 e 147.
13
G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, trad. it. di E. Codignola e G. Sanna, La
Nuova Italia, Firenze 1964, I, p. 170.
14
F. MACDONALD CORNFORD, op. cit., p. 98. La sottolineatura è mia.
15
F. NIETZSCHE, op. cit., p. 154.
16
F. SCHILLER, Gli dèi della Grecia, in Poesie filosofiche, trad. it. a cura di G. Moretti, SE, Milano
1990, p. 13.
17
F. MACDONALD CORNFORD, op cit., p. 80.
18
Ibidem.
19
Ivi, p. 87.
20
F. NIETZSCHE, op. cit., p 144.
21
G. SCALERA MCCLINTOCK, Della stessa materia dell’anima, in F. MACDONALD CORNFORD, op.
cit., pp. 7-33.
22
Ivi, p. 7.
23
Ivi., pagg. 9 e 12.
24
Ivi,, p. 12.
25
Ivi., p. 15 e p. 28 n.50.
26
F. NIETZSCHE, op. cit., p. 156.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
G. SCALERA MCCLINTOCK, op. cit., p. 15.
NOTTE
siero filosofico per contro, è sempre sulle tracce delle cose che più meritano di
essere sapute, delle conoscenze grandi e importanti. […] La filosofia prende
quindi le mosse da una legislazione della grandezza”28.
D’altra parte, Nietzsche fa emergere quell’elemento dionisiaco, entro il
quale, nota Scalera “irrompeva senza mediazioni l’ancestrale, l’arcaico”29. Qui
sta, infatti, il punto critico della ricerca: l’originario non può esser colto ‘in sé’,
come un dato primitivo, come dice Freud dell’inconscio, bensì solo nelle lacune e nelle paqh della coscienza. Ed anche di essa potremmo dire con Mann:
“Profondo è il pozzo del passato. Non potremmo dirlo insondabile?”.
93
IL CLASSICISTA E LA SCIENZA
NOTA SUL DILETTANTISMO FILOSOFICO
DI SEBASTIANO TIMPANARO
di Girolamo de Liguori
ben ch’ io sappia ch’oblio
preme chi troppo all’età propria increbbe.
G. Leopardi
94
Il 26 novembre del 2000 veniva a mancare in Firenze Sebastiano
Timpanaro. Era nato a Parma nel 1923, da un messinese e da un’aretina:
Sebastiano Timpanaro senior (1888-1949) e Maria Cardini (1890-1978). Fisico
e matematico, ma anche storico e critico appassionato d’arte, l’uno; poetessa,
studiosa di filosofia classica, greca in particolare, l’altra. Appartato, schivo ma,
per altri versi, espansivo e leale con amici ed estimatori, lo era anche con critici e avversari. Laureato a Firenze in lettere classiche, dove ebbe per maestro
di filologia Giorgio Pasquali, fu correttore di bozze presso la Nuova Italia per
tutta la vita fino alla pensione. Non seguì la carriera dell’insegnamento: né
medio né universtiario, salvo un incarico di professore a contratto, presso la
cattedra di storia moderna di Antonio Rotondò. La sua produzione letteraria
copre vasti settori: la filologia classica, la storia letteraria, Leopardi, la filosofia,
la psicoanalisi, il marxismo e la politica. La riflessione sulla scienza resta una
costante del suo pensiero sulla storia, anche se non si espresse in ricerche ad
essa specificamente dedicate. Alla sua morte fu ricordato in vario modo dalla
stampa e dalla scuola e, in modo particolare, da studiosi, pochi amici, anche
all’estero, ed estimatori. La Scuola Normale Superiore, l’Università di Pisa
assieme all’Università di Firenze e al Gabinetto Vieusseux, organizzarono un
incontro nel novembre del 2001 i cui Atti sono ora pubblicati con il titolo, Il filologo materialista. Studi per Sebastiano Timpanaro, editi da Riccardo De
Donato, Scuola Normale Superiore, Pisa 2003; e, con l’aggiunta di testi presentati in una giornata di studi a lui dedicata a Torino, in un secondo vol., in
corso di stampa, S. T. e la cultura europea del secondo Ottocento, a cura di
Enrico Ghidetti e Alessandro Pagnini, Edizioni di Storia e Letteratura. Un altro
incontro venne organizzato a Roma, dall’Universtà di Tor Vergata, il 4 febbraio
2002, i cui atti sono usciti nel maggio scorso presso Unicopoli, sotto un titolo
indicativo: Per Sebastiano Timpanaro: il linguaggio, le passioni, la storia, per la
cura di Franco Gallo, Giovanni Iorio Giannoli e Paolo Quintili. La rivista
«Allegoria», (39, 2001) gli dedica un denso numero di 131 pp; e poi, ma prima
di tutto, “Belfagor”! Il Belfagor di Timpanaro ovvero Timpanaro in Belfagor: dal
1953 alla morte, è ormai tema che meriterebbe una ricerca a parte. Per i leopardisti italiani egli è stato un incubo per tutta la vita: alla sua morte, il loro
silenzio dignitoso non nasconde la rozza verità che egli fu di Leopardi tra i
1. Il preteso dilettantismo di Sebastiano Timpanaro nei confronti della scienza veniva di lontano2. Risaliva, per buona parte, a suo padre, fisico e matematico, prima docente a Parma poi direttore della Domus Galilaeana di Pisa: uno
scienziato che dall’interno di una sostanziale prospettiva neo-idealistica, aveva
acutamente e prima di altri rivendicatori di antidealismo, colto la vera debolezza del pensiero di Croce e Gentile nei confronti delle scienze3. A Gentile rinfacciava che “l’unità di filosofia e storia della filosofia”, da lui dimostrata, poteva
benissimo con analoga argomentazione venir dimostrata per l’altra unità: quella tra la scienza e la storia della scienza. Lo scienziato si domandava come mai
le critiche che si muovevano alla matematica venissero dagli idealisti ritenute
pensiero e le opere dei grandi matematici né più né meno che istruzioni per
l’uso. E su Croce dichiarava: “nessuno ha combattuto così accanitamente il
dilettantismo quanto Benedetto Croce, ma il miglior esempio di dilettantismo è
la critica che Croce, analfabeta della scienza, ha fatto alla scienza”4.
In realtà se l’osservazione era giusta, non era esauriente. L’incomprensione
non era solamente tecnica, di ignoratio elenchi, aveva origine in una differente e inadeguata epistemologia. Se ne era accorto il giovane Sebastiano che lo
dichiarava a suo padre, in quelle giovanili discussioni domestiche, «affettuose
e tempestose» a un tempo. Bisognava uscire dall’idealismo: cosa che non
fecero né Spirito, né Calogero, né scienziati o pedagogisti come Timpanaro
senior o Giuseppe Lombardo Radice; né perfino scettici, nemici feroci del neo
idealismo, come Rensi o spiritualisti di alta consapevolezza scientifica come
Martinetti. Ripensando a quel suo filosofico parricidio, molto più tardi, a circa
un anno prima della sua improvvisa scomparsa, in dialogo con Fabio Minazzi,
dichiarava, con il suo solito stile improntato alla sincerità:
fin da giovanissimo ho avuto un vivo (anche se confuso e dilettantesco; e tale è
sostanzialmente rimasto) interesse per la filosofia, derivato soprattutto dall’aver avuto
un padre idealista di sinistra, fautore di un inserimento delle scienze fisico-matematiche e naturali in un idealismo gemntiliano concepito come assoluta immanenza. Il mio
materialismo (dico così per brevità, senza la minima pretesa di aver dato vita a un mio
sistema di pensiero originale) ha avuto le sue prime origini nelle interminabili discissioni con mio padre, discussioni affettuose e tempestose ad un tempo. Io ritenevo che
egli avesse tutte le ragioni nel rivendicare il pieno valore conoscitivo della scienza
contro la riduzione crociana della scienza a pseudo concetto (riduzione e svalutazione in cui era coinvolta la filologia: ecco, qui un legame coi miei interessi per la filologia si può forse ravvisare: di Croce mi urtava anche il disprezzo per la filologia). Mi
andai sempre più convincendo che una vera rivalutazione della scienza dovesse
avvenire contro, non dentro l’idealismo; e che, inoltre, l’idealismo fosse pur sempre
una religione, anche se immanente e non trascendente5
Sebastiano figlio si riferiva in modo più specifico alla esperienza che suo
padre aveva condivisa con Giorgio Fano, il filosofo triestino di cui il nostro filo-
NOTTE
pochissimi originali studiosi che l’Italia abbia avuto, dal De Sanctis ad oggi. Ma,
forse, una tale verità anomala è connaturata alla storia stessa della critica leopardiana. Delle pubblicazioni qui menzionate, e d’altre ancora seguite alla
morte dello studioso, nonché dell’epistolario inedito col sottoscritto (di cui qui
si pubblicano due lettere), tengono conto le considerazioni che seguono1.
95
96
logo si era già occupato, rinfacciando ad Eugenio Garin di averlo appena citato nelle sue pregevoli Cronache, senza dargli quel rilievo che egli meritava,
accanto a Croce, Gentile, De Ruggiero nel quadro della filosofia italiana del
primo Novecento6 In realtà, la storiografia dominante negli anni cinquanta e
sessanta lasciava nell’ombra tutta una zona di pensiero sensibile ai problemi
della scienza e aperta a sviluppi e soluzioni che solo più tardi avrebbero trovato un qualche ascolto. Più in particolare, “il totale disinteresse che verso queste correnti idealistiche di sinistra ha continuato a mostrare Eugenio Garin è
stato […] un grave errore”7. Si avvalorava l’immagine di una filosofia italiana
divisa tra immanentisti idealisti (storicisti o no) e spiritualisti cattolici da una
canto e tra spiritualisti e marxisti dall’altro; spezzando il filo che collegava per
altri versi quel pensiero al positivismo dell’Ottocento e alle suggestioni di altre
filosofie che venivano dall’Europa, sensibili ai problemi della scienza e della linguistica in particolare.
Ma per Timpanaro, l’opzione gneoseologica che si fonda sulla ricerca scientifica, non poteva essere neutra, conciliantesi con altre opzioni di vario impianto filosofico: essa implicava la scelta materialistica. O meglio: storicamente,
essa si è espressa in una sorta di gnoseologia realistica che “ha mirato più a
una depurazione delle religioni tradizionali da tutti gli aspetti superstiziosi trascendenti, mitologici che a un rifiuto totale della religione”. La filosofia ha tenuto nella sua storia una posizione ambigua. Timpanaro sembra qui recepire la
serrata critica di Pierre Bayle alla filosofia cartesiana e moderna in generale ed
accogliere dal sottile autore del Dictionnaire la funzione distruttriuce e critica
della filosofia non come costruttrice di sapere ma come demolitrice di certezze. Visione, del resto, che proprio da Bayle (mediato dai controversisti a lui
familiari nella sua formazione giovanile), sarebbe pervenuta al Leopardi; il
quale rifiuta o penalizza la filosofia per la sua incapacità di dare soluzioni (o
promettendone) e perviene ad una opzione totalmente materialistica, non
metafisica, portandosi oltre la filosofia, in quella opzione gnoseologica che per
Timpanaro è il vero materialismo ateo, non dialettico. “Ora, il materialismo
–precisa– non è soltanto realismo gnoseologico: è negazione di ogni religione
trascendente e immanente, quindi di ogni provvidenza, anche insita nella storia umana”. E in realtà, nella storia, solo pochi pensatori sono pervenuti a tale
opzione. Non Voltaire, non Rousseau, non la cultura dell’Illuminismo in generale: ecco perciò uno dei motivi della individuazione da parte del nostro di alcuni soltanto ma significativi esempi di tale opzione e coerenza: D’Holbach, ad
esempio e, più grande di tutti, Leopardi che a tale scelta era pervenuto
nell’Italia della Restaurazione e in seguito ad una educazione reazionaria,
chiusa e improntata allo spiritualismo trascendente e assoluto di Monaldo e dei
suoi precettori gesuiti8. L’opzione materialistica è pertanto,
riconoscimento di tutto ciò che l’uomo ha di specifico rispetto agli altri animali (la
società, il pensiero, il linguaggio, ciò che Labriola chiamava “terreno artificiale”),
ma è anche consapevolezza che l’animalità, la biologicità dell’uomo (il “terreno
naturale” di Labriola) non sono state annullate dalla socialità. La definizione gramsciana dell’uomo come “l’insieme dei rapporti sociali” è perciò carente, se pretende di definire tutto l’uomo. Aspetti essenziali di quella che […] si è chiamata la con-
Timpanaro prendeva così coscienza di staccarsi, con tale scelta materialistica, per un verso, dagli epistemologi materialisti come Geymonat o anche Giulio
Preti ed Eugenio Colorni, e per un altro, dai materialisti storici o dialettici (e dai
comunisti e socialisti storici) dei quali condivideva, sott’altro profilo, la prospettiva marxista e determinate scelte pratiche10. Il suo leopardismo rifiutava di risolversi in materialismo dialettico se, come egli riteneva, “il concetto di dialettica
implica necessariamente una concezione provvidenzialistica della storia, del
male come elemento negativo destinato a risolversi in un bene più alto”. Nella
immagine che se n’era costruita la cultura italiana, il materialismo si risolveva
tutto o in un equivoco pseudo filosofico di derivazione settecentesca e positivistico-scientistico o, con maggiori possibilità di venire preso sul serio, in materialismo dialettico; per altri versi, anche combattuto dalla tradizione gramsciana e
togliattiana, in Engels, a tutto ventaggio di una sua risoluzione storicistica nel
Marx del Manifesto e del Capitale. Timpanaro veniva allora guardato come un
eccentrico, intelligente, malato di leopardismo: un fine letterato cui si tollerava,
proprio per la sua totale peregrinità, di azzardare ipotesi impossibili o improbabili su Engels, Lenin, Mao, Marx e i teorici discussi dalla sinistra europea degli
anni sessanta. Così avrebbe precisato la sua posizione, già espressa sui primi
saggi materialisti del 1966, nel dialogo con Minazzi che qui si va riproponendo:
La stessa storia umana non ha proceduto sempre (anzi, non ha proceduto il più delle
volte) per successive negazioni-inveramenti: vi sono state, come vi sono nella vita di
ciascun singolo essere umano, quelle che chiamerei “perdite secche”. E la finale
estinzione della specie umana (che avverrà in ogni caso anche se, come è ormai
non improbabile, non sarà affrettata di molto dall’uomo stesso, da un progresso tecnico inquinante e mortifero) sarà la “perdita secca” più globale. Di ciò Engels (che
per certe sue formulazioni può apparire più dialettico, in senso banalmente progressista, di Marx) si era reso conto più di Marx. E più di Marx e di Engels se n’eran resi
conto alcuni materialisti premarxisti, come Holbach e soprattutto Leopardi […]. Per
sfuggire all’obiezione di essere ancora una teodicea, la dialettica marxista dovrebbe
limitarsi a una pura constatazione della realtà come puro divenire; ma non so quale
“materialista dialettico” si accontenterebbe di una tale limitazione11
Da qui la insoddisfazione, latente e non dichiarata, della sua stessa scelta
marxista, profondamente vissuta; il suo leopardismo, l’ascolto sempre attento
agli sviluppi delle scienze, fisiche, biologiche, linguistiche; lo sforzo di mediare
il marxismo, oltre gli ibridismi delle mode francofortesi, o psicoanalitiche (dei
vari parnassiani atlantici) che andavano moltiplicandosi sia in campo politico
che della critica letteraria meno avveduta, con una prospettiva non conciliativa
che dichiarasse con franca lingua, nulla al ver detraendo, il mal che ci fu dato
in sorte, il basso stato e frale: quanto a lui sembrava –ma non ne accettava la
formula deteriorata– la vera condizione umana. Del resto la funzione della
scienza era per lui essenzialmente quella di affermare un suo “contenuto
NOTTE
dizione umana (nascita, sviluppo fisico e in larga parte misura anche mentale,
bisogni e istinti come la fame, l’eros, malattie, morte) non sono vissuti dall’uomo
civilizzato come dagli altri animali, ma rimangono pur sempre inscindibili dalla sua
animalità. Questo non è materialismo volgare (come sarebbe il disconosciemnto
del “terreno artificiale”): è materialismo tout-court 9.
97
obbiettivo di verità”; la battaglia o la militanza materialistica non era, primariamente, che la difesa strenua contro le mistificazioni tecnocratiche di vario
senso e valore, di tale contenuto.
È necessario chiarire (poiché si tratta di un punto sul quale i marxisti stessi non
sono d’accordo) che la “scienza” per me non implica il rifiuto di ogni
Weltanschauung, ma l’adozione di una Weltanschauung materialistica, purché
non dogmatizzata, aperta a tutti gli arricchimenti e le correzioni che non potranno
non venirle da nuove esperienze. Non accetto, quindi, la posizione agnostica
secondo la quale il materialismo e lo spiritualismo sarebbero due “ideologie” o due
forme; press’a poco equivalenti, di metafisica […] Su questo punto concordo pienamente con Ludovico Geymonat12.
98
Riflessione sulla natura, perciò, sull’uomo in rapporto con gli animali e con
l’ambiente fisico, origine e fine della vita sulla terra e nel cosmo si intrecciarono in lui con la lettura di opere letterarie, filosofiche e scientifiche e soprattutto con la sua esperienza di militante politico. Conosce Ambrogio Donini, lo
storico del Cristianesimo, il grande allievo eretico di un eretico, Ernesto
Buonaiuti; polemizza con Lucio Colletti –che i più ricordano affabulatore anticomunista televisivo e non come l’autore del saggio roussoviano Natura e
società o curatore dei Quaderni di Lenin– e, meno vistosamente, anche con
Geymonat, sempre in nome della sua rigorosa opzione materialistica. La sua
biografia intellettuale si avvinghia alle sue scelte filosofiche ed alle sue propensioni culturali e politiche. Lo avrebbe dichiarato, con la solita onestà intellettuale del filologo, che seppe usare anche con se stesso, sulla rivista
“Giano”, nel 1989.
La mia conversione fu dalla religione immanentistica a un materialismo pessimistico, certo ancora tendenziale e confuso. Quante discussioni, tempestose e affettuose a un tempo, con mio padre! Le discussioni non cessarono nemmeno quando, dopo la liberazione, mio padre capì il grande valore socio-politico del marxismo e, come ho accennato, divenne socialista; ma in filosofia, al pari di altri intellettuali italiani di sinistra, aderì a una interpretazione dialettica, tra hegeliana e
gramsciana, non materialistica, del marxismo […]. La lettura del Leopardi mi trovò
quindi già predisposto al suo materialismo e al suo pessimismo agonistico, non
«rassegnato» né «buddhistico» alla Schopenhauer, ma vero, integrale pessimismo (questo è il punto sul quale non mi sono mai trovato d’accordo con Cesare
Luporini […]). Del pessimismo leopardiano faceva parte, insieme a molti altri motivi, anche la «fine del mondo».
Tali dichiarazioni o confessioni non si leggono come emotivi riferimenti a
suggestioni e scelte sentimantali ma si connettono drammaticamente ad un
sofferto itinerario di pensiero, anche se costantemente ignorato con ostinata
ottusaggine da molti suoi critici.
Mi confessava, in sua lettera del 27 maggio 1985:
io godo di una certa stima in quella che è la mia originaria materia professionale, la
filologia classica; ma quanto all’italianistica, e peggio che mai alla storia delle idee e
simili, c’è la radicata convinzione che io sia un dilettante, un pamphlettista autore di
sfoghi politici di estrema sinistra (sgraditi anche ai comunisti) e non scritti seri.
NOTTE
Leopardi, così come Engels o D’Holbach, Marx o gli analisti della società contemporanea che egli leggeva, vengono ad inserirsi nell’itinerario di un
riflessivo costituzionale. Timpanaro è un pensatore che fa il mestiere di filologo e perciò mette a punto i testi su cui riflette ma non si limita a contemplarli, come fa l’antiquario, dopo aver raccolto e classificato i suoi reperti;
con essi prosegue alla demistificazione del reale fino alla scoperta dell’infelicità e della castrofe. Alla faccia ridanciana e soddisfatta di tanta cultura
consolatoria (che egli spesso identifica con lo spiritualismo e con le teodicee trascendenti e immanenti) egli sostituisce il volto dolorante di una riflessione capace di storicizzare l’infelix genus humanum di Lucrezio con le
moderne teorie della fine del cosmo, o la conclusione della Ginestra con le
osservazioni di Fallot su Epicuro. Di tanto in tanto, come preso da stanchezza o abulia, ostenta la serenità del filologo; torna all’antico progetto dei
frammenti di Ennio, a Virgilio, ai virgiliani, al metodo del Lachmann; ma
lascia tutto come incompiuto, di una incompiutezza che denuncia l’ironia del
pessimista: di chi ha consapevolezza che l’opera di vera filologia portata a
termine, completata nella sua estrema perfezione, implica la chiusura ad
altre dimensioni della storia e finisce per fare del filologo, in quanto intellettuale dimidiato e chiuso, un filologo imperfetto. Il suo rigoroso tecnicismo
–ad esempio, sul Leopardi filologo– non è mai settoriale, sempre aperto alla
storia ed alle più svariate implicazioni 13. Arriva perciò al paradosso: la perfezione (possibile) è solo nell’impefezione perseguita con impegno dilettantesco per tutta la vita.
La cautela con la quale egli assumeva e autovalutava la scelta materialistica, ci viene dimostrata anche dalla sua lettura di Freud e dallo scavo, sempre filologicamente attento, delle fonti e degli sbocchi della psicoanalisi. Il
suo materialismo –o in questo caso empirismo metodologico– aveva buon
gioco anche nell’individuazione dei cosiddetti lapsus. L’essere critico testuale gli giovava, in quanto egli raggiungeva, “in confronto allo psicolinguista o
al fisiologo, una maggiore consapevolezza e complessità di cause che concorrono a produrre un lapsus e una più viva esigenza di non limitarsi a raggruppare i lapsus in grandi categorie, ma di cercar di comprendere di volta
in volta come diverse tendenze generali abbiano contribuito a far sorgere
quel singolo errore”14. Il suo materialismo militante diventava un’opera di
demistificazione severa di ogni spaccio non autorizzato di scientificità. Pochi
hanno sentito come Timpanaro il valore civile, etico, direi, della scienza15. A
un tale valore si impronta perciò anche la sua critica a Freud. Egli coglie la
contraddizione costituzionale della psioanalisi: quella di essere ad un tempo
fondata sul materialismo (come del resto –sia detto per inciso– aveva saputo individuare la prima reazione spiritualistico-cattolica alla psicoanalisi) ma
anche su di “una costruzione metafisica e addirittura mitologica”16. Freud, da
una canto, carica di lamarkismo haeckeliano il suo scientismo, radicandosi al
lato deteriore del materialismo, pur congenito alla sua teoria; e, dall’altro, sfocia in un umanesimo più vicino a Kafka a Musil a Proust che non a Darwin,
Marx o Einstein17. Sarà l’involuzione della teoria, dalla neurofisologia, di cui
esempio incomparabile di metodo era stata la médicine expérimental di
99
Claude Bernard, alla teoria generale dell’umanità e della società: da scienza
a mito del decantentismo europeo. Il filologo classico e il leopardiano marxista demistifica, come aveva saputo fare il giovane Marx con Hegel, Freud e
la psicoanalisi anche nelle sue successive ibridazioni francofortesi, strutturalistiche di varia disponibilità antimaterialistica18.
100
2. Sostengono l’opzione materialistica di Timpanaro, sia la filologia che la
storia. In quel pozzo di scienza che fu il Leopardi egli seppe districarsi; anzi,
si fece le ossa per così dire, percorrendo a ritroso i filoni di quella precoce e
ciclopica formazione, tra apolisti, padri della Chiesa, dossografi, testi antichi,
Porfirio, Teofrasto, Stratone, attraverso Diogene Laerzio, Stobeo, ecc. In quel
coacervo, il nostro colse le sfumature dell’itinerario leopardiano, dal teismo
all’ateismo materialistico: la presenza di Pierre Bayle, il posto di Epicuro fino
alla sua emarginazione e il riferimento al D’Holbach. Tuttavia un equivoco
inficia la sua lettura del rapporto tra Leopardi e D’Holbach: non aver ben colto
il precedente rapporto storico tra Bayle e Spinoza e le conseguenze che l’immagine bayliana di Spinoza ha subìto nella storia del naturalismo sette-ottocentesco, da D’Holbach stesso a Feuerbach ed ai materialisti tedeschi del
secondo Ottocento. Rifiutate correttamente le posizioni di Antimo Negri e
della Stancati, che pervengono addirittura a leggere D’Holbach come precursore del vitalismo romantico19, egli individua nel naturalismo animistico schellinghiano un portato dello spinozismo, non curando la biforcazione, subita
storicamente dallo spinozismo, verso il materialismo immanentistico, da un
lato, e l’ilozoismo romantico della riscoperta germanica (Jacobi, Schelling,
ecc.) dell’autore del Tractatus, dall’altro. Lo stratonismo, e perciò anche quello di Leopardi, (se ne accorga o no l’autore che, in un primo tempo, lo aveva
individuato nella controversistica cattolica) altro non era che “la forma moderna […] di una dottrina antichissima che considerava l’universo come una sola
sostanza, facendo di Dio e del mondo un unico essere”; e finiva per coincidere proprio con lo spinozismo, di cui Bayle stendeva l’ambigua condanna nella
omonima voce. Sarà tale figura a sostituirsi all’atomismo di Epicuro nello
svolgimento dell’ateismo moderno, e proprio attraverso la mediazione di
Bayle, fino a spiegare e a rendere più specifica la scelta –tutt’altro che casuale– che Leopardi fa del pensatore aristotelico di Lampsaco. Anzi, per via di
Bayle, sarà proprio Spinoza ateo a giocare il ruolo dell’agnus dei qui tollis
peccata mundi, attirando sopra di se gli strali degli apologisti, dei controversisti e provvidenzialisti dell’età dei lumi. Infine, la configurazione definitiva
dello stratonismo, presentato nel Frammento apocrifo come sistema di
Stratone, sarà quella di “una forma di materialismo alternativa all’epicureismo, anche perché connessa a una prospettiva plenista piuttosto che vacuista”20. Lo scarso peso che la critica ha voluto dare a Timpanaro studioso di
filosofia, ha fatto sì che non si aprisse su questo importantissimo argomento
alcuna discussione. Il solo Cristofolini, ch’io sappia, ha colto molto puntualmente questa che egli chiama «non rimeditata immagine tardo romantica dell’autore dell’Etica», anche se non l’ha connessa, come effettivamente andava (a mio parere) con lo stratonismo. Ma acutamente nota:
In realtà, la storia complessa del materialismo sei-settecentesco annovera
lo spinozismo tra gli elementi che consentono di superare il meccanicismo,
accanto all’influsso di Toland e di Leibniz; ma non verso il pampsichismo
–come forse era parso al nostro– ma verso gli svilippi della chimica e della
visione eterogenea della natura così come si ritrova dapprima nei manoscritti
clandestini (ad es. Dissertation sur la formation du mond, citato da Bloch) e
quindi in Diderot e D’Holbach22.
Oltre, tuttavia, questa messa a punto di carattere storico, resta l’intensa
attenzione di Timpanaro per le scienze biologiche in particolare. Lo ha fatto
notare ancora il Cristofolini che, come altri amici, ha raccolto confessioni personali dello studioso. Era, quella delle scienze,
passione antica perché […] prima di dedicarsi, giovanissimo, alla filologia Sebastiano
aveva pensato di intraprendere gli studi universitari in tutt’altro settore, quello delle
scienze biologiche e in particolare della zoologia. E parlo di passione costante perché
il suo interesse per il mondo animale ha fatto sempre da sostrato a tutto il suo studio
attorno alle vicissitudini storiche, sociali, culturali dell’animale-uomo23.
Ma, come avveniva per tutte le sue propensioni, tale passione si vestiva di
rigore razionale, si inseriva nel quadro mai dimenticato della sua
Weltanschauung, sia che leggesse Leopardi o che seguisse, con ansiosa
attenzione, gli sviluppi delle scienze e le loro applicazioni tecnologiche, sia che
riflettesse sui disastri ecologici o che analizzasse le proposte di ispirazione
marxista in proposito.
Il suo amico e compagno di dialoghi sulla scienza, il genetista Marcello
Buiatti, titolare della cattedra di genetica nella Università di Firenze, lamenta che
oggi “non si discute […] della scienza, quella vera, del pensiero e delle teorie,
anche se, basata sui dati sperimentali, sta dimostrando con chiarezza che la vita
è senz’altro materiale ma tutto meno che meccanica” e arriva a riproprre l’obsoleto volume timpanarano Sul materialismo ai suoi colleghi scienziati, per ricordare quel che l’insigne filologo scomparso aveva ribadito, inascoltato, all’umanità
ridanciana e programmata che sciama nelle nostre città distratte e caotiche:
L’uomo come essere biologico, dotato di una certa (non illimitata) adattabilità
all’ambiente esterno, dotato di certi impulsi all’attività e al raggiungimernto della
felicità, soggetto a vecchiezza e morte, non è una costruzione astratta e non è
nemmeno un nostro antenato presitorico, una specie di pitecantropo ormai superato dall’uomo storico-sociale, ma esiste tutt’ora in ciasuno di noi24.
Ma proprio in quelle sue prime considerazioni, Timpanaro discuteva del
ruolo del biologico nella vita dell’uomo, contro il “grottesco semplicismo” non
NOTTE
Gli è mancato l’artiglio del filologo per vedere in Spinoza il senso anti-teologico
della negazione dell’opposizione tra libertà e necessità, e della libertà come realizzazioine della natura umana; per vedere la critica serrata dei miracoli nel
Trattato Teologico-politico, che attrasse l’attenzione di Marx, e la distruzione del
teleologismo e del provvidenzialismo nell’appendice alla parte prima dell’Etica,
testo che ispirò potentemente tanta parte del pensiero libertino e illuministico del
Settecento francese 21.
101
soltanto della scuola lombrosiana e del razzismo montante nella cultura borghese europea, ma anche contro le conclusioni semplicistiche divenute voga
di marxismi di varia disponoibilità socio-umanistica, volte a ricondurre tale
sostrato materiale di verità a sovrastruttura e, infine, contro le tradizionali sempre risorgenti soluzioni spiritualistiche tout-court. Finemente concludeva:
L’interesse per la matematica o per la fisica o per la fisiologia, certo, non sorge se
non in un determinato ambiente sociale; l’adozione di determinate tecniche di
ricerca non è pensabile se non in una determinata società; […] Ma i risultati di verità obbiettiva a cui le scienze sono pervenute già nelle società presocialistiche […]
non sono risolvibili in termini di ideologia schiavistica o feudale o borghese […]
Filosofia, scienza, arte non traggono stimolo e alimento solo dal terreno artificiale
della società, ma anche dal terreno naturale25.
102
Non solo l’idealismo tende a svilire il portato di verità obbiettivo delle scoperte naturalistiche, anche il marxismo finisce, paradossalmente, per svolgere
“un’azione antimaterialitica e antropocentrica”; almeno laddove trasferisce arbitrariamente il concetto di sovrastruttura dalla critica della religione e del diritto,
dove originariamente era nata, alla “conoscenza scientifica”26. Conoscitore
attento dell’Ottocento, critica il positivismo con una articolata attenzione che non
si riscontra in storici della filosofia professionali. Sul rapporto tra condizioni patologiche e conoscenza, tra temperamento nervoso e poesia, ben consapevole
degli appiattimenti ed eccessi di molti positivisti (malauguratamente sperimentatosi sul pensiero e l’arte del Leopardi stesso), osserva:
L’esperienza della propria malattia e debolezza, se non dà luogo ad evasioni nella irrazionalità e nel misticismo, può aiutare a capir meglio l’ “aspetto
passivo” del rapporto uomo-natura, così come l’esperienza della povertàe
dello sfruttamento può aiutare a capire gli aspetti negatividi un sistema economico-sociale […] la considerazione del rapporto uomo-natura può molto
contribuire alla spiegazione di quei contrasti tra involuzione ideologica e progresso poeticoche riscontriamo per esempio in alcune poesie dell’ultimo
Parini o dell’ultimo Carducci27.
La sua preoccupazione, direi quasi costante, è che il cammino delle
scienze non resti isolato come un fenomeno a parte; e che le scoperte nel
campo delle scienze della vita, come in quello delle scienze fisico matematiche, non vengano spiegate arbitrariamente con criteri estranei, desunti dall’antropologia come dalle scienze dell’uomo, dalla linguistica come dalla filologia usate in chiave antirealistica e irrazionalistica 28. Non è il suo indugio su
Darwin, sul vero o falso evoluzionismo , su Mendel, sulle connessioni tra
modelli fisico-matematici e astrazioni platonizzanti, un attardarsi erudito o
deviare dallo studio precipuo e, direi, professionale, della linguistica o della
letteratura. Egli storicizza e penetra nelle scelte epistemologiche che sono
alla base di determinati statuti disciplinari, come la linguistica, appunto, l’antropologia e la psicologia, per demistificarne affrettate o ideologiche conclusioni conoscitive: quelle soprattutto che finirebbero per svuotare il processo
scientifico della sua razionalità, consegnadolo a finalità di platonica evanescenza ad esso estranee. Dalla scoperta della storicità della natura, com-
3. La sua critica si esercitava, anche e con profondità, non soltanto alle
forme scoperte di antimaterialismo o di spiritualismo scontato, quanto ad
alcuni aspetti classici del materialismo, soprattutto a quelli connessi con altre
forme ideologiche. Non fu molto tenero neppure con il positivismo e lo scientismo; e non sempre, nei nostri scambi d’opinioni, si mostrò convinto del mio
tentativo di riportare sul sentiero della razionalità autori come Arturo Graf e
Giuseppe Rensi, dei quali gli dava fastidio (soprattutto nel primo) il tentativo
di conciliare scienza, razionalità logica con aspirazioni romantiche o vagamente misticheggianti. Io insistevo sulla loro difficile e complessa condizione
storia; la loro mi pareva una condizione improba e, comunque, degna di
essere riguardata con maggior simpatia. Anche con il cosiddetto materialismo volgare di Moleschott, Büchner e Vog, il nostro agguerrito filologo non
mostrò molta indulgenza. A me, che fino ai primi anni Settanta sembrava di
dover condividere tutte le sue scelte, non pareva si dovesse concludere, su
Büchner in modo particolare, come aveva fatto lui in Sul materialismo, collocandolo definitivamente tra i materialisti soddisfatti. Mi era rimasta impressa,
nella lettura di Kraft und Stoff, proprio la vena pessimistica che seguiva la
smitizzazione della condizione umana e la caduta definitiva dell’antropocentrismo, prima ancora dell’affermarsi della teoria darwiniana della selezione
delle specie viventi. Ed ero arrivato a criticare la drastica posizione dell’amico maestro in una modesta rassegna degli studi sul materialismo ottocentesco di cui gli avevo mandato in lettura il dattiloscritto, come spesso solevo
fare con lui per le cose da pubblicare, accompagnandolo con una lettera, il 4
marzo del 1984. N’ebbi risposta il 14 aprile
Anche se nel giudizio sul positivismo italiano e specialmente su singole personalità di quel periodo rimarrà, forse, tra di noi un lieve dissenso, mi sento tuttavia fondamentalmente d’accordo con quanto mi scrivi e vai scrivendo. Non
ignoro d’altronde, che in questo campo […] su vari punti io posso avere errato.
Per es., tu avrai ragione di non accettare l’immagine di Büchner come materialista soddisfatto. Quando scrissi quella frase la mia lettura di Kraft und Stoff
risaliva a molti anni addietro; una lettura più attenta (come dimostrano anche le
citazioni della tua lettera) dovrà con tutta probabilità indurre anche me a modificare quel giudizio.
NOTTE
piuta nella seconda metà del XIX secolo dall’evoluzionismo geologico e biologico, si passa, alla fine del secolo, ad una perdita di prestigio delle scienze biologiche che lasciano il predominio a quelle fisico-matematiche: “che
impongono modelli epistemologici empirico-pragmatisti (l’esperienza come
produzione di fenomeni) o platonizzanti (sganciamento della teoria dall’esperienza)”. Sempre in nome della scienza si avallano scelte gnoseologiche che sembrano portare difilato agli storicismi e neoidealismi dei primi del
Novecento. La maggior parte degli scienziati, dalla parte dello storicismo o
da quella dell’epistemologia, concordano nel condannare o escludere il
materialismo: in un caso come corruttore della scienza (scientismo); nell’altro come definitivamente confutato dalla scienza stessa (moderna epistemologia)29.
103
Trovavo addirittura in un passo di Büchner una consonanza con il suo
Leopardi e non se ne meravigliò. Gli scrivevo:
se la smitizzazione della umana condizione porta “l’affiorare di motivi pessimistici”,
non è [forse] smitizzazione in Büchner, là dove scrive contro l’antropocentrismo,
contro l’idea della centralità dell’uomo nella natura, tanto da far pensare anche a…
Leopardi? Trovo anche accenti che germogliano da una stessa condizione mentale; trovo un vigliaccamente (in B., Forza e materia, trad. Stefanoni, pp. 35-36) e l’orgoglio di avere “confessato sempre la verità”, che mi ricanta… “vigliaccamente
rivolgesti al lume”; “nulla al ver detraendo, confessa il mal…”, ecc..
Del resto in quella rassegna io presentavo il materialismo di Timpanaro
come “il primo tentativo storiograficamente innovatore […] un discorso che, se
per primi coinvolgeva i marxisti, aveva un respiro e una portata ancor più vasta,
tanto da recuperare entro la tradizione della cultura nazionale […] l’originalissimo materialismo leopardiano”. Per quanto concerneva il materialismo ottocentesco, precisavo:
104
Timpanaro, oltre a riportare Engels entro la tradizione del marxismo occidentale,
conduceva parallelamente una lotta contro gli interpreti francofortesi di Marx, gli
strutturalisti e i loro successori, e tutti gli svariati tentativi di dialogo tra psicanalisi e
marxismo: difendendo una rigorosa e coerente linea materialistica entro una profonda adesione al marxismo. Preso atto dei limiti storici dello scientismo di un
Moleschott e di un Büchner, egli sottolineava con forza che “il loro materialismo
aveva più legami con le scienze della natura di quanti ne avesse il cosiddetto materialismo (in realtà, piuttosto umanesimo naturalistico) di Feuerbach”; e ribadiva severamente che la “risposta” alle storture ed agli immediati collegamenti tra il biologico
e lo storico, “doveva esser data all’interno del materialismo: non come semplice
rivendicazione dell’elemento soggettivo, concepito ancora spiritualisticamente30.
Infine, motivavo il mio dissenso dalla sua svalutazione di Büchner, ricordandogli un passo di Forza e materia che, a ripensarci, lo toccò molto, tanto da
prevedere addirittura di cambiar parere sull’argomento –come del resto mi
aveva dichiarato apertamente nella lettera sopra ricordata:
triste attestato di povertà che dà a se medesima la superbia dell’uomo! Dall’un lato
aspira al cielo e ritiene se stesso (tanto si crede privilegiato per il suo spirito!) per
un non so che di superiore a tutta quanta la natura, nel mentre dall’altro si degrada a tal segno da rinnegare la forza di pensare di quello stesso spirito, e da mettere la ragione, suo massimo tesoro, sotto i precetti di assurde dottrine31.
Alla base della sua riserva nel valutare il materialismo ottocentesco, c’era
una ben più che ponderata conoscenza del materialismo settecentesco e delle
ragioni storiche e sociali che avevano, dopo la rivoluzione francese, determinato il cambiamento di rotta degli inettellettuali e, più in particolare, la maniera di
rapportarsi ai problemi della scienza, nonostante il secondo Ottocento si arricchisse di fondamentali contributi all’avanzamento delle discipline scientifiche e
sperimentali (Bernard, Helmoltz, Liebig, Darwin, ecc.). Il suo saggio su Giacomo
Lignana resta fondamentale sulla questione dello stretto nesso che lega linguistica e biologia; ma la sola menzione analitica di quel ricco lavoro, anche per le
Gli studi linguistici lo attraggono in quanto terreno per verificare la loro capacità
maggiore o minore di lumeggiare questa realtà intermedia che è il linguaggio, che
gli appare (ed è) radicata nella biologicità e animalità degli esseri umani e nella
loro storicità. L’avversione per l’idealismo, specie nella versione italiana marcatamente antinaturalistica e antiscientifica, sempre di più nella sua ricerca e riflessione si richiama a motivazioni profonde e unitarie che lo portano a rigettare ogni
sospetto riduzionismo biologistico e naturalistico, anche quando egli riconosca la
positività di istanze scientifiche implicate nel riduzionismo33.
Ma alla base della sua riflessioni sulla natura e sull’uomo restano le scienze biologiche. Anche nel confrontare altri criteri di valutazione antropologica,
come quelli tratti dalla psicologia e dalla psichiatria, la neurofiosiologia e la biologia vengono sempre esplicitamente rimachiamate o sottese. Alle obbiezioni
di Giovanni Jervis, tra gli altri, che «crede ad una scienza moderna tutta antimaterialista», arricchendosi delle deduzioni di Vittorio Somenzi su materialismo e cibernetica, e ricordando le osservazioni di Massimo Aloisi sul rapporto
tra conoscenza e processi biologici, invitava a
studiare sempre più a fondo l’influsso dell’ambiente sullo sviluppo e sulla patologia
del sistema nervoso, [ribadendo] che la spiegazione del processo conoscitivo in
quanto tale sia di pertinenza della neurofisiologia, perché quello che sente e pensa,
che prende conoscenza della realtà esterna e reagisce ad essa, non è un mitico
spirito e nemmeno un non meglio precisato “spirito sociale”, ma è il cervello.34
Tutt’altro che materialista volgare, questo gentile e schivo pensatore ha percorso un cammino molto più lungo e vario della sua stessa riservatissima vita,
tessendo dietro di se una tale fittissima trama di relazioni concettuali che sarà
compito improbo della storiografia sbrigliare e contessere a sempre nuovi orditi e percorsi ideali, chissà per quanti anni ancora.
NOTTE
notevoli implicazioni nel campo epistemologico, richiederebbe un lavoro specifico a parte32. Esso è comunque un importante momento dello sfondo teorico su
cui si fonda il suo interesse per la linguistica. Come ha ben saputo intendere De
Mauro, “la lingua è vista da lui, ben prima della moda biologizzante di anni successivi, più recenti, come un istituto biologico-sociale: le spinte animali alla
comunicazione si incanalano nella formazione di forme strutturate dotate di una
valenza culturale storicamente peculiare, frutto di un lavoro collettivo”. Non si
tratta del piacere dell’erudito di andare spigolando tra figure minori per portare
alla luce aspetti e problemi trascurati e, in definitiva, secondari. Egli si porta
sempre alle ragioni delle scelte e dei rifiuti, indaga le origini dei ritardi della
nostra cultura, non per pura erudizione; sicché l’antidealismo, l’opzione materialistica, l’inchiesta storiografica minuta, con cui si accosta alla linguistica e alle
scienze della natura diventano «un territorio di frontiera privilegiato in cui la
razionalità scientifica è messa alla prova nell’intendere i fenomeni del mondo
umano». Ben lo sa Tullio De Mauro a cui lascio la parola:
105
APPENDICE
DUE LETTERE DI TIMPANARO A DE LIGUORI
106
Sebastiano Timpanaro tenne coi suoi numerosi corrispondenti quella cattedra universitaria che, schivo e appartato, o per voler o per fortuna, gli fu negata. Di lui conservo
57 lettere, tutte da Firenze, e vanno dal 4 febbraio del 1970 all’11 dicembre del 1999, a
un anno dalla sua scomparsa. Copia ne ho fatta alla vedova, dott. Maria Augusta Morelli
Timpanaro, che le consegnerà per la loro definitiva conservazione alla Biblioteca della
Scuola Normale Superiore di Pisa, dove, con il ricchissimo carteggio, si trova la sua
biblioteca. Undici di quelle sono già in corso di stampa, per cura di Michele Feo, che le
pubblica, assieme ad altre dello stesso a Giuseppe Anceschi e a Gian Paolo Marchi, sulla
rivista «Il Ponte», LIX, 2003.
Nella lettera del 1 febbraio dell’81, dopo avermi espresso il suo parere sul dattiloscritto del mio saggio (poi pubblicato col titolo, Leopardi e i gesuiti. Appunti per la storia della censura leopardiana, sulla “Rassegna della letteratura italiana”, diretta da
Walter Binni, a.85, n° 1-2, gennaio-agosto 1981, pp. 171-189) mi specifica il suo giudizio sulla incomprensione di Leopardi da parte di Gramsci e mi suggerisce alcune correzioni. L’Anglani di cui si parla, è il prof. Bartolo Anglani, ora ordinario di letterature
comparate nell’Università di Bari e studioso del Goldoni del Baretti, di Rousseau, dei
fratelli Verri e, più in generale, del Settecento italiano e francese. Umbero Carpi è il noto
storico della letteratura italiana, già ordinario a Pisa e autore del volume Il poeta e la
politica, cui il mio interlocutore si riferisce. La recensione al volume del Botti ricordo di
averla scritta e sottoposta al giudizio di Carlo Alberto Madrignani, ordinario di letteratura italiana a Pisa, ma non dove uscì o se uscì. Il documentario cui allude T., girato in
super-8 sonoro, riguardava un’esperienza didattica fatta con gli alunni di una IV del
Liceo scientifico sul tema della rivoluzione scientifica tra i secoli XVI e XVII.
L’eperienza venne discussa, tra gli altri storici della scienza e pedagogisti, da L.
Lombardo Radice su “Riforma della Scuola”, Taccuino, a. 26, aprile 1980, pp. 26-27.
Nella seconda lettera del 1 giugno 1982, del tutto manoscritta, discute il mio saggio,
La condizione del senso. Per un riconsiderazione della lettura grafiana di Leopardi
(1890-1898), in «La Rassegna della letteratura italiana», a. 87, n°1-2, gennaio-agosto
1983, pp. 125-161. I riferimenti sono agli studi leopardiani di Arturo Graf (raccolti poi
in vol., A.Graf, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Chiantore, Torino, nuova ristampa 1955)
da me presi in considerazione nel saggio sul cui contenuto Timpanaro esprime lealmente notevoli punti di dissenso. Per il riferimento a Galvano Della Volpe, vedi, Crisi dell’estetica romantica, Samonà e Savelli, Roma 1968, pp. 9; 14-15, citato alle pp.135-36
del mio saggio
Ambedue le lettere vengono qui presentate come documenti d’epoca e, come tali,
vanno storicizzati e contestualizzati i giudizi e le valutazioni su uomini e situazioni in
esse pronunciate. Di qualche cenno a questioni personali ritengo non valga la pena dare
più espliciti chiarimenti.
I
Carissimo Girolamo,
sto per partire per Roma (vado a vedere qualcosa nelle biblioteche romane, poiché quelle fiorentine, malgrado la loro fama, vanno sempre peggio per mancanza di acquisti di
nuovi libri e per furti e dispersioni di vecchi libri). È sabato pomeriggio e gli uffici postali sono chiusi, cosicché devo rimandare la spedizione del tuo dattiloscritto leopardiano a
quando ritornerò da Roma (cioè alla fine della prossima settimana). E devo anche rimandare di una settimana la lettura del tuo Graf e così pure una risposta più ampia alle tue
due lettere. Ora, in breve ti dico ciò che –come mi sembra di capire– hai più fretta di
sapere cioè il mio parere su Leopardi e i gesuiti. Ebbene: è un saggio eccellente, sia perché ricostruisce tutta una vicenda che io (e non solo io, probabilmente) ignoravo quasi
del tutto, sia per l’acutezza esemplare con cui tu, nello stesso tempo, conduci una coraggiosa battaglia politico-culturale (una battaglia non solo antigesuitica, ma anche contro
tutto ciò che di gesuitico è filtrato nella cultura borghese del Novecento, anche in quella che si è creduta laica) e valuti nel suo giusto peso (come bisogna fare anche coi nemici, non solo per spirito di imparzialità storica ma anche perché i nemici possono essere
efficacemente combattuti solo se non li sottovalutiamo) l’abilità e l’intelligenza dell’antileopardismo gesuitico nelle sue varie fasi.. Mi dispiace molto di non fare più in tempo
a citare questo tuo saggio in un volume di prossima pubblicazione presso Nistri-Lischi,
Aspetti e figure della cultura ottocentesca: lì ripubblico fra l’altro un mio vecchio articolo su alcune falsificazioni di scritti leopardiani perpretate nel 1898 in ambienti clericali (non, però, specificamente gesuitici, per quel che mi risulta). Ma purtroppo il volume è già in stampa e non sono più in tempo nemmeno ad aggiungere un richiamo al tuo
saggio sulle bozze.
Osservazioni? Una sola, della cui giustezza, del resto, non sono ancora sicuro. Io
credo che Gramsci, per il quale ho sempre avuto un’ammirazione che non è mai venuta
e non verrà mai meno, riguardo al Leopardi sia stato troppo influenzato dal crocianesimo (in misura assai minore dal De Sanctis) e non sia mai veramente arrivato a comprenderlo. Quando leggo nei Quaderni del carcere (ed. Gerratana, II, p.1187) che Goethe
“esprime in forma serena e classica ciò che nel Leopardi, per es., è ancora torbido romanticismo”, e che la natura va vista “non come nemica e antagonosta ma come una forma
da conoscere e dominare” (come se l’uomo, così fragile e così “periferico” nel cosmo,
potesse illudersi di arrivare a “dominarlo” tutto!) oppure quando leggo (vol. cit., p. 1335
sg.) sempre in polemica col Leopardi, enunciata una concezione del “progresso” che
mette sullo stesso piano i mali sociali e quelli “fisici” ed è irrimediabilmente inficiata di
antropocentrismo, di insensato orgogoglio nel “potere dominatore” dell’umanità, devo
pur concludere che Gramsci capì ben poco sia della poesia leopardiana (“torbido romanticismo”??!), sia del pensiero leopardianao. Per ciò che riguarda il rapporto uomo-natura, Gramsci rimase sostanzialmente un idealista. Credeva, al pari di Croce, che il lunghissimo periodo anteriore alla comparsa dell’uomo sulla terra, e così pure la futura
scomparsa della specie Homo sapiens, fossero fantasticherie del “materialismo volgare”.
Eppure un Engels e un Lenin avevano avuto ben altra chiarezza d’idee su questi problemi: non erano giunti al pessimismo come Leopardi, ma avevano capito il carattere arretrato e, in sostanza, irrazionale e irreligioso di ogni antropocentrismo (teocentrismo e
antropocentrismo sono tutte e due concezioni religiose): possiamo preferire la seconda,
NOTTE
[Dattiloscritta]
50122 – Firenze, 17 maggio 1980
via Ricasoli, 31
107
108
ma, se siamo laici e materialisti conseguenti, come Gramsci non fu, dobbiamo respingerle entrambe). So bene che altrove Gramsci accenna a Leopardi con maggiore comprensione; ma è sempre una comprensione molto limitata. Nulla di paragonabile all’acutezza delle osservazioni di Gramsci sui Promessi sposi!
Due correzioni insignificanti di errori di battitura a macchina: a p. 6, poco dopo l’inizio del 1° capoverso, “Luigi La Vista” va corretto, ovviamente, in “Luigi La Via”; e nella
citazione desanctisiana contenuta nella nota 11, “confortatore e combattente” va corretto in “confortatore e combattitore”.
Sarò molto lieto se Anglani e Carpi riusciranno a collocare l’articolo nel “Giornale
storico”. Ho, lo confesso, il timore che Carpi (valente ricercatore e studioso dei moderati toscani, ma totalmente incapace di capire alcunché del Leopardi) trovi il tuo articolo
troppo filoleopardiano, e forse per questo Anglani ti ha consigliato di attenuare certe
punte polemiche. Fammi sapere poi come è andata. Io purtroppo, almeno per ora, non
saprei trovare altra collocazione ad un articolo che, ripeto, considero assolutamente ottimo. Un articolo di questo genere andrebbe benissimo per “Belfagor”; ma tu ricordi come
si comportò quella volta Carlo Ferdinando Russo; ed io, benché amico personalmente di
Russo, non ho alcun potere di influenzare i suoi giudizi e pregiudizi.
Leggerò ora il Graf, e poi scriverò a Binni. Non dubito che anche il Graf sia eccellente.
Mi dispiace moltissimo che sia andata perduta la tua precedente lettera. Dapprima
avevo pensato a una mia amnesia, ma, ora che me ne riferisci il conmtenuto, sono sicuro che non l’ho mai ricevuta. E capisco che era una lettera importante. Sono dolente della
tua amarezza e della tua preoccupazione per tuo fratello: quando finirà questa sciagurata follia del terrorismo? Sono anche molto addolorato della morte di Glauco Viazzi, di
cui nonb avevo saputo nulla. Dell’editore Salerno non ho mai veduto alcuna pubblicazione, che io ricordi. Di F. P. Botti lessi tempo fa un articolo sulla Ginestra che non mi
piacque, e qualche altro articolo su Leopardi che mi sembrò un po’ migliore; ora leggerò La nobiltà del poeta, e, naturalmente, la tua recensione. La notizia del documentario
che stai girando suscita la mia ammirazione per la tua versalità e ampiezza di interessi.
Scusa la telegraficità di tutte queste risposte. Al mio ritorno da Roma, ripeto, ti riscriverò con più calma, ti rimanderò i dattiloscritti e farò anche (ma con scarsa fiducia) ricerche e reclami presso le poste di Firenze per il plico andato perduto.
Un abbraccio affettuoso dal tuo, Sebastiano.
II
[Manoscritta]
Firenze, 1, VI, ‘82
Via Ricasoli, 31
Carissimo Girolamo,
innanzi tutto esprimo i più vivi auguri per la completa guarigione di tuo padre. Spero,
anzi, che i miei Auguri siano ormai superflui e che tuo padre sia del tutto ristabilito in
salute. So bene quanto sia tormentosa l’ansia per la salute dei propri cari.
Ho letto col più vivo interesse il tuo saggio. Che sia un saggio pieno di intelligenza
e di cultura vastissima, è fuori di dubbio, e del resto lo sapevo già prima di leggerlo. Ti
confesso tuttavia che, forse per la prima volta da quando leggo cose tue, mi sento non
del tutto concorde, ma del tutto consenziente per un verso, alquanto dubbioso per un
te speranze, scriverò a Binni.
Arrivederci a Firenze. Tuo
Sebastiano
1
Per una più completa ricognizione bibliografica dell’opera di Timpanaro, ma anche per
molte testimonianze su di lui, si rimanda a M. FEO (a cura di), L’opera di Sebastiano Timpanaro
(1923-2000), “Il Ponte”, suppl. al n° 10-11, ott.-nov. 2001, bibliografia che segue il fasc. della
riv. a. LVII, n° speciale 10-11, ott.-nov. 2001, Per Sebastiano Timpanaro, con vari contributi,
testimonianze ed inediti. Una integrazione bibliografica, curata sempre dal Feo, è nel vol. cit.,
Il filologo materialista, pp. 191-293. Una accurata bibliografia, curata in prima stesura dall’autore, sta preparando per la stampa Emanuele Narducci. Delle opere di Timpanaro, qui ricordiamo soltanto: La filologia di G. Leopardi , Le Monnier, Firenze 1955 (Laterza 1977; 3° ed. riv. ivi,
UL, 1997); La genesi del metodo di Lachmann , Le Monnier, Firenze 1963 (nuova ed. Liviana,
Padova 1981); Classicimo e illuminismo nell’Ottocento europeo , Nistri Lischi, Pisa, 1965 (2°ed.
NOTTE
altro. Consento pienamente ogni volta che Girolamo de Liguori, mettendo Graf un po’
da parte, parla, in persona propria, di Leopardi, o dell’andamento degli studi recenti sul
Leopardi. Ciò si verifica molte volte, e in questo caso le tue osservazioni sono sempre
originali, illuminanti, piene di spunti nuovi. Fra l’altro hai avuto il merito di rivalutare (e
di sviluppare originalmente) quel bellissimo passo di Della Volpe, sul quale io non mi
ero mai soffermato –e credo che non vi si sia soffermato nessuno o quasi–. In breve,
dico: “Via ancora una volta il de Liguori leopardista!”
Più perplesso sono sulla rivalutazione di Graf critico del Leopardi. Tu, certo, hai
messo in opera tutta la tua inmtelligenza per ricavare dal Graf leopardista tutto quello che
si può e altro ancora: mi hai fatto venire in mente certi insigni direttori d’orchestra (come
fu Toscanini) che riescono a far figurare eccezionalmente anche un pezzo di musica
mediocre. Ma tutte le volte che, invece di parlare tu, riferisci brani del Graf, avverto come
una caduta. Capisco che bisogna tener conto della mancata conoscenza dello Zibaldone.
Ma non mi sembra che in Graf ci sia un vero superamento della critica positivistica sul
leopardi: c’è piuttosto un oscillare tra positivismo e romanticismo. L’aspetto materialistico-edonistico, la matrice settecentesca del pensiero leopardiano appare quasi assente; e
invece, tutto un profluvio Schopenhauer, di Hartmann, di Fechner, di chi più ne ha più ne
metta. Tu dici: cita questi signori proprio per far risltare la differenza del Leopardi; eppure a me non sembra che la differenza risaltinella misura dovuta, proprio perché il pessimismo di Graf stesso era troppo tardo-ottocentesco e, in definitiva, poco leopardiano.
Ora tu mi dirai: “Bravo! Fai tanto il mangiapreti, e poi finisci col dar ragione al giudizio dei gesuiti”. I gesuiti (tu lo hai dimostrato meglio di ogni altro a proposito del
Leopardi) erano farabutti ma non stupidi; il carattere caotico del saggio di Graf, a mio
avviso, lo scorsero giustamente. Solo che essi movevano da quella constatazione per
negare Leopardi o per falsificarlo a proprio usa e consumo; e quindi la loro critica era
bassamente strumentale. Del resto io credo tu abbia ragione nel difendere il saggio di
Graf dall’accusa di sfoggio di erudizione; non di questo si tratta ma, piuttosto, di un’intima irrequietessa tutta grafiana, di un cercare affannosamente la verità attraverso cento
filosofi e poeti. In questo senso il saggio su Leopardi ha il suo interesse e il suo pathos;
ma, come saggio sul Leopardi, temo sia fallito.
Scrivo tutto ciò con molti dubbi. Non dimentico che la mia troppo superficiale conoscenza di Graf può indurmi in errore. In ogni caso il tuo saggio è da pubblicare. Se fallissero i tentativi di cui mi parli (Leone de Castris […]) avvertimi e, pur senza mol
109
110
1969)¸ Sul Materialismo, Nistri Lischi, Pisa 1970 (2° ed. 1975, ed. inglese NLB, London 1975;
3° ed, Unicopoli, 1997); Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, La Nuova Italia,
Firenze 1974 (1975, trad. inglesi: 1975, 1976); Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, ETS, Pisa 1982; Giacomo Lignana e i rapporti tra filologia, filosofia, linguistica e darwinismo nell’Italia del secondo Ottocento , «Critica storica», XVI, 1979, pp. 406-503; Aspetti e
figure della cultura ottocentesca , Nistri-Lischi, Pisa 1980; Il socialismo di E. De Amicis,. Lettura
del “Primo Maggio”, Bertani, Verona 1984; Nuovi studi sul nostro Ottocento, Nistri-Lischi, Pisa
1994.
2
La qualifica di dilettante, applicata ai suoi saggi filosofici, è dello stesso Timpanaro che, nel
poscritto ai suoi Nuovi studi sul nostro Ottocento, sopra già menzionato e pubblicato anche in
“Belfagor”, 1995, pp. 337-344, avverte con la sua solita sguarnita autoironia, “forse i filosofi dovrebbero saper trarre qualche utile spunto anche dai dilettanti”.
3
Di Timpanaro padre, vedi, le due antologie scientifiche, Galileo. Pagine di scienza,
Mondadori, Milano 1925; Leonardo. Pagine di scienza, Mondadori, Milano 1926 e soprattutto,
Scritti di storia e critica della scienza, a cura di S. Timpanaro junior, Sansoni, Firenze 1952, dove,
tra l’altro, è ripubblicata la risposta, relativa ai problemi della scienza, data a Piero Gobetti per la
sua inchiesta sull’idealismo, alla quale oltre al Timpanaro, parteciparono Santino Caramella,
Giuseppe Prezzolini, Rodolfo Mondolfo ed altri, già uscita nel “Baretti”, n° 15, novembre 1925, pp.
61 e sgg. Il breve ma interessante carteggio dello studioso con Piero Gobetti ha pubblicato Pietro
Polito, in “Mezzosecolo”, 10, 1993, pp.77-95.
4
S. TIMPANARO jr, Scienza e filosofia: “L’Arduo” (1914; 1921-1923), in AA. VV., Tradizione e
dissenso nelle riviste del primo ‘900, a cura di Mario Quaranta, Ediz. Sapere, Padova 1991, pp.
181-207. È merito di Fabio Minazzi l’avere richiamato l’attenzione su tale testo. Cfr. Scienza e
filosofia in Italia negli anni trenta, in, Il cono d’ombra, Marcos y Marcos, Milano 1991, pp. 117118. Ivi Timpanaro faceva notare che «l’ostilità verso la scienza –cioè verso un aspetto fondamentale della civiltà moderna senza di cui la stessa filosofia moderna non sarebbe mai nata–
aveva un carattere nettamente reazionario e rappresenta un passo indietro rispetto al pur inadeguato positivismo».
5
Vedi S. TIMPANARO, F. MINAZZI, Dialogo sul materialismo, “Marx centouno”, n°4, febbr. 1991,
pp. 99-112; poi nel vol. postumo, S. TIMPANARO, Il verde e il rosso. Scritti militanti, 1966-2000, a
cura di Luigi Cortesi, Odradek, Roma 2001, p. 210-11. Sull’attualismo che si fa religione, importanti considerazioni in A. Del Noce, Giovanni Gentile, vol. postumo, Il Mulino, Bologna 1990, dove si
legge: “Il tratto dunque specifico del suo pensiero è quello di una filosofia che si fa teologia”, p. 33
in particolare; ma vedi anche pp. 164 e sgg.
6
S. TIMPANARO, In margine alle “Cronache di filosofia italiana”, “Società”, n° 1, febbr. 1956, pp.
155 e sgg. Del Fano vedi, Neopositivismo, analisi del linguaggio e cibernetica, Einaudi, Torino
1968 ed ivi la sua bibliografia curata dal Timpanaro, pp. 163-167.
7
Dialogo sul materialismo, in Il verde e il rosso, cit., p. 209.
8
Op. cit., p. 210. Per il riferimento a Bayle, più approfondite considerazioni e richiamo di fonti
nel mio scritto, Il ritorno di Stratone.Per la collocazione del materialismo leopardiano nel pensiero
ottocentesco, in M. BISCUSO e F. GALLO, Leopardi antitaliano, Manifestolibri, Roma 1999, pp. 7198. Per un maggiore approfondimento e sviluppo della tesi timpnariana, ancora di scrive, Da
Teofrasto a Stratone. L’itinerario filosofico di Giacomo Leopardi, di prossima pubblicazione. A me
pare che l’opzione del materialismo ateo nel pensiero moderno, sollecitata dalla ricezione del pensiero classico (Lucrezio, Sesto Empirico, anche con la mediazione dei dossocrafi, Diogene e
Stobeo, ad es.) si sia consegnata per buona parte al pensiero libertino e dei manoscritti clandestini e da essi veicolato, loro malgrado, dai controversisti e apologisti della fede entro frange della
riflessione moderna tra Sette e Ottocento, pervenendo ai nostri giorni.
9
Op. cit., pp. 210-11. Per il riferimento a Labriola, cfr. A. LABRIOLA, La concezione materialistica della storia, a cura di E. Garin, Laterza, Bari 1965, p. 133; che Timpanaro aveva già discusso
in Considerazioni sul materialismo, dapprima in “Quaderni piacentini” del 1966, poi in Sul materialismo, terza ed. cit., pp. 21-22. Di Gramsci, cfr. Quaderni dal carcere, a cura di Valentino
Gerratana, Einaudi, Torino 1975, vol. III, pp. 1874-79.
10
Un confronto tra le posizioni di Timpanaro e di Geymonat ho provato a stabilire in, Geymonat
e il materialismo «verso il basso», “Giornale cr. della fil. It.”, fasc. III, 2003, pp. 484-498; in specie,
pp. 491-98. Ma su Geymonat, più ampia e approfondita analisi in F. MINAZZI, La passione della
NOTTE
ragione. Studi sul pensiero di Ludovico Geymonat, Thélema edizioni, Milano 2001, con pertinenti
riferimenti a Timpanaro.
11
Dialogo sul materialismo, cit., ivi.
12
Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, ETS, Pisa 1982, p. 173. Per il riferimento a Geymonat, mi permetto rinviare al mio, Geymonat e il “materialismo verso il basso”, cit.
13
Finemente ha colto questo punto, L. BLASUCCI, Gli studi leopardiani di Timpanaro, in Il filologo materialista, cit, pp. 107-108.
14
Cfr. Il lapsus freudiano, cit., 1975, p. 70. Bene imposta ed esamina la posizione timpanariana di fronte alla psicanalisi, G. CORLITO, Timpanaro e la psicanalisi, nel n° speciale di “Allegoria”,
cit. pp. 52-72; autore anche di un precedente intervento, Sebastiano Timpanaro e le ragioni del
materialismo, ivi, IX, 27, 1997, pp. 112-122. Del nostro vedi anche, La “fobia romana” e altri scritti su Freud e Meringer, ETS, Pisa 1992.
15
Su questo punto molto bene, R. CASTELLANA, Timpanaro e l’etica del saggio, “Allegoria”, n°
speciale cit., pp. 41 e sgg.
16
Il lapsus, cit., p. 164.
17
Così nella sua postfazione, per così dire, all’op. cit. pp. 200-201. Nella sua recensione al
Lapsus, C.A. MADRIGNANI, Filologia e/o psicanalisi, “Belfagor”, 1973, pp. 505-516, propone “di
vedere in Freud un gestore non decadente del decadentismo”; ma l’antinomia tra scientificità e
ideologia, individuata da Timpanaro, resta autentica.
18
Si ricordi, a tal proposito, Lo strutturalismo e i suoi successori, in, Il materialismo, ed. cit.
pp.105 e sgg.
19
Antimo Negri, trad. it. del Sistema della natura, Utet, Torino 1978, p. 41; C. STANCATI, Letture
di D’Holbach in Italia nel XIX secolo, “Giornale cr. della Fil. It.”, 1979, pp. 279-285. Su cui
Timpanaro, in P. TH. D’HOLBACH, Il buon senso, trad. it., introduzione e cura dello stesso, Garzanti,
Milano, pp. XXXIII-XXXIV in particolare.
20
Vedi su questo punto, e per i richiami nel testo, S. BROGI, Bayle in cerca di materialismo,
“Rivista di Filosofia”, n° 3, dic. 1998, p. 406-7, in partic.
21
P. CRISTOFOLINI, Materialismo e dolore. Appunti sul leopardismo filosofico di Sebastiano
Timpanaro, “Allegoria”, n° cit., p. 83 in particolare; il quale conclude il suo pregevole intervento
citando un poeta bengalese dell’Ottocento: “immagina quanto sarà terribile il giorno della tua
morte; gli altri continueranno a parlare e tu non potrai contraddirli”. Ma, caro Cristofolini, questo
nostro rimpianto non è che la prova storica che Sebastiano era un vero filosofo.
22
Non è possibile affrontare adeguatamente il problema in questa sede. Per una sintetica
esposizione della questione, si rimanda a, O. BLOCH, Il materialismo, trad. it., Marzorati, Milano
1990, pp. 77 e sgg.; cfr., ancora, per il riferimento a Leopardi ed alla critica di Timpanaro a Negri,
di chi scrive, Il ritorno di Stratone, in op. cit, pp. 91-94. Per il riferimento a Toland e a Leibniz, in
relazione alla vicenda dell’atomismo epicureo e dello stratonismo, vedi il densissimo studio di G.
PAGANINI, Tra Epicuro a Stratone: Byle e l’immagine di Epicuro dal Sei al Settecento, “Rivista crit.
di st. della fil.”, fasc. I, 1978, pp. 72-115; e, ancor prima, P. Casini, Toland e l’attività della materia,
«Riv. c. di st. d. f.», XXII, I, 1967, p. 24 e sgg.
23
P. CRISTOFOLINI, op. cit., p.75.
24
Sul Materialismo, I ed. cit., p. 22. Ma cfr. M. BUIATTI, Materialismo e marxismo, “Il Ponte”,
2001, cit., pp. 82-86.
25
Ivi, pp. 25 e sgg.
26
Ibidem e nota 16, in particolare
27
Op. cit., pp. 29-30, nota 21.
28
È il caso, tra i molti altri, di Lévi Strauss, su cui cfr. Lo strutturalismo e i suoi successori, in
Sul materialismo, cit. p. 170 e sgg. in particolare
29
Ivi, p. 138.
30
Cfr. di chi scrive, Materialismo e positivismo in Italia. Questioni di metodo, Annali della Fac.
di Lettere e filosofia dell’Univ. di Bari, XXVII, 1984, p.6 dell’estratto.
31
L. BÜCHNER, Forza e materia, trad. it. di Luigi Stefanoni, Brigola, Milano 1868, p. 25
32
Giacomo Lignana e i rapporti tra filologia, filosofia, linguistica e darwinismo nell’Italia del
secondo Ottocento,cit..
33
T. DE MAURO, Timpanaro e la linguistica, in, Il filologo materialista, cit., pp. 95-100 in particolare. Cfr. anche, S. TIMPANARO, Sul materialismo, ed. cit. 1975, pp. 1-33.
111
34
Sul materialismo, ed cit., pp. 38-39 ed ivi riferimenti testuali a Jervis e a Somenzi. Vedi anche
sulla questione, G. CORLITO, Sebastiano Timpanaro e le ragioni del materialismo, “Allegoria”, n° 27,
a. IX, sett.-dic., 1997, che, con buone ragioni, nota l’assenza in Timpanaro di riferimenti a Jaques
Monod, Il caso e la necessità, trad. it. Mondadori, Milano 1970. A me pare che anche la considerazione del processo storico della biologia molecolare, così come delineato da Fraçois Jacob, La
logia del vivente. Storia dell’ereditarietà, trad. it., Einaudi, Torino 1971, avrebbe fornito ulteriori supporti alle posizione timpanariane.
112
FERRUCCIO ROSSI-LANDI
E LA FILOSOFIA ANALITICA
Presso il Centro internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo di
Brugine (Padova) sono conservati i materiali autografi e la biblioteca personale di Ferruccio Rossi-Landi (1921-1985), che costituiscono il Fondo “Ferruccio
Rossi-Landi”, suddiviso in due sezioni principali: gli “Scritti autografi” e
l’“Epistolario”, e una sezione aggiuntiva intitolata “Materiali vari”. Degli scritti
autografi, che coprono un arco di tempo che va dagli anni Trenta fino all’aprile
del 1985, fanno parte manoscritti e dattiloscritti originali, bozze a stampa di articoli, saggi e volumi, dispense di corsi universitari, copie di lavoro di saggi e libri
editi, dattiloscritti di traduzioni in lingue estere di alcuni lavori del filosofo.
L’epistolario è composto di circa quattrocento cartelle di corrispondenza con
vari interlocutori italiani e stranieri, in parte ordinate alfabeticamente e in parte
radunate per argomenti. La sezione “Materiali vari” comprende invece i materiali riguardanti congressi e conferenze cui Rossi-Landi ha partecipato, i documenti concernenti i suoi rapporti con università e centri di ricerca, e varia corrispondenza.
Alcuni degli inediti custoditi nel Fondo sono stati pubblicati in un volume
dal titolo Scritti su Gilbert Ryle e la filosofia analitica, a cura di Cristina
Zorzella (Il Poligrafo, Padova 2003). Si tratta di otto testi che coprono il
decennio che va dal 1953 al 1963. I primi quattro costituiscono una sorta di
commentario a The Concepì of Mind di Gilbert Ryle, uscito nel 1949, mentre
gli altri quattro riguardano la nozione di ‘assurdo’; vi compaiono inoltre alcune Note che costituiscono una serrata critica al pensiero di Ryle a proposito
del metodo filosofico e della teoria della mente. Completa il volume una
sezione in cui sono raccolte alcune delle lettere che Rossi-Landi e Ryle si
scambiarono tra il 1950 e il 1961. “Alcune di queste –dice C. Zorzella–, scritte durante il soggiorno britannico di Rossi-Landi sono la testimonianza del
suo lavoro svolto a Oxford. L’interesse prevalente che ne emerge riguarda
soprattutto i problemi di ordine teorico e tecnico incontrati da Rossi-Landi
durante la traduzione del testo di Ryle. Non mancano, tuttavia, importanti
considerazioni sul clima filosofico italiano di quegli anni. E altrettanto interessanti sono le considerazioni del filosofo oxoniense su Rossi-Landi, sulla filosofia e sui filosofi italiani. Rossi-Landi viene descritto come uno dei pochi filosofi italiani interessati a comprendere la linea di ricerca intrapresa dalla filosofia oxoniense, quando gli intellettuali italiani sembravano piuttosto trarre
ispirazione, ancora, dalla filosofia tedesca di fine Ottocento. Emerge inoltre
la volontà di Rossi-Landi di dare inizio, in Italia, ad una ‘filosofia linguistica’
sulla scorta di quella oxoniense” (p. 193).
NOTTE
di Cosimo Caputo
113
114
A partire dal 1945 –come è noto– la cultura italiana conosce un processo
di ricostruzione che si intreccia con quello della ricostruzione economica e
sociale del Paese, un processo che vede l’allargamento degli orizzonti oltre i
confini nazionali, la formazione di una nuova coscienza del ruolo dell’intellettuale nella società, la ricerca di un sapere più positivo in polemica con la tradizione speculativa, accusata di essere una cultura di retroguardia, alleata della
reazione e della conservazione politica e sociale, o, quantomeno una cultura
consolatoria e di evasione. Uno spiritualismo retorico e pedagogico che aveva
caratterizzato gran parte della cultura post-unitaria, culminato nel trionfo del
Neoidealismo.
Ferruccio Rossi-Landi ha un preciso ruolo in questa programmatica apertura alle filosofie straniere che ha caratterizzato la filosofia italiana del secondo
dopoguerra.
La più avvertita e stimolante discussione filosofica di quegli anni, che
vede tra i protagonisti Ludovico Geymonat, Nicola Abbagnano, Norberto
Bobbio, Giulio Preti, è impegnata in un rinnovamento dei linguaggi e dei
metodi della ricerca filosofica e in un richiamo ad una più giusta considerazione delle scienze e del loro significato per l’uomo e la società. La filosofia
non può più svolgere discorsi aprioristici sui metodi della scienza, ma chiarire il significato, i limiti e il continuo sviluppo dei metodi in uso pressi i singoli ricercatori e ambiti di studio. La metodologia diventa il terreno privilegiato
per la riforma della filosofia e del sapere, assumendo così una funzione di
rottura e la capacità di superare l’unilateralismo e il conseguente dogmatismo dei punti di vista.
L’interesse verso il linguaggi e i metodi delle scienze è al centro della costituzione, nel gennaio 1948, del Centro di Studi Metodologici di Torino per iniziativa di Ludovico Geymonat e del matematico Eugenio Frola. Rossi-Landi partecipa alle attività del Centro promuovendo la pubblicazione di un volume di
saggi originali sul pensiero americano contemporaneo. L’iniziativa viene approvata in vista di un arricchimento della nostra letteratura scientifica e di una
intensificazione degli scambi culturali col mondo nord-americano.
Tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, dunque, all’attenzione,
in chiave anti-idealistica, per la Fenomenologia e l’Esistenzialismo, si unisce
l’attenzione per il pensiero anglosassone, considerato e apprezzato come
portatore di una filosofia non speculativa, attenta ai problemi della scienza,
del linguaggio scientifico e di quello ordinario. La filosofia italiana raccoglie
la sfida del metodo. Nascono in quegli anni le riviste Analisi (1945-46),
Sigma (1947), Methodos (1949); viene fondato a Milano il Centro italiano di
Metodologia e Analisi del Linguaggio, di cui fa parte Rossi-Landi insieme a
Somenzi, Ceccato, Bergman e altri. Sono gli anni durante i quali Rossi-Landi,
oltre alla filosofia analitica inglese, fa conoscere in Italia Charles Morris e la
sua semiotica, in una situazione di quasi totale incomprensione non solo dei
problemi affrontati ma anche del modo di affrontarli. Al contempo, però, questi suoi interessi non distolgono lo sguardo verso certe correnti della tradizione filosofica italiana.
Nell’introduzione alla 2ª edizione (1980) di Significato, comunicazione e
NOTTE
parlare comune, egli parla di un “patrimonio analitico”, con riferimento a
Cattaneo, Vailati, Calderoni, Enriques, Peano, Colorni, pressoché ignorato. E
nel 1984, nella sua relazione al Convegno dell’Associazione Internazionale
di Studi Semiotici tenutosi a Palermo (A Fragment in the History of Italian
Semiotics, trad. it. in Augusto Ponzio, Rossi-Landi e la filosofia del linguaggio, Adriatica, Bari 1988, pp. 243-261), si appella di nuovo a questa corrente minoritaria della cultura filosofica italiana, che attraverso Cattaneo fa risalire fino a Vico, nel tentativo di rintracciare una linea, anch’essa italiana, negli
sviluppi della filosofia del linguaggio e della semiotica. “Tutte queste persone –egli dice– hanno dato un contributo più o meno diretto alla preparazione
del terreno per una rinascita della semiotica italiana. E un po’ sorprende che
i semioticisti italiani contemporanei sembrano ignorare quanto devono loro”
(pp. 253-254).
Rossi-Landi in quegli anni scopre Giovanni Vailati (che per primo in Italia
aveva compreso l’importanza di Peirce e di Victoria Welby) e Mario Calderoni,
i quali si erano occupati di “questioni di parole” in modo rigoroso ma flessibile,
reagendo alle distinzioni troppo nette fra ciò che è degno di trattamento scientifico e ciò che non lo è. E di Vailati parla come di un ‘analista’ avant la lettre
per aver avviato “un’analisi filosofica del linguaggio in generale, particolareggiate analisi del linguaggio filosofico e spunti di indagini strutturalistiche” (Il
metodo della filosofia, Laterza, Bari 1967, p. 8; 1ª ediz. 1957; nuova ediz. a
cura di A. Ponzio, B.A. Graphis, Bari 2000).
“Questo lavoro di recupero della tradizione italiana –osserva Zorzella (p.
25)– doveva da un lato servire a legittimare l’ingresso della filosofia analitica in
Italia come insieme di tecniche rintracciabili anche nel nostro passato filosofico e dall’altro ad avvicinare la filosofia italiana a quella anglosassone per unirle sotto l’egida della filosofia analitica”. E tutto ciò –come scrive Rossi-Landi ne
Il mestiere del filosofo (Autografo, 1954-1959)– appoggiandosi “su di un concetto allargato di ‘analisi’” per superare i difetti dell’analisi ristretta, quale la “si
intende nel mondo anglosassone e specialmente negli Stati Uniti”, ossia il
“gusto dello strumento per lo strumento”, “la ristrettezza degli interessi storici e
morali”, l’incapacità di suscitare interesse “al di fuori del ristretto campo dei filosofi di professione” (cit. in Zorzella, ibidem).
Il filosofo non deve fare il lessicografo, o il filologo. “Mentre costoro si
volgono alle strutture linguistiche in atto, egli cerca di risalire alle matrici che
queste strutture hanno determinato”, scrive Rossi-Landi (p. 71). Il filosofo si
occupa del linguaggio nella sua globalità e non delle lingue. “Il punto cui
vogliamo giungere è questo. La parte più sana ed aperta della filosofia di
Oxford non è filologia, non si occupa delle parole in quanto tali, non mira a
compilare un gigantesco dizionario, ma […] raccoglie il patrimonio tradizionale dei problemi filosofici, con rinnovati metodi per risolverli. Essa prende
di petto il linguaggio in tutta la sua complessità , rinunciando sia agli schemi
ristretti della logica tradizionale che al sistemismo matematizzante della
nuova logica simbolica” (p. 74; cors. ns.). La filosofia del linguaggio oxoniense “opera consapevolmente sulla lingua in cui si esprime ” (ibidem);
essa è attività chiarificatrice “volta a strutture linguistiche di qualsiasi tipo:
115
116
sia quelle delle varie lingue naturali, sia quelle delle specificazioni che se ne
sono formate come lingue tecniche o come idiomi particolari di certe professioni, o anche solo come gerghi in cui si esprimono certe posizioni di pensiero. È l’intero fatto linguistico, in tutta la sua complessità, in una misura
non mai pensata prima, che va emergendo, dispiegandosi, voltandosi come
un guanto agli occhi del nuovo filosofo. Bisogna essere pronti ad affrontarne qualsiasi settore” (pp. 75-76; cors. ns.).
Siamo ovviamente nell’ambito del linguaggio verbale, ma i presupposti
sono quelli di un approccio globale al linguaggio, a quello verbale e a quello
non verbale, che negli sviluppi successivi della sua riflessione Ferruccio
Rossi-Landi porterà fino al linguaggio delle merci, ponendo le basi di una
sociosemiotica critica, interessata ad evidenziare gli interessi che stanno dietro ai sistemi di segni di una determinata organizzazione sociale e la compenetrazione della semiotica e dell’economia (su questi aspetti rinviamo agli atti
del Convegno Internazionale “The Relevance of Rossi-Landi’s Semiotics
Today”, svoltosi a Bari dal 14 al 16 novembre 2002, e ora pubblicati nel
numero 7 di Athanor col titolo Lavoro immateriale, a cura di S. Petrilli,
Meltemi, Roma 2004).
L’interesse, in questa fase della ricerca rossilandiana, è per quella che Ryle,
nell’articolo “Ordinary Language”, chiama “logica non formale”. Il corsivo è di
Rossi-Landi che prosegue osservando come questo studio filosofico del linguaggio è “una delle forme che può oggi assumere il kantismo più scaltrito. […]
Ma con in più due grossi fattori che Kant non poteva avere: primo, una logica
perfettamente –come dire?– democratizzata, cioè egualmente attenta a tutti gli
aspetti del linguaggio anziché infeudata in classificazioni tradizionali quali la tricotomia di Conoscere, Sentire, Volere e le Dodici Categorie con dentro i magici numeri Tre e Quattro […]; e secondo, il raggiunto realismo del senso comune […], e con ciò l’eliminazione dell’insolubile problema della Cosa in Sé per
via ben diversa da quella dei postkantiani” (pp. 77-78).
Questi richiami, però, a posizioni filosofiche del passato, aggiunge RossiLandi, possono servire soltanto come “provvisorio espediente” per chiarire ad
altri la natura di questo tipo di approccio al linguaggio. A questa nuova situazione di pensiero, “molto complessa e articolata, e tuttavia abbastanza unitaria”, hanno contribuito “i massimi innovatori intellettuali del nostro secolo […]
da Wittgenstein, con gli altri viennesi, a Dewey a Mead, con i loro antecedenti
Peirce e James e con i loro seguaci (come Ch. Morris e Urbay), dai logici
polacchi alla scuola britannica che risale a G.E. Moore e all’operazionismo sia
germanico (H. Dingler) sia americano (P.W. Bridgman) sia italiano (S. Ceccato)
–aperta restando all’indagine storiografica la questione dei meriti e dei demeriti di ognuna delle correnti e delle persone nominate” (p. 78).
Vorremmo aggiungere Louis Hjelmslev a questo movimento di attenzione
“a tutti gli aspetti del linguaggio”. La costituzione della linguistica come scienza –sostiene il Maestro danese– passa attraverso l’abbandono della concezione grammaticale greco-latina (con i suoi sviluppi medievali e moderni) basata
sulla logica tradizionale, rigida e normativa, aprioristica ed escludente, per
porsi sul terreno del linguaggio stesso. Questa logica presta attenzione solo
NOTTE
alle leggi che “dominano il pensiero cosciente, il pensiero artificiale e arbitrario
dell’intelligenza”. La nuova grammatica generale, invece, deve prestare attenzione anche al “pensiero naturale, subcosciente”, che viene espresso nel linguaggio (v. L. HJELMSLEV, Principi di grammatica generale [1928], trad. it.
Levante, Bari 1998, p. 18).
L’atteggiamento di Rossi-Landi nei confronti del pensiero oxoniense non è
di passiva accoglienza, quanto piuttosto di apertura critica, basata su precise
e puntuali prese di posizione. Ciò emerge chiaramente nella traduzione italiana di The Concepì of Mind di Ryle, che è un vero e proprio rifacimento, o
meglio la produzione di un nuovo testo: “Entro certi limiti, il testo che presentiamo è dunque un’interpretazione italiana di quello originale”, come si legge
nel manoscritto che lo stesso Rossi-Landi intitola Traduzione, dove inoltre
espone alcuni problemi connessi alla traduzione del libro ryleano e motiva
alcune scelte lessicali (p. 52).
Più avanti, in un altro degli inediti pubblicati da Cristina Zorzella (Materiali
per la nota introduttiva a “The Concept of Mind”), egli spiega le ragioni del titolo dato alla traduzione italiana: Lo spirito come comportamento (Einaudi, Torino
1955; Laterza, Roma-Bari 1982, 2ª ediz.). Si entra in tal modo in quella che
chiameremmo l’officina rossilandiana degli anni Cinquanta.
In polemica con l’Idealismo Rossi-Landi intende richiamare l’attenzione del
pubblico italiano sulla tesi centrale del libro: la negazione della mente come
sostanza. “Ryle è riuscito a mostrare –o ha compiuti passi radicali verso la dimostrazione– che lo ‘spirito’ filosoficamente inteso è una panzana bella e buona”, ma
la descrizione che egli ci dà del comportamento mentale è “tutt’altro che esauriente” (p. 57). Bisogna andare oltre Ryle, muovendo dalle sue posizioni.
La mente è “una maniera di comportarsi dell’uomo, o meglio un insieme
di maniere di comportarsi. Questo in Lo spirito come comportamento c’è.
Ma quello che vi manca è che alcune di queste maniere di comportarsi sono
non-osservative” (p. 59). Un uomo pensa o non pensa qualcosa o qualcos’altro indipendentemente da una prova esteriore del suo pensare o non
pensare. “Cosa fa il mistico quando se ne sta lì quieto e immagina di mettersi in contatto con Dio? Cosa l’innamorato che costruisce i castelli in aria
della sua felicità?”, si chiede Rossi-Landi (p. 61). La questione va sviluppata sviluppando Ryle che ha avuto anzitutto il merito di averla posta. È vero
che gli eventi mentali li cogliamo dall’esterno, ma “non è vero che ci sia un
interno da contrapporgli” (p. 60). Un comportamento intelligente non può
essere preceduto dall’operazione di pensarlo, perché si dovrebbe risalire a
un altro comportamento intelligente e a un suo precedente pensiero, e così
all’infinito (v. p. 63). L’intelligenza si esplica nella sua pratica: non c’è un’intelligenza pre-data.
In queste pagine troviamo inoltre un’affermazione che, a nostro modo di
vedere, ha in nuce alcuni degli sviluppi semiotici successivi della ricerca rossilandiana: “la linea di distinzione del mentale dal fisico non è in una opposizione ontologica, ma nel diverso modo in cui parliamo di comportamenti nonmentali e di comportamenti mentali” (ibidem). Non sarà infatti un’opposizione ontologica quella tra il segnico e il non-segnico, bensì una distinzione
117
118
derivante da una diversa attribuzione di pertinenza all’interno del processo
comunicativo o semiotico. Allo stesso modo il dentro e il fuori del segno non
saranno visti come luoghi statici e predefiniti, come una spazialità deittica,
quanto piuttosto come una spazialità relazionale che li definisce ancora una
volta in base alla prassi comunicativa e conoscitiva. Viene meno la riduzione
idealistica del mondo a mente (a segno, dirà negli anni successivi RossiLandi) e quella materialistica della mente a corpo (materia).
Una diversità di punti di vista con Gilbert Ryle emerge anche sulla questione dell’assurdo o dell’assurdità. I testi qui pubblicati sull’argomento sono
La riduzione all’assurdo che –come ci informa la curatrice– doveva costituire il tredicesimo capitolo di un progetto editoriale del 1958-59, dal titolo Il
mestiere del filosofo, rimasto inedito; Absurdity (con una discussione su G.
Ryle “Categories”) (1962) ed Elaborazione di “On Absurdity” (1962), entrambi in inglese. Si tratta di materiali preparatori per il saggio On Absurdity, uscito sulla rivista Semiotica (16: 4, 1976, pp. 347-367); a questi segue Some different Kinds of Nonsense (gennaio 1963), adattamento del 5° capitolo
(“Parlare comune e scarsa significazione”) del libro del 1961 Significato,
comunicazine e parlare comune, ma che costituisce la prima stesura di On
Absurdity.
Il principale bersaglio polemico è quanto espone Ryle nel saggio
“Categories”, in cui si sofferma sul concetto di “errore categoriale”, e in
Philosophical Arguments, il cui tema principale è la natura dell’argomentazione filosofica. Secondo Ryle la nozione di assurdità è legata a quella di “errore
categoriale” che si verifica quando un enunciato è privo di senso, ancorché il
suo vocabolario sia convenzionale e la costruzione grammaticale regolare, poiché almeno un’espressione non è del tipo giusto per essere associata alle altre
che ne fanno parte. Rossi-Landi invece propone una versione più larga di
‘assurdità’. Egli sostiene, infatti, che non c’è solo quella “linguistica” causata
dall’errore categoriale, ma c’è anche l’assurdità “reale”, che dipende dal contesto o da particolari determinazioni linguistiche o storiche.
Il suo dissenso da Ryle si estende anche al procedimento della reductio ad
absurdum e alla sua suddivisione in una versione “forte”, che consiste nel
dedurre conseguenze incoerenti da una o più proposizioni, e in una versione
“debole” con cui si dimostra la verità di un teorema deducendo, da un teorema
che lo contraddice, conseguenze contrastanti con gli assiomi del proprio sistema o con conseguenze tratte da questi. Secondo Rossi-Landi il procedimento
della reductio ad absurdum è invece circolare, in quanto prova soltanto qualcosa che è già stato assunto; propone quindi di distinguere l’assurdo dal nonsignificante. Così scrive: “Non-significanti o sprovviste di senso possono essere anche disposizioni qualsiasi di parole, o termini inventati a caso, dei quali
non si direbbe nemmeno che sono assurdi. L’assurdità è rifiuto di una condizione significante, laddove la non-significanza ne è la semplice assenza. La
non-significanza esclude la significanza, mentre l’assurdità in certo modo la
richiama. Il contrario del non-significante è soltanto il significato, mentre il contrario dell’assurdo è già qualcosa che deve in un qualche modo ‘andar bene’,
che noi accettiamo oltre che comprendere” (p. 152).
NOTTE
Accanto ai meriti, quindi, Rossi-Landi esplicita quelli che a suo avviso sono
i difetti o le lacune delle argomentazioni ryleane. Puntuali e parallele corrono
altresì, nelle note critiche che accompagnano questi inediti e nell’introduzione
al volume, le precisazioni, i riscontri sul testo di Ryle, di Cristina Zorzella, in un
lavoro critico che apre un dialogo di ricerca tra i due filosofi.
119
L’“ATTENZIONE” ALL’“ALTRO”
NELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
di Santino Cavaciuti
120
Al di là di tutte le differenze e le opposizioni che caratterizzano la riflessione filosofica contemporanea, un elemento comune sembra potersi riconoscere: l’attenzione all’ “altro”, della quale è dato trovare diversi aspetti e ragioni. Di
queste mi limiterò a segnalarne alcune, tra quelle che mi sembrano le più rilevanti.
La più evidente fra esse –mi pare– è la reazione al lungo primato del
Cogito, soprattutto nel suo svolgimento idealistico e in certi esiti solipsistici. Si
tratta di una esasperazione del principio di «interiorità», che dalle sue radici
platoniche era emerso con particolare vigore e, insieme, equilibrio, nell’agostinismo; ma che, in certe versioni e svolgimenti moderni, era ed è inceppato nel
solipsismo. A questo ha contribuito, in più, la concezione moderna, di ascendenza empiristica, secondo cui “oggetto” diretto della conoscenza sarebbero
non le “cose in sé”, ma le loro “impressioni”, da cui il “nuovo” problema del
“ponte”, cioè il problema del passaggio dalle “impressioni” alle loro “cause” o
“cose in sé”.
La reazione alla chiusura del Cogito –già di quello originario, cartesiano– è
stata molteplice. Delle varie forme di tale reazione, ne segnalo una, che mi
pare abbia avuto un forte seguito in certi settori del pensiero contemporaneo:
quella di Maine de Biran, il quale, senza rinnegarlo integralmente, ha modificato e trasformato il Cogito, e ciò da diversi punti di vista: anzitutto nella sua stessa essenza, che era di ordine “conoscitivo”, e ne ha fatto un Volo. Ma non è di
questa trasformazione che intendo qui parlare direttamente, bensì di un’altra
essenziale “novità” introdotta da Biran: quella per cui l’io (che «vuole») non è
“solo” con il suo “pensiero” o con il suo “volere”, ma è in immediato contatto e
riconoscimento del proprio corpo, mediante il principio della resistenza che il
corpo oppone all’azione volitiva dell’io. Si tratta della volizione-azione di “muovere” liberamente il proprio corpo. Con questo non si raggiunge, certamente e
immediatamente, l’ “altro”, il simile, ma si raggiunge, comunque, la «esteriorità», che ne è il presupposto.
Accanto a quella della reazione al primato assoluto del Cogito, un’altra
“ragione” della particolare attenzione all’“altro” nel pensiero contemporaneo, è
dato trovarla –credo– nell’emergenza, a livello sociale, dell’istanza democratica, un’istanza che si fa luce tra l’intensificarsi –in senso opposto– di movimenti, allargati e potenziati, di egoismo –come tanta globalizzazione e tanto liberismo economico.
All’emergenza dell’istanza democratica contribuisce anche, negli ambienti
cristiani, una rinnovata attenzione al rapporto con l’«altro», in correzione di un
NOTTE
certo cristianesimo individualistico e intimistico che sembrava prevalere in
alcuni settori del mondo cristiano.
Ora, il piano della socialità e, in esso, della democrazia, non è certamente
quello della riflessione filosofica, che opera a un livello ben più profondo; ma
può costituire l’“ambiente” per una problematizzazione del rapporto con
l’“altro”. Se è vero, infatti, che spesso la riflessione filosofica precede i movimenti sociali e politici, è vero pure che la medesima ritorna sul mondo umano
nel suo effettivo darsi, lo interpreta e ne accoglie certe istanze. Sta sicuramente il fatto, comunque, di un parallelo emergere, nel mondo contemporaneo, di
istanze “democratiche” e di teorizzazioni del rapporto alteritativo.
Di tal teorizzazioni può essere espressione, fra le tante, il saggio pubblicato dal sottoscritto: Alle radici del dialogo: l’ “altro” (ed. Bastogi, Foggia
2004), dove si parla appunto del passaggio dal Cogito all’ intersoggettività,
con una esemplificazione concreta di questo emergere del tema dell’ “altro”
nella filosofia contemporanea. Nel medesimo saggio viene poi affrontato,
per sommi capi, il problema dell’ esteriorità, quale presupposto del problema
dell’“altro”. Segue una interpretazione, relativamente ampia, dello stesso
rapporto alteritativo, di cui vengono delineati i vari “gradi”: da quelli «primitivi», fondamentali, costituiti, anzitutto, dalla comunanza dell’idea dell’essere, a quelli “inferiori” (come la semplice contiguità materiale), a quelli “intermedi”, costituiti essenzialmente dalla giustizia, infine a quelli «superiori»,
costituiti essenzialmente dall’amore.
Dal medesimo saggio vorrei estrapolare, nel contesto del presente discorso, un tema particolare, quale terza “ragione” dell’emergenza di cui vado qui
trattando: il tema della libertà. Questa direi che sia la ragione ultima della pluralità ontologica e pertanto il presupposto per il rapporto alteritativo. Si tratta
di una concezione della libertà come qualche cosa che va ben al di là della
sola capacità di “scelta”: è precisamente la libertà quale “iniziativa”, “creatività”. Io dico che l’esistenza della pluralità ontologica è giustificata proprio
dalla libertà quale “creatività”. Più precisamente, alla base del concetto di
libertà quale “iniziativa” (nell’essere) sta la concezione dello stesso essere
quale, in fondo, libertà. L’essere-libertà è, come tale, creatore di essere;
essere è fare essere, io dico. Di tale essenziale creatività dell’essere è
espressione il mondo della vita, dove è evidente –mi pare– che vivere è far
vivere: vivere è produrre vita.
E tale “produzione di vita” è collegata, a sua volta, con la realtà dell’amore,
di quell’amore che nel saggio appena sopra ricordato costituisce il vertice del
rapporto alteritativo. Pertanto il “pluralismo ontologico” e, in esso, il “rapporto
alteritativo” hanno la loro ragione ultima nella libertà, più precisamente nella
libertà che io dico “matura”, cioè la libertà “maturata” nell’amore. È in verità
l’amore che è creativo, a livello biologico, più evidentemente, ma, più radicalmente, a livello ontologico.
Ora, la libertà è un’altra delle emergenze del pensiero contemporaneo,
non dico nel senso integrale della concezione qui sopra espressa, ma
comunque in modo piuttosto generalizzato: dal kantismo alla “filosofia riflessiva” francese, alle esplicite “filosofie della libertà” –come quella di Luigi
121
Pareyson e dei suoi numerosi discepoli e seguaci–. Ed è logico, allora, che,
assieme al tema della libertà, emerga quello dell’ alterità, non solo per la
ragione radicale, ontologica, più sopra espressa, ma anche per il fatto che
la libertà –come aveva ben intuito, fra gli altri, Fichte– vive di libertà, vive
circondandosi di esseri “liberi”. Su questa linea oserei formulare un’ipotesi:
è perché l’Assoluto va concepito come Libertà assoluta –io dico–, che il
medesimo si è circondato, nella “creazione”, di esseri liberi; in altre parole:
è perché l’Assoluto è Libertà, che esiste una pluralità di esseri, ed esiste
pertanto l’“altro”.
122
LA PREGHIERA COME EVENTO NELL’ESSERCI.
LINEE ETICHE DI UN ACCADIMENTO RELIGIOSO
Un fortuito e fortunato caso ha fatto sì che ad alcuni mesi dalla pubblicazione della seconda edizione del ponderoso ed importante lavoro Das dialogische
Denken in Germania1, sia stata data alle stampe la traduzione italiana dell’ultima opera del teologo e filosofo della religione Bernhard Casper, Evento e preghiera - Per un ermeneutica dell’accadimento religioso 2. Il nome di Casper è
già da tempo noto in Italia per la assidua presenza all’interno del dibattito
riguardante la filosofia della religione e la teologia filosofica. Allievo di Bernard
Welte, egli ha concentrato la sua riflessione soprattutto intorno alla filosofia di
Heidegger e del cosiddetto pensiero neo-ebraico, con particolare attenzione a
Lévinas e Rosenzweig. Da alcuni anni la sua produzione filosofica si va concentrando sulla messa in chiaro del rapporto tra religione ed etica, esaminato
alla luce della Fenomenologia ermeneutica. È proprio da una riflessione sulla
metodologia del lavoro di Casper che desideriamo iniziare la presentazione di
questo breve e densissimo testo.
Per comprendere la portata metodologica di tale lavoro appare appropriato
partire dall’epilogo, in cui l’autore esplicita in maniera diretta l’approccio utilizzato nell’ermeneutica filosofica della preghiera. Il fenomeno in questione viene
osservato da un pensiero che si sa coinvolto nel fenomeno da mostrare. È convinzione dell’autore infatti che il pensiero, rivolgendosi alla preghiera (atto
attraverso cui giungere a ciò che autenticamente ed originariamente la parola
religione indica) non può non affidarsi criticamente a tale correlazione, in cui
esso è nel contempo pensare e pensato. Tale atteggiamento tuttavia è, secondo Casper, proprio del filosofare tout court:
Per questo –egli scrive– una fenomenologia dell’accadimento religioso non può
essere astorica e prendere le mosse da un punto di vista soprastorico che in realtà è sempre solo presuntamente tale. Essa non può che partire sempre dall’esperienza religiosa, nella quale chi pensa già si trova, e deve interpretarla con i mezzi
del pensiero. Questa interpretazione deve in questo modo, nel suo stesso compimento, temporalizzarsi ermeneuticamente (pp. 150-1).
Certamente nel rapportarsi al fenomeno religioso vi può essere un atteggiamento tale da renderlo un oggetto; in questo caso il soggetto percipiente non
si ritiene coinvolto nell’oggetto da percepire, addivenendo ad una descrizione
oggettivistica del “fatto”, che rispetto alla religione ha portato, ad esempio,
Durkheim a rilevarne esclusivamente l’aspetto sociale. Casper non nega che
un tale sapere nei confronti delle religioni doni un contributo importante per la
loro conoscenza, ma, a suo parere, per comprendere il senso dell’accadimento religioso è necessario un approccio altro. La festa ad esempio può sicura-
NOTTE
di Virgilio Cesarone
123
124
mente essere mostrata attraverso le strutture sociali che la compongono, ma
in tal modo verrebbe meno il senso dell’accadere di un tempo che si presenta
come fondativo del tempo ordinario. Secondo la fenomenologia ermeneutica
invece il senso dell’accadimento religioso può essere colto autenticamente
solo se chi riflette su di esso ne è nel contempo coinvolto.
Abbandonarsi alla correlazione non è, secondo quanto presentato da
Martin Heidegger in Sein und Zeit, un circolo vizioso, ma un evidenziare le
strutture costitutive di ciò che è, decostruendo i presupposti determinati dall’ovvietà. Ora ciò che è, riferito all’umano, non può che presentarsi come
temporalizzazione, ossia maturazione entro il tempo [Zeitigung]. Il curatore
del testo, Bancalari, nella pregevole introduzione, ricorda giustamente che
per Casper l’esserci dell’uomo non è mai; esso si temporalizza [zeitigt sich],
così come i fenomeni riguardanti l’umano si compiono [vollziehen sich], o
accadono [geschehen], hanno luogo [sich zutragen] e, naturalmente, evengono [sich ereignen]. Lo è quindi si riferisce ad un modo d’essere che va inteso non necessariamente secondo l’essenza dei fenomeni, ma alle loro determinazioni oggettuali, guadagnate attraverso uno sguardo scientifico-positivo,
che li priva della loro storicità. D’altro canto, secondo Casper, la stessa filosofia occidentale ha sostenuto soprattutto nella modernità la possibilità
umana di essere esclusivamente nel tentativo di permanere incondizionatamente nell’essere.
Per il procedere dell’ermeneutica dell’accadimento religioso Casper non fa
mistero di riferirsi alle “indicazioni”, fornite da Heidegger negli importanti corsi
universitari tenuti nel 1920/21 a Friburgo, ed ora pubblicati con il titolo di
Fenomenologia della vita religiosa3. Abbiamo usato le virgolette per il termine
indicazione non a caso, poiché fulcro dell’approccio ermeneutico al fenomeno
religioso è la cosiddetta formale Anzeige, l’indicazione formale, che Heidegger
elabora proprio in quegli anni per cercare di avvicinare in maniera comprendente un fenomeno come quello religioso, evitando di cadere nella fissità categoriale delle speculazioni teoretiche. Non è questo il luogo per un’accurata
analisi della formale Anzeige, basti qui ricordare come essa sia composta da
tre momenti distinti, di cui il principale è quel Vollzugsinn, senso di compimento, che Casper applica in maniera così efficace nella sua ermeneutica.
L’indicazione di un fenomeno come quello religioso deve necessariamente
rimanere formale, astraendo dal contenuto, e concentrandosi sulla modalità di
tale accadere. Il pensiero, pur sapendosi correlato al fenomeno, non può
seguirlo nel suo accadere se non formalmente, mettendo in mostra le strutture essenziali che intervengono nel suo compimento. Il contenuto viene in un
certo senso posto tra parentesi, altrimenti, paradossalmente, la riflessione
sulla preghiera non sarebbe più tale, ma preghiera stessa4.
Entro tale ottica appare chiaro il motivo che spinge Casper a ritenere l’atto
della preghiera l’unico che possa darci un accesso all’autentico fenomeno religioso e, di conseguenza, a considerare l’ermeneutica di questo come l’esplicitazione delle linee fondamentali dell’accadere religioso, come recita il sottotitolo tedesco dell’opera. Da qui l’affermazione dell’autore secondo cui nella preghiera si trova quanto di più autentico si possa dire di una religione. Tale punto
NOTTE
di vista verrà posto in evidenza più avanti da Casper, quando afferma che “più
di quello che viene detto nel pregare in comunità, la fede non può dire. Il pregare l’uno-con-l’altro diventa così contemporaneamente quell’accadimento in
cui la fede è tramandata nella storia nel modo più intenso” (p. 108).
Il lavoro dunque non intende porre in evidenza le strutture trascendentali
della religione, per poi procedere ad una sorta di comparazione tra le differenze empiriche. Ciò significherebbe ancora una volta cercare di comprendere
sincronicamente l’evento religioso, misconoscendo la diacronia che investe la
comprensione di tale fenomeno. Tuttavia, pur muovendosi consapevolmente
nella tradizione biblica cristiana, Casper afferma:
Una meditazione ermeneutica sull’accadimento latreutico, che ha come punto di
riferimento l’esperienza della libertà umana assegnata a se stessa al cospetto
dell’Altro, può diventare un punto di partenza, ben fondato per il nostro proprio
pensiero, per il colloquio tra le religioni, oggi più che mai necessario. Un incontro
delle religioni, che sono altre l’una per l’altra, può riuscire solo in un modo ermeneutico, ossia il modo tale che l’uno tenti di rendersi comprensibile l’Altro, lasciando però che l’Altro resti altro; il che significa: lasciarsi coinvolgere nel contesto di
compimento del rapporto religioso che accade nell’altra religione (pp. 151-2).
L’ipotesi che scorre lungo tutta l’opera è dunque che l’accadimento della
preghiera trovi, nel suo specifico temporalizzarsi, un analogo nelle altre religioni, con tutte le possibili forme di decadimento.
Ma il cuore della riflessione casperiana va ritenuto, a nostro modesto avviso, la proposta di un’ermeneutica dell’evento religioso alla luce di un senso
etico. Questo non viene ricercato attraverso fondazioni trascendentali, ma
mostrato in virtù delle proprietà appartenenti all’evento della preghiera, inteso
come accadimento della libertà nel divenire maturo nel tempo dell’esserci. La
preghiera per Casper è infatti evento, ma si fraintenderebbe il significato di tale
termine, qualora lo si interpretasse come un avvenimento che accade nella
soggettività del singolo. È invece proprio al significato di Erlebnis, di ciò che è
vissuto nell’interiorità personale, che l’autore oppone il termine Ereignis, ed è
questo il senso secondo il quale viene adoperato da Rosenzweig:
Nella comprensione dell’evento –scrive Casper– l’accento batte sul fatto che in quest’ultimo l’uomo esperiente e comprendente viene trascinato dentro qualcosa di
estraneo e diverso che gli sta di fronte. Questa estraneità e diversità però lo riporta
proprio a se stesso. Per lui, infatti, non si tratta di nient’altro che della realtà che egli
non è in grado di costruire. L’evento è perciò sovrano nei confronti del mondo.
Preghiera, come evento di trascendenza è dunque ciò che mi espone all’Altro,
nel mio essere-l’uno-con-l’altro; ma di questo parleremo diffusamente tra breve.
Un ultimo elemento di cui vogliamo rilevare l’importanza riguarda la temporalità, o meglio la temporalizzazione. Si è già accennato brevemente all’abbandono di una dimensione sincronica, di una misurazione temporale propria di
una coscienza fuori dal tempo, a favore dell’interpretazione diacronica del
tempo, in cui questo viene riflettuto nel mio divenire temporale. Tale dimensione però si slarga verso un orizzonte non esclusivamente cronologico, per fornire la misura interpretativa delle dimensioni costitutive dell’umano. Così la dia-
125
cronia assurge a metro per comprendere l’identità (che diviene non-identità)
per la responsabilità verso l’altro. Altrettanto diacronicamente viene interpretato lo spazio, inteso non più come spazio sempre mio, soprattutto quello sacro,
ma come trasfigurazione continua. In questa modalità ermeneutica si dà voce
all’impossibilità di rendere fisso e luogo di dominio ciò che autenticamente si
dà, eviene, esclusivamente nella im-proprietà del diacronico, attraverso l’erramento continuo. Alla radice di questa visione –e Casper lo conferma continuamente nelle sue pagine– vi è l’assidua frequentazione con il pensiero dell’ultimo Cohen, di Rosenzweig e di Lévinas.
126
***
L’incipit di Evento e preghiera è segnato da una domanda fondamentale: è
ancora possibile oggi un oltrepassarsi dell’uomo verso l’indisponibile, o in questo mondo di assoluta immanenza non ha più senso porre tale domanda? La
risposta a tale questione non può che essere filosofica, ossia concretizzarsi
attraverso una meditazione aperta all’interezza della situazione umana, senza
ricorrere a scappatoie psicologiche o sociologiche, ma utilizzando, come si è
detto poc’anzi, il metodo della Fenomenologia ermeneutica. Per comprendere
a fondo la domanda sulla preghiera e ciò che viene domandato in essa, è
necessario allora riuscire a pensare ciò che tale domanda richiede, ossia appare essenziale riuscire a comprendere la possibilità di un oltrepassamento di noi
stessi. Ciò significa innanzitutto una presa di distanza da quella figura umana
che si comprende come trasparente a sé, dall’uomo il cui pensiero non riconosce alcun fuori da sé. Riuscire ad “evadere” levisianamente da questa configurazione d’animo significa tematizzare l’attenzione che si mostra quando ci volgiamo in maniera originaria alla realtà. È questo senza dubbio un momento
importante nell’economia del lavoro, perché l’evento della preghiera secondo
Casper è legato necessariamente all’accadimento originario dell’oltrepassarsi.
Nel volgerci alla riflessione su di noi non possiamo non abbandonare i limiti nei
quali abitualmente viviamo. Si impone la necessità di andare al di là:
Nel nostro oltrepassare i nostri limiti ci esponiamo ad un viaggio nell’ignoto, pieni
di attesa e pronti per ciò che ci viene incontro e che, nella misura in cui non può
essere prevenuto, si mostra sempre come ciò che desta meraviglia. Si mostra
come ciò che è altro, che non si limita a comparire in un contesto già noto e che,
anzi, dimostra di essere ciò che è originariamente altro in quanto fondamentalmente sorprendente (p. 37).
In questo modo ci si rivolge allora a ciò che si presenta “sconcertante” in
una maniera originaria.
Ma l’attenzione ha in sé una ambiguità che Casper giustamente definisce
paradossale. Essa è infatti da una parte l’attività dell’intenzionalità, dall’altra un
essere fondato nella passività, determinata dal dover rispondere a ciò che è
altro, e che solo a partire da se stesso si mostra. Come il pensiero deve abbandonare l’autoreferenzialità, così la volontà deve retrocedere per lasciare spazio
e tempo alla chiamata proveniente da ciò che è altro, radicandosi nella passività originaria. In tal modo il pensiero fa sì che la propria finitezza emerga in manie-
NOTTE
ra evidente come sua struttura costitutiva, mostrandosi anche in una diversa
modalità di temporalizzazione. La prospettiva sincronica, in cui, grazie alla facoltà unificatrice della nostra coscienza, siamo contemporaneamente a casa di
fronte al tutto della realtà, viene disturbata, distorta potremmo dire, dall’indisponibilità dell’altro ad essere raccolto (logicizzato). Così ho esperienza dei miei limiti e di un tempo che non è solo il mio tempo. L’indisponibilità della visione a-sincronica della realtà mi dona una possibilità che si dispiega oltre le mie possibilità, al di là delle mie aspettative di senso pre-date. In tal modo si diviene pronti
per il dono, “che consiste nell’evento del darmisi dell’Altro in quanto Altro” (p. 42).
È possibile dunque trovare se stessi nell’abbandonarsi a ciò che è altro, accadimento che Casper in un saggio enuncia come l’identità nella non-identità dell’elezione per la responsabilità verso l’Altro5. In questo modo ci si rimette al dono di
ciò che è altro, nel raccoglimento verso ciò cui mi dirigo nell’oltrepassamento di
me stesso, che si presenta però non come un oggetto, ma come una profondità
insondabile. Tuttavia non bisogna intendere tale auto-oltrepassamento come
una dimensione di libertà scissa dalla concretezza della mia esistenza. Proprio
nell’assumere fin in fondo la mia finitezza, la mia storicità, il mio essere-già-presso, divento capace di cogliere ciò che è nelle mie possibilità qui ed ora.
L’oltrepassamento deve inoltre, secondo Casper, rifuggire un rischio, quello
di porre come assoluto il luogo in cui tale accesso accade, ossia il nostro esserci. Se così fosse si ignorerebbe l’accadere autentico della temporalità, che eviene integralmente al cospetto dell’altro uomo. L’Altro (che Casper scrive in maiuscolo quando vuole indicare l’alterità dell’altro, la sua completa ed autonoma
modalità di rapportarsi alla realtà delle cose) mi dona il modo di comprendere me
stesso nella mia umanità. Questa mi viene svelata proprio a partire dalla mia
consegna all’Altro, che l’autore, seguendo le riflessioni di Lévinas, contrassegna
come un patire: “Nell’umanità del mio essere un uomo patisco il fatto che ho bisogno dell’altro ancor prima di potere dispiegare una qualche attività o di poter
assumere, nello scambio tra fare e patire, un patire determinato” (pp. 50-1). Se
la passività si attesta come il carattere essenziale della finitudine umana, allora
il dire autentico dell’uomo non può esaurirsi in un atto autoreferente, ma deve
risolversi originariamente in un’apertura all’Altro come Altro. Ecco perché l’accadimento del linguaggio è, originariamente, preghiera. Intorno a quanto si è guadagnato con tale riflessione, si apre un plesso di significati determinanti per il
lavoro di Casper. Innanzitutto la preghiera, intesa in tal senso, domanda sempre
di essere ascoltata dall’Altro come Altro. È l’Altro allora che rende possibile il mio
parlare; e tale atto, in quanto così configurato, si compie come uno sperare che
accade nella temporalizzazione del mio oltrepassamento. Le riflessioni qui presentate comportano certo l’accentuazione del carattere di evento nell’incontro
con l’altro, un evento che, seguendo il secondo imperativo categorico kantiano,
si palesa come un divieto nei confronti dell’altro, il quale nel suo Altro, non va
inteso meramente come oggetto. Tuttavia, a parere dell’autore, ciò non è sufficiente: una semplice indicazione formale –di cui abbiamo già detto– non rende
conto di ciò che nell’incontro tra me e l’altro accade. L’imperativo diviene comando nel momento in cui, riflettendo sull’evento dell’incontro, ordina a me mortale
di non lasciare l’altro solo nella sua mortalità6.
127
128
Siamo giunti ad un punto centrale del lavoro di Casper, ossia all’esplicitazione del rapporto tra temporalizzazione umana e preghiera. Abbiamo già
accennato al significato del verbo essere nel riferirsi all’umano: lo è indica un
legame indissolubile con la temporalizzazione. Solo entro questo quadro allora noi diveniamo questione a noi stessi, lasciandoci coinvolgere dalla libertà
data nella nostra storicità, ed è entro tale quadro che possiamo cercare, secondo Casper, la risposta. Quale senso, quale progetto ha di mira il nostro compiersi? Certamente è possibile, ancora una volta, dare una risposta formale a
tale domanda, astraendo dal contenuto: quello che vogliamo è di giungere alla
pienezza del nostro essere, ad una pienezza da cui siamo tentati ed a cui
acconsentire senza riserve. L’uomo dunque è determinato da questa tentazione, consistente nell’auto-oltrepassamento in vista di un adempimento. Tale è
la comprensione di Rosenzweig della tentazione dell’uomo da parte di Dio,
comprensione che il nostro autore riprende: “È la stessa libertà infinita che ci
chiama in causa e ci provoca. In definitiva è in direzione di una realtà riempita
dalla gloria dell’infinito che ci oltrepassiamo” (p. 67). Ed è ancora Rosenzweig
che ha messo in luce come il rapporto religioso vada compreso in questo accadere della libertà nell’essere tentati. Tale rapporto si configura come rapporto
di fede ed è in esso che la preghiera accade: “Si può intendere il pregare soltanto come atto dell’intero esserci che si realizza nella libertà. È un accadimento della ragione che si realizza, cioè che fa qualcosa di sé” (p. 68).
Il pregare quindi non è un puro e semplice atto d’amore, ma un atto della ragione, che accade nella libertà storica di un essere razionale finito nel suo consegnarsi a se stesso. Il pregare accade nell’aver-tempo, nell’attenzione rivolta ad un
tempo, immemorabile ed inimmaginabile, che non è nel nostro tempo, ma che lo
dirige. L’evento della preghiera accade così grazie ad una intenzionalità non intenzionale (Lévinas), poiché essa si apre all’“allora” più profondo ed al “un giorno”
fuori dall’immaginazione. Nel pregare accade una conversione. Ci si converte,
abbandonando l’abituale, che è l’ovvio ed il solito, e che nasconde le domande
decisive della nostra esistenza: “Il pregare comincia quando per la prima volta
diveniamo attenti sul serio e, in tal modo, scaturisce dalla forza dell’essere-davanti-a-noi: è un modo della speranza” (p. 75). La preghiera accade innanzitutto con
il dirigere lo sguardo in quell’essere avvolto che è il mio essere già sempre in un
mondo, ma nel contempo è uno sguardo che mi porta oltre. Casper scrive anzi
“mi trovo chiamato oltre”. Nella preghiera si assiste allora ad un procedere in cui
l’esserci è assegnato a se stesso, verso una umanità più grande. Il problema da
affrontare è quello di comprendere se la nostra trasformazione dipenda esclusivamente da noi stessi. Casper introduce qui la categoria di correlazione, che si
dispiega tra me ed il senso del nostro esserci. In tal modo esperisco me stesso
come interpellato sul senso e dal senso del mio cammino. Il lasciarsi coinvolgere
da questo appello mi trasforma. La preghiera allora significa che noi poniamo questo attimo nel quale siamo chiamati a noi stessi nella luce del volto divino, per
usare le parole di Rosenzweig. L’appello-pretesa che ci interpella riesce a fare
breccia solo se ci apriamo ad essa, ponendo attenzione alla sua richiesta. In tal
modo la preghiera si rivela come evento responsorio: accade come risposta. Qui
Casper si collega ad un filone che prende le mosse da Agostino, e che attraver-
***
Il Novecento è senza dubbio il secolo in cui il linguaggio è divenuto tema
centrale della riflessione filosofica, ed in ciò è possibile rinvenire il tratto comune alle scuola analitica e continentale. Un esame meditato sull’evento della
preghiera non può evitare quindi di interrogarsi sul proprium del suo linguaggio. Casper cerca di evidenziare una serie di contrassegni della preghiera, con
il presupposto però che la preghiera è innanzitutto un fare, poiché è in ciò che
l’atto linguistico del pregare si distingue sia dall’atto argomentativo sia dal dire
proposizionale. Nel pregare quindi ci troviamo in una dimensione linguistica
propria, che è contrassegnata da una origine an-archica ed in cui mi ritrovo
bisognoso: “Ho bisogno dell’Altro e dell’evento diacronico del linguaggio stesso; e, contemporaneamente, del senso infinito ed indicibile del linguaggio” (p.
84). Il linguaggio della preghiera sarà autentico, poiché io lo parlo in quanto me
stesso, e perché in questo parlare mi oltrepasso in direzione della possibilità
sempre mia. Ciò contrassegna allora tale linguaggio come immediato. Altro
contrassegno è quello della fiducia: nell’atto linguistico della preghiera rimetto
me stesso all’abisso, all’immemorabile non esauribile da alcun linguaggio,
dove ogni parola annuncia se stessa come différance7, ed il rimettersi-a è volto
verso la promessa inimmaginabile. Ulteriore contrassegno fondamentale dell’autenticità nell’atto del pregare è il rapporto con l’altro. Esso è una vera e propria misura, in cui determinante è “la cura dell’essere ostaggio per l’Altro” (p.
87), per cui l’autentica preghiera è, sia nel lamento che nella lode, mai affermazione di se stessi, ne va della salvezza; una salvezza esperita già come
miracolo e che ci è stata già concessa nell’essere-l’uno-con-l’altro.
Potrebbe sembrare strano trovare spazio, in questa meditazione sulla preghiera, per un tema come quello della corporeità, tanto più se questa viene
posta in strettissima correlazione con il linguaggio. Al contrario proprio in virtù
del presupposto che la preghiera investe tutto quanto l’essere dell’uomo, essa
non può ritenersi un accadimento affatto interiore. Qui l’autore denuncia l’insufficienza dei concetti guadagnati finora dalla riflessione fenomenologica sul
corpo; è necessario, a suo parere, “accontentarsi” dell’assunto secondo il
quale il maturare entro il tempo della libertà umana accade sempre nell’essere corporeo dell’uomo. Ma è grazie al Lévinas che si è riusciti a legare tale idea
al linguaggio: ciò che rende significato il divenire carne della libertà è il linguaggio. Ma citiamo per esteso il passo di Lévinas a cui Casper si riferisce:
L’approssimarsi […] non è superabile speculativamente: esso è l’infinizione o la
gloria dell’Infinito. Il volto come traccia –traccia di se stesso, traccia espulsa nella
traccia– non significa un fenomeno indeterminato; la sua ambiguità non è un’indeterminazione di un noema, ma un invito al bel rischio dell’approssimarsi in quanto
approssimarsi, all’esposizione dell’uno all’altro, all’esposizione di questa esposizione, all’espressione dell’esposizione, al dire. Nell’approssimarsi del volto la
carne si fa verbo, la carezza Dire. La tematizzazione del volto disfa il volto e l’approssimarsi. Il modo secondo il quale il volto indica la sua propria assenza sotto la
mia responsabilità esige una descrizione che ricorra al linguaggio etico8.
NOTTE
so Anselmo d’Aosta, Tommaso d’Aquino e Meister Eckhart, giunge fino a Jakob
Böhme, per culminare nella filosofia positiva dell’ultimo Schelling.
129
130
Un altro contrassegno del linguaggio della preghiera è l’ammutolire. La preghiera autentica e dimentica di me si ritrae da ogni nominare presentante.
Essa piuttosto è la contro-parola all’appello infinito, e quindi non può che divenire un tacere eloquente. Qui Casper rimanda all’impossibilità dichiarata da
Platone di cogliere ciò che è epekeina tes ousias, ma anche a Wittgenstein con
la parte taciuta del suo Tractatus. Si lega infine al tema della corporeità la
descrizione della preghiera come lamento, lode, domanda e ringraziamento. È
proprio infatti solo di un essere che vive nella storia, con i propri patimenti e
speranze, il rivolgere una parola contrassegnata dall’abbandono al rapporto in
cui io sono, in quanto essere con l’Altro, chiamato in causa.
Sin qui si è visto come la preghiera sia soprattutto la possibilità in cui, temporalizzando la libertà, l’uomo assume se stesso nel rivolgersi all’altro nella
maniera più autentica. Ma in questo modo non si esclude forse un fenomeno
che le religioni tradizionali hanno da sempre mostrato, il pregare in comune?
Secondo Casper il fatto che la preghiera sia del singolo, e per questo non si
dia la possibilità di un terzo partecipante, non esclude il pregare in comune. Il
pregare è sempre il parlare di un mortale, quindi sempre un atto pubblico,
anche nella forma del tacere. L’autore riporta una delle soluzioni fornite dalla
fenomenologia per fornire una soluzione al rapporto tra le libere varianti ed un
modello in-variante. L’accadere ora della preghiera fa sì che essa sia il mio ora,
ma comprensibile universalmente. Universalismo della preghiera è però tanto
protologico quanto escatologico, poiché ogni pregare investe ciò che era all’inizio, rivolgendosi al futuro regno di giustizia e di pace. Così si mostra chiaramente il motivo per cui la preghiera non trova il suo incipit nell’attimo, ma accade diacronicamente all’interno di una tradizione.
L’atto della preghiera però diviene comune soprattutto grazie all’intervento
di una chiamata. Con la preghiera si conviene dunque in un tempo e, secondo
Casper, “di conseguenza” in uno spazio comune (spazio e spazio sacro).9 Il
tempo e il luogo di questo “convegno” forniscono una mediazione rispetto
all’attimo della libertà singola. L’autore diversifica il comune convenire della
vita umana, determinata dall’incontro autofinalizzato della quotidianità, dal convenire determinato da un senso incondizionato, che investe l’esserci proprio e
l’essere-l’uno-con-l’altro. In tal modo eviene “’un tempo nel tempo’, che è un
tempo in comune” (p. 112). È la festa quel tempo in cui si è liberi da scopi, il
tempo an-archico, che io stesso non posso darmi, ed in cui ho tempo per stare
con l’altro. L’autore lamenta la mancanza di una completa elaborazione fenomenologica della festa, la quale potrebbe fornire il terreno per una futura ermeneutica delle religioni. Esclusivamente in questo modo, evitando i paragoni storici, sarebbe possibile giungere a suo parere ad un colloquio tra le diverse confessioni: partire dall’accadimento della festa, per comprendere ciò che è proprio a ciascuna di esse. Ebbene Casper, muovendo dalla fenomenologia del
tempo della festa, cerca di ricostituirne il significato, evidenziando l’unità del
flusso temporale che essa riesce a donare. Riprendendo Rosenzweig l’autore
sottolinea «l’istituzione dell’ora» della festa, come ciò che dà un senso, un inizio ed una misura al flusso temporale che diviene temporalizzazione comune.
Non vengono naturalmente taciuti i rischi a cui incorre una eventuale interpre-
***
Come comprendere pienamente il fenomeno dell’accadere della preghiera
entro l’ambivalenza della quotidianità? Se infatti si prende spunto dall’analitica di Heidegger, la vita di tutti i giorni è da una parte il luogo delle sicurezze
e della fiducia, ma dall’altra è al contempo il modo in cui accade la chiusura
in sé della vita stessa. In questo senso il temporalizzarsi quotidiano è ancorato a se stesso: in esso il domani appare come un continuo ieri, per cui mi temporalizzo nel modo in cui ci si temporalizza. Ciò porta ad una estraniazione
rispetto a se stessi, poiché il quotidiano, oltre ad essere il terreno sicuro di
ogni nostra esperienza, si presenta come “una violenza che esclude l’uomo”
(p. 127). Questo flusso del divenire temporale del quotidiano può essere interrotto da avvenimenti che fanno (kierkegaardianamente) inorridire, come la
morte, ma secondo Casper anche dall’ingiustizia e dalla violenza. Tali orrori
espongono a ciò che è fuori da sé ed in tal modo riportano l’uomo a sé, facendogli schiudere quella apertura a ciò che è al di fuori della sfera quotidiana.
L’interruzione del tempo quotidiano può essere contrassegnata anche da una
cesura spaziale, dall’appartarsi in un luogo progettato per tale evasione (chiesa, moschea) o creando uno spazio apposito (accendendo una candela, stendendo un tappeto a terra). Ma ciò che contrassegna in maniera più propria
tale interruzione è l’attenzione all’Altro, la quale provoca il mio temporalizzarmi nella maniera più originaria.
Questo non porta però ad un accadimento parallelo tra tempo ordinario e
tempo del raccoglimento, come se quest’ultimo fosse il tempo della vacanza.
Il tempo della preghiera invece è quello in cui accade la possibilità di una sensatezza del quotidiano. Come scrive Casper: “Il rapporto tra l’accadimento
della preghiera e quello del quotidiano non è un’addizione, ma la ‘circumsessio’, la reciproca compenetrazione e in abitazione” (p. 130). Il tempo della preghiera inibisce le coercizioni della quotidianità, dandoci la possibilità di trovare
la sensatezza per il vivere l’uno-con-l’altro nella quotidianità. L’accadere della
preghiera ci apre così una dimensione temporale che illumina il nostro vivere
finito, il quale trova modo di abitare in questo raccoglimento.
Casper tuttavia non si nasconde ad un interrogativo che scuote le fondamenta delle riflessioni fin qui presentate: di fronte al dolore, ed agli orrori che soprattutto il Novecento ha mostrato, è possibile parlare ancora in tali termini del rapporto tra tempo quotidiano e tempo della preghiera? L’indignazione contro il dolore inflitto, l’insorgere contro la violenza perpetrata è secondo l’autore una via per
giungere alla formulazione della risposta a questo dirimente interrogativo. Già
NOTTE
tazione della festa affatto mondana, secolarizzata, finita. Proprio perché la
festa, in quanto temporalizzazione comune, è un fatto politico, essa trova in
tale dimensione il sommo pericolo. L’accadimento della festa «è rimando simbolico in questo senso: che esso si offre in dono come reale punto di appoggio per il senso infinito nella storia, ma non pone tale senso in modo finito e in
un accadimento finito. Se accade questo allora la festa stessa diventa illusione e idolo» (p. 120). È dunque solo a partire da una chiamata immemorabile e
senza limiti che risulta accessibile la piena fenomenicità della festa.
131
132
l’indignazione mostra a noi stessi la capacità di oltrepassarci; ma questo andare
oltre se stessi può da una parte cadere nel vuoto nulla, oppure dirigersi verso
un’oscurità, da cui mi giunge la chiamata all’umanità; una chiamata che mi presenta ciò per cui posso vivere e ciò per cui posso morire. Il pregare quindi si evidenzia kantianamente come l’accadimento estremo della “ragion pura pratica”.
Se il pratico, infatti, è tutto ciò che si rende possibile in virtù della libertà, allora
l’evento della preghiera risulta essere agli estremi di questo accadimento, poiché
in esso vi è una costante messa in pericolo della libertà a partire da se stessa:
«La libertà esposta a se stessa, e perciò tentata, la ragione pratica, messa in
pericolo nel procedere lungo il cammino, si espone alla “luce del volto divino”: ma
è proprio questo che rappresenta l’atto estremo della stessa ragione storica» (p.
134). Se gli atti umani dunque si distinguono in speculativi e pratici, questi ultimi
compaiono nella preghiera alla luce del volto divino.
Come si è detto precedentemente il gioco continuo tra autenticità ed inautenticità, o meglio tra proprio ed improprio, è una traccia che percorre continuamente le riflessioni di Casper sull’accadimento della preghiera. Tale tema è quello
della tentatio, analizzato da Agostino nelle Confessiones e quindi messo a frutto
da Heidegger in Sein und Zeit, dopo averne esaminato profondamente la struttura nelle lezioni del primo periodo friburghese. Ebbene anche nella preghiera è
costante il rischio del decadimento. Proprio perché la preghiera è una apertura
“alle pretese incoraggianti” della gloria dell’infinito, da questo accadere deriva
anche il pericolo. Il rischio sommo è quello di perdere la fiducia nella pretesa che
mi appella, e mi richiama all’attenzione ed all’ascolto, per irrigidirmi invece in
qualcosa che è semplicemente sussistente, in una presenzialità conchiusa e non
più aperta al futuro. Tale decadimento dell’apertura in un’autoaffermazione del
presente è la radice di quelle ideologie che sfociano in totalitarismi. Questo atteggiamento insieme allo scetticismo, che Casper interpreta come mancanza di
capacita proiettiva verso il futuro, hanno la medesima radice nel sottrarsi alla
serietà della storia: “L’esser-assegnato-a-sé nel rischio della storia, che ha luogo
come storia diacronica della responsabilità per l’Altro, è il fondamento da cui si
leva l’accadimento della preghiera come atto estremo della ragione” (p. 139).
Quindi l’autore, esplicando quello che è stato uno dei temi più approfonditi della
sua riflessione filosofica, ci presenta una articolata fenomenologia della costruzione di idoli10. Qui l’idolatria umana si presenta come la venerazione del finito
come infinito, come la costruzione di idoli che divorano il tempo umano non
lasciando tempo per nient’altro, come lo scambiare la ripetizione del rapporto
con l’infinito con la routine coercitiva della ritualizzazione.
Ma il decadimento del religioso è segnato anche dal rischio che la preghiera sia una mera autoaffermazione, trasformandosi in scongiuro o magia. In
essa in tal modo non resterebbe niente della “preghiera senza domanda” di
Lévinas. Il pericolo di decadimento idolatrico maggiore a cui si incorre però
consiste nel considerare la propria comunità come Dio, ovvero nel chiudere
l’apertura verso l’infinito a favore di una determinata religione, istituzione,
nazione o razza. Questo pericolo è serbato nello stesso seno del rapporto religioso originario, in quanto in esso vi è sempre una prolessi dell’adempimento.
Ma questa rimane autenticamente tale esclusivamente nell’attesa.
NOTTE
***
Appare sicuramente improba la volontà di tratteggiare alcune brevi note
conclusive di fronte alla complessità del testo qui presentato, tuttavia non ci
sottraiamo al compito. Innanzitutto è bene rimarcare, ancora una volta, la preminenza, costante e fondamentale, che Casper attribuisce alla temporalità. Un
esempio è dato dall’interpretazione della dimensione –non solo, ma anche–
spaziale dell’essere-a-casa, che viene interpretata da Casper esclusivamente
secondo la temporalizzazione. Accettata come estremamente fruttuosa la
diversificazione tra diacronia e sincronia, ci appare necessario però fornire un
senso nuovo allo stesso rapporto spazio-tempo, quindi anche alla diacronia
(cfr.39). A nostro modesto avviso, infatti, per riuscire a cogliere il nesso tra corporeità e preghiera non appare sufficiente presentare la spazializzazione come
una conseguenza della temporalità (cfr. p. 111). Da questo punto di vista
Casper non sembra assumere con il termine Ereignis dell’ultimo Heidegger il
gioco d’unione tra spazio e tempo, tratteggiato nei Beiträge11. Concordiamo
quindi con quanto Bancalari rileva nella sua puntuale introduzione: Casper pur
richiamandosi ad una parola chiave dell’ultimo Heidegger, sembra essere legato maggiormente alle prime lezioni friburghesi, delle quali assume soprattutto
il metodo fenomenologico. Ma anche qui sembra esserci una sorta di ambiguità. L’autore infatti si rende conto che l’approccio formale alla religione può
garantire una scientificità fenomenologica, la quale però va necessariamente
superata per vedere nella preghiera, e nell’oltrepassamento che in essa accade, la traccia del regno di Dio. Ciò porta nel contempo ad una problematicità
riguardante la possibilità d’accesso al fatto religioso da parte della filosofia.
In tutta l’opera di Casper vi è, infatti, l’esigenza di affrancare una disciplina
come la filosofia della religione dalle strettoie illuministiche delle sue origini, che
hanno finito per portare la riflessione sulla religione a divenire un’attività scientifica con il proprio positum. In opposizione a tale via Casper predilige quella
indicata da Böhme e ripresa dall’ultimo Schelling, quella per cui, per usare una
espressione di Heidegger, posso parlare di religione nel momento in cui ho una
precomprensione determinata di questa. Tralasciando qui una analisi puntuale
di tale abbrivio metodologico, è da chiedersi se nello stesso svolgimento del
tema dell’opera, questo approccio determinato da una precomprensione biblica
della religione dia frutti tali da garantire l’accesso a forme di religione estranee
alla predeterminazione biblica dell’evento religioso. Così è da chiedersi se
quanto detto a proposito della preghiera possa valere come comprensivo delle
esperienze meditative, che sono il fulcro dell’evento latreutico per le religione
dell’estremo oriente. A ciò è da aggiungere naturalmente la problematicità dell’estensione dell’aspetto etico dell’evento religioso a tutte le confessioni.
Tutto questo però non può sminuire la profondità di Evento e preghiera,
opera che riesce a guidare, nonostante le asperità del linguaggio casperiano,
nei complessi intrecci del rapporto tra ragione, fede e preghiera. Anzi, l’opera
impegna ad una riflessione ulteriore, che tenga in giusto conto i problemi portati alla luce da Bernhard Casper.
133
134
1
B. CASPER, Das dialogische Denken: Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin
Bubers (1967), Alber, Freiburg-München 2002, 2a ed. ampliata.
2
B. CASPER, Das Ereignis des Betens – Grundlinien einer Hermeneutik des religiösen
Geschehens, Alber, Freiburg-München 1998, trad. it. a cura di Stefano Bancalari, CEDAM, Padova
2003 (le citazioni da questo testo verranno seguite solamente dall’indicazione della pagina tra
parentesi). Per comprendere il discorso filosofico entro cui si inserisce e si colloca la riflessione di
Casper nella filosofia della religione rimandiamo al saggio di A. FABRIS, Oltre l’ermeneutica – Le
«aperture» della filosofia della religione contemporanea in area tedesca, in Filosofie della religione, “Hermeneutica”, Morcelliana, Brescia 2000, pp. 9-39.
3
M. HEIDEGGER, Phänomenologie des religiösen Lebens, a cura di M. Jung/T. Regehly und C.
Strube, GA vol. 60, Klostermann, Frankfurt a.M. 1995, pp. 62-65 (Fenomenologia della vita religiosa, a cura di C. Esposito, Adelphi, Milano 2003), ma importanti pagine di Heidegger sull‘argomento si trovano anche in Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung, a cura di W. Bröcker, GA vol.61, KIostermann, Frankfurt a.M. 1985, pp.
16-21 (Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Introduzione alla ricerca fenomenologica, a
cura di M. De Carolis, Guida, Napoli 1990) e nel successivo Ontologie (Hermeneutik der
Faktizität), a cura di K. Bröcker-Oltmanns, GA vol. 63, Klostermann, Frankfurt a. M. 1988, pp. 7983 (Ontologia. Ermeneutica dell’effettività, trad. E. Mazzarella, Guida, Napoli 1992).
4
Non è certo questo il luogo per riflettere fino a che punto tale indicazione formale riesca a
sfuggire ad un linguaggio ancorato ancora alla categorizzazione trascendentale della scuola neokantiana e della fenomenologia husserliana da cui lo stesso Heidegger cercava di affrancarsi.
5
B. CASPER, La concezione dell’“evento” nella Stella della redenzione di Franz Rosenzweig e
nel pensiero di Martin Heidegger, “Teoria”, XI/1991/2 (Nuova serie I/2), p. 54.
6
B. CASPER, Die Identität in der Nichtidentität der Erwählung zum Verantwortung für den
Anderen, “Analecta Cracoviensa”, XXIX, 1997, pp. 3-16.
7
Casper interpreta questo incontro con l’Altro come una traccia della “Gloria dell’infinito”,
seguendole riflessioni di Levinas di cui proponiamo una lunga citazione a proposito: “Che la gloria
dell’Infinito non si glorifichi che attraverso la significazione dell’uno-per-l’altro, come sincerità; che
nella mia sincerità l’Infinito ecceda il finito; che l’Infinito vi accada –ecco ciò che rende primordiale
l’intrigo dell’Etica e il linguaggio– irriducibile ad un atto tra atti. Prima di mettersi al servizio della vita
come scambio di informazioni attraverso un sistema linguistico, il Dire è testimonianza, Dire senza
Detto, segno dato ad Altri. Segno di che cosa? Di complicità? Di una complicità per niente, di una
fraternità, di una prossimità che è solo come apertura di sé, imprudente esposizione all’altro, passività senza riserva, fino alla sostituzione è, di conseguenza, esposizione dell’esposizione, precisamente Dire, Dire che non dice parole, che significa, Dire che, responsabilità, è la significazione stessa, l’uno-per-l’altro, soggettività del soggetto che si fa segno, ma che a torto si considererebbe un
enunciato balbuziente di una parola, poiché testimonia della gloria dell’Infinito” (E. LÉVINAS,
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1978), trad. it. Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, a cura di S. Petrosino e M.T. Aiello, Jaca Book, Milano 1983, p. 189). Da notare che la gloria dell’infinito è una ripresa da parte di Levinas del Reichgottes kantiano (cfr. I. KANT, La religione
nei limiti della sola ragione, 1793, trad. it. a cura di A. Poggi, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 108).
8
Casper rinvia tacitamente a JACQUES DERRIDA, La différance, in Marges – De la Philosophie,
Editions de Minuit, Paris 1972, pp. 1-29 (Margini della filosofia, a cura di M. Iofrida, Einaudi,
Torino 1997).
9
E. LEVINAS, Autrement qu’être, cit., p. 118.
10
Su questo tema rimandiamo a B. CASPER, Spazio e spazio sacro, “Idee”, 48, 2001, pp. 17-29.
11
Basti qui ricordare la cura del volume Phänomenologie des Idols, Alber, Freiburg-Münchem,
1981.
12
Cfr. M. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), a cura di F.-W. von Herrmann,
GA vol. 65, Klostermann, Frankfurt a.M., 1989, pp. 371 e segg.
“COME LA SPADA DI ODINO…”:
LE PERSISTENTI RAGIONI DELLO STORICISMO
di Sandro Ciurlia
Dopo aver fissato le tappe fondamentali della vita dello Spirito descrivendone le “forme”, Benedetto Croce, in La storia come pensiero e come azione
(1938), concludeva il suo percorso speculativo con il ridurre la realtà a storia.
Quest’ultima costituisce il luogo volto a celebrare il trionfo dell’umano. Se tutto
è storia ogni autentica conoscenza dev’essere storica ed ogni sforzo deve riconoscersi finalizzato a chiarire quel che germina, vive e si consuma nel divenire storico. Ciò si accompagna al parallelo problema dello studio delle condizioni capaci di rendere valida una simile forma di conoscenza. Queste due preoccupazioni alimentano anche gli intenti critici di Giuseppe Galasso, che, non a
caso, al pensiero di Croce ha dedicato ampi ed autorevoli studi. Il titolo del libro
è perentorio ed invita a riflettere sia sulle ragioni dello storicismo, sia sul modo
in cui presente e passato s’intrecciano e si condizionano prima di sciogliersi, a
loro volta, nella storia.
La domanda da cui muove la riflessione di Galasso assume, da subito, un
tono radicale: “Che cos’è la storia? È un modo d’essere della realtà o è un
nostro modo di pensare la realtà?” (p. 13). In altri termini, esiste la storia o gli
storici che la fanno? Ed ancora: se tutto si riduce a storia, è possibile sostenere che, indagandone le distinte configurazioni di senso, si possa cogliere cosa
sia l’uomo?
Ricondurre la realtà alla storia, però, non significa pretendere di farne una
scienza oggettiva del dato, alla maniera di un Leopold von Ranke. Equivale,
piuttosto, a riflettere sul suo ruolo in una società, come la nostra, caratterizzata dal dominio della scienza e della tecnica, nella convinzione del carattere storicamente determinato tanto dell’interprete delle sequenze storiche, quanto
dell’evento storicamente accaduto. Prendendo posizione contro ogni forma di
strutturalismo storicistico, Galasso chiarisce la relatività storica dei concetti di
“categoria”, “mente” e “sapere”. In questo senso, una critica della ragione storica, per dirla con Dilthey, deve dimostrarsi in grado di provare la propria validità senza eludere la propria storicità. Come ammettere, infatti, categorie d’interpretazione del mondo fisse e necessarie se il soggetto che ne è portatore è
egli stesso un individuo storico? In tal modo, qualunque costruzione di pensiero, cosí come il pensiero stesso, è “nella storia e la riflette” (p. 31) e, nel porsi,
esprime “la perenne storicizzazione della storicità” (p. 37).
Quest’ultima espressione rimanda ad una netta presa di posizione sul tema
del tempo. Nel volgersi ad un altro presente, lo storico risponde ad esigenze
del suo presente. Torna qui, pari pari, il filosofema crociano della contemporaneità della storia. Provvede la filologia, secondo Galasso, a “tutelare lo storico
NOTTE
A proposito di un recente contributo critico
di Giuseppe Galasso*
135
136
dal rischio che la sua inevitabile soggettività possa trasformarsi in arbitrio” (p.
47), avviandola verso una compiuta e fondata forma di pluralismo storiografico. La storia torna ad essere un deposito di senso; è interrogata ed utilizzata
in funzione delle urgenze del presente. Cosí, si garantisce al passato una sorta
di condizione di autonomia dipendente. In quest’ottica, torna a recitare un ruolo
di primo piano la dialettica, definita come “il piú potente e piú specifico strumento” (p. 60) dell’analisi storica. La dialettica del sapere storico fonda uno
storicismo svincolato da derive scettiche o da tentazioni relativistiche. La vita è
la sintesi dialettica di tanti eventi e la storia ne è la rammemorazione. A giudizio di Galasso, non va commesso l’errore, però, di confondere dialettica e progresso storico. Gli storicismi assoluti di sensibilità romantica, infatti, avevano
celebrato il solenne divenire dell’umanità all’insegna di una scala evolutiva
volta ad officiare le ‘magnifiche sorti e progressive’ dell’umano. Nulla di tutto
ciò. Il riferimento alla dialettica –con Croce ed oltre Croce– va colto come sinonimo dell’intricata combinazione di fatti e problemi che caratterizzano la vita e
la storia. Non c’è piú, dunque, la Storia, ma le storie, alla Civiltà si sostituiscono le civiltà, immerse nei circuiti di forze dei contesti socio-economico-culturali di cui sono espressione. Principî spesso in contrasto, traiettorie di pensiero
talvolta non sovrapponibili, salti tra eventi da cui discendono cesure e/o continuità storiche esprimono il senso della dialettica storica. In una parola, “le
modificazioni sono […] la ‘legge’ della storia” (p. 97): la dialettica ne è la chiave interpretativa.
Lo storico vive, dunque, il proprio presente e si volta ad osservare il passato: crea, cosí, un circolo senza un inizio ed una fine tra presente e passato.
Una volta stabilita la “circolarità dell’orizzonte storiografico” (p. 110), maturano
le condizioni per disporsi, a parere di Galasso, lungo un’autentica prospettiva
storica, rendendo possibile un’“intelligenza storicamente atteggiata” (p. 112).
Questo dimostra come le alterne vicende del dibattito sul senso della storia
nella cultura del XX secolo non debbano per forza coincidere con i destini dello
storicismo come teoria critica della storia. Riflettere sulla storia significa pensare ad un largo archivio di significati al quale proprio la storiografia accede
con il suo continuo interrogare il passato a partire dal presente.
Quest’incessante processo elimina ogni proposito di “fondazione ontologica
della storicità” (p. 135) ed educa a guardare al tortuoso e spesso lento sviluppo dei grandi processi. Del resto, l’analisi storiografica non conosce iati tra torni
temporali al suo interno come non li conosce la storia stessa: essa, infatti, nello
storicizzare si storicizza.
Quest’impostazione induce a rivedere affrettati giudizi sulla crisi o la povertà dello storicismo. Il riferimento polemico di Galasso è alle posizioni di Popper,
al quale si può rimproverare, nel complesso, un utilizzo assai riduttivo del concetto di storicismo. Com’è noto, Popper aveva sottoposto a radicale critica ogni
forma di filosofia provvidenzialistica della storia. A suo giudizio, lo storicismo
era, per un verso, il suggello dell’assolutismo politico, fondato su società chiuse ed autoritarie; per l’altro, si dimostrava del tutto erroneo nella sua pretesa di
dare un senso complessivo alla storia dell’umanità, pretendendo di poterne
prevedere gli sviluppi1. Da qui la “miseria” di un metodo, che dimostra di fare
NOTTE
un uso scorretto della categoria dell’“accrescimento”2, per quanto si dimostri
estremamente seducente per la sua disposizione a coordinare le azioni degli
uomini in una trama sovraindividuale3. Qualche anno prima, un altro critico
dello storicismo, Karl Löwith, aveva denunciato il carattere mistico-ieratico di
ogni filosofia della storia, ritenuta ormai non piú in condizione di soddisfare le
esigenze di senso dell’età della tecnica4.
Tale crisi dell’impianto classico dello storicismo coincise con radicali stravolgimenti della cultura europea in anni in cui le urgenze dei conflitti mondiali
costringevano a rivedere la fiducia nelle varie forme di provvidenzialismo filosofico. Prendeva avvio, da questa condizione di crisi, il modello di una “nuova
storia”, consapevole del carattere relativo dei suoi risultati e cosciente di doversi soprattutto confrontare con le scienze sociali. Nessun entusiasmo o nostalgia, dunque, per le grandi storie ‘a disegno’ ottocentesche, a favore, invece,
dell’esigenza di un rinnovato contatto con le singole branche delle scienze dell’uomo. Questi processi –ne è convinto Galasso– non costituiscono di per sé
un superamento dello storicismo, ma designano solo il commiato da un modello di storia finalizzato a celebrare l’evoluzione necessaria del genere umano.
Se ci si è liberati dai grandi quadri dello storicismo assoluto, allora si deve concludere che il relativismo rappresenta lo “sbocco fatale” (p. 159) dello storicismo? No di certo: si continua ad essere influenzati da una robusta mentalità
storicistica che, secondo l’autore, come “la spada di Odino […], guarisce, ma
prima ferisce e lacera” (p. 161).
Torna, cosí, la vexata quaestio dei rapporti tra filosofia e storiografia.
Galasso rimane sempre fedele ad un’idea della filosofia come “coscienza critica della storia” (p. 173), come momento di “chiarificazione metodologica” della
ricerca storica, avrebbe detto Croce5. Il legame tra i due momenti, pertanto, è
strettissimo: “L’identità di filosofia e storia della filosofia […] è un concetto profondo e, nella sostanza, incontrovertibile” (Ib.). Ma la filosofia è, soprattutto, riflessione sul proprio tempo e, dunque, sulla base delle sollecitazioni che coglie
in un dato presente, si volge al passato. Si tratta ancora del tema della contemporaneità della storia. La circolarità dell’orizzonte storiografico pone assieme presente e passato, combina vichianamente filosofia e filologia. In quest’ottica, il celebre adagio classico sulla storia come magistra vitae perde di senso:
guardare al passato con gli occhi del presente significa interpretarlo, aggiungendo “sempre qualcosa di nuovo, di imprevedibile, di indeducibile dallo stesso passato” (p. 176). Com’è piú che evidente, alle spalle di queste posizioni c’è
Croce. Galasso descrive con convinti accenti crociani anche il carattere del
giudizio storico alle prese con l’ardua sintesi tra il «momento individuale» ed il
“momento universale”. Emerge, ad ogni modo, una posizione forte, tesa ad
evidenziare la storicità di ogni forma di giudizio, anche di quello delle scienze:
in tal modo, la netta distinzione storicistica tra scienze idiografiche e scienze
nomotetiche tende, se non ad attenuarsi, quantomeno a problematizzarsi.
“L’opera storiografica, insomma, induce e deduce in simultaneità logica” (p.
186), approfitta di spinte di riflessione nate nel presente, ma non si riconosce
soggetta ai gusti del singolo storico. Il capriccioso spettro del relativismo è,
cosí, scacciato. Naturalmente, questa posizione non riporta in luce vecchie filo-
137
138
sofie della storia; si libera, piuttosto, dagli estremi del “pirronismo” e dello stretto “pragmatismo storiografico” (p. 189). Nel fare storia, lo storico adotta un “criterio di selezione”, sostenuto dagli strumenti offertigli dalla filologia ed in risposta ai problemi che lo agitano nell’intimità della sua coscienza intellettuale e
civile6. Viene in mente, al proposito, l’invito di Lucien Febvre a non scindere
mai l’interesse storico dall’attiva partecipazione al presente7: Galasso ne è, in
questo, un fedele interprete.
La ricerca storiografica, dunque, si articola in molteplici vie e si dimostra
duttile al punto di usufruire dei contributi provenienti dalle scienze umane, specie dalla sociologia. Galasso ricostruisce i percorsi di tale intersecazione, dalla
prospettiva durkheimeana all’odierna sociologia americana. Le due sfere disciplinari conservano, però, una differente idea del concetto di “mutamento”: ciò
sancisce l’“irriducibilità sociologica della storiografia” (p. 239). La storia studia,
infatti, serie definite di eventi, socialmente determinanti o non che siano.
D’altra parte, se lo storico analizza i modelli di società in cui gli uomini di ogni
tempo vissero creando la propria vicenda storica, la storiografia è, a sua volta,
un prodotto sociale. Da qui un rapporto tra gli àmbiti disciplinari che coglie i
migliori frutti di sé quando riconosce le differenze: una netta risposta di
Galasso, questa, a chi propone una riduzione della storia alle scienze sociali.
Secondo Galasso, lo storicismo ha avuto il merito di restituire la storia al suo
ruolo di centralità nel panorama culturale di un’Europa nuova, quella dei primi
del Novecento. Oggi, la divulgazione del “prodotto storiografico” appare assai
ampia, in un’epoca dominata da uno sviluppo cosí elevato della tecnologia da
non poterne non ravvisare gli effetti sia nel concreto esercizio storiografico, sia
nel circuito della diffusione dei risultati della ricerca storica.
Galasso dedica l’ultima parte del suo libro a questa tematica, analizzando
criticamente le modalità attraverso cui va modificata la nostra nozione di “fonte
storica” nella società della comunicazione di massa. Il computer cambia la vita
dello storico, muta la collocazione delle “frontiere” del suo gesto critico.
Bisogna tenere conto, ormai, delle fonti audiovisive, per un verso, e far uso dei
ritrovati della tecnica, per l’altro, al fine di “aderire” nel modo migliore alla realtà delle cose di cui si vuole offrire testimonianza. I calcolatori elettronici, inoltre, consentono una piú rapida consultazione degli archivi. Il numero degli
utenti, dunque, si allarga in modo considerevole. È possibile, a questo punto,
chiedersi: quello dello storico diventa, in tal modo, un mestiere cosí diffuso che
rischia di perdere in specificità? È, questo, uno dei pericoli e Galasso non esita
a ravvisarlo.
Certo, questi nuovi strumenti informatici preservano meglio e piú a lungo il
nostro materiale documentario, superano vecchie barriere e desueti sbarramenti gerarchici; tuttavia, essi presentano anche forti limiti legati alla larga diffusione dei dati ed ai forti interessi che governano tale meccanismo e che possono anche andare, alla lunga, a detrimento della serietà e dell’inflessibile rigore della ricerca critica. I media vanno trattati, dunque, come un prodotto storico e come uno strumento della stessa indagine storica, senza enfasi, né abbattimenti. Lo storico prende atto di tali limiti, “ma neppure può fare di piú” (p.
348). E se egli se ne serve con disinvoltura ogniqualvolta è necessario, li valu-
NOTTE
ta come un prodotto storico del XX secolo e, agli inizi del XXI, li considera
come uno “strumento pedagogico e didattico e come uno strumento di formazione dell’opinione pubblica e della cultura corrente” (p. 350).
Le sollecitazioni critiche e gli spunti problematici che questo libro propone
sono numerosi. Esso innanzitutto testimonia la solida disciplina di una militanza critica e metodologica, quella di Galasso, e, nella fattispecie, la fiducia nel
magistero di Croce; in secondo luogo, leggendo queste righe, è possibile
cogliere, per via indiretta, lo stato di salute dello storicismo dinanzi alle sfide
dell’era della globalizzazione, uno storicismo critico, non piú assoluto. Il primo
aspetto è evidente ad ogni passo: Galasso non solo non esita a definire lo storicismo come la «vetta piú elevata della coscienza e delle scienze europee» e
come la «via regia da seguire» (p. 160) per superare ogni filosofia della crisi,
ma giunge a parlare, crocianamente, della storia come «storia della libertà» o
a far uso di termini quali “universale” ed “individuale”. In fondo, però, non è
questo il punto. Non è in discussione la prossimità di Galasso alle posizioni di
Croce, né ciò costituisce un titolo di demerito, specie in un tempo, come il
nostro, che tende a disconoscere i propri padri.
La questione è, piuttosto, valutare in quale misura l’idea di calare ogni realtà pensabile nella storia sia in grado di offrire effettive risposte alle nostre attuali inquietudini critiche. Galasso si appella alla proposta crociana dell’eterna
contemporaneità della storia. In tal modo, riesce, con disinvoltura, a pensare al
passato come al luogo da cui possono essere tratte lezioni significative solo a
muovere dalle urgenze del presente. Da qui l’invito ad interpretare il passato,
a porgli domande, ad impensierirsi dinanzi a vicende che hanno caratterizzato
lo svolgersi di un altro presente, ad articolare problemi piú che a cercare risposte univoche. Cosí, l’indagine storiografica finisce col diventare un’impresa critica ed un’operazione a suo modo ermeneutica, fatta d’incessanti domande e
di molteplici risposte. Una proposta raffinata, tale da rendere lo storicismo una
prospettiva all’altezza del nostro tempo. Ma l’ombra di una filosofia della storia
tesa a celebrare il primato ontologico del presente è sempre in agguato;
Galasso ne smorza efficacemente i termini, per quanto il suo sguardo pietrificante aleggi seducente e minaccioso sullo sfondo. La proposta di Galasso, ad
ogni modo, costituisce, nell’odierno panorama delle riflessioni sullo statuto
della ricerca storica, un originale modo di guardare alla trasformazione del
ruolo e degli strumenti della storia da una prospettiva fondata sui principî della
tradizione crociana. E non è cosa da poco aver accettato la sfida ed esserne
usciti quantomeno indenni.
La riflessione sul tema delle fonti storiche nell’era della massima fruizione
dei ritrovati della tecnica informatica suscita numerosi interrogativi: la circolazione telematica degli archivi, l’apertura del bacino di utenza del materiale
documentario, i limiti di esattezza e di rigore tipici dei media non rischiano di
rendere quella dello storico una professione di tutti e di nessuno, priva –come
si ridurrebbe ad essere– di ogni specificità? Marc Bloch e Lucien Febvre hanno
insegnato ad intendere quello dello storico come un mestiere aduso all’utilizzo
di certi “ferri” ed alla pratica di certe “tecniche”8. Ora, nella prospettiva della
“nuova storia”, a cosa si riduce il mestiere dello storico? Un utilizzo diretto e
139
140
senza mediazioni delle fonti, com’è consentito dalla telematica, nelle mani di
intelligenze non addestrate a cogliere i ‘trucchi’ del mestiere a quali risultati
condurrebbe? Un dato, infatti, ha bisogno dello sguardo giusto per poter essere colto e può dare risposte solo a domande sensate e ben articolate, altrimenti rimane muto. La pertinenza dell’interrogazione, dunque, rimane una delle
condizioni dell’ottenere risposta. Alla realizzazione della dialettica domandarisposta concorrono sia la massa delle gadameriane “pre-comprensioni”, sia
un rinnovato rapporto con la tradizione, da intendersi come uno sterminato
archivio di senso a cui attingere per comprendere meglio il passato e per capire con maggiore raffinatezza il presente9.
Un’altra questione che Galasso tratta con tatto e competenza è quella del
“pubblico” del prodotto storico. Viviamo in un’età in cui il consenso ed il profitto sembrano essere i soli due indici del successo. Abituarsi a scrivere opere di
storia capaci di essere, al tempo stesso, accattivanti e rigorose, come propone George Duby, è un conto10; ridurre la storia a letteratura piú o meno frivola
e pensare alla ricerca in funzione dei riscontri del mercato è tutt’altra cosa.
Infatti, per incrementare le vendite, bisogna rendersi in grado di colpire il lettore medio senza appesantirlo con ‘gravosi’ apparati filologici. Qui nasce il problema: questi ultimi, talvolta, sono necessari per dare sostanza ad un’ipotesi
interpretativa, anche se possono essere considerati come il frutto della piú
noiosa pedanteria. Porgo solo qualche domanda: in queste condizioni si possono davvero proporre serie questioni d’ordine storico? La storia ridotta a
romanzo storico per ragioni di mercato quali traiettorie euristiche consente di
compiere? A chi rende conto lo storico dei risultati a cui è pervenuto: alla comunità degli specialisti o ai targets delle grandi catene editoriali? È possibile soddisfare le esigenze di entrambi senza perdere né in dignità critica, né in brillantezza espositiva? Difficile rispondere, anche perché, forse, non è dato pervenire ad una sola risposta.
Galasso sollecita a riflettere su ciascuno di questi punti e lascia intendere
quante accezioni abbia il termine storicismo e quanti servigi può ancora offrire. E, tra tante domande, l’autore esprime una ragionevole certezza: riconoscere che ogni realtà ha un carattere storicamente determinato non significa
rendere la storia un Soggetto autotetico in divenire, quanto pensarla alla
maniera di un percorso spesso sconnesso, incerto, casuale, fatto di molteplici
e persino contraddittorie vie lungo cui, da sempre, scorrono non solo gli errori, le passioni, le illusioni, ma anche i grandi progetti della ragione.
* G. GALASSO, Nient’altro che storia. Saggi di teoria e metodologia della storia, Il Mulino,
Bologna 2000, pp. 384. Le citazioni tratte da questo libro sono indicate, nel corpo del testo, in
parentesi tonde.
1
Cfr. K. POPPER, Miseria dello storicismo, tr. it., a c. di C. Montaleone, Feltrinelli, Milano 20023,
p. 17. Com’è noto, la prima edizione di quest’opera risale al 1957.
2
Cfr. Ivi, p. 18.
3
Cfr. Ivi, p. 158.
Cfr. K. LOWITH, Meaning in History, Chicago University Press, Chicago 1949.
B. CROCE, Teoria e storia della storiografia, Laterza, Bari 19669, pp. 141-53 (Appendice III).
La prima edizione di questa celebre opera crociana è del 1917.
6
Qualcosa di analogo ha espresso anche K. Popper quando, nel 1994, ha scritto: «Non è possibile scrivere di storia senza prendere posizione nei confronti dei problemi fondamentali della
società, della politica e della morale» (K. POPPER, Tutta la vita è risolvere problemi. Scritti sulla
conoscenza, la storia e la politica, tr. it., a c. di D. Antiseri, Rusconi, Milano 1996, p. 161).
Nonostante la critica senz’appello di Popper allo storicismo, rimane vivo l’invito del filosofo austriaco, nello studiare la storia, a partire dai problemi del presente e ad offrire nuovi spazi d’espressione alla libera creatività dello storico (cfr. ivi, p. 163).
7
L. FEBVRE, Problemi di metodo storico, tr. it., a c. di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1976, pp. 1523: “Per fare storia […] vivete. Mescolatevi alla vita. […] Ma vivete anche una vita pratica […]. [Non]
dovete continuare a separare la vostra azione dal vostro pensiero, la vostra vita di storici dalla
vostra vita di uomini. Fra azione e pensiero non c’è separazione […]. Bisogna lavorare d’accordo
con tutto il movimento del proprio tempo”.
8
Cfr. soprattutto M. BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, a c. di L. Febvre,
Colin, Paris 1949.
9
Sull’attualità dello storicismo hanno soprattutto insistito in Italia, nell’ultimo quindicennio,
con diverse ragioni e con differenti finalità dimostrative, R. BODEI, La storia senza senso, in G.
VATTIMO, a c. di, Filosofia al presente, Garzanti, Milano 1990, pp. 9-24; R. BODEI, Se la storia ha
un senso, Moretti & Vitali, Bergamo 1997 e F. TESSITORE, Il senso della storia universale,
Garzanti, Milano 1987; ID., La questione dello storicismo, oggi, Rubbettino, Soveria Mannelli
1997. Ciò dimostra come l’impianto dello storicismo sia tutt’altro che sull’orlo del collasso, vista
l’ormai diffusa necessità di combinare, nell’era della globalizzazione, le azioni del singolo con i
processi che le coinvolgono. In quest’ottica ed in seno a tale dibattito, la proposta di Galasso di
uno «storicismo critico» emerge in tutta la sua rilevanza e contribuisce a problematizzare ulteriormente il confronto. Per una discussione del problema della rinascita dello storicismo nell’orizzonte del mutamento della nostra idea critica di storia dopo la crisi delle grandi filosofie della storia, si permetta di rinviare al nostro La sfera e il punto: immagini filosofiche della storia a confronto, “Arché”, IV (2002), pp. 27-60.
10
Cfr. G. DUBY, Scrivere la storia, in A. ASOR ROSA, a c. di, La scrittura e la storia. Problemi di
storiografia letteraria, La Nuova Italia, Firenze 1995, pp. 43-53.
4
NOTTE
5
141
IL FEMMINILE TRA ANTROPOLOGIA
E CRISTIANESIMO.
LA LETTURA DI ANGELA ALES BELLO
di Giovanni Invitto
Il libro di Angela Ales Bello, Sul femminile. Scritti di antropologia e religione,
ripropone il pensiero di questa intellettuale “anomala” nel panorama italiano.
Studiosa, anche filologicamente agguerrita, di Husserl, attenta al pensiero femminile che nasce all’interno della fenomenologia soprattutto tedesca, primo (o
prima?) decano-donna di una Università Pontificia, la Lateranense. È colei,
infine, che ha riproposto, in maniera determinante, Edith Stein come filosofa e
ne ha agevolato il riconoscimento di santità.
Il curatore di questo volume, che raccoglie saggi precedenti, afferma:
“Risulta chiaro quanto sia importante uno sguardo sul ‘femminile’ –ma potremmo dire sull’essere umano– privo, il più possibile, di pregiudizi ideologici e
attento a cogliere nella sua totalità il fenomeno in questione”1.
142
Il cristianesimo e la donna.
La tesi di fondo perseguita e documentata dall’autrice, nel volume di Città
Nuova, è che sia stato il cristianesimo a riconoscere e a valorizzare la differenza di genere e il ruolo delle donna: “E che l’umanità non sia solo fatta da uomini è un’idea che solo recentemente nell’area culturale occidentale si sta mettendo in crisi, si sta cioè distinguendo una concezione androcentrica e un’antropologia –anche se il termine contiene sempre un riferimento al maschile, il
linguaggio non ne possiede uno diverso– secondo la quale l’umanità è fatta da
uomini e da donne. La consapevolezza di questo fatto, che deve entrare nella
coscienza comune, è frutto del messaggio di Cristo. Per tale ragione parlare
della donna nell’antropologia cristiana sembrerebbe quasi un’ovvietà”2.
È superfluo qui ricordare i brani evangelici che possono testimoniare quanto affermato da Ales Bello. Lei riprende anche Gertrud von le Fort, quando
afferma che i maggiori misteri del cristianesimo entrarono nel mondo per
mezzo della donna, non dell’uomo: il messaggio natalizio, quello pasquale, la
discesa dello Spirito Santo che “mostra l’uomo nell’atteggiamento femminile di
chi riceve”, la “cellula primogenita della Chiesa”. “Il motivo femmineo risuona
attraverso tutta la creazione3.
Ma data questa affermazione di principio, la nostra autrice non dissimula il
fatto che spesso la cristianità, i cristiani siano stati diversi dal cristianesimo. E
abbiamo avuto una storia dell’eclisse del “femminile”, anche a causa di certi
modelli culturali della cristianità. Ciò ha comportato alcune contraddizioni teoriche in intellettuali di primario livello. Penso a Tommaso d’Aquino, quando
Edith Stein: il maschile, il virile, il femminile
Uno dei punti teorici ricorrenti, in questa fase della riflessione di Ales Bello,
è il pensiero di Edith Stein. È lei che definisce le peculiarità antropologiche e
culturali della differenza di genere quando afferma che “la specie femminile
dice unità, delimitazione dell’intera personalità corporeo-spirituale, sviluppo
armonico delle potenze; la specie virile dice elevazione di singole energie alle
loro prestazioni più intense”6.
Il termine virile aveva avuto, tra l’altro, nella tradizione cattolica un uso non
limitato alla nuda determinazione sessuale, ma aveva assunto una connotazione più propriamente etica. Il caso forse più interessante è l’uso amplissimo che
ne fa la domenicana Caterina da Siena. Ella scrive alla regina di Napoli, che
era contro il Papa: “Voi avete invitato e invitate il popolo e tutti e’ sudditi vostri
ad essere più contra a voi, che con voi; avendo trovata nella persona vostra
poca verità, non condizione d’uomo con cuore virile, ma di femmina senza
neuna fermezza o stabilità, siccome femmina che si volle come la foglia al
vento”7. Ma in altri passaggi è ancora più chiaro il senso etico, e non di genere, nell’uso cateriniano: “O governatore nostro, io dico che ho lungo tempo
desiderato di vedervi uomo virile e senza veruno timore; imparando dal dolce
e innamorato Verbo, che virilmente corre all’obbrobriosa morte della santissima Croce, per compiere la volontà del Padre e la salute nostra”; e: “Fate virilmente: che Dio è per voi”8. Non va dimenticato, in tutto questo, che l’etimo collegava i termini vir e virtus.
Andando oltre, nella Edith Stein letta da Angela Ales Bello, l’antropologia
del femminile è peculiare perché alle differenze biologiche si accompagnano
NOTTE
aveva afferma che femina est animal imperfectum4, per quanto questa sua
affermazione fosse rivolta al generale animale. Ma il maschio e la femmina
umani non rientrano in questo genere? Però, lo stesso Tommaso, quando
affronta il tema del corpo glorioso, si trova a dover difendere il ruolo della
donna nella chiesa e nell’economia della salvezza. Egli respinge una obiezione relativa alla veridicità della resurrezione di Cristo, presentata da chi aveva
detto: visto che la resurrezione, secondo i testi, fu predicata da donne e visto
che le donne, per dettato paolino e per tradizione magisteriale, nella chiesa
debbono tacere, se ne deduce che la resurrezione non c’è stata. La risposta di
Tommaso è articolata: è vero che le donne non hanno nella chiesa facoltà di
insegnamento, ma è anche vero che possono istruire con potere che deriva dal
ruolo che assolvono nei rapporti famigliari. Qui l’Aquinate ricorda un brano di
Cirillo che, proprio per la testimonianza della resurrezione, chiedeva che
dovessero eliminarsi l’ignominia e la maledizione che pesavano sul genere
femminile. D’altro canto, scrive Tommaso, se la carica di amore è maggiore
nelle donne, perché Cristo non avrebbe dovuto premiarle, manifestando a loro
per prime la sua resurrezione? Non è forse vero, ricorda il filosofo, che, mentre i discepoli maschi si erano allontanati dal sepolcro, per stanchezza o per
sfiducia, le donne erano rimaste lì, forti e fedeli?5
143
differenze spirituali: “Non solo il corpo è strutturato in modo diverso, non solo
sono differenti alcune funzioni fisiologiche particolari, ma tutta la vita del corpo
è diversa, il rapporto dell’anima e col corpo è differente, e nell’anima stessa è
diverso il rapporto dello spirito alla sensibilità, come rapporto delle potenze spirituali tra loro”9.
Antropologia e mistica
144
Una visione che mette insieme la connotazione antropologica e l’esperienza religiosa, deve necessariamente dar conto anche di una categoria
esistenziale che ha visto quel rapporto vissuto anche in parte considerevole dalle donne. Ci si riferisce al misticismo. Ma il misticismo può avere colorazioni diverse a seconda se a viverlo sia un maschio o una donna? Ancora
una volta è Edith Stein a porre, anche se indirettamente, il problema, quando scandisce quasi un inventario delle categorie spirituali del femminile: “La
particolarità del modo di conoscere della donna, che ha una peculiare forza
per intuire il concreto e il vivente, specialmente il personale; l’attitudine di
far propria la vita personale altrui, come anche scopi e tipi di lavoro altrui;
l’importanza fondamentale che ha in lei l’animo inteso come la potenza che
conosce l’oggetto nella sua particolarità e nel suo valore specifico e fa assumere una retta posizione di fronte ad esso; il desiderio di portare alla massima perfezione possibile l’umanità nelle sue espressioni specifiche e individuali, sia in sé che negli altri; il posto predominante dell’elemento erotico
(non sessuale) in tutta la vita; un più puro dispiegamento di tutta una vita in
un amore pronto a servire”10. Angela Ales Ales spiega che il termine erotico,
qui usato, deve essere ben compreso, perché non ha l’accezione corrente,
ma il significato platonico del più alto grado d’amore di cui sia capace un
essere umano11.
Questo è vero, per quanto, nella narrazione che alcune mistiche fanno del
loro incontro con Dio, il linguaggio sia quello di una affettività tipicamente femminile. È Simone Weil a scrivere che Dio “viola l’anima”; lei si definisce “sedotta”, “catturata” da Cristo, l’anima “non si dà ma è presa”. Inoltre la Weil, narrando dei suoi incontri con Cristo, li racconta così: “Cristo è venuto a prendermi per la prima volta”; Dio è “un amante che dice per ore, sommessamente
all’orecchio, io ti amo, ti amo, ti amo”. “A volte […] Cristo è presente in persona, ma di una presenza infinitamente più reale, più pregnante, più chiara e più
piena di amore di quella prima volta quando mi ha presa”12.
Questo va detto perché la corporeità, maschile e femminile, è comunque
ineliminabile da ogni esperienza del soggetto. È ancora Simone Weil a dichiararci la funzione anche ermeneutica del corpo: “Il mondo è un testo a più significati e si passa da un significato all’altro con un lavoro. Un lavoro in cui il corpo
ha sempre parte, come quando s’impara un alfabeto di una lingua straniera:
questo alfabeto deve entrare nella mano a forza di tracciare lettere… Al di fuori
di ciò, ogni cambiamento nel modo di pensare è illusorio”13.
Queste suggestioni teoretiche sono tutte sollecitate e richiamate dalla
1
A. ALES BELLO, Sul femminile. Scritti di antropologia e religione, a c. di M. D’Ambra, Città
Nuova, Roma 2004, p. XXIII.
2
Ivi, p. 3.
3
Ivi, p. 13; la citazione è da G. VON LE FORT, La donna eterna, (1934), trad. it. a c. di G. Federici
Ajroldi, Istituto di Propaganda Libraria, Milano 1960, p. 29.
4
“Quia holocaustum erat perfectissimum inter sacrificia, ideo non offerebatur in holocaustum
nisi masculus, nam femina est animal imperfectum. Oblatio autem turturum et columbarum erat
propter paupertatem offerentium, qui maiora animalia offerre non poterant”; Summa Theologiae,
Ia IIae, q.102, a. 3, ad 9.
5
“Hoc autem testimonium ferebant publice praedicando. Quod quidam non convenit mulieribus: secundun illud I Cor., 14 [34]: Mulieres in ecclesiis taceant; et I Tim. 2, [12]: Docere mulieri
non permitto. Ergo videtur quod inconvenienter resurrectio Christi manifestata fuerit primo mulieribus quam hominibus communiter […]. Respondeo […] dicendum quod mulieri non permittitur
publice docere in ecclesia: permittitur autem et privatim domestica aliquos admonitione instruere.
Et ideo, sicut Ambrosius dicit, super Luc., ad eos femina mittitur qui domestici sunt: non autem mittitur ad hoc quod resurrectionis testimonium ferat ad populum. Ideo autem primo mulieribus apparuit, ut mulier, quae primo initium mortis ad hominem detulit, primo etiam initia resurgentis Christi
in gloria nuntiaret. Unde Cyrillus dicit: Femina, quae quondam fuit mortis ministra, venerandun
resurrectionis mysterium prima percepit et nuntiat. Adeptum est igitur femineum genus et ignominiae absolutionem, et maledictionis repudium [In Ioan., l.XII, c.I, super 20,17]. Simul etiam per hoc
ostenditur quod, quantum ad statum gloriae pertinet, nullum detrimentum patietur sexus femineus,
sed, si maiori caritate fervebunt, maiori etiam gloria ex visione divina potientur: eo quod mulieres,
quae Dominum arctius amaverunt, in tantum ut ab eius supulcro, discipulis etiam recedentibus,
non recederent [GREG., Hom.25 in Evang., n.1,; M.L. 76, 1189 C.], primo viderunt Dominum in gloriam resurgentem” (Summa Theologiae, p.III, q.55 a.1, 3).
6
E. STEIN, La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia, trad. it. a c. di O. M. Nobile,
pref. di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1995, p. 204; cit. alle pp. 19-20 del testo qui discusso.
7
S. CATERINA DA SIENA, Le lettere, a c. di U. Meattini, Ed. Paoline, Milano 1987, lettera n. 317,
p. 315.
8
Ivi, lettera n. 270, pp. 104 e 106.
9
La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia, cit, p. 204; nel volume di A. Ales Bello
la cit. è a p. 19.
10
Ivi, p, 195; in A. ALES BELLO, op. cit., è a p. 144.
11
Ibidem.
NOTTE
importante silloge degli scritti sul femminile di Angela Ales. E, in questo gioco
di echi, ritorna alla mente un pensatore sicuramente lontano dalle rive teroretiche della docente della Lateranense. Mi riferisco a Gianni Vattimo, con il suo
“pensiero debole”, quando rivendica un cristianesimo e una teologia della carità: “Una tale norma –la carità, che è destinata a rimanere tale anche quando
la fede e la speranza non saranno più necessarie, una volta realizzato completamente il regno di Dio– giustifica pienamente, mi pare, la preferenza per una
concezione ‘amichevole’ di Dio e del senso della religione. Se questo è un
eccesso di tenerezza, è Dio stesso che ce ne ha dato l’esempio”14.
Qui si riapre, in maniera inattesa, il discorso di donna e “cura”, recuperato
dal pensiero femminile ma non ridotto ad una asfittica connotazione o “recinto”
di genere, e che può rinviare alla “virtù” della carità. Tutto ciò è una ulteriore
prova di come questa raccolta di scritti di Ales Bello sia importante anche per
le molteplici evocazioni filosofiche, teologiche e letterarie che comporta e sollecita.
145
12
Le citazioni sono tratte dalle seguenti opere weiliane: La connaissence surnaturelle,
Gallimard, Paris 1950, pp. 9-10; Cahiers II, Plon, Paris 1972, p. 299; La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Torino 1967, p. 116; Cahiers II, cit., p. 293; Attente de Dieu, Fayard, Paris 1966,
p. 158; La connaissance surnaturelle, cit., p. 77; Attente de Dieu, cit., p. 49. Su questo aspetto, cfr.
il mio Philosopher “en femme”. Raccontare Simone Weil, in Donne in filosofia, a c. di G. A.
Roggerone, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 1990, pp. 113-125.
13
Cahiers, I, Paris 1970, n. e., p. 132.
14
G. VATTIMO, Credere di credere, [1996], Garzanti, Milano 1998, p. 195. Sul rapporto di Gianni
Vattimo con la fenomenologia e il cristianesimo, cfr. Perché “oltre la fenomenologia”.
Conversazione con Gianni Vattimo, “Segni e comprensione”, n. 52, a. XVIII, maggio-agosto 2004,
pp. 41-52.
146
PARADISI PERDUTI
E DIALOGHI DIFFICILI
La Lettera ai Vescovi del Cardinale Ratzinger, datata 31.5.2004, tratta della
“collaborazione attiva, nel riconoscimento della loro differenza, tra uomo e
donna” proponendone alcuni presupposti da approfondire attraverso un dialogo diffuso e una volenterosa ricerca. Nell’intento di rispondere a queste richieste, propongo a mia volta una serie di considerazioni filosofiche.
La Lettera dichiara nell’Introduzione di ispirare le sue riflessioni, nell’intento di controbattere alcune correnti di pensiero sulla questione femminile, ai
“dati dottrinali dell’antropologia biblica”, e sembra così giustificare il fatto di non
prendere in considerazione le argomentazioni filosofiche e scientifiche di maggior rilievo su tale questione, che non mancano neanche nel pensiero cattolico. Si presenta, quindi, come un invito a misurarsi sul terreno della Sacra
Scrittura: invito che certamente non intendo qui ignorare.
Tuttavia, prima di affrontare l’argomento della Lettera è inevitabile notare
una singolare incongruenza nelle sue prime righe, là dove si riferisce ad alcune “nuove tendenze” che si sarebbero delineate in “questi ultimi anni”, che
sono la tendenza all’antagonismo verso il potere maschile, e l’altra che nega
le differenze tra i due sessi. In realtà, la prima tendenza non solo ha radici
molto antiche nella cultura precristiana, come testimoniano i miti del matriarcato originario e delle amazzoni, ma anche ha dato luogo nella storia moderna,
a partire dal seicento, ad una lunga serie di scritti e di movimenti di lotta e contestazione, in Europa come in America1. Nemmeno la seconda tendenza è
nata oggi, essendosi costituita come corrente di pensiero e diffusa largamente
nel mondo a metà del secolo scorso. Entrambe le tendenze appartengono del
resto ad una storia secolare di critiche e denunce della condizione femminile,
spesso anche firmate da uomini illustri, che ha caratterizzato in modo decisivo
l’evoluzione del pensiero occidentale.
Ma oggetto dell’attenzione del cardinale, in realtà, non sono i movimenti
minoritari di contestazione politica e intellettuale, ma il fatto che l’antagonismo
e l’egualitarismo tra i sessi siano ormai penetrati nella percezione comune, trovando un terreno fertile nello stile di vita individualistico e libertario largamente accettato nel costume sociale. A margine si può notare che il prelato ha scarsa conoscenza del significato che oggi ha assunto la parola “differenza”: dopo
aver sostituito la parola “parità” essa è usata per sottolineare la volontà femminile di essere indipendenti rimarcando forme anche estreme di separatismo,
ma al tempo stesso questa parola convive con i più disinvolti atteggiamenti di
richiamo sessuale e con l’indistinzione dei generi nello stile unisex. Tale è il
mutamento delle cose, del resto, che il discorso di Ratzinger può apparire in
NOTTE
di Graziella Morselli
147
148
molti punti anacronistico e riduttivo, anche se ha cura di fare concessioni a
quello che ormai è senso comune, riconoscendo alcuni diritti acquisiti dalle
donne nei Paesi democratici, come quello della partecipazione alla vita produttiva e alle decisioni politiche, e quello della scelta libera riguardo ad un’attività
di casalinga a tempo pieno. In questo senso il documento ha potuto trovare
l’approvazione di parte delle donne che fanno opinione.
Alle quali, tuttavia, è sfuggita in genere la sostanza della Lettera, che sulle
dinamiche dell’esperienza vissuta fa incombere un “sempre presente” di carattere ideale.e relativizza il tempo storico al cospetto dell’eternità. Ancorato ad un
passato che non conosce evoluzioni reali né trasformazioni possibili, questo
scritto va contro il senso della storia: un anacronismo che ricorrendo alla filosofia possiamo cercare di chiarire nel suo motivo profondo.
Infatti, gli interrogativi che riguardano il gioco degli anacronismi e la sfera di
senso che li accompagna rientrano nella disanima filosofica del tempo. Molti
sono, peraltro, i giochi del pensiero quando intende prescindere dallo scorrere
del tempo, come quello che ha creato nell’antichità l’illusione della philosophia
perennis, o quello della Presenza che ha stabilito il dominio degli Enti o, al contrario, quello che nega l’Essere affermando che tutto cambia. Più interessato
ai problemi del tempo della vita, che ormai ha privato della dimensione della
trascendenza, il pensiero moderno ha a sua volta espresso la grande narrazione della storicità, piegandola ai movimenti della logica dialettica oppure ai flussi vibratili della psiche. I giochi anacronistici che questo pensiero ha condotto,
per contrastare la linea del corso irreversibile delle cose, non sono stati da
meno rispetto al passato, ma in ogni caso il senso complessivo della sua narrazione è stato quello di immettere le realtà di fatto, naturalistiche e antropologiche, nel movimento del tempo immanente.
Da questa visione sono giunti alla contemporaneità i parametri storici che
nessuna scienza oggi ignora, in quanto si riconosce come linguaggio simbolico costruito per interpretare il mondo2 e soggetto a continue revisioni nel
tempo. Per quel che riguarda il nostro argomento, la convinzione che non vi sia
una natura femminile con caratteristiche date ab origine, è una delle interpretazioni possibili, e se non si sottopone a revisione sarà non meno ideologica
della convinzione contraria espressa nella Lettera: sono entrambe idee organizzate all’interno di un dato contesto sociale che presentandosi come verità
possono influenzare, anche pesantemente, la vita di tutti in quanto soggetti in
questo contesto.
Diversamente, se si rivolge la questione “che cosa la donna è stata, che
cosa è e che cosa può diventare” al complesso più avanzato delle scienze
umane (come antropologia culturale, sociologia, linguistica, psicanalisi, psicologia cognitiva, psicologia dell’età evolutiva) ne verranno risposte non ideologiche. Si può anzi affermare che l’individuo ne riceverà una risposta liberatrice
e uno stimolo all’apertura verso gli altri, perché nel complesso queste scienze
gli danno modo di comprendere la sua esistenza nel quadro delle grandi e piccole trasformazioni della specie, della società, delle mentalità, immettendo in
questo flusso anche la propria formazione continua, nello sviluppo delle capacità personali e nella scoperta di potenzialità impreviste. Potrà così sottrarsi al
NOTTE
condizionamento delle appartenenze, che lo destinerebbero a ruoli predeterminati e immutabili3.
Ma una simile prospettiva antropologica di libertà dalle predeterminazioni,
per la quale ognuno partecipa alla dinamica incessante del mutamento delle
cose, sviluppando nuove potenzialità dalle sue esperienze di vita in rapporto
con gli altri e costruendo così la propria identità personale, è banalizzata nella
Lettera del Cardinale Ratzinger come quella concezione per cui “ogni persona
potrebbe e dovrebbe modellarsi a suo piacimento”. In realtà,. a ben vedere, la
prospettiva dell’autodeterminazione risale alla concezione cristiana originaria
della redenzione, che implica la possibilità per l’uomo di collaborare all’opera
divina di salvezza agendo nel mondo e di liberarsi dalle miserie della sua natura segnata dal peccato originale divenendo homo novus4. In età umanistica
questa visione antropologica, riconoscendo la capacità di autocostruirsi dell’homo faber, è divenuta uno dei segni distintivi della modernità.
Si tratta certamente ancora di una concezione idealistica, ma d’altra parte
affermare, come fa il Cardinale, il condizionamento assoluto dell’essere umano
a motivo di una data “costituzione” del corpo, non fa che inclinare il discorso
verso il determinismo materialistico. E inoltre è una concezione largamente
superata sia sul piano scientifico sia su quello filosofico, oggi che anche nelle
scienze biologiche e neurobiologiche si fa strada il concetto dell’autopoiesi e
dell’indistinzione tra spirito e materia, in quanto ogni elemento della vita, dalla
molecola alle funzioni più complesse dell’organismo umano, è visto come processo cognitivo e ricorsivo.
Nonostante le incongruenze segnalate, occorre tenere in vista il fatto che il
discorso di Ratzinger è principalmente basato su riferimenti diversi, e precisamente quelli della teologia testamentaria e del Magistero ecclesiastico. Perciò
è necessario portare l’attenzione sui “dati dottrinari dell’antropologia biblica”
che costituiscono del resto la parte maggiore della Lettera ai vescovi.
Essi sono citati in un ordine dato dal concetto della relazionalità, che dà origine a tre gruppi con le relative indicazioni: essere per l’altro, complementarità
di uomo e donna, amore divino come amore sponsale. Ma la concezione relazionale, la cui novità sta nel riguardare i rapporti tra i due generi dell’umanità,
sembra avere fondamenta più fragili nell’Antico e nel Nuovo Testamento che
non nelle varie filosofie contemporanee che teorizzano il dialogo, l’alterità, l’etica comunicativa, e spesso non distinguono tra uomini e donne5. Infatti, la reciprocità dell’essere per l’altro e la complementarità tra uomo e donna appaiono
nella Lettera attraverso la citazione delle encicliche di Giovanni Paolo II, il
quale ha formato il suo pensiero anche a contatto con la fenomenologia di E.
Husserl, da cui alcune delle filosofie menzionate discendono6. Mentre non uno
dei versetti riportati dal capitolo 2 della Genesi può essere riferito a questi concetti. In essi si narra, per contro, la precedenza di Adamo nella creazione divina, la formazione della Donna dal corpo dell’uomo, il significato che questa
seconda creazione riveste in funzione di Adamo come “aiuto”adatto (ovvero,
secondo altre versioni del testo, simile, degno) che Dio escogita per lui e si
afferma più volte l’unità corporea dei due progenitori e l’identità del loro essere “a immagine di Dio”.
149
150
A proposito di questa stretta unità, è significativo il fatto che, per la mancanza di una parola adatta, nelle traduzioni greca e latina, e quindi italiana, non si
dica che Dio chiamò i primi esseri umani con un nome che fonde i due sessi:
il termine ebraico, infatti, non è traducibile nella parola “uomo” ma dovrebbe
essere tradotto in qualche modo con “uomo-donna” o viceversa7. Se i popoli
convertiti al cristianesimo non avessero già da prima introiettato profondamente l’identificazione patriarcale dei due concetti di “maschio” e “uomo”, nel leggere la Genesi non avrebbero così facilmente trascurato questo aspetto della
parola divina.
Per quanto riguarda il passo dalla Epistola ai Corinzi di San Paolo che
appare citato nella Lettera solo parzialmente, va precisato che esso recita: “E
inoltre l’uomo non è stato creato per la donna, ma la donna per l’uomo”8. Cosa
che contraddice il concetto di un reciproco essere per l’altro, o almeno sta a
confermare come in epoca cristiana fosse mutata la percezione del dettato originario della Genesi sulla fusione di uomo e donna nel disegno divino.
Una reciprocità tra la posizione dei due sessi sembra invece profilarsi nella
formula suggestiva dell’amore sponsale che il cardinale appoggia a numerose
citazioni bibliche per ribadirne la forza. Questo lungo ed elaborato passaggio
tende a dimostrare la centralità dell’unione tra uomo e donna, che è unione dei
corpi e insieme comunione delle persone, fatta “a immagine e somiglianza di
Dio”, ossia della comunione tra Dio e l’umanità realizzata dall’affermarsi dell’amore sul male e sul peccato. Ma va osservato, da una parte, che qui le
immagini dell’unione sponsale sono talmente idealizzate da non potersi riferire, se non nella dimensione della virtù perfetta, ai rapporti tra persone che
maturano le loro esperienze affettive alle prese con la realtà delle difficoltà
esterne e delle proprie stesse complicazioni interne. Dall’altra parte, tali citazioni non aggiungono profili nuovi al concetto dell’amore divino, già costituito
dal cristianesimo entro un’amplissima gamma di forme narrative, dottrinali,
agiografiche e simboliche, in quanto l’idea della comunione nell’amore si è
posta fin dalle origini di questa religione al centro del messaggio della redenzione, e quindi della salvezza universale.
Per quanto diversificati e numerosi, i richiami biblici della Lettera non si prestano del resto ad essere qualcosa di “più che semplici metafore”, dal momento che né Sion (Israele, Gerusalemme), né la Chiesa possono essere identificate in alcun modo con figure reali di donne, e dire con Ratzinger che Maria
“ricapitola e trasfigura la condizione di Israele/Sposa” non fa che confermare lo
spessore simbolico di questi termini.
Nel suo complesso, l’interpretazione dei dati testamentari che la Lettera ai
vescovi ci consegna ha la funzione di sostenere queste due affermazioni: a) la
differenza biologica si iscrive nel carattere femminile come un destino che è
dono di Dio; b) la persona femminile si caratterizza per una sorta di “immediata sintonia” con la dedizione all’altro. La Lettera aggiunge a questo punto che
la dedizione è una capacità umana, potenzialmente sviluppabile anche nei
maschi: un’affermazione che potrebbe aprire interessanti prospettive, se sviluppata nel senso della riaffermazione di principi etici che il nostro tempo non
sembra più disposto a riconoscere.
NOTTE
Ma il Cardinale, ribadendo i due aspetti, destinale e oblativo, del carattere
femminile e caricando sulle donne il grave compito del recupero morale, ottiene piuttosto l’effetto di richiamare le figure sublimate della vergine e della
madre, perpetuando una tradizione secolare del cattolicesimo. Nei riguardi di
queste figure, oggi siamo avvertiti dalle analisi condotte sulla funzione sociale
dei simboli da parte delle scienze socio-psicologiche e linguistiche, le quali
dimostrano ampiamente l’elevazione di talune rappresentazioni ideali, fino a
sfiorare talvolta le frontiere del misticismo, si collega alla necessità delle organizzazioni sociali di stabilire divisioni al loro interno, per reprimere i conflitti. Tali
divisioni producono, spesso, l’esclusione dal gruppo dominante di chi è sentito come diverso e perciò inquietante, ma quando il pericolo proviene da una
parte strettamente connessa alla sopravvivenza del gruppo, come le donne,
l’esclusione viene legittimata attraverso il ricorso al “principio sacrificale”9 e
quindi alla sfera simbolica del sacro. Altre ricerche puntano invece a cercare
l’origine di queste diversificazioni in un meccanismo istintuale dicotomico10, che
tende ad assegnare ruoli per definire i simili e separare i diversi, rispondendo
ad un’esigenza di sicurezza (“sistema della sicurezza di base”11): meccanismo
che finirebbe col pervadere ogni aspetto della vita sociale, compreso l’immaginario e le forme della comunicazione, ovvero di quello che M. Foucault ha chiamato l’“ordine del discorso”12.
Stando, perciò, a quest’ultima interpretazione, una società che ha la necessità di reprimere la persona femminile, più che affetta da quella “disarmonia tra
Dio e l’umanità sopraggiunta col peccato” indicata dal Cardinale Ratzinger,
sarebbe una società particolarmente ben ordinata. Per il motivo che in tale
società il peccato non è ridotto nella sfera dei rapporti individuali, dei casi singoli, dell’inevitabile malvagità umana, ma ha assunto la veste culturale del diritto e delle istituzioni, legittimando il potere e l’ingiustizia. E come ben si sa,
anche le Chiese cristiane hanno fatto parte di quelle istituzioni, e hanno sentito il dovere di sostenere il potere delle autorità temporali: tanto che, per quanto riguarda il nostro tema, avocarono a sé come propria missione l’educazione
delle donne, intesa a modellare e reprimere il loro carattere fin dall’infanzia. Chi
conosce la storia, e ha letto le denunce di queste e di tutte le altre forme di
sopraffazione legalizzata che dovevano subire le donne senza possibilità di
difesa (denunce contemporanee ai fati, e provenienti anche da uomini di orientamento moderato) non deplorerà mai abbastanza i loro effetti perversi, sulla
moralità pubblica prima ancora che sulla vita delle vittime.
Infatti, gli strumenti giuridici che sono stati costituiti nei secoli dalla regolamentazione del matrimonio, della potestà maritale e di quella paterna, della
maggiore età, dei diritti patrimoniali, hanno. avuto effetti devastanti per l’esistenza femminile, per la sua crescita, per le sue possibilità di contribuire con
l’intelligenza e il lavoro alla società. Naturalmente ognuno sa che per la maggior parte le esistenze umane, maschili come femminili, hanno sofferto nella
storia subendo l’imposizione del dominio, la miseria e ogni genere di violenza.
Ma il fatto che distingue la storia delle donne, e che ancora oggi non ha cessato di far sentire i suoi effetti poiché serve da fondamento per la definizione
essenziale della loro natura, è che le norme del diritto hanno avallato e dato
151
152
forza di verità ad una tendenza generale presente nel costume, fissandola per
secoli nelle mentalità, nel linguaggio, nei comportamenti morali.
Da un punto di vista religioso questa è una storia già iscritta nel peccato originale. Tuttavia, se tra gli altri si pensa al passo della Genesi dove Dio condanna Eva, dopo il peccato, a sottomettersi al dominio dell’uomo, nello stesso
tempo viene spontaneo ricordare in quale misura l’interpretazione strumentale
di questo passo abbia contribuito a rinforzare la violenza e la repressione.
Il fosco quadro che abbiamo tratto dalla storia e dalle scienze umane non
si evita con la scappatoia dell’ottimismo, qual’è fornita dai decisivi cambiamenti a favore dei diritti delle donne avvenuti nella legislazione di molti Paesi. Va
riconosciuto che il Cardinale Ratzinger non si è illuso a questo riguardo perché
sa bene che la sua Lettera si rivolge ad un vasto pubblico, e soprattutto costituisce un richiamo decisivo al dialogo con l’Islam che, essendo una delle religioni del Libro, è sensibile alla parola dell’Antico Testamento. Ed è proprio nell’immenso territorio islamico che milioni di donne ancor oggi soffrono di molte
e svariate forme di servitù e disprezzo.
La religione offre la via della virtù teologica della speranza per andare oltre
questo quadro di orrenda ingiustizia. Ma anche la filosofia riconosce il principio della speranza, e lo fa considerando il processo storico come apertura al
nuovo e al possibile13, e inserendo in questa apertura del corso storico l’attualità della ricerca di dialogo tra le culture. Ma s’impongono, a questo punto, due
interrogativi fondamentali: si può pensare che una cultura disposta al dialogo
con le altre non lo pratichi al suo interno? E, se intende veramente praticarlo,
può offrire al dialogo un sistema di interpretazioni riguardanti la vita delle persone, che non sia stato preventivamente discusso e concordato tra gli interessati, ovvero le persone che a questa cultura appartengono?
A corollario del precedente, un interrogativo riporta direttamente al nostro
tema specifico: quando si tratta di formulare tesi che le riguardano, la “collaborazione attiva” delle donne, anziché essere data come costitutiva e operante da
uomini che dichiarano di averne la “retta comprensione”, non dovrebbe essere
più modestamente richiesta ad un largo pubblico di donne che coinvolga nella
discussione sia le cattoliche sia le laiche, sia le studiose di una parte sia quelle
dell’altra? Anche se da perseguirsi in modo laborioso e paziente, un metodo
simile potrebbe offrire qualche interpretazione della vita e del mondo che sorga
realmente dall’esperienza umana, piuttosto che rimanerne al di sopra.
1
Cfr. G. DUBY – M. PIERROT, Storia delle donne in occidente. Dal Rinascimento all’età moderna,
Laterza, Roma-Bari 1991; S. ROWBOTHAM, Donne, resistenza e rivoluzione, Einaudi, Torino 1976.
2
A partire da F. Nietzsche, E. Husserl, J. Dewey e L. Wittgenstein, si sono delineate in ogni
campo del sapere scientifico e filosofico ipotesi, procedure di ricerca, teorie su come la mente
umana “costruisce” il mondo, indagandone soprattutto i processi neurologici autoreferenziali e
ricorsivi, collegati alle trasformazioni dell’ambiente e perciò anche alla dimensione intersoggettiva.
Una sintesi efficace di queste correnti si trova in: A. COSENTINO, Costruttivismo e formazione,
Liguori, Napoli 2002.
3
Cfr. L. HACKING, The looping effects of human kind, in: D. Sperber (a cura di) Causal cogni-
NOTTE
tion: a multidisciplinary approach, Clarendon, Oxford 1995; Id. The social construction of what?,
Harvard University Press, Cambridge 1999; R. HARRÉ – G. GILLET, La mente discorsiva, Cortina,
Milano 1996.
4
“Al contrario, vivremo nella verità e nell’amore, per crescere continuamente e per avvicinarci
sempre più a Cristo […] e invece dovete lasciarvi rinnovare cuore e spirito, diventare uomini nuovi,
creati simili a Dio”, Paolo, Lettera agli Efesini, 4-15, 23 e 24, Bibbia interconfessionale. Edizioni
ELLE DI CI, Leumann, Torino 1994, p.300.
5
Questi concetti si affermano nel periodo 1920-1940, in particolare con il pensiero di E.
Husserl, M. Scheler, H. G. Mead, J. Dewey, H. Bergson.
6
Basterà ricordare gli scritti di E. Lévinas e P. Ricoeur.
7
Cfr. Bibbia Interconfessionale, cit., nota a Genesi, 2.22, p. 22.
8
Paolo, Lettera ai corinzi, 11, 9 in Bibbia interconfessionale, cit., p. 266.
9
Cfr. I. MAGLI, La donna, un problema aperto, Vallecchi, Firenze 1974, pp. 42-45 che si riferiscono in particolare agli studi di antropologia culturale di M. Mauss, sulla struttura del dono
(Sociologie et anthropologie, Paris 1950) e di G. Van der Leeuw su quello del sacrificio (De primitive mensch en de religie, Groninga 1937).
10
Cfr. A. WILDEN, Comunicazione, voce dell’Enciclopedia Einaudi, Torino 1973; H. CANTRIL (a
cura di), Tensions and conflits, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1950.
11
Cfr. A. GIDDENS, The Constitution of Society, University of California Press, Berkeley and Los
Angeles 1984.
12
“Normalizzare è ascrivere gli atti, le prestazioni, le condotte singole ad un insieme che è nello
stesso tempo campo di comparazione, spazio di differenziazione e principio di una regola da
seguire… Far giocare, attraverso questa misura ‘valorizzante’ la costrizione di una conformità da
realizzare”, M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976; cfr. Id. L’ordine del discorso,
Einaudi, Torino, 1972.
13
Cfr. E. BLOCH, Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt a. M., 1959.
153
A. DENTONE, La parola, il silenzio, Bastogi, Foggia 2004, pp. 145.
154
Nell’era delle comunicazioni di massa e della diffusione planetaria delle
informazioni, quando l’evoluzione e la diversificazione dei linguaggi consente il
grado massimo di interazione non solo degli uomini tra di loro, ma anche con
le macchine e con quella che viene chiamata l’intelligenza artificiale; nell’era
dominata da una incrollabile fede nella onnipotenza del progettare, del creare,
del fare, Adriana Dentone si interroga, in questo suo intenso e appassionato
libro, sulla natura e sul senso della comunicazione e sulle modalità secondo
cui essa si compie nella vita di tutti i giorni. Il problema è quello di capire se la
tecnica della comunicazione, o meglio, la comunicazione in quanto tecnica,
“possa esaurire la profondità della comunicazione esistenziale” (p. 10), e quindi se la comunicazione esistenziale sia riducibile ad un processo nel quale il
gioco delle domande e delle risposte si trova ad essere vincolato da schemi
prefissati che ne decidono a priori l’evoluzione e l’esito. In tal senso, quella che
la Dentone chiama “comunicazione esistenziale”, diversamente dalla “comunicazione tecnica”, ha a che vedere con l’uomo inteso non come un puro e semplice emittente e ricevente di informazioni, di stimoli che provocherebbero il lui
corrispondenti risposte automatiche e persino prevedibili, ma come un ente
che va considerato nella integrità della sua appartenenza storica, della sua
corporeità e di quella che lei chiama la sua “intelaiatura relazionale”. La comunicazione può essere indagata solo considerando la complessità della natura
umana e la molteplicità dei fattori che fanno dell’uomo l’unico “animale non
ancora stabilizzato, per dirla con Nietzsche, qualcosa di mai definito una volta
per tutte, in cammino verso una identità mai raggiunta che impedisce qualsiasi previsione delle sue ulteriori e possibili trasformazioni, possibilità di sì e di
non, di riuscita o di fallimento, come ci ricorda l’autrice evocando tematiche filosofiche a lei particolarmente care.
Considerata alla luce di questa preoccupazione, ad un tempo gnoseologica ed etica, la comunicazione si arricchisce di un valore ulteriore in quanto
essa costituisce il luogo di un evento particolarissimo in cui la parola, ma anche
il silenzio, così come ogni sorriso, ogni smorfia, ogni minimo gesto anche solo
accennato, ogni stretta di mano assumono un significato che non è più solo aridamente semiotico, ma fondamentalmente “esistenziale”, vale a dire incarnato nel modo di essere di ciascuno, nel suo corpo, nelle sue azioni, nella trama
di rimandi all’interno della quale la semplice vita biologica si fa unica ed irripetibile esistenza umana. A partire da qui, diventa comprensibile ciò che è il dialogo, esperienza misteriosa che non smette mai di meravigliare per il fatto di
mettere in contatto la solitudine di un io con quella di un altro io, il mondo privato di un singolo con quello di un suo simile, la voce della propria coscienza
con le voci del mondo.
Ma a quali condizioni il dialogo è autenticamente tale e non un semplice
scambio di informazioni, una interazione complessa di stimoli e risposte, un
gioco di opinioni fine a se stesso nel quale si rincorrono, si fronteggiano, si
scontrano parole e suoni senza senso o di cui manca una reale e autentica
comprensione? Quando il dialogo dischiude la possibilità di incontrare l’altro e
RECENSIONI
di fare delle nostre irriducibili solitudini un mondo comune? Innanzitutto, scrive
la Dentone, “l’incontro pre-fissato non è dialogo; non è dialogo perché a priori
è già scritto quel che si vuole dire e, peggio, si pretende di dire; il dialogo non
è un’imposizione, non è prestabilito. È un’esperienza di persone che infrangono eventuali barriere, limiti, chiusure e pensano, costruiscono insieme” (p. 21).
L’impossibilità di prevedere l’incontro con l’altro sottrae tale evento alla presa
del concetto, all’anticipazione rigida del pensiero calcolante, all’aspettativa presuntuosa del giudizio moralistico, laddove solo l’apertura dell’ascolto che si fa
“accoglimento” garantisce quello spazio di libertà in cui l’altro può rivelarsi per
come è. Accoglimento che è rispetto assoluto per l’altro, rispetto incondizionato
che viene prima di una condivisione, prima di una comunanza di vedute, accoglimento come esperienza possibile di rara “finezza” e “discrezione” umana.
Saper ascoltare, pertanto, significa saper accogliere l’altro, nel senso di saper
cogliere i significati profondi della sua esistenza al di là della mera significatività linguistica delle sue parole –miseria di certa semiotica– cogliendo magari le
sue emozioni, la sua sofferenza, per aiutarlo a non sentirsi abbandonato,
donandogli la fiducia necessaria per attraversare il buio della notte nella speranza di un nuovo giorno, di un “giorno che risale” –come recita il titolo di una raccolta di poesie della stessa autrice– confortandolo anche con una presenza
silenziosa e rassicurante: “Accoglimento è offerta, gratuità, disponibilità sempre
aperta; è parola profondamente umana, pensiero, affettività, emozione, è corpo,
psiche, spirito; è la parola che chiede e infonde fiducia all’essere umano nella
sua unità, con le sue sublimi gioie e i suoi dolori dilaceranti. È dono per chi
ascolta ed è ascoltato, per chi sa accogliere ed è accolto. È la reciprocità dettata dalla comprensione, dall’empatia, dall’amore” (p. 70).
Queste preziose considerazioni sul dialogo e sull’ascolto introducono il
tema della potenza della parola, tema classico della sofistica, ad esempio, ma
anche di tutto il campo delle scienze della psiche: dalla psicoanalisi alla psicopatologia fenomenologica, avvalendosi di un dialogo interrotto che da sempre
Adriana Dentone va coltivando con grande successo con alcuni tra i più rappresentativi psichiatri italiani dell’età contemporanea, come Eugenio Borgna,
Bruno Callieri, Lorenzo Calvi, Alberto Gaston, Romolo Rossi, l’autrice ribadisce
la fiducia incrollabile che la parola possa compiere grandi cose, nel bene e nel
male, che possa cambiare il destino degli esseri umani e del mondo, che sia
molto più di un flatus vocis e che possa farsi sguardo, sorriso, carezza, gesto
minimo con cui stabilire un contatto, una vicinanza possibile anche nei confronti dei mondi chiusi dal terrore, dal sospetto, dalla tristezza, poiché “la parola in
quanto logos, affettività, emozione, segno può parlare anche quando cala l’ombra che pietrifica” (p. 72).
In un senso più ampio la parola non è nemmeno più un’esclusività dell’uomo, ma diventa la voce di tutte le cose, di tutti gli esseri, di tutte le creature, la
voce della natura stessa, a patto che si abbiano gli orecchi giusti per saperla
intendere: “Acqua trasparente nel campo e terra che si arricchisce di germogli;
traboccante natura che parla all’essere umano se si raccoglie in silenzio e sa
ascoltare” (p. 124). Ma la società sembra irrefrenabilmente sedotta e travolta
dal mito della velocità e della quantità dell’informazione in tutti gli ambiti della
155
156
vita umana, e meno interessata a porsi in ascolto, a comprendere, scoraggiando o impedendo qualsiasi raccoglimento interiore, qualsiasi ripiegamento su se
stessi, qualsiasi “sosta” –come la chiama l’autrice– che, come ben sa ogni
viandante, ogni infaticabile pellegrino, ogni uomo in viaggio sulla via della
conoscenza, è necessaria per poter dare senso sia al cammino percorso, sia
a quello che resta da fare. Il recupero della interiorità, proprio nel momento in
cui la chiacchiera, il frastuono, il rumore violento dominano e dissacrano il
silenzio, è ciò che consente all’uomo di conoscere meglio se stesso e gli altri,
senza il bisogno di indossare maschere o di ricorrere alle armi per difendersi,
poiché, quando resta solo con se stesso, l’uomo è nel suo “meriggio”, nell’ora
del giorno in cui l’ombra è più corta e nessun rifugio può più nasconderlo
innanzi alla luce che tutto rischiara. Ma fermarsi, vivere la propria sosta significa anche recuperare il senso della propria libertà, riappropriarsi di ciò che ci
contraddistingue come corpo, tempo e relazione, alla ricerca di nuove esperienze che estendano i confini stretti entro cui ci rinchiude la nostra soggettività sociale, quella definita dalle esigenze del lavoro, dai bisogni, dalle necessità della mera sussistenza, quella soggettività orgogliosa ed egocentrica che
siamo diventati per aver barattato, per dirla con Freud, la nostra felicità per un
po’ di sicurezza: “L’esperienza di solitudine, strettamente unita al tempo qualitativo, è anche sosta per la creatività, per la musica, la pittura, la poesia e ogni
espressione artistica […]. Può crearsi anche il dialogo stretto fra il poeta o il lettore e il verso, fra la nota e il musicista, la nota e chi ascolta musica, fra l’immagine e il pittore o chi coglie il senso e la forza dell’artista che fuoriesce dalla
realtà” (p. 121). Dialogo anche con Dio, come ci ricorda con grande sensibilità
Adriana Dentone, apertura al sacro che, a nostro avviso, è cosa differente dall’essere “religioso”, perché lo scadimento del sacro al puro e semplice religioso può anzi degenerare in tracotanza, in fondamentalismo, in ostilità contro
tutto ciò che non è riconducibile alla propria identità, laddove il sacro è invocazione solitaria e personale di fronte al mistero, incontenibile aspirazione ad una
ulteriorità di senso che viene prima di qualsiasi fede, di qualsiasi dottrina, di
qualsiasi contrassegno, di qualsiasi emblema che divida gli uomini non tanto
per la fede in se stessa, quanto per la verità di ciò in cui si crede. Le tracce del
sacro, allora, possono essere trovate in quello che ci circonda e la sua testimonianza è assolutamente irriducibile alla questione del vero e del falso, dal
momento che il sacro riguarda piuttosto il senso dell’esistenza umana, e il
senso, si badi, non è né vero, né falso, ma, propriamente, ciò a partire da cui
è possibile concepire qualcosa come una “verità”.
Michele Bracco
Più ragioni spingono a recensire insieme questi due testi, un saggio il
primo, un’antologia il secondo. La prima è che sono della stessa autrice, la
seconda è che entrambi orbitano nella stessa area tematica, quella del pragmatismo americano, la terza è che entrambi rispondono ad alcune finalità precise che l’autrice si è prefissa e che ella stessa spiega nella prefazione al saggio Pragmatismo: i valori dell’esperienza. Il pragmatismo ha uno strano destino in Italia, che è il paese, se si escludono gli Stati Uniti, in cui questa scuola
di pensiero ha avuto la maggiore risonanza agli inizi nel primo decennio del XX
secolo, ma in cui anche, per la sua attitudine anti-accademica, ha subito
un’ostilità e una diffidenza decisamente fuori dal comune e non sempre giustificata. Il pragmatismo in Italia ha così un fato da vascello fantasma, destinato
a riemergere estemporaneamente dalla deliberata dimenticanza in cui era
stato archiviato, ad opera di singoli studiosi, per poi immergersi di nuovo in
un’ulteriore rimozione, senza riuscire a trovare una sua stabile collocazione
nell’orizzonte degli interessi filosofici accreditati.
Rosa Calcaterra, riconosciuta studiosa del pragmatismo e dei suoi esponenti classici (Interpretare l’esperienza. Scienza etica e metafisica nella filosofia di Ch. S. Peirce, Ianua, 1989; Introduzione al pragmatismo americano,
Laterza, 1997), con il saggio qui presentato vuole fare un passo in avanti nel
tentativo di accreditare e dare stabilità al pragmatismo e offrire “un contributo
ad una più adeguata considerazione di questo movimento della filosofia occidentale che ha dato un apporto significativo al processo di trasformazione culturale stimolato dalla crisi dei sistemi filosofici tradizionali.”
Si tratta innanzitutto di liberare il pragmatismo da semplicistici e anche un
po’ comodi fraintendimenti che lo vogliono una filosofia dell’utilità e del successo, del volontarismo “magico” e di un relativismo qualunquista e praticone,
ossia una filosofia “americana”, come si sente ancora dire, non senza un certo
sussiego, per mostrarne il solido portato epistemologico e critico e la forza
argomentativa. Insomma il ‘vascello fantasma’ pragmatista sembrerà pure un
po’ inquietante e inaffidabile, ma a guardar bene naviga con una certa perizia
e tiene la rotta meglio di tanti altri.
In tal senso si capisce quindi la scelta dell’autrice di articolare la sua analisi del pragmatismo a partire dalla nozione di esperienza per seguirla nello sviluppo e nell’articolazione che essa ha in alcuni esponenti cardine del movimento pragmatista: cfr. Ch. S. Peirce, W. James, G.H. Mead.
Il pragmatismo così considerato è quello della linea più forte, allo stesso
tempo anticartesiano, nel suo riferimento alla dimensione pratica del processo
conoscitivo e nel suo anti-intellettualismo, ma non radicalmente antifondazionista, lontano cioè anche dal neopragmatismo di Rorty. Il pragmatismo, nella
sua prospettiva più strettamente epistemologica, quella di Peirce, autore a cui
è dedicata quasi metà dell’intero volume, si oppone alla tradizione cartesiana
ripartendo da quello che era stato il problema originario di Descartes, ossia
RECENSIONI
R. CALCATERRA, Pragmatismo: i valori dell’esperienza, Carocci, Roma 2003,
pp.168.
R. CALCATERRA, Il pragmatismo, Nuova Italia, Milano 2004, pp. 224.
157
158
garantire la certezza della conoscenza. Quindi il pragmatismo non cerca di dissolvere la nozione di “fondamento”, in quanto giustificazione degli asserti conoscitivi, ma piuttosto –come fa notare la Calcaterra– di riformulare e ristrutturare tale nozione.
Questa ristrutturazione implica la messa a fuoco, assolutamente peculiare
al movimento filosofico in considerazione, della stretta interconnessione tra
aspetti teoretici e aspetti pratici, ossia di quel plesso inestricabile tra azione e
pensiero che costituisce il tessuto vivo dell’esperienza umana. Il riconoscimento di questo presupposto antropologico ed epistemologico significa essenzialmente due cose: la prima è che ammettere che gli esseri umani pensano e
conoscono per agire, e che tale agire fonda e rilancia il processo di conoscenza, non significa una svalutazione della conoscenza stessa. La seconda, che
consegue dalla prima, è che l’azione non è conseguenza causale del pensiero, ma parte integrante a parte ante e a parte post, del ductus logico dimostrativo tradizionalmente riservato alla “pura” attività intellettuale teoretica.
Tale duplice presupposto “fonda” quelli che la Calcaterra evidenzia come i
due aspetti distintivi dell’epistemologia pragmatista: il consequenzialismo,
ovvero la scelta metodologica di privilegiare le conseguenze pratiche, cioè
concrete, sperimentali, dei concetti come loro ambito semantico, e il fallibilismo, che testimonia della componente antidogmatica e quindi “democratica”
della nozione pragmatista di esperienza, animata dalla pulsazione continua tra
credenza e dubbio. Conoscere non è disinteressato theoréin, ma impegno
interessatissimo, cioè di vitale importanza, per districarsi in quel campo di realtà sempre infinitamente aperto e incerto che è il mondo. La certezza della
conoscenza e la sua fondazione non sono questioni puramente accademiche,
ma un problema di sopravvivenza a cui l’umanità nel suo complesso è chiamata a contribuire, nei limiti e nelle condizioni ontologiche che le sono propri. È
questo il senso della nozione processuale di verità di Peirce, per il quale la
conoscenza è sempre in fieri e quindi relativa, ma al tempo stesso asintoticamente diretta ad una sempre maggiore aderenza alla realtà delle cose. La
conoscenza e la verità si consolidano con il procedere dell’esperienza complessiva dell’umanità, eminentemente rappresentata dalla “comunità illimitata
dei ricercatori”; fermo restando il presupposto implicito che la scomparsa dell’umanità come specie rende il problema della verità del tutto ozioso.
Con ciò veniamo a evidenziare un tratto fondamentale del pragmatismo
anche nelle sue versioni più rigorosamente logico-epistemologiche, ossia il
suo umanismo, che si traduce nell’assunto fondante della “socialità” dell’esperienza. Quello della “socialità” dell’esperienza costituisce uno dei temi guida
all’interno di questo saggio che rivela ad una lettura attenta una grande complessità e un lavoro di analisi riccamente articolato e poliedrico. Certo, vi è differenza tra la socialità che “fonda” l’epistemologia di Peirce e di Mead attingendo la dimensione intersoggettiva dell’interpretazione semiotica come
unico livello di attualizzazione dell’attività del pensiero e della conoscenza, e
l’intersoggettività pluralist, ma ancora radicalmente individualista, di James.
Tuttavia questi aspetti non sono realmente contrapposti, ma sembrano doversi articolare l’uno nell’altro.
RECENSIONI
James approda ad una alla concezione pluralista della razionalità e dell’esperienza, entrambe fondate sulla dimensione emozionale e volontaria (in
senso anglosassone, cioè attiva) dell’esistenza umana, che viene sintetizzata
nella nozione chiave di “interessante”. Solo nella mediazione dell’apertura soggettiva dell’“interessante”, si concretizza quella interfusione di fatto e valore,
che è l’assioma centrale della teoria pragmatista dell’esperienza, secondo cui
il fatto può emergere solo in quanto valore e il valore si manifesta solo come
fatto.
Peirce dal canto suo pur riconoscendo il valore primo e fondante delle sensazioni e delle emozioni all’interno del processo cognitivo, sul piano antropologico, sul piano logico e gnoseologico ammette la dimensione sensibile ed emotiva solo in quanto mediata da segni e rifiuta di riconoscere altra forma di conoscenza che non sia il processo inferenziale da segni e la loro interpretazione,
escludendo ogni forma di accesso “diretto” all’oggetto dell’esperienza e sfumando così la linea di confine tra epistemologia ed ermeneutica.
In entrambi i casi emerge il senso complessivo del progetto pragmatista,
che rivela così le sue profonde matrici kantiane, di escludere ogni visione
metafisica della conoscenza, ossia ogni concezione della conoscenza che tenti
di fondarsi su qualcosa di diverso dalle condizioni umane di esperienza e di
sfuggire così al controllo di queste stesse condizioni. Non perché tali condizioni costituiscano un termine di riferimento assoluto in senso, appunto, metafisico, ma piuttosto perché costituiscono l’unico criterio logico-pratico ultimo di cui
possiamo concretamente disporre, e sensatamente parlare, per insufficiente
che sia.
Lo sviluppo di questa tematica porta necessariamente l’autrice ad impegnarsi in quell’area di intersezione tra pragmatismo e neopositivismo logico il
cui rappresentante più eminente è Wittgenstein, il quale viene messo in relazione con Peirce su due temi classici del pensiero wittgensteiniano, quello del
linguaggio privato e quello della del fondamento sociale della significatività del
linguaggio.
Impossibile nel ridotto spazio di una recensione ripercorrere la complessità
dell’intreccio e la ricchezza delle problematiche affrontate nel saggio, che
devono essere giustamente apprezzate nel loro pieno svolgimento. In questa
sede, sembra più opportuno invece segnalare l’estrema attenzione e rispetto
mostrato nei confronti degli autori, di cui si cerca sempre di cogliere il senso
proprio e sostanziale del pensiero, ma anche del lettore, beneficiato da un
discreto ed essenziale apparato di note esplicative e da una dettagliata e
aggiornata bibliografia sugli autori e gli argomenti trattati.
Una cura ed un’attenzione analoghe le ritroviamo anche nell’antologia Il
pragmatismo, concepita come un agile, ma essenziale strumento didattico, in
cui si predilige la qualità, ossia la significatività, alla quantità del materiale presentato. Impostazione che ben si accorda con le attuali contrazioni temporali e
contenutistiche dei programmi accademici. Organizzata con ispirazione strutturalista in tre sezioni –Testi, Contesto, Cotesto– accompagnate da una sezione finale di Guida alla lettura e all’interpretazione, l’antologia risponde alla prospettiva eminentemente epistemologica del pragmatismo che la curatrice pre-
159
160
senta nel saggio precedentemente illustrato di cui appare come una instanziazione.
Nella sezione Testi sono rappresentati tutti i pensatori chiave del pragmatismo americano e i testi selezionati, non più di uno o due per autore, tematicamente concentrati sul problema della conoscenza e della verità, mettono efficacemente a fuoco il nucleo essenziale della specifica visione di ogni filosofo,
fornendo un approccio necessariamente circoscritto, ma molto efficace alla
epistemologia pragmatista. La sezione Contesto offre essenziali prospettive di
inquadramento storico sull’origine e le circostanze in cui il pragmatismo è nato
e si è sviluppato, mentre i rapporti del pragmatismo con alcune delle principali scuole filosofiche e psicologiche con cui si è confrontato, ad esempio il neopositivismo e il behaviorismo, occupano la sezione Cotesto.
Una notazione particolare meritano gli strumenti bibliografici e lessicali e la
sezione di Guida alla lettura e all’interpretazione, che appare come la messa
in opera dell’interesse specifico della curatrice ai problema dell’odierna didattica della filosofia (L’insegnamento della filosofia oggi. Prospettive teoriche e
questioni didattiche, Schena, 1994). La curatrice presenta infatti una bibliografia, primaria e secondaria, di primo approccio ai singoli autori con riferimento
alle edizioni e alla saggistica in inglese e in italiano, a cui si aggiunge una selezione di siti web autorevoli e meritevoli di consultazione.
Le guide alla lettura e all’interpretazione, seguendo una metodologia didattica di tipo anglosassone, portano il lettore ad un approccio critico e riflessivo
che risponde ad una griglia di quesiti generali fondamentali: Quali sono le premesse e le conclusioni che l’autore vuole raggiungere? Perché la conlusione
è interessante? Quali argomentazioni vengono adottate? Sono valide? Quali
ulteriori conseguenze possono discendere dalle conclusioni dell’autore?
All’interno di questa griglia, una struttura di domande chiave circostanziate aiutano lo studente, e lo spingono (e anche questo è necessario), a pensare con
il testo e sul testo, mettendone a fuoco in maniera organica i punti tematicamente più rilevanti, attraverso un esercizio di riformulazione o di sviluppo del
pensiero dell’autore. L’intento, didattico, certamente, ma anche di più generale ispirazione filosofica è quello di evitare che lo studio della filosofia si risolva
in una passiva acquisizione di dati o repertori concettuali, mantenendone invece il senso più propriamente teoretico e analitico, conforme allo spirito pragmatista, di attività di pensiero.
In tal modo i due testi, che dovrebbero essere considerati complementari,
almeno al livello didattico, costituiscono non solo un prezioso contributo allo
studio del pragmatismo americano e alla sua comprensione, ma anche un
significativo stimolo nell’apprendimento e nell’esercizio metodologico del pensare filosofico.
Sergio Franzese
L’analisi svolta da Penelope Deutscher sul pensiero di Irigaray si designa
come una modalità esaustiva, per nulla approssimativa, di riferire totalmente
un pensiero e una filosofia. L’intero volume si presenta come un “percorso”
attraverso le opere di Luce Irigaray che pur presentandosi come revisione critica, in realtà, non fa altro che facilitare ai lettori e alle lettrici la comprensione
stessa di quella che è la filosofia irigariana.
Strutturato in 12 capitoli, comprensivi di un’introduzione e di una conclusione,
il libro pone, all’inizio, una controversa domanda fatta da Susan Moller Okin nel
1999 “Il multiculturalismo è dannoso per le donne?” Nello stesso anno Luce
Irigaray rispose “no”. (Introduzione, p. 1), per poi svilupparsi insistentemente attorno a tre questioni più volte affrontate e che quindi si pongono come centrali:
1) Concetto dell’impossibile differenza;
2) Apporto sostanziale ai dibattiti sul “riconoscimento”;
3) Approccio irigariano sulla effettiva relazione che esiste tra il multiculturalismo e il femminismo;
Inoltre, quella propostaci dalla Deutscher è una lettura di Irigaray dal punto
di vista di molte delle sue colleghe sia francesi che americane quali, Judith
Butler, Michéle Le Doeuff, Drucilla Corner, Gayatri Spivak, ma anche attraverso la prospettiva secondo cui è strutturato il più recente lavoro di Jacques
Derrida.
Ma non solo, accostandosi a questo lavoro di indagine sottile della filosofia
irigariana, l’autrice ha messo ben evidenza, fin dal principio, (p. 1) la sua volontà di, prestando fede alla teoria della differenza sessuale, voler dimostrare
come nel pensiero di Luce Irigaray: a) il multiculturalismo può presentarsi
come strettamente legato al femminismo; b) la differenza è un mezzo per accedere all’eguaglianza; c) in relazione alle politiche del riconoscimento, un’altra
differenza è possibile: una differenza anticipatrice.
Nel primo capitolo (Sexual difference as a basis of equality), attraverso
quella che può essere accolta ed interpretata non solo come una panoramica
introduttiva sul pensiero di Simone de Beauvoir, sul tema dell’uguaglianza tra
donne e uomini quale dinamica di trasformazione positiva per e delle donne
stesse, ma anche come un punto di partenza della filosofia irigariana, al contrario, basata attorno al tema della differenza come sola possibilità di costituzione di soggetti non assoggettati, e ripercorrendo una formulazione proposta
da Joan Scott, secondo cui l’uguaglianza non costituisce un mezzo, e un modo
aggiungerei, per raggiungere l’uguaglianza così come la differenza non è un
mezzo per attingere alla differenza (“…perhaps equality is not the means to
achieve equality, nor difference the means to achieve difference”, p. 1),
Penelope Deutscher ci conduce attraverso il pensiero di Luce Irigaray, che
però non è visto ed analizzato solo ed esclusivamente in relazione a tale contesto e che, invece, proprio per garantire una effettiva percezione dello stesso,
viene visto ed esaminato nel suo insieme.
Assecondando questa intenzionale modalità di approfondire il suo pensie-
RECENSIONI
PENELOPE DEUTSCHER, A politics of impossible differencee. The later work of
Luce Irigary, Cornell University Press, USA, 2002, pp. 228.
161
162
ro, Penelope Deutscher passa sapientemente ad illustrare, di contro, le tesi
affermate da Christine Delphy e Michéle Le Doeuff, che avanzando l’idea di
una società opportunista basata solo sulla necessità di “misurare” e “garantire”
dei diritti sulla base di un tornaconto economico, affermano ad esempio che la
differenza, non solo sessuale ma anche culturale, è semplicemente cinica,
selettiva e opportunista, perché predilige il rispetto stesso in termini di convenienza (Le Doeuff thinks that respect for cultural and sexual difference is regurarly selective, opportunist and cynical, p. 9)
Nel tentativo di mettere in relazione credenze diverse e, soprattutto per fare
emergere la connotazione fondamentale della filosofia della differenza, la
Deutscher, nel primo capitolo del suo libro come pure nel settimo (Interrogating
an unasked question, pp. 107-122) propone l’insistenza di Irigaray nel voler
affermare che la differenza sessuale può diventare una la base di una riforma
istituzionale e sociale a favore delle donne e che pertanto si dovrebbe pensare, più che in termini di un’uguaglianza per l’uguaglianza, in termini di un’uguaglianza fondata sull’affermazione delle differenze.
Passando per una riflessione effettuata sull’azione e la pratica di un linguaggio (in particolare capitolo secondo, Irigaray on language, pp. 23-41) che
si pone come neutrale escludendo la possibilità di un due (si confrontino di
Luce Irigaray, non solo il testo Le langage des dements, ma anche Parler n’est
jamais neutre) la Deutscher ripercorre il filo della filosofia irigariana approfondendo il concetto di “indifferenza” sessuale così come è stata voluta e com’è a
tutt’oggi praticata dalla storia della filosofia occidentale (p. 27). Il testo a cui
l’autrice si riferisce è Speculum. L’altra donna che è quasi completamente
incentrato sul tema di questa indifferenza (vi sono ripresi criticamente Platone,
Aristotele, Plotino, Cartesio, Kant, ma anche Freud e Lacan) che è perfettamente visibile quando la filosofia, le leggi o le scienze suppongono un soggetto sessualmente neutro. Per Irigaray, e qui perveniamo alla prima delle due
questioni fondamentali attorno a cui il libro della Deutscher è strutturato,
insomma, la differenza non è empiricamente conosciuta e praticata se non per
via della sua esclusione. Esclusione che si identifica in una “impossibilità”.
Sempre nel capitolo settimo, accostandosi, questa volta, ad un altro lavoro
della Irigaray Etica della differenza sessuale, l’autrice tende quasi a dimostrare al lettore, che in realtà, al di là di tale “impossibilità” sarebbe forse visibile, o
meglio, auspicabile, una differenza sessuale che diventa possibilità (p. 108),
poiché l’assenza potrebbe essere letta come un qualcosa che sarebbe potuto
essere. Un qualcosa che avrebbe potuto esserci. (p. 111). Per Penelope
Deutscher una tale possibilità è data proprio dal linguaggio (capitolo secondo
ma anche capitolo nono: Sexed discourse and the language of the philosophers, pp. 142-163).
In effetti, in Etica della differenza sessuale Irigaray ammetteva che il discorso tra uomini e donne dovrebbe essere un discorso sessuato, ma essendo
regolato dalle regole del maschile la differenza sessuale non farebbe altro che
ammettere la sua stessa assenza. Nella sua più recente pubblicazione, Tra
Oriente e Occidente, Irigaray, ha, secondo l’analisi svolta dalla Deutscher, cercato di descrivere l’azione di un uomo e di una donna estranei l’uno all’altra,
RECENSIONI
che potrebbero riconoscersi tra di loro come differenti, come due diverse unità
non riducibili vicendevolmente (p. 121). Continuando su questo piano l’autrice
illustra anche l’ipotesi contraria, ovvero l’opinione opposta che ne hanno in
merito Corner, Huffer, Lacey che affermano che data l’impossibilità della differenza tale è anche il suo riconoscimento.
Nell’introduzione al testo, l’autrice sostiene di: “aver situato il lavoro [intendendo per lavoro, il suo ultimo scritto Tra Oriente e Occidente] di Irigaray nel
contesto dei dibattiti contemporanei circa le politiche di performatività, riconoscimento, multiculturalismo, a favore delle diversità e delle politiche sull’identità” (“I situate Irigaray’s work in the context of contemporary debates about the
politics of performativity, recognition, multiculturalism, pro-diversity, and identity politics”, p. 6).
Un altro tema che nel libro di Penolope Deutscher si pone come centrale è
senza dubbio quello relativo al “riconoscimento”, o meglio al mancato riconoscimento della differenza sessuale. Per dare una ulteriore spiegazione di una
simile affermazione, a partire dal terzo capitolo (Rethinking the politics of recognition, pp. 42-55), Penelope Deutscher cerca di spiegare la questione in termini irigariani, e cioè cercando essenzialmente di esprimere e di spiegare il
perché di una volontà a voler dimostrare la necessità di dare spazio, riconoscimento e diritti a delle identità che non sono date una volta per tutte, ma che, al
contrario, sono in continuo divenire. L’autrice, a tal proposito, non a caso afferma “one of her strategies is to leave the contents of the term sexual difference
open, a pair of empty brackets” [“una delle sue strategie –dove l’aggettivo possessivo sue sta per Irigaray– è quella di lasciare i contenuti dei termini ‘differenza sessuale’ aperti, –un paio di parentesi vuote”] (p. 49).
Ma la “rottura” se vogliamo, di Irigaray con il dibattito sul riconoscimento
avviene, secondo la Deutscher, quando la stessa evoca la verginità della
donna come diritto e, aggiungerei dovere, etico alla non-appropriazione dell’altro (p. 50). Ma è pur vero che il richiamo irigariano alla verginità suona piuttosto come una metafora dell’integrità, cioè della possibilità di un riferirsi continuo ad una soggettività data. Un riconoscimento questo che ha molto a che
spartire con la nozione di “genere”, che si configura come il dare senso dell’appartenere degli “uomini” e alle “donne” agli uomini e alle donne, in qualità di
entità e di identità sessuate e pertanto differenti (capitolo quinto, Sexuate
Genre: ethics and politics for improper selves, pp. 74-75). Quello ipotizzato da
Irigaray è un ritorno continuo ad un simbolico che poi è l’essere se stessi ed è
per questo una constatazione pratica di una “possibile differenza”. Una differenza che rispetta l’alterità perché la riconosce e nel riconoscerla sa che è irriducibile, motivo questo che l’ha portata ad auspicare la possibilità dei cosiddetti “diritti sessuati”. Penelope Deutscher fa riferimento al volume di Irigaray
“Amo a te” proprio per spiegare il carattere mediativo che la preposizione “a”
assume. Una mediazione che non riduce. Che rispetta. (pp. 78-79)
“Devo ascoltare a te come ad un qualcuno o ad un qualcosa che non conosco ancora. Che non conosco del tutto” (p. 124) Penelope Deutscher riprende
il senso di questa indagine nell’ottavo capitolo del suo libro (The impossible
friend, pp. 123-141), quando ripartendo dal testo medesimo, Amo a te, giunge
163
164
ad esaminare le possibili relazioni che possono esistere tra due o più soggetti
che non sono necessariamente amanti, ma anche amici. Affrontando l’ultimo
dei tre punti nodali sui quali il libro della Deutscher sembra ruotare, perveniamo, così, al concetto chiave, forse, dell’intero volume, secondo cui il femminismo e il multiculturalismo, contrariamente a quanto ipotizzato, e a quanto criticato alla stessa Irigaray, in proposito, nel suo stesso pensiero, sono, in realtà,
strettamente connessi.
Penelope Deutscher, nelle conclusioni al suo testo (pp. 185-194), approda
a una tale presa di coscienza partendo dalle stesse analisi irigariane in merito,
soprattutto riferendosi ad un dato di fatto piuttosto evidente: Irigaray non
aggiunge al suo interesse per i generi sessuati anche un interesse per lo sviluppo dei diversi generi di culture o generi delle razze (Irigaray does not add to
her interest in sexuate genre an interest in the development of diverse cultural
or racial genre, p. 193). Irigaray, come la Deutscher continua nella sua esposizione, non ha mai offerto letture di Nietzsche o Platone, Hegel o Kant che motivino l’esclusione, da parte di questi filosofi, nelle loro opere, di alcuni tipi di
“razze”, ma, come la Deutscher aggiunge, è comunque intrigante il fatto di riuscire a scorgere in Irigaray un interessamento nei confronti delle razze e quindi nei confronti delle diverse culture, attraverso il suo approccio alla differenza
sessuale (p. 193).
La verità è che, in ogni caso, Irigaray non ha voluto proporre una genealogia di ciò che stato detto, attraverso la storia della filosofia, delle razze, ma
piuttosto di ciò che la storia non ha detto. Vale a dire delle esclusioni. Delle
assenze. Del resto come ella stessa ha affermato in Tra Oriente e Occidente,
prima di parlare del il molteplice, e quindi prima di affermarlo, bisogna essere
due (capitolo decimo, Effacement redoubled?, pp. 164-184) ed è proprio questo che del pensiero di Irigaray la Deutscher ha colto saviamente: l’alterità e il
rispetto dell’appartenenza al proprio genere apre le prospettive del multiculturalismo.
Non solo, tornando all’iniziale e controversa domande posta al principio da
Susan Moller Okin, con la quale tra l’altro si apre il volume stesso della
Deutscher, “Il multiculturalismo è dannoso per le donne?” Irigaray non risponde semplicemente “no”, ma spiega il suo “no” attraverso il concetto della differenza stessa, secondo cui il rispetto tra i due generi, non-gerarchicamente intesi, lascia intravedere la “possibilità” di un rispetto anche tra le diverse culture,
senza però correre il rischio di scivolare in una situazione di omogeneità in cui
le identità si perdono, e in cui a perdersi sono proprio quelle femminili.
Emanuela Monda
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE”
Volumi:
E. BERTI, ARISTOTELE, Eubolo o della Ricchezza, Autentico falso d’autore, Guida, Napoli
2004, pp. 90;
P. COLOTTI, La persuasione dell’impersuadibilità. Saggio su C. Michelstaedter, Ferv,
Roma 2004, pp. 386;
P. DE GIORGI, L’estetica della tarantella. Pizzica, miti e ritmo, Congedo, Galatina 2004,
pp. 262;
B. M. D’IPPOLITO, La cattedrale sommersa. Fenomenologia e psicopatologia in L.
Binswanger, Angeli, Milano 2004, pp. 234;
C. L. FERRARO, Benedetto Croce e Miguel de Unamuno. Comparazione di due “sistemi”
di pensiero, Alfagrafica, Città di Castello 2004, pp. 304;
F. FISTETTI, I filosofi e la polis, Pensa, Lecce 2004, pp. 426;
S. GERACI, Dioniso oltre lo specchio, Imprimitur, Padova 2004, pp. 172;
E. HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, a c. di N. Ghigi, Città Nuova, Roma
200, pp. 140;
F. JOVINE, Scritti critici, a c. di P. Guida, Milella, Lecce 2004, pp. 884;
P. LANDI, Idee per una teoria dell’esperienza, Clinamen, Firenze 2004, pp. 180;
A. NEGRI, De persona. L’indomabilità dell’individuo, Spirali, Milano 2004, pp. 280;
A. PALADINI, Il “De arcanis” di Pietro Galatino. Traditio giudaica e nuove istanze filologiche, Congedo, Galatina 2004, pp. 180;
P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, Congedo, Galatina 2003, pp. 268;
R. PERINI (a. c. di), Sul trascendentale moderno. Genesi, struttura, problemi, E. S. I.,
Napoli 2004, pp. 202;
A. M. PEZZELLA, María Zambrano. Per un sapere poetico della vita, Messaggero,
Padova 2004, pp. 108;
P. RASULO-P. BRUNI, “Primato” ovvero La sfida delle idee, C. S. R. “Francesco Grisi”,
Taranto 2004, pp. 168;
F. RECCHIA LUCIANI, Filosofia scienze umane e razionalità. P. Winch e il relativismo culturale, Pensa, Lecce 2004, pp. 286;
D. RUGGE, La dottrina logica di M. A. Zimara, Congedo, Galatina 2004, pp. 208;
J.-P. SARTRE, La mia autobiografia in un film. Una confessione, ed. it. a c. di G. Invitto,
Marinotti, Milano 2004, pp. 160;
A. SAVIGNANO, María Zambrano. La ragione poetica, Marietti 1820, Genova-Milano
2004, pp. 164;
C. SINI (a c. di), Semiotica ed ermeneutica, Quaderni di Acme, Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia 2003, pp. 376;
G. VALLONE, Le donne guaritrici nella terra del rimorso, Congedo, Galatina 2004, pp. 114;
M. VEGETTI, PLATONE. Repubblica libro XI. Lettera XIV, Autentico falso d’autore, Guida,
Napoli 2004, pp. 54.
165
Periodici:
Aesthetica Preprint, n. 71, agosto 2004: B. ANTOMARINI, La percezione della forma.
Trascendenza e finitezza in H. U. von Balthasar; C.I.S.d.E., Palermo;
Aesthetica Preprint, Supplementa, E. DI STEFANO, Arte e Idea. Francisco de Hollanda e
l’estetica del Cinquecento, n. 12 ottobre 2004; C.I.S.d.E., Palermo;
Ideçao, n. 12, jul./dez. 2003; Universidade Estadual de Feira de Santana;
Il Contributo, nn. 2-3, a. XXV, n. s., 2003; Centro per la Filosofia Italiana,
Montecompatri;
Itinerari, n. 2, 2004, a. XLIII; Ed. Itinerari, Chieti;
L’immaginazione, n. 208, 2004; Manni, San Cesario di Lecce;
Mathesis. Revista de Educaçao, v. 3, nn.1 e 2, 2002; Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Jandaia do Sul, Paraná;
Progresso del Mezzogiorno, 2004; Il problema del male nel mondo e la ricerca di Dio
oggi, parte II; Loffredo, Napoli;
Studia patavina, nn. 1-2, a. LI, 2004; Indici del secondo venticinquennio 1979-2003;
Fac. Teologica Italia Sett., Padova;
VIA, Voices in Italian Americana, v. 15, spring 2004, n. 1; Bordighera Incorporated.
166
AA. VV.
Anno Domini 1968
L’immaginazione che voleva il potere
a cura di Fabio Minazzi e Alessandra Chiappano
Il ruolo del ’68 in Italia e nel mondo, l’analisi del
caso “Zanzara” a Milano, la musica come forma di
protesta, la cronaca dei giorni caldi di Marcuse a
Torino, la critica del pensiero scientifico: cinque
saggi che analizzano i principali aspetti che, da quella data in poi, hanno profondamente cambiato il
modo di rapportarsi con il mondo.
Arricchiscono il volume le testimonianze inedite di
alcuni tra i protagonisti di quella stagione così “formidabile” e feconda: Francesco Guccini, Furio
Colombo, Mario Capanna, Joan Baez, Zeynep Oral.
Umberto Saba
Quante rose a nascondere un abisso
Carteggio con la moglie (1905-1956)
Prefazione di Antonio Debenedetti
Tre temi principali: l’affetto reciproco, i
disagi e le ristrettezze economiche, la sorte
editoriale e il riscontro critico degli scritti di
Saba.
Un quadro di riferimenti prezioso per illuminare la figura del grande scrittore italiano.
Completano il volume 48 foto inedite.
Aldo Maria Valli
Nudi e crudi
Corso di sopravvivenza per famiglie
nell’era del consumismo
Nell’epoca del consumismo e dell’informazione, che occupano ogni istante delle nostre giornate,
il rischio è quello di perdere la capacità di osservare e giudicare quello che ci circonda.
Questo libro è il diario ricco di consigli di un
inviato speciale nella realtà apparentemente meno
speciale di tutte, quella quotidiana della nostra
famiglia.
Con grande ironia, e con un pizzico di indignazione, Valli indaga quello che siamo tra i banchi di
scuola, in metropolitana, nel salotto di casa, davanti alla tv e tra le strade della nostra città.
Marco De Paoli
La relatività e la falsa cosmologia
La teoria della relatività domina la scena della
fisica contemporanea. Rimane tuttavia la necessità
di una più adeguata riflessione epistemologica sui
fondamenti della teoria, anzitutto volta a sfrondarla dalle volgarizzazioni e dai fraintendimenti correnti a partire dall’inverosimile teoria di un universo in espansione causato da una misteriosa “singolarità” creatrice esplosa con il cosiddetto Big Bang.
Un saggio accattivante, rigorosamente scientifico, sorprendentemente innovativo.