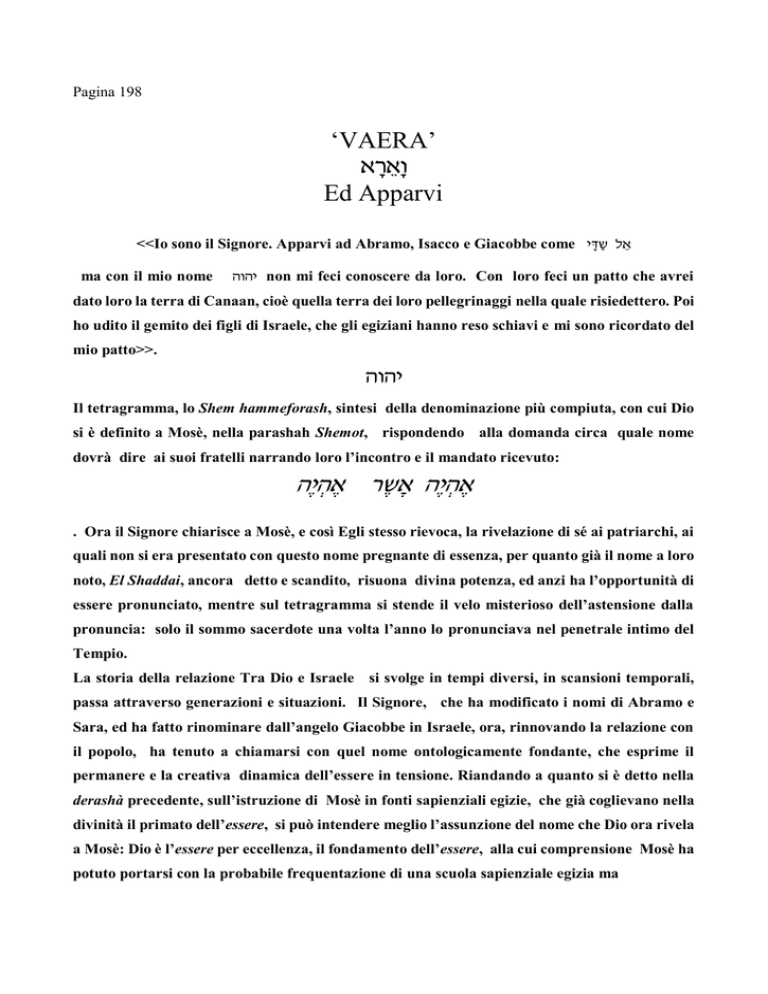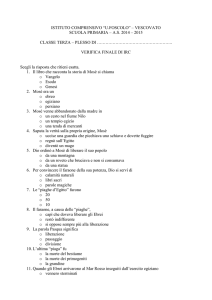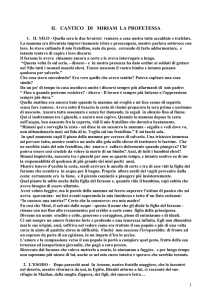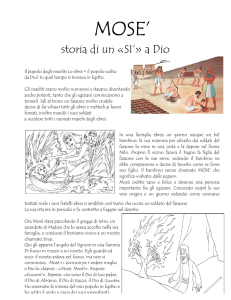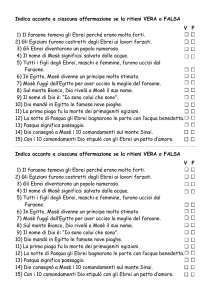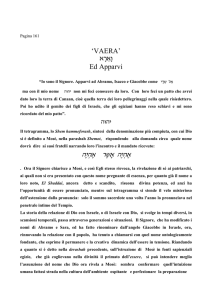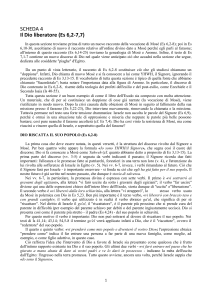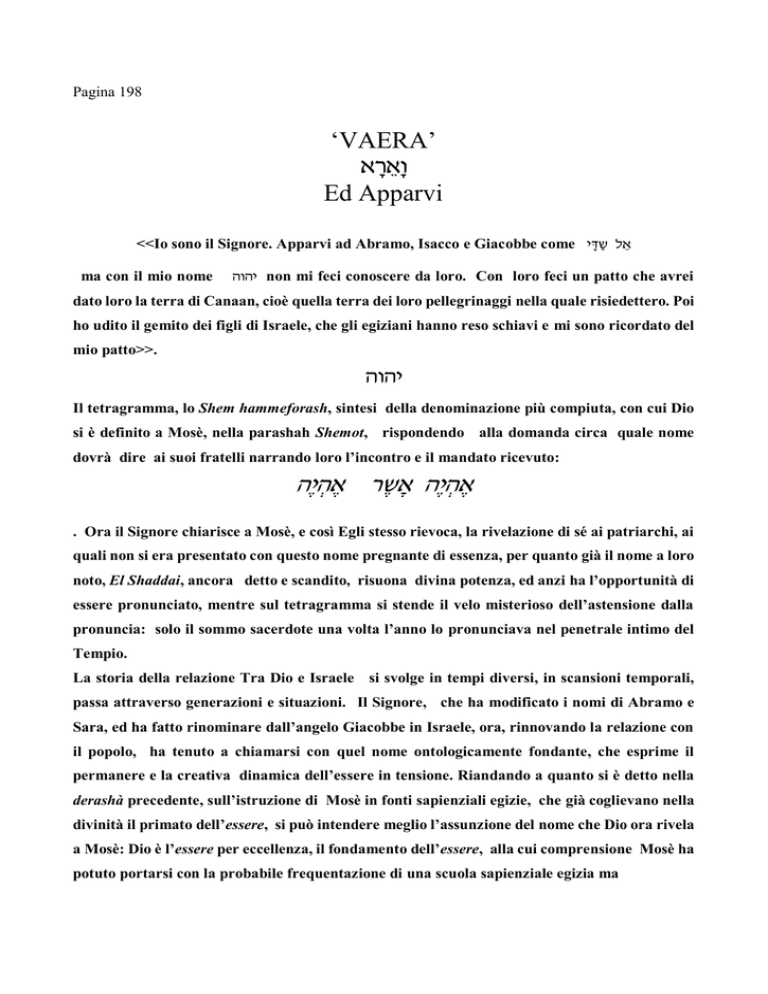
Pagina 198
‘VAERA’
Ed Apparvi
<<Io sono il Signore. Apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe come
ma con il mio nome non mi feci conoscere da loro. Con loro feci un patto che avrei
dato loro la terra di Canaan, cioè quella terra dei loro pellegrinaggi nella quale risiedettero. Poi
ho udito il gemito dei figli di Israele, che gli egiziani hanno reso schiavi e mi sono ricordato del
mio patto>>.
Il tetragramma, lo Shem hammeforash, sintesi della denominazione più compiuta, con cui Dio
si è definito a Mosè, nella parashah Shemot, rispondendo alla domanda circa quale nome
dovrà dire ai suoi fratelli narrando loro l’incontro e il mandato ricevuto:
. Ora il Signore chiarisce a Mosè, e così Egli stesso rievoca, la rivelazione di sé ai patriarchi, ai
quali non si era presentato con questo nome pregnante di essenza, per quanto già il nome a loro
noto, El Shaddai, ancora detto e scandito, risuona divina potenza, ed anzi ha l’opportunità di
essere pronunciato, mentre sul tetragramma si stende il velo misterioso dell’astensione dalla
pronuncia: solo il sommo sacerdote una volta l’anno lo pronunciava nel penetrale intimo del
Tempio.
La storia della relazione Tra Dio e Israele si svolge in tempi diversi, in scansioni temporali,
passa attraverso generazioni e situazioni. Il Signore, che ha modificato i nomi di Abramo e
Sara, ed ha fatto rinominare dall’angelo Giacobbe in Israele, ora, rinnovando la relazione con
il popolo, ha tenuto a chiamarsi con quel nome ontologicamente fondante, che esprime il
permanere e la creativa dinamica dell’essere in tensione. Riandando a quanto si è detto nella
derashà precedente, sull’istruzione di Mosè in fonti sapienziali egizie, che già coglievano nella
divinità il primato dell’essere, si può intendere meglio l’assunzione del nome che Dio ora rivela
a Mosè: Dio è l’essere per eccellenza, il fondamento dell’essere, alla cui comprensione Mosè ha
potuto portarsi con la probabile frequentazione di una scuola sapienziale egizia ma
Pagina 199
di cui coglie ora la percezione in rapporto con la situazione umanamente concreta e dolorante
del popolo di cui egli è figlio, discendente di antenati a Dio già legati in uno stadio antecedente,
prima della migrazione in Egitto, sul suolo di una terra da ritrovare.
L’intravisto supremo
essere si presenta all’uomo Mosè come provvidente liberatore del suo popolo asservito ed
umiliato, di cui ha accolto il grido, affinché questo popolo venga educato nel culto della sua
unicità, sbozzando e testimoniando l’idea monoteistica nella storia religiosa dell’umanità.
Per Martin Buber (La regalità di Dio, ed. Marietti, p. 118), il nome riveste un significato
complementare di divina presenza nel vivo delle situazioni, un vigile, concreto
ESSERCI,
STARCI accanto, ESSER PRESENTE a quanto avviene, con occhio pronto e pronta mano; un
essere che sta in tensione per assistere ed irrompere. La risposta di Dio a Mosè, che gli chiede
cosa dovrà dire quando il popolo gli domanderà come si chiama il Dio che lo manda, al capitolo
3 di Esodo, versetto 14, qualificandosi
Ejjé asher Ejjé esprime, oltre il concetto sostanziale
dell’Essere, oltre la dinamica universale dell’Essere in tensione, particolarmente, ora, per
Israele in quella situazione, la protettiva promessa di un esserci là, in quell’accadere. Dio c’è,
ma non farà tutto da solo, bensì attraverso il coraggio di chi ne ha bisogno: l’uomo Mosè e il
fratello Aronne devono mobilitarsi ad affrontare il duro padrone terreno.
Mosè si reca, per prima cosa, dai connazionali, ad annunciare loro le confortanti parole che
ha ricevuto, ma loro non sono in grado di dargli ascolto per lo stato d’animo di angustia,
accasciati come sono dai pesanti lavori coatti.
Lo shamù el Moshè mikkozer ruah umeavodà kashà
I figli di Israele hanno avuto la sensazione di sentirsi dire da Mosè belle parole, non
corrispondenti alle condizioni aggravate in cui si trovano, dopo che egli era intervenuto la prima
volta invano a loro favore. Compare, a questo punto, la lista genealogica delle famiglie di Ruben,
di Simeone e di Levi, soprattutto allo scopo di far conoscere i discendenti di Levi, la tribù cui
sarà attribuito il sacerdozio, tra cui figurano Mosè ed Aronne, gli incaricati della missione al
Faraone. Ci vengono detti così, tra i diversi altri, i nomi dei loro genitori, Amram e Jocheved e
la loro consanguineità, essendo Jocheved la zia dello sposo, prima che la norma venga a proibire
il matrimonio per tale grado di parentela. L’elenco genealogico ed onomastico è scandito al
momento opportuno per denotare la nobiltà di questa gente asservita e sfiduciata, che non ce la
Pagina 200
fa a sollevarsi quando Mosè le reca l’annuncio dell’intervento divino. Se la missione verso i
fratelli è ardua per il loro sconforto, quella presso il faraone è ancora più ardua per la durezza
dell’uomo sicuro nell’esercizio del potere e sprezzante verso una straniera plebe asservita a
strumento di produzione. Dio si fa carico della durezza di cuore del dominatore. Tanto la
prevede da arrivare a dire che è Lui ad indurirne il cuore nella prova di forza, che infine lo
vincerà.
Quando il Signore lo incarica di tornare dal Faraone con la richiesta di lasciar partire il suo
popolo, Mosè, scoraggiato dal mancato ascolto dei suoi, chiede al Signore come possa sperare
di essere preso sul serio dal cattivo sovrano, tanto più che non ha la parola sciolta, essendo arel
shefataim, alla lettera ottuso di labbra, come avesse un prepuzio, pellicina superflua poggiata
sulle labbra, che non gliele fa bene muovere, balbuziente. Già nella parashà precedente, al
capitolo 4 di Shemot, Mosè ha fatto presente al Signore di non essere un ish devarim, un uomo
di parole, un buon parlatore. Invero, per tanta parte della Torà, Dio gli dirà cosa debba dire e
fare (Vajomer Adonai el Moshè dabber…) fino poi al punto che lui, Mosè, parlerà a lungo, da
condottiero oratore, lungo tutto il quinto libro del Pentateuco, intitolato proprio Devarim:
Il Signore gli aveva detto che ogni umana facoltà è data da Lui e che lo avrebbe sostenuto nel
parlare, e che comunque lo avrebbe assistito il fratello Aharon, buon parlatore. Ora chiama
entrambi, Mosè ed Aronne, e quando Mosè, per esimersi, insiste sul proprio difetto, il Signore,
per stimolare in lui l’autostima e farlo sentire importante, ricorre argutamente ad un paragone
strabiliante: <<guarda, io ti costituisco Dio davanti al Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo
profeta>>.
Netatikha Elohim le farò veaharon ahikha ijjé neviekha
Il paragone, naturalmente, non va preso alla lettera, è un’ardita metafora, in didascalica umiltà,
dello stesso Elohim, o a Lui attribuita dagli autori biblici. Per l’Ebraismo Dio non costituisce
un uomo al proprio livello, mentre può a lui delegare, serbando la propria unica trascendenza.
Pagina 201
Il Faraone favorevole, tanto tempo prima, si era tolto l’anello dal dito, dandolo a Giuseppe per
investirlo di una autorità. Ora il Signore Iddio, per vincere la titubanza del suo inviato Mosè,
gli presta, per così dire, il suo anello, ed attribuisce ad Aronne la funzione di profeta,
che è portavoce di Dio. Lo fa anche, delicatamente, per non umiliare Mosè davanti alla
capacità oratoria del fratello maggiore: guarda, Aronne, sarà il tuo portavoce.
Elohim ha anche un significato di giudice, inerente alla funzione giudicante di cui Dio dà
esempio, e Rashì ha inteso questo passo nel senso che Dio costituisce Mosè giudice del faraone,
ma l’ausiliario compito di profeta attribuito ad Aronne sta meglio in relazione a Dio che al
giudice. Possiamo tranquillamente lasciare alla parola Elohim il significato di Dio, o magari
di un messo divino, come una incoraggiante esagerazione proferita da Dio stesso per rendere
ardito Mosè, il quale non è così vanitoso da credersi lui Dio e neppure un angelo. L’autentico
Dio si riserva il ruolo primario di istruire Mosè su quel che dovrà dire, o far dire da Aronne, al
faraone, e nell’annunciare che sarà Lui, nella fine del gioco, a piegare il faraone, come è Lui a
indurire il cuore del faraone peggio di quanto già sia duro: «Tu comunicherai a lui tutto quanto
ti ho comandato e Aron tuo fratello parlerà al faraone, dicendogli di lasciar partire i figli di
Israele dal suo paese. Io renderò ostinato il cuore del faraone e moltiplicherò i segni di potenza
e i miei prodigi nella terra d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io stenderò la mia mano
sull’Egitto e farò uscire le mie schiere, cioè il mio popolo di Israele dall’Egitto mediante castighi
straordinari».
Anì akshè et lev parò
Veirbeti et ototai veet mofetai
Beerez Mizraim
Io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò
I miei segni e i miei prodigi
Nella terra di Egi
Akshè : indurirò, Kashè significa duro pesante difficile
Ot è segno qui significa segno, dimostrazione, di intervento, di potenza
Ototai : i miei segni
Mofet è prova prodigiosa significa anche un esempio valido, eccezionale un modello
Pagina 202
Dunque Mosè accetta ed assume l’incarico di tornare dal faraone per chiedergli di lasciare
andar libero il popolo. Ce lo immaginiamo giovane o uomo maturo e invece aveva ottant’anni,
e Aronne, il facondo giovanotto, ne aveva ottantatre. Ma dobbiamo prendere le bibliche
indicazioni di età nella dimensione evocativa e trasfigurata di una longevità dei giusti, che è
venuta nella Bibbia a mano a mano scemando verso la media umana dei tempi storici.
Il Signore avvisa i due inviati che il Faraone non li ascolterà. E’ una missione per ora senza
successo, ma va espletata sulla via della vittoria e della liberazione. Vi sono imprese, che lì per
lì paiono fallimentari, ma servono a preparare altri svolgimenti. Per piegare il Faraone, bisogna
pressarlo con una serie di richieste, seguite da altrettanti colpi. Il Faraone si sente dominante
e non molla fino a che pensa di poter resistere.
Se Mosè ha le labbra ottuse, il re di Egitto ha
il cuore duro e pesante, è khaved lev. Avrà bisogno, nella sua ostinazione di ricevere e fare
ricevere al suo popolo molte batoste, prima di decidersi a fare uscire i figli di Israele.
Come già nella parashà precedente, Dio dice a Mosè e ad Aronne di stendere la verga per la
prodigiosa sua trasformazione in serpente. In un tempo e in un contesto di maghi, bisogna
farsi pure mago, competendo coi maghi. Aronne stende la verga davanti al Faraone per
dimostrargli che li manda Dio, ne viene fuori un serpente. Faraone chiama i suoi esperti e i suoi
maghi, che coi loro sortilegi stendono le verghe e fanno uscire altrettanti serpenti.
Vaikrà gam parò lahakhamim velamekhashfim
Vaiaasù gam hem hartumé Mizraim belahatehem ken
ַל ַהט
Laat è sortilegio incantesimo
Rashì intende qui come effetti di procedimenti segreti
E anche il faraone chiamò i sapienti e I maghi
E fecero anche loro, gli esperti dell’Egitto, con i loro sortilegi, così
Pagina 203
Fecero così. Fecero lo stesso, ma la verga-serpente di Aronne inghiotte quelle dei maghi.
Sembra un fantasmagorico gioco di cartoni animati. Allora non c’era la tecnologia
cinematografica dei cartoni animati, ma c’era una tecnologia delle operazioni di destrezza, in
cui i maghi erano esperti, dando performances nelle corti. Sicché il Faraone, fidando in un
migliore round dei suoi specialisti, incassa il colpo e resta facilmente ostinato. Poco male, del
resto, se crepano i serpenti; per ora, ma siamo solo all’inizio del confronto.
Mosè, su ordine divino, si ripresenta al Faraone il mattino seguente, quando egli si reca sulle
rive del Nilo. Gli chiede, a nome di Dio, di lasciare andare il mio popolo, “Shlakh et ammì”.
L’espressione diventerà uno spiritual degli schiavi neri, “Let My People Go” e diventerà il motto
inalberato per l’uscita degli ebrei dalla dittatura sovietica. Gli ebrei sono potuti finalmente
uscire da quel grande paese. I neri in America non sono più schiavi e Barak Obama addirittura
governa alla Casa Bianca.
Anche dall’Egitto gli ebrei alfine sono usciti, ma ci sono volute le
piaghe. Nella storia c’è un comportamento ricorrente, che si chiama ostinazione. Anche la
dittatura sovietica, in tempi recenti, proibì agli ebrei di uscire, concedendo a gocce i permessi
in cambio di altri vantaggi, ed infine cadde, dissolvendosi. Anche allora, nei nostri tempi, è
risuonato il “Let my people go”. “Shlah et ammì”.
L’ostinazione del Faraone viene piegata attraverso dieci piaghe, makkot, dolorose per il suo
regno e il suo popolo. Ci soffermiamo sulle piaghe per il loro rilievo nella celebrazione
tradizionale della Aggadà di Pesah. Nello spazio narrativo di questa parashà VAERA’ ne sono
inferte sette: DAM, Sangue, ZEFARDEA, Rane, KINNIM, insetti alati o pidocchi, AROV,
miscuglio di animali dannosi, che si abbatte sull’Egitto, eccettuata la terra di Goshen, abitata
dagli ebrei, DEVER, pestilenza mortale sugli animali, eccettuati quelli degli ebrei, SHEHIN,
ulcere con bubboni sulla pelle, BARAD, fitta grandine, preceduta da una severa ammonizione
del Signore, riportata da Mosè al Faraone, affinché eviti la piaga, consentendo al popolo ebreo
di andare a prestargli culto. Vien dato al Faraone perfino l’avvertimento di mettere al riparo
gli schiavi e il bestiame prima della terribile grandinata, provvedimento che una parte dei servi
del Faraone ascoltò ed eseguì, temendo la forza del Signore.
Le prime tre piaghe il Signore ordina a Mosè che le produca Aronne, stendendo la mano con
la verga, prima verso le acque, poi verso la polvere: «Il Signore disse a Mosè ‘dì ad Aronne di
Pagina 204
stendere la mano con la verga…» La quarta e la quinta la produce il Signore stesso. La sesta
la producono insieme i due fratelli, raccogliendo la fuliggine delle fornaci per produrre l’effetto,
e poi è Mosè a lanciarla in aria, sempre su direttiva divina. La settima la produce Mosè,
stendendo la mano verso il cielo.
Un maestro, di nome Tanhum (non so se Tanhum ben Hanilai o Tanhum ben Hiyyà)
ha
interpretato l’astensione di Mosè, su indicazione divina, dal colpire le acque e la polvere,
lasciando le due incombenze ad Aronne, come insegnamento di riconoscenza, perché le acque
avevano salvato Mosè, evitando di annegarlo quando era posato col cesto sulla loro superficie,
e la polvere si era prestata a coprire la salma dell’egiziano da lui ucciso nel difendere un fratello
ebreo. Se si è riconoscenti, simbolicamente, verso elementi della natura, tanto più lo si deve
sapere essere per ogni beneficio ricevuto da esseri umani. La riconoscenza rientra nell’abito
morale e comportamentale detto, nella tradizione ebraica, Derekh Erez, corretta via della terra,
giusto ed appropriato modo di stare al mondo con i propri simili.
Le piaghe di Egitto nella AGGADA’
Dopo ognuno dei flagelli si interpone una pausa, con l’apparente cedimento alla ragione da
parte del Faraone. Si ha la preghiera di Mosè e di Aronne al Signore per far cessare i malanni,
Pagina 205
quindi i ripensamenti del Faraone quando gli si lascia una tregua, le perplessità dei ministri
del Faraone che cominciano a rendersi conto dell’ineluttabile resa ad una superiore forza
celeste. Vi sono egiziani che temono l’Eterno e sui quali non si abbattono certe piaghe. Al riparo
sono collettivamente gli ebrei , venendo risparmiato il paese di Goshen, dove risiedevano: «Farò
distinzione fra la terra di Goshen, dove risiede il mio popolo, e nella quale non vi sarà il
miscuglio di animali dannosi». Ma in Goshen non c’erano soltanto loro, dovevano risiedervi i
non pochi addetti alla sorveglianza degli ebrei, beneficiati in grazia di loro; non pochi se si pensa
che gli ebrei erano impiegati in opere pubbliche, evidentemente per luoghi e centri di
popolamento egiziano.
Nel capitolo 9 (versetti 4, 6, 7) è detto che il Signore distingue tra ciò che appartiene agli egiziani
e ciò che appartiene agli ebrei, tra il bestiame degli uni e degli altri, sicché risulta (anzi si
conferma quanto già in precedenza osservato) che gli ebrei, non alienati dalla pastorizia,
conservavano una proprietà di animali.
Altre questioni: come facevano Mosè ed Aronne ad avvicinare il potente sovrano, se si
confronta la situazione con il racconto del libro di Ester, dove lei, che è la regina, non può
presentarsi quando vuole alla presenza del re Assuero? I faraoni egiziani non erano meno
protetti dei re persiani, ma forse nei confronti di Mosè e Aronne, esponenti di una comunità
etnica, valeva una attenzione politica.
Queste osservazioni inducono una verifica, con parziali attenuazioni nel giudizio complessivo
circa la durezza della persecuzione egiziana, che però indubbiamente ci è stata ed ha pesato sul
popolo ebraico. E’ verosimile che, mantenendo margini di vivibilità nella loro occupazione
tradizionale di pastori, con una sussistente proprietà, dovessero nel contempo fornire un
pesante quantitativo di manodopera per i lavori coatti.
SI POSSONO STORICAMENTE SPIEGARE LE PIAGHE DELL’EGITTO?
L’avvenimento delle piaghe, come narrato prodigiosamente dalla Torah, non trova conferme
storiche se non in testi, come Giuseppe Flavio, che alla Torah si rifanno. Ma la matura
considerazione dei ricorrenti travagli umani per eventi naturali, nei quali spesso la coscienza
dei popoli ha veduto dei castighi, può fare intendere il racconto delle piaghe come il concentrato,
in un tempo breve, di disastri e di intemperie che hanno afflitto l’Egitto nel corso dei tempi,
con particolare intensità durante una certa fase. Certi studiosi si sono dati a trovare in testi
Pagina 206
egiziani il racconto dolente di sciagure avvenute per cause naturali, in periodi in cui si
verificarono anche divisioni politiche e occupazioni straniere. Un papiro egiziano, chiamato
Ipawer, pare dal nome dello scriba, lamenta confusioni, sconvolgimenti, miserie, parlando, tra
l’altro, di bestiame che si ammalava o che era razziato, di campi che non producevano più grano
(erano agli anni delle spighe magre avvizzite?) e di acqua del fiume ridotta a sangue, forse per
una strana colorazione rossa. Lo scriba diceva inoltre che queste sventure erano state previste.
Lo si spiega con i moniti che profeti o severi predicatori rivolgono alle loro genti prevedendo le
afflittive conseguenze di peccati e malvagi comportamenti. Questo papiro egiziano o altri simili
scritti sono riscoperti e decifrati per trovare parziali conferme al racconto biblico, che si staglia,
organico, ben tramandato e diffuso nel mondo, illustrando quei lamentevoli accadimenti
dell’Egitto come aspetto della nemesi di un popolo schiavo, risorto e salvato dall’Onnipotente,
per farne l’araldo del monoteismo e il custode di un sacerdotale codice di vita.
Torno sulla rassegna dei capi famiglia di tre tribù, nella quale apprendiamo i nomi di molti
personaggi della generazione dell’Esodo, nomi che si ritrovano nell’onomastica ebraica, come
primi nomi personali e come cognomi, fino ad oggi. Nella tribù di Shimon (Simeone) troviamo
uno Shaul (sarà il nome del primo re di Israele), definito figlio della canaanea (ben hakenaanit). E’ un particolare che attesta il permanere di rapporti con abitanti di Canaan.
Troviamo un levita Livni, il cognome di una esponente politica israeliana. Troviamo Amram, il
padre di Mosè e Aronne (Miriam non è nominata perché si parla per lo più degli uomini), e
sappiamo che visse 137 anni. Amram sposò la propria zia, Jocheved, cosa più tardi proibita.
Troviamo il nome della moglie di Aharon, che si chiamava Elisheva, era figlia di Amminadav e
sorella di Nachshon (l’uomo che per primo, secondo la tradizione, entrò nel mare dei giunchi),
e generò ad Aharon quattro figli (non sappiamo delle figlie): Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. I
primi due moriranno avvolti da una fiamma nell’accendere fuochi sacri in modo improprio. Il
terzo, Elazar, sposò una figlia di Putiel e con lei generò Pinchas, il severo sacerdote che ucciderà
la coppia mista ebreo-midianita di Zimri e Kotzbi. da Pinchas prende nome una parashah dei
Numeri, che si è illustrata alla fine dello scorso anno. Putiel, nonno di Pinchas, sarebbe un
nome di Itrò, il sacerdote midianita, suocero di Mosè, come vedremo più in là, studiando, nel
libro dei Numeri, la parashà Pinchas.
**
Pagina 207
La haftarà è tratta dal libro del profeta Ezechiele, precisamente dalla fine del capitolo 28 e dal
capitolo 29. Il nesso è costituito dal monito che il profeta, per ricorsi della politica di potenza
egiziana, rivolge al faraone e al suo paese, raffigurandoli nell’immagine del grande coccodrillo,
coricato con spavalda sicurezza fra i canali, nell’atto di dire che il Nilo, scenario ed emblema di
forza, è una sua creatura, laddove nella concezione biblica la terra con tutti i suoi paesaggi è
del Signore che la concede agli uomini affinché ci vivano degnamente e ne facciano buon uso.
Ko amar Adonai
Hinneni alekha Parò melekh Mizraim
Hattanim ha gadol ha rovez betokh ieorav
Asher amar li ieorì vaanì asiteni
Così dice il Signore
Eccomi a te (su di te per punirti), o Faraone, re di Egitto,
il grande coccodrillo
Che se ne sta coricato (come sdraiato) in mezzo ai suoi corsi d’acqua,
e che dice ‘a me è il fiume
(mio è il fiume) e io lo ho fatto’
Ritengo che la parola tannim o tannin, che vuol dire coccodrillo si connetta al latino thynnus,
italiano tonno, avendo potuto originariamente il significato di un animale acquatico, poi
precisato in diverse lingue con riferimento a diversi animali acquatici. In ebraico tonno si dice,a
sua volta, tuna per probabile prestito dal greco tiunnos o dal latino. Col nome tonno si indica
peraltro diverse specie affini. Una può arrivare a pesare quattro quintali.
Shabbat Shalom,
Bruno Di Porto