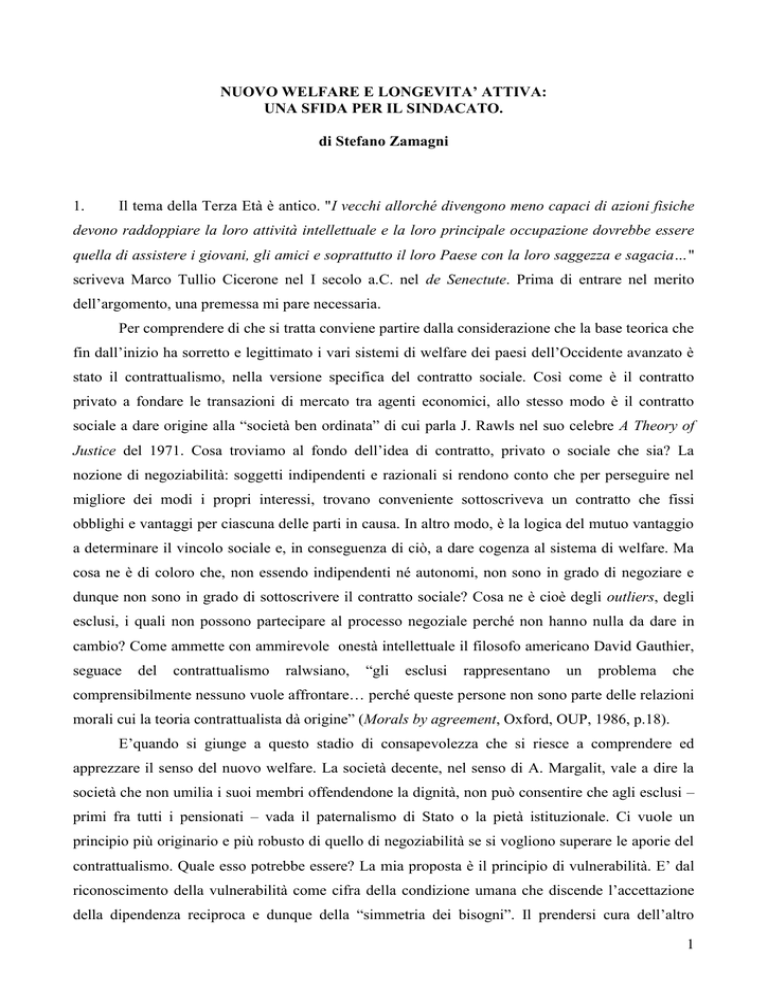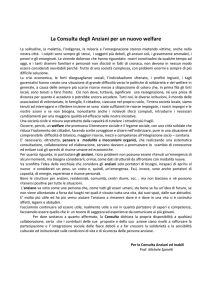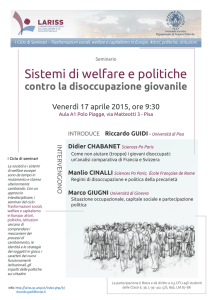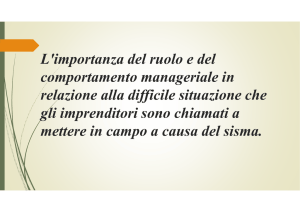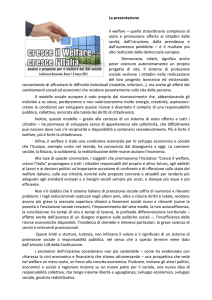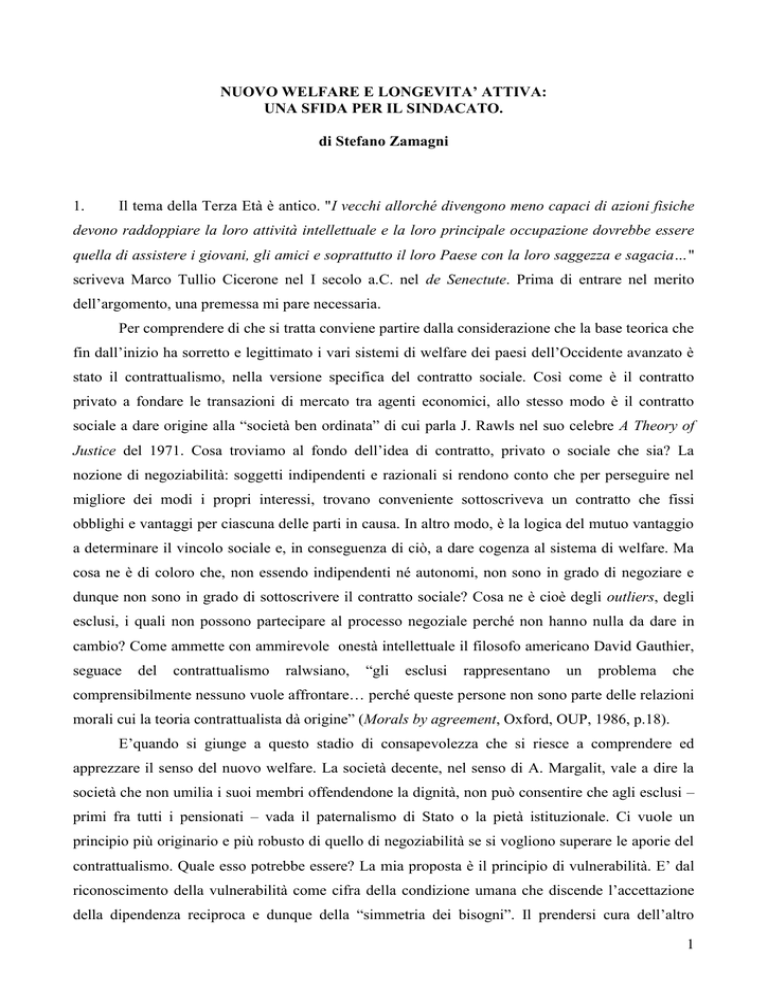
NUOVO WELFARE E LONGEVITA’ ATTIVA:
UNA SFIDA PER IL SINDACATO.
di Stefano Zamagni
1.
Il tema della Terza Età è antico. "I vecchi allorché divengono meno capaci di azioni fisiche
devono raddoppiare la loro attività intellettuale e la loro principale occupazione dovrebbe essere
quella di assistere i giovani, gli amici e soprattutto il loro Paese con la loro saggezza e sagacia…"
scriveva Marco Tullio Cicerone nel I secolo a.C. nel de Senectute. Prima di entrare nel merito
dell’argomento, una premessa mi pare necessaria.
Per comprendere di che si tratta conviene partire dalla considerazione che la base teorica che
fin dall’inizio ha sorretto e legittimato i vari sistemi di welfare dei paesi dell’Occidente avanzato è
stato il contrattualismo, nella versione specifica del contratto sociale. Così come è il contratto
privato a fondare le transazioni di mercato tra agenti economici, allo stesso modo è il contratto
sociale a dare origine alla “società ben ordinata” di cui parla J. Rawls nel suo celebre A Theory of
Justice del 1971. Cosa troviamo al fondo dell’idea di contratto, privato o sociale che sia? La
nozione di negoziabilità: soggetti indipendenti e razionali si rendono conto che per perseguire nel
migliore dei modi i propri interessi, trovano conveniente sottoscriveva un contratto che fissi
obblighi e vantaggi per ciascuna delle parti in causa. In altro modo, è la logica del mutuo vantaggio
a determinare il vincolo sociale e, in conseguenza di ciò, a dare cogenza al sistema di welfare. Ma
cosa ne è di coloro che, non essendo indipendenti né autonomi, non sono in grado di negoziare e
dunque non sono in grado di sottoscrivere il contratto sociale? Cosa ne è cioè degli outliers, degli
esclusi, i quali non possono partecipare al processo negoziale perché non hanno nulla da dare in
cambio? Come ammette con ammirevole onestà intellettuale il filosofo americano David Gauthier,
seguace
del
contrattualismo
ralwsiano,
“gli
esclusi
rappresentano
un
problema
che
comprensibilmente nessuno vuole affrontare… perché queste persone non sono parte delle relazioni
morali cui la teoria contrattualista dà origine” (Morals by agreement, Oxford, OUP, 1986, p.18).
E’quando si giunge a questo stadio di consapevolezza che si riesce a comprendere ed
apprezzare il senso del nuovo welfare. La società decente, nel senso di A. Margalit, vale a dire la
società che non umilia i suoi membri offendendone la dignità, non può consentire che agli esclusi –
primi fra tutti i pensionati – vada il paternalismo di Stato o la pietà istituzionale. Ci vuole un
principio più originario e più robusto di quello di negoziabilità se si vogliono superare le aporie del
contrattualismo. Quale esso potrebbe essere? La mia proposta è il principio di vulnerabilità. E’ dal
riconoscimento della vulnerabilità come cifra della condizione umana che discende l’accettazione
della dipendenza reciproca e dunque della “simmetria dei bisogni”. Il prendersi cura dell’altro
1
diviene allora espressione del bisogno di dare cura, del bisogno cioè di reciprocare il gesto o l’aiuto
ricevuto. Si osservi che il legame sociale che discende dall’accoglimento del principio di
vulnerabilità è assai più solido di quello che nasce dal contratto.
Alla luce di ciò, si comprende perché il nuovo welfare avrà successo se saprà coltivare tra
coloro che vi prendono parte – la cultura della reciprocità. Compito arduo questo perché la
modernità ha letteralmente espunto dal suo orizzonte culturale il principio di reciprocità,
confondendolo, a volte, con il principio dello scambio di equivalenti; altre volte, con la filantropia.
Eppure la reciprocità è qualcosa di molto diverso; essa è l’altro nome della fraternità. Si pone la
domanda: perché abbiamo bisogno di recuperare la categoria di fraternità? Perché ci stiamo
rendendo conto che il nostro bene dipende basicamente da due tipologie di beni: i beni di giustizia e
quelli di gratuità.
I beni di giustizia – ad esempio quelli assicurati dal welfare state – fissano un
preciso dovere in capo a qualche ente (tipicamente, ma non solo, lo stato) affinchè i diritti dei
cittadini su quei beni vengano soddisfatti. I beni di gratuità invece – quali sono ad esempio i beni
relazionali – fissano un’obbligazione che deriva dallo speciale legame che ci unisce l’un l’altro. E’
il riconoscimento di una mutua ligatio tra persone a fondare una ob-ligatio. Si noti che mentre per
difendere un diritto si può ricorrere alla legge, si adempie ad un’obbligazione per via di gratuità e
quindi in seguito al processo di riconoscimento reciproco. Mai nessuna legge, neppure quella
costituzionale, potrà obbligarci alla relazionalità.
Eppure, non v’è chi non veda quanto i beni di gratuità siano fondamentali per il bisogno di
felicità che ciascuna persona si porta appresso. Perché dove non c’è gratuità non può esserci
speranza. La gratuità, infatti, non è una virtù etica, come lo è la giustizia. Essa riguarda la
dimensione sovraetica dell’agire umano; la sua logica è quella della sovrabbondanza. La logica
della giustizia, invece, è quella dell’equivalenza, come già Aristotele insegnava. Capiamo allora
perché la speranza non possa ancorarsi alla giustizia. In una società, per ipotesi, solo perfettamente
giusta non vi sarebbe spazio per la speranza. Cosa potrebbero mai sperare i suoi cittadini? Non così
in una società dove il principio di fraternità fosse riuscito a mettere radici profonde, proprio perché
la speranza, si nutre di sovrabbondanza.
2.
Ciò premesso, soffermo ora l'attenzione su alcuni fatti stilizzati. Il fatto
nuovo di cui dobbiamo acquisire piena consapevolezza è l'allungamento generale e straordinario
della vita umana. All'interno di questa tendenza generalizzata, v'è da osservare che l'Italia è il paese
a più celere tasso di invecchiamento del mondo. Già oggi l’Italia è al secondo posto per indice di
2
anzianità dopo la Germania. Ma essa balzerà al primo posto in Europa nel 2020. Pochi dati sono
sufficienti a darci la misura del fenomeno. Come ci informa M. Livi Bacci, all'inizio del 1998 la
popolazione oltre i 65 anni era pari a 10 milioni di persone; nel 2010 essa salirà a 11,8 milioni e nel
2020 a 13 milioni di persone. Nel frattempo l'esercito degli occupati - comprensivo della
popolazione di età compresa tra i 20 e 65 anni - andrà riducendosi. Il risultato sarà un rapporto
anziani/occupati che dal 28% del 1998, passerà al 34% nel 2010 e al 40% nel 2020. L'Italia è
diventata il primo paese al mondo, nella storia dell'umanità, in cui le persone oltre i 60 anni di vita
sono più di quelle sotto i 20 anni. D’altro canto, gli ultra-sessantacinquenni sono, oggi, il 17,4%
della popolazione, mentre sono il 12,8% negli USA; il 15,9% in Francia; il 16% nel Regno Unito.
Degno di nota, inoltre, è l’avanzamento dell’età mediana. Da 33,4 anni nel 1975 si è passati a 40,6
nel 2000 e si congettura che l’età mediana salirà a 50,9 anni nel 2025. I dati relativi alla Francia
sono, rispettivamente: 31,6; 37,6 e 43; mentre quelli relativi al Regno Unito sono: 33,9; 38,2; 43,1.
Un elemento particolare merita la nostra attenzione ai fini del discorso presente: il veloce
abbassamento della mortalità alle età anziane.
Nessuno aveva pronosticato, o anche solo
congetturato, qualche decennio fa un fenomeno del genere. Si pensava allora che le malattie proprie
della fase anziana della vita fossero pressochè invincibili. Invece, registriamo oggi che i progressi
della sopravvivenza sono stati notevoli e non accennano affatto a diminuire. Ma v'è di più. Ricerche
recenti sulla mortalità hanno posto in risalto il fatto che non esiste un solo universale processo di
invecchiamento e che non è vero che ciascuna persona sarebbe destinata a vivere per un
predeterminato periodo di tempo a prescindere dalle determinanti socio-ambientali. Ciò comporta
che la sopravvivenza futura potrebbe anche superare le pur ottimistiche previsioni. Dobbiamo
dunque aspettarci che nel XXI secolo torneranno i "patriarchi", carichi bensì di anni, ma prestanti
nel corpo e nella mente. Come si sa, l'ingegneria genetica porta, infatti, ad allungare fortemente la
durata
della vita umana in condizioni di soddisfacente efficienza, quanto a dire che vengono
spostate in avanti le cosiddette "barriere naturali" della vita le quali solo in parte dipendono da
fattori di natura genetica; per la restante parte esse sono collegate allo status socioeconomico del
soggetto e alla sua storia clinica. E' questo un punto importante da sottolineare: anche le epoche
passate hanno conosciuto anziani di età ragguardevole - appunto, i patriarchi. La differenza con la
situazione attuale è che oggi, e sempre più in futuro, l'anziano godrà di buona salute, da trascorrere
in piena attività, e non certo nei cronicari.
La presa d'atto che la velocità della senescenza può essere ritardata con appositi interventi
resi disponibili dalla ricerca genetica, ci obbliga a sollevare un interrogativo, per nulla scontato: chi
è anziano? E' un fatto che le generazioni attuali non invecchiano più con gli stessi ritmi e con le
stesse modalità di quelle di ieri. E' dunque un grave errore di prospettiva immaginare il mondo di
3
domani semplicemente come il mondo d'oggi con più anziani. Perché avere 80 anni fra 20 anni non
sarà come avere 80 anni oggi e non è certo come averli avuti 20 anni fa. Con l’allungamento della
aspettativa di vita cambia la soglia della vecchiaia, dal momento che il processo di invecchiamento
dipende non solo dai progressi della medicina, ma anche dal livello di acculturazione conseguito,
dal contesto ambientale in cui si è svolta la vita lavorativa, dagli stili di vita adottati e così via. Ciò
significa che l’espressione “invecchiamento della società” è inadeguata e soprattutto fuorviante.
Invero, quello che sta invecchiando è il concetto stesso di età. Mezzo secolo fa, la gente di 50 anni
si sentiva più vecchia di quel che gli odierni settantenni si sentono. Come a dire – suggerisce Giarini
1
- che le nostre società stanno diventando più giovani,perché si vive più a lungo e meglio, e non già
più vecchia.
Alla luce di ciò, penso si debba concordare con Egidi 2 quando suggerisce che la soglia della
vecchiaia non deve essere fissata in termini statici, ma dinamici. La proposta di questo A. è di
definire anziana quella persona che ha una speranza residua di vita inferiore a 10 anni e non già –
come ancor’oggi avviene - quella che ha superato i 65 anni di età. Se si adotta questa impostazione
dinamica, lo scenario relativo alla quota di anziani sul totale della popolazione, quale emerge dai
calcoli di Egidi, cambia radicalmente. Per i maschi, tale quota al 2020 è pari al 7,9% - invece che il
20,1% come sarebbe se si adottasse il criterio statico dei 65 anni – e per le femmine pari all’8,6% invece che il 26,2%.
La considerazione di soglie dinamiche di vecchiaia, al posto della soglia statica, si rivela
particolarmente opportuna se si vuole dare risposta al seguente interrogativo: l’allungamento della
durata media della vita si traduce o meno in un corrispondente aumento nel numero di anni di buona
salute? In altro modo, l’allungamento della vita attesa è associato all’allungamento o alla
diminuzione dei periodi di malattia? Per abbozzare una risposta, Cambois e Robine3 hanno
introdotto in letteratura il concetto di health expectancy, cioè di durata della vita in buona salute, in
aggiunta al ben noto concetto di life expectancy. Molto semplicemente, la health expectancy (HE) è
definita come il rapporto tra durata dell’attesa di vita priva di disabilità e durata della vita attesa. E’
noto che l’epidemiologia dell’invecchiamento si interessa non solo delle malattie che causano
morbidità e mortalità, ma anche delle principali condizioni dell’autonomia funzionale. E’ a questi
contributi che soprattutto si deve l’allungamento della speranza di vita in buona salute. 4
O. Giarini, “Una società che invecchia? No, una società contro l’invecchiamento”, Macrosnews, 8, nov. 2000.
V. Egidi, “Anziani: Prospettive demografiche e problemi sociali”, in D. Da Empoli e G. Muraro (a cura di), Verso un
nuovo stato sociale, Milano, F. Angeli, 1997.
3
E. Cambois e J.M. Robine, “An international comparison of trends in disability – free life expectancy”, in R.Eisen e F.
Sloan (a cura di), Long – term care: economic issues and policy solutions, Boston, Kluwer,1996.
4
Si veda L. Antico, F. Caretta, M. Petrini, “Progressi in medicina geriatrica”, Dolentium Hominum, 28, 1995.
1
2
4
Perché è necessario, anzi urgente, arrivare a elaborare indicatori di HE? Per un duplice
ordine di ragioni. In primo luogo, per contrastare il convincimento, tipico di chi coltiva una visione
pessimistica, per non dire cinica della vita, secondo cui la più lunga durata della vita attesa si
associerebbe ad un aggravamento delle malattie croniche – come dire che il progresso tecnico –
scientifico varrebbe solamente a peggiorare la condizione umana: ti faccio vivere più a lungo, ma
nella sofferenza. In secondo luogo, per controbilanciare, se non proprio per vincere, un
preoccupante allarmismo, oggi dilagante, nella società civile e all’interno della stessa società
politica. Alla base di tale allarmismo si trova, il seguente argomento.
I cittadini anziani costano di più al settore pubblico dei cittadini non anziani. E ciò non solo
per le ben note ragioni legate all’equilibrio finanziario associato a sistemi pensionistici non più
sostenibili, ma anche perché la spesa sanitaria degli anziani è, in media, 4,2 volte quella per gli altri
cittadini.(Il dato è riferito alle popolazioni dei paesi del G7). Inoltre, l’aumento del rapporto fra
anziani e lavoratori riduce il tasso di risparmio privato nel sistema – tipicamente, il non anziano
risparmia per accumulare risorse da destinare al consumo nella fase di vita della terza età – e ciò ha
effetti negativi sulle possibilità di espansione dell’economia. Come si comprende, argomentazioni
del genere sono figlie di una concezione essenzialmente negativista della vita, di una concezione
che, mentre non può certo negare progressi e miglioramenti, deve ciononostante concludere che la
qualità della vita sarà caratterizzata da un peggioramento delle patologie croniche e delle invalidità.
Ed è allora comprensibile che restando imprigionati in una simile camicia di Nesso, le previsioni
non possono che trasformarsi in mere estrapolazioni, prive di solido fondamento metodologico, ma
pur sempre foriere di più o meno drastiche decisioni di politica sociale.
3.
Ebbene, la grande sfida da raccogliere può essere formulata nei seguenti termini: preso atto
che l’attuale transizione demografica va ponendo seri problemi di sostenibilità economicofinanziaria (per le ormai ben note ragioni associate alla spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale)
e considerato che, grazie ai progressi della ricerca genetica, già oggi, e sempre più in futuro,
l’anziano godrà di buona salute da trascorrere in piena attività e on certo nei cronicari, che fare per
scongiurare il rischio di esiti socialmente e moralmente indesiderati? Tre gli approcci che è
possibile rinvenire nel dibattito corrente. Il senso del primo è bene reso dal titolo di un recente
saggio di Regis Debray, “Fare a meno dei vecchi. Una proposta indecente” (Marsilio, Venezia,
2006). Con la crudezza di discorso che gli è tipica, Debray propone di isolare gli anziani dal resto
della società, raccogliendoli in quella che lui chiama bioland, una sorta di isola i cui ospiti vengono
inseriti in trame di relazioni basate sulla fusione tra naturalismo e misticismo. La “proposta
indecente” è volutamente provocatoria,
ma essa non si distacca molto da certe strategie di
5
istituzionalizzazione il cui unico senso pare quello di separare la terza e la quarta età dalle prime
due. L’anziano come outlier sarebbe il presupposto di tale modo di pensare al problema qui in
discussione.
Il secondo approccio - in linea con il pensiero liberal-individualista - parte dal principio che
lasciando operare liberamente le forze del mercato, le cose tendono ad aggiustarsi da sole. Il
presupposto qui è che la condizione di una persona nell’ultima parte della sua vita dipende dalle
scelte che quella persona ha fatto in precedenza. Se questa, in modo irresponsabile, non ha
provveduto ad accantonare risorse per far fronte alle necessità della vecchiaia, neppure può
invocare, e tanto meno pretendere, l’aiuto altrui. Ora, anche a voler prescindere da considerazioni di
equità, una simile impostazione lascia aperto il problema dell’inutilità di persone umane. E’ un fatto
che, nelle condizioni storiche attuali, il nuovo spreco sociale è costituito da quegli anziani, in buona
o discreta salute in media per dodici anni dal momento in cui giungono alla pensione, ai quali non
viene di fatto consentito di fare nulla di produttivo. E’ quando si giunge a questo stadio di
consapevolezza che si comprende perché una “società decente”, nel senso del filosofo israeliano
Avishai Margalit, non può tollerare di lasciare nell’inutilità quote rilevanti di popolazione. Se è vero
– come credo – che il grado di civiltà di un Paese è misurato dalla sua capacità di non umiliare
alcun cittadino facendolo sentire irrilevante, è allora necessario preoccuparsi, non solo di fornire
l’indispensabile cura all’anziano, ma anche di assicurargli la possibilità – se lo desidera – di sentirsi
e rendersi utile.
Numerosi studi empirici sull’economia della felicità, avviati da Richard Easterly nel 1975 e
portati avanti successivamente da Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia nel 2002, e tanti
altri studiosi mostrano che uno dei fattori più importanti che aumentano l’indice sintetico della
felicità è la stima di sé (self-esteem) a sua volta correlata, positivamente, al lavoro. Fra l’altro ciò
spiega perché la cessazione dell’attività lavorativa molto spesso si accompagna ad un
peggioramento psicologico delle condizioni di vita.
Che fare allora? Il terzo approccio cui facevo riferimento parte dalla considerazione che
nelle nostre società avanzate c’è una domanda implicita di lavoro umano che non riesce ad essere
soddisfatta. Mentre diminuisce la domanda di lavoro da avviare “in fabbrica”, cioè nei luoghi in cui
si producono le merci (o i servizi alla produzione di merci), grazie alle nuove tecnologie
infotelematiche della terza rivoluzione industriale, aumenta in misura impressionante la domanda
di lavoro da utilizzare per la produzione sia di beni immateriali sia di beni relazionali, sia ancora di
talune specie di beni pubblici.
Si pensi al bisogno di diffusione del know-how tecnologico tra coloro che, per una ragione o
l’altra, ne sono rimasti esclusi. Come sappiamo, nella knowledge based society, il sapere deve
6
essere il più possibile distribuito tra la popolazione perché esso possa produrre i risultati desiderati.
Se la conoscenza è accentrata, non si generano né esternalità di rete né si riuscirà a beneficiare di
complementarità strategiche. Eppure, tantissimi sono coloro che ancora non hanno accesso
all’informatizzazione della vita quotidiana. Altro bisogno, in continuo aumento, è quello legato ai
servizi di cura nei confronti dei figli minori di genitori che lavorano o delle persone comunque non
autosufficienti. Si consideri, ancora, il bisogno di diffondere tra la popolazione la cultura di un
ambiente di vita ecologicamente sostenibile, una cultura che non può ridursi a mera informazione,
ma che postula la realizzazione di pratiche di vita e di stili di consumo eco-compatibili. (E in ciò il
fondamento della nozione di consumo critico). Si pensi, infine, al bisogno, sempre più avvertito, di
rendere fruibile, a quote crescenti di popolazione, l’immenso patrimonio di beni culturali di cui il
nostro paese è fortemente dotato – un patrimonio che è ancora troppo poco valorizzato.
Cosa hanno in comune queste categorie di beni? Che per venire prodotti v’è necessità di
attivare processi caratterizzati tutti da alta intensità di lavoro. Di processi, cioè, che richiedono
molto lavoro e relativamente poco capitale e che in quanto tali soffrono della famosa “malattia dei
costi” di cui ha parlato per primo W. Baumol: se devo assistere un paziente o giocare con un
bambino non posso ridurre il tempo dedicato senza compromettere la qualità del servizio reso. Né
posso farmi sostituire da una “macchina”: si tratterebbe di un altro servizio. Ecco perché vi sono
oggi bisogni che non riescono ad essere soddisfatti: se il lavoro deve essere remunerato secondo le
regole del mercato del lavoro salariato, così come questo si è andato evolvendo con l’avvento del
sistema di fabbrica, non ci saranno mai abbastanza soggetti di offerta che riusciranno a collocare
questi servizi a prezzi tali di incontrare tutta la domanda potenziale. Non solo, ma quel che è peggio
è che sono proprio le persone a reddito medio-basso quelle ad avere più necessità di soddisfare quei
bisogni e quindi quelle che più ne risentirebbero.
Riusciamo ora a comprendere il ruolo importante e strategico che la coorte degli anziani
potrebbe svolgere nelle nostre società. Se il lavoro costasse di meno, perché non tenuto a rispettare
gli standard minimi, e soprattutto se il relativo contratto fosse meno rigido e vincolante per
l’impresa (privata o sociale che fosse), allora il prezzo per l’erogazione del servizio potrebbe
portarsi ad un livello tale da incrociare la capacità di spesa del portatore di bisogni e, al tempo
stesso, da rendere contento l’anziano disposto a svolgere un’attività lavorativa. La recente
esperienza francese dei CESU (Chèque emploi service universel) va in questa direzione. I risultati
sono estremamente incoraggianti: in meno di due anni (2005 e 2006) sono note in Francia oltre
10.000 botteghe di artigianato terziario formate da oltre centomila anziani in pensione che
desiderano continuare a lavorare, sia pure in modo ridotto e in forma autonoma. Un altro esempio è
quello delle banche del tempo intergenerazionali, il cui vantaggio è anche (e forse soprattutto)
7
quello di rafforzare il legame sociale tra le persone. Un terzo esempio ci viene dall’esperienza
canadese dei LETS (Local Exchange Trading System) e dall’esperienza statunitense delle
Community Development Corporations. E cosi’ via.
In buona sostanza, la proposta che avanzo è quella di incanalare il lavoro “liberato”
dell’anziano verso attività che producono quei beni che né il settore privato dell’economia né il
settore pubblico ha interesse – il primo – o ha le risorse necessarie – il secondo – per produrre. Quel
che è urgente fare è superare l’idea secondo cui il lavoro è solo quello retribuito secondo le forme
canoniche, a tutte ben note. Piuttosto, il lavoro è l’insieme delle attività necessarie alla crescita
umana, ma dell’uomo inteso nella globalità delle sue dimensioni. Che la nozione di longevità attiva
conosca oggi, anche sull’onda della disastrosa crisi finanziaria in atto, un rinnovato interesse, è
cosa che apre alla speranza. Ha scritto Agostino: la speranza ha due bei figli: la rabbia e il coraggio.
La rabbia nel vedere come vanno le cose; il coraggio di vedere come esse potrebbero andare
diversamente.
La longevità pone la sfida del tempo: il valore della persona è legato alla durata del tempo in
età lavorativa; ora il tempo si dilata con la conseguente nuova dimensione del suo valore legato alla
capacità di generare relazioni e di fare coesione sociale. Sviluppare su ampia scala questo concetto
– che il Censis ha stimato in vari punti percentuali d’incremento del PIL – costituirebbe oltretutto
un grande risparmio nel comparto della spesa pubblica “socio-sanitaria”, perché sarebbero gli stessi
longevi con questa nuova tipologia di prodotto-servizio, a “pagarsi” il costo della non
autosufficienza. Con ciò dando anche una spallata decisiva al concetto della contrapposizione
generazionale (i giovani imputano ai vecchi di assorbire quote crescenti di PIL) e all’inquietante
domanda “chi buttar giù dalla torre” rispetto ai costi crescenti, riportando in circuito fasce meritorie
della società che con l’attuale welfare state c’è interesse/acquiescenza ad emarginare.
4.
Dire che l’Europa vive, oggi, una situazione di stallo è, a dir poco, un eufemismo. I fatti
sono fin troppo noti perché qui si debba anche solo richiamarli. Meglio allora dirigere l’attenzione
sulle vie di uscita dall’attuale impasse. Quella su cui intendo soffermare la mia attenzione in questa
sede ha a che fare con la questione del cosiddetto modello sociale europeo, delineato bensì
nell’Agenda di Lisbona (marzo 2000), ma rimasto finora lettera morta5. Anzi, vanno crescendo di
intensità le voci di coloro che chiedono una revisione del processo di Lisbona, proprio con
Giova osservare che è bensì vero che il Consiglio Europeo di Lisbona licenzia “il modello europeo”, ma i principi che
vengono posti a suo fondamento sono talmente general-generici da renderlo praticamente indistinguibile da altri modelli
sociali. Si tratta, infatti, dei seguenti quattro principi: sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale;
collegamento stretto tra protezione sociale e politiche attive del lavoro; pari opportunità per tutti; strategie di inclusione
sociale. Ora, non vi è chi non veda come principi del genere si trovino anche in altre aree geografiche, ad esempio negli
USA.
5
8
riferimento alle tematiche sociali, allo scopo – così si sostiene - di consentire all’Europa di ritornare
a crescere al più presto. E’ il confronto con il tasso di crescita dell’economia statunitense a destare
le maggiori preoccupazioni, fino ad assumere talvolta toni di vero parossismo. (Un dato per tutti:
nel 2003, il PIL pro capite degli USA era di 33.740 $; quello dell’UE a 15 era di 24.360 $).
Questa osservazione aiuta a comprendere perché nel dibattito (scientifico e politico) in corso
la priorità assoluta venga data alle politiche della crescita e, più in generale, alle politiche
economiche dell’offerta, secondo quanto raccomandato dalla Commissione Kok e finemente
sostenuto nel Rapporto Sapir (2004). L’argomento, chiave di volta, di queste posizioni è che
l’Europa ha bisogno di crescere sia per placare le critiche populiste sia per consentire di generare
risorse in ammontare sufficiente per finanziare il suo modello sociale. (Cfr. Agenda Sociale 20062010). Quanto a dire che la crescita è precondizione, cioè causa, del welfare. E poiché la causa
precede sempre, salvo i casi rari di causalità simultanea, l’effetto, è tempo – così si dice – di
cominciare a pensare alle “cose fondamentali”, per consentire all’Europa di recuperare il ritardo che
la separa dagli USA sul fronte sia della competitività sia dell’innovazione.
C’è motivo di ritenere che questa svolta recente nel modo di pensare l’Europa e il suo futuro
aiuti a comprendere anche le difficoltà di natura propriamente istituzionale. Il fatto che i nove paesi
che non hanno ancora ratificato il Trattato Costituzionale abbiano dichiarato tutte le loro difficoltà
ad accogliere soprattutto la parte III (“politiche e funzionamento” – una parte che occupa oltre cento
del totale di 183 pagine) ci fa capire che è proprio intorno alle politiche di welfare, che di quella
parte sono magna pars, che si registrano i maggiori dissensi6. Certo, la motivazione ufficiale che, a
suo tempo, è stata addotta è altra, e cioè che esisterebbe un trade-off tra rafforzamento dell’identità
europea e identità nazionali. Che si tratti di un tipico argomento ad hoc ci viene confermato sia dal
riconoscimento che l’Europa non è e mai sarà una nazione sia dalla presa d’atto che la pluralità
delle appartenenze identitarie è ormai, nelle nostre società avanzate, un fatto acquisito.
Assai più plausibile è la considerazione, per un verso, che la spesa sociale nell’UE
rappresenta circa il 30% del PIL complessivo e i 2/3 delle spese delle pubbliche amministrazioni e,
per l’altro verso, che almeno quattro e alquanto diversi sono i modelli di protezione sociale di fatto
esistenti in Europa. Si tratta: 1) del modello nordico, caratterizzato da un elevato livello di
tassazione (tra il 47% e il 53% del PIL contro la media europea del 42%) e dalla prevalenza
dell’erogazione di servizi reali a tutti piuttosto che da trasferimenti monetari; 2) del modello
anglosassone, di marca meno universalistica rispetto al precedente e fortemente work-conditional
(tanto che non si parla di sussidi di disoccupazione, ma di job seeker’s allowances); 3) del modello
continentale, in cui i servizi di welfare sono finanziati prevalentemente dalle tasse sull’occupazione
6
La parte I del Trattato (che consta di ben 500 articoli) è dedicata alle istituzioni europee; la parte II, ai diritti
fondamentali; la parte IV alle disposizioni generali. Chiude il testo una serie di allegati.
9
(ciò che in parte spiega i bassi tassi di occupazione); 4) del modello mediterraneo, caratterizzato da
un peso eccessivo dei programmi pensionistici (in Italia, la spesa pensionistica occupa il 63% della
spesa sociale, contro la media europea del 42%), da una scarsa attenzione per la famiglia (in Italia,
la famiglia riceve il 3% della spesa sociale, contro il 7,7% della media europea), dal forte ruolo del
sindacato nella definizione degli interventi, col risultato che alcuni gruppi sociali risultano
sovraprotetti e altri sottoprotetti (Sapir, 2005).
Bastano questi rapidi cenni per comprendere perché il progetto di arrivare per via di
consenso a definire il modello sociale europeo sia, nelle condizioni attuali, poco più che un’utopia.
Ancora troppo forte è la pretesa degli stati membri di conservare per se stessi la sovranità in campo
sociale. Invero, dopo che col ben noto Patto di Stabilità, incorporato nel Trattato di Amsterdam, i
governi nazionali si sono visti restringere i tradizionali spazi di manovra nell’uso delle politiche
fiscali e monetarie, quella del sociale è rimasta l’unica area di un certo peso su cui intervenire per
assicurare ai propri paesi margini di manovra volti ad accrescere il tasso di competitività.
Allora, se più Europa è auspicabile, perché ciò è nell’interesse di tutti, come uscire
dall’attuale posizione di stallo?7 Sono dell’avviso che una via pervia ed efficace sia quella del
confronto delle idee, civile ma coraggioso, centrato su due questioni prioritarie. Per un verso, si
tratta di dichiarare apertamente quali principi normativi si ritiene di dover porre a fondamento del
(futuro) modello sociale europeo e sui quali ricercare, per via di confronto politico, la convergenza
massima possibile. Per l’altro verso, è necessario portare ragioni che valgano a dimostrare che la
tesi secondo cui il welfare è fattore di crescita è più solida e quindi più plausibile della tesi opposta,
che però è quella ancor’oggi dominante. Di questa seconda questione mi occuperò in quel che
segue.
Vien prima la crescita economica o il welfare? Per dirla in altro modo, la spesa per il welfare
va considerata consumo sociale oppure investimento sociale? Come quasi sempre accade in
economia, l’evidenza empirica non è in grado di sciogliere nodi del genere. La tesi che difendo è
che, nelle condizioni storiche attuali, la posizione di chi vede il welfare come fattore di sviluppo
economico è assai più credibile e giustificabile della posizione contraria.
Come si sa, lo Stato sociale nella seconda metà del Novecento ha rappresentato
un’istituzione volta al perseguimento di due obiettivi principali: per un verso, ridurre la povertà e
l’esclusione sociale, ridistribuendo, per mezzo della tassazione, reddito e ricchezza (la cosiddetta
Va da sé che non sto affatto pensando che quello del sociale sia l’unico fronte urgente di intervento per
rimpannucciare la casa europea. Mi basti qui ricordare il fronte delle questioni istituzionali: proporre un altro Trattato,
oppure ridurre sensibilmente quello esistente in modo da renderlo accetto a tutti i paesi membri? Conservare oppure
abbandonare il principio del convoglio più lento? (Alesina e Perotti, 2004). C’è poi il fronte delle questioni
propriamente economiche. I segnali di quello che è stato chiamato un “nuovo nazionalismo economico” mettono a
repentaglio il mercato unico. I parametri del Patto di Stabilità vanno cambiati, posto che non hanno una giustificazione
economicamente razionale, ma in quale modo e in quale direzione? E così via. (Blanchard 2004; Quadrio Curzio, 2006).
7
10
funzione di “Robin Hood”) e, per l’altro verso, offrire servizi assicurativi, favorendo un’allocazione
efficiente delle risorse nel tempo (funzione di “salvadanaio”). Lo strumento escogitato per la
bisogna è stato, basicamente, il seguente: i governi usino il dividendo della crescita economica per
migliorare la posizione relativa di chi sta peggio senza peggiorare la posizione assoluta di chi sta
meglio. Senonchè tutto un insieme di circostanze – la globalizzazione e la terza rivoluzione
industriale – ha causato, nei paesi dell’Occidente avanzato a partire dagli anni ’80, un rallentamento
della crescita potenziale. Ciò ha finito con il dare fiato, nel corso dell’ultimo decennio, al
convincimento per cui i meccanismi redistributivi della tassazione e delle assicurazioni sociali sono
la causa del rallentamento della crescita potenziale e, di conseguenza, sono responsabili di generare
una scarsità di risorse per l’azione sociale dei governi.
I risultati di questo modo di guardare al welfare sono sotto gli occhi di tutti. Non solamente il
vecchio welfare state si dimostra oggi incapace di affrontare le nuove povertà; esso è del pari
impotente nei confronti delle disuguaglianze sociali, in continuo aumento in Europa. Ad esempio,
nell’ultimo quarto di secolo, in Italia la quota dei profitti sul PIL è passata dal 23 al 30 per cento,
mentre quella che va al lavoro è scesa dal 77 al 70 per cento. Come ci rivela l’ultima indagine
CENSIS, l’Italia è ormai diventata un paese caratterizzato da una “mobilità a scartamento ridotto”:
le persone collocate ai livelli bassi della scala sociale hanno oggi maggiori difficoltà di un tempo a
portarsi sui livelli più alti. E’ questo un segno eloquente della presenza di vere e proprie trappole
della povertà: chi vi cade non riesce più ad uscirne. Oggi, la persona inefficiente è tagliata fuori
dalla cittadinanza, perché nessuno ne riconosce la proporzionalità di risorse. Quanto a dire che la
persona inefficiente (o meno efficiente della media) non ha titolo per partecipare al processo
produttivo; ne resta inesorabilmente emarginata perché il lavoro decente è solo per gli efficienti. Per
gli altri vi è il lavoro indecente oppure la pubblica compassione.
Come procedere allora nel disegno di un nuovo welfare? Il primo passo è quello di superare
le ormai obsolete nozioni sia di uguaglianza dei risultati (caro all’impostazione socialdemocratica)
sia di uguaglianza delle posizioni di partenza (l’approccio favorito dalle correnti di pensiero
liberali). Piuttosto si tratta declinare la nozione di eguaglianza delle capacità (nel senso di A. Sen)
mediante interventi che cerchino di dare risorse (monetarie e non) alle persone perché queste
migliorino la propria posizione di vita. L’approccio seniano al benessere suggerisce di spostare il
fuoco dell’attenzione dai beni e servizi che si intende porre a disposizione del portatore di bisogni
alla effettiva capacità di questi di funzionare grazie alla loro fruizione. E’ per questo che il nuovo
welfare deve superare la distorsione autoreferenziale del vecchio welfare. Se le prestazioni sanitarie,
assistenziali, educative, etc., per quanto di qualità sotto il profilo tecnico, non accrescono le
possibilità di funzionamento per coloro ai quali sono rivolte, esse si rivelano inefficaci, e anche
11
dannose, perché non aiutano di certo il processo di sviluppo. In buona sostanza, occorre procedere
in fretta a superare l’errato convincimento in base al quale i diritti soggettivi naturali (alla vita, alla
libertà, alla proprietà) e i diritti sociali di cittadinanza (quelli cui si rivolge il welfare) siano tra loro
incompatibili e che per difendere i secondi sia necessario sacrificare o limitare i primi. Come ben
sappiamo, tale convincimento è stato all’origine in Europa di dispute ideologiche oziose e di sprechi
non marginali di risorse produttive.
Di un secondo passo conviene dire. Il nuovo welfare deve essere sussidiario, deve cioè
dirigere le risorse pubbliche ottenute principalmente dalla tassazione generale per finanziare non già
– come oggi avviene – i soggetti di offerta dei servizi di welfare, ma i soggetti di domanda degli
stessi. Ciò in quanto, il finanziamento diretto da parte dello Stato delle agenzie di welfare altera la
natura dei loro servizi e fa lievitare i loro costi. Soprattutto è vero che finanziare i portatori di
bisogni aumenta la loro responsabilità e mobilità il protagonismo della società civile organizzata.
La conclusione che traggo è che le ragioni a supporto della tesi dell’esistenza di un trade-off
tra protezione sociale e crescita economica sono assai meno plausibili di quelle che militano a
favore della tesi opposta. Non è affatto vero che il rafforzamento degli istituti di tutela sociale
implichi la condanna ad una crescita più bassa, a lungo termine insostenibile. E’ vero, invece, che
un welfare post-hobbesiano, centrato principalmente, su politiche di promozione delle capacità delle
persone, costituisce nella attuale fase post-fordista, caratterizzata – dall’emergenza di nuovi rischi
sociali, l’antidoto più efficace contro possibili tentazioni antidemocratiche e, in conseguenza di ciò,
il fattore decisivo di sviluppo economico.
12