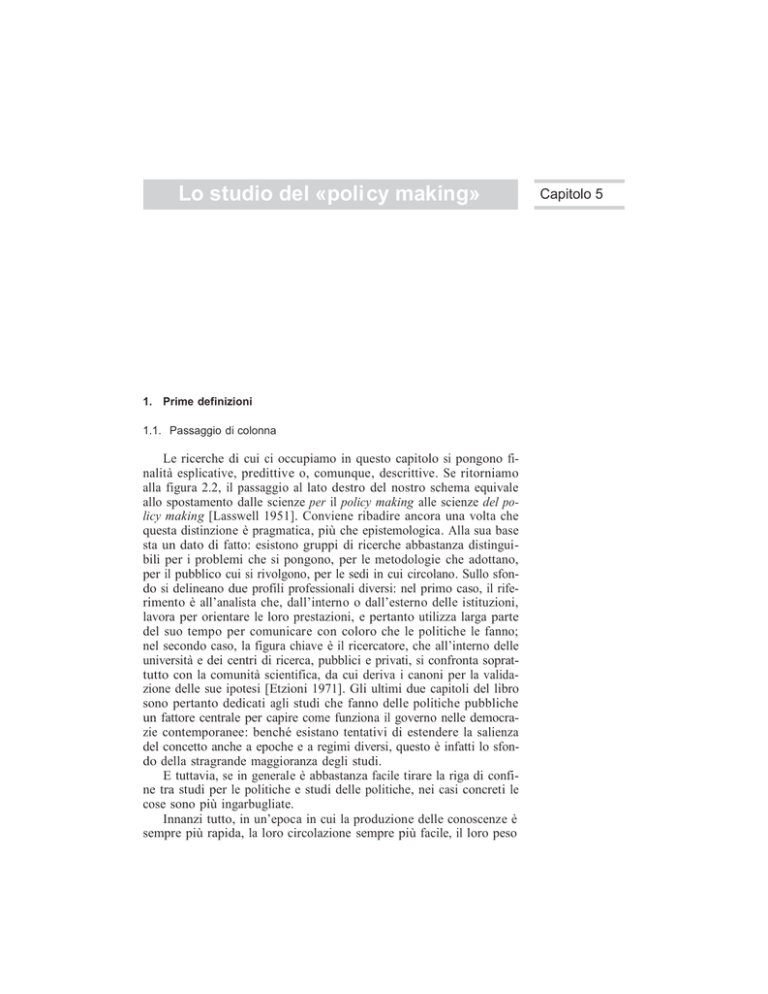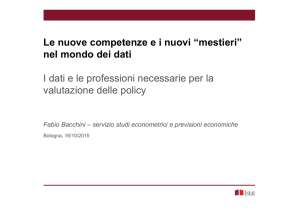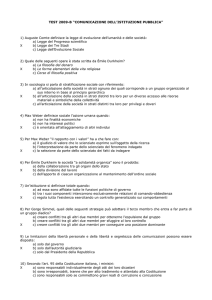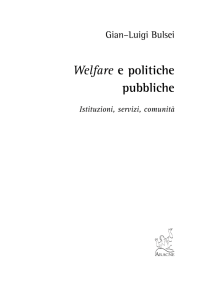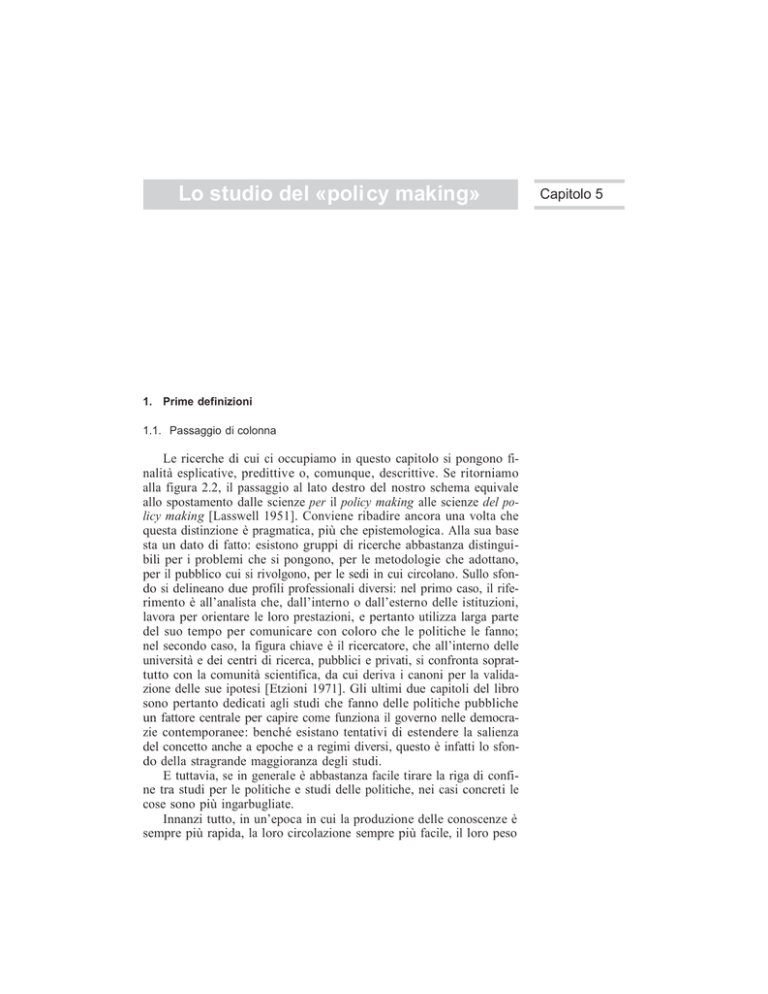
Lo studio del «policy making»
1. Prime definizioni
1.1. Passaggio di colonna
Le ricerche di cui ci occupiamo in questo capitolo si pongono finalità esplicative, predittive o, comunque, descrittive. Se ritorniamo
alla figura 2.2, il passaggio al lato destro del nostro schema equivale
allo spostamento dalle scienze per il policy making alle scienze del policy making [Lasswell 1951]. Conviene ribadire ancora una volta che
questa distinzione è pragmatica, più che epistemologica. Alla sua base
sta un dato di fatto: esistono gruppi di ricerche abbastanza distinguibili per i problemi che si pongono, per le metodologie che adottano,
per il pubblico cui si rivolgono, per le sedi in cui circolano. Sullo sfondo si delineano due profili professionali diversi: nel primo caso, il riferimento è all’analista che, dall’interno o dall’esterno delle istituzioni,
lavora per orientare le loro prestazioni, e pertanto utilizza larga parte
del suo tempo per comunicare con coloro che le politiche le fanno;
nel secondo caso, la figura chiave è il ricercatore, che all’interno delle
università e dei centri di ricerca, pubblici e privati, si confronta soprattutto con la comunità scientifica, da cui deriva i canoni per la validazione delle sue ipotesi [Etzioni 1971]. Gli ultimi due capitoli del libro
sono pertanto dedicati agli studi che fanno delle politiche pubbliche
un fattore centrale per capire come funziona il governo nelle democrazie contemporanee: benché esistano tentativi di estendere la salienza
del concetto anche a epoche e a regimi diversi, questo è infatti lo sfondo della stragrande maggioranza degli studi.
E tuttavia, se in generale è abbastanza facile tirare la riga di confine tra studi per le politiche e studi delle politiche, nei casi concreti le
cose sono più ingarbugliate.
Innanzi tutto, in un’epoca in cui la produzione delle conoscenze è
sempre più rapida, la loro circolazione sempre più facile, il loro peso
Capitolo 5
284
CAPITOLO 5
sempre più importante nel dirimere le controversie [Majone 1996], le
teorie studiate nelle università e discusse nelle riviste scientifiche tendono a uscire dai circuiti accademici, per approdare ai corsi di formazione per funzionari e consulenti, magari appena riconoscibili, come
alla fine del gioco a passaparola. Del resto, una migliore conoscenza
delle dinamiche del policy making permette di ridurre la delusione e la
sorpresa. Se le aspettative circa i comportamenti degli attori si arricchiscono di nuove e più precise ipotesi, si perde meno tempo a riaggiustare le previsioni. E non è detto che una più documentata conoscenza di come vanno effettivamente le cose porti solo ad un ridimensionamento delle attese. Certo, è probabile che esca rimpicciolita la
fiducia nell’automatica capacità della legge di imporsi, o nell’inclinazione delle organizzazioni a farsi carico di interessi di lungo periodo:
ma, nel contempo, si può scoprire che ci sono in giro molte risorse
sottoutilizzate, o molti attori disposti a fare più di quel che è loro richiesto, se solo trovano la molla giusta.
Se una qualche sovrapposizione tra finalità prescrittive e descrittive è rintracciabile in tutte le scienze sociali, compresa l’economia e
la sociologia, l’imprinting pragmatico che segna il concetto di politica
pubblica rende ancora più stretto l’intreccio. Per certi versi, il ricercatore puro si trova a dover resistere alla tendenza del suo oggetto di
studio a scendere in campo, per confrontarsi con le concrete possibilità di verifica anche sul piano applicativo. La scelta di presentare
prima le ricerche con finalità prescrittive è un riconosciment o di
questa tensione: molti dei concetti di cui ci occuperemo nelle pagine
seguenti – implementazione, negoziazione, garbage can, ecc. – sono
nati in contesti legati all’azione, anche se sopportano una declinazione di tipo descrittivo. E sia l’analisi razionale delle politiche, sia la
policy inquiry, ci hanno insegnato che le politiche sono fatte di diversi passaggi, con la mobilitazione di svariate risorse e competenze,
con punti di snodo pieni di incognite, con esiti di difficile lettura.
Questi risultati fissano dei paletti che intendiamo rispettare anche
nei due ultimi capitoli. Pertanto, in queste pagine ci concentreremo
soprattutto su quelle teorie che utilizzano più a fondo l’originalità
del concetto di politica pubblica e ne sfruttano meglio le speciali
implicazioni. L’esercizio che viene proposto intende mostrare a quali
esiti analitici possa portare una impostazione decisamente orientata
alle politiche pubbliche. Parliamo di orientamento deciso per evidenziare un dato: nei modelli che le scienze sociali hanno elaborato le
politiche possono entrare, e sono di fatto entrate, con ruoli più o
meno accentuati e peculiari. In una ideale scala dal meno al più, si
collocano all’estremo «meno» tutte le definizioni che identificano
una politica pubblica con la riaggregazione per aree funzionali di
uno o più di questi elementi:
• l’andamento della spesa in determinate «voci» dei bilanci pubblici;
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
• la ricostruzione della legislazione in determinati settori;
• l’organizzazione di determinati comparti dell’amministrazione.
Tutti e tre questi punti di osservazione forniscono informazioni preziose su quello che i governi fanno. Ma, data l’impostazione di questo
volume, noi concentreremo l’attenzione proprio su ciò che rende le
politiche pubbliche qualcosa di diverso dalla mera somma di atti amministrativi, regolati da leggi e finanziati con risorse pubbliche. Più
precisamente, le teorie che saranno considerate coltivano lo spazio
analitico che si pone tra le politiche e i processi per la loro produzione: uno spazio talvolta ampio, talaltra angusto, fatto spesso di piccoli
particolari e pertanto difficile da sondare, ma comunque importante
per la comprensione del modo in cui i cittadini di una società cercano
di risolvere i problemi di rilevanza collettiva. La politica pensionistica
italiana non è molto cambiata dal 1970 al 1992 per quanto riguarda i
trend di spesa, la struttura dei diritti previdenziali, gli apparati per la
sua amministrazione. Eppure, in quel periodo si è verificato un notevole ricambio degli attori cruciali, delle sedi decisionali, degli stili negoziali, e non solo come semplice rispecchiamento delle trasformazioni
in atto nel sistema politico [Regonini 1996a].
1.2. Il rapporto con la scienza politica
Gli studi che si propongono finalità descrittive e che adottano un
metodo induttivo, mirano a ricostruire l’effettivo svolgimento dei processi che portano alla formulazione, all’approvazione, all’implementazione e alla valutazione delle politiche pubbliche, perché ritengono
queste attività decisive per la comprensione dei rapporti tra cittadini e
istituzioni nelle democrazie contemporanee. Tali ricerche mostrano la
continuità più evidente con i temi e i metodi della scienza politica (political), la disciplina con il rapporto più diretto con il problema del
governo della cosa pubblica [Heclo 1972, 83; Grumm 1975; Hansen
1983, 218]. Gli interrogativi più ricorrenti riguardano infatti il peso
più o meno determinante delle varie categorie di policy makers (politici, burocrati, rappresentanti degli interessi, esperti, opinion leaders,
ecc.), gli stili decisionali seguiti quando sono in gioco queste scelte, le
relazioni tra le varie fasi del policy making, l’influenza degli assetti istituzionali, le dimensioni per formulare una tipologia dei problemi sul
tappeto.
Anche la ricerca politologica può essere più o meno decisamente
orientata alle politiche pubbliche. Nel polo «meno» possono essere
collocate le analisi che si limitano a considerarle come indicatori di
qualcos’altro: dei rapporti di potere, dell’importanza dei risultati elettorali, o delle culture civili. Queste impostazioni poggiano più o meno
esplicitamente su una visione top-down del processo di produzione
delle politiche: le loro caratteristiche sono infatti indagate per trarre
285
286
CAPITOLO 5
conclusioni circa la natura e il funzionamento dei classici centri di interesse della ricerca politologica: i partiti, il parlamento, l’esecutivo,
l’opinione pubblica. Nella nostra presentazione, accenneremo a queste
ricerche soprattutto per far emergere dal contrasto i tratti degli approcci decisamente orientati alle politiche, che anche storicamente
hanno ricavato da questo confronto spunti per rafforzare la loro originalità. In ogni caso, l’obiettivo non è la difesa del grado di purezza di
un approccio, ma l’esplorazione di spazi che possono essere ispezionati solo usando come mezzo di trasporto un concetto forte di politica
pubblica.
1.3. Il problema della «singolarità»
«La “telenovela” ha un titolo: “Uno per tutti o tutto per uno” –
L’estenuante rimpallo del rinnovo contrattuale [degli insegnanti] sembra non avere fine»1. In effetti la vicenda dell’attuazione dell’articolo
38 del Contratto collettivo nazionale integrativo della scuola, contenente le norme per gli aumenti legati al merito, in un anno2 ha offerto
diversi colpi di scena: manifestazioni vivacemente sostenute da organizzazioni in genere su fronti opposti; sindacati che rinnegano accordi
prima salutati con entusiasmo; prove per la verifica delle competenze
sospese a pochi giorni dall’inizio; recriminazioni tra il ministro e la
segreteria del suo partito; rovesciamento degli obiettivi da parte del
nuovo ministro. La prima impressione, ricostruendo gli eventi che
hanno portato allo sviluppo o alla paralisi di una politica pubblica, è
spesso quella di una telenovela con una sceneggiatura di bassa qualità,
dove i colpi di scena sono continui e ingiustificati, dove la personalità
dei protagonisti è mal tratteggiata, dove la trama è ripetitiva e piena di
incoerenze: morti che ricompaiono, improbabili riconciliazioni, catastrofi a ripetizione.
Dato che il mondo reale delle politiche è spesso così distante dalle
immagini ufficiali, così ricco di elementi inattesi e coloriti, il maggior
pericolo da cui si deve guardare questo tipo di studi è lo scadere nell’aneddotico, nel racconto in cui ogni caso fa «storia a sé». Limitarsi a
registrare il fatto che ogni vicenda di policy è diversa dall’altra non fa
avanzare di molto la conoscenza cui aspira questo settore delle scienze
sociali, qualunque sia l’obiettivo del ricercatore: la descrizione «densa»
[Geertz 1973], la spiegazione di tipo causa-effetto [Sabatier 1999b], o
la comprensione sorretta da categorie analitiche, secondo la lezione
weberiana.
Ma arrivare a conclusioni generalizzabili non è semplice. Innanzi
1
2
«Corriere della Sera», supplemento Scuola del 26 febbraio 1999.
Il contratto è stato ratificato il 31 agosto 1999.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
tutto, categorie troppo ampie rischiano di trascurare la rilevanza di
particolari che invece contano. Nei due capitoli precedenti, abbiamo
imparato che i grandi fallimenti spesso sono fatti di piccoli fraintendimenti: rimuovere questi elementi a favore di spiegazioni più generali e
più ambiziose può stravolgere il profilo dei processi che segnano le
politiche. In secondo luogo, anche il risalire a variabili con una solida
reputazione scientifica non è impresa facile, non perché le loro tracce
scarseggino, ma, al contrario, perché ogni fattore studiato dalla scienza
politica può legittimamente rivendicare un qualche ruolo nella determinazione delle politiche:
La gamma e il numero dei fattori che influenzano o determinano quel
che i governi fanno o, quando è il caso, quel che scelgono di non fare, sono
virtualmente infiniti. Le politiche possono essere influenzate da precedenti
impegni di policy, da tensioni internazionali, dal clima nazionale, dalle risorse
economiche, dal grado di conflitto etnico, dalle tradizioni storiche, dalla personalità dei leader, dal livello di istruzione della popolazione, dalla natura del
sistema partitico, dal fatto di essere governate da civili o da militari. L’elenco
può essere allungato in modo indefinito. Virtualmente qualsiasi cosa può influenzare o determinare quello che i governi fanno [Leichter 1979, 38].
Larga parte degli studi riportati in questo capitolo possono essere
letti come tentativi di trovare un passaggio tra questi due opposti pericoli. Il problema analitico fondamentale è trovare le categorie per
cogliere la ricchezza di queste vicende, uscendo dalla padella della
mera ricostruzione storica, senza cadere nella brace di generalizzazioni
troppo ampie.
1.4. La molteplicità dei punti di osservazione
Oltre ad avere profili singolari, le politiche pubbliche, a differenza
dei programmi, hanno un’articolazione che rende possibile la loro osservazione da punti di vista anche molto distanti tra loro. La storiella
indiana dei quattro ciechi che toccano l’elefante è spesso utilizzata per
sottolineare questo aspetto:
Uno sente la gamba dell’elefante, un altro la coda, il terzo un orecchio, e
l’ultimo il corpo. Come risultato di questo esperimento tattile, quello che ciascuno ha sentito è descritto di volta in volta come un tronco, come una corda, come una ventola e come una parete. Gli studiosi di politiche pubbliche
somigliano molto a questi quattro ciechi: ciascuno tende a esaminare una piccola parte di un animale molto grande [ibidem, 8].
Più che l’ampiezza, è la complessità a consentire l’utilizzazione di
diversi codici per decifrare quel che succede quando si tratta di introdurre criteri di merito nelle retribuzioni dei dipendenti pubblici, o di
rafforzare il divieto di fumo, o di programmare il numero di posti
287
288
CAPITOLO 5
negli asili nido. Per presentare uno dei testi di public policy più famosi,
The Essence of Decision, di Graham Allison [1971], Barbara Nelson
[1996, 568] fa riferimento al film giapponese Rashomon, che racconta
quattro ricostruzioni diverse di uno stesso tragico evento da parte di
quattro testimoni, ciascuno spettatore di sequenze diverse, con diversi
colpevoli. Questo tipo di consapevolezza segna uno scarto netto rispetto all’ambito di discorso in cui si muove il politico, il giornalista, il
commentatore. Mentre questi ultimi tendono a ridurre a uno il numero delle variabili significative o degli attori cruciali, per spiegarci «che
cosa ha causato», «di chi è la colpa», lo studioso coltiva un forte scetticismo circa la possibilità di leggere il policy making in base a questi
metri di giudizio.
E la conoscenza di come una stessa politica è stata gestita in momenti diversi nel tempo, o in luoghi diversi nello spazio, in genere
rafforza l’ipotesi della debolezza delle connessioni di causa-effetto,
dell’instabilità degli esiti, della polivalenza delle condizioni di partenza.
La comparazione infatti rivela la straordinaria varietà delle risposte
a uno stesso problema, e dei problemi per una stessa risposta. Se è
difficile trovare due popoli che fanno il caffè allo stesso modo, le
differenze che si spalancano anche in politiche a bassa salienza ideologica, quali il controllo del traffico o la distribuzione dei medicinali,
offrono spunti analitici fondamentali per la comprensione dei processi
di policy. Vedere come, dove, a opera di chi, in problemi o in soluzioni che all’osservatore paiono simili, compaiano i segni della diversità,
dà una fondamentale opportunità per verificare lo spessore di assunzioni che sembrano scontate, ma che invece non lo sono affatto, perché anche l’innervatura della più banale delle politiche pubbliche ha
ramificazioni molto estese.
2. L’affermazione del paradigma
2.1. Stati Uniti
Nel primo capitolo, ci siamo soffermati sull’importanza del pragmatismo e del comportamentalismo per lo sviluppo della prima generazione dei policy studies. La nostra ricostruzione si fermava alle soglie
degli anni ’50. Occorre ora riprendere il racconto degli anni successivi,
che sono stati cruciali per il consolidamento di una prospettiva orientata alle politiche nella scienza politica americana.
2.1.1. Il comportamentalismo
Come abbiamo più volte sottolineato in queste pagine, l’importanza attribuita ai dati, l’interesse per la raccolta delle valutazioni dirette
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
dei cittadini, la curiosità per le descrizioni libere da precoci inquadramenti teorici, sono tratti che caratterizzano la preistoria dei policy studies, a partire dalle ricerche di Charles Merriam, del suo allievo Harold Lasswell e della Scuola di Chicago tra gli anni ’30 e ’40. All’inizio
degli anni ’50, queste caratteristiche acquistano più profondità teorica
e più rigore metodologico, fino a configurare un vero e proprio paradigma, il comportamentalismo, destinato a diventare per quasi due
decenni il principale punto di riferimento della scienza politica americana, la sua dottrina ufficiale3. A caratterizzare questo approccio, e ad
accomunare le ricerche politologiche a quelle sociologiche, psicologiche, antropologiche, è l’attenzione per le azioni effettivamente registrabili, per i comportamenti concreti dei singoli, per le loro opinioni
espresse direttamente attraverso questionari e interviste. Nella scienza
politica, questa impostazione portava a considerare gli individui e i
gruppi come le unità analitiche fondamentali, e le decisioni come i fenomeni più importanti del loro stare insieme. Per gli studiosi di politics, questo orientamento poneva al centro della ricerca soprattutto le
decisioni relative al voto: la scelta tra partecipazione e astensione, le
motivazioni nella selezione del partito, la costanza o la volatilità dei
giudizi, la loro autonomia o il loro condizionamento da parte della
famiglia o dei media. Per gli studiosi delle amministrazioni e dei governi, erano le effettive decisioni sulle singole questioni all’ordine del
giorno a diventare cruciali per la comprensione del funzionamento
delle istituzioni, solo genericamente descritto dai vincoli giuridici o
dalla storia costituzionale [Farr e Seidelman 1993]4. Come diventerà
evidente nel prossimo paragrafo, da qui allo studio delle politiche
pubbliche, il passo è abbastanza breve5.
Negli anni ’50, sullo sfondo della rivoluzione comportamentalista,
due altre correnti di ricerca si incaricano di accorciare ulteriormente le
distanze. La prima ha alla sua base la teoria del sistema politico elaborata da Robert Easton nel 1953; la seconda è il movimento per le policy sciences lanciato da Harold Lasswell nel 1951.
2.1.2. La teoria del sistema politico
Di teoria dei sistemi abbiamo già parlato nel terzo capitolo, indicandola come fondamento di una particolare metodologia manageriale: l’analisi dei sistemi. Torniamo a occuparcene ora, in un diverso
3 «Qualunque unità di misura si adotti, il più importante aspetto della scienza
politica dopo la seconda guerra mondiale è stato lo sviluppo del comportamentalismo» [Waldo 1975, 58].
4 E. Berdtson, Behavioralism: Origins of the Concept, 1997, in http://www.volt.
helsinki.fi/vol/projects/behavior.htm (luglio 2000).
5 V. la 1ª ed. di Dye, Understanding Public Policy del 1972.
289
290
CAPITOLO 5
contesto, perché negli anni ’50 il modello cibernetico basato su inputoutput-feedback viene considerato con sempre maggiore frequenza
come una rappresentazione adeguata a descrivere quello che avviene
nella sfera politica. In un contesto democratico, le organizzazioni degli
interessi e i partiti politici «alimentano» il sistema, permettendo alle
istituzioni di rilevare le domande dei cittadini, di elaborarle, e di rispondere con le politiche adeguate. La reazione al loro impatto da
parte dei destinatari fornisce nuovi elementi per affinare l’input, con
un processo di riaggiustamento continuo, che consente alle componenti del sistema – cittadini, organizzazioni, istituzioni elettive, apparati
amministrativi – di rimanere tra loro in un equilibrio dinamico.
La teoria del sistema politico ha svolto un ruolo fondamentale nel
richiamare l’attenzione degli scienziati politici su ciò che i governi fanno per rispondere alle concrete richieste dei cittadini: «La conversione
dell’input in output, attraverso l’utilizzazione delle risorse del sistema,
fornisce un’approssimazione all’azione specifica nel processo di policy
[...]. È questo continuo flusso senza fine di politiche, alimentato dal
processo di feedback tra il sistema politico, dotato di autorità, e la società, che dà l’idea del processo di produzione delle politiche pubbliche» [Curtis e Schoettle 1968, 169].
Il concetto di processo, già entrato nel bagaglio teorico della scienza politica grazie ai lavori di Arthur Bentley [1908] e di David Truman [1951], sembra ora trovare una più compiuta definizione, saldandosi da un lato alla cibernetica [Deutsch 1963], dall’altro alla teoria
dell’azione di Talcott Parsons [1966] 6, e dischiudendosi alla ricerca
empirica di matrice comportamentalista. Come scrive Truman,
«L’obiettivo finale di uno studioso del comportamento politico è lo
sviluppo di una scienza del processo politico, logicamente completa in
se stessa [...]. Molti dei temi delle altre scienze comportamentiste non
sono rilevanti come questo» [1951, 39]. Il risultato è l’emergere di
aspetti fino a quel momento considerati privi di rilevanza scientifica, se
non vere e proprie patologie: le negoziazioni, i tentativi approssimativi,
gli aggiustamenti «in corso d’opera», le pressioni e i ricatti sono ora
considerati come elementi importanti per il raggiungimento di quell’equilibrio sempre diverso che costituisce la forza del modello.
2.1.3. Il movimento per le «policy sciences»
Nel 1951 Lasswell e Lerner, in un volume destinato a fare storia,
coniano il termine «policy sciences» per definire un programma di ricerca capace di perseguire simultaneamente due obiettivi: «lo sviluppo
6 Il volume in cui compare il saggio di Parsons The Political Aspect of Social
Structure and Process è curato dallo stesso Easton.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
di una scienza della formazione e dell’esecuzione delle politiche [...] e
il miglioramento del contenuto concreto delle informazioni e delle
interpretazioni a disposizione dei policy makers» [Lasswell 1951, 3]. Il
loro progetto mantiene una stretta continuità con l’impostazione pragmatica di Dewey, ora chiamata a confrontarsi con le mutate esigenze
della società americana, dentro e fuori le università. Nella scienza politica, si trattava di innalzare la qualità dello studio delle concrete attività dei governi, per poter competere con gli elevati standard che il
comportamentalismo fissava alla conoscenza dei fatti sociali. Nel rapporto con le istituzioni, occorreva dimostrare che le policy sciences
sapevano effettivamente fornire un aiuto nella soluzione dei problemi
rilevanti per i cittadini, preoccupati per la scarsa qualità dell’istruzione
dei figli o per l’incertezza della loro situazione economica.
Secondo Lasswell, propositi tanto ampi non potevano tradursi soltanto nell’avvio di una nuova scuola accademica, ma richiedevano la
promozione di un vero e proprio movimento, basato sulla fiducia nella
capacità della democrazia e della conoscenza di rafforzarsi a vicenda
[1951]. Le scienze delle politiche sono infatti un «movimento interdisciplinare, al simultaneo servizio dei valori democratici, della costruzione di teorie nell’accademia, e delle esigenze del governo» [Garson
1986, 14].
Proprio per il rifiuto di trovare una nicchia lungo l’asse prescrizione/descrizione, per coltivare invece «la conoscenza necessaria per migliorare la pratica della democrazia» [Lasswell 1951, 15], le policy
sciences sono destinate a uscire rapidamente dalla scena del piano a,
per approfondire i legami con correnti di ricerca di matrice europea,
quali la sociologia della conoscenza e la teoria critica della società
[Dryzek 1990]. Ma negli anni ’50 e ’60, la figura carismatica di Harold
Lasswell, con il suo straordinario curriculum di ricercatore empirico e,
insieme, di raffinato teorico, esercitava una grande influenza nell’orientare anche gli scienziati politici di formazione più tradizionale verso lo
studio delle politiche pubbliche e del loro effettivo impatto sulla vita
della gente.
2.1.4 Un clima non ostile
Il giudizio sull’influsso che le grandi correnti degli anni ’50 e ’60
hanno esercitato sullo studio delle politiche pubbliche è stato fortemente influenzato dalla traumatica conclusione di quel rapporto, con
la spietata autocritica di David Easton nel 1969, sulla quale torneremo
tra breve. Ma la proiezione di questo cono d’ombra non deve oscurare
un dato: quel periodo è stato fondamentale per il decollo dei policy
studies: molti degli interrogativi di ricerca avanzati nelle pagine seguenti, molte delle opere citate, hanno la loro collocazione proprio in
quell’arco di tempo.
291
292
CAPITOLO 5
Nel capitolo precedente ci siamo soffermati su quattro idee, essenziali per la policy inquiry: le politiche come conoscenze in uso, come
interazioni, come processi, come bidoni della spazzatura. Alla fine
degli anni ’60, le basi per queste acquisizioni sono già gettate, e in alcuni casi è già costruito l’intero edificio7.
Ma è interessante notare che in quegli stessi anni, grazie ai lavori
di Edelman sull’importanza dei simboli in politica [1960], di Bachrach
e Baratz sulle non decisioni8 [1963] e, soprattutto, grazie al citatissimo articolo di Lowi sulla capacità delle politiche pubbliche di strutturare autonome arene di potere [1964], sono poste anche le premesse per lo sviluppo di impostazioni nettamente critiche rispetto al
comportamentalismo e all’approccio sistemico, correnti verso le quali
le ricerche di ispirazione pluralista mantenevano invece un atteggiamento simpatetico, o quanto meno accomodante, come vedremo nel
paragrafo seguente.
2.1.5 Il rapporto tra comportamentalismo e positivismo
Lo studioso che ricostruisce la storia di quegli anni rimane impressionato da un’incongruenza. Da un lato, stanno la grande ricchezza del
dibattito teorico e la definitiva consacrazione delle politiche pubbliche
come autonomi oggetti di studio nella scienza politica americana9.
Dall’altro, nel giudizio dei contemporanei [Heclo 1972, 86; Van Dyke
1968, 24] e, soprattutto, in quello di uno dei principali protagonisti,
David Easton [1969], l’impostazione generale delle ricerche politologiche di quel periodo è considerata un pesante ostacolo allo sviluppo di
approcci davvero orientati alle politiche, e il policy turn viene fatto
coincidere con il tramonto delle grandi correnti di pensiero di quegli
anni.
7 Basti pensare ai seguenti lavori: Politics, Economics and Welfare [1953], di Dahl
e Lindblom, intorno al problema di come individui e gruppi riescono ad aggregare in
modo incrementale le loro preferenze in scelte collettive; Who Governs? [1961a], di
Dahl, considerato una pietra miliare da molti studiosi di politiche [Heclo 1972], e
destinato a suscitare un largo dibattito sul potere nelle comunità locali [Clark 1968];
The Science of «Muddling Through» [1959], di Lindblom, e A Strategy of Decision
[1963], di Braybrooke e Lindblom, in cui è presentato il concetto di incremetalismo
sconnesso; American Business and Public Policy [1963], di Bauer, Pool e Dexter, in
cui, grazie a 1.400 interviste e dieci anni di lavoro d’équipe, è ricostruita l’evoluzione
delle politiche tariffarie statunitensi come chiave di volta per capire le trasformazioni
dell’intero sistema politico. Nel caso della metafora del bidone della spazzatura, la sua
esplicita definizione è del 1972 [Cohen, March e Olsen 1972], ma la disarticolazione
tra decisione e processo decisionale è già presente in March [1965].
8 Cioè sui problemi intenzionalmente esclusi dall’agenda politica, nonostante la
loro rilevanza.
9 Tra il 1967 e il 1970, le principali università inaugurano corsi di public policy e
si tengono i primi seminari ai convegni annuali dell’APSA [Hansen 1983].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Noi crediamo che qualche lume per rischiarare questa contraddizione possa derivare dall’analisi dell’ambiguo rapporto che gli studiosi
di policy hanno tenuto verso il comportamentalismo e la teoria dei sistemi, utilizzati in modo un po’ opportunistico per ottenere una patente di scientificità, ma nel contempo guardati con sospetto per il rischio
di derive positiviste. Questa ambivalenza traspare dagli scritti di molte
figure chiave di quel periodo: Easton, Truman, Dahl, Eulau mostrano
spesso un distacco critico verso l’entusiasmo dei più convinti comportamentalisti, verso le loro grandi indagini orientate a cogliere gli atteggiamenti degli elettori per il voto, così come un biologo potrebbe cogliere gli atteggiamenti verso il cibo di una qualche specie animale.
E tuttavia, almeno all’epoca del suo decollo, il behavioralismo diventava un comodo ombrello per due motivi pratici. Innanzi tutto, le
grandi fondazioni, e la Fondazione Ford in primo luogo, esigevano,
quale condizione per l’elargizione dei finanziamenti, la presentazione
di progetti di ricerca con struttura e metodologie solide, il che significava analoghe a quelle utilizzate dalle scienze naturali [Dahl 1961b;
Easton 1965; Farr e Seidelman 1993]. Inoltre, in anni pesantemente
segnati dal maccarthismo 10, le scienze sociali dovevano difendersi dalla
pericolosa assonanza tra «sociale» e «socialista», che induceva l’opinione pubblica e i politici a guardare con diffidenza alla loro espansione
accademica [Easton 1985]. Persino Harold Lasswell, che durante le
seconda guerra mondiale aveva servito il suo paese con delicati compiti di intelligence, finì nell’elenco dei sospetti per le sue teorie sulla società globale e la pace tra i popoli11. Il rifugiarsi dietro indagini almeno apparentemente limitate alla mera registrazione di dati e alla loro
elaborazione statistica forniva un’efficace difesa verso i rischi di una
pesante intrusione della politica nella ricerca.
Nonostante questi aspetti, sarebbe però riduttivo considerare l’ambiguo rapporto tra comportamentalismo e decollo dei policy studies
solo alla luce di esigenze pratiche: da questa relazione, prima coltivata
e poi radicalmente negata, traspare un tipo di complicità più interessante, che potremmo definire come opportunismo analitico.
Innanzi tutto, il nuovo approccio permetteva un’emancipazione
completa e quasi provocatoria da concezioni formalistiche delle istituzioni e delle politiche [Gunnell 1995]: ricostruendo i concreti processi
di adozione e implementazione, gli scienziati politici avevano modo di
10 Dal nome del senatore Joseph McCarthy, che alla fine degli anni ’40 si fece
promotore di una violenta campagna per sradicare nel paese l’influenza del comunismo. La commissione d’inchiesta da lui presieduta adottò metodi intimidatori e formulò sentenze in seguito giudicate inique dallo stesso senato americano.
11 «Pertanto Lasswell dovette scrivere a Merriam per chiedergli una testimonianza scritta del fatto che non era, e non era mai stato, membro del partito comunista, o
simpatizzante dei comunisti e del comunismo» [Berndtson 1987, 97]. Una ricostruzione del clima di quegli anni è fornita anche da Simon [1991, 186-194].
293
294
CAPITOLO 5
dimostrare l’autonomia e la rilevanza del loro specifico punto di osservazione rispetto al diritto, all’economia, alla storia [Easton 1953, 187188 trad. it.]. Ma soprattutto, comportamentalismo, teoria del sistema
politico e policy sciences permettevano, ciascuno a suo modo, di tenersi alla larga dal conflitto epistemologico tra polo naturalistico e polo
antinaturalistico nelle scienze sociali, tra fautori della spiegazione sulla
base di macroleggi, finalizzate a sintetizzare il perché dei fenomeni
sociali, e fautori dell’interpretazion e (Verstehen), secondo la lezione
weberiana.
Come vedremo meglio nelle prossime pagine, lo studio delle politiche pubbliche fatica a reggere il confronto con un dibattito epistemologico impostato in questi termini. Mentre il richiamo allo spirito
empirista di Locke12 appare in sintonia con la sua concretezza, con la
cura per il dettaglio e per l’informazione di prima mano, la rilettura
operata dalla filosofia analitica europea, con l’equiparazione della ricerca scientifica all’individuazione delle cause generali, sta decisamente
stretta a gran parte delle scienze sociali americane. Comportamentalismo, teoria dei sistemi e policy sciences sono in fondo tre modi per
aspirare a elevati standard di rigore scientifico senza impegnarsi in
dispute capaci di svuotare l’originalità del concetto di politica pubblica. Infatti i comportamenti, o gli input, o i problemi non sono cause,
o quanto meno non lo sono allo stesso modo in cui il calore è causa
della trasformazione dell’acqua in vapore: e tuttavia sono elementi fondamentali per capire la dinamica del policy making. Quando David
Easton rivendica la continuità della sua impostazione, per difendersi
dalle critiche di chi considera la sua un’abiura dettata da circostanze
tremende, ha buoni motivi per farlo: «Una lettura attenta del mio discorso presidenziale dovrebbe chiarire che non c’è stato nessun mutamento radicale [...] Mai, neppure nel Sistema politico, sono stato in
grado di accettare un’interpretazione dei valori della scienza legata a
una posizione di positivismo radicale» [Easton 1971, 385 trad. it.]13.
2.1.6. La svolta del ’69
Nel 1969 David Easton, divenuto presidente dell’American Political Science Association, tiene un discorso considerato l’inizio dell’epoca postcomportamentalista nella scienza politica, e soprattutto nello
studio delle politiche. Il periodo è tra i più convulsi della storia americana: «L’umanità oggi agisce in un senso di urgenza. Il tempo non è
più dalla nostra parte» [Easton 1969, 355 trad. it.]. Come ribadirà due
12 Lasswell e Kaplan [1950] pongono in testa al loro volume sul potere questa
sua citazione: «Non sono le denominazioni che costituiscono il governo, ma l’uso e
l’esercizio di quei poteri che dovrebbero accompagnarsi ad esse».
13 Per una lettura opposta, v. Hawkesworth [1988].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
anni dopo, gli scienziati sociali erano «messi di fronte negli Stati Uniti
a una guerra disastrosa nel Vietnam, a bambini che muoiono di fame,
a negri in collera, a bianchi spaventati, a cittadini d’ordine mobilitati,
a tre gravissimi assassinii politici nel giro di cinque anni, a rivolte studentesche nelle università e ai progetti di guerriglia» [Easton 1971,
396 trad. it.]. In questo clima, Easton raccoglie le critiche più volte
mosse al modello sistemico e alle ricerche sul policy making da esso
originate, accusate di coltivare un interesse solo formale per le politiche, perché attente più ai processi decisionali e ai loro effetti sulle istituzioni, anziché al loro impatto concreto sulle condizioni di vita della
gente [Van Dyke 1968; Heatwole, Keller e Wamsley 1976]. Secondo
Easton, il movimento postcomportamentalista è chiamato a opporsi a
questa sterilizzazione del concetto di policy, attraverso «una ricerca più
rilevante, un orientamento verso il mondo che incoraggi gli scienziati
politici, anche nella loro attività professionale, a prescrivere e ad agire
in modo da migliorare la vita politica secondo i criteri umani» [Easton
1969, 355 trad. it.].
Questa netta presa di posizione è destinata a rompere i tenui equilibri su cui si era retta la crescita dei policy studies durante gli anni ’60.
L’effetto è una più netta divisione di questo campo di indagine lungo
tre diverse direttrici, che potremmo tratteggiare in questi termini:
• l’uscita dal piano a, per esplorare inedite modalità di fare ricerca scientifica, prendendo come punto di riferimento la duplice valenza, descrittiva e prescrittiva, dei concetti di politica pubblica e di democrazia;
• una drastica riduzione della complessità del concetto di politica
pubblica, fino a farlo coincidere con le scelte di spesa dei governi, per
adeguare la ricerca a standard più elevati di formalizzazione delle ipotesi e di rigore statistico dell’analisi;
• l’ancoramento alla tradizione di ricerca avviata negli anni ’50 e
’60, per fare studi in regola con i tradizionali standard dell’indagine
empirica politologica, ma nel contempo più consapevoli della complessità del loro oggetto.
Vediamo più da vicino queste tre diverse alternative.
2.1.7. Il criterio della rilevanza e l’uscita dal piano a
«Una teoria non può essere vera nella scienza se non è anche rilevante nella società (indipendentemente da come noi definiamo la verità)» [Easton 1971, 400 trad. it.]. L’appello a una scienza sociale capace di produrre conoscenze rilevanti per lo sviluppo economico e civile
non suonava certo nuovo in un convegno di politologi americani. In
effetti, in quegli anni molti ricercatori, per riorientare il loro lavoro, si
trovavano ad attingere a una tradizione che conta figure quali Dewey,
Merriam e Lasswell. Più precisamente, alcuni autori ritornano sul con-
295
296
CAPITOLO 5
cetto di scienze delle politiche, così come definito da Lasswell nel
1951, per farne un ponte capace sia di collegare la loro riflessione al
pensiero politico europeo [Graham 1988], sia di valorizzare la teoria
dei sistemi come vera e propria tecnologia sociale a servizio della democrazia. Del resto, era lo stesso Easton a suggerire questa evoluzione:
«L’analisi sistemica è un accostamento teorico che nel suo orientamento generale tende a facilitare la ricerca sulle questioni sociali pratiche.
In realtà, questo modello analitico vede in un sistema politico un meccanismo sociale fondamentale per impegnarsi nell’azione collettiva»
[Easton 1971, 400 trad. it.]. Proprio nel 1970 nasce la rivista «Policy
Sciences», destinata a divenire un importante canale per la diffusione
di questo paradigma, dentro e fuori gli Stati Uniti.
A John Dewey e alle ricerche di ispirazione pluralista tornano invece a guardare gli autori che intendono evidenziare la distanza tra
questa tradizione e il formalismo in voga in una parte dell’accademia.
Anche questa evoluzione verso il neopragmatismo è in qualche modo
anticipata e legittimata da Easton: «Con la tesi per cui la conoscenza
comporta una responsabilità per l’azione, il postcomportamentalismo
si ricollega a una tradizione venerabile che fa capo a fonti tanto diverse come la filosofia greca classica, Karl Marx, John Dewey e l’esistenzialismo moderno» [Easton 1971, 370 trad. it.]. Benché i riferimenti al pensiero europeo abbiano trovato scarsissimo seguito nella
scienza politica americana, larga parte dell’ultima elaborazione di Lindblom o di Wildavsky rivela numerosi punti di contatto con questa
impostazione.
Ma quella delle policy sciences e del neopragmatismo è un’altra
storia, che esula dall’orizzonte di questo volume.
2.1.8 Gli studi dell’output e la nuova economia politica
All’inizio degli anni ’60, cominciano a essere disponibili consistenti
serie storiche di dati su molti aspetti del processo politico negli Stati
dell’Unione americana: sulle scelte di voto degli elettori, ma anche
sugli impegni di spesa dei governi; sulle condizioni economiche e sociali, ma anche sulle caratteristiche dei diversi assetti istituzionali.
L’approccio sistemico, con le sue categorie di input e output, con l’attenzione alle modalità di interscambio tra ambiente e sistema, forniva
le ipotesi da applicare ai dati. Lo sviluppo dei calcolatori per il trattamento automatico delle informazioni forniva la tecnologia per elaborarli in fretta e a basso costo.
Dunque, come vedremo meglio tra breve, per tutto il decennio è il
paradigma sistemico a legittimare questo tipo di ricerche e a fornire
l’intelaiatura per leggere i risultati [Salisbury e Heinz 1970, 39]. L’output dei sistemi politici, approssimativamente rappresentato dalle diverse voci di spesa dei loro bilanci, è sensibile all’input, cioè alle variazio-
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
ni degli orientamenti politici degli elettori? E quale ruolo ha l’ambiente, cioè il grado di sviluppo socioeconomico e il tipo di risorse disponibili, nel condizionare il processo?
Ma la svolta del 1969 espone queste ricerche a critiche molto
dure: le accuse rivolte al primo modello eastoniano per la sua indifferenza rispetto alle concrete modalità di implementazione e all’effettivo
impatto sulle condizioni di vita dei destinatari valgono, a maggior ragione, per gli output studies. Infatti la dinamica della spesa è un indicatore molto impreciso degli effetti delle politiche: basti ricordare la
differenza tra output, outcome e impatto, che abbiamo evidenziato nel
terzo capitolo.
Negli anni ’70, quando l’aggettivo «sistemico» suonava quasi come
un’offesa, le ricerche sull’andamento della spesa pubblica per le principali aree di policy sembrano quasi migrare alla ricerca di un altro
paradigma. Molte indagini troveranno in effetti nella razionalità economica la chiave per dare una risposta alle domande circa le scelte dei
governi nell’impostazione dei bilanci e delle politiche macroeconomiche. I vecchi interrogativi saranno quindi riformulati in un contesto
teorico diverso e ormai comunemente definito con il termine di nuova
economia politica. Di questo approccio, che ha rapporti solo nominali
con il nostro concetto originario di politica pubblica, torneremo a
occuparci all’inizio del prossimo paragrafo, per far emergere dal contrasto i tratti analitici dell’impostazione che abbiamo privilegiato in
questo capitolo, e che coincide con la terza linea di sviluppo, qui di
seguito richiamata.
2.1.9. Le politiche pubbliche nella scienza politica «normale»
Negli anni successivi alla svolta di Easton, la maggioranza dei politologi continuava a trovare nelle ricerche dei due decenni precedenti
i punti di riferimento fondamentali per l’accumulazione delle conoscenze sul policy making. Per questi autori, sotto l’accogliente ombrello del comportamentalismo e della teoria dei sistemi, si era di fatto
sviluppato un insieme di concetti e di metodi molto distanti dallo stereotipo indirettamente avallato dalla riflessione autocritica del 1969.
Più precisamente, il fatto di poter considerare le politiche come conoscenze in uso, come interazioni, come processi, come bidoni della
spazzatura, conferiva a questo concetto la flessibilità e le articolazioni
necessarie a esplorare la complessità delle scelte di governo nelle società democratiche contemporanee14. Del resto, in quegli stessi anni, i
14 Da questa specifica prospettiva, appare tutt’altro che infondata la tesi della
continuità tra il prima e il dopo l’evento simbolo del discorso di Easton [Beyme 1986,
544; Torgerson 1995, 226].
297
298
CAPITOLO 5
crudi resoconti sui fallimenti di larga parte dei programmi di riforma
sociale facilitavano il riconoscimento di aspetti quali l’ambiguità degli
obiettivi, la vischiosità delle dinamiche del policy making, la tendenza
ai compromessi e ai rinvii, la difficoltà di imporre dei costi, l’abilità
dei destinatari nel reinterpretare gli interventi nel modo a loro più
congeniale.
I primi anni ’70 coincidono dunque con la piena istituzionalizzazione dello studio delle politiche pubbliche e con la sua accettazione
come campo di ricerca autonomo nella corporazione dei politologi e
nei piani di studio delle principali università15, anche se alcuni lamentano, non a torto, il permanere di un pregiudizio negativo rispetto alla
validità analitica di questi studi [Hill 1997].
2.2. Europa
Nel primo capitolo, abbiamo fornito alcuni elementari indizi per
capire il difficile rapporto tra il concetto di politica pubblica e le rappresentazioni della sfera pubblica in circolazione nei diversi paesi europei. Anche all’interno della scienza politica, la diffusione di un approccio policy oriented avviene con difficoltà, dato che ancora nel 1986
Klaus von Beyme deve fare questa ammissione: «La nuova tendenza a
rivendicare la rilevanza della scienza politica spostando il fuoco dell’analisi dal processo decisionale, dalla politics, ai prodotti e ai risultati
delle decisioni pubbliche, cioè alla policy, in generale non è stata accettata nelle altre nazioni come invece è avvenuto negli Stati Uniti, dove
questa tendenza ha avuto origine» [1986, 541].
Con l’eccezione della Gran Bretagna, più veloce nell’autonomo
inserimento in questo dibattito scientifico16, nel contesto europeo l’interesse per l’analisi politologica delle politiche ha richiesto la mediazione di due concetti più comprensivi e teoricamente più densi o, se si
vuole, più ingombranti: i partiti e lo Stato. Per quanto riguarda i partiti, i tre più importanti progetti di ricerca organizzati nell’ambito dell’European Consortium for Political Research riguardano rispettivamente:
• «Le differenze di partito e le politiche pubbliche»; avviato nel
15 Nel 1971 nasce la «Policy Studies Organization», che dal 1972 pubblica il
«Policy Studies Journal». Nel 1973, tra le categorie utilizzate per schedare i settori di
ricerca del «Biographical Directory» dell’American Political Science Association, compare la sezione «Politica pubblica: formazione e contenuto» [Greenstein e Polsby
1975, xiii]. Una graduatoria degli autori considerati più significativi nel periodo 197076 vede in testa tre studiosi di politiche pubbliche: Lowi, Wildavsky e Dye [Lynn,
1983, 106].
16 Il riferimento è soprattutto ai lavori realizzati negli anni ’70 da Richard Rose,
Jeremy Richardson e Grant Jordan. Dal 1981 è pubblicato il «Journal of Public Policy».
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
1978, nel 1982 produce un primo volume, dal titolo significativo L’impatto dei partiti, non delle politiche [Castles 1982];
• «Il futuro del governo di partito»; avviato nel 1980, produce
due volumi, di cui torneremo a occuparci tra breve [Castles e Wildenmann 1986; Katz 1987];
• «Il gruppo di ricerca sui programmi elettorali» cui si deve la più
vasta ricerca sui contenuti del mandato che i partiti sollecitano agli
elettori [Klingemann, Hofferbert e Budge 1994].
In altri casi, invece, il passaggio a questo oggetto di studio è derivato dai tentativi di dare contorni più precisi al concetto di Stato: del
benessere, capitalista, o pianificatore. Grazie alle ricerche sull’origine
storica del welfare state, l’elenco delle tradizionali variabili politiche,
incentrate sul peso elettorale e sull’orientamento ideologico dei diversi
partiti, si arricchiva di fattori quali la cultura e la disponibilità all’innovazione dei funzionari amministrativi, l’attività delle organizzazioni di
ispirazione religiosa, le reti di solidarietà promosse dai movimenti operai [Burns 1953; Heclo 1974; Flora e Heidenheimer 1981]. Proprio a
questo settore di indagine si riferisce il più vasto progetto avviato per
la raccolta di dati sulle politiche sociali, l’Historical Indicators of Western European Democracy, promosso da Peter Flora, con l’obiettivo di
ricostruire i tratti principali dell’evoluzione delle assicurazioni sociali in
quindici paesi europei, risalendo fino alla loro origine nel diciannovesimo secolo [Flora e Heidenheimer 1981; Alber 1982; Ferrera 1984].
Anche i tentativi di introdurre criteri di programmazione nelle politiche economiche, in atto in molti paesi europei, comportavano trasformazioni difficili da inquadrare con i tradizionali strumenti della scienza politica [Nizard 1973]: ne è prova una vivace attività di ricerca,
destinata a formare molti degli attuali studiosi di politiche pubbliche
[Scharpf 1973; Hayward e Watson 1975].
Gli interrogativi circa il peso rispettivo delle variabili politiche e di
quelle socioeconomiche, negli Stati Uniti ampiamente incanalati entro
il paradigma sistemico, in Europa hanno spesso come punto di riferimento, positivo o negativo, le teorie marxiste; le alternative sono pertanto riformulate in termini di «autonomia del politico», secondo la
riflessione di Antonio Gramsci, oppure di «condizionamento della
struttura», in genere identificata con i rapporti di classe tra capitale e
lavoro [Korpi 1983].
Per sfuggire a questa tenaglia, e per emancipare dal conflitto ideologico tra le diverse scuole marxiste il ruolo del movimento operaio
nel policy making, negli anni ’70 alcuni autori formulano il concetto di
neocorporativismo [Schmitter 1974; 1977; Lehmbruch 1979; 1982].
Nelle pagine seguenti definiremo meglio i contorni di questa forma di
intermediazione tra organizzazioni del lavoro e governi. Qui importa
solo evidenziare come l’uso di questa categoria analitica abbia indotto
molti studiosi a guardare con maggiore attenzione ai contenuti dei singoli accordi e alla loro concreta implementazione: un passo importante
299
300
CAPITOLO 5
per portare almeno alcune politiche – del lavoro, della riconversione
industriale, della previdenza – al centro della ricerca [Jordan 1981;
Cawson 1985; Lange e Regini 1987].
Infine, è interessante notare la coevoluzione dell’interesse per le
politiche pubbliche e di quello per le dinamiche dell’unificazione europea. Come molti osservatori hanno notato, davanti a questo oggetto
istituzionale non identificato, le categorie analitiche intrecciate nel
concetto di policy – conoscenza in uso, interazione, processo, bidone
della spazzatura – sembrano fornire strumenti abbastanza flessibili,
capaci di riuscire là dove hanno fallito i tradizionali frames di riferimento delle discipline giuridiche, economiche, politologiche [Scharpf
1986; 1994; Wallace et al. 1977; Mazey e Richardson 1993]. E l’idea
di fare leva su questi elementi per arrivare a una «governabilità oltre i
governi» affascina per le inedite valenze prescrittive [Rhodes 1997;
Börzel 1998]. La nascita, nel 1994, del «Journal of European Public
Policy», diretto da Jeremy Richardson, rappresenta la più importante
prova di questo legame.
3. Riferimenti teorici e metodologici
Se a livello prescrittivo le politiche pubbliche devono farsi largo
tra i concetti di capacità di governo (governance) e di management,
così sul piano descrittivo devono aprirsi un varco tra impostazioni che
comprimono la loro variegata e complessa valenza analitica. La riduzione delle politiche a output del sistema politico viene adottata come
punto di partenza del nostro itinerario per due motivi. Innanzi tutto,
questo approccio è più familiare al pubblico italiano, visto che nel
dibattito, colto e non, è dato per scontato che le politiche siano il prodotto della politica: degli orientamenti ideologici delle coalizioni di
governo, degli assetti istituzionali, del numero dei partiti, delle loro
caratteristiche organizzative. In secondo luogo, storicamente la discussione degli studi dell’output ha svolto l’importante funzione di chiarire
a chi non si riconosceva in questa impostazione quali dovessero essere
i tratti fondamentali di una ricerca decisamente orientata alle politiche
pubbliche.
3.1. Gli studi incentrati sull’output
Gli studi incentrati sull’output costituiscono, nel loro insieme, un
«quasi paradigma» [Torgeson 1995, 230] caratterizzato dalla ricerca di
risposte a questa domanda: i fattori economici e sociali che definiscono la quantità e la qualità delle risorse che il sistema politico può
estrarre dall’ambiente, contano più o meno dei fattori politici, che
definiscono gli obiettivi e le priorità dei governi?
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Questo interrogativo rivela una duplice ispirazione comportamentalista. Dal lato delle variabili indipendenti, viene presa sul serio anche
un’ipotesi fino a quel momento non considerata esplicitamente dai
politologi americani: quella che la politica non conti, e che siano invece le dinamiche socioeconomiche a determinare le scelte delle istituzioni. Dal lato della variabile dipendente, è promossa la raccolta di
dati più precisi e comparabili circa le decisioni degli esecutivi, al di là
delle loro dichiarazioni ufficiali o delle critiche dei loro avversari politici: la spesa, i dollari passati dalle tasche dei cittadini alle varie voci
dei bilanci pubblici, e da lì eventualmente tornati in altre tasche, sembrano un indicatore rozzo, ma efficace.
Ma da questo impianto di ricerca traspare nettamente anche l’impronta sistemica, evidente nell’idea che il peso della politica equivalga
alla capacità delle istituzioni di rielaborare gli impulsi provenienti dall’ambiente, fino a produrre output capaci di far perdere le tracce delle
tensioni che li hanno originati: «La maggior parte, se non la totalità di
questi studi si collocano in uno schema che è quanto meno “quasieastoniano”. Al centro dell’interesse teorico stanno le decisioni di policy, viste come gli output di un sistema politico che deve rispondere a
input fatti di risorse, domande, sostegni» [Salisbury e Heinz 1970, 39].
Negli anni ’60, la maggior parte delle indagini empiriche orientate
da questa impostazione assume come ambito di studio i livelli di governo subnazionali all’interno della confederazione americana [Dawson e Robinson 1963; Hofferbert 1966; Sharkansky e Hofferbert
1969]. Per fissare una qualche gerarchia tra le variabili che influenzano l’attività dei sistemi politici, è calcolata la forza delle correlazioni
che emergono da larghe serie storiche di dati quantitativi. Le variabili
socioeconomiche più utilizzate fanno riferimento al reddito pro capite,
al livello di industrializzazione, al grado di urbanizzazione, alla composizione della popolazione per fasce di età. Le variabili politiche si basano invece sulla competizione elettorale più o meno serrata, sul livello
della partecipazione al voto, sul partito al governo. La variabile dipendente, l’output, è in genere operazionalizzata con riferimento ai dati
della spesa pubblica, assunta globalmente o considerata per grandi categorie, quali gli impieghi di bilancio per l’ordine pubblico e la sicurezza personale, contrapposti a quelli per gli interventi sociali.
Le prime elaborazioni statistiche, compiute negli anni ’60, con i
loro controversi risultati, hanno impegnato un’intera generazione di
politologi. E tuttavia l’ago della bilancia sembrava nel complesso pendere a favore dell’ipotesi che le dinamiche economico-sociali abbiano
un potere esplicativo più forte rispetto alla competizione politica e ai
programmi di governo [Dawson e Robinson 1963; Dye 1969; Salisbury 1968].
È interessante osservare che i più attenti studiosi del policy
making [Hofferbert 1966; Dye 1966; Salisbury e Heinz 1970; Rose
1980] non erano affatto stupiti o disturbati da questi dati, che arriva-
301
302
CAPITOLO 5
vano a salutare con entusiasmo, perché capaci di mettere a nudo la
rozzezza del modello sistemico: «Considero questo insieme di risultati
come devastante: né si può minimizzarne la portata come se non significassero quello che ci dicono in modo chiaro: e cioè che l’analisi
dei sistemi politici non spiega le decisioni di policy adottate da quegli
stessi sistemi» [Salisbury 1968]. Che le roboanti promesse elettorali
cedano poi il passo a valutazioni più rispettose delle condizioni socioeconomiche e dei vincoli finanziari, appare a questi autori come un
argomento a favore di uno studio più ravvicinato del policy making,
il cui orientamento non può essere semplicemente desunto dalle dinamiche della competizione tra i partiti o dall’affiliazione politica
della maggioranza di governo. Se il rapporto tra politica (politics) e
politiche (policy) potesse essere davvero definito in termini di variabile indipendente e di variabile dipendente, non avrebbe senso investire energie intellettuali per ricostruire la concreta evoluzione delle
decisioni dal momento in cui queste lasciano i palazzi, per confrontarsi con le effettive situazioni in cui operano gli implementatori e
vivono i destinatari. Gli scostamenti dai progetti originari sarebbero
solo distorsioni patologiche, come lo schermo difettoso di un computer ne altera l’output. Ma questa tesi contrasta con tutto quello che
abbiamo imparato nel capitolo precedente sulle politiche come conoscenze in uso, come processi, come interazioni, come bidoni della
spazzatura.
3.1.1. La ricerca diventa comparata
Come abbiamo ricordato nel paragrafo precedente, quel che avviene nei primi anni ’70 è un importante punto di snodo per capire le
attuali tendenze nello studio delle politiche pubbliche. In questi anni
matura l’esplicito riconoscimento che la comparazione costituisce il
principale problema analitico dei policy studies. Dalla comparative policy, un vero «microcosmo di diversità concettuali, metodologiche e
analitiche» [Hancock 1983, 285], sono infatti uscite molte delle categorie che presenteremo nel prossimo paragrafo. All’inizio del decennio, dunque, questo approccio abbandona i familiari confini degli Stati
Uniti, e diventa internazionale.
La sprovincializzazione procede in due sensi. Innanzi tutto, le indagini tendono a comprendere i principali paesi industrializzati, a partire dal Canada e dagli Stati europei. In secondo luogo, gli studiosi
impegnati provengono da varie nazioni e approdano a queste ricerche
da itinerari teorici diversi. Vale la pena notare che la scienza della
politics aveva affrontato questa svolta già negli anni ’50, anche grazie al
ruolo che la potenza americana andava assumendo sul piano internazionale, con il conseguente bisogno di informazioni, di tipologie e di
analisi. La public policy approda alla dimensione internazionale in larga
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
parte per impulsi diversi. Dal lato, per così dire, della domanda, cioè
dell’evoluzione analitica interna, gli output studies avevano il problema
di come sopravvivere alla crisi del loro modello di riferimento. L’autocritica di Easton toglieva infatti plausibilità teorica alle loro ipotesi:
«Forse l’aspetto più interessante dello studio comparato delle politiche
è il modo in cui hanno rimesso in discussione il paradigma convenzionale [quello sistemico] e ci hanno reso più sensibili ai suoi limiti»
[Ashford 1983, 186].
Dal lato dell’offerta, la ricchezza dei dati disponibili e i costi di
elaborazione sempre più contenuti permettono alle ricerche di estendere continuamente i loro confini [Castles 1989, 5]. In quegli anni, le
organizzazioni internazionali iniziano a pubblicare le serie storiche
delle principali variabili demografiche, sociali, economiche dei paesi
membri. E grazie allo sviluppo della comparative politics, le tradizionali
categorie di matrice vetero-istituzionalista, in passato utilizzate per differenziare i diversi sistemi politici – tipo di regime, forma di governo,
sistema elettorale – possono essere integrate con dati sulla cultura
politica [Almond e Verba 1963] o sulle relazioni tra i partiti [Lijphart
1968; Peters et al. 1977], e intrecciate con le informazioni sulle prestazioni dei sistemi economici. Infine, lo straordinario sviluppo delle risorse computazionali e la drastica riduzione del loro costo permettono
di testare facilmente anche i modelli più inediti.
3.1.2. Ma conta la politica?
Internazionalizzazione della ricerca significa anche reinterpretazione delle ipotesi di base, mentre fuori dagli Stati Uniti cresce la riflessione intorno all’effettiva capacità delle forze della sinistra e del movimento operaio di condizionare le politiche, una volta arrivate alla
«stanza dei bottoni», cioè a posizioni di governo. Infatti in Europa la
delusione per le esperienze riformiste degli anni ’60 e per i tentativi
di introdurre criteri di programmazione nelle politiche economiche
non porta a un generale sviluppo delle ricerche sull’implementazione,
ma induce gli studiosi ad interrogarsi sulla capacità della politica di
svolgere un ruolo effettivo nell’indirizzare le dinamiche sociali. L’arco
storico per la verifica delle ipotesi si allunga, fino a comprendere l’intera evoluzione del welfare state. La domanda «Does politics matter?», «Conta davvero la politica?» ricorre in centinaia di studi e diviene il simbolo di questa impostazione [Sharpe e Newton 1984;
Castles e Mc Kinlay 1979; Wilensky 1975]. Per la prima volta si pongono in dubbio affermazioni che il senso comune dà spesso per
scontate: governi con orientamenti ideologici diversi adottano veramente politiche pubbliche tra loro così diverse? Le democrazie portano davvero a più uguaglianza sociale? Sistemi scolastici basati sui
valori del pluralismo sono davvero più efficienti nell’addestramento
303
304
CAPITOLO 5
alle professioni scientifiche rispetto ad altri, basati sull’osservanza dei
dogmi?17
Nel 1975 Harold Wilensky pubblica una ricerca destinata a segnare un’epoca per la sua ampiezza e per i suoi risultati. L’elaborazione,
basata sui dati relativi a 64 nazioni industrializzate, definisce la variabile dipendente come la percentuale del prodotto interno lordo destinata a spese per programmi sociali. Le variabili politiche sono basate
su una tipologia dei regimi (liberaldemocratici, totalitari, autoritari
oligarchici, autoritari populisti); le variabili economiche e sociali considerano, oltre alle tradizionali serie di dati, la percentuale di ultrasessantenni sul totale della popolazione. E proprio quest’ultima variabile
rivela la più netta correlazione con la spesa per il welfare, sorpassando
nettamente per potere esplicativo il peso delle variabili politico-istituzionali. La spiegazione evidenzia il fatto che lo sviluppo economico
comporta un mutamento nella struttura demografica della popolazione, con l’aumento della porzione dei cittadini anziani, che sono i massimi consumatori di due tipi di prestazioni sociali, sanità e pensioni,
cui si deve la lievitazione delle spese per il welfare. La conclusione è
evidentemente destinata a suscitare vivaci reazioni: benché diversi per
assetti istituzionali, per grado di democraticità e per ideologie, i governi sono comunque condizionati da dinamiche demografiche e socioeconomiche più profonde.
La ricerca di Wilensky può essere in un certo senso considerata
come il frutto più maturo di un’impostazione ancora sorretta dal comportamentalismo e dalla teoria del sistema politico. Ma il dibattito che
segue evidenzia l’esigenza di basi teoriche ed empiriche diverse. Da un
lato, sono sottolineati i problemi metodologici interni, legati all’impiego
di variabili per forza di cose piuttosto elementari, se non rozze, e al limitato numero dei casi, che conferisce precarietà ai tentativi di generalizzazione [Tufte 1974]. Ma è soprattutto la povertà analitica a essere
messa sotto accusa. Così è riassunto un dibattito ventennale nelle parole di un autore che pure ha dato un grande contributo a questo tipo di
ricerche: «Lo sviluppo del welfare state è in larga misura funzione dello sviluppo economico, della struttura demografica e di forze politiche
socialdemocratiche [...]. Il problema con queste spiegazioni non è che
sono imprecise: è che, per come stanno evolvendo, non ci raccontano
molte delle cose che invece vorremmo sapere» [Castles 1989, 6].
Il riorientamento segue varie direttrici. Innanzi tutto, l’analisi
quantitativa si concentra sulla verifica di ipotesi con un più solido fondamento nella teoria macroeconomica, quali il trade-off tra sostegno
all’occupazione e lotta all’inflazione [Hibbs 1977], o il ruolo della spe-
17 Occorre ricordare che i successi inizialmente conseguiti dall’Unione Sovietica
nella corsa allo spazio avevano prodotto all’interno degli Stati Uniti un radicale ripensamento dei principi su cui si reggeva la loro istruzione pubblica.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
sa pubblica in funzione anticiclica. Ma soprattutto i governanti, rappresentati nel modello sistemico come una misteriosa scatola nera
dotata solo della possibilità di convertire l’input in output, diventano
ora attori capaci di proprie strategie, attivamente impegnati a reinterpretare le sfide dell’ambiente per piegarle ai loro progetti [Hansen
1983; Alt e Alesina 1996]. Insomma, se negli anni precedenti le ricerche miravano a evidenziare le caratteristiche delle domande che premono sul sistema politico, ora i politici sono considerati come attori
razionali, interessati a strutturare l’offerta di politiche nel modo a loro
più conveniente.
I problemi che ora si aprono riguardano il peso specifico della coerenza ideologica rispetto, ad esempio, a motivazioni puramente opportunistiche, volte alla conservazione delle cariche ricoperte [Hibbs
1977; Tufte 1978; Nordhaus 1975]. Ma altri problemi si chiudono:
ambiente socioeconomico e sistema politico cessano di sfidarsi a duello per la palma di variabile determinante e sono chiamati a una coesistenza pacifica, come due tavoli da gioco – il mercato e la politica –
tra cui si devono destreggiare imprenditori-politici e cittadini-elettoricontribuenti: «Diversamente dall’economia o dalla scienza politica
prese isolatamente, l’economia politica positiva18 rimarca sia il comportamento “economico” nel processo politico, sia il comportamento “politico” nel mercato» [Alt e Alesina 1996, 645].
Come è evidente, nonostante il grande interesse per la ricerca politologica, per le sue categorie, per i suoi dati, le basi teoriche ultime
di questa nuova disciplina sono collocate in un altro paradigma, quello
della razionalità economica [Miller 1997]. Questa migrazione comporta il taglio del cordone ombelicale che nel modello sistemico collega,
almeno formalmente, l’output – le politiche – all’input: si tratta del feedback, delle modalità di implementazione, dell’impatto, del concreto
recapito delle politiche e delle reazioni dei destinatari. Vero è che l’impianto empirico delle ricerche aveva regolarmente trascurato questo
fattore: ma la sua importanza sopravviveva, almeno come tributo formale. La nuova economia politica in genere non concede nemmeno
questo: il fatto che le politiche possano essere deformate e persino
stravolte nel processo di implementazione non riveste un interesse
analitico in sé, così come non modifica la logica della domanda e dell’offerta il fatto che i consumatori acquistino le enciclopedie per usarle
come soprammobili.
La new political economy concilia l’esigenza di solide tecniche di
inferenza statistica con il rigore e l’eleganza del modello. E, contrariamente alla prima impressione, questo paradigma per molti politologi
ha il grande merito di non richiedere abiure circa l’importanza della
18 Cioè senza finalità normative: spesso è utilizzata l’espressione «nuova economia politica», per rimarcare la distanza dall’economia politica classica.
305
306
CAPITOLO 5
politica. Anzi, per certi versi questi approcci sono più realisti del re,
nel senso che ammettono la possibilità di un’influenza diretta dei
modelli istituzionali sulle scelte di policy: un’evenienza, questa, che
nemmeno lo studioso del policy making più attento al peso dei vincoli
normativi, diciamo Ashford o Lowi, sarebbe disposto a considerare
[Lowi 1992; Ashford 1978]. Ai suoi occhi, questo concetto di istituzione è sia troppo potente per efficacia, sia troppo ristretto per ampiezza: «C’è un sacco di comportamento istituzionalizzato che non ha
alcuna ovvia relazione con l’ampiezza degli input e degli output, ma
piuttosto con la riconciliazione delle domande e delle risorse e con la
trasformazione in routine dell’allargamento dell’attività dei governi»
[Ashford 1983, 194].
Ma ora la distanza con gli approcci decisamente orientati alle politiche è talmente larga da obbligarci ad abbandonare questa pista, per
ritornare sulla traccia principale del nostro percorso, anche se occorrerà riprendere alcune sue acquisizioni nel corso del prossimo capitolo.
3.1.3. Comparazione e causalità
A questo punto, nel lettore può sorgere il dubbio che, a forza di
perdere pezzi per strada, l’impostazione decisamente orientata alle
politiche sia destinata ad arrivare nuda alla meta o, meglio, svuotata
dal confluire di tanti rivoli diversi in altri bacini analitici. La realtà è
diversa, perché alla fine degli anni ’70 il suo profilo è molto più preciso che all’inizio del decennio, e proprio grazie alle ricerche comparate19. Se il rapporto con la scienza politica rimane prioritario, l’impostazione decisamente orientata alle politiche si sposta verso «gli affollati
incroci tra le scienze sociali» [Heclo 1975, 8] e, soprattutto, prova a
mettere a punto un diverso modo di intendere gli obiettivi della ricerca comparata.
Il grande potere di attrazione esercitato dalle indagini comparate
che vanno alla ricerca delle determinanti delle politiche risiede nella
loro implicita ambizione a dare risposta al perché le vicende di policy
sono andate in un modo anziché in un altro, producendo certi risultati
anziché altri: «La comparazione forniva al ricercatore una logica causale – o almeno associativa – con cui fondare induttivamente l’argomento che le somiglianze derivavano da precedenti comuni fattori, e le
differenze da precedenti diversità. L’uso della comparazione come
strumento per la spiegazione è stata una delle principali basi per il
decollo nel decennio precedente del campo di ricerca accademico dell’analisi comparata delle politiche pubbliche» [Castles 1989, 4]. Il
19 Cfr. Heclo [1974]; Heclo e Wildavsky [1974]; Heidenheimer, Heclo e Adams
[1975]; Ashford [1978]; Leichter [1979].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
fascino della spiegazione causale aveva dunque trasformato gli input
del sistema politico eastoniano nei fattori capaci di dare un perché alle
singole politiche, nonostante la decisa opposizione del suo inventore,
che in una citatissima frase20 precisa: «Il mio approccio all’analisi dei
sistemi politici non intende aiutarci a capire perché certe specifiche
politiche sono adottate dai membri politicamente rilevanti di un sistema» [Easton 1965, 89].
Mentre gli input diventano determinant, e poi cause, sullo sfondo
si delinea un modello in cui le variabili indipendenti sono collegate a
quelle dipendenti da una relazione di tipo lineare. Ma il costo della
semplificazione appare troppo alto a molti studiosi di politiche:
Un’analisi comparata delle politiche di fatto ristretta a variabili desunte
dai conti pubblici, più qualche tassonomia molto semplice delle strutture
politiche e sociali, implica una simultaneità causale che contrasta con tutto
quello che sappiamo sui processi di sviluppo, e cioè che gli individui, i gruppi, e i leader interpretano la loro esperienza e intraprendono azioni finalizzate
a mantenere o modificare il mondo in cui si trovano [Castles 1989, 11].
Nella ricostruzione storica del paragrafo precedente, abbiamo accennato alla costante ricerca da parte della scienza politica di vie di
fuga da impostazioni appiattite sul modello delle scienze naturali. Per
le ricerche decisamente orientate alle politiche, sottolineare la distanza
che le separa dalla logica della causalità diventa essenziale:
Dobbiamo rinunciare all’accattivante linguaggio della causalità o quanto
meno accantonarlo per un po’ [...]. Il primo compito della ricerca politica è
essenzialmente descrittivo: speriamo che da qui derivi la capacità di lavorare
a un più alto livello di astrazione, incorporando la complessità dello Stato
contemporaneo [Ashford 1978, 144-145].
Le configurazioni di policy non saltano fuori dall’analisi delle correlazioni
generali tra variabili aggregate. Il processo di policy appare troppo delicato
per questo [Heclo 1974, 12].
Dunque, una ricerca autoconfinata nella descrizione, nella collezione di informazioni, nell’elaborazione di dati fini a se stessi? Certo, una
ricostruzione più precisa dei fattori in gioco, della dinamica delle decisioni, dei processi di implementazione può rivestire di per sé un
grande interesse. Ma non è solo questo. Gran parte della difficoltà
nella costruzione di un discorso scientifico sulle politiche pubbliche
deriva dal fatto che questo concetto è come trapassato dalle classiche
dicotomie su cui sono costruite le scienze sociali: micro e macro, attore e sistema, intenzionalità e causalità. Un approccio orientato alle
20
Eulau [1978]; Dallmayr [1986]; Salisbury [1968].
307
308
CAPITOLO 5
politiche esce dilaniato se costretto a scegliere da che parte stare. E
non per un destino sfortunato, ma perché il concetto di policy, come
quello di organizzazione, è maturato proprio per sfuggire alle gabbie
concettuali ereditate dalla tradizione delle scienze sociali. Se questo è
vero, l’orizzonte della ricerca sulle politiche coincide con l’impegno a
scongelare queste dicotomie per renderle, per così dire, navigabili nei
due sensi.
3.2. Una prospettiva di intermediazione
Nel 1972, in una delle prime presentazioni dei policy studies comparse su una rivista europea, Hugh Heclo scrive: «Rispetto al livello di
analisi, policy è un concetto piazzato più o meno a medio raggio»
[1972, 84]. A noi sembra che questo riferimento non vada inteso
come la ricerca di un inconsistente punto di equidistanza dai due
estremi di micro e macro, o di attore e di sistema, ma piuttosto come
una prospettiva di collegamento e di riflessione sui limiti di questa polarizzazione.
Per un verso, è possibile considerare le politiche come esiti del
sistema. Ma simultaneamente, il sistema può essere visto, bottom-up,
come nient’altro che la produzione delle politiche, come sottolinea già
Easton nel 1953: «In effetti stiamo affermando che tutti quei tipi di
attività coinvolte nella formulazione e nell’esecuzione delle politiche
sociali21, che in modo ellittico sono chiamate in scienza politica il processo del policy making, costituiscono il sistema politico (political)»
[Easton 1953, 129]. La reversibilità delle due prospettive analitiche è
il tratto che caratterizza i contributi decisamente orientati alle politiche, permettendo loro una rivisitazione originale delle classiche dicotomie agente/struttura, o attore/sistema. A rendere flessibili queste
alternative è il fatto che le politiche sono, insieme, processi e prodotti:
Le politiche sono tanto processi quanto prodotti. L’uso di questo termine
fa riferimento tanto al processo per l’adozione delle decisioni, quanto al prodotto di questo processo [Wildavsky 1992, 387].
La sfida non è scomporre il processo o il contenuto, ma è trovare la relazione che lega i due [Heclo 1972, 106].
Il richiamo al prodotto, al contenuto è, in fondo, un ancoramento
alla rilevanza dei risultati [Eulau 1978]. Se è vero che le politiche pubbliche non possono esistere senza elaborazioni cognitive, senza interazioni, senza costruzioni sociali del significato, è anche vero che le intenzioni degli attori non bastano a fare le politiche, che devono pro21
Qui usato nel senso di public, cioè che riguarda l’intera società.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
durre effetti, perché sono cosa diversa dai programmi concordati e
mai realizzati, o dai movimenti collettivi coinvolgenti, ma autoconfinati
nei libri dei sogni.
Questa duplice valenza – intenzionale e «produttiva» – può forse
spiegare il rapporto tutto particolare che questi studi intrattengono
con la spiegazione causale. Chi studia le politiche deve prendere sul
serio i modelli causali, perché chi fa le politiche li prende sul serio. Se
le leggi generali 22 non contassero, davanti a un problema di rilevanza
collettiva esisterebbero solo i riti propiziatori o la rassegnazione. Che
l’aumento della quota di cittadini anziani tra la popolazione di una
nazione porti, ceteris paribus, a un aumento della spesa previdenziale e
sanitaria, è una conclusione molto vicina a una «legge» nel senso neopositivista del termine. Che per contrastare questa tendenza occorra,
ad esempio, penalizzare i trattamenti previdenziali dei più giovani tra
gli anziani, è di nuovo una scelta basata su una precisa concatenazione
causale, sottoponibile a verifica empirica né più né meno della validità
di un farmaco. Le politiche nascono da ipotesi del tipo causa-effetto,
anche quando sono una scommessa sulle possibilità degli attori di
modificare il corso degli eventi, per fare in modo che quel che vale
oggi non valga più domani.
Da questo punto di vista, dire che lo studio delle politiche si fonda
su una teoria dell’attore è dire una mezza verità. Innanzi tutto, l’attore
è un plurale, e non solo nel senso, ovvio, che non sono le singole persone a costituire le unità analitiche, ma le loro aggregazioni più o
meno strutturate: i burocrati di certi uffici, i rappresentanti di determinati interessi, i parlamentari di alcune commissioni. Plurale significa
che chi entra nel policy making deve mettersi immediatamente in relazione con chi svolge funzioni diverse dalle sue, ha risorse diverse, appartiene a organizzazioni diverse:
Noi non siamo così ingenui da chiedere «Chi fa le automobili negli Stati
Uniti?» [...]. Siamo abbastanza accorti da lasciar cadere la domanda «chi»
sulle automobili, per porre invece questioni sul complesso sistema da cui
emerge quel prodotto attraverso il contributo di milioni di persone che interagiscono l’un l’altra. Vogliamo lavorare per una simile comprensione del
modo in cui sono fatte le politiche [Lindblom 1980, 63].
Ma lo studio delle politiche tiene solo un piede nelle teorie dell’attore, perché l’altro è piantato nelle teorie che riconoscono al mondo –
naturale o sociale – una sua autonoma consistenza, sostenuta da una
struttura fatta di «leggi», di nessi causali, con cui il policy maker deve
fare i conti, se vuole sfruttare i margini del possibile per risolvere, attenuare o camuffare problemi di rilevanza collettiva. Insomma, le po22 Il riferimento è alle leggi svelate dalla ricerca scientifica quando risponde alla
domanda «perché?» in termini generali.
309
310
CAPITOLO 5
litiche non sono solo scelte, decisioni, ma anche azioni e risultati23;
non sono guidate solo dalle intenzioni, ma anche dall’esperienza, talvolta drammatica, della serietà delle relazioni di causa-effetto.
E tuttavia anche il polo analitico opposto all’attore, l’altro corno
della dicotomia, nelle sue diverse declinazioni (il sistema, la struttura,
ecc.), appena entra nello studio delle politiche, subisce un processo di
scongelamento e, da regno chiuso e ordinato, diventa un universo
aperto e caotico.
In primo luogo, come la teoria del garbage can ci ha insegnato, il
caso non è sradicabile dalle vicende di policy: «Le policy sciences di
seconda generazione si occupano di scelte che interagiscono con la
necessità, la contingenza e il caso, e lo fanno in una varietà di modi,
che di fatto costituiscono sempre un confuso azzardo» [Dror 1994,
14]. Questo costringe sia il policy maker, sia il ricercatore a confrontarsi con la contemporanea influenza dell’imprevisto e del sovradeterminato, per cercare, con le parole di Ashford [1978, 90], «lo stretto sentiero tra l’incongruente e il trascendente», per essere, insieme,
«analitici e realisti» [Heclo 1972, 106].
In secondo luogo, la Legge delle Ampie Soluzioni, formulata da
Wildavsky (quarto capitolo), mette in evidenza la sproporzione tra le
capacità degli attori di monitorare le conseguenze delle politiche e la
vastità degli effetti che queste producono:
Quando le politiche proliferano, cominciano a urtarsi l’un l’altra in modi
inattesi, moltiplicando il numero, la varietà e l’ampiezza delle conseguenze. I
professionisti delle politiche acquisiscono più conoscenze, ma la forbice tra
queste e quello che avrebbero bisogno di sapere si allarga. Mentre la conoscenza cresce aritmeticamente, le conseguenze delle politiche tra loro in collisione crescono geometricamente [Wildavsky 1981, 130].
In terzo luogo, il policy making è fortemente marcato da una proprietà conosciuta in letteratura come dipendenza dal percorso (path
dependency), che può essere sintetizzata in questi termini: dove si sta –
la definizione della situazione – non dipende solo dalle caratteristiche
del posto che si occupa, con i suoi problemi e le sue risorse, ma anche
da dove si viene, dall’esperienza che ha condotto a quel punto [Pierson
2000]. Pertanto, l’efficacia delle scelte non dipende solo dal rapporto tra
il problema che le ha originate e le soluzioni adottate, ma dal modo in
cui si è arrivati ad abbinare quei problemi e quelle soluzioni: «Non
possiamo asserire con sicurezza che “in circostanze comparabili” chi si
comporta in modo simile otterrà effetti simili» [Schön 1971, 233].
Infine, anche il sistema non è singolare, ma plurale. E, di nuovo,
non nel senso banale che i sistemi politici sono tanti, come i sistemi
23 Ricordiamo ancora una volta che per Easton una policy è «una rete di decisioni e azioni che alloca valori» [1953, 130].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
urbani o i sistemi economici. Plurale significa che le diverse sfere dell’attività umana, il diritto, l’economia, la religione, hanno la capacità di
assorbire, filtrare e metabolizzare in modo originale e autonomo le trasformazioni operate dagli altri ambiti, per riaffermare il loro proprio
senso dell’ordine [Brans e Rossbach 1997].
Pertanto un netto orientamento alle politiche porta a rifiutare
come inadeguato un programma di ricerca basato esclusivamente sull’individuazione delle cause ultime: «Quel che normalmente è considerato come variabile dipendente (l’output delle politiche) è anche la variabile indipendente. Le politiche sono invariabilmente costruite sulle
politiche, spostando in avanti ciò che è stato ereditato, o correggendolo, o ripudiandolo» [Heclo 1974, 315].
3.2.1. L’indeterminatezza e la complessità
A questo punto dovrebbe essere chiaro che un tal modo di intendere l’attore e il sistema introduce indeterminatezza da tutti e due gli
estremi delle dicotomie in uso nelle scienze sociali: «Noi consideriamo
il policy making come un processo estremamente complesso, senza un
inizio o una fine, con confini che rimangono in gran parte incerti»
[Lindblom 1980, 5].
Si può obiettare che il problema dell’indeterminatezza, lo studio
delle politiche pubbliche se lo va a cercare, adottando una definizione
di policy che pretende di salvare insieme la capra dell’intenzionalità
dell’attore e il cavolo della consistenza dei sistemi. È questo che costringe l’analisi a «ondeggiare tra la sovradeterminazione e la sottodeterminazione» [Ashford 1978, 91], tra il vedere le politiche come prodotti di forze esterne, e il vederle come processi dotati di una loro
propria dinamica. Tale rilievo è assolutamente corretto. Il concetto di
politica pubblica ha valenze che spiazzano il modo tradizionale di intendere la ricerca nelle discipline sociali. Come l’uso contemporaneo
del concetto di organizzazione, che porta a «sostituire un ragionamento inevitabilmente deterministico con un ragionamento che trae tutte
le conseguenze dal carattere radicalmente indeterminato dell’azione
sociale e dei “quadri” entro cui si dispiega» [Crozier e Friedberg
1977, 203]. O come l’uso che March e Olsen fanno del concetto di
istituzione, sempre in bilico tra logica dell’appropriatezza e logica della
consequenzialità.
La riflessività, l’apprendimento, l’aggiustamento reciproco, l’incrementalismo sconnesso, l’ingegneria dell’intelligenza, sono risorse effettivamente in circolazione nel policy making. E non vengono immesse
solo dall’intervento dell’analista, ma anche dall’iniziativa di produttori
e destinatari intraprendenti, o spregiudicati, o lungimiranti [Greenberg
et al. 1977]. Questa constatazione ha almeno due conseguenze. Innanzi
tutto, quelli che normalmente sono considerati vincoli tenaci, e cioè le
311
312
CAPITOLO 5
norme, le culture, le convenzioni sociali, diventano mobili e flessibili:
«Non-linearità significa che l’atto del giocare il gioco dà modo di cambiare le regole» [Gleick 1987, 24]. L’idea che quelli che sembrano
paletti ben conficcati siano invece boe disancorate, è stata spesso illustrata con il ricorso alla letteratura, quasi a rendere più lieve il peso del
duro confronto con l’indeterminatezza. Karl Deutsch si rifà alla famosa
descrizione della partita a croquet raccontata in Alice nel paese delle
meraviglie, dove «le palle erano dei porcospini vivi, le porte erano dei
soldati piegati in due e i magli erano dei fenicotteri vivi» [Deutsch
1963, 72 trad. it.]. Schön [1971, 211], e molti altri studiosi dopo di lui,
ricordano come già Tolstoj in Guerra e pace avesse fornito una vivida
rappresentazione dell’indeterminatezza che pervade persino le decisioni
di un comandante in capo impegnato sul campo di battaglia. Heclo
[1975, 9] ricorre alla descrizione della spedizione di Il pellegrinaggio in
Oriente, di Herman Hesse. March [1994, 262] cita Sénancour...
La seconda conseguenza ha a che vedere con il concetto di coevoluzione. Per l’approccio sistemico tradizionale, le varie componenti
dell’input e dell’output sono legate da un rapporto di interdipendenza.
Pertanto, «l’impatto delle politiche pubbliche sugli individui e sui
gruppi è un dato politico tanto quanto l’impatto degli individui e dei
gruppi sulle politiche pubbliche» [Grumm 1975, 441]. Ma nel modello eastoniano il flusso dell’influenza scorre in una sola direzione. Così, ad
esempio, è ammessa la possibilità che le politiche vadano a incidere
sui rapporti che i partiti intrattengono tra loro: ma questo effetto passa
attraverso il feedback, e pertanto prende corpo, per così dire, al giro
successivo.
Per un approccio decisamente orientato alle politiche, l’interdipendenza si manifesta invece come un processo di simultanea coevoluzione, in cui perde significato la domanda su chi è il responsabile primo
del cambiamento: «La prima cosa da notare nel paradigma evolutivo è
che non chiede “che cos’è” una cosa in se stessa (come faceva il paradigma classico); ma chiede “come quella cosa (o persona, o evento) è
diventata quella che è ora”» [Laszlo e Laszlo 1997, 94]. Questa impostazione ha le più evidenti conseguenze nell’analisi del rapporto che
lega i vari attori nel processo di policy. Heclo e Wildavsky, nella loro
analisi delle politiche di bilancio in Gran Bretagna, ricorrono a una
metafora presa in prestito dalla biologia: «Il processo di potere nell’esecutivo inglese somiglia a un terrario con poca acqua, dove la crescita di ciascuno dipende dalle emissioni degli altri» [1974, 374].
Come non ha senso chiedersi se nel terrario ha più potere chi consuma anidride carbonica e produce ossigeno, o chi invece fa l’inverso,
così l’obiettivo della ricerca non può essere l’identificazione di chi
esercita più influenza, ma la ricostruzione delle reti di reciproco condizionamento nella comune, continua trasformazione.
Ai lettori con curiosità transdisciplinari non dovrebbe essere sfuggito un dato: molte delle osservazioni presentate in questo paragrafo
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
evidenziano proprietà tipiche dei sistemi complessi. In effetti, oltre a
quello di politica pubblica e di organizzazione, anche questo concetto
può legittimamente rientrare tra quelli nati, o reinventati, per scardinare le classiche aporie ereditate dai precedenti paradigmi.
Se nelle ricerche tradizionali capita spesso che la complessità sia
invocata come alibi per metodologie approssimative o per conclusioni
fumose, questo termine assume un preciso significato tecnico quando
è riferito alle teorie sistemiche di seconda generazione, sviluppate per
analizzare – in genere con linguaggio matematico – l’isomorfismo tra
fenomeni normalmente studiati in campi diversi, dalla biologia alla
meteorologia, dall’ecologia alla sociologia [Daneke 1989]: si pensi, ad
esempio, a una metropoli, al sistema immunitario, a un affollato rientro dalle ferie, alla borsa. Più precisamente, i sistemi complessi adattivi, o non deterministici, hanno alcune caratteristiche molto vicine a
quelle che nelle pagine precedenti abbiamo attribuito alle politiche:
• possono essere analizzati sia bottom-up, sia top-down;
• gli elementi che li compongono sono legati da relazioni non lineari, sicché uno stesso input può produrre conseguenze diverse e tra
loro sproporzionate;
• i flussi delle informazioni si diffondono in modo reticolare;
• i ruoli dei diversi agenti sono diversificati e protetti in nicchie;
• gli agenti sono in grado di apprendere e di replicare i comportamenti che hanno funzionato [Holland 1995].
Eppure, nonostante le evidenti analogie, gli studi decisamente
orientati alle politiche molto raramente fanno esplicito riferimento a
questo tipo di elaborazioni [Backoff e Mitnick 1986]. Il termine «sistema» appare irrimediabilmente compromesso, perché associato da un
lato all’analisi dei sistemi di impronta manageriale e, dall’altro, agli
output studies ispirati al modello di Easton. E le applicazioni della
teoria al campo dei fenomeni naturali, se da un lato hanno il merito di
proteggere dagli effetti paralizzanti e dalle derive antisperimentali che
intuizioni analoghe hanno suscitato nel contesto del pensiero filosofico
europeo, dall’altro, agli occhi di molti politologi, continuano a evocare
il rischio di un determinismo solo più sofisticato.
3.2.2. Comparazione e triangolazione
A conclusione del paragrafo, conviene considerare il sospetto che
questa idea di politica pubblica sia una specie di araba fenice, che incarna l’aspirazione a una scienza sociale capace di tenere sotto controllo le sue aporie. O, in un’interpretazione più malevola, un gioco di
prestigio per far sparire sotto il tappeto della complessità contraddizioni che hanno le loro radici nello stesso pensiero moderno. Anche questi rilievi sono tutt’altro che ingiustificati. La nostra risposta è che può
non essere così, ma a determinate condizioni, per le quali si potrebbe
313
314
CAPITOLO 5
parlare di un paradosso dello studioso di politiche pubbliche. Da una
parte, sta la convinzione che le politiche hanno la loro radice in problemi e in opportunità che toccano la vita di molte persone: è la loro
natura pratica, la loro tensione applicativa ad alimentare il continuo richiamo ai particolari concreti, perché la lunghezza della fila a uno
sportello, o la collocazione dei cartelli «Vietato fumare» hanno una rilevanza analitica che deve trovare riconoscimento. Dall’altra parte, il
ricercatore è costretto a essere metodologicamente esigente, fino a sfiorare il terreno della metateoria, perché continuamente richiamato alla
consapevolezza che «così come non ci sono pasti gratis, nessuna teoria
(o disciplina) è invulnerabile in tutte le condizioni» [Wildavsky 1992,
158]. Questa constatazione porta in primo piano il problema dell’impostazione della ricerca. In modo non diverso da quel che l’incrementalismo sconnesso consente di fare nel policy making, «le strategie permettono al ricercatore di scegliere il difetto della sua ricerca, anziché
inciampare inconsapevolment e in uno peggiore» [Lindblom 1990,
270].
Secondo alcuni autori, tra i vantaggi di questa impostazione occorre considerare anche il fatto che seguirla è più piacevole:
Partire dalla capacità dei governi di affrontare le conseguenze inattese e
di apprendere dalle diverse esperienze nello sviluppo delle politiche rende
l’oggetto di studio complesso, ma anche affascinante [Heclo 1975, 6].
Chi riesce a ricordare la contingenza ultima dei suoi propositi epistemologici operativi, chi riesce a sospendere la sua euristica negativa (le domande
che ha deciso di non essere in grado di porsi) abbastanza a lungo per apprezzare le intuizioni e la conoscenza dischiuse dalle contese metodologiche, fa un
lavoro migliore, contribuisce a un clima professionale e accademico più sano,
e si diverte di più nel farlo [Lustick 1997, 176].
Se questo tipo di vantaggi è solo probabile, perché il divertimento
è questione di gusti, i costi sono certi, e possono essere riassunti nella
necessità di lavorare con categorie analitiche talmente solide, da reggere sia la comparazione tra casi diversi, sia la triangolazione tra ipotesi
interpretative diverse.
La comparazione, non necessariamente basata su ambiti definiti da
giurisdizioni (gli Stati, le regioni, le aree metropolitane, ecc.), è una risorsa fondamentale per cogliere la specificità dei profili dei diversi
casi, salvandoli nel contempo da uno sterile isolamento. Come ci racconta Dalton, «Un vecchio proverbio ebraico esprime questa idea:
“Domanda: chi ha scoperto per primo l’acqua? Risposta: Non so, ma
di sicuro non era un pesce”. Il rimanere immersi in un singolo ambiente rende le sue caratteristiche impercettibili e irriconoscibili» [Dalton 1996, 4].
La triangolazione può essere definita come il chiamare a confronto, su evidenze empiriche riguardanti uno stesso fenomeno, diverse
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
interpretazioni teoriche [Miles e Huberman 1984; Sabatier 1999b]24.
Analogamente a quanto avviene in trigonometria, un buon modo per
prendere le misure a un oggetto lontano consiste nello sfruttare le
proprietà dei triangoli. Come nel caso della comparazione, anche la
triangolazione è più questione di logica che di numeri: al ricercatore
non si chiede il ricorso a una miriade di fonti, di metodi, di teorie: gli
si chiede però di sapere che questa pluralità esiste ed è una risorsa
[Scharpf 1978; Patton 1990]. Come afferma Charles Anderson, «Il
principio ideale, per le scienze di policy di questa ispirazione, è l’affermazione di Charles Pierce, secondo il quale si deve sempre tenere la
porta aperta per un’ulteriore indagine» [Anderson 1987, 43].
Il prossimo paragrafo è dedicato alla messa a punto di categorie
analitiche capaci di reggere il peso sia della comparazione, sia della
triangolazione.
4. Linee di ricerca
4.1. Una mappa nella mappa
Come abbiamo più volte ripetuto, per chi studia le politiche pubbliche è essenziale disporre di concetti, di immagini, di metafore [Kaplan 1964, 265], capaci di togliere le specifiche vicende dall’isolamento
della singolarità, per analizzarle nei loro elementi costitutivi, per collocarle in rapporto ad altre analoghe, per verificare la congruenza delle
ipotesi teoriche. Se l’esigenza di semplificazione e di standardizzazione
dei termini usati è rilevante in tutte le scienze sociali [King, Keohane
e Verba 1994, 43], il compito è particolarmente impegnativo in questo
campo di ricerca: da una parte, ricondurre a uno schema unitario la
molteplicità dei concetti in circolazione può essere un’operazione brutale e arbitraria; dall’altra, la varietà è tale da rendere tangibile il rischio di una babele delle lingue.
I costi dell’operazione sono attenuati se i diversi concetti sono
collocati all’interno di poche, semplici, categorie, dotate di una chiara
consistenza analitica. Queste categorie devono avere una duplice capacità: «Innanzi tutto, suggeriscono all’osservatore che cosa guardare,
cioè quali fattori hanno la probablità di superare la soglia critica dell’importanza, rispetto a quelli che possono essere ignorati senza pericolo» [Sabatier 1999b, 4]. In secondo luogo, ci dicono come raggruppare questi fattori significativi.
Dunque: come individuare queste categorie? Heclo [1975] sottolinea come fin da Aristotele le classiche domande della ricerca politica
24 Probabilmente il più noto studio esplicitamente impostato secondo questa
strategia è la ricerca di Allison sulla crisi dei missili cubani, cui abbiamo accennato
nelle pagine precedenti.
315
316
CAPITOLO 5
siano «Chi governa? Come governa? Con quali risultati?». Il famoso
testo di Lasswell Politica [1936] ha per sottotitolo: Chi ottiene che
cosa, quando e come. Le questioni suggerite dai manuali di giornalismo
per impostare un buon articolo sono «Che cosa? Come? Dove? Chi?
Quando? Perché?».
Se l’ultima domanda merita, come abbiamo visto, l’incarico di
reggere la presentazione dei concetti in circolazione nelle ricerche è
quindi affidato a cinque categorie.
Chi: come definire le caratteristiche degli attori più influenti e più
ricorrenti?
Quando: come delineare la dinamica che distingue il ciclo di vita
di una policy?
Come: quali elementi permettono di individuare lo stile seguito nel
policy making?
Dove: qual è il contesto istituzionale, qual è la scena, il campo di
gioco, e quali sono le sue regole?
Che cosa: in che cosa consiste il contenuto di una politica? per
quali problemi è pensata? quali effetti produce? con quali tecnologie
sociali?
Per ora, possiamo pensare a queste cinque categorie come a scatoloni capaci di contenere una gran varietà di concetti, perché per certi
versi ogni autore «ha il suo modo di tagliare la torta», cioè ha il suo
modo di scandire la complessità dei processi reali, ha le sue tipologie,
le sue catalogazioni. Talvolta questi concetti sono sostenuti da precise
teorie: talaltra la loro rilevanza è soprattutto descrittiva. Per questo
preferiamo per il momento parlare di immagini, o di metafore.
Come vedremo nella conclusione del paragrafo, anche le nostre
cinque categorie di base possono legittimamente aspirare a un ruolo
più significativo rispetto a quello di mero contenitore. Ma questo è
quello che ci serve ora, per cominciare.
4.2. Gli attori
Identificare le categorie di attori più rilevanti in un dato processo
di policy significa innanzi tutto verificare chi davvero ha ricoperto ruoli significativi nella fitta trama di consultazioni, pressioni, negoziazioni,
conflitti, boicottaggi che accompagnano la produzione di una politica
pubblica, dalla sua prima formulazione alla sua implementazione e
valutazione. L’insistenza sulla necessità di non fermarsi alla ricostruzio- ne
degli organigrammi e delle procedure formali, per arrivare a coloro
che davvero hanno avuto nelle loro mani una qualche possibilità di
orientare il corso delle vicende in una direzione anziché in un’altra,
caratterizza già la giovinezza dei policy studies [Lasswell e Kaplan
1950; Dahl 1961a]. In molti casi, infatti, la ricerca tende a smentire,
più che a confermare, il peso delle posizioni formali.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Per semplificare la nostra esposizione, raggrupperemo le varie immagini elaborate per descrivere gli insiemi di attori in due grandi classi: le immagini basate sulla prevalenza e quelle basate sulla relazione.
Rientrano nel primo tipo tutti quei concetti che si reggono sulla possibilità di indicare una categoria dominante di policy makers, sia essa
identificata con i politici, con le organizzazioni degli interessi, o con la
burocrazia. All’interno del secondo tipo, l’obiettivo è invece la ricostruzione del reticolo di rapporti che controlla lo sviluppo di una politica. Le prime rappresentano un po’ l’anello di congiunzione con le
classiche categorie dell’analisi politologica, e ad esse si deve in larga
parte il decollo dei policy studies in Europa. Le seconde hanno invece
un’origine per così dire autoctona, essendo nate proprio per spiegare
specifiche vicende di policy.
4.2.1. Modelli basati sulla prevalenza
Il governo di partito
I primi indiziati dell’origine e dello sviluppo delle politiche in un
sistema democratico sono i partiti politici, e più precisamente le forze
che, avendo vinto le elezioni, siedono al governo, nominano i dirigenti
amministrativi, conducono le trattative con gli interessi organizzati. Ma
l’accertamento empirico di quella che può sembrare un’ovvietà non è
una cosa semplice. Innanzi tutto, la stretta parentela tra il concetto di
governo di partito e il concetto di democrazia carica anche il primo
delle valenze del secondo, che non sono solo descrittive, ma anche
normative.
Sul piano descrittivo, i partiti rappresentano il cardine del più antico e più popolare modello di democrazia parlamentare: infatti «il
sistema inglese di governo, il “modello Westminster” è stato considerato da molti come il modello del governo di partito» [Wildenmann
1986, 2]. E la fondamentale importanza del loro ruolo è sostenuta dal
convergente impegno di tutti i politici: infatti candidati ed eletti spendono larga parte delle loro energie per convincere i cittadini che l’affermazione dell’uno o dell’altro partito, dell’una o dell’altra coalizione,
produrrà effetti dirompenti nei principali settori dell’intervento pubblico.
Sul piano prescrittivo, per molti autori, soprattutto europei, una
democrazia effettivamente funzionante richiede che i cittadini, informati delle diverse piattaforme programmatiche dei partiti che si sfidano nella competizione elettorale, con il loro voto scelgano, insieme, a
chi affidare il governo e quali politiche realizzare. La conformità tra le
promesse e le effettive realizzazioni entrerà poi nel loro giudizio sull’operato del governo, quando saranno richiamati a votare. Sulla base
di questa definizione, il duplice ruolo dei partiti – collettori di voti
317
318
CAPITOLO 5
sulla base di programmi e ispiratori delle decisioni dei governi – sta
alla base del principio di responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Attraverso i partiti, infatti, i cittadini possono facilmente identificare chi porta il merito o la colpa delle scelte dei governi, e possono
premiarlo o punirlo con il voto successivo [Pasquino 1986b].
Alla fine degli anni ’40, questa impostazione esce dai confini europei per venire adottata da una parte della scienza politica americana
[Schattschneider 1942; 1948; American Political Science Association’s
Committee on Political Parties, 1950]. Ma, come vedremo tra breve, il
caso americano, con la bassissima vitalità delle sue organizzazioni partitiche, rimarrà la più clamorosa smentita dell’equivalenza sostenuta da
Schattschneider: «Nella misura in cui la democrazia è giusta, è giusto
anche il governo di partito» [1948, 11].
Sul piano della ricerca, le indagini che si ispirano al concetto di
governo di partito sono interessate a controllare se esiste una relazione
tra le preferenze di policy degli elettori e le scelte dei partiti o delle
coalizioni premiati dal voto: «Dal punto di vista della teoria politica, la
verifica è: le dichiarazioni dei partiti, e dunque le informazioni a disposizione degli elettori, sono segnali attendibili dell’azione futura dei
governi?» [Hofferbert e Cingranelli 1996, 605]. Le questioni più frequentemente poste riguardano due punti:
1. Le piattaforme elettorali sono sufficientemente differenziate,
riconoscibili e note?
2. Le piattaforme sono un buon indicatore di quel che i partiti
fanno, una volta vinte le elezioni?
1. Le differenze tra le piattaforme elettorali. L’idea che i programmi elettorali contengano promesse abbastanza chiare e differenziate è
sfidata da quanti vedono in atto, nelle democrazie di massa, la tendenza verso partiti pigliatutto [Kirchheimer 1957], guidati dall’unico
obiettivo della raccolta dei voti, incuranti delle loro ideologie originarie e della tradizionale base sociale. Le dure leggi del marketing politico e delle comunicazioni di massa porterebbero ad affidare la riconoscibilità del prodotto partito a fattori diversi e più immediati rispetto
alle proposte di policy, quali l’immagine del leader o la coreografia
delle manifestazioni pubbliche [Sabato 1981].
Alla verifica di queste ipotesi è dedicata la più importante iniziativa di ricerca promossa in ambito europeo: il Manifesto Research
Group dell’European Consortium for Political Research25. Le conclusioni sono molto ampie [Klingemann, Hofferbert e Budge 1994]: in
generale comunque confermano l’idea che esista una rilevante differenza nelle piattaforme, espressa più dall’enfasi posta su determinati
25 A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, e per quasi tutti i paesi
OCSE, è stata codificata ogni frase dei programmi pre-elettorali, sulla base di 54 categorie tematiche, facilmente riferibili ad altrettanti settori di policy.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
problemi che dalla distanza tra le soluzioni. Mentre nel merito le proposte tendono a convergere, invece l’ordine di comparizione dei problemi e lo spazio loro dedicato delineano profili non sovrapponibili.
2. Il rapporto tra le piattaforme e le scelte dei governi. Il tema della
coerenza tra le promesse elettorali e le effettive decisioni dei governi si
intreccia strettamente con il dibattito su «quanto conta la politica» e
con i suoi incerti risultati [Castles 1982; Sharpe e Newton 1984; Schmidt 1983]. Uno sguardo più ravvicinato su questa relazione è reso
possibile dalla ricerca appena citata di Klingemann, Hofferbert e Budge [1994]. In questo contesto, infatti, i dati sulle priorità indicate nei
manifesti elettorali in dieci delle maggiori democrazie sono stati incrociati con le effettive scelte di bilancio dei governi, misurate in base alla
percentuale della spesa per voci di bilancio riconducibili alle aree utilizzate per la codifica dei programmi. L’elaborazione dimostra che effettivamente esiste una sensibile correlazione, e che la sua forza non
risente né delle caratteristiche istituzionali, né della configurazione dei
sistemi partitici.
I dubbi teorici. L’impostazione che abbiamo finora discusso, se
può suonare confortante ai nostri orecchi di studiosi europei, in contesti diversi suscita non pochi problemi empirici e teorici. La reazione
di Morris Fiorina, dopo l’uscita del volume di Castles e Wildenmann
[1986], è di sconcerto: «L’immersione in questi scritti lascia a uno studioso americano l’impressione di vivere su un altro pianeta per quanto
riguarda l’importanza del governo di partito» [Fiorina 1987].
Innanzi tutto, la contrapposizione tra contesto socioeconomico e
intenzioni delle forze politiche, tipica del dibattito «Does politics matter?», sottovaluta la capacità dei partiti di interpretare i vincoli dell’ambiente e di instaurare rispetto ad essi rapporti di apprendimento e di
coevoluzione: «Probabilmente i partiti non costruiscono i loro impegni
o non presentano i loro programmi nonostante le condizioni obiettive,
ma piuttosto per tali condizioni» [Hofferbert e Cingranelli 1996, 605].
In secondo luogo, i governi non deliberano in condizioni di vuoto,
ma ereditano l’immane patrimonio costituito da tutte le politiche già in
atto, con il loro carico di soluzioni più o meno riuscite [Rose e Davies
1994]. Le trasformazioni di norma vanno a incidere su una quota molto piccola di tale lascito.
Infine, anche i cittadini cambiano idea nel corso del tempo, quando dall’astratta enunciazione del problema si passa alle misure concrete: quando, ad esempio, la lotta all’inquinamento diventa un’onerosa
revisione dell’impianto di riscaldamento del proprio condominio. Nelle
elezioni presidenziali americane del 1992, il candidato vincente aveva
indicato l’istituzione del servizio sanitario nazionale come il punto centrale del suo programma. Il rapido abbandono del progetto, in seguito
alle critiche suscitate dalla sua prima concreta presentazione, non gli ha
comunque alienato le simpatie degli elettori alla successiva scadenza
319
320
CAPITOLO 5
del voto. Come è noto, sul significato del mandato ricevuto con il voto
dai rappresentanti politici esiste un antico dibattito teorico26. Ma in
questo caso l’osservazione rinvia solo a un dato empirico, evidenziato
dalle ricerche sulle fluttuazioni dell’opinione pubblica: non è detto che
i cittadini considerino più affidabile chi si attiene ai programmi, a costo
di ignorare le difficoltà impreviste e le obiezioni fondate, rispetto a chi
con flessibilità reinterpreta il programma alla luce delle novità che si
presentano.
Per tutti questi motivi, il cambiamento delle politiche è spesso disallineato rispetto alle tornate elettorali: «Le politiche pubbliche possono mutare senza cambiamenti dei partiti in carica, dato che le politiche che non funzionano sono abbandonate, e gli eventi stimolano
risposte inedite» [Rose 1989, 170].
Ma a contenere le ambizioni norma delle ricerche basate sul triangolo partiti-elezioni-scelte di policy dei governi è soprattutto il fatto
che importanti democrazie non identificano la loro fonte di legittimità
nella forza di questa relazione:
Se si riconosce che gli Stati Uniti sono una democrazia liberale in buona
salute e prospera, e non una curiosa anomalia, occorre considerare l’effettiva
possibilità che i partiti non siano le istituzioni centrali e le condizioni necessarie per la democrazia liberale [...]. Importanti? Certamente sì. Condizioni
sine qua non? Probabilmente no [Fiorina 1987, 271].
Anche nella patria del governo di partito, la Gran Bretagna, secondo alcuni autorevoli studiosi il modello teorico è ormai molto lontano
dalla realtà, data la distanza minima delle posizioni dei partiti sulle
questioni principali, con scarse concessioni alle fedeltà ideologiche:
[Rose 1984; Richardson e Jordan 1979].
Questi due casi sono da soli sufficienti a riaprire la forbice tra il
concetto di democrazia e quello di governo di partito: «La democrazia
liberale e il governo di partito appartengono a categorie distinte [...]. La
democrazia liberale non coincide con il governo di partito né concettualmente né istituzionalmente, e da un certo punto di vista il governo
di partito si propone fini che sono collegati alla prima solo incidentalmente, o che forse non lo sono per niente» [Smith 1986, 206-207].
Se nell’Europa continentale il governo di partito «è il mito che
legittima le democrazie rappresentative di massa» [Katz 1987, 3],
un’osservazione più attenta dei casi che non rientrano in questo quadro richiede di ammettere che questo rapporto si possa porre in modo
diverso e addirittura opposto. Negli Stati Uniti, una parte importante
della teoria politica, sulla scorta dell’insegnamento di Madison, ritiene
un pericolo per la democrazia l’idea che gli eletti considerino i loro
26
[1992].
Per una sua rivisitazione cfr. Eulau e Wahlke [1978]; Budge e Hofferbert
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
programmi come espressione della volontà popolare, perché questa
concezione, «versione contemporanea del diritto divino» [Riker 1982,
261], dischiude la possibilità di una tirannia della maggioranza ai danni delle minoranze. Un’impostazione analoga è proposta da Katz, che
giudica incoerente il governo di partito come ideale democratico, perché tende a fagocitare i principi su cui si regge. Se i partiti vincitori
sono i legittimi policy makers, non li si può biasimare se privilegiano
politiche che consolidano le loro probabilità di continuare a governare, perseguendo scelte discriminatorie verso le minoranze, esercitando
potere nel campo dei media, remunerando il loro elettorato a spese
della totalità dei contribuenti [Katz 1987a, 23; v. anche Weede 1990].
Non molto diversa è la preoccupazione espressa da Richard Rose:
Un sistema elettorale che assegna il seggio solo al primo arrivato, come
quello inglese, non dà licenza di privare fino al 60% degli elettori27 dei benefici del buon governo [...]. In una democrazia, gli elettori chiedono di avere
una scelta di partiti per cui votare, ma le loro richieste complessive giustificano un approccio al governo di tipo consensuale anziché antagonista [1984,
xxxii].
Per Giorgio Freddi [1986], il governo di partito responsabile richiede una burocrazia che sappia efficacemente implementare le politiche pubbliche: ma questo requisito destabilizza la tradizionale separazione tra politica e amministrazione, su cui si basa la originaria definizione del primato del mandato rappresentativo.
Dunque, nelle democrazie «i partiti sono necessari e importanti
per determinare chi governa, ma da questo non deriva che essi siano
ugualmente importanti nel determinare quello che i governi fanno»
[Rose 1984, 109]. Una volta liberata da implicazioni prescrittive, l’idea
del governo di partito può affrontare una radicale trasformazione, per
passare da modello unico o prevalente di democrazia a un insieme di
indicatori capaci di cogliere le varie risorse che i partiti possono mettere in campo per condizionare il policy making [Calise 1989].
Questa svolta riporta in primo piano la domanda «Chi?», offuscata
dalle ricerche sui programmi elettorali e sulle scelte di bilancio [Katz
1986], e richiama l’attenzione su tre serie di elementi.
Il primo riguarda le relazioni con altre categorie di attori, in grado
di sfidare il primato dei partiti nell’impostazione e nell’implementazione delle politiche: come vedremo tra breve, funzionari amministrativi,
rappresentanti degli interessi, esperti, magistrati, dirigenti delle agenzie
indipendenti possono disporre di risorse capaci di piegare la «volontà
politica» degli eletti anche nella più solida delle democrazie. Il fatto
che i ministri debbano la loro carica alla militanza nei partiti che han27 Come è noto, in un sistema maggioritario la maggioranza dei seggi può andare
a un partito minoritario in termini di voti.
321
322
CAPITOLO 5
no vinto le elezioni – situazione che ad esempio non si verifica con i
governi tecnici – è condizione necessaria ma non sufficiente perché si
possa dire che sono i politici i principali policy makers:
Perché ci sia governo di partito, il partito deve riuscire a competere con
successo con altre istituzioni tradizionalmente delegate a gestire il processo
esecutivo. Un partito deve essere capace innanzitutto di indirizzare la produzione legislativa e diventare il principio ordinatore delle assemblee elettive,
selezionando i contenuti delle leggi non meno che il personale politico, chiamato a promuoverle. Il controllo istituzionale deve estendersi alla élite di
governo in senso stretto, che diventa un’espressione diretta dell’organizzazione di partito. Ma deve anche includere il meccanismo di implementazione
burocratica, i livelli inferiori della piramide esecutiva [Calise 1989, 23].
Il secondo problema riguarda non le relazioni con l’esterno, ma la
coesione tra le diverse articolazioni che costituiscono un partito [Bowler, Farrell e Katz 1999]. Già nel 1948 Schattschneider notava: «Si ha
governo di partito quando la coesione del partito nelle elezioni è accompagnata dalla coesione del partito all’interno del governo» [1948,
33]. Se la compattezza interna viene meno, risulta compromessa l’identificazione delle specifiche linee di policy del partito. Innanzi tutto, i
conflitti possono presentarsi all’interno stesso dell’esecutivo. Se in genere la segmentazione delle competenze fa sì che i ministri prestino
scarsa attenzione alle proposte dei colleghi, le fratture possono esplodere su temi trasversali (le ritenute previdenziali degli immigrati, la
regolamentazione delle cliniche universitarie, ecc.) o su questioni ad
alta salienza ideologica (le biotecnologie, l’aborto, ecc.) [Blondel 1989].
Ma è soprattutto il passaggio parlamentare delle leggi a rappresentare un’importante sede di verifica della coesione dei partiti [Stokes e
Miller 1978; Rohde 1991]. La disponibilità di ampie serie di dati sul
voto dei singoli parlamentari nel Congresso americano ha fornito la
base empirica per centinaia di ricerche, purtroppo non replicabili nel
contesto italiano, per l’assenza di dati completi sui comportamenti di
voto dei singoli deputati e senatori. Quando sono possibili, le elaborazioni consentono di capire in quali casi le appartenenze partitiche sono
decisive nel determinare la sorte di una legge, e in quali invece sono
poco significative, per la defezione di importanti settori della maggioranza o, più frequentemente, per l’ampio consenso pluripartitico.
Infine, la coesione all’interno di un partito richiede che i responsabili delle sue iniziative nei diversi settori di policy non siano regolarmente contestati o smentiti dagli attivisti o dagli apparati centrali
[Daalder 1983]. Un qualche grado di incomprensione è l’inevitabile
conseguenza dei diversi ruoli ricoperti, e molti funzionari di partito di
ogni paese potrebbero sottoscrivere dichiarazioni di disagio come questa: «Ci sono poche occasioni di discussione, di analisi e confronto.
Nelle scelte prevale il contingente. C’è troppa tattica e poca strategia.
Ci vorrebbe più respiro ideale e culturale. Bisogna ritrovare le radi-
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
ci»28. Ma quando l’imbarazzo diventa aperta ostilità verso specifiche
proposte di policy, ne risulta un sensibile indebolimento del potere
negoziale di un partito rispetto alle altre forze, politiche e non.
Il terzo problema riguarda invece le trasformazioni cui vanno incontro i partiti quando sono direttamente coinvolti nel policy making:
«Nella realtà del parlamentarismo moderno, i partiti sono agenzie
quasi-governative più che organizzazioni sociali» [Lehner e Keman
1984b, 143]. Questa tendenza produce due effetti: una più stretta specializzazione per aree di policy e la personalizzazione del rapporto tra
eletto ed elettore. Rispetto al primo risvolto, se è vero che la causa
delle nuove politiche tende a risiedere sempre di più nei fallimenti o
nelle difficoltà delle vecchie [Wildavsky 1992], gli interventi di riforma
richiedono una specifica competenza circa l’impianto normativo, i vincoli economici, gli indicatori di impatto degli interventi in vigore [Katz
1986]. Gli incarichi di governo e le commissioni parlamentari sono la
sede più importante a disposizione di un politico nazionale per acquisire e far valere tali conoscenze. Ma questo patrimonio di informazioni, se da un lato consente un dialogo proficuo con i dirigenti amministrativi o con gli esperti, dall’altro rende più difficile e squilibrata la
comunicazione con gli organismi dirigenti del partito e, soprattutto,
con i suoi attivisti.
Rispetto al cambiamento del rapporto con gli elettori, occorre ricordare che i politici sono spesso coinvolti direttamente non solo nel
disegno delle politiche, attraverso la partecipazione al law making, ma
anche nel recapito dei benefici ai destinatari finali. Per certi versi,
questa non è una novità, come dimostra l’ampiezza delle ricerche sul
clientelismo [Eisenstadt e Lemarchand 1981; LaPalombara 1964]. E
tuttavia alcuni autori hanno colto la crescente tendenza a una personalizzazione del rapporto tra eletto e elettore, a una «fidelizzazione» non
diversa da quella che un’azienda tenta di instaurare con i consumatori
attraverso la raccolta di punti o le carte-vantaggio [Cain, Ferejohn e
Fiorina 1987] (questa tendenza sarà ripresa nel sesto capitolo in chiave
deduttiva).
Gli interessi al governo
Dalla scienza politica arriva una seconda importante traccia per
rispondere alla domanda «Chi fa le politiche»? Da quasi cent’anni, dal
volume di Bentley, The Process of Government [1908], la risposta di
molti politologi è: coloro che hanno interessi da sostenere.
Questa affermazione ha due implicazioni. In primo luogo, la molla
28 Dall’intervista al senatore Gavino Angius, membro della direzione del PDS,
«Corriere della Sera», 4 gennaio 1998.
323
324
CAPITOLO 5
all’azione nelle arene di policy non va ricercata in impegni presi con gli
elettori, in fedeltà ideologiche, in spirito di servizio verso le istituzioni,
ma nell’affermazione di un interesse: non necessariamente materiale o
miope, perché ci sono gruppi che si battono contro la pena di morte o
per la qualità dell’ambiente. In secondo luogo, la strategia per far
avanzare queste richieste non esige necessariamente la diretta assunzione di cariche politiche o di responsabilità di governo, perché a provare
attrazione per queste forme di esercizio dell’influenza è in genere solo
una piccola parte della popolazione [Dahl 1961a]. Invece, molto più
diffusa è la pratica della pressione su chi ricopre ruoli istituzionali, per
indurlo a concedere quel che sta a cuore: un orario diverso di entrata
e uscita dalle scuole; un piano dei trasporti più favorevole alla rotaia
rispetto alla gomma; una diversa regolazione delle biotecnologie...
Come nel caso del governo di partito, anche per quanto riguarda i
gruppi d’interesse la lettura prevalente negli Stati Uniti fa riferimento
a modelli molto diversi da quelli europei. Anche in questo caso, sullo
sfondo sta un dissenso che non riguarda solo la precisione sul piano
descrittivo, ma anche le valenze sul piano della teoria politica e anche
in questo caso, cruciale è il rapporto con il concetto di democrazia.
Volendo risalire indietro nel tempo, si potrebbe riandare all’influenza
esercitata sulle due culture dalle figure di Madison e Marx. Le loro
elaborazioni hanno fissato due modi opposti di pensare alle potenzialità e ai rischi collegati alla capacità degli uomini di coordinarsi per
raggiungere obiettivi comuni, partendo dalla condivisione delle concrete condizioni in cui si trovano a vivere. Per ritornare a tempi più
vicini, è sufficiente ricordare che il concetto di democrazia pluralista si
basa non su partiti coesi e vincolati da programmi, bensì sulla possibilità per i cittadini di dare vita a comunanze di interessi multiple, incrociate e sovrapposte, sicché nessuno è mai del tutto all’opposizione o al
governo rispetto a tutti i problemi che gli stanno a cuore, mai del tutto impotente o onnipotente. Nella sua ricerca a New Haven, Dahl
[1961a] trova a una società pluralista in cui le ineguaglianze sono disperse e non cumulate e in cui solo tre leader sono in grado di esercitare influenza in più di un settore di policy.
I gruppi d’interesse. Sul piano descrittivo, le ricerche sui gruppi
d’interesse sono caratterizzate da alcuni tratti che interessano da vicino
lo studioso del policy making.
In primo luogo, la loro impostazione si basa su un empirismo antiformalistico, in aperta polemica con le ricostruzioni del processo di
governo edificate sulla base degli statuti, degli organigrammi, delle
competenze formali. Come afferma in modo perentorio Bentley, «Il
grande compito dello studio di qualsiasi forma di vita sociale è l’analisi
di questi gruppi. Quando i gruppi sono adeguatamente presentati,
tutto è presentato, e se dico tutto intendo tutto» [1908, 208].
Truman [1951] si propone di dimostrare che i gruppi d’interesse
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
costituiscono la chiave di volta per capire il processo di governo non
solo nella fase della esplicita contrattazione di un provvedimento con
le associazioni e le categorie interessate, ma anche quando il fluire
delle decisioni entra all’interno delle istituzioni pubbliche e si ammanta di criteri quali la legittimità, l’efficienza, la legalità:
Sia che si guardi a un singolo cittadino, al segretario esecutivo di un’associazione commerciale, al funzionario di un partito politico, al deputato, all’amministratore, al governatore o al giudice, non possiamo spiegare e neppure descrivere la sua partecipazione a una funzione statale salvo che in termini
di interessi con cui egli si identifica e di gruppi dei quali è membro o con i
quali deve misurarsi [Truman 1951, 71 trad. it.].
Come abbiamo evidenziato nel quarto capitolo, e come del resto
dimostrano i titoli dei due volumi qui citati29, l’idea che persino ciò
che avviene all’interno del parlamento, dell’amministrazione , della
magistratura vada spiegato ricorrendo al concetto di interesse, ha una
stretta relazione analitica con la definizione delle politiche come processi, cioè come giochi sempre aperti a ridefinizioni e a rinegoziazioni,
perché tutti coloro che vi mettono mano non sono neutrali giunture di
raccordo tra una fase e la successiva, ma attori che sono arrivati a quel
punto in virtù delle loro motivazioni e convenienze, che intendono far
valere non appena si presenta l’occasione: «Il pluralismo è l’abito
adottato da una generazione di studiosi del processo di policy, che
l’hanno trovato più adeguato ai loro risultati rispetto all’immagine del
policy making da album delle fotografie costruita sui programmi dei
partiti e il parlamento» [Jordan 1990a, 58].
In secondo luogo, ad essere considerate preminenti sulla scena del
policy making non sono solo le organizzazioni formalmente costituite
intorno a precisi interessi, quali un sindacato di categoria, un’associazione di quartiere, un movimento femminista. Sulla base di questa
impostazione, qualunque formazione (un partito, un’istituzione scientifica, una chiesa, un ufficio dell’amministrazione), richiederà, perché
le sue scelte diventino intelligibili, di essere considerata per gli interessi
che difende.
Infine, l’indicazione è a non soffermarsi solo sulle aggregazioni che
esplicitamente hanno la loro ragion d’essere nella difesa di determinati
vantaggi, perché la corposità di un’organizzazione non è considerata
come prova necessaria dell’esistenza di un interesse: «Né l’esistenza
del gruppo, né quella dell’interesse dipende da un’organizzazione formale [...]. L’organizzazione indica soltanto lo stadio o il grado dell’interazione» [Truman 1951, 36]. Un gruppo è infatti un insieme di individui con interessi comuni, in grado di coordinarsi per costituire
29 The Process of Government è il titolo del testo di Arthur Bentley; The Governmental Process quello di David Truman.
325
326
CAPITOLO 5
un’effettiva organizzazione se e quando le circostanze lo richiedono: se,
ad esempio, i loro interessi sono minacciati da altri gruppi.
Questa impostazione ha due importanti implicazioni, la prima normativa, e la seconda analitica. Sul piano normativo, come nota Lowi
[1971a, 32], in fondo per larga parte della teoria pluralista, a partire
da Madison e da Tocqueville, i gruppi d’interesse sono più utili e significativi quando rimangono allo stato nascente che quando si traducono in solide organizzazioni. A contare è il fatto che possa scattare la
molla dell’interesse comune, non il fatto che scatti effettivamente, perché in una democrazia i cittadini «di solito non cercano di influenzare
i funzionari pubblici o i politici, ma i membri delle loro famiglie, gli
amici, i colleghi, i dipendenti, i consumatori, le imprese, e altre persone impegnate in attività non di governo» [Dahl 1961a, 305]30. Questa
lettura fa sì che il pluralismo possa essere invocato come principio
contro il potere della grandi corporations, contro l’invadenza delle associazioni di categoria, contro l’autonomia di cui godono le agenzie regolative.
Per quanto riguarda le implicazioni analitiche, occorre notare che
la teoria dei gruppi d’interesse è più un paradigma che segnala quali
proprietà dell’interazione andare a studiare, che la carta d’identità di
una specifica categoria di attori. Infatti, di per sé non fornisce quella
definizione empirica del suo oggetto che ne permetterebbe la traduzio- ne
in ipotesi di ricerca falsificabili [Sartori 1971]. Vedere negli interessi la molla che porta tutte le categorie di policy maker ora a coordinarsi, ora a scontrarsi, ora a defilarsi, è un assunto che proietta la sua influenza più sulla public choice e sulle teorie di cui ci occuperemo nel
capitolo seguente, che sullo studio di specifiche organizzazioni.
Le organizzazioni degli interessi. Fin qui, dunque, la prima generazione degli studi sui gruppi d’interesse. Ma il dato che presto colpisce
gli studiosi, dalla fine degli anni ’40, è la concreta capacità di molti
gruppi di passare dalla potenza all’atto, da un’influenza solo virtuale,
quasi preventiva, all’efficiente e ostinata pressione proprio sui governi,
i parlamenti, le burocrazie. Già durante il New Deal le grandi organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori avevano assunto un ruolo
significativo nella negoziazione delle riforme sociali. E tuttavia la situazione di emergenza poteva giustificare una lettura di queste contrattazioni in termini di eccezionalità. Trent’anni dopo, il dibattito tra pluralisti e antipluralisti deve fare i conti con una serie di indagini empiriche che dimostrano l’influenza di grandi e piccole organizzazioni
30 Lowi nota acutamente come la metafora più adeguata sia quella del minuteman, il cittadino pronto a prendere le armi in caso di allarme e capace di passare immediatamente dalla sua normale occupazione a quella di soldato: come è noto, a questa figura si deve gran parte del vantaggio americano nella guerra d’indipendenza dal
giogo inglese.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
degli interessi nella concreta formulazione e gestione delle principali
politiche pubbliche, dall’agricoltura alle norme tariffarie, dall’industria
all’urbanistica [Milbrath 1963; Lane 1964; Key 1964].
A questo punto, la riflessione sui gruppi d’interesse cambia impostazione: lascia la tranquilla New Haven e i suoi benevoli riferimenti a
un gioco sostanzialmente equilibrato tra pressioni e contropressioni, e
va a Washington, a confrontarsi con la realtà del lobbying31, con gli
strumenti di pressione delle grandi corporations, con la litigiosità degli
studi legali e, talvolta, con la corruzione.
Non che questi aspetti fossero stati ignorati in passato [Schattschneider 1935]. Del resto, già nella riflessione dei Padri Fondatori l’azione volontaria e coordinata, basata su interessi comuni, se da un lato è
la base di una democrazia vitale, dall’altra può fare della cosa pubblica
il terreno per scorribande di fazioni forti e ben organizzate ai danni
della gente comune. Tra gli anni ’60 e ’70, tuttavia, le ricerche portano
alla luce una serie di dati che suggeriscono letture più generali e più
pessimiste del fenomeno della pressione sulle istituzioni da parte degli
interessi organizzati [Graziano 1995].
Innanzi tutto, le grandi associazioni dimostrano di avere un’articolazione organizzativa, una continuità di iniziative e un ammontare di
risorse finanziarie tali da garantire stabilità alla loro azione. L’attività
di lobbying diventa più penetrante e più professionale, mirando a
«giocare d’anticipo», e a condizionare le varie proposte fin dalla fase
di progettazione. Grazie anche al decollo dell’analisi delle politiche, i
documenti che circolano sono corredati da dati e previsioni; una notevole cura viene posta nell’influenzare l’opinione pubblica, con la presentazione sui media di ragioni ben argomentate [Berry 1989].
In secondo luogo, le organizzazioni degli interessi dimostrano una
capacità di presa su ogni fase del policy making. Infatti non si limitano
a piantonare i corridoi dei parlamenti e a promettere ai singoli legislatori sostegni elettorali e finanziamenti, ma avvolgono il governo e le
agenzie regolative di una fitta rete di contatti, che consentono loro di
conoscere in anteprima le bozze delle norme attuative, di influenzare
la loro stesura, di avere in appalto ampi aspetti dell’implementazione,
di uscire vincitrici nelle vertenze legali intentate all’amministrazione.
Della commistione dei politici nel concreto recapito dei benefici delle
politiche ai loro elettori abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Ora
occorre sottolineare che spesso la fase di implementazione andrebbe
incontro a difficoltà enormi senza l’attivo impegno delle organizzazioni
che rappresentano i destinatari: si pensi al ruolo che le associazioni di
31 «La strategia del lobbying deriva il proprio nome dalla regola che impedisce a
chiunque non faccia parte del corpo legislativo [...] di entrare nelle aule parlamentari,
così che chi vuole tentare di esercitare la propria influenza sui legislatori è costretto a
farlo nei corridoi esterni ad esse» [Lowi 1991, 292 rist. 1999].
327
328
CAPITOLO 5
categoria svolgono, con la loro stampa e con i loro consulenti, per diffondere le informazioni su scadenze fiscali, o per aiutare gli iscritti
nella compilazione di moduli per accedere ai finanziamenti pubblici
[Richardson e Jordan 1979; Navarro 1984].
Ma è soprattutto un terzo aspetto a suscitare il più vivace confronto di dati e di idee: si tratta della sistematica discriminazione degli
interessi dei cittadini comuni a favore degli interessi economicamente
e politicamente più forti. Per molti autori che non si riconoscono nell’impostazione pluralista, l’assunto della non sovrapposizione dell’influenza nel passaggio da un settore all’altro di policy, è solo una pia
illusione:
Il coro pluralista canta con un forte accento dei quartieri alti. Probabilmente circa il 90% della gente non ha modo di entrare a far parte del sistema di pressioni. L’affermazione che il sistema delle pressioni è automaticamente rappresentativo dell’intera comunità è quindi un mito alimentato dalla
tendenza universalizzante delle moderne teorie dei gruppi. La politica dei
gruppi di pressione è un processo selettivo disadatto a servire interessi diffusi.
Il sistema è squilibrato e sbilanciato in favore di una frazione della minoranza» [Schattschneider 1960, 82 trad. it.].
Infatti non tutti gli interessi hanno uguali opportunità o uguali
incentivi per organizzarsi e per avviare un’attività di pressione presso
i policy makers. Anche quando riescono in questo intento, non tutti
sono accolti con la stessa condiscendenza e trattati con lo stesso riguardo. A soffrirne, oltre agli svantaggiati, sono i fondamenti stessi
della democrazia liberale e il successo elettorale delle forze che ad essi
si rifanno. Come denuncia Lowi in The End of Liberalism [1969], un
testo destinato a divenire un punto di riferimento delle ricerche di
orientamento antipluralista, a questo porta l’arbitrarietà che i funzionari delle agenzie regolative possono esercitare, promuovendo alcuni
interessi ai danni di altri, incoraggiando «bottini personali anziché
scelte pubbliche», «attuando il socialismo per gli organizzati, e il capitalismo per i non organizzati» [1969, 278].
Ma sospendiamo per qualche pagina la ricostruzione del contributo americano, per passare dall’altra parte dell’Atlantico e ripercorrere
i passaggi essenziali della riflessione europea.
Il contributo europeo. Le due chiavi di lettura fondamentali prodotte dalle scienze sociali europee per comprendere la rete di interessi
che impronta il policy making sono il concetto di classe sociale e il
concetto di élite: a fare da sfondo e a triangolare con queste idee è
comunque l’esperienza delle grandi organizzazioni che hanno segnato
la vita politica europea del ventesimo secolo: i partiti di massa e i sindacati.
Cercare nelle politiche pubbliche i segni del conflitto di classe e
usarli per spiegare i processi decisionali è un’impostazione che dà la
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
prima grande prova di sé nella ricostruzione che Karl Marx compie
delle leggi per la liberalizzazione del prezzo del grano e per la limitazione dell’orario della giornata lavorativa: «Nulla serve a definire lo
spirito del Capitale meglio della storia della legislazione inglese sulle
fabbriche dal 1833 al 1864» [Marx 1867-94, vol. I, t. 1, 304 trad. it.].
Infatti «La legislazione sulle fabbriche, prima reazione consapevole e
pianificata della società alla figura spontaneamente assunta dal suo
processo di produzione sociale, è, come abbiamo veduto, prodotto
necessario della grande industria, quanto il filo di cotone, i self-actors
e il telegrafo elettrico» [ibidem, t. 2, 193 trad. it.]. Benché la complessità dell’analisi marxiana del law making inglese sia destinata ad avere
rare imitazioni tra gli epigoni, che preferiscono invece assumere come
oggetto di indagine lo stato capitalista nel suo complesso, o le sue strategie macroeconomiche, il conflitto radicato nel luogo di lavoro, la
contrapposizione di classe tra capitalisti e operai, ha per l’analisi politica europea una rilevanza incomparabilmente superiore a quella assegnatale dagli studiosi americani. Sul piano normativo, anche autori
molto distanti dal marxismo individuano nelle relazioni in ambito produttivo la base delle virtù pubbliche richieste dalla nuova società industriale. Come scrive Max Weber,
Uno stato che vuol fondare lo spirito del suo esercito popolare sull’onore
e la solidarietà, non deve dimenticare che, anche quotidianamente, nelle lotte
economiche del lavoro, il sentimento dell’onore e della solidarietà genera le
sole forze morali decisive per l’educazione delle moltitudini, e che perciò bisogna lasciarle operare liberamente. Questo e niente altro significa, riguardata
sotto l’aspetto puramente politico, la «democrazia sociale» in un’età capitalistica che inevitabilmente sarà per durare ancora a lungo [Weber 1918, 16].
Il rafforzamento delle grandi organizzazioni sindacali e dei partiti
socialisti e comunisti ha esercitato un palese influsso sul policy making
nei settori delle politiche economiche, del lavoro, della previdenza
[Lipset e Rokkan 1968]. Nei paesi continentali, l’impronta professionale della protezione sociale, il coinvolgimento delle parti sociali nei
tentativi di programmazione economica, lo stretto legame tra partiti di
sinistra e forze sindacali, il loro ricorso allo sciopero generale contro
iniziative legislative ritenute ingiuste, sono tutti solidi indizi della permeabilità del policy making da parte delle organizzazioni che basano la
loro ragion d’essere sul conflitto tra datori di lavoro e lavoro dipendente.
È importante sottolineare una differenza tra queste impostazioni e
l’elaborazione americana. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la originaria teoria dei gruppi d’interesse non richiede che la loro
forza si manifesti attraverso strutture organizzative formali, perché
spesso è sufficiente il potenziale di aggregazione di un interesse comune per esercitare un effetto di dissuasione nei confronti di eventuali
antagonisti. La teoria marxista richiede invece che «la classe in sé»
329
330
CAPITOLO 5
diventi «classe per sé» grazie a uno straordinario impegno organizzativo, capace di trasformare il comun sentire in strutture politiche e sindacali solide, diversificate, gerarchiche, vere macchine blindate capaci
di resistere alla repressione e di consolidare le conquiste acquisite.
Nell’esperienza europea, dunque, la riflessione sulle organizzazioni
politiche e sindacali come strumento di emancipazione delle classi
svantaggiate è costantemente intrecciata all’analisi delle tendenze oligarchiche innescate da questa prospettiva sia al loro interno, per il
ruolo giocato dai loro potenti apparati, sia al loro esterno, per la tendenza ad affiancare alle istituzioni della democrazia parlamentare sedi
decisionali in cui far valere non la forza dei voti, ma quella della mobilitazione – o del ricatto – sociale.
Come è noto, la prima faccia di questa tendenza è stata individuata e definita con grande efficacia dalla scuola elitista italiana, che conta
figure quali Mosca, Pareto, Michels. Come scrive quest’ultimo,
Addestrandosi nei dettagli della vita politica, nei particolari della legislazione, delle questioni tributarie, delle questioni daziarie e nelle questioni della
politica estera, i capi acquistano un valore che – almeno finché la massa si
attiene alla tattica parlamentare, ma forse anche se vi rinunzia – li rende indispensabili al partito [Michels 1909, 182 trad. it.].
La seconda faccia evidenzia l’instaurazione di arene decisionali
basate sulla rappresentanza funzionale degli interessi: lavoratori e datori di lavoro di un dato settore, coltivatori di prodotti agricoli e corrispondenti comparti dell’industria alimentare... Questa tendenza, manifestatasi per la prima volta all’interno delle democrazie continentali
nel decennio successivo alla prima guerra mondiale [Maier 1975],
dopo la degenerazione del corporativismo di Stato fascista, negli anni
’70 torna a catturare l’attenzione degli studiosi per il suo riemergere
sotto forma di concertazione neocorporativa.
Il neocorporativismo. Questo concetto rappresenta il più importante contributo europeo alla comprensione del ruolo delle grandi organizzazioni nel policy making [Cawson 1978; Lehmbruch e Schmitter
1982; Maraffi 1981]. Già nel 1966 Stein Rokkan notava:
Le decisioni cruciali di politica economica sono prese raramente all’interno dei partiti o del parlamento: l’arena centrale è il tavolo negoziale dove le
autorità di governo incontrano direttamente i leader dei sindacati, i rappresentanti degli agricoltori, i piccoli proprietari, i pescatori, i delegati delle associazioni dei datori di lavoro. Nella vita dei cittadini medi, queste tornate di
negoziazioni lungo l’anno hanno acquisito di fatto un significato maggiore
delle elezioni formali [cit. in Jordan 1990a].
In anni più recenti, è allo sviluppo di questo filone di ricerca che
si deve la rinnovata attenzione per le forme assunte dalle rappresen-
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
tanze degli interessi, soprattutto nei paesi europei. La constatazione
che le organizzazioni su base produttiva e professionale non si limitano a promuovere gli interessi che tutelano presso i partiti presenti in
parlamento, ma invece tendono a instaurare tavoli negoziali in grado
di concludere accordi direttamente con i governi, può essere analizzata
da due punti di vista. Innanzi tutto, può essere considerata per le logiche associative che presuppone, basate su un rapporto esclusivo tra
rappresentanti e rappresentati:
Il corporativismo può essere definito come un sistema di rappresentanza
degli interessi in cui le unità costitutive sono organizzate in un numero limitato di categorie uniche, obbligatorie, non in competizione tra loro, ordinate
gerarchicamente e differenziate funzionalmente, riconosciute o autorizzate (se
non create) dallo Stato, che deliberatamente concede loro il monopolio della
rappresentanza all’interno delle rispettive categorie in cambio dell’osservanza
di certi controlli sulla selezione dei loro leader e sull’articolazione delle domande e degli appoggi da dare [Schmitter 1974, 52 trad. it.].
Le condizioni qui poste in modo tanto netto riguardano il lato
dell’input, cioè le modalità organizzative delle associazioni e il loro
rapporto con la base, aspetti spesso regolati attraverso una legislazione
sulla proclamazione degli scioperi, sulla nomina dei leader, sulla ratifica dei contratti, con l’obiettivo di esorcizzare il rischio della contestazione e la sfida di nuovi raggruppamenti.
Ma il neocorporativismo può essere analizzato anche da un secondo punto di vista, dal lato dell’output, cioè come un modo per
approdare alla selezione e all’implementazione di specifiche politiche
pubbliche, attraverso la negoziazione tra i governi e il cartello dei
gruppi organizzati [Lehmbruch 1979]. Alla fine degli anni ’70, questa
immagine del policy making sembrava particolarmente adeguata a descrivere le modalità attraverso le quali in alcuni paesi europei (Austria, Svezia, Olanda, Finlandia, Norvegia) erano gestite le principali
politiche economiche: controllo dei prezzi e dei salari, interventi per
l’occupazione, riconversione industriale, formazione professionale,
politiche sociali. Questa versione liberale del corporativismo non si
pone pregiudizialment e in competizione con il ruolo dei partiti e
delle assemblee elettive32, anche se la sua continuità richiede forme
istituzionalizzate di coordinamento, quali commissioni tripartitiche,
consigli per l’economia, consultazioni obbligatorie, le cui deliberazioni pongono di fatto dei vincoli alla sovranità parlamentare. Attraverso
questi processi di decisione congiunta, si consolidano meccanismi di
32 Ma esistono anche pareri opposti: «Può darsi che il neocorporativismo non
costituisca un’alternativa secca alla democrazia parlamentare o al governo parlamentare; ma comunque i suoi valori sono radicalmente opposti a quelli pluralisti su cui si
basano i sistemi di partito competitivi» [Smith 1986, 224].
331
332
CAPITOLO 5
scambio da cui tutti i contraenti escono rafforzati. I governi mirano a
prevenire l’eventualità di duri e generalizzati scontri sociali, aumentano le probabilità di successo elettorale e si assicurano la collaborazione di potenti macchine organizzative nella fase di implementazione
dei provvedimenti [Lehmbruch 1982, 5-6]. A loro volta, le grandi
associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono vantare la
loro influenza nel condizionare il policy making, possono garantire
agli associati un accesso privilegiato ai benefici dei programmi approvati, e talvolta possono ottenere risorse più tangibili, con la delega a
gestire direttamente attività quali i corsi di formazione o gli osservatori sul mercato del lavoro.
La segmentazione delle arene. Dunque, da tutte e due le parti dell’Atlantico, sia le teorie che denunciano la fine del liberalismo, sia
quelle, meno catastrofiche, incentrate sul concetto di neocorporativismo, sembrano in grado di rispondere alla domanda «Chi fa le politiche pubbliche?» replicando: «Le grandi organizzazioni degli interessi
economici e professionali». Questa unica risposta non può naturalmente attenuare le fondamentali differenze tra il corporate pluralism
americano e il corporativismo liberale di alcuni Stati europei rispetto
alla base sociale delle organizzazioni, al contesto istituzionale in cui
operano, alle risorse che utilizzano, alle politiche su cui si concentrano
[Foner 1984; Schmitter e Grote 1997]. E tuttavia ad accomunare le
due teorie è un elemento importante: la tendenza delle organizzazioni
degli interessi a non stare nel posto loro assegnato dalla teoria, che le
vorrebbe confinate nelle fasi iniziali del processo di formazione dell’input, per cercare invece un attivo coinvolgimento in ogni tappa del
policy making, dalle campagne di opinione all’approvazione delle leggi,
dalla definizione dei dettagli attuativi alla gestione di aspetti dell’implementazione33 [Jordan 1990a; Martin 1983; Ginsberg, Mebane e
Shefter 1995].
Sul piano prescrittivo, questi aspetti hanno suscitato preoccupazioni per la sorte stessa della democrazia parlamentare e per i loro effetti
sociali, dati i rischi di politiche discriminatorie ai danni delle categorie
con poche risorse organizzative, quali i disoccupati o gli immigrati.
Ma l’aspetto che qui importa sottolineare è un altro. Cercare di
influenzare ogni passaggio del policy making non è un impegno una
tantum, ma richiede competenza, specializzazione, costanza, costruzione di una rete di rapporti. Questi sono investimenti che tendono ad
33 La procedura nota come Negotiated Rulemaking, autorizzata dal Congresso
americano nel 1990, e definitivamente confermata nel 1996, autorizza esplicitamente le
agenzie regolative a instaurare tavoli negoziali con le organizzazioni dei produttori e
dei consumatori e con i diversi gruppi interessati, anche al fine di prevenire il loro
ricorso alla magistratura.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
azzerare il loro valore nel passaggio da un settore di policy a un altro.
La dirigente sindacale che si occupa di formazione professionale e che
pertanto conosce la normativa dell’Unione europea, sa come ottenere
i fondi e mantiene rapporti diretti con i funzionari regionali, deve ripartire daccapo se viene mandata a seguire le politiche per la sicurezza
sui luoghi di lavoro. Il risultato è una sempre più accentuata segmentazione della sfera del governo in tante diverse arene decisionali, ciascuna caratterizzata da suoi canali di accesso, da sue regole del gioco,
da sue logiche di contrattazione. Segmentazione è, in effetti, il termine
che ricorre con maggiore frequenza nelle ricerche sul ruolo degli interessi organizzati nel policy making [Cater 1964; Richardson e Jordan
1979; Laumann e Knoke 1987]. Quando le grandi associazioni si immergono nel processo di produzione delle politiche, lo condizionano,
ma ne escono condizionate: una più precisa segnalazione dei confini
delle diverse arene diventa infatti una necessità sia per le amministrazioni pubbliche, che devono sapere con chi fare davvero i conti, sia
per le associazioni stesse, per le quali generico è sinonimo di infruttuoso [Heinz et al. 1993]. In queste condizioni, è molto difficile dire dove
finisce la cattura delle politiche da parte degli interessi organizzati, e
dove inizia la cattura di questi da parte delle politiche, con le loro
specifiche esigenze, il loro particolare linguaggio, le loro tacite regole.
Il governo della burocrazia
Nell’arco della sua storia, la scienza politica ha accumulato un
gran numero di studi che propongono una terza categoria di attori
come fondamentali protagonisti del policy making: i burocrati. Con
questo termine non ci riferiamo agli impiegati che incontriamo agli
sportelli, ma ai dirigenti e funzionari amministrativi. Il primato nell’elaborazione di una teoria capace di dare conto della loro straordinaria importanza nell’epoca contemporanea spetta, come è noto, a un
europeo, Max Weber:
In uno Stato moderno il potere reale, che non è esercitato né nei discorsi
parlamentari, né nelle enunciazioni dei monarchi, bensì nel maneggio dell’amministrazione nella vita quotidiana, è necessariamente nelle mani della burocrazia [...]. Come il così detto progresso al capitalismo dall’epoca medioevale
è la misura univoca della modernizzazione dell’economia, così il progresso
all’impiego burocratico fondato sull’ufficio, lo stipendio, la pensione, l’avanzamento, la scuola professionale e la divisione del lavoro, le competenze stabilite, l’autenticità degli atti, l’ordinamento gerarchico di superiori e subalterni, è parimente la misura univoca della modernizzazione dello Stato. Del
monarchico come del democratico [Weber 1918, 21 trad. it.].
La tendenza individuata da Weber non coglie soltanto il processo
di crescita degli apparati statali. L’essenza della burocratizzazione è
333
334
CAPITOLO 5
infatti rintracciata nella separazione tra gli affidatari di un compito, e
i mezzi materiali per la sua realizzazione, nell’industria come nel settore pubblico, nei partiti come nelle università. L’organizzazione burocratica sorregge dunque l’intelaiatura di regole e di competenze su cui
si basa l’esercizio dell’autorità nelle società moderne, caratterizzate dai
principi di legalità e di razionalità.
Se «in Europa il corpo specializzato dei funzionari, fondato sul
principio della divisione del lavoro, è sorto a poco a poco attraverso
uno sviluppo di mezzo millennio» negli Stati Uniti alla fine del diciannovesimo secolo è ancora in vigore «il sistema dilettantesco di amministrazione per mezzo di politici predatori» [Weber 1922, vol. II,
696]. In effetti il ruolo della burocrazia è quasi assente nella riflessione
teorica che accompagna la nascita della federazione americana [Stillman 1990] 34. Occorre attendere il 1887 per trovare, con il testo di
Woodrow Wilson, The Study of Administration, una riflessione complessiva sullo spazio che l’amministrazione deve rivendicare, per difendere la sua autonomia e la sua professionalità rispetto a un parlamento
che pretende di condizionarla per bassi motivi clientelari. Così, se per
Weber il problema è il consolidamento di istituzioni politiche capaci
di fare da contrappeso a una burocrazia consapevole delle risorse rappresentate dalla competenza e dalla carriera, per Wilson e per i protagonisti della Progressive Era i termini sono opposti e speculari: come
garantire ai funzionari amministrativi la possibilità di resistere alle
pressioni dei politici e delle lobbies. Come abbiamo più volte sottolineato, la risposta, per oltre cinquant’anni, è stata trovata in due principi guida: la separazione tra politica e amministrazione, e l’applicazione al management pubblico di criteri di efficienza ispirati al settore
privato e richiamati nell’acronimo POSDCORB (terzo capitolo): Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting. E tuttavia, come abbiamo visto nel capitolo precedente, questi
due comandamenti non hanno avuto vita facile, né in ambito amministrativo, né in ambito scientifico. Infatti, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, sia l’espansione delle burocrazie, sia il loro
studio, maturano con il sostegno di un concetto, quello di politica
pubblica, capace di dissolvere il nucleo del POSDCORB.
Le politiche come spiegazioni del cambiamento. Sul piano pratico, gli
anni ’50 e ’60 hanno visto una straordinaria crescita delle burocrazie
nelle principali nazioni. Soprattutto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna,
nei paesi scandinavi, questa espansione avviene all’insegna del continuo
riferimento alle politiche pubbliche: l’estensione dello Stato sociale, la
34 «Se negli Stati Uniti un individuo ha qualche risorsa, si lancia nel commercio
o si fa pioniere, mentre in altri paesi europei, appena è possibile, un uomo cerca un
impiego pubblico» [Tocqueville 1835, 253 trad. it.].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
crescita degli interventi macroeconomici, l’impegno per l’innalzamento
dell’istruzione, comportano un enorme allargamento degli obiettivi dell’intervento pubblico e un aumento della complessità dei programmi per
perseguirli [Wood e Waterman 1994; Peters 1981; Lewis 1980; Page
1985]. Problemi nel passato rimasti affidati alle scelte delle famiglie o
dei mercati, diventano oggetto di iniziative che richiedono più amministrazione. Se ai nostri bisnonni avessero detto che il comune avrebbe
organizzato gare di scopone per gli anziani o i loro soggiorni al mare,
avrebbero stentato a crederlo. Questo cambiamento ha comportato un
aumento del numero dei dipendenti pubblici, un incremento del potere
delle loro organizzazioni sindacali e professionali, una diversificazione
delle loro competenze, con lo spostamento del rapporto tra generalisti e
specialisti a favore di questi ultimi [Ronge 1974].
Ma in molti casi questa evoluzione richiede uno slittamento di
identità ai funzionari amministrativi, che passano da responsabili dell’esecuzione delle scelte politiche, a componenti di un fitto reticolo di
commissioni e comitati, ciascuno dotato di poteri decisionali in specifiche aree di policy, e costituito proprio per mettere la dirigenza burocratica a contatto con gli stakeholders, cioè con quanti hanno delle
poste in gioco, siano questi, ad esempio, le associazioni dei genitori, i
sindacati degli insegnanti o le case editrici scolastiche. Le valutazioni
assunte in queste sedi sono di fatto destinate a condizionare le scelte
formali degli organi di governo. Su di esse, i burocrati possono esercitare una notevole influenza, perché possiedono una specifica risorsa,
essenziale in fasi di cambiamento: si tratta della competenza nella definizione di ciò che è fattibile, e nella stima dei suoi costi finanziari e
organizzativi. Quando il funzionario dice «Non si può fare», difficilmente può essere sfidato, qualunque motivo adduca: finanziario, organizzativo, giuridico.
Questo cambiamento ha sortito effetti deleteri per i principi del
POSDCORB, anche perché, a descriverlo, soprattutto negli Stati Uniti,
c’era un’agguerrita schiera di studiosi dotati di un bagaglio concettuale
ormai molto distante da quello della scienza dell’amministrazione tradizionale. Come sottolinea uno dei protagonisti della svolta, Dwight
Waldo [1990, 76],
Una delle ragioni della scarsa reputazione della scienza dell’amministrazione [...] è stata la sua incapacità di partecipare seriamente al movimento
behavioralista che ha dominato la scienza politica negli anni ’50 e ’60 [...]. In
qualche modo collegata a ciò è l’incapacità di rapportarsi all’area dei policy
studies in modo rapido e deciso. Per qualcosa come due decenni, dopo che
divenne ben chiaro che gli amministratori pubblici sono inevitabilmente e
decisamente impegnati in questioni di policy, sono state avanzate solo poche
significative proposte [analitiche].
In effetti sul piano teorico, non appena vengono meno le esigenze
di monolitica compattezza della macchina bellica, nel giro di pochi
335
336
CAPITOLO 5
anni i tre studi di Paul Appleby [1949], di Herbert Simon [1947] e di
Dwight Waldo [1948] contestano radicalmente i presupposti dell’ortodossia amministrativa. Dalle loro pagine infatti apprendiamo che il
processo decisionale all’interno delle amministrazioni pubbliche è
molto diverso da quello adottato nelle imprese private [Appleby
1949]; comunque, nell’uno e nell’altro caso, l’obiettivo dell’efficienza
attraverso la pianificazione non rispecchia il modo in cui sono prese
davvero le decisioni da attori con razionalità limitata [Simon 1947]; e
la separazione tra politica e amministrazione è un obiettivo irrealistico
e inadeguato [Waldo 1948].
Su questi principi, si fonda il decollo della «scuola politica (o realistica) dell’amministrazione» [Key 1964]. Suo obiettivo è leggere le dinamiche burocratiche con strumenti concettuali costruiti non intorno
alle competenze formali, ma intorno a una mappa delle effettive relazioni di potere: anziché dare per scontata l’uniformità e la razionalità
dell’impianto organizzativo, questa impostazione tende a evidenziare i
conflitti e gli accomodamenti tra i diversi comparti dell’amministrazione, complicati da un sistema federale che rende insieme necessaria e
difficile l’integrazione tra i livelli di governo nazionale, statale, locale
[Selznick 1949; Kaufman 1960].
A partire dagli anni ’70, questo continuo flusso di scambi e di
pressioni, condotti con notevole autonomia e persino con spregiudicatezza dai diversi apparati statali, comincia a fare i conti con una nuova
categoria di attori in grado di imporre vincoli al monopolio delle competenze che il burocrate weberiano può far valere: si tratta dei consulenti esterni, nuove creature prodotte dallo sviluppo stesso della policy
analysis, che vanno ad aggiungersi alla già variegata fauna che popola
i corridoi ministeriali:
Negli Stati Uniti, questo monopolio [delle competenze], che per altro
non è mai stato totale in un sistema di pesi e contrappesi, è stato distrutto dal
successo della policy analysis. In ogni parte del paese, nelle think tanks, nelle
società di consulenza, nelle scuole di policy analysis, negli esecutivi statali e
locali, negli staff parlamentari, dappertutto stanno squadre rivali di analisti
che sono appena stati, o che aspettano di entrare, nelle strutture di governo
[Wildavsky 1990, xv; v. anche Light 1995; Davis 1997]35.
I consulenti di formazione economica, con il loro ingresso in campo, provocano di fatto la crisi dell’ortodossia burocratica, ma ne conservano almeno il simulacro, riaffermando l’importanza della distinzione tra fini e mezzi, tra politica e amministrazione. Quelli che si ispirano alla policy inquiry fanno di più, perché rendono esplicite le conseguenze della sostituzione del concetto di amministrazione con quello
di policy. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, sono soprattut35
Per considerazioni analoghe, riferite al caso inglese, cfr. Weller et al. [1997].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
to le analisi dell’implementazione a sfondare definitivamente la traballante parete che separava i concetti di politica e di amministrazione:
[Nell’implementazione ] l’unico modo attraverso cui un comparto può
indurre gli altri a contribuire, fornendo gli elementi del programma, è attraverso l’uso della persuasione e della contrattazione. Qualcuno può chiamare
questo processo «politics». E di fatto lo è. Ma l’implementation politics è un
tipo particolare di politics. È una forma di politica in cui la salda esistenza di
un mandato di policy già definito, legalmente e legittimamente autorizzato in
qualche precedente processo politico (political), influenza la strategia e la tattica della lotta [Bardach 1979, 37].
Se da molte pagine siamo preparati a considerare l’implementazione come un’arena in cui i burocrati giocano le loro carte, accanto ad
altre categorie, le ricerche comparate portano alla luce una loro insospettata capacità di intervenire con efficacia lungo tutte le fasi del policy making. Come afferma Heclo, nello studio sulle politiche sociali in
Svezia e Gran Bretagna,
Se i partiti e i gruppi d’interesse hanno assunto occasionalmente ruoli
molto importanti, sono stati i funzionari pubblici a fornire le analisi più continuative e le revisioni opportune per gran parte delle linee di azione dei governi. Di norma, i partiti e i gruppi d’interesse richiedono, per aumentare il
loro impegno, stimoli straordinari, come un’impennata della disoccupazione,
mentre l’attenzione degli amministratori rimane relativamente forte attraverso
queste fluttuazioni [Heclo 1974, 301].
Soprattutto, le analisi descrittive portano alla luce la straordinaria
abilità di molte amministrazioni nell’assumere ruoli attivi nella mediazione tra gli interessi che gravitano intorno al loro settore:
I burocrati sono così efficaci nell’affrontare il management dei conflitti
che il termine «gruppo di pressione» è spesso fuorviante, dato che implica
che siano queste organizzazioni a esercitare la pressione. Chi ha osservato da
vicino l’interazione tra i funzionari governativi e i gruppi d’interesse, ha scoperto che i primi esercitano influenza almeno tanto quanto la subiscono
[Aberbach et al. 1981, 246].
Nel paragrafo precedente, abbiamo sottolineato come l’interscambio tra i funzionari delle agenzie regolative e le organizzazioni dei regolati – associazioni sindacali e imprenditoriali toccate dalle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, case farmaceutiche vincolate dai
protocolli sulla sperimentazione dei medicinali, ecc. – raggiunga tali
livelli di simbiosi da comportare, secondo autorevoli studiosi, la fine
della democrazia pluralista [Lowi 1969].
Se questo avviene ai piani alti dell’amministrazione , l’immagine
fornita dai ricercatori che scendono a studiare la burocrazia a livello di
strada rivela la capacità degli ultimi anelli della catena del comando di
337
338
CAPITOLO 5
impostare con notevole autonomia le relazioni con i destinatari finali,
per trarne elementi di forza da opporre alle direttive dei superiori gerarchici [Lipsky 1980]. Del resto, la loro opera spesso avviene in un
quadro normativo di difficile decifrazione: «Oggigiorno le leggi sono
così voluminose e cambiano così spesso che non sono capite dalla gente che le amministra, per non parlare della massa dei cittadini a cui
vanno applicate» [Derthick 1990, 225].
Ma l’aspetto che più colpisce in queste analisi è la tendenza dei
burocrati a occupare ruoli tradizionalmente riservati ai politici. Heclo,
nella sua ampia ricerca comparata, riscontra una loro significativa presenza persino nella fase in cui acquistano forma i frames destinati a
sorreggere le specifiche proposte di riforma sociale:
Un «problema» di policy può talvolta richiedere domande da parte del
pubblico e/o alternative contrastanti avanzate da partiti politici in competizione tra loro, e/o la definizione da parte di un gruppo di un suo interesse leso;
comunque sia, richiede sempre la concezione che la burocrazia di governo ha
di quel che è stato fatto [Heclo 1974, 303].
Con riferimento alla politica previdenziale degli Stati Uniti, altri
autori hanno messo in evidenza la capacità dei funzionari di interagire
direttamente con i membri del Congresso, arrivando a sfidarli sul loro
proprio terreno, quello dell’aggregazione del consenso intorno alle
proposte in agenda [Cobb, Ross e Ross 1976].
La presenza dei burocrati in stadi che, nei modelli più stilizzati sul
funzionamento del sistema politico, sono normalmente considerati di
pertinenza dei partiti, induce un osservatore partecipante a dare una
inedita lettura del ruolo dei programmi elettorali nelle democrazie:
«L’importanza dei programmi non sta nel persuadere gli elettori.
L’importanza dei programmi sta nel fatto di dare al politico un’ancora
quando i funzionari amministrativi cercano di non fargli mantenere la
parola data. Se un politico entra a Whitehall senza un programma, è
perduto» [Crossman36 1972, 24].
E tuttavia, definire il rapporto tra politici e burocrati come un gioco a somma zero sembra controproducente sul piano prescrittivo
[Lynn 1981] e semplicistico su quello descrittivo. Esistono infatti numerose situazioni in cui la coevoluzione e l’interdipendenza caratterizzano meglio questa relazione:
È nostra impressione che sia i politici sia i burocrati siano partecipanti
influenti all’evoluzione delle politiche svedesi. Al contrario, in Italia, né i
politici né i burocrati sembrano avere successo nella produzione di risposte di
policy adeguate alle molteplici sfide che il sistema deve fronteggiare. In generale, condividiamo l’idea di Heclo che considera i burocrati e i politici come
36
Ministro inglese dal 1964 al 1970.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
partecipanti interdipendenti al processo di policy, nel bene come nel male
[Aberbach et al. 1981, 251].
La pluralità dei ruoli ricoperti da una stessa categoria di attori, la
fragilità di giurisdizioni continuamente negoziate e ridefinite, la varietà
delle direzioni prese dall’esercizio dell’influenza, dall’alto, dal basso,
dai lati, sono tratti che disegnano una diversa mappa non solo dell’amministrazione, ma anche dell’intera sfera pubblica. A caratterizzarla
sono profonde spaccature che tendono a ricalcare gli irregolari confini
delle politiche pubbliche. Da una parte, la politica delle pari opportunità, con i suoi centri di interesse, il suo ministero, le sue amministrazioni, le sue associazioni di categoria, la sua stampa, la sua commissione parlamentare, i suoi interlocutori internazionali; dall’altra la politica
sportiva, con il suo proprio seguito di organizzazioni, associazioni,
agenzie, istituzioni, amministrazioni, singole personalità:
L’unità di analisi diventa [...] la policy stessa, uno spazio analitico al cui
interno, e solo al cui interno, è possibile ricostruire il network degli attori
rilevanti, le loro reciproche relazioni, e in definitiva gli esiti stessi della politica, con ciò intendendo le modificazioni della realtà esterna che vengono da
essa generate [Dente 1985, 267].
Questi sottogoverni37 che coinvolgono burocrati, rappresentanti degli
interessi, esperti e, occasionalmente, i politici, sono di norma decisamente
segmentati per aree funzionali – politica agricola, sanità, e così via [Aberbach
et al. 1981, 247].
Sottogoverni, sottosistemi di policy, arene, reti, sono i termini più
usati per identificare gli insiemi di attori che una politica pubblica tiene aggregati all’interno, e disgiunti dall’esterno. Frammentazione, pluralità, segmentazione, sono gli effetti che non faticano a prevalere sulle
immagini del settore pubblico basate sull’omogeneità e l’organicità
[Barzelay 1992].
Amministrare è fare politiche? Se politica (politics) e amministrazione non possono essere separate nella pratica, e se molte delle rispettive
prerogative non lo possono nemmeno nella teoria, per diversi autori è
ormai giunto il momento di abbattere un altro muro, quello tra policy
e amministrazione, che ai loro occhi sembra sostenuto più da logiche
accademiche che da elementi analitici:
Se le politiche sono definite come ciò che viene effettivamente fatto, e
non soltanto detto o auspicato, allora nella pratica è impossibile separare la
politica (policy) dall’amministrazione [Kaufman 1977, 400].
37 Il significato di questo termine è qui notevolmente diverso dall’uso italiano,
come vedremo tra breve.
339
340
CAPITOLO 5
Un’altra implicazione [...] è che le politiche non sono solo un affare dei
responsabili politici di alto livello. Il policy making non è un’attività separata
dall’amministrazione o dall’implementazione [Lynn 1981, 156].
Tutti questi uomini (e solo di uomini si tratta) sono qui come policy
makers, e tutti accettano che i funzionari amministrativi siano legittimi partecipanti al processo di policy [Aberbach et al. 1981, 241].
Se lo Stato è disarticolato, se in concreto è tanto difficile dedurre
le funzioni effettivamente svolte dai ruoli formalmente ricoperti, le
politiche sembrano rappresentare l’unico elemento di coagulazione
capace di ridare un qualche senso, sia pure precario, alle svariate attività che pullulano nella sfera pubblica [Wilson 1989].
Nel primo capitolo abbiamo sottolineato con forza la distanza analitica che separa il concetto di policy da quello di amministrazione.
Dunque, un ripensamento? No: il fatto è che il primo, grazie al suo
imprinting pragmatico e pluralista, riesce facilmente ad adattarsi all’evoluzione teorica e alle evidenze empiriche emerse dall’interno della
scienza politica americana nell’ultimo cinquantennio, mentre in questo
contesto il secondo non riesce a giustificare la sua specificità e la sua
rilevanza. Insomma, quello che abbiamo chiamato il concetto radicale
di politica pubblica, prima o poi si mangia quello di amministrazione,
che come il primo ha una duplice valenza, descrittiva e prescrittiva,
come il primo fa riferimento tanto a una disciplina, quanto a un’attività, ma che, a differenza del primo, subisce, anziché promuovere, quella «perdita dello stato solido» in atto in una parte importante delle
teorie della sfera pubblica.
Comunque, il percorso intellettuale che porta l’amministrazione a
finire sotto l’accogliente ma esigente ombrello dei policy studies è più
accidentato di quello seguito dalle altre categorie di attori. Mentre partiti e organizzazioni degli interessi prestano in genere poca attenzione a
come le scienze sociali li definiscono e a dove li collocano, quello tra
public management, politiche pubbliche, pubblica amministrazione è un
confine molto caldo, piantonato dal diritto e dalla giustizia amministrativa, ma anche dalle discipline accademiche, dalle società di consulenza,
dalle associazioni professionali, dalle scuole di formazione. E gli stessi
funzionari sono costantemente tenuti a esercitare una qualche forma di
riflessività, per capire se sono dentro o fuori i confini loro assegnati.
Questo spiega il lungo travaglio che ha portato al distacco di molti studiosi di pubblica amministrazione dall’APSA, tra il 1970 e il 1983 [Henry 1990]: la motivazione è l’accusa alla scienza politica di fagocitare la
peculiarità della funzione amministrativa, ponendola sotto l’onnivora
etichetta di public policy. La «scuola politica» avrebbe infatti portato a
una rappresentazione della burocrazia tutta sbilanciata sul lato della
pluralità dei fini e dei conflitti d’interesse. Questa impostazione finisce
col richiedere alle amministrazioni compiti che non sono i loro:
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
In un assetto istituzionale con queste caratteristiche, ci sono molte probabilità che le cose prendano una brutta piega per la pubblica amministrazione.
Tutto ciò che emerge come policy dalle disposizioni normative ha un’ambiguità in genere basata su contrattazioni e compromessi. Al massimo, le norme
definiscono un intento, danno all’agenzia la direzione, ma è l’agenzia che
deve esporsi, a suo rischio e pericolo [Derthick 1990, 180].
Per diversi anni, l’incomunicabilità tra chi studiava l’amministrazione all’interno dell’approccio politico, e chi invece ne rifiutava i presupposti, è stata totale. In quegli stessi anni, del resto, per i sostenitori della
specificità della funzione burocratica, alle minacce teoretiche si aggiungevano preoccupazioni più mondane: soprattutto in Gran Bretagna e
negli Stati Uniti, infatti, il loro oggetto di studio tendeva ad assottigliarsi
sempre di più, per il sistematico spostamento della produzione di beni
e servizi a imprese operanti secondo logiche di mercato [Rhodes 1994;
Foster e Plowden 1996]. A torto o a ragione, molti studiosi individuavano nei paradigmi prevalenti nella scienza politica i maggiori responsabili di questo «svuotamento dall’interno» dei concetti – e dei budget –
di Stato e di amministrazione [Weller et al. 1997; Davis 1997]. A queste
teorie, nella loro versione induttiva e deduttiva, veniva infatti imputata
la colpa di avere buttato a mare i concetti di disinteresse, di dedizione
all’ufficio, di lealtà alla norma, contribuendo ad alimentare la diffidenza
dell’opinione pubblica per tutto ciò che è istituzionale.
Quando, negli anni ’90, il dialogo sembra riprendere [Lynn e Wildavsky 1990; Frederickson 1997], quando questo campo disciplinare
torna a fare la sua comparsa ufficiale all’APSA [Frederickson 1999],
quella che riemerge è una scienza dell’amministrazione che ha imparato la lezione della frammentazione, dei networks, del caos e della disarticolazione dello Stato, e che si candida a dare un senso a tutto
questo, e a governarlo38:
Le teorie e i concetti dello scontro tra interessi, della competizione elettorale e tra gruppi d’interesse, dei giochi, con vincitori e perdenti, hanno
dominato e continuano a dominare la scienza politica. La scienza dell’amministrazione si sta allontanando con decisione da queste teorie e concetti, per
andare verso le teorie della cooperazione, della costruzione delle reti, della
governance, della costruzione e manutenzione delle istituzioni [...]. Insomma,
la scienza dell’amministrazione è cambiata a tal punto da trovare una nuova
collocazione nella scienza politica. Nei termini più semplici, le [nuove] ipotesi
sostengono che la pubblica amministrazione è naturalmente inter-giurisdizionale, organizzata per reti, e a suo agio nel nuovo mondo della governance. Per
come è praticata nelle nostre tradizionali istituzioni democratiche, è la politica
(politics) a essere profondamente basata sulle giurisdizioni e confinata in esse.
In queste nicchie di giurisdizioni, la politica è competitiva e preoccupata per
38
[1985].
Un’anticipazione di questo approccio può essere trovata in Italia in Dente
341
342
CAPITOLO 5
la vicinanza dello scontro tra interessi, con vincitori e perdenti. Dunque, è la
pubblica amministrazione ad assumere il ruolo della politica (politics) nell’adattamento delle istituzioni pubbliche all’elevata frammentazione e alla
disarticolazione dello Stato [Frederickson 1999, 710].
L’ambizioso tentativo di reintrodurre coerenza e coordinamento in
attività di governo che lo studio del policy making descrive come frantumate da crepe profonde e irregolari, si sovrappone ampiamente con
il progetto che in più punti del nostro percorso abbiamo identificato
con il termine governance. A caratterizzarne il profilo, è la rielaborazione di concetti quali istituzione, network, sistema, per sfruttarne le
valenze insieme esplicative e prescrittive; l’obiettivo è il potenziamento
della capacità di indirizzo e controllo della complessità nelle democrazie contemporanee [Rhodes 1997; Agranoff e McGuire 1998]. Ma
proseguire lungo questa strada ci allontanerebbe non solo dalla colonna dei contributi descrittivi, ma dallo stesso piano a.
4.2.2. Modelli basati sulla relazione
I modelli di cui ci occuperemo ora preferiscono rimanere ancorati
a un’evidenza empirica che parla un linguaggio un po’ diverso:
È improbabile, se non impossibile, che una politica pubblica di qualche
significato possa derivare dal processo di scelta di una singola categoria di
attori. La formazione e l’implementazione delle politiche sono inevitabilmente
il risultato di interazioni tra una pluralità di attori separati, con i loro separati
interessi, obiettivi, strategie [Scharpf 1978, 347].
Dunque, se le ripartizioni tradizionali della scienza politica e della
sociologia politica ci danno rappresentazioni delle varie categorie di
attori per quadri distinti gli uni dagli altri – i partiti, i gruppi d’interesse, la burocrazia, ecc. –, le metafore basate sulla relazione sottolineano
invece le interazioni, la coevoluzione, la bidirezionalità di tutti i flussi
di influenza [Ripley e Franklin 1984; Hamm 1986].
I triangoli di ferro
La metafora dei triangoli di ferro rappresenta il primo tentativo di
dare contorni e logiche di funzionamento più precisi alle arene (o sottosistemi, o sottogoverni) di policy. Questa immagine, elaborata con
riferimento al policy making americano, si propone di dare conto della
fitta rete di contatti che normalmente si consolidano tra la commissione parlamentare con specifiche competenze in un dato settore, i dirigenti burocratici responsabili della stessa area e le organizzazioni che
rappresentano gli interessi che gravitano intorno ad essa.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
[I triangoli di ferro] si presentano così perché ognuno include persone
che provengono da una commissione o sottocommissione parlamentare, da
un comparto dell’amministrazione e dai responsabili del lobbying delle organizzazioni degli interessi o di altri gruppi. A spingere i tre lati di ciascun
triangolo a interagire, apertamente o dietro la scena politica, è la comune
preoccupazione per la legislazione o l’amministrazione di qualche aspetto
dell’attività politica, quale l’ammontare delle agevolazioni per il cotone o le
tariffe dell’acciaio importato. Le informazioni su questioni di questo tipo
sono in genere così scarse e oscure che gli altri attori sono incapaci di partecipare a queste discussioni e negoziazioni triangolari [Ricci 1993, 8].
All’origine di questa definizione sta un’osservazione di Griffith
[1939], giustamente considerata fondamentale da molti autori [Freeman 1965; Jordan 1990b]: «La relazione tra queste persone – legislatori, amministratori, lobbisti, studiosi – che sono interessate ad un comune problema, è una relazione molto più reale di quella tra parlamentari in generale o tra amministratori in generale» [1939, 182].
Il tipo di relazioni che si consolidano tra queste tre categorie di
attori non implica scambi di risorse politicamente cruciali, come nel
modello neocorporativo, ma piuttosto l’instaurarsi di una serie di attenzioni e di favori di mutua convenienza [Cater 1964]. Infatti, dalle
ricerche condotte negli Stati Uniti, risulta che i responsabili amministrativi sono particolarmente attenti a una tempestiva implementazione
delle misure che pensano avvantaggiare l’elettorato di riferimento dei
parlamentari membri delle commissioni competenti per il loro settore.
Dalle scelte di questi ultimi, infatti, dipendono l’ammontare delle risorse e l’estensione delle competenze che essi sono chiamati a gestire
[McCormick e Tollison 1981]. Soprattutto al momento dell’approvazione delle leggi finanziarie, diventa fondamentale l’aggressività e la
compattezza dei parlamentari nel rivendicare più stanziamenti per il
loro settore, esibendo statistiche da cui risultano penalizzazioni, e minacciando crisi catastrofiche o sollevazioni popolari.
A loro volta, i parlamentari tendono a produrre una legislazione
favorevole a quelle organizzazioni degli interessi che possono ricambiare l’attenzione finanziando le loro campagne elettorali, o comunque
influenzando consistenti pacchetti di voti. Per un politico, il problema
fondamentale è quello di far arrivare il suo messaggio a un target mirato, perché stringere le mani nei supermercati serve a poco, soprattutto se sono in molti a farlo. Le associazioni degli stakeholders svolgono
un ruolo molto importante perché, ospitando un’intervista sulla loro
stampa o organizzando un convegno, possono far arrivare le informazioni su una proposta di legge proprio agli orecchi più attenti e ricettivi. Ma i rappresentanti di queste associazioni mirano ad intrattenere
buoni rapporti anche con l’amministrazione, garantendo ai suoi funzionari sia cooperazione nella fase di implementazione, sia beni più
privati, quali la possibilità di lucrose consulenze o di prestigiosi incarichi a fine carriera, in cambio di informazioni «in anteprima» sui de-
343
344
CAPITOLO 5
creti attuativi, sulle procedure per ottenere finanziamenti, su tutti i
particolari che agevolano l’accesso dei loro aderenti ai benefici previsti
dalle misure legislative.
In alcuni casi, la cooperazione informale può trasformarsi nella delega formale di vere e proprie funzioni governative alle organizzazioni
degli interessi, come dimostrano i casi di autoregolazione dell’accesso
alle professioni liberali, di accoglimento delle pratiche previdenziali, di
sponsorship nel settore dei beni culturali, di joint venture per il risanamento di aree urbane [Salisbury 1968]. Il termine «porta girevole»
intende sottolineare un fenomeno che spesso fa da corollario a questa
unità di intenti: la ricomparsa delle stesse persone con ruoli diversi in
uno stesso settore del policy making; oggi parlamentare, domani consulente di una associazione di categoria, dopodomani coordinatore di
una task force ministeriale [Heclo 1978].
La disarticolazione organizzativa dei grandi attori
A partire dagli anni ’70, la metafora dei triangoli di ferro è sfidata
da rappresentazioni del policy making caratterizzate da quattro elementi:
• l’attenzione per le articolazioni organizzative interne delle grandi
categorie di attori;
• l’allargamento del ventaglio dei policy maker significativi;
• l’attenzione a forme di interazione diverse dalla pressione o dal- lo
scambio di favori;
• il ricorso a figure non chiuse come i triangoli, bensì aperte come
le reti.
Partiamo dal primo aspetto. Il nuovo problema di ricerca può essere riassunto in questi termini: che cosa succede ai partiti, alle grandi
organizzazioni degli interessi, alle burocrazie, quando devono uscire
dalle loro sedi per incontrarsi, per contrattare l’indirizzo da imprimere
a una politica pubblica? Una prima risposta è già stata data dal paragrafo precedente: si frammentano, secondo linee che grosso modo ricalcano le diverse politiche. Le ricerche che approfondiscono le concrete modalità di interazione tra queste diverse categorie danno nel
complesso un’immagine basata su una grande e profonda disarticolazione organizzativa.
Heinz, Laumann, Nelson e Salisbury [1993], al termine di una gigantesca ricerca sulle organizzazioni degli interessi nel policy making
americano, concludono che il loro nucleo è vuoto, eroso dalla necessità delle singole branche di ritagliarsi spazi di autonomia per aderire
alla particolare configurazione delle diverse arene di policy. Con la
parziale eccezione dei sindacati, nelle altre associazioni il capitale che
può essere speso nelle contrattazioni di policy difficilmente è fornito
dal fatto di avere alle spalle un gigante come un cartello di produttori
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
o un’associazione di consumatori: la sua accumulazione dipende invece «da chi si conosce e da che cosa si conosce». Con questa espressione viene sottolineata l’importanza di due serie di fattori: i legami personali stretti durante anni di frequentazione delle commissioni parlamentari, dei ministeri, delle altre organizzazioni di stakeholders, e la
competenza tecnica circa i risvolti giuridici, procedurali, finanziari,
sociali e politici delle issues in discussione [Heinz et al. 1993].
Le ricerche condotte in Italia, pur con risorse di gran lunga inferiori, dimostrano che radicali processi di disarticolazione sono all’opera anche nei partiti politici, soprattutto nella fase del loro massimo
splendore come policy makers, durante gli anni ’80 [Cotta e Isernia
1996; Dente e Regonini 1987].
Nuove categorie
Il secondo contributo degli studi policy oriented riguarda l’allargamento delle categorie cui guardare per capire per quali mani e per
quali menti passano le politiche:
Nei casi che abbiamo esaminato, compaiono quali policy makers non solo
i politici eletti e i dirigenti delle agenzie pubbliche, ma anche i delegati dei
gruppi di interesse, i giudici, i rappresentanti di tutti quelli che hanno poste
in gioco, come i funzionari sindacali o i vertici delle associazioni professionali
dei manager. Inoltre, i casi studiati portano a includere anche istituzioni non
governative, come il MIT39 [Schön e Rein 1994, 190].
I magistrati. Dalla costituzione e dalla storia degli Stati Uniti ci
viene il diretto suggerimento di un nuova categoria da aggiungere alla
nostra lista: quella dei magistrati. Fiorina, nella sua analisi delle forze
che impediscono ai partiti americani di esercitare un qualche primato,
cita al primo posto la magistratura. «La magistratura è senza dubbio
un antagonista del governo di partito più importante negli Stati Uniti
che in Europa e, probabilmente che in qualunque altro posto al mondo» [Fiorina 1987, 286].
L’eccezionalità del caso americano è ammessa da tutti gli osservatori [Canon 1991]. Alla sua origine stanno, come è noto, un impianto
istituzionale basato sulla separazione e sulla uguale dignità dei poteri,
e una dottrina del diritto che assegna un grande valore alle singole
sentenze, che vanno a costituire dei precedenti cui ispirarsi. Ma dal
nostro punto di vista è importante sottolineare il ruolo giocato da una
cultura giuridica in cui il pragmatismo di John Dewey ha trovato più
di qualche sparso estimatore40. L’esercizio della giustizia è pertanto
39
Massachusetts Institute of Technology, una delle principali università americane.
Un ruolo molto importante nell’impostazione di quella che venne chiamata
«giurisprudenza sociologica» fu svolto da Roscoe Pound, preside della prestigiosa
Harvard Law School dal 1916 al 1936 [Heineman et al. 1990, 143].
40
345
346
CAPITOLO 5
concepito non come applicazione di principi, ma come attiva ricognizione delle condizioni che marcano il confine tra una situazione socialmente accettabile e una che non lo è: «Il giudizio finale non intende
suggerire che tutto quel che vale la pena di dire è stato detto, ma solo
che è meglio, tutto considerato, non dire nient’altro per qualche tempo» [Ackerman 1984, 41].
Sulla base di questa impostazione, un ruolo attivo nell’interpretazione e persino nell’integrazione della legge, quando questa risulta
palesemente inadeguata, può diventare non solo inevitabile, ma anche
doveroso:
I giudici americani sono spesso nella posizione di un comandante di plotone. I comandi che arrivano dal potere legislativo non sono chiari, e i giudici
non possono chiedere chiarimenti ai legislatori. In questa situazione, i giudici
non possono considerarsi come archeologi falliti o antiquari41 . Loro sono
parte di un’impresa vitale – l’impresa di governare gli Stati Uniti – e quando
gli ordini dei loro superiori non sono chiari, ciò non li esime dalla responsabilità di dare un aiuto perché l’impresa abbia successo [Posner 1993, 105].
In effetti, almeno dal 1954, cioè da quando una sentenza della
Corte Suprema, nel famoso procedimento Brown v. Board of Education, diede inizio alla desegregazione razziale nelle scuole, le politiche
avviate o reindirizzate dalle decisioni della magistratura sono molte42.
Rimarcare questa influenza può sembrare in contrasto con la differenza tra politiche e leggi, che abbiamo sottolineato con forza nel primo
capitolo. Se questo è vero in generale, è anche vero che esistono settori di policy in cui le risorse pubbliche sono costituite prevalentemente
dalle norme e dalla loro interpretazione. Più precisamente, tre arene
sono particolarmente sensibili alle decisioni prese dai magistrati:
• le politiche a difesa della libertà di parola e delle altre libertà
civili e politiche;
• le politiche sociali, e più precisamente le iniziative che tendono
a ridurre con azioni positive le differenze di opportunità tra gruppi di
cittadini, come nel caso della sentenza del 1954;
• le politiche regolative, che vincolano la libertà di comportamento degli individui e delle imprese per tutelare beni pubblici quali la
qualità dell’aria, la competizione nei mercati, la sicurezza delle strade,
l’igiene degli alimenti.
Proprio su quest’ultimo gruppo di politiche si riversa la grande
maggioranza dell’attività giudiziaria significativa per il policy making
[Wilson 1980]. Infatti a partire dagli anni ’30, cioè da quando il go-
41
Cioè cercare di ricostruire le originali intenzioni del legislatore.
Questo ruolo è stato prontamente colto da Robert Dahl, in un famoso articolo
dal titolo Decision-making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policymaker [1957].
42
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
verno americano scelse di ricorrere ad agenzie regolative indipendenti
dall’amministrazione per garantire il controllo dei mercati dei capitali,
l’implementazione delle politiche regolative è spesso condizionata da
una selva di cause e di ricorsi, che ormai fanno dell’avvocato una figura chiave delle organizzazioni degli interessi di ogni tipo, economici e
non [Heinz et al. 1993]43. In molti casi, infatti, i magistrati diventano
l’ancora di salvataggio dopo un lobbying parlamentare finito male
[McCann 1992].
Questa tendenza suscita contrastanti valutazioni sul piano prescrittivo. Se alcuni autori vi scorgono i segni di quella democrazia giuridica
auspicata da Lowi [1969] come antidoto alla eccessiva discrezionalità
delle contrattazioni dirette tra i dirigenti delle agenzie e le grandi organizzazioni degli interessi, altri rimarcano i limiti di decisioni che sono
pur sempre prese nella logica del caso singolo, e che mancano della
legittimazione politica e del supporto tecnico per rappresentare vere
svolte di carattere generale [Rosenberg 1991; Jackson e Tate 1992].
Nella valutazione dell’influenza che la magistratura esercita sul
policy making, sarebbe comunque riduttivo fermarsi alla fase dell’implementazione, perché le sentenze sono anche una straordinaria leva
per condizionare l’agenda pubblica [Perry 1992; Flemming et al.
1997]. Infatti le corti godono di un’amplissima discrezionalità nella
scelta dei criteri per definire le priorità nell’esame dei singoli casi, cioè
per selezionare, tra le migliaia di apparenti difformità tra le pratiche e
le norme, quelle meritevoli di immediata considerazione. Soprattutto
quando sono in gioco sentenze delle corti costituzionali, questa libertà
può condizionare notevolmente l’agenda dei legislatori, costringendoli
a «correre ai ripari» con nuove leggi.
In Italia, le iniziative giudiziarie contro la corruzione, all’inizio
degli anni ’90, hanno reso evidente anche al grande pubblico il ruolo
che la magistratura può giocare rispetto alla politics [Guarnieri e Pederzoli 1997; Morisi 1999]. Meno note sono le modalità di intervento
rispetto al policy making. Eppure, in molti settori le inchieste e le sentenze dei tribunali hanno profondamente condizionato il corso di alcune politiche, soprattutto negli anni ’70. Basti pensare allo spazio occupato dalla magistratura del lavoro nelle relazioni industriali e nelle
politiche dell’occupazione, alle inchieste-battistrada di alcune procure
contro i reati ambientali, o alle indagini sulle pensioni di invalidità
abusive in alcune città del sud. E tuttavia la crisi organizzativa della
macchina della giustizia, con i suoi tempi lunghi e la sua scarsa specializzazione, tende oggi a ridurre l’incisività delle sue decisioni nel campo delle politiche pubbliche.
43 Negli anni ’90, l’agenzia per la protezione dell’ambiente stimava in circa l’80%
la quota delle sue disposizioni contestate in tribunale. Per contrastare questa tendenza,
nel 1990 è stato approvato il Negotiated Rulemaking Act, cui si è accennato nelle note
precedenti.
347
348
CAPITOLO 5
I media. Che giornali e televisioni siano canali di comunicazione
importanti per le idee che danno forma alle proposte di policy, è dato
per scontato dalla grande maggioranza delle ricerche. Che siano in
grado di intervenire autonomamente nel policy making, è invece questione più controversa. Per dare voce alle diverse ipotesi, conviene
scomporre il problema nei suoi diversi aspetti.
La prima questione è: sono i media in grado di condizionare
l’agenda delle istituzioni pubbliche, inducendole a prendere decisioni
su temi che altrimenti avrebbero ignorato? Rispetto a questo punto, si
fronteggiano due scuole di pensiero. Per la prima, la risposta è sicuramente affermativa: i media sono «la quarta branca del governo» [Cater 1959]; considerati nel loro insieme, sono una vera e propria istituzione politica [Cook 1998]. Contro queste affermazioni, stanno altre
evidenze empiriche, che indicano una loro debole influenza: «Nonostante i buoni motivi per ritenere che i media abbiano un impatto notevole sull’agenda del governo, i nostri indicatori standard danno risultati deludenti. I mass media sono considerati importanti solo nel 26%
delle interviste, molto al di sotto dei gruppi d’interesse (84%) o dei ricercatori (66%)» [Kingdon 1984, 61]. A risultati analoghi giunge la
ricerca di Light [1982] sulle fonti cui si rifanno i componenti dello
staff dei presidenti degli Stati Uniti nel determinare l’agenda del governo.
Se l’ipotesi del condizionamento presenta alcune lacune, una lettura delle interazioni tra politici e media basata invece sulla mutua convenienza a sostenersi reciprocamente coglie una parte importante della
relazione:
I giornalisti devono trasmettere i loro articoli per riempire i giornali, e
quelli di Washington vogliono diffondere informazioni che favoriscano i loro
fini. I due interessi vanno insieme, al punto che la maggior parte delle notizie
nazionali è basata su riunioni ufficiali, audizioni, conferenze stampa, comunicati e discorsi formali, sicché l’informazione passata apertamente alla stampa
è autorevole, ma anche, in larga misura, conveniente per chi la passa [...]. Il
risultato è che le notizie e i commenti su queste fonti di informazione sono
diventate un fattore importante nella vita di Washington. In città tutti sanno
che tutti consultano i media per tenere il conto di chi ha fatto che cosa a chi
[Ricci 1993, 99 e 138].
Il secondo problema ha a che fare non con i temi da sospingere in
agenda, ma con le soluzioni da sostenere: i media praticano una sistematica distorsione del dibattito a favore di alcune proposte e contro
altre? E, nel caso di una risposta affermativa, quali interessi è possibile
leggere in trasparenza nelle notizie di un giornale o di una televisione?
Quelli dei loro proprietari? Quelli dei gruppi influenti nella società?
[Kollman 1998]. Se si fa presto a dire che l’informazione è di parte,
dimostrarlo con dati alla mano non è facile. Oggi l’analisi del testo
dispone di grandi risorse metodologiche e computazionali: ma la di-
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
stanza tra la rozzezza dei dati necessari per dimostrare la tesi della distorsione e la sofisticata abilità di un bravo giornalista è ancora in larga parte incolmata.
Il terzo problema è anche il più spinoso: i media sono in grado di
strutturare la percezione che i cittadini hanno dei problemi e di influenzare le domande che rivolgono alle istituzioni? La risposta a questa domanda risente di tutte le incertezze che caratterizzano decenni di
ricerche su due grandi temi della scienza politica e della sociologia. Il
primo riguarda la forza del condizionamento esercitato dai media sulle
scelte di voto; il secondo riguarda un argomento che sarà ripreso tra
poche righe: il rapporto tra l’informazione e il peso di un’opinione
pubblica autonoma e competente [Page 1996; Sartori 1999]. Nel caso
delle politiche pubbliche, un lume proviene dalle ricerche che collegano la maggiore o minore incisività dell’orientamento assunto dai media
alle specifiche caratteristiche delle issues in discussione. I loro risultati
ci dicono che, in generale, la diretta esperienza di un problema di
policy costituisce un potente antidoto al condizionamento da parte
degli organi di informazione, perché per prima cosa la gente «si guarda attorno e valuta le notizie alla luce di quello che già sa, e stabilisce
se combaciano con la realtà di cui ha avuto esperienza, direttamente o
indirettamente» [Graber 1988, 93]. Anche i temi con una forte carica
emotiva risultano relativamente impermeabili, mentre gli opinionisti
possono risultare più convincenti quando sono in gioco problemi
complessi, con molteplici valenze, colte solo dagli esperti.
Oltre che dalle caratteristiche delle issues, il potere di persuasione
dei media dipende dalle fonti privilegiate da chi è esposto ai loro
messaggi: su temi quali l’aborto o l’istruzione dei figli, la famiglia, la
cerchia degli amici, le associazioni culturali, le chiese sono infatti
identificate come testimoni più affidabili da una larga parte della popolazione.
I cittadini. Come abbiamo più volte sottolineato, una delle implicazioni normative collegate all’uso del concetto di politica pubblica riguarda proprio il riconoscimento del ruolo che i cittadini possono assumere nell’indirizzo e nel controllo delle specifiche iniziative dei governi, perché tutti, prima o poi, finiamo con l’esserne coinvolti: «A un
qualche stadio del ciclo della vita, è probabile che tutti vengano a dipendere dall’istruzione pubblica, dalla sanità, dalla previdenza sociale
o da altri servizi pubblici» [Rose 1989, 7]. A dipendere, o a contare?
1. L’opinione pubblica. Il più importante concetto formulato dalla
teoria politica europea per il controllo in itinere dell’operato dei governi è quello di opinione pubblica, che implica la capacità di una
società civile attenta e ben informata di esercitare una costante vigilanza critica sulle decisioni dell’autorità politica [Habermas 1969]. Negli
anni ’20, dopo i primi segni delle tendenze plebiscitarie manifestatesi
in Europa, e dopo la dimostrazione che negli Stati Uniti stampa e ra-
349
350
CAPITOLO 5
dio davano del loro potere, Walter Lippmann, con due testi [1922;
1925] destinati a suscitare un vasto dibattito, manifesta un totale scetticismo verso la sopravvivenza di un’opinione pubblica attenta, autonoma e autorevole nelle società di massa44. Soltanto qualche anno
dopo, il concetto di opinione pubblica ricompare nelle scienze sociali americane, privato di qualunque riferimento a un’elaborazione critica collettiva, e riferito invece alla somma dei pareri individualmente
espressi da campioni rappresentativi della popolazione nelle grandi
indagini demoscopiche di ispirazione comportamentalista.
A questo punto, l’agenda di ricerca cambia completamente. A essere portate in primo piano sono questioni del tipo:
• che cosa sanno davvero i cittadini dell’operato dei governi?
• la loro ignoranza è un bene o un male per la democrazia?
• le loro opinioni sono in accordo o in contrasto con le scelte
delle istituzioni politiche?
• che cosa viene prima, l’uovo dell’opinione dell’uomo della strada, o la gallina della legittimazione che delle loro decisioni danno i
governi?
Se la seconda domanda ha implicazioni normative che qui non
possiamo affrontare, le risposte agli altri quesiti sono sufficientemente
convergenti da consentire una drastica sintesi. Per quanto riguarda
l’informazione, i risultati in genere sottolineano una drammatica incompetenza anche sui temi più «caldi»: «Di sicuro, il dato che emerge
più comunemente dalle indagini a campione in tutti i paesi è che il
livello di informazione popolare sulle questioni pubbliche è, dal punto
di vista di un osservatore informato, incredibilmente basso» [Converse
1975, 79]45.
La risposta alla domanda circa la congruità tra le opinioni dei cittadini e le scelte delle istituzioni è invece, e forse altrettanto sorprendentemente, decisamente ottimista46. Questa sintonia trova conferma
sia nei dati aggregati, sia nella relazione diadica tra il singolo parlamentare e il suo collegio elettorale. Inoltre, le ricerche longitudinali su
un significativo arco temporale hanno dimostrato che cambiamenti
importanti dell’opinione pubblica in genere precedono, anziché seguire, la definitiva approvazione delle corrispondenti misure di policy
[Page e Shapiro 1992].
Più complicata è invece la questione circa la direzione del flusso
dell’influenza che produce questo accordo. Le indagini sottolineano
44 In risposta a queste tesi, John Dewey scrive nel 1927 The Public and Its Problems, che contiene un concetto completamente diverso di pubblico, cui abbiamo accennato nel primo capitolo.
45 Da un’indagine svolta da Renato Mannheimer a ridosso dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, risulta che metà degli intervistati non
si sono accorti della sua esistenza («Corriere della Sera», 10 novembre 1997).
46 Per una rassegna della letteratura, v. Jacobs e Shapiro [1994].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
infatti che sarebbe ingenuo dedurre da questi dati un qualche rapporto di causa-effetto che faccia dei cambiamenti nell’opinione pubblica il
motore immobile delle svolte impresse alle politiche pubbliche. Anche
in questo caso, il termine coevoluzione descrive meglio la complessità
della relazione. In primo luogo, gli elettori, più che scegliere i partiti
in base alle loro piattaforme programmatiche, tendono ad attribuire ai
partiti per cui hanno votano le loro proprie preferenze di policy. In
secondo luogo, i politici non sono meri barometri del favore popolare,
ma cercano di modificare gli orientamenti dei cittadini con una vasta
serie di strumenti, che vanno dal lancio di campagne di stampa, all’impiego degli attivisti di partito e delle associazioni degli interessi. Questo flusso di influenza «dal politico al cittadino» è stato approfondito
soprattutto con riferimento al ruolo dei discorsi dei presidenti degli
Stati Uniti. Il quadro che esce da queste ricerche colloca la forte sintonia tra il presidente e l’opinione pubblica in un gioco a tre, in cui lo
staff presidenziale si propone di sensibilizzare la cittadinanza per restringere i margini di manovra del Congresso [Cohen 1995]. L’accordo che alla fine risulta esistere tra opinione pubblica e scelte di policy
appare dunque più complicato di una mera dimostrazione di sensibilità democratica da parte dei leader politici.
2. I sostenitori di interessi pubblici. Dalla sua nascita, la democrazia americana ha attirato l’attenzione degli osservatori per la capacità
dei suoi cittadini di autorganizzarsi per il raggiungimento di obiettivi
metaindividuali, siano questi la tutela della libertà di parola, o lo spostamento di una fermata dell’autobus. In genere, con il termine «movimento sociale» si fa riferimento alla difesa attiva di interessi in grado
di toccare larghissime fasce della popolazione: quelli delle donne, dei
consumatori, degli abitanti dell’ecosfera. Un «gruppo d’interesse pubblico» è invece un’organizzazione nata per tutelare specifiche esigenze,
non tenute in adeguata considerazione dalle politiche in atto: la difesa
dal rumore di un aeroporto, l’allontanamento degli spacciatori da un
parco, la migliore pulizia di una strada.
Le ricerche condotte negli Stati Uniti registrano concordi una notevole crescita dei gruppi d’interesse pubblico negli ultimi decenni:
«Oltre la metà dei gruppi di cittadini sono stati creati negli ultimi venticinque anni, con uno spettacolare incremento che ha cambiato la
natura della politica (politics) dei gruppi d’interesse in America. Le
organizzazioni del settore economico non mostrano una simile impennata» [Walker 1991, 34].
Se la mobilitazione dell’opinione pubblica su problemi generali incontra tutte le contraddizioni che abbiamo appena evidenziato, la specifica focalizzazione dell’attenzione su precise decisioni da sostenere o
da contrastare ha più probabilità di rivelarsi efficace [Berry 1989].
Tra le variabili che condizionano l’incisività di queste azioni dal
basso, un ruolo decisivo è giocato dalla capacità di curare la comunicazione con i media: «I sostenitori di interessi pubblici che sono sen-
351
352
CAPITOLO 5
sibili sia alle esigenze operative e alle pratiche nel repertorio della
stampa, sia alla necessità di rendere i loro problemi comprensibili e
rilevanti per il pubblico, possono vincere l’inerzia implicita nel processo di policy e ottenere un sensibile cambiamento nelle politiche»
[Cobb e Elder 1981, 411].
Al limite, anche la fama di «cliente intrattabile» [Hargrove e Glidewell 1990], affibbiata a gruppi di destinatari particolarmente esigenti, può diventare una risorsa efficace per ottenere dai responsabili
politici e amministrativi un trattamento di riguardo.
3. I net-attivisti. Negli ultimi dieci anni, il modo di far valere interessi pubblici è radicalmente cambiato per effetto di Internet e
delle straordinarie risorse tecnologiche disponibili a costi vicini allo
zero, quali siti web, posta elettronica, software per la gestione a distanza di gruppi di lavoro, per il coordinamento delle agende e la
condivisione di bookmarks, dati e documenti [Bimber 1998; Davis e
Owen 1998].
Come sottolinea Russell Neuman, le interpretazioni sugli effetti
sociali di Internet coprono tutta la gamma dall’utopia alla distopia47.
Dal punto di vista dell’influenza sul policy making, due fattori hanno
svolto un ruolo cruciale nel determinare la crescita esponenziale di
queste forme di attivismo. Innanzi tutto, il crollo dei costi del coordinamento interno, del proselitismo e della pressione verso l’esterno, in
termini di personale, di tempo, di denaro, costituisce sicuramente il
fattore più importante della straordinaria crescita delle iniziative per la
difesa di interessi metaindividuali. In secondo luogo, la rete come
struttura fisica e la rete come metafora dei rapporti nelle arene di policy crescono insieme e si sostengono a vicenda [Taylor e Van Every
1993]48. La gerarchia tendenzialmente piatta, la comunicazione in tutti
i sensi, la libertà di tagliare su misura il livello di profondità nella navigazione, sono caratteristiche insieme tecnologiche e sociali, come
dimostra la difficoltà della loro importazione in un contesto quale
quello dell’amministrazione italiana.
47 L’ironico elenco delle conseguenze che i media associano alla rete comprende
queste previsioni: «Indebolisce il sistema dei partiti; offre una nuova tribuna per incitare all’odio; stimola nuove potenzialità per la democrazia dal basso; permette al terzo
mondo di saltare il doloroso stadio dell’industrializzazione per accedere direttamente
all’economia dell’informazione; sottrae ai bambini la loro infanzia, e a tutti il radicamento in un dato luogo; rende troppo veloce il processo di risposta dei governi alle
crisi internazionali, precludendo deliberazioni ponderate; isola tra loro i membri delle
famiglie; stabilizza in modo permanente il ciclo economico; aumenta la distanza tra
chi ha l’informazione e chi non ce l’ha; limita la capacità dei regimi autoritari nel controllo del flusso delle informazioni dentro e fuori il loro dominio». R.W. Neuman,
New Media, Public Knowledge and Political Behavior, Paper presentato al convegno
APSA, Atlanta, 2-5 settembre 1999, p. 1.
48 V. anche G. Regonini, E se fosse Internet a cambiare le istituzioni?, Paper presentato al convegno SISP, Urbino, giugno 1996.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Come è noto, molti autori colgono nella connettività elettronica lo
strumento per la realizzazione di quella democrazia comunitaria che
tanto spazio occupa nel pensiero pragmatico americano, in contrapposizione alla democrazia plebiscitaria, top-down, legata alle potenzialità
di manipolazione a senso unico dei «vecchi» media: stampa, radio,
televisione: «I grandi perdenti, nell’attuale riformulazione e rilancio
dell’influenza pubblica, sono le tradizionali istituzioni che hanno funzionato da principali intermediari tra il governo e i cittadini: i partiti
politici, i sindacati, le associazioni civiche, e i commentatori o i corrispondenti della grande stampa» [Grossman 1995, 161]49.
I fornitori. Dopo questa immersione nel virtuale, a riportarci con i
piedi per terra provvedono le ricerche che cercano di ricostruire la
rete di relazioni tra chi disegna le politiche e chi fornisce i beni e i
servizi per la loro attuazione. Da più di due decenni, ormai, in molti
paesi si è affermata l’idea che le amministrazioni possano conseguire
risultati migliori a costi più contenuti non provvedendo in prima persona alla gestione delle mense scolastiche, o all’organizzazione dei trasporti ferroviari, bensì fissando precise linee contrattuali che vincolino
al rispetto degli standard i fornitori, siano questi imprese che operano
nel mercato o associazioni del cosiddetto terzo settore.
Per quanto riguarda le transazioni del primo tipo, cioè regolate dalla logica del profitto, privatizzazioni, contract out, appalti, sono alcune
delle svariate forme attraverso cui possono passare le istituzioni, nel
tentativo di contenere la crescita del settore pubblico e di recuperare
efficienza. Le ricerche sulla concreta implementazione di queste strategie rivelano le difficoltà che l’attore pubblico incontra nel vincolare le
imprese al rispetto delle condizioni pattuite: se questo è un problema
endemico di tutte le transazioni che coinvolgono grandi corporations,
quando a contrattare sono i responsabili dell’amministrazione, le probabilità di esiti insoddisfacenti sono elevate [Kettl 1993a; Rhodes
1994]. Innanzi tutto, le imprese possono fare lobbying e possono esercitare un qualche ruolo nella competizione politica, trasformandosi da
meri strumenti per la fornitura di beni, in attori in grado di imporre le
loro condizioni. Nei casi peggiori, possono ricorrere alla collusione, alla
truffa e alla corruzione. Ma l’aspetto anche statisticamente più signifi-
49 In questo caso più che mai, la letteratura di riferimento va cercata nell’enorme
e mutevole serbatoio rappresentato dalle migliaia di siti web attivi nel campo della democrazia dal basso, quali, ad esempio, A. Kraus, M. Stein e J. Clark, The Virtual Activist: A Training Course. Netaction. On-Line, http://www.netaction.org/training/
(1988); L.A. Pal, Virtual Policy Networks: The Internet as a Model of Contemporary
Governance?, http://www.botany.uwc.ac.za/mirrors/inet97/G7/g7_1.htm; Id., The
Advocacy Group Guidelines to Effective Lobbying, http://www.advocacy.com/
guidelines.html; Center for Democracy and Technology http://www.cdt.org/mission/
(aprile 2000).
353
354
CAPITOLO 5
cativo è la tendenza delle aziende ad adottare le logiche burocratiche
del loro committente, ad imitarne le rigidità e le inefficienze [Richardson e Dudley 1996]. Questa simbiosi ha portato alcuni autori ad interrogarsi sul reale significato della «cura dimagrante» che vent’anni di
raccomandazioni del new public management dovrebbero aver applicato al settore pubblico: «Con tutta la retorica e le iperboli della reinvenzione del governo, del “Contratto con l’America”, con l’assicurazione
che “l’era del governo largo è passata”, sembra che i nostri leader politici abbiano trovato un modo per salvare la burocrazia: nascondendola» [Frederickson 1999, 703; v. anche Light 1999].
A conclusioni non molto distanti giungono alcune indagini empiriche sul ruolo delle organizzazioni non profit nell’implementazione
[Milward 1994]. Il ricorso al loro contributo è in continua espansione,
anche in Italia, soprattutto nei settori del welfare, dell’istruzione, dell’accoglienza agli immigrati [Ranci 1999]. All’origine del loro crescente
coinvolgimento, in molti casi stanno le stesse ragioni che legittimano il
contract out, e cioè la critica all’uniformità, alla burocratizzazione, alla
passività, alla logica top-down che tendono a caratterizzare le prestazioni delle amministrazioni pubbliche [Powell 1987]. Il dato che contraddistingue le ricerche sull’attribuzione a queste associazioni di responsabilità più o meno formalizzate, è la loro tendenza a non agire in
isolamento, ma a raccogliersi sotto «organizzazioni ombrello», molto
efficaci nello sfruttare i vantaggi del coordinamento. Anche in questo
caso, la rete è la metafora più utilizzata per descrivere un sistema di
relazioni acefalo e basato sulla fiducia reciproca50. Lo stile esalta gli
accordi informali, la sostanza degli impegni, la missione, più che i
dettagli amministrativi. Di conseguenza, i rapporti che queste formazioni instaurano con le istituzioni competenti ad autorizzare il loro
intervento le vedono più nel ruolo di attori politici che in quello di
venditori di servizi [Smith e Lipsky 1993, 171].
I competenti. Come abbiamo sottolineato più volte, il concetto di
politica pubblica ha nel suo codice genetico la fiducia in una più marcata influenza del sapere – comunque definito – nei problemi di rilevanza collettiva. Tale aspirazione dà i risultati più vistosi nel contesto
americano, grazie all’esperienza accumulata dalle think tanks, dalle
commissioni presidenziali, dagli studi professionali, dalle università:
«Questa nuova stirpe di esperti di politiche rappresenta il culmine di
cent’anni di sforzi per portare la conoscenza specialistica a pesare nelle
politiche pubbliche» [Smith 1991, 224]51.
50 Walter Powell, uno dei più noti studiosi del settore non profit americano
[1987], è famoso anche per il suo rilevante contributo alla teoria delle reti [Powell e
di Maggio 1991].
51 Per un’analisi del caso europeo v. Peters e Barker [1993].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Ripercorrendo la tipologia tracciata da James Smith [1991], al vertice di questa nuova progenie troviamo i «consiglieri del principe»,
una cerchia eletta di pochi, prestigiosi esperti, in genere con esperienza accademica, nominati nelle commissioni che affiancano il presidente
per le decisioni in settori quali la politica estera o la politica economica. Il loro ruolo richiede la capacità di adattamento a uno stile di lavoro convulso:
Non è di alcun aiuto avere una teoria brillante, o una buona preparazione, o un paper ben scritto, se non è nel posto giusto al momento giusto e in
formato utilizzabile [...]. I policy makers sono talmente sotto pressione che
possono assorbire solo le informazioni che hanno un significato all’interno dei
loro schemi. A Washington molta gente ha l’impressione di dire esattamente
quello che i capi hanno bisogno di ascoltare52.
Gli specialisti – la nostra seconda categoria –, anche quando legano il loro nome a una specifica riforma, conservano comunque un baricentro professionale sbilanciato verso l’attività di ricerca. La loro influenza, più che nelle singole decisioni, diviene evidente guardando
alla lenta ma continua evoluzione delle idee che danno forma ai problemi di policy [Hall 1989; Goldstein e Keohane 1993].
I consulenti sono invece legati all’amministrazione o a singole personalità politiche da un rapporto contrattuale che lascia al committente la determinazione delle linee guida del loro intervento. In molti casi,
il loro lavoro si svolge tramite l’intermediazione di studi professionali
o di think tanks, che con il loro prestigio si fanno garanti della qualità
del prodotto.
Grazie all’intraprendenza della policy analysis nell’imporre i suoi
standard di valutazione, e grazie al ruolo svolto dalle organizzazioni
internazionali per l’accreditamento delle sue metodologie, oggi molte
amministrazioni sono dotate di uffici studi o di gruppi tecnici interni,
in grado di esprimere competenze di grande valore.
Infine, la tipologia di Smith [1991] riporta la figura dell’esperto
«pronto per l’uso», disponibile per l’editoriale o l’intervista, sulla carta
stampata o in televisione: «Da quando il giornalismo americano è passato da un’informazione politica di corto respiro ad ampie analisi sociali, politiche e economiche, non solo è andato in cerca di giornalisti
più specializzati e più colti, ma ha iniziato ad appoggiarsi decisamente
agli esperti» [ibidem, 225].
Tuttavia sarebbe un errore pensare a queste categorie come a nicchie separate: a caratterizzare il mondo dei produttori di competenze
è infatti la tendenza a «rimanere nel giro», pur cambiando ruolo:
52 Dalla testimonianza del professor E. Vogel, in «Sociology Lives», Harvard
University, Department of Sociology, vol. 12, n. 1, 1995, p. 5.
355
356
CAPITOLO 5
Anche chi lavora nelle think tanks partecipa direttamente al processo di
produzione delle politiche. Innanzi tutto, diventa membro attivo di una delle
reti impegnate sui più svariati temi di policy. Queste reti, deliberatamente
coltivate dagli istituti di ricerca con l’organizzazione di conferenze, simposi,
incontri su problemi specifici, mettono il ricercatore a contatto con giornalisti, dirigenti amministrativi, funzionari parlamentari, lobbisti, consulenti, giuristi, educatori e altre categorie interessate in giro per Washington [Ricci
1993, 165].
A quel punto, l’esperto entra a far parte del serbatoio di persone
qualificate cui un’amministrazione ricorre per gli incarichi di governo.
Tutte insieme, le figure che traggono la loro legittimazione dalla competenza, si sostengono e crescono le une appoggiandosi alle altre, fino
a formare una specie di articolatissima barriera corallina: «Come una
fantastica formazione sottomarina, queste istituzioni hanno creato ponti tra i settori pubblico e privato e hanno riempito quasi tutti gli spazi
aperti da un sistema di governo frammentato» [Smith 1991, 226]53.
Gli imprenditori di policy. La sommaria rassegna degli attori significativi nel policy making chiude con una categoria che fa riferimento
non a ruoli o a funzioni specifici, ma alla capacità di promuovere l’innovazione partendo da una qualunque investitura formale:
Gli imprenditori di policy possono essere membri del parlamento, attivisti
indipendenti, burocrati pubblici, funzionari parlamentari, professori universitari, lobbisti, scrittori. Di solito, non occupano posizioni di grande potere
formale o visibilità. Piuttosto, acquistano influenza soprattutto per la loro
competenza, costanza e abilità, sommate alla capacità di sviluppare una relazione di simbiosi con personaggi politici affamati di proposte operative [Conlan et al. 1995, 135].
La prima qualità di un imprenditore di policy è dunque la creatività, la capacità di trovare soluzioni inedite, di percorrere strade non
ancora tentate. La seconda è l’abilità necessaria per portare avanti la
sua idea, sfruttando tutte le occasioni e muovendosi tra le insidie della
politica, le pressioni degli interessi organizzati, la passività delle burocrazie [Polsby 1984].
53 Può essere interessante contrapporre a questa immagine quella che Giuseppe
De Rita fornisce con riferimento alla situazione italiana: «Non abbiamo strutture solide ed aziendali, visto che solo un paio di centri di ricerca arrivano ai 30-35 ricercatori fissi; abbiamo una notevole confusione di ruoli (oggi dicono di far ricerca anche
società di consulenza, di informatica, di certificazione di bilancio); la trasparenza del
mercato è ancora molto lontana, ed anche la grande innovazione delle “gare” è segnata dalla furbizia generalizzata [...]; ed infine non esiste o non funziona quel retroterra di solidità che in altri sistemi è garantito dalle università, dalle grandi fondazioni,
dagli enti pubblici di finanziamento della ricerca» (in «Corriere della Sera», 1° novembre 1996).
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
È interessante notare come la figura dell’imprenditore di policy si
ponga in un rapporto ambiguo con il quadro normativo che teoricamente dovrebbe condizionarne le strategie:
Uno dei più abili amministratori che abbia avuto la fortuna di conoscere
credo non avesse mai letto, se non casualmente, le norme che traduceva in
realtà. Lui dava per scontato che gli dessero il potere di intervenire sui problemi di fondo di un settore e, sulla base di questo assunto, elaborava le sue
soluzioni [Landis 1966].
Gli imprenditori di politiche pubbliche raggiungono i loro risultati soprattutto sfruttando le ambiguità, le contraddizioni e le complessità implicite
nelle autorevoli decisioni dei politici eletti e dei magistrati. Fanno tesoro della
capacità limitata che gli ordini legislativi, esecutivi e giudiziari hanno di seguire le innumerevoli questioni in cui sono coinvolti e di controllare le organizzazioni che hanno creato per realizzare finalità pubbliche [Lynn 1987, 72].
Fare «come se» le norme dicessero quel che si vorrebbe, sfruttare
la distrazione degli organi di controllo, sono condotte separate dall’illegalità solo dalla forte legittimazione che possono dare concreti risultati di evidente interesse generale. A questi, e ai loro beneficiari, l’imprenditore di policy si appella per garantire la sua impunità, contando
su un sistema giudiziario che, come abbiamo appena visto, fa della
stessa magistratura un attore coinvolto «nell’impresa di governare gli
Stati Uniti».
Oltre la pressione: i «network» per le politiche
Il nostro inventario degli attori, approssimato per difetto54, ha
puntato i riflettori su personaggi che non rientrano nelle «classiche»
categorie di politici, organizzazioni degli interessi, burocrati. Ma, nel
fare questo, ha anche messo in evidenza modalità di interazione diverse dalla mera pressione o dallo scambio, per sottolineare invece l’interdipendenza: «Virtualmente ogni punto di potenziale conflitto è anche
un punto di inevitabile mutua dipendenza. L’autolimitazione dell’autointeresse è presente praticamente in tutte le parti» [Heclo e Wildavsky 1974, 373].
Il ricorso a metafore biologiche – il terrario, la barriera corallina –
sottolinea la complessità di queste formazioni e il rapporto di coevoluzione che lega la crescita dei loro diversi elementi. Da circa trent’anni
[Schön 1971], questi concetti sono riassunti nell’immagine della rete
intessuta intorno a uno specifico settore di policy:
54 Si pensi al ruolo delle istituzioni religiose, o ai personaggi dello spettacolo che
diventano testimoni di una causa.
357
358
CAPITOLO 5
Un policy network comprende tutti gli attori coinvolti nella formulazione e
realizzazione di una politica in uno specifico settore di intervento. È caratterizzato da interazioni preminentemente informali fra attori pubblici e privati con
interessi distinti, ma interdipendenti, che cercano di risolvere problemi di azione collettiva ad un livello centrale non gerarchico [Börzel 1998, 401-402]55.
Gli elementi che caratterizzano questo «nuovo paradigma per l’architettura della complessità» [Kenis e Schneider 1991, 25] possono
essere così definiti:
La funzione costituente della singola politica. Le specifiche politiche, siano il trasporto aereo, la formazione degli insegnanti, o la promozione del vino italiano, hanno la capacità di funzionare come addensanti di relazioni facilmente distinguibili per la loro maggiore frequenza e stabilità. Sullo sfondo stanno quei processi di segmentazione
della sfera pubblica e di disarticolazione delle grandi organizzazioni
cui abbiamo più volte accennato:
Il nucleo di questa prospettiva è un concetto decentralizzato di organizzazione sociale e di governo: la società non è più controllata esclusivamente
da un’intelligenza centrale (ad esempio, lo Stato); piuttosto, i dispositivi di
controllo sono dispersi, e l’intelligenza è distribuita tra una molteplicità di
unità d’azione (o di elaborazione). II coordinamento di queste unità d’azione
non è più il risultato di un indirizzo centrale o di una qualche «armonia prestabilita» ma emerge dall’interazione intenzionale di attori individuali, da se
stessi in grado di azione parallela, scambiando informazioni e altre rilevanti
risorse [Kenis e Schneider 1991, 26].
La pressione esercitata dalla comune necessità di «andarcene fuori» fa sì che chi si occupa di pari opportunità, o di norme sui fertilizzanti, impari a fare i conti con quanti, da ruoli diversi, e persino da
posizioni opposte, sono immersi nel suo stesso problema. È infatti tra
loro, piuttosto che tra «i suoi», tra gli appartenenti alla sua stessa organizzazione, che troverà orecchi sensibili alle sue preoccupazioni.
Muovendosi in contesti inesplorati, in genere caratterizzati da grande
incertezza, i policy makers si tengono d’occhio l’un l’altro, per non
sbagliare da soli.
L’informalità delle relazioni. Il potere formale e le risorse materiali
sono solo due dei molti elementi che condizionano lo sviluppo di queste ragnatele di reciproca influenza. L’esigenza di garantire il fluire
delle informazioni scava suoi originali percorsi che non ricalcano gli
organigrammi ufficiali, così come in una famiglia la notizia di una nascita o di un funerale non si propaga secondo i gradi di parentela, ma
55
Per una diversa concezione del termine, v. Rhodes e Marsh [1992].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
secondo contiguità basate sui più diversi motivi: «L’esperienza accumulata con i numerosi studi sull’implementazione e il policy making
insegna una lezione fondamentale: la forza e la scala delle gerarchie
amministrative formali non spiega nulla dei collegamenti funzionali tra
le varie unità» [Carlsson 1996, 532].
La continuità tra pubblico e privato. Nella formazione delle politiche, il sottile confine tra il diritto di accesso alle informazioni e
l’attiva partecipazione ai processi decisionali viene spesso superato
[Powell 1991; Thompson et al. 1991; Kettl 1993]: imprese, organizzazioni degli interessi, gruppi di cittadini non sono solo consultati,
ma sono coinvolti nella creazione e nell’investiment o del consenso56. Nella fase di implementazione, molte amministrazioni dovrebbero dichiararsi impotenti, se venisse meno il supporto organizzativo delle associazioni dei destinatari:
I networks comprendono accordi di cooperazione tra agenzie, strutture
per la gestione di programmi intergovernativi, complesse disposizioni contrattuali, partnership tra pubblico e privato. Comprendono anche sistemi di recapito dei servizi basati su gruppi di fornitori che possono riunire agenzie pubbliche, imprese, associazioni non profit, unità di volontari, tutti legati da interdipendenza e dal comune interesse per un programma [O’Toole 1997, 446].
L’estensione variabile. Come i festoni a fisarmonica in carta, i
networks possono essere ora piatti, ora sviluppati in altezza o in lunghezza, cioè possono adattarsi alla sempre più stretta compenetrazione
tra diversi livelli di governo: locale, regionale, nazionale, internazionale
[Kenis e Schneider 1991]. Grazie alle loro propaggini, possono essere
colmati i vuoti o le discontinuità tra le diverse giurisdizioni, altamente
probabili in un’epoca di perenne ridisegno delle competenze formali.
Questa caratteristica rende la metafora dei networks particolarmente utile per studiare i sistemi federali: oltre che negli Stati Uniti, la
sua rilevanza è stata infatti colta e utilizzata già negli anni ’70 per descrivere il policy making nella Repubblica Federale Tedesca [Hanf e
Scharpf 1978]. Negli stessi anni, i networks cominciavano a diventare
il concetto più usato per studiare lo sviluppo delle relazioni tra le istituzioni dell’Unione europea, i paesi membri e le unità politiche infranazionali. Quello europeo sembra infatti un caso esemplare, sia per la
funzione costituente assunta dalle singole politiche (si pensi alla politica del carbone e dell’acciaio, alla politica agricola, a quella monetaria), sia per la compenetrazione tra attori pubblici e attori privati
[Scharpf 1986; Mazey e Richardson 1993; Börzel 1998].
56 Su questo solo aspetto si concentra la riduttiva definizione di Jordan e Schubert: «Network è un’etichetta generica che comprende i differenti tipi di relazione tra
Stato e gruppi d’interesse nel processo di determinazione dell’output di una specifica
politica» [1992, 10].
359
360
CAPITOLO 5
A questo punto vale la pena sottolineare che l’Europa è legata alla
teoria dei networks non solo per essere il suo oggetto di studio, ma
anche come area culturale da cui deriva il principale impulso a questo
tipo ricerca. Proprio dal dibattito sulle valenze teoriche dei network
deriva infatti il più importante contributo europeo allo studio del policy making57. In Germania, sono le analisi condotte fin dagli anni ’70
al Max-Plank-Institut für Gesellschaftsforschung di Colonia, con Renate Mayntz, Fritz Scharpf, Vorker Schneider; in Austria, il fulcro è lo
European Centre for Social Welfare Policy and Research di Vienna, con
Bernd Marin e Patrick Kenis58; in Gran Bretagna, il vivace dibattito ha
per protagonisti Grant Jordan, Jeremy Richardson, David Marsh,
R.A.W. Rhodes, Patrick Dunleavy; in Italia, le ricerche sulle politiche
industriali [Trigilia 1992], sulle politiche di devolution [Dente 1985],
sulle politiche sociali [Regonini 1985], sulle politiche ambientali [Diani
1988], hanno utilizzato spesso questo concetto.
Le valenze prescrittive. Fin dal suo debutto nello studio delle politiche pubbliche, l’immagine dei networks ha avuto valenze sia descrittive, sia prescrittive59. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, di
questa «architettura della complessità» si interessa da vicino la policy
inquiry, che fonda larga parte delle sue risorse sul riconoscimento della rilevanza dei networks. Per questo approccio, le reti di policy richiedono solo una manutenzione leggera, per lubrificare i loro punti di
snodo, aumentare la velocità di connessione, gettare qualche leggero
ponte [Schön 1971]. Qualunque ristrutturazione pesante si scontrerebbe infatti con le loro forti tendenze centrifughe: «L’alto grado di differenziazione funzionale e di frammentazione dell’organizzazione dei
governi [...] tende a produrre come esito caos e frustrazione più totale
quando l’iniziativa del coordinamento non proviene in larga misura
dal basso» [Scharpf 1978, 361]. Nell’esecutivo americano, ad esempio,
«nessuno poteva trasformare agevolmente i molti networks di gente
bene informata in una coalizione di azione condivisa» [Heclo 1978,
104].
Dagli anni ’90, tuttavia, la metafora delle reti viene sempre più
spesso utilizzata anche in un contesto analitico diverso, quello della go-
57 Si veda ad esempio il numero monografico dello «European Journal of Political Research» del febbraio 1992 (vol. 21, n. 1-2). Europei sono anche la maggior parte
dei contributi al numero monografico del «Journal of Theoretical Politics» dell’ottobre 1998 (vol. 10, n. 4).
58 Dalla collaborazione tra i due istituti nasce il volume curato da Marin e Mayntz [1991].
59 «L’analisi si propone di identificare i fattori che rendono alcuni networks più
efficaci di altri nel coordinamento delle attività delle organizzazioni che li compongono [...], e che pertanto rappresentano potenziali punti su cui far leva per migliorare le
prestazioni del network» [Hanf 1978, 13].
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
vernance, nella prospettiva di una guida consapevole e globale della
complessità sociale [Atkinson e Coleman 1992; LaPorte 1996]. All’interno di questa impostazione, le reti di policy sono invocate a sostegno
delle superstiti speranze di una qualche capacità di indirizzo e di controllo, per realizzare una governabilità senza governi [Rosenau e
Czempiel 1992; Peters 1996] in formazioni politiche dai contorni istituzionali incompleti, come le aree metropolitane, l’Unione europea, le
organizzazioni sovranazionali.
La formalizzazione fattibile. Il grande vantaggio operativo della
metafora delle reti per le politiche è il fatto di poter eventualmente
contare su una metodologia di ricerca e su una tecnica di visualizzazione dei risultati insieme rigorose e flessibili. Quando il fuoco dell’indagine si sposta su dati relazionali, in qualunque campo delle scienze
sociali, nello studio delle famiglie come in quello dei distretti industriali, da alcuni anni la network analysis costituisce il supporto metodologico fondamentale per organizzare le informazioni che riguardano
le interazioni a livello micro [Scott 1991, 2; Piselli 1997]. In questo
caso, dunque, il termine network è collegato a una precisa impostazione per l’organizzazione dei dati empirici, in genere definita sociometric
o «formal» network analysis [Schneider 1992, 110]. Con riferimento a
quest’ultima espressione, vale solo la pena osservare che il termine
«formale» si riferisce all’uso di tecniche standardizzate di rilevazione e
di rappresentazione dei dati, e non alla natura delle relazioni studiate
[Freeman 1979].
Anzi, obiettivo della network analysis è l’individuazione dell’intera
gamma delle interazioni sociali, dalle più strutturate alle più informali,
dalle più accentrate alle più disperse: «Nella prospettiva formale, un
network non implica una specifica configurazione strutturale, ma ogni
insieme di legami tra punti può essere rappresentato come un
network, anche quando l’intera struttura appare piuttosto come una
gerarchia (o un “albero”)» [Schneider 1992, 110]. Naturalmente, la
verifica empirica della metafora dei policy networks richiede che l’analisi dimostri proprio il loro effettivo decentramento e la disarticolazione delle organizzazioni «madri», siano queste i partiti, gli interessi organizzati, le gerarchie burocratiche.
Tipi di networks per le politiche. La letteratura sui policy networks
fornisce alcuni modelli che possono tornare utili per rispondere alla
domanda: «Chi fa le politiche?» Anche se l’originalità dei vari «prototipi» è difesa con decisione dai loro autori, per chi affronta per la prima volta questi temi è difficile cogliere la rilevanza delle sfumature.
Sembra dunque ragionevole partire dall’ipotesi che tipi di networks
diversi possano coesistere l’uno accanto all’altro, per concentrarsi sulle
loro rispettive caratteristiche [Lehner e Schubert 1984].
1. Le comunità di policy. «L’idea di comunità fa riferimento alle
361
362
CAPITOLO 5
relazioni personali tra i principali attori politici e amministrativi – talvolta in conflitto, spesso in accordo, ma sempre in contatto e in azione
entro un frame condiviso. La comunità è il vincolo di coesione e
orientamento che sta sotto ogni specifico tema» [Heclo e Wildavsky
1974, xv]. I due autori non nascondono la loro simpatia per le metafore etnografiche, e quando parlano di comunità fanno riferimento alla
vita di un villaggio, con le sue tradizioni, i suoi dialetti, i suoi riti, condivisi dagli abitanti e incomprensibili agli estranei [Jordan 1990b].
Nel mantenimento del senso della comunità, giocano un ruolo
importante anche le caratteristiche personali degli attori che la compongono: «L’esigenza di credibilità personale è elevata, perché ogni
ruolo richiede che la persona sia ritenuta accettabile e affidabile da
diverse organizzazioni e persone, ciascuna delle quali tende a difendere i propri criteri di accettabilità» [Schön 1971, 200]. In effetti nel policy making sono disseminati impliciti test di compatibilità, che richiedono il rispetto di regole tacite quali la riservatezza, la non faziosità, e
persino una certa autonomia critica dalle direttive della propria organizzazione60. Talvolta, per preservare la capacità di «interfacciarsi» con
attori che hanno alle spalle storie, sensibilità, interessi diversi, occorre
rinunciare a prevalere, perché non è la mera convenienza materiale, lo
scambio puntuale di favori, a costituire il principale elemento capace
di aggregare una policy community, quanto piuttosto l’intenzione di
«rimanere nel giro che conta», cioè di essere inseriti nella produzione
e nello scambio delle informazioni utili per il rafforzamento del proprio settore [Regonini 1985]. In questo contesto, la risorsa più importante che una policy community può mettere in campo rispetto agli
esterni è la fiducia, il poter contare sul fatto che gli altri membri non
faranno furberie e non sfrutteranno cinicamente un eventuale momento di difficoltà.
2. I networks a tema. In un appello pubblico con un’ampia inserzione a pagamento pubblicata sui principali quotidiani61, il Consiglio
nazionale degli architetti e i presidenti degli Ordini degli architetti
d’Italia: «chiedono al parlamento di avviare subito il dibattito sul d.d.l.
Costa-Bargone che recepisce il testo della cosiddetta Merloni-ter [...].
60 A volte questi tratti finiscono con l’emergere anche in sedi più politiche, quali
una commissione d’inchiesta parlamentare: «È battaglia a Montecitorio per la sostituzio- ne
di Ottaviano Del Turco (nominato ministro delle Finanze) alla presidenza della commissione Antimafia [...]. Molti sono però i pareri contrari alla nomina di un “esterno”.
Per Nichi Vendola di Rifondazione sarebbe “una pesante ipoteca sul lavoro della commissione, paragonabile alla sua sostanziale chiusura”. Gli fa eco il vicepresidente Filippo
Mancuso, di Forza Italia: “Un esterno alla commissione sarebbe una grave indelicatezza.
Siamo insieme da oltre quattro anni, tra contrasti, consensi e lavoro in comune. L’intervento di qualcuno estraneo potrebbe determinare contraccolpi soprattutto se questa
sostituzione avesse un significato ispettivo, innovativo e censorio rispetto all’attività svolta finora dall’Antimafia”» in «Corriere della Sera», 28 aprile 2000.
61 V. «Corriere della Sera», 31 dicembre 1996.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Chiedono inoltre al presidente del Consiglio dei Ministri di non firmare il d.p.c.m. di cui all’art. 23 (comma 1, lettera b) del d.l. n. 157/95
in quanto tradisce nella lettera e nello spirito la direttiva europea 92/
50 sui pubblici servizi». Se un’organizzazione paga milioni per un appello pubblico di questo tenore, è perché sa che c’è qualcuno in grado
di capirlo. Ma giusto qualcuno, perché è probabile che lo stesso presidente del Consiglio debba informarsi per sapere di che si tratta.
Il concetto di network su specifici temi di policy è stato formulato
proprio per dare conto di questa estrema frammentazione degli interessi, delle competenze, dei linguaggi [Heclo 1978]. Secondo questo
modello le aggregazioni tra policy makers tendono a divenire più specializzate, ma nello stesso tempo più instabili, poiché ridefiniscono
confini e struttura di volta in volta, a seconda dello specifico problema
portato al centro dell’agenda. Se rispetto ai temi tradizionali della
scienza politica (Stato, partiti, amministrazioni, ecc.) la disarticolazione
implicita nel concetto di policy network suonava già sinistra, ora viene
evidenziato che «politica del trasporto aereo» è un mondo che diventa
sempre più difficile da identificare e governare, perché chi si occupa
della regolazione degli scioperi dei controllori di volo non sa e non
vuole sapere delle norme doganali o degli standard per la sicurezza
negli aeroporti.
Ma la grande specializzazione porta al decentramento e alla moltiplicazione delle reti significative. In un ambiente caratterizzato da
un’elevata complessità e dalla difficoltà di ragionare in termini di «a
chi giova?», essere riconoscibili è importante quanto conoscere:
I partecipanti vanno costantemente dentro e fuori. Al contrario dei gruppi unificati dal predominio su un progetto, nessuna unità, se di unità si può
parlare, ha il controllo delle politiche o dei singoli problemi. Ogni interesse
materiale diretto è spesso secondario rispetto al coinvolgimento intellettuale o
emotivo. I membri del network considerano loro interesse rinforzare l’un l’altro il senso del problema, anziché farsi guidare dall’interesse nel prendere
posizione sui problemi (come invece sostengono i modelli politici o economici standard) [ibidem, 102].
3. Il potere delle idee: coalizioni di sostegno e comunità epistemiche.
I modelli finora considerati sono in fondo basati su un senso di appartenenza che richiede la continua circolazione delle informazioni e la
condivisione di una cultura, di un linguaggio, di una «teoria in uso».
Alcuni autori ritengono che l’accento posto sui fattori che unificano e
rafforzano la comune sensibilità all’interno dei policy networks finisca
con il dare di questi ultimi un’immagine troppo pacifica e unitaria. Il
fatto che cultura, idee, conoscenza siano elementi che comportano accordo e convergenza viene considerata una mezza verità. L’apprezzamento per questi valori ha infatti un duplice, contrastante effetto: di
coesione tra quanti si riconoscono nelle stesse analisi, ma anche di radicalizzazione delle divisioni rispetto a chi sostiene teorie diverse. Pertan-
363
364
CAPITOLO 5
to, la crescente importanza delle idee nel policy making può andare di
pari passo con la polarizzazione delle posizioni e con l’instabilità:
La tradizionale politica basata sugli interessi è stabile, perché i rapporti
d’interesse che la sostengono cambiano lentamente con l’evoluzione della
società, del governo e dell’economia. Le idee, invece, arrivano non solo sotto
forma di ideologie durevoli, ma anche di bizzarre mode. L’umore del pubbli- co
e l’impegno degli intellettuali possono andare e venire rapidamente [Conlan, Beam e Wrightson 1995, 140].
Mentre i politici e i rappresentanti degli interessi economici tendono ad essere pragmatici, flessibili, ostentano una specie di agnosticismo riguardo alle cause ultime delle loro proposte62, funzionari con
elevate competenze, giornalisti, scienziati, associazioni con un solo
obiettivo, tutti animati più da idee che da interessi, appaiono meno
propensi alla mediazione e sensibili a principi di fondo il cui rispetto
considerano irrinunciabile.
Comunità epistemiche e coalizioni di sostegno (advocacy coalitions)
sono due metafore studiate per dare conto della capacità delle idee
non solo di unire, ma anche di dividere e di ricombinare secondo linee che non ricalcano né le afferenze organizzative formali, né i policy
networks. In comune, hanno il riconoscimento dell’importanza delle
idee nel condizionare lo sviluppo delle politiche, non solo nel bene,
ma anche nel male: «Spiegare i fallimenti delle politiche pubbliche in
termini di qualità delle idee sembra funzionare almeno altrettanto
bene quanto lo spiegarli in termini di forze sociali che catturano e
corrompono il processo di implementazione» [Majone e Wildavsky
1979, 168]. In contrasto con l’opinione corrente, che vuole gli studiosi
assorti nella contemplazione delle teorie, le due metafore condividono
il riconoscimento della facilità con cui chi ha una forte identificazione
disciplinare può passare dal ruolo di competente a quello di militante.
Gli esperti di politiche sociali che lavorano per le organizzazioni internazionali condividono, oltre all’oggetto di studio, il senso di una comune missione [Haas 1992]. Nel settore delle politiche ambientali, i
fronti che si contrappongono difficilmente potrebbero formulare le
loro richieste senza il suggerimento e la sollecitazione degli specialisti.
Il primo esempio può descrivere una comunità epistemica; il secondo,
per la tendenza allo schieramento e alla contrapposizione, richiama
piuttosto una coalizione di sostegno:
62 Da un’intervista a Benedini, presidente della Federchimica: «Al Senato il gruppo Progressista Federativo ha presentato una proposta di legge che ha recepito in
gran parte il nostro lavoro [un progetto per lo snellimento delle procedure]. E alla
Camera, in sede di esame del disegno di legge governativo sulla semplificazione dei
procedimenti amministrativi è stato presentato un emendamento nella direzione della
nostra proposta da Forza Italia, liberaldemocratici e riformatori. Un successo, non le
pare?» (in «Corriere della Sera», 27 dicembre 1995).
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Una comunità epistemica è composta da professionisti (in genere reclutati
tra alcune discipline) che condividono l’apprezzamento per uno stesso modello causale e per uno stesso insieme di valori politici. A tenerli uniti è la fiducia nella verità del loro modello e l’impegno a tradurre questa verità in politiche pubbliche, nella convinzione che il loro risultato migliorerà il benessere
umano [ibidem, 41].
Il modello della coalizione di sostegno considera che all’interno dei sottosistemi [di policy] gli attori possano essere aggregati in un certo numero (in
genere da uno a quattro) di «coalizioni di sostegno», ciascuna composta da
persone delle varie organizzazioni di governo e private che condividono un
insieme di convinzioni normative e causali, e si impegnano per un certo periodo di tempo con un livello notevole di attività coordinate [Sabatier e
Jenkins-Smith 1999, 120].
È importante sottolineare che gli effetti delle reti basate su ipotesi
scientifiche emergono con tempi più lunghi rispetto alle tradizionali
attività di pressione fondate sugli interessi. Una prospettiva decennale
è proposta da Sabatier e Jenkins-Smith come orizzonte temporale congruo per cogliere trasformazioni che hanno la lentezza e la difficoltà di
vere e proprie conversioni.
4.3. La dinamica
Come abbiamo più volte ripetuto, il passaggio da ricerche impostate sulla varianza, quali gli output studies, a ricerche impostate sul
processo segna un salto analitico fondamentale [Rose 1976; May e
Wildavsky 1978]. La prima conseguenza della svolta è un esame più
ravvicinato delle diverse fasi del policy making: l’emergere di una situazione percepita come problema che deve essere risolto con un intervento pubblico, il suo ingresso nell’agenda dei decisori, la formulazione delle proposte, l’adozione di scelte vincolanti, la loro implementazione, la valutazione dei risultati, l’eventuale estinzione della politica
intrapresa. Ciascuno di questi stadi ha elevate probabilità di distinguersi dagli altri per il tipo di attori dominanti, per gli sfondi istituzionali, per gli stili decisionali prevalenti.
Ma, come abbiamo sottolineato parlando di implementazione nel
quarto capitolo, sarebbe un grave errore fermarsi a questo risultato,
che rischierebbe di riproporre sotto nuove etichette le tradizionali divisioni del processo politico: articolazione ed aggregazione degli interessi, decisione delle istituzioni rappresentative, loro esecuzione da
parte degli organi amministrativi [Hogwood e Peters 1983]. Qualunque tentativo di analizzare questi processi facendoli «a fette di salame»
[Heclo 1974, 307] finisce con l’impedire proprio la comprensione
dell’aspetto più interessante: la possibilità di cortocircuiti e di rincorse
tra fasi che sul piano logico appaiono non contigue. Il problema dunque è cogliere i continui rimandi tra la definizione del problema, l’in-
365
366
CAPITOLO 5
dividuazione delle soluzioni, la loro generale legittimazione, la loro effettiva sperimentazione, la loro ridiscussione, perché questi aspetti
sono comunque presenti in ogni momento dello sviluppo di una politica, sia pure in forme e proporzioni diverse: «Il processo di policy
avanza con una serie di stadi interattivi e di connessioni per feedback
[...]. È ormai diffusa l’idea che sia una rete senza cesure, piuttosto che
una serie di singoli stadi o fasi separati tra loro» [deLeon 1988, 369].
La metafora del ciclo di vita di una politica vale dunque per quello che è: un’utile approssimazione per distendere lungo la linea del
tempo processi e relazioni che nella realtà avanzano raggomitolati gli
uni addosso agli altri.
4.3.1. La formazione dell’agenda
Lungi dal voler essere un denigratore del nostro paese, mi chiedo come
mai leggi e provvedimenti vengano presi solo a furor di popolo. Mi riferisco
ai casi di morte a causa dell’ecstasy che hanno appassionato e tanto scandalizzato l’Italia intera e ora caduti nel dimenticatoio, oppure la legge sull’obbligatorietà del casco che, assieme a quella sull’obbligo delle cinture, è da tutti
ignorata, tanto che le stesse autorità preposte al controllo sembrano non interessarsene più di tanto. La lista è assai lunga e costellata da episodi anche
gravi, come le leggi fatte all’ultimo momento dopo le alluvioni. Possibile che
viviamo solo per passioni istantanee? (Lettera al «Corriere della Sera», 6 luglio 2000).
Portare un problema al centro dell’interesse dell’opinione pubblica
e delle istituzioni competenti e tenercelo finché qualcosa viene deciso
è un’impresa molto complicata. La prima credenza da sfatare è che
esista una qualche relazione tra la gravità di un tema e la facilità di
ingresso nell’elenco delle questioni che finiscono all’ordine del giorno
degli organi decisionali pubblici [Elder e Cobb 1984]. Più precisamente, due caratteristiche incidono sull’accesso dei problemi all’agenda pubblica: la loro capacità di suscitare attenzione e il loro presentarsi come risolvibili.
1. L’attenzione. Come abbiamo imparato dalla teoria del bidone
della spazzatura [March e Olsen 1976], l’attenzione è una risorsa
molto scarsa e volubile. Le situazioni di disagio che premono sono
un’infinità, e solo poche riescono a catturare l’interesse dei policy
makers [Jones 1994]. L’appeal dipende tanto da caratteristiche intrinseche al problema, quali la concretezza e la netta delimitazione, quanto dalle circostanze in cui viene a cadere la sua occasione di mettersi
in mostra [Cobb e Elder 1972]. L’attenzione è soggetta a spostamenti
ciclici: nessun tema, per quanto grave, riesce a reggere le prime pagine
dei giornali o le conversazioni al bar per settimane e settimane. Dopo
una fase di «montatura» [Kingdon 1984], i problemi avvizziscono,
anche se eventi fortuiti con una forte valenza emotiva e simbolica,
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
quali sciagure o scandali, possono incidere sensibilmente sulla loro
resistenza.
2. La risolvibilità. Soluzioni e problemi si sostengono a vicenda:
«La formulazione del problema e la proposta di soluzione sono parte
di una stessa ipotesi in cui si fondono pensiero e azione» [Wildavsky
1992, 8363; v. anche March e Olsen 1976; Stone 1989].
Per fare un problema, occorrono soluzioni che «suonino bene»,
cioè che siano in accordo con i valori di fondo di una società, con le
sue conoscenze tecniche e con i suoi miti: «Le idee largamente diffuse
[...] sono idee potenti per la formazione delle politiche pubbliche. Le
loro principali caratteristiche sono: cambiano nel tempo; obbediscono
alla legge dei numeri bassi; restano indietro rispetto agli eventi, anche
in modo drammatico» [Schön 1971, 123-124].
Come avviamo visto nel precedente paragrafo, gli attori con un
notevole bagaglio di competenze svolgono un ruolo importante nel
produrre le idee di cui i problemi hanno bisogno. Ma sarebbe un errore credere che questo dato introduca ordine e razionalità nella comparsa delle soluzioni. Il caso e la serendipità, cioè la fortuita scoperta
di nuove risposte a vecchie domande, hanno molto spazio nell’emersione delle idee. Ecco come Kingdon, in un famoso testo [1984], descrive l’affiorare delle soluzioni:
Si immagini una comunità di specialisti: ricercatori, funzionari del parlamento, gente che lavora in uffici per la pianificazione, la valutazione, il bilancio; accademici, analisti dei gruppi d’interesse. Le idee fluttuano intorno a tali
comunità [...] La germinazione di alternative e proposte in questa comunità è
un processo simile alla selezione naturale biologica. Come le molecole fluttuavano in quella che i biologi chiamano «la zuppa primordiale», prima che
cominciasse ad esserci vita, così le idee fluttuano in queste comunità [...].
Alcune idee sopravvivono e prosperano; alcune proposte sono prese sul serio
più di altre [Kingdon 1984, 122-123].
Tipi di agenda
Le ricerche operano in genere una distinzione tra tre tipi di agenda: dei media, del pubblico, delle istituzioni. Alle prime due abbiamo
già accennato parlando del ruolo dei mezzi di comunicazione e del
loro rapporto con l’opinione pubblica. Qui è importante notare che
non tutti i problemi si presentano altrettanto bene su stampa o televisione [McCombs 1981]. Alcuni sono, per così dire, più fotogenici di
altri. L’offesa al diritto internazionale non suscita la stessa emozione
63 Qualcuno potrebbe ricordare la famosa asserzione di Wittgenstein: «Di una risposta che non si può formulare non può formularsi neppure la domanda» [Wittgenstein 1961, 81 trad. it.].
367
368
CAPITOLO 5
del cormorano con le ali sporche di petrolio, divenuto il simbolo dei
valori da salvare durante la guerra del Golfo. Le difficoltà che devono
affrontare i malati terminali per avere farmaci antidolore allontanano i
lettori, mentre la questione del peso degli zainetti scolastici li attira.
Ma il vero salto di qualità è compiuto quando un problema, con il
suo corredo di soluzioni, cioè di politiche possibili, riesce a entrare
nella più ristretta cerchia dei provvedimenti all’ordine del giorno delle
competenti istituzioni:
Nel dare a un tema lo status di agenda formale, i governi convogliano
importanti messaggi circa chi e che cosa è socialmente importante, circa ciò
che è o non è problematico, circa ciò che ricade o non ricade entro la legittima competenza del governo. Questi messaggi, poiché hanno l’imprimatur
dell’autorità pubblica, servono a definire i vincitori e i vinti in senso sociale e
politico, così come l’allocazione dei beni economici da parte del governo li
definisce in senso economico [Cobb e Elder 1983, 172].
Il controllo del conflitto. Le ricerche sulla formazione dell’agenda
convergono nel sottolineare l’estrema delicatezza di questa fase, dalla
quale dipende l’assegnazione delle probabilità di successo alle varie
parti in causa [Baumgartner e Jones 1993; Cobb e Elder 1983]. Il
modo in cui sono individuate le opzioni sottoposte agli organi decisionali assegna vantaggi e penalizzazioni molto difficili da rimontare perché, come afferma Schattschneider, «la definizione delle alternative è
lo strumento supremo del potere; difficilmente gli antagonisti possono
concordare su qual è il problema, perché il potere è implicito nella
definizione» [1960, 68].
Dunque la formulazione dell’agenda non è neutra rispetto alle alternative che propone, ma rappresenta uno strumento sofisticato per il
controllo o l’allargamento del conflitto.
Quando la strutturazione dei problemi e delle soluzioni gioca sistematicamente per tenere alcune questioni lontane dalle arene decisionali, quando la distorsione è promossa esplicitamente e difesa con ogni
mezzo, allora siamo in presenza di una situazione che alcuni autori
chiamano di «non decisione»:
Si può dire che esiste una situazione di non decisione quando i valori
dominanti, le regole del gioco accettate, le relazioni di potere che esistono tra
i gruppi, gli strumenti di forza, da soli o congiuntamente, riescono a impedire
che il malcontento si trasformi in un esplicito problema che a pieno titolo
sollecita una decisione [Bachrach e Baratz 1963, 641].
L’esclusione dall’agenda diventa in questi casi il segno di una più
generale esclusione dalle risorse a disposizione di una società. Che
questa sistematica discriminazione sia un’eventualità reale e uno strumento analitico adeguato per una democrazia liberale, è questione al
centro di un lungo dibattito, sul quale torneremo tra breve.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Le finestre decisionali. La maggior parte degli studiosi si riconosce
invece in una rappresentazione dell’agenda setting istituzionale basata
sul modello del bidone della spazzatura, per certi versi reso ancora più
precario dall’aggiunta di un nuovo, autonomo flusso: le vicende della
politics, con le loro turbolenze e le loro scadenze.
È questo il momento in cui un abile imprenditore di policy può
sfruttare due elementi: il bisogno dei singoli politici di legare il loro
nome a nuove iniziative, e il conflitto latente tra i diversi comparti istituzionali, ad esempio tra commissioni parlamentari, per marcare il territorio delle loro competenze, dimostrandosi più attivi dei loro colleghi
[Elder e Cobb 1984; King 1997]. In questa fase, l’intraprendenza si
manifesta soprattutto nella capacità di cogliere l’attimo, perché le finestre che aprono un’opportunità di scelta si richiudono con la stessa
rapidità:
Improvvisamente un tema diventa caldo. Sono prese delle iniziative, oppure no, ma in entrambi i casi i policy makers volgono immediatamente la
loro attenzione altrove. Così le occasioni passano, e se gli imprenditori di
policy, che cercavano di abbinare la loro soluzione al tema caldo o alla situazione politica propizia, perdono l’opportunità, devono poi aspettare la prossima occasione [Kingdon 1984, 94].
4.3.2. L’implementazione
Nel quarto capitolo abbiamo già parlato a lungo dell’importanza
dell’implementazione, dei suoi tratti caratterizzanti, delle sue risorse e
dei suoi problemi. Sul piano descrittivo, importa sottolineare ancora
una volta la distanza che separa questo concetto da quelli di amministrazione o di esecuzione:
Se implementazione ha un qualche rilevante significato, è perché fa riferimento a un complesso di attività che stanno tra la policy originaria (un programma, un piano, un’idea, un desiderio) per fare qualcosa rispetto a un
«problema», e qualunque cambiamento si manifesti nella natura, nella dimensione e nell’intensità di quel problema in un tempo successivo [Jordan 1982,
127].
A caratterizzare l’idea di implementazione è soprattutto la complessità delle reti degli attori e dei flussi di influenza che vengono portati alla luce:
Per studiare l’implementazione, occorre capire che sequenze di eventi in
apparenza semplici dipendono da complesse catene di interazioni reciproche
[Pressman e Wildavsky 1973, xxv].
Una struttura di implementazione è un insieme di persone che cercano di
risolvere un problema di policy [...]. Le strutture di implementazione possono
369
370
CAPITOLO 5
essere considerate come creature dalle molte facce: talvolta appaiono come
oggetti «tangibili» (le istituzioni formali), ma tal altra si presentano come
gruppi di persone che formano una struttura visibile solo agli occhi del ricercatore [Carlsson 1996, 537].
La complessità del gioco del potere nel policy making – le sua obliquità,
le imprevedibilità, le frustrazioni, i capovolgimenti, e gli inevitabili parziali
fallimenti – si moltiplica nell’implementazion e delle politiche [Lindblom
1980, 64].
Da un lato, l’avanzare di una politica richiede uno straordinario
impegno e un grande coordinamento da parte di gruppi di attori, istituzionali e no, che si riconoscono nei suoi obiettivi. Dall’altro lato, in
questa fase hanno uno spazio enorme la passività o l’attiva opposizione
dietro cui possono trincerarsi i destinatari riottosi. Anche per il più disincantato studioso, è difficile immaginare i margini di difformità dalla
norma che gli attori, pubblici o privati, riescono a esibire tranquillamente: «L’effetto dominante è il netto carattere difensivo della politics64 dell’implementazione. Gran parte delle energie vanno in manovre
per evitare responsabilità, esami, recriminazioni» [Bardach 1977, 37].
Gli incentivi ufficiali, i premi e le sanzioni sono una leva che fa
poca impressione al destinatario esperto, che sa quanto siano difficili
da assegnare. Innanzi tutto possono avere un effetto negativo sulla
compattezza della policy community; poi hanno elevati costi amministrativi e umani; infine perché i penalizzati possono usare le loro appartenenze politiche o sindacali per accedere agli organi che hanno fissato le regole affinché le cambino:
Non c’è mai una diretta corrispondenza tra l’idea degli incentivi che ha
chi li progetta e quella di chi ne dispone. Il più grande problema è la mancanza di determinazione nell’imporre sanzioni o nell’assegnare premi da parte
dei funzionari incaricati della loro gestione [Stone 1988, 218].
Le agenzie tendono a non utilizzare appieno gli strumenti di coercizione
legale disponibili per le organizzazioni che devono far rispettare la legge [...].
Il numero delle violazioni alle norme che è stato scoperto eccede di gran lunga il numero dei casi in cui le sanzioni sono state effettivamente usate o avviate dalle agenzie [Mayntz 1978, 212]65.
E anche gli incentivi, positivi o negativi, subiscono la legge della
volatilità dell’attenzione:
Non esiste una regola generale per predire come un incentivo modificherà
il comportamento di qualcuno, ma uno scaltro analista deve ricordare che ogni
64
Cioè delle relazioni tra gli attori.
La citazione si riferisce a un paese non lassista quale la Repubblica Federale
Tedesca degli anni ’70.
65
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
nuovo incentivo deve lottare contro la vasta serie di penalità e di compensazioni già esistenti per richiamare l’attenzione; e dovrà comunque passare attraverso
il filtro della percezione della gente cui si rivolge [Stone 1988, 224].
Infine, i rami bassi dell’amministrazione, la burocrazia a livello di
strada [Lipsky 1980] detengono e sfruttano ampi margini di autonomia rispetto al mandato che ricevono dall’alto. È pur sempre nelle
loro mani la scelta tra l’applicazione rigida e quella tollerante: far finta
di non sapere della signora che esce con un modulo e rientra dopo
cinque minuti con la firma del marito in calce; prendere una domanda
incompleta il giorno della scadenza dei termini e tenerla sotto il banco
perché sia integrata il giorno dopo; iscrivere un ragazzo straniero in
una classe superiore evitandogli la prova di italiano. Come abbiamo
più volte sottolineato, questo continuo reciproco adattamento tra implementatori e destinatari può portare a un radicale reindirizzo di una
politica pubblica.
4.3.3. La valutazione
Della valutazione come fase dell’analisi razionale delle politiche, e
dei valutatori come specifica categoria di attori abbiamo già parlato
nelle pagine precedenti. Qui aggiungiamo che le pratiche che caratterizzano la fase di implementazione possono erodere la base scientifica
cui cercano di appoggiarsi gli analisti. Dato che il significato di una
politica pubblica è di norma multiplo e ambiguo, la valutazione condotta da attori esterni deve innanzi tutto decidere a quali obiettivi rifarsi. Una definizione troppo generica porta a concludere che «tutto
va bene»: ma questi rassicuranti resoconti privano gli attori della percezione delle nuove sfide affrontate. Una definizione troppo ristretta
rischia di suscitare conflitti insanabili tra gli stessi policy makers: «Le
discussioni su quali sono realmente, ma realmente e veramente, gli
obiettivi dell’organizzazione possono mettere in ridicolo tutte le azioni
future» [Wildavsky 1992, 216]. In questo modo, «le istituzioni politiche sono condannate a un ciclo infinito di nuove riforme e di scontento» [March e Olsen 1995, 216].
Mettere la parola fine all’analisi degli obiettivi, dei risultati e delle
cause dei fallimenti è di fatto impossibile, perché qualunque politica di
una certa rilevanza è un poliedro con un numero altissimo di facce:
«Ci sono sempre spiegazioni alternative sul perché le politiche falliscono e questo può lasciare i decisori nell’incertezza circa il loro eventuale abbandono» [Wildavsky 1992, 218]. Prendere tempo, richiedere
nuovi dati, aspettare che le circostanze scelgano per loro, sono le strade che i responsabili in genere percorrono per cavarsi d’impaccio [Palumbo 1987].
371
372
CAPITOLO 5
4.4. Gli stili
Se le immagini che descrivono gli attori più influenti cercano di
rispondere alla domanda: «chi?», gli stili decisionali cercano di affrontare la questione: «come?».
In pratica, noi crediamo che spesso i policy makers (siano essi politici o
funzionari) cerchino di sviluppare procedure operative standard per gestire i
problemi che arrivano all’agenda politica. Il flusso dei problemi è inarrestabile e occorre pensare a procedure per trattarli. Per quanto difficile, noi crediamo che alla fine sia possibile per uno scienziato politico identificare le principali caratteristiche del modo in cui una data società formula e implementa
le sue politiche pubbliche [Richardson 1982, 2-3].
Se, come vedremo tra breve, le regole istituzionali sono un’autonoma fonte di vincoli e di risorse, tuttavia esse lasciano in genere ampi
margini per il consolidamento di procedure che, pur senza avere tale
dignità, in pratica finiscono col godere di un universale rispetto. Ecco
ad esempio come Morris Fiorina descrive il policy style americano:
«Decidere» è un verbo troppo intenzionale se riferito alla formazione
delle politiche americane. Le politiche pubbliche sono «compromessi impacchettati delicatamente», o «strutture costruite al risparmio con proposte tra
loro in conflitto». Le politiche «emergono» come «minimo comun denominatore»; sono quel che «sopravvive» dopo che gli «specifici interessi» hanno
detto la loro. Il linguaggio del policy making americano è così ricco e colorito
proprio perché verbi come «decidere» non descrivono come «capitano» le
politiche [Fiorina 1987, 283].
L’analisi comparata si trova spesso a dover prendere atto che in un
certo luogo, o in un certo settore, «lo fanno diverso», anche se poi è
in difficoltà a dare contorni precisi a queste peculiarità: espressioni
quali «il rito ambrosiano», o «la democrazia Italian style»66 fanno riferimento all’esigenza di disporre di categorie sintetiche ma sottili per
descrivere e classificare vicende apparentemente non confrontabili,
quali, ad esempio, la localizzazione di una discarica o la riforma degli
studi universitari.
Questi schemi di riferimento facilitano il decision making perché permettono agli individui di seguire procedure operative standard per le decisioni e
l’implementazione delle politiche, anziché negoziare su tutto ogni volta che
c’è l’esigenza di nuova regolazione67.
66
Il riferimento è al titolo del volume di La Palombara [1987].
M.S. Andersen, Economic Instruments and Clean Water: Why Institutions and
Policy Design Matter, O CSE , 2001, http://www1.oecd.org/puma/regref/pubs/
CleanWater.pdf (agosto 2001).
67
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
Della loro importanza capita di accorgersi nel momento in cui
l’importazione di politiche che altrove hanno funzionato finisce con
l’evidenziare microcosmi di discordanze.
Fin qui, dunque, i vantaggi. Ma il concetto di policy style comporta anche complicazioni non facili da sciogliere.
Il primo grosso problema è l’ambito per la sua applicazione. Più
questo viene a coincidere con le nazioni, o comunque con i livelli di
governo, più il suo spazio analitico è insidiato da altre categorie, con
una ben più solida tradizione di ricerca, quali cultura politica e regime
[Peters et al. 1977]. Sullo sfondo, a incutere un certo timore, sta la
controversa idea di carattere nazionale, che tuttavia qualche base empirica deve avere, se la descrizione di quello italiano, fatta da Leopardi
quasi due secoli fa, sembra scritta appena ieri68.
Alcuni autorevoli studiosi, quali Aaron Wildavsky, non sembrano
impressionati da questa concorrenza e perseguono un loro disegno di
ricerca che mira a collegare il modo con cui sono fatte le politiche ad
alcuni fondamentali stili di vita, che le grandi civilizzazioni traducono
in compatte organizzazioni sociali ma che, in miscugli diversi, sono
presenti in ogni società. Secondo Douglas e Wildavsky [1982], esistono quattro culture elementari, capaci di sostenere e giustificare il
modo in cui è organizzata la vita collettiva: egualitaria, individualistica,
gerarchica e fatalistica. Le politiche sono selezionate in base alla sensibilità che deriva dal riconoscersi nell’una o nell’altra cultura.
Il secondo grande problema legato all’uso di questo concetto riguarda la difficoltà dell’operazionalizzazione, che ne tradisce le origini
estetiche. Come in architettura, in cui talvolta è una colonna talaltra è
un arco a fondare l’attribuzione, così anche per le politiche pubbliche
è difficile dire a quali elementi occorra rifarsi per definire uno stile.
Come è evidente, le complicazioni del primo e del secondo tipo sono
tra loro collegate, perché più il disegno della ricerca è inclusivo, fino a
comprendere gli stati o addirittura le civilizzazioni, più diventa difficile
presentare i risultati in un formato replicabile.
Per questi motivi, il concetto di stile sembra dare frutti più certi
quando ridimensiona le sue pretese, tenendosi ancorato a precisi ambiti di policy e a prospettive di medio raggio, ad esempio con la comparazione di politiche circa uno stesso problema, ma in contesti istituzionali diversi [Gormley e Peters 1992; Vogel 1986; Zahariadis, 1995].
4.4.1. Le diverse dimensioni
Se la prospettiva è questa, una prima, elementare tipologia degli
stili di policy (tab. 5.1) non può che essere basata sulla griglia che nel
68
Giacomo Leopardi, Dei costumi degli Italiani, 1824.
373
374
CAPITOLO 5
TAB. 5.1. Gli stili delle politiche
Policy inquiry
Minima:
Pratica sociale riflessiva
Massima:
Aggiustamento reciproco
Minima:
Incrementalismo sconnesso
Minimo:
Garbage can/ingegneria
dell’intelligenza
Preoccupazione
Oggettività del giudizio
Necessità della mediazione
Completezza del disegno
Controllo del tempo e del caso
Analisi razionale
Massima:
Importanza dei dati
Minima:
Validità scientifica delle ipotesi
Massima:
Analisi sistematica
Massimo:
Valutazione ex ante
quarto capitolo abbiamo proposto per l’analisi dei processi attraverso
cui si affermano le politiche pubbliche. Nella tabella 5.1, le dimensioni
su cui si fonda la policy inquiry sono riprese e contrapposte al loro «altro», cioè alle linee guida dell’analisi razionale delle politiche.
Pratica sociale riflessiva/importanza dei dati
• Gli elementi su cui si basano le politiche sono considerati come
costrutti sociali o come dati oggettivi?
• I problemi inediti sono affrontati ricorrendo alla sperimentazione (exploration) o confidando sulla razionalità strumentale (exploitation)?
• I problemi di identità degli attori hanno risalto oppure no
[Schön e Rein 1994]?
Aggiustamento reciproco/validità scientifica delle ipotesi
• I conflitti sono trattati ricorrendo alla negoziazione o invocando
criteri di efficienza?
• I compromessi tra gli interessi in gioco sono considerati un passo avanti o un cedimento?
• Gli esperti di politiche si ispirano alla policy inquiry o alla
rational policy analysis [Leman 1980; Richardson 1982]?
Incrementalismo sconnesso/analisi sistematica
• I processi decisionali avanzano con la logica del passo dopo
passo o con la logica della massima comprensività del disegno di riferimento?
• Esistono molti tavoli decentrati di negoziazione, o i contrasti si
addensano intorno a poche ma profonde contrapposizioni?
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
• I risultati maggiori sono conseguiti con piccoli aggiustamenti o
con svolte drammatiche [Richardson 1982]?
«Garbage can»/valutazione «ex ante»
• Il caso è considerato una fonte di innovazione o un elemento di
disturbo?
• Proiettare le conseguenze delle scelte su un ampio orizzonte
temporale è visto come un esercizio di retorica o di programmazione?
• Le opportunità di scelta vanno colte o costruite [Kingdon 1984;
Zahariadis 1995]?
4.5. Le regole
La categoria che presentiamo ora deve dare risposte alla domanda:
qual è il contesto istituzionale che fa da sfondo al policy making, qual
è la scena, il campo da gioco, e quali sono le sue regole?
Delle nostre cinque categorie di base, questa probabilmente è la
più difficile da definire e da trattare. In primo luogo, mentre le altre
quattro sono state autonomamente impostate all’interno dei policy studies, questa dipende largamente, per la sua definizione, da un dibattito
esterno alla disciplina: dal diritto, dalla scienza della politics e, più recentemente, dalla sociologia. In secondo luogo, lo studio delle politiche ha nel suo patrimonio genetico una diffidenza di fondo verso le
spiegazioni delle decisioni pubbliche in termini di assetti istituzionali
formali. In generale, come abbiamo visto nel quarto capitolo, condivide l’idea che non tutto ciò che si rivela capace di facilitare il coordinamento è necessariament e scelto e progettato in modo deliberato
[Hayek 1952]. Infine, gli approcci decisamente orientati alle politiche
fanno propria la logica del processo, non quella dell’algoritmo: pertanto sono attenti ai margini per la continua reinterpretazione di tutti i
vincoli, compresi quelli istituzionali.
Detto questo, occorre aggiungere che, paradossalmente, il concetto
di istituzione è stato più facile da dominare quando la definizione del
termine rinviava a componenti tradizionali quali la giurisdizione, le
competenze, la consistenza territoriale [DiMaggio e Powell 1991]. Se
si pensa alle istituzioni come a un parlamento, a una corte costituzionale, a un’amministrazione locale, lo studio delle politiche pubbliche
può facilmente ricorrere a due solide categorie: quella di attore, e
quella di contenuto.
Le istituzioni come attori. Da questa prospettiva, il tema della ricerca viene definito nei seguenti termini: si può sostenere che le isti-
375
376
CAPITOLO 5
tuzioni intervengono nel policy making con criteri di azione autonomi, che ne fanno dei veri e propri attori, al pari di un partito o di
un’organizzazione degli interessi? Dagli anni ’40, la risposta è, invariabilmente, sì.
Innanzi tutto, le istituzioni si ribellano a chi vorrebbe decretarne la
morte: come dimostrano le vicende italiane delle province o del ministero dell’agricoltura, la loro tendenza è all’immortalità [Kaufman
1976]. Inoltre, le istituzioni hanno loro interessi e sono in grado di
difenderli con adeguate strategie. Quando amministrazioni locali, regioni, università, corpi delle forze armate, branche della magistratura
vedono minacciate le loro competenze, o i loro budget, si impegnano
in una pressione che non ha niente da invidiare ai grandi gruppi economici per tenacia, insistenza e spregiudicatezza [Salisbury 1984]. Infine, le istituzioni non rinunciano alle loro aggressive iniziative nemmeno quando si trovano davanti ad altre istituzioni. Le ricostruzioni dei
networks per le politiche trovano spesso, in gangli centrali, corpi dello
Stato attivamente impegnati gli uni contro altri nella promozione di
alcune soluzioni. Come dimostrano gli studi sulle relazioni intergovernative69, la competizione può anche essere molto serrata, se ad esempio sono in gioco le localizzazioni di imprese o di opere pubbliche che
portano occupazione certa e voti probabili [Stoker 1991; Marando e
Florestano 1990].
Il cambiamento istituzionale come politica pubblica. Come vedremo
meglio nel prossimo paragrafo dedicato ai contenuti, molti autori considerano le politiche istituzionali come una specifica arena di policy,
con i suoi attori preminenti, le sue peculiari risorse, i suoi stili, la sua
dinamica. In effetti chi studia questo settore sottolinea la peculiarità
dei processi decisionali che hanno per oggetto non l’allocazione di risorse o la prescrizione di specifici comportamenti, ma le regole che
devono servire per prendere in futuro queste decisioni. Le scelte di
questo tipo sono strutturate da coalizioni di sostegno animate da giuristi e politologi. Queste iniziative devono inoltre confrontarsi con il
problema del frequente collasso del ruolo di policy maker in quello di
policy taker, come avviene nel caso delle decisioni parlamentari sulle
riforme elettorali: tanto più chiare sono le conseguenze in termini di
chi guadagna e chi perde, tanto più probabili sono conflitti e tattiche
dilatorie. Quando invece eventi eccezionali intervengono a scombinare
le capacità previsionali degli attori, i margini per l’accordo tornano ad
aprirsi [Lane 1990; Lijphart e Grofman 1984].
69 Concetto inizialmente utilizzato per descrivere le relazioni tra unità centrali,
statali e locali in un sistema federale, con riferimento soprattutto alle politiche fiscali,
ma ormai esteso a ogni rapporto tra istituzioni politiche.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
4.5.1. Il nuovo istituzionalismo
Il vecchio istituzionalismo induceva a dare per scontato il peso che
gli assetti organizzativi interni al settore pubblico e le regole formali
hanno nel condizionare il processo di policy. Decidere il tracciato di
una metropolitana in una città con strutture decisionali accentrate e
con ampia delega di funzioni ai ruoli manageriali non è come fare la
stessa operazione in un comune con consigli di quartiere potenti e con
una giunta composta da politici gelosi delle loro prerogative. Come
abbiamo più volte ripetuto, lo studio delle politiche pubbliche porta a
considerare tutt’altro che automatica questa conclusione [Ashford
1982; Vogel 1986].
Ma negli anni ’80, il concetto di istituzione subisce una mutazione
genetica e allarga il suo significato, fino a comprendere tutti i vincoli
che gli attori condividono per il fatto stesso di vivere in una determinata società: le culture, i valori, i frames cognitivi:
Nella teoria delle organizzazioni e in sociologia, il nuovo istituzionalismo
comprende il rifiuto dei modelli dell’attore razionale, l’interesse per le istituzioni come variabili indipendenti, una svolta a favore delle spiegazioni cognitive e culturali e un interesse per le proprietà delle unità di analisi sovraindividuali, che non possono essere ridotte all’aggregazione delle conseguenze
dirette delle caratteristiche o delle motivazioni individuali [DiMaggio e
Powell 1991, 272].
Per «regole» noi intendiamo le routine, le procedure, le convenzioni, i
ruoli, le strategie, le forme organizzative e le tecnologie intorno a cui viene
costruita l’attività politica. Intendiamo anche le credenze, i paradigmi, i codici, le culture e le conoscenze che circondano, sostengono, elaborano e contraddicono quei ruoli e quelle routine [March e Olsen 1989, 48 trad. it.].
A questo punto, il concetto di istituzione diventa potente e complesso come quello di politica pubblica o di organizzazione: al pari di
questi suoi concorrenti, si presenta come il nuovo paradigma alternativo alla razionalità economica; come loro, ridefinisce il confine tra
l’ordine e il disordine, e si candida a piantonarlo in modo più efficiente [Lanzalaco 1995].
Riassumere in poche righe questa svolta non avrebbe senso. Due
dati meritano comunque di essere evidenziati. In primo luogo, vecchio
e nuovo istituzionalismo condividono l’idea che sono le istituzioni –
comunque definite – a determinare le politiche. In secondo luogo, da
questo momento, quando nelle scienze sociali si parla di istituzioni o
di regole, si fa riferimento a concetti che si sono completamente liberati delle loro componenti tradizionali: la giurisdizione, le competenze,
la delimitazione territoriale.
Per certi versi, da queste impostazioni deriva un notevole miglioramento d’immagine delle logiche all’opera nelle istituzioni: non più solo
377
378
CAPITOLO 5
interessi, potere e rivalità, ma anche il senso di un’identità metaindividuale, l’impegno ad affermare valori e convinzioni. E tuttavia, come
molti hanno sottolineato [Peters 1999; Sjoblom 1993; Jordan 1990c],
da queste fonti arrivano non solo nuove idee, ma anche suggestioni
confuse e contraddittorie: quali fattori sono significativi per la dinamica del policy making? le istituzioni? le regole? le culture? i contesti organizzativi? i frames cognitivi? E se è di tutto un po’, come va dosato
il mix?
La contrapposizione tra vecchio e nuovo istituzionalismo schiude
nuove prospettive analitiche. Per le teorie tradizionali di matrice politologica, le istituzioni sono qualcosa «là fuori» che interviene a vincolare le scelte dei policy makers, come le regole del poker condizionano
le scelte dei giocatori intorno a un tavolo, dando loro elementi per calcoli strategici e fornendo la base per le negoziazioni che prima della
partita si possono aprire, per integrare con accordi locali i punti controversi, per stabilire il tetto alle giocate o il tempo a disposizione.
Per le nuove teorie di matrice sociologica, le istituzioni hanno inzuppato gli attori, ne hanno plasmato le identità, le preferenze, a una
profondità che lascia poco scampo per comportamenti strategici, per
accordi negoziati, e magari per furberie: pagare il biglietto sul tram,
per chi è cresciuto nei valori della legalità e della città come grande
famiglia, è un comportamento che non dipende dalla frequenza dei
controlli o dall’ammontare delle multe. Da questo punto di vista, dunque, «è pressoché impossibile sradicare una vecchia identità. Da questa prospettiva il mondo appare come un “museo vivente” di identità
e lealtà» [Ferguson e Mansbach 1996, 36].
Rispetto a queste due impostazioni, la prospettiva di medio raggio
delle ricerche decisamente orientate alle politiche permette di considerare le istituzioni come fenomeni né solo «là fuori», come vincoli dati,
che possono al massimo essere erosi o rafforzati a seconda delle situazioni, né solo «qui dentro», calati così in profondità nelle culture degli
attori e sepolti sotto tali cumuli di valori, conoscenze, emozioni, che
l’intenzionalità difficilmente può scalfire.
4.5.2. Le istituzioni viste dalle politiche
Lo specifico contributo che lo studio delle politiche ha autonomamente portato alla conoscenza delle istituzioni si basa sulle seguenti
dimensioni.
Formali/informali. È questa la paratia più facile da sfondare, perché dalla sua nascita lo studio del policy making dimostra che il rapporto tra regole formali e regole informali può essere totalmente squilibrato a vantaggio di queste ultime. Come è noto, i compleanni dei
bambini sono afflitti da una grande omogeneità, anche se nessuna
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
norma esplicita interviene a regolarli. Quando sono in gioco le policy,
i divieti, le prescrizioni, i limiti difficili da scalfire non sono prodotti
solo dalle istituzioni politiche, ma da una serie molto più ampia di vincoli, capaci di condizionare la libertà di azione degli attori, pur senza
obblighi formali:
Oltre alle leggi e ai regolamenti formali, le società hanno molti altri tipi
di regole per coordinare il comportamento: costumi e tradizioni sociali, norme informali delle famiglie e dei piccoli gruppi, regole e principi morali, regolamenti e statuti delle associazioni private. Queste regole non ufficiali spesso hanno la forza della legge, quanto meno per il potente impatto sulla vita
della gente, e possono rinforzare o minacciare le regole ufficiali. L’aspetto più
importante è che le regole non ufficiali modellano sia le categorie e le classificazioni utilizzate nelle regole ufficiali, sia le loro interpretazioni e le applicazioni pratiche. L’analisi delle politiche è incompleta se non considera il modo
in cui interagiscono gli aspetti formali e informali delle regole [Stone 1988,
231].
Nella nostra società contemporanea fatta di molteplici attori, i processi di
policy operano in diverse arene. In questa società, non ci sono evidenti e
univoche relazioni tra le decisioni politiche formali e gli esiti nei singoli campi. Dunque non si può dare per scontato che le gerarchie politiche formali
siano rilevanti per un determinato problema [Carlsson 1996, 542].
È importante notare che, di per sé, l’esistenza di una costante sfasatura tra le regole e le pratiche può essere facilmente incorporata
anche nella teoria istituzionale classica, come ci ricorda, ad esempio, il
concetto di costituzione materiale. Il dato nuovo è la crescente, sistematica incongruenza tra l’architettura delle giurisdizioni, continuamente alle prese con l’inadeguatezza e la porosità dei loro confini, e l’efficacia delle politiche, sempre più spesso basata sul loro scavalcamento.
Cogenti/indeterminate. Nelle pagine precedenti abbiamo già toccato il tema dell’indeterminatezza e della complessità da un punto di vista generale. Ritorniamo ora su questo tema per sottolineare come alla
sua origine non stia solo la folla degli attori stipati anche nelle più modeste aree di policy, ma anche la ressa delle sedi istituzionali autorizzate a intervenire in un momento o nell’altro del processo decisionale.
Lo straordinario affollamento non è più solo una caratteristica di sistemi federali, quale quello americano, che fanno della «cacofonia delle
voci» un esplicito criterio costituzionale, ma accomuna anche ordinamenti nati da un’architettura più razionalistica, e tuttavia obbligati a
fare i conti con appartenenze sovranazionali multiple e con il continuo
pullulare di nuove istanze infranazionali [Schmitter 1996].
Pluralità significa esplosione delle possibilità combinatorie; significa un tale incremento delle interazioni tra sedi che «hanno titolo per
intervenire», da rendere imprevedibili i loro effetti.
379
380
CAPITOLO 5
Secondo una logica non dissimile da quella all’opera per il pluralismo degli attori, l’elevato numero delle combinazioni e la loro continua coevoluzione rendono il pluralismo delle istituzioni più incline all’indeterminatezz a che al sistematico condizionamento [Lindblom
1980]. Di nuovo, le metafore per illustrare questi processi sono prese
più dalla biologia che dalla meccanica:
Le regole in vigore oggi non sono semplicemente la soluzione di qualche
problema di ottimizzazione rispetto all’ambiente attuale, ma sono una rappresentazione interattiva e path dependent di una storia di co-evoluzione tra regole [March 1994, 96].
Questa impostazione porta March e Olsen a parlare di «ecologia
delle regole»70.
Una frequente dimostrazione di questo effetto è il fenomeno degli
incentivi perversi: «Gli incentivi perversi sono involontariamente generati da regole la cui osservanza crea nuovi problemi o esaspera proprio
quelli che intendeva curare» [Stone 1988, 239]. Il più semplice esempio è fornito dalle conseguenze impreviste della densità normativa.
Come il caso italiano dimostra, i margini di autonomia per i policy
maker si allargano quando su un settore gravano centinaia di norme.
Con il crescere del loro numero e della loro complessità, infatti:
• aumentano le probabilità di interpretazioni contraddittorie e di
conflitti;
• diminuisce lo stigma verso l’illegalità; tutti possono farsi schermo
del fatto che «facendo qualsiasi cosa si violano una decina di norme»;
• diminuisce la propensione a investire energie per informarsi sui
loro contenuti; in genere, si fa appello a «quello che conosce la legislazione», senza verificare la fondatezza del suo sapere;
• diminuiscono i controlli, perché gli uffici deputati sono oberati
da problemi interpretativi.
Esogene/endogene. Gli attori che si muovono in arene di policy
non sono bersagli passivi di norme decise da chi sta sopra di loro, ma
sono essi stessi produttori di regole e disegnatori di campi da gioco.
Innanzi tutto, gli attori sono portatori di codici di comportamento, e
non solo destinatari, perché hanno alle spalle delle organizzazioni
«madri» da cui ricevono, in modo più o meno selettivo, principi, sanzioni, rappresentazioni del loro ruolo [Hall 1986]. Se per il cristiano è
un’opera di misericordia andare in soccorso a un immigrato, è probabile che i volontari di organizzazioni religiose che operano in questo
settore vaglino le norme giuridiche sugli obblighi di denuncia o di
70 Come molti autori hanno rilevato, il contributo di March e Olsen allo studio
delle istituzioni ha tali e tante facce da poter essere collocato in più di un settore della
nostra mappa. Ma forse questo è proprio il risultato voluto.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
espulsione alla luce dei loro propri criteri, diversi da quelli della polizia e della magistratura. Per tornare all’esempio del tracciato di una
metropolitana, non è detto che l’ampiezza delle competenze giochi
sempre a favore della capacità di intervento dei consigli di quartiere.
La continua sollecitazione di decisioni può anche portare alla sclerosi,
alla riduzione al ruolo di passacarte, se le organizzazioni che esprimono i loro membri in questi organismi non sanno o non vogliono valorizzare questa prerogativa.
Ma è soprattutto quando sono collegati in un policy network che
gli attori diventano autonome fonti di principi, norme, sanzioni.
Ogni decisore si adatta a un ambiente che comprende altri decisori in
fase di apprendimento, ciascuno situato in organizzazioni in cui interagiscono
individui e sottogruppi in fase di apprendimento. Pertanto la dinamica del
cambiamento delle regole non può essere compresa semplicemente mettendo
a fuoco lo sviluppo delle regole da parte di un singolo decisore o di una singola istituzione decisionale. L’esito di ogni particolare azione dipende da ciò
che fanno gli altri decision makers [March 1994, 97].
Molte azioni, pur rientrando perfettamente nella legalità, sono
escluse perché considerate sfide inaccettabili. Altri comportamenti,
eticamente o giuridicamente più dubbi, sono approvati perché compiuti nel tentativo di dare soluzione a un problema.
In determinate situazioni, i policy networks possono assumere un’autorevolezza tale da fare di essi gli unici affidabili referenti. Dalla loro
hanno alcuni argomenti di sicuro effetto. In primo luogo, i networks
cercano di «andarsene fuori», hanno una tensione verso i risultati e una
sensibilità per il modo in cui sono raggiunti che legittimano la loro intraprendenza, anche quando si fanno da sé le regole [O’Toole 1997].
In secondo luogo, i networks possono riconoscere e trattare il problema della discrezionalità e dell’interpretazione [Hawkins 1992]. Sanno che queste facoltà sono distribuite ovunque, dall’impiegato allo
sportello delle poste, all’esperto con una ricca consulenza, perché «la
varietà delle situazioni umane è sempre più grande della varietà delle
categorie della regola, anche della più precisa» [Stone 1988, 239].
Baldwin e Hawkins [1984 cit. in Black 1997] parlano della discrezionalità come del dentifricio nel tubetto: lo si comprime da una parte, e
si gonfia da un’altra. I partecipanti al policy network sanno quanto sia
importante indirizzare questi margini di autonomia, per alimentare
una comune interpretazione della situazione, delle sue risorse e dei
suoi vincoli, compresi quelli normativi.
Infine, talvolta gli aggiustamenti sperimentati all’interno di un policy network possono vincere la forza di gravità e risalire dal basso di
un singolo settore a livelli istituzionali più ampi e più alti, per gli
aspetti positivi come per quelli negativi. Così, ad esempio, le soluzioni
tecnologiche e organizzative sperimentate in alcuni comuni per il rilascio di documenti via Internet dischiudono scenari capaci di incidere
381
382
CAPITOLO 5
sulla filosofia generale della riforma amministrativa. E l’implementation
network [Carlsson 1996] saldatosi all’interno della politica previdenziale italiana degli anni ’70 ha condizionato non solo l’evoluzione di
questo settore, ma anche i giochi nell’arena della politica nazionale
[Regonini 1996a].
4.6. I contenuti
L’ultima domanda che affrontiamo è anche la più importante:
«che cosa?», cioè quali contenuti una politica propone? quali modificazioni introduce nello status quo? Tra le categorie analitiche che consideriamo essenziali, questa occupa indubbiamente un posto centrale.
Come abbiamo più volte ripetuto, i problemi da trattare hanno la
capacità di attirare attori, di promuovere certe procedure operative
standard, di adattarsi meglio a certi stili. Insomma, le politiche sono il
nucleo intorno a cui si addensano microcosmi dotati delle loro culture,
delle loro regole, della loro rete di interazioni. Con un’espressione
causa di grandi problemi di traduzione, ogni policy ha la sua politics,
cioè le sue relazioni tra gli attori, le sue leve per la distribuzione dell’influenza.
Se questo è il primo passaggio, il secondo è: si può pensare a una
tipologia che permetta di ricondurre la grande diversità tra le politiche
a pochi, elementari modelli che agevolino il riconoscimento o l’anticipazione delle loro diverse componenti? In questo caso, il problema,
come scrive Fritz Scharpf, è «ridurre l’infinita varietà dei casi del
mondo reale a in insieme più piccolo di descrittori, capaci di condurre
a una sistematica tipologia delle situazioni problematiche, degli strumenti di policy, delle strategie di implementazione e delle variabili di
struttura e di processo che influenzano la sostanza del processo di
formazione e di implementazione delle politiche» [Scharpf 1977, 336].
Le risposte che sono state date a questa esigenza, esse stesse molto
varie, ci obbligano a una drastica selezione. Innanzi tutto, alcuni tipi di
politiche emergono per la loro difformità rispetto alle attese che anche il
lettore dovrebbe nutrire, arrivato a questo punto del libro. Infatti ci stupiscono perché non si adeguano a due probabili aspetti del policy
making: il suo procedere per aggiustamenti incrementali e il tendere a
risultati concreti. Da queste due caratteristiche si discostano, rispettivamente, le politiche radicalmente innovative e le politiche simboliche.
4.6.1. Continuità/innovazione
Questa dimensione è stata evidenziata per dare conto del diverso
grado di tenuta del modello incrementale. Lo stesso Lindblom [1959],
infatti, riconosce che la rappresentazione dei processi decisionali basa-
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
ta sul partisan mutual adjustment non ha validità universale e viene talvolta smentita dai fatti.
Lo studio dell’innovazione nelle politiche attinge a un vasto bagaglio teorico, che si estende dagli approcci macro a quelli micro. I primi sono interessati a misurare gli esiti finali dei processi di innovazione, valutandoli in base alla distanza dalle situazioni di partenza o al
grado di convergenza con le risposte date in altri contesti a problemi
analoghi. La crisi dei sistemi previdenziali è fronteggiata con interventi
analoghi per ampiezza e contenuti, o i diversi paesi procedono in ordine sparso? Una volta misurato l’output, è possibile la verifica delle
ipotesi circa la rilevanza dei diversi insiemi di variabili indipendenti,
secondo una strategia di ricerca non diversa da quella utilizzata per
individuare le determinanti della spesa pubblica: gli orientamenti politici dei governi incidono sulla loro maggiore o minore propensione
all’innovazione? e le caratteristiche istituzionali? L’idea che i contesti
democratici tendano a rafforzare l’ipoteca del vecchio sul nuovo è sottolineata già da Tocqueville:
Non è facile che una persona concepisca in una democrazia, d’un tratto,
un sistema di idee del tutto nuovo, come pure è difficilissimo che qualcuno
riesca a convincere un altro su un argomento nuovo. [...] Se Lutero fosse vissuto in un secolo d’eguaglianza e non avesse avuto per uditori principi e signori, forse avrebbe trovato maggiore difficoltà a cambiare la faccia dell’Europ» [Tocqueville 1835, 256 trad. it.].
Gli studi micro considerano invece le innovazioni per i loro risvolti
cognitivi, dato che il passaggio da una linea d’intervento a un’altra richiede l’abbandono delle teorie implicite che sorreggono una politica.
Come abbiamo visto parlando dei policy frames, la tenacia di queste
costruzioni le rende capaci di resistere con successo anche alle evidenze contrarie:
Le teorie implicite riflettono e organizzano gli orientamenti collettivi.
Indifferenti a tutte le contraddizioni e le ambiguità insite nella realtà, esse
stabilizzano pensiero e azione in un particolare contesto sociale. Grazie alla
loro capacità di conferire significati plausibili, questi costrutti teorici producono effetti diretti e pratici [Hoffman 1995, 140].
Un approccio decisamente orientato alle politiche utilizza queste
due serie di ricerche per approfondire le condizioni della disponibilità
alla sperimentazione, all’apprendimento, alla riflessività che, come
abbiamo visto nel quarto capitolo, costituiscono passaggi fondamentali
per l’avvio e il consolidamento dei cambiamenti di policy [Wildavsky
1992]. Inoltre, questo tipo di ricerche si interroga sulle categorie di
attori capaci di dare un contributo a queste svolte. Se si eccettuano
straordinari periodi di riforma, quali il New Deal negli Stati Uniti o la
ricostruzione postbellica in Europa, l’innovazione di policy passa attra-
383
384
CAPITOLO 5
verso reti «dedicate» e si propaga attraverso complessi processi di trasferimento del know how [Dolowitz e Marsh 1996; Mintrom 1997].
Le idee svolgono un ruolo fondamentale nell’addensare i gruppi di
policy makers capaci di promuovere il cambiamento. Pertanto, comunità epistemiche e coalizioni di sostegno [Sabatier e Jenkins-Smith
1993] sono le due metafore più usate per descrivere le relazioni tra gli
attori. Il loro anello più delicato è quello che congiunge gli studiosi ai
funzionari amministrativi, chi deve pensare a chi deve fare. A livello
infranazionale, le associazioni professionali dei dirigenti pubblici e le
scuole per il loro aggiornamento rappresentano sedi di raccordo fondamentali, grazie ai corsi di formazione, ai convegni, alle pubblicazioni, ai siti Internet [Berry e Berry 1999]. A livello internazionale, questo
ruolo è in genere svolto da organizzazioni quali la Banca mondiale,
l’OCSE, l’ONU [Haas 1990]. Si pensi ad esempio all’importanza che
l’Organizzazione mondiale della sanità ha avuto nel promuovere modalità organizzative completamente nuove per fronteggiare l’epidemia
dell’A IDS. L’innovazione infatti cresce più per propagazione che per
autonoma germinazione. L’esistenza di casi da imitare [Walker 1969]
o di lezioni da imparare [Rose 1993] aumenta sensibilmente la velocità
del cambiamento e riduce i costi del suo consolidamento.
4.6.2. Risultati/simboli
Un posto di rilievo nelle tipologie di policy è occupato dalla distinzione tra politiche «sostanziali» e politiche simboliche. Normalmente, le politiche sono considerate come catene di interventi per
arrivare a tangibili modificazioni di uno stato di cose considerato
fonte di problemi: pertanto la loro riuscita dipende dall’effettivo ottenimento degli scopi prefissi. Alcuni autori [Edelman 1964; Gustafsson 1983] hanno messo in evidenza l’esistenza di politiche che
devono la loro ragion d’essere al fatto di non produrre tangibili effetti. La controversa classe delle politiche simboliche è il prototipo di
questa categoria. Come abbiamo visto a proposito dell’implementazione, l’eventualità che i propositi restino sulla carta è tutt’altro che
improbabile. E tuttavia, per gli approcci di ispirazione pluralista,
molti interventi rimangono senza conseguenze per due ordini di
motivi. Innanzi tutto, sono i molteplici, contrastanti, instabili giochi
di pressioni e contropressioni a condannare le proposte a questo
destino. In secondo luogo, le politiche si riducono a buoni propositi
per il mancato riconoscimento dei loro limiti: promesse quali migliorare la salute della gente, ridurre la criminalità, migliorare l’istruzione, sono tanto nobili quanto solo parzialmente nel controllo dell’intervento pubblico [Wildavsky 1992, 47].
Alcuni studiosi colgono invece nella mancata implementazione una
maggiore malizia e intenzionalità. In questi casi, l’aspetto simbolico
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
costituisce l’unico effettivo contenuto di una proposta, sicché la sua
carente attuazione non è da attribuire a imprevisti ostacoli di percorso,
ma è parte integrante della struttura del provvedimento, progettato e
voluto proprio per la sua intrinseca vaghezza. La mancata definizione
dei responsabili dei controlli, le procedure nebulose, i tempi indefiniti,
l’assenza di sanzioni sono utili tracce per identificare il deliberato depotenziamento di una politica. Molti casi di regolazione, dai divieti di
fumo all’impegno didattico dei docenti universitari, sono soggetti a
queste debolezze.
In altri casi, invece, la compensazione simbolica può rivelarsi un
utile sostituto di beni materiali non disponibili nella misura necessaria
per soddisfare le richieste di ampi gruppi. Per Edelman, uno dei modi
più utilizzati per comporre conflitti tendenzialmente irriducibili consiste nel «dare agli uni la retorica, e agli altri la decisione» [1964, 39].
In queste circostanze, possono essere ad esempio sfruttate le gratificazioni che dovrebbero derivare a una categoria dal fatto di cambiare
nome e di passare da spazzino a operatore ecologico, o da preside a
dirigente scolastico.
Questa impostazione riporta al centro dell’analisi l’importanza dei
rapporti di potere nella configurazione del policy making:
L’ambiguità dei simboli facilita la trasformazione degli sforzi individuali
in decisioni collettive. I simboli sostengono le coalizioni mentre i puri interessi materiali dividono la gente. Consentono ai leader di aggregare ampie basi
di sostegno per politiche circoscritte. Facilitano la negoziazione. Permettono
ai policy makers di ritirarsi a realizzare i loro obiettivi in arene più ristrette e
meno visibili. Rintuzzano le resistenze con le rassicurazioni, quando invece le
politiche comportano effettive privazioni [Stone 1988, 126].
Per Edelman e per quanti si riconoscono nella sua teoria, l’incongruenza e l’inefficacia delle politiche è direttamente funzionale alla
conservazione di precise gerarchie di interessi: «Una policy dunque è
un insieme di cangianti, diverse e contraddittorie risposte a uno spettro di interessi politici» [Edelman 1988, 16].
Negli anni ’80, anche per effetto della svolta neoistituzionalista, il
rapporto tra politiche e simboli va incontro a un riorientamento. Le
ricerche tendono infatti a sottolineare come in ogni decisione degli
organi di governo sia insito un aspetto espressivo, non solo in sostituzione di quello strumentale, ma a sua integrazione [Douglas e Wildavsky 1982; Miller 1993]. Infatti le politiche, oltre a proporsi di modificare l’ambiente o i comportamenti, comunicano valori e intenzioni,
affermano la sintonia tra le preoccupazioni dei policy makers e quelle
della gente, danno giustificazioni in armonia con i modelli culturali
prevalenti:
I dati empirici ci dicono fondamentalmente che i simboli della riforma
amministrativa sono importanti per i politici, non solo come strumenti per
385
386
CAPITOLO 5
imbrogliare gli elettori, ma anche come riflessi delle loro credenze. Le amministrazioni rinnovate al pari dei loro sostenitori, credono nella possibilità di
essere realmente diverse; il ricorrere poi di grandi tentativi di riorganizzazione
è connesso proprio a questa credenza [March e Olsen 1989, 141 trad. it].
Le conseguenze per la politics del policy making diventano più
complicate. Se le politiche simboliche del primo tipo sono un po’ un
gioco di bussolotti capace di catturare la credulità e il consenso popolare, la dimensione simbolica di cui sono intrise le varie politiche può
rendere più difficile l’accordo, se le parti in causa si considerano
orientate da una missione basata su principi generali. Nel caso di
molte issues ambientali, ad esempio, il richiamo al valore del mercato
da un lato, e a quello dell’ecosostenibilità dall’altro, può dar luogo a
situazioni di stallo difficilmente aggirabili [Pouncy 1988; Wilkins e
Patterson 1991].
4.6.3. La tipologia di Lowi
Il più organico tentativo di abbinare entro un modello rigoroso il
diverso significato delle politiche pubbliche alle varie configurazioni di
attori, processi decisionali, luoghi istituzionali è stato compiuto da
Lowi [1964; 1972]. La sua tipologia è importante per tre ordini di
motivi: innanzi tutto, per il numero limitato (quattro) di tipi, o arene,
tratteggiati con una precisa fisionomia; in secondo luogo, per la forza
della relazione individuata tra tipi di politiche e tipi di politica; infine,
per le dimensioni che stanno alla base della sua matrice.
Lowi riconduce la grande varietà delle politiche a quattro configurazioni di base, storicamente e funzionalmente distinte.
1. Le politiche distributive. Rientrano in questo genere le politiche
che forniscono precisi benefici a ben delimitati gruppi sociali o ambiti
territoriali: sussidi a sostegno di certe attività economiche, agevolazioni
fiscali a particolari professioni o aree geografiche, programmi per opere pubbliche localizzati in determinate zone. La loro caratteristica fondamentale è la disaggregabilità, cioè la possibilità di ritagliare al loro
interno insiemi sempre più piccoli di destinatari. La politics che caratterizza queste politiche è basata sul log-rolling71, cioè sul compromesso
e sullo scambio di favori. Infatti le coalizioni che sostengono questi
interventi non sono fondate su interessi comuni, ma sulla sommatoria
di richieste e sulla non interferenza reciproca. Il conflitto è quasi assente, perché queste «sono politiche in cui non vi è mai bisogno di un
confronto diretto tra chi viene beneficiato e chi viene penalizzato, tra
chi riceve e chi ci rimette» [Lowi 1964, 20 trad. it.]. In genere le com71 Talvolta sostituito dal termine pork-barrel, espressione colloquiale traducibile
con «mercato delle vacche».
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
missioni parlamentari competenti sono le sedi istituzionali che fanno
da sfondo a decisioni che richiedono discrezione e volontà di arrivare
all’accordo.
2. Le politiche regolative. Queste politiche mirano a condizionare
i comportamenti di determinate categorie, imponendo con sanzioni il
rispetto di codici, di standard, di vincoli alla libera iniziativa. Un codice stradale, una legislazione per la difesa dei consumatori o per la limitazione del potere dei monopoli, una normativa contro l’inquinamento
atmosferico sono esempi di politiche di questo tipo:
Ciò che tutti questi sforzi regolatori hanno in comune è che essi dichiarano certe azioni buone o cattive, e prospettano l’applicazione di sanzioni positive o negative rispetto alla condotta in questione. Vi è sempre qui un principio di esclusione, anche se è spesso espresso in modo vago. Vi è sempre un
principio morale, e la sensazione che alcune cose sono di interesse pubblico
ed altre no [Lowi 1971b, 76 trad. it.].
Le politiche regolative tendono ad innescare processi decisionali
più conflittuali, più visibili, e comunque più vicini all’immagine corrente della democrazia parlamentare. Infatti l’aula del parlamento rappresenta la sede più adeguata per pesare, attraverso votazioni in seduta
plenaria, la forza di chi è a favore e di chi si oppone.
3. Le politiche redistributive. Queste politiche si propongono di
fornire benefici a larghe fasce sociali, modificando gli equilibri allocativi tra i grandi gruppi che costituiscono la società. Esempi possono
essere rintracciati nelle riforme della sanità pubblica e della previdenza
obbligatoria, o nelle misure che modificano la progressione delle imposte sui redditi. Le politiche redistributive sono giocate attraverso
complesse negoziazioni centralizzate tra le grandi organizzazioni degli
interessi (sindacati, associazioni degli imprenditori, ecc.) e i responsabili dell’esecutivo, mentre «il ruolo del Congresso sembra in larga
parte essere stato quello di ratificare gli accordi presi direttamente
dalle burocrazie con gli interessi lì rappresentati» [Lowi 1964, 31 trad.
it.]. Governo e vertici delle associazioni sono chiamati direttamente in
causa dall’esigenza di stabilizzare il conflitto su temi che rischiano di
spaccare la società, perché «le issues di tipo redistributivo si avvicinano più di qualunque altra alle divisioni di classe e attivano interessi
più o meno in termini di classe» [ibidem, 31-32].
4. Le politiche costituzionali. «Il termine costituente è usato qui nel
senso europeo, che ha a che fare con la costruzione di qualcosa, come
nel caso delle assemblee costituenti. Esso riguarda tutte le politiche
statali che stabiliscono strutture, regole del gioco, e attribuiscono sfere
di autorità dentro i cui confini potranno essere create le future politiche governative» [Lowi 1971b, 63 trad. it.]. Benché Lowi sia decisamente avaro di particolari a proposito di questa arena, i corpi dello
stato chiamati a vigilare sul rispetto di queste deliberazioni sono rappresentati come generali senza truppa, tenuti a garantire non specifi-
387
388
CAPITOLO 5
che prestazioni, ma l’instaurazione di linee di autorità e di comunicazione con gli altri comparti dell’amministrazione [Lowi 1985].
Le politiche determinano la politica
La tesi di Lowi è che a ciascuno di questi tipi di policy corrisponda una diversa arena di potere, cioè una diversa rete di attori, una
diversa struttura dei processi decisionali, un diverso sfondo istituzionale: «Ogni arena tende a sviluppare la propria caratteristica struttura
politica, il suo processo politico, le sue élite e i suoi tipi di rapporti tra
gruppi» [Lowi 1964, 20 trad. it.]. Questo concetto è sintetizzato nell’espressione, peraltro intraducibile, policy determines politics [Lowi
1972], che segna un chiaro ribaltamento delle ricerche di derivazione
sistemica, che vedono nelle politiche la variabile dipendente dalla politica.
La prima conseguenza di questa impostazione è che anche la politics diventa plurale:
Non vi è un singolo sistema politico con un singolo insieme di proposizioni che possa descrivere «la distribuzione del potere», «il rapporto tra legislativo ed esecutivo», «il potere delle commissioni», «il sistema partitico». Ci
sono almeno quattro sistemi politici, ed almeno quattro insiemi di generalizzazioni sono necessari per rendere giustizia dell’universo politico americano
dal New Deal in poi. Di nuovo, se la società moderna è differenziata, perché
la politica moderna dovrebbe essere diversa? [Lowi 1971b, 88-89 trad. it.].
Le basi della matrice
La tipologia di Lowi è originale non solo perché presenta configurazioni ben delineate, con una chiara linea di saldatura tra policy e
politics, ma anche perché è ancorata a una grandezza finora rimasta
nell’ombra: la coercizione.
La coercizione, per seguire Weber, è fondamentale per qualunque azione
statale. Diversamente dalle istituzioni private, le istituzioni dello Stato non
sono meri attori nel loro ambiente [...]. Una politica pubblica è, dunque, una
norma formulata da una qualche autorità governativa che esprime una intenzione di influenzare il comportamento dei cittadini, individualmente o collettivamente, attraverso l’uso di sanzioni positive o negative [Lowi 1985, 230
trad. it.].
Sul diverso campo di applicabilità della coercizione e sulla sua
probabilità è infatti costruita la matrice della tipologia, come evidenzia
la figura 5.1.
A questo punto, grazie al loro incardinamento nei diversi modi di
applicare la coercizione, i tipi di politiche acquistano un’investitura
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
APPLICABILITÀ DELLA COERCIZIONE
remota
immediata
PROBABILITÀ DI COERCIZIONE
all’azione individuale
all’ambiente dell’azione
DISTRIBUTIVA
COSTITUENTE
Individuo, impresa, corporation
Scambio e reciproca non interferenza
Commissioni del parlamento, agenzie
Creazione delle regole del gioco e di
nuovi organismi
Definizione di nuovi ambiti
REGOLATIVA
REDISTRIBUTIVA
Gruppo
«Coalizioni», concreti interessi condivisi
Trattativa
Parlamento nel suo ruolo classico
Vertici delle associazioni
«Incontri al vertice», classe, scontro
ideologico
Esecutivo e vertici associativi
FIGURA 5.1. Matrice della tipologia.
Fonte: Adattato da Lowi [1964; 1972].
istituzionale tale da trasformarli in tipi di Stato o di regime: «La mia
assunzione operativa di base è che ogni categoria di politica pubblica,
una volta considerata nel tempo, sia, per importanti aspetti, un regime,
e che ogni regime tenda a creare una politics in consonanza con se
stesso» [Lowi 1988, 726]. Un primo tipo di applicazione di questa
teoria fornisce una nuova chiave per interpretare i cambiamenti nella
sfera pubblica. La storia istituzionale degli Stati Uniti può ad esempio
essere riletta come un passaggio dalle politiche distributive, prevalenti
fino al 1890, a quelle regolative e poi, con le riforme sociali promosse
dal New Deal, a quelle redistributive.
Un secondo tipo di applicazione è di genere prescrittivo, perché
l’idea che siano le politiche a determinare la politica fa delle prime le
leve più efficaci per un intenzionale intervento di ingegneria istituzionale. Scegliendo il tipo di politiche da promuovere, i legislatori optano
anche per il consolidamento di uno specifico sistema di relazioni tra
governanti e governati:
Se desideriamo una politica (politics) aperta e pubblica, dobbiamo limitarci a determinati tipi di politiche pubbliche – indipendentemente dal fatto
che gli obiettivi manifesti di queste politiche vengano o no raggiunti. Di nuovo, cercheremo di evitare politiche distributive, perché nulla di aperto e di
democratico può venire da esse [Lowi 1972, 57 trad. it.].
Le politiche pubbliche sono un tipo di istituzione che fornisce non solo
incentivi e disincentivi, ma che distribuisce anche simboli e valori [...]. Le
politiche pubbliche sono agenti attivi del cambiamento sociale e la scienza
politica dovrebbe considerarle con un interesse di gran lunga maggiore di
quello riservato a concetti più generali e più deterministici, quali le istituzioni
e la storia [Ingram e Schneider 1995, 443].
389
390
CAPITOLO 5
Leggi e politiche
Il modello di Lowi ha avuto un’importanza enorme nel consolidare l’autonomo terreno di ricerca dei policy studies, perché ha evidenziato in tre parole la possibilità di capovolgere il modo tradizionale di
pensare al rapporto tra politica e politiche. E tuttavia l’integrazione di
questo approccio con gli altri, analizzati precedentemente, è rimasta in
larga parte una promessa irrealizzata. I limiti in genere evidenziati riguardano le difficoltà di rendere operativa la tipologia attraverso un
elenco di indicatori univoci [Greenberg et al. 1977; Sabatier 1999b].
A nostro avviso, l’isolamento in cui è rimasta confinata questa istituzione non ha solo cause tecniche, ma ha ragioni teoriche. Infatti le politiche che fanno da perno alla teoria di Lowi sono costrutti analitici
molto diversi da quelli che abbiamo preso a riferimento, parlando di
approcci decisamente orientati alle politiche:
Poiché questo approccio è basato su una concezione formale delle funzioni dello Stato, le nostre classificazioni hanno a che fare con il linguaggio
formale della legge (o di altre espressioni formali delle politiche pubbliche).
Esse non si occupano minimamente dei concreti impatti delle politiche sulla
società, sul mondo politico, o sull’economia [...]. Così una legge può essere
classificata, diciamo, come redistributiva, anche se dopo vent’anni dalla sua
emanazione essa non ha dato luogo ad alcun effetto redistributivo [...]. La
classificazione e l’analisi che ne discende richiedono che le categorie di politiche pubbliche, vale a dire le variabili indipendenti, siano intese come uno
sforzo di afferrare le intenzioni dei governanti così come esse sono espresse
nel linguaggio formale del governo [Lowi 1985, 236 trad. it.].
In effetti, viste da vicino, queste politiche parlano più il linguaggio
del diritto pubblico che quello del policy making [Lowi 1972, 38 trad.
it.]. Lo stesso Lowi del resto ammette che il rapporto tra politiche e
politica va inteso come rapporto tra l’aspetto più formalistico e legalistico dell’attività di un sistema politico, e tutto il resto, cioè la politics
[Lowi 1985, 228 trad. it.]. Come spiega Calise, «l’opera di Lowi rappresenta, forse, lo sforzo più significativo per tenere insieme, entro un
medesimo quadro interpretativo, teoria del diritto e analisi delle politiche pubbliche» [1999, xxxix].
Coercizione, Stato, potere, norma, formalità, sono concetti che non
hanno larga circolazione nel corpo principale dei policy studies. Come
il modello di Lowi, questi approcci rivendicano la capacità delle politiche di strutturare le arene entro cui si giocano i processi decisionali
che le riguardano. Ma a differenza del primo, all’origine di questa loro
intuizione non c’è la coercizione: c’è il problema. Come afferma
Dewey, «Che cosa determina la selezione delle operazioni che devono
essere compiute? La risposta è una sola: la natura del problema che
occorre affrontare» [1929, 123, cit. in Dery 1984].
Lo studio delle politiche ha sviluppato questa idea soprattutto
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
analizzando i passaggi attraverso i quali i problemi, da vaghe esigenze,
diventano precise giustificazioni per un intervento pubblico. Come
abbiamo visto, alcuni autori, sulla base dell’insegnamento di Schattschneider, attribuiscono a questa fase uno statuto tutto speciale, per la
sua capacità di assegnare quote di potere fissando le caratteristiche dei
destinatari:
La definizione del nome del problema è di per sé un processo politico
che coinvolge una varietà di definizioni alternative. Infatti, il nome comporta
questioni di secondo livello: quale tipo di comunità si viene a costituire in
base alla struttura dell’autorità utilizzata per «risolvere» il problema? Quali
voci contano nella scelta dei leader e in quella delle politiche? Chi è subordinato a chi? Che tipo di gerarchia interna è creata? Chi è alleato a chi? Come
la struttura di autorità va a creare lealtà e antagonismi in una comunità? [Stone 1988, 291].
I problemi arrivano nei discorsi e quindi cominciano a esistere in quanto
rafforzano ideologie, e non semplicemente perché stanno lì o perché sono
importanti per il benessere. Essi segnalano chi sono i virtuosi e i validi, e chi
sono i pericolosi o gli inadeguati, quali azioni saranno premiate e quali penalizzate [...]. I problemi sono cruciali nel determinare chi esercita l’autorità e
chi l’accetta [Edelman 1988, 12].
A questa lettura si oppongono quanti considerano la definizione
del problema un processo senza fine, legato al profilo del policy
making da un rapporto di interdipendenza e di coevoluzione, piuttosto che da una dipendenza deterministica72. Per Wildavsky, gli obiettivi di una politica pubblica hanno di norma tre caratteristiche: sono
molteplici, in conflitto tra loro e vaghi [1992, 215]. A conclusioni simili arrivano quanti studiano il processo di delimitazione dell’agenda
come una tappa intermedia in una corsa che non ha traguardi finali,
perché la definizione dei contenuti di una politica coinvolge tutto l’arco della sua vita:
Col riconoscere che le politiche sono questione non solo di quello che il
governo dice e fa, ma delle inferenze tratte da quel che viene detto e fatto,
intendiamo richiamare l’attenzione sulla diversità delle poste in gioco e sulla
molteplicità delle funzioni svolte da una politica pubblica [Cobb e Elder
1981, 394].
Dobbiamo considerare l’ambiguità non come un limite alla comprensione
ma, piuttosto, come una caratteristica centrale e ineluttabile delle politiche
pubbliche. Il fatto che una politica sia elusiva non deve essere considerato un
72 Questa prospettiva è esplicitamente respinta da Lowi: «Quel che rimpiango è
l’accento che ho posto nei miei primi articoli sulle aspettative e le percezioni dei partecipanti politici. Queste cose contano, ma sono secondarie rispetto alla “natura” delle
proposte o delle politiche ormai formalizzate» [Lowi 1988, 727].
391
392
CAPITOLO 5
fattore di disturbo, un ostacolo sulla via di una solida analisi. Piuttosto, deve
essere visto come un elemento fondamentale per la sua definizione. In generale, le politiche non si spiegano da sole [Steinberger 1980, 29 rist. 1981].
Per queste impostazioni, se l’approccio di Lowi ha avuto il merito
di rendere immediatamente evidente con uno slogan la distanza che
separa gli studi decisamente orientati alle politiche dalle ricerche sui
determinants, tuttavia il prezzo pagato alla loro logica algoritmica,
basata sulla varianza e non sul processo, appare troppo alto.
4.7. Oltre la descrizione
Arrivati a questo punto, occorre tirare le somme del lavoro di catalogazione fatto, per passare a problemi di ricerca di carattere più
generale. La raccolta dei dati sul policy making dovrebbe avere già
fornito una risposta a ciascuna di queste cinque domande.
Quali sono le metafore che descrivono meglio le relazioni tra gli
attori? Il governo di partito, il governo degli interessi, il governo della
burocrazia, i triangoli di ferro, le comunità di policy, i networks a
tema, le coalizioni di sostegno o le comunità epistemiche? Nel corso
della politica studiata, c’è stato un passaggio da una configurazione
degli attori a un’altra?
Come è evoluto il ciclo di vita della politica? Quali sono stati gli
snodi più controversi o più significativi? La formazione dell’agenda, il
disegno delle soluzioni, la creazione del consenso, la decisione formale,
l’implementazione, la valutazione, il ridisegno o la soppressione finale?
Come definire lo stile decisionale prevalente? Quali preoccupazioni hanno dominato il policy making? L’oggettività dei giudizi, la necessità della mediazione, la completezza del disegno, il controllo del tempo e del caso?
Come le regole hanno influenzato il policy making? In modo formale o informale? in modo cogente o indeterminato? in modo esogeno o endogeno?
Nella selezione degli strumenti dal repertorio dei possibili tipi di
intervento, quali leve per il cambiamento sono state utilizzate? la continuità o l’innovazione? i risultati o i simboli? la distribuzione, la redistribuzione, la regolazione o il disegno statutario?
A questo punto, una volta completato il lavoro per dare una precisa fisionomia ai cinque «tratti somatici» che identificano una politica
pubblica, una volta definita la sua carta d’identità, la ricercatrice o il
ricercatore possono affrontare una serie di domande di livello più generale.
La prima riguarda il tipo di relazione che tiene insieme queste
cinque caratteristiche. Le ipotesi alternative possono essere riassunte in
questo modo:
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
• nella ricostruzione del policy making, emerge la forza preponderante di uno di questi blocchi di variabili, che dimostra la capacità di
imporsi come determinante rispetto alla configurazione assunta dagli
altri, autorizzandoci a ragionare in termini di causa/effetto;
• oppure il processo si è dipanato all’insegna della coevoluzione e
dell’interdipendenza, in una serie di microaggiustamenti reciproci, senza l’egemonia di alcun fattore specifico?
Queste due ipotesi di ricerca sono entrambe legittime, perché ciascuna è suffragata da numerosi esempi. Le ricostruzioni dello sviluppo
delle politiche sociali nel secolo scorso hanno in genere evidenziato
l’importanza delle reti degli attori nel condizionare i diversi tipi di
welfare sperimentati nei vari paesi [Heclo 1974; Ferrera 1984]. Sempre in questo campo, alcune analisi condotte nel contesto americano
hanno messo invece l’accento sull’importanza di una fase, quella dell’implementazione, cruciale nel ridirigere il significato complessivo di
una politica pubblica [Pressman e Wildavsky 1973]. Con riferimento
alle politiche regolative nei paesi europei, alcuni autori hanno sottolineato l’influenza di fattori impalpabili, ma tenaci, riferibili al concetto
di policy style [Vogel 1986; Majone 1994]. Molte ricerche di policy,
ben prima della svolta neoistituzionalista, hanno richiamato l’attenzione sul ruolo cruciale giocato dalle regole, formali o informali [Selznick
1949; Kaufman 1976].
Ma anche la tesi opposta, quella della coevoluzione e del lento
assestamento reciproco tra le caratteristiche che rivelano il profilo di
una politica pubblica, può vantare numerose evidenze empiriche in
settori non marginali, quali le politiche fiscali o la difesa dell’ambiente [Heclo e Wildavsky 1974; Ostrom 1990; Elliott e Kiel 1999]. In
questi casi, i diversi aspetti di una politica pubblica – gli attori, la dinamica, gli stili, le regole, i contenuti – sembrano capaci di condizionarsi a vicenda, mediante processi che richiamano equilibri più biologici che meccanici, che impediscono l’assegnazione di primati o primogeniture.
Poche righe fa, abbiamo usato la metafora dei tratti somatici e
della carta d’identità: talvolta, il colore della pelle può avere caratteri
tali da dominare la configurazione di altri aspetti fisici, quali il tipo di
capelli o la forma del naso. Ma esistono molti casi in cui il colore della
pelle non è di alcun aiuto per fissare gli altri tratti salienti, ad esempio
perché la persona in esame è all’incrocio tra più razze.
Passiamo ora a esaminare un terzo livello di ricerca, che riguarda il
rapporto tra la politica pubblica e i problemi che l’hanno suscitata. Le
ipotesi concorrenti possono essere riassunte così:
• le crisi nell’ambiente che fa da sfondo alla politica hanno una
presa diretta sull’assetto di quest’ultima, rappresentano effettivamente
le molle della trasformazione ed esercitano il loro influsso in modo
lineare;
• oppure la politica pubblica analizzata intrattiene con i problemi
393
394
CAPITOLO 5
che l’hanno giustificata un rapporto contorto, complesso, ambiguo,
dato che non solo la politica dipende dal problema, ma il problema
dipende dalla politica?
Anche in questo caso, esistono numerosi esempi a sostegno di entrambe le ipotesi. Gli shock petroliferi degli anni ’70 hanno esercitato
una decisiva influenza sulle politiche energetiche dei principali paesi
europei. Le politiche per la riforma amministrativa possono invece permettersi grandi margini di libertà nell’interpretare il disagio cui dovrebbero porre rimedio [March e Olsen 1989].
Nel primo caso, le ricerche aggregate intorno al paradigma della
new political economy possono aggiungere elementi fondamentali alla
nostra conoscenza del policy making, perché ci danno una rappresentazione sintetica dei vincoli che hanno condizionato l’evoluzione delle decisioni. Nel secondo caso, questo esercizio è di scarsa utilità, dati i gradi
di libertà di cui dispongono gli attori nel leggere le sfide che provengono dall’ambiente.
Come è evidente, il secondo e il terzo livello di analisi riprendono in chiave empirica le alternative teoriche che abbiamo presentato
nel terzo paragrafo, per scongelarle dal dibattito epistemologico, che
tende a farne paradigmi tra loro incompatibili, e rileggerle invece
come tipi di relazioni più o meno confermate dalla raccolta dei dati.
Dunque, causa/effetto o coevoluzione, sistema chiuso o sistema aperto non sono solo opzioni in astratti dibattiti metodologici, ma sono
anche modelli di sviluppo del policy making, entrambi documentati
da precise vicende storiche. La scelta tra queste alternative rinvia alla
verifica dei dati, consapevolmente organizzati entro solide categorie
analitiche.
5. Questioni aperte
La conclusione del paragrafo precedente può fornire la base per
un bilancio critico. Infatti le valutazioni circa i risultati degli studi del
policy making difficilmente mettono in dubbio la rilevanza delle cinque categorie che abbiamo presentato e la loro utilità per la ricerca
empirica. Le questioni invece sorgono rispetto all’utilizzazione di questi concetti e delle loro articolazioni interne: quali disegni di ricerca
possono sostenere? a quali interrogativi teorici possono fare fronte?
Come abbiamo sottolineato, la prima e più tranquilla risposta rinvia all’uso di queste classificazioni per arrivare a una descrizione «densa» delle particolari configurazioni assunte dalle politiche pubbliche in
un dato settore, o a un dato livello istituzionale, o in un dato periodo.
In questa prospettiva, le difficoltà metodologiche riguardano soprattutto la delimitazione dell’ambito geografico, settoriale e temporale più
adeguato per verificare la rispondenza alle diverse immagini presentate
nel paragrafo precedente.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
La seconda risposta rimanda alla validità di un impianto di ricerca
eclettico ed elastico, basato sulla comparazione dei casi e la triangolazione delle metodologie, capace di sciogliere in termini empirici i dilemmi teorici che hanno marcato l’evoluzione dei policy studies.
E tuttavia queste risposte soddisfano solo una parte degli studiosi
di politiche pubbliche [per un dibattito tra le varie posizioni v. Dudley
et al. 2000]. Le critiche più significative muovono da tre diverse angolazioni:
• dall’interno di altre impostazioni, pure collocate nell’ambito
degli studi che adottano metodologie induttive;
• come premessa per il passaggio alle teorie deduttive della scelta
pubblica;
• come riflessione sui limiti delle coordinate che individuano il
piano a, in vista dello spostamento verso il piano 3.
5.1. L’assenza di una chiara scelta a favore della spiegazione causale
La nostra presentazione ha considerato il ricorrere di chiari nessi
causali tra le variabili solo come uno dei possibili risultati della ricerca,
di per sé né più valido né più profondo della scoperta di relazioni
spurie, non lineari, non deterministiche. Questa impostazione è duramente criticata dalle correnti di ricerca che si danno l’obiettivo di individuare chiari modelli causali, in grado di identificare le variabili
indipendenti, le leve del cambiamento, gli elementi capaci di innescare
la reazione a catena. Secondo questi approcci, ammettere la possibilità
di mancare questo obiettivo equivale alla resa a una concezione della
scienza mutilata della sua dimensione teorica [Hill 1997]. Come scrive
Paul Sabatier,
Quali sono esattamente i meccanismi attraverso i quali A influisce su B,
che a sua volta influisce su C? L’incapacità di sviluppare chiare catene di
relazioni causali è probabilmente una delle ragioni della caduta di attenzione
per alcuni degli schemi popolari negli anni ’70 [...].
[Una teoria] deve avere chiare guide causali e la capacità di discernere i
processi causali. Le teorie scientifiche sono teorie causali che cercano di spiegare come si verificano certe regolarità nei fenomeni. Identificano i nessi causali critici, che vanno considerati fondamentalmente come gli eventi che danno impulso al sistema, e identificano i processi o i meccanismi attraverso cui
questi elementi motori influenzano le altre variabili [Sabatier 1999, 5, 262].
La teoria della coalizione di sostegno, proposta come modello
positivo nel testo appena citato, fornisce un chiaro esempio degli elementi che caratterizzano questa impostazione. In fondo, a fare la differenza, è il diverso concetto di sistema, che per gli studi da noi privilegiati può essere una configurazione complessa, adattiva, non deterministica, mentre per i ricercatori affascinati dall’individuazione delle
395
396
CAPITOLO 5
leggi causali è una architettura chiusa e deterministica. Così, ad esempio, l’analisi di Sabatier e Jenkins-Smith incorpora larga parte delle
acquisizioni sul ruolo dell’apprendimento e sull’importanza dell’implementazione nei processi di policy73. Ma questi concetti non producono
effetti corrosivi sul tradizionale impianto causale, bensì vengono inquadrati come relazioni tra «condizioni esterne» e «condizioni interne»,
tra «aspetti cognitivi» e «mondo reale», e vengono gestiti aggiungendo
variabili, frecce bidirezionali e circuiti laterali ai principali elementi del
sistema:
L’apprendimento è solo una delle forze che influenzano il cambiamento
delle politiche. In aggiunta a questa attività cognitiva, stanno altre due sorgenti. La prima riguarda i cambiamenti nel mondo reale. I cambiamenti nelle
condizioni socioeconomiche rilevanti e nelle coalizioni di governo del sistema
– come il boicottaggi o del petrolio arabo nel 1973 o la vittoria dell’ala
thatcheriana al congresso del 1974 del partito conservatore inglese – possono
alterare sensibilmente la composizione e le risorse delle varie coalizioni e, a
loro volta, le politiche all’interno del sottosistema di policy. Il turnover del
personale – che talvolta deriva da condizioni esterne, talvolta semplicemente
da morti e pensionamenti – costituisce una seconda fonte non cognitiva di
cambiamento, capace di modificare sostanzialmente le risorse politiche delle
varie coalizioni, e quindi le decisioni di policy [Sabatier e Jenkins-Smith 1999,
123].
Questa impostazione è veramente un arricchimento della ricerca
empirica e un avanzamento nella costruzione di una teoria generale, o
è solo un modo più complicato per far sparire i nodi insoluti sotto lo
spesso tappeto dei vari sottosistemi? La maggiore precisione dell’impianto è reale o solo apparente, in assenza di modelli matematici che
fissino le relazioni tra le diverse variabili? Queste sono questioni che
lasciamo dirimere ai lettori con maggiori curiosità teoriche, ovviamente
non sulla base di due citazioni.
5.2. Verso le teorie della scelta pubblica
L’accusa di ateoreticità che dal versante deduttivo è mossa agli studi di policy, nelle loro varie declinazioni, ha altre ragioni, certo non
scalfite dalle integrazioni proposte da Sabatier e Jenkins-Smith, ma
semmai esasperate da un impianto analitico che procede per aggiunta
di variabili e di frecce causali:
L’insoddisfazione deriva dalla natura ad hoc della teoria di policy. Per
spiegare ogni nuovo fenomeno, si tende a generare una nuova teoria, con il
73 Sabatier e Jenkins-Smith [1999] si rifanno esplicitamente a Heclo [1974] e
all’approccio bottom-up.
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
suo proprio insieme di assunzioni; oppure, in momenti diversi lo stesso fenomeno è spiegato con diverse teorie, senza dare elementi per scegliere al loro
interno. Dunque, l’insoddisfazione nell’analisi delle politiche riguarda la mancanza di una teoria generale che fornisca modelli predittivi applicabili a diverse situazioni, grazie a piccoli aggiustamenti o estensioni delle assunzioni fondamentali [Blair e Maser 1978, 5].
Da questa angolazione, ad essere lamentata è l’assenza di una teoria dell’attore, che sciolga una volte per tutte le ambiguità e le oscillazioni che rendono i policy makers ora condizionati dai frames cognitivi,
ora sensibili agli interessi e al potere, ora casuali ingredienti di bidoni
della spazzatura che vanno e vengono.
Ma con l’avanzare della nostra presentazione, il cerchio si stringe,
e le critiche a un paradigma diventano i punti di forza di un altro.
Alla presentazione delle risorse analitiche su cui si basano le teorie
deduttive è infatti dedicato il prossimo capitolo.
5.3. Verso il piano 3
Gli studi che abbiamo presentato in questo capitolo si tengono
ancorati a un modo di intendere le scienze sociali fondamentalmente
rispettoso dei canoni tradizionali della ricerca empirica, sia questa di
tipo quantitativo o qualitativo.
Questa collocazione è divenuta più difficile negli ultimi anni, perché tale vincolo è esplicitamente infranto dagli autori che sottolineano
due tipi di problemi. In primo luogo, la scelta degli strumenti e dei
metodi per condurre l’indagine esercita un’ineliminabile influenza sui
suoi risultati. Così ad esempio, se di per sé la network analysis può individuare anche sistemi di relazione gerarchici, tuttavia la sua stessa
impostazione può facilmente portare alla sovrastima delle reti piatte e
informali.
Più in generale, «la definizione delle categorie determina il risultato della loro utilizzazione. Le categorie sono costrutti mentali umani in
un mondo che ha solo delle continuità [...]. Le politiche riguardano
soprattutto classificazioni e differenziazioni, come si usano o si devono usare le categorie in un mondo in cui le categorie non sono date»
[Stone, 1988, 307].
Questo fa sì che il punto di osservazione e il bagaglio cognitivo
dell’osservatore incidano sui risultati dell’osservazione. Nel paragrafo
precedente abbiamo utilizzato la metafora della carta d’identità e dei
tratti somatici prevalenti. Ma, come è noto, la razza di appartenenza
dell’osservatore è in genere strettamente correlata al suo giudizio circa la gerarchia dei particolari rilevanti. Se un bianco descrive un
bianco, pone attenzione alla forma del naso, della bocca, degli occhi.
Se descrive un nero, gli sembra che questo aspetto da solo riduca
397
398
CAPITOLO 5
enormemente la varianza dei tratti significativi. Nel primo capitolo
abbiamo citato la teoria di Kaufman [1981], secondo la quale il potere è una variabile che tende a perdere importanza via via che l’osservatore si avvicina a una conoscenza più circostanziata del policy
making.
Arriviamo così a un secondo ordine di problemi: se ciò che si vede
dipende da dove si è, dai riferimenti che si hanno e dagli strumenti di
osservazione che si adottano, la distinzione tra finalità descrittive e finalità prescrittive o valutative tende a diventare più ingarbugliata.
Nonostante le tensioni reali tra gli aspetti comportamentali e quelli prescrittivi nei policy studies, entrambi costituiscono facce di un intero, con strette interdipendenze. Dunque, la formulazione del problema e la percezione
dei fatti dipendono da mappe cognitive basate sugli interessi prescrittivi degli studi delle politiche; le applicazioni prescrittive rappresentano un laboratorio essenziale per avanzare nella comprensione delle realtà di policy [Dror,
1983, 5].
È impossibile descrivere il contare senza parlare di inclusione e esclusione
(termini che di per sé richiamano comunità, confini, alleati e nemici); selezione (un termine che implica privilegio e discriminazione) e importanti caratteristiche (un termine che richiama giudizi di valore e gerarchia) [Stone 1988,
128].
E tuttavia, di per sé queste constatazioni non comportano la demolizione dei risultati cui pervengono le ricerche condotte secondo i
tradizionali metodi dell’indagine politologica e sociologica. Infatti anche all’interno del piano convivono teorie che considerano l’intreccio
tra aspetti descrittivi e aspetti normativi come una prova del carattere
intrinsecamente manipolatore della ricerca sulle politiche, e altre che
invece non rinunciano alla speranza di conoscere meglio quel che succede nelle nostre società, quando un insieme di persone avverte un
problema che non può risolvere da solo.
Come abbiamo più volte sottolineato, rientrano in quest’ultimo
gruppo le impostazioni che riprendono in chiave postcomportamentalista il nucleo centrale del pragmatismo americano. In questa prospettiva, i limiti della singola strategia di ricerca sono distruttivi solo se il
ricercatore coltiva l’aspirazione a raggiungere da solo la verità, al singolare. Se invece la ricerca è concepita come un’impresa collettiva, in
cui i difetti di un approccio sono colti e compensati da un altro, allora
questa consapevolezza permette di non rimanere schiacciati dalla inevitabile parzialità del proprio punto di vista. Come spiega Peirce, la
ricerca filosofica pragmatica si basa
più sulla fiducia nella molteplicità e varietà degli argomenti che sul carattere
conclusivo di uno solo. Il suo modo di ragionare forma non una catena, che
non può essere più forte del suo anello più debole, ma una corda, le cui fibre
LO STUDIO DEL
«POLICY
MAKING»
possono essere anche fragili, purché siano sufficientemente numerose e intimamente intrecciate [Peirce 1868, rist. 1931, 157]74.
Come forse qualche lettore ha notato, questa citazione è straordinariamente simile a quella di Wittgenstein75, che abbiamo posto all’inizio del volume.
74
75
La numerazione delle pagine si riferisce alla ristampa del 1931.
Che tuttavia non fa riferimento a Peirce.
399