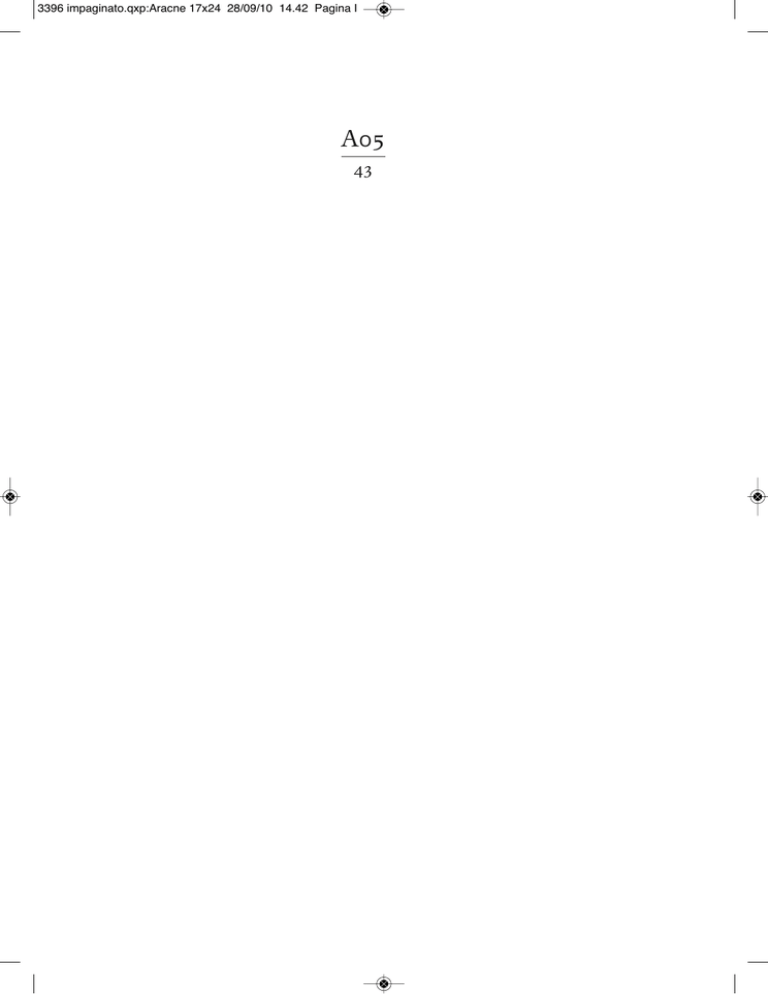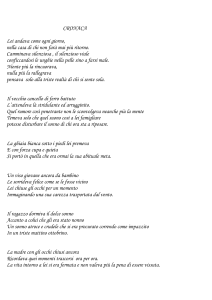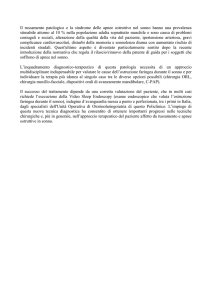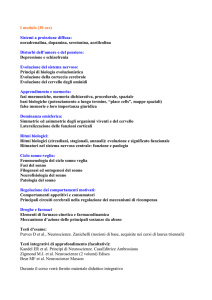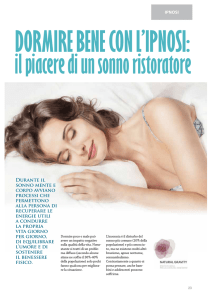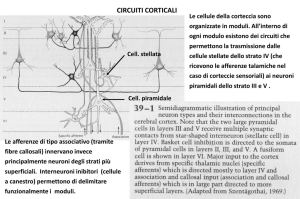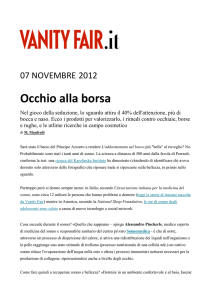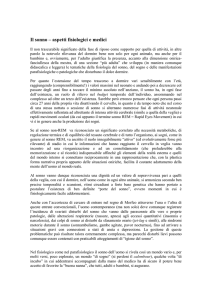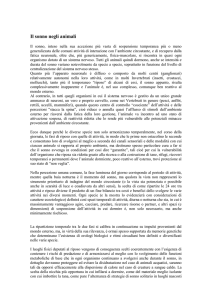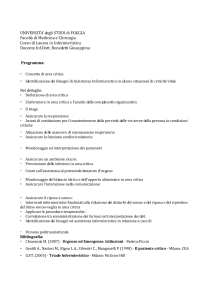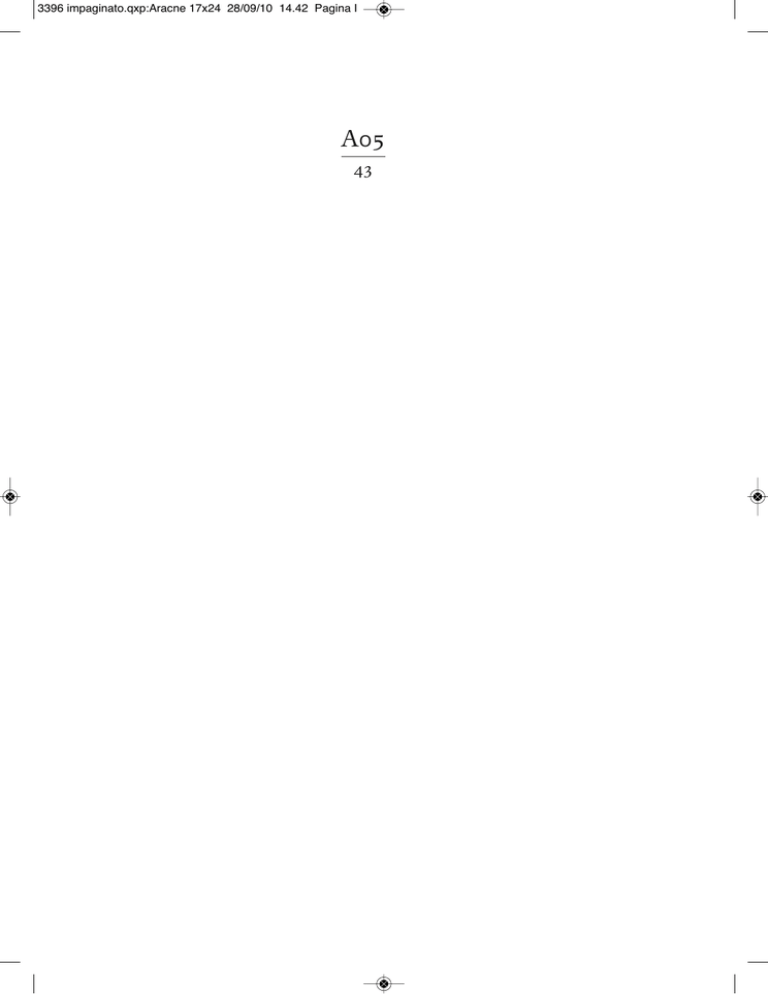
3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 28/09/10 14.42 Pagina I
A05
43
3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 01/10/10 12.40 Pagina II
Si ringraziano i professori Bruno Cozzi (Cap. 12 e 14), Carlo Franzini (Cap. 9),
Ennio Ongini (Cap. 21), Giulio Sergio Roi (Cap. 11) per l’aiuto nella stesura di alcuni capitoli e anche Massimo Valdina e Michele Ruggiero per i consigli.
3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 28/09/10 14.43 Pagina III
Ivana Gritti
IL SONNO
E LA SUA STORIA
3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 28/09/10 14.44 Pagina IV
Copyright © MMX
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN 978–88–548–3396–8
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: settembre 2010
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina V
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina VI
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina VII
Indice
1 Capitolo I
Il sonno
7 Capitolo 2
La storia dell’esplorazione del sonno e del sogno
2.1. le teorie greco–romane del sonno, 7 – 2.2. Il sonno nell’era pre–scientifica, 8 – 2.3.
Il sonno nel corso della storia e la sua negazione, 11 – 2.4. una pletora di teorie sul sonno,
12 – 2.5. le varie teorie: anemica, del flusso sanguineo e chimica, 13 – 2.6. la teoria della
deafferentazione: i primi studi di biologia, 15 – 2.7. le opportunità perse, 16 – 2.8. I centri
del sonno e i centri della veglia, 18 – 2.9. la natura del sognare, 23 – 2.10. l’antico egitto,
24 – 2.11. I primi approcci spirituali e biblici al sognare, 25 – 2.12. la mitologia e la
medicina greca, 30 – 2.13. Il sogno dall’antica roma al XVIII secolo, 31 – 2.14. sognare,
l’inconscio e la psicanalisi verso il terzo millennio, 34
letture scelte, 43 – Bibliografia, 44
51 Capitolo 3
I ritmi circadiani
3.1. sistemi fondamentali di adattamento degli organismi viventi, 51 – 3.2.1
Dall’eliotropio alle grotte di Mammoth, nel Kentucky, fino ai sotterranei dell’Istituto
Max Planck in Germania, 51 – 3.2. l’orologio biologico, 53 – 3.3. Il nucleo
soprachiasmatico, 54 – 3.4. I ritmi del sonno e la loro regolazione, 60 – 3.5. Il processo s:
i meccanismi esecutivi regolatori del sonno, 60 – 3.6. le componenti permissive, 63 –
3.7. le componenti omeostatiche, 63 – 3.8. Il controllo omeostatico del ciclo sonno–
veglia, 64 – 3.9. I substrati anatomici delle interazione tra ritmi circadiani e ciclo
sonno–veglia, 65 – 3.10. le connessioni del nucleo soprachiasmatico, 66 – 3.11. le vie
efferenti dal nucleo soprachiasmatico, 67 – 3.12. In sintesi: Il sonno e le interazioni tra le
varie componenti, 68 – 3.13. I disordini del ritmo circadiano, 70 – 3.2.1 Il jet lag, 70 – 3.14.
la dinamica dell’adattamento di fase, 71
letture scelte, 73 – Bibliografia, 44
VII
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina VIII
VIII
Indice
79 Capitolo 4
Le fasi del sonno
4.1. la strutturazione in stadi del sonno, 80 – 4.2. le variazioni del sonno reM durante
lo sviluppo, 81
letture scelte, 83
85 Capitolo 5
La veglia
5.1. la fisiologia e i meccanismi della veglia, dell’attivazione e della desincronizzazione
elettrocorticale, 85 – 5.2. Il sistema risvegliante del tronco dell’encefalo, 87 – 5.2.1 la
formazione reticolare del tronco, 87 – 5.2.2 I neuroni colinergici del tegmento ponto–
mesencefalico, 89 – 5.2.3 I neuroni noradrenergici del locus coeruleus, 90 – 5.2.4 I neuroni
dopaminergici del tegmento ventro–mesencefalico, 91 – 5.2.5. I neuroni serotoninergici
del rafe, 93 – 5.3. Il sistema attivante talamo–corticale, 94 – 5.3.1 Meccanismi talamo–
corticali e intra–corticali dei processi di desincronizzazione, 96 – 5.4. I sistemi ipotalamici
risveglianti, 97 – 5.4.1. I neuroni istaminergici del nucleo tuberomamillare, 99 – 5.4.2. I
neuroni ipocretinergici/orexinergici dell’area peri–fornicale, 100 – 5.4.3. I neuroni
colinergici del prosencefalo basale, 101 – 5.4.4. I neuroni non–colinergici del prosencefalo
basale, 102 – 5.5. Conclusioni e prospettive, 103
letture scelte, 104 – Bibliografia,
113 Capitolo 6
Il sonno sincrono o sonno non–REM
6.1. la storia della fisiologia del sonno, 113 – 6.2. le componenti reticolari del tronco,
115 – 6.2.1. Dalla teoria della deafferentazione sensoriale di Bremer alla teoria reticolare,
115 – 6.2.2. la teoria reticolare, 117 – 6.2.3. le esperienze: farmacologiche, di raffreddamento ed elettrofisiologiche, 119 – 6.3. I meccanismi omeostatici, 121 – 6.3.1 Il
tronco dell’encefalo, 121 – 6.3.2 la componente prosencefalica ed ipotalamica, 122 – 6.3.3.
la componente talamica, 125 – 6.3.4 sintesi dei meccanismi della sincronizzazione e della
desincronizzazione eeG, 130 – 6.3.5 Il passaggio dal sonno sincrono alla veglia, 130
letture scelte, 133 – Bibliografia, 134
139 Capitolo 7
Il sonno attivo, desincronizzato e paradosso e con i movimenti rapidi degli
occhi
7.1. Il ciclo del sonno sincrono e del sonno desincronizzato, 140 – 7.2. I meccanismi e le
strutture responsabili del ritmo desincronizzato, 143 – 7.3. le esperienze di lesione, di
stimolazione e quelle farmacologiche, 144 – 7.3.1. le esperienze di stimolazione, 145 –
7.3.2. le esperienze farmacologiche, 145 – 7.3.3. le esperienze microfisiologiche, 146 –
7.3.4. le esperienze microelettrofisiologiche, 148 – 7.4. la fenomenologia tonica e fasica
del sonno reM, 149 – 7.4.1. la desincronizzazione elettroencefalografica, 149 – 7.4.2. I
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina IX
Indice
IX
movimenti oculari rapidi o reM, 151 – 7.5. le onde ponto–genicolo–occipitali (PGo),
153 – 7.6. Il sistema motorio e la postura, 156 – 7.7. le modificazioni dei sistemi sensoriali,
161 – 7.8. la graduale diminuzione del bisogno di sonno reM nelle prime fasi dello
sviluppo, 162 – 7.9. Il contenuto mentale dei sogni in rapporto con la fisiologia del sonno
reM, 163
letture scelte, 164 – Bibliografia, 165
169 Capitolo 8
La neurochimica del sonno
8.1. la chimica della regolazione degli stati di sonno e di veglia, 169 – 8.2. I sistemi
neuronali responsabili dello stato di veglia, 173 – Il glutammato (Glu), 173 – la
noradrenalina (nA), 174 – la dopamina (DA), 176 – l’istamina (H), 178 – la serotonina
o 5–idrossitriptamina (5–Ht), 179 – l’acetilcolina (Ach), 181 – le orexine (orx) o
ipocretine, 184 – l’ormone corticotropo (CrH), 184 – 8.3. la chimica del sonno sincrono,
186 – Il GABA (Acido Gamma Amino Butirrico), 186 – la somatostatina e la
corticotropina, 189 – l’ormone che facilita il rilascio dell’ormone della crescita, 189 –
l’adenosina, 190 – l’insulina, la colecistochinina (CCK) e la bombesina, 191 – 8.4. la
chimica del sonno con movimenti rapidi degli occhi, 192 – l’acetilcolina (Ach), 192 – la
noradrenalina, la serotonina e l’istamina (nA, 5–Ht, H), 194 – I sistemi catecolaminergici,
195 – la dopamina (DA), 195 – Il GABA, 196 – la glicina (Gly), 197 – Il glutammato (Glu),
197 – Il peptide intestinale vasoattivo (VIP), 197
letture scelte, 199 – Bibliografia, 200
213 Capitolo 9
Eventi fisiologici nel sonno: il sonno come mezzo diagnostico
9.1. Il sistema respiratorio, 213 – 9.1.1. Il sonno ad onde lente (sWs o nreM), 214 – 9.1.2.
Il sonno reM, 215 – 9.2. Il sistema cardiovascolare, 216 – 9.2.1. la circolazione, 219 –
9.2.2. la circolazione cerebrale, 220 – 9.2.3. I meccanismi di controllo della circolazione
durante il ciclo veglia–sonno, 225 – 9.2.4. l’attività simpatica e sonno, 227 – 9.2.5. la
circolazione muscolare, 227 – 9.2.6. la circolazione splacnica, 227 – 9.2.7. la circolazione
cutanea, 228 – 9.2.8. la circolazione coronarica, 228 – 9.3. la regolazione della
temperatura durante il sonno: un equilibrio tra termogenesi e termolisi cerebrale, 229 –
9.3.1. Gli effetti della circolazione sistemica sulla temperatura ipotalamica negli stati
comportamentali, 230 – 9.3.2. I meccanismi della termolisi cerebrale, 231 – 9.3.3. I fattori
che influiscono sulla temperatura cerebrale, 232 – 9.3.4. I meccanismi delle oscillazioni
della temperatura ipotalamica durante il ritmo ultradiano, 233 – 9.3.5. Gli effetti del
sistema nervoso autonomo simpatico, sulla postura e sulla termolisi cerebrale durante il
ciclo ultradiano veglia–sonno, 234 – 9.4. la pupilla, 237
letture scelte, 238 – Bibliografia, 238
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina X
X
Indice
241 Capitolo 10
La fisiologia della veglia e del sonno in alta quota
10.1. la medicina dell’alta quota, 242 – 10.2. le alterazioni dell’elettroencefalogramma,
244 – 10.3. I disturbi del sonno da altitudine, 244
letture scelte, 248 – Bibliografia, 248
253 Capitolo 11
La nutrizione, il metabolismo e il sonno
11.1. Il ruolo dei fattori nutrizionali e metabolici sul sonno, 253 – 11.1.1. I rapporti tra
nutrizione, metabolismo, sonno e sviluppo, 255 – 11.1.2. sul ruolo dell’organizzazione
del sonno e sul metabolismo, 256 – 11.1.3. I disordini alimentari durante il sonno, 257 –
11.2. le ipocretine/orexine, 258 – 11.2.1. le relazioni omeostatiche tra gli stati di
coscienza desincronizzati, la nutrizione ed il metabolismo, 258 – 11.2.2. le
ipocretine/orexine e la regolazione della nutrizione, 260 – 11.2.3. le orexine nel controllo
dell’omeostasi endocrina e metabolica, 262 – 11.2.4. la veglia e il metabolismo, 263
letture scelte, 265 – Bibliografia, 265
269 Capitolo 12
Sul sonno e sulla sua evoluzione
12.1. la filogenesi del sonno, 270
letture scelte, 280 – Bibliografia, 280
281 Capitolo 13
Lo sviluppo del sonno
13.1 ontogenesi del sonno, 281 – 13.1.1. Il sonno nei feti, 281 – 13.1.2. Il sonno nel
neonato, 283 – 13.1.3. Il sonno nel bambino da 1 a 6 mesi, 285 – 13.1.4. Il sonno dal terzo
al sesto mese, 286 – 13.1.5. Il sonno tra 6 mesi e 5 anni, 287 – 13.1.6. Il sonno tra 5 e 12
anni, 288 – 13.1.7. Il sonno in adolescenza tra 12 e 18 anni, 289 – 13.1.8. le tecniche di
registrazione delle modificazioni del sonno in età evolutiva, 290 – 13.2. Il sonno degli
adulti, 292 – 13.2.1. Il sonno negli adulti tra 18 e 30 anni, 292 – 13.2.2. Il sonno negli adulti
tra i 30 e 45 anni, 293 – 13.2.3. Il sonno negli adulti tra i 45 e i 66 anni, 293 – 13.2.4. Il
sonno oltre i 60 anni, 294
letture scelte, 295 – Bibliografia, 296
299 Capitolo 14
Il comportamento nel sonno
14.1 l’etologia e l’etnologia del sonno, 299 – 14.2. l’etnologia del sonno, 302
letture scelte, 303 – Bibliografia, 303
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XI
Indice
XI
305 Capitolo 15
Struttura e organizzazione funzionale della corteccia cerebrale
15.1 la corteccia cerebrale, 306 – 15.1.1. l’organizzazione morfofunzionale della
corteccia cerebrale, 306 – 15.1.2. le proprietà funzionali dei neuroni della corteccia
cerebrale, 308 – 15.1.3. le due classi principali di neuroni della corteccia cerebrale, 308 –
15.1.4. le funzione delle sinapsi inibitorie in vicinanza del soma dei neuroni, 310 – 15.1.5.
la frequenza di scarica delle cellule piramidali, 311 – 15.1.6. I dendriti e l’amplificazione
dei segnali sinaptici, 312 – 15.1.7. le funzioni delle cellule gliali, 313 – 15.1.8. le
macroregistrazioni delle popolazioni di neuroni corticali nell’uomo, 313 – 15.2.
l’elettroencefalogramma e le cellule piramidali, 319 – 15.2.1. l’elettroencefalogramma
nella veglia, 321 – 15.2.2. le normali variazioni del tracciato elettroencefalografico
durante il sonno, 322 – 15.2.3. Il sonno paradosso detto anche sonno con movimenti
oculari rapidi (sonno reM), 325 – 15.3. le immagini dell’attività cerebrale registrate con
la Pet e la rMn durante gli stati di veglia e di sonno, 326 – 15.4. I potenziali evocati
sensoriali durante la veglia e il sonno, 327
letture scelte, 329 – Bibliografia, 330
331 Capitolo 16
Gli stati di coscienza e di attività elettrica cerebrale
16.1 I fattori che producono variazioni del tracciato elettroencefalografici, 331 – 16.1.1.
I fattori sistemici, 331 – 16.1.2 fattori cerebrali, 332
letture scelte, 343 – Bibliografia, 343
345 Capitolo 17
Gli stati di coscienza
17.1 la fisiopatologia degli stati di coscienza, 361 – 17.1.1. le perdite transitorie di
coscienza, 361 – 17.1.2. Il coma, 362 – 17.1.3. Gli infarti cerebrali, 365
letture scelte, 367 – Bibliografia, 367
369 Capitolo 18
I disturbi del sonno e del risveglio
letture scelte, 373 – Bibliografia, 373
375 Capitolo 19
Psicofisiologia del sonno
letture scelte, 377 – Bibliografia, 378
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XII
XII
Indice
389 Capitolo 20
La funzione del sonno
letture scelte, 380
381 Capitolo 21
La terapia del sonno e della veglia: dallo stile di vita alla farmacologia
21.1 Farmacologia, 383 – 21.1.1. Cenni storici, 383 – 21.1.2. I barbiturici, 383 – 21.1.3. le
benzodiazepine, 384 – 21.1.4. le proprietà farmacologiche delle benzodiazepine, 384 –
21.2 Gli ipnotici: i meccanismi di base e la farmacologia, 385 – 21.2.1. I meccanismi di
azione, 386 – 21.2.2. la farmacocinetica, 389 – 21.2.3. le proprietà farmacologiche, 391
– 21.3 Gli ipnotici: la loro efficacia e gli effetti collaterali, 393 – 21.3.1. l’efficacia delle
benzodiazepine, 393 – 21.3.2 Alcune considerazioni particolari, 395 – 21.3.3. Alcune linee
guida per il trattamento farmacologico, 396 – 21.4 Gli stimolanti della veglia: i
meccanismi di base e la farmacologia, 398 – 21.4.1. la cocaina, l’anfetamina e il
metilfenidato, 399 – 21.4.2. la farmacologia comportamentale, 400 – 21.4.3 Gli effetti
collaterali, 400 – 21.4.4. la tolleranza e la dipendenza, 400 – 21.4.5. la neurofarmacologia,
401 – 21.4.6. Il Modafinil e le pemoline, 402 – 21.5 Gli stimolanti nella terapia delle
ipersonnie: l’efficacia e gli effetti collaterali, 402 – 21.5.1. la storia, 402 – 21.5.2. Gli
stimolanti e la narcolessia, 403 – 21.5.3. Alcuni studi clinici sui farmaci stimolanti, 404 –
21.5.4. Gli effetti collaterali, 405 – 21.5.5. la tolleranza, 406 – 21.5.6. Alcuni casi particolari,
406 – 21.5.7. Alcune conclusioni, 407 – 21.6. I farmaci che disturbano il sonno e la veglia,
407 – 21.6.1. I farmaci antidepressivi, 408 – 21.6.2 Gli antidepressivi triciclici, 408 – 21.6.3.
Gli inibitori delle monoaminoossidasi, 409 – 21.6.4. Gli inibitori selettivi del
riassorbimento della serotonina, 409 – 21.6.5. Altri antidepressivi, 410 – 21.6.6. I farmaci
antipsicotici, 410 – 21.6.7. Gli agenti ansiolitici, 411 – 21.6.8. I farmaci cardiovascolari, 411
– 21.6.9. I farmaci anti–ipertensivi, 411 – 21.6.10. I farmaci anti–lipedipidemici, 412 –
21.6.11. I farmaci antiaritmici, 413 – 21.6.12. Gli antagonisti dell’istamina, 413 – 21.6.13.
Gli antagonisti istaminici H2, 413 – 21.6.14. I corticosteroidi, 413 – 21.6.15. la teofillina,
414 – 21.6.16. I farmaci antiparkinsoniani, 414 – 21.6.17. I farmaci antiepilettici, 414 –
21.2.18. le pseudoefedrine e la fenilpropanolamina, 415
letture scelte, 415
417 Appendice
Alcune definizioni e terminologie, correntemente utilizzate, 417 – Centri di medicina
del sonno, 423 – siti web dedicati al sonno, 427
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XIII
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XIV
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 1
Capitolo I
Il sonno
secondo molti ricercatori — teorici, sperimentali e clinici — per quanto
riguarda la comprensione degli aspetti biologici, psicologici e psicanalitici
del sonno e del sogno, è sopratutto negli ultimi due secoli che si sono fatti
i maggiori progressi.1
si è scoperto, ad esempio, che il sonno è un processo comportamentale dinamico ed è un’attività speciale del cervello controllata attraverso
l’elaborazione di meccanismi specifici. Inoltre, non è uno stato di riposo
o semplicemente l’assenza della veglia, ma ha molteplici funzioni specifiche, benefiche e positive. le nuove dimostrazioni, derivate in massima
parte dallo sviluppo delle neuroscienze, hanno avuto una parte importante soprattutto nell’incremento delle ricerche dell’esplorazione del
sonno e del sogno.2 studiando entrambi, l’uomo ha cambiato la visione
di sé. È stato come «l’accensione improvvisa di una lanterna nel buio»,
dove l’oscurità era (ed è) rappresentata dal modo in cui i nostri ritmi giornalieri, le percezioni, le sensazioni e i pensieri riflettono il lavoro di cento
bilioni di neuroni del nostro cervello. una quantità sterminata di cellule
nervose che, attraverso la decodificazione dei geni, producono, secernono e codificano messaggi chimici ed elettrici che vengono ri–codificati
e immagazzinati — sotto forma di nuovi dati e pensieri, in continua armonia — intorno agli orologi biologici. Questa attività incessante, spon1. Questo libro è stato scritto sulla base e sulla struttura delle opere e degli articoli pubblicati
da MAuro MAnCIA tra il 1974 e il 2006.
2. Per un approfondimento si vedano gli articoli e i libri pubblicati da MAuro MAnCIA dal 1974
al 2006, op. cit.
1
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 2
2
Capitolo I
tanea e regolata dei neuroni del cervello è indirizzata a riflettere le basi
biologiche delle molteplici qualità umane, tra cui l’immaginazione e il
pensiero.
oggi sosteniamo che il «sonno è prodotto dal cervello», non soltanto
perché è sviluppato esclusivamente negli animali che ne sono dotati, ma
anche perché è la sede di importanti modificazioni che avvengono durante
il sonno stesso. Ciò potrebbe essere affermato per tutte le specie animali
che non presentino un sonno vero e proprio, ma uno o più periodi di riposo simili a quest’ultimo ma diversi da esso. I «segni comportamentali»
del sonno, come per esempio la postura, gli occhi chiusi, il movimento
della gabbia toracica, che nel sonno profondo è lento ed ampio, o la riduzione della risposta motoria in seguito alla somministrazione di una stimolazione sensoriale possono essere facilmente male interpretati. Ciò che
può essere meno confuso, invece, sono i segni cerebrali del sonno. le variazioni dell’attività elettrica cerebrale, infatti, possono essere utilizzate
per suddividere il sonno in fasi o stadi tra loro distinti e per definire le loro
transizioni.
Attraverso lo studio dei segni grafici di tale attività, noi siamo in grado
di distinguere il sonno dalla sua imitazione, come ad esempio l’ibernazione, dove alcuni animali danno l’impressione di dormire, mentre, al
contrario, l’attività del loro cervello è solo temporaneamente ridotta.
tale interruzione temporanea non avviene durante il sonno, ma continua
attraverso quest’ultimo, differendo da quella che si osserva nella veglia.
oggi noi sappiamo che il cervello di per sé controlla la produzione del
riposo fisiologico a lui necessario. In questi secoli abbiamo anche appreso
che gli orologi biologici cerebrali, che attivano e disattivano il sonno,
sono composti da una complessa popolazione di neuroni, la più importante delle quali è situata in una regione alla base del cervello detta ipotalamo. Questi orologi non si limitano a regolare il sonno e la veglia. essi
programmano ed elaborano, in una sequenza ordinata, gli eventi cerebrali elettrocorticali e comportamentali della veglia e del sonno e tra questi il sonno con movimenti oculari, detto reM (dall’inglese Rapid Eye
Movement): un sonno, cioé, che si manifesta nell’uomo con uno straordinario aumento dell’attività elettrica cerebrale ogni novanta minuti circa.
È durante questo periodo che noi alziamo il palcoscenico “privato” per
la rappresentazione dei sogni più ricchi di contenuti bizzarri. Dunque,
anche il sogno sembrerebbe, come il sonno, appartenere al cervello oltre
che alla mente e da questi essere messo in atto attraverso la sua attiva-
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 3
Il sonno
3
zione.3 noi siamo abituati a pensare che l’attività mentale conscia, così
come i sogni che ricordiamo al risveglio, rappresenti il prodotto della nostra mente. Ma potremmo dire che anche il cervello permette alla mente
di esprimersi attraverso l’attivazione di diverse popolazioni di neuroni,
di specifiche aree cerebrali.
Quest’ultimo, inoltre, è tra i primi beneficiari del sonno e di quel periodo del sonno stesso in cui emerge il palcoscenico per il sogno, come si
percepisce dal progressivo declino delle nostre capacità cerebrali quando
ne siamo totalmente deprivati. se si è, infatti, in preda alla sonnolenza, si
hanno inizialmente delle difficoltà di concentrazione e di attenzione. Poi,
successivamente, l’esecuzione di un compito motorio, come ad esempio
guidare la macchina, può diventare particolarmente difficile, sofferente e
pericoloso.
Già William Dement dimostrò ai suoi colleghi americani negli anni ‘60
che condizioni estreme di deprivazione del sonno e del sogno possono causare gravi alterazioni della personalità. Dopo 5–6 giorni di tale deprivazione
totale, il cervello perde le capacità d’analisi della realtà. Compaiono — a
seconda della profondità e della qualità della deprivazione — le alterazioni
dell’umore, la depressione, i pensieri paranoici, il razionale diventa irrazionale e il sano inizia a vedere e udire cose che non esistono.4 tutte queste
disfunzioni scompaiono rapidamente quando il sonno nella sua totalità è
recuperato. Questo, però, non accade quando la deprivazione di sonno
reM perdura per più di un anno, oppure nel caso in cui tale sonno venga
sostituito da un sonno artificiale estremamente profondo, tipico delle fasi
s3 e s4 del sonno ad onde lente, che altera i processi di memorizzazione
che si consolidano durante quest’ultimo. Ancora oggi non sappiamo come
il sonno e il sogno assicurino l’efficienza delle funzioni cerebrali. Di conseguenza, quindi, possiamo solo dire che questi ultimi sono necessari per
il cervello e per la mente, sapendo che entrambi sono del cervello e della
3. «(...) fra le molteplici funzioni del sonno una, in particolare è degna di nota per i suoi effetti
sulla nostra vita mentale: durante il sonno, infatti, produciamo metafore su cui possiamo costruire
i sogni. si tratta di un’esperienza umana, che avviene soltanto durante quest’ultimo. tuttavia, bisogna
distinguere, in parte, il processo sognare — che articola impulsi e conflitti inconsci – dallo spazio
onirico, dove il sogno attua queste osservazioni. In molti pazienti, infatti, quel processo avviene senza
che vi sia spazio onirico e perciò essi traggono ben poca soddisfazione dai loro sogni» da Lo spazio
privato del Sé di MArCell MAsuD r. KHAn M, pubblicato da Boringhieri nel 1992, op. cit.
4. Dai filmati d’epoca raccolti dal gruppo di nAtHAlIe KleItMAn e WIllIAM DeMent tra il 1938
e il 1956.
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 4
4
Capitolo I
mente e nascono attraverso modificazioni che si verificano nel cervello e
nella mente stessa per l’integrità dell’uomo. Inoltre, possiamo ribadire che
il sonno nei mammiferi è molto più complesso dello stato di riposo che
noi abbiamo in comune con altre creature viventi del mondo. In tale
mondo, il sonno è caratterizzato da una variazione dell’attività comportamentale e dell’attività cerebrale e i meccanismi che ne regolano e ne controllano il succedersi coinvolgono diverse popolazioni di neuroni. Queste
popolazioni variano le loro proprietà chimiche ed elettriche durante il
sonno, in modo tale da poterne beneficiare durante la veglia.
Letture scelte
BAlDIsserA, F., (2009). Fisiologia e Biofisica Medica. Casa editrice Poletto editore.
DeMent, W.C., (2001). Il sonno e i suoi segreti. Dormire bene per vivere meglio. Baldini,
Castoldi.
FInGer, s., (1994), Origins of Neuroscience. A history of explorations into brain function.
oxford university Press.
GreGor, r., WInDHorst, u., (1996). Comprehensive Human Physiology. In: Comprehensive Human Physiology from Cellular Mechanism to Integration. springer.
HoBson, J.A., (1998). Sleep. scientific American library. new York.
Hobson, J.A., (2002). Dreaming: An introduction to the Science of Sleep. university
Press.
Horne, J.,(1998). Perché dormiamo. Le funzioni del sonno negli esseri umani e negli altri
mammiferi. Armando editore.
JouVet, M., (2002). The paradox of sleep. The Story of Dreaming. the MIt Press.
KrYGer, M.H., rotH, t., DeMent, W.C., (1989, 2000). Principle and Practice of Sleep
Medicine. B. sauders Company, toronto.
MACKenzIe, n., (1967). Il sogno. rizzoli editore, Milano.
MAnCIA, M., (1980). Neurofisiologia e vita mentale. zanichelli.
MAnCIA, M., sMIrne s., (1985). Il sonno e i suoi disturbi, fisiologia, clinica e terapia.
raffaello Cortina editore.
MAnCIA, M., MArInI, G., (1990). The Diencephalon and Sleep. raven Press, new
York.
MAnCIA, M., (1993). Neurofisiologia. raffaello Cortina editore.
MAnCIA, M.,(1996, 2006). Sonno e Sogno. editori laterza.
MAnCIA, M., (2002). Saio introduttivo a: Il Teatro del Sogno di salomon resnik.
Bollati Boringhieri.
MAnCIA, M., (2004). Il sogno e la sua storia. Dall’antichità all’attualità. elementi Marsilio.
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 5
Il sonno
5
MAsuD KHAn, M.M., (1992). Lo spazio privato del Sé. Bollati Boringhieri.
MoruzzI, G., (1986). Fisiologia della vita vegetativa. utet, torino.
MoruzzI, G., (1972). The sleep–waking cycle. ergeb. Physiol., springer, new York.
sCHMIDt–tHeWs, (1992). Fisiologia Umana. Idelson liviana, napoli.
sHePHereD, G.M., (1994). Neurobiology. oxford.
solMs, M., (1997). The Neuropsychology of Dreams. A clinical neuroanatomical study.
lea.
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 6
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 7
Capitolo II
la storia dell’esplorazione del sonno e del sogno
Il sonno e il sogno: una storia di dipendenza. senza il primo non esisterebbe l’altro, ma se non vi fosse il secondo, l’altro perderebbe parte del suo
arcano, cioè parte di quel mistero che da un paio di secoli affascina gli scienziati. In questo capitolo esamineremo le teorie e le ricerche di queste due
fasi negli esseri viventi, ripercorrendo alcune idee generali sul significato del
sogno: dalle civilizzazioni più antiche sino all’inizio del XIX secolo quando,
con l’avvento di apparecchiature più sofisticate, gli sperimentatori ebbero la
possibilità di ampliare il campo delle conoscenze scientifiche sul sonno.
2.1. Le teorie greco–romane del sonno
I poemi omerici ci hanno tramandato che i Greci dell’VIII secolo avanti
Cristo personificavano il sonno in «Colui che tutti doma» e nel «signore
cui non sanno resistere né gli uomini, né gli Dei». un’altra frequente immagine del sonno è quella del gemellaggio tra questo e la morte, tale da
suscitare negli eroi sentimenti opposti: detestata poiché irreversibile viaggio senza ritorno la prima; desiderato il secondo perché ideale per far riposare il corpo e alleviare dolore e tristezza. A questa raffigurazione vanno
fatte risalire alcune espressioni letterarie utilizzate per indicare la morte,
quali: «lungo sonno, sonno invincibile» e, nella tradizione cristiana, «eterno
riposo» (FInGer 1994).
nella tradizione filosofica presocratica e in quella medica antica, il
sonno era considerato una via che sta nel mezzo fra la veglia e la morte.
7
Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 8
8
Capitolo II
secondo Alcameone di Crotone il passaggio dalla veglia al sonno era la
conseguenza di modificazioni nella distribuzione del sangue; per empedocle d’Agrigento, invece, era il frutto di un’alterazione del calore; Diogene
di Apollonia l’interpretava come uno spostamento, provocato dal sangue,
dell’aria ai vasi sanguigni e al torace. tutti questi filosofi ritenevano che la
morte fosse dovuta a modificazioni dello stesso tipo di quelle che inducevano il passaggio dalla veglia al sonno, ma di intensità superiore, a tal punto
da provocare conseguenze estreme irreversibili (FInGer, 1994).
Aristotele fu il primo studioso a sistematizzare le già allora numerose
osservazioni sul sonno, nell’uomo e negli animali. egli postulò uno stretto
parallelismo fra veglia e percezione, localizzando entrambe le funzioni
nello stesso organo: il cuore. Analogamente alla percezione, anche il sonno
era ritenuto essere la conseguenza dello spostamento dell’anima all’interno
del corpo (FInGer, 1994).1
la tradizione medica dello studio del sonno, è fatta risalire al Corpus
Hippocraticum, un’opera raccolta e completata nei secoli IV e V avanti Cristo, nella quale sono riportate le osservazioni sulle variazioni stagionali
della sua durata e, per la prima volta, le descrizioni delle posizioni assunte
dal corpo nel sonno, oltre alle prescrizioni igieniche per migliorarne la qualità. Galeno — grande divulgatore del II secolo dopo Cristo delle conoscenze della tradizione medica antica — analogamente ad Aristotele
localizzò il sonno nel centro della percezione, ma a differenza dello stagirita
e in linea con la tradizione ippocratica e platonica, lo situò nel cervello.
Ipotizzò poi che il sonno avesse anche un’altra funzione: quella di permettere al cervello di recuperare le energie spese durante la veglia e di rinnovare il «calore innato» (FInGer, 1994; HIPPoCrAtes, 1952, 1959).2
2.2. Il sonno nell’era pre–scientifica
un apporto unico alle conoscenze mediche nel Medioevo è costituito
dalle prescrizioni igieniche presenti nel libro Regimen Sanitatis Salernitanum,
1. Per un approfondimento si vedano i testi di fisiologia e le monografie citate nel capitolo 1 e
nel capitolo 2.
2. Per un approfondimento si vedano le opere di MAuro MAnCIA pubblicate op. cit.