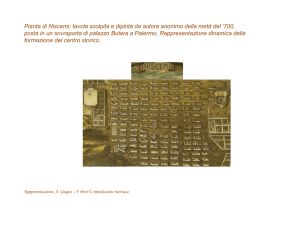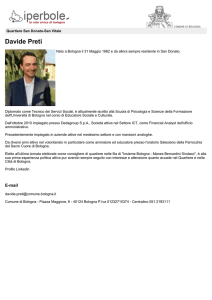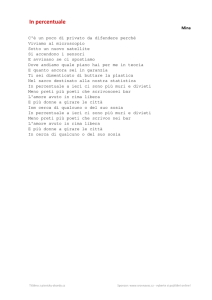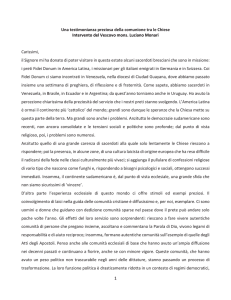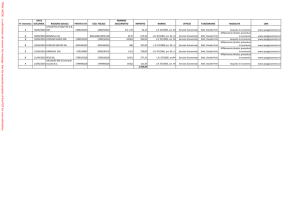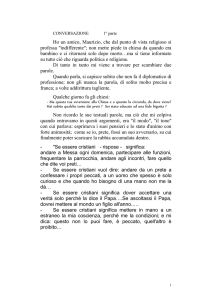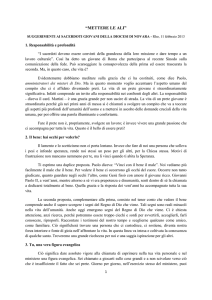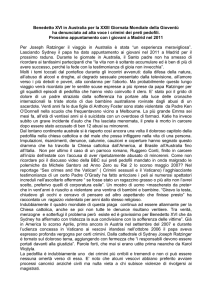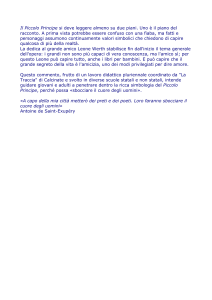Memo n.4 sulla filosofia di Giulio
Preti
Albe!o Per"zi
Dipa!imento # Filosofia • Università # Firenze
(Foto: Marco Salucci 2011)
E-mail: albe!o.per"[email protected]
Alberto Peruzzi – 2011
Ove mettonsi antipatici puntini sulle i.
1. Il Marx pretiano ...
è il teorico della scientificità dello studio della storia più che il teorico della storicità della scienza,
quindi la ripresa di temi marxiani non è legata a quel tipo di languido neostoricismo che poi i fautori della
storia “esterna” della scienza invocheranno, così come non è legata a quella cultura del sospetto che nell’Europa continentale allignava in certi ambienti: non mi riferisco ovviamente agli artefici della cosiddetta
nuova filosofia della scienza, bensì a quegli scienziati e filosofi che negli anni sessanta e settanta si gloriavano di scoprire gli altarini della scienza borghese. Per inciso, se una storia ce l’ha solo il pensiero scientifico e non la scienza (giusta o sbagliata che sia quest’affermazione), non avrebbe dovuto esserci niente
di male a sospettare.
Per Preti, la praxis storico-economica delle società ha una funzione maieutica, non fondativa o antifondativa: paradossalmente, era una funzione simile alla funzione delle api nei confronti del miele, come
dirà un filosofo della scienza che Preti non apprezzava molto. Alle api operaie fece un ben diverso riferimento un fisico italiano. Le api di Bacone erano troppo remote dall’uno e dall’altro.
È facile immaginare che una lettura di Marx come quella proposta da Preti apparisse parziale, o
decisamente impoverita, perché dimenticava l’Ideologia tedesca e Il capitale. E così agli occhi dei marxisti italiani, e degli intellettuali che in loco erano i loro compagni di strada, Preti dev’essere apparso come
un mestatore infiltrato. In effetti, le critiche da parte marxista non tardarono e si espressero anche con
livore verso Praxis ed empirismo. I pochi che aspettavano a gloria quel libro e che poi cercarono in quel
libro la chiave del futuro, al pari dei molti che aspettavano Preti al varco, pronti a disprezzarlo prima ancora d’averlo letto, erano difficilmente in grado di seguire i dettagli del ragionamento, perché ciò avrebbe comportato una familiarità con un background alieno. Non bastava più conoscere le opere di Marx e
avere il lessico proprio dei tesserati. Erano davvero troppe le altre cose da sapere, troppi i rimandi impliciti alla cultura filosofica di lingua inglese e troppo specifici i battibecchi con la migliore filosofia della
scienza del primo Novecento continentale, per chi non aveva idea neanche della peggiore.
Una cosa si poteva ugualmente capire: quello di Preti era un Marx che, ancor prima di storicizzare,
permette di umanizzare e il termine di riferimento di questa umanizzazione è la vita delle persone singo-
2
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
le, non collettive. Il che emerge nitidamente da un passo di In principio era la carne (versione “seconda”)
in relazione alla versione marxiana dell’idea In principio era l’atto:
Un messaggio che è stato raccolto anche da Marx, che ne ha fatto l’azione umana che nel
lavoro mira alla soddisfazione dei bisogni. Il che non sarebbe una mistificazione, se questa
azione non fosse stata subito tradotta in azione sociale, in lavoro sociale, in bisogni sociali;
sì che l’uomo si ritroverebbe ad essere un’ignobile formica senza speranza di poter essere
mai, né al principio né alla fine, quello che è — appunto un uomo, solitario animale da preda, la cui unica possibile felicità consiste nell’essere solo e nel predare (il mondo, la natura
e soprattutto gli altri uomini). Come gli idealisti hanno inventato un Verbo prima dell’uomo, così i marxisti, con quel loro singolare idealismo rovesciato, hanno inventato una socialità che è prima dell’uomo: ché la socialità come tale non significherebbe assolutamente
nulla, se non servisse appunto all’uomo per divenire uomo e affermarsi come tale. La società è per ognuno di noi «gli altri»: qualcosa con cui ci si ritrova originariamente in conflitto,
un conflitto che sempre si pone e sempre si risolve in ognuno di noi, come singolo, quando
«gli altri» da una parte sono divenuti nostro terreno di conquista, dall’altra sono respinti di
nuovo in quell’alterità per la quale sono esseri privi di significato. La formula vera è analoga
a quella di Simmel sopra ricordata: « vita [del singolo] — più che vita [della società] — più
vita [del singolo, in quanto si è appropriato degli «altri»] ». «In principio» è proprio il singolo: ma è l’{azione}, suoi sono i bisogni, suoi i consumi, sua la parola. E questo singolo non è
né materia (una splendida astrazione, ma un’astrazione), tanto meno lo spirito (un’ignobile
mistificazione) — ma la carne, carne ed ossa e sangue, materia organica vivente, gesto muscolare, tatto, respiro. Questa è la realtà prima, il punto d’appoggio archimedeo che regge il
mondo; questa è la realtà ultima, cui tutto ritorna e in cui tutto ciò che ha senso trova un
senso (ivi comprese le astrazioni dei fisici e le mistificazioni degli spiritualisti).
Come risvolto di quel che si poteva capire, l’empirismo si arricchisce di una nuova dimensione,
quella diacronica dei sistemi socio-economici, e di un appassionato impegno per l’emancipazione umana. Il Marx che gli interessa è un do ut des. Preti non lo avrebbe mai seguito nel progetto di ridurre i valori che s’inverano nell’impresa scientifica, e non solo essi, a ethos di una data comunità e a sovrastruttura
dell’economia. In una simile riduzione avrebbe scorto l’annullamento della stessa spinta etica di Marx, o
almeno del suo Marx “umanistico”.
Quanto al marxismo come dottrina del disinganno, in particolare nei confronti della presunta neutralità della scienza, Preti lo avrebbe considerato una dottrina infausta, perché autolesionistica. I marxisti
italiani che giudicarono ingenua la presunzione di Wertfreiheit della scienza erano così ingenui da non
rendersene conto? Si fossero riferiti al primo libro di Preti, forse potevano avere qualche motivo per lamentare carenze nella fenomenologia dei rapporti tra basi economiche e costruzioni culturali. Forse, se
più dotati, potevano anche lamentare scarsa cautela nei confronti del rischio di psicologismo e naturalismo assiologico. In realtà non erano affatto cauti: questo rischio lo correvano allegramente quando con-
3
Alberto Peruzzi – 2011
giungevano sociologia e storia come fonti di conoscenze più solide di quelle reperibili nelle scienze della
natura formulate in linguaggio matematico.
Indubbiamente la lettura di Marx da parte di Preti era selettiva. Lo leggeva come Kant aveva letto
Hume e non c’è quindi di che stupirsi se qua e là finiva per mettere Marx contro Marx. Per accorgersene,
basta guardare al ruolo della dialettica, che per Preti non ha mai quel carattere ecumenico verso cui lo
storicismo marxista tipicamente scivolava. Il primum in sé, che ora si configura come primum per la soggettività trascendentale (de iure, rete di funzioni di sintesi) non può essere il primum per noi, che analogamente si configura come primum per la soggettività empirica (de facto, organizzata nelle forme effettive delle transazioni sociali). Se così non fosse stato, ma si fosse tenuto fermo il telos della ragione scientifica, non restava che un’opzione: lasciar perdere la filosofia e passare armi e bagagli a sociologia, psicologia e pedagogia del sapere. Un’idea, questa, che faceva a pugni con la purezza della teoresi che Preti
esige. Il tradimento dei chierici si trasforma di conseguenza: il bisogno di aprire la riflessione filosofica
alla storia e alla sociologia della cultura era diventato fissazione, con la quale la filosofia finiva per contaminare il proprio compito.
Vaneggiamenti, avranno detto. Preti passava sopra a molte cose. C’era un altro Marx e a quanto
pare Preti se l’è dimenticato. Ma ricordarsi meglio di Marx sarebbe stato, per lui, come dimenticare Kant,
cedendo a un riduzionismo non migliore di quello che i cultori del disinganno imputavano alle scienze
naturali. Sospetto per sospetto, il mio è che che l’interesse di Preti per la fallacia naturalistica tragga origine proprio dall’avervi rinvenuto lo stesso schema soggiacente alle accuse mossegli in relazione alla sua
incomprensione di Marx: chi l’aveva tacciato d’ingenuità era semplicemente reo di una variante della
fallacia – appunto, la variante che culmina in sociologismo e storicismo.
Dunque, il confronto con la critica di Frege e Husserl alla riduzione della logica a psicologia e con
gli argomenti di Moore contro la riduzione dei principi etici a fatti naturali può anche esser visto come
l’acme di un processo di decantazione delle polemiche degli anni Cinquanta su tutt’altri temi. Bisognava
andare al fondo della questione e, a quanto pare, toccava a Preti farlo perché i suoi contemporanei, e i
suoi conterranei in testa, non avevano il coraggio di affrontarla.
La stessa selettività Preti esercitava verso la lezione di Dewey. Il Dewey cui si richiama è l’illuminista che si preoccupa di evidenziare i concetti della scienza come strumenti, non nel senso (svalutativo) di
Croce, bensì nel senso di una valorizzazione della portata pratica del sapere. Di Dewey prende quel tanto
che gli serve per poterlo unire a quel tanto che gli serve di Marx, cioè per sbloccare la staticità dell’esperienza in cui restava intrappolato il vecchio così come il nuovo positivismo. Personalmente, avendo letto
Dewey dopo essere stato allievo di Preti, mi ha colpito che Dewey, anche facendone una bella scrematura, avesse avuto per lui tutta quell’importanza negli anni fra Idealismo e positivismo e Praxis ed empirismo. Mi restava più facile immaginare che Preti avesse trovato in Peirce una serie di spunti per arricchire
4
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
in senso semiotico la riflessione cassireriana sulle forme simboliche. Arrivavo a capire che in Dewey
vedeva la possibilità di inserire in un quadro empiristico socialmente impegnato il valore della logica e
della metodologia scientifica, mentre trovavo incredibile che, vista la passione tutta pretiana per le formulazioni nitide e le argomentazioni stringenti, si fosse potuto trangugiare tanta retorica e tanta approssimazione. Evidentemente, quando una cosa ci serve, guardiamo poco per il sottile.
Nei confronti del materialismo dialettico Preti era stato molto meno generoso. Qui sta anche uno
dei motivi della mancata sintonia con Geymonat. Per Preti, il materialismo dialettico, inteso quale cornice
ontologica del materialismo storico, era infatti da rifiutare in blocco perché ci vedeva una ingenua riproposizione di sogni per nuovi visionari. L’unità formale del mondo era quella materiale, ma riferita alla
materia empiricamente accessibile; e quest’unità non si poteva oltrepassare postulando una legge metascientifica che avrebbe dovuto essere anche superscientifica, perché questo significava riaprire le porte
alla metafisica che il materialismo storico, comunque lo si valutasse, voleva bandire una volta per tutte dal
discorso. Mi limito ad aggiungere che il no al materialismo dialettico va di pari passo in Preti al sì alla
logica, con il suo classico principio di non-contraddizione, non considerato per conto suo ma in rapporto
alla sua funzione entro il discorso scientifico: solo il rispetto della logica offre la garanzia che un’immagine unitaria della razionalità sia possibile e impone di conseguenza un vincolo a ogni architettura
scientifica. 1 Le contraddizioni sono solo nel discorso e sono da evitare.
Tutto ciò autorizzava a farsi l’idea di un Preti che è, sotto sotto, uno scientista? (Perché così fu interpretato.) Ma Preti non lo è mai stato. E, tra i vari motivi, per uno basilare e neanche difficile a capirsi:
la scienza, più che modello della razionalità, ne era modellata e perciò stesso la scienza era apertura, non
irrigidimento, delle conoscenze umane, era testimonianza di valori e non veicolo della loro riduzione, a
differenza di quanto avrebbero scritto i francofortesi e in particolare il Marcuse dell’Uomo a una dimensione. Autorizzava a dire che il sogno di Preti era una filosofia assiomatico-formale (anche se poi il sognatore non aveva la pazienza di elaborarla)? Ma neppure questa era un’idea che lo attirava. Anzi! Perciò non
si può obiettare a Preti che la sua idea di scienza tagli fuori i fenomeni che interessano ai cultori di scienze umane (fenomeni psicologici e sociali, con le relative pratiche culturali ed educative) e che la colpa è
di un suo eccessivo ossequio verso l’ideale della matematizzazione e verso la fisica come modello di spiegazione. Se quei fenomeni sono esprimibili e comunicabili nel linguaggio, che è qualcosa di pubblico,
allora sono descrivibili in asserti che hanno pubblici criteri di controllo empirico (e Preti non era certo
illiberale al riguardo). Se non lo sono, non possono essere addotti come prova a carico della sua idea di
scienza, a meno di dire chiaramente che la scienza non è discorso razionale. E come si fa a dirlo se non
tornando alla retorica del disinganno? Guarda caso, è questa retorica che ha avuto successo, anche se la
chiarezza dei discorsi fatti in questo senso ha lasciato molto a desiderare. Dalle nostre parti, chi si è
1 Quel che Preti non dice è che l’ambiguità rimproverata a Engels tra essere e dover-essere si ripropone nel caso della
logica tra il suo fungere da organon e da ideale verità.
5
Alberto Peruzzi – 2011
riempito la bocca con le “scienze umane” ha venduto per lo più retorica a gente che non era capace di
accorgersene.
E poi: punto primo, la matematizzazione interessava a Preti come individuazione di un medium
linguistico universalmente condiviso di esattezza, più che come modello di verità; punto secondo, Preti
sapeva bene che la fisica, nel suo sviluppo storico, ha accolto in sé una grande varietà di metodi. Accusare
Preti di fisicalismo è, dunque, come pensare che si fosse dimenticato quel che proprio lui aveva esaminato attentamente. Chi l’ha accusato di questo sparava semplicemente nel mucchio, non avendo familiarità
con quella stessa varietà e con la sua storia. Era piuttosto chi muoveva l’accusa a dimenticarsi di qualcosa.
Per esempio, del fatto che Preti fa di Newton un fenomenologo ... costruttivo. Newton, ai suoi occhi,
costituisce la Natura come ontologia regionale e nel far questo tratteggia i caratteri che qualunque indagine sull’uomo come parte-della-natura accoglie in sé. La fisica, anzi, esemplifica questi caratteri meglio
delle cosiddette “scienze morali”; e che la storia successiva della fisica abbia modificato il quadro newtoniano non inficia quell’operazione costitutiva.
Insistendo su questi due punti, non intendo negare che a Preti piacesse il bisturi, né negare la difficoltà di far convivere una certa concezione strutturale-sintatticista delle teorie scientifiche con l’ancoraggio referenziale del loro linguaggio a un piano stabile di dati empirici. Sarei un ipocrita se dicessi che
è del tutto infondata, leggendo Preti, l’impressione che la stessa logica si riduca a grammatica del linguaggio perfetto, che la nozione di “fatto” sia un fossile, che l’ideale della scienza sia conseguire una
sintassi ipercarnapiana, proprio perché la semantica è vista come ulteriore sintassi (meta-linguistica).
Ma le difficoltà che qui emergono non mi sono mai sembrate tali da avvalorare le accuse e tali da
dover dichiarare il fallimento dell’impresa pretiana. Per poter essere superate richiedevano semmai un
affinamento degli strumenti di analisi logica e, in parallelo, un ampliamento della tematica epistemologica, includendovi anche considerazioni che oggi appartengono alle scienze cognitive. E non lo dico per
tirare acqua al mio mulino, essendo un tale affinamento ed ampliamento quel che ho cercato di fare per
non pochi anni. O si pensa che il discorso di Preti non ne avesse bisogno? Affinamento e ampliamento
sono dovuti a un frainteso? Sarebbe una questione lunga. Pigrizia vuole che sia pur libero di pensarla così
chi così la pensa. Resto del parere che Preti non avrebbe disdegnato un tentativo di superare quelle difficoltà e, anche se non avesse condiviso nulla del modo in cui ci ho provato, doveva pur ammettere che era
un tentativo di riportare il lavoro filosofico a una situazione di osmosi con il lavoro scientifico, i filosofi a
quella collaborazione artigianale con gli scienziati, la riflessione propriamente teorica in parallelo e non
in sequenza con la meta-riflessione: insomma un tipo d’attività che aveva animato, se non contraddistinto, le discussioni nel Circolo di Vienna. Oso pure credere che un’operazione del genere corrisponda a
quel che Preti aveva apprezzato in Marx. E così torniamo al tema.
6
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
In Praxis ed empirismo il richiamo a Marx è confinato alla possibilità di elaborare una teoria scientifica della storia. Non si tratta di una limitazione casuale perché dal fatto al valore non c’è inferenza,
esattamente come non c’è dalla praxis all’axion. Dunque nessun stupore che siano ridimensionate le
pretese egemoniche di una particolare analisi dell’economia e della politica nei confronti di qualunque
analisi della cultura. Ogni cultura si fonda su valori e i valori sono irriducibili, come tali, a fatti economici
o ad assetti sociopolitici. Né la settecentesca meccanica dei sentimenti né l’ottocentesca meccanica delle
classi riescono ad assorbire lo scarto di piani tra dati e “regole di sintesi” (come diceva Kant), tra descrittivo e normativo, tra fatti e valori; e tra l’altro ogni operazione assorbente fa passare in sott’ordine il nesso cruciale tra valori e norme.
Per un bravo empirista, più neo che vetero, l’assorbimento potrebbe avvenire unicamente in due,
antitetici, modi: o per induzione o per costruzione metateorica, nel primo caso a spese della necessità,
nel secondo a spese della sinteticità. In ambedue i casi la voce del pur bravo empirista comincia ad avere
qualche incrinatura quando riconosca che le “motivazioni” non bastano a garantire normatività alle “valutazioni” e le “valutazioni” non hanno analiticamente valenza normativa. E qui la voce di Preti s’incrina,
avvertendo in qualche modo che i margini di manovra per il filosofo che (meta-)riflette sull’etica si restringono. Tra le contingenze pratiche che selezionano troppo e i valori che selezionano troppo poco il
sentiero si fa difficile. L’unica chance di oggettività per il suo discorso sembra essere offerta dall’analisi
del linguaggio, non presa a sé ma inquadrata in una più generale analisi delle forme simboliche della cultura.
Non poteva bastare a Preti. Ancora una volta, in lui c’è dell’altro. La sua “analisi” non è mai statica
(o sincronica) né è mai rigidamente chiusa nelle singole “regioni” che di volta in volta focalizza. Mentre
lo dico, penso che sia un pregio del suo discorso. E più ne sono convinto, più avverto una lacuna: se tali
regioni sono da considerare non solo nella loro struttura interna ma anche sotto il profilo delle relazioni
con le altre regioni, allora la preoccupazione affinché tali regioni siano ben distinte l’una dall’altra ha
bisogno di essere suffragata più di quanto Preti suffraghi; se invece è tutto un calderone, pardon: un sistema olistico, allora quella preoccupazione era da ridimensionare. Ecco un altro spunto per chi cerchi
incoerenze nella sua posizione. Per me che non le cerco, è solo un bel problema. L’alternativa è lavarsene
le mani, guardare la questione da storici o da letterati che commentano un testo poetico, e arrendersi alla
di Preti astuta, aristocratica, inafferrabilità. Non facciamolo rigirare nella tomba, per favore! Raccogliamone la sfida, rimbocchiamoci le maniche, facciamoci anche venire un bel mal di testa per capire come si
possa gestire questa tempesta di dimensioni interagenti, e infine proviamo a fare qualcosa perché l’anelito civile che c’era in Praxis ed empirismo torni a respirare. La filosofia politica è solo un ramo (secondario) della filosofia. Chi non lo vuol sentir dire, non sa fare il proprio mestiere. E chi sa fare il mestiere,
non può esimersi dal considerare quel ramo e anche salirci sopra almeno per un po’, invece di sentirsi
autorizzato all’esilio.
7
Alberto Peruzzi – 2011
Lo sguardo di Preti è già negli anni Cinquanta quello di un esule in patria, con il dito accusatore
puntato sul provincialismo ideologico. Disarticola le categorie del pensiero politico, propone un diverso
sistema di assi cartesiani, austero quanto radicale, immette nel dibattito culturale italiano un respiro di
classicità riconquistata proprio laddove appare più “americano”. Ne è spia lo stile nervoso e terso: uno
stile proprio di chi è consapevole di star facendo un discorso dirompente e non si rassegna alla provocazione. Non è però lo stile di chi ha una chiave per tutto. La sua stessa prudenza nell’avanzare proposte sul
“che fare” rivela dei dubbi latenti, nascosti elegantemente nel silenzio: per esempio, il silenzio di alcune
pagine di Praxis ed empirismo su questioni fondamentali che Preti stesso aveva dischiuso (e in modo
originale).
La reazione della cultura marxista italiana a quel testo fa venire in mente, mutatis mutandis (cioè
rabbia in ipocrisia), il processo a Galileo, per le rinnovate accuse di hybris. Preti avrebbe dovuto limitarsi
a salvare i fenomeni (tenendo conto – e qui fate un ampio gesto delle mani che si chiudono in cerchio –
del contesto storico) invece di mitizzare la neutralità della scienza e restare vittima di una “sublimazione
del tecnicismo”. 2 Non manca neppure un avvertimento mafioso, avvolto in un agghiacciante tono biblico: “E tu Barone rampante, non credere di potertela svignare su per gli alberi. Neanche per te c’è scampo, in questo giorno del giudizio”. 3
Ci furono anche letture critiche un po’ più morbide di Praxis ed empirismo, come quelle che arrivavano ad apprezzare la continuità con l’impegno prebellico dell’autore contro lo spiritualismo irrazionalistico – uno spiritualismo riproponentesi nell’aetas dello scudo crociato –, lamentandone però le impuntature rigoristiche, le quali finivano per ribaltare la dialettica hegeliana, staticizzandola in abito logicometodologico e facendola così poggiare di nuovo sulla testa. Quella di Preti sarà anche stata una battaglia
per la ragione ma era una battaglia condotta soltanto o troppo razionalmente. Perciò risultava intellettualistica e, in ultimo, moralistica. Perciò era una battaglia condotta nel nome di una brutta razionalità, perché si dimenticava dei fatti oggettivi e dell’ampia realtà storica in cui la ragione si fa e si trasforma. Insomma, uno sforzo encomiabile viziato da palesi errori – e tali secondo il metro dello stesso autore.
Peccato che leggere Preti con gli occhi di Gramsci peccasse di non minore intellettualismo e moralismo, paludati da attenzione per la “realtà”. Ci possono essere varie cose che non convincono in Praxis
ed empirismo e credo pure che ci siano. Non sono però le cose che una simile lettura permetteva di scorgere. Nell’opera di Preti c’è una freschezza di idee che i parrocchiani non erano in grado di individuare e
per un semplice motivo: per individuarla bisognava aver presenti i suoi punti di riferimento, che erano i
maggiori contributi all’epistemologia forniti nel Novecento, non le tematiche e il lessico familiari a marxisti ex-idealisti e a neoscolastici. Possibile che Preti non avesse chiaro l’effetto che le sue parole avreb2 C. Cases, passim, p. 12.
3 Ivi, p. 98.
8
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
bero fatto all’uditorio al quale erano indirizzate? Erano semplicemente un pugno in un occhio e in specie
quando davano per scontato quel che i lettori sapeva che ignoravano. O tanto grande era la sua fiducia
nella ragione umana? La scienza come baluardo ed emblema della democrazia ... Ma scherziamo? Preti si
rivolgeva ai lettori (italiani) come da un pulpito e con fare amichevole, quasi dialogasse con se stesso. Le
due cose non stavano insieme. Intendiamoci: da un pulpito anglosassone e con anglosassone snobismo.
E perché allora non si rivolgeva direttamente a un pubblico di lingua inglese? Se lo avesse fatto, tra l’altro, gli avrebbe sicuramente giovato. Il giovamento sarebbe stato reciproco, of course, a pro di quei filosofi di madrelingua inglese o che ormai scrivevano in inglese da buoni emigrati negli Stati Uniti, e avrebbe fatto sapere al mondo che un punto di vista profondamente radicato nella tradizione “continentale”
poteva farsi valere tra gli “analitici”.
2. Empirismo
Ho detto che l’empirismo di Preti è “minimalista” e a sostegno di quest’affermazione vorrei ricordare che è lui stesso a indicare che l’empirismo è un “bisogno”, è un “atteggiamento”, è “il punto d’arrivo di una robusta tradizione” (qui si lascia al lettore la nozione di quale) e la “vittoria della tecnica sulla
magia”. Insomma, è qualcosa di più lato di quel che una qualunque definizione dell’empirismo ci potrebbe suggerire e, in particolare, non è in alcun modo condivisione della classica tesi secondo la quale nihil
in intellectu quod pria non fuerit in sensu. Tanto meno si riduce alla tesi che qualsiasi enunciato è significante nella misura in cui c’è un cavetto, il Verificatore, che collega direttamente a dati incontaminati
dell’esperienza. Per tutto questo, basta leggersi quel che scrive nell’articolo intitolato “Il mio punto di
vista empiristico”.
Sono in obbligo di una precisazione. È vero che a una prima lettura l’effetto che l’articolo fa è quello di un invito alla saggezza, a conferma di quanto appena detto, ma a una seconda lettura l’effetto è diverso: ci si accorge che è un minimalismo tutt’altro che pacioso. Il senso è quello di un discorso provocatorio per chiunque abbia in mente l’idea consueta dell’empirismo. La liberazione, infatti, dai cascami
della metafisica non è più sufficiente: occorre cogliere i molteplici strati semantici, uno impilato sull’altro, che costituiscono gli oggetti, sia del comune discorso nella vita quotidiana sia del discorso scientifico. Essere empiristi “alla Preti” chiede meno di quel che gli “empiristi” chiedono e per questo finisce per
chiedere di più: è difficile individuare qualcuno che sia mai stato prima “empirista” in questo senso. Preti
esige che si sappia tenere insieme la più liberale riflessione sull’esperienza e la più attenta considerazione di codesta stratificazione di strutture, esige che si individui uno strato-base senza supporre che il processo di costruzione sia a esso riducibile, esige che si valorizzi la possibilità di più ramificazioni (più “reticolati categoriali”) a partire dallo strato-base, che per lui resta comunque tale relativamente a quel che
ci poggia sopra, non in sé.
9
Alberto Peruzzi – 2011
L’empirista pretiano poterà pure un po’ di rami, ma per far fiorire meglio quelli che restano, e sempre con delicatezza. E questo a beneficio di cosa? Si tratta di far fiorire una cultura. Si tratta di dar corpo
ancora una volta alle parole con cui Kant rispose alla domanda “Che cos’è l’illuminismo?” e di kantiano
quest’empirismo ha anche il riconoscimento del ruolo di a priori svolto dai concetti costitutivi di un qualsiasi dato universo di discorso. Quindi è un empirismo alimentato da Kant, invece che votato alla rimozione dell’eredità kantiana. Mutati i mutandi, Preti ci porta a pensare la tradizione criticista e quella hegeliana in un senso che echeggia Durkheim: Tolto il sistema, resta la funzione (ora funzione non solo
costitutiva e regolativa ma anche ... trasformativa), se non fosse fin troppo evidente che un simile empirismo ha dietro di sé la lezione di Cassirer. E allora la verificazione?
Certo, il controllo empirico è sempre necessario al significato. Ma qui la provocazione non viene
con Preti: c’era già nelle parole degli empiristi e non c’era bisogno di rincarare la dose. Ora piuttosto il
concreto esercizio del verificare non è più staccato dalle ontologie regionali nelle quali sempre s’inscrive
e le quali contribuisce a stabilizzare.
L’errore che, per Preti, hanno commesso certi empiristi del passato è lo stesso di Husserl e consiste nel pensare che sotto alle singole “regioni” in cui si organizzano i contenuti, ci sia una regione primaria, d’immacolata purezza fondante, tanto che a essa si sarebbe dovuta rivolgere l’attenzione per realizzare una super-scienza. La purezza c’è anche, ma è solo quella della forma, da descriversi in un corrispondente discorso formale, che non contrabbandi contenuti, dunque non le corrisponde un’ontologia stricto
sensu, bensì una sintassi, che è luogo geometrico del metodo, ovvero, è logicità.4
Temo che una simile sovrapposizione di errori sia un po’ troppo rapida e che questo sia uno dei
punti specifici in cui l’affinamento e l’ampliamento dello strumentario di Preti si rivelano indispensabili.
La sovrapposizione non aiuta a risolvere i problemi. Se l’immediatezza dell’Erlebnis è un mito (in quanto
confonde lo spirito vitale con una struttura), tutti i nomi che Preti dà ai richiami alla ‘naturalità’ dovrebbero essere nomi non pronunciabili, la sorgente delle tematizzazioni regionali essendo non tematizzabile. Invece Preti ne parla e ne riparla. E anche se è nuovamente minimalista nell’avvertire che non si tratta
di una struttura coerente, bensì di un potpourri, qualcosa in fondo ne dice.
La sua strategia lascia due potenziali gruppi di scontenti: i filosofi che si sarebbero fermati prima e i
filosofi che non si sarebbero fermati ancora. La mia scontentezza è del secondo tipo: il suo empirismo
provocatorio si fa d’un tratto pudico e il discorso si arresta: la sorgente delle strutture dell’esperienza
rimane un orizzonte che non ammette compattazione e dunque oggettivazione; resta là, in lontananza,
quando è l’orizzonte più vicino e anzi pervasivo del nostro stare al mondo. Ma Gentile docet: se il mondodella-vita è davvero il terreno del precategoriale, non può essere categorizzato. Al più se ne potranno
offrire adombramenti, e anche se la forza che agisce in esso ci si manifesta di continuo, la sua azione è
4 Riguardo al linguaggio ideale come ontologia formale, si veda Praxis ed empirismo, p. 83.
10
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
concettualmente ‘agibile’ solo nei suoi prodotti. Be, qui c’era proprio bisogno di quella visione dialettica
che Preti altrove aveva raccomandato. Nel grande mosaico pretiano, questo tassello manca.5
Ciononostante, la lacuna non pregiudica di per sé la tenuta delle altre parti, più specifiche, del suo
discorso e, guardando le cose alla rovescia, l’eventuale successo nel colmarla non cancella il carattere
antinomico di altri aspetti: quando suggerii, nella “Postilla” che chiudeva il quaderno del Vieusseux in
omaggio a Preti nel 1986, che, se il cuore ha le sue ragioni, anche la ragione ha un cuore, non intendevo
suggerire che fosse un’entità monoblocco. Neanche le ragioni del cuore pare siano sempre in docile
connubio. Sta a noi trovare un ragionevole accordo. E, a scanso di equivoci, non lo dico avendo una ricetta per garantire l’accordo. Può anche darsi che l’antinomicità reperibile nel pensiero di Preti sia più fedele all’esperienza conoscitiva di quanto sarei stato e sia propenso ad ammettere.
3. No al sistema
La mancanza di sistematicità è prima, se non voluta, strumentale; poi è subìta , come è riconosciuto
apertis verbis nell’esordio del manoscritto intitolato “Il neorealismo logico” (FP I, 49), ove Preti scrive
che “l’autore non ha avuto il tempo, e probabilmente la capacità, per elaborare un sistema armonico e
coerente” e aggiunge:
Non che l’autore condivida il disprezzo che molti suoi colleghi ostentano per il “sistema”:
anzi, è convinto che la forma del sistema è la forma e il paradigma ideale di ogni pensiero
filosofico — e che solo nel sistema e nel trattato si può parlare di “conoscenza” in senso
perfetto e compiuto.
Poi di nuovo la mancanza di sistematicità è giustificata con la discutibilità di scegliere un punto
d’inizio che trae il suo senso dagli effetti derivanti dall’adozione di quel punto come inizio. Di modo che
quel che conta, per il filosofo e naturalmente per lui, Preti, è “mostrare le ragioni per cui si assume un
punto di vista attraverso una analisi critica e delle posizioni antecedenti la propria e delle posizioni concorrenti”. In sostanza, Preti dialoga, dialoga sempre anche se, a differenza di Platone, non sceglie la forma esplicita del dialogo e i personaggi con cui dialoga li prende dalla storia invece che dalle vie di Atene.
Un’altra differenza è che mentre Platone dice che la sua filosofia non è nei dialoghi, Preti non dice che la
sua filosofia ... invece c’è.
Il primo a notarlo è stato Franco Cambi, op. cit., pp. 77-78. Ho sondato la possibilità di far qualcosa in questa
direzione, cfr. “Action of structures, structure of actions”.
5
11
Alberto Peruzzi – 2011
Alla base di ogni “sistema” filosofico – Preti ci ricorda – c’è un ordinamento di conoscenze e valori,
disposte gerarchicamente, secondo un ordine di rilevanza. Ciò comporta una scelta. In realtà è una metascelta, perché riguarda precedenti selezioni di esperienze, le più varie e in linea di principio ugualmente
degne d’attenzione. Inoltre, la scelta fatta dal filosofo costruttore di un sistema resta implicita al pari dei
motivi che hanno indotto a compierla (che possono essere anch’essi i più vari e, tra loro, non essere
ugualmente nobili) e così capita che non ci si renda conto di come il sistema messo in piedi tagli via molte
cose.
Capita e basta? No, è la norma e basta questo a capire che, per Preti, il rischio di dogmatismo è
endemico nei sistemi. Il dogmatismo è assolutamente da evitare, quindi è sconsigliabile mettere in piedi
un altro sistema ancora. D’accordo, non è tutto qui: non c’è solo il rischio di dogmatismo e neppure c’è,
come unica aggiunta, il fatto che molti sistemi filosofici non sono costruiti con rigore. Il punto, per Preti,
è che la scelta che sta alla base di ciascuno comporta una tradimento del telos stesso dell’attività teoretica, che è prima di tutto quello di capire, discernere e ricomporre la realtà culturale tenendo conto di tutti
i suoi aspetti, anche quelli che non trovano posto nell’immagine del mondo che di volta in volta fa da
sfondo, perciò bisogna evitare di sostituirle una realtà succedanea, per giunta accompagnata dalla presunzione che sia una super-realtà.
I filosofi possono avanzare critiche alla realtà culturale, al senso comune, all’ethos che si è fatto
legge, a dogmi, a ideologie radicate, a costumi religiosi, a dee che in ogni campo scientifico sono diventate “paradigma”. E i filosofi possono anche additare direzioni di sviluppo. Ma lascino perdere i sistemi.
Sarà sempre e soltanto la realtà storico-culturale che ne farà un sistema o no. E se ne farà un sistema, lo
sviluppo in positivo di quelle critiche sarà destinato a diventare oggetto di critiche filosofiche che alimenteranno nuove idee le quali a loro volta eccetera eccetera.
Quel che ci viene proposto ancora una volta è un filosofo-artigiano, più che architetto di mondi, ed
è la proposta fatta da un artigiano diffidente verso ogni regimentazione (in senso ovviamente quineano)
che sia troppo ambiziosa – e per arrivare al ‘troppo’ ci vuol sempre poco. Ovvero: la filosofia non ha un
organo, non è un telaio a Jacquard, non ha una Teoria-del-Metodo e figuriamoci allora se può ambire a
essere il patron delle Scienze Sociali. Su un piano più personale, quel che si avverte è la nobiltà della
rinuncia che Preti impone a sé prima che agli altri filosofi, pur di tener fede a quel telos, sapendo che così
facendo la sua filosofia sarebbe stata considerata quella di un minore. Si capisce allora la sua umanissima
esitazione: tra l’orgoglio di meritarsi rispetto, un rispetto almeno pari a quello che si ha verso i filosofi
“sistematici”, e il rimpianto di non aver fatto quanto avrebbe potuto per guadagnarsi agli occhi dei più un
più alto gradino.
Contorte raffinatezze? La riprova di come il suo tragitto avesse un esito paralizzante? Non è questo
il punto. Il punto è che, con un atteggiamento di tale intima onestà, siamo semplicemente su un altro
pianeta! Su un pianeta lontanissimo dai tanti filosofi (italiani e non) sempre pronti a cavalcare le “ondate
12
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
passionali” della storia, se non della cronaca, con quel tono da preti spretati, con la furbizia di chi dà a
intendere di saperla lunga, con quel vezzo neo-dannunziano dei forzati della suggestività, con il bisogno
di mostrare il proprio acume esegetico facendolo passare per filosofia invece che per commento.
4. Storicità, evoluzione, empirismo
In alcuni scritti di Preti degli anni Cinquanta viene in primo piano non tanto il tema del farsi dell’uomo quanto l’uso esplicito di espressioni che rimandano all’idea vichiano-marxiana dell’uomo che fa
se stesso nella storia. Essendo tema caro alla cultura italiana ante- e dopo-guerra, non c’era alcunché di
originale nel semplice richiamo e del resto esso aveva già lasciato traccia in scritti precedenti di Preti.
L’esplicitazione però conta e permette, a chi all’idea è affezionato, di attribuire benemerenze a chi finalmente l’ha resa esplicita.
La ripresa del tema da parte di Preti è un pochino più sofisticata di quanto gli sarebbe convenuto, a
partire dal fatto che non indulge in alcuna captatio benevolentiae. Dicendo questo mi rendo conto che do
l’impressione di apprezzare almeno quel che di non banale c’è nel nuovo (cioè, nel modo di esplicitare
l’idea). Invece, ho qualche dubbio che l’esplicitazione, con o senza novità, abbia il successo che per molti
indigeni le spettava di diritto.
Partirò da un miserrimo esempio: l’uomo 6 ha costruito tante cose che non c’erano in natura e le
cose che ha costruito hanno modificato la vita dell’uomo (nel bene e nel male, ci mancherebbe altro). Le
modifiche poi non vengono subito bene, così ci tocca modificare le modifiche, e così via. Questo è il grado zero della dialettica: ci arrivo anch’io. Mi permetto solo di aggiungere che le cose non hanno la capacità di fare se stesse. Anche tra gli organismi, quelli che si replicano in maniera pressoché esatta sono rari e
comunque non rientrano ancora fra le cose-fatte-dall’uomo. I prodotti umani che funzionano tendono a
essere riprodotti, ma non si riproducono da sé. Nessun prodotto storico dell’uomo e, per coerenza con il
tema vichiano-marxiano, nessun uomo è finora stato in grado di farsi o di rifarsi – e se qualche biotecnociberscienziato ha oggi dei dubbi al riguardo, di sicuro questi dubbi erano impensabili quandoVico,
Marx, Croce e Preti scrivevano e comunque tali dubbi non sarebbero stati da loro apprezzati. Tanto meno un artefatto umano è stato in grado di fare un uomo. Allo scopo, l’unica attività che ancora funziona è
quella che volgarmente si chiama ‘fare l’amore’ e non ha bisogno di artefatti.
Se qualcuno trova banale quanto appena detto, mi fa piacere perché così sarà più disposto a riconoscere analoga banalità quando si parla di cultura, invece che di natura, e s’impegnerà subito a specificare
6
Abbrevio così la lunga lista di Tizio, Caio, Sempronio e innumerevoli senzanome d’ingegnose doti.
Benché innumerevoli, restano una sparuta minoranza, perché la maggior parte degli esemplari di Homo
sapiens sapiens non ha mai aggiunto nulla in vita sua al mobilio del mondo.
13
Alberto Peruzzi – 2011
a che cos’è che possa alludere di non banalmente vero o di non banalmente falso il tema vico-marxiano
del ‘farsi’ (e non mi riferisco solo alla banale diversità di senso rispetto ai tossicodipendenti). È fin troppo chiaro che sto recitando la parte di La Palisse. Lo faccio per attrarre l’attenzione su una necessità inderogabile: che si dia per filo e per segno una precisazione del “farsi dell’uomo”. Non intendo precisazioni semantiche o filologiche; intendo precisazioni teoretiche, che siano coerenti con l’adozione di un
“punto vista empiristico”, con l’idea che “in principio era la carne”, con l’autotrascendenza della Vita ...
(e mi fermo qui, se no che esercizio è per chi è così masochista da leggere questi memo?)
La parte di La Palisse non è mica finita. Per fare una cosa qualsiasi ci vogliono materiali che abbiano
le caratteristiche giuste, prima ancora di combinare i materiali fino a ottenere la forma richiesta. Per fare
un comune termometro, si usa il mercurio e non, per esempio, il ferro (ma guarda!), e per fare un chiodo
si usa il ferro e non il mercurio. Un termometro sferico avrebbe richiesto troppo mercurio, un chiodo di
mercurio non ha punta e un chiodo a due o tre punte serve a scopi diversi e se lungo e dritto si chiama
“forcone”, ma siccome agli uomini piacciono certe curve, se piccolo si chiama “forchetta”. Ci vogliono
materiali con le caratteristiche giuste: conviene ricordarselo anche quando si dice che l’uomo è l’essere
che fa se stesso. Dunque il tema, come Leitmotiv, era più che vago. Va be’, abbiamo pur sempre modo di
eliminare o ridurre la vaghezza. Il pericolo grave è un altro: quello d’incompatibilità fra tale richiamo e la
fondazione newtoniana della regione “natura”. I rozzi materialisti del passato diventeranno i rozzi fisicalisti nel Novecento, i sacri difensori dello Spirito si faranno i non meno sacri difensori dell’antiriduzionismo (alla fisica o ad altro). Tra il metallo informe e le forchette c’è la vita; tra natura fisica inanimata e
società umane c’è una lunga storia evolutiva.
Nel 1955 Preti pubblica sulla Rivista di Filosofia un articolo intitolato “Materialismo storico e teoria
dell’evoluzione”. Preti l’empirista si era accorto di un grande problema, ontologico ed epistemologico,
introdotto con la teoria dell’evoluzione e, con una certa fretta, sembra voler chiudere la questione con
l’abilità che gli era propria. Gli evoluzionisti dell’epoca non è che lo potessero sospingere verso una tanto più approfondita disamina avendo dato per primi un fulgido esempio di virtù epistemologica. Voglio
dire: niente esempio. Preti l’empirista, d’altro canto, non aveva la minima intenzione di elaborare per filo
e per segno un materialismo evolutivo e neppure di preparare una qualche cornice naturalistica della
cultura, perché avrebbe preso una tale cornice come negazione del tema vichiano-marxiano: a fare l’uomo sarebbe stato non più qualcun altro (Dio) ma qualcos’altro (la natura) e non se stesso.
Ora, la teoria dell’evoluzione si presentava come teoria scientifica e Preti non poteva certo confonderla con le sue volgarizzazioni. Non gli sarebbe costato neanche tanto sforzo individuare e metter da
parte le forme marchiane di evoluzionismo applicato alle società umane. Molto meno facilmente, specie
per un materialista (storico o non storico), poteva esser messa da parte la questione di com’è che nella
storia della vita a un certo punto si è evoluta la cultura, in senso antropologico, dunque inclusiva di classi
sociali con annesso saliscendi, e con tribunali, chiese, partiti politici: com’è che nel grande Libro della
14
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
Natura spunta fuori un organismo in grado di plasmare in tanti modi diversi almeno alcuni tratti della sua
stessa natura?
Preti non va oltre la generica espressione di un’esigenza di raccordo fra evoluzione naturale ed
evoluzione culturale (o se preferite: tra storia della carne e storia dello spirito). Infatti, il succo di quel che
dice al riguardo è quando afferma ieraticamente: “il caso produce l’uomo, e l’uomo introduce l’ordine”.
Se non voleva essere la teorizzazione di un duplice miracolo, aveva tutta l’aria di uno slogan, sul cui senso
si potrebbe ricamare. Lasciando perdere i ricami, è chiaramente un monito contro ogni concezione finalistica. Piani da distinguere (grazie), esigenza di raccordo (più che giusto), niente teleologia (ovvio...) e
poi? Non c’era altro. In realtà l’affermazione ieratica sanciva l’incapacità di conciliare Darwin e Kant.7
Non si diceva che erano inconciliabili e neppure che erano conciliabili: si dava semplicemente l’idea che
ci fosse poco d’interessante. E interessante non si può certo dire che fosse la possibilità di confondere
piani concettuali diversi. Preti non aveva nessuna voglia di cadere in una plateale metabasi.
Un attimo però: a distanza di bel po’ di tempo, generosamente potremmo intendere il versetto pretiano come se avesse voluto significare order from noise. La lettura in chiave order from noise sarebbe
stata già troppo naturalistica per Preti e al contempo la creazione dell’ordine tutta d’un botto con l’ingresso della specie umana sulla scena evolutiva non sarebbe andata bene ai naturalisti. Preti avrebbe avuto da ridire su tentativi come quello (successivo) di Monod che cerca di far convivere caso e necessità in
una prospettiva teleonomica. E perché l’idea dell’uomo-demiurgo, da Kant a Marx, non sarebbe andata
bene ai naturalisti? Perfino ovvio: se l’ordine è introdotto dalla storia umana, prima dell’uomo la natura
doveva esser stata interamente dominata dal caso. È dunque l’uomo che fa muovere i pianeti lungo orbite
ellittiche e dà forma esagonale ai fiocchi di neve, è l’uomo che oltre a imporre i nomi alle cose conferisce
loro un comportamento regolare. Quale naturalista, e più specificamente quale materialista, avrebbe
avuto il coraggio di dire una cosa del genere? Inoltre, se è un vantaggio pensare che l’uomo non sia il
portato di una cicogna metafisica, il vantaggio svanisce subito se l’alternativa consiste nel dire che l’ordine della natura nasce sotto i cavoli della storia. Tanto valeva tenersi la roulette biologica ed estenderla alla
cultura. Così come ci sono limiti al determinismo, ci sono anche a un’arbitraria autopoiesi. L’ordine può
nascere dal caso solo in presenza di certi vincoli strutturali. Non mi riferisco soltanto ad aspetti della
natura biologica dell’uomo che incanalano la cultura in certi canyon. Mi riferisco a una situazione molto
più generale, così come si configura nella teoria dei sistemi dinamici.
E Marx? Era tutto da ripensare. E innanzitutto c’era un problema da risolvere.
7
Ovviamente il Kant della rivoluzione copernicana (Preti: “l’uomo introduce l’ordine”) e non quello che perentoriamente nega il caso (“In natura non datur casus”) quando spiega il senso dei Postulati del Pensiero empirico in
generale. Ovviamente un Kant liberalizzato e dialetticizzato: liberalizzato per poter andar d’accordo con il neo-empirismo e dialetticizzato per potersi prestare a una lettura hegelo-banfiana. Questi “ovviamente” relativi a Kant non
hanno però corrispondente in quel che Preti scrive di Darwin.
15
Alberto Peruzzi – 2011
Per Preti, è merito di Marx aver gettato le basi non tanto delle scienze socio-economiche quanto
della storicità come terreno d’indagine, individuando i concetti generali di un metodo d’analisi in termini
del quale comprendere i cambiamenti socio-economici. Una delle idee-guida di Praxis ed empirismo è
proprio che i canoni metodologici del nuovo empirismo siano applicabili, con i dovuti accorgimenti,
anche al divenire dei sistemi in cui storicamente si manifestano le forme di organizzazione dell’esperienza. Su scala macro, la teoria elaborata da Marx però aveva in sé almeno i semi di un determinismo che,
sebbene diverso dal modello della meccanica, sembrava essere o era difficilmente compatibile con la concreta molteplicità dei modi di fare-se-stesso, propri dell’uomo a dimensione collettiva. D’altra parte, il
sistema economico non poneva solo dei vincoli: aveva una sua intrinseca dinamica la quale passava sopra
alla testa della volontà dei singoli e alle loro idee.
Preti avverte il problema. Reagisce infatti a letture ideologiche della storia del pensiero filosofico.
Come dire che rivendica uno spazio alla storia interna delle idee, invece di accodarsi alla schiera di coloro
che, da buoni disingannatori, ammettevano soltanto una storia esterna, che poi meravigliosamente lasciava intonse le idee di cui si servivano. E non si trattava di dire che il marxismo (o un marxismo opportunamente depurato) poteva ospitare in sé il quadro generale dell’empirismo come l’intendeva Preti. Era
bensì il “suo” approccio empiristico all’ambito dei fenomeni storico-sociali che permetteva di ospitare al
suo interno un marxismo depurato dall’ideologia, ridotto a dottrina minimalista del concreto farsi dell’uomo: il marxismo ospitabile era da identificarsi nella posizione del Marx umanista, il quale si integrava
con il Carnap che aveva affermato il superamento della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio.
Nel corso degli anni Sessanta una simile positività umanistica si riduce fino a tendere a zero. La
battaglia era stata persa. Non sarebbe bastato il riconoscimento della sconfitta. A farsi strada è l’idea che
sia stata una battaglia ugualmente ideologica. Il piano autentico del discorso filosofico era più in profondità e Preti non vuol più lasciarsene distogliere. Restano, com’è comprensibile, gli echi di tante precedenti scintille, che ogni tanto rispuntano fuori nei suoi minima moralia, di aderenza al dibattito culturale
di quegli anni.
Bastava la difesa, in tutta la sua opera, della razionalità che si esprime nella scienza a farlo apparire
agli occhi di alcuni marxisti nostrani come quinta colonna della tecnicizzazione, quindi compartecipe
della disumanizzazione in corso, quindi (ritenendo che Preti fosse in buona fede) un’ingenua vittima
dell’alienazione capitalistica. Gli si potevano facilmente contrapporre le nostalgie bucoliche di Pasolini o
la dialettica negativa di Adorno. Il Male era compatto e non aveva bisogno di ulteriori aiuti; il Bene era un
po’ sparpagliato e aveva bisogno invece di molta buona volontà per ricondurlo a compattezza. Peccato
che nostalgia e utopia, così come espresse negli stereotipi degli intellettuali italiani di sinistra negli anni
Cinquanta e Sessanta, si possano ugualmente additare come indizi di stato alienato. Il bello era che da
quei discorsi di pianto e d’euforia non era assente un qualche appello all’universalità della ragione che
accomuna gli uomini e grazie alla quale chi era intellettualmente onesto tra i borghesi non poteva che
16
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
giungere a riconoscere le Verità della Nuova Scienza che aveva la sua Rivelazione e la sua Provvidenza e,
per meritarsi il perdono, doveva farsi strumento della via verso il Bene, in nome dell’unica, autentica,
comprensione della storia, della società, della vita, ... di tutto. Chi passò, con l’animo ricolmo di verità,
sopra ai ragionamenti di Preti mostrava uno stato alienato ben più preoccupante: in quanto autocontraddittorio, era alienazione da se stessi.
5. L’effetto che faceva
Non voglio fare il furbo: questa era una sola faccia della medaglia. Sul retro c’era il problema della
“crisi dei valori” e la risposta di Preti è indubbiamente elitaria, nel senso che rifiuta quasi pregiudizialmente e con sdegno le filosofie che vengano a patto con il proprio tempo cercando almeno di svelarne i
meccanismi di consenso (comunicazioni di massa ecc.). Adorno avrebbe aggiunto che una ricerca del
genere è già complice del misfatto. La grande differenza tra i due è che tra rigore e denuncia, Adorno
sceglie una cosa e Preti un’altra. Da una parte ci sono gli ultimi paladini, laici, dei lumi della ragione e
dall’altra i fanatici, vecchi e nuovi, sicuri al mille per cento di essere dalla parte del Bene, anche quando
astutamente non lo danno a intendere, ma rei di tradimento nei confronti della loro stessa funzione. È
chiaro da che parte si colloca Preti.
Era la sua una non-risposta? Ma rispetto a quali domande? A quelle considerate fondamentali nel
paese ove i pifferai magici fanno fortuna? Più in generale: francamente, non so perché bisogna per forza
calarsi (e sempre più di quanto io riesca) in un filosofo di una data generazione che si trova a fare i conti
con una data situazione culturale, per valutare se quel che ha detto sta in piedi o no.
Comunque, se quel che conta è solo l’effetto che un ragionamento fa e non se sta in piedi o no, nel
caso di Preti e della sua situazione posso testimoniare il senso di liberazione e di ancor più alta responsabilità che le sue aspre prese di posizione acquisirono per gli studenti dei suoi ultimi anni (la generazione
del fatidico Sessantotto). Personalmente, l’effetto fu soprattutto quello di una sfida. Contemplavo ammirato la serie dei suoi No quando avevo bisogno di un bel Sì. I sottili sentieri che conducevano ai suoi No
incrinavano la maggior parte delle mie precedenti convinzioni. Stranamente, invece di caos, si generava
un minuto ordine, a chiazze, che mi restituì l’entusiasmo dei primi interessi per la filosofia negli anni di
liceo. Accidenti, avevo incontrato un filosofo greco uscito dall’ibernazione. Com’era possibile? Qualche
pulsante doveva esser stato schiacciato per errore da Hegel. Quel filosofo greco, non col peplo ma in
gessato (che già allora apparteneva a un’altra epoca), ci spiegava una serie di cosette ... cosette prima
inaudite e, una volta udite, difficili da far riudire. Leibniz replicava a Locke: che lo scultore rispetti le
venature del marmo! Preti, come i cavatori di Carrara, si divertiva ogni giorno a inserire un cuneo nei
nostri bei blocchi. Il risultato era per noi un esercizio continuo. Dico un esercizio dell’immaginazione
oltre che della ragione: cos’avrebbe pensato Aristotele della logica matematica? E Kant di Einstein? Po-
17
Alberto Peruzzi – 2011
trei andare avanti a lungo perché era diventato un passatempo cui almeno un gruppetto di suoi allievi
faceva spesso insieme.
Non presumo in alcun modo che quest’effetto fosse identico per tutti quelli che andavano a lezione
in quell’aula sul Lungarno dalle 5 del pomeriggio in poi. Non ero il solo e figuriamoci se ero il primo a
pensare di aver trovato in lui una guida, benché l’idea di fare da guida a qualcuno fosse la più lontana dal
suo sentire. L’idea che sembrava trapelare in qualche passaggio e che, più che a parole, si coglieva nel
suo scuoter la testa sorridendo, era un’altra: ormai c’era solo da cercare di salvare il salvabile in un’epoca
di epigoni ... In questo caso, mi dicevo, noi che ci stavamo a fare lì? Ci toccava durare tutta quella fatica
per diventare monaci bibliotecari?
Che il suo insegnamento abbia avuto effetti di così lungo periodo sugli allievi non prova molto, lo
so. Alla fine, si potrebbe dire, il salvabile si riduceva a un costume, un metodo, se non ancor più semplicemente, un po’ più d’attenzione a quel che si afferma o si nega. E ne avevamo indubbiamente bisogno.
Un certo numero di coloro che negli ultimi anni arrivavano alle sue lezioni erano semplicemente frastornati, se non già alla deriva. Erano la concreta testimonianza di un’epoca in cui ci si divertiva a mettere in
discussione tutto anche solo per il gusto di vedere che effetto faceva. (Ricordo un’assemblea in cui un
mio amico di idee anarchiche contestò che si dovesse votare a maggioranza e chiese che prima dovevamo
votare su quale criterio adottare, anticipando che avrebbe contestato anche l’esito di tale decisione perché presa a maggioranza o in base ad altro criterio che doveva a sua volta essere votato ..., e così via.)
Soffrivano (soffrivamo) di un’interna lacerazione tra spinte istintive (o quasi) ad assumere una posizione
e bisogno di far chiarezza sui principi primi. Chi aveva voluto la bicicletta, ora in quell’aula aveva da
pedalare. 8 Se non avevi una minima attitudine alle scienze esatte, i corsi erano un calvario. Se ce l’avevi, i
suoi corsi ti frastornavano ancora di più. Ogni lezione era un invito, attraverso dettagli lì per lì insignificanti, a riandare alle basi della cultura umanistica e scientifica, senza riguardi verso le linee di demarcazione tradizionali. Non era un’esperienza spettatoriale, uno sguardo da lontano, un rendiconto da semiotici circa le possibili decifrazioni di un messaggio nella bottiglia. Ti veniva data la possibilità di impratichirti con un bisturi affilato e se prendevi quel bisturi e lo mettevi alla prova su di te, l’effetto era curiosamente non di sottrazione ma di arricchimento. Quel discorso che si snodava pacato per mesi su un
tema ti disponeva a metter da parte la fissazione di prender partito su tutto e nello stesso tempo a interessarti di cose che fino ad allora non ti avevano fatto né caldo né freddo. La cura che metteva nel preparare
8 Era l’Aula IV. Un po’ di anni dopo ho avuto l’onore di farci lezione e il piacere di invitarvi Paolo Parrini a tenere una
conferenza su Preti filosofo dei valori, dal cui testo Paolo ha poi tratto un bellissimo articolo. Malgrado i manifesti
che avevo affisso in giro, a quella conferenza non venne nessuno di quegli ex-allievi ora docenti. Ai miei studenti
raccontavo di quando io ero al loro posto e al mio c’era Preti. Accennavo al suo modo di fare lezione e, in risposta,
ottenevo sguardi come se avessi parlato di un antico faraone. Feci in modo che l’aula fosse denominata “Aula Giulio
Preti” e che vi fosse apposta una targa in sua memoria – la comprai di persona in un negozio di coppe e targhe pieno
di loghi sportivi, calciatori in bronzo fissati nell’attimo di colpire, tennisti senza pallina, sciatori sull’ottone luccicante. Quando dissi che era per un filosofo, mi guardarono delusi. Con il trasloco della facoltà non so che fine abbia
fatto quella targa. L’Aula Giulio Preti credo che ora sia diventata un ufficio amministrativo dell’università, in cui chi
entra non sa che c’era stato un altro a insegnare come fare conti di tipo un po’ diverso.
18
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
una lezione dopo l’altra produceva un senso di fiducia: non poteva considerarci delle bestie anche se ogni
tanto ci mandava messaggi inequivocabili in tal senso. In filosofia era, ancora o finalmente, possibile discutere in maniera trasparente e arrivare a qualcosa.
Nel giudicare l’adeguatezza o inadeguatezza delle sue non-risposte ai problemi del tempo, anche
questo tipo di effetti dovrebbe esser considerato. Le sue non-risposte facevano capire che le risposte
propalate dagli auctores in voga ed ampiamente trasmesse dall’editoria italiana erano superficiali: ci si
parlava addosso, compiaciuti del proprio sguardo eclettico, senza aver nulla di preciso e serio da poterci
costruire-su qualcosa. La consapevolezza di ciò ha esercitato un’azione a lungo termine su molti dei suoi
allievi, indipendentemente dalla strada scelta, che quando gli veniva comunicata, se non altro come intenzione, gli faceva scuotere la testa. Gigliola Paoletti Sbordoni ha offerto una bella testimonianza al riguardo nel suo intervento al convegno fiorentino del 2004. 9
6. L’antiprovincialismo
Ho già fatto riferimento all’ottusità, unita a partigianeria (guelfi vaticani e ghibellini moscoviti)
unita a investimenti di tempo in trame accademiche, dei filosofi italiani contemporanei di Preti, che impediva loro di cogliere la rilevanza dei suoi contributi in rapporto al dibattito più avanzato in epistemologia, filosofia del linguaggio ed etica. Ora aggiungo che l’antiprovincialismo di Preti lo portò a ignorare o
a non capire la rilevanza di alcuni testi del primo Novecento scritti in italiano. Preti non dedicò ad Enriques e a Vailati l’attenzione che meritavano. Questo su temi specifici, perché non è facile individuare
tematiche filosofiche di carattere generale su cui essi avrebbero avuto qualcosa da insegnargli.
Nel caso di Enriques, la tematica candidata a tale scopo poteva essere duplice: quella riguardante la
filosofia della matematica e quella riguardante la storia della matematica. Nel caso di Vailati, poteva trattarsi del modo in cui il pragmatismo si può declinare in rapporto alla metodologia scientifica. Credo che
nel primo caso la sottovalutazione da parte di Preti del contributo di Enriques sia stata dovuta a un’impressione di fondo: erano riflessioni che, sì, nascevano dall’interno della pratica matematica ma non prestavano la dovuta attenzione all’analisi del linguaggio e non tenevano conto delle critiche allo psicologismo, finendo per passare sopra alla trasformazione che la problematica fondazionale aveva avuto a partire
dalla logica matematica; anche il convenzionalismo di Poincaré, che pure Enriques aveva ben presente,
aveva ricevuto ad opera dei neoempiristi un affinamento che egli non sembrava aver colto. Nel caso di
Vailati, probabilmente Preti giudicò i suoi lavori come sostanzialmente non innovativi, e comunque non
altrettanto sistematici, rispetto alla linea che faceva capo a Dewey.
9 In Giulio Preti filosofo europeo, Olschki, Firenze 2004.
19
Alberto Peruzzi – 2011
Col senno di poi potremmo fare un elenco, in entrambi i casi, di elementi preziosi che erano sfuggiti a Preti e più generalmente all’ottica in cui allora i suoi riferimenti in Europa e America si muovevano,
ma non dimentichiamo che Preti, così come tende ad esaminare le posizioni nella loro forma depurata,
tende anche a far riferimento esclusivo a quelli che considera i suoi sostenitori più convincenti. Se a ciò
uniamo la sua puntigliosa alterigia nei confronti di chi non si attiene ai suoi stessi standard di rigore argomentativo, e starei per dire “lessicale”, abbiamo un’altra ragione del suo isolamento in patria. Non che
se lo fosse andato a cercare, però. Erano gli altri che dovevano documentarsi! È perfino scontato che la
sua ‘operazione’ sia stata avvertita come piatta, brutale, importazione di temi e stili angloamericani, ché
ormai “la svolta in filosofia” era tornata al suo humus primigenio.
L’empirismo, Dewey (quello della transazione e non il pedagogista), l’analisi del linguaggio, la
logica simbolica, il convenzionalismo, la metamorale, l’operazionismo: tutta roba d’importazione. Sarebbe servito a poco obiettare che anche il diverso che per gli indigeni c’era al di là di questi temi e stili
era a sua volta d’importazione.
La cosa curiosa è che il modo in cui Preti combinava i prodotti importati era in realtà alimentato da
istanze condivise dall’idealismo nostrano e ad esso centrali e che, proprio per questo, il risultato della
combinazione finiva per essere un prodotto da esportazione – ammesso che sia sensato attenersi, su un
piano più che cronachistico, a una qualsiasi tradizione nazionale nel discutere di filosofia. Il suo principale errore – l’ho detto molti anni fa e altri di recente l’hanno ripetuto – fu quello di scrivere sempre e
solo in italiano. La peninsularità è comunque un tratto double façe e oggi mi permetto di aggiungere che
non ci fu all’estero nessuno in grado di accorgersi che le sue opere meritavano di essere tradotte in altre
lingue. I filosofi di madrelingua inglese o tedesco non avevano certo l’abitudine di leggere cose scritte in
italiano o spagnolo o altro – tuttalpiù arrivavano al francese. Scrivere in un’altra lingua avrebbe probabilmente privato Preti di quella vena che evidentemente gli dava un senso d’identità.
7. Svolta linguistica e istruzione
L’attenzione per le questioni di logica e di filosofia del linguaggio è sempre stata viva in Preti, tanto
che mi sono chiesto ripetutamente come faccia chi sa poco di entrambe a parlare della filosofia di Preti
(sic ergo sigh) dal momento che gli sfugge il senso di innumerevoli dettagli. Be’, a me ne sfuggono altri,
no? Più che possibile. C’è solo un piccolo fatto sconveniente: negli anni Cinquanta, sull’onda dell’empirismo logico e della semiotica come componenti in maggiore sviluppo rispetto alle altre presenti nella
filosofia di Preti, prende corpo una sua “svolta linguistica” nel modo di impostare i problemi. La mancanza di familiarità con sintassi logica e semantica pregiudica la comprensione degli argomenti allora
elaborati da Preti – e non mi riferisco ai lavori di storiografia che hanno come oggetto temi di logica e
semantica.
20
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
L’inconveniente ha un pernio: la matematica e il suo status. Nella Storia del pensiero scientifico
(1957) Preti ripercorre anche le principali tappe nella storia della matematica e lo fa mettendo in risalto
l’importanza della matematica per le scienze della natura. In più punti ne enfatizza soprattutto un merito:
quello di aver approntato una sempre più ricca sintassi per manipolare le quantità fisiche in conformità a
standard di rigore logico. In buona parte è dunque la storia della matematica applicata quella che ci racconta, ma curiosamente una storia letta in chiave logica.
Siccome mi piace fare l’avvocato del diavolo, aggiungo che quanto poco fa ho affermato necessita di
una correzione. Sarebbe sbagliato dare l’idea di un Preti proteso a incanalare tutta la problematica precedente esclusivamente nel solco dell’analisi del linguaggio. Il linguaggio è il medium del sapere come
del non-sapere, della sottigliezza come della grossolanità. Inoltre, quel che è esplicito nel linguaggio è
solo la punta di un iceberg. E a Preti non interessava solo la punta. Non a caso da parte sua non c’è mai
una deificazione del linguaggio come tema unico o supremo della filosofia. Né Preti si genuflette davanti
ai logici come sacerdoti della perfezione. Tanto meno opta per cesellature crepuscolari, come poi faranno tanti filosofi analitici, da eseguire sul tabernacolo del Linguaggio Comune.
Il piano del linguaggio è per lui un banco di prova. L’obiettivo continua a essere qualcosa di più
ampio, avendo a che fare con la trasparenza teoretica. E per conseguire l’obiettivo si sceglie i suoi bravi
strumenti di lavoro, a cominciare dal metodo dell’analisi logica. Per questo, chi parla di Preti senza non
dico padroneggiare ma almeno aver speso un po’ di fatica per maneggiare questi strumenti non può capire alcuni passi importanti del ragionamento di Preti e, tra l’altro, con tale incuria tradisce il filosofo di cui
parla.
Anche in questa fase di svolta linguistica, intendiamoci, Preti rimane l’empirista minimal-dialettico
che era e non diventa un analitico toto corde esattamente come non aveva trangugiato l’impostazione
neopositivistica senza se e senza ma. Si serve dell’analisi del linguaggio e ne sonda le potenzialità (anche
in campo storiografico), e lo fa a modo suo, così a modo suo che è semplicemente parodistico che sia
stato interpretato come un emissario del Circolo (Vienna-Berlino), tanto parodistico quanto l’accusa di
essere, in quanto positivista (col neo o senza), agente del capitalismo (col neo o senza).
Preti aveva indicato specifiche difficoltà cui andava incontro il positivismo, vecchio e nuovo, e
avrebbe comunque esortato a non dimenticare le differenze interne un po’ alla volta emerse dopo la Wissenschaftliche Weltauffassung. Come prendere allora le accuse? Esse informavano soprattutto su chi le
muoveva, mostrandone due aspetti: analfabetismo scientifico, ottusità dottrinale, malafede. È davvero
buffo che in queste accuse si potevano ritrovare persone di formazione e orientamento molto diversi: dai
crociani che declassavano la scienza a fabbrica di pseudoconcetti ai gramsciani, dai ligi chierichetti dell’ortodossia di partito fino a quelli che si smarcavano facendo proprie le tesi della Scuola di Francoforte.
21
Alberto Peruzzi – 2011
L’accolita di coloro che saltarono a piè pari il pensiero di Preti, in vita e dopo, si sarebbe fatta via via ulteriormente variegata.
È stata la linea vincente nella cultura filosofica di questo paese. Prima si è emarginato il pensiero
scientifico dalla formazione di intere generazioni, poi si è favorito la confusione tra scienza, tecnica e
uso/abuso della tecnica a fini anti-democratici. Bisogna dire che ci sono riusciti, anche se il risultato è
stato un po’ diverso da quello auspicato: la classe dirigente del paese è stata selezionata in base ad altri
criteri, le politiche dell’istruzione e della ricerca sono state miopi, andando a danno della stessa partecipazione dei cittadini al confronto democratico delle idee, perché una democraticità basata sull’ignoranza
e l’incompetenza è solo anticamera del suo esatto contrario. Ma di questo gli intellettuali italiani non
hanno colpa, giusto? Per vedere il miracolo di come un’anima bella possa albergare in un intellettuale
organico, basta partire dalle accuse mosse a Preti.
8. Tornando alle aporie in una vasca
Nel 1987, alla Statale di Milano, si tenne il primo grande convegno dedicato a Preti. Scelsi di parlare di una tematica che non era al centro dei miei specifici interessi (logico-epistemologici) ma che aveva
per lui un’importanza centrale. Supponevo (temevo) che troppe relazioni sarebbero state vittime del
virus del VAT (Vago Apologetico Tardivo) o del suo peninsulare antidoto, il MIC (Micro Italiche Cronache). Così decisi di darle un taglio ‘partecipativo’ e decisi pure di esporre alcune difficoltà di fondo nella
concezione pretiana dei valori. Il titolo faceva evidente riferimento al problema del grounding semantico
e ne presentava la versione etica. Non intendevo suggerire che Preti fosse prigioniero di quelle difficoltà,
anche se ero convinto, e ne dicevo i motivi, che esse testimoniassero ambiguità irrisolte, le quali poi finivano per bloccare lo sviluppo del suo discorso. In primo piano c’era l’ambiguità che lo teneva sospeso tra
lo star dentro all’ethos e lo starne fuori, tra analisi descrittiva dei valori ed esercizio razionale della critica
ai valori descritti, tra storicità e a-storicità. Bisognava pur venirne a capo senza metter tutto in un calderone olistico. D’altra parte i filosofi non possono neanche fare come Alessandro con il nodo di Gordio.
Né possono scappar via dicendo che sono costretti a farlo, perché prigionieri della libertà. Lo so anch’io
che i filosofi sono sempre in bilico tra la colpa per il distacco dalla comunità in cui sono cresciuti e l’ansiogena responsabilità del ritorno alla comunità. Ci vogliono argomenti e, se questi non tornano, o se ne
trovano degli altri o si cambia strada. Non si può star lì indefinitamente a contemplarsi l’ombelico. Per
trovarli, bisogna cercarli.
Ecco, in estrema sintesi, una di quelle difficoltà: le categorie saranno anche secchi che si riempiono
al fiume della storia, ma dov’è che va a finire l’acqua dei secchi? Va alle betoniere, per costruire dighe,
ponti, argini al fiume stesso della storia. Cosa esattamente farsene non si può dire in anticipo e neanche si
può dire a priori qual è il tipo migliore di secchi.
22
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
Uscendo finalmente dalla metafora: possiamo imparare qualcosa dai problemi risolti e diventati
esercizi, dai teoremi dimostrati e poi diventati definizioni, dalle lotte dei cittadini per far valere principi
che poi diventano norme giuridiche, eccetera. Possiamo supporre di aver trovato le forme più generali in
cui calare le nostre domande e le nostre speranze – forme che non è detto siano le più generali in assoluto. Possiamo aver fiducia nella ragione, anche di fronte ai fallimenti, perché è solo grazie a essa che li
riconosciamo e solo così possiamo supporre che i problemi irrisolti e quelli ancora da scoprire potranno
essere risolti. Ma ... Ma non possiamo illuderci di sapere quale sia la migliore soluzione dei problemi di
oggi e di domani. L’illusione di saperlo genera mostri. Eppure dobbiamo giocare la partita, non solo
guardarla dalla tribuna.
Ciò premesso, in quanto filosofi “critici” che si sono liberati dalla fede, e qui intendo dalla fede
metafisica nella Realtà-in-sé o nello Spirito-in-sé, non possiamo fare marcia indietro, quindi non possiamo sottoscrivere una metafisica della Storia.
La verità che ci è dato di poter conseguire è piccola, e al cospetto delle due verità che duellavano
nella Parigi medievale è quasi nulla. Ma se siamo in grado di dare un senso alla parola “verità”, è questa,
per noi, tutta la verità, come diceva spudoratamente Preti. Se Dio sta a significare la pretesa di attingere
l’assoluto, Dio è morto e, in questo senso, la filosofia ne è il definitivo commiato. Finita l’epoca del crociato (parlo in linea di principio), restava in Preti la figura del cavaliere, ramingo (in linea di fatto), con un
sottaciuto rimpianto per quel di più che non aveva voluto o non era riuscito a essere pienamente: il profeta laico di un’umanità non più lacerata dal contrasto fra passione e sapere. E restava la nobiltà di chi alla
fine accetta il proprio status di precarietà e non se ne lascia deprimere.
Pressato fra la figura eroica dello scienziato che invade ogni filosofica landa e la figura eroica di
un’Anima sconsolata che si ritira in sé, orfana di un Dio che era garanzia di senso, il filosofo Preti com’è
che crede di salvarsi? Diventa l’eroe della metariflessione,10 disperatamente in cerca di una fondazione
sempre più remota quanto più la metariflessione è iterata, consapevole che tale fondazione può solo trovarsi nella Lebenswelt, quale sorgente di ogni contenuto e di ogni forma razionale, e consapevole che qui
il termine “fondazione” cambia significato, perché non è più pensiero, discorso, proposizione, giudizio,
assioma. E forse è proprio qui l’aporia che sta sotto a tutte le altre: dove il discorso dovrebbe chiudersi il
discorso comincia e deve sempre di nuovo cominciare. Là ove era l’Es dev’essere l’Io. Nel mio intervento
dicevo che questa non è la soluzione ma il problema. Per evitare l’aporia, oggi aggiungerei che la filosofia
di Preti, nel suo respiro più ampio, è una specie di “teorema d’incompletezza”, non più riferito all’aritmetica e neanche all’insieme delle conoscenze, bensì alla cultura europea nella sua dinamicità, in cui
rientra lo sviluppo del sapere scientifico. È ancora il nostro problema. E invece di tapparci gli occhi con
VAT e con MIC, dovremmo guardarlo bene se ci interessa far avanzare la filosofia.
Sul senso che Preti dava all’idea della filosofia come metariflessione, si veda anche F. Cambi, Metodo e storia, cit.,
p. 116, nota 24.
10
23
Alberto Peruzzi – 2011
Il piano verso il quale così si viene spostando il discorso filosofico è il piano d’una conquistata autocoscienza, come coscienza che il filosofo non può uscire dalla metariflessione senza diventare altro da sé
e al tempo stesso deve da sempre non esserci entrato per intero. Su questo piano ci possiamo porre il
compito di precisare i termini dell’incompletezza nella versione pretiana, stando attenti a non parlare di
pregi e difetti della sua filosofia prima di esserci impegnati in questo compito e stando attenti a non accontentarci del suo personale “sperimentalismo”, che equivarrebbe ad un tronfia avocazione della marginalità cui finì per condannarsi.
9. Una riflessione sulla metariflessione
Diventando metariflessione, la filosofia si fa eternamente nomade. Frase fatta. Si fa? Nomade non
lo è sempre stata dal più al meno? E nel nomadismo perché ci dovrebbe essere qualcosa di tanto fascinoso? Si vede che devo essere proprio un fisicalista viscerale: applico agli atteggiamenti mentali il principio
d’inerzia: per spostarmi ci dev’essere l’azione di forze esterne e non l’anelito a essere sempre altrove. (O
è mera lezioncina appresa by trial and error?) Analogamente, credo che Preti non si muovesse da una
tonalità a un’altra per nomadismo (cromatico), ma per esigenze teoretiche messe in rilievo di volta in
volta a partire dagli errori prevalenti, prevalentemente non riconosciuti.
Un altro senso si poteva dare all’idea della metariflessione. La matematica, la fisica, le stesse scienze cognitive coinvolgono in punti chiave del discorso teorico aspetti di natura meta-riflessiva, i quali hanno effetti a lungo raggio. Poiché era legittimo presumere che lo stesso si verificasse in altri ambiti, verso
la fine degli anni Settanta, mentre rimettevo insieme i quaderni degli ultimi corsi di Preti, cominciai a
pensare che la filosofia, come atteggiamento meta-riflessivo, è distribuita capillarmente nel discorso
scientifico. Per ecumenicità, lo stesso linguaggio ordinario non fa eccezione: nei nostri discorsi della vita
quotidiana non mancano riflessioni, spesso implicite, sulla correttezza dei ragionamenti e sulla sensatezza di quel che diciamo. Qua tante melodie troncate, là una polifonia a otto voci su un singolo verso.
Curiosità: se l’accento ‘meta’ è messo esclusivamente sul linguaggio delle scienze, per questa via si
può perfino arrivare a uno scientismo su basi semantiche. Se si è di manica larga e si presta ascolto anche
alla meta-riflessione che in qualche modo è già presente anche nel linguaggio ordinario, si arriva a una
panfilosofia sulle stesse basi. L’aveva già detto Aristotele che siamo tutti filosofi, ... pardon animali metariflessivi, chi più chi meno. Il fatto che esistano libri di filosofia attesta unicamente il bisogno di raccogliere insieme e organizzare, possibilmente in maniera coerente e (si spera) completa, queste diverse
fonti di meta-riflessione. Naturalmente è anche l’occasione per accorgersi che ciò non è possibile, come
gli scettici non si stancano di ripetere in tutte le salse. Data a tutto ciò una dimensione storica, dinamica,
culturale, per tener conto anche dei cambiamenti nel riflettere e nel metariflettere, il quadro non cambia.
24
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
Se il quadro non ci soddisfa, perché la filosofia non è, non può essere, o non vogliamo che sia solo
questo, allora bisogna rivedere qualcosa nel nomadismo (cromatico) descritto e istanziato da Preti. Cominciando col fissare tre paletti. Il primo è che la revisione deve riuscire ad evitare l’ipertrofia del “meta”
che ha impazzato nella filosofia contemporanea (dico quella seria, non la brodaglia riscaldata), cioè deve
impedire a chiunque sia affetto da mania loquendi di discettare di qualunque cosa gongolando perché il
suo discorso in quanto meta-x-ico non va soggetto ai rigidi criteri di controllo dei discorsi x-ici. Il secondo è che la revisione deve conservare l’iterabilità, in linea di principio, dello spostamento del piano filosofico. Il terzo paletto è che la revisione dev’essere valutabile concretamente, in termini delle sue ricadute sul piano di volta in volta interessato (che sarà ora la tematica di una particolare teoria scientifica, ora
quella di un particolare ethos o di un gusto socialmente diffuso, ora quella di una precedente meta-riflessione).
La filosofia, fissati questi paletti, se perde generalità, la perde uscendone virtuosa e ci guadagna
sotto altri profili. Di sicuro, non perde la propria capacità di indicare modelli di razionalità e non ci rimette quanto a capacità di esercizio critico. Ma, ripeto, se il filosofare è distribuito capillarmente, non
vedo la necessità di considerarla come una disciplina a sé. Mi spiace per la pigrizia lessicale dei nomadi.
Quel che la filosofia svolge è un’attività che in dosi minime o massicce si trova già sotto altre etichette, a
meno che si creda che il matematico, il fisico, lo psicologo e lo storico, o chi altri volete, siano delle slotmachines incapaci di preoccuparsi dei rispettivi outputs.
10. Colligere
Le reazioni negative della cultura italiana a Praxis ed empirismo andarono da una perplessità reticente all’ostilità. Retorica e logica poteva essere l’occasione per un grande dibattito, almeno sulle principali riviste di filosofia e fu ancor più sbrigativamente messa in non cale. E meno male che Preti la sua
cattedra l’aveva già vinta. La perplessità non era testimonianza di misura di fronte alla prosa tranchante
di Preti, l’ostilità non era testimonianza di approfondita riflessione. Né l’una e l’altra erano spia di una
ben diversa presa di posizione circa le due culture che per cortesia accademica si taceva, perché già questo avrebbe significato una minima coscienza dei caratteri dei relativi linguaggi, così come analizzati da
Preti. Detto crudamente: in entrambi i casi i nostri paludati docenti non capirono l’argomentazione di
Preti e la loro scelta del silenzio come reazione fu dettata da un atteggiamento di difesa conservatrice e
non semplicemente ideologica, atteggiamento nel quale si mescolavano in maniera curiosa e quanto mai
italica Provincia ed Ecumenismo. P & E, come Praxis ed Empirismo, ma a significare difesa della pochezza. Con una differenza rispetto al ‘57. Allora del miscuglio facevano parte un sì al Marx maestro del disinganno, un sì a Gramsci e un sì al sentimento solidaristico che non aveva più bisogno di tricorni. Nel
’69 ne potevano far parte un sì ancora a Marx e a Gramsci, ma adesso, non bastando più, unito a un sì a
25
Alberto Peruzzi – 2011
Freud e a quel pastone sociologico-semiotico che tanto avrebbe tirato negli anni seguenti. Il tutto condito magicamente da nostalgie pasoliniane. Come si potesse conservare una metafisica che ospitava relativismo culturale e lotta di classe, l’engagement dei cattolici post-conciliari e la religione come oppio dei
popoli, un’arte libera dai condizionamenti e il doveroso condizionamento dell’artista, lo smantellamento
di qualunque tradizione per far posto a una razionalità ruspante e la tutela delle realtà antropologiche
locali, il giovanilismo e la magnificenza di una prospettiva storicistica, non so. Se il discorso dell’ignorando era irenico, quello dei suoi ignoratori cos’era? Temo che fosse solo confusione mentale venduta da
cerretani a bischeri, la quadratura del cerchio per essere apocalittici e integrati. Può anche darsi che l’ultimo Preti semplificasse più del dovuto quando accomunava quella poltiglia di idee a una rancorosa rivolta contro tutti i valori, come può darsi che non ne abbia colto alcuni tratti. Su una cosa non sbagliò: che
sarebbe passato per reazionario. Sapeva che, rifiutando sdegnosamente una simile melassa imperlata
d’impegno, di lotta e contrizione, avrebbe ricevuto un’alzata di spalle.
I suoi appelli al rigore erano astratti? Accidenti se lo erano! In Italia, erano iperuranici. Tanto che
l’attenzione alla filosofia della scienza fu considerata chez nous un merito del gruppo legato a Geymonat,
che più intensa frequentazione aveva con la dimensione politico-culturale. Geymonat è stato il più grande promotore di cultura filosofico-scientifica che l’Italia abbia avuto dal dopoguerra in poi e coloro dei
quali fu mentore hanno precisato quell’impulso in svariati ambiti (logica, storia della fisica, storia della
biologia, filosofia della matematica). Non si può dire lo stesso di Preti, mentre si può dire che la linea
seguita da Geymonat brillava per l’assenza di scrupoli logico-linguistici propri della tradizione analitica.
Quasi che la filosofia della scienza fosse unicamente bisognosa di una più ampia cornice storico-filosofica. Lo era, certo. I vari Hanson, Lakatos, Kuhn e Feyerabend hanno fatto capire quanto ne avesse bisogno e individuato i problemi che ne seguivano. La linea di Geymonat era meno conflittuale e più cattolica. Non è il caso qui di discutere le notevoli differenze tra i due tipi di approccio a una filosofia “storica”
della scienza. Mi limito a dire una sola cosa: in tutto il polverone che poi ebbe come epicentro la valutazione dell’opera di Popper, si dimenticò che la filosofia della scienza era nata da una cornice epistemologica ben più ampia, che non esentava dai suoi standard le dottrine politiche e ancor meno ne esentava
ogni discorso fatto sulla cultura. Il primo a dimenticarlo era stato Geymonat, molti anni prima.
Chi nel ‘57 si fosse letto Praxis ed empirismo non avrebbe potuto negare che era stato Preti a iniziare in Italia il lavoro di analisi del linguaggio delle scienze storico-sociali. E l’aveva iniziato con una ricchezza prospettica fuori dal comune anche all’estero. Non c’era solo l’analisi logica. C’era attenzione alla
semiotica, all’antropologia e alla linguistica, in direzione di una filosofia positiva delle forme simboliche.
E allora conviene pure ricordare che negli anni Sessanta Preti s’interessa dello strutturalismo come
possibile cornice delle scienze umane, nel senso di un metodo generale con cui avvicinarsi allo studio dei
mondi simbolici. Quest’interesse si accompagna a una visione internista della storia del pensiero. Entrambi gli aspetti emergeranno come compenetrantisi nel colloquio con Foucault. Lo ricordo per un
26
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
motivo: il suo interesse per lo strutturalismo aiuta a capire che la presunta chiusura scientistica, attribuita
come peccato mortale a Preti,11 nutriva un’apertura maggiore all’indagine sui fenomeni culturali che non
la difesa d’ufficio della pluralità di metodi delle scienze umane. Fatto sta che il suo “manifesto” del ’57
era già stato dimenticato e infatti non se ne trova traccia nelle discussioni sulla scienza che scoppiarono
quando soffiò con quarant’anni di ritardo il vento popperiano.
Figuriamoci se ci si preoccupava di cogliere il nesso fra il “manifesto” di Praxis ed empirismo e un
altro grande lavoro pubblicato da Preti nello stesso anno, il libro su Adam Smith, che è invece una tappa
non meno importante del suo cammino, Infatti, a livello di struttura superficiale, Alle origini dell’etica
contemporanea mostra le ragioni dell’equilibrio che Preti stava cercando tra istanze diverse, riconducibili
all’empirismo e allo storicismo e, a livello di struttura profonda, mostra il glissage da Hegel allo strutturalismo, inteso nel senso “verticale” di Piaget più che in quello “orizzontale” (puramente sincronico) di
Saussure. 12 Qui, come altrove il suo discorso si avvolge a spirale fra richiami al piano delle esperienze e il
piano del loro contesto storico, e più specificamente fra la base sensoriale-emozionale e la dinamica culturale dei valori. In rapporto alla fondazione dell’etica un simile movimento spiraliforme diventa più chiaro che nella discussione di altri temi. Così, questo libro potrebbe perfino apparire come il più nitido di
Preti a chi voglia privilegiare nella sua intera opera il momento della teoresi come riflessione dialettica
sulla storia.
Faccio un passo indietro: oggi, col senno di poi, si ammette che ci fu un contrasto fra Geymonat e
Preti, ma si tende a passarci sopra in vista del fatto che lo stesso Geymonat ammise, in relazione al convegno del 1987, un riconoscimento col quale voleva correggere al rialzo una mia affermazione circa l’importanza di Preti nel panorama della filosofia italiana contemporanea. Avendo anche avuto la possibilità di
parlarne con lui e di sentir ripetere a Geymonat lo stesso concetto con parole di cristallina onestà che
però non entravano nel merito di questioni specifiche, non potevo che essergli grato (e non lo dico ora
per la prima volta).
A futura memoria, allorché l’entusiasmo che animava il progetto geymonatiano si smarrì o si smorzò o si arenò, 13 quale ne fu il lascito? Un generico impegno civile di matrice ovviamente laica, corredato
da una altrettanto generica visione panoramica sul rapporto tra storia della scienza e storia della filosofia.
La tensione teoretica di Preti, anche nell’infedeltà ai suoi dettami che si voglia imputare agli allievi diret11
L’accusa faceva leva su varie prese di posizione di Preti. Una di esse è quella che espresse con le parole seguenti:
“Fatti non localizzabili nel tempo e nello spazio, non misurabili in durata e dimensioni spaziali, non sono neppure
fatti” (Il linguaggio della filosofia, in Saggi filosofici, I, p. 125).
12
Lo so: Preti avrebbe storto la bocca a sentire questa descrizione. D’altra parte, la domanda se possa esistere uno
stato privo di estensione geografica era stato lui a pormela, aspettandosi che io rispondessi di sì: io risposi di no e lui
si affrettò a correggermi.
13 Temo che ciò sia avvenuto anche perché Geymonat non aveva “filosofi puri” tra i collaboratori, avendo più bisogno
di storiografi e, se anche ne vennero fuori contributi teoretici, gli unici che ricordo sono in forma dossografica.
27
Alberto Peruzzi – 2011
ti, continua per ripicca a scorrere e, più il tempo passa, più risalta nella sua fecondità e nella sua incisività. Preti aveva fatto i conti con la filosofia del Novecento, invece di saltarla a piè pari come aveva invece
fatto Geymonat.
10. Le due “culture”
Sono – scrive Preti – “due forme di civiltà”, due modalità archetipiche. Orientata all’oggettività e
alla generalità l’una, alla persuasione, alla com-mozione e all’exemplum l’altra; criteriale l’una, partecipativa (perché emotivamente coinvolgente) l’altra. La prima progredisce mettendo in dubbio, la seconda
cercando empatia. Mi fermo qui per non ripetere cose già dette da altri al riguardo.
S’impongono numerose precisazioni. Innanzitutto, Preti non mette le due forme sullo stesso piano, una a fianco dell’altra, in parallelo. Se anche avesse voluto farlo (non foss’altro che per l’apprezzamento trasversale che così facendo avrebbe riscosso), non avrebbe potuto: senza i giudizi di fatto, i giudizi di valore non cominciano neppure. L’aveva detto e ridetto anche a lezione. L’assiologia presuppone
giudizi di valore, e un giudizio di valore, per stare in piedi, presuppone una qualche forma di conoscenza.
In secondo luogo, e qui viene il bello, le stesse caratteristiche di ideale generalità e criterialità proprie del
discorso che vuol essere wertfrei cos’è che esprimono se non valori? Infine, l’interfacciarsi delle due forme di civiltà ha un motivo oggettivo: si colloca sul terreno della vita e riguarda, in senso più ampio, la
naturalità come intesa dai “naturalisti”.
In Praxis ed empirismo Preti aveva già tracciato una fenomenologia del processo per stadi con cui si
va dalla corporeità, e più specificamente dalla propriocezione, all’intersoggettività (e qui si avverte l’eco
delle riflessioni husserliane sul “corpo proprio”) per giungere poi al principio di verificazione, che in
ambito psico-sociale è letto da Preti in chiave comportamentistica. Quasi volesse additare la via ideale
che dalle scienze della natura porta alle scienze della cultura e, in parallelo, da quella che chiama “autocoscienza sensibile” a un controllo cosciente delle proprie azioni. In questa fenomenologia (genetica e
non descrittiva, ci viene offerta una ricostruzione razionale dell’emergere della stessa razionalità e del
suo calarsi in sistemi di convenzioni verbali, i quali sono arbitrari salvo avere sempre due vincoli: la logica
e la praxis.
Il rimando alla vita era ed è decisivo. Se è vero che la scienza prende avvio da una tematizzazione e
poi da una critica dell’immagine intuitiva del mondo, dunque da un distacco che va di pari passo con
l’esame razionale degli argomenti per descrivere e spiegare i fenomeni in un modo o in un altro, portando infine a opporre a ciò che appare (l’immagine manifesta di Sellars) un modello idealizzato di mondo,
calcolabile e manipolabile secondo precisi protocolli, è pure vero che lo stesso processo ha luogo con
l’assiologia, intesa come sistemazione ideale del mondo dei valori rispetto al costume etico e alla doxa. E
28
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
se c’è un motivo oggettivo e vitale dell’interfacciarsi delle due forme (e dei due tipi di discorso) è verosimile che le “condizioni di base” (Retorica e logica, p. 43), vitali sia per la cognizione sia per la valutazione, non siano separate. Del resto, nell’esperienza comune queste condizioni ci si offrono come un tessuto organico indiviso. È solo la riflessione ulteriore, tematizzante, critica e ricostruttiva, che divide i componenti del tessuto in una trama e in un ordito.
Ma allora la linea di demarcazione non coincide con quella fra scienze della natura e scienze umane.
Non è che gli studi sulla mente, sulla società e sulla storia siano di per sé letteratura o più in generale
“retorica” per il semplice fatto di trattare dell’essere umano. Semmai, lo diventano se non si attengono ai
criteri metodologici che garantiscono un controllo empirico di quanto si afferma; e non è detto che tali
criteri siano ricalcati da cima a fondo su quelli che si trovano in un manuale di fisica, chimica o biologia.
Possiamo certo lamentarci che i criteri di fatto adottati siano troppo stretti (come fu, per esempio, nel
caso del comportamentismo), ma questo non implica che stiamo dichiarando infondati i richiami al controllo empirico. Se poi guardiamo all’assetto attuale delle scienze psicologiche e sociali, quei richiami
sono perfino scontati ...
Preti irrigidisce la polarità tra le due culture più di quanto autorizzi l’odierna sociologia della scienza? Finisce per trascurare la dimensione storica del pensiero scientifico che lo stesso Preti aveva enfatizzato molto prima di Retorica e logica’? In questo caso, se non altro, i tanti successivi cultori della storia
della scienza dovrebbero rendergli implicitamente omaggio o dar segno di averci fatto i conti. Perché non
l’hanno ancora fatto?14 Indubbiamente, dopo Kuhn, siamo portati a rinvenire la dimensione “esternista”
nella stessa impresa scientifica, in quanto organizzata in istituzioni. All’inverso, sarebbe ormai improponibile ignorare la scientificità che informa settori di studio come la filologia o l’archeologia o i modelli
matematici della macro-economia. Questo non significa che le preoccupazioni di Preti vengano meno.
Ossigeno puro e idrogeno liquido sono sul nostro pianeta prodotti artificiali tanto quanto i vari tipi di
plastica e le varie carte dei diritti.
Può darsi che Preti si sia lasciato prendere la mano nello schematizzare le componenti della cultura,
correlando aree tematiche ad atteggiamenti, passando sopra sugli intrecci che si sono verificati in passato
e identificando le proprietà caratterizzanti di tali atteggiamenti fino a presentarle come astoriche, quando
invece erano per lui il distillato della storia. Ricordiamoci che se puntiamo sul prodotto olistico invece
che su quello mirante a isolare i singoli fattori del prodotto, rischiamo di condannare il nostro discorso a
una staticità maggiore di quella imputabile al discorso di Preti, per una semplice ragione: se tout se tient,
ogni assetto globale della cultura è un’isola a sé che non si capisce come possa diventare altro da sé, perché di fronte a un complesso [A+B] che diventa [A+B]’, il solo mettersi ad analizzare la trasformazione di
A in A’ e di B in B’ richiede l’individuazione di qualcosa che non cambi, rispetto al quale poter capire
14 L’unica eccezione che conosco è Giulio Barsanti.
29
Alberto Peruzzi – 2011
entrambe le trasformazioni. Lo so, è un’osservazione datata, ma temo che sia sempre valida. Fare come
se l’osservazione si potesse mettere fra parentesi si chiama “ipocrisia” dalle mie parti e prelude a cattiva
filosofia.
Nello specifico, se Preti commette davvero l’errore di correlare emozioni elementari e irrazionalità
dei valori, non si corregge l’errore legittimando la pervasività emozionale dell’ideologia o supponendo
come già data una razionalizzazione olistica dei valori. La storia non ne emerge come più unitaria. Semmai, è molto più disarticolata. Ma si può credere sul serio che non se ne fosse accorto? Così come uno
storico non è automaticamente un ottimo scettico, uno storicista non è automaticamente un ottimo storico.
Il guaio è piuttosto che la sensibilità storicista che perdura in Preti poteva portare a conseguenze
scettiche che egli stesso non avrebbe desiderato. Inoltre, ci voleva un triplo salto mortale dialettico per
far passare che il distillato della storia ne è il seme generatore. Il suo “razionalismo integrale” imponeva
di evitare conseguenze scettiche. Erano evitabili? Penso di sì, così come penso che ciò imponga un ridmensionamento della sensibilità storicista e penso che l’ultimo Preti si muova proprio in questo senso:
cerca di smussare le istanze dello storicismo proiettando la dinamicità diacronica sul piano di una teoria
sincronica dei tipi, ove i tipi sono visioni-del-mondo in sviluppo. Il problema posto da una dialettica di
valori reciprocamente in tensione resta tale e quale dopo la proiezione, ma almeno diventa più chiaro che
un’analisi razionale di questa tensione non può semplicemente riprodurla, a meno di rendere reale il
rischio di contraddittorietà.
11. Verificazionismo
Il verificazionismo di Preti non poteva essere univoco e tanto meno avvalorare un ingenuo scientismo (ovviamente pensando alle scienze “dure”), per una semplice ragione: perché Preti, una volta riconosciuta la pluralità delle ontologie regionali, non poteva presumere che sia i modi di verifica sia i criteri
per la valutazione degli esiti della procedura di verifica fossero gli stessi per ogni universo di discorso.
Passando dall’astratto al concreto: se in ambito psicologico, economico, sociologico, ci sono delle scienze che sono progredite, ciò è stato possibile perché 1) si sono formulati principi suscettibili di verifica, 2)
si sono accettati standard di precisione nella formulazione dei principi, nel loro sviluppo teorico e nel
loro controllo empirico, 3) si sono individuate opportune modifiche relativamente al modello offerto
dalle scienze fisiche quanto a 1) e a 2). In particolare, se psicologi ecc. avessero semplicemente ricopiato
quel modello, saremmo ancora qui ad aspettare il primo piccolo risultato. Quindi anche concretamente
un verificazionismo monolitico è una dubbia opzione. Se non bastasse, già nell’ambito della fisica le procedure e i criteri per la loro attendibilità sono sensibili alla strumentazione disponibile e margini d’errore
30
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
che variano a seconda della scala alla quale si considerano i fenomeni pertinenti al controllo delle ipotesi.
Cose che Preti capiva benissimo.
Perciò sono convinto che Preti non abbia mai scommesso sulla rigidità dei metodi di controllo come garanzia di scientificità. Ciò non toglie che abbia mancato di rendersi pienamente conto che nel suo
stesso discorso circa la verificazione c’erano gli elementi per prendere le distanze da una trasposizione
diretta dell’operazionismo – trasposizione che, assecondando la molteplicità ‘sub-regionale’ dei metodi,
finisce per condurre a una frammentazione degli stessi concetti teorici. Bisogna ammettere che Preti non
sviluppò quanto poteva la discussione sugli ostacoli frapposti da un’idea eccessivamente flessibile della
verificazione allo sviluppo di teorie esplicative.
Se questa è una recriminazione legittima, è chiaro che essa depone contro l’accusa mossa a Preti di
ingenuità ideologica a proposito della sua accettazione del verificazionismo; in effetti, depone contro
anche l’obiezione secondo la quale chiunque faccia proprio un principio generale di verificazione cade in
errore perché dimentica lo sfondo socio-politico in cui la scienza s’inserisce al pari delle correlate procedure di attendibilità scientifica.
Per esser più chiari: che si sia in grado o no di confutare la variante socio-storica degli argomenti
contro lo psicologismo, si può imputare a Preti di non aver prestato sufficiente attenzione alla genesi
empirica delle idee che in un dato contesto storico hanno portato a formulare assiomi, principi teorici,
metodi di controllo e quant’altro pertenga alla scienza, ma non gli si può imputare di aver ignorato questa
genesi – né nei suoi lavori storiografici né sotto il profilo teoretico.
Inoltre, per un pervicace esternismo c’è un guaio addizionale con la logica e la matematica, perché
non sono o non sembrano essere soggette alle procedure empiriche di verifica delle scienze naturali e
sociali, per quanto tali procedure possano differire da un ambito all’altro. A titolo di esempio, se la logica
emerge storicamente come una serie di regole per regimentare le inferenze esprimibili in un linguaggio,
com’è che è successo? E perché ne sono emersi proprio certe “leggi” logiche e non altre? Se si vuol dire
che tali “leggi” sono solo delle convenzioni legate strettamente a un tipo di pratica comunicativa caratteristica di un’epoca storica o di un tipo di società, l’onere della prova tocca a chi lo vuol dire. Ed è pregato
di non dimenticarsi che un empirista antidogmatico per eccellenza come Quine ha espresso le sue riserve
contro la riduzione delle “leggi” logiche a convenzioni, adducendo un semplice ma efficace argomento.
O forse s’intende obiettare a Preti di non esser stato coerente con il suo stesso empirismo? Anche se
Preti non avesse avuto presente l’argomento quineano al riguardo (cosa di cui non sono sicuro), ne recupera per altra via la sostanza. Viceversa, se si vuol battere il chiodo fino in fondo ritenendo non cogente
l’argomento quineano, quali sono le ragioni per ritenerlo tale? E quali sono le conseguenti modifiche da
apportare al quadro pretiano per impostare una ricostruzione della genesi del pensiero scientifico che sia
storicistica ma non idealistica, esternista quanto deve ma non riduttiva?
31
Alberto Peruzzi – 2011
Ha senso imputargli questa lacuna da parte di chi è interessato a fornire un’indagine più adeguata
(più articolata e più concreta) della genesi in questione, non da parte di chi crede che basti alludere a una
vaga cornice (“il contesto sociale”) che secerna automatiche spiegazioni. Perché in tal caso quel che si
ottiene è ridicolo: si rimpiazza l’imputata feticizzazione della Scienza con la (presumibilmente angelica)
feticizzazione della Storia. Chi pensa che io stia esagerando è pregato di considerare attentamente le
osservazioni di Preti sullo “storicismo logico” nel suo penultimo corso di lezioni (1970-71), raccolte in
Logica e filosofia. A seguire, ci risentiamo.
Ma quante cose in più hanno detto quelli così solerti nel contestare a Preti un’ottusa adesione al
verificazionismo e (quelli più edotti) nel contestargli l’adesione a una forma di verificazionismo che non
tiene conto di paradossi della conferma oltreché della molteplicità di dimensioni del discorso cui lo stesso Preti tiene, è pregato di dirci se quel che afferma è in qualche modo controllabile e, nel caso che lo sia,
come controllarlo (e sono molto generoso al riguardo). Se è troppa fatica, almeno ci offra una fenomenologia delle forme di verifica che Preti ha trascurato. Perché in caso contrario si tratta non di un’obiezione
ma di una viscerale attestazione di disaccordo, quanto di più indisponente ci si possa aspettare da chi
vuole fare le pulci a qualcuno che invece si è sforzato di fornire argomenti per ogni cosa che afferma.
12. I panni sciacquati dell’idealismo
Tornando di nuovo sull’hegelismo minimale di Preti, c’è da dire che alcuni degli ostacoli teoretici
che gli avrebbero reso difficile andare avanti, se li andava proprio a cercare lui. Come quando echeggia
Gentile rammentandoci che è impossibile tematizzare sistematicamente le strutture della Lebenswelt
perché, se sono precategoriali, è ovvio che non siano suscettibili di essere descritte, in quanto ogni descrizione presuppone una categorizzazione. Ragion per cui “l’ultimo Husserl” è tacciato da Preti di essere reo di greve, pseudostorico, idealismo. Eppure, di fatto, Preti ne condivide la tesi circa il precategoriale. Perché mai? Dopotutto, avrebbe anche potuto dire che c’era una contraddizione interna al discorso
dell’ultimo Husserl o che ci sono più strutture nella Lebenswelt di quelle che i filosofi finora sono stati
capaci di immaginare; oppure avrebbe potuto avvalorare l’originalità del suo proprio “punto di vista empiristico” dicendo che un empirismo dimentico di tale ricchezza di strutture, dimentico del loro radicarsi
nel mondo materiale, e pigro nel non impegnarsi, a differenza di Locke e Hume, a cercarvi i generatori
della combinatoria cognitiva che si oggettiva nel linguaggio, è solo un aborto di empirismo. Ma qui dal
distillato siamo di nuovo al seme.
Quando ero ancora suo studente nel 1972, non avevo idea della vastità del suo discorso su questi
temi, perché banalmente non avevo la minima idea di quanta filosofia ci fosse stata fatta sopra. Avevo dato
solo una frettolosa scorsa ai testi di Locke e di Hume e ignoravo il fermento allora in atto nelle scienze
cognitive. Allora il mio interesse andava tutto allo strutturalismo di Piaget e alla grammatica di
32
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
Chomsky.15 Mi compiacevo di aver colto che con entrambi la cornice metodologica dello strutturalismo
era radicalmente cambiata. Pensavo che assimilare Chomsky agli strutturalisti era stato un errore bello e
buono, che tacciare Piaget di psicologismo sarebbe stato un altro errore e di conseguenza (per una via un
po’ tortuosa, lo ammetto) pensavo che, corretti gli errori, si poteva anche rilegittimare su basi empiriche
il progetto dell’ultimo Husserl di una”genealogia” della logica. Immaginavo che i fenomenologi stessero
lavorando alacremente in questo senso (tanto che mi misi senza successo a cercare pubblicazioni in tal
senso). Non capivo quindi come gli articoli che uscivano su Aut Aut, invece di affrontare la questione,
che per me era decisiva, continuassero a fare semplicemente esegesi e assemblaggi frankensteiniani,
suggestionati da psicoanalisi esistenziale e dall’obbligo di un impegno politico a senso unico. Era di tutto
questo che avevo intenzione di parlare con lui l’ultima volta che suonai al suo campanello, alla fine di
giugno del 1972. Mi disse al citofono che era ancora nudo e mi suggerì di ripassare. Non lo feci e pochi
giorni dopo lui partì per la Tunisia.
Mi sono ritrovato a dover disfare da solo quei nodi e, da solo, mi c’è voluto molto di più, senza contare che parlandone con lui avrei evitato più di una sciocchezza e probabilmente imboccato altri sentieri
(chissà quali). Ma dalla sua morte in poi, per tutti gli anni Settanta, continuavo a stupirmi di come i custodi dell’eredità husserliana non si muovessero di un passo. Nel ’74 presentai al “Seminario del sabato”
diretto da Casari un’assiomatizzazione della teoria dei noemi usando nozioni puramente categoriali. 16
Poi lasciai perdere. Furono due libri di Robert Tragesser indicatimi da Andrea Bonomi a suggerire un
modo per riprendere il progetto di quell’ultimo Husserl e svilupparlo in termini di schemi gestaltici. Gli
psicologi gestaltisti avevano aperto una strada di cui epistemologi, filosofi del linguaggio e filosofi della
matematica non avevano capito l’importanza. Il nuovo quadro era quello di una geometria cognitiva. Ma
guarda un po’ a cosa si arriva partendo da Preti!
13.Maledetti significati
La dannata questione dello stato dei significati era paradigmatica: la sua soluzione predelineava le
soluzioni da dare a ogni altra questione teoretico-ontologica. Occam docet. Com’era possibile un’oggettività che dipendesse in qualche modo dal soggetto ma non conducesse allo psicologismo? E così da Occam si arriva al noema di Husserl passando per Buridano: un contenuto di atti senza i caratteri ballerini
15
Chissà se a qualcuno verrà mai in mente che, dietro a quel che ho scritto sulla polemica Piaget-Chomsky in occasione del convegno di Royaumont, c’è il tentativo di fare i conti sospesi con l’eredità di Preti su questi stessi temi.
Cfr., per la cronaca, Il singificato inesistente, cap. IV (Firenze University Press, Firenze 2004.
16
Ero partito dal manoscritto husserliano Noema und Sinn, cercando di mettere a frutto un tentativo di algebrizzazione del rapporto Sinn-Bedeutung da parte di Leonard Linsky. Del progetto avevo discusso con Jerrold Katz a New
York. Ho perso quel manoscritto e non ho mai avuto tempo di ricostruirne il contenuto. Formalizzare non serve a
nulla se le idee da esprimere formalmente sono poco nitide e poco unitarie.
33
Alberto Peruzzi – 2011
degli atti. Già, ma com’è possibile? A prescindere dalla risposta un punto è chiaro: la quaestio de universalibus era, per la filosofia, un “universale” nel senso della teoria della categorie e lo era perché lì si decideva la possibilità di una semantica, con portata “realistica” e dunque non “nominalistica” che non finisse in metafisica, come lo stesso Preti ammette nel manoscritto sul neorealismo logico (fine anni Sessanta)
riferendosi alla terminologia ancora usata da Cartesio: “Il rapporto tra l’esse obiectivum e l’esse formale,
nella misura che il discorso intorno a quest’ultimo conserva un senso, costituisce il problema più elevato
e <finale> della gnoseologia e della ontologia critica: il problema della costituzione dell’oggetto.”
L’ingenuità che Preti ascriveva al “rappresentativismo” dei realisti medioevali, poi ritornante in
Cartesio, ecco che ti rivive nella concezione “pittoriale” del linguaggio nel Tractatus. Quell’ingenuità
era stata superata dalla filosofia critica, quindi era prekantiana. Tiè! Sul che gli scribi wittgensteiniani
avrebbero molto da eccepire e, per una volta, non darei loro torto. Il problema che intendo segnalare è
però un altro. Siccome Preti batteva e ribatteva sul fatto che la funzione unificante del concetto nei confronti di una molteplicità di dati non può ridursi alla rappresentazione di tale molteplicità e inoltre sapeva
bene che i fondamenti insiemistici della matematica riducono le funzioni (predicative) a collezioni, mentre al tempo stesso la matematica si presenta come ontologia formale della scienza e la scienza contemporanea è d’impianto relazionale, non ho mai capito perché non proseguisse dicendo che quella fondazione
era sbagliata di per sé, e non solo per l’interpretazione che le era stata assegnata, e non suggerisse la possibilità di esprimere matematicamente la stessa struttura funzionale dei concetti. 17
Era questa l’idea che, dopo aver fatto l’incontro con la teoria della categorie, mi era venuta per tradurre la quaestio de universalibus in forma logica partendo da un’analisi dei testi di Abelardo. Nella teoria delle categorie è infatti possibile mantenere distinti morfismi e oggetti pur in presenza del fatto che
un morfismo o una famiglia di morfismi può essere noematizzata in un esse obiectivum (via esponenziazione). E fu così che gli proposi di fare una tesi su Abelardo … senza dirgli però che ne era questo il vero
intento, un po’ per timore e un po’ per fargli una sorpresa. 18
17
D’accordo, Preti dice che non apprezza l’idea di fondare tutta la matematica sulla teoria degli insiemi e parla di
“bizantinerie metafisiche” e “dogma insiemistico”. Si lascia intendere che, nel momento in cui la matematica è il
linguaggio della scienza, il linguaggio insiemistico sia incapace di esprimere aspetti pur riconoscibili come presenti
in alcune “aree di pensiero”, con l’intento di mettere in guardia contro l’identificazione di logica e teoria degli insiemi e col malcelato sospetto di un eccessiva matematizzazione. Quel che Preti non dice è come bisognerebbe
modificare questo linguaggio per evitare le obiezioni scettiche sulla matematizzabilità – e in vista del sospetto appena menzionato è perfino scontato che non lo dica. Qui il suo atteggiamento sospettoso verso il “matematismo” fa
venire in mente gli stessi motivi che stavano dietro all’analogo atteggiamento da parte di Bacone. Una simile associazione è suffragata dalla nota 25 del manoscritto sul neorealismo logico, ove si rivendica uno spazio più ampio per la
riflessione filosofica sulla matematica. Faccio fatica a non vedervi una critica implicita alla linea seguita dal suo exstudente di cui ero stato a mia volta studente.
18
Ignoravo che con il concetto di funtore aggiunto si riesce a definire il modello generico di un concetto e quindi a
catturare il corrispettivo singolare dell’universale, come quod natum aptum est predicari de pluribus. Restava solo da
collegare questo corrispettivo al processo cognitivo di prototipazione. (Vedi il mio articolo “Constraints on universals”, presentato al Kirchberg Symposium del 1994).
34
Memo n.4 sulla filosofia di Giulio Preti
Be’, un’ipotesi sul perché non abbia proseguito così ce l’avrei: Preti restò della convinzione che il
pattern dell’atomismo (logico) fosse privo di alternative, quasi coestensivo della stessa forma mentis
scientifica [Vedi le osservazioni al riguardo nella cosiddetta ‘seconda’ versione di In principio era la carne], una volta ovviamente liberato l’atomismo dall’errore che Preti ascrive a Russell, cioè, quello di aver
invertito il giusto rapporto di dipendenza che va dalla logica all’ontologia.
L’inversione, tra l’altro, ha un piccolo inconveniente che segnalo en passant:
SE
per evitare le obiezioni degli oxoniensi (per Preti – oxbrigensi per me) si deve dire che “le strutture logiche del linguaggio determinano le strutture logiche del quadro razionale (scientifico) del mondo. Il discorso stabilisce un isomorfismo con i propri oggetti. Poiché esso consta di proposizioni che hanno come
argomenti ultimi dei nomi, il mondo è posto come costituito di oggetti; poiché il discorso scientifico è un
tessuto di proposizioni, il mondo è un tessuto di fatti; etc.”, come Preti afferma che “si deve dire”,
ALLORA
in principio era il verbo, non la carne, perché anche la carne non fa eccezione, essendo ciò che è categorizzato come ‘carne’ in questo e quel modo.
Ebbene, se l’ipotesi è giusta, si capisce anche come mai lo stesso Preti che, sempre nel manoscritto
sul neorealismo logico, riconosceva “l’apporto diretto della filosofia linguistica al tema delle nostre ricerche e alla posizione filosofica che ne risulta” come “ben scarso” e, nei riferimenti a Frege durante le lezioni segnalò l’esito insoddisfacente della pur giusta distinzione tra Sinn e Bedeutung, non sia andato
oltre il recupero della indivisibile correlazione noesi-noema e l’ammonimento a non cadere in tentazione, i peccati essendo psicologismo e metafisica (qui intesa come l’operazione che trasforma significati in
oggetti di tipo superlunare). Si capisce, ma il risultato non cambia: è sempre quello di riservare in un
mondo “reale” descritto dalla scienza un posticino neutro, il limbo della pura intenzionalità, ove si può
solo dire Hic sunt suppositiones.
La cosa curiosa è che, riduci che ti riduco, di sospensione in sospensione, il trascendentale diventa
la cosa più trascendente che si possa immaginare pur di escludere che universalia sunt res. La base ultima
per parlare di “realtà” (e di “irrealtà”, per simmetria) è preter-reale, è come il castello sospeso di Magritte ed è una base inspiegabile, perché le spiegazioni hanno a che fare con la “realtà” e non si può spiegare
come mai la roccia-satellite su cui il castello è eretto non sia già venuta giù e, anche se fosse spiegabile,
non lo sarebbe il fatto che ci dev’esser stato un bel via-vai di gente per costruirlo e per mantenerlo in
buono stato. È più che più-che-vita: è un miracolo, in una filosofia che voleva con tutto il cuore espungere il bisogno di miracoli dalla propria immagine del mondo. Che anche i miracoli tornino alla Vita? Dopotutto, abbiamo bisogno di un bel pizzicotto per uscire dal grigio di giorni e giorni spesi davanti al mo-
35
Alberto Peruzzi – 2011
nitor di un calcolatore, invece che tra le vitali braccia di una bella fanciulla (o di un bel giovanotto) che,
come la moglie di Eddington, in ciò che è di più che modello di un sistema di equazioni differenziali è,
secondo Preti, pre-logica, al pari del linguaggio comune.
14. Noccioli
Dal Pra attribuisce a Preti la tesi della “continuità delle strutture filosofiche” a dispetto del rumore
storico. Vorrei sbagliarmi ma temo che si sovrappongano due questioni diverse: una relativa alla storia
del pensiero filosofico (come per la storia di tanta altra roba, anche in questo caso ci sono continuisti e
discontinuisti) e una relativa alla molteplicità di concetti e dottrine con i quali chi fa filosofia si trova a
fare i conti. Non userei “continuità” per dire che nei vari tipi di ciliege c’è un nocciolo, nei vari tipi di
pesche c’è un diverso tipo di nocciolo, ecc. È fin troppo evidente: Dal Pra sfruttava un termine di Preti.
Basta riandare al titolo dell’articolo metodologico del ’51: “Continuità e discontinuità nella storia della
filosofia”. Bene, e con questo? Quel che intendo dire è molto semplice: la selezione di risposte diverse al
Problemario definisce un ordine punteggiato di equilibri, dunque discrèto. E se è discrèto, non c’è continuità. La filosofia è scientifica, nel senso in cui Preti così l’intendeva, nell’offrire soluzioni che tengano,
mostrando come scartare le altre, e in ciò di continuità ce n’è ancora meno. Se il Problemario è quello e le
strategie-tipo sono quelle (come i tipi d’apertura per gli scacchi), il fatto che in un passaggio storico si
rivendichi o no una rottura e che questa rottura ci sia davvero o no è una questione diversa. Il guaio è,
semmai, che le soluzioni che tengono non sono mai state facili da definire collettivamente. La coerenza e
l’adeguatezza non bastano. Un setaccio per la buona filosofia non c’è. Le “strutture filosofiche”, comunque, sono più di quel Problemario. Una volta fatto l’elenco dei Grandi Temi e Problemi della Filosofia,
con annessa rete di rapporti e toponomastica (autori e opere) si ha in mano solo una cartina per turisti.
L’atteggiamento indotto è quello spettatoriale, proprio dei guardoni, esattamente come nel caso che si
punti sulla “discontinuità” e si canti l’ira funesta della storia che vuole tutta per sé la Verità. Il repertorio
delle “strutture filosofiche” appartiene piuttosto al Soluzionario. Quanto al muoversi all’interno di questo, Preti era un maestro di navigazione.
36