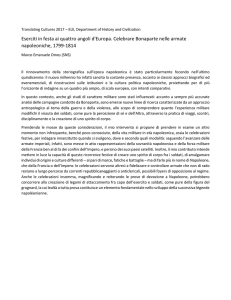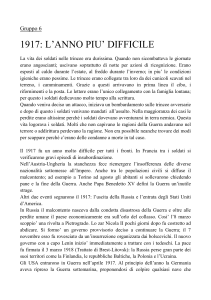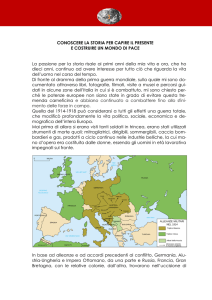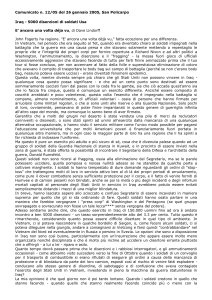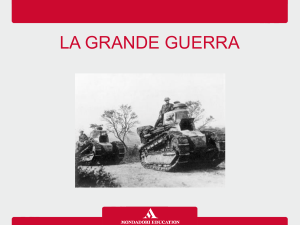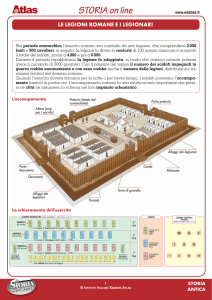L’opuscolo, insieme alla mostra, è uno strumento di controinformazione nato per contrastare le incombenti “Celebrazioni per il centenario della Grande guerra” organizzate dal governo all’insegna dell'esaltazione del sacrificio per la Patria, dell’onore di essere Italiani “brava gente”, del richiamo alla compattezza nazionale contro i nemici interni ed esterni, della necessità di rafforzare il nostro apparato militare contro le “forze ostili”... Una retorica ormai dilagante che impedisce di comprendere le cause di quello che fu uno spaventoso massacro. Un massacro che, oggi con i rumori di guerra sempre più forti, rischia di riproporsi. I contenuti di questo opuscolo sono approfonditi nel sito www.centoannidiguerre.org Le Immagini della mostra – realizzata dalla Rete Napoli No War – possono essere liberamente scaricate all’indirizzo: https://drive.google.com/folderview?id=0B_WENlEYeAwqSGwtbDNzclg4ejQ&usp=sharing 1 1914‐2014: CENTO ANNI DALLA I° GUERRA MONDIALE. Perché anche noi parliamo di Prima Guerra Mondiale Nel centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, il Governo italiano, ma non è il solo, ha avviato una serie di manifestazioni celebrative. Perché celebrare quello che tutti riconoscono essere stato un enorme massacro? Forse per condannare la guerra tra nazioni? Per invocare la fraternizzazione dei popoli? O per fare appello a fermare i tanti conflitti in corso e a mettere fine all’inutile e crescente nuova corsa agli armamenti? Niente di tutto questo. La retorica con cui viene presentato il primo grande macello mondiale è esattamente l’opposto: l’esaltazione della Patria e del sacrificio della vita per la sua difesa; l’onore di essere italiani – brava gente ‐portatori dei valori della “nostra” democrazia nel mondo anche se sulla punta dei fucili. Quotidianamente, sia dalla compagine governativa che sui massmedia, non si perde occasione per richiamare alla compattezza nazionale contro i nemici interni ed esterni e alla necessità di rafforzare il nostro apparato militare contro le “forze ostili”. L’enfasi sulle “nostre” missioni all’estero, come pure l’osceno accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello della Difesa per consentire ai militari di tenere conferenze nelle scuole sulla Prima Guerra Mondiale, sono parte di quelle campagne di opinione che mirano a creare consenso verso un clima di unità nazionale e di criminalizzazione del nemico, condizione imprescindibile per qualsiasi avventura militarista. I rumori di guerra si fanno sempre più forti ed esattamente come nel 1914, si vuole rafforzare il fronte interno, l’union sacrée, per affrontare il nuovo macello che si intravede all’orizzonte. Esageriamo? Non ci sembra. Il ‘900, dopo la Grande Guerra, ha visto la Seconda Guerra Mondiale ed infiniti conflitti “regionali”: dalla Corea al Vietnam, dalle lotte di liberazione contro il colonialismo al conflitto sino‐
giapponese, dallo smembramento della Yugoslavia allo scontro Irak‐Iran fino all’operazione Restore Hope in Somalia. Il nuovo secolo non è da meno. Dal 2001 è un susseguirsi di “conflitti”: Afganistan, Irak, Libia, Siria ed ora, con l’Ucraina, la guerra è alle porte dell’Europa. La corsa agli armamenti e il crescere delle tensioni tra gli stati sta preparando il terreno per un nuovo conflitto generale e devastante. Vogliamo allora partire proprio dalla Prima grande guerra per smascherare le menzogne su quell’immane crimine, per demistificare la retorica patriottica con cui, proprio in occasione della celebrazione dei 100 anni, se ne farà la narrazione. Soprattutto proveremo a raccontare le vere ragioni che stanno dietro a quella guerra come a tutte le altre, a svelare la propaganda che prepara le popolazioni a questi tragici eventi, uguale e sofisticata, ieri ed ancor più oggi. Per impedire che ciò avvenga di nuovo, per organizzarci e opporci ai loro disegni da adesso! Non poteva che essere guerra Non fu certo l’attentato di Sarajevo (l'uccisione di Francesco Ferdinando, erede al trono dell'Impero Asburgico) la vera causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. A determinarla fu, nella sostanza, la lotta tra le potenze imperialiste europee per accaparrarsi le spoglie dell’Impero Ottomano e il tentativo di sfuggire alle crescenti contraddizioni economiche determinate dal giganteggiare della produzione capitalistica e, quindi, dalla necessità di ricercare nuovi mercati per le merci e per i capitali. Questa politica espansionistica nasceva non solo dalle spinte del grande capitale di ogni nazione per creare la possibilità di sempre maggiori profitti, ma anche dalla paura derivante dalla crescente forza del movimento operaio organizzato che, di fronte ad una eventuale crisi economica, rappresentava un potenziale pericolo per la stabilità del regime capitalistico. Ma, in un mondo oramai già spartito in aree di influenza delle maggiori potenze, gli interessi dei diversi capitali nazionali, nonostante ampi livelli di collaborazione per spartirsi il bottino, vedevano crescere la conflittualità per accaparrarsene una quota più consistente. Ben prima della Grande Guerra, le potenze dell'epoca, (in primo luogo, Gran Bretagna e Francia) avevano colonizzato gran parte del mondo per accaparrarsi materie prime e per costituirsi mercati protetti per le merci e i capitali. La Germania ‐ diventata una potenza industriale solo alla fine del XIX secolo ma che dal punto di vista industriale aveva nel frattempo sopravanzato l’Inghilterra – pretendeva, invece, una diversa spartizione coloniale e nuovi 2 rapporti di forza in Europa. Nasce da qui il conflitto tra le potenze della Triplice e quelle dell'Intesa che già avevano condotto “per procura” sanguinosi conflitti. Nei Balcani, ad esempio, Serbia, Bulgaria e Grecia ‐ strozzate dal cappio del debito che avevano stipulato con le banche francesi e austriache ‐ si erano combattute per anni; stessa sorte per i sudditi delle nuove colonie: Tunisia, Algeria, Sudan... Per l’occupazione del Marocco si era già sfiorata la guerra tra Francia e Germania; in Libia, occupata dall'Italia nel 1911, la Francia armava i ribelli. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Già il 28 maggio 1913 la lettera del governatore di Bosnia, Oskar Počorek al ministro asburgico Bjelinski illustrava dettagliatamente i piani di guerra contro la Serbia. Il 28 giugno 1914 ‐ in una Sarajevo dalla quale, stranamente, erano stati fatti allontanare i soldati che avrebbero dovuto proteggere l’arciduca Francesco Ferdinando ‐ arriva l’attentato. Il 23 luglio, l’ultimatum austriaco alla Serbia che sostanzialmente accetta le condizioni imposte. Inutilmente. Il 28 luglio, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Inizia la Grande Guerra. Sebbene tutti i governi sostenessero di voler evitare la guerra, tutti agivano nella direzione che creava le condizioni per la sua deflagrazione: una crescente corsa al riarmo (le spese militari di Germania, Austria‐
Ungheria, Gran Bretagna, Russia, Italia e Francia erano passate da 132 milioni di sterline del 1880, a 205 milioni nel 1900), provocazioni reciproche per sottrarsi aree di influenza, finanziamento e sostegno alle campagne stampa per favorire un clima sciovinistico e nazionalistico, etc. Quindi lo scatenamento della guerra non fu il prodotto di avvenimenti più o meno casuali, ma il risultato necessario del dominio capitalistico nella sua fase imperialistica per garantirne la sua sopravvivenza, nonostante i milioni di morti e le distruzioni che essa avrebbe provocato. L’Italia poteva evitare la guerra? Dopo la rivoluzione di ottobre 1917, i Bolscevichi pubblicarono sul giornale “Izvestija” i trattati segreti conservati presso il Ministero degli Esteri. Tra questi il “Trattato di Londra”, stipulato (senza che il Parlamento italiano, in maggioranza neutralista, ne fosse informato) il 26 aprile 1915, dal governo Salandra. Il trattato ‐ firmato dal marchese Guglielmo Imperiali, ambasciatore a Londra ‐ impegnava l’Italia ad entrare in guerra contro l’Austria ottenendo, in caso di vittoria, Trentino, Sud Tirolo, Friuli, Dalmazia, Albania e qualche colonia in Africa sottratta all’Impero austro‐ungarico. Eppure, Vienna stava già accettando una proposta presentata l’8 aprile 1915 dal ministro degli Esteri italiano Sidney Sonnino che, in cambio della neutralità italiana, prevedeva la cessione del Trentino‐Sud Tirolo, la piena autonomia di Trieste (città libera, porto franco e università italiana) e una sorta di protettorato italiano in vaste zone della Dalmazia e in Albania. Perché il governo italiano optò per la guerra quando avrebbe potuto ottenere, con la neutralità, sostanzialmente gli stessi territori? Le motivazioni costruite dalla propaganda dell’epoca e soprattutto quelle propagate in seguito dal regime dominante e dalla stampa ad esso asservita circa l’obiettivo di recuperare i territori italiani ancora sotto il dominio austro‐ungarico per completare il processo di unità nazionale, sono pura menzogna per coprire le mire imperialistiche dello stato e del capitalismo italiano. L’Italia, giunta in ritardo all’unità nazionale, attraverso una serie di intrighi e approfittando della competizione tra le grandi potenze già esistenti, era stata interessata a ridosso della fine del secolo, da un processo impetuoso di sviluppo, fondato anche sul brutale saccheggio del Meridione. Attraverso le commesse di Stato si erano sviluppati dei grandi poli industriali in particolare nella siderurgia, nella cantieristica e nella produzione di macchinari. Non meno impetuoso era stato lo sviluppo del capitale finanziario che vedeva primeggiare tre grandi istituti: la Banca Commerciale, il Credito Italiano e la Banca di Roma. Nel giro di pochi decenni le capacità produttive ed i capitali accumulati da questi grandi gruppi industriali e finanziari erano andati ben oltre le possibilità di assorbimento dell’asfittico mercato nazionale. Per tale motivo si cominciò a cercare avidamente nuove possibilità di investimenti e di esportazioni in altri paesi. Ma la esistente divisione del mondo tra le altre grandi potenze e le capacità industriali e finanziarie di quest’ultime lasciavano poco spazio alle mire espansionistiche dei nostri famelici capitalisti. In generale, tanto nei paesi già sviluppati quanto nelle aree periferiche, al capitale italiano veniva concesso al massimo un ruolo subalterno che non consentiva grandi sbocchi all’industria e al capitale finanziario. Divenne pertanto impellente ritagliarsi proprie aree di influenza 3 controllate direttamente e dove il capitalismo italiano la potesse fare da padrone. Le linee direttrici di queste mire espansionistiche si concentrarono essenzialmente in tre direzioni: il nord ed il corno d’Africa, l’area balcanica e segnatamente la Dalmazia, il Montenegro e l’Albania ed in ultimo qualche area della Turchia approfittando della decadenza dell’impero Ottomano. I tentativi di sottomettere l’Eritrea e la Somalia si rivelarono un clamoroso fallimento con sonore sconfitte inflitte da parte delle popolazioni locali, mentre l’invasione della Libia richiese circa un trentennio prima di poter essere completata a causa dell’eroica resistenza popolare guidata da Omar Muktar. Tutto ciò non impedì all’esercito italiano in tutte queste circostanze di rendersi protagonista di efferati crimini e di un vero e proprio genocidio. Molti storici considerano l’aggressione alla Libia e lo scontro militare con l’impero Ottomano uno dei fattori che contribuirono ad accelerare il percorso verso la guerra, poiché esso dimostrò quanto quest’ultimo fosse debole, dando la stura ad altre guerre nei Balcani per strappare al controllo ottomano ulteriori territori. Questi due precari insediamenti in Africa non si rivelarono, però, particolarmente remunerativi per il nascente imperialismo italiano, quindi le attenzioni del governo e della borghesia si indirizzarono con maggiore intensità verso i Balcani, in aree che erano fondamentalmente controllate dall’Impero Austro‐ungarico e da quello Ottomano. Qui, non potendo usare immediatamente la forza militare, si agì prevalentemente attraverso gli intrighi, la corruzione e la diplomazia ancora una volta senza ottenere significativi risultati. Anche il tentativo di ritagliarsi una propria area di influenza direttamente nella costa meridionale dell’attuale Turchia si scontrò con la dura opposizione della Germania e dell’Austria che formalmente erano sue alleate. Nonostante il vorticoso protagonismo dell’Italia le sue velleità di entrare nel novero delle grandi potenze imperialiste e colonialiste venivano ripetutamente frustrate. Con l’avvicinarsi dello scoppio della guerra, la classe dirigente italiana si divise tra neutralisti ed interventisti, ma nessuno dei due schieramenti era mosso da ragioni etiche o umanitarie. La parte neutralista, impersonata soprattutto da Giolitti, che tra l’altro era colui che aveva deciso l’invasione della Libia, semplicemente riteneva che facendo balenare la possibilità di un proprio intervento a favore dell’uno o dell’altro schieramento avrebbe potuto ottenere risultati significativi senza impegnarsi in un conflitto che poteva risultare distruttivo per le mire imperialiste del paese. Gli interventisti che erano una minoranza tanto nel parlamento quanto nel paese, erano foraggiati proprio da quel grande capitale che aveva visto sostanzialmente frustrate le proprie mire espansionistiche e riteneva di poter lucrare maggiori risultati scendendo direttamente in campo per poter partecipare alla spartizione del bottino di guerra e consolidare in maniera duratura l’espansione imperialistica del paese. Alla fine l’intervento militare fu deciso proprio perché si riteneva che la guerra sarebbe durata poco, e ci si buttò dalla parte della coalizione ritenuta vincente per potersi sedere al tavolo della “pace” e non essere esclusi dal depredamento delle spoglie dei perdenti. Menzogne di guerra Agli albori della Prima Guerra Mondiale, lo Stato Maggiore francese diffuse quattro milioni di cartoline, realizzate dal disegnatore Francois Poulbot, per attestare un crimine mai commesso: i soldati tedeschi, in Belgio, mozzavano le mani ai bambini. Era una menzogna data per buona da giornalisti disponibili, per un pugno di lire, marchi, sterline, franchi..., a orientare l’opinione pubblica verso questo o quell’altro nemico. Interi giornali e gruppi editoriali erano su libri paga dei governi. In Italia, mentre comincia a delinearsi lo scontro fra interventisti e neutralisti, il Kaiser tenta di acquistare in blocco “Il Messaggero”, “La Stampa”, “Il Secolo”; dall'altra parte i servizi segreti francesi finanziano la nascita de “Il Popolo d’Italia” di Mussolini (già direttore del giornale socialista “Avanti!” e divenuto improvvisamente “interventista”); l’Inghilterra cerca di mettere le mani sul “Corriere della Sera”.... Da allora sono passati cento anni ma le cose non sembrano essere molto cambiate. Oggi, per farci accettare una guerra sono mobilitate agenzie di “pubbliche relazioni”, reti televisive, giornali, siti internet, e persino molte delle cosiddette “organizzazioni umanitarie”. Inventano storie strazianti per convincerci che è indispensabile “fare qualcosa” contro lo “stato canaglia” o il dittatore di turno. E così, quando partono i bombardamenti, ci sentiamo quasi sollevati. Perché ci hanno convinto che, in fondo, non si tratta di un’altra guerra, ma di una sacrosanta “missione umanitaria”. E sono ancora molti gli “opinionisti” sul libro paga di ambasciate, ministeri, servizi segreti, fabbricanti d’armi... 4 La guerra e la Seconda Internazionale Nel 1914, i partiti socialisti (riuniti nella Seconda Internazionale) contano in Europa milioni di elettori, moltissimi militanti, parlamentari, circoli, cooperative, giornali, case editrici... Una forza mai raggiunta fino ad allora dal movimento operaio. Nel 1912 il Congresso di Basilea, di fronte alle ostilità tra Austria e Russia, si era concluso con il “Manifesto contro la guerra” che vincolava i partiti socialisti a non appoggiare una guerra che non poteva che essere generale, a fare ogni sforzo per impedirne l’avvio e, nel caso fosse scoppiata, ad utilizzarla per avviare un processo insurrezionale per abbattere la dominazione capitalista. Nonostante questi principi, solo 2 anni dopo, prevalse la difesa della propria nazione, della propria industria, del proprio capitale, insomma l’union sacrèe con la propria borghesia. Il 4 agosto i socialisti tedeschi votano a favore dei “crediti di guerra”; quindi i socialisti francesi votano a favore della “difesa nazionale”; li seguiranno a ruota i laburisti inglesi e altri partiti socialisti. Pochi i gloriosi esempi di opposizione alla guerra: in Italia, si oppone alla guerra la maggioranza del Partito Socialista; in Francia, Jean Jaurès, leader socialista francese, ucciso da un nazionalista il 31 Luglio; in Germania l’anarchico Ernst Friedrich e, soprattutto, Rosa Luxemburg che insieme a Karl Liebknecht si oppone alla posizione bellicista del partito guidando il fronte antimilitarista. Pagò con il carcere, in cui passò quasi tutti gli anni del conflitto. In Gran Bretagna il piccolo Partito Indipendente del Lavoro; i socialisti serbi che con il loro unico deputato si rifiutano di votare i crediti di guerra. Anche il partito socialista bulgaro rimane all’opposizione. Infine in Russia la sinistra del partito socialdemocratico (bolscevichi) che per la loro agitazione contro la guerra vengono tutti mandati in Siberia. A Zimmerwald (5‐8 Settembre 1915) si riunirono in conferenza i pochi esponenti socialisti rimasti contrari alla guerra. A causa delle diversità di posizioni, fu scartata la mozione che, riprendendo il Manifesto di Basilea, chiedeva di "trasformare la guerra imperialista in guerra civile", e fu votata la più tiepida mozione che, pur denunciando la guerra “prodotto dell’imperialismo”, proponeva di “ripristinare la pace tra i popoli sulla base della pace senza annessioni e del diritto all’autodeterminazione”. Mozione che, ovviamente, non soddisfaceva i più intransigenti come i bolscevichi. Non solo tra i politici, anche tra gli intellettuali, l’opposizione alla guerra fu una voce minoritaria: George B. Shaw in Gran Bretagna, Bertha von Suttner ed Albert Einstein in Germania, Emma Goldman negli USA; tra gli altri, lo scrittore francese Henri Barbusse, autore de “Il Fuoco” (1916) e il filosofo britannico Bertrand Russell, condannato a sei mesi di prigione per le sue pubbliche posizioni contro la guerra. “Né aderire, né sabotare” Quando il 2 agosto 1914 il Presidente del consiglio Salandra annuncia che l’Italia sarebbe rimasta neutrale ebbe l’appoggio di cattolici, giolittiani e socialisti, tutti contrari alla guerra. Soprattutto i “liberali” che facevano riferimento a Giovanni Giolitti ritenevano l'Italia impreparata al conflitto. Tale analisi, all'interno dello schieramento liberale, era accompagnata dalla convinzione per cui l'Impero Asburgico non avrebbe resistito all'“urto delle nazionalità” e, di conseguenza, l'Italia avrebbe potuto ottenere vantaggi e compensazioni dalla sua neutralità. All’avvio delle ostilità da parte dell’Italia nel 1915, i giolittiani, sebbene mantenessero un atteggiamento prudente, dichiararono incondizionato appoggio al governo; stessa cosa fecero i cattolici. Il gruppo neutralista di “Italia nostra” si sciolse per collaborare alla difesa della Patria. Meno compatto il campo socialista. Numerosi i “social‐patrioti”, i “socialisti rivoluzionari” e persino alcuni anarchici (Libero Tancredi, Oberdan Gigli, ad es.), con diverse motivazioni, si dichiararono favorevoli alla guerra partendo addirittura come volontari al fronte. Il Partito socialista si opponeva alla guerra, ritenendola figlia dello scontro inter‐imperialistico tra le grandi potenze e foriera di sciagura e morte per il proletariato. Ma mentre di fronte alla possibilità di una guerra al fianco degli alleati della Triplice (Italia, Germania ed Austria) contro la Francia democratica ribadiva, finanche nelle sue componenti più moderate, tutta la sua opposizione e la volontà di fermare il conflitto con un processo insurrezionale, cominciava ad apparire meno coeso davanti all’ipotesi di una guerra al fianco della Francia. Simbolo della simpatia verso l’Intesa (Francia, Gran Bretagna, Impero Russo) è il cambio di rotta del direttore de l’Avanti!, Mussolini. A soli pochi mesi dall’uscita del suo articolo “Abbasso la guerra” (l’Avanti! Del 26 luglio 5 1914), in cui scriveva “Mobilitate, noi ricorriamo alla forza”, Mussolini pubblica il 18 ottobre l’articolo “Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante”. Era il preludio al suo schieramento pro guerra. Mussolini fu espulso dal partito e di lì a pochi giorni, grazie ai soldi dell’Intesa, faceva uscire il quotidiano interventista “Il popolo d’Italia”. Il Partito Socialista mantenne, nonostante tutto, la sua posizione contro la guerra rifiutando di votare i crediti di guerra e di entrare nel governo. La formula fu quella decisa al Convegno di Bologna del maggio 1915 : “né aderire né sabotare”. Una formula ambigua, frutto del compromesso tra l’ala moderata (a cui si rifaceva quasi interamente il gruppo parlamentare) e quella riformista del partito, che ostacolò la crescita e la generalizzazione delle mobilitazioni dei lavoratori e dei contadini contro la guerra. Come ricorda Gaetano Arfè: «Di fatto l’agitazione socialista, nonostante l'enfasi del linguaggio, è condotta con i metodi classici della pacifica mobilitazione dell'opinione pubblica, assomiglia magari di più a una accesa campagna elettorale che non a una leva di forze rivoluzionarie pronta a un'azione energica e decisa». La destra del Partito non mancò di esprimere il suo patriottismo. Significative le parole dell’onorevole socialista Casalini che alla Camera dichiarava che il Partito socialista sabotava non la guerra “ma l’eventualità di movimenti impulsivi delle masse”. O quelle dell’onorevole Turati che il 14 dicembre 1916 dichiarò, fra gli applausi della maggioranza della Camera, che l’Italia non avrebbe potuto fare la pace senza ottenere sia quel territorio che era veramente italiano sia le garanzie strategiche che le spettavano di diritto. Insomma in una sola dichiarazione seppelliva anche le posizioni uscite dalla conferenza socialista di Zimmerwald. Ciò nonostante, la classe dominante ed il governo, certi di non riuscire ad avere il completo appoggio di tutto il Partito Socialista, si dettero alla più aspra repressione di tutte le voci antimilitariste colpendo duramente tanti dirigenti del Partito. A pagare di più furono i socialisti della frazione della sinistra rivoluzionaria che faceva capo a Bordiga, l’unica a difendere la posizione intransigente contro la guerra e la necessità della mobilitazione disfattista, sin dall’avventura italiana in Libia (1911) e contro la guerra balcanica. Ad essa si deve l’opuscolo il “Soldo al soldato”(agosto 1913) e ”Coscritto, ascolta” (1914) con cui portò avanti la campagna di propaganda ed agitazione antimilitarista presso i lavoratori ed i giovani soldati. Nonostante la censura e la ferrea disciplina militare, il “Soldo al soldato” e ”Coscritto, ascolta” continuarono a circolare tra le truppe per tutti gli anni della Grande Guerra. Molti i soldati socialisti arrestati o fucilati perché promotori delle insubordinazioni. Contrari sino alla fine saranno anche gli anarchici internazionalisti, animati da Errico Malatesta e Camillo Berneri. Nell’agosto 1914, a nome delle donne, l’internazionalista Leda Rafanelli, la profuga russa Angelica Balabanoff e la socialista Maria Giudice firmano un manifesto delle donne intitolato: “Non vogliamo la guerra!” Da il “Soldo al soldato”: Il decalogo del coscritto: 1. Non sparare sui tuoi fratelli lavoratori. 2. Non ti prestare a fare da krumiro. 3. Non odiare né la patria tua, né quella degli altri. Ama la patria dei lavoratori che è il mondo intero… Gli intellettuali e la guerra In Europa il desiderio prima e l’adesione poi alla guerra viene fatta propria ‐ quasi sempre senza dubbi né esitazioni – da tanti intellettuali e da esponenti della cultura che finiscono così per condizionare pesantemente l'opinione pubblica. Rudolf Herzog, Paul Ernst, Thomas Mann e lo stesso Sigmund Freud si schierarono a favore dell’intervento. Non mancarono donne inebriate dall’atmosfera di guerra: la danzatrice Isadora Duncan disse di essersi sentita «tutta fuoco e fiamme». In Italia, l’imminente massacro, salutato come “quarta guerra di Indipendenza” si sovrappone alla lunga stagione risorgimentale, con i suoi miti e la sua retorica: il Risorgimento come crogiolo della nazione; il mito garibaldino del “popolo in armi per interesse supremo della Patria”; un patriottismo declinato come nazionalismo; l'irredentismo come mito della liberazione dal giogo straniero delle “terre irredente” (Trento e Trieste) e, infine, il vagheggiamento dell'Impero, soprattutto dopo la Guerra di Libia (1911). 6 Non furono solo i Futuristi come Filippo Tommaso Marinetti dunque, a partire dal 1909, ad esaltare il dinamismo e l'“igiene del mondo” scaturiti dalla guerra; Ardengo Soffici e Giovanni Papini dalle pagine di “Lacerba”, democratici come Cesare Battisti, persino gli ermetici, con Giuseppe Ungaretti, e, inoltre, Gabriele D'Annunzio, che prima aderì alla Associazione Nazionalista Italiana, fondata da Enrico Corradini, contro l'«Italietta meschina e pacifista», quindi si arruolò volontario, e Carlo E. Gadda, pure lui volontario, col suo “Giornale di Guerra e di Prigionia” (1918). Non mancarono quelli di parte socialista come Giovanni Pascoli che nel discorso tenuto a Barga (1911), “La grande proletaria s’è mossa”, già aveva sostenuto la guerra libica in nome del nazionalismo. Anche di fronte al macello, non fecero un passo indietro: Paul Ernst (“Vossischen Zeitung”, 22 agosto 1915): Oggi siamo la nazione più grande! E’ nostro compito guidare l’umanità verso il progresso. Ogni atto di misericordia verso i popoli inferiori rappresenta un tradimento della nostra missione. Giovanni Papini (“Lacerba”, 20 settembre 1914): «Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? (…) La guerra, infine, giova all’agricoltura e alla modernità. I campi di battaglia rendono, per molti anni, assai più di prima senz’altra spesa di concio. Che bei cavoli mangeranno i francesi dove s’ammucchiarono i fanti tedeschi e che grasse patate si caveranno in Galizia quest’altro anno!». (Lacerba): “Ci vuole alla fine un caldo bagno di sangue. La guerra rimette in pari le partite... Fa il vuoto perché si respiri meglio... Amiamo la guerra ed assaporiamola da buongustai... La guerra è spaventosa ed appunto perchè è spaventosa e tremenda e terribile e distruggitrice dobbiamo amarla con tutto il nostro cuore di maschi”. (Amiamo la guerra “Lacerba”, ottobre 1914): Finalmente è arrivato il giorno dell'ira dopo i lunghi crepuscoli della paura. Finalmente stanno pagando la decima dell'anime per la ripulitura della terra. Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero dopo tanti umidicci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne. Ci voleva una bella innaffiatura di sangue per l'arsura dell'agosto; e una rossa svinatura per le vendemmie di settembre; e una muraglia di svampate per i freschi di settembre. È finita la siesta della vigliaccheria, della diplomazia, dell'ipocrisia e della pacioseria. I fratelli sono sempre buoni ad ammazzare i fratelli! i civili son pronti a tornar selvaggi, gli uomini non rinnegano le madri belve. [...] Chi odia l'umanità ‐ e come si può non odiarla anche compiangendola? ‐ si trova in questi tempi nel suo centro di felicità. La guerra, colla sua ferocia, nello stesso tempo giustifica l'odio e lo consola. Avevo ragione di non stimare gli uomini, e perciò son contento che ne spariscano parecchi. Renato Serra (“Esame di coscienza d’un letterato del 1915” ): Se non parteciperemo alla guerra invecchieremo falliti. Saremo la gente che ha fallito il suo destino. Nessuno ce lo dirà e noi non lo sapremo, ci parrà d’averlo scordato e lo sentiremo sempre, non si scorda il destino. Siamo insieme aspettando oggi come saremo nell’andare domani. … La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo, accanto agli altri che sono stati e che saranno: non vi aggiunge, non vi toglie nulla nel mondo. Neanche la letteratura. I cattolici al fronte Poche settimane dopo l'inizio delle ostilità, viene eletto Papa Benedetto XV, passato alla storia come il “Papa della pace” anche per aver definito la guerra in corso “un'inutile strage”. Ciononostante il clero e le gerarchie cattoliche di tutti i paesi si schierano immediatamente con i rispettivi governi. Così in Francia, in Austria, in Germania. In Italia la Chiesa non ebbe remore nell’accettare uno sbalorditivo accordo con lo Stato Maggiore italiano: la vendita (sei lire al chilo) di migliaia di campane da fondere per produrre cannoni e mitragliatrici. In più, mise a disposizione dell’esercito italiano 24.446 ecclesiastici e 2400 Cappellani. Ben 1582 erano inquadrati come ufficiali e molti erano al comando di reparti ottenendo anche decorazioni al valor militare. I cappellani oltre a benedire i soldati in procinto di uccidere e farsi uccidere, svolsero un’ampia attività di propaganda bellica tra i soldati. 7 Mons. Bartolomasi, “Vescovo del campo” con giurisdizione su tutto il clero in armi, in occasione della prima Pasqua di guerra, spiegò ai soldati quale fosse il loro dovere: “Soldati , vi desidero forti, perché tali vi desidera ed ha bisogno che voi siate la Patria, tale è il dovere vostro; e dalla fortezza vostra compatta per disciplina, temprata per virtù d’animo dipendono le sorti delle armi. La Patria guarda a voi, spera in voi, da voi attende il lieto giorno di pace gloriosa”. e contro le diserzioni: “Credete voi che si possa vincere una battaglia, una lunga e aspra guerra quando il povero capitano invece di pensare a combattere il nemico deve esaurirsi a spronare i suoi soldati e difendersi dai suoi sotterfugi? Il soldato che fa il soldato per paura (delle punizioni, della prigione o della fucilazione n.n.) è la rovina del reggimento e dell’esercito. … Il buon soldato fa quello che deve fare perché è il suo dovere, perché egli ama il superiore, ama la disciplina, ama la Patria, ama il buon Dio” (spiegazione di un passo del Vangelo da parte di un cappellano, 19/9/1915). Uccisi dalla Patria Quando si commemorano i seicentomila soldati italiani morti nella Prima Guerra Mondiale, si fa l’indegna operazione di attribuirli al solo nemico. Volutamente si nascondono le colpe dirette dello Stato italiano in questo bagno di sangue. L’Italia entrò in guerra assolutamente impreparata e con la convinzione che si sarebbe trattato di uno scontro della durata di qualche mese. Le armi erano insufficienti tanto che le reclute venivano istruite con il bastone al posto del fucile (ce n’era 1 per ogni 10 uomini); fino al 1916 la gran parte dei nostri fanti non avevano elmetto e portavano in testa berretti di feltro. Nonostante la zona di guerra fosse prevalentemente sulle montagne, i soldati non venivano riforniti di indumenti di lana; in settembre 1915, nella sola zona Vrata‐Monte Nero si verificarono 700 casi di congelamento. Le condizioni e l’equipaggiamento dei soldati al fronte erano, quindi, sin dall’inizio pessime. A questo si aggiunse la crudeltà del Comando Supremo Militare al capo del qualche era il gen. Luigi Cadorna, sostituito l’8 novembre del 1917 dal gen. Armando Diaz. Tra luglio e agosto 1915 infezioni ed epidemie si diffusero tra le truppe nelle zone di operazioni: circa 6000 casi di tifo e 15‐20 mila casi di colera che venivano curati con poco cognac diluito con acqua. Quelli che venivano considerati per spacciati erano lasciati morire di fame. Ne morirono 4.300. Molto peggio che in altri eserciti, in quello italiano la “disciplina militare” assunse livelli di ferocia inaudita. Le lettere scritte dai soldati dovevano trasmettere “entusiasmo per la guerra”; chi trasgrediva rischiava la condanna al carcere militare. Un soldato poteva essere arrestato se durante la licenza dava notizie o si lamentava delle condizioni al fronte e perfino se si accompagnava in pubblico con la fidanzata. Poteva essere fucilato se tornava in ritardo da una licenza (bastava un semplice ritardo di 24 ore per essere dichiarati disertori) o se “sorpreso a riferire o scrivere una frase ingiuriosa contro un suo superiore”; stessa sorte per gli ufficiali che osavano dubitare pubblicamente della tattica imposta dal Comando Supremo. Con il crescere delle perdite ed i primi episodi di indisciplina, precise disposizioni furono date agli ufficiali al comando ed ai Carabinieri per colpire alle spalle i soldati non sufficientemente “arditi” nell’assalto alle trincee. Per Cadorna, infatti, la giustizia militare era troppo morbida nonostante il numero enorme di processi e condanne. Nei tre anni di guerra ci furono 350mila processi per 150mila condanne, di cui più di 4mila alla pena capitale anche se solo 750 furono quelle realmente eseguite. Qualche giorno dopo la battaglia dell’Altopiano di Asiago ed il cedimento del fronte italiano, Cadorna, In una lettera del 26 maggio 1916 al gen. Lequio, comandante della zona della Carnia, così comandava: “ L’E.V. prenda le più energiche ed estreme misure: faccia fucilare, se occorre, immediatamente e senza alcun provvedimento, i colpevoli di così enormi scandali a qualunque grado appartengano. L’altopiano di Asiago, va mantenuto a qualunque prezzo. Si deve resistere o morire sul posto”. Il 28 maggio 1 sottotenente, 3 sergenti ed 8 uomini di truppa appartenenti al 141° reggimento fanteria messo in fuga dagli austriaci, furono passati per le armi. Fu il primo caso di decimazione nell’esercito italiano. La decimazione fu una pratica diffusa ed usata tutte le volte in cui l’insubordinazione era commessa da un gruppo di soldati. 8 Il gen. Cadorna in una circolare in cui lodava uno dei comandanti artefici delle decimazioni, ricordò che non esisteva “altro mezzo idoneo per reprimere i reati collettivi che quello di fucilare i maggiori colpevoli” . Ma se l’accertamento delle responsabilità personali non fosse stato possibile, ai comandanti restava “il diritto ed il dovere di estrarre a sorte alcuni militari e punirli con la pena di morte”. Vale la pena ricordare uno dei più terribili episodi di massacro per fuoco amico. Ai primi di luglio 1916, i fanti appartenenti all’89° reggimento della brigata Salerno furono non solo decimati ma bombardati con le artiglierie e le mitragliatrici per ordine dei loro comandanti. Erano 250 uomini feriti e rimasti tra le due opposte trincee per due giorni e due notti senza soccorso; furono puniti perché alcuni di loro provarono a consegnarsi agli austriaci. Due giorni dopo, per un nuovo tentativo di diserzione di massa, la brigata Salerno fu allontanata dalla prima linea ed 8 militari furono fucilati (1 dichiarato reo, 3 indiziati e 4 sorteggiati). “Il giorno 1° dello scorso mese di luglio – scrisse Cadorna – in tre successive riprese, nuclei sempre più numerosi, appartenenti al III battaglione dell’89° reggimento fanteria, passavano vilmente al nemico: su di essi si dirigeva, implacabile giustiziere, il fuoco delle nostre artiglierie e delle nostre mitragliatrici.” Quanti furono i soldati italiani fucilati per i reati di insubordinazione, per non aver dato prova di “vigore” o che furono sparati alle spalle dai Carabinieri per non aver dato l’assalto a qualche trincea? Nessuna statistica ufficiale lo dice. Sta di fatto che i soldati facevano di tutto per non combattere e per sottrarsi alla crudele disciplina militare. Alcuni soldati si suicidavano al momento dell’attacco, altri ricorrevano all’autolesionismo o alla diserzione che furono i “reati” più diffusi. Le condanne per mutilazione volontaria ed infermità procurate (finiti spesso con la morte) furono 1403 nel I° anno di guerra, 4133 nel 2°, 3620 nel 3° e 705 nel 4°. In totale 10.000 condanne. Alla fine del 1916 gli episodi di autolesionismo iniziarono diminuire perché un nuovo decreto stabilì che quelli in grado di combattere dovevano tornare al fronte anche se condannati. Era questo il modo per evitare che le stesse carceri diventassero luoghi di “imboscamento”. Inoltre si stabilì che se l’atto autolesionista era compiuto davanti al nemico veniva giudicato come “codardia con atti” e punito con la pena di morte. Un provvedimento che si giustificava con i frequenti episodi di “amichevole” ferimento reciproco tra i soldati delle contrapposte trincee. Le condanne per diserzione furono 101.665. La maggior parte furono alla reclusione da scontarsi dopo la guerra e con l’obbligo di tornare al fronte; le condanne a morte eseguite 370. Ma a tutte le fucilazioni stabilite dalle Corti Marziali vanno aggiunte le centinaia eseguite sul posto e senza processo ricordate sopra. Alla vigilia di Caporetto, secondo Cadorna, c’erano 22.000 disertori dell’esercito mobilitato, circa 34.000 disertori dell’esercito non mobilitato ed altri 48.000 renitenti non presentatisi alla chiamata. Sempre secondo i dati di Cadorna, tra i disertori latitanti non erano numerosi quelli prigionieri del nemico. Al 1 ottobre 1917 lui stesso dichiarava che se ne contavano solo 3000 (tutti condannati a morte in contumacia). Eppure si usò questa ragione per giustificare il grande massacro per mano della Patria dei prigionieri italiani. A loro, infatti, si addebitava di essersi consegnati al nemico, di aver abbandonato le armi ed essersi allontanati dal fronte nel momento cruciale della guerra. Fu questa la giustificazione data da Cadorna e dagli altri ufficiali del Comando Supremo davanti alla sconfitta di Caporetto di cui erano responsabili i loro errori tattici e la superiorità militare dei tedeschi. L’impreparazione, l’abbandono delle linee da parte degli ufficiali, la disorganizzazione nella ritirata, lasciarono in soli 3 giorni (23‐26 ottobre) ben 294.000 soldati nelle mani del nemico. In totale si calcola che furono più di 600.000 gli italiani ammassati nei campi di prigionia dell’Impero austroungarico, abbandonati dall’Italia perché considerati “disertori, arresisi volontariamente al nemico”. Furono centomila i soldati italiani che morirono di fame nei campi di prigionia per volontà dei generali italiani che proibirono ad essi l’invio di viveri e posta. Vienna aveva proposto al governo italiano una soluzione analoga a quella raggiunta da Francia e Germania, con l’invio di treni di rifornimenti, ma Roma rifiutò nella convinzione “che ciò valesse a trattenere i combattenti dalla resa e dalla diserzione”. Gabriele D’Annunzio additava i soldati italiani prigionieri come «Imboscati d’oltralpe, sventurati e svergognati che hanno peccato contro la Patria». E così, mentre, ad es., la mortalità tra i francesi prigionieri di guerra fu di appena 18.882 uomini su 1.600.000, di cui una parte per ferite contratte in precedenza o per tubercolosi, la conseguenza della criminale politica italiana fu la morte per fame e malattie di 100.000 suoi uomini. Non solo. Il sospetto di diserzione veniva 9 pagato con la vergogna, l’emarginazione e la punizione per le stesse famiglie dei soldati a cui veniva tolto anche il misero sussidio. In più. Finita la guerra i prigionieri sopravvissuti furono internati in Italia in campi di concentramento chiusi solo nel gennaio del 1919 sotto la spinta dell’opinione pubblica. Per loro era stato deciso, addirittura, il trasferimento nei lager presenti in Libia e nei Balcani. Condanne a morte e processi si ebbero in tutti gli eserciti. L’esercito austro‐ungarico, composto da elementi di varie nazionalità, era molto meno omogeneo degli altri e ciò si manifestava con una diffusa indisciplina e frequenti diserzioni di boemi, romeni, cecoslovacchi o altri slavi, punite con la Corte marziale. Molti dei disertori passavano letteralmente al nemico. Famoso l’episodio dell’estate del ’17 a Carzano, nel Trentino, quando ufficiali sloveni si accordarono con quelli italiani per consentire a questi di passare oltre le linee. L’operazione fallì per la disorganizzazione italiana. In Francia, dove la condanna a morte del soldato doveva essere validata dal Presidente della Repubblica, ci furono “solo” 554 (49 realmente eseguite) condanne capitali contro 1.492 condanne leggere e 1.381 dai cinque anni all'ergastolo, normalmente condonate a fine guerra. In Gran Bretagna la Corte marziale dovette istruire nel corso della guerra ben 300.000 processi per diserzione, conclusisi con 3.000 condanne a morte (solo un decimo eseguite). La ribellione al fronte A dispetto del terrore della disciplina militare, le inumane condizioni al fronte, la stanchezza di una guerra così lunga, il rifiuto di uccidere ed essere uccisi, determinarono in tutti gli eserciti episodi di insubordinazione e vero e proprio ammutinamento. Ad essi contribuì non poco anche ciò che stava avvenendo nella lontana Russia dove a marzo del 1917 era iniziato il processo rivoluzionario al grido di “pane, pace e libertà”. Nell’agosto del 1917 il Comando supremo austro‐ungarico redarguiva gli ufficiali affinché frenassero il desiderio di pace presente tra le truppe che si esprimeva con scritte sui baraccamenti inneggianti alla fine della guerra. Addirittura una compagnia boema si arrese, sul Carso, al canto dell’Internazionale. In Germania la scintilla fu il peggioramento del rancio. Gli equipaggi di molte navi da guerra elessero le “commissioni per il rancio” collegate tra di loro, molti equipaggi si ammutinarono e ci furono incontri segreti tra i rappresentanti dei marinai ed i deputati schierati contro la guerra. Il 2 agosto ci fu una grande manifestazione dei marinai. Sul fronte francese, tra aprile ed ottobre del 1917, ci furono ammutinamenti e sommosse che coinvolsero la metà dell’esercito. L’episodio più clamoroso si verificò, nel maggio 1917, a Missy‐aux‐Bois dove un reggimento di fanteria francese si impadronì della città e nominò un "governo pacifista". Le autorità militari usarono il pugno di ferro: le corti marziali giudicarono colpevoli di ammutinamento 23.395 soldati, dei quali più di 400 vengono condannati a morte. Sentenza poi ridotta a 50 fucilati e ai lavori forzati nelle colonie penali per gli altri. In un’altra occasione circa 40.000 soldati ammutinatisi manifestarono al canto dell’Internazionale. A Parigi soldati e scioperanti fraternizzarono inneggiando alla rivoluzione, alla pace, alla Russia. L’esercito britannico conosce un unico caso di indisciplina collettiva: nel settembre 1917 le truppe acquartierate nel campo di riposo di Étaples si ribellarono alle dure condizioni cui erano sottoposte scontrandosi con la polizia militare. In Italia, nello stesso periodo, nonostante l’incredibile aumento di processi e fucilazioni, crebbero le insubordinazioni collettive. Anche in questo caso le cause principali sono da ricercare nel peggioramento delle condizioni al fronte: licenze negate, divieto assoluto di ogni attività di svago ‐ tranne l’accesso alle case di tolleranza e la grappa distribuita generosamente prima di ogni battaglia‐ e, soprattutto, la fame. Infatti, alla fine del 1916 la razione di cibo del soldato diminuì: il pane passò da 750 gr. a 600 gr, la carne da 375 a 250 gr.. A dettare il provvedimento fu non solo la difficoltà degli approvvigionamenti ma, udite udite, anche il parere di molti esperti che ritenevano la razione distribuita troppo ricca di proteine. A ciò si aggiunga che quasi mai, né prima né dopo la riduzione, il soldato riceveva la razione stabilita ed in generale era di pessima qualità. 10 Il malcontento era aggravato dalla consapevolezza che in tanti, dentro e fuori l’esercito, lucravano sulla loro pelle, dalla miseria delle loro famiglie e dal diverso trattamento riservato agli ufficiali. La paga del fante era di 89 centesimi + 40 centesimi di soprassoldo. Dagli 89 cent. venivano trattenuti: 38 cent per il vitto, 14 per manutenzione e vestiario, 27 per il pane. Rimanevano 10 centesimi più i 40 di soprassoldo per un totale di 50 centesimi al giorno. Molto poco da mandare alle famiglie che, in gran parte contadine, vedevano il proprio reddito drasticamente ridotto per il venir meno della forza lavoro maschile. Solo alle famiglie più bisognose lo Stato riconosceva un sussidio di 60 centesimi per la moglie e 30 per i figli al di sotto dei 12 anni. Le pensioni in caso di morte o di mutilazione erano un miseria. Gli ufficiali, al contrario, godevano di un trattamento economico consistente oltre al buon rancio. L’odio per gli ufficiali e la voglia di pace, esattamente come sugli altri fronti, diventava sempre più crescente e con esse le ribellioni, al punto che Cadorna invocò una dura repressione contro i pacifisti ed i disfattisti nel paese. In molti episodi, durante il trasporto al fronte, i soldati sparavano all’impazzata dai treni in corsa contro il personale ed i carabinieri in servizio presso le stazioni. Le fucilate erano accompagnate da grida come “Abbasso la guerra, abbasso i guerrafondai, evviva la Russia e la rivoluzione”. Numerosi furono anche i casi di carabinieri assassinati in trincea e impiccati o pugnalati nelle retrovie. Nelle audizioni per l’Inchiesta Caporetto, il gen. Porro ammise che nel semestre precedente l’offensiva di Caporetto, ci furono circa sessanta processi per ammutinamento con rivolta. Il caso più eclatante e drammatico fu quello della brigata Catanzaro (141° e 142° fanteria). L’episodio scatenante fu l’arresto, il 14 luglio ’17, di 9 soldati considerati istigatori di proteste che erano stati individuati da carabinieri infiltrati. La sera successiva nuclei di rivoltosi tentarono di invadere il paese di S. Maria La Longa impiegando bombe a mano e mitragliatrici. Tutta la 6° compagnia del 142° si ammutinò. Per sedare la rivolta intervenne l’artiglieria, carabinieri, cavalleria e autoblindo, insieme ai reparti rimasti fedeli. Negli scontri morirono 2 ufficiali e 9 soldati e 2 ufficiali e 25 soldati furono feriti. Davanti a tale potenza di fuoco, i rivoltosi, approfittando del buio si sciolsero raggiungendo i reparti. All’alba furono fucilati 28 soldati di cui 12 per decimazione. Nei giorni seguenti altri 4 soldati furono fucilati e 135 militari (di cui 123 della 6° compagnia) furono sottoposti a processo. Circa 500 fra soldati sospetti ed ufficiali “di poca energia” furono allontanati dalla brigata. Dopo la battaglia di Caporetto, nel caos della ritirata, furono centinaia di migliaia i soldati che sbandati e terrorizzati, provarono a tornare a casa. In qualche caso addirittura inneggiarono al nemico nella speranza che la sua vittoria mettesse finalmente fine alla guerra. In molti hanno parlato di “sciopero militare”. In realtà non vi fu nulla di organizzato. A prevalere, nello sbando generale della linea di comando, fu la stanchezza della guerra ed il tentativo di cogliere quell’occasione per sottrarsi al fronte. Anche in questo caso, furono decine e decine le fucilazioni. Infatti, pur in piena offensiva nemica, non mancò chi, come il gen. Andrea Graziani, pensò bene di intraprendere, come scrisse egli stesso: “una lotta di aggressione morale e fisica contro le orde di sbandati”. Natale di guerra L’orrore della Prima Guerra Mondiale è costellato anche di eventi straordinari come quando soldati fino al allora “nemici”, fraternizzarono. L’evento più famoso ‐ perché documentato, anche con foto, dal New York Times statunitense (paese in quel momento ancora neutrale) avvenne la notte del 24 dicembre 1914, quando in una trincea delle Fiandre, nei pressi di Wulvergem, alcuni soldati tedeschi iniziarono a cantare “Stille Nacht “ [Astro del ciel] seguiti da lì a poco da un grande coro e dall’inalberarsi di cartelli con la scritta: “Noi non spariamo, voi non sparate”. Dalla parte opposta inglesi e francesi, dopo un po’, risposero con canti natalizi. Uscirono allo scoperto, fraternizzarono e, contro gli ordini degli ufficiali, uscirono fuori dalle trincee e concordarono tre giorni di tregua. I soldati si aiutarono a vicenda per seppellire i morti; ci furono abbracci, scambi di dolci e persino una partita di pallone. Sempre a Natale, a Pervyse, alcuni soldati belgi si riunirono per la messa in una chiesa vicina alla prima linea. Nonostante le luci accese per permettere lo svolgimento della funzione, i tedeschi non spararono un solo colpo per tutta la notte. Il giorno dopo, il 25 dicembre, sulle rive del fiume ghiacciato che separava le due linee comparvero una sessantina di tedeschi disarmati che chiedevano del cappellano militare. Al suo arrivo i tedeschi cominciarono a cantare. Finito il canto natalizio, cui si unirono i belgi, un ufficiale tedesco consegnò al 11 cappellano un reliquiario neo‐gotico, fatto di oro e pietre preziose che avevano trovato in una cantina di una casa occupata dichiarando che erano venuti a restituirlo ai legittimi proprietari. Anche sul fronte italiano si verificarono episodi di fraternizzazione, ma la documentazione è scarna per la ferrea censura che colpiva le lettere dei soldati al fronte. Da alcuni rapporti militari sappiamo di un Natale di Guerra nel 1916 sui monti Kobilek (Friuli) e a Zebio (altopiano di Asiago) quando soldati italiani e austro‐ungarici, addirittura, brindarono gomito a gomito; evento che ispirò Giuseppe Ungaretti, che quel giorno scrisse la poesia “Natale”. Altri episodi nel febbraio del 1916, sul Carso, e, nel maggio del 1917, sulla vetta Chapot in Friuli. In molti casi tra le trincee opposte, a volte distanti pochi metri l’una dall’altra, si barattavano persino le cose, come tabacco e pane. I comandi ostacolavano ogni contatto con il nemico per timore della fraternizzazione; si proibì non soltanto la raccolta dei feriti durante il giorno ma anche l’invio di parlamentari se non in casi eccezionali. L’opposizione sociale In Italia lo scontro tra borghesia nazionalista guerrafondaia e proletariato internazionalista inizia con l’impresa libica. Anarchici e socialisti si opposero all’avventura coloniale italiana: blocchi dei binari per impedire la partenza dei soldati, sabotaggi alle strade ferrate, assalti alle caserme, scioperi, propaganda tra i soldati in partenza e tra quelli che reprimevano le manifestazioni. La repressione giolittiana fu feroce e centinaia furono gli antimilitaristi, anarchici, socialisti e sindacalisti condannati. Per gli effetti che ebbero sui fatti del ’14 ricordiamo: il muratore Augusto Masetti, che la mattina del 30 ottobre 1911, alla caserma Cialdini di Bologna, gridando «Abbasso la guerra! W l’anarchia!», sparò al colonnello Stroppa che elogiava la guerra di Libia, feren‐
dolo alla spalla. Pur di evitare un processo che avrebbe rischiato di dare pubblicità alle sue idee antimilitariste, venne giudicato pazzo e rinchiuso nel manicomio criminale di Imola; e Antonio Moroni che per aver scritto una lettera al fratello, pubblicata dall’«Avanti! » il 23 dicembre 1912, in cui lamentava il durissimo trattamento subito per le sue idee politiche nel reggimento in cui era arruolato, venne incriminato per diffamazione dell’esercito. Prosciolto dal Tribunale di Cagliari il 27 aprile 1913, fu assegnato alla Compagnia di Disciplina di San Leo di Romagna(Pe). Le compagnie di disciplina nell’esercito erano dei veri e propri campi di rieducazione dove finivano le reclute ed i soldati dissidenti che, oltre a subire trattamenti disumani, venivano addetti ai lavori più duri e umilianti ed agli incarichi più pericolosi. Di fronte ai rischi di una nuova guerra, nel 1914 la campagna antimilitarista si fece ancora più aspra. Il 7 giugno, ad Ancona, i circoli repubblicani, anarchici e socialisti convocarono, nell’anniversario dello Statuto Albertino, un comizio antimilitarista, in cui si chiedeva l'abolizione delle Compagnie di Disciplina nell’Esercito, si protestava contro il militarismo e contro la guerra e si chiedeva la liberazione di Augusto Masetti e Antonio Moroni, simboli delle persecuzioni militariste. La manifestazione, duramente repressa dai carabinieri, si concluse con 3 morti e numerosi feriti. La protesta diventò subito rivolta in tutta la città e, con il diffondersi della notizia dell’eccidio, si estese in tutta Italia. Fra le grandi città insorsero Torino, Milano, Parma, Firenze e Napoli dove la marina sbarcò truppe d’assalto (3 i morti, 4 i feriti e 30 gli arresti). Scontri, feriti e morti si contarono in ogni parte. Vengono proclamate repubbliche provvisorie. Fu la settimana rossa. I capi tradirono (la Confederazione del lavoro, ad es., ordinò la fine dello sciopero generale), ma i lavoratori lottarono contro la guerra ed in difesa delle loro condizioni di lavoro. La parola d’ordine era quella della fratellanza con uno schieramento al fianco di quanti lottano anche in altri paesi: i minatori del Colorado massacrati dalla Guardia Nazionale, i dissidenti russi spediti in Siberia, l’argentino Teodoro Antilli e il cubano Eduardo Vasquez, incarcerati per reati di stampa e Juesus Gonzales, ucciso sul Rio Bravo dagli americani mentre raggiunge ribelli messicani. Stroncata la rivolta, Salandra impose la guerra a gente che la odiava. Non mancarono proteste, scioperi e gesti eclatanti, come quello di Libero Merlino che ferì in duello Mussolini interventista. Ma dobbiamo aspettare il 1916 per la discesa in piazza di migliaia di donne, di operai, di contadini e braccianti. Infatti, a partire da gennaio, in tutt’Italia si ebbero centinaia di violente manifestazioni contro il prolungarsi del conflitto. Ad animarle erano soprattutto le donne. Quasi ogni lunedì, giorno in cui venivano distribuiti i sussidi, si verificavano dimostrazioni per il ritorno dei soldati dal fronte e per l’aumento dei sussidi. Ma il dato economico era presso che irrilevante tant’è vero che anche quando i sussidi furono aumentati, la gran parte delle donne si rifiutavano di riscuoterli preoccupate che gli aumenti fossero il contentino per la continuazione 12 indisturbata della guerra. La direzione generale della Pubblica sicurezza calcolò che solo tra il 1 dicembre ’16 al 15 aprile ’17 ci furono circa 500 manifestazioni. Eccezionali furono le manifestazioni in Campania (22 in tra maggio e novembre) con 5 municipi invasi. A S. Gregorio Magno in 2000 assalirono i carabinieri invocando la pace; a Sora invasero la sottoprefettura chiedendo il ritorno dal fronte; a Monte S. Biagio (Caserta) ci fu il tentativo di invadere il municipio e una giovane fu uccisa dalla pubblica sicurezza; ad Orsara di Puglia (allora provincia di Avellino) la popolazione scese nelle piazze e distrusse la linea telegrafica. Manifestazioni si susseguirono a Firenze, Parma, Reggio Emilia, Bologna e nel ferrarese. Nei primi giorni di maggio del ’17 a Milano la manifestazione, composta in maggioranza da donne proletarie, provenienti anche dalle campagne, percorse i quartieri industriali lanciando sassi contro gli stabilimenti di produzione di armi. Insieme agli operai usciti dagli stabilimenti si chiedeva la chiusura delle fabbriche di morte, pace subito e ritorno a casa dei soldati. Le cronache di allora le descrissero come furie. Infine, i moti di Torino dell’agosto del ’17: l’unico esempio di una intera città in rivolta nel pieno della guerra. A Torino l'opposizione alla guerra era stata vivissima fin dal 1914 sia perché la grande, media e piccola borghesia era stata nella grande maggioranza giolittiana e neutralista, sia per la presenza di un proletario operaio combattivo e radicale (il grande sciopero del maggio 1915 lo aveva dimostrato). Lo scoppio della guerra e la presenza a Torino della grande industria avevano fatto della città la prima grande città industriale italiana e quindi la fucina e l'arsenale della guerra. Il numero degli operai si era ingrossato ed ammontava ora a varie centinaia di migliaia con un forte aumento delle donne, soprattutto nell’industria pesante, e del lavoro minorile al di sotto del limite dei 15 anni imposto dalle leggi. La “speciale legislazione di guerra” promulgata dallo Stato aveva di fatto militarizzato gli stabilimenti imponendo la soppressione di tutte le conquiste sindacali a cominciare dal diritto di sciopero ed un regime disciplinare volto a garantire il massimo di sfruttamento (allungamento dell’orario di lavoro, turni di notte, ritmi inauditi) oltre che a punire qualsiasi attività sindacale, le assenze collettive e individuali dalle fabbriche, i rifiuti di obbedienza ed i sabotaggi. Se per le donne ed i bambini le pene si traducevano in multe, minacce e licenziamenti, per gli uomini significavano processi, prigione, internamenti e invio al fronte. La disciplina militare di fabbrica era, quindi, ben lontana dal garantire una situazione di “privilegio” e di “imboscamento” immaginata ed odiata dai soldati al fronte; un risentimento alimentato anche dalla campagna antisocialista del governo e dei comandi militari e su cui, nel dopoguerra, si fece leva da parte delle forze politiche borghesi, in primis il fascismo, per alimentare la contrapposizione tra gli operai e le loro organizzazioni politiche e i disperati che tornavano dal fronte. La militarizzazione, lo sfruttamento selvaggio, il salario reale falcidiato e la costante irreperibilità di vari generi di prima necessità avevano reso le condizioni operaie insopportabili. Il 1917 è l'anno peggiore. Tre anni di guerra avevano portato le condizioni di vita e di lavoro del proletariato urbano al limite. Tra marzo e agosto, la situazione è aggravata dalla penuria di pane. Scendono in agitazione e in sciopero in questi mesi decine di fabbriche torinesi, dalle metallurgiche alle automobilistiche, e alle rivendicazioni economiche si intreccia la propaganda per la pace e, poiché proprio in questo periodo giungono gli echi della rivoluzione russa del febbraio, sempre più spesso la parola d'ordine diventa di "fare come in Russia". Il 21 agosto la crisi si aggrava e si conta che ottanta fornai rimangano chiusi: gruppi di donne manifestano davanti alla Prefettura e davanti al Municipio, mentre il giorno successivo iniziano le battaglie in strada. Nel quartiere Vanchiglia la folla attacca la caserma delle guardie, che sparano ferendo tre dimostranti; gli scontri si allargano a macchia d'olio in tutta la città, mentre sempre più operai scendono in sciopero e da dimostrazione per la penuria del pane diviene lotta politica contro il governo e per la pace (Ce ne infischiamo del pane! Vogliamo la pace! Abbasso i pescecani! Abbasso la guerra!) L'Autorità, seriamente preoccupata, arresta il Segretario della Camera del Lavoro ed occupa militarmente i locali camerali. Il 23 lo sciopero è spontaneo e chiaramente preinsurrezionale in tutta la città, malgrado che nessun ordine sia partito dai sindacati; i negozi vengono saccheggiati, in tutti i quartieri vengono erette barricate, gli scontri a fuoco si moltiplicano, i roghi cominciano ad essere appiccati in punti nevralgici della città. Due reparti 13 dell'esercito vengono disarmati dai dimostranti e due caserme di guardie di città (a Barriera Milano e a Barriera Aurora) vengono assaltate. È in questa giornata che si contano i primi due morti della rivolta, uccisi dalle guardie in Piazza Statuto. Il 24 è la giornata culminante dell'insurrezione. Nella mattinata tutti i quartieri operai periferici sono in mano al proletariato insorto (verranno definiti la "cintura rossa"), mentre il centro città è presidiato dall'esercito; gli operai spingono tutt'intorno al centro, cercando di convincere i soldati, tramite manifesti, volantini e donne infiltrate, a passare dalla propria parte o almeno di disarmarli. I risultati di questo tentativo di fraternizzazione con i soldati sono del tutto deludenti. La riscossa della forza pubblica è terribile. Entrano in campo le automobili blindate e si scagliano a corsa folle per le vie gremite, scaricando le mitragliatrici all'impazzata sulla gente che fugge, su coloro che resistono, nelle finestre delle case, nelle porte, nei negozi alla cieca. Quando i carri si misero in moto: “le donne si slanciarono, disarmate, all'assalto, si aggrapparono alle pesanti ruote, tentarono di arrampicarsi alle mitragliatrici supplicando i soldati di buttare le armi. I soldati non spararono, i loro volti erano rigati di sudore e di lacrime. Le tanks avanzavano lentamente. Le donne non le abbandonavano. Le tanks alfine dovettero arrestarsi» (Da un opuscolo «Agosto 1917: i fatti di Torino» uscito a Parigi nell'agosto 1928 a cura della «Sezione femminile del Partito Comunista d'Italia» riportato da Spriano). Sabato 25 agosto il moto operaio rifluisce, schiacciato dalla repressione armata, dal tradimento della destra del Partito socialista e dalla impreparazione dei «sinistri». Lo sciopero però è ancora quasi unanime in tutta la città e gli scontri si susseguono ovunque, ma le barricate sono state disfatte dalle truppe. Nella notte la polizia arresta tutti i membri delle sezioni esecutive del Partito Socialista e della Camera del Lavoro ed in particolare i «sinistri» che ancora erano a piede libero. Naturalmente non vengono arrestati i massimi dirigenti moderati. Il 26 l'insurrezione è praticamente battuta anche se fino al giorno dopo continua compatto lo sciopero in tutta la città e nelle località della provincia. I morti proletari furono circa 50 e 200 i feriti; i militari caduti meno di una diecina e circa 30 i feriti. Migliaia gli operai arrestati di cui 822 rinviati a giudizio. Un anno dopo il Tribunale Militare condannerà, «quali autori morali» dei fatti di Torino, Barberis a sei anni di reclusione, Rabezzana a quattro di detenzione, Serrati a tre anni e mezzo di detenzione, Pianezza, Dalberto e Giudice a tre anni e un mese di detenzione ciascuno. Anche negli altri paesi non mancarono manifestazioni e scioperi che chiedevano la fine del conflitto. In Germania già nel 1916 c'erano state manifestazioni contro la guerra. Il 1° maggio in una manifestazione operaia Karl Liebknecht fu arrestato mentre, in uniforme, distribuiva volantini. Nell’aprile del 1917 più di 300.000 operai delle industrie belliche entrano in sciopero a Berlino e Lipsia. A gennaio del ‘18 numerosi scioperi di massa guidati dai socialdemocratici espulsi dalla SPD per la loro opposizione alla guerra chiedevano la fine della guerra. A Berlino, proprio durante questi scioperi si ebbe il primo consiglio dei lavoratori, sul modello dei soviet. Nella rivoluzione di novembre saranno oltre 10.000 i “consigli degli operai e dei soldati” nati dall’ondata di scioperi in 30 città tedesche. Anche in Austria nel gennaio 1918 un'ondata straordinaria di scioperi spontanei partita da Wiener Neustadt dilagò in gran parte del paese, compresa Trieste; ad essi, ai primi di febbraio, si collegò la rivolta della flotta ormeggiata a Cattaro. In Gran Bretagna ci furono scioperi già nel febbraio 1915 contro l’abbassamento dei salari e le dure condizioni di lavoro imposte dal padronato. Il conflitto paralizzò i cantieri navali del Clyde; ad agosto scesero in sciopero i minatori del Galles ed i metallurgici. In Francia gli scioperi iniziarono a gennaio del 1916 nel settore dell’abbigliamento al grido “Abbasso i salari da guerra”. Nell’ottobre del ’17 gli scioperi operai sfociarono nella fraternizzazione tra gli scioperanti e migliaia di soldati che si erano ammutinati. 14 Gli internamenti A partire dal giugno del 1915 le autorità militari italiane diedero avvio nei territori ex‐austriaci occupati ad ampi sfollamenti delle popolazioni (si stimano in circa 70.000) e ad una severa politica di internamenti di massa volta a “bonificare” le “zone di guerra” dagli ostili “irredenti”, garantire la sicurezza militare ed imporre una rapida italianizzazione dei territori occupati. Tra le 3.000‐5.000 persone provenienti dall’Isontino, dal Cadore, dal Trentino furono internate con l’accusa di essere “austriacanti”, sovversivi e spie. Con il proseguire del conflitto ed in particolare dopo la sconfitta di Caporetto ed i fatti di Torino del 1917, con l’aumento cioè delle diserzioni e degli scioperi, non solo le “zone di guerra” si allargarono a quasi tutte le regioni dove erano presenti le grandi fabbriche di armi e materiale bellico, passando sotto il controllo delle autorità militari, ma furono emessi una serie di decreti per punire duramente e più liberamente quanti erano anche solo sospettati di disfattismo o di azioni contro la produzione. Le autorità sia civili che militari ebbero mano libera per processare e imprigionare e, nel caso di prove inesistenti o di assoluzione, di ricorrere all’internamento di socialisti, anarchici e sindacalisti. Un potere che si rafforzò con il decreto del 6 marzo 1918 (n. 305) con cui si allargarono ulteriormente le facoltà delle autorità di p.s. riguardo agli allontanamenti dei cittadini italiani, fornendo ai prefetti uno strumento di intimidazione contro gli operai più attivi nelle lotte per ottenere miglioramenti delle condizioni di lavoro. Dopo una prima fase in cui l’internamento significò l’invio in carcere, il governo scelse di creare dei centri di smistamento (Novara e Firenze) dai quali si provvedeva a trasferire gli internati in località individuate dal Ministero degli Interni fuori dalle “zone di guerra”: i soggetti ritenuti più pericolosi in Sardegna (2.276 nel periodo 1915‐1918) e nelle isole di Ponza, Ustica, Lampedusa e Ventotene, vere e proprie colonie penali; gli altri, soprattutto donne e bambini, venivano smistati verso località isolate, specie del Sud. E’ il confino, niente affatto concepito dal fascismo che non si inventò né le modalità né i luoghi. La sorveglianza cui gli internati erano sottoposti era odiosa e la libertà di circolazione era subordinata all’autorizzazione del Segretariato Generale. Dal rispetto del domicilio coatto dipendeva anche il ricevimento del sussidio di una lira al giorno che il governo aveva istituito per far fronte alle condizioni di povertà di gran parte di essi. Una miseria che, insieme alle pessime condizioni abitative, l’isolamento e l’ostilità dei locali, destinò alla morte per malattia e fame molti bambini e donne anziane, in particolare nelle aree del Meridione dove era quasi impossibile trovare un lavoro con cui integrare il sussidio. Di questa disumana condizione non mancò chi si approfittò: spesso gli internati, come i profughi, soprattutto se donne, furono vittime di episodi di sfruttamento sul lavoro, di discriminazioni nell’erogazione dei sussidi o di speculazioni sul vitto e sugli alloggi. Va aggiunto, inoltre, che l’assistenza alle/agli internate/i era subordinata a programmi di “redenzione” atti a favorire il “sentimento di italianità” e dissipare, specie nella popolazione femminile delle terre redente, i pregiudizi “fomentati dal gendarme e dal prete austriaco contro la nuova patria”. Questa volontà “civilizzatrice” permeava tutti i comitati di assistenza, come ad es. il “Comitato nazionale per le colonie dei profughi delle terre redente” costituitosi a Milano nel novembre del 1915 e guidato da esponenti patriottiche, e poi fasciste, dell’emancipazionismo femminile come Ada Negri e Margherita Sarfatti. L’esplicita avversione alla guerra e gli stereotipi femminili, furono alla base dell’accanimento con cui le autorità italiane usarono gli internamenti contro le donne. In particolare nel corso del primo anno di guerra, la motivazione principale di internamento per la componente femminile fu l’“austriacantismo”, spesso accompagnato dall’accusa di spionaggio, con cui si colpivano donne con un cognome austriaco o tedesco, o che avevano i figli o i mariti militari nell’esercito austriaco, o che intrattenevano corrispondenze epistolari con l’estero. Un’accusa talmente vaga da prestarsi ad essere usata largamente per intimidire e minacciare quelle donne che negavano all’esercito occupante quelli che venivano da esso considerati come i diritti acquisiti del vincitore. In non pochi casi, infatti, la reazione alle molestie, l’indisponibilità sessuale venne qualificata come reato di lesa maestà e punita severamente anche con questo provvedimento. Altre ragioni erano: il mancato rispetto di divieti ed ordinanze, il criticare le operazioni militari e l’occupazione, l’esaltazione della potenza dell’esercito austriaco, gli atti di disfattismo. 15 Le donne, infatti, forse più degli uomini, manifestavano apertamente l’ostilità contro l’occupazione delle truppe italiane, resa ancora più insopportabile dal fatto che mariti e fratelli combattessero nell’esercito austroungarico oppure fossero stati internati dalle autorità italiane. Tra il novembre del 1917 e il febbraio del 1918 numerosi furono gli internamenti di donne accusate di reati gravi quali il favoreggiamento alla diserzione, particolarmente ricorrenti nei piccoli paesi veneti delle retrovie dove i soldati in fuga venivano nascosti, ospitati e dotati di abiti civili. Lo strumento repressivo dell’allontanamento si intensificò contro le donne anche nelle altre “zone di guerra” (Milano, Torino e Genova) dove, in particolare contro le straniere o le italiane coniugate con tedeschi, si usò l’accusa di “prostituzione vicino alle industrie” e di “propaganda tedescofila”.
La prostituzione, infatti, fu l’altro elemento usato come accusa strumentale contro la popolazione femminile soprattutto nelle retrovie. In molti casi l’internamento avveniva per “dubbia moralità”, i “facili costumi”, la presunta capacità di “danneggiare scientemente l’efficienza dei soldati col inoculare [...] malattie celtiche”. Ciò era facilitato proprio dal fatto che la prostituzione nelle immediate retrovie del fronte era realmente un fenomeno dilagante a causa della rilevante concentrazione delle truppe e del progressivo peggioramento delle condizioni economiche della popolazione anche grazie alle depredazioni dei nuovi “liberatori”. In particolare, proprio tra gli sfollati il fenomeno ebbe una crescita rilevante dal momento che i miseri sussidi e l’assenza della componente maschile, costringevano le donne all’esercizio della prostituzione per sfamare i propri figli. L’esigenza di frenare la diffusione di malattie veneree che metteva a repentaglio l’integrità dell’esercito, portò, quindi, alla dura repressione della prostituzione clandestina. Come in tutti i teatri di guerra, furono istituiti bordelli regolamentati dove tante donne, con ritmi di fabbrica, facevano da carne di piacere per i soldati. l protagonismo delle donne. La guerra fu per le donne un periodo di trasformazione. L'enorme numero di uomini sotto le armi costrinse tutte le nazioni belligeranti a sostituire i lavoratori maschi con ragazze e donne. In Italia furono centinaia di migliaia quelle che presero il posto degli uomini nell’industria e nell’agricoltura. Il 1 novembre 1918 le donne occupate nelle sole industrie di guerra furono 196.000 (22% degli addetti totali). A Milano nelle 1.757 aziende oggetto di inchiesta, le donne occupate erano passate da 27.106 unità del 1914 alle 42.937 degli inizi del 1918 (+58%). Nelle campagne il loro apporto fu addirittura maggiore, dal momento che oltre la metà dei combattenti (2,600 milioni) proveniva dalle fila dei contadini. In Gran Bretagna tra luglio 1914 e novembre 1918 le lavoratrici passarono da 3,3 a 4,9 milioni portando il tasso di femminilizzazione della manodopera al 38%. Nell'industria degli esplosivi e delle munizioni lavorarono circa 950.000 donne note come munitionettes o canaries (canarini) per il giallo di cui si colorava la pelle dopo pochi mesi di lavoro a contatto persistente col TNT (trinitrotoluene). In queste fabbriche, molto pericolose, ne morirono 200 e altre migliaia furono uccise o soffrirono di malattie professionali dovute ai prodotti chimici usati e alla mancanza di qualsiasi protezione. Il numero di donne impiegate in agricoltura crebbe, ed esse vennero ad essere definite come Women's Land Army. Alla fine della guerra quasi 300.000 donne erano impiegate in questo settore. Un altro settore chiave per l'impiego di manodopera femminile fu quello dei trasporti: si videro le prime autiste di mezzi pubblici, mentre le donne impiegate presso le ferrovie arrivarono alle 50.000 unità. In Francia, paese a forte occupazione femminile già prima della guerra (7,7 milioni di lavoratrici), l’ulteriore ingresso delle donne nelle industrie e nei servizi, porta la manodopera femminile al 40% del totale. In Austria‐Ungheria, se nel 1913 solo il 17,5% degli operai dell'industria era donna, nel 1916 questa percentuale sale al 42,5%. In Germania si assiste ad un incremento di oltre il 50% dell’impiego femminile nella grande industria del settore metallurgico, dell’elettricità e della chimica. In particolare cresce più che negli altri paesi la quota delle donne impiegate nel lavoro a domicilio riconvertito in produzione di guerra (uniformi, maschere antigas, calzature, ecc.). Nel 1918 la quota totale della manodopera femminile raggiunse il 55%. L’entrata nel mondo del lavoro di masse di donne viene raccontata come l’inizio dell’”emancipazione” femminile. In realtà, le donne pagarono a caro prezzo questo traguardo che il dopoguerra si incaricò di dimostrare quanto fosse effimero. 16 Infatti, ovunque, i salari delle lavoratrici, a parità di ore di lavoro e di mansioni, erano in media meno della metà della paga degli uomini. In fabbrica subivano discriminazioni non solo economiche dai datori di lavoro (ad es. in Germania, gli imprenditori facevano firmare alle donne una lettera di dimissioni all’atto dell’assunzione) e molestie sessuali da parte dei capi; infine sopportavano le diffidenze da parte dei compagni maschi anche in ambito sindacale. Alle 10‐12 ore di lavoro in fabbrica si aggiungevano, poi, la fatica di cura della famiglia. Queste terribili condizioni di vita, l’odio per una guerra responsabile della perdita dei loro affetti, spiega l’incredibile protagonismo delle donne nelle lotte per il salario (in particolare la rivendicazione della parità salariale con gli uomini) e contro la guerra. In tutti i paesi sono loro, nella maggioranza dei casi, a dare avvio alle rivolte per la mancanza di pane ed agli scioperi sul lavoro. Questa immissione forzata nel mercato del lavoro e nelle lotte di così tante donne determinò giocoforza un cambiamento sociale e culturale in particolare in Italia. Tale cambiamento, però, rimase ambiguo. Nonostante si assistesse ad uno stravolgimento degli elementi tradizionali dell’identità e dell’immagine femminile, del privato, della stessa riproduzione, non venne mai meno il richiamo ai tradizionali ruoli dei sessi ed alla pericolosità di questa inversione. Specie in Italia, non mancarono assimilazioni della donna che lavorava alla prostituta. Nonostante ciò, finita la guerra, in quasi tutti i paesi coinvolti, la preoccupazione per l’attivismo dimostrato dalle donne come rafforzamento delle lotte operaie e la necessità di farle rientrare nei ranghi, portò ad alcune riforme nel campo dei diritti e del voto. In Italia, la riforma di Ettore Sacchi del 1919 abrogò finalmente l’istituto dell’autorizzazione maritale, garantì piena capacità giuridica alle donne coniugate (anche se gli uomini mantenevano ancora la patria potestà) e legittimò le donne ad esercitare tutte le professioni, incluse quelle pubbliche (eccezion fatta per i magistrati, per le diplomatiche e gli agenti di polizia). Ma negò il diritto di voto (ottenuto solo nel 1946). Germania ed Austria nel 1918 estesero il diritto di voto a tutte le donne, in Gran Bretagna il Parlamento lo varò solo per le donne di età superiore ai 30 anni. In Francia una legge in tal senso, presentata nel 1919, non fu approvata fino al 1944. Fu il “premio” concesso per il sacrificio delle donne; gli fece da contraltare la smobilitazione dal mercato del lavoro: era ora di restituire agli uomini il posto occupato. La retorica dominante fu, infatti, quella che prescriveva alle donne di tornare in seno alla famiglia, ai compiti procreativi e materni. Le prime ad essere licenziate furono quelle impiegate nel settore bellico, ma, in nome del diritto al reintegro degli ex‐combattenti, i licenziamenti proseguirono rapidi in tutti i settori. Nel 1921 nel nostro paese, ad es., risultarono occupate nell’agricoltura 3 milioni di donne, nell’industria un milione e 173.000 in meno rispetto al 1913, mentre le donne inattive erano 14 milioni. A questo veloce rientro nei ranghi familiari si accompagnò ovunque una campagna sempre più ostile al lavoro femminile e di feroce critica nei confronti delle donne emancipate e del femminismo. Ne derivò una esaltazione della casalinga e della figura materna. La drastica caduta della natalità combinata con la morte in guerra di milioni di uomini, alimentarono dovunque, da una parte, misure che vietavano la propaganda anticoncezionale e reprimevano l’aborto, dall’altra, politiche di sostegno all’incremento demografico. In Italia, sarà il fascismo a svilupparle con particolare forza, annientando qualsiasi velleità d’emancipazione femminile. La guerra fuori dall’Europa L’arena principale della Prima Guerra fu l’Europa, ma a causa delle ragioni che l’avevano determinata furono proprio le colonie l’altro fronte su cui si giocarono i nuovi equilibri mondiali. L’avvio della guerra vide, infatti, l’immediato sviluppo delle operazioni militari in Asia, Medio Oriente, Oceania ed Africa per scalzare la Germania dai sui possedimenti coloniali. Grazie al Giappone, all’Australia ed alla Nuova Zelanda, entrati in guerra al fianco di Francia e Gran Bretagna, furono sufficienti pochi mesi e pochi combattimenti per liquidare i possedimenti tedeschi nel Pacifico (Kiao Ciao e Tsing‐Tao in Cina, isole Caroline, isole Marshall, isole Marianne, Samoa e Nuova Guinea Tedesca). Molto più complesso risultò lo scontro in Africa. Qui la Germania, pur partendo da posizioni svantaggiate (presenza di poche guarnigioni e le proprie colonie circondate da quelle inglesi, francesi, belghe e portoghesi) dette del filo da torcere ai suoi competitors. 17 Se, infatti, l’ odierno Togo fu rapidamente occupato dalle forze anglo‐francesi (la Francia la parte orientale e la Gran Bretagna quella occidentale) già entro la fine dell'agosto 1914, ci vorrà un anno per l’occupazione dell'Africa del sudovest (odierna Namibia) da parte del governo bianco del Sud Africa, e si arriverà a febbraio 1916 per avere ragione delle truppe tedesche in Camerun. Ancora più duro lo scontro nell’Africa orientale tedesca (attuale Tanzania) dove gli alleati ebbero bisogno di schierare enormi quantitativi di uomini e mezzi. Qui poco più di 300 tedeschi con circa 2000 indigeni arruolati, con una tattica di guerriglia, riuscirono a ritardare l’occupazione e a portare attacchi alle colonie confinanti; si arrenderanno nella Rhodesia settentrionale (attuale Zambia) solo il 26 novembre 1918, dopo essere stati informati dell'avvenuta capitolazione della Germania. A comandare le truppe tedesche è von Lettow Vòrbeck, lo stesso che nel 1905 aveva guidato le guerre di genocidio contro i Nama e gli Herero che si ribellavano al dominio tedesco (solo tra gli Herero ne furono massacrati 65.000). L’altro fronte fu il Medio Oriente. Con la campagna della Mesopotamia gli inglesi riuscirono non solo a difendere dalla minaccia ottomana i possedimenti nel Golfo Persico, ma avanzarono fino a Baghdad. L’occupazione dell’Egitto ed il controllo del canale di Suez consentirono la sconfitta degli ottomani anche nella Penisola del Sinai. Nel dicembre del 1917 cadde Gerusalemme e nell’ottobre 1918 gli inglesi avanzarono fino in Siria decretando la fine dell’Impero Ottomano. Ciò fu reso possibile anche grazie all’offensiva delle tribù della penisola arabica insorte contro gli ottomani sotto la guida del colonnello britannico Thomas Edward Lawrence (passato alla storia come "Lawrence d'Arabia"). Il conflitto tra i due schieramenti, infatti, fu combattuto anche istigando ed armando rivolte dei popoli dominati. In Africa furono particolarmente attivi i tedeschi che, per supplire alla loro debolezza militare, operarono per sollevare le popolazioni sia nel Sud Africa (appoggio ai boeri contro gli inglesi) sia nell’Africa settentrionale (Marocco, Libia, Darfur, ecc). Queste operazioni riuscivano senza grandi sforzi visto l’odio ed il fuoco sempre acceso delle ribellioni in popoli schiavizzati senza pietà dal dominio bianco. Un odio che il conflitto inter‐imperialistico non fece che aumentare. Infatti, al “normale” sfruttamento ed alle “normali” espropriazioni si aggiunsero il reclutamento forzato dei soldati e dei portatori, le requisizioni di bestiame e di alimenti, i saccheggi e la distruzione di interi villaggi, portati avanti senza eccezione da tutti i paesi colonizzatori. Le rivolte contro il dominio occidentale ed il rifiuto di fare da carne da macello si rafforzarono ovunque e la loro repressione fu spietata. Negli stermini per riportare l’ordine non mancò di distinguersi l’Italia, in Libia come in Somalia ed Eritrea; la strage di Misurata del 24 maggio del 1915 ne è solo un esempio. Il massacro fra gli indigeni fu enorme. Furono loro a pagare il prezzo altissimo di una guerra che almeno in questa area del mondo poco costò alle truppe occidentali in termini di vite umane. In un solo giorno (21 febbraio 1917), ad es., 700 soldati africani morirono annegati per l’affondamento nell’Atlantico di un cargo addetto al trasporto delle truppe. Ma le perdite maggiori ci furono tra i portatori, centinaia di migliaia di indigeni reclutati con la forza per il trasporto di armi e viveri al seguito degli eserciti bianchi. Non si conosce il numero esatto di quanti ne morirono. “Ma sicuramente furono diverse decine di migliaia. In Mozambico, "per i soli britannici", scrive René Pélissier: si calcolano 26.000 tombe scavate per seppellire i portatori. I portoghesi non si sono dati la pena di calcolare rigorosamente queste perdite "civili", dato che avevano già delle difficoltà nel contabilizzare i propri morti in uniforme.” (dal testo “ 1914‐1918 La madre di tutte le guerre di Antonio Moscato). Ad esse vanno aggiunte le vittime della repressione e quelle dovute al lavoro coatto ed alle carestie seguite alle distruzioni seminate dagli eserciti. Le stime calcolano centinaia di migliaia di morti. Ai vivi, invece, la guerra riservò il cambio dei padroni ma lo stesso identico sfruttamento. Contro di esso le rivolte proseguirono fino alle grandiose lotte di liberazione dal colonialismo. Un affare per il Capitale e miseria per le masse La guerra, grazie anche all’intervento degli Stati Uniti al fianco dell’Intesa, ebbe termine alla fine del 1918 con la vittoria di quest’ultima. Con i diversi trattati, il più importante dei quali è quello di Versailles con la Germania, i vincitori imposero le condizioni di pace. I costi umani furono enormi: oltre 16 milioni di morti. 18 In Italia i morti furono circa 600 mila ed altrettanti i feriti e mutilati. Alla fine della guerra si contarono un totale di 345 mila orfani. Ma la Patria per cui ci si era immolati non fu generosa. Quanti tornavano dalla guerra ciechi, sfigurati o amputati agli arti, percepirono pensioni giornaliere di lire 3,45; lire 2,58 chi aveva perduto la mano destra. Per il figlio morto in guerra, la madre ebbe una pensione giornaliera di lire 1,72. Insomma, chi non aveva voluto la guerra veniva ricompensato con una miseria. Viceversa, per il capitale, che quel macello aveva avviato, fu un periodo d’oro in tutti i paesi belligeranti. Grazie alla Prima Guerra Mondiale, il capitalismo italiano raggiunge profitti altrimenti impensabili: i profitti medi delle banche passano dallo 4,26% del 1914 al 7,75% del 1917; quelli dell’industria meccanica dall’8,20% al 30,51%; industria chimica dall’8,02 al 15,39%; pellami e calzature dal 9,31 al 30,51%; lanieri dal 5,18% al 18,74%; cotonieri, dallo ‐0,94 al 12,27%... Clamorosa poi è l’ascesa della FIAT. Agli inizi del 1914 era appena al 30° posto tra le aziende italiane. Legata, allora, agli ambienti giolittiani era su posizioni neutraliste anche perché lavorava prevalentemente su commesse della Marina austroungarica. Poi, fiutato il possibile affare, finanzia il quotidiano interventista “l’Idea Nazionale”. Diventerà il principale fornitore di automezzi per l’esercito italiano. E il suo capitale sociale passa da 25 milioni di lire del 1914 ai 128 milioni del 1918. Nel 1915 i profitti furono calcolati intorno al 70% del suo capitale. Le imprese fornitrici dello Stato, come denunciava La Stampa di Torino, si arricchirono vendendo materiali scadenti a prezzi elevati. Il commercio estero raggiunse importi giganteschi; i titoli azionari volarono. Gli anni della guerra coincisero con la vera rivoluzione industriale italiana; i 4300 operai Fiat diventano oltre 40 mila, i 200 operai dell’Alfa Romeo si moltiplicano per venti, l’Ansaldo passa da 6 mila a 56 mila operai, nasce l’industria aeronautica. Nel 1918 le fabbriche italiane impiegavano più lavoratori di oggi. In compenso le spese dello stato passano da 2 miliardi di lire del 1913‐14 a 30,8 miliardi del 1918‐19. Il deficit statale passa negli stessi anni da 214 milioni a 23,3 miliardi. Debito pubblico e profitti privati. Non è certamente una novità della storia, ma con la Prima Guerra Mondiale questa tendenza raggiunge per la prima volta proporzioni astronomiche, e non solo in Italia. Le conseguenze si faranno sentire immediatamente dopo la guerra: aumento della tassazione, inflazione galoppante con conseguente svalutazione dei titoli del debito pubblico e dei salari. Un impoverimento generalizzato che stavolta coinvolge anche larghi strati delle classi medie, colpite dalla crescente tassazione e dalla perdita di valore dei titoli di stato in cui avevano investito i propri risparmi, mentre i proletari vedono svaporare il valore d’acquisto dei propri salari. La classe lavoratrice si era nel frattempo, come abbiamo visto, enormemente accresciuta di numero e, forte di tale consapevolezza, non fu più disposta a subire passivamente il peggioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro, come era capitato sostanzialmente durante il periodo della guerra. L’esempio della rivoluzione in Russia, non aveva avuto conseguenze solo nell’accelerare la fine della guerra ma anche nella ripresa delle mobilitazioni contro le ingiustizie e la polarizzazione crescente che la stessa guerra avevano reso possibili. Nel biennio 1919‐20 l’Italia fu attraversata da poderose lotte che coinvolsero tanto le campagne quanto le città, culminando nella diffusa occupazione delle terre, le imponenti lotte bracciantili e con l’occupazione delle fabbriche. Ancora una volta i socialisti moderati misero in atto una politica collaborazionista con gli interessi della grande borghesia, come avevano fatto durante la guerra e, invece di sostenere le mobilitazioni che assumevano inevitabilmente anche un connotato sempre più politico, si diedero da fare per farle esaurire. Sul versante dei ceti medi, una cui significativa componente era costituita da reduci, la disillusione per i risultati della guerra ed il crescente impoverimento determinato dalla politica del governo, provocò anche in questo settore sociale una forte attivazione politica che, non trovando approdo nel più ampio movimento di masse proletarie, si orientò verso il fascismo. Quest’ultimo infatti, pur essendo finanziato da quel grande capitale che era stato il vero beneficiario della guerra, univa in una sapiente miscela propagandistica la generica denuncia del potere del capitale plutocratico con la denuncia della patria tradita, in particolare dalle organizzazioni del proletariato contro cui si cercò di indirizzare il crescente malcontento. Non mancavano rivendicazioni economiche e politiche di stampo socialisteggiante, il tutto, però, inserito in un quadro di superamento della lotta tra le classi per la collaborazione tra di esse in nome dei superiori e comuni interessi nazionali. 19 Il vero obiettivo non erano naturalmente queste sbiadite organizzazioni politiche che avevano dato prova di ampia collaborazione con la borghesia durante e dopo la guerra, ma il protagonismo proletario e la sua possibilità di organizzarsi e lottare come classe indipendente con interessi contrapposti a quelli del capitale. La storia delle coperture e del sostegno forniti al fascismo da parte del grande capitale, delle istituzioni e dalla intellettualità borghese è una vicenda oramai nota, ma qualcuno continua a propagandare la favola di un movimento conservatore espressione degli interessi del capitalismo più arretrato. Il fascismo invece rappresentava la risposta della borghesia alla paura della insorgenza proletaria ed il tentativo di darsi una struttura economica ed istituzionale ancora più moderna ed asservita alle esigenze del capitale italiano, che, nonostante avesse vinto la guerra, si sentiva frustrato per i risultati ottenuti rispetto alle proprie mire espansionistiche. Rispetto alle altre potenze imperialiste e agli equilibri usciti dalla guerra, per il capitale italiano vi era bisogno di una ulteriore centralizzazione del potere economico e politico per poter competere con i propri concorrenti, passando prima per la sconfitta e la distruzione del movimento operaio organizzato. La Prima Guerra Mondiale non fu sufficiente Se la Prima Guerra Mondiale era stata la risposta alle difficoltà crescenti del capitalismo nella sua fase imperialistica e al tentativo di dare una più stabile e duratura configurazione agli equilibri internazionali tra le grandi potenze, essa si rivelò inefficace. La “pace” imposta dai vincitori fu particolarmente vessatoria nei confronti della Germania, per non parlare dell’Impero Austro‐ungarico e di quello Ottomano che furono semplicemente smembrati. Francia ed Inghilterra ampliarono a dismisura i propri possedimenti coloniali soprattutto nel Vicino e Medio Oriente ed in Africa, mentre all’orizzonte si profilava il gigante statunitense che, dopo aver imposto il proprio dominio assoluto sul continente americano, si candidava a vera potenza mondiale allargando le sue mire a tutte le aree del globo. Gli esorbitanti debiti di guerra e la privazione di ampi territori nazionali imposti alla Germania, determinarono un crescente risentimento nelle classi dirigenti di quel paese, ma anche in Italia che, nonostante facesse parte dello schieramento vincitore, vide frustrate le sue principali mire espansionistiche. Quanto alle contraddizioni economiche del capitalismo mondiale, dopo una breve ripresa di pochi anni, le maggiori potenze economiche conobbero, dopo solo un decennio dalla fine della guerra, la più grande e generalizzata crisi economica che mai avesse colpito il capitalismo. La I Guerra Mondiale, infatti, anche se comportò significative novità dal punto di vista degli armamenti e delle tattiche militari rispetto a quelle che l’avevano precedute, fu sostanzialmente una guerra combattuta solo tra eserciti con i fronti posizionati sulle linee di confine e scarso coinvolgimento delle aree urbanizzate, salvo poche eccezioni. Le strutture industriali e le grandi città non furono quasi per niente toccate. Nel frattempo però questo già enorme apparato industriale, che era all’origine delle precedenti difficoltà economiche, si era ingigantito proprio a causa della produzione bellica. Di conseguenza alla fine delle ostilità esso riprese a funzionare a pieno ritmo senza più avere a disposizione quell’enorme mercato di sbocco rappresentato dalle spese belliche eccezionali. Le nuove spese per recuperare le distruzioni provocate dalla guerra non riuscivano ad assorbire il giganteggiare della produzione industriale. Non solo. Proprio nel periodo successivo al I° dopoguerra furono introdotte importanti novità nel processo produttivo, sia in termini di macchinari che di metodi di lavoro (catena di montaggio, diffusione massiccia di macchine azionate dall’energia elettrica, taylorismo etc,). Tali novità consentivano incredibili aumenti della produttività e dello sfruttamento operaio, ma rendevano ancora più stringente la necessità di trovare mercati dove smerciare i beni prodotti. Le nuove colonie acquisite, rispetto alle quali si continuava ad applicare il classico metodo della rapina e del saccheggio, non erano in grado di rappresentare un mercato di sbocco sufficiente per questa enorme quantità di merci prodotta dagli apparati industriali. Ecco perché una quota crescente di capitali si cominciò ad indirizzare verso il settore finanziario e la speculazione. Ma nel giro di pochi anni questa enorme bolla finanziaria esplose nel 1929 provocando una recessione inaudita nelle maggiori nazioni sviluppate con conseguenze molto più gravi di quella di fine secolo precedente. La soluzione provvisoria fu trovata ancora una volta nel sostegno della spesa pubblica. Tutti gli stati, fossero essi delle democrazie parlamentari o delle dittature, adottarono le stesse misure: commesse statali e sostegno al reddito, ma soprattutto ripresa vertiginosa della spesa per gli armamenti. Ed effettivamente una ripresa vi fu, ma essa era drogata dal sostegno della spesa pubblica e dal relativo aumento del debito pubblico. Era un espediente che non si sarebbe 20 potuto utilizzare per lungo tempo senza provocare una implosione del bilancio degli stati e l’esplosione di una crisi economica ancora più grave di quella che si pretendeva di aver superato. Intanto le rinnovate difficoltà economiche e gli strascichi lasciati dal primo conflitto mondiale portavano al riemergere della competizione interimperialistica. La Germania, che nel giro di pochi anni si era ripresa dalle conseguenze della guerra e dalle condizioni imposte dai vincitori, aveva avuto uno sviluppo impetuoso ed era alla ricerca ancora una volta di uno spazio di dominio imperialistico per il proprio capitale nazionale. Sul versante asiatico il Giappone, cercava di affermare il proprio dominio esclusivo sull’estremo oriente e sulla Cina in particolare. Ma le potenze vincitrici, non erano disposte a tollerare tale espansionismo che entrava in conflitto con i propri interessi imperialistici. Ancora una volta le contraddizioni del capitalismo e la competizione tra le grandi potenze creavano le condizioni per un nuovo conflitto mondiale. Come nel caso della Prima Guerra Mondiale mancava solo la scintilla per innescare l’incendio di cui nel frattempo si erano andate accumulando tutte le premesse. Il secondo conflitto mondiale fu ancora più generalizzato e devastante del primo. Esso fu condotto con armi ancora più distruttive del precedente, adeguate all’ulteriore sviluppo delle forze produttive determinatosi nel frattempo, provocando morti cinque volte superiori. Ma la vera novità di questo conflitto fu che esso non coinvolse soltanto gli eserciti sulle linee dei vari fronti esistenti. Entrambi gli schieramenti, che ora disponevano di una micidiale aviazione militare, quasi del tutto assente nel primo conflitto, mirarono da subito a colpire le infrastrutture produttive e le città dei propri avversari. Intere aree industriali furono distrutte mentre città grandi e piccole venivano rase al suolo con la giustificazione che si trattava di distruggere le potenzialità produttive dei propri avversari per impedirgli di continuare la guerra e di suscitare nella popolazione urbana colpita dai bombardamenti la rivolta contro i propri governanti. Gli unici che riuscirono a sottrarsi a tale destino furono gli Usa per la distanza del proprio paese dai teatri di guerra e per la mancanza da parte dei propri avversari di basi di appoggio nel continente americano. E gli Usa furono il vero vincitore di questo nuovo conflitto. Le immani distruzioni provocate nelle altre nazioni belligeranti questa volta furono di proporzioni tali, in termini di uomini e di beni distrutti, che in alcuni casi si dovette ricominciare quasi da zero. Gli Usa, memori delle conseguenze del primo conflitto e consapevoli di aver creato un apparato produttivo e finanziario immenso, non applicarono le stesse misure draconiane agli avversari sconfitti, salvo per la Germania che fu divisa in due e fu privata ancora una volta di territori precedentemente controllati. Inondarono, invece, i paesi europei ed il Giappone di prestiti e di prodotti della propria industria per creare uno sbocco al loro gigantesco apparato produttivo e finanziario. Questa volta la ripresa ci fu davvero con la lunga ricostruzione durata almeno venti anni e con uno sfruttamento mai visto in precedenza dei paesi periferici, anche di quelli che nel frattempo avevano raggiunto la formale indipendenza politica. Eppure, nonostante ciò, alla fine degli anni ’70, gli Usa avvertono i primi segni di crisi e sono costretti a dichiarare la inconvertibilità in oro del dollaro impostosi nel frattempo come moneta di scambio internazionale. Una crisi che insieme alla poderosa crescita dei paesi ricostruiti dopo la guerra, fa riemergere la latente conflittualità tra Stati formalmente alleati. Nel frattempo il dopoguerra è stato punteggiato da conflitti regionali che hanno visto protagonisti soprattutto gli Usa per mantenere il proprio incontrastato dominio imperiale. Con la fine dell’Urss, che non rappresentava certamente un competitore economico, ma sicuramente era una potenza militare di livello mondiale, sembrava che il lungo dopoguerra fosse finalmente finito e con esso le tensioni internazionali. Ma è stato subito dopo la scomparsa del muro di Berlino che le aree di crisi sono rapidamente aumentate e si sono moltiplicati i conflitti militari. Nella maggior parte dei casi si è trattato di vere e proprie guerre di aggressione da parte degli Usa e dei suoi alleati per imporre il nuovo ordine mondiale su tutto il pianeta. Cento anni di guerre La Prima Guerra Mondiale fu salutata come “La guerra che avrebbe messo fine alle guerre”. Eppure – secondo uno studio dell’Università di Harvard – dal 1918 in poi circa 200 milioni di persone sono morte a causa, diretta o 21 indiretta, di guerre; resta, invece, incalcolabile il numero di invalidi, traumatizzati psichici e la distruzione di beni economici e culturali. La pianificata distruzione del “territorio del nemico” (le sue città, le fabbriche, le infrastrutture...) resa possibile dall’irrompere dell’arma aerea ha modificato il rapporto tra vittime civili e militari. Nella Prima Guerra mondiale, dei sedici milioni di morti “solo” cinque milioni (il 31%) erano civili; nella Seconda guerra mondiale (71 milioni di morti) i morti civili (48 milioni) costituiscono il 67%. Nelle guerre combattute negli ultimi tre decenni i morti civili arrivano ad essere il 90% del totale. Le nuove letali armi, sperimentate in questi ultimi anni sulla pelle di iracheni, palestinesi e afghani, non muteranno certo questo rapporto. La corsa a dotarsi di armi di distruzioni di massa (queste sì!) da parte di tutti gli eserciti è il segnale che una nuova tendenza alla guerra sta maturando confermando l’assoluta indifferenza verso la perdita di civili e la logica inumana e distruttrice di questo sistema. Ancora armi ‐ Le spese militari nel mondo Secondo il rapporto annuale dello Stockholm international peace research institute (Sipri), nel 2013 le spese militari nel mondo sono state pari a 1.747 miliardi di dollari, l’1,9 per cento in meno rispetto al 2012. L’andamento delle spese militari mondiali dal 1988 al 2013:
(Fonte: Sipri)
Il calo nel 2013 è dovuto soprattutto alla riduzione del 7,8 per cento del budget della difesa degli Stati Uniti rispetto all’anno precedente legata al quasi totale ritiro degli USA dall'Iraq e dall'Afghanistan. Gli Stati Uniti restano comunque il paese con la spesa militare più alta al mondo, 640 miliardi di dollari (in realtà quasi 1000 miliardi se si considerano i fondi extra bilancio), pari al 37 per cento del totale e superiore a quella degli altri primi nove paesi messi insieme. Alla luce degli ultimi avvenimenti (ritorno di migliaia di soldati in Irak ed i bombardamenti per la cosiddetta lotta all’ISIS) c’è da stare certi che questa riduzione sarà rapidamente recuperata. Anche in Europa occidentale, secondo il rapporto, le spese militari sono in calo (‐2,4 per cento). Fa eccezione solo la Germania, che ha speso il 2 per cento in più rispetto al 2012. Non è un caso che il Premio Nobel della Pace Obama, insieme al Segretario della Nato, ha richiamato tutti i leaders europei a portare la spesa militare ad almeno il 2 per cento del PIL. Come a dire: non siamo più disposti ad accollarci il grosso dei costi del mantenimento “dell’ordine internazionale” di cui anche voi beneficiate. In quasi tutto il resto del mondo, invece, le spese militari sono in aumento. Il bilancio della Cina è cresciuto del 7,4 per cento fino a raggiungere i 188 miliardi di dollari, l’11 per cento del totale. Anche la Russia ha aumentato le sue spese militari (+4,8 per cento), e, per la prima volta dal 2003, il rapporto tra spese militari e prodotto interno lordo ha superato quello degli Stati Uniti. In Medio Oriente le tensioni regionali continuano a gonfiare i bilanci militari. La spesa nella regione è salita del 4 per cento rispetto al 2012, ma il dato non include Iran, Qatar, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen, che non 22 hanno fornito cifre per il 2013. L’Arabia Saudita ha addirittura superato Regno Unito, Giappone e Francia diventando la quarta potenza al mondo per valore delle spese militari (+118 per cento rispetto al 2004). La crescita relativa di proporzioni maggiori si è registrata in Africa: +8,3% nel 2013, quasi 45 miliardi di dollari. Il Ghana ha raddoppiato le spese, mentre l'Algeria ha continuato la sua crescita fino a diventare il primo Paese africano a superare i 10 miliardi di assegnazione di fondi. I 15 paesi con le spesa militare più alta: (Fonte: Sipri)
Come mostra la tabella sui 15 maggiori "spender" militari, l'Italia si colloca all’ undicesima posizione con un budget della difesa pari a 32 miliardi di dollari Secondo il rapporto del SIPRI la spesa militare italiana sarebbe in diminuzione. In realtà, i dati presi in considerazione non tengono conto di tutte le altre spese riconducibili alla Difesa ma collocate in altri capitoli del bilancio dello Stato (es. le spese per i sistemi d’arma che sono finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico o le missioni internazionali che sono a carico del Ministero dell’Economia). Calcolando gli stanziamenti extra‐bilancio della Difesa, l'Italia arriva ad una spesa militare che può essere “stimata” in circa 40 miliardi di dollari. Nel 2013, ad es., sono aumentati in modo clamoroso rispetto all’anno precedente i fondi per l'acquisto di armamenti: complessivamente 5,5 miliardi di euro, grazie al contributo del ministero dello Sviluppo Economico che ha messo a disposizione 2.182 milioni per comprare sistemi militari. Gran parte di questi soldi servono per finanziare l'acquisto dei caccia europei Eurofighter. Dopo la denuncia dei movimenti, molto si è discusso sull’enormità dei costi del Lockheed F‐35 con tanto di ipocrite dichiarazioni di contrarietà da parte di quegli stessi partiti che quell’acquisto hanno deciso e con una deliberazione del Parlamento che nei fatti non ne annulla l’acquisto. Ma i 12 miliardi di euro stimati per gli F35 diventano bruscolini se rapportati ai 21,1 miliardi di euro previsti per gli Eurofighter e le decine di miliardi stanziati per gli altri programmi di acquisti pluriennali. A questa enormità di fondi che da sola basterebbe a garantire un salario a tutti, ad accrescere le spese sanitarie ed a garantire una scuola gratuita per tutti, vanno aggiunte le spese per le missioni internazionali. Nel 2011, in base ai dati della Difesa, erano 30 le missioni in ben 27 paesi con 8.181 militari impegnati, di cui oltre la metà operativi in Afganistan. Negli ultimi anni la spesa media annuale per queste cosiddette missioni è stata di circa 1,5 miliardi di euro con significativi aumenti in occasione di nuovi aggressioni ad altri stati. Nel caso dell’intervento italiano in Libia nel 2011, nei primi tre mesi furono spesi 700 milioni; il solo utilizzo della Portaerei Garibaldi è costato circa 135.000 euro al giorno per la sua gestione. 23 Secondo il Ministero degli Interni, per l’intervento in Libia il governo ha speso oltre 1 miliardo di euro. Da questo conto sono esclusi i costi degli ordigni sganciati. La presenza italiana in Afghanistan, è costata finora 4 miliardi e 150 milioni di euro. Anche in questo caso nella cifra non sono incluse le spese per munizioni ed altre dotazioni da combattimento. Queste spese, infatti, non rientrano negli stanziamenti per le missioni decisi dal Parlamento ogni sei mesi, ma sono extra: misure urgenti, incluse nel bilancio ordinario del ministero della Difesa così come altri esborsi per il sostegno delle operazioni internazionali. Nel 2011, ad es., per rimpiazzate i colpi esplosi in soli dodici mesi durante i combattimenti in Afghanistan, sono state acquistate oltre 59 milioni di pallottole, 22 mila granate, 832 razzi portatili, 2.630 bombe da mortaio pesante, 32 mila munizioni per fucili da cecchino, decine di migliaia di proiettili per i cannoni degli elicotteri d'assalto e dei blindati, per una spesa complessiva di oltre 113 milioni. Se la spesa militare è aumentata soprattutto fuori dagli USA ed Europa, la maggior parte del know how e della produzione dei sistemi d’armamento sono collocate in quest’area del mondo. Nella lista delle prime 100 aziende mondiali del settore bisogna arrivare alla posizione 25 per trovare una ditta fuori da questi confini. La holding italiana Finmeccanica è tra le prime dieci aziende produttrici di armi al mondo. La vendita di armi delle cento più grandi aziende del settore al mondo ha fatto registrare un incremento del 60% in termini reali dal 2002 al 2010, anno in cui ha raggiunto i 406 miliardi di dollari. Nel 2011, dopo l’attacco alla Libia, il direttore generale della MBDA (la compartecipata europea dei missili, nel capitale c'è pure Finmeccanica), Antoine Bouvier, dichiarò: “abbiamo ricevuto un feedback ( traduzione: i profitti ottenuti con il massacro di centinaia di migliaia di persone) molto positivo da parte delle campagne militari in Afghanistan, Libia e Costa d'Avorio, sulla MBDA attrezzature e il supporto fornito per le forze armate". Dopo il 2011 c’è stata la “guerra” in Siria, le diverse offensive di Israele contro Gaza, l’intervento francese in Mali, la manomissione dell’occidente ed i combattimenti in Ucraina, la repressione in Egitto, ecc. Il feedback è stato ancora più positivo ed anche per il futuro gli affari armati andranno a gonfie vele. Verso una Terza guerra mondiale? A parte la Seconda Guerra Mondiale, quasi tutte le guerre succedutesi in questi cento anni dalla Grande Guerra del ‘14‐‘18 sono state prevalentemente condotte direttamente dalle principali potenze economiche, o da esse attizzate, per affermare il proprio dominio sulle aree del pianeta che ritenevano essere di propria competenza. Questa strategia è stata perseguita soprattutto dagli Usa che a seguito del secondo conflitto mondiale sono emersi come il vero vincitore e come unica potenza globale. Ma, a partire dalla fine dell’Urss vi è stata una vera e propria escalation poiché ormai non vi era nessuna grande potenza che potesse impedire di imporre il “nuovo ordine mondiale” teorizzato dalla dirigenza statunitense. Si è trattato di vere e proprie guerre di aggressione a senso unico passando dalla ex Jugoslavia all’Iraq, dall’Afganistan alla Somalia, senza dimenticare il recente assalto alla Libia ed il tentativo di ripetere l’operazione con la Siria. Dopo aver provocato immani disastri attizzando delle rivolte più o meno etero dirette si fa finta di indignarsi per gli esiti del proprio intervento economico, diplomatico e militare. Così in Libia si scopre che l’intervento liberatorio condotto con micidiali bombardamenti ha prodotto un caos ingovernabile e l’Italia già si ricandida a riportare l’ordine con proprie truppe di occupazione, in realtà per ristabilire il proprio controllo su quel paese che storicamente ritiene far parte della propria area di influenza. Ancora più emblematica la vicenda siriana: in questo caso si è provveduto a finanziare ed armare l’opposizione al governo di quel paese per sottrarlo all’influenza russa ed aprire un varco alla possibilità di ridisegnare tutta la mappa politica del vicino oriente. Gli effetti di questa “distruzione creativa” sono stati l’affermazione dell’islamismo più radicale, prima quello di Al Qaeda e poi quella dello Stato Islamico, che orami dilaga anche in Iraq. A questo punto gli stessi che hanno provocato e favorito l’incendio si presentano come i pompieri per legittimare il proprio intervento militare diretto che finora gli era stato impossibile realizzare. Sono state tutte guerre condotte fuori dai confini delle grandi potenze, mascherate da operazioni di polizia internazionale, di interventi “umanitari”, di difesa della democrazia che hanno seminato morte e distruzione nei paesi che ne sono stati investiti in misura non minore a quelle del secondo conflitto mondiale. Il loro vero 24 scopo era di affermare l’egemonia statunitense e costringere quei paesi a sottomettersi ai diktat del grande capitale occidentale. Infatti se la potenza egemone erano senza dubbio gli Usa le altre “democrazie” occidentali sono intervenute direttamente ed indirettamente in queste aggressioni per partecipare, sia pure in maniera subalterna, alla politica di rapina e alla penetrazione del grande capitale. Eppure, nonostante l’affermazione incontrastata del liberismo più sfrenato che ha visto aumentare a dismisura lo sfruttamento dei lavoratori ed il predominio imperialista su aree sempre più ampie del pianeta, non si è riusciti ad evitare che le contraddizioni dell’economia capitalistica tornassero prepotentemente a manifestarsi. Dopo un lungo periodo d’incubazione queste sono sfociate in una crisi economica addirittura peggiore di quella del 1929, di cui non si intravede la fuoriuscita all’orizzonte. Insieme a tali contraddizioni si ripresentano i fenomeni di conflittualità crescente tra grandi potenze. Al momento il blocco occidentale mantiene la sua formale unità, anche se aumentano le frizioni al suo interno. È soprattutto nei confronti di Russia e Cina però, le due principali potenze emergenti, che sono indirizzate le manovre di accerchiamento, per impedire che esse si affermino come potenze globali in grado di contrastare il dominio degli Usa e dei suoi alleati. La vicenda ucraina e quella siriana si inscrivono a pieno titolo nelle manovre di accerchiamento della Russia per sottrarle le residue aree di influenza e costringerla ad abbandonare ogni velleità di grande potenza mondiale, per sottometterla in maniera subalterna alla penetrazione dei capitali occidentali. L’insediamento di basi militari nei diversi paesi del blocco sovietico, la loro adesione alla Nato, fanno parte di questo piano strategico. Così come le basi, gli accordi militari ed economici nell’area del Pacifico rappresentano un parallelo tentativo di accerchiamento della potenza cinese per stroncare sul nascere ogni ambizione di sottrarsi al ruolo di semplice officina del mondo e trasformarsi a sua volta in una grande potenza imperialista. Ma in questo caso non si tratta di bocconi relativamente piccoli come i precedenti, bensì di potenze economiche e soprattutto militari di tutto rispetto. Paesi dotati di armamenti nucleari, oltre che di altre micidiali armi di distruzione di massa assai difficili da neutralizzare con un unico grande colpo inferto al momento dell’attacco, come avviene nei sogni dei dott. Stranamore statunitensi. In tale contesto, e sotto le impellenze della crisi assolutamente non risolta, la miscela esplosiva per l’innesco di un nuovo conflitto mondiale va accumulandosi, anche ben oltre le stesse intenzioni degli artefici del crescente interventismo militare. Essi in fondo non sono che le maschere di un regista ben più potente di loro che detta le regole del gioco in maniera ferrea: il grande capitale internazionale e le sue necessità di tutelale le esigenze di una continua accumulazione, di difendere e rafforzare i profitti e con essi i privilegi di classe che esso assicura ai suoi attori. Quando una simile condizione si va determinando “l’incidente di percorso”, deliberatamente cercato o capitato accidentalmente, è sempre a portata di mano. Ma esso non rappresenta che l’innesco più o meno casuale di quella miscela esplosiva che deliberatamente si è contribuito ad alimentare. La crescente corsa agli armamenti, il rinnovato patriottismo e nazionalismo che si cerca di diffondere a piene mani e di cui la stessa campagna di celebrazione del I° conflitto mondiale rappresenta uno dei tasselli decisivi, fanno parte di quel materiale incendiario che i nostri governanti, le istituzioni, la grande stampa ed i padroni vanno accumulando, mentre fanno finta di ripudiare la guerra e di desiderare la pace universale. Mettere in evidenza le ragioni economiche dell’avvicinarsi del clima di guerra è necessario per denunciare che i conflitti militari in cui sono impegnate le nostre truppe non sono altra cosa dalla guerra ultradecennale, ed in via di accentuazione, dichiarata dai governi e padroni alle nostre condizioni di vita e di lavoro, ma ne rappresenta semplicemente l’altra faccia della medaglia. Un esito obbligato, se non viene efficacemente contrastato, di un’economia fondata sulla continua ricerca di maggiori profitti e che, nonostante l’enorme incremento dello sfruttamento di questi anni, tanto nel centro che nelle periferie, non riesce a risollevarsi dalle insanabili contraddizioni da essa stessa determinate. Rete Napoli No War Napoli, gennaio 2015 25