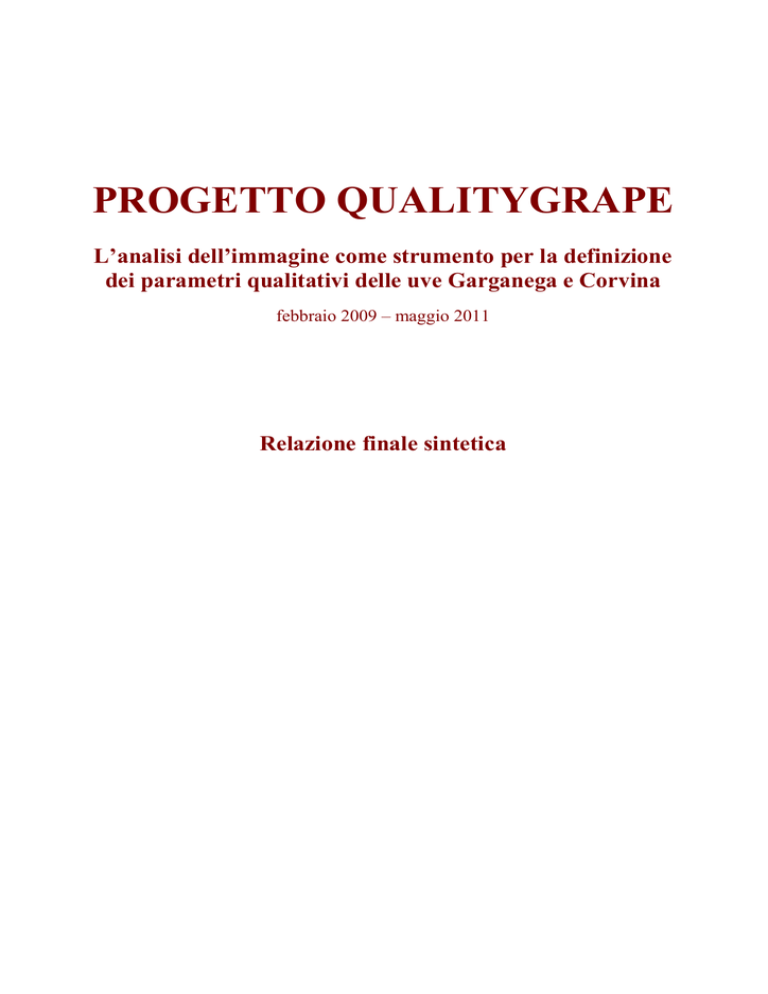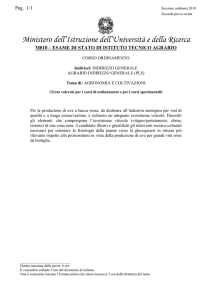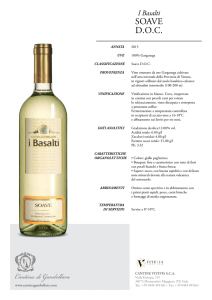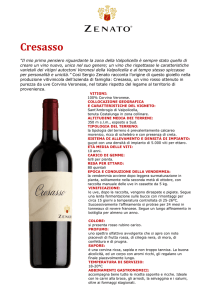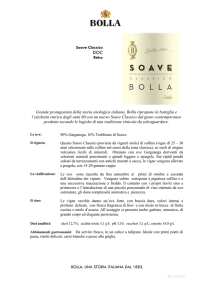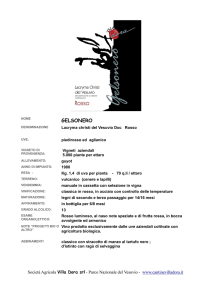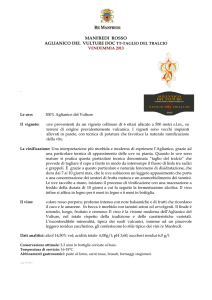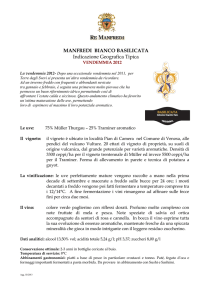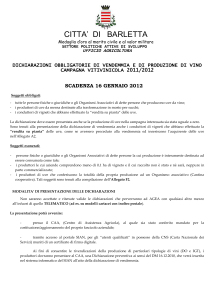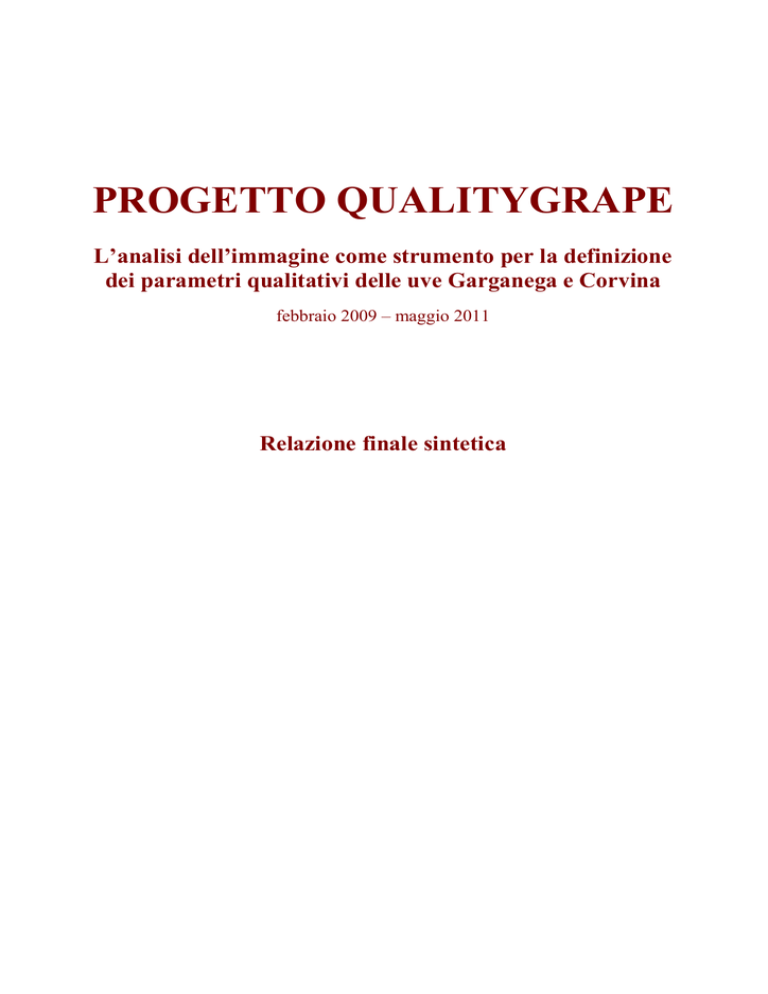
PROGETTO QUALITYGRAPE
L’analisi dell’immagine come strumento per la definizione
dei parametri qualitativi delle uve Garganega e Corvina
febbraio 2009 – maggio 2011
Relazione finale sintetica
1. Premessa
Il presente documento costituisce una relazione di sintesi sulle attività del progetto Quality Grape
“L’analisi dell’immagine come strumento per la definizione dei parametri qualitativi delle uve
Garganega e Corvina”.
2. Obiettivi
Il progetto ha lo scopo principale di verificare la possibilità di mettere a punto un nuovo sistema non
distruttivo, basato sull’analisi dell’immagine, che possa servire per fornire dati da collegare con le
caratteristiche di qualità delle uve Garganega e Corvina, determinate sulla base di indici analitici, e
da utilizzare come indici predittivi della qualità enologica e per la selezione di uve diverse
3. Articolazione del progetto.
Nei tre anni, il progetto si è articolato schematicamente in tre diverse attività.
Attività in vigneto
In questa serie di attività sono stati esaminati, nelle 2 annate successive, campioni di uve delle
varietà Corvina e Garganega, prelevati da tre vigneti diversi situati a altitudini diverse e in tre diversi
periodi di maturazione. Le uve sono state fotografate in vigneto, raccolte ed analizzate per i
parametri chimici classici. Inoltre, sulle uve di Garganega sono stati determinati analiticamente,
separatamente nelle polpe e nelle bucce, sia le sostanze polifenoliche più importanti e collegate alla
qualità dei vini (acidi idrossicinnammil tartarici, HCTA nelle loro varie forme, e i flavonoli) sia le
sostanze aromatiche (singole molecole appartenenti alle famiglie degli alcoli, benzenoidi, terpenoidi,
isoprenoidi). Per la Corvina sono stati determinati i flavonoli (miricetina, quercetina e campferolo)
gli HCTA e gli antociani (cianina, petunidina, peonidina e malvina), nelle loro varie forme.
I parametri così determinati sono stati poi messi in relazione ai dati ottenuti dall’analisi
dell’immagine, in modo da cercare eventuali correlazioni tra loro.
Nei due anni si sono utilizzati a questo scopo due approcci diversi. Nell’anno 2009 si sono prelevate
immagini di singoli grappoli rappresentativi dei vigneti, seguendoli durante il periodo di
maturazione. In questo caso le analisi chimiche sono state effettuate su uve provenienti da piante
adiacenti e simili a quelle che portavano i grappoli seguiti con l’analisi dell’immagine. Questo
approccio serviva a verificare la possibilità di collegare le variazioni dei parametri tecnologici
dell’uva dell’intero vigneto con i dati di immagine prelevati da piante rappresentative dello stesso.
Nel 2010, al contrario, sono stati analizzati chimicamente gli stessi grappoli da cui erano stare
prelevate le immagini. In questo caso si voleva confermare la corrispondenza precisa tra variazioni
di colore dei singoli grappoli e delle loro caratteristiche chimiche.
Attività in cantina: Microvinificazioni
Questa seconda attività ha previsto, nei due anni successivi, di verificare se sia possibile poter
prevedere le caratteristiche qualitative dei vini sulla base dei dati ricavabili dall’analisi
dell’immagine delle uve di partenza. A questo scopo, cassette di uve delle due varietà, raccolte nelle
tre epoche di maturazione diverse e provenienti dai diversi vigneti, sono state fotografate e le uve
delle cassette sottoposte a microvinificazione secondo protocolli standardizzati. I vini ottenuti stato
sono stati analizzati sia chimicamente che sensorialmente.
I dati ottenuti dall’analisi visiva delle cassette di uva sono quindi stati messi in relazione statistica sia
con i parametri chimici determinati sui vini sia con i risultati delle analisi sensoriali.
Attività in cantina: Vinificazioni industriali
Questa terza attività aveva il fine di stabilire se la selezione dei carichi di uva conferiti, effettuata
sulla base dei dati di immagine ottenuta attraverso uno strumento dedicato (Qualiris Reception),
posizionato all’ingresso della cantina, potesse avere degli effetti sulla qualità dei vini ottenuti.
4. Metodi
Rilevazione dei dati di immagine
Si sono utilizzati lo strumento portatile Qualiris Grappes per l’acquisizione dei dati raccolti in
vigneto, e lo strumento fisso Qualiris Reception per quelli raccolti al conferimento delle uve in
cantina. Entrambi gli strumenti funzionano sullo stesso principio: una fotocamera acquisisce, sotto
una luce artificiale, un’immagine digitale che viene trasferita ad un PC, che è in grado di quantificare
le diverse componenti colorimetriche dell’immagine, fornendo dati numerici precisi per ogni gruppo
di lunghezze d’onda. Gli strumenti utilizzati permettono di scattare foto a colori con una alta
risoluzione, senza contatto fisico e velocemente.
Analisi chimiche
Le analisi eseguite sui campioni di uva (peso medio degli acini, grado Brix, zuccheri riducenti,
glucosio, fruttosio, acidità totale, pH, acidi tartarico e malico, densità ottica a 280, antociani estraibili
a pH1 e a pH 3.2, Azoto prontamente assimilabile (APA), sono state eseguite con metodi standard
consolidati, e con analizzatore Foss.
Le determinazioni degli indici e dei profili polifenolici nelle uve sono state eseguite rispettivamente
mediante analisi spettrofotometrica UV-Vis ed analisi HPLC . Le determinazioni degli aromi sono
state eseguite mediante gascromatografia/ spettrometria di massa (GC-MS).
Analisi sensoriali
L’analisi sensoriale dei vini è stata effettuata utilizzando una scheda che prevedeva il rilievo dei
principali descrittori dei vini utilizzando una procedura di tipo QDA e, inoltre, venivano ad essere
quantificati alcuni dei descrittori come presenza/assenza. Il numero dei giudici che ha partecipato al
panel è stato compreso fra 10 e 15.
L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando il test ANOVA e le differenze fra le medie sono state
valutate utilizzando la differenza minima significativa e il test HSD Tukey (P<0.05).
I dati provenienti dalle fotografie (percentuale di pixel appartenenti ad una determinata banda)e sono
stati utilizzati per prevedere il contenuto delle differenti molecole presenti nelle uve e nel vino
attraverso un modello di regressione multipla lineare utilizzando una procedura “Stepwise” con il
limite di inclusione del 5%. Per la valutazione dei dati dell’analisi sensoriale inerenti la
presenza/assenza dei descrittori è stato utilizzato il test χ2.
5. Attività 1 - Analisi dell’immagine in vigneto: Caratterizzazione delle
uve di da vigneti diversi durante la maturazione
Individuazione dei vigneti
Si sono identificati tre vigneti, con caratteristiche diverse, per ogni varietà (A, B, C per la Corvina e
D, E, e F per la Garganega)
5.1. Attività di sperimentazione anno 2009
Analisi dei campioni di uva
All’interno di ognuno dei vigneti prescelti si sono identificate tre ripetizioni di due o più filari.
All’interno delle ripetizioni sono state scelte 10 piante sulle quali si sono scelti 5 grappoli/pianta (50
grappoli/ripetizione.
Ogni grappolo è stato fotografato con lo strumento Qualiris grappes in tre epoche diverse (periodo
precedente alla maturità tecnologica, alla maturità tecnologica e dopo una settimana dalla la maturità
tecnologica. Dai grappoli sono stati quindi prelevati campioni di racimoli.
Analisi dell’immagine
Le diverse immagini digitali ottenute nel corso della maturazione dei grappoli sono state sottoposte
ad elaborazione, estraendo da ognuna di esse i valori di differenti componenti colorimetriche, (blu,
rosa, viola, giallo, verde, marrone).
I dati ottenuti indicano che, la variabilità delle componenti colorimetriche esaminate è abbastanza
contenuta da permettere di differenziarle tra loro. Si possono notare variazioni nell’andamento delle
componenti colorimetriche esaminate sia in relazione all’epoca che alla posizione altimetrica del
vigneto, anche se appare difficile individuare un andamento preciso che si confermi nelle due
diverse annate.
Per il 2009 sembra che la componente che aumenta per la Garganega sia il marrone e per la Corvina
siano il viola e il rosa, mentre il verde sembra diminuire per entrambe le varietà. Questi andamenti
potrebbero essere collegati ad aumenti nella sintesi (flavonoidi, antociani) e nella degradazione
(clorofilla) di pigmenti.
Analisi Chimiche
Nel 2009 le uve da sottoporre alle analisi chimiche sono state prelevate da piante, diverse da quelle
che portavano i grappoli fotografati, ma ad esse analoghe, per non dover sacrificare i grappoli da
fotografare nei tre momenti successivi.
I campioni di uva sono stati analizzati chimicamente, per poter correlare i dati analitici con i dati
colorimetrici. Inoltre, al fine di verificare la possibilità di avere indicazioni sulla maturità fenolica e
aromatica, le polpe e le bucce delle uve delle due varietà sono state analizzate, separatamente , per il
contenuto in componenti polifenolici e aromatici.
In generale, per entrambe le varietà, gli andamenti dei parametri tecnologici rispecchiano un
andamento della maturazione normale, con alcune differenze quantitative, nelle diverse epoche, tra
vigneti. Benché questo non sia oggetto specifico del progetto, i dati ottenuti possono essere utili
anche per avere un riferimento generale sulle cinetiche di maturazione delle due varietà Corvina e
Garganega in relazione alle condizioni di coltivazione.
Relazione tra dati colorimetrici e composizione chimica delle uve
L’analisi statistica di Regressione multipla è stata applicata ai campioni del 2009 considerando
ognuno dei parametri chimici considerati in relazione alle diverse componenti colorimetriche
(percentuale di pixel appartenenti ad una determinata banda rispetto al totale dei pixel).
I parametri statistici determinati indicavano che le componenti colorimetriche che mostravano
significatività per ognuno dei parametri chimici possono spiegare (R2) in nessun caso più del 40%
della varianza. In particolare, per la Corvina, il parametro con R2 più elevato era il contenuto in
zuccheri (R2 ≈ 40%) mentre l’acidità totale mostrava un R2 più basso (≈ 13%). Gli antociani totali
avevano un R2 ≈ 28% e i flavonoidi totali di 27%, ma le loro singole componenti, valutate
analiticamente mostravano R2 variabili a seconda del composto considerato. Per la Garganega l’R2
per gli zuccheri era 24%, mentre per il pH ≈ 32%. Inoltre per la Garganega l’R2 per le singole
componenti aromatiche e per le sostanze polifenoliche era sempre piuttosto basso, raggiungendo il
massimo di ≈ 20 per il 2-esenale.
Alcuni risultati più significativi sono sintetizzati nella seguente tabella.
Uve CORVINA
R2 %
Parametri qualitativi
Parametri colorimetrici correlati
zuccheri
acidità totale
DO 280 (pH 3,2)
antociani (A1)
antociani (A3,2)
zuccheri/acidità
Mp
Ea %
peso medio acino
rosa, verde, marrone
blu, violetto, verde
rosa, giallo, verde, marrone
rosa, giallo, marrone
rosa, giallo, verde, marrone
roa, violetto, verde, marrone
rosa, giallo, verde, marrone
rosa, violetto, verde
blu, rosa, giallo, verde
Flavonoli bucce
miricetina glucuronide
miricetina glucoside
quercetina glucuronide
quercetina glucoside
campferolo glucuronide
campferolo glucoside
parametri visivi (Qualiris grappes)
giallo, marrone
rosa, giallo, verde, marrone
rosa, giallo, verde, marrone
rosa, giallo,marrone
rosa, giallo, marrone
rosa, giallo, marrone
6
10
9
16
18
18
rosa, violetto
blu, violetto, verde
blu, verde, marrone
blu, verde
blu, giallo, verde, marrone
giallo, violetto, verde, marrone
19
18
22
23
10
9
HCTA bucce
ac. Cis-caffeil tartarico
ac. Trans caffeil tartarico
ac. Cis p cumaril tartarico
ac. Trans p cumaril tartarico
ac. Trans feruil tartarico
ac. 2 S glutationil.caffeil tartarico
39
13
5
11
19,5
23
21,5
11
4
HCTA polpe
ac. Cis-caffeil tartarico
ac. Trans caffeil tartarico
ac. Cis p cumaril tartarico
ac. Trans p cumaril tartarico
ac. Trans feruil tartarico
ac. 2 S glutationil.caffeil tartarico
Antociani
delfinidina
cianina
petunidina
peonidina
malvina
Dp glucoside acetato
Cy glucoside acetato
Pt glucoside acetato
Pn glucoside acetato
Mv glucoside acetato
Dp glucoside paracumarato
Pn + Mv glucoside caffeato
Cy glucoside paracumarato
Pt glucoside paracumarato
Pn + Mv glucoside paracumarato
antociani totali (Malvina )
Flavonoidi totali (+ catechina)
giallo, verde
blu, verde, marrone
rosa, verde, marrone
blu, verde, marrone
guallo, verde, marrone
blu, giallo, marrone
marrone
rosa, giallo, verde
blu, verde, marrone
rosa, verde, marrone
rosa, verde, marrone
giallo, verde, marrone
giallo verde
giallo, verde, marrone
giallo, marrone
giallo, viola, marrone
rosa, verde, marrone
rosa, verde, marrone
rosa, verde, marrone
rosa, verde, marrone
rosa, verde
rosa violetto, verde
rosa, giallo, verde
R2 %
1,4
23,5
29,2
34
9,4
28
R2 %
2,8
10
14
18
27
12
27
10
3
2
13
23
12
19
19
28
27
Uve GARGANEGA
Parametri qualitativi
Parametri colorimetrici correlati
R2 %
zuccheri riduttori
glucosio
fruttosio
pH
acido malico
acido tartarico
apa
(Qualiris grappes)
giallo, verde, marrone
blu, violetto, verde, marrone
giallo, verde, marrone
rosa, giallo, verde
rosa, giallo, verde
blu, rosa, verde, marrone
rosa, giallo, verde
alcoli
1-butanolo
3- metil 1 butanolo
2- esenale
3- metil-buten-1-olo
3- metil 2 buten 1 olo
1-esanolo
parametri visivi (Qualiris grappes)
verde, marrone
giallo
blu, rosa, marrone
giallo
rosa, giallo
giallo
R2 %
11
2
29
3
3
0,5
terpenoli
trans furan linalolo
trans piran linalolo
geraniolo
trans-8-oH linalolo
OH geraniolo
cis-OH_linalolo
Terpenoli totali
parametri visivi (Qualiris grappes)
violetto, marrone
rosa, marrone
rosa, giallo
violetto, marrone
violetto, marrone
blu, violetto, verde
blu, giallo, violetto, marrone
R2 %
15,5
6,5
4,6
15
8
4
5,6
rosa, marrone
blu, giallo, marrone
giallo, verde
giallo
violetto, marrone
R2 %
12
4
5
2
10
Benzenoidi
metil salicilato
alcol benzilico
beta fenil etanolo
acetovanillone
alcol omovanillico
Norisoprenoidi
3 oH beta damascone
3- oxo alfa ionolo
3, 9 diidrossimegastigma- 5- ene
3-OH, 7, 8-deidro-beta- ionolo
vomifoliolo
norisoprenoidi totali
HCTA bucce
ac. Cis-caffeil tartarico
ac. Trans caffeil tartarico
ac. Cis p cumaril tartarico
marrone
giallo, violetto, verde
blu, violetto, marrone
giallo
giallo
giallo, verde
giallo
giallo
verde
24
18
27
42
35,4
30
40,6
R2 %
3,6
7
18,7
2
2
5
R2 %
3,7
1,5
5,8
ac. Trans p cumaril tartarico
ac. Trans feruil tartarico
ac. 2 S glutationil.caffeil tartarico
verde, marrone
1,8
verde
0,6
Flavonoli bucce
quercetina glucuronide
quercetina glucoside
campferolo glucuronide
campferolo glucoside
giallo, verde
blu, rosa, verde
giallo
giallo
R2 %
10,6
3
2,9
0,8
HCTA polpe
ac. Cis-caffeil tartarico
ac. Trans caffeil tartarico
ac. Cis p cumaril tartarico
ac. Trans p cumaril tartarico
ac. Trans feruil tartarico
ac. 2 S glutationil.caffeil tartarico
parametri visivi (Qualiris grappes)
blu, violetto, marrone
blu, marrone
marrone
blu, marrone
blu, rosa, verde, marrone
rosa, giallo, marrone
R2 %
9
2,8
0,8
6
5,7
5,6
5.2. Attività di sperimentazione anno 2010
Campioni di uva
Nel 2010, si è proceduto a un campionamento che potesse dare indicazioni più puntuali sulle
relazioni tra dati chimico-analitici e immagine visiva di un singolo medesimo grappolo.
Sono stati scelti tre vigneti di Garganega e tre vigneti di Corvina diversi.
Per ognuna delle piante sono stati contrassegnati 2 grappoli destinati al campionamento. Al termine
di ogni campionamento le immagini di ogni data di campionamento sono state scaricate sul PC e
archiviate.
Analisi dell’immagine
I dati colorimetrici per i singoli grappoli sono stati messi in relazione con le epoche di raccolta e con
i vigneti di provenienza. Nel caso della Corvina i dati ottenuti per singoli colori (in particolare blu,
rosa, giallo e verde) sembrano indicare meglio di quanto visto nel 2009 l’andamento della
maturazione e la posizione altimetrica del vigneto. Per esempio, il giallo e il verde diminuiscono
chiaramente con l’aumentare sia del grado di maturazione sia dell’altitudine del vigneto.
Per la Garganega i migliori risultati si ottengono in relazione all’epoca di maturazione con il il
marrone (che aumenta) e il giallo e il verde (che diminuiscono). Anche in questo caso dunque
sembra che si possano misurare variazioni di alcune componenti colorimetriche che ben rispecchiano
l’andamento della maturazione (in termini di epoca), quasi sicuramente sulla base della variazione
nel contenuto in pigmenti della uva.
Analisi chimiche
I singoli grappoli prescelti sono stati sottoposti ad analisi dei parametri chimici come nell’anno
precedente.
I singoli grappoli prescelti sono stati poi analizzati, per le componenti polifenoliche (HCTA,
flavonoli ed antociani) e per i precursori di aromi.
I risultati dell’analisi sono stati archiviati all’interno di un database in formato excel e sono
disponibili.
Anche nell’annata 2010 la variazione dei parametri di maturazione tecnologica seguono l’andamento
noto per le uve. Inoltre, i risultati riguardanti l’analisi dei metaboliti secondari (polifenoli e aromi),
aggiungendosi a quelli relativi all’anno 2009, vengono a costituire una banca dati importante a cui
fare riferimento per una conoscenza dettagliata delle varietà Corvina e Garganega.
Relazione tra dati colorimetrici e composizione chimica delle uve
Anche per i campioni analizzati nell’anno 2010 si sono cercate le relazioni statisticamente
significative tra componenti colorimetriche e caratteristiche chimiche. In questo caso, come sopra
accennato, la variabile legata alla modalità di campionamento è venuta a cadere, in quanto lo stesso
grappolo analizzato per i colori veniva sottoposto alle analisi chimiche, consentendo di determinare
una relazione diretta tra dati colorimetrica e chimici.
Per quasi tutti i parametri si confermano i dati dell’annata 2009, sia per la Corvina che per la
Garganega.
5.3. Conclusioni
Dai dati raccolti in questa prima parte della ricerca , che ha tentato di verificare la possibilità di
collegare variazioni nel “pattern” colorimetrico delle uve con variazioni nella composizione chimica
riferita a parametri tecnologici e a metaboliti secondari importanti per la qualità del vino, si può
concludere che alcune di queste caratteristiche possono essere spiegate con bassissima possibilità di
errore, ma solo molto parzialmente (R2 non elevati), sulla base dei dati raccolti tramite l’analisi
dell’immagine. Non è possibile dunque indicare in modo certo un determinato parametro
colorimetrico la cui variazione possa consentire di fare previsioni affidabili sulle variazioni di
caratteristiche compositive delle uve. Inoltre, sembra che, per avere dati rappresentativi dell’intero
vigneto, sia necessario acquisire una altissima quantità di dati di immagine, confermando che ogni
acino segue la propria cinetica di maturazione, il che risulta in definitiva nell’impossibilità pratica di
ottenere acini rappresentativi dell’intero vigneto.
Si è dunque verificato che non è possibile, con l’approccio adottato, utilizzare a fini pratici l’analisi
dell’immagine come metodo veloce e non invasivo per seguire e caratterizzare le uve durante la loro
maturazione in condizioni differenti. Tuttavia, la grande massa di dati analitici acquisiti durante i due
anni di indagine costituisce senza dubbio una risorsa preziosa per la conoscenza approfondita delle
caratteristiche delle uve di Corvina e di Garganega.
6. Attività 2 - Analisi dell’immagine in cantina: microvinificazioni
La seconda attività ha riguardato la verifica della possibilità di collegare i dati colorimetrici acquisiti
per diverse partite di uva vendemmiata e le caratteristiche compositive e sensoriali dei vini desse
ottenuti tramite esperimenti di microvinificazione in condizioni standardizzate.
Le uve sono state raccolte in cassette e trasportate in cantina dove sono state fotografate con lo
strumento fisso Qualiris Reception. Quindi le uve delle cassette sono state microvinificate.
6.1. Garganega - Microvinificazioni
Nel 2009 e nel 20101, si sono effettuate una raccolta anticipata, una raccolta a maturità tecnologica ,
e una raccolta posticipata, in fase di lieve surmaturazione.
Le cassette, al momento dell’arrivo in cantina, sono state fotografate con lo strumento Qualiris
Reception. Si riportano di seguito, a titolo di esempio, le immagini e i corrispondenti dati
colorimetrici per i campioni provenienti dal vigneto D nelle tre epoche di raccolta dell’anno 2009.
1
2
3
Garganega: immagini delle cassette
1 Vigneto D raccolta del 23/09; 2. Vigneto D raccolta del 30/09; 3. Vigneto D raccolta del8/10.
Analisi dell’immagine delle cassette: variazioni delle componenti del giallo, giallo scuro e verde
nelle tre epoche di raccolta.
L’analisi colorimetrica ha chiaramente indicato, nel tempo, un aumento della componete gialla e
una diminuzione della componente verde.
In aggiunta alla microvinificazione delle uve provenienti dai vigneti-tipo si sono eseguite anche tre
microvinificazioni di uve Garganega selezionate sulla base del loro profilo di colore giallo (<60%,
60-80%, >80%).
I vini risultanti dalle microvinificazioni sono stati analizzati in dettaglio per i principali parametri
chimico-analitici. I dati ottenuti, e la loro elaborazione statistica sono disponibili.
I parametri visivi delle uve sono state mese in relazione con il metodo statistico della regressione
multipla con i risultati qualitativi dei vini, analitici e sensoriali.
I risultati riportati sono sintetizzati nella tabella seguente e mettono in evidenza interessanti relazioni
significative tra l’analisi dell’immagine, in grado in questo caso di prevedere con un ridotto margine
di errore (R2 elevati) i parametri qualitativi principali dei vini.
GARGANEGA
Parametri dei vini
Parametri colorimetrici
Alcol
acidità totale
I280
A320
Catechine
giallo, giallo scuro
marrone
giallo scuro
giallo scuro
giallo, giallo scuro, verde
R2 %
57
28
57
40
57
Inoltre, i vini sono stati sottoposti ad analisi sensoriale per valutare eventuali differenze in relazione
alla data di raccolta delle uve e alla posizione dei vigneti di provenienza, ma soprattutto in relazione
ai dati colorimetrici che risultavano dalla analisi dell’immagine delle casette contenenti l’uva di
partenza.
6.2. Analisi sensoriale dei vini Garganega
Nel 2009 le sensazioni rilevate dai singoli giudici sono risultate, all’analisi del chi quadro non
differenti per quanto riguarda la posizione del vigneto. Solo per la percezione odore di limone delle
uve scelte con percentuale di colore giallo inferiore al 60% si è avuta una maggiore incidenza delle
segnalazioni.
Sempre nello stesso anno alcuni descrittori relativi alla QDA sono risultati significativi rispetto alla
posizione del vigneto. In particolare è risultata significativa la differenza fra le posizioni per i
descrittori: intensità dell’aroma con riduzione del suo valore al crescere della quota e intensità del
gusto salato con progressione analoga al precedente. Per quanto riguarda le uve selezionate sulla
base della percentuale di giallo, le uve con componente di giallo maggiore dell’80% hanno prodotto
vini con gusto dolce inferiore alle altre. Si è osservata una proporzionalità inversa fra percentuale di
colore giallo e il parametro intensità dell’odore.
Nel 2010 le sensazioni rilevate dai singoli giudici non sono risultate essere significative all’analisi
del chi quadro per quanto riguarda il criterio di classificazione “posizione del vigneto”.
Nel 2010 sono state considerate anche le differenze fra le epoche di raccolta. Per questo criterio di
classificazione sono state riscontrate differenze nella frequenza di percezione da parte dei giudici
solo per il descrittore riflessi gialli a vantaggio dell’epoca di raccolta più tardiva.
Per quanto riguarda i descrittori rilevati tramite QDA sono state riscontrate le seguenti risposte alle
variazioni di altezza dei vigneti e dell’epoche di raccolta:
Intensità di
colore
il vino prodotto in collina presentava un valore più elevato rispetto alle altre due
posizioni. La seconda e la terza epoca di raccolta hanno presentato valori
superiori.
Intensità di odore Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
Intensità
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
dell’aroma
Intensità del
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
sapore dolce
Intensità del
Nessuna differenza fra le altitudini. L’epoca di vendemmia precoce si è
sapore salato
differenziata dall’intermedia
Intensità del
Nessuna differenza fra le altitudini. L’epoca di vendemmia precoce si è
sapore acido
differenziata dalle altre 2 epoche presentando valori maggiori di acidità
Intensità del
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
sapore amaro
L’analisi della regressione multipla (variabili indipendenti: valori colorimetrici delle foto delle
cassette di uva; variabili dipendenti: parametri sensoriali rilevati sui vini) ha permesso di verificare
che esistono solo pochi parametri in grado di essere previsti sulla base dei valori delle bande definiti
dalle fotografie sulle cassette di uva. Sono risultate significative l’intensità del colore e l’intensità
dell’aroma. Tuttavia, le due variabili risultate significative però presentano dei coefficienti di
determinazione piuttosto bassi. In questi due casi i colori che determinano la significatività della
regressione sono risultati essere il blu e il rosa per l’intensità del colore mentre solo il rosa per
l’intensità dell’aroma.
Si può quindi concludere che solo una piccola parte dei descrittori dei vini può essere prevista dai
dati colorimetrici rilevati tramite la fotografia delle uve. Ai fini della previsione della qualità dei vini
le relazioni trovate non sono particolarmente significative e quindi, al momento, non sembrano
essere utilizzabili. Si può ipotizzare però che la suddivisione in bande visive molto ampie, come
quelle qui utilizzate, limiti la possibilità di impiego di tali valori come indici predittivi.
Probabilmente, se la banda del visibile venisse suddivisa in più numerose sottobande la
significatività delle previsioni potrebbe essere incrementata, rendendo la metodica più efficace allo
scopo.
6.3. Corvina - Microvinificazioni
Anche nel caso delle uve corvina si è proceduto alla raccolta di campioni di uva dai vigneti
individuati (A, B, C) raccolte in tre epoche diverse.
Come esempio si riportano le immagini e la relativa analisi dei colori per le cassette di uve del
vigneto A, raccolte nelle date 22 e 29 settembre 2009.
1
1: Corvina, Vigneto A raccolta del 22/9
2
2: Corvina Vigneto A raccolta del 29/9
Analisi dell’immagine delle cassette: variazioni delle componenti colorimetriche in due epoche di
raccolta ( vigneto A)
Come per la Garganega, le uve sono state microvinificate secondo protocollo standard.
I vini ottenuti sono stati analizzati per i parametri chimici. I risultati, con la loro elaborazione
statistica che li relaziona all’epoca di raccolta e al vigneto, sono disponibili.
Anche nel caso della Corvina si possono notare lievi variazioni tra i diversi vini, sia in relazione
all’epoca di raccolta che al vigneto di provenienza. Queste differenze, evidentemente dovute a
diverse cinetiche di maturazione, rispecchiano la variabilità riscontrabile in zone ed epoche diverse,
e la loro evidenziazione precisa può essere considerata un ulteriore contributo alla conoscenza, in
termini enologici, dei due vitigni studiati.
I parametri visivi rilevati delle uve destinate a microvinificazione sono state mese in relazione con il
metodo statistico della regressione multipla con i risultati qualitativi dei vini, analitici e sensoriali.
I risultati sono sintetizzati nelle tabelle seguenti e mettono in evidenza relazioni significative tra
l’analisi dell’immagine, in grado in questo caso di prevedere con un ridotto margine di errore (R2
elevati) i parametri qualitativi principali dei vini.
CORVINA
Parametri dei vini
Parametri colorimetrici
Alcol
acidità totale
I280
A520
Int Colore
Polifenoli totali
Antociani liberi
Catechine
blu, violetto, rosa
Rosa
violetto, rosa
violetto, rosa
violetto, rosa
Violetto, rosa
blu, rosa
violetto
R2 %
84
35
71
83
77
39
50
42
I diversi vini da uva Corvina sono stati sottoposti ad analisi sensoriale, che hanno fornito dati da
correlare con le analisi colorimetriche delle cassette dell’ uva di partenza.
6.4. Analisi sensoriale dei vini Corvina
Nel 2009 le sensazioni rilevate dai singoli giudici sono risultate, all’analisi del chi quadro non
differenti per quanto riguarda la posizione del vigneto. Solo per la percezione Riflessi aranciati del
colore si è avuta una maggior incidenza delle segnalazioni nel vigneto di pianura.
Sempre nello stesso anno alcuni descrittori relativi alla QDA sono risultati significativi rispetto alla
posizione del vigneto, in particolare la differenza fra le posizioni per colore e intensità dell’odore.
Nel 2010 le sensazioni rilevate dai singoli giudici significative all’analisi del chi quadro sono
risultate essere maggiori rispetto all’anno precedente. In particolare i riflessi aranciati che avevano
caratterizzato il vini prodotto da uve raccolte in pianura si è confermato anche nel 2010 ma sono
state riscontrate anche delle differenze per quanto riguarda l’odore di cuoio e l’odore di viola. Nelle
uve provenienti dalla collina sono stati riscontrati con maggior frequenza i gli odori di cuoio e viola.
Nel 2010 sono state considerate anche le differenze fra le epoche di raccolta. Per questo criterio di
classificazione sono state riscontrate delle differenze nella frequenza di percezione da parte dei
giudici per l’odore di ciliegia, l’odore erbaceo, l’odore di lampone, l’odore di peperone, l’odore di
rosa e l’odore speziato. Per tutti questi descrittori i valori di maggiore frequenza sono stati
riscontrati nei vini provenienti da vigneti di collina.
Per quanto riguarda i descrittori rilevati tramite QDA sono state riscontrate le seguenti risposte alle
variazioni di altezza dei vigneti e dell’epoche di raccolta:
Intensità di colore
Intensità di odore
Intensità dell’aroma
Intensità del sapore
dolce
Intensità del sapore
salato
Intensità del sapore
il vino prodotto in collina presentava un valore più elevato rispetto alle altre
due posizioni. Non sono state riscontrate differenze fra le epoche
il vino prodotto in pianura presentava un valore più elevato rispetto alle altre
due posizioni. L’epoca di raccolta più tardiva ha presentato valori più elevati
il vino prodotto in collina presentava un valore più elevato rispetto alle altre
due posizioni. L’epoca di raccolta non ha influenzato questo parametro
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
acido
Intensità del sapore
amaro
Intensità del
descrittore
astringente
il vino prodotto in pianura presentava un valore più elevato rispetto alle altre
due posizioni. L’epoca di raccolta non ha influenzato questo parametro
Nessuna differenza fra le altitudini e le epoche di raccolta
L’analisi della regressione multipla (variabili indipendenti: valori colorimetrici dell’ uva; variabili
dipendenti: i principali parametri chimici dei vini) ha permesso di verificare che:
1) Tutti i parametri chimici sono risultati significativamente prevedibili sulla base dei valori delle
bande definiti dalle fotografie sulle cassette di uva.
2) Almeno alcune delle variabili risultate significative presentano dei coefficienti di
determinazione piuttosto alti, segno che questi parametri possono essere previsti con un ridotto
margine di incertezza a partire dall’analisi dell’immagine delle uve.
I colori che risultano determinare la significatività della regressione sono stati quasi sempre tutti
quelli presi in considerazione. Questo fatto potrebbe essere interpretato come un fenomeno legato
fondamentalmente alla maturazione delle uve: più le uve sono mature più i colori variano verso
tonalità tipiche della maturazione e, parallelamente, gli acini vengono ad assumere una
composizione, in termini di macrocomponenti, ma anche di metaboliti secondari, ottimale per essere
trasformati in un vino di qualità.
7. Attività 3 - Analisi dell’immagine in cantina: vinificazioni industriali
Al momento del conferimento dei carichi di uva in cantina durante la vendemmia, alla valutazione
della qualità chimica delle uve è stata affiancata la valutazione sistematica dei carichi attraverso
l’analisi dell’immagine eseguita con l’uso di Qualiris Reception.
Lo schema delle operazioni è riportato sotto.
L’analisi dell’immagine di ogni carico ha riguardato:
Corvina
% di corpi estranei sul totale
di cui % di raspi
Colore delle uve (analisi detratti i corpi
estranei):
% di blu
% di violetto
% di rosa
% di giallo scuro
% di giallo
% di verde
% di marrone
Garganega
% di corpi estranei sul totale
di cui % di raspi
Colore delle uve (analisi detratti i corpi
estranei):
% di giallo scuro
% giallo
% verde
% marrone
% alterazione
Oltre alle caratteristiche di colore, i parametri analizzati permettono di valutare:
1. la presenza di corpi estranei (foglie, piccioli, tralci ed altro) con la valutazione nel dettaglio della
presenza dei raspi.
2. La presenza di alterazione, (acini non integri, colorazione difforme a quella dell’uva).
Un esempio è riportato sotto per uve di Corvina.
L’analisi della regressione multipla tra il profilo visivo delle uve e l’analisi chimica dei campioni di
mosto prelevati è risultata per alcuni parametri significativa sebbene caratterizzata da R2 bassi e
pertanto dotata di scarsa predittività.
Corvina: Zuccheri, glucosio-fruttosio, acido tartarico, estratto, potassio, solfati, antociani, polifenoli
totali, malico e citrico (solo nella raccolta meccanica),
Garganega: zuccheri, acidità totale, acidità volatile, pH, malico, tartarico, APA, estratto, potassio,
gluconico.
Parametri per cui esiste una relazione significativa di regressione multipla con alcuni parametri
visivi
La fase successiva è consistita nella verifica della possibilità di applicare i parametri visivi come
criterio di selezione delle uve di diversa qualità e con diversa destinazione enologica.
Quindi, sono state definite le classi di colore sulla base delle quali effettuare la selezione su scala
industriale dei carichi.
Per la Corvina i carichi sono stati divisi in due classi sulla base della frequenza degli acini blu (<70%
e >70% per la raccolta manuale e <45% e >45% per la raccolta meccanica).
Dopo vinificazione su scala industriale, nei vini ottenuti da uve con maggiore percentuale di blu
ritroviamo maggiori contenuti in antociani totali e un maggiore intensità colorante.
Nei vini ottenuti da uve meno con minore % di blu si riscontra un maggiore contenuto in catechine e
in acidi idrossicinammici espressi come indice DO320 nm.
Alla degustazione tecnica i vini 2009 risultavano evidentemente diversi, con il vino derivato dalle
uve più blu più colorato e con caratteristiche di volume e struttura migliori.
Le differenze analitiche minori, seppure presenti riscontrate nei vini 2010 sono risultate invece
scarsamente percepibili organoletticamente.
I carchi di uva Garganega del 2009 sono stati selezionati sulla base della percentuale di Giallo
(>75% e <75%), mentre quelli del 2010 sulla base della percentuale di verde (>35% e <35%)
Le analisi chimiche dei mosti mettono in evidenza, le caratteristiche di maggiore maturazione delle
uve della selezione >75% di giallo.
Dopo 18 mesi le uniche differenze nel profilo analitico e fenolico dei vini sono a carico del
contenuto in catechine, doppie nella < 75% di giallo.
I vini 2010, ottenuti da uve più o meno verdi presentano differenze nel contenuto in polifenoli: il
vino da uve più verdi presenta un maggiore contenuto in polifenoli totali ma livelli più bassi sia
dell’indice DO 320 sia nella concentrazione in catechine.
La degustazione dei vini Garganega ottenuti su scala industriale ha permesso di evidenziare alcune
differenze, riscontrabili anche nel profilo analitico, sebbene non ci sia stata concordanza sulla
preferenza sui vini ottenuti da uno o dall’altro profilo visivo.
L’uso del colore come discriminante nella selezione delle uve non porta quindi a risultati certi e
univoci, per cui sono necessari ulteriori verifiche e test i cantina per la valutazione della relazione
che può esistere tra colore delle uve e qualità dei vini.
Nella valutazione dei carichi utilizzati è necessario utilizzare, insieme ad un parametro di colore (il
verde o il giallo) anche il livello di alterazione. Infatti diverso è il caso (e la qualità delle uve e dei
vini che se ne possono ottenere) se un carico presenta una bassa percentuale di verde perché
compensata da una elevata di giallo o se invece è il livello di alterazione ad essere elevato.
L’influenza del livello di alterazione valutato visivamente può rivestire un interesse fondamentale
nella valutazione delle uve bianche anche come parametro di apprezzamento o deprezzamento
economico delle uve, essendo la presenza dei marciumi particolarmente incisiva sulla qualità dei vini
bianchi.
Dai risultati ottenuti sembra che il sistema di analisi visiva dei carichi conferiti in cantina possa
essere in generale considerato con un metodo potenzialmente promettente per valutare su base
oggettiva la qualità delle uve, potendo discriminare le uve sulla base dell’alterazione, della presenza
di corpi estranei e anche del grado di maturità. Tuttavia, per una sua applicazione per la selezione di
uve destinate a produrre vini di qualità effettivamente diversa, sarà necessario trovare il modo di
suddividere i carichi selezionandoli in modo più discriminante sulla base delle classi di colore.