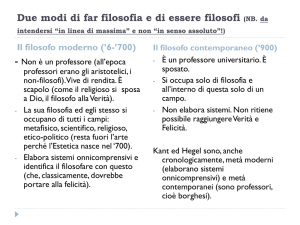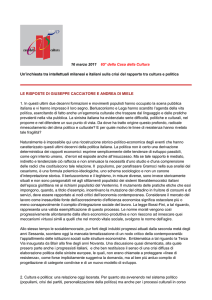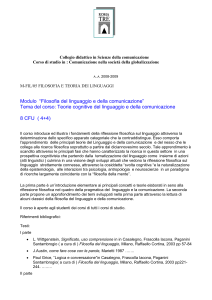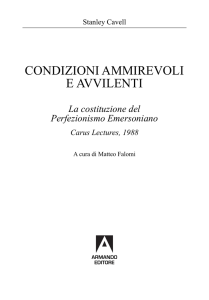540
Bollettino Filosofico XXVI (2010)
cerca di Lacan, in cui abbozza una «struttura quadripartita dell’inconscio» (p. 154),
nella quale trovano spazio, anche graficamente, i tre registri fondamentali della
sua teoria psicoanalitica.
Jacques Lacan ha ancora molto da dire alla cultura contemporanea e il testo di
Fabrizio Palombi ha senza dubbio il merito di stimolare la ricerca su un autore così
complesso e rilevante.
DAVIDE BRUZZESE
S. CAVELL, Little Did I Know: excerpts from memory, Stanford California, Stanford
University Press, 2010, pp. 558, € 27,31.
Cos’è la filosofia? Quale deve essere il tono di una pagina filosofica? Che cosa rende
filosofico il racconto della vita di un filosofo? È a partire da interrogativi come questi
che l’americano Stanley Cavell ha costruito l’edificio portante della sua opera filosofica. Fin dai suoi esordi teorici infatti, l’autore di Must we mean what we said? (1969) e
di The Claim of Reason (1979) si è interrogato sulle condizioni di possibilità della filosofia stessa, inseguendo l’immagine pura e universale di quella che egli definisce la
‘voce’ del filosofo, ossia ciò che si caratterizza come pretesa a parlare a nome di altri
e come esercizio di rappresentatività generica – dire ‘noi’ a partire da ‘io’ – all’interno di una comunità (passata, presente, futura, linguistica, filosofica, artistica) di
riferimento. Simili presupposti sottendono la necessità intellettuale di un confronto
sistematico e continuo con la riflessione autobiografica, al fine di poter attestare il
legame indissolubile esistente tra filosofia, autobiografia e una certa predisposizione
ordinaria all’arroganza, estrinsecabile nell’idea secondo la quale ogni filosofia, per
essere riconosciuta e accettata come tale, deve farsi portatrice di un claim: una presunzione sistematica della voce, espressa dall’uso universalizzante della prima persona plurale. Modelli filosofici fondamentali per Cavell, in tal senso, sono i cosiddetti
filosofi del linguaggio ordinario, ossia il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche e J.L.
Austin, quest’ultimo suo effettivo maestro, incontrato per la prima volta nella primavera del 1955 in occasione delle William James Lectures ad Harvard. Ma non si può
non annoverare nella cerchia delle personalità influenti alcuni autori afferenti al bacino teorico americano, come Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, massimi propugnatori di quel trascendentalismo che impregna le fondamenta dell’identità filosofica di Stanley Cavell. Ebbene, sedici anni dopo A Pitch of Philosophy. Autobiographical Exercises (1994), opera interamente dedicata all’intersezione tra filosofia
e autobiografia, viene data alle stampe la stesura definitiva dell’autobiografia vera e
propria di Cavell: Little Did I Know: excerpts from memory, datata 2010 – il primo capitolo del testo era già apparso in Critical Inquiry nell’estate del 2006. Little Did I Know
si compone di quattordici capitoli (parti), scomposti a loro volta in una serie di paragrafi, ognuno dei quali recante una data e un titolo. Le date non sono quelle relative
Recensioni
541
agli eventi passati raccontati, ma quelle in cui Cavell scrive. Si tratta di un aspetto
strutturale assai rilevante, poiché di fatto l’autore sceglie di adottare, come schema
temporale, un sistema di doppia datazione che prevede l’esplicitazione di tutta una
serie di ‘entrate’, grazie alle quali le memorie finiscono per risultare estratte dal
tempo della vita. L’operazione concettuale ivi compiuta ruota attorno all’immagine
del detour, letteralmente «deviazione». Ogni detour individua un momento di rottura, uno squarcio asincrono in cui si verifica l’innesto di un determinato passato nella
realtà presente. La biforcazione esistenziale che ne deriva si impone come attestazione di una crisi, esprimibile dalla domanda: perché ora e perché allora? Così gli
«ora» e gli «allora» trovano posto in un’impalcatura frattale di memorie riferite a
passati differenti. Lo scopo che si prefigge l’autore è quello di tracciare e, dunque, di
rendere manifesto il sentiero definitivo dell’esistenza, in modo che le memorie evocate dal racconto della sua vita possano contrassegnare ogni sforzo riconoscibile in
vista dell’ottenimento di una certa morte. Il riconoscimento in questione riguarda la
possibilità di testare il proprio grado di rappresentatività all’interno della comunità di
appartenenza, a partire da un atto originario di richiesta di autorizzazione a parlare
filosoficamente di sé. Ma cos’è che conferisce statuto filosofico al parlare di chi viene
considerato un filosofo? La scrittura di quei brani, di quelle memorie, di quelle deviazioni, deve poter esprimere una pretesa filosofica in base alla quale ciò che viene
raccontato possa essere accettato e riconosciuto come tale. È proprio la rivendicazione all’esistenza di un qualcosa che conferisce il diritto stesso a quell’esistenza: noi
non possiamo sapere nulla (da cui il «little did I know» del titolo: non lo sapevo affatto) fino al momento in cui non ci troviamo a dover affrontare una pretesa di rivendicazione per un qualcosa di tragicamente paradigmatico rispetto a quel nulla. Crisi
dopo crisi, seguendo il ritmo concitato di una reazione a catena, l’identità dello
Stanley Cavell filosofo assume possanza, nella linearità postuma di un sentiero, tanto
anonimo quanto accidentale: il rapporto conflittuale con il padre; l’ispirazione continua data dal talento musicale della madre; la consapevolezza di non poter fare della
musica la propria ragione di vita; la conseguente decisione di dedicarsi agli studi filosofici; l’immensa delusione provata di fronte all’impossibilità di prestare servizio militare, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, a causa di un danno subito all’orecchio destro, quando da bambino viene investito da una macchina in corsa; la
scelta di cambiare il proprio nome (da Goldstein a Cavell), prima di partire per andare a studiare a Berkeley; il dottorato ad Harvard e le difficoltà nell’elaborazione
della tesi finale; l’incontro determinante con personalità come Ernest Bloch e J.L.
Austin; il divorzio dalla prima moglie, il secondo matrimonio; gli studi sul teatro e
sul cinema; le aspettative amorose dei tre figli, spesso deluse; la solitudine, il senso
perenne di inadeguatezza, la malattia. La voce del filosofo sorge, dunque, dall’insieme delle sue memorie, come un edificio diroccato costruito sulla polvere di altre
macerie preesistenti.
SIMONA BUSNI