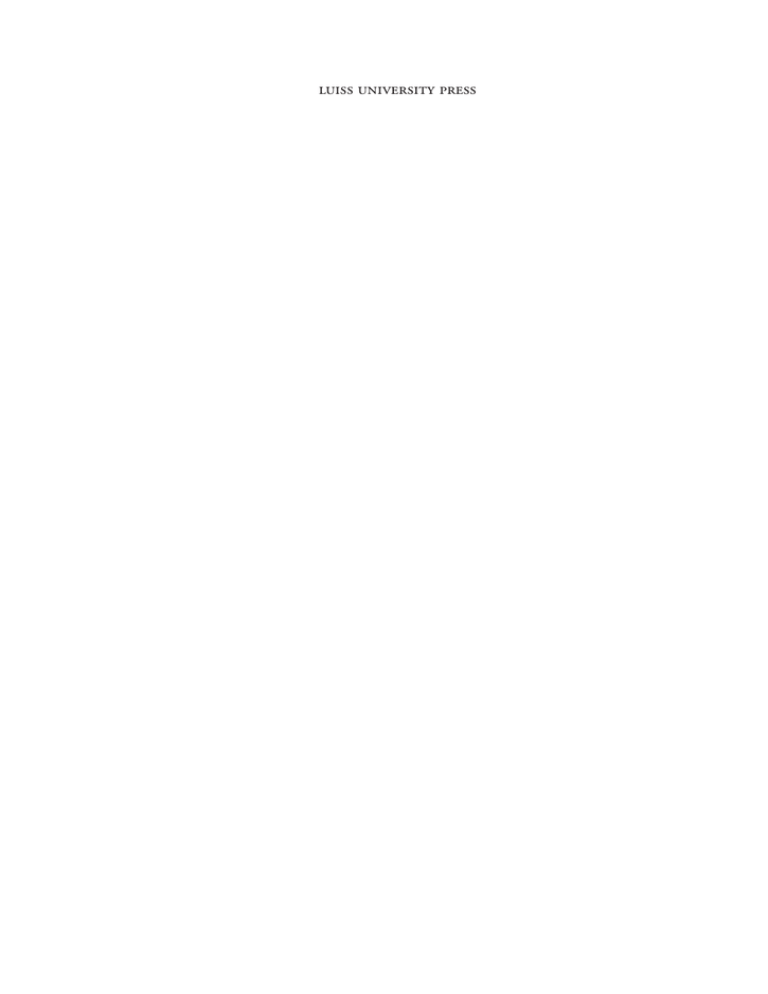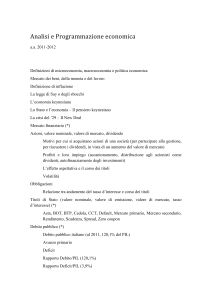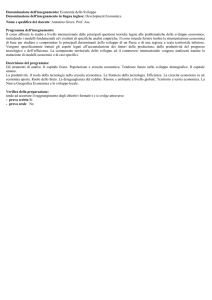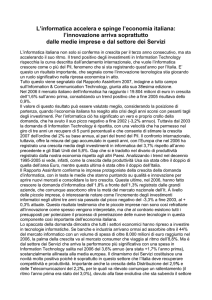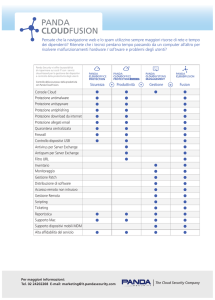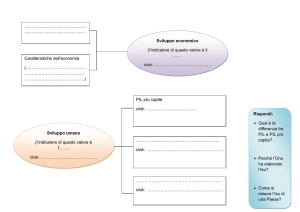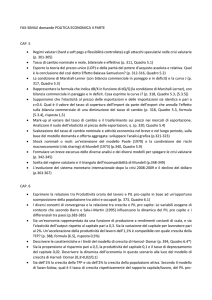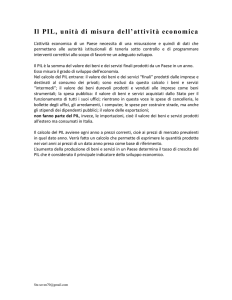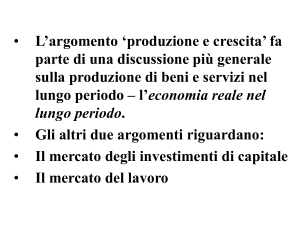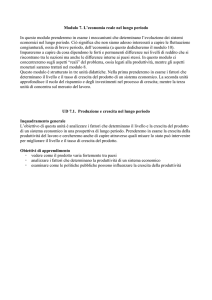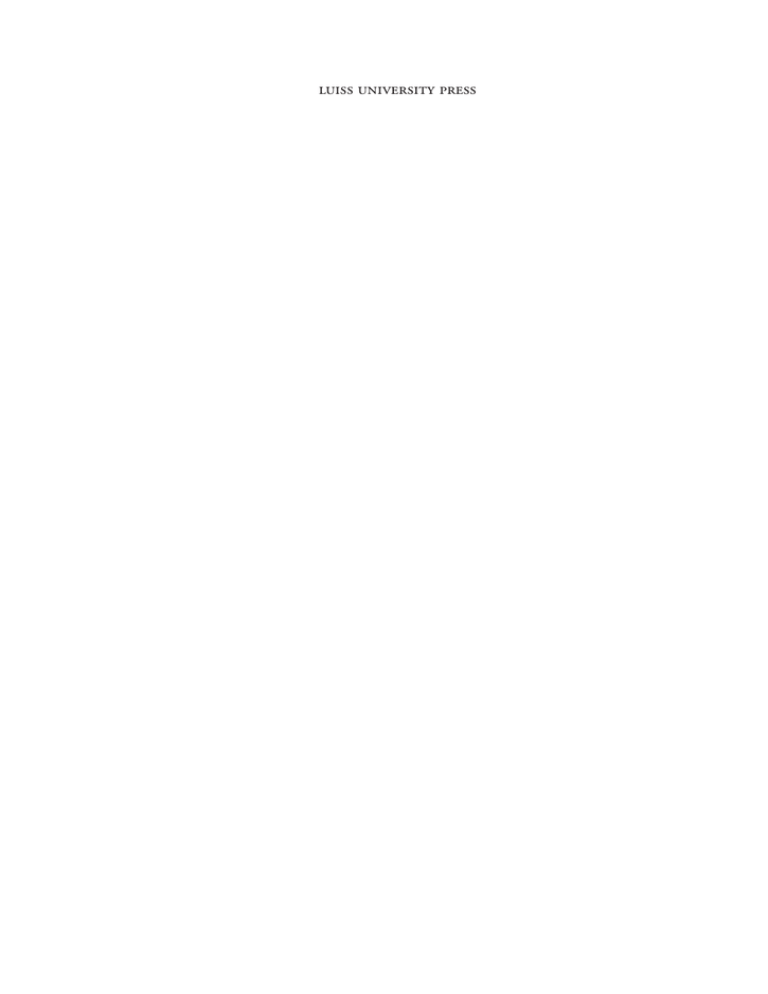
1
luiss university press
2
titolo capitolo
3
L’Europa e l’Italia
nel secolo asiatico
Integrazione e forza industriale
a difesa di libertà e benessere
a cura del
centro studi confindustria
4
titolo capitolo
© Luiss University Press – Pola s.r.l. a socio unico 2013
Proprietà letteraria riservata
isbn 978-88-6105-161-4
Luiss University Press – Pola s.r.l.
Viale Pola, 12
00198 Roma
tel. 06 85225485
fax 06 85225236
www.luissuniversitypress.it
e-mail [email protected]
Progetto grafico: HaunagDesign
Editing e impaginazione: Spell srl
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e
5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque
per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta
Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org.
5
Indice
Prefazione ................................................................................................. p.
Vincenzo Boccia
Introduzione ............................................................................................. “
Luca Paolazzi e Mauro Sylos Labini
1.
Le sfide dell’Europa in un mondo a più velocità ....................................... “
Mauro Sylos Labini
2. Produttività e benessere: la storia insegna
che il destino dell’Europa non è segnato.................................................... “
Gianni Toniolo
3.
Le politiche per rilanciare la competitività europea:
più mercato interno e nuovo welfare ispirato alla flexicurity ....................... “
Stefano Micossi
7
11
21
87
111
4. L’Unione europea in cerca di identità politica: due strade alternative ......... “
Sergio Fabbrini
147
5.
Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero ........ “
Luca Paolazzi
175
Bibliografia ............................................................................................... “
203
6
titolo capitolo
7
Prefazione
Vincenzo Boccia*
Questo volume ha il grande merito di difendere la lucidità del capire in un Paese in cui
i partiti hanno perso il senso dell’emergenza economica e sociale che stiamo vivendo e
dell’importanza di fare presto.
Siamo nel pieno di un’economia di guerra. Non si vedono le macerie ma i danni
sono altrettanto rilevanti e la situazione rischia di avvitarsi. A fine del 2013, e attenendoci
a stime prudenziali, il PIL sarà sceso dell’8,3% dai livelli del 2007; il reddito per abitante
torna quest’anno ai valori del 1997, ossia di 16 anni fa; nel manifatturiero la produzione
è scesa in media di quasi il 25% e in alcuni settori ben oltre il 40%; negli ultimi sei anni
oltre 70.000 imprese manifatturiere hanno cessato l’attività e il ritmo sta salendo, visto
che nel solo 2012, ogni giorno, hanno chiuso i battenti ben 41 aziende; il numero di
occupati è caduto di 1,4 milioni di unità e i disoccupati sono raddoppiati fino a sfiorare
i 3 milioni.
Gianni Toniolo nelle conclusioni del suo saggio ci ricorda che «le macerie fumanti
del 1945 avevano riportato il benessere degli europei indietro di venti o trent’anni».
Siamo incamminati a infliggerci lo stesso arretramento: permanendo la pessima perfomance degli ultimi dieci anni, nel 2060 il nostro PIL, fatto 100 quello americano,
passerà da 65 a 38. Luca Paolazzi chiosa: «è come se fossero cancellati i frutti ottenuti con
il miracolo economico. Addirittura tra mezzo secolo l’Italia sarà diventata un’economia
arretrata, considerato che sarà superata da Cina, Brasile, Turchia, Polonia e sarà tallonata
dall’India».
Il senso di incertezza che origina dall’incapacità di tutte le forze politiche presenti
in Parlamento di anteporre a ogni altro ragionamento l’interesse nazionale e di mettere
la questione dell’economia reale al centro quale unico punto prioritario per il futuro del
Paese, sta tramutando l’ansia che pervade le scelte dei cittadini, dei lavoratori e degli
imprenditori in una paura paralizzante.
Nel tentativo di sbloccare lo stallo dei veti contrapposti, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha incaricato dieci “saggi” di stilare le riforme economiche e
istituzionali indispensabili. Ancora una volta, così, ha dimostrato di essere rimasto l’unico faro, il punto di riferimento della Patria: alla fine del suo settennato, a 88 anni di età,
dà un messaggio chiaro ai partiti su quelle che sono le priorità del Paese e supplisce alla
loro mancanza di visione. Partiti che si stanno dimostrando indifferenti alla gravità di
questa crisi e ai danni che il Paese subisce e ancor più subirà. Mi riferisco a tutti i partiti,
vecchi e nuovi, e all’irresponsabilità profonda che emerge dalla loro condotta.
* Presidente Piccola Industria Confindustria.
8
prefazione
Il messaggio del Capo dello Stato è chiaro: occorre misurarsi sul Paese che vogliamo
costruire, pragmaticamente e senza pregiudizi. Dal quadro attuale si può uscire solo
avviando una nuova ricostruzione. Come si può non percepire tutto ciò? Come si può
continuare nelle tattiche di chi non vuole il “governissimo” e di chi non vuole il governo
che non sia il suo, mentre il Paese soffre?
La priorità è salvare il Paese e ciò si può fare solo unendo le forze politiche e le parti
sociali, con quello spirito del dopoguerra che cita spesso il Presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi. Occorre accantonare gli interessi particolari e guardare solo alle esigenze dell’Italia.
Occorre avere piena consapevolezza della gravità della situazione, occorre parlare
chiaro, occorre far capire che il disagio del Paese parte proprio dalla mancata crescita
e dall’emergenza che il mondo dell’economia reale vive. Solo affrontando la questione
economica si risolvono anche le questioni politiche, come diceva Jean Monnet: «I miei
obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche».
Dobbiamo far uscire le forze politiche da questa irresponsabilità e costringerle ad
affrontare l’emergenza: non c’è più tempo da perdere in giochi di potere. Andare avanti
così significa portare alla paralisi il sistema industriale italiano che ha invece capacità
impressionanti, ma che si deve far carico di un global tax rate di 20 punti superiore alla
Germania, di un costo dell’energia doppio di quello della Francia, con un divario nel
costo del denaro superiore a 1,5 punti percentuali rispetto ai concorrenti tedeschi, con
un costo del lavoro che dall’avvio dell’euro è aumentato, in rapporto alla produttività, di
oltre 30 punti in più rispetto alla Germania. Sono handicap che impediscono di reggere
la concorrenza internazionale, per quanto forti siano le imprese.
Oggi i deficit di competitività del nostro Paese stanno distruggendo la base produttiva. Alle forze politiche, tutte, chiediamo più politica ed è proprio in nome del primato
della politica che vogliamo rivolgerci a quelle persone di qualità, per bene, consapevoli
della situazione di emergenza, con un appello alla buona volontà e al buon senso.
Questo volume ha in sé molti aspetti in linea con “Il progetto Confindustria per
l’Italia”, presentato a gennaio e oggi più che mai attuale. Stefano Micossi, nelle sue
conclusioni, invita a: «Un’azione diffusa, determinata e continua nel tempo da parte
di tutte le istituzioni, comunitarie e nazionali». Su diversi fronti Toniolo parla di una
convergenza istituzionale.
Consapevolezza dell’emergenza e convergenza per la competitività sono le precondizioni per dare un colpo di reni e reagire immediatamente, recuperando quello spirito
di comunità che sembra perduto: il senso dei sacrifici necessari per conquistare il futuro,
coniugando impegno e speranza. Per ricostruire il Paese dalle macerie della decrescita
che oramai dura da troppo tempo e che genera solo miseria e povertà.
La politica economica è fatta di tanti piccoli passi che un Paese deve realizzare in
un’unica direzione e questo volume è, a nostro avviso, uno di questi passi; necessario ma
non sufficiente. Rappresenta un appello a tutte le forze responsabili del Paese, un grido
di dolore e, al tempo stesso, di speranza da parte di Confindustria, la casa comune delle
imprese italiane che, a prescindere dalle loro dimensioni, condividono i fondamentali
9
delle azioni per il Paese e per la nostra Europa, che è il frutto più positivo della nostra
politica post-bellica.
Il dono più bello che emerge dalla lettura di questo volume non è la previsione ma
la visione, una visione di lungo termine, il senso di un progetto per l’Italia, passando
dal cosa a come fare. L’invito a reagire, a pianificare, a sognare ma anzitutto a credere e,
in questo diviene affascinante, la sfida di chi “deve” perché “può” farcela, attraverso le
azioni indicate nel nostro “Progetto per l’Italia”.
Abbiamo voluto qui sottolineare anche la responsabilità di Confindustria, il dovere
nei confronti del Paese di far comprendere come l’Economia sia una questione di interesse nazionale che riguarda tutti i cittadini; la necessità improcrastinabile di un’Agenda
della competitività italiana ed europea, il dovere e la responsabilità nel momento più
difficile della storia della Repubblica.
È il richiamo a un’unica priorità: l’Italia che sogniamo, l’Italia che dimostra al mondo come sa, vuole e può reagire. L’Italia che sa quale direzione prendere per il suo futuro
e che, sciogliendo i nodi che da troppi anni soffocano il suo sviluppo, potrà diventare
con le sue straordinarie imprese la prima nazione industriale del mondo.
11
Introduzione
Luca Paolazzi* e Mauro Sylos Labini**
La crescita dei paesi emergenti è relativamente al di fuori del
campo della nostra esperienza quotidiana Ma le conseguenze
di quella crescita sono di importanza enorme e saranno percepite dalla vasta maggioranza della popolazione mondiale per
molti anni a venire.
Michael Spence, The next convergence, 2011
Verrà un giorno in cui si vedranno questi due immensi gruppi, gli Stati Uniti d’America, gli Stati Uniti d’Europa posti in
faccia l’uno dell’altro, tendersi la mano al di sopra dei mari.
Victor Hugo, Discorso al Congresso della pace, 1849
L’Europa è in crisi. Una crisi politica, economica e sociale. Una crisi istituzionale, anche
se rimane un ampio consenso popolare verso l’Unione europea1. L’esperimento di pacifica unificazione di Stati sovrani volge al tramonto? Come entra l’Italia nella partita?
Quali soluzioni si devono dare alle questioni europea e italiana, tra loro strettamente
legate, per uscire da questa crisi?
Sono le domande che hanno ispirato la ricerca, condotta dal Centro Studi Confindustria
per conto di Piccola Industria, contenuta in questo volume. Domande che trovano risposte
nei capitoli che seguono. In sintesi, la crisi europea è più incalzante di quelle passate perché
è mutato radicalmente il contesto globale con il quale l’UE interagisce e perché sono emerse forti divergenze, di natura strutturale, tra le performance economiche dei paesi membri
(specie all’interno dell’Eurozona). La via di uscita passa attraverso riforme strutturali e istituzionali che puntano su una maggiore integrazione e sulla riaffermazione della vocazione
manifatturiera come motore del progresso economico e civile.
Senza unità e senza industria, l’UE è destinata a essere irrilevante sullo scacchiere
mondiale e a condannarsi a un progressivo impoverimento. Senza una nuova politica
economica che rilanci la crescita e il manifatturiero l’Italia sarà sempre più marginalizzata e condannata a regredire nel benessere.
Tornando sulla natura delle attuali difficoltà, si potrebbe obiettare che una crisi
europea non è poi una grande novità. Il termine “eurosclerosi” fu coniato trent’anni fa
* Centro Studi Confindustria.
** Università di Pisa e Centro Studi Confindustria.
Preziosi contributi alla realizzazione di questo volume sono stati forniti dai colleghi del Centro Studi Confindustria Gianna Bargagli, Alessandro Gambini, Matteo Pignatti e Livio Romano, che qui si ringraziano.
12
introduzione
per indicare le difficoltà europee a fronte dei successi di quelli che allora erano giudicati
i sistemi più dinamici, l’americano post-liberalizzazioni reaganiane e il giapponese predecennio perduto; successi che indicavano che il modello europeo andava cambiato. Si
potrebbe aggiungere, sulla falsariga di quanto hanno più volte affermato molti statisti e
osservatori, che il processo di integrazione europea procede per crisi, anche gravi, perché
queste sono indispensabili per costringere gli Stati nazionali a cedere nuove porzioni di
sovranità al livello comunitario. D’altra parte, fu inventata tempo fa una metafora ciclistica per descrivere il precario equilibrio della costruzione dell’UE: l’Europa è come una
bicicletta che per stare in piedi deve andare avanti.
Infine, si possono fare due ulteriori annotazioni. La prima è economica: l’Europa
è la prima potenza industriale del mondo e anche complessivamente vanta la maggiore
stazza economica; ha fin qui difeso i suoi primati meglio di quanto non abbiano fatto
Stati Uniti e Giappone. Infatti, rispetto ai livelli di picco la sua quota sul PIL mondiale
è diminuita proporzionalmente meno di quanto non siano calate quelle statunitense e
nipponica e altrettanto è accaduto per la sua porzione sulla manifattura globale.
La seconda annotazione è politica. Mai come in anni recenti i cittadini europei hanno beneficiato dei vantaggi dell’unificazione. In termini, per esempio, di libertà di movimento delle
persone e di circolazione dei beni (soprattutto per gli oltre 410 milioni di abitanti che godono
dei benefici dello spazio di Schengen2) oppure di semplicità nel far di conto e nel misurare il
potere d’acquisto (per i 320 milioni che popolano l’Eurozona). Decine di milioni di giovani
sono nati e cresciuti dando per acquisiti questi diritti. Anche per questo, la realizzazione pacifica
del sogno degli Stati Uniti d’Europa, sembrerebbe ormai a portata di mano.
Contemporaneamente, e ciò completa l’annotazione politica, la messa sotto accusa
dell’Europa, a causa delle sue inefficienze e farraginosità, della sua inadeguatezza, fa a
pugni con una realtà troppo spesso (opportunisticamente?) dimenticata: non esiste un
unico modello europeo. Esistono, invece, al suo interno un certo numero di modelli,
numero che cambia a seconda delle categorie classificatorie con cui si raggruppano i
sistemi nazionali, ciascuno dei quali presenta specificità e varianti, anche se tutti condividono radici storiche e culturali e reciproche contaminazioni.
Questi sistemi nazionali non sono rimasti immutati nel tempo, bensì si sono modificati e talvolta lo hanno fatto profondamente, sull’onda di fasi più o meno prolungate
di bassa crescita economica le cui conseguenze occupazionali, reddituali e/o finanziarie
erano divenute intollerabili3. Quelli che hanno saputo cambiare più rapidamente e radicalmente sono riusciti a ottenere risultati molto positivi. E ciò fa giustizia anche dell’uso
dell’Europa stessa (che pure non è affatto esente da pecche, come si dirà più avanti) come
capro espiatorio di tutti gli insuccessi e le difficoltà in cui si dibattono i singoli paesi.
Tutto ciò indurrebbe a concludere che la crisi è una condizione fisiologica, addirittura un tratto genetico, dell’Europa e spingerebbe a trarre conforto da un pensiero
di Thomas Mann (1924): «L’Europa è la terra della ribellione, della critica e dell’attività
riformatrice». Come dire: ha la capacità di stupire e rigenerarsi.
Eppure, molti indizi sembrano suggerire che la crisi attuale sia ben più grave di
quelle passate. Lo dicono le statistiche, lo confermano le tensioni politiche e perfino
diplomatiche tra paesi, lo registrano i mercati finanziari (termometro e al tempo stesso
13
parte delle forze centrifughe) e lo segnala con pressione crescente la protesta popolare,
sia quando prende forma nelle manifestazioni di piazza sia quando si esprime nei risultati elettorali, contro le politiche economiche adottate. La gravità della crisi è evidente
nell’accresciuta complicazione del suo processo decisionale e nella moltiplicazione di
istituzioni che governano l’Unione.
Un altro sintomo della profondità della crisi attuale è la preoccupazione con cui
viene seguita dal resto del mondo. Preoccupazione che è denunciata dalle sollecitazioni a
trovare soluzioni e cambiare rotta nelle politiche economiche, sia per l’Eurozona sia per
quell’importante economia UE che invece ha voluto conservare la sovranità monetaria
(o quel che è dato avere di essa nell’era presente), cioè il Regno Unito.
Questa preoccupazione e tali sollecitazioni dimostrano che nessuno può ricavare
un tornaconto dalla crisi europea e da un suo esito infelice; casomai tutti temono di
riceverne un danno ancora maggiore di quello che già oggi subiscono, per le ondate di
instabilità che da essa promanano.
Al contempo, il resto del mondo non sta ad aspettare e ha imboccato la strada di una
grande convergenza (Spence, 2011). Questa è la vera novità rispetto alla quale misurare
tutte le cose. Una novità che mette la crisi corrente dell’Europa in una luce molto diversa
da quelle sperimentate in passato.
Forze immani si sono messe in moto ormai da oltre due decenni. Forze inarrestabili
che stanno realizzando sotto i nostri occhi un cambiamento epocale, senza precedenti
nella storia dell’umanità. Centinaia di milioni di persone rincorrono gli standard di vita
di quelle che ancora adesso consideriamo economie avanzate, in contrapposizione a
quelle emergenti; la rincorsa è così rapida che tra pochi decenni la linea di demarcazione
tra i due gruppi sarà molto meno netta.
Allo stesso tempo, la mappa della popolazione mondiale è in magmatica e veloce
modificazione. Il numero di abitanti della Terra continuerà a salire, anche se a ritmo
decrescente. Ma lo farà in modo molto disomogeneo tra grandi aree e questo sposterà
gli equilibri e genererà flussi migratori di proporzioni bibliche dalle zone che diverranno
più popolose e continueranno a essere più povere a quelle che sono incamminate verso il
declino demografico (o lo sperimentano già) e rimarranno più ricche e quindi attraenti.
È sicuramente vero che stiamo già vivendo alcune ricadute di questi fenomeni. Dal
rincaro dei prezzi di molte materie prime, a cominciare da quelle energetiche, alle ondate di immigrazione, dalla concorrenza dei prodotti delle economie emergenti all’attrazione degli investimenti in quelle stesse economie e all’aumento delle emissioni di
CO2 su scala mondiale. Ma ciò non basta certo a renderci consapevoli delle sfide che ci
attendono e quindi ad attrezzarci per governarle, anziché subirle passivamente.
Prendere coscienza delle lunghe tendenze di fondo e delle loro conseguenze è il
primo e indispensabile passo per dare risposte all’altezza sia di quelle sfide sia delle politiche, indispensabili per uscire dalla crisi, che vengono già messe in atto dai maggiori
protagonisti del mondo divenuto multipolare (Stati Uniti in testa). Una su tutte, e di
particolare significato per l’Unione europea e per l’Italia: il rilancio del manifatturiero
come motore della crescita economica, perché generatore di sapere e innovazione. È
in corso la promozione del rimpatrio di attività prima delocalizzate oltreconfine e, più
14
introduzione
in generale, di condizioni competitive che permettano di avviare nuove produzioni
industriali.
Questa svolta pro-industria negli USA è avvenuta, sul piano analitico come su quello di politica economica, almeno tre anni fa e sta iniziando a dare risultati misurabili in
termini occupazionali4. Più di recente, anche la Commissione europea ha riconosciuto
il ruolo trainante della trasformazione industriale proponendo di raggiungere entro il
2020 l’obiettivo del 20% nella quota del manifatturiero sul valore aggiunto totale.
È, quindi, fondamentale per capire le prospettive europee e italiane e individuare le
misure da adottare per delineare i trend in atto nel contesto globale. Perciò il primo capitolo di questo volume è formato da un insieme di grafici e tabelle riguardanti le variabili
più rilevanti (selezionate anche in base alla strategia che l’UE si è data con Europa 2020)
e le maggiori economie e macroaree.
È utile, dunque, valutare l’UE usando come pietre di paragone non solo Stati Uniti,
Giappone e Corea del Sud, ormai considerata tra i paesi avanzati, ma anche le principali
economie emergenti, come Cina, India, Brasile e Turchia. La ricerca condotta dal CSC
si basa sul confronto di un insieme di indicatori che mette in luce punti di forza e di
debolezza dell’UE e dei suoi principali paesi membri. È una sorta di misuratore della
salute economica presente e futura dell’Unione europea e delle maggiori economie che
la compongono.
Si tratta di dati statici (una fotografia) e dinamici (un film) sulle caratteristiche e
sulla performance economica (ma non solo) dell’UE e sui motori della crescita individuati dalle strategie dell’Unione. Per ciascun indicatore è stata ricostruita una lunga serie
storica, secolare quando disponibile, che permette di inquadrare l’attuale fase economica
in una prospettiva di lungo periodo. In alcuni casi, sono riportate anche le principali
previsioni che allargano l’orizzonte ai prossimi decenni del XXI secolo.
Il benchmarking è suddiviso in quattro parti. La prima è dedicata alla nuova mappa
dell’economia globale e comprende i dati che descrivono la stazza di ciascun paese/area
in relazione alla popolazione (con il sorpasso dell’India sulla Cina e il boom africano),
al PIL (la Cina che sopravanza gli USA già in questo decennio), la vocazione manifatturiera (che rimane un punto di forza dell’Europa e dell’Italia, nonostante i danni della
crisi) e, quale peculiare indicatore di forza (non solo economica), il medagliere olimpico
La seconda parte raggruppa gli indicatori di benessere e di competitività, che sono
strettamente intrecciati. Si parte dal PIL pro-capite, nel quale l’Italia ha perso terreno
assoluto e relativo (e ancor più rischia di perderne in futuro) e lo si integra con l’indice
di sviluppo umano, si passa alla dinamica della produttività (base di ogni progresso) e a
quella del CLUP (indicatore principe della competitività di costo) e si esamina il tasso
di occupazione (fonte primaria del benessere delle persone), disaggregando in particolare quelli femminile e giovanile. In questi ultimi, soprattutto, l’Italia è molto indietro;
così come lo è nei giovani NEET (cioè non occupati né impegnati nello studio o nella
formazione). Sono ritardi, quelli italiani in tali ambiti, che causano sia iniquità (persone
private di prospettive) sia inefficienza (capitale umano sprecato).
Della competitività si ricordano anche i fattori legati al contesto. Anzitutto, la graduatoria della Banca mondiale sulla facilità del fare impresa, nella quale l’UE è svantag-
15
giata rispetto ai primi della classe (tra cui gli USA) e l’Italia è penalizzata rispetto all’UE.
Infine il costo dell’energia, dove gli USA stanno diventando una sorta di paradiso (grazie
allo sfruttamento di giacimenti non convenzionali) e l’Italia è sempre più un inferno
(giacché l’elettricità costa oltre il 40% in più della media UE e il doppio che in Francia
e Svezia).
La terza parte del confronto internazionale è dedicata alla disuguaglianza nella distribuzione del reddito, sia personale sia territoriale. In entrambe l’Italia fa peggio dei
partner dell’Europa continentale e nordica. La quarta e ultima parte si concentra sulla
gara della conoscenza, ossia sul fattore strategico determinante per il benessere di una
società e per la sua economia. Per la prima volta viene stilata una graduatoria dei Premi
Nobel assegnati nei campi scientifici in base non alla nazionalità del vincitore ma quella
dell’istituzione in cui lavora: gli USA la fanno da padroni assoluti. Si passano in rassegna tutti gli altri più rilevanti indici di aumento della conoscenza e arricchimento del
capitale umano attraverso l’istruzione. In quest’ultima spiccano la supremazia asiatica e
l’enorme divario che continua a distanziare l’Italia dai paesi migliori.
I tre capitoli centrali del volume sono dedicati all’UE, per definirne le potenzialità,
con lo sguardo lungo della storia, indicarne le priorità di politica economica ai fini di un
miglioramento della competitività, e quindi del benessere, e analizzarne i difetti istituzionali, che stanno minando la sua stessa unità.
Le potenzialità sono l’oggetto del secondo capitolo. Nei momenti di crisi è utile allungare la visuale, verso il passato e verso il futuro, facendosi aiutare sia dalle lezioni della
storia sia, consapevoli dei loro limiti, dalle previsioni possibili. L’analisi di Gianni Toniolo ci ricorda che la situazione odierna non è del tutto nuova: l’Europa ha già vissuto
una fase di declino relativo rispetto agli Stati Uniti a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Per
contrastare le difficoltà presenti è utile non fermarsi ai luoghi comuni, ma approfondire
la natura dei problemi.
L’interpretazione di un’UE inchiodata alla lenta crescita a causa di un modello sociale troppo generoso non supera facilmente l’esame dell’evidenza empirica. Primo, è vero
che negli anni 90 la produttività europea ha smesso di crescere rispetto a quella USA,
ma questo è accaduto anche perché il livello del valore aggiunto per ora lavorata (ma
non quello del PIL pro-capite) degli USA era stato sostanzialmente raggiunto dalla UE,
e da alcuni paesi europei persino superato. Secondo, negli ultimi dieci anni, se invece di
guardare alla dinamica del PIL complessivo si prende in considerazione quella del PIL
pro-capite, l’UE ha avuto un tasso di crescita (anche se di poco) superiore a quello USA.
Terzo, sono molti i fattori che, scrive Toniolo, rendono l’economia europea meglio
attrezzata ad affrontare alcune delle sfide poste dalla nuova convergenza globale: una
distribuzione dei redditi meno diseguale, un sistema energetico più efficiente e compatibile con l’ambiente, una migliore organizzazione dell’istruzione primaria e secondaria, costi sanitari meno esplosivi e relativamente sotto controllo. Il problema principale
dell’Unione risiede, invece, nel fatto che le economie dei paesi membri sono meno omogenee di quello che sembrava alla fine del secolo scorso. La divisione dell’Europa in due
aree economiche divergenti, con i paesi del cosiddetto Club Med che faticano a tenere il
passo, è ormai un fenomeno strutturale che richiede risposte urgenti e coordinate.
16
introduzione
Riguardo alle politiche economiche per l’UE nel suo complesso, l’unico modo per
mantenere i livelli di benessere raggiunti nel secolo scorso è invertire il trend di rallentamento della produttività. Stefano Micossi, autore del terzo capitolo, sostiene che l’UE,
anche a causa della rigidità dei mercati e delle resistenze sociali al cambiamento, è stata
meno capace rispetto agli Stati Uniti di sfruttare le nuove opportunità offerte dall’applicazione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT).
Due evidenze rafforzano questa ipotesi: primo, in Europa l’aumento della produttività del lavoro si accompagna sempre all’aumento dell’intensità di capitale. Negli Stati
Uniti invece le due misure sono state a volte divergenti, segno del fatto che è aumentata
l’efficienza complessiva misurata dalla produttività totale dei fattori. Quest’ultima è il
segnale più tangibile della riorganizzazione della produzione necessaria a sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie.
Secondo, l’economia statunitense ha cambiato più rapidamente la sua composizione
settoriale a favore dei comparti che hanno maggiori opportunità di crescita grazie alle
ICT. È proprio nei settori che oggi pesano di più nell’economia USA, i servizi della distribuzione e quelli finanziari per le imprese, che si concentra la grande differenza nella
dinamica della produttività tra le due sponde dell’Atlantico. Il ritardo europeo può paradossalmente essere un’occasione per ripartire con slancio nei prossimi anni, a condizione
che gli Stati nazionali e le istituzioni europee mettano in campo le riforme necessarie per
attivare una nuova fase di convergenza nei confronti della produttività USA.
Le tendenze decennali che riguardano la crescita di popolazione, PIL e produzione industriale rischiano di condannare l’UE all’irrilevanza sullo scacchiere geopolitico
mondiale. È questa la ragione fondamentale per cui oggi c’è bisogno di più Europa.
Dunque, di riforme delle istituzioni che governano l’UE, tema trattato nel quarto capitolo. Questa esigenza si scontra con un preoccupante paradosso che costituisce il punto
di partenza del saggio di Sergio Fabbrini: sul piano istituzionale l’Unione europea (e
soprattutto l’Eurozona) si è ulteriormente integrata, ma sul piano sociale i suoi Stati
membri sono tornati a dividersi.
È il risultato di un sistema decisionale basato su due pilastri, quello sovranazionale
e quello intergovernativo. Quest’ultimo non è riuscito a risolvere tre basilari problemi
tipici di qualsiasi processo di integrazione: il potere di veto, il rispetto degli accordi, la
legittimazione delle decisioni. Durante la crisi le istituzioni dell’Unione hanno allora
affrontato questi problemi con scelte che hanno determinato un vero e proprio avvitamento del processo di integrazione. Si è, infatti, realizzato un “accentramento senza
efficacia e legittimazione”. Per superare questa impasse l’UE ha davanti a sé due strade:
una unitaria, più ambiziosa e problematica, che ha come punto di arrivo il federalismo
parlamentare e che nell’immediato prevede l’estensione del metodo della cooperazione
rafforzata a nuovi ambiti; una differenziata, sicuramente più realistica e in parte già in
atto, che avrebbe come obiettivo principale quello di dare una veste giuridica e istituzionale a un processo di integrazione a più velocità.
E l’Italia? La situazione del Paese è particolarmente delicata: è dentro il tunnel della
peggiore crisi economica dall’Unità. Il capitolo conclusivo è dedicato a questa e alle terapie per uscirne. Ciò interessa anzitutto le famiglie e le imprese italiane. Ma non meno il
17
destino dell’intera Europa, che è legato a doppio filo al nostro. Il Paese ha un’economia
troppo grande sia per essere salvata, se non si salva da sola, sia per essere lasciata alla sua
deriva senza che ciò trascini il resto del Vecchio Continente.
Il punto di partenza dell’analisi è la breve radiografia dei danni causati dalla doppia
recessione. Danni paragonabili a quelli di una guerra mondiale, senza che questa guerra
sia stata (per fortuna) combattuta5. Quando queste pagine vanno in stampa, il PIL è
diminuito di oltre l’8% dai valori del 2007, quello per abitante del 10%; i consumi sono
tornati ai livelli del 1997, la produzione industriale è sotto di un quarto dai massimi del
2008, l’occupazione ha perso 1,4 milioni di unità.
A repentaglio c’è una parte consistente della base industriale del Paese e, se non verrà
cambiata rapidamente rotta, la posta in gioco è il progressivo azzeramento dei risultati
ottenuti con il miracolo economico, e anche successivamente ad esso, nella rincorsa al
reddito pro-capite di USA e UE.
Una parte importante di questo saggio è rivolta al confronto tra l’Italia e gli altri
paesi, sulla scorta dei dati contenuti nel primo capitolo. I risultati salienti di tale confronto sono riportati sopra e per un esame più dettagliato (e opportuno) si rimanda
direttamente al testo.
Prima di arrivare alle terapie, che sono tratte da Il progetto Confindustria per l’Italia6,
vengono ribaditi due concetti-chiave per l’interpretazione delle difficoltà italiane e per
disegnare le politiche economiche più efficaci al rilancio. Il primo concetto è la centralità
del manifatturiero; riguardo alla quale, oltre a quanto già detto sopra, vanno sottolineati
due elementi. Il primo è che per prosperare occorre esportare, per dirla con Carlo Cipolla (1995): «Noi dobbiamo essere pronti a cambiamenti continui. Siamo un popolo che
non può permettersi di fermarsi, di accontentarsi di facili successi. Dobbiamo sempre
inventare cose nuove che piacciono«. E l’Italia è riuscita finora, anche se sempre più faticosamente, a fare di necessità (la mancanza di materie prime) virtù e a vendere al resto
del mondo quanto serviva per pagare le sue importazioni. Il secondo elemento è che lo
ha fatto cambiando molto la propria specializzazione produttiva rivelata dalla composizione delle stesse esportazioni.
L’altro concetto è che l’Italia era “in crisi prima della crisi”. In altre parole, oggi sono
venuti al pettine nodi strutturali che hanno cominciato a formarsi trenta-quarant’anni
fa (sul fronte del sistema politico sono perfino più antichi7) e che hanno via via soffocato
lo sviluppo. Al punto che la crescita si è fermata nei primi anni Duemila, complici gli
shock che avevano messo all’angolo il manifatturiero; angolo dal quale stava uscendo,
con profonde trasformazioni, proprio quando è arrivata la gelata della crisi finanziaria
globale (Rossi, 2009).
Dal pericoloso avvitamento in atto tra caduta della domanda interna, maggiori rischi per le imprese e ulteriore stretta del credito si deve uscire con una politica a due stadi: il primo stadio rimette in moto il Paese e lo colloca su un sentiero di crescita nuovamente elevato (oltre il 2% l’anno); il secondo stadio stabilizza la crescita a quel livello ed
è composto da quelle riforme che sciolgono i nodi strutturali cui si è appena accennato.
Le riforme vanno varate subito, ma occorre del tempo prima che siano pienamente efficaci. Tempo che l’Italia non ha più. Perciò serve il primo stadio, che il Progetto
18
introduzione
Confindustria definisce “terapia d’urto”, perché mobilita 316 miliardi in cinque anni;
risorse progressivamente crescenti e con misure definite tutte subito, nel pieno rispetto
dei vincoli di finanza pubblica. La terapia d’urto è a tenaglia: da un lato, aumento della
competitività, in particolare del manifatturiero, con un taglio dei costi; dall’altro, sostegno alla domanda interna, operando sugli investimenti pubblici e privati.
Gli effetti sono considerevoli: il tasso di crescita del PIL diventa del 3% annuo nel
2017 e 2018, con un aumento cumulato del 12,8% nei prossimi cinque anni (contro il
2,9% a politiche invariate), pari a 156 miliardi aggiuntivi ai prezzi di oggi; gli occupati
salgono di 1,8 milioni di unità. Grazie alla maggiore crescita si ha un drastico miglioramento degli stessi conti pubblici: il disavanzo diventa surplus dal 2017 e il rapporto debito/PIL scende sotto il 104% (superando persino gli obiettivi posti dai vincoli europei).
Ciò prova, una volta di più, che fare scelte, anche se difficili e inizialmente impopolari, paga: la guarigione dell’Italia dalla malattia della lenta crescita è un gioco in cui,
alla fine, ci sono solo vincitori. Una ragione in più perché tutti gli attori economici,
politici e sociali si impegnino nelle cure. Solo con la piena e convinta collaborazione di
ogni componente della nazione la crisi riacquisterà il significato proprio di passaggio da
una condizione a un’altra, di cambiamento e trasformazione in direzione di una nuova
stagione di progresso, anziché di impoverimento. Dipende solo dagli italiani. Sta in noi.
19
note
1.
Secondo l’Eurobarometro condotto nel giugno 2012 l’appartenenza del proprio paese
all’UE era giudicata positiva dal 50% dei rispondenti (+3 sul maggio 2011) e negativa dal
16% (-2).
2. Accordo che prende il nome dalla cittadina lussemburghese in cui fu firmato nel 1985 e che
definisce una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati europei riguardo alla circolazione delle
persone e delle merci, con graduale eliminazione dei controlli doganali alle frontiere.
3. Le nazioni scandinave, in particolare la Danimarca e la Svezia, sono tornate di moda (The
next super model, recita una recente copertina dell’Economist); ma prima e dopo di loro
avevano svoltato radicalmente Regno Unito
(inizi anni 80) e Germania (primo decennio
2000).
4. Dall’avvio della ripresa in corso, ufficialmente
partita nel giugno del 2009 (secondo la datazione dei cicli economici effettuata dal National Bureau of Economic Research americano), la
quota del manifatturiero sull’occupazione totale è rimasta sostanzialmente invariata: una così
lunga stabilità non si osservava dalla seconda
metà degli anni 70.
5. Il paragone tra la situazione economica presente e quella conseguente a un conflitto mondiale
è stato effettuato in Centro Studi Confindustria
(2012a e 2012b).
6. Confindustria (2013).
7 Salvati (2011).
21
1
Le sfide dell’Europa in un mondo a più velocità Mauro Sylos Labini*
Sommario
1.1 La nuova mappa dell’economia globale – 1.2 Le misure di benessere e competitività – 1.3 Il
doppio limite della disuguaglianza: iniquità e inefficienza – 1.4 La gara della conoscenza
Il premio Nobel per la pace 2012 è stato assegnato all’Unione europea. L’istituzione che ha
permesso ai paesi del Vecchio Continente di vivere sei decadi di pace e prosperità e ha promosso, anche lontano dall’Europa, i valori democratici e il rispetto dei diritti umani. Fin dal
1951, quando il Trattato di Parigi istituì la Comunità del carbone e dell’acciaio, le riforme
economiche hanno preceduto e creato le condizioni per l’integrazione politica. Il progresso
materiale e la diffusione del benessere, oltre che fine in sé, si è rivelato fondamentale per
costruire il consenso necessario alla nascita di nuove istituzioni sovranazionali. Nell’epoca
in cui gli Stati nazionali sembrano tartarughe rispetto alla lepre dei mercati internazionali,
l’UE rappresenta uno dei tentativi politici più ambiziosi di governare la globalizzazione.
Il perdurare della crisi economica e la particolare vulnerabilità mostrata da alcuni
paesi membri, soprattutto all’interno dell’Euroarea, hanno però reso evidenti le carenze
di governance delle istituzioni comunitarie, facendo riemergere conflitti nazionali che
sembravano sopiti: il sostegno politico a un’ulteriore integrazione sembra vacillare proprio nel momento in cui è maggiormente necessario. Per uscire dalla crisi serve, infatti,
più Europa e quindi ancora più ampie cessioni di sovranità, soprattutto per i paesi
dell’euro che condividono già, oltre che la moneta, le decisioni di politica monetaria e
le turbolenze dei mercati finanziari. Se l’architettura europea vuole sopravvivere, le decisioni nazionali dovranno essere sempre più subordinate agli obiettivi dell’Unione, così
come indicato da molte delle misure di governance varate nel corso della crisi. D’altra
parte, solo un’Europa più unita e integrata può aspirare a rivaleggiare con i colossi che
già si fronteggiano e sempre più si confronteranno: USA, Cina, India, Russia, Brasile. In
un mondo che sarà sempre più multipolare.
La necessità di un cambio di passo non è, in effetti, un’esigenza nuova. Già negli
anni 90 del secolo scorso, complice l’ottima performance economica degli Stati Uniti,
recuperare competitività era una priorità per le istituzioni comunitarie e i governi nazionali. Nel 2000 a Lisbona il Consiglio europeo lanciò una strategia per far diventare
l’UE nel giro di due lustri la più competitiva e dinamica economia della conoscenza al
mondo. Il metodo scelto per spingere gli Stati membri sulla strada delle riforme (detto
* Università di Pisa e Centro Studi Confindustria.
22
1. Le sfide dell’Europa in un mondo a più velocità
della coordinazione aperta) ha funzionato solo in parte e i risultati sono stati molto inferiori alle attese. Ma i paesi che hanno perseguito gli obiettivi di Lisbona con maggiore
tenacia oggi hanno meno problemi di quelli che invece li hanno presi meno sul serio.
Nel 2010 è nata Europa 2020, una nuova agenda che ha l’obiettivo di far crescere l’economia del Vecchio Continente in modo intelligente, sostenibile e solidale, per usare le tre
parole-slogan che la distinguono. I motori di questo tipo di crescita sono: la conoscenza e
l’innovazione, l’utilizzo delle risorse disponibili in modo efficiente e rispettoso dell’ambiente e tassi di occupazione più alti uniti a una maggiore coesione territoriale e sociale.
A dodici anni dal lancio della strategia di Lisbona e a tre da quella denominata
Europa 2020 il confronto con i soli Stati Uniti appare ormai insufficiente per comprendere le sfide che l’Unione ha davanti. La crescita economica senza precedenti della
Cina e dell’India, unita a quelle di altri paesi emergenti, ha infatti determinato l’entrata
nel mercato del lavoro globale di centinaia di milioni di persone e ciò sta imponendo
cambiamenti profondi in tutte le economie avanzate, incluse quelle europee. Più mondi
distinti convergono nella stazza economica e nel reddito per abitante e il futuro della crescita globale, e in particolare quella europea, dipenderà anche dal modo in cui evolverà
la loro interdipendenza e da come le istituzioni internazionali riusciranno a governare i
cambiamenti che l’integrazione dei mercati sta già imponendo (Spence, 2011).
È utile, dunque, misurare la strada fatta dall’UE e quella ancora da fare, usando come
pietre di paragone non solo Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, ormai considerata nel
novero dei paesi avanzati, ma anche le principali economie emergenti come Cina, India,
Brasile e Turchia. La ricerca condotta dal CSC e contenuta in questo capitolo si basa sul
confronto di un insieme di indicatori che mette in luce punti di forza e di debolezza dell’Unione europea e dei suoi principali paesi membri, anche rispetto alle coordinate definite
da Europa 2020. Il benchmarking diventa il termometro che misura la salute economica
presente e prospettica dell’Unione europea e dei suoi principali paesi membri.
Si tratta di dati statici (una fotografia) e dinamici (un film) sulle caratteristiche e
sulla performance economica (ma non solo) dell’UE e sui motori della crescita individuati dalle strategie dell’Unione. Per ciascun indicatore è stata ricostruita una lunga serie
storica, quando disponibile secolare, che permette di inquadrare l’attuale fase economica
in una prospettiva di lungo periodo. In alcuni casi, sono riportate anche le principali
previsioni che spingono l’orizzonte lungo i prossimi decenni del XXI secolo.
Fare previsioni è molto difficile e l’incapacità di intravedere l’arrivo dell’attuale crisi
economica non ispira molta fiducia nell’abilità di economisti e scienziati sociali di predire gli eventi dei prossimi 50 anni. Ma la previsione è soprattutto un veicolo per chiarire
le sfide che ci attendono e, dato che spesso estrapola dalle esperienze passate, permette
di fare il punto sulle tendenze che hanno caratterizzato la nostra epoca.
1.1
La nuova mappa dell’economia globale
Siamo circa a metà del terzo secolo di quella che potremmo definire l’era delle rivoluzioni industriali. All’inizio del 700, secondo i dati faticosamente costruiti dagli storici
dell’economia, anche nei paesi occidentali la maggior parte della popolazione viveva
23
in condizioni di vita che oggi considereremmo sotto la linea della povertà. Avevano
livelli di benessere accettabili solo le élite politiche, quelle ecclesiastiche e, in alcune
regioni, gli esponenti della classe imprenditoriale-mercantile, le cui fortune dipendevano dal commercio di lunga distanza. La crescita economica complessiva, sempre
secondo i nostri standard, era debole ovunque, inferiore al mezzo punto percentuale
annuo.
La rivoluzione industriale ha rotto questo equilibrio a partire dalla seconda metà del
700. All’inizio in Inghilterra e Paesi Bassi e successivamente in alcuni Stati dell’Europa
occidentale e in USA, Canada e Australia il reddito ha iniziato a crescere a ritmi più
sostenuti. È stato in gran parte il risultato dell’applicazione sistematica delle conoscenze
tecnologiche e (in un secondo momento) scientifiche alla produzione, al trasporto e alla
comunicazione.
Nel 1950, a circa due secoli dall’inizio della rivoluzione industriale, il benessere da
essa scaturito era rimasto confinato ai paesi europei e alle loro propaggini (Stati Uniti,
Canada, Australia e Nuova Zelanda) e interessava circa il 15% della popolazione del pianeta. La situazione è cambiata radicalmente dopo la seconda guerra mondiale, all’inizio
lentamente e negli ultimi decenni in modo impetuoso. Il punto di arrivo della nuova
fase sarà probabilmente un mondo in cui, a metà del XXI secolo, circa il 75% della popolazione godrà di caratteristiche economiche che oggi identificano un paese avanzato.
Gli indicatori principali che descrivono questa transizione riguardano la demografia e la
produzione di reddito.
Un’espansione senza precedenti. La dinamica della popolazione è in alcuni casi motore, in
altri freno e in altri ancora semplice riflesso della performance economica. Nei paesi occidentali la rivoluzione industriale ha coinciso con la profonda trasformazione chiamata
transizione demografica: in circa due secoli la speranza di vita è passata da 25-35 anni a
75-80 e il numero medio di figli per donna è diminuito da 5 a meno di 2. In Europa,
l’effetto di questi cambiamenti è stato un’espansione demografica che in parte era cominciata prima grazie alla rivoluzione agricola e che fu tenuta a freno dall’emigrazioni
bibliche: dal 1700 al 1900 la popolazione è triplicata raggiungendo circa 300 milioni di
abitanti. La crescita del numero di abitanti è poi diminuita e sul finire del XX secolo
e all’inizio del XXI la popolazione europea si è stabilizzata intorno al mezzo miliardo.
L’India nazione più popolosa. L’esaurirsi del ciclo di crescita della popolazione dei paesi
ricchi ha coinciso con l’esplosione demografica di quelli poveri, che è ancora in corso. La
spettacolare crescita della popolazione mondiale nel corso del 900, passata da 1 miliardo
e mezzo a più di 6, è dovuta soprattutto a questo secondo fenomeno. La Cina, che partiva da circa 400 milioni di abitanti, è arrivata a un miliardo e 300 milioni del 2010. Nello
stesso periodo l’India è passata da 295 milioni a un miliardo e 200 milioni e nei prossimi
anni è destinata a superare la Cina e a diventare il paese più popolato del pianeta. I due
giganti stanno per essere a loro volta superati dall’insieme dei paesi africani, dove è previsto che la popolazione raddoppi nei prossimi 40 anni, elevandosi da circa un miliardo
a quasi due miliardi e 200 milioni.
24
1. Le sfide dell’Europa in un mondo a più velocità
La crescita demografica non implica automaticamente un miglioramento delle condizioni economiche e, in un’economia arretrata, può addirittura peggiorarle. Ma anche
sottoscrivendo l’ipotesi di neutralità è innegabile che l’importanza geopolitica dei paesi
con un maggiore sviluppo demografico è destinata ad aumentare. Un utile esempio ricordato da Massimo Livi Bacci (2002) viene dal confronto fra Stati Uniti e Francia. Tra il
1870 e il 1994 i due paesi hanno avuto un ritmo di sviluppo simile in termini di PIL procapite, ma la crescita della popolazione è stata molto diversa. Partendo da livelli molto
simili, oggi gli abitanti USA sono circa cinque volte quelli della Francia. È probabile che
senza quest’aumento di stazza gli Stati Uniti non sarebbero leader a livello mondiale.
Per effetto della crescita di India e Cina, il peso della popolazione dei paesi UE, che
rappresentava quasi il 20% del totale mondiale nel 1900, è oggi il 7,3% e, complice la
crescita dell’Africa, appare destinata a scendere al 5%. Se l’Europa non sarà percepita
come un attore politico unitario in grado di prendere importanti decisioni economiche
(e militari) la sua importanza geopolitica è destinata di conseguenza a diminuire.
Europa e USA restano giganti ma la Cina li sorpasserà. Nonostante le tendenze demografiche, l’UE resta un gigante economico. Nel 2011 il suo PIL, misurato in dollari a prezzi e
cambi correnti, era ancora circa il 25% di quello mondiale, quota di quasi 4 punti più alta
di quella degli Stati Uniti. Le previsioni per i prossimi anni, però, indicano che la crescita
europea, attestata su livelli inferiori al 2% annuo, sarà inferiore a quella USA e già nel
2020 il reddito prodotto nelle due aree economiche sarà simile. Nella stessa data, la Cina
sarà diventata da un po’ la prima economia del mondo e, anche se il suo tasso di crescita
annuo si dimezzerà dal 10% degli anni 2000 al 5% degli anni 2020, arriverà a doppiare
quelle di USA e UE entro un trentennio. Dopo il 2040 la seconda economia mondiale
diventerà quella indiana, il cui sviluppo, rispetto al cinese, è iniziato dieci anni dopo, ma
la cui velocità già dagli anni 2020 sarà superiore, anche grazie alla spinta demografica.
In Asia l’industria corre e solo gli USA tengono il passo. La mappa della produzione manifatturiera mondiale è cambiata con una velocità persino superiore a quella del PIL. Negli ultimi decenni il tasso di crescita globale del valore aggiunto del comparto è rimasto costante
intorno al 3%, ma il mutamento dei rapporti di forza fra aree geografiche ha le caratteristiche di una rivoluzione: nel 1990 più del 72% del valore aggiunto industriale del pianeta,
misurato a prezzi e cambi correnti, era prodotto in Europa, USA e Giappone. In poco più
di 20 anni la loro quota è scesa sotto il 50%. A questo cambiamento ha concorso soprattutto la dinamica della Cina, che ha accresciuto il suo peso di circa 17 punti percentuali, ma vi
hanno contribuito anche le buone performance di Corea del Sud e India. Nonostante l’UE
resti il primo produttore mondiale, il tasso di crescita medio annuo di appena l’1% realizzato negli anni 2000 (8,2% cumulato) non è compatibile con la difesa del primato: la Cina
è cresciuta al tasso annuo del 12%, la Corea del Sud del 6% e persino gli Stati Uniti hanno
avuto un ritmo di crescita annuale doppio rispetto a quello europeo e hanno quindi visto,
nell’arco di un decennio, aumentare il loro valore aggiunto manifatturiero di circa il 20%.
Il tasso di crescita aggregato dell’UE riflette comunque forti eterogeneità nazionali.
L’industria in Polonia, per esempio, è cresciuta a una velocità asiatica, mentre in Spagna, Regno Unito e Italia si è addirittura contratta. Il segno meno è particolarmente
25
preoccupante, dato che, a differenza di quanto avviene in altri settori, le competenze nel
manifatturiero si erodono lentamente, ma una volta perse sono difficili da recuperare.
È questo uno dei motivi per cui una delle iniziative “faro” della strategia Europa 2020
prevede il rafforzamento della politica industriale europea.
1.2
Le misure di benessere e competitività
Gli USA in testa nel PIL pro-capite, ma la Cina si avvicina. La crescita del PIL e della
popolazione determinano congiuntamente i livelli medi di benessere economico. La
rincorsa europea agli Stati Uniti, iniziata dopo la seconda guerra mondiale, si è esaurita
negli anni 80 del secolo scorso, quando il reddito pro-capite UE si è attestato poco al di
sopra del 65% di quello americano (sulle ragioni di ciò e su un’interpretazione del reale
divario si veda il contributo di Gianni Toniolo a questo volume). Le previsioni indicano
che il divario tenderà a rimanere invariato nei prossimi decenni.
La crescita economica impetuosa ha invece determinato una rapida convergenza
del PIL pro-capite cinese, passato negli ultimi tre lustri da circa il 6% di quello USA a
oltre il 17%. Quando la Cina diventerà la prima economia del mondo (prima del 2020),
il suo PIL pro-capite sarà ancora circa un quarto di quello USA e poco più di un terzo
di quello europeo. Dal punto di vista geopolitico sarà una situazione senza precedenti.
Secondo previsioni molto più ardite, giacché va tenuto conto che la probabilità di errori
previsionali aumenta più che proporzionalmente con l’ampiezza del periodo di tempo
preso in considerazione, alla fine degli anni 50 il PIL pro-capite della Cina sarà circa il
60% di quello USA e quindi il 90% di quello UE.
Nello sviluppo umano UE vicina agli Stati Uniti. Il PIL pro-capite, è bene ricordarlo, anche se rimane una buona proxy del benessere, non tiene conto di aspetti importanti della
vita dei cittadini: la salute, la qualità dell’ambiente, la possibilità di partecipare alla vita
pubblica grazie a condizioni di partenza simili. Secondo l’indice di sviluppo umano, che
tiene conto dei livelli di istruzione e della speranza di vita ed è diffuso e utilizzato dalle
Nazioni Unite, la distanza fra Europa e Stati Uniti sembra inferiore a quanto suggerito
dalle misure basate sul reddito medio.
La frenata europea nella produttività. Il PIL pro-capite resta, comunque, la più affidabile
misura del benessere rispetto a tutte le altre sperimentate fino ad ora. E nel medio periodo la sua dinamica dipende moltissimo da quella della produttività del lavoro. Come
ricordato nel contributo di Gianni Toniolo a questo volume, dalla fine della seconda
guerra mondiale fino alla prima metà degli anni 90, l’andamento della produttività europea è stato migliore di quello USA, anche per effetto del catching-up tecnologico.
Dalla seconda metà degli anni 90, la produttività USA è tornata a crescere di più.
Anche in questo caso il dato dell’UE riflette notevoli eterogeneità: la produttività in Polonia, Svezia e Regno Unito è cresciuta a un tasso annuo superiore al 2,4% registrato dagli
USA, mentre Spagna e Italia hanno avuto performance molto deludenti. È una questione
aperta se in questi paesi il rallentamento sia dipeso in misura maggiore dall’entrata nel
26
1. Le sfide dell’Europa in un mondo a più velocità
mercato del lavoro di soggetti con una produttività più bassa, dal passaggio a tecniche più
intensive di lavoro per effetto della maggiore flessibilità introdotta nell’utilizzo di questo
fattore produttivo o dalla loro incapacità di utilizzare con profitto le nuove tecnologie
della comunicazione e dell’informazione, soprattutto in alcuni comparti del terziario.
La crisi rallenta il CLUP, ma non in Francia e Italia. Uno degli effetti collaterali più evidenti della frenata della produttività è stata l’accelerazione del costo del lavoro per unità
di prodotto (CLUP), un’importante misura della competitività di costo. La dinamica di
questo indicatore è ancora una volta molto eterogenea fra paesi europei: negli anni 2000
la sua crescita è stata contenuta in Polonia, Svezia e soprattutto Germania, mentre è stata
sostenuta in Spagna, Italia, Regno Unito e Francia. A livello aggregato l’andamento del
CLUP europeo è stato molto simile a quello USA.
Mercato del lavoro europeo a due velocità. Anche per il funzionamento del mercato del
lavoro l’Europa è divisa in due: da un lato i paesi come Germania e Svezia dove, grazie
all’ottima inclusione di giovani e donne, il tasso di occupazione è elevato e la crisi non
ha provocato un deterioramento dei principali indicatori. Dall’altro Spagna e Italia, lontanissime non solo dal tasso di occupazione fissato come obiettivo da Europa 2020, ma
anche distanti dai target che ciascun governo si è dato nei piani nazionali. In questo ambito un indicatore interessante riguarda i giovani che non lavorano né studiano (NEET):
l’Europa, nonostante Spagna e Italia, ha una quota relativamente bassa di NEET (fra i
20-24enni sono il 17,5% contro il 19,4% degli USA); mentre è ancora indietro nel tasso
di occupazione femminile.
USA avanti nella facilità di fare impresa. Grazie agli indicatori messi a disposizione dalla Banca mondiale è possibile confrontare la facilità di fare impresa fra le due sponde
dell’Atlantico. Nell’indice aggregato nessun paese europeo è davanti agli Stati Uniti e
quindi rimane un ampio margine di miglioramento in questo ambito. I paesi UE hanno
comunque effettuato passi avanti nel facilitare l’avvio di nuove attività imprenditoriali;
fra gli aspetti negativi invece, con la parziale eccezione della Germania, vi è la difficoltà
a velocizzare i tempi della giustizia civile e a ridurre i costi che le imprese devono sopportare per ricorrervi.
1.3
Il doppio limite della disuguaglianza: iniquità e inefficienza
I redditi disuguali penalizzano gli USA. La disuguaglianza è un freno importante alla
crescita: riduce la mobilità intergenerazionale e quindi gli incentivi a investire in istruzione; incoraggia le famiglie a indebitarsi oltre le loro possibilità e in questo modo mette
a rischio la tenuta del sistema finanziario; riduce la domanda aggregata, dato che chi
sta peggio ha in genere una propensione al consumo più alta. Oltre a essere un fattore
socialmente disgregante e che amplia il divario tra l’effettivo benessere e il PIL pro-capite
medio.
Non è facile trovare misure di disuguaglianza aggregate per l’UE, ma gli Stati Uniti
mostrano livelli stabilmente più alti di tutti i principali paesi del Vecchio Continente.
27
Il caso di successo dell’UE è quello della Spagna che, anche grazie a tassi di crescita più
alti, ha visto scendere il suo coefficiente di Gini (forse la misura più usata per della disuguaglianza nella distribuzione del reddito) rispetto agli anni 80. In Italia, Regno Unito,
Svezia e Germania la disuguaglianze è invece aumentata.
Targati USA i maxi redditi. L’indice di Gini degli Stati Uniti si spiega anche con l’aumento della quota di reddito che finisce ai super ricchi: nel 2010, il primo percentile
della popolazione USA percepiva più del 17% del reddito nazionale. Più del doppio della
quota che percepiva negli anni 60. In Europa solo il Regno Unito si è avvicinato recentemente a una quota analoga.
1.4
La gara della conoscenza
Gli USA fanno il pieno di premi Nobel. La strategia Europa 2020 mira a una crescita intelligente (smart), grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione e nell’innovazione. La
maggior parte delle innovazioni ha luogo attraverso molteplici interazioni tra nuove idee,
invenzioni, prototipi tecnologici e domanda di mercato. Ma la ricerca di base, anche quando non produce idee immediatamente utilizzabili per scopi economici, è fondamentale per
la nascita delle invenzioni. La forza relativa di ciascun paese in questo tipo di ricerca può
essere approssimata dalla quota di premi Nobel vinti nelle discipline scientifiche. Il Centro
Studi Confindustria ha rielaborato i dati assegnando i premi non alla nazione di cittadinanza del vincitore ma a quella in cui risiede l’istituzione in cui il vincitore lavora. Questa
assegnazione consente di meglio riconoscere l’ambiente in cui avviene la migliore ricerca.
Gli anni a cavallo della seconda guerra mondiale segnano il passaggio di consegne
fra Europa e Stati Uniti soprattutto per effetto della fine del primato tedesco. Gli ultimi
decenni hanno rafforzato ulteriormente il primato USA. Mentre il Giappone è l’unico
paese nuovo a essere entrato stabilmente nel club di chi ambisce al riconoscimento scandinavo.
La rincorsa della Cina nelle pubblicazioni scientifiche. Il primo output dell’attività di ricerca sono gli articoli pubblicati su riviste scientifiche. Un articolo viene assegnato a un
paese se uno dei suoi autori, indipendentemente dalla sua nazionalità, lavora in una istituzione (università, ente di ricerca o impresa) che si trova in quel paese. Disponibile solo
per gli anni più recenti, la quota di articoli pubblicati su riviste scientifiche rappresenta
un indicatore meno limitato rispetto ai premi Nobel che misurano solo l’importanza
della ricerca di altissimo livello. D’altro canto permette di misurare anche i progressi fatti
dai paesi emergenti. Europa e Stati Uniti restano i due leader mondiali nella produzione
di conoscenza, ma il loro peso congiunto è passato dal 70% del 1995 al 58% del 2009.
Nello stesso periodo la Cina è salita dall’1,6% al 9,5%.
Corea del Sud, Svezia e Giappone in testa nell’innovazione. L’indicatore più utilizzato per
misurare l’input innovativo di un’economia è la quota delle spese in ricerca e sviluppo
(R&S) sul PIL. Sono classificate come R&S tutte le attività intraprese in modo sistema-
28
1. Le sfide dell’Europa in un mondo a più velocità
tico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze esistenti sia per utilizzarle per nuove
applicazioni. Gli Stati Uniti sono avanti all’UE di quasi un punto percentuale (nel 2010
2,77% contro 1,94%) e il distacco è rimasto stabile negli ultimi due lustri. Guidano la
classifica Corea del Sud, Svezia e Giappone con quote comprese fra il 3,26% e il 3,74%.
Data la modestia dei progressi compiuti nei paesi UE finora, gli obiettivi del 3% stabiliti
dall’agenda Europa 2020 sembrano difficile da raggiungere e solo la Svezia e la Germania
hanno concrete possibilità di farcela.
Il Giappone supera Europa e USA nei brevetti. L’output innovativo è invece misurato dalla
quota di brevetti depositati presso i principali uffici internazionali. Il Giappone e l’UE
(spinta dalla Germania) sono davanti agli Stati Uniti. La Cina, nonostante l’aumento
vertiginoso della sua base manifatturiera, ha ancora una quota di brevetti relativamente
bassa; parte della spiegazione di ciò è nella debolezza relativa nel settore farmaceutico,
comparto ad alta intensità brevettuale.
In Asia più istruzione e ad alta qualità. Continua il processo di convergenza negli anni
di istruzione medi ricevuti dalla popolazione. L’Europa però si avvicina lentamente agli
Stati Uniti senza superarli, Giappone e Corea del Sud invece bruciano le tappe. Più
che la durata dell’istruzione, comunque, sono le competenze acquisite dagli studenti a
contare. I test standardizzati di matematica, condotti dal programma OCSE-PISA sui
15enni, rilevano una posizione di forza di tutti i paesi asiatici che, quindi, oltre a convergere nella quantità, conducono la classifica della qualità. Fra i paesi europei tiene il
ritmo solo la Germania, che migliora nelle ultime edizioni dell’indagine. Staccati invece
gli Stati Uniti.
In Giappone e Corea più giovani laureati. Permane il ritardo europeo nella quota di laureati sulla popolazione. Negli Stati Uniti il 42% circa dei 25-34enni hanno un diploma
di istruzione terziaria, in Europa solo il 37,1%. Raggiungere il 40%, che rappresenta
l’obiettivo di Europa 2020, appare realistico.
Imbattibili le università USA. Anche nell’istruzione superiore ciò che conta è la qualità.
In assenza di indicatori affidabili sulle competenze dei laureati è possibile utilizzare le
classifiche delle università. Una delle più usate, lo Shanghai Ranking, rivela un forte ritardo europeo rispetto agli Stati Uniti nelle università di livello eccellente (top100). Più
contenuta, invece, la distanza nel numero di università medio buone (top500).
Popolazione mondiale: la crescita senza precedenti e frenata
in vista – Popolazione: la Cina si sgonfia, l’India nazione più
popolosa, Africa sette volte l’UE – Sarà africano un terzo dei
terrestri – Popolazione: si dimezza il peso dell’Europa, stabile
quello USA – Ritorno all’antico: Cina e India avanti a USA e
UE – Popolazione: Giappone, Germania, Polonia e Italia in
declino nel prossimo decennio – Crescita del PIL: la rivoluzione industriale mette le ali all’Europa nel 700-800… – …
ma la Cina decolla negli anni 80, (in)seguita dall’India – PIL:
la Cina sorpassa e doppia gli USA, l’UE peserà la metà – A valori correnti Europa e USA restano (per ora) giganti – Italia ad
alta vocazione industriale – La crescita dell’industria è in Asia,
gli USA tengono il passo, l’UE no – Manifatturiero: l’ascesa
cinese contro USA e UE – Non solo il PIL spinge sul podio
olimpico – Olimpiadi: l’Europa resta in testa nonostante il calo
tedesco
29
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
1.1
la nuova mappa dell’economia globale
29
30
30
0
100
200
300
400
500
600
Popolazione mondiale
700
800
900 1000 1100
Variazione popolazione decennale (scala destra)
Previsioni dopo il 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
0
2
4
6
8
10
Popolazione mondiale: la crescita senza precedenti e frenata in vista
(Miliardi di abitanti)
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
titolo capitolo
31
31
8
5
1
Turchia
Francia
Regno Unito
Italia
1
1
5
1
6
3
10
4
17
16
9
32
38
12
39
34
10
42
91
262
361
1.278
1870
5
25
19
9
42
40
54
43
18
79
111
295
403
1.566
1900
7
25
28
19
51
42
21
68
82
54
158
230
372
551
2.532
1950
7
29
30
25
53
46
28
73
93
73
186
287
448
658
3.038
1960
8
33
34
31
56
51
35
78
104
96
209
368
554
815
3.696
1970
8
36
37
37
56
54
44
78
116
122
230
483
700
983
4.453
1980
9
38
39
43
57
57
54
79
122
150
253
635
874
1145
5.306
1990
9
38
40
46
59
59
64
82
126
174
282
811
1.054
1.269
6.123
2000
9
38
46
48
62
63
73
82
127
195
310
1.022
1.225
1.341
6.896
2010
10
38
49
50
66
66
81
81
125
210
337
1.278
1.387
1.388
7.657
2020
2100
11
35
51
47
73
72
92
75
109
223
403
2.192
1.692
1.296
12
29
45
37
76
80
79
70
91
177
478
3.574
1.551
941
9.306 10.125
2050
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
Previsioni dopo il 2010. Il dato UE-27 prima del 1950 è basato su tassi di variazione riferiti a 30 Stati europei. Paesi ordinati per il 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite e Maddison Project.
0
4
0
1
0
9
Svezia
8
Polonia
7
12
4
21
31
10
25
30
5
10
75
216
384
1.043
1820
4
9
21
8
15
26
1
1
62
171
139
605
1700
Spagna
6
18
8
16
18
1
2
56
140
161
557
1600
9
4
15
6
12
15
1
2
47
114
104
439
1500
Sud Corea
2
6
7
4
7
1
3
1
Stati Uniti
3
UE-
33
Germania
17
Africa
59
78
Giappone
78
India
1
60
Cina
268
1000
Brasile
226
Mondo
1
Popolazione: la Cina si sgonfia, l’India nazione più popolosa, Africa sette volte l’UE
(Milioni di abitanti)
32
32
1970
1990
UE-27
Africa
Stati Uniti
India
Cina
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
0
1950
5
10
15
20
25
30
35
40
Sarà africano un terzo dei terrestri
(% della popolazione mondiale)
2010
2030
2050
2070
2090
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
titolo capitolo
33
33
0,1
0,1
0,2
1,0
0,2
1,0
0,3
1,3
1,3
0,7
,
2,5
3,0
0,9
3,1
2,6
0,8
3,3
,
7,1
20,5
28,2
1870
0,3
1,6
1,2
0,6
,
2,7
2,6
3,5
2,8
1,2
5,1
,
7,1
18,8
25,7
1900
0,3
1,0
1,1
0,8
,
2,0
1,7
0,8
2,7
3,2
2,1
6,2
,
9,1
14,7
21,8
1950
0,2
1,0
1,0
0,8
,
1,7
1,5
0,9
2,4
3,0
2,4
6,1
,
9,4
14,7
21,7
1960
0,2
0,9
0,9
0,9
,
1,5
1,4
1,0
2,1
2,8
2,6
5,7
,
10,0
15,0
22,0
1970
0,2
0,8
0,8
0,8
,
1,3
1,2
1,0
1,8
2,6
2,7
5,2
,
10,8
15,7
22,1
1980
0,2
0,7
0,7
0,8
,
1,1
1,1
1,0
1,5
2,3
2,8
4,8
,
12,0
16,5
21,6
1990
0,1
0,6
0,7
0,8
,
1,0
1,0
1,0
1,3
2,1
2,8
4,6
,
13,2
17,2
20,7
2000
0,1
0,6
0,7
0,7
,
0,9
0,9
1,1
1,2
1,8
2,8
4,5
,
14,8
17,8
19,5
2010
0,1
0,5
0,6
0,7
,
0,9
0,9
1,1
1,1
1,6
2,7
4,4
,
16,7
18,1
18,1
2020
0,1
0,4
0,6
0,5
,
0,8
0,8
1,0
0,8
1,2
2,4
4,3
,
23,6
18,2
13,9
2050
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
Previsioni dopo il 2010. Il dato UE-27 prima del 1950 è basato su tassi di variazione riferiti a 30 Stati europei. Paesi ordinati per il 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite e Maddison Project.
0,1
0,9
0,1
0,9
Svezia
0,4
0,2
1,5
,
Polonia
1,5
,
2,1
2,9
1,0
2,4
2,9
0,4
1,0
,
7,2
20,7
36,8
1820
1,2
1,5
,
1,4
3,5
1,4
2,5
4,4
0,2
0,2
,
10,2
28,3
23,0
1700
0,8
1,5
,
1,1
3,3
1,4
2,9
3,3
0,1
0,3
,
10,0
25,1
28,9
1600
1,7
,
0,9
3,4
1,4
2,7
3,4
0,2
0,5
,
10,7
25,9
23,6
1500
Spagna
,
Italia
0,8
2,4
2,6
1,3
2,7
0,3
0,5
,
12,2
29,0
22,2
1000
Sud Corea
2,2
3,6
Turchia
0,4
1,3
Germania
Regno Unito
1,3
Giappone
Francia
0,3
,
UE-
0,0
7,6
Africa
Brasile
34,3
India
Stati Uniti
26,5
Cina
1
Popolazione: si dimezza il peso dell’Europa, stabile quello USA
(% abitanti su totale mondiale)
0,1
0,3
0,4
0,4
,
0,7
0,8
0,8
0,7
0,9
1,8
4,7
,
35,3
15,3
9,3
2100
34
34
1
1000
Fonte: elaborazioni CSC su dati Maddison Project e OCSE.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1900
Ritorno all’antico: Cina e India avanti a USA e UE
(% PIL mondiale in dollari USA, 2005, prezzi costanti e PPA costanti)
1950
UE-27
2000
Stati Uniti
Cina
2050
India
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
titolo capitolo
35
35
,
,
1,6
1,2
0,6
Sud Corea
UE-
Italia
Polonia
Giappone
Germania
6,5
12,5
17,0
,
,
30,5
19,5
9,2
8,3
6,6
3,8
34,8
18,1
32,6
20,4
24,7
20,0
c
m
0,7
1,2
1,1
,
,
2,3
2,2
1,1
1,1
0,7
0,6
2,8
1,2
2,3
2,1
2,5
2,0
anni 60
7,4
12,1
12,0
,
,
25,4
23,8
11,1
11,1
7,5
5,9
32,1
12,4
25,9
23,7
28,4
21,6
c
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Previsioni dopo anni 2000. Paesi ordinati per gli anni 10.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
1,8
2,7
Cina
0,8
0,9
Francia
Svezia
Spagna
0,4
0,6
Regno Unito
1,7
2,9
Turchia
3,0
1,9
India
Brasile
2,2
Africa
Stati Uniti
1,8
Mondo
m
anni 50
m
0,0
1,1
0,9
,
,
1,8
1,9
0,6
1,0
0,3
0,1
2,4
0,9
2,2
2,4
2,7
1,9
anni 70
0,2
11,8
9,4
,
,
19,1
20,7
6,1
11,0
3,3
1,2
26,7
9,7
24,4
26,4
31,1
20,5
c
m
0,1
0,5
0,7
,
,
1,4
1,5
0,5
0,4
0,3
0,2
2,1
1,0
2,1
2,2
2,8
1,8
anni 80
1,0
5,5
7,0
,
,
14,7
16,5
5,2
3,7
3,0
1,6
23,0
10,2
22,7
24,8
31,6
19,2
c
Popolazione: Giappone, Germania, Polonia e Italia in declino nel prossimo decennio
(Variazioni %)
,
0,7
1,0
0,4
0,4
0,3
0,3
1,5
1,1
1,6
1,9
2,5
1,4
15,4
4,1
2,8
0,6
,
,
7,0
10,8
4,1
3,6
3,5
2,9
16,6
11,5
17,5
20,6
27,7
c
,
,
0,5
0,6
0,6
1,4
0,6
0,5
1,1
0,9
1,3
1,5
2,3
1,2
-0,0
0,1
-0,0
m
-0,1
0,6
-0,1
,
,
4,8
5,7
6,3
14,4
5,9
5,4
11,8
9,9
14,3
16,2
26,0
12,6
c
anni 2000
0,0
,
,
0,3
0,3
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
2,3
1,1
-0,2
-0,1
m
anni 10
11,0
-1,6
-1,4
0,3
,
,
3,4
3,5
4,9
5,6
5,8
6,1
7,9
8,6
11,0
13,3
25,0
c
-0,2
-0,4
-0,1
-,
,
0,1
0,0
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
2,0
0,8
anni 20
m
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
0,4
0,3
0,1
,
m
anni 90
8,7
-1,9
-3,7
-1,4
-,
,
1,1
0,4
3,9
2,7
4,6
5,3
4,8
7,3
7,3
9,8
22,2
c
36
36
0,4
0,1
0,0
Africa
Giappone
India
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,0
0,2
124,8
79,3
141,5
40,5
-10,0
149,7
104,9
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per il 1820-1870.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Maddison Project.
Polonia
2,5
0,0
165,7
70,9
-4,5
-3,6
15,0
,
294,9
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
,
42,6
55,3
22,7
24,9
21,1
25,4
56,4
33,4
,
0,2
-0,1
0,2
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
,
-13,8
22,2
60,0
10,0
6,3
6,4
12,0
,
25,6
m
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,5
,
0,5
,
1,4
0,7
0,6
1,0
2,7
0,8
0,1
Turchia
0,0
0,0
Spagna
0,3
,
,
67,8
77,6
7,9
78,3
-12,2
c
Cina
0,0
Mondo
16,8
-,
,
0,5
0,6
0,1
0,6
-0,1
m
176,1
12,6
22,8
34,8
21,3
28,5
64,4
86,9
,
81,5
,
407,3
123,0
96,5
238,3
2.281,0
c
1700-1820
0,1
0,0
Italia
,
-14,5
48,6
53,3
113,4
-25,0
c
1600-1700
Sud Corea
0,0
-,
Francia
,
123,8
0,4
0,8
-0,3
,
,
0,2
475,3
251,9
53,8
m
-0,2
-,
100,0
0,4
0,3
0,1
c
,
Svezia
17,1
150,0
m
1500-1600
UE-
0,1
Germania
91,2
c
1000-1500
Brasile
0,1
0,0
Regno Unito
0,1
Stati Uniti
m
1-1000
Crescita del PIL: la rivoluzione industriale mette le ali all’Europa nel 700-800…
(Variazioni % su dati a prezzi e PPA costanti)
0,1
0,4
0,4
0,7
0,8
0,9
0,9
,
1,4
,
1,8
2,0
2,0
2,1
4,2
-0,4
m
-17,0
4,5
21,1
22,4
45,2
50,2
59,0
60,0
,
103,3
,
139,9
168,6
169,0
176,5
684,0
c
1820-1870
m
2,9
0,5
0,8
2,4
1,3
1,8
1,9
,
1,6
,
1,9
2,3
2,7
2,1
3,9
138,3
15,0
26,4
104,9
46,2
69,6
77,7
,
61,9
,
74,7
99,7
125,0
84,5
217,7
c
1870-1900
0,9
0,2
0,5
2,3
2,3
1,2
2,0
,
1,3
,
4,1
2,9
1,0
1,3
3,1
59,8
12,3
30,4
209,4
206,4
85,2
170,6
,
88,9
,
632,3
320,0
63,5
88,2
365,9
c
1900-1950
m
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
titolo capitolo
37
37
4,6
6,3
Polonia
Turchia
2,7
3,5
,
4,6
7,7
8,8
,
Spagna
Regno Unito
Stati Uniti
UE-
Francia
Germania
Giappone
Italia
,
133,0
110,5
56,3
,
40,6
30,2
53,2
38,5
58,0
87,4
85,0
56,6
70,8
48,4
47,1
80,3
c
4,2
5,6
,
4,2
2,8
8,6
4,8
5,0
5,7
5,7
4,2
8,7
5,0
3,7
3,7
,
10,5
m
anni 60
,
170,2
51,0
71,9
,
50,6
32,3
127,4
59,1
63,2
74,7
73,6
51,4
129,9
62,4
43,6
44,2
c
m
,
4,5
2,9
3,7
,
3,2
1,9
3,6
2,0
3,8
8,1
4,1
3,6
9,0
4,0
3,1
6,2
anni 70
,
54,7
33,0
43,5
,
37,6
21,2
42,8
21,4
45,5
118,5
49,0
41,8
135,9
48,2
35,7
82,0
c
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per gli anni 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Maddison Project, OCSE e Nazioni Unite.
3,3
4,4
Svezia
6,5
5,5
Sud Corea
4,7
4,0
Africa
Mondo
3,9
India
Brasile
6,1
Cina
m
anni 50
…ma la Cina decolla negli anni 80, (in)seguita dall’India
(Variazioni % su dati a prezzi e PPA costanti)
9,7
2,2
5,6
9,3
,
4,6
2,3
2,4
,
3,2
2,7
2,9
2,2
3,1
1,5
5,2
-0,5
m
anni 80
,
57,3
25,9
26,5
,
37,4
30,7
33,5
24,3
35,5
16,4
66,2
-4,6
152,9
24,6
72,3
144,0
c
,
11,9
21,2
21,5
,
40,1
31,4
31,8
23,0
35,2
31,1
43,3
44,9
88,3
30,1
73,0
168,0
c
,
0,8
1,0
1,1
,
1,5
1,8
2,0
2,2
3,2
3,6
3,9
3,9
4,2
5,1
7,4
10,5
m
,
7,9
10,2
11,7
,
16,4
19,1
22,4
23,8
37,2
42,6
46,2
46,5
50,2
64,1
104,0
170,9
c
anni 2000
1,0
1,7
2,2
,
2,5
1,8
2,2
2,7
4,1
4,2
5,4
3,1
3,3
7,1
8,3
,
m
anni 10
,
10,5
18,9
24,1
,
28,1
19,8
24,7
30,9
49,5
50,4
69,4
36,2
38,2
98,9
122,9
c
m
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
,
1,1
1,9
2,0
,
3,4
2,8
2,8
2,1
3,1
2,7
3,7
3,8
6,5
2,7
5,6
10,4
m
anni 90
,
1,4
1,0
2,0
,
2,4
2,1
2,3
2,2
3,5
3,8
3,9
2,1
2,2
6,4
5,0
anni 20
,
14,7
10,5
22,2
,
26,6
23,1
25,9
24,0
41,4
45,7
47,2
22,6
24,5
85,2
63,5
c
38
,
Italia
38
0,2
0,2
0,3
0,4
1,3
0,6
0,2
1,3
0,7
2,8
0,0
2,8
0,0
,
7,0
0,8
11,6
10,7
7,6
3,1
4,4
19,4
,
1900
1,1
1,6
0,9
1,9
0,3
,
4,9
2,1
8,0
6,5
3,7
3,6
1,8
33,4
,
1950
0,9
1,6
1,1
1,9
0,4
,
4,8
2,5
6,6
8,6
3,4
5,3
2,1
29,7
,
1960
0,9
1,5
1,1
2,6
0,5
,
5,1
2,7
5,4
8,0
3,0
8,8
1,8
27,4
,
1970
0,8
1,5
1,2
2,6
0,8
,
5,0
4,0
4,5
7,3
2,8
9,3
2,3
25,9
,
1980
La serie UE-27 è stata ricostruita con i tassi di crescita dei principali 30 paesi europei considerati nel Maddison Project.
Paesi ordinati per il 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Maddison project e OCSE.
0,1
1,9
Svezia
2,1
3,0
0,5
,
7,7
0,8
11,1
8,5
10,7
2,7
6,8
10,9
,
1870
2,1
2,2
3,0
0,8
,
6,0
0,5
6,4
5,0
14,2
3,6
13,1
2,2
,
1820
Polonia
5,0
6,0
3,6
Turchia
3,1
3,4
2,5
3,0
Spagna
,
6,2
0,2
3,6
4,8
21,6
4,9
8,9
0,2
,
1700
1,4
,
5,5
0,1
2,2
5,0
19,8
3,5
11,5
0,2
,
1600
Sud Corea
,
5,2
,
0,2
2,7
2,6
1,4
4,3
21,5
3,7
9,9
0,4
,
1500
Francia
0,8
1,5
24,6
3,1
9,0
0,5
,
1000
Brasile
0,4
Regno Unito
28,3
India
1,5
1,4
Giappone
Germania
0,3
10,1
Cina
,
Stati Uniti
UE-
1
PIL: la Cina sorpassa e doppia gli USA, l’UE peserà la metà
(% su PIL mondiale in dollari USA 2005, prezzi costanti e PPA costanti)
1,1
0,6
0,7
1,5
2,5
2,1
,
4,2
3,4
4,2
6,1
4,6
8,9
8,2
27,2
,
2000
1,0
1,4
2,5
1,5
,
4,7
3,5
4,3
6,8
3,6
10,8
4,1
26,3
,
1990
0,6
1,2
1,6
2,2
2,4
,
3,4
3,5
3,6
4,9
6,8
7,0
16,2
23,1
,
2010
0,5
1,1
1,8
1,8
2,2
,
2,8
3,5
2,9
3,9
9,1
5,2
24,2
19,8
,
0,4
0,9
1,9
1,6
1,9
,
2,5
3,6
2,5
3,0
11,9
4,2
28,0
17,8
,
0,4
0,8
1,9
1,4
1,6
,
2,1
3,6
2,4
2,5
14,7
3,6
29,7
16,7
,
0,4
0,7
1,8
1,3
1,4
,
1,9
3,5
2,4
2,2
17,2
3,3
29,5
16,3
,
0,4
0,6
1,7
1,3
1,3
,
1,8
3,3
2,4
2,0
19,4
3,2
27,9
16,3
,
2020 2030 2040 2050 2060
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
titolo capitolo
39
39
6,3
1,9
1,1
Germania
India
Brasile
0,8
Polonia
0,5
1,1
0,8
1,9
0,5
3,6
,
5,8
4,6
1,6
1,6
7,7
9,1
2,6
23,2
,
1980
0,3
1,1
0,9
2,3
1,2
2,2
,
5,6
4,5
1,7
1,5
7,7
13,9
1,8
25,8
,
1990
0,5
0,8
0,8
1,8
1,6
1,9
,
4,1
4,6
2,0
1,4
5,8
14,6
3,7
30,6
,
2000
0,7
0,7
1,1
2,2
1,6
2,7
,
4,0
3,6
3,4
2,6
5,2
8,6
9,4
22,7
,
2010
0,7
0,8
1,1
2,1
1,6
2,7
,
4,0
3,5
3,5
2,7
5,1
8,4
10,3
21,4
,
2011
0,6
0,7
1,1
1,8
1,6
2,7
,
3,5
3,3
3,3
2,7
4,6
8,1
11,1
21,2
,
2012
0,6
0,7
1,1
1,7
1,6
2,7
,
3,3
3,3
3,2
2,8
4,4
7,8
11,6
20,9
,
2013
Paesi ordinati per il 2011.
* Valori in milioni di dollari.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
0,6
0,7
1,1
1,6
1,6
2,7
,
3,1
3,2
3,3
3,1
4,1
7,3
12,5
20,4
,
2015
0,6
0,7
1,2
1,5
1,7
2,8
,
3,0
3,2
3,3
3,2
3,9
7,0
12,9
20,2
,
2016
0,6
0,6
1,2
1,5
1,7
2,8
,
2,9
3,2
3,3
3,4
3,8
6,7
13,3
20,0
,
2017
81.500.583 86.456.449 91.990.632 98.147.229
0,6
0,7
1,1
1,6
1,6
2,7
,
3,2
3,3
3,3
3,0
4,2
7,6
12,0
20,6
,
2014
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
3.294.760 11.903.800 22.274.800 32.370.800 63.580.800 70.201.900 73.573.207 77.195.078
1,1
Svezia
Mondo*
1,2
0,7
Sud Corea
Turchia
0,3
Africa
Spagna
,
2,7
Italia
3,8
6,3
Giappone
4,4
2,8
Cina
Francia
31,1
Stati Uniti
Regno Unito
,
UE-
1970
A valori correnti Europa e USA restano (per ora) giganti
(% PIL mondiale a prezzi e cambi correnti in dollari USA)
40
40
Germania
Giappone
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Sud Corea
Italia ad alta vocazione industriale
(Valore aggiunto manifatturiero pro-capite, a prezzi e cambi 2005)
Stati Uniti
Italia
UE-
1970
2000
Cina
2011
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
titolo capitolo
41
41
4,0
4,7
15,8
5,6
5,2
1,2
3,5
9,3
1,7
4,3
1,7
,
3,4
4,7
1,2
,
India
Polonia
Sud Corea
Turchia
Africa
Svezia
Mondo
Brasile
Stati Uniti
Giappone
Germania
UE-
Francia
Spagna
Regno Unito
Italia
c
,
12,5
58,4
39,4
,
18,3
52,5
18,0
143,1
40,7
12,6
65,5
71,7
334,5
58,3
48,3
143,3
m
,
1,9
2,2
1,1
,
1,7
4,8
2,5
0,3
2,9
2,0
2,6
7,3
12,2
-2,3
7,6
9,6
anni 80
c
,
20,7
23,9
11,6
,
18,3
59,9
28,0
2,7
32,8
21,4
29,5
101,7
215,9
-21,1
107,3
149,1
m
,
0,9
2,3
2,1
,
0,7
0,8
3,8
1,8
2,8
5,8
2,1
4,3
8,4
12,0
5,9
13,9
anni 90
c
,
9,3
25,8
23,5
,
7,5
8,6
45,5
19,6
32,1
75,7
22,7
52,6
124,7
209,9
77,1
266,8
m
-,
-0,9
-0,6
0,1
,
1,1
1,3
1,8
2,4
3,1
3,1
3,5
4,2
6,3
7,7
8,1
12,7
anni 2000
c
-,
-8,3
-6,0
0,7
,
11,3
13,8
19,7
27,3
35,4
35,9
40,4
50,3
84,3
110,5
117,4
231,3
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per gli anni 2000.
Serie della Cina 1970-2003 ricostruita con tassi di crescita del valore aggiunto dell’industria in senso stretto.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
9,3
Cina
m
anni 70
La crescita dell’industria è in Asia, gli USA tengono il passo, l’UE no
(Valore aggiunto manifatturiero, variazioni % su dati in dollari USA, prezzi e cambi 2005)
2011
,
2,1
2,9
0,8
,
8,3
-4,1
2,2
0,1
3,8
6,7
1,2
9,6
7,2
11,5
-0,3
9,7
titolo capitolo
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
Manifatturiero: l'ascesa cinese contro USA e UE
(% valore aggiunto mondiale, prezzi e cambi correnti)
1970
UE-
Cina
1980
,
1990
,
2000
,
2010
2011
,
,
,
3,7
3,9
3,6
7,1
18,9
20,7
Stati Uniti
28,9
21,4
22,7
26,4
18,4
16,8
Giappone
8,1
10,7
17,3
17,6
10,4
9,8
Germania
7,3
8,7
9,2
6,6
6,3
6,4
Italia
,
,
,
,
,
,
Sud Corea
0,2
0,5
1,4
2,3
2,7
2,8
Brasile
1,0
2,3
2,0
1,7
2,9
2,7
Francia
3,4
4,6
4,3
3,2
2,3
2,2
India
0,9
1,0
1,1
1,2
2,3
2,2
Regno Unito
3,9
4,3
4,1
3,5
2,1
2,1
Spagna
1,1
1,9
2,2
1,6
1,6
1,6
Africa
1,4
1,9
1,5
1,3
1,6
1,5
Turchia
0,5
0,7
1,2
0,9
1,1
1,1
Svezia
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
Polonia
Mondo*
1,0
0,7
0,5
0,5
0,7
0,7
830.620
2.626.545
4.411.212
5.325.876
10.203.727
11.316.493
* Valori in milioni di dollari.
Paesi ordinati per il 2011.
Serie della Cina 1970-2003 ricostruita con tassi di crescita del valore aggiunto dell’industria in senso stretto.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
42
42
43
43
0
20.000
PL
Fonte: elaborazioni CSC su dati CIO, FMI e Nazioni Unite
0
2
4
6
8
10
Non solo il PIL spinge sul podio olimpico
Medaglie olimpiadi 2012 per milione di abitanti
UE
SE
USA
60.000
80.000
100.000
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
PIL pro-capite in dollari PPA correnti 2012
40.000
UK
titolo capitolo
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
Olimpiadi: l’Europa resta in testa nonostante il calo tedesco
(Olimpiadi estive, quote % sul totale medaglie assegnate)
anni 50
anni 60
anni 70
anni 90
anni 2000
2012
UE-
,
,
,
,
,
,
,
Stati Uniti
16,2
18,0
15,5
13,0
12,6
10,9
10,8
2,9
6,3
7,9
9,1
4,6
Cina
Germania
5,4
9,6
19,4
15,9
8,9
5,2
Francia
Africa
3,4
2,3
1,8
2,8
4,0
4,0
3,5
1,6
2,0
1,5
1,7
3,6
3,9
3,4
Regno Unito
3,8
3,4
2,6
4,0
2,1
3,7
6,8
Italia
,
,
,
,
,
,
,
Sud Corea
0,4
0,3
0,6
2,5
3,4
3,2
2,9
Giappone
3,0
4,8
4,5
2,2
2,2
2,8
4,0
Spagna
0,1
0,1
0,2
0,7
2,4
1,7
1,8
Brasile
0,4
0,4
0,3
0,9
1,1
1,3
1,8
Polonia
1,4
4,2
3,9
2,3
2,2
1,2
1,0
Svezia
5,8
1,2
1,7
2,0
1,2
0,9
0,8
Turchia
1,1
1,1
0,1
0,2
0,7
0,8
0,5
India
0,3
0,2
0,1
0,0
0,1
0,2
0,6
Paesi ordinati per gli anni 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati CIO.
44
anni 80
44
PIL pro-capite: USA in testa, ma la Cina si avvicina – PIL procapite: si allarga il divario tra Italia e UE – Crescita PIL procapite: l’India sorpassa la Cina, l’Italia fanalino di coda – Indice
di sviluppo umano: Stati Uniti raggiunti dalla Germania, Cina
lontana – Produttività del lavoro: la frenata dell’Italia e l’accelerazione turca – Produttività dei fattori: Cina, India e Corea
crescono a due cifre anche nella crisi – La crisi frena il CLUP,
tranne che in Francia e Italia – CLUP: la crisi rallenta il costo
del lavoro, ma non in Italia – Costo del lavoro: Italia supera
gli Stati Uniti, doppia la Corea – Posti di lavoro: la crisi non
colpisce Turchia, Polonia e Germania – Occupazione: Svezia
e Germania in testa, Italia staccata – Occupazione femminile:
svedesi più favorite, italiane più penalizzate – In Italia i giovani
penalizzati due volte – Giovani occupati: la crisi colpisce duro,
ma non dappertutto – NEET: l’Europa meglio degli USA, nonostante Spagna e Italia – Facilità di fare impresa: Corea in
testa insieme a USA e Regno Unito, Italia distaccata – Italia
penultima nei costi per l’avvio di impresa – Avviare un’attività
imprenditoriale: in Italia resta tre volte più costoso che in Germania – Giustizia civile: quattro volte più lenta dei migliori
europei – Energia elettrica: in Italia è del 44% più cara della
media UE – Emissioni di CO2: la Cina supera gli Stati Uniti
e l’Italia torna ai livelli del 1990 – Intensità energetica: sale nei
paesi emergenti, ma negli avanzati è un multiplo
45
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
1.2
le misure di benessere e competitività
45
46
46
1950
1960
Cina
UE-27
Stati Uniti
1970
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE e Maddison Project.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
PIL pro-capite: USA in testa, ma la Cina si avvicina
(Valori a prezzi e PPA costanti in dollari USA)
1980
India
Italia
1990
Germania
2000
2010
2020
2030
2040
2050
1.2 le misure di benessere e competitività
2060
titolo capitolo
47
47
1.125
1500
1700
1870
1900
1950
1980
1990 2000 2010
2020
2030
5.314 12.948 17.792 26.507 28,876 30.886 34.707 41.325
2050
76.101
91.887
2060
49.194 58.980
51.066 60.992
.
441
Cina
557
576
700
487
807
573
873
1.217
1.751 3.224
5.663 9.547
781 1.377 2.517 6.804 14.823 24.138
3.385 4.432 7.532 7.134 7.882 10.051 14.029 19.505
3.635 4.787 6.454 7.810 8.942 9.969 12.494 17.435 23.535
330
67.034
56.708
1.2 le misure di benessere e competitività
14.703 20.685
34.928 45.364
25.457 31.330
30.594 37.978
32.903 38.771
27.613
55.249
36.395
46.212
44.591
5.155 7.100 9.204 8.199 11.814 17.194 23.280 29.175 34.424 39.055 44.797
2.631 3.643 4.989 5.907 7.914 9.732 12.521 19.093 26.187
984 2.424
401
44.055 48.636
958 1.376 2.432 4.851 10.910 18.730 26.774 35.688 43.968 50.663 57.962
Paesi ordinati per il 2010.
I dati riferiti a Turchia, Italia e Regno Unito si riferiscono per periodi precedenti al 1970 a Bisanzio e Impero ottomano, Nord e Centro Italia e Inghilterra.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE e Maddison Project.
496
390
991 1.034
Brasile
1.135 1.199
4.161 4.189
2.263 3.349 4.103 5.758 11.846 15.275 19.694 25.147 26.899 32.159 38.872
1.337
973 1.070
1.585 1.672 1.526
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
59.034
73.148
72.638
52.754 61.849 72.544
57.034 66.060
69.145 80.094
2040
1.493 2.467 3.782 6.821 9.730 15.008 20.289 24.324 28.296 29.598 35.054 41.336 46.762 52.313
983 1.572 2.560
6.181 9.549 11.896 14.817 17.729 22.812 29.129 32.814 36.851 42.837
4.351 5.657 11.232 15.800 20.857 25.904 30.306 33573 40.627 46.197
Turchia
India
1970
1.833 2.839 9.184 11.839 17.329 20.363 24.567 29.146 34.126 41.413 48.895
2.681
1.517 2.463 3.924
Mondo
1960
1.860 3.342 5.592 13.069 15.485 20.544 25.453 31.827 39.512 41.940 49.564 58.501
1820
1.038 1.826 1.210
1600
Polonia
1.135
.
789
Spagna
Sud Corea
1000
826 1.042 1.494 1.489 2.082 2.854 4.390
Italia
UE-
Francia
Giappone
Regno Unito
Germania
Svezia
Stati Uniti
1
PIL pro-capite: si allarga il divario tra Italia e UE
(Valori a prezzi e PPA costanti in dollari USA)
48
38,5
39,7
43,6
28,9
98,5
40,3
3,3
3,4
2,8
2,8
3,7
2,6
7,1
Turchia
Brasile
Mondo
Polonia
Sud Corea
Svezia
Germania
2,2
,
Regno Unito
Italia
,
24,6
107,5
18,5
,
42,6
1,4
,
2,2
9,3
2,9
,
4,4
7,5
3,5
3,9
5,9
3,3
3,0
2,7
3,2
15,2
,
24,5
143,7
32,7
,
54,2
105,7
40,7
46,4
76,7
37,7
34,8
30,9
37,0
,
1,8
3,2
2,2
,
3,1
2,6
2,8
1,6
7,2
2,6
1,9
5,4
1,7
0,6
4,3
m
,
19,7
37,4
23,9
,
35,2
28,9
32,0
17,5
99,5
29,6
21,0
70,0
18,4
6,0
53,0
c
anni 70
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per gli anni 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE e Maddison Project.
1,7
7,6
Giappone
,
UE-
Stati Uniti
3,4
3,6
Spagna
48
Francia
31,4
31,7
21,7
2,0
India
1,6
17,6
47,8
4,0
Cina
c
c
m
m
anni 60
anni 50
,
2,6
4,1
2,3
,
1,8
2,6
2,2
1,9
8,4
-1,1
1,4
-0,5
3,0
3,6
7,7
m
,
28,7
49,0
25,0
,
19,9
28,9
24,2
20,6
124,9
-10,9
14,5
-5,3
34,0
41,8
110,7
c
anni 80
Crescita PIL pro-capite: l’India sorpassa la Cina, l’Italia fanalino di coda
(Variazioni % su dati a prezzi e PPA costanti)
24,1
8,9
27,7
, -,
2,2
0,9
2,5
,
0,5
1,2
0,7
0,6
,
16,3
,
0,7
1,5
27,7
2,5
1,0
1,6
3,6
3,8
2,3
2,5
2,6
5,9
9,9
m
-,
12,6
7,0
6,1
,
4,6
7,0
10,8
17,1
42,9
45,5
25,3
27,5
28,7
77,0
156,1
c
anni 2000
,
18,6
17,0
1,7
1,6
71,7
5,6
10,5
11,5
23,0
2,1
1,0
44,1
44,5
3,8
1,1
141,8
9,2
3,7
c
m
anni 90
-,
1,2
1,2
1,7
,
1,7
1,8
1,9
2,0
2,9
3,1
3,4
3,4
4,3
5,8
8,1
m
-,
12,3
12,4
18,2
,
18,4
19,6
21,0
21,4
33,3
35,4
39,5
39,6
52,5
75,7
117,8
c
anni 2010
,
1,5
1,8
1,7
,
1,7
1,9
1,3
1,7
2,1
2,3
3,0
3,4
3,2
5,4
5,0
m
,
16,2
19,1
18,0
,
17,9
20,9
13,7
18,1
23,2
25,3
35,0
39,0
37,2
68,6
62,8
c
anni 2020
,
1,8
1,8
1,7
,
1,2
1,3
1,3
1,6
1,4
1,7
2,7
2,7
2,3
4,4
3,8
m
,
19,2
19,0
18,2
,
13,1
13,3
14,2
16,6
15,2
18,0
30,0
30,5
25,6
54,0
44,7
c
anni 2030
1.2 le misure di benessere e competitività
,
1,8
1,8
1,5
,
1,1
1,0
1,6
1,5
1,4
1,3
2,2
2,1
1,7
3,5
2,6
m
,
19,4
19,9
15,8
,
11,9
10,4
17,2
15,8
14,4
13,5
24,1
23,1
17,8
40,7
29,9
c
anni 2040
,
1,8
2,2
1,4
,
1,2
1,5
1,6
1,4
1,5
1,4
2,0
1,5
1,4
2,9
2,0
m
,
19,1
24,0
14,7
,
12,8
16,6
17,3
15,2
15,7
14,7
21,7
16,2
15,0
33,5
21,8
c
anni 2050
titolo capitolo
Indice di sviluppo umano: Stati Uniti raggiunti dalla Germania, Cina lontana
(1 massimo sviluppo, 0 minimo sviluppo)
Stati Uniti
0,84
1985
1990
0,85
0,87
1995
2000
2005
2010
0,88
0,90
0,90
0,91
2011
0,91
Germania
0,73
0,75
0,80
0,84
0,86
0,90
0,90
0,91
Svezia
0,79
0,80
0,82
0,86
0,89
0,90
0,90
0,90
Giappone
0,78
0,80
0,83
0,85
0,87
0,89
0,90
0,90
Sud Corea
0,63
0,69
0,74
0,79
0,83
0,87
0,89
0,90
Francia
0,72
0,74
0,78
0,82
0,85
0,87
0,88
0,88
Spagna
0,69
0,72
0,75
0,80
0,84
0,86
0,88
0,88
Italia
,
,
,
,
,
,
,
,
UE-
,
,
,
,
,
,
,
,
Regno Unito
0,74
0,76
0,78
0,82
0,83
0,86
0,86
0,86
0,73
0,77
0,79
0,81
0,81
0,60
0,63
0,67
0,69
0,72
0,72
Polonia
Brasile
0,55
0,58
Turchia
0,46
0,52
0,56
0,59
0,63
0,67
0,70
0,70
Cina
0,40
0,45
0,49
0,54
0,59
0,63
0,68
0,69
Mondo
0,56
0,58
0,59
0,61
0,63
0,66
0,68
0,68
India
0,34
0,38
0,41
0,44
0,46
0,50
0,54
0,55
Africa
0,37
0,39
0,41
0,42
0,44
0,47
0,50
0,50
1.2 le misure di benessere e competitività
1980
Paesi ordinati per il 2011.
L’indice riflette i livelli di PIL pro-capite, istruzione e speranza di vita.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
49
49
50
5,5
51,8
4,1
50,1
49,0
2,1
1,0
2,6
11,2
5,1
13,9
2,0
2,5
0,2
31,0
10,4
13,2
1,2
12,5
34,8
m
2,4
34,2
9,6
1,9
13,1
2,5
6,1
19,5
0,5
23,2
4,3
3,6
c
50
2,1
0,8
Italia
Cina
India
16,6
8,3
23,0
,
4,0
4,3
,
1,2
2,9
48,4
51,8
,
12,5
32,8
2,9
9,5
,
2,0
2,0
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per la seconda metà anni 2000.
I dati relativi a Cina e India si riferiscono alla produttività del lavoro per addetto.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE, Eurostat e UNIDO.
1,6
,
Svezia
48,3
15,5
57,7
,
10,6
10,3
4,2
5,8
,
2,7
2,0
4,0
Francia
1,8
2,5
15,1
13,1
,
2,8
2,5
2,7
22,2
25,8
Regno Unito
2,0
2,3
UE-
30,9
44,9
22,6
32,5
,
14,1
10,4
13,2
,
9,5
,
12,4
7,2
15,5
,
,
2,4
1,4
2,9
,
5,5
Germania
4,1
31,1
c
7,0
3,8
Giappone
32,1
2,7
6,1
31,1
m
1,1
4,3
Turchia
57,6
1,2
5,6
c
1,4
2,8
Spagna
15,6
104,8
m
prima metà
anni 2000
Euro area
1,6
4,7
Stati Uniti
1,5
7,4
c
seconda metà
anni 90
2,4
17,0
m
prima metà
anni 90
6,2
c
anni 80
Polonia
Sud Corea
m
anni 70
Produttività del lavoro: la frenata dell’Italia e l’accelerazione turca
(Valore aggiunto a prezzi costanti per ora lavorata, intera economia, variazioni %)
m
4,5
,
0,5
0,5
0,7
,
0,8
0,9
1,1
1,4
1,5
1,5
2,9
c
anni 2000
,
2,3
2,7
3,3
,
4,3
4,5
5,6
7,4
7,6
7,9
15,1
24,4
seconda metà
1.2 le misure di benessere e competitività
,
1,5
1,4
2,0
,
1,2
1,6
4,3
2,5
1,4
0,3
3,4
6,6
2011
titolo capitolo
51
51
0,5
,
Svezia
Italia
-14,6
1,8
1,7
,
2,6
-1,2
6,7
15,0
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per la seconda metà anni 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Conference Board.
-3,1
0,9
Regno Unito
Turchia
1,8
Brasile
0,3
0,4
Stati Uniti
0,4
-0,2
Giappone
Francia
4,6
1,3
Germania
Spagna
1,9
9,2
2,8
Polonia
7,5
10,4
1,5
2,0
Sud Corea
24,6
India
4,5
c
Cina
m
prima metà
anni 90
m
-0,1
0,6
-0,4
,
1,3
0,4
-0,2
1,0
-0,2
1,2
3,2
2,0
1,9
-1,4
seconda metà
anni 90
c
-0,3
3,2
-2,1
,
6,7
2,1
-0,8
5,1
-1,1
6,0
16,8
10,3
9,7
-6,6
3,6
0,7
8,3
-,
-4,1
0,4
6,7
1,6
-,
-0,8
0,1
1,3
3,7
0,7
-1,4
3,2
0,6
-0,3
3,1
2,7
0,5
8,8
0,6
11,2
2,1
27,2
1,7
4,9
c
m
-2,3
-0,7
-0,7
-,
-0,5
-0,3
-0,1
0,0
0,3
0,3
0,9
2,4
2,4
3,6
anni 2000
seconda metà
c
-10,9
-3,4
-3,3
-,
-2,7
-1,7
-0,4
-0,2
1,7
1,7
4,7
12,4
12,9
19,3
2011
1.2 le misure di benessere e competitività
m
prima metà
anni 2000
Produttività totale dei fattori: Cina, India e Corea crescono a due cifre anche nella crisi
(Variazioni % su dati a prezzi costanti, intera economia)
1,7
0,5
0,0
,
1,0
-0,1
-0,4
0,6
1,0
1,4
1,3
0,5
0,8
2,1
2012
0,1
-2,1
-1,0
-0,2
-,
0,0
-1,5
-1,8
0,2
0,0
-0,4
-0,6
-0,7
52
52
Spagna
Italia
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Regno Unito Francia
La crisi frena il CLUP, tranne che in Francia e Italia
(Costo del lavoro per unità di prodotto intera economia, variazioni %)
Stati Uniti Sud Corea
UE-17
Svezia
Anni 1990
Germania
Giappone
Anni 2000
1.2 le misure di benessere e competitività
titolo capitolo
53
53
133,9
0,9
9,1
0,0
20,7
1,4
-2,0
c
1.2 le misure di benessere e competitività
0,0
1,9
14,9
,
1,8
1,8
2,1
2,6
,
2,7
8,9
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per gli anni 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
21,2
1,4
,
56,4
23,3
10,2
30,1
,
48,7
m
Giappone
1,9
95,0
,
4,6
2,1
1,0
2,7
,
4,0
c
0,2
71,7
6,9
,
75,3
51,1
64,2
86,0
,
118,5
m
5,6
162,5
,
5,8
4,2
5,1
6,4
,
8,1
c
anni 2000
Germania
10,1
Svezia
,
489,1
107,0
162,4
285,7
,
345,2
m
anni 90
1,0
,
EU-
c
anni 80
Polonia
7,5
10,1
Francia
19,4
14,5
Regno Unito
Stati Uniti
,
Italia
Sud Corea
16,1
Spagna
m
anni 70
CLUP: la crisi rallenta il costo del lavoro, ma non in Italia
(Costo del lavoro per unità di prodotto, intera economia, variazioni %)
-18,5
1,7
10,0
14,4
,
19,1
19,4
22,6
28,7
,
30,4
2011
0,7
0,7
,
0,8
0,8
0,8
,
0,7
titolo capitolo
Costo del lavoro: Italia supera gli Stati Uniti, doppia la Corea
(Costo orario del lavoro nel manifatturiero)
dollari usa
1.2 le misure di benessere e competitività
1997
54
usa = 100
2011
1997
2011
Svezia
25
49
109
138
Germania
29
47
127
133
Francia
25
42
108
119
Italia
Giappone
22
36
95
101
Stati Uniti
23
36
100
100
Regno Unito
19
31
84
87
Spagna
14
28
61
80
Sud Corea
9
19
40
53
Brasile
7
12
31
33
Polonia
3
9
14
25
Paesi ordinati per il 2011.
Fonte: elaborazioni CSC su dati BLS.
54
55
55
1,5
0,5
anni 80
c
5,3
m
Giappone
m = Medie annue.
c = Cumulate.
Paesi ordinati per gli anni 2007-2011.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
UE-
Spagna
2,4
0,8
Stati Uniti
8,7
26,2
0,8
1,2
1,8
7,8
13,1
19,6
c
17,3
2,9
15,2
-,
1,2
6,9
-6,9
17,0
28,0
16,4
m
-0,6
2000-2007
1,5
,
4,0
-0,1
0,9
,
1,0
1,3
1,0
c
,
31,7
-0,5
6,7
,
7,1
9,3
7,0
10,8
4,4
4,9
-3,9
1.2 le misure di benessere e competitività
1,6
0,3
1,4
-,
,
Italia
,
0,1
,
0,7
,
1,6
-0,7
Regno Unito
7,6
32,2
Francia
2,8
0,7
9,9
Svezia
0,9
Sud Corea
2,5
1,5
anni 90
0,6
0,1
m
Germania
c
0,7
Turchia
anni 70
Polonia
m
Posti di lavoro: la crisi non colpisce Turchia, Polonia e Germania
(Numero di occupati, variazioni %)
m
-2,9
-1,7
-1,1
-,
0,1
0,2
0,6
0,9
1,1
1,4
3,8
2007-2011
c
-11,1
-6,8
-4,2
-,
0,2
0,8
2,3
3,4
4,5
5,8
16,3
56
56
51,8
57,4
44,4
67,0
,
64,3
59,4
75,1
,
46,3
Paesi ordinati per il 2011.
UE-21 prima del 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat e OCSE.
48,9
79,3
,
59,3
63,8
63,3
,
66,7
70,1
70,3
71,2
72,7
2010
Turchia
52,4
,
53,0
63,7
63,7
,
71,5
69,3
72,7
65,5
74,0
2005
54,8
54,5
,
55,0
61,7
61,5
,
74,1
68,9
72,2
65,6
74,3
2000
India
Cina
Brasile
,
46,2
48,3
,
57,1
59,5
63,5
,
60,8
61,2
72,5
,
Italia
52,7
72,2
,
69,2
69,2
64,6
72,2
Spagna
60,6
57,4
,
69,0
1995
58,1
,
59,2
,
72,5
64,1
83,1
68,6
1990
Polonia
Francia
Sud Corea
,
67,2
,
UE-
63,1
64,0
Stati Uniti
66,8
66,9
65,8
61,6
80,2
67,9
65,2
79,8
1985
Giappone
64,4
1980
66,7
66,9
Germania
77,0
1975
Regno Unito
72,3
Svezia
1970
Occupazione: Svezia e Germania in testa, Italia staccata
(Quota % di occupati su popolazione 15-64enni)
1.2 le misure di benessere e competitività
70,3
70,4
72,6
74,1
48,4
,
58,5
59,7
63,8
63,9
,
66,6
2011
titolo capitolo
57
57
72,2
26,2
,
22,3
,
52,5
1.2 le misure di benessere e competitività
30,2
,
50,0
,
52,6
26,2
Paesi ordinati per il 2010.
UE-21 prima del 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE e Eurostat.
32,9
,
50,5
53,0
53,0
Turchia
,
49,0
51,9
29,0
,
,
,
Italia
44,1
48,9
42,0
,
59,7
60,1
62,4
65,3
66,1
68,0
70,3
2010
India
44,6
Sud Corea
31,8
47,0
25,8
,
51,8
28,5
,
32,5
31,1
,
58,4
58,1
65,6
66,6
Spagna
,
54,8
56,7
67,8
65,6
71,8
59,6
2005
Polonia
,
52,0
56,4
65,8
62,5
55,3
70,9
2000
55,3
,
,
,
UE-
50,9
55,8
64,0
62,8
52,2
81,0
1995
Brasile
49,5
Francia
53,0
59,3
51,4
55,4
52,8
Giappone
48,8
46,3
Stati Uniti
48,4
55,6
47,7
Regno Unito
49,6
76,8
1990
58,1
47,3
73,3
1985
73,8
46,3
66,5
1980
Germania
58,3
1975
Cina
Svezia
1970
Occupazione femminile: svedesi più favorite, italiane più penalizzate
(Quota % di donne occupate su donne 15-64enni)
71,9
27,8
,
53,1
52,8
53,1
,
59,7
60,3
62,0
65,3
67,7
2011
58
58
Giappone Svezia
Germania Regno Unito Francia
Fonte: elaborazioni su dati OCSE e Eurostat.
50
55
60
65
70
75
80
85
Spagna
Anni 2000
Polonia Stati Uniti UE-27 Sud Corea
In Italia i giovani penalizzati due volte
(Tasso di occupazione 25-29enni in % della popolazione della corrispondente classe di età)
2011
Italia
1.2 le misure di benessere e competitività
Turchia
titolo capitolo
Giovani occupati: la crisi colpisce duro, ma non dappertutto
(Tasso di occupazione 25-29enni in % della popolazione della corrispondente classe di età)
Giappone
69,5
anni 80
anni 90
anni 2000
2010
2011
73,0
78,0
78,9
79,8
80,2
Svezia
80,1
86,6
76,9
77,9
76,3
78,0
Germania
72,2
69,6
73,9
73,2
75,6
77,4
Regno Unito
71,3
75,8
79,4
77,8
77,2
Francia
76,4
74,4
77,5
76,8
76,0
70,3
69,1
73,7
73,8
78,6
77,9
73,1
72,8
Polonia
Stati Uniti
70,0
75,6
UE-
,
,
,
,
,
,
60,5
65,4
67,8
68,2
69,7
Sud Corea
Spagna
61,8
56,9
59,7
72,8
64,9
63,1
Italia
,
,
,
,
,
,
61,3
59,0
54,3
55,4
57,1
Turchia
Brasile
74,2
Cina
88,9
India
85,7
59,3
Paesi ordinati per il 2011.
UE-21 prima degli anni 2000.
Fonte: elaborazioni su dati OCSE e Eurostat.
59
1.2 le misure di benessere e competitività
anni 70
59
titolo capitolo
NEET: l’Europa meglio degli USA, nonostante Spagna e Italia
(Quota % di 20-24enni né occupati né in istruzione o formazione)
2000
1.2 le misure di benessere e competitività
Giappone
60
2006
2007
8,8
9,1
2008
7,6
2009
7,4
2010
8,5
9,9
Germania
16,9
16,7
15,2
14,0
13,7
13,7
UE-
,
,
,
,
,
,
Polonia
30,8
20,7
18,3
15,6
16,4
17,7
Svezia
10,7
15,2
13,1
12,9
16,5
14,3
Regno Unito
15,4
18,2
18,1
18,3
19,1
19,3
Francia
17,6
19,0
17,9
16,6
20,0
20,6
Stati Uniti
14,4
15,6
16,2
17,2
20,1
19,4
22,2
23,0
23,5
Sud Corea
Brasile
23,4
22,5
23,3
Italia
,
,
,
,
,
,
Spagna
15,0
16,9
17,2
19,4
26,3
27,4
Turchia
44,2
48,8
46,3
46,1
46,1
43,7
Paesi ordinati in ordine crescente per il 2009.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
60
61
61
20
24
34
Germania
Giappone
Francia
91
130
132
Italia
Cina
Brasile
India
173
121
151
72
124
136
27
114
106
54
24
19
13
iniziare
un'attività economica
182
131
181
142
161
38
52
72
14
25
26
20
17
105
60
114
68
137
70
42
27
2
9
3
62
19
94
109
44
42
62
57
146
64
81
35
75
73
25
ottenere ottenere registrare
permessi a elettricità
una
costruire
proprietà
Paesi ordinati per facilità di fare impresa.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca Mondiale.
71
Turchia
55
13
Svezia
44
8
Polonia
7
Regno Unito
Sud Corea
Spagna
4
Stati Uniti
facilità
di fare
impresa
49
82
100
70
49
100
82
19
100
32
49
10
6
protezione
degli
investitori
152
156
122
80
114
34
53
127
72
38
30
16
69
pagare
le tasse
127
123
68
78
50
39
27
19
13
8
3
14
22
commercio estero
184
116
19
40
56
64
8
35
5
27
2
21
6
116
143
82
124
37
20
43
1
19
22
14
8
16
rispetto
risolvere
dei
situazioni
contratti
di
insolvenza
1.2 le misure di benessere e competitività
23
104
70
83
4
53
53
23
23
40
12
1
4
ottenere
credito
Facilità di fare impresa: Corea in testa insieme a USA e Regno Unito, Italia distaccata
(Posizioni nelle classifiche 2013)
62
Sud Corea
Italia
India
Paesi ordinati per il 2013.
Fonte: elaborazione CSC su dati Banca mondiale.
0
10
20
30
40
50
60
Polonia
Italia al top nei costi per l’avvio di impresa
(% PIL pro-capite)
2004
Francia
Stati Uniti
Cina
Spagna
Brasile
UE-27
62
2013
Svezia
1.2 le misure di benessere e competitività
titolo capitolo
Regno Unito
Germania
Giappone
Turchia
63
63
3
Svezia
tempo
(giorni)
45
31
38
31
17
89
16
13
41
6
48
114
152
Paesi ordinati per costo (% del PIL pro-capite) nel 2013.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca Mondiale.
8
6
Stati Uniti
6
13
Cina
Regno Unito
10
Spagna
Francia
17
11
Giappone
Brasile
13
Turchia
9
10
Polonia
10
Sud Corea
UE-
Germania
11
Italia
procedure
(numero)
India
paese
2004
1
1
1
1
18
17
13
6
11
37
21
18
53
costo
(% del pil
pro-capite)
13
9
8
6
6
5
12
3
6
5
6
13
10
procedure
(numero)
tempo
(giorni)
16
13
7
6
33
28
119
15
23
6
32
7
27
2013
1
1
1
1
2
5
5
5
8
11
14
15
50
costo
(% del pil
pro-capite)
1.2 le misure di benessere e competitività
39
0
29
0
1.237
18
0
49
75
32
247
348
428
capitale
minimo
versato
(% del pil
pro-capite)
Avviare un’attività imprenditoriale: in Italia resta tre volte più costoso che in Germania
13
0
0
0
86
13
0
0
0
7
13
0
140
capitale
minimo
versato
(% del pil
pro-capite)
titolo capitolo
Giustizia civile: quattro volte più lenta dei migliori europei
risoluzione di una disputa commerciale
2006
1.2 le misure di benessere e competitività
paese
India
Giappone
tempo
(giorni)
2013
costo
(% della
controversia)
procedure
(numero)
1.420
39,6
46
360
32,2
30
costo
(% della
controversia)
procedure
(numero)
1.420
39,6
46
360
32,2
30
Svezia
508
31,3
30
314
31,2
30
Italia
.
,
.
,
Regno Unito
404
23,4
30
399
25,9
28
Turchia
420
27,3
37
420
24,9
36
UE-
,
,
Polonia
980
19,0
37
685
19,0
33
Francia
390
17,4
29
390
17,4
29
Spagna
515
17,2
42
510
17,2
40
Brasile
731
16,5
45
731
16,5
44
Germania
394
14,4
30
394
14,4
30
Stati Uniti
300
14,4
33
370
14,4
32
Cina
406
11,1
37
406
11,1
37
Sud Corea
230
10,3
35
230
10,3
33
Paesi ordinati per costo (% della controversia) nel 2013.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca mondiale.
64
tempo
(giorni)
64
65
65
50
73
71
90
Polonia
Francia
Regno Unito
Spagna
UE-
Germania
Italia
84
73
75
43
65
59
57
2° sem. 2008
Paesi in ordine decrescente per il 2012.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
52
69
Turchia
55
Svezia
1° sem. 2008
85
75
72
49
62
52
47
1° sem. 2009
96
82
74
49
72
59
54
2° sem. 2009
94
78
70
50
72
65
63
2° sem. 2010
96
77
68
58
72
53
64
1° sem. 2011
87
71
66
51
61
47
54
2° sem. 2011
1.2 le misure di benessere e competitività
94
85
73
58
75
66
63
1° sem. 2010
Energia elettrica: in Italia è del 44% più cara della media UE
(Prezzo energia elettrica per usi industriali; clienti con consumo compreso fra 500 MWh e 2.000 MWh; Italia=100)
81
68
65
55
53
49
48
1° sem. 2012
titolo capitolo
Emissioni di CO2: la Cina supera gli Stati Uniti e l’Italia torna ai livelli del 1990
(Emissioni di CO2 da combustibile, milioni di tonnellate)
Mondo
1.2 le misure di benessere e competitività
Cina
66
Stati Uniti
1971
1990
14.089
2000
20.973
2005
23.767
2010
27.654
30.523
824
2.256
3.317
5.560
7.428
4.291
4.869
5.698
5.772
5.369
.
.
.
.
UE-
India
200
582
972
1.165
1.626
Giappone
759
1.064
1.184
1.221
1.143
Germania
979
950
825
809
762
Sud Corea
52
229
438
469
563
Regno Unito
623
549
524
533
484
Italia
Brasile
91
194
304
322
388
Francia
432
352
377
388
358
Polonia
287
342
291
293
305
Spagna
120
205
284
339
268
Turchia
41
127
201
216
266
Svezia
82
53
53
50
48
Paesi ordinati per il 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
66
Intensità energetica: sale nei paesi emergenti, ma negli avanzati è un multiplo
(Emissioni di tonnellate di petrolio equivalenti pro-capite)
1995
2000
India
0,4
0,4
Brasile
0,9
Turchia
1,0
Cina
0,8
2005
2010
0,4
0,5
0,6
1,0
1,1
1,2
1,2
1,0
1,2
1,2
1,4
0,9
0,9
1,3
1,7
Mondo
1,7
1,6
1,6
1,8
1,8
Polonia
2,7
2,6
2,3
2,4
2,7
Spagna
2,3
2,6
3,0
3,3
2,8
Italia
,
,
,
,
,
Regno Unito
3,6
3,7
3,8
3,7
3,3
Giappone
3,6
4,0
4,1
4,1
3,9
Germania
4,4
4,1
4,1
4,1
4,0
Francia
3,9
4,1
4,3
4,4
4,2
Sud Corea
2,2
3,2
4,0
4,4
5,0
Svezia
5,5
5,7
5,4
5,7
5,4
Stati Uniti
7,7
7,8
8,1
7,8
7,2
Paesi in ordine crescente per il 2010.
Per Mondo, Brasile, Cina e India 2009 invece che 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
67
1.2 le misure di benessere e competitività
1990
67
titolo capitolo
68
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
1.3
il doppio limite della disuguaglianza:
iniquità e inefficienza
Disuguaglianza: in Italia più che in Germania e Francia, meno
che in USA (ma pesa il Sud) – Quota reddito top 1%: i maxi
redditi sono targati USA e UK – Disparità interne: l’anomalia
italiana
69
69
1.3 il doppio limite della disuguaglianza: iniquità e inefficienza
70
titolo capitolo
Disuguaglianza: in Italia più che in Germania e Francia, meno che in USA (ma pesa il Sud)
(Indice di Gini calcolato sul reddito disponibile, al netto di tasse e trasferimenti)
anni 80
metà
anni 90
inizio
anni 2000
metà
inizio
0,49
metà
fine
Turchia
0,43
0,43
0,41
Stati Uniti
0,34
0,35
0,36
0,36
0,38
0,38
Regno Unito
0,31
0,35
0,34
0,35
0,33
0,34
Italia
,
,
,
,
,
,
Giappone
0,30
0,32
0,34
0,32
0,33
Spagna
0,37
0,34
0,34
0,32
0,32
0,31
0,31
0,32
0,35
0,31
0,34
Sud Corea
Polonia
Germania
0,25
0,26
0,27
0,26
0,29
0,30
Francia
0,30
0,29
0,28
0,29
0,29
0,29
Svezia
0,20
0,21
0,21
0,24
0,23
0,26
Paesi ordinati per fine anni 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
70
71
71
7,2
6,8
9,3
Paesi ordinati per il 2010.
Dati 2009 per Italia, Francia e Regno Unito, 2011 per Stati Uniti.
Fonte: elaborazioni CSC su dati World Top Incomes Database.
Cina
12,7
7,0
5,2
3,0
4,2
4,3
5,4
7,9
8,1
,
8,4
7,4
5,3
6,2
8,6
8,6
,
9,2
13,5
16,7
anni 2000
2010
6,9
8,1
8,2
,
9,5
13,9
17,4
1.3 il doppio limite della disuguaglianza: iniquità e inefficienza
6,6
13,5
Svezia
,
7,5
8,3
,
8,0
9,4
10,8
7,3
17,7
9,2
13,0
7,4
Francia
10,0
12,3
8,1
Spagna
14,7
16,3
7,5
12,9
Italia
11,3
13,8
India
18,4
9,9
9,7
anni 90
18,6
10,5
7,9
anni 80
Giappone
11,9
8,2
anni 70
11,1
11,3
9,5
anni 60
10,1
12,9
12,2
anni 50
11,3
15,9
anni 40
Germania
17,0
anni 30
Regno Unito
Stati Uniti
anni 20
Quota reddito top 1%: i maxi redditi sono targati USA e UK
(Quota % del reddito percepito dal primo percentile della distribuzione, al lordo di tasse e trasferimenti)
1.3 il doppio limite della disuguaglianza: iniquità e inefficienza
72
titolo capitolo
Disparità interne: l’anomalia italiana
(Quota % popolazione residente in regioni con reddito inferiore al 75% o superiore al 125% della media UE-27)
2000
<75%
2009
>125%
<75%
>125%
Svezia
0
100
0
42
Italia
Germania
0
38
0
31
Francia
3
18
0
28
Regno Unito
1
29
4
5
Spagna
21
18
20
5
Polonia
100
0
100
0
Paesi ordinati per il 2009 >125%.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
72
Gli USA fanno il pieno di premi Nobel – Premi Nobel: gli Stati
Uniti superano l’Europa negli anni 50 e poi la staccano a causa della débâcle tedesca – Pubblicazioni scientifiche: la rincorsa
della Cina al primato europeo – Spese in R&S: Corea, Svezia
e Giappone in testa – Quota di brevetti: il Giappone supera
l’Europa e gli USA – Esportazioni farmaceutiche: la Germania
difende la pole position – Livelli di istruzione: la grande convergenza – Diplomati: la rincorsa riuscita di Polonia e Corea,
l’Italia resta indietro – Matematica: l’Asia davanti a tutti, meglio
la Germania della Francia – Laureati: in Giappone e Corea più
della metà dei giovani hanno la laurea, in Italia solo un quinto –
Laureati: in Italia restano troppo pochi – Le migliori università:
Stati Uniti imbattibili, ma la Cina recupera
73
1.1 la nuova mappa dell’economia globale
1.4
la gara della conoscenza
73
74
Anni 20
Anni 10
Anni 1900
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nobel Foundation.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Stati Uniti
Anni 40
100
UE-27
Anni 60
Gli USA fanno il pieno di premi Nobel
(Quote %, discipline scientifiche)
Giappone
Anni 80
Anni 70
74
Anni 50
1.4 la gara della conoscenza
titolo capitolo
2011-2012
Anni 2000
Anni 90
Anni 30
75
75
0
3
0
3
0
0
0
Cina
Svezia
Italia
India
Spagna
Sud Corea
Polonia
Africa
8
0
0
0
0
0
8
0
29
21
0
13
anni 10
9
0
0
0
0
3
9
0
25
6
0
22
anni 20
0
0
0
0
0
0
0
37
5
0
17
24
anni 30
0
0
0
0
0
5
0
13
0
3
18
39
anni 40
0
0
0
0
0
2
0
9
0
0
16
55
anni 50
0
0
0
0
0
5
0
8
8
2
17
46
anni 60
0
0
0
0
0
1
0
4
1
0
19
60
anni 70
1.4 la gara della conoscenza
0
0
0
0
0
4
0
6
4
1
6
62
anni 80
Paesi ordinati per gli anni 2000.
Premi assegnati sulla base della nazionalità dell’istituzione di appartenenza del vincitore. Non considerati i premi in Pace e Letteratura.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nobel Foundation.
17
39
0
Giappone
Germania
17
Francia
Regno Unito
3
UE-
Stati Uniti
anni 1900
Premi Nobel: gli Stati Uniti superano l’Europa negli anni 50 e poi la staccano a causa della débâcle tedesca
(% di premi Nobel nelle discipline scientifiche)
0
0
0
0
0
1
0
6
5
1
5
71
anni 90
0
0
0
0
0
0
1
5
5
6
10
65
0
0
0
0
0
0
0
0
13
4
4
71
anni 2000 2011-2012
titolo capitolo
Pubblicazioni scientifiche: la rincorsa della Cina al primato europeo
(% articoli pubblicati su riviste scientifiche)
1.4 la gara della conoscenza
1995
76
2000
2005
2009
UE-
,
,
,
,
Stati Uniti
34,2
30,6
28,9
26,5
Cina
1,6
2,9
5,9
9,4
Giappone
8,3
9,1
7,8
6,3
Regno Unito
8,1
7,6
6,4
5,8
Germania
6,7
6,9
6,2
5,7
Francia
5,1
5,0
4,3
4,0
Italia
,
,
,
,
Sud Corea
0,7
1,5
2,3
2,8
Spagna
2,0
2,3
2,6
2,7
India
1,7
1,6
2,1
2,5
Brasile
0,6
1,0
1,4
1,6
Svezia
1,6
1,6
1,4
1,2
Africa
1,1
1,0
1,0
1,2
Turchia
0,3
0,6
1,1
1,1
Polonia
0,8
0,9
1,0
0,9
Paesi ordinati per il 2009.
Articoli contati solo se apparsi su riviste presenti nelle liste Science Citation Index (SCI) and Social Sciences Citation
Index (SSCI).
Fonte: elaborazioni CSC su dati National Science Foundation.
76
Spese in R&S: Corea, Svezia e Giappone in testa
(Spese in R&S in % del PIL)
1990
2000
2005
2,30
Svezia
2,18
Giappone
2,26
2,91
Stati Uniti
2,34
Germania
2,35
Francia
2010
2,79
2011
3,74
3,56
3,39
3,00
3,31
3,26
2,65
2,71
2,59
2,83
2,77
2,61
2,47
2,51
2,80
2,84
1,90
2,32
2,15
2,11
2,24
2,25
,
,
,
,
2,35
2,10
1,82
1,72
1,80
1,77
0,90
1,32
1,76
Spagna
0,40
0,80
0,91
1,12
1,39
1,33
Italia
,
,
,
,
,
,
1,02
0,97
1,08
UE-
Regno Unito
Cina
Brasile
India
0,77
0,78
Turchia
0,24
0,48
0,59
0,84
Polonia
0,88
0,64
0,57
0,74
Paesi ordinati per il 2011.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE e Banca mondiale.
77
3,37
0,77
1.4 la gara della conoscenza
1981
Sud Corea
77
titolo capitolo
Quota di brevetti: il Giappone supera l’Europa e gli USA
(Famiglie di brevetti triadici, quote %)
1.4 la gara della conoscenza
1985
78
1990
1995
2000
2005
2010
Giappone
22,0
29,5
26,6
32,7
29,9
31,2
UE-
,
,
,
,
,
,
Stati Uniti
34,6
34,6
34,2
30,4
30,6
27,8
Germania
16,0
12,7
13,6
12,8
11,5
11,4
Francia
6,6
5,9
5,5
4,7
4,8
4,9
Sud Corea
0,0
0,2
0,9
1,6
4,2
4,4
Regno Unito
5,6
4,5
4,4
3,6
3,3
3,2
Cina
0,1
0,0
0,1
0,2
0,6
1,8
Svezia
1,9
1,4
2,1
1,4
1,7
1,7
Italia
,
,
,
,
,
,
Spagna
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
Turchia
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Polonia
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Paesi ordinati per il 2010.
I brevetti triadici sono quelli depositati presso i principali uffici brevetti internazionali.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
78
Esportazioni farmaceutiche: la Germania difende la pole position
(Quote % esportazioni su totale mondiale)
1990
2000
2005
2010
2011
16,2
18,3
12,5
13,8
13,6
Stati Uniti
17,2
11,7
12,1
9,6
9,5
8,9
Regno Unito
12,3
11,8
9,5
8,0
7,1
7,0
Francia
11,1
11,0
9,5
8,1
7,0
6,7
Italia
,
,
,
,
,
,
1,8
1,8
2,9
3,2
Cina
13,8
Spagna
1,6
1,9
1,9
2,4
2,4
Svezia
2,4
3,5
3,3
2,5
1,9
Giappone
2,6
4,0
2,9
1,5
1,0
1,0
0,1
0,2
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
Polonia
Sud Corea
Turchia
0,1
0,2
Paesi ordinati per il 2011.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
79
1,7
1.4 la gara della conoscenza
1981
Germania
79
titolo capitolo
Livelli di istruzione: la grande convergenza
(Media di anni di istruzione della popolazione adulta)
1970
1.4 la gara della conoscenza
2060
4,9
13,3
15,7
Giappone
9,5
13,4
15,2
Regno Unito
9,5
13,5
15,1
Stati Uniti
10,6
13,0
14,2
Germania
10,6
13,5
14,1
7,1
11,6
14,1
Svezia
9,4
12,2
13,8
UE-
,
,
,
Italia
,
,
,
Spagna
5,9
10,3
12,9
Polonia
7,2
10,3
12,4
Brasile
3,2
8,3
11,4
Turchia
2,4
6,8
10,4
Cina
2,3
6,2
9,6
India
1,6
4,1
8,1
Francia
80
2010
Sud Corea
Paesi ordinati per il 2060.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
80
Diplomati: la rincorsa riuscita di Polonia e Corea, l’Italia resta indietro
(Quote % popolazione con almeno diploma superiore)
2005
25-34enni
25-64enni
2010
25-34enni
25-64enni
25-34enni
Sud Corea
68
95
76
97
80
98
Polonia
46
52
51
62
89
94
Giappone
83
94
Svezia
81
91
84
91
87
91
Stati Uniti
88
88
88
87
89
88
Germania
83
85
83
84
86
86
Francia
64
78
66
81
71
84
Regno Unito
63
68
67
73
75
83
UE-
Italia
Spagna
40
57
49
64
53
65
30
38
41
53
24
30
27
36
31
42
18
20
Brasile
Turchia
Cina
Paesi ordinati per il 2010 24-34enni.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
81
1.4 la gara della conoscenza
2000
25-64enni
81
titolo capitolo
Matematica: l’Asia davanti a tutti, meglio la Germania della Francia
(Media risultati ottenuti nei test OCSE-PISA di matematica, media OCSE=500)
2003
2006
2009
Shanghai-Cina
600
Hong Kong-Cina
550
547
555
Sud Corea
542
547
546
Giappone
534
523
529
Germania
503
504
513
Danimarca
512
513
503
Francia
511
1.4 la gara della conoscenza
Macao-Cina
82
525
UE-
496
497
Polonia
490
495
495
Svezia
509
502
494
495
492
Regno Unito
Stati Uniti
474
487
Spagna
485
480
483
Italia
Turchia
423
424
445
Brasile
356
370
386
Paesi ordinati per il 2009.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE-PISA.
82
Laureati: in Giappone e Corea più della metà dei giovani hanno la laurea, in Italia solo un quinto
(Quote % popolazione con istruzione terziaria)
Sud Corea
2005
25-34enni
22,7
25-64enni
35,1
31,6
2010
25-34enni
25-64enni
51,0
39,7
25-34enni
65,0
Giappone
31,6
45,1
39,9
53,2
44,8
56,7
Regno Unito
24,8
27,3
29,6
35,0
38,2
46,0
Francia
21,5
30,9
24,8
39,3
29,0
42,9
Stati Uniti
35,8
37,4
39,0
39,2
41,7
42,3
Svezia
28,7
31,7
29,6
37,3
34,2
42,2
Spagna
21,0
33,5
28,2
39,7
30,7
39,2
Polonia
11,3
12,3
16,9
25,5
22,9
37,4
UE-
,
,
,
,
,
,
Germania
22,9
21,6
24,6
22,5
26,6
26,1
Italia
,
,
,
,
,
,
Turchia
7,1
7,6
9,7
11,8
13,1
17,4
Brasile
7,5
6,5
7,8
7,9
10,9
11,6
4,6
6,1
Cina
Paesi ordinati per il 2010 24-34enni.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
83
1.4 la gara della conoscenza
1999
25-64enni
83
30
40
50
60
70
84
Giappone
Sud Corea
Fonte: elaborazione CSC su dati OCSE.
0
10
20
Germania
UE-12
Polonia
84
Stati Uniti
Francia
Regno Unito
Laureati: in Italia restano troppo pochi
(Quote % laureati 25-34enni su popolazione corrispondente, 2010)
1.4 la gara della conoscenza
titolo capitolo
Cina
Brasile
Turchia
Italia
Spagna
Svezia
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
4
0
0
0
0
0
0
Italia
Spagna
Svezia
Sud Corea
Brasile
Africa
Polonia
India
Turchia
0
3
2
4
4
8
10
9
22
36
43
42
16
170
0
0
0
0
0
0
4
0
4
5
5
11
0
53
2
3
3
4
4
8
11
9
21
34
40
40
18
168
0
0
0
0
0
0
4
0
4
6
5
11
0
54
0
2
2
1
4
9
11
9
21
32
40
43
19
167
0
0
0
0
0
0
4
0
4
6
6
11
0
54
1
2
2
5
5
8
11
9
23
33
41
42
25
166
0
0
0
0
0
0
4
0
3
4
6
11
0
54
1
2
2
3
6
8
11
9
23
31
40
42
30
159
0
0
0
0
0
0
3
0
3
5
5
11
0
55
1
2
2
3
6
9
11
11
23
31
40
40
30
152
0
0
0
0
0
0
3
0
3
5
5
11
0
54
1.4 la gara della conoscenza
Paesi ordinati per il 2012 Top500.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University.
5
4
Francia
7
Germania
Giappone
0
11
Regno Unito
UE-
Cina
51
Stati Uniti
1
2
2
3
6
10
11
10
22
25
39
38
34
154
0
0
0
0
0
0
3
0
3
5
6
10
0
53
1
1
2
4
7
11
11
11
21
23
39
37
35
151
0
0
0
0
0
0
3
0
3
4
4
9
0
53
1
1
2
4
6
10
11
11
20
21
37
38
42
150
top100 top500 top100 top500 top100 top500 top100 top500 top100 top500 top100 top500 top100 top500 top100 top500 top100 top500
2004
Le migliori università: Stati Uniti imbattibili, ma la Cina recupera
(Numero di università fra le migliori 100 e 500 del mondo)
85
85
87
2
Produttività e benessere:
la storia insegna che il destino dell’Europa non è segnato
Gianni Toniolo*
Sommario
2.1 L’Europa e la grande divergenza – 2.2 Lo shock: 1989-92 – 2.3 Redditi e produttività: Europa
e Stati Uniti – 2.4 L’Europa, 1995 – 2007 – 2.5 L’Europa nella grande recessione – 2.6 I prossimi
anni se continuano le tendenze attuali… – 2.7 …ma ci sono venti contrari, leve da usare, occasioni da cogliere – 2.8 Conclusioni
L’Europa? “Un cimitero con splendide opere d’arte”: questa la definizione del Vecchio Continente che circola in taluni ambienti americani. Definizione estrema, cinica, ingenerosa ma
rivelatrice di come siamo percepiti. Perché alcuni osservatori d’oltre Atlantico si sono formati
di noi un’immagine tanto negativamente definitiva? L’ottimismo, d’altra parte, non abbonda
tra gli stessi europei. Paul Francois Vranken, presidente di Vrenken Pommery Monopole, ha
così spiegato la caduta nelle vendite del nettare di Reims: «Il consumo di champagne dipende
dall’umore del paese e l’umore odierno non porta alla celebrazione» (Daneshkhu, 2012). La
crisi che attraversiamo ormai da quasi sei anni è stata ed è in Europa più lunga e profonda
che negli Stati Uniti, mentre non è stata pressoché avvertita in gran parte dei cosiddetti paesi
emergenti, a cominciare dal gigante cinese. Dal 2008 a oggi, gli investimenti diretti esteri
nell’Unione europea si sono ridotti al ritmo del 10% annuo (Fontanella-Khan, 2013): un
segnale di sfiducia più concreto delle battute sull’arte funeraria.
La crisi che viviamo caratterizza dunque l’Unione europea come il grande malato
dell’economia mondiale, ma la percezione, vedremo se giustificata o meno, di un malessere europeo è di più lunga data. Goodbye Europe è il titolo, tra nostalgico e sprezzante,
che Alesina e Giavazzi (2006) vollero dare a una loro analisi delle differenze tra Stati Uniti
e Unione europea quando la crisi in corso non era ancora in vista. Non tutti gli studiosi
sono tanto pessimisti quanto Alesina e Giavazzi circa la crescita dell’Europa e il futuro
del suo modello istituzionale. Un grande conoscitore americano del Vecchio Continente
concludeva la sua storia economica dell’Europa postbellica in modo assai meno negativo
dei due autori italiani (Eichengreen, 2007). Riccardo Faini (2006) aveva messo in dubbio,
sulla base di una convincente analisi quantitativa, l’esistenza stessa di un declino europeo.
Se l’ottimismo non è oggi di casa, vi sono buoni motivi per non abbandonarsi a un radicale
pessimismo. Per cercare di ragionare su quale possa essere il futuro economico dell’Europa
* Duke University e LUISS Guido Carli.
88
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
e quale la sua posizione nell’economia globale dei prossimi anni e decenni è utile partire da
lontano. Le tendenze di lungo periodo non si formano in pochi anni: hanno radici nelle
istituzioni, nella tecnologia, nella demografia, dipendono dai rapporti geopolitici che, in
pace e in guerra, si instaurano tra le grandi aree del mondo.
2.1
L’Europa e la grande divergenza
Per capire l’Europa di oggi conviene partire da cinque secoli fa. Il lettore non si allarmi:
non ci avventureremo in un lungo excursus storico. Ciò che conta è ricordare che, negli
anni Ottanta del secolo scorso, si è realizzato un evento destinato a cambiare per sempre
la storia, non solo economica, del nostro pianeta. Si tratta della fine della “grande divergenza” tra l’Europa (e poi l’America settentrionale) e il resto del mondo.
Gli storici chiamano “grande divergenza” il progressivo aumento del divario nei redditi per abitante a favore della parte occidentale dell’Eurasia. Nel quindicesimo secolo,
le grandi aree geo-economiche della Terra, culturalmente diverse le une dalle altre, erano
tutte caratterizzate da livelli assai simili di produttività e quindi di reddito pro-capite.
Con la fine del dominio mongolo sull’Eurasia, nel quattordicesimo secolo, il mondo era
tornato all’antica multipolarità. I grandi poli del potere politico e del commercio – Cina,
India, Islam, Europa occidentale – ricercavano tra loro un equilibrio che era al tempo
stesso militare, politico ed economico.
Le cose cominciarono a cambiare nella prima metà del Cinquecento. Secondo Adam
Smith: «La scoperta dell’America e quella del passaggio verso le Indie Orientali attraverso il Capo di Buona Speranza sono i due più importanti eventi che la storia umana
ricorda» (citato da Findlay e O’Rourke, 2007). Forse Smith peccava sin da allora di un
eurocentrismo che oggi riteniamo politicamente scorretto ma la questione sta tutta lì:
a partire dal sedicesimo secolo il mondo diviene sempre più eurocentrico, il millenario
equilibrio multipolare si sgretola, anche se molto lentamente.
La rottura si spiega in gran parte con la progressiva acquisizione da parte dell’Europa
di una leadership tecnologica. Non serve qui discutere le cause dell’allungamento del passo
del progresso tecnico in Europa rispetto al resto del mondo. Basta ricordare che si trattò
anzitutto, come scrisse Cipolla (2003), di vele per la navigazione oceanica e di cannoni per
proteggere il commercio. I primi sviluppi furono seguiti, nel Cinque-Seicento, da una vera
rivoluzione militare, con conseguenze economiche e istituzionali (la creazione dei grandi
Stati-nazione) di enorme portata. Il progresso tecnico non si limitò all’ambito militare: a
poco a poco l’Europa adottò metodi di produzione agricola e manifatturiera più efficienti
di quelli prevalenti in Asia. Lentamente, molto lentamente, si instaurò un divario nella
crescita della produttività tra l’Europa occidentale e il resto del mondo ponendo le basi alla
“grande divergenza” del mezzo millennio successivo alle “scoperte” geografiche.
Gli studiosi non sono concordi sulla dimensione dei divari di produttività e reddito
per abitante sino al momento dell’avvio della prima rivoluzione industriale. Discutono sia
sulla rapidità del progresso tecnico in Europa sia sulla sua mancanza (o lentezza) nel resto
del mondo tra il 1500 e il 1800. Non c’è dubbio, tuttavia, che, a partire dall’inizio del diciannovesimo secolo, la grande divergenza abbia assunto proporzioni via via crescenti. Per
89
circa un secolo e mezzo, lo “sviluppo economico moderno” (Kuznets, 1966) attecchì solo
in Europa e nelle sue proiezioni oltremare (America settentrionale e Oceania). Il Giappone
fu l’unica grande eccezione. Se nel 1820, dopo tre secoli di crescita più rapida della media
mondiale, l’Europa occidentale godeva di un reddito per abitante superiore di circa l’80%
alla media mondiale, nel 1973 il divario era del 184%. Escluso il Giappone, l’Asia aveva un
reddito per abitante pari a un decimo di quello europeo (Maddison, 2002).
Non serve spendere molte parole sugli effetti di un trend semi-millenario di continuo aumento del divario di reddito tra l’economia atlantica (alla metà dell’Ottocento gli
Stati Uniti superano il livello medio di reddito per persona dell’Europa occidentale) e il
resto del mondo. Essi sono stati anzitutto di carattere culturale. Chi ha più di cinquanta anni è cresciuto in una cultura eurocentrica o, comunque, “occidentale” basata sul
postulato della superiorità della cultura, della religione, delle istituzioni e, naturalmente, della tecnologia occidentali. Questo postulato avrebbe posto sulle spalle dell’“uomo
bianco” un pesante fardello, come disse Kipling: quello di provvedere all’incivilimento
del resto del mondo. Era la giustificazione morale e politica del colonialismo. In epoca
post-coloniale, il “fardello” è diventato “missione” alla diffusione nel mondo della democrazia di stampo illuministico-occidentale, se necessario anche con le armi.
Gli effetti culturali e geopolitici della “grande divergenza” erano radicati nella struttura economica che abbiamo conosciuto nel diciannovesimo e ventesimo secolo e che
ancora oggi è sottesa in numerosi libri di testo di economia internazionale. Si trattava di
un’economia mondiale basata sull’industria manifatturiera nei paesi Nord atlantici e sulla produzione di materie prime, agricole e minerarie, nel cosiddetto “Sud del mondo”.
Il commercio internazionale si svolgeva secondo uno schema riconducibile ai vantaggi
comparati ricardiani, con flussi di manufatti da “Nord” a “Sud” e di prodotti primari in
direzione opposta. I movimenti di capitale andavano dai paesi sviluppati a quelli meno
sviluppati ed erano indirizzati soprattutto a investimenti nelle piantagioni e nelle miniere. Quando, dopo la prima guerra mondiale e, soprattutto, dopo la seconda, alcune lavorazioni manifatturiere trovarono conveniente localizzarsi nei paesi del “Sud” ciò avvenne
per trarre vantaggio dal più basso costo del lavoro che li caratterizzava. Questa realtà fu
interpretata teoricamente da Heckscher-Ohlin-Samuelson. Sono questi gli equilibri che
hanno caratterizzato l’economia mondiale per quasi due secoli. La fabbrica, la finanza, le
reti commerciali, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori si erano consolidate entro questo tipo di struttura economica e avevano sviluppato culture a essa adeguate.
La grande divergenza è finita negli anni Ottanta del secolo scorso. La sua fine passò allora quasi del tutto inosservata, come spesso è avvenuto per i mutamenti densi di
conseguenze rivoluzionarie (così fu a fine Settecento per la rivoluzione industriale che si
svolse sotto gli occhi distratti di un’intera generazione).
La “grande divergenza” è finita quando, a distanza di circa un decennio l’uno dall’altro, due giganti demografici, Cina e India, che insieme costituiscono quasi i due quinti
della popolazione del pianeta, hanno allungato il passo della crescita, avviando il proprio
“sviluppo economico moderno”. Nel secondo dopoguerra, alcuni paesi asiatici, allora
detti tigri, si erano aggiunti al Giappone nel togliere a Europa e Stati Uniti il monopolio
dello “sviluppo economico moderno”. Il fenomeno era stato salutato con grande interes-
90
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
se soprattutto nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, ma esso non aveva inciso in modo
rilevante sulla “grande divergenza”, data la modesta consistenza demografica delle “tigri”. L’impatto economico e geopolitico di questa novità storica fu modesto, soprattutto
non rallentò in modo apprezzabile la crescita del divario tra le economie Nord atlantiche
(più Giappone), da un lato, e il resto del mondo, dall’altro.
La “grande divergenza” si arrestò e iniziò a ridursi, dapprima impercettibilmente,
alla fine degli anni Settanta quando, dopo la morte di Mao (9 settembre 1976), Deng
Xiaoping riuscì a imporsi nella complessa manovra per la supremazia e la creazione di
un nuovo equilibrio di potere nel Partito comunista cinese e ad avviare un processo
di riforma economica e sociale (Musu, 2011). Nei successivi trent’anni, come oggi ben
sappiamo, la «Cina si trasformò da paese isolato, povero, contadino e politicamente irrequieto in nazione relativamente aperta, stabile, crescentemente urbana, sulla via di una
rapida modernizzazione» (Fairbank e Goldman, 2006). Tra il 1978 e la fine del secolo, «il
reddito per abitante della Cina si è più che quadruplicato: una crescita unica nella storia
economica mondiale» (World Bank, 1997).
La trasformazione della semi-millenaria divergenza in una convergenza delle economie sino ad allora escluse dai benefici dello sviluppo economico moderno verso quelle più
ricche ha ricevuto nuovo impulso all’inizio degli anni Novanta, con l’accelerazione della
crescita in India. Tra il 1950 e il 1980 il reddito per abitante indiano era aumentato del 50%;
nel successivo ventennio, sino alla fine del secolo, è più che raddoppiato, con una crescita
non spettacolare come quella cinese ma molto superiore a quella europea e statunitense.
I circa 1.350 milioni di cinesi e i 1.200 milioni di indiani costituiscono, insieme,
quasi i due quinti della popolazione mondiale. Mai prima d’oggi si era verificata l’uscita
dalla povertà pluri-millenaria di un numero tanto grande di persone in un tempo tanto
breve. I dati sono noti ma la loro portata storica non è stata ancora pienamente metabolizzata dall’opinione pubblica occidentale. L’unicità del fenomeno non consente di trarre
dalla storia “lezioni”, orientamenti, suggerimenti. Eppure la “questione europea”, non
solo economica, non può essere compresa se non nel quadro rivoluzionario della “fine
della grande divergenza”.
2.2
Lo shock: 1989-1992
La fine della “grande divergenza” è, in sé, uno shock all’economia mondiale di dimensioni incalcolabili. Le sue conseguenze economiche, sociali, ambientali e geopolitiche
saranno probabilmente più radicali di quelle prodotte dalla Grande guerra o dalla conclusione, nel 1945, della “seconda guerra dei trent’anni”.
Gli effetti della fine della grande divergenza, iniziata impercettibilmente negli anni
Ottanta, sono stati potenziati e resi più complessi dalla coincidenza, nel breve lasso di
tempo compreso tra il 1989 e il 1992, di un insieme di circostanze, in parte endogene
in parte esogene, all’inizio della nuova “grande convergenza”. Si tratta di eventi di dimensione talmente epocale da fare sì che si possa datare in quel breve lasso di tempo la
fine del breve ventesimo secolo, iniziato nel 1914. Il grande shock è frutto di sei eventi
quasi concomitanti: il consolidamento della leadership di Deng Xiaoping in Cina dopo
91
il 1989; la svolta di politica economica che apre la stagione di grande crescita in India; la
conclusione della Guerra fredda con il crollo del muro di Berlino e la fine dell’Unione
Sovietica; l’accelerazione della diffusione di una nuova “tecnologia generale” di comunicazione e informazione; il mercato e la moneta unici in Europa; l’avvio di un’area di
libero scambio nell’America settentrionale. Ciascuno di questi episodi ha avuto ed è destinato ad avere un impatto sulla crescita economica dell’Europa, sulla sua collocazione
e sul suo peso internazionali. Il loro insieme, unito alla fine della “grande divergenza”,
costituisce uno shock con ricadute ancora in gran parte non calcolabili ma oggi più evidenti di quanto fossero vent’anni fa.
A cavallo tra anni Ottanta e Novanta vi è stato, anzitutto, un consolidamento della
nuova grande convergenza. Per oltre un decennio, in Cina, le riforme di Deng Xiaoping
e la sua “democrazia socialista” erano state viste con sospetto o avversate da un potente
gruppo di conservatori, guidato da Chen Yun. La repressione delle proteste di Piazza
Tienanmen (3-4 giugno 1989), ordinata dallo stesso Deng, la rimozione di Zhao Ziyang,
che si era rifiutato di usare l’esercito contro i dimostranti, ebbero l’effetto di rafforzare la
posizione del vecchio leader al quale i conservatori non poterono più rimproverare tolleranza verso forze considerate eversive. Negli anni successivi, sino alla morte nel 1997,
Deng Xiaoping poté consolidare le riforme e mettere alla testa del partito e del governo
uomini come Jiang Zemin che credevano nelle riforme stesse.
L’altro grande gigante asiatico, l’India, democrazia parlamentare sin dalla riconquistata
indipendenza nel 1947, aveva da allora adottato politiche economiche che avevano prodotto una crescita modesta (3,6% l’anno tra il 1950 e il 1980). Negli anni Ottanta era iniziato
un processo di limitate liberalizzazioni e ristrutturazioni industriali che avevano alzato il
tasso di crescita (5,5% tra 1980 e 1991) ma accresciuto il disavanzo di bilancio dello Stato e
l’indebitamento estero. Nel luglio 1991 il nuovo primo ministro Narasimha Rao annunciò
una New Industrial Policy che comprendeva, tra l’altro, la riduzione delle barriere tariffarie
e non tariffarie all’importazione, la rimozione dei divieti di ingresso ai capitali stranieri, dei
controlli sulla produzione e sui prezzi e il perseguimento di un equilibrio di bilancio (Panagariya, 2001). La nuova politica economica, gestita dall’attuale primo ministro e allora
ministro delle Finanze Manmohan Singh, produsse una forte accelerazione della crescita
indiana. La svolta cinese e quella indiana a cavallo degli anni Ottanta e Novanta consolidarono e accelerarono la rivoluzione della “grande convergenza”.
La caduta del muro di Berlino (novembre 1989) e la dissoluzione dell’Unione Sovietica
(formalmente sancita il 26 dicembre 1991) sono gli avvenimenti, tra loro collegati, per i
quali gli anni 1989-1991 sono universalmente ricordati. A essi molti storici fanno riferimento per datare la fine del ventesimo secolo (tra tutti: Hobsbawm, 1994). È superfluo
dire dell’impatto non solo, e non tanto, economico della conclusione di un’epoca iniziata
nel 1917. Va semmai ricordato l’ovvio: la storia non finì in quegli anni con l’avvento di un
mondo unipolare caratterizzato dal trionfo della democrazia liberale nata con le rivoluzioni
americana e francese (Fukuyama, 1992). Nella storia successiva l’Europa ebbe, comprensibilmente, non poche difficoltà nel ritrovare una propria collocazione, non solo economica.
Gli anni Novanta sono anche quelli in cui viene a maturazione una nuova “tecnologia
generale” (general purpose technology). Negli ultimi due secoli il progresso tecnico che ha
92
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
generato lo sviluppo economico moderno è stato in gran parte trainato da poche tecnologie
generali: la macchina vapore, il motore elettrico, il semiconduttore. Si tratta di tecnologie
che, per la loro enorme pervasività e adattabilità, per la loro intrinseca capacità di generare progresso tecnico e innovazioni complementari, si applicano alla quasi universalità dei
processi produttivi, producendo forti economie di scala (si veda, per esempio, Bresnahan
e Trajtenberg, 1995). Le tecnologie generali sono state poche e l’apparire di ciascuna di esse
ha segnato l’inizio di una nuova era nella storia economica universale, una vera e propria
rottura nei modi di produrre e di organizzare non solo il lavoro ma l’intera vita della società.
La nuova tecnologia dell’informazione e della comunicazione è la tecnologia generale del nostro tempo. Perché si può collocare la sua maturazione tra gli eventi che hanno
caratterizzato il grande shock degli anni 1980-1992? È difficile datare l’inizio dell’era di
una nuova tecnologia generale perché l’iniziale invenzione si diffonde lentamente, ha
bisogno di adattamenti progressivi alla realtà produttiva, si scontra con resistenze, sino
al limite del luddismo.
Una caratteristica tipica delle tecnologie generali è il lungo lasso di tempo che trascorre tra le prime applicazioni dell’invenzione di base e il momento in cui se ne notano
gli effetti sulla produttività di un sistema economico. Il primo motore a vapore ad avere
successo commerciale fu sviluppato da Newcomen nei primi anni Venti del Settecento; mezzo secolo dopo Boulton e Watt ne crearono una versione molto più efficiente
ma passarono ancora almeno tre decenni prima che la macchina a vapore iniziasse a
dare un contributo visibile alla crescita economica. Una storia analoga si può raccontare
per il motore elettrico le cui prime sperimentazioni risalgono agli anni Venti e Trenta
dell’Ottocento, ma il cui impatto rivoluzionario sul sistema produttivo non si cominciò
a vedere se non nel primo Novecento. L’Intel 4004, il primo microprocessore dotato di
un chip da 4 bit, fu creato da Hoff, Faggin e Mazor nel novembre 1971 per rispondere
alle esigenze di un cliente giapponese. Da allora il numero di bit per chip aumentò rapidamente: i calcolatori divennero sempre più veloci, piccoli e meno costosi. Tuttavia il
loro impatto aggregato sull’economia fu modesto sino alla metà degli anni Novanta. È
plausibile legare la diffusione della più avanzata tecnologia ICT con la fine della guerra
fredda che consentì agli Stati Uniti di liberalizzare la diffusione di tecniche sino ad allora
coperte dal segreto militare. Anche sotto questo profilo, dunque, gli anni 1989-1992 vanno visti come un momento di rottura e di inizio di un’epoca nuova.
Infine, il mercato unico e la moneta unica europei completano l’eccezionale concentrazione di avvenimenti epocali racchiusi nel breve triennio 1989-1992. Il Trattato per il
mercato unico del 1986, divenuto pienamente operativo dal 1° gennaio 1993, rafforza i
quattro pilastri fondamentali del mercato comune (libera circolazione di merci, servizi,
persone e capitali) con misure per la coesione economica e l’armonizzazione delle norme
nazionali. Il Trattato di Maastricht del 1992 apre, come tutti sappiamo, il percorso di
creazione dell’Unione economica e monetaria europea, operativa dal 1° gennaio 1999
con la nascita dell’euro, rispetto al quale erano stati fissati i tassi di cambio irrevocabili
delle valute nazionali e la conduzione di un’unica politica monetaria per gli iniziali 11
Stati membri da parte della Banca centrale europea. All’accelerazione della formazione
93
dell’UEM contribuirono, come è noto, in modo decisivo le vicende seguite alla caduta
del muro di Berlino che portarono, tra l’altro, all’unificazione tedesca.
Nei vent’anni successivi l’adattamento dell’economia europea al grande shock del
1989-1992 e alla fine della “grande divergenza” è stato lento, a volte faticoso, soprattutto
ineguale. È esplosa una divisione tra Nord e Sud del continente che si era sino ad allora
ridotta. È una storia nota che conviene tuttavia ripercorrere brevemente prima di vedere
come l’Europa sta affrontando una crisi inaspettatamente lunga e, soprattutto, quali
sono le prospettive per il futuro.
2.3
Redditi e produttività: Europa e Stati Uniti
La crescita economica europea dell’ultimo ventennio viene giudicata, complessivamente, come piuttosto deludente. La presenza di paesi e settori che hanno ottenuto buoni
risultati di crescita non impedisce a molti osservatori di chiedersi in che misura l’Europa
sia in grado di competere sui mercati mondiali del ventunesimo secolo (es. Faini, 2006;
Eichengreen, 2007; Alesina e Giavazzi, 2006). La lunga crisi, che appare sempre più
come fenomeno spiccatamente europeo, accentua le ansie sul futuro del Vecchio Continente. Quanto sono giustificati questi giudizi, queste preoccupazioni? Un breve sguardo
alle tendenze di lungo andare può aiutare a inquadrare il problema.
Gli economisti si aspettano, con buone ragioni, che paesi con bassi livelli reddito
e produttività crescano più rapidamente di quelli più avanzati, realizzando una convergenza verso questi ultimi. È quanto abbiamo visto sta succedendo dopo la fine della
“grande divergenza”. Questo non vale solo nel rapporto tra Occidente e paesi emergenti.
All’interno della stessa area atlantica “avanzata” ci si doveva attendere sin dall’Ottocento
una crescita più rapida dei paesi allora arretrati rispetto ai leader della produttività. Ciò è
puntualmente successo con la lunga rincorsa della Germania verso i livelli produttivi del
Regno Unito, il pioniere della rivoluzione industriale. Anche l’Italia, a partire dalla fine
dell’Ottocento, ha realizzato un processo di convergenza verso il Regno Unito (Toniolo,
2013). Tra il 1950 e il 1990 la dispersione dei redditi per abitante e della produttività oraria tra i paesi dell’Europa occidentale si è fortemente ridotta, realizzando una crescente
omogeneità nelle condizioni di vita e nell’efficienza produttiva tra i diversi paesi, soprattutto tra quelli aderenti alla CEE (Crafts e Toniolo, 1996).
Già alla metà dell’Ottocento, il reddito per abitante degli Stati Uniti superava di
circa il 10% quello dell’Europa occidentale che, dunque, avrebbe dovuto “convergere”
verso l’area a reddito più elevato. Non è stato così: sino al 1913 gli Stati Uniti (che nel
1903 avevano realizzato il proprio “sorpasso” rispetto al Regno Unito) crebbero più rapidamente della parte più sviluppata del Vecchio Continente che, alla vigilia della Grande
guerra, aveva un reddito per abitante pari solo ai due terzi di quello americano. È utile
sottolineare l’apparente paradosso della divergenza Nord atlantica solo per osservare che
il fenomeno che pare essersi riprodotto dal 1990 al 2007 ha un antecedente ben più
lungo e marcato. Nel 1950, realizzata la ricostruzione postbellica, il reddito pro-capite
dell’Europa occidentale era pari solo alla metà di quello statunitense. Un’analoga divergenza si era realizzata tra il 1913 e il 1950: l’aspra “seconda guerra dei trent’anni”, la lunga
94
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
guerra civile europea, fu per il Vecchio Continente, anche sul piano economico, quella
follia che i trattati del 1951 (CECA) e 1957 (CEE) intesero esorcizzare per sempre.
Gli anni compresi tra il completamento della ricostruzione (attorno al 1950 il reddito
per abitante era tornato ai migliori livelli prebellici) e il primo shock petrolifero (1973) sono
ricordati come l’età dell’oro dell’economia europea, quelli che posero le basi della futura
prosperità e che avvicinarono il benessere del Vecchio Continente a quello degli Stati Uniti. Il reddito per abitante dei 12 paesi dell’Europa occidentale crebbe al tasso medio annuo
del 3,9% (se si allarga la definizione di Europa occidentale a includere 30 paesi, il tasso di
crescita non cambia: 4,0%). Gli Stati Uniti crebbero a un tasso medio annuo del 2,4%, solo
marginalmente superiore al loro trend di crescita secolare (2%, tra 1900 e 2000). È importante osservare, benché esuli dal tema di queste pagine, che anche le economie socialiste
dell’Europa orientale vissero nel medesimo periodo la propria “età dell’argento”, con una
crescita che, benché inferiore a quella della parte occidentale del continente, generò una
robusta convergenza verso gli Stati Uniti (Crafts e Toniolo, 2010 e 2012).
Dalla metà degli anni Settanta alla fine di quelli Novanta le economie dell’Europa
occidentale e degli Stati Uniti camminarono grosso modo con il medesimo passo, un
buon passo. In 17 anni, i redditi medi dei cittadini delle due aree aumentarono di circa
il 40%. L’Europa tuttavia cessò la propria “rincorsa”, non si avvicinò ulteriormente agli
Stati Uniti. Per capire, e valutare, ragioni e implicazioni della mancata convergenza bisogna da un lato tenere conto delle condizioni eccezionali che produssero l’età dell’oro e,
d’altro lato, valutare una variabile che sinora non abbiamo considerato: la produttività.
Le spiegazioni dell’andamento postbellico dell’economia europea si basano su un insieme di fattori geopolitici, istituzionali e strettamente economici. Nella fase iniziale furono decisive le aspettative create dalla fine della lunga “guerra civile europea”. Il trattato di
pace che evitò gli errori del 1919 e la cooperazione tra i paesi europei, favorita dagli Stati
Uniti (il Piano Marshall fu soprattutto un grande incentivo alla cooperazione) portarono
alla precoce creazione di istituzioni europee basate sulla cessione di sovranità. Lo stesso sforzo di ricostruzione, straordinariamente rapido, ebbe un effetto di abbrivio per lo
sviluppo successivo (Crafts e Toniolo, 1996 e 2012). La crescita fu poi sostenuta da nuovi
assetti istituzionali, in particolare la triangolazione sindacato-imprese-Stato in alcuni paesi
dell’Europa centro-settentrionale e la moderazione e lungimiranza delle forti “organizzazioni generali”, soprattutto dei lavoratori (Olson, 1982 e 1996; Eichengreen, 1996 e 2000).
Si configura un “modello” europeo, con importanti varianti nazionali, ispirato dalle culture
democristiana e socialdemocratica. In Germania è noto come “economia sociale di mercato”.
In un quadro di stabilità dei cambi e di progressiva apertura dei mercati, l’importazione
e l’adattamento all’Europa della tecnologia fordista americana si rivelarono particolarmente fruttuose. Tutti i paesi trasferirono rapidamente risorse (soprattutto lavoro) dal settore
agricolo a bassa produttività verso quello manifatturiero: questo processo spiega in buona
misura, anche se non interamente, la “rincorsa” del Vecchio Continente nei confronti del
paese leader nel reddito per abitante e nella produttività durante l’“età dell’oro”. Simmetricamente, il ridursi (e poi l’esaurirsi) delle possibilità di trasferire cospicue risorse da un
settore all’altro spiega il rallentamento della crescita del reddito per abitante in Europa che,
tra gli anni Settanta e Novanta si allineò, grosso modo al tasso di crescita degli Stati Uniti.
95
Sin qui l’andamento del reddito per abitante. Quello della produttività del lavoro
(prodotto interno lordo per ora lavorata) racconta una storia abbastanza diversa (sintetizzata nella tabella 2.1). Mentre, a partire dalla metà degli anni Settanta, il livello del reddito pro-capite europeo si stabilizza fluttuando tra il 70 e il 75% di quello statunitense, la
produttività continua ad avvicinarsi a quella dell’altro lato dell’Atlantico. La crescita della
produttività in molti paesi europei è stata superiore a quella statunitense: il processo di
convergenza, fermatosi per quanto riguarda il prodotto per abitante, prosegue per quanto
concerne l’efficienza del lavoro, misurata dalla quantità prodotta per ora lavorata (Tabella 2.2). Nel 1995 Norvegia, Germania occidentale, Belgio e Francia godevano di “livelli”
medi di produttività superiori a quelli statunitensi; Italia, Paesi Bassi e Danimarca avevano
sostanzialmente raggiunto il livello americano. Era stato, in altre parole, completato il processo di convergenza previsto dagli economisti: molte economie europee erano tanto efficienti quanto quella del paese che per circa un secolo era stato il leader della produttività.
Tabella 2.1 – Reddito per abitante medio di 12 paesi dell’Europa occidentale* rispetto a quello USA
(%)
1850
90,1
1870
87,8
1913
73,7
1921
61,3
1929
63,4
1938
77,1
1950
51,7
1973
72,3
1990
72,4
2000
70,1
2007
70,8
* Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera.
Fonte: dati da Maddison (2001) aggiornati da OCSE.
Tabella 2.2 – Tassi di crescita del PIL per ora lavorata
1973-1995
1995-2005
Svizzera
0,97
1,41
Paesi Bassi
1,94
1,50
Svezia
1,44
2,49
Belgio
2,51
1,40
Italia
2,47
0,48
Germania occidentale/Germania
2,90
1,66
Danimarca
2,44
1,10
Francia
2,84
1,93
Regno Unito
2,48
2,10
Austria
2,83
2,29
Finlandia
2,95
2,40
Grecia
1,91
2,57
Spagna
3,94
-0,21
Irlanda
3,37
4,10
Portogallo
2,02
1,87
Stati Uniti
2,22
2.40
Fonte: Crafts e Toniolo (2010).
96
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
L’andamento a forbice di reddito e produttività si spiega, per definizione, con un minore
numero di ore lavorate all’anno dagli europei rispetto agli abitanti degli Stati Uniti. Ciò
dipende sia da un numero inferiore di ore per lavoratore sia da una minore partecipazione degli europei alla forza lavoro. Se nel 1950 i lavoratori di quasi tutti i paesi europei,
con la cospicua eccezione già allora dell’Italia, lavoravano un maggior numero di ore
l’anno rispetto ai loro colleghi americani, nel 1995 era vero il contrario: in tutta Europa,
con l’eccezione di Grecia e Irlanda, le ore lavorate per occupato erano inferiori a quelle
degli Stati Uniti.
Tenendo conto anche della partecipazione alla forza lavoro, il gap tra i paesi europei
e gli Stati Uniti era, nel 1995, ancora maggiore. In quell’anno, le ore lavorate per abitante
erano 886 negli Stati Uniti, 578 in Spagna, 624 in Italia, 644 in Germania e Francia, 731
nel Regno Unito. Solo la Svizzera, tra i paesi dell’Europa occidentale, aveva un numero
di ore lavorate per abitante (883) circa pari a quello degli Stati Uniti (Crafts e Toniolo,
2010). Il rapporto tra ore lavorate in Francia, dove la produttività era circa uguale a
quella USA, e negli Stati Uniti (72%) è, per definizione, uguale al gap nel reddito per
abitante tra i due paesi. Perché gli europei lavorano meno degli americani? La questione
ha acceso un forte dibattito tra gli studiosi che si sono divisi tra coloro che pensano ciò
derivi da circostanze involontarie (gli europei vorrebbero lavorare più ore e in numero
maggiore ma non trovano lavoro) e chi ritiene che si tratti invece di una scelta volontaria
che privilegia il tempo libero rispetto al lavoro.
Grafico 2.1 – Reddito per abitante e produttività del lavoro. Rapporto Europa-Stati Uniti
100
90
PIL pro-capite
Produttività
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Fonte: dati Total Economy Database, sviluppato dal Groningen Growth and Development Center e ora mantenuto dal
Conference Board: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/.
97
Tra i proponenti della prima tesi spicca il premio Nobel Prescott (2004); essa è sostenuta
anche da Alesina et al. (2005, ripresa in Alesina e Giavazzi, 2006). Secondo questa tesi è la
struttura stessa dell’economia europea a restringere l’offerta di lavoro e quindi a scoraggiare
molti uomini e soprattutto donne dal partecipare alla forza lavoro. Per Prescott la grande
colpevole è la pressione fiscale, troppo elevata e quindi scoraggiante in Europa. Alesina e altri
attribuiscono il fenomeno a una molteplicità di fattori che generano sistemi economici rigidi
e pertanto meno capaci di innovazione e investimenti produttivi. In entrambi i casi, il dito
è puntato contro il “modello economico europeo” appesantito da troppe tasse, troppa regolazione, troppo poca concorrenza e da un sistema finanziario incentrato sulla banca anziché
sul mercato. In quello che è probabilmente il più completo lavoro in argomento, Blanchard
(2004) pur ritenendo che le rigidità del “modello europeo”(e soprattutto la cultura che lo
nutre) siano in parte responsabili della minore partecipazione degli europei alla forza lavoro,
attribuisce il minor numero di ore lavorate per lavoratore in buona misura a una scelta volontaria a favore del tempo libero. Gli europei, soddisfatta una certa soglia di consumo, preferirebbero il tempo libero al denaro in quantità maggiore di quella desiderata dagli americani.
L’esistenza, conclamata da entrambe le tesi, di diversi comportamenti economici (volontari
o involontari) tra le due sponde dell’Atlantico mette ovviamente in discussione il confronto,
fatto nelle pagine precedenti, tra redditi per abitante o, quantomeno, l’efficacia di questa misura quale indicatore non solo di benessere ma anche di capacità produttiva. Non è anche il
tempo libero un bene domandato? La crescita della produttività che caratterizza lo “sviluppo
economico moderno” ha “prodotto” nel secolo ventesimo una drammatica riduzione del
tempo dedicato al lavoro nel ciclo vitale di ogni individuo. Questo è stato, insieme all’allungamento della vita media, uno dei principali contributi della crescita della produttività
all’aumento del benessere. Nessun economista sosterrebbe che non si debba in qualche modo
tenere conto anche di questa circostanza per misurare i benefici dello sviluppo economico.
Prima di cercare di tenere conto di questa variabile nel valutare la performance economica
europea, è però utile vedere a grandi linee che cosa è successo dal 1995 a oggi.
2.4
L’Europa prima della grande crisi (1995-2007)
Attorno alla metà degli anni Novanta inizia una nuova fase della storia economica europea: dopo mezzo secolo di convergenza, in Europa la produttività – la più affidabile
misura dell’efficienza produttiva di un sistema economico – torna a divergere da quella
degli Stati Uniti. Al tempo stesso, riprende ad allargarsi il divario tra Europa e Stati Uniti
in termini di reddito per abitante. È difficile non ricondurre la nuova fase agli shock
globali degli anni 1989-1992.
È noto che gli Stati Uniti hanno goduto, dalla metà degli anni Novanta, di un
rinnovato slancio nella crescita della produttività. Nel medesimo torno di tempo si è
fatto evidente il superamento del paradosso di Solow («Si vedono computer dappertutto
tranne che nelle statistiche della produttività»). È opinione condivisa che gli Stati Uniti
siano stati capaci di utilizzare meglio dell’Europa la nuova “tecnologia generale” dell’informazione e della comunicazione (la cosiddetta “nuova economia”).
98
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
Il dato medio europeo di crescita della produttività nasconde considerevoli diversità
tra i risultati ottenuti dai singoli paesi nel periodo 1995-2005 (Tabella 2.2). Cinque paesi
(Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia e Svezia) hanno addirittura realizzato una crescita
della produttività superiore a quella statunitense. Al polo opposto, Spagna e Italia hanno
avuto un calo drammatico nella crescita del prodotto per ora lavorata.
Quanto alla tecnologia dell’informazione, non è facile stimarne il contributo alla crescita,
né è questo il luogo per accennare ai problemi teorici ed empirici sottesi a un simile esercizio.
Basta dire che alcuni tentativi di misurazione fatti sinora (Nicoletti e Scarpetta, 2005; van
Ark et al., 2003; Timmer e van Ark, 2005) concordano nell’indicare come negli Stati Uniti il
contributo delle nuove tecnologie alla crescita della produttività totale dei fattori sia andato
aumentando nel corso degli anni Novanta e abbia avuto una dimensione quasi doppia rispetto a quella ottenuta nella media dell’Europa occidentale. Si deve anche aggiungere che alcuni
paesi, segnatamente Irlanda, Finlandia e Svezia, hanno saputo trarre dalle nuove tecnologie
vantaggi superiori a quelli ottenuti dagli Stati Uniti.
In che misura il “modello” europeo di economia sociale di mercato (che gli americani vedono come caratterizzato da alte tasse, alta regolazione e bassa concorrenza) è
responsabile della nuova divergenza tra USA ed Europa? Chi propone questa tesi deve rispondere all’ovvia obiezione: il “modello” europeo nella forma attuale esiste almeno dagli anni Ottanta, perché non ha impedito la convergenza sino a circa il 1995? La risposta
che viene data, sulla base di ricerche empiriche, è che gli effetti dell’iper-regolazione sulla
produttività sono diventati più forti al crescere dell’importanza della nuova tecnologia
dell’informazione (Crafts e Toniolo, 2008). La regolazione del mercato del lavoro rende
più difficile la riorganizzazione del lavoro stesso dalla quale dipende gran parte dell’aumento di produttività generato dalle tecnologie informatiche (Gust e Marquez, 2004).
Nicoletti e Scarpetta (2005) inoltre hanno mostrato che esiste una forte correlazione
tra la regolazione del mercato dei prodotti e il contributo dei servizi ad alta intensità di
tecnologia informatica, soprattutto nella grande distribuzione che è uno dei punti deboli
dell’Europa rispetto agli Stati Uniti.
All’apice del lungo ciclo espansivo dell’economia mondiale (2007), l’Europa dava
– secondo molti osservatori soprattutto anglosassoni – segni di declino economico, seppure relativo, sintetizzato dal fatto che, dopo essere arrivata all’inizio degli anni Novanta
a breve distanza dai livelli di produttività americani, l’Europa aveva visto di nuovo allargarsi il gap di produzione e produttività tra le due sponde dell’Atlantico. Il Vecchio
Continente proiettava un’immagine di stanchezza, messa in evidenza dalla recuperata
vitalità dell’America, un po’ come era successo un secolo prima al Regno Unito rispetto
agli Stati Uniti emergenti. Gli shock dei primi anni Novanta sembravano avere avuto
effetti speculari ai due lati dell’Atlantico. Quanto c’era di vero in questa percezione?
Se si considerano solo i tassi di crescita del reddito e della produttività, nel 2007
l’Europa sembrava dare ragione a chi la vedeva, complessivamente, come un’area in
gentile declino, anche se la media nascondeva andamenti diversi nelle diverse aree del
continente. L’Europa del Nord non viveva alcun declino, mettendo a segno performance
di tutto rispetto, superiori a quelle degli Stati Uniti. La Germania assorbiva il colpo
dell’unificazione e preparava il rilancio della propria economia nel secolo che si apriva.
99
Al lato opposto, il cosiddetto Club Med mostrava già i segni del collasso che si sarebbe
verificato negli anni della crisi conclamata. La Spagna, che pure realizzava una buona
crescita del reddito per abitante, aveva un serio problema di produttività. L’Italia cresceva poco sia nel reddito sia nella produttività, anche se otteneva, rispetto al passato,
risultati migliori dal lato dell’occupazione.
All’inizio del ventunesimo secolo una valutazione degli esiti e delle prospettive dei
“modelli” europeo e americano non si può limitare alla dinamica della produttività. Rispetto agli Stati Uniti, il Vecchio Continente può vantare una speranza di vita superiore
di quasi due anni, una mortalità infantile ben più bassa, una minore diffusione della povertà, tassi di criminalità assai inferiori (i reclusi nelle carceri sono solo 87 ogni 100mila
abitanti contro i 685 degli Stati Uniti). La distribuzione del reddito e della ricchezza è in
Europa meno ineguale che oltre Atlantico. Se questi sono i risultati del “modello” continentale di economia sociale di mercato, molti cittadini sono probabilmente contenti di
pagare con una minore crescita i livelli complessivi di benessere che il “modello” stesso
garantisce. A favore del “modello” statunitense milita – come spesso si osserva – un più
accentuato dinamismo, verrebbe da dire un più diffuso ottimismo, rilevabile tra l’altro
nel maggiore tasso di fertilità delle donne nordamericane: 2,07 contro una media di 1,63
nell’Europa occidentale e meridionale e solo 1,36 in Germania, differenze che si riflettono in una minore età mediana della popolazione (36,9 anni negli Stati Uniti, 44,3 in
Germania; http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm). Gli esiti diversi dello
sviluppo economico postbellico in Europa e negli Stati Uniti possono benissimo dipendere da diverse preferenze radicate nella storia e nella cultura dei due popoli. Se così fosse, non avrebbe senso discutere di superiorità di questo o quel sistema, semmai il problema sarebbe quello della sostenibilità nel lungo periodo dell’uno e dell’altro “modello”.
Non sono, ovviamente, mancati i tentativi di quantificare le variabili ricordate sopra che
caratterizzano l’Europa rispetto agli Stati Uniti. Crafts e Toniolo (2008) hanno calcolato
di quanto aumentano sia il livello del reddito sia il tasso di crescita di Europa e Stati
Uniti dando un prezzo ragionevolmente basso alla longevità e al tempo libero. Su questa
base, nel periodo 1973-2005, il tasso di crescita del PIL statunitense passa dall’1,91% al
2,15% annuo, quello dell’Europa occidentale dall’1,88% al 2,71% (Crafts e Toniolo, 2008,
pp. 44-45). Gordon (2007) rivede i livelli rispettivi di reddito nel 2005 tenendo conto
di una serie di variabili. Anzitutto, quelle del lavoro: 2/3 delle minori ore lavorate in
Europa dipenderebbero da una scelta volontaria (piuttosto che dalle tasse e dalle altre
rigidità), mentre solo 1/10 della minore partecipazione alla forza lavoro sarebbe volontario. Nell’insieme queste due correzioni aggiungono il 4,5 % al PIL europeo. In secondo
luogo l’intensità energetica: gli americani hanno un maggior consumo di energia per
abitante rispetto agli europei, questa differenza ammonta al 2% del PIL che Gordon
attribuisce per la metà alla maggiore inclemenza del tempo, per l’altra metà alla minore
efficienza termica delle abitazioni e alla minore diffusione del trasporto pubblico: solo
questa seconda metà va presa in considerazione in un’analisi di benessere, aggiungendo
l’1% al PIL europeo. In terzo luogo, la criminalità: Gordon diminuisce il PIL americano
dell’1% per tenere conto dell’“eccessiva incarcerazione”. Al contrario di Crafts e Toniolo,
Gordon non quantifica l’impatto sul reddito della maggiore durata della vita media eu-
100
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
ropea. Nel complesso il PIL europeo per abitante (2005) passerebbe, sulla base di questi
aggiustamenti, dal 70,5 al 77,0% di quello statunitense.
Si è cercato, inoltre, di fare un’ulteriore correzione, per tenere conto della più ineguale distribuzione del reddito negli Stati Uniti (Spater, 2012). Assumendo ragionevolmente
che il 10% della popolazione in entrambi i lati dell’Atlantico abbia un livello di reddito
tale da assicurarle un elevato benessere, Spater ha confrontato il reddito per abitante del
restante 90% di europei e americani. Tenendo conto anche delle correzioni di Gordon,
per la stragrande maggioranza degli abitanti delle due rive dell’Atlantico la differenza di
reddito si riduce a meno del 20%. Se si tenesse inoltre conto di fattori quali l’efficienza e
il costo dei rispettivi sistemi sanitari, della mortalità infantile, della migliore qualità media
dell’istruzione e di simili fattori meno facilmente quantificabili, il confronto tra gli esiti dei
“modelli” europeo e americano nel 2005-2007 non appariva molto squilibrato a sfavore
dell’Europa, giustificando le preferenze individuali e sociali per l’uno o per l’altro.
2.5
L’Europa nella grande recessione
Il National Bureau of Economic Research (NBER), da decenni la massima autorità nel
datare le fasi del ciclo economico, ha stabilito che quella che va sotto il nome di grande
recessione iniziò negli Stati Uniti nel dicembre 2007. La flessione dei prezzi degli immobili si stava già facendo sentire (in agosto Lehman Brothers aveva già chiuso BNC
Mortgage, la propria banca dedicata ai prestiti subprime). La cronaca del successivo svolgersi della crisi è nota e non serve riprenderla qui. Quanto alla storia, essa già occupa
decine di migliaia di pagine dedicate alle relazioni causa-effetto e alle interpretazioni che
già dividono gli studiosi; essa è destinata a restare controversa e a essere periodicamente
rivisitata nei decenni a venire, come è successo e succede con quella della grande crisi
degli anni Trenta. Finché le crisi finanziarie saranno con noi, ed è facile prevedere che
quella che viviamo non sarà l’ultima, esse sono destinate a suscitare feroci dibattiti. D’altra parte, la grande recessione è ancora in evoluzione e un giudizio storico complessivo
potrà essere dato solo al compimento del ciclo iniziato a fine 2007. Ai nostri fini interessa solo cercare di capire quanto le economie europee abbiano sofferto e soffrano a causa
della crisi tuttora in atto e se questo giustifichi il pessimismo di alcuni osservatori, sino
alla metafora cimiteriale con la quale abbiamo aperto queste pagine.
L’elementare esercizio del confronto tra tassi di crescita del reddito per abitante aiuta
a mettere a fuoco i risultati economici dell’Europa rispetto a quelli ottenuti dai tre colossi con i quali ha senso un confronto (Tabella 2.3). Va detto subito che paragonando
gli andamenti del reddito “per abitante”, piuttosto che quelli del reddito totale come di
solito fanno i media, viene ridimensionata la differenza tra i risultati ottenuti da Europa
e Stati Uniti (ove la crescita della popolazione è più elevata) lungo l’intero ciclo 20022011 (mancano al momento di scrivere questo capitolo i dati OCSE comparabili per il
2012). Tra il 2002 e il 2007 la crescita degli Stati Uniti è stata solo marginalmente più
elevata di quella dell’Area euro, che nella UE rappresenta la parte più istituzionalmente
integrata,, entrambe un po’ inferiori al tasso di crescita secolare. Negli anni della crisi
(2007-2011) la contrazione è stata più marcata nell’Area euro che oltre Atlantico. Nel
101
complesso gli americani avevano nel 2011 un reddito medio superiore del 6,2% rispetto
a quello goduto nel 2002 mentre il reddito medio degli abitanti dell’Area euro superava
del 5,7% quello di nove anni prima. Non si tratta, nel complesso, di una differenza tale
da giustificare una visione catastrofica della performance dell’economia dell’eurozona
rispetto a quella statunitense (come messo in evidenza dal grafico 2.2). Grazie ai paesi
dell’Est e del Nord, nello stesso arco di tempo la crescita dell’intera Unione europea è
stata migliore di quella americana.
Tabella 2.3 – Tassi di crescita medi annui PIL pro-capite
Medie annue
2002-2007
Cumulato
2007-2012
2002-2012
Francia
1,30
-0,41
4,50
Germania
1,73
0,79
13,35
Italia
0,53
-1,90
-6,74
Giappone
1,75
-0,11
8,46
Regno Unito
2,57
-1,07
7,62
Stati Uniti
1,78
-0,26
7,83
Area euro
1,57
-0,53
5,26
Unione europea
2,08
-0,46
8,34
Cina
11,01
8,82
157,33
Fonte: OCSE.
Grafico 2.2 – Reddito pro-capite USA e Area euro
(Migliaia di dollari a prezzi costanti)
45
43
41
39
37
35
Stati Uniti
Area euro
33
31
29
27
25
Fonte: FMI.
2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
102
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
Come diremo più avanti, il problema dell’Area euro non consiste tanto in una crescita
del reddito per abitante inferiore a quella degli Stati Uniti quanto nel divario, nella vera
e propria spaccatura, che si è creata tra l’Europa centro-settentrionale e l’area mediterranea. All’interno di quest’ultima è cruciale la posizione dell’Italia, sia per la dimensione
del paese sia per la sua ormai endemica bassa crescita. Lungo il ciclo 2002-2011, l’aumento del reddito per abitante di un’ipotetica Area euro a 16 dalla quale fosse esclusa l’Italia
sarebbe risultato, seppure di poco, superiore a quello degli Stati Uniti, con un livello nel
2011 pari a 107,3 (contro il 105,7 di tutta l’area a 17 paesi, tabella 2.3).
2.6
I prossimi anni se continuano le tendenze attuali…
Resta valida, per quanto abusata, la citazione di Nils Bohr, premio Nobel per la fisica: «Le previsioni sono difficili, soprattutto quando riguardano il futuro». Per Lao Tsu,
saggio poeta cinese del VI secolo a.C.: «Chi conosce le cose non fa previsioni, chi fa
previsioni non conosce le cose». È tuttavia nella natura umana il cercare di interrogare il
futuro: dagli antichi aruspici ai sondaggi elettorali il bisogno resta sempre il medesimo.
Nell’ultima parte di questo lavoro cerchiamo, dunque, di seguire accreditati analisti nel
loro avventurarsi in previsioni a orizzonti via via più lontani sulla collocazione dell’Europa nell’economia mondiale, cercando di guardarle con l’occhio un po’ disincantato,
sapendo che la storia, soprattutto quella recente, ci ha abituato a enormi sorprese.
Il modo statisticamente meno insicuro di prevedere il futuro è quello di vederlo
come una proiezione delle tendenze attuali; è questa, con qualche dovuto correttivo, la
regola aurea di coloro che si cimentano nel disegno di scenari. Conforta lo storico l’opinione di Lord Halifax che la migliore qualificazione per esercitare il mestiere di profeta è
quella di avere buona memoria. Un po’ più tecnicamente: le previsioni macroeconomiche sono largamente basate sull’idea che ogni paese si colloca, nel lungo periodo, lungo
una traiettoria di crescita di stato stazionario determinata dallo sviluppo della tecnologia
a livello mondiale, dalle condizioni strutturali (tipicamente intensità di capitale fisico
e umano) e dalle istituzioni e politiche proprie di quello stesso paese. Gli economisti
chiamano questo processo “convergenza condizionata”. Le previsioni di base o neutrali
si costruiscono con modelli fondati su questa semplice ipotesi.
Inutile dire che quanto più breve è il lasso di tempo al quale si riferiscono, tanto
meno inaffidabili risultano le previsioni. Vediamo, dunque, anzitutto che cosa prevede
l’OCSE per il biennio 2013-2014 (Tabella 2.4). Se, come si è visto, nel ciclo del primo
decennio del secolo i risultati ottenuti nell’Area euro in termini di benessere (PIL per
abitante puro o “aggiustato”, indicatori di benessere non misurabili a prezzi di mercato)
sembra non sfigurare nel confronto con quello che resta il leader mondiale nel progresso
tecnico e nella produttività, le previsioni per il biennio entrante sono assai meno favorevoli all’eurozona, dove l’uscita dalla lunga crisi si annuncia ancora debole, anche nella
solida Germania nella quale il PIL per abitante dovrebbe crescere nel 2013 solo dello
0,6%, contro l’1,2 % degli Stati Uniti, per avvicinarsi al ritmo di questi ultimi nel 2014
grazie a una crescita nulla (forse lievemente negativa) della popolazione (non proprio
indice di dinamismo sociale).
103
Tabella 2.4 – Tassi di crescita del PIL
(Prezzi PPA costanti in dollari USA 2005, variazioni % medie annue)
pil
2013
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
Eurozona
Stati Uniti
Cina
India
pil pro-capite*
2014
0,3
0,6
-1,0
0,9
-1,4
-0,1
2,0
8,5
5,9
2013
1,3
1,9
0,6
1,6
0,5
1,3
2,8
8,9
7,0
2014
-0,3
0,6
-1,5
0,2
-1,8
-0,5
1,2
7,9
4,5
0,7
1,9
0,1
0,9
0,1
0,9
2,0
8,3
5,6
* Assumendo un tasso di crescita della popolazione invariato (dati World Bank, http://www.indexmundi.com/facts/
indicators/SP.POP.GROW).
Fonte: PIL: OCSE 2012 (http://www.oecd-library.org/economics/real-gross-domestic-product-forecasts_gdp-kusd-grtable-en); popolazione: World Bank (http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.POP.GROW).
Nel complesso, l’OCSE prevede per l’Area euro avanzi di parte corrente vicini al 2% in
entrambi gli anni, con una caduta dei consumi pubblici e privati nel 2013, seguita nel
2014 da un aumento rispettivamente dello 0,4% e dello 0,9%. Si prevede che il cosiddetto output gap, cioè la differenza tra prodotto realizzato e prodotto potenziale, resti
vicino a -5 %.
Allungando l’orizzonte ai prossimi sei anni, sino al 2018, il Conference Board offre
le proprie previsioni in tre scenari più o meno ottimistici (Tabella 2.5). Anche in queste
previsioni la crescita europea si colloca ben al di sotto di quella degli Stati Uniti e delle
altre economie avanzate, a eccezione del Giappone, che, tuttavia, dovrebbe fare meglio
del Vecchio Continente in termini di reddito per abitante, vista la dinamica demografica
negativa dell’Impero del Sol Levante.
Tabella 2.5 – Tassi di crescita del PIL per aree geografiche 2013-2018 – Tre scenari
(Variazioni % medie annue)
Stati Uniti
Europa *
Giappone
Totale economie avanzate **
Cina
India
Totale economie emergenti
scenario
ottimista
2,5
1,5
1,3
,
8,0
5,7
,
scenario
base
2,3
1,2
0,8
,
5,8
4,7
,
scenario
pessimista
2,1
0,8
0,5
,
3,7
3,6
,
* Unione europea, Islanda, Norvegia, Svizzera.
** Include anche Canada, Israele, Corea, Australia e altre minori.
Fonte: The Conference Board Global Economic Outlook 2013, aggiornato nel gennaio 2013 (http://www.conferenceboard.org/data/globaloutlook.cfm), per dettagli e metodologia Chen et al. (2012).
104
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
La lunga crisi economica ha, dunque, in qualche misura finalmente giustificato i giudizi
negativi che molti osservatori americani davano, allora con scarsa ragione, sull’Europa
ante 2007. La differenza tra prodotto realizzato e potenziale sta a indicare che una parte
del problema risiederà, nel prevedibile futuro, nella compressione della domanda dovuta
in grande misura, ma non interamente, alle politiche di rientro dai disavanzi pubblici
eccessivi accumulati prima della crisi e nella sua fase iniziale. Vi sono, accanto alle molte differenze – prima tra tutte l’esistenza della moneta unica e livelli di indebitamento
pubblico allora in media inferiori agli attuali – analogie con la crisi degli anni Trenta.
Esistono, oggi come allora, forti squilibri nelle posizioni creditorie e debitorie tra i paesi
uniti allora dal gold standard, oggi dalla moneta unica. Oggi, come allora, ci si chiede
chi deve aggiustare? La risposta, di nuovo oggi come allora, è: entrambi. Nel 1930-1931
la Francia, dotata di cospicue riserve auree, forti crediti sull’estero e avanzo di parte
corrente, avrebbe dovuto espandere la domanda interna, favorendo indirettamente la
ripresa della Germania alla quale questa opzione era preclusa dai creditori esteri che ne
finanziavano la forte posizione debitoria. Invece, la Francia, che aveva avuto una modesta caduta produttiva tra 1929 e 1931, seguì una politica restrittiva che la condannò alla
stagnazione per gran parte degli anni Trenta, obbligando la Germania a “fare da sé” con
rigidi controlli sui movimenti dei capitali, tariffe doganali e, infine, autarchia. L’analogia
con la condizione attuale è trasparente se solo si scambiano i ruoli tra i paesi, leggendo Germania al posto di Francia e Italia al posto di Germania. La via dell’espansione
fiscale è in buona misura preclusa all’Italia (e alla Francia?) ma non alla Germania: se la
adottasse ne trarrebbero beneficio sia i tedeschi sia gli italiani sia, complessivamente, la
stabilità dell’Area euro.
Detto questo, i problemi economici dell’Area euro sono solo in parte riconducibili
alla dinamica della domanda aggregata. La divisione sempre più netta dell’Europa in due
aree con andamenti divergenti della produzione, dell’occupazione e della produttività è
in buona misura strutturale. Il cosiddetto Club Med deve adottare provvedimenti per
un recupero di crescita della produttività in assenza del quale misure congiunturali come
quelle indicate sopra avrebbero, nella migliore delle ipotesi, effetti effimeri.
Non mancano, infine, gli scenari a lungo termine, basati su una continuazione “corretta” dei trend attuali. La correzione si basa sull’ipotesi che, a mano a mano che i paesi
emergenti si avvicinano alla frontiera della produttività, il loro tasso di crescita rallenti.
Le quote sul PIL mondiale possono essere lette come una mappa del potere economico mondiale al momento attuale (2012) e nel 2025 (Tabella 2.6). Raffigurano gli esiti
di lungo andare della fine della grande divergenza, l’evento millenario della nostra epoca.
Secondo questa rappresentazione, gli Stati Uniti crescerebbero nei prossimi tredici anni
a un ritmo uguale a quello dell’economia mondiale nel suo complesso, mantenendo
dunque sostanzialmente stabile attorno al 18% il proprio contributo al PIL mondiale. I
grandi “perdenti” sarebbero Europa e Giappone che vedrebbero ridotta la propria fetta
nella produzione globale. La Cina diventerebbe, ben presto, la prima potenza economica
e l’India aumenterebbe il proprio peso relativo. Il Conference Board non vede, al contrario di altri, buone prospettive per l’economia africana il cui peso sarebbe destinato a
diminuire, mentre quello dell’America Latina resterebbe costante.
105
L’OCSE, dove Maddison fece scuola, allunga coraggiosamente l’occhio sino al 2060
(Johansson et al., 2012). Le tendenze di lungo andare sulle quali si basano le previsioni
dell’OCSE sono le seguenti: un progressivo invecchiamento della popolazione che ridurrà la partecipazione alla forza lavoro in assenza di riforme strutturali (le migrazioni
aiuteranno poco); un continuo aumento del capitale umano accanto a una stabilizzazione
dell’intensità del capitale fisico e a una diminuzione dei tassi di risparmio (soprattutto in
Cina e India); la produttività sarà il principale veicolo della crescita del reddito; la crescita
mondiale sarà sostenuta soprattutto dalle economie emergenti; la grande convergenza
nei redditi per abitante continuerà ma resteranno importanti differenze di benessere tra
i paesi.
Tabella 2.6 – Distribuzione del PIL mondiale per aree geografiche
(% del totale mondiale)
2012
Stati Uniti
Europa *
di cui Area euro
Giappone
Altre avanzate
Totale economie avanzate
Cina
India
Altre emergenti Asia
America Latina
Medio Oriente
Africa
Russia, Asia centrale, Europa sud orientale
Totale economie emergenti
18,2
20,3
13,8
5,6
7,2
,
16,4
6,3
5,3
7,7
3,7
3,3
5,9
,
2025
18,3
17,4
12,0
4,8
7,3
,
22,7
8,6
4,9
7,1
2,5
2,6
4,1
,
* Unione europea, Islanda, Norvegia, Svizzera.
** Canada, Israele, Corea, Australia e altre.
Fonte: The Conference Board Global Economic Outlook 2013, aggiornato nel gennaio 2013 (http://www.conferenceboard.org/data/globaloutlook.cfm), per dettagli e metodologia Chen et al. (2012).
L’interagire di queste tendenze produrrebbe, secondo gli autori dell’OCSE, una struttura dell’economia mondiale nel 2060 caratterizzata dalla seguente distribuzione del
prodotto globale: Cina 28%, India 18%, Stati Uniti 16%, Unione europea 9%, Giappone
3%. Gli abitanti dei cosiddetti paesi avanzati odierni godrebbero ancora di un benessere
superiore a quello degli altri, ma produrrebbero solo un terzo del reddito mondiale.
Colpisce, in questa proiezione “neutrale” l’enorme restringimento della quota europea
di prodotto mondiale (che si dimezzerebbe nel giro di circa cinquant’anni), mentre quella degli Stati Uniti subirebbe solo una modesta limatura. Le conseguenze geopolitiche
di questo spostamento del “potere” economico mondiale sono difficilmente calcolabili,
potendosi immaginare scenari virtuosi caratterizzati da crescente cooperazione internazionale o, al contrario, scenari con forti tensioni globali.
106
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
2.7
…ma ci sono venti contrari, leve da usare, occasioni da cogliere
Se le previsioni “neutrali” estendono a un futuro lontano le tendenze attuali, la storia del
ventesimo secolo e del primo decennio di quello attuale ci rende cauti nello scommettere
sulla proiezione del presente ai prossimi cinquant’anni. Senza evocare gli scenari apocalittici del secolo scorso, che pure si era aperto con il grande ottimismo della belle époque,
basta andare indietro di cinque anni e chiederci: che cosa è successo della “grande moderazione” sulla quale scommettevano governi e mercati, oltre che ingenui economisti?
Robert Gordon (2012), uno dei maggiori esperti di produttività e crescita, propone
una lettura dei cicli dell’innovazione nell’economia statunitense per aiutarci a guardare
in modo meno “neutrale” al futuro. Benché riferite strettamente al caso americano, le
sue considerazioni aiutano a riflettere anche sull’Europa. Dopo avere ricordato le tre
grandi “tecnologie generali” – la macchina a vapore nella prima metà dell’Ottocento,
il motore elettrico alla fine dello stesso secolo e la recente tecnica dell’informazione
e comunicazione – Gordon sostiene che quest’ultima è quella che ha avuto minore
impatto sulla produttività e sul benessere e anche quella i cui effetti dinamici e propulsivi avranno minore durata nel tempo. Su questa base, prevede un rallentamento
della crescita della produttività nei decenni a venire. Anche se così non fosse, aggiunge
Gordon, l’economia statunitense è destinata ad affrontare problemi (che chiama “venti
contrari”) non facili. Essi sono: l’invecchiamento della popolazione, una bassa qualità
dell’istruzione soprattutto media superiore, i problemi gemelli dell’approvvigionamento
energetico e dell’ambiente, la disuguaglianza nella distribuzione del reddito, un eccesso
di indebitamento pubblico e privato.
Si tratta, come si vede, di venti contrari che, in misura più o meno intensa, dovrà affrontare l’intera economia mondiale. L’Europa non fa eccezione. Al momento, l’elevato
debito pubblico dei paesi mediterranei frena l’Europa più di quanto il debito americano
rallenti la ripresa statunitense. In prospettiva, tuttavia, la dinamica della spesa sanitaria
è destinata a costituire un problema più serio negli Stati Uniti che in Europa dove,
inoltre, è meno pesante l’indebitamento delle famiglie. Il problema demografico è più
serio in Europa che negli Stati Uniti: in Germania, coma abbiamo visto, la crescita della
popolazione negli ultimi anni è stata sostanzialmente nulla (leggermente negativa), in
altri paesi quali l’Italia il modesto aumento demografico è dovuto al contributo dell’immigrazione (sia per il flusso netto in entrata sia per la maggior fertilità delle residenti
straniere rispetto alle italiane).
Il perfezionamento del processo, conosciuto da tempo, di fratturazione idraulica
(anche noto con il termine inglese di fracking), consistente nella fratturazione di rocce
sotterranee tramite l’iniezione di fluidi a pressione per estrarvi petrolio o shale gas, sembra avviato a cambiare la mappa della produzione energetica mondiale. Gli Stati Uniti
si avviano all’autosufficienza energetica. Ciò è destinato ad avere effetti sia ambientali
sia strategici. Il costo ambientale del processo di estrazione di gas con la tecnica della
fratturazione idraulica è molto discusso e ancora incerto. In prospettiva esso è destinato
da un lato a sostituire petrolio (altamente inquinante) con gas (meno inquinante) ma, al
tempo stesso, a ridurre gli incentivi alla ricerca di fonti energetiche alternative; il risulta-
107
to netto di lungo andare sull’effetto serra e su altre variabili ambientali non è facilmente
misurabile. Gli Stati Uniti sono destinati a continuare ad avere, rispetto all’Europa, un
vantaggio nel costo medio dell’energia. La diffusione di questa tecnologia avrà inevitabilmente un impatto di politica estera e militare. Gli Stati Uniti diventeranno, nel tempo,
meno dipendenti da fonti energetiche estere, soprattutto medio orientali, diminuendo il
proprio interesse strategico per quell’area. Per l’Europa questi sviluppi costituiscono una
sfida, non necessariamente perdente. Il Vecchio Continente è più avanti degli Stati Uniti
nel risparmio energetico e nelle connesse emissioni per unità di prodotto. In un mondo
nel quale il problema ambientale è destinato, come ricorda Gordon, a frenare il tasso di
crescita ciò potrebbe costituire un vantaggio: molto dipenderà da come la questione ambientale verrà affrontata dai paesi emergenti, anzitutto dalla Cina, che sembra assumere
un atteggiamento sempre più responsabile.
La prospettata autosufficienza energetica degli Stati Uniti caricherà probabilmente
l’Europa di maggiori responsabilità nell’area medio orientale.
Abbiamo già notato come la disuguaglianza nella distribuzione del reddito sia maggiore negli Stati Uniti che in Europa continentale (soprattutto quella centro settentrionale). Lo stesso Gordon (2012) ricorda il basso tasso di crescita del reddito del 99% delle
famiglie americane (solo 0,55% l’anno tra 1993 e 2008). Abbiamo già detto che se ciò che
conta è il benessere della stragrande maggioranza della popolazione, allora l’Europa si
trova in una posizione assai meno sfavorevole rispetto agli Stati Uniti di quanto apparirebbe se si considerasse il 100% della popolazione stessa. Il “modello” egualitario europeo
ha dato buoni frutti, in confronto con quello americano, sino allo scoppio della grande
recessione. Saprà reggere allo shock attuale?
L’interazione tra globalizzazione e tecnologia dell’informazione, argomenta Gordon,
produce un ben noto effetto Hecksher-Ohlin-Samuelson che prevede una convergenza
dei prezzi dei fattori produttivi, in particolare del lavoro, anche tramite la delocalizzazione di produzioni in aree a basso costo della manodopera con effetti “dannosi sui
paesi a salari più elevati”. È questo un “vento contrario” anche per l’Europa? Nel lungo
andare, il rapporto salari/ produttività è destinato a crescere anche nei paesi emergenti,
il fenomeno è già in atto tanto che ci si chiede se taluni di essi non siano destinati a
cadere precocemente in quel forte rallentamento della crescita chiamato mid-incometrap
(trappola dei paesi a medio-reddito). La globalizzazione non è, dunque, necessariamente
una condanna per i paesi europei, come insegna la Germania. Molto dipenderà dalle
politiche macroeconomiche, industriali e dell’istruzione che saranno adottate. La qualità
dell’istruzione, in particolare, è un punto di forza dell’Europa (di nuovo, escludendo
il Club Med) rispetto agli Stati Uniti, una leva preziosa da utilizzare sia per la crescita
economica sia, comunque, per accrescere la qualità della vita riconoscendo con maggiore
forza di quanto si faccia oggi che l’istruzione è al tempo stesso accumulazione di capitale umano per migliorare lo standard di vita e bene di consumo di gran lusso, offerto
gratuitamente agli europei meno abbienti, che consente una migliore realizzazione delle
potenzialità di crescita biologica e spirituale della persona.
Tra le occasioni da cogliere vi è la recente proposta di un Comprehensive Agreement per
il commercio tra Stati Uniti e Unione europea. Il Gruppo di lavoro bilaterale ad hoc (High
108
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
Level Working Group on Jobs and Growth, 2013) ha appena consegnato (11 febbraio
2013) il proprio rapporto finale come prima base per negoziare un accordo transatlantico
sui seguenti temi: eliminazione di tariffe, quote di importazione e simili; eliminazione o
riduzione delle barriere (non tariffarie) al commercio di beni e servizi e agli investimenti;
migliore compatibilità di regolamenti e standard, eliminazione, riduzione e prevenzione
di non necessarie barriere “oltre confine” di ogni genere; più stretta collaborazione per lo
sviluppo di regole e principi su problemi globali di mutuo interesse, anche per il perseguimento di obiettivi economici comuni. La prospettiva di un simile trattato bilaterale
sconta la critica che esso potrebbe ritardare il raggiungimento di accordi multilaterali e
ridurre l’autorità del WTO, organizzazione che ha ottenuto notevoli successi negli anni
recenti. Vi è chi dissente da questa critica arguendo che grandi accordi bilaterali creano, al contrario, incentivi a procedere lungo la via della multilateralità. La proposta di
accordo transatlantico, rilanciata recentemente dal Presidente Obama, dà all’Europa un
segnale che non può essere sottovalutato: dopo almeno un quindicennio di “ritirata” dal
Vecchio Continente per concentrarsi sul dinamico scacchiere del Pacifico, gli Stati Uniti
mostrano un nuovo interesse, tanto forte da essere inquadrato in una proposta precisa
di negoziato commerciale.
Le difficoltà, sono evidenti ed enormi, a cominciare da quelle poste dall’agricoltura
europea, radicate nella storia degli ultimi centocinquanta anni. Ma i benefici per l’Europa potrebbero essere importanti nel lungo andare, al di là di quelli prospettati dalla
teoria dei costi comparati. Si tratta di ricostruire quella relazione speciale che consentì
la ricostruzione postbellica e il lancio della CEE e che è venuta un po’ impallidendo
negli ultimi decenni sia per la diminuita importanza economica e strategica dell’Europa
sia per la percezione, in parte come abbiamo visto infondata, di una sua minore vitalità
economica.
2.8
Conclusioni
Dalla metà del diciannovesimo secolo sino alla metà di quello successivo l’Europa ha faticato a stare al passo con gli Stati Uniti nella crescita del reddito per abitante e della produttività. La “seconda guerra dei trent’anni”, che Keynes chiamò guerra civile europea,
fu una tragedia che il Vecchio Continente si autoinflisse ritardando la propria crescita
economica. Le macerie fumanti del 1945 avevano riportato il benessere degli europei
indietro di venti o trent’anni. Con l’iniziale sostegno, soprattutto politico ma anche
finanziario e tecnologico, degli Stati Uniti, il dopoguerra vide una rapida convergenza
dei redditi e della produttività europei verso i livelli americani. Se, in media, il reddito
per abitante si fermò attorno ai due terzi di quello americano, la produttività continuò
a convergere sino quasi a raggiungere quella statunitense. Abbiamo visto le ragioni di
questo andamento a forbice e argomentato che il divario di benessere tra le due rive
dell’Atlantico è plausibilmente inferiore a quanto indicato dal confronto fra i redditi
pro-capite. Nel complesso, la caricatura dell’Europa come “cimitero con grande arte”
non ha fondamento nei numeri che abbiamo cercato di allineare nelle pagine precedenti.
109
Il “modello europeo”, se di esso si può parlare, non sfigura rispetto a quello americano.
Almeno fino al 2007.
Benché originata plausibilmente negli Stati Uniti, la grande recessione ha fatto pagare all’Europa il conto più salato. Tanto salato che alcuni scenari di sviluppo per i prossimi dieci anni e oltre scontano una lenta ripresa europea e una crescita a regime più bassa
di quella degli Stati Uniti che continueranno a essere per il prevedibile futuro non più
la maggiore economia del globo ma ancora quella più innovativa. Malgrado la vitalità
dimostrata sino al 2007, sarà, dunque, alla fine davvero perdente il “modello europeo”
perché affossato dalla crisi?
Poco prima dell’attuale grande recessione, un acuto (e benevolo) conoscitore della
storia e dell’economia europea, Barry Eichengreen, vedeva il futuro a lungo termine
dell’Europa dipendere da due insiemi di variabili: il tipo di progresso tecnico che si realizzerà e la capacità delle istituzioni europee di essere agenti di cambiamento (Eichengreen, 2007). Il “sistema europeo”, basato su mercati del lavoro fortemente istituzionalizzati, sulla formazione professionale vocazionale e su sistemi finanziari centrati sulla
banca, gli pare più adatto a recepire tecnologie che si sviluppano lentamente piuttosto
che ad adattarsi a repentini shock tecnologici (come quello recente dell’informazione). Se questa analisi fosse corretta e se il futuro darà ragione a Gordon, che vede in
via di esaurimento l’impatto della tecnologia ICT, il “sistema” europeo si rivelerebbe
adatto al futuro. Se, viceversa, irrompessero nuove tecnologie (es. nanotech e biotech),
l’intero modello europeo andrebbe ripensato a pena di una marginalizzazione tecnologica e produttiva del Vecchio Continente. Sul piano istituzionale, Eichengreen vedeva
l’esigenza di un’ulteriore devoluzione di potere dagli Stati all’Unione. Pur ritenendo
improbabile un’implosione del progetto europeo, Eichengreen riteneva che esso fosse
nel futuro, come nel passato, destinato a vivere periodiche tensioni tra questa esigenza
e la resistenza degli elettorati europei a ulteriori trasferimenti di sovranità e si chiedeva
se in queste prevedibili condizioni l’UE sarà in grado di essere efficace agente e veicolo
di cambiamento.
Oggi costatiamo che l’Europa ha, nel suo complesso, sofferto più di ogni altra “regione” del globo per i sei anni di crisi finanziaria e reale. Essa ci appare come un’area
meno omogenea di quanto – a torto o a ragione – apparisse cinque o sei anni addietro.
La risposta alla grande recessione delle economie centro-settentrionali, quelle nelle quali più radicato e compiuto è il “modello” di economia sociale di mercato, è stata più
efficace di quella della parte meridionale del continente (e del Regno Unito). Si tratta
solo degli effetti macroeconomici della recessione su economie fortemente indebitate,
e pertanto private della possibilità di sostituire domanda pubblica a quella privata in
flessione, o i problemi dei paesi meridionali hanno radici più profonde? Boltho e Carlin
(2013) ritengono che la frattura all’interno dell’Unione monetaria evidenzi una diversità
negli standard amministrativi e di governo radicata in differenze istituzionali, culturali e
nella coesione sociale che furono sottovalutate al momento della creazione dell’Unione
monetaria. L’analisi in sé non è nuova ma è sostenuta dagli autori con abbondanza di
nuova evidenza empirica; se fosse corretta, la cura consisterebbe in un rilancio della convergenza istituzionale sostenuta da una forte legittimazione democratica.
110
2. Produttività e benessere: il destino dell’Europa non è segnato
Nel momento in cui iniziavo a stendere questa nota, la fase più acuta della malattia che secondo alcuni autori, soprattutto anglosassoni, avrebbe dovuto inevitabilmente portare alla morte dell’euro sembrava in via di superamento. Ciò mi induceva
a ritenere che, salvo incidenti di percorso dati come sempre possibili, l’Europa della
moneta unica aveva ancora una volta dimostrato, per dirla con Mark Twain, che la
notizia della sua morte era fortemente esagerata. Poche settimane dopo, consegnando
queste pagine all’editore, l’esito delle elezioni italiane del 24 e 25 febbraio 2013 preoccupa i governi europei. Può essere uno degli incidenti di percorso che rallentano o
fanno addirittura deragliare il treno della costruzione europea? Per il lungo termine la
risposta è con ogni probabilità negativa ma, proprio quando la navigazione sembrava
entrare in acque meno mosse, le previsioni sono state sconvolte e, nel breve e forse
medio termine, si annuncia una nuova tempesta che metterà alla prova la tradizionale
capacità delle istituzioni europee di forgiare soluzioni, spesso con gli orologi fermati
alla ventiquattresima ora.
111
3
Le politiche per rilanciare la competitività europea:
più mercato interno e nuovo welfare ispirato alla flexicurity
Stefano Micossi*
Sommario
3.1 Introduzione – 3.2 L’evoluzione della produttività aggregata negli Stati Uniti e in Europa – 3.3
Gli andamenti disaggregati della produttività – 3.4 Migliorare la performance del mercato del lavoro – 3.5 Il miglioramento della produttività attraverso il completamento del mercato interno – 3.6
A che punto è il mercato interno? – 3.7 Quali interventi – 3.8 Semplificazione – 3.9 Conclusioni
3.1
Introduzione
Un’economia competitiva si riconosce non tanto per un tasso di cambio conveniente
(deprezzato), quanto per l’elevato livello della produttività; come sottolinea il premio
Nobel Edmund Phelps, questo è anche il fondamento di un tenore di vita elevato e di un
mercato del lavoro ricco di opportunità e di soddisfazioni per chi vi partecipa. Da questo punto di vista, in Europa la situazione non solo non è rosea, ma tende a peggiorare.
Un rapporto del World Economic Forum (WEF 2013) ci ricorda che l’Unione europea
è ormai stata superata, in termini di PIL pro-capite, dalla Corea del Sud, paese di ben
più recente industrializzazione. Inoltre, diverse economie dei BRICS presentano livelli
di competitività (misurata dagli indicatori compositi del WEF) simili a quelli dei paesi
dell’Europa del Sud nella capacità di innovare e nell’efficienza del mercato dei prodotti,
addirittura migliori nel mercato finanziario e in quello del lavoro – godendo di salari
significativamente più bassi. Non sorprende, in un tale contesto, che i paesi del Sud
Europa risultino poco attraenti per gli investimenti esteri.
In un ambiente esterno sempre più competitivo, l’Europa può sostenere i suoi alti
livelli di benessere solo migliorando la produttività del lavoro, del capitale e totale dei
fattori; ma negli ultimi cinquant’anni la crescita della produttività è continuamente diminuita, mentre la forbice rispetto agli Stati Uniti ha preso a riaprirsi dalla metà degli anni
Novanta (Grafico 3.1). Nelle pagine seguenti esaminiamo l’evoluzione della produttività
in un’ottica di lungo periodo, a livello aggregato e settoriale, per metterne in luce le grandi
dinamiche. I paragrafi successivi discutono alcune aree prioritarie d’intervento, in particolare nel mercato del lavoro, nell’integrazione nel mercato interno europeo, soprattutto nei
* Direttore Generale Assonime, Collegio d’Europa Bruges e CEPS.
112
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
servizi e nelle reti energetiche, di trasporto e di comunicazione e, infine, nella regolazione
dell’attività d’impresa. In questi ambiti alcune azioni possono essere intraprese a livello
europeo, ma altre riforme devono essere attuate al livello degli Stati nazionali.
3.2
L’evoluzione della produttività aggregata negli Stati Uniti e in Europa
La tabella 3.1 mostra gli indici aggregati del reddito pro-capite e per ora lavorata rapportati
a quelli degli Stati Uniti: come si può vedere, il reddito pro-capite dell’Europa (UE-27)
risulta, nel 2012, inferiore del 33% a quello degli Stati Uniti, con significative variazioni
relative al proprio interno. Un poco meno ampio risulta il divario misurato in termini
di PIL per ora lavorata – una misura più vicina alla produttività aggregata del lavoro – in
particolare per la Francia e la Germania: la differenza tra i due indicatori riflette il tasso di
utilizzo del lavoro, più basso in Europa che negli Stati Uniti.
La tendenza a convergere del tenore di vita, più forte nei primi decenni dopo la
seconda guerra mondiale, si arresta del tutto alla metà degli anni Ottanta; in seguito il
reddito pro-capite cresce essenzialmente alla stessa velocità nelle due aree (Grafico 3.1).
La produttività aggregata del lavoro, invece, continua ad avvicinarsi a quella statunitense
fino alla metà degli anni Novanta, per poi perdere terreno.
Tabella 3.1 – Reddito e produttività del lavoro nel 2012 (USA=100)
pil pro-capite
pil per ora lavorata
UE-27
67
71
Area euro
72
81
Francia
73
93
Germania
82
90
Portogallo
45
42
UE-12 (nuovi Stati membri)
38
36
Slovenia
59
59
Romania
22
22
Regno Unito
79
80
Giappone
76
70
Cina
21
n.d.
India
9
n.d.
Brasile
21
17
Fonte: The Conference Board 2013.
113
Grafico 3.1 – PIL pro-capite e per ora lavorata dell’UE-15 rispetto agli USA
110
100
PIL per ora lavorata
Percento
90
80
70
PIL pro - capite
60
50
40
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000 2005
2010
Fonte: Gordon (2012).
Come già si è notato, il differente andamento delle due grandezze riflette l’andamento dei tassi di utilizzo del lavoro – le ore lavorate per occupato moltiplicate per
l’occupazione pro-capite – che in Europa continuano a cadere, rispetto agli Stati
Uniti, fino alla metà degli anni Novanta, poi recuperano, a seguito di riforme del
mercato del lavoro che hanno aumentato la flessibilità in entrata (Tabella 3.2). Tra il
1960 e il 2011 il calo relativo delle ore pro-capite è considerevole, del 32%. Vi contribuisce in misura più accentuata (circa i due terzi) il calo relativo delle ore lavorate
per occupato (21%), mentre l’occupazione pro-capite cala del 15%. L’andamento della prima componente è leggibile come l’effetto della maggior domanda di “benessere”, soddisfatta anche grazie alla pressione dei sindacati; quello della seconda riflette
l’aumento “involontario” della disoccupazione, legato al maggior costo del lavoro e
alla rigidità crescente d’impiego del lavoro.
Confrontando l’andamento della crescita della produttività aggregata del lavoro in
Europa (UE-15) e negli Stati Uniti, sempre dai primi anni Sessanta, si vede che, in
entrambe le aree il passo della produttività tende a decelerare fino alla fine degli anni
Settanta, fornendo una rappresentazione grafica dell’operare della legge dei rendimenti
decrescenti. In seguito, gli Stati Uniti mostrano un rimbalzo, in due ondate: la prima
all’inizio degli anni Ottanta, a seguito delle politiche di liberalizzazione avviate da Carter
e proseguite da Reagan; la seconda in concomitanza con l’esplosione degli investimenti
in tecnologie dell’informazione e comunicazione negli anni Novanta. In Europa (par-
114
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
ticolarmente in quella continentale), invece, la crescita della produttività continua a
rallentare senza interruzioni; dalla metà degli anni Novanta, il tasso di crescita scende al
di sotto di quello americano (Grafico 3.2).
Tabella 3.2 – Livelli e tassi di crescita del Pil e dell’utilizzo di lavoro
(UE-15 in rapporto agli USA)
pil
pil
pro-capite per ora lavorata
ore
pro-capite
ore per
occupato
occupazione
pro-capite
Livelli
1960
60,1
48,6
126,0
109,8
114,8
1973
68,2
69,0
102,3
101,4
100,8
1995
70,4
91,7
77,3
89,6
86,3
2007
71,5
86,3
82,2
88,0
93,4
2011
70,4
82,6
85,5
87,2
98,0
1960-1973
1,0
2,7
-1,6
-0,6
-1,0
1973-1995
0,1
1,3
-1,3
-0,6
-0,7
1995-2007
0,1
-0,5
0,5
-0,1
0,7
2007-2011
-0,4
-1,1
1,0
-0,2
1,2
Tassi di crescita medi annui
Fonte: Gordon (2012).
Grafico 3.2 – Tasso di crescita annuale della produttività in UE-15 e in USA
(Output per ora lavorata, variazione %)
6
5
UE-15
percento
4
3
Stati Uniti
2
1
0
1961
1966
Fonte: Gordon (2012).
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
115
Ci sono due ulteriori caratteristiche da sottolineare, nel differente andamento della produttività in Europa e negli Stati Uniti, che riguardano la relazione tra produttività oraria
del lavoro e l’input di lavoro pro-capite e il ruolo della produttività totale dei fattori.
Occorre partire dalla relazione tra l’andamento della produttività del lavoro e la variazione del rapporto capitale/lavoro (sempre relativamente agli Stati Uniti): in Europa, l’andamento della produttività è spiegato quasi esclusivamente dalla variazione del rapporto
tra capitale e lavoro, mentre negli Stati Uniti le due curve divergono in misura significativa, riflettendo la presenza di variazioni importanti della produttività totale dei fattori
(Grafico 3.3). Dunque, in Europa la produttività aumentava perché cresceva l’intensità
di capitale per risparmiare sul costo del lavoro, in forte aumento per alte tasse, rigidità
della regolazione e potere sindacale; negli Stati Uniti l’aumento della produttività totale
dei fattori dominava. Ma l’aumento dell’intensità di capitale produce guadagni solo
temporanei della produttività (muovendo l’economia lungo un isoquanto della funzione
di produzione per tecnologia costante), mentre quello della produttività totale dei fattori
determina un “salto” verso l’alto della funzione di produzione, innalzando permanentemente il reddito per ora lavorata.
Grafico 3.3 – Produttività del lavoro e rapporto capitale-lavoro nell’UE-15 e negli USA
(Variazioni %)
UE-15
USA
6,0
3,0
5,o
2,5
4,0
2,0
Sostituzione capitale-lavoro
3,0
1,5
2,0
2,0
Produttività del lavoro
1,0
0,0
1965
1975
1985
1995
Produttività del lavoro
0,5
2005
0,0
Sostituzione capitale-lavoro
1965
1975
1985
1995
2005
Fonte: Denis et al. (2005).
Nel caso europeo, l’aumento dell’input di lavoro (pro-capite) corrisponde tendenzialmente al calo speculare della produttività: in pratica, trovano occupazione lavoratori
marginali con costo e produttività più bassi, grazie all’allentamento delle regole di assunzione (Grafico 3.4). Infatti, come già abbiamo constatato, l’aumento relativo dell’occupazione dopo la metà degli anni Novanta, rispetto agli Stati Uniti, non modifica
l’andamento relativo del PIL pro-capite, proprio perché correlativamente diminuisce la
produttività. In mancanza di guadagni (relativi) della produttività totale dei fattori, il
116
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
livello relativo del PIL pro-capite continua a declinare: poiché le nuove tecnologie sono
facilmente appropriabili, l’incapacità dell’Europa di chiudere il divario di reddito non
può che riflettere i vincoli sociali e organizzativi – quello che Abramovitz (1986) chiamava la social capability – che nel continente europeo impediscono il pieno sfruttamento
delle nuove tecnologie.
Grafico 3.4 – Scomposizione della crescita del PIL, UE-15 rispetto a USA
(USA=100)
Input di lavoro pro-capite
Produttività di lavoro per ora lavorata
PIL pro-capite
Fonte: Denis et al. (2005).
In effetti, come evidenziato in precedenza (Grafico 3.2), a partire dal 1995 il tasso di
crescita della produttività in Europa diminuisce significativamente mentre quello degli
Stati Uniti rialza la testa, almeno fino al 2002. Questa fase di ripresa della produttività
negli Stati Uniti viene attribuita (Jorgenson et al., 2008; Oliner et al., 2007) all’esplosione degli investimenti in ICT (Information and Communication Technologies).
Perché l’Europa non è riuscita a imitare la ripresa della produttività realizzata dagli
Stati Uniti? Secondo Timmer et al. (2010) il problema non è stato tanto la mancanza di
innovazione in ICT in Europa, quanto piuttosto l’utilizzo (scarso) di infrastrutture ICT.
Gli autori individuano in particolare nella bassa produttività nel settore dei servizi destinabili alla vendita il cuore del divario di produttività tra Europa e Stati Uniti. Non ha
aiutato nemmeno la scarsa flessibilità – tranne rare eccezioni – della struttura industriale
che ha rallentato la transizione da sistema produttivo ad alta intensità di capitale, ma
povero di tecnologie ICT, a un sistema produttivo ICT intensive.
Nel periodo successivo alla crisi finanziaria, sia gli Stati Uniti sia l’Europa hanno
registrato una significativa caduta dell’output, ma l’andamento della produttività è stato
diverso nelle due aree. Negli Stati Uniti si è avuta una caduta dell’occupazione repentina
e drammatica, che ha sostenuto la produttività. In Europa, molti paesi hanno privilegiato lo sforzo di mantenere l’occupazione – anche attraverso strumenti di solidarietà
117
tra i lavoratori – inevitabilmente sacrificando la produttività. Se il calo dell’attività verrà
recuperato, ci si può attendere un rimbalzo della produttività; se il calo di attività si rivelerà almeno in parte permanente, sono da attendersi ulteriori cali dell’occupazione in
Europa anche nella fase di ripresa dell’economia.
I diversi andamenti della produttività potrebbero essere però una buona notizia per
l’Europa: esistono in generale dei margini di incremento di produttività da sfruttare
attraverso l’applicazione di tecnologie disponibili – ad esempio, con l’applicazione di
ICT alla distribuzione commerciale – mentre non è sicuro che gli aumenti di produttività dovuti all’ICT continueranno negli Stati Uniti ai ritmi dei due decenni passati. Ad
esempio, Gordon (2012) ritiene che la crescita della produttività post-1995 sia un evento
unico e difficilmente ripetibile, il cui effetto si è ormai esaurito.
Gordon ritiene, più in generale, che nuove innovazioni regime changing, capaci di
sostenere durevoli incrementi di benessere come era avvenuto con le grandi innovazioni
di fine Ottocento (sistemi di fognatura, elettricità, vapore, ecc.), non sono probabili.
Egli individua, inoltre, diversi “venti contrari” che nel medio termine influiranno negativamente sull’andamento della produttività in tutto il mondo avanzato: in particolare,
le dinamiche demografiche, la performance inadeguata dei sistemi scolastici e universitari, la disuguaglianza crescente dei redditi, i vincoli ambientali, e il grande accumulo di
debito pubblico e privato degli ultimi anni1.
3.3
Gli andamenti disaggregati della produttività
Fin qui abbiamo ragionato in termini aggregati, ma la dimensione settoriale ha un rilievo molto importante nell’analisi sulla produttività. Queste analisi sono ora facilitate
grazie alla costruzione del database Klems2 che misura a livello settoriale l’output e la
produttività di 25 paesi europei, del Giappone e degli Stati Uniti dal 1970 al 2007.
I principali risultati sono riassunti nella tabella 3.3, tratta da Timmer et al. (2010). Nella
parte superiore si confrontano le quote sul valore aggiunto dei diversi settori: l’Europa mantiene un peso maggiore del settore manifatturiero – circa quattro punti percentuali di valore
aggiunto più degli Stati Uniti – ma comunque in diminuzione in misura comparabile tra le
due aree. Invece, in Europa il peso della distribuzione commerciale e della finanza è inferiore
rispetto a quello degli Stati Uniti. Lo studio sottolinea che i servizi, in particolare quelli destinati alla vendita, sono il settore chiave per accelerare la crescita della produttività in Europa,
anche perché è probabile che la loro quota del valore aggiunto, che costituisce ben oltre il
70% delle economie3, continui ad aumentare. Ma la Commissione europea non è d’accordo:
i suoi nuovi orientamenti di politica industriale prevedono di fermare e invertire il calo della
quota del manifatturiero (Commissione europea, 2010).
Quel che sappiamo, intanto, è che nell’esperienza americana dietro i rimbalzi di
produttività che abbiamo descritto c’è la performance dei servizi – che in Europa restano
ancora largamente segmentati su base nazionale e chiusi alla concorrenza. Infatti, mentre
nella produzione di ICT la produttività è aumentata significativamente in entrambe
le aree, è nei servizi (distribuzione, servizi finanziari e alle imprese) che gli Stati Uniti
hanno realizzato la parte più significativa dei loro miglioramenti della produttività tra
118
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
il 1980-95 e il 1995-2005. Come si può vedere, il balzo nella produttività è rilevante nel
settore manifatturiero; ma lo è ancora di più nella distribuzione, dove il tasso medio
annuo d’incremento raggiunge il 4% nel 1995-2005.
Tale risultato riflette mutamenti organizzativi e nella struttura della distribuzione
resi possibili dalle nuove tecnologie ICT, ma anche una disponibilità molto maggiore
della società ad accogliere tali cambiamenti – sia nei modelli di lavoro sia nei modelli
di consumo. Si tratta del nuovo modello big box, ossia grandi centri commerciali,
localizzati prevalentemente fuori dai centri urbani o in periferia, che offrono amplissime quantità di prodotti a prezzi concorrenziali e con un forte utilizzo di sistemi di
self-service. I big box hanno una dimensione tale da giustificare importanti investimenti innovativi nel settore e consentono di realizzare le economie di scala necessarie
a realizzarli.
In Europa questo tipo di struttura commerciale stenta a trovare la stessa ampia diffusione raggiunta negli USA, non solo a causa di differenze nella densità di popolazione
nei territori, ma anche perché prevalgono ancora importanti impedimenti che includono sia le restrizioni sull’utilizzo del territorio (i comuni negano le licenze per proteggere
i piccoli negozi sia le regole del lavoro, incompatibili con il tipo di flessibilità utilizzato
negli Stati Uniti dalla grande distribuzione.
Tabella 3.3 – Contributo dei settori alla produttività del lavoro, UE e USA
UE
1980-95
USA
1995-2005
1980-95
1995-2005
Quota media nel valore aggiunto (%)
ICT produzione
6,7
6,6
8,9
8,1
Manifatturiero
27,8
24,3
24,6
20,0
Altri beni
19,1
16,0
15,3
14,1
Distribuzione
21,5
21,5
23,2
22,1
Finanza & Imprese
17,4
22,8
20,3
26,9
Personali
Totale economia
7,5
8,8
7,7
8,9
100,0
100,0
100,0
100,0
Crescita della produttività del lavoro (variazione media annua)
ICT produzione
4,9
6,5
5,9
10,0
Manifatturiero
3,2
2,0
2,1
2,9
Altri beni
3,5
1,6
1,8
-0,4
Distribuzione
2,5
1,7
2,7
4,0
Finanza & Imprese
0,3
0,3
0,3
2,6
Personali
0,5
0,4
1,1
1,2
Totale economia
2,5
0,5
1,9
2,9
Fonte: Timmer et al. (2010).
119
L’evoluzione aggregata della produttività in Europa sottende importanti differenze
tra i singoli paesi. I dati possono essere ricondotti a quattro grandi “famiglie” di paesi
europei4 relativamente omogenei, e inoltre all’Italia (Grafico 3.5).
Come si può vedere, negli ultimi venti anni sono stati i paesi anglosassoni a registrare la performance migliore in termini di aumento della produttività, principalmente
grazie alla spinta degli investimenti diretti esteri (particolarmente in Irlanda). Seguono
i paesi nordici, che hanno attuato riforme radicali dei sistemi di welfare, prima troppo
generosi, e consistenti riduzioni della spesa pubblica; poi i paesi centrali dell’Europa
continentale; e infine i paesi mediterranei.
Il fanalino di coda è l’Italia. In effetti, fino alla metà degli anni Novanta, in Italia vi fu una crescita del prodotto per ora lavorata non dissimile da quello dei paesi
continentali, che rifletteva intensi processi di sostituzione di capitale a lavoro – chiaramente legati al rapido aumento del costo e delle rigidità del lavoro. Le riforme del
mercato del lavoro della fine degli anni Novanta e dei primi anni 2000 hanno contribuito ad aumentare l’occupazione, ma a spese della produttività. La convergenza
rispetto ai paesi dell’Europa continentale si è del tutto arrestata sul finire degli anni
Novanta e poi abbiamo incominciato a scivolare all’indietro, in termini relativi e poi
anche assoluti.
Grafico 3.5 – Produttività del lavoro
(PIL per ora lavorata, 1990=100)
180
Paesi continentali
Paesi nordici
Paesi meridionali
170
160
Paesi anglosassoni
Italia
150
140
130
120
Fonte: The Conference Board Total Economy Database e OCSE. Stime per il 2012.
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1992
1991
100
1990
110
120
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Si può ulteriormente dettagliare il confronto, a livello settoriale e con il più alto
livello di disaggregazione consentito dal database Klems, la performance delle stesse
quattro famiglie di paesi europei e quella italiana (Grafico 3.6). La performance
dei paesi anglosassoni è impressionante: non solo si registrano aumenti del tasso di
crescita della produttività del lavoro tra il 1980-1995 e 1995-2007 in più della metà
dei settori considerati, ma nella stampa ed editoria, nelle componenti elettroniche e
nelle poste e telecomunicazioni il tasso di crescita supera l’8%. Inoltre, in entrambi
i periodi, la crescita della produttività risulta superiore rispetto agli altri gruppi di
paesi nella maggior parte dei casi.
Il tasso di crescita della produttività nei paesi nordici riflette la loro specializzazione industriale, con un notevole aumento di produttività tra il 1995-2007 nel
settore delle componenti elettroniche e delle poste e telecomunicazioni, raggiungendo, rispettivamente, quasi il 17% e l’8%; inoltre nel settore dei servizi si osserva
un significativo aumento anche nel commercio di autoveicoli. I paesi continentali
mostrano un miglioramento nella crescita della produttività del lavoro tra il 19952007 rispetto al periodo precedente in quasi la metà dei settori considerati, con un
andamento migliore per il settore manifatturiero rispetto a quello dei servizi (fatta
eccezione del settore delle poste e telecomunicazioni che registra un aumento di
circa il 7%).
In Italia solo sette settori su venticinque hanno fatto registrare tra il 1995-2007
un aumento nella crescita della produttività rispetto al periodo 1980-1995. Nei servizi, la crescita della produttività non è mai stata brillante, con l’unica eccezione del
settore delle poste e telecomunicazioni dove, tra il 1995-2007, l’Italia ha registrato in
media un tasso di crescita annuale della produttività del lavoro di oltre l’8%, quasi
3 punti percentuali in più rispetto ai paesi meridionali e leggermente superiore a
quello registrato nei paesi continentali. L’analisi settoriale mostra che il commercio
all’ingrosso e al dettaglio non hanno avuto un buon andamento nel primo periodo
esaminato (1980-1995) e sono addirittura peggiorati nel secondo (1995-2007). Nonostante sia leggermente migliorata rispetto al periodo 1980-1995, la dinamica della
produttività in servizi alle imprese, hotel e ristoranti, servizi personali e pubblici
rimane in generale molto bassa.
Il cattivo andamento della produttività in Italia colpisce non solo se si effettua
un confronto con i best-performer ma anche rispetto ai paesi del Sud Europa dove,
tra il 1995 e il 2007, vi è stato un aumento di produttività comune a molti settori
(macchinari, commercio di autoveicoli, componenti di trasporto ed elettroniche,
commercio all’ingrosso e al dettaglio, ecc.). In particolare, è stato notevole l’aumento della crescita della produttività nel settore dei servizi finanziari, superando il 5%
su base annua.
121
Grafico 3.6 – Crescita della produttività del lavoro nelle quattro famiglie di Paesi e in Italia
(Variazione media annua, %)
Paesi anglosassoni
1980-1995
1995-2007
AGRICOLTUR
L RA & ALLEVAMEN
V
TO
ESTRAZIONE DI MINERALI
ALIMENTARI
T
& BEVANDE
V
TESSILI & ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI IN LEGNO
RTA, STAM
T PA
PA E RIPRODUZIONE
CART
CHIMICI
GOMMA
A & MA
ATERIE PLASTICHE
MINERALI NON METALLIFERI
T
MACCHINARI & ATTREZZ
A
A
ATURE
ATTREZZA
A
ATURE ELETTRONICHE
A
ATTREZZ
ATURE PER TRASPORTI
A
R
ALTRE
L
IND. MANIFA
FATTURIERE
"FORNITURA
RA ENERGIA EL., GAS e ACQUA
COMMERCIO AUTO e MOTO VEICOLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO
COMMERCIO AL
L DETTAGLIO
T
"SERVIZI
R
DI ALLOGGIO & RISTORAZIONE
TRASPORTI
R
POSTE & TELECOMUNICAZIONI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
SERVIZI
R
ALLE IMPRESE
SERVIZI
R
SOCIALI E PERSONALI
-5
0
5
10
15
Paesi nordici
1980-1995
1995-2007
AGRICOLTURA & ALLEVAMENTO
ESTRAZIONE DI MINERALI
ALIMENTARI & BEVANDE
TESSILI & ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI IN LEGNO
CARTA, STAMPA E RIPRODUZIONE
CHIMICI
GOMMA & MATERIE PLASTICHE
MINERALI NON METALLIFERI
MACCHINARI & ATTREZZATURE
ATTREZZATURE ELETTRONICHE
ATTREZZATURE PER TRASPORTI
ALTRE IND. MANIFATTURIERE
"FORNITURA ENERGIA EL., GAS e ACQUA
COMMERCIO AUTO e MOTO VEICOLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
"SERVIZI DI ALLOGGIO & RISTORAZIONE
TRASPORTI
POSTE & TELECOMUNICAZIONI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
SERVIZI ALLE IMPRESE
SERVIZI SOCIALI E PERSONALI
-5
0
5
10
15
122
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Paesi continentali
1980-1995
1995-2007
AGRICOLTURA & ALLEVAMENTO
ESTRAZIONE DI MINERALI
ALIMENTARI & BEVANDE
TESSILI & ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI IN LEGNO
CARTA, STAMPA E RIPRODUZIONE
CHIMICI
GOMMA & MATERIE PLASTICHE
MINERALI NON METALLIFERI
MACCHINARI & ATTREZZATURE
ATTREZZATURE ELETTRONICHE
ATTREZZATURE PER TRASPORTI
ALTRE IND. MANIFATTURIERE
"FORNITURA ENERGIA EL., GAS e ACQUA
COMMERCIO AUTO e MOTO VEICOLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
"SERVIZI DI ALLOGGIO & RISTORAZIONE
TRASPORTI
POSTE & TELECOMUNICAZIONI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
SERVIZI ALLE IMPRESE
SERVIZI SOCIALI E PERSONALI
Paesi meridionali
1980-1995
1995-2007
AGRICOLTURA & ALLEVAMENTO
ESTRAZIONE DI MINERALI
ALIMENTARI & BEVANDE
TESSILI & ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI IN LEGNO
CARTA, STAMPA E RIPRODUZIONE
CHIMICI
GOMMA & MATERIE PLASTICHE
MINERALI NON METALLIFERI
MACCHINARI & ATTREZZATURE
ATTREZZATURE ELETTRONICHE
ATTREZZATURE PER TRASPORTI
ALTRE IND. MANIFATTURIERE
"FORNITURA ENERGIA EL., GAS e ACQUA
COMMERCIO AUTO e MOTO VEICOLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
"SERVIZI DI ALLOGGIO & RISTORAZIONE
TRASPORTI
POSTE & TELECOMUNICAZIONI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
SERVIZI ALLE IMPRESE
SERVIZI SOCIALI E PERSONALI
-5
0
5
10
15
123
Italia
1980-1995
1995-2007
AGRICOLTURA & ALLEVAMENTO
ESTRAZIONE DI MINERALI
ALIMENTARI & BEVANDE
TESSILI & ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI IN LEGNO
CARTA, STAMPA E RIPRODUZIONE
CHIMICI
GOMMA & MATERIE PLASTICHE
MINERALI NON METALLIFERI
MACCHINARI & ATTREZZATURE
ATTREZZATURE ELETTRONICHE
ATTREZZATURE PER TRASPORTI
ALTRE IND. MANIFATTURIERE
"FORNITURA ENERGIA EL., GAS e ACQUA
COMMERCIO AUTO e MOTO VEICOLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
"SERVIZI DI ALLOGGIO & RISTORAZIONE
TRASPORTI
POSTE & TELECOMUNICAZIONI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
SERVIZI ALLE IMPRESE
SERVIZI SOCIALI E PERSONALI
-5
0
5
10
15
Fonte: EU KLEMS Database.
Le stime della produttività totale dei fattori confermano l’andamento insoddisfacente
già segnalato dai dati aggregati tra la metà del 1995 e il 2007 (Tabella 3.4). L’incremento
totale è positivo nelle tre famiglie dei paesi anglosassoni, continentali e nordici, ma modesto (tra 0,5% e 0,7%). I paesi nordici mostrano gli incrementi più significativi nella
produzione di beni ICT (8,3%); discreta è anche, in questi beni, la performance dei paesi
anglosassoni e continentali (circa il 4%). Tutti i gruppi di paesi registrano decrementi,
seppur lievi, della produttività totale nei servizi. Variazioni positive si registrano nella
distribuzione in tutte e tre le famiglie sopra citate, mentre l’Italia e la Spagna arretrano
anche qui. Solo nei paesi anglosassoni e in Spagna si registra un contributo positivo alla
produttività totale dei servizi finanziari e alle imprese – di cui però il significato è reso
dubbio dalla successiva crisi finanziaria. Quanto all’Italia, solo in due settori la crescita
della produttività totale dei fattori è positiva (ICT e servizi non destinati alla vendita),
risultando negativa anche nel manifatturiero.
124
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Tabella 3.4 – Produttività totale dei fattori (TFP)
(Variazioni % medie annue, 1995-2007)
paesi
anglosassoni
paesi
continentali*
paesi
nordici
spagna
italia
Totale
0,5
0,5
0,7
-0,7
ICT produzione
4,3
4,0
8,3
-0,6
2,4
Beni
0,5
1,6
0,8
-0,6
-0,5
Manifatturiero
-0,3
1,0
2,1
1,3
-0,4
-0,4
Altri beni
-0,2
0,9
0,1
-0,6
-0,5
Servizi
-0,3
-0,2
-0,2
-0,7
-0,3
Servizi di mercato
1,0
0,0
0,4
-0,8
-0,7
Distribuzione
0,5
0,9
1,4
-1,1
-0,8
Finanza & imprese
1,9
-0,7
-0,3
0,9
-0,1
Personali
-0,6
-0,4
-1,4
-2,3
-1,6
Servizi non di mercato
-1,6
-0,4
-0,8
-0,6
0,1
* I paesi continentali non includono in questo caso il Lussemburgo poiché i dati sulla TFP non sono disponibili. Anche
il dato 2007 per il Belgio non è disponibile.
Non è stato possibile mostrare l’aggregato dei paesi meridionali poiché i dati sulla TFP non sono disponibili per la
Grecia e il Portogallo.
Fonte: elaborazioni su EU KLEMS Database, novembre 2009.
3.4
Migliorare la performance del mercato del lavoro
Contrariamente a opinioni diffuse, la struttura e le regole del mercato del lavoro sono
centrali per l’andamento della produttività. Come già ricordato, tra il 2008 e il 2011
in Europa l’occupazione è diminuita meno che negli Stati Uniti, 1,7% contro 5,8%5,
comportando un certo accumulo di lavoro in eccesso presso le imprese, che deve essere
riassorbito. La caduta dell’occupazione è stata più pronunciata nei paesi dove lo stato del
bilancio pubblico ha imposto un consolidamento dei conti più severo.
I tassi di disoccupazione stanno aumentando: quello dell’Unione europea è salito al
10,6%, quello dell’Area euro all’11,6, il livello più alto dalla nascita dell’euro. I disoccupati di lungo periodo hanno raggiunto un picco nel secondo trimestre del 2012: oltre 11
milioni di persone erano disoccupate da più di 12 mesi, con un aumento di quasi cinque
milioni rispetto al 2008; il 20% di questi disoccupati di lungo periodo sono spagnoli.
L’aumento dei disoccupati di lungo periodo si è concentrato soprattutto su giovani e
lavoratori low skill. Un giovane su cinque è disoccupato, in particolare i giovani che
hanno lasciato precocemente gli studi hanno prospettive molto basse di trovare lavoro.
Il numero di giovani che sono disoccupati e che non studiano e non stanno imparando
un mestiere continua ad aumentare in molti paesi europei.
Non meno preoccupante è il fatto che in Europa la segmentazione del mercato del
lavoro sta crescendo. Dal 2007 al 2011 la quota di occupati che, non per volontà propria, hanno un lavoro con contratto a termine o part-time è aumentata in 21 su 27 Stati
125
(Grafico 3.7 scala di sinistra). Questo dato cela rilevanti differenze: i paesi più duramente
colpiti dalla crisi economica sono quelli che registrano un maggiore incremento dei
contratti a termine o part-time (Irlanda, Spagna, Grecia, Italia), dove già si partiva da
un’accentuata segmentazione del mercato del lavoro, particolarmente nei paesi mediterranei. Invece, in Germania, Austria e Polonia (che però partiva da livelli iniziali piuttosto
elevati), la quota dei contratti a termine o part-time si è ridotta.
Ad essere occupati con lavori temporanei sono principalmente i giovani. Di questi,
in Europa, nel 2011 il 42,5% aveva un lavoro a tempo determinato, contro il 14% della
popolazione totale in età lavorativa (15-64 anni). Se in parte è fisiologico che i giovani
entrino sul mercato del lavoro con queste tipologie contrattuali, si evidenziano differenze rilevanti nei tassi di trasformazione di questi contratti in contratti permanenti
(Grafico 3.7 scala destra). Se nel Regno Unito la percentuale dei contratti temporanei
che vengono trasformati in contratti permanenti supera il 70% e in Germania il 40%, in
Italia questa percentuale supera di poco il 20% ed è ancora più bassa in Grecia e Spagna.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
% di transizione da occupazione a termine
a tempo indeterminato
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
ES
PT
PL
IT
CY
SE
FI
FR
EL
EU-27
SI
IE
BE
DK
LV
HU
NL
CZ
DE
UK
SK
MT
LT
LU
BG
AT
EE
RO
% di contratti a termine o part-time involontari
Grafico 3.7 – Quota di lavoratori che involontariamente hanno contratti a termine o part-time e % di
transizione da lavori temporanei a lavori a tempo indeterminato
Variazione della quota di lavoratori con contratti a termine o part-time involontari, 2007/2011
Quota di lavoratori con contratti a termine o part-time involontari, 2007
Transizione da lavori temporanei a tempo indeterminato, 2010
Fonte: Commissione europea (2012b).
Un altro elemento negativo riguarda la discrasia crescente tra posti disponibili e offerta
di lavoratori per coprirli. La curva di Beveridge – la relazione tra il tasso di disoccupazione e i posti vacanti – mostra che tra il 2008 e il 2012 in Europa i posti vacanti sono cresciuti mentre la disoccupazione aumentava. Se una parte di questo fenomeno è spiegato
dal crollo dell’occupazione in alcuni specifici settori (ad esempio l’edilizia in Spagna) che
richiede una sostanziale riqualificazione dei lavoratori, è anche il sintomo di un aumento
del mis-matching tra la domanda e l’offerta di lavoro: le qualifiche professionali richieste
dalle imprese non sono disponibili tra i lavoratori in cerca di occupazione (Grafico 3.8).
126
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Grafico 3.8 La curva di Beveridge in UE-27, dal 2008 al 2012
12
10
08Q1
% di posti vacanti
8
11Q3
6
11Q4
11Q1
12Q3
12Q1
4
09Q1
2
0
12Q2
10Q1
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
Tasso di disoccupazione (%)
Fonte: Commissione europea (2012b).
A partire dal 2009 sono emersi anche segnali di indebolimento della capacità di protezione dei sistemi di welfare nelle fasi avverse del ciclo, per effetto dei programmi di
riequilibrio dei conti pubblici. Non vi è solo, però, una questione di quantità di spesa
pubblica: vi sono anche grandi differenze, tra i paesi europei, nella qualità e nell’efficacia della spesa per la protezione sociale. Analisi di clustering svolte dalla Commissione
europea6 sull’efficacia dei sistemi di protezione sociale nel ridurre la povertà mostrano
che molti paesi dell’Est Europa (Polonia, Romania, Lettonia e Bulgaria) spendono poco
per queste politiche e hanno pochi risultati, mentre i paesi mediterranei (Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) spendono di più, ma non hanno risultati molto migliori. I paesi
nordici, d’atro canto, spendono molto e ottengono risultati significativi in termini di
contrasto della povertà.
In molti paesi europei, il quadro appena descritto evoca la necessità di azioni più
incisive di riforma: è evidente che, pur se continua a pesare la difficile situazione congiunturale, alcuni problemi sono specifici o più accentuati in alcuni paesi con particolari
caratteristiche istituzionali del mercato del lavoro che ne limitano la capacità di reagire
a shock esterni. Esistono anche, in Europa, storie di successo che potrebbero utilmente
essere imitate (si veda il riquadro Riforme strutturali di successo in Europa: i Paesi Bassi, la
Svezia e la Germania) nel rafforzare la crescita e migliorarne il contenuto occupazionale, ridurre la segmentazione del mercato del lavoro e migliorare i sistemi di protezione
sociale.
127
Riforme strutturali di successo in Europa: i Paesi Bassi, la Svezia e la Germania
I Paesi Bassi negli anni Ottanta e la Svezia negli anni Novanta sono esempi importanti
di come riforme strutturali possono modificare il sentiero di crescita di una economia.
Prima delle riforme entrambi i paesi avevano sperimentato lunghi periodi di bassa crescita
economica. Quando la cattiva performance è per di più stata esacerbata da un forte shock
recessivo (Paesi Bassi 1980-82) e dalla crisi del sistema bancario (Svezia 1990–92), le politiche economiche hanno cambiato passo e, in un decennio, sono state realizzate importanti
politiche macro e riforme strutturali dal lato dell’offerta. La spesa pubblica in rapporto al
PIL è stata ridotta in maniera significativa, consentendo una riduzione sia della elevata
pressione fiscale sia del deficit pubblico, il mercato del lavoro è stato reso più flessibile
migliorando gli incentivi alla partecipazione e contemporaneamente sono state attuate
riforme pro-concorrenziali sul mercato dei beni. La Svezia ha quindi goduto di due decenni di crescita sostenuta, i Paesi Bassi hanno registrato forti miglioramenti del mercato del
lavoro. Quali sono le lezioni che si possono trarre da queste esperienze?
Primo, ciò che deve essere riformato è tipicamente qualcosa di specifico di quel paese. Nei
Paesi Bassi le riforme si sono concentrate sull’aumento dei tassi di occupazione, che prima
degli interventi, erano particolarmente bassi (per effetto di incrementi salariali troppo
rapidi); in Svezia le riforme si sono indirizzate soprattutto al recupero della produttività
che aveva raggiunto livelli molto bassi (a causa di un sistema produttivo obsoleto e di
eccesso di regolazione). In Svezia per far ripartire l’economia sono state utilizzate anche
significative svalutazioni del tasso di cambio effettivo reale, che nel contesto attuale della
moneta unica non sono più accessibili. Le riforme poste in essere nei due paesi hanno degli
elementi in comune: entrambe hanno ridotto il ruolo del settore pubblico nell’economia,
aumentato le concorrenza e modificato fortemente la struttura degli incentivi.
Secondo, le riforme devono subire degli adattamenti nel tempo. Nei Paesi Bassi inizialmente il problema era la bassa occupazione, intesa soprattutto da parte della domanda
ossia delle imprese, per cui i primi interventi riformatori furono indirizzati a ridurre il
costo del lavoro. Quando il tasso di occupazione ha cominciato ad aumentare le riforme si
sono ri-orientate a sostenere l’offerta di lavoro.
Terzo, gli effetti a regime delle riforme si realizzano solo nel medio periodo. Nei Paesi
Bassi, il tasso di occupazione è aumentato dal 53% degli anni Ottanta al 67% nel 2011. In
Svezia, la crescita annuale della produttività è aumentata dall’1% del periodo 1977–92 al
2,5% nel 1992–2007. Alcuni studi empirici hanno valutato che le riforme poste in essere
in Svezia hanno portato in dieci anni a un aumento di 5,5 punti percentuali dell’efficienza,
misurata rispetto alla cosiddetta global best-practice frontier, il miglioramento in termini di
aumento della produttività reale per occupato è stato di circa il 15%.
Un altro importante esempio, più recente, di riforme attuate con successo è quello del
mercato del lavoro in Germania. Verso la fine degli anni Novanta, la Germania veniva
considerata come “il grande malato” dell’Europa, la crescita era bassa, era elevata la disoccupazione strutturale così come era diffusa la percezione che fosse necessario riformare il
sistema di protezione sociale. All’inizio degli anni Duemila la Germania intraprese dunque
un piano di riforme strutturali (Agenda 2010) che includeva azioni sostanziali sul mercato
del lavoro (Hartz).
128
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Gli interventi erano finalizzati principalmente a: introdurre maggiore flessibilità nel mercato del lavoro creando agenzie per il lavoro temporaneo e riformando il quadro normativo in modo da favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali; aumentare l’efficacia delle agenzie del lavoro ristrutturando e ridefinendo il sistema delle politiche attive
per il lavoro; aumentare gli incentivi a lavorare riducendo, tra l’altro, la durata dei sussidi
di disoccupazione ed eliminando alcune delle restrizioni che limitavano la flessibilità nel
rimpiego dei lavoratori. Il sistema di contrattazione salariale fu riformato nel senso di
aumentarne la decentralizzazione e di potenziare gli accordi a livello aziendale nell’ottica
di rendere più flessibile l’impiego del fattore lavoro e di collegare quanto più possibile le
dinamiche salariali con l’andamento della produttività. Il risultato è stato che dal 2003 al
2011 i salari reali in Germania sono diminuiti – anche per il maggior l’utilizzo di forme lavorative tipo part-time, mini-jobs – in presenza di significativi aumenti della produttività,
il che ha portato di fatto ad una deflazione competitiva sostenuta dalla domanda di altri
paesi. L’impatto complessivo di questo insieme di riforme in Germania non è stato immediatamente visibile, ma nel medio termine ha dispiegato effetti importanti in termini di
riduzione del tasso di disoccupazione, e più in generale, anche per la crescita economica.
Il tasso di disoccupazione si è ridotto dall’11% del 2005 al 9% nel 2007 e, secondo le più
recenti previsioni della Commissione europea7, fino al 5,5% nel 2012, attualmente uno dei
livelli più bassi d’Europa. Fonte: B. Barkbu et al (2012).
Le linee di intervento per migliorare l’efficienza del mercato del lavoro sono da
tempo note e condivise, almeno tra gli economisti e le istituzioni internazionali,
anche se è evidente che le difficoltà di attuazione variano significativamente da paese
a paese. Le descriviamo sommariamente qui di seguito, ordinandole per obiettivi
dell’intervento (ma ricordando che tale criterio di classificazione ha natura convenzionale, in quanto ogni intervento agisce contemporaneamente su diversi aspetti del
mercato del lavoro).
Un mercato del lavoro inclusivo. Occorre in primo luogo ridurre il dualismo del mercato del lavoro attraverso la riduzione dell’eccessiva protezione dei lavoratori a tempo
indeterminato, la quale scoraggia le assunzioni permanenti, in particolare di giovani
e lavoratori scarsamente qualificati8. In secondo luogo, è necessario migliorare la flessibilità in uscita e in entrata attraverso forme contrattuali adattabili a diverse esigenze
– ad esempio, per accomodare le esigenza di riconciliazione tra tempo di lavoro e altri
momenti della vita delle lavoratrici, degli studenti lavoratori o dei lavoratori anziani – e
sostenendo il rientro di quelli che hanno perso il lavoro attraverso politiche attive per il
lavoro (ALMP) che diano loro adeguata ri-formazione. L’accesso dei lavoratori a queste
politiche di riqualificazione è inversamente correlato con la disoccupazione a lungo termine (Grafico 3.9). Infine, è necessario facilitare la transizione dei giovani dal sistema
formativo al mondo del lavoro valorizzando e migliorando quanto più possibile i sistemi
di apprendistato.
129
Disoccupazione a lungo termine (%, 2011)
10
Scala di sinistra
Scala di destra
100
90
8
80
70
6
60
50
40
4
30
2
20
10
0
0
Individui che partecipano a ALMP (%, 2010)
Grafico 3.9 – Partecipazione a ALMP e tasso di disoccupazione a lungo termine
SK ES EL LT IE LI EE BG PT HU IT FR PL SL BE RO MT DE CZ UK DK FI CY NL LU SE AT
ALMP: Politiche attive per il lavoro.
Fonte: Commissione europea (2012b).
La contrattazione salariale. Un buon sistema di contrattazione salariale deve mantenere
gli aumenti salariali in linea con la produttività. Questo risultato in molti casi non è
stato garantito e si sono accumulati, all’interno dell’Area euro, enormi divari di costo
(Grafico 3.10). In Italia, in particolare, c’è stata una significativa disconnessione tra la
dinamica della produttività e quella dei salari che ha portato ad un costo del lavoro per
unità di prodotto in forte aumento dal 2000 in poi. Ciò è legato, tra l’altro, al sistema
di contrattazione salariale che è ancora molto centralizzato rispetto a molti altri paesi
europei. Ciò è legato, tra l’altro, al sistema di contrattazione che è ancora molto centralizzato rispetto a molti altri paesi europei. Ulteriori miglioramenti nei meccanismi
di remunerazione, soprattutto attraverso un ruolo maggiore della contrattazione aziendale, possono rafforzare l’allineamento tra le retribuzioni e la produttività, soprattutto
se gli aumenti salariali vengono legati direttamente a miglioramenti dell’organizzazione
produttiva a livello aziendale. L’evidenza empirica conferma l’importanza, tra i fattori
che favoriscono miglioramenti sostenibili della competitività internazionale, della contrattazione salariale di secondo livello. Secondo un recente lavoro del Fondo monetario
internazionale9, in alcuni Stati europei, i sistemi di indicizzazione e i minimi salariali in
vigore non sembrano coerenti con le realtà produttive e dovrebbero essere calibrati più
attentamente.
130
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Grafico 3.10 – Costo del lavoro per unità di prodotto
(2000=100)
150
Francia
Grecia
Italia
Area euro
140
130
Germania
Irlanda
Spagna
120
110
100
90
2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
Fonte: OCSE Economic Outlook Database.
La partecipazione al mercato del lavoro. I punti d’attacco per migliorare i tassi di
partecipazione sono molteplici. È importante che i sistemi pensionistici non incoraggino pensionamenti troppo precoci. Nei paesi del Mediterraneo, in particolare
l’Italia, il basso tasso di partecipazione è connesso in maniera importante alla bassa
partecipazione femminile. A spiegare questa debolezza non bastano i fattori culturali; spesso sono gravemente carenti i sostegni sociali necessari per consentire alle donne la combinazione degli impegni familiari, in particolare per la cura dei figli, con
quelli di lavoro. In effetti, si rileva che la spesa pubblica destinata al sostegno delle
famiglie è significativamente più bassa, in questi paesi, rispetto a quelli dell’Europa
continentale e del Nord, i quali registrano non a caso tassi di partecipazione femminile ben più elevati (Grafico 3.11). Dunque, una ricomposizione della spesa pubblica
a favore della famiglia certamente aumenterebbe la partecipazione al mercato del
lavoro.
Job matching e mobilità del lavoro. In molti paesi è necessario migliorare la corrispondenza tra profili formativi (scuola e università) e domanda di lavoro delle imprese. Le
università, in particolare, devono orientare l’offerta formativa verso i settori che promettono maggiori opportunità occupazionali nel medio termine. Si tratta, secondo la Commissione europea (2012b), dei settori della green economy, dell’ICT e delle applicazioni
131
Grafico 3.11 – Spesa pubblica a sostegno della famiglia diretta, in servizi e in misure fiscali
(In % del PIL, 2009)
Diretta
Servizi
Benefici fiscali
Grecia
Polonia
Italia
Portogallo
Spagna
Slovenia
Paesi Bassi
Slovacchia
Repubblica Ceca
Estonia
Austria
Germania
Finlandia
Belgio
Ungheria
Svezia
Danimarca
Francia
Lussemburgo
Irlanda
Media OCSE=2,6%
Regno Unito
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Fonte: OCSE Family Database 2012.
sanitarie ad elevato contenuto tecnologico. Oltre che dal mismatching tra formazione
ed esigenze delle imprese, la presenza contemporanea di elevati tassi di disoccupazione
e di posti di lavoro vacanti può essere spiegata dalla presenza di frizioni o barriere che
impediscono un’adeguata mobilità del lavoro e da asimmetrie informative tra lavoratori
e imprese. I lavoratori europei fronteggiano ancora troppe barriere legali, amministrative
e pratiche che ostacolano i movimenti tra i paesi membri: molto può esser fatto rafforzando le istituzioni comunitarie che coordinano l’attività delle agenzie per l’occupazione
dei diversi paesi. Il ruolo più importante, però, spetta agli Stati membri, i quali devono
adoperarsi per rimuovere non solo gli ostacoli (si veda infra), ma anche i disincentivi a
trasferirsi da un paese europeo all’altro (ad esempio, la portabilità delle pensioni complementari, l’assicurazione sanitaria, ecc).
I sistemi di protezione sociale. L’esperienza dei paesi del Nord Europa indica gli effetti
benefici dei sistemi di protezione sociale basati sulla protezione del reddito del lavoratore, invece che del posto di lavoro. Questa impostazione richiede una contemporanea
riforma del mercato del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nella direzione dei
modelli di flexicurity. Questi modelli comportano la combinazione di forme contrattuali più flessibili accompagnate però da transizioni più sicure ad altri lavori, strategie
integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mercato del lavoro e un sistema di protezione sociale basato sul sostegno di disoccupazione adeguato,
ma subordinato ad attività formative e decrescente nel tempo. La flexicurity è costosa
132
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
– l’1-2% del PIL in più di spesa rispetto ai sistemi vigenti – e può condurre ad abusi
del sistema; tuttavia, i benefici in termini di miglioramento dell’efficienza del mercato
del lavoro e, soprattutto, di attenuazione della disoccupazione valgono generalmente
la candela10; non mancano, inoltre, proposte tese ad attenuarne i costi e migliorarne
l’efficienza.
3.5
Il miglioramento della produttività attraverso
il completamento del mercato interno
Un contributo importante al miglioramento della produttività può venire dal completamento del mercato interno il quale «costituisce un volano fondamentale per la crescita
economica dell’Europa»11.
Nonostante notevoli progressi, soprattutto nel settore delle merci, l’obiettivo di un
mercato interno integrato non è ancora stato raggiunto. A partire dal Rapporto Monti
del 2010 e dal patto per l’euro del 201112, il mercato interno è tornato in cima alle priorità
di azione dell’Unione, in particolare con il Growth Compact deliberato dal Consiglio
europeo nel giugno 2012.
3.6
A che punto è il mercato interno?
A vent’anni dal lancio del mercato interno, le barriere fisiche lungo i confini nazionali sono state eliminate e i paesi europei hanno potuto beneficiare di un elevato
livello di integrazione in termini di commercio transfrontaliero, in particolare per
i prodotti. Le esportazioni di beni e servizi rappresentano oggi circa il 40% del PIL
dell’Unione europea, e oltre la metà avviene all’interno dell’Unione (Grafico 3.12).
La quota degli scambi di beni intra-UE ha raggiunto nel 2010 il 21% del PIL, tuttavia a partire dal 2000, tale quota è rimasta sostanzialmente invariata ed è addirittura
diminuita per i paesi dell’UE-15 (Grafico 3.12, quadrante in alto). È un risultato che
colpisce, se paragonato alla rapida crescita del commercio globale e degli scambi tra
l’Unione e il resto del mondo. Nei servizi gli scambi intra-UE mostrano andamenti
simili a quelli delle merci; ma il settore risulta decisamente meno integrato – le
esportazioni di servizi tra i paesi europei raggiungono nel 2010 solo il 5,6% del PIL
dell’Unione (Grafico 3.12 quadrante in basso) – e non vi sono segnali significativi di
un aumento.
La forte dispersione dei prezzi nei servizi indica in effetti il permanere della segmentazione dei mercati (Grafico 3.13), in particolare negli Stati membri fondatori (Commissione europea 2012c). In parte, ciò è legato alla natura dei servizi caratterizzati generalmente da una minore trasportabilità, commerciabilità e da eterogeneità; dall’altra parte,
il grado di apertura alla concorrenza in questo settore rimane insufficiente.
133
Grafico 3.12 – Esportazioni di beni e servizi
(% del PIL dell’UE-27)
Beni
Intra UE-27
UE-27 vs extra UE-27
%
24
22
Intra UE-27
%
UE-27 vs extra UE-27
6
5,5
20
18
5
16
4,5
14
12
4
10
3,5
8
6
Servizi
Intra UE-15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: OCSE (2012b).
Grafico 3.13 – Dispersione dei prezzi di beni e servizi tra gli Stati membri dell’UE
(Coefficiente di variazione*)
0,21
0,19
Servizi
0,17
0,15
0,13
Merci
0,11
0,09
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
*Deviazione standard/media (ponderata per il PIL).
Fonte: Commissione europea (2012c).
I dati sul controllo estero delle imprese forniti dalla Commissione europea – utilizzati
come proxy del grado di integrazione del mercato dei servizi – mostrano in quasi tutti gli
Stati membri un grado di apertura inferiore rispetto al resto dell’economia. I paesi più
piccoli (con l’eccezione di Cipro, Slovenia e Portogallo) risultano più aperti; tra gli Stati
membri più grandi, l’Italia risulta il paese più chiuso (Grafico 3.14).
134
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Grafico 3.14 – Imprese controllate da un soggetto di un altro Stato membro dell’UE
(In % del valore aggiunto, 2003-2009*)
35
30
25
20
15
10
5
0
HU EE CZ RO PL BG SK LU LV LT AT DK MT FI NL IE SE UE UK DE FR ES PT IT SI CY
Economia nel suo complesso**
Servizi in senso lato***
* Le differenze per alcuni paesi in determinati anni sono dovute alla disponibilità dei dati.
** Escluse intermediazione finanziaria, agricoltura e pesca.
*** Tutta l’economia escluse industria mineraria, industria manifatturiera, agricoltura e pesca.
Fonte: Commissione europea (2012c).
Quanto al mercato dei capitali, con la crisi finanziaria del 2008-09 gli investimenti transfrontalieri all’interno dell’Unione sono crollati e non si sono ancora ripresi completamente. Lo stesso andamento vale per i mercati finanziari dove l’integrazione è avanzata
a ritmi sostenuti negli ultimi venti anni grazie alla liberalizzazione dei mercati e allo
sviluppo di strumenti finanziari innovativi. Con la crisi, è aumentata la volatilità dei
mercati e in diversi paesi l’attività finanziaria transfrontaliera è crollata, determinando in
alcuni casi una forte frammentazione dei mercati (Grafico 3.15).
Anche la mobilità del lavoro nel mercato interno, nonostante l’aumento del numero
di cittadini europei che lavorano in un altro Stato, è ancora limitata rispetto al potenziale
dell’Unione e non è comparabile a quella osservata negli Stati Uniti. I lavoratori occupati in uno Stato membro diverso da quello di origine rappresentano solo il 3% della forza
lavoro europea (Grafico 3.16).
Fonte: OCSE (2012b).
2011-Q3
2011-Q1
2010-Q3
2010-Q1
2009-Q3
2009-Q1
2011-Q3
2011-Q1
2010-Q3
2010-Q1
2009-Q3
2009-Q1
2008-Q3
2008-Q1
2007-Q3
2007-Q1
2006-Q3
2006-Q1
2005-Q3
2005-Q1
2004-Q3
2004-Q1
2003-Q3
2003-Q1
2002-Q3
2002-Q1
2001-Q3
2001-Q1
Prestiti a soggetti non bancari
2008-Q3
2008-Q1
2007-Q3
2007-Q1
Depositi
2006-Q3
2006-Q1
2005-Q3
2000-Q1
2000-Q3
Titoli e azioni non bancari
2005-Q1
70
2004-Q3
2004-Q1
2003-Q3
2003-Q1
2002-Q3
2002-Q1
2001-Q3
2001-Q1
2000-Q3
2000-Q1
1999-Q1
1999-Q3
0
1999-Q3
1999-Q1
135
Grafico 3.15 – Attività finanziarie transfrontaliere
(In % dell’offerta totale di servizi finanziari dell’Area euro)
70
Attività
60
Prestiti interbancari
50
40
30
20
10
Passività
60
Depositi interbancari
50
40
30
20
10
0
136
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Grafico 3.16 – Lavoratori stranieri in % della popolazione in età lavorativa, 2010
UE-15
UE-12
Non-UE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
UE-15
UE-10
UE-25
UE-12 comprende i nuovi Stati membri, UE-10 comprende i nuovi Stati membri tranne Bulgaria e Romania.
Fonte: OCSE (2012b).
La scarsa mobilità del lavoro riflette in parte l’ostacolo creato dalle diversità linguistiche
e culturali; ma, come già ricordato, permangono anche numerosi ostacoli amministrativi che scoraggiano i cittadini dal muoversi all’interno dell’Unione, quali le numerose
formalità burocratiche e le differenze nelle normative fiscali e sui regimi pensionistici
integrativi (come ottenere indennità, detrazioni fiscali, l’applicazione della doppia imposizione o di aliquote fiscali progressive più alte ai non residenti). Pesa anche la scarsa
consapevolezza di molti lavoratori dei propri diritti e doveri quando si spostano in un
altro Stato.
Anche le difficoltà connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali riducono gli incentivi a muoversi. Il riconoscimento automatico si applica solo a 7 su circa 800
professioni. Tra il 2007 e il 2010 il numero di coloro che hanno richiesto il riconoscimento delle proprie qualifiche in un altro Stato è stato piuttosto basso, ma più del 90%
dei lavoratori che lo hanno chiesto lo hanno ottenuto.
In conclusione, nonostante i progressi compiuti per la creazione del mercato interno, molte cose rimangono ancora da fare, in particolare nei servizi. La frammentazione
del mercato interno ostacola il pieno dispiegamento del potenziale economico europeo.
Secondo l’OCSE (2012b) la maggiore integrazione dei mercati porterebbe benefici in
termini di produttività e di benessere per i consumatori. Il Department for Business
Innovation and Skills del Regno Unito (BIS 2011) ha stimato i potenziali benefici per
l’Unione europea e per gli Stati membri derivanti dalla completa rimozione delle barriere al mercato interno: tenuto conto delle limitazioni che un tale esercizio di simulazione
comporta, entro il 2020 il reddito dell’UE potrebbe aumentare del 14,1% e la produzione
del 24,4% (a prezzi costanti).
137
3.7
Quali interventi
Tra il 2011 e il 2012 la Commissione europea ha adottato il Single Market Act I e II, due
ambiziosi pacchetti di misure (24 aree d’intervento) e un calendario stringente per la
loro attuazione13. Il Single Market I include, tra le altre, la revisione della direttiva sul
riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva sui lavoratori distaccati,
per migliorare la mobilità del lavoro; la revisione del sistema di standardizzazione e
delle direttive sulle forniture pubbliche e i criteri contabili, per facilitare le transazioni
cross-border; il brevetto europeo (ora approvato) e le norme per la firma, l’autenticazione
e l’identificazione digitale, per favorire l’innovazione tecnologica; inoltre, misure per
facilitare l’accesso delle PMI innovative e delle start-up al venture capital.
Il Single Market Act II include iniziative per completare ed estendere il precedente
piano d’azione, concentrandosi in particolar modo sulla realizzazione di reti europee
energetiche e di trasporto integrate; sulla mobilità di lavoratori e imprese, attraverso lo
sviluppo di un portale per il collocamento e l’assunzione dei lavoratori; la mobilitazione
dei fondi di investimento a lungo termine per le imprese e la modernizzazione delle
procedure di insolvenza; e nuove misure per la diffusione dell’economia digitale, in particolare attraverso gli investimenti nella banda larga e il commercio elettronico.
La corretta atuazione delle direttive. Le difficoltà nella realizzazione del mercato interno
sono legate, più che ai difetti di trasposizione, alla mancata applicazione della normativa
europea da parte degli Stati membri.
In effetti, l’ultimo scoreboard della Commissione europea (2013) indica un generale
miglioramento nell’attuazione delle direttive: la quota aggregata di direttive non recepite
tempestivamente sul totale è diminuita, in media, dallo 0,9% nel maggio 2012 allo 0,6%
nel novembre 2012, il miglior risultato di sempre; solo quattro stati membri non hanno
raggiunto l’obiettivo di ridurre al di sotto dell’1% il deficit di trasposizione delle direttive. Per la prima volta in molti anni, grazie al Governo Monti, anche l’Italia è riuscita a
ridurre il suo deficit di trasposizione allo 0,8%, rispetto al 2,4% precedente.
Permangono però molte violazioni delle leggi europee, soprattutto nei settori
dell’ambiente e della fiscalità. Tali violazioni preoccupano forse più dei ritardi degli atti
di recepimento, perché rivelano un’insufficiente considerazione da parte delle amministrazioni nazionali degli obblighi della partecipazione all’Unione europea (Bruzzone e
Peirce, 2012).
Occorre inoltre aumentare gli sforzi per garantire la corretta applicazione ed esecuzione della normativa sul mercato interno da parte dei tribunali nazionali, offrendo
qualità nelle informazioni e strumenti e procedure di amministrazione on line, investendo in meccanismi di risoluzione rapida dei problemi. Solo in questo modo i cittadini e
le imprese potranno avvalersi effettivamente dei diritti del mercato interno e sfruttare
appieno le potenzialità che questo offre.
L’attuazione della direttiva europea sui servizi. La direttiva servizi14 affronta questioni cruciali per la competitività dell’economia europea; il suo carattere orizzontale e generale
consente di aggredire l’enorme varietà di restrizioni che frenano l’entrata e la concorren-
138
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
za in molti mercati dei servizi, soprattutto, ma non solo, a livello locale. La Commissione stima che la completa rimozione di tutte le restrizioni disciplinate dalla direttiva
sui servizi porterebbe a un aumento del PIL dell’Unione del 2,6% entro qualche anno15.
Purtroppo al momento, seppure recepita nella maggior parte dei paesi, la direttiva
servizi fatica ad essere correttamente attuata poiché si scontra con la complessità degli
adempimenti amministrativi e dei vincoli regolamentari imposti dalle normative nazionali, regionali e locali.
In alcuni paesi, tra cui l’Italia e la Polonia, per diversi comparti nel settore del turismo
sono state mantenute restrizioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza dei prestatori
di servizi, oggi vietate dalla direttiva. Sul fronte della libera prestazione dei servizi sembra
che nella maggior parte dei casi sia stato seguito un approccio molto conservativo, per
cui ad esempio i prestatori stranieri di servizi vengono trattati sempre come se fossero
residenti nel proprio territorio di origine, esponendoli così alla doppia regolamentazione
sia del paese d’origine sia di quello ospitante, generando grande incertezza normativa.
In alcuni Stati membri (es. Germania) permangono requisiti che impongono tariffe alle
professioni regolamentate (Commissione europea 2012c).
È vero che la regolamentazione delle professioni può essere giustificata dall’interesse
pubblico, ma in generale essa risulta tuttora troppo eterogenea per dipendere solo da
ragioni legittime di protezione: il numero delle professioni regolamentate in ciascuno
Stato membro varia da 47 a 368. Vi sono inoltre differenze significative nell’ambito delle
attività riservate16 e nel livello delle qualifiche richieste. Nel 2012 sono state rivolte a otto
stati membri (tra cui Austria, Francia, Italia, Germania e Spagna) raccomandazioni tese
a ridurre gli ostacoli normativi ai servizi professionali.
Anche la realizzazione degli sportelli unici risulta eterogenea: Danimarca, Regno
Unito e Spagna vantano i sistemi più avanzati, mentre lo strumento procede a rilento in
Bulgaria, Grecia, Irlanda e, purtroppo, anche in Italia. In particolare, vi sono ampi divari
tra il livello di dettaglio e di condivisibilità delle informazioni offerte dagli sportelli unici
sulle norme nazionali per i principali settori di servizi e molte procedure amministrative
non possono ancora essere completate on line, in particolare per gli utenti stranieri.
I servizi alle imprese risultano ancora caratterizzati da una pesante regolamentazione che impone, ad esempio, limiti alla scelta della forma societaria, generando un
ostacolo allo sviluppo di servizi professionali transfrontalieri. Per la vendita al dettaglio
in alcuni casi le imprese sono tuttora tenute a superare test di necessità economica –
sempre vietati dalla direttiva servizi (restrizione black list), che subordina l’avvio dell’attività alla densità delle autorizzazioni già concesse. Nel settore dell’edilizia il mutuo riconoscimento dei sistemi di autorizzazione o della certificazione di esperti che prestano
servizi specializzati (ad es. per la certificazione ambientale e dell’efficienza energetica)
fatica a essere accettato.
Anche negli appalti pubblici, un comparto di domanda importantissimo per il miglioramento della tecnologia, oltre che degli investimenti, che nel complesso pesa per
oltre il 15% sul PIL dell’Unione, permangono numerosi ostacoli all’integrazione: nel
2010 gli appalti assoggettati alla normativa europea ammontavano a 447 miliardi di euro
139
(3,7% del PIL dell’Unione17; di quel totale, solo il 3,5% è stato aggiudicato a imprese
straniere; nei servizi tale quota scende al 2%).
Dato il peso nell’economia degli appalti e delle forniture pubblici, è preoccupante
che le amministrazioni pubbliche continuino ad accumulare pesanti ritardi nei pagamenti. La differenza, in questo, tra gli Stati membri settentrionali (che pagano in tempo)
e quelli meridionali (che pagano in ritardo, talora enorme ritardo, come in Italia) grava
pesantemente sull’integrazione del mercato interno18. La Commissione europea stima
che, se attuata correttamente, la direttiva sui ritardi di pagamento19 potrebbe generare
flussi addizionali di liquidità per le imprese per circa 180 miliardi di euro l’anno.
La direttiva europea dei servizi prevede un ruolo proattivo dei paesi membri nell’identificare e rimuovere le numerose restrizioni che ancora bloccano l’efficienza e la produttività; un’azione più decisa può dare frutti importanti in termini di crescita e di
occupazione, come mostrano i confronti con gli Stati Uniti – in particolare nei settori
dell’edilizia, della distribuzione commerciale, dei servizi alle imprese e del turismo.
Gli investimenti nelle reti. L’energia è un fattore essenziale di competitività. Seppure a
rilento, il mercato interno dell’energia comincia a dare i suoi frutti: dal 2000 i prezzi
all’ingrosso dell’energia elettrica sono aumentati in misura inferiore rispetto sia ai prezzi
mondiali dell’energia primaria sia all’inflazione. Negli Stati membri in cui i mercati sono
più aperti e concorrenziali, i prezzi all’ingrosso del gas si sono attestati su livelli notevolmente inferiori (Commissione europea, 2012c).
Tuttavia i servizi energetici sono ancora percepiti dai consumatori come poco trasparenti o piuttosto chiusi ai nuovi entranti20. Il mercato europeo dell’energia risulta ancora
poco integrato, come mostra la scarsa convergenza dei prezzi al dettaglio dell’energia
elettrica (Grafico 3.17) e del gas. Secondo la Commissione, le ragioni sono molteplici:
vincoli alle tariffe, scarsa diversificazione dell’approvvigionamento, limitata interconnessione transfrontaliera, differenze nei costi di rete, nella tassazione e nel costo del lavoro.
In particolare, le tariffe vincolate impediscono l’emergere di un contesto concorrenziale;
spesso sono o sono percepite come un fattore di ingerenza politica che allontana gli
investimenti. Inoltre, tariffe vincolate inferiori al prezzo di mercato possono rivelarsi
economicamente insostenibili per i fornitori e comportare un costo che, alla fine, grava
sui consumatori.
Il livello di concorrenza sul prezzo al dettaglio diverge da uno Stato membro all’altro:
l’indice di concentrazione del mercato21 risulta più elevato in Grecia, Portogallo, Estonia,
Lettonia, Lituania, Italia e Francia. Nell’Europa meridionale e orientale i consumatori
difficilmente cambiano fornitore e ravvisano spesso una mancanza di trasparenza. Le
cose sembrano andare meglio nel mercato all’ingrosso sia in termini di funzionamento
sia di concorrenza, dove i prezzi convergono maggiormente.
Servono ancora grandi investimenti nelle reti – gasdotti e reti elettriche – nello
stoccaggio e nei rigassificatori del gas naturale liquefatto. Nel 2012 la Commissione ha
rivolto a 11 stati membri (tra cui Italia, Germania, Francia, Spagna e Polonia) raccomandazioni sulla necessità di aumentare le interconnessioni nel settore dell’energia elettrica
e del gas. Per sfruttare in maniera ottimale le energie rinnovabili sono indispensabili reti
più “intelligenti”, anche in termini di capacità di stoccaggio e di impianti di produzione
140
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
di riserva. Gli investimenti risultano ostacolati dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni, dal quadro di finanziamento e dalle disposizioni normative.
Grafico 3.17 – Prezzi dell’elettricità per le famiglie
(€ per migliaia di kilowatt orari, 2010)
160
140
120
100
80
Portogallo
Irlanda
Regno Unito
Italia
Austria
Slovacchia
Paesi Bassi
Germania
Ungheria
Lussemburgo
Belgio
Spagna
Danimarca
Svezia
Polonia
Rep. Ceca
Lituania
Grecia
Lettonia
Francia
Romania
Estonia
Bulgaria
40
Finlandia
60
Fonte: OCSE (2012b).
L’accelerazione dell’integrazione del mercato dell’energia passa attraverso la piena attuazione del “Terzo pacchetto di misure per il mercato interno e il rafforzamento delle
politiche nazionali per l’efficienza energetica”22; ma l’attuazione delle misure a livello
nazionale ritarda. La costruzione di una vera rete integrata per la distribuzione del gas
consentirebbe di superare la dimensione ancora strettamente nazionale delle reti di distribuzione e, insieme, assicurerebbe la fine della rete di opachi accordi bilaterali con i
paesi produttori, che ancora mantiene troppo alti i prezzi dell’energia.
Anche i trasporti sono tra i settori chiave per il rilancio della crescita e della competitività. Essi rappresentano oggi il 5% circa del valore aggiunto complessivo dell’Unione e
svolgono una funzione ausiliaria agli altri settori dell’economia. Tuttavia la realizzazione
di un vero mercato interno dei trasporti è ancora incompleta, il grado di apertura limitato, così come l’efficienza complessiva. A questo ritardo concorrono in parte il mancato
recepimento e la non corretta attuazione della normativa europea, in particolare nel
trasporto su strada e ferroviario e nella sicurezza marittima. Le infrazioni sono legate
soprattutto alle difficoltà che i nuovi operatori incontrano per entrare sul mercato e
alle procedure d’appalto per la selezione dei prestatori, spesso non conformi al diritto
europeo.
Secondo la Commissione europea (2012c), sono proprio gli Stati membri che hanno un ruolo fondamentale di transito nella rete trans-europea dei trasporti (Austria,
141
Belgio, Francia, Germania e Italia) a mantenere ostacoli all’ingresso dei nuovi operatori
nel mercato e oneri regolamentari sul mercato che frenano l’economia europea nel suo
complesso.
Il settore ferroviario presenta le strozzature più evidenti: se il trasporto merci e quello
internazionale passeggeri possono essere considerati sufficientemente aperti alla concorrenza, il trasporto passeggeri a livello nazionale è ancora chiuso. Gli operatori nazionali
storici conservano il monopolio di fatto sul mercato nazionale e questo contribuisce alla
scarsa qualità e inefficienza dei loro servizi. I mercati ferroviari più aperti sono quelli danesi, svedesi e britannici, tutti paesi dove gli appalti di servizio pubblico sono aggiudicati
con processi di gara effettivamente competitivi.
La liberalizzazione degli anni Novanta del trasporto aereo ha determinato una forte
crescita del settore, in termini sia di passeggeri sia di rotte servite all’interno dell’Unione,
nonché una diminuzione considerevole delle tariffe. Lo spazio aereo europeo resta tuttavia frammentato tra i controllori nazionali, con conseguenti costi supplementari sia per
le compagnie aeree sia per i clienti.
Nel 2011 la Commissione europea ha presentato delle proposte per lo sviluppo di
infrastrutture integrate (TEN-T) e per il loro finanziamento (Connecting Europe Facility). Le misure proposte mirano a concentrare gli interventi europei sui componenti della
rete TEN-T con il più elevato valore aggiunto europeo (collegamenti transfrontalieri
mancanti, punti di connessione intermodale e principali strozzature), ad applicare su
larga scala tecnologie intelligenti e interoperabili per ottimizzare la capacità e l’utilizzo
delle infrastrutture.
I benefici derivanti da un mercato digitale interno potrebbero essere consistenti sia
per l’aumento della produttività delle infrastrutture esistenti sia per nuovi investimenti
su larga scala; si stima che la realizzazione del mercato interno digitale e delle comuncazioni elettroniche possa produrre rispettivamente un aumento del 4% e dello 0,8% del
PIL dell’UE.
Il mercato digitale, in particolare la banda larga, rappresenta un enorme potenziale
di crescita per le applicazioni come il commercio elettronico e il cloud computing: si stima che un aumento di 10 punti percentuali di Internet ad alta velocità possa portare ad
una crescita annua del PIL pro-capite di circa 1-1,5 punti percentuali23.
La diffusione della banda larga è in costante aumento, resa possibile dalla maggiore
concorrenza introdotta con la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche, a cui
si è accompagnata una riduzione dei prezzi al dettaglio dei servizi. Nel 2011 i due terzi di
tutte le linee fisse sono stati venduti da nuovi operatori; eppure, il persistere di differenze
di prezzo fra gli Stati membri indica che, in questo settore, il mercato interno non è
ancora completato.
La dispersione dei tassi di penetrazione e di utilizzo della banda larga ha continuato
a ridursi; resta problematica la copertura delle zone rurali. È importante che gli Stati
membri, oltre ad assicurare la copertura universale, continuino a promuovere investimenti efficaci nella banda larga veloce e ultraveloce, in linea con gli obiettivi di efficienza fissati nell’agenda digitale europea. Occorre a tal fine offrire sia incentivi adeguati
all’investimento, in particolare garantendo un quadro normativo prevedibile ed efficace
142
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
sostenuto da autorità di regolamentazione forti e indipendenti, sia, ove appropriato, un
sostegno pubblico mirato.
Il comparto della telefonia mobile è il segmento più competitivo di tutto il mercato
delle telecomunicazioni: nel 2011 la banda larga per la telefonia mobile è aumentata
molto in un anno, raggiungendo nel gennaio 2012 il 43% della popolazione rispetto al
26,8% del gennaio 2011, seppur con grandi differenze tra stati membri24. Le quote di
mercato degli operatori dominanti fanno registrare una lieve diminuzione in quasi tutti
gli Stati membri; tuttavia alcuni comparti della telefonia mobile (come il roaming) sono
rimasti in gran parte impenetrabili alla concorrenza, rendendo necessario un intervento
legislativo che ne assicurasse la riforma strutturale.
Sebbene si preveda, entro il 201625, un aumento dell’Internet economy di quasi 2 punti percentuali di PIL, il progresso del commercio elettronico rimane molto lento. Nel
2011 soltanto il 10% della popolazione totale dell’Unione aveva effettuato acquisti on line
in un altro Stato membro. Nel 2010 soltanto il 6% delle imprese attive nel commercio
elettronico ha realizzato vendite on line in altri Stati. È evidente dunque che l’Europa
fatica ancora a sfruttare i potenziali guadagni (stimati nell’ordine di 26 miliardi di euro
l’anno) derivanti da una maggiore integrazione del commercio elettronico, a scapito
dei consumatori che potrebbero invece beneficiare di prezzi inferiori e di una scelta più
ampia.
3.8
Semplificazione
La qualità della normativa e dell’azione della pubblica amministrazione è essenziale per
consentire alle imprese di fornire il massimo contributo alla crescita economica. Vincoli ingiustificati, lungaggini burocratiche, regole poco chiare appesantiscono il sistema
rendendolo inadatto allo sviluppo delle imprese. L’instabilità del quadro normativo disincentiva gli investimenti, ingessando l’attività economica. Viceversa, una buona regolazione, procedimenti amministrativi semplici, amministrazioni efficienti in grado di
assicurare il rispetto delle regole e la qualità dei servizi pubblici possono contribuire a
creare un contesto istituzionale favorevole all’assunzione del rischio, un fattore decisivo
per la competitività di un paese.
L’aumento degli adempimenti burocratici e dei controlli amministrativi ha caratterizzato, in forme e misure diverse, tutti i paesi industrializzati, in particolare gli Stati
membri dell’Unione europea. È un fenomeno legato in parte alla globalizzazione dei
mercati, che ha provocato una proliferazione di sistemi istituzionali, e al crescente ricorso ad autorità di regolazione indipendenti e al processo di integrazione europea. Occorre dunque evitare carichi regolativi sproporzionati, rispetto agli interessi da tutelare
e garantire la qualità della regolazione innanzi tutto attraverso la semplificazione degli
adempimenti.
Si tratta di ridurre gli oneri burocratici connessi alle formalità che le imprese sono
tenute ad assolvere. Le procedure amministrative dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e non ritardare le scelte imprenditoriali. Occorre tutelare gli interessi e
dei privati rispetto all’attività o all’inattività dell’amministrazione pubblica. Inoltre, è
143
necessario assicurare un quadro normativo semplice e coerente, accessibile per gli utenti;
vanno evitate le disposizioni inutilmente dettagliate che irrigidiscono il sistema.
Negli ultimi anni il tema della qualità della regolazione e della semplificazione amministrativa è sempre stato ai primi posti tra le priorità dei governi nazionali e delle
istituzioni internazionali. In Europa sono stati compiuti numerosi sforzi diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi e sono state avviate alcune iniziative volte a
migliorare il quadro normativo.
La Commissione europea (2012a) ha recentemente dichiarato che l’obiettivo – fissato nel 2007 – di ridurre del 25% i costi di informazione e comunicazione imposti alle
imprese dalla burocrazia in 13 settori di regolazione è stato raggiunto. I 13 settori interessati dal piano d’azione vanno dai sussidi all’agricoltura e all’ambiente, alla sicurezza
alimentare ai trasporti, alle regole fiscali sulle imprese, alla contabilità aziendale, alla
regolazione in materia farmaceutica fino alla sicurezza sul lavoro. Tale sforzo di semplificazione, secondo la Commissione, potrebbe garantire un incremento dell’1,4% del PIL
potenziale dell’Unione.
Uno dei paesi più avanzati in questo ambito è il Regno Unito, che ha da tempo
adottato delle pratiche generalizzate di semplificazione regolatoria e amministrativa in
tutta l’amministrazione, nonché il meccanismo one in one out, per il quale a ogni nuovo
onere amministrativo introdotto deve corrispondere l’eliminazione di uno esistente.
Anche lo Small Business Act (SBA)26, che definisce la politica a favore delle PMI,
si è posto l’obiettivo di migliorare il contesto in cui operano le imprese. Nel rapporto
sulla sua attuazione (Commissione europea 2011b) si legge che nel 2011 tutte le iniziative
legislative previste dallo SBA erano state adottate, con l’eccezione del regolamento sullo
statuto della società privata europea. In particolare, la direttiva sulla fatturazione elettronica del 2010 ha equiparato le fatture elettroniche a quelle cartacee; le imprese con un
fatturato inferiore a due milioni di euro possono beneficiare di un sistema facoltativo per
differire il pagamento IVA fino al ricevimento del pagamento da parte dei loro clienti; la
direttiva sui ritardi di pagamento impone alle pubbliche amministrazioni il pagamento
entro 30 giorni e fissa un limite di 60 giorni per i pagamenti tra le imprese (ma tocca agli
Stati membri attuare la direttiva).
Tuttavia i progressi nel miglioramento del business environment sono lenti: i metodi
adottati e i risultati ottenuti variano notevolmente tra gli Stati membri. Quasi tutti hanno adottato obiettivi nazionali per la riduzione degli oneri amministrativi, ma non tutti
li hanno effettivamente ridotti.
Dal rapporto Doing business 2013 predisposto dalla Banca mondiale risulta una situazione alquanto diversificata: nel ranking sulla facilità di esercitare un’attività di impresa,
le performance migliori, tra i paesi europei, si registrano in Danimarca e nel Regno Unito, che si collocano rispettivamente al quinto e settimo posto su 185 paesi considerati;
Italia, Grecia e Malta sono il fanalino di coda, occupando il settantatreesimo, settantottesimo e centoduesimo posto.
Per quanto attiene al tempo necessario per avviare un’attività imprenditoriale, in
Europa ci vogliono in media 14 giorni, ma la situazione varia tra i 4 giorni in Belgio e
i 40 a Malta (l’Italia si colloca al diciannovesimo posto, in compagnia di Danimarca e
144
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Slovenia con 6 giorni). Per quanto riguarda il numero degli adempimenti, in Europa le
imprese devono in media espletare circa 6 procedure, ma il dato varia tra un minimo
di 2 (in Slovenia) e un massimo di 10-11 (Spagna, Grecia e Malta). In percentuale del
PIL pro-capite, aprire un’impresa in Slovenia, Danimarca, Irlanda e Svezia costa meno
dell’1%. La situazione è peggiore per l’Italia e la Grecia dove si spende circa il 16,5% e il
20,5% rispettivamente.
Le politiche di semplificazione europee trovano una corrispondenza nelle misure
di semplificazione amministrativa previste dalla direttiva servizi. La direttiva richiede
infatti agli Stati membri di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso
all’attività e al suo esercizio. A tal fine, essi devono garantire nel proprio ordinamento
la predisposizione di sportelli unici e il rispetto di alcuni principi generali riguardo alle
condizioni e alle procedure di rilascio delle autorizzazioni e al loro periodo di validità. In
particolare, la direttiva prevede che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano
giustificate da un motivo imperativo di interesse generale, e soltanto se soddisfano i requisiti di non discriminazione, necessità e proporzionalità; le condizioni devono inoltre
essere oggettive e rese pubbliche in anticipo. L’autorizzazione deve essere concessa non
appena dall’esame delle condizioni richieste risulti che queste sono soddisfatte.
Anche l’utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione può fornire
un importante contributo alla semplificazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le imprese. L’e-government facilita il flusso delle informazioni tra imprese e
amministrazioni e tra le stesse amministrazioni e permette alle imprese di compiere on
line gli adempimenti amministrativi attraverso gli sportelli unici.
Nonostante il diffondersi di numerose iniziative di semplificazione, permane in particolare nei paesi dell’Europa continentale l’abitudine a una attività normativa estremamente dettagliata e non sempre attenta ai costi e ai carichi burocratici che la regolazione
comporta per le imprese.
Vi sono poi forti resistenze alla semplificazione da parte delle stesse amministrazioni
nazionali, locali ed europee, preoccupate del fatto che la semplificazione dei procedimenti possa ridurne i poteri e impedirne un uso arbitrario. Forti ostacoli vengono dalla
mancanza di meccanismi automatici di revisione della normativa e di alternative alla regolazione nonché dalla tendenza dei regolatori, in particolare nel settore dell’ambiente,
a prestare scarsa attenzione ai costi della regolazione (Bassanini, 2011).
Occorre dunque far diventare la qualità della regolazione e la semplificazione oggetto di una visione di lungo periodo e di una vera e leale cooperazione fra tutte le istituzioni a tutti i livelli (enti locali, regioni, stato, autorità indipendenti, Unione europea).
3.9
Conclusioni
Per mantenere i livelli di benessere raggiunti dall’Europa nel secondo dopoguerra occorre un incremento significativo e duraturo della produttività. Da quindici anni la crescita
della produttività totale dei fattori langue sotto l’1% in tutto il continente ed è addirittura negativa nei paesi mediterranei. Un aumento significativo può essere realizzato attraverso l’adozione più estensiva di nuove tecnologie e soprattutto attraverso nuovi metodi
145
organizzativi per tutte le funzioni di impresa – compresa, e per niente secondaria, la
distribuzione commerciale – aree in cui restano enormi benefici potenziali da sfruttare
con le tecnologie esistenti.
I confronti internazionali mostrano che il ritardo europeo è spiegato per una parte
importante dalle rigidità dei mercati e dalle resistenze sociali al cambiamento. Queste
ultime sono evidenti rispetto al funzionamento del mercato del lavoro. Riforme più incisive per migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, attraverso un aumento dei tassi
di partecipazione, la riduzione della segmentazione, il miglioramento del job-matching e
della contrattazione, e dei sistemi di protezione sociale possono riassorbire i dualismi e
spingere la produttività in maniera significativa.
Sia la produttività totale dei fattori sia quella del lavoro nei paesi europei migliorerebbero se si progredisse in maniera più penetrante e rapida nella realizzazione del
mercato interno europeo, soprattutto nei servizi e nelle reti energetiche, di trasporto e di
comunicazione, e nella semplificazione degli oneri burocratici.
Non esiste un “proiettile d’argento” (silver bullet) capace di risolvere in un solo colpo
il problema della produttività in Europa, in particolare in alcuni paesi. Serve un’azione
diffusa, determinata e continua nel tempo da parte di tutte le istituzioni, comunitarie e
nazionali, su diversi fronti.
146
3. Le politiche per rilanciare la competitività europea
Note
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.2
13.
14.
15.
Su questi aspetti si rimanda anche alle pagine
scritte in questo volume da Gianni Toniolo.
www.euklems.net. Per un’analisi sulla metodologia e costruzione del database cfr. O’Mahony
e Timmer (2009).
Commissione europea (2012c).
I paesi europei sono raggruppati nel modo seguente. Paesi nordici: Danimarca, Finlandia e
Svezia; i paesi anglosassoni: Irlanda e Regno Unito; continentali: Francia, Germania, Benelux e
Austria; meridionali: Spagna, Portogallo e Grecia.
Commissione europea (2012b).
Commissione europea (2012b).
Commissione europea, European Economic Forecast Winter 2013.
Secondo il Rapporto Going for Growth 2013
dell’OCSE un ri-bilanciamento delle protezioni sul mercato del lavoro favorirebbe una
allocazione più efficiente del fattore lavoro
contribuendo ad aumentare il tasso di crescita
potenziale.
B. Barkbu et al. (2012).
Tra gli altri, Bredgaard e Daemmrich (2012).
Dichiarazione dei membri del consiglio europeo, Verso un risanamento favorevole alla crescita
e una crescita favorevole alla creazione di posti di
lavoro, 30 gennaio 2012.
Mario Monti, Una nuova strategia per il mercato
unico. al servizio dell’economia e della società europea – Rapporto al presidente della Commissione
europea José Manuel Barroso, 9 maggio 2010 e
Conclusioni dei capi di stato o di governo della
zona euro, Patto per l’euro, Un coordinamento più
stretto delle politiche economiche per la competitività
e la convergenza, Allegato I, 11 marzo 2011.
Commissione europea (2011a e 2012d).
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai
servizi nel mercato interno.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/ecp456_en.htm.
16. Le attività riservate sono attività economiche
riservate ai prestatori di servizi titolari di qualifiche professionali che godono dei diritti esclusivi per esercitarle.
17. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf.
18. Nelle regioni del Sud, le transazioni tra imprese
sono saldate in media in 91 giorni, a fronte dei
31, in media, nel Nord.
19. Direttiva 2011/7/ UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni.
20. Commissione europea, Rendere efficace il mercato interno dell’energia, COM(2012) 663 final.
21. L’indice di Herfindahl-Hirschman, che è una
misura comunemente accettata di concentrazione del mercato, è calcolato sommando i
quadrati delle quote di mercato di tutte le imprese in concorrenza sul mercato (più l’indice è
alto, più è alta la concentrazione del mercato).
La concentrazione del mercato è moderata se
l’indice è compreso tra 750 e 1800, è elevata se
l’indice è compreso tra 1800 e 5000, è elevatissima oltre 5000. Si veda documento di lavoro
dei servizi della Commissione relativo ai mercati dell’energia nell’Unione europea nel 2011
– SWD (2012) 368, parte 2.
22. Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.
23. Czernich et al. (2009). La stima si basa su un
gruppo rappresentativo di paesi dell’OCSE nel
periodo 1996-2007.
24. La maggiore diffusione della banda larga mobile
si registra soprattutto nel Nord Europa dove raggiunge circa l’80 per cento della popolazione.
25. https://www.bcgperspectives.com/content/
articles/media_entertainment_strategic_planning_4_2_trillion_opportunity_internet_economy_g20/
26. Commissione europea, Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno Small Business Act
per l’Europa, COM(2008) 394 final.
147
4
L’Unione europea in cerca di identità politica:
due strade alternative
Sergio Fabbrini*
Sommario
4.1 Introduzione – 4.2 Da Maastricht a Lisbona – 4.3 Il Trattato di Lisbona: la costituzione duale – 4.4 La crisi dell’euro e l’integrazione intergovernativa – 4.5 Accentramento senza efficacia e
legittimità – 4.6 Il futuro dell’Unione europea: due prospettive – 4.7 Conclusioni
4.1
Introduzione
L’Unione europea (UE) si è trasformata radicalmente nel corso della crisi dell’euro che si
è sviluppata a partire dal 2009. L’esplosione della crisi finanziaria è peraltro coincisa con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009). La crisi dell’euro ha messo in
discussione il sistema istituzionale previsto dal Trattato di Lisbona per la gestione della politica economica e finanziaria. Quando è esplosa la crisi, dunque, l’UE aveva a disposizione gli
strumenti istituzionali per affrontarla, strumenti di crisis management collocati in un contesto
costituzionale definito sin dal Trattato di Maastricht del 1992. Per questo motivo è improprio
sostenere che l’UE si sia trovata impreparata per affrontare le sfide della crisi finanziaria.
Tuttavia, è evidente che gli strumenti di cui ha potuto disporre non hanno funzionato come ci si aspettava. Le decisioni infine prese sono risultate regolarmente troppo
limitate (rispetto a ciò che sarebbe stato necessario) e sono arrivate sempre troppo in
ritardo (rispetto ai tempi rapidissimi delle scelte compiute dai mercati finanziari).
Dunque: too late, too little. Il risultato è stato una moltiplicazione dei Trattati oltre
che una serie impressionante di provvedimenti legislativi e regolamentari, ognuno dei
quali, in sé, di grande portata innovativa eppure incapace, di per sé, a mettere in sicurezza la moneta comune.
L’esito di questo processo è stata la formazione di un’Unione (qui userò UE e Unione come dizioni interscambiabili) sempre più accentrata ed invasiva nei confronti degli
Stati membri dell’eurozona in particolare, un’Unione che si è rivelata allo stesso tempo
poco efficace e priva dei basilari requisiti di democrazia per legittimare le proprie decisioni. Di qui l’insoddisfazione diffusa tra i cittadini di molti paesi europei nei confronti
* Direttore LUISS School of Government e University of California di Berkeley.
148
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
delle politiche perseguite e dei metodi adottati per raggiungerle. L’anti-europeismo si è
diffuso a macchia d’olio in tutti gli Stati membri dell’eurozona, negli Stati del Sud “debitore” per via dei costi troppo alti che sono stati a costretti a sostenere per rimettere in
equilibrio i conti pubblici e recuperare competitività e negli Stati del Nord “creditore”
per via degli aiuti richiesti per sostenere (o ritenere di dover sostenere) i paesi debitori.
Si è creato così un vero e proprio paradosso: sul piano istituzionale l’eurozona si è
ulteriormente integrata, sul piano sociale i suoi Stati membri si sono ulteriormente divisi. Come risolvere questo paradosso? Per fare ciò occorre capire perché quel paradosso si
è formato, dipanando il bandolo della matassa.
Qui procederò come segue: dopo aver ricostruito il processo di istituzionalizzazione
dell’UE che ha condotto al Trattato di Lisbona del 2009, discuterò le caratteristiche
costituzionali di quest’ultimo, mostrando come esso abbia formalizzato una doppia
costituzione, sovranazionale per il mercato comune e intergovernativa per la politica
finanziaria (inter alia). Per politica finanziaria intendo l’insieme di politiche legate alla
moneta comune (come la politica di bilancio, fiscale ed economica). Quindi mostrerò
come l’Unione intergovernativa abbia affrontato la crisi dell’euro, attivando un processo
senza precedenti di accentramento decisionale della politica finanziaria a livello intergovernativo, con una forte invasione nelle autonomie decisionali degli Stati dell’eurozona.
Si è trattato di una risposta “paradossale” in quanto ha favorito una maggiore integrazione, ma a danno della efficacia e della legittimità delle decisioni.
Per risolvere i dilemmi della logica intergovernativa, si è dato vita ad un sistema
rigidamente regolato, un sistema che ha sostituito la decisione politica con la norma
giuridica. Siccome questo sistema non ha funzionato, né poteva funzionare, il risultato
è stato un incremento delle divisioni tra gli Stati dell’eurozona e all’interno di ognuno
di essi. Mai l’Europa era stata così divisa nel secondo dopoguerra. Per questo motivo, è
necessario porsi la domanda se c’è un’alternativa alla gestione intergovernativa della politica finanziaria. Per rispondere a questa domanda ho quindi discusso le due principali
alternative all’integrazione intergovernativa, mostrando come quella più efficace non
coincide con la più semplice. Concludo quindi con una riflessione su come realizzare la
strategia (più efficace ma anche più complessa) in un contesto di crescente differenziazione dell’Europa.
È cruciale individuare la strategia per portarci alla formazione di un’autentica unione politica del continente. L’Europa non può permettersi il gioco dei veti reciproci. La
sfida drammatica della crisi dell’euro ha messo in radicale discussione la struttura dei
compromessi che aveva finora sostenuto la costruzione dell’UE. Solamente un’Unione
politicamente unita potrà consentire all’Europa di continuare ad esercitare un ruolo di
influenza in un sistema globale ormai chiaramente strutturato intorno a pochi grandi
paesi o blocchi continentale. Quell’influenza è necessaria se si vuole difendere gli interessi europei in un contesto di spietata competizione globale. Senza questa capacità di
agire unita nel mercato e nelle istituzioni globali, sarà altamente improbabile che l’Europa possa difendere quel suo particolare modello di civiltà generalmente definito come
“economia sociale di mercato”.
149
4.2
Da Maastricht a Lisbona
Il Trattato di Lisbona costituisce l’esito di un lungo e controverso processo di discussione pubblica sull’identità costituzionale dell’UE (Fabbrini, 2008). Già con il Trattato di
Maastricht del 1992 l’integrazione europea aveva iniziato a coinvolgere ambiti di politiche pubbliche considerati fondativi della sovranità nazionale. Dopo Maastricht, non
solamente si sono allargati enormemente gli ambiti di policy collegati al mercato unico,
ma anche ambiti di policy di estrema sensibilità per i singoli Stati membri (come la politica estera e di sicurezza, la politica dell’ordine interno e quindi la politica finanziaria e
monetaria) sono divenuti materie di interesse europeo. Il processo di integrazione aveva
raggiunto una tale profondità (oltre che estensione, con i successivi allargamenti che si
sono susseguiti) che non poteva non sollecitare una maggiore definizione dei suoi assetti
istituzionali e delle sue procedure decisionali.
Il Trattato di Maastricht del 1992 costituisce il punto di svolta nella vicenda
dell’integrazione europea (Lutzeler, 1994). Quel Trattato fu elaborato e approvato in
un contesto storico drasticamente diverso rispetto a quello che aveva portato all’avvio
del processo di integrazione, con il Trattato di Parigi del 1952 e quindi con i Trattati
di Roma del 1957. Nei primi quattro decenni, infatti, il processo di integrazione si era
svolto all’interno dell’Europa occidentale, aveva potuto beneficiare della copertura
politica e della protezione militare degli Stati Uniti (attraverso la loro leadership della
NATO) e si era basato sulla divisione della Germania (che aveva costituito il problema
irrisolto della storia europea almeno dalla guerra franco-prussiana del 1871, con il suo
esito sconvolgente dell’incoronazione dell’imperatore tedesco nella reggia di Versailles
[Judt, 2005]).
Tra il 1989 e il 1991, queste condizioni sistemiche dell’integrazione si indebolirono
irrimediabilmente. Con il crollo del muro di Berlino nel novembre del 1989 si impose il
problema dell’unificazione tedesca e con l’implosione dell’Unione Sovietica nell’agosto
del 1991 si formalizzò la fine della Guerra fredda. L’Europa integrata fu costretta a cambiare la propria agenda. L’UE non poteva più limitarsi a costruire un mercato comune,
lasciando ad altri (agli Stati Uniti in specifico) il compito di garantire la propria sicurezza militare. E soprattutto non poteva più pensare che la riunificazione della Germania
potesse essere rinviata all’infinito. Tant’è che quest’ultima avverrà proprio alla fine del
1991, con l’aiuto degli americani e le diffidenze delle principali cancellerie europee, ma
in cambio dell’Unione economica e monetaria.
Il Trattato di Maastricht, infatti, fu la risposta europea a tali cambiamenti storici.
Una risposta basata su un grande compromesso tra i principali paesi europei. Per la
prima volta, nella preparazione del Trattato, si riconobbe che il progetto di integrazione aveva un carattere politico e non esclusivamente economico. Per la prima volta
si parlò di “unione politica”, tant’è che la denominazione di Unione europea verrà introdotta proprio per siglare la distanza dalla precedente denominazione di Comunità
economica europea (CEE). Per la prima volta venne deciso che il processo di integra-
150
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
zione doveva coinvolgere settori di policy non strettamente legati al mercato comune,
come la politica estera e la politica della giustizia e dell’ordine interno. Per la prima
volta si definirono i tempi e i modi per l’adozione di una moneta comune che potesse
contenere la forza economica della Germania. Dunque, in quell’occasione vennero
siglati due fondamentali compromessi. Il primo fu il compromesso tra gli Stati favorevoli all’integrazione politica e gli Stati invece esclusivamente interessati alla costruzione del mercato comune. Gli Stati interessati all’unione politica furono autorizzati
ad andare avanti, ma agli altri fu consentito di auto-escludersi (attraverso la cosiddetta
clausola di opt-out) dalle politiche più integrate (come quella della moneta unica).
Il secondo compromesso fu quello all’interno degli Stati favorevoli all’integrazione
politica, tra quelli che volevano proseguire sulla strada della costruzione di un’Unione
interamente sovranazionale e quelli invece che volevano rafforzare il controllo dei governi nazionali sulle nuove politiche (degli affari esteri e della sicurezza e della politica
finanziaria in particolare).
Il risultato fu un Trattato basato su tre pilastri: quello sovranazionale del mercato
comune e i due pilastri intergovernativi della politica estera e della politica dell’ordine
interno. Ovvero un Trattato che riconosceva formalmente che l’Unione avrebbe potuto
procedere nel processo di integrazione in ambiti cruciali per i suoi Stati membri a condizione di garantire ai loro governi un ruolo decisionale esclusivo grazie al rafforzamento
delle istituzioni intergovernative.
Tale logica di “differenziazione dei regimi decisionali” si affermò ulteriormente con l’avvio dell’Unione economica e monetaria (UEM) nel 1994. Per dare una
risposta al problema tedesco, fu deciso di dare vita ad una nuova moneta, l’euro,
gestita da un’istituzione autenticamente federale, la Banca centrale europea, peraltro
largamente disegnata sulla base del modello istituzionale della Banca federale tedesca o Deutsche Bundesbank, a condizione che gli Stati mantenessero la loro libertà
d’azione nelle politiche collegate alla moneta comune (come la politica fiscale, di
bilancio e più generalmente la politica economica), seppure entro alcuni vincoli riguardanti i livelli di deficit e debito pubblico (così come verranno formalizzati dal
Patto di stabilità e crescita). Infatti, con una risoluzione e con due regolamentazioni,
il Consiglio dei ministri del luglio 1997 decise di fissare alcuni parametri entro cui
avrebbe dovuto svolgersi il coordinamento volontario. La prima regolamentazione
(entrata in vigore il 1° luglio 1998) doveva intervenire a monte, in quanto stabiliva
la procedura per la sorveglianza dei budget pubblici e per il coordinamento delle
politiche economiche nazionali. La seconda regolamentazione (entrata in vigore il 1°
gennaio 1999) doveva invece intervenire a valle, in quanto stabiliva la procedura di
implementazione da attivare in caso di deficit eccessivo. È la combinazione di queste
due regolamentazioni che costituirà il Patto di stabilità e crescita quindi riconosciuto
nei successivi Trattati.
La decisione presa nel 1994 fu dunque coerente con l’impianto stabilito a Maastricht: centralizzare la politica monetaria e decentralizzare le politiche a quest’ultima collegate. L’integrazione si era spinta fino al punto di mettere in discussione
151
uno dei perni dello Stato moderno, la sovranità monetaria, ma gli Stati membri e i
loro governi avevano imposto un disegno istituzionale che affidava a essi il controllo
del processo decisionale relativo alle nuove cruciali politiche che la fine della Guerra
fredda aveva spinto nell’agenda europea (Dyson, 2012). Dopo tre fasi di convergenza,
l’euro è entrato quindi in circolazione il 1° gennaio 2002, divenendo progressivamente
la moneta di 17 (inizialmente 11) dei 27 stati membri dell’UE (Austria, Belgio, Cipro,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna; la Lettonia l’adotterà a partire
dal 1° gennaio 2014).
Nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, la necessità di accogliere all’interno
dell’UE i nuovi paesi dell’Est e del Sud dell’Europa aveva finito per tenere costantemente
aperto il cosiddetto cantiere istituzionale. In quel decennio, si venne ad accumulare una
complessa struttura di Trattati che a loro volta si aggiungevano a quelli che avevano dato
vita al processo di integrazione: i Trattati di Roma (1957), L’Atto unico europeo (1986),
il Trattato di Maastricht (1992), il Trattato di Amsterdam (1997) e il Trattato di Nizza
(2001).
Di fronte alla prospettiva di un raddoppio degli Stati membri, si decise quindi di
andare verso una razionalizzazione di tale complessa struttura di Trattati, così da mettere l’UE nella condizione di operare con efficacia. Nel 2002-2003 venne riunita una
Convenzione costituzionale a Bruxelles che elaborò un nuovo testo, il Trattato costituzionale, che sostituiva tutti gli altri trattati (Norman, 2003). Seppure firmato dai capi di
Stato e di governo in una solenne riunione a Roma nel 2004, il Trattato costituzionale
venne quindi bocciato dagli elettori francesi ed olandesi in due referendum popolari,
tenuti rispettivamente nel maggio e nel giugno 2005. Dopo una pausa di riflessione fu
deciso quindi di emendare i trattati esistenti recuperando buona parte del Trattato costituzionale in un nuovo testo chiamato Trattato di Lisbona (perché firmato nella capitale
portoghese).
Anche questa soluzione trovò opposizioni in alcuni Stati membri, in particolare in
Irlanda, la cui costituzione impone l’indizione di un referendum popolare per l’approvazione di una modifica ai trattati, anche nella forma di emendamenti a quelli precedenti
approvati. Gli irlandesi votarono contro il Trattato di Lisbona nel giugno 2008, ma furono poi convinti a sostenere quel Trattato in un successivo referendum popolare tenutosi
nell’ottobre 2009. In questo modo, il Trattato di Lisbona potette entrare in vigore il 1°
dicembre 2009.
Il Trattato di Lisbona è formalmente costituito di tre trattati: il Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1992 emendato (TEU), il Trattato di Roma del 1957
emendato e rinominato come Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
e la Carta dei diritti fondamentali (della cui esistenza prese atto la Conferenza intergovernativa che aveva elaborato il Trattato di Nizza del 2001 ma che non l’aveva poi formalizzata, formalizzazione appunto avvenuta con il Trattato di Lisbona). È importante
tenere presente la sequenza dei Trattati che hanno istituzionalizzato l’UE, trasformando
gli Stati nazionali europei in stati membri dell’Unione (Tabella 4.1).
152
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
Tabella 4.1 - I Trattati dell’Unione europea
trattati
stati membri
scopi
Comunità europea del
carbone e dell’acciaio
CECA (Parigi, 1951)
Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Olanda
Garantire un eguale accesso agli Stati membri nel mercato del carbone e
dell’acciaio.
Euratom (Roma, 1957)
Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Olanda
Promuovere la ricerca e la tecnologia
nucleari negli Stati membri
Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Olanda
Creare un mercato comune tra gli
Stati membri.
Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Olanda
Avviare un mercato singolo tra gli
Stati membri.
Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Olanda
Organizzazione a tre pilastri
Pilastro sovranazionale per il mercato singolo (CEE di Roma 1957)
Pilastro intergovernativo per la politica estera e di sicurezza
Pilastro intergovernativo per la
politica della giustizia e dell’ordine
interno
Decisione di dare vita ad una Unione economica e monetaria
.
Comunità economica
europea
CEE (Roma, 1957)
Atto unico europeo
AUE (Lussemburgo,
The Hague, 1986)
Unione europea
UE (Maastricht, 1992)
Comunità europea
CE (Amsterdam, 1997)
Nizza (2001)
Trattato di Lisbona
(2009)
Fonte: Fabbrini (2010).
Austria, Danimarca, Belgio, Finlandia, Grecia, Germania, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Svezia
Austria, Danimarca, Belgio, Finlandia, Grecia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Olanda, Svezia
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica
Ceca, Danimarca, Cipro, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Crozia (2013)
Riorganizzare la CEE (1957) in un
nuovo Trattato (CE).
Proclamazione della Carta dei diritti
fondamentali
Razionalizzazione del sistema istituzionale
Definire la struttura istituzionale
dell’Unione sovranazionale e intergovernativa
Riconoscimento formale della Carta
dei diritti fondamentali
Attribuzione di personalità legale
all’UE
153
4.3
Il Trattato di Lisbona: la costituzione duale
Il versante sovranazionale
Se il Trattato di Lisbona ha abolito la divisione in pilastri formalizzata a Maastricht,
tuttavia, esso ha preservato la distinzione tra diversi regimi decisionali relativamente a
diverse politiche europee. Si può dire che il Trattato di Lisbona abbia formalizzato un
doppio sistema decisionale (Fabbrini, 2012a). Ha istituzionalizzato un “sistema di governo sovranazionale”, costituito di istituzioni che rispettano i principi della separazione
dei poteri, per regolare materie collegate al mercato unico. E, contemporaneamente,
ha istituzionalizzato un “nuovo sistema di governance” per decidere materie sensibili
per gli Stati membri (in particolare per quelli dell’eurozona). Nel primo caso, si è formalizzato un quadrilatero istituzionale basato su un legislativo bicamerale (il Consiglio
dei ministri, in quanto camera di rappresentanza dei governi e costituito da formazioni
differenziate di ministri, e il Parlamento europeo, in quanto camera di rappresentanza
dei cittadini) ed un esecutivo duale (il Consiglio europeo, formato dei capi di Stato e
di governo degli Stati membri, e la Commissione, con un commissario per ogni stato
membro, almeno fino al 2014).
Tale quadrilatero è più o meno noto perché assomiglia assai ad un sistema di governo
a separazione dei poteri, con però un esecutivo duale che ricorda il semipresidenzialismo
francese. La co-decisione legislativa del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo
viene celebrata come la procedura ordinaria per l’approvazione delle leggi europee (regolamentazioni e direttive), mentre la Commissione mantiene il potere di iniziativa del
processo legislativo (sottoponendo all’una o all’altra camera una particolare proposta di
legge) e il Consiglio europeo vede riconosciuto il suo ruolo di “testa politica” dell’esecutivo comunitario.
Si tratta di un sistema di governo sovranazionale perché i ruoli e le funzioni delle
varie istituzioni sono sufficientemente precisati. Si tratta di un sistema di governo separato perché nessuna istituzione dipende dalla fiducia delle altre per poter funzionare in quanto tale. Le istituzioni sono reciprocamente indipendenti e allo stesso tempo
collegate le une alle altre attraverso un meccanismo definibile come check and balance1.
In questo sistema di governo due istituzioni appaiono come le più rilevanti. Da un lato
il Consiglio europeo (dei capi di Stato e di governo) e dall’altro lato il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo (un’istituzione che non esisteva alle origini del processo di
integrazione) si è progressivamente distaccato dal Consiglio dei ministri, assumendo una
funzione prettamente esecutiva (quella di stabilire le grandi linee di azione dell’Unione),
lasciando al Consiglio dei ministri il ruolo e le funzioni proprie della camera degli Stati
di un legislativo federale. Nello stesso tempo, il Parlamento europeo (che era, all’origine del processo di integrazione, poco più che un’assemblea parlamentare costituita di
membri nominati dai parlamenti nazionali) ha acquisito una pari dignità legislativa con
il Consiglio dei ministri, motivando con sapienza e determinazione le sue richieste di
154
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
influenza istituzionale con il fatto di essere l’unica istituzione eletta direttamente (dal
1979) dai cittadini dei singoli Stati membri dell’UE.
Con l’approfondimento del processo di integrazione si è registrata una crescita costante del ruolo dei governi (attraverso il Consiglio europeo), però bilanciata dalla costante crescita di influenza del Parlamento europeo. La crescita d’influenza del Parlamento europeo ha portato a un ridimensionamento del ruolo della Commissione in quanto
istituzione sovranazionale per eccellenza; la crescita del ruolo del Consiglio europeo ha
portato a un ridimensionamento del ruolo del Consiglio dei ministri in quanto istituzionale intergovernativa per eccellenza. Peraltro, l’elezione (con il Trattato di Lisbona) di un
presidente permanente del Consiglio europeo, eletto per 2,5 anni e rinnovabile per un
secondo mandato di durata equivalente (attualmente è il belga Herman van Rompuy),
ha istituzionalizzato il suo potere decisionale, dando continuità alla sua azione esecutiva.
Basti pensare che, se il Trattato di Lisbona prevede che esso «si riunisca due volte ogni
sei mesi» (TUE, art. 15, comma 3), nel 2010 il Consiglio europeo si è riunito 6 volte
(ovvero 7 volte se si considera anche una riunione dei capi di Stato e di governo dei paesi
dell’eurozona), nel 2011 si è riunito 7 volte (ovvero 9 volte se si considerano anche 2 riunioni dei capi di Stato e di governo dei paesi dell’eurozona) e nel 2012 si è riunito 6 volte
con successive riunioni dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’eurozona.
È evidente che la Commissione non costituisce più la forza propulsiva del processo di
integrazione, anche se è pure evidente che le sue competenze tecniche continuano ad
essere indispensabili per tradurre in misure operative le decisioni prese dal Consiglio europeo (De Schoutheete, 2011). Nello stesso tempo, il Parlamento europeo, imponendo
la co-decisione come la procedura ordinaria dell’Unione, ha dato legittimità al processo
legislativo, sottraendolo alle derive tecnocratiche del passato (vedi Grafico 4.1).
Grafico 4.1 – Il versante sovranazionale dell’UE
Consiglio europeo
Consiglio dei ministri
Parlamento europeo
Commissione
155
Dunque, in tutte le politiche collegate al mercato comune (che sono poi la grande maggioranza delle politiche europee), l’UE continua a operare attraverso l’approvazione di
provvedimenti legislativi (regolamenti, che debbono essere applicati dagli Stati membri
così come sono, e direttive, che definiscono gli obiettivi che gli Stati membri debbono
raggiungere lasciando a essi la scelta degli strumenti per farlo), un’attività che è quindi
rigorosamente monitorata dalla Corte europea di giustizia.
È questa l’“integrazione attraverso il diritto” che è all’origine del processo integrativo
e che è garantita da un complesso sistema politico e legale in grado di soddisfare i basilari
criteri dell’efficacia e della legittimità delle decisioni (Craig, 2011). In particolare con il
Trattato di Lisbona, che ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo e istituzionalizzato
il complesso sistema di check and balance, l’Unione sovranazionale ha acquisito una soddisfacente forma democratica. Per di più, la Corte europea di giustizia ha visto riconosciuto
il suo ruolo di garante (se non di promotrice) dell’integrazione attraverso il diritto, agendo
come referente per la soluzione delle contese tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, oltre che tra queste ultime. Dopo tutto, il ruolo della Corte Europea di giustizia è stato
fondamentale per promuovere il processo di integrazione (Stone Sweet, 2000). Basti pensare alle due decisioni da essa prese nella prima metà degli anni Sessanta del secolo scorso
(quella relativa all’effetto diretto della legislazione europea sui cittadini degli Stati membri
e quella relativa alla supremazia della legislazione europea su quella nazionale, anche se la
seconda è stata approvata successivamente alla prima); decisioni che hanno contribuito
a istituire un vero e proprio ordine legale sovranazionale, ovvero a costituzionalizzare il
funzionamento del mercato comune (Amato e Ziller, 2007).
L’organizzazione del quadrilatero decisionale, celebrata dal Trattato di Lisbona, soddisfa ragionevolmente i criteri di efficienza e di legittimità che sono propri di un sistema di governo democratico. Certamente, come dirò più avanti, si può fare di più per
democratizzare la presidenza del Consiglio europeo o per rafforzare i poteri di controllo
e di bilanciamento del Parlamento europeo. Ma si potrebbe fare di più anche nelle
democrazie degli Stati membri dell’UE per accrescere l’efficacia e la legittimità dei loro
governi. Nondimeno, sul versante sovranazionale, il Trattato di Lisbona costituisce un
passo importante in direzione di una democrazia composita europea.
Il versante intergovernativo
Il Trattato di Lisbona ha costituzionalizzato, però, anche un versante intergovernativo.
A Maastricht tale versante aveva ricevuto una formalizzazione specifica in pilastri ad hoc.
Con il Trattato di Lisbona la distinzione in pilastri è stata abolita, ma la differenziazione tra regimi decisionali diversi è rimasta. Con l’estensione dell’integrazione ad ambiti
di policy cruciali per gli Stati membri (come la politica estera e di sicurezza, la politica
monetaria e finanziaria, la politica dell’occupazione), i governi hanno collocato quegli
ambiti in contesti istituzionali assai diversi rispetto a quelli che regolano le innumerevoli
politiche collegate al mercato unico.
Il Trattato di Lisbona ha innovato rispetto al Trattato di Maastricht, nondimeno ha
istituzionalizzato quadri normativi e regimi decisionali differenziati, da un lato, per le
politiche del mercato unico e, dall’altro lato, per la politica estera e di sicurezza (PESC)
156
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
e per la politica economica e monetaria (UEM), in particolare. Per queste ultime, il Trattato di Lisbona ha sospeso il quadrilatero decisionale sopra descritto, per sostituirlo con
un assetto istituzionale basato principalmente sul Consiglio europeo (dei capi di Stato e
di governo) e il Consiglio dei ministri degli Stati membri.
Non solo, relativamente a queste ultime politiche, lo scopo indicato dal Trattato di
Lisbona è quello di favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri, non già
la loro integrazione legale a livello sovranazionale. Le decisioni debbono essere prese attraverso modalità specifiche, talora definite come new mode of governance e talaltra come
“intergovernamentalismo deliberativo” (Puetter, 2012).
Cominciamo dal caso della politica estera e di sicurezza (PESC). L’art. 24, comma 1, del
TEU è esplicito nell’affermare che «l’adozione di atti legislativi è da escludere». Pur introducendo l’importante innovazione di un alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza
che presiede permanentemente (per 5 anni) il Consiglio per gli Affari esteri costituito dai ministri corrispondenti degli Stati membri (l’unica formazione del Consiglio sottratta alle presidenze semestrali) ed è contemporaneamente vicepresidente della Commissione, il Trattato di
Lisbona non ha modificato la logica intergovernativa celebrata dal Trattato di Maastricht per
la politica estera (e allora protetta da uno specifico pilastro istituzionale). Il coordinamento
dovrà avvenire (art. 25, TEU) attraverso decisioni costituite di “azioni” e “posizioni” che, una
volta assunte, gli Stati membri si impegnano “volontariamente” a rispettare.
In questo regime decisionale, la Commissione, attraverso il suo vicepresidente, dovrà assolvere una funzione di supporto tecnico del Consiglio Affari esteri, ma non potrà
esercitare alcuna funzione politica (che spetta al Consiglio europeo). Allo stesso tempo,
il Parlamento europeo dovrà essere consultato, ma non gli è consentito di esercitare alcun ruolo di controllo e bilanciamento. E poiché la PESC procede attraverso decisioni,
e non atti legislativi, la Corte europea di giustizia è esclusa dall’esercitare qualsivoglia
supervisione (Smith, 2008).
Grafico 4.2 – Il versante intergovernativo dell’UE: politica estera
>
Presidente del Consiglio europeo
<
Alto rappresentante politica estera
Presidente della Commissione
<
>
<
PE
<
Vicepresidente
Corpo diplomatico europeo <
<
<
<
> Consiglio Affari esteri <
Rappresentanza permanente
157
Ciò vale ancora di più per l’UEM che aggrega gli Stati membri dell’eurozona. Le decisioni spettano unicamente al Consiglio dei ministri, che potrà raccomandare l’adozione di
particolari misure correttive da parte di uno Stato membro, anche se l’art. 126, comma 6,
del TUE riconosce alla Commissione un ruolo importante nell’attivare le procedure per
i deficit di bilancio eccessivi da parte di uno Stato membro. In ogni caso, la Commissione può fare una “proposta” non già avanzare una “raccomandazione”. Spetta di nuovo al
Consiglio per gli Affari economici e finanziari (Ecofin), cioè alla sua discrezionalità politica, decidere se procedere o meno in conformità con le proposte della Commissione.
Ciò vale anche per le misure che riguardano gli Stati membri dell’eurozona (Titolo VIII,
Capitolo 4), con la conferma del ruolo decisionale dell’Eurogruppo (Puetter, 2006), cioè
del gruppo dei ministri finanziari dell’eurozona.
La politica economica e monetaria celebrata dal Trattato di Lisbona si basa principalmente su misure di coordinamento volontario tra gli Stati membri. Con il risultato
che il Trattato di Lisbona ha centralizzato, con l’euro, la gestione della moneta comune
(attraverso il ruolo federale della Banca centrale europea) e contemporaneamente ha decentralizzato negli Stati dell’eurozona tutte le politiche (fiscali e di bilancio) collegate alla
moneta comune. Sia il Patto di stabilità e crescita (che riguarda tutti gli Stati membri) sia
le misure relative all’euro sono decise dal Consiglio Ecofin (e quindi dai ministri finanziari
dell’eurozona, istituzionalizzati nell’Eurogruppo, quando vengono prese decisioni collegate alla moneta comune), con un ruolo di supporto tecnico della Commissione, un ruolo di
controllo molto marginale del Parlamento europeo e un ruolo di supervisione giudiziaria
inesistente da parte della Corte europea di giustizia (Grafico 4.3).
Grafico 4.3 – Il versante intergovernativo dell’UE: la politica finanziaria
Euro
Summit
>
Informa
>
Parlamento
europeo
>
Euro
Gruppo
>
Consiglio dei ministri
Raccomanda
Consiglia
>
Comitato dei
rappresentanti
permanenti
Consiglio europeo
Commissione
Banca centrale
europea
Insomma, già a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 fu formalmente stabilito che la
politica economica e finanziaria dell’UE venisse definita e regolata all’interno di un regime
decisionale di tipo intergovernativo. Dopo tutto, con la bocciatura del Trattato costituzionale nei referendum popolari tenutisi in Francia e in Olanda nel 2005, la logica intergovernativa è sembrata essere l’àncora di salvezza per il più generale processo di integrazione.
158
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
Quest’ultima, era divenuta opinione comune, avrebbe potuto procedere solamente attraverso la direzione dei governi nazionali, organizzati all’interno del Consiglio europeo dei
capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Unione e finalmente coordinati da un
presidente permanente, oltre che rappresentati dai loro ministri all’interno del Consiglio.
Per di più, visto che la spinta della storia aveva condotto l’Unione a occuparsi delle politiche tradizionalmente connotanti la sovranità nazionale degli Stati membri (come la politica estera e la politica finanziaria, oppure le politiche elettoralmente sensibili come quella
dell’occupazione o del welfare), nessuno mise mai in discussione la decisione di promuovere, in quelle politiche, un modello integrativo basato sul “coordinamento volontario” delle
politiche nazionali (Heritier e Rhodes, 2010). Ovvero un modello necessariamente privo
di vincoli sovranazionali sugli Stati membri (Allerkamp, 2009).
Ecco perché si può argomentare che il Trattato di Lisbona abbia istituzionalizzato un
doppio modello costituzionale. Per quanto riguarda la gestione delle politiche pubbliche
collegate al mercato comune, il Trattato di Lisbona ha previsto un modello di costituzione “sovranazionale” di tipo genericamente federale. Tale costituzione sostiene e giustifica
un “sistema di governo”, connotato da una (pur contraddittoria, come argomenterò
in seguito) separazione dei poteri tra le quattro istituzioni che partecipano al processo
decisionale (un esecutivo duale costituito dal Consiglio europeo e dalla Commissione
e un legislativo bicamerale costituito dal Parlamento europeo e dal Consiglio). E con il
Consiglio europeo e il Parlamento europeo che sono emersi come le istituzioni più forti.
Allo stesso tempo, per quanto riguarda le politiche storicamente sensibili per la
sovranità nazionale (come la politica economica e finanziaria o la politica estera e di
sicurezza), il Trattato di Lisbona ha istituzionalizzato un modello di costituzione “intergovernativa” di tipo genericamente confederale. Tale costituzione sostiene e giustifica un
“sistema di governance”, piuttosto che di government, connotato dalla centralizzazione
della decisione nelle due istituzioni (il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri) che
rappresentano i governi degli Stati membri dell’Unione.
4.4
La crisi dell’euro e l’integrazione intergovernativa
I dilemmi dell’integrazione intergovernativa
La crisi finanziaria, esplosa in Europa proprio a cavallo dell’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, ha rappresentato (sul piano istituzionale) il primo test sulle capacità di governance
della costituzione intergovernativa. Il test ha dato un esito ampiamente insoddisfacente.
Come previsto dal Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo è risultato essere il vero e proprio centro decisionale delle politiche di risposta alla crisi finanziaria, con la Commissione
ridimensionata ad esercitare un ruolo di supporto tecnico nei suoi confronti o un ruolo di
implementazione delle decisioni prese dai governi nazionali all’interno del Consiglio europeo o dai loro ministri finanziari all’interno dell’Ecofin. La costituzione intergovernativa
non è riuscita a risolvere in modo soddisfacente tre basilari dilemmi del processo di inte-
159
grazione: il dilemma del potere di veto, il dilemma del rispetto degli accordi, il dilemma
della legittimazione delle decisioni. Vediamo meglio perché (Fabbrini, 2013).
Se l’integrazione si basa sul coordinamento tra politiche nazionali, ovvero sul principio dell’unanimità nelle decisioni, allora non può sorprendere che ogni decisione (per
rispondere alla crisi dell’euro) abbia richiesto molto tempo. Dopo tutto, all’interno del
Consiglio europeo vi erano capi di governo e di Stato che rappresentavano interessi economici diversi, quelli degli Stati “creditori” del Nord e quelli degli Stati “debitori” del Sud
dell’Europa, così come all’interno di quel Consiglio si sono scontrate strategie differenti di
economic governance (neo-monetarista quella tedesca e neo-keynesiana quella francese). Se
le decisioni debbono essere prese all’unanimità, allora è inevitabile che chi non è d’accordo
o in minoranza attivi i propri poteri di veto per rallentare il processo decisionale. Come si
neutralizzano i poteri di veto in processi decisionali che richiedono il consenso unanime
dei partecipanti? La costituzione intergovernativa non ha saputo come rispondere.
Allo stesso tempo, quella crisi si è amplificata in Europa perché la costituzione intergovernativa non poteva rispondere in modo soddisfacente anche al dilemma del rispetto
degli accordi. Se la politica finanziaria o fiscale o di bilancio si basano sul coordinamento
volontario tra gli Stati membri, allora è possibile che uno Stato membro decida di non applicare una decisione presa volontariamente, se quella applicazione non è più conveniente
per le fortune del governo in carica. Se viene affidata agli Stati membri l’implementazione
della politica di convergenza con i criteri del Patto di stabilità e crescita, allora è difficile
controllare il cheating (l’imbroglio) rispetto agli impegni presi sottoscrivendo quel Patto. Il
non-rispetto degli impegni non ha riguardato solo la Grecia. Basti pensare che gli impegni
del Patto di stabilità e crescita erano stati già disattesi, nel 2003, dalla Germania e dalla
Francia e ciò non aveva portato a nessuna penalità nei loro confronti (Heipertz e Verdun,
2010). Perché stupirsi che un piccolo Stato non rispetti impegni che neppure gli Stati
più grandi avevano rispettato, anche se nel caso della Grecia il non-rispetto degli impegni ha avuto le caratteristiche di una manipolazione dei dati macroeconomici mentre nel
caso degli altrui due paesi ebbe le caratteristiche della richiesta esplicita di essere esonerati
dal rispetto dei parametri stabiliti? Il non-rispetto degli impegni è un problema che può
raggiungere una dimensione drammatica in un sistema altamente interdipendente come
l’eurozona. Con la moneta comune, ogni scelta o non-scelta di uno Stato dell’eurozona si
esternalizza agli altri membri dell’eurozona, creando effetti finanziari difficilmente neutralizzabili (Dyson, 2008). Di nuovo, la costituzione intergovernativa non ha potuto fornire
gli strumenti istituzionali o di policy per contenere quegli effetti. Tant’è che solamente la
Banca centrale europea, cioè un’istituzione federale, ha potuto agire con efficacia per neutralizzare la speculazione finanziaria nei confronti dell’euro.
E, infine, un processo decisionale intergovernativo, in condizioni di crisi esistenziale
come quello dell’euro, ha fatto emergere una gerarchizzazione all’interno del Consiglio
europeo, con la formazione di un “direttorio” tedesco-francese nella politica finanziaria
dell’Unione, divenuto quindi esclusivamente tedesco a partire dal 2012. Dopo tutto, se
le decisioni sono prese esclusivamente dai capi di governo all’interno del Consiglio europeo, o dai ministri finanziari, all’interno dell’Ecofin, è evidente che alcuni paesi pesano
più di altri. Così la forza economica e la coesione politica della Germania hanno finito
160
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
per imporre le esigenze di questo paese su quelle di altri paesi. Per di più, la Germania
è stata portatrice, sin dall’inizio della crisi finanziaria, di una precisa visione di politica
monetaria, in base alla quale la crisi avrebbe potuto essere risolta solamente con politiche
recessive in grado di ridurre l’indebitamento pubblico. Politiche, per di più, incardinate
su inflessibili regolamentazioni giuridiche. Tale visione ha assunto le caratteristiche di
una vera e propria ideologia monetaria, l’ideologia dell’establishment finanziario del paese e in particolare della sua Banca centrale, probabilmente ancora in sofferenza per il
ridimensionamento che ha dovuto registrare con la nascita della Banca centrale europea
(Lacroix e Nicolaidis, 2010).
Fatto si è, comunque, che, all’interno di un organismo intergovernativo, è abbastanza
inevitabile che si istituzionalizzino logiche gerarchiche, che il più forte possa imporsi sul
più debole. Per di più la Francia, con il suo enorme apparato pubblico e con un’economia
bloccata da diversi vincoli statali e corporativi, non era nelle condizioni di riequilibrare
il peso della Germania. Anzi, il timore di perdere la solidarietà di quest’ultima ha spinto
la Francia ad accettare buona parte della ideologia cosiddetta “ordo-liberale” dei tedeschi
(cioè costituita di un monetarismo imposto da regole). Perché stupirsi che tale direttorio
sia stato quindi risentito dai cittadini dei paesi “debitori”, i quali si sono trovati a subire le
conseguenze di politiche decise da capi di governo che essi non avevano votato?
La risposta ai dilemmi intergovernativi
È proprio per rispondere a tali dilemmi che, all’interno della costituzione intergovernativa,
si è verificata una successione senza precedenti di decisioni di grande rilevanza istituzionale
e politica, tra il 2010 e il 2012, per gestire la crisi finanziaria (crisis management) e per prevenirla nel futuro (crisis prevention). Il risultato è stato la formazione di un’Unione intergovernativa sempre più integrata ma anche sempre più accentrata. Almeno quattro round di
decisioni debbono essere ricordati.
Il primo round si è svolto nel 2010. Nell’Ecofin del maggio di quell’anno fu adottata una regolamentazione per istituire lo European Financial Stability Mechanism (EFSM)
come un nuovo strumento legale sulla base del quale è stato possibile dare vita allo European Financial Stability Facility (EFSF), al di fuori del framework legale dell’UE, come lo
strumento finanziario transitorio per aiutare l’Irlanda e il Portogallo ad affrontare la crisi
del debito sovrano. Nel settembre dello stesso anno l’Ecofin approvò il Semestre europeo,
per rafforzare la convergenza delle politiche di bilancio degli Stati membri dell’UE, così da
renderli coerenti con i parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita. Il Semestre europeo è entrato quindi in vigore nel gennaio 2011. Se l’EFSF era uno strumento di gestione
della crisi, il Semestre europeo era uno strumento di prevenzione della crisi.
Il secondo round ha avuto luogo nella prima metà del 2011. Tra il Consiglio europeo
del 24-25 di marzo e il Consiglio europeo del 23-24 giugno di quell’anno furono prese
diverse misure legislative, a cominciare dal cosiddetto Six Pack, misure finalizzate a centralizzare ulteriormente il coordinamento delle politiche di bilancio in coerenza con il
Semestre europeo e il Patto di stabilità e crescita. Le misure di questo pacchetto legislativo sono entrate quindi in vigore nel dicembre 2011. Sempre in questo periodo fu ap-
161
provato l’Euro Plus Pact, una sorta di accordo intergovernativo tra gli Stati dell’eurozona
e alcuni paesi esterni a quest’ultima (Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia, Bulgaria e
Romania), il cui scopo è quello di accentuare ulteriormente il coordinamento delle loro
politiche economiche. I firmatari dell’Euro Plus Pact si impegnarono, attraverso scelte
concrete, a realizzare una serie di riforme strutturali finalizzate a migliorare la competitività delle loro economie e a rafforzare le loro capacità fiscali.
Il terzo round si è svolto nella seconda metà del 2011 e nei primi mesi del 2012. Nel
luglio 2011 venne firmata una prima versione di un trattato intergovernativo nominato
come European Stability Mechanism (ESM), trattato quindi rinegoziato e ridefinito dal
luglio di quell’anno al settembre dell’anno successivo, il cui compito era quello di prendere
il posto dello EFSF, divenendo uno strumento finanziario permanente per il sostegno
ai paesi dell’eurozona oggetto della speculazione finanziaria sul proprio debito sovrano.
Anche l’ESM fu collocato all’esterno del sistema legale del Trattato di Lisbona, sulla base
di una decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 che ha emendato l’art. 136 del
TFUE per consentire agli Stati membri dell’eurozona di istituire meccanismi di stabilità
finanziaria per salvaguardare la moneta comune. Avendo dovuto attendere la decisione
della Corte costituzionale tedesca sulla congruità dell’ESM con la costituzione tedesca, decisione (positiva) finalmente giunta con la sentenza del 12 settembre 2012, l’ESM è entrato
infine in vigore nel gennaio 2013 (si veda il riquadro Il Trattato dell’ESM).
Il Trattato dell’ESM
Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo concordò un emendamento al TFUE, art. 136.
L’emendamento autorizzava gli Stati membri dell’eurozona a istituire uno specifico European Stability Mechanism o Trattato dell’ESM. Il Trattato fu poi sottoscritto dai 27 stati
membri dell’UE. Con questo Trattato si è costituita un’organizzazione internazionale con
sede in Lussemburgo che fornisce assistenza finanziaria agli Stati dell’eurozona che sono
in difficoltà finanziarie. L’ESM è diventato definitivamente operativo, dopo diverse e prolungate negoziazioni, il 27 settembre 2012 e funziona come firewall finanziario permanente
con una capacità massima di aiuto di €500 miliardi. L’ESM sostituisce i due precedenti e
temporanei programmi di finanziamento: European Financial Stability Facility (EFSF) e
l’European Financial Stabilization Mechanism (EFSM). Tutte le nuove richieste di aiuto da
parte degli Stati dell’eurozona, collegate a necessità di stabilità finanziaria, dovranno essere
sottoposte all’ESM, mentre l’EFSF e l’EFSM continueranno a gestire il monitoraggio dei
precedenti prestiti assegnati all’Irlanda, al Portogallo e alla Grecia. L’ESM è diretto da un
Board of Directors che prende decisioni a maggioranza qualificata (dell’80% delle quote
correlate al contributo di ogni singolo Stato firmatario del Trattato). Poiché la Germania
beneficia di più del 27% delle quote, sarà dunque impossibile che il Board possa prendere
decisioni contro il parere di quel paese.
Nella seconda metà del 2011 furono prese altre cruciali decisioni, in particolare nel Consiglio europeo dell’8-9 dicembre di quell’anno. In quel Consiglio, il governo tedesco e il
governo francese proposero di emendare il Trattato di Lisbona per integrare le politiche
162
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
fiscali degli Stati membri, con l’introduzione di sanzioni automatiche verso quegli Stati
membri che non rispettano i criteri divenuti ancora più severi del riformato Patto di
stabilità e crescita: cioè la percentuale dello 0,5% per quanto riguarda il rapporto tra
deficit pubblico PIL e la percentuale del 60% quanto riguarda il rapporto tra debito
pubblico e PIL. Per quegli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60% fu
proposto di ridurre di 1/20 ogni anno la differenza positiva tra il rapporto debito pubblico/PIL e il limite del 60%. Fu infine proposto che gli Stati membri introducessero a
livello costituzionale o di legge di equivalente importanza la regola d’oro del pareggio
di bilancio. Tuttavia, l’opposizione della Gran Bretagna all’integrazione fiscale (motivata
dalla difesa degli interessi finanziari della City of London) bloccò la proposta di emendamento del Trattato di Lisbona (che avrebbe richiesto, appunto, l’unanimità). Di fronte
alla posizione britannica fu dunque deciso di formalizzare quelle proposte in un nuovo
Trattato intergovernativo, esterno al Trattato di Lisbona, a cui fu dato il nome di Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria, più
noto come Fiscal compact. Un Trattato, quest’ultimo, firmato da 25 dei 27 stati membri
dell’UE (si veda il riquadro Il Trattato del Fiscal compact).
Il Trattato del Fiscal compact
Il Trattato del Fiscal compact è un Trattato intergovernativo firmato il 2 marzo 2012 da
tutti gli Stati membri dell’UE, eccetto la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca. Il Trattato
richiede ai suoi firmatari di introdurre leggi di natura costituzionale o equivalente per
garantire che i bilanci pubblici siano in pareggio o in surplus. Tali leggi debbono avere
natura costituzionale proprio per attivare meccanismi di auto-correzione per prevenire il
non-rispetto dell’accordo. Il Trattato definisce come bilancio in pareggio quello che ha un
deficit pubblico di meno del 3% del PIL e un deficit strutturale di meno dello 0,5 o dell’1%
del PIL, a seconda del rapporto tra debito pubblico e PIL del paese firmatario. Se il deficit
strutturale supererà il limite, allora il paese in questione dovrà introdurre immediati correttivi sulla base dei tempi, degli obiettivi e degli interventi stabiliti dalla Commissione. Il
Trattato pone ogni stato firmatario sotto la giurisdizione della Corte europea di giustizia
che potrà comminare a quello che non rispetta l’accordo una penalità finanziaria che può
giungere fino all’0,1% del suo PIL.
Il quarto round si è infine sviluppato tra il Consiglio europeo del 27-28 giugno e il
Consiglio europeo del 13-14 dicembre del 2012. Se l’agenda del Consiglio europeo di
giugno si era centrata sul rigore fiscale, tuttavia aveva aperto la strada al riconoscimento
dell’importanza della crescita, tanto che l’agenda del Consiglio europeo di dicembre si
era finalmente posta il problema della crescita economica. Tale cambiamento di priorità
di politica economica fu dovuto anche all’azione del governo italiano di Mario Monti,
nominato il 16 novembre 2011 e rimasto in carica fino al 21 dicembre 2012. Inoltre, sulla
base di un Rapporto dei quattro presidenti (del Consiglio europeo, della Commissione,
della Banca centrale europea e dell’Eurogruppo) sulla creazione di una “genuina unione
163
economica e monetaria”, il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha avviato la formazione di un’Unione bancaria, definendo le grandi linee di un Meccanismo di Supervisione delle principali banche sistemiche dell’eurozona. Anche in questo caso, tuttavia,
le resistenze della Germania si rivelarono sufficientemente “persuasive” per edulcorare
gli obiettivi del Rapporto, obiettivi finalizzati a sottoporre a supervisione, da parte della
Banca centrale europea, l’intero sistema bancario dell’eurozona. L’esito di questa sequenza straordinaria di decisioni è un’eurozona fortemente integrata sul piano delle politiche
finanziarie, di bilancio e di politica economica, un’integrazione così stretta che non ha
paragoni in nessun paese federale a democrazia consolidata (come gli Stati Uniti, la Svizzera, la Germania, l’Austria, l’Australia, il Belgio o il Canada).
4.5
Accentramento senza efficacia e legittimità
Per rispondere ai dilemmi della logica intergovernativa, l’UE (e in particolare l’eurozona)
ha dovuto dunque mettere in campo una mole impressionante di decisioni e istituzioni
che hanno portato ad un vero e proprio avvitamento del processo di integrazione. Un avvitamento che, se ha spinto verso una maggiore integrazione dell’eurozona, l’ha fatto senza
garantire né l’“efficacia” né la “legittimità” delle decisioni prese e delle istituzioni create.
Siccome la logica intergovernativa non può dare una risposta soddisfacente ai dilemmi
dell’integrazione intergovernativa, il risultato è consistito in una moltiplicazione di Trattati intergovernativi, come l’ESM e il Fiscal compact. Gli obiettivi che si è cercato di raggiungere con quei Trattati avrebbero potuto essere conseguiti con strumenti di già previsti
dal Trattato di Lisbona (come le cooperazioni rafforzate) ovvero con un’estensione della
costituzione sovranazionale ai settori della politica economica e finanziaria (come era avvenuto con l’approvazione del Six Pack con cui si è irrobustito il sistema di coordinamento
del Patto di stabilità e crescita). Però, l’integrazione intergovernativa non consentiva queste possibilità. Così, poiché l’unanimità è necessaria per emendare il Trattato di Lisbona, è
stato sufficiente il veto di uno o due stati membri (Gran Bretagna e Repubblica Ceca) per
bloccare la riforma della politica fiscale, obbligando così gli altri 25 stati membri a dare vita
al Fiscal compact. Così, per evitare la possibilità che uno Stato membro potesse poi votare
contro l’approvazione del Fiscal compact (in un referendum popolare o in parlamento), si
è deciso che esso potrà entrare in vigore il 1° gennaio 2013 (come è avvenuto) a condizione
che venisse approvato solamente da 12 (e non già da tutti i 25) degli Stati contraenti. Così,
per non correre il pericolo corso dal Trattato di Lisbona, bloccato da un piccolo paese
(l’Irlanda) per più di un anno, venne deciso che lo Stato membro che avesse votato contro il Fiscal compact non avrebbe potuto beneficiare della copertura finanziaria garantita
dall’ESM in caso di speculazione nei confronti del suo debito sovrano.
Così, per prevenire la possibile reazione negativa delle opinioni pubbliche degli Stati
membri più forti (come la Germania) nei confronti dell’ESM, si decise che il Fiscal compact imponesse, agli Stati contraenti, di introdurre nelle loro costituzioni la regola d’oro
del pareggio di bilancio, con la conseguenza che il suo non-rispetto attiverà automaticamente l’azione della corte costituzionale di quel paese. Con il Fiscal compact sono stati
introdotti meccanismi automatici di intervento sugli Stati membri che non rispettano
164
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
i parametri stabiliti, meccanismi attivabili dalla Commissione europea o da qualsiasi
altro Stato membro che ha aderito al Trattato. In tutti e due i casi, si fa ricorso alla Corte europea di giustizia che può comminare multe salate agli Stati inadempienti. Così,
per evitare il ripetersi della vicenda del 2003 (quando la Germania e la Francia furono
esonerate dai costi del non-rispetto del Patto di stabilità e crescita con una decisione
dell’Ecofin) o ancora per evitare esperienze come quella recente del Grecia, si è deciso di
ridurre al minimo la discrezionalità degli stessi organismi intergovernativi (Consiglio europeo e Consiglio dei ministri), di rafforzare la capacità di controllo sugli Stati membri
della Commissione europea e di trasformare la Corte europea di giustizia in una sorta di
tribunale amministrativo che commina sanzioni finanziarie agli Stati inadempienti sulla
base di regole giuridiche che non potranno tenere in considerazione la realtà economica
del momento. Siccome i governi nazionali non si fidano l’uno dell’altro, allora si è costruito un sistema iper-centralizzato intorno a regole di politica economica trasformate
in un ordine legale.
Dunque, i nuovi Trattati, ma in particolare il Fiscal compact, hanno introdotto innovazioni importanti nel sistema intergovernativo di economic governance. Non è più
necessaria l’unanimità per la sua entrata in vigore oppure sono stati rafforzati i poteri di
istituzioni terze (come la Commissione e la Corte europea di giustizia) per fare rispettare
“automaticamente” gli accordi presi dagli Stati contraenti (automatismo che potrà essere
neutralizzato solamente dal voto contrario della maggioranza dell’Ecofin).
Tali innovazioni, però, sollevano a loro volta problemi giuridici e politici non di
poco conto. È accettabile, ad esempio, che istituzioni costituite all’interno di un preciso sistema normativo (come il Trattato di Lisbona) siano utilizzate per fare funzionare
un diverso sistema normativo (i Trattati intergovernativi) di cui fanno parte non tutti
gli Stati membri che hanno dato vita al precedente sistema normativo? Se il Trattato
Lisbona consente questa possibilità nel caso della Corte europea di giustizia (TFUE,
art. 273, autorizza la Corte a risolvere una disputa tra stati che, all’interno di un accordo
speciale, decidessero di sottomettersi alla sua decisione), il ricorso alla Commissione (o
alla stessa Banca centrale europea) potrebbe rivelarsi politicamente più insidioso. Infatti,
nella Commissione vi sono commissari scelti dagli Stati membri che non hanno aderito
a quei Trattati (come la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca). È vero che i commissari
scelti dagli Stati membri dell’UE non dovrebbero avere alcun rapporto formale di accountability verso questi ultimi, tuttavia è anche vero che una Commissione costituita di
un commissario per stato membro ha finito per riflettere anche i punti di vista nazionali.
Insomma, la logica intergovernativa ha portato l’UE a rispondere all’esigenza di
garantire l’efficacia delle proprie decisioni (in modo che esse non siano too late, too little)
attraverso un accentramento regolativo che non ha precedenti. La decisione è affidata al
rispetto delle regole, non già alla responsabilità della politica. Ma le regole non possono
sostituire la logica della politica, le regole seguono una loro congruenza interna che non
necessariamente è correlata all’esigenza di rispondere alle sfide esterne. Ma se l’integrazione intergovernativa non può funzionare sul piano dell’efficacia delle decisioni, ancora
di meno può soddisfare l’esigenza di garantire la loro legittimità.
165
I nuovi Trattati, proprio per la loro natura intergovernativa, non hanno risolto, e
non potevano risolvere, i problemi della legittimazione delle decisioni prese dagli e negli
organismi intergovernativi (del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri). Infatti,
quelle decisioni sono state prese e continuano ad essere prese escludendo il Parlamento
europeo, l’istituzione che rappresenta gli elettori che dovranno farsi carico materialmente degli effetti di quelle decisioni. Come si può pensare che siano legittime decisioni
prese all’interno di un club intergovernativo?
Certamente, non sono mancate dichiarazioni di leader governativi che hanno sostenuto che essi potevano prendere quelle decisioni perché legittimati dai loro elettorati nazionali2. Tali dichiarazioni sono prive di logica, prima ancora che infondate. Gli
elettorati nazionali hanno scelto i loro governi nazionali per prendere decisioni nazionali. Ma quando quei governi agiscono a Bruxelles, essi prendono decisioni che hanno
implicazioni per gli elettorati di altri paesi, e non solamente per il proprio elettorato.
La legittimità non si trasferisce dal livello nazionale a quello europeo. Le decisioni prese a livello europeo richiedono di essere legittimate da istituzioni rappresentative degli
elettorati europei (come, appunto, il Parlamento europeo), mentre le decisioni prese a
livello nazionale richiedono di essere legittimate da istituzioni rappresentative degli elettorati nazionali (come, appunto, i parlamenti domestici). Anzi, con l’europeizzazione
delle politiche a Bruxelles, si è indebolito drammaticamente la capacità di controllo dei
parlamenti nazionali sui rispettivi governi nazionali, senza che tale indebolimento venisse compensato da un rafforzamento della capacità di controllo del Parlamento europeo
sui governi nazionali che operano all’interno degli organismi intergovernativi dell’UE.
Per di più, come è avvenuto nel corso della crisi dell’euro, le decisioni intergovernative sono strutturalmente esposte alla pressione degli Stati membri più grandi e più
forti, con il risultato che all’interno degli organismi intergovernativi si riproducono necessariamente gerarchie tra stati membri che sono poco o punto coerenti con lo spirito
con cui si era avviata l’integrazione continentale a Parigi nel 1952 e a Roma nel 1957.
Insomma, come si può considerare legittima una decisione presa su pressione di uno
Stato membro forte ma i cui effetti ricadranno sui cittadini degli altri Stati membri che
non hanno eletto (evidentemente) i governi di quelli più forti?
4.6
Il futuro dell’Unione europea: due prospettive
L’involuzione intergovernativa dell’Unione europea sta sottoponendo quest’ultima ad
una tensione preoccupante. Già ora, l’inefficacia delle decisioni intergovernative e il
metodo con cui sono state raggiunte hanno generato sconquassi strutturali e malessere
sociale diffusi. Le divisioni tra gli Stati membri dell’Unione si sono accentuate come mai
era avvenuto nel passato, contrapponendo stati “debitori” e “creditori” indipendentemente dalle loro coalizioni di governo. La Germania, guidata dalla cristiano-democratica Angela Merkel, e la Spagna, guidata dal cristiano-democratico Mariano Rajoy, si sono
contrapposte sulla base dei loro differenti modelli di political economy, delle loro diverse
organizzazioni finanziarie, dei loro divergenti interessi economici. Ma anche all’interno
dei singoli Stati membri si è drammaticamente accentuata l’insoddisfazione, se non il
166
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
rifiuto, nei confronti dell’Europa integrata. Negli Stati membri più deboli (quelli del
Sud europeo), perché le opinioni pubbliche percepiscono di subire diktat neo-coloniali
da parte degli Stati membri più forti. In questi ultimi (quelli del Nord europeo), perché
le opinioni pubbliche ritengono che il loro aiuto venga richiesto da chi non se lo merita.
L’Unione intergovernativa che ha gestito la crisi dell’euro ci ha dunque lasciato un’Europa debole e divisa, come mai era avvenuto nel passato, anche se paradossalmente più
integrata (per quanto riguarda l’eurozona).
La costituzione intergovernativa del Trattato di Lisbona non ha dato una risposta
soddisfacente alla relazione tra efficacia e legittimazione delle decisioni. Non si può uscire da questa situazione drammatica se non si supera la logica intergovernativa adottata
per la politica finanziaria (e per le altre politiche strategiche dell’Unione). Ma fare ciò
non basta. È il primo passo, ma altri occorre farne. La distinzione tra le responsabilità
dell’Unione e le responsabilità degli Stati membri deve essere più rigorosamente definita.
Ciò vale in particolare per la politica finanziaria. Gli Stati dell’eurozona potranno essere
lasciati “liberi” di fallire a condizione che il loro destino non abbia conseguenze sugli
altri Stati dell’eurozona.
Ci vuole una politica finanziaria dell’Unione distinta da quella degli Stati membri
dell’eurozona. È legittimo imporre regole rigide di pareggio di bilancio (pro-cicliche) in
questi ultimi a condizione, però, che la politica possa esercitare la sua funzione discrezionale (anti-ciclica) a livello dell’Unione. Ciò richiede che l’Unione disponga di risorse finanziarie autonome dagli Stati membri per svolgere la sua azione politica. L’Unione deve
disporre, cioè, di un bilancio che non è dipendente dalla volontà degli Stati membri.
Se si vuole evitare l’esito sconcertante della trattativa intergovernativa sul bilancio
pluriennale dell’UE che si è avuto nel febbraio 2013 (un esito consistente in una riduzione ulteriore delle risorse a disposizione dell’UE così da portarle a meno dell’1% del PIL
complessivo dell’UE), occorre fornire all’Unione fonti autonome di fiscalità. Ovvero
occorre introdurre una tassa federale su tutte le attività che sono rese possibili dall’esistenza dell’UE. Ciò significa che l’Unione dovrebbe dotarsi di un suo Tesoro (e quindi
di un alto rappresentante alla politica finanziaria) con cui sostenere la sua politica. Insomma, occorre rafforzare la “decisione politica” al centro dell’Unione se non si vuole
che quest’ultima deflagri. Che forma istituzionale dovrebbe avere tale decisione politica?
Due diverse prospettive sono da considerare.
Il federalismo parlamentare
Vi è un’opinione predominante che tale forma istituzionale dovrebbe avere le caratteristiche di un federalismo parlamentare, seppure adeguato alle condizioni dell’Unione
(Hix, 2008). Si tratta di andare verso un rafforzamento, “decisionale ed elettorale”, della
Commissione e del suo presidente. La Commissione deve diventare il vero governo
dell’Unione, con il presidente della Commissione che esercita un ruolo comparabile a
quello di un primo ministro. La Commissione dovrà avere l’equivalente di un ministro
o alto rappresentante per gli affari finanziari, con la responsabilità di promuovere interventi coerenti con le richieste degli elettori che hanno dato vita alla maggioranza di
sostegno della Commissione.
167
Il ragionamento è chiaro e familiare. Se il modello intergovernativo non ha funzionato, allora occorre ridurre il potere decisionale acquisito dal Consiglio europeo e dal
suo presidente. Per fare questo, è necessario ricomporre le due presidenze, del Consiglio
europeo e della Commissione, in capo a quest’ultima. Ciò riporterebbe la Commissione
al centro del sistema comunitario (da cui era stata esclusa durante la crisi dell’euro) e,
con essa, si verrebbe a rafforzare il ruolo del Parlamento europeo in quanto istituzione
che legittima (attraverso il suo voto di fiducia o di sfiducia) l’esecutivo comunitario. In
questa prospettiva, i principali partiti politici dovrebbero proporre (come ha già deciso di fare il Partito dei socialisti e dei democratici europei), in occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014, il loro candidato alla presidenza della
Commissione, trasformando di fatto quelle elezioni nell’arena per la scelta del “governo
europeo”. A quel punto al Consiglio europeo e al suo presidente non spetterebbe che
formalizzare una scelta compiuta dagli elettori e istituzionalizzata dai loro rappresentanti
parlamentari. L’UE diventerebbe così l’estensione della democrazia parlamentare propria della maggioranza dei suoi Stati membri, in particolare di quelli connotati anche da
un’organizzazione statale di tipo federale.
Tale strategia di “federalismo parlamentare” ha rappresentato storicamente la bandiera dei federalisti europei. Essa è stata particolarmente condivisa in Italia. A causa sia
delle sue debolezze storiche (come Stato nazionale) che delle sue debolezze costituzionali
(come parlamentarismo debole), l’Italia ha sempre favorito la Commissione rispetto al
Consiglio e poi al Consiglio europeo. Attraverso il sostegno alla Commissione, il nostro
Paese aveva cercato di riequilibrare il peso decisionale degli Stati membri più grandi,
assolvendo al contempo un ruolo di mediazione tra gli interessi di questi ultimi e le
esigenze sovranazionali.
Tuttavia, con il Trattato di Lisbona, l’Unione è andata in un’altra direzione. Certamente il Parlamento europeo si è rafforzato come istituzione, ma tale rafforzamento non
ha implicato la “parlamentarizzazione” dell’Unione. Anzi, più il Parlamento si è rafforzato e più si è rafforzato il Consiglio europeo, de facto prima e de jure dopo quel Trattato.
Così, mentre i sostenitori del federalismo parlamentare continuavano a promuovere la
loro strategia, la “struttura delle relazioni istituzionali” dell’Unione è cambiata radicalmente. La crisi dell’euro poi ci ha messo del suo. Essa ha portato ad un ridimensionamento nella decisione della Commissione, accompagnato però da un suo rafforzamento
nella implementazione delle decisioni prese dal Consiglio europeo. Va capito perché ciò
è avvenuto.
L’Unione ha difficoltà a divenire un federalismo parlamentare per ragioni sistemiche.
L’UE è un’unione di Stati “asimmetricamente” correlati oltre che dei “loro” cittadini. Il
puzzle strutturale che l’UE ha dovuto e deve risolvere (per sopravvivere e consolidarsi) è
il seguente: come tenere insieme stati membri con milioni di abitanti e stati membri con
poche centinaia di migliaia di abitanti.
Parlamentarizzare l’UE significa trasformare il Parlamento europeo nella principale
istituzione per la formazione dell’esecutivo europeo. Le elezioni per il Parlamento europeo dovrebbero decidere chi dovrà guidare la Commissione e quali politiche dovrà
quest’ultima perseguire. Però, questo modello istituzionale non risolve il nostro puzzle,
168
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
in quanto, se nell’Unione viene a contare solamente il Parlamento europeo, è evidente
che gli elettori degli Stati membri più grandi avranno molte più possibilità di contare
degli elettori di quelli più piccoli. E perché questi ultimi (che sono la larga maggioranza
degli Stati membri) dovrebbero rimanere in un’Unione che li vede necessariamente ai
margini del processo decisionale?
Tale modello sarebbe plausibile se l’unica divisione all’interno di tutti gli Stati membri dell’Unione fosse quella tra la “destra” e la “sinistra” e se tale divisione fosse rappresentata da partiti politicamente omogenei sia sull’uno sia sull’altro versante. Ma così non
è (e non potrebbe essere). In un’unione di Stati, oltre alle divisioni ideologiche, contano
anche (se non soprattutto) le divisioni tra stati o tra aree regionali. Inoltre, le storie
diverse degli Stati membri, i loro differenti potenziali economici, le loro differenziate
proiezioni culturali rendono poco o punto probabile che la divisione tra destra e sinistra
possa imporsi su tutte le altre. E, comunque, se il potere della Commissione è stato ridimensionato a favore del Consiglio europeo, portare la Commissione sotto il controllo
del Parlamento europeo non risolve la questione della legittimità della decisione: è come
chiudere la stalla quando i buoi sono già usciti. Ma se così è, quale è allora una strategia
realistica da perseguire per affrontare la sfida di cui sopra?
La separazione dei poteri
Per rispondere occorre adottare un nuovo paradigma istituzionale, quello dell’Unione
come un sistema funzionante secondo una logica di “separazione dei poteri”. Dopo tutto, per ragioni strutturali, l’Unione ha dovuto combinare istituzioni sovranazionali con
istituzioni che rappresentano i governi nazionali, così da tenere in equilibrio le esigenze
degli Stati (senza il sostegno dei quali l’integrazione non può procedere) con le esigenze
dei cittadini (che costituiscono una necessaria fonte di legittimità). È impensabile che in
Europa si costituisca uno “Stato federale” che sostituisca i vecchi Stati nazionali. Piuttosto, l’Europa sovranazionale si è indirizzata verso la formazione di un’“unione federale”
basata su Stati e cittadini, un’unione “composita”, istituzionalmente organizzata intorno
a un quadrilatero di istituzioni reciprocamente separate.
Per quanto riguarda il potere legislativo, il suo bicameralismo ha consentito di tenere
in equilibrio gli Stati e i cittadini. Il Consiglio dei ministri ha sovra-rappresentato gli
Stati membri di piccole e medie dimensioni (con il criterio di voto della maggioranza
qualificata), mentre il Parlamento europeo ha riflettuto un rapporto più proporzionale
con la popolazione degli Stati membri (moderandolo, però, con il criterio della degressive
proportionality, in base al quale lo Stato più grande non può avere più di 96 e lo Stato più
piccolo meno di 6 rappresentanti). Il potere legislativo separato ha mantenuto, tuttavia,
alcune incongruenze. Ad esempio, se il Consiglio dei ministri è un’istituzione preminentemente legislativa “in quanto” camera di rappresentanza degli Stati membri (ovvero dei
loro esecutivi secondo il modello del Bundesrat tedesco), allora il Segretariato generale
del Consiglio (una sorta di presidenza del senato) non dovrebbe assolvere la funzione di
supporto del Consiglio europeo (che è un organismo esecutivo). Né tanto meno l’alto
rappresentante per la politica estera e di sicurezza (che è il vicepresidente della Com-
169
missione) dovrebbe continuare a presiedere il Consiglio Affari esteri (che è l’equivalente
funzionale del comitato affari esteri di un senato).
Allo stesso tempo, l’Unione, con il Consiglio europeo e la Commissione, ha acquisito un potere esecutivo duale, con i loro due presidenti che rappresentano “le due facce
di un Giano bifronte”.
Tale potere esecutivo duale è una garanzia degli equilibri inter-statali in quanto
consente agli Stati membri di piccole e medie dimensioni di avere un’influenza nelle decisioni relative alla scelta del presidente del Consiglio europeo, influenza che sarebbe più
limitata se la presidenza del Consiglio europeo e della Commissione fossero ricomposte
in quest’ultima e se quindi quest’ultima emergesse dal processo elettorale che stabilisce
la distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo.
Il Consiglio europeo assolve un ruolo strategico all’interno dell’Unione. La sua
istituzionalizzazione è stata una condizione per fare avanzare il processo di integrazione
in ambiti cruciali come la politica finanziaria o la politica estera. Con l’elezione del presidente permanente del Consiglio europeo, quest’ultimo si è irreversibilmente istituzionalizzato. È del tutto plausibile proporre di ricomporre le due presidenze, del Consiglio
europeo e della Commissione, all’interno di quest’ultima. È plausibile ma poco realistico. Quando un’istituzione acquisisce un potere, difficilmente rinuncerà a quest’ultimo.
Durante la crisi dell’euro, il Consiglio europeo e il suo presidente si sono imposti
come l’esecutivo politico dell’Unione, lasciando alla Commissione il compito di implementare le loro decisioni (De Schoutheete e Micossi, 2013). Tuttavia, all’interno del
Consiglio europeo, il suo presidente Herman Van Rompuy ha generalmente agito come
un efficace mediatore, anche se non sono mancate accuse di essere divenuto il portavoce
delle richieste degli Stati membri più forti (in particolare durante il periodo della convergenza tra il francese Nicolas Sarkozy e la tedesca Angela Merkel, il cosiddetto governo
di “Merkozy”).
Come evitare il ripetersi di questa esperienza? Se si riconosce che (ormai) il Consiglio
europeo incarna il versante politico dell’Unione, allora si dovrebbe democratizzarne la formazione piuttosto che negarne il ruolo. L’efficienza del Consiglio europeo sarebbe stata di
gran lunga superiore (rispetto a quella dimostrata nella crisi dell’euro) se il suo presidente
avesse potuto beneficiare di una maggiore autonomia decisionale rispetto ai capi di governo (in particolare dei paesi più forti) che costituiscono il Consiglio europeo.
Nello stesso tempo, la Commissione e il suo presidente avrebbero potuto esercitare
un’influenza maggiore se il loro ruolo istituzionale fosse stato costituzionalmente collegato all’altro versante dell’esecutivo, il Consiglio europeo. Per fare questo, occorrerebbe,
nel primo caso, allargare la base di elezione del presidente del Consiglio europeo e, nel
secondo caso, fare della Commissione europea la vera struttura di supporto del Consiglio europeo (al posto del Segretariato generale del Consiglio). Una chiara definizione
dei ruoli all’interno dell’esecutivo e una altrettanto chiara separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo sono necessari per rafforzare l’efficacia dell’esecutivo duale e i poteri
di controllo del legislativo bicamerale (i soli che possono garantire la legittimità delle
decisioni dell’esecutivo duale). La chiara separazione istituzionale tra il legislativo e l’esecutivo costituisce la condizione per promuovere le rispettive efficacia e legittimazione.
170
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
Il presidente dell’Unione
Se si vuole accentuare l’autonomia decisionale del presidente del Consiglio europeo,
allora è necessario ridurre la sua “dipendenza elettorale” dai membri di quest’ultimo.
La strategia da perseguire potrebbe essere quella del “collegio elettorale”, in quanto le
unioni asimmetriche di Stati hanno difficoltà ad accettare le elezioni popolari dirette
dei capi degli esecutivi che favoriscono gli Stati più grandi a danno di quelli più piccoli
(Fabbrini, 2012). I capi di governo del Consiglio europeo selezionano due candidati per
il ruolo di presidente di quest’ultimo, sulla base di valutazioni che sono insieme territoriali e politiche. I due candidati sono quindi sottoposti al voto di elettori presidenziali
organizzati in collegi elettorali nazionali. Gli elettori presidenziali possono essere votati
dai parlamentari nazionali oppure direttamente dagli elettori nazionali. Il numero degli
elettori presidenziali spettante ad ogni singolo Stato membro è equivalente al numero di
seggi di quello Stato membro al Parlamento europeo. Poiché (come abbiamo visto) i seggi di quest’ultimo sono stati assegnati sulla base del criterio della degressive proportionality (gli Stati più piccoli sono sovra-rappresentati e gli Stati più grandi sotto-rappresentati
rispetto alle rispettive popolazioni), ciò consente di moderare l’asimmetria dell’UE.
I due candidati svolgeranno la loro campagna elettorale presentando il loro programma nei vari parlamenti nazionali o alle opinioni pubbliche dei vari Stati membri.
Verrà eletto presidente del Consiglio europeo il candidato, tra i due proposti, che otterrà
la maggioranza (inevitabilmente assoluta) dei voti degli elettori del collegio elettorale.
Il Consiglio europeo continuerebbe ad incontrarsi periodicamente, come previsto dal
Trattato di Lisbona, ma il presidente non sarebbe più il chairman/woman di quell’istituzione, bensì diventerebbe il “presidente dell’Unione”.
Nello stesso tempo, il vincolo operativo tra il presidente del Consiglio europeo e la
Commissione e il suo presidente dovrebbe essere rafforzato, trasformando questi ultimi
nel vero e proprio braccio operativo del primo, pur mantenendo il suo ruolo neutrale
di civil service europeo con il compito di vigilare che i Trattati e le leggi siano rispettati
(Fabbrini e Micossi, 2012). Spetterà alla Commissione, e non già al Segretariato generale
del Consiglio, preparare i lavori del Consiglio europeo e dare seguito alle decisioni prese
al suo interno.
La procedura di nomina e formazione del presidente della Commissione dovrebbe
rimanere la stessa, rendendo però esplicito che il compito del Parlamento europeo è
quello di approvare (o rifiutare) la proposta del Consiglio europeo e del suo presidente,
non già di eleggere il presidente della Commissione europea (come recita il Trattato di
Lisbona). Quello del Parlamento europeo è, e deve rimanere, un potere di advice and
consent, non già di formazione del governo. Anche gli altri membri della Commissione
dovrebbero passare attraverso l’advice and consent del legislativo: del Consiglio dei ministri, i responsabili (o alti rappresentanti) per la politica estera e di sicurezza e per la
politica finanziaria; del Parlamento europeo tutti gli altri. Non ci dovrà essere nessuna
approvazione politica della Commissione da parte del Parlamento europeo.
Se il Parlamento europeo non sarà obbligato a sostenere l’esecutivo, allora potrà
svolgere con più determinazione la sua funzione di controllo di quest’ultimo. La politicizzazione deve riguardare l’elezione separata del presidente del Consiglio europeo
171
e dei membri del Parlamento europeo. È in queste elezioni che i cittadini avranno la
possibilità di esprimere il loro punto di vista sulle politiche perseguite. È sulla base dei
risultati di quelle elezioni che il presidente eletto del Consiglio europeo potrà proporre
i suoi candidati al ruolo di presidente della Commissione o di alti rappresentanti per la
politica finanziaria ed estera, oltre che agli altri ruoli esecutivi, candidati che poi dovranno essere sottoposti al controllo del Parlamento europeo (emerso dalle elezioni europee)
e del Consiglio dei ministri (espressione degli elettorati nazionali).
Insomma, nelle elezioni del presidente del Consiglio europeo e dei membri del Parlamento europeo i cittadini avranno la possibilità di far sentire la loro voce sulle politiche
da seguire a livello dell’Unione. È nella relazione tra quelle due istituzioni che si dovrà formalizzare la “decisione politica”. Decisione politica che sarà tanto più efficace quanto più
potrà disporre di risorse finanziarie autonome per rispondere alle richieste degli elettori.
Spetterà poi al Consiglio dei ministri, nelle sue specifiche formazioni, e al Parlamento
europeo esercitare un ruolo di controllo sulle scelte dell’esecutivo duale, controllo che sarà
tanto più efficace quanto più le due camere legislative saranno separate da quest’ultimo.
Un esecutivo coeso e diretto chiaramente dal presidente del Consiglio europeo richiede
un controllo e un bilanciamento adeguati da parte del legislativo: da parte del Parlamento
europeo sulle scelte di policy dell’esecutivo e da parte del Consiglio su quelle scelte di policy
sensibili per gli Stati membri (come la politica estera e di sicurezza e la politica finanziaria).
La Commissione manterrebbe il monopolio dell’iniziativa legislativa, anche se quell’iniziativa deriverebbe dalla traduzione operativa di decisioni prese dal Consiglio europeo e
dal suo presidente, in collaborazione con il presidente e i commissari della Commissione.
Sarebbe anche opportuno che il Consiglio europeo venisse rinominato “Presidenza europea”, evitando così fraintendimenti con il Consiglio dei ministri (organo legislativo) e
sottolineando allo stesso tempo il suo ruolo istituzionale (di organo esecutivo).
4.7
Conclusioni
Siamo di fronte ad una vera e propria trasformazione dell’UE. Con la moltiplicazione
dei Trattati che si è verificata, occorre stabilire se l’Unione debba conservare un carattere
unitario ed inclusivo oppure se debba differenziarsi istituzionalmente. Nel primo caso,
la strategia sarà quella di riportare i nuovi Trattati (in particolare il Fiscal compact) all’interno del sistema giuridico dell’UE, magari prima dei cinque anni previsti dai firmatari
del nuovo Trattato. Una volta raggiunto il suo principale obiettivo (quello di fare introdurre per via costituzionale o equivalente negli Stati firmatari la golden rule del pareggio
di bilancio), il Fiscal compact potrebbe rientrare nel Trattato di Lisbona, assumendo le
caratteristiche di una cooperazione rafforzata non dissimile da quella realizzatasi con il
Trattato di Schengen.
Il processo di integrazione continuerebbe ad avere il suo carattere unitario, regolato
da un unico framework legale, con differenziazioni funzionali interne relativamente a
specifiche politiche. Questa strategia ha il merito di tenere unita l’Unione, ma ha anche
il demerito di tenere il processo di integrazione al livello del “minimo” comune denominatore. Ciò potrebbe contribuire ad accrescere l’insoddisfazione verso l’Unione da
172
4. L’Unione europea in cerca di identità politica
parte di chi ne sostiene le ragioni, senza conquistare il consenso di chi invece disconosce
quelle ragioni. Per di più, un Fiscal compact intergovernativo, rientrando nel Trattato di
Lisbona, finirebbe per rafforzare la costituzione intergovernativa di quest’ultimo, creando quindi le condizioni per una nuova insoddisfacente gestione della politica finanziaria.
Insomma, si potrebbe sostenere il disegno di “una sola Unione”, facendo ricorso alla
strategia della cooperazione rafforzata per fare avanzare l’integrazione anche nei campi
della politica finanziaria e della sicurezza. Tuttavia, la realtà fin qui descritta sta mettendo
in discussione questa prospettiva della evoluzione as usual dell’UE.
Di qui, una seconda prospettiva. In questo secondo caso, la strategia sarà quella di
costruire sulla differenziazione istituzionale, non solo funzionale, introdotta dai nuovi
Trattati, il Fiscal compact in particolare. Si creerebbe una distinzione tra l’Unione della moneta comune e l’Unione del mercato comune. Tuttavia, sarebbe paradossale che
quest’ultima funzionasse secondo la logica della costituzione sovranazionale prevista dal
Trattato di Lisbona per il mercato comune, mentre la prima funzionasse secondo la
logica della costituzione intergovernativa prevista dai nuovi Trattati e giustificata dallo
stesso Trattato di Lisbona.
Un paradosso che dovrebbe favorire l’evoluzione del Fiscal compact verso un nuovo
Trattato per l’unione politica costruito intorno ad un modello di separazione verticale
e orizzontale dei poteri, a cominciare dalle modalità di elezione del presidente dell’Euro
Summit, al coinvolgimento della Commissione nell’attività esecutiva, alla ridefinizione
dell’Euro Group in quanto organismo legislativo, al riconoscimento del ruolo di bilanciamento di un Europarlamento nei confronti dell’esecutivo duale.
La formazione di un’unione politica non è, e non dovrà, essere un’alternativa all’attuale mercato comune. Anzi, si tratterà di rafforzare quest’ultimo, allargandolo anche ad
altri nuovi paesi europei che sono o saranno in grado di rispettarne i parametri. L’unione
politica costruita intorno ad una moneta condivisa e la comunità economica costruita
intorno ad un mercato comune possono, e debbono, convivere. Il futuro dell’Europa è in una pluralità di organizzazioni reciprocamente collegate. Dopo tutto, l’Europa
unitaria ha già lasciato il posto ad un’Europa differenziata. Si tratta di dare una forma
giuridica e politica a ciò che già esiste nei fatti, prima che la differenziazione produca
paralisi reciproche e rifiuti anti-europei. Un’Europa in stallo, incapace di andare avanti
verso l’unione politica perché bloccata da chi la intende solamente come un mercato
e contemporaneamente impossibilitata a ritornare indietro alla comunità economica
costruita a Roma nel 1957 perché troppo strutturata per essere un’area di libero mercato,
un’Europa paralizzata è destinata prima o poi ad implodere. Per evitare un esito che
avrebbe conseguenze drammatiche, occorre avere il coraggio di promuovere strategie
innovative per giungere all’unione politica in tempi ravvicinati. Le trasformazioni del
sistema globale non sono compatibili con le incertezze e le ambiguità che continuano a
caratterizzare l’Unione. Se l’Europa non vuole diventare una piccola Svizzera nel sistema
globalizzato, è necessario che essa si differenzi al suo interno per consentire all’eurozona
(più gli altri Stati che vogliono partecipare alla moneta comune) di darsi una propria
precisa identità politica, sia rispetto ai suoi Stati membri che rispetto ai suoi competitori
internazionali.
173
note
1.
È vero che il Parlamento europeo può sfiduciare
l’intera Commissione nel caso in cui quest’ultima, o uno dei suoi membri, violi gli standard
previsti di comportamento appropriato, ma ciò
non equivale ad un voto politico di sfiducia nei
suoi confronti. Allo stesso tempo, è vero che il
Parlamento europeo è tenuto a eleggere il presidente e i membri della Commissione, proposti
dal Consiglio europeo, ma ciò non equivale a
un voto politico di fiducia nei loro confronti.
Piuttosto si tratta di un check sulle decisioni
prese dal Consiglio europeo.
2. È rimasto famoso il discorso tenuto dall’allora
presidente francese, Nicolas Sarkozy, a Tolone il
2 dicembre 2011: «La riforma dell’Europa non è
una marcia verso la sopranazionalità. La crisi
ha spinto i capi di Stato e di governo ad assumersi una maggiore responsabilità perché alla
fine essi hanno la legittimità democratica per
prendere le decisioni… L’integrazione dell’Europa dovrà andare nella direzione intergovernativa perché l’Europa abbisogna di prendere
scelte politiche strategiche (che solamente i capi
di Stato e di governo possono prendere).
175
5
Per l’Italia sprofondata nella crisi
la carta vincente del manifatturiero
Luca Paolazzi*
Crisi, dal greco krisis: momento che separa una maniera di essere da altra differente.
Ottorino Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, 1907
Sommario
5.1 La centralità del manifatturiero – 5.2 Italia in crisi prima della crisi: la perdita di competitività – 5.3 L’Italia perde terreno nel mondo che cambia – 5.4 Il progetto Confindustria per l’Italia:
crescere si può, si deve – 5.5 Conclusioni
L’Italia è finita nella fossa della più grave crisi economica in tempo di pace della sua
storia unitaria. E stenta a uscirne. Le cifre mettono a nudo lo stato di emergenza
(Grafico 5.1).
Tra il 2007, anno di manifestazione dei primi sintomi della crisi finanziaria globale, e
il 2013 il PIL totale italiano è sceso dell’8,3%, tornando ai livelli del 2000. Il PIL per
abitante, misura pur imperfetta del benessere, ha fatto peggio, data la dinamica inaspettatamente positiva della popolazione: -10,1%. È tornato così ai livelli del 1997.
Il manifatturiero è il settore che più sta soffrendo, con la produzione che è scesa del
25,5% in media e alcuni settori di oltre il 40%, dal picco dei primi mesi del 2008. Negli
ultimi sei anni oltre 70mila imprese manifatturiere hanno cessato l’attività e il ritmo
delle chiusure sta salendo.
Gli effetti sull’occupazione sono stati molto marcati, anche se meno che proporzionali rispetto a quelli sul PIL: le unità di lavoro, che tengono conto delle varie misure di
riduzione degli orari lavorati1, sono cadute di 1,4 milioni (-5,5%; quarto trimestre 2007,
quarto 2012). Il numero di persone occupate è calato di 506mila unità (-2,2%), ma con
una fortissima concentrazione tra le fasce di età più basse: -1,7 milioni tra i 15-44enni. I
disoccupati sono raddoppiati a oltre tre milioni.
Per far fronte alla contrazione dei propri bilanci, le famiglie hanno intaccato la propensione al risparmio, che è scesa ai minimi storici. E ridimensionato nettamente gli
acquisti sia di prima necessità (dai 28 chili di pasta a testa nel 2006 ai 26 nel 2011) sia di
beni importanti (nel 2012 le immatricolazioni di autovetture sono scese a livelli non più
osservati dal 1979). La quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale,
già molto elevata, è salita di tre punti, raggiungendo il 28% nel 2011; sicuramente è salita
ulteriormente nel 2012.
* Direttore Centro Studi Confindustria.
176 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
Come è stato possibile tutto questo? Quali sono le prospettive e i rischi che corre il
Paese? Come uscirne?
Grafico 5.1 – Storia di tre grandi recessioni italiane (PIL; dati a prezzi costanti; 1913, 1929 e 2007=100)
Anni dall'inizio delle recessioni
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, ISTAT.
5.1
La centralità del manifatturiero
Prima di rispondere ricordiamo qualche dato che qualifica l’economia italiana nel contesto internazionale. Nonostante la doppia profonda recessione che l’ha duramente colpita, la manifattura italiana sfornava ancora nel 2011 un valore aggiunto che per dimensione era il quinto nel mondo, il secondo in Europa dopo quello tedesco; nello stesso anno
il valore delle esportazioni italiane di manufatti era il settimo nella graduatoria globale;
nell’indice di perfomance nel commercio con l’estero è stata superata nel 2010 solo dalla
Germania, vantando nei grandi raggruppamenti settoriali tre primi posti (contro gli otto
germanici) e tre secondi (contro uno)2.
Questi primati non vengono qui elencati come fiori all’occhiello o medaglie da esibire sul petto e tantomeno, come troppo spesso è stato fatto in questi anni, per sminuire
la portata delle difficoltà e della sfide che il Paese fronteggia. Ma come l’esito di un percorso che è riuscito a fare di necessità virtù.
Questa necessità è ben racchiusa nelle memorabili e pluricitate (ma non per questo meno ignorate nel dibattito pubblico e nelle scelte di politica economica) parole
di Carlo Cipolla: «Se l’Italia vuole prosperare deve esportare. Vendere fuori dai propri
confini non è cosa facile, occorre aguzzare continuamente l’ingegno. Si possono perdere preziosi mercati in tempo breve, soprattutto se l’esportazione ha un basso contenuto tecnologico o non si caratterizza per un’originalità accentuata. Noi dobbiamo
essere pronti a cambiamenti continui. Siamo un popolo che non può permettersi di
177
fermarsi, di accontentarsi di facili successi. Dobbiamo sempre inventare cose nuove
che piacciono»3.
È una necessità che discende da un’ovvia presa d’atto della realtà: l’Italia è povera di
materie prime e deve affidarsi al suo ingegno trasformatore per produrre beni da vendere al resto del mondo, in modo da pagare le proprie bollette relative a tutto ciò che
le occorre importare per garantire benessere e lavoro a chi abita il suo suolo. Perciò la
trasformazione manifatturiera è per l’Italia la fonte primaria della creazione di benessere,
reddito, lavoro e, in quanto dipendenti dai primi, civiltà e democrazia.
Infatti, quando lo standard di vita ristagna, o addirittura arretra, come accade ormai
da un decennio, la società si incattivisce e si mettono in moto meccanismi di rivalsa che
riducono la tolleranza, l’equità, la solidarietà e la mobilità sociale. Ciò può finire con il
minare le stesse basi della democrazia; il degrado del confronto e del dibattito politici in
invettiva e insulto è un sintomo allarmante di ciò4.
La centralità del manifatturiero per lo sviluppo economico è confermata da alcune analisi che evidenziano i seguenti aspetti. Anzitutto, sebbene il peso diretto di
questo settore sul valore aggiunto dell’intera economia italiana si sia ridotto a poco
meno al 16,5% nel 2012 dal 29,6% del 1976), la sua incidenza effettiva, che tiene
conto dell’attivazione indiretta di produzioni di altri settori, è pari al doppio. Se, in
estrema ipotesi, il manifatturiero sparisse dal quadro economico italiano, verrebbero a mancare il 34% del valore aggiunto complessivo e oltre 8,2 milioni di unità di
lavoro.
Questi risultati, per quanto suonino già a clamorosa smentita di quanti con superficialità considerano trascurabile la rilevanza del manifatturiero (proprio sull’assunto
della sua diminuita quota sul PIL e sull’occupazione), rischiano ancora di sottostimare il ruolo svolto da questo settore. Infatti, il dato decisivo è costituito proprio dalla
capacità dell’industria manifatturiera nel rispondere all’esortazione di Cipolla citata
sopra: «Se l’Italia vuole prosperare deve esportare». Nel 2012 il 78,7% del valore dei beni
venduti dall’Italia al resto del mondo era costituito da prodotti manufatti, nei quali è
incluso l’apporto fondamentale di altri settori. Ma senza l’oggetto manufatto (dal paio
di scarpe al collante chimico, da un’autovettura di lusso a un macchinario fabbricato
su specifica del cliente) che fa da supporto al contributo di altri importanti comparti
dei servizi, questi ultimi da soli non riuscirebbero a essere autonomamente presenti sui
mercati esteri.
Senza nulla togliere all’importanza, appunto, dei servizi, anche per la stessa promozione del made in Italy (e in ciò sicuramente svetta il turismo, che ha una valenza sistemica), in mancanza delle esportazioni di manufatti l’Italia sarebbe costretta a ridimensionare nettamente i suoi acquisti dagli altri paesi e quindi ad abbassare sensibilmente
il suo PIL e il suo benessere. Da questo punto di vista, dunque, si può affermare “No
industria? No PIL!”5.
Ma l’importanza del manifatturiero va al di là di quanto può essere descritto
con la forza delle statistiche, seppure spiazzanti la vulgata economica e rivelatrici.
Alcuni elementi di natura qualitativa vanno sottolineati con vigore affinché sia riconosciuta la funzione del manifatturiero come motore della crescita economica, cuo-
178 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
re pulsante dell’intera economia. Infatti, dal manifatturiero originano i guadagni
di produttività, che sono la base per l’innalzamento del benessere (anche in termini
di maggior tempo libero), dell’intero sistema economico, direttamente (essendo il
livello e le variazioni della stessa produttività manifatturiera normalmente superiori
a quelli osservati in altri settori) e indirettamente. Quest’ultimo aspetto va meglio
spiegato.
La manifattura è fonte di conoscenza. Sia perché dalle imprese manifatturiere viene
effettuata la maggior parte della ricerca, di base e applicata. Sia perché lo stesso fare,
cioè il produrre, propone miglioramenti e avanza soluzioni nei processi e nei prodotti.
Per questa ragione, troppo trascurata in passato, i maggiori governi dei paesi avanzati,
a cominciare dagli Stati Uniti, si stanno impegnando al rilancio del proprio manifatturiero e a cercare di rimpatriare, là dove i rapporti di filiera lo consentono, parte delle
produzioni delocalizzate per trarre vantaggio da minori costi del lavoro e ambientali.
Le stesse imprese che meglio stanno fronteggiando le sfide della competizione globale e
delle nuove tecnologie tendono ad ampliare il perimetro della loro azione, integrandosi
a monte e a valle.
Questa conoscenza non rimane confinata dentro il settore manifatturiero, ma si
diffonde all’intero sistema economico per due vie. La prima è costituita dai rapporti tra
imprese: ai fornitori l’industria chiede soluzioni innovative e più efficienti, sul piano dei
costi e su quello della qualità. La seconda è quella del progresso tecnologico direttamente
incorporato nei beni manufatti che vengono utilizzati negli altri settori come strumenti
di produzione. In questo modo, l’innovazione e l’incremento della produttività si propagano all’intero sistema economico.
Tali aspetti hanno anche risonanza nel mondo del lavoro. Infatti, proprio perché
mediamente posizionate più avanti verso la frontiera tecnologica e giacché hanno una
produttività più elevata, le imprese manifatturiere offrono opportunità di lavoro che
sono più qualificati e meglio remunerati.
L’enfasi qui posta sul manifatturiero, e in particolare sul ruolo di questo settore per
l’economia italiana, ha tre ragioni di essere. La prima è chiarire quali sia l’ordine di priorità del Paese, in generale, cioè in termini slegati da questa precisa e difficilissima fase della
sua storia economica. La seconda è fornire un angolo visuale con cui guardare alle cause
e soprattutto alle conseguenze della crisi, in termini di ciò che è oggi in gioco per l’Italia.
La terza è introdurre le ricette necessarie per uscire rapidamente da questa pericolosa
situazione.
La prima ragione non ha bisogno di ulteriori approfondimenti, scaturendo naturalmente da quanto già detto. Se c’è bisogno di ribadirlo, allora basti osservare che, se
grazie al manifatturiero l’Italia si guadagna “il pane e il burro” della vita quotidiana,
non può rinunciare a ciò che è irrinunciabile, casomai lo deve difendere e rafforzare. Il
punto è prenderne rapidamente coscienza, contrastando le lusinghe dell’ideologia della
decrescita felice.
179
5.2
Italia in crisi prima della crisi: la perdita di competitività
La crisi globale ha colpito una manifattura italiana in fase delicata di trasformazione
e un’Italia intera ancora caratterizzata da deficit antichi e mai colmati. Ciò ha esposto
l’una e l’altra, ovviamente con reciproci legami ed effetti incrociati, a conseguenze più
marcate rispetto a quelle che si sono registrate altrove. La micidiale combinazione di
riduzione di liquidità, perdita di competitività e caduta della domanda interna stanno
minando la sopravvivenza della base industriale del Paese e quindi il benessere e il lavoro
di milioni di italiani nel prossimo futuro.
I tre fattori appena citati sono strettamente intrecciati in una catena causale multipla. La mancanza di liquidità toglie ossigeno alle imprese e ne minaccia la sopravvivenza
anche quando sono operativamente solide ed è accentuata dal gioco in difesa delle banche, che puntano a salvaguardare il proprio patrimonio di fronte a un’economia che non
dà chiari segnali di uscita dal tunnel della recessione. La perdita di competitività rende
più difficile acquisire nuovi ordini ed è esacerbata dalla riduzione drastica della domanda
interna che riduce la produttività perché crea sottoutilizzo delle risorse. La discesa della
domanda diminuisce i fatturati e indebolisce la posizione competitiva e creditoria delle
imprese.
La trasformazione del manifatturiero italiano era in atto da tempo ed era stata
accelerata nei primi anni 2000 principalmente da tre elementi: l’incalzare della concorrenza asiatica, rafforzata dall’ingresso della Cina nel WTO; l’ingresso nella moneta
unica europea e quindi la fine della possibilità di ricorrere a svalutazioni del cambio;
l’avvento delle tecnologie ICT, che hanno reso ancor più “piccolo” il globo. Contrariamente a quanto si sente spesso ripetere, la specializzazione italiana non era rimasta impietrita ai settori considerati (erroneamente) tradizionali e privi di prospettive
di sviluppo, ma era profondamente mutata. Ciò è ben rivelato dalla composizione
delle esportazioni (Tabella 5.1): il peso aggregato di tessile-abbigliamento, calzature
e articoli in pelle, mobili era sceso dal 21,5% del 1991 al 14,9% del 2007, mentre era
salito simmetricamente quello dei settori che traggono dalle economie di scala e dall’avanzamento tecnologico i vantaggi competitivi6. Altri importanti cambiamenti erano
avvenuti non con spostamenti di attività tra settori, ma dentro i settori e anzi dentro
le imprese stesse, che si erano mosse verso segmenti di mercato più remunerativi e a
maggior valore aggiunto; movimenti, questi ultimi, più ardui da cogliere da parte dei
produttori di statistiche.
Questa trasformazione aveva iniziato a produrre significativi risultati in termini di
crescita economica e di dinamica della produttività, nettamente migliori nel periodo
2005-2007 rispetto a quello precedente. Tra il 2005 e il 2007, infatti, il PIL è salito
dell’1,9% medio annuo, contro lo 0,8% del quadriennio precedente; la produttività del
lavoro nel manifatturiero è aumentata del 2,1% annuo nel primo dei due periodi, contro
lo 0,5% del secondo.
A livello di singole imprese, la diversa perfomance era resa evidente dalla redditività,
con un grande ampliamento tra i risultati delle imprese che avevano effettuato il cambiamento e quelli di quante tardavano o non riuscivano ad avviarlo.
180 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
Tabella 5.1 - Specializzazione italiana: salgono i prodotti metallurgici e farmaceutici
(Composizione % delle esportazioni italiane di beni manufatti, su dati a prezzi correnti)
1991
Macchinari
e apparecchiature
Autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi
2000
2007
17,5
17,5
19,7
8,1
8,0
8,2
Metallurgia
4,5
4,3
7,5
Prodotti chimici
6,0
6,5
6,4
Apparecchiature
elettriche
6,1
6,4
6,3
Prodotti in metallo
4,5
4,2
5,2
Abbigliamento
,
,
,
Alimentari
4,1
3,9
4,1
Articoli in pelle
,
,
,
Gomma e plastica
3,4
3,8
3,8
Coke e prodotti
petroliferi raffinati
2,0
2,0
3,8
Computer e prodotti
di elettronica e ottica
6,3
5,8
3,6
Farmaceutica
1,3
3,0
3,4
Altre industrie
manifatturiere
4,3
4,3
3,4
Altri mezzi di trasporto
3,1
3,9
3,3
Tessili
,
,
,
Minerali non metalliferi
4,1
3,7
2,9
Mobili
,
,
,
Carta e stampa
1,5
1,8
1,6
Bevande e tabacco
1,2
1,3
1,4
Legno
0,5
0,6
0,5
,
,
,
Made in Italy
Ordinati in senso decrescente per il 2007.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
La crisi è arrivata come una gelata che ha colto il sistema industriale italiano in questa
fase di gemmazione e rinnovamento e sta rischiando di tramutare una distruzione creatrice, cioè una dura selezione dei migliori, in una distruzione e basta. La sopravvivenza
delle imprese, infatti, è legata in questo momento a un solo parametro: la quota del
fatturato realizzata nei mercati extra-UE, gli unici che continuano a espandersi. Un
parametro che è sicuramente direttamente proporzionale ad altri, come le strategie di
innovazione, organizzazione aziendale, dimensione e patrimonializzazione; ma che non
può essere il principale discrimine tra un’azienda valida e un’altra non valida.
181
Tuttavia, anche questi primi risultati positivi erano molto inferiori a quanto conseguito in quegli anni dagli altri paesi avanzati. E se guardiamo all’Italia in un’ottica di più
lungo periodo, siamo costretti a riconoscere la lunga frenata e il graduale manifestarsi
della malattia della lenta crescita. I numeri dicono, infatti, che il PIL italiano era salito
in media del 5,8% negli anni 60, del 3,8% nei 70, del 2,4% negli 80, dell’1,6% nei 90 e
dell’1,3% tra 2000-2007. Ed è dal 1990 che la performance del Paese si discosta significativamente da quella degli USA o dell’UE; rispetto ai primi il distacco è stato di 1,7 punti
percentuali di crescita in meno all’anno; rispetto alla seconda di 0,7 punti.
Dunque, la performance italiana era peggiorata sia nei confronti del proprio passato
sia in paragone al novero delle economie occidentali avanzate. In altre parole, l’Italia era
già in crisi prima della crisi. Una crisi, come detto, di lenta crescita che affonda le radici
a cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi 70 e che era stata mascherata dal ricorso ad
alcune droghe: l’accumulo di debito pubblico, l’inflazione elevata, la svalutazione del
cambio. Preclusa la possibilità di ricorrere a tali droghe, la lenta crescita si è manifestata
appieno7. E la manifestazione sarebbe stata ancora più virulenta se la partecipazione
all’euro non avesse prodotto una drastica riduzione dei tassi di interesse che hanno stimolato un boom immobiliare e sostenuto gli investimenti delle imprese, oltre che i
consumi a debito.
La lenta crescita è stata il frutto di un’incapacità di cambiamento, per il quale sarebbero state indispensabili riforme in direzione dell’efficienza. Mentre per un lungo
periodo, ancora negli anni 70 e nei primi 80, l’Italia si mosse in senso opposto. E successivamente, pur intraprendendo la rotta giusta, si è mossa troppo lentamente, mentre
il resto del mondo mutava sempre più rapidamente. Perciò il Paese ha perso via via
competitività, perdita che si è tradotta in bassa dinamica di tutte le componenti della
sua economia: redditi di lavoro, redditi di impresa, consumi, investimenti, esportazioni
(queste ultime rispetto alla dinamica dei mercati di sbocco).
La lentezza dell’adattamento, cioè del processo di riforma, rappresenterà una zavorra
anche nei prossimi anni. Perché il resto del mondo continuerà a cambiare velocemente.
5.3
L’Italia perde terreno nel mondo che cambia
L’Italia non è collocata nel vuoto cosmico. Nel primo capitolo di questo libro si analizzano le grandi tendenze delle principali variabili rilevanti per la dinamica economica
nelle macroaree, nei maggiori paesi e in quelli con cui il Paese direttamente si confronta
dentro l’Unione europea.
Queste tendenze contemporaneamente disegnano il contesto sfidante in cui l’Italia
si troverà a muoversi e il metro di paragone della sua performance a politiche invariate,
cioè senza tener conto di riforme e interventi che verranno adottati per sopperire alle sue
carenze e imprimere svolte alla traiettoria esistente. Il raffronto tra le condizioni inerziali
dell’Italia e quelle di altri sistemi economico-sociali è utile per individuare i vincoli e i
punti deboli su cui intervenire.
182 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
Il calo demografico
La prima variabile è la popolazione, che rappresenta la materia di base delle potenzialità di un paese, perché ne delinea il capitale umano, quindi le capacità dell’offerta, e i
fabbisogni di domanda. La popolazione italiana inizierà a calare, mentre quella di altre
nazioni con cui compete continuerà a espandersi ancora per qualche decennio. Ciò costituisce un handicap per l’Italia, che potrà essere compensato solo da una più intensa
immigrazione, come è già accaduto nel primo decennio degli anni 2000. Ciò richiederà
però una maggiore capacità di accoglienza, in generale, e di attrattività per i talenti, in
particolare rispetto a quanto dimostrato finora. Tenuto conto che la gara per calamitare
le persone competenti, specie i giovani, è già in atto. E che le pressioni che verranno
dalla sponda sud del Mediterraneo saranno sempre più forti (l’Africa è destinata a sperimentare un boom demografico straordinario).
Va ricordato che una popolazione calante è anche simultaneamente una popolazione
che invecchia, il che ha due risvolti: l’aumento delle persone anziane e la riduzione del
peso, se non del numero, di giovani. Questo sbilanciamento ha conseguenze nella capacità di apprendimento e di adattamento e nella mobilità delle persone, con conseguenze
negative sulla dinamica della produttività, che possono essere solo in parte compensate
da un innalzamento della dotazione di capitale fisico (peraltro, i nuovi macchinari richiedono persone preparate in grado di imparare a farli funzionare).
Il PIL stagnante
La seconda variabile considerata in questo benchmark secolare – si parte da lontano
indietro nel tempo e si guarda avanti fin dove le previsioni disponibili lo consentono,
proprio per meglio cogliere le tendenze di fondo – è direttamente il PIL. Nella duplice
veste della sua stazza e della sua evoluzione.
Per stazza, l’Italia è destinata a essere ridimensionata notevolmente nel contesto globale, passando il suo peso sul totale mondiale da un ventesimo (1980) a un centesimo
(2060). È un ridimensionamento piuttosto rapido che sconta l’altrettanto rapida, senza precedenti nella storia umana, ascesa dei paesi emergenti e in particolare dei due
maggiori: la quota di Cina e India, sommate, andrà dal 13% del 2000 al 47% del 2060,
schiacciando tutti gli altri paesi. Uno schiacciamento, tuttavia, che avverrà in misura
diversa e l’Italia è l’economia che, in assenza di un rilancio del suo dinamismo, scenderà
più velocemente nell’importanza relativa.
Sull’evoluzione del PIL la prima cosa che va rilevata è che nella storia unitaria mai si
era registrato un decennio peggiore di quello terminato nel 2010 (+0,4% medio annuo)
se non in quello tra il 1910 e il 1920 (+0,1%), che pagò le conseguenze della Grande
guerra e della riconversione industriale successiva. Se consideriamo tra il 2014 e il 2030
l’andamento potenziale spontaneo (0,5% di incremento medio annuo), il decennio in
corso si chiuderà con un bilancio perfino più negativo e quello successivo non farà molto
meglio: zero tondo nell’uno e 0,5% nell’altro. Una tripletta di tre decenni consecutivi di
ristagno mai vista e per nulla invidiabile. E se è vero che in prospettiva storica il ventennio del miracolo economico, con il suo +6,3% medio annuo, svetta come eccezione non
183
ripetibile (né ripetuta da alcuna altra nazione avanzata pur inseguitrice degli USA), il
trentennio nella cui metà stiamo vivendo si staglia come fenomeno altrettanto unico per
il suo catastrofico bilancio (Grafico 5.2).
Un inciso metodologico è d’obbligo. La conoscenza più approfondita della realtà
italiana permette al CSC di effettuare proiezioni più aggiornate e realistiche di quelle
realizzate da organismi internazionali per gli altri paesi qui considerati. È probabile che,
a posteriori, anche l’andamento del PIL di alcune delle nazioni qui considerate (per
esempio, la Francia) risulterà peggiore di quanto indicato oggi dalle previsioni FMI
e OCSE utilizzate in questo libro e quindi la pessima performance relativa dell’Italia
apparirà meno isolata.
Grafico 5.2 - PIL: l’Italia vive i decenni peggiori
(Variazioni % medie annue su dati a prezzi costanti)
Fonte: elaborazioni e previsioni CSC su dati Banca d’Italia, ISTAT.
Ma quel che preoccupa non è tanto o solo il raffronto con altri paesi, che pure è prezioso
perché afferma che lo scenario internazionale non è sfavorevole e presenta opportunità
che occorre saper cogliere, quanto e soprattutto quello assoluto del Paese, rispetto a ciò
che è riuscito a fare in passato e ai suoi bisogni. Ricordiamo che un PIL che rimane
quasi piatto per trent’anni ha effetti marcati sulla coesione sociale, sull’occupazione,
sulla disuguaglianza, sulle risorse disponibili per investire nel futuro (a cominciare dall’istruzione).
Senza spinta manifatturiera PIL fermo
L’appiattimento del profilo del PIL trova spiegazione nella dinamica della produzione
del manifatturiero. Come è ovvio che sia, considerato quanto detto all’inizio di questo
capitolo circa il ruolo-guida giocato dall’industria come motore della crescita dell’intera
184 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
economia. Anche se la penuria di dati comparabili internazionalmente non consente di
abbracciare un periodo lungo come quello relativo al PIL totale, tuttavia la correlazione
tra variazione di quest’ultimo e variazione del valore aggiunto manifatturiero balza agli
occhi sia a livello nazionale sia nel raffronto tra paesi (Grafico 5.3).
Grafico 5.3 – Il manifatturiero traina la crescita del PIL
(Variazioni medie annue su dati a prezzi costanti)
Var. % media annua del PIL
15
10
5
0
ITA 2000
ITA 80
ITA 90
ITA 70
-5
-10
-10
-5
0
5
10
15
Var. % media annua del valore aggiunto manifatturiero
20
Ogni punto indica le variazioni medie annue in un paese durante uno dei quattro decenni: 70, 80, 90, 2000.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
Il cammino dell’industria in Italia prima è rallentato dal 6,1% medio annuo degli anni
70 all’1,3%, già mediocre, dei 90, poi ha innestato la retromarcia nei primi Duemila, che
al loro interno hanno avuto un avvio molto faticoso (classificato dall’ISTAT addirittura
come recessivo), poi di maggior slancio grazie ai primi frutti della trasformazione del
manifatturiero (come si è spiegato sopra) e, infine, la botta micidiale della crisi dalla
quale ancora l’Italia non si è risollevata. Altrove (Germania, Francia, Giappone e Svezia,
per rimanere nel novero dei paesi avanzati) quella botta è stata meno forte o comunque
è stata riassorbita in maggiore misura.
Ciononostante, l’Italia resta la quinta potenza manifatturiera al mondo. Se si considerano i valori a prezzi e cambi correnti (che meglio rappresentano il potere di mercato,
rispetto a quelli a prezzi costanti), essa ha ancora il 2,8% del valore aggiunto globale e
segue Cina (20,7%), USA (16,8%), Giappone (9,8%) e Germania (6,4%). I dati si riferiscono al 2011 ed è probabile che nel 2012, considerati gli andamenti di produzione
industriale e tasso di cambio, il Paese sia stato sorpassato dalla Corea del Sud, un sistema
che, certo, indirettamente è coinvolto nel turbinoso sviluppo degli emergenti asiatici,
ma che ha anche saputo guardare lungo e conquistare primati in settori in cui incalza gli
stessi Stati Uniti.
Rispetto ai massimi toccati vent’anni fa, l’Italia ha perso un numero di punti percentuali nella quota mondiale di produzione manifatturiera (-2,3) analoghi a quelli lasciati
185
sul campo da Germania (-2,8), Francia (-2,1) e Regno Unito (-2,0), e nettamente inferiori a quelli di USA (-5,9, che però dal 1970 hanno fatto -12,1, complice la svalutazione
del dollaro) e soprattutto Giappone (-5,9). Ciò vuol dire che, astraendo dalla minaccia
immediata costituita dalla crisi e di cui si è parlato sopra, il Paese ha dimostrato di avere
una base industriale solida e capace di reggere il confronto internazionale.
D’altra parte questa capacità è ben rappresentata anche dalla vocazione industriale,
misurata dal valore aggiunto manifatturiero per abitante, che ancora nel 2011 vedeva l’Italia ai valori più alti del mondo: quinta dietro a Germania, Giappone (che ha risentito
in quell’anno della devastazione del maremoto), Corea del Sud e Stati Uniti. Tuttavia,
è proprio questa vocazione che viene minacciata dalle gravi difficoltà delle imprese manifatturiere italiane; già due anni fa il suo valore si era quasi omologato a quello medio
dell’UE-27, sminuendo un tratto caratterizzante l’economia del Paese.
Un benessere minacciato
La crescita economica non è fine a se stessa. Lo scopo ultimo, magari perseguito in modo
non sempre diretto e lineare (basti pensare agli effetti immediati della prima industrializzazione sull’ambiente o sulla disuguaglianza), è quello di elevare il benessere della popolazione. Benessere che può essere misurato in diversi modi e che trae fonte dal lavoro
e dalla sua produttività.
Per quanto messo in discussione da molti anni e da economisti autorevoli8 e nonostante i molti tentativi di elaborare migliori indicatori9, il PIL pro-capite rimane una
buona proxy dello standard di vita di un paese o di un’area10. Abbiamo già visto come
il PIL pro-capite italiano sia calato durante la crisi e sia tornato ai livelli del 1997. Aggiungiamo che il divario rispetto al resto dell’Euroarea sia salito a 13 punti percentuali,
mentre ancora nel 1997 l’Italia vantava un piccolo vantaggio. Ora, per quanto il denaro
e quindi il PIL non facciano la felicità, la decrescita subita dall’Italia non ha certo innalzato gli spiriti e migliorato il benessere in senso lato, come vedremo anche da altri
indicatori.
Bruciare i frutti del miracolo economico?
Ma come si comporterà il PIL per abitante nei prossimi anni? Ovviamente la risposta
dipende da se e come l’Italia saprà ritornare su un sentiero di crescita più sostenuta. Qui
prendiamo in esame uno scenario a bocce ferme e quindi di andamento ancora molto
lento del PIL totale. Il risultato è che il reddito pro-capite salirà poco, circa dello 0,7%
l’anno dalla seconda metà del decennio in corso in avanti, anche per effetto del calo
della popolazione che inizierà negli anni 2020. Meglio di quanto avvenuto dal 2000
a oggi, quando si è verificata la contrazione di cui si è detto all’inizio del capitolo. Ma
molto peggio negli altri paesi avanzati, che stando alle proiezioni OCSE registreranno
ritmi di incremento doppi di quelli italiani. In questo modo il distacco dell’Italia dal
resto dell’UE e dagli Stati Uniti si amplierà ulteriormente. Fatto 100 quello statunitense,
infatti, il PIL per abitante italiano risulterà nel 2060 pari a 38, contro il 65 del 2010.
Posto uguale a 100 quello dell’UE l’italiano scenderà a 57, dal 98 di tre anni fa. Valori raf-
186 5. Per l’Italia affondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
frontabili a quelli del 1950. È come se fossero cancellati i frutti ottenuti con il miracolo
economico (1950-1973), e anche successivamente fino ai primi anni 90, nella rincorsa agli
standard di vita europei e americani. Addirittura tra mezzo secolo l’Italia sarà diventata
un’economia arretrata, considerato che sarà stata superata da Cina, Brasile, Turchia e
Polonia e sarà tallonata dall’India (Grafico 5.4).
Grafico 5.4- PIL pro-capite: Italia relativamente peggio di UE-27 e USA
(Valori %, calcolati su dati a prezzi costanti)
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
Un declino minaccioso
Certo, queste previsioni vanno prese con molte molle. I rivolgimenti che ormai si verificano quasi quotidianamente sotto i nostri occhi rendono ancora più difficile di un
tempo tracciare percorsi lineari di sviluppo per il prossimo decennio. Figuriamoci per i
prossimi cinquant’anni. A maggior ragione se si considerano le sfide epocali, in termini
di tutela ambientale e approvvigionamento energetico che saranno poste dal raggiungimento di standard di vita occidentali da parte di miliardi di persone dei paesi ora
chiamati emergenti ma che un domani saranno avanzati anch’essi. Eppure, per quanto
eroiche, tali proiezioni hanno un valore segnaletico importantissimo: senza un cambio
di rotta, una sterzata rapida e decisa in ogni ambito della sua vita economica e sociale,
l’Italia dovrà affrontare una fase di declino dalle conseguenze imprevedibili. È una sirena
d’allarme che ulula minacciosa.
Ma lo sviluppo umano tiene
Se il PIL per abitante è sceso negli ultimi anni, ciò non significa che il livello di benessere complessivo abbia seguito le stesse sorti. O almeno ciò non è successo se si guarda
187
all’indice dello sviluppo umano, un indice che è elaborato dall’ONU e che miscela
insieme PIL per abitante, grado di istruzione della popolazione e speranza di vita alla
nascita. L’Italia si colloca al 24° posto nel mondo, con un punteggio di 0,87 che è
continuato a salire nel tempo, anche se molto più lentamente di prima e di quanto è
successo in altri paesi, cosicché si è perso terreno sia rispetto alle possibilità di migliorare sia riguardo al quadro altrui. Peraltro, ciò che garantisce la tenuta di questo indice
sono la misura dell’istruzione (calcolata in numero di anni di curriculum scolastico,
che sono un metro molto approssimativo delle competenze acquisite) e la speranza di
vita (che aumenta grazie ai progressi della medicina, non direttamente legati all’andamento dell’economia). In altri termini, la resistenza mostrata dall’Italia nell’indice di
sviluppo umano può essere ingannevole; per esempio, la popolazione può essere stata
più a lungo a scuola ma il grado di preparazione non essere aumentato a causa della diminuzione della qualità dell’insegnamento; oppure i farmaci e le altre cure prolungano
l’esistenza, ma magari in condizioni di povertà e disagio crescenti se non ci sono risorse
per accudire gli anziani.
La produttività bloccata
Dove l’Italia è andata particolarmente male è proprio nel fattore principe di ogni progresso economico: la produttività. L’azzeramento dei guadagni di produttività è avvenuto nel corso degli anni 2000. Tuttavia, la frenata era iniziata prima, benché ancora nella
prima metà degli anni 90 il valore aggiunto per ora lavorata aveva mantenuto un passo
americano: +2,1% medio annuo. Fece però appena +0,9% nella seconda metà di quel
decennio fino a fermarsi del tutto nel primo decennio 2000.
La crisi, ovviamente, ha influito notevolmente. Ma questo è accaduto in tutti i paesi
avanzati, seppure in misura disomogenea. Quel che contraddistingue l’Italia è che i problemi su questo fronte erano emersi, appunto, già nella seconda metà degli anni 90. In quel
quinquennio, e in quello immediatamente successivo, la produttività del lavoro italiana
era salita, rispettivamente, dello 0,9% e dello 0,2% medi annui, contro il 2,5% USA e britannico in entrambi i periodi, il 2,0% giapponese, il 2,0% e l’1,4% francesi, l’1,8% e l’1,4%
tedeschi.
Sono state avanzate diverse spiegazioni su questo aspetto cruciale. C’è chi ha indicato le misure di minor rigidità contrattuale nell’assunzione di persone e quindi il
passaggio a tecniche più intensive di lavoro e meno di capitale. Questa tesi, per quanto
logicamente suggestiva (in effetti negli anni 70 e 80 la rigidità del mercato del lavoro era
stata affrontata accrescendo l’automazione delle produzioni), si scontra con il fatto che
anche la produttività totale dei fattori, che misura l’efficienza del sistema di combinare e
organizzare i fattori produttivi, ha avuto le stesse dinamiche di quelle del lavoro, sia nel
confronto temporale (perdita di velocità nella seconda metà degli anni 90 e addirittura
regresso in quelli successivi) sia nella comparazione internazionale (con l’Italia fanalino
di coda; per i dati puntuali si rimanda alla tabella a pagina 51 del capitolo 1).
Un’altra spiegazione è che il Paese non abbia appieno sfruttato le potenzialità offerte
dall’ICT. Ciò per varie ragioni, che non possono essere qui tutte esaminate ma che han-
188 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
no a che fare sia con la domanda da parte delle imprese sia con l’offerta di infrastrutture
adeguate11. Secondo alcuni analisti il ritardo nell’ICT si spiega anche con alcune rigidità
nei mercati del lavoro e dei beni12.
E il costo del lavoro per unità di prodotto non rallenta
L’altra faccia del pessimo andamento della produttività è l’aumento del costo del lavoro per unità di prodotto. Che in Italia ha da molto tempo mostrato una dinamica
superiore e spiazzante rispetto a quanto osservato nei suoi maggiori competitori e che
però l’entrata nell’euro e la crisi avrebbero dovuto imbrigliare. Ciò è solo in parte accaduto, nel senso che rispetto agli incrementi cumulati a tre cifre registrati negli anni
70 e 80, compensati periodicamente dalle svalutazioni del cambio, negli anni 90 per
l’intera economia si è scesi al 23,3%, contro il 10,2% della Francia, il 14,9% della Svezia,
il 20,7% della Germania e il 23,3% degli USA. Ma nel decennio successivo, anziché
un ulteriore rallentamento, in linea con quanto è avvenuto altrove (con l’eccezione
francese), si è avuta un’accelerazione al 28,8%, rispetto all’1,7% tedesco, al 14,4% svedese, al 19,1% sudcoreano e al 19,4% americano. Questo perché la dinamica del costo
del lavoro, determinata dal sistema di contrattazione centralizzato, si è comportata da
variabile indipendente rispetto alle sorti economiche complessive.
Ciò è confermato dall’aumento relativo del costo orario del lavoro nel settore manifatturiero. Che è salito da 20 dollari nel 1997 a 36 nel 2011, grosso modo lo stesso livello
statunitense e contro i 42 francesi, i 47 tedeschi e i 49 svedesi. Si potrà osservare che sono
valori ancora largamente competitivi, se non fosse che il vantaggio rispetto a Francia e
Germania si è molto ridotto proprio mentre si ampliava la forbice della produttività nel
settore manifatturiero.
Ma l’occupazione accelerò
Il risvolto positivo della lenta crescita coniugata a una produttività stagnante o addirittura calante è l’incremento dell’occupazione. Tra il 2000 e il 2007 il numero di
occupati in Italia è aumentato del 9,4%, un incremento tra i più elevati nel novero dei
paesi di riferimento, più del doppio di quello tedesco, superiore a quelli americano
e inglese, analogo al francese. Peraltro, nei primi quattro anni della crisi la flessione
patita dai posti di lavoro è stata nel Paese molto contenuta rispetto alla caduta verticale subita dal PIL. Ciò induce a dare una lettura positiva degli effetti delle riforme
del mercato del lavoro attuate dalla seconda metà degli anni 90 (sebbene non abbiano
completamente risolto il dualismo tra insider e outsider); e anche delle riforme previdenziali, che ritardano il momento del ritiro e quindi innalzano l’occupazione nelle
coorti di età più elevate (nelle quali il tasso di occupazione italiano era la metà o meno
di quelli degli altri paesi). Sono buone notizie anche sul piano del benessere, visto
che il lavoro ne è il pilastro principale, per quanto riguarda sia la fonte di reddito sia
l’inclusione nella vita sociale.
189
Quelle riforme sono state importanti anche nell’elevare il tasso di occupazione italiano, che prima della crisi era arrivato a sfiorare il 60%, con un incremento di circa otto
punti percentuali rispetto alla metà degli anni 90. Questo aumento è stato conquistato
in gran parte nella componente femminile, nella quale il tasso di occupazione è salito
di dodici punti, arrivando al 47% nel 2011 e senza arretramenti nel corso della grande
recessione. Tuttavia, sia il tasso complessivo sia quello di genere restano di gran lunga
più bassi di quanto si osservi negli altri paesi avanzati (addirittura di 16 punti rispetto
alla Svezia nel totale e di 25 per le donne; per un dettaglio dei dati si rimanda alle tabelle
alle pagine 56-57 del capitolo 1).
I giovani restano esclusi
Ciò che le riforme previdenziali e del mercato del lavoro non sono riuscite a intaccare è
la questione dell’occupazione giovanile (qui definita relativamente alle persone con 2529 anni di età per evitare le forti differenze istituzionali nel rapporto scuola-lavoro). Non
l’hanno intaccata da due punti di vista. Il primo è il livello: nonostante l’aumento dal
60,4% degli anni 90 al 62,8% del primo decennio 2000, il tasso di occupazione è rimasto
di gran lunga inferiore a quello degli altri paesi avanzati (di dieci punti in media e fino
a quindici punti). Il secondo è la tenuta: la crisi, infatti, ha colpito duramente proprio il
lavoro dei giovani, giacché tra il 2007 e il 2012 ben 1,3 milioni di 15-34enni hanno perso
l’impiego (-506mila il calo complessivo degli occupati).
Ma c’è un aspetto ancora più preoccupante, e rivelatore, di come l’Italia bruci le sue
risorse nella costruzione del futuro: la quota di giovani che non studiano né lavorano
(NEET). Già prima della crisi questa quota era molto elevata, ben superiore a quelle
media degli altri paesi avanzati e pari al 22,6% dei 20-24enni nel 2007. Ma nel 2010 era
salita al 27,1%, registrando il più forte incremento (4,5 punti percentuali), dopo quello
spagnolo. Cosicché il divario con le altre economie si è ulteriormente ampliato ed è
quasi di dieci punti rispetto alla media UE. Questo spreco non solo è drammatico dal
punto di vista sociale, ma è un sintomo della bassa competitività del Paese nell’oggi e nel
domani. Infatti, i giovani NEET non acquisiscono competenze, semmai perdono quelle
ottenute studiando. In questo modo il capitale umano dell’Italia si impoverisce e ciò
predetermina un minor livello di produttività, e di retribuzione, in futuro.
L’incertezza del diritto
Di nuovo torna a riaffermarsi il legame stretto tra benessere, produttività e competitività. Che trova la massima espressione nella difficoltà di fare impresa, fondamentalmente
basata sulla mancanza della certezza del diritto. La consapevolezza dell’importanza del
diritto, ossia della chiarezza del disegno delle norme e della rapidità e della univocità
della loro applicazione, è antica anche nel pensiero economico. Ma è rimasta di fatto
ignorata per molto tempo nelle analisi degli economisti riguardo alla performance del
Paese. Ciò ha di fatto creato un clima di distaccata indifferenza rispetto alla stratificazione di leggi, regolamenti, interpretazioni giurisprudenziali, atti della pubblica ammi-
190 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
nistrazione. Indifferenza che nel corso degli anni ha permesso il prevalere di una cultura
giuridica autoreferenziale che impregna la gran parte delle decisioni degli enti pubblici13.
In fondo, per gli economisti contavano e contano soprattutto gli andamenti delle variabili economiche per se stessi, nel senso che la dinamica del PIL o di un’altra grandezza
viene spiegata in funzione di altre variabili economiche o al più demografiche e sociali.
Non che le nuove norme che intervengono nel campo dell’economia non siano oggetto
di analisi anche stringente (per esempio, riguardo alle liberalizzazioni o al mercato del
lavoro). Ma i loro effetti sono sempre considerati al margine e isolatamente rispetto alla
cultura giuridica complessiva del Paese. Al coacervo, cioè, dei codici e al labirinto della
loro messa in pratica e di quanto ciò siano di ostacolo all’attività imprenditoriale, come
costo occulto talvolta insuperabile.
In effetti, questi aspetti che hanno per molto tempo trovato poco spazio nelle interpretazioni degli economisti, sono stati come messi in fondo, mentre andrebbero in realtà
messi all’inizio di ogni considerazione. E si potrebbe arrivare ad affermare che in Italia
la rivoluzione industriale non è stata né preceduta, né accompagnata e neppure seguita
da una rivoluzione liberale. E che anzi le culture prevalenti, di matrice cattolica e socialista, hanno privilegiato il porre barriere e confini e limiti all’iniziativa imprenditoriale.
In realtà, appunto, i principi liberali sono l’humus e quindi l’ingrediente di base dello
sviluppo economico.
Gli ostacoli del fare impresa
Negli ultimi anni si è posto parziale rimedio a ciò con una mole di studi, promossi in
particolare dalla Banca d’Italia, e si è cercato di avviare un processo di semplificazione,
che tuttavia non ha migliorato gran che la posizione relativa del Paese. Vuoi perché
anche gli altri sistemi hanno teso a ridurre i lacci e lacciuoli, e quindi ciò non ha mutato la posizione relativa dell’Italia. Vuoi perché ancora si incontrano grandi resistenze
nel rendere la giustizia più veloce e spedita, nel realizzare una più diretta e immediata
interfaccia tra imprese e pubblica amministrazione. Ciò frena gli investimenti e tarpa le
ali alla crescita.
Cosicché, nella graduatoria della Banca mondiale sul fare impresa (Doing business),
ormai divenuta famosa nel dibattito pubblico, nel 2013 l’Italia si è piazzata al 73° posto,
40 posizioni più indietro della Francia, 54 della Germania, 61 della Svezia (certo non
etichettabile come “turbocapitalista”); per non parlare di Corea del Sud, Regno Unito e
Stati Uniti che stanno nelle top-ten. E i campi in cui il fare impresa deve scalare le montagne più alte sono proprio quelli in cui maggiore è il coinvolgimento della pubblica
amministrazione: il permesso di costruire, l’allacciamento elettrico, gli obblighi fiscali, il
far rispettare i contratti per via giudiziaria.
Un altro grave handicap competitivo dell’Italia, che da anni è sotto i riflettori, senza
però trovare soluzione ma solo annunci tanto roboanti quanto inefficaci (semmai è stato
oggetto di ripetuti errori di politica), anche se ciò non spicca nel dibattito pubblico
come meriterebbe, è l’elevato costo dell’energia elettrica. Per un’impresa che opera nel
Paese la bolletta costa oltre il 40% in più della media UE, un quarto più della Germania,
191
circa il doppio della Francia e della Svezia. Questo divario, per giunta, è salito nel corso
degli ultimi tre anni e ciò si è aggiunto come ulteriore fardello a quelli già pesanti caricati
dalla crisi sulle spalle dell’industria e in generale dell’economia italiane, rendendo ancora
più difficile la ripresa.
E la diseguaglianza è alta
In Italia la lenta crescita si è accompagnata a un ampliamento delle diseguaglianze di reddito, personali e territoriali. I divari nella distribuzione del reddito, che erano già molto
alti, si sono aggravati. Ciò è reso evidente dall’aumento dell’indice di Gini, che era pari
a 0,30 all’inizio degli anni 90 ed era salito a 0,35 a metà di quel decennio, stabilizzandosi
poi su quel valore che si riscontra più nel Regno Unito e negli USA che nell’Europa continentale e nordica. A fine anni 2000, grazie all’efficacia della redistribuzione operata con
il fisco e lo stato sociale, era pari a 0,30 in Germania (dove però era a 0,26 un decennio
prima), 0,29 in Francia (costante nel tempo) e a 0,26 in Svezia (da 0,21 a metà anni 90).
Va rilevato, tuttavia, un elemento di importante distorsione del livello di questo
indicatore: il forte dualismo territoriale della Penisola. L’ampio differenziale tra reddito
medio al Nord e al Sud (nel primo è circa il doppio che nel secondo) giocoforza si traduce in ampi divari anche sul piano personale. Calcoli effettuati separatamente tra le due
aree fanno emergere questo aspetto, con l’indice di Gini che nel Settentrione si avvicina
ai livelli franco-tedeschi e che nel Meridione è molto più alto. Nel Mezzogiorno, quindi,
l’arretratezza si accompagna (causa o effetto?) ad una maggiore iniquità.
Il dualismo territoriale italiano si staglia con forza nel panorama europeo facendo il
seguente computo: la quota di popolazione che vive in regioni il cui reddito è più alto
del 125% del reddito medio UE e la quota di popolazione che abita in regioni dove il PIL
per abitante è inferiore al 75% del reddito medio UE. L’Italia è l’unico membro dell’UE
ad avere entrambe le quote molto elevate: nel 2009 34% la prima (quella di abitanti in
regioni con reddito alto) e 28% la seconda. Gli altri paesi presentano una quota alta
solo in uno dei due casi. Peraltro, l’impoverimento generale del Paese si vede anche dal
fatto che nel 2000 le due quote erano rispettivamente 57% e 22%, cioè è diminuita la
percentuale di persone che vivono in regioni ricche ed è salita quella di quanti abitano
in regioni povere.
L’inefficiente fabbrica della conoscenza
L’economia della conoscenza è un’etichetta coniata nel corso degli anni 90, sull’onda
delle conseguenze della rivoluzione tecnologica prodotta dalle ICT. Ma l’importanza
del progresso tecnico per lo sviluppo economico è da almeno un paio di secoli nota ed
esaminata dagli economisti e dagli storici dell’economia. Perché la stessa rivoluzione
industriale, il maggior cambiamento della storia umana nell’organizzazione sociale della
produzione di beni, si basa fondamentalmente sull’applicazione sistematica di scoperte,
invenzioni e innovazioni ai processi produttivi e alla messa a punto di prodotti.
192 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
È difficile misurare direttamente la portata di un’innovazione e in generale della capacità di innovare di un paese. Ma esiste una serie di indicatori che suggeriscono almeno
l’impegno, e anche qualche risultato, in questa direzione. Riguardano le risorse investite
nella ricerca e nello sviluppo e nell’arricchimento del capitale umano attraverso l’istruzione e gli effetti di questi sforzi in termini di brevetti depositati.
Il quadro che emerge per l’Italia, non nuovo ma non per questo da trascurare, è di
sostanziale distanza rispetto ai paesi di riferimento in tutte le misure rilevanti per l’economia della conoscenza. Con rare eccezioni. Una di queste, per esempio, è la quota di
pubblicazioni scientifiche che, da metà anni 90 alla fine del primo decennio Duemila,
è rimasta pressoché costante attorno al 3,5% del totale mondiale, un valore superiore al
peso dell’economia italiana sul PIL globale e che ha resistito all’ascesa delle economie
emergenti; una resistenza che invece non è riuscita agli altri paesi avanzati.
Nel resto, l’Italia è fanalino di coda, anche se qua e là ha fatto consistenti, ma insufficienti, progressi. Nella spesa in R&S è buon ultima tra i paesi avanzati ed è stata superata
dalla Cina: il suo 1,3% del PIL nel 2010 si paragona all’1,9% della media UE, al 2,8% della
Germania e degli USA e ai siderali 3,3% giapponese, 3,4% svedese e 3,7% sudcoreano. Da
notare che la Corea era al 2,3% nel 2000.
D’altra parte la repubblica asiatica guarda con decisione in avanti, tanto da riorganizzare la compagine governativa e varare il progetto di istituire il Ministero della scienza
e della creazione del futuro, alla cui guida era stato chiamato Jeong Kim, presidente in
USA dei Bell Lab. Un progetto forse troppo all’avanguardia perfino per quel paese, se è
vero che ha sollevato grandi polemiche tanto da indurre Kim a rinunciare all’incarico.
Tuttavia, rimane un episodio istruttivo di come si sta muovendo, con quanta determinazione, visione e aggressività, quella nazione (e non solo essa).
Se l’input del processo produttivo della ricerca (cioè gli investimenti) è più basso in
Italia, altrettanto lo è l’output, ossia la quota di brevetti, pari all’1,4% del totale mondiale
nel 2010 (più bassa quindi della stessa incidenza dell’economia italiana sul PIL globale),
inferiore a quella di un’economia più piccola come la svedese (a 1,7%) e un terzo di quella sudcoreana (4,4%). La Francia è al 4,9% e la Germania all’11,4%. Stati Uniti e Giappone sono al 27,8% e al 31,2% rispettivamente. Tra 2000 e 2010 tali quote si sono mosse
poco, con una tendenza calante per i paesi avanzati e in aumento per quelli emergenti.
La vera “sorpresa”, ma più che altro è una conferma rispetto a quanto detto sopra, è la
Corea del Sud, che era all’1,6% (addirittura a zero tondo nel 1985).
La continua enfasi sul caso coreano è più che giustificata dall’ascesa di quel paese
come potenza manifatturiera, quindi come temibile competitor dell’industria italiana.
Un capitale umano poco curato
La materia prima della conoscenza è e resta il capitale umano. Sia quando si vuole far
avanzare la frontiera tecnologica sia quando, meno ambiziosamente ma con ottimi risultati pratici, si vogliono utilizzare, adattandole e migliorandole, le scoperte e le innovazioni altrui. E le misure della dotazione di sapere contenuto nella popolazione sono
193
quelle relative all’istruzione. Nel complesso, l’Italia ha fatto progressi ma non bastevoli
a colmare i divari.
Il numero medio di anni di istruzione della popolazione adulta italiana è salito da
6 nel 1970 a 11 nel 2010, in linea con la media UE, ma di due anni inferiore a Corea
del Sud, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Germania. La quota di persone giovani
(25-34 anni) con un diploma è aumentata dal 57% del 2000 al 71% nel 2010, e ciò ha
diminuito sensibilmente il gap con le altre maggiori economie, che tuttavia si collocano
tutte abbondantemente sopra l’80% con punte superiori al 90% (Corea del Sud al 98%).
Ma non basta studiare di più e più numerosi. Occorre anche imparare meglio e
acquisire più elevate competenze. Non esistono serie storiche di indicatori di apprendimento, ma solo comparazioni internazionali realizzate dall’OCSE attraverso i test PISA
(Programme for International Student Assessment) condotti sui 15enni che ci dicono
come si posizionano i diversi paesi l’uno con l’altro e rispetto alla media. In matematica, una delle tre materie di valutazione (le altre sono comprensione di un testo scritto
e scienze) e la più appropriata per l’affinamento delle competenze richieste nel campo
della ricerca, l’Italia è molto migliorata, passando da 462 punti nel 2006 a 483 (fatta
pari a 500 la media OCSE); ma è ancora a un livello inferiore agli altri paesi avanzati e
abissalmente lontana dai punteggi asiatici (600 Shanghai, 555 Hong Kong, 546 Corea
del Sud, 529 Giappone).
Il quadro evidenziato per i giovani diplomati si ripropone per i laureati. Anche qui
l’Italia ha fatto enormi progressi, passando dal 10% del 1999 al 21% del 2010 tra i 2534enni. Ma guadagni altrettanto significativi hanno messo a segno gli altri paesi di riferimento, spesso partendo da livelli già di molto superiori. Cosicché il divario non si è
ristretto e anzi si è allargato da 15 a 16 punti con la UE (che sta al 37%), a 22 punti con
la Svezia, gli USA e la Francia (42-43%), a 36 punti con il Giappone (57%) e a 45 punti
con la Corea del Sud (65%).
Peraltro i giovani italiani studiano e conseguono il diploma in università che non
sono proprio in vetta alle classifiche internazionali. Nelle top100 non c’è neppure un
ateneo del Paese e nelle top500 solo 20. È vero che in queste graduatorie si mescolano
talvolta realtà non paragonabili e che dentro le università contano i dipartimenti. Ma
anche l’evidenza aneddotica dice che c’è troppo scarso utilizzo della valutazione dei
docenti.
5.4
Il progetto Confindustria per l’Italia: crescere si può, si deve
L’analisi effettuata indica tre aspetti: l’economia globale è destinata a ulteriori profondi
cambiamenti, la cui natura si può osservare già oggi; l’Italia ha affrontato le mutazioni
epocali in atto, che vengono battezzate “la grande convergenza”14, con un fardello di mali
antichi che si sono aggravati nel corso del tempo e che, alla fin fine, trovano tutti origine
nella sua peculiare incapacità di fare sistema e di essere somma di interessi più che una
vera nazione15; l’insieme di questi due fattori è negativo per il Paese, nel senso che lo pone
tendenzialmente lungo un percorso di sostanziale stagnazione e di regresso (declino) nei
194 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
confronti del resto delle altre nazioni avanzate (verrà superato anche da molti dei paesi
oggi chiamati emergenti).
Per contrastare questo destino c’è un’unica strada: quella delle riforme profonde e
radicali in molti ambiti della vita pubblica e privata. Sui principali contenuti di queste
riforme si tornerà poco sotto, mentre le lezioni su come fare le riforme sono state esaminate in un precedente lavoro del Centro Studi Confindustria16. Lezioni che appaiono
ancora più difficili da seguire, dopo l’esito del voto popolare che ha consegnato un
Parlamento sostanzialmente quadripartito e senza una coesa maggioranza al Senato. Ma
ammesso e non concesso che comunque la strada delle riforme sia imboccata con più
determinazione di quanto avvenuto anche nel recente passato, occorrerà del tempo,
espresso in alcuni anni, prima che esse dispieghino appieno i loro effetti. Un tempo
troppo lungo per essere sopportato nelle condizioni stremate in cui versa oggi l’economia italiana. Perciò è indispensabile mettere subito mano a un piano di rilancio che
promuova una crescita forte e sostenibile.
Ecco perché il Progetto Confindustria per l’Italia17 si compone di due parti strettamente legate dal filo logico degli obiettivi che persegue: riportare la dinamica del PIL
italiano stabilmente sopra il 2%, facendo perno sull’indispensabile vocazione industriale
del Paese. La prima parte è costituita da una terapia d’urto che va varata subito e che si
dispiega in cinque anni. La seconda parte, da avviare simultaneamente alla prima, è fatta
dalle riforme strutturali che inizieranno a essere efficaci quando si affievoliranno gli effetti della terapia d’urto, in una sorta di passaggio del testimone nel sostenere la crescita.
Quali sono le caratteristiche della terapia d’urto e quali i suoi effetti? La terapia
opera da due lati: l’aumento della competitività di costo, soprattutto del manifatturiero,
giacché se ne vuole riportare la rilevanza ai valori di metà anni 90 (elevandone il peso al
20% del PIL dal 16,5% del 2012); il rilancio della domanda interna attivando maggiori
investimenti pubblici e privati.
Metodologicamente, i costi delle proposte della terapia d’urto sono stati quantificati e sono state reperite le risorse intervenendo su altre voci del bilancio pubblico, in
modo da garantire la neutralità per i saldi. In altre parole, si tratta di una manovra di
finanza pubblica che rialloca le risorse, operando precise scelte che hanno l’obiettivo
di innalzare la crescita nel corso del tempo. Proprio in funzione di questo obiettivo, e
per il vincolo rappresentato dalla disponibilità dei fondi, gli interventi sono crescenti
nel tempo (Tabella 5.2).
Le quantificazioni delle proposte sono state inserite nel modello econometrico del
CSC e ne è risultato un significativo aumento del tasso di crescita, che arriva al 3,0% nel
2017, e dell’occupazione (+1,8 milioni di unità nel 2018 rispetto al 2013; si veda la tabella
Scenario con proposte Confindustria: i conti del Paese). L’incremento cumulato del PIL
è pari al 12,8% nei prossimi cinque anni, 9,9 punti in più rispetto allo scenario a politiche
invariate; ai prezzi di oggi 156 miliardi aggiuntivi, quasi 2.617 euro per abitante. Sia per il
PIL sia per i posti di lavoro, la terapia d’urto consente di recuperare rapidamente quanto
perduto durante la doppia recessione e addirittura arrivare a livelli superiori a quelli che
si sarebbero avuti se la recessione non ci fosse stata e fossero proseguite le tendenze in
atto prima della crisi (Grafici 5.5 e 5.6).
195
Tabella 5.2 - Scenario con proposte Confindustria: i conti del Paese
(Var. % salvo diversa indicazione su valori a prezzi costanti)
2013
Consumi delle famiglie
-1,4
1,6
1,7
2,2
2,5
2,3
2013-18
(1)
10,7
Investimenti fissi lordi
-2,0
10,2
10,9
7,7
8,5
9,1
55,8
Macchinari e mezzi di trasporto
-1,9
10,8
14,1
8,9
9,6
10,3
66,4
Costruzioni
-2,0
9,5
7,7
6,4
7,2
7,6
44,7
Esportazioni
0,8
4,7
5,9
7,2
7,6
8,8
39,1
Importazioni
-1,0
9,5
9,9
7,3
8,3
9,5
53,1
PIL
-1,2
1,8
1,9
2,5
3,0
3,0
12,8
Saldo partite correnti (2)
-0,6
-2,1
-3,3
-3,1
-2,3
-1,2
-0,6
Occupazione (ULA)
-0,7
0,4
1,0
1,6
2,1
2,2
7,5
Settore privato
-0,7
0,6
1,3
1,9
2,5
2,6
9,2
Retribuzioni
per addetto
Industria in s.s.
1,0
1,2
1,7
1,6
1,8
1,9
8,5
1,2
1,7
2,0
1,9
2,0
2,0
10,0
Prezzi al consumo
1,7
1,5
1,5
1,6
1,6
1,8
8,3
Saldo conti pubblici (2)
2014
2015
2016
2017
2018
-2,0
-2,0
-1,1
-0,1
0,4
1,5
3,5
Saldo primario (2)
3,5
3,6
4,1
4,7
4,9
5,6
2,1
Saldo primario
corrente (2)
Pressione fiscale (2)
6,5
6,8
7,3
7,8
8,2
9,0
2,5
45,1
44,3
43,8
43,1
42,4
42,1
-3,0
Debito pubblico (2)
129,2
126,5
122,6
117,1
110,8
103,7
-25,5
Per memoria
Quota dell'industria (3) in s.s.
18,8
19,4
20,1
20,7
21,4
22,0
3,2
Quota dell'export (4)
29,8
30,6
31,9
33,3
34,8
36,7
6,9
Occupazione (ULA) (5)
23.569
23.658
23.898
24.270
24.776
25.324
1.756
Settore privato (5)
20.215
20.339
20.597
20.985
21.507
22.071
1.856
56,4
56,3
56,6
57,4
58,9
60,6
4,2
Tasso di disoccupazione (5)
11,9
12,3
12,6
11,9
10,4
8,4
-3,5
Produttività
-0,4
2,6
1,1
1,1
1,2
1,0
7,2
1,5
-1,1
0,0
-0,2
0,1
0,5
-0,7
Tasso occupazione (5)
CLUP
(1) Variazione cumulata. (2) In % del PIL. (3) In % del valore aggiunto a prezzi costanti. (4) In % del PIL a prezzi
costanti. (5) Livelli.
Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria.
196 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
Grafic0 5.5 – Le differenze nella crescita del PIL…
(Italia, PIL, livello in miliardi)
Con proposte
Senza proposte
Fonte: elaborazioni e stime CSC.
Figura 5.6 – …sull’occupazione…
(Italia, occupati, migliaia)
Con proposte
Senza proposte
Fonte: elaborazioni e stime CSC.
Il combinato disposto delle misure (che comprendono anche dismissioni per oltre l’1% del
PIL l’anno) e della maggior crescita hanno effetti estremamente positivi sugli stessi conti
pubblici, a dimostrazione del fatto che il ritorno alla crescita è la via maestra anche per il risanamento della finanza pubblica: il rapporto debito pubblico/PIL cala al 104% nel 2018, ben
sotto quanto richiesto dagli impegni europei (6-pack e fiscal compact); il saldo di bilancio passa da un deficit pari al 2,0% del PIL nel 2014 a un attivo dell’1,5% nel 2018 (Grafici 5.7 e 5.8)
197
Grafico 5.7 – ...sul saldo della PA e...
(Italia, in % del PIL)
Con proposte
Senza proposte
Fonte: elaborazioni e stime CSC.
Grafico 5.8 – ... sul debito pubblco
(Italia, in % del PIL)
Senza proposte
Con proposte
Fonte: elaborazioni e stime CSC.
Nell’insieme il progetto Confindustria mobilita 316 miliardi di euro in cinque anni e le
principali voci possono essere distinte a seconda che agiscano dal lato della competitività, dal lato della domanda e dal lato del reperimento delle risorse.
Sul fronte della competitività agiscono: l’eliminazione in cinque anni del costo del
lavoro dalla base imponibile IRAP; il taglio di 11 punti in tre anni degli oneri sociali
pagati dalle imprese manifatturiere, in modo da abbassare dell’8% il costo del lavoro; la
198 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
detassazione strutturale per un miliardo l’anno del salario di produttività contrattato in
azienda; l’introduzione di un credito di imposta strutturale del 10% sugli investimenti
in ricerca e sviluppo.
Dal lato della domanda intervengono: la liquidazione dei due terzi (48 miliardi)
dei debiti commerciali accumulati in passato dalla PA per acquisti di beni e servizi e
per lavori (una misura che da sola vale oltre 10 miliardi di investimenti aggiuntivi in
tre anni, un aumento del PIL dell’1,4% e la creazione di 243mila posti di lavoro entro
il 2018); il potenziamento dell’ACE, che facilita la patrimonializzazione delle imprese e
quindi l’accesso al credito; la riduzione dei tempi di ammortamento dei beni di investimento, in particolare per quelli ad alto contenuto tecnologico; l’introduzione di un
credito d’imposta di un miliardo annuo per sette anni per gli investimenti innovativi al
Sud, utilizzando i fondi europei per la coesione; il varo di un incentivo di 250 milioni
annui per rilanciare gli investimenti in beni strumentali sul modello della legge Sabatini; la proroga strutturale della detrazione del 50% per la riqualificazione del patrimonio
edilizio, con estensione anche all’arredo; il deciso aumento degli investimenti pubblici
in infrastrutture e a difesa idrogeologica e antisismica del territorio e del patrimonio
edilizio; la riduzione dell’IRPEF sui redditi più bassi da lavoro dipendente, rimodulando aliquote e detrazioni e aumentando i trasferimenti agli incapienti (ciò stimola i
consumi, data la maggiore propensione alla spesa delle famiglie con redditi bassi).
A metà strada tra le misure di aumento della competitività e quelle di aumento
della domanda stanno: diminuire dal 27,5% al 23,0% l’aliquota IRES e simultaneamente
innalzare dal 20% al 23% l’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie; lavorare 40 ore
in più all’anno pagate il doppio perché la retribuzione su quelle ore viene esentata da
IRPEF, contributi sociali e IRAP; incentivare forme di part-time per i lavoratori con
almeno quarant’anni di contributi finalizzate all’assunzione di giovani; favorire la conciliazione tra partecipazione femminile al lavoro e accudimento familiare attraverso lo
strumento dei voucher, estendendo le migliori pratiche già attuate in alcune aree del
Paese; rendere strutturale il credito d’imposta per l’occupazione al Sud; aumentare gli
assegni familiari per combattere la povertà tra i minori, legando la maggiorazione alla
frequenza e al profitto scolastico dei giovani. La maggior parte di queste misure, assieme
alla diminuzione dell’IRPEF sui redditi bassi, accresce la coesione sociale.
Gli interventi per reperire le risorse sono stati individuati in: taglio del 5% (l’1%
all’anno) della spesa pubblica corrente al netto di interessi, prestazioni sociali, acquisti
di beni e servizi e incentivi alle imprese; estensione agli enti territoriali dell’obbligo di
ricorrere alle convenzioni CONSIP per tutti gli acquisti di beni e servizi; innalzamento
di due punti delle aliquote IVA ridotte (gran parte del maggior gettito finisce alle famiglie sottoforma, come detto sopra, di riduzione dell’IRPEF), rafforzando così gli effetti
paragonabili a una svalutazione del cambio dei contenuti del progetto; riordino degli incentivi alle imprese; armonizzazione dei contributi per gli ammortizzatori sociali contro
il rischio di disoccupazione; aumento del contrasto all’evasione.
La seconda parte del progetto Confindustria è costituita dalle riforme strutturali, da
avviare simultaneamente al varo della terapia d’urto in modo che, come detto, dispieghino la loro efficacia quando si affievoliranno gli effetti di quella terapia. Le riforme
199
riguardano ogni campo. Le istituzioni, con il superamento del bicameralismo perfetto,
la riduzione del numero dei parlamentari, l’abolizione delle province, l’accorpamento
dei piccoli Comuni, la riforma del Titolo V della Costituzione (riattribuendo esclusivamente allo Stato le competenze su materie di interesse nazionale). L’affermazione dello
Stato di diritto, tutelando cittadini e imprese dagli abusi compiuti da qualunque organo
pubblico. Il mercato, riducendo il perimetro dell’intervento pubblico, proseguendo nelle liberalizzazioni e riformando le Authority. La giustizia civile, allineandone i tempi alla
media europea con il rafforzamento dei Tribunali delle imprese, il completamento della
geografia giudiziaria e la digitalizzazione del processo.
È cruciale un salto di qualità nella pubblica amministrazione e nei rapporti di questa
con le imprese e con i cittadini. Ciò comincia con una profonda riorganizzazione attraverso la riduzione degli enti, la concentrazione delle funzioni, la revisione degli uffici, un
meccanismo di premi e sanzioni del personale. Questo salto, per essere reale, deve essere
accompagnato da una radicale semplificazione che abbatta gli oneri burocratici, velocizzi
i procedimenti attraverso il passaggio al digitale, valorizzi le certificazioni di qualità e
ambientali e standardizzi su tutto il territorio l’applicazione delle norme.
Inoltre, il progetto chiede di intervenire per arricchire il capitale umano con l’abolizione del valore legale dei titoli di studio e con la valutazione pienamente efficace di
scuola e università. In particolare, vanno liberalizzate le tasse universitarie e potenziate
le borse di studio. Inoltre va resa obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro negli istituti
professionali come in Austria, Germania e Svizzera e introdotti tirocini e praticantati durante i corsi universitari seguiti da tutor aziendali. La durata del curriculum scolastico va
abbassata di un anno, da 13 a 12, equiparandola così a quella dei maggiori paesi europei.
Altri importanti interventi riguardano il fisco e il mercato del lavoro, l’energia e
l’ambiente, la ricerca e l’internazionalizzazione delle imprese, le infrastrutture, i trasporti
e la logistica, la cultura come motore di sviluppo.
5.5
Conclusioni
L’economia e la società italiane patiscono gli effetti di una recessione che per profondità
e durata non ha precedenti nella storia del Paese. Questa recessione si è innestata su un
lungo periodo di stagnazione. L’una e l’altra trovano spiegazione nei nodi strutturali che
ostacolano lo sviluppo, il fare impresa e l’arricchimento del capitale umano. Nodi che,
se non sciolti rapidamente, porteranno l’Italia ad arretrare sensibilmente rispetto ad altre
economie, avanzate e non.
L’esercizio di benchmarking indica chiaramente che la posizione relativa del Paese
può tornare indietro, nei confronti degli USA e della media UE a quel che era all’inizio
del miracolo economico seguito alla ricostruzione post-bellica. Ma indica anche quali
sono i punti di forza su cui continuare a puntare, con maggiore decisione, e quali sono
invece le lacune su cui intervenire.
Il principale punto di forza è la vocazione manifatturiera: una virtù figlia della necessità di produrre “cose che piacciono” per venderle oltreconfine e avere così le risorse
per pagare le bollette di import legate a un elevato standard di vita. Il manifatturiero è
200 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
minacciato dalla perdita di competitività di costo e dalla bassa domanda interna: si può
operare su entrambi i fronti, come dimostra il progetto Confindustria, senza pregiudicare l’equilibrio dei conti pubblici e ottenendo significativi e rapidi risultati.
I punti di debolezza riguardano soprattutto il contesto del fare impresa e l’utilizzo e
la dotazione di capitale umano. Bassa occupazione giovanile e femminile sono fonte di
iniquità e un grande spreco. I pochi investimenti in ricerca e l’inadeguatezza del sistema
di istruzione, nella quantità e nella qualità, pregiudicano il benessere futuro dell’Italia
perché la rendono male attrezzata a partecipare alla gara della conoscenza.
La guarigione dell’Italia dalla malattia della lenta crescita è un gioco a somma positiva, in cui tutti sono vincitori. A maggior ragione essa richiede la condivisione e la
partecipazione di tutti gli attori economici, politici e sociali. Nessuno si può chiamare
fuori. Sia perché nessuna classe o categoria sociale è pienamente esente da responsabilità
riguardo alle cause che hanno portato l’economia italiana alle difficoltà attuali. Sia perché solo con la piena e convinta collaborazione di tutti la crisi riacquisterà il significato
proprio di passaggio da una condizione a un’altra, di cambiamento e trasformazione in
direzione di una nuova stagione di progresso, anziché di impoverimento. Dipende solo
dagli italiani.
201
Note
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CIG, contratti di solidarietà, trasformazione da
tempo pieno a part-time, non ricorso agli straordinari.
Si tratta del Trade Performance Index costruito
da WTO e UNCTAD sulla base di 22 indicatori
quantitativi. Per una descrizione completa del
TPI si veda International Trade Centre (2007).
Cipolla (1995).
Su quest’ultimo aspetto si veda Franklin (2006).
Scrive Friedman, a proposito degli Stati Uniti:
«Perfino il linguaggio politico nei dibattiti pubblici ha ultimamente perso gran parte del suo
già scarso contegno civile, fondandosi invece
su accuse personali, indagini e recriminazioni».
Una constatazione che calza a pennello al caso
italiano. Sul legame tra convivenza civile e crescita economica si veda anche Paolazzi (2011).
Così si intitola un approfondimento contenuto
in Centro Studi Confindustria (2011).
Questo cambiamento strutturale è stato messo
in luce in Centro Studi Confindustria (2010a).
Su questo punto si veda Paolazzi e Sylos Labini,
(2013).
Tra i primi a mettere in dubbio la valenza del
PIL e del PIL per abitante per misurare il benessere ci fu Giorgio Fuà (1993).
Ultimo, in ordine di tempo, è il primo rapporto sul Benessere equo e sostenibile, elaborato da
CNEL e ISTAT e pubblicato nel 2013 e che in-
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
dividua dodici dimensioni del benessere: salute,
istruzione e formazione, lavoro e conciliazione
dei tempi di vita, benessere economico, relazioni
sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere
soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi.
Dimensioni difficilmente aggregabili in un solo
indice, per un’ovvia questione di ponderazione.
In questo stesso volume Gianni Toniolo dà
conto di possibili aggiustamenti del PIL nel
confronto tra Stati Uniti e UE per includere
alcune delle differenze nei sistemi sociali.
Per un’analisi completa su questi due aspetti si
veda Centro Studi Confindustria (2010b).
Si veda il contributo di Stefano Micossi a questo volume.
Su questo punto si rimanda a Rossi (2009).
Si veda in questo volume il saggio di Gianni
Toniolo.
Le difficoltà che avrebbe incontrato l’Italia
nell’affrontare le sfide della globalizzazione e
delle nuove tecnologia a causa delle sue caratteristiche sociologiche radicate nella storia erano
già prevedibili alla fine degli anni 90. Si veda su
questo Galimberti e Paolazzi (1998).
Paolazzi e Sylos Labini (2013).
Il progetto Confindustria per l’Italia: crescere si
può, si deve è scaricabile sul sito www.confindustria.it.
202 5. Per l’Italia sprofondata nella crisi la carta vincente del manifatturiero
203
Bibliografia
Abramovitz, M. (1986), “Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind”, The Journal of Economic History, vol. 46, n. 2, pp. 385-406.
Alesina, A. e F. Giavazzi (2006), Goodbye Europe,
MIT Press, Cambridge Mass. (trad. it.: Goodbye
Europa, Rizzoli, Milano 2006).
Alesina, A., Glaeser, E. e B. Sacerdote (2005), “Work
and Leisure in the United States and Europe:
Why So Different?”, NBER Macroeconomics
Annual, MIT Press, Cambridge Mass.
Allerkamp, D.K. (2009), “Intergovernmentalism reloaded: The Transformative Power of ‘Intergovernmental’ Council Policy-Making”, mimeo.
Amato, G. e J. Ziller (2007),The European Constitution: Cases and Materials in EU and Member
States’ Law, Edward Elgar, Cheltenham.
Baily, M. e J.F. Kirkegaard (2004), “Transforming
the European Economy”, Institute for International Economics, Washington DC.
Banca Mondiale (2013), Doing Business in a more
transparent world.
Barkbu, B., Rahman, J. e R. Valdes (2012), Fostering
growth in Europe, IMF Staff Discussion Note,
SDN/12/07, 18 giugno.
Bassanini, F. (2010), Deregolazione, migliore regolazione e competitività del Paese, in A. Natalini e
G. Tiberi (a cura di), La tela di Penelope. Primo
rapporto Astrid sulla qualità della regolazione e la
semplificazione burocratica, Il Mulino, Bologna.
BIS Department for Business Innovation & skills
(2011), “The economic consequences for the
UK and the EU of completing the Single Market”, BIS Economic Paper n. 11.
Blanchard, O. (2004), “The Economic Future of Europe”, The Journal of Economic Perspectives,
18(4), pp. 3-26.
Boltho, A. e W. Carlin (2013), “EMU’s Problems:
Asymmetric Shocks or Asymmetric Behavior?”,
Comparative Economic Studies, pubblicato
online.
Bredgaard, T. e A. Daemmrich (2012), “The Welfare State as an Investment Strategy: Denmark’s
Flexicurity Policies”, mimeo, forthcoming in
Oxford Handbook.
Bresnahan, T. e M. Trajtenberg (1995), “General
Purpose Technologies. Engines of Growth?”,
Journal of Econometrics, 65, pp. 83-108.
Bruzzone G. e F. Peirce (2012), “Formazione e attuazione delle politiche europee: le sfide per le
pubbliche amministrazioni in Italia”, in M.P.
Chiti e A. Natalini (a cura di), Lo Spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni
dopo il Trattato di Lisbona, il Mulino, Bologna.
Centro Studi Confindustria (2010a), Scenari industriali, n. 1, SIPI, Roma.
Centro Studi Confindustria (2010b), “Se l’Italia punta sull’ICT come motore di sviluppo”, Scenari economici, n. 10, SIPI, Roma.
Centro Studi Confindustria (2011), Scenari Industriali, n. 2, SIPI, Roma.
Centro Studi Confindustria (2012a e 2012b), Scenari
economici, n. 14, giugno 2012, e n. 15, settembre
2012.
Chen, V., Cheng, B., Levanon, G., Ozyildirim, A. e
B. van Ark (2012), “Projecting Global Growth”
The Conference Board, Economics Working
Papers, EPWP n. 12-02, novembre.
Cipolla, C. M. (1995), Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi, Mondadori, Milano.
Cipolla, C.M. (2003), Vele e cannoni, Il Mulino,
Bologna.
Commissione europea (2010), Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Una politica industriale
integrata per l’era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità, COM(2010) 614 final.
Commissione europea (2011a), Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare
la fiducia, COM(2011) 206 final, Bruxelles, 13
aprile.
Commissione europea (2011b), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
204
al Comitato delle regioni – Riesame dello “Small
Business Act” per l’Europa, COM(2011) 78 final,
23 febbraio.
Commissione europea (2012a), Commission staff
working document. Action programme for reducing administrative burdens in the EU final report, Accompanying the document Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Regulatory Fitness,
SWD(2012) 423 final, 12 dicembre.
Commissione europea (2012b), Annex – Draft Joint
Employment Report to the Communication from
the Commission Annual Growth Survey 2013,
COM(2012) 750 final, 28 novembre.
Commissione europea (2012c), Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e
alla Banca europea per gli investimenti – Stato
dell’integrazione del Mercato Unico 2013 - Contributo all’analisi annuale della crescita 2013,
COM(2012) 752 final, 28 novembre.
Commissione europea (2012d), Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L’Atto per il mercato unico
II. Insieme per una nuova crescita, COM(2012)
573 final, Bruxelles, 3 ottobre.
Commissione europea (2013), Internal Market Scoreboard 26, febbraio.
Confindustria (2013), Il progetto Confindustria per
l’Italia: crescere si può, si deve, www.confindustria.it.
Crafts, N. e G. Toniolo (1996), “Postwar Growth:
An Overview” in N. Crafts e G. Toniolo (a
cura di), Economic Growth in Europe Since 1945,
Cambridge University Press, Cambridge.
Crafts, N. e G. Toniolo (2008), “European Economic Growth, 1950-2005: An Overview”, CEPR
Discussion paper 6863.
Crafts, N. e G. Toniolo (2010), “Aggregate Growth
1950-2005”, in S. Broadberry e K. O’Rourke
(a cura di) The Cambridge Economic History of
Modern Europe, Cambridge University Press,
Cambridge, vol. 2, pp. 296-332.
Crafts, N. e G. Toniolo (2012), “‘Les Trenteglorieuses’:
From the Marshall Plan to the Oil Crisis” in
Dan Stone, The Oxford Handbook of Postwar
European History, Oxford University Press, Oxford, pp. 356-378.
bibliografia
Craig, P. (2011), The Lisbon Treaty: Law, Politics and
Treaty Reform, Oxford University Press, Oxford.
Czernich, N., Falck, O., Kretschmer, T. e L. Woessman, (2009), “Broadband infrastructure and
economic growth”, CESifo Working Paper n.
2861.
Daneshkhu, S. (2012), “Champagne stops flowing
and toy sales suffer as French lose their joie de
vivre”, The Financial Times, 22-23 dicembre, p.
1.
De Schoutheete, P. (2011), “Decision-making in the
Union”, Notre Europe: Policy Brief, n. 24.
De Schoutheete, P. e S. Micossi (2013), “On Political
Union in Europe: The Changing Landscape of
Decision-making and Political Accountability”,
CEPS Essay, n. 4, 21 febbraio.
Denis C., Mc Morrow, K., Röger, W. e R. Veugelers (2005), “The Lisbon Strategy and the EU’s
structural productivity problem”, Economic
Papers n. 221.
Dyson, K. (2012), “Economic and Monetary
Union”, in E. Jones, A. Menon e S. Weatherill
(a cura di), The Oxford Handbook of the European Union, Oxford University Press, Oxford,
pp. 453-68.
Dyson, K. (a cura di) (2008), The Euro at 10: Europeanization, Power, and Convergence, Oxford
University Press Oxford.
Eichengreen, B. (1996), “Institutions and Economic Growth: Europe after World War II”, in
N. Crafts e G. Toniolo (a cura di), Economic
Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 38-72.
Eichengreen, B. (2007), The European Economy since
1945, Princeton University Press, Princeton.
Eichengreen, B. e P. Velasquez (2000), “Institutions
and Economic Growth in Postwar Europe: Evidence and Conjectures”, in B. van Ark, S. Kuipers e B. Kuper (a cura di), Productivity, Technology and Economic Growth, Kluwer, Dordrecht,
pp. 91-126.
Fabbrini, S. (2008), “Contesting the Lisbon Treaty:
Structure and Implications of the Constitutional Divisions Within the European Union”,
European Journal of Law Reform, X, n. 4, pp.
457-476.
Fabbrini, S. (2010),Compound Democracies: Why the
United States and Europe Are Becoming Similar,
Oxford University Press, Oxford.
Fabbrini, S. (2012a), “Le implicazioni istituzionali
della crisi dell’euro”, il Mulino, n. 1, pp. 96-106.
205
Fabbrini, S. (2012b), “After the Euro Crisis: The
President of Europe. A New Paradigm for Increasing Legitimacy and Effectiveness in the
EU”, CEPS and EuropEos Commentary, n.12, 1
giugno, pp. 1-8.
Fabbrini, S. (2013), “Intergovernmentalism and Its
Limits: The Implications of the Euro Crisis on
the European Union”, Comparative Political
Studies, di prossima pubblicazione.
Fabbrini, S. e S. Micossi (2012), “Sul futuro dell’Unione Europea”, EuropEos, n. 1, 13 luglio.
Faini, R. (2006), “Europe: A Continent in Decline?”
in R. Paul e G. Toniolo (a cura di), The Global
Economy in the 1990s. A Long-run Perspective,
Cambridge University Press, New York, pp.
69-89.
Fairbank, J.K. e M. Goldman (2006), China, Harvard University Press, Cambridge Mass.
Findlay, R. e K. O’Rourke (2007), Power and Plenty.
Trade, War and the World Economy in the Second
Millennium, Princeton University Press, Princeton.
Fontanella-Kahn, J. (2013), “Burnt and abandoned”,
The Financial Times, 3 gennaio, p. 7.
Franklin, B. (2006), Il valore etico della crescita. Sviluppo economico e progresso civile, Università
Bocconi editore, Milano.
Fuà, G. (1993), Crescita economica. L’insidia delle cifre, Il Mulino, Bologna.
Fukuyama, F. (1992), The End of History and the Last
Man, Free press, New York.
Galimberti, F. e L. Paolazzi, (1998), Il volo del calabrone. Breve storia dell’economia italiana nel
Novecento, Le Monnier, Firenze.
Gordon, R. (2007), “Comparing welfare in Europe and the United States”, in B. Eichengreen,
D. Stiefel e M.A. Landesmann (a cura di),
The European Economy in an American Mirror,
Routledge, New York, pp. 15-40.
Gordon, R. (2012), “Is US Economic Growth Over?
Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds”, NBER Working Paper 18315.
Gordon, R. (2012), “The Source of Productivity
Growth”, in J.P. Fitoussi (a cura di), Beyond the
short term. A study of past productivity trends and
an educated guess on futures ones, Ligep Report
Luiss, Roma.
Gust, C. e J. Marquez (2004), “International Comparisons of Productivity Growth: the Role of
Information Technology and Regulatory Practices”, Labour Economics, 11, pp. 33-58.
Heipertz, M. e A. Verdun (2010), Ruling Europe: The
Politics of the Stability and Growth Pact, Cambridge University Press, Cambridge.
Heritier, A. e M. Rhodes (a cura di) (2010), New
Modes of Governance in Europe, Palgrave Macmillan, Londra.
High Level Working Group on Jobs and Growth
(2013), Final Report (February 11).
Hix, S. (2008), What’s Wrong with the European
Union and How To Fix It, Polity, Cambridge.
Hobsbawm, E. (1994), The Age of Extremes, The Short
Twentieth Century, 1914-1991, Vintage Books,
New York.
International Trade Centre (2007), Trade Competitiveness Map, Technical Notes.
Jorgenson, D., Ho, M. e K. Stiroh (2008), “A Retrospective Look at the U. S. Productivity Growth
Resurgence”, Journal of Economic Perspectives,
vol. 22, n. 1.
Judt, T. (2005), Postwar. A History of Europe Since
1945, Penguin Books, Londra.
Kuznets, S. (1966), Modern Economic Growth, Yale
University Press, New Haven.
Lacroix, J. e K. Nicolaidis (a cura di) (2010),European Stories: Intellectual Debates on Europe in
National Context, Oxford University Press, Oxford.
Livi Bacci, M. (2002), Storia minima della popolazione del mondo, Il Mulino, Bologna.
Lutzeler, P.M. (1994), Europe after Maastricht: American and European Perspectives, Berghahn Books, Oxford.
Maddison, A. (2001), The World Economy. A Millennial Perspective, OCSE, Parigi.
Mann, T. (1924), La montagna incantata, traduzione
italiana, Mondadori, Milano 1965.
Musu, I. (2011), La Cina contemporanea, Il Mulino,
Bologna.
Nicoletti, G. e S. Scarpetta (2005), “Regulation and
Economic Performance: Product Market Reforms and Productivity in the OECD”, OECD
Economics Department Working Paper n. 460.
Norman, P. (2003), The Accidental Constitution. The
Story of the European Convention, Eurocomment, Bruxelles.
O’Mahony, M. e M. Timmer (2009), “Output, Input and Productivity Measures at the Industry
Level: the EU KLEMS Database”, Economic
Journal, 119(538), pp. F374-F403.
OCSE (2012), “Looking to 2060: Long-term global
growth prospects”, OECD Economic Policy
Papers, n. 3.
OCSE (2012a), Employment Outlook.
206
OCSE (2012b), Economic Surveys – European Union,
marzo.
OCSE (2013), Going for Growth 2013, febbraio.
Oliner S., Sichel, D. e K. Stiroh (2007), “Explaining
a Productive Decade”, Brookings Papers on
Economic Activity n. 2.
Olson, M. (1982), The Rise and Decline of Nations,
Yale University Press, New Haven.
Olson, M. (1996), “The Varieties of Eurosclerosis,
the Rise and Decline of Nations since 1982”,
in N. Crafts e G. Toniolo (a cura di), Economic
Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 73-94.
Panagariya, A. (2001), “India’s Economic Reforms”,
Asian Development Bank, ERDC Policy Briefs
n. 2.
Paolazzi, L. (2011) a cura di, Libertà e benessere in Italia. 150 di storia unitaria e i traguardi del futuro,
Laterza, Bari.
Paolazzi, L. e M. Sylos Labini (2013) a cura di, Italia
al bivio. Riforme o declino: la lezione dei paesi di
successo, LUISS University Press, Roma.
Prescott E. (2004), “Why do Americans Work So
Much More than Europeans?”, Federal Reserve
Bank of Minneapolis Quarterly Review.
Puetter, U. (2006), The Eurogroup: How a Secretive Circle of Finance Ministers Shape European
Economic Governance, Manchester University
Press, Manchester.
Puetter, U. (2012), “Europe’s deliberative intergovernmentalism: the role of the Council and European Council in EU economic governance”,
bibliografia
Journal of European Public Policy, 19, n. 2, pp.
161-178.
Rossi, S. (2009), Controtempo. L’Italia nella crisi
mondiale, Laterza, Bari.
Salvati, M. (2011), Tre pezzi facili sull’Italia. Democrazia, crisi economica, Berlusconi. Il Mulino,
Bologna.
Smith, K.E. (2008), European Union Foreign Policy
in a Changing World, Polity, Cambridge.
Spater, J. (2012), “Comapring Welfare in Europe
and the US: beyond GDP per capita”, mimeo,
Duke University Economics Department.
Spence, M. (2011), The next convergence. The future
of economic growth in a multispeed world, Farrar,
Straus and Giroux, New York; trad. it. La convergenza inevitabile, Laterza, Roma-Bari 2012.
Stone Sweet, A. (2000), Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe, Oxford University
Press, Oxford.
Timmer M., Inklaar, R., O’Mahony, M. e B. Van
Ark (2010), Economic Growth in Europe: a comparative industries perspectives, Cambridge University Press, Cambridge Mass.
Toniolo G. (a cura di) (2013), The Oxford Handbook
of the Italian Economy Since Unification, Oxford
University Press, New York.
World Bank (1997), China 2020: Development Challenges in the New Century, World Bank, Washington, DC.
World Economic Forum (2013), Rebuilding Europe’s
competitiveness, gennaio.
Carta ecologica:
La carta che hai in mano è Elementary Chlorine Free, cioè prodotta senza l’uso di cloro.
Il rispetto dell’ambiente significa qualità della vita.
Finito di stampare nel mese di aprile 2013
presso Prontostampa srl
Via Redipuglia 150 - 24045 Fara Gera d’Adda (BG)