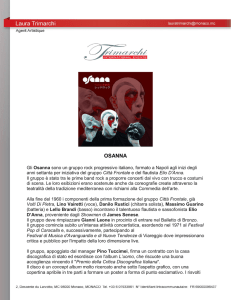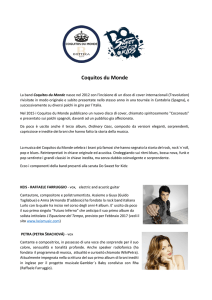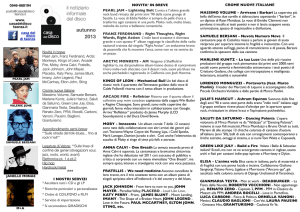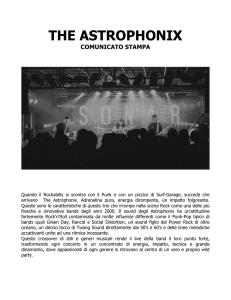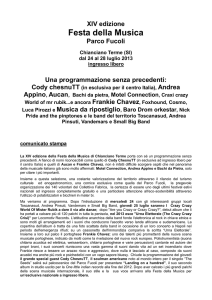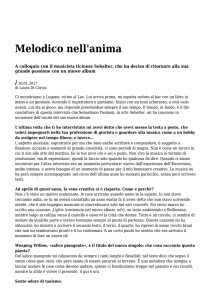digital magazine novembre 2009
N.61
ooioo
La battaglia di Yoshimi
Moon duo // Black To Comm
Lucky Elephant // Edda
Michael J. Sheeny // Felix
happy birthday warp!
20 Warped Years
RUINS // JOOKABOX
HALF-HANDED CLOUD
TEARDROP EXPLODES
Sentireascoltare n.61
La casa editrice Odoya e SentireAscoltare presentano:
Turn On
PJ Harvey
Musica.Maschere.Vita
Un libro di Stefano Solventi
La sua musica è una sferzata misteriosa e misteriosamente liberatoria.
Un’ossessione blues sbocciata nella culla del Dorset, cresciuta tra inquietudini adolescenziali e una incontenibile brama di mondo. Quando infine
è esplosa, lo ha fatto col piglio travolgente dei predestinati. Dei suoi primi
quaranta anni, Polly Jean Harvey ne ha dedicati venti a tracciare una
parabola fatta di musica, maschere e vita.
240 pagine
Volume illustrato
euro 15,00
p. 4
Moon Duo
5
Black to Comm
6
Lucky Elephant
7
Edda
8
Michael J Sheeny
9
Felix
10
Ruins
12
Jookabox
14
Half-Handed Cloud
Rubriche
108
Giant Steps
109
Classic Album
116
La sera della prima
122
A night at the Opera
124
I cosiddetti contemporanei
Drop Out
16
20 warped years
24
(OO) I (OO) got the rhythm
concept Album
Recensioni
Un libro di Daniele Follero
Introduzione Franco Fabbri
Nata sull’onda della rivoluzione musicale di fine anni Sessanta, la pratica
del concept album ha accompagnato la maturità del rock, scrivendo un
capitolo importantissimo nella storia della popular music. I dischi “a tema”
continuano ancora oggi a rappresentare un affascinante mezzo espressivo,
anche negli ambienti del pop da classifica. I recenti concept album dei Green Day sono la testimonianza più lampante di un filo rosso che, partendo
da Frank Sinatra, tiene insieme Sgt. Pepper’s dei Beatles, Tommy degli Who,
The Dark Side of the Moon e The Wall dei Pink Floyd, le storie d’amore di
Claudio Baglioni arrivando fino ai Dream Theater e al brit-pop.
226 pagine
Volume illustrato
34
Bloody Beetroots, Broadcast/Focus Group, Teatro degli Orrori, Comaneci...
Rearview Mirror
98
Teardrop Explodes, Flipper, MF Doom...
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale, Teresa Greco
euro 15,00
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Giorgio Avezzù, Luca Barachetti, Salvatore Borrelli,
Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo, Luca Colnaghi, Daniele Follero, Gabriele Marino, Francesca
Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio
Puglia, Aldo Romanelli, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Stefano Solventi, Giancarlo Turra, Fabrizio
www.odoya.it
www.sentireascoltare.com
Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
In tutte le librerie dal 19 novembre
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
OOIOO
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza
autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Black To comm
Moon Duo
New kraut wave
Alphabet Drones
I suoni e la magia di Marc Richter, boss della
Dekorder, alchimista del laptop, krauto illuminato a
suon di drones
Dal frontman dei Wooden Shjips arriva
un nuovo progetto solista e questa volta
il ''rock'' è davvero lontano.
C
osa induce il cantante e chitarrista di una band
piuttosto nota (sempre negli angusti limiti dei
rispettivi ambiti) come i Wooden Shjips ad intraprendere un progetto parallelo dalle più ristrette
sembianze? La volontà di dar vita ad un duo, formula
da cui Ripley Johnson dichiara di essere da sempre affascinato, per poter mantenere la cosa il più
possibile essenziale e facile da gestire, specialmente
in sede live. Ed è così che nasce la collaborazione tra
Johnson e Sanae Yamada, artista performativa
forse già nota al pubblico del quartetto di Frisco
per aver partecipato con le proprie proiezioni ad
alcuni concerti della band. Nella scorsa primavera è
un pezzo di partecipazione al CD compilation Yeti
7 dell'omonimo magazine a sancire l'esistenza del
Moon Duo: si tratta di una prima versione, più
breve, di quella Love On The Sea che sarà di lì a poco
ripresa in forma più dilatata sulla prima facciata del
disco d'esordio.Tuttavia la proposta è già chiara: psichedelia solo vagamente chitarristica e molto più
incline ai vortici del kraut che non ai riff di matrice
4
Turn On
U
blues/rock di cui invece si cibano i progenitori Wooden Shjips; il tutto cullato (se così si può dire)
da un cantato/parlato di chiara ispirazione Veganiana. Ma è presto tempo per autoprodursi il primo
singolo; esce così per Sick Thirst, label inventata per
l'occasione, un 12 pollici composto da due lunghe
jam in cui i nostri mettono sul tavolo le carte delle proprie influenze: Suicide, Neu!/La Düsseldorf, Silver Apples e ovviamente molti altri.
La cosa non passa inosservata ed infatti è l'iperattiva Sacred Bones a farsi avanti e a pubblicare,
proprio di recente, il secondo EP 12" Killing Time, i
cui quattro pezzi risultano meno feroci dei precedenti e maggiormente sospesi in un limbo astrale
creato dalle tastiere della Yamada e delle algide
drum-machine che meccanicizzano ed ovattano il
tutto. Se l'evoluzione reggerà il ritmo fin qui sostenuto e se il nome di Woodsist che campeggia, tra
gli altri, sul Myspace del gruppo non è lì per caso,
sentiremo ancora parlare del duo lunare.
Andrea Napoli
n personaggio del genere non poteva non destare l’attenzione di Julian Cope, che dall’alto della sua regolare rubrica, Head Heritage, si trova
ad un certo punto a magnificare il tedesco Marc
Richter, ovvero Black To Comm, innalzandolo al rango di drone master dei nostri giorni, di quelli che
possono salvare “tutti i drone freaks annoiati da una
pletora ininterrotta di dischi tutti simili e con packaging
ridotti all’osso”. La scoperta per Cope avviene con il
tentacolare e cacofonico WIR KÖNNEN LEIDER NICHT ETWAS MEHR ZU TUN, ovvero “Non possiamo fare queste canzoni in un modo
diverso da come le abbiamo fatte”.
Canzoni per modo di dire. Black to Comm è infatti un musicista abbastanza sui generis, di quelli che
individui subito in una folla, e per un genere così inflazionato come l’ambient noise dei nostri giorni, la
caratteristica è di quelle da porre all’occhiello come
un vanto. Richter eccelle nel bozzetto naive, surreale e onirico, condito con una sapiente miscela di
kraut rock anni 2000, laptop music, field recordings
a tutto spiano. Ingredienti tutto sommato consueti
di questi tempi, ma è il modo in cui vengono miscelati, che fa di lui un nome da tenere sott’occhio per
i suoni più originali dell’attuale scena sperimentale.
Non a caso Richter è anche l’uomo che gestisce
la Dekorder etichetta tedesca che sta pubblicando tutto il meglio del settore. La prolificità è degna
dell’epoca contemporanea, questo 2009 però merita di essere considerato come l’anno della svolta.
Prima una pubblicazione su Digitalis, interessante,
ma ancora in regola con lo stile standard, intitolata
Charlemagne & Pippin, per poi passare al vero
asso nella manica calato su Type records proprio in
questi giorni, ovvero il migliore dei suoi lavori, intitolato Alphabet 1968.
Trattasi di un disco quanto meno di svolta, innanzitutto nella durata delle composizioni e nel taglio
generale che viene dato al disco: ovvero dieci tracce
in 45 minuti, uno standard compresso e regolarizzato se paragonato alle precedenti espressioni del
musicista tedesco e comunque all’andazzo generale
della scena ambient contemporanea. Alphabet
1968 quindi ragiona maggiormente sul concetto di
vignetta, che come sempre è surreale e astratta, ma
con un senso della sintesi che giova. Richter ha la
mano giusta per dosare tutti gli equilibri necessari. Registrazioni e field recordings impiantate su un
panorama algido, ma non severo, di ariette digitali
leggere come l’aria e a tratti dense come le nebbie
invernali.
Antonello Comunale
Turn On
5
Lucky Elephant
Edda
Happy Sad
Secondo natura
Pop e scrittura dinamica, un’attitudine giocoso/malinconica e una buona miscela degli ingredienti a
disposizione fanno un esordio promettente. Lucky
Elephant is the reason.
R
ob Da Bank, dj inglese di Radio 1 nonché titolare dell’etichetta Sunday Best e organizzatore,
tra le altre cose, del Bestival che si tiene nell’isola di
Wight, ha avuto l’occhio lungo a scoprire e mettere
sotto contratto i quattro Lucky Elephant. Metà
gruppo proviene appunto dall’isola citata, il cantante e frontman Emmanuel ‘Manu’ Labescat è
invece originario del sud ovest della Francia, ed è
colui il quale fornisce alla band il tocco vocale esotico così riconoscibile ad un primo ascolto.
Il cuore della formazione si è costituito intorno ai
Treacle Studios a Londra, gestito dal bassista Paul
Burnley, un piccolo ma attivo studio di registrazione
indipendente, che ha visto la nascita del collettivo. In
realtà prima ci sono stati i Boomclick, formazione
a due di Burnley e Sam Johnson, attuale chitarrista
e pianista degli Elefanti, già sotto contratto con Rob
Da Bank e poi l’incontro con Labescat. Il resto è già
storia attuale.
Forse la provenienza geografica non continentale
ha fatto sì che la band si stabilizzasse nei dintorni di
una solarità e di un’attitudine gioiosa/giocosa che
fa del pop e di una scrittura dinamica le sue carte
vincenti. Il lato happy/sad della vicenda è ben dosato,
contribuendo ai cambi di ritmo dell’album d’esordio
Starsign Trampoline (in spazio recensioni),
che si mantiene sobrio nelle sonorità, prevedendo
6
Turn On
anche l’uso di vecchi synth, di un piano Wurlitzer,
di un harmonium, nonché ukulele e chitarre spesso acustiche. Il contrasto della musica può riflettere
sociologicamente le caratteristiche dei posti turistici dai quali il gruppo proviene, nei quali la frenesia
delle estati è seguita dalla lunga noia invernale. Ma
queste sono solo ipotesi, in realtà. Quel che conta
è il risultato dato dalla fusione degli elementi a disposizione.
Ecco allora un french touch sensuale con accento prettamente nasale, una miscela che prevede brit
pop emotivo/espressivo coniugato con la chanson
francese da un lato, e con una scrittura d’autore
mediata dai Sixties e rivista con gli ultimi decenni
dei Morrissey e dei Paul Weller. E ancora elementi di afrobeat e spezie tropical che ultimamente
abbiamo trovato spesso, dai Vampire Weekend
in su e in giù, e un sentore jazzy da revival Style
Council che ogni tanto si manifesta. Ma ci sono
anche il dub, il blues e lo shoegaze tra le melodie
sparse dell’esordio. A questo si aggiunga un’emotività che si percepisce nelle liriche di Labescat, passionali, introspettive e dotate nello stesso tempo di
humour e curiosità, e che rivelano un’osservazione
minuziosa della realtà. Promettenti.
Teresa Greco
Torna l'ex cantante dei Ritmo Tribale con un disco
colmo di rarefazioni e riferimenti autobiografici
“C
reare mi aveva impedito di vivere veramente.
Scrivevo canzoni. Il mio lavoro era andare dietro alle emozioni, che è anche una cosa giusta. Ma ad
un certo punto le emozioni finiscono. E allora bisogna
cercare di trovare qualcosa di vero, come la vita reale.
E io di questa cosa avevo paura”. E la vita reale l'ha
trovata, Stefano “Edda” Rampoldi. Operaio
specializzato in ponteggi e quarantaseienne musicista a “tempo perso” con in carniere un mezzo capolavoro come l'ultimo Semper Biot. Oltre che - dettagli - una delle figure cardine del rock italiano tra
Ottanta e Novanta alla guida dei seminali Ritmo
Tribale. Seminali, certo, perché seme furono di
tutta quella scena milanese - Afterhours in testa che proprio nei Novanta sdoganò il rock in italiano,
creando un nuovo punto di riferimento per miriadi
di musicisti e ascoltatori. Il Nostro, nel frattempo, si
era già eclissato tra i flutti di una tossicodipendenza
quasi inevitabile, nella spiritualità degli Hare Krishna,
comunque lontano dalla band che gli aveva regalato
notorietà e rispetto. Abbandonata, neanche a dirlo,
nel momento di massimo successo, in preda a quella
crisi di identità ben circoscritta dalle parole riportate in apertura e che già allora rivelava una sensibilità enorme ma fragilissima.Tanto che ad ascoltare
ora la musica dell'Edda solista ci si chiede quanto
lontana fosse la realtà dei Ritmo Tribale dalla personalità dubbiosa e solitaria del front-man della band.
Allora si parlava di un suono preso in prestito dai
Novanta americani - Red Hot Chili Peppers,
Pearl Jam, ma non solo - mentre il presente si
attesta su una canzone d'autore acustica, peculiare,
estremamente catartica e difficilmente riconducibile a modelli stranieri. “Semper Biot”, per parafrasare
il titolo del disco, ovvero scarna, spoglia di qualsiasi
retaggio del passato musicale del suo autore ma nel
contempo dai contenuti fortemente autobiografici.
L'idea che ci si fa ascoltando brani come Io e te,
Milano, Scamarcio, Snigdelina, è che tutto nasca da
un input immediato, quasi irresistibile, come se la
musica fosse parte integrante del percorso di recupero dell'uomo, questa volta affrontato senza l'aiuto
di comunità esterne. Da un lato verso la riscoperta
di una creatività messa in stand-by per dodici anni
ma evidentemente innata e dall'altro nel tentativo
di riprendere coscienza di sé stessi. I risultati sorprendono, se si ha la pazienza di leggere tra le righe,
anche perché è dentro ai brani che c'è tutto quello
che serve per entrare in contatto con l'artista. Grazie anche al lavoro egregio di collaboratori come
Walter Somà - autore con Edda della maggior
parte degli episodi - e Andrea Rabuffetti, fondamentale nel riscrivere la storia recente di Stefano
Rampoldi oltre la facciata da rocker maledetto che
così poco si addice a un carattere tanto trasparente.
Fabrizio Zampighi
Turn On
7
felix
Michael J. Sheehy
Ascesa e caduta di un songwriter
Per sottrazione
Una parabola da perdente, un pugno di dischi che
migliorano invecchiando, un concept album sul pugilato. Ladies & gentlemen... Mr. Sheehy
P
er chi si interessa di loosers e cause perse, il personaggio Michael J. Sheehy non è certo nuovo. I
più attenti lo avvistano una decina di anni fa, quando
canta alla testa dei Dream City Film Club, sfortunatissima band britannica che si trovò inghiottita
nell’oblio allorché in piena epopea “brit pop” pensò
di poter avere attenzione con un repertorio che
aveva per modelli Elvis e i Virgin Prunes. La
rapida fine della band causò in maniera più o meno
indiretta, da un lato l’apparizione sulle scene dei Placebo, che giocarono carte molto simili a loro, forti però di un taglio glam molto più pronunciato e
commerciabile e dall’altro l’inizio delle trasmissioni
soliste dello Sheehy. Va da sé che l’attenzione attorno ai suoi dischi ha continuato ad essere fumosa,
poco monetizzabile, parecchio dimessa e discreta,
che è poi anche un riflesso della personalità del suo
autore.
Cresciuto in una famiglia di cattolici parecchio
praticanti, con una predilezione per i dischi di Elvis
e del rock’n’roll anni ’50/ ’60, salvo poi una tardiva
e leggera inclinazione per la new wave tendente al
gotico, Sheehy è un autore classico la cui specialità
principale è quella di saper trovare sempre nuovi
varianti sul modello di Love Me Tender. Con il tempo
si è fatto sempre più raffinato e smaliziato arrivando
nel 2009 al quinto lavoro in proprio. With These
8
Turn On
Hands merita di essere considerato uno dei migliori dischi dell’anno, una sorta di concept album,
ideato su un musical ambientato nei primi anni ’60,
che Sheehy ha messo su con una band di musicisti di
supporto, omaggiati nell’intestazione del disco con
il nome di Hired Mourners. Il ciclo delle canzoni
narra la storia di Francis Delaney, un pugile fittizio
che è un riflesso distorto dell’autore, pugile anche
lui in tenera età.
Più che dalle parti di Rocky Balboa o Tony Montana, Francis Delaney e la sua storia sono più avvicinabili a quella di Rocky Graziano nelle sembianze
del Paul Newman di Lassù Qualcuno Mi Ama,
quindi una storia che vive nella sociologia e nell’immaginario tipici dello sport più popolano e popolare, con una fauna di personaggi viziosi e una serie di
ambienti maleodoranti, che giustamente stimolano
alla vignetta satirica. Un disco quindi che va ascoltato come se si stesse all’Opera tenendo il libretto
con i testi costantemente a portata di mano. Come
lonesome man Sheehy non fa una piega. Si diverte
ad immaginarsi come uno storyteller demodè riuscendoci perfettamente, anche quando indossa le
maschere un po’ storte di Tom Waits o Nick
Cave o meglio ancora… dell’icona Elvis.
Antonello Comunale
Vengono da Nottingham ed esordiscono su Kranky.
Le trame sonore dei Felix tra chamber pop, ambient
e minimalismo
U
n accumulo di elementi che in musica si risolve
nella sottrazione: questa la parabola degli inglesi Felix, duo di trentenni proveniente da Nottingham, esordienti su Kranky, autori di un chamber
pop colto e rarefatto tra ambient e droning.
Accumulo si diceva, per la mole di esperienze
variegate dei due componenti il gruppo: l’una, Lucinda Chua, con studi classici alle spalle, è violoncello, piano e voce del gruppo, nonché fotografa
professionista nonché pianista /violoncellista in tour
per Stars Of The Lid; l’altro, Chris Summerlin chitarre e drones nonché componente di molti gruppi (Lords, Kogumaza, Stage Blood nonché
Damo Suzuki's Network e Glenn Branca e la lista
qui è piuttosto lunga) nonché graphic designer e illustratore freelance per magazine e in campo musicale. Tra queste attività, l’incontro reciproco e la
nascita del duo Felix, che esordisce nel 2007 con un
split 7" single con Chris Herbert su Low Point
(As Blue As Your Eyes Lover / What I Learned From TV).
In mezzo collaborazioni a tutto campo, come si diceva, e poi l’esordio sulla lunga distanza a novembre
2009 con You Are The One I Pick (in recensioni).
Con l’album si finisce per sottrarre, costituendo nello stesso tempo una sintesi apprezzabile tra
ambient e chamber pop, droning e minimalismo, chi-
tarrismo post rock e sonorità dream pop, elementi
tutti che convivono unificati e bilanciati da un’emotività controllata ma non troppo, che rappresenta il
valore aggiunto del disco. Come dei Low più rivolti
all’ambient e al minimalismo, ma con la stessa capacità comunicativa ed emozionale.
Disco piuttosto breve, You Are The One I
Pick, che ha il merito di riportare su un versante
più pop, ma non troppo, diremo abbastanza colto,
le influenze reciproche di cui s’è detto. Il gioco di
corrispondenze intime tra il piano e il violoncello
della Chua e l’accompagnamento chitarristico di
Summerlin, uniti ad un’espressività mai strabordante sono il punto di forza del duo e dell’album tutto. Si aggiungano all’insieme liriche minimalistiche e
sghembe tra surreale, humour ed esplorazione di
sentimenti e realtà, liriche che diventano a tratti uno
spiazzante spoken word da parte di Lucinda Chua,
quasi una declamazione di intenti e che lasciano così
intravedere l’inquietudine sottesa e non troppo nascosta, a dire la verità. Finendo per assomigliare a
una Cat Power più dimessa in questo, e c’è da
dire che musicalmente, nonostante l’apparente diversità, i punti in comune tra le due non mancano.
Non si sa se Felix sia un progetto sulla lunga distanza, per il momento ci è piaciuto così com’è.
Teresa Greco
Turn On
9
I
Ruins
Goes jazzcore
Dopo l'autarchia radicale degli ultimi anni, Yoshida
torna a suonare Ruins assieme ad un altro essere
umano. Mette il sax al posto del basso e dice chiaro
e tondo di essere uno dei papà del jazzcore
10
Turn On
Ruins sono - come si dice - una band di culto.
E una di quelle senza il cui precedente sarebbe
forse venuto a mancare un intero ramo dell'albero
genealogico della musica d'oggi. Il ramo che - tra efficacia descrittiva, abuso e svuotamento di senso di
un'etichetta - chiamiamo jazzcore. Senza perdersi in
ricerche archeologiche che ci porterebbero indietro alla fine degli anni Sessanta (Stooges? Captain Beefheart? Free jazz?), e senza pensare di
potere ridurre il fenomeno ai suoi riferimenti di
base, comunque, senza i Ruins (sponda prog-based
della faccenda), e senza certi fermenti post punkhc (l'altra sponda, anche dell'oceano) che vanno dai
Minutemen alle sperimentazioni della "musica
compressa" dei Naked City di John Zorn (con
dietro tutta la No Wave che ci può essere), senza
tutto questo, il jazzcore non esisterebbe. Chiedere ai nostrani Diego D'Agata (Splatterpink,
Testadeporcu), Zu e compagnia (Neo, Squartet). Ma anche ai Lightning Bolt, che pure hanno
già avuto modo di precisare che: «Noi "insegniamo"
educazione fisica. Loro fisica teorica».
I Ruins dunque. Creatura tiranneggiata dal piccolo gigante Tatsuya Yoshida, giapponese dagli
occhialetti rotondi, raccoglitore giramondo di immagini di pietre strane ed esoteriche, batterista dallo stile architettonico, polipesco, grappoloso, uomo
di punta della scena radical/impro giappa, compagno
di merende, per capirci, di tipi come Keiji Haino
e Otomo Yoshihide. Yoshida è stato negli anni,
dalla metà degli Ottanta in avanti, un vero sciupabassisti, sempre alla ricerca del feeling perfetto per
il suo power-duo e per il suo ideale di progcore geometrico, melmoso, esagerato. Nel 2004 ha mandato
tutti a quel paese e ha continuato da solo (Ruins
Alone), suonando e cantando (sempre in perfetto
stile Zeuhl, tribal dadadelirante) sopra basi pre-registrate, in una dichiarazione di autarchia che è una
dichiarazione di autismo, ad un tempo commovente
e al limite del ridicolo.
Dopo mille progetti da solista, da leader o da
"semplice" batterista (vedi Korekyojinn, Koenji
Hyakkei e Acid Mothers Gong, capaci di regalare ai maniaci del prog momenti di vera goduria),
e collaborazioni che ne hanno fatto scoprire la figura anche ai non cultori di genere (ha suonato in una
delle incarnazioni live dei Painkiller di Zorn, per
la serie tutto si tiene), nel 2006 Yoshi ha messo in piedi - un po' a sorpresa - i Sax Ruins, rispolverando quindi l'idea perduta di Ruins-come-gruppo, per
rileggere - col sax al posto del solito monumentale
basso - un repertorio di fatto già cristallizzato (in
senso positivo e negativo).
Le label su cui ritroviamo il marchio Ruins si
commentano da sole, e rivelano molto della natura della musica del nostro: Skin Graft, Shimmy Disc
(quando questa lanciava negli USA anche i Boredoms di Yamatsuka Eye), Tzadik, Ipecac (che
ospita anche il debutto dei Sax Ruins). La musica
di Yoshi è, nei suoi momenti di massima ispirazione, una deflagrazione totale di muscolarità e cervelloticità (non cerebralità) che concilia cinetismo
e senso del massiccio (con stop&go che sono veri
schiaffi sonori) e che riesce ad appagare un po' tutti
gli amanti delle musiche estreme: con la sua intricatezza prog (ipertecnicismo, senso della struttura
e gusto della giustapposizione, temi contorti, tempi
composti), la sua foga hardcore e il suo spesso compiaciuto casinarismo noise (e in tal senso va letta
la sua componente jazz, pensando, come suggerisce
Zorn, che il free era in fondo una musica "punk"), la
sua geometrica solidità (leggi math), la sua capacità,
insomma, di sposare deriv(azion)e punk, prog alla
Magma e alla Henry Cow e stranezze caricaturali alla Frank Zappa.
Certo, come accade a chi inventa davvero qualcosa, fa spesso capolino lo spettro della fissità,
dell'eterna ripetizione di sé (e il pensiero corre ai
Primus), rischio questo che Yoshi ha sempre cercato di arginare - pur rimanendo fedele alle proprie ossessioni - variando formazioni e organici (e
questo è anche il caso dei Sax Ruins), non sempre
riuscendoci però. Altro spettro, anche questo inevitabile, avendo Yoshi a che fare con un'idea di musica
difficile (complessa, ossessiva, nodosa; ancora i Primus) e dovendo gestire una tecnica e una espressività comunque debordanti, quello della godibilità di
una proposta che spesso non riesce a uscire dallo
stile, dal virtuosismo, dall'esercizio, per quanto agonisticamente avvincente.
Gabriele Marino
Turn On
11
Jookabox
Indiana kings of inconvenience
David Adamson è un dropout folk rinnegato con in
mano un microfono e nell'altra il fucile. Attenzione
alle definizioni: questa è world wave soul freakout...
B
isognerà pur inventarci un’etichetta nostra per
descrivere gente come Dan Deacon e David
Adamson / Jookabox. Grassi di sound e di stazza, creativi democratici stellestrisce, drum machine
e beat box come pane quotidiano, un’attitudine a
far muovere le hips a diverse velocità e il classico
12
Turn On
canovaccio d’overdubbing esuberante ad alto tasso ritmico. Caratteristiche comuni a loro e a molti
musicisti off del panorama down under americano;
nessuna grande sorpresa per chi ne osserva il sottobosco, neppure salti con i già frullanti Novanta ma
sicuramente tante e molte più possibilities. Dan, per
esempio, in Bromst ha spinto a tavoletta sull’elettronica e l’estetica rave. Adamson si è rinominato
Grandpall Jookabox ed è partito unendo due
lembi stilistici di questi anni: il folk delle origini e il
lo-fi. Ne ha fatto un DIY di chitarra e ritmi registrati,
blues del Delta e Appalachi, tenendosi nel cuore - il
suo e di milioni di nerd cresciuti con il sequencer l'amore per l’hip hop e una mentalità quattro tracce
che poi diventa Pro Tools.
Dicendovi di una voglia deep house sottotraccia che li accomuna, le somiglianze finiscono e le
stranezze che ti fanno il caso iniziano a farsi notare: Moose è nativo dall’Indiana, lo Stato americano
dimenticato da Dio. La recessione è costante e le
tensioni razziali nell'aria quanto l’odor della polvere
da sparo. E che dire del downtown popolato da soli
negozi di liquori? In pratica è l'epitome del White
Trash USA altro che gli skater di Van Sant. Tanto più
che da adolescente, David trova un modo creativo
per godere di quelle strane energie: si butta pesto
sui funghi finendo per amare la psichedelia e un
modo di comporre per immagini appese al muro,
lo stesso che notammo il mese scorso analizzando
il piccolo fenomeno Tune-Yards. Per entrambi
torniamo a parlare di una fake world music, etnica appresa in TV o sentita in altri dischi, o meglio
un’idea di etnica senza legami di terra. Nel caso di
David però, la terra in cui abita conta tantissimo, le
sue difficoltà e sofferenze vengono sputate fuori attraverso i millenari modi afro-americani. Dal secondo disco in avanti maturano curosi furti: spirituals
e canzoni ball & chain, canzoni che lui imbottisce
di elio trasformandole da negre in esquimesi (à la
Residents) e c'è una grande nuvola di fumo sopra
agli arrangiamenti.
Fate conto un Beck in combutta con Michael Moore, un produttore ‘ardkore britannico che
rinnega tutto per l’amore di Tricky. Fortuna che a
tener salda la baracca, c’è il ritmo tribale. Ti riporta
a terra, nella brutta provincia a suon di rime sgangherate dallo humor secco come una pistola e lo
straniamento tipico andersoniano è servito. Prendete Girls Ain't Preggers, un talking blues alla Lcd
Soundsystem in combutta Jon Spencer fatto
da un B-Boy fallito, un singolo must per senzatetto
con le rime a mo di lista della spesa e un coretto in
tono farsesco Pere Ubu a recitare "fortuna che le
ragazze non sono incinte". I modi sono quelli filiati
dal mainstream, l'estetica di partenza il white negro.
E' il fare disperato di chi non ha niente da perdere
e ti fa ridere senza ridere. Sotto, a tenere il tem-
po, c'è un ritmo battente e un right now a chiudere
ogni strofa; ritmo che ci riporta all’altra caratteristica degli USA di questi anni (vedi lo Smell e Foot
Village, Health e compagnia bella), un monoloch
scompaginante a guastare l’idea folky originaria giocata con le parole Grandpall (il nonnaccio) e jookabox (il jukebox).
Il taglio della ragione sociale viene naturale: per
Dead Zone Boys, terzo disco del nostro, a rimanere
è soltanto la seconda parola e, già dal titolo gangsta,
alcuni cambiamenti sono evidenti. Ben oltre il blues,
il lo-fi e il muso duro di Ropechain, il sound pensa
in grande e non resiste nemmeno all’altro vento in
freschezza black, certo glam-soul cibernetico. Inevitabile il confronto con la confraternita Tv On
The Radio / Rain Machine, vero marchio forte quando mescoli wave a negritudine, ennesima
testimonianza dell’oggi che David si porta a casa
preferendo al taglio freaky-romantichy-proggy del
Malone, un Beck anti-folk e anti-cool, amante di
dada e fervente predicatore di un culto I-hate-metropoli-che-fa-figo e al diavolo la fottuta Scientology.
A fargli da conforto gli ritroviamo in bocca la puzza
di whisky di un dropout come David Thomas,
uno dei suoi idoli, e lui che non è certo un lunatico
o uno snob intellettuale, al rantolo beefartiano, c’attacca un falsetto blasfemo à la Micheal Jackson, un
brother dell'indiana naturalmente. Il brano celeberrimo è naturalmente I Will Save Young Michael, tra i
soliti talking e svolazzi soul, confida al King Of Pop
di tornare agli amori per James Brown e Jackie
Wilson.
In pratica, Moose disegna una parabola folk per
il nuovo millennio: provinciale e globale, torta millegusti psycoattiva e ballabile senza negasi il piacere
della caricatura. Per Dead Zone Boys, parla di una
storia d’amore e uno zombie musical psichedelico,
un concept sui generis dove compaiono ancora i
canti rubati ai bambini del debutto Scientific Cricket
mescolati ad alcune visioni del Peter Gabriel di
Shock The Monkey. I risvolti sono tragicomici, pure
per merito dei due nuovi membri in formazione,
gli psych-poppers Everthus the Deadbeats. Se
date un occhio alle press foto del neo formato quartetto vi renderete conto con chi avete a che fare:
dei perdenti con in mano un microfono e dall'altra
un fucile e, in questa terza puntata, un arcigno yes
scritto in fronte.
Edoardo Bridda
Turn On
13
Half-handed Cloud
Anarchia pop
Un cantautore che scava dal di dentro l’indie-pop
per fare piccole gemme senza barincentro. Un devoto cristiano che fa docili esercizi di anarchia. John
Ringofer, aka Half-handed Cloud
Hello, my name is John Ringhofer, and welcome to this
collection of Half-handed Cloud from the 17 non-album
releases between the years 2000 and 2009, now available in one convenient place.
Così si presenta, mr. Ringhofer da Knoxville, Tennessee, ideatore senza freni di piccole canzoni che del
pop hanno gli elementi ma non la compiutezza, polistrumentista e lo-fier artigianale. Anzi, così inaugura
le note contenute nel booklet di quel posto con14
Turn On
veniente in cui ha deciso di mettere in ordine tutta
la carriera. Si chiama Cut Me Down & Count
My Rings, titolo che già dice molto, come del resto la citazione iniziale potrebbe da sola mettere a
fuoco questa stranissima creatura chiamata Halfhanded Cloud.
Cut me down and count my rings, ci suggerisce il nome
della raccolta, ma non per segnalarci presunte discontinuità e ritrovati anelli mancanti, quanto l’op-
posto, o quasi, sia a livello esistenziale sia musicale.
La raccolta o macro-album (46 tracce di artigianato
lo-fi melodico) con cui John si propone a un pubblico senza dubbio più vasto - tramite promozione più
sviluppata, soprattutto in Europa - è infatti un flusso
dove i pezzi si rincorrono tra loro senza soluzioni di
continuità percepite. E si ha davvero l’impressione
di scoperchiare un mondo, per il quale sono a disposizione almeno due atteggiamenti: la riluttanza a
entrarci, ché vi si può rimanere incastrati per giorni,
imbrigliati entro una precisa strategia nei confronti dell’ascoltatore. Una massa critica che, in fin dei
conti, non è altro che il prodotto di una levatrice
di canzoni, oppure di un unico canzoniere quasi
infinito, eppure compatto per durata, se pensiamo
alla quantità di gemme che contiene. Già, dimenticavamo il secondo atteggiamento, ma è insito nelle
premesse: è quello per cui si accettano le condizioni
e ci si butta a capofitto nel discorso di Half-handed
Cloud, dei suoi schizzi apparentemente non-finiti, o
witz cantautoriali.
Non che Cut Me Down & Count My Rings
possa a tutti gli effetti essere considerato il primo
album di John; né che prima d’ora da questa parte
dell’Oceano potessimo ritenerci esclusi dalla distribuzione. Anzi, già Thy Is A Word And Feet
Need Lamps (Asthmatic Kitty, 2006), terzo disco
di Half-Handed Cloud, aveva viaggiato oltreoceano.
Ma è lo stesso Ringhofer, come abbiamo visto, che
vede le precedenti uscite come non-album, e in un
certo senso a ragione. È l’atmosfera che sa di eppì,
in Thy…, nel precedente We Haven't Just Been Told,
We Have Been Loved (Asthmatic Kitty, 2002), e ovviamente a partire da un EP vero e proprio, l’aurorale
I’m So Sheepy, del 2000, pubblicato inizialmente sull’etichetta Corner Room dell’amico Brandon
Buckner, con cui John aveva condiviso l’esperienza
di una band precendete, i Wookieback.
Entriamo di getto nella biografia di Ringhofer, giusto
per sottolineare due elementi che, ancora una volta,
sintetizzano l’insieme. John è stato il primo artista
dopo Sufjan Stevens ad aver pubblicato su Asthmatic Kitty, che praticamente ha tenuto con l’amico
Sufjan a battesimo. Dopo l’EP del 2000, il Nostro
era diventato amico di penna del cantautore newyorkese, che gli chiese qualche brano da mettere su
una compilation della sua neonata label, To Spirit
Back The Mews. In seguito, lo Stevens farà anche da batterista per il già menzionato terzo disco
di Half-handed Cloud. Insieme a lui altre figure a noi
note (una su tutti: Nedelle Torrisi dei Cryptaci-
ze) faranno compagnia a Ringhofer, interrompendo
la sua mania di comporre e suonare tutto da solo,
usando strumenti del più classico indie-pop ma anche fiati e piccola elettronica cheap. Ma il rapporto
tra Sufjan e John non si basava e non si basa solo
sull’intesa musicale. Nel nome della band, nei titoli
succitati delle uscite, ma più banalmente nelle liriche
delle vocalità poppy e strampalate di Ringhofer non
si parla di adolescenza o amore. Si parla di religione, devozione cristiana, Gesù Cristo. Half-Handed
Cloud è un nome che deriva dal Vecchio Testamento, e la one-man-band non si è trasferita a Berkeley
per respirare aria giovane e idee frizzanti e audaci,
ma per offrire i propri servigi alla chiesa locale.
Eppure crea stupore il modo in cui le sonorità di
Half-handed Cloud non risentano degli stigmi del
christian rock. Il tutto più che composizioni clericali sembra piuttosto un esercizio divertito di complessità nata dalla semplicità. Stesso discorso dei
non-album: è la velocità con cui questi frammenti si
susseguono a orientarne la lettura come forme brevi, anche se organizzate, e completamente sprovviste dell’aulicità che ci si aspetterebbe. Half-handed
Cloud è anzi la riscoperta del livello n-1 delle costruzioni pop. Attira chi ascolta e poi gli mette confusione in testa. È un calderone di musica a-baricenrica, e questo non vuol dire che essa sia rizomatica,
o centripeta, perché usa tutti gli elementi che normalmente ci farebbero ricondurre a un baricentro, a
una struttura pop. Usando gli strumenti della musica
pop, oltre che piccoli inserti di elettronica cacofonica in sordina, Half-handed Cloud produce qualcosa
di completamente anarchico. Altro che gerarchie
divine. Il divertimento di John è affatto terreno. E
lo stress indotto nell’ascoltatore dipende proprio
da questa capacità di lasciare sempre degli appigli
a qualcosa di orecchiabile senza mai raggiungerla,
continuando a cambiarla, e quindi non consentendo
alla memoria e al taccuino visuo-spaziale delle nostre orecchie di aggrapparsi a qualcosa.
Ovviamente, tutto questo è molto Residents-iano.
Colpo di piatti. E non temiamo di essere considerati
bestemmiatori se al capitan scoreggia pensiamo per
segnalare come in queste 46 tracce ci siano sempre
le stesse forme, gli stessi timbri, quasi le stesse note.
Altro colpo di piatti, che in conclusione trascina un
dubbio. Cut Me Down & Count My Rings è una summa,
un punto e a capo, sotto molti aspetti. E dopo? Ce la
dobbiamo aspettare per il futuro, la discontinuità?
Gaspare Caliri
Turn On
15
2009: A Warp O dissey
20 Warped Years
Sono poche le etichette che hanno cambiato le menti di milioni
di ascoltatori. La Warp è una di queste. A 20 anni dal primo LP, vi
raccontiamo di fatti, suoni, letti e marketing intelligente
- Edoardo Bridda e Marco Braggion
16
DROP OUT
Arriva tutto per posta. Non elettronica. Come ai
vecchi tempi, quando aspettavi il postino con i pacchi quadrati e sapevi che dentro c’erano i vinili. Arriva in questo ottobre 2009, dopo mesi di attesa, il
box della Warp. Come diceva Lester Bangs "per un
momento il solo piacere sta nello scartare la plastica
e assaporare il profumo dell’ignoto". è un edizione
limitata a 500 copie, come il primo vinile stampato,
un monolite come quello del Kubrick di 2001: A
Space Odissey e c’è la celebrazione di un ragazzo
di Sheffield in tutto ciò. Si celebrano i vent’anni di
Warp, dell’IDM e di tutta una scuola, rendendo così
doverosa una retrospettiva e un’analisi su quanto
fatto e cogitato fin’ora.
Il mese scorso avevamo trattato le due compilation Warp 20 che raccoglievano la classifica suggerita dai frequentatori del sito (nel doppio Chosen)
e la selecta di reinterpretazioni scelta dal quartier
generale (in Recreated) (vedi recensioni in SentireAscoltare 60), ora s'aggiungono altri due cd, 4
vinili e il catalogo delle copertine in un book stiloso e minimalista. Da un lato, la musica, dall’altro il
design. Perché se il suono è importante, dopo 20
anni il succo è (anche) lo stile e niente di meglio
che partire da qui per descrivere il pianeta Warp,
una delle realtà più abili nello sfruttare e nel godere
di un design a 360° dentro e fuori la musica. Sinergie innovative che hanno visto innanzitutto l'intesa
con lo studio Designers Republic (purtroppo fallito
lo scorso anno), responsabile delle immagini indimenticabili di molte delle cover chiave della label
e del layout del vecchio sito (quello con il treddì a
ricordare i vecchi coin up); e soprattutto, l’incontro
con il pianeta (Chris) Cunningham, matrimonio extra musicale senza precedenti e tra i più scintillanti
esperimenti marketing del tempo.
Sinestesie di un sound visivo, tattile, interattivo
che presto le regalano un alone mitologico e un rispetto quasi religioso. In pratica, Warp si fa testimone di un futuro più reale di quello gelido e robotico
dell’Underground Resistance detroitiano, per sempre legato all’ortodossia kraftwerchiana. Visione e
missione che dopo dieci anni la label consegnerà
ad altri, considerando la “scomparsa della musica
strumentale e la supremazia della musica elettronica”
un’ingenuità di gioventù, sorpassando il suo ruolo di
virus nel mercato, sposterà i propri interessi e campi d’azione senza tagliare con il passato. “Se Warp ha
voluto rompere i legami, è con un certo tipo d’etichetta
tematica. Ha portato i suoi interessi a livello interna-
zionale”, afferma quest’anno George Evelyn, ovvero
Nightmares On Wax, personaggio che ha appena inciso (sempre su Warp) il recente Thought So... e
di fatto l’artista più longevo nel rooster. Evelyn per
la label firmava proprio nel lontano 1989, all’inizio
di questa storia…
We A re R easonable People
L’idea di promuovere l’elettronica su disco nasce
dalle menti di Steve Beckett, Rob Mitchell e
del produttore Robert Gordon e, come da pratiche UK che portano indietro le lancette del tempo
fino alla post-punker Rough Trade, anche in questo
caso: la label nasce, dopo due anni di brainstorming, nel
1989 intorno a un negozio di dischi. Siamo a Sheffield
e il negozio si chiama FON. A Londra e Manchester
si fa festa da un anno e, per i posteri, quel periodo si chiamerà Second Summer Of Love, alludendo
allo stato di peace and love indotto chimicamente
e tagliato con quello strano mix di suoni balearici
e tecnoidi che alcuni illuminati s’erano portati da
Ibiza. "Era l'estate dell'acid e dei rave illegali ma era pur
sempre da Club come lo Shoom o l’Haçienda che tutto
era partito e tutto era destinato a tornare". E parlando
di starter è ai tre di Belleville (Atkins, May e Saunderson), che va la mente e il legame d’acciaio senza
il quale questa avventura non avrebbe avuto luogo.
I loro dischi, importati dall’America proprio
come ai tempi del r’n’r, acquistano un’aura divina e
generano nei ragazzi brit uno spasmodico bisogno
di emulazione. Nel 1989, escono Newbuild di 808
State e l’inno Voodoo Ray di Gerald Simpson (in
arte A Guy Called Gerald). La risposta a tutto
questo di due clerk di Sheffield si chiama: Track With
No Name, vinile a firma Forgemasters. Lo portano, fieri e impavidi, in giro per i negozi del Regno
con una macchina a noleggio. è il primo successo
da club, l’inizio della produzione del marchio e soprattutto il tassello che ci voleva per emancipare
pienamente il suono techno americano taggandolo
finalmente con una bella union jack come sarebbe
piaciuto agli Who. Segue un 12 pollici chiamato Dextrous, e a firmarlo è Nightmares On Wax. La leggenda narra che il ragazzo sia entrato nel negozio
per vendere delle lacche white labelled e sia stato
scritturato all’attimo. A differenza dei Forgemaster,
caratterizzati da fitte trame di Roland, sapori etno
e ipno, phuture sound e le famose tastiere spettrali
e antemiche, il sound di Evelyn è hip hop con una
punta di acido e solide basi black: una formula che
sbancherà facendo vendere all’etichetta 30 mila coDROP OUT
17
pie. Di lì a breve l’attitudine killing diventa una cosa
sulla quale farci i soldi.
Ed è di nuovo rock’n’roll a Sheffield. C’è la stessa
effervescenza nell’aria e quell’ingenuo – ma solo con
il senno di poi – miraggio di poter cambiare la storia
è anche dei fondatori Warp. Ad un set dei loro Forgemasters al Sunset Boulevard a Huddersfield, sentono un sound micidiale: batterie funky mescolate a
bassi e bleep sinusoidali in acido. I suoni provengono
da due amici di Winston Hazell: gli LFO. Il quinto
vinile prodotto da Beckett e Mitchell è il loro successo per eccellenza LFO. Venderà 120 mila copie
e scalerà la classifica inglese fino a raggiungere il
dodicesimo posto nel luglio del 1990, preludendo al
successo del classico Frequencies.
Ma la bolla sta per scoppiare.Tempo quattro anni
e arriverà il Criminal Justice and Public Order Act
(del 1994) a vietare de facto il rave e a segnare uno
spartiacque nella scena. In barba alle leggi, già da
due anni qualcosa si sta muovendo fuori dai rave. La
non-rivoluzione viene da dentro le case: sul piatto
18
DROP OUT
girano B Side che contengono della roba diversa,
sperimentale che non è la solita intro new age di inizio serata. Nasce così l’idea di riunire in una compilation (successivamente bissata) il gotha della scena
off-club. Il disco si chiama Artificial Intelligence
e segna il passo, coniando di fatto il verbo per un
genere che prenderà il nome di Intelligent Dance
Music.
Beckett ironizza sulla nascita del tanto vituperato
termine. Si riferiva alle performance al Top Of The
Pops di Orbital o Orb. Al fatto che premendo
un bottone la musica suonava da sola. Roba da androidi, come quello in copertina della compila che
fuma il sigaro virtuale sprofondato in poltrona. I non
raver nerd hanno finalmente una casa a cui tornare
per ascoltarsi, rigorosamente in cuffia, la crema della scena capitanata dagli esordienti Aphex Twin,
Autechre, Richie Hawtin, B12, Alex Paterson
(poi negli Orb) e Black Dog.
“Eravamo noi a guidare il mercato. La musica era
prodotta per l’home listening piuttosto che per i club
e i dance floor. La gente tornava a casa, si rilassava e
passava la maggior parte della notte ascoltando musica
totalmente tripped. Il suono nutriva la scena”, ricorda
Beckett a proposito di un disco che preannuncia e
pontifica il suono Warp fino alla metà dei novanta.
Quel suono, infarcito di sci-fi alle volte cupa e
altre estatica, insaporito talvolta di acidità e spezzante del break che nasce dall’hop ma che subito
lo travisa, si impone subito come moda e piccolo
business. “Casper Pound mi chiese all’epoca di fare
dell’ambient music. Dovevo spedirgli una cassetta e così
composi velocemente della roba sul genere. Mentivo. Divenne il mio primo disco che con il senno di poi non è
per nulla ambient, anzi era l’idea che me n’ero fatto. È
stato molto facile da completare: un album e un EP in
una settimana”. A parlarci è Luke Vibert da un
po’ di anni su Warp, l’esempio migliore della forbice
ritmica che in quegli anni si stava allargando terribilmente: breakbeat versus abstract e broken beat e
4/4. Due scuole inconciliabili sia in ambito dance sia
in quello casalingo.
A risolvere la questione, o meglio, a sublimare
le sterili dialettiche tra la musica per intelligenti e
quella per cammelli masticanti, ci pensa un disco
che all’altezza del 1994 si pone come fine dell’ondata anemica che aveva caratterizzato certa musica
oltre-ballo. Richard D. James di un Aphex Twin
travestito da se stesso, è la pietra miliare del caso.
Approda a un tipo d’elettronica decisamente autoriale, ricca di momenti tosti, pause, sketch e sul finale persino una overture. Con lavori come questo,
si comprende come la Warp e i suoi protagonisti
crescono assieme e se gli inizi possono strapparci
alcuni paragoni con le label di inizio ’80, è la parabola PiL il miglior paragone con le politiche dei due di
Sheffield. Percorso che li porterà, infine, sulla scia di
Green / Scritti Politti, in una personale versione
del Meta-pop per la fine del millennio: Windowlicker.
Pop Tones
Windowlicker è, al tempo in cui scriviamo, la traccia
più votata dai frequentatori del sito. Autore: ancora
lui, Aphex Twin. Il pezzo è il sunto massimo tra le
istanze elettroniche emerse dalla provincia Briannica e il pop da classifica virato sul piatto più danaroso del pianeta, il soul. Soul come parte dell’impianto
hip hop americano e sua presa per il culo dall’interno: stessi mezzi utilizzati e una tecnica esasperata a
tal punto da sparare il mix cento anni nel futuro. Lo
storico video di Chris Cunningham, dal minutaggio
faraonico à la Michael Jackson, ne è il completamento ideale: un inno per le masse basato sull’ossessione per il deforme. Lo sfottò prima al gansta rap e poi
al pensiero borghese imbrigliato da un background
socioculturale a base di Nip & Tuck.
è la rivincita degli electro headz, ragazzi che condividono un certo svacco con gli indie kids immersi
nell'ascolto ossessivo delle chitarre, ma che diversamente da questi hanno un'attenzione maniacale per
il suono, un approccio in rigorosa cuffia paragonabile alla serietà degli ascoltatori degli anni '70. Sono gli
ingegneri smanettoni, quelli che dalla provincia non
hanno mai mangiato una pastiglia, quelli che lo sballo
ce l'hanno solo davanti al monitor a 16 colori. Sono
anche gli altri, che di acidi ne hanno presi troppi e
che ora devono far passare la sbornia del dopo rave.
Fuori c'è un mondo in rapida evoluzione (internet,
laptop, mail..) che ancora permette lentezza, ma di
lì a poco la velocità aumenterà di brutto. Tra i tanti cambiamenti, Warp migra da Sheffield a Londra.
E non solo per logistica. Identifichiamo dunque nel
1998 l'anno terminale per un certo mondo. L'anno
in cui un altopiano ambient dato per morto e sepolto ricomincia a tremare.
Con Music Has The Right To Children, la
label e i Boards Of Canada promulgano una nostalgia pastorale come rapiti da una profonda gnosi.
Quel pizzico di sinistro che farà scuola ne è una
parte fondamentale. Diventerà il suono più imitato tra quelli elettronici della label appunto perché
il più essenziale e aggregante una certa sensibilità
IDM che guarda a un Nord idealtipico non senza
scordarsi gli hippy, gli ufo e i documentari degli anni
Settanta. Poi Napster farà saltare tutto. E dalla Summer of Love si passerà alla summer of download. I
Novanta sono finiti.
D ieci
e non più dieci
“Quando trovo artisti unici e autentici nasce una sorta di affinità sentimentale. Quando sono originali e si
percepisce un netto rifiuto di parametri preimpostati,
insieme a grandi melodie e buona produzione, intuisci
che è questo è il cocktail vincente. A quell’epoca [gli anni
90, ndSA] pensavo non esistessero limiti, mentre ora mi
rendo conto che il limite delle nuove sonorità è la stessa
tecnologia. Si era arrivati a un punto di stallo, ripetitivo.
Aphex Twin o Squarepusher avevano esplorato ben oltre
i confini. Bisognava andare in direzioni diverse. È per
questo che non volevo firmare con artisti elettronici ma
lavorare con chi utilizzasse strumenti. Come i Battles:
affondano le loro radici nella musica elettronica ma utiDROP OUT
19
10 D ischi
F ondamentali
Aphex Twin
lizzano gli strumenti in una nuova forma”.
Dopo il coraggioso tiro al bersaglio di pubblico e critica con Drukqs (ancora Aphex Twin),
doppio tomo tombale che conclude l'era della complicazione drill, l’eterodossia nell’overloading informativo pare sia la carta migliore per Beckett che, a
differenza delle coeve e ortodosse Rephlex, Planet
Mu e Ninja Tune, sceglie la via dell’imprenditorialità
intelligente e inizia un percorso a doppio canale fatto di acquisti a 360° nel panorama indie rock-pop e
contratti garantiti agli storici della scuderia. A chiudere una fase e aprirne un’altra, nel 1999, a 10 anni
dalla nascita arriva la compilation ‘monstre’ Warp
10: Influences, Classics, Remixes. La prima celebrazione di un sound, ma anche il tentativo di un
revival (come accadrà per l’acid poco più tardi con
l'Analord di AFX e la produzione a firma Luke
Vibert). Quell’anno, abbracciando l’eredità street,
Beckett inaugura la Lex, costola devota ai suoni hiphop based (Subtle e gli eredi dispersi del suono
Anticon), e ricongiungendosi così, senza artefazioni,
con il breaking che porterà poi a Hudson Mohawke e Harmonic 313. è una delle tante rivincite dei tanto disprezzati ardkorer giustamente
osannati da Simon Reynolds. Il breakbeat continua
20
DROP OUT
a rappresentare una fonte creativa per le nuove generazioni.
Di lì appresso si apriranno le porte su Warp
all’hip-hop mutante degli Anti-pop Consortium, ai mondi elettro-hop di Prefuse 73 e ai rimasugli dell’elettronica con le macchine a 8 bit fino
ad arrivare a gente che con l’elettronica non ha nulla a che fare come i Maxïmo Park. Il trasloco da
Sheffield a Londra è stato cruciale. Ha significato il
nuovo negozio Warpmart ma anche un’espansione
nel settore dei clip indipendenti con la Warp Films
(già pionerizzata nel VHS Motion che accompagnava
la seconda Artificial Intelligence) e un duplice
approdo online sia attraverso il portale Bleep, uno
dei primi siti a tralasciare il Digital Rights Management delle tracce scaricate (non come la multinazionale iTunes), sia attraverso il sito ufficiale che
aggiorna look e interfacce allineandosi al miglior 2.0
possibile (www.warp20.net). Infine, per celebrare il
ventennale, una vera tournée marchiata Warp20 sta
girando il pianeta.
LFO – Frequencies (1991)
E all’inizio era filo Detroit. E all’inizio la variante brit era una e faceva tremare i vetri. Si chiamava bleep and
bass e i suoi protagonisti warp erano un commando a prova di test tone. Tricky Disco, Kid Unknown,
Nightmares On Wax e naturalmente LFO con l’ormai leggendario Frequencies. Le sentite quelle voci
deformi in intro? Ci cresceranno Richie Hawtin (a nome Fuse lo troviamo dal
1993 su Warp). E sempre lì, all’inizio dell’album, li sentite quelle laserate verdi? In
pratica forgiarono un modo di ballare e un’illuminazione precisa sul dancefloor.
E infine il settaggio della Roland è o non è quello devotissimo a Detroit?
Già. Detroit-Sheffield sola andata. La traccia numero due fa la storia del ballo
sballo made in UK e si chiama come la ragione sociale del duo, LFO. Dei bleep
dicevamo, mancano i bass. Il giro di basso in contrappunto è un’altra Roland. Poi
però c’è la specialità della casa: il SUB-basso contrappuntato a colpetti di silicio
che fa anthem. E non solo: sotto alle devozioni ritmiche anche per gli LFO c’è la
tradizione sci-fi che diventerà marchio della Warp post-balearica e post-party.
Cinema di genere che si popola dei replicanti di Scott nell’altro singolaccio We
Are Back, numero sul lettore 6 e Underworld sintonizzatissimi sul canale. Brek. Il resto dell’album si muove su ferree linee electro con altre lezioni ben servite ai posteri: Simon From Sydney, da un po’ di consigli
agli Orbital su come assestare la maturità 5 anni dopo (In Sides). Nurture con i lustrini e quel fare kitch e
la raffinata Tan Ta Ha parlano ai Mouse On Mars. In pratica queste frequenze non solo sono la bibbia per
l’elettronica europea, ma anche la sintesi più efficace per comprendere quanto la Warp volesse un marchio
interdipendente e poi autonomo rispetto sia a Detroit sia al ballo. Ci dispiace per A Word Of Science di
Nightmares On Wax, dovendo scegliere tra i due al primo posto c'è Frequencies.
Sabres Of Paradise – Haunted Dancehall (1994)
Il nome dietro a questo dimenticato trio è Andrew Weatherall. L’album è
per forza Haunted Dancehall anche perché Sabresonic uno e due non lasciano granché dietro di sé.Anno di grazia 1994. L’anno di re Aphex e Black Dog,
ma anche l’anno di un album come questo che ha saputo promulgare il verbo
dell’uomo di Screamadelia anche in territori meticciati idm come questo. Ingrediente must oltre ai soliti sci-fi, il dance hall robotico e robotizzato messo in
mezzo alle sciabole e rigorosamente servito crudo in salsa house (con qualche
spezia latina). Da riscoprire.
Black Dog – Spanners (1994)
1 Autechre 2 Aphex Twin 3 Black Dog. Il gruppo numero tre se vogliamo fare
le scalette come una volta all’interno dello stesso genere o casa. La scelta cade
su Spanners, album cruciale per certa exotica d’alta classe ficcata in breakbeat
pruriginosi e afosi tessuti sintetici. Black Dog imporanti anche per il cordone
con gli Ottanta di un Thomas Leer e profondi anticipatori di quella nostalgia
da futuro (vedi David Toop) che influenzerà umori e filosofia del suonare con
l’avvento dell’internet e del digitale. Lezioni infinite per Mouse On Mars e tutta
la scuola che va da Parigi (Air) e il down tempo di casa Ninja Tune annesse e
DROP OUT
21
connesse senza farsi mancare l’aggancio devoto a Detroit. In pratica, è quel nome che con l’etichetta anticipa numerose direzioni future e sul lettore non pare invecchiato di una nota. Provare per credere.
Aphex Twin - I Care Because You Do (1995)
Una scelta non facile ma alla fine naturale che cade sull’album più ‘cantautorale’ (se ci passate il termine) di
James. Un canzoniere, anzi una raccolta di ritratti e sketch fatti con elettroniche analogiche povere e synth
aperti e modificati durante notti insonni. A riascoltarlo ora sembra così artigianale e vintage quanto allora sembrò geniale e avanti. A maggior ragione un album
con la firma in maiuscolo. Momenti di buio pesto e robot nell’iniziale Come On
You Slags, e poi agrodolci con la classicheggiante Waxed Pitch o l’aquerello naif di
Alberto Balsam e il suo riff entrato nella storia, la sublimazione del lato bambino
in Mookid, l’apologia della droga che fa bene per eccellenza con il campionamento della boccata del Ventolin per asmatici (altro mito), e i cantieri da videogioco
al sapor di funk di Cow Cud Is A Twin, altri momenti d’affetto e ricordo dell’infanzia
cornovagliese e l’overture finale Next Heap With. Se non ce l’avete in casa siete
nati prima dei ’70 ed è meglio che vi dedichiate al progressive. Complicazioni
a cui l’Aphex poi non saprà imbrigliare, firmando con Drukqs il suo album da
dinosauro elettro precoce.
Squarepusher – Hard Normal Daddy (1997)
Quando Jenkinson fa sul serio e invece di atteggiarsi col suo basso slappato porta di brutto la sua passione
per il jazz dentro alla drum’n’ambient del pre-Boards. In più qui c’è un gusto
melodico che avrà una pletora di amanti su Ninja con quelle ingellate di brillantina che sono state la generazione Funky Porcini. La senti tutta la maturità
nella suite Papalon con quella perfezione jazz che di nu ha solo l’idea, ci vai a
nozze poi anche col popolo dei fan di Aphex quando senti quelle sintesi in Anirog D9 che sarebbero state colonna sonora del dopo Trainspotting (uscito
nel 1996) o quel drum’n’bass senza sosta di Chin Hippy e il bbreaking acido
dell’inno Fat Controller. In più lo storico booklet dedicato alle grafiche a 8 bit del
Vic 20, con i ravers pixellosi di Chelmsford (paese natale di Jenkinson) che scappano dalla polizia. Oggi fa un po’ quello che gli pare, ma una volta quando era
nel tunnel dell’acido (Vic Acid), Squarepusher ci consigliava il trip giusto.
Autechre – LP 5 (1998)
Uno dei gruppi della triade di culto della compila Artificial Intelligence assieme a Black Dog e l’impareggiabile Aphex erano gli Autechre. Avete presente? A distanza tre lustri il duo è finito per identificare
non solo l’IDM britannica e il suono Warp, ma anche l’idea più evoluta di cibernetica in musica. I loro glifi
sonori, incastri caustici, l’eleganza impersonale e quel modo di farti crescere la
melodia astratta dietro ai loop ritmici hanno fatto non scuola ma paradigma. Fra
tutta la produzione Novanta la scelta è stata dura ma probabilmente LP 5 è il
sunto. L’album più organico in tutti i sensi e il più complicato da realizzare. Più di
300 ore di nastri accumulate ed elaborate e più di un anno d’attività per completarlo. Un lavoro incredibile che contiene pure vertici assoluti sul versante minimal ambient (Melve, Caliper Remote e Drane2), incubi antemici in bassa battuta
(Arch Carrier), sci-fi d’alta classe (Fold4, Wrap5) e uno dei loro finali imperdibili, la
japonesata di Drane2 (23 minuti!)
22
DROP OUT
Boards Of Canada – Music Has The Right To Children (1998)
Sono la coda della stirpe degli idiemmers su Warp. E che gran finale. Contenente brani già apparsi nei loro
eppì precedenti, Music… è l’esordio datato 1998 che si presenta come un monolite. Proporzioni totali.
Sci-fi, ambient, ingredienti sciolti nella consueta melassa break beat. L’aggiunta di
un richiamo psych e un immaginario che valica i confini e si piazza nella storia.
Grazie a un lavoro sulla nostalgia, attraverso una patina sepia da documentario
televisivo che è poi la metafora per eccellenza dei nostri, l’album gioca sull’infanzia polarizzandosi esattamente tra angelico/demoniaco, onirico e ultraterreno.
Ecco perché lo mettiamo in top 10 al posto del grandioso Soccur dei Seefeel.
Etichette come la Ghost Box non faranno poi che rendere più scientifico e speleologico questo approccio. La mano perfetta su questo mondo rimane però di
Mike Sandison e Marcus Eoin.
Mira Calix - Eyes Set Against The Sun (2006)
Terzo album su Warp e piena maturità per Mira Calix che traghetta la sezione
ritmica Warp post Detroit e post AFX in una dimensione panteistica all'insegna
dell'electroshifting. Emblematico lo spostamento, suo e di molti elettronici nei
Duemila, verso una mimesi analogica sempre più diffusa. Sempre più comune
trovare nelle campagne weird e psych un ideale terreno di confronto che sfocerà in un vero ritorno al Popol Vuh in tutti i sensi. Eyes Set Against The
Sun è popolato da una fauna fantastica in un paradiso terrestre senza tempo tra
rigagnoli e cinguettii, cori di bambini e concretismi attinti dal mondo animale e
minerale a interferire continuamente sulla traccia sonora.
Battles – Mirrored (2007)
Più dei !!! e dei Maxïmo Park -che con l’etichetta hanno una coerenza piuttosto dubbia-, i Battles lontanissimi da Autechre e Black Dog, non sfigurano
in un certo fiuto per le mutazioni elettrock che contano. In pratica è il segno
dei tempi: dai loop programmati sulle macchine dei ’90 si passa ai loop manipolati dal vivo e riprendendosi pure certe correnti americane coeve alla nascita
dell’etichetta, certo post e math. Frastagli di ritmi che agli amanti degli Autechre potrebbero far pensare paradossalmente agli Storm & Stress. Lì c’erano le chitarre e le batterie, qui i sampler e le tastiere. Con Mirrored il mutante
dei due corpi ha una testa sola. E non sculetta per niente male.
Harmonic 313 – When Machines Exceed Human Intelligence (2009)
Dopo aver fiutato un buon cavallo di razza come Flying Lotus, Warp sbanca con un vecchio amico e si
porta a casa l’album per eccellenza del wonky sound. Sound che peraltro ha una
storia lunga che riporta indietro a gente altrettanto navigata come Neil Landstrumm e a “rivals” come la Planet Mu, sempre più sobria e attenta alle cose
più puriste dell’elettronica. When Machines Exceed Human Intelligence
è il colpaccio, perché è l’album da consigliare al pubblico più allargato e quello
che il pubblico di nicchia erge a culto assoluto. è inoltre una quadratura che
rappresenta un ritorno al Kraftwerk sound (che animò la techno dell’anno
zero) e al ritmo zoppicato e dispari del post-step (che ha dominato i rivoli di
una scena brit stanca delle drillate di Aphex e Squarepusher di fine novanta).
DROP OUT
23
N ara , Japan
(OO)I(OO) Got
The Rhythm!
Il ritorno di Yoshimi sotto OOIOO per Thrill Jockey è uno di quelli
che tengono il passo. Dentro ci sono vent'anni di carriera con e
senza i Boredoms. Una cosmologia ritmica senza precedenti
- Massimo Padalino, Edoardo Bridda
24
DROP OUT
Una ragazza si sveglia, ciabatta a piedi nudi sulle assi
levigate di legno che scricchiolano, ha voglia di tamburellare la punta delle dita sulla schiena di un suo
vecchio amico, quindi procede rintronata verso la
cucina. Quel vecchio amico è lì ad attenderla: è il
suo amico a quattro zampe. Si chiama Spy, spia, ed è
un labrador scansafatiche, di quelli non più di primissimo pelo. Pure lei non è più una fanciullina, e di faticare non ne avrebbe forse voglia, ma sono le 11 del
mattino e c'è un sole bello che è stampato in cielo,
anche laggiù, lontano lontano, perché quella terra è
la terra del Sol Levante. Quel giorno lì, come tutti gli
altri del resto, la gente chiassosa per le vie deve pur
guadagnarsi la pagnotta (o i ramen, come dicono da
quelle parti) quotidiana. Lei invece è di umore pensoso, e gironzola pigra per casa, tutta indaffarata. La
ragazza - segno dell'acquario: volitiva, caparbia, strana propensione per tamburellamenti vari e per il
ritmo - la osserviamo adesso furtivi, così: scalza, con
arretrati di sonno inappagato e intenso desiderio di
futon nei suoi occhi strizzati a mandorla. Quella ragazza allergica ai gatti, è una che ama la musica folk
tradizionale giapponese (quella del popolo Ainu, per
la precisione, come la chiamano quelli che sanno)
e ha un marito. Tutto farebbe propendere per un
ritratto modello, ora. L'immaginetta di una mogliettina perfettina e in odore di santità domestica.Tanto
che in quella stanza all'altro capo del mondo - siamo
nel 2005 - c'è anche un'altra lei a tenerle compagnia:
la sua primogenita di appena un anno e mezzo, quasi
a comprovare l'azzardata ipotesi di cui si cianciava.
Invece, di anni, ne sono passati quasi venti, da quando questa tranquilla ed innocua tipa dalla faccia di
bambina ha iniziato a darsi da fare come musicista,
a guadagnarsi la sua ciotola di spaghetti quotidiani,
i ramen.
Lì seduta, a gambe incrociate, nella sua casetta
carezzata dalle ombre della vicina collina, nel cuore
verde della città di Nara, la nostra donna si sente
davvero tranquilla ed appagata. Nara, la città famosa
in tutto il Giappone per due cose almeno: un'enorme statua di Buddha circondata dai daini ammaestrati che ci gironzolano intorno senza posa (e questa
è la prima) e perché, pur essendo un centro tutto
sommato da sempre periferico nella madrepatria
dei Samurai, a lei toccò l'indubbio onore di fare da
capitale dell'impero in secoli da noi lontani (e questa
la seconda). Lei, la donna-bambina che tamburella su
tutto quello che le capita a tiro, di nome fa Yoshimi.
Yoshimi P-We, per gli amici. Mica lo sapeva che
andava a finire così, due decadi fa... E forse, con vicina la piccola Shoji che tenta di afferrare e stringere il
dito della mamma nel suo raggrinzito piccolo pugno,
persa amorevolmente nei suoi pensieri di madre ed
artista affermata, qualcosa di quegli esordi lontani
Yoshimi, in quella tarda mattinata dagli occhi pesanti
di sonno, riesce a riagguantare con la memoria...
Yamatsuka
Ricorda che era il 1985. Ricorda pure che qualcuno le chiese, tanto tempo dopo, quando ormai tutti
sapevano tutto di quei suoi oscuri esordi, come era
iniziata la cosa coi folli Boredoms e quale demone l'avesse posseduta perché lei (angelo dagli occhi a mandorla), fosse spinta ineluttabilmente fra le
braccia di lui (demone dagli occhi a mandorla, che di
nome fa Yamatsuka Eye), complice il Caso: "Beh, non
avevo mai sentito parlare di lui prima di incontrarlo, ma
avevo sentito cose sugli Hanatarash, dove lui cantava.
Non avrei neanche mai pensato di mettermi a suonare la batteria se un giorno Eye non mi avesse chiesto
di usarla per uno spettacolo degli UFO or Die! Dopo
quella volta, mi ripropose l'invito: voleva che percuotessi
la batteria anche nel suo nuovo gruppo: i Boredoms.
Il batterista originale dei Boredoms, Yoshikawa, era uno
che pestava forte. Il suo drumming era roba da manicomio - mai in vita mia ho visto un altro che suonava
come lui, giuro! - faceva un tale casino. E poi mulinava di braccia come un matto, c'era sudore che volava
dappertutto quando ci dava dentro. Anche oggi che va
ad una scuola di musica e si esercita col metronomo,
Yoshikawa fa davvero cagare. Però ha del genio. Con gli
anni un altro batterista si è unito ai Boredoms, Atari, e
Yoshikawa è passato alla voce invece che rimanere alle
percussioni. Così i Boredoms si sono trasformati da una
band a doppia batteria, ad una band con due vocalist.
Confesso che col tempo abbiamo imparato a suonare
come una vera e propria 'squadra di percussioni'. E più
suoniamo assieme, meglio la cosa ci riesce".
I Boredoms sono il cul-de-sac della Tokyo musicale di metà anni '80. Dove passano loro, non cresce più l'erba. Anzi: quella forse se la fumano beati,
ma le canzoni davvero non crescono più quando
Yoshimi, il chitarrista Seiichi Yamamoto, l'urlatore
invasato Yamatsuka Eye e compagni danno sfogo ai
loro barbarici e basici rituali noise (sicuramente un
lascito degli scassatissimi Hanatarash). Loro fanno
così: si mettono tutti posizionati al centro di una
stanza, chiudono a chiave la porta, si avvicinano fino
a toccarsi gomito a gomito, chiudendosi ad anello...
e poi attaccano il terremoto. La gente deve stare
DROP OUT
25
Boredoms
26
DROP OUT
alle loro spalle (loro vogliono così), mentre i membri della band si guardano in faccia e si sfiancano a
suonare. Una messa al contrario, coi fedeli che officiano e gli officianti che fanno i fedeli, in quella loro
confraternita che si chiude a cerchio. Pareti di spesso plexiglass parano ai Boredoms il culo: evitano le
lamentele di vicini troppo curiosi. Ma una domanda,
ora come ora, nasce spontanea: MA CHE DIAVOLO SUONANO questi demoni di Boredoms? Ecco:
qui casca l'asino. E casca male, perché casca come
una pera cotta nel cestino assassino delle musiche
dei Boredoms. Prendiamo il loro disco di esordio.
Un ep. Una cosetta breve e dal gusto sobrio, come
già si arguisce dal titolo: Anal By Anal (etichetta
Trans). No dico: provate un po' a sentirlo. Certo,
c'è la nostra Yoshimi che si dà da fare, ma le scena
è tutta di quel gattaccio scorticato vivo alla voce di
Eye. E' in questo modo che la giovane Yoshimi viene
traviata. A suon di rumore, brutalità sonore, anticonformismo esecutivo. La musica è quella cosa che
se suona brutta ma ti avvince allora la chiami musica. Ma forse non è neanche così. Forse Yoshimi lo
sa che musica o non musica, la questione è un'altra:
come si fa a resistere a certe performance al limite?
Limite della sopportazione umana, della resistenza
fisica, dell'anarchia più destrutturante e destrutturata. Si fa che album dopo album - cosette come
Osoresan no Stooges Kyo (Selfish, 1988), Soul
Discharge (Shimmy Disc, 1989) o ancora Pop Tatari (Reprise, 1992), Wow 2 (Avant, 1993) e Chocolate Synthesizer (Reprise, 1994) - una strada
la trovi da sola, con le tue sole forze: una strada
verso la purificazione dalle insopportabili trappole
di rumore e ardore dei Boredoms.
Ma adesso siamo nel bel mezzo del 1994, e la
ragazza non è per nulla sulla via della redenzione. Ci
arriverà, passin passetto. Ma non adesso, col tempo... Ora è solo una cenerentola fracassona che ha
perduto la sua 'bacchetta della batteria/scarpetta da
principessa stracciona' al ballo dei punk scatenati,
in mezzo ai quali (e la cosa è durata per anni) si è
divertita a fare stage diving. In questo senso, le Free
Kitten sono una tappa quasi inevitabile per lei, a
metà del decennio dei Nirvana e del Grunge. Sebbene le Kitten, alle orecchie di un profano, facciano
più rumore della pala meccanica sotto casa, Julia Cafritz (ex Pussy Galore), Kim Gordon (Sonic Youth),
Mark Ibold (bassista con i Pavement) e Yoshimi
Yakota (suo nome per intero) sono una classe di
educande all'ora di religione se solo paragonate ai
macelli di casa Boredoms. La loro discografia inizia,
neanche con chissà che balzo felino, con una manciata di singoli. Un classico. Tutti irreperibili o quasi,
oggi, ma prima di andarvi a pescare l'album che li
raccoglie (Unboxed, Wiiija, 1994), aspettate almeno di ascoltare il loro primo 33 giri. Quello che,
un anno dopo appena, si qualifica come il debutto
lungo vero e proprio delle Kitten: Nice Ass (Kill
Rock Stars, 1995). Solita pappa: indie-rock fra Pussy Galore e Sonic Youth. E con l'aggravante
dello scarso nerbo. Quello che ci si aspetterebbe da
loro, senza neanche averle ascoltate, ma soltanto tenendo conto del blasone dei rispettivi componenti,
questo disco ve lo dà. Senza infamia, senza lode. E
ancora più importante del disco, sarà per Yoshimi
l'etichetta discografica per cui quel disco uscirà. La
Kill Rock Stars...
Would you
youth ?
marry a sonic
Un attimo di pazienza adesso: stiamo coi piedi piantati nel 1996. Dodici mesi precisi da quando Nice
Ass compare negli scaffali dei negozi di dischi. Dieci
anni esatti dal primo vinile dei Boredoms. Dieci anni
dove Yoshimi P-We ne ha viste di tutti i colori. Di
crude e di cotte. E qualcuna anche di passabilmente
al sangue. Come la sera con quel tizio allampanato
ritto fra il pubblico, che lo vedevi anche da lontano,
quel lampione di uomo, rosso di capelli e che ti assomigliava a Ricky di Happy Days. Quello è il mitico
Thurston. Thurston Moore, il chitarrista e cantante dei Sonic Youth, quelli famosi. Yoshimi è li
che suona con i Boredoms, quella notte di metà anni
'90, e l'altro è perso fra il pubblico pagante, mentre
si strugge e cerca di ricordarsi quando e come, per
la prima volta, lui e lei si sono incontrati e hanno
fatto amicizia. Poi tutto nella testa gli si fa chiaro, e
un'immagine più limpida dell'acqua di sorgente gli
attraversa la mente... Tokyo. Giappone, Primavera
1988. Lui è lì per vedere i Boredoms. Quell'anno i
Sonic Youth, la sua band, daranno alle stampe il loro
White Album, il loro Electric Ladyland: Daydream
Nation. C'è di che essere soddisfatti. Ma lui ancora
non lo sa. A quell'album ci sta pensando, non è mica
ancora uscito. Comunque sia, quella sera è lì, in piedi
e col drink in mano, che vuole capirci qualcosa di
quello che succede sul palco. E che succede mai sul
palco? Chi può mai dirlo! Quando a scannarsi sono
i Boredoms, tutto il resto è leggenda, mica storia.
E allora due passi nella leggenda personale di Mr.
Moore adesso li facciamo davvero, attraverso la rievocazione delle parole del protagonista su quella
DROP OUT
27
ufo or die
mitica serata dal sapor di epifania: "Mai, in tutti gli
anni che ho passato ad assistere ad attacchi noise-rock
di tutti i tipi, ripeto mai, ero stato spazzato via come
quando ho assistito allo spettacolo di questa band di
kamikaze del suono, che hanno letteralmente spaccato
a metà l'aria con i loro esperimenti. C'erano due batteristi, di cui uno dei quali (per almeno tre volte a numero)
si metteva in piedi sul suo seggiolino, e poi si lasciava
cadere così: faccia al set di percussioni. Poi continuava a
suonare, come nulla fosse accaduto. E suonava feroce,
28
DROP OUT
selvaggio, tuonante. Dietro il secondo kit di percussioni
c'era invece nascosta lei. La più notevole batterista che
abbia mai ascoltato. Vicino a me c'era un amico che
mi traduceva tutto, e che mi aveva insegnato a dire in
giapponese: "Yoshimi, vuoi sposarmi?". Alla fine di ogni
canzone urlavo: "Yoshimi, vuoi sposarmi?". Concluso il
concerto Yoshimi mi si fece vicina e mi diede un paio di
mutandine. E sai cosa feci io allora? Me le misi in testa
e il resto della notte lo passai conciato così: orgogliosamente". "Yoshimi, vuoi sposarmi?".
E matrimonio fu. Un sodalizio artistico che è, ancora oggi, vitalissima amicizia fra il lungagnone Moore e la fricchettona P-We. Un sodalizio discografico,
anche, visto che a metà anni '90 Yoshimi, per la Ecstatic Peace! di Mr. Moore, qualche disco, seppure
nel formato breve e vinilico del 7", lo pubblica pure;
a cominciare dal singolo Big Toast: Speaker/
Tuna Power (1993) e continuando con altre due
uscite, intitolate semplicemente Two (1994) e Three
(1995). Ci siamo. Ormai siamo arrivati. E' il 1995.
Ad un anno quasi da quella che sarà la Big Thing
di Yoshimi. E' quindi ora di dare corpo al catalogo,
perché se proprio dovessimo, un catalogo compileremmo, parlando dei copiosissimi side-project della
nipponica già a metà fine secolo scorso. Qualche
nome? I già citati Ufo Or Die! (per dirne uno)
che la vedono in trio con il solito Yamatsuka Eye
(chitarra e voce) e con High Ash (al basso). Tutta
la loro discografia di un certo interesse si posiziona fra il 1990 e il 1994: il nastro UFO or Diamond? (1991), il cd-3" UOD (Bron Records, 1991),
il cd UFO or Die Live (Dead Inc., 1992), il picture disc Cassettetape Superstar (Timebomb/
Public Bath, 1993), e il 7" per l'allora in ascesa Skin
Graft dal titolo Shock Shoppers/Zombie Tube
(1994). Se ci aggiungiamo un nastro del 1990, in cui
figura un cameo del folle man in black giapponese Keiji Haino, dal titolo Bee Haibu (etichetta
SSS) e un contributo alla raccolta Galaxy & New
Beauty (1992), abbiamo tutto quel che di loro vale
la pena avere. Jazz-core (?) sporco e cattivo. I Fugs
ritratti come una lucertola senza coda che non sa
più che direzione prendere per fuggire via e salvarsi.
E poi che altro, nel curriculum della batterista più
amata da Thurston Moore? Ed eccoci che continuiamo il catalogo delle partecipazioni: quella con gli
Omoide Hatoba (al fianco del Boredoms Seiichi,
di Tsuyama Atsushi e di Hasagawa Chew), le comparsate negli Hanadensha (che coinvolgevano pure
il bassista dei Boredoms: Hira), e ancora il suo nome
compare, a vario titolo, anche nelle copertine di di-
schi a firma Dowser, Rise From The Dead, e via dicendo. Ma questo non è niente. Niente al confronto
di quello che succederà alla Nostra nel 1996. Un
nuovo gruppo, tutto suo, stavolta, e che manco a
dirlo ha il suo battesimo del fuoco dal vivo.
O h O h E ye O h O h
La prima volta non si scorda mai, e quella delle OOIOO Yoshimi la ricorda così: "Il nostro primo concerto
dal vivo fu al fianco dei Sonic Youth, mentre facevano il
loro tour in Giappone. Avevamo provato appena una volta, poi ci esibimmo sul palco quella notte e diverse altre,
sempre al fianco di Moore e della Gordon". OOIOO. Ma
che razza di nome si è scelto Yoshimi per il suo progetto???: "Volevamo un nome che fosse essenzialmente un
simbolo", spiega allora la percussionista, "qualcosa che
puoi... vedere, diciamo". Ed infatti OOIOO qualcosa
suggerisce alla mente. Che ne so: un simbolo alchemico? Una chiave grafica al concetto di infinito? La
verità delle OOIOO è però di gran lunga più terra
terra. Le OOIOO fanno parte, insieme ai gloriosi Faust, delle band nate per burla e riuscite col
botto. La parola sempre alla fondatrice della band:
"Un magazine giapponese che si chiama Switch voleva
scrivere una storia basata su di me, ma non volevo essere fotografata sola soletta per la rivista, così ho chiamato un gruppo di amiche e abbiamo scattato una foto,
fingendo di essere una vera band. Poi pensammo che
sarebbe stato figo che questa band che non esisteva
diventasse una band reale. Prima delle OOIOO non mi
ero mai cimentata alla chitarra, e neanche gli altri membri della band erano dei gran musicisti, a dire il vero. La
bassista, per esempio, non aveva mai visto un basso vero
e proprio prima di iniziare con noi. Ai, la batterista, era
forse l'unica persona fra di noi davvero capace di suonare il suo strumento". Modesta la ragazza. Ed ecco nata
una nuova band. La band di Yoshimi (chitarra, voce,
jewsharp, cashio tone, tromba, theremin, batteria,
synth, effetti vari), Kyoko (chitarra, voce), Maki (basso, cori) e Yoshiko (batteria, cori). L'esordio su disco
avviene nel 1997, complice il solito Yamatsuka Eye,
che con l'uscita n°3 delle Nostre rafforza il catalogo
della sua personale etichetta: la Shock City. La prima
cosa, anche per chi distrattamente abbia seguito le
vicende dei Boredoms, che salta all'occhio è che qui
Yoshimi suona una quantità di strumenti, non solo
la batteria.
A cominciare dalla chitarra: "La prima volta che
ho provato a suonarne una, mi ci sono volute due ore
solo per capire dove infilare gli spinotti al posto giusto
e per cercare di fare uscire dallo strumento dei suoni
che per me avessero un senso. Le canzoni delle OOIOO
nascono così di solito: caos e rumore generale, poi ci
diamo da fare per raffinare il tutto". Anche se, a dirla
tutta, 'raffinato' il disco omonimo (poi ristampato,
nel 1998, per la statunitense Kill Rock Stars: in vinile
è un disco bianco latte con copertina apribile) non
potrebbe certo essere definito. E' vero che Yoshimi
ci suona la tromba ("Una volta, alle scuole elementari,
suonavo il trombone"), ma bisogna vedere che suoni
ci tira fuori da quello strumento che fu anche di
Miles Davis. Diciamo che le coglionerie geniali
dei Boredoms non sono passate invano (Sister 001
figurerebbe bene anche su Pop Tatari), e diciamo
anche che l'anarchia che fu degli Ufo or Die! non è
andata persa, e anzi si arricchisce ancora di più se
maltrattata alla maniera dei gruppi della storica No
Wave (azzardiamo Teenage Jesus?) o della (allora) contemporanea Skin Graft. Ci sono i pattern
ritmici prossimi all'industrial che incontrano l'indie
song (Right Hand Ponk), ci sono tonfi ipnotici e tribali nella musica cosmica e nel prog-jazz (Switch), ci
sono canzoni regolari (Ring A Ring A Lee, le Shonen
Knife strafatte?), e non mancano schizzi hardcore
che ben figurano nell'epoca dei Truman Water (OOai-OO). E si conta pure qualche numero che pirleggia
sui Sonic Youth di Goo, e sul modo di cantare afono
di Kim Gordon, strafogandosi in una paccottiglia di
suoni sgusciante che fa plink plonk e si perde in un
puzzle hardcore-cosmico a metà strada fra le sfere
celesti e due sfere così (nel (doppio)senso che avete
certamente intuito!). Affascinante. Il disco - prodotto da Yoshimi stessa, registrato presso gli studi Free
People fra luglio e ottobre del '96, e che nei credits
ringrazia anche Julie Caflitz - chiude i suoi 32 minuti
di durata con i 4 del remix di Eye dal titolo Sister
OO1 (Eye Mix): esercizio sublime di decostruzione
ritmica nell'evo del drum'n'bass al suo culmine.
Freak B eats
of the
World
Ecco: i break beat. Qualcosa di più sul fatto che questo disco possieda mille vie di fuga ritmiche come
pochi al mondo mai, ce lo spiega Yoshimi stessa, che
alla domanda "quali sono state le tue influenza come
batterista e percussionista", così risponde: "I break
beat. Tu non sai quanto mi abbia influenzato vedere i
Public Ebemy dal vivo". Supponiamo molto. Come
(e non si fatica affatto a immaginarlo), ascoltando
l'album, pare abbastanza chiaro che la signorina in
questione non ami troppo le partiture codificate.
Piuttosto si gasa improvvisando. Forse tutto deriva
da traumi infantili, da quando era piccolina e la mamDROP OUT
29
free kitten
ma la 'obbligava' alla settimanale lezione di Cho-on:
"Quando avevo quattro o cinque anni, chiesi a mia madre se potevo prendere lezioni di piano. Lei mi disse che
potevo, ma solo se prima prendevo lezioni di Cho-on,
una specie di musica di chiesa corale che abbiamo qui
in Giappone. Tutto l'affare consisteva nell'ascoltare. Una
religiosa suonava il piano, e tutte noi dovevamo imparare la partitura direttamente dalle note e dall'armonia
ascoltata. All'inizio mi divertiva pure, alla lunga era pallosissimo. Non mi piace, neanche oggi che sono cresciuta,
lavorare con le partiture musicali". Ritornando a questo primo vagito sonoro delle OOIOO, aggiungiamo
solo che riescono alla grande là dove Le Free Kitten ci provarono (e fallirono), rispolverando anche
qualcosa del poderoso caos di metafisico rumore
zozzo che era stato dei Pussy Galore più lerci e
dei Royal Trux con più eroina in corpo. Altri due
anni, e siamo al 1999, e Yoshimi darà un seguito a
quel primo disco, che nel frattempo in USA un po'
tutti gli addetti ai lavori hanno notato. E siamo in piena zona Father Float. Prima erano solo un gruppo
di ragazzotte scombinate e geniali ma non troppo
pratiche degli strumenti imbracciati? Ora non più.
Ora con quegli affari che gli altri chiamano strumenti
musicali, e che loro usano come armi improprie, ci
hanno preso dimestichezza. Squadra che vince, non
30
DROP OUT
si cambia, e l'organico, compresi gli strumenti suonati, rimane pressoché identico a prima. Quello che
cambia è il gioco giocato dalle OOIOO. Prima erano
i Fall. Adesso sono i Can. Prima c'erano echi dei
Boredoms di Anal By Anal. Adesso cade sull'album,
pubblicato dalla Polystar e poi ristampato dall'etichetta di San Francisco Birdman Records nel 2000,
una polvere sottile che chiama alla mente Sun Ra
che si concede ad una session con i Boredoms a
venire, quelli capaci di volare alto con Vision Creation Newsun.
Il prog è un altra fonte di sollecitazione fortissima
per le OOIOO di allora. Meglio: da allora (in poi).
Registrato sempre presso il Free People, fra l'agosto
e il novembre 1998, Father Float è il primo frutto
maturo della band. Da bambine capricciose a donne
magari un po' bizzose, ma dai gusti precisi e a loro
modo sofisticati. Un esempio? L'apertura di Be Sure
To Loop, che pur di non smentire l'asserzione del suo
titolo, ripete all'infinito indovinate che frase? Be sure
to loop. Un loop vocale, un coro in crescendo, che
un po' rimanda ai Can di Tago Mago nei momenti
delle progressioni armoniche più coinvolgenti, e un
po' a certe cose prog-jazz di metà Seventies. E, manco a volerlo fare apposta, quel che segue il pezzo
citato è un nuovo numero di costruzione strumen-
tale armonicamente ardita (anche se fortemente
ancorata a modelli ritmici basati sulla ripetitività). Il
pezzo si intitola Oizumio, ed è in realtà una cover dei
nipponici 和泉希洋志.
Non siamo distanti, ancora una volta, da quello
che i coevi Boredoms vanno propinando in dischi
come Super Ae, o l'ep Super Go!. Senza tenere
conte che, stavolta, tutte le partiture (ci perdoni Yoshimi se così le chiamiamo) hanno una qualità etnica
(poliritmie africaneggianti e nipponizzate: Ina) e psichedelica (il tropical punk degli Abe Vigoda con
10 anni quasi di anticipo? Eccolo: Ah Yeah!) inclassificabili. I pezzi da due minuti due, poi, non mancano,
ma hanno un sapore molto diverso dal disco precedente: la black exploitation riletta e cazzeggiata di
Jackson's Club "Sunspot", ad esempio, che introduce ai
dieci minuti posti quasi in dirittura d'arrivo del disco:
quelli di 1000 Frogs And 3 Sun In A House. Sempre
ritmicamente incalzanti, con la chitarra che libera il
twang, l'elettronica che disturba ma non troppo, l'atmosfera generale che sa di animismo puro e pure
un pizzico di zen. Questo è un disco religioso che
ormai omaggia sole, vento, acqua e fuoco, ma lo fa
senza pensare che il rumore sia molesto e rovini la
sacralità degli elementi della natura. Anzi: il rumore e il ritmo, l'essenza di queste OOIOO, sono qui
compenetrazioni di una stessa essenza universale.
Che queste OOIOO non siano le grandi eredi che
il prog-rock nipponico (eversivo per natura) attende
dai Seventies? Che non abbiano davvero raccolto la
fiaccola che fu della Far East Family Band di Nipponjin? O magari dei Blues Creation? O forse di tutti e
due messi assieme (l'incredibile coda strumentale e
poliritmica di 1000 Frogs) solo aggiornati all'epoca
dei break beats? Ai posteri l'ardua sentenza. Fino a
questo punto della loro, seppur breve carriera discografica, le OOIOO sono state essenzialmente
un progetto scanzonato e senza troppe implicazioni
artistoidi.
Japan
underground rhythm
Rispetto agli impegni istituzionali con Kim Gordon e
le OOIOO, a partire da Yoshimio, P-We porta avanti
con altrettanto impegno una copiosa attività underground sconosciuta ai più e volta ad esplorare lati
ancora differenti dei già molteplici campi d’azione.
Inaugurata nel lontano 1993 con il citato moniker
(sospeso per più di un decennio), è a partire dal 1999
che la solo career diventa prassi parallela all’attività
nelle band. Da questa data a oggi vengono inaugurati
progetti specifici per l’approfondimento di alternati-
ve tribali all’ipotesi Boredoms ma anche, all’inverso,
volti sviluppare un’idea di ambient con accenti davisiani (la one shot Yoshimi & Yuka) e alcune collaborazioni fee-jazz miratissime con personaggi assai
di culto come Mats Gustafson (Words on the
Floor, Smalltown Superjazz, 2007), Jim O'Rourke
e Akira Sakata (Hagyou, BounDEE, 2008). In tutta
questa frenetica attività basata perlopiù sul ritmo,
Yoshimio è il ritratto di una musicista che ogni
tanto ama tornare a casa e ripartire dal proprio
folclore, un progetto eminentemente domestico
dunque, nel quale l’elettronica (pensate ai Mouse
On Mars ma non troppo) si tinge di misurati slanci
avant, ambient e al bozzetto elettroacustico. Dopo
l’occidente e l’alienazione/liberazione mai lineare e
armonica di jazz e noise, tornare a Oriente significa
catarsi nel quotidiano, aspetti fondanti di Yunnan
Colorfree (etichetta Commmons), lavoro commissionato per un documentario dello stesso nome
popolato da fugaci fotografie e acquerelli di vite e
mestieri. Non mancano i soliti svolazzi d’elettro povera stile San Francisco, l’industrial più ambientale
che confina con la scuola rumorista, un jazz diluito ma sono soprattutto i field recordings di voci e
suoni della sua terra che catturano l’immaginazione,
proprio come un film di Yasujiro Ozu. L'album
contiene anche una versione - registrata dalla Nostra assieme a Kim Gordon (che canta pure) e alla
figlioletta Uta di 5 anni - di Death Valley 69, di
sonicyouthiana memoria.
Il ritmo qui è variabile aleatoria quando il percuotere è alla base degli altri due progetti. Il primo e
probabilmente concluso nel 2002, è Psycho Baba
dove assieme a P-We alle percussioni e agli effetti
voce (la Kaoss Pad) troviamo il maestro Yoshidadaitiki al sitar e il batterista dei Boredoms ATR. Sotto
questa ragione escono: TabLoveDubla TabLoveDubla
TabLoveDubla (1998, Japan Overseas), una mesmerica
traccia di un'ora che parte dai syntetisimi circolari
del Terry Riley più barbuto per finire in un tripudio di tablas altrettanto circolari e ipnotiche dopo
un’attesa interminabile ed efficacissima. E due sequel
On The Roof Of Kedar Lodge (2000, Japan Overseas) e
Liveeep (2001, Japan Overseas), album che ne ripercorrono le strategie e gli invisibili interventi digitali.
Per essere veramente completisti sotto PsychoBaba escono poi una serie di EPs soltanto per il mercato giapponese sotto il nome – scritto però come
si pronuncia questa volta - di Saicobab. Sono lavori più dilatati e astratti tra droni di sitar e le voci
effettate di Yoshimi, l’esatto contrario dello spirito
DROP OUT
31
del progetto imbastito dalla ragazza quattro anni più
tardi, Olaibi, quintetto tutto al femminile e tutto
jappo formato dall’omonima Olaibi alle conga, djembe, kalimba, campanacci, elettroniche e ukelele, Yoshimi alle vocals, melodica e effetti, la OOIOO Aya al
basso e altre due donne (Misato Thiam and Chieko)
ancora alle congas e djembe. Non così facilmente
sintetizzabile, il progetto presenta sia lunghi trip su
locked groove di percussioni serrate (la traccia che
dà il nome all’album Humming Moon) sia bozzetti
più veloci con gli inevitabili rimandi ai Residents
ma sempre in una dimensione ultra pagana. Ad ogni
modo, due gli album partoriti: Humming Moon
Drip (3d, 2006) e il recente e ancor più dispersivo
Tingaruda (3d, 2009), che in pratica potrebbero
rappresentare dei Boredoms in un universo parallelo fatto del medesimo cerchio attorno al quale macinare loop ma senza la severità Zen sotto la quale
sottostare. Inoltre dove per Psycho Baba era l’india,
qui il terreno prediletto pare l’Africa sottoforma di
Savana a doppia velocità oppure un Magreb bello
sessuale e arrapato nei rush tanto che vien da pensare alla Tribal House ma – naturalmente senza cassa
(Tower) e senza una personalità ad emergere.
Altra caratteristica di tutti i progetti nei quali Yoshimi collabora è infatti l’impersonalità. Tutto il suono è il risultato di un afflato collettivo oppure una
pennellata ambientale. Soltanto nelle collaborazioni
all’insegna del free jazz è ammesso un solista. E adesso, dopo tanti succulenti antipastini, si ritorna alla
portata principale. Loro sono sempre le OOIOO e
hanno ancora qualche numero (notevolissimo) con
cui sorprenderci...
F lamin '
drums
Passato Father Float, Yoshimi e compagne incominciano seriamente a pensare cosa fare di loro.
Sono grandi. Sanno suonare. E suonano così particolari e uniche. Che fare dopo un secondo disco
come quello, così diverso dal primo, ma anche meglio riuscito? La risposta è il terzo album della band:
Gold & Green (PSCR, 2000). Un disco inferiore al
precedente (e infatti avrà meno successo di quello),
ma totalmente immerso nei poliritmi etnici (Brasile, Africa: vedi l'opener Moss Trumpeter), o in giochi
avant-garde (già in parte sviluppati nel progetto solista di Yoshimi che, appunto, da lei prende il nome:Yoshimi) come lo scazzo prog-jazz minimalista di Grow
Sound Tree; e ci vorranno quattro anni per dargli un
seguito.
Kila Kila Kila (Thrill Jockey, 2004) è ancora
32
DROP OUT
un album incerto, sottotono, ma che presenta delle
novità. Novità numero 1: le OOIOO non sono più
quelle di prima. No, non intendo le solite menate
ontologico-psicologiche-confessionali. Non sono più
quelle di prima perché, a parte il deus ex machina
Yoshimi (che cura tutti i testi), per davvero non è
rimasto a suonarci nessuno dei vecchi membri della
band. E così i nuovi si chiamano Kayan (chitarra e
cori), AyA (basso elettrico e cori) e Yuka Yoshimura
(batterie e cori). Yoshimi alla tromba, all'organo, al
piano e alle percussioni e siamo di nuovo in pista. E
qui sta la novità numero 2: ma non sembrano neanche loro su questo disco!
Paiono una cosa a metà fra Moondog, Cibo
Matto, Partch e una band krauta al suo apice
jazz-prog (facciamo i Guru Guru di Don't Call
Us We Call You, 1974, solo dediti al terzomondismo di Fela Kuti: vedi On Mani). Album di transizione. Ma anche album che mica si capisce verso
cosa vuole mai transitare: la lounge? Il prog? L'etnica?
La psichedelia? Otto tracce che hanno il loro apice
nei 15 minuti di Aster. Estasi zen e persino una strana commistione, astrattissima, di chitarre funk-punk
su di un tappeto sbrodolante prog. Nel frattempo,
proprio quell'anno a dire il vero, i Boredoms
pubblicano un altro dei loro classici (Seadrum/
House Of Sun) e, qualche tempo dopo, qualcuno
domanderà a Yoshimi se di quel suo primo gruppo
rimpianga qualcosa: "No, per nulla. Non guardo alla mia
esperienza con i Boredoms con nostalgia. Certo, con Hira
e Yamamoto come membri siamo stati grandissimi, ma
abbiamo comunque espresso tutto il possibile con quella
lineup".Yoshimi ci ha messo una croce sopra a "quei"
Boredoms. Ce lo spiega in un bel servizio al magazine Signal To Noise dello stesso anno. Ma qual è
la vera cifra stilistica delle OOIOO? La critica stufa
delle canzoni, delle solite mode, e di tutto ciò che
si compiace dei cliché, le adora per l’imprevedibilità
che ogni brano OOIOO come dio comanda si porta
appresso. Le intellighenzie avant le amano per le abilità strumentiste sotto ai panni freakadelici in grado
di blindarti un groove per ore come andar di free
per altrettanto tempo. Il pubblico, beh il pubblico farebbe bene a non fermarsi ai bei visini e al fascino
esotico di queste cinque signorine nipponiche e a lei,
Yoshimi, che ne è la famigerata leader. Farebbe bene
a smetterla con quello che è un autentico luogo comune che l’associa ogni santa volta a un album al
quale ha certamente collaborato ma ha poco a che
fare con lei. Quale? Yoshimi Battles The Pink
Robots dei Flaming Lips ovviamente, che per la
cronaca parla di lei come metafora (sapete i Lips
come sono complicati) e poi racconta di un’altra Yoshimi proprietaria di un negozio di dischi e morta in
circostanze tragiche e improvvise.
I Lips hanno caratterizzato quell’album mettendoci la nostalgia/affetto in un braccio e l’effetto speciale cartoon nell’altro, due aspetti che Yoshimi sembra rispedire al mittente restringendo i ranghi in un
suo mondo che semmai dell’infantile cava l’aspetto
più cattivello, istintuale e anarchico. Yoshimi è innanzitutto questa bella dicotomia: una ragazza minuta
dalle cui bacchette/mani/strumenti esce di tutto e,
per giunta in maniera persino impersonale (per noi
occidentali ovviamente) e un’enciclopedia musicale
tagliata sotto una ferrea idelogia trans-global che
unisce tre generazione di hippy. E che passione che
ne esce anche se a vederla dal vivo con il suo gruppo
storico di riferimento, i mitici Boredoms, suonare un
ritmo base di batteria incessantemente per decine
di minuti è assolutamente glaciale.
E lì in ballo c’è lo zen fatto con i tamburi. Misticismo trans-qualcosa appunto e fate conto che il
primo brano del precedente album Taiga (2006)
firmato OOIOO è figlio di quell’esperienza. E’ musica di resistenza personale e per chi l’ascolta. Ma è
anche la pietra d’angolo per tracciare un’importante
differenza tra i progetti di Yoshimi e il gruppo di Eye,
a differenza di quest’ultimo infatti il sound di Yoshimi è intimamente freak, un melting pot di esotismi
afro-orientali in perenne tensione e qualche rilascio
dove non manca neanche la wave e il rock, l’exotica e il kraut. Taiga poi, nasconde delle soprese.
Come in Uma, dove compare un frammento corale
del Secondo Coro Delle Lavandaie (tratto dall'opera teatrale del 1976 dal titolo La Gatta Cenerentola) di Roberto de Simone. Al che gliene
domanderanno pure, a Yoshimi, ed ecco che ne dirà:
"Mi capitò di ascoltare un dj mix di un dj tedesco che
includeva un sample di quella canzone. Una canzone
che sembrava sprizzare amore per la vita da ogni nota.
Non capivo di certo il significato delle parole, ma ebbi
come una folgorazione: "Devo fare questa canzone [nda:
Uma]". Così mi misi a fare qualche ricerca e mi procurai
quel cd".
A rmoniche
hewa
A conti fatti, in Taiga c’è talmente tanto che il too
much è matrice di un sound che non vuole gabbie
e detesta ogni commerciabilità e naturalmente così
facendo finisce per farsi riconoscere. Yoshimi oggi
è ampiamente riconoscibile sia come parte interdipendente dei Boredoms (il virtuosismo e la severa
matrice zen applicata al locked groove strumentale)
sia come entità autonoma nei suoi Oh Oh Eye che
con Armonico Hewa (2009) sesto album della
band firma anche il personale capolavoro. Certamente i riferimenti post-punk, come la maturazione
di quelli sanfranciscoani di vecchia data (dai quali il
post punk ha a sua volta preso molto), hanno aiutato
non poco a stendere un giudizio così lusinghiero, eppure qualcosa di magico nel nuovo lavoro di Yoshimi
c’è ed è un equilibrio tra essenze rock e avant al
quale definitivamente tutte le altre spezie si piegano.
Rispetto a Taiga e ai suoi giochi call and response
colati nelle mille fascinazioni afro, Harmonico carica
l’urbano e lo mistifica, s’avvicina a esperienze artpunk The Wire e naturalmente slabbrature alla sei
corde Gang Of Four.
Postilla conclusiva: per i completisti della discografia delle OOIOO, sono almeno da segnare una
manciata di dischi: Shock City Shockers 2 (Shock
City, 2001), contenente remix su pezzi delle Nostre
a firma Yamantaka Eye, Kan Takagi, Kiyoshi Izumi e
Nobukazu Takemura; il discretamente interessante
e semi-compilativo COCOCOOOIOO: The Best
of Shock City 1997–2001 (uscito nel dicembre
2004), un singoletto di remix curato dal solito Eye
(OOEYEOO - Eye Remix, Thrill Jockey, 2007) ed
infine il dvd, ancora su Shock City OOHOHOOOOIOO Music Video's '99-'07.
DROP OUT
33
Recensioni::::novembre::
►►►►
2562 - Unbalance (Tectonic,
Ottobre 2009)
G enere : techstep broken house
Menù fisso techstep per l’olandese Dave Huismans. Se nel primo Aerial 2652 ci andava di
ortodossia emula e non esaltava, oggi il ragazzo si
sposta dai binari già battuti dei padri nobili inserendo vocals e ritmi appartenenti alle esperienze
trasversali di Flying Lotus e Martyn. Lo step
che si sporca con le atmosfere di A Guy Called
Gerald (Lost), con l’acidità e gli organetti jazz distopici (Dinosaur e Unbalance), il dub à la O.R.B di
Superflight e gli spezzettamenti manieristici di Who
Are You Fooling? e per finire con l’ambient ereditata
dai Boards Of Canada (Narita).
Una scalibratura verso suoni più trancey e progressivi lo accostano idealmente al Belgio e al nord Europa continentale: per far uscire l’anima dalle macchine ci vorrebbe però il culto Joey Beltram.
Non siamo ancora a quei livelli, ma ci stiamo avvicinando (vedi la conclusiva Escape Velocity). Il distacco
dal citazionismo che promette bene.Take your time,
Dave.(6/10)
Marco Braggion
A Place To Bury Strangers Exploding Head (Mute, Ottobre
2009)
G enere : shoegaze rumorosa
Presentarsi all'esordio con un disco al limite del tributo da cover band di paese si può perdonare come
errore di gioventù. Perseverare col secondo riproponendo - se possibile accentuandola ancor di più l'ossessione per il suono della trimurti My Bloody
Valentine/Jesus & Mary Chain/Spacemen
3 può suonare come a) una estrema mancanza di
creatività; b) un culto al limite del patologico; c) una
clamorosa presa per il culo.
Sia come sia, questo Exploding Head esplode
letteralmente di suoni e deviazioni (prevalentemente) chitarristiche giocando come al solito con
volumi eccessivi ma anche introducendo qua e là
- sporadicamente a dire il vero - qualche elemen34
recensioni
to diverso nel tessuto da post-shoegaze in totale
overdrive che è la cifra stilistica dei tre: non solo
dei Black Rebel Motorcycle Club in trip da
steroidi (Ego Death), insomma, ma anche un minimo
di grezzume r’n’r (ossessivo alla Cramps, per intendersi) come in Deadbeat, una bella spruzzatina di
goth-industrial, diciamo sul versante più pomposo e
pompato alla Sisters Of Mercy come in In Your
Heart o nella title track, rimandi citazionisti alla wave
più dark come dei giovani e violenti Cure (Keep
Slipping Away).
Il risultato, stranoto quasi sino alla nausea, suona
però credibile, catchy fino al midollo, impossibile da
dimenticare anche e soprattutto per via di una produzione al limite della perfezione che sopperisce in
tecnica (oltre che in wall of sound stratificato e a
tratti devastante) ad una innegabile limitatezza creativa dettata anche dal recinto di genere. Così alla
fine del disco, mentre ci si ritrova imbambolati a far
ripartire il lettore, ci si rende conto che forse delle
3 ipotesi di cui sopra, la seconda non è che sia proprio così sbagliata.(7.1/10)
Stefano Pifferi
AA. VV. - Ciao My Shining Star: The
Songs Of Mark Mulcahy (Shout!
Factory, Settembre 2009)
G enere : indie rock
Una vicenda che tocca il cuore e l’anima, l’antefatto
a questo disco. Mark Mulcahy era negli anni ’80 il
motore creativo degli americani Miracle Legion,
formazione tra le più valenti e originali nel seguire
le orme dei R.E.M. Lo scorso settembre, poiché la
giustizia non appartiene a questo mondo, è venuta
a mancare Melissa, moglie di Mark e madre di due
gemelle di tre anni. Ci si chiede come l’uomo possa
tirare avanti e un contributo lo porge questo “benefit”, dal non indifferente merito di esortare una
riflessione sulla classe di quei ragazzi del Connecticut.
Che raccolsero poco o nulla economicamente ma
sfornarono almeno due lavori consigliati prima di
sciogliersi a metà dello scorso decennio, pertanto
highlight
Bloody Beetroots (The) - Romborama (Dim Mak, Ottobre 2009)
G enere : italo post - fidget
Dopo una svagonata di remix per chiunque personaggio del panorama ritmo, ecco il disco di
Bob Rifo e Tommy Tea. E qui siamo al doppio che riassume un orgoglio italo che non è
manco più italo, perché solo dopo aver ottenuto il successo internazionale li abbiamo voluti di
nuovo in patria. Tornano come vincitori e il messaggio è chiaro: spaccarsi il culo -alle volte- paga.
Ci sta anche il parallelo con i Justice. La cattiveria e la cupezza ci sono, gli inni anche, il fashion
non manca (anche se qui è un po' più de noantri).
Partire allora alla conquista di infiniti dancefloor: dal loro pulpito ti
sparano delle cose del calibro di Romborama, ma anche dei cambi di
stile che ti fanno pensare alla melodia di un Benassi (Have Mercy On
Us) o al tocco di Mr. Oizo (Storm). 20 canzoni per la generazione
post-fidget, per chi ha come idoli i Daft Punk e cavalca la notte
incurante di far parte di una catalogazione il più delle volte forzata. Se
siamo ancora qui a parlare di fidget, di french touch e di scuola Kitzuné, probabilmente le tracce sono ancora fresche. Oggi siamo così,
ascoltiamo e balliamo le cose che tempo fa pensavamo fossero solo per maniaci. Questo disco
trasforma in pop tutta quell'eredità acido/nerdy e la innesta con il metal e il breaking. Un disco
che chiude in anticipo di un anno la prima decade degli anni 00. Rifo e Tea: orgoglio e pregiudizio.(7.4/10)
Marco Braggion
quale migliore occasione per (ri)scoprire un talento
che trasfigura in chiave favolistica radici e nevrosi
new wave. Tutto so eighties, penserete, eppure i Miracle Legion oggi reggono benissimo e lo dimostra
il materiale - proveniente anche dal seguito della
carriera del Nostro - interpretato da una platea eccezionale per blasone e ricchezza.
Scontato un pugno d’inefficaci ben intenzionati (inclusi i Mercury Rev, ormai alla frutta), spiccano
Thom Yorke (All For The Best) e Michael Stipe
(Everything’s Coming Undone) in bilico tra cuore acustico e abiti elettronici, un Frank Black torbido
e convincente come mai (Bill Jocko) e il “solito” Vic
Chesnutt che commuoverebbe anche le pietre
(Little Man), laddove le contorsioni dei Rocket
From The Tombs (In Pursuit Of Happiness) contrappuntano il folk fragrante di Juliana Hatfield
(We’re Not In Charleston Anymore) e quello agitato di
Elvis Perkins (She Watches Over Me). Apprezzabile anche il resto, soprattutto i Dinosaur Jr. che
si appropriano di The Backyard e l’epica sostenibile
con cui The National infagottano Ashamed Of
The Story I Told.Ventuno in totale i brani che ci auguriamo donino un po’ di sostentamento economico
a Mulcahy. Quasi altrettante le ragioni per acquistare Ciao My Shining Star, bello a prescindere dai suoi
drammatici risvolti.(7.4/10)
Giancarlo Turra
recensioni
35
AA. VV. - Quit Having Fun (Boring
Machines, Ottobre 2009)
G enere : experimental sounds
Ci si chiede spesso se ha ancora senso pubblicare
compilation più o meno tematiche nell’era della circolazione infinita delle musiche. La risposta è sovente no, con alcune sporadiche eccezioni. Quit Having
Fun è una di quelle.
Apparentemente senza un filo conduttore che non
sia la voglia di riunire artisti amati e amici - non necessariamente apparsi sul catalogo Boring Machines
- sotto l’insegna del motto della label che da titolo
al tutto, questo doppio cd in edizione cartonata e
curata come da tradizione inanella 23 artisti per 143
minuti di musiche sperimentali e fuori asse. Si passa cioè con estrema nonchalance dai flutti droning
al field recording più o meno trattato e/o astratto, dall’elettroacustica all’improvvisata più o meno
radicale. E il risultato, molto meno disomogeneo
di quanto sia lecito attendersi da una compilation
che riunisce progetti molto distanti come Arbdesastr e Black Forest/Black Sea o Sparkle
In Grey e Ben Reynolds. Un apprezzamento
particolare (e personale) va ad un insolito Claudio Rocchetti in vena di nenie sub-atomiche (Be
Shy!), alle basse battute atmosferiche degli sloveni
Coma Stereo (Ghostly), al crescendo in saturazione di Die Stadt Der Romantische Punks,
side project di Jukka Reverberi (Guitar Act. 2) e alle
consuete stasi ambientali di Andrea Marutti (A
Depressing Study In Wandering Wonders).
Insomma, nata come affare di famiglia o quasi, Quit
Having Fun rischia di diventare il barometro della scena sperimentale internazionale sul finire degli
anni 00.(6.8/10)
Stefano Pifferi
AA. VV. - Clowns And Jugglers - A
Tribute To Syd Barrett (Octopus,
Settembre 2009)
G enere : vari
Esce per Octopus Records questa raccolta di saggi
sull'arte musicale del Cappellaio Matto e i motivi di
interesse sono molti. In primo luogo perché si parla
di Syd Barrett, con tutta l'aura di obliquità chimica
che il Nostro si porta dietro e le difficoltà a rielaborare un songbook così particolare. Poi perché a dar
voce alla psichedelia slabbrata di The Madcap Laughs, Barrett e Opel è un plotone agguerritissimo
di band (più o meno) underground internazionali
e italiane. Infine perché i brani proposti sono quasi
36
recensioni
sempre reinterpretazioni - spesso radicali - e non a
omaggi rispettosi, fatta eccezione forse per le sole
It Is Obvious di Moltheni e Love Song dei Roses
King Castles.
Il che significa ascoltare i notevoli Fuh trasformare
una Long Gone in origine chiaroscurale in un assalto
sonico spropositato, i Gasparazzo sollazzarsi con
una versione reggae di Love You (si, Syd Barrett funziona anche in “levare”), i Super Elastic Bubble
Plastic ritagliare una efficacissima Dominoes su un
tappeto noise, i Baby Blue “garagizzare” una Dark
Globe trasformandone
l'innocente disperazione
originale in una cavalcata
scoordinata e sonnacchiosa di chitarre elettriche. La palma di “miglior
talebano delle cover” va
a Vanproof (Baby Lemonade), Entrofobesse (She Took A Long Cold
Look) e Filippo e Francesco Gatti (Golden
Hair), capaci di trasfigurare completamente i brani passati sotto setaccio, mentre quella di “episodio
più stiloso” se la aggiudica una Terrapin degli Atari
in bilico tra sussurri e elettronica.
Oltre alle formazioni citate sono della partita anche
Mesmerico (No Good Trying), Low-fi (No Man's
Land), Mad Hatters Project (Octopus), From
Tropics With Love (Rats) e quei Jennifer
Gentle emanazione diretta del verbo del Cappellaio Matto, qui chiamati a spiegare una Opel per tradizione margine estremo della produzione ufficiale di
Barrett. In un disco che impone un giudizio più che
positivo, visto come si arrischia a maneggiare materiale ampiamente interiorizzato senza scadere nel
ridicolo e anzi aggiungendo classe a un canzoniere
di per sé già geniale. Quest'ultimo raccolta di spaccati musicali inaspettatamente malleabile, tanto da
non temere nemmeno attualizzazioni lontane anni
luce dallo stile originale del suo autore.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
AA. VV. - Variations in white part
1 (White_Line Edition, Settembre
2009)
G enere : microsuoni
Primo di una serie di meditazioni sul colore bianco, l'uscita White_Line gioca e modella il suono
tra melodia e drones, dichiarandosi suggestionata,
per semplicità e purezza, dall'elettronica digitale e
microsonica. Utilizzando un marcato sottofondo
di onde corte, un rallentato e granuloso fraseggio
di superficie ed una miriade di fluttuanti particelle,
Variations in white Part 1 decide di mettere
in mostra l'intensità dei propri cromatismi attraverso la luce, filtrata da un leggero e sospeso correre di
minuscoli aghi sonori accorpati poi in quattro tracce, per quattro artisti e quaranta minuti in tutto.
Comune denominatore l'ambient, un bianco ascetico e magmatico, divenire di un risveglio per Lawrence English, raccontanto e ritrovato tra accartocciati field recording e contrappunti atonali in
Shinkei, sovraesposto al forte contrasto (e sottolineato dalle fisicità del suono) in Miguel a Garcia, oppure narcolettico - e risonante - per Andy
Graydon.
Magnifici laboratori d'elettronica asciutta da incontrare nel silenzio e assumere quotidianamente alla
ricerca di un iniziato rinnovamento.(7.2/10)
Sara Bracco
AA. VV. - New Moon (Original
motion picture soundtrack) (Chop
Shop, Ottobre 2009)
G enere : indiewaves for the mas ses
Non abbiamo visto il primo capitolo della saga di
Bella e del vampiro Edward, adattamento del romanzo di Stephenie Meyer. Uno dei fenomeni del
momento, come si dice, e infatti accostato da molti al mondo emo-teen, accolto tra beatificazioni e
crocifissioni alla Nonciclopedia. Adesso sta per uscire il seguito, New Moon (Bella, mollata da Edward,
si avvicina al lupomannaro Jacob), ed eccoci qui ad
ascoltarne la colonna sonora. Come per il primo
film, canzoni scritte ad hoc da un serie di nomi di richiamo. Lì, tra gli altri, Muse, Linkin Park, Perry
Farrell e Iron & Wine. Un prodotto fatto bene.
E se non proprio in territori emo, ci troviamo in
territori emotional latu sensu, tra poprock enfatico (e con qualche affondo glammie), folk lamentoso
o sussurrato alla Giuppy Izzo e derivazioni postpunk.
La formula, perfettamente funzionale, si replica. Qui i
nomi sono Death Cab for Cutie (forse il pezzo
più incisivo), Thom Yorke (pulsante e atmosferico), Killers (col loro retrogusto gospel), Black
Rebel Motorcycle Club (niente di che la loro
take folkie-blues), Editors (piano, voce, cori) e ancora - Muse (un classico dei loro). Tutti i brani si
lasciano ascoltare (e molto meglio di quello che si
poteva credere). Rosyln di Bon Iver & St. Vin-
cent prende la base di chitarrine dalla Chinese Firedrill di Mike Watt e Black Francis.(6.4/10)
Gabriele Marino
AA. VV. - Cosmic Balearic Beats
Vol. 2 (Eskimo Recordings, Ottobre
2009)
G enere : balearica
Che gusto nello scrivere balearica tout court per una
compilation. Quell’aggettivo è un utopia mai realizzata: il sogno paradisiaco di vivere in una nuvola, di
avere albe a disposizione nelle tasche, di poter sorseggiare cocktail guardando il mare, tralasciando il
business, accompagnati da qualche visione pompata
da coadiuvanti chimici. Il post-Manchester di chi ha
passato i trenta, di chi sa che tra poco diventerà
adulto e che non avrà più tempo per i tramonti e
lo sciabordìo. La compila che abbiamo sottomano
surclassa il primo volume di qualche anno fa e si
pone come unica alternativa ai party ibizenchi per
questo lungo inverno
09. Come nelle migliori selecta, non lo senti
il passaggio da traccia a
traccia. Le dissolvenze
si nascondono in un lento crescendo che va dal
piano jazz 80 di Slight
Delay (Can You Feel It) ai
pizzicati rondovenezianeschi di Nelue (No Strings
Attached), dal basso e i synth di Giorgio nel pezzo
di Marbeya Sound (Salomon’s Take), alle affinità
con l’archeologia dei Chromeo in Zoe Et Heine
di Premier Rang. E poi ancora progressioni, uptempo white funkiness (Volgograd), un tocco gitano
(YES Maam) e tanta tanta anima. Merita l’ascolto
ripetuto. Altro che Buddha Bar.(7.5/10)
Marco Braggion
Adrian Crowley - Season Of The
Sparks (Chemikal Underground
Records, Novembre 2009)
G enere : songwriting , chamber folk
Quinto album in carriera e primo su Chemikal Underground, Season Of The Sparks vede il songwriter irlandese Adrian Crowley raccogliere le
fila del suo cantautorato intimistico.
Una vena melodica e canzoni che rimandano prettamente da una parte, come atmosfere e vocalità,
ai classici Leonard Cohen, Robert Wyatt e
Lee Hazlewood, dall’altra si estendono fino a
recensioni
37
lambire territori vicini a un Bill Callahan, ma con
maggiore solarità e ad un Antony per pathos nonché all'Arab Strap Aidan Moffat.
Immerso totalmente in atmosfere bucoliche e pastorali dedicate alla sua
terra, con liriche che
vanno così a formare un
concept, il disco si pone
tra canzone d’autore e
chamber folk; viola, violoncello,
harmonium,
mellotron creano atmosfere rarefatte e sospese,
tra ballad, pezzi stratificati che richiamano il Brian
Eno solista dei primi anni ’70, citazioni (l’omaggio
a Ivor Cutler in Squeeze Bees) e in generale una
scrittura personale che ben tiene insieme il tutto,
facendo assomigliare Crowley solo a se stesso ormai. Season Of The Sparks è allora un album
che conferma la crescita di un autore interessante
che merita visibilità.(7.2/10)
Teresa Greco
Ahleuchatistas - Of The Body Prone
(Tzadik, Settembre 2009)
G enere : hardcore beefheartiano
Una foto promozionale li ritrae in un negozio di
dischi tra gli scaffali del settore metal estremo, ma
non fanno metal. I loro concerti sono tesi - da vene
sul collo ingrossate e magliette zuppe di sudore - ma
compostissimi. Il sito della Tzadik li etichetta come
hardcore improvisers. Loro si definiscono avant-technical, post-Beefheart, improv-core, math-metal, art-damage, punk-rock power trio from Asheville, North Carolina.
Ci siamo capiti: una sfibratura rock come la intedeva il Capitano (e quindi come la intende certo post)
applicata ad un hardcore cerebralizzato secondo i
dettami avant/impro dei Massacre di Fred Frith
(ma senza richiami prog). Una demuscolarizzazione
delle intuizioni dei Don Caballero, una demat(h)
ematizzazione di quelle degli Hella (i cuginetti chitarristici dei Lightning Bolt).
Il difetto di questo quinto album del gruppo è lo
stesso che affligge i dischi precedenti (come pure
gran parte delle produzioni del genere), ed è un piccolo paradosso: ripetitività e dispersività. L'effetto
fuffa (soprattutto nei momenti di loungerumorismo
aleatorio) di molta radicalshitness.Tre-quattro pezzi
comunque si impongono sugli altri.(5.7/10)
Gabriele Marino
38
recensioni
Alberorovesciato - Tigers In Acid
In The Hell Of The Brushwood
(Singing Knives, Settembre 2009)
G enere : tribal madnes s
Sono al secondo disco dopo Ancient Shining Drums
of the Covered City su Stunned, ma forse - complice
anche una tiratura che dire limitata è eufemistico
- in pochi se ne sono accorti. Eppure sono italiani, seppur residenti a Berlino, e gironzolano marginalmente per il giro sommerso della Hundebiss
oltre che essere coinvolti nell’ensemble Phonorama con Sinistri, Claudio Rocchetti (a.k.a.
Olyvetty), 3/4HadBeenEliminated e altri.
Il moniker che si sono scelti è già in sé un neanche
tanto velato rimando alle filosofie orientali, cabalistiche e anche classicamente europee. Roba che
marchia a fondo le musiche del duo, perché il legame con il mondo naturale evocato dal progetto è
nulla in confronto allo stridore primitivo del percussionismo tribaloide, estenuante e brutale col quale
Francesco Cavaliere e Marco Lampis annientano chi
ascolta. Tutto rigorosamente acustico, magicamente naturale e ossessivamente ritualistico, Tigers
In Acid… è nichilismo dada al limite dell’autismo,
tour de force percussivo che rasenta il rito voodoo,
sabba psicotico che rifugge tecnologia ed effettistica
digitale per (ri)piegarsi in un contatto materiale con
le fonti sonore più disparate, purché percuotibili. Se
si potesse ipotizzare un gamelan occidentale, beh,
molto probabilmente sarebbe simile a Alberorovesciato.(7.1/10)
Stefano Pifferi
Alec Ounsworth - Mo Beauty (ANTI-,
Ottobre 2009)
G enere : S ongwriter
C’è un produttore d’esperienza dietro al debutto
del Clap Your Hands Say Yeah, Alec Ounswrth. Steve Berlin ha lavorato con un sacco di
gente disparata dai Los Lobos ai mitologici Replacements e il leggendario John Lee Hooker. Poi ci
sono dei bravi musicisti: George Porter, Jr. al basso,
Stanton Moore alla batteria, Robert Walter (tastiere), e Matt Sutton (pedal-steel) più i sessionmen del
luogo, Mark Mullins, Craig Klein, Greg Hicks, Washboard Chaz, Shannon Powell, John Boute, Al "Carnival Time" Johnson e Meschiya Lake; e uno studio, il
Piety St. tra i più famosi di New Orleans consigliato
dallo stesso Berlin e il solo luogo in cui certe magie
possono accadere. Il ragazzo di Philadelphia di suo
per quest’esordio, Mo Beauty, c’ha messo il sale.
Ce n’ha messo tanto e, per cominciare, una penna
inclinata al solito tra folk e wave, ma ben d’altro passo rispetto al gruppo. David Byrne, Bob Dylan,
Tom Verlaine, Tom Waits e uno più vicino a
noi, Darren Hayman (ovvero Hefner e già mito
per il sottoscritto) li troviamo già perfettamente incamerati e assimilati. E le ambientazioni sono incantevoli: dissonanze appena accarezzate nell’operner,
country elettrico a passo di marcia per Me And You
Watson, bandismi neworleansiani dai sapori stax in
una funambolica Idiots in the Rain, latitudini esotiche
nell’honky tonk darreniano South Philadelphia (Drug
Days) e di più, verso metà scaletta strutture che si
fanno più asciutte per una scrittura che ha fame di
dire e raccontare e scopriamo una noir Modern Girl
(...with scissors), la romantica Obscene Queen Bee #2
(chitarra e tastiere quasi Dire Straits) per poi venire
di nuovo travolti dallo studio e dai guest. Soundtrack
quasi da piccola opera condensata per That is not my
Home (after Bruegel) dove a suonare con Alec pare
ci sia un’orchestra intera. Così, arrivati a What Fun e
WhenYou've No Eyes, quest’album non può che strapparti il proverbiale “fatto bene come i classici di un
tempo” e non è uno scherzo. Produzioni, scrittura
e artigianato di questo tipo sono difficili da trovare
sotto lo stesso tetto, soprattutto nei Duemila. E del
resto Mo Beauty non ha bisogno di paragoni, il sapore di un classico ce l’avrebbe comunque.(7.2/10)
Edoardo Bridda
Alela Diane/Alina Hardin - Alela
and Alina – Alela Diane featuring
Alina Hardin (Rough Trade, Ottobre
2009)
G enere : folk
Un paio di originali di Alela, uno di Alina Hardin
(Crying Wolf), una cover di Townes Van Zandt
(Rake) e due traditional folk (Bowling Green e Matt
Groves) per questo EP uscito in vinile e in digitale
realizzato in collaborazione con Alina Hardin,
da un po’ di tempo ai cori con la Diane e qui alla
sua prima uscita ufficiale. Voce e chitarre delle due
folkeuses, tutto in acustico, con la voce della Hardin più sottile ed evanescente rispetto alla profondità della headliner; sei pezzi che richiamano per
atmosfere il disco d’esordio di Alela, The Pirate’s
Gospel (2007) più che l’ultimissimo To Be Still
(2009), per lo scarno folk blues, con il solito retrogusto inquieto. Un’attitudine nude folk che ci piace
sempre.(7/10)
Teresa Greco
Alessandro Grazian - L'abito EP
(Trovarobato, Ottobre 2009)
G enere : cantautorato da camera
L'unico difetto di Alessandro Grazian è sempre stato quello di peccare di auto-indulgenza. Non tanto nelle musiche. Quelle, da Caduto in avanti sono
cresciute esponenzialmente trasformando un cantautorato aristocratico un po' à la Branduardi
- almeno nell'idea generale - nella musica da camera che abbiamo avuto il piacere di ascoltare nell'ultimo Indossai. Quanto nei testi, spesso sorpresi a
contorcersi in un rimpiattino dalle mire fin troppo
alte rispetto alle reali capacità comunicative. L'impressione, insomma, è sempre stata quella che fosse
necessaria un'asciuttezza maggiore, quando non un
centro di gravità semantico che fosse una reale
mediazione tra le esigenze dell'autore e l'autorevolezza di un testo proposto a terzi.
Ci voleva un Ep perché
tutto ciò si realizzasse, il
qui presente L'abito, in cui
si arriva finalmente alla sintesi perfetta tra musica e
parole. Una verità che ne nasconde un'altra: se non
ci si trova sempre davanti ai brani più riusciti della
produzione di Grazian - ma L'abito e Solo lei sono
da applausi -, di sicuro si può godere dei più maturi musicalmente parlando. Tanto che non si scorge
un solo difetto nei cinque episodi in scaletta e ci si
stupisce della complessità raggiunta da una scrittura
coraggiosa e da orchestrazioni - Nicola Manzan
al violino, Giambattista Tornielli al violoncello,
Riccardo Marogna ai fiati, Nereo Fiori alla fisarmonica, Alessandro Arcuri al contrabbasso,
Tommaso Cappellato alla batteria, - raffinatissime. Un incedere elegante che tra le accelerazioni quasi orientaleggianti di Incensatevi e gli archi
suadenti di Sulla via conferma il peso specifico di un
autore elaborato ma (finalmente) non pretenzioso,
sulla via della maturità artistica.(7.4/10)
Fabrizio Zampighi
Amor Fou - Filemone e Bauci
(Autoprodotto, Giugno 2009)
G enere : pop d ' autore
L'aurea mitologica del titolo non segna nostalgie
museali o sterili classicismi ma un'intenzione narrativa nei confronti di una storia d'amore estinta come
tutte le cose sacre del nostro tempo ed evocata per
recensioni
39
via di una tradizione il più possibile condivisa. Gli
Amor Fou post La stagione del cannibale - buon esordio di due anni fa per la compianta
Homesleep - così ripartono dopo la fuoriuscita di
Cesare Malfatti e Luca Saporiti dal gruppo,
andando verso un suono che pianta stabilmente in
Italia le sue tende.
Nelle Metamorfosi di Ovidio Filemone e Bauci invecchiano insieme in una capanna di canne e fango
lasciando che il loro amore renda meno invivibile la
povertà. Sono gli unici ad accogliere Zeus ed Ermes
scesi sulla terra in sembianze umane e il re degli dei
li premierà trasformandoli in una quercia e un tiglio
uniti per il tronco, esaudendo così il loro desiderio
di morire insieme. Queste poche immagini servono
ad Alessandro Raina e compagni per raccontare la
fine di un legame persosi nelle paure e negli errori
di una generazione, quella dei trentenni, impossibilitata e incapace di un oltre che non sia fatto d'eterno
e immutabile presente. Gli Amor Fou lasciano nel
ripostiglio le ascendenze Morr dell'opera prima e si
concentrano su un songwriting che riqualifica con
linguaggio e tonalità attuali ma gusto retrò il ventennio migliore del cantautorato nostrano, ovvero
i sessanta-settanta. Il Lucio Battisti con coda
strumentale in drumming raveliano sempre sul punto di esplodere della splendida title-track (sicuramente una delle canzoni italiane dell'anno); la nudità
erosiva di Piero Ciampi nei cori cangianti della
brevilinea Il ticinese; in ultimo, la rilettura convincente, soprattutto sotto il profilo vocale, de L'ultima
occasione scritta nel 1965 da Jimmy Fontana e
Tony Del Monaco per Mina e rifatta recentemente anche dai Non Voglio Che Clara.
Tre brani per ridisegnare un percorso che sull'onda
dei vari Baustelle e Paolo Benvegnù, e nella
prospettiva di un nuovo disco sulla lunga distanza, si
fa ancora più consapevole e personale. Ne sentiremo delle belle.(6.7/10)
Luca Barachetti
Annie Hall - Carousel
(Pippolamusic, Ottobre 2009)
G enere : folk pop
Due anni dopo il buon Cloud Cuckoo Land
riecco tra noi gli Annie Hall. Fa piacere che siano
cresciuti come e quanto potevamo augurarci. Ascoltando le undici tracce di questo Carousel ti viene
infatti da pensare che abbiano riflettuto bene sugli
argomenti giusti, concentrandosi sui punti di forza,
sulle inclinazioni, sulle declinazioni possibili. Auspi40
recensioni
cabili. Hanno tirato le fila delle esperienze con risoluta tenerezza, così da far quadrare le coordinate
espressive e sentimentali.
Scrittura e interpretazione si sono fatte un bel giro
fuori dalla cameretta guadagnandone in credibilità. Quel che gli senti tremare dentro è un adulto
stare tra le cose, ciò che vale tanto per l'ebbrezza
beat da cuginetti scabri degli Oasis di Paralyzed che
per la preziosa trepidazione Magnetic Fields via
Mojave 3 di Lips. Quella brama pop che tremolava
tra brit e psych, con esiti invero già abbastanza intensi, s'ispessisce oggi di accorto malanimo Wilco
e delicati indolenzimenti Eels (vedi Jelly's Dream),
caracolla tra tepori Elliott Smith (Here Is Love)
concedendosi d'amblé un impeto accorato Lou
Barlow (Letters).
Archi, steel guitars, pianoforte, wurlitzer, glockenspiel, fisarmoniche, contrabbasso, hammond, farfisa,
mandolini, coretti kinksiani: sono i molti ingredienti di un linguaggio che riesce comunque a suonare essenziale. Ne hanno fatta di strada, gli Annie
Hall.(7.2/10)
Stefano Solventi
Appaloosa - Savana (Urtovox,
Ottobre 2009)
G enere : electro math
Un terzo di furia, un terzo di calcolo, un terzo di
goliardia. Poi, siccome le somme in questi casi trascendono l'unità, aggiungete un pizzico di delirio e
un'oncia d'imponderabile. Ecco, più o meno, quel che
sembrano gli Appaloosa atto terzo: una compagine solida e screanzata al servizio di un estro funkwave dalla strana drittezza che diresti dance, con
una febbre acida annidata nei morsi dei due bassi
e delle chitarre e tra le sciroppose aperture spacey. Divertirsi aggrappandosi alla fregola d'un groove non sembra affatto un movente da poco, meglio
se la collusione ritmico-armonica è di quelle che ti
spettinano con serrata baldanza (Genny, Civilizzare)
o ti provocano spasmi spezzettati come math-funk
irriguardosi (i connubi tra Shellac e Parliament
di Bostongigi e Tg).
Il cuore del programma cela poi sorprendenti escursioni che diresti ereditate da attitudini funk-soul
cosmicheggiante Zero 7 (Mons Royal Rumble), per
non dire dei garruli orientalismi in passo marziale come certi spurghi Flaming Lips di Chinatown
Panda e del pulsante sfrigolio techno-industrial della
title track. L'effetto è disturbante, come un viaggio
su un ascensore supersonico che ti porta al piano
highlight
Broadcast/Focus Group (The) - Investigate Witch Cults Of The
Radio Age (Warp Records, Ottobre 2009)
G enere : elettro psych
James Cargill e Trish Keenan avevano bisogno di uno come Julian House, la mente che sta dietro
il progetto The Focus Group (nonchè uno dei luminari che tengono le fila della Ghost Box).
Ne avevano bisogno per tirare fuori i Broadcast da una dimensione stanca fatta di luci e pailette sempre meno accecanti.
Questo mini album, che si fa parecchio vanto della componente sperimentale, cala l'asso della
liturgia psichedelica e acida consegnando alle stampe un patchwork di micro vignette deviate
dall'umore allucinato e allucinante. Salvo qualche caso maggiormente meditato - come il singolo
The Be Colony e la nenia iper psichedelica Make My Sleep His Song - il proposito del trio non è
tanto quello di concepire musica pop, quanto proprio quello di creare
un umore, un'atmosfera, un brivido. Si uniscono così cadenze tipicamente britanniche a venature algide ed eteree a metà tra Stereolab e Pram che hanno fatto la gloria dei Broadcast, un'inquietudine
costante che sa di paganesimo folk modello The Wicker Man,
registrazioni e strumentazioni analogiche, field recordings, farfisa, arpe,
ciondoli, cori di bimbi.
All'inizio si rimane frastornati e storditi da un simile groviglio di idee,
salvo poi lasciarsi prendere dalla malia dell'operazione: certe trovate
inquietanti da psichedelia negativa meritano di entrare nella collezione degli orrori della musica
rock, a due passi dagli incubi più neri di Ummagumma dei Pink Floyd. In altre circostanze,
la mano di Julian House prende oggettivamente il sopravvento portandoci per terreni decisamente Ghost Box a certi misteriosi strumentali sempre ricchi di soluzioni e incanto (library music,
colonne sonore di film perduti di serie B, repertori classici straniati, inserti psichedelici da ogni
latitudine).
Se è il lasciapassare per un nuovo percorso all'insegna della bizzaria più programmatica allora i
Broadcast avranno una vecchiaia delle più eccitanti. Dal canto suo The Focus Group si conferma
uno dei nomi più elettrizzanti dell'attuale scena sperimentale.(7.8/10)
Antonello Comunale
prestabilito attraversando due o tre corti dei miracoli. Partecipano al baccanale tra gli altri Andrea
Appino degli Zen Circus (in Glù) e Giulio "Ragno"
Favero ad incisione e missaggio. (7.2/10)
Stefano Solventi
Armstrong? - Collateral (70
Horses, Ottobre 2009)
G enere : indie dream shoegaze
Li ascoltammo tre anni fa in versione demo e ci lasciarono intravedere qualcosa di buono in una coltre
di cliché post-post rock. Oggi che esordiscono sulla
lunga distanza, possiamo dire che quelle premesse
hanno trovato conferma con l'aggiunta di qualcos'al-
tro. I piemontesi Armstrong? riescono a lanciarsi
oltre l'ostacolo azzardando una sintesi tra istanze
dream-pop, noise-wave e sadcore capace in qualche
modo di riallacciare i contatti ossidati del post-post
alla centralina esausta dello shoegaze. Con tutto ciò
che questo comporta: siano certi spurghi di watt
ereditati da sani ascolti Sonic Youth (vedi la tensione wave sincopata di Aftermath), siano le fregole
caliginose Clientele o una stordente gelatina My
Bloody Valentine, o ancora il riffone contrito
da primi Radiohead sedato dallo struggimento
dei più carezzevoli L'Altra (in What Control).
Tra canto fiabesco, jingle dolciastro, drumming febbrile e spurghi elettrici si consuma quindi una scaletrecensioni
41
ta ben congegnata, un alternarsi di languore e furia,
di foga tagliente e soffici malinconie, quale contorno
di una scrittura abile a ravvivare circostanze altrimenti desuete. Come in quella Shivers che parte da
un cincischio jazz-folk quasi Jim O'Rourke e finisce tra pensose aperture pastello non lontane dai
Mogwai altezza Rock Action. O come quella
Winning You che ipotizza twee pop per post-adolescenti col background che s'allunga fino ai sixties. A
suggellare la scaletta arrivano gli scorci folktronici
introdotti da High Precision Work, come a dire: aspettatevi ulteriori sviluppi. E noi aspettiamo.(6.9/10)
Stefano Solventi
Au - Versions (Aagoo Records,
Ottobre 2009)
G enere : freak - folk
Avevamo apprezzato, a metà di quest’anno, a Verbs, seconda uscita di Au. Ne avevamo colto uno
statuto collettivo (animalesco?) e pensato come di
un ottimo prodotto-summa del decennio.
Nessuna individualità, flussi fatti di sciami. Nell’EP
Versions gli Au sono invece più grandiosi, che collettivi. Emerge un’individualità, quella di Luke Wyland,
voce e polistrumentista della band, che in realtà è
un duo - con Dana Valatka (Jackie 'O Motherfucker, Mustaphamond) alla batteria. E
quando il tenore diventa
individuale,
l’arrangiamento diventa opulento,
da corale. Niente di più
facile per fare il confronto con l’episodio precedente, dato che una
buona metà delle tracce
sono nuove versioni di brani già apparsi su Verbs. Ciò
che emerge di più plateale è la voce di Luke, che
prima si perdeva nei rivoli dei cori, e ora va in primo
piano - comprese le chiare ascendenze Antony &
The Johnsons - anche quando (Are Animals) quelle corde vocali individuali vengono accompagnate
da consimili. Persino nello spirito delle esplosioni
free-form di Death.
La differenza è poi che prima gli arrangiamenti erano sfrangiati da un senso di comunità, ora sono più
netti, anche se corali. Eppure, punto primo, le canzoni (di questo si tratta), nella nuova veste para-cantautoriale, rimangono convincenti. E, punto secondo,
qualcosa rimane, di collettivo, polistrumentistico, a
volte libero, di vastità freak-folk, insomma proprio di
42
recensioni
questi Duemila indie. La domanda prima era: siamo
in presenza di un residuo (per quanto pregevole) di
decennio? Ma ora diventa: siamo in presenza di un
potenziale classico di fine decennio?(7.2/10)
Gaspare Caliri
Be Maledetto Now! - Abisso Del
Passato Pt.1 e 2 (Boring Machines,
Ottobre 2009)
G enere : kosmische sound
Be Maledetto Now! è creatura a due teste, insana unione di spiriti affini al limite dell’incestuoso
come Be Invisibile Now! (a.k.a. Marco Giotto)
e Nihil Is Me/Maledetto (a.k.a. Andrea Giotto).
E come giano bifronte offre due lati di sé sotto forma di due dischi separati: uno, la parte prima, in free
dwld e/o vinile, l’altro, la seconda, in cd.
La materia però è in sostanza unica: drone-ambient
dal sapore materico, umano, terrestre ma insieme
spaziale, cosmica di vaga ascendenza krauta (depurata, però, di ogni ombra di ritmo) e pesantemente
infiltrata di dosi sci-fi, cinematografiche e letterarie.
Come guardare il cosmo oggi attraverso la lente
deformata di un fanta-b-movie dei ’60. Retrofuturismo, in una parola (almeno in apparenza): tributo non esplicito all’anniversario dell’allunaggio, in
cui uomini con mezzi (oggigiorno) datati sfidavano
le oscurità del cosmo in viaggi dal ritorno incerto.
Nello stesso modo i due Giotto si armano di strumentazione desueta - in prevalenza synth ed effettistica analogica - e indagano gli abissi di un passato
che mai come ora, in questa età di mezzo, diviene
attualità. Lunghe, sinuose, (e)statiche cavalcate deumanizzate a rappresentare il sogno più umano tra
tutti: quel desiderare mondi lontani che etimologicamente è de-siderare, togliere lo sguardo dalle
stelle e ricrearle con la propria arte.
Nel suo genere, un disco (anzi due) della madonna!(7.5/10)
Stefano Pifferi
Beak> - Beak> (Invada, Ottobre
2009)
G enere : kraut - cosmic
Ci tengono molto i Beak> (Geoff Barrow, Billy
Fuller, Matt Williams) a far notare quanto poco tempo ci abbiano messo a scrivere e registrare i pezzi
del loro Self Titled. La notizia è affascinante perché
non di cose facili si parla; l’album con cui il trio fa
la comparsa è un incastro complesso di tutto ciò
che questi anni stanno riprendendo dal kraut più
angolare e macchinico (leggi Faust e This Heat),
con qualche inserto di Pink Floyd versione Ummagumma Live (Backwell, con seconda parte
motorik alla Neu!) e in generale la via cosmica anglo-tedesca primi Settanta. Il che, per una band che
viene da Bristol e i cui componenti hanno bazzicato
in ambienti Portishead / Massive Attack, desta curiosità.
L’argomentazione iniziale è tanto forte che il modo
in cui gli interessati descrivono le 12 tracce dell’album è “registrazioni dal 5 al 17 gennaio 2009”. Dodici giorni di session nei Soa Studios bristoliani, presa
diretta, niente overdubs né produzione, al massimo
aggiustamenti a partire da edit già presenti.
Detto e ri-detto questo, non si è spiegato nulla. Una
persona può provare due anni la stessa cosa e poi
entrare in sala di registrazione e dire “ho registrato
in 100 minuti il mio disco da 100 minuti”. L’ascolto
di Beak> diventa allora una caccia alle tracce lasciate nella musica di quanto è emerso nelle sessioni e
di quanto invece fosse praticamente pronto all’uso.
Il solo per synth rumorista di Burrow Gurney è evidentemente un’invenzione ispirata dal momento
genetico della produzione del suono. Al contrario i
frequenti motorik erano presumibilmente già pronti (come le seppur pregevoli variazioni sul tema del
riff paranoide alla Faust di Blagdon Lake).
Ma il motorik, si sa, di fatto nasce come canovaccio e rimane tale, un’idea percussiva, e in questo
sta la sua forza. Le dilatazioni (come in Dundry Hill)
probabilmente no, e va detto che affascinano di più.
Tutto sommato, è nell’equilibrio di forze e inerzie
che si reggono i Beak>; nella relazione tra strutture
più o meno tese. Non importa quanto ci abbiano
messo.(7/10)
Gaspare Caliri
Beatallica - Masterful Mystery
Tour (Oglio, Ottobre 2009)
G enere : M etal P op
Con piglio goliarda Dictators aggiornato nerd, è
la seconda volta che la band di deficienti ci prova
con il cut up a base di Metallica e Beatles (i primi che coverizzano i secondi). Masterful Mystery Tour
è Masters Of Puppets e Magical Mystery Tour assieme,
la chitarra di Hetfield con il basso di Paul incrociati,
ancora (e solo) cover prese a coppie e fuse dentro
un corpo solo, testi e arrangiamenti - non solo da
quei due dischi però - fusi uno dentro l’altro. E con
il titolo dell'album e una cover art (quasi) geniale la
curiosità di sentirlo ti viene.
Inutile resistergli. Non c’è niente di più buffo che
infinocchiare il machismo dei primi Metallica con il
kitsch firmato Fab Four; mandare gli intellettuali che
amarono le cover latine dei Kraftwerk in campagna
ad ascoltare T(h)rash Metal. E infatti, le idee e lo
humor ai Beatallica non mancano, peccato che la
realizzazione (abbondantemente pallosa) e i ringtone (a pagamento sul sito) confermano che il bel
gioco è durato anche troppo. Si salva Fuel On The
Hill (bella quanto il titolo - e finalmente qualcuno
che gli desse fuoco a quella canzone...). E Let It Be
(adesso so da dove vengono tutte quelle ballate hair
metal...)(5.5/10)
Edoardo Bridda
Bibio - The Apple And The Tooth
(Warp Records, Novembre 2009)
G enere : electro folk
Un'eppì tanto per confermare la nuova stella di
casa Warp. Stephen Wilkinson ci sforna 4 tracce (+1 remix pseudoacustico) veloci, senza discostarsi troppo dalla proposta di Ambivalence Avenue:
atmosfere soffuse e cori beachboysiani in Steal The
Lamp (attenzione però alla chiusa che richiama il
drill'n'step di squarepushiana memoria), le chitarrine in glitch'n'loop che fanno tanto Tarwater nella
traccia omonima, il break pulito e white di Rotten
Rudd e per finire l'inevitabile ricordo targato Boards Of Canada, mentori che probabilmente
avrebbe voluto pure come remixatori. Ma non c'è
riuscito.
Nelle altre 8 tracce troviamo infatti il buon vecchio
Clark (bello il bbreaking di S'vive), l'amico Rob Lee
(che di solito bazzica nel giro Friendly Fires) che
a nome Wax Stag rilegge attraverso il vocoder
wonky pop Sugarette con
un vago sapore ereditato
dal culto Computer Love
dei Kraftwerk. C’è poi
Eskmo, un brutto ceffo
dagli slums del dubstep
che riporta gli echi del
primo Burial e qualche
rasoiata acida in Dwrcan.
Per finire il lavoro del produttore Lone che inserisce un po’ di glitch in quel singolone che è (e che
sarà) All The Flowers.
Se lo coccolano così, ci sarà un motivo. In casa Warp
han capito di avere un musicista che vale. L’EP non
aggiunge molto rispetto all’album. Solo per completisti? Se non fosse per quella deriva drill e per il
recensioni
43
remix di se stesso (Palm Of Your Wave vale l’ascolto
e il brivido) direi di sì. Stai a vedere che non si converte alla techno pure il Bibio. Per i pazzi c’è pure
un’edizione limitata a 1000 copie ricoperta da un
folder dorato.(6.5/10)
Marco Braggion
Black Boned Angel - Verdun (Riot
Season, Ottobre 2009)
G enere : D rone
Verdun è il luogo di una battaglia tra le più sanguinose dell'umanità: durata undici mesi, dal Febbraio
1916 ha tolto la vita a quasi un milione di persone,
tra francesi e tedeschi. Che il riferimento storico
abbia qualche significato politico o sia dovuto soltanto alla volontà di intensificare il potere evocativo
dell'album, non è dato sapere. Anche se le origini di
Black Boned Angel - Nuova Zelanda - fanno
propendere per la seconda ipotesi. Musicalmente si
ha a che fare con 50 minuti di autentico drone: lenti
riff cavernosi, chitarre lasciate reagire, percussioni
marziali. Dalle parti di Earth 2, per intenderci. A un
certo punto funerei cori di voci femminili emergono dal magma sonoro e infine, la guerra: campionata
chissà quando e riprodotta per l'occasione. Il disco
procede senza sbavature lungo gli stilemi del genere, e un impeccabile scrittura e cura dei suoni ne valorizza a pieno le possibilità drammatiche. Piacerà a
chi i Sunn 0))) li preferiva senza superproduzioni,
collaborazioni accademiche, riferimenti colti, corni
e apparecchi rotanti.(6.5/10)
Leonardo Amico
Blk Jks - After Robots (Secretly
Canadian, Ottobre 2009)
G enere : afro - rock
Non convince del tutto l’esordio del quartetto sudafricano Blk Jks. La spinta è ovviamente verso un
afrofuturismo rock a 360 gradi mai come ora sulla cresta dell’onda, ma nonostante la tavolozza di
colori usata dal quartetto sia ampia spesso le tinte
che ne risultano sono monocromatiche. Le coordinate sono troppo incentrate su un miscuglio tra i
passaggi più etno-prog di Mars Volta e quelli da
terzomondismo (quello sì, hype) pompato e massimalista di Tv On The Radio, e spingere sull’acceleratore (Taxidermy) non giova più di tanto. C’è
di buono che almeno in questo caso, vista la provenienza, l’attitudine afro non è semplice e paracula
necessità da hype ma reale melting-pot tra tradizione e influenze/ascolti occidentali: gli intarsi etno44
recensioni
vocali dell’opener Molalatladi, le dubbosità da Kingston londinese di Skeleton e la cantilena da mother
africa della conclusiva Tselane su tutte sono ottimi
esempi della musica globalizzata dei quattro. È però
oggettivamente poco per consolarsi dopo le ottime
premesse/promesse dell’ep Mystery.(6/10)
Stefano Pifferi
Blues Control - Local Flavor
(Siltbreeze Records, Ottobre 2009)
G enere : kraut - york
Sono meno oscuri, meno putrescenti, i Blues Control. Local Flavor è lì per dirci quanto improvvisata
forse è stata l’etichetta shit-gaze a loro affibbiata. Già
il self-titled ci aveva parlato delle passioni del duo,
che fanno - con tutta probabilità e semplicemente
- i newyorkesi che fagocitano il passato e lo re-immettono nel presente. Adesso, tolti anche gli spigoli
più noise, che operavano da evidenti distanziatori, le
quattro tracce del terzo album trasudano quasi senza intermediari di quei mondi andati; quasi, perché la
lente applicata dai due conserva una presenza che
non è poi così difficile rilevare. In Good Morning, cavalcata psichedelica su riff hard-kraut-blues con tanto
di citazione ai 13th Floor Elevators, le chitarre
primi anni Settanta sono coperte da una patina di
sporco che sgrana l’effetto di insieme. Rest On Water
parla con le atmosfere dei Popol Vuh, ma senza
la colossale mistica tedesca. Tangier si prende sotto
braccio i primissimi Kraftwerk (pre Autobahn) miscelati alla solita pratica del motorik, e fa da anticamera alla suite dove tutto viene messo a frutto, la
finale On Through The Night, sogno cosmic-REM alla
Tangerine Dream (con gli occhi che si muovono
lentamente) su cui viene innestata una drum-machine d’accatto (al posto di Schulze, niente male come
scarto fonico). Vedendoli dal vivo ci si rende conto
che nel compost del krautrock ciò che più è messo in
presenza e parla dello specifico Blues Control sono
l’uso propriamente Duemila della seicorde distorta
e il costante reminder cheap dell’elettronica. Vale a
dire, una summa degli ultimi due album della band, se
applichiamo l’economia dei mezzi del secondo elemento alla produzione di Local Flavor. Aspettiamo la
sintesi, dopo tesi e antitesi.(7.1/10)
Gaspare Caliri
Bobo Rondelli - Per amor del cielo
(Live Global, Maggio 2009)
G enere : C antautore
Mentre nel documentario a lui dedicato dal conter-
highlight
Comaneci - You A Lie (Madcap Collective, Ottobre 2009)
G enere : folk
“Comaneci” è un marchio di registrato, più che una band. Anche perché attualmente la band non
esiste più, eccezion fatta per una Francesca Amati sempre più Cat Power e sempre meno
pop con la sua chitarra classica a tracolla. Un brand che significa semplicità, home made, nude lentezze acustiche, house concerts, tour nei luoghi più improbabili, spesso
col minimo indispensabile e magari per il puro gusto di suonare. Una
scelta volontaria e al tempo stesso imposta. L'artista che si confonde
col pubblico e il pubblico che diventa un cosa sola con l'artista - come
accadeva col folk dei Sessanta - in un rito che è esperienza collettiva
prima di essere spettacolo. Tanto che la parola “indie” sembra quasi
di una taglia più grande. Tanto che ci si scopre quasi iniziatori di una
corrente minimalista che fa pure proselitismo (Le-Li).
Appurata la valenza sociale del brand, ci spingiamo oltre e vi diciamo
che paradossalmente dal cambio di line-up il suono trae giovamento. Guadagna in intensità e agilità, prescindendo da quell'approccio cameristico che aveva tenuto in ostaggio Volcano - elegante
ma ampiamente contestualizzato - e scendendo a patti con la semplicità alla base del progetto.
Voce e chitarra, insomma, con un Glauco Salvo - a tutti gli effetti parte integrante del gruppo alle decorazioni (elettriche) e Bruno Dorella, Mattia Coletti, Bob Corn e Pete Cohen
dei Sodastream a dare una mano a rassettare.
Tra pianoforti rinsecchiti e timidi banjo, violoncelli sparuti e arpeggi acustici nascono alcuni tra i
migliori episodi della storia del gruppo. Inquietudini rurali già presenti nell'Ep Girl Was Sent
To Grandma's In 1914 pubblicato questa estate (Like, Promised, Satisfied Girld, On My Path, Not)
o brani del tutto inediti (Green e Good Company). Col classicismo english degli esordi che lascia
il posto a un'America (dentro) desolata, a un blues imperfetto in combutta con la psichedelia, a
una malinconia invernale che diventa tratto distintivo della formazione ravennate. Unico rimedio
contro la solita provincia fatta di solitudine a cui un po' tutti apparteniamo.(7.5/10)
Fabrizio Zampighi
raneo Virzì si celebra la sua figura esaltandone la teatralità beffarda e lo spirito caustico, nel nuovo disco
troviamo invece Bobo in vesti cantautorali sommesse e malinconiche, tra certo Gaber e morbidezze
stordite Nick Drake nelle quali l'ironia è limitata
a pochi tratti (il punto di vista de La marmellata e
dell'intenso omaggio a Livorno di Madame Sitri, e la
chiusa della conclusiva Niente più di questo è l'amore)
e l'ispirazione volge al lato meno teso delle muse di
Tenco e dell'altro conterraneo Ciampi.
Curioso ma non più di tanto: si tratta infatti di un
equivoco alimentato dal modo in cui il Nostro si
presenta dal vivo e da una discografia da sempre
poco rispettosa delle date di composizione delle
singole canzoni, al punto di nascondere il fatto che
in quelle effettivamente scritte negli scorsi 15 anni
circa (a parte l'ultimo Ottavo Padiglione Ultimafollia,
2003) aveva prevalso il lato amaro e rabbioso su
quello comico, tra l'altro non senza qualche eccesso
di seriosità e qualche caduta di tono.
Per amor del cielo invece, presentando nove pezzi
recenti senza cover, ripescaggi o altro, per una volta
rappresenta lo stato dell'arte dell'autore il quale, abbandonata la rabbia e aiutato dalla produzione delicata da Filippo Gatti degli Elettrojoyce, si trova
a suo agio a cantare con un'aria sospesa da domenica pomeriggio ma col sole, guardando ai ricordi o
all'oggi con partecipazione ma da un passo indietro.
Nel disco convivono la vivacità degli arpeggi di chitarra e piano o del sax di Dimitri Espinosa con
l'atmosfera generale quasi dimessa, in un flusso nel
quale entra alla perfezione anche l'innocenza sorrecensioni
45
presa de Il cielo è di tutti di Rodari, unico testo non
originale del disco.
Non si tratta del Bobo della leggenda, perciò, ma
l'asse in realtà si è spostato di poco; un autore che
dopo qualche anno di silenzio discografico ritroviamo in piena salute.(7.2/10)
Giulio Pasquali
Brothers movement (The) - self
titled (Rocket Girl, Ottobre 2009)
G enere : retro brit - pop
Pur essendo una formazione di recente nascita, i
dublinesi Brothers Movement hanno fatto in fretta
a mettersi in mostra e aprire i concerti dei pezzi
da novanta Chemical
Brothers e Sonic
Youth. Curioso assai,
specialmente in ragione
del fatto che con entrambi c’azzeccano nulla
e preferiscono battere i
territori del classico pop
britannico. Nulla di male,
non fosse che - come in qualsiasi altro ambito - bisogna sapersi scegliere i numi tutelari con accortezza. Se l’immagine di copertina e il libretto possono
richiamare l’approccio smaliziato verso gli anni ’60
dei Coral, l’ascolto consegna viceversa un incrocio
enfatico e pompato (quella produzione meticolosa
che cerca di ingraziarsi il pubblico major con l’approccio “indie”) tra Oasis e Verve.
Meglio se punteggiato da sbiadite contraffazioni
Spiritualized, camuffato prelevando dai primi
Settanta organo e pianoforte imponenti e un pizzico di baldanza Faces; oppure tirato per i capelli,
con un salto nel decennio successivo, a inseguire
l’epica dei James e lo scintillio degli Stone Roses. Senza, alla fin fine, cogliere un bersaglio che sia
uno e nemmeno segnalandosi come comunicatore
sociale e/o di costume. Roba da incasellare nella categoria “dimenticati presto e bene” per far sentire
meno soli i Kasabian. La stessa casella in cui, anni
fa, infilavamo analoga e scarsamente qualificata manovalanza come Cast, Bluetones, Hurricane
#1.(5/10)
Giancarlo Turra
Built To Spill - There Is No Enemy
(Warner Music Group, Ottobre
2009)
G enere : rock
46
recensioni
Si ostinano a non deludere, i Built To Spill. Una turbina indomita lanciata a bomba su una strada che credevamo senza uscita, e forse lo è. Da quei nineties di
mezzo che li videro nascere e scorazzare, il mondo
è cambiato parecchio. La generazione a cavallo tra
X e Y cui prestarono suoni e voce (non certo da
soli), si è spostata, non abita più qui. Lo scetticismo
aspro condito a straniamento, escapismo e un pizzico di sacro furore ha lasciato il posto ad uno strano
impasto di angoscia ed eccitazione, un'effervescenza
di cui nel tempo valuteremo esiti e sostanza.
Fatto sta che non si capisce bene a chi si rivolga il
Doug Martsch appassionato, volitivo, contrito, onirico e feroce che impazza tra queste nuove undici
tracce. è un po' quel che accade ascoltando il nuovo
disco dei redivivi Phish, fatte le debite proporzioni. Eppure, in questo caso e come spesso capita, la
convinzione si basta da sé (col non piccolo aiuto - of
course - del ben noto talento). Sentire con quanta
fiera risolutezza incalzino gli assolo, con quale cuore le melodie si accartoccino, quanto sciroccato
struggimento pervada quel ciondolare dolciastro e
indolenzito, che razza di impeto ribolla nei pugnaci
intrecci di basso e batteria, è di per sé uno spettacolo.
Una mischia in cui fanno buon gioco vampe di tromba, trepidi bordoni d'organo e un violoncello a pettinare il malanimo. I Wilco via Grandaddy di
Hindsight, una Oh Yeah nel guado tra torvo tremolio
Crazy Horse e solenne rapimento Smashing
Pumpkins, il tumulto Hüsker Dü di Pat (che
annichilisce d'amblé gli ultimi Pearl Jam) e l'assorta gravità quasi Black Sabbath (!!!) di Things
Fall Apart sono gli episodi migliori di un programma
di tutto rispetto. Che forse non ha molti appigli nel
presente, ma sa abitarlo con entusiasmo ammirevole. (7/10)
Stefano Solventi
Camillas - Le Politiche Del Prato
(Wallace Records, Ottobre 2009)
G enere : pop
Ruben e Zagor Camillas sono due fratelli (ma anche
no) finto-deficienti che vanno di surreale e grottesco a go-go, se ne sbattono di stili e cliché perché
loro “sono” lo stile e i cliché li rielaborano rivoltandoli dal di dentro. Roba che non si deve essere proprio a posto con la zucca (svuotata in pieno
clima halloween) per pensare soltanto a musiche
del genere, fatte di calembour sonori e lirici a incastro simil-cubo di Rubik, metà teatro dell’assurdo
e metà cabaret degli anni andati, ipotetica colonna
sonora per ludoteche composta da bambini troppo
cresciuti in altezza e larghezza, di pop fuori asse e
demente di una demenza che sfiora il geniale, tanto
è semplice e insieme candido come zucchero filato
alla fiera del paese.
Le Politiche Del Prato è un comeback in coproduzione (da Wallace a Tafuzzy…) e apparentemente
vive di genialità a basso costo: qualche tastierina,
qualche percussione, una chitarrina, moltissimi intrecci vocali e una capacità compositivo-creativa
(auto)ironica e grottesca
da spavento. Ma altro
che povertà; qui si moltiplicano pani e pesci e
si va di pop a 361 gradi,
tanto che ci sarebbe da
scrivere un saggio di sociologia della musica per intendere un minimo (ma
proprio poco, perché quando pensi di aver capito
loro sono già altrove) dell’universo buffonesco dei
Camillas, tanta è la roba da dire sul cantautorato
“all’italiana” e il folk agreste sui generis, sul cabaret
autistico-esistenziale e l’elettronica da fritto misto,
sul Bugo centrifugato a forza di cartoni animati
tra 70 e 80 e il Cochi e Renato meets Devo del
2.0. O, per finirla, per comprendere l’immaginario
pop deforme, allegro fuori e triste dentro, di un duo
che merita incondizionatamente tutto il rispetto del
mondo. Ché alla fine scrivono pure delle signore
canzoni.(7.5/10)
Stefano Pifferi
Chaos Physique - The Science
Of Chaotic Solutions (Jestrai
Records, Ottobre 2009)
G enere : kraut - psych - noise
Dici Amaury Cambuzat e pensi Ulan Bator
e Faust. Ovvero post-rock liquido, kraut destrutturato e sperimentazioni sulla stratificazione dei
suoni. Più che un'opinione, una questione di assiomi e di teoremi dimostrati, per chi ci sta dentro.
Tanto che nell'ennesima trasfigurazione sonora del
musicista francese - questa volta sono della partita
Diego Geko e Pier Mecca - si arriva a parlare
apertamente di “scienza”.
“Fisica del caos”, per essere precisi, che in termini
più prosaici e meno ad effetto significa unire alle solite dilatazioni oniriche - riprendetevi anche l'ultimo
Marigold Tajga (Acid Cobra, 2009) a cui Cambu-
zat ha prestato chitarre e produzione, se volete farvi
un'idea dello stile - una quadratura cosmica Neu!
(Spaghetti Frogs) e una psichedelia fatta di landscapes
elettrici (Jeaux De Promesses). Materiale che trasforma il post-rock di base del Cambuzat-pensiero nei
tredici minuti in riverbero di Socraterock, nel noise
intorpidito di Arum Titan, nel crescendo indistinto
Carla Bozulich via For Carnation di Cul De
Sac.Tra chitarre, voci sommerse e una cassa in quattro quarti statica ma inarrestabile.
Più che di caos, insomma, si parla di un fluire ricercato in cui si innestano particolari sonori capaci di
razionalizzare la natura dispersiva dei suoni in un'inquietudine che sa di mesmerico e universale. Lontana, tuttavia, dal perdersi o dal suonare autoreferenziale, nonostante - o forse proprio per quello - i soli
cinque giorni impiegati dai musicisti per registrare
le otto tracce di questo The Science Of Chaotic Solutions.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
Chll Pll - Aggressively Humble
(Porter, Ottobre 2009)
G enere : experimental pop
La rivincita degli Zach, verrebbe da dire. Ce lo aveva accennato nel corso dell’intervista di qualche
tempo fa, Zac Nelson aka Hexlove che avrebbe
pubblicato a breve un nuovo disco con un nuovo
progetto, ma non pensavamo che fosse di tale levatura. Innanzitutto, Chll Pll è basicamente un duo
condiviso con un altro Zach, che di cognome fa Hill
e che, tra le mille altre cose, percuote(va) tamburi
con i funambolici Hella. Se aggiungete che in un
paio di tracce è ospite un terzo Zach - in realtà si
presenta come Zachariah Dellorto Blackwell (Danava) - capirete il senso della frase d’attacco.
Aggressively Humble è un 10 tracce come immaginabile frastagliato e dirompente, ovviamente ricco
dal punto di vista ritmico, potente sotto quello della
stratificazione ma pur sempre agile e scattante tra
le mille curve a gomito che i due disseminano senza
soste. Immaginate il portato-base delle band madre dei due - il massimalismo experimental-pop di
Hexlove e l’irruenza scattosa degli Hella - fuso insieme ad una idea balearica di elettronica e ad un gusto
surreale per la composizione. Ne escono frammenti
e schizofreniche citazioni che si accavallano le une
sulle altre in estatica fusione, frullando Mercury
Rev dei primordi e procedere Zappiano, coralità
Broken Social Scene e tropical-punk d’accatto,
teatralità farsesca e Arcade Fire ubriachi e derecensioni
47
highlight
Dixon - Temporary Secretary (Innervisions, Ottobre 2009)
G enere : compil ation minimal tribal deep
Steffen Berkhahn si è fatto le ossa nel circuito house con svariate compilation tra cui l’acclamata Body Language Vol. 4 su Get Physical. Nel suo curriculum vanta poi una collaborazione
duratura con Âme e Henrik Schwarz. Oggi torna a fare il suo mestiere di artigiano con
l’esperienza tecnica di un patron (è lui una delle menti in casa Innervisions) e il giusto savoir faire
che si confà a un berlinese.
Il titolo della compilation è una citazione a un pezzo dell’80 di Paul McCartney: la traccia
era una specie di sperimentazione dove l’ex-Beatle mescolava sintetizzatori, pezzi di chitarre
acustiche e testi deliranti. Anche qui si crea quindi qualcosa di nuovo
da pezzi di amici e colleghi, tagliando, cucendo e rimescolando a più
non posso. Dato che il nostro ha nel suo archivio tutti i nastri originali, quello che ne esce è uno dei mix più originali di questa fine 2009.
Sembra quasi che siano tracce nuove, coerenti in un tutt’uno che solo
i grandi riescono a sostenere dall’inizio alla fine.
I nomi sono comunque dei pezzi grossi: Danny Tenaglia sotto il
moniker Code 718 nella deeppissima Equinox remixata dall’amico
Schwarz, The Machine con un gregoriano misto tribale da pelle
d’oca (Fuse), il retrò color sepia dei Tokyo Black Star, la precisione della maga Kiki (Good
Voodoo), il touch balearico nell’incipit di Icasol (Ongou), il romanticismo degli Junior Boys nella
rivisitazione di Ewan Pearson (Hazel) e la bossa al cardiopalma di Peter Kruder in salita
(Law Of Return).
Sarà anche una compilation, ma sfido a trovarne una così compatta e stilosa. Siamo in odore di
alta classe deep: il livello ricorda Carl Craig, Ricardo Villalobos e gli Apparat. Ottimo
lavoro Dixon.(7.5/10)
Marco Braggion
Criminal Jokers (The) - This Was
Supposed To Be The Future (Ice for
everyone Records, Novembre 2009)
G enere : F olk - punk wave
C'è un altro trio pisano amante dei Violent Femmes in giro: si tratta dei poco più che 20enni Criminal Jokers, già messisi in luce come spalla degli
amici e concittadini Zen Circus e ora all'esordio
con Appino dietro la consolle insieme a Manuele
Fusari, bravi nel rendere l'energia live del trio.
Il disco testimonia l'amore per Gano e soci (Burning
e Song For Lovers potrebbero mimetizzarsi onorevolmente nel canzoniere del trio di Milwaukee) ma
anche le capacità del gruppo di emanciparsi, grazie
a una scrittura abbastanza disinvolta da maneggiare
tranquillamente altri spunti: i tempi di 4/4 con i riff
in 3 di harveyana memoria nell'apertura massiccia
della title track (sorta di I'm Waiting For The Man con
la cassa doppia e bassi con profondità quasi grunge); gli anni '50 visti dai Television in birreria di
Killer, i cori Devo di This Song Is Dead, i Clash di
Sightseeing, la psichedelia di Deep Rider che morbida
nasconde un altro beat raddoppiato (retaggio dei
live nei quali il batterista-cantante si presenta con
un rullante e basta).
Ne risulta una scaletta nella quale i riferimenti wave
mantengono le distanze dalla maniera di tanti contemporanei, arricchendo un rock classico suonato
con la scioltezza dei Grant Lee Buffalo, senza
starci troppo a pensare.(7/10)
Giulio Pasquali
menti, ecc. ecc. ecc. Insomma, se siete alla ricerca di
un pop sperimentale mai banale e variopinto, drogato il giusto e visionario quanto basta Chll Pll è il
nome che fa per voi. Massimo rispetto.(7/10)
Stefano Pifferi
Cinematics (The) - Love and Terror
(The Orchard, Ottobre 2009)
G enere : W ave
Scuro e dandy come gli Interpol ma senza disdegnare le tastiere degli ultimi Editors e un'enfasi
tutta Arcade Fire, il quartetto si presenta al secondo appuntamento discografico con una buona
verve superando così l'effetto derivazione dell'arrangiamento. I ragazzi originari di Dingwall, Scozia, e
ora residenti a Glasgow, hanno dalla loro un guitar
sound solido e altrettanto gusto per le citazioni: ne
è un esempio l'umbratile road song che è anche il
singolo apripista, l'omonima Love and Terror: pennate
48
recensioni
The Edge altezza October e bell'intreccio sul finale di
Scott Rinning (anche cantante) e Larry Reid (il main
guitarist).Anche le liriche si difendono e proteggono
benone il nucleo wave rock delle loro composizioni:
in Wish (When the Banks Collapse), la band gioca garbatamente un serpente a due teste, Echo & Bunnymen (nella prosopopea) e Smiths (nei falsetti),
in She Talks to the Trees e Moving To Berlin a colpire
invece è la scioltezza melodica, come dei Rakes al
massimo della forma. Disco riuscito Love and Terror
ma non tempista. Arrivato sulla coda di un revival
wave che ha lasciato perplessi molti, avrebbe potuto
fargli fare un ulteriore guizzo, ma è semplicemente
un lavoro di genere quando per questo "mondo"
ci vorrebbe quel qualcosa di generazionale. E come
potrebbe essere diversamente con northern story
come quelle di Joy Division, Bunnymen e Teardrop Explodes?(6.5/10)
Edoardo Bridda
Damien* - Crippled Cute (Suiteside
Drive, Ottobre 2009)
G enere : post punk _ wave
è irruenza giovanile che si cristallizza, quella che leggiamo nella seconda prova dei Damien*. Un imborghesimento portato a termine senza grosse crisi di
identità, rubacchiando qualche sussulto agli Strokes (Softcore e Confidants) e contando sulle stesse
chitarre sotto speed (On Ice) già utilizzate in passato.
Viene da pensare che da un lato si vivacchi un po'
troppo di rendita sulle buone capacità di scrittura
messe in mostra ai tempi dell'esordio Mart/Art (Suitside, 2008) e dall'altro si corra il rischio di essere
assorbiti dal mare magnum delle produzioni sul genere che quotidianamente intasa un mercato discografico saturo come il nostro. Un universo parallelo,
quest'ultimo, in cui guardarsi allo specchio per un
momento può significare perdere il bandolo della
matassa.
La band pesarese dimostra ancora una volta di saperci fare quando si tratta di collezionare saltelli vigorosi e battere da dancefloor su melodie uncinanti
ma dimentica che a maneggiare certo post-punk/
wave ci si può anche scottare. Che ritrovarsi avvinghiato a una “maniera” un po' soporifera nonostante buone capacità espressive non è cosa difficile,
soprattutto in un genere in cui a uno sgambettare
adolescenziale non corrisponde, sempre, una florida creatività. Si coglie un passo in avanti rispetto al
primo disco, in primis nella cura dei dettagli tecnici
- suoni e arrangiamenti -, ma è un alzare la voce in
un dialogo di cui si conoscono quasi tutte le battute
a memoria.(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Daniel Johnston - Is And Always
Was (Feraltone, Ottobre 2009)
G enere : low - fi songwriting
Fin troppo facile trovare per questo nuovo album di
Daniel Johnston un referente diretto in Fear Yourself.
Nel senso che come colà, si affida una cifra stilistica efficacemente sbilenca e unica nel suo genere a
un produttore. A un elemento esterno convocato a
colorare la scrittura e le visioni dell’Uomo e nello
specifico si tratta di Jason Falkner, già dietro il
banco con Beck, Air e Paul McCartney. Una
notizia da indurre il sospetto che si voglia snaturare
Johnston per - viene da ridere al solo pensiero! renderlo accettabile a un più ampio pubblico. Tranquilli: nulla di tutto ciò qui, nel senso che (come accadeva col competente discepolo Mark Linkous
e, ancora prima, nell'album Fun cui presiedeva Paul
Leary dei Butthole Surfers) la splendida calligrafia del Nostro emerge anche lavorando in eccesso o difetto sulla “fedeltà” sonora.
Falkner espande come da curriculum tutto in technicolor, tuttavia scava da archeologo per portare
alla luce l’anima popedelica del texano. Quel che
fa di Daniel un Genio è - oltre all’umanità profonda e alla penna sublime - la capacità miracolosa di
vivere al contempo dentro e fuori da sé e dalla sua
musica. L’affascinare proprio in virtù di una perenne
oscillazione che qui non va perduta. La questione
è semmai che dopo un’ottima partenza il disco un
po’ finisce per afflosciarsi compositivamente. Mind
Movies è un traslucido capolavoro barrettiano e
Fake Records Of Rock And Roll un boogie apparentemente scolastico, viceversa pugnalata al vetriolo che
consegna Neil Young al glam; Queenie The Doggie
scorre da tenerissima filastrocca bubblegum countrecensioni
49
ry e High Horse come sontuoso pop anni ’70. Un
poker da maestro, insomma, con l’unico difetto di
oscurare la vacua cavalcata Without You e la malinconia all’ingrosso di Tears, di far apparire le brevi I Had
Lost My Mind (i Grandaddy dei bei tempi) e Freedom (come sopra: aggiungete un’oncia di Frank
Black) meno pregiate di quanto siano. Quando poi
la title-track e Lost In My Infinite Memory chiamano
a testimoniare rispettivamente gli ultimi Guided
By Voices e il collettivo Elephant 6, il giudizio
si blocca a mezz’aria e le carte sparse sulla tavola
si confondono vieppiù. Ciò nonostante, i Flaming
Lips maturi però minimalisti - se vi pare, gli Air
sul serio floydiani - dipinti dalla conclusiva Light Of
Day persuadono che, come recita il titolo, Johnston
“è e sempre fu”. Un songwriter immenso, vale a dire,
che rende migliore questo scriteriato mondo. A
prescindere da chi siede al di là del vetro, ovviamente.(7.4/10)
Giancarlo Turra
Dead Man's Bones - Dead Man's
Bones (ANTI-, Novembre 2009)
G enere : ghost - rock
Più che un album sui fantasmi, questo dei Dead
Man's Bones è un album sull'ossessione al tema dei
fantasmi. Zach Shields e Ryan Gosling si incontrano
nel 2005 e che passione scoprono mai in comune?
Donne, motori, gioie, dolori? No, niente affatto. Gli
ectoplasmi! Questo affascina i futuri membri e fondatori del gruppo. Teniamo presente che Gosling
(che proviene dal Canada) ha alle spalle una carriera da attore non da poco e che, invece, fra le sue
influenze musicali cita tanto i Beatles e i Beach
Boys quanto Shags, Shangri-Las, Misfits, Joy
Division e Daniel Johnston.
Ciò detto partiamo con
Dead Hearts, sonnambula e ectoplasmatica che
farebbe invidia a certi
Black Heart Procession. E proseguiamo
col rock'n'roll alla Screaming Lord Sutch
(ma più serioso) di In The
Room Where You Sleep.
Produce Tim Anderson degli I’m A Robot. Canta
il coro dei bambini del Silverlake Conservatory (la
ballata macabra Buried In Water). E questo è quanto.(7/10)
Massimo Padalino
50
recensioni
Del tha Funkee Homosapien/Tame
One - Parallel Uni-Verses (Gold
Dust, Ottobre 2009)
G enere : HIP HOP
Due rapper, underground di quello marcio, di quelli
che li vedi e pensi subito che sono due "mangiati". Per dire, Tame ha dedicato tutto un disco alla
polvere d'angelo. Drogatissimi e talentuosi, sempre
coinvolti in progetti di culto. Del, cugino di Ice
Cube, un primo disco solista freakissimo (e ottimo), a capo poi degli Hyerogliphics (collettivo di
Oakland vicino al classicismo Native Tongues, altro
che Anticon), scrive i testi per l'all star project Deltron 3030 (prodotto da Dan The Automator),
e lì conosce Damon Albarn, che lo vuole a rappare
sulla Clint Eastwood dei suoi Gorillaz. Tame, prima il duo Artifacts, il supergruppone Weathermen
(Aesop Rock, El-P e altri), poi l'avvio da solista
e il duo assieme a Cage a nome Leak Bros (e con
questa sigla licenzia il dopatissimo disco di cui sopra,
ottimo e con pruriti sperimentali).
Su questo Parallel Uni-Verses, pochissimo da dire. è
un discone hip hop classico, attaccato alle sue radici funk. Lo dice Del, in Flashback, e c'è poco da
aggiungere: Rap is the funk, our music is the funk. Le
evoluzioni di Del e di Tame, ma senza eccessi di tecnica, servite alla perfezione dal funk-lounge del duo
Parallel Thought e dagli scratch di Zac Hendrix. Punto. Ha fatto bene la Gold Dust a non inseguire qui le mode, ma a dare voce a due outsider
di classe. Quando il classicismo non è maniera, né
retroguardia, ma solo stile. Come dicono i bboyz,
Dope!(7.3/10)
Gabriele Marino
Devendra Banhart - Baby EP
(Warner Music Group, Ottobre
2009)
G enere : soul rock
Non c'è da stupirsi che l'uscita del nuovo lavoro di
Devendra rappresenti un evento nel panorama sclerotico del rock "alternativo". E che quindi il relativo
antipasto susciti curiosità, effervescenza, eccitazione. Baby EP è un singolo che propone tre tasselli
dei quattordici (pare) che comporranno la scaletta
dell'imminente What Will We Be, primo titolo
per la Warner dopo il commiato dalla XL. Album
che, con queste premesse, dovrebbe riservare non
poche sorprese.
Esaurito il "naturalismo" da naftalina e vecchi (ectoplasmatici) merletti, sbrigliata la vena bossa, sfogata
la truce goliardia, il buon Banhart finalmente si concede: una digressione soul-pop sorniona e vagamente esotica (Baby); un post-glam tra marciapiede e
dancefloor (16th & Valencia Roxy Music); un countryerrebì meno oppiaceo che sciropposo (Goin Back).
Su una ideale cartina geografica potremmo stringere le coordinate tra Badfinger, M.Ward, Marc
Bolan e... Mika, una mischia mantecata con tutto
il senso di pantomima che è lecito supporre.
L'impressione è di un artista nel guado, e non è chiaro quanto ci si trovi bene. Ovvero, questi tre pezzi
non bastano a farci capire se Devendra sia più sbrigliato o incerto, se vivacchi oppure se la crisi gli faccia un baffo e se la stia passando alla grande. Attendiamo gli sviluppi. Abbastanza fiduciosi.(6.3/10)
Stefano Solventi
Devendra Banhart - What Will We
Be (Warner Music Group, Novembre
2009)
G enere : psych soul bos sa
Le 14 tracce del nuovo What Will We Be chiariscono finalmente portata e direzione della "svolta"
preannunciata dal singolo Baby. Ebbene, il Devendra griffato Warner si presenta con un album che
sembra lo spettacolo d'arte varia di uno cui sono rimaste più fissazioni che ispirazione. C'è da dire che
le fissazioni sono di quelle che intrigano, anche se
il modo in cui si accavallano e impastano non sempre convince: talora ti sconcerta, talaltra disturba,
altrove ti ammalia. Detto della vena latin soul e dello spasmo glam nelle tracce anticipate dal suddetto
singolo, aggiungiamo che le recenti sbandate garagepsych sembrano come metabolizzate in una vena
folk madreperlacea che sì riconduce all'originale
"naturalismo", però fermandosi da qualche parte tra
il Neil Young più oppiaceo (vedi le due Song For B)
ed il Caetano Veloso londinese (Brindo, Angelika),
per poi ciondolare da qualche parte tra Canterbury
e Macondo (nella ineffabile Maria Leonza).
Ama stupirci restando seduto nella sua cameretta assieme agli amici neo-hippy, il caro Banhart. Fa
l'estroso e si diletta a stemperare languori jazz
Chet Baker nell'avanspettacolo latino di Chin Chin
& Muck Muck. E cosa dire dei Black Sabbath speziati Ultimate Spinach di Rats? In definitiva, è un
disco ricco di espedienti e qualche buona idea, ma
in mezzo a tutto questo non riesce a farsi battere
un cuore. E, di conseguenza, fallisce l'appuntamento
con la magia. (6.1/10)
Stefano Solventi
Diana Torto/John Taylor/Anders
Jormin - Triangoli (Egea, Ottobre
2009)
G enere : jazz
Metti una straordinaria vocalist italiana tanto apprezzata nel giro del jazz quanto misconosciuta al
grande pubblico, un pianista di Manchester che se la
gioca per il titolo dei più sensibili e arguti interpreti degli ottantotto tasti contemporanei, e un contrabbassista svedese dalla diteggiatura "senziente":
ne viene fuori un triangolo meravigliosamente imperfetto, dai vertici smussati, aperti, generosamente
disposti ad accogliere e dare.
Lei è Diana Torto, voce flautata e intensa come una
cantante di fado con tentazioni liriche e blues, da
oltre dieci anni sulle scene e già al lavoro con calibri quali Steve Coleman, Mike Stern, Enrico Rava e Kenny Wheeler, per citarne solo
alcuni. Il pianista è quel John Taylor che da un quarantennio mette a segno
lavori sempre più egregi
e raffinati, prima nel trio
Azimuth (con Kenny
Wheeler e Norma
Winstone) e poi con
Jan Garbarek, Lee
Konitz e Gil Evans
tra gli altri. Infine c'è Anders Jormin, classe '57 da Göteborg e una marea di
dischi sia come leader che a nome Don Cherry,
Elvin Jones o Rita Marcotulli.
Al di là dei rispettivi pedigree, questo Triangoli è
il frutto di un'intesa straordinaria che salda la combinazione di calligrafie così peculiari e così affini: languori latini, romanze pensose, trame distese e geometrie dinamiche, swing che covano e d'improvviso
prendono la mano: nove originali più la rilettura di
Summer Night e una Deseo scritta da Stefania Tallini
(altro nome da tenere d'occhio) con liriche di Garcia Lorca.(7.3/10)
Stefano Solventi
Diverting Duo - Lover/Lover (Zahr,
Ottobre 2009)
G enere : pop minimale
Dalla scuola svedese - Labrador e dintorni - riprendono l'elettronica epiteliale e certe melodie allo
zucchero filato; dai Galaxie 500 la psichedelia vaporosa; dall'indie-pop nostrano la capacità di creare
suggestioni che operano sulla sottrazione e sull'ordine formale. Insomma, poche idee ma chiare, il
recensioni
51
suono prima di tutto e un'emotività screziata che si
sostituisce alla compattezza del messaggio. Materiale che nella sua semplicità rapisce e gratifica fin dal
primo ascolto, ma che pare indirizzato soprattutto
agli indie lovers più embedded. I segnali, in questo senso, ci sono tutti e vanno da una formazione minimale - Gianmarco e Sara armati di organo, chitarra,
violoncello, elettronica - alle tessiture onirico/medidativo/dimesse che costituiscono la base del suono,
da brani da un paio di accordi all'attitudine da losers
(ricercati) che traspare dalle foto ufficiali.
Dietro al disco c'è una Sardegna musicalmente spumeggiante e pure lo zampino dei Le Man Avec
Les Lunettes, visto che lo studio in cui si è registrato tutto pare sia il loro. Per suoni che se da un
lato preannunciano un futuro artistico di ripetizione
ad libitum, dall'altro non possono che raccogliere i
giusti consensi tra i cultori del genere.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Dizzee Rascal - Tongue N' Cheek
(Dirtee Stank, Settembre 2009)
G enere : hiphop - grime based dance
Premesso che, se c'è un genere che il sottoscritto
proprio non riesce a digerire (capire, sopportare,
sentire filtrare lontano dal walkman di qualcuno,
fate voi), questo genere è il grime (persino nella sua
declinazione "intellighenzia" a firma di gente come
Kevin Martin aka The Bug), Dizzee Rascal resta un tipo con cui è obbligatorio confrontarsi. Per il
primato nel campo, le capacità tecniche come singer
rap e (soprattutto?) i numeri che riesce a smuovere.
Un primo album, Boy in da Corner (2003), definito da molti come un "punto di svolta nell'HH europeo", acclamato da gente come Mos Def ed Eminem (si spiegano così molte cose), bagnato - come
i successivi - da un incredibile successo di critica e
di pubblico (si spiegano così molte cose). Rascal ha
dato fama mondiale al grime (rap-ragga+elettronica
technoindustrial+step & dance in varie salse), traghettandone il passaggio da musica underground
a genere sdoganato sulle piste da ballo. E questo
quarto disco pare confermare una definitiva svolta
in senso pop-commerciale, con una forte riduzione
dei passaggi di grime duro e puro.
Tolta l'antipatia per il cantato (un rappato-raggato
velocissimo, gommoso e viscido), per i testi (che a
riassumerli viene fuori qualcosa tipo ribellismo street-discotecaro tra consciousness e rigurgiti papponi
& gansta-style), gli effettacci elettronici a profusio52
recensioni
ne, e due-tre pezzi sul ciglio del cassonetto, tolto
tutto questo, abbiamo canzoni costruite in maniera
scientifica per essere perversamente ficcanti. Come
poteva esserlo, per dire, Believe di Cher: a metà
cioè tra coltivazione in vitro dell'orrido, motivetto
supercatchy ed innegabile bravura di chi siede dietro al mixer (qui Armand Van Helden, Tiesto,
Calvin Harris, Cage). Per gli scopi che probabilmente si prefigge, e cioè alto intrattenimento tamarro per una notte tra casse a palla e piste (...) a
base di hip-hop commerciale, dance primi Novanta
ed elettro Duemila, si metiterebbe un sette. Però
non scherziamo con le cose serie. Voto ideologico?
è ottima brutta musica. Solite lodi sperticate sui vari
Times, Pitchfork e NME.(6.4/10)
Gabriele Marino
Do Make Say Think - The Other
Truths (Constellation Records,
Ottobre 2009)
G enere : post - rock
Ispirano parecchia simpatia, Do Make Say Think.
Per il semplice fatto che li si è sempre trattati con
sufficienza, come fossero la ruota di scorta - debitamente sgonfia e impolverata - del carrozzone postrock mentre in giro c’era e c’è ancora ben peggio;
poi, perché quando si cerca di dimostrare il coma
profondo del suddetto genere, si finisce sempre per
tirare in ballo loro. Zimbelli senza un’autentica ragione, in definitiva, e lo chiarisce questo sesto album
in cui appaiono invecchiati meglio dei Tortoise.
Si dirà: bella forza, se uno vola alto fa alla svelta a
precipitare, mentre i mediocri giammai decollano e
pertanto neppure rischiano lo schianto. Vero, non
fosse che la limitatezza dei Nostri resta da dimostrare: non è da tutti ergersi dalla cintola in su a
prescindere da un genere che fu glorioso e ora pare
non aver più nulla di rilevante da dire (e le cose
stanno in parte anche così, benché ogni corrente
viva su una spinta iniziale che si smorza progressivamente finché non riaffiora…).
In ragione di ciò ti scopri a farlo girare spesso, The
Other Truths, alternandolo con la nuova fatica di Jim
O’Rourke e apprezzandone, se non un’impossibile freschezza, l’indubbia e piena classicità formale
che al pari di quella offre. In una Do cavalcante verso
Düsseldorf con al fianco i Pell Mell e che, avvistata la fine dell’autostrada, rallenta per spegnersi nel
tumultuare di Make; nel pulsante jazz industriale Say
che diventa western alla Ennio Morricone e sfocia in
Think, commiato toccante e credibile ipotesi di un
highlight
Half-handed Cloud - Cut Me Down & Count My Rings (Asthmatic
Kitty Records, Novembre 2009)
G enere : lo - fi
Un disco composto da 46 tracce lo-fi di un minuto, fatte di frammenti; un disco di facili melodie
indie-pop. Può sembrare un’opposizione irrisolvibile, eppure Cut Me Down & Count My Rings,
summa della produzione di John Ringhofer dal 2000 al 2009, contiene
entrambi i mondi nella stessa misura.
Il primo elemento di questa sintesi disgiuntiva ci fa subito pensare a
Captain Beefheart e al suo Trout Mask Replica; in effetti
Ringhofer, mente e braccio di Half-handed Cloud, ha qualcosa di
Van Vliet; ma qui abbiamo una musica di punti senza contrappunti, concettualmente identica e opposta a quella della faccia di trota. I brani
sono degli sketch multipli, e la brevità ne è testimonianza. Hanno una
schizofrenia melodica che ricorda per certi versi il modo di arrangiare
del David Thomas di Monster Walks the Winter Lake. E probabilmente questo è un disco che interesserebbe moltissimo a Thomas. Così come a tanti fan dell’obliquità.
Ma, ancora, Was He Really Doubting ricorda i Pavement, nel tipo di melodie, con perturbazioni
che citano gli Animal Collective e un modus operandi patafisico.
Tutto il disco è una proliferazione di melodie talmente accumulate che è impossibile ricondurle a
un baricentro melodico. Eppure sono docili linee vocali che ce la fanno cercare, la pietra angolare,
in ogni canzone. Come se i cut-up dei Fiery Furnaces (Once, Twice, Seven Times a Werewolf)
fosse virato in un flusso di continua permutazione che crea cacofonia, a forza di continuare a installare microstrutture su microstrutture, tutte da canzone pop e tutte acustiche, con quel poco
di suoni quasi glitch e una mini-sezione di fiati modello fagotto.
E quando per Bees Are Trying To Build Their Nest In You segue le regole della canzone melodica e
leggera, John riesce a rifarsi felicemente alla tradizione indie-pop più giocosa, con tanto di tuba
e diamonica. Cut Me Down & Count My Rings viene dall’indie-pop e nell’indie-pop lavora, ma corrodendolo dal di dentro, come se la corrosione partisse dal centro del metallo. Un disco che va
direttamente ai posteri.(7.6/10)
Gaspare Caliri
Laughing Stock desertico e non brumoso. Argomenti
ed esposizione ben oltre lo svogliato mestiere. Sarebbe ora di dirlo chiaro e forte.(7/10)
Giancarlo Turra
Dominique Leone - Abstract
Expression (Important Records,
Novembre 2009)
G enere : art rock
Se ne esce storditi, confusi, straniti. Divertiti, senza
dubbio. Il nuovo lavoro di Dominique Leone è
un opera balistica. Genio illuminato o truffaldino da
marciapiede il ragazzo venuto dalla Louisiana?
Noi ci divertiamo a scovare paralleli, tangenze tra
questo e quell’artista. In un Leone tirato a nuovo
convergono e si scontrano progressive e pop. Forse
progressive nel pop. Oppure pop applicato al progressive. Musica stupefacente nel senso di sostanza:
erotta, probabilmente, nel rush del Mdma. Prendete
King Crimson, Genesis, Battles, Boredoms,
Electric Light Orchestra, Brian Wilson,
Todd Rundgren e consegnateli nelle mani di
Carl Stalling (l’Uomo dietro i Jingle Looney Tunes).
è Art rock caricaturale suonato a 45 giri.
Un disco giocattolo, Abstract Expression. Accelerato
e frenetico. Poca quiete e tanta goliardia. Per prinrecensioni
53
cipio, non citiamo un pezzo che sia uno. Toccherà
a voi ascoltare. Farvene una ragione. Con i dovuti
distinguo, il fratellino dispettoso di Repo dei Black
Dice.(7/10)
Gianni Avella
Doseone - Be Evil (Autoprodotto,
Ottobre 2009)
G enere : R ap freestyle
Collezione di freestyle in edizione stralimitata
(cd-r con copertine realizzate a mano dallo stesso
Dose) venduta ai concerti 2009 dei Themselves. La maggior parte dei pezzi è stata registrata
durante le freestyle classes che Dose, assieme a Jel
e Kevin Akhidenor aka Kev, ha tenuto alla Youth
Movement Records di Oakland, organizzazione
che si occupa di coinvolgere in progetti di educazione musicale i ragazzi delle zone metropolitante
"a rischio". Ci sono momenti interessanti (si parla
molto di rapper famosi) e ci sono momenti divertenti (soprattutto nelle battles con gli studenti). Basi
pauperistiche (loop cheapissimi, un semplice beat di
batteria), qualità audio da bootleg. L'idea di mostrare la faccia più rap-based della faccenda Anticon
(l'altra è evidentemente quella elettronica) non è
male, ma il risultato è molto meno pirotecnico di
come si poteva immaginare, conoscendo la fama e
le doti di Dose. Per paradosso, interessante più per
il lato - per così dire - antropologico che per quello
tecnico.(6.2/10)
Gabriele Marino
Ducktails - Landscapes (Olde
English Spelling Bee, Ottobre 2009)
G enere : T ropical - psych
Forse la finalità ultima di Matt Mondanile aka Ducktails è proprio questa: appoggiarsi alla sensibilità
di chi ascolta per evocare nostalgicamente il tempo che fu (qualunque esso sia). È proprio quando
ci si trova ad ascoltare quello che è ufficialmente
il nuovo album dell’americano dopo la raccoltona
di stramberie Backyard, che ci si rende conto pioggia battente, foglie
che cadono, autunno che
si trasforma in inverno che il meccanismo scatta
senza remore. A tornare
in mente sono tramonti
(spettrali) sulla spiaggia,
sfumature (inacidite) di
colori estivi, rumorio
54
recensioni
(quasi droning) di flutti marini e, perché no?, drink
(drogati) con ombrellini da gustare a piedi scalzi sulla sabbia.
Troppo banale? Beh, provate ad ascoltare la lunga
Deck Observatory dagli umori quasi ambient-orientali, l’opening onirico di On The Boardwalk, il cantautorato psych subacqueo della conclusiva House Of
Mirrors, le stratificazioni hypnagogic-pop di Seagull’s
Flight. Converrete con me che è un gran piacere lasciarsi cullare dalle note a metà tra psichedelia da
spiaggia al tramonto e cantautorato (quasi) speechless per giovani freakettoni messe su da Mondanile in un full length in cui l'accento sul versante pop
è, se possibile, ancor più evidente.(7.2/10)
Stefano Pifferi
Echo & the Bunnymen - The
Fountain (Ocean Rain, Ottobre
2009)
G enere : P op
Annunciato più di un anno fa, The Fountain esce
sul mercato soltanto ora. Ad accompagnarlo zero
promozione e un fattaccio brutto. Il tastierista Jake
Brockman muore in un incidente motociclistico
nell’isola di Man in circostanze simili a quelle che
provocarono la morte di Pete De Freitas, allora
batterista della band, esattamente vent’anni fa. Il
singolo non è niente male, Think I Needed Too ha il
sapore di una dedica. Commovente addio di quelli firmati McCulloch in chiodo e motocicletta che
se ne va dal pub con grandi sogni e la certezza in
fondo al cuore di non poterli realizzare e… whatever. Come direbbe lui. Per The Fountain in cabina
c’è John McLaughlin (produttore di gruppacci
quali Busted, Worlds Apart e 911), mentre l'ospite
di lusso è un ragazzo che è cresciuto a pane U2 e
Bunnymen, Chris Martin; ed è un lavoro diretto,
essenzialmente pop e curatissimo nelle parti di chitarra da un Will Sergeant che fa il session man più
che se stesso.
Il disco lo tiene su il solito Ian, in eterno trip rockabilly colato nella sempiterna scrittura Ottanta. Per
lui come per Bernard Sumner (e i suoi Bad Lieutenant) vale la medesima critica: classe, voce e
attitudine sono rimaste a livelli incantevoli, eppure
le canzoni servono sempre a livelli difficili da garantire quando le nuove tracce vengono continuamente confrontate con il passato. Traccia laterale e
proprio per questo preferibile è una Life Of 1,000
Crimes: sembra un giochetto di produzione e invece
regala di più dell’ennesima ballatona nicotinica, The
Fountain, con il Coldplay guest a dimostrarci come
possiamo fare a meno di entrambi i lati di questa
medaglia.
Insistendo sull’amore per i Sixties e sul Nicolas
Cage che è in lui, McCulloch potrebbe sfornare album concentrandosi proprio sugli aspetti di nostaglia e mito, macchine e strade, che in tracce come
Drivetime sono solo abbozzati (o comunque mai
sviluppati in formato album); avrebbe la licenza per
fare se stesso, o perlomeno un sé meno prigioniero
dei Bunnymen. In questo Sumner è stato più coraggioso.
I fan non temano: un terzetto di tune piaceranno sicuramente e Siberia meritava leggermente di
più.(5.5/10)
Edoardo Bridda
Edda - Semper Biot (Niegazowana,
Settembre 2009)
G enere : musica d ' autore
Vorremmo parlare di Stefano “Edda” Rampoldi diversamente da quanto verrebbe da fare
leggendo la sua biografia. Lasciando perdere cioè
i problemi di tossicodipendenza superati dall'ex
front-man dei Ritmo Tribale e quell'immagine da sopravvissuto che l'assenza prolungata dalla scene da
una parte e la mitologia spicciola dall'altra tendono
ad affibbiargli. Quasi fosse un nuovo profeta di una
qualche strana religione
e non un “ragazzo” di più
di quarant'anni con una
vita alle spalle notevole e
tragica al tempo stesso.
Anche perché abbiamo
tra le mani un disco che
parla per lui e dice che
altro modo di ripresentarsi non ci poteva essere. Così lontano nei suoni e
nell'approccio dalla giovinezza sconvolta della band
che in passato gli ha dato notorietà e l'ha infine costretto a mollare tutto, ma anche legato indissolubilmente a un percorso musicale oggi affrontato quasi
sottovoce. Con l'obiettivo di conciliare l'equilibrio
ritrovato con le passioni di un'anima “sempre nuda”
che a distanza di anni non ha perso un grammo della
sua poetica.
Dodici tracce acustiche, in cui si respira una tensione emotiva terrificante stemperata soltanto in
parte dai contributi di Andrea Rabuffetti, Taketo Gohara, Walter Somà - quest'ultimo coautore con Edda della maggior parte degli episodi
in scaletta - e del violino di Mauro Pagani. Brani
in cui si respira l'India Krishna così cara al musicista
(Yogini) ma anche un esistenzialismo autobiografico spietato (Amare te, Io e te, Milano), su uno stile
vocale spesso sopra le righe e vicino a certi teatri di Demetrio Stratos. C'è il passato di Edda
in Semper Biot, ci sono le paure e c'è la spiritualità,
ma ci sono anche gli anni novanta degli esordi. Con
la loro complessità, la materialità sofferta e il peso
specifico della sostanza contrapposta alla forma fin
troppo leggera che si coglie in certe nuove leve figlie dell'inconsistenza del virtuale. A dar voce a un
ritorno inaspettato e sorprendente che qualcuno si
azzarda già a chiamare commiato.(7.6/10)
Fabrizio Zampighi
Elio e le Storie Tese - Gattini
(Hukapan, Ottobre 2009)
G enere : E lio puts rent smoking
Note tecniche: in assenza di promo fisici, abbiamo
fatto riferimento allo streaming integrale disponibile su deejay.it. E non c'è stato modo di far "partire"
la traccia 11, Psichedelia, uno dei pezzi più belli di
Elio, ospite - qui come nell'originale - Lucio Dalla.
L'album è cd + dvd, e il dvd ancora non s'è visto, e
neppure si sa bene cosa ci sia dentro (backstage,
prove, live?).
Vent'anni dal mitico esordio (il tempo passa per tutti e "il visagista delle dive... adesso è un altro") e gli Elio
festeggiano facendo orchestrare alcuni pezzi storici
ad Alessandro Nidi e affidando l'esecuzione a
Danilo Grassi (musicisti classici dal curriculum
prestigioso che hanno già avuto modo di collaborare con Elio-Stefano Belisari). Rock + orchestra
è un binomio pericoloso, il rischio quello dell'appesantimento o comunque dello snaturamento dei
pezzi. Qui il repertorio è salvo, non si tratta della
solita pacchianata, ma il disco delude lo stesso, e
molto.
I brani non nascono a vita nuova con l'inserimento
di archi e fiati, sono anzi in una dimensione come
trasparente - una sorta di doppione orchestral-pop
degli originali - che nulla aggiunge al mondo musicale creato dagli Elio, e che neppure riesce a dire
le stesse identiche cose ma in modo particolarmente nuovo o interessante. Un'operazione un po'
inutile, per dirla tutta, col retrogusto del capriccio
elegante. Una Shpalman dai toni crepuscolari, solo
piano (Rocco Tanica in punta di dita) e voce (un
Max Pezzali calibratissimo), bagatella di chiusura, è l'unico pezzo illuminato da una luce diversa,
recensioni
55
highlight
Il Teatro degli Orrori - A Sangue Freddo (La Tempesta Records,
Ottobre 2009)
G enere : rock
Mostrandosi in tutta la sua maturità, A Sangue Freddo ricomincia (materialmente) da dove
finiva Dell’Impero Delle Tenebre, portando comunque a compimento un ulteriore scarto
lirico-produttivo.
Assodato l’impatto strumentale tecnicamente devastante, come si confà a una macchina da guerra rodata, a caratterizzare il comeback troviamo suoni levigati e ricercati, in apparenza più accessibili e meno ostici che, però, nulla tolgono
al potenziale anthemico di un quartetto portentoso, a cui non dispiace
nemmeno concedersi momenti altri; si veda la riscrittura in divenire
offerta dai Bloody Beetroots in Direzioni Diverse. Le bombe da
potenziale hit dell’underground comunque ci sono e si vestono di abiti
diversi: spesso aggressive e brucianti come Due, Mai Dire Mai (slide jesuslizardiana e midtempo assassino), Il Terzo Mondo (batteria monstre
e interplay da urlo); a volte diluite e poetiche, al limite del sognante
come l’opener Io Ti Aspetto e È Colpa Mia; altre volte ancora, emotive e
struggenti come La Vita È Breve o la conclusiva, devastante seduta psicanalitica a cuore aperto Die
Zeit (ospiti Richard e Roberto Tiso e lo Zu Jacopo Battaglia).
Tutta visceralità e passione, sudore e coinvolgimento, con liriche che ci vanno di stomaco e un
Capovilla ai massimi livelli: sputa sentenze e vomita bile giocando - lui ancora sì - direttamente
o di sponda con uno spettro ampissimo della tradizione letteraria e musicale italiana e non, dal
teatro-canzone di Gaber a Majakovskij (di cui si parafrasa All’amato se stesso…) e Pino Daniele, da
Celentano a Battiato, dagli immancabili De André a Carmelo Bene e infilandoci in mezzo pure il
Padre Nostro (nel pezzo omonimo) e il poeta nigeriano Ken Saro Wiwa.
Tagliando corto. Se di rock applicato alla canzone d’autore si leggeva un po’ ovunque in merito
all’esordio, con A Sangue Freddo abbiamo il classic album italiano per il terzo millennio.(8/10)
Stefano Pifferi
inaspettamente bellissimo. Il singolo, l'inedito Storia
di un bellimbusto, è un poppettino funkydiscobalera,
facile ma carino, sulla Milano da bere/dabbene. Sarebbe stato interessante tentare la resa di un pezzo
di per sé già sinfonico come La vendetta del fantasma
formaggino, capolavoro della meta-musica elica (un
po' il Greggery Peccary de noantri).
Gli Elio sono dei classici, ma per dire questo non
c'era davvero bisogno di scomodare l'orchestra.
Neppure gli hardcore fanatics (il sottoscritto nel
mucchio) saranno contenti.(5.5/10)
Gabriele Marino
56
recensioni
Elisabetta Fadini - Desmodus
(Discipline, Luglio 2009)
G enere : reading
Primo album per Elisabetta Fadini, attrice e ricercatrice vocale già da anni dedita a un’esplorazione musical teatrale variegata e a numerose collaborazioni (dal Living Theatre a Stefano Bollani,
Paolo Fresu, Mauro Ermanno Giovanardi,
Cristiano Godano tra gli altri). Il progetto Desmodus nasce da musica e soggetto di Garbo,
con l’intento di creare un personaggio anche letterario, impersonificato dall’attrice; si è immaginato
un protagonista che rappresentasse le varie tensioni del’artista, viste nello scorrere del tempo, quindi
l’immortalità dell’arte e dei suoi personaggi, in pa-
rallelo alla mortalità degli uomini. Trenta minuti di
musica ipnotica, a tratti iterativa, atmosferica, per un
dramma gotico del quale è protagonista assoluta la
voce della Fadini, nelle sue più diverse modulazioni,
che dà anima al vampiresco personaggio.
Un’opera ambiziosa allora, che si pone al confine tra
musica, recitazione e teatro, fondendole in un ibrido
certamente affascinante e ben calibrato.(7.2/10)
Teresa Greco
Factums - Flowers (Sacred Bones,
Ottobre 2009)
G enere : I ndustrial W ave
Quinto album nel giro di pochi anni per il trio di
Seattle che, dopo il debutto del 2007 su Siltbreeze,
ha macinato release e feedback positivi da tutti i
freak delle realtà musicali più out e disturbanti del
globo; e per tornare i Factums scelgono una generosa manciata di brani registrati tra il 2006 e il
2007 che solo ora vedono la pubblicazione. Benché
i pezzi non siano di recente fattura, qualche novità
è comunque presente su questo Flowers: viene
ridotto il numero di skit e collage rumoristici, con
cui da sempre il gruppo taglia e cuce brandelli di
realtà e finzione sonora, ed aumentano le canzoni
propriamente (o quasi) dette.
Suonano infatti piuttosto nuove le aperture melodiche ed al passo coi tempi di See Inside e Split
Screen, così come le schegge impazzite di post-punk
(When, Sod), noise (Secret Police, Bend) e simil sludge
(Mumbles) sparse in giro per i solchi. Un album che
ha senza dubbio nella sua varietà la sua più evidente caratteristica, specialmente se raffrontato ai più
monolitici precedenti; se ciò sia un bene, e conceda il giusto respiro, o sia piuttosto un limite, e renda il disco dispersivo e pretenzioso, è un giudizio
che ognuno può formulare da sé dopo un attento
ascolto delle 22 tracce che compongono questo
LP. (6.8/10)
Andrea Napoli
Falty Dl - Bravery EP (Planet Mu
Records, Ottobre 2009)
G enere : A mbient , wonky
Lo senti da subito che il nuovo ep di Falty Dl suona
più coeso e maturo del precedente Love Is A Liability
recensito lo scorso giugno. Riferimenti wonky - e
soprattutto memorabilia '92 - sono sotto controllo
e dalle casse esce una calda jam fatta di campionamenti black à la Bibio e quel fare zoppicante che
piace tanto dopo che Harmonic 313 l'ha sbanca-
to superando in notorietà e fama il più longevo (ma
sempre troppo nerd) Neil Landstrum. Il meglio
Falty lo dà però quando si allontana dal battito oramai moda: Play Child mescola la zampa del capo MuZiq con tagli jazzy e old skool Chicago, Tronman infila una vecchia diva house in uno scenario rave. Le
basi sono sempre piuttosto dritte, o drittissime con
nel caso del bel funky-dub afoso chiamato Pressure.
Ce n'è ancora prima di chiamarlo nome e cognome
ma il ragazzo impara in fretta e guarda già oltre i
vestiti...(6.9/10)
Edoardo Bridda
Felix - You Are The One I Pick
(Kranky, Novembre 2009)
G enere : chamber pop
Lucinda Chua (violoncello, piano e voce) e Chris
Summerlin (chitarre e drones) ovvero Felix, duo
di Nottingham che esordisce su Kranky con You
Are The One I Pick, con alle spalle variegate
esperienze, la prima come pianista /violoncellista
per Stars Of The Lid, il secondo come chitarrista dei Lords.
Formazione classica alle spalle per un esperimento
a cavallo tra ambient e chamber pop; la scommessa
(vinta) dei Felix sembra essere quella di aspirare ad
una maggiore leggibilità della materia trattata, una
divulgazione, ma sempre mantenendosi entro certi
canoni di musica piuttosto colta.
Strutturazione e svolgimento sono allora prettamente chamber, con coloriture ed aperture verso
il pop alto e il droning; la scrittura risulta varia, centrandosi su una contrapposizione tra il piano e il
violoncello della Chua e l’accompagnamento chitarristico di Summerlin e giocando sulla sottrazione,
piuttosto che sull’accumulo di elementi. Si aggiunga
poi un carico emozionale bilanciato che non guasta
mai in questo genere e il risultato è piuttosto equilibrato. La Joni Mitchell “mingusiana” più jazzata ed
elaborata dei tardi Settanta, l’espressività e gli umori
colorati di una Shannon Wright, l’emotività di
Antony & The Johnsons, qualche eco di Nico
insieme ad aspirazioni da soundtrack ambient, e tanti richiami alla musica che ha fatto la fortuna della
Kranky. Richiami anche a un dream pop rielaborato
alla loro maniera. Dei Low più ambient. Non difetta
di certo la personalità ai Felix.(7.2/10)
Teresa Greco
recensioni
57
Fire! - You Liked Me Five Minutes
Ago (Rune Grammofon, Novembre
2009)
G enere : free rock
Groove melmoso. Crasi tra Black Sabbath, Guru
Guru e la new thing di John Coltrane e Archie
Shepp. Nuovo gruppo di stanza Rune Grammofon.
Nuovo per modo di dire, dacché il nucleo è familiare: Mats Gustafsson al sassofono e Rhodes;
Johan Berthling (Tape) alla chitarra, basso e hammond; Andreas Werliin (Wildbirds & Peacedrums)
alla batteria.
Come un mantra indemoniato. Musicisti col diavolo
in corpo, letteralmente. You Liked Me Five Minutes Ago apre al funk-doom con If I Took Your
Hand. Il sax di Gustafsson pare tarantolato: Stride.
Urla. Ansima. Spaventa. But Sometimes I Am fa anche
meglio. Diciassette minuti dove il blues incappa nel
krautrock dei primi e selvaggi Can. Un tour de force lancinante. La voce femminile, a noi sconosciuta,
biascica lamenti a là Damo Suzuki. Il sax ormai è andato. In Can I Hold You For A Minute?, il kraut-sabbath
- Julian Cope ci perdoni la citazione! - dei Guru
Guru apre al Coltrane di Ascension. Jazz libero
impantanato nel doom.
Dopo cotanto inveire sul malcapitato udito, You Liked Me Five Minutes Ago chiude all’insegna di un notturno hard-boiled. Fatevi rapire.(7/10)
Gianni Avella
Foot Village - Anti-Magic (Upset
The Rhythm, Novembre 2009)
G enere : tribal madnes s
Torna la thunderous drum'n'shout assembly in tutta la
sua irruente potenza di fuoco da no-electricity hardcore. Il nuovo album attraversa l’oceano (il marchio è quello di qualità della Upset! The Rhythm) e
sposta di un passo ancora le coordinate ideologiche
che da sempre caratterizzano l’incompromissoria
proposta del quartetto losangelino.
Se nelle prime prove centrale era, infatti, prima
la riflessione su altri stati (World Fantasy) e poi la
costituzione di una propria nation under one drum
(Friendship Nation), ora la “matura” nazione
Foot Village si confronta con l’idea della guerra.
Anti-Magic diviene così una specie di concept
guerresco che vive sempre di costante tensione,
come dimostrano Reggae Warzone (“This is the war
for the human race…” urla sguaiata l’unica signorina del gruppo…) o National Jamthum in cui le sirene antisommossa che qua e là fanno capolino ri58
recensioni
evocano il clima riottoso
dell’intera faccenda. La
conclusiva, lunghissima
jam collettiva Chicken And
Cheese 2 - in cui si celebra la fine della guerra e
la “rivelazione delle virtù
della musica” con amici di
vecchia data e spiriti affini (da Aids Wolf a Tussle passando per Blue Sabbath Black Fiji) seppur nella sua naturale frammentazione mantiene
sempre in nuce quel ribellismo anarcoide (stilistico
e ideologico) che è ormai segno caratteristico di
Foot Village. Insomma, esperienza estenuante ma fascinosa.(7.2/10)
Stefano Pifferi
Former Ghosts - Fleurs (Upset The
Rhythm, Novembre 2009)
G enere : synth - wave
In epoca di collaborazioni trasversali e commistioni stilistiche come l’attuale, parlare di supergruppo
non è che abbia molto senso, soprattutto in ambiti
realmente underground. Quando però ci si trova
di fronte a formazioni (non estemporanee) come
Former Ghosts, beh, un pensierino tocca farcelo.
Nato da una idea di Freddy Ruppert titolare della
sigla This Song Is A Mess But So Am I, Former Ghosts vede infatti come restanti vertici del
trio Jamie Stewart (Xiu Xiu) e Nika Roza (Zola
Jesus). Un trio di piccoli fenomeni totalmente
immolato al culto di Ian Curtis e della synth-wave
in modalità lo-fi. Non c’è, difatti, una singola nota
(tutte rigorosamente synthetiche come da manuale
del nerd 2.0) in queste 12 piccole gemme che non
trasudi un immaginario nero-pece, tetro e accorato,
fatto di disperata e depressa poesia urbana quale
era quello dei Joy Division.
Non di mera imitazione si tratta, però, come spesso accade ultimamente. Qui, sarà il trasporto nelle
parti vocali, sarà la plumbea ma ricercata atmosfera
evocata dalle musiche, la sensazione è che di reale
comunanza di sentire si tratti. Quasi che quella tra i
tre - col proprio, rispettivo background - e il ragazzo di Manchester sia una questione di reali affinità
elettive più che di semplice (e genuina, sia chiaro)
imitatio. Molto più spontaneamente vissuto, sentito
e sofferto di molto del synth-pop ascoltato di recente (Cold Cave e tutto il giro minimal-wave per
fare un nome).
La sensazione è che il gruppo sia tale e non uno
one-shot. La speranza (speriamo di molti) è che lo
sia realmente perché Fleurs è uno dei dischi più
belli ascoltati ultimamente.(7.3/10)
Stefano Pifferi
Gary Higgins - Seconds (Drag City,
Ottobre 2009)
G enere : folk rock
Un altro della schiera degli scomparsi eccellenti e
poi riscoperti di recente, come Vashti Bunyan
e Linda Perhacs, Gary Higgins aveva beneficiato nel 2005, sotto il patrocinio di Ben Chasny
(Six Organs Of Admittance) dei riflettori ancora puntati sulla sua musica con la ristampa - a
cura di Drag City - dell’unico disco, il gioiellino folk
Red Hash (1973), finalmente disponibile con un
paio di bonus.
Il Nostro quindi si rimette on the road ed ecco
questo Seconds, dal titolo che più anodino non
si potrebbe. Con il ritorno di alcuni vecchi sodali
(Dave Beaujon e Jerry Fenton) ma anche dal figlio
alla chitarra, Higgins sorprende ancora per intenti e
attitudine; con un folk rock diretto e senza fronzoli,
accompagnato dalla voce avvolgente che ben gli si
conosce, fa il suo ingresso tra ballad, numeri psych,
talking blues e la sublime ed articolata 5 A. M Trilogy,
un gioiellino tra sussurri e malinconie, qualcosa a
metà strada tra il suo passato e un presente recente che potrebbe richiamare il Will Oldham
classico.
Non tutto è però all’altezza, ma un paio di numeri oltre al già citato fanno la differenza (Demons,
Ten-Speed quest’ultima un vecchio pezzo rimesso a
nuovo), in un album che non compete certamente
con Red Hash ma ha la sua ragione d’essere nella
continuazione di un percorso artistico di tutto rispetto.(7.1/10)
Teresa Greco
Gerardo Balestrieri - Un turco
napoletano a Venezia (Egea,
Ottobre 2009)
G enere : etno folk
Un po' guappo e un po' guitto, Gerardo Balestrieri
si cala nella parte dell'apolide veneziano. Metà del
cuore rivolto a Napoli, la natia Napoli. L'altra verso
il Bosforo, d'onde proviene l'Arif Azerturk Ensemble, quintetto tradizionale turco che condisce
di folto esotismo l'estro e i languori mediterranei di
pezzi storici del canzoniere napoletano quali Maruz-
zella, 'O guappo 'nnammurato e Caravan petrol. Non
contento, Balestrieri ha chiamato a collaborare Paola Fernandez Dell'Erba, cantante argentina di
origini lucane, col risultato che già con l'iniziale A
Marecchiare siamo ubriachi di latinerie tanghesche
partenopee orientaleggianti, roba che fatichi a tener
dritta la testa.
Così, con Gerardo che volutamente spende una
voce più blues possibile - tanto per squadernare
ulteriormente le coordinate - si compie questo
lungo e denso cerimoniale contaminato e contaminante, dove il mistero è una melma felpata e struggente (sentitevi la straordinaria Scetate), dove una
Tammurriata nera può ritrovare il senso di dramma perduto nelle troppe versioni macchiettistiche,
dove una Nascette mmiezz'o mare si aggira laconica
e fatalista pennellando il ritratto d'una città-mondo
come avrebbe potuto (e
amato poter fare) Fabrizio De André.
Balestrieri è un visionario che non si fa troppe
illusioni, uno che coltiva
il proprio golfo mistico
di suggestioni e lo porta
in giro con amore tanto
appassionato quanto discreto. Tuttavia, non è uno
che si tira indietro se, come in questo caso, c'è da
spendere il proprio cent riguardo al tema (scottante) del sincretismo culturale. Certo, mi piacerebbe
risentirlo più "cantautore", ma sospetto che farà
sempre semplicemente quel che gli parrà opportuno. Bontà sua.(7.2/10)
Stefano Solventi
Gerda - Self Titled (Bloody Sound
Fucktory, Settembre 2009)
G enere : post - hc
Ritorna il combo forse più disturbante e incompromissorio delle Marche rumorose con una mezzora
di viscerale post-hardcore devastante. Se rimaniamo convinti che ci sia del marcio in quel fazzoletto
d’Italia, altrettanto certi siamo del fatto che ad animare la formazione jesina sia una rabbia furibonda e
primordiale, ferina e incontrollabile.
Cinque pezzi untitled che sono un urlo munchiano
senza soste né possibilità di redenzione non solo
per chi ascolta ma soprattutto per chi suona. Certo,
non di solo screamo vive questo omonimo vinile
(+ cd, come da prassi), perché sarebbe limitativo e
banale, visto il passato della band. E così riechegrecensioni
59
gia, tra brutalità da dopo hardcore svedese (altezza
Breach) una tendenza alla dilatazione disperata e
alienante che si riverbera negli spasmi dei pezzi del
lato b. La tensione sembra allentarsi specie negli 11
minuti di 04, che parte pestona e greve per poi diluirsi in contrazioni quasi psycho-sludge, ma è un falso
allarme: la cieca e iconoclasta furia della conclusiva
05 riconduce i Gerda sul loro terreno. Quello di
portabandiera del dopo hc italiano.(6.8/10)
Stefano Pifferi
Giuliano Dottori - Temporali e
rivoluzioni (ViaAudio Records,
Novembre 2009)
G enere : songwriting
Chitarrista che vanta numerose collaborazioni
(Amor Fou e Atleticodefina tra le ultime),
Giuliano Dottori arriva con Temporali e rivoluzioni al secondo album solista, con la produzione artistica di Giovanni Ferrario, dopo l’esordio
del 2007 con Lucida.
Autore di un songwriting sommesso e morbido, di
base rock, fatto di ballate e pezzi più mossi, il disco
si muove tra ispirazioni di songwriting classico, italiano in primis, dagli storici Francesco De Gregori e Lucio Battisti ai più recenti Moltheni si sentano per esempio le iniziali Chiudi l’emergenza
nello specchio e Amuleto - e Riccardo Sinigallia,
fino ad umori psichedelici pieni di echi battistiani
(Catene e gioie fragili).
Riflessioni amare e disincantate su attualità e società (Inno nazionale del mio isolato), tra intimismo ed
aperture, sempre con uno sguardo piuttosto ironico e sottile sulla realtà, per un album realizzato
con eleganza ed arrangiamenti sempre impeccabili.(7.1/10)
Teresa Greco
Goose - 30:40 (Seahorse
Recordings, Ottobre 2009)
G enere : pop - rock
Ci mancava solo la band indie con le crisi di identità
da over trenta. Per di più capitata a uno che con
quel tipo di crisi ci convive tutti i giorni e nemmeno
troppo serenamente. Si, perché il 30:40 del titolo
starebbe ad indicare il passaggio critico dagli -enta
agli -anta (sorta di vero e proprio concept per il
disco), vissuto come un momento utile per tirare le
somme - quasi sempre poco soddisfacenti - o magari soltanto per riflettere sul vissuto fin lì condotto.
Fortuna che i Goose sono artisti abituati a vedere
60
recensioni
tutto con leggerezza, a masticare tematiche importanti con piglio ironico, a non prendersi troppo sul
serio anche quando la situazione non è delle migliori. Grazie a scelte musicali che ne sottolineano l'approccio easy ma non superficiale, in bilico tra rock
di impronta Pearl Jam (Sogna) e country svogliato (La vita a trentaquattro anni), power pop (Qui
per te) e ballate in stile Perturbazione (Quando
ero felice), parentesi elettroacustiche senza pretese
(Indietro) e fingerpicking della buona notte (Neve).
Vengono in mente i Mr Brace, se non nei suoni
almeno nell'approccio, anche se qui l'ironia è meno
manifesta e più sottile. Sostenuta da testi che parlano di quotidianità e odorano di canzone d'autore, significativi nella loro essenzialità e ben lontani
dall'apparire noiosi o eccessivi.
Insomma la seconda fatica dei Goose è un bel disco. Un'opera democratica - perché non pretende
conoscenze specifiche da parte di chi ascolta - e
fondamentalmente popolare, ma assemblata con intelligenza e acume.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Grant Lee Phillips - Little Moon
(Yep Roc, Ottobre 2009)
G enere : folk rock pop
Anno 1994. Programma pomeridiano di Videomusic.
Ospiti: i Grant Lee Buffalo. Eseguono un paio di
pezzi di Mighty Joe Moon, se non ricordo male
Side By Side e Lone Star Song. Gli astanti si spellano le mani. Dopodiché, la canonica intervista. Anzi,
non troppo canonica. Il conduttore lascia la parola
ai ragazzi del pubblico. Un tipo barbuto dall'aria abbastanza competente chiede loro: siete consapevoli d'essere in questo momento la migliore band al
mondo? Grant Lee Phillips si schernisce, risponde
smozzicando parole di circostanza. Mi colpiscono
però i suoi gesti, il suo sguardo. Si ciondola senza
posa aggrappato alla chitarra arpeggiando note imperscrutabili, come se solo quello gl'importasse: un
suonare necessario, cardiaco.
Nei suoi occhi cova un lampo scuro raggelato,
una consapevolezza morbida e profonda di mistero. Quei tre forse non erano la migliore band al
mondo, però in quel preciso momento tenevano il
fulmine al guinzaglio, cavalcavano una bestia antica
aggirandosi come minacciosi fantasmi contemporanei. In qualche modo, partecipavano di una stirpe
formidabile che univa trasversalmente Leadbelly
e Howlin' Wolf, Gram Parsons e la Band,
Blasters e Gun Club, Dream Syndicate e
highlight
Lucky Elephant - Star Sign Trampoline (Pias, Ottobre 2009)
G enere : indie pop
Una solarità e un’attitudine al divertimento rendono interessanti a un primo ascolto questi esordienti inglesi Lucky Elephant. Elementi essenziali man mano che si procede con Star Sign
Trampoline sono una musicalità pop e un uso estremamente intelligente degli elementi a
disposizione.
Arrivano dall’isola di Wight e il cantante e frontman Emmanuel ‘Manu’ Labescat è di origine
francese e si sente, anche nell’accento deliziosamente nasale. Cosa ci
propongono è presto detto: pop all’ennesima potenza, una scrittura sicura, una miscela in equilibrio di emotività ed espressività prettamente
brit, coniugata in parte con elementi di chanson francese (ah quell’organo!) e songwriting d’autore, diciamo dalle parti di un Morrissey o
di un Paul Weller, con ritmiche anche jazzy. Si aggiungano poi anche
elementi sparsi di afro beat e tropical alla Vampire Weekend, insieme a una malinconia che ben si associa di contrasto al sunny side ed
è fatta.
Una sobrietà di fondo nei suoni, vecchi synth, un piano Wurlitzer, un
harmonium, ukulele e chitarra spesso acustica. È nella fusione il segreto dell’album, sia quando nel
pezzo migliore Modern Life, Changing People si pongono in sospensione tra uptempo e ritmiche
dub, sia quando viaggiano su blues e shoegaze (The Beginning), sia nella facilità alla melodia, caratteristica del gruppo.
Un esordio interessante allora Star Sign Trampoline, che ci fa rivivere alla grande il calore dell’estate da poco trascorsa.(7.2/10)
Teresa Greco
Thin White Rope. Tre lustri dopo, dimenticati
oramai i GLB, sperimentate digressioni electro-pop
e carezzevoli nenie da front porch, il caro Grant Lee
Phillips si ritrova immerso nelle dolcezze della neopaternità, da cui trae oggi ispirazione per regalarci
un disco "ennesimo". Ben suonato, ben scritto, ben
interpretato. Sapientemente in bilico tra folk-rock
e chamber-pop con un pizzico del solito vaudeville. Uno dei suoi migliori lavori da solista. Gradevolmente innocuo dalla prima all'ultima nota.
Così vanno le cose, così devono andare. Non so se
riuscirò mai a perdonarlo. (6/10)
Stefano Solventi
Grischa Lichtenberger - Treibgut
(Raster Noton DE, Maggio 2009)
G enere : G licth
Un ritorno si sperava e in perfetta forma se lo attendeva. Pronta ancora una volta a non deludere la
Raster Norton si concede un seguido in nove libera-
zioni a breve dagli ultimi SND e Atom™.
Una serie intitolata unum (dal greco numero atomico) che prende spunto dagli elementi chimici
111-119 della tavola periodica arrivata qui alla seconda uscita con Treibgut (unumbium r-n 112)
del giovane artista Grischa Lichtenberger.
La sostanza è sin da principio forte ed inaspettata,
field recordings e texture più o meno concrete lasciate al loro naturale stato - acerbo, animato, denso
e rumoroso - a seguire i territori più sperimentali
(quelli per cromatismi ed impatto sonoro più vicino ad un Alva Noto o per destrutturazione
di ritmo agli Autechre) percorsi prima in stati
tortuosi, interrotti poi o abbandonati alle tempeste
ritmiche.
Non è necessario all'ascolto di Treibgut cercare
una continuità di significato, per queste cinque tempeste di droning e glitch organizzate sotto forma di
residui industrial o per certe circostanze rappresentate al limite della dancefloor, l'espressività maggiore
recensioni
61
sta nella deriva e nella collisione degli elementi.
Da 0406_01_RS_! a 0106_12_LV_3 Sand Ausheben,
grammattiche anomali che non scendono a compromessi con la funzionalità ma ne cercano dichiaratamente esilio. Un esilio impossibile da dimenticare.(7/10)
Sara Bracco
Guano Padano - Guano Padano
(Important Records, Novembre
2009)
G enere : calexico - style
Ecco: Alessandro "Asso" Stefana, uno per cui vale
spendere davvero un po’ di parole. “Sei passato da
un grande nome come Marc Ribot, a due musicisti
italiani giovani". Uno di quei due giovani di belle speranze è Asso. "Perché questa scelta?". Qualcuno a
Capossela, ai tempi di Da Solo, questa domanda
la pone. E lui così risponde:
"Credo che Asso sia uno straordinario chitarrista e
che possieda anche un eccezionale senso estetico e
un grande amore per il suono. Era quindi il compagno perfetto per un viaggio come questo. Le persone con cui ho lavorato all’inizio sono anche quelle
che avevo già molto vicine: non c’è stato bisogno di
andare a cercare all’esterno delle mie conoscenze
per trovare collaboratori. Questo mi ha permesso
da subito di lavorare bene e con affiatamento. Sono
quindi molto contento di aver riscontrato questa
vicinanza, così come sono molto contento di aver
lavorato con un musicista bravo e geniale come
Enrico Gabrielli. Perché fino a ora ho parlato di
rapporti, di conoscenze,
di vicinanza, ma di fatto
il motivo principale per
cui li ho scelti è un altro
ed è molto semplice. Ho
lavorato con loro perché
sono i più bravi. Punto".
Di Stefana, chitarrista
davvero talentuoso, si
potrebbero dire un’infinità cose; ad esempio che è nato a Brescia nel 1981.
Ad esempio che sa suonare una miriade di strumenti oltre la chitarra (steel e pedal steel guitar, kalimba, omnichord, ukulele, balafon, banjo, eccetera). Ad
esempio che ha accompagnato moltissimi nomi celebri, oltre Vinicio o i Calexico: Matteo Salvatore,
Shane McGowan, Flaco Jimenez, Emidio Clementi,
Marco Parente. Ma soprattutto Marc Ribot,
del quale, per molti aspetti, è l’erede nei nuovi la62
recensioni
vori firmati Vinicio Capossela. Chi cercasse il vero
passaggio di testimone dall’uno all’altro può andare
ad ascoltarsi un disco di Stefana uscito nel 2007 per
l’etichetta indipendente statunitense Important Records: è un lavoro di musica sperimentale, si intitola
Poste e Telegrafi, e dentro ci suona anche Mastro Ribot. Un maestro che per Vinicio è garanzia di
qualità sulle scelte delle sue collaborazioni.
Adesso ci sono i Guano Padano negli orizzonti artistici del Nostro. Un soldalizio nato fra i banchi di
scuola. E la scuola è sempre quella, quella di Vinicio
Capossela. I Guano Padano sono infatti un terzetto: Danilo Gallo al contrabbasso, vibrafono, piano e
organo, Zeno De Rossi alla batteria e ammenicoli vari oltre allo stesso Stefana alla chitarra. Come
suona questo loro esordio comune, per il quale
lo stesso Joey Burns si è scomodato a recensire (dare un'occhiata al booklet del cd, please) ogni
canzone una per una? Suona come i Friends of
Dean Martinez non sono mai stati capaci di suonare: desertico ed evocativativamente surfy (Guano
Padano), teso sulle corde d'un banjo 'd'assenza' (A
Country Concept), fischiettato su melodie spaghetti
western di Morricone (El Divino, con lo storico
Alessandro Alessandroni, fischiatore storico
di Ennio), o ancora come un pezzo da colonna sonora hollywoodiana che pare i Ventures alle prese con Tarantino (Epiphany).
E non finisce qui: lo strumentale folle di Bull Buster,
o magari la splendida cover di Ramblin' Man, con un
Bobby Solo spezzacuori da urlo. Partecipano al
disco anche il grande Gary Lucas e Chris Speed.
Chapeau.(7.5/10)
Massimo Padalino
GusGus - 24/7 (Kompakt, Settembre
2009)
G enere : technohouse b / n
Da collettivo multimediale a trio concentrato
sull'elettronica, dall'intelligent house a colori acidi di
Polydistortion (1997, ottimo, e con momenti già
indicativi degli sviluppi futuri) al minimalismo biancoenero di questo 24/7: i GusGus hanno lavorato
di sottrazione, o meglio, per asciugamento. Tra i due
estremi, una manciata di dischi e collaborazioni rivelatrici come i remix per Björk, Sigur Rós (naturalmente) e Depeche Mode (ovviamente).
Il disco è austero ed elegante, fin dalla formula scelta, pochi pezzi tutti medio-lunghi, ben visualizzato
da una copertina ambiguamente ammiccante e praticamente surrealista, animato dai piccoli palpiti di
una tensione sottopellesottoghiaccio che non
viene mai risolta. Lo
strumentale deeptechno Bremen Cowboy a un
certo punto "parte", ma
senza esplodere davvero.
Una tensione innervata
di soulness bianca (una voce a tratti Bono primi
anni Novanta), che è una tensione sicuramente sensuale-sessuale, con l'idea di un orgasmo che monta
ma viene solo sfiorato, e quindi frustrato. Il risultato
sono pezzi come Take Me Baby, con quella voce Eyes
Wide Shut-izzata che comunica epidermicamente un
momento di torbido voyeurismo.
Disco intimamente notturno, fatto di attese disattese e di vuoti, tutto giocato sul concetto di stilizzazione.(7.2/10)
Gabriele Marino
Hecuba - Paradise (Manimal Vinyl
Records, Ottobre 2009)
G enere : electro rock pop
Un accenno vagamente radioheadiano con la voce
di Jon Beasley che si stiracchia in lamenti (Paradise), mentre Isabelle Albuquerque richiama
Madonna (Even So, Miles Away), l’elettronica che
non disturba, la produzione raffinata che gioca sul
dettaglio. In una parola Hecuba. L’esordio per il duo
losangeliano riassume le esperienze dell’ultimo pop
femminile che guarda agli 80 (Bat For Lashes) e
le trasfigura in un mix arty à la Yacht (guardacaso
anche qui si gioca in due).
Sembra di stare in un quadro di Andy Warhol, litografie che si ripetono identiche a se stesse, ma in
questa ripetizione (di ritmi, di tecniche, di strumenti e di riff) sta il bello. Il minimalismo che inconsciamente (?) deriva dalla tradizione newyorchese
di Philip Glass e soci gioca sullo scarto minimo,
sull’insistenza ossessiva per il particolare e su atmosfere lievemente minori. Il tutto è amalgamato
con le ultime cose che ha proposto quella potenza
rediviva che è Yoko Ono: in La Musica e in Extra
Connection rivive quel sentimento di sperimentazione calibrato Now, con l’introduzione a cappella, il
crescendo un po’ acido un po’ acustico e lo spoken
word sulla base visionaria. Se i riferimenti non bastavano, c’è pure il fantasma LCD Soundsystem.
Pronti insomma a sbancare il dancefloor con successivi e (speriamo) gordi remix, qui si prosegue e si
costruisce un suono che eredita ma che non emula.
Una buona prova di surfing degli ‘stili che fanno stile’. Poshy con l’anima.(6.8/10)
Marco Braggion
I Melt - Il nostro cuore a pezzi (La
Tempesta Records, Novembre 2009)
G enere : indie rock pop
Dopo ben sei album all’attivo, tornano con Il nostro cuore a pezzi i vicentini I Melt; presenti
nel panorama indie italiano dal lontano 1992, si sono
distinti per collaborazioni con Giorgio Canali
(che ha prodotto alcuni dei loro dischi precedenti)
e Tre Allegri Ragazzi Morti tra gli altri.
Autori di un indie rock con influenze che vanno dal
brit pop al post punk e all’indie americano, insieme
alla musica italiana più o meno recente, si caratterizzano innanzitutto per il cantato in italiano e per
una vena melodica spiccata che emerge prepotente
anche nei pezzi più insospettati. Sono soprattutto
le melodie che poi restano in testa (Anidride, la title
track) e alcune soluzioni più aggressive (Raccontami
il tuo inverno) e personali (l’acustica Non mordo più e
Il cielo sopra Francoforte).
Cantori disincantati del quotidiano, I Melt realizzano un disco eterogeneo per sonorità che ha il suo
perché nella cifra personale raggiunta.(6.8/10)
Teresa Greco
Ian Brown - My Way (Polydor,
Ottobre 2009)
G enere : pop
Il sottoscritto non ha sottomano i dati di vendita, ma
sospetta che The World Is Yours di due anni
fa non sia stato per Ian Brown quel che si dice
un trionfo di vendite. Disco convincente il quinto
dell'ex Stone Roses, pieno di belle canzoni tra
modern soul, r'n'b e hip hop con qualche sbirciatina
al (glorioso) passato, ma non abbastanza probabilmente da pagare al botteghino. Non si spiegherebbe altrimenti l'esegesi di questo My way (titolo in
omaggio dichiarato a Sid Vicious) che a dispetto
del predecessore calca la mano su archetipi quasi
sempre poppeggianti, per dodici canzoni che scalano definitivamente il decennio - dai settanta agli
ottanta - e si assestano su coordinate tanto derivative (vedi in primis alla voce Michael Jackson)
quanto succulente, visto il talento da “fine melodista” del nostro.
Peccato però che il risultato sia ben diverso da
quanto lasciato intendere dalle premesse: si arriva in
fondo facilmente alla track-list, ma che noia. Dave
recensioni
63
highlight
OOIOO - Armonico Hewa (Thrill Jockey, Ottobre 2009)
G enere : P ost -P unk
Tribale come le cose che ci sono piaciute nell'america dei tamburi del nostro speciale, psychedelico come l'altro fiume in piena undergound, sempre analizzato in queste pagine, cerebrale e
scherzoso come un parto di San Francisco fine Settanta, e infine post-punk, parola chiave e ombrello attorno al quale gira tutto ciò che nell'(avant)rock ci è sempre piaciuto.
A tre anni dal già notevole Taiga, Yoshimi si ripresenta in quartetto e con il sorriso tranchant
proprio solo dei grandi. In pratica ci dirà che tra Gang Of Four, Wire e il mondo krauto più
fricchettone non ci sono né barriere né impedimenti. E che le cose possono anche lievitare e
diventare misticheggianti senza perdere in forza e impatto. Poi, se le
energie in campo sono quelle dello yang piuttosto che dello ying, la
sensibilità apre prospettive e traiettorie imprevedibili e davanti alle
orecchie hai un souno totale che non dimentica neppure la lezione gli
ultimi Boredoms in veste live: si può essere punk partendo da ferree discipline orientali. E se qui di regole non ce ne sono, e fare ritmo
significa liberarlo in cielo, è ancora il pensiero a orientare le azioni,
seguendo l'intimo carattere play(ful) della musica, e così coordinando
braccia e spirito.
Le Oh oh eye oh oh si muovono talmente bene che pensare in grande viene spontaneo. è il corpo
rock, bruciato sotto l'altare di chissà quale panteismo, a resuscitare. E ancora una volta ne esce
rinnovato, come dei Pop Group per i Duemila, e senza imbarazzi di paragone sentita quella
chilata di funk ancestrale (motore Mark Stewart per eccellenza) unito a un tribale che le
Slits possono (e potevano) soltanto immaginare. E infine, cari progger, questo è anche un disco
per voi, fatto com'è di cambi ritmo, altri stili ancora, accelerazioni, incastri, Ibiza, fare da concept
dedicato a Gaia ecc. Tagliando corto: una delle band '00 con il più alto peso specifico in circolazione.(8/10)
Edoardo Bridda
-, altre volte è lo specchio fedele di chi ci suona
dentro. è il caso dell'esordio de Il disordine delle
cose, opera a cui partecipano, tra gli altri, Paolo
Benvegnù, Marco Notari, i Perturbazione
e Carmelo Pipitone dei Marta sui tubi. Per una
formula che abbraccia in pieno il mood dei musicisti coinvolti, confezionando melodie sul modello
di quelle della formazione torinese, affidandosi a un
impianto fondamentalmente acustico, cedendo a
un'eleganza formale retaggio del Benvegnù-pensiero
ma risultato del lavoro in fase di produzione dello stesso Marco Notari, Gigi Giancursi e Luigi
Giotto Napolitano.
Tra pianoforti al rallentatore e voci suadenti, violoncelli e violini, trombe e rhodes, ci si ritrova invischiati in certo pop à la Beatles/ Radiohead prima
maniera (La mia fetta, Muscoli di carta) come in una
ricerca melodica formalmente impeccabile (il Moltheni de Il colore del vetro, ma anche L'altra metà
di me stesso, Infezione, Lacrime e fango) figlia della
tradizione autoriale degli ultimi anni. In uno scarto
generazionale che innalza i “nuovi” cantautori (quelli citati in apertura) a modello da imitare.
La formazione novarese non si tira indietro quando c'è da sfruttare la gloria riflessa di un'estetica
ormai istituzionalizzata, confezionando un'opera
certamente di richiamo. Per poi peccare, alla lunga,
di eccessivo conformismo, in un disco che è intuito e gusto melodico ma anche vanitosa innocenza.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
McCraken, vent'anni dopo l'esordio Stone Roses,
mette tutto a posto a livello di produzione; Brown di
suo canta come sa fare, crooner moderno qui spesso al servizio di impasti vocali passati a macchina.
Sono gli spunti decisivi invece a mancare. 
In
sintesi, ma neanche poi tanto, il canovaccio è quello
di un pop fortemente cadenzato nelle ritmiche, che
di volta in volta sceglie di affidarsi alle didascalie più
ruffiane (un bozzetto da Moby elegante in Marathon man, un synth-pop tipo Depeche Mode illuminati in Own brain, dei Coldplay danzerecci per
By all means necessary e via dicendo) senza neanche
sforzarsi troppo per trovarne di troppo inaspettate,
e anzi scovandone alcune da brividi alla schiena (la
grana hip hop di Crowning of the poor, per intenderci,
ricorda i Bomfunk MC's).
Altrove il risultato è un po' più confortante, come
64
recensioni
nel ben singolo Stellify in cui Brown gioca a fare il
Robbie Williams della situazione innestando
fiati Motown su una pop-song piuttosto appiccicosa o nella ballad strappacuore Always remember me,
immersa in una profondità di tastiere ed elettriche
assai composte. Però l'impressione generale è di un
deficit di idee proprio quando c'era anche il bisogno
di fare cassa. Il re scimmia per questa volta è nudo,
speriamo si (ris)copra.(5.2/10)
Luca Barachetti
Il disordine delle cose - Self
Titled (Tamburi Usati, Ottobre
2009)
G enere : folk - pop d ' autore
Spesso un disco va oltre la somma delle parti che
lo compongono - musicisti, ospiti, produttore, ecc
Jookabox - Dead Zone Boys
(Asthmatic Kitty Records,
Novembre 2009)
G enere : B ig kitch
Si permette un po’ di tutto, David Adamson. Apre
(Phantom Don’t Go) con una finta percussione da
pellerossa e mette subito sul piatto la sua estetica:
hip-hop, indie obliquo, e tanta, tanta disinvoltura. Un
cantato tipico del bianco che cita il nero e la classica esplosione dell’indie da cameretta che non sta
nella pelle ed esce per strada, nel mondo, negli altri
mondi.
Disinvoltura, si diceva, per molti versi figlia di quella
inaugurata da Beck ma qui tutta interna all’universo che sta sotto alla linea che separa dal mainstream.
Anche quando i Jookabox tentano Evil Guh, una
sorta di ballata meditata su un tappeto di inquietudine, il prodotto non è rettilineo e - cosa gradita
qui a SA - non ci fa certo puntare al tavolo su come
la vicenda potrebbe finire. Il protagonista di Dead
Zone Boys è un fantasma birichino (eufemismo per
spaccone) che si apposta nelle tracce per fare loro
attraversare i muri. E Don’t Go Phantom se ne fa portavoce, rendendo evidente, fra l’altro, il contributo di
un altro personaggio che non sta quieto neanche un
attimo, e che gioca come David costantemente con
l’accumulo, piuttosto che con la sottrazione. Parliamo di Rafter, che qui è responsabile di missaggio e
masterizzazione, come anche forse di un’atmosfera
condivisa con Jookabox. Senza dire chi ha donato
cosa o chi ha influenzato chi; i due vanno insieme
per sensibilità ipertrofica e divertimento tronfio.
I quattro Jookabox sono dei bear (con bearesse)
che amano smuovere le acque, ma di fatto è possibile spogliare il loro operato, e scoprire che sotto ci
sono canzoni indie. Grossa differenza con l’hip-hop
da cui questa musica sembra a ogni traccia provenire con più forza. Eppure l’operazione è ingiusta. Se
anche questo è folk o indie-pop per gente che ha
una soglia del popolare molto alta (East Side Bangs/
East Side Fade), è nella smania produttiva che si articola la cantautorialità da cameretta di Adamson. Ed
è così che You Cried Me sembra una facile canzone
con tutti i crismi, ma in realtà è appena più veloce
del dovuto, ha fretta e non può fare a meno di farcelo notare, finendo per non essere banale come
sembrava. Stesso discorso per l’elettropop di Zombie Tear Drops. Stessa analisi per il disco: è il fantasma
che si aggira a diventare elettronico, artificiale, eppure tanto terreno…(7/10)
Gaspare Caliri
Jules Not Jude - Clouds Of Fish ep
(Rec Bed Room, Ottobre 2009)
G enere : pop psych
Il nome mette il dito nella piaga tra immaginifico e
reale - una delle tante - della produzione beatlesiana, laddove il nomignolo "vero" del figlio di Lennon
venne dissimulato da McCartney nel celeberrimo
Jude, perché forse una "Hey Jules" non si sarebbe
staccata abbastanza dalle cose terrene. C'è bisogno di un pizzico di finzione per alzarsi in volo fino
all'iperuranio, come la polverina di fata per gli amichetti di Peter Pan. Ma restiamo coi piedi per terra,
magari dalle parti di Brescia, dove dal 2007 agisce
l'arguta cospirazione dei Jules Not Jude, ovvero
Simone Ferrari e Mirza Sahman, un duo col pallino
del beat popadelico da ravvivare ad uso e consumo
dei trepidi visionari d'oggidì.
Debuttano con Clouds Of Fish, cinque tracce per
recensioni
65
un ep zeppo di stuzzicanti premesse a base di emulsioni sfrigolanti e languori vibratili, battito sbrigliato
e cambi di scena, tutto un pullulare di trovate in fase
di arrangiamento - farfisa, diamonica, glockenspiel,
chitarre a plettro duro e arpeggi luccicosi, coretti distorti e violino... - che si spalmano come una
glassa sulle melodie indolenti e beffardelle, toccanti
e circospette. Coprendo un ventaglio di riferimenti
che vanno dai primi Small Faces al Billy Corgan più bucolico, dalle più morbidi propaggini Elephant 6 all'estro pop dei Belle And Sebastian,
dal ciondolio asprigno d'un Robyn Hitchcock ai
languori lisergici Zombies, piazzano molte idee al
servizio di una scrittura ispirata, che fa quasi fatica
a tenere a bada l'esuberanza però tutto sommato
ci riesce.
Basterebbe la title track, col suo folk-psych che va
ad espandersi tra vaudeville e stravisioni flaminglipsiane, a farceli catalogare tra i runners più promettenti.(7.3/10)
Stefano Solventi
Julian Casablancas - Phrazes for
the Young (RCA, Novembre 2009)
G enere : W ave P op
La barca Strokes era un capello di carta e loro lo
avevano capito prima di tutti. I boys che ieri furono Re ora possono soltanto sventolarci una fama
virtuale. L'every kid indie simpatizzante gli voltò le
spalle e i side project (sempre meno side) dimostrano interessi reali in seno a una band che nel lontano
2006 ci lasciò con un pugno di mosche chiamato
First Impressions of Earth, stroncato quasi ovunque
e salvato soltanto da chi aveva qualche interesse di
booking. Così i fatti riportano family life per Fraiture e Valesi (ammogliati e neo babbi), carriera solista (e già due album all'attivo) per il bravino (ma
non troppo) Albert Hammond Jr., i giochi di
sponda à la Ringo Starr per il Moretti tirato per la
camicia da mille parti che se non altro ha prodotto
due belle collaborazioni a nome Little Joy e Megapuss. E Julian?
Già, mancava lui. Il brandizzante/cristallizzante di
un'esperienza che poteva contare sugli incastri - altezza sophomore - di Valesi-Hammond e che invece buttò alle ortiche pure quelli. In Phrazes for the
Young, Casablancas non farà che avvalorarci la tesi.
Converte elettro-wave il formato rockish della band
cantandoci esattamente come sa e sfornandoci una
tracklist di otto canzoncine nelle quali la maturazione artistica è ferma all'esordio strokesiano. In Out
66
recensioni
Of The Blue parrebbe prendersi di petto Is This It?
e suonarcelo syntetico, magari Blondie-style, ma è
soltanto un miraggio. Lo troviamo intento in scialbe
versioni di vecchi hit con le macchine (Glass), oppure
in ballate autoironiche per salvarsi le chiappe. Rari i
momenti di nota (Tourist), pur con una produzione
di pregio e di carattere (quello che manca a lui).
Dopo il deludente - ma non insufficiente - Paul Banks / Julian Plenti, solista di un'altra band su cui
si era puntato molto (gli Interpol), abbiamo un
esordio senza uscita e la garanzia di un brutto album firmato Strokes per il futuro.(4.5/10)
Edoardo Bridda
K-Conjog - Il nuovo è al passo coi
tempi (Snowdonia, Ottobre 2009)
G enere : electro folk
Fabrizio Somma è K-Conjog. Uno che si prende la
premura di specificare: "nessuno strumento o campione è stato maltrattato durante la realizzazione di
questo disco". Insomma: snowdoniano doc. A partire dal titolo di questo suo album d'esordio: Il nuovo è al passo coi tempi. Che altro aggiungere?
Ah, già: il disco è ottimo, strutturato su intuizioni
semplici ma profonde e ben realizzate.
Il bestiario imbastito a furia di campioni e field recordings in loop diventa tessitura astrusa tra le cui
maglie spuntano ricami melodici minimali ma ficcanti (di piano, chitarra, ukulele...), nella cui ombra
si agitano fantasmi ora blues/jazz ora rumba ora
country-folk oppure mambo, con un fare da slacker
reso cinico dal circolo vizioso della post-modernità,
tuttavia disperatamente incline a trovare conforto
nel potere lenitivo d'una melodia.
Potrebbe passare per il cuginastro scostante dei
Mùm (Distesa), per il guru in incognito delle Cocorosie (Ippopotami), per il nipotino scellerato
della Penguin Cafe Orchestra (Uno stupido)
e forse anche di zio Brian Eno (la bellissima Il
pensiero resta sempre da solo). Sensazioni di leggera
follia, come diceva quel tale. Ma c'è sempre un po'
di ragione nella follia, diceva il tal altro. In ogni caso,
l'importante è stare al passo coi tempi. (7.2/10)
Stefano Solventi
Karen O - Karen O And The Kids
- Where The Wild Things Are
(Interscope Records, Settembre
2009)
G enere : K id ' s P op
Dopo averla vista, insolitamente friendly e simpati-
ca, fare i gesti degli animali nel nuovo video dei Flaming Lips I Can Be A Frog, Karen - Yeah Yeah
Yeahs - O torna a indagare l’infantile siglando la
colonna sonora di Where The Wild Things Are, il
nuovo film di Spike Jonze.
Ad accompagnarla, oltre
ai due YYY Brian Chase
e Nick Zinner, uno stuolo d’hypissimi kid: prezzemolo Bradford Cox
(Deerhunter e Atlas Sound), Dean Fertita
(Queens of the Stone Age,The Dead Weather,
The Raconteurs), Aaron Hemphill (Liars), Greg
Kurstin (The Bird and the Bee), Jack Lawrence
(The Dead Weather,The Raconteurs,The Greenhornes), Oscar Michel (Gris Gris), Imaad Wasif (New Folk Implosion, Alaska) e per ultimo
Tristan Bechet (Services). Poi ci sono i bambini
veri: un coro che senti particolarmente nell'anthem
puberal-punk all'inizio della scaletta, nonché singolo
prescelto per rappresentarla (All Is Love).
La notizia vera però è la bellezza di una tracklist con
protagonista una Karen O maturata e perfettamente a suo agio sia nella pletora di stili rivisti sotto la
lente dei bimbi, sia in ballatone adulte a contrappeso (Worried Shoes, Hidaway). Sui primi ci si aggiudica
già molto del buon giudizio dell'album: folk magico,
lo-fi, indie, tribale, oriente e wave come in un album
di Kimya Dawson, Daniel Johnston (All Is
Love), Pavement, Atlas Sound, Go! Team messi
assieme (e una freschezza che raramente si sente in
esperimenti del genere spesso troppo stucchevoli o
eccessivamente naif). Sulle seconde, interpretazione e afflato sono le chiavi di lettura e non manca
neppure una bella fumata con i freak dell’Arizona
sottoforma di desert-psych, la chicca Animal.
Un gioiello d'album che più ascolti e più sfugge,
come un’infanzia perduta e poi ritrovata e ancora
perduta...(7/10)
Edoardo Bridda
Langhorne Slim - Be Set Free
(Kemado, Ottobre 2009)
G enere : folk rock
Se tra l'album d'esordio e l'omonimo sophomore
passarono quattro lunghi anni, quindici mesi sono
bastati a Langhorne Slim per sfornare il terzo lavoro
lungo. In questo Be Set Free - nel quale la consueta formazione in trio (basso-chitarre-batteria) si
apre al multistrumentista nonché producer Chris
Funk dei Decemberists - il circa trentenne folksinger della Pennsylvania sgombera il terreno dagli
equivoci che ne hanno accompagnato lo sbocciare,
licenziando un programma che poco concede ad
ipotesi "prewar".
Rispetto al rurale invasamento con cui si presentò
al mondo, tutto appare un bel po' addomesticato
in direzione folk-errebì, senza con ciò venir meno
all'entusiasmo, ad un senso di necessità basale. I riferimenti appaiono abbastanza chiari: c'è l'impeto
sanguigno Animals (nell'ipercinetica Cinderella,
nella tesa For A Little While), c'è una ruspante intensità Dylan (in Boots Boy, in Back To The Wild), c'è il
trasporto languido e pettoruto d'un giovane Van
Morrison (I Love You, Goodbye), il cruccio dolciastro
di Cat Stevens (Leaving
My Love) e la lena febbrile
del John Mellencamp
più gioioso (nell'incalzante Say Yes). Ambiti sonori
grattugiati dal muro degli
archetipi, su cui gli archi, il
piano e l'organo proiettano bambage cinematiche
che talora rimandano agli
Eels (come in Sunday By The Sea) e talaltra bazzicano un'epica terrigna tra Springsteen e Arcade
Fire (in Land Of Dreams).
Alla fine però l'entusiasmo finisce strozzato dalla
sensazione che il buon Sean Scolnick da Langhorne
stia piegando la barra verso una carriera soltanto
dignitosa, che lo vedrà buon interprete di buone
ballate (la title track, quella So Glad That I'm Coming
Home che non spiacerebbe a Will Oldham). Lo
credevamo un indemoniato, invece (forse) è un
buon diavolo.(6.8/10)
Stefano Solventi
Lee Everton - Sing a Song for Me
(Rootdown Records, Settembre
2009)
G enere : reggae - folk - blues
L'immagine di copertina sottende ambientazioni
bucoliche dell'ennesimo folksinger di turno che imbraccia la chitarra dopo aver parcheggiato il trattore. Invero Lee Everton, svizzero di Zurigo, ai
pascoli della patria natale ha preferito le spiagge di
Kingston, trasferendosi in Giamaica qualche anno fa
prima di un non meno fondamentale soggiorno a
New York. E lungo queste due direzioni, con una
recensioni
67
highlight
Raveonettes (The) - In And Out Of Control (Fierce Panda UK,
Ottobre 2009)
G enere : noise - pop
Sin dai primi passi, sul capo di Sharin Foo e Sune Rose Wagner pende la spada di Damocle
dei Jesus & Mary Chain spiaccicati contro il muro del suono. Solleticano l’ipotesi di un lp
mai uscito collocabile tra le psicocaramelle e l’affilato glam ‘n’ roll di Automatic (si vedano Bang! e
Break Up Girls!); che, saltato con slancio Darklands, mostra chi comanda ai cloni frattanto venuti al
mondo. Grossomodo, perché l’ascolto attento rivela interessanti sfumature e persuade come, per
conquistarsi il rispetto di Alan Vega e Moe Tucker (altri santini di peso rilevante), qualcosa
devi averlo; idem per non finire come The Kills, inghiottiti da un glamour senza sostanza.
E, già che ci siamo, anche e soprattutto per risultare freschi, riciclando con arguzia quando tratteggi cartoline anni ’50 avvolte in lynchiani stridori (facile immaginare Julee Cruise alle prese
con Oh, I Buried You Today e Wine), quando allestisci un twang modernista per motociclisti intellettuali (Heart Of Stone) e quando cali l’asso Gone Forever (i Ramones di Pet Semetary cosparsi
di lustrini del duemila). Come a dire che il duo guarda indietro spesso e volentieri, eppure creandosi una nicchia personale e sovrapponendo le epoche una sull’altra, ri-creando in laboratorio la nostalgia per tramutarla in sfuggente
“attualità”.
Ecco spiegati i riverberi techno-pop in ricercata bassa fedeltà che non
potevano darsi negli ‘80 e oggi invece sì (D.R.U.G.S., Breaking Into Cars);
ecco quel discettare di suicidi e violenze col sorriso sulle labbra, riproponendo lo scarto tra parole e musica appartenuto ai Phil Spector
e Brian Wilson che presenziano all’ottimamente congegnata Boys
Who Rape (Should All Be Destroyed) e a Suicide, stellare riassunto delle
influenze sin qui nominate. Non geni ma neppure ordinari mestieranti, i Raveonettes. Dei birbanti
dotati di intuizioni di pregio e stile da vendere, casomai, scivolati fuori da un “remake” a cartoni
animati di Velluto Blu.(7.2/10)
Giancarlo Turra
decisa virata verso Detroit per quanto riguarda la
parte americana, si muove Sing a Song for Me,
seconda fatica dopo Inner Exile dell'anno scorso
e nuova miscela di reggae, r'n'b e folk-rock che fa
apparire l'elvetico come un emulo del Ben Harper di Diamonds On The Inside, ma più solare e positivo.
Non c'è difatti un momento di ombra vera e propria in queste undici tracce, e pure quando ciò che
viene raccontato prova a virare verso il piagnisteo
ci pensano hammond e wah-wah gioiosi a tirare su
il morale della truppa. Ma tanta positività è forse
l'unico tratto peculiare di una scrittura indebitata
verso riferimenti precisi ancora tutti da ripagare:
vedasi l'alone Wailers presente un po' ovunque,
lo spirito Van Morrison di Don't make it too hard
e il soffio Marvin Gaye di You've still got a hold on
68
recensioni
me - così come le riletture un po' troppo costrette da Bob Dylan (If not for you) e Tom Waits
(Anywhere I lay my head). Insomma: il nostro sa fare
al meglio e con massima onestà il suo mestiere. Ma
appunto di onesto mestiere si tratta.(6/10)
Luca Barachetti
Lemmings - Lemmings (La grande
onda, Novembre 2009)
G enere : patchanka
Dal punk al surf al rock’nroll allo ska al folk al reggae
al citazionismo a piene mani, questa la miscela proposta dai Lemmings - progetto di Ra-B, autore e
produttore - con l’omonimo e primo album.
Una mescolanza che ripropone essenzialmente l’essenza live del giovane gruppo romano e le sue influenze composite. Una band che fa subito pensare
all’anarchia dei Gogol Bordello, a quella patchanka ingovernabile etno-folk e a corrispondenti progetti italiani passati e presenti, girando anche dalle
parti nostrane di un Vinicio Capossela e dei gloriosi Africa Unite, per fare qualche nome. Uso di
strumenti vintage e un sentore pulp costituiscono
poi l’estetica della band.
Quello che distingue i Lemmings e quest’album
è una certa freschezza compositiva e l’impatto da
“concerto” dei pezzi, che rende l’ascolto godibile.(6.5/10)
Teresa Greco
Lomé - La Ragione (non ce l'ha
nessuno) (L'Eubage, Ottobre 2009)
G enere : funk , jazz , elettronica , musica
d ' autore ...
Hanno un curriculum lungo un chilometro i Lomé
da Biella, tra studi accademici sulla voce e il pianoforte, il contrabbasso e la batteria. Con in più un
disco d'esordio alle spalle (Fiori su Marte) e una partecipazione al doppio CD Bruno Lauzi e il Club Tenco. Tutto in linea con un percorso istituzionale che
ovviamente trova la sua massima espressione nella
musica del gruppo, anch'essa impeccabile, pulita, tradizionalmente sperimentale, tecnicamente ineccepibile. Un coacervo di funk, jazz, elettronica, musica
d'autore, progressive, rock - si, c'è tutta questa roba
dentro a La Ragione (non ce l'ha nessuno) - che mette
in mostra un bagaglio tecnico da far paura pur suonando, allo stesso tempo, piuttosto sterile. A meno
che non siate affezionati cultori del Conservatorio
e delle sue politiche, non abbiate bisogno di un modello per verificare i vostri progressi nello studio
dell'armonia o non siate tra i tanti che pensano ancora che per fare buona musica si debba per forza
“smanettare” il più possibile sullo strumento.
Fa specie che uno dei migliori episodi del disco sia
una Anche gli scheletri possono salvarsi teatrale e visionaria (alla maniera degli Avion Travel, per intenderci) ma non a caso grammaticalmente poco
affascinante. Come fanno riflettere i continui rimandi alla tecnica (vocale, pianistica) che si leggono sul
MySpace del gruppo e su cui si potrebbe essere anche essere d'accordo, se fossero accompagnati da
contenuti di valore (Quintorigo docet).
Il fatto è che in questo senso La ragione (non ce l'ha
nessuno) non soddisfa le richieste, pur non potendosi definire in assoluto un brutto disco. Lo specchio
di un modo di intendere la musica che fatica a stimolare qualsiasi tipo di reazione, pero', si.(6/10)
Fabrizio Zampighi
Lymbyc Systym - Shutter Release
(Mush Records, Novembre 2009)
G enere : post rock
Che tiri aria di revival del post-rock, a dieci anni
circa da che esso entrò nella maturità? Forse, ma in
considerazione di un’attualità dove tutto si accavalla
incurante della ciclicità di tempi e mode, saremmo
più propensi a parlare di una corrente mai esauritasi, che casomai ha preso a scorrere sottotraccia
allorché i riflettori si volgevano altrove. Lo provano quelle nuove generazioni che, mentre i maestri
del genere si scioglievano o dilatavano cronologicamente le uscite, hanno cercato di raccogliere il
testimone.
Tra i tanti vi sono i Lymbyc Systym dei fratelli Jared e Michael Bell, partiti nel 2001 da Tempe,
Arizona, per collezionare un discreto curriculum di
un album debitamente edito anche in versione remix e due mini, più svariati tour con Broken Social Scene, Books e Album Leaf. Scordatevi
però contaminazioni “folktroniche” e grandeur pop,
giacché il risultato rimanda smaccatamente - per
tramite dell’ultimo nome succitato - ai Tortoise
di TNT, quelli sì a tratti manierati ma ciò nonostante
ancora capaci di convincere.
Il duo, prodotto e si sente da “prezzemolo” John
Congleton, maneggia disinvolto i fondamentali e
non si fa mancare nulla di quanto ti aspetti: elettronica integrata a sonorità organiche e ritmica vigorosa; slanci in transito dall’ambientale al grandioso;
accorti riferimenti al kraut, a certa new wave e al
prog meno sbrodolone; un rintanarsi in sospensioni
intimiste che offre la cosa migliore della scorrevole
scaletta, la delicata Late Night Classic. Studenti diligenti seppur privi di personalità, i ragazzi, in ciò perfetti figli di quest’epoca ipertrofica.(6.6/10)
Giancarlo Turra
Madlib - The Last Electro-Acoustic
Space Jazz & Percussion Ensemble
- Fall Suite (Stones Throw,
Settembre 2009)
G enere : funk - l atin - lounge
La seconda delle ambiziose suite stagionali di Madlib arriva puntuale a fine settembre. Siamo qualche gradino sotto la prima (che era ottima), per freschezza dell'ispirazione e generosità dei momenti
musicali, con più vuoti, più ripetizioni (e autoricicli)
e qualche passaggio fuori fuoco. Se di solito la tecrecensioni
69
nica artigianale di Madlib come strumentista diventa
valore aggiunto, qui risulta a tratti un po' d'impaccio.
Restano i soliti ottimi spunti latin-jazz e funk da colonna sonora. Quaranta minuti di lounge rilassata e
imperfetta innervata di effetti atmosferici che sembrano presi da Eskimo dei Residents, con una
chitarrina dalle timide evoluzioni quasi-prog che,
forse per la prima volta, fa capolino verso la fine. Da
uno come lui però ci si aspetta molto di più. Cd e
digital download, con la prospettiva probabile di un
box di vinile a progetto completato.(6.3/10)
Gabriele Marino
Madlove - White With Foam (Ipecac
Recordings, Settembre 2009)
G enere : M ainstream rock revisited
Se dicessimo che questa band è in realtà un progetto di Trevor Dunn, sarebbero in molti a sgranare
gli occhi dalla sorpresa. Trevor chi?? Gli basterebbe
sapere che dietro questo nome si cela il co-fondatore, insieme a Mike Patton, di Mr. Bungle e
Fantomas, per far loro aumentare le attese, senza
tuttavia riuscire ad arginarne la sorpresa al momento dell’ascolto.
Cosa c’entra l’estremismo eclettico dei Mr.Bungle
e il metal cut-up dei Fantomas, con questa band
di pop rock senza grandi pretese? Niente. O, più
semplicemente, è la riprova della smania creativa
di Dunn, che, dopo le esplorazioni jazzistiche del
Trio Convulsant, ritorna al rock per la porta più
grande, quella del mainstream. A parte l’origine “colta” del nome della band
(che sarebbe la traduzione inglese de L’Amour
Fou, opera del surrealista
francese Andrè Breton) i punti di partenza di Dunn sono molto
più “volgari”: Blondie,
Cheap Trick, Pretenders. Il pop-rock anni’80 all’americana, insomma, filtrato dall’irriverente imprevedibilità dei primi
Faith No More.
Rintanato nel suo abituale ruolo di bassista, Trevor
Dunn lascia la scena alla coreana Sunny Kim, cantante la cui voce sensuale e ricca di armonici fa pensare
a uno strano incrocio tra Joni Mitchell e Sade
. Ma la mano creativa è tutta dell’ex Mr. Bungle. E si
sente. Ad un primo ascolto, il disco da l’impressione di non avere alcunché di interessante. Ma basta
poco a rendersi conto che la vacuità di canzoncine
70
recensioni
di buona fattura (Rats With Wings; As Sad As It Was Beautiful; Thread), rappresenta solo un divertissement
di buon mestiere, bilanciato da episodi più intensi
e “progressivi” come Knowing e la schizofrenica All
The Nerve Endings.
Un album di buon rock senza aggettivi, conciso e
diretto, che sfida la banalità di certo mainstream,
provocandola con soluzioni mai troppo prevedibili.
Peccato solo che i Faith No More un tentativo del
genere, anche meglio riuscito, lo avevano già fatto
quasi trent’anni fa. Mammamia come passa il tempo!(6.6/10)
Daniele Follero
Magda - Fabric 49 (Fabric,
Novembre 2009)
G enere : minimal cinematica
L'avevamo già sentita nel 2006 nell'affollatissimo mix
d'esordio She's A Dancing Machine. L'avevamo vista
sui palchi di molti festival e dancefloor. Oggi la lady
della minimal torna sull'olimpo del Fabric adattando
la bandiera inglese ai colori della Minus. E dunque
eccoti gli amici: Gaiser, Marc Houle ed Heartthrob, i remix della ragazza, e il gotha del ritmo
indie di Circlesquare e Pronsato.
A colpire è l'aspetto cinematico di spezzoni degli
italianissimi Goblin (super disco horror '70 tagliato minimal), oppure gli spigoli di Berlino affusolati da Simonetti & Co. Visione e intelligenza per
Mag.(7.2/10)
Marco Braggion
Mark Eitzel - Klamath (Decor,
Settembre 2009)
G enere : elettro - folk
Non si capisce per quale motivo un musicista dotato come Mark Eitzel continui a baloccarsi con dischi
inconsistenti come Klamath. Per di più pubblicati a
suo nome, il che certo non giova alla reputazione di
songwriter di razza che lo accompagna fin dai tempi
degli American Music Club. Insomma, cosa avrà di
così fascinoso l'elettro-folk generalista e evanescente filtrato da una voce che è tutto un sussurro - o
un mono tono, fate voi - di brani come Buried Treasure o I Know There's Someone Waiting? La risposta è
“nulla”. Tanto che lo sbadiglio è dietro l'angolo e lì
rimane per tutta la durata del programma.
Rispetto al precedente Candy Ass ci si sposta verso
la parte acustica del binomio, tra gli arpeggi di Why
I'm Bullshit e le eteree pianure di Remember, ma i
risultati sono tutt'altro che convincenti: mestiere e
nemmeno un oncia di personalità a cui aggrapparsi.
In un'opera che confonde l'arte col lavoro impiegatizio, spingendo a tal punto sul pedale dei chiaroscuri da farci chiudere gli occhi sul serio.(5/10)
Fabrizio Zampighi
Marta Collica - About Anything
(Desvelos, Novembre 2009)
G enere : folk rock psych
Il mio problema con questo About Anything,
secondo lavoro per la catanese trapiantata a Berlino Marta Collica, è che non riesco ad ascoltarlo
senza pormi domande. Ad esempio, mi chiedo se il
ricorso ad un sound scarno, intimo, minimale anzi
frugale - la maggior parte delle incisioni è avvenuta
sul 4 piste casalingo della Collica - obbedisca ad un
precisa scelta poetico/formale, affine alla sensibilità
dell'autrice, o non si tratti piuttosto di una specie
di fuga autarchica dalle iperproduzioni formattate,
una dimostrazione di languida e fiera insofferenza.
O ancora d'una sorta di sfida estetica a se stessa, un
misurarsi con la capacità di creare incantesimi con
poche cose, giusto quello che indossi vivendo.
Più probabilmente, è una mischia di tutto ciò, come
mi sembra ribadire il contributo degli amici Hugo
Race (chitarra in Number08925) e soprattutto
John Parish (nella cui casa-studio di Bristol Marta
si è recata per incidere alcuni brani), la cui presenza sembra quasi una certificazione d'appartenenza
al versante schivo di certo rock d'autore, dove le
meraviglie accadono senza clamore. Parish è oltretutto il trait d'union con quella Goldfrapp alle cui
malie riconducono le mesmeriche suggestioni di
Lessons And Games e della strumentale Where Was I,
pervase d'un senso di frusta psichedelia che altrove
s'accascia blasé (Just Water Just Air) e poi va a struggersi come una rumba ombrosa tra Howe Gelb e
Francoise Hardy (Future #1). Rimandi fin troppo
evidenti, al punto che sospetti facciano parte di una
strategia di maschere, un enigmatico gioco di ruolo.
Ancora domande, dunque.
Ma forse il problema vero è la scrittura, che mi sembra un passo indietro rispetto all'intuizione sonora,
alla voglia di cucire loro addosso quell'aria da interno berlinese. Non starei a pormi tutte queste
domande se Marta azzeccasse sempre gioielli come
Never Look Back, una roba tipo dei Portishead
lo-fi conditi di fragranza obliqua Lisa Germano.
Inoltre, a forza di pedinare l'aura Velvet Underground & Nico, finisce che in Giulia l'imitatio
Femme Fatale si fa quasi imbarazzante. è un disco
insomma che ribadisce il peso specifico di Marta
Collica, ma non le fa compiere il balzo che mi attendevo. Ci sono fantasmi di cui si deve liberare,
ammesso che lo desideri.
(6.4/10)
Stefano Solventi
Mary Onettes (The) - Islands
(Labrador, Novembre 2009)
G enere : crap pop
Storia travagliata, quella dei The Mary Onettes, svedesi di Jönköping in circolazione dagli albori del decennio. Formatisi sul comune interesse per il suono
britannico degli Ottanta e Novanta, hanno visto
alternarsi numerosi membri attorno al leader - e
produttore, e responsabile della scrittura - Philip
Ekström. Servivano però ben quattro anni per ottenere un contratto discografico, stracciato dopo
sei mesi senza pubblicare alcunché.
Interveniva poi addirittura la Sony/BMG, dando alle
stampe un e.p. che non andava da nessuna parte, cosicché i ragazzi restavano nuovamente a piedi, salvo
decidere infine di autoprodursi. Un demo planava
negli uffici della connazionale Labrador e nell’aprile
2006 il debutto era cosa fatta. Questo per la gioia di
Pitchfork e degli sceneggiatori di Grey's Anatomy che
ne prelevavano la bellezza di due brani.
Che dite? Che non sono attestati di stima bastanti?
Che nemmeno in Svezia
tutte le ciambelle escono
col buco? Esatto: non ce
ne vogliano i Mary Onettes, ma dell’anello mancante tra A-Ha e ultimi
Killers non sentivamo
il bisogno. Quando va di
lusso, si ha di fronte la versione ipoglicemica - un
pop epico strangolato da arrangiamenti elettronici
d’impatto orchestrale - dei Railway Children.
Chi? Ecco, appunto. Una volta tanto, le case discografiche avevano visto giusto.(3/10)
Giancarlo Turra
Melvins - Chicken Switch (Ipecac
Recordings, Settembre 2009)
G enere : N oise
Chicken Switch tenta la carta del remix album stravagante come piace agli elettronici noise. Buzzo e
Crover hanno chiesto ai loro mille amici musicisti
di scavare nel repertorio, di pescare una traccia sola
da ciascun album, naturalmente remissarla e, giurecensioni
71
sto per confondere un po' le acque, chiamarla in
un altro modo e riconsegnargliela. Fin qui niente di
così strano ma fate caso ai nomi coinvolti che per
primi saltano all'occhio: John Duncan, Merzbow, Yamatsuka Eye. Accade che ti ritrovi una
melma di tracce puzzolenti da far friggere le sinapsi che hanno scarsi (o assenti) riferimenti rispetto
ai brani originali. Tra i vip presenti allo scempio, gli
ottimi Matmos: in Linkshänder si cimenteranno in
un minimalismo metal cosmico con tanti saluti agli
Hawkwind. Deludente invece Lee Renaldo nella
trilogia EggNog Trilogy: I) She's Ivanhoe, II) Cancer, III)
Inebriated, un pastiche ultra punk senza scossoni.
In buona sostanza: la solita compila griffata con i
suoi tratti inevitabilmente gratuiti da prendere un
po' con il taglio del noiser radical chic oltre l'ortodossia delle cassettine. E rimarrei con le cassettine.
Più fascinose.(6.4/10)
Edoardo Bridda
Mew - No More Stories / Are Told
Today / I'm Sorry / They Washed
Away // No More Stories / The
World Is Grey / I'm Tired / Let's
Wash Away (Columbia Records,
Ottobre 2009)
G enere : art rock
Beach, credeteci, è il singolo perfetto in un mondo
migliore. Tre-minuti-tre di passione. Non un secondo fuori posto. Nessun calo di tensione. E l'album
incredibilmente raddoppia in un campo quale il neoprogressive declinato europop.
Debuttanti sul mercato con sotto il culo una major
e uno dei titoli più lunghi della storia, i danesi stanno
sulla scia dei Menomena e paiono dei Phoenix
cresciuti a pane e Yes. Un ballad come Silas The
Magic Car traccia sentieri post emo, laddove potevano gli smarriti Sunny Day Real Eatate di The
Rising Tide se solo avessero voluto. Cartoons And Macrame Wounds, ancora prossima ai SDRE, concede
una coda degna dei Supertramp: falsetti e striduli
per un finale che sa di eroico e kitsch insieme. Hawaii poi, esagerato pop esotico dal refrain infallibile,
è il vertice più alto: umori epici in fattezze Yeasayer ai massimi livelli.
Di prog sovvengono certe dinamiche sbieche (la ritmica di Introducing Palace Players) o la struttura di
talune sortite (vedi New Terrain), ma la vera sorpresa
è prendere atto che l’idilliaca Reprise (come i migliori Sigur-Rós, solo meno pachidermici) e Tricks
(synth pop sulla scia degli ultimi Radio Dept.) sia72
recensioni
no farina della stessa banda. Si chiama estro.
E loro si chiamano Mew. E sono una stella.(7.5/10)
Gianni Avella
Misero spettacolo L'inconcepibile (Zeta Factory,
Settembre 2009)
G enere : folk - rock - popol are
Non si capisce se il percorso intrapreso dai Misero
spettacolo con L'inconcepibile sia indirizzato verso
una canzone d'autore con inflessioni etniche (le cadenze cubane di 78 mesi) o dalle parti di un Ligabue autore di ballate (Il Ponte dei Sospiri), tra le
braccia un rock dozzinale
(Delitto e castigo) o su un
palco sanremese (Il gioco
delle parti), vicino a certa elettronica ad ampio
spettro (La maculata di
Laura) o nei paraggi di un
folk à la Modena City
Ramblers (La druda e il
soldato). Ciò che è certo è che le pretese sono molte - più di un'ora di musica per quindici tracce totali,
tra cui una “Trilogia del mare in tre atti” - e la carne
al fuoco troppa, senza che alla quantità si affianchi
una qualità altrettanto evidente.
Dovessimo valutare un disco dalle capacità di chi
suona vi diremmo forse che la band bolognese si
impegna e non poco per dare di sé un'immagine
artisticamente consona, riuscendo pure a far funzionare qualcosa. Il problema è che le variabili fondamentali per la buona riuscita di un prodotto musicale coinvolgono concetti come la personalità, il
carattere, l'originalità e non il gesto tecnico, tanto
più in un mercato discografico abnorme come quello in cui ci troviamo ad operare.
Tutte cose che fatichiamo a cogliere in un'opera che
suona “stanca” fin dalla copertina.(5/10)
Fabrizio Zampighi
Mission Of Burma - The Sound the
Speed the Light (Matador, Ottobre
2009)
G enere : old school wave
Ciò che continua a lasciare stupiti e ammirati nei
Mission Of Burma è la solidità con la quale si riaffacciarono sulle scene un lustro fa. Li guida un atteggiamento riservato e attento alla sostanza e, molto
probabilmente, il loro segreto sta in buona parte
lì: nel sempiterno interesse ad aprire il rubinetto
e lasciar scorrere le idee, nella voglia di coniugare
senza sforzo impeto e cervello, nel convincere che
intellettualismo e muscolarità possono convivere
felicemente. Poiché non devono dimostrare nulla a
nessuno, una miscela di distacco e partecipazione gli
consente ogni volta di uscirsene con qualcosa che è
familiare e nondimeno possiede contorni cangianti.
Se dunque lo splendido The Obliterati tre anni or
sono poggiava sulla varietà delle angolazioni e
OnOffOn restituiva nel 2004 uno stile senza rughe,
questo terzo atto rinforza - e al contempo ritocca
in modo sottile - l’Arte dei signori Miller, Prescott e Conley. Sempre aiutati dal prezioso Bob
Weston in cabina di regia e alla manipolazione di
nastri, i bostoniani guardano indietro e pure avanti
allestendo una suite in quattro parti, dove i brani
scorrono uno dentro all’altro senza soluzione di
continuità tra schiumare di ritmiche, chitarre qui
rovinose e là contorte e favolose melodie a lento
rilascio. Ci sentirete gli Hüsker Dü - loro coetanei - maturi e struggenti (After The Rain, Good Cheer),
ipotesi di Jam (So Fuck It) e Joy Division nati
sull’altra sponda dell’Atlantico (Blunder); al di là di
ogni paragone, apprezzerete l’aggressività innodica
del punk corretta dallo spirito avventuroso del suo
“post”, soprattutto nell’articolata Ssl 83, in una One
Day We Will Live There che brutalizza Bo Diddley e
nei cadenzati capolavori Slow Faucet e Feed.
E, mi raccomando, niente tiritere sui dischi/gruppi
“di una volta”, ché questa è musica attuale come pochissime altre. Per un (impietoso) confronto, vi basterà mettete queste dodici tracce accanto a Franz
Ferdinand, Interpol e anemica compagnia. Li
scioglieranno come il sole con la neve.(7.5/10)
Giancarlo Turra
Modeselektor - Body Language Vol.
8 (Get Physical, Settembre 2009)
G enere : compil ation minimal techno deep step
Li avevamo lasciati nelle nebbie del minimal romanticismo di Apparat con il progetto (e disco annesso) Moderat: Gernot Bronsert e Sebastian
Szary i nomi dietro al discorso Modeselektor. Si
godono il momento di popolarità e ritornano alla
dura arte del mix. Spaccano qui con una compila fatta di certezze per il dancefloor (Felix Da Housecat, Robert Hood), ma anche con qualche
minuto lasciato ai dubsteppers (Rustie, Benga,
Scuba), ai fidgettari (Boys Noize, Major Lazer) o stranamente alle melodie del pop (Missy El-
liott, Busta Rhymes).
Il giro di boa che sorpassa l’(ormai dubbio) incasellamento berlinese e che sfora nelle soleggiate praterie del ritmo tout court. C’è sempre una buona
dose di deepness (vedi la space trance di Huyendo
Pt. 2), ma l’impressione che si ha dopo un’ora di beats è di essere di fronte a un’ottima selecta che non
si sbilancia su nessuna corrente in particolare e che
sposa l’eterogeneità senza strafare. In più c’è anche
la sapiente arte del mix che contribuisce con dei
passaggi da urlo (vedi l’apertura per il pezzo degli
Animal Collective, il passaggio fra Lick Shots/The
Count/Cricket Scores o il finalone con l'autocelebrativa A New Error) alla riuscita di uno dei migliori mix
dell’anno. Ben fatto ragazzi.(7.3/10)
Marco Braggion
Moon Duo - Killing Time EP (Sacred
Bones, Ottobre 2009)
G enere : K raut W ave
Dopo il primo, autoprodotto singolo su 12 pollici,
presto esaurito e prontamente ristampato, il progetto (semi)solista di Ripley Johnson dei Wooden Shjips raddoppia e lo fa, questa volta, per la
label più attiva nella rinascita delle sonorità wave in
quel di New York, ovvero Sacred Bones; e l'accostamento al roster di Caleb Braaten sembra indurre
effetti congeniti, benché probabilmente involontari,
sulla natura dei pezzi rilasciati con questo EP. Se infatti il primo Love On The Sea si era caratterizzato per due lunghe jam dal sapore spiccatamente
kraut rock, questo nuovo Killing Time si sporca
maggiormente di quei riverberi che da due anni a
questa parte abbiamo imparato a riconoscere come
il marchio di fabbrica delle ossa sacre.
Così i (quattro) pezzi si fanno più brevi e al contempo meno ossessivi e più ambientali, più narcolettici
e sfuocati, con la voce di Johnson a citare in più
di un passaggio il celebre cyber-crooning di Alan
Vega; e se il compito di un EP è quello di fornire un
assaggio e nel contempo di invogliare l'ascoltatore
a chiedere di più, beh, non c'è che dire: bersaglio
centrato.(7/10)
Andrea Napoli
Mr. Henry - Ornery (Terra
Desolata, Giugno 2009)
G enere : folk post - apocalittico
L'eredità Tom Waits non in carta-carbone ma
riplasmata su una poetica urgente, che cattura le fitte dell'istantaneità e le rimescola con ululati Mark
recensioni
73
Lanegan, barcollamenti Violent Femmes,
abrasioni di vario genere. Questo nei primi due dischi - soprattutto il secondo, splendido, da avere - di
Enrico Mangione alias Mr. Henry da Varese, folksinger che fa dell'autarchia una reazione-denuncia al
desolato stato delle cose e scrive, produce, pubblica
con una sua etichetta (La Terra Desolata, appunto)
questo Ornery. Lavoro che butta per aria le influenze precedente e riutilizza quelle che cadendo
si sono rotte di più. Molto meno Waits dunque, e
molti più scompaginamenti in zona Captain Beefheart uniti a larghe dosi di povera elettronica industrial trattata con piglio da artigiano e tante idee,
si prendano ad esempio il beat scuro e siderale dei
primi Nine Inch Nails in Sols Icker, le asperità da
ciclo produttivo tipo Throbbing Gristle in Fre
Imef Dedei, ma anche i delay intercostali nella ballad
spezzagambe Ber Naut.
Henry racconta, con le poche macchine sopravvissute e un'elettrica da maltrattare, cosa è rimasto
dopo l'esplosione che ha raso al suolo tutto: non le
parole (i testi sono lessico sonoro a cui attribuire
un senso), non le canzoni come la conosciamo oggi,
ma il vuoto e la solitudine - che da condizione necessaria diviene rigenerante - di bozzetti non finiti
da registrare all'istante e sotterrare a terra per chi
verrà poi, come testimonianza e monito. Un disco
piccolo capolavoro di cui ci si sarebbe dovuti accorgere prima.(7.5/10)
Luca Barachetti
N.A.M.B. - Bman (Monotreme,
Novembre 2009)
G enere : electro - rock
Il secondo disco del combo torinese vive di eclettismo electro-rock spinto e elefantiasi dell'esistente.
Quelle del quartetto sono musiche incostanti tanto quanto è variabile il loro umore e il significato
dell’acronimo che si scelsero ormai un buon lustro fa. Diciamo che di base hanno come referente
potenza ed eterogeneità alla Nine Inch Nails /
Faith No More, depurati però della verve schizoide della band di Patton e della monolitica presenza ieratica di Reznor, ma con in più una particolare predilezione per la totale mancanza di misura
e paletti.
Bman inanella in un concept sulle avventure del
robottino Bman musiche che dire varie è poco,
tanto si ondeggia nei 18 pezzi tra elettronica spinta, industrial-sound, psichedelia liofilizzata e rock
sui generis. Prendete Radiorace: va come un treno,
74
recensioni
ma sotto c’è quel ritornello yeyè che non sai se ti
stanno prendendo per il culo o no. Eppure funziona
eccome. O il superfunkettone di derivazione industriale di TV Invasion che, non c’entra un granché,
ma ricorda i primigeni Bluevertigo, con quell’alternanza tra alto e basso, serio e faceto. O ancora
l’industrial in modalità sci-fi di Running, le (in)quiete
evanescenze di L.O.N., le psichedelia liquide di Bye
Bye Sides, il reminder radioheadiano di Work It Out.
Troppa carne al fuoco, direte voi. E purtroppo sì.
Perché il problema di fondo è riuscire a mantenere
la stessa ispirazione per i 70 lunghi minuti dell’album. Cosa piuttosto difficile e che in Bman spesso
si fa notare.(6.2/10)
Stefano Pifferi
Natural Snow Buildings - Shadow
Kingdom (Blackest Rainbow,
Ottobre 2009)
G enere : drone folk
Si riaffacciano al grande pubblico i Natural Snow
Buildins. Detto che la grandeur del duo transalpino si manifesta come sempre sia nella durata delle
proprio pubblicazioni, quanto nelle tirature limitate
all’inverosimile, questo 2009 ha registrato una vera
e propria messe di lavori dal taglio underground che
non hanno fatto altro che preparare il terreno per
questo doppio cd ovvero triplo Lp edito dalla britannica Blackest Rainbow.
Quindi ad inizio 2009 assistiamo alla pubblicazione di un incredibile boxset di appena 150 copie e
composto da 5 cassette, chiamato Daughter Of
Darkness che si completa con una sesta cassetta
pubblicata dalla casalinga etichetta di Ben Nash,
chiamata Recollection Of Knulp. Più tardi Mehdi Ameziane pubblica un nuovo lavoro di Twinsistermoon su Dull Knife, intitolato The Hollow
Mountain e anticipato da un 45giri con annesso
book fotografico di Alison Scarpulla, con tirature
come al solito micro. Solange di contro le batte tutte e pubblica in appena sei copie (salvo poi editarne
una second edition di dieci) una cassetta con articolatissimo artwork intitolato Journey Of the Seven
Stars.
Un riassunto veloce per dire del momento in cui
viene ad essere pubblicato Shadow Kingdom,
lavoro destinato ad un pubblico vasto, a partire dalle dimensioni della tiratura cd. Quello dei Natural
Snow Buildings è un mondo dentro cui perdersi per
ritrovarsi. La malia delle composizioni s’è fatta ancora più spregiudicata e questo lavoro abbonda in
highlight
The calorifer is very hot! - Evolution On Stand-by (We Were Never
Being Boring Collective, Novembre 2009)
G enere : elettro - fok - pop
Lo aspettavamo al varco il “calorifero”. Lui, rielaboratore di linguaggi, drogato di cut up, elettronico solo per rimorchiare, ma capace di buttarti tra capo e collo un pop centrifugato e irresistibile.
Con un Marzipan In Zurich che un anno fa scricchiolava lo-fi e inanellava sussulti di un'orecchiabilità sopraffina. Con un nuovo Evolution On Stand-by persino superiore all'esordio, consapevole
com'è di ciò che serve a una formula musicale come quella di Nicola Donà, Nazareno Realdini e Samuele Palazzi per non cadere nel tranello del “doppione”. Nello specifico, un'insana
follia, figlia di una mancata evoluzione. In altre parole, allargare ancora di più gli orizzonti fino a
toccare l'Hank Williams ritardato di Lester, il Jonathan Richman in chiave Libertines di Me, You And Hugh o magari i Kinks
abbozzati di Get Up Mr. Peace.
Tanto che verrebbe da chiedersi quale sia il segreto di quel suono così
schizofrenico e al tempo stesso credibile nascosto sotto gli Strokes
da Commodore 64 di My Dressing Room, nella musica da camera e le
chitarre acustiche scassate di Dying Bursting Out o in quel sommare
incasinato di note e coretti della title-track. Probabilmente la coscienziosa certezza di essere si intagliatori di synth-beat-folk-pop polverizzato, ma anche gente che ha bisogno di realizzare: significati, parabole, sotto forma di canzoni.
Della serie si gioca, ci si diverte, ma alla fine i conti devono tornare.
C'è un fascino outroad ma al tempo stesso razionale nei brani, ci sono incursioni stilistiche azzardate, c'è l'estrema mutevolezza delle geometrie filtrata da una creatività riconoscibile: e se
Evolution On Stand-by fosse il White Album del gruppo?(7.5/10)
Fabrizio Zampighi
quello dove i due riescono meglio: ovvero gettarsi
senza paura nei turbinii più sfrenati del drone folk.
Dopo gli esperimenti solisti che avevano influito pesantemente anche sul precedente doppio The Snowbringer Cult, questo nuovo lavoro segna un parziale
ritorno alle origini, quelle più vere dei due, quando
all'inizio tentavano di trovare una propria coloritura alle risacche del post rock. Ergo di tutti i loro
precedenti lavori, Shadow Kingdom riporta alla
mente proprio i primi: The Winter Ray, Ghost
Folks e parzialmente Dance Of The Moon
and the Sun.
L'iniziale The Fall Of Shadow Kingdom dice subito del
taglio dato al disco, con 24 minuti di cavalcate nelle
terre del drone folk più selvaggio. Il taglio thrillerhorror dato dai due a molte delle loro composizioni qui trova il suo apice con Os Deus Cannibais, che
ha cadenze quasi Goblin e il trittico The Desolated/
Vampires Introduced To Fear/Slayer March. Non mancano gli innesti british folk nello stile di Twinsistermoon e i paradisi più eligiaci e celestiali con le planate stellari di Cauled Ones And Birth Rugs e Chthonian
Odyssey/Hell's Foundations/A Birth Mark Like A Scar. In
pratica un altro capolavoro dei Natural Snow Buildings ma destinato esclusivamente a quelli che non
si spaventano di fronte alla magniloquenza, ai kilometri e alle durate importanti. Come premio per i
più perseveranti non soltanto un pieno di grande
musica, ma anche un fumetto splatter su vampiri e
mostri a firma di Solange. Imperdibile.(8/10)
Antonello Comunale
Neon Indian - Psychic Chasms
(Lefse, Ottobre 2009)
G enere : ' omly E ighties
Se vi ricordate di Ariel Pink e di quel mostruoso
recensioni
75
caleidoscopio di musica che ha creato, è possibile
che vi venga un piccolo groppo in gola al solo pensiero di tanta spaventosa glassa pop autosabotata e
mandata direttamente al candeggio della memoria.
Eppure, una volta sentita e soprattutto interpretata,
quella lezione non si dimentica perché non è soltanto una strategia lo-fi, ma un autentico portale. E se
c'è gente che tra droghine fatte più o meno in casa
e frittura di neuroni davanti alle consolle è finita a
fare la solita tiritera del dopo Dinosaur Jr, vedi
Wavves, qualcun altro, più nerd e casalingo, ci si
è tuffato in quel varco spazio temporale ed è finito
dal Texas direttamente dietro le quinte di qualche
scadente videoclip inglese degli anni '80. è il caso di Alan Palomo per il quale David Keenan (The Wire) cerca
di affibbiare l'ennesimo
tag. Ipno pop e la definizione ci piace come
pure gli amici del Neon
indiano che si chiamano
Washed Out, Memory Tapes, Teengirl Fantasy, Nite
Jewel. Tutti più o meno
intepretanti il dogma pinkiano, o perlomeno sedanti la prescrizione perché se da un lato Haunted
Graffitti affresca una parete mettendoci dal folk
a Madonna, i ragazzi sono totalmente flippati negli Ottanta e salvo qualche incursione sbadata nel
Kraut, la loro cup of tea ha dentro le elettroniche
da mercatino di Daft Punk e AIR.
Del resto, remando in coerenza, non si finisce tanto lontani dallo psych-caramello di Ducktails e
compagnia sintetica. Il distinguo però è ancora una
volta pop, polpa di una faccenda fatta di canzoncine
scialacquate, remember a palla e colori per forza technicolor quelli dei vecchi Nordmende. Affascinante Alan, pure nelle track dove imbraccia la chitarra; e attenzione ai paragoni con i protagonisti di
Investigate Witch Cults Of The Radio Age? o gente di
città come Bibio. Questo è l'underground di gente
come Girls. Di una generazione diversa.(7.2/10)
Edoardo Bridda
Nikki Sudden/Phil Shoenfelt
- Golden Vanity (Easy Action,
Ottobre 2009)
G enere : rock
Esce solo ora questo lost album registrato a Berlino
da Nikki Sudden nel 1998 e frutto della collabo76
recensioni
razione con il songwriter inglese Phil Shoenfelt.
Scomparso nel 2006, il cult hero Sudden rappresentava la figura del rock’n’ roller la cui carriera,
con Swell Maps e Jacobites, oscillava intorno ai
classici Bob Dylan, Neil Young, Rolling Stones e Marc Bolan e a un percorso scomposto
ma genuino.
In Golden Vanity la vena più anarchica del Nostro viene disciplinata in un certo modo dal connazionale Shoenfelt, e incanalata in un rock anche
psych e dai toni prettamente glam. Non mancano gli
omaggi agli amati T-Rex (Bang a Gong) e in generale a tutta la musica preferita da Nikki, in una sintesi
cristallina che avremmo ritrovato in parte anche nel
postumo The Truth Doesn't Matter (2006),
l’ultimo album al quale aveva lavorato prima di morire.
Una testimonianza che riporta indietro e rinnova il
ricordo di Sudden.(7.2/10)
Teresa Greco
Orenda Fink/O + S - O + S (Saddle
Creek, Ottobre 2009)
G enere : dream pop
Fa capo a Orenda Fink (Azure Ray, Art In
Manila) e The Scalpelist alias Cedric LeMoyne
(Remy Zero) il progetto O + S, che con l’omonimo album combina un dream pop di marca 4AD
(Cocteau Twins essenzialmente) con echi di
soundtrack David Lynch-Angelo Badalamenti e un pop cinematico in parte proveniente
dalle rispettive band di origine, in parte di derivazione pop Settanta (10 cc e affini) e chanson francese
dei Sessanta.
Album piuttosto impalpabile che ogni tanto si fa
ritmico, giocando essenzialmente sul contrasto tra
voce e loop sonori, mentre per la maggior parte
resta etereo, alla ricerca di atmosfere e sensazioni.
Pare che il duo sia destinato a proseguire, mentre in
parallelo la Fink prosegue la carriera solista (Ask
The Night, 2009), di cui diremo altrove. Per ora
questo resta un tentativo forse non ancora messo
completamente a fuoco ma con qualche potenzialità.(6.5/10)
Teresa Greco
Orenda Fink - Ask The Night (Saddle
Creek, Ottobre 2009)
G enere : folk
Secondo album solo dopo il debutto del 2005 (Invisible Ones) e il parallelo progetto O + S di
cui diciamo altrove, per la Azure Ray e Art In
Manila Orenda Fink. Dopo le esplorazioni in India, Cambogia e Haiti che si riflettevano anche sulla
produzione musicale precedente, ora la Fink ritorna
con Ask The Night alle sue radici del sud; ecco
che le ispirazioni primarie si rivolgono al folk tradizionale e alla letteratura gotica americana, risultando nei contenuti un mix rielaborato di esperienze
personali e non.
Si va dal country (Alabama) e bluegrass (High
Ground) al folk (The Garden), dalla ballad al valzer
(Sister), tra malinconie e dolenze, tutto in chiave
piuttosto tradizionale, anche se rivisto, ma non c’è
traccia di alt- qui.
Nel complesso c’è da dire che l’insieme manca di
personalità, di quel guizzo che fa di una rielaborazione una interiorizzazione, rimanendo piuttosto
piatto.(6/10)
Teresa Greco
Panther - Entropy (Kill Rock Stars,
Settembre 2009)
G enere : P op -F unk
Come disilludere le attese. Quello che avevano prospettato i Panther con 14 Kt God era la rivitalizzazione del punk-funk, in un’ottica intraprendente,
scomposta ed eclettica. A Certain Ratio, B 52’s
apparivano, appena un anno fa, i punti di riferimento
di una band che, dopo il secondo lavoro in studio,
faceva davvero ben sperare.
La virata verso uno stile appiattito su posizioni più
“educate” a metà tra i Television di Marquee
Moon e il più recente brit pop, cade come un fulmine a ciel sereno sulle aspettative costruite dai due
precedenti album. Le melodie ariose, la presenza
del pianoforte, determinante per addolcire il sound,
nascondono lo spastico approccio punk-funk dietro una coltre di arrangiamenti morbidi e ritornelli
molto orecchiabili, vagamente ispirati ad Electric
Light Orchestra e Supertramp. Si distingue
dal mucchio l’iniziale Latitudes For Centuries, un funk
dalla ritmica irregolare che ricorda la gestualità musicale di Dirty Projectors.
Molto più interessanti i
remix in coda all’album,
in cui vengono totalmente ridefinite le coordinate dei brani originali, intinti in sonorità electro
stile primi Depeche
Mode e, in alcuni casi, smontati perfino nella struttura, come in Love Is Sold, il cui insistente incedere
deraglia, nel Lips & Ribs Remix, in un caos di martellanti ritmi elettronici.
In questa occasione il nomadismo stilistico non
ha portato giovamento, allontanando i Panther da
spiagge migliori, che avrebbero fatto bene ad esplorare meglio. Speriamo che, nel loro continuo vagare,
non si fermino proprio adesso. E magari facciano
anche qualche passettino indietro.(6.4/10)
Daniele Follero
Paradise Lost - Faith Divides Us
Death Unites Us (Century Media,
Settembre 2009)
G enere : G othic M etal
Al declino del gothic metal, genere che ha avuto gran
lustro una quindicina di anni fa grazie a band provenienti dal doom come Anathema, My Dying
Bride e gli stessi Paradise Lost, non c’è rimedio.
Meglio tornare ai fasti di allora e giocare un po’ con
la propria (relativa) celebrità, ondeggiante tra il nu
metal e MTV. Riproporre schemi del passato provando ad arginare la deriva melodiosa che affligge il
genere da ormai troppi anni, appare una soluzione
comoda e poco rischiosa, quando non si riesce a
cambiare strada o si fallisce nel tentativo di farlo.
Del resto, quindici anni sono un lasso di tempo
consistente, sufficiente a giustificare un' operazione
revivalistica. Nel 1995 usciva Draconian Times,
ancora oggi l’album più riuscito della band britannica e uno dei dischi che maggiormente ha contribuito a portare alla luce (del mainstream) le atmosfere
fredde e caustiche del doom metal. Oggi, nel 2009,
riascoltare quei riff pesanti e compressi, quelle melodie vocali languide ma pronte a trasformarsi in
spaventosi ruggiti, quei colpi di batteria lenti e inesorabili come una campana a morte, fa sorgere la
solita domanda: ma c’era proprio bisogno di rifarlo?
Anche perché nel frattempo il sound della band è
cambiato, spostandosi verso un metal più convenzionale in stile Metallica di qualche anno fa. Tanto
che la Title Track sembra scritta e cantata da James
Hatfield in persona.
Una buona notizia per i metallari, questo ritorno
dei Paradise Lost a sonorità più dure e spigolose,
dopo le infelici divagazioni synth pop di fine anni
’90, già anticipato dal precedente In Requiem. Ma a
parte le esplosioni death di Living With Scars, le tipiche orchestrazioni gothic di Frailty e l’attacco senza
recensioni
77
fronzoli di Universal Dream, l’album è tutto un susseguirsi di ritornelli orecchiabili e fraseggi di chitarra
prevedibili. Che sia giunta anche per loro l’ora di
farsi da parte?(5/10)
Daniele Follero
Pens - Hey friend, what you doing?
(De Stjil, Settembre 2009)
G enere : pop punk lo - fi
è bastato davvero poco a queste tre ragazze inglesi
per entrare nelle grazie della Rough Trade e della
De Stijl: un paio di canzoncine con un refrain azzeccato e nulla più, a parte un look che più revival
'80/'90 non si può. Così, un po' dal nulla, arriva questo primo LP che conferma sostanzialmente quanto
si potrebbe pensare a priori; pop-punk in salsa garage lo-fi, minimalismo e pressapochismo esecutivo, e spesso anche di idee, che vorrebbe rifarsi alla
K Records ma che finisce per sapere di Captured
Tracks & Co.
Non che manchino i pezzi orecchiabili (I Sing Just For
You, High In The Cinema, Freddie), anche perché sono
essi gli unici in cui risiede il, seppur piccolo, senso
di questa musica; ma il limite non sta qui. Davvero
troppi sono infatti i riempitivi che, per un gruppo
che già mira al minimo storico dell'impegno, è davvero un'onta imperdonabile: un mezza dozzina di
(bozze di) pezzi così buttati là che persino i primissimi Queers avrebbero avuto qualche remora a
pubblicare e il loro era il 1982. Questo è il 2009 e
quanti dischi così devono ancora uscire prima che si
possa dirli definitivamente inutili? (6/10)
Andrea Napoli
Philomankind (The) - All Things
Philos (A Buzz Supreme, Ottobre
2009)
G enere : rock
Tutto è estremamente prevedibile. O se volete coerente. A cominciare da un digipack che nella grafica
richiama gli anni sessanta e il periodo esotico/spirituale dei Beatles (Rickenbacker, amplificatori Vox,
Guru indiani) per arrivare a una musica che fin dalla
prima traccia (Yogi Dananta) riprende il discorso lasciato in sospeso dai Fab Four ai tempi di Revolver - fascinazioni etniche comprese - per aggiornarlo con i cloni anni novanta tipo Kula Shaker.
Eppure questo secondo disco dei Philomankind - in
linea con l'esordio Ask del 2005 - si lascia ascoltare
con un certo piacere. Da un lato per la semplicità
e la cura con cui la formazione pisana rielabora un
78
recensioni
po' tutto il pop inglese e americano dei Sixties (gli
Who di Benjamin, il soul di Nothing To You, ancora
i Beatles di I'm Gonna Wait For The Time, i Beach
Boys di Goodbye Ev'rybody) intrecciando voci, pianoforti, chitarre elettriche e un basso rubato al McCartney più psichedelico. Dall'altro perché il lavoro
dei cinque è un riciclo ad ampio raggio ma filtrato
da una leggerezza quasi da cartone animato.
C'è la voglia di non prendersi troppo sul serio, insomma, e di portare a termine una raccolta differenziata del decennio d'oro del rock con sguardo
disilluso. Mettendo in mostra tutta la propria arte
ma anche un'ironia di fondo (Mr Guru, please, won't
you liberate my mind / doctors have all failed / everyone left me behind / i will wisper OM / till you tell me
to stop to / when the work is done / i will sign a check
to you) che non dispiace per nulla. Si tratta di un
prodotto ovviamente derivativo, ma ma c'è il filtro
deformante della provincia italiana ad assicurare
qualcosa di più di un semplice dejavù della Londra
più swinging.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Pippo Pollina - Fra due isole
(Storie di note, Ottobre 2009)
G enere : canzone d ' autore
Nuovo disco dal vivo per Pippo Pollina a tre anni
da cd-dvd Racconti e canzoni che documentava
un tour teatrale dove il cantautore siciliano portava
i suoi pezzi ad interagire con gli scampoli teatrali
della cantattrice Serena Bandoli. Questa volta il
dialogo è con gli arrangiamenti orchestrali dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di
Zurigo diretta da Massimiliano Matesic, progetto riepilogativo di venticinque anni di attività che
dalla seconda metà degli
anni ottanta ad oggi ha
sfornato una quindicina
di dischi di buon cantautorato italiano per lo più
tradizionale rinforzato
da tanta passione civile Pollina, siciliano d'origine,
è emigrato in Germania
per cercare (e trovare) fortuna dopo una prima
esperienza musicale negli Agricantus e un'altra,
fondamentale, in campo giornalistico accanto al reporter antimafia Giuseppe Fava ucciso dai boss nel
1984.
Si sa che esperimenti del genere (i cosiddetti “matrimoni” tra pop e classica) danno solitamente pa-
recchi motivi per storcere il naso. Spesso l'intento
è più "battesimale" che artistico, con la musica leggera ad immergersi nel fiume sacro della classica e
quest'ultima a stendere il proprio manto pietoso su
un mondo sonoro che a suo dire non potrà mai arrivare agli stessi livelli. A dirla tutta però è spesso la
classica a non cogliere del tutto la leggerezza, formale prima che contenutistica, della musica popolare e
se molti esperimenti fino ad oggi sono crollati sotto
il peso insopportabile del peggior kitsch il motivo è
che anche il pop ha una sua grammatica che merita
cura e rispetto.
Discorso comunque lungo e meritevole di un approfondimento in separata sede, ma non del tutto valido per la coppia Pollina-Matesic. Fra due
isole infatti dosa al meglio la propria componente
classica, limitando l'Orchestra ad un compito in alcuni casi di mero accompagnamento (Marrakesh) e
in altri di nuova ambientazione di canzoni perfette
all'uso (gli accenti klezmer di Sambadiò). In generale però è proprio il canzoniere di Pollina, estremamente italiano (dunque melodico) e dalla scrittura
a tratti teatrale e vocalmente vigorosa (Due di due),
a risultare adatto ad un trattamento di violini, fiati e
via dicendo. Per Matesic dunque compito non troppo difficile, ma condotto al meglio, in primis per la
scelta saggia di aggiungere solamente una batteria
all'orchestra e alla chitarra del titolare. Il quale si
dimostra ancora una volta a suo agio anche in campi
non del tutto famigliari.(6.5/10)
Luca Barachetti
Plush - Bright Penny (Broken
Horse Records, Novembre 2009)
G enere : soul rock
Al nuovo album firmato Plush hanno partecipano,
tra i tanti, Jackie Wilson dei Pieces Of Peace
(leggenda soul-funk di primi ’70), The Autumn
Defense (John Stirratt e Pat Sansone dei Wilco),
Jim Hines e Bob Lizek (dalla band di Brian Wilson) e Morris Jennings (il batterista di Curtis Mayfield ai tempi di Superfly, nientemeno). L’ incipit, Take
A Chance, è esemplare, un brioso pop-soul tutta fiati
e refrain impeccabile ma non si può dire altrettanto
per So Much Music e White Telescope, stessa pasta,
ma insapore. Le restanti tracce alternano gioie (vedi
We Made It, funk psichedelico e vellutato) e dolori
(Look Up, Look Down e I Sing Silence citano senza
sostanza il Jonh Lennon solista), brividi (la ballad The
Goose Is Out) e fastidi (O Street, con una slide FM che
manco Loggins & Messina!).
Non si poteva chiedere di più a Liam Hayes dopo
il dispendio economico, fisico e mentale riversato in
Fed. Gli perdoniamo perciò quest'album sincero ma
ispirato solo a tratti.(5.5/10)
Gianni Avella
RAaH Project (The) - Score
(Summer Dawn, Ottobre 2009)
G enere : orchestral nu - jazz
L'esordio per gli australiani Ryan Ritchie e Tamil Rogeon riporta in tavola le suggestioni orchestrali del Miles Davis infatuato dell'orchestra
mescolate al downtempo moderno dei Portishead. Il tutto con molto garbo e con una sensibilità
ereditata dalla Cinematic Orchestra e dal soulhop poshy. Lo stile c'è ed è quello del gran galà, ma
quello su cui il duo punta (la cura degli arrangiamenti e il taglio vagamente classico) alla lunga non
soddisfa a pieno.
Il barocchismo oggi va bene se portato all'estremo,
mentre qui non si capisce dove si vuol andare
a parare: rifacimento dei
Gotan Project (Funeral Wedding) o dei SaRa Creative Partners (Trick Of The Light)?
Le Big Band di Herbert
(Swing On Her Shoes) o il
soul commerciale (Will You Be There)? Insomma, le
idee ci sarebbero, la tecnica anche (ottima la performance dell'Australian Show Big Band), l'etichetta lungimirante pure (il disco è infatti l'esordio
per la Summer Dawn, nuova costola internazionale
della Schema). Manca il botto. Buono per il chilling e
per i fan del soul in slow motion.(6.3/10)
Marco Braggion
Raz Ohara & The Odd Orchestra - II
(Get Physical, Ottobre 2009)
G enere : song - soft - tronica
Torna ad un anno e spiccioli dall'esordio Raz Ohara & The Odd Orchestra. Brani cant-folkie con
chitarrine acustiche e pulsazioni troniche, e pezzi
con piglio quasi da club, funky come intendono il
funky di Prince i Super Collider. Vedi così le
prime due canzoni, e soprattutto The Kingdom, con
questo trattamento wonky della voce, canzoni che
sono le più incisive del disco e anche le migliori assieme alla centrale The Day You Suffer..., col suo crescendo finale (appartenente però all'altra categoria).
recensioni
79
Peccato il tutto si perda un po' in una vena sperimentale (gli intermezzi, le code) alla fine un po' fuffa
e in una scrittura non qualitativamente omogenea.
Perché i pezzi riusciti, e sono praticamente la metà
(e aggiungete anche il singolo da scaricare Miracle),
sono davvero ottimi.(6.7/10)
Gabriele Marino
Reigning Sound - Love And Curses
(In The Red Records, Ottobre 2009)
G enere : american rock
Greg un tempo Oblivians e ora semplicemente Cartwright è uno che, per dirla in breve, se ne fotte altamente delle logiche di mercato e si prende il tempo che vuole per far uscire dischi. Semplicemente,
li fa quando gli vengono. E così non è raro assistere
ad uno iato quinquennale come quello che divide
questo comeback dal precedente Too Much Guitar.
Così come non è strano immaginare, ad ogni nuova
uscita, una linea continua e sottotraccia tra le mille esperienze seminali che il nostro ha disseminato
nell’ultimo ventennio. Ecco così che le song targate
Reigning Sound possono essere lette come il versante moody & melancholic (parole sue) dell’Oblivians
sound. Tanto quelle erano sguaiate e grezzamente
garage-punk queste sono potenti e melodiche, intrise di umori sixties, spezie rhythm’n’blues, armonie
soul spesso e volentieri virate - come da titolo verso il topos amore/maledizioni. Ovvero, il nucleo
per certi versi centrale
del suono tradizionale
dell’american rock preesplosione punk. E tradizione è proprio l’altra
chiave per interpretare
non solo questo disco o
questo progetto, quanto
l’intero percorso musicale di Cartwright. Il piglio è dunque sempre combattivo e aggressivo (Is It True? è la hit che gli Strokes
non scriveranno mai), mai ossequioso o riverente
anche quando va di traditional (Banker And A Liar),
ma addirittura sbruffone in alcuni casi (Dangerous
Game, rifacimento personalizzato del contributo
dato all’omonimo comeback della ex Shangri-La
Mary Weiss) ma la tavolozza di colori usata da Greg
è talmente ampia nel ripercorre in lungo e in largo
i ’60 che finisce quasi col tributare un omaggio ai
suoni dell’infanzia non solo sua, ma anche di una
intera nazione.(7/10)
Stefano Pifferi
80
recensioni
Richard Youngs - Under Stellar
Stream (Jagjaguwar, Ottobre
2009)
G enere : songwriting experimental
Se il precedente Autumn Response aveva posto
un particolare accento sulla voce come risultato, tra
l'altro, di un'attenzione maniacale per le intonazioni
e le timbriche vocali, il nuovo lavoro a tutto tondo
(ovvero fatto salvo le pubblicazioni a tiratura per
pochi intimi, tipo Valley Of The Ultrahits...), gli si dedica completamente con risultati quanto mai ostici.
Under Stellar Stream è fin da subito un lavoro rigido, caratterizzato da un approccio monolitico quasi a cappella e in chiave iper-minimal: ovvero
voce, doppia voce, terza voce... ed un arredo flebile
di elettronica diafana. C'è certamente molto della
tradizione vocale gaelica nell'approccio canoro di
Youngs, in quel suo incedere solitario con le vocali stirate e la ripetizione di una frase come modus
mantrico e un accenno appena di delay che proietta
tutto in una dimensione al di là della nostra quotidianità. E tutto il disco ha a che fare con il concetto
di ascesa già a partire dal titolo stellare e da quello
delle canzoni (Cluster To A Star, Arise Arise), come dal
tono mistico e spirituale delle composizioni.
In particolare, quando a suonare è lui, la sua voce e
un accenno di piano (My Mind is in Garlands), l'album
fa il paio con il precedente Making Paper: ci avverti dentro un'immacolata mestizia a due passi da
Rober Wyatt o David Sylvian Un disco oltremodo affascinante che tuttavia cristallizza il discorso poetico dell'artista Youngs su un
quieta tregua con sé stesso e il mondo circostante.
Chi non lo sopporta avrà altri 6 motivi per considerarlo un genio del tedio fatto musica. Chi lo ama
invece, lo avrà aggiunto alla collezione dei capolavori minimali del musicista. La verità per chi scrive sta
come non mai nel mezzo.(6.8/10)
Antonello Comunale
Richmond Fontaine - We Used To
Think The Freeway Sounded Like A
River (Decor, Ottobre 2009)
G enere : folk rock
Ottavo album in studio per il collettivo Richmond
Fontaine guidato dallo scrittore musicista Willy Vautlin, intestatario di un folk rock agitato da
pulsioni umorali e intimistiche. Wilco, Calexico,
Jayhawks, i nomi che vengono in mente, ma anche i non alternativi Bruce Springsteen e Bob
Dylan, nomi con i quali confrontarsi per musica di
questo tipo. È l’umanità da sempre la chiave di lettura del gruppo, quel mesto malessere che si stempera appena appena in canzoni trepidanti e partecipi,
tra acustico ed elettrico. Ma c’è anche il Lou Reed
tardo più dolente (Watch Out, A Letter To The Patron
Saint Of Nurses) o le derive psych desert ossessive
alla 16 Horsepower / Woven Hand (43).
C’è sempre qualcosa di non banale nascosto tra
le pieghe di un disco dei Richmond Fontaine, che
emerge via via con gli ascolti, in quest’ultimo caso
un più accentuato virare verso un versante intimo e
raccolto, anche musicalmente. Un traguardo questo
We Used To Think… che fa il punto di una
ormai abbastanza longeva carriera e che conferma
il gruppo come uno dei meno visibili ma abbastanza
rappresentativi di un folk rock americano personale
ed espressivo. Con qualche punto sotto il precedente Thirteen Cities.(6.8/10)
Teresa Greco
Ruins - Sax Ruins - Yawiquo (Ipecac
Recordings, Luglio 2009)
G enere : progcore goes jazzcore
Tatsuya Yoshida torna su Ipecac e riscopre il
gusto dell'interplay sul repertorio Ruins dopo anni
di solitaria a nome Ruins Alone (ovvero un uomo
e le sue ossessioni). Ad accompagnarlo c'è Ono
Ryoko, fiatista dal talento multiforme che spazia
dal turnismo di studio all'avanguardia sperimentale.
Il disco contiene solo tre inediti, due in apertura e
uno in chiusura, il resto è tutto un affondo nel catalogo Ruins altezza Pallaschtom (Sonore, 2000)
e Tzomborgha (sempre Ipecac, 2002), e cioè un
Ruins-modo già maniera, ma al picco della sua efficacia per impatto strutturale e sonoro. Non mancano ripescaggi più vecchi come i classici assoluti
Hyderomastgroningem (dal disco omonimo, Tzadik,
1995) e Snare (Vrresto, Magaibutsu, 1998).
I Sax Ruins non aggiungono nulla al percorso di
"Yoshi", e sarebbe cosa difficile. Non è questo il loro
scopo. Il loro scopo è fare ritrovare al nostro il piacere di rimodellare le proprie personali ossessioni
progcore in simbiosi con un altro essere umano. E
rivendicare la paternità di certe tendenze facendo esplodere tutto il potenziale jazzcore dei Ruins,
introducendo - inequivocabile - il suono del sax.
Praticamente un'operazione politica e concettuale.
Come già quella che stava dietro alla band madre: la
ribellione della sezione ritmica al suo ruolo tradizionale di semplice base.
Il risultato è un'orgia orchestrale (la Ono sovrinci-
de più linee di sax) di jazzcore nella sua accezione
più bandistico-circense, scintillante e giocosa, che
ricorda fortemente gli Zu quando ancora con Roy
Paci. Il maestro che riprende (in tutti i sensi) i propri allievi.(7.2/10)
Gabriele Marino
Ryota Kanasaki - Phonetilosophy
(Koyuki sound, Ottobre 2009)
G enere : elettronica / ambient minimali
è proprio vero che con la Koyuki iniziamo ad andare sul sicuro, la certezza è quella di avere a che
fare con progetti di "limite" sia per chi compone sia
per chi dall'altra parte ascolta, ed è sicuramente un
pregio specialmente se a questo si aggiungono nuove mappature al panorama dei microsuoni e inoltre
tutt'altro che prevedibili.
è il caso di Phonetilosophy mini-suite dell'artista Ryota Kanasaki, ventidue minuti in tutto lasciati ad un unica fonte la voce umana qui utilizzata
come un vero e proprio strumento. Le potenzialità
espressive del mezzo sono molte come sappiamo
e non è necessario che si facciano uso solamente
di parole o fraseggi, le complessità del suono qui
sono lasciate alla semplice modulazione di tono,
regolate per lunghezza e
tensione dalle corde vocali, fatte interagire con
l'aria della laringe o articolate nello schioccare
della lingua sul palato,
sulle guance o sulle labbra con lìobbiettivo di evidenziare o indebolirne il
timbro.
Il suono diventa così oggetto e l'esperienza - allo
scorrere di queste quattro tracce - diventa notevole, mai avremmo potuto immaginare tale fluidità e
tanto memorabile collage.
La questione va oltre l'indagine, nessuna documentazione forzata nei confronti della materia, tutto si
cristallizza, si riempie di sfumature e diventa forma,
cucita tagliata e curata ma prima di tutto narrata.
Estesi i parametri di lettura e superate le barriere
comuni il suono arriva a diventare inno alla bellezza
scultorea.Notevole.(7/10)
Sara Bracco
recensioni
81
Samuele Bersani - Manifesto
abusivo (SonyBMG, Ottobre 2009)
G enere : canzone d ' autore
La passione per le parole Samuele Bersani non
l'ha mai nascosta. Canzoni dense di lemmi le sue,
secondo quella tradizione cantautorale tipicamente
italiana - ma verrebbe da dire emiliano-romana, soprattutto - che nell'importanza del testo ha trovato
a seconda dei casi forza letteraria o sovraccarico libresco, spesso dimentico, ahinoi, di una controparte
musicale all'altezza. Su questo discrimine il cantautore di Cattolica si è giocato fino ad oggi una buona
fetta della sua carriera, un cammino per lo più fortunato e meritevole, contrassegnato da almeno due
o tre canzoni che immaginiamo rimarranno negli
anni a venire (Giudizi universali e Replay: non poco in
questi tempi a scorrimento veloce) e contenute in
dischi sempre più che discreti. Non ultimo, se non in
ordine d'apparizione, il recente L'Aldiqua, piccolo perfetto manuale di come l'innamoramento per
le liriche di cui sopra possa accasarsi in strutture
pop certamente radiofoniche, ma ficcanti e gustose,
supporto ideale alle storie di un lavoro che era del
tutto votato alla narrazione (amara e pietosa) delle
magagne del presente.
Manifesto abusivo, settima fatica d'inediti, non
rinuncia ne alle strategie ne ai toni del predecessore, ma sposta il focus sul lato personale, raccontando di storie d'amore già cestinante o sul desktop in
attesa di destinazione - che a loro volta generano riflessioni esistenziali - e di nuovi sguardi ad un mondo sempre piuttosto assurdo. Quello che cambia è
invece l'ispirazione del nostro, che qui non sembra
trovare lo spleen dei momenti migliori soprattutto
nella scrittura musicale. La track-list naviga così a
vista, con un po' di artigianato buono e un po' di
esperienza maturata, lasciando che i pochi sprazzi
davvero significativi coincidano - paradossalmente,
ma neanche poi tanto - agli episodi dove Bersani
asciuga un po' i testi.
Dunque poche parole ma pesanti, e più di ogni altra
cosa arrangiamenti che si discostino anche solo un
poco dalle pettinature inscalfibili del solito pop erretielliano. Accade nella pur trattenutissima didascalia
trip-hop di Ferragosto (riff di chitarra chiaroscurale,
cello a spandere nuvole, il fecondo connubio con
Sergio Cammariere nella scrittura) e nella storia di umana precarietà su cascatella di pianoforte e
spruzzate d'archi con finale in sicurezza Coldplay
di 16:9. Il resto latita pur promettendo molto (la
title-track e il singolo Un periodo pieno di sorprese), o
82
recensioni
cerca di mischiare le carte (le incisioni Police con
ritornello funky-pop di A Bologna: per la serie “che
hai combinato Cofferati...”), o ancora prova l'azzardo e va del tutto fuori centro (Ragno, parentesi
swing romanesca per la penna di Angelo Conte).
Disco transitorio? Diciamo, e soprattutto speriamo,
che sia così.(5.5/10)
Luca Barachetti
Shit & Shine - 229 2299 Girls
Against Shit (Riot Season,
Settembre 2009)
G enere : N oise & D rums
Forse gli Shit & Shine pensavano a Faust IV quando hanno dato un titolo alla prima traccia di 229
2299 Girls Against Shit, essendo Have You Really Thought About Your Presentation una valanga rock
che più krauta non si può. Nove minuti di groove
ipnotico e assassino, perennemente sparato sul
rosso dell'amplificatore
e con trucchi ritmici degni dei Meshuggah più
maligni. In un brano, tutto il meglio dell'universo
Shit & Shine. Ma non finisce qui.
L'album continua con il dub ultraclippato di Penthouse Is A Must, il grind-core per macchine rotte di USAMexico, gli alleluya-alleluya in odor di scomunica di
The Cusp Of Innocence, Prettily, le pause inquietanti
e i campioni di Formula 1 della title track fino al
Benny Benassi versione bidonville di Shit No!.
E ce ne sono ancora di belle, nelle 17 tracce del
doppio vinile per Riot Season. I soliti Shit & Shine,
sia chiaro, scoregge e demenze sopra ritmi ultradistorti, ma in una fase d'ispirazione particolarmente
proficua.(7/10)
Leonardo Amico
Shrinebuilder - Shrinebuilder
(Neurot, Ottobre 2009)
G enere : doom
I saliscendi epici di Solar Benediction, la riflessione
quasi cantautorale di Pyramid of the Moon, il dedalo
di riff e voci della conclusiva Science of Anger. Diciamocelo subito: l'esordio degli Shrinebuilder
è ottimo. Si presenta ottimamente. è una perfetta
sintesi di diverse divagazioni doom/sludge e si porta dietro almeno due decenni di scorribande in tal
senso. E la line-up non a caso è un reliquario viven-
te: Dale Crover dei Melvins, Wino (Obsessed Saint Vitus) e piccoli eroi come il neurosiano
Scott Kelly e il rampante Al Cisneros a completamento. Un quadrumvirato che macina un platter
sicuro senza deludere né attese, né fans dei rispettivi gruppi di appartenenza, con un unico dubbio sul
risultato in rapporto al dispiego di mezzi. Un dubbio che non penalizza il giudizio, semmai ne testa
prospettive future, possibilità che ne possa nascere
qualcosa oltre il presente one-shot. Eppure una perplessità tangibile...(7/10)
Nicolas Campagnari
Slits (The) - Trapped Animal (Sweet
Nothing, Ottobre 2009)
G enere : D ub , punk
In tour ci sono state fino a l'altro ieri e il long playing
a lungo covato, aperto dall’eppì Revenge of the Killer
Slits, doveva uscire per forza ora. Tre anni di realizzazione sono un eternità ma di cose da dire - e di
novità - Trapped Animal, se ne porta parecchie. Innanzitutto, il dito puntato, e non al solito sistema 2d,
bensì al domestico e all'urbano: nell’album si parla di
abuso di minori, del rapporto maschio femmina, del
perché fare figli per questo o quel paese, del sesso
e dell'amore senza ideologie.
Le continuità tra un ieri Typical girls e l’oggi di Pay
Rent è garantita anche da un taglio intergenerazionale che le Slits realizzano al loro interno. La band,
ora quintetto - comprendente, oltre le storiche
Ari e Tessa, tre balde giovine (tra cui la figlia di Paul
Cook) - rinfresca non poco le dinamiche e le modalità del suonare. Scelte che le ragazze portano
all'esterno in un difficile contesto che - come sappiamo - ha assimilato tutto, dalle riottts e gli incazzamenti, alle parabole di Courtney Love e non
ultime le Spice Girls. Ed è proprio prendendo
spunto da quest'ultime che arriva la zampata: in un
presente globalizzato solo economicamente, certo grime e naturalmente M.I.A. e Gang Gang
Dance che ci stanno a pennello, riportare il girl
power sulla strada è l'insperata top move, specie
mettendoci le esperienze di Bristol e rime come
questa: We wanna pay rent with a passion / We don’t
wanna follow fashion.
è sempre lotta dentro babilonia (come ai tempi dei
PiL), ma attenzione agli entusiasmi: una seconda via,
e seconda parte del disco, vedrà Ari Up portar dentro tutto il proprio retroterra '80 e '90 tra fughe
dub in tre lingue (inglese, tedesco e giapponese) e
altrettanti applicazioni volutamente boring dei sot-
tostili reggae. Una retroguardia nella quale il buon
ring di rime della prima metà (salvo episodi non felicissimi come Lazy Slam o complicazioni come Trapped Animal) si stempera, e quello che poteva essere
un botto, è un democratico successo.(7/10)
Edoardo Bridda
Solo Andata - Solo Andata (12k,
Settembre 2009)
G enere : ambient / elettroacustica
Vige autenticità del materiale in questo secondo album del duo australiano Solo Andata in uscita
per la 12k, mixato dallo stesso Taylor Deupree
e masterizzato da Giuseppe Ielasi.
Una scelta questa che accompagna tutta la durata del disco, che lascia coesistere simultaneamente
natura (field recordings che catturano risonanze di
ghiaccio, acqua o vento) ed artificio (quello creato
dallo strumento, pochi per la verità qualche tratto
di chitarra acustica, pianoforte, violoncello).
Il tutto, per assiomi e ragionamenti deduttivi perseguito con un unico intento l'armonia, narrata nel
continuo fluido di architetture orizzontali, prive di
goemetrie prestabile, addomesticate si ma non lasciate allo stato selvaggio.
Paul Fiocco e Kane Ikin hanno bisogno delle miniature è in questo che acquista qualità figurativa
l'arte sonora di Solo Andata nessuna severa scelta di
dettagli in micro-droni ma caldi e graduali inni, vicini
a un certo stile alla Lawrence English.
Dichiaratamente ambient questo esordio con la 12k
si trova a suo agio prima nell'isolazionista e introversa Ablation poi, in una morsa di mcrosuoni in gorghi (Hydraulic Fluctuations), si lascia sprofondare, increspare (In the Light Storming) o incantare da mondi
acusitici (Look For Me Here) o negli intensi bagliori
in loop che evocano l'origine e le polveri d'archivio
alla William Basinski (Canal Rocks).
Facile associare elementi di astrazione e libertà a
queste otto tracce, difficile trovarvi qualcosa fuori posto ed alla fine dei conti necessario ricorrervi
per dissetare sogni.(7.4/10)
Sara Bracco
Spectrum - War Sucks (Mind
Expansion, Ottobre 2009)
G enere : psichedelia
E fu così che la storia ripartì dall’inizio. L’ultima uscita a nome Spectrum, l’EP War Sucks, torna alla
lettera e al comandamento degli Spacemen 3, né
più né meno.
recensioni
83
Non è una novità, per chi ne ha seguito i live e le testimonianze degli ultimi anni. E chi ha visto le ultime
comparsate dal vivo di Sonic Boom e compagni
(in questo caso Roger Brogan e Nolan Watkinson)
sa già che nel repertorio è presente da qualche tempo la cover di War Sucks dei Red Crayola di The
Parable Of Arable Land, pezzo davvero mitico
e dunque mitologizzabile dal famelico Kember. Pare
che Peter sia parecchio soddisfatto dal suono raggiunto dalla sua band, pari per intensità (a suo dire,
ma gli diamo ragione) ai migliori Spacemen 3; e dalle pratiche soprattutto dei primi Spacemen - quelli
di Sound Of Confusion - sembra uscire la War Sucks
degli Spectrum, splendida dilatazione (con eterno
giro di chitarra che va dritto allo spazio) che tratta
il classico della psichedelia ultraunderground come
un tempo gli uomini dello spazio trattarono un altro cavallo di battaglia psichedelico, la Rollercoaster
dei 13th Floor Elevators. In realtà non solo in
War Sucks (e anche in Razzle Dazzle Mind) si torna
indietro alla metà degli Ottanta Spacemen, ma nelle
successive due tracce il suono si trasforma come
negli anni tramutò quello della band “madre”; al
punto che di questa si può quasi dire che questo
eppì tracci tutta la carriera in quattro brani, passando dalla Walking & Falling di Laurie Anderson
fino all’acquoso acidume cosmico della conclusiva
Over and Over. Una gran manifestazione di purezza. E
la capacità di ritrovarsi come allora senza sembrare
una mummia.(7.2/10)
Gaspare Caliri
Spread - Anche i cinghiali hanno
la testa (Il verso del cinghiale,
Settembre 2009)
G enere : grunge - stoner
Vogliamo dare fiducia agli Spread. Nonostante un
grunge à la Soundgarden narcotico, d'effetto ma
piuttosto scontato; nonostante un approccio lo-fi
quasi da demotape; nonostante la palese volontà di
rimanere un passo indietro nel percorso evolutivo
dell'essere (umano) musicista (ma non è detto che
sia un difetto). Vogliamo dar loro fiducia perché nel
cut-up drogato, surreale, terreno e volgarissimo di
brani come Tum l'aspirapolvere, Spremuta di cazzo,
Cova l'arabia, riusciamo a cogliere una cifra creativa
che non è di quest'epoca mediocre. Risale invece ai
Novanta, quando a scandalizzare sul serio pensavano formazioni come i Wolfango.
Ciò che accomuna le due formazione non è il genere
di riferimento, quanto la stessa disperazione subur84
recensioni
bana, la stessa bassezza
visionaria da agglomerato popolare, la stessa naturalezza borderline, lo
stesso odio per una forma mentis convenzionale
e precostituita. Oltre alla
malcelata superbia tipica
di chi è convinto di essere dalla parte del giusto. Nel
decennio della New Economy la riflessione estetica
dei Wolfango non la prese in considerazione quasi
nessuno. Nel mercato discografico attuale i confini
si sono allargati e potrebbe esserci spazio anche per
produzioni come quella degli Spread. A patto che il
gruppo decida di spingersi oltre, pagando il prezzo
di un evoluzione (involuzione?) verso una specificità
(estremizzazione?) fuori dai cliché di rito.
Del resto, come si fa a non voler bene a una band
che registra un disco da criminali e nei crediti
ringrazia Mara Maionchi per averci regalato Mango?(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Squarcicatrici - Self Titled
(Wallace Records, Novembre 2009)
G enere : afro - jazz punk
Diavolo d’un Andreini e diavolo d’una Wallace.
Quando meno te lo aspetti ecco che ti rigirano le
carte in tavola sconvolgendo tutto ciò che ti eri preparato ad ascoltare. Se dell’eclettismo del catalogo
della seconda si è ampiamente detto (che qualche
sorpresa mr.Wallace ce la tira sempre fuori) forse al
primo non è mai stata data la giusta attenzione.
Sassofonista, batterista, improvvisatore tentacolare
e completamente fuori di testa in questo progetto - al secondo disco dopo Bossa Storta di qualche
anno fa - Andreini si circonda al solito di uno stuolo
di supereroi per imbastire un 13 pezzi di ruspante
afro-punk e apolide jazz contemporaneo.
L’attacco è da urlo. Afrotellaci è esattamente come
da titolo: un pezzo di una maestria Astatkiana smontato e rimontato dentro l’officina più sgangherata
del panorama italiano. A ruota arriva Macedone: folk
sui generis, ubriaco e cabarettistico come potevano concepirlo i CCCP di Epica, Etica, Etnica,
Pathos se avessero guardato più a sud-est.
Forse è una bestemmia visto che si tratta di uno
dei più liberi e “no compromises” personaggi del
panorama italiano, ma Squarcicatrici è forse proprio il mezzo espressivo più free dello spirito libero
di Andreini. Che si muove, cioè, letteralmente sen-
za barriere o steccati che non siano solo la voglia
di suonare/comunicare una musica letteralmente
“world”: sentita, appassionata, bellissima.(7/10)
Stefano Pifferi
Stereo Plastica - Eleven (Jestrai
Records, Ottobre 2009)
G enere : pop - rock
C'è tutta l'Inghilterra che conta in questo Eleven degli Stereoplastica. Dai Beatles di Give It Up al britpop anni novanta di So, dal post-punk/wave Franz
Ferdinand di Waste ai Soft Boys - virati Killers - di Blind. Per un campionario di suoni in bilico tra chitarre elettriche, batterie morbide, basso e
voce che ha il non trascurabile pregio di lavorare di
rimando su soluzioni musicali ampiamente metabolizzate senza scadere nel plagio. Sommando invece
al retroterra culturale citato funk (Butterflies, The
Last Time), ritmiche in levare e riff quasi hard-rock
(Superficial), in una coesistenza forzata di stili che
coinvolge senza annoiare.
Certo la logica del “di tutto di più” si coglie eccome negli undici episodi in scaletta - quasi fosse
una garanzia della perfetta riuscita del disco - come
emerge il buon lavoro portato a termine in fase di
produzione da Fabrizio Chiappello (Baustelle,
Subsonica, Caparezza). Eppure l'equilibrio generale
dell'opera convince, oltre le evidenti potenzialità
commerciali.(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Still Life Still - Girls Come Too
(Arts & Crafts, Settembre 2009)
G enere : I ndie pop scene
Broken Social Scene, neanche a dirlo vengono
in mente loro non appena attacca Girls Come Too,
ennesimo album che esce per la loro Arts & Crafts,
e forse uno degli esempi più evidenti di come i canadesi scelgano chi prendere o meno nel proprio
rooster. Poi c'è Kevin Drew stesso ai bottoni, e
non ci resta che prenderne atto del buon mestiere (e tocco) che l'uomo mette sempre in queste
cose; eppure qui, più che al massimalismo dei Most
Serene Republic, la storia vira back to indie e
l'arma se poteva tagliare da un lato, può ferire anche
dall'altro.
C'è Pastel, ep preparatorio, che dice già molto sul
quintetto di base a Toronto. Il riflettore punta proprio dove le scelte arty della Arts&Crafts sembrano
dirigersi ultimamente, ovvero sempre meno post e
sempre più quel fare sghembo à la Joan Of Arc
barra Jade Tree. Lo stillicidio dancey di Danse Cave,
per dire, affiora alla melodia in maniera ben più netta rispetto alla band chicagoana e non c'è neanche
il tempo di digerire l'operner che in Flowers And A
Wreath, con i Joan Of Arc lontani anni luce, e a prevalere è una glassa shoegaze rilucente di ebrezze
glam tutta imperniata sulla melodia. Medesima la lezione applicata su basi folk nella successiva Kid e da
qui l'appunto da fare a Brendon Saarinen e soci: evitare la talking song accattivante dove tutto è stato
detto, piuttosto puntare una via arty verace senza
senza troppo indugiare in pose Broken Social Scene,
evitando cioé di deconcentrarsi troppo dalla meta.
Quale? Sembrerebbe la forma canzone, magari l'arrangiamento brillante, ma di strada da fare ce n'è
ancora molta.(6/10)
Massimo Padalino
Sufjan Stevens - The BQE
(Asthmatic Kitty Records, Ottobre
2009)
G enere : cl as sica ?
Sufjan Stevens dice di aver perso un po’ la bussola. Eppure se gli commissionano un disco di pop
orchestrale senza pop, cioè una composizione per
orchestra punto, alla fine ci sta. Ritrova motivazione. The BQE ne è il risultato, in due versioni: CD e
DVD.
Il committente del caso è la Brooklyn Academy of
Music (BAM), che con quest’opera intende celebrare il venticinquesimo anniversario del Next Wave
Festival; la prima è avvenuta due anni fa esatti, a inizio novembre 2007, e quello che ascoltiamo oggi
è la riproduzione di quell’esecuzione, con qualche
aggiunta successiva di Stevens.
Potrebbe finire qui, questa recensione, ed evitare
di affrontare l’esito musicale della faccenda, finendo
per dire che il concerto può tranquillamente essere accusato di essere una pacchianata, cercando di
smorzare dall’espressione il tracotante effetto giudicante. Cioè musica pacchiana, kitch, come lo era
Atom Heart Mother, del resto, a cui la memoria va
spesso, durante l'ascolto
(Interlude I: Dream Sequence in Subi Circumnavigation). Un'opera che
sembra
scimmiottare
l’Europa come spesso gli
americani fanno. Eppure
alcune qualità ci sono.
Un velato chiaro-scuro,
recensioni
85
86
che limita i fortissimo e si concentra su momenti
più alessandrini. Eppoi, sopra a tutto, un odore appena percepibile (ma in qualche modo pungente) di
ironia, che sembra aleggiare, dal CD al coloratissimo
(e urbano, con estetica quasi psicho-writer) booklet, fino al DVD, dove la combinazione tra scenari
da street Settanta e la musica crea paradossi convincenti.
Quanto alla missione dello Stevens cantautore
con mille dubbi, gli suggeriamo una certezza: pensi
ai successi (senza sedercisi sopra, certo) della sua
Asthmatic Kitty, label che sta sfornando solo cose
interessanti e su cui è bello ragionare. Aspetto che
manca un po’ all’ultima fatica del Nostro.(6/10)
Nico Muhly, già al servizio di Antony e Grizzly Bear). L’elettronica pauperista e sui generis
dell’originale ne esce ovviamente trasfigurata quando non totalmente stravolta, divenendo più che altro il pretesto per un’opera di riscrittura entro i
canoni della musica “colta”, per quanto lontana dalle
sale dell’accademia.
Dismessi i tramestii sintetici e il vago alone Warp,
le canzoni prendono così la forma di soundscapes
disneyani (Year of the Rooster), musiche da camera
(degli orrori) (Year of the Dog) e avanguardia in un
profluvio di note che non sai se più pretenzioso o
ammorbante. Fate un po’ voi. Io mi tengo la foto di
Sufjan nel taschino, e qualche perplessità(5/10)
Gaspare Caliri
Nunzio Tomasello
Sufjan Stevens - Run Rabbit
Run (Asthmatic Kitty Records,
Novembre 2009)
G enere : C l as sica ?
Dell’impagabile follia del caro Sufjan sappiamo già,
sintomo di un talento popedelico come minimo
eclettico e parecchio scombiccherato, quel tanto
che basta a scardinare aspettative, tracimare steccati di genere e catalizzare attorno a sé una bella fetta di scena underground (St. Vincent, My
Brightest Diamond, DM Stith, Welcome
Wagon). Fare un disco normale? Figuriamoci,
manco a parlarne, e del resto il sospetto è che il
ragazzo si diverta così, scodellando album un po’
come e quando gli pare, mosso da smisurata ambizione (Greetings from Michigan e Illinoise, i primi due
capitoli della serie “dedicare un album a ciascuno
stato degli States”), fervore ecclesiastico (Songs for
Christmas, indigestione di vischio, scampanellii e carole natalizie) e strampalatissimi concept (Enjoy Your
Rabbit, dedicato all’oroscopo cinese).
Per quanto mi riguarda, un (geniale) cialtrone. Il
problema, semmai, sta nella difficoltà oggettiva di
giudicare operazioni laterali e all’apparenza imperscrutabili come questo Run Rabbit Run: non un disco nuovo o quasi, trattandosi di una riedizione in
chiave interamente orchestrale del già citato
Enjoy your rabbit (2001),
commissionata dal collega Bryce Dessner (The
National) al quartetto
d’archi Osso e affidata agli arrangiamenti di
nomi illustri (fra gli altri
Systems Officer - Underslept
(Temporary Residence, Novembre
2009)
G enere : pop
Già membro di Pinback e Three Mile Pilot,
Armistead Burwell Smith IV espone la sua idea di
musica pop sotto lo pseudonimo Systems Officer.
Un'idea sfaccettata la sua, che prova ad immettere
sostanza in strutture serrate e rotondissime, anche
prevedibili, ma tenute in piedi da tanti spunti ben assemblati. Insomma: alla terza, massimo quarta traccia si comincia a capire fin dai primi accordi dove
vadano a parare le canzoni di Underslept, ma
ogni volta qualche piccolo accorgimento, solo apparentemente secondario, aumenta il valore dei brani
e il gusto all'ascolto. E il nostro di accorgimenti ne
infila davvero parecchi.
East viene giocata sul contrasto tra un'elettrica piuttosto legnosa che via via s'irrobustice e un piano
quantomai limpido; Quan nasce da cadenze di tastiera aeriforme in loop; Shape Shifter, la migliore fra
tutte, comincia sinteticamente squadrata alla Peter Gabriel e introduce ricami funky-new wave di
chitarra e controcanti U2. Ancora: Oui apre radure
soleggiate tra Beach Boys e Belle and Sebastian con chitarre appiccicose e coretti dolciastri;
Sand One riporta in auge dei Police non del tutto
a bolla, mentre Sand Two allunga un pianoforte di
disarmante semplicità sull'apertura alare di un orchestra d'archi (crediamo) sintetici.
La chiusa è con una Deyos più elettrificata delle
sue compagne che nasconde un innesto di tastiera Kraftwerk, vera colonna portante di tutto il
brano ed esempio più significativo dell'arte di un
recensioni
cuoco capace di mischiare tanti ingredienti sempre
con mano esperta.(6.4/10)
Luca Barachetti
Thao Nguyen - Thao Nguyen & the
Get Down Stay Down - Know Better
Learn Faster (Kill Rock Stars,
Ottobre 2009)
G enere : alt folk pop
Secondo album per Thao Nguyen e i Get Down
Stay Down, realizzato con Tucker Martine
(Decemberists e Spoon tra gli altri ) e con l’apporto di numerosi ospiti (Andrew Bird, Laura
Veirs, tUnE-yArDs, e alcuni Blitzen Trapper e
Horse Feather).
Le caratteristiche dell’album precedente con cui
aveva fatto il botto, We
Brave Bee Stings And All
(2008), rimangono pressoché inalterate, vale a
dire un folk pop non banale declinato verso una
ritmicità e una stratificazione sonora, associato a
una giocosità contagiante. Qui in Know Better
Learn Faster sia che si tratti dell’iniziale esplosiva marcetta Cool Yourself dal sapore wave, che delle
ritmiche When We Swam, Body (spasmi chamber a
volontà) e della coralità della Pavement-iana Goodbye Good Luck, nonché della stratificazione orientaleggiante della title track con violino di Andrew
Bird annesso, e di altre particolarità assortite che si
scoprono man mano nel corso dell’ ascolto, il livello
si mantiene buono per tutto l’album, confermando
l’efficacia della produzione. Produzione che esalta le
caratteristiche migliori del gruppo e ci ha ricordato
in più di un’occasione l’analogo lavoro fatto da Tucker Martine per Laura Veirs (Saltbreakers,
2007) e che conferma l’interesse intorno a Thao
Nguyen.(7.1/10)
Teresa Greco
Throbbing Gristle - The Third Mind
Movements (INDUSTRIAL RECORDS
Ltd., Ottobre 2009)
G enere : D ark ambient
Il ritorno in pianta stabile dei Throbbing Gristle
è, artisticamente e umanamente, un nuovo capitolo
per Genesis e co.; eppure certi formati e modalità
rimangono strategie valide allora come oggi. Riesumata la Industrial Records nel 2004, The Third Mind
Movements rappresenta il primo album di inediti
sotto la label, e, avendo tutto l'aspetto del classico
dispaccio di vecchia data, potrebbe essere annoverato tra i nuovi lavori tout court.
Registrato live tra Los Angeles, San Francisco, Chicago, e New York, con tanto di suite - The Third Mind
Movements - in stile After Cease To Exist, la tracklist
fotografa il classico report della band, non più annuale, eppure nel classico streaming psicologico dei
Nostri. Strumentale, dark e ambient, la scaletta ci
ricorda da vicino la psichedelia marcia degli esordi
e i recenti set europei, dunque il richiamo a After
Cease è anche di natura concettuale. Del resto, la
delusione è cocente: il mancato trip claustrofobico/
angoscioso che toccammo dal vivo lo scorso anno
e l'assenza degli spoken di Genesis non sono aspetti
di poco conto. In pratica, The Third Mind... si limita
a ronzare quando quel giorno sudammo freddo. E
resta niente più che uno dei tanti souvenir (a pagamento) da portarsi a casa dai concerti...(5/10)
Edoardo Bridda
Times New Viking - Born Again
Revisited (Matador, Ottobre 2009)
G enere : shitgaze
Shitgaze o non shitgaze, non è questo il dilemma. Il
dilemma è come possa essere attraente una musica
come quella dei Times New Viking, il trio misto da Columbus che di quell’ondata è (fu?) il portavoce più o meno riconosciuto. Forse è proprio
quel modo “merdoso” di insozzare le canzoncine
da due-minuti-due che ormai da un bel po’ di anni
sparpagliano tra vinili a 45 giri e cd più o meno ufficiali (dovremmo essere al quarto, se non sbagliamo) e che in maniera irriverente, da scazzati cazzoni
bianchi americani, mischia e tritura Velvet in lo-fi e
gioventù sonica del medio periodo, C86 for dummies
e twee-pop sgangherato, il segreto del loro (minimo) successo. Oppure sarà la formula che rimbalza
continuamente la doppia voce maschile/femminile,
le melodie rotonde (sì, ci sono, sotto la melma, ma ci
sono) che si appiccicano in testa e ti fanno ritrovare
a canticchiarle qua e là, o quel paraculo modo di
rubacchiare a destra e a manca come se ogni disco
fosse un bignami del prima più che una proposta per
il dopo. E infatti se si può muovere un appunto ad
un disco praticamente perfetto (almeno per i suoi
canoni di genere) com’è Born Again Revisited
è che è giunta l’ora di affrontare il dopo. O almeno
tentare di farlo.(6.9/10)
Stefano Pifferi
recensioni
87
Vic Chesnutt - Skitter On Take Off
(Vapor, Novembre 2009)
G enere : new A merican songwriting
Singolare e inimmaginabile, l’apparizione a pochi
mesi dal predecessore di una nuova fatica di Vic
Chesnutt. Dobbiamo a Jonathan Richman e al
suo batterista Tommy Larkins se Skitter On Take
Off ha visto la luce: mentre viaggiavano per gli Stati
Uniti in tour, i due hanno considerato che produrre
un disco del georgiano fosse una buona idea; che
l’unico modo per preservarne l’onestà risiedesse
nel registrare in diretta e senza fronzoli. Piazzare
l’uomo e le canzoni davanti al microfono, accendere
le macchine e far partire la registrazione come nella
notte dei tempi.
Gesto basato sulla reciproca stima, l’opera di
Chesnutt numero tredici è, di conseguenza, una
macchina del tempo che
riconduce al minimalismo
dell’esordio Little, nondimeno osservato con la
maturità frattanto acquisita e - a dire il vero - uno
standard compositivo al di sotto della recente, stellare media. è in effetti una certa uniformità l’unico
(perdonabile) difetto di queste nove composizioni,
spoglie e allestite attorno a pochi accordi di chitarra acustica e spazzole discrete, ma soprattutto sulla
voce, sulle parole e le storie cui non puoi rinunciare.
Prova ne sia che l’interpretazione non ne fa le spese
e neppure il risultato complessivo, vibrante e autentico a partire dal giocare con gli “errori” - le corde
stirate, la voce tremolante, il tono qui aspro e là
arruffato, estemporaneo ma sorridente… - fino alla
bellezza inconfutabile di quanto si impone sul resto,
ovvero la cupa Dimples e la gentile Unpacking My Suitcase, una fluttuante Sewing Machine e il classicismo
conclamato di Worst Friend. Deviazione dalla strada
maestra o inizio di una nuova fase, è arduo se non
impossibile dirlo. Certo è che, anche da distratto,
Vic fa vibrare l’anima come oggigiorno quasi nessuno.(7/10)
Giancarlo Turra
Walter Marocchi Mala Hierba
- Impollinazioni (Ultra-Sound
Records, Ottobre 2009)
G enere : etno jazz rock
Primo album per il quartetto guidato dal chitarrista
88
recensioni
Walter Marocchi, che passa dal rock all’elettronica alle soundtrack fino alle produzioni per video e
cinema (è anche chitarrista nella band progressiverock Anacondia tra le altre cose); compongono il
gruppo Fabrizio Mocata al piano e tastiere, Carlo
Ferrara al basso e Stefano Lazzari alla batteria.
Un disco questo Impollinazioni che fin dal titolo
rivela la contaminazione tra diversi elementi, in questo caso il jazz, il rock, il tango argentino e la musica
etnica; ne nasce così un ibrido espressivo, tra umori
soundtrack e malinconie, inquietudini e digressioni
di rock progressive che non ci si aspetterebbe in
questo contesto. In realtà il progetto è sinonimo di
mescolanze all’insegna della massima libertà espressiva e dell’improvvisazione, come si può constatare
man mano che si procede con l’ascolto. Non un album canonico di jazz e dintorni allora, caratterizzato in prevalenza da chitarra elettrica, piano, piano
elettrico, melodica e tastiera e con pochissimi fiati.
Un disco delicato che vede anche la presenza del
trombettista Paolo Milanesi (La Crus, Tullio De
Piscopo, Enrico Rava) e del chitarrista/polistrumentista Antonio Neglia. Un viaggio tra umori diversi che si distingue per carattere.(7/10)
Teresa Greco
Will Johnson/Jason Molina Molina & Johnson (Secretly
Canadian, Novembre 2009)
G enere : folk rock blues
L'uscita programmata per il 2 novembre sembra parecchio azzeccata per un disco non proprio garrulo
anzi piuttosto cimiteriale. Del resto, da un'accoppiata del genere non c'era da attendersi un lavoro
da far suonare alla vostra festa di compleanno. Uno
dei due è Will Johnson, chitarrista e cantante dei
Centro-Matic, l'altro è Jason Molina e non c'è
bisogno di presentazioni. Si firmano senza fronzoli
cioè mettono uno dietro l'altro i loro cognomi, non
stanno neanche a perdere tempo ad inventarsi un
titolo per l'album, quindi sfornano quattordici tracce folk rock con venature gospel e blues, perlopù
minimali, contrite, solenni come può esserlo chi ha
ficcato lo sguardo nell'abisso e non ci ha trovato
nulla di carino.
Se pensate ad un ritorno di Molina sugli antichi sentieri Songs:Ohia, in parte è così, però in tal senso
i segnali più intensi e compiuti gungono da pezzi
interpretati da Johnson, vedi la cartilaginosa Lenore's
Lullaby (forse il pezzo migliore del lotto) o quella
Almost Let You In impreziosita da cori in stile CSN.
Il buon Jason prova a snocciolare qualche afflizione
delle sue, ma ne viene fuori tra il compunto e il
sostenuto (Each Stars Marks A Day, For As Long As It
Will Matter) quando non fuori fuoco (The Lily And
The Brakeman), riuscendo meglio in un folk blues
dalla bella semplicità come 34 Blues, come se l'esperienza Magnolia And Co. fosse di quelle senza
biglietto di ritorno.
Tocca rivolgere di nuovo l'attenzione sulla voce legnosa e indolenzita di Will Johnson dunque, per riferire della marcia claudicante e aspra di What You
Reckon, What You Breathe che non fa rimpiangere il
Will Oldham più asciutto (il violino nel finale è
un'autentica fatamorgana desertica) e quella All Gone,
All Gone che rimanda direttamente ai Black Heart
Procession un po' per la sega sonora e malgrado
il febbricitante intervento della vocalist Sarah Jaffe. Il disco in definitiva non è male, caracolla tutto
sommato agile attraverso la propria stessa gravità,
calcolando lo spessore dello sconforto che ognuno
si porta dentro. Chi più chi meno.(6.8/10)
Stefano Solventi
Windmill - Epcot Starfields
(Melodic UK, Ottobre 2009)
G enere : wave psych pop
Un paio d'anni fa Puddle City Racing Lights
non ci convinse fino in fondo. Un tentativo curioso di ritagliarsi una dimensione fumettistica sci-fi,
romanticamente apocalittica a partire dall'artwork,
qualche buona intuizione in un minestrone sì iridescente ma del tutto artificioso, un ascolto improbabile anche a sforzarsi di sospendere la credibilità.
Il qui presente Epcot Starfields, opera seconda
dei londinesi Windmill, compie in effetti un apprezzabile salto di qualità.
Perché spinge il gioco al livello successivo, decolla in un proprio altroquando dove la scenografia è
una mischia assieme intima e cosmica, cameristica
e visionaria, stropicciata fin dalla voce dell'one man
band Matthew Thomas Dillon. Una voce improbabile e immaginifica come il fervore balzano dei Flaming Lips più spacey, però mediata da uno slancio
bucolico Polyphonic Spree (Big Boom, Ellen Save
Our Energy). Al suo meglio, ti sembra di avere a che
fare con la grandeur dei Coldplay accartocciata
fino a diventare una pallina rugosa galleggiante nello
stesso cielo dei Mercury Rev (Airsuit). In altre circostanze, ti ritrovi a bazzicare certe luccicose atmosfere Eels tra sbroccamenti Daniel Johnston
(Epcot Slow), così come di scomodare le intuizioni
post-prog del Billy Corgan altezza Adore (Sony
Metropolis Stars).
Il trucco c'è e si vede. Ma in certe baracconate c'è
del fascino. E un sospetto di sostanza. (6.4/10)
Stefano Solventi
Yoga - Megafauna (Holy Mountain,
Ottobre 2009)
G enere : elettronica
A scrutare un po' nell'universo Yoga ci si trova subito come sprofondati nella testa di Aleister Crowley. Nella band di Los Angeles convivono tutti i temi
chiave del maestro dell'occulto: magia nera, stregonerie, filosofie orientali. Riportati in blocco all'epoca
delle macchine, precisamente quando la tecnologia
era ancora acerba e gruppi come Throbbing
Gristle ed Einsturzende Neubauten iniziavano a comunicare sotto forma di sgorbi elettronici
le loro pulsioni intestinali.
Megafauna puzza di
circuiti bruciati in chiese sconsacrate, frequenze urticanti dai sentori d'oriente risuonano
come prodotte da radioline “d'antan” in debito d'ossigeno, mentre
scorrono lenti, scheletrici riff in scale minori.
Un'atmosfera da musiche oscure, sicuramente, ma
che non si concede mai ai toni epici di Burzum, nè
all'oppressività malefica di Xasthur. Il nero di Yoga
è qualcosa di diverso. Sotto ai reverberi gracchianti
di samples in bassa qualità non c'è la solita dannazione e disperazione, ma una dimensione "altra" del
male, straniante, che non trova facili riferimenti nelle musiche di genere. Con l'utilizzo di nenie orientali, in particolare, gli Yoga svolgono una funzione di
disorientamento, riuscendo nel non facile compito
di integrare linguaggi diversi nella loro scrittura, ma
sempre mantenendo un risultato organico, senza
che passi per un forzato eclettismo intellettualoide.
A parte qualche episodio in cui si limitano a macinare sporchi drones che non aggiungono niente a
quello che Blue Sabbath Black Cheer riesce a
fare molto meglio, gli Yoga forniscono un modo per
approcciare l'oscurità da nuove direzioni. E gli riesce
bene, sin dal primo disco.(6.7/10)
Leonardo Amico
recensioni
89
dvd
AA. VV. - Live At The Smell (Cold Hands Video, Ottobre 2009)
G enere : compil ation
Della serie è bello ascoltarli, ma vederli fa tutto un altro effetto. Il titolo spiega già da subito
cosa e dove, noi ci aggiungiamo chi: No Age, High Places, Health, Abe Vigoda, Gowns,
Foot Village, Mae Shi, Ponytail, Captain Ahab e Barr. In poche parole tutta la scena
bislacca e deforme che ruota intorno al locale losangelino da noi ispezionata tempo addietro
nello speciale The Smell – Il Profumo Degli Angeli.
Lì cercavamo di dare una ipotesi di direzione comunitaria alla multiforme esplosione di suoni
tanto vari quanto eccitanti ed eccitati; ora questo Live At The Smell, ottimamente curato dal
regista e produttore Bob Bellevue, ci permette di entrare fisicamente in quel tempietto delle
musiche strane – metà squat, metà laboratorio autogestito e vissuto da volontari appassionati
e senza grosse pretese che non siano quelle di “divertirsi e produrre cultura”. Soprattutto però
questo dvd ci offre la possibilità di tastare (quasi) con mano le performances di alcune tra le
più eccitanti bands del sottobosco americano proliferate negli ultimi anni.
Il taglio del dvd non è documentaristico, ma propone una serie di live footage delle succitate band;
l’uso di una strumentazione piuttosto povera – più
camere a mano e digitali – ha il merito di rendere
appieno l’idea di live-show nel regno del diy: campi
e controcampi si fondono spesso con le isteriche
proposte delle band dello Smell. I fantastici Health, ad esempio, protagonisti di un vero e proprio
tour de force strumentale in cui dimostrano alla
grande di essere la punta di diamante di un suono
a metà tra la wave più rumorosa e il tribalismo più
estremo. O le atmosfere sospese, sempre sull’orlo
della implo/esplosione dei Gowns; l’aggro-punk
in falsetto di Mae Shi; le tensioni percussive dei
Foot Village veri e propri trascinatori primitivi;
l’anarcoide punk-shoegaze dei (quasi) padroni di
casa No Age. Premio alla proposta più personale
al one man show al limite della psicanalisi di Barr
mentre quello alla proposta più cafona indubbiamente a Captain Ahab, white trash la cui gabber buzzurra e citazionista è nulla in confronto
all’adorazione della crew e alla bruttezza dei performer, rigorosamente in mutande.
Insomma, un ottimo documento per indagare ancor più a fondo una idea più che un suono da
parte di una crew, quella di Cold Hands, che ci aveva già dato People Who Do Noise, altro
docu-dvd sulla scena noise di Portland.
(7/10)
Nicola Quiriconi - Tagofest III (Fratto9 Under The Sky,
Ottobre 2009)
G enere : compil ation
Tagofest III capita paradossalmente nello stesso momento in cui un altro docu-dvd
celebra le gesta di un altro luogo/scena, quello dello Smell losangelino. Paradossalmente perché non siamo nella frizzante costa ovest degli Stati Uniti, bensì nella bacchettona
Italia di provincia e (sempre paradossalmente, speriamo) questo dvd potrebbe divenire
l’epitaffio di un luogo (il Tago Mago di Massa) e una idea di scena (quella appunto del
festival estivo che dal locale prende il nome) dal basso, collaborativa, all’insegna del diy e della amicizia.
E così, mentre si addensano nubi minacciose sul Tago Mago,
questo bel documentario sulla edizione numero 3 del festival
delle etichette capita a fagiolo per aiutare a conoscere meglio
(per chi non ci fosse mai stato…) e a comprendere cosa si rischia di perdere (ma chi c’è stato lo sa già…) quello che ormai
è una istituzione del rock in Italia: il Festival Indipendente
per Indipendenti, come recita il sottotitolo.
A fronte della esiguità dei mezzi a disposizione, ma con una
notevole capacità di manipolazione delle immagini, l’opera di
Nicola Quiriconi (voce di VipCancro) mostra, una spartana
ma accattivante fotografia delle esibizioni live di Almandino
Quite Deluxe, Fuzz Orchestra, Dadamatto, Harshcore, I/O, Ovo tra gli altri, evidenziando insieme ottima
sensibilità registica e visionarietà non da poco nel saper rendere al meglio le proposte eterogenee dei vari progetti. In
questo senso si possono intendere le scelte dello sgranato
slowmotion per Be Invisibile Now o With Love, perfettamente a tono con le musiche dilatate ed evocative, o quella
dell’epilettica zoomata che evidenzia il procedere a scatti nevrotici dei Miranda, o ancora quella del monocromo e della
saturazione dei colori. Insomma, ottimo da vedere oltre che
bellissimo da ascoltare.
A sottolineare ancor di più lo spirito cooperativo che sta alla base del Tagofest lo
stuolo di etichette che ha contribuito alla realizzazione del presente dvd: From Scratch,
Wallace, Boring Machines, Lizard, Bar La Muerte, Fratto9UnderTheSky e molte altre.
Grazie a tutte e arrivederci Tagofest.
(7/10)
Stefano Pifferi
Stefano Pifferi
90
recensioni
recensioni
91
live report
Amor Fou
C asa 139, M il ano (2 ottobre )
Sopravvissuti a ben due cambi di line-up nello stretto giro di un biennio – via l'ex La Crus Cesare
Malfatti e il bassista Luca Saporiti (al suo posto Paolo Perego dei Nuovi Orizzonti Artificiali) – e con un bell'ep uscito lo scorso giugno
– Filemone e Bauci, che anche di quei cambi è
figlio, soprattutto a livello di sonorità – gli Amor
Fou rodano con una serie di date dal vivo i pezzi
del nuovo disco in uscita nei primi mesi del prossimo anno. Ad accompagnarli le proiezioni visuali di
Ilenia Corti, spezzoni a colori e in bianco e nero
che si riveleranno durante la serata (titolo “A parte
quel silenzio che ci separa”) l'esatto complemento
alle canzoni eleganti e letterarie di Alessandro
Raina e soci.
A che punto siano i quattro Fou dunque dopo un
periodo così intenso e rivoluzionante è presto
detto: a metà del guado, senza che tale espressione venga accolta con qualche accezione negativa.
Ben consapevoli dei limiti e dei pregi dell'esordio
La stagione del cannibale ma pronti a trarne
i debiti vantaggi, non dimenticando di fare i conti
con ciò che nel frattempo è accaduto. Via quindi
quell'elettronica di maniera Notwist che a volte
congelava un po' troppo il songwriting. Dentro un
suono più caldo, sovente chitarristico (due le sei
corde on stage: quella di Raina e quella di Giuliano Dottori), che guarda alla nostra miglior canzone d'autore (versante Umberto Bindi - Sergio
Endrigo) votandosi per quanto riguardi i suoni a
tensioni wave e a coinvolgenti fughe post mai pacificate dal drumming energico di Leziero Rescigno
(lo strumentale con recording di un Brunetta sproloquiante a fine set; l'intensa Dolmen quale omaggio
autografo agli Altro in chiusura) o a nostalgie di
stampo beat-settantiano in zona Lucio Battisti Equipe 84. Influenze queste ultime, bisogna sottolinearlo, a rischio moda come non mai ma riscattate
da una qualità di scrittura sempre sopra la media
(Peccatori in blue jeans), che racconta i rapporti umani contemporanei cercando prima di tutto un linguaggio preciso e un immaginario importante. Proprio come accade nella splendida Filemone e Bauci,
fra le migliori canzoni italiane pubblicate nell'anno
in corso, nonché esempio della direzione intrapresa
dagli Amor Fou: un tentativo di scardinare la facilità
del presente andando a riprendere con tanta personalità un passato che non passa.
Luca Barachetti
amor fou
92
recensioni
Fuck Buttons
L ocomotiv , B ologna (18 ottobre )
Ce se ne rende conto in cuffia, o guardando i loro
clip (il recente Surf Solar). Dietro al fascino dei Fuck
Buttons, non c’è il mix, ma la forza dell’esecuzione.
A fare la differenza, non è il laser synth o la ripresa
4/4 techno, il noise o l’estetica digital-shoegaze che
ne rappresenta l’evoluzione. John Cumming, produttore del primo disco, ci aveva visto giusto: all’inizio,
il vero discrimine è la fisicità di un trip inesorabile, in crescita, impersonale e senza botti come ci
si potrebbe aspettare dal chitarrista dei Mogwai
dietro al vetro. Una carica prorompente, eppure in
provetta che, al sotto dei layer, e a prescindere da
ogni mezzo, possiede un cuore, un’urgenza a polarità invertita, catarsi che infine, anzi da principio, è la
polpa di queste argomentazioni.
Dal vivo sono un viaggio su per giù di un ora. A
livello d'improvvisazione o negli aspetti che fanno
la gioia dei bootleggari non c’è molto: qualche accenno di fusione tra brani (un po' di Ribs Out in Colours Move), allungano qualche traccia. Eppure, giunti
alla seconda tournée mondiale, i Fuck Buttons non
godrebbero di tanta stima e affluenza se non fosse
per un’intima e potente sensibilità primordiale. Lo
sballo vero è l’esperienza del suonato e il senso del
ritmo che c'ha dentro. Sound che peraltro è eseguito, mosso, da manopole e tasti. Una componente
essenziale per la generazione post-glitch.
Sul tavolo Andrew Hung and Benjamin John Power
hanno sempre svariate tastiere analogiche, un sequencer, un non ben identificato strumento a bocca,
un microfono attaccato a un distorsore stile Wolf
Eyes o Black Dice e un tamburo per la celebre sciamanata a nome Colours Move. L’ultimo per
importanza è proprio il laptop: serve per lanciare alcune linee di noise trattato. Inoltre, in questo
tour c’è il materiale di Taro Tarot, più elettronico
anche grazie a un nuovo illustre produttore come
Andrew Weatherall. Le possibilità aperte dal
sophomore permettono un focus maggiore sulle
composizioni. I crescendo, o meglio, l'oramai famoso pumping di Sweet Love for Planet Earth (che copriva metà delle perfromance del 2008) sono stati
abilmente aggirati.
Non ultimo, l’immaginario: è affascinante sentirci
un ricordo di quella grandeur tastieristica che impattava l’immaginario futurista dello storico Blade
Runner, come altrettanto notevole la fusione di
quelle reminescenze nelle esperienze capitali della
manipolazione elettronica di quest’ultimo ventennio: la techno e il noise post-glitch (quello che da
Fennesz in poi ha fatto riscoprire il fascino dei
test-tone poi lanciato nei duemila su scala mondiale). Il roboante ronzio modulabile - che farebbe
tutt’ora impazzire i futuristi - si fa di pasticche senza euforizzanti. Ne viene fuori un salto temporale
interessante: in un sol colpo elimina tutto lo sballo
dell’E tenendoti buono lo sfasamento della chimica,
asciuga la retorica sul futuro del Novecento (e si va
indietro fino a Metropolis) e ti ficca in un trip per
macchine fatte totalmente di tessuto umano. Una
vera soundtrack per replicanti. E non ce ne voglia
Ridley Scott.
Edoardo Bridda
James Chance
L ocomotiv , B ologna (12 ottobre )
Uno dei capisaldi di quella che fu, trent'anni or sono,
l'avanguardia della New York più arty e tossica va in
scena di Lunedì sera al Locomotiv di Bologna; e già
questo basterebbe a porre una serie di interrogativi
sul ruolo giocato dall'industria della musica live ed
il continuo ripescaggio di tutte le glorie del passato.
Anche a personaggi considerati icone solo da una
ristretta schiera di fedeli, infatti, vengono trovati
spazi e momenti deputati, ma ciò non è necessariamente un bene. Ad aprire le danze in questa data
c'è un non meglio identificato trio di (free) jazz che
non sembra testimoniare altro se non il peso che
esperienze come quella di James Chance e soci
hanno avuto e tutt'ora hanno su una gamma poliedrica di musicisti ed orchestrali.
Non è dunque un caso se il pubblico – né scarso né
copioso – affluito per vedere la ''star'' della serata
si riversi davanti al palco quando è effettivamente il
turno di quest'ultima. Ad accompagnare il nostro c'è
un trio di musicisti francesi (Les Contortions),
già da qualche anno backing band nelle sue date europee; lui si presenta come tutti se lo aspettano:
chioma folta e scapigliata alla David Lynch, ma con
più brillantina, giacca bianca da teddy boy, sax a portata di mano. Quando lo show inizia c'è subito qualcosa che non quadra: Chance sembra un bambino
con la luna storta, il suo entusiasmo di stare sul palco scarseggia. Rumors tra la gente dicono che è di
cattivo umore perché la sera prima ha dimenticato
il suo paio di scarpe preferite nell'albergo a Napoli,
o chissà dove.
Purtroppo la prima impressione non sembra venir
contraddetta dai pezzi successivi in scaletta; l'alternarsi tedioso tra miti attacchi di funk compulsivo e
lenti episodi jazz/lounge non sembra infatti rendere
conto di quello che fu il merito primo dell'esperienza dei Contortions: la fusione e la contaminazione barbara tra ritmiche funk, ansietà jazz e insolenza
NO. Quasi a riprova di come il passato possa vantare un pedigree che oggi scarseggia ampiamente,
i pezzi più coinvolgenti della selezione sono una
cover di James Brown (aspra ironia della sorte
per lui, l'alter ego James White) e l'immortale
Contort Yourself.
Non che lo show sia irrimediabilmente sottotono,
solo ad esso manca un ingrediente portante: il punk;
il che è facilmente comprensibile se si considerano
i tre lustri che separano l'uomo che stasera è sul
palco da quello che creava deliberatamente le risse
recensioni
93
ai suoi concerti con la scusa di abbattere le barriere
tra pubblico ed artista. Ciò non di meno, senza il contagio di quel morbo la proposta attuale del gruppo è
poco più che mero intrattenimento; piacevole forse
per chi apprezza l'aspetto dell'esecuzione musicale,
ma piuttosto deludente per chi invece ha sempre
visto in personaggi come questo uno schiaffo ed una
sfida lanciata, sprezzante, proprio alla musica come
intrattenimento e svago.
Andrea Napoli
Fiery Furnaces (The)
C ovo , B ologna (3 ottobre )
Scelta radicale. Faremo tutto senza tastiere, chitarra-basso-batteria e voce. Niente macchine per il
concerto al Covo di Bologna dei Fiery Furnaces. Su
questa anticipazione, che ci dà Matthew Friedberger
appena prima dell’inizio del live, non abbiamo tempo
di costruire aspettative. Pochi minuti e si parte.
La prima domanda che ci saremmo fatti avrebbe sicuramente riguardato gli escamotage che le fornaci avrebbero potuto utilizzare per rendere i cut-up
schizofrenici dei dischi in una veste tradizionalmente rock. Prima ipotesi. Scelte timbriche differenziate
degli strumenti, a mimare la metamorfosi perenne.
Scartata. Le canzoni del live suonano tutte alla stessa maniera, arrangiate nello stesso modo. Un effetto
che ci ricorda un live di qualche anno fa all’Interzona di Verona dei Red Crayola. Ma qui si opera il
ribaltamento. Il cut-up e la frammentazione, i microluoghi che si susseguono con incastri e passaggi di
stato repentini, sono diventati un flusso ininterrotto,
per quanto frastornante, straniante e destrutturato;
una sorta di maratona per il musicista ma anche per
l’ascoltatore, un tour de force che ha messo sullo
stesso piano la difficoltà tecnica e la fatica dei musicisti di riprodurre le microstrutture in continua
variazione (crediamo siano state notevoli) e la resistenza di ascolto, o meglio, la concentrazione necessaria per stare dietro al quartetto. E ancora, di
converso, la possibilità di lasciarsi andare nel flusso
e decidere di perdere l’orientamento, di smettere di
cercare di seguire e collocare i pezzi. Ruolo chiave
in questo senso è andato a Eleanor, la cui voce è
l’anello di collegamento (timbrico, ancora, arrangiativo, ma soprattutto stilistico e contestuale) con le
versioni su disco. Sarà per questo che non abbiamo
realizzato fino in fondo, probabilmente, quanto ci
ha convinto o meno l’aproccio del duo/quartetto in
versione strettamente rock…
Gaspare Caliri
94
recensioni
Evangelista, Matteah Baim
A migdal a T heatre , M il ano (28 O ttobre
2009)
Torna in Italia l'ensemble di Carla Bozulich dopo la
pubblicazione di “Prince of Truth” ed è sempre la
solita magnifica intensità.
L'apertura di Matteah Baim si raffredda forse a
causa di un pubblico poco numeroso e di qualche
problema tecnico inaspettato, ma le canzoni della
pittrice newyorchese, già al fianco di Devendra
Banhart e di Sierra Cassidy (Cocorosie) nelle Metallic Falcons, arrivano come incompiuti
abbozzi folk in punta di elettrica che non scaldano
l'anima né la incantano. Ad accompagnarla Rose
Lazar con pochi e svogliati ricami di synth, mentre la chitarra si muove tra arpeggi reiterati, accordi
quadrati in loop e qualche rumorismo. Non sembra
Matteah la stessa delle tante critiche positive ricevute per l'ultimo Laughing Boy, e forse è solo una
serata sbagliata, o invece se ella non fosse l'artista
newyorchese pittrice-collaboratrice-di-Devendra-eSierra ma semplicemente una ragazza di Forlimpopoli con le stesse canzoni deboli non ce la ritroveremmo qui sul palco stasera.
Inutile quindi dire quanto il confronto con gli Evangelista non regga. Carla Bozulich e compagni
imbastiscono un set di un'ora soltanto e tale scelta
la si comprende a pieno proprio alla fine dell'esibizione, la cui intensità – parola insufficiente per definire un approccio al palco che per la cantautrice in
primis è soprattutto una questione estremamente e
profondamente umana – raggiunge livelli che di rado
si trovano in giro. Coadiuvata dai fedeli Tara Ill
Barnes al basso e Dominic Cramp all'organo
ed elettronica, con l'aggiunta del cello del nostro
Andrea Serrapiglio e del drumming di Young
Michael Tracy, l'ex Geraldine Fibbers (alla
chitarra) riprende a sorpresa parecchi brani dallo
splendido Evangelista più che dall'ultimo Prince
Of Truth, tra cui le due ieratiche e strazianti title
track e una Pissing dei Low (in medley con Nel's Box)
che non ha nemmeno bisogno di estendere più di
tanto il proprio crescendo per rapire e trafiggere,
tale e tanta è la catarsi che questa donna trova sul
palco nel cantare le parole dei brani. Una liberazione
la sua che è svuotamento interiore dai demoni di
una vita che non lasciano spazio a spiragli di luce ma
solo a un vuoto sviscerante e stancante (pare difatti esausta alla fine), a una salvezza che pur essendo
solo sopravvivenza redime l'anima.
La coesione tra i membri del gruppo – tutt'altro
che dolenti negli spazi tra un brano e l'altro, ma anzi
scherzosi tra loro e col pubblico – permettono al
noise-folk dei brani in scaletta un'omogeneità perfetta anche nelle parti maggiormente improvvisate.
Il drumming e il basso essenziali, irreversibilmente
tellurico il primo, perfetto nello spandere bolle di
oscurità il secondo, il lavoro multiforme tra rumorismi e calligrafie folk della chitarra, lo spleen sabbatico dell'organo e l'aurea chiaroscurale se non
proprio funeraria dipinta dal cello sulla pelle delle
canzoni rendono il concerto un'esperienza in cui
songwriting, avanguardia, vita e tragedia coincidono.
Con il loro spiritual eretico e scatenante gli Evangelista uniscono cielo e terra, per trovarne quella spaccatura dove l'esistenza diviene un passaggio denso e
inconoscibile tra nulla e nulla.
Luca Barachetti
Directing Hand, Pantaleimon,
Current 93, Spiritual Front,
Ardecore, Mouse On Mars
I nit , R oma ( dal 17 O ttobre al 18 O ttobre )
Pre Final Fest è l'ultima esperienza di Post Romantic
Empire, la sua manifestazione finale. Un allegro funerale. Lì, dove vanno i sogni quando muoiono.
Trenta ore di musica. Due giorni, dal pomeriggio di
sabato 17 alla notte di domenica 18 ottobre. Post
Romantic Empire, anfratto romantico della capitale (tra le attività del collettivo, un'etichetta discografica, Precordings, e varie iniziative in territorio
romano come il Classix 90’s, techno parties) chiude i
battenti e si pavoneggia allestendo il Prefinalfest.
Una cerimonia regale, con petali neri a contornare e
una musa, Joan Fontane, a simboleggiare.
“Vieni, ti mostrerò dove vanno i sogni quando muoiono” è il tema, lo slogan del festival. Nel segno dei
Current 93, va da sè. Ma c’è un iter da seguire,
prima di David Tibet & Co. Spetta a Gianluca
Polverari schiudere le porte dell’Init. Segue il poker MIR + Gamers In Exile + Gianni Music
+ Valentina Carnelutti. Si balla, in pratica, per
far fronte al freddo clima capitolino. Sarah Dietrich, donna rossocrinita dall’anagrafe impegnativa,
accompagnata tra i tanti da Lili Refrain, monta un
set di catartica improvvisazione elettronica che strega e stordisce. Come posseduta, Sarah. Sul serio. La
scaletta, vuoi anche per i soundcheck tra un'esibizione e l’altra, cambia in corso d’opera. Federico
Fiumani ad esempio, atteso in tarda nottata, lo si
vede poco prima degli Ardecore. Beh, non il massimo della vita, l’ex-Diaframma. Chitarra elettrica
e voce per un canzoniere rilevante (Siberia e Labbra
Blu non potevano mancare) ma sterile se spoglio di
basso e batteria. Qualche presente mugugna e non
possiamo dargli torto. Gli Ardecore (per la cronaca, senza i tre Zu) si presentano con la Dietrich ad
affiancare Felici al microfono. Dopo la prima parte di
stornelli (incluso un cameo di David Tibet), sul palco
compare Nada e la situazione si rivolta. Il combo
romano riedita i classici della Malanima. Nada ancheggia. Tutti cantano Amore Disperato e Ma Che
Freddo Fa. Nel finale, Fiore De Gioventù. Risoluto il set
degli Spiritual Front. Innocuo Danilo Fatur.
Formali i Naevus. L’indomani toccherà ai Mouse On Mars, ma prima c’è una notte da danzare.
A Legowelt e Claudio Fabrianesi il compito.
Degnamente risolto.
Jan Werner e Andi Toma, dunque, salgono sul palco
alle dieci del mattino. Lo abbandoneranno due ore
dopo forti di un gig maiuscolo. Si comincia ad intravedere intanto l’entourage Current 93: suonano
Hush Harbors (delizioso folk d’antan) e Baby
Dee (delizioso e basta). Nel mentre, il passionale
Sieben (un uomo, il violino e tanti pedali) nonché
un banchetto per presenti e musicisti a base di Capriolo. La proiezione di Nekromantik, presentato dallo stesso regista, Buttgereit, e sonorizzato
per l’occasione da un gruppo capitanato da Othon
Mataragas, precede il singolare progetto di Fabrizio Modenese Palumbo, Andrew Liles e
Paul Beauchamp. Una somma delle parti, la loro,
risolta in muzak pseudo bossanova. Divertente. Fastidioso, e non ce ne voglia l’interessato, invece Ernesto Tomasini nel suo falsetto e pose teatranti.
E pensare che in principio, accompagnato dagli stessi
Palumbo e Beauchamp, si era ben presentato.
Di ben altra stoffa il concerto dei Current 93.
Tra i tanti, si nota James Blackshaw alla chitarra
e Baby Dee al piano. Si privilegia il recente corso
del gruppo, quindi tanta elettricità al servizio dello
sciamanico Tibet. Live intenso, in una parola: bellissimo. Sugli scudi l’ultimo Aleph At Hallucinatory Mountain. Anche I Looked to the South Side of
the Door e She Took Us to the Places Where the Sun
Sets, dall’ep Birth Canal Blues, placide nella veste
originaria, si prestano ai watts. Evento nell’evento, la
performance di David Tibet, uomo nato artista che
si emoziona, urla. Rapisce. E saluta.
Per chi non c’era, come allegato al libro di prossima
uscita Post Romantic Empire, in arrivo un dvd
dell’intero evento.
Gianni Avella
recensioni
95
WE ARE DEMO
#41
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati
dai vostri devoluti redattori di S&A.Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Fuh - Extinct (Canalese Noise Records, Novembre 2009)
G enere : noise - post grunge
Siamo colpevoli. Di averli persi di vista nella pila di demo che ormai
fa da muro portante al soffitto di casa. Tanto che dovrebbe essere in
procinto di uscire il primo disco lungo(?) del gruppo - e a quello vi
rimandiamo -, successore dell'Ep Extinct di cui ci accingiamo a fare la
cronaca compita in questa sede. Quest'ultima, un'opera che potrebbe
anche bastare per prendere contatto con i noise/post-hardcore deragliante dei Fuh, con il Captain Beefheart virato Henry Rollins
di brani come Supersonic Covenience, con un approccio alla musica che
è tutto fuorché convenzionale.
Parliamoci chiaro: i Fuh sembrano sbucati da qualche avanzo di certi Novanta tecnici, perennemente in controtempo, dispari fino al midollo, volutamente grunge. A patto che del grunge si riprenda
l'anima più deviante e oltraggiosa e la si fonda con una congestione delle geometrie à la Three
Second Kiss, 120 bpm più in là. L'avrete capito: c'è di che divertirsi in questo disco registrato
presso i Canalese Noise Studios (in effetti si tratta più o meno di un disco “vero” e non proprio di
un demo). In attesa che le cose si facciano più serie - lo meriterebbero - per Akem La Biscia, Julio
Amores, Los Grembos e Nasturzio Particolare.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
A man called Pj/Obajah - European
Regaae Music (Autoprodotto,
Settembre 2009)
G enere : reggae
Non so voi, ma a me il reggae ha rotto i coglioni
più o meno venti anni fa. Rispetto imperituro per
Marley, Tosh e compagnia, ma non riesco più a calarmici. Al più gli concedo di farmi compagnia quando
ci sento quel po' di fibra e piglio che ne rianimino
l'ostinato ed esausto cliché. Il qui presente, beh, è
proprio uno di quei casi. Sbocciato dall'incontro tra
il parigino Obajah e l'italiano - di Abbiategrasso - A
man called PJ, questo ep mette in fila la miseria di tre
tracce ma belle fragranti, benedette da quella grana
essenziale che fa tanto roots e sorretto da un entusiasmo senza pretese d'assoluto. Una combinazione
che smuove. Poi, vabbè, le vibrations sono una cosa
da devoti. Io, ripeto, non riesco a calarmici. Non più
di tanto.(6.6/10)
Vinyl Fucktory - Evitare noie
(Autoprodotto, Novembre 2009)
G enere : rock
Il dna del gruppo ha il gene deviante degli Afterhours delle origini, evidente in certe ballate
crepuscolari come in un cantato che si rifà palesemente allo stile di Manuel Agnelli (Evitare noie). Con
in più i Soundgarden meno psichedelici e più heavy a fare capolino nelle parentesi distorte (Paradox),
naturale approdo di una scrittura che alterna momenti di stasi a energiche svisate elettriche.
Da un lato si apprezza il tentativo di andare oltre
uno stile consolidato per cercare una formula che
non sia semplice riciclo, dall'altra si assiste a un alternanza di buone idee e banalità. Il che ci fa pensare
che se è vero che ai Vinyl Fucktory non manca la
buona volontà, è vero anche che ancora non è ben
chiara la direzione da prendere.(6/10)
NK - Sleep Spindles (Autoprodotto,
Ottobre 2009)
G enere : electro avant
Nino Lo Bue è un tastierista e chitarrista palermitano classe '81 che nel 2008 ha avuto la buona idea
di avviare il progetto solista NK, con l'intenzione
- parole sue - di combinare atmosfere elettroniche
con le suggestioni del post-rock nordeuropeo. In
questo Sleep Spindels, uscito in free download
per la netlabel milanese 51beats.net, tenta quindi di
trovare il punto di fusione fredda tra istanze electro
ambient, folktronica e la tipica apprensione spaziale
(col corredo di gelidi esotismi e romanticismo lunare) di certi cavalieri venuti dal freddo.
A spanna, una triangolazione Sigur Ros, Mùm e
Autechre che non disdegna talora contagi downtempo e trip-hop, come quella Cat&Wo dove fa la
sua comparsa una voce femminile (è la brava Marcella Giuffré, già all'opera in band progressive metal
del palermitano). Ma a rendere davvero interessante la cosa è un senso di sbrigliata libertà, il non precludersi sbocchi e diramazioni, che siano diversivi
eniani o palpitazioni folk-prog.(6.8/10)
Stefano Solventi
Synthromantics (The) Everything’s Sad But The
Discotheque (Autoprodotto,
Ottobre 2009)
G enere : electro pop
Più che un ponte, quello che nella musica dei Synthromantics collega il pop contagiato electro dei
novanta al neoromanticismo degli eigthies sembra
un ponticello, un espediente da basetta elettronica
per saltare il sovraffollamento delle piste o mettere
in corto sezioni di circuito. Questi tre baldi giovani
allestiscono quindi un videogame dove i Blur (altezza Parklife)fanno gli sparatutto contro Visage e O.M.D., i Postal Services si fanno strapazzare dai Pet Shop Boys, Fat Boy Slim mena
fendenti contro i Police e via discorrendo.
Si tratta, appunto, d'un gioco, un escamotage portato
avanti con quel senso di ansia friabile che caratterizza le cose che sotto sotto contano. Lo possiedono
eccome quello straccio di senso che le rende vive,
e ti vien voglia di aggrappartici, di provare a starci
dentro. è il loro tentativo. Si fa ascoltare.
(6.8/10)
Vetronova - Self Titled
(Autoprodotto, Novembre 2009)
G enere : indie - noise
Noise, ma dall'anima fondamentalmente melodica.
è necessario scavare per accorgersene, dissotterrare l'indie rock di base per riportarlo in superficie,
magari sulle ali di quella Just Like Heaven dei Cure
presente in scaletta e meno fuori posto di quel che
potrebbe sembrare.
A sentire il gruppo, la scuola di pensiero sarebbe da
ricondurre all'America meno allineata e più rumorosa, quella di Slint, Tortoise, Don Caballero,
ma anche ai deragliamenti degli Zu. Noi vi diciamo
che degli Zu non v'è traccia alcuna, ma che in effetti il mood generale parla con l'accento scontroso
del post-qualcosa, spesso su una cassa martellante. Quest'ultima tratto distintivo del suono di una
formazione che potrebbe riservare qualche buona
sorpresa, dopo una messa a fuoco ulteriore e con
un po' di coraggio in più.(6.5/10)
Fabrizio Zampighi
Floss - Welkin (Autoprodotto,
Novembre 2009)
G enere : noise - psichedelia
Mantengono le istanze pinkfloydiane del precedente Russia EP, i Floss da Brescia, ibridandole con una
psichedelia ruvidissima alla Motorpsycho (Quarks Cannot Exist Individually, forse il pezzo migliore del
pacchetto) e suoni decisamente spacey.
Dal magma sonoro che ne scaturisce - un tutt'uno
di chitarre elettriche, sintetizzatori, echoes, basso,
batteria - emerge una formula musicale articolata
e preda delle dilatazioni strutturali. Con un sound
che bivacca tra le progressioni heavy di In Progress
Of e i rigurgiti in feedback di Matthew, i sussulti
post-rock di The Bees Are Dying e le parentesi acustiche di Where Am I Now?. Verrebbe da parlare di
conferma, visti anche i precedenti di una band che
già in passato aveva dimostrato di saper maneggiare con sapienza chimiche potenzialmente detonanti
senza timori reverenziali, ma forse c'è qualcosa in
più.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Stefano Solventi
Fabrizio Zampighi
Stefano Solventi
96
recensioni
recensioni
97
"Le persone al giorno d'oggi sembrano troppo
imbarazzate per mostrare emozioni. Ma è proprio
quello che voglio!"
Julian Cope
E
il punk calò anche su Liverpool. Giovani teste
e giovani gambe investite dall'onda anomala.
Un'intera generazione, come usa dire, strappata all'imperio pernicioso del rockismo hard e alla
coda lunga del prog. Restituita alla scossa basale, al
grado zero elettrico dove non c'è nulla da perdere neppure se stessi. Con qualche significativa eccezione. Julian Cope, ad esempio. Per lui il punk fu
un'esperienza divertente, un gran bel modo di scuotersi le giunture in mezzo ad una mischia di coetanei
ipereccitati. Una celebrazione esorcistica allestita da
un manipolo di irresistibili marionette ad uso di un
fronte di adolescenti disillusi. Molto disillusi. Il punk
non fu che una messinscena, in fondo.
Un
Teardrop Explodes
Formidabili stranezze pop
Nei plumbei anni settanta, in attesa dello tsunami punk, una generazione di ventenni
del Merseyside covava una piccola rivoluzione. Destinata a lasciare un segno indelebile
- Stefano Solventi
98
rearview mirror
bacio in bocca alla diversità
Secondo il diciannovenne Cope, mancava al punk
l'ingrediente fondamentale: una vitalistica stravaganza. Gallese di Deri, nel South Glamorgan, dove era
nato il 21 ottobre del '57, Julian si trasferì da ragazzino a Tamworth, nello Staffordshire, cinquantamila
anime adagiate cento miglia a sud-est di Liverpool.
Crebbe come un adolescente inquieto, piuttosto
insofferente rispetto al sonnacchioso conformismo
proletario e piccolo borghese di Tamworth, dal quale si divincolava pasturando l'insaziabile curiosità
musicale. E una fiera alterità che lo aiutava a sentirsi vivo. Come racconta nella sua autobiografia, uno
dei momenti fondamentali della sua adolescenza fu
il bacio che mollò in bocca ad un bulletto che lo
stava provocando.
Accadde nel corridoio della scuola. Correva il
1970. Da tempo Julian veniva sbeffeggiato per i suoi
modi insoliti, per la sensibilità teatrale (sostenne con
successo una parte nella recita scolastica di Oliver
Twist) che lo rendeva agli occhi dei coetanei un sospetto gay. Il bullo infatti lo apostrofava "Julie-Ann!",
e Cope ebbe l'impulso di agguantarlo per stampargli
le labbra sulle labbra davanti ad un bel manipolo di
coetanei allibiti. In quel momento il dileggio si trasformò in timore per quell'informe ragazzetto, da lì
in avanti bollato ufficialmente come "strano". Per la
soddisfazione di Julian, che ebbe finalmente chiara
la sua missione: non farsi integrare mai. Neanche
nelle forme della ribellione: un bacio "scandaloso"
laddove ti saresti atteso una rissa isterica. Difficile da comprendere, impossibile non dedicargli una
qualche forma di rispetto.
Ovviamente di lì a poco allestì una band scolastica, nella quale cantava perché altro non sapeva fare.
Il meccanismo della passione era ormai in moto.
Quindicenne, assistette ad un concerto dei Faust,
dei quali amava l'approccio ludico, quel folle stare sul
palco come un party da un altro mondo. Più avanti, nel '74, si recò a Birmingham per vedere John
Cale. Cose del genere. All'epoca già amava i Can e
altri cosmici tedeschi, materia che diverrà centrale
nella sua maturità. In quel momento si trattava di
crescere. Un percorso di formazione niente male.
Venne quindi il '76, il fatidico '76. Dopo il fallimento agli esami per l'ammissione all'università, Cope fu
spedito al Mott College di Prescot, una ventina di
km da Liverpool. In quel luogo gli si aprì un mondo.
La situazione si presentò subito radicalmente diversa da quella di Tamworth, dove era quasi impossibile
trovare dischi e qualcuno che ne possedesse, dove
le notizie sul fermento in corso al Cbgb's di New
York, che Julian leggeva sul Melody Maker, rimanevano perlopiù sulla carta, difficile per non dire impossibile verificare su vinile la portata di fenomeni quali
Television o Talking Heads.
B ombe,
molla .
bastimenti e trenini a
Al college di Prescot, in pieno Merseyside, Cope si
trovò immerso in una comunità di ragazze e ragazzi
bramosi di aprirsi al mondo. Nel campus circolavano dischi di ogni ordine e grado, tanto che nel giro
di due mesi il buon Julian ebbe modo di spararsi una
quantità industriale di ascolti, incentrati sul folk psych americano (da Tim Buckley a Country Joe
And The Fish, passando per Love e ovviamente Doors) ma anche i cosmici Can, i... funkadelici
Funkadelic, le scellerate (scellerati) New York
Dolls, la somma imprendibilità di Nick Drake, la
sbrigliata hybris dei Traffic, la genialoide arguzia
di Frank Zappa. Inoltre, e soprattutto, circolavano dischi di Patti Smith, Modern Lovers,
Richard Hell e Ramones, pura vibrazione
Cbgb's. Gli ascolti venivano - per così dire - carburati e integrati con ore di interminabili discussioni
e chiacchiere, magari al suono delle serali John Peel
Sessions. Un universo che si spalancava.
La Liverpool del periodo era, dal punto di vista
del pop-rock, una bomba ibernata. Da una parte
guardava con eccitato sconcerto all'oltremondo
statunitense, dove Television, Pere Ubu, Voivods e via discorrendo stavano mettendo a punrearview mirror
99
to un discorso che in un certo senso proseguiva
e per l'altro stravolgeva le sfrigolanti premesse di
Mc5 e Captain Beefheart, di Velvet Underground e Stooges. Questo dello sguardo ad
ovest era del resto un antico vizio del Merseyside
fin da prima dei Beatles: interi bastimenti di suggestioni americane accolti sui docks e trascinati con
ogni onore fin nelle più riposte Penny Lane. D'altra
parte non si poteva rimanere indifferenti alla pres-
sione esercitata dal punk impellente, e quindi dalla
City, direzione sud sud-est. Quando uscì Anarchy In
The UK, il famigerato esordio dei Sex Pistols del
novembre '76, i giradischi del Regno furono monopolizzati, Merseyside compreso. è però significativo
che a Cope, pur trascinato dall'entusiasmo generale,
sembrasse un singolo "troppo perfetto" perché se
ne sentisse realmente coinvolto. Ugualmente, quando poche settimane più tardi vide il concerto dei
Clash all'Eric's - il club di riferimento per la Liver100
rearview mirror
pool più cool - trovò la loro trascinante presenza
scenica ritualizzata, schematica, come un "trenino a
molla".
Gli eventi che rivoluzionarono in profondità l'immaginario del giovane Julian furono semmai, e non
necessariamente in quest'ordine: l'acquisto di Nuggets; l'acquisto di Final Solution dei Pere Ubu; l'incontro con Pete Wylie e Ian McCulloch, la sera stessa del concerto dei Clash. Cope viveva ormai come
immerso in un mondo sonico, tutti i
soldi se ne andavano in vinili - per la
gioia del cassiere del Probe, negozio
di dischi situato nei pressi dell'Eric's
- e i due titoli summenzionati furono tra quelli che avrebbero segnato
più di altri il percorso del futuro sciamano rock. Nuggets, la compilation
di gemme garage-psych imbastita nel
1972 dal fondatore della Elektra Jac
Holzman e dal chitarrista Lenny Kaye
(poi nel Patti Smith Group), divenne
un must per i ragazzi del Merseyside,
imprimendo in essi una indelebile fascinazione nei confronti dei fantasmagorici "one hit wonders" dei sixties
statunitensi. Non a caso quando Bill
Drummond e Dave Balfe fonderanno
l'etichetta indipendente Zoo, sarà col
dichiarato scopo di non pubblicare
long playing ma solo singoli a 45'', individuando in essi l'essenza stessa del
pop.
Quanto a Final Solution dei
Pere Ubu, per Cope si trattò di una
sorta di verifica e assieme una definitiva presa di coscienza: la canzone
doveva contenere uno slancio vitalistico che squarciasse la convenzione,
che instillase il sospetto di un diverso
ordine percettivo e cognitivo (concetto molto psych) senza però mai
rinunciare all'emozione, al divertimento, allospasmo
vitale. Come riporta Simon Reynolds nel suo PostPunk, tra le dichiarazioni dell'epoca attribuite a
Cope c'è questa: "Ho una mia teoria secondo cui noi
siamo il dubbio in agguato... Che sussurra nelle orecchie
della gente". Chiaro, no?
Infine, ci fu l'incontro "cruciale" all'Eric's: fu una
sera memorabile, con l'opening act dei Subway
Sect che infiammò la fantasia di Julian rammentandogli le possibilità ipnotiche della reiterazione mini-
male (un po' kraut, un po' Velvet), con le Slits che
trovò toste ma "troppo distanti" e forzatamente
strane, coi Clash di cui abbiamo già detto. In occasione di serate come questa, all'Eric's si radunava tutta
una generazione di futuri fenomeni: c'erano il futuro
Dead Or Alive - e oggi formidabile transgender
per la gioia dei reality show - Pete Burns, il cantante
degli Spitfire Boys - forse la prima e l'unica band
punk di Liverpool - Paul Rutheford (poi vocalist e
ballerino nei Frankie Goes To Hollywood), il
futuro batterista dei Banshees Budgie e - last but
not least - il caro Holly Johnson, prossimo membro
dei Big In Japan e poi celeberrimo mattatore
dei Frankies. In questa composita fauna, sguazzavano pieni di fantomatiche e febbrili intenzioni Pete
Wylie ed il di lui amico Ian McCulloch. Cantanti e
chitarristi entrambi, il primo si autodefiniva "poeta
ruffiano", adorava Velvet Underground, Doors e Jack
Kerouack, il secondo si faceva chiamare Duke perché in sostanza voleva diventare il nuovo Bowie.
G iochi
di ruolo
I tre si conobbero, si annusarono, si parlarono addosso e decisero seduta stante di mettere su una
band, i Crucial Three. Il tempo di qualche prova
approssimativa - un ipercinetico Wylie alla chitarra,
un volenteroso Cope al basso, uno svogliato McCulloch al canto, il piccolo aiuto di Stephen Spence
alla batteria - che fruttò un pugno di canzoni abbozzate, quindi tutto evaporò. Non era che un gioco, in
fondo. Un crogiolarsi nelle intenzioni. Dei Crucial
Three possiamo dire che sono stati uno dei più famosi gruppi mai esistiti. Quasi come i Nova-Mob,
band allestita da Wylie, Cope, Budgie e Peter Griffiths detto Griff, cantante e già bassista negli Spitfire
Boys: neppure loro realizzarono uno straccio di singolo, però se non altro hanno lasciato ai posteri una
T-shirt (la loro prima e unica realizzazione ufficiale) e conobbero il battesimo del palcoscenico con un'esibizione
all'Eric's, peraltro disastrosa.
Seguirono altre combinazioni più o
meno effimere, come gli Uh? (Cope,
McCulloch e Dave Pickett), The Mystery Girls (Wylie, Cope e Pete
Burns) e A Shallow Madness
(Cope, McCulloch, Paul Simpson e
Dave Pickett). Questo "teorizzare musica" era però tutt'altro che un cazzeggio, era il senso stesso della cosa: per
quei ragazzi, in pratica la nuova generazione rock di Liverpool, l'assioma "no future" non
aveva senso anzi lo aveva ed era deplorevole. Questi
abbozzi di band, questi sogni di rock'n'roll, venivano
carburati dalla prospettiva, dal desiderio, dalla speranza, diciamo pure dall'illusione del successo. Credevano infatti nel successo come completamento
di un discorso espressivo fondato sul comunicare
emozione, non distanti in questo dagli atteggiamenti
del "new pop" - vedi ancora Reynolds - di Heaven
17 e ABC. Un atteggiamento che si rivelò fruttuoso, vero e proprio brodo primordiale che tra il '78
ed il '79 vide formarsi almeno quattro ottime band:
i Big In Japan (con Johnson, Drummond e Budgie
tra gli altri), gli splendidi Wah! Heat di Wylie, i
celeberrimi Echo And The Bunnymen di McCulloch ed i Teardrop Explodes di Cope.
Questi ultimi nacquero come una sorta di emanazione degli A Shallow Madness, ma ben presto
attorno a Julian - che s'incaricò di basso e canto
- i volti cambiarono del tutto. Subentrarono David
Balfe alle tastiere, il chitarrista Alan Gill (già negli
elettronici Dalek I Love You) e Gary Dwyer
alla batteria. A far loro da manager si propose Bill
Drummond, fondatore della Zoo assieme a Balfe e
sempre con quest'ultimo membro dei Big In Japan,
band contro la quale lo stesso Cope promosse un
burlesca petizione per chiederne lo scioglimento, rimarcando il senso di gioco (di ruolo) che informava
tutta la scena.
Licenziati ovviamente dalla Zoo, i singoli dei Teardrop ottennero riscontri considerevoli: il motorik
avvampato di Sleeping Gas, con le trombe squillanti,
la veemenza assertiva del canto, i bordoni psicotici
d'organo, la misteriosa e tragicomica alienazione del
testo, in pratica la facevano sembrare la cuginetta
ipercromatica di Talking Heads e Pere Ubu via Can;
poi l'impetuosa wave-psych di Bouncing Babies, dalle
rearview mirror
101
venature acide Syd Barrett e una teatralità cupa
che rimanda ai primi Ultravox! (peraltro odiati da
Cope); quindi il dinamismo guizzante e sinuoso di
Treason, coi sudenti esotismi melodici intruppati tra
riff brillanti e serrati orditi Stranglers. Piccoli ordigni sonori che fanno affiorare un caleidoscopio di
agganci, dalle garage band "nuggetsiane" come Seeds o Standells ai primi Pink Floyd, dai Kraftwerk ai Funkadelic, dai Television ai 13th Floor
Elevator.
Are You Unexperienced?
Stranezze giocose, "screanzata vitalità", gioia di
esprimere e quindi di esistere, liberi da categorie
preconfezionate. Un po' come il nome della band,
ispirato ad un fumetto Marvel (potete trovare la
battuta in Daredevil numero 77 del giugno 1971,
pagina 17 per la precisione) ma in realtà slegato
da qualsiasi motivo diverso dal voler suonare così,
esplosivo e brioso senza negarsi un retrogusto
oscuro. Impossibile non sfociare in un album, ed
ecco quindi l'accordo con la Mercury ed il folgorante debutto lungo Kilimanjaro (Mercury, 1980,
7.8/10). Originariamente intitolato Everybody
Wants To Shag The Teardrop Explodes, si fa
102
rearview mirror
forza di una scaletta prodigiosa che annovera oltre
ai singoli già citati Second Hand (i Television centrifugati Stranglers), una Books che stempera Doors,
Barrett e Seeds (composta ai tempi dei Crucial Three) e la fascinosa Poppies In The Field, pezzo e testo
emblematico ("Poppies are in the field, don't ask me
what that means") che forse più di ogni altro giustifica l'epiteto di new psychedelia affibbiato ai Teardrop
e un po' a tutta la scena del Merseyside.
Si tratta in realtà di una targa poco appropriata. Il
taglio psych era solo una delle fonti, come abbiamo
visto. Soprattutto, si era ben distanti dall'originale
messaggio dei sixties che, con un bel po' d'ingenuità
se vogliamo, propugnava la possibilità di squarciare
il velo per approdare all'other side. Nel Break On
Through dei Doors c'era tutto un vissuto, c'era una
missione culturale e generazionale di cui farsi agenti
e portavoce. Se Hendrix ammiccava esplicitamente
Are You Experienced? e persino i Beatles finirono per
giochicchiare con messaggi lisergici neanche troppo
subliminali, nei Teardrop la psichedelia era sostanzialmente "unexperienced", le uniche sostanze psicotrope conosciute venivano spillate dentro boccali
nei pub.
La loro psych attitude era quindi un prodotto
della passione sfrenata per tutto un immaginario
(iconografico, musicale, culturale) ricevuto in eredità dalla generazione che erano chiamati a sostituire,
quella stessa che poi aveva tradito tutto tra filosofie
hippy, rinculi conformisti, droga pesante, velleità rockiste (fu l'istrionico Pete Wylie a coniare il termine
"rockismo", intendendo con ciò mettere alla berlina
quelli del rock muscolare fine a se stesso, colmo
di cliché chitarristici, alla Cream per intendersi) e
immaginifiche masturbazioni tra colta e jazz.
Di psichedelico in effetti c'è tutto un contorno
di possibilità sonore, è una eventualità sempre presente ai margini o al centro, ma se tornando ai Teardrop prendiamo la travolgente Reward - il singolo
del 1981 che seguì il successo di Kilimanjaro è evidente come l'impianto si basi semmai su una
straordinaria verve Motown motorizzata wave, un
garrulo e minaccioso delirio che non si risparmia
slanci jazz-soul, un bailamme al cui interno hanno
piena cittadinanza gorghi di tastiere e raffiche di
chitarra queste sì floydiane porco cane. Il bello di
questi primi Teardrop è proprio la festosa, lucida,
spettacolare, folta anarchia.
Laddove i più autorevoli "rivali" Bunnymen perseguiranno un approccio sempre più solenne, ambientale ed epico - cogliendo con ciò lo spirito dei
tempi, desiderosi di recuperare un rock in grado di
produrre orizzonti, di restituire prospettiva, ciò che
poi riuscira appieno alla "big music" di Waterboys
e soprattutto U2 - per Cope e soci (ma soprattutto
per Cope) importava mettere in fila le perle di una
collana magica, tre minuti di guizzo immaginifico che
schiudesse lo scrigno del meraviglioso che ognuno si
porta inconsapevolmente nel cuore.
A cida
dissolvenza
Purtroppo, questo approccio sì visionario ma tutto
sommato puro, ben presto si corruppe. Cope era
sempre più affascinato da ciò che stavano portando avanti i Fall ed i loro "gemelli" Blue Orchids,
questi ultimi sì immersi nella cultura acida fino alla
punta dei capelli. Si convinse così ad abbracciare
l'esperienza, iniziando ad imbottirsi di acidi fino ai
limiti del sostenibile. Fino all'insostenibile. Divenendo insostenibile, soprattutto per i compagni d'avventura. Alan Gill, intenzionato ad impegnarsi a fondo
nei suoi Dalek I Love You, preferì mollare i Teardrop,
sostituito da un Troy Tate buon chitarrista ma non
certo alla sua altezza.
Poco male in fondo perché il secondo album dei
Teardrop Wilder (Mercury, 1981, 7.3/10), doveva
comunque spostare il sound su territori diversi. Un
pop più sfrangiato, soffuso, cangiante e articolato,
che vedeva ad esempio Seven Views Of Jerusalem caracollare in un esotismo da Talking Heads sornioni,
una Tiny Children alle prese con vaporose sublimazioni wave pseudo-Japan, una The Great Dominions
abbozzare palpitante solennità come un Bunnymen
posterizzato. Se il ruolo dei synth e del basso si dleinea più intenso e a fuoco, gli ottoni stanno a quel-
li di Kilimanjaro come una parata di espedienti
(vedi la psych-errebì plastificata di Colours Fly Away),
mentre la scrittura rivela una certa fiacchezza, a partire dal singolo Passionate Friend (come uno di quei
parti garage-psych floreali minori) o quella Like Leila
Kahled Said che ha il merito di farsi carico di un testo
"importante" (Leila Kahled è riconosciuta come la
prima donna combattente per la causa palestinese)
ma s'arriccia su una melodia monotona affossata da
esotismi senza sbocco. Le intuizioni brillanti come il
chorus di Bent Out Of Shape o quella The Culture Bunker che da sola vale mezzo repertorio degli Ultravox
periodo Midge Ure, fanno di Wilder un notevole
album di pop "deviante", una sorta di compimento
dell'idea che stava alla base del progetto - affabilità
contagiata di mistero, l'insidia che innerva la carezza
- ma le vette di briosa ispirazione raggiunte dal predecessore rimasero piuttosto lontane.
Se ne accorsero per primi Cope e compagni, questi ultimi ormai consapevoli di recitare un ruolo sempre più di sponda rispetto al sempre più incontrollabile leader. La magnifica avventura degli Explodes finì
rapidamente nel 1982, durante le registrazioni per
il terzo album. Incisioni (una ipnotica Ouch Monkeys
che non sarà spiaciuta ai Radiohead, una Serious
Danger che fa i Frankie Goes To Hollywood prima
dei Frankies, una Metranil Vavin quanto mai Japan...)
che videro la luce nella raccolta Everybody Wants
To Shag ... The Teardrop Explodes (Mercury,
1990, 7.4/10) - della serie non si butta via niente, a
partire dai titoli - edita da Cope nel 1990, quando
oramai era un guru di un altro pianeta. Il suo pianeta
personale. E anche il nostro, casomai. Per fortuna.
rearview mirror
103
Ristampe
Black Devil Disco Club - The
Strange New World Of Bernard
Fevre (Lo Recordings, Ottobre
2009)
G enere : elettronica
Prima di farsi culto con la dance fisica di Black
Devil Disco Club, Bernard Fevre, nel 1975, esordiva all’insegna di un'elettronica sintetica e filmica.
In The Strange New World Of Bernard
Fevre sembra Piero Umiliani che gioca a fare
Jean Michel Jarre: Sci-fi pop (Dali) e sortite funk
al silicio (Dangerous misture, Stay On Grey, Misererum), muzak lunare (Cosmic Rays, Pendulum) e preavvisi cosmic in anticipo sui tempi (Fantasm). Seppur
rimasterizzato, quindi limato digitalmente, il mood
è terribilmente fresco che si stenta a dargli 34 primavere.
Paradossalmente,più attuale qui che nelle recenti sortite come Black Devil Disco Club.(6.5/10)
Gianni Avella
Feelies (The) - Crazy Rhythms / The
Good Heart (Domino, Ottobre 2009)
G enere : post - punk - folk
Verrebbe voglia di scrivere la recensione delle ristampe dei primi due dischi dei Feelies (ad opera della solita Domino) cercando di inseguirne lo
stile. Cercando di essere raffinati e veloci, ritmici,
dirompenti ma classici.Verrebbe da farlo perché è la
stessa critica musicale che ha sempre cercato - senza riuscirci fino in fondo - di inseguire quello stile,
di andare oltre lo stupore per definire al meglio le
maratone folk-percussive di Crazy Rhythms e la
parziale distensione di The Good Heart. E allora
riproviamoci.
C’è una tensione che monta, nell’esordio, Crazy
Rhythms, del 1980. E non è un caso che spesso i
brani abbiano bisogno di un minuto buono per decollare, levitare, e per poi restare in cielo per sempre, finché c’è carburante. La musica dei Feelies è un
autentico sorvolo, che potrebbe non atterrare mai.
Una simulazione di volo evasiva, ma molto terrena, un perpetuo esercizio di ritmica e articolazione
104
rearview mirror
percussiva in cui può prodursi uno sdoppiamento
melodico, un solo minimale della chitarra (Moskow
Nights), una piccola perturbazione che stupisce ma
non distrae dalla sostanza volatile del disco: l'alienazione.
Viene da ipotizzare che Crazy Rhythms sia appunto un disco sull’alienazione, nei due sensi: che
parli di alienazione, in qualche modo, ma anche che
sappia ergersi sopra l’alienazione; che si erga sopra
il reale alienato e in questo modo riesca a essere
psichedelico. Forces At Work è la traccia esemplificativa: fa fatica a decollare e poi si tiene a un'alta quota deformata e deformante, simulando la chitarra
di Tom Verlaine e portando alle estreme e geniali
conseguenze lo stile dei Television. È questo il
meccanismo che spiega come faccia un disco nevrotico di post-punk a essere psichedelico. Sotto
pelle nei Feelies c'è sempre un atteggiamento meditativo, schizzato prima, esplicitato dopo, in The
Good Heart (Coyote, 1986), dopo una pausa interminabile che ha scompaginerà la formazione pur
mantenendo le linee di continuità. Un abbandono
della nevrosi per affrontare una vera e territoriale
fuga dalla città.
E, per concludere, viene in mente una frase programmatica di Albini, che espresse quando presentò su disco il progetto Shellac, appena prima
dell'uscita di At Action Park. Disse di avere in
mente una musica fatta per un accordo solo, per
una nota sola, sulla quale violentare la ritmica. Ecco, i
Feelies facevano folk per un accordo solo. Folk perpetuo. Un’eterna ghirlanda brillante che mette sullo
stesso piano melodia e ritmo. Continua reciprocità
tra musicalità e nevrosi. Tra folk e astrattismo ritmico.(8/10)
Gaspare Caliri
Max Richter - Memoryhouse (Fat
Cat, Novembre 2009)
G enere : post cl as sicismo
Se doveva esserci un momento giusto, è questo. Memoryhouse, il debutto di Max Richter del 2002, da
tempo fuori catalogo, viene ristampato dalla Fat Cat
mentre il compositore, forte dei riscontri positivi
ottenuti per la soundtrack di Valzer Con Bashir, sta
portando in giro (stivale incluso, lo scorso 8 ottobre a Firenze) il progetto The Art Of Mirrors che
sonorizza vecchi e inediti (almeno per l’Italia) super8mm di Derek Jarman.
Gli inizi di Max Richter, dopo l’apprendistato toscano per studiare Berio e le collaborazioni con Future
Sound Of London e Roni Size, sono dunque racchiusi nel suo primo step solista. Si evince dai nomi
di cui sopra, o meglio nella loro possibile convivenza
ideologica, che il tedesco di stanza anglosassone è
di certo un compositore atipico. Per dirla come lo
stesso Richter, Post Classico.
Quasi tutte le composizioni di Memoryhouse
vivono su di un tema
portante, esposto nel
melanconico violino di
Europe, After the Rain. In
Sarajevo, il soprano Sarah
Leonard rileva gli archi:
il corpo si fa drammatico. Corale. Sotto certi
aspetti,Wagner-iano. La BBC Philharmonic Orchestra e Alex Balanescu, nell’epico crescendo di November, rifiniscono l’ennesima sfumatura sul
tema. C’è anche spazio per particolari dediche: una
al noto cagnolino spedito sulla luna nel 1957, Laika,
in Laika's Journey (muzak elettronica in miniatura),
l’altra al compositore olandese Jan Sweelinck, Jan's
Notebook, per solo clavicembalo. Mentre The Twins
(Prague), se non proprio una dedica, è quantomeno
un palese omaggio all’arte di Michael Nyman.
Detto questo, donate l’elegiaca Arbenita (11 Years) al
vostro cuore.
Primi appunti sul quaderno blu.(7/10)
Gianni Avella
MF Doom - DOOM - Unexspected
Guests (Gold Dust, Ottobre 2009)
G enere : hip - hop
Il promo ha una copertina che è la stessa che troviamo ovunque sul web, ma è diversa da quella sul
sito della Gold Dust. Dentro ci sono 14 pezzi, mentre
Undergroundhiphop ne indica 16 e il sito della label
addirittura 17. Ci atteniamo al promo fisico. A collection of non-album tracks, guest features & exclusives
selected and mixed by the Super Villain himself. Rarità
99-08 che i non follower potrebbero benissimo non
conoscere (come il one-shot Bells Of Doom uscito
anonimo anni fa per Marvel Comics), ed è un peccato
perché si tratta di ottimi pezzi HH.
Per lo più feat di DOOM su dischi di altri (De
La Soul, Talib Kweli, Vast Aire dei Cannibal
Ox, membri del Wu-Tang Clan), con primato
quantitativo ai produttori Jake One e The Prof
(ma ci sono anche produzioni del nostro). Anche un
ripescaggio da J Dilla-Donuts, rappato assieme a
Ghostface Killah. Anche un anemico riuscitissimo remix di Street Corners di Masta Killa assieme ad altri wutangclaniani. Niente sperimentazione
a tutti i costi, produzioni compatte, solitamente di
colore scuro, il solito surreale flow melmoso di Mr.
Dumile e prove di rapping altrui di prima classe. Insomma, per i delusi dall'ultimo pompatissimo Born
Like This. Come a dire che, nonostante tutto, DOOM's as evil as ever.(7/10)
Gabriele Marino
Mulatu Astatke - New York Addis
London (Strut Records, Ottobre
2009)
G enere : ethio - jazz
Anno mirabile, il 2009, per Maestro Astatke, “inventore” dell’Ethio-jazz, virtuoso di piano e vibrafono
e via elecando. A uno dei capisaldi meno noti della
musica mondiale si sono infatti definitivamente spalancate le porte del mondo occidentale, coronando un processo di notorietà e apprezzamento in
costante crescita da che Jim Jarmusch ne inserì un
brano nel film Broken Flowers. E che ha preso il volo
tramite uno dei lavori più significativi che possiate
ascoltare al momento, quell’Inspiration Information Vol.
3 realizzato assieme agli Heliocentrics e su cui ci
siamo lungamente spesi. è pertanto mossa intelligente della Strut mostrare quanto esiste a monte di
tale contemporanea bellezza, fornendo un ritratto
dell’artista a prescindere dal qui e ora.
E, anche, di indicare cosa gli permette di essere
ciò che è e fare ciò che fa nel mentre esorta ad
approfondirne la conoscenza. Retrospettiva curata e competente com’è costume della label (note
puntuali di Miles Cleret; apparato iconografico di
prim’ordine), New York-Addis-London pesca lungo un
decennio sensazionale dal punto di vista artistico e
umano per l’etiope: primo musicista del suo paese
a viaggiare e registrare all’estero, verrà a contatto
con la scena jazz londinese dei ’60 nel mentre studia al prestigioso Trinity College Of Music. Da lì a
Harvard - di nuovo: primo africano a frequentare
l’istituto! - ci vorrà poco e ancor meno complicato
rearview mirror
105
sarà, per un individuo di siffatto Genio e personalità, sviluppare linguaggi che fondano jazz occidentale
e tradizioni autoctone riconsegnando così il primo
alle origini. Caratteristiche che, nel terzo millennio,
restano immutate e anzi scintillano più che mai in
una musica straordinaria. In una sola e semplice parola, imperdibile.(8/10)
Giancarlo Turra
Not Moving - Not Moving (Spittle,
Ottobre 2009)
G enere : post punk
Chi segue la rinata Spittle Records si ricorderà forse i Not Moving per Baron Samedi, gothabilly da
cattedrale e da manuale con il quale fecero la loro
comparsata nella compilation Gathered. Ciò che
oggi si dà alle ristampe con un self-tilted ex post è
il Frankenstein nato dall’assemblaggio del 12” Black
‘N’ Wild (uscito per la Spittle originale, nel 1985) e
dell’LP Sinnermen (Spittle 1986, compreso di outtakes), di qualche anno successivi al brano aurorale
succitato. E allora via col senno del poi.
Due giudizi con un ponte, che collega le due uscite raccolte. In Black ‘N’ Wild i Not Moving riprendevano la tradizione wave inglese incrociata a
discendenze Gun Club, cantando in inglese, senza
però importare alcuna angolatura - anzi sposando a
volte la versione Bauhaus più che Gun Club, con
le discendenze hard-glam del caso, le chitarre gotiche, una voce femminile vicina alla solita Siouxsie.
Le cose più felici venivano da ispirazioni Cramps o
X (l’ottimo anthem rockabilly di I Just Wanna Make
Love To You, molto divertente, con la splendida coda
fatta di urla di chitarre e di persone); ma l’opzione
sembrava quasi non essere percorsa fino in fondo.
Un anno dopo, in Sinnermen, arrivavano a cimentarsi
con il post-hard-core melodico di I KnowYour Feelings
e con il blues di Lost Bay, dove non è male assistere a
come quelle chitarre passino il testimone da un riff
a un solo, per quanto semplice. Eppure il perno su
due colonne di Not Moving è quel punto di passaggio tra il 12” e l’LP. Si chiama proprio Sinnermen,
scaglia di tardo beat psichedelico, lasciata andare
come piccola gemma mal prodotta alla fine dell’EP;
ripresa, con una produzione meno confusa ma forse
con anche meno impatto, nell’album dell’86. E con
Baron Samedi fa rima, almeno in una cosa: nell’essere
non più indissociabile dal momento in cui nacquero.
Finendo per resistere al tempo.(6.8/10)
Gaspare Caliri
106
rearview mirror
State Of Art - Dancefloor
Statements 1981-1982 (Spittle,
Ottobre 2009)
G enere : post - punk / funk bianco
Si diceva spesso in quegli anni che a un certo punto
tutti, in Italia, si sono messi a fare funk bianco. Parliamo dei primi anni Ottanta del post-punk nostrano,
e di quelle band che, più che essere esterofile, cercavano semplicemente di sprovincializzarsi. I punti
di riferimento erano quelli dati dalle intersezioni
che ben conosciamo, tra Talking Heads e Contorsions, banalmente. Gli State Of Art rientravano sicuramente nel discorso, ma per tempismo
e qualità media dei risultati non andrebbero menzionati nella schiera della vulgata senza infamia né
lode, ma qualche passo sopra. Ceto, c’era la band di
David Byrne nei loro ascolti e nelle loro corde tese
(Dantzig Station, Keep On Moving), così come James
Chance e i suoi Blacks. Come per quest’ultimo
però la parabola della band andava a ritroso, fino a
James Brown e in genere alla soulness Settanta del funk, seppure aggiornata alle angolature del
dopo 77. Discorsi banali forse, ma non troppo se
pensiamo che questa ristampa Spittle si intitola proprio Dancefloor Statements 1981-1982 e
raccoglie - ad opera dei leader e autori del gruppo milanese, cioè Fred Ventura / Federico Di Bonaventura e Stefano Tirone - gli spasmi funkici di
un biennio che sotto questo aspetto probabilmente
non ha avuto repliche, sul suolo italiano. Le derivazioni post-punk inglesi ci sono comunque tutte. Ma
ormai grazie alla stessa Spittle le possiamo catalogare come milieu. Va messa in luce invece la qualità
media della produzione (già nell’originale, dato che
questi pezzi sono tratti dai nastri originali), molto
alta rispetto a quello a cui si era abituati, e alcune
avvisaglie poliritmiche e ovviamente mutanti (Scoop
‘n’ Loop), così come tentativi di emancipazione dai
retaggi melodici anglosassoni. Ciò che impreziosisce maggiormente la raccolta è però la manciata di
brani conclusiva, e specie per una cosa: per il buon
innesto tra la complessità dell’elemento ritmico e la
foga punk nelle tracce live, che in effetti sono dirompenti e forse da sole valgono la ristampa.(6.9/10)
Gaspare Caliri
Terror Danjah - Gremlinz
(Instrumentals 2003-2009) (Planet
Mu Records, Settembre 2009)
G enere : horror step
Le nuove leve del dubstep sono passate in gran par-
highlight
Flipper - Album Generic / Gone Fishin' / Sex Bomb Baby (Domino,
Agosto 2009)
G enere : noise - hard - core
Un nome che drasticamente divide in due. Chi li conosce pensa a un
panzer in corsa folle sulle strade (o anche sulla spiaggia), chi non ne ha
mai sentito parlare incorre nella fluida ambiguità suggerita dal nome. In
realtà, seppure non li si citi spesso, i Flipper hanno avuto un'importanza enorme, e non a caso persino la Domino decide oggi di metterli
sotto i fari puntati attraverso la ristampa degli unici due veri album della
band in formazione originale (Album Generic - Subterranean, 1982
- e Gone Fishin' - Subterranean, 1984) e del primo resumé della carriera (Sex Bomb Baby - Subterranean, 1988). Non è un caso, innanzitutto, data la recente uscita di un
nuovo disco (Love) sotto la ragione sociale Flipper. Ma non tanto per salire e cavalcare l'onda della
riunione di intenti, ma forse per rimarcare la distanza della conservazione violenta di oggi da quegli
esercizi dirompenti che ebbero luogo prima della morte del cantante Will Shatter, avvenuta nel
1987. è anche grazie a lui per cui si parla del gruppo post-hardcore di San Francisco come ponte di
collegamento tra PIL (Nothing) e musica industriale, in generale tra l'hardcore (Way Of The World)
e il post-punk. Il suo cantato inaugura il lascito dell’ugola di Lydon che poi sfocerà, tra gli altri innumerevoli, in Yow. Ma nei Flipper ci sono autentiche scorribande, che vanno da filastrocche mutanti
alla Residents in Life Is Cheap (dall'esordio) fino alla psichedelia marcia di One By One (in Gone
Fishin'). Il ruolo storico dei Flipper è stato fare il punto dell’humus culturale della musica becera di
allora, necessario perché arrivassero le eccellenze che oggi tutti citiamo, Big Black in testa. Albini
ne era un grande fan ma soprattutto li stimava da critico musicale. Da lì, possiamo dire, partì per
la sua parabola. E come gran finale (che diede nome alla raccolta oggi ristampata) rimane davvero
mitica Sex Bomb, divertimento di piffero sintetico con sax (memore del titolo del brano?), panzer a
due bassi, chitarre PIL-iane; un sabba che è un puro spasso, e si erge nella tracklist delle stramberie
(dopotutto accessibili) del decennio. Una demenzialità demoniaca e terribilmente rumorosa con
dentro tutti i Butthole Surfers più sbracati. Un lottatore di sumo che tenta delle mossette funk.
Un perfetto esempio del suono dei Flipper e del loro lascito ingombrante.(8/10)
Gaspare Caliri
te al wonky e al ragga. Sono pochi quelli che battono il ferro, ormai l'onda è passata ed è sempre più
un affaire che gestiscono le internet radio pirata,
qualche compilation di Mary Anne Hobbs o le
serate di Rinse FM. Una cosa autocelebrativa che si
parla addosso e che in molti danno già per consumata. Ben vengano allora le ristampe e le raccolte
del tempo che fu e che è ancora una volta già passato sotto i cingolati delle pastiglie e dello sballo
a base di MDMA. Questi singoli di Terror Danja ci
parlano dalle barricate della velocità horror, dal digrigno di denti in acido che Skream aveva incarnato nei suoi mix. Quel tempo così vicino ma così
già lontano per la perdita di anima e di innocenza è
qui. In quest'ora al fulmicotone -sulla sempre meritevole Planet Mu del fido Paradinas- ci catapultiamo
in un videogioco glitch che è stato già spremuto da
orde di teen brufolosi, sudati e con le manine paffute alla ricerca del record sull'ultima uscita per PSP.
La riscoperta di un talento del calibro del terrorista britannico ci apre un mondo di tracce nascoste,
quasi come avevamo sentito nell'esordio (bruciato)
di Ital Tek. Ora qui, sempre noi a cavallo tra spezzettamenti à la Autechre (Stiff) e omaggi al genio dei Kraftwerk (impressionante Planet Shock),
richiami all'organico giocattoloso del Richard D.
James più ambient (Crowbar 2) e techno nei denti
marci (Limbo, Splash), classici d'n'b (Reloadz) e malinconie horror (Poltergeist appunto). Niente di nuovo.
Ma fatto veramente con uno stile impeccabile. Oltremanica c'è ancora qualche terrorista pronto a far
esplodere la bomba.(7.5/10)
Marco Braggion
rearview mirror
107
(GI)Ant Steps #32
classic album rev
Cannonball Adderley
The Kinks
Somethin' Else (Blue Note, Marzo 1958)
The Kinks Are The Village Green Preservation
Society (Pye, Novembre 1968)
Ispirato dalla stazza piuttosto ingombrante del sassofonista americano - ma mutuato da un “cannibal”
sinonimo di voracità particolarmente sviluppata -,
il soprannome “cannonball” ha sempre rappresentato una sorta di biglietto da visita per Julian Adderley, oltre che un'involontaria chiave di lettura per il
suo stile. Quest'ultimo ben radicato in un ingorgo
di note compresse e perennemente in procinto di
esplodere, con un sax tutto impeto fisico e rapidità
di fraseggio. Più o meno ciò che si ascoltava da un
certo Charlie Parker in tempi non sospetti, di
cui non a caso il Nostro farà le veci in una New York
di fine anni cinquanta orfana dei virtuosismi di un
“Bird” già passato a miglior vita.
Ed è proprio in quella New York che nasce anche
Somethin' Else. Più che un disco, una parata di all stars
colte un attimo prima della consacrazione definitiva.
Alla tromba c'è Miles Davis, con in testa l'idea
meravigliosa del cool ma ancora disponibile a fare da
gregario; alla batteria quell'Art Blakey che dimostrerà di lì a poco tutto il suo valore con i Jazz Messengers; al piano e al contrabbasso rispettivamente
Hank Jones e Sam Jones, session men di lusso
provenienti il primo dalla big band di Benny Goodman e il secondo dai Jazz Prophets di Kenny Dorham. L'anima del disco, comunque, sono loro due,
Adderley e Davis, e con loro la diversa concezione
di suono che si portano dietro. Il primo a stento frenato in uno sbrodolare di note e scale rapidissime, il
secondo impostato oltremisura con la sordina dello
strumento a dipingere scenari di un'eleganza d'altri
tempi. L'hard bop che scende a compromessi con il
cool e il risultato sono brani strutturati e fascinosi
come l'introduttiva Autumn Leaves.
Il tema, in questo caso, lo annuncia con un certo
orgoglio il trombettista - primo segno evidente di
108
rearview mirror
un ruolo che sarà tutt'altro che marginale all'interno del disco - in un distendersi di note che ricorda
le malinconie di Chet Baker ma Birth Of The Cool
fino al midollo. Col sax che entra solo in un secondo tempo, quasi intimorito, sull'onda di qualche svolazzo coerente, comunque, con il mood minimale del
pezzo. Sarà molto meno rispettoso in quella Somthin'
Else scritta dallo stesso Davis che troviamo a metà
scaletta e da cui emerge tutta l'adrenalina rinchiusa
in un ottone palpitante che pennella con vigore, pur
non raggiungendo i picchi di dischi come Mercy Mercy Mercy. Del resto siamo nel 1958 e non nel '66 e la
scena jazzistica newyorkese sta per abbandonare il
bop per buttarsi nel rigore della coolness. Davis lo sa
bene e decide di spiegarlo anche a Julian. Interpretando una Love Sale di Cole Porter sul filo dell'essenzialità, con un Blakey su di giri che si improvvisa
tribale e al tempo stesso disegna ritmiche personalizzate ad ogni cambio di registro: crepuscolari o
rumorose, a seconda del solista che si alterna alla
guida. Il piano di Hank Jones cura l'intro e la cornice
armonica mentre il basso di Sam Jones fa il paio con
le percussioni, in un tutt'uno che entusiasma senza
strafare. La One For Daddy-O scritta dal fratello di
Adderley è un soffiare continuo di ottoni in chiave
blues in cui anche Davis trova il modo di elaborare
qualche parentesi scoppiettante mentre Dancing In
The Dark è la tipica melodia notturna e “piaciona”
dove i solisti possono dar prova di gusto e classe. Il
disco finirebbe qui, ma nella ristampa in CD, a fine
corsa, ci si imbatte anche nel notevole be-bop della
Bangoon scritta da Hank Jones, in cui ci si diverte
parecchio e dove si assiste a un pari e patta nella
sfida tra i due contendenti. Diversa conclusione, del
resto, non ci si poteva aspettare.
Fabrizio Zampighi
Se il fanatismo e l’isteria collettiva che accompagnarono l’ascesa di Beatles e Rolling Stones,
non avessero monopolizzato la scena mediatica a
partire dal fenomeno della “british invasion”, probabilmente saremmo costretti a riscrivere buona
parte della storia del rock. Con il senno di poi, se
i Kinks ricorressero ad un ipotetico tribunale della
storia, otterrebbero senza ombra di dubbio i riconoscimenti (economici e non) ingiustamente negati
all’epoca.
Dopo il discreto successo di You Really Got Me, la
band di Ray Davies, infatti, non riuscì più a ripetersi e, accantonati i riconoscimenti, i Kinks voltarono
pagina scegliendo la strada tortuosa della creatività
senza compromessi, a scapito del successo commerciale.
Già nel ’66, con il brano Village Green Davies introduce un nuovo punto focale nelle tematiche espresse dalla band, preannunciandone la linea futura.
L’irriverenza della critica politica diretta si veste di
nostalgia, guardando indietro ad un mondo immaginario, ancestrale. Due anni dopo, sul rapporto tra
questo passato ideale e la realtà urbana contemporanea Ray Davies costruirà un intero album, seguito
da una rock opera (Arthur) e una rappresentazione teatrale (Preservation, 1972-1974) che ne
riprenderanno l’ambientazione e le tematiche.
Quella di The Kinks Are The Village Green Preservation Society è una storia a dir poco travagliata. Nato
inizialmente come progetto per un doppio album,
scartato senza indugi dalla Pye, il disco uscì in una
prima versione con 12 brani, poi sostituita da quella
definitiva, che ne contiene tre in più. Nel mezzo c’è
la vicenda di Four More Respected Gentlemen, un album preparato appositamente per il mercato americano e mai pubblicato.
Tanta fatica per nulla.The Kinks Are The Village Green… esce il 22 Novembre 1968, lo stesso giorno
in cui viene distribuito l’Album Bianco dei Beatles. Il
destino, ancora una volta. Sarà un flop. Ma si tratterà
del “Most successful flop of all time”, come lo ha
definito Ray Davies di recente, dopo aver raccolto
i meritati frutti postumi di uno dei più importanti
album della band.
Strutturato in una serie di scenette, l’album propone fotografie sbiadite di un’Inghilterra che fu. Il
rimpianto per la tradizione, però, non è da intendersi come un rigurgito conservatore, bensì come
uno spunto per ironizzare su certo buonismo della
middle-class inglese.
L’atmosfera nostalgica che pervade i testi dell’album
è ricreata musicalmente da scelte quanto mai eterogenee. Dalle atmosfere un po’ cabarettistiche e
un po’ malinconiche di All Of My Friends Were There,
ai ritmi caraibici di Monica; dai deliranti proclami di
We Are The Village Green Preservation Society, alla sbeffeggiante psichedelia di Phenomenal Cat, i Kinks mettono in piedi un circo di immagini che non può non
ricordare Sgt. Pepper’s nel suo sollevare cumuli
di polvere su oggetti antichi, infondendo nuova vita
ad epoche storiche lontane un’eternità dallo spirito
del tempo.
Un universo di ricordi, fotografie (Picture Book), paesaggi agresti (Animal Farm), personaggi indimenticabili (Do You Remember Walter?; Johnny Thunder),
vengono riesumati e messi a confronto con la folle
e confusa società contemporanea. L’importanza di
“trattenere i ricordi”, elemento unificante di tutto
l’album, emerge con chiarezza nella scena finale di
questo insieme di schizzetti, People Take Pictures From
Each Other. Come in preda ad una mania, le persone
scattano fotografie ad ogni cosa si trovino davanti,
per poter provare in futuro l’esistenza di quel momento. Un ultimo, estremo tentativo di far parte di
un mondo che non esiste più.
Daniele Follero
rearview mirror
109
Champagne
Arte
contemporanea
Riflessioni su arte contemporanea, video arte e cinema, in
occasione di una visita al Guggenheim Museum di Bilbao
- Luca Colnaghi
110
la sera della prima
e noccioline
New York, Berlino,Venezia, Bilbao, Abu Dhabi. Ecco i
luoghi dei cinque più famosi Dolmen dell’arte moderna e contemporanea, i Guggenheim Museum.
L’inestinguibile sofisma dello statuto dell’opera d’arte, oggi ormai spolpato ed esautorato a chiacchiera
da bar. Cedrata Tassoni e salatini. E se la vita è un po’
come la scatola di cioccolatini – Gump insegna - un
museo d’arte moderna e contemporanea è un po’
come la ciotola dei salatini. Può contenere Fonzies, e
finisci che ti lecchi le dita, così come ti possono capitare le noccioline, potenzialmente quelle di …E alla
fine arriva Polly di John Hamburg, quelle che
contengono il raduno mondiale dei nemici dell’igiene. E allora ciao. è stomacata per sempre. Come per
le cozze. E se ti va bene. Chi non si ricorda l’enorme fallo di porcellana che uccide la vecchia che fa
yoga in Arancia Meccanica (Stanley Kubrick,
1971)? Andy Warhol era un coatto dice Tommaso Labranca nel suo celebre libro. Sarà. Ma di
furbetti ce ne sono tanti. Artisti o presunti tali. Poi
ti dicono che non puoi capire e capirai tra cent’anni. Come le sperimentazioni elettroniche di Lucio
Battisti. La devi capire o sei out. Ed ecco che quindi
il museo d’arte contemporanea diventa una sorta di
purga culturale. è Fantozzi che spegne la radiolina
dove trasmettono la partita di calcio e si mette a
patire volontariamente di fronte al Potemkin. Si va
anche per non capire, come la messa in latino nel
medioevo.
E al Guggenheim di Bilbao il pubblico è vario, nonostante l’audio guida. Ci sono quelli che passano
l’intera giornata in una galleria, prendono appunti
con febbrile devozione, tracciano bozzetti e consultano tutto il materiale multimediale. Chiamali amanuensi. Ci sono quelli nel mezzo. Ci sono gli altri,
come in Lost. E come in Lost se guardi bene sono
sempre di più e ovunque. Molti si arrendono subito
lasciando l’audio guida penzolare al collo, altri dopo
aver confuso il numero dell’opera con quello della
sala o della galleria, ricevendo segnale muto dall’apparecchio. Nervosismo. Resa. I diecimila metri quadri di spazio espositivo diventano pascolo dove la
suggestione diventa libera. Perché indubbiamente,
anche se non si capisce l’intento originale dell’artista
(il sospetto spesso è che l’intento che ha dato via al
folgorante colpo di genio sia in realtà un’osservazione fatta a posteriori), suggestione, curiosità o per lo
meno perplessità sono stati d’animo democratici. Lo
spazio sognante inizia all’esterno a Bilbao. Lo scafo
di una nave rovesciata ricoperta dalle lastre che do-
vrebbero ricordare le squame di un pesce. Quello di
una carpa che la nonna dell’architetto Frank Gehry teneva in una vasca. Succede anche nelle migliori
famiglie. Ora, non si prenda questo come il manifesto della controcultura o il baluardo di chi come
qualche nostro politico grida fiero, «un film di Pierino
vale tutto Antonioni». Tutt’altro. Il populismo culturale
ha fatto tante vittime quanto la cucina cinese, l’aids, il
tabagismo. Piuttosto c’è da chiedersi cosa sia e quali potenzialità abbia effettivamente l’arte moderna,
quale sia il suo pubblico, se vi sono dei livelli di comprensione. Una sorta di scala a gradi come per il terremoto o la massoneria. Bilbao, galleria Learning
through art, l’arte moderna fatta da bambini. Dimostrazione del mito futurista dell’artista bambino
o dubbio amletico dei seguaci di Sordi? Tutto questo
nell’epoca in cui un altro reperto museale, il recentemente scomparso Mike Bongiorno, si metteva
alla prova con Sei più bravo di un ragazzino di
5a su Sky.
La Cugina
chic del cinema copia!
È in questo clima sognante o semplicemente assopito, dipende dai punti di vista, che la cugina più chic
del cinema, la video arte, si presenta con tutto il
suo corredo di intellettualismi, macchinazioni, artifici
e sorprendente intelligenza. Due cose mi hanno colpito sempre dell’arte moderna: la riflessione sul sociale traducibile come dramma del messaggio; l’aspetto di riproducibilità, la riflessione sul suo essere copia
di. Il secondo ha avvelenato gli ultimi 50 anni almeno,
e a ben dirla gli ultimi due secoli. Da copia del reale, a
copia dell’oggetto, a copia di copia. Apogeo di zuppe
Campbell e guerriglieri eroici: dall’oggetto comune
all’opera d’arte il passo era stato breve. Poi l’esplosione delle pretese un po’ artistoidi e a volte anche
un po’ cazzare di un gruppetto radunato attorno
alla corte di miracoli del furbetto del quartierino di
Pittsburgh. Iniziava il Camp quintessenziale.
Se nell’epoca del boom economico ad essere trasformato in oggetto d’arte era l’oggetto industriale,
quindi la bottiglia della Coca Cola, latte di zuppa e
quant’altro, oggigiorno la società dello spettacolo si
diverte a guardare alle moderne forme di intrattenimento. Sport e musica in primis, usati per ricavarne altro: un film-opera o molti film-opera. Se il film
in sala è diverso da quello in DVD grazie a inserti
speciali, giochi, poster, menù interrativi, la video arte
nei musei non è da meno. Prendiamo Zidane, un
portrait du 21e siècle (2006). Il film è conosciuto già ai più. Se ne parlò tanto in Tv, ne hanno fatto
la sera della prima
111
un edizione in DVD, sulla scia c’è stato poi Kobe
Doin’ Work (USA, 2009) di Spike Lee su Kobe
Bryant che avevamo recensito il mese scorso. Douglas Gordon e Philippe Parreno riprendono
Zizou con 17 camere sincronizzate, mischiando HD
e 35mm, in&out tecnico per il corpo e i gesti dell’atleta immortalati come opera d’arte. Come per il
body painting qui il soggetto è più vivo che mai. Corre, impreca, sbraita, sputa, fa magie. Ovviamente non
potevano mancare i Mogwai. Al museo però il film
è riproposto in una
vesta innovativa su
due schermi. Sul primo il final cut cinematografico presentato
a Cannes. Sul secondo delle immagini
inedite che a volte si
allineano con quello
dello schermo primario. Il real-time portrait
in questo caso si arricchisce di qualcosa
in più. Non si tratta
necessariamente di
un film diverso, ma
nemmeno si può parlare dello stesso film.
Gemelli, si ma come
Danny de Vito e Arnold Schwarzenegger. E se sul secondo
schermo fosse possibile selezionare quali
immagini proiettare
in una sorta di montaggio immediato ad opera degli
spettatori? Il mantra temuto è 2.0. Nessun cifrario
cabalistico o passaggio biblico. Solo il destino che
l’opera (d’arte) ha già iniziato a percorrere in internet e sui nuovi media. Riassumibile nella formula:
opera collettiva. Più che a spaventarsi per il destino
dell’opera d’arte, dell’autore, dovremmo forse pensare che dopo Bryant e Zidane a qualcuno verrà la
brillante idea di compiere un’operazione analoga su
Tiger Woods o Vishy Anand, campione del
mondo in carica di scacchi. Sai che brividi. Il resto è
normale operazione di routine. Si filma un evento, lo
si decontestualizza come i migliori ready-made ci hanno insegnato. Però se questi erano comuni manufatti
di uso quotidiano, ora ci troviamo di fronte a copie,
modifiche, derivate di prodotti dello spettacolo che
112
la sera della prima
oltretutto erano già presenti in video. La partita di
calcio tra Real Madrid e Villareal del 23 aprile 2005
esiste come ricordo nella memoria degli spettatori,
come montato televisivo, come versione presentata
a Cannes dell’opera di Gordon e Parreno, come versione DVD e infine – con possibilità di ulteriori sviluppi – nella versione presentata al Guggenheim di
Bilbao. Insomma, un Rashomon calcistico. Le stesse
possibilità, forse, in un futuro, potrebbero essere allargate anche alla regia televisiva che già permette
per la Tv digitale di
selezionare il tipo di
inquadratura. Immaginatevi la possibilità di
eseguire per ogni giocatore in campo quanto fatto dai due registi
per Zidane. E ad opera
di ogni spettatore. Privatamente. Dalla propria poltrona, dal proprio televisore, con il
proprio telecomando.
L’incubo di George
Orwell tramutato in
forma di espressione
artistica. Le vite degli
altri, presenta il signor
Rossi.
Sempre di copie ed
esercito dei cloni si
parla nello splendido
The doppelganger
slater bradley
Trilogy di Slater
Bradley, classe ’75.
Tre schermi (nella video arte lo schermo multiplo
va forte), tre star si esibiscono live: Michael Jackson, Kurt Cobain, Ian Curtis. Stile documentarista per questo falso footage. Jako è filmato con un
bianco e nero in super8, muto. L’esibizione di Curtis
è resa da una pellicola rovinata, metafora del doloroso ritmo musicale dei Joy Division. Cobain con
una telecamera amatoriale che incornicia primi piani
mossi. Fin qui niente di diverso da quanto ci hanno
abituato Julien Temple o Martin Scorsese,
più qualche vezzo in più da artista. Peccato che ad
esibirsi sia sempre il sosia di Bradley, Benjamin
Brock. Per chi non aveva considerato il triangolo:
il sosia di qualcuno che diventa il sosia di un altro,
idolo di quel qualcuno. L’artista californiano è solito
lavorare con video istallazioni, fotografie che voglio-
Mika Rottenberg
no essere frammenti di storie dimenticate, non raccontate, spesso legate agli idoli della sua adolescenza.
Un olimpo iconografico tutto personale insomma.
Romanticismo del consumo e dell’eroe decadente.
Brock studia la psicologia di Bradley attraverso i
dischi che ascoltava in adolescenza. Il monito della società dei simulacri è chiaro: siamo quello che
consumiamo. Il legame tra realtà, vita e morte passa
attraverso il consumo, da intendersi sia come deterioramento che come utilizzo. Tre eroi decadenti.
Due suicidi e un Jackson sconvolto dallo scandalo
pedofilia. L’opera d’arte si intreccia con la vita, anzi
come nel caso del film dedicato a Zidane, la vita – o
per lo meno le sue porzioni performative – diventano opere d’arte. Del resto questo statuto lo avevano
nel DNA. I tre saranno risarciti del falso da Last
Days (2005) di Gus Van Sant, Control (2007)
di Anton Corbijin e nel caso di Jackson bisogna solo
saper aspettare, i diritti se li è già accaparrati la Sony
e alla regia dovrebbe esserci Kenny Ortega, quello di
High School Musical (2006). Un film per bambini,
ironia della sorte.
Il Dramma
del
Messaggio
Il secondo aspetto sul quale la video arte e in senso lato l’arte contemporanea non può fare a meno
è il messaggio, specie se legato al contesto sociale.
Diciamo che è quasi una sorta di giustificazione, il
contro altare della sua difficoltà concettuale. Mika
Rottenberg con il suo Dough (2006) di 7’ propone delle operaie che sembrano essere uscite da
un film di Tim Burton. Abbiamo la sentimentale cicciona di colore, l’annoiata segretaria di Twin
Peaks, l’anoressica dall’unghia laccata rosa shocking.
Tutte intente a lavorare un impasto melmoso nella
filiale futurista di Willy Wonka, un edificio brevettato
Freddy Sport dove girandole, pedaliere sono l’unica forma di divertissement, ovviamente non sfruttato
dalle operaie. Queste sono in mezzo a una fanghiglia
color ocra, non a bolle di sapone del resto. Quello
che sembra lo spot ideale per il Mr. Muscolo o per
qualsiasi integratore della flora intestinale è ovviamente un’acuta osservazione sul mondo del lavoro.
Una sorta di Tempi moderni di noi altri. Al femminile. Per le quote rosa. Del resto dopo gli anni ’40
i baffetti sono visti con sospetto. Mika Rottenberg
come Charlie Chaplin mostra l’apatia e la meccanicità del lavoro. Anche quando sembra fantasioso è sempre meccanico. Del resto puoi suonare la
tastiera gigante a F.A.O. Schwarz, ma se per anni
suoni sempre Fra’ Martino alla fine son sempre i soliti tasti o se la fai in RE minore, la stessa successiola sera della prima
113
suna corrente politica è per sempre, forse il tempo
non è stato gentile nemmeno con la religione. Di
certo non lo è con l’arte né con ogni sua corrente
artistica. Nel gruppo di Court Yard viene riproposta
una celebre opera cinese, leitmotif dello sfruttamento da parte dei proprietari terrieri ed inno alla liberazione nazionale di Mao. Ma Cai Quo Quiang e Cai
Fei mostrano una rivoluzione incompiuta nelle loro
opere. L’esercito di terracotta di Mao si sgretola differentemente da quello del primo imperatore Qin
Shi Huang. L’armata eterna cede il passo al nuovo
millennio, a crollare sono le ideologie e le correnti.
Quale
ne. Ti scassi. Resta indubbiamente l’interesse per il
mondo del lavoro. Bisognerebbe chiedersi se questo
interesse è una presa di coscienza, una sorta di socialismo proattivo targato nuovo millennio da parte
dell’arte e dell’artista o semplicemente un vezzo un
po’ naif come la kefia griffata e colorata.
Poi ti capita tra le mani un video sponsorizzato da
un’azienda come Whose Utopia di Cao Fei. In questo caso i soldi sono della Osram. Mi sia permesso
il gioco di parole: l’imperatore della lampadina come
luminario? Illuminato lo è di certo, ma al punto di
finanziare un video nel quale viene mostrato il grigiore del processo di lavorazione dei semiconduttori? Bell’ossimoro. Perché al di là dello spottone,
il girato in fabbrica nasconde il germe della verità.
Parte prima: Imagination of a Product, traducibile in danza meccanica delle lampadine nella catena
di montaggio; parte seconda: Factory Fairtale, una
sorta di risveglio da primavera del Botticelli dell’era
industriale; terza parte: My Future is not a Dream, musica onirica e laghetto dei cigni e delle gru,
quelle che spostano gli scatoloni e li mettono sui
bancali. Per un certo illuso ottimismo ricorda i primi
documentari industriali di Ermanno Olmi. Addirittura qui le magnifiche sorti e progressive della fase
onirica, escapismo virtuale per una massa di operai
cinesi, sono celebrate dalla musichetta che parte proprio quando inizia l’incursione nel fantastico. Operai
che cantano, ballano, giocano. Almeno come desiderata. Ed ovviamente ecco comparire il logo del gruppo. La falsa coscienza storica che si respira ricorda
il pay off del più grande villaggio vacanze della storia:
il lavoro rende liberi. Sappiamo tutti che di sognante
in fabbrica - tolti i sogni rivoluzionari degli Stormy
Six – c’è ben poco. Se Rottenberg, con le lacrime
114
la sera della prima
dell’operaia, mostra emozioni impacchettate nella
freddezza del cellophane e interiorizza un rapporto di routine proprio alla vita lavorativa quanto alla
sfera degli affetti, cosa fa Cao Fei? Siamo nel canone
tipico della sua produzione a cui ci aveva abituato nel
corso dell’esposizione Asian Dub Photography
(Foro Boario di Modena nel 2008), quindi lo stile
scanzonato rappresentato da fantasie volutamente
naif e adolescenziali? O siamo di fronte ad un’amara
riflessione del mondo reale? Il colosso Osram China
Lighting ha pagato e acconsentito le riprese nello
stabilimento di Guangzhou. Cao Fei insiste sui volti
come in What are you Doing Here? sempre del
2006, non cerca più rifugi come in Cosplayers (
2004). Volti. Nonostante i primi piani anonimi. Nella massa indistinta. Nonostante i sogni. Il motore di
sviluppo sognato da Mao si è ingolfato. Eduardo
Galeano non ce ne vorrà, ma l’utopia a camminare sul nastro di una corsia di montaggio in fabbrica serve a ben poco. Tra porci con le ali e cinghiali
laureati in matematica pura, resti sempre nel solito
punto. Immobile come in Head One, istallazione di
design teatrale presentata al Guggenheim di Berlino
e presente in copia a Bilbao, di Cai Guo Quiang; o
alle statue d’argilla della Collezione Court Yard.
Nel primo 99 lupi imbalsamati si schiantano contro
un vetro, un muro invisibile che fuori dalla metafora
diviene emblema del Muro di Berlino o di qualsiasi
altro regime politico. Per il branco ideologico di matrice nazista c’è ancora speranza, però. Avrà forse
ragione Hobbes , homo hominis lupus, ma i lupi sono
99. Ogni epoca ha il suo centesimo: Cristo, Marx,
Ghandi, Buddha. Anche se lì vicino il gruppo The
Age of not believing in God fa da chiaro monito
sulle sorti che aspettano anche a questi ultimi. Nes-
futuro?
Domanda che ci siamo fatti per il cinema a suo tempo. Figurarsi per l’arte, è almeno dai tempi di Nadar che l’interrogativo è diventato quasi pruriginoso.
Qui non si parla più solo di ready made, video arte
o cultura pop. Cioè non saranno certo le incursioni
del linguaggio pubblicitario o del quotidiano a intimidire l’arte moderna. Sono cose che non intimidiscono nemmeno il cinema, decisamente più bacchettone. Operazioni come i neon a cascata carichi
di frammenti di spot pubblicitari di Jenny Molzer
dimostrano tutti i loro cinquant’anni abbondanti di
servizio. E il legame non proprio poetico tra necessità commerciali e intenti artistici di un museo sono
ormai evidenti ai più. L’opera Names del brasiliano
Jac Leirner, che da i sacchetti brandizzati di altri
musei trae un’opera per il Guggenheim di Bilbao, fa
riflettere due volte. Oltre al giudizio ad personam o
in base al luogo, lo statuto d’opera d’arte può oscillare tra luoghi con le stesse competenze, dato che
sempre di musei si tratta. Uno presente come brand.
L’altro come luogo dell’allestimento. Non solo che
cos’è l’opera d’arte, ma cos’è il museo, oggi. Ed è
da questo interrogativo che muove i passi l’iniziativa
Everything is a Museum. Riconversione di spazi
altri. Per ora tre, uno in Giappone, uno in Toscana
e uno a Taiwan che utilizza ex bunker della guerra
combattuta contro la Cina. Tutto questo mentre architetti illustri progettano nuove sedi del Guggenheim in giro per il mondo.Tutto questo mentre alcune scolaresche disegnano e costruiscono i modellini
del loro museo ideale. Sorprendentemente il genio
non ha né età né titolo di studi. L’impressione che se
ne ricava è che per l’arte contemporanea, oggi, dopo
la rivoluzione pop e digitale, gli interrogativi spinosi
non siano tanto cos’è un’opera d’arte o cos’è un
museo. Ormai è divenuto chiaro a tutti che ci sarà
sempre qualche genio che dipingerà con tuorli d’uo-
vo un copertone, qualche intellettuale che lo vedrà
come una critica alle quote alimentari dell’Unione
Europea e qualche yuppie che lo acquisterà. La vera
sfida, oggi, è dopo aver fatto entrare in questo club
esclusivo una tecnica o un’opera capire come è possibile copiarla, riprodurla nella maniera più precisa
possibile e su quanti canali. L’artista cinese Cai Guo
Quiang rilancia con le esplosioni, l’ architettura della
deflagrazione. Altro ossimoro. Nel 2008 è divenuto
famoso con i giochi olimpici di Pechino, ma è da molto più tempo che nel settore il suo è un nome ben
noto. Del resto sono in pochi gli artisti in grado di
lavorare con l’imprevedibilità della dinamite. Ancor
meno quelli in grado di abbinare colori, forme, suoni,
ritmo.A testimoniarcelo lavori su tela, video che mostrano il suo modo di operare, una sorta di dietro le
quinte e risultati finali non così poi distanti da quel
cinema Hollywoodiano d’azione che va oggi. L’arte
pirotecnica non aggiunge niente di nuovo al dialogo
sulla caducità delle correnti artistiche e delle opere
stesse, del resto già arti performative e body painting
avevano sostituito il miraggio dell’immortalità fisica
ad un carpe diem emozionale e ad un’eternità virtuale, quella video ad esempio. Sicuramente offre uno
spunto di riflessione per il nuovo millennio. Possono
essere due spettacoli pirotecnici davvero identici o
per lo meno sembrar tali? Salvo cataclismi meteo
verrebbe da dire sì. Ma cosa dire in merito alle tele
istantanee dipinte in cielo con esplosivo e vernice?
I fattori discriminanti sono le condizioni atmosferiche: luce, vento, umidità e molti altri. Ancora più
aleatoria ogni tipo di conclusione se ad esser presa
in considerazione è l’azione della polvere da sparo
su una superficie di lavoro, ad esempio la carta. Domandiamoci prima di tutto se la composizione tra
una tela e l’altra sia la medesima. Poi se chi dovrà
soffocare il principio di incendio userà la stessa forza o avrà gli stessi riflessi e tempi d’azione. Anche a
rendere l’operazione meccanica, il fuoco resta sempre imprevedibile. Vi è una sottile differenza tra le
due prospettive. L’interlocutore del tenzone cambia
e l’altro viene seppellito. Nietzsche ha detto che
Dio era morto. Nas alla liste dei defunti ha aggiunto recentemente l’hip hop. Schicchi nel suo libro
autobiografico piange la morte della pornografia.
Un loculo nel camposanto dei prodotti di consumo
forse spetta anche all’arte contemporanea. Suicidio
preterintenzionale o colposo? Unico vero highlander è l’idea di copia, la volontà di copiare che resta
fine a se stessa. Per ricordarci che chi di spada ferisce, di spada perisce.
la sera della prima
115
Baarìa
di G iuseppe T ornatore (I talia , 2009)
Vi dico subito che il film non mi ha lasciato molto. Magniloquente, forse più tendente al pomposo.
Budget da sceicco, minutaggio elevato (Tornatore
e le forbici sono due cose a sé), cammei a volte pretestuosi ed introdotti da insopportabili primi piani
frontali e dolly. Giusto per dire: guarda chi abbiamo in questa scena, e compiacere la parte feticista
del pubblico. Impossibile nominarli tutti. Michele
Placido, Beppe Fiorello, Aldo Baglio, Nino
Frassica nella parte di Nino Frassica, Leo Gullotta, Luigi Lo Cascio, Raoul Bova, Giorgio
Faletti, Laura Chiatti (2 secondi di celebrità)
e Monica Bellucci in quella che se non esistesse
il marketing verrebbe ricordata come la più inutile
partecipazione della storia, ma che così viene tradotta nella più consueta formula di amichevole partecipazione di. Comunque grazie, grazie Monica.
Come ultima terribile colpa un simbolismo presumibilmente poetico che farebbe storcere il naso
anche ai più ferventi amanti del montaggio delle
attrazioni o di Rimbaud. Il problema è che differentemente da Nuovo Cinema Paradiso (1988) il
film manca d’anima. Le vicende di tre generazioni di
una famiglia di Bagheria coprono un cinquantennio
che va dagli anni ’30 agli anni ’80, ripercorrono una
serie di stereotipi che al cinema hanno già avuto
eco - come l’immancabile sessantotto italiano evidentemente ancora in corso - per poi perdersi in
un niente di fatto quando il regista cerca di allargare
il cerchio all’universale. Sogni, disillusioni, ideali fino
ad una serie di immagini metaforiche che si rincorrono e ricorrono per tutto il film per quello che
vuole essere un film familiare, cittadino, universale,
ma soprattutto un’evidente summa personale. Per
ricordarci che la storia si ripete, che l’uomo rincorre i propri errori. Che siano una dittatura, l’assenza
di democrazia, una guerra, un pacchetto di sigarette.
La memoria storica passa dai racconti degli anziani,
dal cinema, poi dalla televisione di Mina e dei primi spot pubblicitari con le minigonne delle ragazze
yeye. Celebrazione della propria poetica, autocitazioni, feticci ricorrenti messi in scena in una serie di
canovacci e parate barocche. Santi inclusi.
L’idea che Giuseppe Tornatore ha del suo cinema passa attraverso la tradizione realista, il cinema
classico americano, ma non disdegna momenti onirici che ricordano un certo cinema sudamericano
post rivoluzione sessantottina. Roba malavogliana
all’Arrabal. Il problema che il passaggio tra questi
116
la sera della prima
registri formali e visivi è assolutamente irregolare e
l’ossessione per la cartolina hollywodiana da premio oscar soffoca velocemente tutte le buone idee.
Perché la cura maniacale del lirismo di ogni aspetto fa perdere naturalezza e anima ad un prodotto
che vista la natura autobiografica doveva puntare
su quello. Invece sembra di assistere ad un’opera
teatrale studiata in soli, gravi, ascensioni. Il tutto è
così architettato e fittizio che la scena nella quale un
bovino viene realmente colpito con un punteruolo
nel cranio e lasciato morire mentre gli attori ne bevono il sangue risulta ancora più fastidiosa. Come
se bastasse questo a far gridare al realismo, seppur
doloroso. Tutto questo potrebbe essere riassunto
semplicemente dicendo: Baarìa è un film di Tornatore, e non poteva essere altrimenti, come la sua idea
di cinema, sempre uguale a se stessa. Come la vita
a Bagheria.
Quando Peppino (l’ottimo Francesco Scianna)
di ritorno da un periodo di lavoro in Francia passa attraverso la piazza del paese, i compaesani gli
chiedono dove è diretto, proprio a sottolineare che
nessuno si era reso conto della sua assenza, o meglio nessuno aveva voluto sovvertire l’ordine delle
cose. Per farla breve: candidato all’oscar. Per l’idea
che gli americani hanno dell’Italia, non tanto pizza
mafia e mandolino quando si tratta di cinema. Ma biciclette, quelle di Vittorio De Sica e guarda caso
anche di La vita è bella (1997), Nuovo Cinema Paradiso e Malena (2000); scene d’ozio in
piazza e vita familiare tra casa, sellino e porfidi. Le
locandine della distribuzione d’oltreoceano parlano
chiaro e presumibilmente Medusa non sbaglierà tiro
quando si tratterà di distribuire e posizionare il film
negli USA. C’è l’amore per il cinema, l’interesse per
la politica e la microstoria, il macchiettiamo dell’Italia esportabile in America. Insomma l’epopea di noi
altri.
L’ampiezza di respiro del racconto prodotto ricorda quella di alcuni film dal impianto operistico come
C’era una volta in America (Sergio Leone,
1984), ma soprattutto Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976) e La meglio gioventù
(Marco Tullio Giordana, 2003). Bandiere rosse
ovunque, la rivoluzione agraria, rivolte sociali. L’incontro sui colli tra le delegazioni di braccianti di
paesi differenti e la corsa agli appezzamenti ricorda
la corsa ai latifondi della frontiera americana, penso a Cuori Ribelli (Ron Howard, 1992). Nella terra dei limoni, però, il gusto finale non poteva
che essere agrodolce, come la scena dell’assessore
cieco nominato all’urbanistica. Ecco quelle che sembrano essere le parole d’ordine dei grandi affreschi
cinematografici prodotti in Italia. Come se Pelizza
da Volpedo avesse segnato più di chiunque altro
il nostro immaginario. Ma questo clima epico da limoni e lupara si sgonfia a causa di un’epica tronfia
studiata a tavolino. Persino le partiture di Ennio
Morricone arrivano a nauseare, il che sembra
quasi impossibile, soprattutto dopo la lezione de
La sconosciuta (2006), in cui era stato commesso il medesimo errore. Eppure alla fine, ubriachi di
sinfonie roboanti e immagini perfette e luminose, ci
si inginocchia e si implora un solo minuto di cinema
del silenzio. Perché Tornatore conoscerà a perfezione la Sicilia, ma dove sono i silenzi e la quiete delle
due del pomeriggio, il rumore della sabbia sulle gradinate, il profumo della terra arsa?
Baarìa è un romanzo popolare picaresco, un amarcord nella terra dei limoni in cui la ciclicità dei ricordi disorienta lo spettatore, non il regista che ha
la planimetria completa della sua cosmogonia. Al
punto da citare e autocitarsi con enorme naturalezza: la scena con i fotogrammi delle pellicole cinematografiche, gli omaggi al cinema di Alberto
Lattuada e Sordi, i ricordi dei bombardamenti e
dei rifugi antiaerei da Malena (2000). Questi sono
i momenti in cui davvero ci si può commuovere,
perché si intende subito il gesto d’amore per il cinema e nel cinema di Tornatore, la devozione che il
regista nutre per la sua terra. A fallire invece sono
le scene madri e le immagini metaforiche. Le uova
rotte, la presenza dei serpenti, l’orecchino, la mosca nella trottola con cui si chiude il film. Più che
lirismo rasentiamo troppo facilmente il folklore, e
caricando tali passaggi di un’importanza eccessiva
perdiamo di vista la loro natura spirituale, portando a casa un nulla di fatto proprio quando si cerca
di accordarli con la voce dell’universale. All’uscita
della sala mi sono sentito come quelli che con l’arrivo degli americani facevano irruzione nelle sedi
del fascio per portarsi via qualcosa, qualsiasi cosa.
Ma oltre all’amarezza per il poco che ne rimaneva,
dopo i tentativi più disperati, ho potuto anche io
solo prendere la porta e tornarmene a casa.
Luca Colnaghi
Ben X – il coraggio è tutto
di N ic B althazar (B elgio – O l anda , 2009)
Ben (lo sconosciuto Greg Timmermans) è diverso, è un diciassettenne affatto dalla sindrome di
Aspergen, forma lieve di autismo. Detto in breve
ha problemi relazionali, per il resto funziona tutto
(o quasi) alla perfezione. Per questo preferisce vivere in un mondo tutto suo aggrappato alla realtà del gioco on-line Archlord. Bullismo, autismo e
logiche di branco per una gioventù inquieta. Ecco
i dati essenziali per l’esordio alla regia di Nic Balthazar, risalente al 2007. Una campagna promozionale sapientemente orchestrata, un costo di soli
15M€, una serie di premi collezionati nei più
svariati festival.
Non siamo di fronte ad un nuovo Rain Man (Barry Levinson, 1988), forse più legittimo pensare a
Donnie Darko (Richard Kelly, 2001), conigli
esclusi. Certo è che dopo il terribile sequel del film
di Levinson, S.Darko ogni riferimento al vecchio
e caro Donnie è andato a farsi benedire, quindi si
potrebbe dire più semplicemente che non si tratta
della classica menata sociologica. Per fortuna. Non
che in più di un’ora di pellicola non vengano toccate
tematiche spinose, tutt’altro. Solo che il regista ci
risparmia il pietismo e le lacrime, nell’ultimo scatto
pecca di morale, ma non poteva essere altrimenti
visto il colpo di scena finale forzato, forse indigestione di ostie e acqua santa. Del resto per tutto il
film lo spirito da chierichetto del regista un po’ lo
si respira. Ben sotto effetto di una droga sintetica
la sera della prima
117
recita le stesse parole di Cristo in croce, nel suo
tragitto verso scuola osserva costantemente la facciata di una chiesa, la sua arma è un crocifisso. Del
resto i suoi nemici sono simili alle presenze infernali
che affronta on-line. Ovviamente premio della giuria
Ecumenica al Montréal World Film Festival.
Indubbiamente lodevole, però, il tentativo di non
fermarsi semplicemente ad una condanna di certi
atteggiamenti. Donnie, Ben, sono tutti primi piani
di una panoramica sulla generazione d’oggi. Se il
telefilm e il piccolo schermo offrono una visione
più spensierata e glitter, il cinema ne mostra il lato
sofferente. Filo di conduzione è l’incomunicabilità, e
non siamo in un film di Antonioni. Perché qui non ci
sono silenzi. Ci sono monologhi e discorsi profondi
senza prospettive. Ci sono telefonini e computer
che trasferiscono frammenti di una personalità che
tende a comporsi quotidianamente come un avatar
virtuale allo specchio. Signori e signore ecco l’ovvio paradosso nella società dell’iper-comunicazione,
niente di nuovo dal fronte. Camere che diventano
bunker per una generazione di otaku senza fumetti,
universi personali che parallelamente sono segnale
evidente della disgregazione della famiglia. Filo ratzingeriano. Autistico e figlio di una coppia separata.
Si riscatta dai pensieri suicidi solo quando in soccorso vengono entrambi i genitori. Titolo e nickname
118
la sera della prima
ma anche indizio, in olandese «Ik ben niks» significa
sono nessuno. Per noi traducibile nel pirandelliano
uno, nessuno, centomila. Nessuno come quello che
è convinto di valere il protagonista. L’ultima è la possibilità delle vite online, ma anche l’universalità della
storia di un Ben qualunque. E visto il modo in cui la
notizia del suicidio viene data dal telegiornale, una
percentuale di suicidi e casi depressivi tra i giovani
fiamminghi ci si rende conto che poi tanto singolare
questa vicenda non è.
Ispirato ad una vicenda realmente accaduta, poi bestseller come romanzo e successo teatrale, ora film,
futuro remake targato Hollywood. Un po’ quest’ultima vita spaventa, ma si sa, quando si parla di videogiochi è abbastanza facile guadagnare una vita in
corso. +1up. Per quando la realtà virtuale è un rifugio contro l’impossibilità del quotidiano. E verrebbe
da dire, non solo per quelli come Ben. Chi si ricorda
il Thomas In Love di Pierre Paul? Nell’epoca
di Second Life e Second Skin (Juean Carlos
Pineiro Escoriaza, 2008) i MMORPG (Massive
Multiplayer Online Role Game) diventano l’ultima
frontiera della Terra Promessa. I rifugiati aumentano proporzionalmente ai video di certe bravate su
youtube. Così la vita di Ben è in realtà quella di Ben
X. Costruzione dell’avatar allo specchio. Quella reale è solo una parentesi obbligatoria tra il caricamento di un livello e l’altro. Realtà antitetiche che
si vengono a scontrare. La celebrità per il conseguimento dell’80° livello in rete e la celebrità per
le angherie cui è costretto a sottoporsi. Ben poco
di eroico nella vita vera. Il problema sarà quando in
pericolo verrà messo il suo mondo online, la sua
isola felice. Dopo essere stato denudato e filmato,
il ragazzo scopre che il video è stato caricato in
internet. Viene violato così il suo universo sacro.
Game Over o quasi. Fino a quel momento il film
procede abbastanza linearmente, nonostante i salti
anche visivi tra il mondo virtuale e quello reale. Poi
nonostante tutto il nostro buon cuore ci si aspetta
che, insomma, Ben schiatti. Ogni società ha bisogno
di un martire e il nostro perbenismo era già pronto
a usare questo esempio per commuovere.
Tolta la breve parentesi in cui si assapora la possibilità di un omicidio di un’ignara passante, la parte
finale è centrata sul progetto autodistruttivo del
protagonista. Distruzione della postazione di gioco
al pc in un going berserker allucinato, quindi temporanea morte nel mondo virtuale. Poi pianificazione
di quella reale, ma a ritmo sincopato. Requiem che
inizia con una lametta davanti allo specchio, poi in
un letto ed infine in stazione. La storia vera probabilmente sarebbe finita lì. Ma il Gianni Rodari d’
Olanda ricorda che se per fare un albero ci vuole
un fiore, per fare capire certe cose ci vuole un martire. Solo che il suo nascosto fervore religioso deve
averlo spinto ad una resurrezione on stage.
Luca Colnaghi
Bastardi senza gloria
di Q uentin T arantino (USA - G ermania ,
2009)
Avvertenza: quanto segue è complicato. È un insieme di citazioni, fastidioso e non lineare. Più o meno
pertinenti. Come il film. E non vale dire che Tarantino può perché è Tarantino o perché l’ha sempre
fatto. Ha ancora senso parlare di storia degli autori
oggi? A questo punto tanto vale fare un'apologia del
nazismo, del reality show, delle infradito. Insomma
sto giocando con voi.Vi offro una seconda frustrante occasione. La morale potrebbe essere: non augurerei nemmeno al mio peggior nemico di essere un
cinefilo.
L’armata Brancaleone veste i panni borghesi e va
a caccia di nazisti. Quentin Tarantino, il genio
masturbatorio per eccellenza, immortala l’ultima
grande Sturmtruppen e riscrive il corso della
storia in quello che nell’ottica postmoderna è comunque un esercizio calligrafico, il citazionismo.
Bastardi senza gloria lo fa dal titolo, sulla scia
della pellicola di Enzo G. Castellari, Quel maledetto treno blindato (1977), foderato stelle e strisce come The Inglorious Basterds. Il
recentemente riesumato maccheroni combat si respirava già in una famosa scazzottata de Le Iene
(1992) e in alcune esternazioni di Grindhouse
(2007); ora si degusta a masticazione concitata di
elementi che vanno dalla figura del tedesco disertore passepartout all’immancabile immaginario dinamitardo made in Robert Aldrich di Quella
sporca dozzina (1967). Aldo Raine (Brad Pitt)
e compagni non sono più sporchi, forse nemmeno
più cattivi. Sono più ebrei, ma anche questo è solo
a discrezione dell’anagrafe. La logica di gruppo supera quella manichea di divisione tra buoni e cattivi,
perché nell’universo tarantiniano non può esistere
nessuna limitazione al sangue. Con l’amichetto di
merende Eli Roth nei paraggi, l’overdose compiaciuta da emoglobina è quasi scontata.
I bastardi sono più esperti nei genocidi nonsense,
dove il sangue è facile: fanno del macinato grosso,
insomma. In questo sono molto simili ai nazisti o
al Mucchio di Sam Peckinpah del ’69. Esistono
soltanto come entità collettiva, l’iniziativa del singolo è pericolosa, benché limitata ad un innocuo gesto
con la mano. Premesse da botte epiche e aspettative degne dell’ingresso in scena di Vin Diesel in
Compagnie pericolose di Brian Koppelman (2001), ma l’azione atomizzata risulta poco
spettacolare. Persino la mazza del sanguinolento
urside sionista interpretato da Roth delude e non
concede un bel primo piano sui crani spappolati
come angurie. Prima del Vietnam i Rambo antesignani con il veterano per eccellenza condividevano
solo un coltellaccio da macello, residuo di quel western continuamente evocato nelle inquadrature (il
campo lungo iniziale è trasportato di peso da John
Ford e Sergio Leone), con le musiche di Ennio
Morricone, con l’immaginario di scalpi e nomi
(Apache è il soprannome di Aldo Raine). Tarantino
gioca con la storia. Perché il cinema inventa e può
giocare con il sangue compiacendosi della sindrome
di Lady Macbeth che attanaglia una giovane protagonista, Melanie Laurent, in un eterno carnevale cinematografico a cavallo tra Charlie Chaplin
e Marlene Dietrich. Così può permettersi uno
sconto sulla durata - la fine del conflitto è datata
la sera della prima
119
1944 -, ma non sulle quantità di sangue versato visto
lo sfogo finale alla Scarface. Ma soprattutto può
dove solo Topolino era riuscito. Anzi, meglio dato
l’epilogo del Kosher Porno all’amatriciana.
Tarantino si muove sul confine, anzi sui confini.
Quello della linea di frontiera del far west degli
anni ’40, trincee e future cortine di ferro dalla parte degli indiani liberal; quello razziale e linguistico
raffigurando una Babele in cui l’unico poliglotta
è il colonnello nazista Hans Landa ( un istrionico
Christoph Waltz), cugino teutonico e reazionario di Sherlock Holmes. Quello degli spazi, con
una camera che segue in movimento gli attori attraversando una parete come solo il miglior Alfred Hitchcock potrebbe fare. Infine quello del
verosimile, unica sfera semantica possibile e primo
ammiccamento. «C’era un volta» recita un cartello.
Come il West di Leone (1968) o come il Dio nel Far
West a base di spaghetti di Martino Girolami
(1968). Il cinema può inventare la storia e del resto
il luogo dove è riproposta la storia (con il film nel
film, girato da Eli Roth) e il luogo dove si fa la storia
(il luogo dove si consuma il massacro) è il cinema.
Il trionfo dell’immagine in movimento sulla parola?
Non scordiamoci che siamo in un film di Tarantino, i dialoghi ci devono seviziare almeno quel tanto
che basta. Ma al dualismo vita/letteratura proprio
del film retrospettivo sulla guerra, che concedeva
sempre un malinconico letterata costretto alle armi,
è sostituito dal rapporto monco tra cinema e storia
che al massimo può dare un cinefilo, ego in scena
del regista stesso. Anche se, a dirla tutta, lo spirito
goliarda e truculento del videotecaro del Tennesse
si nasconde anche nelle risate isteriche di un Hitler
cerebroleso alla vista di una video carneficina.
Tarantino più o meno consapevolmente consegna ai posteri l’ennesimo capitolo delle nuove
Histoire(s) du Cinéma godardiane: monadi impazzite che alla matrix si replicano seguedo alternative, ma che soprattutto vivono di impianti clonati
da una matrice originaria. Ovviamente lo scontro
è quello tra la cultura classica da manuale di cinema - con i suoi favoriti Fassbinder, Lubitsch,
Coppola/Brando (nella mascella serrata al cotone della versione siciliana di Pitt), Ford, Hawks,
Pabst - e quella popolare di B-movie e porno. Un
nome solo per molti presenti: Aristide Massaccesi, per i più ottusi Joe d’Amato. La declinazione al plurale sta nei livelli di lettura che tutti i film di
Tarantino hanno, nella diramazione che il corso della
storia prende, ma soprattutto nella riproposizione
120
la sera della prima
di un’immagine cristallo uguale e identica a se stessa
impiantata dal regista come un cerotto nel luogo
della frattura. Un breve scambio di battute tra una
sentinella ed il sentimentale Goebbels che viene
copiato e incollato dal regista proprio dove la storia
cambia il suo corso. I personaggi non sono altro che
figurine, che siano nazisti, ebrei o inglesi. Dialoghi
ovviamente trasbordanti, ma con la profondità psicologica di una scimmia che gioca con una ruota.
Abbiamo il soldatino di piombo re di ogni zerbino, la Lady Vendetta che gioca a fare la borchiata, il
boscaiolo crucco. Del resto le loro identità stanno
appunto su carte da gioco. Piatte, scambiabili. Come
quelle che utilizzano su un tavolo di trattative in cui
il doppio gioco fa da minore comune denominatore.
Il Vogliamo vivere (1942) di Ernst Lubitsch
ancora gestito da una compagnia di buffoni e attori dà un bel calcio nel sedere al Tom Cruise di
Operazione Valchiria (Brian Singer, 2008).
Moralmente si intende, perché addirittura gli attentati orditi qui sono tre e vanno tutti in porto. Ovviamente l’unico a sapere della concomitanza delle
iniziative bombarole è il regista che si diverte a mo’
di Alfred Hitchcock inquadrando i candelotti inerti
disseminati in sala.
Non il film migliore del Quentin, nonostante l’ultimo sguardo in camera. Tuttavia il pastis lo si mastica
volentieri. Macinato: qualcosa rimane sempre tra i
denti e si va con le mani per levarlo o con qualche
stuzzicadente per fare leva. E lì ovviamente un po’
di sangue ci sta.
Luca Colnaghi
Ricky - Una storia d'amore e
libertà
di F rançois O zon (F rancia , 2009)
“...Leave no trace of grace just in your honor...”
Canta così Cat Power nella sua meravigliosa The
Greatest scelta da François Ozon come colonna
sonora degli ultimi istanti del suo nuovo film Ricky - Una storia d'amore e libertà (Ricky,
2009), in concorso al 59' Festival di Berlino e da
pochi giorni in Italia. Non si può che darle ragione
perché, in certo qual modo, Ricky è il più grande.
François Ozon è un regista controverso e dalla cinematografia ondivaga per generi e modalità esecutive ma riesce qui ad allontanarsi da ogni possibile
categorizzazione o riduzione a schema. Ma in realtà Ozon ha qui un'intenzione ben diversa: rapire lo
spettatore e svegliarlo alla fine del film lasciando a
lui decifrare quanto mostrato. Nella triste periferia
parigina fatta di palazzi grigi, di freddi che si infilano
dentro le ossa e di scadenze economiche sempre
troppo ravvicinate, Katie, Alexandra Lamy, vive la
sua routine quotidiana senza guardarsi attorno ma
solamente percorrendo triste la sua strada. Quella
che porta dal suo piccolo appartamento alla scuola
di sua figlia Lisa, Mélusine Mayance, e da lì fino alla
fabbrica dove lavora alla catena di montaggio. Un
giorno incontra Paco, Sergi Lòpez, e presto si ritrova incinta di un bambino al quale sarà dato nome
Ricky e che ha un dono molto particolare e straordinario.
Non precederò oltre nella sinossi perché quanto
di più bello c'è in questo film è proprio il non riuscire a collocarsi nel racconto e lo straniamento
nei confronti di quanto avviene da questo momento
del film in poi. La surreale naturalezza con la quale
tutto il mondo continua a girare allo stesso modo
dinanzi al portento di Ricky stravolge le aspettative
dello spettatore che si attenderebbe, naturalmente, di potersi immedesimare nelle paure, nei sorrisi
e nei dubbi dei protagonisti. Essi, invece, vivono il
miracolo di Ricky con la “tranquillità” del quotidiano irrorato da una nascita, come avviene in tutte
le case nelle quali è accolta una nuova vita. La morbosità della stampa e della gente attorno a loro è
la stessa che si riversa in qualsiasi evento raro o
insolito e non sfiora minimamente il prodigio e il
mistero del piccolo.
Ozon dice che ha voluto girare un film su una famiglia e non su un bambino straordinario ed è evidente questo intento. Qui sta la grandezza del film.
La progressione narrativa si riempie di segnali, di
indizi che lo spettatore coglie ma che non portano
a nessuno sviluppo risolutivo dal punto di vista del
mistero. Il gas che la donna respira, l'avvicinamento del Natale, il già citato quotidiano triste e grigio
fanno da cassa d'altoparlante a quanto si vede. Lo
sguardo della piccola Lisa è posto da Ozon sempre
dove si fa più forte il vincolo metaforico, la fantasia
e il sentimento, quasi a mostrare che lei sola può
sentire, capire e difficilmente sopravvivere a tale
portata epifanica perchè ancora nel tempo del sogno e delle favole. Come se sapesse già tutto, la sorellastra di Ricky avrà in dote le sue ali d'angelo nella
squisita scena conclusiva del film: l'abbraccio di una
famiglia ricostituitasi nel momento unico e magico
in cui tutto, finalmente, non richiede più spiegazioni.
Anche oltre il ricordo della sequenza iniziale così
forviante e forte.
Molti raccordi temporali sono labili o errati: si fa
difficile collocare a posteriori, così lavora qui Ozon,
la sequenza iniziale del film e credere alla didascalia
che recita “Pochi mesi prima” ma proprio qui devono tornare utili le parole di François Truffaut
quando, parlando dei critici cinematografici, diceva
che è così facile amare se si smette per un istante
di pensare. Proprio qui lo spettatore si rianima, si
riprende dal mostrato e assimila quanto visto. Solo
grazie all'endemica necessità d'amore e poesia che,
comunque, abita questo mondo. E che spesso rende
possibile accettare senza porre domande che risulterebbero superflue.
Aldo Romanelli
la sera della prima
121
a night
at the opera
Martha, my dear!
Riaprono i battenti i Teatri d’Opera e presentano le nuove stagioni. In attesa della Salome di Strauss, il Comunale di Bologna si affida a Facebook.
Martha Argerich e i suoi “amici” chiudono il Bologna Festival con un programma tutto
incentrato sul duo pianistico
Per i teatri italiani, ottobre è il mese della riapertura
dei battenti, dopo la lunga (e obbligata) pausa estiva.
In attesa del nuovo cartellone, nella stagione delle
foglie morte gli ex-Enti Lirici (ora Fondazioni) e i
teatri dedicati alla musica sinfonica si affannano a
chiudere la precedente stagione e, nel frattempo, a
presentare i nuovi programmi.
Come al solito, a dare sfoggio di nomi importanti
e costose produzioni è il teatro più prestigioso e
potente del Belpaese: La Scala di Milano. Claudio Abbado, Pierre Boulez, Myung-WhunChung, James Conlon, Daniel Harding, Daniel Barenboim, sono solo alcuni dei direttori
che si alterneranno nel 2010 sul podio del teatro
meneghino. L’apertura della fitta Stagione Lirica è affidata alla Carmen di Bizet, con la regia di Emma
Dante e la direzione di Barenboim. Premesse interessanti anche per la nuova produzione del Ring
wagneriano e la presenza della compagnia catalana
Fura Dels Baus. Ma a fare il pienone sarà senza
dubbio lo stagionato Placido Domingo, protagonista in aprile del Simon Boccanegra di Verdi
per festeggiare i suoi quarant’anni alla Scala.
Con Verdi hanno deciso di aprire la nuova stagione d’Opera anche il Massimo di Palermo (Nabucco a Gennaio) e il Regio di Parma (I Lombardi
Alla prima Crociata, sempre a Gennaio), mentre
l’Opera di Roma e il Regio di Torino, chiuderanno l’anno con l’opera più popolare del compositore di Busseto, Traviata (regia, rispettivamente, di
Franco Zeffirelli e Laurent Pelly). Degnissima di nota l’apertura del nuovo Petruzzelli di
Bari, il 4 ottobre scorso. La prima opera ad andare
in scena sul nuovo palco del teatro pugliese, rinato dopo l’incendio che lo distrusse completamente
nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 1991, sarà
Turandot di Puccini.
In grande stile e fuori dal coro apre, come suo
solito, il San Carlo di Napoli, che inaugurerà il
2010 con l’ultima opera “seria” di Mozart, La
Clemenza Di Tito, un cast d’eccezione e due
nomi che parlano da soli: la coppia Luca Ronconi
(regia) e Jeffrey Tate (direzione) non ha bisogno
di presentazioni. La Salome di Strauss aprirà, invece, il nuovo cartellone operistico del Comunale di Bologna. Un programma sulla carta più che
dignitoso, ricco di nuovi allestimenti e coproduzioni.
Al fianco dei soliti titoli “di repertorio” (quest’anno
Carmen, Traviata e L’Elisir D’Amore di Donizetti) quest’anno a Bologna ci sarà anche spazio per
il musical rock. A quarant’anni dalla prima assoluta
(1970) e a due dalla sua versione cinematografica,
l’opera pop-rock Orfeo 9 di Tito Schipa Jr (figlio del celebre tenore), ispirata liberamente al mito
di Orfeo ed Euridice, sarà presentata in un nuovo
allestimento a dicembre del prossimo anno.
La Bohème di Giacomo Puccini –
Teatro Comunale di Bologna (6 – 18
Ottobre 2009)
In attesa delle novità, il teatro bolognese ha riaperto
le porte al pubblico con una “vecchia conoscenza”:
La Bohème con la regia di Lorenzo Mariani,
cui gli spettatori del teatro felsineo avevano avuto già modo di assistere ben due volte, appena due
anni fa e nel ’99, quando sul podio c’era ancora Daniele Gatti. Una regia sobria ed essenziale, quella
di Mariani, così come la scenografia. Una struttura
in ferro fa da perno scenico a tutti e quattro gli
atti, ruotando su se stessa in modo da ricreare, di
volta in volta, gli ambienti dell’opera. All’inizio e alla
fine è l’impalcatura della casa dei bohèmiennes, poi
diventa il cafè Momus, infine un ponte nei pressi del
locale dove si incontrano Mimì e Rodolfo nel terzo
atto.
Niente di nuovo, dunque. Una vera e propria
“replica”, che assume valore più per l’iniziativa ad
essa collegata, che per lo spettacolo in sé. Tramite
Facebook, infatti, era possibile acquistare i biglietti a
basso prezzo, iscrivendosi al gruppo “Amici del Comunale”. Un tentativo di avvicinamento al giovane
pubblico dei social network che non risulta avere
precedenti e che ha avuto l’effetto sperato di riempire il teatro di spettatori under 35.
Nonostante le polemiche montate lo scorso anno
sulla direzione artistica di Tutino, soprattutto in relazione allo spazio dato alla Scuola dell’Opera, sono
ancora questi giovani esordienti a vestire i panni dei
protagonisti. Ma La Bohème non è La Rondine e il
peso della tradizione, unito alla difficoltà esecutiva, è
piombato inesorabile sugli interpreti, tra cui si sono
salvati solo i pochi capaci di imporsi con una personalità vocale più marcata, senza farsi sovrastare
da un’orchestra (diretta da Massimiliano Caldi)
non sempre in sintonia con i cantanti.
Martha Argerich & Friends –
Teatro Manzoni di Bologna (5
Ottobre 2009)
Insieme a quella dei teatri, ad ottobre è ripresa anche l’attività del Bologna Festival che aveva conservato per ottobre il pezzo forte del suo programma. Un’edizione incentrata, nella sua parte dedicata
agli Interpreti, sui grandi nomi del pianismo inter-
nazionale (da Andras Schiff a Radu Lupu e
Murray Perahia), si è conclusa nel migliore dei
modi con la presenza, sul palco del Teatro Manzoni,
di Martha Argerich, la figura più autorevole del
pianismo al femminile.
L’ancora affascinante sessantottenne non è venuta a Bologna da sola, ma in compagnia di due “amici”:
Walter Delahunt e il giovanissimo Gabriele
Baldocci (classe 1980), scelti per suonare fianco
a fianco con lei in un insolito programma tutto costruito sul duo per pianoforte. La formula del duo viene conservata fino alla
fine, alternando spartiti per due pianoforti (tra cui
si sono distinte le interpretazioni del Concertino in la minore op. 94 di Shostakovich e
della Suite n.1 op.5 diRachmaninov) con più
“intime” esecuzioni a quattro mani (la Sonata in
Do Maggiore K521 di Mozart; le Danze Unghersi di Brahms).
La confidenza e l’abilità con la quale i due “amici” duettano con la pianista argentina gli vale tale
appellativo, anche se la loro presenza è sembrata
quasi una limitazione al genio della Argerich. Non
capita tutti i giorni di avere la possibilità di ascoltare
il suo pianismo fluido e le sue grandi interpretazioni. Forse è per questo che molti avrebbero sperato
di poter ascoltare qualche sua esecuzione solistica.
Almeno un bis. E invece niente. Martha non abbandona mai gli “amici”, neanche quando è richiamata
più volte dagli applausi finali del pubblico.
Sarà per un’altra volta. Speriamo.
Daniele Follero
Martha argerich
a night at the opera /
123
i cosiddetti
contemporanei
Hans Werner Henze
Un comunista neoclassico d’avanguardia
Nella sua lunga carriera di compositore, Henze ha solo sfiorato le avanguardie preferendo un atteggiamento eclettico che lo ha portato dal neoclassicismo all’attivismo
politico.
«[il mio è] un temperamento "contrappuntistico" tipicamente tedesco del nord proiettato nell'"arioso" sud»
(H.W. Henze)
Non deve essere stato facile, per il popolo tedesco,
immaginare la vita dopo il crollo del regime nazista
e la seconda, pesante sconfitta in guerra nel giro di
appena ventisei anni. Le ferite della crisi degli anni
’20 non si erano ancora rimarginate che già sanguinavano di nuovo. Insieme alle coscienze. L’orrore
della guerra e dell’olocausto lasciavano nei tedeschi,
all’indomani del secondo conflitto mondiale, un rimorso e un senso di colpa impossibili da lasciarsi
alle spalle.
La voglia di cancellare il passato si riflesse in un atteggiamento radicale, che non ammetteva legami
di continuità con la recente storia della Germania.
In campo culturale, la politica censoria e autocratica del Terzo Reich, in maniera molto più intensa
e restrittiva rispetto ai “cugini” fascisti, aveva praticamente tagliato i ponti con l’Europa, causando
un prolungato isolamento, difficile da colmare. Un
motivo in più ad accendere nelle nuove generazioni
di artisti e intellettuali tedeschi un senso di rivalsa
verso le ingiustizie della Storia. Un’ impresa resa più
ardua dalla mancanza di punti di riferimento, dopo
l’emigrazione in massa di buona parte degli artisti e
intellettuali tedeschi che avevano pensato bene di
rifarsi una vita altrove.
Ricominciare da zero era impossibile. Un salto
nel vuoto non avrebbe risolto i problemi. E allora
il primo passo fu quello di ristabilire i legami con
la cultura europea spezzati dal nazionalsocialismo.
Ripescando nell’eredità lasciata da Schoenberg e i
suoi due allievi Berg e Webern, la giovane genera-
124
contemporanei
zione di compositori nati attorno alla metà degli
anni ’20, vide nella musica essenziale e sintetica di
quest’ultimo il punto di partenza ideale. Le strutture ridotte all’osso, il senso di spazialità ricercato
nel suono, l’annullamento del discorso musicale e
del concetto stesso di melodia, apparvero ai giovani
musicisti riuniti ai Ferienkursen di Darmstadt, segni
di una purezza incontaminata.Il modo migliore per
fare tabula rasa.
Un atteggiamento radicale non ammette compromessi, avendo il fine di rivoluzionare completamente la situazione preesistente. O con noi o contro di
noi. Il motto del serialismo radicale escludeva ogni
legame con il passato, fino a trasformarsi in ideologia. A pagarne le spese, furono quei musicisti che,
pur avendo rigettato il nazismo, credevano ancora
nella potenza comunicativa della musica e non guardavano di buon occhio l’isolamento in cui si stava
rintanando lo strutturalismo di Stockhausen e
Boulez.
Una delle vittime illustri dell’ostracismo di Darmstadt, prima ancora che John Cage arrivasse a
sconvolgere i presupposti stessi della Nuova Musica, fu Hans Werner Henze. Il suo peccato era stato
quello di “contaminare” la musica “pura” con scelte
eclettiche e neo-classiche. In poche parole: un conservatore reazionario. Lungi dall’”uccidere” Schoenberg, come proclamò in un suo celebre articolo del
1952 Pierre Boulez (“Schoenberg è morto”, pubblicato sulla rivista “The Score”), è proprio il compositore del Pierrot Lunaire che Henze prende come
punto di riferimento. Se per Boulez e Stockhausen
liberarsi di Schoenberg vuol dire staccare definitivamente il cordone ombelicale con la tradizione, per
Wolfgang Fortner e il suo allievo Henze, invece,
ricucire è più importante che tagliare. In quest’ottica, il serialismo diventa nient’altro che un metodo
compositivo a disposizione del compositore, che lo
utilizza per i suoi fini espressivi. Un punto di partenza, dunque, più che un fine.
D alla G ioventù H itleriana al
P.C.I. passando per la C uba del
“C he ”
Nato nel ’26 a Gütersloh, un paesino della Westfalia,
Hans Werner Henze è costretto a subire, da adolescente, le convinzioni naziste del padre. Non potè
evitare di iscriversi alla Gioventù Hitleriana (chissà
se lì ha avuto modo di conoscere un certo Joseph
Ratzinger), ma non manifestò mai piena adesione
volontaria al regime. Anche perché non ne ebbe
tempo. Aveva appena diciotto anni quando fu fatto
prigioniero di guerra dagli inglesi, poco prima della
resa dei tedeschi. La guerra finì, ma Henze, musicista
ancora in erba, non arrivò a subire la demonizzazione di cui furono preda colleghi più noti come Furtwaengler e Strauss, accusati di collaborazionismo solo per non aver abbandonato la Germania
durante il regime. Ruoli scomodi, contraddittori,
che non condizionarono, invece, la generazione successiva.
Ironia della sorte, la carriera di compositore di Hen-
ze cominciò proprio a Darmstadt, culla dell’anticonformismo musicale tedesco. Dopo gli studi giovanili,
infatti, il giovane Hans venne attirato dall’avanguardismo dei Ferienkursen e dall’approccio innovatore
che li contraddistingueva. Sono di questo periodo
il primo Concerto Per Violino e la prima Sinfonia (1947), in cui la tecnica dodecafonica è alla base
della composizione. Così come nel caso del “poema
coreografico” Ballett-Variationen, primo approccio ad un genere, il balletto appunto, che in seguito, insieme alla musica vocale, rappresenterà uno
dei maggiori interessi del compositore tedesco.
Il connubio con la “scuola” di Darmstadt durò poco.
Spostata la sua attenzione verso il balletto, l’opera
e, più in generale, la musica vocale, Henze inaugurò
con Das Wundertheater, il suo felice rapporto
con la letteratura e il melodramma, dando vita ad
importanti collaborazioni con scrittori del calibro di
Auden e Bachmann. Un rapporto che lo condusse
direttamente all’opera, genere in cui meglio si identificò il suo stile eclettico, curioso incrocio tra la
dodecafonia, Stravinskij e il jazz.
La prova di questo approccio a 360° è Boulevard
Solitude, una rivisitazione in chiave moderna della
storia di Manon Lescaut, che non rinuncia a vere e
proprie citazioni dall’opera di Puccini. Una precisa
dichiarazione di allontanamento dalle avanguardie e
contemporanei
125
Henze con bachmann
di avvicinamento ad un linguaggio più marcatamente
neo-classico. Come culla della sua “svolta”, Henze
scelse l’Italia del sud, ricca di sole e cultura e meno
omofoba (a quei tempi) della Germania, stabilendosi prima a Marino, un piccolo paesino del Lazio,
poi ad Ischia e Napoli. L’amore per la melodia e la
musicalità tipicamente mediterrane della Campania
si insinuano nel suo stile, caricandolo di sonorità
vive e sensuali. L’Opera Koening Hirsh, le Cinque Canzoni Napoletane (scritte per il famoso
baritono Dietrich Fischer-Dieskau), il balletto Maratona di Danza (su libretto di Luchino
Visconti) testimoniano questo nuovo approccio.
O meglio, questa nuova vita. La scelta dell’Italia non
è solo musicale, ma anche politica. Arrivato nella penisola, Henze si iscrisse al P.C.I., cominciando una
militanza che lo ha accompagnato fino ad oggi. E che
lo ha portato ad attraversare le contraddizioni del
movimento e la crisi del socialismo reale, ad amare
la Cuba rivoluzionaria per poi criticare il regime di
Castro.
126
contemporanei
Tra S alisburgo
M ontepulciano
e
Gli anni ’60 rappresentano la fase più militante di
Henze ed anche un periodo particolarmente prolifico. I numerosi viaggi (Austria, Germania, Cuba, il ritorno a Roma) gli incarichi importanti (è insegnante
di composizione al Mozarteum di Salisburgo e “visiting Professor” al Darthmouth College del New
Hampshire) e l’interesse per il cinema e la musica
da film, contribuirono ad accrescere la sua fama di
personaggio multiforme, capace di far convivere nel
suo stile il classicismo, i nuovi media, l’avanguardia
e il pensiero politico. Summa di questa commistione di interessi sarà Die Bassariden (1967), in
cui la scelta di costruire l’opera come una sinfonia
in quattro movimenti appare, più che un semplice
omaggio al Wozzeck di Berg, un’adesione ai princìpi compositivi del più “classicista” tra gli allievi di
Schoenberg.
Ma è il suo attivismo politico a condizionare maggiormente le opere di questo periodo, segnato dalla celebre Prima di Das Floss Der Medusa ad
Amburgo. Alla presentazione dell’oratorio “volgare
e militare” dedicato a Ernesto Guevara, fece abbastanza scandalo l’idea di suonare dietro il ritratto
del “Che”, provocando il rifiuto di alcuni collaboratori di partecipare all’esecuzione. Così come stupirono le sue Prison Songs, basate su poesie di Ho
Chi Min, soprattutto se accostate ad opere molto
più sobrie come il ciclo di pezzi per chitarra Royal
Winter Music, ispirate ai personaggi del teatro
shakespeariano. Un dualismo, quello tra un approccio decisamente neoclassico (giudicato a quei tempi
conservatore) e il sostegno convinto ad una musica
veramente popolare, di matrice decisamente progressista.
Una contraddizione volutamente mai risolta, che
lo rende un personaggio particolarissimo, l’unico a
poter essere paragonato contemporaneamente a
Kurt Weill, Hans Eisler, Igor Stravinskij e Alban Berg.
Raggiunto il culmine del suo attivismo con l’opera We Come To The River, seguita ad una serie
di lavori molto influenzati dal socialismo cubano
(El Cimarròn, pièce per voce recitante e orchestra basata su un libro dell’autore cubano Miguel
Barnet; la Sinfonia n.6; il Secondo Concerto
per Violino), Henze si trasfersce a Montepulciano,
in provincia di Siena, dove fonda il Cantiere Internazionale d’Arte, dedicato alla produzione
della nuova musica.
è qui che viene presentata nel 1980 la sua opera
per bambini Pollicino, divenuta col tempo celebre
quanto Pierino e il Lupo di Prokofiev. L’istituzionalizzazione del personaggio, avviene proprio in
questi anni. Compositore ormai anziano ed esperto,
Henze si abbandona ad un lirismo più spiccato e
ad uno stile più convenzionale con The English
Cat (1983) e Das Verratene Meer (1990), senza
tuttavia abbandonare l’impegno politico. La Nona
Sinfonia “dedicata agli eroi e ai martiri dell’antifascismo tedesco” (1997) è l'esempio più chiaro e
convincente di un antifascismo convinto e ancora
duro a morire. E anche il marchio di uno dei compositori più prolifici del Novecento, che non accenna a
fermarsi, a dispetto dei suoi ottantatrè anni. Con lui
l’opera sembra non essere mai morta. Phaedra, la
sua ultima fatica operistica è di appena due anni fa
(2007). Ma nessuno crede sia l’ultima, almeno nelle
intenzioni del compositore.
La risposta di Henze al periodo di riflusso politico
che hanno vissuto e che vivono tutt’ora i movimenti
progressisti è stato il rifugio in una realtà piccola.
Una scelta simile al suo più giovane collega Salvatore Sciarrino, scappato dal caos della città per rifugiarsi nella tranquillità della provincia senese. Sono
vicini da molti anni, ormai. Uno, Henze, vive a Montepulciano, dove da anni porta avanti i suoi progetti
musicali; l’altro, Sciarrino, personalità molto diversa,
ha preferito chiudersi nella meravigliosa solitudine
di Pienza. Chissà cosa si dicono quando parlano di
musica davanti ad una bistecca al sangue o ad un
piatto di pici all’aglio. Ammesso che non siano vegetariani. Per il vino c’è l’imbarazzo della scelta.
Daniele Follero
T he E ssential H ans Werner H enze
• Kammerkonzert per pianoforte, flauto e orchestra d'archi (1946)
• Sinfonia n. 1 (1947, rev. 1963 e 1991)
• Das Wundertheater (1948)
• Ballett-Variationen (1949)
• Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra (1950)
• Boulevard Solitude (1951)
• König Hirsch (1952–1955) testo di Heinz von Cramer
• Undine (1956–1957)
• Ode an den Westwind per violoncello e orchestra
(1953)
• Die Bassariden (1965)
• Das Floss der Medusa, oratorio "alla memoria di Che
Guevara" per solisti, recitante, coro e orchestra (1968)
• Sinfonia n. 6 per due orchestre da camera (1969, rev.
1994)
• Tristan per pianoforte, orchestra e nastro magnetico
(1972–1973)
• We Come To The River (1974–1976)
• Pollicino (1980, opera per bambini)
• Requiem, "Geistliche Konzerte" per pianoforte, tromba e
orchestra (1990–1992)
• Sinfonia n. 9 per coro e orchestra, da un racconto di
Anna Seghers (1995-1997)
• Concerto n. 3 per violino e orchestra "Drei Porträts aus
Thomas Manns Doktor Faustus" (1996)
• L'Upupa (2003)
• Phaedra (2006-2007)
contemporanei
127
www.sentireascoltare.com