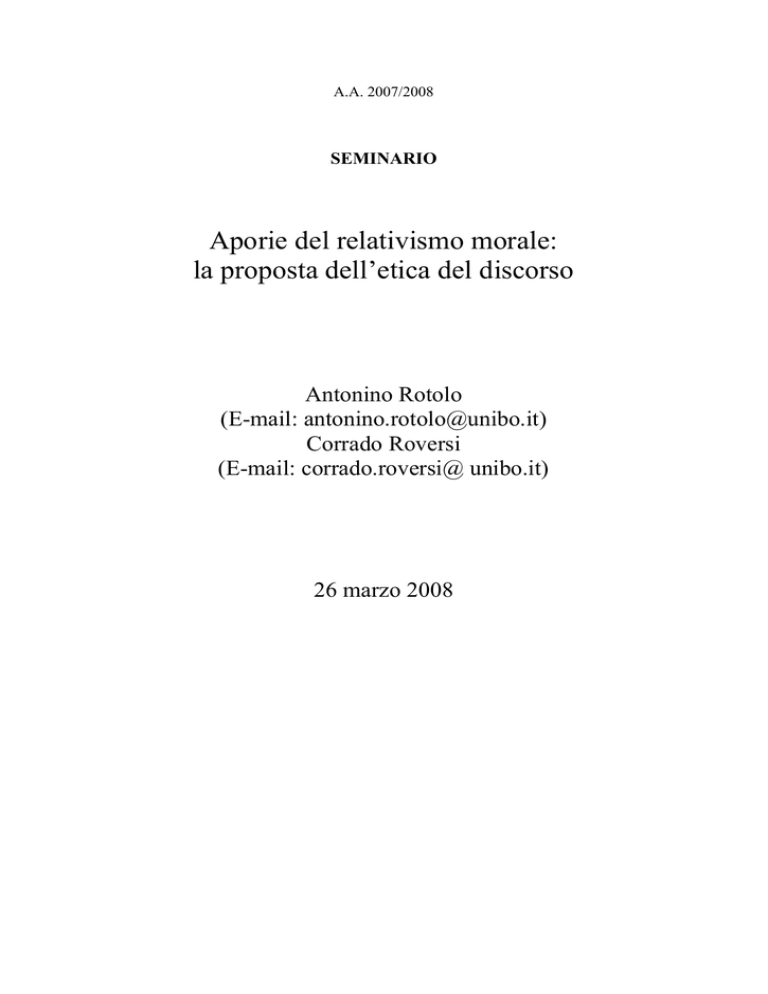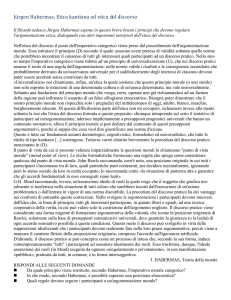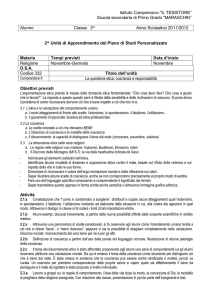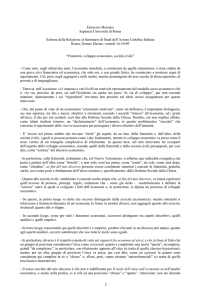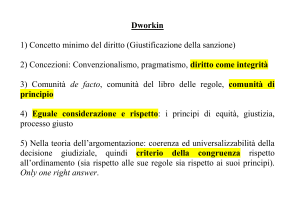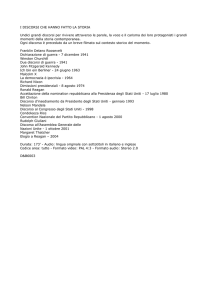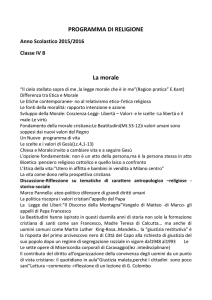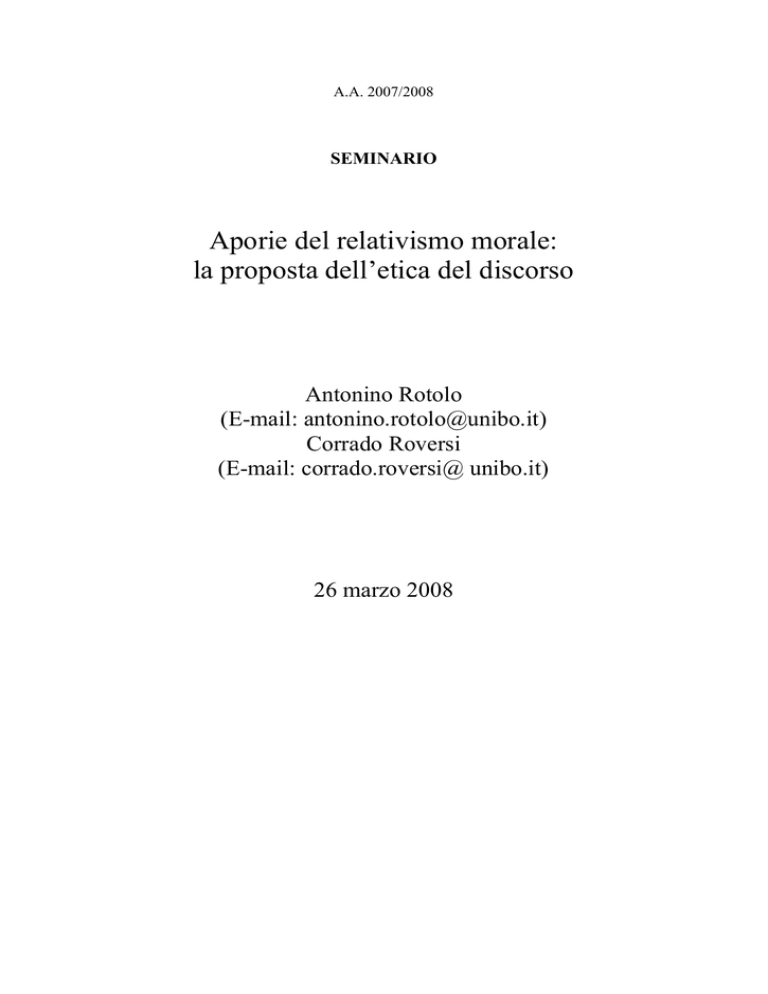
A.A. 2007/2008
SEMINARIO
Aporie del relativismo morale:
la proposta dell’etica del discorso
Antonino Rotolo
(E-mail: [email protected])
Corrado Roversi
(E-mail: corrado.roversi@ unibo.it)
26 marzo 2008
0. Preludio. Auto-confutazione dello scetticismo
La questione teorica preliminare che è necessario comprendere per cogliere il nodo
concettuale fondamentale dell’etica del discorso è la questione dello scetticismo
filosofico, e della peculiare contraddizione in cui esso, secondo alcuni, incorre. Lo
scetticismo filosofico, in linea generale, è quella posizione per la quale non è mai
possibile stabilire una verità oggettiva: secondo lo scettico qualsiasi postulato,
principio, giudizio (di qualsiasi scienza, sia essa una scienza empirica, come la fisica,
formale, come la matematica, o normativa, come l’etica o la scienza giuridica) è per
sua stessa natura passibile di dubbio, e come tale privo di capacità fondative.
L’intuizione teorica fondamentale che sta alla base dell’etica del discorso è che lo
scetticismo, così formulato, è auto-contraddittorio in un senso molto lato (e non
rigorosamente logico) di ‘contraddizione.’ Non è affatto complesso cogliere il punto
di questa contraddizione: lo scetticismo, dopotutto, è a sua volta una tesi teorica che,
come tale, avanza una pretesa di verità. Ma se la posizione di colui che mette in
dubbio ogni verità avanza a sua volta una pretesa di verità (se, cioè, nel sostenere
che qualsiasi verità è passibile di dubbio, lo scettico pretende di avanzare una verità
che non sia invece passibile di dubbio), essa non può essere coerentemente
sostenuta. La situazione può essere agevolmente mostrata come segue:
Lo scettico dice “nessuna tesi può ambire alla verità assoluta”
Ma ciò che lo scettico dice è a sua volta una tesi, che dunque non può ambire a verità
assoluta
Dunque, se la tesi dello scettico è vera, allora essa è del tutto dubitabile, e non si vede
perché dovremmo assumerla come vera.
Nel sostenere come una verità la tesi secondo la quale non è possibile riconoscere in
modo oggettivo alcuna verità, lo scettico incorre in una peculiare forma di
contraddizione, derivata dal fatto che egli non si avvede che la sua tesi generale (la
tesi dello scetticismo per la quale “tutte le tesi sono passibili di dubbio”) si riferisce,
tra le infinite possibili tesi enunciabili, anche a se stessa. Come scrive Aristotele,
e in effetti, proprio per distruggere il ragionamento, quegli si avvale del ragionamento.1
1. Etica del discorso: gli autori
Gli autori comunemente associati all’Etica del discorso sono tre: Karl Otto Apel,
Jürgen Habermas, Robert Alexy. I primi due (filosofi per formazione, e per un certo
periodo in stretto rapporto di collaborazione) possono dirsi i padri fondatori della
teoria, e nel corso del tempo ne hanno adottato due diverse varianti (Apel una
variante forte detta pragmatico-trascendentale, Habermas una variante indebolita detta
pragmatico-universale); il terzo (giurista e filosofo del diritto, allievo di Habermas) ha
più che altro recepito la discussione generale, e ne ha dato applicazione all’ambito
giuridico.
1
Aristotele, Metafisica, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano, 2004, 1006a, 25.
2. Problema: il Trilemma di Münchausen
La sfida teorica che i filosofi dell’etica del discorso si propongono di affrontare è
rappresentata dal cosiddetto “Trilemma di Münchausen”, formulato dal filosofo
falsificazionista Hans Albert, allievo di Karl Popper.
Il Trilemma di Münchausen ha come oggetto la possibilità di fondazione oggettiva
dell’etica, vale a dire (in termini più semplici) la possibilità di costruire un sistema di
principi morali razionali ed oggettivamente fondati. Secondo Albert, questa
possibilità non vi è, in quanto qualsiasi tentativo di fondazione etica oggettiva
incorre 1) o in un regresso all’infinito, 2) o in una petitio principii, 3) o in un circolo
vizioso.
1) Si ha regresso all’infinito, qualora la fondazione oggettiva di una morale si fondi
su principi, i quali a loro volta necessitano di una fondazione alla luce di nuovi
principi. Se il fondamento di giustificazione oggettiva richiede a sua volta una
giustificazione, e dunque un nuovo fondamento, si risale all’infinito la catena della
fondazione e della giustificazione, senza avere possibilità di raggiungere un punto
fermo.
2) Si ha petitio principii, qualora, in questo risalire la catena dei fondamenti, ci si fermi
ad un principio ritenendo che esso non richieda giustificazione. Questo certamente
fermerebbe il regresso, ma solleverebbe la domanda sulle motivazioni di questa
scelta. Perché quel principio (e non magari un altro) non dovrebbe richiedere una
giustificazione? La scelta di sottrarre uno specifico principio al bisogno di
giustificazione, ritenendolo al contrario un fondamento della giustificazione, non
sembra trovare ragioni a proprio supporto: è piuttosto una forma di giustificazione
morale fondata su un qualche dogma.
3) Si ha circolo vizioso, qualora nel corso della fondazione si utilizzi implicitamente,
quale fondamento, ciò che al contrario si intende dimostrare. Questa forma di
difetto del ragionamento è molto diffusa: se, ad esempio, dovendo dimostrare che
una determinata area è una triangolo, noi ponessimo quale premessa della
dimostrazione che la somma degli angoli interni di quell’area è 180° (una proprietà
del triangolo), non avremmo fatto altro che derivare una conclusione (l’area è un
triangolo) da premesse che già contengono quella conclusione (l’area ha come
somma degli angoli interni 180°, ovvero è un triangolo).
3. La risposta di Apel: analisi delle presupposizioni del Trilemma
Secondo Apel, il Trilemma di Münchausen è inevitabile soltanto se si danno per
scontati alcuni presupposti teoretici. Questi presupposti sono:
1) Solipsismo metodico. Il Trilemma dà per scontato che il problema della validità
morale (e, più in generale, della verità) si ponga in termini di oggettività, vale a dire
di corrispondenza tra quanto il soggetto (l’individuo, colui che conosce) asserisce
come valido e le caratteristiche dell’oggetto (ciò che invece il soggetto intende
conoscere) sul quale verte l’asserzione. L’idea di fondo è dunque che il problema
della verità oggettiva di una qualsiasi asserzione (e, più nello specifico, della validità
oggettiva di qualsiasi giudizio morale) si risolva, in ultima analisi, in una verifica, da
parte del soggetto, del fatto che vi sia corrispondenza tra ciò che egli dice e l’oggetto
su cui verte la sua asserzione ed il suo giudizio morale. Nel problema della
fondazione come oggettività, non vi è terzo attore tra il soggetto conoscente, da un
lato, e l’oggetto conosciuto, dall’altro: la validità di un giudizio morale è
corrispondenza ad un oggetto (principio, realtà) morale di qualche tipo; ed è il
soggetto, da solo, a verificare questa sorta di corrispondenza. Questo modello a due
soli elementi è chiamato da Apel “solipsismo metodico”: è cioè un approccio
metodologico al problema dell’oggettività in cui il soggetto può, da solo, riscattare le
pretese di validità (teoretica o morale) di ciò che sta dicendo. Il modello è di
evidente ascendenza cartesiana: fu infatti Cartesio il primo ad asserire, con
l’argomento del cogito, che il soggetto da solo, chiudendosi in se stesso tramite
riflessione, poteva stabilire verità oggettive (“chiare e distinte,” diceva Cartesio), in
grado di fondare l’intero edificio teoretico della filosofia prima, o metafisica.
2) Linguaggio subordinato al pensiero. I giudizi morali, come qualsiasi asserzione, sono
formulati con mezzi linguistici, vale a dire tramite un qualche linguaggio. Se vale il
modello del solipismo metodico, risulta evidente che questa forma linguistica dei
giudizi morali non è altro che una espressione diretta di ciò che il soggetto, da solo,
pensa: il soggetto conoscente esprime tramite giudizi linguistici ciò che pensa e
questa formulazione è una perfetta rappresentazione di ciò che egli pensa. Stando a
questa concezione, il linguaggio è semplicemente un modo per esprimere il pensiero
dell’individuo: prima viene il pensiero, poi viene il linguaggio, inteso come segno che
esprime (proietta, rappresenta) questo pensiero. L’individuo, da solo, ha in sé tutti gli
elementi per dominare il linguaggio.
3) Fondazione come derivazione da qualcos’altro. Risulta abbastanza evidente dalla sopra
effettuata esposizione del Trilemma di Münchausen che il concetto di “fondazione”
sotteso implica che fondare una qualsiasi verità (o validità) sia equivalente a derivarla
da una qualche verità (o validità) in qualche senso precedente alla prima. Ad
esempio, fondare la validità del giudizio morale “mentire è moralmente sbagliato”
significa derivarlo da un qualche principio di ordine superiore e più generale, ad
esempio “ingannare è moralmente sbagliato”, il quale a sua volta può essere derivato
da un principio come “è moralmente sbagliato fare ad altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te stesso”. Come abbiamo visto, questa concezione della fondazione
come derivazione porta al problema del regresso all’infinito e della petitio principii: se
fondare significa derivare da qualcos’altro, allora questa derivazione o va avanti
all’infinito (risalendo indefinitamente a principi via via più astratti e generali, ognuno
dei quali richiede a sua volta giustificazione) o si ferma, dogmaticamente, ad un
certo punto.
4) Razionalità in termini logico semantici. La concezione della fondazione come
derivazione discende da una specifica concezione della razionalità come razionalità
logico-semantica. Per cogliere che cosa si intenda con “razionalità logicosemantica”, è sufficiente pensare alla geometria assiomatica euclidea. Nel sistema
euclideo, ogni teorema (ad esempio, il teorema di Pitagora) viene dimostrato sulla
base di teoremi precedenti o di assiomi, facendo esclusivo riferimento al significato
dei termini che appaiono in questi teoremi ed assiomi (da cui l’elemento semantico) e
a leggi logiche di derivazione (ad esempio, il principio di non contraddizione, o la
legge per la quale se una tesi B discende da una tesi A, e A è dimostrata, allora anche
la tesi B è dimostrata: è questo l’elemento logico).
Ciò che si deve notare, di questi quattro presupposti, è che essi sono in certo modo
inscritti in larga parte della tradizione filosofica occidentale, se non altro moderna
(intendendo con ciò la tradizione filosofica che ha tradizionalmente inizio con la
“svolta soggettivista” di Cartesio, intorno alla metà del XVII secolo). L’idea di
fondazione come derivazione e di razionalità in termini logici è senz’altro più antica,
ma è soltanto con l’enorme impulso dato alle scienze matematiche nel corso del
XVII secolo (impulso al quale lo stesso Cartesio non fu affatto estraneo, essendo il
padre della odierna geometria analitica) che queste idee si estendono a tutti gli
ambito filosofici, etica compresa (l’idea di un Ethica ordine geometrico demonstrata risale
infatti a Spinoza, la cui opera principale è conclusa nel 1675; ma dovremmo contare
anche la sistematica razionalistica del giusnaturalisti seicenteschi, particolarmente del
Leviathan di Hobbes, del 1651).
Nell’attaccare questi presupposti, dunque, Apel attacca una tradizione filosofica
secolare: ma gli argomenti che egli oppone ad ognuno di questi presupposti sono
largamente derivati dalle conclusioni della filosofia analitica novecentesca, in
particolare da due profonde conclusioni tratte da Ludwig Wittgenstein e dalle sue
Philosophische Untersuchungen (Ricerche Filosofiche, del 1953).
a) In primo luogo, Apel attacca il solipsismo metodico di matrice cartesiana, l’idea
cioè che un soggetto possa, da solo, riscattare le pretese di validità ed oggettività dei
propri giudizi (giungere da solo alle proprie conclusioni conoscitive; capire da solo,
riflettendo, se ha ragione o ha torto). Questa idea è stata, secondo Apel, superata
dall’argomento del linguaggio privato di Wittgenstein. Secondo Wittgenstein, nessun
soggetto può parlare un linguaggio che sia esclusivamente privato, vale a dire un
linguaggio di cui sia lui solo a conoscere la grammatica ed il lessico. Parlare un
linguaggio significa infatti seguire una regola, vale a dire portare avanti un
comportamento del quale si possiedono, in qualche senso, i criteri di correttezza e di
scorrettezza: ma è requisito fondamentale del seguire una regola che questi criteri
siano in qualche senso indipendenti dal soggetto, che non dipendano da ciò che il
soggetto semplicemente crede che essi siano. Wittgenstein mostra che, nel caso di
un linguaggio privato, non vi è alcun fatto indipendente dal soggetto che egli possa
utilizzare per discernere quando parla correttamente il proprio linguaggio e quando
lo parla scorrettamente: la qual cosa significa che qualsiasi linguaggio privato, parlato
esclusivamente dal soggetto, sarebbe più un parlare in modo sconnesso ed instabile
che un parlare in modo sensato. Da questo argomento, Wittgenstein deduce che
ogni linguaggio è sempre un fatto sociale: che ogni soggetto impara a parlare un
linguaggio, distinguendo ciò che è grammaticalmente e lessicalmente corretto da ciò
che non lo è, sulla base dei segnali positivi e negativi (di approvazione o
disapprovazione, di accordo o disaccordo) che riceve nella propria comunità.
b) A questa conclusione di Wittgenstein, Apel associa la tesi che non esiste pensiero
che non sia linguistico, e linguisticamente strutturato: vale a dire, che le categorie
fondanti del nostro pensiero sono rappresentate nella grammatica profonda del
nostro linguaggio. Anche questa tesi può essere fatta risalire alla filosofia analitica
novecentesca, la quale, fin dai propri padri fondatori (Gottlob Frege in primis, a
cavallo tra Ottocento e Novecento) ha sempre avuto un atteggiamento definito
“antimentalistico” (vale a dire, un atteggiamento che privilegiava lo studio oggettivo
delle regole e del lessico del nostro linguaggio, in quanto pubblico, piuttosto che la
congettura sui meccanismi mentali individuali, “privati” per definizione). Ma se ogni
pensiero è linguisticamente strutturato, e non vi può essere linguaggio che non sia
un fatto collettivo, sociale, l’intero impianto del Trilemma di Münchausen viene
messo in discussione. Infatti, la questione della fondazione di una morale oggettiva
è, in primo luogo, un fatto linguistico e, in secondo luogo, un fatto linguistico che si
pone, e sul quale si decide, all’interno di una comunità di parlanti, e non nell’ambito
inaccessibile di un individuo-soggetto che riflette tra sé e sé su pensieri astratti e
privi di forma.
4. L’argomento pragmatico-trascendentale e la contraddizione performativa
Ritorna la figura dello scettico, declinata in senso morale: lo scettico morale è colui
che dubita della possibilità stessa di una morale oggettivamente fondata. Ciò che
abbiamo tratto dall’analisi critica dei presupposti del Trilemma di Münchausen,
tuttavia, è che la questione dello scetticismo morale non è qualcosa che si possa
semplicemente pensare, e risolvere nel pensiero individuale (come certamente
avrebbe fatto Cartesio). Se così fosse, infatti, ricadremmo nel solipsismo metodico, e
non terremmo conto dell’argomento del linguaggio privato. Piuttosto, la tesi dello
scetticismo morale deve essere enunciata linguisticamente dallo scettico, ed
enunciata in un contesto pubblico, inter-soggettivo: il contesto complessivo,
potremmo dire, dei parlanti interessati alla questione. Immaginiamo dunque che lo
scettico entri in un anfiteatro (l’anfiteatro del discorso morale) insieme ad altri mille
parlanti; che ognuno dei parlanti prenda la parola ed avanzi un giudizio morale di
qualche tipo; e che, una volta venuto il turno dello scettico, egli salga sul
palcoscenico e, rivolgendosi agli altri parlanti lì riuniti, sostenga la tesi dello scetticismo
morale.
Questo nuovo ruolo “pubblico” mette tuttavia lo scettico in una posizione
scomoda. Egli deve infatti enunciare la sua tesi, avanzando un’asserzione del tipo
“non vi è possibilità alcuna di una morale oggettivamente fondata” (TSM, tesi dello
scetticismo morale). Ma, così facendo, lo scettico avanza un’asserzione rivolgendosi
agli altri parlanti lì riuniti: e il fatto di avanzare un’asserzione rivolta ad altri non è
privo di presupposti. In primo luogo, lo scettico avanza una pretesa di verità:
pretende cioè, nel momento in cui sale sul palcoscenico e sostiene la TSM, che essa
sia una tesi vera; se egli ci dicesse “non vi è possibilità alcuna di una morale
oggettivamente fondata, ma questa stessa tesi che sto enunciando è una falsità”,
incorrerebbe in quella forma peculiare di contraddizione che, in apertura, abbiamo
commentato con le parole di Aristotele (“e in effetti, proprio per distruggere il
ragionamento, quegli si avvale del ragionamento”). Nell’avanzare una tesi come vera,
cioè, egli direbbe che la sua tesi è falsa: vi sarebbe cioè una contraddizione tra ciò
che lo scettico fa (avanzare una tesi come vera, pretendere la verità di una tesi) e ciò
che lo scettico dice (che la stessa tesi che sta avanzando come vera è invece falsa);
questa sorta di peculiare contraddizione tra il dire ed il fare, nella quale incorrerebbe
lo scettico se non accettasse che la TSM implica una pretesa di verità, è ciò che Apel
chiama “contraddizione performativa”.
In secondo luogo, lo scettico avanza una pretesa di senso: pretende cioè che TSM
sia una tesi sensata, oltre che vera; infatti, se non fosse sensata, non potrebbe
nemmeno essere vera. In terzo luogo, lo scettico avanza una pretesa di sincerità:
se lo scettico dicesse “non vi è possibilità alcuna di una morale oggettivamente
fondata, ma non credo in ciò che dico”, tutti gli astanti nell’anfiteatro della questione
morale penserebbero che è pazzo, esattamente come se avesse enunciato la falsità
della sua tesi nel momento in cui la asserisce.
Ma, nell’avanzare queste pretese, lo scettico si rivolge a qualcuno (i parlanti
nell’anfiteatro della questione morale) ed è pronto a riscattare queste pretese: vale a
dire, a rispondere se qualcuno dovesse metterle in dubbio. Questo significa che
l’enunciazione pubblica di TSM in una comunità di parlanti implica il riconoscimento, da
parte dello scettico, dei suoi interlocutori come possibili partner di
un’argomentazione sulla questione morale. Lo scettico, infatti, nell’avanzare pretese
che è pronto a riscattare di fronte ai suoi interlocutori, si prende delle responsabilità:
in particolare, si prende la responsabilità ad argomentare la sua tesi, su richiesta.
Ora, l’intuizione fondativa dell’etica del discorso è che questa disponibilità
all’argomentazione, inscritta nella logica stessa delle nostre asserzioni, sia già di per
sé un fatto morale. E dunque che colui che solleva il dubbio più radicale sulla
possibilità di un’etica oggettiva in realtà presuppone, in quanto avanza la propria tesi
verso interlocutori che riconosce come tali, una serie di principi dell’argomentazione
che hanno carattere morale. Anche nel sollevare questo dubbio, dunque, lo scettico
incorre in contraddizione performativa (nel dubitare della possibilità di un’etica
normativa, egli presuppone principi dell’argomentazione di natura morale): e se il
dubbio radicale sulla possibilità di una morale oggettivamente fondata è autocontraddittorio, allora una tale morale è possibile. Questo argomento, fondato sulle
presupposizioni dell’enunciazione di TSM da parte dello scettico, è chiamato da
Apel “argomento pragmatico-trascendentale”.
5. Analisi dei presupposti dell’argomento pragmatico-trascendentale
Risulta sufficientemente chiaro che, come il Trilemma di Münchausen, anche
l’argomento pragmatico trascendentale ha una serie nutrita di presupposti.
1) Il primo presupposto è che l’asserzione dello scettico equivale ad una pretesa
(anzi, come abbiamo visto, ad una serie di pretese), la quale a sua volta implica una
precisa assunzione di responsabilità. I teorici dell’etica del discorso sembrano
assumere che (a) in primo luogo, quando avanza la sua tesi lo scettico fa qualcosa; (b)
in secondo luogo, questo qualcosa che egli fa ha delle precise presupposizioni di
natura morale.
L’assunzione (a) non è una tesi originale dell’etica del discorso, bensì è tratta dalla
teoria degli atti linguistici dei filosofi del linguaggio J. L. Austin e J. R. Searle. Nel
1955, in una serie di ben note lezioni dal titolo How to Do Things with Words (Come
fare cose con le parole), J. L. Austin ha mostrato come sia una caratteristica
funzione del linguaggio quella (non di descrivere, né di prescrivere, né di esprimere,
bensì) di fare (to perform, in inglese): ad esempio, l’enunciazione della frase “battezzo
questa nave con il nome ‘Regina Elisabetta’”, nel contesto di una specifica
cerimonia, non descrive il nome della name, né prescrive ad alcuno di fare qualcosa;
piuttosto, l’enunciazione è volta a fare qualcosa, vale a dire, dare quel nome alla nave
(all’enunciazione corrisponde un risultato che ne è l’oggetto, mediato o immediato).
Austin chiama questa la funzione performativa del linguaggio. In una fase successiva
del suo lavoro, Austin ha esteso questo aspetto performativo di alcune enunciazioni
linguistiche al linguaggio nella sua interezza: ha cioè sottolineato come ogni
proposizione sia sempre anche una mossa concreta nel gioco del linguaggio, un atto
equivalente al fare qualcosa (nel lessico di Searle, allievo di Austin, un atto linguistico).
Ad esempio, una proposizione come “domani parteciperò alla manifestazione” ha
certamente un contenuto semantico, che ci dice qual è il significato della proposizione,
ma ha anche un aspetto pragmatico, che ci dice che ruolo ha tale proposizione nel
contesto della nostra enunciazione: se essa sia una descrizione di ciò che farò
domani, ad esempio, o piuttosto una specifica promessa rivolta a qualcuno.
Dovrebbe ora risultare chiaro come, nella prospettiva dei teorici dell’etica del
discorso, l’argomento pragmatico-trascendentale contro lo scetticismo morale si
fonda su una precisa concezione dell’atto linguistico dell’asserzione: è infatti soltanto
a partire da una precisa analisi dei presupposti dell’asserzione dello scettico
(l’asserzione TSM: “non vi è possibilità alcuna di una morale oggettivamente
fondata”) che l’argomento, come abbiamo visto, funziona.
In cosa consiste questa concezione dell’asserzione? Secondo Searle, la regola
essenziale dell’atto linguistico dell’asserzione è la seguente:
Un’asserzione ha valore di assunzione di un impegno sul fatto che ciò che si asserisce
corrisponda ad uno stato di cose reale,
il che non significa altro che dire che, quando qualcuno asserisce qualcosa, ritiene
che le cose stiano nel modo in cui si è detto. Secondo i teorici dell’etica del discorso,
la regola essenziale dell’atto linguistico dell’asserzione muta leggermente:
Un’asserzione ha valore di assunzione di un impegno sul fatto che ciò che si asserisce
corrisponda ad uno stato di cose reale, e di un impegno a giustificare la propria credenza
che ciò che si asserisce corrisponda ad uno stato di cose reale.
In quest’ottica, l’asserzione è simile ad una promessa: come la promessa ha valore di
assunzione di un obbligo a compiere ciò che si è promesso, così l’asserzione ha
valore di assunzione di un obbligo a giustificare ciò che si asserisce, su richiesta.
Chiameremo questa particolare prospettiva sull’atto linguistico dell’asserzione, che è
il primo dei presupposti dell’argomento anti-scettico formulato dai teorici dell’etica
del discorso, tesi del carattere intrinsecamente commissivo dell’asserzione (“commissivo”
perché, nel lessico di Searle, la promessa è un caso particolare degli atti linguistici
commissivi, ovvero atti che determinano l’assunzione di un obbligo). Si noti che,
sotto questa interpretazione, l’asserzione è equivalente all’argomentazione: asserire
qualcosa è sempre equivalente a prendersi degli impegni nel “teatro”
dell’argomentazione, di fronte cioè ai parlanti interessati (reali o immaginari) che
partecipano al discorso.
2) Il secondo presupposto dell’argomento pragmatico-trascendentale utilizzato dai
teorici dell’etica del discorso è strettamente legato al primo. La domanda che sorge
spontanea di fronte alla tesi del carattere intrinsecamente commissivo dell’asserzione
è la seguente: come è possibile dimostrare questa tesi? Come abbiamo visto, Apel ed
Habermas fanno riferimento, a questo proposito, al concetto di “contraddizione
performativa”: essi sostengono, cioè, che un’asserzione che contraddica il proprio
carattere di assunzione di responsabilità a giustificare sia non un’asserzione genuina,
bensì una contraddizione tra ciò che dico e ciò che faccio nel dire; e sostengono
altresì che questa contraddizione sia del tutto evidente (in questa prospettiva, se io
asserisco “in questo momento il gatto è sul tavolo, ma questa asserzione è del tutto
ingiustificabile”, dico qualcosa di totalmente assurdo, e di assurdo in modo evidente
a chiunque). In ciò è possibile cogliere la portata del rifiuto, da parte dei teorici
dell’etica del discorso, della concezione logico-semantica della razionalità (cfr. sopra,
Sezione 3): secondo una concezione logicista della dimostrazione, infatti, le
contraddizioni logiche (nella forma “A e non-A”: “Giovanni è biondo e non è
biondo”) vanno evitate in quanto violano, in virtù del proprio significato, un
principio primitivo, vale a dire il principio di non contraddizione. In una prospettiva
pragmatico-trascendentale, invece, le contraddizioni si mostrano in actu, in ciò che
faccio nel momento in cui asserisco davanti ad un uditorio un’assurdità. Non vi è
derivazione da altri principi, né interpretazione semantica: soltanto diretta evidenza
del fatto che, se asserisco qualcosa e simultaneamente nego alcune verità che sono il
presupposto della mia asserzione, faccio qualcosa di semplicemente assurdo.
Chiameremo questo presupposto, cruciale per l’etica del discorso, la tesi dell’autoevidenza delle contraddizioni performative. Per Apel, l’auto-evidenza delle contraddizioni
performative diventa il criterio essenziale per la fondazione di regole del discorso
oggettivamente valide; egli scrive infatti:
Se non posso contestare qualcosa, senza incorrere in una contraddizione in actu [=
contraddizione performativa] esso rientra tra i presupposti pragmatico-trascendentali
dell'argomentazione, che devono esser stati già sempre riconosciuti, affinchè il gioco
linguistico dell'argomentazione conservi il suo senso.2
6. Le regole del discorso e il proceduralismo. Principio D e Principio U.
Secondo i teorici dell’etica del discorso, dunque, ciò che non è possibile contestare
senza incorrere in contraddizione performativa (ad esempio, il fatto che l’asserzione
implica pretese, che a queste pretese sono connesse precise responsabilità, etc.) può
dirsi oggettivamente fondato. Ma l’impresa fondazionalista dei teorici dell’etica del
discorso riguarda, in primo luogo, l’ambito morale; la domanda rilevante che essi
devon porsi è dunque: che tipo di norme o principi morali è effettivamente possibile
dedurre sulla base del criterio della contraddizione performativa?
È bene notare, in primo luogo, che le norme deducibili, a pena di contraddizione
performativa, da atti linguistici enunciati in un contesto argomentativo sono,
appunto, più che norme morali sostanziali, regole inevitabili della situazione
argomentativa: vale a dire, regole del discorso moralmente rilevanti, ma necessariamente
limitate nell’ambito di validità. La formulazione più completa delle regole del
discorso pratico generale si deve, senza dubbio, all’opera Theorie der juristischen
Argumentation (Teoria dell’argomentazione giuridica, del 1973) di Robert Alexy. In
quest’opera, Alexy costruisce un intero codice dell’argomentazione pratica, un
codice dal quale poi deriva, mediante una serie di restrizioni successive, le regole
dell’argomentazione giuridica (la tesi per la quale l’argomentazione giuridica deve
considerarsi come un caso particolare dell’argomentazione pratica generale è la
cosiddetta “tesi del caso particolare”: Sonderfallthese). Sono esempi rilevanti di regole
del discorso pratico generale, secondo Alexy, le seguenti:
1. Chiunque sia in grado di parlare può prendere parte ai discorsi
2.1. Chiunque può problematizzare qualsiasi affermazione
2.2. Chiunque può introdurre nel discorso qualunque affermazione
2.3. Chiunque può esprimere le proprie opinioni, i propri desideri, i propri bisogni
3. Nessun parlante può essere ostacolato nell'esercizio dei propri diritti stabiliti sopra da
costrizioni che abbiano luogo all'interno o all'esterno del discorso.3
2
3
K. O. Apel, Discorso, verità, responsabilità, Guerini, 1997, p. 143.
R. Alexy, Teoria dell'argomentazione giuridica, Giuffrè, Milano, 1998, p. 153.
Apel, dal canto suo, in Etica della comunicazione (del 1992) individua tre norme
fondamentali del discorso: una norma della giustizia, secondo la quale, nel discorso,
vi è "uguale diritto per tutti i possibili partner del discorso ad articolare le proprie
pretese di validità"; una norma della solidarietà, secondo la quale nel discorso è
presupposto un "reciproco appoggio e dipendenza nel quadro del comune intento di
una soluzione argomentativa dei problemi"; una norma della co-responsabilità, secondo
la quale tutti i partecipanti al discorso sono egualmente responsabili del suo esito.
Il fatto che regole del discorso, così formulate, abbiano una rilevanza morale è di per
sé evidente. Non altrettanto evidente, tuttavia, è che regole di questo tipo possano
estendere il proprio dominio di validità al di là del mero àmbito dell’argomentazione.
Nel nostro teatro dell’argomentazione, in cui si discute la questione morale, queste
regole valgono: ma, evidentemente, non è il contesto altamente ritualizzato
dell’argomentazione l’unico àmbito in cui sorgono problemi morali. La domanda,
dunque, è la seguente: come può l’etica del discorso, dopo aver costruito il sistema
delle regole formali del discorso, fornire una risposta a problemi morali sostanziali?
I teorici dell’etica del discorso rispondono a questo problema con il concetto di
proceduralismo. Non sono le regole formali del discorso a fondare direttamente un
contenuto morale sostanziale: esse, tuttavia, rendono possibile una situazione
argomentativa moralmente fondata a partire dalla quale è possibile stabilire
contenuti morali sostanziali su qualsiasi problema, a patto che tali contenuti abbiano
ricevuto il consenso ultimo di tutti i possibili partecipanti al discorso. L’idea di
fondo, dunque, è quella di fornire un metodo per risolvere i problemi morali, e non
un codice di verità morali sostanziali: questo metodo consiste nel raggiungimento
del consenso in una situazione argomentativa nella quale vengono rispettate le
regole formali del discorso; possono ritenersi fondati soltanto i giudizi morali che
ottengono il consenso di tutti i partecipanti in una situazione linguistica “ideale”,
nella quale, cioè, le regole formali del discorso sono rispettate (in cui dunque tutti
accettano la propria responsabilità ad argomentare; tutti accettano le obiezioni da
qualunque parte esse vengano e rispondono ad ognuna di esse in modo razionale; in
cui chiunque può portare qualsiasi considerazione o attestazione d’interesse, purché
rilevante per il caso in questione, etc.). È quest’ultimo il cosiddetto Principio D,
formulato da Habermas:
possono pretendere validità soltanto quelle norme che trovano (o possono trovare) il
consenso di tutti i soggetti coinvolti quali partecipanti a un discorso pratico.4
Riformulando D come principio per la soluzione dei problemi morali, si giunge al
Principio U, che può ritenersi, in ultima analisi, il criterio centrale per la soluzione
razionale di problemi morali dal punto di vista dei teorici dell’etica del discorso.
Nella formulazione di Habermas, una norma o un principio morale sono validi se e
soltanto se
tutti i partecipanti in una comunità ideale della comunicazione possono accettare
liberamente quelle conseguenze e quegli effetti secondari che si prevedono derivare, per la
soddisfazione degli interessi di ciascun singolo individuo, da un'osservanza universale della
norma discussa.5
4
5
J. Habermas, Etica del discorso, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 103.
Ibidem.
Il principio U è chiamato in questo modo, evidentemente, perché equivale ad un test
di universalizzazione: se, in una situazione linguistica ideale in cui valgono le regole
del discorso (in cui dunque tutti accettano la propria responsabilità ad argomentare;
tutti accettano le obiezioni da qualunque parte esse vengano e rispondono ad
ognuna di esse in modo razionale; in cui chiunque può portare qualsiasi
considerazione o attestazione d’interesse, purché rilevante per il caso in questione,
etc.) una norma riceve il consenso unanime, in quanto ogni singolo partecipante
accetta le conseguenze di una eventuale osservanza universale di questa norma, sia
con riferimento ai propri specifici interessi, sia con riferimenti agli interessi di
qualunque altro individuo, allora (e soltanto allora) la norma morale può dirsi, da un
punto di vista di etica del discorso, razionalmente fondata.
7. Alcune obiezioni contro l’etica del discorso
L’impianto teorico dell’etica del discorso, anche in virtù della sua originalità e
profondità speculativa, è stato in più occasioni bersaglio di alcune obiezioni
notevoli. Nel seguito, discuteremo cinque delle obiezioni più rilevanti.
1) Obiezione della petitio principii. In primo luogo, si può obiettare ai teorici dell’etica
del discorso che essi, nel loro programma di fondazione morale per mezzo di un
proceduralismo fondato su regole del discorso, presuppongono un’intera teoria degli
atti linguistici senza dimostrarla: inoltre, essi non soltanto presuppongono la verità
delle tesi di Austin e Searle sull’aspetto performativo del linguaggio e sulla
costituzione interna dell’atto linguistico dell’asserzione, ma estendono queste
considerazioni fino a stabilire il carattere intrinsecamente commissivo
dell’asserzione, vale a dire, come abbiamo visto, la sostanziale equivalenza tra
asserzione ed argomentazione. Né Apel, né Habermas, né Alexy, tuttavia,
forniscono argomenti a supporto della teoria degli atti linguistici: in un certo senso,
essi confidano nella sua verità. In ciò, essi sottopongono l’intero impianto
fondazionalista dell’etica del discorso al rischio, molto concreto, di una petitio principii
(di una assunzione non giustificata, dogmaticamente presupposta).
Questa obiezione, si potrebbe obiettare agli obiettori, è “di parte”: vale a dire che
essa presuppone proprio quella concezione logico-semantica della razionalità che
Apel ritiene essere un preludio allo scetticismo morale. Apel, infatti, come abbiamo
visto, fornisce un criterio per la individuazione degli elementi oggettivi
dell’asserzione-argomentazione: questo criterio è la contraddizione performativa.
Anzi, proprio in antitesi ad una concezione della dimostrazione come deduzione
logica da principi, egli sostiene che è l’autoevidenza riflessiva della contraddizione
performativa a mostrarci i presupposti fondamentali del discorso. Non soltanto: egli
riconosce che un qualsiasi criterio dimostrato per mezzo di contraddizione
performativa non possa essere dimostrato logicamente se non a pena di petitio
principii: ma in questo egli vede semplicemente un limite della dimostrazione logica,
la quale non è in grado di mostrare quali evidenze appaiano tali a chi partecipa al
gioco linguistico dell’asserzione-argomentazione.
2) Obiezione della circolarità. L’obiezione della petitio principii, di conseguenza, necessita
di un complemento, vale a dire una critica alla tesi dell’auto-evidenza delle contraddizioni
performative. Non è sufficiente dire che l’etica del discorso presuppone, come suo
fondamento, la teoria degli atti linguistici: visto che il criterio di fondazione delle
regole del discorso risiede nella auto-evidenza delle contraddizioni performative
(ovvero, come abbiamo visto, di quelle assurdità del linguaggio che nascono quando,
nell’asserire qualcosa, neghiamo una delle regole del discorso), è questo criterio al
quale è necessario obiettare. Più in particolare, si potrebbe obiettare ad Apel che,
argomentando che l’asserzione ha un carattere intrinsecamente commissivo sulla
base del fatto che colui che nega il carattere commissivo di un’asserzione (dicendo,
ad esempio, “affermo che l’attuale tasso di disoccupazione in Italia è minore di
quello dell’anno scorso, ma non mi prendo alcuna responsabilità a giustificare questa
asserzione”) incorre in una assurdità manifesta, in realtà si presuppone ciò che si
vuole dimostrare, ovvero che un’asserzione ha un carattere commissivo che non
può essere sensatamente contraddetto: si cade, cioè, in un circolo vizioso.
Anche a questa obiezione, tuttavia, Apel risponderebbe dicendo che la
contraddizione performativa che nasce dal negare il carattere commissivo di
un’asserzione non dipende da una qualche presupposizione (o premessa) nascosta
nell’argomento: ancora una volta, questa sarebbe un’interpretazione logico-deduttiva
dell’argomento pragmatico-trascendentale. La contraddizione performativa che
nasce dal dire, ad esempio, “affermo che l’attuale tasso di disoccupazione in Italia è
minore di quello dell’anno scorso, ma non mi prendo alcuna responsabilità a
giustificare questa asserzione” è evidente a chiunque: ed è questa evidenza (e non la
presupposizione di un principio nascosto) a costituire il fondamento
dell’argomentazione pragmatico-trascendentale.
3) Obiezione della fallacia naturalistica. Alcuni autori hanno obiettato all’etica del
discorso sostenendo che è fallace dedurre principi di carattere normativo dalla
costituzione interna dei nostri atti linguistici: tale costituzione, infatti, è una
questione di fatto. In questa prospettiva, l’etica del discorso cadrebbe in un caso
particolare di fallacia naturalistica, deducendo proposizioni di tipo normativo (le
regole del discorso) da proposizioni di tipo descrittivo (le quali esplicitano la
costituzione dei nostri atti linguistici).
Questa obiezione non può essere trattata approfonditamente in questa sede, in virtù
dell’ampiezza dei problemi che essa solleva. Basti dire, qui, che la possibilità di
dedurre principi o proposizioni normative dalla costituzione di atti linguistici è stata
ampiamente discussa con riferimento ad un noto articolo di Searle, intitolato How to
Derive ‘Ought’ from ‘Is’ (Come derivare ‘Dovere’ da ‘Essere’, del 1969). Inoltre, sia
Alexy che Apel hanno affrontato l’obiezione, sostenendo che esplicitare i principi
normativi presenti, come presupposti, nelle nostre pratiche argomentative non è la
stessa cosa che derivare principi normativi da proprietà o stati di cose naturali: nel
momento in cui gli individui entrano in pratiche argomentative, infatti, si può
ritenere che essi, in quanto agenti morali, abbiano già riconosciuto i principi normativi
impliciti in tali pratiche; mentre non è possibile ritenere che gli stati di fatto naturali
abbiano in qualche modo, di per se stessi, una connotazione morale.
4) Obiezione del formalismo. Una delle accuse più frequenti all’etica del discorso è quella
di cadere nel formalismo etico: secondo questa obiezione, l’etica del discorso, al di là
dell’esplicitazione di regole procedurali dell’argomentazione, non è in grado di
fornire una soluzione reale ai problemi etici sostanziali. Infatti, in primo luogo, la
realizzazione di un contesto argomentativo in cui valgano le regole del discorso è del
tutto ideale: un tale contesto non può essere concretamente realizzato. Un qualsiasi
discorso reale non potrà mai includere tutti i potenziali interessati alla questione, né
sarà sufficientemente esteso nel tempo da permettere a chiunque di argomentare le
proprie tesi contro qualsiasi obiezione. In secondo luogo, quand’anche fosse
possibile realizzare il contesto argomentativo ideale dell’etica del discorso, non è
affatto detto che sia possibile raggiungere un consenso tra tutti i partecipanti,
nemmeno con riferimento alle questioni etiche più minimali. Ma se un tale consenso
non viene raggiunto, il principio U del discorso, che abbiamo visto essere il criterio
procedurale fondamentale per la risoluzione delle questioni morali sostanziali, di
fatto non ci dice niente: è soltanto un criterio formale privo di applicazione.
L’obiezione al formalismo è senza dubbio la più forte delle obiezioni all’etica del
discorso finora sollevate. Effettivamente, non vi è motivo di ritenere che il consenso
sia effettivamente raggiungibile in un discorso reale, né che, qualora esso sia
raggiunto, si riveli poi inclusivo di tutti i possibili punti di vista. Sia Apel che
Habermas hanno risposto all’obiezione del formalismo insistendo sul carattere
dialettico delle regole del discorso La loro tesi è la seguente: pur essendo certamente
vero che le regole del discorso sono idealizzazioni, esse sono idealizzazioni
presupposte nelle nostre pratiche argomentative reali; ogni essere razionale, di fatto,
argomenta come se chiunque potesse obiettare a ciò che dice, e come se dovesse
giustificare le proprie posizioni contro ogni potenziale obiettore, anche se,
evidentemente, ciò non avviene nel concreto, e non è nemmeno possibile che ciò
avvenga. Da un lato, le nostre pratiche argomentative devono andare avanti
concretamente, e in ciò necessariamente si allontanano dall’ideale delle regole del
discorso; dall’altro lato, tuttavia, le nostre pratiche argomentative tendono verso
l’ideale rappresentato da quelle regole: vi è cioè, una tensione dialettica costante tra
fattualità della pratica reale e idealità delle regole del discorso presupposte. Nel
riconoscere questa tensione, e nel ricostruire le idealizzazioni normative (le regole
del discorso) cui tendere per la realizzazione di una situazione argomentativa
razionale, l’etica del discorso non è affatto inutile; essa, piuttosto, indica un “ideale
regolativo” nel senso kantiano: un ideale mai raggiungibile, e tuttavia necessario per
indicare la direzione cui avvicinarsi mediante approssimazioni successive.
5) Obiezione dell’universalità dell’argomentazione. L’ultima obiezione che considereremo è
vólta a mettere in dubbio che la ricostruzione dei presupposti ideali
dell’argomentazione possa essere un punto di partenza valido per la risoluzione
delle controversie morali: infatti, non è affatto detto che l’argomentazione sia un
contesto universale ed inevitabile della discussione morale, ed anzi forse ne è uno
dei contesti più ristretti (ad esempio, si pensi all’impatto che dogmi di tipo religioso,
non argomentati né argomentabili, hanno sulla discussione morale). È forse vero
che la discussione e l’argomentazione razionale caratterizzano la filosofia morale di
derivazione genericamente occidentale: ma non è affatto detto che questa
impostazione debba essere onnicomprensiva; né, dunque, che sia possibile
presupporla quale fondamento di un’etica procedurale universale.
I teorici dell’etica del discorso hanno risposto a questa obiezione in modi differenti.
Secondo Apel, che fornisce certamente la risposta di carattere più teorico,
l’obiezione dell’universalità dell’argomentazione è, a rigore, del tutto irrilevante:
infatti, dal suo punto di vista, nel momento in cui si avanza un’asserzione di tipo
morale, si è già all’interno dell’argomentazione e se ne accettano i presupposti (Apel
esprime questo concetto sostenendo che il contesto linguistico dell’asserzioneargomentazione è il “gioco linguistico trascendentale” al di là e al di sopra dei singoli
giochi linguistici specifici). Ciò, secondo Apel, è mostrato dal fatto che anche colui
che solleva il dubbio morale più radicale, cioè lo scettico morale, non può non
accettare questi presupposti senza incorrere in contraddizione performativa. E, se
ciò avviene nel caso del dubbio morale più radicale, secondo il quale la discussione
morale non dovrebbe nemmeno essere possibile, a fortiori la fondazione delle regole
del discorso deve considerarsi valida in tutti gli altri contesti di discussione morale.
Secondo Habermas, invece, il contesto dell’asserzione-argomentazione, per quanto
non “universale” nel senso di “concettualmente inaggirabile” (come invece sostiene
Apel), è tuttavia un universale fattuale, frutto di uno specifico meccanismo evolutivo
(Habermas chiama questa prospettiva “naturalismo debole”). Alexy, infine,
indebolisce ulteriormente la prospettiva di Habermas, sostenendo che il contesto
linguistico dell'asserzione-argomentazione non è trascendentalmente necessario, nè
empiricamente universale, bensì è la “più generale delle forme di vita umane”.
Questo progressivo indebolimento della tesi dell’universalità dell’argomentazione
(frutto dell’abbandono dell’impostazione teorica originaria di Apel) riduce,
evidentemente, la portata fondativa dell’etica del discorso: la questione che rimane
aperta è se questa riduzione non equivalga, in ultima analisi, ad una resa del progetto
fondazionalista.