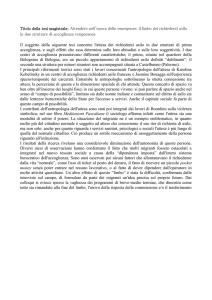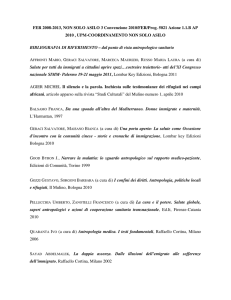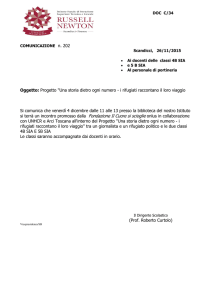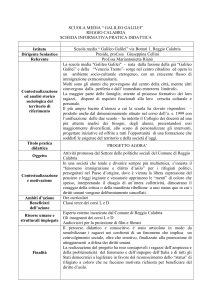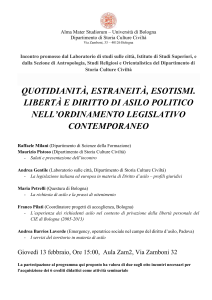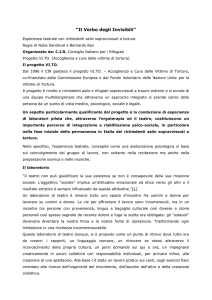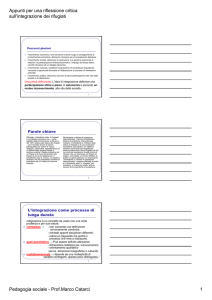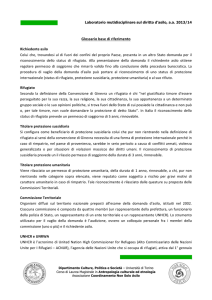PROTEO BERGAMO
associazione culturale no profit - PROmozione Tecnologie Esperienze Organizzazione
Provider ECM nazionale accreditamento n. 1519.
24122 - Bergamo - Via Garibaldi 3. tel. 035.3594246, fax 035.3594459 - E-Mail [email protected] -
BERGAMO
LE COMUNITÀ STRANIERE
E IL CONTESTO SOCIO SANITARIO
Corso ECF FAD 87446 – Dal 10 Marzo al 31 Maggio 2014 – Per tutte le professioni – 14 crediti
Materiale n. 4
RIFLETTERE SULLA SALUTE DI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
COME OCCASIONE PER RIPENSARE LE PRATICHE
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI.
UN PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA.
(di Andrea Pendezzini, Medico volontario Associazione Oikos)
INTRODUZIONE: LA “FUNZIONE SPECCHIO” DELL'IMMIGAZIONE
La tesi da cui muovono le seguenti riflessioni è la seguente: l'immigrazione, più di ogni altro fenomeno, è capace di rivelare la natura della società cosiddetta di accoglienza. I migranti sarebbero coloro che, per il solo fatto di essere tra noi, ci costringono a rivelare chi siamo: nei discorsi che facciamo, nel sapere che produciamo, nelle pratiche che agiamo.
“Abitualmente si parla di “funzione specchio” dell'immigrazione, cioè dell'occasione privilegiata
che essa costituisce per rendere palese ciò che è latente nella costituzione e nel funzionamento di
un ordine sociale, per smascherare ciò che è mascherato, per rivelare ciò che si ha interesse a lasciare in uno stato di “innocenza” o ignoranza sociale, per portare alla luce o ingrandire (ecco
l'effetto specchio) ciò che abitualmente è nascosto nell'inconscio sociale ed è per ciò votato a rimanere nell'ombra, allo stato di segreto o non pensiero sociale (Sayad, 1996, p.10)”.
Il settore socio-sanitario e più in generale della cura, che ormai da anni si confronta con la necessità
di prendere in carico pazienti stranieri, provenienti da contesti differenti da quello italiano e spesso
molto eterogenei tra loro, riveste un ruolo centrale in questa dinamica. Gli studi e le ricerche recenti
delle scienze sociali, dell'antropologia medica in particolare, restituiscono un'idea complessa della
salute e della malattia, la quale, in questa prospettiva, è lontana dall'essere una condizione unicamente determinata da variabili biologiche. Essa si configura da un lato come incorporazione delle
diseguaglianze sociali e della violenza strutturale (Farmer, 2004) e dall'altro come un idioma socialmente legittimato per esprimere il proprio disagio, parallelamente al venir meno di altri canali
condivisibili per mettere in scena la propria indignazione nei confronti dell'ordine sociale (Lock,
Scheper-Hugher, 1990).
Cosa significa tutto ciò? A più di sessant'anni da quando nel 1948 l'Organizzazione Mondiale della
Sanità propose di passare da un modello bio-medico (salute come assenza di malattia) ad uno biopsico-sociale, l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica, degli finanziatori la ricerca scientifica
appare oggi ancora concentrata sulla dimensione biologica della malattia. Come se esistesse una
dimensione naturale, evidente, misurabile con precisione e per questo primaria, sulla quale poi va1
riabili psicologiche, sociale e politiche vanno ad incidere. Un infarto è un infarto, una tubercolosi è
una tubercolosi, un diabete è un diabete.
L'ipotesi che guida queste pagine è che la realtà sia più complessa, che esista una “patogenesi sociale” della malattia. Cioè che le cosiddette “variabili ambientali” non siamo semplicemente qualcosa in grado di modulare un processo biologico autonomo, al limite rappresentandone dei fattori di
rischio, come è nella lettura classica dell'igiene e della sanità pubblica (stili di vita scorretti, inquinanti ambientali come causa di malattia). La medicina, oltre all'efficacia terapeutica, partecipa ad un
processo di produzione sociale della malattia.
Alcuni anni fa l'OMS abbassò da 7,8mM a 7,0mM di glicemia a digiuno la soglia per la diagnosi di
diabete (che poi viene perfezionata con altri esami ematici). Questa riduzione, giustificata con criteri di pertinenza preventiva, ha aumentato di 6 milioni di persone i diabetici nella sola Europa
(Rossi, 2003). Come è noto ogni soglia è arbitraria e può venire innalzata o ridotta in base a criteri
di vario tipo: se da un lato è indubbio che una diagnosi precoce possa concorrere alla riduzione delle complicanze di una malattia cronica come il diabete, dall'altro lato è altrettanto verosimile pensare che un costante abbassamento di una soglia come quella in oggetto, con il conseguente allargamento dell'area individui considerati patologici, possa indirettamente veicolare l'idea che esista una
soluzione rapida, precoce, farmacologica ad un disturbo metabolico che è invece fortemente legato
allo stile di vita. Se si considera poi, come dimostra la letteratura epidemiologica, che esiste una
correlazione inversa tra status socioeconomico e prevalenza di diabete (Connoly et al., 2000), che
cioè al diminuire di tale status aumenta il numero di diabetici, a parità di altre condizioni, si può
concludere che la decisione di abbassare la soglia glicemica a partire dalla quale viene fatta diagnosi di diabete non rappresenta un processo neutro. Espandendo l'area di competenza della medicina
su di una condizione, quella cioè dell'avere valori glicemici lievemente elevati, tale decisione di fatto concorre a sottrarre visibilità alle determinati comportamentali (stili di vita), ma sopratutto sociali
ed economiche di tale condizione1.
Un secondo esempio illustra la produzione della categoria diagnostica di silicosi negli Stati Uniti, in
connessione con la trasformazione del processo di estrazione del carbone e alla nascita dei movimenti sindacali (Smith, 1987). In una fase iniziale i minatori lavoravano in città minerarie lontane
dalla famiglie e dai propri centri di residenza abituale, e l'unica assistenza che avevano era quella
del medico della compagnia per cui essi lavoravano, selezionato da quest'ultima e pagato dai minatori. In questa fase per i problemi di salute che riguardavano diversi lavoratori si parlava di “asma
del minatore”, imputata alla malsane abitudini di vita, in particolare il consumo d'alcool e di sigarette. In seguito all'evoluzione della tecniche di estrazione del carbone e al consolidarsi del movimento
sindacale, si passò ad un sistema di assistenza per i minatori organizzato dal sindacato e pagato dalla compagnia: l'asma del minatori venne allora concepita in termini assai diversi e cioè come silicosi, malattia professionale, per la quale era legittimo richiedere un risarcimento in caso di danno grave o morte. Questo esempio mette in luce come l'analisi della produzione delle categorie diagnostiche debba tenere in considerazione interessi economici e sociali.
La natura stessa della malattia non è - in questa prospettiva - un dato di fatto semplicemente da studiare, diagnosticare, trattare, ma una costruzione sociale, soggetta ad innumerevoli forze ed interessi
che la plasmano.
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano, con il suo carattere universalistico, da accesso alle cure mediche a cittadini italiani, così come stranieri residenti o temporaneamente permanenti sul territorio2.
Quando venne creato nel 1978, sul modello inglese, esso fu concepito come finanziato dalla fiscalità generale, al fine di garantire l'equità sociale dell'accesso alla cure (accesso per tutti e pagamento
1
Per chi fosse interessato alla riflessione dell'epidemiologia sociale segnalo: Krieger N., 2011, Epidemiology
and The People’s Health: Theory and Context, Oxford University Press, New York e Krieger N, 2004, Embodying Inequality: Epidemiologic Perspectives, Baywood Publications, Inc, Amityville, NY.
2
Altri contributi di questo corso approfondiscono la legislazione sanitaria in materia di immigrazione.
2
indiretto in base alle tasse che ognuno paga e quindi al reddito). Questa impostazione ha favorito tra
gli operatori sanitari lo stratificarsi dell'idea di una omogeneità sociale dei propri utenti, tutti infatti avevano (ed hanno) accesso al SSN a prescindere da reddito3.
Il fenomeno migratorio negli anni novanta e duemila ha progressivamente modificato il quando. Da
un lato portando all'attenzione del sistema sanitario individui e famiglie provenienti da contesti linguisticamente, culturalmente e socialmente eterogenei rispetto a quello italiano, e dall'altro lato rivelando la presenza sul territorio nazionale situazioni di precarietà socio-economiche anche molto
serie, legate agli ampi fenomeni della globalizzazione dei mercati e dei processi di competizione al
ribasso del costo del lavoro. Tali processi hanno anticipato di almeno un decennio la grave crisi sociale che oggi investa ampi settori della società nel suo complesso.
Individui malati e, contemporaneamente, in una situazione di forte precarietà economica, sociale,
relazionale rappresentano una lente di ingrandimento utile per osservare e decodificare le implicazioni delle determinanti sociali della salute.
Rifugiati e richiedenti asilo rappresentano un piccola ma significativa parte dei cittadini stranieri
presenti in Italia. Fuggendo da paesi teatro di guerre e violenze, avendo dovuto abbandonare la propria terra e le proprie case, non per scelta, ma per necessità, essi si trovano, nella fase iniziale di approdo nel paese di accoglienza, in una condizione di importante precarietà giuridica, economica, sociale, psicologica. E' proprio nella pratica clinica con queste persone che possiamo osservare più
chiaramente quanto ricordato in precedenza che, in fin dei conti, vale per tutti: la salute, la sofferenza, la malattia sono condizioni complesse che si manifestano all'interno di una rete di rapporti di
forza sociali, di variabili biologiche, di strategie incorporate di critica dell'ordine costituito, di richieste di riconoscimento.
Riflettere sulle “differenze” (linguistiche, culturali, sociali, economiche) portate dentro al sistema
sanitario da soggetti provenienti da altri paesi, significa dunque riflettere sugli impliciti su cui si
basa e funziona il sistema stesso. Ciò consente, in ultima analisi, di considerare – ad esempio quanto la diagnosi non sia un processo tecnico e neutro, ma una pratica che produce realtà, collocata
all'interno di una arena di interessi scientifici, economici, professionali; come la sofferenza che assume la forma di una patologia non sia solo un evento biologico, ma anche un fenomeno capace di
rivelare molto sulla condizione sociale di una persona e della società in cui essa vive; come la presa
in carico fatta da un operatore sanitario – infine – non sia unicamente un atto tecnico, ma anche uno
spazio dove è possibile il riconoscimento di quanto vi è di irriducibilmente soggettivo (e cioè attinente alla storia individuale del paziente che si ha davanti) in una malattia.
LA COSTRUZIONE DELLA CATEGORIA DI RIFUGIATO
L'esistenza di persone che cercano di fuggire dal loro paese, segnato da violenze e conflitti, per trovare rifugio in altri luoghi non è certamente una novità del mondo contemporaneo, né una specificità del continente europeo. Tuttavia è in epoca recente, e in particolare a partire dalla seconda metà
del XX secolo, che i rifugiati diventano un problema centrale di politica internazionale. Ed è in seguito alle drammatiche conseguenze della seconda guerra mondiale che in Europa vengono elaborati gli elementi principali del diritto internazionale in questa materia, nel tentativo di produrre una
possibile risposta al senso di orrore, vergogna e responsabilità che attraversava il continente. Il rifugiato come specifica categoria sociale e come problema legale di dimensioni globali nasce in questo periodo (Malkki, 1995). Questo momento storico segna inoltre la nascita di alcune tecniche di
gestione del dislocamento di massa, per la prima volta standardizzate e globalizzate, oltre che di una
nuova classe di professionisti e di specifiche tecnologie di cura e di controllo di quella che verrà a
costituire una nuova categoria sociale e antropologica. Le categorie di “richiedente asilo” o di “ri3
Non mi interessa in questa sede discutere la controversa realtà dei ticket sanitari ed il pesante impatto che essi
hanno sull'equità in accesso al Servizio Sanitario Nazionale.
3
fugiato” non hanno una natura fissa, immutabile nel tempo, costitutiva di una qualche predefinita
identità. Al contrario, esse costituiscono piuttosto costruzioni sociali fluide, in perpetuo movimento
ed evoluzione nel tempo. Come ha messo in luce Lisa Malkki (1995, 1996) infatti, il concetto di “rifugiato” è in realtà un involucro che racchiude al suo interno un mondo di differenti status socioeconomici, storie personali, desideri e memorie.
Il diritto di asilo si appoggia su normative internazionali in definitiva vaghe e dai confini indistinti,
che lasciano ampio spazio ad applicazioni nazionali e prassi locali. La definizione del “vero” richiedente asilo viene infatti costruita attraverso l’applicazione di concetti come “persecuzione”,
“timore fondato”, “gruppo sociale”, che lasciano margine a differenti definizioni e interpretazioni
nazionali e prassi territoriali4. E’ dunque importante problematizzare la costruzione dei rifugiati e
del diritto di asilo come oggetto di conoscenza e analisi, nel tentativo di evitare visioni essenzializzanti e semplicistiche.
Per Giorgio Agamben (1995), i rifugiati, proprio perché con la loro presenza mettono in crisi la
consolidata trinità Stato–Nazione-Territorio5, possono essere considerati come una della figure centrali della storia politica contemporanea. Implicito prodotto endogeno del paradigma nazionale
(Sassen, 1999) o piuttosto emblema di un ordine post-nazionale emergente (Appadurai, 1996), i richiedenti asilo affrontano e incarnano oggi alcuni dei paradossi costitutivi dell'architettura, delle
narrazioni e dei valori degli ordinamenti politici contemporanei, scissi in una continua tensione tra
retoriche dei diritti umani e dell'aiuto umanitario e squilibrati rapporti di oppressione e violenza tra
stati, gruppi sociali, individui.
Essi rappresentano una gruppo particolare di migranti: non spostandosi principalmente per motivi
economici, rientrano con difficoltà nelle recenti politiche che, nei paesi ricchi, sempre più legano la
possibilità di risiedere sul territorio nazionale al possesso di un lavoro6. Il rapporto che con essi
hanno gli Stati è ambiguo: da un lato le carte costituzionali ed i trattati internazionali affermano
formalmente di garantire protezione a chi fugge da situazioni di violenza e persecuzione7, dall'altro
lato – ad esempio - l'Unione Europea ha implementato negli ultimi anni un sistema di “esternalizzazione” e monitoraggio delle frontiere (Frontex) che nei fatti rallenta il flusso di migranti cosiddetti
“economici”, ma anche di potenziali richiedenti asilo, verso il proprio territorio. Essi, ci ricorda Liisa Malkki possono “far sanguinare o indebolire i confini nazionali, e al tempo stesso rappresentano
una minaccia per la sicurezza nazionale” e “un attacco all'ordine assoluto della nazioni, un ordine
percepito spesso come naturale e dotato di una legittimità intrinseca (Malkki 1995b, pp. 7-8)”.
La figura del richiedente asilo occupa dunque uno spazio sociale scomodo: egli è investito allo stesso tempo dell’immagine della vittima e di quella del truffatore, del potenziale destinatario di assistenza umanitaria e del “clandestino invasore” da cui la società deve difendersi.
MIGRANTE ECONOMICO O RIFUGIATO?
Nell'ultimo decennio in molti paesi europei è crollato il numero di permessi di soggiorno per
lavoro: le interpretazioni di questo fenomeno sono differenti e politicamente connotate (calo
dell'offerta lavorativa legata alla crisi versus volontà di lasciare in una condizione di irregolarità
giuridica e dunque di maggiore ricattabilità i lavoratori stranieri). Quello che qui interessa è sottoli4
Altri contributi di questo corso approfondiscono il quadro giuridico e amministrativo in cui si colloca il richiedente o titolare di Protezione Internazionale in Europa ed in Italia.
5
Uno stato ha il diritto di limitare l'accesso al proprio territorio ai cosiddetti “migranti economici”, ma - nella
misura in cui ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra - non si può permettere di respingere persone che fanno richiesta di protezione internazionale, fino a quando non venga verificata l'accoglibilità o meno della domanda stessa.
6
Per quanto riguarda nello specifico l'Italia si vada la legge Bossi-Fini (Legge 30 luglio 2002, n. 189).
7
Basti pensare all'art. 10 della Costituzione Italiana (1948): “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.” Per i riferimenti normativi rimando agli altri contributi.
4
neare come il chiudersi del canale di acceso legato al lavoro abbia messo sotto tensione la via della
richiesta di protezione internazionale, cioè dell'asilo. Quest'ultima strada sembra essere rimasta
l'ultima possibilità per sperare di essere ammessi in Europa. Quando ci si trova di fronte un richiedente asilo, con chi si ha a che fare? Con una persona che effettivamente scappa da guerra e violenze o da un “furbo” che sta tentando la sorte imbrogliando il sistema? Sembra essere questa la domanda che assilla molti operatori dei servizi pubblici che si occupano di richiedenti asilo (questure,
operatori sociali, personale sanitario ecc).
Gli studi e le ricerche delle scienze sociali, sociologia ad antropologia, mostrano però come questa
ambiguità sia stata anche stimolata dalle istituzioni governative stesse. E' il caso dell'Italia e
della cosiddetta “Emergenza nord Africa”. A partire dall'inizio del 2011, in seguito ai conflitti
scoppiati prima in Tunisia, Egitto e successivamente in Libia si è registrato un incremento del flusso
di persone che via mare hanno cercato di raggiungere le coste dei paesi del sud dell'Unione Europea
e in particolare, per le sua posizione geografica, dell'Italia. L'attenzione mediatica su questi avvenimenti è stata particolarmente alta e dichiarazioni forti sono stata fatte da numerosi rappresentanti
delle istituzioni. Il Ministro degli Interni italiano, Roberto Maroni, ha dichiarato il 2 Marzo 2011 al
Corriere della Sera: “Stimiamo che in Libia ci siano circa 1,5 milioni di clandestini, entrati dai confini a sud, dal deserto. Mi aspetto che non appena la situazione lo consentirà questi riprenderanno
la direzione nord verso l'Europa: sarebbe lo scenario peggiore possibile, che prevede movimenti di
forse 200.000 persone in fuga8”. Il governo italiano ha dunque deciso di gestire il flussi di migranti
proveniente in quei mesi dai paesi del nord Africa con un dispositivo di tipo emergenziale, affidandone le gestione alla Protezione Civile Nazionale9. La”capienza totale” prevista dal “Piano per
l'accoglienza dei migranti10” è stato però di massimo 50.000 unità e cioè un numero di persone inferiore all'1% delle presenze di cittadini stranieri in Italia11, tanto da indurre numerose prese di posizione contro suddetta la gestione emergenziale: a fronte di più di 5 milioni di cittadini stranieri che
regolarmente soggiornano sul territorio nazionale, le gestione di alcune decine di migliaia di persona sbarcate in seguito al conflitto libico necessitava realmente di un dispositivo emergenziale per
essere gestito? O piuttosto l'inserimento in una logica, appunto, emergenziale di questi in fin dei
conti modesti flussi migratori non rispondeva a logiche di ordine mediatico e politico?12
Le persone interessate da questo “piano”, prima chiamate dai documenti ufficiali “profughi” e in
seguito “migranti”, sono state fatte transitare da Lampedusa ai grossi centri di smistamento del sud
Italia, come i C.A.R.A. (Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo) di Mineo e Manduria, oltre ai
nuovi C.I.E. (Centro Identificazione ed Espulsione), verso i punti di arrivo situati nel resto del territorio nazionale, specialmente al centro-nord. Il 6 Ottobre 2011 il governo italiano ha prorogato di
12 mesi, fino al 31 Dicembre 2012 lo “Stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa” ed in seguito nuovamente fino al 28
Febbraio 2013.
La gestione dell'emergenza da parte della Protezione Civile Nazionale ha portato ad una emarginazione del Sistema d’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), come testimoniato
dalle dichiarazioni della Direttrice del Servizio Centrale SPRAR13. La gestione da parte della
Protezione Civile e alle forze dell’ordine dei richiedenti asilo nei CARA (Centri accoglienza
richiedenti asilo) costa al giorno circa 70-80 euro pro capite, escluse le spese dei controlli di sicurezza. Nell'ambito della cosiddetta “Emergenza nord Africa” la Protezione Civile Nazionale
erogava 46 euro pro capite al giorno agli enti a cui appalta la gestione della persone coinvolte
8
Vedi http://www.corriere.it/cronache/11_marzo_02/profughi-sbarco-lampedusa_12cf5c7c-4497-11e0-9331d6a950f4a7ad.shtml
9
Vedi http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS24090
10
Vedi http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Piano_migranti.pdf
11
Cfr. Caritas-Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2011.
12
Vedi
http://www.fieri.it/oltre_l_emergenza_nordafrica_spunti_di_riflessione_sul_sistema_di_accoglienza_in_italia.php;
http://rbe.it/news/files/2012/11/convegno.jpg; http://www.meltingpot.org/articolo18207.html.
13
Vedi http://www.meltingpot.org/articolo16709.html
5
nel piano di accoglienza. Il costo di una persona inserita in un progetto ordinario SPRAR invece è di circa 35 euro al giorno.
Il non aver concesso fin da subito, da parte delle istituzioni, una protezione umanitaria (prevista
dall'art. 20 del Testo Unico sull'immigrazione) a coloro che fuggivano dalla Libia in guerra ed aver
invece imposto come strada quella della domanda individuale di protezione internazionale (asilo),
che poi per un numero significativo di persone è stata respinta14, non è stato senza conseguenze. Si
sono generate aspettative poi non corrisposte, che hanno in molti casi influito sull'equilibrio e sulla
salute delle persone. L'affidamento ad enti pubblici e privati più o meno improvvisatisi la gestione
delle domande e dell'accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dalla Libia, ha portato al verificarsi di situazioni sociali ed abitative molto precarie.
La vicenda della cosiddetta “Emergenza nord Africa” ha rappresentato un esempio di come siano
gli Stati stessi, in alcuni casi, ad implementare procedure che contribuiscono a sfumare e rendere
poco chiaro il confine tra la categoria del “migrante economico” e quella del “richiedente asilo
o rifugiato” (Manocchi 2012).
ESSERE RIFUGIATI: VITTIMA O SOGGETTO?
“Sono stanco, mi sento affaticato e stanco, la notte non dormo mai, ho paura. Spesso al centro di
accoglienza entrano i militari (...) no, volevo dire, la polizia (...) fa dei controlli, guarda i fogli dei
permessi di soggiorno. Ad agosto sono entrati una notte e hanno frugato nelle stanze. Cercavano
qualcuno, entravano nelle camere con le torce elettriche e sollevavano le lenzuola di chi dormiva.
Avevo paura, non sono tornato al dormitorio per tre giorni. Poi qualche giorno dopo mi hanno
fermato per strada. Un agente ha detto che la ricevuta del permesso di soggiorno era falsa e che
dovevo seguirlo. Io ho avuto di nuovo paura, gli ho lasciato il foglio e sono scappato. In quei giorni
ero spaventato, tremavo, ho preso tutte le gocce che restavano (...)”. (Richard, richiedente asilo
della Repubblica del Congo, citato in Vacchiano, 2005) .
La maggior parte della letteratura che tratta la salute dei rifugiati si è soffermata, in una prima fase,
sulle conseguenze della violenza, della tortura e dello sradicamento (Ager 1993). Vi è la tendenza a mettere in rapporto i problemi dei rifugiati con l’esperienza della privazione, la quale include la
perdita della propria cultura, che iene spesso considerata una conseguenza della fuga, oppure con la
violenza o con le torture subite, a causa delle quali molte persone sono state costrette a fuggire dal
proprio paese. Vi è un numero crescente di centri che offrono aiuto terapeutico alle “vittime” di torture e si è sviluppata una vera e propria industria semi-globale che si occupa di questo fenomeno
(Summerfield, Hume 1993; Summerfield 1991, 1997). Nuove ricerche hanno però fatto emergere
come la precarietà materiale e sociale nel contesto di arrivo, l'ambiguità delle pratiche di accoglienza, l'arbitrarietà della procedure amministrative per l'ottenimento dello status di protezione internazionale giochino un ruolo centrale nella genesi della sofferenza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia e in Europa (Agier 2005, Fassin, Rechtman 2009, Beneduce 2010, Sorgoni
2011).
Richiedenti asilo e rifugiati in Italia possono ritrovarsi in tre differenti situazioni (Manocchi
2012): quella di non avere alcun appoggio e di finire letteralmente sulla strada, quella di appoggiarsi
presso connazionali o amici e, infine, quella di entrare in progetti pubblici di accoglienza.
La prima situazione si verifica spesso all'arrivo del richiedente asilo, ma non è escluso che torni a
presentarsi in concomitanza con situazione acuta di sofferenza sociale (perdita del lavoro ed impossibilità concomitante di essere aiutati da amici o da progetti pubblici). L'accoglienza presso amici e
connazionali rappresenta una modalità frequente di transito tra le situazioni più precarie delle fasi
14
La domanda di asilo infatti si basa sulla situazione del paese di cui il richiedente è cittadino (dal quale magari
la persona è lontana da anni) e non su quella del paese di dimora effettiva (dove la persona lavorava spesso da anni nel
casi dei cosiddetti profughi dell'”Emergenza nord Africa).
6
iniziali e l'auspicata stabilizzazione. Quest'ultima però spesso non arriverà mai e il titolare di protezione internazionale, ormai con un regolare permesso di soggiorno, potrà dunque trascorrere anni in
una situazione di più o meno forte precarietà abitativa, lavorativa e sociale, con evidenti ricadute
anche in termini di salute fisica e psichica. L'accoglienza nei progetti pubblici, infine, è quella su
cui si è concentrata maggiormente l'attenzione della ricerca sociale. Recentemente il Ministero degli
Interni ha innalzato sensibilmente il numero di posti disponibili presso lo SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), portandoli a circa 16.000 unità15. Al richiedente asilo viene offerta un'accoglienza di sei mesi, rinnovabile di altri sei, che prevede un supporto abitativo, corsi di
lingua, tentativi di inserimenti lavorativi, pur con le attuali difficoltà legate alla crisi economica che
investa la società italiana nel suo complesso. E' previsto anche un supporto all'iter di richiesta della
protezione internazionale. Molto spesso i progetti sono affidati dagli enti pubblici attivatori (i Comuni) a cooperative ed altri realtà del privato sociale. Il panorama di soggetti che entrano in gioco
nel gestire la vita dei richiedenti asilo e rifugiati è quindi molto composito: dipendenti pubblici, cooperative sociali, volontari.
Se da un lato è innegabile che i richiedenti asilo, una volta arrivati nei paesi di accoglienza e sopratutto nelle prime fasi del loro inserimento, abbiano bisogno di aiuto, il problema riguarda, viene
suggerito della ricerche di sociologi ed antropologi, il tipo di aiuto che ricevono, il modo in cui
l’aiuto viene offerto e il ruolo che i richiedenti asilo sono costretti ad assumere per riceverlo. Barbara Harrell-Bond (2005, p. 22) cita un episodio significativo, che ricorda molte situazioni raccolte
nell'ambito delle ricerche etnografiche svolte in Italia e all'estero presso le strutture di accoglienza
per rifugiati e richiedenti asilo (campi e progetti territoriali):
“Un rifugiato palestinese, che oggi ha quarantasei anni ed è padre di cinque figli, ricorda ancora
una sua esperienza che risale a quando aveva sette anni. In occasione di una cerimonia di premiazione la preside aveva detto: “e infine un premio speciale per Ahmed, i cui vestiti, benché vecchi e
strappati, sono sempre puliti”. Ahmed dovette camminare di fronte ai suoi quaranta compagni per
andare a ricevere il certificato. <<Dopo avermi raccontato questa storia, Ahmed mi disse che questo era stato il momento più drammatico della sua vita. Di fronte a questo episodio, il fatto che
Ahmed abbia vissuto non solo la perdita del proprio paese, ma anche trent’anni di occupazione israeliana sembrano fatti irrilevanti. Era determinato a fare in modo che i suoi figli non subissero lo
stesso genere di umiliazione (Louise Weighill, comunicazione personale)>>”.
Il confine tra quanto spetta di diritto al richiedente asilo e quanto è concesso caritatevolmente appare a volte sfumato. Come ha mostrato Marcel Mauss in quello che è ormai un classico della letteratura delle scienze sociali (1925), l’atto di donare non è un qualcosa di semplicemente meccanico:
il dono definisce le relazioni di status e di potere che esistono tra il donatore e colui che riceve il
dono stesso. L’importante intuizione antropologica di Mauss era che i piccoli o grandi atti di generosità raramente sono scevri da interessi personali, a prescindere dal fatto che il dono venga offerto
da uno Stato o da un individuo. Fare un regalo richiede reciprocità, sia in termini materiali che simbolici (ad esempio, una ricompensa spirituale). L’atto di ricevere colloca colui che riceve in una posizione di obbligo, in una posizione di inferiorità rispetto al benefattore, almeno fino a quando il
dono non viene contraccambiato.
Venendo all'esperienza di essere rifugiati in Europa, la ricerca sociale mostra come ciò che viene
richiesto in cambio dagli Stati che accolgono i richiedenti asilo non sia qualcosa di materiale, quanto piuttosto che essi imparino – o meglio interiorizzino - le regole del paese di accoglienza. Come
sottolinea Aihwa Ong nel suo fondamentale lavoro sui rifugiati cambogiani in California (2005,
p.86):
15
7
Vedi: http://www.serviziocentrale.it/
“[...] tanto nella politica quanto nelle pratiche dei professioni assistenziali – medici, operatori sociali, agenti di polizia, avvocati – c'è notevole continuità nel depurare i nuovi arrivati da quegli aspetti della loro cultura originaria che sono considerati arretrati o immorali, nel governare il loro
comportamento di tutti i giorni e nel renderli soggetti individualmente responsabili in una società
di mercato neoliberale. In clinica, negli uffici del welfare, in famiglia, alla stazione di polizia, in
tribunale, i nuovi immigrati cambogiani interagivano con una vasta gamma di professionisti che
erogavano i loro servizi, facendo loro da mediatori nella varie situazioni e fornendo resoconti autorizzati (“verità”) sull'identità dei loro utenti, sui loro problemi, su ciò che dovevano fare, sul modo di comportarsi per avere successo in America”.
E ancora (pp.95-96):
“La diagnosi di Post- Traumatic Stress Disorder – o, come suo surrogato, la depressione, venne
usata in modo abituale e molto vago per riferirsi a qualsiasi cambogiano che sembrasse turbato
per qualcosa, tanto che, dal punto di vista medico, il solo essere cambogiano finì per significare essere depressi. [...] Per molti rifugiati l'essere depressi o l'ottenere un certificato di malattia divenne
a volte l'unico modo per avere un minimo di assistenza sanitaria e per poter fruire dei benefici del
welfare. L'industria dell'assistenza ai rifugiati si intrecciò così con la burocrazia del welfare e i rifugiati-pazienti finirono per capire che i servizi per i rifugiati e i paletti impliciti nelle etichette mediche utilizzate a scopi sanitari non erano che un aspetto particolare di una più ampia regolamentazione della loro vita quotidiana e del loro accesso ad una molteplicità di risorse”.
Al momento dell'arrivo i rifugiati adulti ricevevano un guida che costituiva una specie di vademecum della competenze sociali necessarie per orientarsi nella società americana. Il libretto era disponibile in trenta lingue e dopo essersi soffermato sullo status giuridico dei rifugiati si dilungava sulle
norme igieniche e di sicurezza da seguire in pubblico e privato, con una particolare attenzione ai
modi con cui gli americani praticavano un vita sana:
“Gli americani sono moto sensibili agli odori emessi dai corpi degli individui. E' per questa ragione che è bene farsi quotidianamente il bagno o la doccia , mettersi ogni giorno indumenti puliti e
lavarsi spesso capelli e vestiti […]. Il dentista ci ricorda che dobbiamo lavarci i denti almeno due
volte al giorno […]. Gli americani usano vari prodotti per nascondere gli odori naturali del corpo.
La maggior parte di noi usa deodoranti o colluttori. Le persone fanno tutto questo per evitare odori
spiacevoli del corpo che possano offendere gli altri16”.
La guida continua con un misto di norme igienico-sanitarie e di consigli paternalistici difficile da
sbrogilare. Nella mediazione tra differenti esigenze materiali, culturali e simboliche della società di
accoglienza da un lato e dei rifugiati dall'altro, il confine tra il dialogo, la dialettica e l'imposizione di modelli categoriali e valoriali risulta essere molto sottile, ed il campo sanitario non è esente
da queste dinamiche. Sempre Aihwa Ong scrive (p.112 e 116):
“Il centro di salute mentale asiatica, malgrado l'enfasi posta sull'importanza di venire incontro alla
cultura dei rifugiati, funzionava comunque secondo modalità rigorosamente regolare dalla psichiatria. Era un approccio che consisteva nel far emergere tutti i tratti culturali al fine di invalidarli o
eliminarli, in modo tale che l'autodisciplina potesse poi iniziare a prestare il proprio soccorso alle
menti dei rifugiati rese caotiche dalla guerra e dallo spaesamento. Da alcuni miei colloqui con un
operatore sanitario e con alcuni pazienti emerge che una delle tecniche chiave era quella di differenziare i ricordi appropriati, che cioè si adattavano bene alle categorie diagnostiche, da quelli i16
Fact od Life in the United States: information for Refugees who Come to the United States, Lutheran Immigration and Refugee Services, Migration and Refugee Services/U.S. Catholic Services, Oakland (Ca.), 1987, p.18.
8
nappropriati cui bisognava resistere. Era questo il cuore del metodo terapeutico, basato sulla diagnosi del DSM (il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali): un dolore troppo prolungato era considerato una forma di lutto complicato che non rientrava nella varie fasi di normalizzazione di un lutto appropriato. […] I pazienti di Eam, tuttavia, non accettavano di perdere i propri
ricordi, e assumevano farmaci loro prescritti solo nella misura in cui ritenevano che giovassero ai
loro mali quotidiani, senza lasciare che il loro dolore venisse disciplinato. Come in molte altre culture, piangere i morti veniva considerato parte della vita, anzi poteva diventare un processo che
durava tutta la vita quando si trattava di trovare la ragione della morte di persona amate. Lo stesso
Freud era contro al trasformazione del lutto in patologia”.
Mi sono soffermato sul lavoro di Aihwa Ong perché è unanimemente considerato nella comunità
scientifica un riferimento imprescindibile della riflessione sulla produttività sociale della pratiche
mediche:
“Gli incontri quotidiani tra rifugiati e operatori sanitari costituivano vere e proprie lezioni su quali
nuovi 'regimi del corpo' fossero importanti per coltivare tutta una serie di comportamenti: per esempio imparare la routine dei check-up, delle vaccinazioni, della pianificazione familiare e dei
trattamenti farmacologici, cioè la strutturazione temporale della vita cui i rifugiati erano stati assoggettati per la prima volta all'interno dei campi di transito. I regimi medici non si limitavano così
ad adeguare le persone alle norme cui si aspettava dovesse conformarsi il comportamento di un
paziente, ma insegnavano ai pazienti anche le regole e i diritti che vanno a costruire un adeguato
soggetto biomedico e giuridico” (p.118).
La Ong parla di meccanismi terapeutocratici che, nella presa in carico della sofferenza fisica e psichica di rifugiati e richiedenti asilo, rischiano di spogliare della dimensione politica la loro vicenda
biografica, reificando in categorie medico-psichiatriche, come il Post-Traumatic Stress Disorder
(PTSD), la complessità storica della sofferenza di queste persone. L'antropologa americana conclude con un passaggio molto importante (p.133-134):
“[…] riluttanza a mostrarsi in disaccordo con gli americani, verso i quali i cambogiani si sentivano comunque riconoscenti e che, in definitiva, continuavano a fornire loro tutto ciò di cui avevano
bisogno, dalle pillole alle entrate necessarie per la sopravvivenza. Il luogo della resistenza era invece nel loro corpo, nel rifiuto e nella sovversione della disciplina medica [...]. Cambogiani di ogni
età si recavano continuamente da medici per ottenere farmaci e un certificato medico che desse loro accesso a forme di sostegno aggiuntive. In certi casi, nel corso delle visite mediche, i cambogiani – temendo una vita di strada – si fingevano pazzi, creando cioè corpi e menti malfunzionanti che
riproducevano in realtà la loro mancanza di una adeguato sostegno sociale […]. L'essere malati
divenne una condizione indotta più dal sistema sanitario che da cause riconducibili al modello
biomedico […]. Sottomettendosi al luogo comune dei “cambogiani depressi, i rifugiati svilupparono malattie che accrescevano le loro possibilità di accedere all'assistenza sanitaria e a forme di sostegno sociale”.
INCORPORAZIONE E RICONOSCIMENTO
In questa prospettiva, riprendendo la distinzione sviluppata dalla fenomenologia tra lieb e köerper
(Husserl 1931)17, il corpo può essere visto non come una mera sommatoria di organi, ma come un
17 Köerper è il nome che Husserl utilizza per designare il “corpo-oggetto” o “corporappresentazione”: il corpo in
quanto occupa un certo spazio e risponde quindi a certe misure, il corpo in quanto res extensa, insomma, ridotta
alla mera misurazione di certe quantità (peso, larghezza, lunghezza, etc.). E’ chiaro come una simile definizione del
corpo vale per qualsiasi corpo, ossia per un corpo qualsiasi: tanto per i corpi umani quanto per quelli degli altri
esseri viventi e persino delle cose. Ma proprio perché quella definizione vale per qualsiasi corpo, essa non risponde
9
corpo senziente, dotato di una intenzionalità. Una volta che il corpo viene problematizzato in temini
fenomenologico-culturali, emerge la possibilità di pensare la salute e la malattia indipendentemente
dai presupposti delle biomedicina. Se per la scuola antropologia di Harvard (Kleinman 1995, 2005)
la cultura plasma la malattia (disease) dando forma alle concezioni (illness) attraverso cui essa viene interpretata, Margaret Lock e Nancy Scheper-Huger (1990), non a caso due donne, mettono in
luce come il corpo stesso sia già culturalmente informato e dunque i suoi stati d'essere non aspettino
di essere mediati da categorie cognitive per assumete significati culturalmente variabili: le esperienze somatiche rappresentano già veri e propri discorsi sociali. In quest'ottica la malattia emerge
come una particolare tecnica del corpo, come linguaggio che richiede un'interpretazione capace
di dipanare il fitto intrico di esperienze personali, processi culturali e forze sociopolitiche che vengono vissute nell'immediatezza dell'esperienza. In questo senso va inteso il loro saggio del 1990: the
mindful body, il corpo cosciente, consapevole, che attivamente si relaziona al mondo sociale. Esso
cessa di essere mera entità passiva radicata nel mondo inerte della materia organica e interessata di
processi culturali solo in quanto oggetto della loro azione plasmatrice, per emergere invece come
soggetto dei processi culturali, produttore di significati: l'esperienza corporea emerge come modalità di posizionamento dei soggetti nel mondo sociale e la malattia come momento di resistenza
all'ordine costituito.
L'essere ammalati si configura dunque come un idioma socialmente legittimato per esprimete il
proprio disagio, parallelamente al venir meno di altri canali condivisibili per mettere in scena la
propria indignazione nei confronti dell'ordine sociale. Emblematico in questo senso è il caso dell'isteria a cavallo tra XIX e XX secolo in Europa (Freud 1895): all'epoca, l'esclusione sociale della
donna era giustificata dall'assunto, tutto culturale, che la sua unica funzione fosse quella procreativa. In questa cornice si riteneva che il disagio femminile fosse riconducibile al malfunzionamento
dell'apparato riproduttivo, che veniva rimosso a scopo terapeutico. Tuttavia è significativo che le
donne esprimessero il proprio disagio nei confronti di tale ordine sociale proprio attraverso il disordinato movimento dell'utero, ovvero attraverso forme simboliche incorporate relativamente alla
propria natura ed al proprio ruolo nella società. Possiamo allora comprendere come la sofferenza
fosse, da un lato, effetto dell'oppressione di quel mondo sociale, e dall'altro rappresentasse una protesta incarnata contro di esso: il corpo che soffre, allora, diviene metafora del disagiato rapporto fra
sé e società, mettendo il luce l'intreccio profondo tra esperienza personale, simbologie sociali e processi politici.
La malattia è allora qualcosa che gli esseri umano fanno: non solo attraverso la categorie con cui
interpretano il disagio (illness), non solo attraverso le forze sociali che producono specifici regimi
discorsivi che fondano regimi di verità (sickness), ma anche attraverso i loro corpi, attraverso la loro esperienza incorporata18.
Come abbiamo visto per il caso dei rifugiati cambogiani in Califorina e come vedremo tra breve per
i richiedenti asili in Europa ed in Italia condizioni cliniche come depressione, disturbi psicosomatici e disturbo post-traumatico da stress rimandano a dimensioni ben più ampie rispetto a quella della sindrome medico-psichiatrica, configurandosi come posizionamento, come strategia agita
da un corpo-mente consapevole (the mindful body) nell'interazione con il contesto sociale in cui è
inserito.
18
10
alla peculiarità dell’esperienza del corpo che sono e per cui sono al mondo gli essere umani. E’ il corpo vissuto
secondo questa esperienza che Husserl chiama Leib, un corpo dotato in intenzionalità. La riflessione della
fenomenologia cerca in questo modo di superare il cosiddetto dualismo cartesiano tra mente e corpo che
caratterizza la filosofia occidentale moderna e che ha così fortemente influenzato la rappresentazione che le scienze
mediche danno dell'essere umano.
Per una trattazione approfondita del classica triade disease, illness, sickness indagata dall'antropologia medica si
rimanda a: QUARANTA I, 2005, Antropologia Medica. I testi fondamentali, R. Cortina Editore, Milano. Per quanto
riguarda il concetto antropologico di incorporazione si rimanda a CSORDAS T. J., 2003, “Incorporazione e
fenomenologia culturale”, Annuario Antropologia. Corpi, n.3, Meltemi Edizioni, Roma.
UNA STORIA CREDIBILE:
POLITICHE DELLA MEMORIA TRA VERITA' E MENZOGNA
Il richiedente asilo per vedere accolta la propria domanda deve presentarsi presso le Commissioni
Territoriali predisposte dal Ministero degli Interni, organismi deputatati a valutare la rispondenza
della storia riferita come motivo della fuga dal paese d'origine con i criteri previsti dalla normativa
per la concessione della protezione internazionale19. Secondo l’art. 1 della Convenzione di Ginevra
il rifugiato è colui che “avendo un fondato timore di persecuzione per motivo do razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori
dal Paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione
di tale Paese20”.
Quello che dovrebbe essere un processo amministrativo è però diventato un'arena in cui si incontrano e scontrano interessi e aspettative contrapposti. Da un lato, come dicevamo, gli Stati pongono
una grande attenzione nell'individuare eventuali persone che, pur senza averne diritto, fanno domanda di asilo. I metodi di conduzione del colloquio in Commissione Territoriale sono spesso dei
tipo indiziario e cercano di mettere sotto pressione il richiedente per testare la veridicità e la coerenza della sua storia. Del resto però, come segnalano gli psicologi che si occupano specificamente di tortura, può far parte delle conseguenze di esperienze di violenza estrema il non avere un ricordi perfettamente coerenti e temporalmente orientati di quanto è accaduto (Sironi 1999). In questo
modo le Commissioni Territoriali corrono il rischio di bollare come incoerenti i racconti e le ricostruzioni di richiedenti asilo che, proprio in virtù delle esperienze di tortura subite, richiedono la
protezione internazionale.
Operatori sociali dei progetti SPRAR ed avvocati sono dunque attivi nel co-costruire con i richiedenti asilo stessi le storie da presentare alla Commissione Territoriale in modo che esse rispettino i
criteri di stretta coerenza interna e di verificabilità documentale apprezzati dei funzionari ministeriali. In questo modo però, come rilevano i lavori etnografici delle scienze sociali (Sorgoni 2011, Taliani 2011, Manocchi 2012), viene dato rilevo solo a particolare aspetti dell'esperienza del richiedenti asilo che rischiano di schiacciarne l'immagine dentro un ruolo di vittima. Se ciò, da un lato,
può essere utile per l'ottenimento dello status di protezione internazionale, dall'altro – favorendo un
certo tipo di memoria dell'esperienza passata - può in alcuni casi concorrere ad imprigionare il rifugiato dentro ad una rappresentazione di sé come vittima, non senza conseguenze sull'equilibrio psichico.
La costruzione della “biografia coerente e funzionale” dei richiedenti asilo è dunque prodotta attraverso l’interazione tra differenti attori e la sovrapposizione di molteplici narrazioni. La costruzione
di un racconto, di una memoria e di un’identità socialmente conveniente e moralmente merite19
20
11
Esistono due forme di Protezione Internazionale: l'asilo e protezione sussidiaria. Il titolare di permesso di
soggiorno per asilo è il rifugiato, cioè colui che " […] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori
del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di
questo Paese(...)". Questa definizione viene enunciata dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita
nell'ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954. La protezione sussidiaria è un'ulteriore forma di protezione
internazionale: chi ne è titolare - pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave.
Questa definizione viene enunciata dall'art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007. Nel caso, infine, in cui la
Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere
gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore
competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del
decreto legislativo n. 286/1998).
Si rimanda a pubblicazione specifiche per approfondire la legislazione che riguarda richiedenti asilo e rifugiati e la
sua invero non omogenea applicazione da parte dei paesi che hanno sottoscritto la Convenzone di di Ginevra del
1951, la Convenzione di Addis Abeba del 1969 e la dichiarazione di Cartagena del 1984.
vole emergono infatti come processi centrali attraverso cui cercare di accedere ad un possibile riconoscimento nel paese di approdo.
La storia narrata e rielaborata nei rapporti con gli attori istituzionali, non è però l’unico elemento su
cui si basa l’analisi governativa della legittimità della richiesta. Al contrario, in un contesto segnato da un sospetto sempre più marcato nei confronti di questa categoria sociale, le parole dei richiedenti sembrano perdere importanza, per lasciare posto a una ricerca di evidenza sempre più orientata a riconoscere ferite, patologie e traumi come vero fondamento di una presenza legittima. In
questo ampio scenario si inserisce il valore sempre più rilevante della medicalizzazione della sofferenza di rifugiati e richiedenti asilo, e dunque della diagnosi e della certificazione medica nella
procedura di valutazione delle domande. Il linguaggio medico viene interpellato per sostituirsi alle
parole del richiedente e conferire autorevolezza ad un racconto e ad un corpo, scandagliato e messo
sotto scrutinio. Come ha evidenziato Didier Fassin (2001a; 2001b; 2006; 2011b), le società contemporanee appaiono più pronte a riconoscere e concedere diritti agli individui in quanto esistenza biologica e organica, piuttosto che come esistenza sociale significativa. Il corpo sofferente, a livello
fisico o psichico, emerge così come l’ultima possibile risorsa nella relazione con lo Stato, la verità
inscritta su di esso un possibile strumento di riconoscimento sociale (Fassin, D’Halluin, 2005). Le
certificazioni della presenza segni permanenti di tortura da parte di medici legali e quelle di psicologi e psichiatri che attestano la presenza di sindromi post-traumatiche sono, infatti, elementi spesso
determinanti nell'esito delle Commissioni Territoriali per la concessione o meno della protezione
internazionale.
L'iter di riconoscimento della richiesta di asilo, insomma, sembra collocarsi all'interno delle dinamiche più generali di medicalizzazione della vita (Illich 2004, AA.VV. 2008). Il “linguaggio” medico tende a sostituirsi alle parole del richiedente, conferendo autorevolezza alla sua storia e ad un
corpo, scandagliato e messo sotto scrutinio nell'iter per la domanda di asilo. Didier Fassin e Richard
Rechtman (2009) sottolineano come il sapersi adeguare all'immaginario socialmente condiviso della
condizione di vittima, anche tramite il collocamento all'intendo di etichette diagnostiche come il Disturbo Post-traumatico da Stress, costituisca un passaggio imprescindibile del procedimento di richiesta di asilo.
L'AMBIGUITA' del TRAUMA
La condizione di vittima risulta oggi strettamente connessa alla crescente affermazione, nella letteratura scientifica e nelle pratiche di accoglienza, della nozione di trauma. Una particolare categoria
medica, il Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), il suo sempre più frequente utilizzo e la presa in
carico che di esso fanno i servizi socio-sanitari, fornice una cornice predeterminata dentro la quale il
richiedente asilo può declinare la propria sofferenza. La categoria di PTSD concorre ad orientare il
focus della nostra attenzione solo sugli eventi traumatici passati, su alcuni gruppi di persone, sui
profili individuali della sofferenza: “in questo senso una particolare politica del trauma converge
verso una precisa politica della memoria” (Beneduce 2007, p.310). In questo modo la dimensione
politica della sofferenza del richiedente asilo e del rifugiato, spesso legata alle difficoltà sociali ed
alle arbitrarietà dei percorsi istituzionali sperimentate nel contesto di accoglienza, rischia di essere
significativamente occultata. Didier Fassin (2007) ci segnala il lento e costante slittamento che è
possibile osservare, nell'ambito della letteratura scientifica, biomedica e psicotraumatologica, da resistenza a resilienza. E più in particolare da resistenza politica (molti rifugiati erano attivisti politici
nei propri paesi d'origine), a resistenza fisica e, infine, a resilienza, cioè capacità di adattamento ad
eventi stressanti e traumatici da ascriversi a caratteristiche individuali in una certa parte biologicamente determinate. Il politico ed il sociale – dunque – vengono sempre più spinti dentro al biologico. La letteratura antropologica ha evidenziato l'ambiguità di questo movimento, riflettendo sulla
necessità di “considerare le matrici sociali e storiche della sofferenza, della memoria e del lutto,
senza ricondurre il dolore di queste donne e di questi uomini ad un principio già scritto ed indiffe12
rente ai vincoli della Storia (Beneduce 2010, p. 3)”. La nozione di trauma, travalicando l'ambito
esclusivamente psichiatrico, si inscrive nel senso comune e nello spazio morale collettivo, conferendo una attestazione socialmente riconosciuta alla sofferenza individuale. Questa traduzione degli effetti della violenza politica e dell'ingiustizia sociale in una nozione psicopatologica è densa
però di importanti conseguenze: essa elude e sfuma la diversità delle esperienze che è chiamata a
nominare, finendo col rendere pressoché invisibili le cause della sofferenza e le disuguaglianze che
la sottendono (Fassin e Rechtman, 2007; Beneduce, 2010).
TRAUMA e POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER
In psicopatologia fin dai tempi di Janet e Freud si faceva riferimento al trauma come causa di diversi quadri psicopatologici. Sotto questa influenza le teorie successive distingueranno le patologie
“reattive” da quelle “endogene”, che risulterebbero invece connesse ad alterazioni congenite, strutturali, innate, indipendenti dai fattori esterni. L'evoluzione del concetto di “trauma” e la riflessione
sul rapporto tra psichismo e Storia rappresentano uno degli argomenti più affascinanti delle discipline psicologico-psichiatriche.
La categoria diagnostica odierna di Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) venne introdotta nel
1980, nella terza edizione del manuale statistico-diagnostico della psichiatria americana21. Vennero
in essa classificati diversi tra i disturbi presenti in molti soldati di ritorno dalla guerra in Vietnam,
numerosi dei quali rappresentavano per la società americana un doloroso ricordo di un evento controverso ed umiliante. Il quadro sintomatologico definito dalla categoria del PTSD è caratterizzato
prevalentemente da intrusioni diurne e notturne, aventi per oggetto il ricordo dell'evento traumatico,
con associate reazioni emotive e fisiche, disturbi della concentrazione, del sonno e della memoria.
Non di rado si accompagnano una deflessione del tono dell'umore, sospettosità, irritabilità, episodi
dissociativi, condotte di evitamento, ideazione suicidaria, abuso di sostanze e sintomi somatoformi.
Alcune delle contraddizioni nella narrazione della propria storia traumatica, che possono mettere in
difficoltà ed essere mal interpretate dagli operatori socio-sanitari, così come dai membri delle
Commissioni Territoriali preposte alla valutazione delle domande di protezione internazionale,
sembrano connesse alla peculiare situazione cognitiva (deficit del l’attenzione e della memoria) che
si può ritrovare in persone, per esempio, vittime tortura. Può anche accadere che le stesse vittime
possano dubitare della loro memoria a causa della indicibilità delle violenze subite:
“Oggi, questo vero oggi in cui sto seduto a un tavolo e scrivo, io stesso non sono convinto che queste cose siano realmente accadute (Levi, 1947, p.106)”.
E' fondamentale notare che per una significativa parte dei soldati che ricevettero questa diagnosi
l'evento traumatico non era rappresentato da una violenza subita, ma al contrario da un atto perpetrato nei confronti di nemici e di civili, spesso inermi, nel contesto della guerriglia in Vietnam. Un
primo elemento di forte problematicità è dunque questo: mettendo sullo stesso piano torturatori e
vittime, si rischia di annullare o, quantomeno, depotenziare, la dimensione morale della violenza
stessa. A questo proposito è utile ricordare le parole di Primo Levi (1986, p.14), riferite a tutt'altro
contesto, quello dei campi di concentramento nazisti, ma valide anche per la riflessione contemporanea della psicotraumatologia:
“Qui come in altri fenomeni ci troviamo davanti ad una paradossale analogia tra vittima ed oppressore, e ci preme essere chiari: i due sono nella stessa trappola, ma è l'oppressore, e solo lui,
che l'ha approntata e che l'ha fatta scattare, e se ne soffre è giusto che ne soffra; ed è iniquo che ne
soffra la vittima, che invece ne soffre anche a distanza di decenni”.
21
13
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition (DSM-III), 1980, published by the
American Psychiatric Association.
In secondo luogo nella codificazione della fenomenologia della sofferenza da ascrivere ad eventi
traumatici, nella scelta di alcuni criteri diagnostici piuttosto che altri, si corre il rischio, come segnala Judit Butler (2005), di ricalcarla sulle forme, gli impliciti e le premesse epistemologiche valide
per i soli wasp (white anglo-saxson protestant), camuffando con le vesti dell'universalismo un ben
preciso posizionamento storico e culturale. In terzo luogo, come ricorda Didier Fassin quando afferma che la certificazione dello psicologo conta di più della verità della Storia, la diagnosi assume
un ruolo predominante rispetto alla traiettorie biografiche. Più della violenza collettiva, la sofferenza individuale rappresenta un motivo valido per riconoscere le ragioni di una permanenza
forzata lontano dalla propria terra.
LA CENTRALITA' DEL CORPO DOLENTE
L'analisi della vita dei richiedenti asilo e dei rifugiati ci riporta dunque alle riflessioni da cui eravamo partiti. Il corpo dolente, il sintomo indocile, la sindrome che non guarisce rappresentano condizioni complesse: non sono solo risultato di processi biologici, ma, allargando lo sguardo, si rivelano
essere entità fluide, determinate da un più largo contesto bio-psico-sociale, che esse stesse per certi
versi contribuiscono a plasmare.
E' a questo punto importante sottolineare come le considerazioni dell'antropologia medica sulle determinanti sociali della malattia, della fenomenologia sul corpo come attore sociale che produce realtà e quella che ho chiamato “patogenesi sociale” non siano discorsi semplicemente metaforici. Esistono discipline scientifiche come la psico-neuro-endocrino-immunologia (Bottacccioli 2005) che
indagano da tempo le relazioni fra il funzionamento del sistema nervoso, del sistema immunitario e
del sistema endocrino e che forniscono una base organica alle conclusioni delle scienze sociali di
qui abbiamo fino qui parlato. Dire che esiste una intenzionalità in un corpo che non guarisce da una
malattia professionale (e che questo porterà un qualche vantaggio in ternino sociali ed ecomomici),
che una precisa configurazione della memoria in un soggetto che a subito un'esperienza di tortura ed
ora si trova di fronte alla possibilità che tale vissuto concorra all'ottenimento dello status giuridico
di rifugiato, significa riconoscere che esiste qualcosa di più complesso del causalismo determinista che rappresenta a tutt'oggi il paradigma centrale della biomedicina.
RIPOSIZIONAMENTI
Nei rifugiati e richiedenti asilo afferma Katie Caruth (1995) “è la Storia a presentarsi come sintomo”. La storia di un passato di guerra e di violenza, la storia di un presente di difficoltà materiali,
precarietà sociale, ambiguità nei rapporti con le istituzioni e gli operatori dei paesi di accoglienza.
Queste persone portano in occidente racconti, storie e memorie di violenze che, ad un approfondimento storico attento (Fanon 1956, 1962), mostrano stretti legami con un passato coloniale di dominio e depredazione che le società europee tendono oggi a rimuovere. Le ripercussioni di tutto ciò
nella clinica interroga gli operatori sanitari che si trovano ad avere in cura pazienti rifugiati. Roberto
Beneduce in questo senso scrive:
“Il territorio dentro il quale situare le nostre domande comprende dunque anche il modo con il
quale le società ricordano e dimenticano, e la maniera con cui trattano o ignorano quei singolari
testimoni del passato che sono i sintomi. Il trauma in fondo non è che una domanda sul difficile
rapporto tra oblio e memoria: ma è una domanda sociale, non solo individuale” (2010, p. 109).
Farsi carico del complesse situazioni sociali, psicologiche e cliniche che si determinano nell'interazione tra chi fugge da paesi in conflitto e gli stati di accoglienza rappresenta una grande sfida per i
servizi sanitari e gli operatori che in essi lavorano.
14
“Nei laboratori dell’etnopsichiatria ci si deve far carico anche dell’ingannevole e del fittizio. Queste biografie sono – volenti o nolenti – costellate, impregnate, di mezze verità, di verità non-dette o
non-dicibili. Raccogliere storie in modo completo e senza censure obbliga, dunque, il terapeuta a
garantire le condizioni perché l’inganno sia mantenuto fino a quando il paziente non si sente ‘al sicuro’ per poter dire la ‘verità’, qualunque cosa questo termine voglia significare nella clinica (Taliani, 2010, p.92)”.
I luoghi della cura sono attraversati da una strutturale ambivalenza (Pizza, Johannessen,
2009): da una lato, come abbiamo visto, partecipano a processi più generali di medicalizzazione
della vita, i quali, per certi versi, concorrono a occultare le determinanti sociali e politiche della sofferenza e della malattia, dall'altro lato rappresentano possibili spazi di speranza, luoghi dove può
avvenire la comprensione22 della malattia come richiesta di riconoscimento e del sintomo come
forma di soggettivazione agita da individui per i quali è chiuso ogni altro canale per esprimere la
propria sofferenza sociale.
In conclusione possiamo tornare all'ipotesi con cui si aprivano queste pagine: la funzione specchio
del fenomeno migratorio. Non è forse vero che alcune delle considerazioni qui trattate nel parlare
della vita e della cura di richiedenti asilo e rifugiati possono in verità riguardare ogni persona? Non
è forse valido anche per i cittadini italiani il processo di medicalizzazione della vita che sembra
oggi sempre più risucchiare aspetti relazionali e sociali della sofferenza dentro chiavi di lettura biologiche, quando non addirittura generiche? E una lettura fenomenologica ed antropologica del corpo
come attore attivo di processi intenzionali non può essere d'aiuto nella lettura di condizioni cliniche
complesse come i disturbi psico-somatici, forme depressive, piuttosto che quelle malattie professionali che non guariscono e che a volte, forse un po' troppo frettolosamente, vengono bollate che
“forme di simulazione”?
Ecco dunque che lo sforzo che i servizi sanitari ed i professionisti in essi attivi devono affrontare
per farsi carico del paziente straniero, migrante, rifugiato, invece che un problema, può rappresentare una straordinaria opportunità: quella cioè di essere un'occasione irripetibile per riflettere sui propri presupposti epistemologici (la scissione mente-corpo, il causalismo determinista
ecc), sugli impliciti che fondano l'attività dalla medicina (la preponderanza della dimensione biologica, su quella psicologica, sociale e politica), che spesso restano in ombra.
Solo attraverso un costante ripensamento di se stesso il mondo della cura può far pendere l'ago della
bilancia delle sue pratiche dalla parte del riconoscimento della sofferenza, piuttosto che verso il suo
occultamento. Come già scriveva Friedrich Nietzsche (1885, p.86):
“Medico aiuta te stesso: così aiuterai anche i tuoi malati. Questo sia il suo aiuto migliore: che egli
guardi con gli occhi colui che risana se stesso.”
22
15
Uno qui “comprendere” in alternativa a “spiegare” nell'accezione che ne propone Karl Jasper (1913): “Ad evitare
ambiguità e oscurità impiegheremo sempre l’espressione comprendere per la visione intuitiva dello spirito, dal di
dentro. Non chiameremo mai comprendere, ma spiegare il conoscere i nessi causali oggettivi che sono sempre visti
dal di fuori. […] E’ dunque possibile spiegare qualcosa senza comprenderlo”.
BIBLIOGAFIA
AA.VV., 2008, La medicalizzazione della vita, Aut Aut, n. 340, Il Saggiatore, Milano.
AGAMBEN Giorgio, 1995, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino.
AGER A., 1993, Mental health issues in refugee populations: a review, Project on International
Mental and Behavioral Health, Harvard Medical School, Department of Social Medicine.
AGIER M., 2005, Ordine e disordini dell’umanitario. Dalla vittima al soggetto politico, in Van Aken.
M., (a cura di), Rifugiati. Annuario di Antropologia. Rifugiati, n. 5, Meltemi, Roma.
APPADURAI A., 1996, Modernity at large. Cultural Dimesions of Globalization, University of
Minnesota Press, Minneapolis.
BENEDUCE R., 2010, Archeologie del Trauma. Un'antropologia del sottosuolo, Laterza, Bari.
BOTTACCIOLI F., 2005, Psiconeuroendocrinoimmunologia. I fondamenti scientifici delle relazioni
mente-corpo. Le basi razionali della medicina integrata, Red Edizioni, Milano.
BUTLER J., 2005, La vita psichica del potere, Meltemi, Roma.
CARUTH K., 1995, Introduction, in Trauma. Explorations in Memory, John Hopkins University, Baltimore-London, pp. 3-13.
CONNOLY V. et al., 2000, “Diabetes prevalence and socioeconomic status: a population based
study showing increased prevalence of type 2 diabetes mellitus in deprived areas”, Journal of Epidemiology & Community Health, 54, pp. 173-177.
FANON F., 1996 (ed.or 1952), I dannati della terra, Tropea Editore, Milano.
FANON F., 1962 (ed.or 1961), I dannati della terra, Einaudi, Torino.
FARMER P., 2004, Antrhopology of Structural Violence, Current Antrhopolgy, 45, 3, pp. 305-325.
FASSIN D., 2001a, “The biopolitics of otherness. Undocumented foreigners and racial discrimination in French public debate”, Anthropology today, vol. 17, n. 1, pp. 3-7.
FASSIN D., 2001b, “Quand le corps fait loi. La raison humanitaire dans les procédures de
régularisation des étrangers”, Sciences Sociales et Santé, 19, 4: 5-32.
FASSIN D., 2006, “La bipolitique n'est pas une politique de la vie”, Sociologie et sociétés, 2; 35-48.
FASSIN D., 2011a, “Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration
in Dark Times”, Annual Review of Anthropology, 40; 213-26.
FASSIN D., 2011b, Humanitarian Reason. A Moral History of the Present, Berkeley, University of
California Press.
FASSIN D., D’HALLUIN E., 2005, “The Truth from the Body. Medical Certificates as Ultimate
Evidence of Asylum Seekers”, American Anthropologist, 107, 4; 507-608.
FASSIN D., RECHTMAN Richard., 2009 (ed. or. 2007), The empire of trauma. An inquiry into the
condition of victimhood, Princeton University Press, Princeton.
16
FREUD S., 2003 (ed. or. 1895), Opere (vol. 1), 1886-1895: Studi sull'isteria e altri scritti, Bollati Boringhieri, Torino.
HARREL-BOND B., 2005, “L’esperienza dei rifugiati in quanto beneficiari d’aiuto”, Annuario Antropologia. Corpi, n. 5.
HUSSERL E., 1970 (ed. or. 1931), Meditazioni cartesiane, Bompiani, Milano.
ILLICH Ivan, 2004 (ed. or. 1974), Nemesi Medica, Bruno Mondadori Editore, Milano.
JASPER K., 1964 (ed. or. 1913), Psicopatologia Generale, Il Pensieri Scientifico Editore, Roma.
KLEINMAN A., 2005 (ed. Or. 1978), “Alcuni concetti e un modello per la comparazione dei sistemi
medici intesi come sistemi culturali”, in Quaranta I. (a cura di), 2005, Antropologia Medica. I testi
fondamentali, R. Cortina Editore, Milano.
KLEINMAN A., 1995, Writing at the Margin, The University of California Press, Berkeley-Los
Angeles-London.
KRIEGER N., 2011, Epidemiology and The People’s Health: Theory and Context, Oxford University
Press, New York.
KRIEGER N, 2004, Embodying Inequality: Epidemiologic Perspectives, Baywood Publications, Inc,
Amityville, NY.
LEVI P, 1958 (ed. or. 1947), Se questo è un uomo, Einaudi, Torino.
LEVI P., 1986, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino.
LOCK M., SCHEPER-HUGHES N., 1990, “A critical-interpretative approach in madical anthropoloy: rituals and routines of discipline and dissident”. In Johnson, T. e Sargent, C. (a cura di), Medical anthropology, Contemporary Theroy and Method. Praegher Publishers, Westport.
MALKKI L., 1995, “ Refugees and exile: from “refugees studies” to the national order of things”,
Annual Review of Anthropology, 24; 495-523.
MALKKI L., 1995b, Purity and exile. Violence, Memory, and Nationale Cosmology among Hutu
Refugees in Tanzania, Chicago University Press, Chicago-London.
MALKKI L., 1996, “Speechless emissaries. Refugees, humanitarism and dehistoricization”, Cultural
Anthropology; 11, 4; 377-404.
MANOCCHI M., 2012, Richiedenti asilo e rifugiati politici. Percorsi di ricostruzione identitaria: il caso torinese. Franco Angeli, Milano.
MAUSS M., 2002 (ed. or. 1925), Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Einaudi, Torino.
NIETZSCHE F., 1968 (ed. or. 1885), Così parlo Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano.
ONG A., 2005 (ed. or. 2002), Da rifugiati a cittadini. Pratiche di governo nella nuova America, Raffaello Cortina Editore, Milano.
PIZZA G., JOHANNESSEN H., 2009, “Two or three things about Embodiment and the State”. AM.
Rivista della Società italiana di antropologia medica, n. 27-28, Argo Editrice, Lecce, pp. 13-20.
17
ROSSI I., 2003, “La malattia cronica come marchio del corpo”, Anniario Antropologia. Corpi, n.3,
Meltemi Edizioni, Roma, pp. 75-91.
SASSEN S., 1999, Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa,
Feltrinelli, Milano.
SAYAD A., 1981, “Santé et équilibre social chez les immigrés”, Psychologie Médicale, 11, pp.
1747-1775.
SAYAD A., 1996, “La doppia pena del migrante. Riflessioni sul pensiero di stato”, Aut Aut, 275.
SAYAD A., 2002 (ed. or. 1999), La doppia assenza. Dalle illusioni dell'immigrato alle sofferenze
dell'emigrato, Cortina, Milano.
SIRONI F., 2001 (ed. or. 1999), Persecutori e Vittime. Strategie di violenza, Feltrinelli, Milano.
SMITH B.E., 1987, Digging Our Own Graves: Coal Miners and the Struggle Over Black Lung Disease, Temple University Press, Philadelphia.
SORGONI B., 2011, Etnografia dell'accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna, CISU,
Roma.
SUMMERFIELD D., 1991, “The rise of post-traumatic stress disorders”, British Medical Journal, n.
303, p. 1271.
SUMMERFIELD D., 1997, “The legacy of war: beyond trauma to the social fabric”, Lancet, n. 349,
p. 1568.
SUMMERFIELD D., HUME F., 1993, “War and post-traumatic stress disorder: the question of social context”, Journal of Nervous and Mental Disease, n. 181, p. 522.
TALIANI S., 2010, “Etnografie della cura”, in Del Corno F., Rizzi P., La ricerca qualitativa in psicologia, Raffaello Cortina, Milano.
TALIANI S., 2011, “Il passato credibile e il corpo impodico. Storia, violenza e trauma nella biografie
di donne africane richiedenti asilo in Italia”, LARES, vol. LXXVII, n. 1, p. 135-158.
18