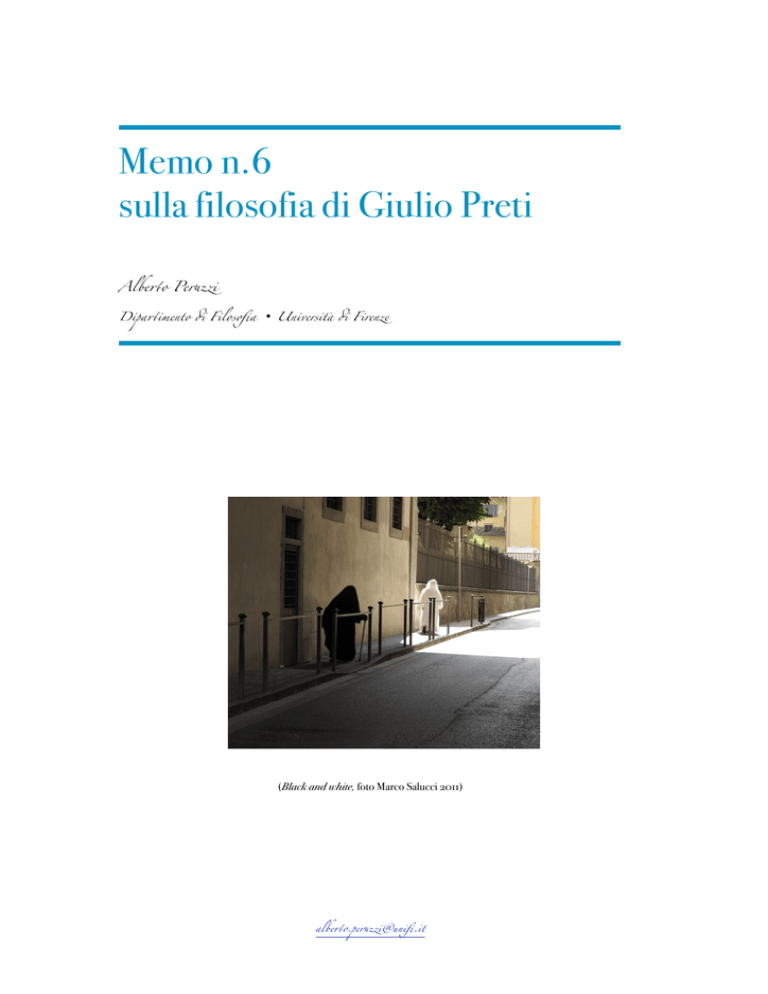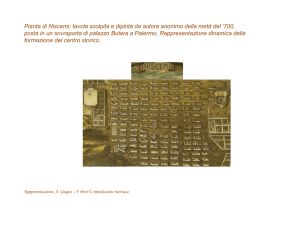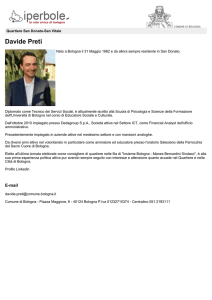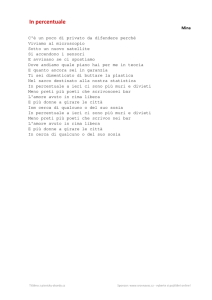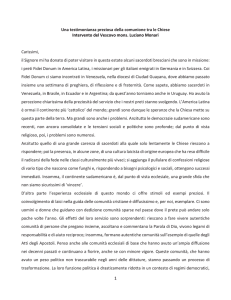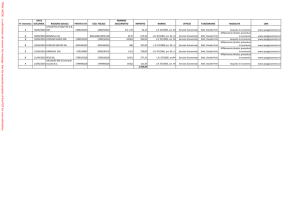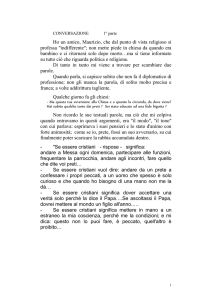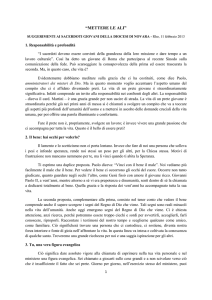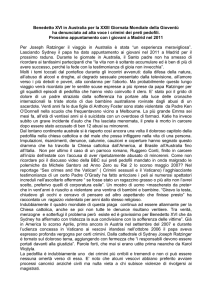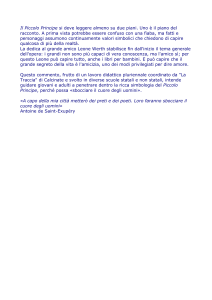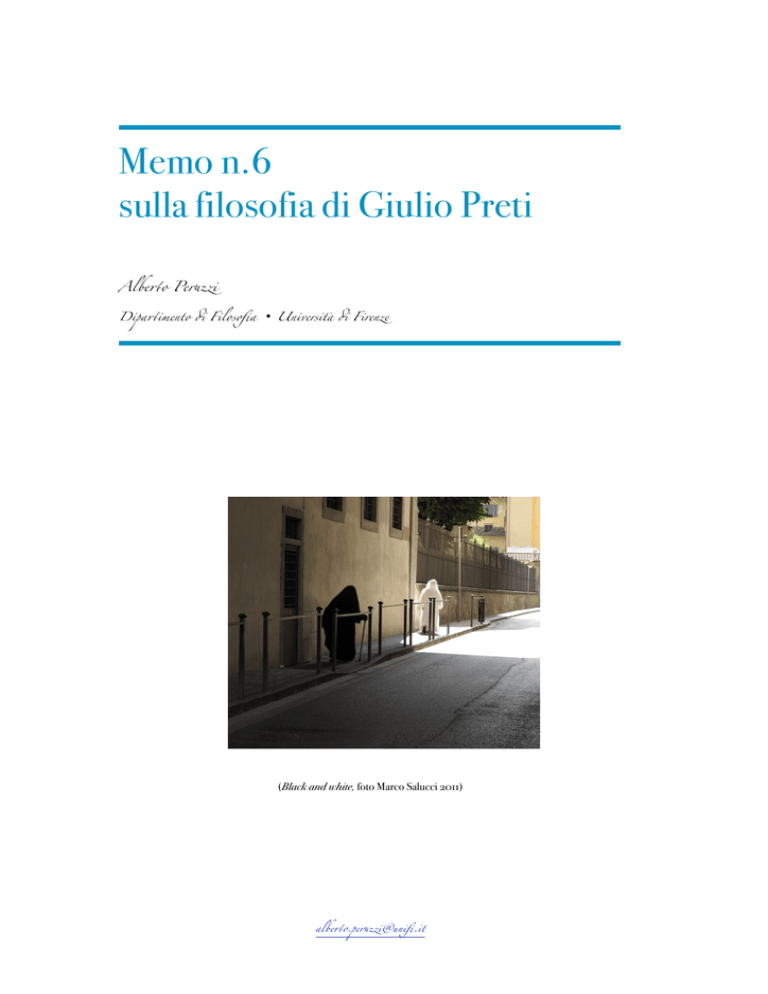
Memo n.6
sulla filosofia di Giulio Preti
Albe!o Per"zi
Dipa!imento # Filosofia • Università # Firenze
(Black and white, foto Marco Salucci 2011)
albe!o.per"[email protected]
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
2
Alberto Peruzzi – 2012
Come possiamo ampliare il Quarto Stato con un’immagine che rappresenti la weberiana Wertfreiheit del
sapere? E come fa un Viaggiatore sopra un mare di nebbia a pensarsi come L’ortolano di Arcimboldi?
Due domande stralunate che però immettono nel reale problemario di Preti. Seguendo il suo percorso
intellettuale, questo Memo n.6 ospita una serie di esercizi di metariflessione sui valori. Dico “esercizi” e
ormai intendo una specie di ginnastica concettuale che temo fine a se stessa, perché comincio a pensare
che non interessi più a nessuno. Siccome mi sono anche stancato di trascrivere vecchi quaderni, è molto
probabile che i promessi sette Memo si riducano a sei. Ringrazio Stefano Zipoli Caiani per la segnalazione dei refusi della lettera. Quelli dello spirito sono lasciati a chi riesca ad arrivare in fondo.
1. Scienza, tecnica, ideologia e filosofia
Non è che la scienza diventi ideologia nel momento in cui la si assuma come unica forma coerentemente strutturata di conoscenza. Se “coerentemente strutturata” sta a indicare una forma che sia logicamente organizzata in postulati e concetti primitivi, dimostrazioni e definizioni, che non diano luogo a
contraddizioni, e sia inoltre munita di un affidabile set di metodi di controllo empirico cui tutti in linea di
principio possiamo aver accesso, tale qualificazione è superflua, perché mancando tali caratteri non
avremmo titolo a parlare di “conoscenza”. Ovvero, quella che diciamo “scientifica” è l’unica forma di
conoscenza che l’umanità sia riuscita a elaborare nel corso della storia. NB: una rete di conoscenze non è
una conoscenza, perché non è organizzata in tale forma, allo stesso modo in cui una biblioteca non è un
megalibro.
Se di altro non siamo capaci, dire che potrebbe anche esserci qualcosa di meglio fa poco onore allo
spirito umano (a commento della celebre frase di Jacobi). Questo non vuol dire che la scienza è divinamente legittimata a rimuovere dal nostro cervello ogni altra cosa. Vuole dire semplicemente che è nel
discorso scientifico che trova la sua realizzazione una cosa cui già diamo peso nella vita quotidiana: la
trasparenza nell’inferire e nel controllo delle nostre più amate ipotesi, per noi ovviamente “certezze”,
mediante la verifica delle loro conclusioni. Anche il metodo sperimentale nasce at home, come direbbe
Quine. La verifica scientifica non sarà mai definitiva, ma di meglio non c’è.
Riconoscere un simile ruolo alla scienza – ci insegna Preti – non porta a confondere quel che è
teorico con quel che è tecnico-pratico. La scienza diventerebbe ideologia se non inglobasse l’analisi critica dei suoi fondamenti. Grazie ai filosofi o loro malgrado, quest’analisi c’è sempre stata e continua a
esserci. E qui è opportuna una piccola precisazione sul grazie e sul malgrado: a impegnarsi in quest’analisi non sono stati tutti i “filosofi” e non sono stati soltanto i “filosofi”, perché molti “filosofi”, non essendo in grado di svolgerla, l’hanno disprezzata, mentre anche coloro ai quali attribuiamo oggi il nome di
3
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
“scienziati” hanno dato una mano a svolgerla. Non ho usato le virgolette a caso: togliendole, presupporrei il divorzio fra scienza e filosofia. Il punto è che, tanto prima quanto dopo (il divorzio), da sempre ci si
è interrogati sui modi per scoprire il ‘perché’ delle cose e sui criteri da seguire per accertare quel che si è
scoperto. È proprio quando ci interroghiamo sull’ars inveniendi e sulle varianti della prova del nove che
diventa difficile stabilire un punto in cui finisce la scienza e comincia la filosofia, o viceversa.
La scienza diventerebbe ideologia se facesse finta di ignorare che in ogni momento ci sono aree
dell’esperienza ancora non comprese scientificamente. La filosofia (della scienza) diventerebbe ideologia
se presumesse di ridurre ogni domanda su metodi e criteri, sulla loro gamma e sulle relative variazioni nel
corso dei secoli, a un prefissato modello linguistico e teorico – tenendo però a mente che, con o senza la
consapevolezza critica, le tecniche per correre più veloci non corrono e le analisi filosofiche neppure.
Tutto questo, Preti lo sapeva bene. Coloro i quali si lamentano di lacune nel suo discorso sulla
Wertfreiheit della scienza avrebbero fatto gran cosa se invece di fermarsi al lamento si fossero rimboccati
le maniche per colmarle. Chi non lamenti alcunché, ha ancor più da fare.
Interessa andare al cuore della Wertfreiheit della scienza? Allora conviene porsi una domanda. Dato
che nessuno (salvo patologie) si sveglia la mattina e per tutto il giorno si danna a stabilire se la conoscenza scientifica è libera o no da valori, ecco la domanda: *perché la questione della Wertfreiheit è diventata
un problema così sentito?* Qui c’è lo zampino dei filosofi e non direi che è segno di superiore coscienza o
di nanico impegno (Andiam, andiam a lavorar), ancorché tardivo, visti i decenni trascorsi da quando
Weber aveva aperto i giochi. Faccio un esempio: se tutti i fisici dell’Ottocento si fossero strappati i capelli per il fatto di non saper dire se c’era o no veramente bisogno di postulare lo spazio assoluto, dubito che
il progresso della fisica ne sarebbe stato favorito. Inoltre, una volta risposto alla domanda *...*, non
avremmo ancora stabilito se la scienza è davvero wertfrei o no. Non sto suggerendo che è legittimo ma
inutile chiedersi perché la questione è percepita come una di quelle che contano. Sto solo dicendo, ‘alla
Preti’, che un’analisi storico-sociologica non basta a rispondere.
Preti sperava che il tipo di costruzione razionale esemplificato nella scienza potesse diventare il
modello di una cultura democratica, pur avendo chiaro che le dimensioni di ciò che non si lasciava assorbire entro tale modello erano tutt’altro che trascurabili. Era il primo a capirlo proprio per il fatto di essere libero dai pregiudizi di scientisti e antiscientisti. Quanto non si lasciava assorbire non coincideva con
il Male (idola, chiacchiere e attrezzatura orwelliana) e neanche con il Bene (l’autentica Verità). Il bisogno
di inquadrare razionalmente esigenze non soddisfatte dal sapere scientifico (che sono state anche indicate come pascaliane)1 perdurava anche dopo aver riconosciuto che tali esigenze non trovavano sbocco
1
Si veda però il titolo, difficilmente equivocabile, che nel 1986 scelsi per gli atti di un incontro in onore di Preti: “Il
cuore della ragione”: il titolo voleva appunto additare uno sviluppo diverso dalla classica contrapposizione fra esprit
géométrique ed esprit de finesse.
4
Alberto Peruzzi – 2012
nella scienza del momento. Si trattava pur sempre di capire in quali modi alternativi potevano essere intese. Una filosofia che avesse voluto mantenere una qualche valenza progettuale-educativa (...) non poteva
affidarsi a una visione manichea.
La Wertfreiheit della scienza è un tema su cui l’ultimo Preti torna a più riprese e le considerazioni
che ho fatto fin qui derivano da una lettura e rilettura dei suoi scritti che ha richiesto anni. Ma negli anni
immediatamente successivi al ‘68 quale valenza progettuale-educativa era riconoscibile in un libro come
Retorica e logica da parte di uno studente che non conosceva altri scritti di Preti? Per quanto mi riguarda,
posso dire che il discorso di Preti suonava come una dialettica negativa, senza sintesi, e il senso della DNP
(Dialettica Negativa alla Preti) si trovava nitidamente espresso da una frase:
compito del filosofo non è la progettazione, più o meno rivoluzionaria, di un avvenire: ma,
se vuole occuparsi del presente, la critica razionale di questo.2
Critica razionale, ma alquanto diversa da quella di Marcuse, Horkheimer e Adorno: diverso il rapporto fra cultura scientifica e cultura umanistica, diversa l’analisi – e già nel precedente articolo su “Sodoma e Gomorra” – della società dei consumi, diverso il concetto di ‘razionalità’. Quando i depositari del
“pensiero critico” contestavano lo status quo rivelandone miti e complotti, denunciandone la disumanità
e ridicolizzando la piattezza dei benpensanti gioiosamente diffusa dai mass media, non si fermavano di
fronte alla razionalità scientifica e, in particolare, alla stessa logica. Quindi, per coerenza, tale critica razionale non poteva essere guidata dagli stessi valori che avevano reso possibile la scienza. Questa coerenza c’era davvero? Non è che la denuncia delle contraddizioni fosse anch’essa contraddittoria? Lo scenario dei Werte e della relativa Freiheit era un po’ più complicato di come astutamente si voleva far sembrare. In Preti la funzione della filosofia tornava a essere maieutica, ma non favoriva il recupero di una raffinata dimensione erotico-estetica, ma semmai quello di una elementare corporeità. Il compito era quello
‘classico’: educare alla chiarezza del pensiero, fatta di premesse esplicite, di linguaggio non allusivo, di
inferenze passin passino, di asserzioni verificabili. Anche chi diceva che i “fatti” sono un inganno, prima
o poi faceva riferimento a evidenze empiriche. Se no, sarebbe stato più onesto a proporsi come teologo.
Adorno escludeva tuffi in quella che oggi chiamiamo “partecipazione” (alla vita politica nelle forme
istituzionalizzate) pur di salvaguardare la possibilità di una vita autentica. E così, in fondo, anche Preti.
Ma Preti escludeva nella maniera più assoluta l’adozione di un punto di vista paurosamente ibrido come
era quello, moralistico e sociologico, dei francofortesi. Il modo in cui bisognava far posto alle ragioni che
la non-ragione ospitava era molto meno esaltante e alla fine quel che ne veniva fuori era troppo poco per
2 Que sera sera, p. 11. Si noti la differenza di accenti rispetto all’ultimo capitolo di Praxis ed empirismo.
5
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
imbastire un progetto di riforma social-democratica, troppo poco per lanciare proclami rivoluzionari,
troppo poco per dare indicazioni politiche e dirci come vivere, invece che dirci solo come non vivere.
L’onestà intellettuale è sempre stata scomoda, e più scomoda degli annunci dei profeti.
Negli anni in cui Preti metteva a punto i pensieri poi affidati a Retorica e logica, si ritrova a combattere una nuova battaglia: per la difesa di valori che vede minacciati da un rivoluzionarismo allo stato grezzo, ammantato di stilemi dialettici e invece, au fond, viscerale, prossimo a quell’irrazionalità che i contestatori additavano nella Tecnica, ormai antibaconiana, impadronitasi cioè della vita umana invece d’essere al servizio del regnum hominis. La sua era davvero una strana battaglia: combattuta contro l’acquiescenza di tanti intellettuali (e, in prima fila, colleghi di università) alle rivendicazioni dei contestatori e
combattuta non certo in difesa della casta accademica, fu una battaglia che gli fece assumere toni provocatori, come quando, in una dichiarazione rilasciata a L’Espresso (18 ottobre 1970) Preti afferma di non
aver “nessun interesse per il mondo della prassi che considero sporco e plebeo” – parole da mettere insieme, per ulteriore (nostro) scomodo esercizio, con quelle scritte tanto tempo prima contro coloro che,
ovviamente in nome del Bene Assoluto, se ne sentono strumenti (mansueti o arrabbiati):
La nostra vita di uomini è vita di lavoro e sofferenza [...] non si crea con la certezza che ciò
che si fa abbia un valore eterno, ma si costruisce faticosamente ciò che si sa che sarà distrutto: costruiamo una casetta per noi, non un monumentum aere perennius.3
Non che Preti fosse cieco di fronte alla pervasività che la tecnica aveva raggiunto nella vita dell’uomo contemporaneo. Entro la società “opulenta” (l’Occidente capitalistico) ogni aspetto della quotidianità ne era influenzato e in modi camaleontici, non dipendenti da bisogni reali ma dal rapido progresso
della tecnica e dal risultante afflusso di nuovi prodotti sul mercato. Va bene, e con questo? Non c’era, per
Preti, da trarne lezioni moralistiche. Semmai era l’occasione per diventare più consapevoli che il valore
della scienza non sta per intero nell’utilità pratica dei suoi risultati, esattamente come il suo valore non
sta per intero nel suo essere ‘funzionale’ a un sistema di potere disumanizzante.
Eppure, alla fin fine, un’indicazione di tipo morale c’era. Per esempio, come giustamente ricordato
da Minazzi, Preti prese posizione sull’industria ludica che sfruttava i progressi della tecnica (si pensi oggi
alla diffusione dei videogiochi) scorgendovi un’evasione dalle proprie responsabilità, ulteriore sintomo
della crisi dei valori: era il “bisogno di lasciarsi andare alla deriva voltando le spalle al senso della corrente
per non vedere dove sta andando”. Preti allora proponeva una “coscienza scientifica di massa”, ove è
3 Idealismo e positivismo, p. 236.
6
Alberto Peruzzi – 2012
chiaro ancora una volta che “scientifica” non può significare “tecnica” e, a fortiori, che la teoresi non si
lascia ridurre alla praxis.
Con ciò non è che il piano pratico perda l’importanza che Preti gli aveva riconosciuto in Praxis ed
empirismo: è pur sempre grazie ai risultati della tecnica (in senso lato, dall’ingegneria civile alla chirurgia) che la vita umana, diciamo non dell’umanità intera ma almeno di una sua parte (crescente), ha visto
un decisivo miglioramento rispetto a tempi in cui epidemie, fame, elevato tasso di mortalità infantile,
rientravano nella normalità. La differenza tra vivere e morire sarà banale e non farà parte di una riflessione su quella che oggi chiamiamo “qualità della vita”, ma chi dimentica l’incremento della sopravvivenza
reso possibile dalla ricerca scientifica, chi vede solo danni all’ambiente, chi punta il dito accusatore sull’incremento del numero di vittime per unità di tempo in un conflitto con le armi moderne, gioca una
partita che in partenza ha truccato. La conoscenza non è teoria è basta, ma non coincide neppure con gli
impieghi che ne sono stati fatti.
Preti affronta la questione in tutta la sua ampiezza e si rende conto che la verità, anche ammesso di
poterla ricondurre alla verificabilità empirica, non si lascia schiacciare nel rapporto pragmatico mezzi-fini, seppur nobilitato alla maniera di Dewey, contro l’usuale lettura del motto machiavellico. Se nella razionalità c’è qualcosa di più che pura ragione, c’è anche qualcosa di più che baconiano. Il regnum hominis è per forza in funzione della hominis vita ma, se lo sforzo di comprendere la natura non si esaurisce
nella migliore giustificazione della migliore strumentalità, c’è un residuo assiologico non assorbito dalla
prassi. E allora quale status possiamo assegnare a questo residuo? Un altro bell’esercizio, che investe
anche lo status della filosofia.
Pur con la vena di auto-ironia che Preti tira fuori quando s’accorge d’aver fatto affermazioni un po’
solenni, gli tocca rivendicare l’autonomia del discorso filosofico da ogni tutela morale, politica, religiosa
... e per coerenza anche da ogni tutela scientifica così come da ogni funzione vitalistica – se non fosse
che questo anche non va tanto d’accordo con quel che Preti scrive altrove). Gli tocca ergersi a difesa di
quest’autonomia in un paese in cui l’imperativo categorico era (ed è ancora) Mi schiero, dunque sono. E
il modo in cui la difende che cosa attesta? Attesta la solitudine di chi vuol fare il mestiere con onestà,
perché ne richiede la distanza da qualsivoglia community.
A Preti non sfugge che questa difesa poteva apparire aristocratica, quasi un insulto alla democrazia,
già documentato dal caso Socrate: «La democrazia ateniese, che era saggia, teneva in serbo per lui la
cicuta». 4 I filosofi si prestano all’accusa di hybris? Pazienza. È il prezzo da pagare per la funzione educativa (direi “pedagogica”, ma Preti si arrabbierebbe) della filosofia – un compito che la scienza, da sola,
non assolve. Ma siamo davvero sicuri che la scienza (o la religione, o altro ancora) non possa assolvere il
compito meglio della filosofia? Variando quel che c’è da variare rispetto a quanto detto inizialmente sulla
4 Da Terzoprogramma, 3, 1972, p. 128.
7
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
scienza e su ciò che fa onore allo spirito umano, è un dato di fatto che finora gli esseri umani non sono
stati capaci d’inventarsi niente di meglio di una paideia che sia addestramento a quella «neutralità critico-razionale», che sarà noiosa ma è anche indispensabile per discutere sensatamente, chiarire e valutare
il significato di ogni asserzione in ogni campo. La solitudine della filosofia è, in fondo, un prezzo accettabile per tale addestramento. Evidentemente, ci sono dei valori che contano più dei disagi delle singole
persone: un discorso sufficientemente fuori tempo, no? E per restare fuori tempo, ecco due flashback.
***
Flashback 1. Nello stesso anno di Idealismo e positivismo esce il Socrate banfiano. Recensito da
Preti tre anni dopo, 5 è proprio in merito all’immagine di Socrate che si manifesta uno dei primi dissensi
di Preti da Banfi: infatti, Preti indica come erronea la sovrapposizione tra persona (qui, Socrate) e valore
(qui, il valore testimoniato da Socrate). 6 Dietro c’è il costante confronto di Preti con il personalismo di
Scheler e l’esito è di nuovo che c’è un residuo assiologico il quale non si lascia assorbire né dalla praxis
né dalla persona.
Per il fatto di rivendicare questo residuo (e la sua importanza), Preti poteva esser additato quale
servo del capitalismo e delle forme di oppiacei che gli fanno comodo. Esattamente come poteva essere
additato se, invece di rivendicarlo, avesse insistito sulla praxis nel senso di Dewey! Ai moralisti secondo i
quali la scienza era parte della trappola (perché doveva esser al servizio dell’umanità mentre rispondeva a
interessi di parte) già l’enfasi sul valore della scienza-in-quanto-tale doveva apparire sospetta, figuriamoci l’idea di una teoresi staccata dall’engagement.
Insomma, Preti non aveva alcun modo di salvarsi di fronte al Tribunale dei Giusti: agli occhi di chi
oltre a dar voce agli oppressi si calava nei panni dell’inquirente/inquisitore, il suo ragionamento era un
reato, perché indeboliva la lotta contro il Male e contro i suoi perfidi lacchè liberali. Il Male era il capitalismo. E il capitalismo, che dopo aver sfruttato l’oppio dei popoli ora sfruttava tecniche di persuasione
occulta, era la religione dell’utile. Ma allora come si poteva pensare di batterlo facendo leva sul pragmatismo? ... Se non fosse che, nell’indicare le ragioni per cui bisognava batterlo, tanto i fautori ortodossi
della rivoluzione quanto i non ortodossi del “pensiero critico” si affidavano a un’etica che non ammetteva storicizzazione. Infatti, l’oppressione è un disvalore non relativo al contesto e per questo i Giusti erano giusti: avevano un’etica che doveva guidare la politica, alveo di ogni sensato impegno. Preti invece
viveva nel peccato. Ma anche l’incoerenza è un peccato.
5 Su Studi filosofici, VII, 1946, pp. 75-80.
6 Qui ci sarebbe da fare un lungo, troppo lungo, discorso su come poi Preti si misurò con il personalismo di Scheler.
8
Alberto Peruzzi – 2012
I Giusti in loco non si accorgevano che Preti metteva in guardia verso la manipolazione delle menti
più di quanto riuscissero a fare loro, anche quando denunciavano l’alienazione nelle sue ultime forme.7
Posso capirli, perché avrebbero dovuto riconsiderare uno a uno i passaggi logici con cui erano arrivati a
far propria ora un’ideologia messianica ora una semplice “nostalgia del futuro”, e una tale riconsiderazione sarebbe stata per loro ben poco utile. Detto questo, però, è semplicemente straordinario il modo in
cui la cultura italiana passò senza batter ciglio da un senso di colpa su basi trascendenti a un senso di
colpa su basi immanenti; e non meno straordinario è che la seguente sbornia psicoanalitica, invece di
aiutare a liberarsi dal senso di colpa, contribuì a incrementarlo. Passata la sbornia, i Giusti in questo paese continuano a essere identificati dall’atteggiamento penitenziale (vedi oppio).
Il punto dolente era la neutralità della scienza: se la scienza doveva aiutare l’emancipazione dell’umanità rompendo le distinzioni tra una classe e l’altra, come mai la scienza si prestava a così ampio uso
da parte del nemico degli oppressi? Se negli effetti non c’è più male di quello che c’è già nelle loro premesse, allora perché servirsi dei megafoni nei comizi, se anche i megafoni erano frutto del demonio?
Oggi sembra quasi una controversia buona per un episodio di Peppone e Don Camillo. Da non credere
che qualcuno l’abbia presa sul serio e tuttavia ... deridere chi ci giocò sopra serve a ben poco.
Di fronte al diffondersi di consimili sciocchezze, è facile capire che la fichtiana missione del dotto
dovesse riconfigurarsi. Diventava sempre più ascetica, anche se l’esercizio di quest’ascesi era molto diverso dal voyeurismo metalinguistico caro (si fa per dire) ai filosofi analitici. La razionalità dimenticata, di
cui i filosofi non asserviti al regime si facevano missionari, poteva entrare in simbiosi con la scienza solo
se da questa non era depressa, cioè, se non era costretta a una continua cerimonia di auto da fé.
Quella di Preti era una soluzione troppo esigente per i connazionali e troppo complicata per i forestieri. Altrove, la soluzione più radicale per far cessare le ostilità tra scienza e filosofia era stata un’altra:
rinunciare alla costruzione teoretica per votarsi all’analisi logico-linguistica, nella convinzione che questa, essendo meta-scientifica, fosse intrinsecamente esterna alla scienza. Una convinzione discutibile.
Preti cerca un compromesso nella Storia del pensiero scientifico mentre nello stesso anno (1957) pubblica
un libro come Praxis ed empirismo in cui il compromesso già si fa instabile.
Che la soluzione fosse quella più immediata o quella più complicata, l’ascesi filosofica avviata con il
passaggio dal linguaggio al metalinguaggio, innescava una bachiana fuga di meta, metameta, metametameta, verso una sempre più remota dimensione metaculturale, del discorso filosofico. Conseguita la quale, come si fa a non diventare e a non sentirsi degli alieni? Mantenersi in equilibrio fra “fedeltà alla verità”
(che è apertura a tutta la gamma dei valori) e “moralità” (che è responsabilità verso la gerarchia dei valori
scelta) era molto difficile. Nel discorso di Preti c’è umiltà e c’è coraggio: una congiunzione che si esprime
7
Naturalmente, quando si parlava delle forme di alienazione dell’uomo contemporaneo s’intendeva l’uomo che vive
nella società capitalistica, non il membro di una tribù dell’interno del Borneo, il quale suppongo potesse risentirsi se
informato che non era un contemporaneo.
9
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
prima nella coscienza critica del cambiamento cui ogni rappresentazione del mondo è soggetta e poi
nella decisa opposizione a ogni mitologia (compresa quella scientista), senza rinunciare alla nostra responsabilità qui e ora.
Sotto il profilo epistemologico, l’hegelismo che di tanto in tanto riaffiora nei suoi scritti è minimalista e tale è anche il riaffiorante kantismo. Da un lato, anche chi vuole uscire dal fiume della storia vi è
immerso; dall’altro, a chi vi è per forza immerso non si può impedire di voler guardare il fiume dalla riva.
Non gli riesce bene? O la smette o si allena di più – e non lo dico con tono spocchioso, perché quella di
trascendere è pur sempre un’esigenza immanente, riconosciuta dallo stesso Preti, così come riconosciuta, prima di lui, da Kant e, in anni più recenti, da Putnam. Quindi non si tratta di reintrodurre ipostasi,
che sarebbero in aperta contraddizione con quanto indicato da Preti già nel 1943, 8 ribadito nel 1948 affermando che “qualunque trascendenza significa eteronomia”,9 e riproposto in seguito come esigenza
inderogabile che non si affida a paradisi perduti e a futuri predestinati (di progresso o decadenza).
Verso l’idea di una auto-nomia ancorata all’esperienza convergono del resto gli sforzi di tutti i filosofi che non hanno piegato la testa ai dogmi della religione o della più laica ideologia, e vi convergono
non da una data o da un autore dei tempi moderni ma dalle origini greche. Tutte le concezioni che invece
hanno negato tale auto-nomia hanno misconosciuto il carattere emancipativo del riconoscimento dell’uomo come autolegislatore, vedi la risposta kantiana alla domanda “Che cos’è l’Illuminismo?”.10
***
Flashback 2. Queste ultime considerazioni dovrebbero aiutare a capire il progetto, sviluppato da
Preti negli anni Cinquanta, di fondere convenzionalismo e contrattualismo – il primo d’estrazione epistemologica, il secondo d’estrazione politologica. Non si possono tuttavia ignorare due inconvenienti ai
quali tale progetto andava incontro.
Un inconveniente è che se la natura retrocede allo status di materia che attende solo d’essere plasmata – e così è intesa come qualcosa di “pre-etico”11 (e pre-categoriale)–, allora non può esser fonte di
alcun definito vincolo. Quindi, l’appello di Preti all’uomo “in carne, ossa e sangue” è vacuo. Quest’inconveniente è riconoscibile già nel primo capitolo di Praxis ed empirismo, ove il richiamo alla natura
materiale è giocato ambiguamente, perché l’essere-che-fa-se-stesso si fa nella storia, per via culturale, e
allora la sua materialità consiste in ‘cose’ diverse da un luogo a un altro e da un tempo a un altro, mentre
8 Nel volume Idealismo e positivismo.
9 Nell’articolo “Libertà e responsabilità”, Studi filosofici, 3, 1948, p. 135.
10
Non tutte le ciambelle autolegislative sono venute bene? Chi, per induzione, ne conclude la Crisi della Ragione,
sfrutta un principio (quello d’induzione) che la ragione (in minuscolo) educa a usare con maggior cautela.
11 Ivi, p.135.
10
Alberto Peruzzi – 2012
il richiamo alla natura dei corpi era rivolto a valorizzare la basilare fisicità del reale (ivi compreso il corpo
umano). È su tale fisicità che, infatti, la cultura s’innesta. Pertanto la base dello “spirito” non può esser
un prodotto integrale dello stesso “spirito”.
Un altro inconveniente è quello che riguarda la storicizzazione delle categorie. Preti non si ferma,
infatti, a sottoscrivere la lezione neokantiana in base alla quale le categorie sono secchi vuoti che si riempiono al fiume della storia, perché questi secchi hanno anche forma mutevole: non solo le categorie si
riempiono di contenuti diversi nel tempo, ma il loro insieme muta. Ai filosofi toccherebbe indagare la
serie di forme che via via si manifestano, tenendo presente che la serie è potenzialmente più ricca di
quanto finora testimoniato dalla storia (il passato non contenendo il futuro). Ma quanto più ricca? In
presenza del primo inconveniente, non si capisce se e in quale modo la ricchezza in esubero sia connessa
alla natura umana. Se questa natura è anch’essa interamente in fieri, l’indagine filosofica è destinata a
restare in stand-by.
Questo secondo inconveniente è aggravato dal fatto che la funzione costitutiva delle categorie tende a sdoppiarsi nel discorso di Preti. Il sintetico a priori ora si deposita nel nesso tra tipi diversi di funzione (valutativa e normativa) e ora è assimilato all’analitico per il semplice motivo che è ciò che definisce la
cornice di ogni singolo dominio dell’esperienza. Ma, una volta che qualcosa si è sdoppiato, bisogna mostrare come fanno i due a stare insieme e Preti non lo mostra. Sente almeno l’esigenza di mostrarlo? Sarebbe ingeneroso negarlo, perché Preti avverte la mancanza di un raccordo fra il trascendentale che si fa
convenzione formatrice-definitoria e il trascendentale che è trans-categoriale. Preti, però, non dice come
soddisfare a quest’esigenza. Talvolta sembra che Preti sia orientato a pensare che nell’interfaccia tra i due
tipi di funzione entrano in gioco strutture epistemico-assiologiche intrinseche, dunque non empiriche
ma, se anche arrivò a pensare questo, non ebbe il tempo, la forza, la convinzione di sviluppare una simile
ipotesi.
Provare a svilupparla sarebbe un buon esercizio. Personalmente, posso dire di averci provato e, se
sono andato poco lontano, mi aspetto che anche altri ci provino e facciano di meglio. Qui propongo un
altro esercizio: quello di provare a immaginarsi come la rivendicazione di un piano alto del filosofare,
irriducibile a ogni contingenza e cosciente di non poter dettare una specifica linea politica, fosse recepita
dalla generazione di intellettuali plasmati dalla Resistenza e dalla relativa ricostruzione idealizzata. Dal
più al meno avrebbero ripetuto il motto marxiano: è l’ora di smetterla con l’interpretare il mondo, è giunto il momento di impegnarsi a trasformarlo ... e invece i filosofi non ne vogliono saperne di smettere, e
così rivelano ancora una volta quel che sono, cioè, alienazione personificata, dunque zavorra. Come recitava il detto popolare, “la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale, tutto resta tale e quale”.
Per sbarazzarsi del superfluo c’era un solo modo, penitenziale o autogratificante secondo i gusti, ed
era già stato sancito: partecipare alla lotta politica, ovviamente nei modi previsti dalla segreteria del PCI.
11
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Possibile che lorsignori, i filosofi accademici, non si rendessero conto che la pretesa di essere coscienza
critica di ogni sapere finiva per essere al servizio di interessi di classe?
NB.1 Per contrappasso storico, un buon numero degli eredi dei filosofi che così fortemente avvertirono il dovere dell’engagement sono diventati ermeneuti, dunque si sono condannati a un ergastolo interpretativo.
NB.2. Se per gli intellettuali italiani che erano veri “marxisti” l’autonomia del filosofo era hybris,
tale era anche per gli intellettuali italiani d’ispirazione cattolica. Il guaio dei secondi era una cambiale
metafisica in protesto, il guaio dei primi stava nel non voler rinunciare a tre cose che solo un miracolo
poteva tenere insieme, ovvero: realismo ingenuo, scientificità, metafisica su basi dialettiche. Il primo non
si contentava di presentarsi come realismo del senso comune, la seconda era buona solo quando serviva
alla causa, la terza restava meravigliosamente intonsa da scrupoli empiristici. Come se ciò non bastasse,
la fede nel realismo ingenuo era in palese contraddizione con l’obbligo di rinunciarvi (essendo la realtà in
divenire al pari della sua immagine scientifica). Basti pensare a Geymonat: fuori dalle questioni di metodologia e storia della scienza non c’era spazio per altra filosofia che non fosse quella già codificata nel
materialismo dialettico – insomma, un buon filosofo della scienza era uno che conosceva la scienza e la
sua storia, non la filosofia e la sua storia.
2. Coscienza storica e razionalità
In Kant, Husserl e Carnap mancava una metacritica storico-sociale della ragione e a denunciare
questa mancanza era il “pensiero critico”. Nel nuovo orizzonte delineato da Preti c’era forse il rimedio a
questa mancanza? Domanda retorica. Il rimedio non c’era – la domanda era un’imputazione. Per evitare
equivoci, meglio chiarire: giusta o sbagliata che fosse l’accusa, chi lamentava la mancanza non chiedeva
qualcosa di sbagliato o di irrilevante. Di nuovo, però, i Giusti dovevano almeno preoccuparsi di essere
coerenti. Quando, da studente di Preti, lessi Storia e coscienza di classe di Lukacs, non riuscivo a capacitarmi di come si potesse preferire quella visione riduttiva di Kant e delle scuole neokantiane all’ampiezza
prospettica che scaturiva dal connubio di filosofia dei valori e storicismo. E per evitare altri equivoci meglio chiarire di nuovo: per me, quel connubio apparteneva al passato – cioè, non era riproponibile – e
inoltre l’epistemologia e l’etica di Kant non erano affatto al riparo dalle critiche di Lukacs. Eppure mi
sembrava che l’indagine trascendentale, rivista e corretta, aveva trovato nuova linfa proprio nella riflessione di Preti l’empirista! Per questo non me ne capacitavo. Avrei dovuto avere il il coraggio di scriverlo a
qualcuno degli allievi di Lukacs a Budapest12 ma ero solo uno studente ignorante e ormai è troppo tardi
12
Di questo volevo parlare a Preti nell’ultimo colloquio a casa sua. Mi disse al citofono che era nudo e che tornassi
più tardi, ma ci potevamo vedere anche un altro giorno. Giusto. Quando ho rivisto quell’appartamento, era ormai
vuoto e ad aprirmi la porta c’era un mediatore per la compravendita di appartamenti.
12
Alberto Peruzzi – 2012
(grazie). Così, tanto per mettere qualche puntino su qualche i, mi limiterò alla questione di coerenza di
chi puntava il dito.
L’accusa di astrarre dai fatti storico-sociali era un boomerang, un boomerang che finiva per colpire
chi ignorava la varietà e la complessità del mondo dei valori. (Mi ricordo appena appena le discussioni in
famiglia sul rock che era interdetto dalle Feste dell’Unità, ma da adolescente ricordo molto bene le sparate contro l’arte e la letteratura contemporanea da parte dei Giusti. Una tanto esigente metacritica implicava il realismo proletario e progressista?)
Se qualcuno mi dice Devi prendere coscienza della problematicità storica della ragione! e m’invita a
non mitizzarne la purezza, posso anche ringraziarlo, però vorrei che l’invito fosse argomentato. E come
può essere argomentato? O (a) è argomentato sulla base di fatti storici, o (b) sulla base di una prova puramente logica, o (c) sulla base di un qualche giudizio di valore, o (d) facendo un miscuglio di (a), (b) e
(c). È chiaro che in tutti e tre i casi (a), (b) e (c), e anche nelle loro varie combinazioni in (d), chi me lo
dice è nei guai. Esercizio.
Non provo alcuna libidine a dire che è nei guai, perché non intendo riproporre l’antitesi fra razionalità e storicità. Quello che pongo è un semplice quesito di metodo e lo pongo per arrivare a un più sereno esame dei fattori che intervengono nel divenire della storia. La storia dipende non solo da quel che
c’è e da quel che si fa per cambiarlo, ma anche da cosa gli agenti pensano di quel che c’è e di quel che ci
potrà essere al suo posto. Conta la specifica situazione in cui decidiamo di fare questo invece di quello,
quanto conta la specifica situazione che ci immaginiamo e che crediamo sia aiutata a realizzarsi dal mettere in atto la decisione. La storia è il risultato di tante contingenze e di tante decisioni. Il passato è scritto
dalle più varie, fondate o strampalate, idee sul futuro. O si scrive da sé e i decisori sono marionette? Ma
allora lo è anche chi decide di promuovere una coscienza di classe. Se non lo è, sia gentile e conceda magnanimemente il diritto a non esserlo anche ad altri. Per inciso, l’ape che riuscisse a leggere Darwin e a
farsene divulgatrice non saprebbe ancora spiegare le leggi trigonometriche coinvolte nel proprio orientamento. Oh, so bene che si può essere anche più maliziosi e, restando in chiave evolutiva, dire che il piùche-vita che ritorna come più-vita è una specie di pollice del Panda, un fossile dell’astuzia della ragione.
Non so come Preti avrebbe potuto replicare, perché (il suo) convenzionalismo richiedeva un bel po’
di lavoro per andar d’accordo con il suo nominalismo. Praxis ed empirismo fa invece sembrare tutto liscio
– come quando Preti argomenta la legittimità, in termini comportamentistici, di asserzioni sulla “miseria” della classe operaia. Perché poi escludere tassativamente l’adozione convenzionale dell’esistenza di
essenze platoniche se fosse utile a creare un’immagine pragmaticamente più efficace della realtà? Ci
sono tanti modi di “salvare i fenomeni”, no? E i pensatori dialettici ne sanno pur qualcosa.
Quanto al materialismo storico, nel Novecento la sua trasformazione in catechesi popolare è stata
per i parlanti lingue neolatine quel che lo strutturalismo è diventato passando dai raffinati linguisti euro-
13
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
pei ai manuali di grammatica per la scuola secondaria, o quel che l’olismo, da Quine in poi, è diventato
per i filosofi americani post-analitici: cioè, una litania di richiami alla totalità come proton hypokeimenon. Se la filosofia educata all’analisi logica è analisi più-che-logica, è pur sempre fedeltà alla cartesiana
chiarezza e distinzione. Come si faccia a esserle fedeli se non seguendo un qualche principio di composizionalità mi risulta oscuro. Cos’è un Divide se poi l’impera resta a chi non divide?
Facile immaginare come appariva ai Giusti chi come Preti avesse osato insistere sull’analisi, logica e
più che logica: faceva il gioco della parcellizzazione del sapere, ne avallava la frammentazione, a scapito
degli oppressi e a vantaggio degli oppressori. Di nuovo per coerenza, se il Divide et impera dei Cattivi
funzionava così bene, perché non avrebbe potuto funzionare in mano ai Buoni? Proprio mediante
un’analisi dei componenti del sistema e delle loro mutue relazioni si poteva arrivare a capire come il sistema funziona. Trattandolo come monolito, no. Newton aveva cominciato a capire la luce servendosi di
un prisma che la scomponeva, non viceversa.
L’atteggiamento analitico non esclude bensì prepara la comprensione dei processi che intervengono nell’integrazione di più componenti all’interno di un sistema – in fisica così come in ogni altro campo.
L’analisi ha dei limiti? I suoi limiti si capiscono grazie alla stessa analisi e non in altro modo. Guarda caso,
i grandi olisti, da Spinoza a Hegel e da Marx a Quine hanno coltivato un’indefessa e scrupolosa attività di
analisi. I loro pedissequi ripetitori hanno trasformato l’olon in un celestiale condono edilizio. Ci sarebbe
da dire molto al riguardo. Mi limito a osservare che tra mettersi i paraocchi e metter tutto in un calderone
c’è anche qualche opzione intermedia.
Franco Alessio parlò giustamente della repulsione pretiana verso il “materialismo storico selvaggio”: nel momento in cui il filosofo pavese rivendicava che la teoresi deve prendere le distanze dal contesto storico-culturale, non aveva alcuna intenzione di mettersi o rimettersi i paraocchi. Purtroppo, nel
momento in cui a questa presa di distanza si univa una tesi storicista, declinata nel rispetto dei canoni
dell’empirismo, scattava un’immediata obiezione. Infatti, una volta che so che ogni sapere è sapere storico, come faccio a dire di saperlo? Una volta che so che i metodi della storiografia sono storici, so anche
come farne uso per capire uno specifico fenomeno storico? Ci pensa la Storia a dirmelo?
Chiunque abbia creduto che ci pensa la Storia, con o senza il coraggio di dirlo, faceva teologia sotto
mentite spoglie, e teologia di bassa lega. Se proprio dobbiamo fare teologia, meglio farla come Dio comanda, senza tanti giochetti. Ma forse sono un po’ sordo e così, chiedo scusa, non odo distintamente
quel che la Storia mi dice. Anche in tal caso non mi resta che pregare. E la preghiera è: Ti supplico, o
Storia, che sicuramente odi la mia voce più di quanto io oda la tua, a farti sentire meglio, articolando le
tue parole in un ragionamento, dunque fornendomi argomenti il controllo della cui validità mi sia accessibile. Per mia (e altrui) sfortuna, pare che simili preghiere siano sistematicamente ignorate; pare che la
“verità storica” non solo si scriva da sé ma anche che la Storia non si abbassi a esaudire del tutto la pre-
14
Alberto Peruzzi – 2012
ghiera e cioè a fornire anche argomenti. Si diverte piuttosto a sfornare indovinelli che mettano i suoi
laudatori nel massimo imbarazzo. Di questo, la ringrazio.
Qualcuno sbotterà: Ah, è chiaro, si vuol preparare la strada a un platonismo furbamente espresso
in modo tale da apparir innocuo, facendo finta che sia innocuo sostituire “Quel che vale, vale storicamente” a “Quel che vale storicamente, vale”. Peccato che Preti non fosse né un platonico né un neo-platonico,
e su questo non ho alcuna intenzione di correggerlo. Le sue parole, riportate in apertura del Memo n.5,
sono inequivocabili. Le sottoscrivo e invito a fare altrettanto.
Banale dettaglio: che la ragione sia coscienza critica dei propri limiti, se non ricordo male, lo disse
quell’ignobile nemico della coscienza di classe che si chiamava Kant. “Critica” viene dal greco krino, che
significa distinguo. Passando dal conoscere all’esprimere conoscenze, nel Novecento ci si è resi conto
che l’attività “critica” aveva bisogno di un veicolo espressivo cristallino e così ci si è industriati a definire
l’architettura di un linguaggio-modello, “perfetto” relativamente ai più diversi tipi di discorsi e capace di
servire da medium dell’analisi “critica” del conoscere. Le cose non sono andate nel verso sperato e qualcuno è stato indotto a concluderne come Bartali che “Gl’ètuttosbagliatho, gl’ètuttodarifare”. Ahimè,
quando diagnostichiamo la staticità “astratta” dei tentativi di fondare la validità, e in ultimo la stessa razionalità, facciamo pur sempre uso di qualche suo frammento. Quindi? Quindi anche l’acidità con cui
prima Lukacs guardò alla filosofia dei valori e poi Adorno alla filosofia analitica era espressione di astio
più che di superiore comprensione. Nel più-che-vita c’è più vita di quel che pensavano.
Che non ci sia dietro una nostalgia irrazionalistica? “Irrazionalismo” è la tipica etichetta offensiva
appioppata da dogmatici a chiunque segnali che al loro Divino Sistema sfugge qualcosa, mentre di gente
pronta a sbavare alla sola idea che il cuore vede cose che la ragione non vede, oh ... ce n’è sempre stata
tanta! Quanto pertiene alla vita è irrazionale? Non direi. Credo, piuttosto, che cattiva razionalità sia
quella che porta a dirlo. Preti torna a Simmel attraverso la lezione di Banfi, al quale aveva riconosciuto il
merito di essere stato il solo a fare i conti con Simmel. Coloro i quali si lasciarono rapire dalle filosofie del
sospetto, qui il veleno di Lukacs sul (neo-)criticismo e di Adorno sull’illuminismo, non avrebbero mai
pensato che si dovevano fare questi conti. Un certo qual vitalismo, che non mi sembra tanto pascaliano
quanto erotico, resterà in Preti fino all’ultimo, confinato al registro dell’understatement, nel timore che
non appena esplicitato fosse fatto proprio da chi aveva voglia di sbavare. Di qui le sue reazioni stizzite di
fronte alla deriva degli esistenzialisti verso l’irrazionale. Il messaggio era: niente sbavature e niente deriva, please. Sufficiente a impedire l’assimilazione di Preti ad anima bella? Ah, per i vecchi compagni e per i
nuovi (a Francoforte o a Budapest) era ovvio che no.
15
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
3. Delusioni
Dopo il vero e proprio ardore con cui Preti partecipò al Politecnico di Vittorini, alcuni accenni
epistolari dei primi anni Cinquanta rivelano un Preti che comincia ad avvertire il peso del filosofare, talora un senso di impotenza e declino. Sì, ma questa sensazione non è mai trasposta sul piano epocale, facendone sintomo di un secondo tramonto dell’Occidente. Altri ci avrebbero marciato, scrivendo un bestseller e calandosi nei panni del profeta o, più prudentemente, in quelli di un’inascoltata Cassandra.
Non Preti, che a un certo punto si sente incompreso e stanco. Il che vien letto perfino da un amico quale
Remo Cantoni in un senso curioso: è “orgoglio eccessivo”, è “pigrizia”, è “risentimento”.
Quanto all’orgoglio, com’è che Cantoni avrebbe combinato il primo di questi sostantivi con il vezzo pretiano di ricordare che siamo degli “epigoni”? Certo, Preti aveva l’orgoglio del teoreta di razza.
Quanto all’esser pigro, egli stesso lo ammetteva con una certa gigioneria, perché dopotutto l’ampiezza e la densità dei lavori nei quali aveva concretato le sue ricerche erano prove del contrario. A parte
questo, la sua “pigrizia” era anche correlabile all’isolamento così come all’intimo cruccio, fatto di onestà,
che lo portava a dubbi sull’importanza di quel che aveva da dire. Questi dubbi di Preti su Preti, di tanto in
tanto riaffioranti non sono da confondere con la sua ritrosia di fronte all’idea di offrire una presentazione
sistematica: riluttante com’era a far proprie le modalità compositive di un trattatista e incline a percorrere
simultaneamente più linee di ricerca, le immancabili ragioni di contingenza lo portavano a dedicare
un’attenzione intermittente a uno stesso cantiere, tant’è che, se Praxis ed empirismo era un “libro domenicale”, anche la sua opera prima, Fenomenologia del valore, era stata redatta, dando fede alla testimonianza di Daria Menicanti, in maniera rapsodica.
Quanto al risentimento, Cantoni non immaginava che Preti avrebbe scritto pagine di grande acume
sul tema, nelle quali prende corpo anche una critica delle analisi che ne avevano fatto Nietzsche e Scheler. Ma non dimentichiamo il momento cui le parole dell’amico Cantoni si riferivano: un momento in cui
le speranze di una cattedra universitaria erano mortificate dal vedersi passare avanti, oltre ai soliti ammanicati e portaborse, una schiera di retori, unti di spiritualismo e storicismo (naturalmente i soliti e la
schiera ammettono un’intersezione non vuota). Ci voleva poco a capire che Preti volesse restarsene al
liceo di Pavia piuttosto che entrare nei salotti buoni di Milano. Proprio non gli si confaceva l’idea di autopromuoversi sgomitando, per entrare nell’accademia e nell’industria culturale.
Rispetto ai pensatori da rotocalco che avrebbero imperversato nei decenni successivi alla morte di
Preti, brilla ancor più la differenza. Pochi di loro avrebbero respinto offerte come quella di Alberto Mondadori quando lo invitò a collaborare a Epoca (allora settimanale di grido). Che peccato quel no. Sarebbe
stato un modo per far conoscere le sue idee a un più ampio pubblico e così, di rimpallo, smuovere l’indifferenza degli eruditissimi colleghi eternamente in abito grigio con pulloverino in tinta, cui per nemesi è
seguita l’epoca del più demagogico casual.
16
Alberto Peruzzi – 2012
Intendiamoci: Preti accettò anche lavori su commissione pur di sbarcare il lunario, ma restavano
cose occasionali. Una collaborazione fissa e a cadenza rapida l’avrebbe obbligato a sottrarre troppo tempo alla ricerca. Tuttavia, accettare quell’offerta poteva servirgli in un senso non economico, perché
avrebbe fatto capire che non era un ossequioso emissario del neopositivismo in Italia.
Già in un precedente Memo ho accennato alle ragioni per le quali il filosofo pavese non poteva esser scambiato per un emissario del neopositivismo. Qui mi limito a ricordare che è in una lettera a Banfi
del 20 luglio 1950 che Preti chiarisce la propria posizione, quando afferma di “intravedere” la via d’uscita
dal pericolo, cioè, dalla riduzione del lavoro filosofico a “inutile gioco tecnico”, sulla scia di Carnap. 13
Intravedere un simile pericolo non significava avallare sdilinquimenti come quelli che in terra patria e
altrove conferivano le stigmate del pensatore. E poi: “intravedere” non bastava. Preti se ne rende conto,
tant’è che con rammarico e con una punta di fatalismo aggiunge: “ma sono troppo pigro per costruire
tecnicamente le teorie che mi sarebbero necessarie”. 14 Aveva dunque ragione Cantoni? Be’, la mancata
costruzione di quelle teorie non poteva essere ciò che Cantoni aveva in mente per un Preti meno pigro,
perché mi permetto di dubitare che Cantoni fosse in grado di capire, prima di apprezzare, quelle teorie
(irte di dettagli logici) che Preti considerava “necessarie”.
Tornando al Che peccato, c’è un’altra correzione da fare. Si comincia col dare un dito alla divulgazione e si finisce col fare i divulgatori a tempo pieno, rinunciando alla ricerca e dimenticandone lo standard. Di modo che, quando si decide di tornare a farla (ammesso che ne resti la voglia), la fatica è tripla.
Coerente con tale preoccupazione fu l’estraniarsi di Preti da polemiche culturali consumer-oriented.
Quanto, infine, alla sua vituperata presa di distanza dall’impegno politico diretto, le sue parole furono
viste come qualcosa di ancor peggio che un orgoglioso diniego. Erano tradimento del gramsciano pessimismo della ragione, ottimismo della volontà e finivano per dare l’idea che la res publica non potesse
avere un futuro, se non ovviamente quello adatto al pesce più grosso nella famosa vignetta di Bob
Mankoff (New York Times, 1981).
13
Nella stessa lettera diventa chiaro il rifiuto di voler entrare nel salotto buono della cultura milanese. Particolarmente significativa è poi la risposta che Preti dà allo stesso Banfi quando questi gli chiede se sono ancora “compagni di
strada”.
14 Sono venuto a conoscenza della lettera del 20 luglio 1950 quando già stavo lavorando a “costruire tecnicamente” la
parte semantica di quel che a Preti sarebbe stato necessario.
17
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Dunque, Preti... orgoglioso pessimista. E dal suo punto di vista? Anche se dell’idea che qualunque
suo intervento sull’attualità avrebbe avuto “l’amaro sapore di utopia e di dissertazione accademica”, Preti
sentì il bisogno di metter da parte l’amaro in una serie di minima moralia, complementari agli sforzi che
dedicò alla divulgazione, perché gli uni e gli altri animati da una forte passione civile. Semmai, più volte
si servì di canali a limitata diffusione, diminuendo così la potenziale risonanza delle sue idee. Per fare due
esempi, penso alla sua Breve storia del pensiero scientifico uscita a puntate sul «Calendario del Popolo» e
penso alla rivista cui dette vita un gruppo di intellettuali fiorentini che si proponevano nientemeno che di
sviluppare le idee di Preti: una rivista che, guarda caso, si chiamava Quartiere!
Al di là di tutte le ragioni contingenti che vogliamo, è sinistramente emblematico che un filosofo
come Preti non abbia vinto una cattedra di Teoretica bensì di Storia. La vinse nel 1954, mentre nel concorso di Teoretica svoltosi nello stesso anno Preti fu bocciato. Uno dei commissari gli rinfacciò il carattere dogmatico della sua posizione anti-metafisica 15 ed evidentemente fece pesare questo giudizio negativo
in sede di comparazione fra i candidati.
4. Compagni di quale strada?
Nel 1946 escono su Studi filosofici sia l’articolo “I limiti del neopositivismo” a firma di Preti sia
l’articolo “Il pensiero di Kant alla luce della critica neo-empiristica” a firma di Geymonat. In questi due
articoli si manifesta la divergenza tra la linea di Preti e quella di Geymonat, divergenza che non verrà meno in seguito anche se, sfortunatamente, mancheranno occasioni di altrettanto diretto confronto.
È significativo che la divergenza riguardi il pensiero kantiano. Anzi, la vicenda è perfino curiosa.
Preti l’idealpositivista difendeva Kant mentre iniziava un percorso che l’avrebbe portato ad ampliare, in
chiave materialistico-storica, quella stessa prospettiva neoempiristica i cui padri si era prefissati di confutare Kant! Geymonat il neorazionalista attaccava Kant muovendo obiezioni ispirate al convenzionalismo
15 Come riportato da Fabio Minazzi a p. 41 di Giulio Preti: Bibliografia (Franco Angeli, Milano 1984).
18
Alberto Peruzzi – 2012
degli stessi neoempiristi mentre preparava una conciliazione, che ben poco aveva di convenzionalistico,
tra realismo e storicità della scienza! Ancora una volta la realtà superava l’immaginazione.
Benché entrambi sentissero il bisogno di integrare l’impostazione analitica e metodologica della
filosofia della scienza con la dimensione storico-sociale che la dottrina marxista metteva in primo piano,
il focus del discorso pretiano e quello del discorso geymonatiano erano diversi e diverse erano le domande che Preti e Gymonat giudicavano prioritarie. Preti voleva cambiare la filosofia facendola aderire meglio al discorso scientifico in modo da liberarla dalla propensione speculativa ancora presente nel razionalismo critico di Banfi. Geymonat aveva un problema inverso: integrare la lezione neoempiristica nel
quadro materialistico-dialettico, che non aveva alcun bisogno di essere cambiato. Non è casuale che in
seguito Preti si volgerà al recupero del pensiero del giovane Marx, Geymonat al recupero di Engels. Due
recuperi divergenti, eppure pensati entrambi come sviluppo di quella filosofia della scienza cui tanto
Preti quanto Geymonat si richiamavano – i cui padri fondatori avrebbero storto la bocca all’idea tanto
dell’uno quanto dell’altro sviluppo.
Preti e Geymonat si richiamavano entrambi allo spirito di una rigorosa wissenschaftliche Weltauffasung e poi entrambi si vedevano costretti ad ampliare l’orizzonte neoempiristico pur di far posto ad altro.
Chi di sicuro non avvertiva il problema era Banfi, il quale, schiacciato dal peso delle responsabilità politiche, avrebbe finito per optare, nel nome del Popolo, per una palingenesi umanitaria, pentendosi della sua
precedente hybris panottica.
Il Marx cui Preti rivolge la sua attenzione a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta è, più
che ideologo e più che scienziato sociale, il filosofo che aveva additato la possibilità di trasformare il logos in praxis coniugando umanismo ed empirismo. Questa lettura, unita al richiamo alle sensate esperienze, impediva una deriva diamattiana come quella di Geymonat, e, con la rinuncia a mettere tutta l’automobile nel carburatore (l’etica nella politica), evitava una curvatura strumentale dell’ideale politico,
come quella cui si prestava l’uomo banfo.
5. Natura e storia
Nel 1948 Preti torna sulla polarità natura-storia che aveva considerato in Fenomenologia del valore.
Ora si tratta di combinare il feuerbachiano rimando alla materialità dell’uomo con l’autopoiesi cantata da
Vico e Marx. Anche in questa nuova forma, la questione non è risolta, Preti limitandosi a delineare una
cornice generale in cui poi procedere alla vera e propria soluzione.
Solo una scelta tattica? Temo che la posticipazione non si possa giustificare in termini di un piano.
Non c’era modo di venire a capo della questione, così come impostata da Preti, e per una ragione semplice: più l’uomo che si ha in mente è l’individuo “in carne e ossa e sangue”, meno univoco è il nesso tra
19
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
l’uomo e il farsi che passa per sistemi di regole, codici, convenzioni sociali – tutte cose costrittive della
“carne”. Più l’uomo è genere storico, meno è genere naturale (“organismo vivente”). A un estremo troviamo una polarità rotta (vedi Rousseau), all’altro estremo una forma d’emanazione neoplatonica, della
quale la dialettica tra poli opposti è schiuma superficiale. Meno si accetta il determinismo in ambito storico-sociale, più l’idea del materialismo storico si mostra bisognosa di chiarimenti e “revisioni”.
Non l’avesse mai detto! Marx si lasciava forse riassorbire in Feuerbach? In tal caso, tra l’altro, diventava ancor più difficile capire l’oggettività autonoma delle strutture economico-politiche, e autonoma
perché irriducibile all’uomo “in carne e ossa e sangue”. Una polarità irrisolta, d’altra parte, non è degna
d’elogio alcuno, perché lascia inspiegato come facciano i due poli a star insieme, quindi la questione non
poteva chiudersi qui, perché in tal caso sarebbe stato proprio lui, Preti, a cadere nel difetto che imputava
a Banfi: un oscillamento non-mediato fra un astratto razionalismo, benché “critico” e dinamico, e un
tuffo “nel gran mare della vita”.
La polarità non può, dunque, esser presa così com’è, ma Preti non ne viene a capo. Troppe erano le
cose da chiarire. La stessa nozione di praxis cui fa riferimento è tanto fascinosa quanto ambivalente,
troppo carica della volontà, da parte sua, di servirsene come panacea per sanare esigenze opposte. Così,
la cornice appena delineata finiva per rivelarsi più banfiana del previsto e più banfiana di quanto Preti
avrebbe mai ammesso.
La nozione di praxis si avviava a diventare un sorta di tredicesima categoria, con la quale uscire
dall’isolamento dell’individuo kierkegaardiano attraverso la dimensione del lavoro e della produzione; e
già in questa fase germinale si annunciava l’ambivalenza della nozione, perché in nome della praxis, per
limitarsi al piano economico, è possibile conseguire emancipazione dal bisogno quanto ulteriore alienazione. L’idea di un “umanismo concreto” che Preti propone l’anno dopo16 esprime soltanto una scelta fra
le due possibilità, ed è sicuramente fascinosa, ma niente più che una dichiarazione d’intenti. Invece di
lasciarci rapire dal fascino dell’idea, faremmo meglio a riconoscere che era un’etichetta, un post-it su un
groviglio di problemi. Preti si vide costretto a scioglierlo nel decennio successivo e il risultato dei suoi
sforzi fu un po’ più complicato di quanto gli avrebbe fatto gioco pensare nel 1948.
6. Antialienanti e immanenza
L’essenza negativa dell’alienazione è stato uno degli assiomi più ricorrenti nei discorsi di chi teorizzava la relatività di tutto, scienza inclusa, al contesto storico-sociale. L’alienazione è stata comunque
un tema su cui i filosofi della generazione di Preti difficilmente potevano esimersi dall’intervenire. Per
Preti, il rimedio all’alienazione consisterebbe nel rafforzare l’autodeterminazione, a partire dal recupero
16 Nell’articolo “Libertà e responsabilità”, Studi filosofici, 3, 1949.
20
Alberto Peruzzi – 2012
di senso che si ottiene risalendo al “momento” della contrattazione delle regole, analogamente a come
per Husserl si trattava di recuperare il senso delle costruzioni che stanno a fondamento delle scienze
europee in crisi risalendo all’originaria Sinngebung, diventandone nuovamente coscienti e riumanizzando così l’impresa scientifica. Questo rimedio voleva anche dire “rivoluzione permanente”, cui associare
il progressivo eticizzarsi della natura. Tradotto in volgare: più coscienza, più responsabilità; più responsabilità, più libertà.
Come non approvare? Onestamente, però, un simile rimedio si prestava a più di un’obiezione. Ne
basti indicare un paio. Una prima obiezione è che il rimedio aveva un tono più kantiano che marxiano e,
se Preti voleva davvero innestarlo su uno sfondo marxista, aveva di che rimboccarsi le maniche. Il tentativo di fondare il materialismo storico su assunti etici essendo antimarxiano, nel migliore dei casi si poteva
pensare a una convergenza storico-fattuale (più o meno provvidenziale, ma non è questo il punto). Ora,
di assunti etici in Marx ce ne sono eccome, abilmente travestiti da descrizioni fattuali e inseriti di soppiatto nella ricostruzione di cause ed effetti. Ma se tali assunti fossero mai stati sufficienti a fondare il materialismo storico, Marx non sarebbe stato Marx e i marxisti, alla fine, avrebbero dovuto scoprire, con stupore, di essere antimarxisti.
Era più che legittimo richiamarsi a Marx come campione d’empirismo: bisognava infatti rimettere
in piedi la dialettica invece che farla poggiare sulla testa. Era più che legittimo vedere in Marx il campione
di coloro che hanno fiducia nella ragione quale motore del progresso civile. Era più che legittimo ricordare che per Marx la ragione è capace di retroagire sulla praxis da cui sorge, modificandola. Sì, ma né
allora né oggi si può pensare che in queste tre cose consista l’originalità della lezione marxiana: non c’era
affatto bisogno di Marx per apprezzare empirismo, fiducia nella ragione e feedback teorico-pratico –
tutte conquiste che, come minimo, risalgono all’illuminismo. Per di più, l’impianto dialettico non poteva
andar d’accordo con quella componente germinale dell’empirismo moderno che aveva accompagnato nel
Medioevo le argomentazioni dei nominalisti e ora riviveva in quelle di Preti: ovvero, la critica al sostanzialismo in tutte le sue forme. Il connubio cercato da Preti, anche se fosse stato meglio individuato e rifinito,
non poteva durare a lungo. E non durò. I compromessi costati tanta fatica cominciano a venire al pettine
dopo Praxis ed empirismo.
Una seconda obiezione, sempre per fare l’avvocato del diavolo, riguarda il fatto che le “ragioni di
politica contingente” invocate da Preti per spiegare l’ostilità reciproca fra marxisti europei e pragmatisti
americani (leggi: Dewey) si potevano anche far pesare in tutt’altro modo. Vale a dire, si poteva minimizzare la distanza tra la praxis come intesa dai comunisti italiani e la praxis funzionale al capitalismo. E poi
perché il comun denominatore trovato tra marxisti e pragmatisti doveva essere minimo invece che massimo? E “minimo” in effetti risultava se costituito dall’idea della conoscenza come motore d’interventi
pratici e da un comportamentismo dilatato e depurato, cioè, non più relegato alla sfera individuale e non
più associato a meccanismi di selezione programmata dei bravi cittadini (via condizionamento operante).
21
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Dietro all’idea del connubio c’era attenzione alle nuove frontiere apertesi alle scienze umane e così
come una lettura antimetafisica di tali frontiere. Se vogliamo additare una linea caratteristica su cui gli
illuministi potevano andar d’accordo a dispetto delle divergenze su tanti punti specifici, era proprio questa. Ma appunto, gli illuministi c’erano arrivati un po’ prima di Marx.
In mano a Preti l’empirismo andava storicizzandosi (o meglio, andava storicizzato) secondo modalità più ambiziose di quelle raccomandate da Dewey, perché il privilegio che questi aveva accordato al momento psico-pedagogico rischiava, secondo Preti, di restar confinato a una dimensione pre-sociale, con il
pericolo di ridurre tutte quante le leggi dello “spirito” a leggi psicologiche, ovvero l’oggettivo al soggettivo.
Preti limava e rilimava idee senza mai omettere i nomi di chi ne aveva il copyright e senza per questo
rinunciare a una teoresi distinta dalla storia di se stessa, e allora poteva fare anche un passo in più: invece
di preoccuparsi tanto di dare a Cesare quel che è di Cesare (per ciascuno dei Cesari cui di volta in volta si
richiama), avrebbe potuto insistere di più su quel che di nuovo proponeva – in questo caso, rispetto a
illuministi, Marx e Dewey. Lo fece poche volte e in forme comunque troppo raffinate per dar luogo a
etichette rampanti.
C’è anche da dire che il momento non era propizio. Perché il neo-illuminismo italiano potesse decollare, non avrebbe dovuto esserci la cappa imposta dalla divisione del mondo in due blocchi anche sul
piano intellettuale. In un clima meno fazioso, e con meno spocchia da parte di scriveva in inglese o francese o tedesco, il neo-illuminismo italiano poteva essere un movimento filosofico di rilievo internazionale, invece che fronda in una provincia dell’impero. Per decollare, però, in Italia c’era bisogno di meno
esterofilìa, di un po’ di battage mediatico, ma anche di qualche ritocco.
Infatti, uno storicismo illuministico, se non è un ossimoro, è non meno panlogistico dell’idealismo
hegeliano, un albero che di frutti illuminati non mi risulta che ne abbia dati molti. La ragione che si cala
nell’attività scientifica è sperimentale e l’atteggiamento sperimentale mal si concilia con la certezza di
avere già in tasca le leggi dello Spirito Dialettico. Dunque bisognava lavorarci sopra. Non che Preti non si
sia impegnato in questo lavoro. Gli mancò piuttosto la convinzione che quanto via via stava mettendo
insieme avesse un rilievo per il dibattito filosofico in corso fuori dai patrii confini – e se c’era un posto in
cui questo rilievo poteva esser pienamente riconosciuto non era all’interno di essi. La situazione era
dunque, ‘pragmaticamente’, paradossale.
Sullo sfondo delle esitazioni di Preti restavano problemi irrisolti e uno di essi era proprio il problema di come conciliare natura e storia. Più specificamente: com’è che si concilia il richiamo a quella che
oggi indicheremmo come “corporeità” con il richiamo alla “autonomia” della ragione che si esprime sul
22
Alberto Peruzzi – 2012
piano della socialità, anche una volta rilegittimata da un sistematica cosciente Sinngebung? Lecis17 ha
colto in questa fase del pensiero di Preti un ritorno a Hegel, o meglio: allo Hegel assertore del farsi dell’uomo nella storia. Se anche tale lettura è giusta, non toglie una sola castagna dal fuoco – il problema
resta tale e quale, cioè, irrisolto. Del resto, nessun rimando a fonti storiche ha mai risolto un solo problema filosofico; e poiché a Preti l’idea dei “problemi eterni” della filosofia non piaceva molto, non gli
doveva sicuramente far piacere accorgersi di star presentando una dichiarazione d’intenti come soluzione.
La questione era ed è se, quanto e come la storia (culturale) può modificare la natura umana. La può
modificare con la stessa facilità con cui di fatto modifica gli stili di comportamento, la lunghezza delle
gonne, il taglio dei capelli, gli intercalari, ecc.? In tal caso la “carne” è hyle plasmabile a piacere dal demiurgo (la storia) e, se questi la plasma in un modo in cui alcuni, vedi la classe operaia, ci rimettono, tanto peggio per loro – avrebbe detto Hegel – dato che il reale è comunque razionale. Tante grazie, Preti
non voleva dire questo. Consideriamo allora l’altra opzione: la storia può modificare la natura umana ma
non sotto ogni rispetto. In tal caso, l’autonomia della ragione non è coestensiva con la convenzionalità
statu nascenti, come invece Preti voleva credere.
Ecco una riformulazione meta-riflessiva del problema lasciato irrisolto: fino a che punto i nostri
stessi criteri di valutazione – circa correttezza dei ragionamenti, attendibilità delle prove empiriche e
“asseribilità garantita” – sono frutto dell’evoluzione culturale? Se ammettiamo che ne dipendono per
intero e ammettiamo che una diversa evoluzione era, è e sarà possibile, non si capisce più quale residua
oggettività possiamo attribuire a questi, se non la mera, ballerina, corrispondenza con usi e costumi di
volta in volta vigenti de facto nella propria tribù. Se invece non ne dipendono per intero, allora sì che
c’era da lavorare.
Curiosamente, questa stessa difficoltà ha un bonus: aiuta a capire l’impegno poi messo da Preti
nell’analisi dell’oggettività del valore. Giusto o sbagliato che sia il modo in cui Preti s’impegna, almeno
non ci lascia lì dove eravamo e, se anche il problema continua a restare irrisolto, almeno subisce uno
“slittamento progressivo” (per dirla con Lakatos), che non mi sembra sia stato elaborato quanto meritava, nei dettagli, da chi è venuto dopo.
Oggi nessuno, neppure i filosofi in minigonna mediatica, affronta il problema nature-nurture senza
far riferimento a dati tratti dalla ricerca in biologia, etologia comparata, antropologia, psicologia cognitiva, neuroscienze. Talvolta si sfruttano anche lemmi su deficit linguistici e pattern sociobiologici. In confronto al quadro di conoscenze che Preti aveva davanti a sé, i passi in avanti sono stati molti e molto importanti. Eppure, continuano ugualmente le polemiche su come polarizzare il grigio tessuto di natura e
cultura. Non è ancora chiaro quale sia la trama di fili dell’oggettività naturale e quale sia l’ordito di fili
17 Op. cit., pp. 223-225.
23
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
dell’oggettività storico-culturale – per tacere che quella che chiamiamo “oggettività” potrebbe anche
stare in qualcosa che appartiene al prodotto e non ai fattori. Evidentemente, molto resta da capire, ma
siccome sentiamo un impellente bisogno di prender posizione, in genere i filosofi puntano sulla trama o
sull’ordito a seconda di quel che di volta in volta conviene. Che importa se i diritti degli animali non vanno automaticamente d’accordo con i diritti umani? Che importa se i dilemmi della bioetica riproducono
antiche questioni morali facendole passare per novità assolute? Ci sono sempre filosofi pronti ad assecondare il gioco delle parti e poi ci sono anche quelli che si riempiono la bocca dicendo che la polarizzazione è impossibile e così passano da saggi anche se non hanno la minima idea di cosa tiene insieme il
tessuto – né si preoccupano di capirlo.
Preti non aveva di fronte l’attuale quadro di conoscenze e l’impresa che prospettava non era riuscita
a nessuno. Dico l’impresa di fare dello storicismo un nuovo umanesimo “concreto”, dunque empiristicamente legittimo, improntato alla scienza, o meglio: alle scienze naturali. Dewey ci aveva almeno provato e Preti respingeva il veto imposto dal Migliore all’importazione di merci a stelle e strisce. Nei termini
che poi saranno di Hacking ma che i marxisti nostrani non avrebbero osato impiegare, l’intervenire
scientifico, che è sperimentale e dunque è più che un rappresentare/rispecchiare, diventa il pernio dell’attiva trasformazione di se stesso da parte dell’uomo; ed è una trasformazione che l’uomo compie, nel
tempo, in quanto partecipe di una comunità razionale che non si lascia confondere con nessuna comunità
storico-fattuale. Naturalmente si osava dirlo con un auspicio: che dall’educazione all’atteggiamento
scientifico potesse scaturire una società ‘migliore’. E quest’auspicio sottintendeva un giudizio di valore,
il cui status per il momento non era esaminato.
In realtà, la questione di fondo era tanto chiara quanto antipatica: nel processo di auto-trasformazione è la Ragione che si dispiega storicamente o è la Storia che trasforma una Ragione1 in un’altra Ragione2 e così via, cambiando dunque i modelli stessi di razionalità? Preti vuole offrire due sì, cioè, vuole
capra e cavoli. Di nuovo, come dargli torto? Di nuovo, cerchiamo di essere onesti. Possiamo intonare
tutti i peana che vogliamo a un movimento a spirale del suo pensiero che si manifesta diversamente in
relazione a temi diversi, ma non possiamo pensare che questo risolva la questione, perché non è possibile
avere capra e cavoli. Perciò occorreva chiarire l’alternativa per poi valutare se tale chiarimento è d’aiuto o
no (a Preti e a noi).
Sto dimenticando che quest’impegno fu già di Preti? Sto dimenticando che fin dall’inizio si sforzò
di raccordare la pura ragione con lo spirito oggettivo, la spinta al progresso sorretta da ideali morali con
quell’eticità che compensa il carattere unilaterale delle prospettive individuali, per giungere infine ai
legami di ogni assetto comunitario con le sue sorgenti naturali, che sono concreta vita vissuta, esistenza,
corporeità? Non l’ho dimenticato. La questione è se, oltre che sorgente, tale piano è anche fonte di vincoli e, se sì, di quali. Poiché c’è ethos e ethos, l’appello alla storicità non è sufficiente. L’uomo che fa se
stesso è colui che si dà tanto le regole della logica quanto le superstizioni, si dà ciclicamente tolleranza e
24
Alberto Peruzzi – 2012
dogmatismo, si dà dottrine salvifiche e rassegnata ironia, eccetera, a meno che diciamo che “uomo” è chi
fa una di queste scelte e non l’altra, in tal caso autorizzando a trattare chi ha fatto la scelta diversa come
un Untermensch, su basi hegeliane invece che hitleriane.
Preti prende posizione a sostegno dell’ethos scientifico. Ma lo fa in un modo un po’ diverso dai
positivisti (vecchi e nuovi). Invece di contrapporre l’oggettività del sapere a quella dei valori, argomenta
la presa di posizione collocandola in una cornice assiologica ove il sapere è un valore che si colloca accanto ad altri e la sua importanza sul piano etico sta nell’apporto che dà alla formazione di cittadini effettivamente partecipi e responsabili, perché il processo deliberativo che ha luogo nella scienza possiede caratteri che ne fanno un modello anche quando si tratta di prendere decisioni su argomenti che scientifici
non sono. In questo, a mio parere, l’impresa di Preti rappresenta uno dei momenti più alti della filosofia
del Novecento.
Ripeto: le difficoltà cui quest’impresa va incontro hanno un merito, ovvero, fanno venire allo scoperto problemi che in altri filosofi restano nascosti, aggirati, liquidati con disinvoltura quando non semplicemente ignorati. In genere succede infatti che, a parte la messinscena erudita, ci si limiti a esclamare
o che la scienza è buona o che la scienza è cattiva, adducendo a sostegno effetti ovviamente opposti.
Qualche volta si arriva a dire che la scienza non è né buona né cattiva e che il buono e il cattivo dipendono
dall’uso che ne facciamo. È già qualcosa, ma se siamo ancora a discutere di questo o se ci fermiamo qui,
vuol dire che siamo ancora all’asilo. Per Preti, il punto era un altro e (almeno a mio giudizio) era ben più
interessante: si trattava di capire se nell’atteggiamento scientifico, e nella sua praxis, c’è o no qualcosa di
buono indipendentemente dagli effetti che in ciascun dato momento sono in actu in questa o quella pratica applicazione delle scoperte scientifiche.
Il motore avviato con l’apprezzamento della cultura scientifica riesce però a raggiungere i pieni
giri? Non mi sembra. Gli argomenti messi in campo da Preti hanno un vantaggio immediato, quello di
evitare le più diverse ipostatizzazioni (che riguardano la Società, la Scienza, lo Spirito, la Vita), non quello di preparare una sistemazione teoretica compiuta, in cui le diverse istanze alle quali Preti era sensibile
– pragmatiche, storiche, trascendentali – trovino organica unificazione. Ognuna di esse agisce piuttosto
come controllo sulle altre, punto. E nell’impresa di Preti, questa è la cosa più pretiana che ci sia. L’impresario non viene sospinto dall’idea del mutuo controllo dei valori a cercare un insieme di principi che
regolino lo stesso mutuo controllo ancorandolo al piano naturale.
All’orizzonte non si profila alcuna teoria. Per prudenza, dovuta all’esser come pochi consapevole di
quanto sia ardua una teoria del mutuo controllo fra valori, ma ancor più per il fatto che l’impresario giudica l’idea stessa di una filosofia sistematica come appartenente al passato – a un passato da non ripetere.
Ciò che si profila è piuttosto una strategia ricorsiva di equilibrazione, fra istanze esigenze valori in tensione, una strategia che di volta in volta acquista caratteri nuovi e si concreta in una serie di avvertenze e
25
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
niente più. A volere di più, evidentemente, si finisce nella metafisica, si ricade in un sistema o un altro. Il
passato insegna pur qualcosa, no? Dunque, quella che Preti coltiva è una filosofia portatile, elastica, parametrica (anche se per arrivarci c’è voluta una ponderosa conoscenza della filosofia recente e meno recente). Non plus ultra.
Plus ultra o Non plus ultra? Confesso di trovarmi in una situazione aporetica, perché continuo ad
aspettarmi di più dalla filosofia e continuo a pensare che non ci si dovrebbe aspettare di più. Quando
infatti si cerca di giustificare questo di più, si fanno pastrocchi. I pastrocchi degli altri, sfortunatamente,
si vedono meglio dei propri e così le ulteriori aspettative sono foriere di sventura. Insomma, non riesco a
mettere a tacere il bisogno di qualcosa di più che una strategia equilibratrice, di volta in volta calata nelle
specifiche contingenze, e nello stesso tempo capisco che quelle che a me appaiono lacune o mancati sviluppi sono per Preti un sovrappiù che deve mancare. Quindi, in certo senso, il problema è mio, non di
Preti. È colpa mia se non so trarre la dovuta lezione. Nessuno può pensare di determinare una volta per
tutte l’architettura di tutti i piani di discorso e di tutti i valori che convivono in una data, effettiva, realtà
culturale e, in fondo, anche in noi stessi. Perciò è colpa mia se non riesco a vincere l’aspettativa di qualcosa di più. Volendo esser generosi, si potrebbe dire che è un’aporia pragmatica, non teoretica, e ridurre
così il contrasto fra Plus ultra e Non plus ultra.
Invece non sono tanto convinto che sia solo un’aporia pragmatica e neppure che sia un’aporia
stampata solo sulla mia fronte. Qualunque progetto di ricerca, non importa in quale ambito (ma di sicuro
anche in filosofia), comporta delle decisioni (di metodo, di modellizzazione ecc.). Chi non prende una
decisione non può sottrarsi alla responsabilità di non averla presa, esattamente come non può sottrarsi
chi la prende. Ora, le decisioni dei filosofi (qua filosofi) sono sul piano della teoresi. In nome di un sublime equilibrio meta-teoretico, è comprensibile che, da parte dei filosofi che vogliono vedere le cose in
un quadro metaculturale il più possibile non di parte, ci sia una giustificata titubanza a lasciarsi trascinare
alla tenzone tra opposte idee scientifiche, estetiche, politiche ..., ma neanche i filosofi possono rinunciare a prendere decisioni. Saranno decisioni meta- e in primo luogo meta-linguistiche, e tuttavia, se non
avessero avuto ricadute sul linguaggio-oggetto e, per suo tramite, su ciò cui ci riferiamo parlando nel
linguaggio-oggetto, la filosofia sarebbe diventata un orpello. (Se spesso lo è, qualche volta non lo è.)
Questo, Preti lo capiva bene e, per parte mia, capisco bene che non è per evitare il peso della responsabilità che si rinuncia al “sovrappiù”.
Il punto è che anche la tesi della strategia equilibratrice finisce per avere ricadute sul piano teoretico e pratico e allora il risultato è non meno aporetico: siccome una vista dall’alto dovrebbe ospitare anche
le ragioni delle decisioni altrui e le rispettive responsabilità, il compito dell’ospitalità a un certo punto
deve arrestarsi, perché il peso diventerebbe paralizzante, e non direi che è una buona cosa chiamare la
paralisi “equilibrio” e nobilitare la china percorsa per arrivarci con il termine “strategia”. Se il compito si
arresta, la strategia non è più equilibratrice; se non si arresta, l’equilibrio diventa paralisi.
26
Alberto Peruzzi – 2012
Non voglio insisterci oltre. Preferisco notare che l’equilibrio cercato tra le diverse esigenze (e filosofie) della ragione, così come il fatto che si possano e si debbano apprezzare per il mutuo controllo che
esercitano le une sulle altre, induce Preti a tenere un basso profilo. Certo, ha disposto le diverse esigenze
in orizzontale, su un piano di democrazia assiologica, l’una esigenza accanto all’altra invece che in un
ordine gerarchico, e non ha mancato di cogliere in ciascuna l’aspirazione a essere globale; ma nello stesso suo discorso ci sono indicazioni in contrario. Il nostro andirivieni fra linguaggio e metalinguaggio è
ortogonale al piano in cui le diverse esigenze coesistono; e le nostre scelte, con la sottesa gerarchizzazione di valori, operano sempre su scala locale. Ma dire che hanno solo delle motivazioni pragmatiche è dire
Hic sunt leones – e in bocca a un filosofo-della-praxis la cosa sarebbe quanto meno curiosa.
Insomma: pur di uscire dall’eterno accapigliarsi dei filosofi non è detto che l’unica opzione sia
quella di delegare la responsabilità teoretica a una cangiante serie di ruoli. Con tale delega il basso profilo che accompagna il mutuo controllo tra le esigenze diventa troppo basso e la strategia scivola nella paralisi. È un po’ quello che succede in un dialogo tra due agenti reciprocamente insoddisfatti (l’uno del
comportamento dell’altro), quando ognuno dei due (a turno) si lamenta con l’altro: io so che la tua decisione di agire così è dipesa dalle intenzioni che mi attribuivi ma in realtà le mie intenzioni dipendevano
dalla decisione che mi aspettavo tu avresti preso. Non c’è equilibrazione in grado di toglierci da una situazione del genere. Se questo è il massimo cui la filosofia conduce, possiamo anche farne a meno. Quale
premessa rivedere?
Quella di Preti è una ragione essenzialmente aperta che vorrebbe anche essere selettiva: non lascia
spazio all’irrazionale, così come non lo lascia al Sistema.18 Un’apertura che sia così selettiva esclude deleghe a terzi (praxis, vita o altro). Dentro o fuori di noi, di GPS che forniscano il migliore percorso non ce
ne sono.19 Ma una selezione che non sia assorbita dallo specifico contesto culturale in cui si inserisce, in
un certo posto e in un certo tempo, dovrebbe pur sempre essere suffragata da argomenti. E siccome non
possono essere esclusivamente argomenti contestuali, devono essere anche trans-contestuali e, in linea
di principio, di portata universale. Per non essere vuoti, tali argomenti avranno bisogno di essere ricalibrati di volta in volta, giocando un argomento contro l’altro. Questa è appunto la lezione pretiana. Il suo
è un razionalismo minimale perché parametrico: è la democrazia della ragione contro la teocrazia dei
Sistemi. Ma anche per lui c’è un vincolo in virtù del quale il gioco non è così libero come doveva essere: la
gamma dei parametri non è convenzionale e per le ragioni già viste, se corrisponde a un nocciolo vitalistico com’è quello dell’uomo “in carne e ossa e sangue”, non può essere convenzionale. Ecco l’aporia
pragmatica, non mia ma di Preti: invece di vedere il vincolo come una restrizione capace di indirizzare a
una nuova philosophia naturalis, lo apprezza perché è generoso (fa posto a tutto uno sciame di forme
18
Dal punto di vista interno al Sistema, quel che non ci rientra è irrazionale; dall’esterno, l’irrazionale è più che razionale. I filosofi che si rispettino stanno a cavallo del bordo fra dentro e fuori e quindi ...? (Esercizio.)
19 Intendo General Problem Solver nel senso di Simon, Shaw e Newell.
27
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
culturali), dunque ancora una volta quel che a me sembra una lacuna era per lui un pregio, in quanto
garanzia di flessibilità, indispensabile all’impiego non dogmatico degli strumenti di un onesto filosofare.
Il modo in cui Preti presta ascolto alle molteplici dimensioni della vita è esemplare per lucidità e ampiezza, e tuttavia la composizione delle dimensioni resta fuori dal quadro offerto. La filosofia che sempre di
nuovo slitta di piano non è philosophia naturalis.
Se mai c’è stata “pigrizia”, è da cercarsi qui. Altrimenti possiamo scorgervi un meraviglioso elogio
dell’ozio. Dette le ragioni del Plus ultra e del Non plus ultra, il discorso dovrebbe chiudersi qui. In realtà, non si chiude perché in gioco c’è anche una questione di coerenza. Più d’una volta ho lasciato trapelare una ‘sensazione’: che Preti non sia rimasto sempre coerente, non soltanto con quel che prima aveva
scritto ma anche con i suoi stessi standard. L’ho sussurrato a malincuore, cercando di far leva sui punti
forti del suo filosofare piuttosto che su tesi e argomentazioni problematiche. Per esempio, sarebbe stato
agevole far riferimento alla dicotomia20 fra pensiero scientifico e scienza, ove il primo, in quanto processo elaborativo, avrebbe una storia, a differenza della seconda in quanto corpus di conoscenze conseguite
– quando c’è anche un Preti disposto ad ammettere che gli stessi criteri di prova hanno una loro dinamica
nello sviluppo delle teorie scientifiche. Ho parlato di tesi “problematiche”, non di tesi “indifendibili”.
Nel caso specifico, chiunque si dedichi a ricerche di storia del pensiero scientifico o della scienza si serve
di una ragione che si suppone possa permettersi uno sguardo sulla dinamica di questi criteri e, di fatto, si
affida pur sempre a uno specifico set di criteri, ovvero, quelli che definiscono il rigore del lavoro storiografico (il fatto che tali criteri cambino e diventino a loro volta oggetto di riflessione critica non sposta di
un millimetro la questione). Preti non avrebbe detto che quanto si suppone è un lusso eccessivo; avrebbe
detto, con tocco hegelo-kantiano, che nel pensare-la-storia-del-pensiero c’è una salutare tensione fra
forme concrete del sapere e ideale scientificità.
Ma se c’è un’universalità sottesa ai pattern del sapere, ai (col lessico di poi) “paradigmi” e agli “stili
di pensiero”, da dove spunta fuori? La possibilità di trascendere l’assetto delle conoscenze via via raggiunto in qualsiasi dato campo non piove dal cielo e non per questo diventa un semplice fatto tra altri
fatti. Il carattere immanente della trascendenza non è semplicemente un fatto tra altri. Preti non era forse
partito dal Principio d’Immanenza? Qui è la voce di Husserl a ricordarci che, solo se ci impegniamo a
individuare le radici dell’universalità, possiamo sperare di sviluppare una visione integralmente “immanente” della conoscenza umana.
Per me (reo confesso di aporia), la ricerca di tali radici conduce ad adottare non un “punto di vista
empiristico”, bensì un punto di vista naturalistico, anche se non devo sforzarmi molto a presumere che
Preti avrebbe avuto riserve sul termine e, temo, anche sul progetto correlato, perché vi avrebbe scorto un
pericolo: il pericolo di sminuire l’autonomia delle Forme Categoriali dai Contenuti Vitali, sminuendo
20 Cfr. la Prefazione a Storia del pensiero scientifico.
28
Alberto Peruzzi – 2012
così la funzione guida, regolativa, che almeno certi concetti generali assumono. (Tutti sanno che le
“Idee” kantiane erano appunto caratterizzate da questa funzione.)
Un tale pericolo c’è, è vero, ma credo che correre un pericolo sia meglio che accettare la paralisi.
Individuato il pericolo, con un po’ d’attenzione possiamo evitarlo conservando un punto di vista naturalistico (che, dopotutto, è coerente con un’osservazione di Preti in Praxis ed empirismo, anche se è meno
generico rispetto alla descrizione che Preti ne dà). L’idea di fondo è duplice: 1) i gradi di libertà combinatoria dei pattern possono anche andare d’accordo con il carattere immanente della trascendenza che
compete ai valori/ideali (della scientificità e di altro ancora); 2) sia chi fa l’ipotesi che vadano d’accordo
sia chi la nega non fanno affermazioni confinabili all’attico, in ricorsiva ascesa, del filosofo “meta-”.
7. Effetti del progresso
A partire dalla rivoluzione scientifica del Seicento, il progresso delle conoscenze raggiunte in fisica, chimica, biologia, con le applicazioni che ne sono scaturite in campo medico, in campo ingegneristico, nel settore dei trasporti o in quello dei mezzi di comunicazione, ha trasformato le condizioni di vita
dell’uomo, con effetti che dall’Europa si sono poi diffusi fino a diventare planetari. Preti osserva che,
come conseguenza della trasformazione, “l’umanità è diversa”.21 In un certo senso è verissimo. Aggiungerei che, oltre all’ambiente sociale, è cambiato anche l’habitat naturale. D’accordo, foreste come quella
di Teutoburgo avevano cominciato a sparire già da tempo, ma l’impatto della meccanica e della chimica
dopo il Seicento è stato di ben altre proporzioni e molto più rapido. Di pari passo con quest’impatto, la
fiducia nelle potenzialità dell’homo sciens è cresciuta costantemente, almeno fino a Hiroshima e Nagasaki e, anche in seguito, in molti ambiti la fiducia è rimasta pressoché incontaminata. L’immagine che abbiamo del nostro stesso corpo è stata profondamente cambiata dalle conoscenze biomediche.
Preti non considera una prospettiva più radicale, inerente all’ipotesi che si verifichi una trasformazione di alcuni tratti della stessa natura umana. Per considerarla non c’era bisogno di aspettare la bio-ingegneria odierna, che ci mette di fronte a cambiamenti che Preti non era tenuto a immaginare. Eppure,
questa prospettiva più radicale non era esclusa dalle parole di Preti. Si ripropone allora un quesito: se con
il progresso scientifico l’umanità si trasforma fino al punto di modificare le risposte ai valori, entro quali
limiti la trasformazione è additabile come qualcosa di buono? (Ogni giudizio del genere, infatti, è dato in
base a una risposta che è, o non è, stata modificata anch’essa, con conseguenze diverse dall’un caso all’atro.) I cambiamenti ai quali allude Preti sono quelli che hanno a che fare con il modo di vita, la salute,
l’edilizia, i trasporti. Sono cambiamenti che non toccano il DNA della specie e che non prevedono im-
“Dewey e la filosofia della scienza” (1951), in Saggi filosofici, vol. I, La Nuova Italia, Firenze, 1973 (p. 82, corsivo
dell’autore).
21
29
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
pianti di tipo cyborg. E nel caso in cui si arrivasse a influenzare la nostra stessa risposta ai valori? La
valutazione dell’auto-determinarsi dell’umanità continuerebbe a essere la stessa, positiva se era positiva e
negativa se era negativa? I pareri sull’aggressività sono alquanto diversi se dati da una zebra o da un leone. E per uno zebrone o una leonebra? Una domanda come la precedente potrebbe anche non aver più
senso. Come ci insegnerebbe un redivivo Leibniz, l’egoismo e l’altruismo dei singoli sono, dal punto di
vista dell’ecosistema, chincaglieria.
Immagino la delusa replica di Preti: Carino, gli interrogativi che poni sono fasulli. Sai bene che rispondere è come sfogliare la margherita – mentre evidentemente crediamo di poter rispondere a interrogativi che si mantengano ben all’interno dell’orizzonte di cambiamenti assunto da Preti. Capaci di rispondere o no, è difficile accettare l’irrilevanza di simili interrogativi. Se tabù non sono e neppure sono
errori di grammatica filosofica, come affrontarli? Non basta certo elencare i cambiamenti avvenuti. A
essere in questione è la possibilità di un loro, ragionato, apprezzamento – e l’apprezzamento che ora
possiamo esprimere nei confronti della futura “diversità” non ha uno status diverso, perché nessun presente ha un privilegio su altri presenti. Se qualcuno pensa che ce l’abbia, fornisca un argomento.
Sembreranno giochetti da analisti del linguaggio, ma sotto c’è qualcosa di più: non ci sono, non ci
possono o non ci debbono essere, limiti all’auto-trasformazione? Se ci sono, che cos’è che ci preme di
più conservare degli esseri umani come sono ora? Dicendo no a ogni limite (e non mi riferisco solo a temi
d’interesse per l’odierna bio-etica), una volta diventati molto “diversi” come faremmo a esser sicuri di
(non) apprezzare la trasformazione come (non) l’apprezziamo prima che abbia avuto luogo? L’esercizio
empatico richiesto è proibitivo ma è anche moralmente proficuo. Chi invece ritiene che dei limiti ci siano
(ci possano, ci debbano essere) ha bel po’ di lavoro per argomentare quali e per indicare il motivo per cui
dovremmo volere che siano rispettati.
Queste non sono domande contro la scienza. È solo grazie al progresso scientifico che possiamo
cominciare a interrogarci con cognizione di causa sulla zona di confine tra evoluzione naturale ed evoluzione storico-culturale. Circa questa zona, sembra che il discorso di Preti escluda un confine netto tra
natura e cultura, ma più la zona è ampia, meno è chiaro quale tipo di criteri debbano prevalere nel giudicare come buona o cattiva (per l’umanità) una data auto-trasformazione. Ci sarà chi è propenso a dare un
valore positivo alla preservazione di un sistema di valori proprio di stadi precedenti nella storia dell’umanità, e ci sarà chi è propenso ad approvare la trasformazione della natura umana come radicale soluzione
di problemi che ci trasciniamo dietro da sempre e che ci fanno star male.
Nel momento in cui non fossimo più sensibili a un dilemma morale, le opzioni al riguardo, i relativi
errori e sensi di colpa, sparirebbero. NB: quando il dentista mi ha reso insensibile un dente pur di salvarlo, non ho eccepito, quindi non ho pregiudizi in merito e non li sfrutto come captatio benevolentiae.
Fuor di metafora, non sto suggerendo che un’insensibilità morale sia banalmente da disprezzare. Chiedo
30
Alberto Peruzzi – 2012
semplicemente: in base a quale argomento si può legittimare la preservazione o il cambiamento di una
qualche risposta ai valori?
Preti ci teneva alla lezione di Hegel. Ma era una lezione ambigua: si poteva sfruttarla in chiave
scientista così come in chiave antiscientista. Nell’insegnarci che “il reale è razionale” Hegel non si riferiva al futuro, altrimenti avrebbe detto che “il reale sarà razionale”. La nostra libertà può spingersi fino a
dire che, se ci sono limiti all’auto-trasformazione, possiamo decidere quali fissando dei postulati che
riteniamo utili in base alle previsioni che ora siamo in grado di fare? Va da sé che, se decidiamo, lo facciamo prima di esserci auto-trasformati e prima di aver verificato le previsioni.
Con questi interrogativi siamo già oltre la presa d’atto che “l’umanità è diversa”. Siamo anche oltre
l’automatica positività del cambiamento seguito alla rivoluzione scientifica. Nel 1951 è più che comprensibile che Preti non la facesse tanto complicata. Che si possa o non si possa rispondere agli interrogativi e
che si esca o no dall’idea che è cosa buona e giusta trasformarsi in base alla scienza, ci troviamo di fronte
a un conflitto di metavalori e per venirne a capo non c’è nessun oracolo da consultare. Vorremmo tanto
avere un oracolo, o una bussola bell’e confezionata, ma ci accorgiamo che quelle del passato non sono
più affidabili e allora ci viene il sospetto che il problema stia nel bisogno stesso di una tale bussola. Così,
avviamo una terapia d’urto, i cui motivi però costituiscono un’altra bussola ...
Finalmente rispondo alla delusa replica di Preti: non è che, siccome il nuovo scenario è spiacevole e
ci mette in un’altra situazione aporetica, siamo autorizzati a ignorarlo. Guardando le cose con l’occhio
del Divino dialettico, dovremmo guardare al conflitto come a qualcosa di positivo in vista della sua fecondità? O possiamo accontentarci di dire che simili interrogativi ci rendono più consapevoli e più responsabili? Ma che gusto c’è se l’incremento di consapevolezza e responsabilità ci lacera più di prima? Personalmente, non riesco a immedesimarmi in Machiavelli (come campione di cinismo) e nello stesso tempo
immedesimarmi in Brahma. L’esercizio poliempatico sarà anche salutare, ma sto peggio di prima quanto
ad argomenti. L’unico risultato è che sono indotto a gettare la spugna. Temo che il Preti di Retorica e
logica si avvicini a quest’esito perché si era posto domande analoghe, che hanno un analogo effetto lacerante, domande che ancora non si era posto nel 1951. Una volta poste, però, non possiamo recuperare la
verginità facendo come se nulla fosse. Neanche un occhio meno divino, quello del dialettico simmeliano,
che dà alla Vita quel che era dello Spirito, ci aiuta. Ne ricaviamo appena un post-it con su scritto <naturacultura>. Le raffinatezze filosofiche sono servite a poco: non abbiamo idea di come sia organizzata la
zona di confine e non sappiamo quali fatti e metodi d’indagine siano primari e quali secondari al fine di
capirci qualcosa. Non vorremo mica rimandare tutto ai posteri e farci pure bella figura! Morale: le parole
di Preti sull’umanità che è cambiata vanno benissimo, come va benissimo commentarle scrivendoci su
papiri come questo, ma teniamo a mente che si tratta di pensieri scambiati nella sala d’aspetto del dentista. Altrimenti, siamo solo degli ipocriti.
31
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
8. Convenzionalità
La prima grande novità del Preti ‘anni Cinquanta’ consiste nel collegare autodeterminazione e convenzionalità. In virtù di questo collegamento, il focus si sposta sul linguaggio. Il carattere istituito del
diritto così come di ogni altra forma in cui si manifesti lo “spirito oggettivo” conduce a riconoscere la
centralità delle “strutture logico-sintattiche del discorso”, non scritte nella natura ma libere creazioni,
analoghe a segnali stradali (con in più una sintassi).
Come dire che si è pronti a riconoscere la convenzionalità di qualunque sistema di regole, norme,
assiomi, leggi, principi, conservando come irrinunciabile il solo requisito della non-contraddittorietà. E
l’adeguatezza empirica? In un’ottica coerentistica si poteva anche pensare che fosse assorbita dal requisito logico. Preti segue e non segue questa pista. Per non complicarci la vita, supponiamo sia sempre stato
convinto che la coerenza non è sufficiente, perché ciò che voleva esportare dall’ambito logico-epistemologico alla tematica propria della “filosofia della cultura” non era soltanto la convenzionalità dei principi
e lo scrupolo per la coerenza; era anche la verificabilità del discorso mediante operazioni concrete, intesa
come qualcosa che non si ottiene semplicemente assemblando un insieme sempre più ampio di enunciati
e preoccupandosi che non ci siano contraddizioni – l’insieme più cresce e più è a rischio d’incoerenza.
Lato A: il requisito congiunto, ‘coerenza + controllo operativo’, è sottoscritto in alcuni lavori di Preti.
Lato B: il coerentismo è presente in altri lavori.
Negli anni Cinquanta, nuova è l’enfasi sulla convenzionalità e nuovo è l’uso che se ne vuol fare,
cioè, come antidoto all’ideologia. Altra grande novità: l’appello all’esperienza e i conseguenti verdetti
sono da vedersi nella loro storicità, adottando un punto di vista ispirato alla semiotica, perché la semiotica permetteva di trattare entro una stessa cornice i sistemi teorici presenti nelle scienze, i sistemi giuridici, le dottrine politiche, le teorie etiche, e così via.
Mettiamo insieme queste due novità. Risultato: la storia diventa una macchina che seleziona convenzioni. Ma siccome per Preti la storia è da vedersi come legittimo ambito scientifico, nel senso del materialismo storico, un problemino c’era. Infatti, la storia ospita e seleziona i passaggi da un sistema all’altro di convenzioni e nel momento in cui i discorsi relativi a questi passaggi acquistano dignità scientifica,
rientrano anch’essi nel quadro convenzionalistico. Se spiegano qualcosa, fra ciò che spiegano rientra
anche la serie di cambiamenti di convenzione; e lo fanno servendosi di convenzioni. Ai materialisti storici
nostrani per forza l’idea non andava giù, ma era dubbia anche a prescindere da preoccupazioni parrocchiali.
Supponiamo di poter dimenticare il problemino e, quindi, di poter beneficiare al massimo del piano empirico associato alle scienze storico-sociali. Com’è che la storia seleziona le convenzioni? Sono
32
Alberto Peruzzi – 2012
ragioni pragmatiche, di economia culturale, quelle che soggiacciono al cambiamento storico, esattamente come lo sono le ragioni che soggiacciono al non cambiamento. Risultato: l’economicità assurge a
super-categoria, in termini della quale ogni forma intersoggettiva andava spiegata e valutata. Purtroppo,
una volta intesa l’economicità in un senso tanto lato, non c’era più garanzia alcuna che il marxismo degno
di sopravvivere (perché conforme allo standard verificazionistico – la somma coerenza + controllo empirico) coincidesse con quello “umanistico” che Preti aveva a cuore. L’economicità era più ampia del bene
e del male.
Intendo dire: il progetto di ricerca che avrebbe occupato Preti per anni nasceva da una duplice novità la quale aveva in sé un potenziale aporetico di tutto rispetto, fermo restando che era comunque un
grande progetto. Capito poco, quel poco che ne fu capito piacque poco e soprattutto non suscitò la discussione che meritava e che Preti sperava. Coloro che inserivano nelle frasi il nome di Marx per avvalorare la verità di una qualsiasi affermazione non la presero bene. L’umana, e umanistica, tendenza all’ipse
dixit si riproduce a ogni nuova generazione.
Curiosamente, per capire i punti critici del progetto – il problemino e la mancata garanzia di cui
sopra–, si sarebbe dovuto prima di tutto rimuovere i presupposti che facevano piacere poco quel poco
che i novelli ipsedixisti capivano del progetto, ma anche una volta rimossi restavano altri problemi. E
c’erano anche problemi accessibili senza rimozione, come per esempio l’idea di un’esperienza umana
che, in tutte le sue diramazioni, scaturisce da una sorgente vitale, pre-tecnica, pre-scientifica, pre-artistica, e alla fine pre-categoriale, ... dunque scaturisce da qualcosa che per un altro Preti non dovrebbe
neanche esistere.
Che gli animali in esame, detti “simbolici”, “politici” o “razionali”, fossero appunto animali prima
d’inventarsi altari votivi, termometri e palazzetti dello sport, si poteva anche dire senza paura d’essere
scomunicati dai sacerdoti del materialismo – mentre la scomunica era scontato che sarebbe venuta da
altre tipologie di custodi della Verità. Non è che gli esseri umani abbiano smesso di essere un po’ lupi, un
po’ pecore, predatori solitari o in branco, e simili: si sono abilmente inventati freni e sublimazioni, codici
stradali e dibattiti. Fa benissimo Preti a ricordarlo e la sua non può esser scambiata con una difesa del
lupo della steppa. Ma un bravo marxista non ci avrebbe messo molto a contestare l’eccessiva insistenza su
questo stadio primitivo dell’uomo, tutto sensazioni, impulsi, emozioni e appetiti, perché l’uomo in cui ci
riconosciamo, l’uomo-che-fa-se-stesso, è nato con la cultura, la quale non è pre-categoriale. E allora perché fare di ciò in cui non ci riconosciamo il seme e il metro ultimo di valori e disvalori? Dulcis in fundo: al
riguardo, il saccente professore si contraddiceva!
Preti non aveva a disposizione le conoscenze che negli stessi anni aiutarono Chomsky a difendere
l’idea che il ricorso a universali innati era “di sinistra”. In seguito, le scienze cognitive hanno messo in
luce la presenza di un ancor più ampio insieme di strutture hardwired, molto articolate, all’interno di ciò
33
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
che avrebbe dovuto essere privo di struttura. L’etologia stava aprendo nuove frontiere sulla naturalità dei
comportamenti umani. Le neuroscienze e la biologia evoluzionista hanno poi cominciato a mappare la
zona grigia fra natura e cultura. Col senno di poi, la tesi e l’antitesi considerate da Preti erano sbagliate.
Col senno di poi! Meriterei almeno un cartellino giallo e qualcuno potrebbe anche obiettare che
con tutto questo brulichio di nuove conoscenze la questione cambia poco, perché le nostre costruzioni
assiologiche continuano a dover fare i conti con la mutevole realtà storica. Qui è di nuovo rilevante che ci
si contenti di mettere un post-it sulle strutture della sensibilità o si proceda alla loro indagine. Comunque, se la sorgente non è più un quid plasmabile ad arbitrio, le convenzioni (di qualunque tipo) sono
vincolate alla sorgente. L’ampiezza della finestra combinatoria, cioè, la varietà dei possibili sistemi di
convenzioni non è convenzionale; e la gamma dei possibili tipi di cultura non è essenzialmente ed esclusivamente culturale. Le stesse categorie di cui ci serviamo per capire la vita sociale, ad esempio quelle
riguardanti l’economia, sono vincolate a strutture cognitive ed emotive hardwired e anzi ne sono fondamentalmente intessute. Anche i “formatori” cui si appella Preti ne dipendono e in particolare ne dipendono le forme di socialità. Di conseguenza, il contrasto fra individui naturali atomizzati e istituti sociali
(costruibili ad libitum o determinati dalla meccanica della storia) risulta fittizio.
Il fallo, con relativo cartellino giallo, era a fin di bene. Il riconoscimento di strutture schematiche
proprie della natura umana avrebbe aiutato il discorso di Preti, impedendogli di scavare un solco troppo
profondo tra la dimensione esistenziale (degli individui), la dimensione biologico-evolutiva (della specie)
e la dimensione “istituzionale”, perché un solco troppo profondo finisce per gettare dubbi sull’efficacia
dell’istanza vitalista. Chi, invece di partire dall’uomo “in carne, ossa e sangue” partiva dalla Società era
chiaramente sospettoso verso l’assimilazione di Marx a Feuerbach.
In presenza di un solco troppo profondo, la stessa stabilità delle forme della ragione appare come
miracolosa. Il miracolo comincia a sparire allorché queste forme sono intese come protesi di strutture
vitali, a spiegare il cui esser-ci finalmente ci interessiamo. La stessa libertà dell’uomo si configura in
modo diverso, che non chiede più, a chi non la vuol rinchiudere in una noumenica riserva, di fare i salti
mortali pur di evitare un determinismo su basi socio-economiche. La riduzione del solco ha effetti anche
sul piano epistemologico. Del lascito dei neoempiristi, infatti, Preti accoglie sia il logicismo, seppur addolcito, sia il convenzionalismo, ora declinato storicamente. Le due cose messe insieme portano allo
stallo. La loro congiunzione era aporetica e l’onestà intellettuale di Preti impediva soluzioni ad hoc, addolcimenti, declinazioni contestuali.
8. Ur-Gefühlen e linguaggio comune
34
Alberto Peruzzi – 2012
In Praxis ed empirismo Preti scrive che emozioni e sentimenti primari non sono confinabili a una
sfera “privata”, né sono separabili dai costumi e “dal corso complessivo della storia” (p. 178). Una così
risoluta affermazione solleva un altro bel problema. L’appello alla dialettica non basta a risolverlo. Inoltre, se costumi istituzioni abitudini hanno la capacità di plasmare, ad libitum, la nostra sensibilità (latamente intesa), allora l’appello alla base esperienziale rischia di essere vacuo. L’appello doveva servire da
cartina al tornasole e invece l’empirìa è già acida o basica di suo. I biblisti potranno sempre tirarne fuori il
solito circolo virtuoso, ma li invito ad andarci piano. Benché la loro devozione sia ammirevole, la trasformazione di un circolo da vizioso a virtuoso è una pietra filosofale da usare con massima parsimonia. Dopotutto, le opere di Preti non sono testi sacri. La filosofia, per statuto, non dispone di certificazione divina. Perciò attenzione: l’uso indiscriminato della pietra filosofale serve semplicemente a togliere l’etichetta “problema” a un problema, senza risolverlo.
Cerchiamo invece di guardare in faccia il problema. Se la plasmabilità fosse ad libitum, l’esistenza,
con quel che più strettamente le pertiene, in quanto sorgente non analizzabile nei suoi “vettori unitari”
regredirebbe ancor più sullo sfondo. Invece Preti ce la voleva render più vicina. L’affermazione che le
emozioni vitali non sono isolabili “dal corso complessivo della storia” mi sembra una contradictio in
adjecto (l’opzione di farne un asserto analitico sposta solo il problema un po’ più in là). Preti, evidentemente, era di diverso avviso stando a come qui si esprime. Ho detto che “mi sembra” e può anche darsi
che mi sbagli. Allora faccio una piccola ritirata e mi limito a dire che è, quanto meno, dubbio che l’affermazione sia coerente. Mi basta questo per notare che bisogna fornire un argomento a sostegno della
coerenza, un argomento che invece nel testo non c’è.
Dall’impasse non aiuta a uscire il rimando al piano del linguaggio comune, come qualcosa di indifferenziato e perciò (?) anche fluido. Inoltre, tale piano è tutt’altro che indifferenziato come invece il testo
suggerisce, ed è semmai un piano meno fluido di quello su cui si esprimono scienze e tecniche, più aperte al cambiamento semantico, a partire da quello lessicale. Preti prende invece come riferimento l’inerzia
delle istituzioni sociali che si oppone alla forza vitale. A maggior ragione, il rapporto tra dimensione esistenziale e linguaggio comune esigeva di essere chiarito. Il linguaggio comune come orizzonte globale?
Un’astrazione non meno dubbia di quella che Preti identificava nel ricorso al “privato” di emozioni e
sentimenti. In poche righe di testo si concentra una matassa che aveva bisogno di essere dipanata, e ben
al di là di ciò che qui, specificamente, interessava a Preti: il rapporto fra linguaggio comune e linguaggi
scientifici. Per non ripetere cose già dette,22 mi limiterò a una considerazione generale.
Pieno di nozioni vaghe, ambiguità, presupposizioni implicite, il linguaggio comune può ugualmente essere indagato sotto il profilo sintattico e semantico oltre che pragmatico, dando luogo a qualcosa di
22 Nell’articolo intitolato “Preti e l’analisi del linguaggio”, testo della relazione tenuta al convegno Giulio Preti a
trent’anni dalla scomparsa, Castiglioncello, 17-19 ottobre 2002. L’articolo è pubblicato negli atti del convegno, a
cura di P. Parrini e L. Scarantino: Il pensiero filosofico di Giulio Preti, Guerini, Milano 2004 (pp. 159-190).
35
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
più che una mera casistica. La linguistica strutturale e poi quella generativa attestano questa possibilità (e
già negli anni Settanta si è fatto uso di simulazioni artificiali, più o meno affidabili – ma questo è un altro
discorso), mentre Preti pensava che il linguaggio comune ammettesse solo una casistica, non principi
generali, e che ammettesse solo una pragmatica, non una sintassi, non una semantica.
Il fatto stesso che ci siano teorie sintattiche e semantiche, empiricamente controllabili e ben lontane dall’idea di una grammatica normativa, non può essere ignorato se interessa chiarire il rapporto tra
linguaggio comune e senso comune. A Preti va comunque il merito d’aver capito quanto problematico sia
questo rapporto e d’averlo capito prima di molti altri, in Italia e all’estero. Preti aveva tutto il diritto di
pensare che la fenomenologia del senso comune è troppo soggetto-centrica e che la prospettiva del materialismo storico consenta di affrontare in maniera più oggettiva la dinamica dei rapporti umani che producono nuovi rapporti umani; come pure aveva il diritto di pensare che la stessa prospettiva fornisca una
chiave per ripensare (in modo diverso dai filosofi analitici) il medium linguistico in cui tali rapporti si
esprimono.23 Bisognava allora mostrare come usare la chiave in concreto. Anche in questo caso abbiamo
invece un altro dei tanti spunti che non hanno avuto seguito nei lavori di Preti. Per trovarne un qualche
sviluppo (che ovviamente ha ignorato il contributo di Preti) bisogna andare all’estero: si pensi all’idea di
una razionalità comunicativa come l’ha proposta Jürgen Habermas. Ma è uno sviluppo successivo. Quando da noi è diventato di moda Habermas, chi ne discuteva aveva rimosso il nome stesso di Preti. E poi:
vogliamo mettere come suona più ricca di significato una traduzione, col suo odore esotico, che non un
testo originale in italiano!
Dall’analisi pragmatica del senso comune torniamo alla questione della possibilità di una teoria
linguistica. Nello stesso anno di Praxis ed empirismo esce il primo libro di Chomsky. Il progetto di una
grammatica generativa rompeva la dicotomia cara ai filosofi analitici tra ordinary language e formal language e il valore di questa rottura pesa più delle difficoltà cui poi il progetto sarebbe andato incontro,
specialmente quando si cercò di estenderlo dalla sintassi alla semantica. Nel ’75 Chomsky pubblica le
Reflections on language, un testo in cui fa i conti con la tradizione analitica. Il nome di Preti avrebbe potuto benissimo fare parte della lista dei filosofi che si erano fermati alla dicotomia e ai quali Chomsky
contrappone i suoi argomenti.
E tuttavia, curiosamente, Preti era più avanti di quel che nel dibattito successivo alla rottura della
dicotomia sarebbe emerso: più avanti grazie all’idea che fra i due tipi di linguaggi c’è da interpolare la
23
Incidentalmente, la praxis motiva il superamento degli assetti istituzionali, in ogni ambito, così come l’introduzione di nuovi linguaggi goal-oriented. Mi permetto di riassumere: la rottura con la tradizione fa parte della dinamica
storica; non si tratta mai di una rottura totale, che sancirebbe l’impossibilità di un confronto razionale tra nuovo e
vecchio; ogni nuovo linguaggio, anche il linguaggio della più rivoluzionaria teoria, adopera parole già in uso per
spiegare il senso di quelle nuove; senza continuità, non c’è neanche discontinuità. Si capisce allora il valore positivo
che Preti attribuisce alla tradizione: anche quando essa assume i contorni del dogma, la battaglia degli eretici di turno si nutre di elementi forniti dalla tradizione. “Bisogna mangiare i nostri padri” e digerirli bene.
36
Alberto Peruzzi – 2012
gamma dei linguaggi tecnici. Per via di questa interpolazione, la prospettiva materialistico-storica poteva
fornire un reale appoggio al suo discorso, ma poteva e basta, perché, per fornirlo davvero, bisognava far
uscire la prospettiva dal generico e di sicuro la tarda scolastica marxiana non era d’alcun aiuto. Isolato
com’era, Preti non fu sollecitato a valorizzare il potenziale presente in quello spunto e, d’altronde, il privilegio accordato alla dimensione sintattica nell’architettura dei linguaggi formali non lo aiutava a considerare importante lo sviluppo dello stesso spunto. La purezza incontaminata della sintassi logica continuava a rappresentare per lui un ideale, vuoto di contenuti, kantianamente un’idea regolativa di contro al
magma di contenuti espressi nel linguaggio comune, quando la familiarità con la lezione fenomenologica
gli avrebbe potuto segnalare le residue àncore di significato che persistono in tale “purezza” e suggerire
l’importanza di ricostruire la genesi che conduce dall’impuro al puro.
Magma? Il fatto che ogni “attività culturale” ritagli un suo spicchio di terreno a partire dalla “esperienza-base” non richiede che questa sia “indifferenziata”. Dal nulla non nasce nulla e dall’informe non
spunta fuori alcuna forma. Ci dev’essere sempre qualche seme, qualche piccola anomalia ...o qualche
nascosta regolarità, e qualche principio generatore. Lo stesso vale per il linguaggio: dall’assenza totale di
strutture sintattico-semantiche nel linguaggio comune non si capisce come si arrivi alla struttura cristallina dei linguaggi formali. Se si tratta di selezionare un qualche aspetto entro quella “esperienza-base”,
per poi farlo crescere, la selezione può esercitarsi solo nei confronti di qualcosa che è selezionabile e ciò
implica che ci sia non tanto assenza di struttura ma sovrapposizione (confusa) di più strutture che la morfogenesi tecnico-scientifica scomporrà. Analogamente, un terreno di esperienze vitali totalmente indeterminato non avrebbe potuto fornire alcuna determinata conferma o sconferma di ipotesi etiche.
Sto fingendo d’ignorare tutte le difficoltà che linguisti e filosofi hanno incontrato nell’analisi del
linguaggio ordinario? No, intendo dire che un’analisi degli enunciati che usiamo nella vita quotidiana ha
più senso – e ha con l’analisi degli enunciati delle più diverse teorie un legame più stretto di quanto Preti
fosse disposto a concedere. È la varietà di significati latenti a permettere la selezione di significati specifici, la cui organizzazione in questa o quella “regione” culturale non è creazione di significato ex nihilo
bensì dissezione, ordinamento, bricolage, ricombinazione che poi retroagisce sul linguaggio comune.
Questa retroazione è in atto già a partire dai linguaggi tecnici. Se la materia prima della semantica fosse
ineffabile, la semantica si ridurrebbe a gioco sintattico. E talvolta Preti sembra pensare che si riduca. La
sintassi logica sarà anche la massima astrazione, ma ogni astrazione (trahere ab) resta, per definizione,
un’impresa estrattiva (trahere ex) e così è selettiva.
Su questo punto, paradossalmente, Preti finisce invece per ritrovarsi su una posizione che aveva
ricevuto già espressione in un libro da lui non molto apprezzato, cioè nel Tractatus di Wittgenstein. Molti anni dopo, facendo riferimento al famoso saggio di George Edward Moore in difesa del senso comune,
Preti dirà che enunciati come Questa è la mia mano, Mio nonno è nato prima di me, ecc., sono certamente veri, ma l’evidenza per cui sono tali è puramente pragmatica e si scioglie come neve al sole nel momen-
37
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
to stesso in cui ci mettiamo ad analizzarne il senso. Di nuovo, una sentenza che confermava la dicotomia
assoluta tra linguaggi! Preti invero proseguiva: qualora simili verità del senso comune, singolarmente
prese, risultassero tali anche dopo l’analisi, ciò sarebbe possibile solo perché ci siamo spostati di piano
inserendole in una rete interconnessa di altri enunciati ... e con ciò dalla dicotomia si usciva solo con un
tuffo nell’olismo che in linguistica avevano propagandato gli strutturalisti europei e in filosofia della
scienza sarebbe stato riscoperto da Quine: c’è una rete che si autosostiene e il significato del singolo
enunciato è il posto che esso occupa, il ruolo che svolge, nella rete. Ma, se è così, Preti non avrebbe potuto spiegare come mai certi significati siano “capaci di unirsi in unità sistematiche”, 24 perché ovviamente
sono le unità sistematiche a istituire ogni significato.
A ciò si aggiunga che in Preti lo slittamento della riflessione filosofica dal linguaggio al metalinguaggio continua a essere unidirezionale. Si va sempre verso l’alto, dal metalinguaggio si “sale” nel meta-meta-linguaggio e via di seguito, allontanandosi sempre più dalla base esperienziale e riducendo la
selettività di questa. Il che è come spiegare perché un vestito stia tanto bene a una persona dicendo che le
sta bene in considerazione del cappotto che può essere indossato sopra al vestito. Non c’è di che stupirsi
se le ricadute Preti diceva che c’erano, perché dovevano pur esserci ..., ma non mi risulta che ne abbia
indicata una in modo perspicuo.
Visto che Preti non voleva rinunciare a quella sorgente di significati e valori che individua nella
Lebenswelt, ecco perché in precedenza ho detto che occorreva un chiarimento: intendevo un chiarimento circa la genesi del formale dall’informale, del puro dall’impuro ... Quest’esigenza resta insoddisfatta. I
nodi indicati con tanta abilità, restavano da sciogliere. Da parte di tutti coloro che hanno a cuore che
l’impresa di Preti non venga dimenticata, non mi pare che sia stato messo grande impegno nello scioglierli. Forse si è tentato senza riuscirvi e per pudore si è nascosto il fallito tentativo? O si è creduto che
quei nodi non fossero così importanti?25
9. Esperimenti assiologici
Quando confrontiamo cultura scientifica e cultura umanistica, rischiamo di tradire il senso che
Preti attribuiva all’assiologia se il confronto è inteso tra qualcosa che è wert-frei e qualcosa che è wertvoll. Preti riprende da Scheler una grande idea: che la moralità non abbia una sua specifica provincia di
valori e sia piuttosto gerarchizzazione di valori, a qualunque dominio esperienziale essi ineriscono. In
questo senso molto generale la moralità ingloba i valori della logicità e della scientificità, dell’esteticità e
dell’economicità, della religiosità e di quel che altro vogliamo (etica dello sport, etica del lavoro, etica
24 “Linguaggio comune e linguaggi scientifici”, cit., p. 153.
25 Per generosità, escludo l’ ipotesi che i nodi non siano stati neppure visti.
38
Alberto Peruzzi – 2012
ecologica, ecc.) e ciò ben prima che i valori siano sanciti da norme scritte. A differenza di Scheler, Preti
non suppone che esista una gerarchia eterna dei valori cui l’uomo giusto si conforma mentre l’uomo
“risentito” non sa conformarsi: la gerarchia è nelle nostre mani.
Il guaio è che gli umani procedono per tentativi ed errori e non amano pensare che gli stessi valori
in base ai quali giudicano i tentativi e gli errori siano individuati allo stesso modo. Ogni stadio dello spirito oggettivo incarna una particolare sistemazione gerarchica di valori ma, come la storia insegna, la gerarchizzazione non è mai stabile. Da un lato la pressione della vita, dall’altro la spinta a una sempre maggiore sistematicità: entrambe esercitano un’azione selettiva nei confronti di qualsiasi tessuto di valori e di
qualsiasi prassi lo esemplifichi – e non è necessariamente un’azione concorde.
Affermando che non ci sono valori propriamente morali accanto agli altri, in quanto la moralità
consiste nel gerarchizzare valori facendone oggetto di giudizi comparativi e a fortiori oggetto di discorso
e di critica, affermando che non c’è una gerarchia in sé, affermando che la scientificità rientra tra i valori
invece di contrapporsi a essi, Preti sta ridisegnando in un modo tutto suo il terreno della meta-morale
d’impianto analitico. Ne vuol salvaguardare la portata empirica, perché la gerarchia adottata (qualunque
essa sia) indica quali azioni preferire ad altre e quali azioni compiere piuttosto che altre, sempre relativamente a un contesto. Se il contesto è assunto come variabile la gerarchia avrà portata universale, ma questa è un’opzione che il discorso effettivo di Preti non suffraga. Per avere indicazioni in merito bisognerà
aspettare Retorica e logica e anche in tal caso l’universalità conseguita sarà relativa a fatti rilevanti da un
punto di vista antropologico-culturale, non a essenze o a leggi a priori.
Intesa così l’assiologia, l’antitesi fra una praxis guidata dalla scienza e una guidata dal sentimento
risulta improponibile, perché i valori scientifici sono oggetto, non guida, della riflessione morale, e tutti i
valori sono da raccordare a qualche sentimento, atteggiamento, emozione, propensione, desiderio (togliete quella cosa che si chiama “curiosità” agli scienziati e di scienza ce ne sarebbe poca in giro). Ma non
essendoci specifici valori morali, non ci possono neanche essere specifici sentimenti morali. Ebbene,
una volta intesa così l’assiologia, si profila il suo scollamento dalla morale come usualmente intesa, perché l’analisi metamorale è metalinguistica e non è dunque dottrina senza il “meta”. Di modo che il problema di come faccia la metamorale a svolgere un compito più che descrittivo diventa arduo da risolvere
(anche se non impossibile).
A questo punto Preti riprende una distinzione imparata da Banfi e separa la filosofia morale dalla
filosofia della morale. La prima è vista come nettamente distinta dalla metamorale, dato che rientra nella
materia subiecta di questa; la seconda, anche se non totalmente assorbita nella metamorale, sembra doverne conservare il carattere puramente teoretico-descrittivo, senza possibilità di generare norme. Con
riferimento al dibattito filosofico che allora si svolgeva in Italia, un simile scollamento, insieme al metodo
39
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
analitico che l’accompagnava, era quanto meno una ventata di freschezza, se non una vento rivoluzionario.
O era blasfemia? Se capita (participio di “capire”), tale sarebbe infatti apparsa l’impresa di Preti ad
animi eccitati da una qualche fede. In senso lato, fede è convinzione che esista la vera gerarchia di valori.
Nel caso di fede ideologica l’impresa era revisionismo, nel caso di fede religiosa era minaccia a valori che
non è l’uomo a porre. Perfino ad animi privi di fede ma avvolti nel perbenismo, l’impresa appariva paurosamente destabilizzante. Ripeto: se capita. Detto questo, era tutto da vedere di quale effettiva forza pratica una simile impresa fosse capace. Se la ragione ha a che fare con la conoscenza, occorreva non solo
chiedersi daccapo qual è il posto della ragione nell’etica ma anche chiedersi qual è il posto del ragionamento scientifico nella ragion pratica. E per capire l’impresa di Preti occorre chiedersi qual è il posto
dell’etica nel quadro dell’empirismo dinamico elaborato da lui elaborato sul piano epistemologico.
Anche sul piano epistemologico c’erano pillole non facili da mandar giù. Nel nuovo empirismo
Preti vedeva lo sviluppo coerente della filosofia critica piuttosto che il suo definitivo affossamento, dunque non c’è da stupirsi se l’uso dell’approccio analitico nell’esame dei giudizi di valore era inserito senza
soluzione di continuità in un’indagine sulle condizioni formali della ragion pratica. Le emozioni son quel
che sono, cioè a-razionali, la ragione entra nell’etica con il discorso, l’ordinamento cosciente di valutazioni e norme si manifesta in coppie di dichiarativi e valutativi, da cui si fa conseguire un enunciato che
dice come comportarsi – un tipo sui generis d’argomentazione. In Praxis ed empirismo non ci si limita
però a prendere atto di questa manifestazione. L’analisi del linguaggio chiarisce il senso di quel che diciamo di apprezzare, e di volere, e questo chiarimento non è chiuso in sé: il chiarimento conduce a questioni di correttezza (delle inferenze), coerenza (delle tesi) e universalità (riferita alle applicazioni pratiche), che hanno, possono o debbono avere, effetti sulla praxis.
In tutto ciò, Preti è palesemente più vicino all’ala “ideal-linguista” degli analitici, perché (a suo
giudizio) è quella che ha in sé un feedback riformatore, l’altra ala essendo animata (sempre a suo giudizio) da spirito conservatore. La ragione che c’è nell’etica è quella che scegliamo di metterci e a questa
scelta si accompagna un’operazione che investe anche il linguaggio. Se il linguaggio subisce qualche
alterazione, pazienza. La scelta di campo (cioè, di ala) è innanzitutto motivata da criteri di logicità. Non
che Preti ignori le preoccupazioni dell’altra ala, quella (diciamo) “oxoniense”: non si può dire sì o no
senza prima essersi preoccupati di capire il senso di ciò cui assentiamo o da cui dissentiamo, e impegnarsi a capire il senso degli enunciati valutativi e normativi vuol dire rintracciare le radici di questo senso
nella varietà dei concreti contesti d’uso (ahimé, tanti e mobili qual piume al vento).
Rintracciare queste radici non basta. Preti non intende venir meno al compito dell’organizzazione
teoretica ma siccome vuol evitare il normativismo come soluzione al problema del raccordo fra usi de-
40
Alberto Peruzzi – 2012
scrittivi e usi prescrittivi del linguaggio, non può certo contrabbandare il normativismo come esigenza
dell’organizzazione teoretica.
Quindi: (1) se la morale fosse riducibile a un insieme di regole, non ci sarebbe posto per una vera
razionalità, (2) se la morale si fondasse su fatti (emozionali), non ci sarebbe modo di estrarne norme dotate di validità universale (in linea di principio); (3) gli errori denunciati in (1) e (2) non possono essere
rilegittimati quando l’oggetto del discorso sia non la morale ma la metamorale.
I riferimenti non occasionali, nelle opere e nei corsi universitari, a Hare, Toulmin, Nowell-Smith,
Stevenson rappresentavano per lettori e studenti di Preti un invito a esplorare un pianeta alieno e soprattutto a munirsi di lessico e schemi concettuali più raffinati di quanto avessero mai potuto trovare nel panorama di dottrine etiche che la cultura italiana del tempo dibatteva, fossero esse di stampo idealistico,
religioso o materialistico. L’effetto si faceva dirompente allorché Preti si sforzava di animare la strumentazione analitica (presente nella letteratura filosofica di lingua inglese) reimmergendola in una cornice
filosofica mitteleuropea pre-Circolo-di-Vienna, come era quella del materialismo storico.
In realtà, nella prima fase del neopositivismo si era già prospettato un parallelo tra dimensione epistemica e valutativa (nel senso usuale di questo termine). Il parallelo è riassumibile nel modo che segue:
come
(a) la significanza empirica di un asserto conoscitivo, una volta discesa tutta la catena inferenziale di presupposto in presupposto, si fonda su protocolli osservativi, come atomi allo
stato criologico,
così
(b) la significanza empirica di una valutazione/prescrizione, una volta discesa tutta la corrispondente catena, si fonda sulla registrazione di reazioni emotive, come atomi fortemente
eccitati.
Negli anni Cinquanta, Preti sposa questo parallelismo – e non mi risulta che in seguito abbia chiesto il divorzio – e poiché in seguito prenderà le distanze da (a), avrebbe dovuto prenderle anche da (b), a
meno di rinunciare al parallelo. Ma Preti non aveva intenzione di rinunciarvi. Comunque, non c’era neppure bisogno di uscire dall’orizzonte neopositivistico per dire che, come le osservazioni, isolatamente
prese, non producono nessuna teoria esplicativa, così le emozioni basilari, nella loro nudità, non legittimano alcuna norma. Interessante, si dirà, ma niente di originale.
L’originalità comincia ad affiorare quando Preti si vede costretto a prendere le distanze da un’altra
cosa a lui cara ed è significativo che questa presa di distanza sia legata all’ambito etico. Qui mi riferisco in
particolare alla critica che fa del pragmatismo di Dewey perché reo di fallacia naturalistica.
41
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Noticina: allora, sempre tenendo fermo il parallelo, Preti si sarebbe dovuto esprimere (o esprimere
più nitidamente) contro l’interpretazione strumentalistica delle teorie. Se infatti il valore non si riduce a
emozioni e neanche si riduce a una serie di rapporti mezzo-fine, l’empirismo incentrato sulla praxis è alle
corde. Caso A: l’additivo ‘continentale’, ovvero la coscienza storica-culturale della praxis, sarebbe riuscito a rimettere a posto le cose. Caso B: a Preti dava una mano il vitalismo di ritorno, alla Simmel, benché
diverso dal vitalismo “yankee”. Seconda noticina: in entrambi i casi A e B, Preti anticipava i ‘nuovi’ filosofi della scienza, ma se ne distingueva in anticipo per il fatto di prendere garbatamente le distanze dal
pragmatismo.
È utile rifarsi a un esempio dello stesso Preti, espandendolo appena un po’: – Se esci, prendi l’ombrello! – Perché? – Perché piove. – E allora? – Se piove, ti bagni, e se ti bagni, puoi ammalarti. – Non
m’interessa. Non ho intenzione di preoccuparmene. – Ma come! Se ti ammali, non potrai fare quel che
vorresti, e anche se non vuoi far proprio nulla è probabile che starai male. Immagino che t’interessi non
stare male. Quindi evita di bagnarti! In quest’argomento non c’è altro che una serie di motivazioni pragmatiche (mezzi-fini-mezzi) accanto a impliciti presupposti: l’ombrello offre l’unico modo per ripararsi
dalla pioggia, l’ombrello dev’essere privo di buchi, la probabilità di ammalarsi se p è maggiore della probabilità di ammalarsi se non-p, ecc.
Ora, se rifiutiamo la fallacia naturalistica, la dobbiamo rifiutare in ogni caso. Cos’è che, allora,
manca all’argomento precedente? Che la malattia (lo “stare male”) sia davvero un male può o non può
essere dedotto? La denuncia della fallacia naturalistica obbliga a dire che non può esserlo: c’è un “salto
logico” (come scrive Preti) fra descrizione e valutazione già a questo elementarissimo livello. Ma dato che
il salto c’è comunque (cioè, che si decida per un comportamento o per un altro), perché mai i giudizi di
valore dovrebbero tener tanto conto dei fatti e in particolare di quei fatti che sono risposte emotive di
base?
Preti distingue due passaggi: da fatto a valore e da valore a norma. E fa benissimo a distinguerli. Si
tratta di capire se questi passaggi sono “salti logici” o no. Se lo sono e se quel che è fallace è da evitare, la
ragion pura pratica se la passa male. Se non lo sono, quali sono gli schemi logici in gioco e quale status
assegnare a essi? E Preti è anche molto attento a non confondere la logica deontica con quella aletica.
In Praxis ed empirismo troviamo la riaffermazione del piano delle forme, che ora sono forme di
discorso, come nettamente distinte dal piano dei contenuti – ivi comprese le correlazioni fra stati di cose
e stati emotivi, fra stare male e che cosa si prova a stare male, e via di seguito. La ragione è, ‘per costruzione’, formatrice-ordinatrice anche in ambito morale e la forma che così si costituisce non deriva dal
contenuto né ha in sé capacità alcuna di prescrivere contenuti: non può dirci di volere A invece che volere
B, ove A e B facciano riferimento a contenuti particolari. Al massimo può dirci se possiamo o non possiamo volere A e B una volta specificate le risorse, il tempo disponibile, le condizioni al contorno. È pur
42
Alberto Peruzzi – 2012
sempre qualcosa di prezioso, no? Poiché la nostra vita non è fatta di eventi, pensieri, sentimenti isolati gli
uni dagli altri, ci vuole un po’ d’ordine, no? Se ora c’è un problema che le nuove vesti convenzionalistiche del formalismo kantiano mettono in primo piano, è il problema di come garantire la coerenza del
sistema di principi che decidiamo di fare nostri.
Sì, ma ... Facendo l’avvocato del diavolo, mi chiedo: perché un sistema di valori coerente dovrebbe
esser preferibile a uno che non lo è? Perché disporre di una garanzia di coerenza sarebbe meglio che non
disporne? Intravedo solo due specie di risposta. La prima specie è logico-epistemologica: un sistema
incoerente, in presenza del principio classico secondo cui ex absurdo quodlibet, non ha alcuna selettività
normativa sul piano dell’azione: tutte le azioni sono legittimate e non possiamo più credere che una scelta moralmente responsabile, buona, doverosa sia quella per compiere la quale abbiamo delle ragioni,
perché ne abbiamo per qualunque scelta. La seconda specie è empirica: i sistemi coerenti sono più efficaci. Ma come facciamo a esserne sicuri? Su basi statistiche? E le nostre proiezioni ... quanto attendibili
sono? Entrambe le specie di risposta non fanno che riproporre sul piano meta-meta-etico un problema
che era già presente sul piano meta-etico (e personalmente credo che non ci fosse neanche bisogno di
uscire dal piano etico per incontrarlo in forma più ... terragnola). Ovvero: la coerenza non basta (un sistema di valori può benissimo essere giudicato coerente ed esser giudicato ingiusto), mentre l’efficacia
presuppone la scelta di una specifica assiologia a parte, che a sua volta è contestabile – in linea di principio, perché non possiamo escludere che un sistema sia efficace e ingiusto. Ahimè, la reduplicazione di un
problema non è la sua soluzione.
O conviviamo con il problema irrisolto o teniamo conto in un altro modo delle emozioni-base e di
quant’altro competa a come siamo fatti. Nel primo caso, tanto valeva affidarsi alla saggezza della nonna
senza fare tanti ghirigori filosofici. Nel secondo, ci vediamo costretti a ritirare la denuncia della fallacia
naturalistica, se mai avendo il garbo di farlo per via obliqua, cioè dicendo che le forme ordinatrici della
razionalità sono anch’esse parte della sostanza (qui, la natura umana), che la sintassi è impura perché
carica di semantica, che la storia della civiltà attesta solo un’opera di filtraggio e riassemblaggio esercitata
nei confronti di uno stesso pacchetto di capacità e inclinazioni naturali, cognitive e valutative; in questo
senso, il surplus che può rendere un giudizio morale aprioristico più ricco di contenuto di un giudizio
morale pragmatico essenzialmente legato a un contesto non è il suo distacco dai rapporti mezzo-fine ma
il suo tener conto di altri aspetti della nostra natura. Dopotutto, siamo anche sensibili a considerazioni
controfattuali. Il surplus può esserci, ma non è detto che ci sia, e il più delle volte, in effetti, di meri pregiudizi si tratta, tant’è che non hanno potere controfattuale o se ce l’hanno è egocentrico.
È nondimeno un dato significativo che valutiamo il da farsi in una data situazione reale in termini di
quel che potremmo, vorremmo, dovremmo fare in situazioni che sappiamo o supponiamo alternative alla
realtà, passando per questa via dal più egocentrico dei desideri ad apprezzamenti circa la tutela di altre
“forme di vita” (Wittgenstein), con gerarchie di valori diverse dalla nostra, e in quest’iter maturiamo
43
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
come persone, anche se in vista non c’è alcuna utilità derivante da tale passaggio. Se non c’è utilità in
vista, perché allora preoccuparsi di simili scenari? Per esempio, come si fa a preferire uno scenario in cui
guardiamo a noi stessi come co-autori del futuro della Terra e non più destinatari privilegiati di tale futuro? Quale risposta pragmatica o emozionale può essere addotta quando si ha a che fare con una scala
temporale che va oltre ogni ragionevole nostro interesse? Sia che riusciamo ad addurne una sia che non
riusciamo, non siamo autorizzati a buttare nel cassonetto le preoccupazioni relative a scenari ipotetici.
Che Preti non si accontentasse di una razionalità puramente architettonica in campo morale risulta
chiaro dal fatto che, pur apprezzando i sistemi di logica deontica come quello di von Wright, non li riteneva sufficienti. L’etica non si lascia pigiare nel diritto. Quei fissati che pensano che le leggi emanino
profumo di bene aggiungono la beffa al danno, perché fanno il gioco dei furbi: corruptissima re publica
plurimae leges (a notarlo è Tacito, ben prima di Cartesio). Qualunque norma deve (poter) essere giustificata da un argomento che si affida a principi (etici) tanto quanto a fatti relativi all’esistenza umana. Ma se
è così, anche il “formalismo” dell’etica è da intendersi in nuovo modo – e per “nuovo” non intendo
“convenzionale” o “convenzionalistico”.
Facciamo un passo indietro. Ripensandoci, un motivo per dire che Preti mette in discussione il
parallelo tra impianto epistemico ed etico ci sarebbe: percezione e cognizione hanno una base omogenea, per tutti gli uomini, mentre emozioni e atteggiamenti valutativi non ce l’hanno. Quando si genera un
disaccordo di credenze o giudizi fattuali, abbiamo la possibilità di venirne a capo in un modo condiviso
(in linea di principio) mentre, quando si genera un disaccordo di valore, non possiamo più appellarci a un
piano di verifiche empiriche concordanti e neppure possiamo contare su criteri formali perché il confronto stesso tra presupposti diversi richiederebbe un piano meta-meta-teorico condiviso, ammesso che
riusciamo a esprimere tali criteri in un nitido sistema assiomatico. Io ho questa gerarchia, tu quella: ci
vorrebbe una metagerarchia per confrontare le nostre due gerarchie, ma sfortunatamente succede che io
abbia una metagerarchia e tu un’altra. Così, ci vorrebbe una metametagerarchia ... e via di seguito.
In realtà, questo motivo per accantonare il parallelo non è d’aiuto, per almeno due ragioni. La prima è che di fatto non va d’accordo con quanto Preti scrive in Praxis ed empirismo sul risposte percettive
“normali” e non “normali” (ma su questo mi soffermerò tra poco, facendo riferimento al caso del daltonismo che è Preti stesso a menzionare). La seconda è che Preti (temo) non potesse giustificare la differenza
che ho appena segnalato. Infatti, se il senso di p, sia p un’osservazione o sia p una valutazione, sta nella
rete di rapporti inferenziali di p con altri asserti sulla base di principi unificanti, allora possiamo venire a
capo di un disaccordo di credenze esattamente come possiamo per un disaccordo di valutazioni, cioè,
facendo appello alla coerenza, eventualmente coerenza con un più ampio sistema di principi. Invece,
sembra che per Preti le qualità valutative siano puntuali, mentre quelle epistemiche sono relazionali.
Quest’asimmetria è da lui assunta come dato di fatto, che però è ricollegabile alla omogeneità o disomo-
44
Alberto Peruzzi – 2012
geneità degli atteggiamenti valutativi solo supponendo che relazionalità e omogeneità vadano di pari
passo – cosa, a dir poco, stupefacente.
Il parallelo inerente tra fatti elementari della sensazione e dell’emozione è per Preti rilevante per
altri due aspetti. Il primo è che il discorso morale è suscettibile di essere deduttivamente articolato né più
né meno di quello scientifico, e ovviamente la raccomandazione è a preoccuparsi di diventarne consapevoli e farsene promotori – una raccomandazione antica, da Aristotele a Spinoza (con esiti alquanto diversi, d’accordo). Il secondo riguarda le definizioni: il ruolo delle definizioni che nelle scienze coordinano
piano teorico e piano osservativo è preso nel discorso morale dalle “definizioni persuasive”, come intese
da Stevenson.
Il primo aspetto non presenta altro problema che la fatica richiestaci nel risolverlo. Il secondo, che
completa il parallelo, suscita perplessità, ancor più di quanto la corrispondenza tra tipi di fatti elementari
potesse già suscitare. Una definizione persuasiva è un tipo di enunciato, asserito da A rivolgendosi a B,
che ha la forma: X è bene e t’invito a pensarla al mio stesso modo.26 In forma di condizione definitoria: X è
bene se e solo se R(X, Y) e VA(X) e VA(VB(X)), ove 1) al posto di Y può esserci anche una n-pla di termini
(diversi da X) che servono a caratterizzare le qualità di X in relazione ad altre cose, e 2) VA(X) sta per A
vuole che X. Si noti che al posto del termine bene si può usare qualunque altro termine contrassegnato da
un valore positivo – e, specularmente, lo stesso si può fare con un termine contrassegnato da un valore
negativo, ma in questo caso invece che VA(X) avremo non VA(X). L’aspetto “persuasivo” sta nell’approvazione, solitamente implicita, di X da parte di A e nell’invito (qui equiparato a un volere) rivolto a B di
condividere tale approvazione.
Ora, si possono anche leggere le definizioni coordinative (di metro campione, secondo campione,
grado di temperatura, ecc,) come enunciati che asseriscono una volontà istitutiva (di una convenzione)
da parte di qualcuno, unitamente al suo invito a condividere l’istituzione di uno standard (per esempio,
l’istituzione di un’unità di misura), ma temo che il giudizio X è bene non abbia la stessa affidabilità, quale
canone per un numero potenzialmente infinito di altri giudizi, di una definizione coordinativa. “Temo” è
eufemistico, perché è sotto gli occhi di tutti che il giudizio in questione non ha la stessa affidabilità.
Anche supponendo di poter rimediare a questo inconveniente, c’è un altro motivo per cui è difficile
pensare a una perfetta corrispondenza tra la struttura del discorso scientifico e la struttura del discorso
morale. Cercherò di esprimere nel modo più breve questa difficoltà, rinunciando alla precisione.
È vero che la logica deontica parte da principi di obbligatorietà formulati in forma dichiarativa, che
intendono esprimere prescrizioni in positivo o in negativo (affermando che X è proibito s’intende pre-
Per non complicare le cose, lascio nell’indeterminato se X stia per uno stato di cose o per una proprietà di qualcosa di precedentemente fissato.
26
45
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
scrivere: Non fate X, chiunque voi siate) così com’è vero che i principi della logica (intendo quella aletica)
generano regole e si possono anche introdurre fin dall’inizio in forma di regole (per esempio, in quella
che si chiama “deduzione naturale”). Tuttavia, lo stesso Preti ci ricorderebbe che in ambedue i casi la
giustificazione di un dato assioma/regola è (deve essere) sempre in forma dichiarativa.
A questo punto sorge una domanda: in ambedue i casi si può dire che è stata istituita una convenzione? Intendiamoci, si può anche dire, ma – e qui sorvolo su una ulteriore difficoltà derivante dal fatto
che Preti sovrappone il senso di “tautologia” e il senso di “definizione implicita” – c’è un risvolto scomodo per chi voglia sostenere fino in fondo la tesi della simmetria. Cioè, si ha l’impressione di un sottile
inganno che, in virtù della simmetria, si trasmette dal caso epistemico al caso etico. L’inganno riguarda il
fatto che ci sono molte conoscenze coinvolte nella definizione accurata di un’unità di misura, mentre il
discorso di Preti fa finta che non ci siano.
Se l’analisi del discorso è buona dovrebbe dar conto dell’uso effettivo dei termini, perché il loro uso
è pur sempre un insieme di fatti (sociolinguistici). Ma allora non si capisce perché sentirsi in dovere di
regolamentare quel che è già in essere, invece di descriverlo semplicemente. Bisogna proprio regolamentarlo in qualche modo? Sì, perché i fatti in questione non sono concordanti neanche nel caso epistemico:
qualche volta la gente ragiona male, cioè organizza male le proprie credenze, prima ancora che i propri
atteggiamenti. Neanche qui l’uso ha l’ultima parola: moralità è diverso da eticità.
Vengo al punto: è dubbio che si riesca a convincere circa il dire sì o no a una qualsiasi data tesi, e a
regolamentare con successo l’uso/ethos, semplicemente facendo appello alla volontà istitutrice di una
qualche convenzione (o insieme di convenzioni). Parlare di “convenzioni” serve a rassicurare sul carattere non dogmatico di quanto stabilito. Ottimo, ma, se fosse tutto qui, nessun motivo sarebbe ancora stato
fornito per adottare una convenzione piuttosto che un’altra al fine di risolvere un problema concreto,
conoscitivo o etico. Se chiedete a un architetto perché ha disegnato le campate di un ponte così e non in
altro modo, vi aspettate una risposta che faccia appello a vincoli fisici e/o a motivi estetici, non una risposta che, volendo rassicurare, si faccia vanto di di aver istituito una nuova convenzione edilizia. Gli chiedereste perché ha scelto quella convenzione e non accettereste che l’architetto si limitasse a rivendicare la
sua libertà di sceglierla. Se le convenzioni hanno dei motivi, i motivi non sono convenzionali. Ma se è
così, non tutte le convenzioni sono possibili relativamente a come siamo fatti. La nostra libertà di scelta è
nomica.
Insomma, posso anche capire l’interesse di Preti per la simmetria, volta a far uscire il dibattito sull’etica dalle secche di una contrapposizione fra massimi sistemi, depositari di verità ultime, ma non credo
che questo beneficio chiuda la questione, in virtù della stessa sua insistenza sul fatto che la ragione entra
nell’etica con le motivazioni delle norme. Peccato. Mi dispiace che Preti non si sia preoccupato di individuare l’analogo, sul piano del discorso morale, dei linguaggi tecnici come stadio intermedio fra linguag-
46
Alberto Peruzzi – 2012
gio comune e linguaggi scientifici (a meno che si voglia intendere tale stadio come quello corrispondente
alla pubblicità): qui avrebbe trovato cose come l’etica dello sport, l’etica del giornalismo, la deontologia
dei notai e dei medici, ecc.
Torniamo ora alla questione dell’atomicità o non-atomicità dei dati che stanno alla base del controllo empirico delle teorie. Si è detto che nel caso degli atteggiamenti valutativi la base è emozionale e che
non è altrettanto omogenea (stabile) della base sensoriale a partire dalla quale può avviarsi qualunque
procedura di verifica delle asserzioni. Preti scrive a p. 220 di Praxis ed empirismo che il fatto di considerare un’anomalia il daltonismo e non un’anomalia una divergenza di gusti potrebbe avere esclusivamente
un rilievo “statistico”. E qui c’è un altro problema, perché alle pagine 48-49 di Fenomenologia del valore
Preti si era espresso notando che le qualità estetiche (legate a gusto, piacere, risposta emotiva) sono puntuali, cioè, riguardano una specifica presentazione di un complesso fenomenico, preso in isolamento dai
suoi nessi con altri complessi: le qualità-di-valore primitive non sono dunque relazionali. Ma allora in
quale senso si può dire che un giudizio etico è verificabile relativamente al sistema in cui è inserito? E in
quale senso il sistema è verificabile, come intero, senza passare attraverso la verifica separata di ciascun
suo componente o almeno di qualche suo componente? (A scanso di equivoci, non mi interessa mettere
Preti contro Preti. Mi interessa ripulire il problema sollevato da Preti per poterlo risolvere.)
Sembra che nel caso del discorso valutativo la rete di relazioni riguardi i valori, non le ‘cose’ (oggetti, stati-di-cose, o quel che volete) cui i valori sono ascritti. Se l’idea è questa, non mi sembra molto felice
o almeno non può essere un’idea felice per chi intenda suggerire una qualche sorta di verificazionismo in
campo etico: se il sistema seleziona certe relazioni tra valori e tra atteggiamenti verso di essi, non si vede
quale esperienza emotiva possa verificare tali relazioni dato che (per ipotesi) ogni esperienza valutativa è,
alla base, puntuale.
Delle due una: o in ambito etico (ed estetico) rinunciamo alla liberalizzazione dell’empirismo che
poi sfocia in una cornice olistica del verificazionismo, e così ammettiamo un’asimmetria nel metodo di
controllo, oppure rivediamo la tesi del carattere puntuale degli atti basilari di valutazione. In entrambi i
casi l’osservazione sul rilievo unicamente “statistico” della differenza tra divergenze percettive e divergenze valutative non aiuta. Che cosa cambierebbe, ai fini dell’opzione per l’una o per l’altra opzione, se
ci fosse perfetta omogeneità di risposte emotive o se non ci fosse alcuna omogeneità percettiva? Qui si fa
sentire di nuovo il mancato chiarimento della soglia (zona) fra natura e cultura, lasciando aperta la possibilità che la disomogeneità di risposte emotive nel caso del discorso valutativo sia imputabile a fattori
culturali e quindi non sia pertinente al piano della verifica, laddove non credo proprio che Preti avesse in
animo di suffragare il relativismo culturale.
Bilancio: la corrispondenza fra discorso morale e discorso scientifico ha caratteri di originalità, ma
alla fine è apprezzabile più per le difficoltà che fa emergere che per i meriti della corrispondenza come
47
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
tale. Sono difficoltà peculiari che portano a una peculiare aporia, perché per proseguire lungo la via indicata da Preti bisognava disporre di conoscenze psicologiche, etologiche, antropologiche, che a quel tempo non c’erano, e nello stesso tempo il rifiuto della fallacia naturalistica comportava che tali conoscenze
fossero irrilevanti. Quest’aporia induce a riconsiderare le basi del discorso etico. Del resto, una riflessione sulle metariflessioni di Preti ha senso filosofico solo se non se si ferma a un esercizio esegetico.
10. “Sistematica” per empiristi vecchi e nuovi
A dispetto di quel che l’appello alla base emozionale potrebbe far pensare, lo scopo di Preti è contrario all’individualismo degli “emozionalisti” di lingua inglese. La ragione non interviene come un vigile
urbano interviene nel caso di un ingorgo: non è la mera (si fa per dire!) regolamentazione di un trambusto irrazionale. Né il senso dell’intervento consiste nell’uscire dal ‘particulare’ facendo leva su un’assiomatica astratta. La ragione si oggettiva storicamente in istituzioni, nel linguaggio parlato e nel costume,
in sistemi di norme che vigono, e vigono per una comunità. Proprio mettendo in risalto la dimensione
dell’ethos, Preti scombina l’aut aut, caro agli autori di lingua inglese, fra emozionalisti e assiomatici. Il
ricorso a principi dottrinali e l’esclusivo richiamo alle emozioni sono, per Preti, due facce della stessa
medaglia: sono entrambi inadeguati. L’ethos che qui entra in gioco è colto nella sua dinamica e quindi
l’attenzione all’ethos rompe la staticità propria delle immagini che i filosofi analitici davano del linguaggio comune così come rompe la staticità dell’iperuranio logico.
Quanto specificamente al discorso morale, il compito di realizzare un’analisi chiarificatrice delle
sue strutture non è che venga meno, o perda importanza, nel momento in cui la filosofia rinuncia a essere
Sistema. Se il discorso morale non si riduce né a propaganda ‘alternativa’ né a celebrazione conformistica, il compito perdura. Chi se lo assume si fa carico dell’esigenza di controllo intersoggettivo per le tesi
analizzate e gli argomenti prodotti pro o contro; e quest’esigenza motiva la preoccupazione nei confronti
della correttezza delle inferenze. Diventando più consapevole di qual è il senso di una norma, di come
essa implica o è implicata da altre, e di quali situazioni modellino la congiunzione di due norme o ne mostrino l’incompatibilità, le scelte che facciamo, e poi le azioni che decideremp di fare per dar corpo alle
scelte – saranno più oculate, più meditate, più ... razionali in vista di una vita in comune. E con la dimensione pubblica, invece che solo privata, entra in campo la politica.
Una simile linea di pensiero non comporta impegni verso uno specifico sistema di etica e ancor
meno verso una specifica dottrina politica, eppure non rinuncia ad avere una qualche efficacia selettiva,
con ricadute concrete sul piano sociale ed educativo, dunque non rinuncia ad avere una qualche forza
persuasiva. Il che ha una sua valenza politica. Trattandosi però di una forza persuasiva non basata su slogan, tecniche retoriche di persuasione o dogmi, la razionalità che si coltiva con l’esercizio dell’analisi del
linguaggio, con i suoi annessi e connessi, è al servizio di una democrazia come dovrebbe essere, non
48
Alberto Peruzzi – 2012
come è (praticata). La razionalità non si riduce a vuoto formalismo se induce a certi tipi di comportamento piuttosto che altri. Le indicazioni a non comportarsi in un modo irrazionale, se seguite, hanno effetti
peculiari. Per esempio ci ritroviamo ad attribuire valore a cose che non ci riguardano, in prima persona,
sul piano pratico. Se l’inutile è utile, il problema non è mio: è di chi ha cominciato a enfatizzare l’utile in
alternativa a teorie morali che enfatizzavano altri concetti, e si ritrova a dire che tutto può essere utile.
Ora, non c’è alcuna garanzia che l’impresa immaginata da Preti riesca, così come non c’è garanzia
che l’analisi porti a individuare uno e un solo insieme di principi. La prima lezione della modernità è
l’auto-nomia della ragione pratica. La lezione finale della modernità è che i principi non sono altro che
postulati. Per un bravo empirista i postulati si scelgono sulla scorta di considerazioni d’efficacia pratica,
per un bravo antinaturalista nessuna considerazione del genere è sufficiente. Preti vuol esser bravo in
tutti e due i modi. Per forza il suo pensiero è tormentato.
Comunque intesi, i postulati sono asserti di portata universale e nel caso dei principi morali quest’universalità riguarda il bene di tutti, indipendentemente dalle risposte emotive diverse che soggetti
diversi hanno di fronte a una stessa situazione. Perciò l’adozione di un sistema di postulati piuttosto che
un altro non può essere motivata dalle proprie personali risposte emotive (di assenso o dissenso basilare). Può trattarsi di postulati (sistemi di postulati) che trovano ampia esemplificazione nell’ethos vigente
e che in qualche misura lo legittimano e ne sono legittimati in termini d’efficacia, come può trattarsi di
postulati che portano a negare l’ethos corrente (alle corride credo che vadano pochi vegetariani). Fatto
sta che i postulati secernono norme e una norma non è giustificata in virtù di chi la promulga o in virtù
della sua corrispondenza con una realtà-modello (naturale o metafisica).
La prima lezione è kantiana, la lezione finale della modernità è antikantiana. Sul piano epistemologico, a trarre quest’ultima lezione sono stati i nuovi empiristi: quel che vale per la geometria euclidea
dopo Einstein vale per qualunque altro sistema di postulati in qualunque altro campo, compresa la logica.
Neanche in logica c’è più spazio per l’Assoluto e allora, a chi ha a cuore la razionalità, non resta che farsi
portavoce di un Principio di Tolleranza (Carnap). Trasferendo la lezione dall’ambito logico-conoscitivo a
quello morale la tolleranza riacquista il suo senso originario, arricchito dal passaggio attraverso l’analisi
meta-morale. È dunque in termini di questa lezione finale che ci troviamo ad affrontare questioncine
come: Quale valore da dare a un sistema di valori? Come controllare l’adeguatezza empirica del sistema?
Come integrare i principi generali di un’etica, pubblica e razionale, con una base emozionale che è personale? Non c’è di che stupirsi se anche a questo riguardo il pensiero di Preti è tormentato, appunto perché vuole ospitare tanto la prima quanto l’ultima lezione della modernità.
Una cosa è chiara: nel passaggio dalla prima all’ultima, l’eticismo è bandito e così a Preti non resta
che riaffermare la prospettiva banfiana di una “sistematica” delle leggi trascendentali che informano i
diversi assetti storici dell’ethos (codificato o informale). Come già in Banfi, questa sistematica aperta e
49
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
dialettica rimane però allo stadio progettuale. Poteva (può) tradursi in qualcosa di più? O il massimo
conseguibile dall’analisi del discorso morale (analisi che è Preti, non Banfi, a intraprendere) non è altro
che una generica saggezza, resa ora più raffinata dalla coscienza metateorica? Domande un po’ vaghe, lo
ammetto. Così a qualcuno può sembrare che si esce dal vago solo contestualizzando, e più specificamente storicizzando. Ma la storicizzazione di tutti i reticolati categoriali (ivi compresi quelli etici) è o non è
anch’essa soggetta a principi? (Stavo per dire “leggi”, ma ...) Nel momento in cui si afferma la dignità
scientifica della storia, nel pieno rispetto dei canoni empiristici, si dovrebbe rispondere che è soggetta.
C’è solo da augurarsi che le leggi in questione siano meno vaghe di un richiamo a Idee-guida.
Morale della favola: la razionalità che si trova sedimentata nello spirito oggettivo non è tutta quanta
la razionalità. La sedimentazione ha il suo peso e senza di essa ci sarebbe solo un astratto battibecco, ma
ne resta sempre fuori qualcosa, qualcosa che preme su quel che c’è dentro. Il non sedimentato ha una
funzione dinamica: può arricchire, integrare, rafforzare il sedimentato così come può diventare destabilizzante. Ponendo infatti alla coscienza il problema di adeguare l’idealità che non trova rispecchiamento
nello spirito oggettivo, quel che non si lascia sedimentare sollecita un cambiamenti nei costumi.
Eccoci riportati al contrasto Kant-Hegel, anch’esso letto da Preti in chiave dialettica (o meglio,
metadialettica), con una novità: la consapevolezza critica che si è fatta dialettica si realizza attraverso
l’analisi logica del discorso morale e attraverso il riconoscimento del carattere convenzionale di ogni
sistema di postulati. Data la molteplicità irriducibile dei sistemi, questo riconoscimento a sua volta produce maggiore tolleranza. Vien da dire: meglio di così non si può,
Vien da dire e basta, però, perché si delinea subito un nuovo problema: il requisito di universalità
dei valori, agendo da trascendenza immanente27 collide con la tolleranza ut sic, che dopotutto dovrebbe
essere tolleranza anche verso l’ethos vigente, mentre Preti non intende rinunciare a prender posizione,
esprimendosi decisamente a favore di un tipo-di-cultura contro un altro. A questo scopo lo slittamento
verso il ‘meta’ non lo aiuta più. Così, alla fine, si ritroverà (e ci metterà) in una posizione di stallo. Chiunque abbia giocato un po’ a scacchi sa che è solo in situazioni svantaggiose che ci si prefigge di “stallare”.
Tutto il percorso argomentativo fatto doveva aver messo Preti in una posizione di vantaggio ...
Un attimo: e se lo stallo, che si farà più chiaro in lavori successivi di Preti, fosse davvero la migliore
lezione possibile, dopo la prima e l’ultima della modernità? Che si apprezzi o no un simile esito, bisognerebbe avere il coraggio di dire che questo è uno dei punti più alti della filosofia contemporanea. Personalmente, ho difficoltà ad apprezzare un gioco in cui so fin dall’inizio che il massimo è conseguire una
posizione di stallo, ma riconosco che Preti ha il merito di sbatterci in faccia il problema in tutta la sua
antipatica radicalità, elaborando argomenti che anticipano un analogo stallo sul piano epistemologico,
27
La moralità, nel senso di Preti, porta fuori dall’ethos ma la spinta centrifuga inerisce al sistema: in realtà, non c’è
alcun “fuori”.
50
Alberto Peruzzi – 2012
così come verrà alla ribalta internazionale con la filosofia post-neo-empiristica, nei decenni seguenti.
sotto forma di dubbi sulla razionalità della storia della razionalità, unitamente a dubbi sull’efficacia euristica (dunque pratica) di questi dubbi. Dopo la carne, pare che anche la ragione sia debole. Ammesso e
non concesso che la debolezza della ragione sia la massima conquista della filosofia del Novecento, a mia
volta dubito che in ciò stia il senso dei dubbi pretiani. C’è pure stato un Preti per il quale una conquista
del genere è semplicemente l’ultimo di una serie di errori di ragionamento, un Preti per il quale i nostri
sontuosi enigmi sono quelli che gli epigoni non riescono a risolvere. Esercizio. 28
11. Non esistono valori morali
In quale senso? Primo, nel senso che non esistono valori specificamente morali.29 La moralità sta
nella risposta a tutti i valori. Secondo, nel senso che non esiste uno specifico sentimento morale. Tesi
scheleriana che Preti espone in Adamo Smith: alle origini dell’etica contemporanea. Ma quale sentimento
avrebbe potuto essere “morale”? Se c’è qualcosa definibile come simpatia, attaccamento al gruppo, è
qualcosa di tanto generico da finire nel formalismo e, quando si determina concretamente, va soggetto a
tutta la variabilità storica e geografica dei tipi di società.30 Senza una qualche caratterizzazione, che passa
però per un ragionamento, lo stesso “senso del dovere” si presta a usi opposti a seconda che uno faccia
parte di un gruppo terroristico o di un’unità speciale anti-terrorismo.
Nella natura umana ci sono sentimenti contrastanti, c’è egoismo come c’è altruismo, c’è la propensione dell’individuo ad affermare se stesso a scapito degli altri come la disponibilità a sacrificarsi per gli
altri, e ambedue i tratti ammettono un’estesa gradazione. Ci sono società che premiano certi sentimenti
e società che li reprimono, benché (suppongo) tutte necessitino del loro ampio ventaglio per durare e
possibilmente prosperare. Preti avrebbe potuto limitarsi a richiamare tutto questo (richiamare, perché
c’era chi l’aveva già detto) e, vista l’insopprimibile pulsione dei filosofi, professionisti e dilettanti, a valorizzare un tratto rispetto all’altro, anche questo solo richiamo non sarebbe stato banale.
Invece, il senso del suo discorso va oltre il richiamo. Si vuol mettere in evidenza lo iato non fra natura e cultura, ma fra una generica natura, quale alveo di tutto e del contrario di tutto, e una particolare
cultura, quale sede propria di una determinazione oggettiva dei valori, che è poi una particolare determinazione gerarchica. I valori non potendo trovare fondamento nella natura più di quanto non possano i
28
Per risparmiare fatica a chi abbia la ventura di non essersi ancora addormentato: in tale stallo rientra anche il mio
apprezzamento verso la trascendenza immanente, che altrove ho descritto non come caratteristica intrinseca alla
moralità ma come caratteristica intrinseca alla dinamica del conoscere. In questo caso l’esercizio tocca a me.
29 Lo stesso dovrebbe dirsi per altri aggettivi messi al posto di “morali”, come indici di area.
30
Preti nota che il cosiddetto “senso sociale” si manifesta (e si riempie di contenuto) in una società contadina ben
diversamente che in una società industriale e urbanizzata. Vedi Praxis ed empirismo, p. 225.
51
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
disvalori, si vuol mettere in evidenza che ogni assiologia si costituisce sul piano extra-naturale, ovvero sul
piano della società.
Duplice messa in evidenza, duplice bonus. E duplice malus. Il primo malus è che in questo modo la
società diventa una sorgente di processi nettamente staccati dalla natura. Inoltre, si noti che si poteva
anche vedere lo iato in altro modo, cioè tra una natura non generica e una generica cultura e così il secondo malus è che pure la società è alveo di tutto e del contrario di tutto, come del resto la storia testimonia.
Se in quest’opera Preti avesse ragionato coerentemente con il metro che usa in chiave antinaturalistica, il discorso avrebbe dovuto condurlo a un esito anti-eticista e anti-storicista. Il che sarebbe stato in
linea con l’enfasi di Praxis ed empirismo sulle emozioni vitali come base di verifica, non con l’identificazione della società come sede oggettiva dei valori ma neppure in linea con l’idea della storia come romanzo progressista in cui l’auto-liberarsi dell’uomo prende forma, in linea di principio fino al punto ... di
fregarsene ampiamente della base di verifica! Vedi il samurai che si suicida, il martire religioso ecc. Problemini per la gioia degli esegeti.
12. Alle origini. Nome: Immanuel. Cognome: Hegel
Tra eredità kantiana ed eredità hegeliana il rapporto non è, per Preti, d’inconciliabile opposizione.
L’ethos è importante come àncora oggettiva quanto lo è il trascendimento di ciascuna forma di ethos in
conformità a principi morali che siano dotati o si presentino come dotati di superiore ampiezza (non si
tratta solo di maggior ampiezza, ma lasciamo stare). Il punto di saldatura? Si ottiene tenendo conto che la
spinta a trascendere ogni dato (specifico) ethos nasce da una situazione di crisi di valori, interna alle relazioni oggettivamente vigenti fra gli uomini, e che la spinta si differenzia dall’astratto appello a una pura,
formale, universalità perché la spinta si precisa sempre in relazione una data situazione di crisi e di questa situazione reca traccia.
Un tale approccio è più che meta-dialettico, cioè, non si riduce a un’analisi del rapporto fra dialettica e antidialettica. Preti prospetta una dialettica di second’ordine; e questo modo di impostare la dinamica tra ancorare e disancorare le scelte morali ha un merito immediatamente riconoscibile per contrasto:
staccando un elemento dall’altro si finisce immancabilmente per privilegiare l’uno a scapito dell’altro e si
cade o nel conservatorismo o nel moralismo. 31 A notare i difetti di entrambi era evidentemente un Preti
convinto che l’approccio meta-dialettico (o meglio: dialettico di ordine 2), empiristicamente rivisto e
31
Il concetto di “persona” come sede dei valori è considerato da Preti un mito, sia perché prescinde dall’individuo in
carne e ossa (Adamo Smith ..., p. 29) sia perché perde di vista la dimensione sociale. Il bersaglio è ovviamente Scheler.
52
Alberto Peruzzi – 2012
corretto, potesse portare a uno storicismo ‘buono’, centrato sull’autotrascendenza dello spirito oggettivo e, per questo, antidoto a ogni teleologia.
La sua convinzione circa un tale effetto positivo era un’ipotesi. Quest’ipotesi era legata a un ‘concetto’ che Preti accenna ma non sviluppa mai. Di nuovo, peccato – perché credo che avrebbe meritato
uno sviluppo. Ecco una formulazione stringata del ‘concetto’:
la contingenza di ogni sistemazione storica dei valori è relazionale (relativa), tanto relazionale quanto lo è la necessità dei principi ideali che inducono a modificare una data sistemazione storica dei valori. 32
Ricordiamoci quali sono i due punti salienti del ragionamento che sta dietro a questo ‘concetto’: (a)
siamo noi a giudicare contingenza e necessità e siamo noi a farlo sempre situazionalmente, cioè in relazione alla specifica situazione in cui ci troviamo a giudicare, (b) la fecondità del dover-essere che trascende l’ethos è misurata dal nuovo ethos che s’instaura.
Sulla coerenza di (a) con (b) nutro qualche perplessità, come sulla possibilità di portare avanti (e
non semplicemente di annunciare) un ragionamento filosofico che riesca a dire qualcosa mantenendosi
da cima a fondo a un simile livello di generalità dialettica (di secondo ordine, ma poi anche di terzo, di
quarto, ecc.). Quine notò che alla domanda Che cosa c’è? la risposta logicamente avvertita è Tutto. Facendogli il verso, alla domanda Che cosa vale? penso che la risposta assiologicamente avvertita, frutto di
una dialettica di ordine n, per n che tende all’infinito, sia identica.
Un biologo evoluzionista non dirà che l’evoluzione ha fatto bene o male a imboccare una strada
selettiva piuttosto che un altra: si sforzerà piuttosto di capire che cosa è successo e che cosa ha favorito
quella strada a scapito di altre. Più che legittimo. Un filosofo che faccia lo stesso, indossando i panni di
un alieno che guardi alle passioni umane e alle istituzioni sociali dei terrestri da un remoto angolo della
galassia, fa un altro effetto, anche se l’esigenza di prendere le distanze da ogni contenuto specifico del
discorso etico, se coltivata con coerenza e fino in fondo, spinge a diventare alieni. Curiosamente, dunque, si ripropone sul piano meta-etico una questione che si poneva già sul piano etico: partecipare o lavarsene le mani.
In Oriente, la dottrina del “vuoto” acquistò per i buddhisti una valenza etica che in Occidente pensatori dialettici come Preti esitano ad articolare. Altrove, per esempio in fisica, c’è stata maggiore disponibilità, e per quanto riguarda la musica John Cage voleva rieducarci ad ascoltare le pause – non so con
quanto successo. Preti annuncia un silenzio/non-silenzio che poi non articola. Il risultato, sul piano etico, è ambiguo: va da uno stoicismo minimal a una specie di gioco al massacro – alle origini dell’etica contemporanea troviamo le aporie dell’etica futura. Segnali in questo senso si trovavano già, per quanto ri32 Vedi anche il Memo n.5, p. 3.
53
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
guarda l’epistemologia, in Fenomenologia del valore, allorché si osserva che la spinta a conoscere la verità ha un valore pragmatico in contrapposizione al valore non meno pragmatico dell’utile qui-e-ora, e a
tale osservazione ci si ferma, nella superiore consapevolezza che l’analisi dialettica della spinta verso la
verità non avvalora alcuna specifica verità.
Evidentemente dev’esserci qualcosa che non ho capito perché trovo difficile conciliare la lezione di
questo testo con quella di Praxis ed empirismo. Forse le perplessità che ho espresso sul carattere “negativo” della dialettica pretiana sono dovute all’inadeguato apprezzamento del bonus (rispetto al malus) e
qui intendo ovviamente il beneficio che deriva dal negare allo stesso tempo il sentimentalismo dei ribelli
e lo schiacciamento della morale nell’ethos. Dopotutto, Preti stava proseguendo con coerenza una campagna leibniziana, finalizzata a mettere d’accordo prima idealisti e positivisti, e poi neoempiristi, neocriticisti e materialisti storici, attraverso un raffinato ripensamento degli stessi termini che identificano i
contendenti. Il suo materialismo non era economicistico e il suo neorazionalismo non è aprioristico (nel
senso tradizionale), perché ... tutti i valori sono economici (vedi Fenomenologia del valore) e ogni sistemazione storica dei valori dà corpo a un reticolato categoriale che funge (convenzionalmente) da a priori.
Allora come si deve valutare chi infrange l’ethos in nome di valori che lo trascendono? Il ribelle che
si ammanta del titolo di rivoluzionario è soltanto un disadattato? O è da nobilitarsi come eroe in vista di
quella superiore razionalità che tocca in regalo ai posteri? Chi non lo infrange è, invece che un conformista, uno strenuo difensore dell’umanità in tempi di barbarie? Sono le facce opposte di uno stesso cubo
meta-dialettico.
Premesso che anche a Preti si applica l’immanente trascendenza, di modo che Preti l’hegeliano
pragmatista, o il pragmatista hegeliano, di Alle origini dell’etica contemporanea non esaurisce il Preti
meta-dialettico, il Preti situazionale mostra qui di avere un occhio di riguardo per una delle facce del
cubo a scapito delle altre. Dopo aver ricordato che anche la più radicale e creativa delle ribellioni sfrutta
in realtà risorse del tessuto culturale che vorrebbe strappare (comportamenti, abitudini, modi di pensare
... e di parlare), Preti l’hegeliano pragmatista arriva alla conclusione che l’unico metro è il successo. La
storia è scritta col senno di poi, cioè è scritta dai vincitori e i vincitori hanno il vezzo di riscrivere sempre
il proprio albero genealogico. Il loro successo è determinato dall’aver colto (intuito, il più delle volte) i
semi del mutamento che già agivano all’interno di una data realtà. C’è osa esplicitare le “contraddizioni”
presenti e fa crescere e moltiplicare quei semi fino a produrre un nuovo assetto complessivo, sarà ricompensato da posteri che non hanno intenzione di osare. (Ma quanti semi ci sono nel presente? C’è qualcuno che li ha contati?) Il meta-dialettico vuol tener conto di tutto ciò e allora non gli resta che stallare.
Un percorso simile, riferito alla filosofia della scienza, dovrebbe collocare Preti accanto a Kuhn e
Lakatos, a differenza dei quali Preti non sviluppa le sue considerazioni in una polemica contro l’assetto
dato alla filosofia della scienza dai neoempiristi e, più in generale, in chiave anti-metodologica. Il suo
54
Alberto Peruzzi – 2012
intento è diverso, guidato com’è dall’idea di un’integrazione storicista della struttura della scienza che
voglia avere l’efficacia di una politica culturale.
Col senno di poi, questa volta esercitato nei confronti degli esiti della “nuova” filosofia della scienza, vien da chiedersi se invece che un difetto il suo silenzio/non-silenzio non sia un pregio. Anche qui c’è
qualcosa che mi sfugge. Nel caso fosse un pregio, ci sarebbe voluta da parte sua una maggiore considerazione dello scienziato “normale” che difende saggiamente il sapere costituito e fa funzionare la macchina
a dispetto delle “anomalie”; e maggiore considerazione del corrispettivo sul piano etico, anche quando
tale impegno conservatore sia malriposto (malriposto, naturalmente, col senno di poi). 33
Mettendo da parte le asperità relative ai dettagli del ragionamento, la questione di fondo resta: in
quale misura valori come verità e giustizia, se dotati di immanente trascendenza, possono prestarsi alla
storicizzazione? Qui si apre una rosa di alternative ...
13. Il dramma del filosofo morale
È stupefacente quanto Preti scrisse fra il ’57 e il ’68 e quanto poco di questa produzione pubblicò.
Pur continuando a coltivare interessi teoretici, in quest’arco di tempo Preti dedica grande attenzione a
una problematica che per brevità può dirsi etico-culturale. Lo slancio civile che fino ad allora aveva animato il suo lavoro non viene meno; ora prende una curvatura più meditativa, che lo vede spesso rivendicare
un bios theoretikos autonomo dall’impegno politico-ideologico, perché il piano delle ragioni è prioritario
a qualunque impegno. 34 “Moralità e democrazia” (1962) è splendida testimonianza di questa nuova stagione.
Preti sente il bisogno di contestare le astrazioni ideologiche. Per esempio, la dimensione economico-politica che i marxisti hanno fatto bene a mettere in evidenza resta lontana dal tessuto della vita, tanto
da far dimenticare quella “sostanza dell’ethos” che fluisce sotto le griglie (qualunque sia la loro forma).
Gli uomini dormono, mangiano, bevono, si lavano, lavorano, si divertono, fanno all’amore,
qualcuno ama l’arte, qualcuno tenta di pensare ... Tutte queste attività rispondono a impulsi
33
Tutto questo a correzione di quanto affermato a p. 35 del Memo n.5. Anche la lettura dei Memo dev’essere dialettica.
L’enfasi sulla priorità non implicava un’abiura: l’autonoma dignità del filosofare era già un bandiera di Idealismo e
positivismo.
34
55
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
vecchi quanto l’umanità (almeno l’umanità storica) – si può dire che fanno parte della «natura umana», sia pure con tutte le riserve del caso.35
Con ciò, i precedenti richiami a una concezione materialistica sono non tanto negati quanto radicalizzati.
All’ambizione di guardare la storia dall’alto Preti antepone (torna ad anteporre) un diretto confronto con
il terreno vitale-esistenziale. Il tipo di economia, di diritto, di sistema politico che una società realizza è
come una cornice formale imposta alla vita degli uomini. La fluidità della vita scava l’alveo in cui scorrere
e poi se ne sente oppressa. Preti ci ricorda che la cornice non è il quadro, la forma non è la sostanza, il
sistema di vita non è vita.
Tutte le forme economiche, giuridiche, ..., ricevono il loro senso da uno strato più profondo, che
Preti appunto chiama “sostanza dell’ethos” e che, come il brano su riportato suggerisce, ha a che fare
con bisogni fondamentali degli esseri umani. Stabilito che questi bisogni non sono il portato di una cornice bensì il presupposto di qualunque cornice, la sostanza dell’ethos che fluisce sotto alle griglie non è
un magma informe: è “soggetta a leggi proprie” (ivi). Quindi, fra il terreno originario di una Lebenswelt
che è precategoriale e il terreno dell’ethos (istituzionalizzato e supercategorizzato) sembra ora interporsi
uno strato che è, al tempo stesso, oggettivo e vitale. Dico “sembra” auspicando che tale strato non coincida con il terreno originario, altrimenti sorge subito una contraddizione fra l’esserci “leggi”, che presuppongono una categorizzazione, e il carattere precategoriale attribuito alla Lebenwelt – che esclude
“leggi”. Ebbene, se l’auspicio è fondato, allora c’è un primo quesito cui occorre rispondere: quali sono
queste benedette leggi? E poi ce n’è un secondo: come si rapportano queste leggi alle forme dell’economia, alle forme del diritto ecc.?
Qualunque sia la risposta che ci piace dare, esige un’accurata analisi della zona di confine naturacultura. Ho già insistito sulla mancanza di quest’analisi in Preti, perciò mi limiterò a suggerire un paio di
esercizi sul senso da dare a fatti come Gli uomini dormono, mangiano ... Prima di formulare gli esercizi,
conviene richimare alcune cosette.
In linea di principio, nell’uno e nell’altro quesito non c’è niente di strano: si inseriscono perfettamente nell’indagine avviata in Fenomenologia del valore. Preti se li era già posti e aveva già tentato di
fornire a essi una risposta. In linea di fatto, dicendo questo, si va poco lontano. Guarda caso, Preti evita di
far il benché minimo riferimento al suo primo libro. La questione di come intendere la gerarchia dei valori, relativamente a una data comunità, si era venuta complicando. Dalla compresenza di disposizioni gerarchiche diverse e reciprocamente incompatibili scaturiva l’esigenza di ripensare i termini del loro confronto. Un modello dominante di ethos rappresenta solo l’esito di più o meno consapevoli decisioni in
35 In In principio era la carne, cit., p. 107.
56
Alberto Peruzzi – 2012
merito e, in più, ora c’è una novità con cui misurarsi, associata alla “massificazione” dei valori. 36 Resta
dunque da capire com’è possibile che il modello non coincida più con l’ethos del gruppo o della classe
dominante.
Anche se l’analisi condotta da Preti è acuta e coinvolgente, questi pregi non ci autorizzano a ignorare un problema, ovvero: le obiezioni mosse a tale massificazione sono coerenti con il richiamo alla sostanza dell’ethos e alle sue ipotetiche leggi? Vorrei tanto rispondere di sì. Invece, mi pare un po’ difficile.
Ecco allora il primo esercizio: trovare cosa va messo al posto dei puntini nei condizionali seguenti
Se c’è coerenza, allora ...
Se non c’è coerenza, allora ...
Il secondo esercizio è: fornire delle ragioni per rispondere che c’è coerenza o che non c’è.
14. L’io diviso dei buoni filosofi
Preti si sarà sentito superiore agli altri ma non si è mai atteggiato a profeta. Il fatto che giunga a dire
che non c’è più spazio per profeti razionali non esprime dunque un ravvedimento. Sembra piuttosto una
pacifica, ancorché ironica, denuncia di uno stuolo di malfattori e un invito a non seguirne l’hameliano
piffero.
Una simile denuncia (con allegato invito) dovrebbe trovarci tutti d’accordo, no? E allora perché
lascia l’amaro in bocca? A chi non lo lasciasse, potrei solo dire: mi dispiace per te, non sarai un malfattore
ma ti resta solo il lavoro d’ufficio. Confidando che tutti, più o meno, sentiamo l’amaro, perché lo sentiamo? Credo che dipenda dalla fiducia che nel lavoro filosofico sia possibile amalgamare un compito conoscitivo – e metaconoscitivo perché, a meno di pensare che gli scienziati siano automi incoscienti, la consapevolezza metodologica è parte integrante dell’attività scientifica – e un compito di orientamento morale.
L’amaro si può ridurre facendo leva sulla divisione del lavoro, se non fosse che l’amalgama non era
da intendersi come distribuito: in porta un filosofo-scienziato con davanti uno storico del pensiero, a
centrocampo un puro metodologo, sulle fasce uno specialista di estetica e uno di semio-linguistica, punte un teoreta e un filosofo morale, e così via37 fino a soddisfare tutti i gusti e le comodità di ciascun aspirante titolare (queste sono cose per chi s’è inventato i settori disciplinari al MIUR come per chi li prende
36 Lecis ha ben riassunto la questione nella sua, già citata, monografia su Preti (vedi in particolare, p. 280).
37 Se non piace quest’abbozzo di formazione, lo si può tranquillamente cambiare.
57
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
sul serio). No, il compendio era da intendersi come riferito alla stessa persona, o meglio a uno stesso tipo
di attività.
Quindi in filosofia l’altrove più che ragionevole divisione del lavoro intellettuale non andava bene; e
se per caso la divisione era in actu, Preti avrebbe detto che bisognava porre rimedio, invece di prenderne
atto come i polli d’allevamento prendono atto che il giorno non è mai seguito dalla notte, e ciò anche di
fronte a un in actu maestosamente comprovato nella storia della filosofia degli ultimi due secoli.
Siamo sinceri: l’uso del termine “profeta” era un bel tocco di retorica. Tolta la quale? Tolta la quale
non c’è più spazio per filosofi-scienziati (maschi e femmine) che siano guide morali. Ecco l’amaro in
bocca. Anche per quella di Preti. Perché significa mettere definitivamente in soffitta l’idea che sia di pertinenza della filosofia formulare un programma come quello espresso in Praxis ed empirismo (con tutte le
correzioni che sembri doveroso apportargli) e di ogni altro programma di “filosofia civile”, argomentato
e non solo esclamato con passione per farci riconoscere come bravi bambini agli occhi della collettività
che paga i nostri stipendi. I filosofi devono essere pagati solo per quel che possono fare e dunque solo
per riflettere criticamente, non per proporre.
Lo trovo onesto, metaeroico e ... funebre. Perché funebre è il riconoscimento che dovremmo fare
nostro: non c’è ragione d’avere fiducia nella possibilità di una società migliore sulla base di indicazioni
provenienti da qualcuno che si è rimboccato le maniche per chiarire, confutare, rielaborare dottrine epistemologiche, logico-linguistiche, etiche e politiche. La fiducia che tutto questo “impegno” serva allo
scopo (e serva pure ai nostri cospecifici) ce la possiamo scordare. Ma su quale altra base, su quali altre
indicazioni regolarci per guidare la nostra vita? Ecco che l’amaro non riguarda più l’identità professionale del filosofo che si guarda deluso allo specchio. (Oh, ci sono già troppi filosofi che godono nel dipingere la propria delusione.) Riguarda tutti quanti. E questa è la conclusione più amara. A scanso di equivooci: non ho nostalgia dei filosofi “profeti” e, se ci ho messo un po’ d’enfasi, mi scuso ma la posta in gioco
credo che la meritasse, perché ho fiducia che la posta in gioco interessi ancora agli animali razionali.
In Preti, il puzzle dell’io diviso si complica e per un preciso motivo: aveva maturato il convincimento che la strada imboccata dagli autori più vicini all’idea di una filosofia scientifica in chiave di logotecnoepistemologia (allora l’ala ideal-linguistica del movimento analitico, poi quella informatica, poi chissà
cosa) conduceva a una figura di operaio specializzato, una figura che tradiva non soltanto il compito di
una visione più ampia delle questioni ma anche il compito di critica dei costumi e, ancora nel 1957, di
indirizzo verso un modello di vita un po’ diverso da quello corrente.38 La metariflessione a tutto campo
che i grandi filosofi del passato avevano coltivato non poteva configurarsi soltanto come analisi (logica)
del linguaggio (comune o scientifico). Ma perché preoccuparsi di quel che non poteva esser così configu-
38 Vedi Saggi filosofici, I, pp. 112-113.
58
Alberto Peruzzi – 2012
rato se poi l’in-più non serviva a nulla e comunque l’in-più aveva sempre di nuovo bisogno di farsi visitare
dall’analista?
Mettendo, per il momento, da parte il dilemma, almeno una cosa spero sia chiara: come l’etica non
si lascia pigiare nella politica, così la filosofia non si lascia pigiare in logic, methodology and philosophy
of science. Nell’importanza che Preti dà alla questione non è neppure da vedere una svolta rispetto alle
sue posizioni precedenti, perché in esse non c’era niente che lasciasse pensare a un riassorbimento linguistico della filosofia. Però, non c’è più da puntare sull’analisi fiduciosi di poterne ricavare un apporto
decisivo nell’affrontare i problemi della conoscenza e del valore e nel trarne indicazioni per la praxis.
L’analisi metamorale diventa semplicemente, da componente ineludibile dell’indagine, oggetto d’indagine e d’indagine storico-critica, su un piano altro dal linguaggio, e per essa vale quanto più in generale
già osservato a proposito dell’analisi del linguaggio come strumento dell’epistemologia.
Eppure ... agli occhi di Preti il privilegio del momento descrittivo, anche il più certosinamente
scrupoloso, circa l’uso linguistico dei termini valutativi correva il rischio di legittimare l’ethos, arrivando
di sottigliezza in sottigliezza a nuove forme di conservatorismo; in parallelo, il privilegio accordato alla
modellizzazione logica della ragione morale, per quanto apprezzabile ne fosse il rigore, correva il rischio
di dimenticare le ragioni vitali su cui si regge la concreta realtà del costume, finendo per tirare troppo
l’elastico e svuotare di ogni contenuto gli ideali capaci di indurci a cambiare l’ethos.
Quindi non possiamo mettere da parte il dilemma. La razionalità che Preti era interessato a salvare
nell’etica era legata all’equilibrazione fra due istanze, descrittiva e normativa, e non era finalizzata né a
conservare né a sostituire gli ardori rivoluzionari con un formalismo adatto a macchine logico-formali. In
un primo momento l’esigenza di equilibrio allontana dalla praxis, ma allontana per vederla meglio (come
potrebbe dire un lupo filosofo a Cappuccetto Rosso) e, vedendola meglio, per agire in maniera più efficace. In un secondo momento, si fa strada la consapevolezza della difficoltà estrema di conseguire un
simile equilibrio, così come si fa strada il dubbio circa l’efficacia di un’impresa così estenuante. Si affievolisce la fiducia nel lavoro del filosofo-scienziato e si affievolisce la fiducia di poter salvare il ruolo di
guida morale, laica, prima attributo al filosofo della cultura. E allora compito descrittivo e compito normativo non trovano più saldatura. Se non lavori che smentiscono le loro premesse, restano solo lavori di
artigianato, sfruttando di volta in volta materiali offerti dalla cronaca. E dato che la voce dei filosofi non è
più ascoltata neanche da chi si batte per “il progresso”, non resta che cantare il ritornello di Doris Day.
Ora, rimettiamo nuovamente da parte il dilemma e riprendiamo l’analisi che Preti fa della struttura
(logica) del discorso valutativo. È un’analisi che brilla per la sua valenza provocatoria nei confronti della
tradizione indigena, con il suo eterno avantindré fra fede e determinismo (dal fisico al sociale). Un avantindré di per sé increscioso e, quando si tratta di ascrivere a chicchessia una responsabilità, paradossale
tanto per chi professa una fede quanto per chi la sprofessa. Alla luce di tale intento provocatorio il ritrarsi
59
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
dalla praxis si poteva configurare come mossa tattica, non strategica, perfettamente in linea con la polemica contro la riduzione della scienza a tecnica. Per capire la successiva insistenza sulla a-valutatività
della scienza, non c’è bisogno di altri tasselli.
È un Preti più-che-simmeliano che a questo punto ci dice: la messa fra parentesi di ciò che è vitale
... è vitale, anzi è “altamente” vitale. 39 Ma perché lo è? A più riprese ho sollevato questa domanda. Non
l’ho sollevata per mettere in luce l’assenza di una risposta, dal momento che motivi o ragioni per rispondere sono facilmente rintracciabili negli scritti di Preti. E dico “facilmente” fra il serio e il faceto, perché
l’avvocato del diavolo mi ha appena sussurrato all’orecchio che tutti i motivi o ragioni che possono venir
in mente finiscono per riprodurre la situazione di partenza: la scienza wertfrei contribuisce a soddisfare
certi bisogni elementari quanto contribuisce a creare situazioni in cui altri bisogni risultano insoddisfatti,
aiuta a liberarsi da superstizioni così come favorisce un più efficace controllo da parte del potere costituito sugli individui. La natura umana, si sa, è in perenne lotta con se stessa, quindi è a disagio, quindi ringrazia chiunque la tolga dal disagio in un modo o in un altro, salvo poi pentirsi. Insomma, l’efficacia è
neutra, non perché ci asteniamo da qualcosa ma perché ci imbarchiamo in ogni sorta di imprese: il bianco
si ottiene per miscela. In quanto neutra, a sua volta si offre ai più opposti scopi, definiti altrove, nel cuore
dei buoni o nella pancia dei cattivi, e quest’altrove è off-limits per la ragion pura pratica, con o senza analisi del linguaggio.
L’avvocato del diavolo è furbo e sa celare abilmente la sua tendenziosità. Ma il punto è che se teniamo presenti le molteplici, opposte ragioni per le quali la sospensione della vita è vitale, quella che si
delinea è una drastica revisione dell’idea baconiana: l’imperium hominis è anche supra hominem, con
tutta l’ambiguità che un tale imperio si porta dietro dalla rivoluzione scientifica in poi. Preti dà un’occhiata al vaso di Pandora e si affretta a richiuderlo. Non elabora la retroazione dell’immagine che ci formiamo della natura su qualcosa che ugualmente ci appartiene, ovvero l’immagine che abbiamo della cultura (ethos, arte, conoscenza). Capisce perfettamente che è tenuto a dire che la retroazione c’è; d’altro
lato, capisce che essa non basterà mai a togliere le castagne dal fuoco, cioè a dedurre una scelta morale
piuttosto che un’altra da principi decontestualizzati o da meri fatti.
È chiaro come a un certo punto Preti abbia visto nello “strumentalismo” alla Dewey una ciambella
di salvataggio. Ma chi insiste sul Preti pragmatista dovrebbe dire chiaramente che sta privilegiando un
aspetto del pensiero di Preti dal quale lo stesso Preti ha preso le distanze. “Moralità e democrazia” è anche a questo riguardo una tappa chiarificatrice, perché indica cosa c’è che non va nel pensiero di quel
Dewey che tanto era stato considerato da Preti e così fa capire cosa c’è che non va nelle speranze che
Preti aveva fatto proprie. A scanso di dubbi, ecco le sue parole, che è utile riportare anche in relazione
ad altre difficoltà precedentemente segnalate.
39 Saggi filosofici, I, p. 123.
60
Alberto Peruzzi – 2012
Dewey ha cercato una versione contemporanea del vecchio ideale della filosofia, di essere
profezia razionale, «scientifica»; ha cercato una nozione di «filosofia» in cui si fondessero
l’engagement del profeta con l’abilità intellettuale del «tecnico-scienziato». Disgraziatamente, il suo sforzo non si può dire riuscito. [...] quando Dewey fa una teoria della scienza,
fa in realtà una teoria della tecnologia, senza riuscire a dare un posto e una fisionomia reale
alla scienza pura (cioè, alla scienza tout court). [...] quello che i critici nordamericani di
Dewey non hanno messo in rilievo, né c’era da aspettarsi che lo facessero, è il carattere
yankee (acutamente notato invece da B. Russel) di quel pensiero. Soprattutto il conformismo che tutta la sua filosofia presuppone come un dato ovvio. Il «metodo dell’intelligenza»
teorizzato da Dewey può funzionare se, e solo se, gli uomini sono d’accordo su determinati
fini e valori fondamentali. [...] Due persone che hanno le stese idee circa il matrimonio e la
famiglia possono applicare il «metodo dell’intelligenza» per discutere l’opportunità o meno
del divorzio; ma non lo possono fare quando è proprio sul matrimonio e sulla famiglia che
non sono d’accordo. E se, e a quale livello, si possa raggiungere l’accordo, è cosa che non si
può stabilire a priori in nessun caso.
Perché la differenza essenziale sta in ciò: che mentre la verifica di un enunciato teorico è,
prima o poi, empirico-fattuale, la verifica di un giudizio di valore, è prima o poi emozionale.
[...] I giudizi di valore si «sentono» come giusti o sbagliati, ma non possono provarsi come
veri o come falsi.
Per un altro aspetto il pragmatismo deweyano è strettamente legato al mondo yankee – in
sostanza, un mondo infantile, femminile e alquanto animalesco: per il suo vitalismo. [...]
Che, come disse Scheler, l’uomo sia l’«asceta della vita» e che nella cultura la vita sia non
solo sospesa (il che ammette anche Dewey), ma si autotrascenda e possa persino invertire la
sua direzione (muovendo verso la morte anziché verso la vita) è cosa di cui Dewey era troppo americano per accorgersi. La cultura muove dalla vita, e alla fine ritorna pur sempre alla
vita [...] ma in sé non è solo una pausa di raccoglimento [...] è la costruzione di un altro
mondo – o forse meglio è la costruzione del «mondo», dato che quello della vita non è un
cosmo ma un caos [...]40
Naturalmente, qui non interessa la questione storico-filologica, né il fatto che il Pretin abbia preso
le distanze dal Pretin-1 significa che avesse ragione a prenderle. Si è liberi di ritenere erronea questa critica al pragmatismo, ma si deve allora dire perché quanto si afferma in “Moralità e democrazia” è sbagliato.
Altrimenti, si è solo dei furbacchioni, non dei filosofi. Le parole citate sono da mettere insieme alle seguenti, tratte da Retorica e logica, per fare un ottimo esercizio di ginnastica mentale. Auguri.
Il sapere, in quanto regolato dal solo autovalore della verità, è meno vischioso dell'ethos:
naturalmente tende anch'esso a conservarsi, ma la legge della verità, con l’accentuato ascetismo che richiede, neutralizza gran parte dei motivi di vischiosità. La scienza è più spre-
40 In In principio era la carne, pp. 114-115.
61
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
giudicata, e quindi, per il suo stesso ufficio, più aderente ai mutamenti che intervengono
nella rea!tà. Onde essa, operando criticamente contro l'invecchiata base pseudo-teoretica
che sorregge un arcaico sistema di istituzioni etiche (e quindi di valori), la costringe a mutarsi, costringendo con ciò l'intero sistema a rimotivarsi, quindi a riorganizzarsi: con il risultato che nasceranno istituzioni etiche diverse, e spesso molto diverse, dalle precedenti.
E così l’ascesi scientifica è strumento di riadattamento dell’ethos alle esigenze della vita:
restituisce al mondo dei valori la sua fondazione, la condizione stessa della sua efficacia –
mantiene aperte le vie della sua stessa autotrascendenza.
Questa, e non altra, è la funzione primaria della conoscenza scientifica, in quanto conoscenza, entro la dialettica storica della civiltà. Chiederle altro – chiederle di divenire teologia
oppure tecnologia, ideologia oppure progettazione pratica, è chiederle di tradire la sua
funzione, di sparire come tale dalla civiltà. Ma è anche chiedere alla vita di chiudersi in una
immanenza antivitale, in una pace e sicurezza che è la pace della morte.
15. Sostanza dell’ethos, autovalori, circoli viziosi
La sostanza dell’ethos si fonda su bisogni fondamentali, come quello di sopravvivenza, e su risposte
(emotive) hardwired, come sono le più immediate reazioni di piacere e dispiacere, per passare poi a
quelle concettualmente mediate di gioia e dolore, divertimento e noia. È a partire da questa base che si
instaurano i più elementari legami tra due persone (dalla semplice amicizia alla convivenza familiare,
dalla collaborazione per uno scopo comune al contrasto reale o simulato (in un gioco di finzione); e sempre a partire da qui si instaurano relazioni sociali elementari come quelle legate al mangiare insieme e alle
relative buone maniere. Qui, infine, si definisce anche il primo spazio per le differenze: a me piace più
questo di quello, a te più quello di questo; per me si dovrebbe fare così, per te si dovrebbe fare cosà.
Se Preti punta su questo piano di risposte “sostanziali” per ancorare le dottrine etiche all’esperienza, evidentemente non considera più sufficiente (determinante) il rimando alla rete di strutture d’insieme, socio-economiche. Qualora l’unica sorgente di struttura del valore stesse in questa rete, non ci sarebbe motivo, infatti, di tirare in ballo la sostanza dell’ethos; ma, per l’ennesima volta, qualora tale sostanza fosse priva di struttura, sarebbe difficile capire com’è che un caos può generare ordine (anche se
un ordine che non ci piace). Dunque, per costruzione, la sostanza dell’ethos non può essere caotica – o
caotica per intero. Il fatto stesso che la Lebenswelt si presti a essere articolata in una serie finita (dopotutto, abbastanza limitata) di forme primitive, pochi temi per le tante variazioni nei diversi tipi di società, è
spia di un paesaggio epigenetico in evoluzione, e allora il precategoriale sfuma sempre più nell’irriflesso
operare di pattern percettivi, emotivi e cognitivi.
Com’è chiaro (spero), se Preti avesse espresso in termini simili il suo ragionamento, la sua indagine doveva cominciare, non finire, qui. Invece è qui che l’indagine si arresta. In principio era la carne, ma
la carne com’è che funziona? Arrivato alle soglie di una fenomenologia degli schemi incarnati della cognizione e della valutazione, il discorso s’interrompe. Forse, Preti avrebbe osservato che è giusto così:
62
Alberto Peruzzi – 2012
proseguirlo significava fare un altro mestiere. Il suo era quello del filosofo. 41 Gli interessava dirci che la
gamma di forme culturali in actu, documentate da storici e antropologi, non esauriscono le potenzialità
combinatorie racchiuse nella sostanza dell’ethos. E ce l’ha detto. Ma se poi manca un’analisi dei ‘generatori’ che danno luogo alle combinatoria, allora tutta la fatica fatta per arrivare a un empirismo che eviti la
soluzione del ‘punto esclamativo’ è stata poco remunerativa.
Proprio l’attenzione tanto caldeggiata verso le risorse semantiche avrebbe potuto svolgere un ruolo
più “sostanzioso”. Ogni minima assiologia sfrutta l’oggettivazione / astrazione / nominalizzazione, nel
passaggio da Questo mazzo di fiori ha la proprietà P, ove P è un predicato di valore (come “bello) a La Pità di questo mazzo di fiori ha la proprietà Q, ove Q può variare molto ma in particolare può anche
esprimere la proprietà di essere un valore, con implicita un’attribuzione di valore al fatto che un valore (la
P-ità) si manifesti nel mazzo di fiori – un valore che ... ha valore e che sussiste anche indipendentemente
dal mazzo. Insomma, (1) passiamo dal parlare delle cose al parlare del valore delle cose; (2) passiamo dal
conferire-valore alle cose al conferire valore ai valori. Finendo dove? Finendo a valori che hanno lo stesso
valore che esprimono: autovalori.
Preti individua entrambi i passaggi, (1) e (2) e li descrive con grande finezza ma non esamina le radici del secondo nella sostanza dell’ethos e non esamina le radici del primo in quella che chiamerei, per
fargli il verso, “sostanza della ragione”. La sua preoccupazione è soprattutto rivolta alla struttura comparativa interna a ciascun valore (da x è bello a x è più bello di y) e poi alla comparazione gerarchica fra valori (da La bellezza non è utile a Il valore della bellezza è minore del valore dell’utilità). L’analisi del linguaggio valutativo giunge infine a individuare un predicato-di-valore ultimo: l’esser “degno-di-valore”
(axion), solitamente espresso da frasi come “... è (un) bene”.
Ora, anche il predicato “degno-di-valore” è articolabile comparativamente e così trova espressione
in giudizi di preferenza (il tale bene è maggiore/minore del talaltro bene). Si tratta di un predicato formale, nel senso che lascia completamente indeterminate le ragioni della preferenza; e siccome Il valore v
è più degno-di-valore del valore v’ comporta Si deve preferire il valore v al valore v’, la norma che ne possiamo estrarre è vuota: ha bisogno di riempirsi altrove.
Alcuni esempi familiari illustrano quanto vario possa essere il modo di esprimere una tale comparazione tra valori: La bellezza di un quadro sta/non sta nella verosimiglianza, L’uguaglianza è un bene
maggiore/minore della libertà, Primum vivere ... deinde philosophari , Testimoniare la verità è più importante della stessa vita, Che senso ha la vita senza l’amore? Fai ciò che devi, avvenga quel che può. Benché
la fenomenologia di comparazioni assiologiche sia ancor più vasta, già questi pochi esempi di V(v) >
V(v’) meriterebbero una fastidiosa analisi semantica; e la meriterebbero non solo perché nascondono la
41 Chissà cosa avrebbe pensato del libro di René Thom che uscì nel 1972.
63
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
genesi della comparazione ma anche perché ciascuno suggerisce un modo diverso dagli altri di impostare
la comparazione stessa.
NB.I) Secondo Preti, la comparazione dev’essere considerata essenzialmente metamorale, ove l’essenzialità sta a significare che il dominio delle cose, il dominio dei valori delle cose e il dominio dell’axion formale non possono stare tutti e tre assieme, ma devono restare distinti (su piani linguistici distinti), a dispetto del fatto che il linguaggio comune in cui i giudizi di valore (comparativo) sono formulati
sia semanticamente chiuso.
NB.II) Sempre secondo Preti, poiché non si può trovare una verifica empirica (quand’anche, non è
univoca) di asserti del genere, dall’indeterminatezza empirica delle ragioni a loro sostegno si può inferire
che essi hanno carattere di “tautologie”. In quale senso? Nel senso che (ed è una lettura benevola) il loro
status è riconducibile a definizioni circolari, auto-legittimantisi, quasi dicessimo che la giustizia è giusta
o che la maggiore bellezza è più bella della minore bellezza. Certo, possiamo addurre motivazioni a sostegno di ciascun asserto, però potremmo trovarne anche per la sua negazione e, anche se non riuscissimo a trovare evidenze in contrario, ciò non sarebbe ancora sufficiente a giustificare asseerti del genere
nella loro perentoria generalità. Quindi – Preti conclude – i valori supremi, in quanto autovalori, si possono contemplare e basta: trascendono la praxis e tuttavia sono perché fungono. In altri termini: hanno
un’essenza performativa. E com’è che fungono? Fungono da Idee nel senso di Kant, cioè, da guida regolativa del vivere e così trasformano il caos della Lebenwelt in ordine.
Ondivaghi e birbanti come siamo, abbiamo bisogno di una guida e, se non c’è, la inventiamo. Siccome (vedi Rivoluzione Copernicana) è una guida che noi diamo a noi stessi, non c’è alcuna etero-nomia.
Di fatto però, la guida scelta ci fa sentire inadeguati esattamente come una guida eteronoma. E vissero
infelici e scontenti perché così avevano deciso di vivere sarebbe dunque il nostro riscatto, il premio che
un’analisi dei valori non viziata da pregiudizi offre a chi sorride di fronte a E vissero infelici e scontenti
perché costava di meno. Qui il ragionamento di Preti, mi spiace dirlo, è penetrante quanto sbrigativo, per
le stesse ragioni che ho indicato a proposito dello status “tautologico” dei principi che dovrebbero definire le ontologie regionali e poi i singoli domini empirici di ciascuna scienza. Invece di ripeterle, mi limito a un esempio.
64
Alberto Peruzzi – 2012
Consideriamo una valutazione comparativa come quella espressa dall’asserto L’uguaglianza è un
bene maggiore della libertà.42 C’è stato un dibattito plurisecolare al riguardo e sono stati individuati pro e
contro, con i più svariati tipi di considerazioni, da quelle utilitaristiche (relative a un particolare contesto)
a quelle metafisiche. Il dibattito ha messo in luce una difficoltà che non può esser liquidata con una mossa
convenzionalistica, ovvero, la difficoltà di confrontare non due concetti-valore isolati ma due sistemi di
valori, accompagnati dalle loro relative argomentazioni. Perché, se in gioco sono autovalori, allora ciò su
cui si contende è, in ultimo, il significato stesso dell’axion da ascrivere a uguaglianza e libertà. Chi fa
una mossa convenzionalistica sul piano metamorale una volta, per coerenza è tenuto a ripeterla una seconda volta e poi un’altra ancora. Purtroppo, chi dice che ogni decisione su quali convenzioni adottare è
convenzionale (appellandosi al carattere autovaloriale dell’institutio), bara. Infatti, andar a dire ai contendenti (vale più l’uguaglianza / vale più la libertà) che si mettano l’animo in pace, tanto si tratta solo di
accettare una tautologia piuttosto che un’altra, che senso ha? Immaginiamo qualcuno che in nome di una
superiore, liberale, coscienza della variabilità dei concetti ci venisse a dire che la forma logica fondamentale di un asserto deve, per non essere viziata da pregiudizi, contenere solo variabili. Il guaio di una forma
logica in cui ci siano solo variabili (quindi anche variabili logiche al posto di connettivi e quantificatori) è
che non ha più nulla a che vedere con quel che intendiamo per “logica”. Analogamente, il formalismo
metamorale, associato alla totale indeterminatezza dell’axion, non ha più nulla di assiologico. Antipatico,
vero?
Se non bastasse, è dubbio che il carattere tautologico di un auto-valore possa andar d’accordo con
il carattere comparativo (seppure nascosto) di tutti i giudizi di valore. Certo, si può pensare all’autovalore come al top della scala comparativa che, come tale, è inteso coprire ogni grado inferiore, ma è un’operazione che comporta un bel po’ di lavoro logico.
Prendiamo due asserti come La verità è vera e I valori hanno valore. Possiamo giudicarli strampalati o sublimi: non è questo il punto. Il punto è piuttosto che a) non è affatto ovvio che abbiano carattere
tautologico o siano dei circoli viziosi; e b) è difficile capire come, se poi devono funzionare da principi
regolativi a mo’ di Idee-della-Ragione, questa funzione possa essere svolta da tautologie (nel senso generoso su indicato). Sarò ottuso ma penso che qui si conceda troppo al formalismo, perché non basta parlare genericamente di funzione regolativa: bisogna dire quale. Il trucco sta nell’aver presupposto quale,
facendo poi come se in questa identificazione non fosse presente alcun giudizio comparativo specifico.
Manca insomma un’analisi come quella condotta da Robert Nozick nell’ultima parte di Spiegazioni filosoAvrei potuto prendere La libertà è un bene maggiore dell’uguaglianza, ma non sarebbe cambiato il senso di quel
che segue. Do per scontato che in entrambi i casi qualcuno senta la mancanza di un locativo spaziotemporale: “In
presenza di tali e tali condizioni empiriche (sociali, politiche, ecc.) ...”. Cambiando il locativo, potrebbe non esserci
più disaccordo di valore. Ignorerò questo tipo di argomenti perché facilitare una partita non è mai rientrato nei miei
gusti. Il Preti più-che-pragmatista ci mette di fronte a una bella sfida intellettuale. Se la contestualizziamo pragmaticamente, ce la perdiamo (e con essa ci perdiamo il Preti più-che-pragmatista). Personalmente, preferisco accettare
una sfida mettendo in conto l’eventualità di perderla, piuttosto che far finta di accettarla e poi reinterpretarla in
modo tale che non rischio più nulla.
42
65
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
fiche. Risultato: il piano degli autovalori che Preti ha il merito di aver elaborato in modo originale (anche
se non è stato il primo a tematizzarlo) non trova sviluppo. È significativo che ci sia voluto un Nozick per
avviare questo sviluppo, se pensiamo a quanti hanno preso la parola sul tema (e continuano).43 Voglio
dire: non mi sembra che tra coloro che lessero Preti, con simpatia o antipatia, ci sia stato qualcuno capace
di intavolare con lui un dialogo che lo aiutasse a sviluppare le sue osservazioni sugli autovalori.
14. Alla ricerca di valori intrinseci
Anche se il discorso pretiano si arresta sul più bello, resta il suo coraggio di essersi avventurato non
alle origini ma alla frontiera dell’etica contemporanea, anche se non l’ha detto. Questo coraggio è, in
particolare, avvertibile quando Preti discute la distinzione tra valori estrinseci e intrinseci.
Il fatto che nel tempo insista di più su questa distinzione è un altro segnale del suo progressivo
allontanamento dalle istanze pragmatiste – allontanamento che va di pari passo con il recupero delle
obiezioni di Frege e Husserl alla riducibilità della necessità logica a qualunque sorta di fatti. Un giudizio
di valore sarà motivato quanto si vuole da fatti situazioni contesti problemi concreti e avrà bisogno pure di
un concreto ‘portatore’ che si proponga obiettivi pratici, ma se fosse tutto qui avremmo accesso soltanto a
valori estrinseci. Invece, per Preti, non è così e i valori intrinseci si manifestano in asserti che isolano una
qualità assiologica dal contesto. 44
Prendiamo l’asserto Questo è un bel palazzo, che attribuisce un valore estetico a un oggetto e supponiamo che sia inteso come attribuzione di una qualità (sui generis) a qualcosa di isolato dal contesto.
Beh, una volta che l’abbiamo isolato, non possiamo forse ricontestualizzarlo? Per esempio, se immaginiamo che il palazzo sia collocato in un altro posto, a fianco di altri edifici di dimensione molto diversa e
di stile molto diverso, può anche darsi che non diremmo più Questo è un bel palazzo. Fin troppo facile. Il
punto è che l’isolamento stesso dell’oggetto presuppone che si abbia accesso a qualcosa da cui lo si isola.
Banale? Non direi, perché c’è isolamento e isolamento. Anche per un robottino della forma giusta e che
fa bau bau si può dire Questo è un bel cane. Chi l’ha progettato lo dirà in considerazione di quel che c’è
dentro e il pubblico cui viene presentato lo dirà perché non si preoccupa di guardare com’è fatto dentro.
Anche la piazza in cui è collocato il bel palazzo può essere detta bella isolandola dal palazzo o dall’intero
quartiere che le sta attorno. Ma fino a che punto? Un isolamento troppo generico non porta da nessuna
parte e un isolamento troppo specifico non porta ad alcunché di intrinseco. Dovremmo concluderne che
l’attribuzione di intrinsecità a un valore è tanto formale e vuota quanto gli asserti “tautologici” circa gli
43 Altrettanto significativo è che ci sia stato così scarso interesse per questa parte della ricerca di Nozick.
44
Volendo ricamare, si potrebbe ricordare che la non-contestualità (e non ‘puntiformità’) era per lui legata al discorso scientifico, ma lasciamo stare. È comunque un buon esercizio.
66
Alberto Peruzzi – 2012
autovalori? In tal caso si tratterebbe di un’esclamazione e di un invito a condividerla. Non era questo
l’intento di Preti, giusto? Ma Preti non ci dice come evitare un tale esito.
Isolare l’oggetto X, concreto o astratto che sia, è anche mettere fra parentesi la sua funzionalità per
qualcosa d’altro. Di conseguenza si potrebbe dire che un valore è ascrivibile come intrinseco a X se e
solo se prescindiamo dall’utilità di X a uno scopo Y, per ogni Y. L’ascrivibilità non è però l’ascrizione. È
ragionevole supporre che l’ascrizione avvenga in virtù di alcune relazioni tra le componenti di X, anche
se nessuna di esse, presa a sé, è depositaria o responsabile del valore intrinseco. Non supponendolo,
infatti, rischiamo di dover considerare dogmatica o viscerale l’ascrizione.
A parte l’implicito assunto che X abbia componenti riconosciute o riconoscibili, dunque sia una
configurazione strutturata (il che non è scontato), la domanda allora è: in virtù di quali relazioni tra le
componenti X ha valore intrinseco? È un dato di fatto che alcune proprietà (per esempio, simmetria,
equilibrio, ecc.) di una configurazione sono apprezzate come tali e che tale apprezzamento rimanda a un
particolare assetto relazionale delle componenti, fatta astrazione da tutto il resto. Purtroppo ciò non
basta a fondare una distinzione netta fra valori intrinseci ed estrinseci che sia più di una dichiarazione
puramente formale, ‘di principio’. Se non abbiamo la minima idea di cosa sia un quark che glubbifica,
dire che c’è una distinzione netta fra i quark che glubbificano e quelli che non glubbificano non aiuta a
capire alcunché. Fuor di metafora: se si vuol dire che X è una gestalt emergente sotto il profilo assiologico, bisogna dire cosa individua tale gestalt, dire come fa ad emergere e dire come mai quella e non un’altra.
Preti affronta la questione da un angolo diverso, cioè, quello della funzione che svolgono i valori
intrinseci e, a questo riguardo, afferma che i valori intrinseci fondano quelli pratici, i quali sono inseriti
in una catena di rapporti mezzo-fine-mezzo-... da cui i valori intrinseci sono (per costruzione) indipendenti. Che siamo d’accordo o no, in ultima analisi quale funzione ha il carattere fondativo dei valori intrinseci ? A mio parere, il senso dell’enunciato che asserisce che i valori intrinseci fondano quelli pratici è
semplicemente quello di un postulato esistenziale: esiste qualcosa degno di valore, punto 45.
Non è curioso? Questo è esattamente quanto direbbe (con altre parole) una buona percentuale di
ordinary people, senza bisogno di tanto sofisticate analisi ... però c’è una piccola differenza: anche i valori che sembrano non avere alcun significato vitale ce l’hanno. Questo, l’uomo della strada non lo direbbe.
E questo invece, dopo Simmel, Preti non si stanca di ripetere. Quindi verrebbe la tentazione di osservare
che la differenza tra valori estrinseci ed intrinseci è una questione di grado, di ampiezza, di tempo (quel
che vale intrinsecamente è quel che è massimamente durevole, stile Diodoro Crono.
45 Sto saltando qualche passaggio, lo ammetto.
67
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Ma no, non può funzionare, perché farebbe rientrare nell’etica dalla finestra quel che era uscito
dalla porta: l’eteronomia. Il metro ultimo sarebbe ancora una volta pratico (onnipratico, se mi si passa il
termine), mentre se è vero che i valori intrinseci fondano quelli pratici allora anche la maggiore o minore
praticità dovrebbe fondarsi su qualcosa di intrinseco. 46
Ci troviamo dunque in una situazione aporetica, ove la morale convenzionalista arriva a un punto
morto. (Questi sono i miei assiomi, quali sono i tuoi? Non sembra che ci siano contraddizioni, in tutte e
due i casi. Ci sono prove che stabiliscano quale dei due è più efficace sul lungo periodo? No? Allora grazie
e arrivederci.) L’idea che sia intrinseco quel che definiamo o postuliamo come tale lascia insoddisfatti e, a
meno di seguire una terapia rieducativa che ci faccia apparire l’idea come soddisfacente, sentiamo di
dover cercare un’alternativa.
Volevamo guardare le gerarchie di valori dall’alto, anzi meglio andare in orbita. E una volta in orbita ci vediamo costretti a dichiarare qual è la metagerarchia inerente al nostro sguardo, ma siamo anche
diventati consapevoli che di metagerarchie ce ne possono essere altre e dichiararla non ci basta più. Il
ritorno a un’ancestrale Sinngebung che si esprime esclamando Che tu sia un valore intrinseco! non fornisce una ragione dell’intrinsecità, mentre era questa ragione ciò che cercavamo. Alcuni usciranno dal
punto morto affidandosi alla fede pur di garantire assolutezza ai valori intrinseci, altri dando alla distinzione tra intrinseco ed estrinseco un senso darwinistico, altri appellandosi al Teorema di Gödel per spiegare l’impossibilità di tracciare una distinzione netta, altri ancora ricorreranno a trucchi vari per dissolvere, piuttosto che risolvere, il problema.
E Preti? Sembra voler additare una soluzione diversa da tutte queste, ma onestamente non capisco
bene quale sia, a meno che non consista nel giocare un’ultima residua carta. E questa carta riguarda appunto la funzione: i valori intrinseci esercitano una funzione normativa che i valori estrinseci non esercitano, ovvero, i primi autorizzano imperativi categorici, i secondi autorizzano imperativi esclusivamente
ipotetici. Se ogni norma si fonda su un valore, anche laddove non sia chiaro quale esso sia, le norme che
sono, o scaturiscono da imperativi categorici si fondano su valori intrinseci, quindi hanno massima stabilità, mentre le altre no.
Tra l’altro, giocare questa carta comporta l’impegno a identificare tutti i valori soggiacenti a una
qualsiasi norma. Non sarà un gran che ma è già un basilare programma di razionalizzazione assiologica.
Sottoscrivere o no il programma? Io lo sottoscrivo e invito gli altri a fare altrettanto. Ahimè, il fatto di
sottoscriverlo (da parte di uno o di tutti) non è sufficiente, semplicemente perché non è un argomento
per sottoscriverlo. Si tratta di trovare argomenti che permettano di dire che la carta di Preti è vincente e
per costruzione non possono essere argomenti basati sull’assenso (o il dissenso) da parte degli esegeti di
46
Non ho mai visto Preti approvare l’argomento vittorioso di Diodoro Crono e così non credo che approverebbe
l’equivalenza intrinseco ≈ onnipratico.
68
Alberto Peruzzi – 2012
Preti intervistati all’uopo, anche se il loro assenso fosse unanime. Neanche una descrizione fenomenologica, o un’analisi linguistica degli usi che comunemente facciamo di termini come “giusto”, “bene”,
“valore”, e così via, servirebbe allo scopo, offrendo nel migliore di casi una serie di fatti (come passi in
actu del processo ‘costitutivo’) a fondamento di qualcosa che doveva essere indipendente da fatti.47
Quindi (per la n+n-sima volta) o si rivede la Grande Divisione tra Fatti e Valori o si trova un modo
per uscire dalla situazione aporetica accettandone i presupposti. Che si scelga l’una o l’altra opzione, il
recupero di temi scheleriani e di argomenti à la Moore non garantisce alcunché. Preti non condivideva la
tesi di Scheler secondo la quale i giudizi assiologici esprimono vere e proprie conoscenze, benché sui
generis. In tal caso, infatti, avrebbe riaperto la via verso un’unica gerarchia, che non voleva riaprire. Né
condivideva fino in fondo l’intuizionismo di Moore. 48 Perciò, nell’ammettere che ci siano valori intrinseci
e nell’ammettere che essi non sono valori finali (per evitare che tornino a essere collegati a un corso di
azioni), Preti sta semplicemente ripetendo che siamo, sì, di fronte a un salto categoriale, ma che il salto è
pur sempre relativo a situazioni empiriche: è un salto distributivo, non collettivo. Un completo svincolamento dei predicati di valore da predicati descrittivi pregiudicherebbe la stessa intelligibilità dei primi.
Mi rendo conto che quel che ho appena detto non eccelle per chiarezza e proverò a chiarirlo con un
esempio.
Vogliamo poter affermare che i Girasoli di van Gogh sono belli. Ma per poterlo affermare (come per
poterlo negare) presupponiamo una qualche esperienza di qualcosa (girasoli e/o altro). Anche nel caso
del più puro astrattismo, resta pur sempre una traccia di sensazioni cromatiche associate a oggetti, paesaggi, forme, macchie (la stessa individuazione del carattere ‘informe’ di una spruzzata di vernice reca
traccia di quel che informe non è (vedi test di Rorschach). Se la nostra comune esperienza quotidiana dei
colori fosse ‘alla Pollock’, i quadri di Pollock sarebbero veristici.
Analogamente vogliamo poter affermare che questo è giusto e quello no, che questo è un bene e
quello no ... Vogliamo continuare a dire che i principi espressi nella Costituzione di Weimar sono più
giusti di quelli introdotti col nazismo. In tutti i casi ci serviamo di predicati descrittivi (anche sub specie
negationis) per identificare, prima che per suffragare, ciò cui ascriviamo valore. E qui rientra in gioco il
parallelo tra conoscenza e valutazione: in entrambi i casi c’è il rimando a un’esperienza irriducibile alla
47
Variante: ci dovrebbero essere delle speciali ragioni pragmatiche che spiegano perché i valori non sono riducibili
alla praxis ordinaria. Temo che proprio questa fosse l’idea che Preti aveva in testa. Lo “temo” perché un’idea simile
obbliga a fornire un criterio pragmatico per individuare tanto speciali ragioni – criterio che non so individuare né
sulla base di quel che Preti scrisse né su altra base. Non escludo che qualcuno sia capace di individuarlo. Se ci riesce,
è solo pregato di farmi sapere come ci è riuscito.
48
I suoi distinguo in merito sono rimasti nei quaderni di appunti delle lezioni dell’ultimo corso, 1971-72, esclusi dal
testo poi pubblicato (Il problema dei valori).
69
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
strumentalità. La scienza non si riduce a tecnica, il bello non si riduce al vero, il valore non si riduce all’utile. Anzi, l’intrinsecità del valore è legata alla sua stessa non-pragmaticità.
Questo legame, però, è poco indicativo e tale doveva essere anche per Preti, in considerazione della
dialettica simmeliana della vita, perché alla fin fine bisogna pur trovare un modo per dire che l’irriducibilità della scienza a tecnica è, lato sensu, tecnicamente funzionale e che l’irriducibilità del valore intrinseco all’estrinseco ha in sé un bonus pratico. Così arriviamo anche a chiederci se questo bonus è intrinseco
o estrinseco. Ecco il busillis. Se è intrinseco, allora ... Se è estrinseco, allora ... Personalmente, non so
cosa si debba mettere al posto dei puntini. O meglio: ho qualche idea al riguardo ma sono anche convinto
che si possano riempire in altri modi e non dispongo di un criterio per decidere quale sia il modo migliore. Potrei contentarmi di dire che il bonus è polivalente? Sarebbe come dire, in stile baconiano, che obbedendo alla natura la governiamo meglio e poi aggiungere che questo “meglio” può corrispondere ora a
una maggiore obbedienza ora a una maggiore libertà dai vincoli della stessa natura. Analogamente: riconoscendo l’oggettività dei valori potrei alla fine servirmene come guida pratica più efficace di qualunque
ideologia pragmatica e poi, in nome della polivalenza, aggiungere che questa maggiore efficacia è ora più
realista ora più ‘copernicana’ (in senso kantiano). Se questo è il culmine della saggezza, c’è di che essere
perplessi, o sconfortati. La polivalenza è un invito alla reticenza? La reticenza è un valore intrinseco del
discorso filosofico? Se lo è, viene la tentazione di dire, come Raymond Smullyan: The Tao is silent. (Ma
per esser più in sintonia, perché dirlo?)
Evitando di generalizzare interessi e preferenze che non sappiamo se sono davvero universali de
iure, evitiamo di commettere errori di giudizio e di conseguenza – se le nostre decisioni su cosa fare si
basano, o si devono basare, su ragionamenti – evitiamo errori pratici di cui poi pentirci. Come si fa a dire
di no? Il punto è che anche in tutto questo discorso è implicita una presa di posizione (meta-assiologica):
un sistema assiologico aperto è preferibile a uno chiuso, valori universali sono preferibili a valori di parte,
l’unificazione coerente del nostro mondo di valori è preferibile alla sua frammentazione, l’incremento del
numero di cose prodotte dalla creatività umana è preferibile al loro decremento ... E da ultimo la ciliegina: è preferibile affidarsi a valori intrinseci che a valori estrinseci. Con ciò ci accorgiamo con sgomento
che un giudizio che avrebbe dovuto stare sopra a tutti i precedenti, in realtà fa parte della stessa lista: non
è qualcosa di aggiuntivo o di separato, anche se non consegue dai precedenti. L’esser fine-a-se-stesso è
un tratto intrinseco di un valore quanto è un tratto di un valore intrinseco e rende degno di essere perseguito qualcosa che non solo è riconosciuto come privo di utilità ma che può anche essere (o è già) in contrasto con il nostro utile. Solo che ... questa non è una spiegazione, una giustificazione o una “fondazione”; è solo l’esplicitazione di propensioni definitorie che abbiamo assecondato.
Per franchezza, una simile linea di pensiero è oggi molto lontana dal sentire comune dei buoni, il
quale è più conformista e vago di quanto si ha voglia di riconoscere, puntato com’è sull’utilità a lungo
termine dei valori intrinseci per il maggior numero possibile di abitanti del pianeta, e al quale sembra
70
Alberto Peruzzi – 2012
potersi contrapporre solo il sentire dei fanatici (fondamentalisti ecc.). Di modo che ... resta poca scelta.
Per uscire da questo conformismo è illusorio supporre che serva chiedersi perché è preferibile affidarsi a
valori intrinseci che a valori estrinseci. Forse aiuta di più chiedersi perché dovrei preferire il bene della
specie umana a qualunque altro. Se non altro, a questa domanda siamo in grado di dare una risposta (anche se banale), mentre temo che alla prima non siamo in grado di darla; e poi, la seconda domanda aiuta a
uscire dall’ipocrisia.
Lasciando entrambe le domande ad altri, cerco di consolarmi dicendo che quel che manca a Preti, e
a tutta l’etica cui si riferiva, è semplicemente la teoria dei giochi a somma non nulla, relativa a un Lifegame (molto più complicato di quello inventato da John Conway) in cui ci sono più agenti/player umani e
più agenti/player non-umani. La consolazione così ottenuta ha una data di scadenza molto ravvicinata,
purtroppo, fintanto che siamo incapaci di garantire che una tale teoria sia applicabile a (funzioni con)
agenti/player che se ne servono nel prendere decisioni. Qualora risultasse applicabile, cioè, fossimo in
grado di garantirne l’applicazione, sarebbe il culmine dell’illuminismo.
Tornando a Preti, se non ci resta che contemplare gli autovalori, allora, per simmetria fra conoscenza e valutazione, un’analoga enfasi sul carattere “contemplativo”49 dei principi fondamentali delle
teorie scientifiche avrebbe costretto Preti a rivedere l’idea che tali principi sono convenzioni, ogni convenzione essendo giustificata soltanto su basi pragmatiche. Non mi risulta infatti che qualcuno abbia mai
pensato di contemplare una convenzione – eccetto forse nel caso delle opere della conceptual art.
Preti enfatizza il carattere wertfrei della scienza nel suo complesso, ma proprio seguendo il suo
percorso lo scenario si popola di altre istanze. Ci sono per caso valori finali dell’impresa scientifica che
non sono intrinseci? Resterebbe comunque il problema di come si concili tale carattere “contemplativo”
verso i valori supremi con il loro status di Idee regolative. Non è chiaro, infatti, in quale senso chi ha un
“punto di vista empiristico” possa dire Sto contemplando una Regola Suprema e in quale senso una qualunque regola (suprema o no) sia intuibile.
Se Preti fosse stato un Kant redivivo, avrebbe potuto aggiornare quanto scritto nella Critica della
ragion pura dicendo che i Valori sono completamenti ideali di serie potenzialmente infinite di atti di
volontà, limiti non empirici trasformati dalla comune prassi semantica in entità: una costruzione del pensiero che poniamo come autonoma dal pensiero e dunque esterna a noi, garantendo ai limiti una ricaduta
di effetti pratici che altrimenti mancherebbe (tipo completamento della retta razionale con gli irrazionali). È così che i valori agiscono nel mondo umano e guidano la sua trasformazione. Ok, ma allora resta da
capire come si faccia a sostenere che i valori intrinseci non sono valori finali (sebbene il fine ora sia
proiettato così lontano da essere di fatto irraggiungibile).
49 Vedi Saggi filosofici, I, p. 140.
71
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Qui entra in campo una delle idee più interessanti (e – ma sono felice se mi sbaglio – meno studiata) di Preti: l’idea che il nesso fra valori e norme sia sintetico a priori, di modo che intrinsecità e teleologia
(autonomamente posta) si saldano reciprocamente.
C’è subito un problema: se il nesso è sintetico, deve escludere qualcosa. Ma cosa? Be’, Preti ha
escluso di poter fondare il valore sulla norma: ogni norma trae la propria legittimità da valori, anche se
questi non secernono automaticamente alcuna norma. Sotto questo profilo, il carattere sintetico del nesso sembra essere giustificato dal fatto che tra ciò che rientra nel piano dell’essere e ciò che rientra nel
piano del dover-essere non est inferentia (in un senso o nell’altro). Il catalizzatore della sintesi è affidato,
kantianamente, alla Volontà. Kantianamente ... se non fosse che i valori si pongono come fini per la volontà, ma non ne dipendono, e questo è un tratto decisamente anti-kantiano ereditato via Scheler: i valori
continuerebbero a valere anche se mancasse la volontà di realizzarli.
Dico a me stesso: come c’è un modo per evitare la lettura in chiave platonica di Kant, dovrebbe
esserci anche per evitare un’analoga lettura di questo esito del discorso pretiano. Lascio volentieri ad
altri il compito di individuare questo modo, pregando chi si accinga a svolgerlo di non camuffare da ragionamento la mera esclamazione che Preti non può e non deve essere considerato un platonico, ancorché anonimo (come i cristiani di Rahner). 50
Mi limito a un suggerimento: da tutto il discorso fatto fin qui è rimasta fuori l’intersoggettività, o
meglio è rimasta fuori per quanto attiene alla dimensione costitutiva dei valori (perché certo era presente
ogni volta che si parla di fini), ove l’intersoggettività intesa non è quella empirica, bensì quella che pertiene al piano trascendentale e che può anche trovarsi in contrasto con l’intersoggettività empirica. Né
c’è da stupirsi del contrasto perché il carattere “intrinseco” di un valore non si costituisce sul piano empirico. Il riferimento all’intersoggettività trascendentale nella fase di costituzione dei valori è dunque
necessario e il fatto che sia necessario aiuta a scongiurare un fantomatico iper-uranio.
È solo un suggerimento, che lascia irrisolta la questione epistemica: come facciamo a entrare in
sintonia con il punto di vista trascendentale? Le indicazioni di Preti sono scarse: a) abbiamo la capacità di
adottare una prospettiva universale che astragga da interessi personali o di parte, b) grazie a questa capacità arriviamo a riconoscere certi valori come intrinseci e siamo disposti a lasciarci guidare da essi nelle
decisioni e nelle conseguenti azioni, c) questa capacità e questa disponibilità sono parte della nostra dotazione di esseri umani in carne e ossa. Ebbene, quali sono i canali e le procedure in cui le suddette capacità e disponibilità trovano attuazione? Una ricostruzione delle modalità fenomenologiche del costituirsi
dei valori può davvero essere nettamente separata dalla psicogenesi, dall’etologia, dalla storia evolutiva
della specie umana?
50 A scanso di equivoci: non è mai stata mia intenzione scovare contraddizioni nel pensiero di Preti.
72
Alberto Peruzzi – 2012
Il che motiva un secondo suggerimento. Come ci sono gestalt(-en) percettive, possono esserci
gestalt cognitive e gestalt valutative che ci permettono di accedere alla dimensione formale del valore,
che se non ci casca in testa dal cielo non è neanche un costrutto limite della “pura” ragione. Se questa
possibilità corrisponde al vero, allora si tratta di capire come la dimensione formale del valore emerga nel
mondo-della-vita (sempre nell’ipotesi che esso non sia quel caos informe che aspettava un demiurgo).
Percorrere questa strada significa fare l’analogo, per l’assiologia, di quel che ho provato a fare per la semantica in alcuni lavori. 51 È anche un modo per proseguire l’analisi di Preti dal punto in cui essa si interrompe. Non presumo che sia l’unico modo possibile, né il più ‘conservativo’ rispetto al lascito pretiano,
ma almeno è un tentativo di proseguire quell’analisi, invece di ... contemplarla o di camuffare l’esegesi da
filosofia.
15. Parentesi sulla volontà
Rapporto tra valori e norme: in questo rapporto c’è un elemento sul quale è opportuno tornare. S’è
detto che la mediazione, in cui si attua una sintesi a priori, coinvolge la volontà. Ma perché si devono
volere i valori? Perché l’artista deve voler fare opere che siano belle? Perché lo scienziato deve voler fare
ragionamenti coerenti che portino a conclusioni vere? Perché il politico che siede in parlamento deve
voler fare delle leggi giuste? Preti era convinto che qualunque risposta a tali domande sarebbe stata
circolare. 52 Forse è solo per questo che la mediazione era sintetica a priori (un’attribuzione kantiana in
virtù di un motivo poco kantiano). Ecco, infatti, i due modi possibili, secondo Preti, di rispondere:
(1) “I valori si devono volere perché valori”.
(2) “I valori si devono volere perché si devono volere”.53
Ad (1), Preti osserva che questa risposta è “vuoto formalismo”, la norma così espressa essendo sì
assoluta ma totalmente indeterminata sul piano pratico. Ad (2), questa seconda risposta si oppone alla
precedente perché in luogo di un vuoto formalismo esprime un puro normativismo. Ma allora (1) non era
del tutto vuota, perché almeno escludeva una tale opzione. Il che risulta anche per un’altra via, in quanto
51
Cfr. “An essay on the notion of schema” (1999) e “Geometric roots of semantics” (2000). Lo so che è antipatico
fare riferimenti a propri lavori. Per quanto mi riguarda, si può tranquillamente omettere il mio nome e citarli come
opere anonime o frutto di qualche collettivo studentesco. Mi dispiacerebbe che si ignorassero le considerazioni fatte
in questi due lavori perché tutto il discorso che sto facendo finirebbe per essere un’elucubrazione priva di conseguenze.
52
Si sottintende: circolare, a meno che sia introdotto di soppiatto qualche elemento contenutistico, illegittimo sul
piano universale/formale del valore. (Il sottinteso era spesso enfatizzato da Preti per denunciare un vizio comune a
troppi filosofi.)
53 Cfr. Saggi filosofici, I, p. 146.
73
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
l’asserto (1), inteso alla lettera, è incompatibile con il carattere sintetico attribuito al nesso valore-norma:
infatti, (1) esprime pur sempre una norma ma dice che la norma è analiticamente derivabile dall’esserci i
valori.
Quindi (1) non può essere inteso alla lettera. In quale altro modo, allora, può essere inteso? Di
nuovo, chiedo scusa ma non ne ho idea. L’unico sostegno che riesco a trovare per (1) sta in affermazioni
come quelle che seguono: i valori meritano di essere realizzati, sono degni di essere voluti, non volendoli
toglieremmo valore a noi stessi ... Queste affermazioni non dicono nulla, eppure danno l’impressione di
dire qualcosa. È sicuro che non dicono nulla?
Prendiamo la prima affermazione: dire che i valori meritano di essere realizzati è dire che la realizzazione dei valori ha valore, ma da questo non scende che dobbiamo volerli realizzare; e se non scende,
allora perché dobbiamo? Non trovo di meglio che rispondere: dobbiamo, perché ciò che merita di essere
voluto, deve essere voluto. Purtroppo, un lampante circolo: giustifichiamo (1) ripetendo (1) con altre
parole.
Quanto alla variante (non proprio ‘ortodossa’) che fa riferimento al togliere valore a noi stessi, essa
sembra dire qualcosa unicamente perché si presuppone che noi abbiamo valore. E come si giustifica il
presupposto? Semplice: dobbiamo voler attribuire valore a noi stessi perché abbiamo valore. Che è come
dire: ciò che ha valore deve essere voluto – ovverosia, riaffermare (1) producendo un altro circolo.
Allora, come mai siamo convinti di star dicendo qualcosa quando affermiamo (1)? Di primo acchito,
sembra che ci stiamo impegnando nei confronti di qualcosa che stia a fondamento di tutte le nostre scelte
concrete e che proviamo una sorta di repulsione verso quel che negare (1) significherebbe. E cosa significherebbe, per lo scienziato, non essere tenuto a ricercare la verità; per l’artista, la bellezza; per il politico,
la promulgazione di leggi giuste? La più immediata risposta è: perché non sarebbero un vero (bravo,
buono) scienziato, un vero artista, un vero politico. Ma tale risposta è ancora una volta circolare (e le
risposte meno immediate sono ipocrite varianti di quella immediata). Infatti, che cos’è che rende “vero”
(bravo, buono) lo scienziato, l’artista, il politico?54 Un “vero” scienziato è un tizio o una tizia che oltre ad
aver acquisito un bel po’ di conoscenze/competenze s’impegna nei confronti di un valore. Cercando di
capire come stanno le cose e perché stanno così invece che in un altro modo, è qualcuno che ricerca. In
volgare, quel che ricerca si chiama “verità” e a tal fine s’impegna produrre le prove di quel che dice essere “vero”. La verità è un valore ma questo valore è qualcosa (invece che nulla) per chi sente una specie di
“dovere”, il “dovere” di cercarla (e viceversa, perché non si sente il dovere di cercare qualcosa che non
54 Se gli aggettivi sembrano rozzi, si possono sempre raffinare.
74
Alberto Peruzzi – 2012
abbia valore). Analogo discorso si può ripetere, mutatis mutandis, per l’artista, il politico e chi altri desideriamo aggiungere. 55
L’impegno etico è verso tutti i tipi di valori: epistemici, estetici, etici e anche religiosi. L’assiologia,
come teoria razionale, non è unitaria in virtù di un’unitaria gerarchia di valori, bensì in virtù di un comune impegno verso i valori. Non a caso Preti ci ha presentato la moralità come trans-categoriale.
Il che non fornisce ancora il benché minimo criterio per identificare i valori, ma ... teniamo presente l’effetto che ci fa uno che ha bisogno di un criterio per accedere a un valore. Comunque, nel caso che
un criterio non si trovasse, ci toccherà elencare un valore dopo l’altro (come del resto è sempre successo), per poi eventualmente accapigliarci sulla loro gerarchia. Un platonismo coerente richiederebbe l’individuazione del criterio, esattamente come Socrate non voleva che gli fosse presentato “uno sciame” di
virtù in risposta alla domanda: Che cos’è la virtù? Anche per i non-platonici l’esigenza da Socrate dovrebbe contare qualcosa. Se si decide che è fuorviante, tanto meglio o tanto peggio per Preti?
Siamo già in difficoltà con gli esempi principali di valore (verità, bellezza, libertà, giustizia) e così
non c’è bisogno di infierire. Se però l’elenco dei valori che riusciamo a stilare non è completo, i valori
esclusi non comportano impegni e quindi ne risultano pragmaticamente danneggiati. Questo, nell’ipotesi che gli esclusi si possano manifestare anche se di fatto non si manifestano qui e ora alla nostra sensibilità e alla nostra coscienza – altrimenti dovremmo dire che sono valori solo quelli che qui e ora riconosciamo come tali. Be’, in fondo, potremmo anche non essere completamente trasparenti alla coscienza e non
riuscire mai a sollevare il velo. Ma se fossimo insensibili? E anche se fossimo trasparenti, non vedo come
escludere a priori l’emergere di un numero potenzialmente infinito di nuovi valori se non facendo riferimento a un bricolage di vincoli naturali – i quali un’etica puramente razionale è in comprensibile imbarazzo a far propri – e a un surplus combinatorio rispetto a ogni data configurazione attuale di valori.
Non si insiste mai abbastanza sul fatto che una coerente organizzazione dei valori rimanda implicitamente a una serie di atti, e non ad atti isolati, ma ad atti tra loro connessi, in filiera. In ogni ambito dell’esperienza ci sono procedure, tecniche e relative regole, per fare bene qualcosa; e comunque, le indicazioni culturalmente sedimentate per una filiera di atti non bastano. Ci vuole anche abilità nel servirsene
bene per realizzare un qualche bene. L’impegno verso i valori è, insomma, ereditario: si trasmette al processo (gli atti che compiamo) e dunque investe le azioni compiute in ciascuno stadio della loro realizzazione. Se è buona cosa conoscere il mondo, è buona cosa conoscere come fare un buon telescopio per
osservare le stelle; e allora è buona cosa anche levigare bene una lente. Ecc. ecc.
55
Naturalmente, se l’artista si propone di squarciare il presunto “vero” e il politico di prospettare qualcosa di rivoluzionario, la questione non si sposta di una virgola. Il discorso è sufficientemente generico da ospitare modalità differenziate, e opposte, di realizzazione. Eppure, è un discorso che sembra dire qualcosa ...
75
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Il senso di quest’ereditarietà è completamente diverso da “il fine giustifica i mezzi”. Si potrebbe
puntare sul carattere ereditario dell’impegno verso i valori per dire che affermazioni come (1), anche se
non ci dicono cosa fare esattamente, esercitano un’azione persuasiva che sollecita a impegnarci nelle
tecniche impiegate, in ogni passo della filiera di atti. Il che, appunto, non significa che il fine giustifica i
mezzi, bensì che il fine esige che i mezzi abbiano lo stesso carattere attribuito al fine. E questo lo si poteva
già dire, del resto, per il formalismo dell’etica kantiana. Quindi, invece di lamentare una frattura fra sentimenti vitali e razionalità, dalle considerazioni precedenti potremmo ricavare che c’è un terreno basilare
di esperienze-di-valore da cui emergono i valori e che a quel terreno poi i valori, filtrati dalla consapevolezza critica, ritornano, dando luogo a effetti che una banale circolarità non spiegherebbe.
Non sapendo come proseguire restando aderente alle parole di Preti, cambio registro. Tale era
l’impatto che su noi studenti aveva l’idea di un’assiologia generale, comprensiva di logica, etica ed estetica, che leggendo i più svariati testi filosofici ci sembrava di trovare continue conferme di quest’idea: le
lacune argomentative (nel saldare una forma e un contenuto) conducevano a dire che in filosofia era finora mancata un’analisi della struttura del discorso assiologico come tale e ad aggiungere che più quest’analisi diventava primaria e più l’articolazione disciplinare della filosofia diventava secondaria, e fuorviante.
Avevamo la sensazione di una meravigliosa convergenza tra fenomenologia, neocriticismo e filosofia
analitica, a dispetto della letteratura che insisteva sulle differenze. Pensavamo che le polemiche tra le
scuole fossero dovute semplicemente all’incapacità di sviluppare con coerenza il disegno di un’assiologia
generale così come era configurato, e argomentato, da Preti.
In quest’ottica, la stessa periodizzazione del suo pensiero ci appariva superficiale, anzi non etica,
perché non teneva fede all’esigenza di trarre le conseguenze dalla sua indagine. Non avevamo sentore di
quanto scarso rilievo le indicazioni pretiane avessero nel panorama degli studi filosofici in Italia e all’estero. Con l’ingenuità degli allievi innamorati, davamo per scontato che tutti conoscessero quel che il
nostro grande prof aveva scritto.
Quelli che, dopo la laurea, decisero di fare ricerca, misero da parte il compito additato da Preti e
focalizzarono l’attenzione su questioni specifiche pur di non restare paralizzati dall’entità del compito. A
distanza di tanti anni ci si può pure permettere di essere franchi, riconoscendo la difficoltà oggettiva (se
non il carattere aporetico) del compito. Preti ci aveva messo in un bel guaio e, se un modo per venirne
fuori non si trovava, la colpa poteva anche essere sua, invece che nostra. Più o meno in questo modo anch’io mi sono sentito giustificato per aver messo da parte il compito. Se la franchezza è un paragrafo dell’onestà, impone anche di riconoscere che in questo modo non si è risolto alcunché e che ai suoi allievi è
mancato ... diciamo ... un po’ di etica.
76
Alberto Peruzzi – 2012
16. Differenze di credenza, differenze di valutazione
La volontà di credere che una tripla piroetta sotto la pioggia eviti il raffreddore non lo evita. La
mancanza di evidenze a sostegno è tale che non ci viene in mente di dover produrre argomenti che denuncino tale mancanza. In altri casi, specie quando la volontà di credere qualcosa è forte, bisogna argomentare tenendo conto dell’effetto placebo (ove al posto di una terapia c’è una convinzione morale), di
campioni e relative proiezioni induttive, e di quant’altro si renda necessario.
Ciò premesso, un disaccordo di valutazione (Tizio preferisce essere ingombrato dall’ombrello che
rischiare un raffreddore, Caio preferisce il contrario ) non implica un disaccordo di credenza (nell’esempio, circa i modi in cui si prende un raffreddore e i suoi effetti, così come circa l’azione svolta da un ombrello in buono stato, se aperto). Una stessa persona può cambiare le sue valutazioni nel corso del tempo,
ovviamente. E un disaccordo/cambiamento di credenza implica invece – è su questo che Preti insiste –
un disaccordo/cambiamento di valutazione. Esempio: quando si è smesso di credere che i salassi servissero a guarire da svariate malattie, si è smesso di pensare che fosse bene collocare sanguisughe sulla pelle
del paziente e si è messo in atto tale ravvedimento. Una credenza falsa non può essere addotta a sostegno
di un giudizio di valore (anche se il giudizio è di carattere strumentale, come nel caso delle sanguisughe).
La differenza nell’implicare o non implicare può ovviamente essere resa più cauta premettendo un generico “nella maggior parte dei casi finora esaminati ...” o limitandosi a considerare giudizi di credenza e di
valutazione relativi a un particolare ambito; ma, anche così facendo, il rapporto logico fra disaccordi/cambiamenti di valutazione e disaccordi/cambiamenti di credenza resta tale e quale.
Ora, perché una credenza falsa non può legittimare una valutazione? Per quanto smaliziati possiamo essere, al punto da sorridere all’idea che ci siano garanzie razionali di verità e coerenza, restiamo
animali razionali nel rifiutare l’idea che un giudizio di valore sia legittimato da credenze false. E ciò, a
dispetto del fatto che siamo vittime designate dell’effetto placebo, a dispetto del fatto che siamo scettici
su ogni pretesa realistica, e a dispetto del fatto che siamo facilmente inclini a ignorare sempre qualche
opzione oppure inclini a esser così cauti nell’escluderne una, tanto da finire come l’asino di Buridano.
Solo animali razionali, del resto, si accorgono di tutti questi ‘dispetti’.
Esempi più o meno banali: (1) in un processo relativo a un efferato delitto, nel momento in cui il
collegio giudicante acquisisce le prove che il reato non è stato commesso dall’imputato, il giudizio/norma In un caso come questo è giusto/nostro obbligo applicare il massimo della pena non ha senso, non è
razionale e a fortiori, in un “buon” sistema giuridico, non è applicabile all’imputato, visto che la credenza
che sia stato lui a compiere il delitto è risultata falsa;56 (2) A telefona a B: Devi uscire subito di casa perché
56
L’affermazione che “non ha senso” è un po’ forte, lo ammetto. Inoltre, il linguaggio giuridico richiederebbe maggiore precisazione, ma le finalità dell’esempio non la richiedono. Chi comincia ad allargare le piume della coda con
le sottili precisazioni del diritto, farebbe bene a seguire un corso di logica prima di finire il dispiegamento pavonesco.
77
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
fra un attimo esploderà una bomba non ha senso se B è già fuori di casa. A credeva che B fosse ancora in
casa, ma la sua credenza era falsa. (3) Se esci, è bene che tu prenda l’ombrello non ha senso se non c’è una
sola nuvola all’orizzonte e le previsioni del tempo non avvalorano l’ipotesi che pioverà. Quanto ai casi (1)
e (2), l’irrazionalità si misura col fatto che non cambierebbe nulla se si fosse detto che è opportuno applicare il minimo, invece del massimo, della pena o A avesse detto a B il contrario (NON devi uscire subito di
casa ... (che in italiano sta per Devi NON uscire subito di casa). Nel caso (3) c’è una residua compatibilità
fra dire che l’invito a prendere l’ombrello non ha senso e dire che Se esci, è male che tu prenda l’ombrello.
È comunque irrilevante osservare che il giudizio La rosa è bella perché ha serici petali di un rosso acceso,
una forma armoniosa e un profumo molto gradevole può non valere perché i nostri sensi ci ingannano.
Se una credenza che giudichiamo falsa, avendo più che giustificati motivi per giudicarla così, non
può suffragare una valutazione e se non ci sono altre credenze che avremmo motivo di considerare vere a
sostegno della stessa valutazione, è legittimo affermare che la valutazione è scorretta o infondata o ..., in
quanto manca una ragione fattuale. Con ciò stiamo appunto dando per implicito che ogni giudizio di
valore deve pur basarsi su qualche credenza fattuale (a sostegno della quale occorre addurre delle prove).
Altrimenti, un giudizio di valore riguarderebbe solo un ipotetico mondo possibile. Se ciò che di fatto si
verifica o non si verifica fosse per noi irrilevante ai fini di un giudizio di valore, o tanto rilevante quanto
lo è quello che si verifica in un mondo in cui la vita non si basa sul carbonio) non saremmo i liberali che ci
piace credere, ma saremmo vittime di un atteggiamento dogmatico, tipo Pereat mundus, fiat veritas. Il
dogmatismo è un disvalore: viola quei principi che distinguono una civiltà emancipata da superstizioni,
tabù e imposizioni autoritarie, prive di motivazioni razionali e fattuali.
Tutto il ragionamento svolto per rispondere alla domanda iniziale mette semplicemente in luce una
cosa: lo stretto nesso fra razionalità, sensatezza e valori. Per un verso è un ragionamento circolare, per
un altro esige una legittimazione empirica di almeno uno di questi tre termini per poter legittimare gli
altri due proprio in virtù della circolarità. (Esercizio post-quineano.)
Tre precisazioni sono necessarie.
(a) In rapporto al venir meno di motivazioni fattuali Preti fa l’esempio della stregoneria in Retorica e logica (p. 234): se non esistono streghe (in quanto ciò che viene loro attribuito, in quanto streghe, è
falso), allora non è legittimo accusare qualcuno di stregoneria e tanto meno abbrustolirlo. Ciò è
detto a maggior gloria della scienza. Quel che Preti non dice è che nel nome stesso della scienza
sono stati compiuti molti ‘errori’ e legittimato azioni che giudichiamo ingiuste né dice che, in
alcuni casi, quegli ‘errori’ sono stati riconosciuti come tali non tanto grazie al dibattito critico
interno alla scienza ‘ufficiale’ quanto a dispetto di tale dibattito, e che le sollecitazioni in tal senso sono derivate anche da preoccupazioni di natura extrascientifica (etiche, in senso tradizionale). Ma quel che non dice non è in contraddizione con quel che dice: semmai, lo completa o lo
78
Alberto Peruzzi – 2012
rafforza. L’idea che ci sia una moralità aletica che include propriamente l’impresa scientifica è
d’altronde indispensabile per evitare che i cambiamenti nelle modalità di condurre la ricerca, di
organizzarla e di comunicarla siano da spiegare solo in chiave strumentale.
(b) In rapporto alla sostituzione di una credenza/conoscenza con un’altra, a sostegno di uno stesso giudizio di valore, Preti fa l’esempio della condanna dell’adulterio: dopo la diffusione dei profilattici (e ancor più dopo la scoperta della pillola) il ‘rischio’ derivante dalla nascita di figli illegittimi
è stato sostituito dal ‘rischio’ di instabilità nel nucleo familiare e nelle cure parentali. I giudizi al
riguardo variano molto: da quelli che attestano semplicemente la propria condivisione dell’ethos
corrente a quelli che ribadiscono la propria condivisione di dogmi di fede, da quelli che esentano la morale dall’ingerirsi in faccende di sesso a quelli che non l’esentano proponendo piuttosto
una morale ispirata al “ritorno alla natura”, da quelli che mettono in dubbio l’istituto del matrimonio a quelli che si affidano a considerazioni etologiche per difenderlo. Qualunque sia l’opzione che decidiamo di fare nostra, dobbiamo renderci conto che ne derivano conseguenze
‘spiacevoli’. Il senso etico, del resto, cresce con la consapevolezza del costo che hanno le nostre
scelte (nella gerarchia di valori e nella linea d’azione che di conseguenza viene scelta) e decresce
invece con l’idea infantile che ci sia sempre un modo per negare il costo. Il senso etico è legato
alla responsabilità – e qui prendo per assiomatico che conservazione e crescita del senso etico
siano un bene.
(c) Può succedere che un comportamento socialmente sanzionato senza motivazioni scientifiche acquisisca in seguito tali motivazioni. Il fatto che le acquisisca non obbliga a condividere il giudizio
negativo sul comportamento. La diffusione dell’AIDS tra gli omosessuali e tra chi aveva frequenti rapporti ‘occasionali’ ha indotto alcuni a vedere nel maggiore rischio di contrarre l’AIDS
la conferma di un giudizio negativo, se non una nemesi anticipata. Il semplice uso del profilattico (con un materiale plastico prodotto artificialmente grazie alla ricerca chimica) riduce notevolmente il rischio. Ma supponiamo che un’altra ricerca scientifica mostri danni collaterali derivanti da questo tipo di pratiche sessuali e supponiamo che i tentativi di contestare i risultati di
tale ricerca falliscano. Chi desiderava punire gli altri contagiandoli ne sarebbe più che contento,
perché ora sa che la punizione è incrementata e, se vuol punire anche se stesso, ne ha l’opportunità. Quindi l’appello alla scienza può finire per essere surrettizio. Non è affatto chiaro dove
passi la linea tra i casi in cui è surrettizio e i casi in cui non lo è.
Il discorso di Preti è dunque quello di un illuminista? Solo fino a un certo punto, perché i giudizi di
valore fanno appello a ma non sono implicati da giudizi di fatto. Perciò una maggiore conoscenza dei
fatti non basta. Gli illuministi erano empiristi anche in campo etico (o meglio: avrebbero dovuto esserlo,
per coerenza) ma Preti non poteva seguirli in questo perché seguirli avrebbe significato avallare una
qualche versione della fallacia naturalistica. Per di più, la riflessione che fa sui valori non è affatto scienti-
79
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
fica, o scientista. La Wertfreiheit della scienza ha un grandissimo valore ai suoi occhi, ma non tale da
portarlo a credere che l’assiologia sia (sarà) o possa essere un capitolo delle di una (futura) autoscienza
con i fiocchi.
La richiesta weberiana di Wertfreiheit per discipline come l’economia, la sociologia e la storia era
un più che comprensibile requisito metodologico per garantire una qualche chance di scientificità a indagini condotte da formiche, naturalmente tendenziose, sul loro formicaio. Il quadro si complica per chi,
come Preti, arriva a sostenere l’irriducibilità dei valori della persona all’ethos di una collettività, all’economia e alla storia: la filosofia-della-cultura, finché resta filosofia, non è una scienza storica o sociale, e
non può esserlo in quanto, a chiare lettere o di soppiatto, afferma valori (afferma la “validità” di certi
valori) in senso performativo, cioè, non si limita a descriverne l’esistenza sul piano sociale e il loro divenire sul piano storico. Perciò il riconoscimento che i giudizi di valore dipendano da giudizi di fatto è solo
un mattone, non la casa che si ha in mente di costruire. E se la filosofia afferma valori, il suo compito non
può ridursi a quello di educare alla problematicità, al senso di responsabilità verso i valori, alla consapevolezza dei costi che le nostre scelte hanno in rapporto ai dilemmi che il vivere insieme agli altri ci pone.
Qui però, ancora una volta socraticamente, Preti si ferma.
15. Genesi sì, genesi no
Insieme alla netta divisione tra questioni de facto e questioni de iure, fatti e valori, conoscenze e
norme, Preti accoglie anche la separazione fra ragioni storico-genetiche e ragioni teoretiche. Una volta
che un’indagine condotta secondo i dettami delle scienze psico-storico-sociali avesse fornito tutti i dettagli inerenti al come una credenza o conoscenza è venuta in essere e si è manifestata nell’ethos condiviso
di una comunità, oppure è assurta al grado di canone superiore in tensione con l’ethos, non sapremmo
ancora perché accettarlo o respingerlo, conservarlo (se già vigente) o farcene paladini. Qui il perché è
sinonimo non di insieme-di-cause ma di insieme-di-ragioni. (Con ciò, si noti, sto reduplicando la dicotomia.)
La questione non riguarda solo i valori conoscitivi; riguarda tutti quanti i valori. Le leggi della dinamica che descrivono l’evoluzione di un sistema fisico non si evolvono insieme al sistema che descrivono; lo stesso dovrebbe succedere con le leggi morali (se hanno da esserci). Ora, il pensiero di Preti al
riguardo è un po’ imbarazzante perché in questo secondo caso il sistema in evoluzione dovrebbe includere anche tali leggi.
Senza negare che ci siano differenze tra i due casi – e non intendo, banalmente, differenze sul piano
storico –, un modello per elaborare un approccio al contempo genetico e nomico nei confronti delle
diverse strutture che un sistema assume c’era già: era quello proposto da Piaget con la sua epistemologia
80
Alberto Peruzzi – 2012
genetica, che evidentemente non ha mai attratto Preti. Infatti l’equivalente si poteva pensare che fosse
un’assiologia genetica, che invece, stando a Preti, non era possibile. A fortiori, non avrebbe dovuto essere possibile neanche un’epistemologia genetica, perché rea di ricadere nello psicologismo. Cosa che
Piaget negava, negando sia l’innatismo sia il comportamentismo e rivendicando l’autenticità del carattere
epistemologico della sua indagine. La via intrapresa da Piaget – con le ragioni addotte per tale duplice
negazione – forse non ebbe da parte da Preti l’attenzione che meritava.
Con ciò non intendo suggerire che l’impostazione piagetiana risolva il problema e tanto meno che
lo risolva in maniera indolore . Un suo vantaggio era però quello di evitare una difficoltà in cui s’imbatte
la linea seguita da Preti: se capiamo i valori e li capiamo così bene da servircene per oltrepassare i confini
dell’ethos nel quale siamo cresciuti, com’è che ci siamo riusciti? Per dire che li abbiamo estratti dall’ethos, bisogna che questo non sia mai monolitico. E allora perché estrarne una parte piuttosto che un’altra? Oppure intuiamo cosa c’è da estrarre? In tal caso non c’era bisogno di perder tempo con la genesi
delle strutture del discorso. Se i valori fossero innati, dovrebbero appartenere a tutti dalla culla alla tomba, mentre così non pare che sia. Sto semplicemente mimando le critiche di Piaget alle direzioni seguite
per spiegare l’esperienza conoscitiva, così come queste direzioni erano consuetamente espresse a metà
del Novecento.
Spostando il discorso dall’epistemico all’assiologico, Preti si sentiva a disagio. Lo si vede da una
cosa: nei suoi scritti si trovano spunti che vanno in ciascuna di queste direzioni e spunti critici verso tali
spunti. Il risultato è una diffusa sensazione di indeterminatezza.
Non è questa sensazione ciò che più mi preoccupa, bensì l’appello all’irrilevanza di qualunque
ricostruzione di come arriviamo a capire (cogliere, fare nostri) i valori, ai fini della validità o meno di un
qualsiasi giudizio di valore. Se la genesi è davvero irrilevante, l’intuizionismo etico è la più semplice delle
soluzioni, non quella più problematica. E se c’è simmetria fra conoscenza e valutazione, un analogo appello dovrebbe funzionare altrettanto bene, purtroppo conducendo (ri-conducendo) all’intuizione platonica delle idee. Col che, diventano meri orpelli gli scrupoli empiristici e verificazionistici.
Sto facendo ricorso a molti se perché, oltre a non aver chiaro come Preti ne volesse e ne potesse
venir fuori, ho anche qualche dubbio sulla coerenza della sua posizione.
Per esempio, Preti afferma che le leggi logiche sono state riconosciute come tali nel corso della
storia. Se non è lapalissiano, che cosa significa? Qualora tutta la sua polemica contro il realismo di Frege
si risolvesse nel dire che c’è voluto tempo per arrivarci, che, se la logica non è finita oggi come Kant pensava che fosse finita al suo tempo, ci vorrà altro tempo per scoprire altre leggi logiche e che senza le opportunità offerte da problemi da risolvere non ci saremmo arrivati, la polemica si ridurrebbe a una tempesta in un bicchier d’acqua. Preti deve dunque intendere qualcosa di diverso. Ci voleva così tanto a capirlo? È solo sulla base di una millenaria esperienza culturale che siamo arrivati a identificare come “logi-
81
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
che” certe verità, con le proprietà che a ciò si accompagnano, ovverosia, necessità, universale validità,
carattere a priori, intrinsecità al pensiero “razionale”, naturalmente da leggersi in un’ottica critico-trascendentale invece che in una realistica (metafisica).
Bene, ma l’analogo si dovrebbe poter dire per la legge morale (mi riferisco ovviamente al lessico
kantiano), per i diritti universali dell’uomo, per i valori in generale. Per ogni x, se siamo legittimati ad
assegnare a x una funzione trascendentale57 è perché il divenire storico ha messo in luce l’irriducibilità di
x ... al divenire storico! E allora c’è perfino un senso in cui la contemplazione dei valori intrinseci è un
portato della praxis.
I valori non si potranno inferire dalla loro genesi, ma se ignoriamo la genesi non capiamo neppure
che cosa non dovrebbe essere inferibile da che cosa. Al riguardo, Preti è penetrante quanto ambiguo.
Sembra che ci voglia dire la stessa cosa che nel ’57 aveva detto su pensiero scientifico e scienza, il primo
con una storia, la seconda senza. Ovvero: ciò che non si capisce senza considerarne la genesi è l’ethos,
non i valori, perché i valori non hanno genesi (non solo vigono e non sono, ma vigono e non vengono
neppure a essere). Il problema è come faccia a stare insieme questo loro carattere peculiare con il fatto
che i valori nascono dalla vita (e – Simmel – a questa ritornano) precisandosi nel corso della storia dell’umanità. L’unica via d’uscita che scorgo consiste nel dire che a) gli uomini non possono essere ciechi ai
valori che la storia dell’umanità ha selezionato, se no ... non sarebbero più uomini, e b) più si riconoscono nella responsabilità verso i valori, più scelgono la razionalità. Ma siccome Preti era convinto che la vita
non ha altro senso che quello che le diamo noi, penso che lo stesso avrebbe dovuto dire per la storia, e
siccome non pare che in entrambi i casi la gamma dei sensi possibili sia arbitraria, la genesi della razionalità e di ogni altro valore sembra dover essere vincolata a pattern di emergenza e autoregolazione – che è
appunto il nocciolo del discorso piagetiano.
16. Sfida
Le reazioni suscitate da Praxis ed empirismo e l’ancor più forte esigenza di tener fede alla missione
del filosofo indussero Preti a giocare una partita al rialzo. Veniva accusato di freddo scientismo e di non
aver inteso la ben più concreta ‘logica’ che c’è dietro al paravento degli ideali scientifici? Allora il demonietto si metteva a parlare di valori verso i quali l’impegno è tassativo e svincolato da ogni praxis, si metteva a smascherare gli assunti valutativi nascosti nei discorsi che astutamente miscelavano pretesa di dire
come stanno veramente le cose e anelito partecipativo, in difesa degli oppressi e contro gli ingannevoli
standard di rigore logico e di evidenza empirica di una scientificità i cui veri lumi si erano mostrati ad
Sottinteso: x ha tale funzione solo nel momento in cui effettivamente la svolge. Altrimenti si ricade nel realismo
platonico.
57
82
Alberto Peruzzi – 2012
Auschwitz. Ma se c’era una cosa immorale, era l’ipocrisia con cui si finiva per giustificare la sordità a
valori che non si lasciano esaurire da nessuna serie di fatti. E allora lo scontro non poteva che essere radicale, impopolare, fuori luogo e fuori tempo. Solo così si potevano smascherare gli ipocriti.
Scientista? E allora il demonietto Preti si faceva paladino di una moralità in cui il valore della conoscenza è solo uno tra altri e mostrava di tenere a ciò che è altro dal sapere ancor più di chi gli muoveva
l’accusa. Non aveva capito il ruolo di scienza e tecnica nell’asservimento dell’uomo al capitale? Ma l’accusa doveva essere suffragata da standard ancora più alti di scientificità per aver titolo a esser considerata,
contro l’ipotesi. Se mi permetto un po’ d’ironia su vicende ormai lontane, è perché mutatis mutandis
quelle reazioni temo che siano endemiche, visto che periodicamente si ripropongono (penso a quanti
hanno fatto finta di inventarsi chissà quale novità discettando di bioetica o di bioingegneria). Di fronte
alla cecità verso i valori che trovano espressione nella scienza (fatta opportunamente collassare nella
techne) e di fronte al buonismo di chi metteva al primo posto i “problemi dell’uomo”, Preti lanciava il
guanto e si presentava in veste da anacoreta plotiniano, o se vogliamo faceva l’ultimo dei Mohicani, non
secondo a nessuno quanto a radicale opposizione nei confronti di miti, o malattie, dei visi pallidi invasori.
17. Quale uditorio?
Presa da Perelman la distinzione fra uditorio parziale, con location fissata, cui si rivolge il discorso
retorico, e uditorio universale cui si rivolge il discorso scientifico, Preti ne effettua una trasvalutazione in
Retorica e logica. A chiarimento dell’operazione faccio tre annotazioni: primo, in entrambi i casi ci sono
motivazioni pragmatiche, situazionali, con dietro una loro precisa storia o cronaca; secondo, in entrambi
i casi c’è dell’altro; terzo, nessuna intersoggettività de facto esaurisce l’apertura virtuale e “idealizzante”
del convincere dimostrativo che ha come riferimento un pubblico generico composto da generici animali
razionali e che accede alla massima universalità. Si potrebbe dire: delocalized audience. In Italiano abbiamo “pubblico generico”. Sto scherzando nel suggerire che le due espressioni siano intercambiabili?
No, perché intendo “generico” in senso matematico. Ahimè, quel che ne risulta è un’universalità potenziale, di volta in volta appannaggio di una élite. Che ci siano pratiche retoriche anche nello spirito scientifico oggettivato, vuol dir poco. Lo schema di fondo è: ciò che è essenzialmente persuasivo, lo è in relazione a un’intersoggettività circoscritta nello spazio e nel tempo, mentre ciò che fa appello alla forza di
convinzione del discorso razionale, fa appello a un’intersoggettività ... trascendentale.
La trasvalutazione cui alludevo ha un’immagine inversa: la coppia dialettica moralità /eticità si trasferisce sul piano della struttura del discorso e dei relativi criteri di validità. Le due cose sono da vedersi
insieme, così si ha un più nitido senso della continuità dell’indagine (e anche delle sue motivazioni). A
Preti l’idea di una pragmatica razionale, o formale, o trascendentale, sarebbe parsa un ossimoro: un contesto comunicativo slegato da qualunque contingenza storico-empirica non appartiene a questo mondo,
83
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
mentre un’élite resta sempre quel che è, quindi non è, di fatto, universale. Senza l’esercizio dell’ingegno
nel dibattere su un qualunque argomento, non sarebbero stati riconosciuti certi canoni di validità (nel
ragionare e nel controllare a scala della nostra vita quitidiana) lungo il corso della storia, ma senza elitarie
comunità di studiosi questi canoni non sarebbero stati tematizzati, discussi, precisati, “valorizzati” al
punto da riconoscerne la trascendenza rispetto a ogni specifico contesto (empirico o di fantasia). E qui
rispunta un concetto: appartiene all’essenza della razionalità la volontà di essere indipendente dallo spazio e dal tempo, o, come diceva Preti, eterna.58
Le tre annotazioni non sono così innocenti come vorrebbero sembrare. Per esempio, la prima delle
tre porta a pensare che l’essenza della razionalità abbia riscontri pragmatici. Quando aspiriamo a fare un
discorso che sia il meno condizionato possibile dalle contingenze (comunicative, pragmatiche, contestuali ...) non escludiamo che vi siano conseguenze empiriche di tale aspirazione. E tuttavia la rottura di
una determinata configurazione dell’ethos non ci rituffa immediatamente in un altro ethos. Voglio dire:
c’è uno spazio di manovra trans-contestuale ed esso può avere portata empirica anche se non trova conferma nel contesto di partenza. Ogni specifico ethos incorpora un qualche principio d’autorità e un qualche appello alla tradizione – un principio e un appello che disdegnano lo spazio di manovra. L’intersoggettività ideale del discorso scientifico è svincolata dall’uno e dall’altro ed esige dunque tale spazio – o
meglio: si pone come intrinseca aspirazione a essere svincolabile. Cosicché il suo stesso essere sta nel
rivendicare il diritto all’universalità.
Quel che Preti omette di dire in maniera chiara in Retorica e logica è che lo stesso tipo di considerazioni si può fare, oltre che per la scienza, per ogni altro grande dominio assiologico, dunque anche nell’ambito delle discipline ‘umanistiche’. Perciò, c’è qualcosa che non torna in un ragionamento che s’impernia sulla negazione del riduzionismo psico-sociologico dei valori. Ma, anche limitandosi a quel che
non omette di dire, c’è ugualmente qualcosa che non torna, se esistono conseguenze pratiche di questa
“libera ideale universalità umana in generale”59 – conseguenze che possiamo riscontrare grazie alla nostra stessa capacità di muoverci in uno spazio di manovra de-contestualizzato. Infatti, capiamo perfettamente la differenza che fa l’esser guidati da un teorema geometrico nel tracciare il percorso più breve di
una galleria nella montagna fra la città A e la città B, rispetto all’esser guidati da motivazioni come il rispetto per la montagna che è sacra alla popolazione locale o il timore di danni agli interessi dei proprietari terrieri, laddove tra la popolazione locale c’è chi parla di superstizione nel primo caso e di timore infondato nel secondo (il teorema è universalmente condivisibile, motivazioni e relative obiezioni non lo
sono).
58 Cfr. Retorica e logica, p. 160.
59 Retorica e logica, p. 197.
84
Alberto Peruzzi – 2012
A questo proposito, Preti ribadisce che i criteri della verità scientifica sono a priori pur essendo
stati scoperti a posteriori.60 Il che, messo da parte il senso banale della clausola, non so intendere in altro
modo che il seguente: la loro funzione di guida era già implicitamente attiva nella loro scoperta. E allora
le cose si complicano, perché, se la verità è un valore insieme ad altri e la irriducibilità a fatti si applica a
tutti i valori, allora l’appello alla “libera ideale universalità umana” riguarda non solo la verità scientifica
ma anche il bene, la bellezza e quel che altro volete. Di conseguenza, la linea di divisione fra cultura
scientifica e cultura umanistica non coincide più con quella fra la razionalità scientifica wertfrei e tutto il
resto che è carico-di-valore, bensì con due diverse gerarchie globali di valori, ove l’aggettivo “globali” è
essenziale, perché i due modi di argomentare e i due tipi di consenso si possono trovare esemplificati in
proporzioni variabili su entrambi i fronti, a seconda di come disponiamo i fattori da considerare tra ideale
e reale, teoria e prassi e a seconda di come li misceliamo.
In alcuni passaggi sembra che Preti non sia lontano da un’idea del genere, in altri ne sembra lontano: non è questione di miscele. Né poteva esserlo, dal momento in cui Preti ha sovrapposto la dicotomia
fra le due culture, scientifica e umanistica, con altre dicotomie di tipo linguistico, epistemologico e
pragmatico. Sovrapponendole, ha ispessito la linea di divisione fino a farne una barriera insormontabile
fra scienza e valori, eccezion fatta per il valore della conoscenza e della razionalità delle motivazioni.
Anche se fossimo d’accordo con tale barriera, dovrebbe lasciarci interdetti il fatto che a tale risultato giunga un filosofo il quale non condivideva l’idea che tutta la moralità sta dalla pare dell’idealità scientifica e tutta l’eticità sta dalla parte di quel che scienza non è, o l’idea che la funzione trascendentale sta
tutta da una parte e l’empirìa tutta dall’altra. Il problema di scegliere tra il consenso di un uditorio locale,
concreto, tangibile, e il consenso di un uditorio universale, ma solo potenziale, si pone anche all’interno
di ciascun fronte. Non è raro che si attribuisca a un uditorio particolare l’universalità, che non ha certo
per dono divino. Il problema riguarda il modo in cui si legittima l’attribuzione. Così come non è raro
l’appello a un’universalità che trascenda l’uditorio in actu semplicemente allo scopo di legittimare un
punto di vista eterodosso. Di nuovo, il problema sta in quali argomenti si adducono. In entrambi i casi la
questione di legittimità non può che essere indagata e risolta ragionandoci sopra a lungo (vedi Rawls).
Con ciò non intendo proporre implicitamente un’idea fuzzy del confine, perché sarebbe un’opzione davvero semplicistica. Sto solo dicendo che le diverse dicotomie, anche laddove si rafforzino, non si
sovrappongono. Tornando a quanto detto sul senso di “sfida”, la supposizione che si sovrappongano
poteva anche essere un artificio retorico sfruttato da Preti per renderci la vita (intellettuale) più scomoda,
renderci più consapevoli di quel che è in gioco e più responsabili del costo che le nostre idee filosofiche
comportano, insomma una specie di tranello per la nostra ipocrisia.
60 Ibidem.
85
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
18. Temporale/atemporale
Moralità come irriducibile all’eticità, ma definentesi relativamente a questa; immanenza del trascendere; storicità che genera qualcosa di non-storico ... È uno stesso pattern tipicamente pretiano che
qui è in azione e si lascia ricondurre a un modo di intendere anche la filosofia che era già stato presentanto in Idealismo e positivismo: la filosofia è tanto un “pensare sub specie aetherni” quanto una creazione
nel tempo”.61 Nel ‘43 questa congiunzione era descritta come una “antinomia caratteristica”, nel ‘68 il
pensiero capace di valere per chiunque, in ogni tempo, è quello che si esprime nella scienza ed è l’emblema di una cultura “libera da ogni vincolo storico e sociale”, al di là di ogni “condizionamento”.62
Anche rispetto a questa variante del pattern Preti omette di ricordare, con scelta tattica efficace ma
strategicamente dubbia, che l’universalità intesa, costituita nel corso della storia e non appannaggio
esclusivo della scienza, non ha portata ontologica, perché il suo essere sta tutto nella funzione che svolge. Ovverosia, anche i valori della scienza, verità in primis, valgono e non sono. Mi dico: non aveva bisogno di ricordarlo, perché era Preti. Sì, ma il discorso allora si lasciava leggere in un’altra chiave e prestava
il fianco ai rilievi dei malintenzionati.
Il fatto si è (come diceva la mia bisnonna) che dal ’43 al ‘68 il discorso si era complicato e, guarda
caso, Preti non insiste più, kantianamente, sulla funzione regolativa delle Idee: la funzione assiologica
non è più assorbita da quella regolativa. I valori non sono semplicemente delle norme. Che valgono e non
sono non significa che prescrivono [categoricamente] e non sono. Si potrebbe allora dire che Preti arriva
a un’impasse quando cominciava a svilupparsi la “nuova filosofia della scienza” (post-neoempiristica) e.
Ma si potrebbe dire anche un’altra cosa: che Preti porta al pettine i nodi irrisolti della “nuova filosofia
della scienza”.
La temporalità cambia di valore nel ‘tempo-di-Preti’. Lecis ha giustamente sottolineato lo slittamento d’accento, da Praxis ed empirismo a Retorica e logica, che investe la dimensione dell’eticità, che è
temporalmente caratterizzata. 63 Il costume, da sfera in cui i valori perdono il loro aspetto formale, si concretano e prendono corpo, assume sempre più i caratteri di un’altra sfera: quella che oppone ostacoli alla
libertà. Da alveo dello sviluppo dell’individuo, il senso comune diventa sistema chiuso, che reprime l’individuo. Qui la su menzionata “antinomia” si ripropone, ora con un tocco nuovo: le spinte rivoluzionarie
che fanno appello a considerazioni pragmatiche sono viziate da sordità ai valori e, come tali, sono superficiali. L’utopia che si propone come emergente dalle “contraddizioni” della realtà sociale è espressione
di falsa moralità, alimentata com’è dagli stessi semi del più ottuso conservatorismo. Invece di lasciarsi
61 Idealismo e positivismo, p. 48.
62 Retorica e logica, p. 202.
63 Op. cit., p. 343.
86
Alberto Peruzzi – 2012
guidare dai valori della ragione, si fa appello a bisogni contro altri bisogni. La mera denuncia di un ethos
orwelliano tradisce i valori la cui violazione denuncia.64
E ritorna pure una difficoltà più volte segnalata. Per far tornare le cose, bisognerebbe sovrapporre
eticità e cultura letteraria, come se la grande narrativa e la grande poesia non parlassero a tutti gli uomini,
non esercitassero da sempre una sottile funzione regolativa, non esprimessero un senso morale non meno alto della dedizione alla più spassionata ricerca scientifica.
Qual è il Preti da seguire? Ci troviamo di fronte alla scelta fra due opzioni. O diciamo che la grande
letteratura non rientra nella cultura umanistica votata alla “persuasione”, facendo sul piano filosofico
quel che gli artisti già fanno quando contestano i critici in quanto critici, oppure diciamo che la civiltà
delle lettere, per il fatto di non espungere emozioni contesto ethos e quant’altro, tradisce gli stessi valori
cui tiene tanto.
La prima opzione è un po’ difficile da adottare ... e non trova sostegno in quel che Preti scrive. La
seconda opzione ci pone davanti a un ulteriore problema perché, se l’adottiamo, ci avviciniamo pericolosamente a una metafisica di stampo platonico o, come minimo, all’esistenza di intuizioni a priori.
... A meno che non ci facciamo furbi e diciamo che entrambi i corni del dilemma sono anch’essi da
intendersi in chiave strumentale, in vista di un ritorno alla vita passando per il più-che-vita. La finezza
simmeliana che diventa furbizia? Sono davvero così ignobile? E allora mi spiego: la difficoltà sta nel fatto
che, se questa è davvero la soluzione, allora gli errori denunciati da Preti come forme di riduzionismo
possono essere funzionali alla vita tanto quanto ciò che vale atemporalmente e tanto quanto la sua reticenza su come facciamo ad avervi accesso.
Nel momento in cui l’enfasi sull’autotrascendenza dell’uomo e sull’inderivabilità dei valori rientrano così in gioco, la contrapposizione fra la pura dimensione teoretica e quella pragmatica circa la natura
dei valori era una tempesta in un bicchier d’acqua o, più generosamente, una mossa tattica: dovremmo
allora dire che la stessa contemplazione di valori universali e atemporali è finalizzata a ciò che universale
e atemporale non è affatto. Ma se c’è davvero questa funzionalità, essa è o da provare con un qualche argomento a priori o da prendere come un fatto. Preti non l‘argomenta – posso capirlo. La dobbiamo
prendere come un semplice, per quanto meraviglioso, fatto? In questo caso, la fallacia naturalistica è
meno fallace di quel che sembrava. L’importante è smetterla di baloccarsi con giochetti ricorsivi tipo: (1)
L’Astuzia della Vita vince sull’Astuzia della Ragione, (2) La Ragione è così astuta da concedere (1), La
Vita si serve di (2), ... Per esser più costruttivi: c’è naturalismo e naturalismo e allora ci vediamo costretti
a fornire argomenti per scegliere e, ovviamente, a scegliere nel modo più ... saggio.
Su questo aspetto nuovo dell’antinomia ci sono soltanto sporadici cenni in Retorica e logica, come quando si parla
di un “eticismo rivoluzionario” che finisce per produrre più tabù di quelli che imputa allo status quo (p. 207).
64
87
Memo n° 6 sulla filosofia di Giulio Preti
Il discorso si Preti si arresta sulla soglia di questa distinzione e della relativa scelta. Di nuovo: Non
plus ultra. Preti vede saggezza nel far proprio il motto (lo so che non lo dice, grazie). Dalla sua ha la superiore consapevolezza che la dialettica fra le due culture (gerarchie di valori) è stata ed è vitale per la civiltà
occidentale e che è proprio questa dialettica a conferire alla civiltà occidentale un valore di universalità
che non potrebbe essere giustificato su basi razziali, storiche, economiche o altre ancora, anche ammesso che queste basi fossero più scientifiche di quanto che si è creduto in passato. La stessa consapevolezza
d’altra parte suffraga un atteggiamento di ascesi assiologica (una sorta di meta-Wertfreiheit), sconsigliando di credere che distinzioni e scelte aiutino davvero a uscire dal dilemma e suggerendo invece che
l’ascetismo assiologico sia tutt’uno con una vita più saggiamente vissuta perché vissuta nella consapevolezza dei paradossi da autoriferimento – che non fanno sconti a enunciati meta-culturali. La via di una
divisione ispessita, per la sovrapposizione di più dicotomie, diventa per Preti la via di una più profonda
unione.
Personalmente, su questo punto esito a seguirlo: non condivido l’ispessimento, considero necessario sviluppare un confronto fra un tipo e un altro di naturalismo, antepongo la responsabilità di una scelta
alla consapevolezza dei limiti di qualunque scelta (da cui non è esente la non-scelta), e il fatto che, dopotutto, anche una-presa-di-posizione-che-mette-fra-parentesi-la-dialettica-cui-contribuisce contribuisca alla
stessa dialettica, mi lascia indifferente. Qui la partita si fa avvincente, non in termini di coerenza o incoerenza della filosofia di Preti o, più in particolare, in termini di questo o quel suo cambiamento di idee (o
anche solo di enfasi) nel corso degli anni. Nella fattispecie, si potrebbe puntare sul venir meno, passando
da Praxis ed empirismo a Retorica e logica, dell’appello al controllo empirico dei giudizi di valore via
risposte emotive. Dove la partita si fa avvincente, questo Memo n.6 si conclude. In stile pretiano.
88