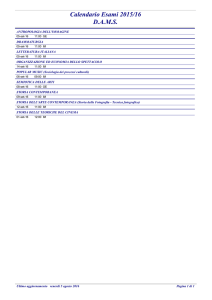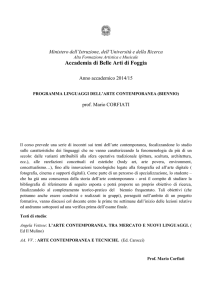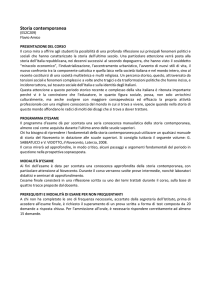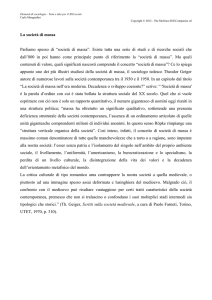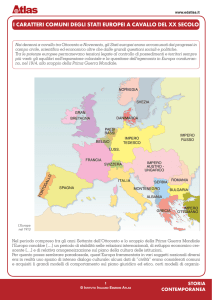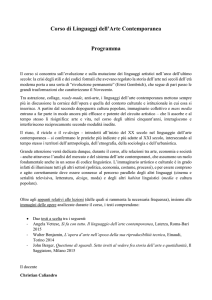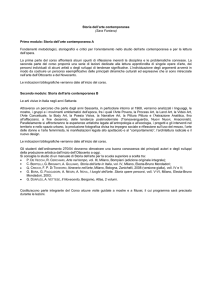Mercoledì 16 maggio 2007
Dove si va? Nuovi orientamenti dell’arte contemporanea
Angela Vettese
A me l’onore ma anche la difficoltà di concludere un corso che è stato globalmente, credo,
piuttosto difficile perché lavorare sul contemporaneo è sempre difficile e naturalmente non potrò
rendere veramente giustizia al titolo di questo intervento: “Dove si va? Nuovi orientamenti dell’arte
contemporanea”. Non so dove si va, sono naturalmente normale, non sono una profetessa, non sono
una rabdomante! Quello che posso dire innanzitutto è che si va nel senso che l’arte è stata
dichiarata morta da molti filosofi, da molti critici, addirittura da molti artisti. Credo che non ci sia
stata disciplina al mondo per la quale si sia utilizzato questo senso di funerale incipiente così spesso
e invece l’arte continua caparbiamente a esistere e a fare la sua parte nel mondo e addirittura a
volere di più, cioè a riuscire ad attirare e a catalizzare su di sé delle attenzioni assolutamente
formidabili: noi siamo qui ora anche per questo!
Forse 10-20 anni fa non si sarebbe fatto nell’aula magna dell’Università Statale di Milano un corso
sull’arte contemporanea, io ho studiato qui e non ho potuto studiare arte contemporanea perché non
c’era possibilità di farlo, quindi, appunto, davvero l’arte va avanti e, almeno dal punto di vista delle
attenzioni che il pubblico ha per essa, non è assolutamente morta.
Chi lo diceva?
In Italia, molto spesso Giulio Carlo Argan ha detto che l’arte era morta, sulla base di una
formazione marxista per la quale, dal punto di vista dei paesi che hanno adottato il marxismo, l’arte
era ridotta a cosa propagandistica, ma non volendo fare ad Argan questo torto, il torto di dire che
era sostenitore di un’arte propagandistica, (cosa che non fu affatto, anzi fu il sostenitore solitario di
un’arte cinetica, di un’arte programmata, di un’arte che voleva essere ancora di nuovo linguaggio e
quindi di avanguardia) non volendo fare ad Argan questo torto, diciamo che l’espressione morte
dell’arte è di origine hegelliana, ma non di Hegel, cioè si ritiene che l’estetica hegelliana abbia
parlato di morte dell’arte. In realtà sono stati soltanto dei divulgatori, degli allievi, diciamo degli
allievi infedeli di Hegel, che hanno appunto utilizzato questa espressione. Ciò che volle dire Hegel
non fu che l’arte sarebbe scomparsa, ma che l’arte avrebbe trovato una sorta di pace dei sensi in
quanto avrebbe continuato ad esistere, ma una nuova maniera di esprimersi avrebbe fatto sì che
l’uomo la considerasse non la punta di diamante ma una delle tante maniere in cui era possibile
esprimersi. In buona sostanza la filosofia avrebbe sostituito l’arte, diventando, ad un certo punto
della storia dell’umanità, l’espressione massima del pensiero.
L’arte sarebbe rimasta un’espressione del pensiero, ma la filosofia sarebbe diventata l’espressione
massima del pensiero. Rimettiamo quindi nella sua cornice l’espressione morte dell’arte così ci
rendiamo conto che nessuno ha mai pensato che sarebbe scomparsa quell’attività per la quale
l’uomo si distingue (perché noi abbiamo un 98% di similitudine a livello genetico con gli
scimpanzé, in quel 2% che ci distingue dagli scimpanzé, io direi che sicuramente c’è l’arte, cioè c’è
della capacità di fare degli atti inutili che hanno solo una valenza simbolica o narrativa che poi
possono sfociare in tante funzioni che possono essere quella consolatoria, quella descrittiva, quella
di adorazione), il fare una scultura, fare un’immagine, fare una poesia, fare un suono senza una
diretta funzionalità, cercando in essa o in esso l’armonia e/o la disarmonia, comunque una certa
struttura formale mi sembra che sia non solo prettamente umano, ma assolutamente umano, mi
sembra cioè che non ci sia umanità senza questo, cioè la disposizione all’arte mi sembra
francamente condizione necessaria e sufficiente per definire l’umanità.
Ci troviamo in imbarazzo di fronte al divorzio tra arte e bellezza, tra arte e tecnica, tra arte e
rappresentazione; sono i tre grandi problemi che saltano sempre sul piatto quando si parla di arte
contemporanea.
Ormai voi siete espertissimi e riterrete ingenua questa mia sottolineatura, però che l’arte non
corrisponda alla bellezza, che l’arte non corrisponda alla perizia tecnica, che l’arte non debba
portare con se’ necessariamente un aspetto rappresentativo e cioè essere mimesi di qualcosa che
siamo in grado di vedere, questo, ripeto, mette in imbarazzo.
Questi divorzi non si stanno perpetuando oggi, è da un secolo ormai che li abbiamo alle spalle.
Queste cose sono accadute ormai irreversibilmente, non stanno accadendo ora, ma sono accadute
nei primi momenti del Novecento, esattamente un secolo fa e dirò di più che sono accadute con una
forza dirompente. Io stessa quando scrivo, o quando semplicemente spiego, tendo a seguire quella
traccia un po’ scolastica per la quale si dice prima c’è il fauvismo, poi c’è il cubismo, poi c’è il
futurismo, poi c’è il dadaismo e via discorrendo. In realtà non è così, questo è un espediente che noi
utilizziamo per insegnare, però se pensiamo che i fauves erano fauves nel 1905, se pensiamo che i
cubisti - almeno Picasso - erano cubisti nel 1906/1907, se pensiamo che il futurismo iniziò nel
1909, se pensiamo che nel 1910 abbiamo il primo quadro astrattista, se pensiamo che già nel 1913
abbiamo la ruota di bicicletta di Duchamp e quindi il dadaismo e in un certo senso persino il
surrealismo; insomma se pensiamo che tra il 1903-1905 e il 1918-1920 abbiamo un’esplosione
come un fuoco d’artificio continuo di tendenze, dobbiamo riconoscere che questi “ismi” non
nacquero uno dopo l’altro, non furono esattamente l’uno la conseguenza dell’altro, ma furono
influenzati l’uno dall’altro e furono proprio lo scoppio di un’esigenza antiaccademica, antimuseale,
antistorica che avvenne quasi con un effetto big-bang. Se vogliamo usare un’altra orribile metafora,
come un fungo atomico, questi “ismi” continuarono a esplodere l’uno dentro l’altro, uno dopo
l’altro, ma in una successione rapidissima e quindi proprio questa successione rapidissima ci parla
di una necessità, di un bisogno, di uno sfogo di quella forma di forza espressiva con cui si palesano
i fenomeni che a lungo sono stati repressi e che a quel punto non potevano più stare nascosti e
silenti.
Quindi è da un secolo che abbiamo alle spalle questi divorzi e non saremo noi a ricongiungere i vari
matrimoni che si sono spezzati e d’altra parte questi divorzi non hanno portato ad una carenza di
pubblico per l’arte. C’è stato un momento in cui l’arte visiva ha avuto una pausa di silenzio, ha
avuto una fruizione relativamente ristretta, di nicchia, con una grande sensazione di essere in un
mondo massonico fatto per pochi. Si parla soprattutto del momento in cui ci fu un altro boom di
“ismi” o comunque di tendenze, che in realtà sono tutte facce della stessa tendenza, mi riferisco al
periodo dell’arte minimale, dell’arte concettuale, della land art, dell’arte di performance, di tutte
quelle espressioni che oggi normalmente si fanno stare sotto l’ombrello della parola “concettuale”
ma che in realtà ebbero un’enormità di espressioni e di cui ancora l’arte di oggi è assolutamente
figlia. In quegli anni effettivamente certe manifestazioni (pensiamo alla crudezza di alcune
performance, all’uso del corpo tagliato, offeso, leso, oppure pensiamo più che alla crudezza alla
difficoltà di capire certe espressioni dell’arte concettuale come quattro parole scritte su quattro
lastre di vetro oppure una frase scritta su di una architrave (mi riferisco a opere per esempio di
Kosuth e di Lawrence Weiner), questo genere di espressioni furono scioccanti e furono fatte in
fondo in assenza del pubblico. Oggi il pubblico ha un apparato di conoscenze che gli consente di
capire cosa volevano dire quegli artisti o comunque gli consente almeno di guardare queste opere.
Nel momento in cui sono nate, cioè 40 anni fa, non saremmo nemmeno stati in grado di guardarle,
parlo per la maggior parte di noi, non per i pionieri che sono sempre quelli che sanno guardare in
faccia per primi il presente foriero del futuro, il presente portatore di quello che sarebbe accaduto
dopo. Oggi siamo così sedotti dall’arte contemporanea, in generale dall’arte visiva: proliferano gli
allegati ai quotidiani, la televisione si è mossa e qualche volta qualcosa di contemporaneo ce lo fa
vedere, esistono case editrici che non devono più vivere sui diritti di Gombrich e di Panofsky ma
possono vivere vendendo libri di arte contemporanea (non parlo dell’asfittico mercato editoriale
italiano ma senz’altro questo accade nel mercato editoriale in lingua inglese), la Cina ha bisogno di
fare affermare i suoi artisti viventi in una platea internazionale, di portarli alle aste, alle mostre, alle
fiere.
Noi siano praticamente da una decina d’anni veramente divertiti, ma al tempo stesso anche quasi
oppressi dall’arrivo di questi artisti cinesi che desiderano in tutti i modi farsi notare e che ormai
hanno raggiunto quotazioni elevatissime anche a livello mercantile, perché evidentemente per un
paese, Cina, India, ma anche naturalmente America, Italia, Inghilterra, l’arte contemporanea è
diventata importante quanto lo era al tempo in cui l ‘Italia e le Fiandre erano i fulcri della creazione
artistica (parlo ovviamente del ‘400). Noi italiani non siamo più al centro della creazione artistica da
secoli e non lo saremo mai più per molti motivi. Come mai i paesi sentono così importante il fatto
di essere rappresentati dall’arte contemporanea? A prescindere da considerazioni geopolitiche, dal
fatto che l’arte contemporanea è diventata un biglietto da visita (perché noi andiamo nei musei,
veniamo in questa sala, siamo attratti da un linguaggio che poi però dobbiamo spiegare e che
vogliamo capire, come recita il titolo di questo ciclo che oggi si conclude), forse perché sentiamo
che l’arte contemporanea ci può essere di aiuto.
Ci sono stati altri filosofi che hanno cercato di pestare l’arte e di dire che è morta, in parte
Baudrillard, in parte Liotar, prima ancora Adorno, Horkaimer, De Boor sono tutti quei filosofi che
hanno detto che l’arte esiste ma che in fondo oggi l’aspetto peculiare è quello dello spettacolo, del
fare festa, del mettere l’arte più scandalosa, più ridicola, più capace di spettacolarizzare il presente,
di darla in pasto al “popolo bue” (ma non è vero che il popolo è così bue, ormai c’è una percentuale
di alfabetizzazione elevatissima: oggi il 50% dei genitori di ragazzi di scuola media ha un diploma,
almeno in Italia. Oggi la situazione della scolarizzazione è ben diversa rispetto a quella di 50 anni
fa, quando moltissime persone non si vergognavano di dire che avevano la terza media, anzi la terza
elementare).
Evidentemente noi sentiamo che non è così, che non c’è solo spettacolo, che non c’è soltanto
menzogna, che non c’è soltanto un imbroglio dietro all’arte contemporanea, forse c’è anche quello,
ma del resto dove non c’è imbroglio? C’è imbroglio nella politica, nell’economia, nella
trasmissione del sapere perché ciascuno cerca di trasmettere il sapere che ha creato lui. Può
sembrare scandaloso, ma invece se pensiamo al caso Di Bella in ambito della medicina, forse Di
Bella aveva ragione, certamente però ciascuno nell’ambito medico ha cercato di portare avanti il
proprio punto di vista.
Ecco allora come in ogni disciplina dell’umano agire c’è una parte di azione fatta in maniera non
sincera; nell’arte di oggi, però non credo che il quantitativo di disonestà presente sia superiore al
quantitativo di disonestà presente in quasi tutte le attività umane, forse solo l’allevare dei figli può
essere completamente esente dalla disonestà, talmente è istintivo.
Noi stiamo vivendo in una fase dell’umanità senza precedenti, pensiamo soltanto a questa strana
condizione dicotomica per la quale da una parte ci dicono che il pianeta avrà forse 20 anni di vita e
dall’altra ci dicono che noi possiamo cominciare a sperare che avremo 20 anni di vita in più come
speranza di vita personale rispetto ai nostri genitori. Ci dicono che se oggi si pensa di avere una
speranza di vita, non dico la vita media, ma una speranza di vita di 80 anni, presto potremo sperare
di avere una speranza di vita di 100 anni, peraltro ci viene detto quasi dagli stessi scienziati che tra
20 anni non riusciremo più a vivere nel pianeta terra.
Pensate solo questo quanto ci disorienta il fatto che non sappiamo più i confini del nostro corpo,
noi possiamo avere il fegato di un altro nel nostro corpo: possiamo avere una semplice valvola
mitralica sostituita, possiamo avere l’anca di un materiale sintetico, possiamo avere una dipendenza
da farmaci che evidentemente è una dipendenza da sostanze che entrano nel nostro corpo come se
fossero sostanze che il nostro corpo produce, come se fossero ormoni piuttosto che bile che noi
produciamo da soli.
Qual è il nostro corpo, quello che vive senza medicine o quello che ha bisogno di medicine? Dov’è
il confine fra la nostra identità e l’identità che invece ci ha costruito una, per fortuna, galoppante
scienza medica? Qual è il limite per il quale noi siamo simili nei modelli morali ai nostri avi, ai
nostri genitori o invece siamo assolutamente diversi perché possiamo decidere molte più cose della
nostra vita? Possiamo per esempio decidere di non essere obesi perché sappiamo che questo ci
rende molto rischiosa la mezza età, oppure possiamo decidere di non affaticare il nostro corpo con
l’assunzione di sostanze sbagliate perché sappiamo quali sono, possiamo decidere di vaccinare i
nostri bambini o di non vaccinarli, cioè possiamo decidere delle cose che riguardano il destino del
nostro corpo o del corpo dei nostri amati. Siamo oltretutto in una condizione molto diversa dal
punto di vista del raggiungimento delle informazioni (a parte gli occhiali, prima protesi benedetta
del mondo), a parte la televisione, a parte il rendersi in generale più rapide le comunicazioni, noi
stiamo cominciando a vivere in una società dell’”always on”, nel senso di “sempre connessi”.
In ogni casa penso ci sia almeno una persona che vive sempre connessa, significa che ha un telefono
che gli manda anche le email, tutti noi ormai o quasi abbiamo un telefonino, ma abbiamo spesso
anche un telefonino cui giunge la posta elettronica e se non l’abbiamo ogni paio d’ore andiamo a
vederci la posta elettronica, parlo di chi è dipendente. Il lasso di differenza tra chi è dipendente e chi
non lo è sta diventando sempre minore perché se noi ci rifiutiamo di essere dipendenti ci pensa il
lavoro a renderci tali perché ormai il lavoro richiede che siamo sempre connessi. Se non ne avete
esperienza diretta, immagino comunque che sappiate che molte ditte, non solo più gli ospedali,
danno il telefonino gratis al proprio dipendente purché sia sempre reperibile, compresa la notte.
Insomma siamo sempre connessi e le informazioni tendono ad arrivarci continuamente; e non
possiamo più nemmeno pensare di avere il grado di concentrazione di 20 anni fa perché una volta
uno poteva studiare. Da sempre i professori si lamentano che i ragazzi non studiano, però c’è anche
da dire che quando studiavamo noi ogni tanto squillava il telefono di casa e se eravamo stufi
guardavamo un po’ di televisione ma oggi i ragazzi hanno il telefonino che squilla continuamente e
soprattutto studiano con un computer, il quale è continuamente attaccato all’email e che quindi li
distrae continuamente. Anche la forma-computer incide: ora io ne ho uno abbastanza buono qui, ma
ce ne sono alcuni molto molesti i quali rimandano riflessi e io ora ad esempio sono abbastanza
deconcentrata da questa luce, ma questa è la condizione in cui l’umanità sta per essere
costantemente, quindi è inutile che mi lamenti dei monitor perché tanto questa è la condizione che
devo digerire in un modo o nell’altro.
L’arte visiva ci può dire tante cose su di noi in generale (poi torneremo su questo), ma in particolare
sul mondo dell’immagine perché in questo essere “always on”, in questo essere sempre connessi, in
questo arrivo tra le nostre mille protesi corporee, anche della protesi computer, succede che noi
siamo immersi sempre più fortemente nelle immagini. Siamo immersi in un mondo di immagini
fatte però per promuovere prodotti, che sia un viaggio, che sia un’automobile, che sia un
personaggio, siamo immersi in un mondo di immagini che ci richiede una capacità di lettura senza
la quale abbiamo una sorta di analfabetismo di ritorno e forse l’arte visiva ci può appunto aiutare a
leggere delle immagini senza dover pensare che queste ci propongano di comperare qualcosa, di
dover capire il loro messaggio per poi averne un’informazione di carattere funzionale. Le arti
visive ci danno delle immagini che ci parlano di noi in maniera apparentemente disinteressata, direi
comunque che quel poco di interesse che ci può essere (perché ogni artista vuole fare carriera, vuol
vedere il suo quadro in un museo e vuole vederlo ben piazzato all’asta), ma è un interesse
addirittura veniale se lo compariamo agli interessi veramente bombardanti con i quali sono
connotate le immagini del mondo mediatico in cui siamo e dobbiamo anche dire che noi abbiamo
un mondo nel quale si è sviluppata una tecnica per fare immagini che dobbiamo imparare a
decifrare.
Io sto lavorando in questo periodo con un artista molto divertente, è un signore di 84 anni che ha
fondato la pop art, si chiama Richard Hamilton, è un inglese. La pop art è nata in Inghilterra e lui,
nel 1956, fu il grandioso inventore dei collages; la tecnica del collages è sempre esistita ma i suoi
erano molto narrativi e molto rivolti al mondo del consumo.
Oggi questo signore fa ancora dei collages e li fa però attraverso la funzione “copia-incolla” del
computer, tra l’altro con enorme orgoglio perché sa utilizzare i computer alla loro massima
potenzialità, almeno nell’ambito delle immagini. Quindi ci sono degli artisti, (lui non è il solo, è
solo il più bizzarro), che cercano proprio di combattere le immagini dei media con le stesse armi dei
media cioè con i “pixel”, con il “dpi”, il grado di definizione dell’immagine, con una capacità di
creare una figura godibile, con la capacità di creare una figura che abbia a che fare con la storia
dell’arte ma anche con il nostro presente tecnico.
Anche questo non è sufficiente, cioè non è che poi noi abbiamo bisogno di capire l’arte
contemporanea o di frequentare l’arte contemporanea per capire la tecnica, sono proprio i contenuti
quelli che ci possono aiutare a capire appunto chi siamo in questo mondo così disorientante.
Vi farei vedere un paio di filmati per parlare così di fronte a delle immagini che sappiano raccontare
qualcosa di questo nostro disorientamento. Il primo filmato (sono brevissimi), ci fa vedere una
grande opera, nel senso di un’opera molto grande, gigantesca, esposta alla Tate Gallery, concepita
da Mona Hatoum, un’arista di origine libanese-palestinese, che poi si è stabilita in Inghilterra e che
ci mostra il dramma della sua identità, questa identità che non sa dov’è casa sua perchè un
palestinese è nomade, un libanese non è un inglese, e lei è arrivata in Inghilterra per caso e ci è
dovuta rimanere perché non aveva più la possibilità di rientrare. E’ andata via in quei 20 giorni in
cui era poi diventato impossibile rientrare in Libano e quello che ci fa vedere in tutte le sue opere
(in questa in modo particolarmente chiaro) è proprio la paura che può fare la casa, la casa come
oggetto che rischia di essere perduto. Chi non ha patria vive la casa come una sorta di metafora
della patria, e appunto di una patria perduta, ma anche la casa come un insieme di oggetti che a loro
volta, ci possono fare paura, anche cose banalissime come un girapomodoro, che però diventano
pericolosissimi animali preistorici. Ecco una pinna del passino, non so ciascuno lo chiama in un
certo modo, vedete questa manovellona, diventa quasi la testa di una formica, queste gambe
diventano simili a gambe di insetti e questi sono i terribili dischi con i quali si decide se passare fitto
fitto o un po’ più largo il pomodoro o la verdura, e vedete quasi, per chi conosce il grande vetro di
Duchamp, come questa forma assomiglia alla sposa di Duchamp, con la testa, ora è mozzata, e
questo corpo di vespa con questi dischi che assomigliano anch’essi stranamente ai testimoni
oculisti. Una parte dell’opera del grande vetro di Duchamp, allora un passino, uno scolapomodoro,
diventano un ragno, una vespa, qualcosa che ci fa paura, qualcosa con cui potremmo tagliarci, sì
perché lei è palestinese, perché lei è libanese, perché lei non ha casa, ma se generalizziamo in realtà
tutti non abbiamo più casa perché siamo diventati tutti persone che non vivono necessariamente
nella città in cui sono nati e che hanno un contesto così di vicinato spesso muto, silente e che hanno
un contesto di vita quotidiana per cui forse un passino per il pomodoro è più un nemico (perché è un
qualcosa che non sappiamo usare e che pensiamo di dovere sapere usare, parlo per noi donne), e
comunque è un oggetto che ha nelle sue valenze pericolose, queste piccole lame, ha qualcosa che ci
strabilia. Ci strabilia anche una lampada, un divano, una finestra, siamo quasi sgraditi ospiti a casa
nostra perché le nostre case sono o fatte di cose vecchie che non riconosciamo più o fatte di cose
nuove che non conosciamo ancora. Non so se vi è capitato mai di andare in quei bagni, (ci sono
delle case che ce l’hanno già, a me è capitato solo nei bagni pubblici), quei bagni incredibili (il
Giappone è fantastico per questo), in cui come entri si accende la luce, parte lo sciacquone, si
abbassa una cosa che copre e scalda anche la tazza del water. Ecco, queste cose qui saranno nel
nostro domani; quindi la domesticità, il modo in cui viviamo nel nostro domestico è già - ma
diventerà ancora di più - un luogo di paura, di pericolo, forse anche di grande agio perché, per
carità, non abbiamo più bisogno di rifare ogni 2 anni i materassi come faceva mia nonna, non
abbiamo più bisogno di disfare la lana per essere certi che non abbiano parassiti dentro; ci sono un
sacco di bellissime cose che oggi possiamo comperare che non hanno i difetti che avevano quelle
cose antiche e che qualcuno rimpiange. Ci sono anche i patiti del rimpianto, noi non credo che
dovremmo essere dei patiti del rimpianto però, certamente, il nuovo fa paura in qualsiasi contesto.
Un secondo filmato che vedremo fra poco che ci parla appunto di questo rimpianto, della
tentazione, della nostalgia per quanto riguarda la sfera domestica. Io parlo della sfera domestica
perché è così evocativa, simbolica e metaforica, quindi quando parlo di casa, in realtà potrei portare
degli esempi che riguardano invece il mondo, gli alberi, la natura, ecc. Vedremo un filmato con due
opere di Rachel Whiteread, anch’essa artista inglese, la quale ha preso il calco di un’antica casa che
era in via di demolizione nel sobborgo di Londra. In questo caso invece ha fatto il calco di una
stanza assolutamente solitaria dove c’è un camino di cui possiamo vedere ancora, non le fiamme,
ma il residuo nerastro che hanno lasciato. Questo è proprio il calco di una stanzetta, con una
boiserie con un camino che in questo caso si chiama fantasma, “Ghost”, perché è qualcosa che
riguarda il nostro passato, le case erano una volta così e in fondo in noi continua a lavorare questa
idea di casa, questa idea di stanza. Così come continua a lavorare in noi l’idea della vasca da bagno
per esempio all’antica, quella con le zampette, quella con questa forma stondata alla testa, quella
con questo senso di tempo passato ottocento-novecento che ormai non ci appartiene più nei fatti, ma
ci appartiene nella memoria, che ci fa spesso essere nostalgici, ci fa spesso rimpiangere ciò che non
possiamo più avere.
Ecco noi abbiamo bisogno di superare la paura del futuro, questo è evidente e abbiamo bisogno
talvolta di un’arte che ci ecciti, talvolta di un’arte che ci tranquillizzi, talvolta anche di un’arte che
ci racconti che tutto resta come prima per certi aspetti. Ci sono dei sentimenti come la paura,
l’amore, la solidità, il sentirsi solidi oppure il sentirsi disorientati che sono sempre gli stessi.
Alla fine ci sono anche delle permanenze in questo grande cambiamento di fronte al quale noi
siamo. Forse io pecco di idealismo però quando leggo di messaggi che parlano di caduta della sua
pregnanza, penso sempre a quello che ci dice Mac Luan nel più illuminato dei suoi saggi, in una
delle più illuminate frasi o comunque posizioni sull’arte del nostro tempo e cioè che l’arte è ciò che
ci vaccina, che ci spiega cos’è il nostro presente e che cosa sarà il nostro futuro e però ci spiega
anche cosa resta permanente, insomma ci racconta come possiamo reagire allo shock del nuovo
facendoci anche ricordare che il nuovo non è globalizzato. Non ci porta, cioè, completamente da
un’altra parte: la nostra natura umana in parte è sempre la stessa altrimenti non avremmo questa
capacità di leggere Dante o Joyce malgrado passino i secoli. E’ una cosa molto bizzarra che noi
riusciamo a leggere Dante dal momento che tutto il contesto nel quale è stato è passato e addirittura
lui ci raccontava cose relative alla sua vita personale o alla politica del tempo di cui veramente non
ci importa assolutamente più niente. Vuol dire che dietro ad una scena dantesca o shakesperiana,
dietro ad una Didone, o dietro ad una Lady Macbeth c’è anche una natura umana che permane che è
sempre la stessa. Quindi abbiamo da un lato la necessità di adattarci al presente e al futuro e
dall’altro la necessità di capire, ricordarci ogni tanto che una sorta di cuore permanente resta a fare
di noi degli uomini come sono sempre stati gli uomini.
Ci sarà sempre bisogno di qualcosa che nutre la nostra interiorità, la nostra spiritualità e credo
proprio che questa sia la chiave di volta dell’arte a venire, della prossima arte, un’arte che si mette
in relazione con il pubblico ma che anche cerca di metterci in relazione. Se non la vogliamo definire
“spiritualità”, definiamola “capacità di meditare”, che è appunto il toccasana per qualsiasi
inquietudine. Probabilmente nel futuro ci sarà bisogno non di meno, ma di più filosofia, di più
musica, di più arte - visiva, ma anche non visiva- , proprio per poter assorbire, godere o attutire i
cambiamenti a cui andiamo incontro.
Vorrei terminare questa lezione (breve, se volete forse anche generica ma d’altra parte questo “dove
va l’arte” non poteva suggerirmi delle cose più specifiche) con un filmato breve, molto intenso,
creato da una videoartista finlandese. Abbiamo tutto questo freddo e abbiamo tutta questa paura di
incontrare l’altro; qui abbiamo una storia d’amore incompiuta di due adolescenti o meglio un amore
forse non corrisposto di una ragazza verso un ragazzo e vediamo in tutto questo luogo, potrebbe
essere una metafora dell’arte stessa, in tutto questo luogo quasi gelato dall’inverno e quasi
mortificato dalla rigidezza del contesto invece nascere e palesarsi e manifestarsi un sentimento che
porta appunto addirittura alle lacrime e porta avanti la nostra vita come l’arte e come la vita di
questa adolescente che stiamo appunto per vedere.
Io intanto vi ringrazio e spero che il prossimo ciclo di conferenze sia altrettanto seguito come questo
e ringrazio tutti a nome del comitato scientifico per la fedeltà della partecipazione.