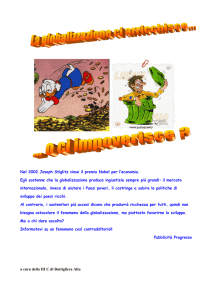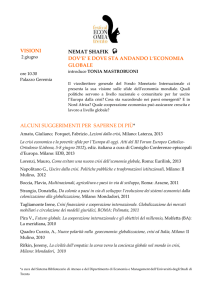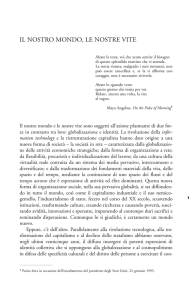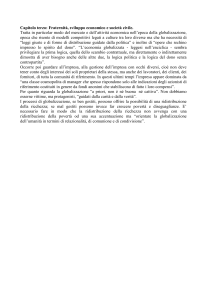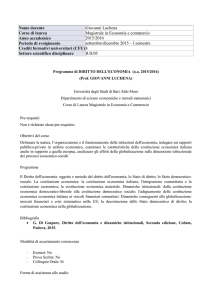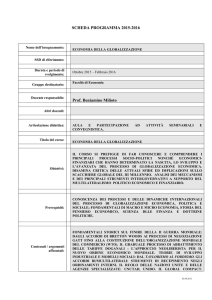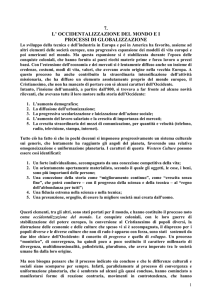5/02
36
La città inv
La città invisibile
Pietro Del Soldà
JEAN-LUC NANCY
Globalizzazione
e “morte di Dio”
C
Cosa significa essere liberi nel
mondo globalizzato? Come
cambiano due parole antiche
come libertà e comunità, dinanzi al tramonto degli statinazione e dei confini che hanno segnato la storia antica e
moderna? Su questi interrogativi getta luce l’opera di JeanLuc Nancy, la voce forse più
nuova e profonda del pensiero
francese di oggi. Nelle sue
opere, da La comunità inoperosa (Napoli, 1992) sino a Essere singolare e plurale, testo
del ’96 che Einaudi ha pubblicato nel 2001 introdotto da un
dialogo con Roberto Esposito,
l’occidente appare come un
orizzonte determinato dalla ricerca di un fondamento dell’esistenza che doni senso alla vita. L’esito vano di questa ricerca, ciò che da Nietzsche in poi
si chiamò la scoperta della
“morte di Dio”, è l’esperienza
propria dell’occidente, che diviene però esperienza del
mondo intero. Per Jean-Luc
Nancy, in questa esperienza,
nella scoperta che non vi è un
fondamento trascendente per
questo mondo, né un fine ultimo che imponga un senso e
una direzione alla storia, getta
le sue radici l’unica autentica
globalizzazione.
“In questa esperienza, che viene prima di ogni forma di globalizzazione – ci dice Nancy muta radicalmente il significato
della relazione tra gli uomini,
della comunità, e, con essa,
dell’idea di libertà. Tramonta
l’immagine di un uomo-soggetto che dispone della relazione con gli altri uomini e che
vive la libertà come una proprietà e come autosufficienza e
indipendenza dalla comunità”.
Professor Nancy, come
cambia dunque l’idea di libertà di fronte all’annuncio
della morte di Dio?
Innanzitutto, per morte di Dio,
espressione che spesso suona
scioccante, non intendo la
morte del dio della fede, ma la
fine di un pensiero che pone
un essere supremo come causa e fine del mondo.
Di fronte a questo essere supremo, la libertà è vissuta come libertà di scegliere il bene e
l’amore di dio contro il male e
il rifiuto di dio. Allo stesso modo, in termini secolarizzati,
questa libertà sta nella scelta
del bene o del male secondo
un certo fine della storia o una
certa visione dell’umanità che
si vuol realizzare.
Questa è quella che io chiamo
una “piccola libertà”, per distinguerla dalla “grande libertà”.
Con la morte di dio il mondo
non ha più né principio né fine, e la libertà emerge come il
“fatto” di essere gettati nell’esistenza, senza più la necessità
né di un principio né di un
fine. Potrei dire che si tratta
di una libertà d’invenzione e
visibile
non più di una libertà di scelta.
La libertà di scelta, il libero arbitrio della tradizione occidentale, presuppone una conoscenza di cosa è bene e cosa è
male che precede la decisione.
Al contrario, ciò che io chiamo
“libertà d’invenzione” non presuppone più alcuna conoscenza del principio o del fine
della storia, su cui la mia decisione si possa fondare.
Questa è la grande libertà, la
libertà del rischio e della possibilità di uscire da sé verso l’ignoto, e come tale essa non
può soggiacere all’idea di un
ordine del mondo prestabilito
ed imposto a tutti gli uomini.
Il mondo globalizzato non si
regge più su principi metafisici, su un’idea del bene che
dall’alto domina le azioni degli uomini.
La scomparsa “globale” di un
principio metafisico comporta
la fine della libertà come mera
facoltà di scegliere tra il bene e
il male che sono già definiti oltre i confini dell’esistenza.
Il vero contributo della globalizzazione è di far emergere
una libertà diversa: la libertà di
creare di volta in volta la mia
esistenza, le relazioni con gli
uomini, la forma e l’organizzazione della comunità in cui vivo, senza un criterio metafisico
già dato a cui far riferimento.
La libertà di “inventare” il mondo è il contributo positivo di
una autentica globalizzazione.
Questa libertà d’invenzione, lei dice inoltre, non è
più libertà “da” qualcosa,
non è più dispensa da un
obbligo imposto dalla comunità, anche se come tale, forse, continua ad essere
proposta e vissuta nelle nostre democrazie liberali. Libertà e comunità, nelle sue
parole, non sono più opposti e paiono quasi coincidere.
La libertà d’invenzione è innanzitutto libertà che mi mette
in rapporto con gli altri uomini
e con tutto il resto del mondo.
La libertà è la posizione di un
rapporto che non ha un fine,
che non ha un obbiettivo al di
là di se stesso. La relazione con
gli altri uomini emerge allora
come qualcosa che precede e
rende possibile il rapporto di
ogni uomo con se stesso.
La morte di dio è la scomparsa
di un essere supremo che imponga alla comunità un principio ed un fine al di là della
relazione. A partire dal momento in cui la comunità non
è più qualcosa di donato dall’alto, governato da un essere
supremo, vengono meno l’idea dell’uomo come individuo
indipendente dalla relazione
con gli altri uomini: la relazione stessa è l’origine.
Si dissolve così l’immagine, che ha dominato la tradizione occidentale, dell’uomo
5/02
37
come soggetto che tende ad
un fine che sta oltre la relazione con gli altri. Quando si
esaurisce questa tensione metafisica, la relazione si manifesta come l’orizzonte unico ed
insuperabile dell’esistenza,
senza fine e sempre di nuovo
inventata.
Cerchiamo adesso di capire, professor Nancy, perché questo cambiamento
radicale, questo emergere
della relazione tra gli uomini come l’origine di tutto, è un’esperienza globale.
Che c’entra cioè tutto questo con la globalizzazione
dell’economia, delle tecnologie e dei diritti di cui si
discute da Seattle a Porto
Alegre?
La “relazione sempre di nuovo inventata”, non più governata da principi metafisici,
che raccoglie dentro i suoi
confini l’intera esistenza, è
un’esperienza universale,
“globale”. L’occidente cioè,
facendo esperienza dell’assenza di un fondamento supremo, pare aprire un cammino che coinvolgerà il mondo
intero.
La filosofia, la ricerca di un
senso del mondo propria dell’occidente,
non indaga più
oltre i confini
del mondo, ma
viene a coinci-
"
5/02
38
La città inv
La città invisibile
dere col mondo stesso, e in
questo movimento, diventando “mondana”, da esperienza
occidentale si fa esperienza
mondiale. La mondanizzazione della filosofia coincide con
la sua mondializzazione.
E che rapporto c’è tra questa mondializzazione e la
nozione comune di globalizzazione?
La nozione “comune”, lei dice…è interessante notare come l’occidente conosca due
sensi della parola comune, come relazione nel senso detto,
ma anche come banalità, trivialità.
Noi viviamo in un mondo che
ha di se stesso, della comunità,
una visione “comune” appunto, banale, volgare. Tale visione della società, ad esempio,
americana, ci è proposta dal
suo stesso cinema, e porta ad
una condanna senz’appello
della globalizzazione, del capitalismo che domina il mondo accrescendo la povertà.
Tutto questo è vero, così com’è da condannare la fede cieca nelle “magnifiche sorti e
progressive” della scienza e
della tecnica. L’avanzamento
della tecnica ha condotto infatti l’uomo, per la prima volta,
di fronte alla possibilità del
proprio annientamento. Con
la seconda guerra mondiale si
è conclusa la fede nella positività della tecnica, ci si è fatti
consapevoli piuttosto della sua
neutralità, della sua ambivalenza, per cui dalla tecnica
possono provenire sia il peggio che il meglio per l’uomo.
E tuttavia, insieme alla natura
ambivalente della tecnica, diviene chiaro un altro aspetto
fondamentale, e cioè che la
tecnica non ha fine, e dunque
ha il merito di esporre l’uomo
all’assenza di un fine. La tecnica è la messa in atto di un’assenza di fine trascendente, che
dal di fuori impone un senso e
una direzione all’esistenza. In
questo la tecnica offre all’uomo l’opportunità straordinaria
di pensare “senza un fine”, di
progettare, di inventare un
mondo, una comunità, un’esistenza fondata solo sulla relazione e non più su un fine.
Come la tecnica, anche la
globalizzazione è allora ambigua, nasconde cioè in sé
la libertà e il suo contrario?
Bisogna chiedersi se la globalizzazione significa la scomparsa dalla storia di ogni altro
agente all’infuori del capitalismo, con la sua tecnica e l’equivalenza monetaria, o se,
invece, un sistema di scambio
che raggiunge i confini del
mondo, scambio non solo di
merci ma degli uomini stessi
e delle loro creazioni, non
apra per l’umanità un cammino verso la libertà vera, la
“grande libertà”.
Analogamente Marx, se pur in
termini differenti, non diceva
semplicemente “abbasso il capitalismo”, ma sosteneva che
il capitalismo ha una missione
storica: pervenendo ad uno
stadio mondiale, producendo
un mercato mondiale, una dimensione mondiale dello
scambio, fornisce in tal modo
la possibilità oggettiva della rivoluzione. Infatti solo attraverso questa mondializzazione del capitalismo, pensava
Marx, la rivoluzione della proprietà dei mezzi di produzione può offrire all’umanità intera la possibilità di gioire della produzione.
Come giudica dunque il
composito mondo definito, forse scorrettamente,
no global, che da poco si è
riunito di nuovo a Porto
Alegre?
Lo giudico positivamente, a
condizione però che sia chiaro che non si tratta di essere
contro la globalizzazione, ma
a favore di una globalizzazione autentica, delle libertà e
dei diritti. La straordinaria
esperienza dell’assenza di un
principio che dall’alto governa la comunità e le relazioni
tra tutti gli uomini è proprio
ciò su cui si fonda questa globalizzazione autentica.
Un’idea nuova di comunità,
una relazione tra gli uomini
che sia vissuta come origine
visibile
e fine dell’esistenza, e non
come uno strumento di cui
l’individuo dispone per i suoi
scopi, insomma tutto ciò che
ho raccolto nell’espressione
“libertà di invenzione”, si
compierà solo quando diverrà un’esperienza globale.
La globalizzazione delle tecnologie, in virtù del contributo che la tecnica può dare per
scoprire che non c’è un fine
trascendente che dà senso alla vita e alla comunità, può
diventare un veicolo della libertà di invenzione.
È dunque inevitabile opporsi
alle ingiustizie prodotte dal
mercato e dal dominio delle
tecnologie occidentali, senza
però dimenticare la fondamentale “ambivalenza” della tecnica che ho appena ricordato.
In questa ambivalenza sta la radice di una libertà che sia autentica e dunque “globale”.
Lo spettro di un conflitto di
civiltà che oppone l’Occidente all’Islam è respinto
da tutti ma continua ad
aleggiare, mentre
si teme l’allargamento del conflitto antiterrorismo ad altre
regioni del pianeta in cui prevale la fede musulmana.
Il pensiero occidentale può fare
qualcosa per sconfiggere
questo spettro?
Non so se il pensiero occidentale possa evitare il conflitto.
Ritengo però che vi sia un
compito essenziale per il pensiero, quello di considerare che
l’Islam è la terza parte del monoteismo, assieme all’ebraismo, e ha un ruolo storico molto importante nello sviluppo
dell’occidente.
Non credo quindi che si tratti
di un conflitto di civiltà, ma
piuttosto di una guerra civile,
di un conflitto interno alla fede, all’Occidente e all’Islam.
Se l’occidente rappresenta la
tecnica, l’abbandono del divino, del senso religioso, rappresentato invece dalla tensione
che unisce i musulmani, ebbene, dobbiamo capire che Occidente e Islam sono uniti in un
comune destino che da occidentale è divenuto mondiale, e
devono “tenersi insieme” per
sopravvivere: l’Islam non so-
5/02
39
pravviverà senza la tecnica, come l’ebraismo e il cristianesimo, né la tecnica sopravviverà
senza aprire uno spazio per il
senso. Un senso non più donato dall’alto, un senso inventato, creato nel rapporto.
Il problema più grave che
sembra pesare sul futuro di
un dialogo tra cultura occidentale ed islam parrebbe
quello del rapporto tra religione e politica. Ma è poi
vero che l’Islam non può
esistere senza far coincidere queste due dimensioni?
È una questione molto complessa. Non è affatto vero che
nella storia dell’Islam il legame
tra religione e politica sia stato
costante e necessario.
Nel mondo islamico si sono
costituiti degli stati-nazione,
come ad esempio il Marocco o
l’Egitto, che hanno praticato
una distinzione importante tra
la religione e la politica, e che
sono stati estremamente tolleranti sul piano religioso, mentre in altre aree dell’Islam si è
prodotta una piena identificazione di religione e politica.
Il cristianesimo ha prodotto
"
Illustrazione di Nevio De Zolt
5/02
40
La città invisibile
La città invisibile
una teoria completa, elaborata
nei secoli, di doppio potere.
Il potere europeo di diritto divino, il potere dello stato sovrano, è un potere essenzialmente non religioso. Lo stesso
potere di Luigi XIV, ritenuto di
diritto divino, è a suo modo un
potere non religioso. Dunque,
la separazione di religione e
politica è possibile per tutti, ed
è una grande acquisizione della cultura illuminista, e come
tale va preservata. D’altro canto, tale separazione non può
più essere mantenuta negli
stessi termini, poiché religione
e politica si trovano entrambe
in uno stadio di grande trasformazione. Sono tutte e due molto stanche, molto invecchiate.
Questo vale anche per l’Islam,
anche se per il Cristianesimo
ciò è più visibile.
La religione non è più l’elemento che struttura la vita dell’uomo moderno, ed anche la
politica ha ormai perduto il suo
grande potere di strutturazione, di definizione del destino
dei popoli. Quindi, ogni considerazione circa la separazione
o la riunione di religione e politica dovrà supporre nell’avvenire dei termini totalmente differenti. Si tratta dunque di ripensare in profondità ciò che
religione e politica possono significare.
È evidentemente un lavoro
enorme, che i giovani dovran!
no affrontare.
Jean Léonard Touadi
Il tramonto
dell’icona SENGHOR
La voce poetica di Léopold Sédar Senghor, il massimo intellettuale senegalese del ventesimo secolo e uomo politico di primo piano, si è spenta lo scorso dicembre.
Con lui scompare un’icona rispettata, venerata ma anche
discussa della cultura e della politica africana. Si può davvero dire che la sua morte, avvenuta all’età di 95 anni,
chiude il tormentato ventesimo secolo africano.
È proprio Senghor che inaugura a Parigi, agli inizi degli
anni ’20, la esaltante stagione letteraria detta della “Negritudine”, ossia l’orgogliosa affermazione della personalità e
dell’identità dei popoli neri sottomessi politicamente e
alienati culturalmente. In realtà il giovane intellettuale senegalese subisce, insieme ad altri studenti della diaspora
nera d’origine caraibica e statunitense, il fascino irresistibile degli ideali del panafricanesimo promossi da W.E. Dubois negli Usa e dal vulcanico visionario della Giamaica,
Marcus Garvey. Lo slogan coniato da quest’ultimo “Back to
Africa” (ritorno in Africa) diventerà per tutti gli intellettuali della diaspora un paradigma ideale. Ritornare all’Africa
come operazione catartica di purificazione delle scorie
della dominazione coloniale e della sistematica negazione
culturale operata dalla mentalità bianca della “Missione
Civilizzatrice”,
“Lo Studente Nero”, “Legittima Difesa” sono le riviste attraverso le quali Senghor e i suoi amici lanciano i proclami di riscossa del mondo nero nell’effervescente clima
intellettuale parigino. Amico di Aimé Césaire, il brillante
poeta della Martinica, autore del vibrante e famoso
“Discorso sul Colonialismo”, Senghor inventa il moviFoto: Del Canale mento della “Negritudine” riprendendo e rivisitando in chiave psicoanalitica lo strumento, veicolo dell’offesa
bianca per secoli, ossia la parola “Negro”, condensato di tutto il disprezzo
che aveva colpito tutto un popolo il
cui spazio e la sua storia furono negati dall’impresa coloniale.
Léopold Sédar Senghor, ex presidente del Senegal