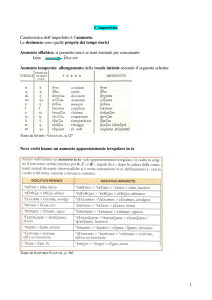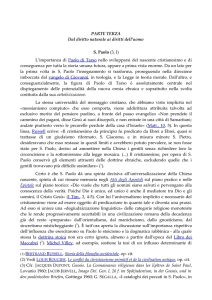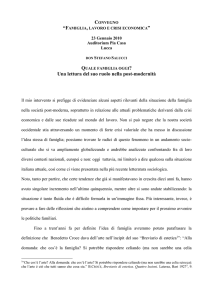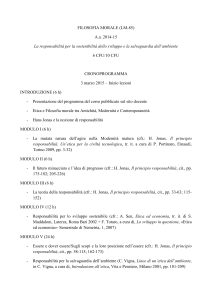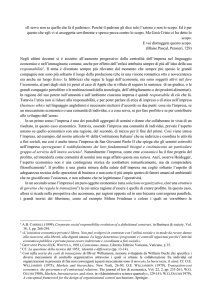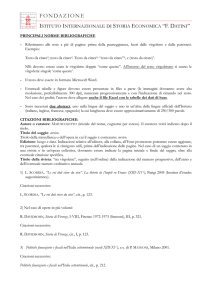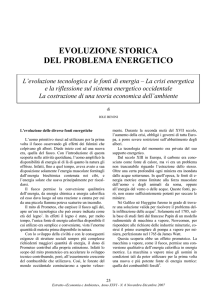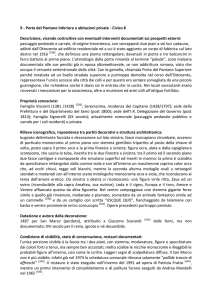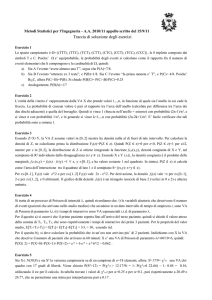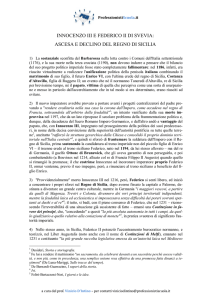Media e costruzione della realtà (I)
Una riflessione sulla didattica e sulla ricerca
nella prospettiva delle scienze sociali
di Franz Brandmayr *
La prima regola era di non accettare mai nulla per
vero, senza conoscerlo evidentemente come tale: cioè di
evitare scrupolosamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei giudizi niente più
di quanto si fosse presentato alla mia ragione tanto
chiaramente e distintamente da non lasciarmi nessuna
occasione di dubitarne.1
Chi ha un bastone più grosso ha una maggiore probabilità di riuscire a imporre la sua definizione della realtà.2
1.0 Epistemologia minima (I): i media sono fonti affidabili?
Mi accingo a condurre questa riflessione con l’atteggiamento
dell’insegnante, quindi del lavoratore intellettuale,3 che si interroga sulla propria attività di ricerca (didattica e non), sul proprio
*
Docente di I.R.c.
CARTESIO R., Discorso sul metodo, Editori Riuniti, Roma 19963 (1637), p. 72.
2
BERGER P.L.-LUCKMANN TH., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 1969 (1966), p. 153.
3
Sottraggo all’espressione qualsiasi sussiego o contenuto snobistico e – per
motivi di spazio – rinvio, per un primo approccio tematico alla figura e all’attività dell’intellettuale, solo ai seguenti testi scelti, peraltro, in maniera quasi
casuale: GUITTON J., Arte nuova di pensare, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
198611 (s.d. orig.), passim; ID., Il lavoro intellettuale. Consigli a coloro che studiano e
lavorano, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1987 11 (s.d. orig.), passim;
1
41
Franz Brandmayr
rapporto con le fonti in generale, ma soprattutto con quelle risorse conoscitive rappresentate dai mezzi di comunicazione di
massa. A spingermi ad affrontare questa disamina, che svolgo
nella prospettiva delle scienze sociali,4 pesano in buona misura i
frequenti correttivi che, nel processo dell’insegnamento-apprendimento, il lavoro di docenza impone di apportare ai media più
comunemente adoperati nell’attività in aula. Enciclopedie in rete,
articoli di quotidiani o di periodici, talvolta persino i manuali
scolastici5 sono cosparsi di approssimazioni, di stereotipie,6 di
stigmi,7 di tautologie,8 di effetti alone,9 di varie forme di etno-
SERTILLANGES A.D., La vita intellettuale, Studium, Roma 19986 (1920), passim;
WALZER M., L’intellettuale militante. Critica sociale e impegno politico nel Novecento, Il
Mulino, Bologna 20042 (1988), passim.
4
Come il lettore potrà constatare, attingo primariamente a opere di Sociologia
generale e di Sociologia della Comunicazione inserite in un quadro complessivo di carattere antropologico-culturale. I contributi forniti dai giornalisti
(in qualche caso anche quelli di accademici-giornalisti) occupano, solitamente, il carattere di testimonianze più che di contributi teorici.
5
A titolo di esempio, rinvio a BRANDMAYR F., Medioevo: un pregiudizio secolare che
perdura nel discorso comune. Esercizi di decostruzione alla luce delle scienze sociali, in
BIANCHI B.-ID.-COSIMI R.-CREAZZO F.-STROPPOLO D.-ZOCCHI M., Dialoghi al
Liceo Dante. Pagine di cultura e didattica, n. 2, Liceo Ginnasio Statale “Dante
Alighieri”-LINT, Trieste 2011, soprattutto alle pp. 64-69 e 80-81.
6
ARCURI L., Percezione e cognizione sociale, in I D. (a cura di), Manuale di psicologia
sociale, Il Mulino, Bologna 1995, p. 126; M AZZARA B.M., Stereotipi e pregiudizi, Il
Mulino, Bologna 1997, p. 16.
7
AIME M., s.v. Stigma, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), Dizionario di
antropologia. Etnologia antropologia culturale antropologia sociale, Zanichelli, Bologna 1997, p. 709.
8
ABBAGNANO N., s.v. Tautologia, in ID., Dizionario di filosofia, U.T.E.T., Torino
19712 (s.d. orig.), p. 857.
9
MANDL H., s.v. Alone/effetto, in A RNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a cura
di), Dizionario di psicologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1986 3 (1975),
p. 61.
42
Media e costruzione della realtà
centrismo,10 di esclusivismo culturale,11 di selettività,12 di anacronismo13 e – non di rado – di errori veri e propri.
È vero che – sovente – questi difetti espositivi risultano difficilmente evitabili: lo si deve riconoscere, la “narrativizzazione”14
giornalistica consente spesso formati15 e tempi16 solo molto ristretti, con tutte le deficienze che possono derivarne 17. Ne consegue che – come sostengono gli studiosi – «ogni tipo di comunicazione (giornalistica) non può che essere selettiva, sintetica, forgiata sull’esclusione di elementi che si ritengono meno
interessanti»18.
Il mio scopo, quindi, non è certo quello di stigmatizzare una
certa tipologia di mezzi, magari per promuoverne altri, quali
potrebbero essere – ad esempio – i libri. Oltre a essere una battaglia perduta in partenza,19 si tratterebbe chiaramente di un
anacronismo esiziale per la stessa ricerca, che di una differen-
10
Vd. ad es. BERNARDI B., Uomo cultura società. Introduzione agli studi etno-antropologici, Franco Angeli, Milano 19848 (s.d. orig.), p. 44.
11
CIRESE A.M., Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo
popolare tradizionale, Palumbo, Palermo 1973, p. 7.
12
SCHENCK J., s.v. Sociale/percezione, in ARNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a
cura di), op. cit., pp. 1078-1080; vd. anche infra, nt. 18 e 95.
13
Vd. ad es. BRANDMAYR F., op. cit., pp. 60-62.
14
Vd. infra, nt. 126.
15
Cfr. ad es. AGOSTINI A., “la Repubblica”. Un’idea dell’Italia, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 59-70; SORRENTINO C., Tutto fa notizia. Leggere il giornale, capire il
giornalismo, Carocci, Roma 2010, pp. 95-96.
16
Cfr. infra, nt. 120.
17
Cfr. infra, nt. 126 e 127.
18
SORRENTINO C., op. cit., p. 28 (parentesi tonda mia).
19
Cfr. SARTORI G., Prefazione, in ID., Homo videns. Televisione e post-pensiero, Laterza,
Roma-Bari 201012 (1997), p. XVI.
43
Franz Brandmayr
ziazione degli strumenti e delle tecniche non può che avvalersi
fruttuosamente.20
Mi pare – tuttavia – che la vera posta in gioco sia la stessa
affidabilità21 dei mezzi di informazione, i quali vedono impegnata – pur nelle sue notevoli differenziazioni interne22 – un’unica
classe di lavoratori intellettuali: quella dei giornalisti. Nell’ambito accademico non sono poche le testimonianze di una certa
disistima della qualità professionale dei giornalisti,23 ma in que-
20
Cfr. ad es. il chiaro nesso positivo fra istruzione e un certo utilizzo di
Internet rilevato dai sociologi (SARTORI L., Il divario digitale. Internet e le nuove
disuguaglianze sociali, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 87 e 94). Per un approfondimento dei significati simbolici sottesi all’uso dei media rinvio al suggestivo
MOORES SH., La televisione satellitare come segno culturale, in ID., Il consumo dei
media, Il Mulino, Bologna 1998 (1993), pp. 187-202 e all’opera tutta.
21
Cfr. FROIO F., L’informazione spettacolo. Giornali e giornalisti oggi, Editori Riuniti,
Roma 2000, p. 206; MARLETTI C., Media e politica. Saggi sull’uso simbolico della politica
e della violenza nelle comunicazioni, Franco Angeli – Istituto di Scienze politiche “G.
Solari” Università di Torino, Milano 1984, p. 72; cfr. anche infra, nt. 129.
22
Per una sintesi efficace sulla differenziazione interna alla pratica giornalistica attuale cfr. ad es. AGOSTINI A., Orizzonti digitali, in ID., Giornalismi. Media
e giornalisti in Italia, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 141-187.
23
Cfr., solo a titolo di esempio, CARMO FELICIANI S., Introduzione, in DAWSON
CH., Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, Rizzoli, Milano 1997 2
(1950), p. 6; FERRAROTTI F., Prefazione, in BARBANO A., L’Italia dei giornali
fotocopia. Viaggio nella crisi di una professione, Franco Angeli, Milano 2003, p.
12; LO IACONO P., La concezione islamica dell’occidente, in A LLIEVI S. (a cura di),
L’occidente di fronte all’islam, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 146 e 151;
PERNOUD R., Medio Evo. Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 19985 (1977),
p. 145; PIVATO S., Vuoti di memoria. Usi ed abusi della storia nella vita pubblica
italiana, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 22, 26, 34, 74, 87-88, 129, 131 et alibi;
POPPER K.R., Una patente per fare tv, in I D.-CONDRY J.-WOJTYÙA K., Cattiva
maestra televisione, Donzelli, Milano 1996, p. 34; V ASOLI C., Prefazione, in
BURDACH K., Riforma Rinascimento Umanesimo. Due dissertazioni sui fondamenti
della cultura e dell’arte della parola moderne, Sansoni, Firenze 1986 2 (1918), p.
VII. Vd. anche infra, nt. 109.
44
Media e costruzione della realtà
sta sede si vuole pensare a quello del giornalista come a un lavoro intellettuale nel senso pieno del termine,24 professione – per
di più – gravata da pesi e responsabilità non indifferenti.25
Queste poche pagine non hanno certo il fine di dare conto
del dibattito interno al mondo mediatico circa le finalità del giornalismo stesso o intorno al problema dell’obiettività, se essa esista e in quali termini,26 se venga considerata, e da chi, un proposito ancora perseguibile,27 se configuri – al contrario – un ideale
donchisciottesco e anacronistico, oppure illusorio28 e – in definitiva – mistificante;29 se il mercato30 rappresentato dai media
destituisca di significato ogni riferimento forte alla verità e via
dicendo. Analogamente, sono costretto a lasciare da parte, o a
sfiorare appena, tematiche ancora più impegnative, come la
nozione di “dato concreto”, di “fatto”31 e di “verità”, che attraversano il dibattito epistemologico da svariati decenni. Mi richiamo – invece – a una concezione più limitata e, nella nostra
24
Cfr. MARLETTI C., op. cit., p. 88.
Cfr. infra, nt. 176 e 180.
26
Vd. infra, nt. 78-79 e 177.
27
Cfr. ad es. infra, nt. 70.
28
AGOSTINI A., “la Repubblica”, cit., p. 7.
29
ECO U., Obiettività dell’informazione: il dibattito teorico e le trasformazioni della
società italiana, in ID.-LIVOLSI M.-PANOZZO G., Informazione. Consenso e dissenso,
Il Saggiatore, Milano 1979, pp. 15 et passim.
30
Cfr. infra, nt. 173-175.
31
ABBAGNANO N., s.v. Fatto, in ID., op. cit., pp. 379-381. Con riferimento al
nostro oggetto di studio scrive LASCH CH., La ribellione delle élite. Il tradimento
della democrazia, Feltrinelli, Milano 1995 (1994), p. 70 (parentesi tonda mia):
«In certi ambienti, l’idea stessa di realtà è stata messa in discussione, forse
perché le “classi parlanti” (quelle che hanno maggiore accesso ai media) vivono in un mondo artificiale, in cui la simulazione della realtà ha preso il posto
delle cose in sé».
25
45
Franz Brandmayr
prospettiva delle scienze sociali, più operativa di «tecnica della
verità»32, intendendola come «ipotetica» e «plausibile»33 presa in
esame dei fatti e delle interpretazioni, che a questi fatti conferiscono un significato.34
1.1 Epistemologia minima (II): finalità del contributo
A questo scopo attingo qualche spunto sommario, visti i limiti
di questo studio, anche da ambiti – lo ammetto – estranei a
quello giornalistico: mi riferisco in particolare a quello delle scienze sociali e, in parte, a quello storiografico. È certo che mi si
potrà opporre facilmente l’obiezione circa la specificità della
professione di giornalista, che scienziato sociale o storico – so-
32
MARLETTI C., op. cit., p. 76; cfr. anche infra, nt. 76.
Vd. anche infra, nt. 68.
34
A questa scelta metodologica non è sotteso alcun misconoscimento della
dignità filosofica del tema della ricerca della verità e della sua conoscibilità,
come dell’opportunità di un approfondimento euristico costante anche in
queste direzioni. A questo proposito vd. ad es. C OTTIER G., Le vie della ragione:
temi di epistemologia teologica e filosofica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2002;
GIORDANI A., Il problema della verità: Heidegger vs Aristotele, V&P università,
Milano 2001; IACCARINO A., Verità e giustizia: per un’ontologia del pluralismo, Città
nuova, Roma 2008; POSSENTI V. (a cura di), La questione della verità: filosofia,
scienze, teologia, Armando, Roma 2003; POSSENTI V.-MASSARENTI A. (a cura di),
Nichilismo, relativismo, verità: un dibattito, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ)
2001; STAGLIANÒ A., Su due ali: l’impegno per la ragione, responsabilità della fede,
Lateran University Press, Roma 2005. In una prospettiva filosofica diversa si
colloca ad es. VATTIMO G., Verità, comunicazione, espressione, in AA.VV., Il problema della comunicazione, Gregoriana, Padova 1964, pp. 260-266; I D., Arte e verità
nel pensiero di M. Heidegger, corso di Estetica dell’a.a. 1965-66, Giappichelli,
Torino 1966, passim; ID., Verità e pace, in AA.VV., Identità culturale dell’Europa. Le
vie della pace, Atti del colloquio internazionale (Torino, 19-22 giugno 1984),
Aic, Torino 1984, pp. 69-75.
33
46
Media e costruzione della realtà
litamente – non è, ma perseguo egualmente il mio intento per
una serie di motivi.
In primo luogo non ambisco ad avere tutte le ragioni in questa riflessione: voler impartire lezioni metodologiche dall’esterno a una categoria di lavoratori, cui non si appartiene e delle cui
difficoltà non si ha viva esperienza, sarebbe soprattutto ridicolo, più che biasimevole. Inoltre, accingendomi a esplorare qualche aspetto del «mondo sociale»35 del giornalismo, non mi pare
opportuno “far parlare i fatti”36, dando – surrettiziamente – uno
spazio retorico al diffuso sentimento di sfiducia 37 nei confronti
degli organi di informazione: non è con la demagogia che si
può tentare di avviare un leale confronto con una categoria professionale “altra”.38 In terza istanza – al seguito di una tradizione scientifica consolidata39 – intendo esplicitare chiaramente,
senza mimetismi di sorta, i presupposti epistemologici dai quali
prendo le mosse per questa riflessione.
L’intento di queste pagine è – soprattutto – quello di fornire
delle testimonianze raccolte nel mondo dei giornalisti e del
materiale descrittivo ricavato dalle analisi degli studiosi, il tutto
in vista di uno sviluppo euristico ulteriore. Sarebbe mia intenzione, infatti, riservare a una pubblicazione futura la presa in
considerazione della problematica affidabilità dei media, particolarmente quando si occupano dello specifico ambito delle
35
BERTAUX D., Racconti di vita. La prospettiva etnosociologica, Franco Angeli, Milano 2003 (1998), pp. 37-38.
36
Cfr. FORCELLA E., Millecinquecento lettori. Confessioni di un giornalista politico, in
“Tempo Presente”, n. 6, p. 454.
37
Cfr. infra, nt. 181 e 183-188.
38
Cfr. infra, nt. 49.
39
Cfr., ad es., GEERTZ C., L’io testimoniante. I figli di Malinowsky, in I D., Opere e
vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna 1995 (1992), pp. 85-86.
47
Franz Brandmayr
religioni;40 il mondo dei mezzi di comunicazione di massa potrebbe «coprire»41 questi temi con effetti di palese resa stereotipica,42 di oscuramento43 e di discredito.44 D’altra parte, secondo studi sociologici autorevoli, queste caratteristiche (ma soprattutto quella della resa stereotipica) costituirebbero addirittura delle «regole precise», che «la società di massa impone alle religioni e a chi vuole parlarne in TV e sulla carta stampata»45.
40
Ho già svolto un lavoro di questo genere per quanto concerne, in modo
particolare, l’islâm, per il quale rinvio a BRANDMAYR F., L’islàm nelle rappresentazioni collettive degli italiani. Le etichettazioni “orientalistiche”, in “A.N.I.R.”, XXI
(2006), nn. 2-3, pp. 20-22; ID., L’ islàm nei media italiani. La comunicazione
funzionale al processo dell’etnicità, in “A.N.I.R.”, XXII (2007), n. 1, gennaio-aprile, pp. 11-15; ID., L’ islàm nei media italiani. La deriva islamofobica, in “A.N.I.R.”,
XXIII (2008), nn. 2-3, pp. 8-10; ID., L’ islàm nei media italiani. La deriva
islamofobica (II parte), in “A.N.I.R.”, XXIV (2009), n. 1, pp. 12-14. Sono
consultabili anche ID., Jihad, contributi per un’ermeneutica, in “Cristiani nel Mondo”, XXV (2010), n. 2, aprile/maggio, pp. 8-10; ID., Parlare di islàm. Per una
comprensione del concetto di “sottomissione”. Dalle stereotipie ad un approccio ermeneutico,
in BIAGINI P.E.-BIANCHI B.-ID.-CREAZZO F.-SERGI M.-STROPPOLO D., Dialoghi
al Liceo Dante. Pagine di cultura e didattica, Liceo-Ginnasio Statale Dante AlighieriLINT, Trieste 2010, pp. 85-131.
41
Significa «assumere il compito di informazione attraverso uno o più servizi giornalistici o radiotelevisivi, relativamente a eventi di particolare rilievo»
(cfr. DEVOTO G.-OLI G.C., s.v. Coprire, in IID., Il dizionario della lingua italiana,
Le Monnier, Firenze 1995). A volte viene usato l’anglismo coverage.
42
Cfr. supra, nt. 6.
43
GILI G., Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 116-117; cfr. anche C ASILLO S., Fattoidi, bufale e falsi
giornalistici, in ID.-DI TROCCHIO F.-SICA S., Falsi giornalistici. Finti scoop e bufale
quotidiane, Guida, Napoli 1997, pp. 25-27.
44
Cfr. GILI G., op. cit., pp. 98-102 e, solo per quanto concerne la strategia
della «costruzione del nemico», DAL LAGO A., Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano 2004 2 (1999), p. 50.
45
PACE E., in ACQUAVIVA S.-ID., Sociologia delle religioni. Problemi e prospettive,
Carocci, Roma 19962 (1992), p. 174.
48
Media e costruzione della realtà
Nonostante questo proposito mirato al futuro, mi pare che
lo «sguardo»46, che – ab extra – mi propongo di rivolgere al mondo
dei media, possa avere un suo significato anche a prescindere
dagli eventuali sviluppi della ricerca. Ritengo, ad esempio, che
queste pagine possano dare voce a una esigenza di fondo – quella
dell’obiettività – non del tutto sopita nel mondo della stampa e
che – in ogni caso – interpella qualsiasi lavoratore intellettuale e,
in fondo, ogni soggetto che ritenga importante la propria
maturazione personale e civica.
Per porre le premesse alla formulazione delle suddette ipotesi
plausibili ho tentato di entrare in relazione, diretta o attraverso i
testi, con diversi addetti ai lavori, celebri o meno che fossero. 47 Al
«gruppo»48 dei giornalisti, che ho avvicinato come fosse una sorta
di «cultura professionale»49 specifica, mi illudo di avere guardato
– inoltre – con una certa «simpatia metodologica»50, che – indi-
46
Mi rifaccio al concetto di «sguardo antropologico» così come emerge dalle
suggestioni che mi provengono da APOLITO P., Sguardi e modelli. Saggi di antropologia, Franco Angeli, Milano 1994, passim.
47
Nella fase esplorativa che precede il lavoro sul campo vero e proprio si
rivelano utili anche i colloqui informali (BIANCO C., Dall’evento al documento.
Orientamenti etnografici, C.I.S.U., Roma 1988, p. 112). Vd. anche C IRESE A.M.,
op. cit., p. 244: alcune conversazioni con giornalisti si sono rivelate per me
significative ai fini dell’elaborazione di questa riflessione.
48
Quando si occupano di professioni i sociologi si riferiscono a «gruppi
secondari […] regolati da norme formali, razionali», cfr. G ABASSI P., s.v. Gruppo,
in DEMARCHI F.-ELLENA A.-CATTARINUSSI B. (a cura di), Nuovo dizionario di
sociologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19943 (1987), p. 941.
49
DUBAR C., La socializzazione. Come si costruisce l’identità sociale, Il Mulino, Bologna 2004 (2000), p. 153. Vd. le riserve di CUCHE D., La nozione di cultura nelle
scienze sociali, Il Mulino, Bologna 2003 (2001), pp. 123-125 su questo utilizzo
del concetto di cultura.
50
Cfr. ad es. il riferimento alla «simpatia» dell’antropologo per la cultura
studiata (FIRTH R., I simboli e le mode, Laterza, Bari 1977, p. 40). È un’espres-
49
Franz Brandmayr
spensabile in ogni approccio antropologico-culturale all’oggetto
di studio – abbiamo visto che non sempre impronta le critiche
portate da altri mondi sociali51 al gruppo costituito dagli operatori
dei media. Si tratta di una simpatia che – voglio sottolinearlo – trae
origine anche da una considerazione di ordine politico, se per
«politica» intendiamo quella intesa nel «senso forte»52 del termine,
cioè l’arte di ricercare il bene comune:53 lo “sguardo giornalistico” sulla realtà è carico di un potere che «può innalzare e può
abbattere» e che può influire sui destini di molti. Non a caso,
infatti, Weber accosta il ruolo del giornalista a quello del politico
(per cui «i nomi di “scrittore mercenario” e di “oratore mercenario” risuoneranno […] alle orecchie dell’uno e dell’altro»)54: ad
ambedue sono riservate «gioie intime» quali il «sentimento del
potere […] e di elevarsi al di sopra della realtà quotidiana»55.
Nella sua pratica lavorativa il giornalista può, quindi, proporre
un’azione altamente costruttiva nella direzione della preservazione
e dell’incremento della prassi democratica56 all’interno della com-
sione, tuttavia, che non va intesa in senso «emotivo», né va confusa con
opzioni teoriche che rifiutino a priori il tentativo di una «comprensione»
oggettiva della cultura studiata; cfr. T ULLIO-ALTAN C., Manuale di antropologia
culturale. Storia e metodo, Bompiani, Milano 1979 (1971), p. 543. Vd. anche la
nozione di «osservazione partecipante» in SCHULTZ E.A.-LAVENDA R.H., Antropologia culturale, Zanichelli, Bologna 1999 (1998), pp. 34-35.
51
Vd. supra, nt. 23.
52
Vd., da un punto di vista prettamente antropologico-culturale, TULLIO-ALTAN
C., Antropologia. Storia e problemi, Feltrinelli, Milano 19852 (1983), pp. 227-233.
53
Vd. ad es. HÕFFNER J., La dottrina sociale cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19863 (1983), pp. 33-39.
54
WEBER M., La politica come professione, in I D., Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1966 (1919), p. 100.
55
Ib.; cfr. infra, nt. 148.
56
Vd. infra, nt. 173.
50
Media e costruzione della realtà
pagine statuale oppure, al contrario, può contribuirne al degrado.
È, questa del lavoro giornalistico, un’opportunità che – se valorizzata – può impreziosire considerevolmente la funzione sociale e politica dell’operatore dell’informazione. La sua azione
sociale andrebbe, pertanto, più che demonizzata, orientata e finalizzata a scopi compatibili con le battaglie più significative
dell’attuale emergenza democratica. Il venire meno dello Statonazione,57 infatti, sembra imporre un faticoso, ma irrinunciabile58 lavoro di ricerca delle forme più adatte di convivenza fra
sensibilità culturali diversificate59 e della diffusione di un «orientamento di valore»60 meno succube del mercato61 e dei modelli
57
Cfr., ad es., da un punto di vista sociologico C OLOMBO E., Le società
multiculturali, Carocci, Roma 2002, pp. 22-25; in una prospettiva storica
REINHARD W., Storia dello stato moderno, Il Mulino, Bologna 2010 (2007), pp.
118-119.
58
La «vita comune» e la «disponibilità» a «riconoscersi reciprocamente» fra
diverse culture sembrano venire pensati da POSSENTI V., Le ragioni della laicità,
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), p. 38, come una premessa di fondo ed
una condizione di sopravvivenza della società postsecolare.
59
Con sensibilità differenziate rispetto a questi problemi si possono leggere
BERNARDI U., La nuova insalatiera etnica. Società multiculturale e relazioni interetniche
nell’era della globalizzazione, Franco Angeli, Milano 2000, passim e C OLOMBO E.,
op. cit., passim.
60
Con questa nozione intendo l’applicazione di «complessi di valori organizzati […] ad ampi segmenti della vita», valori funzionali «all’integrazione
culturale» (cfr. SEYMOUR-SMITH CH., s.v. Valori, in E AD., Dizionario di antropologia, Sansoni, Firenze 1991 [1986], pp. 420-421) del soggetto, ma anche
all’«espressione» (cfr. TURNER V., Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna 1986
[1982], p. 36) di giudizi, di comportamenti etici e di sentimenti (ivi, pp.
120-121), che possono essere cognitivamente dissonanti (T RENTIN R., Gli
atteggiamenti sociali, in A RCURI L. [a cura di], op. cit., pp. 274-281) rispetto al
contesto sociale.
61
Cfr. ARDIGÒ A., Introduzione, in PARSONS T., Comunità societaria e pluralismo. Le
differenze etniche e religiose nel complesso della cittadinanza, Franco Angeli, Milano
51
Franz Brandmayr
egemonici62 elitari63 concomitanti al fenomeno della globalizzazione.
In definitiva, alle procedure critiche proprie delle scienze
sociali, che improntano le riflessioni che seguono, soggiace
un’opzione dichiaratamente etico-sociale,64 mirata – nei suoi limiti – a rinforzare il rapporto di fiducia65 fra chi le notizie le
produce e noi fruitori dei mezzi di comunicazione di massa.
1994, pp. 13-14. Per un primo approccio interdisciplinare al tema socioeconomico del mercato vd., ad es., AA.VV., Fuori dal mercato non c’è salvezza?, in
“Concilium”, XXXIII (1997), 2, passim.
62
SEYMOUR-SMITH CH., s.v. Egemonia, in EAD., op. cit., p. 151.
63
Su questo aspetto della ricerca sociale non ho trovato opere che abbiano
una lucidità pari a quella di LASCH CH., op. cit., pp. 29-46 et passim.
64
Come tale valutativa e a sua volta passibile di essere fatta oggetto del giudizio di valore del lettore, vd. W EBER M., Il metodo delle scienze storico-sociali,
Einaudi, Torino 19812 (1922), pp. 60-61, 335-337 et alibi. Del resto – come è
noto – adesione al valore (in questo caso: la democrazia) e scientificità non
sono inconciliabili: l’essenziale è distinguere accuratamente i diversi piani del
discorso (cfr. ad es. ivi, pp. 68 e 97).
65
Sul tema della fiducia nel contesto della modernità, vd. ad es. i contributi di
Sztompka P., Jedlowski P., Tarozzi A. e Cotesta V. nella II parte di C RESPI F.SEGATORI R. (a cura di), Multiculturalismo e democrazia, Donzelli, Roma 1996,
pp. 49-96; GIDDENS A., Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e
pericolo, Il Mulino, Bologna 1994 (1990), soprattutto i capp. III e IV. Come si
sa, anche il sociologo anglo-polacco Zygmunt Bauman ha dato spazio a
tematiche come le «paure postmoderne» (B AUMAN Z., La società dell’incertezza,
Il Mulino, Bologna 1999 [1999], pp. 99-126) o l’«insicurezza» (I D., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2008 [1999], pp. 17-63), che presentano una certa complementarità con l’argomento.
52
Media e costruzione della realtà
1.2 Epistemologia minima (III): fatti e interpretazioni
Il fatto che il giornalista abbia fra i suoi fini quello di tradurre,66
in qualche modo, i «mondi della vita»67 e la realtà sociale (sia
quando si occupa di cronaca nera, che quando scrive di arte o di
moda o altro ancora) nel linguaggio e nei formati propri della
sua professione, credo possa avvicinarlo – perlomeno sotto certi aspetti – allo studioso di scienze sociali. Anche questi non
presume tanto di spiegare esaustivamente il significato dei «“meccanismi sociali”», quanto – piuttosto – di
elaborare progressivamente un corpo di ipotesi plausibili […]
fondato sulle osservazioni, ricco di descrizioni […] e di proposte interpretative […] dei fenomeni osservati.68
Emerge, come si può agevolmente constatare, la componente empirica, «fattuale»,69 che senza dubbio informa anche
il lavoro giornalistico;70 inoltre, mi pare ciò possa valere – mutatis
mutandis – anche quando la notizia viene elaborata con l’attività di desk71 e il giornalista, pur non muovendosi dalla sua postazione al computer, è costretto a rapportarsi con le fonti rappresentate dalle diverse notizie d’agenzia, spesso contraddit-
66
CHAKRABARTY D., Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004 (2000), pp.
105 e ss.
67
ABBAGNANO N., s.v. Mondo della vita, in I D., op. cit., p. 596; P ARDI F., s.v.
Soggettività, in D EMARCHI F.-E LLENA A.-CATTARINUSSI B. (a cura di), op. cit.,
p. 1986.
68
BERTAUX D., op. cit., p. 41.
69
Ivi, p. 43.
70
Piero Ottone, già direttore del “Corriere della Sera”, richiamava alla concretezza i suoi colleghi con queste semplici parole: «Dire le cose come stanno:
questo è l’imperativo del buon giornalista» (ID. cit. in FROIO F., op. cit., p. 30).
53
Franz Brandmayr
torie, variamente interpretabili e la cui notiziabilità va valutata
di volta in volta.72
I dati [...] mostrano come “funziona” un mondo sociale o
una situazione sociale. Questa funzione […] permette […]
una descrizione in profondità dell’oggetto sociale, […] prende in carico le configurazioni dei rapporti sociali interne all’oggetto, i suoi rapporti di potere, le sue tensioni, i suoi processi di riproduzione permanente, le sue dinamiche di trasformazione.73
Credo si tratti – quindi – di non eccedere nel «relativismo»74
tipicamente postmoderno, che «mette in dubbio la distinzione tra
fatto e finzione, realtà oggettiva e discorso concettuale»75 e di attenersi a «una concezione pragmatica delle “verità fattibili”
(workable), fondate su nozioni condivise e razionali del fatto e della prova»76. Per quanto nella storiografia una oggettività «totale»77
71
È il «lavoro di scrivania» (SORRENTINO C., op. cit., p. 102), cioè effettuato a
tavolino.
72
Per notiziabilità (cfr. ivi, pp. 73 e ss.) l’Autore sembra intendere quel complesso di criteri, di opzioni e di pratiche professionali mediante il quale un
fatto, un fenomeno o un processo sociale può diventare notizia.
73
BERTAUX D., op. cit., p. 41.
74
Cfr. HOBSBAWM E.J., On History, Weikenfeld and Nicholson, London 1997,
p. 311; per un approfondimento del tema nell’ambito delle scienze sociali
vd., ad es.: BOUDON R., Il relativismo, Il Mulino, Bologna 2009 (2008), passim e
GEERTZ C., Contro l’anti-relativismo, in I D., Antropologia e filosofia, Il Mulino,
Bologna 2001 (1984), pp. 57-83.
75
Cfr. HOBSBAWM E.J., op. cit., p. 311.
76
CHAKRABARTY D., op. cit., p. 138. Direttamente pertinente con la pratica
giornalistica è l’attualissima riflessione in materia prodotta da M ARLETTI C.,
Informazione, falsi giornalistici e costruzioni di realtà, in I D., Media, cit., pp. 50-82.
77
SCHULTZ E.A.-LAVENDA R.H., op. cit., p. 38.
54
Media e costruzione della realtà
sia irraggiungibile78 e lo storico possa «aspirare al massimo alla
plausibilità […] la plausibilità, naturalmente, non si fonda sull’invenzione arbitraria di una descrizione storica; essa implica invece
strategie razionali per determinare ciò che è plausibile in realtà»79.
A questo richiamo alla concretezza dei fatti non è sottesa –
d’altra parte – una superata fattualità positivistica,80 quasi un
feticismo del cosiddetto “dato concreto”. È – in effetti – un’opinione che viene discussa ormai da lungo tempo, e persino nell’ambito delle scienze della natura, quella che ritiene ancora che
la ricerca si configuri come una «passiva registrazione di nudi
fatti»81. Nel caso delle «discipline sociali», poi, proprio in quanto
il ricercatore deve confrontarsi con attori sociali che sono portatori di schemi culturali82 peculiari, la «comprensione»83 dei fatti esige «una grandissima intimità con le fonti: gli informatori.
Di conseguenza i dati […] sono […] intersoggettivi, prodotto di
lunghi dialoghi tra ricercatore e informatore»84.
Ora, non occorre dilungarsi sul fatto che – solitamente – il
giornalista non può soffermarsi «sul terreno»85 (sempre nel caso
78
IGGERS G.G., Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to
Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, Hannover-London 1997, p.
145; cfr. anche WEBER M., Il metodo, cit., p. 84 e W ALZER M., op. cit., p. 288.
79
IGGERS G.G., op. cit., p. 145.
80
Vd. ad es. SCHULTZ E.A.-LAVENDA R.H., op. cit., pp. 36-37.
81
DEI F.-CLEMENTE P., I fabbricanti di alieni. Sul problema della descrizione in antropologia, in FABIETTI U. (a cura di), Il sapere dell’antropologia. Pensare, comprendere,
descrivere l’Altro, Mursia, Milano 1993, p. 84. Secondo B OURDIEU P., Ragioni
pratiche, Il Mulino, Bologna 20092 (1994), pp. 85-86, la «costruzione scientifica» è «anche una costruzione sociale».
82
TENTORI T., Antropologia culturale, Studium, Roma, 1960, p. 19.
83
MALIGHETTI R., s.v. Verstehen, in FABIETTI U.-REMOTTI F. (a cura di), op. cit., p. 790.
84
SCHULTZ E.A.-LAVENDA R.H., op. cit., p. 39.
85
Cfr. infra, nt. 104.
55
Franz Brandmayr
ci vada personalmente)86 se non per pochi giorni, quando non
per poche ore soltanto, né si può sempre chiedere all’inviato di
avere competenze linguistiche e di ricerca sul campo di livello
antropologico, né – tanto meno – delle relazioni avviate e consolidate come è auspicabile intessa l’antropologo nei suoi prolungati soggiorni. Attraverso questa suggestione ricavata dalle
scienze sociali ho inteso, però, porre egualmente l’accento sull’importanza, ritengo, per il giornalista, di svolgere «due compiti
distinti e strettamente intrecciati: da un lato, ricostruire i fatti;
dall’altro metterli in relazione attraverso interpretazioni» 87, in un
intreccio dialettico88 che dovrebbe rendere conto delle diverse
«posizioni»89 occupate dai differenti attori coinvolti nell’evento
o nella «situazione sociale»90 narrata. Questo composto di cronaca e di interpretazione, peraltro opportunamente dosate a
seconda dei contesti e delle circostanze, potrebbe – inoltre –
offrire l’estro per un fecondo connubio fra diverse tradizioni
giornalistiche: quella italiana, di solito più versata nel commento dei fatti, e quella anglosassone, particolarmente focalizzata
sulla cronaca.91
In queste pagine – tuttavia – più che sull’operatore mediatico
soffermerei la mia attenzione soprattutto sul destinatario dei
media: ciò per fare esercizio di sensibilizzazione, da un lato, di
noi lettori adulti di quotidiani, noi telespettatori, noi utenti della
86
Cfr. infra, nt. 100-106.
BERTAUX D., op. cit., p. 84.
88
Sulla dialettica intesa come ragionamento filosoficamente rigoroso vd. ad
es. GUITTON J., Arte, cit., pp. 114-120. Da un punto di vista storiografico vd.
ad es. PIVATO S., op. cit., pp. 87-88.
89
BERTAUX D., op. cit., p. 44.
90
Ivi, p. 38.
91
Cfr. infra, nt. 145.
87
56
Media e costruzione della realtà
rete onde affinare gli strumenti critici dei quali disponiamo e,
dall’altra parte, degli studenti, al fine di trasmettere loro queste
stesse chiavi di lettura e contribuire a fare instaurare loro un
rapporto più consapevole e meditato con i media stessi.
2.0 «Questa insostenibile leggerezza del pensare…»
Nel 2001 Stefano Allievi, uno dei massimi esperti di sociologia
dell’islâm in Europa, da ex giornalista definiva in questo modo
caustico92 la produzione di «fattoidi»93 e di «esagerazioni», la superficialità94 e la selettività95 messi in campo dal mondo della comunicazione italiano impegnato a rendere conto della realtà
islamica internazionale e italiana. Secondo il nostro, infatti, sembrava che il ruolo dei media non fosse «più solo quello di informare, ma propriamente di costruire96 i nostri mondi conoscitivi»97.
92
ALLIEVI S., Parole dell’islam, parole sull’islam. Formazione culturale, comunicazione
e ruolo dei mass media, in SIGGILLINO I. (a cura di), I media e l’islam. L’informazione
e la sfida del pluralismo religioso, E.M.I., Bologna 2001, p. 41.
93
ALLIEVI S., Parole, cit., p. 36. «I fattoidi sono eventi mai avvenuti, dotati di
peculiarità e caratteristiche anomale e curiose, ma plausibili e verosimili,
sul cui conto, nel tessuto sociale o in alcuni ambienti di esso, circolano
indizi, liberamente disponibili per tutti i mass media, che possono far supporre – con maggiori o minori forzature – una loro reale esistenza» (C ASILLO
S., Fattoidi, bufale e falsi giornalistici, in I D.-DI TROCCHIO F.-SICA S., Falsi giornalistici. Finti scoop e bufale quotidiane, Guida, Napoli 1997, p. 30). Vd. anche
GILI G., op. cit., pp. 250-254.
94
Cfr. ALLIEVI S., Parole, cit., p. 42.
95
Ivi, p. 35. Sul concetto di selettività vd. supra, nt. 12, 18 e infra, nt. 167-171.
96
Cfr. BERGER P.L.-LUCKMANN TH., op. cit., soprattutto il cap. III; sulla costruzione giornalistica come «inevitabile» vd. SORRENTINO C., op. cit., p. 18.
97
ALLIEVI S., Parole, cit., p. 44.
57
Franz Brandmayr
Le critiche mosse dal sociologo – peraltro – venivano
suffragate qualche anno più tardi – con un riferimento più ampio della copertura del solo islâm e con un’attribuzione allargata
a tutto il mondo dei media italiani – dalla valutazione di Paese
«parzialmente libero» data all’Italia, collocata dal “Freedom of
the press 2004 – Table of Global Press Freedom Ranking” al
74° posto nel mondo98 a New York nel maggio del 2004, mentre nello stesso anno i Reporters sans frontières assegnavano al nostro Paese – sempre relativamente alla libertà di stampa – il 53°
posto su settanta Stati considerati99. Questa situazione sarebbe
derivata da un insieme di fattori, fra i quali potremmo indicare –
senza alcuna pretesa di esaustività – i seguenti: a) il fatto che la
carenza di inchieste in loco100 (causata dai costi)101 determini una
dipendenza sempre maggiore dei giornali dalle agenzie (soprattutto: Ansa102 e Reuter103); b) pertanto l’informazione risulterebbe sempre più povera di rilevamenti «sul campo»104 e c) ap-
98
MASTELLARINI G., Assalto alla stampa. Controllare i media per governare l’opinione
pubblica, Dedalo, Bari 2004, p. 147.
99
TRANFAGLIA N., Prefazione, in MASTELLARINI G., op. cit., p. 11. Una posizione
contraria rispetto a queste evidenze emerge da E. Mauro, in ivi, p. 110.
100
CASILLO S., op. cit., pp. 19-21; cfr. AGOSTINI A., Giornalismi, cit., p. 132.
101
CASILLO S., op. cit., p. 19; MARTIN H.-J., Storia e potere della scrittura, Laterza,
Roma-Bari 2009 (1988), p. 527.
102
BARBANO A., op. cit., p. 36.
103
Vd. ad es. CASILLO S., op. cit., pp. 18 e, per il passaggio dal newsmaking
(l’elaborare la notizia) al gatekeeping (la «selezione e la presentazione di notizie
prodotte da altri»), 21; M ARTIN H.-J., op. cit., pp. 449 e 527.
104
CIRESE A.M., op. cit., p. 238. Per un primo approccio al tema vd. ivi, pp.
244-257 e SEYMOUR-SMITH CH., s.v. Ricerca sul campo, in E AD., op. cit., pp. 340343. Equivale all’espressione «sul terreno» (S OLINAS P.G., Itinerari di letture per
l’antropologia. Guida bibliografica ragionata, C.I.S.U., Roma 1991, p. 26; una ricca
messe di indicazioni bibliografiche intorno all’argomento è reperibile ivi, pp.
58
Media e costruzione della realtà
piattita e omologata nei contenuti e nelle chiavi interpretative
forniti – in buona sostanza – in una prospettiva rispettivamente
statunitense e britannica; d) ciò determinerebbe una perdita di
rapporto con il reale105 e anche e) un «crescente provincialismo»106. Un’altra delle riprove più significative di questa perdita
di qualità professionale sarebbe rappresentata dalla f) consuetudine delle redazioni di «fotocopiare» 107 pedissequamente
l’«agenda»108 delle testate televisive e giornalistiche più quotate.
Ancora, c’è chi lamenta a chiare lettere g) «l’inadeguatezza delle
competenze professionali»109 e chi pare nemmeno interrogarsi
sul fatto se sia opportuno che h) «il giornalismo raccont[…(i)]
la realtà attraverso la sottolineatura dell’eclatante, dell’iperbolico,
del significativo»110. Nondimeno, la difficile situazione dei media
26-30). Vd. anche le riserve circa l’analogia fra inchiesta giornalistica e lavoro
antropologico sul campo espresse supra, nel paragrafo 1.1.
105
RIGHETTO R., La situazione odierna: segnali di ottimismo, in SIGGILLINO I. (a
cura di), op. cit., p. 26; cfr. MARLETTI C., Media, cit., pp. 64-65; cfr. supra, nt. 31.
106
CLEMENTE P., Lontananze vicine: sui modi di pensare e insegnare l’antropologia nel
mondo globale, in PASQUINELLI C. (a cura di), Occidentalismi, Carocci, Roma 2005,
pp. 161-162; TAGLIAFERRI F., Islam e comunicazione, in SIGGILLINO I. (a cura di),
op. cit., pp. 101 e 109; cfr. SORRENTINO C., op. cit., p. 67. E. Scalfari cit. in F ROIO
F., op. cit., p. 15 sembra dissentire in merito.
107
BARBANO A., op. cit., passim; G. Bocca, cit. in FROIO F., op. cit., p. 9; U. Eco,
cit. ivi, p. 22.
108
Sull’importanza della gerarchizzazione delle notizie cfr. S ORRENTINO C.,
op. cit., p. 76 e le osservazioni critiche di C HELI E., La realtà mediata. L’influenza
dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà, Franco Angeli, Milano 20026 (1992), pp. 106-110.
109
BARBANO A., op. cit., pp. 42-43.
110
SORRENTINO C., op. cit., p. 73; BARBANO A., op. cit., pp. 45-46 – meno entusiasticamente di Sorrentino – mette invece in luce l’effetto di «proiezione
amplificata di alcuni punti di crisi» e porta l’esempio specifico della resa
caricaturale dell’immagine mediatica della famiglia italiana.
59
Franz Brandmayr
italiani verrebbe a complicarsi ulteriormente alla luce della i)
«teledipendenza» della stampa italiana,111 stampa gravemente condizionata dall’informazione televisiva non solo nello stabilire la
rilevanza112 degli eventi, ma anche dal crescente affermarsi dell’informazione «urlata»,113 dello «sfottò»,114 della «battuta ad effetto»,115 del «culto dell’immagine»,116 della «personalizzazione»,117 del
sensazionalismo118 più spinto, della predilezione per le «tinte forti»,119 tutti atteggiamenti che sembrano impoverire e finanche sostituire la narrazione giornalistica e l’analisi.
Questi aspetti sembrano intrecciarsi anche con una sorta di
l) tendenza a elementarizzare la narrazione, per cui
la contrapposizione, la rappresentazione del conflitto diventa
l’artificio […] più frequentemente adoperato. Anziché rap-
111
Ad es. U. Eco, cit. in FROIO F., op. cit., pp. 12-13 e 16. Per una valutazione
dissonante vd. AGOSTINI A., Giornalismi, cit., p. 70, mentre S ORRENTINO C.,
op. cit., p. 91, sembra evidenziare piuttosto la complementarità fra i diversi
media.
112
CHELI E., op. cit., p. 107; SORRENTINO C., op. cit., pp. 28-29 e 76.
113
W. Veltroni, cit. in FROIO F., op. cit., p. 17.
114
U. Eco, cit. ivi, p. 22.
115
SORRENTINO C., op. cit., pp. 86 e 134.
116
W. Veltroni, cit. in FROIO F., op. cit., p. 17.
117
Per personalizzazione si intende «porre l’enfasi sul protagonista di un
evento […] attraverso il racconto dell’esperienza individuale», cosa che «facilita l’attribuzione di significatività […] la riconoscibilità e la memorizzazione
[… (il)] concentrarsi sul protagonista come simbolo caratterizzante l’oggetto di trattazione» (SORRENTINO C., op. cit., p. 85; parentesi tonda mia). Cfr.
anche ivi, p. 87.
118
Ivi, pp. 85-87; da un punto di vista filosofico vd. POPPER K.R., op. cit., pp. 34 e
37. Sulla nascita del giornalismo sensazionalista vd. MARTIN H.-J., op. cit., p. 451.
119
SORRENTINO C., op. cit., p. 86.
60
Media e costruzione della realtà
presentare la realtà […] come un prisma a più facce, ci si
limita a vederla come una medaglia con solo [sic] due rovesci: il bianco e il nero, il bello e il brutto, il giusto e l’ingiusto.
Questa semplificazione ben si adatta ai tempi sempre più
rapidi della notiziabilità ed è facilmente adeguabile ai formati giornalistici.120
In questo caso – però – all’insito rischio, opportunamente
segnalato da Sorrentino, di «rappresentare una realtà più opaca»
e frammentata121 e – perciò – tutt’altro che oggettiva, si assomma
– a mio avviso – l’azzardo forse più rilevante della possibile
riproduzione e dell’amplificazione mediatica del conflitto eretta
a duplice schema: interpretativo della realtà e risolutivo delle
questioni (individuali, sociali, interetniche, politiche etc.), con
tutte le complicazioni che possono derivarne per quanto attiene
la pace sociale e internazionale.122 Alla fine di un elenco così
preoccupante può forse fare addirittura sorridere la menzione
della pur grave prassi della m) mancata verifica 123 dei continui
“si dice” e dei n) discorsi messi fra virgolette, ma del tutto inventati dal giornalista.124
120
Ivi, p. 134; cfr. anche AGOSTINI A., Giornalismi, cit., p. 140 e LASCH CH., op.
cit., p. 95.
121
SORRENTINO C., op. cit., p. 134.
122
In questo senso resta a mio parere esemplare – sotto il profilo giornalistico – la serie di indagini e le riflessioni svolte da R UMIZ P., Maschere per un
massacro, Editori Riuniti, Roma 1996, passim, dalle quali emerge come la sistematica costruzione mediatica della diversità etnica sia stata decisiva nel far
deflagrare il conflitto nelle repubbliche e nelle regioni autonome della ex
Repubblica federale jugoslava.
123
MARLETTI C., Media, cit., p. 61; da un punto di vista giuridico cfr. anche
SICA S., Profili giuridici del falso giornalistico, in CASILLO S.-DI TROCCHIO F.-ID., op.
cit., pp. 181-182, 186-187 e 200-202.
124
Cfr. FROIO F., op. cit., pp. 7, 246 et alibi.
61
Franz Brandmayr
Come si può agevolmente costatare, fra le manchevolezze
riportate si può riconoscere una buona parte degli elementi
costitutivi dell’informazione televisiva, dove «oggi – scriveva la
Farinotti già nel 1997 – è diventato pressoché impossibile individuare una zona incontaminata, uno spazio “puro” dell’informazione in cui non entrino elementi di spettacolo o di fiction»125.
A equilibrare la valutazione circa il sistema mediatico italiano può giovare, tuttavia, il richiamo alla reale difficoltà imposta
dalle esigenze della «narrativizzazione». Essa consiste nel lavoro di ineludibile «semplificazione della realtà» svolto dagli operatori dei media, che comporta un «processo di decontestualizzazione degli eventi dal flusso di cui fanno parte e
ri-contestualizzazione nei formati giornalistici» 126: è possibile,
sostiene Sorrentino, che il giornalista-narratore ritenga «meno
significative le parti omesse», senza che – con ciò – egli abbia
avuto necessariamente l’intenzione di mentire od occultare parte dell’evento raccontato127.
Questa semplice osservazione ci permette di prendere una
certa distanza critica dal paradigma tradizionale della teoria della manipolazione, che dagli anni Cinquanta e Sessanta sostiene
la tesi della «“cospirazione” delle élite». Secondo questa interpretazione la manipolazione sarebbe sempre e soltanto il frutto
di una intenzione deliberata dell’emittente.128 Pare opportuno
riconoscere, invece, che – se il medium vuole conservare una
125
FARINOTTI L., L’informazione, in COLOMBO F. (a cura di), Televisione e industria
culturale in Italia, Cooperativa Libraria I.U.L.M., Milano 1997, p. 71; D I
TROCCHIO F., Falsi scoop e scienza spettacolo nei quotidiani, in C ASILLO S.-ID.-SICA
S., op. cit., p. 128; MASTELLARINI G., op. cit., p. 169.
126
SORRENTINO C., op. cit., p. 73; cfr. anche ivi, p. 74 e CASILLO S., op. cit., pp. 21-23.
127
SORRENTINO C., op. cit., p. 74.
128
GILI G., op. cit., p. 72; cfr. SORRENTINO C., op. cit., p. 160.
62
Media e costruzione della realtà
propria «credibilità»129 – deve in realtà negoziare la propria «posizione, in risposta a pressioni interne ed esterne»; esso deve
tener conto – infatti – della pluralità dell’offerta informativa,
dei meccanismi strutturali che condizionano la logica dei media130 (si pensi, ad es., alla sola «sfida contro il tempo» 131), delle
politiche editoriali dei singoli organi d’informazione 132 e
dell’interazione di questi e di altri fattori ancora.
2.1 Media e gruppi di interesse
In aggiunta alle carenze e alle problematiche di ordine strettamente tecnico-professionale, però, va senz’altro ribadito il fatto
che la situazione appena descritta sarebbe funzionale – secondo
Allievi almeno per la copertura dell’islâm – agli interessi dei poteri
forti. Questi sarebbero rappresentati da «illustri storici e politologi,
e meno illustri commentatori e giornalisti»133, ma, secondo altri
Autori e a un livello più generale, anche da «importanti case editrici» e prestigiose firme del giornalismo italiano.134 Non mancano, peraltro, soggetti denominati «fonti stabili centrali»135, «che si
129
GILI G., op. cit., pp. 39-40, dove l’Autore scrive di «attendibilità» e «sincerità», e 75-98.
130
Ivi, p. 72. Vd. anche AGOSTINI A., Giornalismi, cit., pp. 13-14 e SORRENTINO
C., op. cit., pp. 93-149, dove l’Autore descrive Una giornata in redazione e Gli
ambiti giornalistici.
131
Ivi, p. 82. In merito alla velocizzazione dei tempi di produzione delle notizie cfr. anche ALLIEVI S., Parole, cit., pp. 44-45.
132
GILI G., op. cit., p. 72.
133
ALLIEVI S., Parole, cit., p. 41.
134
Cfr. CASILLO S., op. cit., p. 85.
135
Ivi, p. 22.
63
Franz Brandmayr
collocano a livelli molto alti nella struttura del potere politico,
militare, statuale, giuridico, scientifico, economico»136.
Del resto, pur nelle sue diverse fasi storiche,137 il giornalismo
italiano è sempre stato dipendente dalla politica,138 politica strettamente connessa a «un sistema economico tendenzialmente
oligopolistico, basato sulla centralità di poche grandi famiglie» 139,
che si configurano come «gruppi di interesse»140 politico-economico.141 Peraltro non bisogna pensare che questa situazione
storica contraddistingua il giornalismo italiano in maniera peculiare ed esclusiva.142
136
CESAREO G., Fa notizia. Fonti, processi, tecnologie e soggetti nella macchina dell’informazione, Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 87-88; cfr. anche C ASILLO S., op.
cit., pp. 91-103; G. Ferrara, in BARBANO A., op. cit., p. 77; FROIO F., op. cit., pp.
24, 30 e 90; SORRENTINO C., op. cit., pp. 35 e 47 e infra, nt. 98.
137
SORRENTINO C., op. cit., pp. 31-32. Per lo studio della storia del giornalismo
italiano rinvio a: CASTRONOVO V.-TRANFAGLIA N. (a cura di), La stampa italiana,
Laterza, Roma-Bari 1976-1994, 7 voll., passim; FARINELLI G.-PACCAGNINI E.SANTAMBROGIO G.-VILLA A.I., Storia del giornalismo italiano, U.T.E.T., Milano 1997,
passim; GOZZINI G., Storia del giornalismo, Bruno Mondadori, Milano 2000, passim;
MURIALDI P., Storia del giornalismo italiano, Gutenberg 2000, Torino 1986, passim.
138
SORRENTINO C., op. cit., pp. 131-132.
139
Ivi, p. 32.
140
Per la nozione di gruppo d’interesse vd. T ELLIA B., s.v. Gruppo di pressione,
in DEMARCHI F.-ELLENA A.-CATTARINUSSI B. (a cura di), op. cit., p. 946; scriveva
MARLETTI C., Media, cit., p. 103 già nel 1984: «Vi è da pensare che anche da
noi come negli Stati Uniti accanto ed oltre ai partiti acquisteranno sempre
maggior peso i gruppi di pressione, le lobbies più o meno occulte [… (che)]
hanno origini e natura extrapolitica, in rapporto a gruppi d’interesse» (parentesi tonda mia).
141
Per una descrizione giornalistica dei maggiori gruppi di pressione italiani
vd. MASTELLARINI G., Stampa e potere, in ID., Assalto, cit., pp. 19-50. Una posizione critica rispetto alla logica del mercato emerge palesemente in W OJTYÙA
K., La potenza dei media, in POPPER K.R.-CONDRY J.-ID., op. cit., p. 48.
142
Ad es. anche la Francia presenta una storia significativa sotto il profilo
64
Media e costruzione della realtà
In un contesto di questo genere «i quotidiani si trasformano
in canali attraverso cui i vari attori politici spediscono messaggi», comprensibili appieno «soltanto a coloro che sono interni a
questo campo», messaggi che vanno a costituire «l’arena di scontro fra i diversi rappresentanti (politici), piuttosto che sottolineare l’interesse per la funzione della politica di mediare fra i conflitti e i differenti interessi posti in gioco dai soggetti sociali» 143.
Va letta, ad esempio, in questo modo la consuetudine tutta italiana con il cosiddetto «pastone», «lungo articolo nel quale il
giornalista assembla gli eventi politici della giornata, inserendovi anche le proprie opinioni»144. Ciò fa concludere a un noto
studioso di Teoria e Tecniche delle Comunicazioni di massa che
in Italia «la cronaca non costituisce l’essenza della professione
(giornalistica), le si preferisce il commento, l’opinione» 145.
Va segnalato, però, che negli «ultimi quindici anni […] si è notevolmente modificato il rapporto fra politica e informazione»146;
dell’influenza esercitata sulle masse dai capitali privati per il tramite della
stampa quotidiana (MARTIN H.-J., op. cit., p. 457), con punte storiche massime, che gli specialisti collocano nella fase della Terza Repubblica (ivi, p. 452).
143
SORRENTINO C., op. cit., p. 33 (parentesi tonda mia). Cfr. anche B ARBANO A.,
op. cit., p. 37; LASCH CH., op. cit., pp. 12, 17 e 93; M ARLETTI C.A., La Repubblica
dei media. L’Italia dal politichese alla politica iperreale, Il Mulino, Bologna 2010,
pp. 42 et passim. Vd. anche supra, nt. 36 e FORCELLA E., op. cit., p. 451.
144
SORRENTINO C., op. cit., p. 33; cfr. MARLETTI C., Media, cit., p. 48, che scrive –
attingendo ad un contributo del giornalista Pansa – del «“giornalismo dimezzato”» di quanti «“partecipano” agli eventi che dovrebbero commentare». A
questo proposito SICA S., op. cit., pp. 206-207 scrive – da un punto di vista
prettamente giuridico – del «falso da commistione fra cronaca e critica».
145
SORRENTINO C., op. cit., pp. 33 e 35 (parentesi tonda mia); cfr. anche ivi, p.
78, dove si sottolinea che la tradizione giornalistica anglosassone predilige,
invece, la cronaca rispetto al commento sui fatti.
146
Ivi, p. 131. Vd., a proposito dei prodromi storici di questo processo,
MARLETTI C., Media, cit., pp. 31-49.
65
Franz Brandmayr
i climi d’opinione [… (sono)] meno tributari alla centralità
della classe politica, mentre [… (risentono)] della varietà dei
punti di vista propri di una società caratterizzata da identità
plurime, in cui i consumi materiali e culturali dei singoli definiscono appartenenze sociali articolate e complesse.147
È questo spostamento negli assetti di potere che fa scrivere
ad Agostini che
a metà degli anni Novanta, le agenzie di socializzazione politica, gli attori che definiscono la scena, il gioco e le mete della
politica non sono più soltanto i partiti […]. Questi altri attori
sono i giornali.148
Queste osservazioni, ricavate da alcuni sociologi e da altri
studiosi delle comunicazioni, sembrano avallare – certo, in modo
nuovo – la concezione del sistema dell’informazione (non più
solo della stampa, come nel Settecento di Burke) visto come
«quarto potere»149 e rinforzano, inoltre, gli effetti di «iperrealtà»150
e di «autoreferenzialità» diagnosticati da Marletti «in rapporto ai
media e alla comunicazione politica»151.
147
SORRENTINO C., op. cit., p. 132 (parentesi tonde mie); cfr. anche ivi, pp. 135136.
148
AGOSTINI A., “la Repubblica”, cit., p. 8; LASCH CH., op. cit., p. 39; MARLETTI
C.A., La Repubblica, cit., p. 83. Cfr. supra, nt. 55.
149
MARTIN H.-J., op. cit., p. 438.
150
MARLETTI C.A., La Repubblica, cit., pp. 113-122; in estrema sintesi, con
questo termine l’Autore designa la tendenza dei politici a sviluppare indefinitamente le attese sociali senza dover temere un riscontro puntuale con la
realtà, che sembra perdere il confronto con la più fascinosa realtà mediale
(cfr. soprattutto ivi, pp. 115-116).
151
Ivi, p. 41; cfr. supra, nt. 143.
66
Media e costruzione della realtà
Le logiche del potere – come è noto – non sono sempre compatibili con un’oggettività almeno germinale. Indicazioni in questo senso sembrano emergere, peraltro, anche dall’interno del giornalismo italiano, in parte propenso a credere che la stampa e la
TV abdichino al dovere della cronaca e della ricerca della verità152.
Già nel 1991 Mazzanti153 aveva sostenuto che la ricerca dell’obiettività da parte dei mezzi di comunicazione fosse un ideale in crisi
patente, tuttavia l’accusa di tale mancanza non sembra scuotere
più di tanto una parte del mondo giornalistico.154
Pare – anzi – che, ad esempio, la seconda (per numero di
lettori)155 testata italiana faccia professione esplicita del proprio
indirizzo ideologico, con il quale intenderebbe porsi, non senza
enfasi,156 quale «strumento di costruzione di identità per i lettori»157. In questo caso il giornalismo nel suo insieme viene interpretato da alcuni studiosi quale vera e propria «bussola della
modernità»158, mentre il singolo giornalista sembra assumersi il
compito di orientare il lettore, diventando una sorta di «definitore
ufficialmente accreditato della realtà»159. Può – dunque – affer-
152
Cfr. ad es. NASO P., L’informazione religiosa: costruire il pluralismo, in SIGGILLINO
I. (a cura di), op. cit., p. 14.
153
MAZZANTI A., L’obiettività giornalistica. Un ideale maltrattato, Liguori, Napoli
1991, passim.
154
MARLETTI C., Media, cit., pp. 62-63 e 80-82.
155
È “la Repubblica” (cfr. SORRENTINO C., op. cit., p. 60).
156
Cfr. ad es. gli accenti encomiastici e celebrativi di A GOSTINI A., “la Repubblica”, cit., pp. 16, 47-58, 70 et alibi.
157
Ivi, pp. 29 et alibi; SORRENTINO C., op. cit., p. 132.
158
Ivi, pp. 23-26.
159
Cfr. BERGER P.L.-LUCKMANN TH., op. cit., p. 138; per quanto riguarda certi
grandi eventi trasmessi in diretta televisiva DAYAN D.-KATZ E., Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta, Baskerville, Bologna 1993 (1992), p. 10
scrivono del «ruolo quasi sacerdotale giocato dai giornalisti».
67
Franz Brandmayr
marsi «un modello giornalistico forgiato da un’ottica educativa,
pedagogica, attento a formare più che a informare»160, che si
colloca così significativamente in una consolidata tradizione giornalistica italiana.161 «L’appartenenza politica […] è determinante nella formazione delle identità individuali, e i media
assecondano tali processi»162, fino a poter diventare – scriveva
uno dei più noti sociologi della comunicazione italiani già negli
anni Ottanta – dei «quasi-partiti»163 o, come aggiunge qualcun
altro, delle «“testate-stili di vita”»164.
È evidente che, se alcuni media possono proporsi come «officine dell’identità»165, ciò accade in quanto emerge dalla base
sociale dei lettori una «ricerca di senso»166 generalizzata. Questa esigenza diffusa induce poi senz’altro una quantità di attori
sociali all’esposizione omofila,167 cioè alla tendenza a leggere e
160
SORRENTINO C., op. cit., p. 132.
Cfr. la «strategia pedagogizzante» considerata da C OLOMBO F., La cultura
sottile. Media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni novanta, Bompiani,
Milano 20094 (1991), pp. 16-18, 26, 33-35 et alibi.
162
SORRENTINO C., op. cit., p. 35 (cfr. anche ivi, p. 85). Sul «giornalismo “partigiano” o “moschettiere” [… (e)] animoso», che avrebbe segnato la storia
italiana e che arriverebbe fino agli Scalfari e ai Montanelli dei nostri giorni,
vd. MARLETTI C., Media, cit., pp. 74-75 (parentesi tonda mia).
163
Ivi, pp. 46 e 102; cfr. anche le pp. 83-94. In AGOSTINI A., Giornalismi, cit.,
pp. 77-92 e ID., “la Repubblica”, cit., pp. 15-16 si può trovare un’appassionata
apologia della linea editoriale de “la Repubblica” intesa come «officina dell’identità» (vd. supra, nt. 157 e infra, nt. 165).
164
SORRENTINO C., op. cit., p. 41; vd. anche A GOSTINI A., Giornalismi, cit., pp.
127-140.
165
ID., “la Repubblica”, cit., p. 11. Cfr. supra, nt. 144, 145 e 163.
166
Ricavo l’espressione da una prospettiva filosofica (N ANNI C., L’educazione tra crisi e ricerca di senso. Un approccio filosofico, LAS, Roma 1986, pp. 29-49 et
passim).
167
GILI G., op. cit., pp. 87-88. È appena il caso di ricordare che il concetto di
161
68
Media e costruzione della realtà
ad ascoltare soltanto le fonti e i contenuti consonanti 168 con il
proprio sentire-pensare-agire. 169 Di questo atteggiamento
selettivo, ben noto agli addetti ai lavori170, sembra pervenire
tuttavia a piena consapevolezza solo una minoranza di lettori,
i quali – in un’indagine del 2005 – ammettono una conformità
di opinioni rispetto alla testata preferita appena nel 12% dei
casi rilevati.171
Le istanze identitarie, comunque, per quanto importanti, non
fanno certo dimenticare che quello dei quotidiani rimane, in
tutti i casi, un mercato. Anche se un importante fine sotteso alla
gestione del medium può essere quello del «maggiore coinvolgimento e identificazione del lettore»172, ciò non toglie che la
dimensione di impresa del giornale non possa esimere la dire-
«omofilia» fatto proprio dalla Sociologia della Comunicazione non ha nulla a
che vedere con il lemma omofono, dall’etimologia peraltro approssimativa,
in uso presso gli psicologi [cfr. ad es. A RNOLD W.-EYSENCK H.J.-MEILI R. (a
cura di), op. cit., p. 764].
168
Cfr. anche CARTOCCI R., Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia,
Il Mulino, Bologna 2007, p. 72, nt. 2; G ILI G., op. cit., pp. 42-43; M ARLETTI
C.A., La Repubblica, cit., p. 103; T RENTIN R., op. cit., pp. 274-281 e soprattutto p. 276.
169
Secondo TURNER V., op. cit., p. 120, sono le tre «strutture dell’esperienza»
del soggetto; cfr., sotto il profilo della ricerca antropologica sul campo, B IANCO
C., op. cit., pp. 162-163.
170
Sulla fedeltà alle «lealtà sociali» e alle «appartenenze» che prevalgono sul
«giudizio personale» cfr. GILI G., op. cit., p. 140. Del resto, negli studi di psicologia sociale sono noti gli effetti della «familiarità» fra la fonte emittente e il
destinatario (vd. ad es. GUÉGUEN N., Psicologia del consumatore, Il Mulino, Bologna 2010 [2009], pp. 170-173), che non risparmiano neanche il «consumatore di informazioni» (SUNSTEIN C.R., repubblic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?, Il Mulino, Bologna 2003 [2002], passim).
171
SORRENTINO C., op. cit., p. 61.
172
Ivi, pp. 40-41.
69
Franz Brandmayr
zione dal prestare la dovuta attenzione alla voce relativa ai
profitti.173
La compatta saldatura fra l’informazione e la logica commerciale, infine, sembra portare inevitabilmente ad almeno due
tipologie di conflitti d’interessi: da un lato, può accadere che –
come abbiamo già visto – un medium rischi di diventare meno
affidabile per i lettori,174 in quanto succube di gruppi di pressione, ai quali deve rendere conto del proprio operato. Da un’altra
parte, può venire a prodursi la situazione per la quale l’esigenza
del cittadino di venire informato con competenza e obiettività
incontra la risposta di testate che pongono «la maggiore attenzione alle esigenze del mercato» e che sono propense «a compiacere il lettore più che ad informarlo»175, mancando, così, al
compito di fornire un quadro attendibile della realtà.
Nel rimandare a un’altra sede le riflessioni propriamente attinenti alla copertura delle religioni concludo la prima parte di
questo mio contributo con il fermo richiamo di uno dei decani
della Sociologia della Comunicazione:
Obiettività e credibilità dell’informazione rappresentano risorse fondamentali per la qualità di una democrazia.176
173
Vd. ad es. E. Scalfari, cit. in FROIO F., op. cit., p. 15; G. Anselmi cit. ivi, p. 16;
AGOSTINI A., Giornalismi, cit., pp. 119-127; POPPER K.R., op. cit., pp. 36-37;
SORRENTINO C., op. cit., pp. 85 e 88. È in questo ambito che si colloca anche il
nodo problematico relativo al marketing: per un primo approccio rinvio a
GOFFREDO D.-VANTAGGIO L., Dietro la pubblicità. Guida alla formazione critica dei
recettori, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1987, passim, che – pur superato –
presenta apprezzabili caratteristiche di sintesi e di equilibrio nelle conclusioni.
174
Cfr. BARBANO A., op. cit., p. 46.
175
SORRENTINO C., op. cit., p. 88; cfr. anche AGOSTINI A., Giornalismi, cit., pp.
48-56, 74 e 119-127 e COLOMBO F., op. cit., pp. 261 e ss.
176
MARLETTI C.A., La Repubblica, cit., p. 64. Cfr. anche FERRAROTTI F., op. cit.,
p. 13 e POPPER K.R., op. cit., p. 45.
70
Media e costruzione della realtà
A tal fine non si rendono necessarie prestazioni che siano al
di là delle possibilità umane, perché, come abbiamo già osservato sopra, ogni testata e ogni singolo giornalista sono portatori
di una propria concezione del mondo e di propri interessi e si
avvalgono di una mappa concettuale dotata di filtri e di griglie
interpretative, dei quali sono più o meno consapevoli.
Ciononostante
l’obiettività […] va considerata una meta, un orientamento a
cui tendere proprio per capire meglio come si costrui(scono)
questi filtri e chi li costrui(sce), dando per scontato che la loro
costruzione [… (sia)] inevitabile.177
Come invita a fare il linguista Tullio De Mauro, pertanto, si
tratterebbe soltanto di chiedere ai giornalisti di elaborare
una buona informazione [(, che) …] deve essere sempre smontabile nelle sue componenti per poter essere verificabile.178
A tal fine è fondamentale, a mio parere, promuovere nei rispettivi «microcosmi sociali»179 uno spirito di riscoperta del lavoro critico, che niente impedisce possa venire fatto proprio in
misura maggiore anche dagli operatori mediatici.
In ogni caso resta il fatto che chi impronta la propria azione
sociale all’autoeducazione180 e alla partecipazione civica è co-
177
SORRENTINO C., op. cit., p. 18 (parentesi tonde mie).
FROIO F., op. cit., p. 28 (parentesi tonda mia).
179
Cfr. BERTAUX D., op. cit., pp. 37-38.
180
Dal punto di vista psicologico cfr., ad es., S OVERNIGO G., Divenire liberi.
Educazione alla libertà, LDC, Leumann (TO) 1981, pp. 102-115 soprattutto.
Nel proporre anche una prospettiva pedagogica mi rifaccio a P OPPER K.R.,
op. cit., pp. 42-43, dove il filosofo liberale austriaco non esita a definire il
giornalista come un «educatore».
178
71
Franz Brandmayr
stretto a misurarsi – in maniera palese – con una forte pressione
culturale di segno contrario rispetto alle istanze dell’onestà intellettuale. Le reazioni più immediate a uno stato di avanzato
degrado professionale (che non concerne certamente i soli giornalisti) e di crisi di fiducia,181 come quello in cui versa l’Italia di
oggi, configurano un complesso di atteggiamenti, che potrebbero oramai innervare un certo tipo di senso comune.182 Potrebbe incombere – in effetti – una sorta di acedia inibita e «apatica»183 spesso pronta a colorarsi (forse nell’intento di nobilitarsi)
di un’aura di «disincanto»184 e di «distacco dai propri concittadini»185, e che – nelle «rappresentazioni collettive»186 proprie di
una certa tipologia di “colti” – caratterizzerebbe il modello dell’intellettuale cinico187 e consapevole … Però, probabilmente
pessimismo e scetticismo non creano gli anticorpi della critica e della consapevolezza, ma soltanto quelli del disinteresse
e della disillusione, in cui possono pescare demagoghi e populisti.188
(Prima parte – continua)
181
Cfr. supra, nt. 65.
GEERTZ C., Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna 1988 (1983), pp.
91-117.
183
Cfr. LASCH CH., op. cit., p. 79.
184
È il noto concetto weberiano (cfr. PACE E., s.v. Secolarizzazione, in ID. [a cura
di], Dizionario di sociologia e di antropologia culturale, Cittadella, Assisi 1984, p. 505).
185
WALZER M., op. cit., p. 304.
186
DURKHEIM É., Rappresentazioni individuali e rappresentazioni collettive, in I D., Le
Regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Comunità, Torino 2001 (1895),
pp. 137-164.
187
LASCH CH., op. cit., p. 79.
188
SORRENTINO C., op. cit., p. 20.
182
72