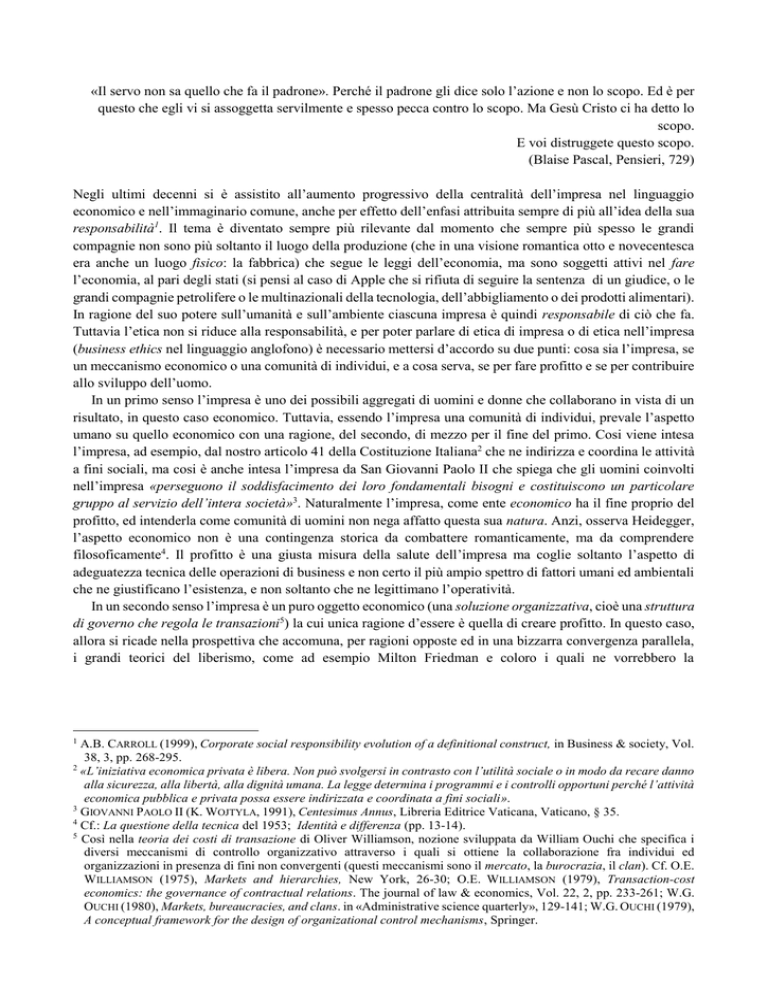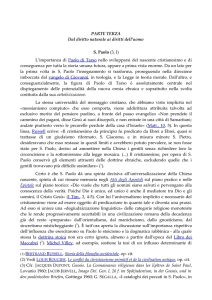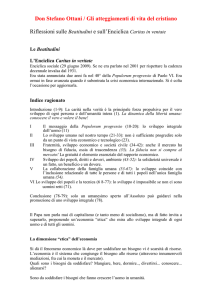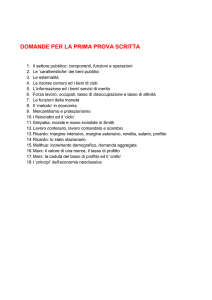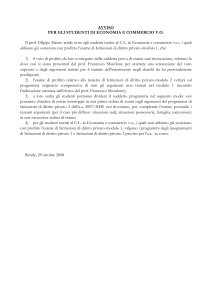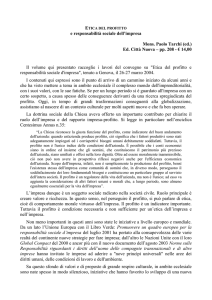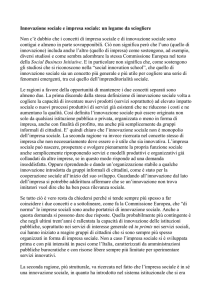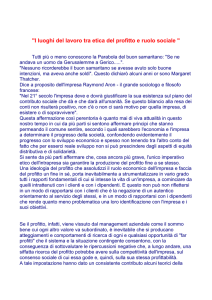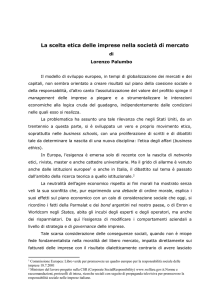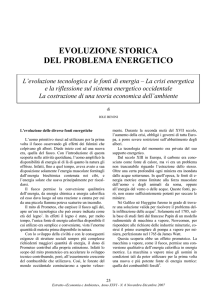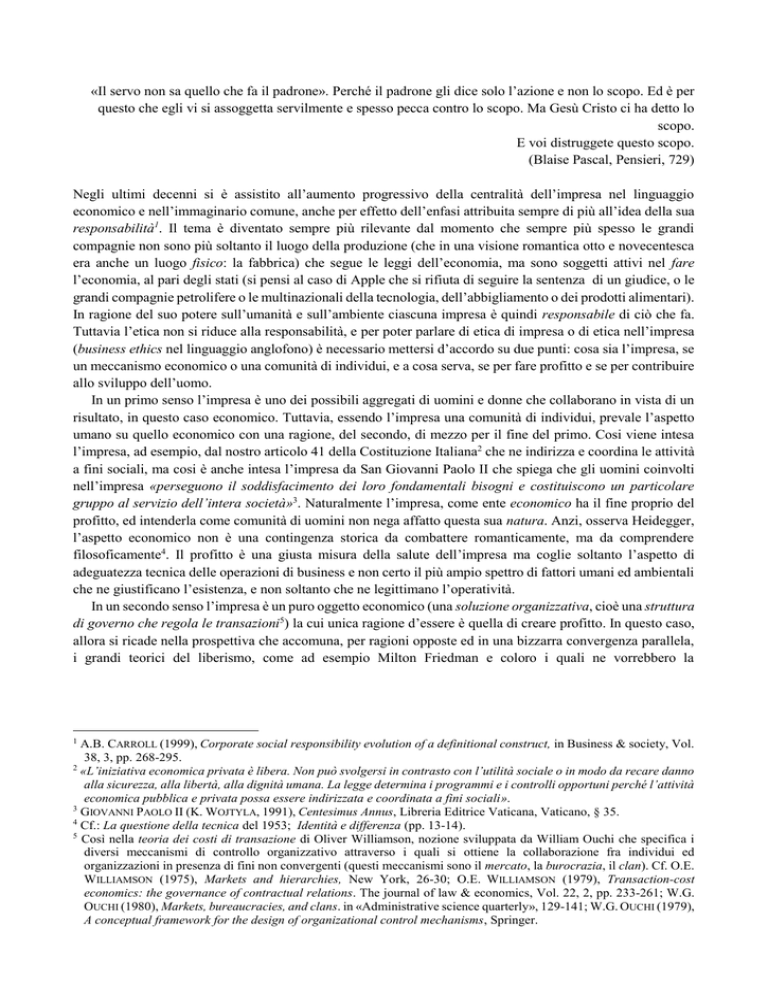
«Il servo non sa quello che fa il padrone». Perché il padrone gli dice solo l’azione e non lo scopo. Ed è per
questo che egli vi si assoggetta servilmente e spesso pecca contro lo scopo. Ma Gesù Cristo ci ha detto lo
scopo.
E voi distruggete questo scopo.
(Blaise Pascal, Pensieri, 729)
Negli ultimi decenni si è assistito all’aumento progressivo della centralità dell’impresa nel linguaggio
economico e nell’immaginario comune, anche per effetto dell’enfasi attribuita sempre di più all’idea della sua
responsabilità1. Il tema è diventato sempre più rilevante dal momento che sempre più spesso le grandi
compagnie non sono più soltanto il luogo della produzione (che in una visione romantica otto e novecentesca
era anche un luogo fisico: la fabbrica) che segue le leggi dell’economia, ma sono soggetti attivi nel fare
l’economia, al pari degli stati (si pensi al caso di Apple che si rifiuta di seguire la sentenza di un giudice, o le
grandi compagnie petrolifere o le multinazionali della tecnologia, dell’abbigliamento o dei prodotti alimentari).
In ragione del suo potere sull’umanità e sull’ambiente ciascuna impresa è quindi responsabile di ciò che fa.
Tuttavia l’etica non si riduce alla responsabilità, e per poter parlare di etica di impresa o di etica nell’impresa
(business ethics nel linguaggio anglofono) è necessario mettersi d’accordo su due punti: cosa sia l’impresa, se
un meccanismo economico o una comunità di individui, e a cosa serva, se per fare profitto e se per contribuire
allo sviluppo dell’uomo.
In un primo senso l’impresa è uno dei possibili aggregati di uomini e donne che collaborano in vista di un
risultato, in questo caso economico. Tuttavia, essendo l’impresa una comunità di individui, prevale l’aspetto
umano su quello economico con una ragione, del secondo, di mezzo per il fine del primo. Cosi viene intesa
l’impresa, ad esempio, dal nostro articolo 41 della Costituzione Italiana2 che ne indirizza e coordina le attività
a fini sociali, ma cosi è anche intesa l’impresa da San Giovanni Paolo II che spiega che gli uomini coinvolti
nell’impresa «perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare
gruppo al servizio dell’intera società»3. Naturalmente l’impresa, come ente economico ha il fine proprio del
profitto, ed intenderla come comunità di uomini non nega affatto questa sua natura. Anzi, osserva Heidegger,
l’aspetto economico non è una contingenza storica da combattere romanticamente, ma da comprendere
filosoficamente4. Il profitto è una giusta misura della salute dell’impresa ma coglie soltanto l’aspetto di
adeguatezza tecnica delle operazioni di business e non certo il più ampio spettro di fattori umani ed ambientali
che ne giustificano l’esistenza, e non soltanto che ne legittimano l’operatività.
In un secondo senso l’impresa è un puro oggetto economico (una soluzione organizzativa, cioè una struttura
di governo che regola le transazioni5) la cui unica ragione d’essere è quella di creare profitto. In questo caso,
allora si ricade nella prospettiva che accomuna, per ragioni opposte ed in una bizzarra convergenza parallela,
i grandi teorici del liberismo, come ad esempio Milton Friedman e coloro i quali ne vorrebbero la
1
A.B. CARROLL (1999), Corporate social responsibility evolution of a definitional construct, in Business & society, Vol.
38, 3, pp. 268-295.
2
«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
3
GIOVANNI PAOLO II (K. WOJTYLA, 1991), Centesimus Annus, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano, § 35.
4
Cf.: La questione della tecnica del 1953; Identità e differenza (pp. 13-14).
5
Così nella teoria dei costi di transazione di Oliver Williamson, nozione sviluppata da William Ouchi che specifica i
diversi meccanismi di controllo organizzativo attraverso i quali si ottiene la collaborazione fra individui ed
organizzazioni in presenza di fini non convergenti (questi meccanismi sono il mercato, la burocrazia, il clan). Cf. O.E.
WILLIAMSON (1975), Markets and hierarchies, New York, 26-30; O.E. WILLIAMSON (1979), Transaction-cost
economics: the governance of contractual relations. The journal of law & economics, Vol. 22, 2, pp. 233-261; W.G.
OUCHI (1980), Markets, bureaucracies, and clans. in «Administrative science quarterly», 129-141; W.G. OUCHI (1979),
A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms, Springer.
decostruzione, come ad esempio i marxisti del novecento o i critici contemporanei della decrescita felice6 o
del complotto capitalista. Di certo, come già osservava sempre Heidegger7, nell’economia intesa come pura
tecnica che sovrasta l’uomo, l’impresa non ha più il compito di favorire l’opera della natura, come il mulino a
vento o la coltivazione dei campi, ma organizza le risorse, comprese quelle umane, al fine di estrarne valore
che poi si accumula: tutto ormai è risorsa, deposito, riserva. Persino l’uomo8. Ma «Quando si propone una
visione della natura come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la
società»9. Dal punto di vista filosofico questo sovrastare dell’economico rispetto all’umano nella seconda
prospettiva è ontologico e non solamente fattuale: l’uomo cioè è a servizio del processo economico. La realtà
dell’uomo è, platonicamente, una realizzazione imperfetta di ciò che descrivono o predicono le equazioni del
modello economico. Quando il modello non è rispettato, è la realtà che devia dalle previsioni del modello, e
non certo il modello ad essere errato. I modelli economici hanno un respiro globale ma anche una granularità
individuale: il soggetto individuale dell’economia è il decisore. L’uomo infatti è imprenditore, o manager, o
lavoratore o consumatore ma in ogni caso è visto, nell’economia e nella teoria di impresa, sotto la prospettiva
delle sue decisioni. Da questo punto di vista egli è massimizzatore dell’utilità personale: è un ente in grado di
valutare e di misurare le conseguenze delle scelte, e di ricavarne un giudizio di utilità. La teoria insegna, cioè,
che l’ente economico è fatto per questo: l’uomo massimizza (o ottimizza) l’utile e l’impresa massimizza il
profitto10. Con l’ambizione di essere una scienza sul modello delle scienze naturali, l’economia considera solo
ciò che è empirico e misurabile, determinando cosi l’esclusione delle considerazioni etiche dal modello di
razionalità tecnica dell’uomo che non può che vederlo come (tecnicamente) egoista. Ma a differenza dei sassi
o degli atomi oggetti delle scienze naturali, gli oggetti della teoria, formale, della razionalità del decisore sono
gli uomini. E gli uomini non sempre sono egoisti, ed ogni volta che prendono una decisione, come direbbe
Jacques Maritain11, sperimentano l’universo della propria umanità e della tensione della coscienza che si pone
la domanda sul fatto che ciò che si decide sia giusto o sbagliato. A differenza dell’economia, che tutt’al più
considera l’etica come espressione di una preferenza o come un vincolo nelle decisioni, la soluzione che hanno
trovato gli studiosi d’impresa, sia quando prendono in esame le decisioni dei manager che quelle dei
consumatori, è di ricorrere alle motivazioni del comportamento. Questa soluzione è stata possibile dal salto
culturale che ha posto l’impresa, cioè la corporate, al centro del dibattito economico a partire dalla seconda
metà del novecento, ma si è realizzata al di fuori della riflessione economica nelle discipline di management
per la forte attenzioni di queste ultime alle teorie, ai risultati ed ai metodi della psicologia e della sociologia.
Nel quadro della decisione razionale12 è pacifico che, sotto l’aspetto formale del modello, si possa valutare
solamente la relazione fra la decisione ed il suo esito. Tradizionalmente, l’economia e le scienze sociali, fra le
quali il management, il marketing e la finanza, hanno da sempre avuto la tendenza ad operare una cesura
radicale fra fatto e valore13. Ma questo era già noto ad Hegel, che nella Prefazione alla fenomenologia scriveva,
a proposito delle scienze moderne che «Ciò che in generale è noto, proprio perché è noto, non è conosciuto»,
essendo il fatto ciò che è misurabile e noto, ed il valore ciò che le scienze empiriche non riescono a conoscere.
Ma ciò era noto anche a Marx, che criticava già nei Manoscritti economico filosofici del 1844 il grosso limite
dell’economia politica che da un lato ha una grande teoria sui fatti (o meglio: su come debbano essere i fatti),
Un riferimento si trova in FRANCESCO (J.M. Bergoglio, 2015), Laudato si’, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano, §9
dove si propone di «passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, in un’ascesi che “significa imparare
a dare, e non semplicemente rinunciare”».
7
«Ci sono ormai soltanto risorse: depositi, riserve, mezzi» (Seminari, p. 141)
8
Tanto è vero che l’uomo è sostituibile con la tecnologia (cf. FRANCESCO, ivi, §128)
9
FRANCESCO, ivi §82.
10
Ad esempio in: D. HAUSMAN (2003), Filosofia dell’economia, in N. VASSALLO, Filosofie delle scienze, Einaudi, Torino.
11
J. MARITAIN (1996), Nove lezioni sulle prime nozioni di filosofia morale, Massimo, Ferrara. Osserva FRANCESCO, ivi,
§195, che «Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è
una distorsione concettuale dell’economia».
12
Dove la razionalità qui è da intendersi nel senso di razionalità secondo lo scopo di Weber o nell’accezione di razionalità
strumentale, come usata in FRANCESCO, op. cit. ad esempio ai§195, §206 e §210.
13
Ad esempio FRANCESCO, op. cit.: «L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza
prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale» ($109).
6
ma non sa spiegare nulla del perché delle cose reali. Si è creata così una doppia ermeneutica nella quale la
stessa decisione è valutata sotto il profilo tecnico scientifico della sua efficienza per l’obiettivo di profitto (o
di utile individuale) senza che vi sia comunicazione con il suo significato in termini umani. In questa
prospettiva, sotto il profilo tecnico fa bene il manager che delocalizza gli impianti perché costa meno produrre
altrove o fa bene l’impresa ad inquinare in una situazione di vuoto normativo, se questo riduce i costi di
produzione14. La soluzione trovata in ambiente anglofono è quella della pollution tax, che internalizza i costi
di inquinamento15. Questo modo di vedere le cose si insinua in una visione contrattualistica della convivenza
fra uomini ed in particolare dell’impresa e dei rapporti economici: l’impresa, al di fuori, o a conclusione di un
rapporto contrattuale, non ha più alcun obbligo di natura morale con i referenti delle proprie azioni: non si
istituisce una relazione morale fra i membri della società (come voleva, ad esempio Rousseau che, nel suo
Contract Social, definisce lo Stato come un corps moral, un corpo morale) ma puri rapporti contrattuali. E
d’altra parte era la stessa Margaret Tatcher ad affermare che «la società non esiste». In una visione di questo
tipo, cioè, gli operai senza lavoro per via della delocalizzazione non possono rivendicare nessuna pretesa nei
confronti dell’impresa perché si trovano in una situazione di assoluta libertà (formale16) di cercare qualche
altro tipo di impiego secondo le leggi del mercato del lavoro ed il contesto sociale che può essere danneggiato
da un impianto o dall’uso di risorse può organizzarsi per legiferare17. In assenza di norme specifiche non vi è,
a priori, alcun obbligo ambientale o sociale del business. Il fondamento di questo atteggiamento generalizzato
è dato da una concezione salvifica del libero mercato come se «la realtà, il bene e la verità sbocciassero
spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia»18. Si realizza così una «concezione
magica del mercato, che tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle
imprese e degli individui»19.
Valutare dal punto di vista tecnico il fatto è valutare la capacità di fare bene, cioè di organizzare bene le
risorse in vista del profitto, mentre valutare dal punto di vista etico il valore è valutare la capacità di fare del
bene in termini umani. Separare cosi radicalmente il fatto tecnico della combinazione delle risorse dal valore
di decisioni e azioni, e delle loro conseguenze sull’uomo e sull’ambiente, ha creato due effetti collegati, ma
storicamente verificatisi in successione. L’iniziale constatazione dell’assoluta libertà formale del business di
prelevare risorse dal contesto per estrarne valore orientato all’incremento del profitto ha creato ciò che Jed
Emerson20 chiama dissonanza della somma zero: la percezione cioè che business e società operano in un gioco
a somma zero nel quale il valore è dato e fisso ed impresa e società competono per aggiudicarsene una quota:
tutto il valore che si aggiudica il business è sottratto alla società, tutto ciò che la società tiene per sé è un vincolo
o un costo per la libera iniziativa d’impresa. Il solito Milton Friedman21 ha affermato che l’idea stessa di una
La giustificazione è presto trovata: «In alcuni circoli si sostiene che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno
tutti i problemi ambientali, allo stesso modo in cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della
fame e della miseria del mondo si risolveranno semplicemente con la crescita di mercato» (FRANCESCO, op. cit., §109).
15
A questo ci si riferisce anche come crediti di emissione, cf.: FRANCESCO, op. cit. §171.
16
Perché in questa situazione si consuma di nuovo la differenza fra libertà formale e libertà sostanziale del cittadino e
del borghese rispettivamente: «Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà
di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che
detiene il potere economico e finanziario» (FRANCESCO, op. cit. §203).
17
I vescovi della Patagonia notano che «Generalmente, quando [alcuni paesi ricchi] cessano le loro attività e si ritirano,
lasciano [nei paesi poveri] grandi danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento
di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e dell’allevamento locale, crateri, colline
devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può più sostenere» (FRANCESCO, op. cit. §51).
18
FRANCESCO, op. cit. §105. Cf. §109.
19
FRANCESCO, op. cit. §190. Questa è «anche la logica interna di chi afferma: lasciamo che le forze invisibili del mercato
regolino l’economia, perché i loro effetti sulla società e sulla natura sono danni inevitabili» (§123). Cf. §60.
20
J. EMERSON (2003), The Blended Value Proposition: Integrating Social and Financial Returns, in «California
Management Review», Vol. 45, 4, pp. 35-51.
21
M. FRIEDMAN (1962), Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Chicago; M. FRIEDMAN (1970), The Social
Responsibility of Business is to Increase its Profits, in The New York Times Magazine, 13 Settembre.
14
responsabilità sociale dell’impresa è qualcosa che mina le fondamenta della libertà22. Ma questa percezione è,
di più, una dissonanza perché ha una connotazione marcatamente negativa che si è andata via via rinforzando
sulla base delle varie crisi, ambientali, sociali o finanziarie, determinate da questo modo di vedere il business.
Michael Porter e Mark Kramer hanno osservato23, quindi, che come conseguenza il capitalismo è stato messo
sotto assedio dalla società che ha iniziato a chiedere conto al business del suo reale contributo allo sviluppo
umano. Successivamente, l’insufficienza della razionalità tecnica o strumentale, alla base della valutazione del
fatto, ha mostrato la propria urgenza, non solo in termini di conseguenze (sociali ed ambientali) ma anche
etiche24. L’etica di riferimento del business è quella di area anglofona che è l’etica dell’utile come scienza del
movente dell’azione dell’uomo, sviluppatasi nei termini dell’utilitarismo settecentesco sulla base dell’etica
protestante, come insegna Max Weber. Questa etica ben si relaziona con il modello formale dell’uomo come
massimizzatore del proprio utile: anche senza fare riferimento ai fini, se non rifiutando l’idea stessa di un fine
dell’uomo, le etiche utilitaristiche sono in grado di dare senso ai comportamenti umani ricorrendo alla nozione
di motivazioni. Così facendo, per riempire di contenuto le motivazioni alla base dei comportamenti, la
riflessione (anglofona) di business ethics ha sviluppato la distinzione fra motivazioni intrinseche e motivazioni
estrinseche. L’impresa, cioè, quando decide di intraprendere attività sostenibili economicamente, socialmente
ed ecologicamente (la cosiddetta triple bottom line) lo fa perché ciò determina maggior legittimità da parte del
contesto in cui opera, o perché l’immagine o il brand ne ricevono beneficio, o perché migliorano i rapporti con
i cosiddetti stakeholder (cioè i portatori di interesse dell’impresa), o perché diminuiscono i costi o aumentano
i profitti o il valore nel mercato del capitale25. Che questo accada è un dato di fatto presente nella letteratura
scientifica che valuta questi risultati come conseguenze attese del business responsabile e sostenibile, ovvero
come “motivazioni strumentali” o “estrinseche”. Poi però ci sono gli imprenditori che decidono di valorizzare,
sostenere e sviluppare le caratteristiche individuali dei propri dipendenti anche al di fuori della catena del
valore, come fa Brunello Cuccinelli, o le imprese che si impegnano contro lo sfruttamento del lavoro minorile,
come ad esempio sembrano fare alcune compagnie del Tabacco e i maggiori produttori di abbigliamento
sportivo, o le imprese che decidono di partecipare allo sviluppo umano attraverso innovazioni di prodotto o di
processo che integrano elevati standard di sostenibilità ambientale. Che questo accada è un altro dato di fatto
presente nella letteratura scientifica che attribuisce l’origine di questi comportamenti ad un forte
convincimento interiore e che quindi si configura come una “motivazione intrinseca”.
Ma c’è di più, forse, della motivazione intrinseca per riuscire a valutare il business sia dal punto di vista del
fatto che del valore. Michael Porter e Mark Kramer presentano, non più di dieci anni fa, la possibilità
dell’impresa di incidere sulla propria catena del valore in modo che la sua attività caratteristica crei valore per
l’impresa ma anche per il contesto in cui opera. Andando al di là della filantropia strategica26, popolare nel
business anglofono, i due autori portano numerosi esempi di imprese che hanno individuato un’occasione di
innovazione di prodotto o di processo che allo stesso tempo determina maggior profitto o vantaggio
competitivo per l’impresa e che contribuisce allo sviluppo di una particolare problematica sociale o ambientale.
Così Nestlè, investendo nella creazione di cultura imprenditoriale fra i produttori di caffè è riuscita ad avere
una materia prima migliore a minori costi e a condizioni più efficienti per il proprio marchio Nescaffè ed allo
stesso tempo ha migliorato le condizioni di vita delle popolazioni rurali della zona. Così, ad esempio,
22
Il ragionamento è semplice: visto che il manager è legato da un contratto al capitale e visto che gli obiettivi sociali ed
ambientali si perseguono su un mandato maggioritario di natura politica, fare responsabilità di impresa significherebbe
violare il contratto ed imporre indebitamente una tassa senza un mandato politico.
23
M.E. PORTER – M.R. KRAMER (2011), Creating Shared Value, in Harvard Business Review, Vol. 89, 1, pp. 62-77.
24
Tuttavia, questa razionalità «che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle necessità del momento,
è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, sia quando lo fa uno Stato pianificatore», FRANCESCO, op.
cit. §195. Cf. §210.
25
«È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far si che si smetta di acquistare certi prodotti e
così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese » FRANCESCO, op. cit.§206.
26
Tuttavia «aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio», FRANCESCO, op. cit.§128.
McDonald27 o Danone, riducendo il cartone usato per incartare o per commercializzare i prodotti ha risparmiato
sui costi di packaging ed allo stesso tempo ha ridotto l’impatto ambientale sia delle prelevate dal territorio che
degli scarti immessi nel territorio. Azioni di questo tipo sono state possibili perché, usando le parole del Libro
Verde della Commissione Europea, le imprese hanno integrato volontariamente le pratiche di responsabilità e
di sostenibilità nella propria attività caratteristica andando ad orientare i mezzi di produzione ad un fine più
ampio e più remoto del profitto.
Volente o nolente, il linguaggio di management (accademico e pratico) ha così recuperato il fine dell’azione
umana come motivazione (intrinseca) riconoscendo che, in fondo, «l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta
la vita economico-sociale»28. Questo fine non è quindi il tradizionale benessere come declinazione individuale
dell’obiettivo del decisore economico razionale, ma non è nemmeno il bene comune come somma o prodotto
dei beni individuali. Questo fine è il fine dell’uomo, è il bene comune inteso come «la somma totale di tutte le
condizioni sociali che permettono alle persone, sia come gruppi che come individui, di raggiungere la loro
realizzazione più pienamente e più semplicemente» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, § 164).
Forse aveva ragione Hegel, quando osservava nei Lineamenti di Filosofia del Diritto che la società civile,
teatro dei rapporti economici, lasciata sola non può che produrre lo spettacolo triste dell’accumulo di ricchezze
nelle mane di pochi e di discesa di molti sotto la soglia della dignità, e forse il mondo occidentale ha dovuto
aspettare le grandi tragedie dell’economico recente prima di accorgersene29. Il mondo del business si è accorto
che subordinando l’uomo al profitto e incaponendosi a valutare l’operato dell’impresa senza includere la
dimensione umana ed ambientale ha creato e crea disastri di proporzioni sociali incalcolabili: è il momento di
agire per un cambiamento positivo del business che realmente partecipi allo sviluppo umano. Il concetto di
creazione del valore comune è recente, ma è stato già accolto dagli organismi sovranazionali ed è un punto di
riferimento ineludibile per le imprese di oggi. È giunto il momento di farne parte integrante della mission
dell’impresa: è giunto il momento di ricongiungere il fine dell’impresa al fine dell’uomo.
Qual è la soluzione possibile? Da un lato, certamente, gli attuali modelli di consumo vanno rivisti. Uno dei
maggiori problemi dell’economia intesa in modo assoluto è che le persone rischiano di essere «travolte dal
vortice degli acquisti e delle spese superflue»30 in un circolo vizioso che cancella le differenze fra culture e
particolarità locali31. È quindi necessario riempire di nuovo il cuore delle persone con un fine, perché più «il
cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare»32. Questo passa
attraverso la ridefinizione dell’idea di progresso33 non coincide con il solo progresso materiale che ci
garantiscono la scienza e la tecnica34. Gli individui singoli hanno quindi il dovere di impegnarsi in un
cambiamento del proprio approccio alla vita consumistica perché l’acquisto non è semplicemente un evento
economico ma è un atto morale35: «La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi
Dall’altro lato però, episodi di spreco di cibo sono intollerabili: «il cibo che si butta via è come se lo si rubasse dalla
mensa dei poveri», FRANCESCO, op. cit.§50.
28
FRANCESCO, op. cit.§127.
29
« la società civile offre anche lo spettacolo della dissolutezza, della miseria e della corruzione fisica ed etica comune a
entrambi i lati », Lineamenti di Filosofia del Diritto, §185.
30
«Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti, le
persone finiscono con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il
riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico» FRANCESCO, op. cit. §203.
31
«La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a
rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale, che è un tesoro dell’umanità» FRANCESCO,
op. cit.§144.
32
FRANCESCO, op. cit. §204.
33
«Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso» FRANCESCO, op. cit. §194.
34
«Prende coscienza che il progresso della scienza e della tecnica non equivale al progresso dell’umanità e della storia,
e intravede che sono altre le strade fondamentali per un futuro felice» FRANCESCO, op. cit. §113.
35
«Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il
potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si
smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole
a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i
27
in nuove abitudini. Molti sanno che il progresso attuale e il semplice accumulo di oggetti o piaceri non bastano
per dare senso e gioia al cuore umano, ma non si sentono capaci di rinunciare a quanto il mercato offre loro.
Nei Paesi che dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di consumo, i giovani hanno una
nuova sensibilità ecologica e uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la difesa
dell’ambiente, ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di benessere che rende difficile la
maturazione di altre abitudini. Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educativa»36.
Ma praticamente com’è possibile tutto ciò?
profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale
dei consumatori. “Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico”» FRANCESCO, op. cit. §206.
36
FRANCESCO, op. cit. §209.