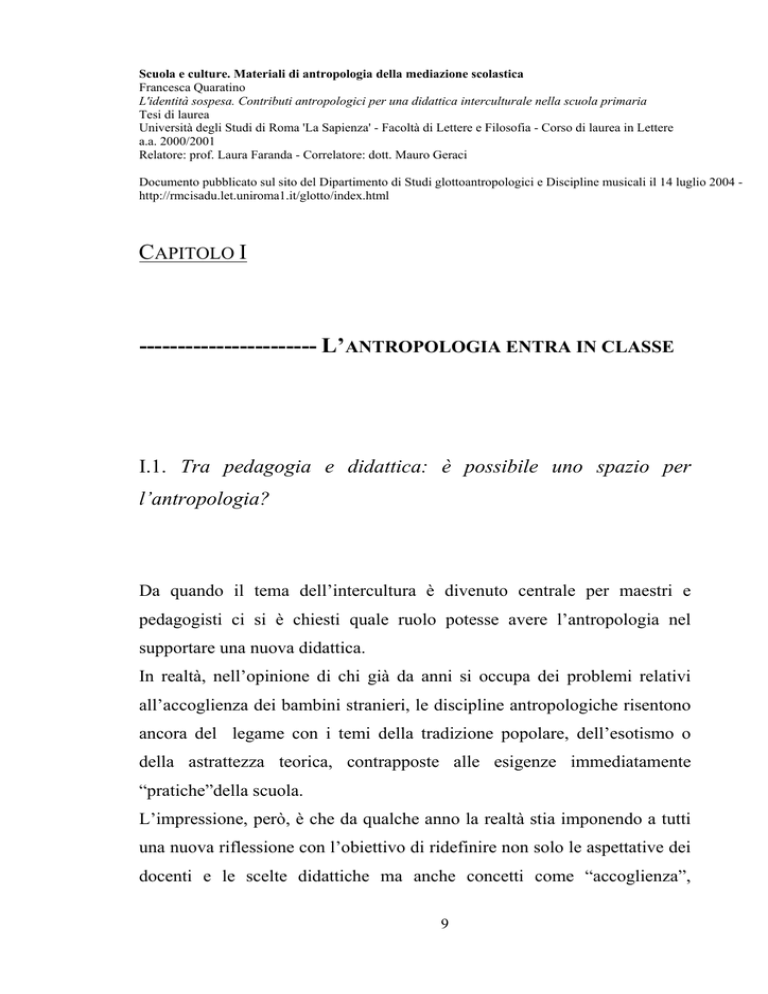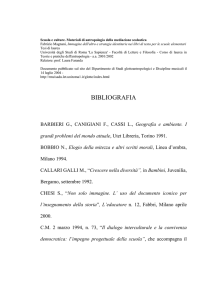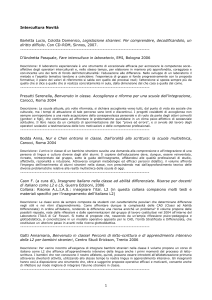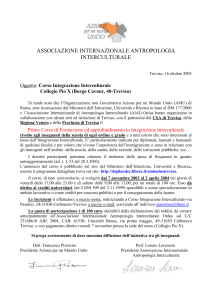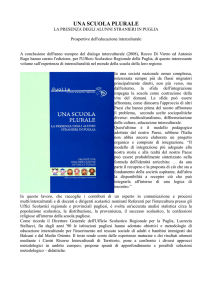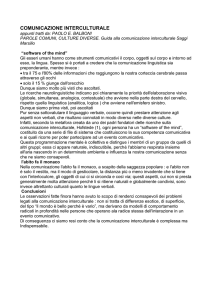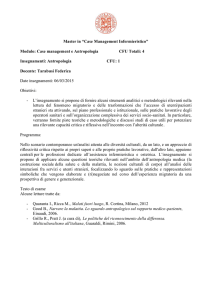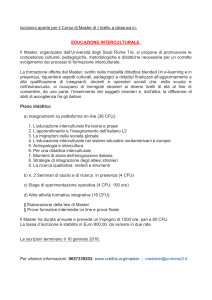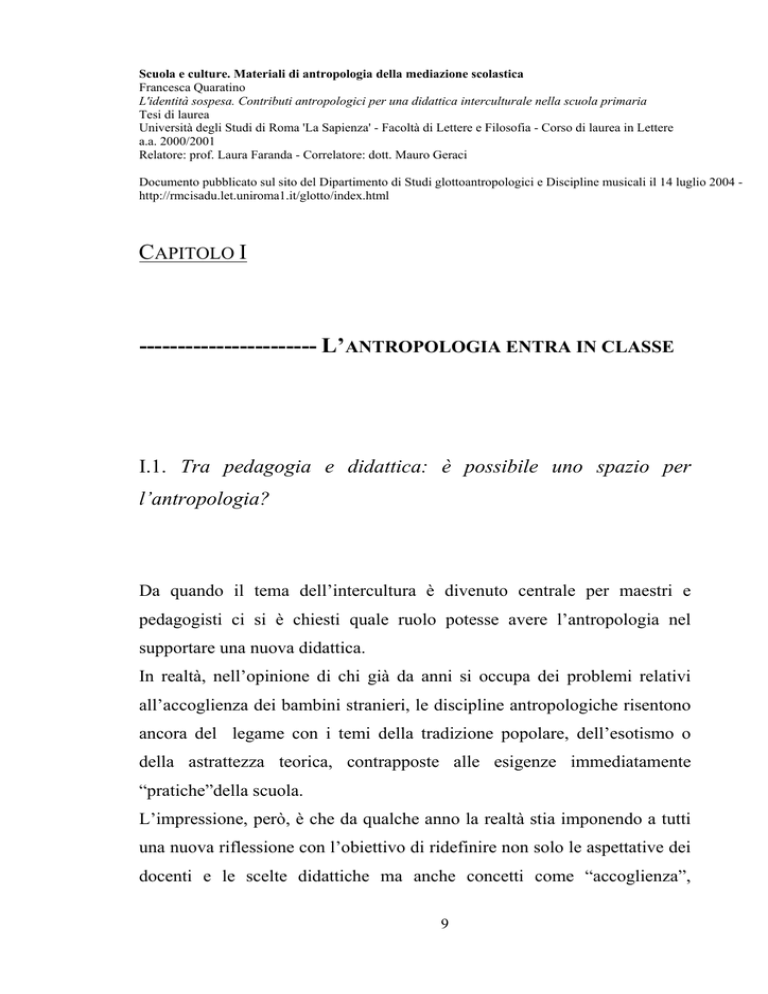
Scuola e culture. Materiali di antropologia della mediazione scolastica
Francesca Quaratino
L'identità sospesa. Contributi antropologici per una didattica interculturale nella scuola primaria
Tesi di laurea
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' - Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di laurea in Lettere
a.a. 2000/2001
Relatore: prof. Laura Faranda - Correlatore: dott. Mauro Geraci
Documento pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi glottoantropologici e Discipline musicali il 14 luglio 2004 http://rmcisadu.let.uniroma1.it/glotto/index.html
CAPITOLO I
----------------------- L’ANTROPOLOGIA ENTRA IN CLASSE
I.1. Tra pedagogia e didattica: è possibile uno spazio per
l’antropologia?
Da quando il tema dell’intercultura è divenuto centrale per maestri e
pedagogisti ci si è chiesti quale ruolo potesse avere l’antropologia nel
supportare una nuova didattica.
In realtà, nell’opinione di chi già da anni si occupa dei problemi relativi
all’accoglienza dei bambini stranieri, le discipline antropologiche risentono
ancora del legame con i temi della tradizione popolare, dell’esotismo o
della astrattezza teorica, contrapposte alle esigenze immediatamente
“pratiche”della scuola.
L’impressione, però, è che da qualche anno la realtà stia imponendo a tutti
una nuova riflessione con l’obiettivo di ridefinire non solo le aspettative dei
docenti e le scelte didattiche ma anche concetti come “accoglienza”,
9
“tolleranza” e quello stesso di “intercultura”, somCaterinamente definibile
come l’insieme delle pratiche volte all’inserimento, alla conoscenza e
all’affermazione dell’identità degli stranieri nella comunità scolastica1
Sviscerati i temi dell’accoglienza linguistica e della necessità di
programmare attività che permettessero il rapido inserimento degli alunni
stranieri, le discussioni e gli studi in materia si sono rivolti a temi utili a
guidare gli operatori della scuola sul terreno più complesso delle dinamiche
dell’incontro e della reciprocità, valore principale di ogni relazione tra
uomini.
Reciprocità è, probabilmente, la parola che più di ogni altra caratterizza le
riflessioni di interesse antropologico riguardo alle possibilità e alle ricadute
pratiche del “fare” intercultura.
Non è un caso che siano proprio gli studi recenti a considerarla come un
tema centrale; una rapida lettura dei contributi dati alla materia nell’arco di
un decennio mette in evidenza, infatti, una complessità di temi sempre
crescente anche a seguito delle mutate realtà delle migrazioni e delle
presenze straniere nel nostro paese.
Duccio Demetrio, pedagogista che da tempo si occupa dell’argomento,
sostiene che in educazione interculturale serve una osservazione dialogante
purché la si concepisca come “una conversazione continua dalla quale nasce
sempre qualche cosa che prima non c’era e non si sapeva”2.
E reciprocità è divenuta, così ( con i suoi sinonimi quali antropologia
reciproca, sguardo riflesso, osservazione dialogante), la parola–chiave della
molteplicità di relazioni coinvolte nell’accoglienza, nella tolleranza come
principio di riconoscimento dell’altro e nell’Incontro, non più solo quello
tra adulti ma anche, e soprattutto, quello tra adulto e bambino.
1
2
Per una riflessione più approfondita sul tema si veda il capitolo I.5.
Demetrio D. Agenda interculturale, Meltemi, Roma 1997, pag. 82.
10
Così, anche temi che inizialmente avevano trovato spazio nelle circolari
ministeriali o nei manuali per la didattica, si sono aperti agli studi sulle
culture metropolitane, all’antropologia interpretativa di Clifford Geertz e
alle riflessioni di James Clifford circa la possibilità di immaginare la ricerca
etnologica come una lettura reciproca nella quale osservatore e osservato
sono parte di un’ unica dinamica di scrittura culturale3.
C’è da sottolineare anche, però, che l’interesse nei confronti di autori
stranieri non è andato di pari passo con la curiosità nei confronti del mondo
culturale italiano che invece, già dagli anni sessanta, aveva ripensato, con
Ernesto De Martino, la pratica etnografica alla luce di una presa di
coscienza dei “limiti umanistici” della nostra civiltà4.
Torna, pertanto, a trovare una conferma l’impressione che in ambito
nazionale il peso principale del pensiero antropologico venga valutato nelle
relazioni con gli studi folclorici.
Se a conti fatti, tuttavia, appare possibile affermare con soddisfazione che
l’antropologia sia entrata con forza negli studi teorici, ben più difficile
sembra essere l’ingresso nella dimensione pratica che invece, come si
vedrà, viene considerata dagli operatori della scuola il nucleo risolutivo
delle difficoltà di inserimento degli stranieri.
Quando, nel gennaio del 2001, ebbe inizio la nostra ricerca, verificammo
che la possibilità che si realizzasse quale tentativo di studio sulla possibilità
dei bambini stranieri di vivere potendo conciliare aspettative familiari,
dinamiche e pratiche di assimilazione e desiderio di inserimento nel gruppo
3
Si vedano Rosalba Terranova Cecchini “Antropologia reciproca- famiglie immigrate e il loro lavoro
antropologico nella nostra cultura”, relazione tenuta al convegno nazionale Le famiglie interrogano le
politiche sociali promosso dal Ministero degli Affari Sociali, e svoltosi a Bologna nel marzo 1999;
Francesco Busi “Prospettive interculturali” testo contenuto nel documento della Commissione Nazionale
per l’Educazione interculturale, Roma 2000; Matilde Callari Galli Lo spazio dell’incontro, Meltemi,
Roma1996;
11
dei coetanei, si scontrava l’effettiva disponibilità di quanti, inizialmente
entusiasti della collaborazione, si dimostravano sempre più dubbiosi
riguardo alla effettiva permanenza nelle classi di un osservatore
partecipante. Si discusse soprattutto sul carattere della partecipazione: se
doveva essere “utile” allora doveva essere impostata dal docente, e
generalmente lo fu, nei termini del sostegno al bambino più in difficoltà.
Si può dire che questa resistenza iniziale si sciolse nel tempo e nella
conoscenza delle specifiche situazioni ma che, tuttavia, fu un vero e proprio
blocco al primo mese di indagine.
Ciò va detto non tanto in rapporto alle condizioni della nostra inchiesta, che
ebbe la fortuna di svolgersi nella classe della coordinatrice del progetto,
quanto piuttosto riguardo agli incontri con la “comunità” dei docenti
durante la ricreazione o in cortile dopo pranzo.
L’impressione che una partecipazione al quotidiano scolastico caratterizzata
da uno sguardo antropologico sui fatti fosse di difficile comprensione trovò
conferma in diverse occasioni: la scuola è abituata da anni agli psicologi, ai
tirocinanti di istituti magistrali, ai neuropsichiatri e anche ai volontari, ma
agli antropologi proprio no.
Scrive Matilde Callari Galli, che al rapporto tra sistema educativo e
antropologia ha dedicato buona parte dei propri studi:
Esistono analogie tra il lavoro sul campo, compiuto dagli antropologi e il lavoro
svolto quotidianamente dagli insegnanti: si tratta in ambedue i casi di esplorare e
registrare quotidiane dinamiche scomposte, spesso apparentemente prive di
un’organizzazione coerente e finalizzata, di intravedere i microprocessi e le
5
microrelazioni e trovare strumenti di notazione e interpretazione.
4
De Martino E. (1961) La terra del rimorso, Il Saggiatore, Milano 1996, pag 21. V a anche detto che gli
studi di Ernesto De Martino hanno avuto una vera e propria riscoperta in altri ambiti, primo tra tutti quello
etnopsichiatrico.
5
Callari Galli M. Lo spazio dell’incontro, cit., pag.34.
12
Ancora oggi la presenza antropologica viene vista come parzialmente
legittima, comunque sottomessa alla dimensione pedagogica, e, nei casi più
eclatanti di incomprensione (dei quali anche a noi è capitato di essere
protagonisti), portatrice di un punto di vista eretico: ed è per questo che la
progettazione dell’inchiesta e la sua stessa realizzazione possono trovare
ostacoli burocratici e di comunicazione.
Chi sei? Fai tirocinio o ricerca? Osservi o giudichi? Produrrai del
materiale utile per i docenti o tornerai tra le mura dell’Università? Sono
solo alcune delle domande che ci vennero rivolte all’inizio della nostra
ricerca e alle quali dovemmo trovare risposte per superare l’imbarazzo
nostro e di quanti conoscemmo o per giustificare l’ “ambiguità” della nostra
presenza.
L’ impressione di oggi, a lavoro concluso, è che a questi quesiti si dovrà
continuare a rispondere ancora per molto tempo finché l’incontro tra
antropologia, pedagogia e didattica non acquisterà la dimensione di una
necessaria collaborazione interdisciplinare.
I.2. La ricerca sul campo in una classe di scuola elementare: gli
obiettivi, le aspettative, i ruoli.
Sono passati circa dieci anni da quando si pose il problema burocratico di
accogliere i bambini stranieri nelle classi delle scuole statali: si trattava,
inizialmente, di individuare le linee di indirizzo che permettessero di
risolvere problemi di ordine burocratico, quali la ricostruzione delle carriere
scolastiche iniziate nei Paesi di provenienza.
13
Oggi garantire loro un pari livello di istruzione rispetto ai coetanei, unito
alla possibilità di vivere secondo modelli alimentari, religiosi, affettivi ed
emotivi propri delle loro famiglie sembra essere più di una necessità. In
molti casi è una vera e propria urgenza volta a fronteggiare il disagio e
l’abbandono scolastico, in altri, soprattutto laddove le comunità straniere si
presentano compatte, una pratica quotidiana e una modalità di accoglienza
nelle classi faticosamente acquisite e ora in via di radicamento.
Quando si decise di progettare un’ indagine sul campo nella scuola
elementare si partì dalla necessità di osservare, a distanza di qualche anno
dalle prime formulazioni teoriche riguardo alla necessità di una pedagogia
interculturale, i percorsi scolastici di alcuni bambini stranieri, lo stato delle
relazioni nel gruppo e la generale risposta allo stimolo dell’inserimento
nell’ottica dell’ abbandono-rifiuto-riscoperta dell’identità culturale delle
famiglie di origine.
Pur non essendo tra gli scopi dichiarati ci sembrò difficile non considerare,
seppure nel caso particolare, il principio base dell’accoglienza, vale a dire le
possibilità di reale fruizione del servizio scolastico ed educativo: un aspetto,
questo, che, pur presentandosi inizialmente con un velo di pedanteria, si
rivelò, al contrario, molto interessante.
L’attività quotidiana dei bambini e alcune lamentele delle loro famiglie
poterono essere lette anche in questa ulteriore luce: il fatto che i propri figli
possano essere educati in una scuola pubblica rappresenta per molti
immigrati il vero salto di qualità rispetto alla propria vicenda biografica,
tanto che, non di rado, la dimensione scolastica dei loro bambini si carica di
un forte peso di attese, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano
psicologico ed emotivo.
La ricerca, che coinvolse un gruppo di laureandi distribuiti tra seconde,
terze, quarte elementari e scuola materna, fu coordinata dalla cattedra di
14
Etnologia III dell’Università La Sapienza di Roma che curò anche un ciclo
di incontri a carattere formativo rivolti esclusivamente ai docenti.
L’istituto statale nel quale si svolse l’indagine è la scuola elementare F. A.
di Roma, ospitata in uno dei più vecchi edifici del quartiere Fleming, nella
zona nord della Capitale.
Compreso tra la Via Cassia e la Via Flaminia il quartiere può considerarsi
diviso tra una zona bassa, nella quale tra i palazzi per la media borghesia
costruiti tra gli anni ‘50 e ’60 ancora è possibile scorgere i resti di
un’edilizia popolare dei primi del ‘900 unita a qualche casetta che racconta
di un passato non lontano quando si era più in campagna che in città, e una
zona alta, considerata non a torto esclusiva. In questa parte alta sorge
l’edificio scolastico.
La scuola è succursale della sede centrale di Via Zandonai fatto, questo, che
da solo potrebbe indurre l’impressione di una certa assenza di guida e di
progettualità interclasse.
La presenza di immigrati in un quartiere alto borghese è facilmente
spiegabile: si tratta di famiglie a servizio o assegnatarie di portierati i cui
figli vanno a scuola con quelli dei propri datori di lavoro.
Ciò detto, bisogna chiarire che il terreno di indagine si “impose” alla ricerca
da svolgere come risposta alla richiesta di collaborazione da parte di
un’insegnante di una seconda classe elementare di ventisei bambini, sei dei
quali stranieri.
La ricognizione nella classe, la II C, si basò soprattutto sul colloquio con la
maestra e sulla conoscenza diretta di una situazione familiare; nel gruppo
dei sei bambini, tra i quali due filippini, un capoverdiano, un peruviano, un
rumeno e una giapponese, vennero evidenziati problemi di apprendimento e
di relazione che, in alcuni casi, sembravano direttamente connessi alla
scarsa competenza linguistica e alle difficoltà di comunicazione tra
insegnanti e genitori. Difficoltà non legate alla comprensione dell’italiano,
15
ma a quelle che la maestra definì, almeno in un caso, resistenze di tipo
relazionale.
A ciò si aggiunga che, su sei bambini stranieri, era necessario seguire, nel
nome di un principio di ordinata e puntuale raccolta delle storie, un numero
limitato a due situazioni di inserimento scolastico.
La scelta si orientò verso quella di Julio, il bambino di Capo Verde
(segnalato dalla neuropsichiatria con una diagnosi di “depressione
inibitoria”) e quella di Felipe, il bambino del Perù.
Il tempo a disposizione coincise con il secondo quadrimestre, da febbraio a
giugno 2001, e con un lungo periodo di sospensione dell’attività scolastica
legato alla vicinanza di vacanze pasquali e elezioni politiche.
L’ingresso nella classe pose anche problemi di definizione delle modalità
della nostra presenza.
Quale posto occupare, quale strategia di osservazione adottare, per quanti
giorni e quante ore settimanali restare, cosa rispondere ai bambini e come
giustificare l’attenzione maggiore per alcuni di loro non sembrarono
problemi immediatamente risolvibili se non affrontandoli nella pratica
quotidiana.
Si optò, dunque, per una osservazione di dodici ore settimanali, tutte
coincidenti con quelle dell’insegnante di italiano; l’altra maestra, infatti,
lamentò da subito il rischio di un’ulteriore penalizzazione delle proprie
materie, già relegate ai pomeriggi da un orario scolastico mal concepito.
In più, la maestra di italiano (era lei che aveva chiesto la collaborazione con
la cattedra di Etnologia) mostrava grande interesse verso i possibili risultati.
Va detto, oltretutto, che la nostra presenza attirò anche l’interesse
dell’insegnante di sostegno che in quella classe impiegava quattro ore
settimanali equamente divise tra il bambino “segnalato” e i due filippini.
16
Il ruolo svolto dalle aspettative degli insegnanti fu molto importante per
tutti i quattro mesi sia perché li portò ad esprimere con chiarezza i
“problemi da risolvere” mettendo così in luce anche elementi di delusione o
di soddisfazione per il nostro lavoro sia perché aprì le porte ad un proficuo
scambio di idee e ad una vera e propria collaborazione alla realizzazione di
un progetto di didattica finalizzato all’ emersione dei bambini stranieri6.
Benché la ricerca fosse stata progettata immaginando una presenza in classe
di discreta e silenziosa osservazione fu da subito esplicito che la maestra di
italiano si aspettava un concreto aiuto per i casi più eclatanti di disagio
scolastico, in particolare nei riguardi di Julio che sembrava avere una
costante necessità di essere seguito.
Così, stare accanto ai bambini stranieri durante le ore di lezione, accogliere
le loro emozioni e seguirne l’apprendimento divenne quasi il lavoro
principale.
Questo aspetto dell’inchiesta, inutile a dirsi, fu quello che si presentò come
il più difficile da gestire.
I bambini che avremmo dovuto seguire per alleviare il lavoro della maestra
si mostrarono subito felici e disponibili, poi iniziarono a manifestare un
comprensibile desiderio di autonomia; come già si è detto, dei sei stranieri
considerammo che solo due potevano essere seguiti ai fini di una ricerca
antropologica che mantenesse confini sicuri e solidi, ma vi era il rischio
che, se il nostro interesse fosse uscito dall’osservazione discreta per
spostarsi sul piano del sostegno pratico, si sarebbe creata una penosa
condizione di disparità per quei due bambini.
Proprio il contrario di ciò che dovrebbe accadere in una scuola.
6
Il progetto viene descritto nel capitolo V ed è presentato come nella parte degli Allegati in chiusura di
questo lavoro.
17
Si optò, così, per un vasto sostegno a tutta la classe nella quale emersero
ben presto i desideri di tutti di essere aiutati nei momenti critici delle lunghe
giornate imposte dal tempo pieno.
Quotidianamente, a fine giornata, veniva redatto il diario di classe7.
Non va trascurato, da ultimo, un particolare riguardante la situazione
specifica dell’andamento della didattica e della presenza in classe degli
adulti.
Un giorno a settimana un volontario legato alla vicina parrocchia si
aggiungeva a noi nel sostegno agli stranieri. Tale presenza, autorizzata
l’anno prima dal dirigente scolastico in base a quanto previsto da Circolari
Ministeriali (interpretate, forse, con una certa larghezza) era in qualche
modo il riferimento di tutti gli stranieri in difficoltà.
L’aiuto dato ai bambini dal volontario consisteva nel far svolgere loro altre
attività,
principalmente
volte
all’alfabetizzazione,
durante
l’orario
scolastico, imponendo, di fatto, un allontanamento dal gruppo che la stessa
insegnante di sostegno, consapevole di quanto previsto dalla legge in
materia, si rifiutava di fare.
Il volontario si occupava anche di dare lezioni a domicilio alla bambina
giapponese, che lo considerava a tutti gli effetti “cosa sua” ingelosendosi se
aiutava gli altri e creando un clima di forte tensione; a fine anno venimmo a
sapere che erano stati affidati a questo ragazzo anche i due filippini che per
due giorni a settimana sarebbero rimasti a scuola oltre l’orario (ricordiamo
che la classe faceva tempo pieno), per fare vere e proprie ripetizioni.
Questo esempio, è evidente, manifestava un caso-limite della realtà
scolastica nella quale ci trovammo a lavorare; una realtà inizialmente
sconfortante poi, progressivamente, sempre più utile a guidare la
convinzione che in tale disagio potesse nascere anche una riflessione
maggiormente consapevole dei problemi della scuola.
18
Una breve considerazione riguarda, poi, i rapporti che si instaurano in una
ricerca così atipica per tempi, luoghi e ricadute sulla comunità.
Un maestro, per quanto curioso e disponibile nei confronti del ricercatore,
avrà sempre un rapporto speciale con la propria classe; e così i bambini, per
quanto buoni e disciplinati, sapranno sempre riconoscere un maestro vero
da chi non lo è.
E’ possibile che dopo un mese l’insegnante venga a chiedere quali risultati
abbia prodotto l’osservazione e che si sia costretti a giustificare la propria
impreparazione alla domanda facendo appello al poco tempo trascorso; ma
verrà sempre il tempo del “prodotto” , considerato spesso più importante
della presenza dell’osservatore, della sua capacità di relazione con i
bambini e delle sue stesse risposte a problemi quotidiani.
Convivere con il ruolo del maestro è sempre possibile se ci si pone
nell’ottica di una trasparente dichiarazione di intenti: quali sono le domande
dalle quali si parte, come si è arrivati a interessarsi al problema e,
soprattutto, cosa non si intende fare in classe.
Per esempio, non si farà educazione interculturale e non la si farà per il
semplice motivo che non spetta a chi conduce una ricerca di questo tipo
farlo bensì ai maestri stessi, sempre che abbiano chiaro in mente cosa si
intenda con tale espressione (e molti di loro ammettono le difficoltà a
gestire l’argomento).
Se da una parte si raccolgono i dati per il proprio lavoro, dall’altra sarà
possibile, invece, affiancare un maestro suggerendo alcuni temi specifici
come quello del viaggio, del cibo e della favola per orientare il percorso di
tutta la classe e mettere in luce aspetti delle tradizioni di paesi stranieri e
delle regioni italiane. Generalmente, tuttavia, i docenti già conoscono
queste risorse didattiche.
7
Per una lettura integrale del “Diario di classe” si veda l’Appendice.
19
Se ci sarà la disponibilità e l’aiuto sarà anche possibile conoscere le
famiglie dei bambini e raccoglierne le richieste e le aspettative da una
posizione privilegiata: chi fa ricerca viene visto come una presenza
importante ma non autorevole né potente, caratteristiche attribuite a maestri
e insegnanti di sostegno che sono spesso alla base di quei rapporti vissuti
con inibizione da molte mamme straniere.
Abituare tutti a una presenza che eserciti specificatamente una mediazione
tra famiglie straniere, maestri e le stesse famiglie italiane sarebbe, in effetti,
l’obiettivo principale da perseguire benché le possibilità di realizzazione
siano legate, oltre che a un riconoscimento giuridico della medesima, anche
alla capacità di non sovrapporre ruoli e competenze che per formazione
degli uni e degli altri dovrebbero restare specifici seppure aperti alla
collaborazione.
Come evidenzieranno alcuni casi particolari8, la nostra presenza si rivolse
naturalmente alla mediazione, grazie soprattutto alla disponibilità della
maestra che incoraggiava i nostri incontri con le famiglie dei bambini
sostenendo contemporaneamente l’idea che il nostro tirocinio nella classe si
potesse concretizzare anche come attiva partecipazione alla realizzazione di
alcuni progetti di integrazione alle attività didattiche.
La fase successiva al lavoro quotidiano consistette nelle rilettura e
nell’organizzazione del diario nel tentativo di individuarne da un lato gli
elementi utili a raccontare i bambini e le loro vicende, dall’altro ad
individuare le aree tematiche di maggior interesse per quella che divenne
una vera e propria agenda delle idee nella quale trovarono spazio le
riflessioni sul tempo, sull’emotività, sul gioco e sull’apprendimento
linguistico.
8
Le due storie sulle quali costruimmo il nostro lavoro vengono presentate nel capitolo II.
20
Nella redazione di queste pagine e nella scansione dei capitoli si è scelto di
mantenere l’ordine cronologico della sistemazione e della lettura del
materiale.
I.3. Breve viaggio tra circolari9,commissioni e realtà quotidiana.
La scuola italiana iniziò a porsi il problema dei bambini stranieri negli anni
’80, a seguito degli aumentati flussi migratori.
Il problema centrale era, allora, quello dell’inserimento nelle classi della
scuola dell’obbligo e della regolamentazione di questioni di ordine
amministrativo10.
Fu negli anni novanta che la riflessione sulla necessità di attuare un piano di
educazione interculturale si spostò su termini più generali e comunque
indipendenti dalla presenza in classe di bambini di etnie diverse.
Tra il 1990 e il 1997 si segnarono le tappe fondamentali di un percorso che
spostò
progressivamente
l’attenzione
dalle
questioni
di
semplice
accoglienza verso temi come le società multiculturali, la prevenzione del
razzismo e le possibili attuazioni di percorsi che stimolassero le relazioni e
il dialogo.
L’educazione interculturale venne considerata da subito una “dimensione”
dell’insegnamento, comune a tutte le discipline, per la quale non era
9
Per le circolari si è fatto riferimento al documento programmatico della Commissione Nazionale per
l’Educazione Interculturale pubblicato sotto la presidenza dell’allora sottosegretario alla Pubblica
Istruzione On. Carla Rocchi. Tale documento è facilmente reperibile in rete nel sito di RAI Educational.
10
C.M. n° 301/1989.
21
possibile immaginare un percosso che la equiparasse ad una materia
scolastica11.
A tutt’oggi, comunque, la circolare ministeriale alla quale si può fare
riferimento per comprendere lo stato delle politiche di accoglienza in
ambito scolastico è la n°205 del 26 luglio 1990: qui si delineano
competenze e nuovi obiettivi di dirigenti scolastici e insegnanti, si indica
con chiarezza l’urgenza formativa per questi ultimi ma, soprattutto, si parla
della necessità di collaborare con “mediatori linguistico-culturali”.
Il passo successivo alla produzione di circolari ministeriali e di studi
specifici fu quello di costituzione della Commissione Nazionale per
l’Educazione Interculturale con il compito di discutere ed elaborare percorsi
di attuazione che stimolassero gli operatori della scuola a considerare questi
temi come la “normalità” dei processi educativi.
“Il punto di arrivo dell’educazione interculturale - si afferma nel
documento della Commissione Nazionale per l’Educazione Interculturale –
è il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, di genere in primo
luogo, entro un percorso di formazione alla cittadinanza planetaria vista
come nuova dimensione della convivenza democratica.”
Nella Commissione , presieduta dal sottosegretario alla Pubblica Istruzione
Albertina Soliani prima, e, successivamente, dal sottosegretario Carla
Rocchi, pedagogisti, maestri, esperti di altre culture e religioni e antropologi
collaborarono a definire ulteriormente le linee guida dell’educazione
interculturale nella scuola dell’obbligo: venne prodotto un cd rom, si stabilì
la collaborazione con RAI Educational per un corso di formazione a
11
Si vedano le C.M. n° 205/1990, C.M. n° 73/1994, lo studio L’educazione interculturale nei programmi
scolastici pubblicato nel 1995 negli Annali della Pubblica Istruzione, tutti disponibili in rete sul sito della
Commissione Nazionale per l’Educazione Interculturale.
22
distanza in dieci puntate e si creò uno spazio di riflessione con una visibilità
in rete12.
Come si vede, in più di dieci anni, molto è stato prodotto per stimolare la
scuola a occuparsi di temi come l’educazione all’incontro, alla
cooperazione, al rispetto delle identità individuali e allo scambio;
nell’ambito della scuola dell’autonomia queste istanze possono trovare
spazio nei Piani di Offerta Formativa ai quali viene fatto continuamente
riferimento come ambito privilegiato della programmazione e realizzazione
della proposta didattica.
Lo stesso documento della Commissione fa riferimento in più di
un’occasione alla necessità di un incontro tra scuola e mondo
associazionistico, cooperativo e privato sociale per la realizzazione di
progetti di inserimento e di sostegno didattico ai bambini stranieri.
Come si sa, tuttavia, la questione ricade nelle mani dei presidi, sempre più
manager con bilanci da gestire; non è improbabile, così, che un Piano di
Offerta Formativa nel segno dell’intercultura e un corso di teatro si trovino
a competere per pochi milioni da investire entro la fine della primavera.
Ciò che davvero risulta incomprensibile, invece, è l’assenza di progetti di
definizione della figura del mediatore culturale. Sembra che la riflessione
sia ferma alle necessità di traduzione linguistica mentre sarebbe il caso che
iniziassero a definirsi funzioni e competenze di un ruolo sempre più
necessario a completare l’accoglienza.
Non c’è dubbio che sia proprio dal mondo della realtà quotidiana che
giungono gli stimoli più importanti per una riflessione sulla complessità di
12
Segnaliamo che il sito contiene, oltre alle informazioni sulla commissione e sulle sue attività, anche un
interessante serie di contributi alla riflessione sul rapporto tra bambini stranieri, scuola e famiglie. Si
segnalano, tra gli altri: Callari Galli M. “Differenze culturali e processi formativi”; l’approfondimento a
cura del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e sull’Adolescenza dal titolo
“Identità e diversità etnica”; Susi F. “Prospettive interculturali”; Bosi A. “Gente di strada nella “Città di
Culture”.
23
una attuazione pratica dei principi guida espressi dalle circolari e dalle
commissioni.
In quest’ ambito è da prendere in considerazione anche il ruolo del
Dirigente scolastico al quale spettano le scelte riguardanti gli eventuali corsi
di recupero, le iniziative di aggiornamento e formazione del personale e
quella che potremmo definire una politica di apertura alle famiglie, al
territorio e alle realtà dei servizi.
Resta, poi, il problema dei fondi limitati della scuola pubblica; da qui
bisogna partire anche per comprendere le scelte tutto sommato autarchiche
di molti insegnanti dei quali si conosce l’esperienza di lavoro grazie alla
scelta di renderla pubblica in libri, articoli o pagine web nei siti scolastici.
Si pensi, per esempio, al contributo prezioso fornito da due di loro, Monica
Mezzini e Cristina Rossi, a tutti i colleghi che siano interessati a progetti
interculturali: Gli specchi rubati è un libro agile, ricco e molto utile sul
piano delle idee per la didattica. Vi si propongono temi di lavoro e di gioco
come quelli dello Spazio, del Tempo, del Cibo , del Gruppo e della
Famiglia oltre a un’interessante elenco di film e libri per adulti e ragazzi
che siano mossi dalla curiosità di percorrere le strade della convivenza
democratica.
Non mancano i testi che riguardano il ruolo del capo d’istituto e la
possibilità di impostare corsi di aggiornamento per insegnanti all’interno
dei quali far “emergere” le linee pedagogiche piuttosto che calarle dall’alto
di una lezione13.
Questi contributi raccontano di un mondo scolastico sensibile a
sollecitazioni, fossero anche generiche, quali necessariamente debbono
essere a livello di circolari ministeriali.
13
Durino Allegra A., Fabi F., Traversi M. Dall’accoglienza alla convivenza: il capo di Istituto e gli
insegnanti nella scuola multiculturale, Meltemi, Roma, 1997.
24
L’esperienza personale, tuttavia, ci ha aiutato a comprendere che non tutte
le figure coinvolte nella progettazione di una didattica di nuovi valori
possono essere pienamente consapevoli del lavoro da svolgere nelle classi e
che, anche quando sia presente, non è facile che la disponibilità dei singoli
valga per tutti gli aspetti del processo.
Come si è detto durante la ricerca il contatto diretto col dirigente scolastico
si limitò a un frettoloso saluto nei corridoi, mentre quello con gli insegnanti
costituì un quotidiano terreno di incontro tra desiderio di fare e
conflittualità.
L’aspetto formativo del lavoro, per esempio, venne interpretato come
un’intrusione e trovò molte resistenze tra coloro che sostenevano di non
avere bisogno di un intervento esterno.
Anche in ambito didattico, poi, se da un lato sembrò esserci curiosità e
disponibilità verso le tematiche e le scelte interculturali, dall’altro molti
maestri lamentarono una generale difficoltà a muoversi su progetti elaborati
da altri, magari in contesti socioculturali completamente diversi.
Nella nostra esperienza verificammo costantemente che le richieste di aiuto
e consiglio erano modulate sulla consapevolezza che ogni situazione avesse
una propria unicità legata al numero di bambini presenti in classe, alle loro
famiglie, all’organizzazione didattica e, soprattutto, alla realtà culturale dei
bambini stranieri.
Questa disponibilità al lavoro “sul caso personale” è, in parte, la dimensione
nella quale ci si muove nella scuola italiana e per molti versi è ampiamente
comprensibile: c’è chi, come gli insegnanti di Prato, si trova di fronte
bambini che provengono prevalentemente dalla Cina e cerca di risolvere
problemi specifici, magari prevalentemente linguistici, c’è chi si trova a
insegnare ai nomadi del quartiere Casilino di Roma e sente l’esigenza di
una mediazione per calarsi nella realtà dei campi e c’è chi, come nella
classe dove fu condotta la ricerca, ha per alunni bambini che provengono
25
tutti da paesi diversi e si sente, per usare un’espressione della loro maestra,
ricco di stimoli ma confuso rispetto a un percorso che non dimentichi
nessuno.
E’ per questi insegnanti che si deve pensare una dimensione di sostegno più
complessa, che garantisca sia sul piano della molteplicità di rapporti
familiari sia riguardo alla possibilità di accogliere il singolo bambino: sono
insegnanti più dubbiosi sulle effettive possibilità di integrazione, forse
anche perché meno stimolati dalla forza e dall’omogeneità etnica del
gruppo di bambini (che, poi, è spesso una omogeneità di problemi), alle
prese ora con un colloquio con la mamma filippina che chiede di fare del
figlio un “italiano a tutti gli effetti” ora con il padre giapponese che ritiene
necessario che la figlia abbia più compiti a casa affinché possa esercitarsi
sull’italiano
26
nel fine settimana14.
E ci sono, prima di tutto, i bambini, spesso sospesi tra due culture, tra due
mondi economici, tra due alternative delle quali la prima, quella familiare,
può apparire lontana o addirittura inconciliabile con quella scolastica.
Come afferma Duccio Demetrio nei bambini si esprime “il diritto ad
imparare a vivere, assorbendo il più possibile nel qui ed ora”15, tendendo
verso l’uguaglianza con i compagni, non verso l’esaltazione delle
differenze.
E’ proprio in questi momenti che la formazione del maestro e le sue
capacità di vedere anche le dinamiche di esclusione di tratti propri della
cultura di origine del bambino divengono fondamentali.
I numerosi percorsi di assimilazione apparvero anche ai nostri occhi come
un tratto distintivo della personalità degli stranieri presenti in classe, e i
temi dell’identità, della vulnerabilità emotiva e del contrasto con le
aspettative familiari furono destinati a orientare significativamente
l’inchiesta.
Una breve riflessione merita anche la politica dell’editoria.
La rapidità con la quale i libri di testo si adeguano ai mutamenti della scuola
presenta, talvolta, aspetti inquietanti: è come se, circolari alla mano, i loro
curatori si impegnassero di anno in anno a non trascurare le nuove
sollecitazioni ministeriali, dedicandosi all’operazione con una tale
leggerezza che viene da chiedersi se ne valutino l’opportunità e le modalità
14
Entrambi i casi ci furono riportati dalla maestra di italiano, storia e geografia della IIC. Il bambino
filippino era in un’altra classe ma tutti conoscevano la sua situazione di disperato tentativo di integrazione
sostenuto dalla madre; la bambina giapponese,invece, costrinse le maestre a rivedere le posizioni dalle
quali erano partite e a prendere in considerazione che, forse, la provenienza da un paese ricco e
industrializzato (e da una famiglia benestante) non erano elementi sufficienti a garantirne l’integrazione.
Il fatto che questa piccola immigrata non avesse il volto dei bambini dei paesi poveri aveva portato tutti a
considerarla una occidentale a tutti gli effetti mentre lei e la sua famiglia si sentivano (ed erano per molti
aspetti) “stranieri”.
15
Demetrio D. Agenda interculturale, cit., pag. 20.
27
con il senso critico dovuto a chi, da editore, avrebbe il dovere di proporre
scelte culturali.
Nello sfogliare alcuni sussidiari non sarà difficile imbattersi nelle storie dei
piccoli Abdullà, felici di raccontare agli alunni delle nostre classi elementari
quanto sia bella la scuola quando non ci puoi andare o perché devi mungere
tutte le mattine o perché è a venti chilometri dal villaggio.
E’ sconfortante vedere come questi racconti vengano fatti rientrare sotto la
categoria di “educazione interculturale”, soprattutto se si considera che la
morale soggiacente non ha alcun fine conoscitivo bensì quello più subdolo
di trasmettere ai bambini italiani il senso del dovere.
Consapevole di queste operazioni la maestra della classe II C preferiva
leggere Le avventure di Pinocchio.
Molto spesso in questi testi è sottolineata la contrapposizione tra le loro
sfortune e le nostre fortune: i bambini arrivano a conoscere l’altro per
negazione, partendo dalle sue disgrazie, sviluppando, spesso, un
atteggiamento che conosce la pietà prima della curiosità16; in altri casi, poi,
la rappresentazione dell’altro ha più i caratteri del ritratto che non quelli
della riflessione.
Francesco Susi, uno dei membri della Commissione Nazionale per
l’Educazione Interculturale, nonché Preside della Facoltà di Scienza
dell’Educazione all’Università Roma Tre, ha notato che uno dei limiti
dell’interpretazione della dimensione pratica dell’intercultura sia proprio
una tendenza alla cristallizzazione delle realtà che vorrebbe rappresentare:
Le culture cosiddette “altre” divengono così dei contenitori vuoti, dei riferimenti
astratti, privi dei necessari agganci con la realtà concreta dei soggetti immigrati,
con le loro storie individuali, spesso in bilico tra passato e presente, tra paesi di
partenza e paesi di accoglienza. Si determina, per così dire, un certo
16
Il problema venne posto con forza durante gli incontri della classe con il maestro senegalese Ibrahima
Camara sui quali torneremo al capitolo V.
28
“culturalismo”, che fotografa staticamente la realtà culturale del cosiddetto diverso
e non tiene conto di quel processo dialettico di incontro\scontro tra autoctoni e
17
stranieri che caratterizza i rapporti sociali nei paesi ormai multietnici.
In un paese ricco di tradizioni locali -e di tensioni antimeridionaliste - come
l’Italia appare grave anche l’assenza di racconti regionali: l’immagine che si
ha è quella di una perdita delle specificità culturali per costituirsi in un
unico blocco “occidentale” paternalisticamente proteso verso il mondo
povero e disperato.
Su questo tema tornammo verso aprile quando, nel corso del lavoro sulla
storia personale, ci rendemmo conto che quasi la metà dei bambini presenti
in classe avevano un genitore o un nonno originario di altre regioni italiane,
prevalentemente del Sud.
Va detto, tuttavia, che queste carenze non poterono essere verificate sui libri
di tutto il ciclo elementare e che, sfogliando alcuni testi di terza nei quali si
accennava alla geografia, avemmo l’impressione di una cura maggiore degli
argomenti geoantropici e culturali.
I.4. Le migrazioni, le mediazioni, la famiglia: guardare la scuola
con “ occhi stranieri”.
La realtà delle migrazioni si è connotata di nuovi aspetti, primo tra tutti
quello familiare: istituti quali il ricongiungimento e la maggiore tutela per la
maternità hanno modificato la condizione di molti immigrati che hanno
potuto ricostituire un nucleo familiare o crearsene uno nel nostro Paese.
17
Susi “Prospettive interculturali” in L’educazione culturale nella scuola dell’autonomia, cit. , pag. 1.
29
Come emerge dagli studi più recenti in materia di politiche sociali di
inclusione
18
, la famiglia in immigrazione pone governi e legislatori di
fronte alla necessità di prevedere azioni di tutela e sostegno di segno
completamente nuovo rispetto alle risposte date ai primi fenomeni
migratori, marcatamente maschili.
La scuola, dunque, come polo di riferimento extrafamiliare, diviene il luogo
centrale entro il quale progettare un incontro, non solo con il bambino, ma
anche con sua madre e suo padre. Saper affrontare le difficoltà
dell’integrazione, dialogare con adulti che provengono da paesi con sistemi
scolastici concepiti diversamente o per i quali la separazione dei bambini
dalle famiglie imposta dal sistema educativo delle società occidentali può
sembrare invasiva, diventano nuove sfide sulle quali concepire l’
accoglienza.
Si pensi, per esempio, al fenomeno dei bambini e delle bambine rimandati
nei paesi islamici, magari dopo faticosi ricongiungimenti, in conseguenza
della delusione per il sistema educativo italiano19 o ai figli dei rifugiati
politici che si lasciano alle spalle la fuga dall’orrore della guerra e più che
mai hanno nella famiglia il punto di riferimento di un’esistenza
precocemente segnata dalla precarietà.
Roberto Beneduce, psichiatra e psicoterapeuta che da anni si occupa di
antropologia medica, afferma che la stessa questione dell’apprendimento
della lingua del paese di arrivo può rappresentare un evento carico di
significati emotivi, affettivi e sociali.
18
Per gli studi sulla famiglia immigrate si è fatto riferimento, in particolare, alla relazione “Le famiglie
straniere: strutture relazionali e familiari” presentata da Mara Tognetti Bordogna al Convegno dei
sociologi italiani tenutosi a Forlì nell’ottobre 1999.
19
Durante la nostra ricerca avemmo modo di parlare con maestri di altre scuole di Roma, per lo più amici
interessati al lavoro che stavamo conducendo. Alcuni ci raccontarono casi di veri e propri scontri con
famiglie musulmane che lamentavano scarsa attenzione e rispetto per le usanze familiari. La vicenda più
triste era quella di due sorelle tunisine allontanate dalla scuola dopo che una maestra si era lamentata del
30
Scrive Beneduce:
L’istituzione scolastica considera, del resto, di poco valore legami e appartenenze:
la sua logica di funzionamento esige individui, non gruppi. Nei bambini che
vivono una particolare distanza tra modelli di apprendimento, di relazione o di
potere, come è tipicamente il caso dei bambini immigrati, la dissonanza può –
quando non opportunamente gestita- risultare rilevante, e l’apprendimento di una
seconda lingua farsi strada al prezzo di una cancellazione o “messa fra parentesi”
di quella materna: non è proprio nella misura in cui la nuova lingua viene appresa
20
ed utilizzata che più si misura il grado di integrazione?.
L’osservazione di Beneduce può essere applicata a tutti gli altri ambiti
dell’integrazione nella scuola e delle dinamiche di apprendimento, tanto che
per ognuno di essi si potranno delineare difficoltà non solo pratiche ma
anche di natura psicologica che coinvolgono bambini e famiglie.
Lo stesso psichiatra, arrivando per altre strade lì dove si fermano le circolari
ministeriali, immagina che l’incontro possa avvenire in uno “spazio
intermedio che sia in grado di articolare i mondi culturali, linguistici ed
affettivi di cui il bambino immigrato è attore”21.
Uno spazio per l’incontro e per la mediazione che nella scuola manca
completamente.
Nell’esperienza italiana la mediazione culturale è stata interpretata
generalmente come mediazione linguistica nella quale l’interprete ha come
lingua madre quella straniera; questo per ovvie ragioni: è più facile trovare
senegalesi, albanesi, curdi che parlino italiano che non viceversa.
fatto che avessero le mani tinte di henna. Le due bambine furono rimandate in Tunisia dalla nonna
materna per decisione di entrambi i genitori.
20
Beneduce R. Frontiere dell’identità e della memoria, Franco Angeli, Milano 1998, pag. 188.
21
ivi, pag. 190.
31
Ogni traduzione linguistica è anche una traduzione culturale22, ma la
sensazione è che fermarsi alla comunicazione verbale non basti più e non
rappresenti una forma di accoglienza completa.
Fermo restando che sia possibile parlare di “traduzione” riferendosi a una
cultura, si può immaginare la quantità di conoscenze che si dovrebbero
richiedere a questi interpreti per estendere le loro competenze ad altre sfere
dello scambio culturale. Matilde Callari Galli afferma che l’educazione
interculturale debba innanzi tutto fondarsi su un esame accurato e profondo
dei valori delle culture coinvolte nell’incontro e che ciò sia possibile
solamente a partire dal possesso di “strumenti concettuali e critici per
analizzare valori, stili di vita, comportamenti…”23.
Non è raro, tuttavia, incontrare stranieri che per cultura e formazione
potrebbero rappresentare bene un ruolo di mediatore. Certo è che se le
esigenze di un mondo che ospita i migranti sono ferme alla traducibilità
delle loro lingue sui moli della Puglia, nelle aule giudiziarie e,in rari casi,
negli ospedali, è difficile immaginare che ci sia spazio per figure di
maggiore complessità.
C’è di più. Come osserva Duccio Demetrio, si può introdurre un’ulteriore
specificazione tra chi è mediatore culturale, e chi è mediatore
interculturale. Nel primo caso si tratta di un individuo che divulga una
cultura poiché vi appartiene per nascita, nel secondo di chi, seppure legato
alle proprie origini, fa in modo di tradurre i valori dell’interculturalismo
indipendentemente dalle proprie radici24.
22
Sulle implicazioni della traduzione culturale è stata di grande stimolo la lettura del saggio di Talal Asad
“Il concetto di traduzione di culture nell’antropologia sociale britannica” (in Clifford J., Marcus G.
Scrivere le culture : poetiche e politiche in etnografia, Meltemi, Roma 1997) .nel quale, per la serie di
implicazioni di natura anche “intima”, l’attività del traduttore-mediatore viene presentata come più vicina
al lavoro dello psicanalista che non a quella del linguista.
23
Callari Galli M., “Differenze culturali e processi formativi” in L’educazione interculturale nella scuola
dell’autonomia, cit., pag. .5.
24
Demetrio D. Agenda interculturale, cit., pag. 78.
32
Durante l’arco di tempo della nostra permanenza ci rendemmo conto che
concepire l’accoglienza nella scuola secondo le modalità dell’ascolto e del
racconto è oggi quanto mai necessario.
Il panorama generale e la nostra esperienza in particolare mettono in luce
una evidente diminuzione delle difficoltà comunicative grazie alle acquisite
competenze linguistiche dei genitori e una sempre crescente richiesta di
attenzione sul piano del rispetto della tradizione (menù privi di alcuni
alimenti, possibilità di assentarsi in giorni di festa o di indossare abiti
tradizionali, etc.), quasi che la strada della consapevolezza o, se si vuole,
del recupero delle culture di origine, si fosse schiusa repentinamente.
A ciò va aggiunto che accogliere le incertezze e le richieste delle famiglie
straniere potrebbe rappresentare un valido aiuto nelle situazioni di disagio
scolastico che spesso accompagnano i bambini stranieri: il loro mondo
affettivo ed emotivo passa dalla porta delle loro case, dalla cultura delle
loro madri, dal lavoro dei loro padri e fratelli, dalle mura delle case in cui
vivono. Come quello dei bambini italiani, d’altronde.
Immaginare e progettare l’incontro appare oggi possibile solo nella
prospettiva di non isolare le singole sfere di mediazione, facendo
comunicare gli operatori nell’ambito di un gruppo che aiuti la scuola a
gestire un’accoglienza difficile, troppo spesso affidata a insegnanti alle
prese con programmi da rispettare e, comunque, con classi numerosissime.
Nei giorni passati a scuola e, soprattutto, nei brevi ma intensissimi incontri
con le mamme dei due bambini ci capitò di percepire interamente le
difficoltà del dialogo: le due lingue, i racconti di vite geograficamente
lontane, la ricerca del consenso nel giudicare i figli dovettero essere
affrontati
uscendo
progressivamente
da
un’ottica
giudicante
o
scontatamente solidale per entrare in quella dinamica empatica che Luigi
M. Lombardi Satriani ha descritto così puntualmente nelle sue fasi:
33
Nell’incontro continuamente rinnovantesi io-altro si dispiega, prima ancora che la
dinamica dell’intervista demo-etno-antropologica, la dinamica della vita,
gigantesca intervista nella quale siamo coinvolti e nella quale siamo, volta a volta,
intervistatori e intervistati, ascoltanti e parlanti prima di divenire definitivamente
25
silenti”.
Questa tensione verso il noi, unita alla consapevolezza che ogni atto di
ascolto e ogni singolo sguardo siano i termini di un unico percorso
conoscitivo, oggi rappresentano le risorse più grandi che l’antropologia
possa offrire all’ educazione in un mondo creolo.
La realtà della scuola, poi, evidenzia un ulteriore tratto del confronto con i
migranti, quello della presenza femminile e della sua caratteristica modalità
di arrivo e permanenza.
Basta percorrere i corridoi di un istituto elementare durante l’ingresso dei
bambini per rendersi conto che gli adulti sono quasi tutte donne. Sono le
madri a tenere i rapporti con le maestre, a fare le rappresentanti di classe, a
partecipare alle riunioni, a parlare del rendimento scolastico dei figli: sono
le madri, insomma, che si occupano della dimensione scolastica dei bambini
riportandone i successi e i conflitti.
Nel caso delle mamme straniere questo aspetto è particolarmente
importante; alle prese con le separazioni dalle loro madri e sorelle, spesso
dal modello di famiglia estesa all’interno del quale far crescere i propri
figli, svuotate dalle scarse relazioni di vicinato di una città, queste donne
danno spesso l’impressione di vivere in uno stato di fragilità che si riflette
nella ricerca di nuovi punti di riferimento atti a contenere un’identità
“vacillante”26.
25
26
Lombardi Satriani L. M. La stanza degli specchi, Meltemi, Roma 1994, pag. 51.
Beneduce R. Frontiere dell’identità e della memoria, cit. , pag. 155.
34
Scrive Beneduce che quello delle immigrate può essere considerato come
un “doppio transito” nella società che le accoglie: doppio perché segnato
contemporaneamente dall’identità di straniera e da quella di donna, “l’Altro
per eccellenza”27. Questa specificità femminile porta ad un profondo
mutamento dei conflitti di genere:
Al suo interno le questioni concernenti l’identità culturale assumono nuovi profili
e gli itinerari delle donne migranti prendono la forma di un transito duplice quanto
doloroso: non le attende infatti solo il confronto con altri valori e altre norme
comportamentali, con differenti codici estetici e nuove responsabilità, ma anche il
confronto lacerante con il proprio ruolo quale viene concepito e riprodotto nella
cultura d’origine e quale viene invece modellato dalle ideologie dei paesi
occidentali.
28
Al tempo stesso esse sono le più esposte nei processi di acquisizione,
comprensione, accettazione e rifiuto delle dinamiche culturali29: basti
pensare ai contatti maggiori con le strutture sanitarie, ma anche a quelli con
luoghi più quotidiani quali un mercato o, appunto, la scuola dei figli.
La maternità, infatti, può rappresentare un ulteriore e significativo percorso:
la gravidanza, il parto nelle strutture pubbliche, l’incontro con i pediatri e
quello con la scuola sono eventi che obbligano le donne a un confronto
rapido con nuovi ruoli in contesti sovente sconosciuti.
Quando, nel corso della ricerca, ci rendemmo conto di essere entrati a
nostra volta in una rete di relazioni femminili, provammo a immaginare che
fosse possibile introdurre la variabile di genere in una riflessione sulla
27
ivi, pag. 162
ivi, pag. 159.
29
Si veda “Antropologia reciproca” , relazione di Rosalba Terranova Cecchini tenuta in occasione del
Convegno Nazionale “Le famiglie interrogano le politiche sociali” promosso dal Ministero degli Affari
Sociali nel marzo 1999.
28
35
mediazione culturale e sull’identità tesa tra due mondi dei bambini presenti
nella classe.
Parlare con le loro madri servì a comprendere quanto la fonte delle
insicurezze dei figli fosse di origine familiare: le ansie, le fatiche, i disagi e
l’assenza di riferimenti affettivi di quelle donne sembrarono, allora, essere
la chiave di interpretazione delle difficoltà dei bambini.
Come già si è detto la presenza in una classe non riuscirà mai a concentrare
lo sguardo solo su una o due situazioni, per quanto farlo sarà , poi,
necessario; come testimonieremo col racconto della nostra esperienza la
classe come luogo della relazione di gruppo, dell’affermazione del singolo
bambino nella sua dimensione extrafamiliare e dell’emersione del conflitto
tra individui avrà sempre la precedenza su qualunque realtà particolare.
Se è vero che per gli stranieri si presentano difficoltà legate alla lingua e
alla comunicazione con le loro famiglie, non va dimenticato che, guardando
all’intero gruppo, sarà possibile accorgersi che alcune responsabilità vanno
cercate nel sistema scolastico.
Se si considera l’apprendimento un processo da condurre lentamente,
tenendo conto dell’età del bambino e delle sue necessità di non
abbandonare tratti caratteristici dell’esperienza infantile quali il disegno e il
gioco, sarà facile trovarsi d’accordo con quanti -e sono in molti- sostengono
che la scuola italiana a livello di istruzione elementare sia ancora
eccessivamente costrittiva sul piano fisico, intellettuale e spaziale.
Scrivono Monica Mezzini e Cristina Rossi:
Negli ultimi anni la scuola stessa –non avulsa dalle trasformazioni sociali e forse
rea di aver interpretato un po’ troppo alla lettera alcuni aspetti della riforma- ha
cercato di rimpiazzare il corpo, la manipolazione, l’esperienza, lo spazio e il tempo
vissuti con pile di quadernoni faticosamente vergati attraverso i quali, persino agli
36
alunni più giovani, si chiede di imparare per “mappe” astratte senza mai passare al
“territorio”.
30
Una sorta di implicita richiesta di passività, così come quella che appariva
come una attenzione troppo rigida alla didattica “da sussidiario”,
sembrarono inizialmente caratteristiche del rapporto tra i bambini stranieri e
le insegnanti della classe che seguivamo; col passare del tempo, invece, si
affermarono quali aspetti centrali di un sistema scolastico che opera in un
clima di precarietà nel quale si sceglie la strada del rigore didattico e del
contenimento fisico (in alcuni giorni i bambini restavano seduti anche per
tre ore consecutive) come l’unica possibile in un luogo privo di spazi.
La stessa progettazione didattica e la scelta di argomenti e compiti da
affidare ai bambini ben presto apparvero giustificate dalla complessità dei
libri di testo e dei manuali utilizzati dall’insegnante; va detto, oltretutto, che
questi limiti venivano vissuti dalla stessa maestra con grande frustrazione,
legata all’impossibilità di progettare una scuola diversa in un istituto come
quello, nel quale ogni classe lavorava nella solitudine delle proprie attività.
Ci sembrò evidente, allora, che quale che fosse il progetto didattico mirante
all’educazione interculturale, al rispetto e alla valorizzazione delle identità
nonché al recupero delle difficoltà di apprendimento dei bambini stranieri,
questo rischiava di porre le sue basi su un terreno poco solido.
Ancora ne Gli specchi rubati le autrici, riferendosi ai messaggi impliciti
veicolati dalla scuola attraverso le sue mura, le sue aule, i suoi spazi esterni
e i programmi, affermano la necessità di riportare l’attenzione anche sul
non-verbale, recuperando la consapevolezza della sua influenza e della sua
valenza inculturativa31.
30
31
Mezzini M., Rossi C. Gli Specchi rubati, Meltemi, Roma 1997, pag. 21.
ivi, pag. 20.
37
La presenza di bambini stranieri nella scuola ha contribuito a livello teorico
a far rileggere criticamente le pratiche didattiche che si sono imposte negli
ultimi anni osservando l’ evidenza con la quale si manifestavano difficoltà e
ritardi di apprendimento in bambini che partivano, quasi sempre, da una
necessità di recupero sul piano linguistico.
Nel concreto della nostra esperienza avemmo modo di vedere come,
movendo da una riflessione specifica su un singolo bambino, non fosse
difficile individuare anche negli altri la noia per le attività quotidiane, la
difficoltà a resistere immobili dietro un banco, la necessità di disegnare e,
soprattutto, la voglia di giocare.
Rispondendo al nostro invito a completare un testo di particolare difficoltà
un bambino ci disse “sono stanco, ho solo voglia di giocare” e iniziò a
immaginare di poter scendere in cortile con i suoi compagni alle dieci del
mattino.
In tempi di riforme scolastiche che vengono approvate, ritirate, discusse
secondo modalità confusamente democratiche e scarsamente proficue sul
piano delle idee non deve essere facile trovare linee di coerenza, ma sarebbe
auspicabile32, tuttavia, che il nostro sistema di istruzione concedesse più
spazio al gioco e al riposo dalla produzione di testi considerandoli una volta
per tutte quali momenti ugualmente validi di apprendimento.
Nella classe che avemmo modo di osservare, poi, si presentò anche il caso
dell’ elevato numero di alunni approdati in prima elementare in condizioni
di completa alfabetizzazione acquisita alla scuola materna.
Questi bambini erano stati messi in una doppia condizione: avvantaggiati
nell’apprendimento ma costretti a passare tutto il primo anno ad aspettare
che gli altri, per lo più gli stranieri per i quali non c’era stato passaggio
32
L’anno scolastico durante il quale si svolse la ricerca fu vissuto dalle maestre in un clima di generale
incertezza. La possibilità che la riforma della scuola potesse entrare in vigore dal settembre 2001, infatti,
metteva tutti nella condizione di adeguarsi in tempi brevi ai cambiamenti annunciati; immaginiamo che il
successivo ritiro della legge da parte dell’attuale governo non abbia facilitato la situazione.
38
dalle materne statali e comunali, imparassero ciò che, per generazioni, è
stato insegnato a bambini di sei o sette anni e non a quelli di cinque.
Ora non è difficile immaginare quali ricadute avesse avuto sul gruppo
questo fenomeno: dal primo giorno di scuola era stato chiaro che gli
stranieri avrebbero lavorato al recupero prima ancora che all’integrazione,
come ancora avveniva in seconda elementare quando iniziò la nostra
ricerca.
Chiunque si preoccupasse di guardare la scuola almeno una volta con occhi
stranieri vedrebbe che lo svantaggio di quei bambini non é di segno molto
diverso dalla necessità di giocare dei loro coetanei alfabetizzati alle scuole
materne, a disagio nell’attesa che gli altri imparino ciò che loro sanno già
fare, svantaggiati perché per imparare a leggere e scrivere è stato loro
sottratto tempo al gioco.
Così, l’incontro con le difficoltà degli stranieri può essere letto non solo alla
luce dell’urgenza di trovare soluzioni praticabili, ma anche come occasione
autoriflessiva a partire dalla quale attuare un vero e proprio ripensamento
del nostro sistema scolastico.
I.5. Ma che cos’è l’intercultura?
Esistono molti modi per definire concetti di ampio respiro e se fin ora si è
ritenuto di dover citare solo la Circolare ministeriale nel quale compare il
termine “intercultura” è perché essa ne contiene gli aspetti più generali e
onnicomprensivi.
39
Molto spesso, tuttavia, si ha l’impressione che l’educazione interculturale
venga intesa più nelle immediate possibilità di applicazione pratica che non
come insieme di proposte interpretative degli aspetti culturali coinvolti in
una relazione di incontro e di reciproco scambio che siano inevitabilmente
volti a modificare le dimensioni culturali degli uni e degli altri.
Se troppa teoria può far perdere di vista l’obiettivo è vero anche che gettarsi
sulla dimensione pratica può allontanare gli aspetti critici più produttivi.
Come è stato già chiarito, la ricerca non ebbe mai il fine di valutare quali
stimoli e materiali didattici, tra l’altro facilmente reperibili, fossero più
adatti ad attuare un progetto di educazione interculturale, bensì quello di
osservare quali ripercussioni potesse avere l’inserimento in quella classe di
quella scuola per due bambini e quali influenze sulle loro famiglie
nell’ottica di una strada che affermasse l’identità come valore e
l’apprendimento come diritto.
Materiali e idee per la didattica servirono come mezzo adatto a favorire
un’ottica privilegiata sulla classe e per valutare gli aspetti della vita
relazionale e di gruppo dei due bambini stranieri.
Ciò detto, il concetto di intercultura ha attraversato anche la nostra
esperienza, poiché è lì che possono vedersi sommati i principi di
accoglienza, curiosità, incontro e difesa della differenza.
Delle molte disponibili, quando ci confrontammo con la complessità dei
temi contenuti in “intercultura” quella di Duccio Demetrio33 ci sembrò, e
tuttora ci appare, la più duttile.
Per Demetrio di possono considerare tre ambiti: quello dell’interazione,
basato sull’azione, sul pensiero, sul progetto comuni; quello della
reciprocazione, basato sullo scambio di saperi, risorse e possibilità; quello
dell’accettazione, basato sull’accettazione delle differenze (“che non si
tratta soltanto di tollerare, ma di assumere come legittime, laddove queste
40
non ledano i diritti dell’uomo e del cittadino, in quanto principi universali
che salvaguardano la sopravvivenza fisica oltre che culturale delle genti e
dei popoli”34).
Nel suo terzo aspetto, quindi, l’intercultura come la definisce Demetrio si
preoccupa di dare risposte anche a coloro che domandano a chi si occupa di
questi temi con quale coscienza si possano tollerare l’infibulazione, la
sottomissione della donna e l’infanticidio femminile: capita di frequente,
infatti, che gli interlocutori vedano nell’antropologo un legittimatore di
pratiche culturali che l’occidente considera disumane.
Sempre Demetrio, individua nella pedagogia interculturale il suo carattere
“esemplare”, vale a dire quello degli incontri che hanno il chiaro intento di
conoscersi reciprocamente, e quello “quotidiano” basato sulla creazione di
un clima di curiosità e di ascolto; sottolineando, quindi, come nel fare
intercultura non si attuino altro che intenzioni comunicative.
Più “tecnica” e appartenente più al linguaggio delle direttive ministeriali, è
la definizione che ne dà Francesco Susi, che non a caso è stato membro
della Commissione Nazionale per l’Educazione Interculturale:
L’educazione interculturale é la risposta in termini di prassi formativa alle sfide e
ai problemi che pone il mondo delle interdipendenze; è un progetto educativo
intenzionale che taglia trasversalmente tutte le discipline insegnate nella scuola e
che si propone di modificare le percezioni e gli abiti cognitivi con cui
generalmente
ci
rappresentiamo
sia
gli
stranieri
sia
il
mondo
delle
35
interdipendenze”.
Entrambe le definizioni, secondo noi, dovrebbero essere ricordate durante il
lavoro di classe; con le loro differenze, con la diversa attenzione accordata
33
Demetrio D. Agenda interculturale, cit. , pag. 92.
Ibidem.
35
Susi F. “Prospettive interculturali” in L’educazione interculturale nella scuola dell’autonomia, cit.,
pag.1.
34
41
al piano delle relazioni interpersonali esse rappresentano una buona risposta
per chi voglia affrontare il tema dell’educazione interculturale con serietà.
Vorremmo aggiungere, tuttavia, che la nostra esperienza ci ha convinti del
fatto che l’educazione e i suoi processi si basino fondamentalmente sul
rapporto tra le persone e sui percorsi intellettuali, esperienziali e di
costruzione della personalità dei singoli individui: la biografia, le scelte
ideologiche, le capacità relazionali e le curiosità del maestro, del mediatore
culturale o della madre di un bambino appaiono, così, come le fondamenta
di qualsiasi discorso.
Laddove, come accade oggi nella scuola, venga meno la possibilità per gli
insegnanti di affrontare un percorso formativo in grado di stimolare la
discussione e la critica, non si può far altro che affidarsi alle circolari e al
buon senso.
42