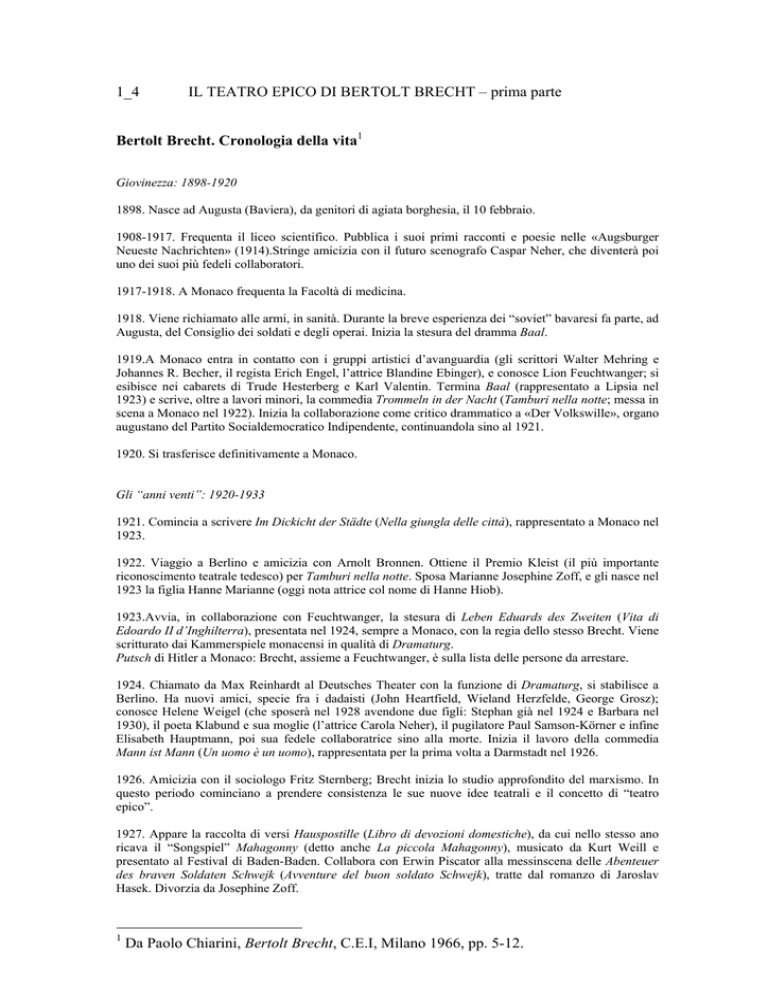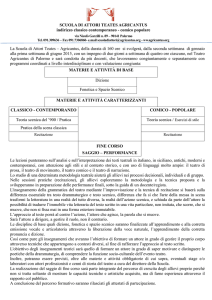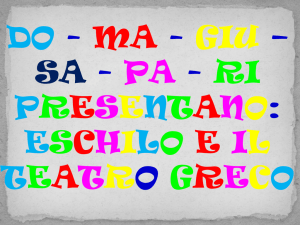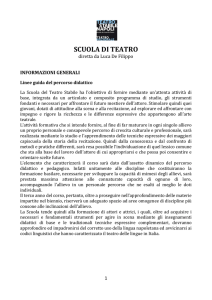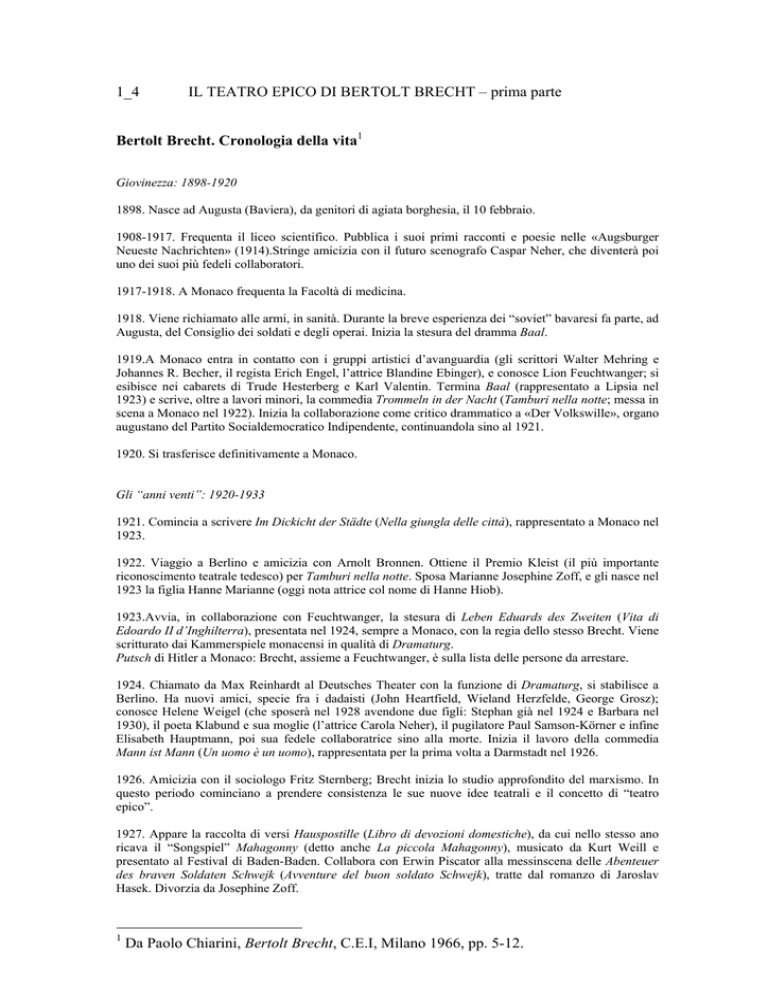
1_4
IL TEATRO EPICO DI BERTOLT BRECHT – prima parte
Bertolt Brecht. Cronologia della vita1
Giovinezza: 1898-1920
1898. Nasce ad Augusta (Baviera), da genitori di agiata borghesia, il 10 febbraio.
1908-1917. Frequenta il liceo scientifico. Pubblica i suoi primi racconti e poesie nelle «Augsburger
Neueste Nachrichten» (1914).Stringe amicizia con il futuro scenografo Caspar Neher, che diventerà poi
uno dei suoi più fedeli collaboratori.
1917-1918. A Monaco frequenta la Facoltà di medicina.
1918. Viene richiamato alle armi, in sanità. Durante la breve esperienza dei “soviet” bavaresi fa parte, ad
Augusta, del Consiglio dei soldati e degli operai. Inizia la stesura del dramma Baal.
1919.A Monaco entra in contatto con i gruppi artistici d’avanguardia (gli scrittori Walter Mehring e
Johannes R. Becher, il regista Erich Engel, l’attrice Blandine Ebinger), e conosce Lion Feuchtwanger; si
esibisce nei cabarets di Trude Hesterberg e Karl Valentin. Termina Baal (rappresentato a Lipsia nel
1923) e scrive, oltre a lavori minori, la commedia Trommeln in der Nacht (Tamburi nella notte; messa in
scena a Monaco nel 1922). Inizia la collaborazione come critico drammatico a «Der Volkswille», organo
augustano del Partito Socialdemocratico Indipendente, continuandola sino al 1921.
1920. Si trasferisce definitivamente a Monaco.
Gli “anni venti”: 1920-1933
1921. Comincia a scrivere Im Dickicht der Städte (Nella giungla delle città), rappresentato a Monaco nel
1923.
1922. Viaggio a Berlino e amicizia con Arnolt Bronnen. Ottiene il Premio Kleist (il più importante
riconoscimento teatrale tedesco) per Tamburi nella notte. Sposa Marianne Josephine Zoff, e gli nasce nel
1923 la figlia Hanne Marianne (oggi nota attrice col nome di Hanne Hiob).
1923.Avvia, in collaborazione con Feuchtwanger, la stesura di Leben Eduards des Zweiten (Vita di
Edoardo II d’Inghilterra), presentata nel 1924, sempre a Monaco, con la regia dello stesso Brecht. Viene
scritturato dai Kammerspiele monacensi in qualità di Dramaturg.
Putsch di Hitler a Monaco: Brecht, assieme a Feuchtwanger, è sulla lista delle persone da arrestare.
1924. Chiamato da Max Reinhardt al Deutsches Theater con la funzione di Dramaturg, si stabilisce a
Berlino. Ha nuovi amici, specie fra i dadaisti (John Heartfield, Wieland Herzfelde, George Grosz);
conosce Helene Weigel (che sposerà nel 1928 avendone due figli: Stephan già nel 1924 e Barbara nel
1930), il poeta Klabund e sua moglie (l’attrice Carola Neher), il pugilatore Paul Samson-Körner e infine
Elisabeth Hauptmann, poi sua fedele collaboratrice sino alla morte. Inizia il lavoro della commedia
Mann ist Mann (Un uomo è un uomo), rappresentata per la prima volta a Darmstadt nel 1926.
1926. Amicizia con il sociologo Fritz Sternberg; Brecht inizia lo studio approfondito del marxismo. In
questo periodo cominciano a prendere consistenza le sue nuove idee teatrali e il concetto di “teatro
epico”.
1927. Appare la raccolta di versi Hauspostille (Libro di devozioni domestiche), da cui nello stesso ano
ricava il “Songspiel” Mahagonny (detto anche La piccola Mahagonny), musicato da Kurt Weill e
presentato al Festival di Baden-Baden. Collabora con Erwin Piscator alla messinscena delle Abenteuer
des braven Soldaten Schwejk (Avventure del buon soldato Schwejk), tratte dal romanzo di Jaroslav
Hasek. Divorzia da Josephine Zoff.
1
Da Paolo Chiarini, Bertolt Brecht, C.E.I, Milano 1966, pp. 5-12.
1928. Successo clamoroso, al Theater am Schiffbauerdamm, della Dreigroschenoper (Opera da tre
soldi), rifacimento della Beggar’s Opera di John Gay realizzato in collaborazione con Weill, per il quale
inizia la stesura di Aufstieg un Fall der Stadt Mahagonny (Ascesa e rovina della città di Mahagonny;
eseguita a Lipsia nel 1930).
1929. Inaugura il periodo dei cosiddetti Lehrstücke (“drammi didattici”). Al Festival musicale di BadenBaden vengono presentati Der Ozeanflug (La trasvolata oceanica; anche Der Flug der Lindberghs),
cominciato a scrivere l’anno precedente, e Das Badener Lehrstück vom Einverständnis (L’accordo),
musicati da Weill e Paul Hindemith. La rappresentazione berlinese di un altro testo operistico, Happy
End, in realtà dovuto in gran parte alla Hauptmann, registra un netto insuccesso. Prepara le opere
scolastiche Der Jasager (Il consenziente) e Der Neinsager (Il dissenziente), messe in scena a Berlino nel
1930 e discusse collettivamente alla scuola marxista di Neukölln.
1930. Inizia la pubblicazione dei Versuche (Esperimenti), quaderni in cui raccoglie lavori teatrali,
poesie, pagine narrative, scritti teorici. Termina Die Heilige Johanna der Schlachthöfe (Santa Giovanna
dei macelli), iniziata l’anno precedente e, dopo una riduzione radiofonica trasmessa nel 1932,
rappresentata integralmente per la prima volta nel 1956, ad Amburgo, con la regia di G. Gründgens.
Scrive i drammi didattici Die Massnahme (La linea di condotta), eseguita subito a Berlino, e Die
Ausnahme un die Regel (L’eccezione e la regola), mai rappresentata in Germania. Comincia Die Mutter
(La madre), dal romanzo omonimo di M. Gorkij (prima assoluta, Berlino, 1932).
1931-1932. Scrive la sceneggiatura del film Kuhle Wampe (dal nome di un quartiere operai berlinese),
realizzato da Slatan Dudow; musiche di Hanns Eisler.
1932. Lavora a Die Rundköpfe un die Spitzköpfe (Teste tonde e teste a punta), satira del razzismo nazista
conclusa nel 1934 e allestita a Copenhagen nel 1936.
Il periodo dell’esilio: 1933-1948
1933. Nel gennaio una rappresentazione della Linea di condotta viene sospesa, a Erfurt, dalla polizia. Il
28 febbraio, all’indomani dell’incendio del Reichstag, Brecht abbandona con la famiglia la Germania,
dove ritornerà soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il 10 maggio anche i suoi libri
vengono bruciati dai nazisti nel grande rogo davanti all’Opera di Berlino.
1933. Le prime tappe dell’emigrazione lo portano successivamente a Praga, Vienna, Zurigo (qui ritrova
Anna Seghers, Heinrich Mann, Walter Benjamin e altri intellettuali tedeschi democratici), Carona sul
lago di Lugano (incontro con Hermann Hesse). Si trasferisce in Danimarca.
G. Balanchine cura l’allestimento coreografico del balletto Die sieben Todsünden (I sette peccati
capitali), con Lotte Lenja. Comincia Der Dreigroscheroman (Il romanzo da tre soldi), uscito ad
Amsterdam nel 1934.
1934. Collabora a varie riviste dei fuoriusciti tedeschi. Concepisce l’ultimo “dramma didattico”, Die
Horatier und Kuriatier (Gli Orazi e i Curiazi), che verrà rappresentato solo nel 1958 a Halle.
A Parigi appare la seconda raccolta di versi: Lieder, Gedichte, Chöre (Canzoni, poesie, cori).
1935. Nel giugno, a Parigi, interviene al Convegno internazionale degli scrittori per la difesa della pace.
È privato della cittadinanza tedesca. Redige il saggio Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben del Warheit
(Cinque difficoltà per chi scrive la verità), diffuso clandestinamente anche in Germania. Pone mano alle
24 scene Furcht und Elend des Dritten Reiches (Terrore e miseria del Terzo Reich), portate a termine
nel 1938 e rappresentate nello stesso anno a Parigi. A Mosca, l’incontro con l’attore cinese Mei LanFang (e forse anche con le teorie del critico formalistico russo Viktor Sklovskij) esercita un notevole
influsso sulla sua concezione del teatro, specie per quanto riguarda la nozione di Verfremdung
(estraniamento).
1936. Con Feuchtwanger e Willi Bredel dirige la rivista «Das Wort» e collabora a «Internationale
Literatur», che si stampano a Mosca.
1937. A Parigi scrive e fa rappresentare (con la Weigel protagonista) il dramma Die Gewehre der Frau
Carrar (I fucili della signora Carrar), ispirato alla guerra civile spagnola. Inizia la stesura del romanzo
Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar (Gli affari del signor Giulio Cesare), portata avanti sino al 1939
ma rimasta poi interrotta.
1938. Presso il Mali-Verlag dell’amico Herzfelde compaiono i primi due volumi di una raccolta dei
Gesammelte Werke (Opere complete). Comincia il lavoro alla “parabola” Der gute Mensch von Sezuan
(L’anima buona di Sezuan), terminato quattro ani dopo in America, e alla prima redazione di Leben des
Galilei (Vita di Galilei), allestita a Zurigo nel 1943 (una seconda redazione, in lingua inglese, compiuta
fra il 1945 e il 1947 assieme a Charles Laughton, verrà messa in scena nel 1947 con lo stesso Laughton
come protagonista; una terza, del 1954-56, sarà realizzata nel 1957 dal Berliner Ensemble con Ernst
Busch nelle vesti di Galilei).
1939. Scrive Mutter Courage und ihre Kinder (Madre Courage e i suoi figli), allestita nel 1941 a Zurigo.
Nell’aprile si trasferisce in Svezia, dove compone il radiodramma Das Verhör des Lukullus
(L’interrogatorio di Lucullo), ridotto più tardi a libretto d’opera per la musica di Paul Dessau ed
eseguito a Berlino nel 1951 col titolo Die Verurteilung des Lukullus (La condanna di Lucullo). Pubblica
a Londra gli Svendborger Gedichte (Poesie di Svendborg).
1940. Nell’aprile si rifugia in Finlandia, aiutato dalla scrittrice Hella Wuolijoki.
Scrive il “dramma popolare” Herr Puntila und sein Knecht Matti (Il signor Puntila e il suo servo Matti),
rappresentato a Zurigo nel 1948, iniziando anche la stesura della “parabola” Der aufhaltsame Aufstieg
des Arturo Ui (La contenibile ascesa di Arturo Ui), allestita nel 1958 a Stoccarda, e del dramma Die
Gesischte der Simone Machard (Le visioni di Simone Machard), portato a termine nel 1943 in America
con la collaborazione di Feuchtwanger e messo in scena a Francoforte sul meno nel 1957. A questo
periodo appartengono anche i frammenti in prosa dei Flüchtlingsgespräche (Dialoghi di profughi).
1941. Abbandona la Finlandia e, attraverso l’Unione Sovietica, ripara negli Stati Uniti. A Hollywood,
dove si incontra con la folta colonia di intellettuali tedeschi in esilio (Feuchtwanger, H. e Th. Mann,
Leonhard Frank, Fritz Lang) e conosce Charlie Chaplin, cerca di affermarsi come sceneggiatore
cinematografico. Scrive intanto, Schwejk in zweiten Weltrieg (Schwejk nella seconda guerra mondiale),
terminato nel 1944 e messo in scena a Varsavia nel 1957.
1944-45. Compone Der Kaukasische Kreiderkreis (Il cerchio di gesso del Caucaso), rappresentato a
Northfield (USA) nel 1948.
1947. Sottoposto a inchiesta dal Comitato per le attività antiamericane (che per altro lo scagiona da ogni
addebito), abbandona gli Stati Uniti rientrando in Europa. In Svizzera rielabora l’Antigone di Sofocle
nella versione di Fr. Hölderlin (prima assoluta, Coira, 1948). Conosce Max Frisch.
1948. Scrive il Kleines Organon für das Theater (Breviario di estetica teatrale; edito nel 1949), forse il
suo testo teorico più maturo e importante. Nell’ottobre si trasferisce a Berlino (settore orientale).
Gli anni del secondo soggiorno berlinese: 1948-1956
1949. Riprende la pubblicazione dei Versuche, interrotta negli anni dell’esilio. La ormai celebre
messinscena-modello di Madre Courage al Deutsches Theater, con la Weigel come protagonista, segna
la nascita del Berliner Ensemble, successivamente attivo (a partire dal 1954) nel Theater am
Schiffbauerdamm. Porta a termine Die Tage der Commune (I giorni della Comune), iniziato in Svizzera
nel 1948 ed allestito al Karl-Marx-Stadt nel 1956. Vengono pubblicate le Kalendergeschichten (Storie
da calendario).
1950. È nominato membro della Akademie der Künste (Accademia delle arti). Rielabora per il Berliner
Ensemble Der Hofmeister (Il precettore) di J.M.R. Lenz. Ottiene la cittadinanza austriaca.
1951. Riceve il Premio nazionale di prima classe. Redige il Herrnburger Bericht (Rapporto di
Herrnburg), scene con musica di Paul Dessau scritte e rappresentate per il Festival mondiale della
gioventù a Berlino. Stampa la raccolta di versi Hundert Gedichte (Cento poesie).
1952. Rielabora il Don Juan di Molière (Rostock, 1952) e il radiodramma Der Prozess der Jeanne d’Arc
zu Rouen 1431 (Il processo di Giovanna d’Arco a Rouen nel 1431; Berlino, 1952). Inizia il rifacimento
del Coriolano di W. Shakespeare, che nel 1953 resta per altro frammento (rappresentato a Francoforte
sul Meno nel 1962).
1953. Viene eletto presidente del PEN-Zentrum. Il 17 giugno invia una lettera aperta a W. Ulbricht in
seguito alla sollevazione operaia di Berlino-Est; essendo stata pubblicata solo l’ultima frase, indirizza a
Ulbricht un secondo messaggio il 21 giugno.
1954. Riceve il Premio Stalin per la pace. Partecipa con il Berliner Ensemble al Festival internazionale
del teatro di Parigi, dove la messinscena di Madre Courage riceve il primo premio.
1955. Rielabora L’ufficiale reclutatore di J. Farquhar col titolo Pauken und Trompeten (Tamburi e
trombe; messo in scena a Berlino nello stesso anno).
1956. Assiste alla prima dell’Opera da tre soldi al Piccolo Teatro di Milano. Lavora alle prove del
Galilei. Interviene al IV congresso degli scrittori tedeschi. Invia al Bundestag una lettera aperta contro il
riarmo della Germania. Il 14 agosto muore di infarto miocardico a Berlino e viene sepolto nel
Dorotheenfriedhof, accanto alla tomba di Hegel.
Da BERTOLT BRECHT, Scritti teatrali, vol. I, Teoria e tecnica dello spettacolo
(1918-1942), Einaudi, Torino 1975 [prima ed. in vol. unico 1962]
Dialogo sull’arte della recitazione
—Gli attori hanno sempre grande successo con i tuoi lavori. Ma tu sei soddisfatto di
loro?
—No.
—Perché recitano male?
—No, perché recitano in modo sbagliato.
—Come dovrebbero recitare?
—Per un pubblico dell’era scientifica.
—Sarebbe a dire?
—Mostrando quello che sanno.
—In che senso?
—Circa i rapporti umani, i comportamenti umani, le forze umane
—Bene, queste cose le devono sapere. Ma come le possono mostrare?
—Proponendole consapevolmente. Descrivendole.
—E invece adesso come fanno?
—Si aiutano con la suggestione. Mettono se stessi e il pubblico in uno stato di trance.
—Citami un esempio.
—Devono rappresentare un commiato, un addio. E che fanno? Si mettono nello stato
d’animo dell’addio. Vogliono che il pubblico entri nello stato d’animo dell’addio.
Finisce che, se la «seduta» riesce, nessuno vede nulla, nessuno impara nulla. Nel
migliore dei casi la gente ricorda: tutti «sentono», insomma.
—Tu stai descrivendo un processo quasi erotico. Ma come dovrebbe essere, invece?
—Spirituale, cerimoniale, rituale. Spettatori e attori non devono avvicinarsi, ma
allontanarsi gli uni dagli altri. Ciascuno dovrebbe allontanarsi perfino da se stesso.
Altrimenti svanisce lo sgomento necessario alla presa di conoscenza.
—Poc’anzi hai usato il termine «scientifico». Intendevi dire che l’ameba quando viene
osservata non dà confidenza all’uomo; ma l’uomo scientifico cerca di capirla. Finisce
per capirla, almeno?
—Non lo so. Desidera metterla in relazione con altre cose già note.
—L’attore non dovrebbe dunque cercare di rendere comprensibile il personaggio che
rappresenta?
—Non tanto il personaggio, piuttosto i fatti. Vale a dire: se voglio vedere Riccardo III
non devo sentirmi Riccardo III, ma voglio vedere questo fenomeno con distacco, in
tutta la sua estraneità e incomprensibilità.
—Dovremmo dunque andare a teatro per acquisire cognizioni scientifiche?
—No, per vedere del teatro.
—Capisco. Anche il tipo scientifico, come tutti gli altri, ha un suo teatro.
—Sì. Oggi il teatro ha per spettatore il tipo scientifico ma non si rivolge ad esso.
Perché questo spettatore lascia la propria intelligenza in guardaroba insieme al
soprabito.
—E tu non puoi dire all’attore come deve recitare?
—No. Egli oggi dipende per intero dallo spettatore, gli soggiace ciecamente.
—Non hai mai provato?
—Come no. Lo faccio continuamente.
—E l’attore è riuscito a fare come gli dici?
—Sì, qualche volta; quando era dotato ma ancora ingenuo, quando ancora si divertiva a
recitare. Ma, anche in questo caso, sempre soltanto alle prove, in presenza mia e di
nessun altro, fintantoché, insomma, si trovava di fronte al tipo di spettatore di cui ti
dicevo. Ma quanto più si avvicinava il momento della rappresentazione tanto più egli si
scostava dalle mie indicazioni, diventava un altro. Sentiva benissimo che, così, al
pubblico non sarebbe piaciuto.
—E tu credi che davvero non sarebbe piaciuto?
—Lo temo. Comunque sarebbe stato un grosso rischio.
—La cosa non potrebbe maturare poco alla volta?
—No. Perché in questo caso non nascerebbe poco alla volta un qualcosa di nuovo per
lo spettatore, ma sparirebbe poco alla volta qualcosa di vecchio. E lo spettatore, poco
alla volta, smetterebbe di venire a teatro. Perché la novità, data a piccole dosi, sarebbe,
in definitiva, data soltanto per metà, quindi priva di forza e di effetto. Qui non si tratta
di un miglioramento qualitativo ma di un radicale mutamento delle finalità; vale a dire,
il teatro non consegue in modo migliore una stessa finalità ma un’altra, secondo me,
cattiva fin dall’inizio. Che effetto farebbe un simile tentativo di introdurre merce di
contrabbando? L’attore verrebbe gratificato della qualifica di «notevole», punto e
basta. Ma non la sua arte, bensì egli stesso risulterebbe «notevole». Diventerebbe
«penetrante». D’altra parte il farsi notare, il sorprendere, è appunto una caratteristica di
questa nuova arte della recitazione. Oppure all’attore verrebbe mosso il rimprovero di
essere consapevole; e la consapevolezza è un’altra di tali caratteristiche.
—Si sono fatti tentativi del genere?
—Sì, alcuni.
—Citami un esempio.
—Recitando la parte dell’ancella nell’Edipo, un’attrice di questo nuovo tipo, per
annunziare la morte della sua regina gridava «Morta, morta!» con voce assolutamente
inespressiva ma penetrante; poi ripeteva «Giocasta è morta!» senza la minima
inflessione lamentosa, ma con una decisione, con un impeto così irrefrenabile, che il
nudo fatto della morte in quel momento faceva più effetto di quanto avrebbe potuto
farne qualsiasi personale espressione di dolore. L’attrice aveva concentrato l’orrore
non già nella voce ma nel volto; e sul viso imbellettato di bianco mostrava
l’impressione che la morte produce sulle persone presenti. Nel riferire che la suicida
era crollata come sotto la spinta di qualcuno, essa riusciva ad esprimere non tanto la
sua compassione per l’infelice regina quanto il trionfo di chi l’aveva spinta, di modo
che anche al più beatamente sentimentale degli spettatori apparisse chiaro il verificarsi
d’un evento decisivo, che lo voleva partecipe e consenziente. Con limpido e stupito
periodare, descriveva il delirio e le apparenti insanie della moritura; e nel tono
inequivocabile della battuta: «Come finì non lo sappiamo» — sobrio ma irrevocabile
rendimento d’omaggio — c’era la netta ricusa di dare qualsiasi altra notizia intorno a
quella morte. Ma, nel discendere i pochi scalini, la minuscola figuretta pareva lasciarsi
indietro una distanza abissale fra lo spazio vuoto dell’orrore e gli uomini della scena
sottostante, talmente lunghi erano i suoi passi. E, mentre tendeva le braccia al cielo
lamentandosi macchinalmente, la donna implorava pietà anche per sé, che aveva visto
la sventura. La sua alta e sonora esortazione: «Ed ora piangete!» contestava il diritto di
ogni altra precedente e ingiustificata lamentazione.
—E ha avuto successo?
—Modesto, tranne che fra gli intenditori. Quasi nessuno degli spettatori, a furia di
immedesimarsi nei sentimenti dei personaggi, aveva partecipato ai fatti spiritualmente
decisivi dell’azione; cosìcché l’evento mostruoso, decisivo, annunziato dall’ancella
rimase quasi privo di effetto per chi lo aveva considerato una mera occasione di
sensazioni nuove.
17 febbraio 1929
Critica dell’immedesimazione: la Poetica di Aristotele
1.
L’espressione «drammaturgia non aristotelica» richiede un chiarimento. Per
drammaturgia aristotelica (dalla quale un’altra vuole distinguersi, definendosi «non»
aristotelica), si intende tutta la drammaturgia a cui si adatta la definizione della tragedia
enunziata da Aristotele nella Poetica, almeno per quanto ne è, secondo noi, il punto
principale. Questo non è, a nostro modo di vedere, il noto canone delle «tre unità», cui
lo stesso Aristotele, come i più recenti studi hanno dimostrato, non dà particolare
rilievo. A noi sembra di maggiore interesse sociale ciò che Aristotele pone a finalità
della tragedia, e cioè la katharsis, la purificazione dello spettatore dalla paura e dalla
compassione, mediante l’imitazione di atti suscitatori di compassione e di paura. Tale
purificazione avviene in seguito a un processo psichico particolare: la
immedesimazione dello spettatore nei personaggi imitati dagli attori. Noi definiamo
«aristotelica» una drammaturgia quando essa provoca questa immedesimazione — non
importa se nel rispetto delle regole proposte da Aristotele o no. Lo speciale processo
psichico della immedesimazione si compie, nel corso dei secoli, in molte maniere
diverse.
2. Critica della «Poetica»
Fintantoché Aristotele (nel quarto capitolo della Poetica) parla, in linea generale, della
gioia di assistere alla rappresentazione imitativa, motivando tale piacere con
l’«apprendimento», noi siamo d’accordo con lui. Ma già nel sesto capitolo egli si fa più
preciso — e delimita, per la tragedia, il campo dell’imitazione. Soltanto, dunque, le
azioni suscitatrici di paura e di compassione dovrebbero venire imitate, e (seconda e
più stretta limitazione) all’unico fine di dissipare la compassione e la paura. Risulta
evidente che l’imitazione di persone operanti, effettuata dagli attori, deve indurre gli
spettatori ad imitare questi ultimi. Il modo di accogliere un’opera d’arte sarebbe quindi
l’immedesimarsi nell’attore e, per tramite suo, nel personaggio.
3. L’immedesimazione in Aristotele.
Non è che noi troviamo in Aristotele, come modo di accogliere l’opera d’arte, quel
genere di immedesimazione che oggi si ripete quando lo spettatore si immedesima
nell’individuo dell’alto capitalismo. Tuttavia, qualsiasi cosa vogliamo intendere per
«catarsi», quando questo fenomeno si verificava in circostanze a noi tanto estranee,
abbiamo motivo di supporre che, presso i greci, alla base di essa ci fosse una sorta di
immedesimazione. Se lo spettatore tiene un atteggiamento pienamente libero, critico,
preoccupato di trovar soluzioni puramente terrene alle varie difficoltà, ciò non può
servire da base per una catarsi.
4. Rinunzia soltanto temporanea alla immedesimazione?
Si può facilmente ammettere che la rinunzia alla immedesimazione, cui si è vista
costretta la drammaturgia del nostro tempo, sia un fatto puramente temporaneo,
risultante dalla difficile situazione della drammaturgia del capitalismo avanzato: poiché
essa deve pur offrire una propria rappresentazione della convivenza umana ad un
pubblico impegnato in una durissima lotta di classe, ma non può far nulla per
scongiurarla. La temporaneità d’una simile rinunzia non deporrebbe — almeno per noi
— a sfavore della rinunzia medesima. Ma non è molto incoraggiante che
l’immedesimazione vada riacquistando il suo antico posto, come avviene per la
religiosità, di cui essa è una forma. Se essa è marcita lo deve unicamente alla generale
putrefazione del nostro ordinamento sociale; ma non ha alcun motivo di
sopravvivergli.
Tesi sulla funzione dell’immedesimazione nelle arti teatrali
1.
Il teatro contemporaneo muove dal presupposto che la trasmissione d’un’opera teatrale
allo spettatore possa avvenire soltanto se questi si immedesima nei personaggi del
lavoro. Il teatro contemporaneo non conosce alcun’altra via per trasmettere un’opera
d’arte; e tutti i suoi progressi tecnici si limitano al perfezionamento del metodo più
adatto a provocare l’immedesimazione suddetta.
2.
Anche il complesso della costruzione scenica, sia naturalistica che allusiva, deve
contribuire alla totale e forzata immedesimazione dello spettatore nell’ambiente
rappresentato.
3.
Tale immedesimazione (= identificazione) — un fenomeno sociale che per una
determinata epoca storica rappresentò un grande progresso — sta diventando un
ostacolo sempre più grave per la funzione sociale delle arti rappresentative. La
borghesia in ascesa, dopo aver portato a poderoso sviluppo le forze produttive
mediante l’emancipazione economica della personalità individuale, si trovò interessata
a questa identificazione con la propria arte. Oggi, essendo la «libera» personalità
individuale divenuta di ostacolo ad un ulteriore sviluppo delle forze di produzione, la
tecnica dell’immedesimazione, in arte, ha perso la sua giustificazione. La personalità
singola deve cedere la propria funzione alle grandi collettività, ed è quanto appunto sta
accadendo, fra lotte accanite, sotto i nostri occhi. Dal punto di vista del singolo, gli
eventi decisivi dell’epoca nostra non possono più venire compresi, né possono venire
influenzati dalle singole personalità. Cadono con ciò i vantaggi della tecnica
dell’immedesimazione; ma la fine dell’immedesimazione non significa affatto la fine
dell’arte.
4.
I tentativi di trasformare la tecnica dell’immedesimazione in modo che questa si
verifichi a livello di collettività (di classi) non offrono molte prospettive di successo.
Condurrebbero ad astrazioni grossolane e irrealistiche delle persone e delle collettività
al tempo stesso. La parte della personalità singola nell’ambito della collettività sta
diventando non rappresentabile, quantunque proprio essa sia della massima
importanza.
5.
Le arti teatrali si trovano poste di fronte al compito di perfezionare una nuova maniera
di trasmettere l’opera d’arte allo spettatore. Devono anzitutto rinunziare a «guidarlo»,
come in virtù d’un monopolio che non ammette contraddizioni né critiche, e cercar di
offrirgli rappresentazioni di umana convivenza sociale tali da render possibile, anzi, da
organizzare, un suo atteggiamento critico, eventualmente contraddittorio, di fronte ai
fatti rappresentati ed alla rappresentazione dei medesimi.
6.
I fatti devono dunque, in primo luogo, venire comunicati allo spettatore in tutta la loro
sconcertante e sorprendente singolarità. Ciò è necessario affinché essi gli si presentino
sotto il loro aspetto dominabile e, da noti, divengano conosciuti.
7.
Con questo, le arti teatrali liquidano gli avanzi della mentalità culturale rimasti loro
incollati addosso dalle epoche precedenti; ma passano anche dallo stadio in cui
aiutavano a interpretare il mondo a quello in cui aiutano a trasformarlo.
8.
Tale capovolgimento delle funzioni sociali rende necessaria una riforma radicale della
tecnica.
9.
Ma non elimina affatto i sentimenti dall’arte, come si potrebbe temere. Trasforma però
senza misericordia la funzione sociale delle emozioni, che oggi giocano in favore di chi
sta al potere. Togliendo all’immedesimazione il suo posto predominante, non si
sopprimono le reazioni sentimentali che dipendono dagli interessi e che li favoriscono.
La tecnica dell’immedesimazione permette appunto di organizzare reazioni
sentimentali assolutamente estranee agli interessi. Uno spettacolo che faccia ampia
rinunzia all’immedesimazione permetterà una presa di posizione in base ad interessi
riconosciuti validi, una presa di posizione, cioè, il cui lato sentimentale concordi
perfettamente col lato critico.
Il filosofo a teatro
[L’INTERESSE DEI FILOSOFI]
Fino dai tempi antichi i filosofi hanno sempre prestato molta attenzione al teatro.
Aristotele scrisse un trattato classico sull’argomento e Bacone ne trattò dal punto di
vista pedagogico. Alcuni giungono perfino a supporre ch’egli fosse molto vicino al
teatro di Shakespeare. Voltaire e Diderot acquistarono fama sia come filosofi che come
commediografi, e così pure, fra i tedeschi, Lessing. Di tutti i grandi autori teatrali si
dice che avessero per maestro un determinato filosofo, come Schiller ebbe Kant, ad
esempio.
In effetti, la gente di teatro tratta argomenti che dovrebbero interessare molto i filosofi,
e cioè il comportamento, le opinioni, le azioni umane e relative conseguenze.
IL TIPO DI ATTIVITÀ FILOSOFICA
Se dello scrivere ed eseguire lavori teatrali ho fatto una consuetudine filosofica, senza
preoccuparmi di quanto gli altri potessero intendere, ora devo pure in qualche modo
precisare questo tipo di attività filosofica, perché oggigiorno — e già da molto tempo
— per filosofare si intende un qualcosa di molto preciso, cui io non volevo affatto
alludere.
Per natura io non ho alcuna attitudine alla metafisica; come si possano pensare tante
cose e conciliare i vari concetti tra loro, tutto questo è turco per me. Perciò mi attengo a
un tipo di filosofia molto corrente, in ispecie presso il popolino — alla filosofia cui
allude la gente quando ti dice: «Va’a farti consigliare da quel tale: è un filosofo»,
oppure: «Quello si è comportato da vero filosofo!» Vorrei qui, tuttavia, fare una sola
distinzione. Quando il popolo attribuisce a qualcuno un atteggiamento filosofico allude
quasi sempre ad una capacità di sopportazione. Nel pugilato si fa distinzione fra «buoni
incassatori» e «buoni picchiatori». Il popolo per filosofi intende «quelli che incassano»
— e ciò deriva dalla sua situazione. Io, invece, per filosofare voglio intendere l’arte di
prenderle e di darle, quando si combatte; ma in quanto al resto, circa il significato del
termine, rimango, come ho già detto, d’accordo col popolo. È dunque semplicemente
l’interessarsi al comportamento degli uomini, il giudicare delle arti mediante le quali
essi creano la propria vita — un interessamento assolutamente pratico, dunque, e
utilitaristico — ciò che contraddistingue un filosofo di questo genere; e i concetti della
filosofia accademica e dotta potranno inserirsi in questa filosofia di strada (che è poi
una filosofia empirica) soltanto in quanto siano strumenti per far girare concretamente
le cose — cose, non altri concetti! E se l’utile dovesse apparire un tantino prosaico,
allora noi dovremmo guardare al prosaico con occhi nuovi e rinunziare al sentimento
poetico, piuttosto che dispensarlo dall’essere utile.
[L’ATTIVITÀ TEATRALE]
1. Come una fra le varie forme di pubblica espressione.
Per «fare del teatro» (parlando sia di autori che di attori) si intende tradizionalmente
questo: essere indotti a presentarsi in pubblico, sui palcoscenici, da una certa attitudine,
da un certo desiderio di riprodurre avvenimenti reali, oppure di travestirsi e imitare
altre persone. La gente di teatro esercita semplicemente il proprio mestiere in teatro,
così come i panettieri lo esercitano nelle panetterie. Il teatro ha una storia antica, un
suo posto ben definito fra le diverse istituzioni; ha pure una sua tecnica e procura un
certo tipo di godimento, il cui verificarsi dipende dall’osservanza, da parte dei teatranti
come degli spettatori, di regole talmente antiche da non essere quasi più ricordate come
regole. Bisogna tener presente tutto questo per comprendere quale atto di violenza
occorra compiere su noi stessi volendo considerare così, all’improvviso (anche per la
sola durata di un’indagine) una cosa tanto sottintesa qual è il far del teatro come una fra
le tante forme, fra le tante maniere di esprimere pubblicamente la propria opinione su
faccende di pubblico interesse. Ma questo appunto dobbiamo fare.
Dobbiamo per un certo tempo — per la durata della nostra indagine, immaginare che
alcune persone abbiano desiderio di far pubbliche enunciazioni su questioni di
pubblico interesse, servendosi del teatro. Non come se nei lavori e nelle
rappresentazioni teatrali enunciazioni del genere non fossero mai state fatte! Ma è cosa
ben diversa immaginare che il teatro debba servire esclusivamente a tale scopo, cioè
consistere per intero nelle enunciazioni di cui si è detto, e che le persone in questione,
fra le tante maniere di esprimersi, abbiano scelto appunto il teatro. Chi giunge al teatro
con simili propositi, ne lascia, naturalmente, in disparte molti elementi consueti, se
inutili al proprio scopo; lo riorganizza a nuovo, non si limita a fornirgli le nuove
enunciazioni, ma conduce il teatro stesso verso esse, che potrebbero venir espresse in
vari modi. Supponiamo si tratti di filosofi. In tal caso, se si è seguito il nostro
ragionamento, essi non sarebbero uomini di teatro filosofeggianti, bensì filosofi
occupati a far del teatro: vale a dire, assai meno impegnati verso il teatro che non verso
la filosofia. Quindi, facendo del teatro lascerebbero forse in disparte tutto ciò che non
si adatta alla loro filosofia — ma non mai dalla filosofia ciò che non si adatta al teatro.
Vorrebbero descrivere come vanno le cose nel mondo, come si comportano gli uomini
gli uni verso gli altri, forse scoprire modi di comportamento tali da render più saggi gli
uomini, e perfezionare il teatro fino a renderlo capace di tanto. Come chiunque potrà
immaginare, il teatro, quest’antica e consueta istituzione, distolto da tante altre e volto
a quest’unica finalità, muterebbe notevolmente il suo antico aspetto.
2. Il teatro come determinata forma di pubblica espressione.
Non potremo mai renderci conto abbastanza che il vecchio teatro di cui ci occupiamo
(vecchio per longevità, e vecchio in rapporto all’età nuova) è una forma determinata di
pubblica espressione, non una qualsiasi, non cioè tale da permetterci di misurarla
senz’altro col metro usualmente applicabile agli altri mezzi di pubblica espressione.
Sui palcoscenici accadono molti fatti presi dalla vita reale; ma, mentre nella vita noi li
sottoponiamo a critiche d’ogni genere, a teatro li sentiamo espressi in termini tali che
in nessun altro luogo accetteremmo senza diffidenza. Esistono nozioni scientifiche,
ogni giorno più precise, intorno ai moti dell’anima, scienze che si occupano di
problemi economici e avvenimenti storici, e che ci permetterebbero di valutare le cose
che anche il teatro ci rappresenta; ma non ci passa neppure per la mente di applicare al
teatro tali cognizioni e tali metodi. Lasciamo al teatro il compito di informarsene e da
esso accettiamo giudizi sul mondo e sulla vita che non accetteremmo in nessun’altra
sede. Come non prenderemmo sul serio gli anatomisti se pretendessero di criticare i
quadri del grande Greco in base alla loro conoscenza della struttura ossea, così
volgiamo le spalle agli storici i quali rimproverano a Shakespeare di non aver reso
comprensibile agli economisti, nel suo Giulio Cesare, il modo d’agire di Bruto. Noi ci
accontentiamo del piacere di veder il mondo rispecchiato e ingrandito dall’occhio di un
determinato nostro simile e diamo perciò carta bianca a taluni artisti particolarmente
dotati, autorizzandoli a raffigurare il mondo come meglio credono, purché riescano a
trasmetterci tutte le loro sensazioni.
Tutto questo ci è entrato talmente nel sangue che nel momento stesso in cui diamo
carta bianca all’arte e abdichiamo al nostro discernimento, dovremmo venir colti dal
sospetto di non voler avere più nulla a che fare con l’arte. Prendere l’attività teatrale
per una fra le tante forme di pubblica espressione significa, né più né meno, che voler
sottoporre tali espressioni alle critiche cui generalmente vengono sottoposte; significa
non pretendere più che gli spettatori chiudano un occhio ma pretendere dai teatri una
rinunzia a tutte le pratiche che inducono gli spettatori a chiudere un occhio. Una simile
rinunzia demolisce l’arte teatrale. […]
Frammentario
[I FATTI CELATI DIETRO AI FATTI]
1. Intesi come fatti che accadono fra gli uomini.
Sarà forse già apparso chiaro che i filosofi, i descrittori del mondo, i maestri di
comportamento dei quali parliamo si interessano in modo particolare ai destini umani.
Essi non si limitano ad elencare sistematicamente le reazioni degli individui al proprio
destino ma intervengono e mettono mano nel destino stesso. Le reazioni umane le
descrivono unicamente dal lato da cui possono venir considerate come azioni; ma il
destino lo descrivono come un’attività umana. I fatti che lo determinano, quelli celati
dietro i fatti e intervenendo nei quali si può influire sul destino umano, accadono
dunque fra gli uomini.
L’oggetto della rappresentazione è pertanto un intreccio di rapporti umani e sociali.
Una simile rappresentazione è fuori dell’ordinario e non può essere intesa se non è
intesa come insolita. Sulle scene del vecchio teatro vediamo forse qualcos’altro, oltre
agli uomini? Fatti da non potersi comprendere senza riferirsi a qualcosa di diverso
dalle attività umane?
Per dirla in altre parole, dal nostro punto di vista: fatti che debbano venir compresi con
qualcosa di meno — compresi, cioè, senza che in ogni loro fase vengano mostrati
uomini all’opera?
2. Recitare ciò che accade dietro i fatti.
In un certo senso ci si potrebbe domandare: «Che cosa può esserci di così sorprendente
nei fatti costituenti la nostra vita, la nostra convivenza con altri uomini? Non sono fatti
assolutamente naturali? Si ripetono di continuo, fanno parte dei fenomeni di natura.
Coloro i quali li dominano non se ne meravigliano eccessivamente; se ne meravigliano,
semmai, coloro i quali finiscono sotto le ruote. Non si può forse dire: «Se il terreno è
troppo pietroso la segala non cresce bene», non c’è nulla di strano? Oppure: «Se
qualcuno non paga la pigione viene sfrattato», non c’è nulla di sorprendente?
Bene, secondo l’opinione dei filosofi non lo si può dire. Certo, lo si dice, ma è
perlomeno una stranezza. Comunque, c’è della gente che non pronunzia mai la prima
delle frasi sopra riportate — ma la seconda sì. Costoro un giorno si stupirono che il
terreno pietroso producesse segala corta di stelo; cercarono una qualità di seme che
crescesse bene anche nei terreni pietrosi e la trovarono. Il loro stupore fu dunque
ricompensato. Eppure, per l’appunto costoro continuarono a pronunziare la seconda
delle due frasi. Possedevano non soltanto terreni ma anche case e ne scacciavano
spietatamente gli inquilini se non pagavano l’affitto. Questo modo di procedere —
dicevano agli sfrattati — non era affatto sorprendente. Ma perché mai gli inquilini, dal
canto loro, non avrebbero dovuto stupirsene? Forse anche il loro stupore verrà
ricompensato?
Per dirla in termini tecnici: come si può far apparire strano, rendere inaccettabile uno
sfratto, un evento di massa nelle nostre grandi città?
Un uomo in uniforme porta un documento in forza al quale gli inquilini devono
mettere i loro mobili in mezzo alla strada. Non è chiaro? Non è così da tanto tempo?
Sì, è così da tanto tempo. E allora non è naturale? No, non è naturale.
Oggi è così, da tanto tempo è così — ma non è sempre stato così. In una caverna
dell’età della pietra, ad esempio, nessuno portava simili documenti o lastre di pietra
con su inciso un testo del genere. E neppure nelle capanne dei contadini medievali.
Naturalmente, anche allora qualcuno veniva scacciato, ma non in questo modo.
L’uomo inviato per farlo non lo aveva stipendiato lo stato perché recapitasse quella tale
lettera. Le persone costrette a sloggiare erano in un altro rapporto con lui, e via
dicendo. Comunque sia, dietro un fatto se ne cela un altro. Il solo fatto rappresentato
non contiene ancora la chiave. Ci sono, per così dire, troppo poche persone sulla scena
perché, agli occhi dello spettatore, la spiegazione possa emergere da sé. I soli presenti
non possono offrire altra soluzione all’infuori di quella rappresentata. Il fatto non lo si
può veramente comprendere — e ciò dev’essere dimostrato.
Si può procedere, e solitamente si procede, così: si esaminano i fatti storici usati come
termini di paragone cercando in essi gli aspetti rimasti immutati anche presso di noi. Il
pagamento della pigione diventa «comprensibile», vale a dire, passa inosservato, se si
considerano canoni di affitto anche i tributi in natura versati dai contadini-vassalli
medievali. Lo sfratto passa inosservato se sfratti si considerano le cacciate dei
cavernicoli dalle loro caverne, all’età della pietra. Ma così facendo si dà un colpo di
spugna su ogni aspetto particolare, attuale della vicenda. I mutamenti avvenuti nei
processi sociali non vengono più descritti come mutamenti — cioè, non più da questo
lato del divenire e del modificarsi — bensì come ripetizioni. Gli sforzi rinnovatori in
campo sociale non appaiono quindi sotto il loro aspetto più significativo, non risultano
plasticamente evidenti. Unicamente i modi di procedere capaci di provocare un
mutamento radicale dovrebbero essere intesi e descritti come novità.
Che cosa sono dunque i fatti celati — e da scoprirsi — dietro i fatti, alla luce dei quali
quelli normalmente considerati consueti dovrebbero invece apparirci ignoti ed
estranei?
Scelgo per la mia vicenda un titolo adattabile a un capitolo della storia, tale dunque da
potersi adattare, insieme a molti altri, a una storia politica o di costume.
Lo sgombero forzato d’una abitazione è un evento di massa e, come tale, d’importanza
storica. Io devo presentarlo in modo che questa sua importanza storica possa venir
compresa. Come evento di massa (e questo soltanto ne fa un momento storico), esso
riguarda un certo disoccupato — un signor X qualsiasi. Si potrebbe dunque supporre
che costui debba essere presentato unicamente nella sua anonimità, cioè nella sua
indeterminatezza di appartenere a una massa, privo di caratteristiche personali, come il
disoccupato X, insomma. Ma sarebbe un errore. Fa parte della storicità d’un
avvenimento (d’uno sfratto come questo), che lo sfrattato sia un signor X. Ma della
storia fa pure parte il fatto che il signor X sia un individuo, un determinato uomo con
determinate qualità, assolutamente diverso da tutti gli altri sfrattati. Lo chiameremo
dunque Franz Dietz. Allora la sua lotta consisterà appunto nel non voler essere un X
qualsiasi, un numero per l’ufficio del registro, un corpo di troppo per il padrone di
casa; se poi questo corpo che rende indisponibile un alloggio debba avere i baffi biondi
o neri, essere sano o malato e via dicendo, non farà, naturalmente, alcuna differenza.
Ma l’evento storico dovrà consistere appunto nella lotta sostenuta da Dietz per non
venir trattato come un X qualsiasi; il modo in cui Dietz, per evitare di essere
cancellato, disumanizzato, trarrà profitto proprio dall’appartenenza alla massa che lo
degrada a un X — ecco, questo sarà storia.
L’ARTE DI MOSTRARE IL MONDO IN MODO CHE DIVENTI DOMINABILE
Chi voglia mostrare il mondo in modo ch’esso diventi dominabile farà bene, anzitutto,
a non parlare di arte, a non orientarsi sui suoi canoni, a non aspirare ad essa.
Addossando all’arte un simile compito, infatti, si potrà giungere, tutt’al più, a
spiacevoli compromessi; l’arte, bene o male, proseguirà per la propria strada senza
cessare d’esser tale, mentre coloro si vedranno continuamente costretti a perseguire i
propri fini nell’ambito dell’arte. L’Arte — quest’antica, gloriosa potenza, ricca di
esperienze, appoggiata da istituzioni e da professionisti eruditi — accondiscenderà
contro voglia a propugnare alcune delle nuove tendenze, insieme alle sue molte altre
più antiche; ma i nostri filosofi dovranno assecondarla nel servire a tutte le sue
tendenze più antiche. Se invece rinunzieranno a parlar d’arte, ad orientarsi sui canoni
dell’arte, ad aspirare all’arte, potranno promuovere senza ritegni la propria causa, senza
per questo dover rinunziare completamente ai servigi dell’arte. Infatti, beninteso dopo
attento esame, essi potranno usare liberamente per le proprie finalità di tutte le
esperienze, le nozioni professionali, le istituzioni artistiche. Inserendola unicamente
laddove è necessaria alle loro finalità, essi potranno costruire un’arte; perché sarà
indubbiamente un’arte quella di presentare il mondo in modo ch’esso diventi
dominabile.
Teatro di divertimento o teatro d’insegnamento?
Quando, alcuni anni fa, si parlava di teatro moderno, i teatri che si nominavano erano
quelli di Mosca, New York e Berlino. Si parlava forse anche di questo o di quello
spettacolo di Jouvet a Parigi o di Cochran a Londra, oppure della messinscena del
Dybbuk dell’Habima, che in realtà appartiene anch’essa al teatro russo, poiché il suo
regista era Vachtangov; ma, tutto sommato, di capitali moderne del teatro ce n’erano
soltanto tre.
I teatri russi, americani e tedeschi si differenziavano nettamente tra loro, ma avevano in
comune un carattere: quello di essere moderni, ossia di applicare innovazioni tecniche
ed artistiche. In certo senso, anzi, presentavano delle affinità nel campo stilistico, e
questo proprio perché la tecnica è internazionale (non solo per ciò che riguarda le
esigenze immediate della scena, ma anche per ciò che esplica un’influenza su di essa,
come ad esempio il cinema) e perché si trattava sempre di grandi e progredite città in
grandi paesi industriali. In tempi più recenti, il teatro berlinese parve tuttavia svolgere
una funzione di guida su tutti gli altri paesi di antico capitalismo: in esso, ciò che è
comune al teatro moderno riuscì per un certo tempo ad esprimersi nella maniera più
forte e momentaneamente più matura.
L’ultima fase del teatro berlinese, nella quale — come abbiamo detto — più
chiaramente si manifestò in tal modo solo la linea tendenziale di sviluppo del teatro
moderno, corrispose al cosìddetto teatro epico. Tutto quello che prese i nomi di
Zeitstück [dramma d’attualità], Piscatorbühne [teatro di Piscator], o Lehrstück
[dramma didattico] appartiene al teatro epico.
Il teatro epico.
Il termine «teatro epico» apparve a molti contraddittorio in se stesso, in quanto che,
secondo l’insegnamento di Aristotele, la forma epica e la forma drammatica di esporre
una vicenda venivano considerate come qualche cosa di assolutamente diverso. La
differenza tra le due forme, tuttavia, non veniva assolutamente ravvisata nel solo fatto
che l’una fosse rappresentata da esseri viventi, mentre l’altra si valeva del libro: opere
epiche come i poemi omerici, o quelli dei cantori medievali, erano
contemporaneamente anche rappresentazioni teatrali, e drammi come il Faust di
Goethe o il Manfredi di Byron, per generale riconoscimento, avevano esplicato la loro
massima efficacia come libri. La differenza tra la forma drammatica e la forma epica
veniva già ravvisata, conforme ad Aristotele, nella diversità delle tecniche costruttive,
le cui leggi erano trattate da due diverse branche dell’estetica. Le due tecniche
dipendevano dal diverso modo in cui le opere venivano presentate al pubblico, queste
mediante la scena, quelle mediante il libro; ma, a prescindere da ciò, era ben possibile
che opere epiche contenessero dementi drammatici, e viceversa. Il romanzo borghese
del secolo passato sviluppa non poca materia «drammatica», se si intende con questo la
forte concentrazione di una trama, un momento di reciproca complementarietà delle
singole parti. Un certo tono appassionato nell’esposizione, un forte rilievo dato al
reciproco cozzare delle forze in gioco, erano i segni distintivi di questa
«drammaticità». Un narratore come Döblin caratterizzò perfettamente la situazione
quando disse che l’epica, al contrario della drammatica, poteva essere tagliata con le
forbici in tanti pezzi, ciascuno dei quali conservava tutta la sua vitalità.
Non è qui il luogo di approfondire le ragioni per le quali il divario fra epica e
drammatica, per tanto tempo ritenuto insormontabile, abbia finito col perdere tale
carattere di rigidità; ci limiteremo ad accennare al fatto che attraverso mere conquiste
tecniche la scena era stata posta in grado di immettere elementi narrativi nelle
rappresentazioni drammatiche. La possibilità delle proiezioni, di una maggiore
trasformabilità della scena grazie a procedimenti meccanici, il cinema, vennero ad
integrare l’attrezzamento scenico precisamente al momento in cui non era più tanto
semplice rappresentare i principali eventi umani mediante una personificazione delle
loro forze motrici o col porre i personaggi sotto l’influsso di invisibili forze
metafisiche,
Per la comprensione di quegli avvenimenti era diventato necessario dare un grande,
«significativo», rilievo al mondo, all’ambiente nel quale vivevano gli uomini.
Questo mondo era senza dubbio già apparso nel teatro precedente, ma non come
elemento a sé stante, bensì soltanto nella prospettiva del personaggio centrale del
dramma. Esso nasceva dal modo come l’eroe reagiva su lui; era visto come può esser
vista una tempesta da chi osservi, su una superficie acquea, le navi che spiegano le vele
e le vele che si inclinano. Nel teatro epico, invece, doveva formare oggetto
d’attenzione in sé e per sé.
La scena incominciò a raccontare. Non era più assente, oltre alla quarta parete, anche il
narratore. Non era solo lo sfondo scenico a prendere posizione di fronte agli
avvenimenti che si svolgevano alla ribalta, col rievocare su grandi cartelli altri
avvenimenti che nello stesso momento si svolgevano in altri luoghi, col presentare o
col contrapporre, mediante la proiezione di documenti, parole dette da determinate
persone, con l’opporre a discorsi astratti cifre concrete, materialmente percepibili, con
l’arricchire di cifre e di frasi vicende plasticamente evidenti, ma il cui significato
poteva essere ambiguo; anche gli attori non compivano più una trasformazione
completa, ma mantenevano un distacco rispetto al personaggio da loro interpretato e
giungevano fino a sollecitarne palesemente una critica.
Nessun aspetto della rappresentazione doveva più consentire allo spettatore di
abbandonarsi, attraverso la semplice immedesimazione, ad emozioni incontrollate (e
praticamente inconcludenti). La recita sottoponeva dati e vicende a un processo di
straniamento: quello straniamento che è appunto necessario perché si capisca. A forza
di dire: «Si capisce che è così», si rinunzia semplicemente a capire.
Il «naturale» doveva assumere l’importanza del sorprendente: solo così potevano
venire in luce le leggi di causa ed effetto. Il comportamento degli uomini doveva
contemporaneamente essere così e contemporaneamente poter essere diverso.
Erano cambiamenti di grande portata.
Lo spettatore del teatro drammatico dice: «Sì, anch’io ho provato questo sentimento.
— Sì, anch’io sono così. — Be’, questo è naturale. — Sarà sempre così. — La
sofferenza di quest’uomo mi commuove, perché non ha altra via d’uscita. — Questa è
grande arte: qui tutto è ovvio, è evidente. — Io piango con quello che piange, rido con
quello che ride».
Lo spettatore del teatro epico dice: «A questo non ci avrei pensato. — Questo non si
deve fare così. — È sorprendente, quasi inconcepibile. — Non può andare avanti così.
— La sofferenza di quest’uomo mi commuove, perché avrebbe pure una via d’uscita!
— Questa è grande arte: qui non c’è nulla di ovvio. — Io rido di quello che piange,
piango di quello che ride».
Il teatro didattico.
La scena incominciò ad avere l’efficacia di un insegnamento. Il petrolio, l’inflazione,
la guerra, le lotte sociali, la famiglia, la religione, il grano, il mercato del bestiame
diventavano oggetto di rappresentazione teatrale. Mediante cori lo spettatore era
istruito in merito a circostanze di fatto a lui ignote. Mediante film si mostravano
montaggi di avvenimenti in tutto il mondo. Mediante proiezioni si portavano a
conoscenza dati statistici. Erano altrettanti modi di mettere in rilievo i vari «sfondi», e
ciò equivaleva ad esporre alla critica l’operato dell’uomo. Venivano mostrati
comportamenti sbagliati e giusti, uomini che sapevano quello che facevano e uomini
che non lo sapevano. Il teatro divenne accessibile ai filosofi, beninteso a filosofi che si
proponessero non solo di spiegare il mondo, ma anche di cambiario, Dunque, si
parlava di filosofia; dunque, s’insegnava. E allora, che ne era più del divertimento? Ci
si doveva sedere di nuovo sui banchi di scuola ed essere trattati da analfabeti?
Bisognava passare degli esami, sforzarsi di avere dei bei voti? Secondo l’opinione
diffusa, tra imparare e divertirsi la differenza è molto forte. Imparare può essere utile,
ma solo divertirsi è piacevole. Occorre perciò difendere il teatro epico contro il
sospetto che debba essere qualcosa di assai spiacevole, di noioso, o addirittura di
faticoso.
Ci basterà allora osservare che la contrapposizione fra studio e divertimento non
corrisponde affatto a una legge di natura, non è qualcosa di immutato e di immutabile.
Indubbiamente lo studio, quale lo abbiamo conosciuto a scuola, nella preparazione
professionale ecc., è qualcosa di deprimente. Ma si rifletta anche in quali circostanze si
svolge e a quale scopo si rivolge.
Esso è in realtà una compra. La scienza non è altro che merce, che viene comperata per
essere rivenduta. Chiunque non sia più in età di sedersi sui banchi di scuola, deve
praticare lo studio, per così dire, in assoluta segretezza; poiché chi ammette di dover
ancora imparare, si svaluta e si pone al livello di chi sa troppo poco. Inoltre, l’utilità
dello studio è fortemente limitata da fattori estranei alla volontà di chi studia. Contro la
disoccupazione non c’è sapere che tenga; e la divisione del lavoro rende inutile e
impossibile ogni sapere multiforme. Sicché lo studio finisce col diventare lavoro
proprio di coloro che non hanno alcun bisogno di lavorare. Non è il molto sapere che
procura potenza, ma è molto quello che ci si può procurare solo se si è potenti.
Assai diversa è l’importanza che lo studio ha per i diversi strati sociali. Alcuni di questi
non pensano affatto a migliorare le loro condizioni di vita, poiché le giudicano ben
soddisfacenti. Si dica quel che si voglia del petrolio, essi ci guadagnano sopra. Inoltre
si sentono già un po’attempati: non gli restano più molti anni da vivere. E allora, a che
pro studiate tanto? Hanno già detto la loro ultima parola e amen. Ma vi sono altri strati
sociali, quelli «il cui momento non è ancora venuto», e che si sentono scontenti dei
rapporti in cui vivono: costoro hanno per lo studio uno smisurato interesse pratico,
vogliono assolutamente orientarsi, sanno che, senza lo studio, saranno perduti. Essi
sono i migliori, i più avidi studiosi. Le medesime differenze valgono anche fra paesi,
fra popoli. Il desiderio d’imparare dipende dunque da vari fattori; ma non si può negare
l’esistenza di un entusiasmo per lo studio, di uno studio gioioso e combattivo.
Se non vi fosse questa possibilità di studiare divertendosi, allora veramente il teatro,
per quella che è tutta la sua struttura, non sarebbe assolutamente in grado d’insegnare.
Il teatro rimane teatro, anche se insegna; e, nella misura in cui è buon teatro, è
divertente.
Teatro e scienza.
«Ma che cos’ha in comune la scienza con l’arte? Sappiamo benissimo che la scienza
può essere divertente; ma non tutto ciò che diverte rientra necessariamente nel dominio
del teatro».
Spesso mi è accaduto di ascoltare, quando insistevo sui servizi inestimabili che la
scienza moderna, se rettamente usata, può rendere all’arte e in particolare al teatro,
l’affermazione che l’arte e la scienza siano due campi dell’attività umana
stimabilissimi, ma totalmente diversi. Questo è naturalmente un marchiano luogo
comune, e si farà bene a rispondervi sempre di sì, che è giustissimo, come lo è la
maggior parte dei luoghi comuni. Il piano della scienza e quello dell’arte sono
diversissimi, d’accordo. Eppure io devo confessare, per quanto sgradevole ciò possa
apparire, che non riesco a lavorare come artista senza servirmi di un certo bagaglio
scientifico. È possibile che tale fatto susciti in molte persone seri dubbi circa le mie
capacità artistiche: costoro sono avvezzi a vedere, nei poeti, esseri singolari, in certo
modo fuori della natura, che con la sicurezza di autentici dèi intuiscono cose che gli
altri non possono penetrare se non a costo di duri sforzi e di grande studio. È
spiacevole, evidentemente, dover ammettere di non appartenere a codesta schiera di
eletti; ma bisogna ammetterlo. Bisogna anche negare che tali confessati interessi
scientifici si riducano a scusabili attività marginali, a occupazioni del sabato sera, una
sorta di dopolavoro. E noto che anche Goethe coltivò le scienze naturali e Schiller la
storia, ma, si tende cortesemente a pensare, come una specie di hobby. Non voglio
senz’altro accusare quei due di aver avuto bisogno di quelle scienze per la loro attività
poetica, non voglio giustificarmi per mezzo loro, ma tuttavia devo ripetere che a me la
scienza è necessaria. Più ancora, devo confessare che non vedo di buon occhio una
quantità di persone, delle quali mi è nota la non completa padronanza del campo
scientifico, persone cioè che cantano come cantano gli uccelli, o come ci si immagina
che cantino gli uccelli. Non dico con questo che respingo un grazioso componimento
poetico sul sapore di una triglia o sul piacere di una gita in canotto solo perché il suo
autore non ha studiato gastronomia o nautica. Ma sostengo che i grandi e complicati
avvenimenti non possono essere sufficientemente riconosciuti in un mondo di uomini
che non si provvedano di tutti gli strumenti utili ad intenderli.
Supponiamo che si debbano rappresentare grandi passioni o fatti capaci di influire sul
corso della storia dei popoli. Una di tali passioni è ritenuta oggi, diciamo, l’impulso del
potere. Ammesso che uno scrittore «senta» questo impulso, e voglia presentarci un
uomo in lotta per il potere: come riuscirà a compenetrarsi del complicatissimo
meccanismo che costituisce oggi l’ambiente di ogni lotta per il potere? Se il suo eroe è
un politico, qual è il reale ingranaggio della politica? Se invece è un uomo d’affari,
qual è l’ingranaggio degli affari? Eppoi, ci sono pure scrittori che s’interessano e si
appassionano agli affari e alla politica in misura assai minore che all’impulso di potere
dei singoli individui! Come possono essi procurarsi le nozioni necessarie? Con
l’andare semplicemente attorno tenendo gli occhi aperti, non otterranno certo una
visione sufficientemente chiara delle cose; comunque, sempre di più che se si
limitassero a strabuzzare gli occhi in un sacro delirio! La fondazione di un giornale
come il «Völkischer Beobachter» o di una società come la Standard Oil è una faccenda
piuttosto complicata: non sono cose che uno si trova da un momento all’altro bell’e
cotte dinanzi. Un campo importante per gli autori di teatro è la psicologia. Molti
credono che, se non un uomo qualunque, uno scrittore perlomeno dovrebbe essere in
grado, senza bisogno di particolare istruzione, di rintracciare i motivi che spingono un
uomo all’omicidio; che dovrebbe potere, per «virtù propria», dare un quadro dello stato
psichico di un assassino. Si ritiene che basti, in casi consimili, guardare dentro se
stessi: e poi, deve pur soccorrere un po’di fantasia... E invece, per una quantità di
ragioni, io non riesco più ad abbandonarmi alla piacevole speranza di potermela cavare
tanto a buon mercato. Non posso più trovare in me stesso tutti i motivi determinanti
che — come si apprende dai resoconti giornalistici o scientifici — sono individuabili
negli uomini. Così come avviene al giudice comune che pronuncia la condanna, anche
a me non è possibile formarmi un quadro completo delle condizioni psichiche di un
assassino. La psicologia moderna, dalla psicoanalisi al behaviorismo, mi procura
nozioni che possono benissimo indurmi a un giudizio totalmente diverso sul caso in
esame, soprattutto se tengo conto dei risultati delle indagini sociologiche e se non
trascuro l’economia e la storia. Si dirà che questo è voler complicare le cose. Io non
posso che rispondere: le cose sono complicate. Forse allora qualcuno si lascerà
convincere e consentirà con me nel riconoscere che una quantità di letteratura è a uno
stadio fortemente primitivo, ma si chiederà anche, molto preoccupato, se serate teatrali
di questo genere non corrano il rischio di essere notevolmente opprimenti. La risposta
è: no.
Il contenuto scientifico che può essere racchiuso in un’opera poetica deve essere,
infatti, completamente risolto in poesia. La sua utilizzazione soddisfa appunto il
piacere che è reso possibile dal contenuto poetico. Comunque, anche se non soddisfa
quel piacere che trova appagamento nella autentica scienza, è sempre necessaria una
certa disposizione a penetrare più a fondo nelle cose, un desiderio di rendere il mondo
padroneggiabile all’uomo, per poterci assicurare, in un’epoca di grandi scoperte e
invenzioni come la nostra, anche il godimento della poesia.
Il teatro epico può definirsi un’«istituzione morale»?
Secondo l’opinione di Friedrich Schiller, il teatro dev’essere una istituzione morale.
Quando Schiller espresse quest’esigenza, non lo sfiorò neppure il pensiero che una
ribalta moraleggiante avrebbe avuto come effetto la diserzione del pubblico dai teatri.
A quel tempo il pubblico non aveva nulla da obiettare contro un teatro moralistico.
Solo più tardi Friedrich Nietzsche lo bollò con la definizione di «trombettiere moralista
di Säckingen». Nietzsche considerava il fatto di occuparsi di morale come qualcosa di
deprimente: Schiller vi ravvisava invece una fonte di alto diletto. Per lui, nulla poteva
procurare maggior divertimento e soddisfazione che il propagare ideali. La borghesia si
accingeva a costituire il patrimonio ideale della nazione. Arredare la nostra casa, lodare
il nostro cappello, presentare i nostri conti: tutto ciò è molto piacevole, mentre è
davvero assai deprimente parlare della rovina della nostra casa, vendere il nostro
vecchio cappello, dover pagare i nostri conti: e questa era precisamente la prospettiva
di Friedrich Nietzsche un secolo dopo. Lui vedeva di mal occhio la morale e, di
conseguenza, anche l’altro Friedrich.
Pure contro il teatro epico molti si sono ribellati, accusandolo di essere troppo
moralistico. In esso, tuttavia, le considerazioni d’ordine morale apparivano solo in
secondo piano. Più che parlar di morale, esso si proponeva di studiare; ed in realtà vi si
studiava. Ma alla fine capitava il guaio che la favola avesse una sua morale. Non
vogliamo certo affermare di esserci dati allo studio per puro desiderio di studiare e
senza altri moventi ben più concreti, né che i risultati del nostro studio ci abbiano colti
assolutamente di sorpresa. Nel mondo che ci circondava erano indubbiamente rilevabili
alcune dolorose incongruenze, condizioni difficili a sopportarsi, e difficili non solo per
ragioni puramente morali. Non solo per ragioni morali è difficile sopportare la fame, il
freddo, l’oppressione. Lo scopo stesso delle nostre ricerche non era semplicemente di
suscitare delle reazioni morali contro determinate condizioni di vita (benché tali
reazioni nascessero facilmente, anche se non in tutti gli ascoltatori: nascevano di rado,
ad esempio, in quegli ascoltatori che traevano vantaggio dalle condizioni di cui si
trattava!): lo scopo delle nostre ricerche era piuttosto quello di scoprire i mezzi
attraverso cui fosse possibile eliminare quelle condizioni difficilmente sopportabili.
Parlavamo cioè non in nome della morale, ma in nome degli offesi: e queste sono due
cose davvero molto diverse, perché ben spesso accade che, con abbondanza di prediche
morali, si dica agli offesi che devono esser ben contenti della loro situazione. Pei
moralisti di questo genere, gli uomini sono fatti per la morale, non la morale per gli
uomini.
E comunque possibile dedurre da quanto abbiamo detto, fino a che punto ed in qual
senso il teatro epico possa definirsi un’istituzione morale.
Può sorgere ovunque un teatro epico?
Sotto l’aspetto stilistico il teatro epico non costituisce nulla di particolarmente nuovo.
Il suo carattere dimostrativo e la sua accentuazione dell’artificio scenico lo
apparentano all’antichissimo teatro asiatico. Anche i misteri medievali, come pure il
teatro classico spagnolo e il teatro gesuita, presentano tendenze didattiche.
Queste forme di teatro corrisposero a determinate tendenze delle loro epoche, e
decaddero col passare di esse. Del pari, il teatro epico moderno è legato a tendenze ben
definite, e perciò non può assolutamente sorgere dappertutto. Oggi le grandi nazioni
non tendono, per lo più, a discutere i loro problemi sulla scena teatrale. Londra, Parigi,
Tokio, Roma dirigono i loro teatri a tutt’altri scopi. Solo in pochi luoghi e per non
lungo tempo sono esistite finora condizioni favorevoli alla nascita di un teatro epico
con fini didattici. A Berlino il fascismo ha posto un drastico alt allo sviluppo di questo
teatro.
Premessa necessaria a un fenomeno del genere è, oltre a un determinato standard
tecnico, l’esistenza di un potente moto di vita sociale, che abbia interesse alla libera
discussione dei problemi dell’esistenza in vista della loro soluzione, e che tale interesse
possa difendere contro tutte le tendenze avverse.
Il teatro epico è il più vasto e progredito tentativo di giungere a un grande teatro
moderno, e deve vincere tutte le enormi difficoltà che si oppongono a qualsiasi energia
vitale, così nel campo della politica come in quelli della filosofia, della scienza e
dell’arte.
Il teatro sperimentale
Il teatro serio europeo sta attraversando, da almeno due generazioni, un periodo
sperimentale. I vari esperimenti non hanno finora dato risultati inequivocabili,
chiaramente sinottici, ma il periodo sperimentale non è ancora affatto concluso. A mio
parere, gli esperimenti vennero effettuati su due linee le quali, se pure talvolta
interferivano l’una nell’altra, possono ora venir seguite separatamente. Queste due
linee di sviluppo si distinguono per le rispettive funzioni di divertimento e di
ammaestramento. Il teatro, cioè, effettuò esperimenti destinati ad accrescere la sua
capacità di divertire ed altri destinati ad accrescere il suo valore didattico.
Per quanto riguarda il divertimento, in un mondo instabile e «dinamico» come il nostro
tutte le attrattive si logorano molto in fretta. Alla crescente apatia del pubblico bisogna
offrire sempre nuove sensazioni. Per distrarre i distratti spettatori, il teatro deve
anzitutto riuscire a farli concentrare; deve attrarli nel suo cerchio magico togliendoli da
un ambiente chiassoso. Il teatro ha a che fare con spettatori stanchi, esauriti da un
lavoro quotidiano razionalizzato, irritati da frizioni sociali d’ogni genere. Lo spettatore,
sfuggito al suo piccolo mondo, siede là, come un evaso dal carcere. È un evaso, ma è
anche un cliente — può venire a rifugiarsi qui ma potrebbe anche andare altrove. La
concorrenza dei teatri fra loro e del teatro col cinema esige sempre nuovi sforzi per
apparire ogni volta nuovi.
Se gettiamo uno sguardo d’assieme sugli esperimenti dei vari Antoine, Brahm,
Stanilslavskij, Gordon Craig, Reinhardt, Jessner, Mejerchol’d, Vachtangov, Piscator,
constatiamo che essi hanno sorprendentemente arricchito le possibilità espressive del
teatro, accrescendone senza alcun dubbio la capacità di divertire. L’arte d’assieme, ad
esempio, ha creato un corpo di operatori teatrali estremamente sensibile ed elastico.
L’ambiente sociale può ora venir descritto, dipinto finanche nei più sottili dettagli.
Vachtangov e Mejerchol’d desunsero dal teatro asiatico certe forme di danza e
crearono tutta una coreografia per il dramma. Mejerchol’d elaborò un costruttivismo
radicale e Reinhardt usò per palcoscenico i cosìddetti scenari naturali: rappresentò
Ognuno e il Faust su pubbliche piazze. Compagnie di teatro all’aperto eseguirono il
Sogno d’una notte d’estate in mezzo a un bosco vero e nell’Unione Sovietica si tentò
di ricostruire l’assalto al Palazzo d’Inverno usando la nave da guerra «Aurora».
Caddero le barriere fra palcoscenico e spettatori. Nel Grosse Schauspielhaus, durante la
rappresentazione del Danton di Reinhardt, alcuni attori sedevano fra il pubblico, e
Ochlopkov, a Mosca, collocò un certo numero di spettatori sul palcoscenico. Reinhardt
usò la passerella floreale del teatro cinese e, per recitare in mezzo alle folle, scese
nell’arena del circo. La regia delle masse venne perfezionata da Stanislavskij,
Reinhardt e Jessner, il quale ultimo con le sue incastellature a scala conquistò al
palcoscenico una terza dimensione. Si inventarono il palcoscenico girevole e
l’orizzonte a cupola, si riscoperse la luce. Il proiettore permise di effettuare
illuminazioni grandiose. Un’intera gamma di luci permise di creare magicamente
atmosfere «rembrandtiane». Nella storia del teatro certi effetti di luce poterono
denominarsi «reinhardtiani», così come nella storia della medicina un certo intervento
sul cuore viene denominato «operazione di Trendelenburg». Nacquero nuovi
procedimenti di proiezione basati sul sistema Schüfftan, nacque una nuova regia dei
rumori. Nell’arte dello spettacolo, i confini fra cabaret e teatro, fra rivista e teatro
vennero abbattuti. Si fecero innumerevoli esperimenti con maschere, coturni,
pantomime, sull’antico repertorio classico. Shakespeare venne rivestito e rigirato in
mille modi. Tutte le possibili maniere di affrontare i classici possono ormai dirsi
praticamente esaurite: abbiamo visto Amleto in smoking e Giulio Cesare in uniforme
— e quanto meno lo smoking e l’uniforme ne hanno tratto un utile, guadagnando in
rispettabilità. Come vedete, esperimenti molto diversi per valore; e se i meno vistosi
non sempre furono i meno validi, anche quelli di minor pregio non furono mai
totalmente privi di valore. L’Amleto in smoking, ad esempio non fu certamente un
sacrilegio maggiore, nei confronti di Shakespeare, di quanto non lo sia l’Amleto
convenzionale in calze di seta. Si rimase, comunque, nell’ambito della recita in
costume.
In generale si può dire che gli esperimenti effettuati al fine di rendere il teatro più
divertente non rimasero affatto privi di risultato. Essi contribuirono specialmente al
perfezionamento delle attrezzature meccaniche e, come si è detto, non sono ancora
conclusi. Anzi, non sono ancora neppure divenuti d’uso comune come invece è
accaduto per i risultati sperimentali in altri campi. Una nuova operazione chirurgica
effettuata a New York entro breve tempo verrà compiuta anche a Tokio, mentre nel
campo della tecnica teatrale moderna ciò non avviene. Un evidente senso di
soggezione impedisce ancora sempre agli artisti di accettare con disinvoltura i risultati
sperimentali ottenuti da altri artisti e di svilupparli. L’imitazione, in arte, passa per
un’ignominia — e questo è uno dei motivi per cui i progressi tecnici sono ancora ben
lontani dall’essere notevoli come potrebbero, e il teatro è ben lontano dall’aver
raggiunto il livello medio della tecnica moderna. Esso si accontenta ancora di usare,
per lo più in maniera assai maldestra, un girevole rudimentale per il palcoscenico, un
microfono, l’installazione di qualche faro d’auto. Anche nel campo della recitazione gli
esperimenti vengono scarsamente sfruttati. Soltanto oggi qualche attore newyorkese
incomincia ad interessarsi ai metodi della scuola di Stanislavskij.
E con l’altra, con la seconda funzione assegnata al teatro dalla estetica, la funzione
educativa, come stanno le cose? Anche qui si ebbero esperimenti e risultati dei
medesimi. La drammaturgia di Ibsen, Tolstoj, Strindberg, Gor’kij, Cechov,
Hauptmann, Shaw, Kaiser e O’Neill fu drammaturgia sperimentale — furono tutti
grandiosi tentativi di dar forma teatrale ai problemi delle rispettive epoche.2 Abbiamo
la drammaturgia critico-sociale di ambiente (da Ibsen a Nordahl Grieg), quella
simbolistica (da Strindberg a Pär Lagerkvist); abbiamo una drammaturgia sul tipo,
tanto per intenderci, della mia Opera da tre soldi e un tipo di parabola con sbriciolature
di ideologie; ed abbiamo infine particolari forme drammatiche perfezionate da poeti
come Auden e Kjeld Abell, le quali, da un punto di vista puramente tecnico,
contengono elementi della rivista. Il teatro riuscì talvolta a dare impulso a taluni
movimenti sociali, come l’emancipazione della donna, l’amministrazione della
giustizia, l’igiene e perfino il moto di emancipazione del proletariato. Ma non si può
tacere che esso non permise mai di affondare eccessivamente lo sguardo nel
meccanismo sociale, limitandosi — come è stato obiettato — a mettere più o meno in
evidenza una sintomatologia superficiale e non mai la vera e propria legittimità delle
strutture sociali. Gli esperimenti in campo drammatico condussero infine alla quasi
totale distruzione della favola e della figura umana. Il teatro, ponendosi al servizio
delle aspirazioni sociali riformatrici, sacrificò molta parte della propria efficacia
artistica. Non a torto, sebbene con argomentazioni assai dubbie, oggi si deplora
l’appiattimento del gusto artistico e l’ottundimento della sensibilità stilistica; e
effettivamente, in seguito a tanti e così svariati esperimenti, oggigiorno in teatro regna
una confusione di stili addirittura babelica. Su uno stesso palcoscenico, nel corso d’uno
stesso lavoro, gli attori recitano usando tecniche diversissime l’una dall’altra, ad
esempio in stile naturalistico sullo sfondo di scenografie fantastiche. La tecnica della
dizione è caduta a un livello deplorevole, si recitano giambi come se si parlasse in
linguaggio corrente, si scandisce ritmicamente il gergo dei mercati, ecc. ecc. Non meno
sprovveduto si trova l’attore moderno nei confronti dell’arte gestuale, cosìcché il gesto
risulta arbitrario quando dovrebbe essere individuale e puramente fortuito quando
dovrebbe essere naturale e spontaneo. Uno stesso attore è capace di esprimersi con una
gestualità buona per il circo e con una mimica facciale percepibile soltanto dai palchi
di prim’ordine e con l’aiuto d’un binocolo. Una vera e propria liquidazione di stili di
tutte le epoche, una vera e propria competizione sleale nel campo di tutti gli effetti
possibili e impossibili! Non si può dire davvero che qualche risultato non lo si sia
2
Naturalmente sono i grandi teatri che hanno compiuto il maggior numero di tentativi di questo genere.
Čechov ebbe il suo Stanislavskij, Ibsen il suo Brahm, ecc. Ma sul piano dell’accrescimento del valore
didattico fu senz’altro la drammaturgia a prendere per prima l’iniziativa.
ottenuto — ma tanto meno che non sia costato nulla.
Giungo ora alla fase in cui tutti gli sforzi sperimentali fin qui descritti toccarono il
massimo livello e insieme il punto critico. In questa fase si accentuarono al massimo
grado tutti i fenomeni del grande processo, quelli positivi e quelli negativi:
l’accrescimento della capacità di divertire, il perfezionamento della tecnica
illusionistica, l’accrescimento del valore educativo e la decadenza del gusto artistico.
Il tentativo più radicale di conferire al teatro un carattere educativo venne intrapreso da
Piscator. Io partecipai a tutti i suoi esperimenti e, fra tanti, non uno solo ne venne
effettuato che non avesse per scopo il potenziamento del valore didattico del teatro. Si
trattò addirittura di affrontare sulla scena i massimi temi della vita contemporanea: le
lotte per il petrolio, la guerra, la rivoluzione, la giustizia, il problema razziale e via
dicendo. Si dimostrò subito indispensabile una radicale riorganizzazione della scena. È
impossibile in questa sede enumerare le invenzioni e le innovazioni di cui Piscator si
valse insieme a quasi tutte le conquiste tecniche più moderne. Di qualcuna avrete
probabilmente inteso parlare, come ad esempio dell’impiego del film per fare del
rigido fondale un compartecipe attivo, con funzioni simili a quelle del coro greco, del
nastro corrente per rendere mobile il pavimento del palcoscenico, di modo che gli
avvenimenti epici — come la marcia del buon soldato Švejk che va alla guerra —
potessero scorrere via come sulle ruote. Queste trovate non sono finora state riprese dal
teatro internazionale, questa elettrificazione della scena oggi è quasi dimenticata, le
ingegnosissime attrezzature meccaniche sono arrugginite e sopra vi cresce l’erba. Da
che dipende?
La rovina di questo teatro eminentemente politico ebbe cause politiche, ed è necessario
nominarle. Il potenziamento del valore educativo politico coincise con l’insorgere della
reazione. Oggi vogliamo tuttavia limitarci a seguire gli sviluppi della crisi teatrale nel
solo campo dell’estetica.
Gli esperimenti di Piscator scatenarono a tutta prima un caos completo: trasformarono i
palcoscenici in capannoni zeppi di macchinari e le platee in luoghi di comizio. Per
Piscator il teatro era un parlamento e il pubblico un organo legislativo. A tale
parlamento venivano presentati plasticamente i grandi problemi di pubblico interesse,
quelli che assolutamente esigevano una soluzione. In luogo del discorso d’un deputato
su certe situazioni sociali insostenibili si presentava una fedele riproduzione artistica
delle situazioni medesime. Orgoglio del teatro era mettere il suo parlamento, il
pubblico, in grado di prendere decisioni politiche basandosi sulle situazioni, le
statistiche, le parole d’ordine da esso rappresentate. Il teatro di Piscator non rinunziava
al successo ma gli preferiva di gran lunga la discussione, non voleva presentare
soltanto una vicenda allo spettatore ma anche strappargli una decisione pratica,
inserirsi attivamente nella vita. E per giungere a tanto ogni mezzo era buono.
La tecnica scenica si complicò enormemente. Il regista Piscator aveva dinanzi a sé un
copione diverso da quello del regista Reinhardt quanto una partitura di Strawinsky si
differenzia da una intavolatura per liuto. Le attrezzature meccaniche erano talmente
pesanti che a Nollendorf si dovette rinforzare l’impiantito del palcoscenico con
contraffissi di ferro e cemento; alle cupole si appendevano tali e tanti macchinari che
una di esse una volta crollò. I punti di vista estetici venivano totalmente subordinati a
quelli politici. Via gli scenari dipinti quando si poteva presentare un film ripreso sul
posto e perciò di valore documentario attendibile. Benvenuti invece i cartoni dipinti
quando un artista, ad esempio George Grosz, aveva qualcosa da dire al pubblicoparlamento. Piscator era addirittura disposto a rinunziare quasi per intero agli attori.
Quando il Kaiser gli fece presentare una protesta da cinque avvocati perché egli aveva
manifestato l’intenzione di farlo impersonare sulla scena da un attore, Piscator chiese
se il Kaiser non volesse presentarsi personalmente alla ribalta, offrendogli, per così
dire, una scrittura. In breve: la finalità era talmente grande e importante che tutti i
mezzi parevano buoni. All’allestimento scenico corrispondeva, d’altronde, la
composizione del lavoro. Una intera équipe di drammaturghi lavorava di concerto
intorno a un copione, sotto il controllo e con l’appoggio di un’équipe di esperti:
storici, economisti, statistici.
Gli esperimenti di Piscator mandavano all’aria quasi tutte le convenzioni: si inserivano
nella tecnica creativa degli autori, nello stile della recitazione, nell’opera degli
scenografi, trasformando ogni cosa. Esse tendevano a dare al teatro una funzione
sociale totalmente nuova.
L’estetica rivoluzionaria borghese, basata sui grandi illuministi Diderot e Lessing,
definiva il teatro un luogo di divertimento e di istruzione. L’epoca illuministica, che
diede l’avvio al poderoso balzo in avanti del teatro europeo, non vedeva alcun
contrasto fra divertimento e istruzione. I1 puro divertimento, anche se procurato da
argomenti tragici, sembrava vacuo ed indegno a Diderot e compagni, se non
aggiungeva nulla alla cultura dello spettatore, e gli elementi istruttivi, naturalmente
presentati in forma artistica, a loro avviso non toglievano sapore al divertimento, anzi,
lo rendevano più profondo e completo.
Se ora noi consideriamo il teatro del nostro tempo, constatiamo che fra i due elementi
costitutivi del dramma — divertimento e istruzione — si è andato creando un conflitto
di giorno in giorno più aspro. Oggi fra le due cose sussiste un contrasto.
Già il naturalismo, dando veste scientifica all’arte per procurarsi una influenza sociale,
aveva paralizzato talune energie artistiche indubbiamente essenziali, in particolar modo
la fantasia, l’amore della recitazione, lo slancio poetico vero e proprio. Gli elementi
didattici nuocevano evidentemente a quelli artistici.
L’espressionismo postbellico aveva rappresentato il mondo come «volontà e
rappresentazione» giungendo a conclusioni nettamente solipsistiche. Era la risposta del
teatro alla grande crisi sociale, come il machismo [sic] era stata quella della filosofia.
Era la rivolta dell’arte contro la vita, nella quale il mondo sussisteva unicamente allo
stato di visione — una visione stranamente distorta, un aborto di spiriti angosciati.
L’espressionismo, pur arricchendo moltissimo i mezzi espressivi del teatro e
apportandogli risorse estetiche fin là inutilizzate, si dimostrò assolutamente incapace di
spiegare il mondo come un oggetto della prassi umana. Il valore didattico del teatro
avvizzí. In uno spettacolo di Piscator o nell’Opera da tre soldi gli dementi istruttivi
erano, per così dire, inseriti dall’esterno, non risultavano organicamente dall’assieme
ma contrastavano con tutto l’assieme; interrompevano il fluire della recitazione e delle
vicende sceniche, impedivano l’immedesimazione, erano docce fredde per i
sentimentalmente partecipi. Spero che le parti moraleggianti e i song didascalici
dell’Opera da tre soldi siano in qualche modo divertenti, ma senza dubbio si tratta
d’un genere di divertimento diverso da quello procurato dalle scene recitate. Il carattere
di questo lavoro è contraddittorio: divertimento e ammaestramento si fronteggiano sul
piede di guerra.
Nel teatro di Piscator, sul piede di guerra stavano invece gli attori e i macchinari, gli
uni contro gli altri.
Il pubblico, assistendo allo spettacolo, si divideva in almeno due gruppi sociali avversi,
cosìcché l’esperienza artistica collettiva andava in fumo. Ma era un fatto politico, e da
questo punto prescindiamo. Il divertirsi o meno nell’apprendere qualcosa dipende dalla
situazione di classe, il godimento artistico dipende dall’atteggiamento politico, il quale
viene provocato e può essere assunto. Ma, pur volendo considerare la sola parte del
pubblico politicamente d’accordo con noi, vediamo di quanto si sia acuito il conflitto
fra gli elementi intesi a divertire e quelli ricchi di valore didattico. Parliamo di un
nuovo e ben preciso modo di apprendere che non va più d’accordo con una vecchia,
determinata maniera di divertirsi.
In una ulteriore fase sperimentale qualsiasi incremento del valore didattico provocava
un’immediata attenuazione del divertimento. («Questo non è più teatro, è università
popolare!») E, per converso, le reazioni nervose provocate dalla recitazione
emozionale minacciavano di continuo il valore didattico dello spettacolo. (Spesso, ai
fini dell’efficacia didattica, i cattivi attori erano preferibili ai buoni). In altre parole:
quanto più il pubblico veniva nevroticamente commosso, tanto meno era in grado di
imparare. E cioè: quanto più costringevamo il pubblico a seguirci, a vivere, a «sentire»
con noi, tanto meno esso scorgeva i nessi, i rapporti — e quanto più c’era da imparare
tanto meno si riusciva a dare in godimento artistico.
E fu la crisi. Mezzo secolo di esperimenti condotti in quasi tutti i paesi civili aveva
conquistato al teatro campi di contenuti e di problematiche fin là inesplorati,
trasformandolo in un fattore di eminente importanza sociale. Ma lo aveva anche posto
in una situazione in cui un ulteriore sviluppo della componente conoscitiva, sociale
(politica) avrebbe rovinato la componente artistica. D’altra parte, quest’ultima diveniva
sempre meno valida senza un ulteriore sviluppo dell’elemento informativo e culturale.
Si era perfezionato un apparato tecnico e uno stile rappresentativo capace di dare
illusioni piuttosto che esperienze, di inebriare anziché di elevare, di ingannare anziché
di illuminare le menti.
A che era servito un teatro tendenzialmente costruttivista se non era socialmente
costruttivo — a che servivano i mirabili impianti di illuminazione se illuminavano
soltanto rappresentazioni del mondo sbilenche e puerili, a che valeva un’arte teatrale
così suggestiva se riusciva soltanto a farci prendere lucciole per lanterne? A che pro
tutto quel magico armamentario se poteva offrirci soltanto un surrogato artificiale, in
luogo di vicende reali? A che pro quel continuo lumeggiare problemi destinati a
rimanere eternamente insoluti? Quel solleticare non soltanto i nervi ma anche
l’intelligenza? Non era possibile fermarsi a questo punto.
L’evoluzione premeva nel senso d’una fusione delle due funzioni, — divertire e
istruire.
Per acquistare un significato sociale, questi sforzi, questi esperimenti dovrebbero, alla
fin fine, porre il teatro in condizione di tracciare con mezzi artistici un quadro del
mondo e modelli di convivenza umana tali da dare allo spettatore la possibilità di
comprendere il proprio ambiente sociale e di dominarlo razionalmente e
sentimentalmente.
L’uomo odierno poco sa delle leggi che governano la sua vita. Come individuo sociale
reagisce per lo più sentimentalmente; ma questa reazione sentimentale è confusa,
indeterminata, apparente. Le fonti dei suoi sentimenti e delle sue passioni, così come
quelle delle sue cognizioni, sono ostruite e come intorbidate. L’uomo odierno, vivendo
in un mondo in rapida trasformazione e trasformandosi rapidamente egli stesso, non ha
di questo mondo la benché minima idea in base alla quale gli sia possibile agire con
prospettive di successo; le sue concezioni della convivenza umana sono distorte,
inesatte, contraddittorie, potremmo dire impraticabili; cioè, con una simile visione del
mondo — del mondo umano — davanti agli occhi, l’uomo questo mondo non può
dominarlo. Egli non sa da che cosa dipende, non sa maneggiare la macchina sociale in
modo da conseguire l’effetto desiderato. La conoscenza della natura delle cose, per
quanto ingegnosamente approfondita ed ampliata, non è in grado di ricavare dal
dominio della natura una fonte di umana felicità, anzi, diverrà più facilmente una fonte
di infelicità se non è illuminata dalla conoscenza della natura dell’uomo, della società
umana globalmente intesa. Perciò le grandi invenzioni, le grandi scoperte stanno
diventando una minaccia sempre più terrificante per l’umanità; e non per nulla ognuna
di esse viene accolta con un grido di trionfo che subito si converte in un grido di
terrore.
Prima della guerra assistei per radio a una scena veramente storica: i fisici dell’istituto
Niels Bohr di Copenaghen vennero intervistati a proposito d’una scoperta
rivoluzionaria nel campo della scissione atomica, la scoperta di una nuova, immane
fonte di energia. Quando l’intervistatore domandò se una applicazione pratica di quei
tali esperimenti fosse già possibile gli fu risposto: «No, non ancora». «Dio sia lodato!»,
commentò l’intervistatore in tono di immenso sollievo, «credo proprio che l’umanità
non sia ancora assolutamente matura per entrare in possesso d’una simile fonte di
energia!» Era chiaro che egli aveva immediatamente ed esclusivamente pensato
all’industria bellica. Il fisico Albert Einstein non giunse fino a questo punto, ma si
spinse pur sempre abbastanza avanti quando scrisse le poche righe destinate a venir
seppellite dentro un astuccio, in occasione dell’esposizione universale di New York,
per recare alle generazioni future un resoconto informativo sul nostro tempo. Einstein
scrisse infatti: «La nostra epoca è ricca di menti inventive le cui scoperte potrebbero
alleviarci notevolmente la vita. Noi attraversiamo i mari utilizzando energie
meccaniche, e le stesse energie usiamo per liberare l’umanità dalla fatica del lavoro
muscolare. Abbiamo imparato a volare e a diffondere notizie e comunicazioni in tutto
il mondo per mezzo di onde elettriche. Tuttavia la produzione e la distribuzione delle
merci non è ancora affatto organizzata, cosìcché tutti vivono nel timore di venire
esclusi dal circuito economico. Inoltre, gli uomini abitanti nei vari paesi si uccidono gli
uni con gli altri a intervalli di tempo irregolari e perciò chiunque si preoccupi del
futuro è costretto a vivere nel timore. Ciò dipende dal fatto che l’intelligenza e il
carattere delle masse sono ancora senza confronto inferiori all’intelligenza e al
carattere dei pochi che producono beni pregiati per la comunità».
Il così scarso contributo alla felicità della vita umana recato dal dominio sulla natura —
in cui siamo tanto progrediti — Einstein lo motiva, dunque, con la mancanza negli
uomini, in generale, dell’istruzione necessaria ad impiegare utilmente le scoperte e le
invenzioni.3
Gli uomini sanno troppo poco di se stessi ed è proprio a causa di tale ignoranza che
traggono così scarso beneficio dalla loro conoscenza della natura. In effetti, le
oppressioni, gli sfruttamenti mostruosi, i massacri bellici, le degradazioni pacifiche
d’ogni genere di cui tante creature umane sono vittime per opera di altri uomini su tutto
il nostro pianeta, hanno già quasi acquisito un qualcosa di naturale; ma di fronte a
questo fatto l’uomo è purtroppo assai meno ricco di abilità e di inventiva di quanto non
lo sia di fronte ad altri fenomeni naturali. Le grandi guerre, ad esempio, sono per
moltissime persone un qualcosa di simile ai terremoti; ma, mentre contro i terremoti gli
uomini finiscono per spuntarla, contro se stessi non vengono a capo di nulla. È dunque
chiaro quanto sarebbe di guadagnato se ad esempio il teatro e l’arte in genere fossero in
grado di fornire un’immagine del mondo finalmente praticabile. Un’arte capace di
tanto potrebbe influire profondamente sull’evoluzione sociale, non limitarsi a suscitare
impulsi più o meno oscuri ma consegnare all’uomo senziente e pensante il «mondo
degli uomini», perché egli possa agirvi.
Il problema tuttavia non era affatto semplice. Già da una primissima indagine risulta
che l’arte per adempiere la propria funzione, e cioè per suscitare certe emozioni e
procurare certe esperienze, non ha alcuna necessità di offrire riproduzioni fedeli del
mondo, della vita e dei casi umani, poiché essa consegue ugualmente il suo effetto
anche fornendo immagini del mondo difettose, ingannevoli e sorpassate. Grazie alla
suggestione artistica che essa è in grado di esercitare, può conferire una parvenza di
verità anche alle affermazioni più assurde circa i rapporti umani; e la sua
rappresentazione risulta tanto più incontrollabile quanto più è potente. Così, alla logica
si sostituisce il brio, alle argomentazioni l’eloquenza. L’estetica richiede, è vero, una
certa verosimiglianza dei fatti, altrimenti se ne distrugge o se ne sminuisce l’efficacia.
3
Non ci sembra qui necessario sottoporre ad una critica minuziosa il punto di vista tecnocratico del
grande scienziato. Indiscutibilmente i beni utili alla comunità vengono prodotti dalle masse, e le poche
menti inventive si trovano molto sprovvedute di fronte al circuito economico delle merci. A noi basta
qui rilevare come Einstein constatati l’ignoranza degli interessi sociali, direttamente e indirettamente.
Ma si tratta d’una verosimiglianza puramente estetica — della cosìddetta «logica
artistica». Al poeta si concede un mondo suo personale, governato da leggi particolari.
Se uno o più elementi appaiono deformati, dovranno venir deformati anche tutti gli
altri, così il principio della deformazione risulterà in certo qual modo unitario, e il tutto
sarà salvo.
L’arte ottiene il privilegio di potersi costruire un proprio mondo, che non ha bisogno di
coincidere con quello vero, grazie a un fenomeno particolare, vale a dire alla
immedesimazione (basata sulla suggestione) dello spettatore nell’artista, e, per suo
tramite, nei personaggi e nei fatti rappresentati sulla scena. Noi ora dobbiamo prendere
in esame il principio dell’immedesimazione.
L’immedesimazione è un pilastro fondamentale dell’estetica dominante. Già nella
grandiosa Poetica di Aristotele si descrive come la «katharsis» (la purificazione
spirituale dello spettatore) venga provocata per mezzo della «mimesis». L’attore imita
l’eroe (Edipo o Prometeo) e lo fa con tanta forza di suggestione e di trasfigurazione da
costringere lo spettatore ad imitarlo e a far sua la vicenda dell’eroe. Hegel che, per
quanto ne so, fu l’autore dell’ultima grande estetica, si riferisce alla facoltà dell’uomo
di provare, di fronte a una realtà simulata, le stesse emozioni che proverebbe di fronte
alla realtà vera. Quanto io volevo qui riferire è che una serie di esperimenti intesi ad
offrire per mezzo del teatro un’immagine praticabile del mondo ci hanno posti di fronte
alla sbalorditiva questione se non sia necessario, per conseguir questo scopo, rinunziare
più o meno totalmente all’immedesimazione. Infatti se si concepisce l’umanità,
nell’assieme dei suoi rapporti, processi, comportamenti e istituzioni, come un qualcosa
di non immobile, di non immutabile, e di fronte ad essa si assume l’atteggiamento già
assunto da secoli, e con tanto successo, di fronte alla natura — un atteggiamento
critico, mirante ai cambiamenti, tendente al dominio della natura stessa — allora non si
può più far ricorso all’immedesimazione. Immedesimarsi nei personaggi mutevoli,
nelle situazioni evitabili, nel dolore superfluo e via dicendo non è possibile.
Fintantoché nel petto di re Lear brillano gli astri del suo destino ed egli vien preso
come un qualcosa di immutabile, e le sue azioni appaiono condizionate dalla natura,
assolutamente inevitabili, fatali insomma, ci si può immedesimare nel personaggio.
Discuterne comunque la condotta sarebbe altrettanto impossibile quanto discutere della
scissione atomica sarebbe stato impossibile ad un uomo del X secolo.
Quando il rapporto fra palcoscenico e pubblico si stabiliva sulla base della
immedesimazione, lo spettatore poteva vedere di volta in volta solo quel tanto che
vedeva l’eroe in cui egli si immedesimava. E, di fronte a determinate situazioni
sceniche, poteva provare le sole emozioni sentimentali suggeritegli dall’«atmosfera»
delle situazioni medesime. Le percezioni, i sentimenti, le nozioni dello spettatore si
uniformavano a quelle dei personaggi in scena. Il teatro ben difficilmente poteva
suscitare reazioni sentimentali, consentire osservazioni, trasmettere nozioni di qualsiasi
genere senza darne una rappresentazione suggestiva. La collera di Lear contro le figlie
contagiava lo spettatore il quale, seguendo la vicenda, non poteva provare altro
sentimento (ad esempio stupore o inquietudine) all’infuori della collera. La collera di
Lear non poteva dunque venire analizzata dal punto di vista della sua legittimità né
accompagnata da previsioni circa le sue possibili conseguenze: non era da discutersi
ma soltanto da condividersi. I fenomeni sociali apparivano dunque come un qualcosa
di eterno, naturale, immutabile, al di fuori della storia — e non venivano posti in
discussione. Usando qui il termine «discussione» non alludo alla disamina spassionata
di un tema, a un mero processo intellettuale. Non si trattava unicamente di
immunizzare lo spettatore dalla collera di Lear ma di evitarne il trapianto diretto. Un
esempio: la collera di Lear è condivisa dal suo fedele servitore Kent. Questi bastona un
servo delle figlie ingrate il quale ha ricevuto l’ordine di respingere una richiesta del
vecchio re. Lo spettatore del nostro tempo dovrebbe dunque condividere questa collera
e approvarla? Associarsi in ispirito a chi bastona un servo che ha eseguito un incarico?
La questione va dunque posta nei seguenti termini: come si può recitare la scena
suddetta in modo da suscitare nello spettatore un senso di indignazione nei confronti di
una simile manifestazione di collera? Soltanto una indignazione di questo genere, che
scuote lo spettatore dall’empatia, cioè un’indignazione che egli può provare, che può
venirgli in animo solo se riesce a rompere l’incanto della suggestione scenica, è
socialmente giustificabile ai nostri giorni. Tolstoj ha detto cose eccellenti
sull’argomento.
L’immedesimazione era il grande espediente artistico di un’epoca di cui l’uomo
costituiva l’elemento variabile e il suo ambiente l’elemento costante. Ci si può
immedesimare soltanto in un personaggio il quale — a differenza di noi — rechi in
seno gli astri del proprio destino.
Non è difficile rendersi conto che rinunziare all’immedesimazione rappresenterebbe,
per il teatro, una decisione d’immensa portata — sarebbe forse il più grande di tutti gli
esperimenti immaginabili.
La gente va a teatro per venire trascinata, ammaliata, impressionata, per elevarsi,
inorridire, commuoversi, appassionarsi, liberarsi, distrarsi, redimersi, scuotersi,
strapparsi al proprio tempo — per farsi riempire di illusioni. Tuttociò è talmente
sottinteso che i concetti di liberazione, rapimento, elevazione ecc. sono parte
costitutiva della definizione stessa di arte. Se l’arte non fa tutto questo, non è arte.
La questione era questa, dunque: il godimento artistico, in genere, è possibile senza
immedesimazione, o comunque, è possibile procurarlo muovendo da una base diversa?
E che cosa avrebbe potuto fornirci questa nuova base?
Che cosa si sarebbe potuto sostituire alla «paura» e alla «compassione», il classico
«tiro a due» per provocare la «katharsis» aristotelica? Rinunziando alla «ipnosi», a che
cosa ci si poteva appellare? Quale atteggiamento doveva assumere l’ascoltatore, nei
nuovi teatri, se gli si fosse impedito di adagiarsi nell’atteggiamento consueto di
sognante, passiva rassegnazione al destino? Egli non avrebbe più dovuto venir
trasportato dal proprio mondo in quello dell’arte, come vittima di un «kidnapping»,
ma, al contrario, venire condotto, desto e cosciente, nel suo mondo reale. Sarebbe stato
possibile sostituire al timore del fato la sete di sapere, alla compassione lo slancio di
solidarietà? Si sarebbe potuto in tal modo stabilire un nuovo contatto fra la scena e lo
spettatore, dare una nuova base al godimento artistico?
Non posso qui descrivere la nuova tecnica relativa alla costruzione del dramma, alla
messinscena, alla recitazione su cui effettuammo i nostri esperimenti. Essa si fonda sul
principio di provocare, in luogo dell’immedesimazione, lo straniamento.
Che cos’è lo straniamento?
Straniare una vicenda o il carattere di un personaggio significa in primo luogo togliere
semplicemente al personaggio o alla vicenda qualsiasi elemento sottinteso, noto,
lampante e farne oggetto di stupore e di curiosità. Ritorniamo alla collera di re Lear per
l’ingratitudine delle figlie. Mediante la tecnica dell’immedesimazione l’attore può
rappresentare questa collera in modo che lo spettatore la consideri la cosa più naturale
del mondo, non riesca neppure a immaginare che Lear possa non andare in collera, si
renda pienamente solidale con lui, senta esattamente come lui e vada in collera
anch’egli. Invece, mediante la tecnica dello straniamento l’attore rappresenterà la
collera di re Lear in modo che lo spettatore possa stupirsene e immaginare un re Lear
capace di altre reazioni, diverse dalla collera. L’atteggiamento di Lear verrà dunque
«straniato», vale a dire rappresentato come singolare, sorprendente, notevole, come un
fenomeno sociale non ovvio. La sua è una collera umana ma non universalmente
umana e vi sono anche uomini che non la provano. Le esperienze di Lear non devono
scatenare la collera in tutti gli uomini e in ogni circostanza. La collera è bensi una
reazione umana eternamente possibile, ma questa collera, espressa in questo modo e
provocata da una simile causa, è contingente. Straniare significa dunque storicizzare,
significa rappresentare fatti e personaggi come storici e perciò stesso effimeri. Ciò può
avvenire, naturalmente, anche nel caso di personaggi contemporanei, anche i loro
atteggiamenti si possono rappresentare come contingenti, storici, transitori.
Che cosa se ne guadagna? Se ne guadagna che lo spettatore non vede più, sulle scene,
personaggi immutabili, non influenzabili, in totale balia del proprio destino, e può dire:
«Quest’uomo è così e così perché le circostanze sono così e così; e le circostanze sono
così e così perché l’uomo è così e così. Ma è possibile rappresentarlo non soltanto così
com’è, ma anche altrimenti — come potrebbe essere; e anche le circostanze potrebbero
rappresentarsi in altro modo». Se ne guadagna che lo spettatore, a teatro, assume un
nuovo atteggiamento di fronte alle immagini del mondo umano sulla scena,
l’atteggiamento che, come uomo di questo secolo, già assume di fronte alla natura. Egli
verrà accolto anche in teatro come il grande trasformatore, in grado di intervenire nei
processi naturali e sociali, non più destinato a subire il mondo ma a dominarlo. Il teatro
non tenterà più di ubriacarlo colmandolo di illusioni, di fargli dimenticare il mondo, di
conciliarlo col proprio destino ma, d’ora innanzi, gli porrà davanti il mondo perché egli
vi metta mano.
La tecnica dello straniamento venne perfezionata in Germania attraverso una serie di
esperimenti. Nello Schiffbauerdammtheater di Berlino si tentò di perfezionare un
nuovo stile di rappresentazione col concorso dei più dotati fra gli attori della giovane
generazione, come la Weigel, Peter Lorre, Oskar Homolka, la Neher, Busch. I nostri
esperimenti non poterono venir effettuati in modo così metodico come quelli (di
tutt’altro genere) del gruppo di Stanislavskij, Mejerchol’d e Vachtangov, ma in
compenso furono compiuti su un campo più vasto, non soltanto nel teatro
professionale. Gli artisti partecipavano a saggi scolastici, cori di operai, gruppi
filodrammatici e via dicendo. Fin dall’inizio si immisero gruppi filodrammatici in
questo lavoro di formazione. E gli esperimenti portarono a una grande semplificazione
delle apparecchiature, dello stile rappresentativo, delle tematiche.
Si trattava, in sostanza, d’una prosecuzione degli esperimenti precedenti, specialmente
di quelli di Piscator il quale, perfezionando con coerenza le apparecchiature tecniche,
aveva ottenuto alla fine, grazie all’ormai acquisito dominio dei macchinari, una bella
semplicità di recitazione.
Il cosìddetto stile epico, da noi perfezionato nello Schiffbauerdammtheater, mostrò
relativamente presto i suoi pregi artistici, e la drammaturgia non aristotelica già stava
incominciando a trattare grandiosamente i grandi problemi sociali, Si delineava la
possibilità di trasformare gli elementi danzanti e compositivi di gruppo della scuola di
Mejerchol’d da artificiosi in artistici, quelli naturalistici della scuola di Stanislavskij in
realistici. La dizione veniva associata alla gestualità, il linguaggio familiare, la
recitazione di versi si riplasmavano sul cosìddetto principio gestuale. La scenografia
venne totalmente rivoluzionata. I postulati di Piscator, trattati liberamente, permisero la
strutturazione di una scena istruttiva quanto bella. Simbolismo e illuminismo poterono
venir liquidati allo stesso modo e il «principio di Neher», relativo all’allestimento
d’una scenografia conforme alle esigenze delineatesi nel corso delle prove degli attori,
consentiva allo scenografo di trarre vantaggio dalla recitazione e al tempo stesso di
influenzarla. L’autore del copione poteva intraprendere i propri tentativi in costante
collaborazione con attori e scenografi, influenzandoli e venendone influenzato. Intanto,
pittori e musicisti riacquistavano la propria indipendenza e potevano esprimersi sul
tema avvalendosi dei rispettivi mezzi artistici: l’opera d’arte globale veniva proposta
agli spettatori nei suoi elementi separati.
Il repertorio classico costituì fin dall’inizio la base di molti esperimenti. Gli artifici
dello straniamento apersero un ampio accesso ai valori vitali delle drammaturgie di
altre epoche e permisero di eseguire in modo divertente e istruttivo gli antichi lavori di
pregio, senza ricorrere ad attualizzazioni disastrose né a procedimenti da museo.
Il riscatto dalla costrizione dell’ipnosi si mostrò particolarmente benefico per il
moderno teatro di filodrammatici (operai, studenti, bambini). Divenne pensabile la
possibilità di tracciare un limite fra le prestazioni filodrammatiche e quelle
professionistiche senza dover rinunziare ad alcuna delle funzioni fondamentali della
recitazione teatrale. Su tali nuove basi si poterono, ad esempio, associare stili di
recitazione differenti come quelli del gruppo di Vachtangov e Ochlopkov e quelli delle
compagnie filodrammatiche operaie. I numerosi e svariati esperimenti compiuti
durante mezzo secolo parevano aver trovato una comune base d’impiego.
Questi esperimenti non sono tuttavia così facili a descriversi, e qui io devo limitarmi ad
affermare che noi riteniamo di poter effettivamente dare godimento artistico basandoci
sullo straniamento. La cosa non è poi così strana dal momento che, da un punto di vista
puramente tecnico, è già stata fatta in passato: il teatro cinese, ad esempio, quello
spagnolo classico, quello popolaresco dell’era bruegeliana e l’elisabettiano hanno
conseguito risultati artistici con effetti di straniamento.
Questo nuovo stile teatrale sarebbe dunque lo stile nuovo? La sua tecnica sarebbe
ormai perfetta, da potersi abbracciare tutta con lo sguardo? Il risultato definitivo di tutti
gli esperimenti? La risposta è: no. Quella da noi percorsa è una delle tante vie. Gli
esperimenti devono continuare. Il problema permane per tutta l’arte — ed è immenso.
La soluzione qui perseguita è soltanto una fra le molte forse possibili. E il problema
consiste in questo: come può il teatro riuscire divertente e istruttivo al tempo stesso?
Come può uscire dagli spacci di stupefacenti mentali e da centro di illusione venir
trasformato in centro di esperienze? Come può l’uomo del nostro secolo, oggi schiavo
e ignorante ma assetato di libertà e di sapere, l’uomo tormentato ed eroico, vittima di
violenze ed abusi, ingegnoso e mutevole, capace di trasformare il mondo in questo
grande e terribile secolo nostro, come può quest’uomo avere un suo teatro che lo aiuti a
signoreggiare se stesso ed il mondo?
1939
Breve descrizione di una nuova tecnica della recitazione
che produce l’effetto di straniamento
Nelle pagine che seguono si tenterà di descrivere una tecnica della recitazione che
venne usata in alcuni teatri (1)4 per «straniare» lo spettatore rispetto ai fatti
rappresentati. Scopo di questa tecnica dell’«effetto di straniamento» era di far assumere
allo spettatore un atteggiamento d’indagine e di critica nei confronti della vicenda
esposta. I mezzi impiegati erano d’ordine artistico.
Condizione essenziale perché si possa usare l’effetto di straniamento allo scopo
indicato è che la scena e la sala siano ripulite da ogni aura «magica» e che non sorgano
«campi ipnotici». Abbiamo perciò sempre rinunciato al tentativo di creare sulla scena
l’atmosfera di un dato ambiente (stanza al crepuscolo, strada d’autunno) (2), come pure
al tentativo di ricorrere ad effetti speciali mediante un ritmo prestabilito della dizione;
il pubblico non veniva né «sovreccitato» dallo scatenarsi dei temperamenti, né
«ipnotizzato» da una recitazione coi muscoli tesi; insomma, non ci si sforzava di far
cadere il pubblico in trance, di dargli l’illusione che stesse assistendo a un fatto
naturale, spontaneo, non preparato. Come si vedrà più avanti, è necessario far uso di
particolari mezzi artistici per vincere la tendenza del pubblico ad abbandonarsi a
quest’illusione (3).
Condizione per dar luogo all’effetto di straniamento è invece che l’attore corredi ciò
che deve mostrare con un esplicito gesto dimostrativo. La finzione della quarta parete,
che nell’immaginazione dovrebbe separare palcoscenico e pubblico — a giustificare
l’illusione che la vicenda scenica si svolga nella realtà, senza la presenza di spettatori
4
Le cifre fra parentesi rinviano all’appendice riportata alla fine di questo scritto.
— viene perciò naturalmente a cadere; e di massima gli attori possono, in queste
condizioni, rivolgersi al pubblico (4).
Normalmente, il contatto fra il pubblico e la scena avviene, come è noto, per mezzo
dell’immedesimazione. Tutti gli sforzi dell’attore di tipo convenzionale sono diretti a
provocare questo atto psichico, a tal punto che egli — si può dire — fa consistere in
esso la meta precipua della sua arte (5). Già dalle nostre osservazioni introduttive si
deduce che la tecnica che dà luogo all’effetto di straniamento è diametralmente opposta
a quella che si prefigge l’immedesimazione fra attore e personaggio. Essa impegna
l’attore a non agire in modo da provocare il processo d’immedesimazione.
Tuttavia, nell’adempiere il suo compito di riprodurre determinati personaggi e di
mostrarne il comportamento, non è necessario che egli rinunci totalmente all’ausilio
dell’immedesimazione. Può benissimo servirsene, precisamente nella misura in cui se
ne servirebbe qualsiasi persona priva di attitudini e di ambizioni drammatiche, per
imitare un’altra persona, ossia appunto per mostrarne il comportamento. Tale
dimostrazione del comportamento di terze persone avviene giornalmente in
innumerevoli circostanze (quando, per esempio, i testimoni di un incidente
riproducono davanti a nuovi sopraggiunti il contegno degli infortunati, quando un
burlone rifà la buffa andatura di un amico, ecc.), senza la minima intenzione, da parte
di codesti imitatori occasionali, di provocare nei loro spettatori un’illusione di verità.
Essi però si immedesimano pur sempre negli individui imitati, per appropriarsi delle
loro caratteristiche.
L’attore dunque si varrà, come abbiamo detto, anche di questo processo psichico; ma,
contrariamente a ciò che avviene nel modo tradizionale di recitazione — dove
l’immedesimazione si attua nel momento stesso della recita, allo scopo di costringere
lo spettatore a fare altrettanto — se ne varrà solo in uno stadio preliminare, a un
momento dato dell’elaborazione della parte durante le prove.
Ad evitare un’interpretazione troppo «impulsiva», piatta e acritica dei personaggi e
della vicenda, si possono prolungare più del consueto le prove al tavolino. L’attore
deve eliminare ogni tendenza troppo precoce a rivivere dentro di sé la parte, e limitarsi
il più a lungo possibile al ruolo di lettore (non di declamatore). Un procedimento assai
utile è quello di mandare a memoria le prime impressioni ricevute.
L’attore deve leggere la sua parte nell’atteggiamento di chi prova stupore, di chi
contraddice. Non solo il verificarsi degli avvenimenti, oggetto della sua lettura, ma
anche il contegno del personaggio affidatogli, oggetto del suo studio, devono essere da
lui posti sulla bilancia, penetrati nei loro aspetti peculiari; egli non deve prendere
nessuno di questi aspetti come un dato acquisito, come «qualcosa che non poteva
andare altrimenti», che «ci si doveva aspettare dato il carattere del personaggio». Prima
ancora di mandare a memoria la parte, egli deve mandare a memoria ciò che ha
provocato la sua meraviglia e a cui ha avuto motivo di contraddire: poiché questi
momenti devono costituire dei punti fermi nella sua interpretazione.
Quando poi sarà sulla scena, in tutti i momenti importanti, accanto a quello che fa,
permetterà di scoprire, metterà in rilievo, renderà intuibili anche cose che non fa; in
altre parole, reciterà in modo da dare la più chiara evidenza all’alternativa, da far sì che
la sua prestazione lasci intravedere anche le altre possibilità, mentre quella che ha
luogo sulla scena è una sola delle varianti possibili. Dirà per esempio: «Questa me la
pagherai», e nello stesso tempo non dirà: «Ti perdono»; odierà i suoi figli, e non ci sarà
in lui nessun amore per loro; andrà avanti a sinistra, e non indietro a destra. Tutto ciò
che egli non fa, dovrà insomma essere contenuto e racchiuso in ciò che fa. In tal modo
ogni battuta, ogni gesto corrisponde a una decisione, il personaggio resta sotto
controllo e viene collaudato. Possiamo formulare tecnicamente questo procedimento
come la fissazione del «non così - ma così».
L’attore sulla scena non dà luogo alla totale metamorfosi nel personaggio da
rappresentare. Non è Lear, Arpagone o Švejk, ma mostra queste figure. Riferisce i loro
detti quanto più esattamente possibile, riproduce il loro modo di comportarsi per
quanto la sua conoscenza umana glielo consente; ma non tenta di convincersi (e perciò
di convincere gli altri) di essersi completamente incarnato in essi. Gli attori si
renderanno conto di ciò che intendiamo, quando citeremo loro, come esempio di una
recitazione senza immedesimazione totale, il caso in cui un regista, o un altro attore,
mostra a un collega come si debba eseguire un passo particolare. Dato che non si tratta
della sua parte, egli non vi si trasfonderà completamente: sottolineerà gli aspetti tecnici
e manterrà il contegno di chi si limita a suggerire, a proporre (6).
Rinunciato che abbia alla totale metamorfosi, l’attore recita il suo testo non come colui
che improvvisa, ma come chi fa una citazione (7). Beninteso, in questa citazione egli
deve rendere tutti i toni complementari, tutta la concreta plasticità umana
dell’enunciato; del pari, il gesto che egli assume, pur dovendo figurare una semplice
copia (8), deve possedere la piena corposità di un gesto umano.
Per realizzare, in una recitazione con immedesimazione non completa, lo straniamento
degli enunciati e delle vicende del personaggio da rappresentare, possono servire tre
accorgimenti:
1)la trasposizione alla terza persona;
2) la trasposizione al tempo passato;
3) il pronunciare ad alta voce didascalie e commenti.
L’uso della terza persona e del tempo passato consente all’attore il giusto
atteggiamento del «tenersi a distanza». Egli inoltre studia didascalie e frasi di
commento adatte al suo testo e le pronuncia nel corso delle prove («Si alzò e disse con
rabbia, poiché non aveva mangiato:...» oppure: «Udiva questa notizia per la prima
volta e non sapeva se corrispondeva a verità...» o ancora: «Sorrise e disse, troppo
impulsivamente:...»). Il pronunciare le didascalie in terza persona fa sì che due diverse
intonazioni vengano a cozzare l’una contro l’altra, con conseguente straniamento della
seconda, cioè del testo propriamente detto. Inoltre viene straniata la recitazione stessa,
in quanto avviene dopo essere già stata caratterizzata ed annunciata a parole. L’uso del
tempo passato, infine, pone il dicitore in un punto di visione retrospettivo rispetto alla
battuta: in tal modo questa viene ulteriormente straniata, senza però che il dicitore si
ponga in una prospettiva irreale: egli infatti, contrariamente allo spettatore, ha già letto
l’intera opera ed è quindi meglio in grado di giudicare — tenendo conto della
conclusione, del seguito dei fatti — di quanto non sia quest’ultimo, meno informato e,
perciò, più colto di sorpresa di fronte alla battuta.
Attraverso questo procedimento molteplice il testo viene straniato nel corso delle
prove, e tale rimane generalmente anche all’esecuzione (9). Per la dizione in senso
stretto, emerge dal diretto contatto col pubblico la necessità o l’opportunità di
variazioni, secondo il maggiore o minor significato che s’intende imprimere alle
battute. Un esempio può ravvisarsi nelle deposizioni di testimoni davanti ai tribunali.
Le sottolineature, l’agganciamento dei personaggi ai loro enunciati, devono formare
oggetto di un particolare esercizio di virtuosismo. Allorché poi l’attore si rivolge al
pubblico, questo rivolgersi deve essere totale, con esclusione di ogni «discorso a parte»
e della vecchia tecnica teatrale del monologo. Per raggiungere in pieno l’effetto di
straniamento nelle opere in poesia, l’attore farà bene, durante le prove, a rendere
dapprima il contenuto dei versi in prosa corrente, compiendo, se del caso, anche i gesti
prescritti per i versi. Una bella e ardita architettura delle forme linguistiche ottiene
l’effetto di straniare il testo. (La prosa invece può essere straniata col tradurla nel
dialetto nativo dell’attore).
Della gestualità si tratterà più avanti, ma fin d’ora è da osservare che tutto ciò che
attiene al sentimento deve essere esteriorizzato, essere cioè sviluppato nel gesto.
L’attore deve trovare un’espressione percettibile, esterna, per le emozioni del suo
personaggio, possibilmente un’azione scenica che ne tradisca le intime vicissitudini.
L’emozione deve venire alla luce, emanciparsi, per poter essere trattata con maestria.
Da un gesto di particolare eleganza, forza e grazia scaturisce lo straniamento.
Esemplare nel trattamento del gesto è l’arte drammatica cinese: il fatto di studiare
visibilmente i propri movimenti è quello che permette agli attori cinesi di raggiungere
l’effetto di straniamento (10). Ciò che l’attore fornisce nel campo della gestualità, della
metrica ecc., deve essere ben definito, recare il suggello dello sperimentato e del
concluso Deve prodursi un’impressione di facilità, che è quanto dire di difficoltà
superate. La sua stessa arte peculiare, la sua maestria tecnica, devono essere presentate
dall’artista al pubblico in modo da essere accolte facilmente. Egli propone allo
spettatore la vicenda in maniera compiuta, così come, a suo parere, può svolgersi o
essersi svolta nella realtà. Non tenta di nascondere di averla appresa con studio, allo
stesso modo che l’acrobata non nasconde di essersi esercitato; anzi, sottolinea che
quella è la sua — di lui attore — testimonianza, opinione, versione in merito alla
vicenda (11).
Poiché egli non s’identifica col personaggio rappresentato, può scegliere rispetto a lui
un certo punto di vista, manifestare l’opinione che ne ha, sollecitare lo spettatore — il
quale pure, dal canto suo, non è spinto a identificarsi — alla critica del personaggio in
parola (12). Il punto di vista che l’attore sceglie è un punto di vista sociale. Con la
prospettiva che imprime alla vicenda, con la caratterizzazione che dà del personaggio,
egli rende evidenti quei tratti che rientrano nel campo d’azione della società. Così la
sua arte diviene un colloquio (sulle condizioni sociali) col pubblico al quale si rivolge,
e induce lo spettatore a giustificare o a rifiutare quelle condizioni, a seconda della
classe sociale cui appartiene (13). Scopo dell’effetto che studiamo è di straniare il
«gesto sociale» sotteso ad ogni vicenda. Per «gesto sociale» deve intendersi
l’espressione mimica e gestuale dei rapporti sociali che presiedono alla convivenza
degli uomini di una data epoca (14).
La formulazione della vicenda ad uso della società — il presentarla, cioè, in maniera
che la società ne riceva la chiave — è agevolata dall’invenzione di titoli per le singole
scene (15). Questi titoli devono avere carattere storico. Veniamo così a parlare di un
espediente tecnico decisivo la storicizzazione. L’attore deve recitare la vicenda come
una vicenda «storica»: cioè come un fatto che si verifica una sola volta, transitorio,
connesso con una determinata epoca. Il comportamento dei personaggi all’interno della
vicenda non è alcunché di tipicamente umano e invariabile, presenta invece certe
particolarità, aspetti superati o superabili dal corso della storia, ed è soggetto a critica
per chi si ponga dal punto di vista dell’epoca immediatamente successiva. Un processo
di sviluppo costante ci rende ostico il comportamento di quelli che vissero prima di
noi. E questa presa di distanza che lo storico compie verso avvenimenti e modi di
vivere del passato, l’attore deve compierla verso gli avvenimenti e i modi del presente:
deve cioè straniare ai nostri occhi quei fatti e quelle persone.
Fatti e persone della vita d’ogni giorno, del nostro ambiente più immediato, hanno per
noi qualcosa di naturale, appunto perché usuale: lo straniarli serve a renderli inusitati
(16). La tecnica della diffidenza di fronte ai fatti consueti, «ovvi», mai posti in dubbio,
è una meditata conquista della scienza; e non v’è ragione perché l’arte non adotti
questo atteggiamento utile quant’altri mai (17). È un atteggiamento che è venuto alla
scienza dall’incremento della forza di produttività umana, e dallo stesso motivo
proviene all’arte.
Per quanto riguarda la capacità emotiva, i tentativi esperiti con l’effetto di straniamento
negli esempi di teatro epico in Germania, hanno dimostrato che anche da questa tecnica
possono derivare emozioni, pur se si tratta di emozioni di natura diversa di quelle
prodotte dal teatro tradizionale (18). Un atteggiamento critico dello spettatore è un
atteggiamento innegabilmente artistico (19). La descrizione dell’effetto di straniamento
dà un’impressione di artificiosità assai più della sua esecuzione. Naturalmente questo
tipo di recitazione non ha nulla a che fare con la cosiddetta «stilizzazione». Il pregio
principale del teatro epico, basato sullo straniamento — il cui unico scopo è di
rappresentare il mondo in maniera che divenga maneggevole — è precisamente la sua
naturalezza, il suo carattere tutto terrestre, il suo umorismo, la sua rinuncia a tutte le
incrostazioni mistiche che il teatro tradizionale si porta appresso fin dall’antichità.
APPENDICE
1.------------------------------------------2. Se, nel teatro epico, una determinata atmosfera è oggetto della rappresentazione
perché serve a spiegare certi atteggiamenti dei personaggi, anch’essa deve venire
straniata.
3. Esempi di espedienti meccanici: illuminazione vivissima del palcoscenico (perché
un’illuminazione crepuscolare aggiunta alla totale oscurità della sala impedisce allo
spettatore di vedere i propri vicini e lo nasconde ad essi, togliendogli gran parte della
sua obiettività); e visibilità delle sorgenti luminose.
4. Rapporto dell’attore col pubblico. Il rapporto dell’attore col pubblico dovrebbe
essere quanto più franco e diretto possibile. L’attore deve semplicemente comunicare,
presentare qualcosa; e l’atteggiamento di chi si limita a comunicare, a presentare,
dovrebbe d’ora innanzi stare alla base di tutto. Non fa nessuna differenza che la cosa
avvenga in platea fra il pubblico, in mezzo a una strada, in una camera o su un
palcoscenico, quest’assito delimitato e riservato alle comunicazioni e alle
presentazioni; non ha alcuna importanza che l’attore indossi un determinato costume e
si sia creato una maschera — il motivo di queste cose potrà spiegarlo ugualmente bene
sia prima che dopo. Soltanto, egli non deve dare l’impressione che ci fosse un’intesa
preventiva, in base alla quale in quel luogo, a quell’ora, dovesse svolgersi un certo
fatto; e svolgersi come se avvenisse in modo naturale, senza preparazione; un’intesa la
quale prevedesse, fra l’altro, che non dovesse esserci alcuna intesa. Semplicemente si
fa avanti un tale e mostra qualcosa in pubblico, anche l’atto del mostrare. Imita
un’altra persona ma non al punto di diventare quella persona, e non col proposito di far
dimenticare se stesso: e viene visto come una persona qualsiasi, diversa dalle altre pur
con i propri tratti caratteristici — e perciò appunto rassomigliante a tutte le persone che
lo stanno a guardare.
5. Vedi ora le seguenti dichiarazioni del noto attore danese Poaul Reumert:
«... Quando io sento che muoio, quando lo sento veramente, lo sentono anche tutti gli
altri; quando fingo di stringere un pugnale e sono dominato dall’idea di voler uccidere
il bambino, tutti rabbrividiscono... È tutta una questione di attività mentale trasmessa
dai sentimenti — o, se si preferisce, del contrario: d’un sentimento fortissimo,
ossessivo, che si traduce in pensiero. Se questo riesce è la cosa più contagiosa del
mondo; e allora tutte le cose esteriori divengono completamente indifferenti...»
E Rapaport, in The Work of the Actor, Theater Workshop, ottobre 1936: «... Sul
palcoscenico l’attore è interamente circondato da finzioni... Egli deve riuscire a
guardarle come se fossero vere, come se fosse convinto che tutto ciò che lo attornia sia
realtà viva; deve convincersene e convincerne l’uditorio. Questa è la caratteristica
principale del nostro metodo di studio della parte... Prendete un oggetto qualsiasi, un
berretto ad esempio, posatelo su un tavolo o sul pavimento e cercate di guardarlo come
se fosse un grosso topo, non un berretto... Descrivete, dipingete che genere di topo, la
taglia, il colore... Così impariamo a credere in perfetta ingenuità che l’oggetto posto
davanti a noi sia diverso da quello che è, e contemporaneamente impariamo a
costringere l’uditorio a credere la stessa cosa...»
Parrebbe di star leggendo un corso di magia, e invece è un corso di recitazione che si
pretende impostato sul metodo Stanislavskij. Ci si domanda se una tecnica pensata per
mettere la gente in condizione di vedere grossi topi dove non ce ne sono sia veramente
adatta a diffondere la verità. Anche senza minimamente ricorrere all’arte della
recitazione — purché con una sufficiente dose di alcoolici in corpo — chiunque, o
press’a poco, può mettersi in grado di vedere, se non topi di chiavica, almeno qualche
topolino bianco.
6. Ottimo esercizio per un attore è insegnare la propria parte ad altri (a un allievo, a un
collega di diverso sesso, al partner, a un comico e così via), perché ciò facendo egli
fissa per sé il proprio atteggiamento dimostrativo. Gli gioverà inoltre vedere la propria
parte recitata da altri: particolarmente istruttiva gli riuscirà l’interpretazione del
comico.
7. La citazione. In libero e diretto rapporto col pubblico, l’attore fa parlare ed agire il
proprio personaggio — riferisce. Non gli occorre far dimenticare che il testo non nasce
estemporaneamente ma è stato imparato a memoria, è qualcosa di prefissato; egli non
recita una parte, perché l’assunto non è che egli riferisca di sé, ma di altri. Se parlasse a
memoria il suo atteggiamento sarebbe il medesimo. Egli cita un personaggio, è il
testimonio a un processo. Nulla gli impedisce di far capire chiaramente quando il
personaggio parla per moto spontaneo: nel suo comportamento c’è, tutto sommato, una
certa contraddizione (se si osserva chi sta sul palcoscenico e parla): l’attore parla nel
passato, il personaggio nel presente. C’è poi ancora una seconda contraddizione, ed è
di grande importanza. Nulla impedisce all’attore di infondere nel personaggio i
sentimenti che esso deve provare; l’attore non è freddo, anch’egli manifesta dei
sentimenti ma non necessariamente gli stessi del personaggio. Supponiamo che questi
dica qualcosa che crede vero. L’attore può, deve saperlo ripetere facendo sentire che
non è vero, oppure che il dire quella verità provoca conseguenze fatali o qualcos’altro.
8. All’attore del teatro epico è indispensabile raccogliere materiale in quantità
maggiore che per il passato. Egli non deve più rappresentare un sovrano, uno
scienziato, un becchino ecc., bensì sovrani, scienziati, becchini; deve dunque guardarsi
intorno nella realtà. Deve pure imparare a copiare, cosa severamente vietata dalle
moderne scuole di recitazione perché «rovina le caratteristiche personali».
9. Da parte del teatro, l’effetto di straniamento adatto al caso può venir prodotto in vari
modi. Nella Vita di Edoardo II d’Inghilterra rappresentata a Monaco, le scene vennero
per la prima volta precedute da titoli indicativi del contenuto; nella rappresentazione
berlinese dell’Opera da tre soldi si proiettarono i titoli dei song mentre questi venivano
cantati; e in Un uomo è un uomo, pure rappresentato a Berlino, si proiettarono le figure
degli attori su grandi schermi.
10. -------------------------------------------------------11. Soprattutto è da osservare quella recitazione sommaria, riassuntiva, filata delle
prove immediatamente precedenti la recita, quando gli attori si limitano ad
«accennare» di sfuggita le posizioni, i gesti, le intonazioni di voce. Queste prove,
tenute anche spesso per orientare i nuovi attori nel caso d’una nuova distribuzione delle
parti, servono unicamente a chiarirsi le idee; ci si deve quindi immaginare anche l’atto
di rivolgersi al pubblico, ma non in modo che esso avvenga per intensificazione, cioè
per suggestione. Da osservarsi la differenza fra recitazione suggestiva e recitazione
plastica, convincente!
12. Nell’Espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali Darwin si duole che lo
studio dell’espressione sia tanto difficile perché «quando siamo testimoni d’un fatto
profondamente eccitante ci emozioniamo talmente, per simpatia, da dimenticarci, o da
perdere quasi totalmente la capacità, di osservare con attenzione». L’artista deve
partire di qui e rappresentare anche gli stati di emozione più profonda in modo che il
testimone — lo spettatore — conservi la capacità di osservare.
13. Il libero atteggiamento dell’attore nei confronti del pubblico consiste anche nel non
trattarlo come una massa uniforme, nel non fonderlo entro il proprio calderone
emozionale per ridurlo a un agglomerato informe. Egli non deve rivolgersi a tutti nella
stessa misura ma rispettare le divisioni esistenti fra il pubblico, anzi, approfondirle. Là
in mezzo ci sono amici e nemici, ed egli deve mostrarsi gentile verso gli uni, ostile
verso gli altri; prender partito, non sempre per il proprio personaggio ma, se non per
lui, contro di lui. (Questo, almeno, è l’atteggiamento fondamentale; ma dev’essere
anch’esso mutevole, variare a seconda delle diverse dichiarazioni del personaggio. Ma
vi possono anche essere alternative ove tutto rimane indeciso, ove l’attore sospende il
giudizio; tuttavia egli deve indicarlo chiaramente attraverso la recitazione).
14. Quando re Lear (atto I, scena i), nel ripartire il proprio regno fra le figlie, strappa
una carta geografica, l’atto della ripartizione viene straniato. Lear, in tal modo, non
soltanto attrae l’attenzione sul regno ma, per il fatto di trattarlo così evidentemente
come proprietà privata, getta un po’ di luce sui fondamenti dell’ideologia familiare
feudale. Nel Giulio Cesare il tirannicidio di Bruto risulta straniato se mentre questi, nel
suo monologo, accusa Cesare di atti tirannici, maltratta uno schiavo che lo serve. Nella
parte di Maria Stuarda, la Weigel portava al collo un crocifisso e all’improvviso se ne
serviva come d’un ventaglio per arieggiarsi con civetteria.
15 – 16. --------------------------------------------------17. L’effetto di straniamento come pratica di vita quotidiana. Nella produzione
dell’effetto di straniamento ci troviamo di fronte a un qualcosa di estremamente
consueto, già visto migliaia di volte; non è che un modo, già abbondantemente
praticato, di far capire qualcosa a se stessi e agli altri, e lo si può osservare in questa o
quella forma sia nello studio che nelle conferenze di affari. L’effetto di straniamento
consiste nel portare a comprensione una cosa usuale, nota, sempre sott’occhio,
richiamando l’attenzione su di essa in modo da farla apparire speciale, sorprendente,
inattesa. L’ovvio viene reso, in certo qual modo, incomprensibile — ma unicamente
perché risulti molto più comprensibile dopo. Perché una cosa nota possa venire
riconosciuta deve uscire dalla sua inappariscenza: bisogna farla finita con l’abitudine di
credere che essa non richieda schiarimenti. Per quanto usuale, modesta, popolare possa
essere, dovrà d’ora innanzi ricevere l’impronta dell’insolito. Un semplice effetto di
straniamento lo si può ottenere domandando a qualcuno: «Hai mai guardato bene il tuo
orologio?» Chi parla sa che io l’ho già guardato molte volte ma con la sua domanda mi
fa capire di non alludere alla solita occhiata che ormai non mi dice più nulla. Io
guardavo l’orologio per vedere l’ora, adesso, messo alle strette, mi rendo conto di non
averlo mai degnato d’uno sguardo stupito, benché esso sia, in molti sensi, un
meccanismo sorprendente. Altro semplice effetto di straniamento lo si ottiene aprendo
una discussione di affari con la frase: «Avete mai riflettuto come vanno a finire i rifiuti
che, giorno per giorno, la vostra fabbrica scarica nel fiume?» Questi rifiuti finora non
erano andati a finire nel fiume all’insaputa di tutti; Io scarico era stato accuratamente
predisposto con impiego di uomini e di macchine, il fiume ne era già tutto verde, i
rifiuti defluivano in modo ben evidente. Quindi ci si era pensato, ma come a rifiuti
soltanto — roba dannosa al processo di fabbricazione. Ma ora deve diventare oggetto
della fabbricazione e l’occhio si sofferma a considerarla con interesse. Quella domanda
ha ottenuto l’effetto di straniarla, ed era ciò che doveva fare. I mezzi più elementari per
ottenere effetti di straniamento sono le proposizioni con l’avversativo «non — ma»
(«Egli non disse “entrate” ma “andatevene”; la cosa non gli fece piacere ma lo irritò»).
C’era un’attesa giustificata dall’esperienza ma venne delusa. Si sarebbe potuto credere
che... ma non lo si sarebbe dovuto credere. Non esisteva una sola possibilità ma due e,
citando entrambe, si è straniata dapprima la seconda e quindi la prima di esse. Perché
un uomo possa vedere nella propria madre la moglie di un uomo è necessario un effetto
di straniamento, e ciò si verifica per esempio quando nella sua vita entra un patrigno.
Vedere il proprio maestro nelle grinfie di un ufficiale giudiziario produce un effetto di
straniamento: strappato da un rapporto in cui ci appariva grande, il maestro viene
trascinato in un altro in cui ci appare piccolo. Si ha lo straniamento di un’auto se, dopo
esserci serviti con frequenza di macchine moderne, saliamo su una vecchia Ford
modello T. Improvvisamente torniamo ad udire delle esplosioni: il motore è dunque un
«motore a scoppio». Incominciamo a stupirci che un simile veicolo — che un qualsiasi
veicolo non trainato da forza animale — riesca a camminare; prendiamo, insomma,
coscienza dell’auto, rendendoci conto che è qualcosa di insolito, di nuovo, un successo
della meccanica; in quanto, dunque, la consideriamo un qualcosa di innaturale. La
natura, di cui anche l’auto indiscutibilmente fa parte, ci ha tutt’a un tratto rivelato il suo
intrinseco aspetto innaturale, e il suo concetto ne è ormai saturato. Anche l’avverbio
«effettivamente» può straniare una frase. («Effettivamente non era in casa; così ci
disse, ma noi non ci credemmo e lo abbiamo cercato»; oppure: «Non avremmo creduto
possibile che non fosse in casa, ma effettivamente non c’era»). Non meno utile è
l’avverbio «proprio». («Proprio non sono d’accordo»). Anche la seguente definizione
degli esquimesi può straniare l’auto: «L’auto è un aereo senz’ali che striscia per terra».
La precedente esposizione avrà in un certo senso straniato lo stesso effetto di
straniamento; noi abbiamo tentato di portare a comprensione un processo abituale,
frequentissimo, rilevabile ovunque, presentandolo come una singolarità. Ma l’effetto ci
sarà riuscito soltanto su coloro i quali avranno veramente («effettivamente») compreso
che esso «non» è prodotto da qualsiasi rappresentazione «ma» soltanto da alcune:
soltanto quando è «proprio» così è qualcosa di usuale.
18 – 19. ---------------------------------------------------1940
Il mestiere dell’attore (1935-41)
[Costruzione del personaggio]
1. Il metodo graduale per lo studio e la costruzione del personaggio.
L’attore deve usare con parsimonia della fantasia; costruire il personaggio procedendo
di battuta in battuta, controllandosi di continuo in riferimento ad esso, raccogliendo,
scena per scena, conferme e contraddizioni alle battute che deve pronunziare o udire,
imprimendosi bene nella memoria questo procedimento dell’«a poco a poco» onde
essere in grado, al termine dello studio, di presentare il personaggio allo spettatore
nella gradualità della sua evoluzione. Tale gradualità deve permanere non soltanto nei
mutamenti che il personaggio subisce attraverso i fatti e le situazioni della vicenda, ma
anche nello svelarne allo spettatore la struttura essenziale; e ciò per assicurargli le
sorprese, talvolta piccole ma sempre importanti, che il personaggio stesso gli riserva,
così da mantenerlo nell’atteggiamento di chi scopre ed impara tutto daccapo. Perché
ciò sia possibile, l’attore deve imprimersi profondamente nella memoria le sorprese
personalmente provate durante lo studio, ch’egli avrà effettuato tenendo appunto
l’atteggiamento di chi scopre ed impara tutto daccapo. Questo procedimento graduale è
migliore di quello deduttivo e sviante che, prendendo le mosse da un’idea d’insieme
della figura da rappresentare, concepita affrettatamente dopo una fugace scorsa della
parte, ricava, per così dire, a posteriori, dai materiali sotto mano, dal copione, gli
argomenti e le occasioni utili agli sviluppi del tipo in questione. In tal modo molta
parte del materiale rimane inutilizzata e il resto viene il più delle volte travisato, e
quindi indebolito. Ma soprattutto è questa maniera di prendere conoscenza di un uomo
a non essere raccomandabile. Procedendo così, l’attore vela agli occhi dello spettatore
il processo attraverso il quale egli stesso è giunto a conoscenza del personaggio.
Anziché trasformarsi sotto i suoi occhi, gli si presenta davanti già trasformato, come un
fatto compiuto, non influenzato da nulla e, apparentemente, non influenzabile in alcun
modo, come un essere generico, assoluto, astratto. Il giudizio ch’egli consente di
esprimere non consente più di mutare nulla nel personaggio. Tali giudizi sono pertanto
inutili e non devono venir resi possibili. Il più delle volte, d’altronde, in questo modo
non si perviene a un giudizio ma solo a una emozione personale. Gli attori che
procedono così, anziché dare del personaggio indicazioni esatte, vedute d’assieme ben
valutabili, ne danno un qualcosa che rimane nella memoria come un’immagine
confusa, più grande del vero — il cosìddetto «mythos»; ne danno una cattiva copia,
non l’immagine originale, danno il ricordo, anziché «divenire» ricordo. Per la
realizzazione di simili quadri visionari, più grandi del vero, i mezzi forniti dal
«materiale» nonché quelli dell’attore molto spesso non sono sufficienti; e sotto
l’impressione di «voler far grande» sorge quella della guitteria. Eppure, gli attori per
natura propendono assai più alla maniera deduttiva, anzitutto perché possono
incominciare prestissimo, magari fin dalla prima prova, a «fare l’attore»: a sentirsi,
cioè, quel tipo di attore che hanno in mente e desiderano impersonare più d’ogni altra
cosa, ancor più del personaggio specifico, concreto, di turno. Chiamata in causa in tal
misura, la fantasia esercita una funzione dannosa; ma nel procedimento induttivo,
graduale, essa è assolutamente indispensabile. Procedendo di battuta in battuta, chi
studia ha continuamente bisogno che la fantasia gli ponga davanti all’occhio interiore
personaggi via via più precisi, poi già solidi e infine quasi perfetti, in condizione di
poter pronunziare quella determinata battuta in quella determinata situazione. Battute e
situazioni volta a volta susseguenti si devono studiare tanto seriamente e tanto
spregiudicatamente rispetto alle costruzioni (soluzioni) anticipate — e perciò
probabilmente precipitose — della fantasia, da poter suggerire emendamenti di queste
costruzioni fantastiche. Così come l’attore deduttivo non fa bene a fissarsi troppo
presto su un tipo fondamentale, l’attore che procede induttivamente non fa bene a
fissarsi su certi «tratti» caratteristici. Tutte le sue ricerche, con l’ausilio della fantasia e
del controllo dei fatti, devono tendere alla scoperta e alla rappresentabilità del
personaggio globale, come figura concreta e in evoluzione.
2. Procedendo gradualmente, può l’attore trascinare l’uditorio?
Il procedimento graduale potrebbe apparire meschino e suggerire all’attore la
preoccupazione di non giungere mai, per tale via, a trascinare l’uditorio. La fatica che
egli si dà, e che gli si consiglia persino di lasciar intravvedere nel risultato finale, non
toglierà al medesimo l’apparenza (così importante!) della cosa facile, spontanea?
Questa preoccupazione nasce, a nostro avviso, da una falsa idea del significato di
«trascinare». Fa parte del trascinare la volontà di resistenza di chi dev’essere trascinato.
Il trascinatore deve poter contare sulla propria forza di trazione come su quella di
resistenza di chi egli vuole trascinare. Deve dapprima porsi in uno stato di lucida
obiettività per poi saperlo trasformare in ebbrezza. L’altitudine d’un rilievo la si valuta
soltanto in rapporto al livello del suolo. E il trascinatore, mentre trascina, deve mostrar
l’atto del trascinare anche all’uomo che trascina — perché ciò può essergli necessario
quanto il venir trascinato. Considerato da un altro punto di vista, egli deve dare
un’impressione di autenticità e ispirare fiducia; perché chi gli si abbandona deve poter
contare proprio su di lui.
3. La scelta dei tratti caratteristici.
Studiando il personaggio da rappresentare, la cosa migliore è procedere gradualmente.
Da quali punti di vista, o per chi, o per quali fini si deve studiare e costruire il
personaggio? Mentre l’attore, quando studia, cerca di ripetere tutte le estrinsecazioni
del personaggio con un minimo di partecipazione spirituale, nei toni a lui più comodi, a
puro titolo di prova, attribuendo invece la massima importanza alla scoperta di gesti
drastici, tenta pure di scoprire, attraverso tanti piccoli tratti caratteristici isolati,
l’essenza tipica e insieme particolare del personaggio, pronto a stupirsene egli stesso
per primo. (La tecnica della disposizione allo stupore si può imparare ed è una delle più
importanti per l’attore. Poiché il suo compito principale consiste nel far notare talune
cose, egli deve essere in grado di trovar sorprendenti tutte le cose). Attento e divertito
(anche questi sono atteggiamenti apprendibili, non vuote espressioni — accorgimenti
facenti parte del lavoro, come le posizioni del corpo del falegname accanto al banco),
divertito anche quando ricerca nel campo del tragico, egli si sforza di mettere insieme
soprattutto i tratti caratteristici contraddittori; il suo compito è unirli ed equilibrarli in
un personaggio preciso, concreto, facile a distinguersi e diverso dagli altri; ma al fine,
poniamo, di rendere più agevole questo lavoro, non gli è concesso trascurare talune
caratteristiche chiaramente rilevabili, e cioè partire dall’assieme basandosi su un’idea,
a suo modo di vedere, centrale. Per la costruzione del suo personaggio egli deve usare
appunto i tratti caratteristici «non confacenti», cioè quelli contraddicenti agli altri. Ma
anche quando è già personaggio completo, intrinsecamente contraddittorio, egli deve
tenersi a totale disposizione della vicenda, lasciarsi, per così dire, usare per tutti gli usi
ma continuare a fare il possibile perché il conto non torni mai esattamente. Proprio
così: l’attore raffrena il corso dell’azione non meno di quanto lo rende possibile,
procede di pari passo con esso, impuntandosi, trascinando o facendosi trascinare.
Perché i singoli tratti del suo comportamento non sono ricavati esclusivamente dal
copione, dal «mondo del poeta», ma egli stesso (staccando un determinato tratto
caratteristico dal contesto, dal «mondo del poeta» e inserendolo nell’altro mondo,
quello reale, a lui noto) ha dato loro un significato speciale, trascendente il testo del
lavoro e non nato interamente da esso.
Ma con quali criteri, per chi, o a che scopo l’attore sceglie i tratti caratteristici in questa
maniera graduale? Li sceglie in modo che il prenderne conoscenza renda possibile la
trattazione del personaggio. Quindi dall’esterno, dal punto di vista del mondo esteriore,
delle persone circostanti, della società.
L’attore si attiene dunque a ciò che il personaggio obiettivamente fa — a ciò che
intraprende e che gli altri possono percepire. Il secondo aspetto, quello contraddittorio,
che pure dev’essere nel personaggio e di cui abbiamo parlato, è l’altra alternativa
dell’azione, volta a volta teoricamente possibile, desunta anche dalla situazione di
classe e dalle circostanze (con la tecnica del distacco dal contesto) — l’azione che però
quell’individuo non compie. Anch’essa deve essere resa visibile dall’attore. I «tratti
caratteristici» saranno dunque, in un certo senso, simili a «mosse sulla scacchiera», non
pure e semplici espressioni (reazioni a determinati stimoli) d’una persona definita in
modo affatto autonomo. E quando saranno espressioni dovranno venir motivate
dall’ambiente. I tratti caratteristici hanno cause e conseguenze sociali. Soltanto se
costruiti così i personaggi risultano trattabili e, per tramite loro, partendo dal
personaggio soggettivamente inteso, diventa possibile mostrare una maniera di trattare
il mondo circostante.
4. La diversità rappresentata per amore della diversità.
Abbiamo spiegato perché l’attore non debba costruire il personaggio basandosi
esclusivamente sul suo comportamento indicato dal testo; perché assolutamente non
basti fornirlo soltanto dei requisiti necessari al procedere dell’azione. Il personaggio
deve avere in più un che di concreto, di irripetibile, nonché la possibilità di agire —
entro certi limiti sociologici — diversamente da quanto agisce. Oppure deve risultare
evidente che agisce così e non altrimenti, e che la sua azione potrebbe venir compiuta
anche da persone totalmente diverse. Si deve, cioè, poter dire: «In generale ci sono tipi
ben diversi che agiscono come costui». Ma questo differenziarsi del personaggio
l’attore non deve condurlo troppo oltre. La constatazione «Come sono diversi gli
uomini!» è una verità parziale. È necessario dirla se si nega che per indurre gli uomini
— o per lasciarsi indurre da loro — a fare qualcosa si debba prendere in esatta
considerazione i singoli individui.
Ma questa verità parziale viene spesso spacciata per la suprema conclusione della
saggezza, al fine di negare la possibilità di prevedere qualsiasi azione umana. Appunto
studiando le differenze concrete esistenti fra uomo e uomo si possono predire le azioni
presumibili dei vari individui; e a tale scopo le differenze devono venire esposte e
spiegate. Dire: «Come sono diversi gli uomini!» sottolineando l’assoluta impossibilità
di fare previsioni, e immaginare che simili verità possano arricchire l’uomo è falso.
Coloro i quali danno questa accentuazione alla frase suddetta, trovano appagamento
nella varietà di aspetti e nell’irrefrenabile potenza dell’essere umano, alludono alla
possibilità di ulteriori e finora impensabili evoluzioni e, mentre si atteggiano
assolutamente impotenti di fronte a tanta fecondità e varietà di aspetti, cercano di
persuadere se stessi e gli altri di esserne partecipi — pur senza far nulla perché ciò sia
vero. Rimpiccioliscono l’uomo per ingrandire l’umanità. Ma queste sono sciocche
illusioni. Perché, in realtà, così facendo essi si scusano di subire tali e tante influenze
da ogni parte, e di esser, da parte loro, tanto privi di influenza in ogni direzione; e
persistono, di fronte a se stessi, nella loro fede miracolistica. Come se non facessero
parte anche loro dell’umanità!
L’attore non deve dunque cercare di trasmettere questa verità parziale in una forma
inebriante, ma deve invece farla immediatamente seguire dalla domanda risolutiva: «In
che modo sono dunque diversi gli uomini, praticamente parlando?»
5. Lo storicizzare.
Agli occhi di chi storicizza, l’uomo ha un che di ambiguo, di incompiuto. Egli appare
in più d’un personaggio. È com’è, senza dubbio, perché nel suo tempo ve ne sono
motivi sufficienti; ma contemporaneamente è anche un altro, se si fa astrazione dal
tempo e lo si lascia foggiare da un’altra epoca. Proprio perché oggi è così, ieri sarebbe
stato diverso. Ha ricevuto, in più, quello che i biologi chiamano plasticità. Molte cose
si celano in lui, già sviluppate e ancora passibili di sviluppo. Si è già modificato e può
pertanto modificarsi ancora. Se non potesse modificarsi più oltre (almeno, non in modo
decisivo) anche questo contribuirebbe a completarne l’immagine. Ma effettivamente,
soltanto se inserito nell’ambito di grandi unità sociali egli potrebbe incorrere in una
simile immutabilità.
Per l’attore si tratta dunque di prestare alla propria voce un’enorme quantità di suoni
armonici superiori. Il suo personaggio storicizzato parla come con molti echi, che
vanno pensati simultaneamente ma con contenuti sempre diversi.
6. La singolarità del personaggio.
Quando dunque il personaggio viene storicizzato — presentato cioè come carattere
condizionato dal tempo e perciò effimero, quando fra le numerose risposte che devono
risuonare per simpatia ne dà una sola, mentre le altre (quelle che non dà) potrebbe darle
in circostanze leggermente diverse — quel personaggio non è semplicemente ognuno
di noi? Secondo o i tempi o l’appartenenza a una data classe sociale, un individuo dà
una certa risposta; se fosse vissuto in altri tempi, o meno a lungo, o nella zona d’ombra
della vita, avrebbe indubbiamente risposto in altro modo, seppure con la stessa
sicurezza e come chiunque avrebbe risposto in quella situazione, in quel tempo: non
verrebbe fatto di domandare se non potrebbero esservi ancora molte altre risposte
diverse? Dov’è mai l’uomo vivo, inconfondibile, che rispetto ai propri simili (uomini
nella sua stessa situazione) non è del tutto uguale? Nessun dubbio, è questo l’Ego che
deve venire rappresentato. Colui che qui reagisce non può limitarsi [a mostrare] il
proprio «IO» (degli attori) e il «TU» (degli spettatori), soltanto in una situazione
diversa. La rappresentazione che egli ne dà quale appartenente a una classe, a
un’epoca, non è possibile senza la rappresentazione che egli ne dà quale essere vivente
particolare, nell’ambito della propria classe e della propria epoca. Consideriamo la
religiosità di un personaggio e facciamo che sia un operaio. La grande industria
distrugge in misura gigantesca le concezioni religiose della classe operaia; ma
l’operaio singolo reagirà in modo molto diverso a tali problemi. Noi possiamo sempre
essere tentati di ricondurre la sua reazione — ov’essa sia diversa da quella più generale
— a differenze di natura sociale, ed anche essere in grado di farlo; ma ciò potrebbe
rimanere molto teorico, vale a dire, noi potremmo anche non disporre delle misure
sociali atte a mutare la sua reazione nel senso di quella più generale (di classe). Agli
effetti pratici (dell’azione sociale) noi ci imbattiamo in un qualcosa di immobile, in un
amalgama che resiste ai nostri strumenti, in qualcosa che dobbiamo trascinarci dietro
nelle nostre rappresentazioni perché costituisce una parte di quell’uomo. Gli armonici
superiori riecheggianti nelle sue risposte non proverranno più da lui, posto in una
situazione o in un tempo diverso, bensì da gente non simile a lui — da altri.
Rapporto dell’attore col suo pubblico
1. Il rapporto dell’attore col suo pubblico dovrebbe essere il più libero e diretto
possibile. Egli ha semplicemente da comunicargli e da rappresentargli una certa cosa, e
perciò l’atteggiamento base di tutto dovrebbe essere quello di chi comunica e di chi
rappresenta. Al riguardo non fa differenza se la comunicazione e rappresentazione ha
luogo in mezzo al pubblico, su una strada o in una stanza, oppure sulla scena, su questo
assito circoscritto, riservato alle comunicazioni e alle rappresentazioni. Non ha
importanza se l’attore abbia già indossato un particolare vestito e si sia fatto un trucco:
la ragione di questi accorgimenti egli la può chiarire a posteriori come a priori. Quella
che non deve sorgere è l’impressione che in altri tempi ci sia stata una convenzione per
la quale, qui e in una data ora, debba verificarsi un certo fatto, riguardante determinate
persone, come se avvenisse proprio in quel dato momento, in modo impreparato e
«naturale»; e che in quella convenzione fosse detto che non deve risultare nessuna
convenzione. Uno non fa che apparire in scena e mostra qualcosa in tutta franchezza,
anche il fatto di mostrare. Imiterà un’altra persona, ma non in modo, non al punto di
essere lui quella persona, non con l’intento di far dimenticare se stesso. La sua
personalità rimane inalterata, come una qualunque personalità distinta dalle altre e
provvista di tratti propri: una personalità, perciò, simile a tutte le altre che la stanno a
guardare. Ciò dev’essere detto perché l’uso è tutt’altro. Abitualmente l’attore non
guarda gli spettatori prima di presentare la propria esecuzione, non usa agire
rivolgendosi manifestamente al pubblico, in modo accentuatamente diretto. Questo
«guardare la gente negli occhi» come per dire: «Fa’attenzione a quanto sta per fare il
personaggio che ti presento», oppure: «Hai visto?», «E tu che ne pensi?», se
artisticamente trattato (poiché è suscettibile di molte sfumature) può cancellare ogni
traccia di rigidità, di primitivismo; ma è questo che va fatto, perché questo è
l’atteggiamento fondamentale di chi vuol conseguire l’effetto di straniamento; tale
effetto non può basarsi su niente altro.
2. Perché mai l’attore dovrebbe limitarsi a fornire allo spettatore l’occasione di vivere
un’«esperienza», avendo la possibilità di fornirgli un’occasione di acquisire una
«cognizione»? Certo, un modo di «capire» l’attore è il fatto che egli, provando dolore,
generi dolore; ma allora egli scarica soltanto la forza d’immaginazione dello spettatore
invece di aggiungere qualcosa alle sue cognizioni, il che è qualcosa di più. Si potrebbe
dire che provare dei sentimenti arricchisce la conoscenza di se stessi; ma è proprio
questo che non va: è meglio che l’attore impari a trascurare se stesso e la propria sfera
sentimentale, e a conoscere quella altrui! Perfino i propri sentimenti si provano meglio
se vengono presentati come quelli di un altro! Perciò l’attore deve produrre
tecnicamente i propri effetti, vale a dire mostrare che può comprendere quanto non
coincide perfettamente con quanto sta avvenendo sulla scena (a una determinata
persona, in determinate situazioni).
Egli deve mostrare fin dapprincipio ciò che di lui possono percepire tutti coloro che
agiscono al suo fianco sulla scena, e quindi non si immedesimano con lui. Così, ad
esempio, volendo mostrare lo spavento di un personaggio ne mostrerà di preferenza lo
sforzo di dominare o nascondere quello spavento. Un attore procedendo così agisce in
concreto sullo spettatore anziché limitarsi ad «essere».
In questo modo i personaggi nascono attraverso la conoscenza del loro comportamento
verso altri personaggi.
Ciò è molto importante, perché per qualsiasi raggruppamento umano l’essenziale è che
il singolo individuo venga giudicato secondo quanto egli fa o mostra di sé al gruppo
stesso, e veda in viso ciò che come tale può suscitare in un altro. Non basta essere. È la
funzione che crea il carattere di un uomo.
L’arte drammatica intesa a questo fine poggia più sulla gestualità che non
sull’espressione. Anche le parole devono venir ricondotte ad un gesto.
Quando tu mostri: «È così», fallo in modo che lo spettatore si domandi: «È proprio
così?»
Dialogo su una attrice del teatro epico
L’ATTORE Ho letto i Suoi scritti sul teatro epico. Ma poi quando ho assistito alla
rappresentazione del Suo piccolo dramma sulla guerra civile spagnola, con la più
eminente attrice di questo nuovo stile drammatico nella parte della protagonista,
sinceramente, sono rimasto stupito. Stupito che fosse vero teatro.
IO Davvero?
L’ATTORE La sorprende che, dopo aver letto i Suoi scritti su questo nuovo stile
drammatico, mi aspettassi qualcosa di arido, di astratto, di pedante, insomma?
IO Non eccessivamente. La cultura non gode buona fama.
L’ATTORE Non Le riuscirà certamente lusinghiero. Ma mi ero preparato ad
assistere a un qualcosa che non avesse nulla a che fare col teatro, non soltanto perché
Lei nei Suoi scritti propugna un teatro didattico, ma perché sembra voler eliminare
tutto ciò che rende teatrale il teatro.
IO E cioè?
L’ATTORE L’illusione, la tensione, la possibilità di immedesimarsi.
IO E Lei ha seguito con attenzione?
L’ATTORE
Sì.
IO Si è immedesimato?
L’ATTORE
Non completamente. No.
IO È riuscito a crearsi un’illusione?
L’ATTORE
Veramente no. No.
IO Eppure ha avuto l’impressione che fosse teatro?
L’ATTORE
Sì, l’ho avuta. E proprio questo mi ha stupito. Ma non canti ancora
vittoria. Era teatro, ma niente di così nuovo come mi sarei aspettato dopo aver letto i
Suoi scritti.
IO Le sarebbe parso veramente nuovo se non fosse stato vero teatro. È così?
L’ATTORE
Voglio dire, non mi è parso poi tanto difficile fare ciò che Lei vuole. A
parte la protagonista, la Weigel, gli altri erano tutti profani, semplici operai che non
avevano mai messo piede su un palcoscenico. La Weigel invece ha una grandissima
tecnica. Si è formata, molto evidentemente, sull’antico teatro tradizionale da Lei tanto
vilipeso.
IO D’accordo. Il nuovo stile di recitazione ci dà un vero teatro. A certe condizioni
permette di recitare anche ai profani, purché non abbiano ancora imparato
completamente lo stile drammatico del vecchio teatro — e permette di recitare anche
agli artisti, purché quello stile lo abbiano almeno in parte dimenticato.
L’ATTORE Oh! Trovo che la Weigel di tecnica dimostrava di averne anche troppa!
IO Non dimostrava, mi pare, soltanto la sua tecnica; mostrava anche come si
comporta una pescivendola di fronte a dei generali. Non è vero?
L’ATTORE Certo. Ma mostrava anche la sua tecnica. Voglio dire, non era una
pescivendola, ma ne recitava la parte.
IO E difatti non è una pescivendola: si limita a recitarne la parte. Questo è un dato di
fatto.
L’ATTORE Naturale, è un’attrice. Ma quando recita da pescivendola dovrebbe farlo
dimenticare. Mostrava tutto ciò che di notevole, di caratteristico c’è in una
pescivendola. Ma lasciava anche vedere che lo mostrava.
IO Capisco. Non dava l’illusione di esserlo.
L’ATTORE Sapeva anche troppo bene quello che doveva essere messo in rilievo. Si
vedeva che lo sapeva. Mostrava, anzi, di saperlo. Ma una vera pescivendola,
naturalmente, non lo sa, non sa che cosa c’è di degno di nota, in lei. Però, se sulla
scena si vede una persona che lo sa, quella che si vede non è una pescivendola.
IO No, capisco: è un’attrice.
L’ATTORE Mancava soltanto che in certi momenti si rivolgesse al pubblico come
per domandare: «Lo vedete che tipo di donna sono?» Sono convinto che si è costruita
tutta una tecnica per mantenere costantemente desta questa sensazione nel pubblico,
per ricordargli di continuo di non essere quello che rappresenta.
IO Potrebbe descrivermi questa tecnica?
L’ATTORE Se, prima di ogni battuta, lei avesse pensato dentro di sé: «Allora la
pescivendola disse», la battuta sarebbe venuta fuori all’incirca in quel modo.
Pronunziava ostentatamente le frasi di un’altra donna, intendo dire.
IO Questo è giusto. Ma perché Lei fa pensare all’attrice quell’«allora disse»? Perché
al tempo passato?
L’ATTORE Perché rifaceva chiaramente qualcosa di avvenuto in passato. Vale a
dire, lo spettatore non aveva l’illusione che il fatto stesse accadendo in quel momento,
non si sentiva presente a un avvenimento originale.
IO Infatti, lo spettatore non è mai presente a un avvenimento originale. Non è in
Spagna, ma a teatro.
L’ATTORE Ma a teatro si va per avere l’illusione di essere in Spagna, se l’azione si
svolge in quel paese. Perché si andrebbe a teatro, altrimenti?
IO La Sua è una esclamazione o una domanda? Penso si possano trovare motivi per
andare a teatro anche senza voler avere l’illusione di trovarsi in Spagna.
L’ATTORE Se si vuole rimanere qui a Copenaghen non c’è bisogno di andare a
teatro a vedere un lavoro ambientato in Spagna.
IO Lei potrebbe anche dire: «Se si vuole restare a Copenaghen non c’è bisogno di
andare a teatro per vedere un lavoro ambientato a Copenaghen». Le pare?
L’ATTORE Se a teatro non si prova qualcosa che non si può provare anche a casa
non c’è bisogno di andarci, infatti.
[I maestri mostrano il mutamento]
I maestri mostrano le cose mostrandone il mutamento. La miseria diventa visibile sotto
forma di decadenza o di arretratezza. In un ambiente miserevole, un avanzo — o il
presentarsi — di qualcosa di buono mostra la miseria. Le differenze fra i vari quadri
devono venir studiate e messe in evidenza con cura. Se si sommerge un campo sotto
masse di sabbia, fra il quadro senza sabbia e quello senza campo deve esserci un
quadro in cui un albero emerga ancora dalla sabbia.
Il mutamento
ATTORE Tu dicevi che l’attore deve mostrare il mutamento delle cose. Che cosa
significa?
SPETTATORE Significa che il vostro spettatore è anche uno storico.
ATTORE Allora tu stai parlando di lavori storici?
SPETTATORE I lavori ambientati in epoche passate si chiamano storici, lo so. Ma
voi raramente li recitate per un pubblico di storici.
ATTORE Potresti dirmi che cosa intendi per «storici»? Non vorrai certo alludere ai
collezionisti di curiosità né agli scienziati. A teatro, uno storico dev’essere qualcosa di
diverso, no?
SPETTATORE Lo storico si interessa al mutamento delle cose.
ATTORE E come bisogna recitare per lui?
SPETTATORE Mostrando quel che una volta era diverso da oggi e accennando al
motivo della diversità. Ma bisogna anche mostrare come dallo ieri sia nato l’oggi.
Perciò, se mostrate dei re del XVI secolo dovete rendere evidente che simili
comportamenti, simili personaggi oggigiorno non sarebbero più possibili; o, se lo
fossero, dovrebbero suscitare stupore.
ATTORE Dovremmo dunque mostrare l’elemento umano eternamente immutabile?
SPETTATORE L’elemento umano si mostra nei suoi mutamenti. Se lo si separa dalle
sue manifestazioni sempre diverse, nasce una indifferenza nei confronti della nostra
forma di vita e, implicitamente, una approvazione di quella che si presenta ora.
ATTORE Portami un esempio.
SPETTATORE Nella prima scena del Re Lear, il vecchio re spartisce il regno fra le
sue tre figliole. Una volta gli vidi spaccare in tre pezzi la corona a colpi di spada. Ciò
non mi piacque. Avrei preferito che strappasse in tre pezzi una carta geografica del
regno e ne desse un pezzo a ciascuna figliola. Così sarebbe apparso evidente quale
fosse la sorte delle nazioni sottoposte a simili signorie. L’atto sarebbe parso più
sconcertante. Qualcuno avrebbe pensato che c’è una certa differenza fra il lasciare ai
propri eredi delle suppellettili domestiche o dei regni. Sarebbe risorta un’età lontana,
estranea alla nostra concezione, e sotto quella forma sorpassata avremmo visto
delinearsi la forma attuale. Nello stesso lavoro, un servitore fedele al re detronizzato ne
bastona uno infedele, dimostrando così, nell’intenzione dell’autore, la propria fedeltà.
Ma l’attore che recitava la parte del servo bastonato avrebbe dovuto fingere di soffrire
non per scherzo ma sul serio. Se fosse uscito trascinandosi con la spina dorsale
spezzata, la scena avrebbe suscitato maggior turbamento. E questo avrebbe dovuto
fare.
ATTORE E come vanno le cose con i lavori che si recitano adesso?
SPETTATORE L’essenziale è appunto questo: che i lavori contemporanei vengano
recitati storicamente.
ATTORE Che dovremmo fare, dunque, quando rappresentiamo una piccola famiglia
borghese del nostro secolo?
SPETTATORE Questa famiglia, presa nel suo complesso, si comporta come non si
sarebbe comportata in passato; e si possono immaginare tempi in cui non si
comporterebbe più così. Si deve dunque mostrate quanto c’è di speciale, di tipico in
questo nostro tempo, ciò che è cambiato rispetto alle epoche precedenti e le abitudini
che oggi ancora si difendono contro certi mutamenti o incominciano a cambiare. Il
singolo individuo ha pure una sua storia, sottoposta al mutar delle cose; ciò che gli
accade può avere un’importanza storica. Altrimenti si dovrebbe mostrare soltanto ciò
che ne ha.
ATTORE Ma così, l’uomo come tale non diventa troppo insignificante
SPETTATORE Al contrario. Mettendo bene in chiaro tutti i mutamenti visibili in lui
e operati da lui lo si onora. L’uomo viene preso sul serio come i Napoleoni di una
volta. Una scena di questo contenuto: «L’operaio tal dei tali è condannato a morire di
fame dal suo padrone» non deve aver minore importanza di una scena che rappresenti
Napoleone battuto a Waterloo. I gesti dei personaggi che vi agiscono devono essere
altrettanto efficaci e memorabili, lo sfondo scelto con altrettanta cura.
ATTORE Devo dunque impostare un personaggio in modo da rendere sempre
evidente: «Così era quest’uomo in quel periodo della vita, così in quell’altro. Così si
pronunziava — oppure — così usava parlare ed agire a quel tempo». E ciò deve
apparire in connessione con enunciati come: «Così le persone della sua classe usavano
parlare ed agire — oppure ancora — con questa azione, con questa locuzione, l’uomo
che rappresento si differenziava dagli altri della sua classe»?
SPETTATORE Esattamente. Leggendo la vostra parte vi troverete per prima cosa
didascalie storiche di questo tipo. Ma non dimenticate: la storia è una storia di lotte di
classe, e perciò le didascalie devono essere importanti dal punto di vista sociale.
ATTORE Lo spettatore sarebbe dunque uno storico della società?
SPETTATORE Sì.
Come si comporta un direttore di prova (nel procedimento induttivo)
Qui da noi il direttore di prova non viene in teatro con una «idea», o una «visione», o
un «piano delle posizioni» e con una scenografia bell’e fatta. Non desidera «realizzare
un’idea». Il suo compito è suscitare e organizzare il rendimento degli attori (musicisti,
pittori ecc.). Per «provare» egli non intende imporre con la sferza certe sue idee
preconcette, intende sperimentare. Deve insistere perché volta a volta vengano prese in
considerazione parecchie possibilità. È pericoloso fargli premura perché trovi, più in
fretta possibile, l’unica soluzione «giusta». L’unica soluzione giusta, dato che ci sia,
può essere soltanto una fra le molte possibili; ma val la pena di provarne anche altre,
non fosse che per arricchire la soluzione definitiva. Questa trae forza dal processo di
eliminazione e di scelta. Inoltre, il rendimento dei vari collaboratori non è uniforme;
ognuno di essi rende in tempi diversi e richiede incentivi particolari; ognuno di essi ha
interessi diversi che bisogna sviluppare pienamente per arricchire la soluzione globale.
Uno dei compiti più importanti del direttore di prova è smascherare tutte le soluzioni
schematiche, abituali, convenzionali delle varie difficoltà. Egli deve scatenare delle
crisi e, naturalmente, non lasciarsi inibire dal timore di confessare che non ha già bell’e
pronta in ogni caso la soluzione giusta. La fiducia dei collaboratori deve basarsi sulla
sua capacità di scoprire ciò che non è una soluzione. Egli deve sollevare dubbi,
problemi, proporre una quantità di possibili punti di vista, di confronti, ricordi,
esperienze. Di solito farà fatica ad impedire una impostazione troppo precipitosa delle
situazioni e delle parti, perché appunto questo dà occasione al mestierante più scaltrito,
o al più forte (al più celebre) di paralizzare il rendimento degli altri e di imporre loro
soluzioni convenzionali. Durante la lettura collettiva del copione, a parti già assegnate,
egli deve organizzare l’atteggiamento stupito degli attori. Deve ottenere che ciascuno
si domandi: «Perché dico questo?» «Perché quell’altro dice così?» Deve addirittura
ottenere che giungano a dirsi: «Io (o quell’altro) potremmo dire piuttosto...» Deve
badare che le esitazioni stupite, le contraddizioni iniziali, una volta ottenuta una data
risposta, non scompaiano del tutto col procedere delle prove. La singolarità delle frasi
pronunziate e delle azioni compiute di volta in volta deve rimanere avvertibile nella
forma definitiva. Anche lo spettatore deve aver occasione di fermarsi stupito e di
contraddire. Il passaggio dal tavolo di lettura al palcoscenico non deve avvenire
bruscamente: meglio trasferire le scene sul palco pezzo per pezzo. Passando dal
tavolino al palcoscenico, i dettagli si devono sbrigare in modo «approssimativo»,
«allusivo»; e anche questo tono provvisorio, approssimativo, allusivo, deve venir
ancora mantenuto vivo nella forma finale. Nel risultato, lo spettatore deve vedere una
soluzione particolare, ma deve vedervi anche quel certo non so che di casuale che, in
effetti, ancora vi rimane attaccato. La linea generale non risulta migliore se i dettagli si
saldano l’uno all’altro senza chiodature; risulta meglio quale concatenazione logica di
dettagli che serbino ancora il carattere di dettagli. Soltanto così si valorizza la logica
del loro susseguirsi e passare dall’uno all’altro. Non basta confrontare a tavolino, in
forma dialogica, le singole enunciazioni, i singoli gesti ecc., con altre enunciazioni e
altri gesti ugualmente possibili — anche queste altre possibilità devono venire provate
sulla scena. Ciò che sorprende presuppone un qualcosa di atteso, che non è sempre
tutto ciò che ci si può attendere. E la sorpresa è un elemento fondamentale dell’effetto.
L’attore tende all’effetto — è una tendenza sana, egli cerca di sorprendere. Ma, se fra
tutte le cose che ci si può attendere non sceglie quella che «logicamente» ci si può
attendere, consegue soltanto l’«effetto teatrale» — l’effetto «illecito». Si ha la sorpresa
di genere «sano» quando la soluzione logica è sorprendente. Durante le prove dei
dettagli in palcoscenico, la posizione della sala dovrebbe in un primo tempo venir
trascurata. La si deve prendere in considerazione in una seconda fase, quando si tratta
di procurare allo spettatore la visione più chiara possibile degli avvenimenti; si giunge
allora a un rimaneggiamento delle posizioni già scelte, al fine di rendere più chiara ed
evidente ogni cosa. Per ogni avvenimento scenico, il direttore di prova deve scoprire
una situazione della vita reale in cui sia possibile organizzare la dimostrazione d’un
avvenimento analogo. La prima scena del Re Lear, con la ripartizione del regno,
potrebbe, ad esempio, venir pensata come una dimostrazione di fronte a una
commissione di giuristi, medici, maestri di cerimonia, membri di famiglia, storici,
politici, eccetera. I dettagli dovrebbero soddisfare le esigenze di tante persone dagli
interessi così diversi.
Qualche cenno sugli attori proletari
Ciò che per prima cosa ci colpisce d’un attore proletario è la semplicità della
recitazione. Per attore proletario non intendo un attore del teatro borghese di origini
proletarie o che reciti per il proletariato. Intendo un proletario che non sia passato
attraverso la scuola d’arte drammatica borghese e non appartenga a nessuna
associazione professionale. Quello che ho definito «semplicità di recitazione» è,
secondo me, l’Alfa e l’Omega dell’arte drammatica proletaria.
Voglio subito premettere che io non trovo affatto buona una «recitazione semplice» di
per se stessa, e le preferisco qualsiasi altra, meno semplice. Non mi lascio tanto
facilmente commuovere dall’impegno di un attore poco o affatto preparato ma pieno di
sacro fuoco per l’«arte», e nutro poca tenerezza per lo snobismo di certa gente dal
palato guasto che preferisce il «tozzo di pan nero» ai cibi prelibati.
Gli attori dei piccoli teatri operai esistenti in tutte le grandi città d’Europa, d’America e
d’Asia non paralizzate dal fascismo non sono affatto dei dilettanti, e la loro recitazione
non è «pan nero». È semplice, ma solo in un certo senso.
I piccoli teatri degli operai sono sempre molto poveri. Non possono permettersi il lusso
di attrezzature grandiose. Gli attori sono gente che lavora tutto il giorno; i disoccupati
devono darsi da fare non meno degli altri per cercar lavoro e la sera, quando vengono
alle prove, non sono certo i meno esausti. La recitazione di simili attori tradisce un po’
questa mancanza di energie sovrabbondanti, e una certa mancanza di sicurezza
contribuisce a renderla scarsamente brillante. Le grandi emozioni individuali, la messa
in mostra delle singole diversità psicologiche, la «ricchezza di vita interiore» in genere
non figurano nei teatri operai. Sotto questo rapporto i loro spettacoli possono dirsi
«semplici», nel senso di poveri.
Tuttavia vi si può anche trovare una semplicità d’altro genere, non conseguente a
deficienze di qualsiasi origine ma risultante da un assieme di vedute e di sforzi
particolari. Noi parliamo di semplicità anche quando certi problemi complicatissimi
vengono dominati in modo da essere resi facilmente trattabili e perdono la loro
impenetrabilità. Innumerevoli fatti, in apparenza contraddittori fra loro, colossali,
scoraggianti guazzabugli, vengono spesso riordinati dalla scienza in modo tale da farne
risultare una verità relativamente semplice. Questa è semplicità che non ha nulla in sé
di povero. E la recitazione dei migliori attori proletari ha per l’appunto una semplicità
di questo genere, quando si tratta di rappresentare la convivenza umana, sociale.
I piccoli teatri operai mettono in luce con sorprendente frequenza le grandi e semplici
verità riguardanti i complicati ed oscuri rapporti umani dell’epoca nostra: qual è
l’origine delle guerre, e chi le combatte, e chi le paga; a quali rovine conduce
l’oppressione di alcuni uomini su altri, a che pro vada la fatica dei molti, da che cosa
tragga origine la vita facile dei pochi; quale cultura sia utile, e a chi, quali azioni siano
dannose, e a chi — questo ci mostrano i piccoli e poveri teatri operai. Non parlo
soltanto dei copioni, parlo di coloro che li recitano nel migliore dei modi e col
massimo interesse.
Un po’ più di denaro, e quella camera sul palcoscenico sarebbe una camera; un po’ più
di scuola di dizione, e la lingua degli attori sarebbe quella delle «persone colte»; un po’
di notorietà, e la recitazione diverrebbe più efficace, avrebbe maggior forza di
penetrazione. Un altro po’ di denaro in più per il cibo e il riposo, e gli attori non
sarebbero più così stanchi.
Non altrettanto facile sarebbe dare quello che manca anche ai ricchi teatri borghesi.
Come può, su quei palcoscenici, una guerra diventare una guerra? Come è possibile
dimostrare a che pro vada la fatica dei molti e da che derivi la vita facile dei pochi?
Come trovare — e come rappresentare — le grandi e semplici verità sull’umana
convivenza? I piccoli teatri degli operai si propongono di eliminare quel tanto di
semplicistico avvertibile nella loro recitazione a causa dell’indigenza, eliminando
l’indigenza stessa; ma i ricchi teatri borghesi certamente non tendono a conseguire
quella semplicità derivante dall’aspirazione alla verità.
E le grandi emozioni individuali? Le differenziazioni psicologiche delle personalità
singole? La ricchezza di vita interiore? Che ne è di questa ricca vita interiore che per
alcuni intellettuali rappresenta ancora il miserevole surrogato d’una ricca vita
esteriore? La risposta è: se di un surrogato si tratta, l’arte non vi ha nulla a che fare. Le
grandi emozioni individuali in arte diventano un parlare distorto e innaturale, una
recitazione enfatica e gigionesca — le differenziazioni psicologiche delle personalità
singole diventano casi morbosi individuali sopravvalutati, fino a che l’individualità
rimane un privilegio di pochi i quali, oltre alla «personalità», possiedono altri beni
materiali. La vera arte s’impoverisce con le masse, e con esse si arricchisce.
Scenografia e musica nel teatro epico (1935-42)
Scenografia della drammaturgia non aristotelica
1. Compito sociale dello scenografo e struttura in profondità.
Alcune drammaturgie non aristoteliche (non basate sull’immedesimazione) le quali,
nelle loro raffigurazioni della convivenza umana, tentano di dar forma alle leggi che la
regolano, hanno elaborato per le loro scenografie certe pratiche comuni, benché di tipi
parzialmente diversi (tipo storico, biografico, parabolico). Base comune di tali pratiche
è il rifiuto dell’immedesimazione totale e quindi anche della scenografia tendente
all’illusione perfetta. L’ambiente umano (per un’altra drammaturgia semplicemente il
«mondo esteriore») ha, nella drammaturgia non aristotelica, una funzione maggiore e
di ben diverso genere. Esso non è più soltanto una cornice. La nostra conoscenza del
processo di «scambio organico» fra natura e uomo, visto come processo sociale
storicamente mutevole che si compie nel lavoro, impronta i nostri modelli di ambiente
umano. Gli interventi dell’uomo sulla natura si fanno sempre più profondi; e questo
deve trovare una sua espressione nella scenografia teatrale. Inoltre, ogni raffigurazione
pone a ciascuno dei vari tipi di dramma un problema sociale assolutamente nuovo e
concreto, alla cui soluzione deve partecipare anche lo scenografo, studiando l’assieme
dell’architettura teatrale e scenica dal punto di vista dell’adeguatezza, della potenza, e
perfezionandola. La costruzione dell’economia collettiva rappresentata nel Razbeg di
Ochlopkov per i lavoratori intellettuali e manuali di Mosca, poneva un problema
sociale d’altro genere e richiedeva quindi una scenografia diversa da quella adatta
all’apparato demagogico dei nazionalsocialisti in Teste tonde e teste a punta (Brecht,
Knutzon), rappresentato a Copenaghen nel 1936, o ai sabotaggi di guerra del piccolo
borghese in Le avventure del buon soldato Švejk (Piscator, Brecht, Grosz)
rappresentato a Berlino nel 1929 di fronte a un pubblico ben altrimenti composto dal
punto di vista di classe. Poiché la scena è interamente da rifare per ogni lavoro e in
ogni caso si rende necessaria una ristrutturazione in profondità, è giustificato introdurre
il termine di «costruttore scenico», usato di solito per chi costruisce direttamente la
scena, vale a dire l’impalcatura normalmente stabile su cui si montano gli scenari.
Il «costruttore di scene» deve dunque, secondo i casi, sostituire il pavimento con bande
scorrevoli, il fondale con uno schermo per proiezioni, le quinte laterali con
un’orchestra; deve trasformare il soffitto in una travatura portante per montacarichi e
prendere in considerazione perfino un eventuale spostamento del palcoscenico al
centro della platea, in mezzo al pubblico. Il suo compito è quello di mostrare il mondo.
Ma se nulla deve lasciar fermo al proprio posto senza un motivo, non deve neppure
spostare nulla senza un motivo; perché riproduce immagini del mondo, e questo si
muove secondo leggi non note a tutti; ma non egli soltanto ne vede il movimento, bensì
anche quelli che ne vedono le immagini; e non si tratta unicamente di come egli vede il
mondo, ma di fare in modo che coloro i quali ne vedono le immagini ci si
raccapezzino. Egli deve dunque costruire i propri quadri per occhi critici e, ove quegli
occhi non lo siano, renderli tali; e ricordare sempre che grande cosa sia mostrare agli
altri il mondo in cui devono vivere.
2. Separazione degli elementi. Gli attori come parti dello scenario.
Quando lo scenografo si trova d’accordo coi regista, l’autore, il musicista e l’attore per
quanto riguarda la finalità sociale dello spettacolo, e procede assecondando ciascuno di
loro e valendosi dell’appoggio di tutti, non per questo deve permettere che il suo lavoro
si fonda totalmente con gli altri elementi per venire a formare un’«opera d’arte
cumulativa». Pur nel lavoro associato, ciascuno deve conservare in un certo senso
l’individualità della propria arte mediante una separazione degli elementi.
Il concerto delle arti diventa così una cosa viva, il contrasto fra i vari elementi non
viene soppresso. Dal canto suo, lo scenografo prende posizione rispetto al tema e lo
affronta con i propri mezzi, in una certa libertà. La proiezione di grafici o di film potrà
inserirsi nella rappresentazione.5 Lo scenografo procede d’accordo con le altre arti
anche quando, ad esempio, gli strumenti musicali o gli attori diventano parti del suo
scenario.6 In un certo senso gli attori costituiranno per lui gli accessori scenici più
importanti. Non basta che per gli attori sia riservato un tanto di spazio. Se lo scenario
consiste in un albero e tre uomini, oppure in un uomo, un albero e poi ancora due
uomini, l’albero da solo non deve — o meglio, non può — costituire una scenografia.
Lo spiegamento dei raggruppamenti fa parte dello spiegamento scenografico ed è
quindi compito precipuo dello scenografo. Se la collaborazione con gli attori gli è resa
difficile, egli verrà a trovarsi nella condizione d’un pittore di quadri storici costretto a
dipingere sulla sua tela soltanto mobilia e accessori, perché poi un altro dipinga i
personaggi seduti sulle sedie e le mani che impugnano le spade sospese nell’aria.
3. Costruzione del campo scenico (metodo induttivo).
Nell’uso corrente le costruzioni sono fissate prima che inizino le prove degli attori,
appunto perché queste «possano incominciare». L’essenziale è che siano cariche di
atmosfera, di colore locale e diano, comunque, un’impressione. Al fatto che si deve
rappresentare si bada quanto alla scelta di una cartolina illustrata da spedirsi durante un
viaggio. Si tratta, tutt’al più, di creare ambienti che offrano piacevoli possibilità al
movimento e alla recitazione, ma in senso assolutamente generico, e cioè adattabili a
qualsiasi possibile raggruppamento o, se per un raggruppamento determinato, per
quello della prima scena. Anche quando il regista ha fissato le posizioni e i movimenti
dei suoi attori prima dell’inizio delle prove — modo, questo, infelicissimo di procedere
— cede generalmente alla tentazione di conservare l’ambiente scelto per la prima scena
anche per tutte le altre, perché ad esso è, o sembra essere, legata una certa soluzione
scenica, ed egli inconsciamente adotta l’idea che uno stesso individuo possa
attraversare varie vicende in uno stesso luogo: egli non ricostruirà il suo appartamento
per una scena di gelosia! Se si procede così si perdono tutti i vantaggi di intere
settimane di collaborazione con tante persone diverse tra loro e si ha, già fin da
principio, un ambiente rigido, inelastico, che nessun movimento degli attori varrà a
mutare. Il termine «Bühnenbild»7 usato in tedesco per indicare scenografie del genere
descritto è ben scelto perché ne rivela tutti gli svantaggi. Pur prescindendo dal fatto che
nella sala ci saranno sì e no tre o quattro posti visto dai quali un «quadro» possa
produrre il suo pieno effetto, perché da tutti gli altri apparirà deformato, l’ambiente
scenico composto come un quadro non ha le qualità né di un rilievo né di una
superficie, pur volendo dare ad intendere d’essere entrambe le cose. Un buon scenario
deve essere completato soltanto con il contributo dei personaggi che vi si muovono, e
la miglior cosa è ultimarlo durante le prove. Ciò è molto insolito per i nostri scenografi
che si sentono «pittori» e sostengono di avere una «visione» degna di venir realizzata;
e raramente fanno i conti con gli attori, dal momento che i loro «quadri» dovrebbero
far buon effetto, se non migliore, anche senza di essi.
Il buon scenografo procede sperimentando lentamente. Una ipotesi di lavoro sulla base
di una scrupolosa lettura del copione e di un ampio scambio di vedute con gli altri
membri del teatro, specialmente sulla particolare finalità sociale del lavoro e dello
spettacolo, gli sarà indubbiamente utile. Ma la sua idea di fondo dovrà essere quanto
più possibile generica ed elastica. Egli dovrà saggiare continuamente i risultati delle
5
Vedi i disegni assolutamente originali ed autonomi di George Grosz proiettati nelle Avventure del buon
soldato Svejk e quelli di Caspar Neher per Ascesa e rovina della città di Mahagonny.
6
Nell’Opera da tre soldi Neher pose in mezzo alla scena un organino da fiera. Max Gorelik nella
rappresentazione della Madre a New York occupò la metà del palcoscenico con due pianoforti a coda.
7
[Letteralmente: «quadro scenico»].
prove; i desideri e le intenzioni degli attori stimoleranno la sua inventiva; studierà fino
a che punto giungano le loro forze e soltanto allora interverrà. L’andatura zoppicante di
un personaggio può richiedere spazio per venire in risalto, certi episodi visti da lontano
sembrano comici, da vicino tragici, e via dicendo. E gli attori gli saranno d’aiuto. Se
dovrà presentare una sedia preziosa, questa apparirà tale se gli attori la porteranno in
scena e vi si siederanno con tutte le precauzioni. Trattandosi d’un seggio di tribunale, si
otterrà un effetto particolare facendolo, ad esempio, molto grande e il giudice troppo
piccolo per riempirlo tutto. Quando entra in gioco l’attore molte cose inutili si possono
eliminare — e agli attori lo scenografo può risparmiare molte cose.
Lo scenografo può trasformare completamente il senso delle battute e rendere possibili
nuovi gesti.
Se, ad esempio, nel Macbeth costruisce per il protagonista un castello malandato e
meschino, le lodi del re e del suo seguito (atto I, scena vi) da pura e semplice
espressione di credulità diventeranno espressione di cortesia e di bontà d’animo;
eppure il re rimane incapace di premunirsi contro Macbeth, di cui non riconosce la
miserabile condizione.
Spesso è piacevole per gli attori lavorare ispirandosi a schizzi riproducenti qualche
fatto importante; ed è anche utile, sia perché possono copiare gli atteggiamenti, sia
perché il fatto, artisticamente riprodotto nella sua singolarità e nella sua importanza,
viene, per così dire, reso famoso; ha assunto una forma precisa e può diventare oggetto
di critica. Altrettanto utili possono riuscire gli schizzi che riproducono gli attori stessi.
Così dunque lavora il buon scenografo, ora precedendo l’attore, ora seguendolo, ma
sempre di concerto con lui. Costruisce la propria scena a poco a poco, sperimentando,
esattamente come fa l’attore, e provando più d’una soluzione. Una parete e una sedia
sono già molto, tracciare bene una parete e collocare bene una sedia è già molto
difficile. Parete e sedia non devono soltanto esser disposte in modo pratico per l’attore
ma anche in armonioso rapporto fra loro, e riuscire di per se stesse efficaci.
La maggior parte degli scenografi hanno quella che fra pittori si chiama una «tavolozza
sporca»; i colori, cioè, sono già impastati e confusi l’un con l’altro sull’assicella. Simili
individui non sanno più che cosa sia una luce normale, un colore fondamentale puro, e
così, anziché valorizzare, smorzano tutti i contrasti cromatici e colorano la luce. I
maestri sanno quale valore abbia accanto a un gruppo di persone una semplice tovaglia
azzurra appesa a una fune del bucato; sanno, cioè, quanto poco si possa ancora
aggiungere.
La scelta dei particolari caratteristici, indicativi, è talvolta molto difficile. Essi devono
esser sufficienti alle loro funzioni.
Quanto poco badiamo alla funzione di un oggetto lo dice l’esempio seguente. In Teste
tonde e teste a punta bisognava mostrare due famiglie di contadini al lavoro. Come
strumento di lavoro scegliemmo un pozzo a carrucola. Quantunque uno dei contadini
dicesse: «Giacché il padrone non ci dà cavalli, ognuno di noi dev’essere il cavallo di se
stesso», e quantunque la mancanza dei cavalli avesse una grande parte nel copione, non
venne in mente a nessuno — né all’autore, né al regista, né allo scenografo, né a uno
solo degli spettatori — che un cavallo non avrebbe mai potuto azionare quella
carrucola. Giusto sarebbe stato applicare gli uomini ad una macchina primitiva
destinata a venir mossa dai cavalli. Le conseguenze d’un simile sproposito sono
notevoli. Così la fatica umana appare subito «naturale», immutabile, fatale; il lavoro
dev’esser fatto e tutt’al più ci si domanderà da chi, non pensando ai cavalli ma agli
uomini. Una condizione sentita come opprimente non viene mostrata come superflua,
l’attenzione non viene attratta su quegli accorgimenti che potrebbero eliminare il male.
Altro problema importante è quello dei materiali.8 Si raccomanda una semplice scelta
8
Utilizzando certi materiali si possono suscitare con profitto particolari associazioni di idee nello
spettatore. Per la parabola Teste tonde e teste a punta, ad esempio, i paraventi sullo sfondo richiamavano
fra un numero non eccessivo di materie prime. Non è compito dell’arte fabbricare una
determinata imitazione con ogni mezzo. I materiali devono far buon effetto anche di
per se stessi. E senza subire violenza. Non si deve pretendere che «si trasformino», che
il cartone dia l’illusione d’essere tela, il legno ferro e così via. Legname ben lavorato,
corde, cornici metalliche, tela, ecc., se ben disposti possono produrre effetti di
singolare bellezza.
Lo scenografo, inoltre, non perda di vista le suggestioni che le sue scene devono,
esercitare anche sugli attori. Gli oggetti possono avere due facce, una rivolta al
pubblico, l’altra verso l’attore, ma anche questa deve essere artisticamente
soddisfacente a vedersi. All’attore non occorre dar l’illusione di trovarsi nel mondo
reale ma la conferma di trovarsi in un vero teatro. Proporzioni armoniose, bel
materiale, arredamenti sensati e accessori ben lavorati impegnano l’attore; egli non è
indifferente al lato interno di una maschera, al fatto che essa sia o no un prodotto
artistico.
Per un vero scenografo nulla dev’essere fisso, inamovibile, né il luogo né le maniere
consuete di utilizzare la scena. Soltanto seguendo il graduale farsi dello spettacolo egli
potrà stabilire se la sua costruzione significhi qualcosa, troppo o nulla. E non soltanto
per l’utile che ne traggono gli attori — o per quello ch’egli trae da loro — ma anche
per poter migliorare il proprio scenario da un punto di vista puramente tecnico, egli
farà bene a predisporne il montaggio con elementi mobili, a costruire l’arredamento
scenico con pezzi staccati, autonomi, spostabili. Lo stipite d’una porta deve poter
provare esattamente come l’attore che ne fa uso, potersi mostrare da tutti i lati, avere
un certo suo valore intrinseco, una vita propria, in modo da riuscire efficace nel
maggior numero possibile di combinazioni con altri elementi. Esso recita una parte o
anche più parti, come qualsiasi altro attore —ha lo stesso diritto e lo stesso dovere di
farsi notare. Può essere una comparsa o un protagonista. Le estremità d’un montante di
finestra mobile, siano corde o cavalletti, non dovrebbero venire nascoste ma
contribuire all’abbellimento della veduta d’assieme. Lo stesso valga per le lampade e
gli strumenti musicali. Quanto più si darà evidenza allo spazio scenico in cui sono
disposti mobili e accessori vari, tanto meglio questi prenderanno risalto come mobili.
Visibilità delle sorgenti luminose
Il mettere in mostra l’apparecchiatura delle luci riveste un suo significato, poiché può
essere un mezzo per impedire un’indesiderabile illusione. Non impedisce punto,
invece, la desiderabile concentrazione. Se illuminiamo lo spazio in cui recitano gli
attori in modo che lampade e riflettori entrino nel campo visivo dello spettatore,
disturbiamo in una certa misura l’illusione, che questi ha, di trovarsi al cospetto di un
avvenimento «colto nel suo momento», spontaneo, non sperimentato, vero insomma.
Egli vede che sono state prese disposizioni per mostrargli un certo fatto, vede che qui si
sta ripetendo alcunché in particolari circostanze: per esempio, sotto una luce vivissima.
Col mettere in mostra le sorgenti luminose si tende a combattere l’intenzione di
nasconderle, tipica del vecchio teatro. In una serata sportiva – per esempio, in un
incontro di pugilato – nessuno si spetterebbe che venissero occultate le lampade; e
l’idea della pergamena e quindi dei libri antichi. Poiché di fronte a un pubblico borghese il senso della
parabola avrebbe necessariamente incontrato resistenza, riuscì vantaggioso darle un poco del credito di
cui godono le antiche e famose parabole. Il teatro yiddisch di Mosca usò per la messinscena del Lear una
struttura in forma di tabernacolo di legno, ribaltabile, che richiamava l’idea delle bibbie medievali. Per
una commedia cinese, nel teatro di Piscator, John Heartfield usò grandi bandiere di carta, avvolgibili;
nello stesso teatro Moholy-Nagy si servì, con minor fortuna, per una commedia sull’inflazione, di certe
costruzioni in nichel e vetro, richiamando alla mente un’immagine indesiderata di attrezzature e ferri
chirurgici.
sebbene le manifestazioni del teatro moderno siano indubbiamente altra cosa da quelle
sportive, non si differenziano da esse sul punto della necessità, propria al vecchio
teatro, di occultare le fonti di luce.
La musica nel teatro epico
Nel teatro epico, per quanto riguarda la mia produzione, è stato fatto uso di musica per
i seguenti drammi: Tamburi nella notte, Carriera dell’asociale Baal, Vita di Edoardo
II d’Inghilterra, Mahagonny, L’opera da tre soldi, La madre, Teste tonde e teste a
punta.
Nei primi due o tre lavori, la musica appariva in forme piuttosto consuete: si trattava di
canzoni o di marce, e i vari pezzi inseriti avevano pressappoco sempre una
giustificazione naturalistica. Tuttavia, l’uso della musica costituì comunque una rottura
con le convenzioni drammatiche dell’epoca: il dramma, per dir così, perdeva di peso,
diventava più snello, le esecuzioni nei teatri acquistavano un carattere più spettacolare.
Già per il semplice fatto di introdurre un diversivo, la musica era un elemento di
reazione rispetto all’angustia, all’opacità, alla viscosità della drammaturgia
impressionista, alla maniaca unilateralità di quella espressionista. Ma
contemporaneamente essa rendeva nuovamente possibile qualcosa che già da parecchio
tempo era tutt’altro che ovvia e naturale, e cioè un «teatro poetico». Io stesso scrissi
quelle musiche. Cinque anni dopo, per il secondo allestimento berlinese della
commedia Un uomo è un uomo allo Stadttheater, le scrisse Kurt Weill. Da questo
momento, la musica assunse carattere d’arte (cioè valore autonomo). Il lavoro contiene
scene di una violenta comicità: Weill introdusse una «piccola musica notturna» quale
sottofondo alle proiezioni di Caspar Neher, e inoltre una musica di battaglia e una
canzone, le cui strofe erano da cantarsi durante i cambiamenti di scena a vista. Ma nel
frattempo erano già state enunciate le prime teorie circa la separazione degli elementi.
La messinscena dell’Opera da tre soldi (1928) fu il più fortunato esempio del teatro
epico. In essa le musiche di scena vennero per la prima volta usate secondo una
prospettiva moderna. L’innovazione più vistosa consisté nel fatto che le parti musicali
erano nettamente distinte dalle altre; ciò veniva anche sottolineato dalla collocazione
dell’orchestrina, piazzata visibilmente sul palcoscenico. Per le parti cantate (song) era
previsto un cambiamento di luci, l’orchestra veniva illuminata, e sullo schermo
disposto contro la parete di fondo apparivano i titoli dei singoli numeri, per esempio:
«Canzone dell’inadeguatezza degli umani sforzi», o: «Con una canzoncina la signorina
Polly Peachum confessa ai suoi inorriditi genitori le sue nozze col bandito Macheath»;
inoltre, gli attori compivano un cambiamento di posizioni. Vi erano duetti, terzetti,
assoli e finali a coro. I pezzi musicali, nei quali prevaleva il carattere della ballata,
erano d’indole speculativa e moralistica. Il lavoro mostrava la stretta affinità esistente
fra la vita sentimentale dei borghesi e quella dei banditi da strada. I banditi da strada
mostravano, anche in musica, come le loro sensazioni, sentimenti e pregiudizi fossero
identici a quelli del borghese e dello spettatore medio. Uno dei temi era, per esempio,
la dimostrazione che solo chi vive nel benessere vive in modo piacevole, anche se per
questo sia necessario rinunciare a molte «cose elevate». In un duetto d’amore era
messo in rilievo come certe circostanze esteriori, quali l’estrazione sociale della
partner, o la sua situazione economica, non dovessero minimamente influire sulla
scelta fatta dallo sposo. In un terzetto veniva espresso il disappunto per il fatto che
l’insicurezza dell’esistenza su questo pianeta non consente all’uomo di assecondare la
sua naturale inclinazione alla bontà e ad un contegno civile. Il più soave e tenero canto
d’amore dell’opera descriveva l’ininterrotto, incancellabile affetto tra un «protettore» e
la sua donna: non senza commozione i due amanti cantavano le lodi della loro piccola
dimora, un bordello. In tal modo la musica, proprio con l’atteggiarsi a pura
sentimentalità, con lo sfruttare accuratamente tutti gli abituali lenocini narcotizzanti,
aiutava a svelare le ideologie borghesi; adempiva, diciamo, un compito di sollevatrice
di sudiciume, di provocatrice, di denunziante. Quei song conobbero larga diffusione,
gli incassi da loro realizzati vennero commentati in articoli di fondo, in discorsi. Molti
li cantarono accompagnandosi col pianoforte o coi dischi suonati dall’orchestra, così
come solevano cantare i pezzi di successo delle operette.
Il song di questo tipo nacque allorché, per la Settimana musicale di Baden-Baden del
1927, dove venivano presentate opere in un atto, io chiesi a Weill semplicemente di
comporre una nuova musica per una mezza dozzina di song già esistenti. Fino a quel
momento Weill aveva scritto della musica piuttosto complicata, generalmente
psicologizzante; acconsentendo a musicare testi di canzoni più o meno banali, egli
ebbe il coraggio di rompere con un tenace pregiudizio della compatta maggioranza
degli autori di musica seria. Quest’applicazione della musica moderna al song riportò
un successo notevole. In che consisteva la sostanziale novità di quella musica, a
prescindere dal suo finora inusitato criterio di utilizzazione? Il teatro epico s’interessa
principalmente al comportamento reciproco degli uomini, in ciò che esso ha di
socialmente e storicamente significativo, ossia tipico. Nelle scene che presenta, gli
uomini si comportano in guisa che le leggi sociali cui essi sottostanno divengano
visibili. Ne consegue la necessità di definizioni praticabili: in altri termini, i processi
presi in esame debbono ricevere definizioni tali che, utilizzandole, si possa agire sui
processi medesimi. L’interesse del teatro epico è perciò di natura eminentemente
pratica. Il contegno umano è presentato come passibile di mutamenti, l’uomo come
un’entità soggetta a determinati rapporti economico-politici, ma capace, al tempo
stesso, di cambiarli. Per dare un esempio: una scena nella quale tre uomini vengono
noleggiati da un quarto uomo per un certo scopo illegale (Un uomo è un uomo), deve
essere esposta dal teatro epico in maniera tale che sia anche possibile figurarsi, da parte
dei quattro uomini, un contegno diverso da quello rappresentato: che si possano cioè
immaginare, o condizioni politico-economiche in base alle quali quegli uomini
parlerebbero diversamente, oppure un contegno di quegli uomini di fronte alle
condizioni date, che li faccia del pari parlare in maniera diversa. Insomma, allo
spettatore vien dato lo spunto per una critica d’impostazione sociale nei confronti del
comportamento umano, e la scena viene recitata come se fosse storicamente vera. Lo
spettatore deve dunque essere in condizione di stabilire dei confronti in materia di vari
possibili comportamenti umani. Dal punto di vista estetico ciò significa che il «gesto»
degli attori riveste una particolare importanza: nel campo artistico è quindi
indispensabile un’educazione della gestualità (in quanto beninteso essa ha di
socialmente valevole, non già come fatto illustrativo e interpretativo). Al principio
mimico viene, per così dire, dato il cambio dal principio gestuale.
Ciò corrisponde ad un grande rivolgimento della concezione drammatica. Questa,
anche nella nostra epoca, è ancora fedele alle ricette con cui Aristotele insegnò a
produrre la cosiddetta catarsi (purificazione spirituale dello spettatore). Nella
drammaturgia aristotelica l’eroe viene posto, mediante l’azione scenica, in situazioni
che gli consentono di manifestare il più profondo di se stesso. Tutti gli avvenimenti
rappresentati mirano allo scopo di spingere l’eroe in conflitti spirituali. È un confronto
forse irriverente, ma utile, il pensare a questo proposito ai burlesques di Broadway,
dove il pubblico, coi suoi ruggenti «Take it off!» incita le ragazze a dare sempre più
ampia mostra dei loro corpi. L’individuo la cui parte più intima viene messa in piazza,
rappresenta naturalmente l’«uomo puro e semplice». Ognuno — anche ogni spettatore
— si sentirà allora preso dal corso ineluttabile degli eventi rappresentati; così che, detto
in parole povere, ad ogni recita di Edipo avremo una platea piena di tanti piccoli Edipi,
ad ogni recita dell’Imperatore Jones una platea di tanti Imperatori Jones. La
drammaturgia non aristotelica si guarderebbe bene dal fare, delle vicende che
rappresenta, una sorta di fato inesorabile, a cui consegnare in balia un essere umano
inerme, anche se capace di giuste e intelligenti reazioni. Al contrario, essa porrebbe
questo «fato» sotto la sua lente e ne svelerebbe la trama, intessuta di umanissime
macchinazioni.
Il nostro discorso, occasionato dall’esame di alcuni modesti song, potrebbe apparire
alquanto eccessivo, se questi song non costituissero gli altrettanto modesti inizi di un
altro teatro, il teatro della nuova epoca, o la partecipazione della musica a questo
teatro. Il carattere di quelle musiche, in quanto esempi di cosiddetta musica «gestuale»,
non può essere chiarito se non da considerazioni che, come queste, mettano in rilievo
l’intento sociale di tali innovazioni. In parole pratiche, la musica gestuale è una musica
che consente all’attore di eseguire determinati gesti fondamentali. La cosiddetta musica
leggera, specialmente del cabaret e dell’operetta, è già da parecchio tempo una musica
di questo tipo. Invece la musica «seria» si mantiene ancora fedele al lirismo e persegue
scopi di espressione individuale.
Nell’opera Ascesa e rovina della città di Mahagonny l’applicazione dei nuovi principi
avvenne in una certa misura. Non posso [fare] a meno di osservare che, a mio avviso,
la musica composta da Weill per quest’opera non è propriamente gestuale: contiene
però molte parti di carattere gestuale, abbastanza comunque da provocare una energica
messa in questione dell’opera di tipo normale, quella che nella sua veste odierna
possiamo definire come opera puramente culinaria. Tale culinarismo è appunto il tema
di Mahagonny, come ho cercato di chiarire nello scritto Note all’opera.9 In quello
scritto ho anche spiegato come e perché sia impossibile un rinnovamento dell’opera nei
paesi capitalisti: tutte le innovazioni che vengono apportate conducono semplicemente
alla distruzione dell’opera, e i musicisti che compiono tentativi in tal senso, come
Hindemith o Strawinsky, inevitabilmente falliscono di fronte all’apparato lirico. «I
grandi apparati come l’opera, il teatro, la stampa fanno passare le loro opinioni, per
così dire, in incognito. Mentre già da lungo tempo questi apparati si servono del lavoro
(musica, poesia, critica ecc.) prestato da lavoratori intellettuali che ancora partecipano
al guadagno — economicamente dunque appartenenti alla classe dominante,
socialmente già semiproletarizzati — soltanto al fine di alimentare i loro modi di
organizzazione del pubblico, e con ciò valutano questo lavoro a modo loro e
l’orientano nel loro senso, i lavoratori intellettuali stessi continuano a credere che
l’attività di codeste imprese consista soltanto nell’utilizzare il loro lavoro intellettuale,
e venga perciò a costituire un fattore secondario che non influenza il loro lavoro, ma, al
contrario, gli procura influenza. Tale imprecisione d’idee di musicisti, autori, critici
circa la realtà della loro condizione, produce conseguenze enormi, di cui si tien conto
in modo affatto inadeguato. Poiché, illudendosi di possedere un apparato che in realtà
li possiede, essi difendono un apparato che non controllano più, che non è più — come
essi continuano a credere — un mezzo che serve i produttori intellettuali, ma è
diventato un mezzo che si rivolge contro di essi, contro la loro produzione (quando
cioè questa produzione persegua tendenze proprie, nuove, non corrispondenti o
addirittura contrarie a quelle dell’apparato). Essi sono ridotti allo stato di fornitori. Il
valore della loro produzione finisce per essere misurato a una scala che ha per base la
nozione della smerciabilità. Da qui l’uso invalso di esaminare ogni opera d’arte sotto il
profilo della sua convenienza all’apparato, e di non preoccuparsi se l’apparato sia, o
no, conveniente all’opera d’arte. Si dice: “Questa o quell’opera è buona”; e s’intende
senza dirlo: “buona per l’apparato”. Ma quest’apparato è determinato dalla società
esistente e assimila solo ciò che gli permette di sussistere in questa società. Si potrà
dunque discutere di tutte le novità che non abbiano un carattere minaccioso per la
funzione sociale di quest’apparato, cioè quella del divertimento serale. Non si potrà
invece discutere di tutte quelle novità che tendano a fargli mutare funzione, vale a dire
a situare diversamente l’apparato nella società, per esempio connettendolo alle
9
Cfr. Note all’opera «Ascesa e rovina della città di Mahagonny», vol. III, p. 53.
istituzioni d’insegnamento o ai grandi organi di pubblicazione. Attraverso l’apparato la
società assimila ciò che le serve per riprodursi. Così, nel migliore dei casi, l’apparato
lascerà passare una “novità” che porti al rinnovamento, ma non mai al cambiamento
della società esistente, buona o cattiva che sia la forma di questa società. I più evoluti
non pensano nemmeno a cambiare l’apparato, perché sono convinti di avere a
disposizione un apparato che serve ciò che essi liberamente inventano, un apparato,
dunque, che si trasforma da sé con ogni loro nuovo pensiero. Il fatto è che la loro
invenzione non è libera: l’apparato adempie la sua funzione con loro o senza di loro, i
teatri lavorano ogni sera, i giornali escono x volte al giorno, ed accolgono ciò di cui
hanno bisogno; e ciò di cui hanno bisogno non è che una certa quantità di materiale».10
I pericoli derivanti dall’apparato si rivelarono nella rappresentazione della Madre
allestita a New York. La Theatre Union, per la sua impostazione politica, si
differenziava nettamente dai teatri che avevano messo in scena l’opera Mahagonny; ma
l’apparato teatrale reagì come un tipico apparato, quanto agli effetti d’ordine narcotico,
alterando non solo il testo, ma anche la musica: con la conseguenza di annullare in gran
parte la portata didattica del lavoro. La musica era stata introdotta nel dramma con
maggior coscienza che in qualsiasi altro esempio del teatro epico, per trasmettere allo
spettatore l’atteggiamento di osservazione critica sopra descritto. La musica di Eisler
non è davvero quel che si dice semplice: come musica, anzi, è piuttosto complicata, e
non ne conosco nessuna di più «seria». Essa consentiva in maniera veramente
ammirevole certe semplificazioni di problemi politici assai complessi, la cui soluzione
è per il proletariato di vitale necessità. Nel breve passo in cui si controbattono le accuse
secondo le quali il comunismo preparerebbe il caos, la musica, col suo gesto di cortese
consigliera, per così dire procaccia ascolto alla voce della ragione. Al brano intitolato
«Lode dello studio», che collega il problema dell’assunzione del potere da parte del
proletariato al problema dello studio, la musica conferisce un gesto eroico e tuttavia
naturalmente sereno. Così pure il coro finale «Lode della dialettica», che assai
facilmente potrebbe dare l’impressione di un canto trionfale inteso solo alla mozione
degli affetti, viene mantenuto dalla musica nella sfera del ragionevole. (È un errore
molto corrente quello di affermare che questo tipo di spettacolo — epico — respinga
senz’altro ogni effetto emotivo: in realtà le emozioni cui esso tende sono emozioni non
oscure, che non si alimentano alla sorgente del subconscio e che nulla hanno a che fare
con l’ebbrezza).
Chi crede che a un movimento di massa, il quale si oppone alla violenza,
all’oppressione e allo sfruttamento illimitati, non convenga un gesto così severo, ma
nello stesso tempo così dolce e ragionevole, quale lo propone una simile musica, non
ha inteso un lato importante di questa lotta. È chiaro però che l’effetto di tale musica
dipende molto dal modo in cui è eseguita. Se gli attori per primi non capiscono il suo
gesto, v’è poco da sperare che essa possa adempiere la sua missione di organizzare
determinati atteggiamenti dello spettatore. Occorre un’accurata educazione, un severo
allenamento dei nostri teatri operai, perché possano affrontare i compiti che la loro
funzione comporta e sfruttare le possibilità che essa offre. Anche il pubblico che li
frequenta deve, per loro mezzo, acquisire un ammaestramento ben preciso. È
necessario riuscire a tener fuori l’apparato produttivo del teatro operaio dall’attività di
spaccio di stupefacenti, propria in genere all’industria teatrale borghese. Per il dramma
Teste tonde e teste a punta, che, diversamente dalla Madre, si rivolge a un «vasto»
pubblico, e che perciò tiene maggior conto delle pure esigenze di divertimento, Bisler
scrisse musiche di song. Anche questa musica è in certo senso filosofica. Anch’essa
evita gli effetti narcotici, segnatamente per il fatto di connettere la soluzione dei
10
I produttori invece sono totalmente condizionati dall’apparato, sia economicamente che socialmente;
esso monopolizza la loro azione, e i prodotti degli scrittori, dei compositori, dei critici, assumono sempre
più il carattere di materia prima: il prodotto finito è quello che esce dall’apparato.
problemi musicali con la chiara ed univoca enucleazione del significato politico e
filosofico dei versi.
Da quanto fin qui detto, risulta dunque evidente quali difficoltà la musica debba
superare per far fronte ai compiti che le pone un teatro epico.
Oggi, la musica «progressiva» continua ad essere scritta per le sale da concerto. Un
semplice sguardo sull’uditorio di un concerto basta a convincere dell’impossibilità di
utilizzare a scopi politici e filosofici una musica che susciti consimili reazioni.
Vediamo intere file di persone immerse in uno stato tutto particolare di ebbrezza:
totalmente passive, sprofondate in se stesse e, secondo ogni apparenza, gravemente
intossicate. Gli sguardi fissi, attoniti, denotano in costoro uno stato di impotente abulia,
di completo abbandono ai moti più incontrollati del sentimento; gli abbondanti sudori
cui sono in preda comprovano come siano affranti da tali eccessi. Gli spettatori del
peggiore film di gangster meritano più di questi la qualifica di esseri pensanti. La
musica si presenta come «il destino in sé»: il destino spaventosamente complicato,
assolutamente non prevedibile, di questa nostra epoca in cui l’uomo è soggetto al più
atroce e consapevole sfruttamento da parte dell’uomo. Le ambizioni di questa musica
sono ormai di ordine puramente culinario. Essa induce l’ascoltatore a un atto di
godimento sterile e perciò snervante; e nessuna raffinatezza riuscirà a convincermi che
la sua funzione sociale sia differente da quella dei burlesques di Broadway.
Non si deve tuttavia disconoscere che tra i musicisti «seri» va oggi delineandosi un
movimento contrario a questa funzione socialmente depravatrice. Gli esperimenti che
vengono compiuti nel campo della tecnica musicale assumono man mano una portata
considerevole: non solo per il modo di trattare la propria materia, ma anche in riguardo
alla conquista di nuovi strati di consumatori, la musica più avanzata compie ogni
sforzo possibile. Vi è però tutta una serie di problemi che essa non è ancora in grado di
risolvere e alla cui soluzione non lavora neppure. L’arte di musicare epopee, ad
esempio, è completamente andata perduta. Non sappiamo quali musiche intonassero
l’Odissea o il Canto dei Nibelunghi; nessun nostro musicista saprebbe più assicurare
l’esecuzione cantata di un poema narrativo di una certa lunghezza. La musica
educativa è ugualmente a terra; e pensare che vi sono state epoche in cui la musica
poteva essere usata a scopi terapeutici! I compositori di oggi lasciano generalmente
agli osti la briga di studiare gli effetti della loro musica. Uno dei pochi risultati
d’indagine, in cui mi sia capitato d’imbattermi nel corso di decenni, furono le
dichiarazioni del padrone di un ristorante parigino circa le diverse ordinazioni cui i
clienti erano indotti sotto l’effetto di quella musica. Egli riteneva di avere scoperto che
a certi compositori corrispondesse regolarmente la consumazione di determinate
bevande. In realtà, sarebbe un grande vantaggio per il teatro drammatico se i
compositori fossero in grado di fornire musiche che esercitassero sugli spettatori effetti
calcolabili — in una certa misura — esattamente. Ciò allevierebbe di molto il compito
degli attori; particolarmente augurabile sarebbe allora che gli attori potessero recitare
«contro» l’atmosfera generata dalla musica. (Per il lavoro di prova di opere teatrali di
stile elevato, la musica che già esiste può considerarsi sufficiente). Il film muto fornì
l’occasione per alcuni tentativi di un commento musicale capace di creare atmosfere
emotive precisamente preordinate. Ho ascoltato musiche interessanti di Hindemith e
soprattutto di Eisler. Eisler, anzi, scrisse musiche di commento per film commerciali di
tipo assolutamente convenzionale: ed erano musiche assai serie.
Ma il film sonoro, ramo fra tutti fiorente del mercato internazionale di stupefacenti,
non permetterà a lungo la continuazione di esperimenti in questo campo.
Una prospettiva alla musica contemporanea, oltre che dal teatro epico, è aperta a mio
parere anche dal dramma didattico. Per alcuni esempi di questo genere teatrale, sono
state composte musiche eccezionalmente interessanti da Weill, Hindemith e Eisler, e
precisamente: da Weill e Hindemith in collaborazione per il [Volo oceanico], dramma
didattico radiofonico destinato alle scuole; da Weill per l’opera didattica Il
consenziente, da Hindemith per L’accordo, da Eisler per La linea di condotta.
La musica gestuale
1. Definizione.
Per «gesto» non si deve intendere la gesticolazione: non si tratta di movimenti delle
mani intesi a sottolineare o a chiarire, bensì di un atteggiamento d’insieme. «Gestuale»
è un linguaggio che si basa sul gesto così inteso: un linguaggio che dimostra
determinati atteggiamenti che colui che lo tiene assume di fronte ad altre persone. La
frase: «Strappa il tuo occhio che ti dà scandalo» è gestualmente più debole della frase:
«Se il tuo occhio ti dà scandalo, strappalo». In quest’ultima viene prima di tutto
indicato l’occhio, quindi il primo membro della frase contiene l’evidente atteggiamento
di chi fa una supposizione, e da ultimo, come un attacco di sorpresa, come un consiglio
liberatore, ecco giungere il secondo membro.
2. È una regola artistica?
Per il musicista si tratta anzitutto di una regola artistica, e come tale di non grande
interesse: regola che può tuttavia aiutarlo a conferire ai suoi testi maggiore vivacità e
comprensibilità. Importante è invece il fatto che la regola di porre attenzione al gesto
possa consentirgli di assumere, nell’atto di scrivere la musica, un atteggiamento
politico. A tale scopo è necessario che egli configuri un gesto sociale.
3. Che cos’è un gesto sociale?
Non ogni gesto può dirsi sociale. Certamente non è un gesto sociale quello di
difendersi da una mosca: può invece esserlo quello di difendersi da un cane, se per
esempio in esso si esprime la lotta che un uomo miseramente vestito deve condurre
contro dei cani da guardia. I tentativi di non sdrucciolare su un pavimento liscio
possono produrre un gesto sociale solo se chi scivola rischi di «perdere la faccia», ossia
ci rimetta d’autorità. Il gesto del lavoro è senz’altro un gesto sociale, inquantoché
l’attività umana diretta al dominio della natura è qualcosa che interessa la società, i
rapporti tra gli uomini. Un gesto di dolore, invece, nella misura in cui rimane tanto
astratto e generico da non superare il puro ambito animale, non è ancora un gesto
sociale. Ma proprio a questo, cioè a «dissocializzare» il gesto, tende sovente l’arte.
L’attore non si dì pace finché non è giunto ad avere «lo sguardo del cane bastonato»:
perché quell’uomo è allora semplicemente «l’uomo»; il suo gesto è spogliato da ogni
qualificazione di carattere sociale, è svuotato di ogni riferimento o misura concernente
quell’uomo particolare in mezzo agli uomini. Lo «sguardo di cane bastonato» può
diventare un gesto sociale solo se si intenda dimostrare come un singolo uomo possa,
per determinate macchinazioni dei suoi simili, essere ridotto al rango della bestia. Il
gesto sociale è il gesto rilevante per la società, il gesto che permette di trarre illazioni
circa le condizioni sociali.
4. Come può il compositore esprimere, nel suo atteggiamento verso il testo, il suo
atteggiamento verso la lotta di classe?
Supponiamo che, in una cantata sulla morte di Lenin, il musicista debba esprimere il
suo atteggiamento nella lotta di classe. La narrazione della morte di Lenin può
naturalmente essere presentata in modi assai diversi, per quanto attiene al «gesto». Un
certo atteggiarsi a solennità non ha grande significato, dato che può essere ritenuto
opportuno anche di fronte a un nemico in caso di morte. Lo sdegno verso la «cieca
furia della natura», che immaturamente ha stroncato il miglior uomo del gruppo, non
sarebbe un «gesto comunista»; così come non lo sarebbe il saggio rassegnarsi a un
cotal «volere del fato»: il gesto del cordoglio comunista per la morte di un comunista è,
infatti, un gesto tutto particolare. Il comportamento del musicista di fronte al suo testo,
del referente di fronte alla sua relazione, indica il grado della rispettiva maturità
politica e quindi umana. Per quale motivo un uomo provi cordoglio, e quale specie di
cordoglio, ciò dimostra la sua statura. L’elevare, ad esempio, il cordoglio su un piano
più ampio, il farne qualcosa che contribuisca al progresso della società, è un compito
artistico.
5. La materia in sé è priva di carattere umano.
In certo senso, come è noto a ogni artista, qualsiasi materia in sé e per sé ha qualcosa di
semplice, d’inqualificato, di vuoto e di autosufficiente. Solo il gesto sociale — critica,
astuzia, ironia, propaganda ecc. — vi inserisce l’elemento umano. La pomposità
fascista, se considerata unicamente come pomposità, mostra un gesto vuoto di
contenuto: il gesto, appunto, semplicemente pomposo, un’esteriorità indifferenziata.
Gente che cammina al passo invece che normalmente, una certa rigidezza di
movimenti, molto colore, petto ostentatamente in fuori, ecc. Tutto ciò potrebbe
benissimo costituire il «gesto» di uno svago popolare, essere cioè qualcosa
d’innocente, d’immediato, un puro dato di fatto. Solo quando il passo di marcia
avviene sopra i cadaveri, si ha il gesto sociale del fascismo. In altre parole, di fronte al
fatto «pomposità», l’artista deve assumere un atteggiamento: non può limitarsi a
lasciarlo parlare da sé, ad esprimersi come a lui stesso — al fatto — più garba.
6. Un consiglio.
È un ottimo criterio, di fronte a una composizione musicale con testo, di far vedere
all’artista l’atteggiamento, il «gesto» che egli dovrà osservare nell’eseguire le varie
parti: cortesia o ira, umiltà, o disprezzo, assenso o rifiuto, astuzia o semplicità; dando la
preferenza ai gesti più correnti, più volgari e più banali. Così sarà possibile giudicare
esattamente del valore politico di quella musica.
1938 circa
[Alternativa per l’arte]
In questo tempo di decisioni anche l’arte deve decidersi. Essa può farsi strumento di
alcuni pochi che si atteggiano a «dèi del fato» per i molti ed esigono una fede che
prima di tutto dev’essere cieca; e può mettersi dalla parte dei molti e porre il «fato»
nelle loro mani. Può abbandonare gli uomini agli stati di ebbrezza, di illusione, di
stupore — e può consegnare il mondo agli uomini. Può accrescere l’ignoranza, e può
accrescere il sapere. Può fare appello alle potenze che dispiegano la loro forza nelle
opere di distruzione, e alle potenze che la dispiegano nel prestare aiuto.