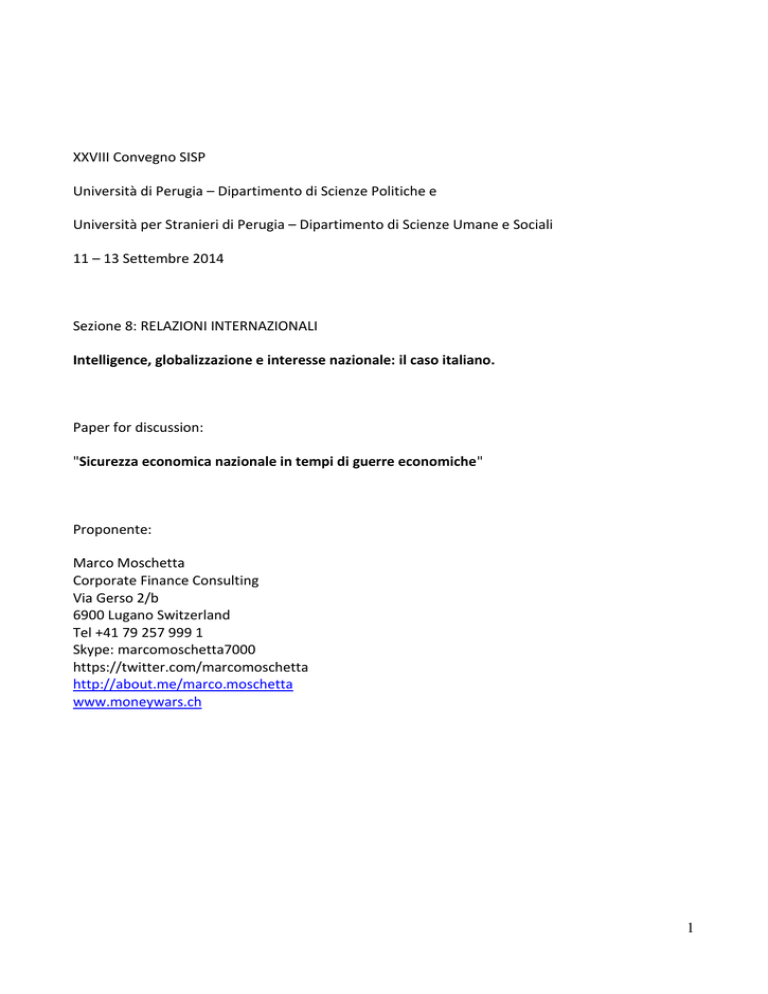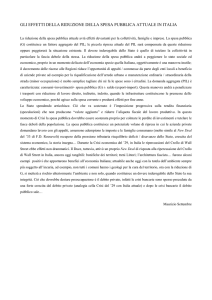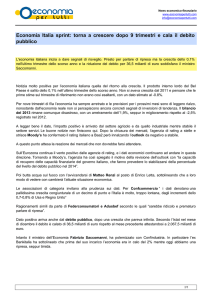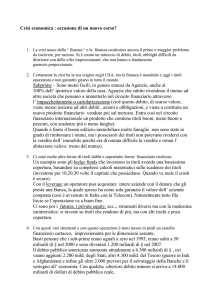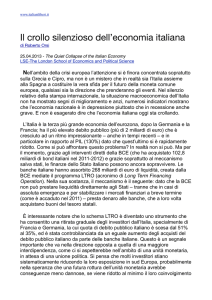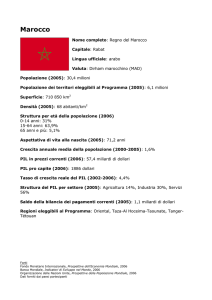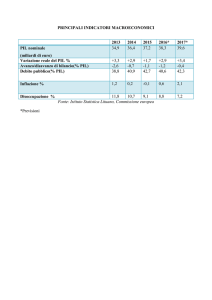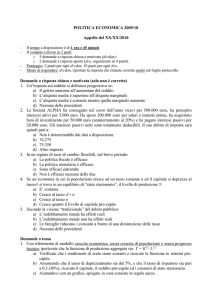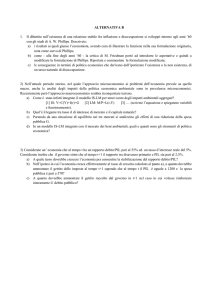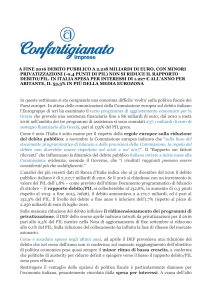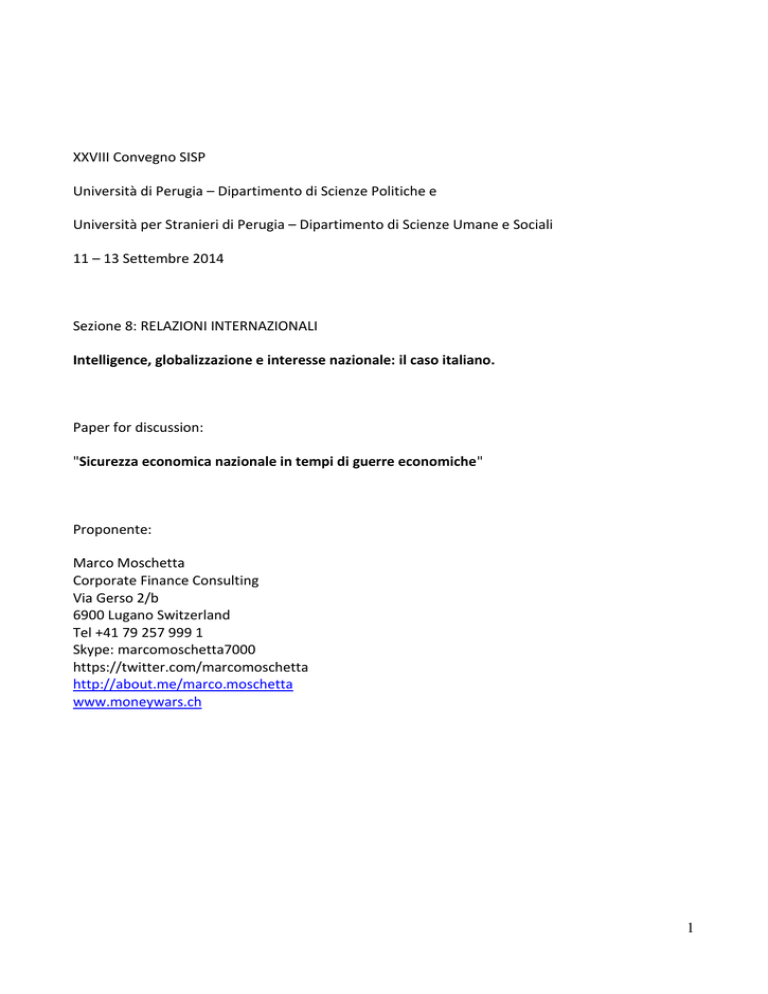
XXVIII Convegno SISP
Università di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche e
Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
11 – 13 Settembre 2014
Sezione 8: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Intelligence, globalizzazione e interesse nazionale: il caso italiano.
Paper for discussion:
"Sicurezza economica nazionale in tempi di guerre economiche"
Proponente:
Marco Moschetta
Corporate Finance Consulting
Via Gerso 2/b
6900 Lugano Switzerland
Tel +41 79 257 999 1
Skype: marcomoschetta7000
https://twitter.com/marcomoschetta
http://about.me/marco.moschetta
www.moneywars.ch
1
Sommario:
Sommario ............................................................................................................................................. 2
1. Le origini euro-atlantiche dell’Euro.................................................................................................. 3
2. L’ingresso dell’Italia nell’Euro e la promessa di risanamento ......................................................... 4
3. Le origini della Grande Crisi Finanziaria globale .............................................................................. 6
4. L’intervento di salvataggio della Fed ............................................................................................... 7
5. Uno spill-over della Grande Crisi USA: la Crisi dell’Euro .................................................................. 8
6. Perché l’Italia non ha fatto default ed è ancora nell’Euro ............................................................. 10
7. La finanza globale come “Sistema Complesso” ............................................................................. 11
8. #moneywars ................................................................................................................................... 13
9. Money war game ........................................................................................................................... 15
10. Un attacco finanziario all’Italia .................................................................................................... 17
11. La sicurezza economica nazionale ............................................................................................... 18
2
1. Le origini euro-atlantiche dell’Euro
Esiste un filo rosso, continuo e mai interrotto, tra Piano Marshall, OECE (poi OECD), ECSC1 (CECA,
in Italiano), CEE-UE ed Euro. Nel luglio del 1947, poco dopo il discorso del Generale Marshall ad
Harvard, la Conferenza per la Cooperazione Economica Europea si riunì a Parigi per studiare
l’implementazione dell’ingente piano di aiuti e ricostruzione al quale, in gran parte, dobbiamo
l’Europa di oggi. Il Dipartimento di Stato americano mise in chiaro, in quell’occasione, che il piano
di aiuti sarebbe stato condizionato ad un disegno di sistematica cooperazione tra i paesi
destinatari, che avrebbe poi posto le premesse di un progetto di unione politica.
Allora lo sforzo economico USA fu di circa 17 miliardi di dollari, quando il PIL USA era di 225
miliardi. Si trattò di qualcosa come il 7,7% del PIL, una somma che oggi sarebbe pari a 1,3 trilioni di
dollari.
Date le condizioni disastrate in cui si trovavano le economie europee all’epoca, tali paragoni in %
sul PIL non possono che sottostimare gli effetti del Piano. Tale iniziativa si configurava anche come
un attacco di guerra economica nei confronti dell’URSS, che avrebbero avuto gioco facile
all’espansione economica e culturale in Europa (e nella devastata Germania, in particolare), se
fosse passata la linea isolazionista e massimalista rappresentata dal Piano Morgenthau, che, con
scarsa comprensione delle dinamiche geo-economiche, puntava ad una riduzione punitiva della
Germania a paese agro-pastorale.
L’altro filo rosso geo-economico riguarda il ruolo delle élites politiche ed economiche tedesche nel
sistema di ri-organizzazione dell’Europa post-bellica. La Questione Tedesca rappresentò uno degli
elementi fondanti della CEE-UE. Ne troviamo traccia nella ECSC (CECA), organizzazione
sovranazionale destinata a inserire in un quadro continentale l’enorme potenziale economico
tedesco nell’industria pesante; e nella presenza di una controversa leadership tedesca2
nell’Istituzione che ha operato come incubatore dell’EMI (European Monetary Institute) – che è
poi diventato ECB (European Central Bank): la BIS (Bank of International Settlements). La BIS a sua
volta nacque per risolvere un’altra Questione Tedesca, quella delle riparazioni successive alla
prima Guerra Mondiale (Piano Dawes, 1928); ed è anch’essa sfuggita alla liquidazione forzata,
promossa negli USA proprio dal Segretario del Tesoro Henry Morgenthau.
Sempre alla Questione Tedesca, più di recente, è legata la nascita dell’Euro, almeno secondo
alcune fonti riportate, tra gli altri, dall’autorevole “Der Spiegel3” che cita documenti de-classificati
del Ministero degli Esteri tedesco riferiti ai giorni precipitosi che portarono alla riunificazione alla
fine del 1989, quando venne trovato l’accordo per il progetto di Unione Monetaria e l’inizio
dell’Europa a guida franco-tedesca.
Al di là di considerazioni legate alle facilitazioni degli scambi e di eliminazione del rischio di
cambio, l’adesione all’Euro rappresentò per l’Italia una porta verso l’Europa “di serie A”. I
parametri di Maastricht, che prescrivono condizioni di gestione conservativa e prudente della
politica monetaria e fiscale, non avrebbero consentito al Paese di entrare a far parte della moneta
unica, in particolare per il parametro del rapporto tra debito e PIL: per Maastricht, tale rapporto
1
European Community of Steel and Carbon.
Cfr Adam Le Bor, Tower of Basel; pp. 73 ss.
3
Der Spiegel International, The Price of Unity: Was the Deutsche Mark Sacrificed for Reunification? Di Michael
Sauga, Stefan Simons and Klaus Wiegrefe; 30 Settembre 2010.
2
3
non dovrebbe eccedere il 60%, mentre l’Italia del 1998 aveva un rapporto debito / PIL di oltre il
114%.
A livello puramente finanziario, con il “sì” a Maastricht (Ricordiamo a stragrande maggioranza: 403
favorevoli, 46 contrari e 18 astenuti) l’Italia perde il controllo della propria valuta ma entra in un
sistema monetario tra i più forti e credibili al mondo. L’Euro si guadagna ben presto, infatti, la
credibilità degli investitori internazionali, diventando la principale alternativa al dollaro come
valuta di riserva (Cfr Figura 1).
Figura 1
2. L’ingresso dell’Italia nell’Euro e la promessa di risanamento
L’ingresso dell’Italia nell’Euro avviene quindi nell’ambito di una promessa di un percorso di
risanamento e riduzione del debito che, in teoria, apparirebbe facilitato dall’immediato calo del
costo del finanziamento del debito pubblico, che passa dal 10,5% (media 1990-1995) al 5% (media
2000-2005). Tale promessa di risanamento, come abbiamo visto, trova le proprie origini storiche e
geopolitiche nella collocazione “Euro-Atlantica” del Paese, che è uno dei fondamenti della sua
modernità (nel bene e nel male, si obietterà).
Quello che è invece successo è purtroppo cosa nota, ed è sintetizzato nella Figura 2 in basso.
Mentre il costo del finanziamento del debito pubblico, come previsto, si è quasi dimezzato, lo
stock di debito si è ridotto solo nel 1997/98, nel 2000 e nel 2002/03, e di percentuali non molto
significative (la migliore performance, a parte il 2013, è stata quella del 1997, anno in cui il debito
si è ridotto del 1,9%).
I governi di destra e di sinistra hanno speso integralmente tutto il cospicuo risparmio di interessi
derivante dall’ingresso nell’Euro, stimabile in circa 30/40 miliardi l’anno per il periodo 2000-2012.
Questa “pacifica ignoranza” della promessa che il Paese aveva fatto con la ratifica del Trattato di
4
Maastricht è costata molto in termini di fiducia dei mercati, di maggior indebitamento, di maggiori
sprechi e oneri della macchina statale e di maggiore tassazione per cittadini e imprese.
Se i governi avessero tesaurizzato (invece di spendere e disperdere) anche solo il 50% del
risparmio di spesa per interessi, l’Italia sarebbe arrivata al 2011 con un debito di 1.737 miliardi
circa (il 110% del PIL) invece che di 1.880 miliardi (>119% del PIL). Anche qualora vi fosse stata una
“crisi dello spread”, sarebbe stata meno severa, e il Paese vi sarebbe arrivato con un maggiore
potenziale di crescita derivante dal minore peso fiscale (stimabile in circa 1% di PIL solo per la
quota derivante da risparmi da interessi sul minor stock di debito, nell’ipotesi – molto conservativa
- che la produttività delle risorse rilasciate nell’economia privata sia uguale a quella delle risorse
rilasciate nell’economia pubblica).
Figura 2
Mettendo da parte i “se” e i “ma” e inquadrando invece la posizione dell’Italia nel contesto dei
mercati internazionali in quel fatidico 2011, occorre fare un passo indietro e occuparsi di un’altra,
più grande bolla finanziaria – quella dei mercati americani nel periodo 2002-2008.
5
3. Le origini della Grande Crisi Finanziaria globale
La politica ha le sue responsabilità nella Grande Crisi Finanziaria, segnatamente per due atti
entrambi relativi agli USA: il rigetto della legislazione Glass Steagall, che dal 1930 separava le
attività bancarie commerciali ordinarie dalle più rischiose attività di investment banking; e
l’American Dream Downpayment Assistance Act di George Bush, con cui il governo USA si
proponeva di assistere, nell’ambito di una Aggressive Housing Initiative, anche le famiglie che non
avevano alcun risparmio a versare l’anticipo per la stipula del mutuo. Questi eventi, all’inizio degli
anni 2000 e a seguito dello sboom dei titoli internet e degli attacchi del 11 settembre, hanno dato
inizio alla più grande speculazione immobiliare della storia.
I mercati americani sono entrati, a partire da quel periodo, in una spirale di crescita finanziata da
debito che nel periodo 2003-2007 ha creato un’enorme bolla immobiliare e finanziaria. Mentre nel
periodo 2003-2007 il debito pubblico italiano cresceva di circa il 3,5% l’anno, il trend di crescita del
debito privato USA e dei vari strumenti ad esso legati (prevalentemente Residential Mortgage
Backed Securities) è stato di oltre 5 volte superiore. E’ stata proprio questa bolla di debito che ha
portato al collasso, nel 2008, la Lehman Bros (Figura 3). Per analogia, e con risultati di poco
difformi, possiamo utilizzare l’espansione dell’indebitamento di Lehman come proxy della crescita
del debito di tutto il sistema finanziario privato americano.
Figura 3
La crisi dei mutui sub-prime ha avuto portata e ripercussioni tali che possiamo dire che dal 2008 il
mondo è entrato in una nuova fase. Il fallimento della Lehman ne ha segnato la cuspide
evidenziando il moral hazard indotto da un sistema di incentivi distorto e dai concetti – rivelatisi
poi errati – della parcellizzazione del rischio e del too big to fail.
6
Un’analisi “statica” della situazione alla metà del 2007 avrebbe permesso di stimare in circa 600 /
700 miliardi di dollari l’ammontare della perdita cumulata del mercato sub-prime. Cifre importanti,
si, ma non tali – almeno in teoria – di destabilizzare un’economia da oltre 16 trilioni di dollari come
gli USA. E invece gli effetti moltiplicativi di:
-
modelli di rischio sbagliati (VAR) basati sulla “bell curve” (distr. normale)
moltiplicazione dell’esposizione data dalle securitization
rischio-controparte e “interconnessione globale”
derivati
hanno portato il mondo vicino al collasso finanziario globale a poche settimane dal fallimento
Lehman ed hanno innescato la crisi economica più grave dal 1929. La Grande Crisi Finanziaria,
come è stata definita, ha avuto anch’essa ripercussioni globali, per ragioni simili a quelle che
causarono la diffusione anche in Europa della Crisi del 1929.
4. L’intervento di salvataggio della Fed
La reazione delle autorità monetarie statunitensi si è materializzata con la più grande attività di
stimolo monetario che il mondo abbia mai subito. Se, da un lato, questo ha evitato che la crisi
toccasse i livelli drammatici del 1929 in termini di perdita di occupazione e servizi sociali; dall’altro
l’immissione nel sistema finanziario internazionale di quantitativi ingentissimi di dollari ha creato
squilibri tali che sono stati descritti come currency wars.
Per dare la misura di questo stimolo, ricordiamo che la Fed nel settembre 2008 aveva in bilancio
titoli a garanzia per circa 600 miliardi di USD. Dopo una serie di interventi di stimolo all’economia,
nell’Aprile del 2014, la Fed si ritrova con oltre 4.000 miliardi di USD di titoli all’attivo (Cfr. Figura 4
dal sito della Federal Reserve). Questo enorme stimolo monetario ha trovato il suo contraltare nel
valore dell’oro, passato da circa 900 USD/oz nell’autunno del 2008 ad oltre 1.200 USD/oz nel
maggio 2014. Quello che si è verificato, in sintesi, è stato un massiccio debasement del valore del
dollaro USA, realizzato per salvare i bilanci dei colossi bancari di Wall Street e per cercare di ridare
fiato all’economia per il tramite del canale export.
Questo salvataggio, se aveva delle implicazioni moralmente riprovevoli (tirare fuori le castagne dal
fuoco ai c.d. banksters), è stato comunque necessario per evitare il collasso del sistema:
ricordiamo che proprio dopo il weekend (14-15 settembre 2008) in cui Lehman venne “lasciata
andare”, la Fed dovette intervenire, il 16 settembre, con il più grande salvataggio privato della
storia per evitare il collasso del gigante assicurativo AIG che era esposto sul mercato tramite Credit
Default Swaps emessi a fronte di Collateralized Debt Obligations (in sostanza, assicurazioni sul
default di pacchetti di mutui) per oltre 440 miliardi di dollari. Per prevenire il collasso della Società
l’intervento della Fed fu di 85 miliardi di dollari nella forma di una linea di credito che permettesse
a AIG di rispondere positivamente alle margin calls4 dei suoi creditori. Poche ore dopo aver dovuto
tenere una linea di austerità con Lehman la Fed si trovò a sconfessare se stessa in maniera
drammatica e massiccia. In barba alla linea di tutela della taxpayer money di Henry Paulson5.
4
Per “margin call” si intende la richiesta, da parte di un creditore, di una integrazione della garanzia erogata in forma di
deposito cash, pena la perdita del beneficio del credito e l’onere al rientro delle somme prestate.
5
Paulson ‘Never Once’ Considered Using Taxpayer Money for Lehman; The Wall Street Journal, 16 September 2008.
7
Figura 4
5. Uno spill-over della Grande Crisi USA: la Crisi dell’Euro
L’Europa è stata colpita duramente da queste dinamiche tipicamente finanziarie, a cui si è
sommato l’effetto di anni di politiche di spesa pubblica in deficit e delle prime ondate
dell’inversione della curva demografica, che ha pesato (e peserà ancora nei prossimi decenni) sui
sistemi previdenziale e sanitario. L’Italia si è ritrovata, a metà del 2011, ad essere uno dei link
deboli del sistema ed ha rischiato, per la prima volta, di dover ricorrere all’aiuto del FMI.
La Grande Crisi Finanziaria del 2007-2008, in cui ci troviamo tuttora, ha avuto il seguente trend di
cause ed effetti (Cfr. Figura 5 infra): un trend di lungo periodo, complesso ed esponenziale, ha
creato accumuli enormi di debito presso le economie iper-finanziarizzate del settore anglo
sassone. L’eccesso di debito, il cui flusso si è interrotto bruscamente nel 2008, in condizioni di
interconnessione finanziaria globale ha creato la stretta creditizia delle principali economie
sviluppate. In una condizione di decrescita delle masse monetarie, queste economie hanno subito
un deciso rallentamento dell’attività economica, che a sua volta ha influito negativamente sui
proventi fiscali degli stati. I governi si sono trovati all’inizio a reagire con politiche di deficit
spending (le usuali) ma in una situazione di costi crescenti del finanziamento del debito questo ha
provocato (per gli stati eccessivamente indebitati, come l’Italia) la crisi dello spread.
8
Figura 5
Nel periodo gennaio-giugno 2011, ad esempio, mentre BCE e UE negoziavano un ulteriore
pacchetto di aiuti per la Grecia, gli analisti di Deutsche Bank si accorsero di un fatto che era sotto
gli occhi di tutti ma nessuno aveva ancora considerato: il debito pubblico italiano era già al 120%
del PIL, ossia era il II^ più importante dopo la Grecia. La Deutsche Bank iniziò quindi a vendere, per
tutto il I semestre 2011, titoli italiani, riducendo le proprie posizioni da oltre 8 miliardi di Euro a 1
miliardo. La notizia venne resa pubblica dal Financial Times il 26 luglio 2011 (“Deutsche hedges
Italian risk”) e fu accompagnata da un balzo dei rendimenti dei titoli italiani (da 150 a 289 b.p. di
spread sul Bund) e dalla crescita del Credit Default Swap su questi titoli (da 124 a 274 b.p.). Da
notare che l’articolo del FT fu accompagnato da una dichiarazione “diplomatica” di Stefan Krause,
il Direttore Finanziario di DB, che collegava le vendite italiane al portafoglio di BTP che DB si era
ritrovata in dote dall’acquisizione di Postbank. Per la serie “la pezza è peggio del buco” !
Nel volger di qualche mese, i titoli dei giornali divennero pieni di accostamenti retorici che più o
meno preconizzavano la fine imminente e tragica dell’Euro, mentre economisti di levatura
riempivano metri quadri di giornali e pagine web con analisi sugli (ovvi, evidenti, ma non tali da
provocarne il collasso) squilibri di natura economica dell’unione monetaria, mentre il peso del
debito italiano – oggettivamente too big to bail – iniziava a fare davvero paura ai mercati. Anche
un diligente studente del secondo anno di economia sa che l’Europa non è una “area valutaria
ottimale6”, ma a coloro che si focalizzavano solo sulle convenienze economiche di breve e medio
periodo sfuggiva il fatto che la UE non è solo una unione economica e che l’Euro non è solo uno
strumento valutario.
6
In breve, dicesi area valutaria ottimale una zona geografica in cui vi è piena mobilità dei fattori della produzione, non
vi sono barriere legislative, linguistiche, orografiche, valutarie etc. alla libera circolazione di merci e servizi; dove vi è
una politica economica e sociale unica o quantomeno simile, dove vi sono situazioni di simmetria nell’indebitamento
pubblico e nei deficit degli stati etc.
9
E così vivemmo il 2011 e buona parte del 2012:
l’Euro in calo costante vs. il dollaro USA (che pure
veniva immesso nel sistema monetario globale in
quantitativi mai visti in precedenza) e i vari
pundits di matrice prevalentemente anglo
sassone, puntualmente accompagnati da qualche
Tafazzi italiano, che dicevano che l’Euro sarebbe
crollato perché sarebbe crollata l’Italia.
Ci volle l’intervento, ormai più di moral suasion
che di portafoglio, di Mario Draghi, che nel luglio
2012 fermò le speculazioni (finanziarie e
intellettuali) affermando che:
1) La tutela della valuta europea è tra le priorità
della BCE, e che;
2) La BCE, in quanto istituto di emissione (se pur
anomalo) dispone di un potere finanziario
incomparabilmente superiore a quello di chiunque
voglia mettersi a speculare contro la valuta
europea (o contro il debito italiano, che più o meno venivano visti come la stessa cosa).
Credo che la Figura 6 in basso, che riporta il tasso di cambio EUR / USD, dia la misura del legame
tra crisi del debito (prevalentemente italiano, ma anche spagnolo e greco) e crisi dell’Euro,
mostrando l’inversione di marcia rappresentata dell’intervento BCE.
Figura 6
6. Perché l’Italia non ha fatto default ed è ancora nell’Euro
Il mantenimento dell’Italia all’interno dell’Euro (e delle sue origini euroatlantiche, come indicato
all’inizio) è invece dipeso da un intervento esogeno, non-trasparente ma massiccio della BCE. Dalla
Figura 7 (Tratta da Panorama, Ecco chi possiede il debito pubblico italiano, 29 aprile 2014) si
apprende che, tra la metà del 2011 e la metà del 2012 circa un 13% di debito italiano (una somma
10
di circa 240 miliardi di euro) è passato da detentori esteri a detentori italiani, prevalentemente
banche nazionali, finanziate dalla BCE.
Figura 7
Data questa dipendenza da fattori esogeni, per di più sottratti7 a controllo democratico o processi
decisionali trasparenti, ci si chiede se non sia arrivato il momento di attivare nel nostro Paese un
forum permanente di analisi strategica geo-economica e geo-finanziaria. Quantomeno per sapere
da quale parte potrà arrivare, e che forma potrà assumere, una nuova dirompente minaccia alla
stabilità finanziaria del paese e per creare le condizioni in cui, qualora ancora se ne presentasse la
necessità, possa ancora arrivare una scialuppa di salvataggio sostanziale, come quella delle grandi
immissioni di liquidità del 2011-12 o di moral suasion, come il “whatever it takes” di Draghi del
luglio 2012.
7. La finanza globale come “Sistema Complesso”
L’architettura finanziaria globale si regge tuttora sulle stesse premesse che ne hanno generato la
crisi, nel 2007. Esse sono:
1. Grandi istituzioni private scarsamente regolamentate, e altamente interconnesse tra di
loro;
2. Diffusi e perversi incentivi che rendono quasi obbligatoria la focalizzazione sul conto
economico e sulla creazione di valore per gli azionisti in un’ottica di breve periodo;
3. Un enorme mercato dei derivati;
4. Strumenti e veicoli finanziari complicati, difficilmente comprensibili e dalla rischiosità /
pricing difficilmente determinabili.
5. Premesse teoriche infondate (la teoria dei mercati efficienti, che ha come corollario il
corretto pricing del rischio; e la teoria della distribuzione normale, per cui gli eventi estremi
sarebbero estremamente rari – c.d. black swan events).
7
Una delle ragioni del salvataggio dell’Italia è molto probabilmente una condizione di dipendenza reciproca: il Paese ha
bisogno del salvataggio della BCE; la quale a sua volta non può permettersi il fallimento di un paese della dimensione
dell’Italia senza essere trascinata anch’essa nell’aftershock di mercato che conseguirebbe ad una situazione di crisi
catastrofica del debito italiano.
11
Più volte a livello di G20, FMI, Banca Mondiale, Financial Stability Board e BIS, si è stressata la
necessità che almeno alcune delle cause di squilibrio sistemico vengano affrontate e quanto meno
corrette. Su invito del G20, ad esempio, il FMI si è pronunciato per una semplificazione delle
“Systemically Important Institutions - SIIs” - leggi le grandi banche internazionali - o per la
revisione del monitoraggio sui mercati dei derivati e per regole più stringenti sullo “Shadow
Banking Sector” (gli investment vehicles, le securitizations e i derivati). Resta però il fatto che il
potere legislativo non è in grado di opporre resistenza alle lobbies che hanno un interesse,
tipicamente rappresentato dai conti economici e dai salari e bonus dei vertici delle SIIs, a che tutto
rimanga com’è attualmente, in una situazione in cui l’espansione del rischio trova sempre una rete
finanziaria nel bail-out delle banche centrali. Che è proprio quello che continua ad accadere, anche
se apparentemente le immense iniezioni di liquidità hanno spostato il problema dal rischio
sistemico di fallimenti a catena al rischio di deflazione-stagnazione.
Le ingenti immissioni di liquidità non
hanno ancora trovato un termine nelle
dichiarazioni delle banche centrali, e
continuano a riversarsi nel prezzo dei titoli
finanziari, che sta raggiungendo e
superando le vette del 2007 (Cfr. Figura 8,
l’indice S&P 500). Il prezzo dei titoli,
inoltre, appare ancor più slegato dai
fondamentali dell’economia, e può essere
letto anche come un generale
deprezzamento della valuta di riferimento,
il dollaro USA.
Figura 8
La Grande Crisi Finanziaria è stata paragonata8 ad un accumulo di neve in quota, su un pendio
scosceso, che entra in crisi e genera un catastrofico mutamento di stato: una valanga. Un
accumulo di neve in quota presenta le caratteristiche di un sistema complesso: è soggetto ad un
8
James Rickards, Currency Wars, Chapter 10: Currencies, Capital and Complexity; Portfolio / Penguin, 2011.
12
equilibrio sempre meno stabile a mano a mano che la sua massa cresce, ed ha delle dinamiche
interne (di temperatura, fluidità, relazione tra le proprie parti) che non rispondono a delle logiche
di causa ed effetto riproducibili in laboratorio (sarebbe, se lo fosse, un sistema “complicato” non
“complesso”). Le immissioni di liquidità della Fed (che proseguono al ritmo di 60/70 miliardi di USD
al mese) possono essere paragonate alla neve che si accumula, in vari strati, in quota. Gli eventi
interni al sistema finanziario (acquisti e vendite di titoli, andamento di qualche mercato dei
derivati ritenuto come critico come per esempio il mercato dei Credit Default Swaps) o gli eventi
esterni ad esso (politici, sociali, bellici, tecnologici) si combinano tra di loro e, fino a quando non si
arriva ad uno stato critico, danno come risultato le oscillazioni quotidiane dei mercati.
8. #moneywars
Le opinioni pubbliche non hanno mai pienamente apprezzato il processo di unificazione europea,
ed oggi non comprendono il livello di complessità delle economie finanziarizzate in cui si trovano a
vivere.
La Grande Crisi Finanziaria ha prodotto una enorme compressione del reddito disponibile nelle
maggiori economie sviluppate (basti ricordare che il tasso di disoccupazione è balzato, tra il 2008 e
il 2009 negli USA dal 4,5 % al 10%, mentre nella Eurozona è passato dal 6,5% al 11,5% nel periodo
2008-2012) che è andata, per la prima volta dal dopoguerra, a comporsi ad una massiccia
riduzione dei livelli di welfare a causa proprio dalla crisi del debito sovrano e delle necessità di
risanare i bilanci.
Negli USA le condizioni di recessione (recessione dei redditi privati, delle possibilità di impiego, dei
salari per chi ha un impiego, delle prospettive di accesso all’American Dream, dell’uguaglianza
sociale e di opportunità) hanno provocato un attacco senza precedenti all’establishment
finanziario di Wall Street, riconosciuto (a ragione, ad avviso di chi scrive) come il responsabile del
global meltdown. Le Banche Centrali a livello globale, tramite la loro presenza nel Financial
Stability Board, sembrano concordare con le accuse del movimento Occupy Wall Street, anche se
con toni meno accessi (ovviamente) e con una sfumatura di auto-tutela proprio del business
finanziario privato.
Sintetizzando opinioni diffuse a livello di governi (G20) e di istituzioni finanziarie globali (IMF, BIS),
la ricetta del Financial Stability Board propone di ridurre il rischio finanziario sistemico attraverso
una serie di provvedimenti, quali:
1. Riduzione delle dimensioni dei bilanci delle SIIs tramite regole di riserva più stringenti;
2. Maggiore supervisione dello shadow banking sector, della speculazione (degli hedge
funds), delle agenzie di rating e dei mercati dei derivati OTC;
3. Attenzione al problema too big to fail e attivazione di un sistema per risolvere le crisi delle
SIIs senza utilizzo di risorse pubbliche;
4. Sistema di controllo internazionale sui paradisi fiscali, sul riciclaggio internazionale e sul
finanziamento del terrorismo.
Il FSB non parla apertamente (ancora) di rigetto del Glass-Steagall Act, anche se questa indicazione
si percepisce chiaramente nel linguaggio dei comunicati ufficiali del G20, del Fmi e di molte banche
centrali.
13
Quello che sta avvenendo, in particolare per quanto riguarda gli USA, è che le banche centrali,
tramite il FSB, stanno cercando di promuovere un intervento del Congresso al fine di limitare il
potenziale di creazione di disordine finanziario delle grandi istituzioni finanziarie private.
OWS e i banchieri centrali sono meno lontani di quanto possa apparire.
Figura 9
In Europa, ed in Italia in particolare, si assiste ad un movimento di protesta che trova le sue radici
nelle stesse condizioni di riduzione delle aspettative vissute negli USA.
Tutta la discussione (e la critica) sul Patto di Stabilità non tiene conto del fatto che l’Italia, proprio
per colpa del suo “Congresso”, ha rischiato a sua volta di far saltare gli equilibri finanziari macro a
causa della sua condizione di debito fuori controllo.
Come negli USA, anche in Italia la apparentemente fondata percezione di guerra finanziaria contro
l’uomo della strada trova il suo alleato nei banchieri centrali (della ECB) che, pur nella loro
privilegiatissima torre d’avorio, stanno cercando di regolamentare i livelli di spesa a tutela
dell’attuale equilibrio economico continentale e a tutela della collocazione geo-economica (e geopolitica e geo-strategica) dell’Europa a livello globale. Specialmente vs. le economie emergenti e
gli assi valutari in formazione (Rublo – Yuan, valute del Golfo).
14
Una notazione quantitativa dovrebbe però far riflettere: se negli USA l’intervento di bail-out è
stato di oltre 3 trilioni di dollari, e non ha ancora trovato una conclusione definita; in Europa
l’espansione massima del LTRO (Long Term Refinancing Operation) è stata di 1,4 trilioni di dollari,
ed un processo di rientro di queste somme si è avviato già dalla metà del 2012, per cui alla data
odierna l’ammontare totale del LTRO in attivo alla BCE è inferiore ad 1 trilione di dollari.
9. Money war game
L’Applied Physics Laboratory è uno dei gioielli del sistema strategico degli USA. Fondato nel 1942,
dopo l’attacco di Pearl Harbour, il Laboratorio ha l’obiettivo di sfruttare l’immenso potenziale
scientifico e tecnologico del Paese per migliorarne le capacità difensive e offensive. Uno dei primi
progetti seguiti dall’APL riguardò una testata per un missile antiaereo destinato alla difesa navale.
Da quel momento in poi, il laboratorio si è occupato di vari progetti di trasferimento tecnologico
dal mondo civile a quello della difesa.
Nel 2009, in una sessione di due giornate (17 e 18 Marzo) l’APL ha tenuto un war game
finanziario9, utilizzando le strutture fisiche e tecnologiche con cui il laboratorio tiene le sue
ordinarie sessioni di war gaming “cinetico”. I partecipanti a questo war game erano esperti di
politica internazionale, economisti e operatori dei mercati finanziari. Il gioco consisteva nella
creazione di 5 team in rappresentanza di altrettante aree strategiche del pianeta (Gli USA,
l’Europa, la Russia, la Cina e l’area del sud-est del Pacifico) a cui veniva attribuito, all’inizio, un
certo ammontare di risorse (PIL, riserve, import ed export, curva demografica etc).
Il war game ebbe inizio con una mossa a sorpresa del “team Russia” con la quale la Banca Centrale
Russa dichiarava la creazione di una Gold Dolar Bank a Londra che avrebbe emesso Gold Dolars a
fronte di depositi di oro presso camere di sicurezza localizzate in Svizzera e a Singapore. Da quel
momento, inoltre, la Banca Centrale Russa dichiarava che le esportazioni russe avrebbero dovuto
essere pagate solo tramite Gold Dolar e che era attivo un tender per cui la Banca avrebbe
acquistato infiniti quantitativi di oro fisico pagandoli in USD o titoli del Tesoro USA al valore di
mercato dell’oro così come riportato da Bloomberg (Cfr press release fittizia della Bank of Russia,
Figura 10).
La reazione degli altri teams a questa prima mossa fu di pressoché totale distacco, nella
convinzione che l’oro rappresentasse per il sistema dei pagamenti internazionali niente più di un
reperto storico, come i vecchi certificati azionari in filigrana che si vedono appesi negli uffici di
qualche commercialista o avvocato d’affari nostalgico. Una discussione venne attivata all’interno
del Team Cina, sull’opportunità o meno di aderire alla proposta russa e di acquistare Gold Dolars.
Prevalse il parere ortodosso di evitare di spendere preziosa valuta internazionale, pronta ad essere
utilizzata per gli scambi, con un esperimento proveniente da un Paese così atipico e dedicato ad
un oggetto ormai lontano dal sistema delle transazioni internazionali. Dopo un rapido dibattito
interno, addirittura, il Team Cina decise di vendere quasi tutte le sue riserve di oro, circa 1.000
tonnellate, in una transazione privata con il Team Russia, di fatto raddoppiando, con scarso effetto
sul prezzo spot dell’oro, la dotazione di oro del Team.
Il war game finisce con un lieve vantaggio del Team Russia e con qualche credito al suo
esperimento di gold standard bank. Quello che successe però mentre il war game era ancora
9
Citato da James Rickards, Currency Wars, Portfolio Penguin 2011; pp. 6 ss.
15
aperto provocò uno shock nei player: proprio all’inizio del secondo giorno vi fu una dichiarazione
di Putin che auspicava la fine del sistema di scambi internazionali basati sul dollaro, dichiarazione
che venne ripresa e supportata dalla Cina nel corso del G20 del settembre successivo. Non
abbiamo notizia di war games più sofisticati e successivi a questo di cui parla Rickards, ma
sappiamo che molto del brainstorming effettuato in quell’occasione ha trovato riscontro nella
realtà degli anni seguenti.
Figura 10
16
10. Un attacco finanziario all’Italia
Il documento programmatico di bilancio dell’Italia nel 201410 prevede un deficit pari al 1,8% del
PIL, in calo rispetto al 2,9% programmato per il 2013 (il consuntivo è stato -3,2%). Tale documento
era stato preparato sulla base di un PIL in crescita del PIL del 2014 di 0,8%, mentre sappiamo che il
tendenziale ad oggi è pari ad un 0,1%.
Sul fronte delle spese, il documento programmatico 2014 prevede spese complessive (al lordo
degli interessi passivi pari a 84 miliardi) per 806 miliardi, mentre alla data del 30 giugno 2014 pare
che i dati tendenziali siano peggiori del previsto: uscite previste per l’esercizio pari a 825 miliardi 11.
Ipotizzando che negli ultimi 5 mesi dell’anno il Governo sia stato in grado, tra risparmi e rinvii di
spesa, a riportare la spesa pubblica nell’ambito degli 805,5 miliardi previsti, il calo del PIL
comporta (a causa di minori entrate fiscali proporzionate al PIL stesso e maggiori costi, in
particolare, degli ammortizzatori sociali) una previsione (modello elaborato dall’autore) di deficit
pari a circa il 4,1% del PIL per l’esercizio 2014.
Questo deficit genera un ulteriore incremento del rapporto debito / PIL (mia previsione) al 136,2%
per l’esercizio 2014. Si tratta di dati molto lontani rispetto agli impegni del Patto di Stabilità.
Immaginiamo ora il seguente scenario (Cfr Figura 11): il riacutirsi della crisi Ucraina, combinato a
nuovi attacchi e al dilagare dei focolai di crisi in Medi Oriente inizia a rallentare la crescita in tutta
Europa, ed in particolare in Italia anche nel 2015. A metà del 2015, degli istituti di ricerca privati
rilasciano proiezioni di crescita negativa del PIL ed una proiezione di crescita del debito pubblico al
144% per la fine dell’esercizio. All’inizio dell’anno il Governo è riuscito a varare un pacchetto di
riforme più di facciata che di sostanza, e la stagnazione dell’economia fa crescere i dubbi degli
investitori internazionali sulla sostenibilità del debito pubblico italiano.
La crisi di governo in Italia preoccupa i mercati, mentre lo Spiegel apre con una caricatura di Renzi
dietro un carretto dei gelati e la didascalia “Ciao Bello”. Le élites economiche, finanziarie e
politiche tedesche decidono che è giunta l’ora di staccare la spina ai PIIGS e all’Euro nella sua
attuale configurazione, tentando di riorientare tutto il sistema di potere economico europeo
attorno a Francoforte. Per affondare l’Euro si sceglie di silurare l’Italia, il suo anello più debole: si
attiva un mix di vendite di titoli, annunci stampa e utilizzo di derivati da parte di fondi hedge
controllati e operativi da tempo per attività di mercato nascoste.
Parte di questa mossa passa tramite un nuovo “conservative consensus” nella BCE, dove vengono
fermate le mani di Draghi che vorrebbe intervenire a tutela dell’Euro nella sua attuale
configurazione e della posizione dell’Italia. Le dimissioni violente di Draghi portano
definitivamente l’Italia verso la strada del default / uscita dall’Euro, con Bankitalia che studia un
“Piano di Emergenza” mentre il Paese è praticamente fuori dal circuito finanziario globale dopo il
ritiro di una importante asta di titoli di debito pubblico.
10
11
Cfr Ministero del Tesoro, Documento di Economia e Finanze 2014, Tabella II.1-3, pag. 9.
Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore; Spesa pubblica: balzo del 7,8% nel 2014; 6 agosto 2014.
17
L’attacco all’Italia, e la sua uscita dall’euro, sono costati qualche miliardi di euro in perdite in
c/capitale da parte delle banche che hanno operato il dumping di titoli di valore nominale di circa
60/70 miliardi. Con ulteriori investimenti per circa 8 / 10 miliardi gli investitori “attaccanti” hanno
finanziato l’acquisto dei Credit Default Swaps che hanno lanciato sul mercato un ulteriore segnale
di panico: qualcuno si sta coprendo in maniera massiccia contro un possibile default dell’Italia,
realizzando una classica profezia che si auto-avvera. Questo attacco può essere stato preparato
anche tramite l’uso di trolls che operando sui vari social network hanno diffuso notizie e rumours
propedeutici all’operazione.
Con una disponibilità di 15 / 20 miliardi, in sintesi, si potrebbe riuscire, date le opportune
condizioni congiunturali, a realizzare un progetto di attacco all’Italia con conseguenze devastanti
per il Paese. Il successo di un attacco del genere riconfigurerebbe il sistema di potenza europeo in
maniera radicale, rappresentando, per alcuni in Germania, l’equivalente di una Operazione
Barbarossa geo-economica.
Figura 11
11. La sicurezza economica nazionale
Le conseguenze di un attacco del genere all’Italia, qualora avesse successo, sarebbero incalcolabili.
In sintesi, potremmo parlare dell’estromissione del Paese dal consesso che guida l’Unione Europea
e la marginalizzazione e l’impoverimento economico e finanziario per cittadini, imprese, Stato. La
sicurezza nazionale non è mai stata così legata alla sicurezza finanziaria come oggi, specie per
nazioni ad elevato indebitamento e alta dipendenza dai flussi (e dalla fiducia) finanziari globali.
Dagli anni ’80 in poi l’Italia ha cercato di creare crescita e benessere tramite la spesa pubblica,
nella (falsa) teoria (para) keynesiana che per ogni Euro di crescita del debito vi fosse una più che
proporzionale crescita del reddito. Quello che emerge dall’analisi dei dati è che (Figura 12), invece,
il moltiplicatore reale nel corso del periodo di grande espansione del debito sia stato inferiore
all’unità, attestandosi a circa 0,6. Ciò significa che per ogni euro in più di spesa pubblica il prodotto
18
nazionale è aumentato di soli 0,6. Risultato: un inesorabile e continua crescita dell’indebitamento.
In barba agli impegni di Maastricht.
La ricerca del consenso elettorale, unita ad una visione miope – o a nessuna visione – del Paese
come potenza continentale hanno generato un mostro di de-responsabilizzazione che ha distrutto
la competitività del Paese.
Figura 12
Dalle analisi di competitività del World Economic Forum, infatti, il ritratto dell’Italia è
perfettamente rispondente all’esperienza di investitori, imprenditori e operatori d’affari: un paese
con un ottimo livello di sviluppo umano, buone infrastrutture ed un grande mercato potenziale,
ma frenato da scarsa fiducia e qualità delle istituzioni, basso sviluppo del mercato finanziario,
tassazione elevata, complessa e non adeguata al livello dei servizi e bassa efficienza del mercato
del lavoro.
19
A tutti questi elementi – su cui qualche attento diplomatico italiano ha dedicato attenzione12 –
aggiungerei l’assoluta mancanza di un dibattito italiano sulle opportunità e le minacce per la
sicurezza nazionale nell’ambito dell’attuale (post prima ondata di globalizzazione?) scenario geoeconomico globale.
Nel 2007 le prima pagine dei giornali italiani erano piene di commenti editoriali ed analisi di
bilancio riguardanti l’avventura dei “Capitani Coraggiosi” lanciati da Berlusconi e Tremonti al
salvataggio di Alitalia e dell’Onore Nazionale. Sempre in quell’anno, senza alcuna riflessione
pubblica, si consumò la cessione (passata per fusione) della Borsa Italiana SpA al London Stock
Exchange.
Ciò significa che, fino al 2007, per attivare il processo di quotazione e l’ammissione in borsa di una
società italiana si passava attraverso un gestore di mercato controllato dall’Italia e il cui top
management era italiano. Oggi rimane la grande sala di rappresentanza dell’amministratore
delegato di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, ma l’azienda è controllata da soci (banche,
prevalentemente) inglesi. Le decisioni ultime su chi ammettere in borsa vengono prese a Londra.
Stimolare la creazione di un tessuto imprenditoriale dinamico e competitivo, ed affiancarlo con
una presenza istituzionale efficace, competente e snella e creare un ambiente favorevole al
capitale di rischio (venture capital, private equity, IPO) dovrebbe essere un elemento di supporto
della sicurezza economica nazionale e di creazione di forza lavoro stabile e di valore aggiunto
sostenibile. L’esempio Alitalia – Borsa Italiana, e il modo in cui l’Italia ha trattato il proprio bilancio
nel periodo successivo all’ingresso dell’Euro mostrano che al di là di qualche episodio di lip service
i boiardi che governano i grandi partiti nazionali non hanno alcun interesse a farsi davvero carico
di questi temi.
Negli ultimi 15 anni uno stuolo di aziende italiane di grandissimo prestigio internazionale sono
state cedute (Figura 13) segnalando, oltre al noto nanismo dell’imprenditoria italiana, anche una
diffusa sfiducia degli imprenditori italiani nella possibilità di continuare a fare business nel Paese.
Vi sono anche casi in cui, famiglie imprenditoriali molto ricche, abbiano de-investito nei loro
business principali, che a volte avevano il potenziale di diventare dei global brands, per ritirarsi a
vita privata e investire in attività che generano rendite, a volte all’ombra dello stato.
Quello che è andato perduto, non si recupera. Vi sono peraltro casi molto interessanti di “terze
generazioni” imprenditoriali che hanno fatto tesoro della ricchezza culturale e di immagine
dell’Italia per veicolare all’estero prodotti e servizi di qualità. Credo sia questa la strada da
incentivare e promuovere, ovviamente considerando le ben note riforme come un pre-requisito,
per migliorare le condizioni di sicurezza economica e sociale dell’Italia.
12
Tommaso Coniglio; L’imperativo della competitività. Sicurezza nazionale ed economia di mercato nell’era della
globalizzazione; Franco Angeli, 2007; con prefazione di Carlo Jean.
20
Figura 13
21