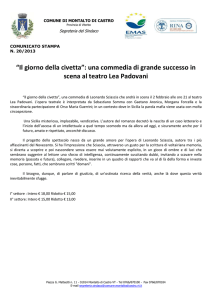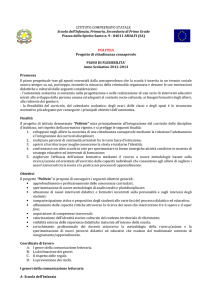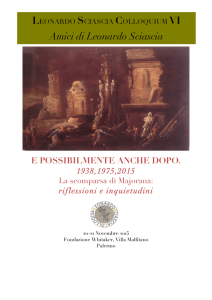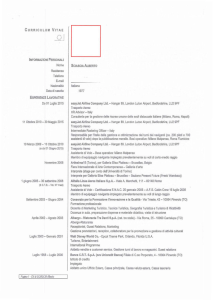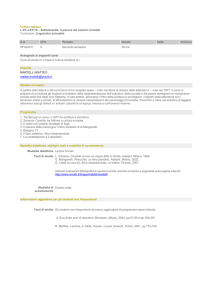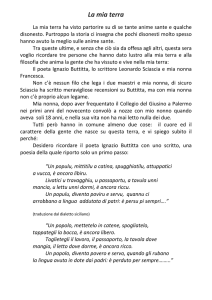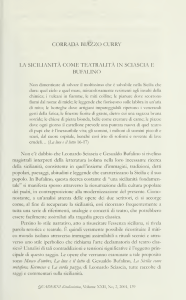Il convitato di pietra
Altre cure più gravi di queste,
altra brama quaggiù mi guidò!
(Da Ponte–Mozart, Don Giovanni)
1. I “professionisti dell’antimafia”
A Racalmuto gli hanno fatto una statua. Uno Sciascia iperrealista, formato naturale, giacca gualcita e sigaretta in mano. Ma
lasciato lì, in un punto qualunque d’un qualunque marciapiede,
sul corso popolato di passanti distratti e frettolosi. Una scelta
ardita, dice qualcuno, quello Sciascia senza piedistallo, uomo
tra gli uomini. Solo che mette i brividi, imbattersi in quel buffo
replicante da museo delle cere. E sa tanto, a prescindere dalle
buone intenzioni degli amministratori, di ridimensionamento
voluto e anzi vendicativo, da parte d’un paese che non sempre
seppe capirlo ed amarlo.
Il ritorno di Leonardo Sciascia a Racalmuto, da Palermo e
anzi da Parigi che fu per lui capitale dell’anima, e le estati alla
76
“Noce” fra i parenti e gli amici scrittori (qualcosa di simile alle
Soirées de Médan di Zola), e quei funerali tradizionali e istituzionali nel cuore del paese, e la scommessa testamentaria sulla
Fondazione, cattedrale nel deserto: tutto questo appartiene alla
nobile retorica del nóstos, cara ai nostri grandi scrittori, da Verga
in poi, quando come possenti elefanti hanno deciso di chiudere
i conti con la vita.
È il ritorno a quella terra che meglio d’ogni altra sa essere croce e delizia, grembo accogliente e trappola mortale, è il ritorno
al dolce ricatto delle abitudini e delle amicizie, è il bisogno di
chiudere il giro, di riappropriarsi di sé: «tel qu’en Lui-même enfin
l’éternité le change», quale in lui stesso alfine l’eternità lo muta,
come recita un verso di Mallarmé sulla tomba di Poe, caro
all’ultimo Sciascia.
E quella frase di Villiers de l’Isle-Adam, sulla candida lastra
tombale nel cimitero di Racalmuto, nella sua serenità beffarda,
nel suo siderale distacco, è carica di quello stesso amore scontroso, di quella contrastata nostalgia, di quel rancore venato di
pietas, che segnarono il rapporto di Sciascia con Racalmuto, con
la Sicilia, con il mondo: «Ce ne ricorderemo, di questo pianeta».
Scriveva Ibn Hamdis, poeta arabo-siciliano dell’XI secolo,
dell’isola da cui era esule: «vuote le mani, ma pieni gli occhi
del ricordo di lei». Finché Sciascia fu esule, la sua Sicilia fu il
mondo, nel bene e nel male: fu la Racalmuto-Regalpetra delle Parrocchie, coi suoi notabili vaniloquenti e trasformisti e coi
suoi ragazzi avidi di pane e di verità; fu la zolfara dell’Antimonio,
teatro dell’offesa al genere umano ma anche della presa di coscienza; fu il “cuore” assolato e desolato dell’isola, intossicato
di tracotanza mafiosa e rovelli pirandelliani, dei “gialli” degli
anni Sessanta.
Fu, anche, teatro della memoria e laboratorio di moralità e
di stile. Fu osservatorio sul mondo, a sfatarne le magnifiche
sorti e progressive, a svelare qui come altrove le ricorrenti e
77
corresponsabilizzanti infamie del “contesto”. Fu un’utopia d’irriducibile diversità, di resistenza all’omologazione, d’intelligenza critica, concepita in assenza (“vuote le mani, ma pieni gli
occhi”) di un’isola reale effettualmente diversa, che invece, nel
frattempo, si andava omologando a quel feroce “contesto”.
Fu, infine, l’ultimo approdo. Il “cancello della preghiera” intravisto, ma non varcato, dal laico Vice de Il cavaliere e la morte; il gesto di liberatoria indifferenza dell’“uomo della Volvo”
nell’ultima pagina vergata dallo scrittore morente, in coda a Una
storia semplice: «Uscì dalla città cantando». Tornando alle radici, a
quella “dimora vitale” compitata sulle pagine dello storiografo
dell’hispanidad Américo Castro, a quel “teatro della metamorfosi” che Pirandello aveva edificato fra i templi della costa e i
latifondi dell’interno, Sciascia null’altro vi cerca che un varco,
lo stesso da cui ha avuto origine il suo “involontario soggiorno
sulla terra”, per fuoruscirne, e magari “cantando”. O gemendo,
come invece, purtroppo, accadde a lui di uscire, angosciosamente, di scena.
Tutto questo e tant’altro fu, ed è per chi vi s’inoltri da lettore,
la mitica Regalpetra: che già nel suo nome univa l’etimo arabo
di quel luogo di pena con un toponimo (I fatti di Petra, di Savarese) di pura, fantastica letterarietà. E come in una pagina di
letteratura isolana Sciascia sfilò, per l’ultima volta, per le anguste strade di Regalpetra: «Così vanno via i morti, al mio paese; /
finestre e porte chiuse, ad implorarli / di passar oltre, di dimenticare...» (Sciascia, I morti, in La Sicilia, il suo cuore).
Oggi, fra quelle quinte di carta stampata ma anche di sangue
rappreso, quel monumento accigliato come il Commendatore
mozartiano potrebbe apparire superfluo, inutilmente intimidatorio, al cospetto di nuovi crimini e nuove malversazioni, mezzo secolo dopo Il giorno della civetta. E sembra scoraggiare ogni
ulteriore tentativo di riprendere, contro la volontà stessa più
volte espressa dallo scrittore, la vecchia querelle su Sciascia e la
78
mafia che gli avvelenò gli ultimi anni di vita già insidiati dal male
e che periodicamente torna, con ottusa protervia, a infangarne
la memoria.
Certo non si può limitare o appiattire la complessa e copiosa
produzione letteraria di Leonardo Sciascia, né l’incessante travaglio intellettuale che la percorre e la anima, riducendo l’una e
l’altro all’unica chiave, o al tema dominante, della mafia. Si cadrebbe, così facendo, nello stesso errore di certa critica “impegnata” del dopoguerra, che dell’autore delle Parrocchie di Regalpetra e del Giorno della civetta aveva inteso solo la “corda civile”,
non il rovello pirandelliano né certe profondità manzoniane,
che l’avrebbero indotto ad analisi sempre più sottili e sfumate, a seminare dubbi anziché certezze, a investigare – piuttosto
– sulle responsabilità individuali e sull’universale correità del
“contesto”.
E perciò, quando quella stessa critica, inaugurando una interminabile teoria di polemiche, si scandalizzò di quella sorta di
reciproca intesa, o onore delle armi, fra il combattente anti-mafioso (il capitano Bellodi) del Giorno della civetta e il boss mafioso
don Mariano Arena, “uomini” entrambi, quel che non s’intese
era il fatto che Sciascia si dichiarava estraneo, in tal modo, alla
retorica manichea (“uomini e no”) del neorealismo, e aspirava
ad analisi più complesse, a un’antropologia del Potere e della
“sicilitudine” affinata, per esempio, nelle considerazioni di Pirandello e la Sicilia sulla «sofistificazione» della morale sessuale ad
opera del codice «borgese-mafioso».
Lo stesso può dirsi, qualche anno dopo, a proposito del secondo “giallo di mafia” firmato da Sciascia, A ciascuno il suo,
dove a dar scandalo, e a liquidare l’agiografia “di sinistra”, era il
fatto che l’indagine anti-mafiosa fosse affidata a un «cretino», o
meglio a un perdente, a uno sgomento anti-eroe, come Laurana; e del resto già in quel libro Sciascia, un liberal-radicale che
come tanti allora simpatizzava per l’opposizione comunista,
79
non si nascondeva affatto i silenzi e le omissioni di questa parte politica a proposito dei misfatti del “contesto” notabiliareclerical-mafioso.
Ma se Sciascia non è solo mafia, e piuttosto rimanda a temi
più vasti come la giustizia e la ragione, la scrittura e la morte, la
memoria e l’inquisizione, pure non si può parlare di mafia senza
citare Sciascia, le sue intuizioni anticipatrici, le sue polemiche
generose e irritanti. Senza quei “gialli di mafia”, che pure erano
ben altro e ben più che cronache giornalistiche o laiche omelie,
non si potrebbe intendere quell’escalation dalle mafie rurali alla
conquista della città e degli appalti, infine alla internazionalizzazione degli affari e dei legami mafiosi, che Sciascia fu comunque il primo, o uno dei primi, a prevedere, sia con circostanziate
analisi sia con trasparenti metafore: come quella che prende a
prestito dai botanici le valutazioni sulla «linea della palma», che
progressivamente «va a nord», ovvero sposta la frontiera del
costume e del sentire mafiosi ben oltre i confini entro i quali
erano germogliati e si erano alimentati.
Altre metafore, più astratte e più terribili, Sciascia va forgiando, via via che la sua scrittura e la sua riflessione si approfondiscono e si complicano: e in primo luogo quella del «contesto»
che dà il titolo al romanzo del 1971. A seguito dell’assassinio
d’un alto magistrato, che ancora una volta prefigura un’escalation
di là da venire e i “cadaveri eccellenti” dei successivi decenni, si
aprono agli occhi del lettore (e dell’investigatore) gl’inquietanti
scenari d’un regime-piovra artefice d’intrighi e di crimini, ma
quel ch’è peggio d’una omertosa corresponsabilità dell’opposizione (anche il “compromesso storico” e il “consociativismo”
erano di là da venire). E di una più profonda, irredimibile corresponsabilità del singolo: anche l’onesto investigatore, il dubbioso e colto Rogas, prototipo dei tanti detective-controfigure fino al
Vice del testamentario Il cavaliere e la morte, lungi dal condividere
il fermo garantismo di Sciascia, consente che il reo-vittima Cres
80
continui a farsi giustizia da sé, così come s’erano fatti o si faranno giustizia da sé l’eretico fra’ Diego La Matina di Morte dell’inquisitore e lo sgomento pittore capitato nell’eremo penitenziale
e criminoso di Todo modo.
Sciascia fu un autore che programmaticamente «contraddisse
e si contraddisse». In merito al problema cruciale «del giudicare», angosciosamente dibattuto nel Contesto, problematicamente esitava tra il culto del diritto e la sete di giustizia, tra il
garantismo connesso alla sua formazione illuministico-liberale
e il giustizialismo di fra’ Diego (il suo personaggio prediletto!).
Anche i suoi numerosi interventi in materia di mafia, e di lotta alla mafia, rientrano in quest’irrisolta dialettica, tuttavia più
feconda d’insostenibili verità e affilati paradossi di quanto non
siano state le certezze di certi ayatollah dell’antimafia o di certi
cultori d’un garantismo pro domo sua.
Gli scritti giornalistici dell’ultimo decennio, raccolti nel volume postumo A futura memoria (se la memoria ha un futuro), testimoniano dell’impegno di Sciascia non per questo o quello
schieramento ma per la quotidiana invenzione della verità, la
meno accomodante, la più inedita e anticonformista. Si collocano, perciò, accanto agli Scritti corsari di Pasolini, così come Sciascia – da Todo modo, giallo di Palazzo e processo all’establishment
democristiano, all’Affaire Moro, che si apre nel segno delle “lucciole” pasoliniane – si era trovato sempre più vicino all’impegno critico e alle battaglie civili, ma soprattutto alla figura di
dolente testimone e caparbio “uomo-contro”, dell’amico poeta
scomparso nel 1975.
E dunque è alla letteratura che quegli scritti vanno ricondotti,
non per sminuirli ma anzi per esaltarne la portata metaforica
e lo spessore problematico: e infatti è a un Flaubert o a un
Borges che Sciascia chiede, di volta in volta, le chiavi di lettura
d’un “contesto” mafioso sempre più indecifrabile, mentre gl’interventi contro il “pentitismo” non sono che accorate repliche