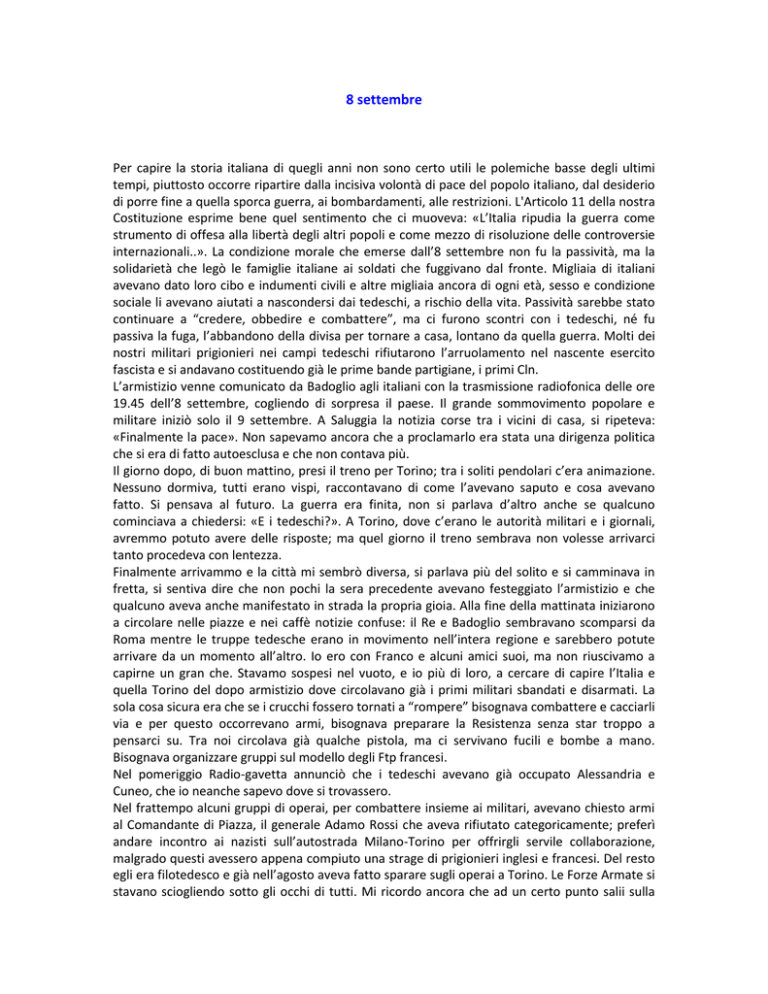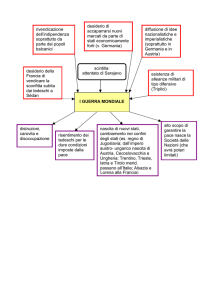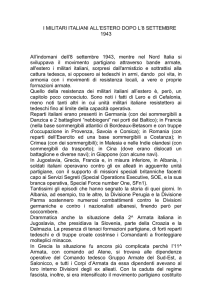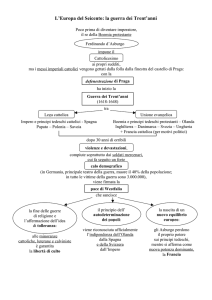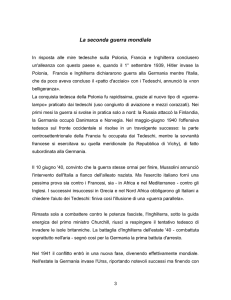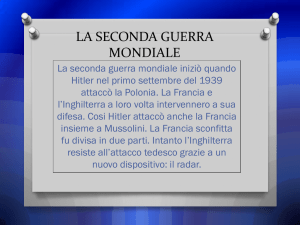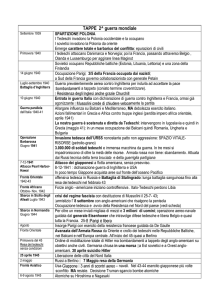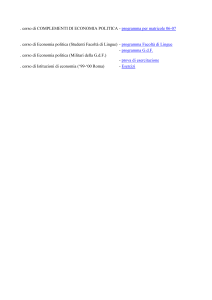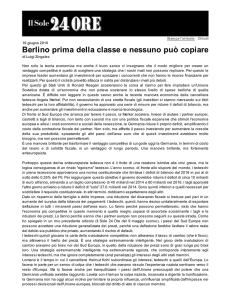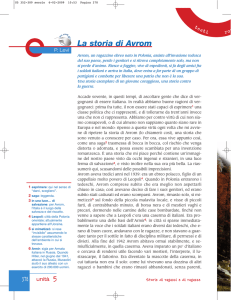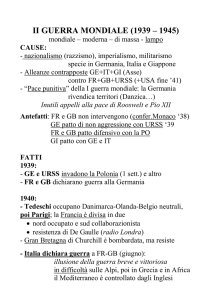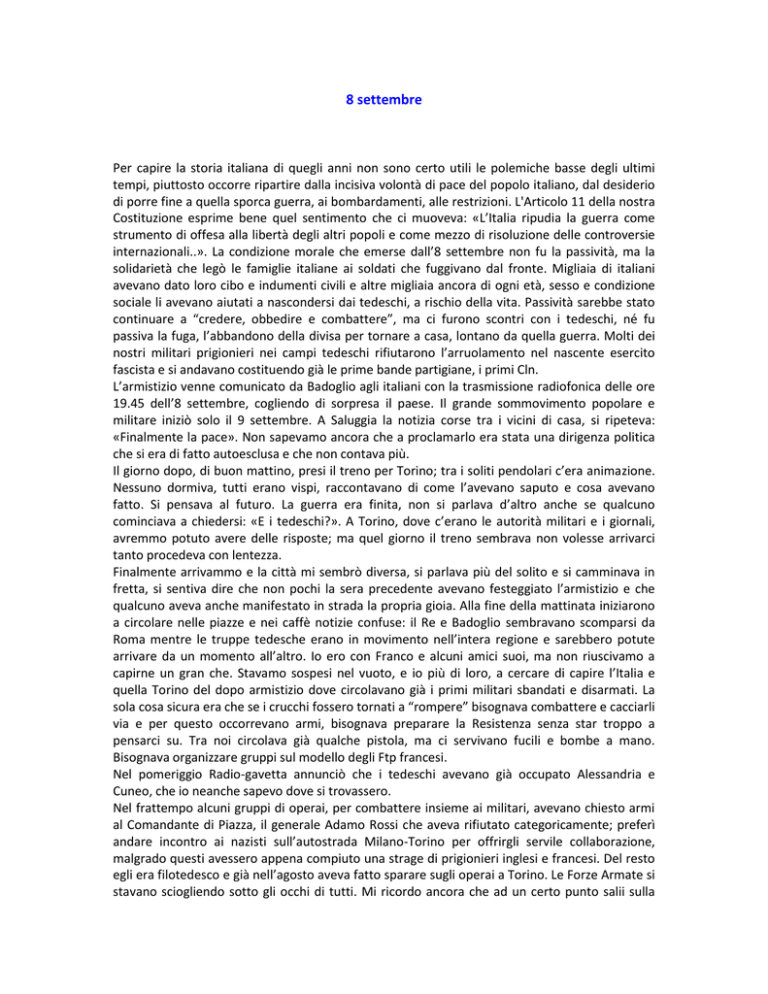
8 settembre
Per capire la storia italiana di quegli anni non sono certo utili le polemiche basse degli ultimi
tempi, piuttosto occorre ripartire dalla incisiva volontà di pace del popolo italiano, dal desiderio
di porre fine a quella sporca guerra, ai bombardamenti, alle restrizioni. L'Articolo 11 della nostra
Costituzione esprime bene quel sentimento che ci muoveva: «L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali..». La condizione morale che emerse dall’8 settembre non fu la passività, ma la
solidarietà che legò le famiglie italiane ai soldati che fuggivano dal fronte. Migliaia di italiani
avevano dato loro cibo e indumenti civili e altre migliaia ancora di ogni età, sesso e condizione
sociale li avevano aiutati a nascondersi dai tedeschi, a rischio della vita. Passività sarebbe stato
continuare a “credere, obbedire e combattere”, ma ci furono scontri con i tedeschi, né fu
passiva la fuga, l’abbandono della divisa per tornare a casa, lontano da quella guerra. Molti dei
nostri militari prigionieri nei campi tedeschi rifiutarono l’arruolamento nel nascente esercito
fascista e si andavano costituendo già le prime bande partigiane, i primi Cln.
L’armistizio venne comunicato da Badoglio agli italiani con la trasmissione radiofonica delle ore
19.45 dell’8 settembre, cogliendo di sorpresa il paese. Il grande sommovimento popolare e
militare iniziò solo il 9 settembre. A Saluggia la notizia corse tra i vicini di casa, si ripeteva:
«Finalmente la pace». Non sapevamo ancora che a proclamarlo era stata una dirigenza politica
che si era di fatto autoesclusa e che non contava più.
Il giorno dopo, di buon mattino, presi il treno per Torino; tra i soliti pendolari c’era animazione.
Nessuno dormiva, tutti erano vispi, raccontavano di come l’avevano saputo e cosa avevano
fatto. Si pensava al futuro. La guerra era finita, non si parlava d’altro anche se qualcuno
cominciava a chiedersi: «E i tedeschi?». A Torino, dove c’erano le autorità militari e i giornali,
avremmo potuto avere delle risposte; ma quel giorno il treno sembrava non volesse arrivarci
tanto procedeva con lentezza.
Finalmente arrivammo e la città mi sembrò diversa, si parlava più del solito e si camminava in
fretta, si sentiva dire che non pochi la sera precedente avevano festeggiato l’armistizio e che
qualcuno aveva anche manifestato in strada la propria gioia. Alla fine della mattinata iniziarono
a circolare nelle piazze e nei caffè notizie confuse: il Re e Badoglio sembravano scomparsi da
Roma mentre le truppe tedesche erano in movimento nell’intera regione e sarebbero potute
arrivare da un momento all’altro. Io ero con Franco e alcuni amici suoi, ma non riuscivamo a
capirne un gran che. Stavamo sospesi nel vuoto, e io più di loro, a cercare di capire l’Italia e
quella Torino del dopo armistizio dove circolavano già i primi militari sbandati e disarmati. La
sola cosa sicura era che se i crucchi fossero tornati a “rompere” bisognava combattere e cacciarli
via e per questo occorrevano armi, bisognava preparare la Resistenza senza star troppo a
pensarci su. Tra noi circolava già qualche pistola, ma ci servivano fucili e bombe a mano.
Bisognava organizzare gruppi sul modello degli Ftp francesi.
Nel pomeriggio Radio-gavetta annunciò che i tedeschi avevano già occupato Alessandria e
Cuneo, che io neanche sapevo dove si trovassero.
Nel frattempo alcuni gruppi di operai, per combattere insieme ai militari, avevano chiesto armi
al Comandante di Piazza, il generale Adamo Rossi che aveva rifiutato categoricamente; preferì
andare incontro ai nazisti sull’autostrada Milano-Torino per offrirgli servile collaborazione,
malgrado questi avessero appena compiuto una strage di prigionieri inglesi e francesi. Del resto
egli era filotedesco e già nell’agosto aveva fatto sparare sugli operai a Torino. Le Forze Armate si
stavano sciogliendo sotto gli occhi di tutti. Mi ricordo ancora che ad un certo punto salii sulla
bicicletta di un ragazzo che con altri si dirigeva verso una caserma dove si diceva distribuissero
armi; la trovammo chiusa e sbarrata. Dissero che qualcuno prima di noi era riuscito a portarne
via un po’. I tedeschi giunsero a Torino poco dopo, inizialmente non erano molti, si parlava di
circa trecentocinquanta uomini. Erano in pantaloni corti, indossavano le divise color kaki
dell’Africa Korps e verso sera giravano minacciosi nei rioni operai. Arrivarono in Borgo San Paolo
proprio quando Franco mi stava presentando D’Amico, incontrato per caso non lontano
dall’abitazione di via Monginevro. Le nostre furono pochissime parole, due autoblindo stavano
puntando verso di noi e qualcuno, correndo, aveva gridato di scappare. Arrestavano i giovani
che si trovavano in strada; per nostra fortuna riuscimmo a fuggire. Era quasi buio, era iniziata
una sorta di coprifuoco.
Alcuni giorni dopo decisi di incontrare Edoardo, che prima della partenza per l’Italia si era
raccomandato perché lo andassi a trovare a Novara. Sui treni la caccia dei tedeschi ai militari
sbandati proseguiva con accanimento, quel giorno riuscimmo a nasconderne uno sotto la panca
di legno dello scompartimento nel tratto tra Santhià e Vercelli. Edoardo mi era sembrato più a
suo agio a casa sua, anche se le difficoltà organizzative erano le stesse, richiedevano pazienza e
fiducia. Intanto a Novara avevo saputo molte cose: la Resistenza camminava oltre Torino,
compiva i suoi primi passi nel Novarese, nel Vercellese, nell’Alessandrino, nel Cuneese; poche
notizie scarne ma non prive di significato. Della immane strage di Boves non si sapeva ancora
nulla. Edoardo mi aveva parlato, per sentito dire, di scontri armati il 9 settembre
nell’Alessandrino, a Valenza, Tortona, Serravalle e di civili uccisi nel capoluogo. Seppi che si
andavano organizzando le prime bande in Valsesia, a Campertogno, Borgosesia, Varallo,
Grignasco. Nel Biellese, a Oropa, Graglia e sul Monte Cerchio, si erano raggruppati dei militari
sbandati. Si andava organizzando un grande movimento di assistenza agli ex prigionieri alleati
per favorire il loro passaggio in Svizzera. Infine nel Cuneese, dove era transitata la IV armata
sciolta dal generale Vercellino, si era formato un gruppo di Resistenti. Alcuni dei capi partigiani
mi erano noti: Moscatelli, Gastone, Beltrami, Jacometti mentre per la prima volta sentivo i nomi
di Nuto Revelli, Duccio Galimberti, Livio Bianco, Geymonat e Pompeo Colajanni Barbato.
Sul treno che mi riportava a Saluggia ripensavo alla IV Armata che aveva operato in zona
francese. Il movimento di Resistenza degli emigrati italiani delle due Savoie, di Marsiglia e della
zona mediterranea aveva saputo affrontarli con intelligenza politica: pochi giorni dopo l’11
novembre 1942 già circolava tra le truppe italiane d’Occupazione il giornale clandestino “La
parola del soldato”. Prima del 25 luglio, alcuni soldati della IV Armata erano passati nelle file
degli Ftp francesi e altri avevano preferito restare in Francia piuttosto che tornare in Italia.
Per alcuni giorni andai con una certa regolarità a Torino, lì mi fu presentato un “compagno
anziano” che mi chiese di andare in Val di Lanzo dove si trovava un gruppo di soldati e ufficiali
sbandati e bene armati, avrei dovuto darci un'occhiata, capirne le intenzioni e verificare il loro
armamento. Finalmente si cominciava a fare qualcosa di concreto! Mi domandavo soltanto
perché avessero scelto me che parlavo piuttosto male l'italiano e non avevo mai conosciuto la
naia. Prima dell’agosto 1943 non avevo mai visto un soldato italiano in carne e ossa e quella mi
pareva un’avventura un po’ folle. Comunque il giorno successivo giunsi a destinazione, non ero
mai stato in una valle alpina. Trovai la famiglia di compagni che mi era stata indicata e che mi
avrebbe ospitato anche se avevo messo nel conto la possibilità di vivere e dormire con quei
militari. Li contattai subito, facendomi passare per un attendente rimasto senza il suo
comandante, che aveva anche un nome che ora ho dimenticato. Conducevano una vita alquanto
spensierata, i viveri non mancavano e sembravano in vacanza, in attesa di qualcosa che loro
stessi non riuscivano a immaginare. Gironzolavano per il paese disarmati e alcuni erano riusciti
anche a farsi la ragazza. Impegnati in questa libera uscita senza interruzioni non facevano certo
molto caso al sottoscritto. Se fossero arrivati i tedeschi, di questi militari, ne avrebbero fatto “un
sol boccone”. Non mi fu difficile trovare l’armamento: era depositato in una stanza in fondo a un
cortiletto, accessibile a tutti. Trovai anche una mitragliatrice. Più difficile era capire che cosa
intendessero farne. Altro che mettermi a chiacchierare o a cercare ragazze nel paese! Ero
costretto a fare il taciturno e a non impegnarmi in amicizie. Anche il compagno che mi ospitò in
quella occasione si dimostrò molto scettico sull’operazione. Mi lasciai guidare dal buonsenso,
dal coraggio e dalla giusta dose di prudenza a cui mi ero abituato nel lavoro clandestino a Parigi.
Dopo circa 48 ore ritornai a Torino con informazioni abbastanza precise sulla consistenza del
gruppo e del suo armamento, ma niente più.
I militari che ritornavano a casa parlavano del loro 8 settembre: alcuni si trovavano in Jugoslavia
o in Albania, credevamo fossero pochi per la verità, ma per noi era stato già abbastanza per
capire la tragedia che avevano vissuto. I tedeschi, come sempre e ovunque, avevano rastrellato,
arrestato e fucilato e questa volta era toccato agli italiani; ne erano stati catturati tantissimi.
Altri erano passati con armi e bagagli coi partigiani jugoslavi, albanesi e greci. Ci sembrava che la
lotta armata degli italiani contro i tedeschi fosse scoppiata con più asprezza nei territori
occupati. I racconti dei primi reduci passavano dai casolari di campagna alle piazze dei paesi,
fino a divenire argomento di conversazione tra gli amici. Si trattava di frammenti di una realtà
che saremmo riusciti ad afferrare nella sua reale ampiezza solo dopo la Liberazione1.
Ho avuto in seguito la fortuna di conoscere alcuni militari che avevano vissuto quella terribile
esperienza e che erano poi divenuti partigiani.
Il mio amico Osvaldo Vinizio Pagella, dell’Anpi di Alessandria, negli anni Ottanta amava ancora
ricordare come da ufficiale del Regio Esercito in Jugoslavia fosse poi diventato partigiano in
Italia: «In Jugoslavia la mia compagnia aveva avuto molte volte a che fare con i partigiani e aveva
subito perdite. Non è difficile la guerra partigiana. Basta conoscere i posti e avere qualche
mitragliatore... la sorpresa e la possibilità di fuga assicurano azioni vittoriose». Prese il nome di
Gatto e grazie alla sua esperienza, nel settembre 1943, già aveva costituito una prima banda
partigiana vicino ad Alessandria. In tutto erano dodici uomini, tre pistole Beretta, una Mauser
6.35, quattro moschetti e un fucile da caccia. Alla Liberazione di Alessandria era divenuto il
Comandante della Brigata Po della Divisione Matteotti Marengo.
Anche Giacinto Franzosi Lodo, un altro mio amico dell’Anpi di Alessandria, nel 1943 si trovava in
Jugoslavia. Dopo l’8 settembre era ritornato dalla Croazia passando da Postumia. Aveva
superato numerosi posti di blocco tedeschi ed era riuscito ad arrivare a casa. Poco dopo aveva
sentito il bisogno di organizzare una banda partigiana di dodici uomini in Valle Staffora. Alla
Liberazione di Tortona nel 1945 partecipò come vicecommissario della Brigata d’Assalto
Garibaldi Po-Argo. Il vicecomandante di quella stessa Brigata era l’ufficiale dei Carabinieri Silvio
1
Allora si poteva ragionare sul fatto che i soldati italiani presenti nei territori occupati all’8 settembre e
abbandonati da Vittorio Emanuele fossero circa 900.000, di cui 670.000 disseminati dalle Alpi Dinariche
alle isole dell'Egeo. In altre parole: trentuno Divisioni italiane senza più ordini in balia dei tedeschi. Di
Cefalonia non sapevamo nulla e tanto meno della resistenza italiana nell'Egeo, a Samo, nell’Isola di Rodi.
Ancora non sapevamo che i tedeschi avevano fatto strage di decine di migliaia di italiani e che ne avevano
catturati 400.000 nei Balcani. Né tanto meno si poteva immaginare che stava nascendo la guerra
partigiana con le Divisioni Firenze e Perugia in Albania, con la Pinerolo e il reggimento Lancieri Aosta in
Tessaglia, non sapevamo dei militari italiani che avevano costituito il Battaglione Garibaldi in Jugoslavia e
che si erano già scontrati con i tedeschi a Klissa il 13 settembre. insomma: non si sapeva che la Guerra di
liberazione era iniziata all’estero, esemplificata nella Resistenza della Divisione Acqui a Cefalonia, che
dall’11 al 22 settembre vide centottantacinque ufficiali e cinquemila sottufficiali fucilati dai tedeschi e altri
tremila mitragliati in mare. Non tutti avevano però capito fino a quel momento che la violenza e la
barbarie hitleriana non avrebbe avuto riguardo neppure per gli italiani.
Ceva Paolo, anche lui tornato a casa nel ’43 dai Balcani e, con Franco Anselmi, era subito entrato
a far parte della banda Casalini che operava sulla Genova-Serravalle. Negli anni Ottanta venne
promosso generale dell’Arma, una smentita ulteriore per chi, per ignoranza o malafede,
sosteneva che i partigiani delle Garibaldi erano comunisti che volevano imporre la rivoluzione e
la dittatura.
Dino Cassano si era arruolato nell’Arma nel 1942. Da Alessandria era stato trasferito alle
dipendenze della Tenenza dei CC per il Servizio Reale a Bra. Prestava servizio presso la Tenuta
Reale di Valdieri. Quando i membri della famiglia reale fuggirono senza avvertire nessuno, il
piccolo presidio preferì sciogliersi piuttosto che arrendersi ai carri armati tedeschi. Dino, a Borgo
San Dalmazzo, aveva spogliato uno spaventapasseri e sostituito la sua divisa militare con abiti
civili; dieci giorni dopo era scampato al rastrellamento delle SS a Boves. Con il nome di
Maschietto divenne partigiano nella I Divisione autonoma Langhe con la quale combatté fino
alla Liberazione.