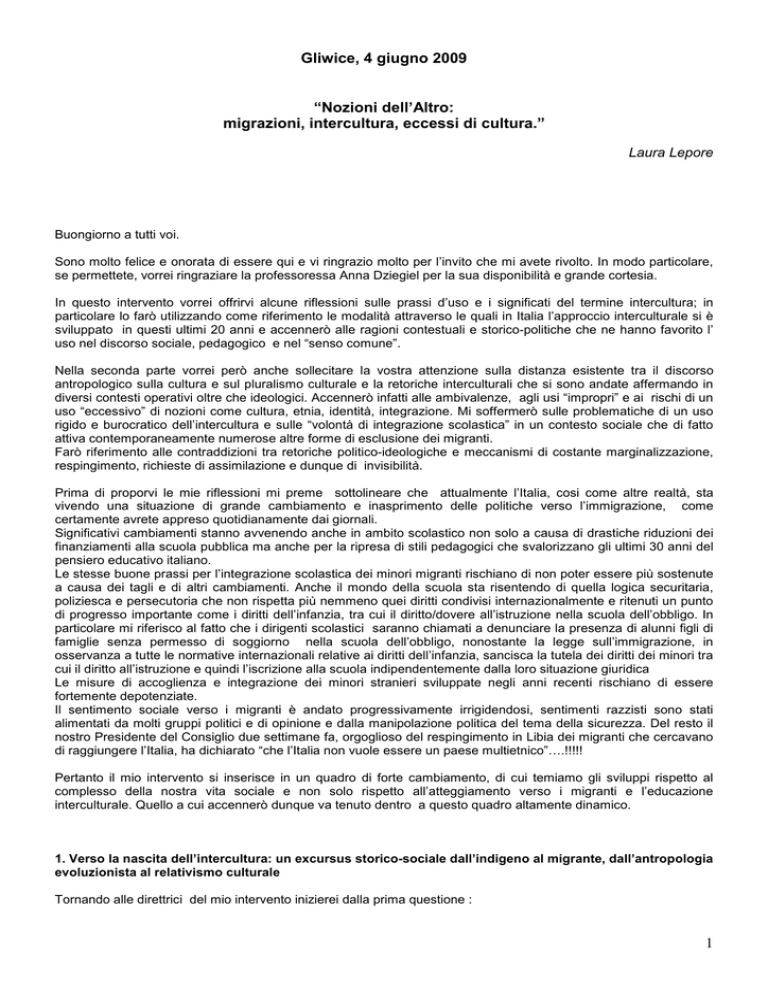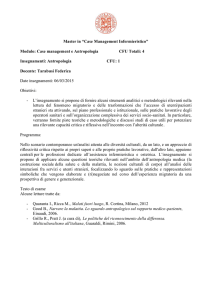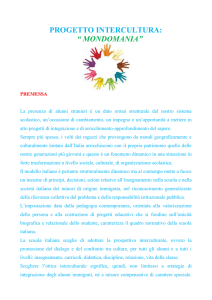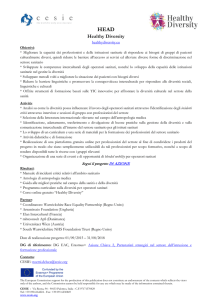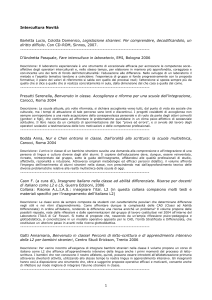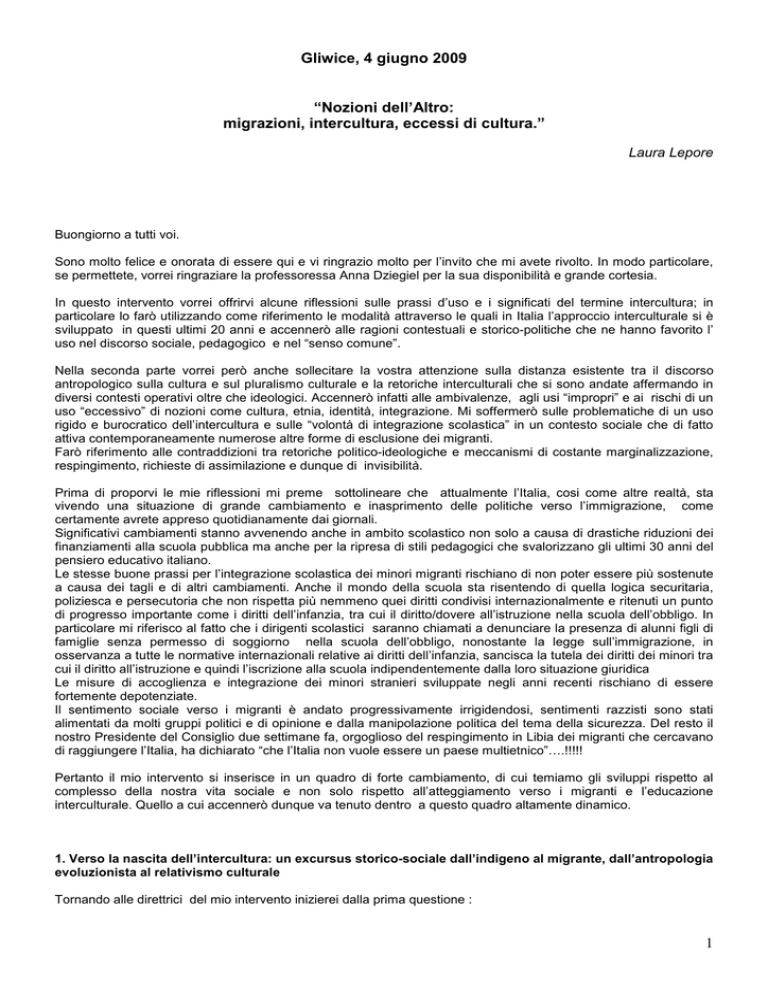
Gliwice, 4 giugno 2009
“Nozioni dell’Altro:
migrazioni, intercultura, eccessi di cultura.”
Laura Lepore
Buongiorno a tutti voi.
Sono molto felice e onorata di essere qui e vi ringrazio molto per l’invito che mi avete rivolto. In modo particolare,
se permettete, vorrei ringraziare la professoressa Anna Dziegiel per la sua disponibilità e grande cortesia.
In questo intervento vorrei offrirvi alcune riflessioni sulle prassi d’uso e i significati del termine intercultura; in
particolare lo farò utilizzando come riferimento le modalità attraverso le quali in Italia l’approccio interculturale si è
sviluppato in questi ultimi 20 anni e accennerò alle ragioni contestuali e storico-politiche che ne hanno favorito l’
uso nel discorso sociale, pedagogico e nel “senso comune”.
Nella seconda parte vorrei però anche sollecitare la vostra attenzione sulla distanza esistente tra il discorso
antropologico sulla cultura e sul pluralismo culturale e la retoriche interculturali che si sono andate affermando in
diversi contesti operativi oltre che ideologici. Accennerò infatti alle ambivalenze, agli usi “impropri” e ai rischi di un
uso “eccessivo” di nozioni come cultura, etnia, identità, integrazione. Mi soffermerò sulle problematiche di un uso
rigido e burocratico dell’intercultura e sulle “volontà di integrazione scolastica” in un contesto sociale che di fatto
attiva contemporaneamente numerose altre forme di esclusione dei migranti.
Farò riferimento alle contraddizioni tra retoriche politico-ideologiche e meccanismi di costante marginalizzazione,
respingimento, richieste di assimilazione e dunque di invisibilità.
Prima di proporvi le mie riflessioni mi preme sottolineare che attualmente l’Italia, cosi come altre realtà, sta
vivendo una situazione di grande cambiamento e inasprimento delle politiche verso l’immigrazione, come
certamente avrete appreso quotidianamente dai giornali.
Significativi cambiamenti stanno avvenendo anche in ambito scolastico non solo a causa di drastiche riduzioni dei
finanziamenti alla scuola pubblica ma anche per la ripresa di stili pedagogici che svalorizzano gli ultimi 30 anni del
pensiero educativo italiano.
Le stesse buone prassi per l’integrazione scolastica dei minori migranti rischiano di non poter essere più sostenute
a causa dei tagli e di altri cambiamenti. Anche il mondo della scuola sta risentendo di quella logica securitaria,
poliziesca e persecutoria che non rispetta più nemmeno quei diritti condivisi internazionalmente e ritenuti un punto
di progresso importante come i diritti dell’infanzia, tra cui il diritto/dovere all’istruzione nella scuola dell’obbligo. In
particolare mi riferisco al fatto che i dirigenti scolastici saranno chiamati a denunciare la presenza di alunni figli di
famiglie senza permesso di soggiorno nella scuola dell’obbligo, nonostante la legge sull’immigrazione, in
osservanza a tutte le normative internazionali relative ai diritti dell’infanzia, sancisca la tutela dei diritti dei minori tra
cui il diritto all’istruzione e quindi l’iscrizione alla scuola indipendentemente dalla loro situazione giuridica
Le misure di accoglienza e integrazione dei minori stranieri sviluppate negli anni recenti rischiano di essere
fortemente depotenziate.
Il sentimento sociale verso i migranti è andato progressivamente irrigidendosi, sentimenti razzisti sono stati
alimentati da molti gruppi politici e di opinione e dalla manipolazione politica del tema della sicurezza. Del resto il
nostro Presidente del Consiglio due settimane fa, orgoglioso del respingimento in Libia dei migranti che cercavano
di raggiungere l’Italia, ha dichiarato “che l’Italia non vuole essere un paese multietnico”….!!!!!
Pertanto il mio intervento si inserisce in un quadro di forte cambiamento, di cui temiamo gli sviluppi rispetto al
complesso della nostra vita sociale e non solo rispetto all’atteggiamento verso i migranti e l’educazione
interculturale. Quello a cui accennerò dunque va tenuto dentro a questo quadro altamente dinamico.
1. Verso la nascita dell’intercultura: un excursus storico-sociale dall’indigeno al migrante, dall’antropologia
evoluzionista al relativismo culturale
Tornando alle direttrici del mio intervento inizierei dalla prima questione :
1
1. Quando inizia ad essere utilizzata la nozione di intercultura nei contesti scolastici in Italia? E cosa si intende
per educazione interculturale? Intanto, l’antropologia europea e quella italiana, in che termini riflettevano sulle
differenze tra popoli, sulla fenomenologia della cultura e sui cambiamenti culturali?
Come sappiamo i significati e gli usi delle parole e dei concetti riflettono, esprimono e raccontano il contesto
sociale e culturale a cui rimandano. Pertanto per parlare di intercultura e di immaginari storici sulla diversità
umana dovrete permettermi di aprire una finestra sia su alcuni eventi storico-sociali sia su alcuni aspetti dello
sviluppo dell’antropologia come scienza sociale e umana, intimamente connessa ai contesti occidentali .
Non possiamo qui fare una cronologia antropologica dell’incontro storico dell’occidente con l’Altro, ripercorrere la
genealogia occidentale della rappresentazione/costruzione dell’Altro e della “gerarchizzazione del genere umano”.
E’ però necessario tornare indietro almeno alla fine dell’800, quando il dibattito sulla evoluzione dell’uomo
attraversa molti ambiti scientifici, antropologici, e la vita sociale.
In quel periodo, mentre si andavano imponendo i processi coloniali, in Europa una certa umanità, quella dei
“selvaggi”, veniva ancora rappresentata come una umanità ai confini dell’umano, fuori dall’umano, descritta
1
utilizzando metafore bestializzanti e disumanizzanti .
Verso il 1870 in Europa si diffuse una moda che durò fino all’ultima grande esposizione coloniale del 1931 a
2
Parigi: fu quella degli zoo umani . La diversità, intesa come diversità subumana e quasi animalesca, veniva
esibita in grandi “circhi” in cui veniva radunata ed esposta l’alterità delle “razze”. Uomini e donne “catturati” in
diversi paesi del mondo venivano portati in Europa ed esposti in questi zoo pieni di animali esotici e “uomini non
meno singolari”. Spettacoli che per circa 60 anni in Europa attirarono milioni di visitatori in tutte le grandi città.
Questi eventi divennero un mezzo di informazione particolarmente potente per mostrare agli occhi del pubblico la
barbarie e la natura “primitiva” dell’Altro, permettendo cosi la diffusione di teorie scientifiche che sostenevamo
l’arretratezza di questi popoli, e accelerando vertiginosamente l’adesione su larga scala alle politiche coloniali che
stavano imponendosi un po’ ovunque nei territori d’oltremare.
Gli stessi membri della Società d’antropologia di Parigi si recarono molte volte in quei luoghi per compiere le loro
ricerche, soprattutto di antropologia fisica. Tra gli organizzatori delle esibizioni e i ricercatori di allora si creò un
vincolo che li porterà reciprocamente a rafforzare la dimostrazione della fondatezza delle teorie razziste attraverso
la presenza fisica di questi selvaggi.
1
Come diceva Frantz Fanon (psichiatra della Martinica), il linguaggio del colono, quando parla del colonizzato, lo animalizza, utilizza un
linguaggio zoologico o patologizzante (gli psichiatri coloniali parlavano differenze tra africani e bianchi sostenendo scientificamente l’inferiorità
cerebrale. Un africano non è paragonabile a un adulto europeo di età corrispondente, ma a un lobotomizzato… Carothers, anni 50) Uomini che
non possono accedere alla modernità fuori dallo sviluppo, specie di sotto uomini )Il mondo coloniale è un mondo manicheo. Non basta al colono
limitare fisicamente, vale a dire con l'aiuto della sua polizia e della sua gendarmeria, lo spazio del colonizzato. Come ad illustrare il carattere
totalitario dello sfruttamento coloniale, il colono fa del colonizzato una specie di quintessenza del male. La società colonizzata non è solo
descritta come una società priva di valori. Non basta al colono affermare che i valori hanno abbandonato, o meglio non hanno mai abitato, il
mondo colonizzato. L'indigeno lo si dichiara impermeabile all'etica, assenza di valori, ma anche negazione dei valori. [...] In questo senso, è il
male assoluto. [...]A volte tale manicheismo arriva fino in fondo alla sua logica e disumanizza il colonizzato. A rigor di termini, lo animalizza. E,
difatti, il linguaggio del colono, quando parla del colonizzato, è un linguaggio zoologico. Si fa allusione ai movimenti serpeggianti dell'indocinese,
agli effluvi della città indigena, alle orde, al puzzo, al pullulare, al brulicare, ai gesticolamenti. Il colono, quando vuole descrivere bene e trovare
la parola giusta, si riferisce costantemente al bestiario. L'europeo incorre di rado nei termini "immaginosi". Ma il colonizzato, che coglie il
progetto del colono, la causa precisa che gli viene intentata, sa subito a che cosa si pensa. Quella demografia galoppante, quelle masse
isteriche, quei visi da cui ogni umanità si è dileguata, quei corpi obesi che non assomigliano più a niente, quella coorte senza capo né coda,
quei bambini che sembrano non appartenere a nessuno, quella pigrizia sciorinata sotto il sole, quel ritmo vegetale, tutto ciò fa parte del lessico
coloniale. Il generale De Gaulle parla delle "moltitudini gialle" e Mauriac delle masse nere, brune e gialle che presto traboccheranno. Il
colonizzato sa tutto questo e ride di cuore ogni volta che si scopre animale nelle parole dell'altro. Poiché sa di non essere un animale. E
appunto, al tempo stesso che scopre la sua umanità, comincia ad affilare le armi per farla trionfare. [...] (da Fanon F., I dannati della terra,
Torino, Einaudi, 1979, ed orig.1961)
Divenuto famoso negli anni '60 come teorico dei movimenti di liberazione, Franz Fanon è stato soprattutto un attento studioso dei meccanismi di
alienazione mentale e culturale dei colonizzati e degli immigrati. Afro-americano, cresciuto nella cultura francese, egli conosce infatti sulla
propria pelle di nero sia la situazione coloniale che quella di immigrato in Francia. I suoi sforzi intellettuali tentano di evidenziare e comprendere
le zone d'ombra del potere coloniale così come si possono rintracciare da un lato nei luoghi della cura - nel linguaggio della psichiatria, nel suo
razzismo come nel suo paternalismo - dall'altro nella quotidianità di rapporti sociali in cui, spesso inconsapevolmente, vengono agiti sotterranei
conflitti psicologici tipici del rapporto fra colonizzatore e colonizzato, (padrone e servo) che caratterizzano la relazione fra Bianco e Negro;
Fanon ne evidenzia le conseguenze sul mondo emozionale ed affettivo, i modi in cui reciprocamente vengono costruite le immagini dei
dominatori e dei dominati, e le loro identità. Come osserva Roberto Beneduce, del Centro F. Fanon di Torino, "Il lavoro di Fanon è
estremamente acuto: pur nel linguaggio dell'epoca e del contesto della lotta coloniale, nell'enfasi e nella violenza con la quale difende i diritti del
popolo algerino e nella costante sottolineatura di quella che egli chiamava "attitudine rivoluzionaria", il suo sguardo mette a fuoco (e qui la
metafora è quanto mai appropriata) tutti o quasi i problemi dell'incontro e dello scontro con l'Altro culturale, la volontà di dominio e di controllo
che si introduce nelle pieghe più sottili del comportamento, della sessualità o del discorso scientifico."
2
Simboli dell'epoca coloniale, gli "zoo umani" sono stati completamente rimossi dalla nostra memoria collettiva. Tuttavia, le esibizioni
dell'esotico sono state in Occidente una tappa fondamentale del passaggio da un "razzismo scientifico" a un "razzismo popolare". A partire
dall'inizio del xix secolo, cioè con l'esibizione in Europa della Venere ottentotta, esse hanno interessato milioni di spettatori, da Parigi ad
Amburgo, da Londra a New York, da Mosca a Milano. In queste esibizioni "antropozoologiche", individui "esotici" mescolati a bestie selvagge
venivano messi in scena dietro sbarre e cancelli. Legittimiate dalla scienza, esse costituivano la prova evidente dello scarto tra discorso e
pratica al tempo della costituzione degli imperi. Valutati dagli scienziati, sfruttati nei cabaret, utilizzati nelle esposizioni ufficiali, uomini, donne e
bambini provenienti dalle colonie diventavano i figuranti di un immaginario e di una storia che non erano i loro. Prima opera di sintesi
sull'argomento, Zoo umani mette in prospettiva la "spettacolarizzazione" dell'Altro - di cui i reality show costituiscono l'ultima trasformazione -,
all'origine di molti degli stereotipi attuali. Tutto questo ci aiuta a capire anche la costruzione dell'identità occidentale.
2
La spettacolarizzazione della differenza culturale dell’Altro era un discorso condiviso tra scienziati, politici e società
che concordavano sulla “legittimità” della strategia della violenza portata avanti nelle colonie.
Accanto agli zoo umani, pian piano vennero spettacolarizzati i villaggi coloniali: nelle grandi esposizioni venivano
ricostruiti il villaggio negro, indocinese, arabo etc. Ai fini dello spettacolo venivano esaltati aspetti bestiali come
3
l’antropofagia. Fu in quel periodo che prese corpo l’ immaginario sulla una bestiale sessualità degli africani .
Tutto questo riproduceva il mito occidentale del progresso e della civilizzazione, della superiorità dell’occidente.
Queste popolazioni selvagge erano infatti fuori dal progresso ma cominciava ad intravvedersi la possibilità che
potessero migliorare e cambiare sotto alla missione civilizzatrice dei coloni. In sostanza l’Altro era visto come una
bestia addomesticabile, secondo il disegno e la razionalizzazione promossi dalle amministrazioni coloniali.
Questa memoria storica è piuttosto misconosciuta, ma estremamente attiva anche sugli immaginari
contemporanei, abita sottilmente i nostri stereotipi e la nostra missione integratrice.
Proseguendo nel nostro excursus, gli esiti perversi e radicali della manipolazione politica degli studi sull’evoluzione
umana, porteranno alle teorie del razzismo che diventeranno la base dell’ideologia razzista, del pensiero coloniale,
del nazionalismo, del nazismo, del fascismo con tutti gli orrori che ben conosciamo.
Nuove categorie di alterità vengono costruite e perseguitate, fino al loro annullamento fisico in nome della purezza
ariana. L’ “Altro”, rappresentato dagli ebrei, omosessuali, rom, comunisti, etc.
In Italia, paese dove l’antropologia si è affermata lentamente rispetto ad altri paesi europei (anche perché non
eravamo un paese coloniale) alcuni antropologi, cosi come molti scienziati ed intellettuali, si posero al servizio di
4
tale ideologia, della “Difesa della razza” .
Dopo la guerra, le mostruosità dell’olocausto e le reazioni internazionali a questi eventi, si attiva una svolta
importante nella ridefinizione della diversità umana e della dignità individuale di tutti gli uomini. Il tema della
diversità umana viene ricollocato dentro al quadro della uguaglianza tra gli uomini. In quegli anni viene redatta la
Dichiarazione dei diritti umani che, pur nel suo etnocentrismo, riflette tuttavia principi che delegittimano sul piano
del diritto l’esistenza di razze superiori, pure etc. A tale dichiarazione si ispira anche la nostra Costituzione, come
altre.
L’uguaglianza degli uomini e delle razze diviene un principio fondante del nuovo occidente, almeno in termini di
riferimento normativo e valoriale. Ma non si enfatizza e riconosce l’ eguaglianza delle culture, il valore intrinseco di
ciascuna cultura, nonostante le avvertenze che l’antropologo statunitense Herskovits aveva inviato alla
commissione che stava redigendo la Dichiarazione.
3
Ricordiamo qui la triste storia della cosiddetta “Venere ottentotta”: si tratta di una donna che probabilmente apparteneva al popolo dei
Khosan, i più antichi umani stabilitisi in Africa australe, che i primi invasori europei chiamarono ottentotti o boscimani. Fu assunta come serva
dai Bartman, coltivatori olandesi vicino a Capetown, che le dettero il nome Saartjie ("piccola Sara", pronunciato Sarkey) Bartman. Il fratello del
padrone propose di portarla in tournée in Europa promettendole la metà degli incassi dei biglietti pagati per vederla. Saartjie era alta un metro e
35 cm, ed era chiamata la "Venere ottentotta" perché considerata particolarmente bella tra le donne del suo popolo e perché aveva molto
sviluppate le caratteristiche fisiche per cui da tanti secoli si favoleggiava sulle donne boscimane: natiche prominentissime e rialzate (i boscimani
trattengono l'adipe in sovrappiù non sull'addome, ma sulle natiche) e piccole labbra altrettanto sviluppate (tanto che sporgevano dall'inguine di
8-10 cm verso il basso), chiamate il "grembiule ottentotto". Nello spettacolo della tournée, Saartjie appariva legata alla catena (nuda ma con la
vagina coperta) e camminava a quattro zampe in modo da mettere in risalto il suo deretano e sottolineare la natura "animalesca" che allora
veniva attribuita alla sensualità. Lei comunque affermò sempre di farlo di sua volontà, per guadagnare denaro. A Londra Saartjie si sposò con
un uomo delle Indie occidentali ed ebbe due figli: dunque aveva una sua vita, anche mentre veniva esposta come un fenomeno da circo. Dopo
un soggiorno inglese di tre anni e mezzo, passò a Parigi dove un addestratore di animali la esibì per 15 mesi, propagandandone le natiche e le
piccole labbra ("somiglianti ai bargigli dei tacchini" era scritto nei dépliants). Posò nuda per ritratti "scientifici" al Jardin du Roi, fu esaminata da
tutti i più importanti scienziati dell'epoca, tra cui George Cuvier, ma si ammalò e, invece di diventare ricca in Sudafrica come doveva aver
sognato, morì in Europa di una malattia infiammatoria, nel dicembre 1815. Cuvier le fece l'autopsia e asportò il pube che fece conservare e poi
esporre al Musée de l'Homme al Palais de Chaillot. Solo quest'anno il Parlamento francese ha infine approvato una legge perché i resti fossero
restituiti al Sudafrica.
4
La rivista «La Difesa della razza» fu pubblicata con cadenza quindicinale dal 5 agosto 1938 al 20 giugno 1943 sotto gli auspici del ministero
della Cultura Popolare e giocò un ruolo fondamentale nella definizione della «questione razziale» in Italia e nella diffusione dell'antisemitismo
negli anni cruciali della discriminazione e persecuzione degli ebrei. «La Difesa della razza» nasce nell'agosto 1938 dalla saldatura di due
distinti ambiti razzisti: da un lato il gruppo di giornalisti legati da tempo a Telesio Interlandi e ai periodici da lui diretti; dall'altro, alcuni degli
scienziati firmatari, nel luglio 1938, del cosiddetto Manifesto della Razza. Tale nucleo originario si caratterizza per l'impostazione
prevalentemente biologica del problema razziale: una linea che impegnerà la rivista in aspre polemiche con le altre correnti del razzismo
fascista:
rispettivamente
quella
nazionalista
(Acerbo,
Pende)
e
quella
esoterico-tradizionalista
(Preziosi,
Evola).
Al di là delle contrapposizioni politico-ideologiche, la rivista si configura in realtà come una macchina sincretica in cui argomentazioni
biologizzanti e culturalizzanti, dosate e gerarchizzate di volta in volta in modo diverso, convergono in un progetto di trasformazione
palingenetica della società, della cultura e dell'arte italiane. Lungi dall'essere il frutto di un'improvvisazione estemporanea dettata dalle esigenze
dell'alleanza con la Germania nazista, «La Difesa della razza» appare in quest'ottica come il prodotto di una logica tutta interna al fascismo.
L'ultimo atto della rivoluzione antropologica perseguita dal regime, il culmine estremo dei dibattiti sull'«italianità» della cultura e dell'arte che
avevano attraversato il fascismo.
3
Herskovits era figlio di scuole antropologiche statunitensi sviluppatesi negli anni ‘20-‘30 che avevano messo a
fuoco la nozione di relativismo culturale, dimensione che superava l’approccio evoluzionista nella teoria della
cultura e segnava una fondamentale svolta epistemologica riconoscendo a ciascuna manifestazione culturale
significato e validità entro il proprio contesto. Al relativismo sono state fatte molte critiche e la nozione è stata nel
tempo elaborata dall’antropologia., ridefinendo i rapporti tra universalismo e particolarismo. Ma è da questa
nozione che si inizia a concettualizzare l’idea che le diverse società siano su uno stesso piano e che l’umanità si
esprima storicamente e socialmente in modalità diverse che forniscono all’uomo strumenti psichici per stare al
mondo, riconoscersi e strutturarsi, e che sono funzionali al loro contesto di vita. Questo vuol dire non suddividere
più l’umanità tra un mondo di popoli senza cultura, e altri con una cultura, “la cultura”, o popoli con culture superiori
e inferiori.
5
Nel 1947 Herskovits scrive lo Statement on human rights (1947) e prova a sottolineare che i principi su cui si
fondava la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo erano di fatto principi etnocentrici elevati a valori e concezioni
culturali assolute e universali.
Il Comitato che stava redigendo il testo della Dichiarazione, sotto la presidenza di Eleonor Roosvelt, rifiutò
d'accogliere, tra le tutele fondamentali, anche quella di riconoscere a tutti gli uomini il diritto a vivere secondo le
proprie tradizioni; e ciò, in campo antropologico dette l'avvio ad una querelle interminabile - ed ancora interminata tra relativisti ed anti-relativisti ed anti-anti-relativisti, e via di seguito, sulla universalità dei diritti umani, che peraltro
sono stati invece assunti proprio così dalla Dichiarazione del 1948, e sin dal suo titolo. Il dibattito antropologico sui
diritti umani e civili si è andato articolando in questi ultimi anni secondo numerose direzioni di ricerca e indagine e
ha contribuito ad arricchire fattivamente la consapevolezza circa la radicalità delle questioni coinvolte da tale
tematica. Da sempre la questione dei diritti umani ha imposto alla riflessione antropologica un esercizio di vero
equilibrismo intellettuale tra una tendenza relativista e una universalista. La posizione relativista, esaltando la
coerenza intraculturale a discapito dell'etnocentrismo implicito nella formulazione universalistica della
Dichiarazione, consapevolmente transnazionale, imponeva, in materia di diritti - come d'altronde nelle sue estreme
conseguenze a qualsiasi livello della riflessione - una sorta di sospensione del giudizio che sottoponeva, di fatto, la
Dichiarazione Universale ad una potenziale decostruzione, in quanto espressione dell'egemonia politicodiplomatica e culturale rappresentata all'interno dell'ONU dai paesi occidentali. La posizione universalista, che
certo soggiace alle intenzioni globalistiche della Dichiarazione, presenta d'altro canto alcune forzature
epistemologiche: l'istituzione di una non meglio specificata categoria di "umano", la selezione in nome di questa di
un cartello di diritti e valori ad essa connessi. Tale elemento si congiunge inoltre a quello di rischiose ricadute
pratiche: ad esempio la minaccia implicita per tutte quelle culture e comunità i cui valori fondamentali non
ricomprendessero i principi fondamentali contenuti nella Dichiarazione. In realtà tutto questo dibattito, che è stato
oltre che molto vivace, anche molto acuto nelle sue punte critiche, sembra non tener conto che marginalmente del
farsi largo nella riflessione antropologica da un lato e giuridico-politica dall'altro di una tendenza alla mediazione nei
contesti di scambio culturale, di risoluzione dei conflitti. Sia a livello teorico che pratico le forme dibattimentali della
negoziazione, le modalità di conciliazione dei dissensi, che si allontanano da un'idea ancora un po' impositiva di un
insieme sovranazionale come quello dei diritti umani sulla specificità di ciascun contesto culturale, si vanno
facendo sempre più spazio. La stessa riflessione recente del movimento per la Pace a livello mondiale ha insistito
sulla pratica non oppositiva, frontale, su un impegno nel quotidiano rivolto all'affinamento di strumenti teorici e
strategie.
Continuando il nostro percorso storico, dopo aver accennato a come da fine 800 in linee molto generali si è andata
affrontando la questione dell’Altro e della differenza, guardiamo per un attimo l’Italia del dopoguerra: ricostruzione,
trasformazione sociale, sviluppo, crescita economica, industrializzazione e urbanizzazione.
Molte persone e famiglie migrano dalle città alle campagne alla ricerca di lavoro, di migliori condizioni di vita, attratti
dalla cosiddetta “modernità”. E il razzismo assume altre connotazioni, di valore e impatto estremamente diverso
5
Si tratta della Dichiarazione sui Diritti Umani presentata alla Commissione sui Diritti Umani della nazioni Unite dal Consiglio Direttivo
dell'American Anthropological Association. Herskovits, caposcuola della corrente relativista dell'antropologia americana, oltre ad invitare in
questa dichiarazione ad un generico rispetto per l'individuo e per le culture dei diversi gruppi umani, mise in guardia, in quel testo, dal rischio
connesso con la stesura della Dichiarazione Universale, di un'affermazione di diritti prevalenti in Europa e in America, segno dunque
dell'egemonia di questi contesti geopolitica nel complesso delle Nazioni Unite. Egli mise anche in rilievo i danni commessi in nome di questa
egemonia, implicitamente ed esplicitamente affermata dell'Occidente, e i rischi legati alla "missione dell'uomo bianco". Si deve tra l'altro a
questo documento l'accentuazione del rapporto inscindibile tra sviluppo della personalità individuale e cultura del gruppo di riferimento, da cui
deriva anche l'impossibilità di pensare a individui liberi da ogni appartenenza culturale specifica. La Dichiarazione sui Diritti Umani, proprio
perché formulata all'interno di un contesto culturale e ideologico dato, non poteva essere rappresentativa - a giudizio di Herskovits - del corredo
di valori e principi validi per l'umanità tutta. Si legge nello Statement: Devono essere riconosciuti come fondamentali modelli planetari di giustizia
e libertà basati sul principio che l'uomo è libero solo quando vive conformemente alla definizione di libertà elaborata dalla propria cultura e che
in suoi diritti sono quelli che egli stesso riconosce come membro della sua società.
Si è detto che l'approccio di Herskovits al problema dei diritti concorresse allo slittamento dell'antropologia da posizioni relativiste verso forme di
neutralismo acritico. Se da un lato c'è il rischio che la "vulgata" relativista vanifichi gli sforzi di applicazione fattiva dei diritti umani, dall'altro però
si deve ammettere che proprio il relativismo antropologico ha portato all'attenzione dei legislatori e degli estensori della Dichiarazione
Universale il problema della estendibilità indiscriminata dei valori e dei principi occidentali a tutte le culture e a tutti i gruppi, senza che vi fosse
piena coscienza né valorizzazione della loro imprescindibile diversità.
4
rispetto agli anni precedenti: è quello delle classi medie urbane verso i contadini, considerati arcaici, irrazionali,
premoderni.
Mentre in America e in Europa si delineano le società multiculturali e l’antropologia si inizia ad occupare di
relativismo culturale e multiculturalismo, di fenomeni migratori e razzismo verso i neri, l’Italia negli anni ’50, ’60 e
’70 studia la diversità culturale endogena, cioè quelle realtà culturali diverse rappresentate dalle culture cosiddette
popolari o folcloriche: il contadino meridionale è il rappresentante di quel mondo magico che studia Ernesto de
Martino, grande antropologo, storico delle religioni e filosofo italiano (1908-1965). Il sud Italia, oggetto anch‘esso di
studi popolari, sembra immerso ancora nella grande stagione magica.
In relazione a questi fenomeni che oppongo rurale e urbano, ai nuovi stili di vita - l’abbandono delle campagne ma
anche la permanenza di realtà rurali molto povere - l’antropologia italiana, in gran parte di taglio marxista,
analizza le dinamiche del cambiamento in termini di rapporti di forza tra classi dominanti e classi dominante, tra
classi egemoni e classi subalterne (ispirate al pensiero di Antonio Gramsci) tra modernità e tradizione, tra sviluppo
e arretratezza. Il mondo contadino comincia a diventare un mondo in via di sparizione e per questo viene
ulteriormente studiato.
Intanto negli anni ‘60 inizia la migrazione dal sud Italia verso l’Europa e verso il nord Italia. Saranno proprio gli
emigrati provenienti dal sud Italia a far crescere il nord industrializzato.
Ma nelle città del nord Italia l’accoglienza non è delle migliori. Il migrante è accolto solo come forza lavoro, ma è
“brutto, sporco, ignorante e cattivo”.
Cosi si leggono cartelli nei quali si scrive che “non si affittano case ai meridionali”. Inizia la stagione del razzismo
del nord Italia verso i lavoratori e le famiglie provenienti dal sud.
Il razzismo sperimentato dai migranti italiani in America si riproduce nel nostro paese. L’”Altro quindi è per le
classi borghesi del nord il contadino, il povero, il migrante del sud.
In quegli anni non si parla di intercultura, ma si fa attenzione al apprendimento dell’italiano da parte dei bambini
meridionali, perche i meridionali parlano dialetti molto diversi, in alcuni casi delle vere e proprie lingue.
Mentre nei paesi coloniali si scatenano i processi di decolonizzazione cresce una prospettiva terzomondista, che si
riflette anche in ambito educativo, che guarda un po’ paternalisticamente ai paesi “sottosviluppati”, che
rappresentano una realtà ulteriormente “premoderna” rispetto a quella degli emigrati meridionali., e che vanno
aiutati nel loro percorso “verso la civiltà”.
In ambito scolastico la pedagogia che guarda alla differenza si esprimeva in termini di educazione alla mondialità,
allo sviluppo, guardava ai paesi emergenti, alle popolazioni del sud del mondo,ma ancora il termine intercultura
6
non era arrivato nei nostri testi e discorsi .
6
La storia dell’Educazione allo Sviluppo (EaS) è indissolubilmente legata all’evoluzione delle teorie sullo sviluppo, il cui insieme fornisce il
quadro di riferimento per l’analisi e la contestualizzazione delle diverse esperienze educative realizzate nel suo ambito nell’ultimo
cinquantennio. Nel dopo guerra, con l’avvio dei primi processi di decolonizzazione e il diffondersi nell’opinione pubblica della nozione di
sottosviluppo, le campagne di sensibilizzazione rappresentavano più una informazione sul “sottosviluppo” che una reale educazione per lo
“sviluppo”. Il paradigma dominante era quello della modernizzazione e della fiducia nel progresso e l’obiettivo principale dell’EaS era affermare
la necessità di intervenire in aiuto dei paesi poveri, attraverso il trasferimento del know how e delle tecnologie occidentali e l’invio di capitali
finanziari ai paesi rimasti “indietroNel 1963, il Presidente degli Stati Uniti Kennedy, in occasione del Secondo Congresso Mondiale
sull’alimentazione afferma: “Abbiamo i mezzi e le capacità per cancellare la fame e la povertà dalla faccia della terra nella nostra vita, ci occorre
solamente la volontà”. Tale volontà verrà creata grazie al lavoro delle prime agenzie di educazione allo sviluppo, che garantiranno un immediato
sostegno alle politiche pubbliche di cooperazione. Sul finire degli anni ’60, le lotte contro le dittature, che sorgono in numerose regioni del
mondo, i nuovi movimenti sociali nei paesi industrializzati e il contributo degli esperti delle scienze sociali, hanno cambiato il senso e la pratica
dell’EaS. Il concetto di modernità viene, infatti, sostituito con quello di dipendenza, attraverso il quale si afferma che il sottosviluppo non è un
ritardo di alcuni paesi rispetto ad altri, ma al contrario, la conseguenza dello sfruttamento e del dominio dei paesi sviluppati del “Centro” sui
paesi sottosviluppati della “Periferia”.6 Verso la metà del decennio successivo si fa strada il concetto di interdipendenza, che troverà conferma
negli anni ‘80 quando i Paesi Occidentali prenderanno atto che la questione dello sviluppo non riguarda solamente i problemi del sud del mondo
e che è necessaria una messa in discussione del modello stesso di sviluppo del Nord. Lo scenario della EaS diviene sempre più complesso e
nuove tematiche vengono affrontate: i problemi ambientali, la crisi del debito, i conflitti e gli armamenti, le crisi alimentari. La EaS diviene uno
spazio per la rimessa in causa del modello di sviluppo occidentale ed entra nel campo della politica mettendo in atto azioni di lobbying, inoltre
vengono utilizzate nuove forme comunicative come le emissioni televisive o festival di musica. Negli stessi anni, allorché i Paesi del nord
Europa si trovano a gestire i problemi posti dalla massiccia immigrazione favorita dal boom economico del decennio precedente, si sviluppa,
parallelamente all’EaS, l’approccio interculturale all’educazione.
La Educazione allo sviluppo e la scuola
Negli anni ’90, la scena internazionale vive radicali trasformazioni come la fine del bipolarismo, la internazionalizzazione
dell’economia, i disastri ambientali e l’affermazione di ciò che viene definito il ‘pensiero unico’. In questo contesto, la EaS vede il suo ruolo
amplificato: se fino a questo momento, veniva realizzata quasi esclusivamente dalle organizzazioni di volontariato, ora cerca un nuovo spazio
nell’educazione formale, nei media, nell’educazione permanente, nei sindacati del sud e del nord del mondo, con l’obiettivo di favorire la
costruzione di un mondo più giusto e uno sviluppo più equo e sostenibile, di partecipare alla lotta contro le ideologie xenofobe e razziste e
contro i particolarismi etnici e i nazionalismi. In particolare, negli anni ’80, hanno luogo nelle scuole le prime esperienze educative nel campo
dell’EaS, con lo scopo di inserire nella istituzione scolastica quel sistema di valori, conoscenze e competenze legato al tema dello sviluppo.
Contemporaneamente, si fanno strada i cosiddetti programmi di educazione interculturale, il cui obiettivo principale è favorire l'accoglienza e
l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole, unitamente alla elaborazione di un approccio educativo nuovo.
Da molte parti messo in discussione in ragione del contenuto ambiguo ed ideologico, lo sviluppo è stato ed è una delle costruzioni
simboliche più importanti del mondo occidentale, capace di influenzare le modalità di interazione tra stati e le popolazioni nella storia moderna,
tanto da essere considerato uno dei cardini su cui si fonda l’idea stessa di modernità.6 Impostosi alla ribalta della politica internazionale dopo la
fine della seconda guerra mondiale, il concetto di sviluppo, affonda le proprie radici nell’humus politico, economico e culturale dell’Ottocento.
5
In quegli stessi anni negli USA ed in alcuni paesi europei come Francia, Inghilterra, Germania, intanto si era
andata sviluppando da tempo una seria sociologia della migrazione e le ipotesi di modelli sociali che possano
comporre tanti diversità culturali si iniziano a sperimentare: dal melting pot al multiculturalismo canadese,
in Francia si parla di modello di integrazione fondato su una adesione ai valori della Repubblica etc.
In Italia fino alla fine degli anni ’80, l’arrivo dei migranti dai paesi extraeuropei era molto ridotto. Non si era ancora
dunque messa a fuoco la problematicità della integrazione del “diverso” (si lavorava però già sulla integrazione dei
diversamente abili, una esperienza pedagogica che diventerà in parte un riferimento anche per la pedagogia
interculturale)
Ma è al principio degli anni ‘90 che iniziano ad arrivare molti migranti stranieri e comincia a cogliersi diversamente
il tema della differenza. Si avvia la costruzione del migrante come il nostro nuovo e potente “Altro”.
Questo è un momento chiave di cambiamento del nostro immaginario.
In un recente lavoro del 2002, due studiosi francesi, Blanchard e Bancel, in De l’indigène a l’immigré sottolineano
il passaggio degli excolonizzati maghrebini da indigeni a immigrati dopo le decolonizzazioni. Ripercorrono la strada
che condusse il primitivo, il nativo, il colonizzato, verso quel profilo sociale oggi a noi più familiare che è
l’immigrato.
In questo lavoro i due autori segnano uno a uno i momenti salienti di questa trasformazione: dal mito
dell’assimilazione riuscita, che intorno al 1950 si diffuse e ridusse (anche se di poco) la distanza tra colonizzato e
colonizzatore, al bisogno di mano d’opera immigrata, che proprio in quegli anni indusse molti colonizzati ad
emigrare (temporaneamente, pensavano allora gli Europei) in Francia, per arrivare infine alla grande immigrazione
che, dal 1960 in avanti finì per riprodurre nelle metropoli quegli spazi urbani periferici, isolati dal resto della città,
che sono le banlieues.
Alla domanda cosa siano oggi le banlieues, i due autori rispondono: “Sempre più questi luoghi sono concepiti
come enclave coloniale in seno alla Repubblica, dei buchi neri, degli spazi da riconquistare. La strategia volta a
installare qui commissariati e scuole e a promuovere forme di assistenzialismo sociale, riproduce precisamente la
politica coloniale, facendo del militare, dell’insegnante e del missionario le teste di ponte dell’assimilazione
coloniale”.
Il termine intercultura emerge in Italia negli anni ‘90 a seguito delle massicce migrazioni di gruppi umani diversi
che arrivano dai paesi dall’Albania, dall’Est, dai Balcani a seguito della caduta del muro di Berlino e dai conflitti
Strettamente legata all’idea di progresso la questione dello sviluppo viene trattata diffusamente nell’ambito delle discipline
economiche che, dalla metà degli anni ’40, si specializzano nello studio delle ragioni alla base del ritardo di alcune società rispetto ad altre,
fondando un nuovo settore disciplinare: l’Economia dello Sviluppo. Questa nuova dottrina, nonostante tenga in considerazione anche aspetti
non economici dello sviluppo, considera la crescita del PIL pro-capite, attraverso il trasferimento di capitali e tecnologie, unita all’affermazione
della democrazia, come la giusta via per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e aiutare i Paesi beneficiari a divenire competitivi nel
sistema capitalistico mondiale e dunque indipendenti dal sistema degli aiuti internazionali, così come era stato per l’Europa dopo
l’implementazione del Piano Marshal. L’idea evoluzionista di sviluppo per stadi, processo unilineare verso il modello di civiltà occidentale, dopo
aver permeato tutta l’epoca coloniale, viene, in un certo senso, riaffermata nel dopo guerra dagli Economisti dello Sviluppo. Così l’americano
Rostow, nel 1960, formula la sua famosa Teoria degli Stadi riproponendo l’idea che tutte le società dovrebbero percorrere lo stesso cammino
verso il modello della società dei consumi di massa.6
Alla nozione di sviluppo, nel 1945, viene affiancata quella di sottosviluppo, coniata dall’allora Presidente degli Stati Uniti Truman, nel
famoso punto IV del suo Discorso Annuale alla Nazione. Da questo momento in poi, le diverse regioni del mondo verranno collocate sull’asse
ideale sviluppo/sottosviluppo che rappresenterà la dimensione di riferimento per classificare le diverse regioni del mondo.
L’ideale dello sviluppo, paradigma della società occidentale, viene interiorizzato e fatto proprio non solo dall’opinione pubblica
occidentale ma anche dalle classi dirigenti degli stessi paesi poveri che cominciano a chiedere con forza il rispetto del diritto a svilupparsi per i
propri popoli. Si apre quella che Gilbert Rist sviluppo, includendo in essa variabili non economiche e dando vita a concetti come lo sviluppo
umano, endogeno, autocentrato, partecipativo, sostenibile. Tra questi, di particolare successo sarà il concetto di sviluppo umano, alla base
della nota teoria di Amartya Sen. Questo importante economista indiano, premio Nobel nel 1998, riformula i concetti di povertà e
disuguaglianza, affermando che le definizioni di sviluppo e di benessere non possono riferirsi solamente alle dimensioni strettamente
quantitative e monetarie, ma debbano guardare a ciò che gli individui riescono a fare, e ad essere, attraverso i mezzi, ma anche le capacità a
loro disposizione.6 Altra definizione assai in voga nel gergo dei pianificatori dello sviluppo è quella di sviluppo partecipativo. Tale nozione,
elaborata a partire dal contributo dell’antropologia, sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle popolazioni nella ideazione e realizzazione
del proprio sviluppo. O ancora lo sviluppo sostenibile, ideato in ambito ecologista e basato prevalentemente sui concetti di solidarietà intragenerazionale e di salvaguardia dell’ambiente.
Parlare di sviluppo significa rifarsi ad un fenomeno complesso, pluridimensionale e dalle molteplici sfaccettature, inoltre, è
fondamentale tenere a mente che questo non è un concetto neutro, apolitico, ma che, al contrario, il significato che gli si attribuisce mette in
campo la propria visione del mondo. definisce “l’era dello sviluppo”, in nome del quale sfumano le diversità tra i popoli, che ora condividono un
obiettivo comune: la crescita economica.6 In questa visione le civiltà occidentali sono chiamate a soccorrere le neo-nate nazioni indipendenti
attraverso un sistema nuovo che favorisca il trasferimento di conoscenze, dai paesi più progrediti a quelli meno, attraverso metodi diversi dal
sistema coloniale e nel rispetto dei diritti umani: nasce il sistema della cooperazione internazionale e degli aiuti allo sviluppo.
Negli anni successivi, di fronte al fallimento di tutti i tentativi di sviluppo pianificato, basato su un approccio economico-centrico, le
scienze sociali hanno contribuito a ridefinire la nozione di sviluppo.
6
scatenatesi nella ex-Jugoslavia. Gli Italiani smettono di emigrare, e anzi alcuni ritornano o tornano i loro figli e
7
nipoti .
I migranti occupano il nostro immaginario e i nostri campi semantici connessi all”’Alterità, i migranti che
improvvisamente irrompono nel nostro paese e “invadono” i nostri mari (le grandi barche traboccanti di gente che
arrivavano dall’Albania), i nostri panorami mediatici, le nostre scene urbane. Un'altra umanità, che vediamo e
costruiamo “diversa dal noi” che iniziamo a concettualizzare, che ci fa paura, comincia ad infastidirci, che comincia
a diventare l’icona non solo della diversità ma anche della criminalità, pericolosità, arretratezza….
Si inizia a parlare di migranti come diversità culturali con cui ci si incontra e scontra, con cui è necessario
dialogare, che si devono “tollerare”, rispettare nella loro diversità, si devono accogliere ed “integrare”.
Si iniziano ad inserire nella scena sociale italiana i principi del relativismo culturale.
Nelle scuole inizia a svilupparsi una nuova attenzione verso i tanti bambini albanesi, ex Jugoslavia, maghrebini
che iniziano a popolare le nostre classi. Si inizia a parlare di educare alla diversità culturale.
8
Tuttavia in Europa e in particolare in Inghilterra il termine intercultura era già emerso . Negli anni ’80 qualcuno
ne aveva offerto una concettualizzazione efficace per parlare di dialogo tra diversità culturali e di ambito educativo.
A partire dal 1990 il termine intercultura entra nella scuola e nel mondo educativo. La crescente presenza di
bambini immigrati rende ormai improcrastinabile la tematizzazione di una formazione profondamente rinnovata in
questa direzione. Nei documenti ufficiali comincia a comparire l’educazione interculturale, la Circolare Ministeriale
del luglio 1990, “La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale”, tratta per la prima volta i
9
temi dell'inserimento degli alunni stranieri nella scuola e quello dell'educazione interculturale . Più tardi, un’altra
circolare del 1994 "Dialogo interculturale e convivenza democratica", ne indica le strategie operative: a)
l'attivazione nella scuola di un clima relazionale di apertura e di dialogo; b) l'impegno interculturale
nell'insegnamento disciplinare e interdisciplinare; c) lo svolgimento di interventi integrativi delle attività curricolari,
10
anche con il contributo di Enti e Istituzioni varie; d) l'adozione di strategie mirate, in presenza di alunni stranieri .
Come appare dalle parole di questo e di molti altri documenti ufficiali, l'educazione interculturale non è una
disciplina aggiuntiva che si colloca in un momento prestabilito e definito dell'orario scolastico, ma è un approccio
per rivedere i curricoli formativi, gli stili comunicativi, la gestione delle differenze, delle identità, dei bisogni di
apprendimento. L’educazione interculturale nella scuola, nelle elaborazioni teoriche che ne vengono fatte, opera
per realizzare un progetto di: integrazione, poiché favorisce l’accoglienza; interazione, poiché fa cadere i pregiudizi
e considera il processo di incontro e di "rimescolamento" come il terreno privilegiato dell'intervento educativo;
relazione, poiché, attraverso l'incontro e lo scambio facilita i processi di cambiamento e ibridazione, sostiene la
gestione dei conflitti ed è attenta alla dimensione affettiva; decentramento, poiché facilita e promuove la capacità di
decentrarsi rispetto a dimensioni molteplici (quella temporale, quella spaziale e quella simbolica) e permette di
contestualizzare fatti e comportamenti propri e altrui.
Ma raramente il decentramento cognitivo viene praticato…!
7
Nel corso degli anni Settanta il ruolo dell'Italia nel mercato internazionale del lavoro e i movimenti di popolazione riguardanti il paese fanno
registrare cambiamenti di enorme portata. Innanzitutto si registra l'ormai definitivo ridimensionamento dell'emigrazione italiana all'estero, che è
dovuto sia alla modificazione dell'effetto di richiamo che alla modificazione dell'effetto di spinta. Per quel che riguarda il primo aspetto va tenuto
conto del fatto che - come mostrarono Castles e Kosack nel 1973 - la componente immigrata della forza lavoro è quella sulla quale si riflettono
più pesantemente le variazioni congiunturali della situazione economica e dell'industria in particolare. E in effetti la dimostrazione si ebbe nel
1967 con la riduzione dell'emigrazione italiana in occasione della recessione in Germania. Negli anni Settanta, poi, a dare il definitivo stop ai
flussi di immigrazione è anche la politica migratoria tedesca, che con l'Anwerbenstop del 1973 inaugura a livello europeo la politica europea di
chiusura all'immigrazione, destinata a proseguire e a estendersi a tutti gli altri paesi nei decenni successivi.
8
Si deve a un testo del Consiglio d’Europa, a cura di Micheline Rey, importante rappresentante politica svizzera, una delle prime definizioni di
“interculturale”: “Chi dice interculturale dice necessariamente - se dà tutto il suo senso al prefisso inter - interazione, scambio, apertura,
reciprocità, solidarietà obiettiva. Dice anche, dando il suo pieno senso al termine cultura, riconoscimento dei valori, dei modi di vita, delle
rappresentazioni simboliche alle quali si riferiscono gli esseri umani, individui e società, nelle loro relazioni con l’altro e nella loro comprensione
del mondo, riconoscimento delle loro diversità, riconoscimento delle interazioni che intervengono di volta in volta tra i molteplici registri di una
stessa cultura e fra differenti culture, nello spazio e nel tempo”. ( Rey M., Former les enseignants à l’éducation interculturelle, Strasburgo, Ed.
Consiglio d’Europa, 1986)
Questa definizione sottolinea i concetti chiave di interazione culturale e di riconoscimento delle diversità che sono alla base dell'educazione
interculturale e richiama una nozione di cultura considerata in senso ampio, non limitata alle forme "alte" del pensiero e dell'agire, ma estesa
all'intero modo di vivere, di pensare e di esprimersi di ogni gruppo sociale.
9
Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare n° 205, 26 luglio 1990
10
Tra queste si segnala in particolare per la ricchezza degli spunti e del messaggio la Circolare Ministeriale, "Dialogo interculturale e
convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola", n° 73 del 2 marzo 1994
7
Accanto alla necessità di adattare la normativa sull’inserimento scolastico di alunni stranieri si avverte forte anche il
bisogno di conoscere la situazione: CSER (Centro Studi Emigrazione di Roma), conduce per il Ministero
dell’Istruzione un monitoraggio che individua la grande complessità del fenomeno.
I parametri adottati nella ricerca, permettono di individuare:
1. il grande numero e varietà delle popolazioni presenti in Italia e la conseguente necessità di tener
conto delle specificità culturali
2. la tipologia della distribuzione nelle scuole
3. i differenti interessi educativi, le diverse aspettative delle famiglie immigrate rispetto all’interesse
per la lingua e la cultura d’origine, con conseguente necessità da parte dei decisori e degli
operatori di un’attenta analisi del progetto migratorio (gli adulti sono in Italia per lavoro? e per
quanto tempo? come rifugiati?…) e della tipologia (il differente livello culturale, sociale ed
economico delle famiglie)
“Rispetto ad un fenomeno così complesso, le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in
sede locale sulla base della conoscenza puntuale delle situazioni, dell’analisi dei bisogni e della ricognizione
delle risorse disponibili”. Gli enti che si occupano di scuola e i territori devono attuare “le opportune modalità di
coordinamento, al fine di promuovere, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza
presente sul territorio”. Devono curare “la raccolta e la diffusione di documentazione sulle esperienze attuate e
in corso; l’informazione bibliografica e attinente ai sussidi audiovisivi; l’organizzazione di incontri per un
confronto di esperienze fra i docenti coinvolti; il coordinamento di iniziative di aggiornamento, con la
segnalazione alle scuole di iniziative promosse da enti culturali e da associazioni professionali”; acquisire “la
collaborazione di docenti con competenze nel settore dell’educazione degli adulti nonché di esperti di
comunicazione e di organizzazione”.
SI inizia poi ad elaborare la nozione di accoglienza. Nella normativa si legge:
a) è necessaria, fin dal primo momento, una ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero per
determinare:
la classe d’iscrizione (scelta d’ufficio in base all’età anagrafica, ed invece con delibera obbligatoria del
Collegio Docenti se si ritenesse di posticipare o anticipare il percorso scolastico sulla base di parametri
quali la scarsa conoscenza dell’Italiano, la scolarità pregressa ecc.)
l’elaborazione di un percorso formativo personalizzato
l’introduzione dell’insegnamento dell’Italiano come L2
la scuola deve promuovere la collaborazione con le famiglie e le comunità interessate
è necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico con quello del paese di provenienza
le prove per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana non saranno selettive, ma effettuate per
programmare le attività didattiche
Grazie alla peculiare tradizione della scuola italiana in tema di accoglienza e di attenzione all’insegnamento
individualizzato, il legislatore ha privilegiato l’intervento mirato alle necessità del singolo alunno (elaborazione di
percorsi formativi personalizzati, come nel caso dell’integrazione dei disabili), piuttosto che predisporre percorsi
scolastici paralleli, come avviene in molti paesi europei. L’adattamento dei programmi di insegnamento, in
relazione al livello di competenza dei singoli alunni, comporta altresì un adattamento della valutazione e delle
prove di accertamento. (Alcune scuole hanno deliberato in tema di prove graduate per l’esame di licenza media)
Le commissioni che lavorano a livello ministeriali iniziano a descrivere l’intercultura come “nuova normalità”
dell’educazione.
Alcuni aspetti della normativa che qui riassumo codificano alcune delle dimensioni peculiari dell’intercultura:
il dialogo tra le culture, lo sviluppo di una scuola multiculturale, la relazione tra diversi, sono a più riprese ricordati
nelle circolari ministeriali, dove vengono superati:
a) i modelli della “separazione” e dell’ ”assimilazione” ed introdotto quello dell’ “integrazione”, cioè
dell’accoglienza dell’immigrato nella società ospitante come oggetto caratterizzato dalla particolarità culturale.
Il modello adottato comporta l’insegnamento della lingua dello Stato ospitante, adattato alle specifiche
esigenze dell’alunno straniero; la promozione della lingua e della cultura d’origine; il coordinamento della lingua
e cultura d’origine con il normale insegnamento
e dove vengono illustrati, secondo il livello degli studi,
b) gli aspetti ed elementi culturali, linguistici, storici e geografici del paese d’origine degli stranieri presenti in
classe e introdotti confronti tra gli stili di vita, ponendo in risalto le diversità in un quadro di riconoscimento delle
somiglianze. Le attività di confronto richiedono misura ed attenzione alle sensibilità individuali. Non si tratta di
enfatizzare la qualità di “straniero”, ma di accoglierlo nell’ “ordinario” della vita scolastica in una società
pluralista
Alla luce del principio della “valorizzazione delle diversità”, il modello di “integrazione” si svolge in quello di
“interazione”, che implica il coinvolgimento degli alunni italiani e stranieri in progetti interculturali comuni.
8
Concetti come “educazione alle differenze”, “il sé e l’Altro”, “sviluppo dell’identità”, rispetto delle radici”, “lotta al
pregiudizio e allo stereotipo” eccetera, trovano applicazione in una pedagogia attiva della relazione, piuttosto che in
una prospettiva di crescita unicamente intellettuale e cognitiva (certamente necessaria, ma non sufficiente).
Questo aspetto dell’intercultura, che mette in gioco lo stesso docente ed il modo di condurre la classe, le
dinamiche di gruppo ed il riconoscimento delle risorse in un’ottica della pedagogia del successo, sta sempre più
sostituendosi all’iniziale curiosità per gli usi e costumi di altre culture, che facilmente può scadere nel folklorico e
nel gusto per l’esotismo, se non è adeguatamente inserita in percorsi di effettiva valorizzazione e di confronto.
La presa di posizione ministeriale intorno alle tematiche interculturali è stata decisa e forte fin dall’inizio.
Quanto all’insegnamento della lingua italiana, la normativa fino ad un paio di anni fa sottolinea questi punti:
a) si ritiene utile l’alternanza di presenza dell’alunno straniero nella classe con momenti di laboratorio linguistico a
soli gruppi di stranieri
b) vengono fornite indicazioni rispetto ad ore di insegnamento da destinarsi al recupero individualizzato,
all’utilizzo del personale in esubero
Attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli alunni stranieri
È stato fin dall’inizio un punto dolente di tutta la scuola italiana che si è dovuta confrontare in maniera insicura ed
affannosa con l’emergenza causata dal continuo ingresso degli alunni stranieri; la scuola dell’autonomia, nella sua
possibilità decisionale in materia didattica e di formazione, si è vista ultimamente decurtare le risorse in maniera
drastica, e spesso riesce difficile mettere a regime corsi di insegnamento dell’Italiano L2 che abbiano una certa
consistenza, garantendone la continuità e la professionalità.
11
Intanto si vanno introducendo le nuove figure dei mediatori culturali , per la valorizzazione della cultura d’origine:
a) a più riprese la normativa sottolinea l’importanza di valorizzare la cultura d’origine, di attivare corsi di
insegnamento delle diverse lingue parlate dagli alunni stranieri, in posizione non marginale bensì
coordinata con l’insegnamento ordinario
b) in mancanza di risorse specifiche, per l’organizzazione di corsi di lingua e cultura d’origine richiesti da
gruppi etnici concentrati sul territorio, si consiglia di avvalersi dell’intervento degli Enti locali. e delle
Comunità di immigrati
c) le scuole, per quanto possibile, devono fornire locali ed attrezzature
I modelli della “cultura occidentale”, sostiene la normativa, non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e,
perciò, non debbono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.
Valorizzare la cultura d’origine significa soprattutto stabilire un rapporto di fiducia e scambio reale con la famiglia
immigrata, che ha bisogno di rendere domestico lo spazio della scuola, di cui non conosce le modalità educative e
relazionali.
Significa poi riconoscere e restituire l’autorità genitoriale nella guida alla formazione della nuova identità del
minore, minacciata non soltanto dalle fratture legate alla migrazione, ma ancor più dal disconoscimento e dalla
squalifica verso i valori e le abitudini della propria famiglia e della propria cultura.
L’ausilio del Mediatore Culturale e l’attenzione alle dinamiche relazionali; lo stabilirsi, anche in modo informale, di
uno spazio di conoscenza reciproca tra l’insegnante e la famiglia, possono essere di valido aiuto, qualora
comunque si riconosca all’Altro la sua competenza e autorità in ambito educativo.
Il ruolo dell’insegnante
a) Viene di continuo sottolineata l’importanza di portare nella classe non solo stimoli ed opportunità sul piano
cognitivo, ma di porre l’attenzione al “clima” relazionale e socio-affettivo fondato sulla collaborazione e
sulla partecipazione
b) Si raccomanda di introdurre una riflessione sulla propria cultura e di rafforzarne la consapevolezza
c) Il “clima” interattivo suggerito contempla la conoscenza del progetto migratorio della famiglia, così come il
rapporto di scambio con la famiglia stessa, i singoli e le comunità immigrate
d) La professionalità dei docenti dovrebbe essere indirizzata a promuovere una comunicazione in cui essi
stessi accettano di “mettersi in gioco”, ponendo sotto osservazione i propri comportamenti ed i propri
giudizi, attivando un atteggiamento di decentramento.
e) A più riprese viene menzionata la necessità di coinvolgere il personale docente in percorsi di formazione
che consentano di assicurare le necessarie conoscenze culturali di tipo filosofico, storico-sociale,
antropologico, linguistico e pedagogico, anche in prospettiva comparativa, come anche le competenze
metodologiche che riguardano la gestione della classe, la conciliazione degli obiettivi cognitivi e affettivi
con quelli comportamentali, l’animazione dei gruppi, l’individualizzazione dell’insegnamento, la didattica
11
Ai mediatori culturali come risorsi e “pericoli” andrebbe riservato un lungo capitolo a parte.
9
f)
disciplinare ed interdisciplinare per problemi, per obiettivi e per concetti, sia infine le competenze
istituzionali che consentono di interagire produttivamente con i colleghi, con le famiglie e con le istituzioni
pubbliche e private, anche di altre nazioni
Il rinnovamento dei programmi, il curricolo in verticale, gli obiettivi disciplinari e le attività integrative sono
citati come strategie e risorse di promozione interculturale
In maniera davvero molto molto sintetica vi ho esposto come la nostra normativa italiana approccia la questione del
diverso a scuola, delle oltre 170 nazionalità presenti nelle nostre scuole.
Ma il passaggio dalle linee teoriche e dalle normative all’applicazione dei contenuti è molto complesso e lungo:
innanzitutto perche gli insegnanti non sono pronti e aperti al cambiamento, a una ridefinizione epistemologica dei
propri saperi, a un lavoro profondo sugli stereotipi e sulla nostra costruzione dell’Altro, dell’immigrato, del
clandestino.
Certamente si creano molte nuove sensibilità, attraverso la formazione crescono competenze e capacità di
accoglienza, ma ad oggi la distanza tra i contenuti di questa avanzata normativa e le prassi attivate è purtroppo
piuttosto evidente.
Una normativa che è riassunta e ridefinita in una sua significativa sintesi nel documento del 2006 del Ministero
dell’Istruzione La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri che coglie peraltro le
trasformazioni avvenute dal 1990 al 2006 nel panorama migratorio e sociale, fa un bilancio delle politiche attivate e
dei risultati avuti, indica la necessita di messa a punto del “modello” e sottolinea l’emergere di nuove attenzioni da
sviluppare, come quelle verso la crescita delle “seconde generazioni”, la crescita della dispersione e abbandono
scolastico.
Intanto, nonostante le difficoltà, soprattutto in alcune regioni d’Italia a più forte migrazione, le scuole diventano
comunque centri attivi di buone pratiche per l’integrazione; la nozione di differenza culturale e rispetto della
differenza, il termine intercultura e la necessità del “dialogo tra culture”, si affermano e diventano “luoghi comuni”
del discorso sullo straniero.
Tuttavia nell’ansia di catalogare la differenza dell’Altro, si comincia a costruire un meccanismo di riduzione
culturale che vede ogni bambino migrante ingabbiato in “una cultura”.
Nella necessità di capire e semplificare, gli insegnanti, anche con l’aiuto dei mediatori, vanno alla ricerca di
“manuali” che spieghino la diversità e che possano aiutarli a capire chi sono i bambini cinesi, attivando dunque un
processo di radicalizzazione culturale che non ha nulla a che fare con il riconoscimento del soggetto e delle sue
interpretazioni specifiche di un orizzonte culturale; non si riconosce come la soggettività culturale sia
profondamente dinamica, meticcia, singolare ed aperta a costanti contatti e contaminazioni, specie in un mondo
dove le culture sono ormai deterritorializzate, diasporiche, in cui le opportunità della globalizzazione della
comunicazione forniscono tanti riferimenti di identificazione e modelli culturali contemporanei. Si parla infatti di
identità fluide, aperte, caleidoscopiche.
Si declinano concezioni di cultura e di etnicità che lentamente vanno a sempre più a consolidare nuovi stereotipi e
nuovi differenzialismi culturali fino a un razzismo culturalista che irrigidisce i confini della culture.
Si costruisce insomma una retorica interculturale che mentre diffonde valori ne irrigidisce i principi e si fonda su
una idea di cultura fissa, statica che non ha nulla a che vedere con la riflessione dell’antropologia contemporanea.
Nel frattempo, mentre il mondo delle associazioni, le scuole, i mediatori culturali, le politiche locali cercano di
strutturare “una cultura dell’accoglienza”, nella società si diffondono paura, razzismo, esclusione, abilmente
manipolati dalla politica della destra. Lo straniero viene stigmatizzato, criminalizzato, diviene l’icona del male.
In questi 20 anni il nostro paese è stato governato alternativamente dall’alleanza di Berlusconi e dal centro sinistra.
Il governo dell’immigrazione diventa un punto importante della lotta politica. E segna la differenza tra i due governi
che si avvicendano. Ad oggi la situazione è definita da una politica generale che come ben sappiamo ha elaborato
una totale criminalizzazione dell’altro, il migrante è sempre più malvoluto, respinto ai confini del nostro mondo
“civile”. La “fortezza” Italia va sempre più attivando politiche di esclusione e di evidente razzismo.
3) Gli eccessi di cultura e le retoriche dell’intercultura: nuovi stereotipi e riduzionismi
Ho di recente condotto nella scuole della mia regione dei laboratori che volevano portare l’attenzione sugli
”eccessi di cultura” e sul riduzionismo culturalista che si è avviato nelle scuole entro le cosiddette “buone prassi”.
Ho creato un certo spiazzamento negli insegnanti ma anche, credo, essi siano stati condotti a riflettere con senso
critico su come le prassi dell’accoglienza e le retoriche dell’integrazione in questi anni, se da una parte hanno
funzionato nel creare una certa sensibilità, dall’altro lato hanno contribuito sia all’irreggimentazione delle diversità e
a processi di assimilazione e dall’altro hanno praticato una idea dell’Altro che ha ingabbiato la diversità dei bambini
(boxification of cultures) migranti e dei loro genitori, riducendo tutte le problematiche, la psicologia e i bisogni delle
persone venute da lontano alla differenza culturale, occultando le dimensioni sociali di esclusione, la violenza
10
istituzionale, la manipolazione politica (basterebbe guardare tutta la produzione didattica di questi anni). Ho inoltre
sottolineato come la “rivoluzione epistemologica” che sarebbe stata necessaria non si è realizzata. Infatti il lavoro
sui propri saperi e modelli anche pedagogici non è stato affrontato, e la nostra pedagogia continua a pensarsi
unica, cosi come nelle scuole anche nei tribunali e nei nostri servizi, operando senza dubbio costantemente un
certo grado di violenza istituzionale.
I laboratori proposti avevano come obbiettivo quello di focalizzare l’attenzione sulle pratiche discorsive, presenti
12
nei nostri contesti istituzionali e in specifico scolastici, riferite ai migranti e all’“alterità culturale” , in cui ho cercato
di sollecitare uno sguardo che rintracciasse le dimensioni ideologiche e retoriche del discorso interculturalista, i
limiti di una pratica interculturale in gran parte distante dalla riflessione dell’antropologia contemporanea.
Il discorso interculturalista e integrazionista, che appartiene all’orizzonte degli orientamenti normativi per la scuola
13
cosiddetta “multiculturale” , è abitato da una serie di oggetti concettuali che nelle pratiche dell’accoglienza
rischiano di irrigidirsi trasformandosi in nuovi stereotipi per rappresentare e “addomesticare” l’Altro.
14
Alcuni concetti mutuati dalle scienze umane e sociali (cultura, etnia, razza, identità culturale, differenza culturale )
e che costituiscono il prontuario terminologico percepito come politicamente corretto per definire l’Altro - parole
chiave del modello integrazionista rispettoso delle diversità - nel loro trasferirsi al senso comune dell’intercultura
hanno perso potere ermeneutico, diventando nuove gabbie per incasellare i “corpi estranei” - gli stranieri enfatizzando e costruendo la diversità culturale allo scopo di disciplinare e governare l’Altro attraverso una serie
15
di codificazioni delle pratiche di accoglienza e integrazione .
Nel discorso interculturalista dell’accoglienza, l’Altro viene sottratto allo stigma negativo di una diversità non
accettabile, impensabile, intollerabile, quella alterità che si attribuisce ai migranti, delle alterità non conformi, corpi
estranei al corpo sociale omogeneo e uguale a se stesso, disturbatori dell’ordine sociale, minaccia alla sicurezza e
alle identità nazionali.
L’Altro, nel discorso dell’intercultura, diviene occasione, opportunità arricchente per la società “ospite” a partire
dalla sua diversità, che entro certi limiti, addomesticata e addolcita diviene “buona da mangiare”, una opportunità di
crescita della cultura cosmopolita della nazione, sempre più aperta alle dinamiche della globalizzazione.
16
Tuttavia come direbbe Abdelmalek Sayad , sociologo algerino, le società ospiti leggono l’immigrazione secondo
una tabella che fa figurare i suoi apporti ora nella colonna dei profitti ora dei costi in quella grande contabilità cui dà
luogo a presenza degli immigrati….
I migranti, nella retorica interculturalista, sono essenzializzati nella loro “interessante diversità culturale”, emergono
nello scenario come presenze buone da usare per l’arricchimento delle esperienze dei bambini italiani, per una
pedagogia pluralista e della convivenza, uno sguardo cosmopolita che si porta nelle classi, una occasione di
17
confronto .
Fino a che punto però la nostra capacità di accoglienza si estende? siamo disponibili ad accogliere altri modelli di
infanzia, di disciplina, di famiglia, di genitorialità, di codice delle relazioni tra generi, di moralità, di uso del corpo e
della sessualità? Fino a che punto l’Altro è “accettabile”? quando è che la sua “cultura” non è più interessante e
arricchente e anzi confligge fortemente con il nostro ordine irremovibile di valori?
Cosa facciamo quando i valori dell’Altro confliggono con i valori su cui poggia la Carta dei diritti umani, essi stessi
espressioni culturalmente e storicamente definite estese come valori assoluti?
Dovremmo chiederci quali nozioni e pratiche di “umanità” si celano dietro alla Dichiarazione dei diritti umani. Ma
18
siamo disposti a riflettere sul fatto che anche la nozione di umanità è un prodotto storico, socio-culturale ?
Forse dovremmo anche chiederci, cercando risposte, alle domande appena poste, quanto l’integrazione chieda ai
migranti una alienazione dai propri riferimenti.
Nel laboratorio che ho condotto, le nozioni e gli usi dei termini accoglienza e di integrazione sono stata
ampiamente affrontate e ne è stata evidenziata la labilità del loro campo semantico, la loro dimensione politica, il
loro essere strumenti di ammortizzazione del conflitto sociale, strumenti di omologazione, ambigui perchè non
12
M. Kilani, L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico, Edizioni Dedalo, Bari, 1997
Sul multiculturalismo vedi Baumann G., L'enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni , Il Mulino 2003; Leghissa G., Zoletto D., Gli equivoci
del multiculturalismo, “ Aut Aut”, 312, 2002
14
Gallissot R., Kilani M., Rivera A., L’imbroglio etnico in 14 parole chiave, Dedalo, Bari, 2001 e Amselle J., M’Bokolo E, L’invenzione dell’etnia,
Meltemi, Roma, 2008
15
cfr . Zoletto D., Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospitalità, Raffaello Cortina, Milano, 2007
16
Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002
17
Come nota Burdieu nell’Introduzione a La doppia assenza di Sayad, “l’atteggiamento relativistico dell’accoglienza è un atteggiamento colto di persone che hanno un rapporto colto con la propria cultura – verso la cultura degli altri che essi considerano in modo da farne un oggetto di
cultura di cui possono appropriarsi e che possono aggiungere alla propria”.
18
Sulla plasmazione dell’umano e sulla nozione di umanità vedi Remotti F. (a cura di), Figure dell’umano. Le rappresentazioni dell’antropologia,
Meltemi, Roma, 2006
13
11
esplicitano chiaramente i propri confini e non definiscono il limite, di fatto agito, tra diversità “integrabili e
accoglibili” e quelle non integrabili, le “alterità radicali”.
L’integrazione rischia infatti di identificarsi con quella “tolleranza” che come disse il politologo Giovanni Sartori
significa “permettere all’Altro di avere credenze sbagliate”.
19
Ho cercato di sottolineare come la retorica interculturalista che di fatto viene agita, poggi su una nozione di
cultura lontana da quella concettualizzata dall’antropologia contemporanea. ’antropologia ha avviato da tempo un
ripensamento radicale delle nozioni culturali di appartenenza identità, etnicità e l’antropologia delle migrazioni ha
fatto di questo ripensamento critico il presupposto stesso delle sue analisi: come misurare altrimenti le nuove
culture deterritorializzate, le comunità immaginate, le identità transnazionali?
Invece nelle scuole e nei discorsi del senso comune interculturalista troviamo delle pragmatiche della differenza
che cercano nei bambini stranieri l’aggancio con una idea di cultura chiusa, destorificata, immobile, inscatolata,
ossificata, irrigidita, incasellante, assolutamente distante dalla nozione aperta, fluida, porosa, ibrida, dinamica di
cultura presente nell’antropologia contemporanea. Nel senso comune dell’intercultura troviamo quella nozione di
cultura rappresentabile e consultabile in strumenti prêt-à-porter come i Quaderni delle culture, i kit per
l’accoglienza, i manuali per spiegare e affrontare l’Altro, portatore dei malintesi e dei problemi.
Quanto più problemi e malintesi vengono ricondotti all’Altro e alla sua diversità tanto meno si è disposti a
sottoporre una rigorosa lettura critica il proprio dispositivo istituzionale e le proprie categorie. Tutto è orami
20
spiegabile nei termini della cultura dell’Altro . Una sorta di neorazzismo differenzialista, culturalista, che ingabbia
l’Altro e lo inchioda alla sua diversità culturale che tutto spiega.
Mentre in antropologia si è decretato il requiem dell’informatore onnisciente e si sottolinea la diversità intraculturale
delle categorie emiche, nei dispositivi per l’integrazione primeggia invece la figura del mediatore culturale, come
l’interprete della diversità, il testimone di “Una cultura”, colui a cui affidiamo e su cui depositiamo la nostra ansia di
svelamento dell’Altro, a cui deleghiamo molte delle nostre competenze comunicative possibili. In questo modo ci
autoescludiamo dalla possibilità di interrogare quelle differenze, che non sono solo culturali, ma riguardano
21
individui, storie, famiglie, posizioni sociali, dimenticando che abbiamo davanti persone e non culture .
E cosi ecco la mediatrice cinese, il mediatore pakistano, la mediatrice rumena e cosi via.
Attraverso di loro ci aspettiamo di apprendere finalmente chi sono i cinesi, i pakistani, i rumeni etc. I mediatori
appaiono come un esercito con la divisa delle diverse culture, segmenti discreti giustapposti uno all’altro, senza
22
nessun contatto e sintesi sincretica, i “frutti puri” .
Spesso i mediatori si prestano diligentemente a diventare icone della presunta identità etnica, contribuendo
inconsapevolmente a quel discorso che governa la diversità riducendola a folclore (le feste etniche, la danza
etnica, il cibo etnico…la pedagogia del cous cous….), che destorifica gli individui e le appartenenze, dimentica i
ruoli di genere e le posizioni sociali degli individui, spoliticizza la posizione asimmetrica dei migranti di fronte alle
società cosiddette ospiti, dimentica il loro portato biografico rivelatore di grandi problemi sociali, le condizioni
egemoniche e rapporti postcoloniali e neocoloniali tra paesi.
Le grammatiche invisibili non vengono indagate.
In questi ultimi decenni i nuovi rapporti di forza tra paesi colonizzati e paesi colonizzatori hanno imposto una
nuova consapevolezza autoriflessiva all’etnologia e all’antropologia. Tali mutati rapporti hanno eroso in modo
significativo strategie metodologiche e categorie descrittive, rendendole obsolete. Etnie, culture, tradizioni hanno
finito per essere sempre più definite come costruzioni o invenzioni che hanno fatto vacillare il mito della ricerca sul
campo.
Oggi l’antropologia è quindi “tornata a casa” per fattori politici economici oltre che epistemologici.
Ma in questo nuovo scenario l’incontro con gli immigrati che in molti casi alcuni secoli fa erano ancora gli indigeni
primitivi ha mostrato nuovi e inattesi profili per ripensare la cultura e il rapporto che i singoli individui intrattengono
con essa.
Unità etniche dai confini sempre più arbitrari, società e culture sempre più indefinite sono state messe in
discussione da esodi e flussi migratori spesso caotici e da identità deterritorializzate che hanno prodotto una forte
cambiamento degli scenari sociali delle popolazioni.
23
Le etnie , categorie inventate e ontologizzate dalla storia dell’antropologia coloniale hanno riassunto una realtà
sovente drammatica; l’uso politico che ne è stato fatto le ha trasformate sino a farle diventare gabbie grottesche o
tragiche come in Ruanda, o nei Balcani, si sono ispessite di morte proprio quando si pensava di non utilizzare più
questo concetto, e invece costituiscono unità di rappresentazione ancora tenacemente presenti nei rapporti tra
gruppi e nazioni, non meno di quanto lo siano nel sentimento di e nelle relazioni interpersonali.
Anche i nostri discorsi istituzionali (normativa scolastica per l’integrazione dei migranti) mettono in scena senza
questo potere di morte, una terminologia delle differenza che si rifà ad un uso delle nozioni di cultura, etnia, etnicità
etc. che non trova più corrispondenza nelle scienze sociali.
19
Rivera A. M., Oltre la retorica dell’intercultura, pp.35-44 in Religioni e civiltà tra conflitto e dialogo, “Rassegna. Periodico dell’Istituto
pedagogico”, anno XIII, aprile 2005
20
cfr. Aime M., Eccessi di cultura, Einaudi, Torino, 2004
21
cfr. Castiglioni C., Galetto C. (a cura di), Se le persone non sono la loro cultura. Intervista a Marco Aime, “Animazione Sociale”, anno XXXVII,
n. 210, Febbraio 2007
22
Clifford J., I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino, 1999
23
M’Bokolo E, L’invenzione dell’etnia, Meltemi, Roma, 2008
12
Questo scarto esiste: mentre si vorrebbe usare un linguaggio e pratiche politicamente corrette per integrare l’Altro,
lo marginalizziamo, spesso inconsapevolmente, condannandolo e alienandolo sempre più in queste categorie in
disuso in antropologia.
Tutto ciò che non capiamo diventa etnico o culturale, a maglie molto larghe, occultando dimensioni macrosociali,
disuguaglianze, scenari storici, politici ed economici. Quante volte ci sentiamo dire che i marocchini, i cinesi, etc.
“fanno cosi perché è la loro cultura!”?
Quante volte le scuole richiedono un mediatore di etnia rumena, moldava, cinese? Non giungono richieste per un
mediatore di etnia francese o olandese, anche se a Ferrara ci sono militari della Nato e spesso si interviene anche
per i loro figli a scuola.
Etnia diviene ormai sinonimo di nazionalità. Ho perfino sentito qualcuno chiedere a un utente di un servizio se era
di “di etnia italiana o straniera”.
Nella scuola, luogo di normalizzazione dei “corpi estranei”, di costruzione di”stranieri docili e integrati” sono ormai
disponibili tutta una serie di prassi di accoglienza che valutano conoscenze competenze e abilità, come nel
linguaggio caro alla scuola.
Griglie per osservare e inquadrare il neo allievo su un piano cognitivo, affettivo, sociale, relazionale, comunicativo.
Strumenti che possono rivelarsi preziosi ma che dovrebbero essere accompagnati dalla domanda: ci aiutano a
conoscere o a costruire l’Altro?
Conoscere l’Altro presuppone che egli abbia effettivamente delle caratteristiche sue proprie che dobbiamo
scoprire, svelare. Costruire l’Altro significa che quelle caratteristiche non appartengono a chi abbiamo
davanti ma a noi che lo guardiamo. Nelle pratiche dei rapporti con gli allievi stranieri le due modalità si
confondono costantemente.
L’allievo è un problema da risolvere e regolare. Ci importa il suo essere qui come immigrato e i problemi che ci
crea, non la sua storia e il suo essere emigrato (come ci ricorda sempre Sayad).
Gli allievi stranieri, corpi estranei, pongono alla scuola problemi di ordine, sono perturbatori.
Sarebbero invece degli ottimi rivelatori epistemologici utilizzabili per revisionare e decentrare i nostri saperi cosi
sicuri di sé stessi e della loro validità universale. Buona parte dei nostri saperi sugli allievi stranieri risponde
proprio a queste esigenze di ordine: ci piace pensare che siano prodotti sugli e per gli allievi stranieri ma in realtà
sono soprattutto saperi e tecniche prodotte dalla scuola e per la scuola nel tentativo di porre argine i problemi di
disordine e minaccia di anarchia delle identità poste dai nuovi allievi.
Cosi quelle prime informazioni che gli insegnanti ricavano servono alla scuola per controllare il perturbamento delle
routine.
Protocolli, buone prassi, strumenti vari vengono considerati scientifici e oggettivi quando si rivelano efficaci nel
mettere ordine in classe, nel ricomporre il disordine visibile prodotto dalla visibile diversità degli allievi stranieri.
Governare il disordine, come ci ricorda Zoletto, rimanda alla nozione di governamentalità, formulata da Michel
Foucault che intendeva quell’insieme di saperi e tecniche attraverso cui a partire dal XVIII secolo si è esercitato il
potere sulla popolazione degli Stati moderni.
In passato il potere di controllare e orientare la condotta degli individui era affidata alla sovranità di un principe, o
di uno Stato su un dato territorio. Dal ‘700 il potere assume invece la molteplicità di saperi e tecniche di controllo
derivanti da fonti diverse: dalla salute pubblica all’economia, dalla pubblica sicurezza alla pedagogia. Questi saperi
e queste tecniche si esercitano in luoghi e istituzioni specifiche a cui lo stato si limita a fornire organizzazione e
articolazione: dagli ospedali ai luoghi di lavoro alle scuole.
Nei recenti studi sulla governamentalità anche la pedagogia e la scuola vengono lette come una fonte e un luogo
della governamentalità attraverso tre meccanismi che Foucault individua:
1. nella visibilità obbligatoria dell’allievo; 2. nella documentazione della sua specificità, e 3. facendo di ogni allievo
un caso.
Un reticolo di razionalità livellatrici, dice Zoletto citando De Certau, cerca di adattare gli alunni stranieri alla scuola,
rilevando, categorizzando, analizzando, osservando, esaminando. Con un intreccio di etichettature e
disciplinamenti si cerca di livellare tutti gli stranieri, facendo si che interiorizzino con una seconda socializzazione
norme e standard per diventare quasi degli italiani. E soprattutto governabili.
Insegnanti, mediatori e allievi diventano tutti prigionieri di questo stesso meccanismo.
I professionisti dell’integrazione, zelanti nelle procedure, sempre più specializzati, non devono smettere di utilizzare
questi strumenti, ma ci dice ancora Davide Zoletto, riconoscerne i rischi, le cornici in cui sono inseriti, devono
essere maggiormente consapevoli degli strumenti che utilizzano, affinare le proprie conoscenze
antropologiche, riconoscere le traiettorie degli individui, devono ricongiungere la storia della emigrazione
e quella della immigrazione, devono intaccare il reticolo livellatore, cercare di riguadagnare quegli spazi
che le tecniche di governamentalità cercano costantemente di organizzare. Giocare con gli eventi per
trasformarli in occasioni di reale incontro dell’Altro, situandolo, contestualizzandolo, liberando gli alunni
migranti dalle gabbie della diversità, ascoltando la cultura incarnata nei loro corpi e nelle loro specifiche
individualità, senza cercare di ricondurli alla logica dei manuali delle culture.
Devono cercare anche di riconoscere le dimensioni sociali di individui che sono stretti in condizioni di
necessità, che lasciano i loro paesi, mondi morali e locali, culture interiorizzate e pratiche dei corpi,
individui che siedono ai nostri banchi con il loro portato biografico e appartenenze fortemente instabili,
13
che si vanno riconfigurando e che non sono riducibili a presunte etnicità, ma con identità e vite affettive
sempre più transnazionali.
Spero che con questo forse troppo intrecciato percorso io vi abbia potuto evidenziare come l’intercultura debba
essere costantemente vigilata affinché essa non diventi uno strumento di riduzionismo culturale o di
differenzialismo o peggio non si presti a sostenere pratiche di irrigidimento delle identità. Si deve poter riconoscere
che l’intercultura è una delle modalità contemporanee delle “costruzione” e “categorizzazione” del “noi” e del “loro”,
strumento utile, approccio costruttivo e critico se utilizzato consapevolmente e criticamente e accompagnato
costantemente da un aggiornamento del taglio antropologico e da un consapevolezza della sua dimensione
politica.
14