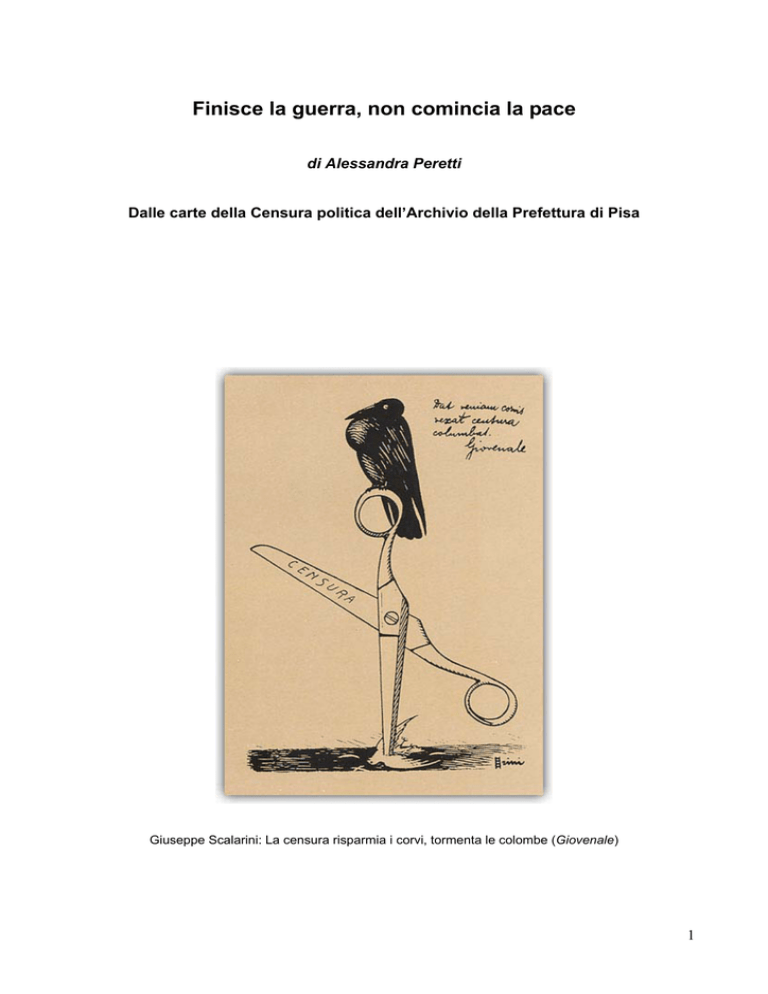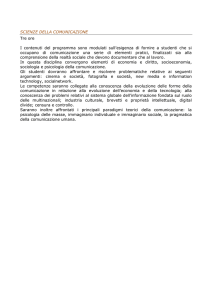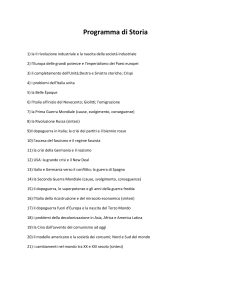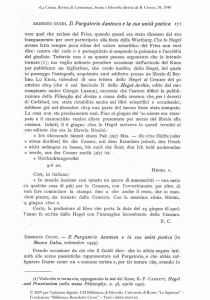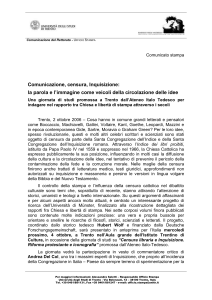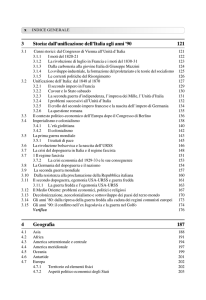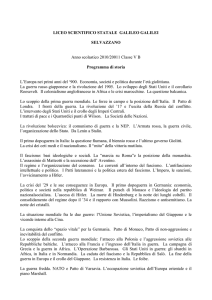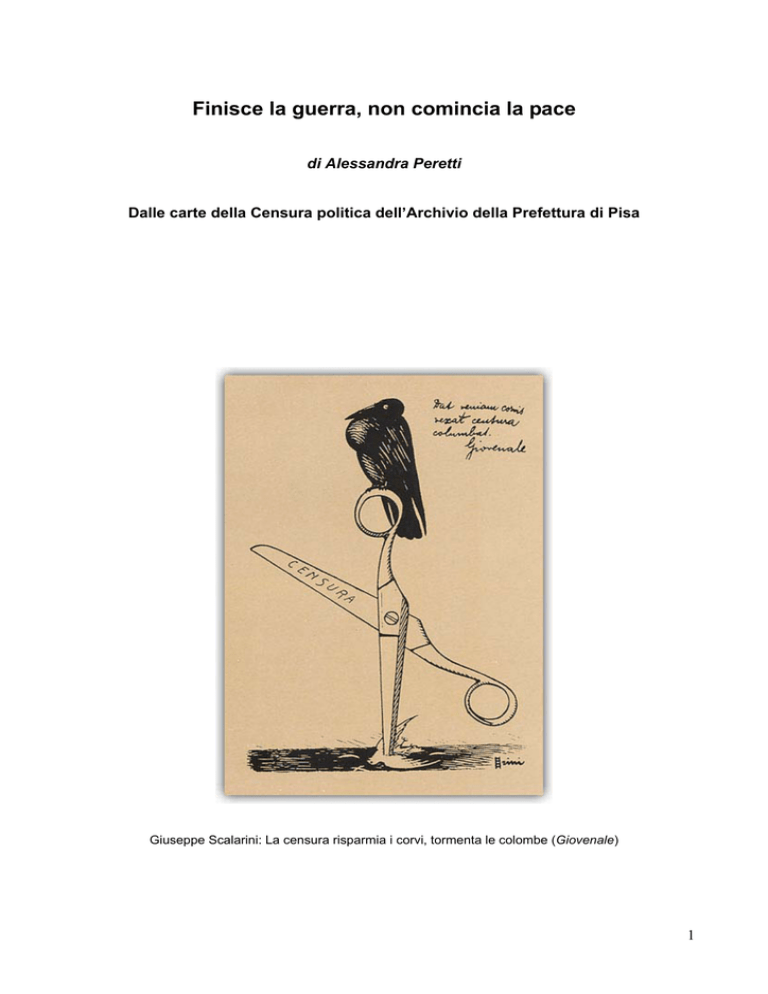
Finisce la guerra, non comincia la pace
di Alessandra Peretti
Dalle carte della Censura politica dell’Archivio della Prefettura di Pisa
Giuseppe Scalarini: La censura risparmia i corvi, tormenta le colombe (Giovenale)
1
La questione adriatica
Il 3 novembre 1918, con l’armistizio di Villa Giusti, finisce per l’Italia la grande guerra. Tutti
gli italiani si ritrovano uniti nel sollievo per la conclusione di un periodo inaspettatamente lungo di
lutti e sacrifici enormi: 650.000 morti, 947.000 feriti, 600.000 prigionieri e dispersi sono
approssimativamente i costi che in termini di vite umane il paese ha pagato a più di tre anni di
guerra di trincea. Ed è proprio la convinzione di aver superato vittoriosamente una prova storica che
produce la diffusa richiesta di un rinnovamento radicale: al sacrificio di tanti caduti e allo sforzo
collettivo del popolo italiano si può dare un senso solo creando una società più moderna e più giusta
dal punto di vista morale, sociale, politico.
Ma la lacerazione che aveva diviso la società italiana tra neutralisti e interventisti nella
stagione della neutralità, tra il luglio del ’14 e il 24 maggio 1915, si ripropone immediatamente sul
valore da riconoscere alla guerra appena vinta e sulle aspettative con cui si guarda alla pace tanto
sospirata. E’ una lacerazione che coinvolge in prima linea le forze politiche: la vecchia classe
dirigente liberale ne viene disintegrata, nello scontro tra posizioni giolittiane, di interventismo
democratico e di destra conservatrice sempre più risucchiata nell’area nazionalistica. Risultano
invece accomunati dal rifiuto di riconoscere un valore ideale alla guerra e dal fatto di non averne
condiviso la responsabilità quelli che - anche per questa ragione - si avviano a diventare, con le
elezioni a sistema proporzionale del novembre del ’19, i due maggiori partiti italiani: i socialisti e i
popolari. Nel partito socialista, in particolare, il massimalismo del dopoguerra, alimentato
dall’attesa messianica della rivoluzione, non eviterà l’errore di trasformare la lotta alla guerra in
lotta a chi la guerra l’ha fatta, allontanandosi ben presto dalla possibilità di un incontro con i settori
democratici del movimento degli ex combattenti. Nella società italiana, per altro, sale in relazione
alle difficoltà del momento la recriminazione sull’inutilità dei sacrifici compiuti, che investe chi ha
imposto tali sacrifici e chi in nome di essi ha fatto tante promesse che ora appaiono illusorie.
Nei primi mesi del dopoguerra dunque, mentre si moltiplicano gli scioperi operai e le
agitazioni popolari contro il carovita, si assiste anche a un progressivo affermarsi di parole d’ordine
e battaglie politiche di ispirazione nazionalista e fascista, contro chi è accusato di voler defraudare
gli italiani dei risultati di tante sofferenze negandone valore e sacralità. Sulla base di un tale stato
d’animo diffuso è destinato a crescere quello che è stato chiamato il mito, o anche il fungo
velenoso, della vittoria mutilata.
Se infatti da tutto questo, e da altro ancora, derivano al dopoguerra italiano quei caratteri di
guerra civile che lo faranno sfociare in breve nella dittatura fascista, tra la fine del 1918 e i primi
mesi del 1919 la crisi si alimenta in particolare delle polemiche sulle rivendicazioni territoriali da
2
avanzare nelle trattative di pace, il cui nucleo centrale è rappresentato dalla cosiddetta questione
adriatica.
Il patto di Londra, sottoscritto dall’Italia con le forze dell’Intesa alla vigilia dell’entrata in
guerra, nell’aprile del 1915, e rimasto segreto fino al 1917, era ispirato all’obbiettivo tradizionale
della diplomazia europea che vedeva nell’equilibrio delle forze la garanzia di ogni stabilità futura.
Per questo l’Italia doveva avere un ruolo centrale nel ridimensionamento dell’Austria-Ungheria e il
patto di Londra le riservava ampie concessioni sul confine orientale, in modo da togliere all’Austria
il predominio sul mare Adriatico. Dei due firmatari di parte italiana, Salandra era stato un anno
dopo costretto a lasciare il governo, mentre Sonnino era rimasto come ministro degli esteri
l’intransigente garante del rispetto e delle intenzioni di quel patto per tutta la durata della guerra.
Quando però alla fine della guerra si trattò di riscuotere il credito relativo, non solo la
situazione internazionale era profondamente cambiata, ma l’intero vecchio ordine europeo si era
dissolto. L’America di Wilson, il cui intervento aveva determinato l’esito della guerra a favore
dell’Intesa, non aveva sottoscritto il patto di Londra e la sua azione diplomatica era tutta incentrata
sui 14 punti, vera e propria nuova diplomazia contrapposta alla tradizione precedente. Il punto 9 in
particolare dichiarava: “Una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere effettuata secondo le linee
di nazionalità chiaramente riconoscibili”. Lo stesso governo italiano, in particolare il presidente
Orlando, aveva manifestato nel corso del 1918 la sua piena adesione alla politica delle nazionalità e
promosso in Campidoglio un Congresso dei popoli oppressi dall’Austria, che si era concluso con la
proclamazione del diritto all’autodeterminazione e alla piena indipendenza dei popoli italiano,
polacco, rumeno, ceco e jugoslavo.
Per altro la dissoluzione dell’Austria-Ungheria e dell’impero zarista con la sua tradizionale
politica di espansionismo balcanico, e la conseguente creazione di un nuovo stato jugoslavo,
cambiavano radicalmente i termini della questione. L’interesse dell’Italia a svolgere un ruolo nella
regione adriatica e balcanica doveva fare i conti ora con le legittime aspirazioni nazionali e le assai
meno legittime ingordigie nazionalistiche degli slavi del sud. I due poli intorno a cui si scatenò la
contesa furono la Dalmazia e Fiume: la prima italiana in base al patto di Londra, ma jugoslava ora
in nome del principio wilsoniano di nazionalità, la seconda croata per il patto di Londra, ma italiana
per la scelta della stragrande maggioranza della sua popolazione urbana.
Intorno a questo scontro si dissolse in Italia il già composito schieramento interventista.
Mentre i democratici venivano tacciati di “rinunciatari” per la volontà di rispettare rigorosamente il
principio wilsoniano (fino alla rinuncia del confine del Brennero), i nazionalisti, indifferenti
all’incoerenza delle loro pretese, andarono rumorosamente all’attacco in nome del “sacro egoismo”
nazionale interessato sia a Fiume che alla Dalmazia. Il governo di Vittorio Emanuele Orlando, che
3
aveva portato il paese alla vittoria nella guerra, si dissolse nel vivo della battaglia sulla pace e dopo
le ambiguità e contraddizioni manifestate nel corso della conferenza di Parigi finì per dimettersi nel
giugno 1919. Il governo successivo, presieduto dall’on. Nitti, sarà costretto nell’autunno ad
affrontare il precipitare della crisi e la marcia su Fiume di D’Annunzio.
La censura sulla stampa
Dai documenti dell’Archivio della Prefettura di Pisa che qui vengono presentati e che
appartengono alla serie delle buste della Censura politica (v. Quaderno n. 4), emerge chiaramente la
preoccupazione del governo riguardo a tali temi, almeno nel periodo fino al giugno 1919 che è
quello coperto dalla documentazione. Gran parte delle disposizioni che Orlando, il suo
capogabinetto Flores, il vicepresidente Colosimo e altri diramano telegraficamente per orientare
l’attività della censura sulla stampa è dedicata ai temi della politica estera: dalla questione jugoslava
alle tensioni con la Francia e con Wilson alla rivalità con la Grecia in Asia minore. Le
preoccupazioni del governo sembrano soprattutto ispirate al desiderio di non alimentare le
polemiche nazionalistiche e di non irritare gli alleati con cui si sta discutendo a Parigi. Se altri temi
sono presenti qua e là, come quelli della riconversione industriale o delle agitazioni per il carovita o
dell’amnistia, hanno comunque un rilievo quantitativamente modesto.
Le norme sulla censura sulla stampa ebbero alla fine della guerra una provvisoria revisione
che finì per lasciare le cose come stavano. Una circolare del 21 novembre 1918 firmata dal
presidente del Consiglio annunciava un Regio decreto in corso di pubblicazione che avrebbe dovuto
limitare a tre soli casi gli interventi degli uffici censura: alle notizie di carattere militare, alle notizie
“non conformi al vero che possano generare allarmi nella pubblica opinione o turbare i rapporti
internazionali”, alle notizie contenenti elementi di reato perseguibile di ufficio. Per quanto si
prevedesse una graduale limitazione dei compiti della censura, per ora si ricordava che “talvolta
basta un particolare non vero, aggiunto ad una notizia fondamentale vera, a svisare la realtà e a
generare allarme nel pubblico”. Successivamente, dal 1° aprile 1919 venne abolita la censura
telegrafica per l’interno del regno, ma non quella sui telegrammi internazionali o indirizzati a quella
parte dell’Italia settentrionale che continuava ad essere definita zona di guerra. Solo nel luglio il
governo Nitti ne decise la soppressione, nell’intento di normalizzare il clima postbellico.
A ciò si aggiunsero le particolari preoccupazioni relative alla diffusione di notizie sulle
discussioni in corso alla conferenza di pace di Parigi, che si aprì il 18 gennaio 1919. Le
corrispondenze giornalistiche da Parigi dovevano essere vistate dall’ufficio stampa di là ed essere
poi controllate dai vari uffici di censura locali. Una complessa procedura, che subì via via marginali
4
aggiustamenti, fu avviata in proposito e si moltiplicarono i telegrammi da Roma col sunto delle
direttive alla stampa, vere e proprie veline a cui ispirare le cronache dei giornali.
Oltre ai documenti della censura, è presente in questa sezione una notificazione del Comune
di Pisa che si riferisce alla drammatica partenza da Parigi della delegazione italiana alla fine di
aprile 1919.
La memoria dei caduti
Nel contesto generale di contrapposizioni accanite di cui si è evidenziato qui un aspetto, la
fine della guerra segna anche l’inizio di un processo che avrà nella successiva dittatura fascista il
suo compimento e la sua apoteosi. Quella che gli storici chiamano oggi “sacralizzazione della
memoria della guerra” si avvia anche in Italia a partire dal culto dei caduti, attraverso
la
proliferazione di “monumenti che via via vengono eretti nel primo dopoguerra, dai capoluoghi di
provincia alle località più modeste: quelle nei cui negozi saranno per anni reperibili e offerte all’uso
solo una o due cartoline con le attrazioni locali: la chiesa parrocchiale e, appunto, il monumento ai
Caduti” (M. Isnenghi, Le guerre degli italiani, Milano 1989). Nella presentazione delle sezioni
successive dei documenti qui raccolti questo fenomeno verrà più puntualmente illustrato. Qui mi
interessa solo rilevare due elementi che riguardano specificamente l’argomento da me considerato.
Da un lato tutti quei morti il cui nome e numero erano stati rigorosamente censurati durante la
guerra per non deprimere il fronte interno, si prendono ora la rivincita di ricomparire uno per uno a
caratteri cubitali sui manifesti che ne annunziano il ritorno dai campi di battaglia, sulle lapidi dei
monumenti a loro dedicati. Le autorità che li avevano banditi dalle colonne dei giornali,
prescrivendo perfino di ridurre al minimo i caratteri tipografici dei necrologi (v. Quaderno n. 4), ora
chiamano tutti i cittadini ad affollare le cerimonie funebri in loro onore.
D’altra parte il fenomeno coinvolge tutte le nazioni europee fin dai primi mesi della pace, ma
in Italia proprio le lacerazioni tra neutralisti e interventisti, tra democratici e nazionalisti che si
prolungano nel dopoguerra lo caratterizzano specificamente. Nell’uso dell’eufemistico e
sdrammatizzante termine di caduti, invece che morti, nell’insistenza con cui si vuole celebrare la
vittoria anziché la pace, nell’interpretazione ufficiale imposta dall’alto attraverso la diffusione
molecolare di lapidi e monumenti si esprime la volontà di esorcizzare la realtà di una memoria
divisa e di imporre a tutti un comune senso del valore e della sacralità della guerra. Dice ancora lo
storico Isnenghi: “La Francia, che era stata per forza di cose più pronta nell’entrare in guerra e più
compatta nel farla, appare meno accanita e dogmatica nel ricordo; l’Italia, che aveva dibattuto per
5
dieci lunghi mesi se farla o no e che poi, nel 1915-1918, si era manifestata più divisa, cancella i
contrasti rispecchiandosi in una memoria pubblica che si vuole unanime” .
Bibliografia
L. Salvatorelli – G. Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Torino 1964
G. Salvemini, Scritti sul fascismo, Milano 1961
R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo: l’Italia dalla grande guerra alla marcia su
Roma, Bologna 1991
M. Isnenghi, Le guerre degli italiani, Milano 1989
M. Isnenghi, La grande guerra, Firenze 1997
A. Gibelli, La grande guerra degli italiani 1915-18, Firenze 1998
G.L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Bari 1990
Giuseppe Scalarini: La censura e l’Avanti!
6