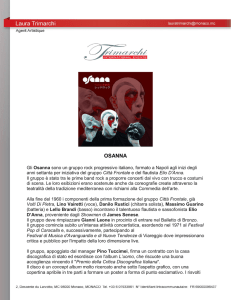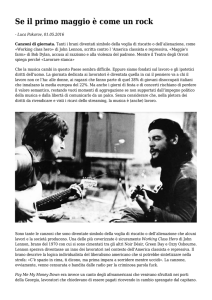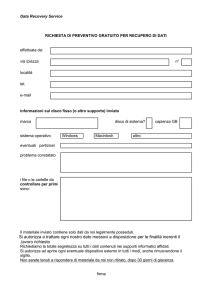digital magazine APRILE 2009
il suono della Detroit ‘00
Madlib
+
The Clever Nerd
qemists//camera
obscura//here we go
magic//malakai//mulatu astatke//
passe montagne//adriano modica//
animal collective//shinkei
N.54
Sentireascoltare n.54
Turn On
4 5 . N 9002 ELIRPA enizagam latigid
p. 6
The Qemists
7
Camera Obscura
8
Here We Go Magic
9
Malakai
10
Mulatu Astatke
12
Passe Montagne
Tune In
00‘ tiorteD alled onous li
Rubriche
14 Adriano Modica
140
Giant steps
18 Animal Collective
141
Classic album
142
La sera della prima
150
A night a the opera
152
I cosiddetti contemporanei
Drop Out
22
Shinkei
30 Madlib
46
Mutoid Motown
Recensioni
60
Elvin Perkins, Cryptacize, Matteah Baim, Mariposa, Here We Go Magic...
Rearview Mirror
bildaM
+
dreN revelC ehT
//stsimeq
//arucsbo aremac
//iakalam//cigam og ew ereh
//engatnom essap//ektatsa utalum
evitcelloc lamina//acidom onairda
132
Mantronix
136
Sylvain Chaveau, Death, Swayzak....
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Consulenti
alla redazione:
Daniele Follero, Stefano Solventi
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale, Teresa Greco
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo,
Alessandro Grassi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali,
Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra, Fabrizio
Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
Madlib
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Come già annunciato, torneranno dopo cinque anni i Tortoise, il prossimo 23 giugno: Beacons Of Ancestorship è il titolo dell’album dei
chicagoani che uscirà su Thrill Jockey…
Death Cab for Cutie faranno seguire a
Narrow Stairs non un album ma un EP, The
Open Door, che è uscito digitalmente il 31 marzo e fisicamente il14 aprile; include quattro pezzi
inediti e un demo di Talking Bird, già apparsa sul
precedente album…
Jona Bechtolt annuncia che Yacht non è più
un progetto in solitaria, ma un duo di cui fa parte
anche Claire L. Evans; il gruppo pubblicherà
il secondo album in estate, dal titolo See Mystery Lights su DFA…
Uscirà a maggio Primary Colours, secondo
disco degli Horrors, a dispetto delle voci di scioglimento…
Nuovo album in uscita, il secondo, per il duo
scandinavo Prins Thomas e Hans-Peter Lindstrom, che ritornano a maggio con II…
Sempre a maggio, Smalltown Supersound
pubblica Desire Lines dei Meanderthals, una
collaborazione tra i veterani disco-not-disco Idjut
Boys (Dan Tyler e Conrad McConnell) e Rune
Lindbaek, quest’ultimo sulla scena dance norvegese dagli Ottanta…
Secondo album solista per Conor Oberst
(Bright Eyes): Outer South uscirà a maggio per
la Merge…
Un altro gruppo in vista per Jack White,
dopo White Stripes e Raconteurs: The Dead
Weather è il suo nome ed è formata da Alison
Mosshart (cantante dei Kills), Jack Lawrence (già
nei Raconteurs) e Dean Fertita dei Queens Of
The Stone Age. Un album, Horehound, sarà
pubblicato a giugno su Third Man Records, anticipato dal singolo Hang You From The Heavens,
che ha sul retro la cover di Are Friends Electric? di
Gary Numan…
Tornano gli scozzesi My Latest Novel, a tre
anni da Wolves: il nuovo disco Deaths and Entrances vedrà al luce il prossimo 18 maggio…
a cura di Teresa Greco
è uscito il 27 marzo su Rough Trade The
Hazards of Love dei The Decemberists, il
seguito di The Crane Wife (2006) e loro quinto album. Tra revival folk inglese e classic metal,
prende spunto da un EP di Anne Briggs dallo
stesso titolo. Ospiti: Becky Stark (Lavender Diamond), Shara Worden (My Brightest Diamond),
Jim James (My Morning Jacket), Robyn Hitchcock e Rebecca Gates (The Spinanes)…
Electricpriest presenta i Butthole Surfers
(Usa), sabato 25 aprile a Bologna all’Estragon,
per un’unica data italiana. Dopo 7 anni torna
dal vivo una delle band più destabilizzanti del
post-punk americano. La formazione con cui si
Cooperative Music…
Torna il bolognese Claudio Lolli con un
nuovo album, già in prevendita su www.storiedinote.com. Si tratta di reinterpretazioni delle sue
canzoni d’amore più significative e in parte meno
conosciute, con arrangiamenti di Nicola Alesini e
Paolo Capodacqua. Esce il 25 aprile…
patrick wolk
Esce il 28 maggio The Bachelor, il quarto
album di Patrick Wolf, contenente 14 brani ai
quali hanno collaborato Eliza Carthy, Thomas
Bloch, Alec Empire, Matthew Herbert e Tilda
Swinton. Era stato concepito come doppio album, ora scisso. L’altro disco, The Conqueror
uscirà in seguito. Le due parti saranno unificate
nel 2010 con Battle…
Il maestro etiope Mulatu Astatké, padre
dell’ethio-jazz (una miscela di jazz, il funk e il soul
più il sound indigeno) e gli inglesi The Heliocentrics saranno in Italia per due date live, l’8
aprile all’Auditorium Flog/Firenze e il 9 aprile al
Circolo degli Artisti/Roma.Il loro album insieme,
Inspiration Information 3 è uscito su Strut…
ensemble pittoresque
butthole surfers
mul atu astatke
presenteranno live è quella che li vide protagonisti negli anni 80: Gibby Haynes, Paul Leary, Jeff
Pinkus, King Coffey and Teresa Taylor. Maggiori
informazioni sul sito di electripriest booking management organizzazione e promozione eventi
www.electricpriest.com, prevendite su ticketone.
it…
Gli Eels pubblicheranno il loro nuovo album
dal titolo Hombre Lobo a giugno su Vagrant/
Dopo 26 anni (!) esce l’attesa ristampa di un
disco-culto, For This Is Past degli olandesi
Ensemble Pittoresque, album diventato negli
anni un riferimento musicale per il synth-pop, la
minimal-wave e in generale l’elettronica melodica, sia del passato che attuale. Tutte le info su
www.martinrecs.com
Mentre sta per cominciare un nuovo tour
americano, Langhorne Slim si rimette al lavoro su un nuovo album, a cui lavorerà insieme a
Chris Funk dei Decemberists…
Gli OM su Drag City e nuovo album in arrivo: il gruppo nato nel 2003 con Al Cisneros e
Chris Hakius (già insieme negli Sleep), è oggi
un duo composto da Al a basso e voce ed Emil
Amos alla batteria. Il nuovo disco, attualmente in
lavorazione con la collaborazione di Steve Albini,
sarà pubblicato a settembre…
L’interminabile saga canadese pop ha ancora
un disco quasi pronto: Spencer Krug e i Sunset Rubdown usciranno a giugno con il quarto
album, Dragonslayer, sempre su Jagjaguwar;
per l’occasione, c’è il nuovo Mark Nicol, bassista
e batterista…
News /
5
Camera Obscura
The Qemists
join the Qemists!
Qemists. Il combo 2009 che avvicina l’energia
del drum’n’bass al pogo rave. La macchina sonica (3 uomini, 2 deck e 2 laptop DJ) tutta London
based che riaccende la scintilla meshy dei Prodigy e che guarda al futuro imbevuto di contaminazioni. Le origini stanno al confine tra la
cultura del cut’n’mix (remix per Coldcut, Roots
Manuva, live sound engineering per Basement
Jaxx e Lady Sovereign) e si fondono con l’energia del metal. Un marchio di fabbrica tutto brit.
Dall’esordio 2005 con il remix di Everything Is Under
Control dei Coldcut (padroni di casa Ninja Tune) e
dalle frequentazioni di fine novanta con la galassia
d’n’b, oggi esce un disco che ripropone quei suoni
veloci con i superbassi e però spacca. Il continuum hardcore reynoldsiano (di cui i nostri non conoscono l’esistenza) sporcato con il palco, i suoni
che ritornano in loop di ricordi infiniti, ma senza
troppa nostalgia ci trafiggono. Un’affinità quindi
con le band che hanno segnato il suono trashy meticcio (Rage Against The Machine, Asian Dub
Foundation) ma che si connette inevitabilmente
all’oggi di Klaxxons, Ladyhawke e Bloc Party
(come ci dicono da un’intervista via myspace).
Il dubstep si configura quindi come una palet6
/ Turn On
te sonora che i nostri usano come base su cui
fondare il loro suono più che mai now. Pompati
dall’hype radiofonico di BBC Radio 1, 1Xtra e
dagli apprezzamenti di un vecchio guru del calibro di Laurent Garnier, si avvalgono di featuring che spaziano dal rock dell’ex Faith No
More Mike Patton (Lost Weekend), al padrino
del grime Wiley (Dem Na Like Me), dal mago del
beatbox Beardyman, al soul di Devlin Love degli Alabama 3 (S.W.A.G.), per arrivare alla reginetta del d’n’b Jenna G e a molti altri ancora.
Un’evoluzione che prende le mosse dall’underground londinese geeky e si fa mainstream su
una delle etichette storiche, la mastodontica Ninja Tune. Ne sono passati di anni e di dischi da
quando i Coldcut ci allietavano con sample fatti
apposta per nerd con le mani paffute. Oggi si ritorna a mostrarsi, più incazzati che mai, ma con
il cuore sintetico di chi ha vissuto sulla pelle (e sui
neuroni persi) le stagioni novanta del ritmo. La
nuova crew che guarda al phuture è compatta e
pronta demolirci i timpani e le ossa sotto il palco.
Pronti al pogo? Join the Q!
Marco Braggion
Ready to Heartbroken
Non citate più i Belle & Sebastian a Tracyanne
Campbell, voce e chitarra degli scozzesi Camera Obscura. Non si sa come potrebbe reagire.
Eppure Stuart Murdoch figura tra i mentori
del gruppo, avendo partecipato alla produzione
dell’album d’esordio, Biggest Bluest Hi-Fi nel
2001, nonché collaborato al successivo Underachevers Please Try Harder (2003). Quest’ultimo vanta anche un suo scatto rétro in copertina, due fanciulle che sembrano provenire da un
immaginario prettamente B&S. Eppure. Eppure
le due band condividono influenze e attitudini (il
pop soul sixties, il folk inglese, la Sarah Records),
un background letterario-cinematografico e tanto altro ancora.
È comprensibile a questo punto la reazione di
Tracyanne. Da ex-girlfriend del leader dei B&S,
a cui viene di continuo accomunata, non deve essere stato facile non far troppo caso ai continui
paragoni tra le due band e potersi poi scrollare di
dosso a un certo punto il confronto. Eppure l’eredità di nuovi Belle per i Camera Obscura non è
un demerito, anzi, se la cosa è stata guadagnata
sul campo. La cifra stilistica della band è infatti netta e personale oramai dal non temere confronti con l’altro più celebre gruppo scozzese.
Sembra lontano quel fatidico giorno del 1996,
quando Tracyanne e John Henderson facevano
il loro ingresso nel negozio di dischi del bassista
Gavin Dunbar per esporre un annuncio in cui
cercavano musicisti per ampliare il gruppo. Poi
ai tre si uniranno Gavin Skinbirg (chitarra), Lee
Thompson e Lindsay Boyd. La formazione realizza un paio di singoli e un EP (Rare UK Bird
nel ’99), fino ad arrivare al primo citato album
nel 2001 (un chamber pop etereo). Segue intanto anche l’appoggio di John Peel per il singolo
Eighties Fan. Poi il secondo disco nel 2003, Underachevers Please Try Harder (più personale e
strutturato) e la dipartita di John Henderson. Fino
alla consacrazione nel 2006 con Let’s Get Out
Of This Country dove liricità e compiutezza si
coniugano al meglio. Seguono intanto altri cambi
di formazione.
Ed arriviamo all’oggi con il signing per 4AD e
la pubblicazione di My Maudlin Career (in
recensioni). Indie pop, orchestrazioni, gusto jazzato e soprattutto i ritmi soul più accentuati che
in precedenza. La Campbell lo giudica “intenso e
piuttosto dark e dai testi più espliciti che in passato, che
documentano le mie esperienze più recenti”. Van Morrison, Al Green, Lou Reed, Paul Simon le
maggiori ispirazioni questa volta. Con il gruppo
più malinconico e intenso che mai. Siamo pronti
per farci spezzare il cuore anche a questo giro.
Teresa Greco
Turn On /
7
here we go magic
Malakai
Luke Temple in Graceland
Si torna a parlare di New York. Luke Temple,
cittadino acquisito della grande mela, prende il
faccione bonario di Paul Simon e lo travasa nel
quattro piste. Il risultato? Beh, “magico…”
Dalla città delle streghe a quella che non dorme mai.
Luke Temple, nativo di Salem, Massachusetts,
sito da tempo nella grande mela si candida, alla
luce del suo nuovo progetto Here We Go Magic,
come frizzante sorpresa della primavera in musica. Alcuni di voi lo conosceranno per via dei due
precedenti lavori, Hold A Match to a Gasoline
World del 2005 e Snowbeast del 2007, licenziati dalla Washington-iana – sede, Seattle - Mill
Pond Records, altri magari, in modo subliminale, grazie alla presenza di Make Right With You
nell’episodio “Un nuovo inizio” dalla terza serie
di Grey’s Anatomy. Non un novellino, insomma.
Valgano in tal senso le parole spese da personaggi
quali Ben Gibbard di Death Cab For Cutie(“La
voce di Luke Temple, da sola, è così dannatamente bella…una delle più carine della scena indie, m’inchino”) e
Sufjan Stevens (“Una delle voci più belle della musica
pop”), definizioni che da sole farebbero la gioia di
qualsiasi cartella stampa; metteteci poi i riconoscimenti da parte Uncut (“Suona come Neil Young
e Sufjan Stevens. Delicato e dolce”) e Rolling Stone
(“Le canzoni sono semplici, con delle melodie vicine a Simon & Garfunkel…il suo registro di voce così alto può
ricordare un giovane Graham Nash, passato attraverso la
lente deformante di Elliott Smith…ha sufficienti capaci8
/ Turn On
tà da surclassare uno come Conor Oberst”) e capirete
che Luke, oltre a cantarle le manda, senza volere,
pure a dire. Come avrete notato, tutti premono
sulle corde vocali del Nostro. Un registro tendente al confidenziale il suo, prossimo, nel debutto,
all’ugola gentile di Paul Simon (a conti fatti, la
sua maggior influenza) laddove eloquenti paiono
Make Right With You e Mr. Disgrace. Un folk d’altri
tempi. Nella seconda prova, il canovaccio assume
toni meno bucolici e la musica si fa più raffinata.
Di tanto in tanto lo spauracchio di un altro new
yorkese acquisito, Jeff Buckely, si manifesta sornione (sentite People Do e Serius e dite se non è così)
e l’aria di un suono ancora in divenire si palesa.
Come infatti, nel nuovo progetto Here We Go
Magic c’è l’incontro “magico” tra nuovo suono di
New York (Animal Collettive e Yeasayerin primis)
e palpito negroide. Un gioco di specchi, poiché
il rimando a Paul Simon - sempre e comunque
- stavolta ripiega nei solchi etnici di Graceland.
Tutto da solo - eccetto una traccia, l’ultima del
disco - se non per il quattro piste e le mura del
suo appartamento, tramutatosi in studio di registrazione per due mesi. Ora il suono ha groove
e pulsa, nella vertiginosa Tunnelvision, dalla prima all’ultima nota. Pensate, potete pure ballarlo!
L’avreste mai detto?!
Gianni Avella
Warriors, come out to play?
Un immaginario variegato, tra psych rock acido,
roots reggae e garage, con attitudine al collage,
divertimento e autoironia.
Commentare pubblicamente con divertimento le
recensioni del proprio disco può apparire inconsueto. E’ quanto si può leggere sul myspace dei
bristoliani Malakai, il cui album d’esordio - Ugly
Side Of Love – è prodotto da Geoff Barrow
(Portishead) per la sua label Invada. Quello che
lì ci ha incuriosito sono le considerazioni anche
ironiche su come la stampa finisca per interpretare intenzioni e influenze; la pagina si dimostra
allora una lettura anche surreale piuttosto rivelatoria di certi meccanismi bilaterali di comunicazione. Per dire, si chiedono dove alcuni abbiano
sentito il dubstep nell’album, come risulti scontato
citare il trip hop associato a Barrow, e via di questo passo. L’incipit la dice lunga sulle intenzioni
del gruppo in questione, formato essenzialmente
dal cantante e songwriter Studio-Gee e dal musicista Scott, rispettivamente un dj e un MC che
hanno unito le loro attività. E’ Gee comunque a
mostrarsi come portavoce, facendo pensare erroneamente a un solista, mentre invece di collettivo
trattasi, legato anche alla fervida scena artistica di
Bristol. L’incontro con Barrow ha fatto sì poi che
il progetto musicale si concretizzasse. Per fare un
paragone immediato e generale sulla produzione,
ci si potrebbe riallacciare a quanto ha realizzato negli ultimi anni uno come Danger Mouse,
Gnarls Barkley inclusi. Ecco allora che la cifra
stilistica del progetto Malakai si costruisce intorno a uno psych rock sixties piuttosto acido, venato
di roots reggae, misto a garage di marca Nuggets,
psichedelia rivisitata alla maniera di un Barrett
hip hop, più alcuni influssi di marca portisheadiana (come potevano mancare dato il contesto?). E
ancora qua e là coloriture funkadeliche e black.
Il mood come si intuisce, è quello collagistico alla
maniera di uno Zappa ’70, una propensione diremmo oggi verso un postmoderno cut up; l’ossatura per alcuni brani è costituita essenzialmente
da basi e samples su cui via via si vengono a costruire e stratificare i pezzi. Beach Boys per la
parte melodica, Zombies, Who, Kinks, Love.
Ma anche il cantato del nume giamaicano Horace Andy e di Dose One. Un che di kraut dub
nell’unico pezzo scritto con Geoff Barrow, Only
For You. E ancora gli omaggi allo street combact
di un film come I guerrieri della notte di Walter Hill (1979) campionato nell’opener Warriors,
un garage rock acido. L’autoironia del progetto è
evidente, il suo merito consiste nell’aver reso unitario un album così vario, che sfugge alle catalogazioni rimanendo piuttosto ispirato.
teresa greco
Turn On /
9
Mulatu Astatke
Un altro mondo è possibile
“Ho sempre desiderato inserire strumenti della mia cultura d’origine nell’Ethio-jazz,
meglio se suonando musica occidentale in dodici toni. Sperimenteremo, perché questi strumentisti sono grandiosi e credo
che ne verrà fuori un disco splendido.” Così si esprimeva la leggenda del jazz - non solo africano: mondiale - Mulatu Astatke prima di entrare in studio
assieme agli Heliocentrics. In retrospettiva,
possiamo affermare che sapeva bene a cosa stesse
andando incontro e idem la formazione britannica. Un po’ meno noi, che, considerati gli esiti
10
/ Turn On
essenzialmente
mediocri dei due
precedenti
tomi
della collana Inspiration Information, attendevamo
l’album al varco con pronto in mano un classico
“non c’è due senza tre”. E invece niente, perché
di rado in anni recenti smentita discografica è
stata per noi più piacevole di quest’ora generosa
che ci ha dapprima esaltato e poi - come sempre
dovrebbe accadere - spinto ad approfondire.
Lanciato dalla serie di album Ethiopiques, il nome
del percussionista e orchestratore etiope ha rag-
giunto un apice di successo più diffuso con due
memorabili esibizioni tenute nel giugno 2008 a
Londra e Glastonbury, capaci di mettere d’accordo gli intellettuali e quelli che amano sudare, chi
insegue lo stimolo cerebrale e chi predilige la fisicità. Impresa non facile, in passato riuscita solo
a calibri epocali come - giusto per citare i primi
che vengono in mente - Can e Talking Heads,
Art Ensemble Of Chicago e Miles Davis.
Gente che travalicava etichette e distinzioni ferree, scavava una nicchia storica di propria pertinenza dalla quale indicava vie che sarebbero stati
in legioni a percorrere. Ora: affermare lo stesso
per questa collaborazione è molto probabilmente azzardato, e la causa della cautela è l’attuale
panorama assurdamente frammentario e confuso, nondimeno ci sentiamo di scommettere su un
album che resterà negli anni a venire. E non solo
perché si tratta del primo in studio di Mulatu da
due decenni in qua. È perché in esso si respirano intuito e talento, arguzia e genuinità. Perché
ti piomba addosso una Musica splendida che fa
della comunicazione un credo e dell’abbattere le
barriere un vanto; che non si ripiega su se stessa
ma scuote, induce a pensare e frattanto riempie
di gioia.
E dire che il progetto ha preso forma quasi per
caso: lo scorso anno, in occasione di una serata al
londinese Cargo, gli Heliocentrics funsero da lussuosa backing band per Mulatu, sciorinando la
perfetta conoscenza di numerosi classici del loro
(e nostro…) eroe. Qualcosa deve essere poi scattato, giacché il Nostro sul volo che lo riportava ad
Addis Abeba custodiva in valigia un cd colmo di
idee e “grooves” appositamente incisi con Malcom Catto e sodali. Nella rilassante atmosfera di
casa, ha vergato le partiture di tastiere e vibrafono
e s’è ingegnato al meglio per inserire sonorità che
non avessero sapore alcuno di cartolina. Integrati
sapientemente i contributi vocali e strumentali di
suoi conterranei, si è poi deciso a ritornare nella
capitale inglese. All’inizio dello scorso settembre,
tra le mura dell’Eliocentrico - e analogico: si sen-
te - Quatermass Studio, i due mondi si sono ulteriormente mescolati durante una settimana di
registrazioni e aggiungendo gli strumenti tradizionali di Yezina e Mesafnit Nagash e Dawit
Gebreab. Le parti di fiati sono state invece poste
su carta da Joel Yennior della bostoniana Either Orchestra, a ennesima sottolineatura di
come la grandezza di questo disco risieda nel coniugare antico e moderno senza sforzo, facendo
leva sulla naturalezza di chi possiede idee chiare
e sa come tradurle in realtà. Sulla manna che ne
è derivata ci siamo dilungati sullo scorso numero
di Sentireascoltare in una recensione dai toni entusiastici che confermiamo in pieno.
In questa sede, ci preme rilevare come il valore di
Inspiration Information vol. 3 sia addirittura cresciuto alla distanza, in ciò confermando la sensazione data dai primi ascolti. Un lavoro stratificato e
adatto alla fruizione attenta, ma che non esclude
l’impatto viscerale; nel quale anime e background
degli artefici si fondono in modo indistinguibile.
Lo stesso dicasi per la differenza - annullata lei e
annichiliti noi - tra brani di fresca scrittura e standard: Addis Black Widow coniuga il funk classico
e quello modernista, Blue Nile stende ponti tra il
blues e accenni bristoliani, Live From Tigre Lounge
fonde il senso di New York per un jazz intellettuale senza spocchia con le origini terzomondiste. E
non sono che tre titoli pescati a caso tra quattordici. Abbiamo aperto con una dichiarazione di
Mulatu e con le parole degli Heliocentrics vogliamo chiudere: “Non abbiamo cercato di rifare un disco
in stile Ethiopiques: ci interessava piuttosto far collidere i
nostri mondi sonori, completarli con influenze ed esperienze
diverse in uno vero scambio di idee. Qualcosa di nuovo che
avesse radici nel vecchio.” Definizione più indovinata
per Inspiration Information vol. 3 non poteva esserci
e, ve lo garantiamo, una volta tanto non si tratta
di presunzione. È “solo” la forza di sapere dove
stai andando senza starci troppo a pensare su.
Giancarlo Turra
Turn On /
11
scara. Gilles vive 3 mesi dell’anno in Colombia e
poi torna a Nantes. Sam, lui, vive sempre a Nantes. Si suona poco quindi, ma quando si suona,
c’è sempre un’eccitazione particolare che genera
l’urgenza della nostra musica.
passe montagne
oh, mio satana
In barba alla lontananza che ora li separa geograficamente Gilles Montaufray (chitarra, residenza
ufficiale Colombia), Samuel Cochetel (chitarra,
Francia) e Julien Fernandez (batteria, Italia) hanno avuto il coraggio d’asciugare ancor più una
formula che, nel debutto Long Play (Ruminance, 2006) era già breve e ruvida. E’ la perfetta occasione per riparlare di loro, Oh My Satan; un
nuovo e cocente assalto all’arma bianca ancor
più secco e bastardo, ma che nasconde anche
qualcosa di più, una autentica filosofia, non un
semplice modo per guadagnar tempo. Il retroterra è sempre riconoscibilmente math-noise, ma gli
innesti, i riferimenti, i passaggi strumentali sono lì
a rimandare a dimensioni altre rispetto agli usuali
scenari di genere. In particolare, alcuni momenti
sembrano evidenziare il legame – mai troppo nascosto – tra il rock deturpatamente noise e quello
più hard-oriented dei seventies. Pensare a certi
momenti più (ehm) pomposi degli Shellac che
non invecchiano facilmente non è né inutile, né
azzardato.
All’epoca del debutto i tre amavano sottolineare
12
/ Turn On
come il gruppo suona senza esistere ed esiste senza suonare. Era il 2004. Ora è come se il chiasma citato si
perpetuasse. Come, cosa e quando ce lo ha spiegato il batterista Julien Fernandez, italiano d’adozione nonché titolare dell’etichetta che mette il
sigillo a Oh My Satan, la African Tape.
Julien vuoi raccontarci le evoluzioni del
gruppo dopo l’uscita di Long Play? Sono
passati quasi tre anni e sappiamo che siete
sparsi per il mondo...
Quando è uscito Long Play, era già un periodo
strano per noi. Il gruppo si era appena formato
come trio perché all’inizio Passe Montagne era
un duo formato da me e Gilles. Sam è arrivato
un po’ così, all’ultimo momento e suona su qualche pezzo di Long Play e Extended Play. Io
avevo già un mezzo piede in Italia. Venivo spesso
a Pescara e avevo la testa un po’ altrove. In quel
momento volevo fare una pausa, prendere un po’
di distanza dalla musica e crearmi una nuova vita
qui in Italia. Adesso, la situazione è sempre strana comunque. Io sono il 90% del tempo a Pe-
E di urgenza ce n’è molta visto che bruciate in 20 minuti i 12 pezzi dell’album…
un’urgenza quasi punk, direi. Siete molto
essenziali, sbaglio?
Il termine essenziali mi sembra giusto. Generalmente passiamo più tempo a togliere parti che
ad aggiungerne. Vogliamo arrivare all’essenza
dell’idea del pezzo. Senza farne troppo. Semplicemente limitare il pezzo a quello che è. Niente di più. Poi, mi chiedo sempre: ma perché i
gruppi perdono tempo a ripetere diverse volte
i riffs? Hanno paura di non essere sentiti bene?
A me piace l’idea di una musica che si genera
e subito, si mangia, si automutila. Una musica
cannibale, pulsionale, immediata. Possiamo dire
urgenza Punk, si…proprio urgenza Punk.
Allora diciamo che appartenete di diritto
alla scena math, anche se ne fornite una
prova più essiccata, scarna ed esplosiva rispetto al genere…
La scena math…Il termine math mi ha sempre
fatto un po’ ridere perché da un aria un po’ intellettuale e superiore alla musica rock che secondo
me è solo una musica viscerale, pulsionale e meccanica. Ho anche notato che fa molto figo durante le serate tra amici: Ascolto math rock o faccio
musica matematica…ah ah! va di moda diciamo!
In fondo, non credo che la musica rock di oggi sia
più math di quella di Elvis Presley ai suoi tempi.
La musica cerca solo soluzioni alla noia e cerca di
evolvere. Comunque, è solo il mio parere. So che
questo termine math è solo un modo per classificare un genere. Per tornare a Passe Montagne
direi che è semplicemente un gruppo rock che fa
la scelta di concentrare le cose all’estremo. Credo
che la nostra musica sia, in fondo, una cosa molto
semplice se prendi il tempo di ascoltare bene che
cosa succede. Il disco da questa idea di esplosione
forse perché tutto va velocemente e ci sono tanti
cambiamenti in tempi molto stretti. Ma alla fine,
noi suoniamo così per una ragione unica: cercare di non annoiarsi suonando senza cadere nella
performance tecnica.
Ok...l’idea di “math band” vi sta stretta e
ciò si deduce pure all’ascolto del disco...
emergono riferimenti oltre che al noise rock dei primi Novanta, anche quelli
al rock pesante dei Settanta...insomma,
guardate al futuro ma avete i piedi ben saldi nel passato, sbaglio?
Le referenze Sessanta/Settanta sono molto presenti nel disco. Direi che a volte usiamo degli
stereotipi della musica hard rock o garage degli
anni Sessanta e Settanta cercando di inserirli in
un discorso contemporaneo, come una sorta di
riciclaggio. Tutto ciò crea un atmosfera che trovo
molto divertente e controcorrente. Forse più che
guardare al futuro, guardiamo semplicemente altrove.
Pubblica la tua etichetta African Tape che
ha già dato alle stampe l’ottimo nuovo album di Three Second Kiss e l’esordio di
Aucan…parlacene…
Ci sembrava naturale pubblicare il disco su Africantape perché l’identità del disco riflette quella
dell’etichetta. Africantape è molto giovane e poco
conosciuta, ma poco a poco cresce, soprattutto in
Europa e in Giappone. È difficile per me parlarne in realtà; diciamo che la concepisco come una
sorta di famiglia, di collettivo di persone, musicisti, artisti che guardano nella stessa direzione ma
con punti di vista diversi. Non saprei cosa dire di
più, tranne invitare i lettori a visitare il nostro sito
africantape.com, ascoltare, documentarsi, andare ai concerti dei nostri gruppi ed anche ordinare
dischi!
Stefano Pifferi
Turn On /
13
© saverio autellitano
adriano modica
Quello che (non) grida
- Stefano Solventi
Tra le “nuove proposte” che periodicamente si staccano dai formicolanti margini del rock italiano, quella di
Adriano Modica è tra le più sconcertanti. Una poetica di tuffi al cuore e cervello in subbuglio, di nostalgie marinate nell’incubo della modernità, di memorie irrisolte che germogliano incantevoli angosce. Insomma: un formidabile casino. Per capirci qualcosa, lo abbiamo intervistato.
C
alabrese di Reggio, fatidica classe ‘77, Adriano Modica sembrerebbe un attore, visto il
physique du role e la carriera cinematografica e
televisiva intrapresa subito dopo il diploma conseguito all’Accademia di Arte Drammatica nel
2000. Qualcosa però covava nell’ombra della famosa cameretta, dove fin da ragazzino Adriano
ha dato sfogo e smerigliato la passione per le sette
note, imparando a suonare chitarra, pianoforte,
batteria, basso e flauto traverso.
14
/ Tune In
Finché nel 2001 non licenziò Iano, un demo
casalingo che provocò buone vibrazioni sulle testate più occhiute. In qualche modo, la breccia
era ormai aperta. Quello stesso anno compone le
musiche di uno spettacolo teatrale (Ingranaggi
di Bernardo Migliaccio Spina), quindi - nel 2003
- allestisce La Terza Mano, un quartetto col
quale inizia a dare vita alle proprie (stra)visioni.
La cifra è il rock, ma stranito e sperso laddove lo
portano l’estro, le allucinazioni, le rimembranze,
le vampe e gli spasmi di una archeologia emozionale senza riguardo né remore.
Ciò porterà ad Annanna (2005), lavoro che rimarrà inedito fino a dicembre 2008 (recensione
nel n° 52 di SA), primo capitolo di una trilogia
che proseguì con Il Fantasma Ha Paura del
2007 e si concluderà con La Sedia, rispettivamente dischi “di stoffa”, “di pietra” e “di legno”,
secondo una simbologia tattile legata alle fasi della individuazione, della crescita, del farsi del sé.
Nel frattempo Adriano suona con gli Ulan Bator, con Marco Parente, cogli Addamanera,
coi Jennifer Gentle. È complice attivo in uno
dei progetti più eccitanti che ci sia capitato di sentire recentemente, i Mimes Of Wine di Laura
Loriga.
Questo ragazzo di oltre trentanni è, insomma,
una di quelle cose che ti auguri per ravvivare la
scena, da troppo tempo - da sempre? - affamata di situazioni profonde, forti, significative. Alla
luce di tutto ciò, per noi di SA intervistarlo era
più o meno un dovere.
Precedenza alle news: come procede la lavorazione de La Sedia? Hai già un’idea di
quando uscirà?
I lavori procedono, stiamo in questa fase lavorando alle apparecchiature per registrarlo in casa e
soprattutto alla vecchia, cioè completamente in
analogico. Non voglio più vedere un computer se
non per il campo minato e il tetris; al limite un
Commodore 64 per una rimpatriata con international soccer. Mi mancano i bei tempi dell’audiocassetta, il calore umano del nastro, l’oggetto
fisico. Avrò un ospite speciale ed insolito ma non
so dirti ancora quando uscirà. Per il momento
questo è quanto.
Al momento della pubblicazione de Il Fantasma Ha Paura - di fatto un capitolo due
in assenza di capitolo uno - sono rimasto
parecchio spiazzato... Come è successo
che Annanna - disco splendido tra l’altro
- sia rimasto senza una distribuzione ufficiale?
Annanna l’ho registrato quando ancora fare il
disco era l’unico motivo per farlo. Non ho mai
cercato più di tanto dei riscontri. Quando ho deciso di fare le cose con un criterio più da azienda,
cercare un confronto con un pubblico e trovato un’etichetta, i tempi erano già maturi per Il
fantasma ha paura, così abbiamo deciso di
pubblicare la cosa che mi rappresentava di più
in quel momento e ristampare Annanna in un
secondo momento. Una specie di citazione beatlesiana coatta...
Debuttare con una trilogia in fieri in
quest’epoca di dischi e discografie sempre più atomizzate, significa: puntare
artisticamente in alto; togliersi subito il
pensiero del suicidio commerciale; regolare i conti con l’ossessione di una vita...
Cos’altro?
Probabilmente cercare di mettere ordine in questo casino.
In tutto ciò cosa ci azzecca - come direbbe
quel tale - la carriera di attore?
È semplicemente una cosa che ha fatto una delle
persone che vivono dentro di me, ognuno di loro
ha la sua vita, le sue passioni.
Prevedi di ripetere l’esperienza delle colonne sonore per cinema o teatro in futuro?
Sarei pronto a ripetere l’esperienza solo nel caso
si dovesse verificare di nuovo la sinergia magica
con l’altra parte.
Guardando all’attualità, credi che in Italia
esista un movimento, una scena (seppure
carbonara o in embrione), un manipolo
di cani sciolti visionari, qualcosa insomma in cui potresti oggi o domani trovarti
annoverato?
Tune In /
15
A proposito, qui in redazione siamo rimasti colpiti dall’esordio di Laura Loriga aka
Mimes Of Wine, che tu conosci bene... Ci
aspettiamo molto da lei. Ci stiamo sbagliando?
Laura è brava. Ho accettato di partecipare al suo
lavoro perché mi piaceva molto il suo gusto nello
scrivere. Nelle sue musiche ho sentito da subito
un mondo proprio.
Ecco, Laura per esempio ha scelto di
esprimersi in inglese, che tra l’altro padroneggia benissimo. Lo so, quella della
lingua per il rock made in Italy è una vecchia diatriba, ma tu che dici?
Io dico innanzi tutto che ognuno è libero di fare
quello che gli va, lo diceva un grande che all’odio
e all’ignoranza preferì la morte. A me piace l’idea
di esprimermi con i miei mezzi, nella mia lingua
ed è una
cosa questa che mi piace vedere anche negli altri. Dipende da quello che uno vuole fare, dove
vuole arrivare e soprattutto da dove vuole partire.
Quello che non mi piace è l’esterofilia maniacale,
quando cioè la scelta di
un’altra lingua diventa una malattia da complessati o da incapaci.
Quanto devi alla scuola romana dei De
Gregori e del primissimo Venditti, quanto alla narrazione rock dei Massimo Volume, alle febbrili geremiadi del Ferretti e
alle trasfigurazioni poetiche di un Marco
Parente?
Ti dico con sincerità che devo qualcosa a tutta
la musica che ho ascoltato. Nello specifico Theorius Campus (album del 1972 a firma De Gregori
e Venditti, ndi) l’ho scoperto quando un mio amico
16
/ Tune In
mi ha detto che sentiva molto di quel disco nei
miei pezzi. I Massimo Volume li adoro, i CSI
li ho ascoltati molto e con Marco Parente ci suono dopo esserne stato fan. Sono sicuramente cose
che ho assimilato.
Credi di rappresentare un possibile prototipo di cantautorato per il futuro prossimo?
Direi piuttosto che sto cercando di lavorare all’essere un buon passato per il futuro prossimo.
Nei La Terza Mano, che potremmo definire la tua band, ti occupi di chitarra e
tastiere. Però sei stato anche batterista,
pianista, bassista... Il fatto di padroneggiare tanti strumenti ti porta a concepire
i pezzi a trecentosessanta gradi o per l’arrangiamento preferisci delegare?
Mi è sempre piaciuto curare per intero i miei album e questa malattia sta degenerando al punto che come ti dicevo prima il prossimo lo voglio
anche registrare. Per gli album passati ho sempre avuto un tecnico di riferimento ma una delle
condizioni che mi sono imposto è che le prossime
orecchie amiche dovranno essere attaccate a teste
non fissate e che magari non sanno neanche cos’è
un microfono o una chitarra. Riguardo il gruppo
negli ultimi tempi si è affiatato molto così abbiamo lavorato insieme ai brani nuovi, cosa questa
che ha dato ai brani un po’ di respiro e a me la
sensazione di freschezza. Si tratta di grandi musicisti ma soprattutto di grandi persone che hanno
capito quello che voglio fare. Sono Marco, Coci
e Bruno.
bientazioni sonore. Grumi mnemonici
irrisolti, che non trovano soluzione nel
divenire individuale. E che pure sono producono, fanno - l’individuo. Insomma,
sembri voler dire: siamo i nostri mostri.
Sto delirando?
Si, stai delirando. Dunque direi che ti è arrivato il
messaggio e mi fa piacere.
In una vecchia intervista hai dichiarato di
voler partecipare a Sanremo. Non m’importa se eri più serio o faceto, mi preme
semmai sapere: ci hai veramente provato?
Nel caso, non credi sia opportuno aspettare un’età - anagrafica e professionale più consona, tipo quella degli Afterhours?
La domanda, ovviamente, è oziosa...
Scusa se ti correggo, ho detto che avrei voluto
presentarlo e per quello sinceramente non mi
sento ancora pronto.
Per i canoni nostrani - e tanto per rimanere nel gergo festivaliero - sei quel che si
dice una “nuova proposta”. A 31 anni suonati (ehm...). Non te ne faccio certo una
colpa, da noi le cose vanno così. Diversamente nei paesi anglosassoni i runners in
genere esplodono a 20 anni (penso ad un
Patrick
Wolf o a Devendra Banhart). Sana pigrizia mediterranea, la nostra?
No, pigrizia non direi proprio, è semplicemente
che ho iniziato tardi perché prima mi occupavo
di altro.
Poi preferisco fare pochi dischi ma buoni, cioè
quelli che voglio fare perché ho qualcosa da dire
e non sempre ho qualcosa da dire. In quel caso
preferisco stare zitto e ascoltare. Penso anche a
che tipo di disco avrei
potuto fare a 20 anni e penso che ho fatto bene
a non farlo. Evidentemente ho sviluppato il buon
senso prima della vena compositiva.
Chiuderei con una curiosità: cosa succede, una volta conclusa la trilogia?
Devo ancora decidere se mi sparo, se smetto semplicemente o se inizio il decalogo.
Del progetto John Merrick - nome ispirato alla straziante vicenda del celebre Elephant Man - cosa puoi dirmi?
È un progetto che si muove lentamente e soprattutto per il semplice gusto di fare musica. Nessuna mira espansionistica.
Sono pieni di mostri i tuoi testi e le am-
© saverio autellitano
Cani sciolti? Mi piace quest’immagine. Direi che
mi ritrovo a mio agio nel gruppo di quelli che non
gridano e cercano di andare piano, sano e lontano il giusto.
Tune In /
17
Animal
collective
ALL ROADS LEAD TO HEAVEN
- Luca Collepiccolo
“R
agazzi vi faccio partecipi di questa cosa,
sto registrando questa intervista su un
vecchio nastro dei Butthole Surfers...”[Sorrisi]
The Geologist prende la palla al balzo e dice:
“sai che è un piacere tornare ai vecchi mixtape concepiti per l’autoradio? Ultimamente ho rimesso mano su dei vecchi nastri dei
Pavement...”Conrad Deaken ha fatto le valigie,
non sarà più il chitarrista degli Animal Collective, il gruppo di adozione newyorkese non rimedia alla dipartita, sarà Avey Tare a coprire parzialmente il ruolo vacante. Il caos è lontano, così
come le danze della pioggia in ‘crosta’ moderna
di Here Comes The Indian. È una tecnologia
di basso profilo quella che informa Merryweather Post Pavillon, ultimo cimento su Domino e forse uno dei primi grandi dischi di questo
2009. Qualora sia lecito parlare di grandi dischi
in questo decennio ed in questo secolo, sapete
come vanno le cose...Cambia l’estetica ma non
18
/ Tune In
la forma, è il pop la finalità, canzoni con un
bridge ed un ritornello, làddove fosse possibile
ossessivo, vedi alla voce My Girls.
Un disco che risente anche della benevola influenza di quel piccolo miracolo chiamato Person Pitch, edito da Paw Tracks e concepito
nella sua disordinata cameretta in quel di Williamsburg da Panda Bear. È già in quel disco che
si schiude la valvola creativa del complesso, un
sommo anticipo, pur se ideato da un terzo dei
cospiratori in azione. Più che parlare di addizione è bene soffermarsi sugli estremi, attratti da
una filosofia che prevede agli antipodi reliquie
sixties ed ombre da chimico dancefloor gli Animal Collective non sono altro che nuovi depositari di un malandrino gioco andato in scena a
più riprese negli ultimi venti anni. Madchester,
con gli eroi locali a rimpinzarsi di ecstasy sulle
note del tridimensionale movimento acid house. Od anche i beffardi autori breakcore – da
Venetian Snares in giù – che in un’altra vita si
lasciavano andare nel circle pit al concerto crust
punk di turno. Uno scambio che prevede un’appartenza, un’identità storicizzata.
Se in Europa le camere di dialogo tra rock estremo e visionario – Inghilterra in primis ovviamente, mettete in relazione Crass, Ozric Tentacles e la cultura dei rave party – sono state da
sempre trafficate a spron battuto, il fenomeno
negli States è forse meno radicato e radicalizzato. Tentativi ve ne sono stati, ma sempre piuttosto timidi, laddove era semplice accostare indie, post-rock e l’esacerbante termine IDM. È
stata probabilmente la DFA di James Murphy
a rendere meno ovvia l’associazione, portando
alcuni protagonisti della tarda scena post punk
a cimentarsi con la musica da ballo, seppure
attraverso dinamiche diverse. Perchése in Juan
MacLean (ex chitarra dei Six Fingers Satellite,
uno dei gruppi più alieni ad esser passato da
casa Sub Pop) il ritmo è scandito, manifestando
anche un certo gusto per italo disco ed house, è
con i Black Dice che si compie il vero miracolo.
Un altro trio di Brooklyn, anch’esso adottivo. E
da tempo immemore legato alle stesse sorti degli
Animal Collective.
Lo stesso van, la stima reciproca, pur nella convinzione di muoversi ai lati opposti di un comune spettro. E come accaduto per i Black Dice di
Repo, che definiscono in maniera ineluttabile
il loro stato dell’arte - convogliando se possibile
tutte le musiche ritmiche contemporanee – anche gli Animal Collective verranno ricordati per
il loro strepitoso slancio tecnologico, laddove i
sospiri acustici sono sostituiti da un robotico e
consenziente ritmo cardiaco.
Torniamo alla cronaca. Concerto che fa registrare il tutto esaurito quello dell’Auditorium in
Roma, il gruppo ha il vento in poppa. Per loro
è l’esordio europeo in un luogo che abbia le fattezze di un vero e proprio teatro. Sarà anche la
prima volta per molti presenti, che del vizioso
circolo lisergico del gruppo avevano sentito par-
lare, distrattamente. Sono cambiate molte cose.
Gli Animal Collective da beniamini di una scena
underground divengono punto focale di un macrocosmo indipendente in disfacimento. Suonano di fronte ad una media di 1000 persone negli
States e sono tra i primi ad ammettere che il
viaggio in Europa non sia poi così conveniente,
d’accordo per il cambio, ma il loro cachet negli
States è sensibilmente più alto...
Voglio focalizzare la mi attenzione sul
vostro suono, che oggi è più indirizzato
verso una certa elettronica. Volevo comprendere quale fosse il processo che vi ha
portato a realizzare l’ultimo album, partendo dalle digressioni chitarristiche psichedeliche e dal sound percussivo che in
qualche maniera avevano contraddistinto il vostro suono alle origini.
Il dettaglio più importante credo sia nell’attenzione riservata ai bassi, ad una forma che appunto utilizzasse una forte componente ritmica.
Ovviamente l’abbandono del nostro chitarrista
ci ha spinto a scrivere e a pensare in maniera
diversa, ed onestamente abbiamo tutti accolto
con grande entusiasmo questo tipo di cambiamento. L’interesse suscitato in noi dalla musica
techno, dall’ elettronica in salsa lo-fi e da una
certa idea di ‘campionamento hanno accelerato
questo processo.
In tutto questo diviene più difficile riprodurre la vostra musica dal vivo
Questo dipende dalla percezione che il pubblico
ha dei nostri concerti dal vivo, dal loro stesso
desiderio di vedere riprodotta esattamente quel
tipo di composizione. Abbiamo un’idea piuttosto chiara di come debbano suonare i nostri pezzi. Ovviamente l’esperienza live va ad alterare
certi processi generati in studio, nel nostro caso
si tratta di aggiungere, piuttosto che di sottrarre. In tutto questo evitiamo anche di abusare di
troppi suoni pre-registrati.
Tune In /
19
Com’è cambiata la percezione del pubblico nei vostri confronti?
Sicuramente possiamo dirti che il nostro pubblico è cresciuto progressivamente, si è ampliato
il cerchio dei nostri ascoltatori. E ci sono molte
persone presenti sin dalla prima ora che hanno
apprezzato tutti i nostri piccoli cambiamenti stilistici.
C’è anche una percentuale minore di sostenitori
che ci ha abbandonati lungo la strada, magari
non abbracciando completamente la nostra attrazione verso sonorità elettroniche.
Ma il nostro desiderio non è mai stato quello di
realizzare dischi rivolti ad una piccola nicchia.
Un altro dato importante rappresenta l’età dei
nostri sostenitori, ora sono mediamente più giovani, ed anche questo è un processo maturato
nel corso degli anni.
Come del resto possiamo affermare l’equilibrio
tra i sessi, dato che ai nostri concerti il numero
delle ragazze presenti sta quasi per pareggiare
quello dei ragazzi.
Ci sono stati cambi attitudinali? Spesso,
nel periodo medio della vostra carriera,
20
/ Tune In
siete stati associati al movimento neofolk...
Abbiamo iniziato a ricevere maggiori attenzioni
dopo Sung Tones, che era un album che effettivamente spostava gli equilibri verso quel tipo di
sonorità, quindi fu anche più semplice associarci
a quel movimento. Era cambiato anche il tenore
delle formazioni con cui solitamente giravamo,
per dire, agli esordi abbiamo spesso diviso il palco con gruppi più ‘noise’, come i Black Dice ad
esempio. Ma non ci piace pensare alla musica in
termini esclusivi. È chiaro, esistono una miriade
di micro scene, e ci sono persone non necessariamente disposte ad accettare il cambiamento,
soprattutto quando inizi ad ottenere determinati riscontri. Ma in questo caso entriamo davvero
nella sfera personale. Il nostro obiettivo, sin dagli inizi, è stato quello di raggiungere il maggior
numero di persone, senza ovviamente cedere ad
alcun tipo di compromesso. Non abbiamo mai
chiuso ad altri suoni o ad altre idee per finalizzare il nostro programma. Non ci siamo mai
chiusi rispetto alla possibilità di crescere pur
muovendo la nostra ispirazione.
L’altra influenza determinante sul disco
è l’approccio vocale, che oltre a rimandare ai Beach Boys suggerisce paralleli con
i gruppi vocali femminili dei sixties e le
produzioni di Phil Spector...
Per questo disco abbiamo parlato molto degli arrangiamenti vocali, quindi si è trattato di un pensiero conscio. Non abbiamo del resto mai fatto
mistero di amare i Beach Boys od i Beatles. Non
volevamo spingerci oltre come su alcuni album
del passato, utilizzando le stesse armonie all’unisono con più persone atte a ripetere la stessa
frase. Abbiamo invece riflettuto a lungo sul contrappunto, sull’utilizzo di voci in sottofondo che
potessero andare in un’altra direzione, al fine di
ottenere un effetto meno immediato e scontato.
Non volevamo ripeterci in questo senso. Il risultato da ottenere su disco nasceva proprio dalla
contrapposizione di quello stile vocale molto anni
sessanta, affiancato ad una produzione in cui ci
fosse una presenza importante della componente
elettronica, anche se in ottica meno hi-tech, dato
che abbiamo lavorato su campionatori molto basici (ed economici) e molti dei suoni che ascolti su
disco sono stati proprio ricreati in studio, da fonti
quindi autentiche. C’è poi l’influenza del dub, il
modo incredibile da parte dei produttori giamaicani di gestire le proprie risorse. Siamo dei grandi
ammiratori di gente come King Tubby, invidiamo la sua capacità di ricreare dei suoni anche
con mezzi di autentica fortuna.
Non pensate che la musica odierna abbia
un impatto più timido sugli ascoltatori?
È anche cambiato il modo di fruire e le
cose accadono spesso in maniera più precipitosa...
Certo, non spetta propriamente a noi determinare la bontà di un disco, in termini di storia. È un
po’ prematuro eleggere i classici contemporanei
e questo è un tipo di atteggiamento che ha conosciuto le sue conseguenze estreme con l’avvento di internet, dove le informazioni viaggiano in
maniera estremamente veloce. Bisogna attendere
per poter storicizzare anche un singolo movimento, non puoi decidere nell’immediato che tipo di
impatto potrà avere quel disco sull’evoluzione
della musica. I ragazzi di oggi non hanno le nostre stesse reazioni, se un disco come Nevermind
ha in qualche maniera contribuito a plasmare la
nostra generazione, magari potrebbe rappresentare un ascolto qualsiasi ai giorni nostri.
Sta cambiando anche il modo di approcciarsi alla musica, penso anche alla miriade di blog che quotidianamente ci propongono dischi rari o misconosciuti in
libero downloading...
Definitivamente, sono le stesse cose che ci toccano da vicini. Magari proprio attraverso quei blog
arriviamo a mettere ‘le mani’ su di un disco che
alla fine finirà con l’influenzare la nostra musica.
Personalmente preferiamo acquistare un vinile
nei negozi appositi, del resto è un atteggiamento
che ci ha sempre distinti, sin da quando ai tempi
della high school ci ritrovavamo alla mostra del
disco e ci confrontavamo coi nostri rivenditori di
fiducia. Però è ovvio realizzare quali sono i meccanismi che oggi portano a questo tipo di ricerca,
c’è una miriada di musica là fuori, ottenibile gratuitamente con un click. Non credo che oggi la
musica sia divenuta più ‘popolare’, credo invece
che siamo in una fase di produzione massificata.
Tutti possono arrivare ad incidere con estrema
semplicità oggi. Se riflettiamo anche sulle modalità in cui la gente interagisce, notiamo anche
uno svilimento dell’aspetto sociale. Non penso
che internet sia un mezzo necessariamente democratico. Tutta la marea di informazioni condivise, i forum, i message board, spesso rendono
i contenuti più impersonali. È semplice dettare
legge in queste condizioni, quando nessuno ci
mette la faccia. Sono condizioni che sono cambiate drasticamente. Le opinioni volano, non
vengono firmate e sottoscritte, e spesso è facile
dubitare della natura di questi stessi interventi.
Personalmente non ce ne curiamo troppo.
Tune In /
21
Shinkei
Lo Spazio del Suono/3
- Sara Bracco e Vincenzo Santarcangelo
Legata intimamente alla percezione sonora, ai movimenti sull’orlo dell’udibilità, agli spazi
e alla punteggiatura, la ricerca di David Sani in arte Shinkei pare giocare con fonti audio
insolite (il computer brainwaves simulato, incisioni di segnali biologici, o la neve che precipita su un microfono) legandolo o liberandolo alla sperimentazione; da ascoltare in cuffia o
in uno spazio scuro e in quiete.
22
/ Tune In
N
el 2000 David Sani fonda Microsuoni,
web shop attenta alle uscite e alla distribuzione di contemporary minimal music, lowercase, sound_art e digital glitch mentre,
dopo l’incontro con il compositore Luigi Turra
nel 2008, nasce Koyuki, etichetta che vedremo
affezionata alle pubblicazioni e alle composizioni
più minimali. L’esordio di Binaural Beats con
l’artista Philip Lemieux risale a inizio 2008; più
recenti Biostatics o Hidamari|Metrics con il
compositore Fourm, mentre per la collaborazione
con Luigi Turra bisognerà aspettare sino al 2009
- la recente uscita siglata NonVisualObjects dal
titolo Yu Shinkei opera con precisa coscienza dei
valori tra natura e materia: la sua ricerca, lungi
dal ridursi a semplice gesto, è continua riflessione
sonora su elementi primari come parte di un processo mutevole, quello definito da un segno preciso e calibrato, senza sbavature, ma teso come non
mai tra sensibilità ed espressione.
Una ricerca che punta dritto alle origini del suono, quelle che Toral individuava in monologhi
autistici di macchine improvvisate e Shinkei identifica invece in quel non-suono che comprende
l’ascolto di tutti i suoni, che oltrepassano il convenzionale (Binaural Beats- Koyuki 2008) per
restituire memoria e significato (Yu-NVO 2009).
Alvin Lucier sottolinea l’importanza del
ruolo del soggetto ascoltatore, della sua
attenzione e partecipazione all’evento sonoro. Le tue opere paiono sottostare alla
funzione e alla condizione d’ascolto. Qual
è il ruolo del contesto, del mezzo e del volume in tutto questo?
Come scrive Steve Roden, la musica lowercase
richiede attenzione ed una volontà di partecipazione attiva da parte dell’ascoltatore. Aggiungerei
che la mia musica chiede quiete e pazienza.Purtroppo e paradossalmente (ma non troppo) l’era
digitale ha portato un alto degrado nella qualità
dell’ascolto musicale: si sono privilegiate velocità
e quantità dell’informazione a danno della quali-
tà. I formati killer di compressione musicale sono
considerati di fatto lo standard dalle giovani generazioni (perdipiù spesso riprodotti attraverso il
computer), e la fruizione codificata da myspace
è superficiale come le relazioni che i nuovi media interattivi suggeriscono. Posso solo dire che
la mia musica non può essere ascoltata al computer, molti suoni sarebbero coperti dal rumore
di fondo delle ventole di raffreddamento...Per me
l’ascolto rappresenta un momento di concentrazione e riflessione sui suoni e sulla struttura della
composizione, una sessione di meditazione accompagnata dai suoni che amo.
I termini di formato e grafica sia per i tuoi
lavori che quelli in uscita per Koyuki, sembrano legarsi strettamente ai concetti di
aesthetica e minimalismo.Perché questa
scelta?
Adoro il formato minicd! Anche per quanto dicevo prima, credo che la lunghezza intorno ai
20 minuti sia ideale per ascolti così impegnativi,
dopo un certo periodo di tempo la soglia di attenzione decade inevitabilmente. Purtroppo spesso il
minicd è considerato opera minore nella discografia di un artista e sinceramente trovo sbagliato
che si valuti il valore della musica basandosi sulla durata di una composizione. Anche in questo
caso, si tende a privilegiare la valutazione quantitativa su quella qualitativa. Per quanto riguarda
invece l’immagine di Koyuki, è opera del genio
grafico di Luigi Turra. Fin dai primi momenti di
discussione sulle caratteristiche estetiche di Koyuki abbiamo concordato di dare un’impronta grafica molto rigorosa all’etichetta, che la rendesse
immediatamente riconoscibile e che potesse indurre una sensazione positiva di quiete e concentrazione, preparando in qualche modo all’ascolto
del contenuto sonoro. Questo riferimento grafico
alla cultura zen sarà ancora più evidente nelle
prossime uscite per le quali Luigi si è ispirato alla
pittura ad inchiostro dei monaci pittori, i gasô.
Le caratteristiche del sumi-e sono ben distinte da
Tune In /
23
quelle della pittura ad inchiostro convenzionale
eliminato ogni compiacimento estetico o stilistico, il dipinto zen trae il suo profondo significato e
valore dall’essere espressione immediata di quella condizione di “non-mente” o “vuoto mentale”
(mu-shin), che si genera nel satori.
Spazio/Tempo, forme a priori proprie alla
sensibilità umana, strettamente legate alla
percezione e al centro dei maggiori dibattiti sull’estetica. Come e che ruolo hanno
questi temi sul tuo comporre?
La nostra percezione dello spazio esterno è una
proiezione del nostro spazio interiore, ma il nostro spazio interiore viene a sua volta condizionato dall’ambiente esterno. La percezione della
realtà può passare, a seconda delle caratteristiche
individuali e del momento, attraverso il nostro
emisfero cerebrale sinistro, analitico e temporale, oppure attraverso l’emisfero destro, che non
24
/ Tune In
conosce lo scorrere del tempo, che osserva le
cose nel loro insieme, che è legato alla intuizione,
all’emotività e all’affettività. Purtroppo la società
moderna occidentale ha esasperato progressivamente l’utilizzazione delle facoltà legate al cervello sinistro, trascurando e soffocando una parte di
noi stessi necessaria ed essenziale. Fino a quando
il nostro io non trova un suo equilibrio nell’accettare ogni sua parte a livello cosciente, l’esasperazione di soddisfare i nostri bisogni emotivi (ricerca di identità, autoaffermazione, insicurezza,
narcisismo, dipendenza) produce a livello inconscio una modificazione percettiva della realtà che
viene percepita secondo i nostri desideri. Questo
meccanismo costituisce il motivo principale per
cui lo spazio in cui viviamo rispecchia nelle sue
caratteristiche i nostri conflitti interiori, le nostre
“nevrosi”. Al contrario, uno spazio semplice ed
essenziale può avere un effetto positivo sulla psiche e sul corpo evocando nello spazio interno
una sensazione di serenità e pace, di semplicità
ed essenzialità, che invita ad una trasformazione
interiore, permettendo così alla mente di superare anche i limiti spazio-temporali. Nella mia musica cerco di riprodurre queste caratteristiche di
semplicità ed essenzialità.
Evidente nell’architettura giapponese,
come nell’arte della pittura ad inchiostro,
l’importanza dello spazio, il valore dell’intervallo (vedi i lavori per pianoforte di
“Piano Piece 10” di Stockhausen). Valori
che perdono il legame con la funzionalità e
lo stato fisico, relazioni simbiotica necessaria tra gli opposti.
Sono importantissimi. I miei ultimi lavori soprattutto tendono ad essere costruiti su un susseguirsi
di eventi discreti, mi piace esplorare lo spazio fra i
suoni, reale o percepito, è un elemento essenziale
della mia composizione. E’ un silenzio implicito,
come lo definisce Richard Chartier, che in realtà
non è silenzio. Mi trovo a mio agio tra i suoni che
si muovono sulla soglia dell’udibile, è un mondo
apparentemente statico che invece nasconde attività continua e rivela sorprese piacevoli. Per questo le mie composizioni dovrebbero essere ascoltate a basso volume o in cuffia, aumentare troppo
il volume muta la natura del suono, ne distorce la
percezione. Un silenzio fatto di strati sovrapposti, non assoluto ma relativo, una sorta di “suono
colorato” lo definiva così Stockhausen… Nello
Zen si definisce il silenzio come quel non-suono
che comprende l’ascolto di tutti i suoni. Al contrario, la cultura occidentale insegna la paura del
silenzio, il silenzio è vissuto come situazione di
disagio ed imbarazzo, da coprire e annullare.Nel
ritmo frenetico della nostra vita, siamo circondati, immersi, in un rumore di fondo continuo, distratti e catturati da suoni ingerenti, invasivi e da
sollecitazioni visive che ci diseducano all’ascolto
profondo. Solo se riusciamo a creare una pausa
dal rumore che costantemente ci accompagna,
possiamo rivalutare tutta la varietà di sensazioni
acustiche che ci circonda e cambiare la ricettività
dei suoni intorno a noi. Possiamo diventare più
sensibili, più in risonanza con le vibrazioni del
mondo. Allora anche il nostro modo di definire i
suoni con le parole cambia con la nostra differente percezione: il rumore del vento e della pioggia
diventa il suono del vento e della pioggia.
I silenzi, oltre all’attenzione, richiedono
una sorta di confronto con il rumore di
fondo. All’inizio considerato vero e proprio
conflitto, che diventa poi parte stessa della
composizione, necessario quasi all’esercizio del microsuono. Come nascono i tuoi
suoni: su carta bianca ed in cuffia, oppure
sentono strettamente necessario proprio
questo confronto?
Ho la fortuna di vivere in un luogo molto silenzioso per cui la soglia del mio “rumore di fondo”
è minima, se non inesistente. Ho saputo che molti
ascoltano la mia musica ponendosi in una condizione di concentrazione e di silenzio estremo,
preferibilmente di notte, ovviamente tutta questa
attenzione mi rende molto felice! Certamente esiste anche la possibilità opposta, ricordo che gli
Zelle suggerivano di non ascoltare il loro cd in
cuffia ma di lasciarlo semplicemente interagire
con i rumori d’ambiente. Lo stesso chiede spesso
Steve Roden. Io sono abituato ad ascoltare e comporre in silenzio e in cuffia quindi per me è naturale questo tipo di esperienza, ma non escludo di
poter comporre in futuro qualcosa per l’ascolto
“d’ambiente”. Binaural Beats e la tua collaborazione con Lemieux, com’è nato questo lavoro?
Qui affronti il tema dell’interazione tra fenomeni
acustici e la percezione, tema caro ad esempio al
Ryoji Ikeda di “+/-“… Binaural Beats nasce come
studio sulle onde cerebrali. Il nostro cervello
emette continuamente piccole cariche elettriche
che mutano a seconda dello stato dell’attività cerebrale, dalle Beta che corrispondono allo stato
di veglia attiva, fino alle Delta che sono prodotte
nel sonno profondo. Esistono oggi molti software
che permettono di ricreare frequenze audio nel
tentativo inverso di “indurre” il cervello in uno di
questi stati attraverso la trasmissione delle onde
corrispondenti e quindi la sincronizzazione cerebrale. E’ lo stesso processo che si cercò di ottenere
a livello visuale con le famose “dreamachines”.
Nel mio caso ho utilizzato prevalentemente onde
alpha e beta: queste sono comunemente associate
con stati cerebrali di profonda concentrazione e
“superlearning”. Devo aggiungere che il mio lavoro non è puramente scientifico ma “musicale”
quindi ho utilizzato queste frequenze come materiale di partenza su cui operare un certo grado di
processing e di composizione dei suoni e questo
potrebbe ridurre la capacità di sincronizzazione
cerebrale.
Sulla materia, operi attraverso processi di
sperimentazione ma anche di composizione; tra elettronica e strumenti tradizionali,
confrontandoti con il campionamento, con
il concetto di “paesaggio sonoro”, elementi
cari alla cosiddetta musica concreta, quali
Tune In /
25
sono state le influenze che maggiormente
hanno suggestionato la tua scrittura?
In realtà devo dire che oggi le influenze e le suggestioni che avverto maggiormente sono “extramusicali”. Ad esempio le lunghe camminate nella
campagna senese in cui vivo. Oppure la visione
del bellissimo film di Philip Groning “Il Grande
Silenzio”, interamente girato in un monastero
certosino, senza voci narranti o intrusioni esterne. O ancora una registrazione del Chanoyu, la
Cerimonia giapponese del Tè. Questo tipo di
esperienze si riflettono molto nella mia musica.
Comunque per non eludere del tutto la tua domanda posso citare i nomi di 4 compositori con i
quali sto lavorando attualmente e che mi hanno
influenzato moltissimo: Pierre Gerard, Fourm,
Richard Garet e ovviamente Luigi Turra.
Nel tuo progetto con Fourm “Hidamari/
Metrics”, per la serie Archisonic, si colgono sentori del dibattito sull’architettura di
Isamu Noguchi. Hidamari è infatti la piramide di vetro interna al Parco Moerenuma
progettato dallo stesso Noguchi; perché la
scelta di questa opera?
Il parco Moerenuma a Sapporo fu progettato da Noguchi come una grande scultura ecofriendly, una zona di riposo e gioco, interamente costruito su un terrapieno di 2.7 milioni di
tonnellate di rifiuti, nel contesto di un piano per
un network di aree verdi nell’area di Sapporo.
Comprende una montagna artificiale, la Moere Mountain, una Fontana con un programma
di riduzione della CO2, la Tetra Mound che
consiste di una piccola collina e una piramide
triangolare di acciaio, varie aree gioco, la Forest of Cherry Blossoms con decine di sculture/giocattolo e la piramide di vetro Hidamari.
Hidamari significa “trappola per il sole”, è una
grande costruzione di vetro che in inverno si riscalda grazie all’esposizione totale al sole, in estate
è raffreddata da un sistema di condizionamento
che utilizza solo la neve accumulata in un ma26
/ Tune In
gazzino sotterraneo durante la stagione invernale.Penso che aree come questa dovrebbero essere
un esempio nella progettazione delle città.
Sempre a proposito di “Hidamari/Metrics”: qui i field recordings e i microsuoni
sono trattati con rigore minimale. Un rigore dettato da un qualche tipo di regola? C’è
un riferimento all’architettura, alle regole
composite; quelle della geometria spaziale
e della simbologia costruttiva, per esempio?
In Hidamari ho cercato di esprimere la fragilità
del rapporto uomo-natura, tra architettura artificiale e naturale, rappresentata dalla fragilità della
grande piramide di vetro nel parco. I parchi nelle
città sono fragili polmoni di vetro. Parlando del
rapporto tra uomo e macchina, com’è il tuo legame con la strumentazione? Che strumentazioni hai usato e utilizzi di solito? Utilizzo software
molto semplici, molto “immediati”. I software
musicali oggi sono fantastici perché permettono
di costruirsi uno studio semiprofessionale nel proprio laptop a costo zero. Tuttavia ci sono alcuni
rischi da evitare, come la dispersività nel correre
costantemente dietro alla plug-in di ultimissima
generazione per avere il suono cool del momento; l’utilizzo eccessivo di effetti e plug-ins vista
l’abbondanza di offerta a costi irrisori. Inoltre da
parte mia ho sempre evitato di utilizzare Max oppure Reason o comunque i software più “in”, il
fatto che li abbiano tutti è per conto mio buona
ragione per non farlo.
L’estrema ricerca di fonti sonore ai limiti dell’udibile, evidente nelle incisioni dei
segnali elettrici di “Biostatics”, a cosa è
dovuta? C’è relazione con il collettivo di
“musicisti-scienziati” e la ricerca di quei
punti di dissolveza da Toshiya Tsunoda,
Minoru Sato, Mark Bain ecc..
Agli artisti da te citati devo aggiungere Michael
Prime, autore di registrazioni bio-elettriche, an-
che se nel suo caso gli esiti sonori sono del tutto
differenti rispetto ai miei. Biostatics ha rappresentato una naturale estensione al mondo vegetale
degli esperimenti di Binaural Beats. Anche in
questo caso si tratta di segnali elettrici estremamente deboli che devono essere amplificati per
essere uditi. E’ come ascoltare il fluire della linfa
all’interno delle piante, o meglio ancora, il “rumore” prodotto dalle cellule nella loro frenetica
attività. Certamente ci sono analogie con il lavoro
del collettivo Wrk di Toshiya Tsunoda, nel loro
caso l’attenzione è rivolta a rendere udibile la “vibrazione” della materia e dello spazio, nel mio ad
organismi vegetali e animali ma dal punto di vista
puramente fisico si tratta sempre di oscillazioni di
particelle di materia.
Nel progetto con Luigi Turra “Yu” , le
scritture minimale e i micro suoni sperimentano nuovi e differenti spazi, tra le registrazioni di campo (voci umane, uccelli)
o le intromissioni elettroacustiche (flauti e
gong). Da dove arriva questa scelta, quasi
una svolta? Cosa ispira la materia sonora?
La “svolta” è stato l’incontro artistico con Luigi, si è creata subito un’intesa totale tra noi per
cui collaborare insieme è stato naturale e molto stimolante. Yu è un termine zen che significa
quiete. Anche gli altri capitoli sono espressione
di concetti o luoghi della cultura orientale. Wa è
l’armonia, Karesansui è il giardino Zen, Roji è il
sentiero rugiadoso ovvero la strada nel giardino
che conduce alla stanza del te’, mentre Kin-hin è
un tipo di meditazione camminata.
Credo che l’armonia e la quiete di un giardino
zen rappresentino alla perfezione la nostra ricerca sonora attuale, in questo senso l’utilizzo di field
recordings giapponesi e strumenti acustici orientali è stata una scelta del tutto naturale.
In “Yu”, lo spazio è mutevole di registro
Tune In /
27
e d’atmosfera, raccontato quasi in termini
di narrativa, lo spazio è un elemento importante. Come è mutato nel tempo e con
l’esperienza? E che cosa cerchi nei tuoi
spazi sonori?
Direi che è molto cambiato dalle mie prime produzioni ad oggi. In Binaural Beats e Biostatics era
uno spazio artificiale, digitale, soprattutto mentale. Oggi è uno spazio aperto a tutte le possibilità,
uno spazio mutevole in cui puoi ascoltare un bosco mattutino, un frammento di blues anni ‘30 o
una marcia di protesta Tibetana.
Secondo Tadao Ando, un superbo giardino giapponese non sarebbe mai immobile,
bensì in continuo movimento. Attraverso
una lenta trasformazione delle cose e senza interruzione creerebbe una nuova unità. Così gli spazi si affermano senza gerar-
chie, si congiungono, ognuno con il proprio
ruolo, il proprio colore, per partecipare
all’unità del tutto..
Così è stato per il vostro approccio alla composizione? Molto bella questa definizione. E si applica
totalmente al nostro modo di comporre Yu, è un
tutto così unico che ad oggi sarebbe impossibile
specificare quali parti sono state create da me e
quali da Luigi. Lo spirito che anima la concezione del giardino zen è completamente diverso da
quello riscontrabile nei nostri giardini. Questi infatti rispecchiano fedelmente la tendenza dell’uomo occidentale a dominare la natura, a vedere
nel giardino un’ennesima possibilità di esprimere
la propria razionalità nelle forme geometriche
precise, nelle simmetrie quasi ossessive.Al contrario, nel giardino giapponese troviamo un profondo rispetto per la natura, per l’equilibrio e le
proporzioni dei suoi elementi, una concezione
taoista, improntata al rispetto e all’integrazione
del mondo naturale piuttosto che al tentativo di
modificarlo.Penso che questo atteggiamento sia lo
stesso che guida me e Luigi nella composizione.
Il tuo rapporto con il visuale e le installazioni?
Le installazioni sono un aspetto che mi piacerebbe molto approfondire prossimamente, tempo
permettendo. Al momento sto lavorando ad un
progetto insieme a Luigi per una installazione
audio-video autogenerativa, Shizen. In assenza di
ogni gesto volontario che ne determini la direzione e la creazione, i loop audio e video si strutturano autonomamente in combinazioni casuali
sempre differenti, generando infinite possibilità di
ascolto e visione. Shizen, che significa naturalezza,
è una delle caratteristiche fondamentali dell’estetica Zen, poiché è il riflesso del processo creativo:
la realizzazione di un’opera d’arte il cui contenuto sia la visione illuminata dell’esistenza, deve
avvenire senza scopo, in totale assenza di volontà,
del sé e di qualsiasi tipo di artificio; tutto ciò che
viene prodotto trovandosi in questo stato sarà di
conseguenza simile alla spontaneità della natura,
meravigliosamente armonioso, fresco, libero, fluido. Tutti i suoni originali sono registrazioni di
neve e ghiaccio, riprocessate da Luigi Turra e
Shinkei.
Ci sembrava interessante mettere a confronto alcuni temi emersi intervistando,
per la rubrica “Lo Spazio del Suono” artisti provenienti da esperienze diverisficate...Ralph Steinbruechel, con Mit Ohne,
documento sonoro di un’installazione di
Yves Netzhammer, mette in gioco attraverso le leggi della riflessione e l’utilizzo di un
sistema multicanale , esperienze spaziali
e sonore, ponendo estrema attenzione al
concetto di spazio in sé e alla percezione
del suono nello spazio. Per la realizzazione
di Shizen, che ruolo giocherà la scelta del-
28
/ Tune In
lo spazio e del contesto?
Si tratterà di elementi che entreranno in stretta
relazione con il naturale evolversi della composizione audio/video, o parte di un fondale a cui la
stessa opera d’arte darà forma e significato… La
versione che abbiamo pensato è a 5 schermi, per
una esperienza il più possibile immersiva. In questo caso lo spazio installativo dovrebbe essere il
più neutro possibile. Installaziani site-specific,
come Mit Ohne, richiedono invece uno studio
preventivo approfondito dell’ambiente installativo, per poter ottenere gli effetti desiderati con le
frequenze sonore e l’interazione con la location.
Per questo motivo questo tipo di installazioni è
pensato in rapporto ad uno spazio ben definito,
o comunque è adattato all’ambiente previsto tramite uno studio accurato sulle qualità sonore del
posto.
Rafael Toral considera la performance
“come quell’attività in grado di coinvolgere il corpo del musicista e stimolare una
gestualità-una serie di gesti- all’interno di
uno spazio” cosa ne pensi?
Sono totalmente d’accordo. Anzi credo che ogni
artista lowercase dovrebbe sforzarsi di studiare
delle forme di performance che superino il limite
del semplice laptop set, che spesso risulta noioso e poco significativo per il pubblico. A questo
proposito mi viene in mente una bellissima performance a cui ho assistito questa estate a Piombino Experimenta di Xavier Quérel della Cellule
d’Intervention Metamkine. Xavier amplifica e
“suona” i meccanismi interni del proprio proiettore 16mm, accompagnando i suoni a immagini
astratte su un microschermo posto sul tavolino.
Tutto molto intimo e delicato.Anche in questo
caso la gestualità dell’artista che opera in tempo reale sul proiettore è elemento essenziale alla
performance, è chiaro che quei medesimi suoni
riprodotti da un laptop non avrebbero lo stesso
fascino.
Tune In /
29
Madlib
M
adlib è un mistero. O forse no. Forse
è semplicemente un drogato. Un drogato di musica che può permettersi di
non uscire dal tunnel. Un bimbo che può giocare
quanto vuole coi suoi giocattoli preferiti: ritmi,
note, suoni. Eccone un profilo essenziale, possibile guida per cominciare a orientarsi nella sua
personale giungla discografica.
Il mad libs è un gioco per bambini tipicamente
americano, come tale figlio del dopoguerra, inventato dalla premiata ditta Stern & Price, la stessa dei droodle. Al contrario di questi ultimi però,
indovinelli grafici dai titoli che sono le loro surreali soluzioni, il mad libs è un word game, in pratica
la versione popular del cadavere squisito: si devono elencare una serie di parole senza conoscere
il contesto in cui verranno poi inserite. L’effetto
finale è quasi sempre spiazzante, ora divertente
ora inquietante. Mad libs allude ad un folle ad
libitum, “a piacere”, “a volontà”, “all’infinito”.
Tutto questo giro per dire: potenziale infinità, improvvisazione e gusto del momento. Non è solo
una trovata giornalistica, davvero nel suo moniker Madlib ha sintetizzato compiutamente la sua
essenza più profonda e vera. [g.m.]
D a O tis
The clever nerd
- Gabriele Marino
contributi di Gaspare Caliri
30
/ Drop Out
a
M adlib
La storia oggi come oggi è stranota. Cercheremo quindi l’estrema sintesi biografica, giusto un
paio di date, per soffermaci sui punti principali di
una produzione discografica vastissima. Madlib
nasce Otis Jackson Jr. nel 1973 a Oxnard, sessanta chilometri sopra Los Angeles. Come direbbe
qualcuno, nasce spacciato: immerso nella musica
fino al collo. Il padre, Otis Sr., è un cantante e
studio man molto richiesto della scena soul californiana, la madre, Dora Sinesca Faddis, è
autrice di canzoni, e il fratello di lei, Jon, è un
trombettista che collabora con tanti pezzi grossi
e piace soprattutto a Gillespie. Il piccolo Otis
cresce immerso nel jazz, nel funk e nel soul (ma
ascolta anche rock), segue il padre nel suo lavoro
di studio: lo affascinano quelle leve, quei bottoni,
quei cursori, e poi le cuffie, il piatto dei dischi,
tutto ciò che registra, manipola, diffonde musica.
Diventa ben presto un curioso totale del mondo
dei suoni, ma soprattutto un fanatico del vinile,
un suo amante, cultore e collezionista senza appello. Madlib prende il virus quando ancora adolescente non è ancora Madlib, e sarà per sempre
felicemente affetto. E anche contagioso. Dato che
il fratello minore Michael, come già lui dal padre,
prenderà il gusto di armeggiare ancora ragazzino nel suo studio di registrazione e intraprenderà
poi la sua stessa carriera col nome di battaglia di
Oh No (autoironico gesto di sdegno per il suono
del proprio nome e cognome: Michael Jackson). Otis
Jr. scopre poi il mondo della nuova musica nera,
l’hip-hop, quella musica che come strumenti utilizza i suoi amati vinili, ed entra nella scena locale
con un actdi talentuosi, i Lootpack. Siamo a fine
anni Ottanta. Otis diventa Madlib, come detto
sopra gioco di parole tra mad, mad libs e ad libitum.
Ma anche acronimo mascherato di Mind Altering
Demented Lessons In Beat. Arrivano le prime produzioni underground, primi anni Novanta, e poi la
scoperta da parte di Chris Manak aka Peanut
Butter Wolf, deus ex machina della label Stones Throw e suo fan istantaneo, che si innamora
di un suono di cui intuisce le potenzialità ancora
inespresse. Siamo nel 1999. Accadono tante cose.
Fino al 2003, quando arriva la consacrazione definitiva nel mondo della musica senza aggettivi (né
musica nera, né bianca, né hip-hop, né jazz, né
altro: musica): esce Shades Of Blue. [g.m.]
C hi
è
M adlib
Mica facile rispondere. Uno dei produttori più
importanti di sempre? Ma poi, uno? Uno, nessuno, centomila. Madlib è Madlib, ma anche e soprattutto Beat Konducta, Quasimoto, Yesterdays
New Quintet. E restiamo così sui fondamentali,
dato che ognuno di questi alias se ne trascina appresso altrettanti. Lui stesso si descrive in maniera molto semplice: «prima di tutto un dj, poi un
Drop Out /
31
produttore, per
ultimo un rapper». Ma è
davvero difficile tracciare un
profilo unitario
di una personalità artistica
tanto ricca e
debordante da
aver bisogno di
una decina di
pseudonimi e
decine di dischi
per esprimersi.
La produzione
di Madlib è una
vera giungla, e
rischia ormai
di superare le
umane possibilità di assorbimento. Basta dare
un’occhiata a discogs.com, siamo sui livelli di Zappa, Zorn o Sun Ra (personaggi coi quali Madlib
condivide ben più della semplice prolificità). Madlib è un workaholic, ma non è per lui una questione di stacanovismo, si tratta piuttosto di biologia, metabolismo, sopravvivenza, carne: Madlib fa
musica come mangia, dorme e va di corpo. Con
tutti i pregi e i difetti del caso. La sua non è una
vocazione, è un istinto, non è una benedizione, è
una condanna. Madlib ha fatto delle proprie ossessioni il proprio pane quotidiano: come i meglio
creatori di cose artistiche della storia, ha deciso
di esorcizzarle non combattendole ma abbandonandovisi completamente. Anche solo per questo
merita il titolo di eroe, eroe dei nerd musicali: un
nerd non guarito, ma santificato anzi nella sua
diversità. Vinyl junkie totale, ascoltatore ossessivo, maniaco del digging (la ricerca spasmodica di
vinili, anche e soprattutto nei negozi e cestoni più
scrausi; stanno qui il divertimento e il virtuosismo
più grandi, nel cercare la chicca, il “solco magico” dove meno te lo aspetti). Vinyl junkie totale,
32
/ Drop Out
lui che nel 2004
dichiarava di
fare i dischi, ma
si tratta quasi
certamente di
un’esagerazione, con soltanto un sampler
e un registratore otto piste,
niente computer. Puro integralismo analogico in epoca
pro-tools. Girano leggende forse non
troppo lontane
dal vero sulla
sua personalità schiva e monomaniacale: la sua compagna lo
avrebbe addirittura mollato perché esasperata
dal suo stare tutto il giorno chiuso in studio a registrare suonare ascoltare. Quante ore di musica
sono già pronte e ancora inedite, quante lo resteranno? Sicuramente una montagna. Purtroppo e
per fortuna. Peanut Butter Wolf, il suo mecenate,
dice che Mad produce più o meno un album al
giorno, sicuramente tra i dieci e i venti pezzi fatti
e finiti, e che lavora a più progetti contemporaneamente. Insomma, al di là di una figura anche
oculatamente costruita per “fare personaggio”,
quello dell’artista totalmente votato alla musica,
logorroico su vinile ma reticente su tutto il resto e
per tutto il resto (interviste col contagocce e sempre meno negli ultimi anni, due parole appena su
qualsiasi cosa che non siano musica e dischi, riservatissimo sulla vita privata), sfuggente in tutto, già
sfumato in mito come da un alone di incolmabile
distanza, di alterità, cristallizzato, è certo insomma che Madlib davvero viva di musica e per la
musica. Dall’hip-hop alle sue fonti primarie, nel
tempo la sua voracità ne ha fatto ampliare a diDrop Out /
33
smisura il campo d’azione: produzioni, rapping,
remix, musica suonata; hip-hop cantato, strumentale, “free-form”, una sorta di jazz funk latin soul; gruppi veri, gruppi fantomatici, progetti
solisti, collaborazioni. Per questa sua versatilità,
unita a una riconoscibilità immediata, PBW lo
ha paragonato a Quincy Jones. Mad fa dischi
con naturalezza, per riflesso condizionato, non
potrebbe non farli. Ed essendo per lui fare dischi
una questione innanzitutto fisiologica, è normale
che di fisiologico abbia anche dei cali: non dischi brutti, semmai minori, forse superflui, note a
margine che nulla aggiungono a quanto già detto. Dischi magari frettolosi, dai quali ci si sarebbe
aspettati di più, mai però davvero brutti. Madlib
quando produce, è risaputo, va “in automatico”,
come fosse già tutto lì, già tutto scritto: il suo felice
(?) autismo diventa automatismo. È musicista tutto fuorché cervellotico, è anzi istintivo, tutto pancia, si fissa su certe cose e poi brucia questo suo
interesse, e le intuizioni orientate in quel senso,
in brevissimo tempo, famelicamente. Questo suo
chiamiamolo “disturbo dell’attenzione” spiega
tanto i dischi monotematici (vedi i tributi targati Yesterdays New Quintet) quanto quelli votati al contrario all’eclettismo più sfrenato (certe
cose Beat Konducta e molte sue produzioni per
altri artisti), giù fino alle tracce sincretiche, fatte di scarti netti, di momenti che (lo) stancano
subito e allora via avanti il prossimo, come in uno
zapping (vedi i pezzi di Quasimoto e Madvillain).
Madlib fa coi suoi dischi un elogio del frammento (fin dal titolo del suo discone hip-hop,
Soundpieces), e la sua è spesso una poetica
dell’accostamento brutale, della cozzatura, della frizione. Frammenti che sono magari immaginati come cinematografici: i primi due volumi
della serie Beat Konducta hanno come sottotitolo Movie Scenes, il terzo e il quarto sono calati
nell’immaginario bollywoodiano; i pezzi del primo Quasimoto vengono descritti come piccole
gag di un film demenziale; tra i miti assoluti di
Mad ci sono Melvin Van Peebles, regista di
34
/ Drop Out
con esplosioni di groove micidiali). [g.m.]
L a S tones T hrow
film orgogliosamente negri, picareschi, grotteschi,
e Galt MacDermot, l’autore di Hair. Questa
sua dichiarata consacrazione al momento, all’intuizione volante, questa sua istintività viscerale ne
fanno sopra ogni cosa un produttore riconoscibilissimo. Capace soprattutto di fare di vizi di forma virtù: perché la sua connaturata (e comunque
voluta, ricercata) imperfezione diventa tocco, la
sua naturale propensione alla confusione (si vedano anche le foto del suo Bomb Shelter, lo studio di registrazione preferito) diventa stile. Il suo
suono è quello tra mille: granuloso, ruvido, fragrante. Se fosse un colore sarebbe marrone caffè.
Un filo conduttore poi, una linea che crea continuità: un’attitudine intimamente funk. Ora
trascinante ora profondamente rallentato asson-
nacchiato impigrito. Madlib è un grandissimo
fumatore d’erba, si definisce anzi in un suo disco
come «il più fumato d’America», ed una delle sue
foto più famose lo ritrae con in mano un cespuglietto di marijuana. Coerenti con l’estetica del
frammento, lo definiremmo con due indizi (o due
flash), due video che acciuffano l’inafferrabilità di
Madlib e ne restituiscono allo stesso tempo con la
migliore sintesi l’immagine canonica: il videoclip
per la Slim’s Return estratta dal già citato Shades
Of Blue (Madlib impegnato in un ossessivo e immaginifico djing e digging) e il video contenuto
nel dvd Stones Throw 101 (2004) girato durante l’afterhour di uno dei primissimi concerti del
progetto Jaylib (Mad alla batteria che improvvisa
da solo per ore, occhi chiusi, ingessatissimo ma
Due parole su quella che è la principale responsabile del catalogo madlibiano. La Stones Throw
è l’indie black oriented, baricentro decisamente
nel funk, fondata dal bianchissimo Peanut Butter
Wolf, altro nerd del vinile niente male, nel 1996.
Dal 2000 la sacra trimurti ST è completata da
Egon, il nerd “riuscito” che tutti i nerd vorrebbero
essere (maniaco del funk terzo e quartomondista,
ma che, per capirci, tiene anche corsi universitari), tuttofare a tuttocampo e titolare delle dependance di “archeologia musicale” Now-Again e
Soul-Cal, e Jeff Jank, fumettista underground
promosso a grafico e webmaster. Una label fichissima fatta da nerd senza speranza: che bello. Con
questa estetica ostentata, che prima ancora che
estetica è etica, del vinile, con gli album che vengono pubblicati prima in questo formato e solo in
un secondo momento in cd o digital download.
Anche fuori da facili entusiasmi per quello che
appare un clima positivamente cameratesco e
un meccanismo perfettamente oliato, la ST resta
una delle fucine più interessanti del panorama
musicale contemporaneo. In scuderia campioni
del rap come Percee P, Med(aphoar), Guilty
Simpson e MF Doom, artisti (per accorciare)
funk e/o soul come Dudley Perkins, Georgia
Anne Muldrow, Heliocentrics, Breakestra,
produttori superstar assolute come il compianto
J Dilla e nuove promesse come Koushik e lo
stesso Oh No. E ovviamente Madlib, che della
ST è un po’ il figlio prediletto ma anche il padrepadrone spirituale. Senza l’amore incondizionato
per la sua musica da parte di PBW difficilmente
oggi Madlib sarebbe il Madlib che conosciamo,
con tutti questi dischi, questa libertà, questa autorevolezza, e senza di lui la ST non sarebbe la
piccola grande potenza indie che è oggi, capace di attirare musicisti di fama anche dal mondo
rock&dintorni, vedi John McEntire e Omar
Rodriguez Lopez.
Drop Out /
35
L ootpack
La culla di Madlib musicista è la sua crew tardoadolescenziale di Oxnard, i Lootpack, nata ai tempi del liceo: Mad dichiara di avere iniziato a “fare
sul serio” già nell’87. Nei Lootpack lui produce le
basi, Wildchild rappa e Dj Romes scratcha. La
primissima traccia del trio sarebbe sull’introvabile
12 pollici Throw ‘Em Up degli Hood 2 No Good,
1992, etichetta Phat Wrekards, feat che però alcuni attribuiscono al solo Romes. Nel ‘93 il primo
feat riconosciuto, due pezzi sul disco 21 & Over
degli Tha Alkaholics. Nel ’96 l’esordio a nome
proprio con un EP stampato dalla Crate Diggas
Palace, etichetta effimera creata ad hoc dal padre
di Mad. Queste e altre piccole produzioni, nulla
comunque per cui strapparsi i capelli (scheletriche
rispetto ai barocchismi futuri, scratch in primo
piano e batteria secca secca, molto old school),
attirano l’attenzione di Peanut Butter Wolf, che
mette i Lootpack sotto la sua ala nella neonata
Stones Throw. Esce così nel 1999 il mastodontico
Soundpieces:
Da
Antidote!,
doppio, addirittura triplo in edizione limitata.
E’ la visione
hardcore
old school
di Madlib, il
suo manifesto hip-hop
nel suo periodo hiphop. Emergono
già
quel suono
ruvido che
sarà la sua
caratteristica di base e
36
/ Drop Out
il suo eclettismo (condito da un sano pizzico di
ostentata follia) in quanto a referenti musicali.
Due inni alle sue due ossessioni, l’erba e il digging, feat di Declaime (moniker usato da Dudley Perkins nelle vesti di rapper), Alkaholics, Quasimoto (vedi sotto). Non c’è un solo riempitivo.
Summa della summa, i nove intensissimi minuti
della conclusiva Episodes. [g.m.]
M adlib “ solista ”
Il nome Madlib, fuori dai crediti dei Lootpack,
compare per la prima volta in Subtext (1999),
compilation di underground hip-hop prodotta
dallo Strenght Magazine di casa Sire. Mad firma
gli skit. Il primo progetto a nome proprio è Invazion (2000), mini con sei pezzi brevissimi, una
piccola chicca. Feat di Wildchild, Medaphoar, Oh
No, Declaime, Godz Gift, Kazi (sempre giro
Lootpack) e scratch di Romes. Quasi un’appendice dell’esperienza Lootpack, ma che, nonostante
la durata ridotta (in totale meno di dieci minuti), conferma
la solidità di
Mad produttore. I cantati
poi sono una
vera bomba.
Per
trovare il nome
Madlib sulla
copertina di
un disco importante bisogna aspettare il 2003. Si
tratta di uno
dei picchi di
Mad e del
suo miglior
disco nato
fuori
dalla tana ST:
Shades Of
Blue. Abbiamo visto come Mad sia stato battezzato alla musica dal jazz, non abbiamo però specificato come sia letteralmente cresciuto a pane
e Blue Note. A fine anni Novanta si sente pronto
per dire la sua, per fare jazz. Nasce lo Yesterdays
New Quintet (vedi sotto). Quei dischi, e i suoi remix di materiali reggae-dub Trojan per la Antidote (Blunted In The Bomb Shelter, 2002),
convincono i capoccia Blue Note a dare nuova
forma a quel progetto già abbozzato nel 1996
e confluito nel disco The New Groove, in cui
nomi hot del mondo cut’n’mix intervenivano su
vecchi materiali della prestigiosa label. Stavolta il
nome hot è Madlib. Un cerchio si chiude. A lui
onore ed onere di scegliere cosa e come passare
al suo trattamento. E la
scelta cade su cose più e
(soprattutto) meno note
del catalogo jazz funk
soul metà anni Settanta:
il suono di cui Madlib è
figlio. Il sottotitolo del
disco recita Madlib invades Blue Note, ma sappiamo essere stato il
contrario, è stato Mad
a farsi invadere. Lo immaginiamo intento ad
ascoltare vecchi nastri
commuovendosi
nel
sentire errori o voci che
confabulano su questo o quell’arrangiamento. La
devozione per quel suono tanto amato traspare anche dalla dedica di uno dei pezzi al padre,
responsabile del virus jazz del figlio. Mad è qui
nella sua dimensione ideale di dj plenipotenziario
(ricordiamo la sua icastica autodefinizione), remixa, taglia, cuce, risuona alcune cose. Il risultato
è un vellutato, elegantissimo disco d’atmosfera.
Inutile rincorrere la tracklist, basta citare l’iniziale instant tormentone Slim’s Return, esercizio micidiale su un pezzo del pianista Gene Harris,
scelto non a caso per il video rivelatore di cui si è
già detto. La resa impeccabile di questo progetto
canonizza Mad nel mondo della musica e della
musica che conta. [g.m.]
Q uasimoto
Quasimoto è uno dei progetti di Mad più amati
dal suo pubblico. Culto già prima che ne uscissero
i dischi, almeno per quei fortunati della crew Lootpack e di casa ST che ne hanno visto in diretta
la nascita e ne hanno testato per primi gli effetti.
Metà anni Novanta, per puro gusto del cazzeggio e, come lui stesso ha dichiarato, strafumato,
Mad si chiude nel suo Bomb Shelter e si mette a
fare freestyle su basi a mezza velocità. E’ stanco
del suo vocione profondo e stranegro, «alla Barry
White», vuole qualcosa
di diverso, di divertente, fa strani esperimenti: di questo cantato
innaturalmente lento
raddoppia la velocità,
che torna quindi normale, e ottiene così una
voce deformata. Mad fa
sentire alcune di queste
cose a PBW, così per
farsi due risate, e PBW
impazzisce: quella roba
va assolutamente pubblicata. Quasimoto è la
bomba freak di Madlib,
il suo alter ego supersballato (il che è quanto dire).
Un personaggio a tutti gli effetti, creato visivamente
da Dj Design e sviluppato dal grafico di fiducia
della ST Jeff Jank, con le fattezze di un alieno nasone e peloso, sorta di Alf anni Duemila. La gobba cui allude il moniker non è però somatica, sta
invece tutta nelle storture di questa voce all’elio,
sorta di joker rap, con un cantato allucinato, appiccicoso, inaudito, che può ricordare forse certe
cose dell’Eminem più acido o meglio ancora il
Sir Nose D’voidoffunk immaginato da George
Clinton nel 1977. Il tono è quello di una perenne
Drop Out /
37
irritante lamentela. Il contenuto non-sense, slang
e tante parolacce, un frullatone di underground
pop, immaginario adolescenziale, fumetti, film di
serie B e vita di strada. L’esordio su disco è su un
pezzo del one shot di PBW, My Vinyl Weight A
Tons (1998). Il disco a nome Quasimoto esce nel
2000, titolo The Unseen. Su tutto domina un
senso di rintronamento, di torpore. I pezzi sono
delle mini sceneggiate vocali e, lo abbiamo det38
/ Drop Out
to, Madlib li immagina come estrapolati da un
film squinternato. Le basi sono funk soul geneticamente modificato con inserti dei più vari, ma
la musica è tutta al servizio del cantato: questo
è prima di tutto un disco di rapping. Omaggio
ai jazzisti preferiti di Mad, citati (e campionati)
nel lungo elenco che è Jazzcats Part 1. Egon definisce Unseen «il più incredibile album di alternative hip-hop di tutti i tempi». Sicuramente, un
disco alieno. Checché ne dica poi lo stesso autore
(«niente di nuovo, niente di vecchio, solo la stessa
roba in un momento diverso»), la seconda uscita
a nome Quasimoto, The Further Adventures
Of Lord Quas(2005), supera addirittura la prima. Le coordinate sono chiare fin dalla copertina,
in due indizi chiave: in un angolo il baloon (che
esce dalla bocca di J Dilla) che recita Freak Out,
“campionato”
dalla copertina
dell’omonimo
esordio zappiano; in un altro
angolo la sagoma di Wild
Man Fischer,
il personaggio
più out degli
anni Sessanta,
presa dal suo
An Evening
With, discoculto che da
Zappa fu prodotto. Siamo in
pieni territori
“fuori di testa”,
e Further risulta così ancora più sballato della prima prova. Soprattutto, adesso il progetto non intriga soltanto per la sua eccentricità intrinseca,
ma per meriti anche più squisitamente musicali (sotto questo profilo Unseen era un disco quasi
spartano). Il risultato è più cartoonesco e giocoso,
sempre grottesco, ma meno inquietante. Tantissimi campioni vocali dai film di Van Peebles, basi
più ricche e varie, anche caotiche, ma di un caos
che giova. Torna l’idea dell’omaggio ai maestri,
questa volta hip-hop, nella bellissima Rappcats Part
3. Ultimissima diapositiva sulla coolness ST: il 19
febbraio è uscita la action figure di Quasimoto,
prodotta dalla Kid Robot. 50 dollari. Superflua e
fichissima. [g.m.]
J aylib
e
M advill ain
Le due più importanti joint venture madlibiane
sono accomunate da alcune interessanti similitudini “strutturali”. Entrambe nate come onesong-project, poi dilatatesi fino alla forma-album,
entrambe strapubblicizzati incontri tra “pesi massimi”, attesissimi, vendutissimi. Due dischi molto
belli, diciamolo subito, ma per i quali alcuni non
hanno risparmiato (e non
a torto, nel
primo caso),
il classico “mi
aspettavo
di
più”. Champion Sound
(2003), a nome
Jaylib, è la collaborazione
tra i due massimi beat maker black indie
del momento, Mad e Jay
Dee/J Dilla: i
due si conosco
a distanza per
le rispettive produzioni, si stimano, decidono di
fare qualcosa assieme. Il disco in effetti delude
in partenza, proprio a livello progettuale, perché
non presenta nessuna produzione a quattro mani,
ma soltanto pezzi “montati a distanza”, con Dilla che rappa sulle produzioni di Mad e viceversa (Mad anche nelle vesti di Quas). Ospiti Talib
Kweli, Percee P, Guilty Simpson. Il disco ha però
un suo interesse estetico e perfino antropologico:
è l’incontro tra due visionari music junkie che
declinano questa loro ossessione attraverso poetiche diverse, qui perfettamente sinottiche. Semplificando molto, un suono urgente, incoerente,
granuloso, funk, di pancia, per Mad, un suono più
studiato, asciutto, vellutato, hip-hop-soul, cerebrale, per Dilla. Più che un incontro, in effetti è uno
Drop Out /
39
showcase di lusso di due grandi personalità, ma
va comunque registrato come soprattutto Dilla
mimi spesso e volentieri certe sporcature madlibiane. Madvillainy (2004), a nome Madvillain,
è l’incontro tra Mad e uno dei rapper più eccentrici e misteriosi di sempre, la “primadonna” MF
Doom. Si tratta di una delle migliori produzioni
di Mad per altri. L’immaginario sci-fi b-movie e
fumettistico, attraversato da una tensione come
da fine del mondo, rintracciabile nel flow melmoso e arrancante di Doom è servito da una parte
musicale che mescola ruvidamente soul,
jazz, funk e influenze latine (Curls),
probabile retaggio queste ultime di un viaggio di Mad
in Brasile (leggenda vuole che il disco sia stato
prodotto tutto durante
quel viaggio, in pochi
giorni, a partire da
vinili locali). Il disco
profuma di una eccentricità che non può non
ricordare
Quasimoto
(citato nei testi e “presente” in due brani), ma virata
in maniera più compatta ed
essenziale. Molte le perle, da Raid
a All Caps. Feat di Med e Wildchild. Nel
2008, in attesa di un annunciato e sempre rinviato capitolo secondo, Mad si è esercitato con un
remix del disco (disponibile solo in un cofanetto
limitato) che ne è una vera e propria virtuosistica
e intrigante ri-produzione. [g.m.]
T he B eat K onducta
Beat Konducta è Madlib senza veli, ne espone
il cuore della tecnica produttiva, con l’aggravante di un altissimo tasso di sperimentazione, nel
senso proprio etimologico di “esperimento” e
“prova”. L’intera serie, finora sei volumi in vinile
raccolti su tre cd, porta all’estremo quell’estetica
del frammento e dell’intuizione e quel gusto per
40
/ Drop Out
l’accumulazione barocca di cui si diceva. Caratteristiche che sono una lama a doppio taglio, suo
maggior pregio e suo maggior difetto. BK è Madlib che salta di pala in frasca, è nel bene e nel
male una marmellatona. La serie viene inaugurata
in sordina da una specie di numero zero nel 2001,
un doppio 7 pollici a nome The Loop Digga, titolo The Beat Conducta (noto anche come Earth
Sounds). Il disco, tredici tracce ultrabrevi, caratteristica questa che resterà in tutte le altre uscite,
si discosta però per tutto il resto dai BK di là da
venire, perché molto omogeneo, giocato su un soft funk soul trattenuto
e asciutto, vicino alle cose più
lineari degli Yesterdays. La
prima vera uscita del progetto BK è datata allora
addirittura 2006, BK
Vol. 1-2: Movie Scenes (anche se il primo
dei due vinili che lo
compongono esce già
nel settembre dell’anno precedente). Eclettismo esagerato al contrario del volume zero, tracce
sempre brevissime, qui massimo due minuti, ma dalla struttura
interna brutalmente spezzettata. Il disco
dovrebbe essere letto come raccolta di estratti da
colonne sonore di film immaginari, e proprio per
questo sorprende la non totale aderenza in alcuni
casi delle musiche ai titoli loro appioppati. Questione veniale comunque. Predominano a inizio e
fine disco citazioni funk soul (esplicito l’omaggio
alla Stax e a James Brown), ma in mezzo c’è
di tutto, found voices, un paio di suggestioni africane, i Kraftwerk di Trans Europe, Raymond
Scott, roba più grassamente gangsta rap, ipnotismi da “terzo orecchio”, perle sbilenche che
potrebbero stare su Quasimoto (e infatti usano
materiali dei Residents). Tutti esercizi di stile,
tutti possibili intermezzi di dischi “altri”, tutte
mini-intuizioni che, quando lo spunto iniziale è
ricco, lasciano all’ascoltatore mille suggestioni,
ancora più forti proprio perché mai compiute, mai risolte. I volumi BK Vol. 3-4: In India
(2007), sono introdotti da un annuncio programmatico: «Come on let’s journey». E il viaggio è
in India, come da titolo, alla base ancora suggestioni cinematografiche, focus sulla Bollywood
anni Settanta, protagonisti assoluti una quantità
di campioni vocali tratti dalle pellicole di genere.
Il disco è frutto di una fascinazione magari momentanea ma totale, come spesso per Madlib, e
l’idea è molto intrigante, ma il risultato è come
sospeso a mezzo volo. Ovviamente, ci sono anche
qui le perle che regalano momenti intensissimi, e
comunque il disco può suonare più o meno interessante a seconda della familiarità che si ha con
questi suoni. Ma quelli che riescono meglio sono
soprattutto quei pezzi dove Mad rifà quella Bollywood che più si allontana dalla tradizione e più
si butta nell’esotismo caricaturale e fumettistico,
e che più guarda all’America e a Hollywood, in
un divertente cortocircuito (Piano Garden). Fin qui
insomma, abbiamo visto un BK come progetto
interessantissimo e coi suoi picchi, ma non del
tutto riuscito, non al cento per cento, con le imperfezioni costitutive del modus madlibiano forse
lasciate troppo sbrigliate, troppo scoperte, e quindi destabilizzanti. E’ da poco stato pubblicato su
cd (10 febbraio, già esaurito) quanto contenuto
nei due BK volumi 5 (The Dil Cosby Suite) e
6 (The Dil Withers Suite), al solito usciti prima
su vinile, e separatamente, nell’agosto e ottobre
2008. BK Vol. 5-6 è, come recita il sottotitolo, A
Tribute To J Dilla, il produttore black scomparso nel 2006 a causa di una malattia degenerativa
pochissimo tempo dopo la pubblicazione del suo
capolavoro immenso Donuts(fuori da ogni banalità della formula, con ogni parola che pesa un
macigno, funk-soul per il nuovo millennio). Il tributo è
voluto dai suoi colleghi-amici Madlib e J Rocc, dj
e producer sempre accasato ST, che qui scratcha.
Alla base del disco c’è la solita miscela di funk
modificato e maltrattato usata da Mad, ma con
percentuali soul decisamente più alte del solito,
e soprattutto un suono più vellutato ed etereo. E’
Madlib che cerca di avvicinare il suono di Dilla.
Il disco è il più omogeneo, organico e compatto
della serie, basi più asciutte, meno sconnesse, sia
del solito Mad che dei precedenti BK. Tanti gli
inserti vocali, e decisamente più rap. Pezzi ipnotici, si direbbe da club spettrale (c’è anche uno
shuffle electro con inserti da videogame). Su tutto
aleggia una spiritualità urbana, tra abbandono
(vedi la citazione del dio rasta Jah) e disperazione,
la sensazione è quella di un’ultima spiaggia guardata da lontano ma non troppo. L’atmosfera è
intrisa di emotività, ora drammatica (uno dei picchi è in Sacrifice: Beat-a-holic Thoughts, ma anche in
Anthenagin’) ora semplicemente epica (The String).
E’ probabilmente il migliore BK finora. Rispetto
al primo stock, ha dietro un vero tema-progetto
che dà un senso al tutto e ha forse fatto muovere meglio in partenza lo stesso Mad. Rispetto al
secondo, presenta una selecta di intuizioni semplicemente più ricche, centrate, curate. Così è anche il BK più bello da ascoltare. Un disco mosso
da una motivazione forte, con uno spettro che vi
aleggia sopra, quello dell’impossibilità di altri incontri musicali con Dilla, pittato qui come una
specie di Coltrane dei beat. Ed è forse qui che
avviene davvero quell’incontro che era mancato
su Champion Sound: Mad avvicina Dilla non
per timore reverenziale, ma per fare un sentito
omaggio ad uno dei pochissimi che lo vedevano
come suo pari. Breve menzione a parte per la dependence extra-ST del progetto BK, WLIB AM:
King Of The Wigflip, settembre 2008, pubblicato nella serie Beat Generation di Rapster/
Barely Breaking Even. E’ un disco diversissimo
dagli altri BK, di cui condivide soltanto la sigla
e la natura eclettica, o meglio, l’eterogeneità. E’
strapieno di feat vocali (Oh No, Guilty Simpson
in due pezzi, Prince Po, Talib Kweli, Med, la
Muldrow, Kariem Riggins) e ogni pezzo è diverso dall’altro, ma con risultati alterni, che diDrop Out /
41
pendono soprattutto dall’aderenza del rapper di
turno al mondo musicale di Mad. Le produzioni
sono spesso sorprendentemente pulite, si direbbe
quasi mainstream. Da prendere soprattutto come
spettro delle molte facce black, e soprattutto hiphop, di Madlib oggi. [g.m.]
Y estardays N ew Q uintet
Tra il 1999 e il 2000, Madlib, drogato di jazz e devoto a figure come Sun Ra e Thelonius Monk,
si comincia ad interessare alla musica suonata.
Da performer, non più solo da ascoltatore o dj.
La folgorazione avviene causa un incontro ravvicinato con un Fender Rhodes, il piano elettrico responsabile di quei suoni da lui tanto amati
in certo jazz anni Settanta. Madlib decide che si
metterà a fare jazz, e intende fare tutto da solo.
Come un bravo papà che non può tarpare le ali
al figlioletto che profuma di genio, PBW esce di
casa e va a comprare i giocattoli nuovi. Coi quali
Mad mette in piedi un quintetto (Yesterdays New
Quintet, con tutte le varianti grafiche tra plurale,
singolare e genitivo sassone) così composto: Monk
Hughes al basso, Otis Jackson Jr. alla batteria, Joe
McDuphrey alle tastiere, Malik Flavors alle percussioni, Ahmad Miller al vibrafono. Ognuno di
questi musicisti immaginari (ma Otis Jackson è
il vero nome di Mad)
sarà intestatario di
almeno un disco “solista” del progetto,
senza contare i dischi
“collettivi” e altri progetti collaterali: una
vera valanga di pubblicazioni, di cui è impossibile rendere qui
conto. Mad comincia
a studiare, autodidatta, non ha mai toccato
strumento prima, ma
è un ossessivo, lo sappiamo, e non è diffici42
/ Drop Out
le immaginarlo mentre suona tutto il santo giorno
cercando di rifare a orecchio questo o quel pezzo
preferito, riuscendo a raggiungere livelli impensabili per qualsiasi altra persona. In meno di un
anno registra ore di materiale, dice PBW qualcosa come 20 cd-r, per lo più improvvisazioni, motivetti, esercizi sui timbri. La prima uscita discografica a nome YNQ è un mini, Elle’s Theme,
2001. Nello stesso anno arriva anche il primo
album, Angels Without Edges, che di quella pila di cd presentati a Peanut è praticamente
un best of. Le batterie sono qui ancora quasi tutte
campionate (e va comunque sfatato il mito che il
cento per cento del materiale YNQ sia suonato
e non campionato) e l’enfasi, fin dalla copertina,
è tutta sulle tastiere. Il carattere sperimentale del
progetto (ancora, in senso etimologico) è lampante per come alle volte cozzano tra loro certe parti
strumentali: è lampante che si tratti di un one man
show. Con ancora molto da affinare. Ma il gusto
del suono e un appeal funk sottopelle riscattano
anche le tracce meno ispirate. Perché si, è molto
semplice, per i caratteri con cui nasce questa musica (musica suonata da uno che non sa suonare),
qui l’ispirazione è la chiave di tutto e il discrimine
tra il materiale interessante e quello francamente
superfluo (come molti dei dischi di cui non tratteremo). Angels, ma
a ben vedere tutta
l’avventura YNQ , ha
anche questa caratteristica, come dire,
antropologica da non
sottovalutare: YNQ è
un uomo già “arrivato” che si mette alla
prova inseguendo il
sogno di una vita, è
il bambino che gioca
ipnotizzato col fuoco,
è Madlib che cerca di
suonare quella musica che finora ha sem-
pre e solo “subito”
(di cui ha subito il
fascino da ascoltatore). Che questi
dischi esistano è
un vero miracolo di commovente
umana ostinazione.
Angels è solare e placido, un funk soul
jazzato con influenze latine: è il suono
YNQ al suo nascere, ancora acerbo.
Unico brano fuori
da questa direttrice,
ma che non stona,
è il casino totale di
Last Day. Da questo disco si spargono i semi del
progetto, che ossessionerà Mad per anni e lo porterà ad una prolificità, come detto, sconcertante.
E anche dissennata. Si va così dalle intuizioni annegate in una decina di mini qualitativamente altalenanti sparsi tra il 2001 e il 2008, ai due tribute album, il primo di cover da Stevie Wonder (Stevie,
pronto già nel 2002, pubblicato nel 2004), sostanzialmente deludente, il secondo con brani ispirati al jazzista Irvine Weldon, suicidatosi nel 2002
(A Tribute To Brother Weldon, 2004), disco
invece riuscito, forse il disco free di Mad, molto
interessante perché insolitamente torbido e meditativo, fino all’ubriacatura carioca di Sujinho
(Kindred Spirits, 2008), collaborazione a distanza
con Ivan “Mamao” Conti degli Azymuth, un po’
troppo stiracchiato e di maniera. Sempre ascrivibile all’universo YNQ (e pubblicato infatti con la
dicitura YNQ presents Sound Directions), The Funky
Side Of Life (2005) presenta un numero incredibile di collaborazioni di musicisti in carne e ossa,
da Catto degli Heliocentrics a turnisti e arrangiatori di area jazz funk che hanno lavorato anche
con Beck Hansen e Stevie Wonder. La musica
è appunto un jazz funk marcatamente funk, che
sa tanto di colonna
sonora Seventies.
L’iniziale Directions
è una delle possibili
intro definitive della storia. L’atmosfera è vividamente
urbana, ora serena
e impigrita, da passeggiata (Wanda Vidal), ora minacciosa e concitata, da
inseguimento (Ivory
Black). Forse non
tutti i pezzi hanno
la stessa incisività
o restano allo stesso
modo, ma il disco è
uno dei musicalmente più compiuti e accattivanti di tutta la discografia madlibiana. Cover della
classica Forty Days di Billy Brooks e di A Divine
Image del mito David Axelrod. Chiudiamo questa nostra scrematura della discografia YNQ col
disco che del progetto rappresenta sintesi, summa
e (pare) requiem, Yesterdays Universe: Prepare For A New Yesterday Vol. 1 (2007). Si
tratta di una compilation delle ultime produzioni YNQ , un contraltare di Angels insomma, con
materiale edito (pezzi presi dai vari satelliti YNQ)
e inedito. Il suo pregio, la varietà, è anche il suo
difetto. Si va dal pianismo alla George Duke di
Umoja, al free alla Art Ensemble di Slave Riot, alla
fusion alla Chick Corea di One For The Monica
Lingas Band, al funk d’assalto di Street Talkin’ e Free
Son. E’ il disco ultra-jazz, e più megalomane, del
Quintetto: frammentario, stordente, ma davvero
capace di aprire squarci su tanti mondi possibili.
In apertura, una rispettosissima Bitches Brew, opportunamente accentuata in melmosità. Piccola
nota: assurda la scelta di fare di una chicca come
Summer Suite un promo allegato solo ad alcune tirature di Universe, quando si tratta invece di
una delle prove più riuscite, fluide, musicali, belle
Drop Out /
43
del YNQ. La durata (quaranta minuti), la varietà
e allo stesso tempo la cifra stilistica limpida e riconoscibile, ne fanno anzi un vero piccolo compendio, un bignami di tutto il progetto. Doveroso
elenco di release importanti ma di cui, per motivi
di spazio e di coerenza tematica (per non rendere
dispersivo un discorso già così amplissimo), dobbiamo qui
tacere: la take madlibiana su deephouse
e breakbeat a nome
DJ Rels, Theme
For A Broken Soul
(2004); le produzioni
per Dudley Perkins
(dalla sue cose rap
come Declaime fino
a A Lil’ Light, 2003,
e
Expressions,
2006),
Wildchild
(Secondary Protocol, 2003), Percee
P (Perseverance,
2007), Talib Kweli (Liberation, 2007), Med (11
pezzi di Push Comes To Shove, 2005), Guilty
Simpson (5 pezzi di Ode To The Ghetto, 2008),
Erykha Badu (2 pezzi di New Amerykah,
Universal/Motown, 2008), Mos Def (2 pezzi di
Ecstatic, Downtown, 2009), più pezzi sciolti per
De La Soul, Planet Asia, Prince Po, Oh No,
MF Doom; i pezzi sui due volumi collettivi ST/
Adult Swim, Chrome Children(2006, 2007), e
su Hella International (2007), triplo 12 pollici
celebrativo; i (finora) sette volumi no-label di mixremix per il solo mercato giapponese Mind Fusion(2004-2009); il progetto “percussion + djing”
della Mochilla confluito nel dvd Brasilintime
(2006); alcuni remix one shot come la Nuclear War
di Sun Ra sulla compilation The Other Side Of
Los Angeles (Time Out, 2007). [Grazie a Mirko
“DaBeast” Andreassi, Marco “Wolf” Iacono, David
“LittleTonyNegri” Nerattini]
44
/ Drop Out
Il
culto dei frammenti
Come concludere – provvisoriamente - una cavalcata su un mare di produzione e “dispersione” musicale? Si parlava sopra, appena prima
di intraprendere il viaggio tra i moniker, di una
chiave di lettura del fenomeno ad libitum del Madlib. Si accennava al
culto del frammento,
dell’attimo colto e
riportato, del potere
di immortalare i particolari che consente
la stanza che Otis
Jr. conosce meglio;
quella dei bottoni.
Da qui ripartiamo,
alla luce delle sfaccettature
musicali
del ritratto, per fare
un’ipotesi di massima un po’ più generale, che abbracci quei frammenti
come un taccheggiatore maldestro tiene visibilmente sotto l’impermeabile tutta la merce da portare a casa.
Innanzitutto quel potere di immortalità che
Madlib detiene con la massima autorità è in
realtà un mero strumento di un compito molto impegnativo ma per lui naturale; non uno
scettro evidenziato. Madlib coglie i frammenti
e li trascina con sé, nella sua musica, nel mare
magnum della sua produzione; e però nel farlo
lascia a quelli la natura di frammenti; li usa ma
solo nel flusso continuo di qualcosa che quei
tocchi, piano piano, e nel loro insieme, costruiscono con un non ben definito senno del di poi.
Basta ascoltare l’ultimo Beat Konducta, per capire un po’ meglio quanto si cerca qui di focalizzare invano, a parole. I pezzi sono presi e mai
isolati; il loro soul e il loro funk sono adoperati
per un obiettivo a scala più ampia; certo la cosa
pare scontata, se si pensa che si parla di un episo-
dio dedicato al mito di molti J Dilla. Ma Madlib
coglie sempre le occasioni come pretesti, le priva
di un’essenza individuale per rendere conto di
un costrutto che sta prendendo corpo e anima;
nei dischi di Madlib si sentono anche quelle cose
che il nostro conserva ancora nel cassetto (negli
infiniti cassetti della sua stanza bottoniera). Nelle produzioni ufficiali entrano in risonanza indiretta e inspiegabile i cdr che mai ascolteremo.
Basterebbe dire forse che il frammento di Madlib
sussiste solo in quanto parte di un flusso; ma ancora
manca qualcosa, a questa area di decompressione
tra l’ascolto e la visione critica. Il confronto con J
Dilla a cui ci presta il fianco l’ultimo BK è un piatto d’argento ossidabile; è vero che entrambi hanno una natura una e trina, ma non solo; ciò che li
accomuna è un’attenzione alla cultura nera in toto
che si riflette nel lavoro di produzione e di repertorio della loro attività. I mille moniker di Madlib
non sono solo il risultato di un delirio ipertrofico;
sono il tentativo, spasmodicamente rilassato, di
fare tutta la musica che fa parte della sua cultura.
Pensiamo a cuor leggero a quel che Madlib ha
fatto; con Yesterdays New Quintet ha affronta-
to dal be-bop al free jazz; con Beat Konducta è
passato da J Dilla fino addirittura a catalogare
il kitsch bollywoodiano, senza darne un giudizio o estetizzarlo, ma semplicemente prendendone la fattezza di seconda mano, come può
arrivare in una black California, fake del fake.
Quello che fa Madlib è spersonalizzarsi per fare
una catalogazione della black music, dal funk,
al jazz, alle sonorità in arrivo. Il culto del frammento discende allora forse dalla volontà di sciogliere le (sue) molteplici individualità nel corpo
frizzante della cultura musicale di cui fa parte.
Detto con una formula: Madlib non è un produttore di musica nera, è colui che si è preso la briga
di abbracciare tutte le diramazioni della matrice;
siamo nel 2009, l’hip-hop si ritrova storicizzato
all’interno della cultura nera, parte essenziale accanto alle altre… E allora Madlib è il produttore
della musica nera in genere, con le dirette conseguenze di “atlantificazione” che una tale occupazione comporta. Mad ad libitum, ma produttore,
catalogatore, repertorio di un mondo intero; in
questo, qui lo si dice e lo si nega, personaggio assolutamente ’00. 10 dischi per avvicinare Madlib
[tutti Stones Throw, eccetto ove indicato]:
• Lootpack [Madlib, Wildchild, Dj Romes] – Soundpieces: Da Antidote! (1999)
• Yesterdays New Quintet – Angels Without Edges (2001)
• Madlib – Shades Of Blue: Madlib Invades Blue Note (Blue Note, 2003)
• Jaylib [Madlib & J Dilla] – Champion Sound (2003)
• Madvillain [Madlib & MF Doom] – Madvillainy (2004)
• Quasimoto – The Further Adventures Of Lord Quas (2005)
• Yesterdays New Quintet presents Sound Directions – The Funky Side Of Life (2005)
• Madlib – Beat Konducta Vol. 1-2: Movie Scenes (2006)
• Yesterdays Universe – Yesterdays Universe: Prepare For A New Yesterday Vol.
1 (2007) [+ bonus promo The Last Electro-Acoustic Space Jazz & Percussion
Ensemble – Summer Suite]
• Madlib – Beat Konducta Vol. 5-6: A Tribute To J Dilla (2009)
Drop Out /
45
Mutoid motown
il Suono della Detroit ‘00
A Detroit la crisi è arrivata prima; ma per quanto ci riguarda ciò che ci ha visto
lungo nella motown degli ultimi dieci anni è una scena che sotto l’etichetta mutantpunk raccoglie stupefacenti creatività musicali e artistiche. Ecco a voi una schizo-
- Stefano Pifferi, Gaspare Caliri e Massimo Padalino
mappatura di band veterane, come Human Eye e Piranhas, nuove attesissime
conferme, vedi Druid Perfume, etichette, persone e compile che levano il fiato e il
dubbio. Il suono della motor city dei Duemila è mutoid motown!
D etr - oid
D
i cosa si compone una scena? Di storie individuali e di storie collettive, che si intrecciano senza soluzioni di continuità. E di un contesto. Quello che oggi fa da quinta teatrale alla scena
di cui vi si vuole parlare non è dei migliori; la città dei motori era di fatto una delle capitali
mondiali dell’automobile, e sicuramente era negli Stati Uniti città sinonimo di quattro ruote e di motorizzazione di massa, al punto che quando negli States qualcuno si compra un’auto, gli si dice proverbialmente “buon acciaio detroitiano”. Quasi due milioni di persone – oggi dimezzate – lavoravano
nelle catene di montaggio di Ford, Chrysler, Dodge, Cadillac. Cose di cui ci si accorge veramente,
forse, quando non ci sono più, come in questi anni.
Ma se di crisi si parla fin troppo, di fervido gorgoglio si parla sempre troppo poco. A Detroit noi di SA
non ci siamo certo avvicinati per cogliere i frutti acerbi della recessione; ma per gustarci e farvi gustare
il marciume vitalissimo che sprizza dalla motor city da ormai almeno dieci anni. Per introdurlo ci ri46
/ Drop Out
facciamo solo un poco a quel rumore macchinico
e ai clangori ripetuti come sezioni ritmiche figli
delle catene di montaggio. Le macchine infernali che animano la scena detroitiana oggi sono
androidi e informi; perennemente ancorate nel
punk più sanguigno, spiccano voli pindarici di un
mutantismo alieno; questi i due elementi con cui
definiremmo il core della motown odierna; questi
i tratti distintivi musicali che ci fanno parlare oggi
– nella nostra schizo-mappatura della città che fu
“soulful” e degli Stooges – di mutoid-punk. L’etichetta è densa e stringente, ma non deve esclude-
re una quantità di sfumature di cui faticosamente
cercheremo di rendere conto. C’è, dietro ogni angolo android punk, del free-jazz incontrollabile;
c’è l’eccentricità del sottobosco post-punk/new
wave americano; ci sono artwork ed etichette che
confezionano un’estetica irresistibile.
E se una scena è fatta di storie di individui e di
gruppi di persone, c’è anche da dire che nella Detroit dei Duemila ciò che sembra funzionare particolarmente bene è la trasversalità di quell’approccio punk mutante, che fa sì che nel discorso
che sta avendo la sua introduzione si mescolino e
Drop Out /
47
si intreccino luoghi delegati alla musica – anche
la più violenta – e all’arte – da piccole gallerie
al museo cittadino di arte contemporanea. Ma,
fedeli alla ripercussione spaziale figlia dell’estetica android-retro-sci-fi dei Chrome, è là tra gli
astri che spariamo il colpo, per poi catapultarci
in caduta libera nella città dei motori mutanti…
[g.c.]
H uman E ye . E ye A m T he H uman A lien !
Nell’immensità del cosmo, su immense distese
spaziotemporali, i gas vanno alla deriva: le scorie
di diecimila soli, un diffuso miasma di esplosioni
oramai soffocate, di fuochi infernali oramai morti e le furie di centinaia di milioni di formidabili
macchie solari...Informi, senza scopo.
Al centro di questo uragano emerge, portandosi dietro un manipolo di creature mostruose a
vedersi, la città della macchina, Detroit, Motor
City per eccellenza. Il drappello di esseri mutanti che, imbracciata l’usuale strumentazione rock,
riesce a varcare le soglie dell’Universo punk
sgattaiolando via dalle casematte psych’n’heavy ha per guida lui, Timmy “Vulgar” Lampinen. Biondo, stravagante, cultore dell’improbabile, amante della grafica e devoto asservito al
rock’n’roll sguaiato. Lo dicono, innanzitutto, i lavori dei Clone Defects. La Detroit del gruppo
è stata quella di Jim Diamond, proprietario della
Ghetto Recorders, mitico studio di registrazione
analogico, anima e core del suono vintage. Goddamn, Easy Action, Valentinos, Death In Custody, I Accuse, H8 Inc e Amino Acids sono stati gli
eroi di questa scena.
Discontinua assai la carriera di Lampinen, Wild
Mid Wes, Chuck Fog e Fast Eddie, che ancor’oggi, nel 2008, si esibiscono live. Dapprima il 7”
eponimo (Addition Records/Tom Perkins Records, 1999), registrato e prodotto da Jack White
dei White Stripes e stampato in mille copie; poi
singoletti quali Scissors Chop (Italy Records,
2000), The Lizard Boy (2000) e Shapes Of
Venus (In The Red, 2003). Il primo e il terzo
48
/ Drop Out
prodotti da Jim Diamond: garanzia di qualità!
Così come i piatti forti della casa. Due LP – Blood On Jupiter (Tom Perkins Records, 2001) e
Shapes Of Venus (In The Red, 2003) – saturi
del sound di Stooges, MC5, Stones e Damned.
Ancora nulla al confronto di quanto sarebbe venuto. Billy Haffer (aka Billy Tornado o Hurricane Williams) Tim lo incontra nel backstage di un
concerto dei Defects, al Magic Stick. Così come
Johnny Lzr. Nascono gli Human Eye. Alla chitarra c’è lui, l’alieno biondo che fa impazzire il
mondo delle sette note: Timmy Vulgar! L’estetica della band sarà ancor più punk che quella
dei Defects. Beefheart, Germs, Chrome, Soupy
Sales, Residents, Hendrix, Boredoms, Hawkwind, Screamers, Electric Eels, le influenze dello
psicotico combo. Esso autodefinisce la propria
human eye
musica “alien punk” o “experimental psychedelic punk”. Esce l’esordio, per la In The Red, a
confermare la veridicità dell’assunto. Siamo nel
2005. L’LP contiene 12 canzoni, scritte per intero da Lampinen, mixate da Tim assieme a Ryan
Sabatis dei Piranhas ed eseguite da Johnny Lazer
(‘alien pianos’), Thommy Hawk (basso), Timmy
Vulgar Lampinen (voce, chitarra, tromba) e ben
due batteristi ad alternarsi (Billy Hafner, anche
allo xilofono, e Jimmy Vomits). Human Eye, brano apripista, risale le correnti astrali per andarsi
a posizionare davanti a quel geoide sonoro che
fu abitato dal primo Helios Creed solista (The
Last Laugh, 1989). Distorsioni senza posa, chitarre filtrate, interferenze rumorose abbandonate
a se stesse, velleitarie ed arty eppure spastiche.
Una gran devastazione di generi “classici” (blues,
rockabilly, garage, hard rock, scum-punk ecc.)
dominata dalla voce, assolutamente non filtrata
(Timmy è miglior cantante che non Creed), di
Lampinen (Episode People, Girl Named Trouble, Extraterrtrial March, Car Was Alive... durata media due
minuti o poco più). I testi, poi, sono altrettanto
caustici. Eccovi qui Kill Pop Culture: “Have an alien
lazer kill you all! Wanna ufo invasion I wanna help em
shut it down i can hear the new culture call”.
Intanto i Nostri partecipano al Gonerfest 2 nel
2005 a Memphis (ma non vengono inclusi nel
relativo DVD/CD) e pubblicano un po’ di cose
su 7” ed affini (Dinosaur Bones, Spiders And
Their Kin, Rare Little Creature, il cd-r Serpent Shadow). Tim, dal canto suo, si perfeziona nel disegnare poster sempre più visionari (vedi
le copertine della band, ma non solo quelle!) e si
lancia in tour scalmanati – pure in Europa (Madrid, Marsiglia, Firenze) – durante i quali leggenda vuole i musicisti gettino sul pubblico, travestiti
da marziani dei b movie, rane, anguille elettriche,
serpenti, polpi...Un album nuovo viene incubato
nel mentre. La In The Red decide di passare la
mano. Billy Tornado (anche al sax stavolta), Johnny Lzr, Brad Hales (Lamps Bass guitar) e Timmy
Vulgar suonano nel nuovo Fragments Of The
Universe Nurse (Hook Or Crook) sfornando
un’epidemia di suoni aliena e virulenta, denunciabile quale spacejazz-noise. Perfetto surrogato di quell’electroshock che mai aveste a patire!
[m.p.]
X! R ecs , T asty S oil , O dd C louds ,
J imbo E aster ; tra rumore e arte .
Uno dei centri propulsori della Detroit underground ha sede poco fuori dalla motor city più
famosa del mondo. È un’etichetta e risponde al
nome di X! Recordings; la gestisce Scott Dunkerley e ha il proprio quartier generale in quel di
Ferndale, poche miglia a nord di Detroit, in quel
dedalo ortogonale di sobborghi e cittadine che
formano l’immensa suburbia tipica delle metropoli americane.
Poche uscite quelle contraddistinte dal marchio
X! e spesso in formato vinilico minore a testimonianza di un approccio diy mai domo, come conferma Scott via mail: […] Idea e nome della label
risalgono al 2003 quand’ero ancora alla high school e volevo far uscire i dischi delle band con cui suonavo (Skinny
Fists e Yarbles), poi la cosa è cresciuta: prima qualche cd-r,
poi i primi 7” e via via lp e cd. L’incontro con spiriti affini
come Terribile Twos mi ha fatto rendere conto che c’erano
molte band simili al mio approccio che sarebbe stato giusto
riunire sotto lo stesso tetto e promuovere come un unicum.
Una tendenza all’aggregazione che ha dato i
suoi frutti proprio in questo ultimo periodo. Due
eventi organizzati dalla X! hanno caratterizzato
la scena proprio mentre scriviamo questo articolo. In primis l’uscita della compilation Shitfless
Decay, programmaticamente sottotitolata New
Sounds Of Detroit, in cui fanno bella e spavalda mostra di sé molti dei gioielli di città e dintorni: i veterani Terrible Twos, Tyvek, Human Eye,
Frustrations, le nuove leve The Mahonies, Johnny
Ill Band, Heroes & Villains, l’ala più freak (Odd
Clouds) e out (Tentacle Lizardo), qualche “prestito” (Little Claw); tutte bands stilisticamente diverse ma accomunate dalla trasversalità dell’approccio alle musiche punk. È, però, nelle liner
Drop Out /
49
frustrations
notes dell’album che risiede lo spirito ultimo che
ha mosso la X! Recs, nella persona del suo unico
titolare Scott Dunkerley, alla compilazione in oggetto. Shiftless Decay racchiude musicalmente
il suono che ha definito la scena di Detroit nel
periodo 2005-2009, ma anche sociologicamente
una riflessione sullo stato della città e della sua
suburbia e sulla possibile rinascita culturale attraverso l’arte e la musica.
Il secondo evento è diretta emanazione del primo. Nei martedì del mese di febbraio quasi tutte
le band della compilation hanno partecipato a
due a due agli Shiftless Decay Thursdays, serate intese per promuovere la compilation omonima ma
in realtà, immaginiamo, sorta di mappatura degli scompigli che il sottobosco mutoid-punk della
città sta creando: La compilation e la label stessa sono
focalizzate principalmente sulle band di Detroit, ma non
è che sia contrario a pubblicare gruppi di altre scene, come
ad esempio Michael Yonkers. Il fatto è che, solo a Detroit,
c’è un tale fermento da documentare e approfondire che non
mi restano tempo e soldi per band di altre aree.
50
/ Drop Out
Ad inaugurare l’accoppiata Frustrations/Mahonies; a chiudere Terribile Twos e Fontana; in
mezzo Tyvek/Johnny Ill Band e Human Eye/
Heroes & Villains. Il tutto rigorosamente free al
PJ’s Lager House, ennesimo punto di ritrovo di
una geografia musicale cittadina che ormai non
fa più distinzione tra gallerie d’arte sui generis e
localacci maleodoranti e lerci, tra esposizioni di
arti visive e approccio diy scalcinato e raw.
Proprio nella serata iniziale era di scena il capo
della combriccola X!, Scott Dunkerley col suo
attuale progetto Frustrations. Trio considerato
di punta in questa nuova alien noise wave cittadina – appropriata definizione fornita da Victim
Of Time – i Frustrations sono giovani white trash
inquieti e devastanti, in fissa con Birthday Party,
post-punk e alienati suoni post-Chrome. Dopo il
7” Nerves Are Fried è stata la volta del disco
lungo Glowing Red Pill, concentrato di postpunk in overdrive e reiterazione indiavolata.
Instancabile nonostante l’aspetto low budget,
Scott/X! Recs ha già pronto un nuovo asso nella
manica: la release del secondo volume della compilation “itinerante” Tarantismo Summit che,
come indica il nome, è un inno al tarantolismo.
Il primo volume è da poco uscito per l’etichetta
di Chicago Rampage e vedeva in scena Smegma,
K.K. Rampage, Insect Joy e Ghost Moth. Roba
che esula dal contento del presente articolo ma
rende sempre l’idea della trasversalità che si respira da quelle parti. [s.p.]
Non solo Ferndale e non solo X! Recs infiammano il sottobosco detroitiano. A ben vedere è
tutto il circondario di Detroit a brulicare di personaggi enigmatici e di suoni spigolosi. Senza tirare in ballo la vicina Ann Arbor, basterebbero
pochi nomi ultranoti per comprendere quanto
l’aria della motor city e delle zone limitrofe sia
allo stesso tempo malsana e fertile per personaggi
borderline: Stooges, Dirtbombs, White Stripes,
giusto per rimanere in ambiti garage-punk.
Prendete Royal Oak, ad esempio; sempre un
sobborgo e sempre ad un tiro di schioppo in
direzione nord-est dal cuore della città. Lì agisce Chris Pottinger: artista grafico, musicista, “discografico”. Tutto questo (e molto altro
ancora) non rigorosamente in questo ordine.
Sul versante prettamente artistico Pottinger è
grossomodo un illustratore: armato principalmente di pen & ink ama dilettarsi con una sorta di deturpata art brut fumettistica da applicare
indistintamente a cover di dischi, pins, manifesti
e ovviamente disegni in formati diversi e alternativamente a colori o b/n. Nulla di dilettantesco,
sia chiaro. Il nostro espone pure in circuiti convenzionali e, pare, anche con un certo successo.
Pottinger, come nella miglior tradizione del nerd
del terzo millennio, non si fa mancare la classica
etichetta homemade da nerd 2.0. Il nome scelto
è Tasty Soil e nelle rade ma interessanti uscite si
premura di pubblicare le weirditudini più off non
solo dei progetti di casa – Odd Clouds, Cotton
Museum, Slither, tutti ruotanti intorno alla
sua figura – o di quelli limitrofi – i Sick Llama
del sodale Heath Moerland – ma anche di spiriti
affini più o meno noti come Sixes e Thurston
Moore.
Tasty Soil – ci conferma Chris telematicamente – è
nata sul finire del 2004 perché volevo pubblicare la mia
musica e quella dei miei amici, e nello stesso tempo avere il
controllo sull’artwork delle uscite. È importante per me che
ogni disco che pubblico abbia un artwork interessante che
lo accompagni. Voglio pubblicare dischi che la gente, pur
ignorandone il contenuto, prenda in mano e guardi anche
solo per la copertina. Tasty Soil deve perciò essere molto più
di una semplice etichetta: voglio che si focalizzi su poster,
magliette, libri, dvd e tutto ciò che mi permetta di disegnare
più possibile. Da che ho memoria sono sempre stato interessato dal dipingere creature deformi e bestie.
L’arte, perciò, e l’interazione di questa con la musica sembrano essere al centro dell’universo artistico di Pottinger. Non vi sfuggono le sue attività più
strettamente musicali che, a dirla tutta, si svolgono prevalentemente in solitaria coi progetti Cotton Museum e Slither. Slither – in combutta
con l’amico Moerland – mortifica il “free-jazz” a
base di droni in bassa frequenza, elettronica garbage e sax/clarinetto in modalità improv tanto
da far esclamare tempo addietro a Bull Tongue
– invero esagerando un po’ – che la musica del
duo sia Today’s jazz for today’s playboys; Cotton Museum invece è il progetto onanistico-rumorista di
Pottinger armato di theremin + synth + oscillatori ed elettronica sfatta: lunghi drones di rumore
bianco nella migliore (peggiore?) tradizione della
vicina Ann Arbor in cui riemerge il legame arte
visuale/musica: Cotton Museum è partito come progetto
harsh crudo e grezzo, ma negli anni si è spostato verso una
maggiore complessità focalizzandosi su suoni fuori asse.
Ho sempre sentito i suoni CM come provenienti direttamente dalle bestie e dai mostri che ritraggo nelle copertine, come se fossero i field recordings dei luoghi immaginari
dove quegli esseri vivono.
Entrambi i progetti hanno uscite indifferentemente in k7, vinile, cd-r per etichette come Fag Tapes,
Not Not Fun e la nostrana Qbico, a testimonianza della credibilità in certi giri underground più o
meno free, più o meno grezzi.
Drop Out /
51
slither
È però il progetto Odd Clouds ad attirare la nostra attenzione. Sorta di collettivo/supergruppo
aperto – per quanto la seconda definizione possa
risultare bizzarra visto che si parla di musiche decisamente “di nicchia” – Odd Clouds ruota intor52
/ Drop Out
no a mr. Tasty
Soil e ad altri
svitati come il
già citato Heath Moerland
aka Sick Llama
e Jamie Jimbo
Easter. Più la
degenerazione
weird del suono psych che la
trasfigurazione
del suono della
Detroit dei 60s,
in realtà, ma è
impossibile evitare di parlarne
in questa sede,
in quanto parte integrante di
quel sottobosco
mutoide – si
veda la compilation-manifesto da cui siamo partiti – cui
facciamo riferimento. Tra i
tanti progetti
di
Pottinger,
Odd Clouds
sembra quello
più intento a
“mutare” dal
di dentro gli
stilemi di una
tradizione; che
in questo caso
abbia poco a che vedere con quella genericamente raw-rock di altri gruppi esaminati qui, poco
importa. È il modus operandi che conta.
Nella frantumata discografia Odd Clouds spicca, insieme all’omonimo vinile per Qbico, il cd-r
Cleft Foot Of The Woods. Vera e propria summa dell’operato del collettivo è nelle parole di
Pottinger una sorta di tributo alla vita delle foreste attraverso rumorismo e jazz libero, stralci
weird-folk e percussività ossessiva, spesso in modalità impro che si muove come un monolite lungo 11 tracce untitled e 74 minuti di puro delirio/
deliquio.
Legato a doppia mandata con la Tasty Soil e con
Pottinger è un altro personaggio della Detroit più
out & weird. Il suo nome è già noto a quanti siano
avvezzi a frequentare le melmose paludi dell’underground Usa. Voce e automutilazioni punk per
i seminali Piranhas e membro (futuro o passato,
a titolo definitivo o meno non è dato sapere) di
Little Claw, Jamie “Jimbo” Easter è l’ennesimo
personaggio inquietante prodotto dalla Detroit
degli ultimi anni a meritare un posto d’onore nella presente indagine perché anche lui cortocircuita punk e arte, come ricorda Pottinger: Posso affermare tranquillamente che siamo diventati amici attraverso
la musica e l’arte. Il mio rapporto con lui risale al 2002,
quando dopo una performance che tenni come Cotton Museum all’annuale festival Noise Camp organizzato dai tipi
di Time Stereo (gente del giro Ufo Factory/His Name Is
Alive, nda), rimanemmo a parlare della nostra ossessione
per i ritratti di bestie e mostri.
Da quella chiacchierata, complice anche lo scioglimento dei Piranhas, nasce il sodalizio che
avrebbe portato a Odd Clouds – sorta di comune
musicale primi anni 70, la definisce sempre Pottinger – e a numerosi travasi, prestiti, collaborazioni
in campo strettamente artistico.
Personaggio chiave, dicevamo questo James Easter, per comprendere il sottobosco arty-alienpunk di Detroit. C’è lui infatti dietro i fantastici
Druid Perfume – di cui leggerete più avanti – ma
ultimamente Jimbo si è riciclato come il più weirdo
performance artist della città dal punto di vista meramente artistico: scultore, illustratore, pittore sempre sul filone artbruttista più mongoloide. Cosa
questa che ci viene confermata da Scott della X!
Recs: Non solo Jamie Easter ma anche Timmy Vulgar
(Human Eye) hanno sempre fatto arte e un po’ meno artshows; è però pur vero che entrambi con le rispettive band
hanno sempre considerato molto l’aspetto visuale dei live,
molto più della media delle band da queste parti. Qualcosa
che si può definire mutoid-punk e che si può considerare
come outsider art che va di pari passo con le loro musiche
da outsider.
Una retrospettiva/omaggio/celebrazione delle
opere di Jimbo Easter è proprio in questi giorni
ospitata da un altro luogo famoso per i cortocircuiti tra esposizioni d’arte e musiche off, la UFO
Factory gestita da Davin Brainard, Dion Fisher
e quel Warren Defever fondatore di His Name
Is Alive.
È nei programmi schedulati da posti come questa art-gallery che risiede forse il senso ultimo del
suono mutoide e mutante della scena detroitiana:
art-shows in cui collidono la pop-art trasfigurata
di Dion Fischer e le asperità di Wolf Eyes, la concettualità buddista e post-postmoderna del progetto HNH – Humanities Not Heroes di Trong
G. Nguyen (obbligatorio approfondire) - e il postpunk alieno dei Druid Perfume di Easter.
L’Ufo Factory – continua sempre Scott via mail –
ha fatto molti ottimi show in passato, sia d’arte che di
musica…c’è inoltre uno studio di registrazione gestito da
Warren di His Name Is Alive. I Druid Perfume ad esempio hanno registrato tutto lì, così come si accingono a fare
Terrible Twos e i miei Frustrations.
Un luogo minuscolo, con le pareti completamente color argento che ricordano giocoforza quelle
di una astronave aliena. Una TAZ (le zone temporaneamente autonome teorizzate da Hakim Bey, a.k.a.
Peter Lamborn Wilson) nel cuore dismesso della
città, l’Easter Market district, riconosciuta perfino dal Mocad, il Museo di Arte Contemporanea
di Detroit che ha ospitato una installazione che
riproduceva in cardboard gli spazi della galleria.
Un luogo in cui ha sede la Church Of The Infinite
gestita dal reverendo Dion Fischer e disponibile
per matrimoni, funerali, battesimi e quant’altro;
in cui si organizzano concerti/proiezioni/colazioni all’alba incentrate sul 2012 (Silver Sunrise) o
Drop Out /
53
eventi musicali per festeggiare il piano argentato
appena acquisito. Insomma, qualcosa che tende
a motivare e smuovere la fantasia della Detroit
underground. A playhouse for arty outsiders, in definitiva.
A dirla tutta, Chris Pottinger sembra però scettico sulla sopravvivenza di questa ondata a metà
tra punk alieno e arte concettuale: La scena mutoidpunk di Detroit è molto interessante, ma credo che qualche
anno fa fosse veramente eccitante. Oggigiorno è difficile
trovare uno spazio in cui organizzare weirdo-music show
tanto che credo sia sempre più arduo iniziare per le nuove
band. Realisticamente, la Ufo Factory gestita dalla crew
di Time Stereo è una delle poche art-venues che organizza
concerti regolarmente.
Cosa che apparentemente stride col nostro articolo, tanto e tale il fermento che agita la città e i
suoi sobborghi in questo periodo. [s.p.]
I
diseredati
Infatti intorno ai poli di cui ci siamo occupati, c’è
una intera genia in fermento continuo che diviene impossibile focalizzare in qualsivoglia compilation, per quanto lungimirante fermoimmagine
di un suono tentacolare in continuo mutamento
essa possa essere.
Ecco così che accanto a quei nomi già (ehm) noti,
si aggirano per i basement metropolitani o in
scalcinati bar disposti a tutto pur di attirare movimento, bands di furibondi capaci di declinare
in varie forme il concetto di (dopo)punk, zozzo e
garagey o deviante e mutoide poco importa.
Spesso, al centro di questo vorticoso riprodursi di mutanti dopo-punk – mutante mutandis, verrebbe da pensare – si ritrova lui, Timmy Vulgar
(de)mente di Human Eye/Clone Defects. Alieno
visionario e volgare, sboccato quanto completamente folle, spalma le sue perversioni tra vari moniker. I Reptile Forcefield innanzitutto; sorta
di Devo psychodelic più raw e rissosi, strutturati as
usual nella sacra triade rock (Vulgar a chitarra e
voce, Ben alla batteria e Sean al basso) con un 7”
in uscita per Solid Sex Lovie Doll Records e una
54
/ Drop Out
quanto mai appropriata traccia disponibile sul
myspace dall’eloquente titolo Alien Creeps. Oppure nella incarnazione più zozza, sguaiata e garagey del solo project Timmy’s Organism, in
cui a raggiungerlo è spesso il sodale Fast Eddie.
A far compagnia al volgare per antonomasia, ci
sono però degni compari. Ad esempio i Tentacle Lizardo e Tentacle Saxophone, misteriosi
e scarsamente prolifici – per usare un eufemismo,
dato che la pubblicazione di dischi sembra essere
giusto un optional – duetti batteria/basso e batteria/sax ruotanti intorno al drummer Christmas
Woods. Uno che cambia ragione sociale come
cambia le mutande; uno che dichiara a chiare
lettere I am not human anymore su uno dei suoi infiniti myspace; uno che sembra capace di sondare
l’intero spettro delle musiche larvatamente rock
passando con nonchalance dalle declinazioni
noise a quelle post-punk abbrutite, dal black metal sintetico da immaginario Dungeons&Dragons
di Fantastic Dungeon alla onanistica art-brut
del collettivo E.A.R. Immortal, per finire con
l’electro-pop deviato di Ill Tongue o con la
lounge da cabaret satanico del progetto omonimo. L’elenco potrebbe realmente continuare,
tanti e tali sono i moniker sotto i quali si rifrange
la musica di Woods, ma giusto per inquadrarne
la follia latente, basta leggere ciò che scrive di sé:
I am a creature of habit seeking myth, might and magic.
I am child of the living dead who happily plays in the
blood and bile of slayed beasts of lore. I tell stories with
harsh noise to warn the coming of the TENTACLE. BEWARE foolish humans for your existence is but a mere
teardropped stain on my cape of terror. I am TENTACLE
LIZARDO!
Roba che proprio nell’ascolto di Tentacle Lizardo risulta essere piuttosto affine alla realtà delle
cose. Accompagnato dal basso di Chris Fusion,
Tentacle Lizardo sembra uno spin-off di Hella e
Lightning Bolt in fissa col metal e con i giochi di
ruolo. Il sax di Ryan Sabatis che lo accompagna
in Tentacle Saxophone invece ne propone una
variante (ehm) jazz ancor più schizoide e aliena.
Da dissociati, insomma. Ma credo che questo sia
ben chiaro ormai.
Intorno a questi veri e propri personaggi ruota
ancora un microcosmo sfaccettato e lurido che
assume di volta in volta connotati musicali diversi: giusto per rimanere sul versante garage-rock
Lee Marvin Computer Arm e Mahonies, ad
esempio. I primi, un sestetto aperto dagli umori
fortemente sixties, sono addirittura additati come
The future of Detroit Rock dalla stampa locale e hanno
un nuovo album in dirittura d’arrivo per Italy Records, altra realtà che andrebbe investigata a fondo, se solo
ci fosse lo
spazio.
I
Mahonies,
invece,
sono un
duo form a t o
under the
influence
of many
beers, e si
dilettano
a sputapiranhas
re fuori
grezze
minuterie rock con piglio punk e dissacratorio
come d’ordinanza nel loro unico 7” per X!. Più
articolati sono i suoni prodotti da altri nomi sconosciuti ai più, magari già sciolti e riformati sotto
altri nomi come Mountains & Rainbows – al
confine tra psych, impro e rock grezzo –, Gardens, trio in fissa pesante coi Velvet o gli oramai
incensati ovunque Tyvek che dopo aver mutato
per ragioni di copyright il moniker in Tivjk ed
esser stati inseriti praticamente ovunque nel filone shitgaze, continuano imperterriti a produrre
vinili su vinili di garage storto e spastico. L’attualizzazione mutata del rock, in definitiva. [s.p.]
P iranhas
Si diceva sopra di Jamie “Jimbo” Easter e del fermento che si raccoglie intorno al suo convincente
nuovo progetto, i nascenti Druid Perfume, che
ha proposto di mettere in piedi all’amico Bryan
Wade all’inizio del 2008; una summa e parziale
pretesto per questo articolo di mappatura della
città dei motori. In effetti il brivido che corre lungo la schiena mentre si ascolta il loro recentissimo
self titled è qualcosa che raccoglie una sommatoria di unghie che per anni hanno minato e scavato la nostra pelle e le nostre orecchie – tutte provenienti
dai suoni lontani da
noi, ma
vicini
tra loro,
di una
città decadente
ma fervidissima.
Per arrivare ai
Druid
Pe r f u me, è di piacevole obbligo parlare innanzitutto
della formazione da cui la band di oggi ha preso corpo, se non altro per il passaggio massivo
dei componenti da un gruppo all’altro. Stiamo
parlando dei Piranhas, formazione leggendaria
che per ferocia punk-oriented e per estetica seminalmente deviata e mutante è stato un sicuro
pilastro della Detroit di cui vi parliamo.
Chris Pottinger probabilmente si riferiva infatti a loro e a Human Eye, quando faceva cenno,
durante la nostra conversazione via mail, ai bei
tempi andati (qualche anno fa, non di più) in cui
la scena mutoid-punk detroitiana era veramente
fresca e frizzante. E se la sfilza di nomi che oggi
Drop Out /
55
druid perfume
vi proponiamo lo contraddice di facto, è la facilità di impatto dei piccoli ferocissimi pesci che
pensiamo avesse in mente Chris quando chiosava così il lustro passato. I Piranhas sono brutti
sporchi e cattivi, sono il cuore punk (ma anche
garage) della faccenda, ma soprattutto sono agitatori. Non agitatori sociali, niente agit prop, ma
agitatori fisici. È la massa la chiave del suono dei
Piranhas. Lo si intuisce fin dalle due primissime
uscite, ancora non assestate nella formazione: il
56
/ Drop Out
singolo d’esordio Garbage Can (Addition Records/Tom Perkins Records, 1999) e il 12 pollici
Piranhas Attack (Tom Perkins Records, 2000)
– che fa guadagnare alla band la copertina di Maximum Rock n’ Roll – vero spasmo punk (sentite
Hard To Do) dove però il suono è ancora memore
della dirompenza del garage più puro.
Tutto aggredisce della carica dei Piranhas; tutti
e cinque i componenti – Nai, Ami, Jamie, Brian,
Karl, Ryan – ce lo dimostrano nel vero debutto
full-length, Erotic Grit Movies, uscito nel 2002
per la In The Red, etichetta in cui i pesci sembrano nuotare con la disinvoltura di casa, e per cui
faranno uscire anche il successivo sguaiato canto
del cigno Piscis Clangor, del 2004. Ma non andiamo troppo di fretta, resistiamo alla tentazione
di seguire i folli binari del combo. Se ci sono due
cose che dei Piranhas rimangono tatuate nelle
orecchie, sono la voce smaccatamente eccessiva
di Jamie e l’organo impazzito di Ami, che trascina i riff della chitarra verso velocità supersoniche
o gorgoglii infernali. Pare ovvio parlare di denti
e tagli; quella tastiera – rubata alle spiagge della
West Coast – rende scellerato e ancor più tagliente il sound di Erotic Grit Movies, dove inizia
a prendere una maggiore autorità rispetto agli
esordi. Ma un altro elemento da non dimenticare
è il sax, strumento che ci traghetterà verso i druidi. Lo suonerà Bryan Wade, e si fa sentire già da
Soft Mold Prisons (in Piscis Clangor), traccia che
prima occhieggia al jazz modale e lo trasfigura
in una visione quasi sci-fi a bassissima definizione, melmoso ma sempre e comunque inevitabilmente dentato. Sempre in Piscis, i latrati della
title-track ci fanno pensare a qualcosa che lentamente si allontanano dalla veemenza punk per
raggiungere uno statuto di declamazione sgolata;
nascono probabilmente qui i timbri vocali di Jamie che poi sentiremo nel nuovo gruppo che sa
di druido.
Certo un riassunto sulla vicenda Piranhas non
potrebbe finire qui; si dimenticherebbe di singoli
come Dictating Machine Service (Rocknroll
Blitzkrieg, 2002) ma soprattutto di quella che forse
è la vera dimensione totale dei piranha della città
dei motori. Si è detto dell’attenzione all’aspetto
visivo e performativo di Jamie “Jimbo” Easter; e
se i dischi sotto la ragione sociale Piranhas non
mancano di farci sballottare la carne, è anche vero
che fanno immediatamente pensare alla foga che
questi cinque potevano esprimere dal vivo. Una
delle loro ultime apparizioni è stata sotto il natale
scorso, in un concerto proprio a Detroit di cui si
fa menzione da qualche parte nella rete. La vera
testimonianza a portata di tutti è però raccolta e
consegnataci nel Live On WFMU, registrazione
di un concerto del 24 gennaio 2003 in una radio
del New Jersey; purtroppo neanche qui possiamo
cogliere la carica visiva del combo – ma un’idea
ce la si può fare sentendo il modo in cui risolvono
decomprimendone in successive esplosioni il riff
della finale Isolation – presente appunto in Dictating…, il 7” sopra menzionato.
In definitiva il punk dei Piranhas è fatto di addizione e di continua esplosione. È uno sfogo sulla
lunga distanza con fortissimo potere aggregativo
– e quindi anche in questo fondamentale per la
scena mutoide di Detroit. Ascoltandoli non vengono certo in mente Chrome – paradossalmente
risuonano più i Deerhoof e i loro discepoli, comunque spazzati da quella voce anti-indulgente
e da quella velocità supersonica figlia della velocizzazione del punk. Ma anche, per tornare alla
chiave garage di cui sopra, viene in mente quella
psichedelia di metà Sessanta – ascoltate la versione del live di My Desease per avere un’idea di
quello di cui stiamo parlando. E, esagerando un
poco, si pascola fino nella no-wave nel lato B di
Dictating…, come nel caos intollerabile di cui
raccontano i testimoni della sala prove in cui i
primi PF provavano liberi Interstellar Overdrive. E,
infine c’è l’ironia dalla loro; quella con cui rubano a un luna-park i jingle di Piranhas Attack,
facendoli diventare anthem deturpati. [g.c.]
D ruid P erfume
Insomma, una la costante nei Piranhas; trattare
con foga qualsiasi riferimento. In questo i Druid
Perfume non sembrano figli loro; e però l’anagrafe ci smentisce. Nei Druid confluiscono infatti
tre dei cinque piranha della formazione dei dischi
su In The Red – per l’esattezza Jamie “Jimbo”
Easter, Ryan Sabatis e Bryan Wade. E sicuramente i druidi hanno ancora in bocca il sapore del
sangue delle razzie acquatiche del gruppo di provenienza. Eppure l’esperienza della storica band
Drop Out /
57
In The Red in qualche modo è svanita. Brian, da
noi intervistato in proposito, si prende poco sul
serio e minimizza:
“Riguardo al nostro rapporto con Ian e Ami, chitarra e
tastiere dei Piranhas, siamo ancora buoni amici. Quella
band ha semplicemente finito il suo corso, agli occhi di tutte
le persone che ne erano coinvolte. Parlando invece di cosa
è cambiato musicalmente, posso dire che i Druid Perfume
sono una cosa del tutto diversa. Il modo in cui scriviamo è
molto più “sciolto”, quasi sfilacciato, ognuno di noi contribuisce, e soprattutto nessuno di noi pensa a cosa facevano
prima i Piranhas e a cosa fanno ora i Druid Perfume.
L’unica cosa rimasta uguale è che ci sono ancora cinque
idioti che si mostrano le terga a vicenda”.
Comunque sia, se dovessimo trovare dietro ai DP
un albero genealogico immanente (quindi basato
solo sulla musica come testo) e tutto interno a Detroit, forse approcceremmo più Human Eye che
Piranhas. Di fatto, non smettiamo di dirlo, è una
matrice intera che schizza le sue linee storte verso
la vicenda dei Perfume. Storia che inizia acusticamente solo qualche mese fa, con la pubblicazione
dello splendido self titled, che qui su SA vi abbiamo presentato il mese scorso.
Il 2008 aveva già partorito un altro supergruppo dalle parti della motor city. Si chiamavano
Fashion e pescavano da Terrible Twos, The
Mahonies, Tentacle Lizardo e ovviamente Piranhas. Ma i protagonisti dell’anno rimarranno
innegabilmente i Druid. Del loro album di debutto dà notizia il co-proprietario della piccola
etichetta Pigs, per cui uscirà a dicembre 2008, su
un forum, un paio di mesi prima dell’uscita – specificando di non accettare pre-order, e sotto sotto
già sapendo di fare il botto.
Certo i Druid Perfume sono innanzitutto dei maestri nel sapersi scegliere i riferimenti, che disposti su un tavolo uno affianco all’altro, come carte,
fanno venire davvero voglia di giocare. La prima
cosa di cui ci si stupisce, dato il paragone con
la band di provenienza, è la trasformazione del
piglio vocale di Jamie. Non più un ossesso punk
ma un maturo – post-hippy – declamatore con
58
/ Drop Out
l’ugola in fiamme. C’è innanzitutto, dietro al suo
nuovo modo di prevalere, la raucedine cadenzata
di Captain Beefheart; ma non solo. Tutto il
suono Druid Perfume è in qualche modo figlio
dell’attitudine free dei Sessanta. La voce risente
dei happening, dei jukebox idrogenati di Allen
Ginsberg, e solo da lì partendo – e sopra tornando – del para-blues/anti-blues delle folli armonie
di Don Van Vliet.
A piè pari si va nel terreno che in suolo vicino al
nostro ricorda ovviamente gli Zu, e cioè il freejazz fragoroso del sax. I Perfume però sono in
grado di fare di più, cioè di riuscire ad avvicinare
le modalità jazz, quei riff sostenuti dal sassofono
di Wade e poi lasciati andare come cani liberati
dal guinzaglio verso accidentate lande free – lande in cui lo strumento a fiato spesso rincorre o si
fa rincorrere dalle macchine analogiche.
L’estetica anche qui è insomma l’accrescimento
smodato, a volte. Ma più a parole che ai fatti –
come invece facevano i Piranhas. Si legga l’autodescrizione sul loro MySpace per avere conferma
(www.myspace.com/druidperfume); proprio lì si
menziona la componente circense, altra chiave
espressa nel sound dei druidi, che li avvicina alla
parabola di Laughing Clowns, oltre che ai Lubricated Goat del nuovissimo mondo, e, ancora su beefheartiana memoria, a Stu Spasm.
Si pensi poi anche a una leggendaria band postpunk/newwave che proveniva anch’essa da territori lontani dalle metropoli LA e NY, ovvero i
Debris; un viaggio fino a metà Settanta fatto forse
per arrivare all’ultimo tassello per così dire “naturale” da citare, parlando della creatura detroitiana. Parliamo dei Pere Ubu, per almeno un paio
di buone ragioni. La prima risiede in una sorta di
suddivisione interna del sound dei DP, che riesce
a miscelare gli elementi pur mantenendo una scissione coerente e sinergica tra sezione ritmica rock
e dada-follia free. Una scelta che già David Thomas, a suo tempo, sanzionava, durante i live dei
figli di Jarry, segnando con un gesso sul palco la
riga che divideva la parte intellettuale della band
da quella primordialmente rock.
Ego Death dei DP è
la traccia che forse
si espone meglio a
questo paragone,
con quel suo rapporto tra synth/
theremin-sassofono da un lato
e batteria-bassochitarra dall’altro,
con la voce e la
decelerazione che
fanno da collante
dell’assurdo.
Di micro in macro,
e per finire, c’è poi
un confronto possibile tra la Clevedruid perfume
land di allora con
la Detroit di oggi;
due città industriali in crisi, due realtà che devono raccogliere i pezzi del capitalismo che vedono
a pezzi; due posti dove la musica in determinati
momenti ha fatto versare litri di inchiostro.
Insomma nei Druid Perfume c’è tutta l’arte del
florilegio che ha in sé la scena di Detroit. Chiamiamo a testimone anche l’ancor più recente
7” Goat Skin Glue (Italy Records, 2009), ma
soprattutto il DVD appena uscito sulla parabola
Perfume, che ci sembra un po’ chiuda il cerchio
con musica e immagini della motor city druida e
mutoide. I diretti interessati glissano ironicamente in proposito:
“Il DVD è solo una compilation di pezzi di show dell’anno scorso. C’è un po’ di gente che ha girato dei video durante i nostri live e poi li ha condivisi con noi. Il nostro amico
Davin Brainard ha editato il tutto e l’ha infiocchettato, art
work compreso. Ma non siamo tanto soddisfatti; su video
non abbiamo la fisicità che vorremmo, sapete, ci piacerebbe
avere dei fisici scolpiti e oleati tipo quelli dei Manowar.
Fortunatamente abbiamo tutta la primavera davanti per
rinnovare a fondo la
nostra immagine…
“A proposito di Detroit, poi, sì, la puoi
sicuramente chiamare “scena”, ma
la cosa non significa
poi molto per noi.
Abbiamo attorno
grandissime band
con cui suonare, e
tante delle persone
che le compongono
sono nostri grandi
amici da tanto tempo. Ciò detto, nessuno si preoccupa di
stare dentro “generi”
o “scene”. Facciamo
solo la musica che ci
piace, vogliamo che
le nostre orecchie
siano colpite dal suono di una navicella spaziale che si
scontra con il vertice della classifica di Billboard. Davvero.”
Ma forse dietro questa scrollata di spalle c’è una
forma sottile “di autoconsapevolezza”. Di fatto, a far cortocircuitare più parti di questo articolo, a brevissimo usciranno due 7” dei DP,
uno su X! Records e uno su M’Lady’s Records.
Non si può poi non menzionare uno degli strumenti per così dire “interni” di Detroit più efficaci di auto-rappresentazione. Per concludere il sopralluogo sul mutoidismo di Detroit,
andate a visitare il sito Detroit Art Space (www.
detroitartspace.10eastern.com). E, come suggerisce il gestore, “Stay Tuned for Fut! ure Events!” [g.c.]
Drop Out /
59
quietudine consolata da un profluvio di carezze,
ben vengano le malinconie ma come potrebbe un
ibrido tra Abba e Bangles (The Crowning), scomodando al limite un Brian Wilson senza follia
(Love Has Left the Room) o delle Ronettes circuite
Goldfrapp (Here Are Many Wild Animals). Il senso
di aurea piattezza si dissolve ascolto dopo ascolto, rivelando lievi ma significative oscillazioni
come il country-soul esotico della conclusiva The
Weed Had Got There First (Mark Linkous alla slide), una Golden Teeth And Silver Medals tra mollezze
Rufus Wainwright e lalleggio da cartoon (in
duetto con Nicolai Dunger) e una fastosa Chinatown pervasa di effluvi Steely Dan e scenografie Andrew Lloyd Webber.
Disco innocuo come da copione ma smerigliato
con cognizione di causa, per chill out senza sensi
di colpa.
(6.1/10)
►►►►recensioni ►► ►► aprile
cryptacize
Matteah Baim
1990s - Kicks (Rough Trade, Mar
2009)
G enere : I ndie rock
Se pensate che il titolo assomigli a quello del precedente Cookies, non avete sentito il disco.
I 1990s sono un gruppo degli anni 00s (in realtà, sotto altre vesti è attivo fin dal decennio del
nome), che contrariamente ai contemporanei
non suona tanto 80s ma piuttosto un po’ 70s e
un po’ 60s.
Nonostante ciò, si comporta come quei gruppi
dei 00s che hanno introiettato il no future e sparano tutto subito in un debutto magari non originale ma vivace, magari uno o più singoli assassini,
anche piacevole come viaggio nel suono del momento, ma alla seconda tornata già non proprio a
secco di idee ma quasi. Accantonarli dopo il primo disco verrebbe quasi automatico, se non bisognasse recensirli: e allora scopriamo che la lunga
esperienza ha dato ai 1990s una professionalità
per cui non si può dire che queste canzoni siano
60
/ recensioni
particolarmente “brutte”, e nemmeno “noiose”:
solo che non prendono mai vita più di tanto. Né
d’altra parte, l’esperienza ha impedito loro di cedere a quella legge (misteriosa nell’epoca del cd)
per cui i pezzi più interessanti si trovano verso
la fine dell’album (con l’eccezione dell’iniziale
Vondelpark la quale faceva sperare meglio, almeno
quanto a verve).
Ne consegue che, dopo aver vagato tra maniera rock appena sporcata di modernità, un po’ di
grinta congenita allo stile ma senza la freschezza
del primo, qualche whoo-whoo, e un singolo irritante e prolisso come 59, Kicks si anima solo
in occasione della morbidezza 60s di Local Science
(ma allora le sapete scrivere…), e un po’ nei brani
successivi. Per cui alla fine non è tanto questione
di ordine delle canzoni, ma di poche idee e vivacità addomesticata: no, non somiglia a Cookies.
(5.7/10)
Giulio Pasquali
A Camp - Colonia (Pias, Gen 2009)
G enere : pop
Otto anni dopo Gran Turismo torna il side
project di Nina Persson, l’intrigante frontwoman dei The Cardigans, fiancheggiata dall’ex
chitarrista degli Shudder To Think - nonché
marito - Nathan Larson e da Nicolas Frisk degli
Atomic Swing, più alcuni ospiti ragguardevoli
come la poliziotta Joan Wasser, il redivivo James Iha e la violoncellista Jane Scarpantoni.
Strana personaggia Nina, che non sai bene dove
voglia andare a parare, sia quando beccheggia tra
pop ammiccante e fregola alternativa, sia quando
come in questo Colonia si concede tutta intera
alle più accomodanti situazioni, morbidezze radiofoniche pervase di languide sofisticherie, con
una onnipresente venolina country a pulsare un
po’ Chrissye Hinde e un po’ Sheryl Crow
(vedi il singolo Stronger Than Jesus ).
La scaletta è una pulitissima dozzina che mira ad
ingraziarsi i melomani a bassa intensità, poca in-
Stefano Solventi
AA. VV. - Dillanthology 1 (Rapster
Records, Mar 2009)
G enere : hip hop
Ciò che più spiace del povero James Yancey a.k.a.
Jay Dee/J Dilla/Jaylib è che, ad anni dalla pre-
matura dipartita per arresto cardiaco, ancora non
abbia ottenuto il posto che gli spetta nel gotha
dell’hip-hop. Dotata di peso pari a quella di altri
grandi produttori e stile acuto e riconoscibile, la
sua opera resta patrimonio dei più avvertiti e non
aiuta che, mentre era tra noi, James mantenesse
un basso profilo pubblico: per lui poco glamour e
molta sostanza, la musica a parlare eloquente in
numerose produzioni, sovente nemmeno accreditate. Poiché tuttavia il tempo è galantuomo siamo
certi che la riscoperta non tarderà, e nel frattempo appuntiamo il contributo offerto alla causa da
questo primo tomo della serie Dillanthology.
Ideale per il neofita, la raccolta alterna note gemme (una Stakes Is High che per qualche minuto
sottrasse De La Soul dal ruolo di decaduti; lo
scintillio donato a Common in The Light; Didn’t
recensioni /
61
Highlight
Cryptacize - Mythomania (Asthmatic Kitty Records, Apr 2009)
G enere : mes sindiepop
È possibile decidere, la domenica mattina, di tenersi le
ciglia attorcigliate tra loro, il viso assonnato, di mantenere quello stato, quel torpore per tutta la giornata, per
tutta la settimana seguente? E, variatio, per un album
intero? Bisogna saper costruire un pop trasognato, canzoni che vagano in testa dopo averle sentite come i neuroni nel cervello di quella Sunday Morning. Difficilissima
più che innocente l’operazione dei Cryptacize di Mythomania, perché condotta senza sbagliare un colpo,
senza farci rinsavire né cedere ai richiami di Morfeo. Sentite What You Can’t See Is, il
modo in cui i diversi passi ritmici dei tamburi discreti, del basso, della voce, creano layer
di relazioni soffuse; chiuse da un accenno melodico sospeso nel vuoto.I responsabili di
questo album azzeccatissimo sono Chris Cohen (vecchia conoscenza seminale Deerhoof, e poi Curtains) e Nedelle Torrisi. Si chiamano fuori se interpellati da un mondo
del passato pop che chiamano in causa in tanti modi diversi, ma prima di tutto per il
loro modo di costruire le canzoni. Sostengono di aver scritto solo un disco “romantico”. Ma hanno un’evidente coda di paglia. C’è una sensazione che cresce negli ascolti
ripetuti di questo album. Qualcosa che inizialmente ci fa pensare, senza un preciso
raziocinio possibile, a Raincoats e Young Marble Giants, magari – anzi sicuramente
– passando dalla breccia creata dai Beach House l’anno scorso. Dopo un po’ si focalizza un’ipotesi; riguarda l’intera messthetics del primo periodo Rough Trade – ancora
torpore, dolce confusione, niente di violento o effettivamente derivante dal caos. L’idea
è insomma che i Cryptacize stiano traghettando l’atteggiamento – che agiva per punti
– della messthetics alla struttura armonica delle canzoni (Gotta Get Into That Feeling), cosa
che del resto faceva anche Barrett, ancor prima che la messthetics esistesse, con quel
gioco ai dadi tra un accordo e l’altro. Quindi messthetics applicata all’intera struttura
della canzone, sopra la levità di tastiere chitarre pelli di tamburo. E per fare questo ci
sono le pause. Quelle che interrompono Blue Tears prima della conclusione, giusto per
citare il primo esempio del disco. Nella delicatezza della composizione è contemplato
l’attimo del silenzio. Ci sono tecniche che eludono la bellezza di sapersi sovrapporre
al pop anni Sessanta, e quindi dall’esercito di persone che hanno già condotto quella
azione. E, per concludere, arriviamo a una constatazione abbastanza basilare, forse la
prima da fare, qui però non a caso messa alla fine; in Mythomania non c’è un brano
che metteremmo da parte – forse anche grazie al testimone equilibratissimo che si passano le due voci di Chris e Nedelle. C’è una continuità impressionante, la stessa che
ci aveva impressionato nei Beach House; quella che semplicemente appartiene ai
grandi dischi.(7.5/10)
Gaspare Caliri
Cha Know, pura sensualità carnosa che avvolge
Erykah Badu), classici favolosi che a metà dei ’90
lanciarono il Nostro nell’empireo - Runnin’ e la citazionista Drop a beneficio dei Pharcyde; il Busta
Rhymes snodato in Show Me What You Got - e ma-
teriale da intenditori. Nel quale spiccano le curve pericolose di una Fall In Love appartenuta ai
suoi Slum Village che stenti a credere abbia due
decenni sul groppone, oppure le deformazioni di
una levità prossima al subliminale che fecero la
grandezza dell’uomo di Detroit, evidenti in Hip
Hop Quotable (AG & Aloe Blacc) e nella più tarda
Dolla di Steve Spacek. Assapori il gusto sommo
per l’intarsio e il trattamento inusuale dei campioni, i dettagli che emergono alla distanza e lo
sdrucciolare obliquo della ritmica che hanno indicato una via percorsa da moltitudini. Figura di
Genio e modestia pari solo alla sfortuna che lo
bersagliò, Yancey ci manca. Ogni giorno di più.
(7/10)
Nello specifico, spiccano le schermaglie lui vs. lei
in F Your Ex (Sway più Stush), il contorto Joker
con Retro Racer e l’orientaleggiante Standard Vip
di Jme. Il resto lo fanno tinte soul mutanti (Dva e
Alanha con I’m Leaving; Ps Vip di Lauren Mason e
Dok) e il pioniere Dizzee Rascal con la satura I Luv
You, una sensazionale contaminazione electro-folk
(!!) come I Don’t Smoke architettata da Dee Kline
e il rhythm & horror Interested intestato a Terror
Danjah. Materia un poco ardua da maneggiare se
non respirata sul campo e ciò nonostante perfetto
specchio dell’epoca in cui viviamo, tutta frenesia
di vita e consumo che influenza tanto la fruizione
della musica che la sua concezione. Ne consegue
un loop sonoro vivace, per quanto livellato verso
il basso dall’eccesso di offerta. E ciò a prescindere
dall’ambito di riferimento, come da qualsiasi futura crisi che ci aspetta dietro l’angolo.
(6,6/10)
Giancarlo Turra
Giancarlo Turra
AA. VV. - Rinse:07 Spyro (Rinse, Apr
2009)
G enere : ragga , grime
La Rinse è l’etichetta fondata dai Klaxons qual-
cosa come tre anni e rotti or sono con l’appoggio
della Polydor e consacrata a tracciare una mappa
della proliferazione britannica di ragga e grime.
Che sono qui proposti in ogni possibile variante
attraverso uno stordente assemblaggio di assalti
e storture ritmico-verbali in tracce che di rado
superano i due minuti di durata (bizzarro che
l’unica volta in cui ciò accade si tocchi il vertice della raccolta: la splendida Shadow Boxing di
Spyro è robotica sinfonietta dal passo stralunato
e cinematico). Poiché i brani scorrono uno dentro
all’altro a comporre un mix frammentato e collagistico, i maniaci non esiteranno a mandarlo giù
tutto d’un fiato. Tutti gli altri possono piluccare
il meglio, ossia quanto trascende i confini di due
sottogeneri tra i più “pompati” dell’ultimo lustro
al presente dati come ampiamente digeriti.
AA. VV. - Iberico Jazz (Vampisoul,
Gen 2009)
G enere : jazz lounge
Dopo aver ampiamente indagato certe stramberie “cool” fuori da casa propria, la Vampisoul
punta con quest’uscita i riflettori verso la patria:
Antoliano Toldos fu pioniere spagnolo del jazz indipendente con la sua etichetta Calandria, attiva
sul mercato dei 45 giri tra il 1967 e il 1972. Da
buoni latini sottomessi a un regime militare, il loro
concetto di jazz era disteso e groovy, specialmente nei brani dei primi anni ’70 prossimi all’estetica “acid” poi riscoperta dalla Talkin’ Loud (si
vedano la title track del Quinteto Montelirio, o la
funky Modulo Jazz opera dell’ensemble di Toldos
stesso); altrove dedita invece a solare e scorrevole
gradevolezza in cui il Davis degli “schizzi di Spagna” perde ogni drammaticità e lentezza a favore della componente ritmica (Opaco, sempre dei
Montelirio).
La qual cosa non significa necessariamente mancanza di spessore, semmai un po’ troppa oleograrecensioni /
63
fia nel cercare la gioia in musica per sfuggire la
realtà, di conseguenza bandendo uno sperimentalismo “free” dalle eccessive connotazioni sociopolitiche. Ecco dunque una vena leggera e festaiola farsi largo, tanto nell’indiavolata Tom Jazz a
firma Conjunto Estif che nella sorniona Nocturno
Jazz (sempre farina del padrone di casa), in una
Jazz A Las Tres (Conjunto Segali) da commedia
leggera e una Improvisando del Quinteto Diamont altrettanto. A conti fatti e in considerazione
dell’epoca, niente più di una pagina destinata agli
amanti di musiche incredibilmente strane. Che in
verità strane lo sono poco e anzi nulla.
(6.3/10)
Giancarlo Turra
AA. VV. - Real Authentic Reggae Compiled By David Rodigan Vol. 2 (BBE,
Mar 2009)
G enere : reggae
Bella maniera per David Rodigan di festeggiare
il trentennale della sua attività di dj radiofonico:
appassionato e collezionista di reggae sin da giovane, si affacciò infatti nell’etere dai prestigiosi
microfoni della BBC nel 1979, passando poi alla
Capital Radio cantata dai Clash col popolarissimo
show Roots Rockers, nel quale ospitò numi tutelari
tipo Bob Marley e Burning Spear. Nel frattempo consolidava la sua reputazione nei club, acquisendo popolarità finanche in Giamaica grazie
anche alle competizioni coi titolati colleghi locali.
Questo il sintetico curriculum che offre il destro
a festeggiamenti e doverose celebrazioni giunte al
secondo capitolo, dove la scaletta è improntata a
un mellow mood che della musica in levare raccoglie il senso di gioiosa e vitalistica indolenza,
e - eccezion fatta per il godereccio Macka B - allo
stesso tempo redime e critica una realtà sociale
drammatica. Non manca nulla da questo punto
di vista e acuto è l’alternarsi tra nomi noti (Melodians, Sugar Minott) e di nicchia (Jimmy London,
Leo Hall): dall’anello di congiunzione tra rocksteady e dub della fiatistica This Is Another Festival
64
/ recensioni
(Jackie Edwards) a un Gregory Isaacs che caracolla su basi primi Ottanta, dalla ruffianeria sorridente di Chakademus & Pliers alle dilatazioni
sornione del maestro di melodica Augustus Pablo in No Entry si gode, sempre e comunque. Altri
momenti memorabili? Eccovi serviti: Brent Dowe
e la distesa innodia tra country e Sandinista! di
Deh Pon Di Wicked; perle lovers innervate di soul
come Do You Love Me e My Confession, rispettivamente dal repertorio di Johnny Clark e Cornel
Campbell; uno svagato Delroy Wilson sospeso tra
funk, jungla e bassi gommosi; Wayne Wade, la cui
fluviale meraviglia Billy Red diresti madre sia di
Bankrobber che della facciata B di Combat Rock.
Meglio fermarsi qui con le citazioni, sia della ditta
Strummer-Jones che delle tracce di Real Authentic
Reggae. Il rischio sarebbe di elencarle tutte, tanto
quest’antologia si racconta ottimamente assemblata. Fateci un pensiero.
(7/10)
Giancarlo Turra
AA. VV. - Soul Jazz Singles 2008-2009
(Soul Jazz Records, Apr 2009)
G enere : urban sounds
Non lascia ma raddoppia, Soul Jazz, approntando
un nuovo tomo di brani sparsi sui 12” pubblicati
lo scorso anno, replicando così la felice iniziativa dedicata alle annate 2006-2007. A dire il vero
triplica, giacché a
questo giro la raccolta è un’autentica abbuffata di
tre dischetti - uno
dei quali mixato
e disponibilie solo
in tiratura limitata - venduti però al
prezzo di un singolo. Senso acuto per il commercio in tempi di crisi, e va bene, rafforzato però dal
rispetto nei confronti di acquirenti e appassionati
che è una delle caratteristiche fondanti della griffe londinese. La quale, come ben sappiamo, è per
lo più attiva nella riscoperta di materiali dimenticati ancorché degnissimi infondendo la medesima passione di quando preferisce tastare il polso
del “qui e ora”.
All’attualità sonora, peraltro edificata su cento e
più ieri, Soul jazz destina principalmente le uscite
in vinile di durata medio/breve qui recuperate. Se
siete dell’opinione scettica che non sempre quantità rimi con qualità, sappiate che a questo giro
c’è da scartare giusto un pugno di brani “dopo disco” poco incisivi e qualche ridondanza stilistica
eccessiva. Quasi non vi si fa caso, avendo l’opportunità di affondare i denti nel meglio del dubstep
(i classici Kode 9, Digital Mystikz e Cult Of The
13th Hour a.k.a. Kevin Martin sono all’apice della forma) e segnare sul taccuino nomi meno noti
epperò di rilievo: su tutti il Ramadanman aereo di
Carla e profondamente ambient-dub di Dayrider,
per quanto non siano certo da meno un nervoso
Kutz o le venature post-industriali escogitate da
Kalbata. Altrove si gioca di baile-funk screziato
wave (Tetine remixati da CSS: I Go To The Doctor
è da sfracello su qualsiasi pista), il ragga(muffin)
urbano della fenomenale Warrior Queen (sia nella rutilante Things Change che nel martello Shooting Range) e ibridi assortiti come Pinch, la cui
Fighting Talk distilla orrore in frammentato ralenti techno. Nondimeno, la palma di capolavoro assoluto se l’aggiudica Simplex di Subway, otto minuti in decollo dall’electro e planata su paesaggi
alla Blade Runner attraverso la Germania dipinta
da Harmonia e Cluster. La festa, avrete inteso, è
grande: di quelle che il mattino seguente lasciano,
per svariate ore, un benefico cerchio alla testa.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
AA. VV. - Shiftless Decay: New
Sounds Of Detroit (X! Recs, Feb
2009)
G enere : alien - punk
Eccola qui la compilation che fotografa il suono
della/nella motor city degli ultimi anni. Una doz-
zina di gruppi che sferragliano principalmente su
chitarre e ampli, sporcando i suoni d’origine a
seconda delle proprie inclinazioni e perversioni
sono stati reclutati da mr. X! Recs, al secolo Scott
Dunkerley, qui presente coi suoi Frustrations.
Passato e presente, nomi (ehm) noti e iper-underground, veterani della scena e pivellini all’esordio
come in una compila che si rispetti, insomma. A
far la differenza – si veda anche lo speciale Mutant Motown – c’è il fatto che Shiftless Decay non è solo un programmatico e lungimirante
fermo-immagine sull’attualità musicale cittadina,
ma anche una indagine/riflessione sociologica
sul sottobosco “artistico” detroitiano come mezzo per il superamento del decadimento che sta attanagliando (un po’ tutte a dir la verità) le ex città
dell’automobile mondiale. Quasi che la compila
stessa sia un tentativo – seguito dall’esecuzione
live on stage negli Shiftless Decay Thursdays di febbraio – di cementare la scena cittadina, di compattarla per poter dare un calcio in culo alla crisi
dei finanzieri e rinascere nel segno dell’arte.
Sul versante musicale – che è poi quel che ci
interessa in sede di recensione – la meglio/peggio gioventù di Detroit sciorina pezzi quasi tutti esclusivi eccezion fatta per un paio: dentro ci
trovate lo shit-rock-gaze di Tyvek (Flashing Lights
in versione demo), il fuzz distorto e robotico di
Frustrations (Psychedelic Motorcrash più che un
titolo è una dichiarazione d’intenti), il lightningbolt-goes-to-forest sound di Tentacle Lizardo,
l’ossessione alien-punk dei fantastici Human
Eye, il twee-pop talmente datato da apparire
fake di Heroes & Villains, quello horror-wavey
di Johnny Ill Band e quello ipervitaminico e in
totale overdrive punk di Mahonies, il lamentoso
e ossessivo grido no-wave di Little Claw. Palma
del miglior pezzo del lotto va indubbiamente a
Odd Clouds. Gum Coup Follicle è as usual una
escursione free (rock, psych, jazz e chi più ne ha
più ne metta) che più free non si potrebbe.
(7/10)
Stefano Pifferi
recensioni /
65
Highlight
Agaskodo Teliverek - Psycho Goulash (Midfinger, Feb 2009)
G enere : noise - pop - rock
Di lui avrete forse apprezzato l’esordio Ash Wednesday (XL / Self, 13 luglio 2007), celebrato fin dall’uscita
come uno dei migliori album di stampo folk sfornato
da questi anni zero. Probabilmente ricorderete anche
qualche particolare biografico, vista l’assoluta peculiarità: classe ‘76, Elvis è figlio del grande attore hitchcockiano Anthony Perkins (morto di AIDS nel ‘91)
e della fotografa Berry Berenson (morta nell’attacco
alle Twin Towers dell’undicisettembre), nonché nipote
della stilista Elsa Schiaparelli e pronipote dell’astronomo Giovanni Schiaparelli.
Casomai non bastasse, dall’albero genealogico potreste cogliere nobili, atleti, diplomatici, teosofisti... Come da tutto ciò sia uscito un folksinger fa parte dei misteri che
rendono gustosa l’esistenza, fatto sta che Mr. Perkins e i suoi Dearland sono una band
dal ragguardevole impatto, il cui approccio alla materia suona febbrile e generoso,
sottilmente esotico e inguaribilmente balzano. Con questo omonimo secondo lavoro
dimostrano almeno d’aver smaltito quell’inevitabile retrogusto luttuoso vagamente
Eels, spostandosi dalle parti d’un M. Ward colto da nevrastenia Okkervil River.
Anche la voce sembra più sbrigliata, echeggiando ora nuances Roy Orbison (nella
processione a cuore bigio di Hours Last Stand), ora l’appassionato flemma di Paul
Simon (soprattutto in I Heard Your Voice In Dresden) oppure la devozione strascicata
d’un Jeff Magnum (nella malinconica 123 Goodbye). Quanto ai pezzi, beh, sono
folli e trepidi, improbabili frenesie capaci di svolte incantevoli e striscianti ripescaggi
mnemonici (che spaziano dal Dylan più grifagno al Van Morrison più estatico),
tirando in ballo spesso e volentieri ebbrezze sgangherate da brass-band (Doomsday,
Send My Fond Regards To Lonelyville). Tra una Shampoo che ti spiazza col passo epico e le
analogie stralunate, una I’ll Be Arriving che trascina blues in un bitume d’hammond e
la struggente levità di Chain Chain Chain, si consumano gli estremi poetici di un album
forse non all’altezza del predecessore, se volete meno intenso e un pizzico più giocoso
(casomai fosse una colpa), ma dalla statura indubbiamente elevata.
(7.3/10)
Torna il “cavallo rampante” – questa grossomodo la traduzione del nome Agaskodo Teliverek
– col suo concentrato di noise-rock convulso e
schizzato. Per chi non avesse incrociato l’omonimo esordio di un paio d’anni fa, si tratta di un
quartetto multietnico di base a Londra formato
da due chitarristi d’origine ungherese (Miklos
“Miki” Kemecsi e Tamas “Tomi” Szabo), una
tastierista/cantante made in japan (Hiroe Takei)
e un batterista new entry apparentemente autoctono (Pharoah S. Russell al posto del dimissionario Thomas R. Fuglesang). Psycho Goulash è
esattamente quello che vi viene in mente da titolo
e copertina. Svisate skingraftiane e ritmi spasticcore coloratissimi uniti a cavalcate ipercinetiche
capaci di macinare e masticare indie-rock d’annata, potente noise-rock sboccato, immaginario
da video game impazzito, attitudine ludica retrofuturista virata dance e gusto pop a tutto tondo. E
così melodie (strumentali e vocali) si appiccicano
al cervello mentre giri grassi di tastiere/chitarre
fanno muovere le chiappe che è un piacere, mentre non cessa mai la voglia schizoide e fanciullesca
di rompere, mischiare, sovrapporre pezzi e suoni
come fossero tasselli di un meccano surrealista.
Quando a tutto ciò si uniscono le fascinazioni da
“oriente in disarmo” dei due chitarristi come in
Mousy, si rischia la potenziale hit del sottobosco.
Forse non supereranno il limite del culto ristretto,
ma sarebbe un peccato visto anche che – vedasi
foto online – sono brutti come la fame. Potrebbero, si spera, essere l’ennesimo schiaffo in faccia
all’indie fighetto e laccato.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Stefano Pifferi
Elvis Perkins - Elvis Perkins In Dearland (XL Recordings, Mar
2009)
G enere : folk rock
Airportman/Tommaso Cerasuolo Weeds (Lizard, Mar 2009)
G enere : cover album
C’è poco da aggiungere sui dischi di cover, dato
66
/ recensioni
che molto – a torto o a ragione – è stato già detto.
Alla fin fine, quale che sia la motivazione dietro
una scelta del genere, c’è solo una unica grossa,
innegabile quanto banale verità: che piacciano
o meno. Che riescano cioè a toccare le corde
dell’animo dell’ascoltatore. Che le facciano vibrare. Tutto qui. Semplicissimo.
Tanto quanto affermare che questo Weeds, nato
dalla joint-venture tra Airportman e Tommaso Cerasuolo, voce dei Perturbazione, le corde
dell’animo dell’ascoltatore le tocca eccome. Sarà
molto probabilmente per affinità elettive con chi
ascolta, piacevolmente “costretto” ad un percorso a ritroso nella propria genesi musicale. O forse
molto probabilmente sarà perché queste prove di
pura poesia vengono fuori dal cuore di chi le ha
volute omaggiare.
Ci piace immaginarceli in una casa calda. D’inverno. Di lunedì. Lì a provare pezzi di memoria
in compagnia. Lì riuniti a tracciare una sorta di
autobiografia artistica più che un tributo agli autori tirati in ballo (dai Cure a PJ Harvey, passando per That Petrol Emotion, Porno For
Pyros, The The, Echo & The Bunnymen,
ecc.). Ci piace immaginarceli come quattro amici
che si raccontano l’un l’altro a botte di pezzi e accordi, melodie e ritornelli; e che attraverso la musica si raccontano all’esterno. In punta di plettro.
Delicatamente. Senza essere invadenti. Proprio
come i pezzi omaggiati in questo Weeds, roba
che cresce a “lievitazione naturale”.
A noi ha dato immenso piacere lavorare insieme, stare insieme, suonare insieme, concludono i quattro nella
presentazione del disco. A noi da immenso piacere starvi ad ascoltare, ci sentiamo di aggiungere.
(7/10)
Stefano Pifferi
Alessandro Benvenuti - Capodiavolo .01 (Materiali Sonori, Mar 2009)
G enere : canzone d ’ autore
Attore di cinema ma soprattutto di teatro, Alessandro Benvenuti non ha certo bisogno di presenrecensioni /
67
tazioni. Parlano per lui i trent’anni e più di carriera spesi sui palchi di tutta Italia e le numerose
pellicole a cui ha prestato corpo e anima. Poche
persone, tuttavia, conoscono il musicista che si
nasconde dietro a quel sorriso un po’ ironico da
toscanaccio di provincia.
A porre rimedio pensa allora questo Capodiavolo .n1, prima uscita ufficiale del Nostro nel
mondo della discografia adulta e raccolta di brani scritti per l’omonimo spettacolo teatrale/concerto. Sette episodi prodotti da Arlo Bigazzi che
richiamano in toto la tradizione della canzone
d’autore, pur con un’impronta piuttosto personale. Non tanto dal punto di vista musicale, dal momento che per tutta la mezz’ora di programma
si viaggia tra arrangiamenti acustici, folk leggermente jazzato e qualche accento etnico comunque in linea con una certa istituzionalità formale
della scuola di appartenenza. Quanto dal punto
di vista dei testi: ironici, intimisti, ma anche disillusi e disposti a schierarsi. La Capodiavolo che dà il
titolo al disco è forse la track più significativa, con
i suoi parallelismi commoventi tra Italia e famiglia Benvenuti, ma anche il resto del programma,
diviso tra impegno e sentimenti, non dispiace affatto: Professione: terza vittima parla di stragi di Stato e servizi segreti deviati, Cretini dentro riflette sui
nostri tempi con fare quasi bandistico, Incantevole
caduta sa di autobiografia, Souvenir d’Alassio è uno
strumentale di pregevole fattura. Il tutto filtrato
dai caratteri tipici del personaggio Benvenuti, che
non sono né l’esistenzialismo lucido di De Andrè
né l’alto lignaggio di Fossati. Semmai la leggerezza e l’orgoglio di un Guccini sui generis, con la
voglia di prendersi sul serio ma anche di ridere
– amaro – della vita.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Aliftree - Clockwork (Compost Records, Mar 2009)
G enere : downtempo
A volte ti domandi chi glielo faccia fare, a certa
68
/ recensioni
gente, di pubblicare dischi. Nell’anno in cui Tosca
tornano a calcare le scene, uno sarebbe portato
a dire che il downtempo si stia sollevando dalla
polvere; che, testimoniato lo svilimento in cui è
finito, qualcuno ne tenti la riabilitazione. Non è
così, poiché ormai siamo andati ben oltre la decadenza a mera tappezzeria sonora di qualcosa
che - per quei proverbiali quindici minuti - fresco
e nuovo lo fu. Poveri Massive Attack e Kruder &
Dorfmeister: per quanto incolpevoli, a osservare
l’inettitudine della loro figliolanza devono sentirsi
non poco male.
Ebbene, c’è da sperare che nessuno consigli loro
l’ascolto di Clockwork, settanta minuti che si destreggiano negligenti tra lati b degli Hooverphonics
(Timestretched), becero soul-pop (Never Be The Same)
e sigle televisive
da anni Ottanta
(Not Gonna Waste
My Time). Grande cura formale e peso specifico scarsissimo in
questo trip-hop atmosferico senza un briciolo di
personalità o ironia, in grado di smuovere moderatamente l’attenzione solo quando sulla battuta
rallentata innesta pulito pianismo jazz alla Keith
Jarrett e soluzioni cameristiche come nell’iniziale
Aurevoir e nel felpato congedo Dead Flowerz. Per
il resto, soltanto sbadigli e noia. I salatini, prego. (5.5/10)
Giancarlo Turra
Art Brut - Art Brut vs. Satan (Cooking Vinyl UK, Apr 2009)
Rakes (The) - Klang! (V2 Music, Apr
2009)
G enere : I ndie rock
A quanto pare cominciano ad essere vecchi anche i “gruppi nuovi”: non è arrivato solo per i
Franz Ferdinand il momento del “difficile ter-
zo disco”, infatti, ma è tempo di bilanci anche per
Art Brut e Rakes che lo pubblicano in contemporanea (e siccome quando toccò ai capostipiti
Strokes poi seguì il silenzio, allora il passaggio è
cruciale davvero).
Per entrambi, l’opera seconda era stata l’occasione di fare un passetto in avanti rispetto agli esordi, specialmente per i Rakes che, pur pagando
qualcosa in freschezza, si erano allontanati dai
ristretti canoni del genere mostrando progressi di
scrittura e di varietà e definizione del suono.
Nei nuovi dischi, invece, le cose cambiano. Gli
Art Brut si dimostrano molto più fedeli alla linea di Ferretti continuando con l’autoironia
(Am I Normal) e lo spirito postmoderno con cui si
parla di fumetti ed altri elementi della contemporaneità (DC Comics and Milkshakes) compreso il
rock, satireggiato come sempre nei furti di Mysterious Bruises, nel culto di The Replacements (gruppo
omaggiato anche da Fiumani, sempre parlando
più dell’oggetto disco che della musica dei Mats)
e nella resurrezione del conflitto Beatles/Stones in What A Rush, ma anche giocando con i
titoli delle canzoni (I Will Survive e Jealous Guy nel
precedente, qui abbiamo Twist and Shout). Sempre
scherzando a 300 all’ora, con melodie che pur
non incocciando il singolo memorabile sembrano uscire senza sforzo, con un Argos che insieme
ironizza su/adotta il cantato venato di ansia da
ortodossia angular e uno stile che indulge all’essenzialità degli esordi e rinuncia ad eventuali
esperimenti e strade nuove.
I Rakes, invece, operano una restaurazione ancora più netta di una formula iniziale che già si
distingueva poco da quella di molti coevi: sezione
ritmica a tavoletta anche qui, un cantato che più
che altro recita, chitarre con abuso di mignolino
sulle quarte, stop and go, qualche bella distorsione ogni tanto, ironia/citazioni quanto richieste
dal genere, qualche pezzo efficace e l’unica variante di un piano in The Woes of The Working Woman e nella nevrotica Muller’s Ratchet, non a caso
tra le migliori del lotto.
Un passo indietro per entrambi, insomma, anche
se gli Art brut continuano a farsi preferire perché
il discorso di scardinare un genere dall’interno
a suo modo può anche tornare, e perché l’intelligenza continua a tenerli un passo più in là di
quella stretta osservanza emul che porta i Rakes
al paradosso di una musica tanto energica e frizzante quanto ormai immobile.
Poi i dischi divertenti e gradevoli lo sono, non
sono la verve, la grinta e l’arguzia a mancare,
non è l’ironia: è che anche il divertimento può
evolversi, e in prospettiva di carriera forse sarebbe meglio.
(6.3/10)
Giulio Pasquali, Edoardo Bridda
Bat For Lashes - Two Suns (Parlophone, Apr 2009)
G enere : songriting , avant pop
La sintesi postmodernista operata dalla multistrumentista e artista visiva anglopakistana Natasha
Khan, alias Bat For Lashes con il secondo album
ci colpisce favorevolmente. L’avevamo vista l’anno
scorso di spalla ai Radiohead e in quell’occasione il live avrebbe meritato una sede più tranquilla e consona agli input che mandava. Il debutto
del 2007 (Fur And Gold) ci era sembrato un po’
dispersivo, ancorché ricco di spunti interessanti,
sulla scia di un songwriting tra espressività Bjork
e tentazioni anche folk rock.
Two Suns opera invece una riuscita mediazione tra il suo cantautorato classico ed umori che
oscillano tra psych, gospel, dance e pop di marca
prettamente Eighties. Nell’ultimo anno e mezzo
infatti Natasha è volata a New York, dalle parti di
Brooklyn, dove ha convissuto con la scena artistica locale, tra Gang Gang Dance, TV on the Radio,
MGMT e gli Yeasayer, titolari l’anno scorso della
psichedelia pop di All Hour Cymbals.
Proprio il gruppo in questione, per mano di Chris
Keating and Ira Wolf Tuton, fornisce le basi e il
basso per due dei pezzi del cambiamento del disco, il singolo Daniel, pop dance autoironica come
recensioni /
69
potrebbe suonare oggi una Kate Bush sintetica,
e Pearl’s Dream, brano che è concettualmente il
cardine del concept che è Two Suns. Altrove è
mediazione tra la sua anima più normalizzata di
songwriter, nelle ballad soprattutto, e quanto c’è
di nuovo, come il gospel psych tribale di Peace Of
Mind tra Yeasayer e Vampire Weekend, l’incedere
ultimi Portishead dell’opener, la solenne Glass, la
bjorkiana Two Planets.
Con un ‘attitudine mistica di cui l’album è permeato, una base concettuale e una miriade di citazioni tra letteratura, cinema e musica, l’artista
cosmopolita rivela così un eclettismo di fondo che
avevamo solo supposto. Non ultimo, il contributo
di Scott Walker nell’ultimo pezzo, The Big Sleep,
un duetto breve ma intenso su una ballad minimal sulla scia delle ultime cose dell’autore americano.
(7.2/10)
Teresa Greco
Bill Callahan - Sometimes I Wish We
Were An Eagle (Drag City, Apr 2009)
G enere : indie - folk
Lungi dal voler negare all’artista il sacrosanto diritto a rinnovarsi, bruciare il suo stesso passato,
ridimensionarlo. Tuttavia la seconda prova del
Callahan ex-Smog, oltre a scordare nell’armadio
la magia dei tempi andati, non aggiunge nulla di
sostanziale oltre ai titoli di 9 canzoni nuove, che
poi tanto ‘nuove’, a ben guardare, non sono. Mica infastidisce l’operazione di pulizia, la quale alle imprecisioni esecutive del periodo lo-fi qui
preferisce un rigore ben arrangiato, evidente nella
notturna The Wind
And The Dove. Il fatto è che la voce del
nostro, ingabbiata
all’interno di ritmini metronomici e
orchestrazioni leccate, subito dopo
il primo ascolto, si
70
/ recensioni
aggiudica per un secondo tentativo come mero
sottofondo. E allora ai voglia a giocare agli autocitazionismi (i 2 secondi della chitarra sgangherata in Rococo Zephyr, l’iconografia degli animali,
il timbro inconfondibile del cantato/ recitato),
giusto per tenersi stretta la frangia nostalgica del
proprio pubblico.
Fa rabbia e ci si chiede il perchè dello sfacciato
riciclaggio della struttura (già debitrice a Satellite
Of Love di Reed) di Sycamore, che puoi riascoltare
in Too Many Birds ben più flaccida e risaputa. Poi è
logico che, sparando in aria, qualcosa la puoi anche colpire, e la conclusiva Faith/ Void, lungi dalla
pretesa di divenire un classico, ti smuove dentro
una fisiologica delicatezza, sussurrando sconsolata “It’s time/ to put God away”. Non stupirebbe insomma che oggi Bill centrasse la classifica,
magari grazie a un bel videoclip a promozionarlo
con un’acustica sdrucita e un cappellino di traverso, per aggiungere un tocco di mistero e un
vezzo di vanità nei quali l’ascoltatore si possa riconoscere.
(6.3/10)
Filippo Bordignon
Black Dice - Repo (Paw tracks, Apr
2009)
G enere : spastic - dance - dice
Cosa rimane oggi dei Black Dice? Bjorn Copeland, Eric Copeland e Aaron Warren veleggiano
sempre più distanti da quelle Beaches & Canyons presso cui amavano dar prova del loro masculino coraggio sonoro. Questa non è più, o solo,
la band che animò la Brooklyn d’inizio decennio,
insieme ad altre amiche per la pelle, quali Animal Collective o Gang Gang Dance, facendoci conoscere uno dei migliori live act dell’epoca. Questa non è più, o solo, la band che ha a che
fare con la visual art (DFA Records, Picturebox
Inc, Fusetron) e che pubblica curati libri in collaborazione col fotografo Jason Frank Rothernberg (Gore) atti a testimoniare l’incontenibile
verve espressiva dei Nostri. E, certamente, non
è più o solo il gruppo che ci donò Load Blown
non molto tempo fa, per darsi al divin-repellente
gioco della decostruzione dancey. Repo, quinto
studio album dei Dice, si compone di home recordings e sessioni registrate presso gli studi Rare
Book Room della Grande Mela. L’artwork, 20
pagine di libro in cui pullula la solita immaginatività della band, ricorda il summenzionato Gore.
La musica, invece, riparte da quanto detto in Load
Blown. Nite Creme è
un frullato appiccicoso di Tutu di
Miles Davis con
una band che fosse
passata dall’hardrock alla Cher
per vocoder. Una
versione ‘taragna’
e spasticoide delle
movenze da dancefloor già sublimate nel disco
precedente. Ogni pezzo declina la propria antinomia stilistica: il ‘collage-invasione degli ultracorpi’ di Glazin, le coglionerie hip-hop di Earnings
Plus Interest, l’On The Corner-frullato che qui si
intitola La Cucaracha. Inanellando il bizzarro al futuribile, i Renaldo And The Loaf a Moroder,
DAF ai Butthole Surfers, i Black Dice hanno
individuato l’orticello in cui piantare, annaffiare e
poi raccogliere le stravaganze stilistiche di cui da
sempre capaci. Spesso il tutto sa di bubble gum
alieno, o di critica sociologica mal digerita. Non
tutti gli incastri reggono perfettamente il puzzle
in Repo. Seppure ogni tessera, presa di per sè,
palesi più pregi che difetti.
(6.5/10)
Massimo Padalino
Bliss - No One Built This Moment
(Music For Dreams, Apr 2009)
G enere : N ew A ge
Se il genere new age partito musicalmente e discograficamente negli anni Settanta s’è via via
trasformato e adattato alle mode e alla società,
l’ultimo lascito di quel sentire, almeno a livello di
immaginario condiviso, sono stati gli Enigma.
Quei canti gregoriani e break beat ultra patinati
erano la più funzionale contropartita spirituale
dell’elettronica di ‘consumo’ dance.
All’epoca erano il ‘nuovo’ per l’ascoltatore già troppo vecchio per i rave ma affamato di suoni chic con quel che di ‘profondo’.
Oggi. Nel 2009. Quel nuovo si traduce in chimiche soniche differenti solo per la facciata. Nella nuova produzione dei danesi Bliss (avvezzi a
comparire in infinite compilation simil-Buddha
Bar) quei synth stiracchiati e quelle voci calde e
esotiche sono un filo diretto con le antiche glasse.
La scuola mainstream adult pop exotic è sempre
la stessa.
Due glitch, qualche risciacquo ritmico molto
white à la Everything But The Girl, buoni
inserti di chitarra e archi figli di una qualità del
registrato più alla portata delle tasche se non di
tutti ma di tanti e ci siamo. Da segnalare Stop Me,
traccia ambient house versione 2.0 con ritornello
appiccicoso per il chill after (nu) rave. Da sconsigliare per chi vuole entrare nel groove da dancefloor. Sarà apprezzato invece da qualsiasi locale e
ascoltatore pro chill-out. Se un disco può essere
onesto, i Bliss lo hanno prodotto.
(6.1/10)
Marco Braggion, Edoardo Bridda
Bonnie “Prince” Billy - Beware (Domino, Mar 2009)
G enere : indie country
Da che ha raggiunto il proprio abbagliante zenit con Arise, Therefore prima e Now I See A
Darkness poi, Will Oldham ha genialmente peregrinato attorno al nucleo del suo stile di fresca
consolida, così antico e in ragione di ciò attuale.
Dall’ascesa nell’empireo dei classici, l’uomo del
Kentucky si è così concesso il lusso di rileggere
se stesso, indagare felici accenni di modernità e
immergersi in benefici bagni tradizionali mai tradizionalisti.
recensioni /
71
Ciò che seguita a stupire, nondimeno, è la qualità
elevata di una discografia-fiume dalla quale toglieresti giusto quel paio di pleonastici live; senza
dimenticare l’abilità di mescolare continuamente
le carte e lasciarci in positivo confusi circa la natura della sua musica.
Non fa eccezione Beware che, dopo lo splendore
folk a lievi tinte visionarie offerto meno di dodici
mesi or sono, abbraccia forme country-rock lontane tanto dall’ingessata Nashville quanto dalla
controcorrente di
Steve Earle. I clichè sono irrisi e superati alla stregua
del Townes Van
Zandt maturo, ma
ancora non ci siamo, perché il disco
è spesso avvolto da
un’indolenza traslucida, lontana parente del falso sereno di Harvest se Neil Young l’avesse registrato con la testa di
On The Beach. Il che significa che il conto di nuovo
un po’ torna e un po’ no. Che la penna scintilla e
gli arrangiamenti puntano l’intarsio, ricchi di cori
e fiati, marimba e organi, violini e plettri assortiti
senza imporsi su brani il cui lignaggio, alto come
d’abitudine, emerge alla distanza.
C’è una sequenza finale splendida da ascrivere tra
le cose oldhamiane migliori di sempre, un viaggio
che dai fantasmi metà celtici e metà del border
della sublime There Is Someting I Have To Say introduce al sensazionale commiato Afraid Ain’t Me,
galoppo di luci del Van Morrison “astrale” e
tentazioni Calexico sciolte in puro stile Oldham.
Per giungerci attraversi l’innodica malinconia
senza pari di I Am Goodbye e il passo da sardonico
e anticato jazz anni ’20 di Without Work, You Have
Nothing. Qui il nucleo significativo di un’opera che
per il resto sgorga con la naturalezza di chi non
deve dimostrare niente a nessuno, perciò si prende i rischi che gli aggradano. Canone del più fragrante e cristallino offrono - pescate quasi a caso,
72
/ recensioni
sappiatelo - Death Final, My Life’s Work e Heart’s
Arms, ché nella vita occorrono anche e soprattutto sicurezze. Continua a camminare, Will.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
Broken Family Band (The) - Please
And Thank You (The Track & Field
Organisation, Apr 2009)
G enere : pop rock
Quinto album in sei anni per questo quartetto
inglese che sembra aver scoperto il trucco per
tracciare la linea più breve tra rock alternativo
britannico e americano, così da togliere di mezzo
ogni intralcio alla verve, libera così di sbrigliarsi
frizzantella e passionale. Chitarre, basso e batteria - non si scappa - fanno una quadratura inattaccabile, solida, carezzevole. Il passo è fresco e
vigoroso e fresco con implicazioni malinconiche,
le ruggini che senti sono scosse d’assestamento da
linea d’ombra, le melodie spacciano trepidazioni
senza mai mollare la briglia dell’entusiasmo.
Ecco quindi una St Albans che stempera ugge
Steve Wynn ed estro Blue Aeroplanes, ecco
Don’t Bury Us come potrebbero dei Pavement
impelagati Blur, oppure una Stay Friendly come
degli Oasis strattonati Uncle Tupelo. E poi altre combinazioni di sapori sempre sul filo tra alternativo d’Albione e il dirimpettaio Americana,
scomodando Neutral Milk Hotel in Cinema vs.
House, Gomez e Sebadoh in Son Of The Man,
certi Stereophonics in orbita Malkmus in Old
Wounds, e via discorrendo.
Disco di cose semplici e banali ma convinto e perciò - convincente. Come dire: il segreto del
buon pop-rock.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Bruce Peninsula - A Mountain Is A
Mouth (Bruce Trail, Feb 2009)
G enere : G ospel post - punk
2nd 4th World War è semplicemente i 16 Horsepo-
Highlight
Here We Go Magic - Self Titled (Western Viny, Apr 2009)
G enere : indie pop
Era dai tempi dei Lemonheads, quando questi riadattarono il classico Mrs. Robinson nel lontano 1992, che il
nome di Paul Simon non circolava in ambienti indie.
Tutto merito, prima, dei Vampire Weekend e del loro
lavoro echeggiante, in diversi tratti, la world music di
Graceland, e ora di Luke Temple nelle vesti di Here
We Go Magic.
Da New York, come lo stesso Simon. Da New York,
come Animal Collective e Yeasayer. A detta di
qualcuno, non poteva essere altrimenti. Vero. In Here We Go Magic c’è tutto quello
di cui sopra: world music e pop sghembo. Due mesi di lavoro homemade con un
quattro piste al seguito. Punto. Only Pieces e Fangela sembrano provini “andati a male”
di Graceland: voce salmodiante e musica intrisa d’umori etno. In Ahab, il canovaccio
ripiega in lidi ipnotici. strana sensazione: Sting nei solchi di Remain In Light?
Strano, ripetiamo, ma credibile.
Poi lei, Tunnelvision, il singolo ideale in un mondo migliore: prendete A Paw In My Face
di The Field, privatela del beat minimale e immaginatela nelle mani di un busker new
yorkese. Se escludiamo le digressioni “cosmiche” di Ghost List, Babyohbabyijustcantstanditanymore e Nat’s Alien, Temple non fa che prendere il pop di traverso, come se gli Animal Collective giocassero a fare Yeasayer o viceversa (I Just Want To See You Underwater)
oppure alla stregua di un cantore off di Broadway (il valzer di Everything’s Big).
True magic.
(7.5/10)
Gianni Avella
wer di Heel On The Shovel, accompagnati da
un coro gospel, nero come la pece, paccaminoso
come la notte, perduto come l’anima vostra, se
una ne avete. Ci voleva una band così. Il vecchio
e il nuovo che, in maniera né vecchia né nuova, si
danno la mano. Ispirazione, la parola chiave.
I Bruce Peninsula vengono da Toronto, Canada. E portano con sé “singers, yellers, whisperers, whiners, garglers, gentles and goons”. Una
folla suona questo disco. Tre batteristi, un coro,
composto di 5 donne... Ne esce fuori una sorta di
“ghostly choral music” che beve il sangue a Nick
Cave e ai 16 Horsepower. Leon Taheny (batterista coi Sebastien Grainger & The Mountains
e tecnico con i Final Fantasy) è un po’ l’anima
dell’operazione. Due i traditional presenti. Il primo, Satisfied, è il pezzo che, così riletto, Cave
anela di rileggere la notte: una tempesta gospel
disperata e una danza senza veli, sfrenata, lubrica
e impudica al contempo. Musica del diavolo, la
recensioni /
73
chiamano. Anche se passa attraverso quella degli angeli. L’altro, Drinking All Day, un inno gospel
reso ‘progressivamente’. Il lavoro raccoglie le atmosfere dei posti in cui è stato registrato: la chiesa
St. George The Martyr, uno scantinato presso la
Toronto University e sei altre stanze sparse per
Toronto. Il lamento febbrile del call’n’response
Crabapples, l’impressionista Weave Myself A Dress
o ancora il pow wow Steamroller prendono forza
dalla debolezza umana ivi cantata. Forza oscura,
mai oscurante
(7.5/10)
Massimo Padalino
Camera Obscura - My Maudlin Career (4AD, Apr 2009)
G enere : indie pop
I Belle & Sebastian odierni, molto più che
un’affermazione. Il gruppo scozzese in passato
ha collaborato non a caso con Stuart Murdoch
ed ha avuto tra i suoi fan il fu John Peel, e dopo
l’affermazione nel 2006 con il “difficile terzo album” Let’s Get Out Of This Country fa ora il
suo ritorno. E’ più che una conferma, questo My
Maudlin Career. La consueta mistura di indie
pop e orchestrazioni, con il gusto per ritmi jazz,
non dissimilmente da Broadcast,
Stereolab e compagnia. In aggiunta qui c’è la presenza, molto più
che in passato, di
elementi di soul (il
cantato Al Green
dell’opener French Navy, per esempio e un dichiarato amore per Van Morrison tra le altre cose),
di ispirazioni al cantautorato USA seventies, pensiamo in particolare a Paul Simon, citato in The
Sweetest Thing con la sua frase “50 ways to leave your
lover”e Lou Reed; e persino accenni di country
nella svenevole Away With Murder.
Nel complesso c’è un buon equilibrio tra gli ele74
/ recensioni
menti strutturali dell’album, e le aggiunte arricchiscono piuttosto che dividere. La voce suadente di Tracyanne Campbell sia quando rimanda
all’altro nume tutelare Lloyd Cole, sia quando si
apre a piena voce e si strugge di malinconia, è un
lasciapassare per il calore e l’intensità che riesce a
sprigionare il disco. Bentornati.
(7.1/10)
Teresa Greco
Capital - Days And Nights Of Love
And War (Fierce Panda UK, Apr 2009)
G enere : new wave
Quella dei Capital è una wave dal taglio enfatico, tra Echo & The Bunnymen, The Sound e
Cure altezza Pornography.
Il debutto degli inglesi di Eastbourne, Days And
Nights Of Love And War, è un ep di sei tracce dal
cuore epico/romantico come lo sapeva essere il
compianto Adrian Borland (Ruin) oppure il Robert Smith di un tempo (in Public Square e Easier To
Leave vi ascolterete quei gloriosi giorni). Si respira
una brezza simile alla Liverpool di primi eighties (la cadenza Echo & The Bunnymen di Broken
Glass) per via di quei ricami di chitarre e tastiere
retrò, e menzione particolare va al vocalist Nick
Webb il cui registro, seppur reazionario, cesella
alla perfezione un lavoro dove la sola Earphones –
scialba ballad electro – funge da elemento fuori
contesto. Chissà, forse ci troviamo al cospetto dei
nuovi Interpol. Le potenzialità ci sono. Altro che
Metric.
(6.5/10)
Gianni Avella
Casiotone For The Painfully Alone Advance Base Battery Life (Tomlab
DE, Mar 2009)
Casiotone For The Painfully Alone Vs. Children (Tomlab DE, Apr 2009)
G enere : R aw synth pop
Nel mentre avevo in testa ogni concetto e sfumatura, introduzione e conclusione di Advance
Base Battery Life, album di ben quindici a me
inediti brani di Owen Ashworth, venivo a scoprire con ugual imbarazzo e soddisfazione che
il promo già stramacinato all’incirca due mesi fa
non era il nuovo lavoro d’inediti del tweepopper
a stelle e strisce più amato di Sentireascoltare,
bensì una raccolta di singoli e tracce compilation
only registrate tra il 2004 e 2007, periodo in cui
il Nostro aveva portato Etiquette in giro per il
mondo e oltre. Reset dunque per una recensione già scritta che si concludeva nel più roseo dei
modi. È il “migliore disco e l’ideale compendio
di quanto scritto e arrangiato finora” ...e dunque
sotto con le aspettative, maggiorate chiaramente,
per Vs. Children, l’album scritto e pensato per
essere un tutt’uno.
Sono le peggiori premesse psicologiche per affrontare il nuovo lavoro, soprattutto quando si rivelerà
il classico disco minore o l’altrettanto proverbiale retroguardia. Più interessante a questo punto
spostare il ragionamento su uno dei
più classici paragoni che in questi
casi si applicano in
ambito indie pop.
Visti i tempi e la
nostra retrospettiva, la produzione
di Casiotone è idealmente vicina a quella degli Smiths: l’immediatezza e l’impatto sono una questione di febbrili,
emozionanti, lacrimevoli singoli (ancora meglio
se scritti e arrangiati ad hoc in occasioni differenti), e di contro album mai così belli o così insostituibili. Dunque canzoni sparse come veicolo
espressivo ideale sia per la freschezza del risultato
(si ascoltino i registri alti del già classico Old Panda
Days con Nick Krgovich dei No Kids oppure il
carezzevole twee pop di White Corolla) sia per arrangiamenti (il vocoder della cover di Springsteen
Born in the USA, le drum machine WARP della
menzionata Old Panda Days), e seguendo questo
ragionamento il passato di Ashworth ti torna
come pugno di Advance quando il nuovo lavoro ha qualcosa di ex post pensato e scritto in un
recinto.
Probabile un piccolo momento di stanchezza
classica di quando sai di ripeterti, di contro non
è il caso di affondare colpo alcuno quando i nuovi brani non portano con sé pesanti stanchezze.
Eppure, la magia di una Holly Hobby, ritratto dalla disarmante potenza, non la troverete in Vs.
Children, e neanche la seconda cover del Boss
in scaletta Streets Of Phildadelphia.
A proposito di ques’ultimo brano: importante
sottolineare come sia stereotipico, in pratica un
pre, di ogni Casiotone song. Nel pezzo del Boss
comprendi tutto il succo della faccenda: ritmo
filo hip hop in richiamo alla strada, crooning da
sconfitto appena accarezzato di romanticismo,
quel trascinarsi della melodia che significa accettazione di una condizione impossibile da convertire ma soltanto da accettare. È una grande cover.
Cover che significa pure quanto l’uomo sia oltre
il confronto con i miti appesi in cameretta. Che
sia un se stesso che dentro al Casiotono cresce e
mantiene onestà d’intenti. Quindi niente paura
se Graceland di Simon viene detronizzata da una
marcetta e da un vocoder. Lui che ha sempre
amato l’hip hop ha capito che prendere e rifare
non è vergogna ma un vanto. E ancora di Advance parliamo e non di Vs. Children. Allora
(7.3/10) al primo e (6.0/10) al secondo.
Edoardo Bridda
Celer/Mathieu Ruhlmann - Mesoscaphe (Spekk, Mag 2008)
G enere : elettroacustica minimale
L’incontro tra acustico e digitale si fanno in Mesoscaphe mezzo di memorie di viaggio, quelle dell’itinerario lungo 30 giorni che nel 1969 il
sottomarino a propulsione Ben Franklin fece per
esplorare le correnti del Golfo.
Memorie che, grazie al lavoro degli artisti Celer
(Danielle Baquet Long & Will Long) e Mathieu
recensioni /
75
Highlight
Malakai - Ugly Side Of Love (Invada, Apr 2009)
G enere : psych rock , reggae , garage
Un duo psych reggae garage di Bristol all’esordio, prodotto da Geoff Barrow (Portishead) per la sua label Invada incuriosisce abbastanza? I Malakai sono il cantante e
songwriter Studio-Gee e il musicista Scott, rispettivamente
un dj e un MC che hanno ricombinato le rispettive attività
per questo gruppo.
Una miscela variegata è la loro, con un’attitudine prettamente collagistica, e una base acida, che va dal reggae
giamaicano rivisto in salsa dub, allo psych rock sixties mischiato al garage di marca Nuggets, e ancora gli influssi portisheadiani, la psichedelia
rivisitata di un Barrett hip hop, il Frank Zappa dei ’70, gli influssi Funkadelici.
Di base in Ugly Side Of Love c’è quindi un’attitudine al cut up post-tutto, che parte
dall’uso di basi e samples (si comincia con una citazione da Warriors alias I Guerrieri della notte di Walter Hill nel pezzo omonimo – campionando Warriors, come out to
play? suono di bottiglie di vetro compreso che si sviluppa in un garage rock sanguigno)
per ricomporsi in un unicum, con nel sottotesto un’anima melodica evidente (Fading
World) di marca Beach Boys, Zombies (Another Sun dove sembra di sentire anche i
primi Who e Kinks), e Love. Con più di un omaggio nella vocalità di Studio-Gee al
nume giamaicano Horace Andy.
Barrow ha supervisionato l’album e partecipato alla stesura di Only For You, un kraut
virato dub nel quale si avvertono non pochi echi dei Portishead; per il resto molto
garage aggiornato al funk dei ’70 USA passando per un’attitudine zappiana, non dissimilmente da quanto fatto negli ultimi anni da Gnarls Barkley e Danger Mouse.
E Ugly Side Of Love si può anche accostare idealmente a quanto fatto da Beck in
Mellow Gold.
Il senso di divertimento e autoironia insito nell’operazione è tanto e si percepisce, con
il pregio di aver reso unitario un album così vario e a rischio di dispersione, merito
anche di un produzione ineccepibile da questo punto di vista. Il disco convince quindi
per coesione ed ispirazione, riuscendo a sfuggire in ultima analisi a una catalogazione
ben definita, gran pregio quest’ultimo.
(7.2/10)
Teresa Greco
Ruhlmann diventano suono, ottenuto con le
registrazioni di campo dello stesso sottomarino,
strumenti acustici (pianoforte, archi, theremin)
76
/ recensioni
ed elettronica - quest’ultimi a simboleggiare l’elemento umano.
Morbidezza, fluidità e lentezza sono certo espe-
rienze linguistiche tipiche dei lavori di Celer, che
di recente (Nacreous Clouds-and/Oar 2008)
avevamo visto adagiate in loop, velocità e stasi.
Estremamente puntuale
l’arte della rappresentazione, dal realismo acustico nonostante occultata sia la fonte d’origne.
E’ un viaggio, quello di
Mesoscaphe, da non
intendersi solo come
esperienza poetica, ma
anche come operazione
relazionale, quella che nelle tre tracce gli artisti
strutturano con estrema naturalezza e narrativa.
Scultoreo, legato agli umori più scuri o in stati di
grazia, preso in prestito ma non per questo privo
d’espressione, intrappolato o soffocato, concesso
alle derivazioni e ai capricci del tempo tempo, il
suono, qui,. sia per gesto che creatività, è un ambiente liquido nel quale immergersi, pratica sensibile e sapiente.
(7.1/10)
Sara Bracco
Chain And The Gang - Down With
Liberty... Up With Chains (K Records,
Apr 2009)
G enere : N ew - aavv -Y ork
Ian Svenonius è un gatto accorto che si aggira da
vent’anni ormai nell’area di Washington DC. Prima ha fatto le pulci all’hard-core con i Nation Of
Ulysses, poi ha iniziato – oltre a suonare con altri
gruppi - a teorizzare e a parlare come opinionista
musicale. E ora esce con un progetto che una volta di più lo mette a fuoco nella sua astuzia.
I Chain And The Gang sono anzitutto un pouy
pourri della musica rock a New York, praticamente dalla fine dei Sessanta a quindici anni fa.
Ma c’è solo quello che della musica uscita dalla Grande Mela è più efficace a primo impatto,
comunque e sempre piacevole e poco impegnativa da ascoltare. Un esempio è fin dall’inizio la
mutant asciugata e secca di Chain Gang Theme (I
See...); oppure il Lou Reed più semplice e più ingagliardito di Trash Talk. I Chain & The Gang
potrebbero chiamarsi insomma più onestamente
Cool & The Gang. Non solo perché il funk di James Brown a volte sembra esplicito riferimento
– anzi tutto quel funk volontariamente filtrato dai
fichissimi anni della New York Noise repertoriata dalla Soul Jazz. Può darsi che l’omaggio sia
esplicito ma ascoltando Cemetery Map abbiamo già
un’altra cosa.
Lo scenario scorre e il fuoco si spiana sulla risaia
del Sud. Schiavitù
gospel. Slaker vocale e controcanto
call & response al
femminile – e del
resto Ian ci aveva
già provato a metà
Novanta, a fare
del “Gospel YehYeh”.
C’è quindi il nero fatto dal bianco, che vuole
ostentare i suoi occhiali da sole Nwe York Dolls
(e Lou Reed) e lo fa probabilmente scegliendo la
via più facile. Non nascondiamo che il risultato ci
piaccia – come in Interview With The Chain Gang,
una wave che gira NO, Un giochino alla Murphy
DFA chef, una automitologia applicata; come
non diciamo certamente no alla motown di Room
19, alle marcette basic ((Lookin’ For A) Cave Girl), ai
Blues Bros. tirati all’osso sotto confettura Zappa
(Unpronouceable Name).
Davanti a tante scenografie – o forse di tante
versioni della stessa - c’è da rimanere sedotti da
Down With Liberty... Up With Chains!. Rimane quel senso di prodotto in vitro, perchè alla
fine il gioco è spersonalizzante. I Chain rimangono incatenati alla loro astuzia cool, Ian alla sua
parlantina facile. Che sia questa una nuova chiave di interesse?
(6.5/10)
Gaspare Caliri, Edoardo Bridda
recensioni /
77
Chapelier Fou - Darling, darling,
darling (Ici d’ailleurs, Dic 2008)
G enere : elettronica / elettroacustica
In fondo a volte il gioco sta anche nel non prendersi troppo sul serio, concedendosi all’estro piuttosto che alle affinate armi del mestiere, senza per
questo perdere in credibilità o valore.
E’ il caso del giovane musicista e compositore
francese Chapelier Fou e del suo Ep Darling,
darling, darling. Un’elettronica che fa parlare
di sè tra laptop, ambient e rumori più o meno
frenetici, quelli che giocano con i riferimenti alle
sonorità di scuola Warp senza cadere nel rischio
del derivativo.
Anche se è con il violino che tutto è cominciato,
nelle aule di un conservatorio, dove il giovane artista si confrontava con i repertori del ‘900 (Ravel, Debussy o Bartok) e il Jazz, strumenti come
tastiere, mandolino e chitarra hanno sempre rappresentato il contraltare folk di un apprendistato
musicale curioso e variegato.
Convivono entrambe le attitudini, senza forzatura ma con consapevolezza di spazi e colore, affini
alle sonorità di uno Yan Tiersen ma senza dimenticare la raffinatezza della cosiddetta nuova
musica. Malinconiche ma amichevoli le corde,
le voci campionate e le armonie della title trak,
abili i giri di giostra e gli intermezzi di Horses, i
cambiamenti di registro ritmico (Le grand n’importe
quoi). Sei tracce certo non di passaggio, che non
chiedono nulla in cambio ma dispensano ispirati
e creativi motivi fiabeschi.
(6.7/10)
Sara Bracco
Cheater Slicks - Bats In The Dead
Trees (Lost Treasures Of The Underworld, Feb 2009)
G enere : experimental garage - rock
La saga dei fratelli Shannon si arricchisce di un
nuovo capitolo, il nono per la precisione, se consideriamo soltanto i dischi in studio; forse nove album in vent’anni (il primo è esattamente dell’89)
78
/ recensioni
possono sembrare pochi eppure è forse proprio
l’aver evitato le frenesia produttiva che sembra
invece caratterizzare certi gruppi d’oggi (Wavves, Blank Dogs e compagnia ipertrofica) che
ha consentito al gruppo di Columbus, OH di costruire una parabola tanto avveniristica quanto
degna di essere seguita passo per passo.
Non da meno è dunque questa nuova release,
che dalla sua può vantare anche un’altra componente; se infatti la
scena garage-punk
americana
(la
stessa in cui pure
loro hanno sempre sguazzato) è
attualmente presa
dai suoni ludici dei
vari progetti bedroom synth, questo Bats in the Dead Trees rilancia
e raddoppia la posta in gioco schiacciando senza
remore il pedale della sperimentazione.
Ciò che ci perviene sono dunque quattro pezzi
strumentali, non titolati, totalmente improvvisati
e non ritoccati successivamente in cui il trio da
sfogo alla sua vena più cacofonica e, appunto, impro.
L’unica effettiva continuità con i picchi più weird
della precedente discografia può essere riscontrata nel garage psichedelico a base di corde rotte
e piatti brutalizzati di Pt. II, il brano più classicamente Cheaters del disco; i pezzi restanti sono
tutto un lato caratteriale del gruppo che non conoscevamo finora. Apre una Pt. I che si protrae
per quasi quindici minuti a soli colpi di feedback,
senza riff, senza batteria, senza rock e già manca
l’aria; dopo il breve cameo di Pt. II si gira lato e
cala la scure. Pt. III è ancora un incubo asfittico
di un quarto d’ora, mentre il pezzo conclusivo è
una suite di synth e flanger che ricorda certe follie
kraut dei ’70 tedeschi.
Il tutto è stampato in sole 300 copie, un numero
esiguo ma comprensibile dato l’indelebile punto
di sperimentazione che il gruppo marca con que-
sto nuovo lavoro; se infatti la radicalità della proposta non lascia spazio a mezzi giudizi, i motivi
per cui si può amare o detestare un disco come
questo sono esattamente gli stessi.
(7/10)
Andrea Napoli
Cheer-Accident - Fear Draws Misfortune (Cuneiform, Gen 2009)
G enere : prog - artrock
La prima informazione è che non sono cambiati,
i Cheer-Accident. Chi avrà apprezzato le loro
scorribande tra generi negli altri (ultimi) dischi,
probabilmente apprezzerà anche queste. La seconda informazione – un po’ meno informativa,
un po’ più dubitativa – è che è sempre più difficile
discernere ciò che è valido da ciò che non lo è
in formule così impastate di abilità strumentale e
gioco di generi musicali.
Se c’è una cosa di cui i Cheer-Accident di oggi
sono maestri è ubriacare con la storia della musica (del Novecento e non solo) chi li ascolta. L’alternativa è enucleare l’elenco o sbatterli – metaforicamente – al muro. Il loro scegliere generi
e non atmosfere, generi come fini e non mezzi,
questo è quello che convince meno.
Così la seconda traccia del disco (Mescalito) può
anche – ancora, per l’ennesima volta – stupire
per la capacità con cui si va dal math ad accenni
Primus alla solita leziosità prog. C’è un’attenzione
ai temi sicuramente maggiore del 90% dei gruppi
in giro, e il loro numero migliore è forse quello
grazie al quale riescono a nascondere un tema
dietro a un riff. Oppure il modo in cui sfuma lentamente il tema melodico in coda alla penultima
traccia, Humanizing The DIstance. Ma per il resto
sono passaggi di linguaggio ed estetica. Mai reali
ibridazioni; e il connettore è la capacità tecnica
– e qui a primeggiare c’è la voce effettivamente
validissima della violinista Carla Kihlstedt. Ma
qual è la base, l’idea di fondo?
Ne avete ancora una, Thymme Jones, tu e/o i
quindici ligi musicisti che ti si raccolgono spetta-
colarmente attorno per Fear Draws Misfortune?
(5.8/10)
Gaspare Caliri
Chris Robley - Movie Theatre Haiku
(Cutthroat Pop Records, Mar 2009)
G enere : art pop
Coi due album precedenti il prode Chris Robley
è riuscito a guadagnarsi - pensate un po’ che roba
- l’epiteto di “Stephen King of indie-pop”, vuoi per
la pronunciata verve letteraria e vuoi per i drammatici azzardi musicali. Insomma, se eravamo
in attesa di stupirci con un terzo album carico di
effetti speciali, Movie Theatre Haiku non delude, semmai rilancia strutturando ulteriormente la calligrafia (elettricità ed elettroniche, archi
e ottoni, armonica, flauti e kazoo...), disegnando
traiettorie sempre meno prevedibili, tese e distese, toste ed eteree, accattivanti e scontrose.
Tutto ciò accade centrifugando senza indugio brit
e power pop (una Concrete & Nails tutta inquieti
turgori Badfinger, una Premiere tipo Damien
Rice in fregola Raspberries, una User-Friendly
Guide to Change che sposa i Blur più trafelati a
dei Suede imbizzarriti Elton John), misticismo
folk psych con apparizioni Morricone (Baltimore
Fugitives Buried in Brownsville, TX) o glauca febbre
Waterboys (Atheist’s Prayer), per non dire degli
XTC avariati tra miraggi di pop sinfonico in Permanent Fixture of Regret, degli ectoplasmi vaudeville
bitòlsiani nel robofunk strinito di Solipsist In Love
oppure del neo-prog innestato sui palpiti acustici
di My Life in Film Festivals. Insomma tanta roba,
Mr. Robley.
Per quanto mi riguarda, lo classifico tra coloro
che hanno molto da dire ma lo fanno con troppa frenesia e poco freno, senza quella capacità di
economizzare che spesso decide l’efficacia di un
linguaggio. Lo metterò quindi sullo stesso scaffale
su cui lascio a farsi compagnia i Conor Oberst,
i Decemberists, i Secret Machines e i British Sea Power, tanto per fare qualche nome di
recensioni /
79
traverso ai generi. Con la speranza di una futura
congrua decantazione.
(6.7/10)
Stefano Solventi
Crippled Black Phoenix - 200 Tons
Of Bad Luck (Invada, Apr 2009)
G enere : D ark P sych R ock
Nati quattro anni fa dalla mente del batterista degli Electric Wizards Justin Greaves, gli inglesi
Crippled Black Phoenix rappresentano una sorta
di crocevia per alcuni musicisti che, provenienti tutti da esperienze musicali parallele, si sono
incontrati a metà
strada per dare vita
a questo progetto.
Tra questi il bassista dei Mogwai,
Dominique Aitchison, due membri
della band doom
Pantheist e il
cantautore folk (!)
Joe Volk (che milita anche nella band heavy rock
Gonga). Insomma uno zibaldone di stili musicali
a confronto che, dopo l’esordio discografico del
2006, partorisce il secondo album in studio per
la Invada, etichetta di Geoff Barrow dei Portishead.
I presupposti a tutto farebbero pensare tranne
che ai Pink Floyd. Già, cosa c’entrano Gilmour
e Waters con il doom? Apparentemente niente.
Eppure non può non saltare all’occhio, ascoltando 200 Tons Of Bad Luck, la miriade di riferimenti, più o meno diretti ai Floyd. Come ascoltare l’iniziale Burnt Reynolds senza farsi venire in
mente all’istante il riff di Sorrow (A Momentary
Lapse Of Reason, 1987)? Come non cogliere,
nella successiva Rise Up And Fight, la citazione di
One Of These Days (Meddle, 1971)? E come definire la parte intermedia della suite Time Of Ye
Life / Born For Nothing / Paranoid Arm Of Narcolectic Empire, se non una copia spiaccicata di Pigs
80
/ recensioni
(Animals, 1977). Quando poi comincia a cantare Joe Volk, con la sua voce sottile ma decisa,
verrebbe da contattare Gilmour in persona per
fargli ascoltare la sua imitazione più fedele mai
eseguita. Roba che manco la buonanima di Gigi
Sabani…
Per fortuna non c’è solo questo. Anzi, gli stili messi in campo, anche se non amalgamati a dovere,
(tanto da creare un semplice accostamento, più
che una fusione) sono numerosi. Ma sembrano
tanti ingredienti messi a caso, alla puttanesca, per
usare un termine di paragone culinario. Le atmosfere poetiche degli Slint, il metal dilatato degli Isis, il dark doom dei My Dying Bride e
(rimanendo in campo floydiano) i lavori solisti di
David Gilmour (Little Step potrebbe essere una
bonus track di About Face), sono gettati nella
mischia senza un collante che li tenga uniti. Molto meglio quando la band si abbandona ad una
versione più personale del rock psichedelico, velata di noise (A Lack Of Common Sense) e ambient (I
Am Free, Today I Perished).
Consigliato a chi, almeno una volta, ha immaginato i Pink Floyd vestiti di nero e con lo sguardo
tenebroso.
(6.3/10)
Daniele Follero
Cult Of Youth - A Stick To Bind, A
Seed To Grow (Dais, Gen 2009)
G enere : ( garage ) neo - folk
Dopo un primo interessante singolo su Axiomata, il progetto del newyorkese Sean Ragon arriva al debutto sulla lunga distanza per Dais, etichetta che si è fatta recentemente conoscere per
la pubblicazione dell’apprezzato EP dei Cold
Cave. Con questi ultimi e con tutta l’attuale scena synth/wave però i Cult Of Youth di Brooklyn non hanno molto da spartire, se non la decadenza di certe atmosfere che si respirano qua
e la tra i brani dell’LP in questione; non senza
qualche affinità con quanto detto tempo addietro
per Yussuf Jerusalem, infatti, il nostro propo-
Highlight
Mariposa - Self Titled (Trovarobato, Mar 2009)
G enere : avant pop rock
Quattro anni dopo il doppio Proffiti Now!, i Mariposa tornano con un album di inediti che promette di
far parlare di sé. Soprattutto per l’equivoco che si porta
dentro. Difatti, come è chiaro fin dalla opening track,
la proverbiale scelleratezza formale dei Nostri - beffardamente spacciata per “musica componibile” - rincula
entro fattezze che quasi quasi diresti pop. Intendiamoci: pur sempre roba che sui palchi sanremesi sembrerebbe piovuta da Marte. Per dire, in Specchio sembra
di scorgere dei Perturbazione allampanatri Wyatt e carburati Grandaddy, in
Notel Hotel ti figuri Sergio Endrigo contagiato di bizzarria Wayne Coyne, mentre
Vattene pur via è praticamente un Gino Paoli sul punto di decollare Mercury Rev.
Per non dire di quella Clinique Veterinaire che manda allo sbaraglio uno sciroccatissimo
Daevid Allen - proprio il santone canterburiano - tra fregole wave e synth-pop che
frullano i primi XTC con Men At Work e - chessò - Kajagoogoo(!).
In realtà è una strategia subdola, quella dei sette pseudo bolognesi: strizzare
l’occhiolino, ammorbidire le difese per inoculare il germe dello spaesamento,
dell’amarezza, dell’impotenza culturale e sentimentale. Depistaggi sonici e testuali
- prendete le genialoidi impertinenze bifronte da Panella battistiano nella cupa Sudoku, oppure la tiritera ossessiva sulla beghina seriale in Zia Vienna - che ti circuiscono
scioccarelli e poi ti foderano con l’angoscia ed il senso di perdita annidati tra memoria
e quotidiano. Se un ruolo importantissimo lo gioca il canto laconico di Alessandro
Fiori - nella cui felpata rassegnazione indovini una tensione inafferrabile e alla lunga
stordente - il circo sonoro (registrato live in studio, ché il gusto ci guadagna) possiede
la turgida sbrigliatezza che ben sappiamo, capace di misurarsi senza tema con guizzi
Capossela (nella bislacca Piero, dedicata al grande Ciampi) e deliri pataprog (una
Can I Have Bon Bon? che centrifuga Crimson, Generator e Stranglers in un brodo
anfetaminico), inneschi kraut e valzerini fanciulleschi, soul funkadelico e irradiazioni
cinematiche (vedi la cavalcata vintage di 81 Guerra Atomica, 84 Confronto Rivoluzione).
Talentuosi e cazzoni, concettuali e istintivi, profondi e sbrigliati, talmente avanti da
mordere i polpacci della tradizione sul punto di doppiarla, i Mariposa confermano di
essere una delle più solide realtà indipendenti italiane. Ossia, una grande band.
(7.6/10)
Stefano Solventi
recensioni /
81
ne un pagan (neo) folk piuttosto ruvido che, se di
certo presenta qualche inflessione goticheggiante,
trova nelle ballate più vitalistiche ed energiche i
suoi punti di maggior forza.
Mentre pezzi come The Final Myth e Love Will Save
Us ricordano esplicitamente i Death In June di
Rose Clouds of Holocaust, sono brani come
la title-track a segnare in maniera più personale e
convincente un esordio che, se non può far gridare al miracolo per originalità ed innovazione, si fa
comunque ascoltare con piacevolezza (cosa non
sempre così scontata, specialmente oggigiorno),
tra chitarre acustiche suonate senza paura di far
male alle corde (Cold Black Earth, A New Dawn), intermezzi militareschi (To the Floor!, cmIII) e nenie
tribali come We Will Rise, pezzo che chiude l’album nonché vero e proprio jingle per i bambini
della nuova alba.
(7.2/10)
Andrea Napoli
Cursive - Mama, I’m Swollen (Saddle Creek, Mar 2009)
G enere : indie rock
La band di Omaha continua sulla strada della maturità imboccata magistralmente da The
Ugly Organ e continuata fedelmente da Happy
Hollow. Questo sesto album non fa che adagiarsi su quell’indie rock aspro ma allo stesso tempo
melodrammatico, ammorbidendo ancor più le
sonorità.
Ma, se quei succitati lp avevano ancora un costruttivo legame con certe sfuriate emo(hard)core
– caratteristiche della prima metà discografica
dei Cursive -, Mama, I’m Swollen sembra ora
recidere ogni radice, almeno dal punto di vista
rumoristico. Infatti, esclusion fatta per l’elettricità
noise dell’iniziale In The Now, le restanti tracce si
muovono su ambienti più quieti e rilassati. Certo,
non mancano quei peculiari saliscendi strumentali e improvvisi cambi di tempo che il malinconico cantato di Tim Kasher valorizza oltremodo,
ma il risultato finale è quello di una morbidezza
82
/ recensioni
musicale mai raggiunta prima.
E, anche se tale
scelta stilistica può
esser
scambiata
apparentemente
per manieristica
piattezza, dobbiamo ammettere che
non dispiace affatto, anzi. Se a tutto ciò si aggiunge la sempre ottima lucidità lirica di Kasher,
Mama, I’m Swollen si fa ben apprezzare rivelando la giusta misura adottata dai Cursive.
(6.8/10)
Andrea Provinciali
Cut In The Hill Gang - Cut Down
(Stag-O-Lee, Apr 2009)
G enere : punk - blues
Suonano blues del delta con piglio punk. Arrischiano svisate di slide insieme a tamburi pestati a sangue, stomp blues cacato dall’inferno e
rock’n’roll vecchio come l’invenzione delle chitarre. Roba già sentita, vero? Eppure se mettete sul
piatto Cut Down, scommetto che lo toglierete
con enorme difficoltà per quanto gira alla perfezione.
Cut In The Hill Gang è un trio americano, questo
è il loro primo album ma hanno la storia alle spalle (e si spera anche davanti): dietro le pelli siede
Lance Kaufman, mentre Brad Meinerding e Johnny Walker si dividono le chitarre, acustiche ed
elettriche, oltre a vari altri ammennicoli a corda.
Quest’ultimo in particolare non è di primo pelo,
visto che era lui il leader dei Soledad Brothers,
storica formazione di punk-blues di cui i CITHG
ereditano ruvidezze stooges-oriented (in certi momenti vicini alla prima Blues Explosion, ma
non ditelo a Walker) e amore per la tradizione
a stelle e strisce, anche se più interessati – parole
sempre del leader – agli aspetti più bluegrass e
alle screziature country.
Cut Down è la riedizione di un vinile split chia-
mato Hung Up, ai cui 5 pezzi si aggiungono
quelli di nuova composizione, inclusa una cover
dai primissimi passi di White Stripes, amici per
la pelle di Walker. Insomma, se siete in vena di
chitarre urlanti e sing-along indimenticabili, bandiere sudiste e rock marcio e sudato fate vostro
questo disco.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Dan Zimmerman - Cosmic Patriot
(Sounds Familyre, Apr 2009)
G enere : folk blues
L’uomo è di quelli strani, figlio incredibile d’un
Paese scellerato e meraviglioso, percorso in lungo e in largo nei sessanta e rotti anni di esistenza
terrena da Mr. Dan Zimmermann, dalla California all’Arizona, dall’Oregon al New Jersey, dove
infine grazie ai buoni uffici di Daniel Smith della
Danielson Famile ha concretizzato un’attitudine covata dai tempi di Elvis e lasciata macerare
tra vicissitudini parecchio randage.
Prima del contratto con Sounds Familyre, il buon
Dan ha avuto modo di covare meditazioni filosofico/esistenziali nonché di affinare l’estro pittorico, talento che può constatare chi assiste ai
suoi concerti, durante i quali le sue suggestive
raffigurazioni vengono proiettate sullo sfondo a
mo’ di light show. Questo Cosmic Patriot è il
terzo album solista, quasi un decennio dopo Great Small (Sounds Familyre, 1999), ed è opera
carezzevole e intensa, colma di sguardi da hobo
saggio senza alterigia, di sentenze e profezie che
non perdono la tenerezza, suonate come potrebbe un fratello parecchio stagionato che si è fatto
la storia del pop-rock più o meno tutta intera, restandone ai margini, ovviamente sul lato americano del marciapiede.
Ragion per cui quella voce chioccia e generosa
da baritono stradaiolo si aggira tra ballate folk
blues asperse gospel, soul e vaga psichedelia, coprendo in maniera ondivaga ma piuttosto puntuale l’arco emotivo/espressivo che va - poniamo
- dai Crazy Horse più beceri (Lost My Technique) ai palpiti Tim Hardin (Steady Plodder). Nel
mezzo capitano ballatine Hazlewood illanguidite Tindersticks (Everyday In My Heart), rumbe
stregate da ipnosi cameristiche (Silence Is A Golden
Mountain) oppure tentate da fregole tex-mex tipo
Lanegan strattonato dai Calexico (Twilight Romance), per non dire delle ugge Roy Orbison felpate Lambchop di Lonely Way, del country-blues
circa Tom Petty di Symbols In This World o dello
sdrucciolare jazzy vagamente Tim Buckley di
The Thing Itself.
Archi, organini e fisarmoniche come le quinte
di una pantomima arguta e struggente, bassi e
contrabbassi a riempirti l’addome di spessa tensione, chitarre che non disdegnano il graffio e lo
spasmo, il sospetto di uno scherzo freak sempre
dietro l’angolo: Cosmic Patriot è un disco che
non sembra vero eppure ci credi, proprio come il
suo autore.
(7/10)
Stefano Solventi
Dario De Filippo - Excès D’Identitè
(Improvvisatore Involontario, Apr
2009)
G enere : etno - jazz
Un progetto per certi versi inedito quello curato
da Improvvisatore Involontario con la pubblicazione di Excès D’Identitè, disco accreditato al duo
Dario De Filippo (percussioni) e Misato Hayashi
(marimba) Registrato dal vivo presso il conservatorio Erik Satie di Parigi a cavallo tra il 4 ed il 7 di
aprile del 2008, l’album è uno spaccato di musica
exotica contemporanea.
Delizioso sin dai
primi passi, si arricchisce di volta
in volta di piacevoli
accortezze,
come nella sentita
cover di Rumba Di
recensioni /
83
Livorno dell’immortale Piero Ciampi. Grande la
morbidezza nel tocco dei due interpreti e la loro
grande abilità nel dialogare, ponendo le basi per
un progetto che oltre a riconciliarsi con i padri
dell’easy listening – Les Baxter su tutti – punta
anche in direzioni moderne, sollevando dall’oblio
l’opera impareggiabile di un personaggio off quale Richard Crandell (esegeta della mbira africana)
che spesso ha collaborato con un autentico mago
dell percussioni quale Cyro Baptista. Altrove – di
soppiatto – si insinua l’idea globale di ritmo così
come architettata da Max Roach coi suoi M’Boom.
Del resto la comunione artistica tra un’artista
giapponese ed uno siciliano non poteva che generare un visibilio di ritmi, assottigliando le distanze
tra oriente e mediterraneo, in uno scambio materiale rispettoso ed immediato. Delizia.
(7.2/10)
Luca Collepiccolo
Decemberists (The) - The Hazards Of
Love (Rough Trade, Apr 2009)
G enere : folk revival , protometal , pop
Ci sono band che hanno raggiunto nel corso degli anni una sicurezza e un’esperienza tale, nel
loro percorso artistico, che viene loro naturale
immetterla in quello che fanno. È il caso della
carriera decennale dei Decemberists e del deus
ex machina Colin Meloy, il quale centra con
l’ultimo The Hazards Of Love la sua quadratura del cerchio.
Il pretesto per la scrittura dell’album è giunto da
un vecchio EP di Anne Briggs dal medesimo titolo. Meloy se ne innamora e decide di scriverne
una title track, dato che nell’EP mancava. Da qui
l’incipit per il resto del disco, che oramai aveva
preso la forma del concept intorno a quella song.
Musicalmente The Hazards Of Love prende
ispirazione dal british folk revival ibridato con
il proto metal (echi di Led Zeppelin e Black
Sabbath) accomunati secondo il Nostro da un
medesimo senso della narrazione e dell’ambien84
/ recensioni
te, e dal superamento della scrittura in prima
persona. Sperimentare con lunghezze importanti e temi espansi non è in realtà una novità per
la band, che già da The Tain (2004) aveva usato il mito irlandese, mentre nel precedente The
Crane Wife si era trattato di un antico racconto
giapponese.
Qui il valore aggiunto è il risultato mai barocco
ma molto equilibrato, ambizioso ma non autoreferenziale. Ben arrangiato e strutturato in sezioni, con i temi concettuali e musicali che vengono
ripresi e nel finale
si mescolano come
ogni rockopera che
si rispetti. Quindi folk, elementi
protometal e prog
ma anche pop a
fare da collante
all’intera struttura
musicale, che ruota concettualmente intorno al racconto che vede
protagonista una donna, Margaret, che rimane
vittima di una bestia proteiforme, il suo amato
William, la regina della foresta e un libertino pericoloso. Classici temi da leggenda quindi, come
era naturale.
Il disco è stato realizzato con l’aiuto di numerosi ospiti, che vanno da Shara Worden (My
Brightest Diamond) e Becky Stark (Lavender Diamond), per le parti cantate femminili, a
Jim James dei My Morning Jacket e Robyn
Hitchcock in alcuni brani. Prevale il senso narrativo, l’ampiezza da suite, ben resa dalle ospiti
femminili, sia quando riprendono Anne Briggs
nella vocalità (Becky Stark in Margaret In Captivity
che sa dell’ariosità di una Kate Bush), sia quando
si sente l’impeto Arcade Fire come nell’articolata The Wanting Comes in Waves / Repaid cantata
dalla Worden.
(7.4/10)
Depeche Mode - Sounds Of The Universe (Mute, Apr 2009)
G enere : S ynth P op
Dresda - Pequod (Marsiglia Records, Dic 2008)
G enere : post - rock / ambient
La discreta maturità dei Depeche ’00 continua
con Sound Of The Universe, dodicesimo album a praticamente trent’anni dall’esordio (del
1980), e nuovo sforzo in studio a riprendere l’ormai inossidabile format dello spiritual synth pop
che li accompagna dai tempi di Violator.
Abbandonata la componente noiseggiante, e gli
aspetti cyber rivisti laptop, il nuovo lavoro converte in oscurità e meditazione la spettacolarità
emozionale del fortunato predecessore: se la giocano testi morbosi e visioni notturne ma sono
gli arrangiamenti ’70, grazie al recupero – sbandierato a stampa e dispacci – di synth analogici,
vecchi sequencer e drum machine, a far parlare
di sé. Nonostante le dichiarazioni di Gahan in
perfetto stile U2, non è una svolta “sperimentale”
bensì il proverbiale aggiustamento di produzione
su quanto consolidato nel recente passato. L’eccezione di Peace, un curioso mix tra Jarre e Kraftwerk filtrato certe cose Kraut non sposta quanto
detto, salvo ammettere una scrittura automatica
in oltre metà della scaletta: standard i brani scritti
da Gahan (meglio forse quelli dell’ultimo solista),
soprattutto poca ispirazione per Gore, nonostante una Jezebel a galleggiare nell’Oxygen jarriano.
Una botta e via infine per le liriche di Wrong, singolo gothic tra blues e gospel dal clip decisamente
più sperimentale e arty, contraltare di un sound
che, non dimentichiamolo, sta vivendo una seconda giovinezza in una manciata di gruppi 00s
(Bloc Pary, Tv On The Radio fino a, perché no,
Interpol e Peter Bjorn And John).
Lo spiritual (synth) pop è uno stile che può dare
ancora molto ma le tentazioni uber tech à la Trent
Reznor/Nine Inch Nails sono sempre il monito
perfetto per questi casi. E’ il desiderio d’immortalità la base di ogni decadenza.
(6.5/10)
Li si potrebbe liquidare dicendo che fanno una via
di mezzo tra un post-rock etereo e certa ambient
ricca di field recordings, ma sarebbe sminuire la
valenza artistica di questi Dresda da Genova. Che
invece si guardano bene dal non cadere preda dei
maneggi auto-distruttivi tipici di chi traffica coi
suddetti generi generando spesso prolissi intellettualismi autoindulgenti, per scegliere una terza via.
Quella delle suggestioni a vocazione cinematica,
delle indolenze torbide e malinconiche, delle dinamiche ariose ma al tempo stesso misurate, nell’ottica di un suono che segue le asperità del terreno senza barcollare e favorisce il naturale evolversi della
melodia. Lo scotto per amori giovanili non ancora
sopiti si paga solo con l’ultimo dei cinque brani in
scaletta – Attraverso lenti colorate, post rock, certo, ma
imponente e di ottima caratura – mentre tutto il
resto del programma si traduce in esplorazioni di
pianoforte su torpori scenografici vagamente industriali (Città di vetro), rumori su chitarre minimali
(Il grande macchinario della notte), incombere tribale a
metà strada tra Joy Division e For Carnation
(L’eterno ritorno dell’uguale), reading à la Massimo
Volume con velleità spacey (La stanza e l’orologio).
è l’estrema varietà stilistica e la cura maniacale
per il dettaglio a salvare dal limbo delle produzioni
mediocri questo Pequod e a trasformarlo in un lavoro brillante – il disco è scaricabile gratuitamente
dal sito dell’etichetta che ne cura la pubblicazione,
all’indirizzo www.marsigliarecords.it/m030.php
–, sulle basi anche di una scrittura che fa della lentezza un marchio di fabbrica e dell’intensità una
questione di vita o di morte.
(7.2/10)
Teresa Greco
Edoardo Bridda
Fabrizio Zampighi
Droning Maud - The World Of Make
Believe (Udu Records, Ago 2008)
G enere : new wave
Bravi a contestualizzare senza cadere nel tranello
recensioni /
85
della scopiazzatura, bravi a gestire uno stile ispirato ma non invadente, bravi a suonare al disco
d’esordio come una band con dieci anni di storia alle spalle. Droning Maud da Rieti, ovvero
lirismo new wave
senza tanti orpelli
abbonato a chitarre elettriche, basso,
batteria. Una formula che dal punto di vista della varietà strumentale
forse non promette
molto, ma che riesce a dare il meglio di se quando si tratta di lavorare di cesello sulle melodie.
Queste ultime sempre puntuali, spiccatamente
anni ottanta, armonicamente elaborate. Tanto
che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare osservando il peso specifico dei fattori in gioco,
non sono soltanto i soliti Joy Division a emergere dalle sette stazioni di The World Of Make
Believe, ma una serie di rimandi diversissimi
tra loro. Tra i tanti, i R.e.m., le chitarre di The
Edge, gli Smiths, ma anche inaspettati accenti
melodici new romantic. Materiale comunque, in
linea con l’immaginario di riferimento e capace
di conquistare credito senza grosse difficoltà.
(6.9/10)
Laisse Nous La Mer e Je Dors Debout, così come la
trepidazione tesa di Monsieur Paul).
Come avrete intuito, quello che nell’esordio sembrava un vezzo o una più o meno estemporanea
bizzarria, diventa qui un elemento basilare: i testi
difatti sono vergati in francese, tutti ad eccezione
della conclusiva Nessuno Mi Risponde, che poi è uno
strumentale col suo cinematico incedere d’archi,
piano e tastiere. L’effetto è un pizzico straniante
ma in fondo tutto si tiene, non sembra affatto la
posa posticcia di chi vuole distinguersi ad ogni
costo, ragion per cui forma ed espressione sono
libere di travolgerci senza intoppi. Può dirsi riuscita anche la metabolizzazione dei retaggi postpost à la Giardini Di Mirò, un effluvio che
aleggia ad esempio nelle inquietudini seventies di
Qu’est-Ce Que Vous Voulez?, mentre in Mémoire Aide
Moi ne resta appena traccia omeopatica sotto la
fiabesca trama di glockenspiel, archi e flauto.
Disco che convince per urgenza, personalità ed
ispirazione, cui fanno buon gioco gli interventi di
Davide Arneodo (violino nei Marlene Kuntz),
Francesco Di Bella (chitarra e voce dei 24 Grana)
e soprattutto di Luca Fadda coi fraseggi irrequieti
della sua tromba, ingrediente quest’ultimo tanto
prezioso da sembrare - da augurarci - organico.
(7.4/10)
Wasn’t The Time) à la Pretenders, lubrificando
una rumba di mescalina sixties (I Love Planet Earth)
oppure di miele come certa Feist (Tiny Waist) per
poi imbastire con Don’t Let It Happen una plausibile
e garbata nipotina della stoniana Beast Of Burden.
Il tutto senza mai perdere il polso della situazione,
la padronanza di una calligrafia che non smette
di somigliare all’autriceu2s ezzevtenders
Stefano Solventi
Fabrizio Zampighi
El-Ghor - Merci Cucù (Seahorse Recordings, Mar 2009)
G enere : rock
Due anni dopo il bel debutto Dada Danzé, i partenopei El-Ghor ribadiscono le buone impressioni con Merci Cucù, album che li vede stringere
più saldamente le redini (non a caso si producono da sé, coadiuvati dal “solito” Paolo Messere e
da Alessandro D’Aniello) cavalcando una fregola
wave che strattona l’estro autoriale sempre rivolto
alle vicende d’oltralpe e anche più sù, scomodando cioè trafelati anelli di congiunzione tra Noir
Desìr e dEUS (si prenda il lirismo febbrile di
86
/ recensioni
Eleni Mandell - Artificial Fire
(Make My Day, Feb 2009)
G enere : pop rock
C’è un motivo preciso per cui Eleni Mandell, cantante e chitarrista californiana con già un pugno
di album alle spalle per l’indipendente Zedtone, mi sembra la tipica cavallina di razza. Ed è
questo: nelle quindici tracce di Artificial Fire
si permette di sciorinare marcette brass carezzevoli e argute come una Norah Jones corrotta
da Cat Power (Right Side), brusche sgarberie da
cuginastra disinvolta di Liz Phair (Cracked), allusiva ruvidità errebì (la title track), scorrerie frizzantelle (Bigger Burn) e sdilinquimenti dolciastri (It
recensioni /
87
cimenta anche al canto in Ukimwi) e la star del
Benga Opiyo Bilongo, frontman carismatico
che offre una prestazione superlativa in questa
nuova fatica da studio.
La bontà degli Extra Golden risiede nella personale interpretazione dei canoni occidentali ed
africani, làddove le musiche vengono sovrapposte
in un gioco di specchi sempre intelligente ed autentico. Non ci sono tentazioni afro-funk o numeri propriamente soul, i suoni vengono sovrapposti
in espansivi incastri che uniscono mirabilmente
blues ed highlife, complesse figure ritmiche ed
anticaglie del paese nero.
Meravigliosi anche i brani in lingua yankee come
la title track o Fantasies Of The Orient a disegnare
una via oltre le schermaglie del black-rock. Deliziosi connubi analogici, che riproducono la sostanziale attitudine live della band. Che proprio
nel mese di marzo ha reso omaggio ai suoi padri
spirituali imbarcandosi in un tour inglese a nome
African Soul Rebels, dividendo il palco con Baaba Maal e Oliver Mtudkudzi introduceva le
magie del combo ora a tutti gli effetti multirazziale.
(7.4/10)
Luca Collepiccolo
Fabio Mercuri - Di tutto quello che
c’è (Novunque, Mar 2009)
G enere : songwriting
Arriva al disco di debutto il salentino Fabio Mercùri, dopo una lunga attività nella scena musicale
italiana come chitarrista e numerose altre collaborazioni. Tra musica d’autore e pop, psichedelia e una cinematicità di fondo, gli undici brani
dell’album colpiscono per un senso della spazialità sonora e per arrangiamenti molto curati; la
suggestione è di fatto la chiave di volta per accedere nell’universo del musicista.
Suggestione nascosta nelle pieghe dei testi, piccoli affreschi di quotidianità (Accade), riflessioni sul
senso del nostro essere (la title track), evocazioni tra
archi e batteria appena accennata (il singolo Alti88
/ recensioni
tudini), il senso anche delle piccole cose (Particolari),
del riappropriarsi del tempo a dimensione umana
(l’appello contro la velocità ne L’invasione delle biciclette). Un universo compiuto e suggestioni sparse
che ci hanno ricordato le immagini dei migliori
Baustelle, Afterhours e Perturbazione, la
musicalità di Morgan e Moltheni, oltre che il
senso dell’immaginifico di Tricarico, con cui
Mercuri ha collaborato. Con la partecipazione di
diversi artisti protagonisti della scena indie rock
italiana, da Paolo Agosta produttore del disco, a
Roberto Dellera, Enrico Gabrielli (Aftehours) e
Paolo Iafelice (produttore tra gli altri di Pacifico).
(7/10)
Teresa Greco
Fabrizio Consoli - Musica per ballare (Novunque, Apr 2009)
G enere : songwriting , rock
Con all’attivo una lunga e variegata carriera di
session man sin dagli Ottanta e poi in proprio dal
decennio successivo, Fabrizio Consoli approda
ora all’ultimo Musica per ballare.
La sua cifra stilistica si nutre di suggestioni per
una musica contaminata colma di racconti visivi (Una rosa, Musica per sordi), nei quali l’amore
profondo per il racconto si fonde alla musica. Un
misto tra jazz, canzone d’autore e Sud America,
in cui la base jazz rock si contamina via via di elementi diversi mantenendo una propria unità. Tra
Paolo Conte e Vinicio Capossela per l’affabulazione, con storie anche autoironiche, con alla
base anche un senso profondo di malinconia “sudamericana”; l’album raccoglie bozzetti in bilico
tra voglia e desiderio, nostalgia ed esperienze più
colorite.
Da segnalare un omaggio a Cochi e Renato con
il classico La canzone intelligente, ballad rallentata
che mostra tutta la dolenza profonda e l’ironia di
Consoli.
(6.8/10)
Highlight
Matteah Baim - Laughing Boy (DiCristina Stair Builders, Apr
2009)
G enere : cantautoriale dil atata
Matteah Baim ha la capacità di essere delicata e altera allo stesso tempo. Ci sono dei dischi che appena
li si inizia ad ascoltare preannunciano l’impegno che
dovremo dedicare loro; Matteah ci chiede un impegno
con grande discrezione, quasi a bassissimo volume.
Laughing Boy è un album chiaro/oscuro e raffinato,
come se Nico avesse tentato una dimensione più pop,
in qualche modo AOR. Come se Cale semplificasse le
sue tecniche compositive e di messa a sistema di uno
stato d’animo avvicinandole alla canzone d’autore. E forse il succo di questa musica
è cantautoriale, nulla di più. In realtà tutto, produzione, arrangiamento, quello che
contiene questo album è fatto da Matteah, ex membra dei Metallic Falcons, pittrice,
originaria del Wisconsin, oggi newyorkese - e qui al suo secondo disco solista, ricco di
archi e di ambienti, di pelli simili alla batteria dei Dirty Three di …Apollo – che
ci figureremmo ad accompagnarla – e di avventure in qualche modo spirituali (Big
Cat).
Il terreno su cui si lavora di cesello e atmosfere è la dilatazione, l’arrangiamento,
l’incastro di carezze attorno alla voce calda e però mai riscaldatrice della Baim. La
delicatezza, il tocco di Birthdays, traccia 4, sono spiazzanti, quando ci aspettavamo
un’oscurità crescente, anticipata dalle lande di Pagoda, confermata del resto dai brani
seguenti – a volte con trovate armoniche davvero riuscite, come la piccola dissonanza
del refrain di Wildness. Questa Nico più dolce replica il fascino teutonico della freddezza con melodie e scenari sonori che nulla hanno della durezza degli zigomi della
algida nibelunga di Desertshore. Lo fa, cosa che stupisce data la lunghezza del
disco, catturando a diversi stadi lo stupore dell’ascoltatore; lo fa isolare, gli fga abbandonare le attività che stavano avendo corso mentre iniziava l’ascolto; rubando
il tempo al tempo, da un certo punto di vista, sicuramente slegandosi da un’idea di
brevitas o di lunghezza. Le canzoni appaiono e poi scompaiono, senza che le si riesca
a quantificare, per numero e tempo di ciascuna; senza annoiare; scolpendo nella freddezza del ghiaccio delle forme avvolgenti, accoglienti, quasi amichevoli. Un risultato
già di per sé abbastanza sorprendente.
(7.3/10)
Gaspare Caliri
Teresa Greco
recensioni /
89
Filastine - Dirty Bomb (Soot, Feb
2009)
G enere : fragment hip - hop
Sembra stare al mondo per simbolizzare il villaggio (post) globale, Grey Filastine: nato a Seattle, risiede attualmente a Barcellona, ma la sua è
un’attitudine da eterno giramondo. La quale finisce, inevitabilmente, per influenzare questo suo
secondo lp, in cui coabitano Arabia e Bollywood,
dubstep e baile funk, tecnologia e tribalismo. Che
esso veda la luce per la Soot, etichetta di DJ/Rupture, offre ulteriori conferme circa l’assenza di
frontiere geopolitiche e mentali che si respira in
questi quarantotto minuti. Al loro posto troviamo
una vitale urgenza di raccontare - e denunciare
- cosa accade nel mondo, scegliendo di volta in
volta il panorama sonoro più coerente all’insegna
del meticciato stilistico.
Non fosse troppo spesso appesantito da tracce
strumentali che faticano a trovare autonomia
(eccezione gli archi “falsi” dell’apertura Singularities, l’ipnotica Blung e la Spagna orrorosa raffigurata da The Sinking Ship) di Dirty Bomb andrebbe
senz’altro consigliato l’acquisto. Così non è e purtroppo spiace, perché quando la messa in scena è
ben focalizzata, Filastine ostenta idee che buona
parte dei colleghi può sognare: in Con Las Manos
En La Masa un loop sudamericano funge da sfondo al rap efficace dell’argentina Malena D’Alessio
e From The South To The West... sparge paranoia
orientaleggiante; Fitnah è un flamenco mutante e
Hungry Ghosts conduce il two-step lungo allucinate camere d’eco. Ben vengano comunque dischi
come questi, perfettibili contributi al dibattito
sull’estetica del frammento. Nel bene e nel male,
s’intende.
(6.5/10)
Giancarlo Turra
Fischerspooner - Entertainment (Lo
Records, Mag 2009)
G enere : retrofuture dance pop
Una nuova avventura sonica e remi in barca per
90
/ recensioni
i due amanti del synth. Se qualche anno fa i ragazzi avevano missato i mondi del pop e del floor
con hit del calibro di Emerge, oggi non si scrollano di dosso il passato, anzi ci annegano con
un misto di citazioni proverbiali à la Depeche
Mode (Money Can’t Dance, e ricordiamoci pure le
maldestre prove dei Bloc Party), estetiche 80 (In A
Modern World), e altrettanto istituzionali copia-incolla man machine e Moroder (Supply & Demand)
quando non auto riproporre se stessi tuot court
(The Best Revenge). Che questa ennesima ondata di retrofuturismo si
stia facendo sentire forte in un determinato electropop d’autore
è ormai assodato (vedi il ritorno
di Miss Kittin
& The Hacker,
Röyksopp, Client,
Dat Politics e altri),
tuttavia come difendere un progetto che si è ridotto a
una raccolta di cliché primi Duemila? Non sarà
qualche singoletto accattivante a convincerci del
contrario come è piuttosto scoperta la mossa del
come back proprio sull’onda dello stesso revival
che a primi 00s avevano (e meglio) contribuito a
istituzionalizzare. Prodotto scaduto.
(5/10)
dai preziosi lavori in catalogo.
Materiale registrato sul campo, per essere precisi in alcune fabbriche asiatiche, prese dirette
successivamente concesse alla tattile lettura spaziale e all’abilità in risonanza dell’artista Gendreau; mentre a Lopez, sempre attento al profondo
ascolto del mondo, spettano i soggetti e le fonti
trattate con unidirezionalità e stasi; certamente
distanti le origini sonore dei lavori più recenti del
compositore, ma non per questo prive di vibrante
sensorialità.
Uno spazio, quello di Gendreau, inseguito tra
cambi di volume e tonalità, che attinge al riverbero tra assenze di fondo o ciclicità in eco, quelle
proprie delle macchine o dinastro trasportatore
(T921); senza mai spogliarle d’identità sonora,
l’artista le consegna a nuova vita attraverso un
certo naturale senso del “ritmo”(M928). Atteggiamenti decisamenti più sommessi quelli di Lopez,
tra oscillazioni, circolarità o pulsazioni (D156).
Lettura ambient per D138, che tra fruscii, abissi
di profonda privazione sonora e brusche rotture,
riesce con maniacale e ipnotica semplicità a ottenere molto.
Nonostante il quadro sonoro e gli elementi primari siano già conosciuti, si tratta di un lavoro
interessante per l’indagine sul rapporto tra spazio
e suono.
(6.5/10)
Sara Bracco
Marco Braggion
Francisco Lopez/Michael Gendreau
- Tddm (Sonoris, Set 2008)
G enere : minimalismi ambient
Facciamo un passo indietro per soffermarci su
Tddm, collaborazione del portoghese Francisco
Lopez con il noto compositore elettroacustico
Michael Gendreau.
Risalgono ai periodi tra 1992 e il 2004 i quattro elementi del doppio CD pubblicato nel 2008
per la label Sonoris, sempre prodiga di attento
riguardo alle uscite proposte, come si può notare
Full English Breakfast - Self Titled
(Scratchy, Apr 2009)
G enere : A vant lo - fi pop
E’ probabile che se scrivete Full English Breakfast
su google vi appaiano proprio le immagini del
booklet di quest’album omonimo degli omonimi
in questione che, badate bene, non sono quelli di
Itchy Fingers (un’altra cosa, altri anni) ma una
one man band.
Parliamo dell’esordio di progetto in solitaria
strampalato e low fi, strambo e tradizionale come
ci piacciono certe produzioni made in UK. Fate
conto humour à la
Beta Band misto
certe pose chitarristiche del Coxon di
Park Life e, sempre
dai “suoi” Blur,
troviamo pure biscotti analog vintagetronici e una
bella teiera alle erbe space della citata band ora
defunta. Naturalmente sono english e, in questi casi, dell’avant spettacolo non possono fare a
meno. Naturale che le cose migliori vengano fuori proprio da questo box. Spetz farcisce di vaudeville cazzone e fumato alcune scorribande da
Sergente peperone nello spazio ficcando una riuscitissima Cake Stand, praticamente come sentire
la Beta Band post punk. Altrove una Duster piglia
da Snakefinger proprio quell’anello di congiunzione con tutto questo, il dada rock. Chitarra
eccentrica e voce filtrata, entrate e uscite di effetti
e non solo: Duster è anche una glam song perché
un inglese non può fare il punk senza rinunciare
al Duca come dire: glam e avant-straccione sono
la stessa cosa, l’una l’aggiornamento dell’altra.
Zappa? L’uomo ama pure lui figuriamoci, quando non si diverte a citare Canterbury con quei
moog all’ora del Tea ti spara una Fish Tank Bubbles (Shining On), salvo poi ritornare a giocare nel
naif prendendo in giro i francesi (Winder Kills The
Clock). Niente male l’arte del collage se l’ispirazione e l’erba regalano un prodotto come questo.
(7/10)
Edoardo Bridda
Giancarlo Frigieri/Mosquitos - In
Love (Black Candy, Feb 2009)
G enere : rock
Tu chiamali se vuoi outsider. Oppure, semplicemente, Giancarlo Frigieri e i Mosquitos sono
gente che ama fare rock prima che stare nel cono
di luce, ragion per cui questo incontro - piuttosto
imprevedibile a dire il vero - alla fine suona parecensioni /
91
recchio naturale. Ascolti In Love e ti immagini
l’atmosfera nello studio, il riconoscersi a pelle indovinando la direzione delle vibrazioni nel momento stesso in cui sterzano, chiudendosi in un
compartimento stagno dove regna un’intensità
che è l’unica cosa che conta, scrigno che si basta
col suo inafferrabile tesoro di sincerità liberatoria.
In ragione di ciò, non stupisce che il principale
riferimento sia Mr. Howe Gelb, non tanto per lo
stile e il mood (comunque talora immediatamente riconducibili al menestrello di Tucson, vedi
Courage In Thrift Account e la title track) quanto per
quel senso di calda frugalità, per quel fare che si
nutre di rapporti umani prima che professionali, e
siano benvenute le imperfezioni nel caldo intreccio delle corde (una Rickenbacker, una Gibson,
una Gretsch e un basso Fender: una quadratura
timbrica che non si fa mancare nulla).
Capita così che per ogni gravità (il ballatone Neil
Young a cuore nero di A Ship) ci sia una sbrigliatezza (quella Mr. Carelesness che spedisce i Lambchop sul furgoncino del jingle jangle), ad ogni
ombroso languore (il Lou Reed immerso nel
vernel di She Sticks Like Glue) faccia eco un guizzo
ruvidello (una Pravda che rimesta da qualche parte tra Sebadoh e Steely Dan), espiando - si fa
per dire - le dolciastre evasioni La’s (The Matchless
Dream Of An Unsuitable Romeo) e Blue Ash (Horoscopausen) con l’ovattato profluvio psych della conclusiva Like Aliens.
Gran bel disco. Che fa ben sperare anche per il
prossimo lavoro solista di Frigieri. Imminente e gosh! - in italiano.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Ginevra Di Marco - Donna Ginevra
(Materiali Sonori, Apr 2009)
G enere : traditional folk
Dopo il riuscito Puerto Libre per la Di Marco
ancora un viaggio nel profondo delle tradizioni e
dei margini, recuperando brani come frammenti
92
/ recensioni
di Storia più o meno sommersa e dimenticata.
Passando da Napoli a Cuba, dalla Bretagna al
Lazio, dalla Toscana al Cilento e ai Balcani, la
voce di Ginevra sposa con trasporto e generosità
il vitalismo delle proteste popolari (l’ottocentesca
ma attualissima - fin dal titolo - Il crack delle banche),
le doglianze e le meditazioni sulla difficile arte
di stare al mondo (una struggente In Maremma,
il malanimo ipnotico di La Maza), i volti diversi
e complementari dell’amore (la trascinante Usti
Usti Baba, la serrata Au Bord De La Fontaine), rivelandosi interprete a tutto tondo nella screanzata
M’aggia curà e nella fervida Le figliole.
La produzione artistica del “solito” Francesco
Magnelli determina arrangiamenti ingegnosi
ma essenziali, rispettosi delle radici ma senza timore
reverenziale, valga
per tutti ciò che
accade in Ali Pasha,
canto storico albanese avviluppato
in ubriacante trama gitana con venature jazz. Da sottolineare infine l’inclusione in
scaletta di due pezzi firmati Tenco (una Io sì dalle azzeccate derive sirtaki) e Pino Daniele (una
trepida - e non potrebbe essere altrimenti - Terra
mia), di fatto poste sullo stesso piano delle altre,
quasi si intendesse riannodare e un po’ rimpiangere quel legame tra canzone d’autore e vita ad
altezza d’uomo un tempo saldissimo e oggi parecchio più labile.
Prendetelo come un affascinante, a tratti divertente, grido d’allarme. Se vi pare.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Grand Duchy - Petits Fours (Cooking Vinyl UK, Feb 2009)
G enere : I ndie pop rock
Ancora lui? Sì, ancora lui: Black Francis, il
Grandepixies. Ma stavolta non è in solitaria come
le sue recenti uscite: è sua moglie Violet Clark
ad accompagnarlo in questa avventura ispirata al
Granducato del Lussemburgo (eh?!!), Grand Duchy.
Comunque, ragione sociale a parte, paradossalmente è proprio la componente femminile a rappresentare il valore aggiunto dell’album. Infatti,
Petits Fours si muove su un elettrico indie rock
contrappuntato da un elettronica mai invasiva ma
strutturale, dando ampio spazio alle melodie. E
quest’ultime, quando assumono le coordinate vocali di Violet, riescono a coinvolgere con la loro
graziosa morbidezza: come avviene per esempio
in Lovesick, in Seeing Star e in The Long Song.
Anche se i risultati migliori vengono raggiunti
quando le due dolci metà si fondono duettando:
Fort Wayne, l’episodio più riuscito, è emblematico
di ciò.
Petits Fours non sconvolgerà le sorti del rock,
ma solo per il fatto di evocare Stereolab, Grandaddy e Star con in filigrana la genialità dei Pixies e per la sua capacità di contagiare morbidamente è da annoverare come una delle migliori
produzioni post-Pixies del capofolletto.
(7/10)
Andrea Provinciali
Gui Boratto - Take My Breath Away
(Kompakt, Mar 2009)
G enere : minimal deep IDM
Le strade deep di Boratto si fanno anima. Dopo
il non troppo entusiasmante Chromophobia, il
ragazzo Kompakt si riporta nella scia del clubbismo chic che Andy Stott e Apparat hanno reso
un marchio per il nuovo millennio. La sua proposta è fatta di casse dritte senza scrupoli, di bassi
caldi e di stanze ossessive, al limite della catarsi.
Questo sentimento che cola dai solchi del nuovo
CD è una dichiarazione d’amore al minimalismo
da dancefloor e anche se i patterns ritmici non
hanno l’impertinenza dell’hardcore o la poshyness del retrofuturismo nu-rave, l’ortodossia tutta
Berlino paga. Vedi le bordate acide in coda ad Atomic Soda, gli echi melo à la Circlesquare di Opus
17, il vocoder che richiama i primi esperimenti di
Erlend Øye (No Turning Back), le tastierine 80 dei
Depeche Mode (Azurra) e altri esercizi di stile che
contribuiscono a creare una deep cameristica, ai
confini molte volte con l’IDM (Les Enfants, Besides).
Un ritorno -per vie meno battute dai più- alle estetiche dei novanta del dopo-E, trafitto dall’identità
berlinese.
La via è tracciata, accomodiamoci in poltrona.
(7/10)
Marco Braggion
I Monster - A Dense Swarm Of Ancient Starsdh (Dharma, Apr 2009)
G enere : pop rock
Col fortunato nonché palindromo secondo album
NeveroddoreveN (Dharma Records, 2004),
gli inglesi (di Sheffield) I Monster ribadirono
quanto già palesato col singolo Daydream In Blue
(Cercle Records, 2001): una straordinaria propensione per i pezzi da soundtrack pubblicitaria,
avvincenti e adesivi malgrado la - anzi forse grazie alla - irriducibile stranezza che li pervadeva.
Col terzo album A Dense Swarm Of Ancient
Stars la calligrafia se possibile si frammenta ulteriormente, pur obbedendo ad una strisciante
ma tangibile maturazione. Ne esce un pop che,
pur sprimacciato da influssi vaudeville, fregole
electro, languori filmici e ciondolamenti onirici,
suona più solido, lasciando intravedere una sarabanda di rimandi ubriacanti per varietà ma fin
troppo riconoscibili.
Ferma restando la brillantezza delle intuizioni
e l’estro frizzantino delle soluzioni soniche, alla
lunga l’eccitazione lascia il posto ad un compiacimento auditivo gradevole ma tutto sommato privo di sussulti. Privo di mistero, aggiungerei.
Detto del dadaismo scenografico vagamente
Beatles che informa l’introduttiva The Circus Of
Deaf e Dear John, il programma scomoda sovente
rimandi alle angolose bizzarrie Blur (She’s Giving
recensioni /
93
Highlight
Qemists (The) - Join The Q (Ninja Tune, Feb 2009)
G enere : electrodub mesh - ravecore
Quando meno te l’aspetti esce qualcosa di necessario. Il
disco dei Qemists è quello che si dice una rappresentazione fedele dello zeitgeist 09 che rivendica la tradizione
hardcore. E se qualcuno l’ha già rispolverato nei territori
più affini al ballo e al dubstep (Zomby), qui ci si sposta
sul drum’n’bass mescolato con il rock. Gocce di sudore
e pogo, cose che ricordano la stagione dei RATM e che
innestano le lezioni di Roni Size e dei suoi Reprazent
per la presenza live. Quei draghi che suonavano tutto dal
vivo si sentono nelle batterie di questo disco che ti spara in faccia tutto senza mediazioni, la copertina che ti ricorda la Washington dell’altro sentire hardcore (Youth of Today tanto per fare un nome), le chitarre che ritornano e che si mescolano con il drum.
Non più solo bass insomma. Qua si spara alto e si rompe il muro del sintetico con una
vitalità nuova, non ci si scandalizza più se la palette sonora proviene alternativamente
dall’analogico o dagli spippolamenti di macchine da nerd occhialuti. La lezione di
Missil e dei Prodigy è stata metabolizzata (il crescendo di svisate acide di When Ur
Lonely), ma non solo. Qui si rivanga anche la stagione degli Asian Dub Foundation
(Got One Life), che è come dire roots giamaicane innestate con il techno-dub. Insomma
una presa di posizione che mescola mescola mescola e dipinge ancora una volta un
quadro mutante, un’identità globale e meticcia già profetizzata da The Bug. Ninja
Tune, chi l’avrebbe mai detto.
(7.5/10)
Marco Braggion
Me The I), alle caligini dream pop stile Ooberman e Delgados (vedi la Sickly Suite), al glam
cibernetico di stampo Goldfrapp (le screanzate
A Sucker For Your Sound e Lust For A Vampyr), bazzicando neo psichedelia screamedelica (Escape
From New Yorkshire) e spasmi wave balcanizzati
(Insects), mentre Cool Coconuts trasfigura bossanova con lasciva disinvoltura e Goodbye Sun a tratti
sembra ipotizzare un Jens Lekman rapito dagli
Air (!).
Una intrigante sarabanda di espedienti, certo,
94
/ recensioni
però il guizzo più sbalorditivo arriva con la conclusiva The Best, cover quasi irriconoscibile del
celeberrimo pezzo di Tina Turner, spianato da
un talkin’ androide tipo la Fitter Happier radioheddiana dopo un overdose di prozac.
Questi I Monster insomma sono così divertenti
e così tutto sommato evitabili. State certi che li
ribeccherete in qualche spot.
(6.3/10)
Stefano Solventi
Il Maniscalco Maldestro - Panna,
polvere e vertigine (A Buzz Supreme, Mar 2009)
G enere : A rt rock
Durante gli anni trascorsi dal giustamente lodato
esordio, il Maniscalco Maldestro è diventato una
statua d’alabastro (opera dell’artista concittadino Alessandro Marzetti), ha cambiato bassista e,
dopo un 2008 onusto di vittorie (Heineken Jammin’ Contest, Italia Wave Band Toscana e Contest del MEI), ora dà alle stampe il suo secondo
disco, pubblicizzandolo con una caccia al tesoro
virtuale dispiegata sui vari Facebook, YouTube,
MySpace ecc... a dimostrazione che lo spirito che
animava il precedente lavoro è rimasto lo stesso.
Rispetto all’esordio, però, non sono cambiati solo
i colori della mascotte: l’ensemble volterrano ha
infatti ripulito il cantato da alcune occasionali sbavature vibrazionsubsonicoidi (con
annesso eccesso
di sdrucciole) che
inficiavano qua e
là la riuscita dei
brani, portandolo più vicino
semmai alla bella impudenza del
Teatro degli Orrori; mentre musicalmente ha
preso più saldamente in mano il tourbillon di stili
che è ormai il suo marchio di fabbrica centrandolo su un robusto rock classico virato QOTSA da
cui partire con destinazione ovunque.
Dal boogie sulfureo dell’iniziale La mia vita in ozio
alla conclusione con una versione “estesa” e molto più folle di Sorridi al muro, i nostri trovano il
modo di mantenere la rotta passando per ribollii
Alice in Chains, valzer un po’ francesi un po’
Capossela (spesso anche nella stessa canzone),
una Ogni giorno che mette insieme Gogol Bordello e Bobo Rondelli, spiegandoci anche che
la jungle e lo ska non sono così lontani (la citata
Sorridi al muro) e che se Les Claypool collabora
da anni con Tom Waits un motivo c’è (Filastrocca
scirocca).
Panna, polvere e vertigine è il disco di un
gruppo in piena salute e maturità artistica, con
le quali padroneggia efficacemente la lezione dei
campioni della follia rock rimanendo a modo
loro “cantabili”, quasi una versione Stones dei
“Beatles” Mariposa.
Un confronto cui si assiste con estremo piacere...
(7.2/10)
Giulio Pasquali
Jackie ‘O Motherfucker - The Blood
Of Life (Fire Records, Apr 2009)
G enere : psych folk
I Jackie O’ Motherfucker debuttano su Fire Records con una sorta di live registrato negli studi
della Radio VPRO di Amsterdam. In scaletta
alcuni classici recenti della band, un traditional
intitolato The Lost Jimmy Walen e un brano nuovo
che è quello che dà il titolo al disco chiudendolo
in piena gloria psichedelica con i suoi 17 minuti
abbondanti. E’ un piglio morbidamente bucolico, quasi hippie, certamente psych-folk quello di
questa session live, che si allinea evidentemente al corso nuovo intrapreso a partire da Flags
of the Sacred Harp. Qui semmai si aumenta
sensibilmente il tocco folk. Le chitarre acustiche
pizzicate con arpeggi circolari e un canto da folkster della buona per Tom Greenwood rileggono
brani chiave degli ultimi dischi come Valley Of
Fire o Hey! Mr. Sky, rendendo la scaletta forse un
po’ troppo monocromatica. Potremmo a questo
punto dire che tutto è un po’ fine a se stesso o che
questo disco può essere considerato come una fotografia unplugged della band, laddove America
Mystica ne riprendeva il lato elettrico. Alla fine
quello che si ottiene è un’oretta scarsa di buon
folk psichedelico, di quello che a Matt Valentine
sembra non interessare più
(6.8/10)
Antonello Comunale
recensioni /
95
James Orr Complex - Com Favo
(Rock Action, Apr 2009)
G enere : folk - blues
Immaginatevi un John Fahey in gita a San Paolo, in Brasile. O per essere più precisi, immaginatevi uno scozzese di Glasgow innamorato del
fingerpicking in gita a San Paolo. Come dire, il
blues che incontra il tropicalismo e mescola la
tradizione nera anni ‘30 e ‘40 a una saudade tutta
sudamericana, il folk più scarno a un’insolita ampiezza di vedute armoniche. Nulla di ostentato,
nessuna raffinatezza d’autore per palati finto-intellettuali e nemmeno strutture troppo riconoscibili, ma una naturalezza espositiva che si limita
ad accennare il cognome della famiglia adottiva,
senza descriverne la quotidianità. Lasciando invece che le redini del comando rimangano a vecchi hobo nostalgici (Angry Mob e Man-O-War Way)
o a paladini di un folk arpeggiato su accordature
personalizzate (Balisada).
Christopher Mack e la sua Martin D15 acustica sono al secondo episodio a nome James Orr
Complex ma l’impressione è che nonostante le
buone capacita tecniche messe in mostra e le ottime motivazioni di fondo, ancora non si vada oltre il “buon disco canonico”. Dotato di uno stile
personale, godibile, colorato da una leggerezza
strumentale che appassiona senza stancare, ma
poco adatto a farsi psicanalizzare per scovare significati troppo profondi.
(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Jeniferever - Spring Tides (Monotreme Records, Apr 2009)
G enere : post rock
Secondo album per gli svedesi Jeniferever a distanza di tre anni dal loro debutto Choose A Bright
Morning. Il raggio su cui si muove Spring Tides è sempre il medesimo: etereo e melenso post
rock aperto tanto a sospensioni shoegaze quanto a esplosioni emozionali e inflessioni slowcore,
a metà strada tra Slowdive, Mogwai, Early
96
/ recensioni
Day Miners e Cure. La malinconia è la regina incontrastata di queste dieci tracce, e la voce
di Kristofer Jonson non fa che evocarla, ora
con sfuggenti traiettorie ora con una profondità
new wave in puro stile Robert Smith (Ox-Eye
sembra una delle ballad strappalacrime di Bloodflower). La languidezza delle chitarre e la delicatezza delle tastiere creano dilatazioni sonore al
limite della commozione, ma finiscono anche per
sfiorare la narcolessia pura. Il minutaggio medio
troppo elevato e una produzione eccessivamente
fredda e laccata appesantiscano l’ascolto dell’intero album, mettendo in secondo piano la non
banale ricerca emozionale del quartetto. Questa
sì da evidenziare.
Siamo certi che una cura meno formale e una
formula artistica meno cerebrale farebbero uscire
i Jeniferever dal cono d’ombra in cui si trovano.
(5.5/10)
A testimonianza, brani come Spin Me Around o
Don’t Lay Your Head On My Shoulder, New Day Dawning o Singing In The Brain, abbuffate elettriche in linea con l’immaginario chiamato in causa tuttavia
sostanziate da una scrittura che mantiene tutte le
promesse di naturalezza e organicità. Come del
resto le parentesi aliene di Puddles o Soft As Breeze,
in cui si mescolano pacatezze alt-country/folk e
derive melodiche inaspettate in bilico tra R.e.m.
e Neil Young. Ci si accorge sin dal primo ascolto
che tutto è in ordine nei quarantacinque minuti
che vanno a compilare questo nuovo capitolo della storia musicale dei Jenny’s Joke, dalla sicurezza
che traspare dai passaggi strumentali, ma soprattutto da un programma che rimane godibile pur
non rinunciando a una certa voglia di osare.
(7/10)
Andrea Provinciali
Joe Bataan - King Of Latin Soul
(Vampisoul, Mar 2009)
G enere : l atin
Jenny’s Joke - Self Titled (Seahorse
Recordings, Mar 2009)
G enere : rock
Basso in evidenza, brani strutturati e in crescendo, chitarre elettriche sfibrate capaci di sciogliersi in arpeggi liquidi come di trasformarsi in
cavalcate elettriche urticanti. C’è il marchio dei
dEUS nelle undici tracce di questo secondo disco a nome Jenny’s Joke – il primo, Ninth Scene, risale al 2005 -, nella cura che viene riservata
ai suoni come nei picchi di intensità raggiunti la
musica grazie alla stratificazione degli strumenti. Un legame di parentela che metterebbe su chi
va là chiunque, vista la complessità della materia
trattata e le vette qualitative raggiunte dai padri
putativi, ma che non preoccupa più di tanto la
band di Cremona. Capace, invece, di sfruttare i
caratteri dell’ereditarietà a proprio vantaggio, per
un disco estremamente equilibrato che gioca con
i canoni estetici di riferimento senza farsi prendere eccessivamente la mano dalla “sindrome della
fotocopia”.
Fabrizio Zampighi
Per far capire con efficacia e rapidità l’aria che si
respira in questi tre quarti d’ora basterebbe chiamare in causa il titolo di un’antologia dedicata
anni or sono a Joe Bataan dalla stessa casa madrilena che pubblica questo suo nuovo lavoro: latin
funk brother. Ecco, sta tutto in quelle tre magiche
parole il succo - caldo e invitante, va da sé - del
discorso sonoro, esemplificato alla perfezione da
una Mestizo tutta saliscendi di fiati sottratti da
Move On Up e “call and response” di vitalità quasi
impossibile. Ti chiedi che cos’abbia da essere così
allegro señor Bataan, con i tempi che corrono;
ci rifletti sopra un
attimo, a mente
serena e televisione spenta, e aferri
quanto alla fin fine
una risata seppellirà ogni cosa e chi
vuol esser lieto, lo
sia.
Ancor di più se il Nostro gioca sul sicuro in questo ritorno coi validissimi catalani Los Fullanos,
rileggendo The Bottle di Gil Scott-Heron a passo
torrenziale e ripescando il cavallo di battaglia della mayfieldiana Gipsy Woman; alternando classici
e chicche sulle ali di una classe eccelsa con pochissime rughe (soltanto in I Wish You Love l’ugola
non è all’altezza, ma la si sostituisce al volo con
una The Prayer registrata dal vivo). Impossibile
restare fermi, insomma, che si abbia a che fare
con l’incalzante Johnny’s No Good o con la sorniona Special Girl, con una Rap-o-clap-o 2008
da infiammare pista e onde FM o con le gustosamente tautologiche Latin Soul Square Dance e
Puerto Rico Me Llama. Uscita di rilevanza storica
essenzialmente nulla, questa, ciò nonostante baciata da una godibilità assoluta e non solo in barba ai lievi acciacchi dell’età del Fratello. Muchas
gracias, Joe!
(6.9/10)
Giancarlo Turra
Juan MacLean (The) - The Future
Will Come (DFA, Apr 2009)
G enere : disco
The Future Will Come è un lavoro quadrato. Nostalgico, come di costume alla Dfa. Disco, come
di costume Juan MacLean. Euro-pop al silicio
stile Human League, vertiginoso a là Moroder.
John MacLean a tutti noto come Juan apre e chiude, il nuovo parto, con due bombe targate 2008.
Una, The Simple Life, muove un groove pregno di
rimandi high energy disco. Il cantato è questione
a due, laddove spicca la felina Nancy Whang
(in prestito da Lcd Soundsystem) a cesellare la
traccia nei suoi spigoli sexy. L’altra, Happy House,
è puro garage New York: sempre lei, Nancy, sugli scudi a puntellare un canovaccio forte di un
piano ipnotico reiterato sino allo sfinimento. Una
vera supernova.
Nel mentre, otto tracce. The Future Will Come parafrasa Regiment di Eno/Byrne alla stessa marecensioni /
97
niera del James Murphy di Yr City’s A Sucker.
The Station – e in misura minore One Day - parla
la lingua degli ’80, quando la congrega di Philip
Oakey, dopo gli austeri esordi, partiva alla volta
delle hit parade. Accusations acumina il taglio sexy
di cui sopra: space funk da manuale. Tonight, tutta
campanacci e synth epici, vi trascinerà sul serio
lontano; No Time è un marziale funk da autostrada mentre Human Disaster, piece per piano e voce
mesta, è l’unico momento dove la cassa dritta si
defila. Lo ballerete tutto dall’inizio alla fine. Feeling e groove garantiti.
(7/10)
Gianni Avella
K-Branding - Facial (Humpty Dumpty, Mar 2009)
G enere : impro - noise industrial
Una sorpresa inattesa, questi K-Branding, trio
belga passato per peripezie varie e stabilizzatosi come tale solo in occasione di questo esordio
Facial. Che, tanto per mettere in chiaro subito le cose, è un gran bel disco. Equilibrato, ben
calibrato, ottimamente prodotto. Ma è anche
un disco tosto, difficile da assimilare dato che si
muove sui territori paludosi dell’improvvisazione
industrial-noise.
Vincent Stefanutti (sax, macchine e percussioni),
Sebastien Schmit (batteria) e Grégory Duby (chitarra, effetti) sono a proprio agio nella miscela,
invero esplosiva e radicale, di noise primigenio e
industrial made in UK, improvvisazione da freejazz deturpato e no-wave claustrofobica e compatta. Con l’aggiunta di un altro elemento da
sempre caro alle derive industrial: il tribalismo
organico e metallico che fu di acts come Test
Dept e Einsturzende Neubauten.
Non c’è mai però efferatezza né tanto meno parossismo fine a se stesso nei dieci pezzi di Facial,
il cui pregio, anche nei momenti più schizoidi
(Nieu-Latyn), è quello di risultare sempre sotto
controllo. Quasi represso. Dopotutto è nel canone del genere tendere alla cupezza e pezzi come
98
/ recensioni
Der Morgen Kommt – nenia post-industriale che si
avvita su un tribalismo ossessionante – stanno lì a
dimostrarcelo.
Il paragone più immediato, sia per consonanza
geografica che per libertà e mobilità stilistica,
sono i Kong, collettivo aperto olandese capace di
farsi apprezzare per alcuni dischi nei ’90 e, pare,
sul punto di ritornare in pista; ma i K-Branding
sopravvivono del loro.
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Kashiwa Daisuke - 5 Dec (Noble, Mar
2009)
G enere : elettronica
A seguire Program Music 1, album interamente strumentale dell’artista giapponese Kashiwa
Daisuke risalente al 2007, ecco le marcate esposizioni al contrasto di 5 dec.
Le gestualità espressive di ritmica e dinamica
aggiungono qui una nuova formula d’intrecciati
piani conoscitivi (Drum&Bass, Techno, Elettronica ambient, progressive, glitchy o avanguardia)
che attingono al suono senza negare espressione
e differenza. Nessuna violenza a forma o tecnica,
disposte al fluire o a policromie in ritmo che mettono in moto campioni, drones, battiti o strumentazione più o meno acustica.
La commissione a tratti isterica o estrema non
è rigorosa negli accostamenti: ecco allora che in
coda ai minimali loop in pianoforte di Red Moon si
trovano le destrutturate incuriosi di Requiem, una
batteria dat bpm sostenuta tra sospensioni e glissati (Taurus Prelude), l’elettronca particellare di Siler
Moon o le gocce in cinematografica elttroacustica
di Broken Device.
5 dec è allora un laboratorio di sintesi e scrittura
a cui prestare particolare attenzione, guardando
oltre le metamorfosi figurative, per riscoprire il
valore del ritmo e delle geometrie.
(7/10)
Sara Bracco
Kill The Vultures - Ecce Beast (Autoprodotto, Apr 2009)
G enere : A vant H ip H op
Sono rimasti in due. L’anima musicale della band,
l’alchimista dei suoni Anatomy, e il rapper la cui
voce ha rappresentato meglio lo spirito avant del
combo di Minneapolis, Crescent Moon. Dopo
un tour mondiale, che li ha riportati qui in Italia, dove la stima di pubblico e critica non gli è
mai mancata, i Kill The Vultures ritornano a far
parlare di loro con il terzo lavoro in studio, Ecce
Beast, presentato e venduto in anteprima dal vivo
e su myspace.
La trasformazione (chissà quanto definitiva?) del
quartetto in un duo, non ha stravolto le linee guida stilistiche della
band, ma ne ha
inevitabilmente
accentuato alcuni
aspetti a scapito
di altri. Rispetto ai
due lavori precedenti, Ecce Beast è
costruito tutto sul
rapping flemmatico e poetico di Crescent Moon
che, lasciato solo, occupa tutti gli spazi a disposizione, trascinando la musica verso i beats lenti
e profondi del Tricky prima maniera (ascoltare
l’ipnotica Searchlights And Suspects per credere). Dal
canto suo, Anatomy, si sbizzarrisce nella scelta dei
samples, spesso e volentieri tratti dal repertorio
jazzistico, con fraseggi di trombe e sax in primo
piano e profonde linee di basso (sia elettrico che
acustico) a costruire la base ritmica in cooperazione con la battuta lenta e non sempre regolare
della drum machine.A completare un panorama
piuttosto essenziale ed omogeneo, se confrontato
con le prove precedenti della band, si insinuano
qua e là languide melodie di archi (Walk On Water)
e flauti atonali (Cherish My Desease), geniali trovate
che donano un tocco di raffinatezza al minimalismo degli arrangiamenti.
In questa cornice di suoni jazz e ritmiche ten-
denti al dub (ma pronte a sconfinare addirittura
verso i territori dell’afro beat di Crownfeathers), che
si spinge fino all’avant più destrutturato (Heat Of
The Night) l’hip hop non è più al centro della scena, scomparendo dietro una coltre di influenze,
ormai ben amalgamate, ma lasciando residui ben
visibili nell’uso dei samples e nella costruzione dei
testi, recitati da Crescent Moon con il suo ormai
inconfondibile stile declamatorio.
(7.7/10)
Daniele Follero
Kinetix - Absolute Grey (Koyuki
sound, Gen 2009)
G enere : sintesi minimali
Chi segue da tempo il percorso artistico di Gianluca Becuzzi, conoscerà sicuramente il suo lato
più sperimentale, quello legato alle ricerche sul
sound processing digitale con il quale l’artista già
si cimentava all’inizio degli anni ‘80 con il moniker Kinetix.
Absolute Grey è la nuova uscita di Kinetix per
l’etichetta Koyuki, che stiamo imparando a conoscere ed apprezzare viste le uscite dal carattere
decisamente intrigante nell’ambito dell’universo
dei microsuoni.
Fatta esperienza con la materia, quella che Becuzzi ha dimostrato di saper maneggiare con grande
mestiere nei dischi pubblicati con la Small Voices,
tra esperienze in lettura spaziale (White Rooms,
2004) e dinamiche d’ascolto (Gestaltsystem01,
2006), in Absolute Grey ci si concentra sul metodo per poi concedersi alla monotraccia, tra sfumature in sintesi minimali ed affinata estetica dei
microsuoni. Le traiettorie sono quelle atmosferiche, che non si negano a paesaggi più oscuri, riprodotti con fondali in drones e rumbligs ai quali
si legano modularità, oscillazioni e pulsioni più o
meno sottili, in ritmo o in frammento. Ritorno in
grande stile.
(6.9/10)
Sara Bracco
recensioni /
99
Kinny - Idle Forest Of Chit Chat (Tru
Thoughts, Apr 2009)
G enere : P op
Idle Forest Of Chit Chat, la canzone non l’album, parte come una Lauryn Hill d’annata che
si sia, abbastanza prepotentemente, invaghita
di certi passaggi del Bowie americano, quello di
Young Americans (1975).
Caitlin Simpson - nata e cresciuta in Canada, mistura delle più impure nel crogiolo di
razze in quell’angolo di mondo
(Native Canadian
Indian, radici svedesi ed anche francesi) - ama definirsi
come una “freestyle improv vocalist”. Una specie di Erykah Badu
che fonda attitudini vocali da mezzo-soprano ai
tipici stilemi vocali del moderno (e cosiddetto
r’n’b). Adesso non collabora più con Espen Horne, col quale aveva dato vita a Kinny And Horne,
al quale va attribuito l’album del 2005 Forgetting To Remember.
Adesso Kinny corre da sola, e in questo primo disco tutto a suo nome, gioca stratificando il suono
e porta la produzioni a livelli barocchi di complessità, come da manuale dell’ottima starlette
r’n’b dei giorni d’oggi.
Ci son campionamenti, svisate electro, squarci
a metà fra West Coast e Rod Stewart (Water For
Chocolate), che per quanto strani funzionano. Bel
disco. Un disco a cui riservare almeno più di un
ascolto. Magari consecutivo. E magari non troppo distratto!
(6.5/10)
Massimo Padalino
Land Of Kush - Against The Day
(Constellation Records, Mar 2009)
G enere : avant
E’ sulla via della commistione di generi, culture,
100
/ recensioni
suoni e visioni che si è sempre mossa la mano di
Sam Shalabi, uno dei più fini pensatori del giro
canadese della Constellation. Un disco come questo dei Land Of Kush si inserisce perfettamente
nella traiettoria dello Shalabi pensiero al punto
da rappresentare una sorta di summa teoricomusicale di quanto detto fino ad ora. L’artista, lo ricordiamo, ha sempre cercato di
muoversi con astuzia ed intelligenza sul crinale
tra oriente e occidente, lavorando spesso e volentieri su composizioni che travalicassero gli stretti
confini di genere. Gli episodi migliori sono, ad
oggi, quelli firmati con il nome di Shalabi Effect e quelli su Alien8 a proprio nome, compreso il
controverso Osama del 2003 pensato come collezione di “canzoni di protesta contro l’Arabofobia”.
Quella che sta dietro al nome Land Of Kush, che
in realtà sarebbe una regione del nord Africa, è
una vera e propria orchestra modellata sugli ensemble egiziani degli anni ’50 dell’epoca di Nasser e la musica è al tempo stesso sinfonica, jazzata
e psichedelica con una costante fortemente orientale. In pratica una via di mezzo tra Sun Ra e
gli Shalabi Effect con una magniloquenza degna
delle premesse. Ricalcato sull’omonimo libro di
Tomas Pynchon, al punto che sembra quasi una
colonna sonora (5 composizioni con lo stesso titolo dei 5 capitoli del libro), il disco si muove come
una rappresentazione e ha il carattere della registrazione live con le voci al centro dell’opera. Gli episodi centrali sono quelli forse più accessibili. Jason Grimmer canta carismatico allungandosi sulle scale arabe della cadenzata Iceland
Spar, mentre Molly Sweeney si cimenta con il pop
medio-orientale di Bilocations. Quello che si ottiene alla fine è un disco strano. Al tempo stesso desueto e ovvio, demodé e attuale, semplice e complesso. Shalabi si riconferma una delle penne più
originali e creative di oggi, anche se il suo capo
d’opera non è arrivato nemmeno questa volta.
(7/10)
Antonello Comunale
Lawrence English - A Colour For
Autumn (12k, Apr 2009)
G enere : A mbient /D rone
Registrato tra il 2007 e il 2009, A Colour For
Autumn è il secondo episodio di una serie di album dedicati da Lawrence English al transito
delle stagioni, ai loro segni (e ai relativi stati d’animo indotti) - For Varying Degrees of Winter
era stato pubblicato da Baskaru a inizio 2007. In
quello che è il suo primo album per la 12k, l’australiano si conferma una volta di più maestro nel
maneggiare suoni di dimensioni ambientali e al
tempo stesso fine cesellatore di frequenze microscopiche - esemplare la chiusa liminare al silenzio
di ...and Clouds For Company.
E’ un suono umorale, quello di A Colour For
Autumn, metereopatico, come d’altra parte questa sorta di concept ciclico gli impone di essere:
il colore dell’autunno qui inseguito - o meglio le
sfumature che caratterizzano il corredo cromatico tipico dell’autunno - è una serie tonalità soffuse, che animano tanto esempi di maestosa drone
music - Galaxies of Dust, l’iniziale Droplet, insufflata
da quel soffio vitale che è la voce di Dean Roberts mista al rumore del Maestrale registrato a
Marsiglia - quanto i più canonici esercizi di elettroacustica Watching It Unfold e The Surface of Everything (riconoscibilissimo, in quest’ultima, il tocco
digitale dell’altro ospite Fennesz) dai quali, pure,
riesce ad emerge uno stile personale ed elegante
che è ormai cifra peculiare del sound artist di Brisbane.
(7.2/10)
e Mathieu Cournoyer tornano a deliziarci.
Lo smalto progressivo, che prende magari dagli
Ange dei medi Settanta, si ibrida, pasticcia, perde
la linea retta del segmento filamentoso di dna da
cui fu generato; ne nasce una cosa curiosa curiosa,
che ha a che vedere con i Beatles, i Raspberries,
Chris De Burgh, il
bubblegum più in
generale, ma anche con i Broken
Social Scene, ad
esempio, e molto,
tanto, denuncia in
termini di influenze alla psichedelia
classica (Pink Floyd), a quelle dei tempi del britpop (i Radiohead più intellettuali), ai lambiccati e siderei battistrada astrali su cui beati hanno
passeggiato i Sigur Ros più metafisici. Tutto
condensato, compresso, ridotto ad infinitesimale mondo-canzone. Appena tre, quattro, cinque,
più spesso sei minuti.
Ogni brano è consumato come in una mini-sinfonia pop che non conosca movimenti, intesi nel
senso di ripartizioni della traccia-brano.
Tutto si perde e poi ritrova in un marasma di chitarre, cori incantati, armonie sofisticate. Ma non
è roba pallosa questo Layrinthes. E’ un demone
furbo e giocoso, che prende per la coda il gatto
del pop e lo fa roteare, roteare, roteare intorno
al proprio capo. Ingannevole è il pop...più d’ogni
cosa.
(7/10)
Vincenzo Santarcangelo
Massimo Padalino
Malajube - Layrinthes (City Slang,
Apr 2009)
G enere : P op
Marmaduke Duke - Duke Pandemonium (14th Floor Records, Mag
2009)
G enere : talkin ’ neowaves
Il giochino à la Nine Inch Nails falsettati – che è
I Malajube stanno crescendo esponenzialmente.
Del loro pop, tutto cantato in francese ed incubato al freddo e al gelo del Québec, ce ne eravamo
già occupati un paio di annetti, scarsi, fa. Ora Julien Mineau, Thomas Augustin, Francis Mineau
anche proto-EBM synhtipop, o funky singers su
tappeti Kid A (Heartburn) - convince poco e insospettisce. Sculettare divini è una facoltà di pochi
recensioni /
101
su questa terra e i Marmaduke Duke che giocano
d’angoli con gli Autechre nel taschino non sembrano certo camminare sospesi. Neanche stupido
lo facciamo tuttavia, questo duo scozzese composto da The Dragon (JP Reid dei Sucioperro)
e The Atmosphere (Simon Neil dei Biffy Clyro);
e però nel volersi comprare un posto al sole si
rischia di giocare scoperti; e tasti bianco neri in
stile Talking Heads bombati di amfetamine ’90
(Everybody Dance) non sono proprio l’ultima
moda in fatto di ‘00s. In certi casi poi bisogna
astrarre dalle cose che ci piacciono di default. Se
veniamo sempre scossi e riscaldati dalle scoppiettanti chitarre etnoritmiche direttamente prese da
Fear Of Music (Everybody Dance) non possiamo
caldeggiarne automaticamente l’ascolto.
Specie se questo significa far carovana synth-wave d’ordinanza. Eppure senza stupide girate di
coltello da blogger, Duke Pandemonium è un disco che, al pari del primo Telefon Tel Aviv, mette
d’accordo diversi personaggi e soprattutto palati
che sonorità di questo tipo le vedono con il binocolo. Lo sanno pure i due ed è logico aspettarsi
la ballata synth pop che accomoda la platea. In
questo caso si chiama Kid Gloves e ti vedi dei Tv
On The Radio che invece di spremere Gabriel ci
duettano assieme altezza fine Ottanta. Logico poi
vedersi sfumare track by track le cose più ardite per stemperamenti compiaciuti e compiacenti
(Pandemonium).
Come prevedibile è quel fare ondivago ma sempre effettato (il rap di Erotic Robotic, di nuovo il
funky ma discomusic di Je Suis Funky Homme).
Probabilmente giocare ai cow boy postmoderni
nei duemila vorrà dire qualcosa del genere. Una
chiave per la quasi-sufficienza se la sono guadagnata dunque ed è dal vivo che si gioca il senso
del progetto. Intanto, divertimento usa, gira in
tondo e getta…
(5.9/10)
Edoardo Bridda, Gaspare Caliri
102
/ recensioni
Maserati/Zombi - Split (Temporary
Residence, Gen 2009)
G enere : new kraut
Con un lungo passato post rock alle spalle, i Maserati siglano il loro patto con il delay e si apprestano a confondersi tra gli esegeti
del suono kraut. Il
problema è che
costoro, a dispetto
dei nuovi corrieri
cosmici, restano
saldamente ancorati a terra. L’entrata nel combo di
Jerry Fuchs (primo batterista dei !!!) ha contribuito a traghettare il loro sound verso una sorta
di krautdisco (ascoltare Monoliths per credere), inframmezzata da residui post-rock sparsi qua e là
con quel tanto di ripetitività e prevedibilità che
provoca entusiasmi facili a sfumare. Se la cavano meglio gli Zombi nella long-track Infinity, dove
l’anima prog si esprime in un assolo di batteria
ribelle ai loop krauti e le atmosfere epiche a cui ci
hanno abituati sono sacrificate all’oscurità di una
notte del terrore. Lo split, uscito su Temporary
Residence, risulta piacevole all’ascolto e scivola
giù rapido e indolore, qualora si voglia perdonare
al quartetto di Atene (Georgia) una certa banalità. Là dove gli Zombi coniugano cosmogonia e
fascinazione horror, i Maserati sembrano dei turisti arrivati in Germania da un paio di giorni.
Si rimanda al futuro per eventuali aggiornamenti
con un voto che fa media.
(6.5/10)
Highlight
Shipwreck Bag Show (The) - Il Tempo…Tra Le Nostre Mani,
Scoppiaaaaaaaaaaaaa! (Wallace Records, Apr 2009)
G enere : avant - blues
Non si può prescindere dagli antecedenti. È impossibile. Ché la musica di questo album è larvatamente memore di percorsi precedenti, di traiettorie ormai
decennali tracciate su percorsi sconnessi e fuori mano.
Xabier Iriondo (chitarra, mahai metak, taisho koto,
electronics, ecc.) e Roberto Bertacchini (batteria ridotta all’osso e voce mesmerica) si rimanifestano in jointventure dopo il cd 3” omonimo sempre su Wallace, col
loro tentativo di esplorare l’avant-blues più spettrale e
il rock più destrutturato e afasico.
Come se le parallele A Short Apnea e Sinistri avessero trovato un loro neanche
troppo lontano punto di congiunzione. Un punto che fa tornare a galla, alla memoria di chi ha avuto modo di seguirli, non solo la frammentata dilatazione di A Short
Apnea e il blues in eterno soundcheck dei Sinistri ma anche l’urlo primigenio degli
Starfuckers al confine tra Brodo Di Cagne Strategico e Sinistri.
Il tempo…tra le nostre mani, scoppiaaaaaaaaaaaaa! però non vive di ricordi, né si culla su allori passati. È infatti un album di canzoni; storte, sghembe,
monche, in alcuni casi; complete nella loro convulsa destrutturazione e addirittura
cantate in altri. Più d’uno i picchi di eccellenza: Scoppia, aritmica ballad incendiaria
e insurrezionale; Tempo, in continuo fluttuare impro tra vuoti passatisti e concreti e
pieni in overdrive; Tuamare devastata da clangori post-industriali limitrofi a musiche
estreme, o ancora la sinistra, tesa, sospesa Tra Le Nostre Mani, incudine e martello di
un suono ancora molto avanti. Ma è il senso generale a lasciare a bocca aperta per
la naturale coabitazione e congiunzione tra musica concreta e improvvisazione più o
meno radicale, sapienza da blues anteguerra e rumorosità asincrona e disturbante.
Dicono di essere naufraghi nell’oceano del pop, rifugiati su di un’isola fuori dal tempo…ma a noi
mai sembrò tanto dolce, il naufragar in questo mare.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Francesca Marongiu
Maurizio Bianchi - Dekadenz (Young
Girls Records, Mar 2009)
G enere : minimal - ambient
8 tracce che fluiscono in realtà in un unico filo
di luce sospeso tra la veglia e il sonno. Più prosaicamente, la decadenza omaggiata da Bianchi
in questa nuova prova in proprio (“Dedicated
to my own terminal decadentism” recita una
nota nel retro copertina), consta di una serie di
sali-e-scendi pianistici con il pedale della risonanza pigiato dalla prima all’ultima nota.Ne
consegue una semplificazione di certi tour de
force minimalisti (su tutti The Harp Of New
Albion di Terry Riley) capaci di tratteggiare
con la vibrazione di un suono collettivo lo stupore della propria stessa creazione, omaggio
recensioni /
103
all’atto creativo per eccellenza, l’atto del nascere.
Qui Bianchi torna alle investigazioni ambient
della trilogia Colori/ First Day Last Day/
Dates ma in formato acustico, operazione comunque già testata in M.I.Nheem Alysm.La
risultante, dilatata nell’arco di 71 minuti, suonerà
pretenziosa per molti e preziosa per alcuni, quegli stessi ‘alcuni’ che sanno addolcire la gravità
di una pessima giornata ascoltando un cinguettio
provenire da chissà dove.
(7/10)
Filippo Bordignon
Metric - Fantasies (Last Gang Records, Apr 2009)
G enere : new wave
Morfologicamente, Emily Haines sembra una
Aimee Mann dal taglio più vizioso. Di sicuro la
sua silhouette compensa la sterilità dei Metric.
Canadesi con un passato nella grande mela dove tra l’altro è nato il gruppo -, i Metric muovono dalle parti dei Killers, quindi una new wave
dall’appeal ruffiano e pacione. Fantasies mostra
refrain a presa rapida (Help I’m Alive, Sick Muse,
Gimme Sympahy) e sortite elettroniche a là Crossover senza lattice (Twilight Galaxy), chitarre voluminose prive di sostanza (Gold Guns And Girls) e
un leggero bagliore, Blindness, evidenziato solo ed
esclusivamente dalla pochezza del contesto. Tuttavia lei, la Haines, è veramente carina.
(5/10)
Gianni Avella
Mokira - Persona (Type Records,
Apr 2009)
G enere : elettronica
Un nuovo album di Mokira, ovvero Andreas Tilliander, è davvero un’apparizione imprevista nel
catalogo Type. Il suo precedente Album aveva in
qualche modo plasmato la stessa identità creativa
della prima Type, ovvero quella di un etichetta
giovane che riusciva ad intercettare le ipotesi migliori in circolazione su argomenti musicali come
104
/ recensioni
ambient, glitch, elettronica. Una via mediana per
passare indenni e con una propria personalità tra
due estremi come Kranky e Warp. Il metodo di
Tilliander, nel corso del tempo, sembra poi essere stato messo in secondo piano per tutta una
serie di ragioni e in primis per gli orientamenti di
Twells sempre più diretto ad accantonare per la
tua Type un esclusivo profilo da elettro label. Per
la serie: diversifichiamo il portafoglio.
E’ per questo che fa un effetto strano vedere dopo
cinque anni di nuovo Mokira sulla label inglese.
Persona è un titolo impegnativo già di per se,
con tutto il suo fascino bergmaniano, di contro la
musica in esso racchiusa svela il Tillandier pensiero a proposito di ambient salottiera e glitch
fantasmatici provenienti dal passato. In altre parole se avete apprezzato gli ultimi lavori di Fennesz, Pan American o Tim Hecker potrete
aggiungere un ulteriore tassello al mosaico. Non
che Mokira si allinei ai modelli suddetti a testa
bassa. L’apertura con i dieci densissimi minuti di
About Last Step And Scalein piena coltre boschiva
stile GAS sono più che convincenti. Mentre lo
sono assai di meno i tentativi retrò di allinearsi
alla nuova moda kraut quando si citano Cluster
ed Harmonia nelle ellissi centrali di Valla Torg
Kraut e Oscillations And Tremolo. Il finale chiude in
cerchio virando verso una appena accennata malinconia neo-classica che non sembra per niente
la strada da seguire. A conti fatti un ritorno importante, ma con risultati altalenanti. Il problema semmai è tornare
non riuscendo a portare con se argomenti sufficienti ad elevarsi al di sopra della media.
(6.5/10)
Antonello Comunale
Mono - Hymn To The Immortal Wind
(Conspiracy Records, Mar 2009)
G enere : D ream R ock O rchestrale
Una storia d’amore, ambientata nei paesaggi
fantastici della memoria. Una storia di tenerezza,
malinconia e speranza. Un inno al vento, metafo-
ra dell’anima, l’unica essenza capace di attraversare dimensioni spazio-temporali inaccessibili al
corpo. Una storia, insomma, che indaga il limite
tra sogno e realtà, tra vita e morte. E’ ciò che sta
alla base del quinto album della band giapponese
Mono, un concept strumentale, strutturato sulla
sequenza dei paragrafi dell’omonimo racconto,
che fa un tutt’uno con il disco. Un’operazione,
quella di comporre la musica traducendo le sensazioni derivate da
un testo letterario,
che ricorda il poema sinfonico ottocentesco. Anche
in quel caso il testo
scritto diveniva pre-testo, punto di partenza, origine dell’ispirazione. Ma i paragoni si limitano
alle premesse.
Accompagnato da un’intera orchestra, il quartetto costruisce il suo inno con un linguaggio tipicamente post-rock: dilatazione temporale (quasi
tutti i brani superano i dieci minuti) e impiego
di strumenti estranei alla gamma timbrica impiegata convenzionalmente nel rock (glockenspiel,
archi, flauti). Lo stile, gli arrangiamenti e le continue variazioni di intensità giocate su lunghi crescendo, ricordano in molti casi i Mogwai, anche
se al sound non si risparmiano virate verso atmosfere più cupe e ruvide in stile Goodspeed You!
Black Emperor e Isis (The Battle To Heaven) o
verso paesaggi sonori più distesi, colorati e fiabeschi.
Hymn To The Immortal Wind potrebbe essere anche interpretato come una lunghissima
suite, con i singoli brani a rappresentare le parti della storia. Una storia languida, da groppo in
gola, così come la musica, spesso tesa verso la lacrimuccia. In realtà, però, l’impronta monolitica
che assume il lavoro, non aiuta a cogliere le sfumature del testo e si allontana dalle sue esigenze
drammatiche. I brani ripetono più o meno tutti
la stessa struttura, basata su una progressiva intensificazione del tessuto sonoro, sostenuta a sua
volta da semplici giri armonici in tonalità minore
e da una melodia essenziale. Una formula che, ripetuta ad libitum non può che condurre, inesorabilmente, alla noia. Il languore è una sensazione
molto esposta al rischio di sfociare nel patetismo.
(5.8/10)
Daniele Follero
MSTRKRFT - Fist Of God (Pias, Mar
2009)
G enere : fidget minimal acid
La moda del sound acido virato fidget ogni tanto ritorna e con essa siamo inevitabilmente costretti a rispolverare i 90 dei Daft, le connessioni con il french touch e la deriva da dancefloor
che Aoki, Oizo, Crookers e Bloody Beetroots
ripropongono da un po’ di anni a questa parte.
Il percorso del duo canadese formato da Jesse F.
Keeler (ex Death From Above 1979) e Al-P si
inserisce in questa corrente dance che nei 90 ha
la sua radice, fatta di distorsioni e di filtraggi progressivi, cose che vibrano acidità. Il tutto condito
con una tonnellata di break, la sapiente arte del
taglia e cuci in stile Scuola Furano (Fist of God), i
laser che tagliano la gola in distorsioni tarate sugli 8 bit (Click Click), le casse drittissime di derivazione Jack con il featuring dei campioni dell’hiphop (sua maestà Ghostface Killah in Word Up),
l’inevitabile scorcio tastierato midi 90, cose che
neanche Sabrina Salerno si sogna di fare col vocoder (Breakaway) e in generale un sentire retrofuturistico che con i Justice ha ritrovato ragion
d’essere (citazioni a profusione in 1000 Cigarettes).
Il secondo disco che fa muovere il culo con gli
ingredienti necessari, senza strafare ma nemmeno stravolgere. Per chi si sveglia da un lungo sonno potrebbe alzare la libidine auditiva; per chi è
avvezzo a queste sonorità basta una sufficienza
stiracchiata.
(6/10)
Marco Braggion
recensioni /
105
Nana April Jun - The Ontology Of
Noise (Touch Music UK, Feb 2009)
G enere : D rone
Obits - I Blame You (Sub Pop, Apr
2009)
G enere : garage - rock
Piuttosto soddisfacente da un punto di vista percettivo, quella di The Ontology Of Noise rimane nondimeno un’esperienza musicalmente
povera, in grado di disilludere aspettative generate da un titolo altisonante e premesse teoriche
sulla carta altamente promettenti.
Nana April Jun è il progetto sonoro dello svedese Christofer Lämgren (Goteborg, 1974), artista
visuale, compositore ed editor dell’ottimo art magazine YKKY. The Ontology Of Noise ambirebbe,
nelle intenzioni dell’autore - previo un riferimento
piuttosto di maniera al Burzum di Filosofem a collocarsi in quello spazio interstiziale nel quale
sembrano oggi confluire l’eredità del black metal
classico e alcune delle esperienze più estreme in
ambito di elettronica e harsh noise. Non ci riesce - è riuscito invece, di recente, agli GNAW di
This Face (Conspiracy, 2009) - e l’esperimento si
esaurisce in uno scurissimo ed estenuante drone
(per convenzione suddiviso in cinque tracce) di
frequenze generate con l’esclusivo utilizzo di filtri
digitali.
L’approccio alla composizione è, per stessa ammissione dell’autore, di tipo intuitivo, essendo qui
il suono (o meglio, il rumore) trattato alla stregua
di una serie di flussi di diversa portata volumetrica da convogliare nello spazio. Ma nessuna intuizione particolare permette a un brano, piuttosto
che a un altro, di emergere da una situazione di
stasi che, prima che tonale (o timbrica, o dinamica) è, ci pare di capire, creativa. Il ricorso esclusivo a tecniche di processing e mastering digitali, in
questo senso, non aiuta affatto. Nota di demerito
per i titoli delle composizioni che, quelli sì - The
One Substance, Process Philosophy, Space-Time Continuum, Semantic Shift - fanno pensare ai filosofemi di
Burzum. Un mezzo passo falso per la Touch.
(5.5/10)
Obits, ovvero evviva la tradizione! Nel senso che
essere innovativi può anche essere considerata
una stronzata immensa da chi suona rock’n’roll
di viscere e stomaco.
Television, Wipers, Gun Club cita la press-sheet
ma – aggiungiamo noi – punk-wave, grunge e r’n’r
più mille altre note ancora che hanno segnato le
nostre vite si scontrano e incontrano nei 12 pezzi
d’esordio di questo quartetto americano, tanto che
solo abbozzare riferimenti diviene arduo. Dopotutto Rick Froberg (chitarra, voce), Sohrab Habibion
(chitarra, voce), Greg Simpson (basso) e Scott Gursky (batteria) non sono educande né tanto meno
pivellini, visto che hanno alle spalle esperienze
come Pitchfork, Drive Like Jehu, Hot Snakes, Edsel, Shortshack. E I Blame You lo dimostra appieno, in quanto porta con sé come eredità della
scena punk sperimentale di San Diego l’attitudine
a scartare il banale per tentare vie personali, anche
quando come in questo caso si è in presenza di
garage-rock tradizionale e sudicio.
Zero novità, si diceva, perciò solo rock cristallino
nelle sue infinite variabili e accezioni. Piglio retrofuturista alla Man Or Astroman?, chitarre suonate con grazia punk’n’roll, virate surf-garage da
urlo, strambi esercizi da art-wave mutante, adrenalina a go-go, sing-a-long irresistibili come da
consuetudine rock. Siamo grossomodo sul terreno
calcato dagli ultimi Black Lips o da Jay Reatard, per dare due coordinate spicciole e labili,
ma in I Blame You c’è molto, molto di più. A voi
scoprirlo attraverso 12 piccole gemme in cui tutto
suona al posto giusto e al momento giusto.
(6.8/10)
Vincenzo Santarcangelo
Stefano Pifferi
Omar S - Fabric 45 (Fabric, Mar
2009)
G enere : deep D etroit techno
Più che una compilation questo è un album
106
/ recensioni
dell’uomo Omar S. Direttamente in fiero stile
detroitiano. Un all man show per l’ennesimo volume del club londinese. E non c’è presunzione
quando scopriamo che tutte le tracce hanno uno
stesso autore. Qui si tratta di una celebrazione
del suono di una città e di una scuola che ancor oggi spacca. Senza l’aiuto di nuovi software o sample ereditati dai vari angoli del mondo.
Si viaggia direttamente al cuore del ritmo: le
spiagge delle varie Oasis, i tocchi da maestro in
cassa dritta sempre con quel nonsoché di onirico
e quindi balearico (U), gli affondi nel magma deep
(Simple Than Sorry), le escursioni nel funk (Psychotic
Photosynthesis) e nel tribale (Blade Runner): sono solo
alcune delle sensazioni che si riescono a tradurre
su carta da questa bomba che risuona nella mente
per poco più di un’ora ma che ci ricorda come la
Motor City sia ancora lì a pulsare. Senza nostalgia. Qui solo anima in ebollizione. Ed è lo stesso
Omar che ci consiglia di ascoltare la compilation
a volume molto molto molto alto. Provare per
credere. Handz up for Detroit again!
(7/10)
Marco Braggion
One’s (The) - The Debut Of Lady June
(Forears, Gen 2009)
G enere : folk pop
Giovani, carini (in senso indie) e napoletani. Di
Quarto, per la precisione. Ok, i debuttanti The
One’s fanno un folk rock parecchio risaputo e aggiungerei abboccato, dalle evidentissime filiazioni, ma ci mettono cuore, devozione e quel certo
brio che non è il caso di fargliene una colpa. Alla
fine la quadratura del cerchio è inattaccabile,
chitarre, piano, organo e armonica si spalmano
come burro sulle fragranti basi ritmiche, la voce è
una marmellatina trepida per melodie tutto sommato felici. E, quindi, ci siamo.
Ok, ok, l’inglese non è proprio madrelingua, mentirei sostenendo che non conta nulla, ma l’entusiasmo investito dai quattro aiuta a soprassedere. Entusiasmo che pervade l’estro Counting
Crows di Midnight’s Talker, l’impeto Tom Petty
tra vampe di ottoni di All Night Bar, quella I’ll Disappear che sembra i Wilco più garruli in fregola
Mellencamp, il ciondolare dello Young harvestiano in Brown-haired Girl e quello della spiaggia
desolata nella lunga Roads. C’è poi da dire che se
l’intensità piano-voce di Shine In The Wind accoglie echi del primo Springsteen, desta un filo
di sconcerto la distrazione iperromantica di Kathy
& Me, come potrebbe - chessò - un Elton John
crepuscolare.
Se ci sono attitudini diverse e non del tutto armoniche in seno alla band, speriamo siano nutritive.
Staremo a vedere, e ben volentieri.
(6.4/10)
Stefano Solventi
Orka - Livandi Oyða (Ici d’ailleurs,
Feb 2009)
G enere : I ndustrial folk
L’origine atavica del suono e il gusto per l’arcaico
sono spesso elementi che attraggono il compositore. Direttamente alle origini del suono sembra
andare Livandi Oyða, esordio discografico degli Orka, gruppo che arriva dalle remote Isole
Faroe; esordio che nasce sotto il segno di una
attenzione, minuziosa, rivolta al materiale - strumenti autocostruiti con materiali provenienti dalla fattoria in cui è stato registrato il disco - e di
una dovuta presa di distanza dalle più riscontrate
forme melodiche e tecniche.
Non conoscono evidenti ritorni tematici, le undici sembianze sonore e questo finisce per conferire
loro un’ampia caratterizzazione.
I suggerimenti
sembrano arrivare dall’industrial,
per intenderci,
quelle alienate
dissonanze dei tedeschi Einstürzende
Neurecensioni /
107
bauten, arricchite con suggestione sonore tra
antologie urbane o rurali e nitidi contributi vocali
in lingue difficilmente comprensibili.Quello che
cambia è il registro, aspro, graffiante come quello
di Volmar, concordato con l’ipnosi (Heilabruni), le
tensioni (Inni) dal formato limitato, tra elasticità
in corde, prestazioni ambientali e in percussione
(Livandi oyða).
Brutali, inquiete o temerarie le peculiarità timbriche di Livandi Oyða, non fanno a meno neppure delle stesure alla The Third Eye Foundation,
Oktopus/Deadverse o Data-Com, preziosi giochi di elementi che si concedendono alle parvenze tribali, elettro, arabeggianti o psichedeliche.
Il principio di una nuova arte, quella distante dalle implicazioni, libera di esistere, aperta all’insolito, ma mai priva di significato e comunicazione.
(6.8/10)
Sara Bracco
Ozric Tentacles - The Yumyum Tree
(Snapper Music, Apr 2009)
G enere : S pace R ock
Durante i venticinque anni trascorsi dai loro
esordi, attorno alla metà degli anni ’80, gli Ozric
Tentacles ai cambi di formazione ci hanno fatto
davvero il callo. Eppure, l’abbandono di un simbolo della band, il flautista John Egan, non deve
essere stato molto facile da metabolizzare. Champignon (questo il suo nomignolo), aveva da sempre rappresentato l’anima più hippie del gruppo,
anche nell’aspetto, e il timbro del suo flauto traverso aveva accompagnato tutti i passaggi del tortuoso cammino degli Ozric.
L’assenza di Egan toglie respiro e poesia a Ed
Wynne (unico superstite del nucleo originario)
e compagni, costretti a reinventarsi uno stile.
La musica, in ogni caso, non cambia poi granché, nonostante tutto e in perfetta sintonia con
l’evoluzione della band, da sempre molto lenta
e statica. E’ dai tempi di Strangeitude (1991)
e Jurassic Shift (1993) che la band, dopo un
periodo di grande creatività (e perfino qualche
108
/ recensioni
riconoscimento da classifica, il colmo per dei
fricchettoni come loro), sembra essersi fermata,
come incantata negli stessi paesaggi fantastici
che aveva creato. Luoghi lisergici dove le sonorità progressive incontrano la techno, l’ambient, la
trance, la fusion e il dub su uno sfondo psichedelico, precursore di quella che oggi comunemente
viene denominata Goa Trance.
Il tutto, tenuto insieme dalla batteria e dall’inconfondibile stile chitarristico di Wynne, ormai
praticamente rimasto solo a tenere alta la bandiera del rock. Senza il flauto gli Ozric guardano
molto più da vicino la dance (Magick Valley, Plant
Music) e il dub (Mooncalf, con i suoi passaggi dal
funk al reggae sembra un brano dei Police rovesciato nell’LSD), ma senza stravolgere il sound
complessivo. C’è tutto (o quasi) quello che c’era
prima e niente aggiunge, questo Yum Yum Tree,
a ciò che già sapevamo sul combo britannico: ottima qualità, idee e sound un bel po’ datati e tanta psichedelia.
(6/10)
Daniele Follero
Passe Montagne - Oh My Satan
(Africantape, Apr 2009)
G enere : math - noise
Jupiter apre con un interplay furibondo; di quelli
che solo gli Oneida di Each One, Teach One
erano capaci. Una corsa a mille all’ora a cassa
dritta e ampli in fiamme che brucia in un minuto
e mezzo, con un solo refrain nel mezzo giusto per
prendere una boccata d’aria.
Si presenta così, senza mezzi termini Oh My
Satan, ritorno dei Passe Montagne, costola degli Chevreuil – in coabitazione c’è Julien Fernandez alla batteria – e ennesima dimostrazione
della vitalità della scena grossomodo math-noise
d’oltralpe.
Diciamo grossomodo per il semplice fatto che, se
innegabili sembrano i referenti di partenza dietro
le 12 tracce dell’album (tutta la costellazione del
rock rumoroso da Shellac a Don Caballero), è
pur vero che il trio innesta qua e là, quasi in una
sorta di riciclaggio (pro)positivo schegge soniche
che tornano indietro fino agli anni 70. Le battute
iniziali di 98% Cuir 2% Sky, l’assolo di Traga Maluca, la (apparentemente) slide di Made In China lo
dimostrano appieno, anche se i tre restano sempre fedeli ad un ideale di musica scarna e scarnificata, priva di orpelli e depurata da ogni inutilità,
esplosiva e furiosamente essenziale.
(7/10)
Stefano Pifferi
Peter Bjorn And John - Living Thing
(Wichita Recordings, Mar 2009)
G enere : pop
Un passato lontano appena tre anni (e spesso poco
più di quattro minuti) eppure così ingombrante.
Diciamocelo, un po’ tutti, dal metallaro all’hiphopper, dall’indie rocker all’elettroacustico, hanno canticchiato Young Folks. O meglio, fischiettato.
Fare i conti con quella perla di singolo, per Peter
Morén, Björn Yttling e John Eriksson, non sarà
stato facile. Andare oltre, un obbligo.
Il nuovo Living Thing agisce alla pari se non di più
Writer’s Block. Ne è funzionale, senza dubbio.
Non si colgono fischi, ma lo stato
d’arte del trio svedese prosegue alla
volta del (loro) disco perfetto. L’armamentario dei
Nostri, che guarda
al pop tradendone
la stessa lettera, riesce ad arrivare, per esempio, là
dove gli Hot Chip falliscono, ovvero: stupire.
Stay This Way è di parsimonia quasi Beatles-iana:
oltre la voce - tanto Lennon - è la cura del dettaglio (leggasi arrangiamento) a fare la differenza. Blue Period Picasso, seppur priva di fischiettio,
farà breccia per la disinvolta combine tra appeal
friendy e disegno astruso. Poi - sarà pure un caso,
ma ormai cominciamo a farcene una ragione -
anche qui, come per Vampire Weekend e Here
We Go Magic, lo spauracchio del Paul Simon
di Graceland si manifesta, in minima parte, nella
tropicale Living Thing e appieno nell’ariosa I Want
You!. Nothing to Worry About, il singolo, ha molto del
Beck di un tempo; Just the Past, invece, tanto dei
Depeche Mode. The Feeling scivola come una
danza sinistra, It Don’t Move Me ha una verve tutta
’80.
Nessun hit ma tanti probabili hit, in prospettiva.
Virtù o difetto?
(6.5/10)
Gianni Avella
Peter Doherty - Grace/ Wastelands
(EMI, Mar 2004)
G enere : R etro P op
Si va presto in saturazione con gli egomaniaci
così come loro sono saturi di se stessi e dei loro
vizi. Soprattutto è Pete a scocciare, lui mai pago,
un disco all’anno e tournée. Tournée e poi l’album e noi, a ogni nuova recensione, non poter
prescindere dal personaggio. Da quello pubblico
e privato e dal fardello di tutto ciò. Mi sono scocciato di parlare di Pete, di leggerne sulle riviste di
critichella ancor di più, ma è in sostanza il vincolo
a cui ti lega che devasta: droga e talento. Talento
e droga.
Ti annoi a far mitologia punk ogni santa volta.
Sei patetico. Kate e coca. Questo e quello. Con
condanna finale: ti rimane da dire che è bravo.
Ha personalità. Sa interpretare le sfumature della madida e translucida persona amplificata qual
è ecc. tanto che alla terza volta preferiresti fare
tutt’altro. Odi farlo quanto lui odi o ami se stesso
a seconda di quello che lo addiziona.
Il nuovo album in proprio non lo smentisce,
Grace / Wastelands è un’uscita acustica con
il piglio un po’ Conor Oberst. La raccolta adulta
del ragazzo adulto che si confronta con la tradizione da dove il suo esser giovane proviene. Dunque rhythm’n’blues, giamaica crooning, accordi
blues, quelle cosine avant spettacolo dei Liberrecensioni /
109
tines portate a salotto buono, il ragtime con gli
amati anni trenta e tante storie di girls. C’è pure
un ensemble d’archi in una paio di occasioni a
tingere di raffinata decadenza le ballate come piacerebbe a un Lou Reed. Proprio come lui, pure
Pete adora quanto
di nero e reietto
abita in un’anima
rock che ci piace
pur sempre prostituta, decadente e
egomaniaca.
Non ci piace parlarne, ma siamo
così, trasferiamo nel solito nero laido e bianchissimo Syd like i nostri reconditi desiderata. E Pete,
più forte, o perlomeno meglio consigliato dei soliti
martiri rock, sorprende per costanza e argomenti in fiammella. Ruffiano come sa cambia arrangiamenti e amicizie e il sempre più scaltro piglio
produttivo rafforzano un’indole sempre più musicata e musicabile (qui l’ormai sodale Street ai
bottoni e niente meno che Coxon che di nome
fa Graham alla chitarra, fanno un lavoro da veri
professionisti).
E tutto torna nei nuovi pezzi a spina staccata,
senza pretese di far generazione, ideali esercizi di
stile da portare, chitarra a braccio (…meglio se
di Coxon), davanti a un teatro. Pete o Peter (che
fa più serio) interprete fa propria la tradizione. E
in sostanza è così: ancora bravo o bravino e poco
c’importa. A non annoiare è questo vestito da
hobo rock quattro stagioni, quattro generazioni e
più. E quanto bene ci si muova dentro. E quanto
ci piaccia il Novecento. E l’Europa vecchia e decadente.
(6.9/10)
2009 con un graffio che ci obbliga a ripensare
all’eredità del rave. Loro e la loro eredità ardkore UK, il loro successo planetario, l’influenza
su tutta la scuola nu- (Justice, Soulwax, etc.):
oggi con qualche ruga in più si ripresentano
alle platee di tutto il globo. E come i sempreverdi Oasis, conoscono bene le folle oceaniche
sotto il palco. Da quel 2004 in cui hanno cristallizzato al mainstream l’esperienza underground degli esordi (con quel simbolo che è The
Fat Of The Land) ne sono passate di mode.
Oggi Liam, Keith e Maxim riprendono gli ingredienti che li hanno resi famosi e li rivisitano
con sapienza produttiva: le tastierine acide del singolo Omen, i bassi e le
voci robotiche di
Take Me To The Hospital, il punkettino
di Run With The
Wolves, l’elio nelle
strofe di Warriors Dance e altri ingredienti classici che definiscono un sentire definitivamente
rave innestato nei binari del rock. La mutazione
mainstream è ormai compiuta da tempo. Questo
ritorno conferma che la storia completamente infusa di DIYness e di vinili white label buoni per
4 o 5 parties si è consolidata e ha cambiato il nostro modo di sentire la musica d’intrattenimento.
Perché qui non siamo dalle parti della ricercatezza della Werk. Qui si punta al(la) pop(olarità). E
ancora una volta si sbanca. Una conferma per
chi è stato bruciato dal fuoco di Firestarter e una
sorpresa per i nuovi adepti. Rave is here to stay.
(6.5/10)
Marco Braggion
Edoardo Bridda
Prodigy (The) - Invaders Must Die
(Cooking Vinyl UK, Mar 2009)
G enere : rave rock
Il ritorno dei Prodigy segna la carrozzeria del
110
/ recensioni
Pumajaw - Curiosity Box (Fire Records, Mar 2009)
G enere : folk
Al secondo disco come Pumajaw, l’ormai storico duo anglo-scozzese di Pinkie Maclure e John
Wills trova finalmente la quadratura del cerchio.
L’ultima volta che li avevamo sentiti era stato con
una traccia apparsa nella già di culto compilation
curata da Mark Coyle sul dark folk britannico
e intitolata John Barleycorn Reborn (ultimo
parto per Whoven Wheat Whispers che chiuderà
i battenti poco dopo causa conclamato insuccesso del suo database sul folk. Un peccato davvero…).
Per tornare ai Pumajaw, loro sono un esempio perfetto di folk britannico degli anni 2000, che tiene
tanto in considerazione il passato illustre quanto
le mode attuali. Con tutto il trend sul weid-folk
e le ristampe dei classici, questa prima decade
del nuovo millennio è stata un perfetto terreno di
sviluppo per formazioni come queste, che fanno
del loro essere retrò la ragion d’essere della loro
attualità. Quello di Pinkie Maclure e John Wills è
un repertorio quanto mai classico mosso prima di
tutto dalla voce di Pinkie, una brava e carismatica
novella Sandy Denny e dalle chitarre effettate e
calibrate dall’ex batterista dei Loop.
Con loro non dobbiamo pensare agli eccessi americani
Sono inglesi, l’eleganza è il metro di giudizio delle loro composizioni e si rimane sempre ancorati
alla forma canzone, anche se timidi accenni verso una deriva più propriamente psichedelica non
mancano come si evince dal bellissimo attacco
delle due parti di Visiting Hour. A marcare ulteriormente gli angoli entro cui si muove il disco i
due ospiti illustri nelle persone di James Yorkston
e Alasdair Roberts. Il risultato è un concentrato
di astuzia e sincerità, malizia compositiva e perfezione esecutiva.
Un prodotto con tutte le cose che ti aspetti e forse
privo di quel quid che ti può sorprendere. Le canzoni comunque ci sono e questo per un gruppo
come loro è la cosa fondamentale.
(7/10)
Antonello Comunale
Remember Remember - Self Titled
(Rock Action, Apr 2009)
G enere : chamber music
Rimarrete abbagliati, tramortiti. Inermi e plagiati, una volta pigiato il play del lettore cd, al
cospetto di The Dancing: l’anello mancante tra
I Zimbra dei Talking Heads e il debutto dei
Glissandro 70. una danza etno-funk radiosa
che rima con primavera. Occhio però, giacché
di contro alla meraviglia seguirà, subito dopo, il
depistaggio.
La musica dei Remember Remember, infatti, sfila come una partitura di Glass e/o Reich
rivisitata dai Mice Parade. Lasciatevi rapire
quindi, ma non ingannare, dall’episodio di cui
sopra: accomodatevi in salotto e calate le palpebre. Genie (For Amaya), How Did You End Up Like
This?, Imagining Things (i), Imagining Things (ii) e Up
In A Blue Light sono mirabili esempi di policroma
chamber music orchestrata da un unico uomo,
Graeme Ronald, diviso, tra le tante cose, fra
glockenspiel, chitarra, kalimba, e-bow e sorretto
da uno stuolo di compari delegati ai violini, fiati
e batteria. Il lato quieto dei Mogwai a braccetto
con le architetture di Sufjan Stevens e Jens Lekman.
Menzione finale serbata a Fountain e Mountain:
unica traccia, in origine, rieditata ora per l’occasione. Danza epica, prima arpeggiata poi incalzante, pari ad un alba in piena. Garantisce la
Rock Action. E pure noi!
(7/10)
Gianni Avella
Rodolfo Montuoro - Orfeo (Believe,
Feb 2009)
G enere : pop rock
Che le mitologie radicate nel contemporaneo rappresentassero un’ossessione per Rodolfo Montuoro lo sapevamo, del resto già il precedente Hannibal portava come sottotilo un Mythologies 1 che
lasciava intuire ulteriori sviluppi sulla stessa falsariga. Eccoci quindi ad Orfeo, ep distribuito digirecensioni /
111
talmente dedicato
alla ricca, complessa, ambigua figura
della semidivinità
tracia. Tema che il
Nostro affronta col
consueto aplomb
intenso e sfuggente,
procedendo
per allusioni evocative, in virtù di visioni come
squarci e depistaggi, cui il tipico fraseggio pastoso
conferisce un’aura spiazzante, da allucinazione
demodé, da altrove fieramente e un po’ bizzarramente magico.
Prosegue il processo di ispessimento della trama
sonora, oramai quasi un muro di chitarre effettate, archi, synth, theremin e loop, un affastellamento di segni che costeggia l’impeto misticista
posticcio del Battiato altezza Caffé de la Paix
nella title track, l’epica roboante e allarmata dei
Floyd periodo The Division Bells ne La Svolta,
disperdendo tracce e coordinate con la conclusiva Giorni messicani, il violino quale contraltare
romantico al clamore delle sovrastrutture, gli inserti spettrali e la spossata risolutezza del canto
(al limite del talkin’).Montuoro segue un percorso
poetico peculiare, in bilico tra mainstream e alternativo, pericolosamente e gustosamente alieno
ad entrambe le dimensioni.
(6.5/10)
Stefano Solventi
Röyksopp - Junior (Astralwerks,
Mar 2009)
G enere : E lectro D ancey P op 80
Il duo che viene dal freddo e che dopo i Gus
Gus ha fatto risorgere il mondo di paillettes un
po’ melo degli 80. Loro al terzo album tornano bambini. Ancora una volta: retrofuturismo.
Dopo aver sentito il ritorno di Miss Kittin &
The Hacker il mese scorso, anche qui si rispolverano tonnellate di progressività moroderiane e
sciccosissimi riff di plastica. Un percorso che ne112
/ recensioni
gli ultimi tempi sembra essere tornato à la page.
E allora per rinnovare (?) l’estetica now pop si usano quei trucchetti di filtering che ci hanno insegnato i Daft (Vision One), i crescendi del buon visionario Lindstrøm (This Must Be It nuovo inno
europop) o le retoriche passatiste degli Abba (You
Don’t Have A Clue). Non è di sicuro Melody A.M.,
ma Svein Berge e Torbjørn Brundtland sanno ancora parlare al popolo della classifica. Speriamo che questo processo di ringiovanimento
non li porti pericolosamente vicini all’infanzia.
(6/10)
rimpiangere quei primi Devics dove malinconia
faceva rima con layout commoventi, con un sentirsi avvolti che permeava la mente e andava dritto al cuore. Persino nei momenti in cui il compare d’avventure Dustin O’Halloran si aggiunge
alla partita (e sono ben 3 su 10), manca lo spunto,
la virgola decisiva, il candore necessario ad aumentare l’interesse in ciò che si ascolta. Quando
un passo solista sembra raccogliere le bside anoressiche del gruppo madre, c’è da preoccuparsi.
(5/10)
Alessandro Grassi
Marco Braggion
Sara Lov - Seasoned Eyes Were
Beaming (Nettwerk Music Group,
Apr 2009)
G enere : indie pop , S adcore
Malinconico e dimesso, questi gli aggettivi migliori per descrivere le atmosfere raccolte in questa
prima avventura solista di Sara Lov, famosa per
essere la vocalist degli americani Devics. Prerogativa di un certo indie pop “autoriale” è quello
di giocare con canoni di costruzione melodica
classicissimi che diventano trampolini di lancio
negli olimpi della bellezza quando la scrittura è
veramente ottima.
La cifra stilistica di questo Seasoned Eyes Were
Beaming è un sadcore emotivamente genuflesso
che perde inesorabilmente la sfida di abbracciare
l’ascoltatore e trascinarlo dentro ai suoi paesaggi
desolati principalmente per il fatto che il canovaccio utilizzato nella forma canzone è supportato
da un livello solo mediocre di scrittura che ahimè
mostra il lato proprio nello scorrere monocorde e
senza passione del disco.
Ci mancherebbe, la voce della cantante è sempre meravigliosa ma la sensazione è la stessa di
osservare un oggetto bello ma senza alcun scopo:
si pensa a quanto sia esteticamente carino ma altrettanto soprassedibile e inutile. E quando manca la brillantezza e ti rendi conto di quanto queste dieci canzoni scorrano senza colpire, viene da
Schiele - Pictures Of Mountains
(Autoprodotto, Dic 2008)
G enere : noise - post grunge
Ne parliamo con evidente ritardo. Colpa – in
parte – della miriade di uscite discografiche propagandata da etichette di ogni genere che di mese
in mese affolla la nostra casella postale e che ci
costringe a relegare in secondo piano autoproduzioni come questa. Anche se il livello qualitativo
del secondo disco degli Schiele non è certamente
quello di una demo improvvisata ma di un’opera
compiuta e già matura, come testimonia il nome
di Giulio Favero del Teatro degli Orrori dietro
al mixer. Nel caso
della band vicentina, infatti, ci sono
tutti i presupposti
per “fare bene”, a
cominciare da una
formula musicale
vibrante fatta di
nevrotiche cavalcate elettriche rubate
ai Jesus Lizard (We Don’t Want To Be Your Fiends)
e post-rock dall’ardito fragore noise (Spider VS Spider), bassi compatti e riverberi claustrofobici. In
un disco che attrae per un’asprezza dei suoni fuori dai canoni mediata da una scrittura capace di
aggredire gli spazi senza sbavature. Poco glamour
e molta sostanza, insomma, qualche vocalizzo in
odore di Chris Cornell (My Death) e la voglia di
farsi guidare dal “manico” senza stare a guardare
alle simmetrie o alle convergenze stilistiche. Un
aspetto, quest’ultimo, che garantisce a Pictures
Of Mountains un quasi sette lasciando tuttavia
presagire un processo evolutivo ancora da ultimare.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Seaworthy - 1897 (12k, Apr 2009)
G enere : C hitarra minimale / A mbient
Composto a partire da materiale registrato a
Newport, Australia, negli spazi interni e nei luoghi
circostanti un vecchio deposito di munizioni solo
recentemente dismesso, 1897 è il secondo album
di Seaworthy, terzetto ruotante attorno al genio
multiforme di Cameron Webb, a uscire per la
12k di Taylor Deupree. Un lungo e meticoloso
lavoro di post-produzione - il cui ritmo, peraltro,
è stato rallentato dalla recente paternità di Webb
- è servito al trio per manipolare l’ingente quantitativo di registrazioni realizzate in tre mesi di sedute finanziate da una borsa di studio del Sydney
Olympic Park Authority’s Arts Program - per il
quale Webb è stato Artist in Residence.
Loop di chitarra acustica di lontana ascendenza
folk, field recordings e delicati intermezzi drone:
le tinte, qui, sono ancora quelle acquerellate e tenui che, già ai tempi di Map in Hand (12k, 2006)
avevano fatto tornare la memoria agli Hood pastorali di Outside Closer. Senonché, in 1897,
quelle tinte sono utilizzate per la realizzazione di
un quadro astratto, anti-figurativo, recalcitrante
ai richiami della forma.
Quello di Seaworthy è un suono minimale, sparuto, che non sembra seguire nessuna traiettoria,
se non quella indicata a tentoni dalla chitarra
di Webb (la lunga Ammunition 3, quasi epicentro
dell’intero album): pur cristallizzandosi talvolta in
grumi armonici o melodici, è un flusso a-direzionale, si direbbe quasi improvvisato, a condurlo.
La meta è, il più delle volte, un senso di quiete che
recensioni /
113
pare essere il corrispettivo in musica di quei luoghi ritratti dalle splendide fotografie (a opera dello
stesso Webb) che corredano, in pieno stile 12k, la
ricca limited edition disponibile in sole cinquanta
copie.
(6.8/10)
Vincenzo Santarcangelo
Shinkei - Biostatics (Transparent
Radiation, Gen 2009)
G enere : sintesi minimali
Biostatics è il nuovo lavoro dell’artista minimalista David Sani (Shinkei) per la Transparent
Radiation. Se nella collaborazione con Philip Lemieux Binaural Beats (Koyuki 2007), il collettivo stabiliva un
certo interesse
per fonti sonore
provenienti
da registrazioni
bio-elettriche in quel caso i file
sonori nascevano come studio
delle onde cerebrali - costituiti, o meglio sarebbe dire catturati,
grazie all’utilizzo di un brainwave software; con
Biostatics, si sposta l’attenzione verso i segnali
emessi dal mondo vegetale (foglie, piante, fiori),
resi udibili attraverso processi audification.
Un delicato e impercettibile risveglio di fondo,
concesso alle sommesse e fluttuanti puntualità, ai
tepori e agli sfrigolii di particelle: la sottile proporzione delle cinque tracce e l’arte della scrittura garantiscono trasparente bellezza a elementi
limitrofi al silenzio. Sicure ma mai imposte le stesure del silenzio, naturali estensioni a cui l’artista
detta le condizioni in minimali contesti ai limiti
dell’udibile.
Oltre il puro significato scentifico, attraverso le
vibrazioni della materia.
(6.8/10)
Sara Bracco
114
/ recensioni
Shinkei/Luigi Turra - Yu (Non Visual
Objects, Feb 2009)
G enere : F ield recordings
Interessante capire a questo punto della traiettoria artistica di Luigi Turra e Shinkei, quello che
succede intorno a un percorso certo fatto d’affinità stilistica e d’intesa - il linguaggio minimale,
le fonti sonore al limite dell’udibile, l’attenzione
ai silenzi e agli spazi - ma pure costantemente in
bilico tra ricerca sonora e naturale devozione al
suono e, proprio perciò, libero di accadere e mutare.
Ciò che avviene nella recente collaborazione dei
due artisti per la label NVO: Yu, termine zen che
significa quiete, affianca alla tecnica in field recordings, strumenti acusici, per una fonetica che
prende ancora una volta spunto dalla cultura
giapponese, intrappolandone i dettagli in primi
piani, assenze, rumori di fondo, di spazio o di paesaggio.
Scorci di vita, quelli ambientali rasenti l’armonia
(Wa), tra sfumature e mutate forme di un giardino zen (Karesansu), condotti al silenzio, ad uso di
cerimonie (Roji), meditazione (Kin-hin), distribuiti
nello spazio tra frammenti di un blues anni ‘30 o
istanti di quotidianità (Nagoya Koen).
Arte del dettaglio e scelte incolore che sembrano andare oltre la naturale tonalità del reale, distruggere la figurazione per abbracciare in pieno
l’astratto.
(7/10)
Sara Bracco
Squartet - Uwaga! (Jazzcore Inc.,
Mar 2009)
G enere : jazzcore
È tempo di rinascite jazz-core dalle parti di Roma.
Prima il nuovo lavoro dei tre Zu in (quasi) perfetta solitudine; roba che non si ascoltava – se non
andiamo errati – dall’epoca di Igneo. A quanto pare, a breve sarà la volta di altri loschi figuri
imparentati o semplicemente spiriti affini ai qui
presenti, come Neo e Testa De Porcu (sempre
Storsveit Nix Noltes - Royal FamilyDivorce (Fat Cat Records, Apr 2009)
G enere : balkan - folk
su Jazzcore Inc.). Ora invece è la volta di Squartet, power-trio + 1 formato da Fabiano Marcucci
(basso), Marco Di Gasbarro (batteria) e Manlio
Maresca (chitarra) con l’aggiunta del sound man
Francesco Fazzi, fomentare visioni schizzate in
forma di canzone.Disco corposissimo, questo
Uwaga! Muscolare e atletico, ma non come quei
coatti della periferia romana soliti lustrare pettorali in estenuanti sedute di palestra. Il suono che
esce dagli 11 pezzi dell’album pubblicato per Jazzcore Inc. è tanto possente quanto fitto di ricami
e intarsi di matrice
rock, quanto jazz,
prog e fusion, ottimamente rodato
da ben tre anni di
lavoro in studio e
on stage.
Proprio nella coabitazione di furente rock di matrice
math e/o punk (core, come da suffisso) e virtuosistica ricerca libera e fruttuosa (jazz, come nel prefisso) risiede la forza di quest’album. Che a dirla
tutta un tempo si sarebbe detto hardcore evoluto
e che invece oggi, metabolizzate influenze e rimandi non si può che dire necessariamente e pienamente rock, pur nelle sue geometrie e percorsi
intricati e funambolici.
Dentro si ritrovano infatti in un ordine casuale
schegge di Sharrock e NoMeansNo, claudicante
andamento alla Primus e Iceburn Collective,
vertiginose scale ascendenti e drumming furibondo, partiture degne dei primi Don Caballero
e attacchi (quasi)metal, prog-noise come degli
adolescenti King Crimson de noantri e funkettoni agili e ritmatissimi che sconfinano in fusion
ebete. We are not fool! We are old school! chiosano nel
loro myspace. E noi siamo completamente d’accordo.
(7/10)
Islanda. No, per un attimo concentratevi su una
sarabanda, su uno di quegli sketch a rotta di collo
che fecero la fortuna di una pellicola come Gatto
Nero, Gatto Bianco di Emir Kusturica. Nonostante Storsveit Nix Noltes sia una formazione nord
europea con ben 11 elementi in campo – Storsveit sta per big band nell’idioma locale – il loro
bacino d’influenza è da ascriversi in toto al folk
balcanico. Suonato ovviamente con piglio poco
tradizionalista, tant’è che scampoli d’improvvisazione, alchimie neo-classiche e squarci poco
meno che rumorosi fanno di Royal Family-Divorce un disco infine originale. Non propriamente
dalle parti dei due meravigliosi album dei Kletka
Red, anche se a livello epidermico tracce di quello
stentoreo esperimento possono ritrovarsi in Krivo
Sadovsko Horo o Kopanitsa. L’accademia non ha
fatto male ai nostri, musicisti che nonostante il
pedigree di razza riescono a muoversi con piglio
decisamente aggressivo nei meandri della musica
popolare, che -come dicevamo in apertura – non
è il folk del proprio paese. Alla festa partecipano
membri assortiti di Mum, Benni Hemm Hemm,
Lost In Hildurness, Numer Null, Rùnk, Kanada, Hestbak e Kria Brekkan. Dopo l’esordio del
2005 con Orkideur Havai – accolto da uno stuolo
di fans niente male tra cui vale la pena citare Animal Collective, Emiliana Torrini e Mice Parade
– per 12 Tonar è la volta del secondo cimento su
lunga distanza, che viene realizzato localmente in
piena autonomia sul finire del 2007, per poi essere licenziato a livello globale da Fat Cat nel 2009.
Un disco da balera alternativa, scoppiettante, ma
anche struggente, come molte delle storie che
quotidianamente giungono dall’Europa orientale. Un album che trasuda umanità, sfrenato e
dissacrante nel suo essere.
(7/10)
Stefano Pifferi
Luca Collepiccolo
recensioni /
115
Super Furry Animals - Dark Days /
Light Years (Rough Trade, Apr 2009)
G enere : psych pop
A quel paese la maturità. I Super Furry Animals
non ci tengono proprio a diventare grandi, a cullarsi nello status di band pop semiclassica (per
quanto ancora obliqua, ci mancherebbe) fieramente conquistato sul campo con le prove recenti.
Tutto sommato, dopo tre lustri di carriera, sarebbe stato anche piuttosto naturale accontentarsi di
una sorta di equilibrio, pur mantenendo quell’inconfondibile attitudine
curiosa, storta e
onnivora che ha
fatto dei gallesi
uno tra i segreti
meglio custoditi di
Albione. E invece
no. Tanto il precedente Hey, Venus! era – infine conciso, ordinato e coerente, quanto questo Dark
Days / Light Years ritorna anarchico, debordante
e allegramente fracassone. Galeotte le liberatorie
escursioni di vari membri in progetti alternativi (Gruff Rhys nei Neon Neon, Dafydd Ieuan e
Guto Pryce nei Peth, Cian Ciaran negli Acid Casualties), si è ritornati all’approccio mangiatutto
e ipercazzone di una decina d’anni fa, i tempi di
Guerrilla, Mwng e Ice Hockey Hair.
Un colpo di mano fortemente voluto (banditi
dallo studio lap steel e sassofoni, nonché le ballatone), che inevitabilmente si porta dietro tutti i
pro e i contro del caso. Di certo, la band sentiva
disperatamente il bisogno di togliersi le briglie, di
sconfinare dal recinto della canzone; una mossa
per quanto gratificante (vedi i fantastici viaggi cosmici di Cardiff In The Sun - ovvero i Primal Scream
più krauti che ci siano - e della conclusiva Pric),
comunque rischiosa (l’iniziale macigno trash-freak di Crazy Naked Girl, divertente ma non poi così
tanto). D’altro canto, cose come Mt., White Socks
/ Flip Flop e Inconvenience (trascurabili quando
116
/ recensioni
non irritanti), Moped Eyes e The Very Best Of Neil
Diamond (usuali e stuzzicanti ibridi electrofunkpsychpoptrance, forse con un po’ di pepe in meno
del solito) denotano la ricerca di quella vena amabilmente bastarda, ironica e contaminata dei loro
lavori ante-2000. Fortunatamente, il risultato viene salvato da quattro superclassici SFA del calibro di Inaugural Trams (un singolone poppissimo,
ma così crucco e autobahn-ico da figurare un esilarante rap tedesco di Nick McCarthy dei Franz
Ferdinand), Helium Hearts (meraviglioso pastiche
ELO-soul ’70, l’erede di Juxtaposed With You) e le
speculari Where Do You Wanna Go? / Lliwiau Llachar (stessa base ritmica per un sixties pop appiccicosissimo, che pare tirato fuori da Radiator).
Insomma, pur nella loro ritrovata incontinenza,
sembra comunque impossibile non continuare a
voler bene agli animalozzi (soprattutto in patria,
complice una critica che deve perdonarsi il fatto che una band così sia destinata a un perenne
stato di culto). E’ ok cascare in piedi, però, uhm,
attenzione a non sottovalutare certi scivoloni.
(6.7/10)
Antonio Puglia
Sweet Billy Pilgrim - Twice Born
Men (Samadhi Sound, Apr 2009)
G enere : avant - pop
C’è la benedizione dell’ex Japan Steve Jansen
per il debutto su Samadhisound dei londinesi
Sweet Billy Pilgrim, che al meglio rappresentano
l’avanguardia pop inglese del momento, con solidi link ai Talk Talk della svolta storica di Spirit
Of Eden. Un sound che più che muovere dalle
barocche derive di certa new wave, sembra portare in dote la passionalità di certo romantico rock
come del tardo e meno esasperato progressive.
In questo Twice Born Men è disco inequivocabilmente britannico, vuoi per l’immaginario di
riferimento, vuoi per i contenuti espressamente
musicali. Non sempre l’elettricità recita un ruolo
preponderante, spesso sono infatti gli strumenti
acustici a rendere ancora più spessa la coltre ove
i tre si muovono, come vecchi fantasmi da palcoscenico.
C’è il clarinetto basso di Alphonse Elsenburg –
già collaboratore dello stesso David Sylvian, al
quale Sweet Pilgrim debbono proprio l’ingaggio
– ad aumentare la profondità di brani come Truth
Only Smiles, cartoline da Canterbury col Wyatt solista in somma ammirazione, e There Will It End,
dove unitamente
ai suoni processati
e ad un piano in
distanza si consuma un pastorale
numero di sinfonico pop.
Altrove sembrano
più minimali le scelte del trio – guidato dalla magnetica voce di Tim Elsenburg – quando incrociano la folktronica in punta di piedi di Longshore
Drift, solo screziata dal drammatico volteggiare
degli archi.
Questo è il loro secondo album e suona come il
lavoro di una band di veterani, ancora cosciente
delle potenzialità della forma canzone, eppure affascinata da tanti innovativi scenari d’alto borgo.
Se è lecito parlare di pop aristocratico...
(6.9/10)
Luca Collepiccolo
Syntheme - Lasers ‘N’ Shit (Planet
Mu Records, Feb 2009)
G enere : wonky acid breakz
Già dal titolo lo capisci che quei laser mentali
la fanno da padrone. Dopo Volume 1 (sempre
sull’etichetta di Paradinas) e Lov3, torna Louise Wood da Brighton (qualcuno dice sia Global Goon...). La ricetta si accoda all’esplosione
della supernova breakbeat con l’esperimento di
Zomby. Solo che qui, dato che siamo su Planet
Mu, non si viaggia sulle spiagge del dubstep: qua
ci si va direttamente di acido. E se state aspettando il nuovo disco di Aphex, accomodatevi.
Un bel giro in pista a base di perversione synth (i
laseroni e i colpi maranza di Csiris), i ricordi della
primissima Warp a base di 303 (una Scotch Paper
da nostalgia), le visioni acidissime della scuola
Jack detroitiana in salsa Autechre (Qarth, Frf3k
Up!, Heat), qualche accenno al sound gaming a 8
bit IDM (144a Acacia Overdrive e la tripletta nerdy Easy Medium Hard) e il catalogo è completo.
Niente di nuovo? Alle volte non serve. Il passato
trasforma il presente. E se lo scavo non può prescindere dalla motor city, chissenefrega. Quello
che conta è come viene riletta la tradizione. Lasciamoci trafiggere dai laser.
(7/10)
Marco Braggion
Takeo Toyama - Etudes (Karaoke
Kalk, Apr 2009)
G enere : avanguardie ( elettro ) acustiche
A segnare un altro punto a favore per la label Karaoke Kalk, a poco più di un mese dalla notevole
uscita firmata Dakota Suite, ci pensano le undici tracce del giapponese Takeo Toyama.
Etudes, terzo album del giovane compositore di
Osaka, oltrepassa i limiti del pianoforte preparato, tra nuova musica, avanguardie jazz, svisate
classiche e una massiccia carica melodica di fondo.
Alle registrazioni sul campo (Tremolo), agli strumenti preparati (Tuner) - pianoforte, tastiere, archi
e percussioni - è lasciata totale libertà di agire con
o senza concessione d’improvvisazione: in progressioni (Gauche), disarmonie, rime o ridondanze
(Leo). Raggiunta metà album (Drawing), si rivelano
le stesure più ludiche, complici le filastrocche di
una diamonica e un violoncello (Bobbin), fantasie
e lustrini ritmiche (Troll), le inattese derive sintetiche (Odd) o le punteggiatura di tasti e archetto
(Drops).
C’è estro e metodo nelle fiabe sonore di Takeo
Toyama, a cui non manca retroterra culturale (da
Bartòk, Reich o Glass) e un senso di freschezza
tipico del Sol Levante.
In fondo anche se si parla di combinazioni sonorecensioni /
117
re, c’è comunque da fare i conti con la fantasia,
l’interpretazione, le formule narrative, i luoghi
indefiniti, la magia o l’allegoria.
(7.2/10)
Sara Bracco
Tellaro - Jars, Jams & You (2nd Rec,
Dic 2008)
G enere : indietronica
Non si chiamano né Radiohead né Yuppie Flu,
ma la formula che adottano i siciliani Tellaro per
presentare la loro terza fatica è la stessa già sperimentata dalle due formazioni citate: vendere il
disco on-line in formato mp3 lasciando che siano
gli utenti a stabilire il prezzo da pagare. Per farlo,
è sufficiente andare sul sito dell’etichetta che ne
cura la pubblicazione – la 2nd Records, all’indirizzo
www.2ndrec.com/
blog – decidere
quanto spendere
e scaricarsi Jars,
Jams & You, per
ritrovarsi sul lettore un buon disco di indietronica nostrana. Materiale, per intenderci, in linea con certe produzioni dei Tunng ma al tempo stesso capace di
de-localizzarsi rispetto alla miriade di uscite sul
genere grazie a una quadratura di fondo e a qualche brillante intuizione.
Come, ad esempio, i campionamenti vocali di
The Divorce, le voci fuori campo dagli accenti “regionali” di Maria, i controtempo di Zaurdetto, le
evanescenze della conclusiva Things Are Tired Of
Being Desired. Fragili stratificazioni di superficie e
suoni elettro-acustici capaci di donare dignità a
un disco che, ne siamo certi, avrebbe raccolto apprezzamenti maggiori fosse uscito soltanto due o
tre anni fa quando certe sonorità erano la regola.
(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
118
/ recensioni
The Sweet Vandals - Lovelite (Differ-Ant, Mar 2009)
G enere : soul
Thelema - La Sangre Real (Black
Light District, Mar 2009)
G enere : dark - folk - rock
Quando dici che la musica è un autentico esperanto: gli Sweet Vandals provengono da Madrid
e sono di etnia mista. La qual cosa non influenza
minimamente la musica che fanno, fedele alla
linea di quella riscoperta del “vintage soul” in
corso da grossomodo un triennio. In Lovelite,
loro secondo lp, maneggiano la materia black
con disinvoltura e adeguata padronanza tecnica
dei fondamentali, impastano con vigoria da live
band (ambito dove daranno senz’altro il meglio)
robustezza errebì e groove funky.
Intinta nel gospel l’ugola di Mayka Edjole - fate
conto una Bettye LaVette senza pathos da vita
vissuta… - ed esperti gli accompagnatori, su tutti Santiago Vallejo allo sfrigolante, incontenibile
organo Hammond. Si guarda indietro sin dalla
registrazione, che coerentemente odora di antico
cercando di ripetere la concisione della Stax attraverso il calore degli strumenti anni ’60.
Non fanno insomma del male a nessuno gli Sweet Vandals, misoneisti che tra revival e attualizzazione sanno bene dove schierarsi e sin qui
nulla di male. Avessero, oltre a solido mestiere
e scolastico zelo, anche l’abilità di scrivere brani
capaci di fissarsi nella mente in modo duraturo,
per loro fioccherebbero le lodi.
Così non è se non sporadicamente, tuttavia, con
apici affatto disprezzabili nel gioco di pieni e
vuoti Thank You For You e nella divertita Funky
Children, in una Let’s Have Some Fun dalle parti di Mustang Sally e, soprattutto, nella vibrante
What About Love. Gradevole ancorché poco incisivo il resto e Vandali assolti con una pacca sulla
spalla, finché di questo ennesimo recupero non
ne avremo tutti le tasche piene.
A meno che per qualcuno già non sia così.
(6.5/10)
La Sangre Real – terzo comeback della band
modenese – segna l’esordio di Black Light District, ennesima etichetta folk-dark oriented a
nascere dalle parti del tacco dello stivale, quasi
che l’influenza delle leggende legate a Castel del
Monte allungasse la propria ombra sul pentagramma.
Questo di Thelema è un ottimo disco dal mood
dark-rock, come si conviene al genere, ma riesce a
schivare le soluzioni di genere più scontate per allargare confini e vedute anche verso una tipologia
di rock più (ehm)
solare. Si prenda
ad esempio Yet To
Come: ballata darkfolk quanto si vuole, ma l’emergere
nella parte finale
di armonie vocali
in pieno stile primo Wyatt, in un crescendo umorale ed emotivo
di altissimo spessore.
Il cuore della questione, però, batte ovviamente
per le lande più oscure e apparentemente demodé
del rock gotico e tinto di nero: Inquisition, mesmerica ballad folk apocalittica pronta a disintegrarsi
in sfuriate elettriche limitrofe a certo indie-wave
movimentato e urlato. O ancora l’ossianica e
conclusiva title-track, ossessivamente corale; o In
Arcadia, impreziosita dalla viola dell’ospite Pino
Dieni (anche alla tromba in un paio di episodi)
che disegna paesaggi pastorali limitrofi a certo
dark-folk inglese.
Esempi che la dicono lunga sull’ampio orizzonte musicale del quartetto e sulla sua capacità di
gestire la materia sonora con cura, attenzione e
passione. Non meno importante è il fondamento
teorico alle spalle di La Sangre Real, sorta di
concept sulla figura del cristo storico, elaborato
dal nucleo fondatore Massimo Mantovani (voce)
Giancarlo Turra
e Giorgio Parmigiani (basso, tastiere) con le new
entry Gianluca Artioli (chitarre acustiche e elettriche) e Alex Facciolo (batteria).
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Tosca - No Hassle (!K7, Apr 2009)
G enere : L oungetronica D owntempo
Ogni tanto il downtiming ritorna. Anche se l’apice di quel movimento che ha sbancato le nostre
menti alla fine dei 90 non è più molto in auge
- se non per l’insonorizzazione di qualche locale
a tema o per rinfrancare qualche nostalgico - c’è
ancora qualcuno che ci crede. E la parabola creativa di Richard Dorfmeister ci narra con
il suo progetto Tosca (assieme al fido Rupert
Huber) la storia di questa estetica.
Lui assieme al compagno Kruder è stato il promotore (complice l’impeccabile produzione !K7) di una
minirivoluzione che inesorabilmente ha riportato i danceclub di mezzo mondo sull’onda lounge.
Questo nuovo album non è deputato a dire
niente di nuovo, dato che difficilmente ci si può
discostare dai cliché del genere. Lo stile c’è sempre e comunque: tra elettronica e soul (My First),
ballad jazzy (Elitsa, Birthday), accenni alla deep
house (Springer, Oysters In May) e al latin funky
(Fondue) si riesce ad intrattenere l’orecchio per
un’ora. Senza strafare e nemmeno stupire Tosca
porta avanti il testimone di un’epoca passata,
che sporadicamente ci può ancora far rilassare.
Piacevole ‘e mai niente di più’.
(6/10)
Marco Braggion
Uochi Toki - Libro Audio (La Tempesta Records, Feb 2009)
G enere : rap esistenziale
Era inevitabile che Uochi Toki arrivassero alla
propria Spoon River. Così come era inevitabile
che i centri concentrici delle loro (ehm) narrazioni/investigazioni si allargassero fino ad includere,
oltre che l’attualità come al solito causticamente
recensioni /
119
indagata, anche passato e futuro.
Libro Audio, serie di racconti e/o aneddoti più
o meno verosimili incastrati come al solito su basi
crude, è strutturato in due parti: dal vero/reale/
credibile dei primi 6 pezzi all’immaginario/impossibile/incredibile dei secondi 6.
In mezzo, a fungere da spartiacque L’osservatore:
10 minuti di sludge-core organico e slabbrato
sputato fuori dalle macchine di Rico, sotto l’occhio clinico ed inquisitorio dell’osservatore Napo,
grillo (s)parlante di una generazione di vuoti cosmici.
Sono però tutte le composizioni ad essere pervase da una sorta di filosofia della genealogia in
divenire; cercare un (non)autoritratto in forma
di corrosiva cantilena che mette a nudo il re del
quotidiano di ognuno di noi. Libro Audio tenta
la mappatura dell’esistente attraverso gli occhi (a
voler essere ottimisti) disillusi, di uno come tanti, ma nello stesso
tempo scarta lateralmente l’obbiettivo dei precedenti lavori: nulla
è più riconoscibile
e evidente come
nelle passate ridicolizzazioni della
presunta “scena
alternativa”, bensì diventa classico, nel senso più
letterario del termine. Capace cioè di sopravvivere al proprio tempo e rendendosi immortale al
passare delle situazioni.
Uochi Toki è come al solito un Joyce senza pretese letterarie e cresciuto nella provincia denuclearizzata del post-moderno che si accompagna ad
un misto nudo e crudo di beats rovinosi e rovinati, metà Einsturzende Neubauten, metà The
Bug. E come al solito è un successo.
(7/10)
Stefano Pifferi
120
/ recensioni
Various Production/Gerry Mitchell
- The Invisible Lodger (Fire Records,
Mar 2009)
G enere : spoken word electronica
Gerry Mitchell – artista e poeta da Glasgow – non
è nuovo al muoversi in appoggio ad altre entità.
Lo avevamo ascoltato salmodiare le
sue litanie poetiche sull’art-rock
da camera di Little Sparta in un
disco di un paio
di anni fa; ora lo
ritroviamo in joint
venture con Various Production, coppia di semianonimi musicisti inglesi che definire prolifici è eufemistico (almeno una dozzina di singoli ed ep al loro attivo).
Se al tempo di The Ragged Garden, lyrics &
vocals di Mitchell si adagiavano sulle progressioni cameristiche del “gruppo spalla”, ora applicate
sulla sorta di colonna sonora immaginaria e horror aggregata da Various Production acquistano
ancor più spessore evocativo.
The Invisibile Lodger è composto da 17
sketches più o meno brevi strumentalmente a
metà tra le ambientazioni grigio-weird-industriali
dell’Eraserhead lynchiano e i momenti più cupi
e meno orchestrali della filmografia di Jarman.
Le divagazioni e gli sconfinamenti verso folkerie
albioniche varie (cornamuse, violini e quant’altro,
tutto rigorosamente processato) con addirittura
soluzioni latamente grime segnano il gusto per una
elettronica raffinata e bastarda, non a caso definita (con molta fantasia) folk-dubstep.
L’apporto di Mitchell è invece immolato ad una
sorta di “scream of consciousness”, per usare le
parole della casa madre, in cui i timbri e le atmosfere gloomy ricordano i momenti più ispirati di
Coil et similia, ben sposandosi con l’immaginario
evocato dal duo elettronico.
Collaborazione decisamente riuscita per un al-
bum indubbiamente notturno da catalogare sotto
il termine spoken-word electronica.
(7/10)
Stefano Pifferi
Veils (The) - Sun Gangs (Rough
Trade, Apr 2009)
G enere : P op
The Runaway Found (2004) rimane la migliore delle tre uscite maggiori a nome The Veils. Il
neozelandese di stanza a Londra Finn Andrews
(voce, chitarra, piano), figlio di quel Barry Andrews già negli XTC e negli Shriekback, non si
regge in piedi stavolta. Non si reggono in piedi le
sue canzoni. Il sound è ancora quello dell’opera prima datata 2004, con vaghi passi à la Coldplay. Ma tranne rarissime eccezioni (vedi alla
voce The Letter), questo tripudio indie-gaze di
svavillanti e profonde armonie, tristi-amare, non
trova nessun nerbo scrittorio ‘importante’ a sorreggerne l’enfasi. Il peggio lo fa forse Sit Down The
Fire in apertura, ballata busona e dalla grandeur
troppo troppo pronunciata. Segue Sun Gangs ed
è anche peggio: uno strazio di pezzo pianistico e
confidenziale ad alto tasso di noia incorporata.
In generale, quando il quartetto accelera i tempi,
e si smuove dalle paludi del brit-rock più vetusto,
riesce ancora a lasciare il segno (i Big Country in versione gaze di Three Sisters). Ma è troppo
poco per rivalutare un album, nel complesso, assai carente e debole.
(5.5/10)
Massimo Padalino
Wau Y Los Arrrghs - ¡¡¡Viven!!! (Munster, Apr 2009)
G enere : garage - beat
Non si chiede innovazione per certi tipi di musica. Non si chiede la luna quando si tratta di macinare garage, beat, rock a forti tinte fuzz…Si chiede energia, velocità, sudore. E si chiede passione.
Punto e basta.
In occasione del comeback dopo l’ottimo Cantan
En Español su
Voodoo Rhythm,
il quintetto di Valencia ci mette
pure sarcasmo e
(auto)ironia. Ergo,
cosa chiedere di
più? Cantato quasi interamente in
castellano, l’album su Munster – vera e propria
autorità in ambito garage, beat e psychobilly, con
in catalogo l’universo mondo – inanella gemme
da un paio di minuti o poco più equamente divise
tra pezzi originali e cover; da urlo tra le seconde
l’opener Delincuente, in origine degli Hatfields,
così come No Mientas Màs di Pereira & Hirschfeld, tarantinata al punto giusto. Tra gli originali,
Bli, Blu, Bla (bla bla bla) merita il podio in virtù di
un testo tra i più divertenti ascoltati ultimamente, così come la conclusiva dichiarazione d’amore
Viva Link Wray!!!.
In ¡¡¡Viven!!!, insomma, troverete divertimento
e 60s garage, Nuggets e farfisa a manetta, melodie poppissime e completi mod iper-stilosi, brillantina per capelli e punk sarcastico da sparare al
massimo del volume. Come, dopotutto, recita lo
sticker in copertina. Possibile esimersi?
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Whitest Boy Alive (The) - Rules (Bubbles Records, Mar 2009)
G enere : M inimal E lectrosoulful P op
Dopo Circlesquare, ritorna uno dei campioncini della minimal electro pop. Lui si chiama
Erlend Øye, e di secondo nome fa Kings Of
Convenience. Questo suo secondo album col
progetto parallelo TWBA (dopo l’esordio Dreams del 2006) sembra essere diventato più di un
passatempo. Come il canadese di cui sopra, anche qui la realness gravita attorno a Berlino, la
grande incubatrice microhouse, minimal e glitch.
Il ragazzo occhialuto non segue tanto le direzioni
recensioni /
121
di Basic Channel o di nerd da camera techno. Lui
con quella spocchia da Loser con la L maiuscola
ci va di soul. E quindi ecco il ritorno dei suoni
che avevamo imparato a conoscee con Kruder
& Dorfmeister. Stavolta tutto quasi senza elettronica, il trionfo dell’analogica
calda, senza vocoder, senza orpelli che ammiccano all’effetto
acido, senz’anima.
Questa
tendenza al calore la senti anche nei pochissimi crescendi vagamente DFA (Courage), nelle pennellate che
rievocano il tropicalismo dei 70 brasiliani (Intensions) o il p-funk di scuola New York (Timebomb).
Insomma l’elettronica di domani è ancora una
volta sulla via del retrofuturismo. E quasi quasi
anche noi ci innamoriamo di queste perle che di
electro ormai hanno pochissimo, ma che comunque crescono ascolto dopo ascolto, orgogliose
della loro purezza pop. Un po’ di rhodes, un po’
di lounge (ritorna per qualche istante lo spettro
di Tellier) e per chiudere il melo pastello dei paesi nordici. Erlend: conosce e detta le regole del
gioco.
(7.1/10)
Marco Braggion
Who Made Who - The Plot (Gomma,
Mar 2009)
G enere : minimal post - p - funk
La compilation tripla del 2004 della DFA (#2)
ha segnato più di qualche mente ritmica. Murphy non lo si vede molto in giro in questi ultimi
anni, ma il quasi ragazzo è personaggio scaltro.
Viaggia nell’ombra. E la sua eredità la senti anche in questo nuovo disco partorito dalla berlinese Gomma. Who Made Who che rifanno il sound
newyorchese in levare con la cadenza krauta.
122
/ recensioni
Cose robotiche mescolate alle vibrazioni più rock
di Franz Ferdinand e affini (This Train e The
Plot con quell’incedere da gangsters), l’inevitabile
minimalismo condito da qualche effettino tribale à la Talking Heads (Small Town City, Motown
Bizarre), o da qualche coro pieno di falsetti che
riportano l’analogico già richiamato da Circlesquare qualche mese fa (Keep In My Plane).
Ma se vai un po’ più indietro senti come la componente wave sia predominante. Wall Of Voodoo,
Fripp e altri nomi cardine 80. Che purtroppo
sono citati involontariamente. Un peccato, dato
che l’album migliora le sorti del precedente, sia
per un impegno maggiore negli arrangiamenti,
sia per scelte più oculate nei chorus, lontani dunque dai falsetti à la Sommerville e di converso più
intarsiati nel legno (vedi lo stile di un certo Gahan).
Oculati sono pure gli inserimenti Kraftwerk
versante ultima prova, quel Tour De France che non
brillava d’inventiva ma raffinava certa robo-tech
all’ennesima potenza. Questa materia
è la sostanza di un
buon disco mancato che per tanti versi
sceglie mezze misure:
due o tre canzoni sulla scia dei proverbiali
Franz, altrettante soluzioni p-funk ancora in derivata, tocchi Depeche che spingono paragoni pericolosi, etc.
Sono le ultime due canzoni (Raveo e Working After
Midnight) a rappresentare il clou del disco. Una
coda del genere ci fa capire che se gli Who Made
Who insistono, magari scrivono un bel pezzo.
Magari lo arrangiano pure con consapevolezza
dei loro riferimenti. Dal vivo sono già una certezza, d’accordo, ma quando si decideranno ad
applicare la pratica allo studio di registrazione ci
faranno ballare la testa.
(6.5/10)
Marco Braggion, Edoardo Bridda
Wooden Birds (The) - Magnolia
(Morr Music, Apr 2009)
G enere : I ndie slow pop
Vi dice niente il nome American Analog Set,
band texana che in nove anni di carriera – dal ’96
al 2005 – ha conquistato il cuore di molti con sei
album in equilibrio perfetto tra post rock e indie
pop? Ecco, Andrew Kenny, colui che si celava
dietro quella sigla, torna con una nuova creatura:
i Wooden Birds.
Cambia il nome ma non il contenuto. Quest’ultimo si connette direttamente a Set Free, l’ultimo
lavoro degli American Analog Set, l’unico griffato
Morr Music. Non una novità, non un miglioramento: la sensazione è quella di trovarsi dinnanzi
sempre alla stessa canzone. Si gira intorno a fragili e repetitive melodie circolari tra intimistiche
palpitazioni folk e morbidezze pop, sulle quali la
voce del Nostro plana a bassa quota. Come se i
Mojave 3 incontrassero Elliott Smith e decidessero di fare canzoni in formato tascabile basate sulla circolarità della medesima melodia, senza
picchi emotivi o deflagrazioni sonore.
Non un demerito, anzi: proprio la sommessa ripetitività è sempre stata la peculiarità di Andrew
Kenny. Ma ci aspettavamo qualcosa in più, anche solo un piccolo cambio di rotta che invece
non è stato effettuato, se non nel nome.
(5.8/10)
genza questi ascendenti, che pervadono ma non
prevaricano il sound. In altre parole, tengono le
redini della bestia conducendola con mansueta
veemenza - se mi consentite - lungo nove tracce
piuttosto ispirate.
Meglio le prime, oserei dire, ché nel finale di scaletta si azzardano cincischi psych non troppo a
fuoco (la spersa Greta, l’estatica Then
She Came) oppure
più fragore che
altro (Now What It
Seems), laddove Selfish Man se la cava
mesclando ballad
uggiosa e turgore
come talvolta abbiamo sentito fare a Mr. Lou
Barlow. Di contro ci sono episodi come Spiders,
febbricitante anello di congiunzione tra i migliori
Foo Fighters e i Fugazi, una Her Flattery che
spedisce Husker Du nell’alcova Mark Kozelek, oppure gli sfrigolanti spigoli di Tubchair, più
o meno una mischia Polvo-Dinosaurs Jr e ho
detto tutto.
Tolto un retrogusto nostalgico di cui non s’avverte il bisogno - troppo freschi e definitivi i nineties
per meritarsi rimpianto - questo Frames è disco
energico, fresco, teso e intenso. Di pronta beva.
(6.8/10)
Andrea Provinciali
Stefano Solventi
Zenerswoon - Frames (Nowherez,
Apr 2009)
G enere : indie rock
E’ passato quasi un lustro - un’era geologica in
ambito rock - dall’esordio There In The Sun,
non c’è più Francesco Frilli alla batteria ma Stefano Tamborrino, ma a parte ciò constatiamo
intatte la convinzione e l’attitudine per ciò che
è uscito vivo dagli anni novanta. Post, emo-core,
tardo grunge, math-rock: i fiorentini Zenerswoon se ne sono evidentemente nutriti e non fanno
nulla per nasconderlo, però vivono con intellirecensioni /
123
il dvd
il libro
Hugh Barker/Yuval Taylor (Isbn, 2009) - Musica di plastica
Mission (The) - The Final Chapter (SPV, aprile 2009)
Due DVD celebrativi dell’addio alle scene dei Mission e del relativo tour del febbraio-marzo 2008, colti nei quattro concerti finali allo Shepherds Bush Empire di
Londra più un terzo di interviste, prove e backstage assortiti.
Questo il sunto di quello che ci si appresta a vedere con The Final Chapter, che
sin dal titolo richiama The First Chapter, raccolta del primo materiale del gruppo
inciso su etichette indipendenti, subito dopo l’uscita di Wayne Hussey e Craig
Adams dai Sister Of Mercy nel 1985.
Attenzione però che il marchio The Mission ruota ormai da anni intorno al solo
Hussey, impegnato anche con altro (il Nostro si è trasferito in Brasile dove ha uno
studio di registrazione), per cui la band è tutta nuova.
I pezzi eseguiti appartengono principalmente ai primi
quattro album – The First Chapter, Children, God’s Own
Medicine e Carved In Sand - più altri brani sparsi, segno
che il periodo d’oro è stato essenzialmente il primo, su questo non ci sono dubbi. La formula della band d’altronde è
rimasta più o meno immutata negli anni, un granitico goth
rock con tentazioni da stadio, immune da qualsiasi evoluzione musicale posteriore.
Hussey è un frontman carismatico e comunicativo (si vede
anche dai vari backstage) e la band si muove bene, nonostante il suono della batteria suoni piuttosto ovattato. La
mescolanza di basso e chitarre fa il suo lavoro e i pezzi
rendono come devono rendere, con tutta l’enfasi del caso,
va da sé. D’altra parte assistiamo a una celebrazione e un
addio e l’esagerazione e la retorica ci sta tutta, per carità.
Sembrerebbe strano il contrario.
Tirando le somme sappiamo che il gruppo non è stato tra i
capisaldi del genere, tutt’altro, ma un onesto ensemble che
ha avuto i suoi meriti e il suo breve momento d’oro, e che visto oggi ha il pregio
(tutto quanto va ovviamente riferito a a Wayne Hussey) di portare bene gli anni e
saper far fruttare l’esperienza acquisita sul palco.
(6.8/10)
Teresa Greco
Due le domande che è lecito porsi a proposito di questo libro. La prima: quanto è
importante la questione dell’autenticità per gli appassionati di pop(rock)? Molto, a giudicare da quanto viene presa a metro di giudizio nelle recensioni e nelle diatribe che
infiammano regolarmente i forum. La seconda: è un caso che qualcuno abbia avuto
l’idea di scriverlo oggi e non - poniamo - quaranta anni fa quando la questione era già
all’ordine del giorno? Forse no.
Forse l’autenticità è un dilemma che pervade più aspetti del vivere di quanto non sia mai
stato, ci attende al varco in ogni momento, mediando la percezione di base, annidandosi nella catena dei pensieri che riteniamo più nostri, scavando
tunnel insidiosi nella terra su cui poggiamo fiduciosi piedi.
Ragion per cui questo Musica di plastica (titolo originale:
Faking It) scritto a quattro mani dal filosofo e compositore
londinese Hugh Barker e dal musicologo chicagoano Yuval
Taylor, cianciando di pop in senso ampio (blues, folk, rock,
disco, wave, hip hop...) dal punto di vista della produzione e
della fruizione, finisce per sondare il denso e complesso rapporto tra i media e noi, che ai media dedichiamo sempre più
energie, conformandoci ad essi nei più insospettabili modi.
Ne esce un affresco che, tra paradossi e rivelazioni, tra miserie ed eroismi, abbraccia John Mississippi Hurt e Kurt Cobain, Elvis Presley e Diana Ross, Neil Young (protagonista
di un capitolo che sfiora l’agiografia, ma come biasimarli?)
e Moby, Ry Cooder e John Lydon, con inevitabili accenni a
personaggi di contorno - si fa per dire - quali Mick Jagger e
Malcolm McLaren, Giorgio Moroder e Ibrahim Ferrer, Lennon e Frank Sinatra, Paul Simon e Nick Cave. Alla fine del
quale esci con la sensazione che il nodo non sia stato sciolto,
che il dilemma si ripresenterà sempre e ancora perché l’autenticità (o l’inautenticità, se preferite) non conosce altra unità di misura che l’importanza che siamo disposti a tributarle secondo i casi e le situazioni. Certo, meglio essere
consapevoli di quanto sia facile farsi gabbare quando i parametri in gioco sono tanto
aleatori, con l’esperienza accumulata in quasi un secolo dall’industria discografica, tenendo in debita considerazione che gettare l’acqua sporca e il bambino può essere un
esercizio di mediocre masochismo.
Forse per esprimere il succo bastava un articolo lungo, ma la lettura scorre godibile,
condita da anedottica intrigante e chiose acuminate.
Stefano Solventi
124
/ recensioni
recensioni /
125
live report
B.Fleischmann
C ittà del T eatro , P isa
Nell’ambito della rassegna Fosfeni, giunta al suo
quinto anno, arriva in Italia l’austriaco Bernard
Fleischmann, sull’onda dell’apprezzato Angst is
not a Weltanschauung!.
In un teatro dalle pareti nere che favorisce l’immersione nelle atmosfere della musica, il palco
ospita un grande tavolo con le apparecchiature
del dj, una Les Paul nera e altri due microfoni destinati alle ugole di Marilies Jagsch e Sweet Wil-
B.Fleischmann
126
/ Rearview Mirror
liam Van Ghost, già voci del disco e occasionalmente alla chitarra; nonché uno schermo bianco
sul quale vengono proiettati dei video, rigorosamente in b/n, di rielaborazioni da vecchi film.
Se si eccettuano i due momenti in cui il leader
lascia la scena in solitaria prima all’una e poi
all’altro, in realtà della chitarra ci sarebbe relativo bisogno: bastano il suo computer e le tastiere
a creare un paesaggio sonoro che l’alto volume
dell’impianto contribuisce a rendere nei dettagli.
La scaletta è centrata sul materiale più recente,
quello della
svolta
verso la forma
canzone, e su
qualche anticipazione del
materiale futuro, e la resa
fuga eventuali perplessità
sulla riuscita
live di musica
creata al laptop. Non solo
perché la voce
di Van Ghost
non
risulta
così Nick Cave
come sul disco, ma anche
perché la situazione consente un ascolto avvolgente, difficile da ottenere altrove a questo livello,
che permette di cogliere le nuances e i dettagli
delle canzoni.
Dal laptop poi esce la quarta voce della serata, il
Daniel Johnston presente, anche lì digitalmente, già nella versione su disco di Phones, Machines
and King Kong, col leader che appunto ringrazia il
suo pc per avergli consentito di fare musica insieme a Johnston (il fatto che le iniziali del cantante
americano siano DJ è curioso ma probabilmente
non vuol dire nulla).
Come tutti gli altri brani in scaletta anche questa canzone risulta in qualche modo più calda
e potente che in studio: segno che, elettronica o
meno, Fleischmann suona, confermando non solo
la bontà del disco ma, col materiale nuovo, anche
la salute della sua musa al momento.
Giulio Pasquali
musicale. Decisivi, tuttavia, nel convertire le pause in attese spasmodiche ma soprattutto nell’esaltare i momenti più sognanti del film. Secondo un
copione che prevede un piccolo stravolgimento
all’interno della band, dal momento che il cavallo di Troia chiamato ad eccitare le sinapsi non è
più la voce di Emidio Clementi – nessuna parte vocale vocale è prevista - ma la chitarra elettrica di Egle Sommacal. Bravo, quest’ultimo,
a distendere una ragnatela di fraseggi pressoché
infinita, ad auto campionarsi per donare profondità ai suoni, a giocare con pedali ed effetti per
sottolineare i crescendo della trama. Con a destra un Clementi pulito ed essenziale al basso e
a sinistra una Vittoria Burattini puntuale nel
compensare i vuoti della chitarra con coloriture
ritmiche ampie e spaziose. Un’esperienza audiovisiva inedita, questa di casa Usher, che convince,
emoziona e lascia il segno.
Fabrizio Zampighi
Massimo Volume
T eatro di B udrio , B ologna
Più che questa versione cinematografica del racconto di Edgar Allan Poe, chi vi parla conosceva
la trasposizione resa celebre da Roger Corman
negli anni 60, con l’irraggiungibile Vincent Price
a fare da mattatore. Una colpa, più che un vanto,
dal momento che il film protagonista della sonorizzazione in oggetto ci è parso assai più visionario e inquietante della pellicola di Corman. Sarà
stato per il bianco e nero sdrucito o magari per
certi fuori fuoco disturbanti, per i grandangoli
quasi distorti o per quei ralenti così eloquenti, ma
il film girato nel 1929 da Jean Epstein ha mostrato una modernità di linguaggio superiore alla
media degli horror e dei thriller di ultima generazione. Grazie anche all’espressionismo fascinoso
del muto, in cui ogni gesto, per quanto banale,
assume significati profondi e teatrali.
Certo buona parte del merito va anche ai Massimo Volume, qui chiamati a dare spessore alle
vicende narrate con una successione di scambi
strumentali non lontani dalla propria tradizione
Bachi Da Pietra
D iagonal C lub , F orlì
Trovare una chiave di lettura per la nostra passione
per i Bachi da Pietra, non è facile. E’ un po’ come
chiedersi per quale motivo in Italia si continui a
suonare – e a scrivere di - musica indipendente
senza avere a disposizione risorse di alcun genere, nonostante una politica imbarazzante e completamente insensibile, a dispetto di una crisi che
prima che essere economica è sociale e culturale.
Autolesionismo? Forse, o più probabilmente necessità. Di comunicare, ma anche di condividere
esperienze, sensazioni, conoscenze, che nell’altro
mondo – l’esterno, il quotidiano, la realtà del paese, direbbe il signor Agnelli - sarebbero precluse.
In questo social network di disperati a parametro
zero non valgono le lauree o la rispettabilità, il
lavoro che fai o i soldi, ma quello che sai dare.
La moneta di scambio è l’onestà, il porti senza
mediazioni verso chi ti ascolta, l’integrità umana,
prima che artistica. E in questo senso i Bachi da
pietra sono esemplari, che li si ascolti su disco –
Rearview Mirror /
127
andate a riprendervi l’ultimo Tarlo Terzo dalle
classifiche di fine anno di Sentire Ascoltare – o su
un palco.
Merito di una formula musicale che fa dell’essenzialità e del rigore un punto d’orgoglio, di un
blues of consciousness ipnotico ma artigianale, di un
mostrarsi senza vergogna evitando stupide coloriture modaiole. Un godere comune che sa quasi di
filosofia, umorale e sotterraneo, ruvido e reiterato, per certi versi intransigente. E in grado anche,
nella pratica, di cortocircuitare col proprio peso
specifico quel chiacchiericcio menefreghista ormai consuetudine del localino di provincia come
del club metropolitano, scavando in profondità,
toccando gli estremi dello stile, trovando un senso
logico solo in sé stesso. Succi continua a rimanere quel chitarrista istintivo e viscerale che era
ai tempi del primo Tornare nella terra, senza
filtri, come il cantato gorgogliante che sputa fuori nell’ora circa di concerto. Dorella è Dorella,
rapito dai tamburi, con gli occhi perennemente
chiusi, in uno stato di abbandono che richiama
– come del resto la scritta sulla maglietta nera
indossata dal Nostro – la ritualità dell’altro brand
di cui è depositario, gli Ovo. Entrambi interconnessi, i due musicisti, l’uno all’altro, e entrambi
ugualmente persi in una trance fatta di automatismi inconsci e puro feeling. Poetica cadenzata
che lavora per sottrazione in cui nulla è superfluo
e ogni piccola variazione di temperatura colpisce
dritta allo stomaco.
Ecco perché parlare ancora e bene dei Bachi da
Pietra. Perché è uno dei progetti più potenti dello
“stivale”. Ennesimo aggiornamento di quel rock
“declamato” - per chiarimenti, c’è SA n. 50 – che
recuperando idealmente il passato dei Madrigali
Magri e dei CCCP, si affianca a Offlaga Disco
Pax e Massimo Volume. In un cammino che col
rock di scuola americana mantiene giusto un legame di parentela ma che è anche e soprattutto,
“roba nostra”.
Fabrizio Zampighi
128
/ recensioni
Lara Martelli
C ircolo C aracol , P isa
Viso da diva del cinema, si comporta come tale
rimanendo per tutta la durata dello show con un
impermeabile, benché senza maniche, all’interno
di un Caracol-fornace perché “è il mio costume
di scena”: e considerate che mentre il disco dava
un’idea di tranquillità quasi invernale dal vivo le
canzoni acquistano calore e passione soltanto intravisti nella versione registrata, cosa che insieme
alla grande affluenza di pubblico aumenta ulteriormente la temperatura del locale.
Accompagnata da una formazione a tre (l’alterego musicale Pierfrancesco Aliotta a computer,
tastiere e basso, Marco Marzo alla chitarra e
Claudia Della Gatta al violoncello) ridotta ma
estremamente efficace, Lara Martelli conferma
per l’ennesima volta la misteriosa legge per cui i
dischi in Italia sono anche belli, anche fatti bene,
ma il 95% dei gruppi e cantanti italiani è meglio
dal vivo.
Lei dice che è perché le canzoni portate in tournée
nel tempo vengono rilavorate, migliorando arrangiamenti ed esecuzioni, ma quale che sia la causa, il viaggio nella versione live di Cerridwen ha
qualcosa di magico davvero nella compiuta padronanza con cui si ribadisce che il trip-hop che
domina l’album è un genere fatto di freddo nord,
è lunare come la dea che lo intitola, ma è fatto
anche di passione bruciante ed aperture stordite
da cielo estivo. Una dicotomia nella quale la nostra si trova bene forse grazie anche alla doppia
origine, tra il sole di Roma e il freddo della Finlandia, e che viene resa efficacemente anche dalle
morbide movenze con cui la cantante trattiene la
tensione e poi la fa esplodere qua e là in improvvisi abbandoni a danze frenetiche.
Dopo aver recuperato nei bis qualcosa dal precedente Orchidea rossa e dintorni (anche qui
la cottura degli anni ha agito in meglio), tocca
all’omaggio “al più grande amore della mia vita,
non corrisposto” di una sommessa e intensa There’s A Light That Never Goes Out e a quello alla raffi-
l ara martelli
nata leggerezza dei Beatles di Blackbird chiudere
l’esibizione di un talento in grado di affermarsi
bene all’interno di un genere che sta tornando in
auge.
Giulio Pasquali
Blixa Bargeld
T eatro R asi , R avenna
Nonostante l’età e il panciotto del completo nero
tenuto sollevato da un tono addominale non
proprio fulgido – un po’ alla Horst Tapper, lasciatecelo dire – Blixa Bargeld fa ancora la sua
porca figura. Sarà forse per quel caschetto liscio
che fa tanto direttore d’orchestra o per lo sguardo da pluriomicida con cui ti osserva, ma provare nei suoi confronti riverenza mista a timore
viene quasi naturale. Del resto stiamo parlando
di un terrorista del pentagramma, un artista che
ha sorpassato da destra Nick Cave lasciandolo
con un palmo di naso e decretandone, nei fatti,
l’oblio creativo. Quando te lo ritrovi su un palco, da solo, senza strumenti, con un microfono di
fronte e qualche pedale vicino alle casse spia, non
sai proprio cosa aspettarti ma hai il sospetto che
sarà comunque qualcosa di grandioso.
Lo spettacolo si chiama Rede Speech e in soldoni si tratta di uno studio sull’emissione, il campionamento, la sovrapposizione della voce, per
ottenere spaccati sonori vicini all’ambient, al
noise, al rumorismo, all’elettronica. Detta così
potrebbe sembrare poca cosa e probabilmente,
se a fare gli onori di casa ci fosse stato un musicista mediocre, lo sarebbe stata davvero. Invece
davanti a noi c’era il deus ex-machina degli Einstürzende Neubauten, uno a cui carisma, presenza scenica ed esperienza non mancano di certo.
Virtù che non si comprano al supermercato ma
sono diretta conseguenza di un percorso artistico
ben preciso, nel caso di Bargeld, costellato di razionalismo, intransigenza, rifiuto per i compromessi, voglia di spingere il concetto di musica oltre le barriere del comune sentire. Tutta roba che
viene fuori durante la performance, nella sana
follia che regge il discorso, nella voce inquietante che regola l’intensità delle suggestioni, nelle
urla criminali che rimandano ai tempi gloriosi di
Stagger Lee menando fendenti per tutta la platea.
Lo scopo è creare veri e propri brani o magari
descrivere con i suoni un ideale processo di ricombinazione del DNA; dare forma a pensieri e
sensazioni sconnesse o tornare alla preistoria collezionando grugniti animaleschi persi nel tempo.
Per sapere fino a che punto può arrivare la voce,
quando è foraggiata da una creatività che è un
misto di metodo scientifico e devianza.
Alla fine uno spettacolo disturbante e sorprendente, questo Rede Speech, personificazione
perfetta del suo creatore.
Fabrizio Zampighi
recensioni /
129
WE ARE DEMO
#35
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati dai vostri devoluti redattori di
S&A. Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Ear - Asfodeli da conservare (Autoprodotto, Feb 2009)
G enere : F olk pop
Trio acustico dall’Emilia Romagna, due chitarre
e un violino, l’onda lunga e sorniona del NAM si
sfalda di delicatezze pop in italiano (e quindi un
po’ italiane), coglie sdilinquimenti cameristici e si
fa cogliere da ebbrezze vagamente psych, per poi
concedersi jazz-folk nella sbrigliata Cose, tra flauti, cornamuse, fisarmoniche, clarinetti e un’enfasi che arrivano a scomodare il Van Morrison
bucolico. Decisamente e programmaticamente
fuori dal tempo, ma in fondo sembrano suggerirti
- con una certa convinzione cui finisci per credere
- che la loro calligrafia sta alla base di tanto poprock più o meno evoluto che ci capita di ascoltare. Li aiutano in questo i bravi Martinicca Boison
e Sara Piolanti. (6.5/10) SS
Lam - Wild (Autoprodotto, Feb 2009)
G enere : post rock cinematica
Duo cosentino attivo dal 2001, i Lam si sono fatti
venire un’idea mica male: riempire la desolazione
atmosferica del post rock con le palpitazioni emotive e - è proprio il caso di dirlo - cinematiche dei
Badalamenti, dei Vangelis e dei Morricone.
Claustrofobie tra i landscapes sconfinati. Strane
angosce t’inchiodano al suolo eppure cammini.
Ciò che ha gli ha guadagnato la partecipazione
a Poison Ochs, compilation-tributo al grande
Phil Ochs licenziata nel 2003 dall’etichetta statunitense Wood Records, esperienza doppiata un
paio di anni più tardi con I’ll Never Leave You
(dedicata stavolta a Harry Nilsson). Insomma, hanno questa capacità di allestire scenografie ipnotiche e minacciose, come una marcia in
un deserto senza tempo o forse post-atomico, le
venature dark della chitarra e i panneggi eterei
delle tastiere s’impastano con un certo languore
130
/ recensioni
rimagliati da drum machine, tramestii sintetici
e occasionali apparizioni d’archi. Non troppe le
idee, la cui reiterazione ossessiva non sempre si
fa bastare. Resta la validità dell’intuizione di partenza. Che sia una partenza, però.(6.6/10) SS
Magpie Wedding - Torches EP (Autoprodotto, Feb 2009)
G enere : psych folk
Sono in quattro, tre italiani (alle prese con chitarre, piano, batteria, sega e banjo) e una inglese
(la cantante, chitarrista e fisarmonicista Grace), e
fanno perno nella sonica Bologna dal 2007. Questo Torches, il loro ep d’esordio, mette in mostra una fibra folk perturbata di tremori elettrici
e torpori emozionali, qualcosa come un impasto
spugnoso della Sinead O’Connor più inafferrabile e i Bardo Pond più affabili, strizzando
l’occhio ai sentieri traditional più o meno anomali di una Vashti Bunyan e impelagandosi senza
tema nella brumosa solennita di certo post-rock.
Quando cedono sul versante Strawbs è solo per
rimarcare la melmosa inquietudine quasi Arcade Fire che li anima, e che potrebbe portarli lontano se saranno bravi a non smarrirsi nella loro
stessa caligine.(7/10) SS
My Speaking Shoes - Wow, Introspection! (Autoprodotto, Feb 2009)
G enere : indie stoner
Tornano i quattro My Speaking Shoes da Sassuolo, età media vent’anni, cui non manca certo il carattere né una certa versatilità nel disimpegnarsi
tra spurghi stoner, guizzi indie-wave e repentine
parentesi psych-blues in derapage noise. Chitarre
ghignanti, casomai effettate, basso e batteria che
se la intendono, una cantante senza timore reverenziale. Resta da capire quanto queste capacita
Claudia Is On The Sofa - Sweet Daisy (Autoprodotto, Feb 2009)
G enere : folk rock
Claudia sul suo sofà sogna di fare la folk singer il che significa
tutto e niente se non ti scegli la scia da annusare, inseguendola
come si fa coi sogni di gloria o con certe infatuazioni che ti
rivelano chi sei. In questo caso, la ragazza bresciana guarda al
country però dall’angolazione affabile e polverosa dell’ultima
Cat Power, con le sue movenze devote sopra la polpa di una
perdizione che nel caso della cara Chan gli anni hanno sedato
e smarrito (bontà sua), qui invece presumo si tratti di dolcezza
fisiologica unita all’impudenza tipica di chisa ciò che vuole.
Insomma, i quattro pezzi di Sweet Daisy sono ballate dal passo caldo e disinvolto, capaci di
una strana, solenne saggezza (vi basti la palpitante Apple Tree) cui fa eco il puntuale contorno di
piano e chitarre (slide e steel) per arrangiamenti che ti lasciano di stucco tanto è l’equilibrio tra
inventiva e misura (prendi la title track, con nulla da invidiare a certe delizie Norah Jones).
Molto brava: presto il sofà le starà stretto.
(7.1/10) SS
e questa energia sapranno darsi una forma, come
dire, propria, inconfondibile. E’ il prossimo passo
ragazzi. Quello decisivo. (6.6/10) SS
Novalium - Self Titled (Autoprodotto, Apr 2009)
G enere : rock
Si parte con il blues di Sangue e piombo nell’omonimo EP dei Novalium, sonorità hard applicate
alla musica del diavolo che, crediamo, sarebbero
piaciute molto allo Slash periodo Snakepit. Per
poi imboccare un percorso non necessariamente
retto che cita i Timoria di 2020 (Amaro), si attarda tra Alice in Chains e stoner (Nuovo documento di testo), mostra di gradire crossover e affini
(Generazione), cede il passo a qualche momento di
riflessione (Il volo). Il risultato finale piace pur senza sconvolgere e mostra una band impegnata a
cercare una proprio linguaggio partendo da una
formazione musicale piuttosto convenzionale.
Talkbackparrot - Rewiring (Autoprodotto, Apr 2009)
G enere : ambient - field recordings
Tra armoniche a bocca e quintali di field recordings, atmosfere distese ed elettronica casalinga,
timide chitarre e rumori dal fondo, ci si imbatte,
con questo Rewiring, in un’opera che valorizza il sentire dimesso, il lento fluire dei suoni, le
sonorità concrete, ma anche la musica contemporanea. Un carattere introspettivo vagamente
ambient dietro cui si nasconde Fabio Damiani,
deus ex machina del progetto nonché polistrumentista col vizio dei suoni sintetici. Che in questa sede certifica una collezione di umori, più che
un disco a sé stante, sorta di museo delle microvariazioni assemblato con un gusto e in grado di
esaltare le idee di fondo del padrone di casa.
(6.8/10) FZ
(6.2/10) FZ
recensioni /
131
our electro friend
- Giancarlo Turra
R evolutions
at
33
A costo di risultare noiosi, lo rimarchiamo di nuovo: frammento e ritmo mostrano una delle vie
odierne plausibili della musica infinita, a partire
dal rock citazionista per giungere a chi, dei due
elementi, fa uso più strutturale. Al proprio meglio, questa contemporaneità che profuma di infiniti ieri indica percorsi degni di interesse, perché
sa dove pescare nell’infinito mare della tradizione
e, di quel che sale nelle reti, fa poi buono se non
132
/ Rearview Mirror
ottimo uso. Sui “beats and pieces” già discussi in
precedenza vogliamo tornare per indagarne alcune radici: breakbeat sempre protagonista, ma
colto ai primi vagiti quando non addirittura nei
giorni di gestazione e concepimento; ed electro,
anche, ad esso saldata sul solido tronco dell’hiphop old school. Di Mantronix tesseremo le lodi
e lo faremo soprattutto guardando allo ieri: poiché se è vero che il buon Kurtis è tuttora in circolazione, non vi sono dubbi che sia la via indicata
due decenni or sono a renderlo importante. Nel
ruolo di “originatore”, svela l’influenza esercitata
nell’avvertire il mondo già come un rizoma infinito, un frattale all’ennesima potenza cui fornì
colonna sonora adeguata. Beat e bit in lui si fondono e spezzano (break) per ricomporsi secondo
potenzialità inesauribili degne di mattoncini lego
compatti e basilari; elementi accostati l’un l’altro
e ricchi di forza sincretica superiore alla somma
delle parti. Umano e tecnologico, strada e club,
pop e sperimentazione: nessuna differenza, giacché gli anni Ottanta mostrarono che si poteva
mescolare non solo “alto” e “basso” o passato e
presente, ma soprattutto culture tra loro distanti.
Nasce qui il suono del villaggio globale, quello
spirito progettato da Remain In Light e Sandinista! oramai dato per scontato o quasi: fate scorrere i Massive Attack che rivedono Musstt Musstt
del divino Nusrat Fateh Ali Khan in coda al
remix marca Coldcut di Paid In Full (Erik B. &
Rakim: epocale in origine e ancor più dilatata a
sette minuti preconizzatori del breakbeat) e - immersi nell’energetico suono del 33 d’esordio dei
Mantronix - sarà autentica rivelazione. Allorché i
M/A/R/R/S smerceranno milioni di esemplari di puro cut-up “state of art” con Pump Up The
Volume, l’avanguardia sarà nelle case e nelle teste
di ognuno; tuttavia, siffatta rivoluzione e quelle che
seguirono non avrebbero potuto essere - o sarebbero state certo diverse - senza l’apporto di chi
certi passi stilistici li aveva saputi anticipare. I mille e uno trafficanti del frammento sonoro arrivati
da lì in poi, la lezione l’hanno senz’altro assimilata. “This is a journey into sound!”, e per davvero.
T he
man machine
“We got two turntables and a microphone.”
(Mantronix)
C’è da restare abbagliati da come gli afroamericani si siano costruiti un epos che della cruda
realtà di sofferenza secolare è sia esorcismo che
reazione. Basta pensare a Sun Ra e George
Clinton, a Rammelzee e Drexciya per rendersi conto di come certe cosmogonie oscillino
costanti tra fantascienza e riscrittura della storia.
Di come cerchino di unire - così spingendosi già
oltre il postmoderno - tecnologia e umanità, giungla africana e d’asfalto. Pochi hanno maneggiato
circuiti e fili elettrici mettendo al loro centro un
cuore palpitante e, su tutti e per primi, i visi pallidi crucchi Kraftwerk, al punto da diventare padri di techno(pop), house e hip-hop. Caso unico
di bianchi che influenzano la musica dei neri e
non viceversa, generarono moltitudini di seguaci
e Mantronix spiccava tra questi. Chiaro fin dal
principio, Kurtis Mantronik, circa le sue intenzioni, sin da un nome di battaglia crasi eloquente
di man ed electronics in omaggio a Ralf e Florian (ma che ne dite dell’avveniristico Herbie
Hancock di Sextant?), non oggetto di imitazione
ma rivisti alla luce della cultura hip-hop in via
di definizione. Inscena così una rivoluzione nella rivoluzione, giacché a quest’uomo dobbiamo
l’uso non accessorio di sintetizzatori e campioni
(eccoli già qui, i pezzetti!) che tramutano il silicio
in carne e - raccogliendo il testimone dalla Planet
Rock di Afrika Bambaata - riportando anima e
Soul nei territori di appartenenza. Partiva da una
cultura sonora concreta, lui, e non dalle asettiche
camere di un laboratorio; possedeva sensibilità
verso una musica che fosse fortemente ritmica e
la sapienza di tesserla melodicamente. Coerente
e sincero, cambiò strada allorquando l’innovazione stava scadendo nel clichè.
Alla novità arrivò, come del resto Grandmaster
Flash e svariati altri Padrini, da immigrato, partito dalla Giamaica che lo vide nascere Kurtis
Khaleel e ritrovatosi, uomo giusto al momento e
luogo giusti, dentro al calderone della Big Apple
di fine ‘70. Di nuovo, al pari del Granmaestro,
Mantronik inizia presto a far girare Technics in
giro per la città mentre lavora al negozio di dischi
- e dove, sennò - Downtown Records di Manhattan. Si imbatte in MC Tee, ovvero l’haitiano
Rearview Mirror /
133
Touré Embden, col quale si intende al volo e
confeziona un demo. Talmente ben fatto che il
capoccia della Sleeping Bag William Socolov
mette seduta stante quelli che ora si chiamano
Mantronix sotto contratto. Il singolo di debutto
dice tutto nel titolo, Fresh Is The Word, e nel 1985
è la gomma attaccata sotto le suole di mezza metropoli e sale al sedicesimo posto delle classifiche
dance di Billboard. Altrettanto epocale l’album
che lo contiene, Mantronix (Sleeping Bag,
1986; 8,0/10), arrampicatosi al fondo dei Top
50 R&B: innovativa sarabanda funky ballabile di
poliritmi arcaici ricreati a colpi di Roland e Korg,
ugola vocoderizzata con gusto e ondate di sintetizzatori che gettano il ponte tra old school e new
jack. Avveniristico, nonostante una delle tracce
s’intitoli Hardcore Hip-Hop, parte dalla strada e la
conduce per mano un passo oltre con gemme del
calibro di Needle To The Groove e Mega-mix in barba
allo storcere di naso dei b-boys. Questa bomba
influentissima sarà tesoro dei più avvertiti e spesso apertamente ossequiata, ad esempio dal Beck
di Where It’s At e dai Beastie Boys in Jimmy James. Altri caucasici, come avrete notato: gli stessi
che, in Inghilterra, apprezzano e recepiscono le
basi di una discendenza tramite Ladies e Basslines,
Capolavori che vedono la luce su singolo e suscitano un certo clamore nelle lande albioniche.
Frattanto Kurtis è stato promosso talent scout e
produttore della Sleeping Bag (dal fiuto niente
male: assolderà EPMD e Just-Ice…), la qual
cosa non impedisce a Music Madness (Sleeping Bag, 1986; 7,0/10) di mantenere caldo il
nome e scalare altre posizioni in classifica. MC
Tee seguita a snocciolare rime secondo la voga
dell’epoca, tuttavia il suono risponde alla durezza
Def Jam e guarda avanti, svoltando in parte verso
il club e la scena go-go e house di Chicago, cavando dal cilindro un crocevia tra dance, hip-hop
ed elettro-funk. Il tutto, beninteso, accanto a brani che proseguono il piglio futurista del debutto
come Scream e Who Is It. Bontà che cagiona fama
crescente e, nell’87, una relativa caccia all’uomo
134
/ Rearview Mirror
vinta dalla Capitol in ragione di un contratto a
sette cifre sette. In Full Effect (Capitol, 1988;
7,2/10) farà storcere il naso ai “duri e puri”, con
la sua mistura non banale di errebì e dance che
preconizza la hip-house. Curatissimo per produzione e taglio dei suoni (è il primo disco in assoluto a essere ricavato da un DAT), semplifica le
strutture ritmiche e rinuncia in parte al funk, portando un passo avanti le tematiche del predecessore ma con polso più solido e maggior sicurezza.
Resterà il massimo successo commerciale del duo
ed è il commiato di MC Tee, che da forfait per
arruolarsi in aviazione. Senza l’amico dei primi
tempi e soprattutto esauritosi l’effetto sorpresa, i
dischi successivi si sviluppano secondo logica abbracciando ulteriormente l’orientamento morbido di cui sopra, mentre oltremanica si risponde al
messaggio in modo forte e chiaro attraverso la già
citata Pump Up The Volume, il Bomb The Bass in
vertigine di Beat Dis e il martello nazionalpopolare Theme From S’Express. Poi arriveranno i Coldcut
col botto di cui si dice in apertura, e il resto è
storia.
I rimpiazzi al microfono si chiamano Bryce Luvah e il cugino di Kurtis, DJ Dee, coi quali si
appronta
Rearview Mirror /
135
Ristampe
AA. VV. - German Funk Fieber Vol. 2
(ShowUp, Dic 2008)
G enere : retro easy funk
La domanda sa di barzelletta, ma tant’è: possono
i tedeschi essere funk? Sì, purché dalla parola si
tolgano sensualità e groove: ne resta l’abito sonoro, lo scheletro su cui incastrare un fare spiritoso
e disimpegnato nei confronti della materia.
Non solo: permane nell’aria quel sentore fragrante da film di serie B che siamo soliti associare
a questo genere di sonorità frizzanti e sorridenti,
che proprio di prendersi sul serio non sono capaci
neanche se lo volessero. Si prenda il groove succoso - nondimeno inevitabilmente bianco quanto
a piglio ed esecuzione - High Snobiety di Siegfrid
Schwab, strategicamente collocato in apertura:
le chitarre sono acide ma gli inserti di fiati ricordano l’orchestra di un’ipotetica Canzonissima del
’74 e il trucco sta esattamente lì. Lo stesso valga
per la chiusura, affidata a Evening Air, sensazionale onomatopea strumentale da far impallidire gli
Air e viceversa opera risalente alla metà dei Settanta di Peter Thomas (culto già oggetto, a fine
del secolo scorso, di un tributo con dentro gente
come Stereolab…)
O, ancora, gli svariati tormentoni che - a colpi di
hammond sfrigolante e rombar d’ottoni - farebbero furore su qualsiasi dancefloor “retrofuturista” o (per assurdo, ma mica tanto) potrebbero
provenire da qualche compilation acid jazz di
un ventennio fa. Va meno bene quando ascoltia136
/ Rearview Mirror
mo del vibrante hard funk cantato nella lingua di
Schiller e Goethe: l’effetto ve lo potete immaginare. Il problema di queste operazioni risiede nel
sottile confine tra l’interesse, per così dire, “scientifico” e la reale consistenza artistica; una linea
che non è affatto facile districare e presenta più
d’un problema di definizione.
Fortuna vuole che in quest’ora scarsa i momenti
di dubbio gusto si contino sulle dita di una mano:
funk über alles, ma con moderazione e senza perdere di vista l’angolatura amorevolmente “artigianale” che ci fa apprezzare questa fetta di immaginario sonoro.
(6.7/10)
Giancarlo Turra
AA. VV. - Nigeria ‘70 The Definitive
Story Of 1970’s Funky Lagos (Strut
Records, Apr 2009)
G enere : world
Un autentico pozzo senza fondo: ecco cos’era la
scena musicale della Nigeria negli anni Settanta. Ci puoi scavare e scavare senza
mai estrarre pirite,
no; solo oro per
quanto di caratura variabile ma, in
ogni caso, capace
di raccontare una
cultura
sonora
sfaccettata e rivelatrice. Accade anche in questa
antologia, finalmente ripubblicata dopo che l’originale collocò nel 2001 le musiche nigeriane sotto
i riflettori come raramente era accaduto in precedenza. Capimmo subito che non di solo afrobeat
o juju - cioè di Fela Kuti e Sunny Ade, ovviamente inclusi noblesse oblige - si campava laggiù;
fu chiaro quanto nomi all’occidente sconosciuti
come Monotono Tire, Ofo The Black Company e Lijadu Sisters possedessero appuntite
frecce in grado di centrare il bersaglio.
Concepita in modo da fornire una panoramica
delle diverse varianti regionali sonore, la raccolta
si premura di levar via polvere da materiale raro
e nondimeno esaltate - la gassosa ma agitata ma
gassosa Chant To Mother Earth di Blo, un’ipnosi
afro-disco come Agboju Logun a firma Shina Williams - nel mentre spazia agile dallo stile igbo
allo hausa, oppure accosta la savana elettronica
evocata da Bala Miller alla possanza yoruba di
Segun Bucknor & His Revolution. C’è dentro di tutto e il suo armonizzato contrario: jazz
restituito alle proprie tribali origini e funk altrettanto, echi di Can e Miles Davis, anticipi di
Talking Heads e finanche di Lcd Soundsystem, poliritmi stratificati all’inverosimile e uso
falsamente ingenuo della tecnologia. E’ tuttora
una giostra di atavismo e futuro alle porte, noi
le scimmie che tocchiamo li monolito e ne siamo
illuminati.
Un ben degli dei andato fuori catalogo sei anni
or sono e da allora conteso in rete a cifre assai
elevate: ora non avete più scuse per inserirlo negli scaffali in caso sprovvisti, annotando la solita,
enorme cura profferta nell’operazione e considerando che il libretto recupera le note al tempo
vergate dal giornalista John Armstrong e dal
boss della Strut, Mr. Quinton Scott. Al quale il
sottoscritto sta seriamente pensando di erigere un
monumento.
(8/10)
Giancarlo Turra
Cécile Le Prado - Le Triangle d’Incertitude (césaré, Set 2008)
G enere : F ield recordings
Lodevole, tra le intenzioni della Césaré (Centro
Nazionale per la Creazione Musicale) quella atta
a mantenere vivo e rendere di conseguenza più
accessibile, attraverso la ristampa
discografica, ciò
che si può ben
considerare un
importante patrimonio di memoria e di creatività
artistica.
E’ il caso della ritrovata pubblicazione della compositrice francese
Cécile Le Prado, Le Triangle d’Incertitude,
rilasciato in una prima edizione tra il 1995-1996
dal rinomato Istituto Francese di Ricerca e Coordinamento di Musica Acustica (IRCAM) e concessa, per questa nuova ristampa, ad una notevole
attenzione di formato, tra digipak, grafica curatissima e un mastering di tutto riguardo. Esporsi
ai paesaggi d’ambientazione acustica della compositrice francese, è come sempre, un’esperienza
del tutto inedita, merito non solo dell’interazione
o delle condizioni d’ascolto, ma anche di quell’attenta capacità di catturare tra memorie sonore e
identicazione lo spazio, a tratti puramente immaginato, a tratti, in certi bagliori, inaspettatamente
familiare, ma allo stesso tempo incerto.
Quasi tridimensionali, le suite de Le Triangle
d’Incertitude, prendono forma in field recordings ad alta definizione che Cecile Le Prado registra in tre località differenti tra Irlanda, Bretagna
e Spagna. Tre località di mare, rotte di navigazione e fonti sonore legate da un unico, immaginato, percorso d’unione, a formare un triangolo,
un non luogo foriero d’incertezza, in cui sostare
e porsi a confronto con un suono plasmato ma
lasciato libero agire nello spazio.
Ed ecco che i luoghi si rivestono di un nuovo siRearview Mirror /
137
gnificato: grazie a fotogrammi vocali (Triangle), di
acqua, barche o campane (Passages),di gabbiani e
vento (Nocturne2), delle chiacchere di porto (Portuaire) o all’orizzonte (Nocturne3).
Arte di un paessaggio per guardare al quale non
basta certo uno sguardo: bisogna camminarvi incontro per conoscerlo ancora più a fondo ed ecco
che ne scoprirete la metafora più profonda.
(6.9/10)
Sara Bracco
lounge di Tosca e di gran parte della !K7 (stupende le aperture di Fukumachi), le stanze lo-fi
della Basic Channel vicina di casa (L.o.9.v.e.)
e le atmosfere di Pole (Evil Dub inno cosmico).
Tutto con un piglio deciso, personale e scaltro.
Il rimescolo in chiave positiva dei Novanta prima
della decadenza o se preferite della ‘svolta pop’.
Swayzak al 200%. Obbligatoria per chiunque
ascolti electro(-dub).
(7.5/10)
Marco Braggion
Swayzak - Snowboarding In Argentina (Kompakt, Apr 2009)
G enere : deep minimal dub
Nel 98 tirava un’altra aria. I personaggi che si cimentavano col ritmo non avevano a disposizione
la pletora di materiale che oggi, dopo 10 anni, ci
sommerge. E quindi forse i dischi erano più curati. O per lo meno prima di pubblicare si meditava. Ci ricapita tra le mani uno di quei dischetti
che inconsapevolmente hanno scolpito le nostre
orecchie ritmiche. E suona come se fosse adesso.
Già dalla copertina non la diresti un’uscita ufficiale: quella foto
scattata quasi per
caso ti fa pensare a come a quei
tempi l’elettronica
fosse una questione più rilassata;
e anche se Snowboarding In Argentina è un disco
sostanzialmente deep, la profondità emerge in
modo caldo dai bassi, senza troppi problemi
di convoluzioni glitch. In una parola: anima.
Qui c’è ancora tutta la lezione post-balearic
che sarebbe poi confluita nelle mani della FCommunications del maghetto Garnier. Da
queste lunghe tracce (tutte intorno alla decina
di minuti) senti il caldo di Ibiza (Speedboat, LowRez Skyline), le visioni vicine al dub cosmico
degli O.R.B. (Burma Heights), i discorsi deep138
/ Rearview Mirror
Sylvain Chaveau - The Black Book of
Capitalism (Type Records, Ott 2008)
G enere : avanguardia
Clamorose furono le scritture dello Chauveau del
Libro Nero del Capitalismo, originariamente uscito nel 2000 e successivamente riedito, nel
2003, dalla Disques Du Soleil et de l’Acier.
A sei anni di distanza eccoci con l’attesa ristampa
firmata Type Records, che siamo certi non mancherà di concedere più visibilità alle tredici tracce
del compositore francese.
La fermezza del
mirabile post-minimalismo di The
Black Book of
Capitalism (originariamente intitolato in francese)
era venuta un po’
a mancare nelle
più recenti parentesi del 2007 (Nuage, Type/
Wide 2007), senza comunque perdere identità
nelle concessioni soliste al post-rock (S, Type/
Wire 2007).
La lunga distanza non ha fatto male alle note di
pianoforte di Et peu à peu les flots respiraient comme,
alle contemporanee jazz di Hurlements en faveur de
Serge T. o alle introspettive fughe in violoncello
di Le marin rejeté par la mer. Anche se il passar del
tempo non ha sfiorato l’inconfondibile plasticità
e la tenuta di scrittura, a tratti pure finisce per
Highlight
Death - …For The Whole World To See (City Slang, Mar 2009)
G enere : garage - rock
Corsi e ricorsi storici, verrebbe da dire; oppure una di quelle strane coincidenze che ci
fanno apprezzare l’esistenza. Proprio nel mese in cui approfondiamo il nostro sguardo sulla scena di Detroit ecco che da un buco spazio-temporale emerge un pezzo tra
i più sconosciuti della storia passata del rock della motor city.
O riemerge, si potrebbe dire, a seconda del punto di vista col quale si guarda la
questione. Perché …For The Whole World To See, unico album postumo del trio
Death – pubblicato oggi dalla City Slang per un caso decisamente fortuito – è considerabile anche come una ristampa, visto che venne
composto, suonato e registrato un trentennio fa senza
mai vedere la luce. La storia è nota e se non lo fosse
basterà farsi un giro online per scoprirla.
Oggi, a quasi 35 anni di distanza il black rock a forti
tinte garage dei tre afro-americani folgorati sulla via
degli Stooges suona insieme datato e avanguardistico,
col quel suo mescolare in maniera semplice, genuina,
entusiasta sonorità nere non scontate su un tessuto rock
pesante, proto-punk, inficiato da pulsioni prog-psichedeliche come è giusto che fosse a quell’altezza ma totalmente libero nell’approccio.
Crossover prima che il termine venisse coniato; attitudinalmente punk nella sostanza
– chi fu più no future di loro? – quando i semi della rivoluzione punk erano sul punto
di essere gettati; sgraziatamente glam prima ancora che quella potenzialità vocale si
ergesse a stilema classico.
I Death erano un gruppo potenzialmente avanguardistico e dall’ascolto della scarsa
mezzora dell’album emerge il grosso rammarico di cosa sarebbe potuto accadere se
la loro parabola non si fosse esaurita prima ancora di cominciare.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
decontestualizzarsi, se si considerano i mutevoli
seguiti del più recente Chauveau.
Una certezza da riscoprire per chi aveva saputo carpire i segreti di questa gemma nascosta
all’epoca del suo comparire e un buon punto di
partenza per chi decidesse solo ora di avventurar-
si tra i mille sentieri dell’universo sonoro di questo artista.
(7/10)
Sara Bracco
Rearview Mirror /
139
(GI)Ant Steps #26
classic album rev
Charles Mingus
Rollins Band
The Black Saint And The Sinner Lady (Impulse!,
Gen 1963)
The end of silence (imago, 1992)
«Credo che per spiegare la musica che c’è qui dentro
non ci sia altro da dire se non: gettate via tutti gli altri
miei dischi». Così, inequivocabile, brutale, esagerato,
Mingus sul suo Black Saint. Potremmo anche chiudere qui. Con la consapevolezza di avere davanti la
summa di tutta un’esperienza umana e musicale, la
summa di un’esperienza eccezionale.
Potremmo chiudere qui perché Black Saint è
nell’Olimpo del jazz e della musica tutta, e per capire
come mai basta ascoltarlo. Perché è un disco tanto
bello e importante da sconfinare nella mitologia. Le
note di copertina scritte dallo psichiatra di Mingus, il
dr. Edmund Pollock. Le ossessive, maniacali session di
sovrincisione. La nascita di quella che il suo stesso autore ha definito «ethnic-folk-dance music». L’immagine potente del Santo Negro e della sua Peccatrice.
In quel manifesto filosofico che è Psychotic Reactions, Lester Bangs descrive Black Saint come una
delle massime esperienze sonore, uno di quei dischi
che ti cambia la vita, una di quelle esperienze che da’
un senso alla vita, la rende degna di essere vissuta.
Ecco, potremmo anche chiudere qui. Ma cerchiamo
comunque di dire due paroline. Suggestionato dalle
suite di Ellington, e da sempre ossessionato dall’idea
di fare della propria musica una ritrattistica antropologica di portata universale, anche Mingus decide di
dipingere la propria epopea negra. Lui che al contrario del “Duca” la tragedia di essere un diverso, un
(auto)emarginato l’ha vissuta tutta sulla propria carne. Lui che si sente «peggio di un bastardo». Prende
così di peso la sua visione e la sublima sbattendola
su spartito, per poi farla suono, intrecciando orgoglio
negro e storia d’amore, in un concept in forma di bal140
/ Rearview Mirror
letto, sei movimenti, affidato ad un’orchestra jazz di
undici elementi.
Il risultato è un’opera gigantesca, il capolavoro di
Mingus, uno dei punti più alti del jazz. Un disco di
una intensità, di una ricchezza, banalmente, di una
bellezza travolgenti, ogni volta sorprendenti, traboccante di una emotività esagerata, teatrale, quasi
espressionista. E’ un jazz “post-bop”, intriso di blues,
a tratti caricaturale, che ha metabolizzato certi modi
latini, soprattutto flamenco, e certe veemenze free. Il
capolavoro di Mingus, per intensità e compattezza.
Che pure sorprende per la varietà di strutture compositive, per i crescendo e le accelerazioni parossistiche,
metafore perfetta della lotta, per i bruschi stop, per gli
intrecci e i cluster turgidi di fiati, mozzafiato. L’atmosfera: ci si immagina i luoghi di questa storia d’amore
estenuata e maledetta, bastarda, fatta di peccato, impossibilità, ansia di redenzione. Un club fumoso e i
bassifondi più alcolizzati e drogati, ma pittati qui con
eleganza e misura, tanto che i momenti caotici non si
fanno mai confusione, le sfuriate strumentali non si
fanno mai sbracatura.
Citare i singoli movimenti non ha alcun senso. Solo
una piccola noticina. Quando si sente Duet Solo Dancer, con quella tromba parlata e maltrattata, probabilmente ubriaca, e quel motivo lì, non si può non
pensare a Taxi Driver. C’è la stessa indolenza di
fondo, quella stessa lotta stanca, quella stessa sofferenza soffocata.
(8/10)
Gabriele Marino
Con molta probabilità, quando ideò il festival itinerante Lollapalooza, nel 1991, l’ex Jane’s Addiction
e Porno For Pyros Perry Farrell, non avrebbe mai
immaginato che su quel palco sarebbe nata la storia
musicale degli anni ’90. Così come, con altrettanta
probabilità, l’ex cantante della band hardcore Black
Flag, Henry Rollins, non era neanche sfiorato dal
pensiero che quel festival lo avrebbe imposto a livello
internazionale come uno dei punti di riferimento del
magma musicale che stava prendendo forma sotto
l’ombrello del crossover.
Nel nome della contaminazione, musicisti provenienti da esperienze finora tenutesi a debita distanza (l’hip hop, il metal, l’hardcore), cominciavano ad
incrociarsi e a contemplare nuove soluzioni possibili.
Basta dare un’occhiata al cartellone di quella prima
edizione del Lollapalooza per rendersi conto di quale fosse la portata dell’evento nella prospettiva delle
future evoluzioni del rock: Jane’s Addiction, Ice-T
con i Body Count, Living Colours, Nine Inch
Nails, Butthole Surfers, Rollins Band, Siouxie
And The Banshees e Violent Femmes. Il palco
di Lollapalooza ’91 lanciò nell’immaginario collettivo
dell’ultimo decennio del XX secolo (e nel cielo stellato di MTV), la figura di Henry Rollins, personaggio
al tempo stesso chiaro ed enigmatico, poeta e violento
urlatore, intellettuale e palestrato. Ma, soprattutto, un
grande animale da palcoscenico, perfetto in una fase
di grande ritorno della dimensione live del rock.
A livello discografico, il seguito di questo successo si
esprime con una virata stilistica in linea con i nuovi
principi del rock fin de siècle. In cabina di regia c’è
Andy Wallace, uno che di crossover se ne intende (già
dai tempi della pionieristica collaborazione tra Run
DMC e Aerosmith). Il sound della Rollins Band,
ancora legato ai canoni del post-hardcore dopo i primi due dischi in studio, si lascia travolgere dal metal,
dal funk e dal power rock. Ne viene fuori qualcosa
di assolutamente nuovo, che accomuna, come per
magia, i Pearl Jam e i Rage Against The Machine, gli Alice In Chains e i Nine Inch Nails e
che esprime il nuovo sentire di una generazione spinta verso il buio di una società in piena crisi ideologica e della quale Kurt Cobain è inconsapevolmente
divenuto eroe e martire. The End Of Silence è un
disco duro, urlato, ma anche pronto a concedersi il
lusso di un singolo (Low Self Opinion). Diretto come un
pugno allo stomaco (You Didn’t Need), ma anche acido e psichedelico come nella lunghissima Blues Jam
e negli infuocati finali di Another Life e di Just Like You,
un vortice sonoro che culmina in quell’urlo disperato
sulla parola “Rage” (rabbia), ripetuto fino allo stremo. Una rabbia, quella di Rollins, che si esprime in
un cantato quasi declamato, che sfiora l’hip hop (Low
Self Opinion) o in vocalizzi a metà tra il cantato e
il parlato tipici dell’hardcore punk (Tearing ricorda il
debito del Nostro nei confronti di band come Bad
Brains e D.R.I.). Ma Rollins sa anche far venire
i brividi, come nei sussurri di Obscene, che sfociano
in urla strozzate su uno sfondo musicale quasi doom
metal. Non ci sono confini che tengano in questo terremoto di metamorfosi che più che distruggere, però,
costruisce. Una trasformazione figlia di una stagione
felicemente creativa che ha segnato irreversibilmente
il nuovo corso del rock.
Daniele Follero
Rearview Mirror /
141
Yakuza
di Sydney Pollack (USA, 1975)
The night is lovely, dark and deep, but I have promises to
keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep.
Robert Frost (Stopping By Woods On A Snowy
Night)
La fortuna critica di Pollack è stata incostante.
La mia Africa, che pure vinse sette Oscar, in
patria è piaciuto a pochi e altrove è sempre stato
considerato un gran drammone romantico/turistico. I film successivi, Havana e Il socio, hanno provocato reazioni alterne sia di critica che di
pubblico. Sabrina è stato stroncato e gli ultimi
due - a parte l’interessante documentario Frank
Gehry - sono passati alquanto inosservati.
Pochi testi anglo-americani sulla New Hollywood – periodo nel quale Pollack inizia la sua carriera cinematografica, dopo essere passato dalla
recitazione e dalla regia televisiva - lo citano e, sia
in Francia che in Italia, i critici hanno cominciato ad occuparsene solo dal suo quinto film, Non
si uccidono così anche i cavalli? per motivi
del tutto ideologici. Eppure ci sarebbero ben altri motivi per rivalutarlo e riscoprirlo a partire,
magari, da Yakuza. La storia è quella di Kilmer
(Mitchum), ex poliziotto che ha combattuto in
Giappone durante la seconda guerra mondiale,
costretto a ritornarvi, passati venti anni, per un
debito di riconoscenza con Tanner, un amico
americano di lunga data che ha seri problemi con
la yakuza, una spietata organizzazione malavitosa giapponese. Kilmer deve coinvolgere Tanaka
(Takakura Ken), anch’egli uno yakuza, per cercare di sbrogliare la matassa in cui si è cacciato
Tanner. Anche Tanaka, per altro, è legato a sua
142
/ Cult Cinema
volta da un debito d’onore verso Kilmer che negli
anni della guerra gli ha salvato la sorella Eiko,
essendosene del tutto innamorato. Ci sarà poi un
colpo di scena che disegnerà un classico triangolo
d’amore di cui non dico nulla per non rovinare
le cose.
Sempre accade nel cinema di Pollack che il nucleo del film emerga fin dalle prime immagini e
dai titoli di testa. Come dice la prima nota che
scorre sul titolo del film, l’ideogramma Ya-ku-za da pronunciare con l’accento sul primo ‘fonema’
- è costituito dalle tre cifre 8, 9 e 3 la cui somma
è 20, numero che indica il concetto di “perdente”
nel gioco d’azzardo giapponese. Ma, appunto,
yakuza è anche il nome che venne attribuito a
questo antico gruppo di gangster come segno di
palese sfida alle avversità, manifestazione di orgoglio e, forse, di destino segnato. Questo senso
di perdita è un primo riferimento importante.
Infatti, la logica dell’obbligazione (giri, il debito
di riconoscenza di cui si parlava nella trama) che
sottende tutto il film rappresenta il nucleo del codice d’onore della yakuza e l’ottemperanza ad un
sentimento che non può essere spiegato perché
non è scritto da nessuna parte se non dentro al
proprio animo (…if you don’t feel it, you don’t have it,
dice il fratello di Tanaka a Mitchum, come a dire:
è scritto nelle stelle e dentro di te…). Ma questa
obbligazione sta anche nel saper fronteggiare le
sue estreme - inevitabili - conseguenze: perdita,
sconfitta, sacrificio, abnegazione. Questioni di
natura morale soprattutto più che religiosa o mistica; non si tratta, infatti, di un atto di fede o di
ricerca della salvezza ultraterrena quanto, invece,
del senso morale più puro, quello che appartiene all’individuo e a lui solo, come singolo, essere
pensante che agisce secondo un dettato interiore, una forma intima di persuasione, in un certo
senso, intuitiva. Il risultato di un’azione rimanda,
quindi, all’assunzione di una responsabilità verso
se stessi principalmente e questo risultato rappre-
senta sempre una perdita o una sconfitta. Qui la
salvezza come premio ultraterreno non c’entra
nulla: è solo un fatto individuale che nasce dalla
coscienza di un singolo e che disdegna il fatto di
essere la manifestazione di un destino superiore.
In sostanza da questa scelta non ci si aspetta nulla
in cambio: è quello che è e basta, qualsiasi conseguenza comporti. È tipico, si sa, della tragedia
Cult Cinema /
143
(classica) fare cose inopportune e a me non convenienti, con sfregio di qualsivoglia conseguenza
strumentale. Ma è qualcosa che deve pur essere
fatto se, a monte, esiste una colpa, una tara morale. Non è, in questo senso, una forma di pura
ipocrisia la scappatoia cristiana della confessione? Come può un banale ‘chiedo scusa’ riparare
ogni cosa?
La primissima immagine che compare rossa su
sfondo nero, è l’immagine del “crisantemo” e
della “spada” che già costituivano il titolo di uno
studio antropologico commissionato dal governo
americano a Ruth Benedict sulla cultura giapponese (La Polla). Non a caso questo riferimento
potrebbe essere interessante dal momento che il
film di Pollack è il risultato di un accurato studio
delle usanze e dei codici di una subcultura, quella
della mafia giapponese e, più in generale, delle
regole di comportamento estremamente formali
dell’intera popolazione. Il film, infatti, non è solo
un racconto umanistico sull’obbligo morale e
sull’integrità, quanto anche, in modo pienamente
pollackiano, un incontro/scontro di culture differenti affrontato con occhi davvero affascinati.
La sequenza dei titoli di testa, per esempio, è un
ossequio, anche se un po’ ingenuo, all’arte del tatuaggio: sono riflessi d’inchiostro rosso immersi
nell’acqua. I giapponesi hanno un vero e proprio
culto per la forma, i colori e l’aspetto esteriore
dei concetti con cui danno senso alla realtà. Per
trovare un corrispettivo visivo a questo mondo
Pollack ha potuto contare su due presenze molto
importanti in molti suoi film: la musica di Dave
Grusin e la scenografia di Stephen Grimes. Il
primo è riuscito a mescolare note jazz, piacevoli
all’orecchio occidentale e molto amate in Giappone ad elementi esotici: note sparse nel flauto
basso intervallate da colpi in Pianissimo del gong
(Comuzio) di grande efficacia quando contrapposte alle veloci scene d’azione violenta. Ma anche
Grimes, instancabile production designer di Pollack, ha realizzato il décor e le scenografie secondo un approccio estetico tipicamente giapponese
144
/ Cult Cinema
pur senza mai sconfinare nel documentarismo. Il
fatto che poi Pollack si avvalesse di un direttore
della fotografia giapponese (col quale riusciva a
comprendersi tramite un codice con sei valori di
grigi dal più chiaro al più scuro) ha ulteriormente spinto nella direzione di un’estetica orientale.
I direttori della fotografia giapponesi lavorano,
infatti, costruendo l’ambiente come se fosse un
quadro, partendo dall’angolo basso a sinistra e
costruendo punti e fasci di luce. Al contrario gli
americani lavorano sull’ambiente generale per
creare un’atmosfera di fondo.
Ma diremo subito, a scanso di equivoci, che Yakuza è un film profondamente americano. Non
solo perché la focale è questa e si orienta su un
oggetto altro, il Giappone, ma anche perché è
intriso di stilemi tipicamente americani. Certo
il punto di partenza è il genere giapponese del
film di yakuza (scene al cimitero, coreografia basata sul katana, famosa spada affilatissima, vicende che vedono il protagonista, in genere appena
uscito di prigione, ritornare all’azione per vendicarsi) ma è anche virato su modi e temi che, oltre
ad essere classicamente presenti nel gangster film
americano, sono anche molto pollackiani: la violenza principalmente che fiorisce dalla più lunga
tradizione e la riflessione sul tempo che, invece, è
un marchio di fabbrica del cinema di Pollack. Sul
primo tema. Il fatto che l’originaria sceneggiatura
fosse di Paul Schrader (Hard Core, Il bacio
della pantera, Mishima, Affliction) avrebbe
portato il film in una direzione diversa; direzione che Scorsese avrebbe ben voluto alimentare,
dimostrando, come fece, il suo interesse per lo
script. Ma la Warner decise di ripiegare su Pollack che era allora un regista più conosciuto. La
violenza – tema classicamente americano – non
è un ambito nel quale il nostro si sente completamente a suo agio. Il suo, è stato detto, è un cinema che affronta in modo obliquo gli argomenti, è
ellittico, allegorico, eufemistico (La Polla) e spesso
solo apparentemente parla di una cosa, in realtà
sta affrontando tutt’altro. Questo è il suo ‘tocco’.
Tant’è che nelle sue mani la sceneggiatura subì
una diversa sorte passando prima sotto un’opera
di rimaneggiamento fatta da Robert Towne. Il risultato fu che la violenza estrema dai toni pulp di
Schrader subì un arresto e - come accadde per il
film Corvo rosso e poco dopo per I tre giorni del Condor - si appoggiò quasi interamente
sugli stacchi di montaggio. Lo si nota, per esempio, quando Kilmer spara all’ex amico traditore
Tanner in una scena che deve molto, tra l’altro,
ad una analoga del film di Boorman, Senza un
attimo di tregua. È pur vero che nel primo scontro c’è persino un braccio, armato di pistola, che
viene letteralmente mozzato ma è l’unica concessione in un contesto in cui la brutalità viene trasfigurata in una dimensione culturale, antropologica quasi. È lo scontro fra due tipi molto diversi
di azione e di lotta che a Pollack interessa: quello
giapponese, elegante, agile, felino, a volte persino erotico, ripreso come se fosse una danza (cosa
che, di fatto, è) e quello americano fatto di esplosioni e pistole, rozzo, sbrigativo, goffo e iperbolico. Non è, quindi, la violenza di Scorsese, che
è molto spesso di natura estetica e formalmente
perfetta, scientifica, non è nemmeno quella di
Peckinpah, che ha una natura ‘ideologica’ ed
è sempre segnata dal tema anarchico/romantico.
La violenza di Pollack è ellittica e, in questo caso,
pretesto per mettere in scena ciò che veramente lo riguarda: l’incontro con l’altro. Cosa che ci
porta al secondo tema pollackiano di cui volevo
parlare: il tempo.
Quasi sempre i suoi film ruotano attorno ad una
specie di casuale incontro, un incrocio di destini che sono destinati a consumarsi nel breve
arco temporale, a volte, come ne I tre giorni
del Condor, si tratta addirittura di poche ore
trascorse prima di lasciarsi definitivamente. Più
spesso succede che gli amanti s’incontrino di
nuovo ma il destino di separazione non cambia
e, comunque, si deve sempre scontrare con una
forma ideale. Tempo passato (come eravamo), la
nostalgia, il ricordo: qualcosa di definitivamente
perduto e ugualmente presente. Il più delle volte
è un sentimento d’amore ma non è sempre così.
In un certo senso i suoi protagonisti sono sempre
sfasati rispetto ad un eventuale presente e vivono nell’ossequio di un codice antico, di un amore
idealizzato, di un momento felice della vita ormai
consumato (in questo Pollack si rivela davvero il
Truffaut americano). Mitchum, in Yakuza,
torna in Giappone per un vero e solo motivo di
fondo: l’amore perduto ma sempre vivo verso
una donna. E, in questo senso, è davvero esemplare la sequenza di montaggio - di cui Pollack
è sempre stato grande esecutore - in cui Kilmer
ed Eiko si scambiano gesti d’amore e di dolcezza
di fronte ad un vecchio album di fotografie. Qui
- di fronte ad un passato che, ripresentatosi, non
sembra (mai) all’altezza delle aspettative, degli
anni passati a sognarlo, a cercare di riviverlo - la
sensazione di vuoto lasciata dal consumarsi del
tempo si mescola al dubbio su di sé, sulla propria
inadeguatezza, sul fatto di non essere più capaci
di cambiare insieme alle cose che il tempo ha irrimediabilmente cambiato. Mi sembra un fatto
molto importante questo dal momento che, chiudendosi così il cerchio che questo film disegna,
anche l’obbligazione di cui si parlava all’inizio,
vive in questa contraddizione: la responsabilità si
assume solo grazie ad una riflessione sul passato
e, nello stesso tempo, si trasforma in un’ipoteca
sul futuro che ti costringerà per sempre ad essere quello che sei, nonostante la perdita (Dedico
questa mia recensione a Franco La Polla, l’uomo
cui devo tutto quello che presumo di sapere sul
cinema).
Costanza Salvi
Cult Cinema /
145
Gran Torino
C lint E astwood (U.S.A. 2009)
La Ford Torino venne prodotta dalla Ford Motor
Company per il mercato americano tra il 1968 e
il 1976 (Wikipedia). Il nome ‘Torino’ deriva appunto dalla città di Torino che era considerata la
Detroit italiana. Nel 1972 subì modificazioni e fu
disegnata secondo uno stile che enfatizzava quella configurazione definita ‘long hood, short deck’
(ovvero cofano lungo, tettuccio corto). Come
molte delle ‘muscle car’ - macchine a due porte
di grande cilindrata e capaci di alte performance – anche la Gran Torino era dotata di forma
aerodinamica con paraurti curvi verso l’esterno e
la parte centrale più stretta. Se osservata dall’alto
ricorda le forme a clessidra di una donna o della
bottiglia della Coca Cola. ‘Coke-bottle styling’ è,
infatti, lo stile di automobili come la Pontiac Gto o
la Dodge Charger, uno stile che aiuta l’aerodinamica
dell’auto e ne conferisce un disegno accattivante: simboli di forza, aggressività, velocità. Certamente di mascolinità, con i loro becchi adunchi
protesi all’esterno per fendere bene l’aria, auto
da maschi, massicce e taglienti, auto veloci, per
scappare, inseguire o rimorchiare. Se la Citroen
Déesse, nei miti analizzati da Barthes, è femmina,
levigata – auto da toccare, farci scorrere la mano
nei larghi solchi di gomma – la Ford Gran Torino,
invece, è cattiva, con quella sua griglia frontale
per proteggere il radiatore (la calandra) che sembra disegnata come il muso dell’orca assassina.
Se, ancora, i finestrini della Déesse sono pannelli
d’aria e di vuoto, con la bombatura delle bolle di
sapone, la Gran Torino ha eroici squarci di vetro
a forma di fiamma sull’acciaio surriscaldato che
ne costituisce la superficie in massima parte. La
Déesse è casalinga, ispirata, cioè, al design sobrio
e confortevole che ne sublima l’utilità; la Gran
Torino va all’avventura, è scomoda, è prestante.
Se la Déesse è l’auto piccolo borghese, di certo
la Gran Torino è l’auto del ribelle. Quanti film
americani negli anni 70 hanno celebrato (o decostruito, fatto a pezzi, esaltato, demistificato…)
146
/ La Sera della Prima
il mito dell’auto: la Chevrolet truccata e la Ferrari
Gto di Strada a doppia corsia, le gare di velocità in
Punto Zero, le fughe ribelli sulle quattro (a volte
due) ruote - tutto poi ripreso da Tarantino. Anche solo nel serial, l’auto rappresenta un appeal
indiscusso: Starsky and Hutch in testa con una
Gran Torino e Hazzard con il Generale Lee
(una Dodge Charger).
Ora voi vi chiederete, magari, cosa caspita starà
facendo e dicendo la Salvi? Perché mi sta parlando di macchine invece di parlarmi di film?
Perché questa Ford Gran Torino che dà il titolo
al film di Eastwood è, in un certo senso, una metafora. A volte si è portati ad intendere una cosa
pur indicandone un’altra: Eastwood è maestro di
understatement (quel suo carattere sommesso e
trattenuto che adesso che è vecchio gli sta anche
meglio) di cui il sottinteso è un importante corollario.
E allora di cosa è metafora? Se mi concedete l’azzardo è addirittura metafora di tre ordini di cose
differenti. Prima di tutto di Kowalski stesso, in
lotta col mondo, che nutre superbamente il suo
disgusto per gli altri; costretto a marcire dentro
uno spazio chiuso di un nitore inquietante, come
la macchina, lucida e senza un graffio, è costretta
a consumarsi dentro un garage. Ma è anche la
metafora di un momento del cinema americano
(ecco di nuovo i 70) visto con gli occhi di chi lo
ha fatto, chi lo ha vissuto in prima persona. Callaghan ne è l’esponente principale: lui è la carogna (Dirty Harry), il giustiziere che segue una
sola legge intima di fronte ai soprusi e alla violenza; la sua giustizia è quella brutale che riporta l’ordine facendosi beffe della legge - quando
corrisponde a burocrazia - e che si cura solo di
picchiare più duro, di sparare prima, di anticipare l’avversario. Nell’ordine morale, se il bene non
appartiene del tutto a Callaghan, di certo il male
sta sempre dall’altra parte. Infine la Gran Torino
è anche una metafora dell’America nella sua fase
di passaggio e di rinascita. Nel corso del film la
macchina esce fuori dal suo garage - dove gia-
ce coperta quando sta per essere rubata da Thao - e comincia
ad ammorbidirsi, diventa quasi
più luminosa. Viene lucidata,
esce sul vialetto di casa. Viene
addirittura prestata, per essere,
infine, ereditata con l’obiettivo
di riprendere la sua strada.
Tre forme e aspetti diversi di violenza, giustizia, morale, Storia,
rappresentati da una macchina
americana, maschile, aggressiva,
sportiva, ribelle, individualista (e
che funziona anche come una
pubblicità tra il pop e il cultivé).
Gran Torino è un film che ha
una cura dello spazio estrema
anche se sembra sommessa,
sotterranea. La cura è talmente grande da diventare geografia. Ci sono le villette a schiera,
separate nettamente, ciascuna
col proprio giardino. Fermo sul
suo prato Kowalski impugna il
fucile contro pericolosi sconfinamenti (ricordate l’inquadratura top shot della gang che sta
importunando Thao? Kowalski,
con un’ironia verbale che arriva dritta dritta da Callaghan,
punta il fucile contro il nemico e lancia anatemi
e minacce). C’è, poi, un front door con un portico dove Kowalski si scola le birre e manda al
diavolo i Hmong considerandoli alla stregua dei
sorci. Mentre sventola la bandiera americana arriva il reverendo che cerca di dargli una lezione
su come i veterani riescano con fatica a superare
le angosce e le ansie provocate dalla guerra (lui
ha combattuto in Corea) ma come possono i semplici precetti di un ragazzo fare breccia nella sua
corazza? Nel suo portico, è stato scritto, Eastwood assomiglia un po’ ad un vecchio Wyatt Earp
ormai macerato dalla rabbia per il mondo che
gli cambia attorno. A volte Kowalski si prende
in giro (il se stesso di prima? Il guerrigliero? O
la marmaglia della gang?) e al posto del fucile
usa indice e pollice. Poi c’è il giardino degli altri
abbandonato all’incuria o, comunque, selvaggio.
Selva da attraversare per entrare in una casa di
estranei, guardarsi in uno specchio e scoprirsi
diversi da se stessi e, magari, ironicamente simili
agli altri. Intanto la Gran Torino viene fuori dal
garage. E mentre lei viene fuori le cose che prima erano inconciliabili appaiono più vicine. Ci
sono, poi, due basements, quello di Kowalski e
quello della scalcagnata famiglia di Thao. È in
La Sera della Prima /
147
questo luogo un po’ sotterraneo, dell’inconscio,
dei ricordi, della memoria che Kowalski trova un
modo per fare da padre al ragazzo e Thao trova
il padre che non ha mai avuto. Poi c’è il back yard
dove si fa il barbecue, la Gran Torino brilla alla
luce e il padre dimostra la sua fiducia al figlio.
Sembra tutto il risultato di una costante divagazione, è meraviglioso come Eastwood centri tutti
i bersagli facendo finta di niente, come se fosse
una specie d’indifferente passeggiata che inaspettatamente porta dritto dritto alla meta. Eccoli lì,
infatti, tutti i suoi motivi: la civiltà e l’individuo,
i rapporti padre/figlio non genetici, la denuncia
della sofferenza degli innocenti, una chiara e netta posizione contro i soprusi di qualsiasi forma e
colore. È nitida l’operazione attraverso cui Eastwood riesce a trovare esatte metafore – oggetti,
spazi, note – che possono concentrare un pensiero. In un certo senso la stessa cosa accadeva
in Changeling, giudicato da alcuni farraginoso,
sbilenco, con una sceneggiatura che metteva troppa carne al fuoco; anche lì quella divagazione e
obliquità poteva dare l’impressione d’inesattezza,
malformazione della messa in scena. In realtà, mi
sembra, Eastwood è un abile traduttore: traduce
la realtà in una forma che veicola un pensiero.
Per cui è entrambe le cose: diretto, nel senso che
i rapporti fra oggetto e pensiero sono diretti, precisi; obliquo, nel senso che pensa per metafore visive. Un esempio è la scena dal barbiere italiano:
allenta la tensione, dilata il ritmo, si concede la
divagazione. Cinema di costume o dramma? Denuncia sociale o analisi sulle differenze etniche?
Ma chissenefrega!
Kowalski è sul suo camioncino e ha appena salvato Sue Lor dalle grinfie di un gruppetto di negri minorati – dovremo pur chiamare le cose con
il loro nome - in vena di scherzare. Chiacchiera
sulla sua provenienza etnica: i Hmong sono una
minoranza sino-vietnamita che stava dalla parte
degli americani durante la guerra, poi, quando
questi ultimi stremati se ne andarono, i Hmong
abbandonati a loro stessi, iniziarono l’esodo, cac148
/ Tune In
ciati dal loro paese (esame di coscienza degli americani, conseguenze delle proprie azioni, denuncia dell’oblio della Storia). Eastwood non è più il
mitografo della nazione quanto invece l’esegeta,
l’interprete, l’analista (Menarini, ‘Segnocinema’
155). È inutile incanalarlo in uno schieramento
politico, in un’ideologia. Inutile fargli dire qualcosa di sinistra per servire un sistema. Tanto lui
fa cinema civile lo stesso anche senza essere un
liberal. Continuando sempre a chiamare le cose
col loro nome. Senza ipocrisie.
Costanza Salvi
The Wrestler
D arren A ronofsky (U.S.A, 2009)
Per molti il wrestling non è nemmeno ascrivibile alla categoria dello sport. Puro show business
costruito sugli istinti bassi della cultura americana, o per dirla in modo più elegante, moderno
colosseo pop-corn dove finti gladiatori fanno finta di darsele di buona ragione. Forse anche per
questa sua natura impura il wrestling al cinema
è un tema assai poco praticato. Il periodo d’oro
è quello degli anni ’80. Dalle macerie di quella
decade riescono a tirarsi fuori in pochi. In quegli
anni Hulk Hogan diventa un simbolo dello spettacolo U.S.A. e getta come i videoclip di Madonna e George Michael, come la pepsi e Michael
Jackson. Hogan fa in tempo anche ad avere un
suo minimo percorso cinematografico. Dà una
mano a Mr.T contro Stallone in Rocky 3, poi lo
avvistiamo in film di cassetta che vanno dritti nel
mercato home video. Robe con alieni, commedie demenziali e via di questo passo. Altrimenti
il wrestler che meglio ha fatto al cinema è quel
Roddy Piper messo da Carpenter contro l’invasione aliena in Essi Vivono e presto caduto,
anche lui, nella trappola della serie B. Il film di
Aronofsky fa i conti anche con questi esempi di
vita, così come con i casi eclatanti di morti illustri
del settore: Chris Benoit, Owen Hart, il recentissimo caso di Test. Non ultimo, questo film si pone
per forza di cose il problema di rappresentare an-
cora una volta, al cinema, lo slancio e la caduta
dell’atleta, quando gli anni sono diventati troppi
e il corpo non ce la fa più. Sotto questo punto di vista, il pugilato è lo sport
cinematografico per eccellenza, da Rober Wise a
Stallone passando per Scorsese. Cinema sportivo con una lente socio esistenziale. Un modo per
narrare dei vinti e mettere in campo tutte gli stratagemmi retorici del melodramma. E’ a questo
punto che il film di Aronofsky evita per un pelo
(e non sempre) l’aria viziata del già visto e si salda
in un tutt’uno con il suo protagonista, un altro
residuato bellico degli eighties: Mickey Rourke.
Pare che quest’ultimo abbia collaborato per più
di qualche riga anche alla sceneggiatura e c’è da
crederci. Quando a Venezia Wenders si è lamen-
tato per le assurde regole del concorso
che impediscono di dare contemporaneamente un premio sia al film che al
suo protagonista, ha implicitamente
ammesso che il film è il suo protagonista e niente più. Da un punto di
vista strettamente registico facciamo
in tempo ad osservare un Aronofsky
in crescita rispetto al disastro di The
Fountain, con uno stile che si sta lentamente asciugando di tutti i precedenti virtuosismi videoclip da cinema
giovanil-indie. Non che si potesse scegliere un registro diverso per un film
classico come questo, ma per la storia
di “The Ram” non dobbiamo sorbirci gli iperrealistici effetti con tanto di
split screen De Palmiani di Requiem
For A Dream. Il film a questo punto diventa puro Mickey Rourke. Sulla
spiaggia, in lacrime, davanti ad una
figlia che non lo riconosce più come
padre (una bravissima Evan Rachel
Wood) narra il manifesto di se stesso,
come “pura carne putrefatta” con addosso i morsi della solitudine. Il film è quindi un dramma esistenziale per un uomo che non riesce ad uscire vivo
dagli anni ’80, perché totalmente ancorato al suo
passato ai suoi anni giovani. La misura della distanza rispetto all’oggi è anche la colonna sonora
del film tutta a base di glam metal (Cinderella,
Motley Crue)… con un battuta che resterà negli
annali: “Quel frocetto di Cobain… non ho mai potuto
digerire quella roba anni ’90. Noi volevamo soltanto divertirci…”. The Ram per fuggire alla solitudine, da
un mondo che lo relega ad un marginale angolo
in una salumeria cerca la compagnia di una spogliarellista (una Marisa Tomei, ancora una volta
da Oscar…) per chiudere tutto sulle note di Sweet
Child O’ Mine dei Gun’s N’ Roses. Alla fine c’è
sempre qualcuno che ci rimane sotto.
Antonello Comunale
Tune In /
149
Lo sciopero ruba la Gazza al Comunale.
Radu Lupu inaugura
il Bologna Festival
Un sciopero degli orchestrali blocca le prime quattro recite della Gazza Ladra di Rossini al Comunale di Bologna, con il
primo cast costretto ad esordire l’ultimo giorno. Esordio senza macchia invece, per il Bologna Festival, che apre i battenti
con un concerto tutto romeno: il grande pianista Radu Lupu accompagnato dalla Filarmonica George Enescu di Bucarest,
diretta da Cristian Mendeal. Di Daniele Follero
La Stagione operistica del Teatro Comunale di
Bologna non trova pace. Neanche dopo l’annullamento di ben due opere dal cartellone, sembrano finiti gli incubi per il sovrintendente Tutino,
contestato da una parte degli orchestrali per sua
la gestione del teatro felsineo, a detta dei manifestanti fallimentare e deficitaria. La polemica,
però, pur prendendo in considerazione una particolare situazione, nasce dalla paura più generalizzata per il sistema dei Teatri-Fondazioni, di cui
si cominciano a percepire le conseguenze. E così,
dopo tante polemiche, con tanto di striscioni di
protesta del personale del teatro, sulla testa di Tutino è caduta anche la scure di uno sciopero che
ha bloccato le prime quattro recite della Gazza
Ladra di Rossini, uno degli spettacoli più attesi
della stagione. Saltate le serate principali, la ripresa dei lavori, in maniera alquanto inconsueta,
è caduta in una delle due serate che prevedevano
la presenza del secondo cast. Un gruppo di giovani cantanti che si è trovato inaspettatamente ad
esordire ancor prima dei protagonisti principali
(tra cui spiccava il nome del tenore Lawrence
Brownlee nel ruolo di Giannetto). Una “prima”
alquanto anomala, che si porterà dietro non pochi strascichi, considerato il fatto che il conflitto
tra le parti in causa non pare affatto risolto. Un
vero peccato, perché lo spettacolo, con la regia
del giovane Damiano Michieletto avrebbe meri-
tato ben altra sorte. Non foss’altro che per l’importanza dell’evento: il ritorno a Bologna della
Gazza dopo centosettantasette anni (!), ovvero
da quel 18 ottobre 1832, quando sul palco del
Gran Teatro di Bologna la grande Maria Malibran vestì i panni di Ninetta. Una rivisitazione,
quella di Micheletto, nata due anni fa per il Rossini Opera Festival di Pesaro e già pluripremiata, grazie alla carica innovativa che il regista
veneziano ha provato ad infondere alla rilettura
dell’opera. A partire dal personaggio della gazza, trasformata in una ragazzina sognatrice e
monella, inserita costantemente nell’azione, alla
quale partecipa con i sentimenti di un umano
più che di un uccello, fino a pentirsi delle proprie
azioni al momento di ristabilire la giustizia nei
confronti dell’abominevole condanna a morte di
Ninetta.L’attualizzazione della messa in scena trasforma i personaggi, pur mantenendo inalterati i
loro ruoli all’interno del dramma. Così, Giannetto diventa un marinaio, innamorato ma con poca
personalità, mentre il Podestà è un criminale mafioso e colluso con il potere, contrastato dal padre di Ninetta, un disertore alla Rambo, che, solo
contro tutti, prova a combattere l’ingiustizia, ma
ne diviene vittima egli stesso. Una chiave di lettura che non evidenzia abusi e in cui le forzature al
testo e il poco rispetto per le didascalie originali
(l’opera comincia e finisce con un’invenzione di
sana pianta del regista, con la ra-gazza a letto a
tu per tu con i suoi sogni e il mondo fantastico dei
giochi) dimostrano sempre di avere una loro coerenza interna e non stravolgono in nessun caso
il senso dell’opera. Il lavoro registico va di pari
passo con la scenografia, che si sviluppa insieme
all’azione attraverso lo spostamento di enormi
colonne cilindriche (le quali, rappresentano di
volta in volta, in base alle esigenze sceniche, una
casa, poi delle enormi bocche di fucile, infine una
prigione) e le variazioni cromatiche degli sfondi
(il rosso del primo atto in contrapposizione al blu
del secondo, che sfocia, nel finale, in un chiaro
e limpido azzurro). La musica, dal canto suo, si
incastra bene nel dramma, anche se non sempre
risulta efficace nei momenti cruciali. Mariotti, comunque, che con Rossini se la cava molto bene,
continua a guadagnare consensi in un ambiente
che pure si aspetterebbe un direttore stabile di
una certa fama. Se non altro per una mera questione di prestigio. Se il Comunale vive momenti di estrema difficoltà, il Bologna Festival, come
ha dimostrato l’apertura della XXVIII edizione,
sembra godere di ottima salute. Ad inaugurare
un cartellone di grande interesse, che, diviso in
tre sezioni (Grandi Interpreti, Talenti e Il Nuovo
L’antico) si estenderà fino ad Ottobre, un esecutore d’eccezione. O forse sarebbe meglio definirlo
una vera e propria celebrità. Già perché il pianista romeno Radu Lupu, entrato ormai nell’alveo
dei grandi artisti della tastiera, è ormai qualcosa
di più di un semplice interprete. Accompagnato
dalla Filarmonica George Enescu di Bucarest, diretta da Cristian Mandeal, il sessantaquattrenne
pianista di Galati, ha dato ancora una volta prova
delle sue grandi doti interpretative del repertorio
classico-romantico, pur non essendosi sprecato
tanto.
Oltre all’esecuzione del Concerto Per Piano E
Orchestra n.3 di Beethoven, Lupu ha concesso
al pubblico che ha affollato il Manzoni, solo due intensi bis, costretto ad uscire di scena solo dopo una
decina di “chiamate” degli applausi. Il suo è un
tocco inconfondibilmente
delicato,
fluttuante,
ma che
sa essere
deciso e
duro, senza perdere la tenerezza, teso
senza che
i numerosi
interventi
personali
c o m p ro mettano in qualche modo il rapporto tra il solista e
l’orchestra. Ma è negli episodi più intimi, quando
è solo, che Lupu da il meglio di se (la cadenza del I
Movimento e i bis) giocando con il tempo a proprio
piacimento e concentrandosi su ogni singolo suono come se fosse un’entità a se stante, un momento
emozionante da vivere intensamente. L’orchestra
Enescu, dotata di un timbro deciso e denso si è
dimostrata all’altezza della situazione, diretta in
maniera impeccabile da Mandeal, sempre attento
a seguire le “licenze poetiche” del pianista per controllare gli attacchi.
Peccato siano passate in secondo piano l’esecuzione iniziale dell’Overture di Egmont, sempre di
Beethoven e della Sinfonia Fantastica di Berlioz. Ma la richiesta del bis anche per l’orchestra,
dopo due ore e mezza piene di concerto, è lì a dimostrare il gradimento del pubblico al di là della
presenza di Radu Lupu. Un gradimento ripagato
con la Seconda Rapsodia Rumena di Enescu
(compositore al quale Mendeal è particolarmente
affezionato), scelta un po’ simbolica, un po’ identitaria, ma, in ogni caso, felice, per salutare il pubblico italiano.
Daniele Follero
a night at the opera /
151
Sant’Andrea
degli Amplificatori
Musica in cantina
Nei bassifondi del centro medievale di Bologna, nascosta in una cantina di una nota strada del capoluogo emiliano, vive
una realtà musicale estremamente interessante, dove la musica si esegue per un piacere comune a pubblico, artisti e organizzatori. E dove l’unico grande escluso è il mercato. Benvenuti nel mondo dei concerti domestici di Sant’Andrea degli
Amplificatori. Di Daniele Follero
“Contemporaneo è colui che riceve in pieno viso
il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo.”
(Giorgio Agamben)
Esiste un luogo, nel cuore della Bologna medievale, dove la musica si libera dai vincoli del business
e del mercato che lo regola; dove la musica diventa una faccenda privata e l’aggettivo “cameristico” riacquista il suo senso più letterale; e dove la
SIAE non è riuscita a stringere la sua morsa tentacolare nel nome di un diritto d’autore sempre più
in discussione. Un luogo come ce ne sono tanti.
“Di queste esperienze in Europa e nel mondo ce ne sono diverse da molti anni. Quella dei concerti privati è una realtà
ormai consolidata” mi spiega Luciano, che insieme
a Domenico e Dominique è l’ideatore del progetto Sant’Andrea Degli Amplificatori. Già, perché
basta una cantina, un impianto di amplificazione
senza grandi pretese e tanta passione per la musica, per realizzare il progetto che i tre “bolognesi” hanno deciso di mettere su quasi due anni fa.
“Nell’agosto del 2007” continua Luciano (disponibilissimo, come anche gli altri due “colleghi” a soddisfare la mia sete di informazioni su una realtà
così realmente underground) “ricevetti una mail da
Z’ev, che chiedeva se fosse stato possibile organizzare un
suo concerto qui a Bologna per settembre. Allora, una sera
parlandone con Domenico e Dominique, nacque l’ipotesi di
organizzare concerti con una programmazione casuale”.
E’ così che nasce Sant’Andrea, dalla volontà e la
voglia di tre giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti, di creare un posto dove poter
fruire della musica che interessasse prima di tutto
loro. Questo posto è lo studio di Domenico, una
cantina nel centro del capoluogo emiliano, adibita
a sala da concerto quando si riesce a contattare
qualche artista, preferibilmente di passaggio in
Italia, se non autoctono. La mia prima curiosità
riguarda il nome. Cosa c’entra l’apostolo Andrea,
figlio di Giona e fratello minore di San Pietro, con
la musica contemporanea? Nulla, ovviamente.
Andrea, come mi spiega Dominique, “è un nostro
caro amico che alla notizia del progetto si è offerto di prestarci l’amplificazione. Il minimo era intestargli la faccenda”. Tutto qui, niente di sofisticato, così come non
è per niente complicata l’organizzazione dei concerti, che non seguono una particolare cadenza
e dipendono unicamente dalla disponibilità dei
musicisti. “Normalmente veniamo contattati dai musicisti
che si trovano a passare in Italia o nei pressi. Il lavoro d’organizzazione è variabile ma mai nulla di troppo impegnativo, dipende sempre dalle richieste che fa il musicista e da
quello che necessita per il concerto che propone. Per quanto
riguarda la programmazione –mi spiega Luciano-, fino
ad ora siamo riusciti a rispettare due tacite regole che ci
eravamo preposti:1) non fare più di due concerti al mese; 2)
fare in modo che questa cosa non diventasse un lavoro/un
peso.” Una volta ingaggiati gli artisti, ci si accorda
con il pubblico tramite una mailing list, alla quale
chiede di iscriversi chi è riuscito a venire a cono-
scenza delle performance (spesso con un semplice
passaparola) e ci si incontra tutti dove “già si sa”,
all’esterno dell’isolato. I tempi di tolleranza non
sono rigidi, basta presentarsi ad un orario “decente” rispetto a quello prefissato e il gioco è fatto. Il
resto viene da sé e quando il gruppetto di ascoltatori è più o meno sostanzioso (si parla di decine di
persone) si scende tutti giù in cantina e ci si adagia dove capita: divani, tappeti e quant’altro possa
servire a stare comodi. Ad allietare i partecipanti, ai quali viene chiesto un contributo a dir poco
simbolico (che ha lo scopo di rimborsare le spese
ai musicisti), c’è anche del vino e qualche birra,
come se ci si trovasse ad una festa. Insomma, l’atmosfera è di quelle che si trovano negli ambienti intimi, tra amici e conoscenti che condividono
una passione con gli stessi organizzatori, i quali un
secondo dopo le presentazioni di rito, diventano
essi stessi appassionati fruitori. A
pl ace for contemporary music
La rassegna ha come sottotitolo “A place for
contemporary music”, un luogo per la musica
contemporanea. Ma qui l’aggettivo “contemporaneo” non fa riferimento ad un filone storicostilistico, anche se, come sostiene Luciano, “non si
può non riconoscere che un debito, nei confronti di compositori come Varèse, Cage, Stockhausen, Reich.
Io, però, personalmente mi sento più legato all’esperienza
‘non scritta’ delle avanguardie, soprattutto alla musica concreta e acusmatica, che vede tra i propri capifila Pierre
Schaeffer, Luc Ferrari, Robert Ashley, Alvin Lucier..”. Per Domenico, invece, l’aggettivo contemporaneo, riferito a Sant’Andrea, vuole
essere “una semplice identificazione dell’oggi, che non ha
nessuna pretesa di essere sinonimo di innovativo e, di conseguenza, negare il passato”. Nessuna connotazione
storica, né vincoli stilistici, dunque. Contemporaneo è il qui ed ora della musica. Punto e basta.
i cosiddetti contemporanei /
153
nere, giurano gli organizzatori, in coro. Anche se,
ci tiene a precisare Dominique “sia ben inteso che
questo nostro modo di fare, non è un atteggiamento, un
rifiuto o una negazione delle istituzioni o cose del genere.
Non c’è nessuna volontà politica nel carattere della nostra,
chiamiamola così, impresa. Solo una naturale inclinazione: un approccio che soddisfa immediatamente la nostra
aspettativa”.
La
O meglio, Punto e a capo. Perché qui parte la
musica e comincia il bello.. Ciò che accomuna gli
artisti che hanno risposto all’appello non è un genere musicale, uno stile, né una posizione politica
rispetto al mercato musicale, quanto un’attitudine alla sperimentazione radicale, che non prevede limiti, se non logistico-strutturali. Per quasi
due anni, fino ad ora, si sono alternati sul “palco”
di Sant’Andrea musicisti più o meno noti, italiani
e stranieri, tutti disposti ad offrire un’oretta della
propria arte in cambio di attenzione e buona disposizione all’ascolto. Tra questi, spulciando nella
programmazione, si ritrovano anche nomi di una
certa fama, come lo statunitense John Duncan,
il giapponese Toshimaru Nakamura (che può
vantare collaborazioni con il fondatore del collettivo AMM Keith Rowe) e il chitarrista chicagoano David Daniell, noto ai più per aver partecipato al progetto 100 Guitars di Rys Chatam
e aver collaborato con gente come Thurston
Moore. A questi personaggi “accreditati” si
sono alternati, in nome di un’assoluta parità di
spazio e attenzione, musicisti altrettanto interessanti anche se meno noti, come il suonatore di
tuba Robin Hayward, Katsura Yamauchi,
attivo nella scena free jazz giapponese e i “nostrani” Francesco Cavaliere, Stefano Pilia (di
¾ Had Been Eliminated), Salvatore Arangio, Renato Rinaldi, Claudio Rocchetti (ma
l’elenco dovrebbe essere molto più lungo). Glitch,
computer music, audio-installazioni, fields recordings, noise, free improvisation, acusmatica: tante,
diverse modalità di approccio alla sperimentazione, più che generi musicali comunemente intesi,
che creano il substrato sul quale si costruiscono le
performance dei singoli artisti. Performance quasi sempre individuali, anche se in alcune occasioni
i musicisti si sono esibiti anche in duo (come nel
caso di Seijiro Murayama e Renato Rinaldi).
Una modalità che ricorda, rimanendo sempre in
territorio bolognese, i concerti di Angelica. Ma,
attenzione, “nessun rapporto” con istituzioni del ge-
necessità artistica dell ’ intimo
Per le caratteristiche descritte fin qui, Sant’Andrea potrebbe rappresentare l’estremo opposto
degli eventi di massa: nessun interesse commerciale, nessuna rigidità nella programmazione, assoluta libertà di scelta degli artisti e, da parte loro,
nessun vincolo alla performance, tranne quello
dello spazio a disposizione. Una scena già vista
negli ambienti più underground e avant-garde,
spesso accusati di un elitismo che esclude il grande pubblico creando delle nicchie autocratiche.
Accuse spesso ingiuste, se si tiene conto del fatto
che la musica e il suo messaggio non sono necessariamente giudicabili in base al consenso. Da
questo punto di vista i tre organizzatori hanno le
idee chiare nel negare qualsiasi tipo di contrapposizione tra i due piani, quanto piuttosto, una
distinzione netta, una chiara e pacifica alterità
di due modi completamente diversi di concepire la musica. “Credo che alcune cose vadano assorbite
in un determinato contesto. La massificazione di qualsiasi
forma di cultura, non è necessariamente cultura. D’altra
parte, non credo neanche all’elitarismo come ad un modo di
preservare qualità o libertà di sorta” mi spiega Dominique, mentre Luciano sposta l’attenzione sulla
necessità di certa musica di vivere in contesti performativi di dimensioni ridotte: “credo sia fondamentale il rispetto che si traduce in compostezza, silenzio e
concentrazione, condizione che è sempre utile al musicista
ai fini della sua ricerca, così come al pubblico per un ottimale ascolto. Se alla base della fruizione c’è questo, c’è
anche libertà espressiva. C’è da dire, inoltre, che quando
si propongono musicisti che effettuano spesso operazioni al
limite del silenzio, probabilmente mille persone e uno stadio
non sono il miglior posto per fruire qualcosa del genere”.
E se Sant’Andrea uscisse dalla sua nicchia? Se ad
un certo punto riuscisse, seppure involontariamente, ad uscire dagli argini, a superare i limiti
della cantina di Domenico e di eventi organizzati
per puro piacere? Viene da chiedersi cosa ne sarebbe di un’esperienza del genere se, come è successo in altre occasioni, l’attenzione si allargasse.
Perderebbe la sua natura? Metterebbe in discussione i suoi principi di base? Dominique mi rigira
la domanda: “Un allargamento dell’esperienza, porta
ad una necessaria trasformazione dell’esperienza stessa.
Tutto è possibile, anche cambiare. Ma fino a che punto
è possibile farlo, senza snaturare e dimenticare il punto
da dove tutto è incominciato?” Già, fino a che punto?
Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto, nell’atteggiamento degli organizzatori non c’è nulla che
faccia presagire ad un’intenzione di espandersi.
Tutt’altro. “Facciamo un uso centellinato dei mezzi di
comunicazione. Questo non deriva da un rifiuto o da strane
manie primitiviste. Cerchiamo di non esagerare con pubblicità e cose del genere perché non troviamo siano necessarie
per la buona riuscita di una serata; anzi troviamo che la
cosa sia alquanto controproducente. Lo spazio che abbiamo a disposizione non può contenere un gran numero di
persone, dunque sarebbe inutile dire a mille persone dove si
trova un luogo che può ospitarne cinquanta”. Basta uno
spazio su Myspace e un indirizzo email per venire
incontro alle necessità di tutte le parti in causa. Il
futuro, com’è ovvio in un contesto che vive della
logica del qui ed ora, è incerto. “Il futuro lo conosce
solo il veggente” scherza Dominique. Non un nome
né un’idea. Nessuna certezza, solo un’importante
sicurezza: che Sant’Andrea continuerà a proporre ottima musica… almeno fin quando Luciano,
Dominique e Domenico ne avranno voglia.
Daniele Follero
i cosiddetti contemporanei /
155
ULTIMI ABBONAMENTI
IN VENDITA.
DISPONIBILI BIGLIETTI
GIORNALIERI.
OASIS
GIOVEDI' 16
VENERDI' 17
ALDO LINARES ANNI B SWEET
THE BISHOPS THE CORONAS
GLASVEGAS MYSTERY JETS
NAIVE NEW BEATERS
NO REPLY THE WALKMEN
WE ARE STANDARD
SABATO 18
FRANZ FERDINAND
AEROPLANE BELL X1
ELBOW JOSELE SANTIAGO
LILY ALLEN THE MIGHTY STEF
STEVE AOKI PEACHES TADEO
KINGS OF LEON
BOYS NOIZE JOE CREPÚSCULO
FIGHT LIKE APES
MAGAZINE NACHO VEGAS
NUDOZURDO
PAUL WELLER YUKSEK
DOMENICA 19
THE KILLERS
CATPEOPLE FRIENDLY FIRES
LATE OF THE PIER LAURENT GARNIER
THE PSYCHEDELIC FURS
TV ON THE RADIO WHITE LIES
...E MOLTRI ALTRI
SARA
SERGIO
IERI NOTTE
HO SOGNATO
CHE VOLAVO.
PAOLA
DOMANI DEVO ESSERE
IN FORMA PERCHE'
HO INVITATO LA MIA
VICINA DI TENDA AL
FESTIVAL DI
CORTOMETRAGGI.
QUEST'ANNO MIO
CUGINO SUONA
SULLO SCENARIO
FIBERFIB.COM.
SPAGNA
ESTATE-CORTOMETRAGGI-ARTE
SOLE-MODA-TEATRO-DANZA-SPIAGGIA
ABBONAMENTI IN VENDITA SU TICKETONE.IT
CAMPING GRATUITO DAL 13 AL 21 LUGLIO.
INFORMAZIONI SU TICKETS.FIBERFIB.COM
ORGANIZZA:
SPONSOR PRINCIPALE:
OFFICIAL PARTNERS:
COLLABORATORI ISTITUZIONALI:
MEDIA PARTNERS:
TICKETS:
COLLABORIAMO CON: