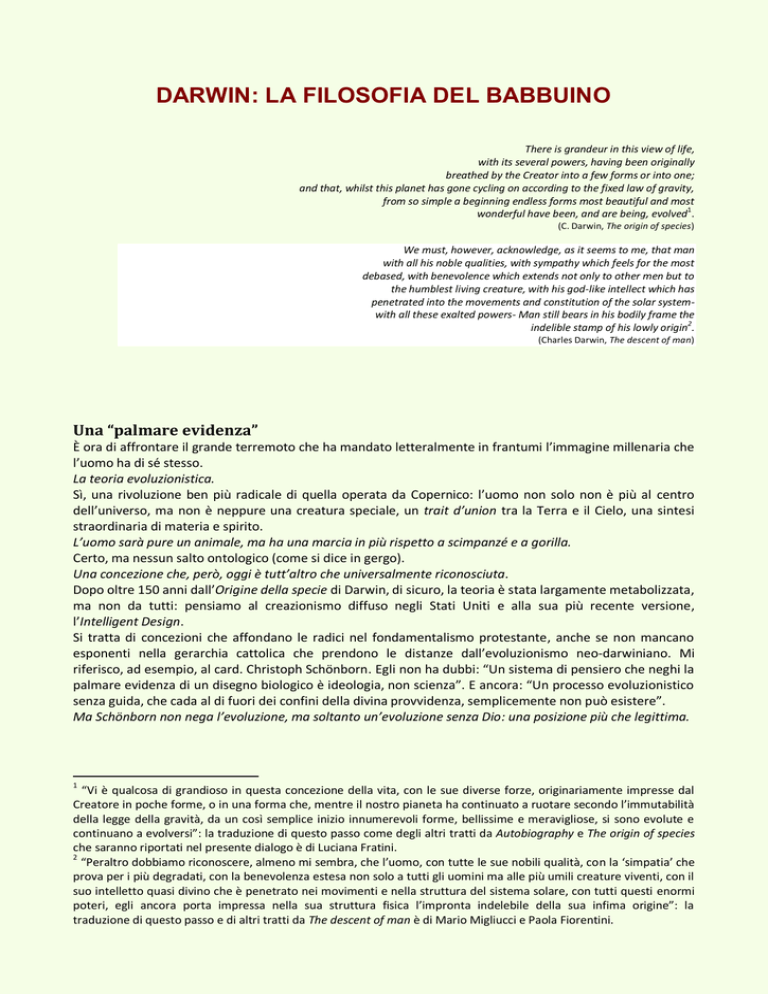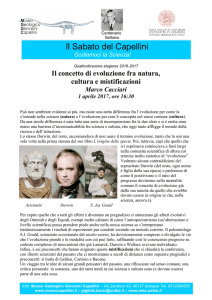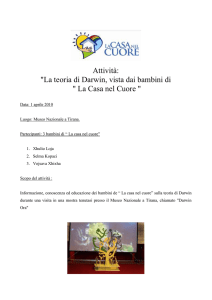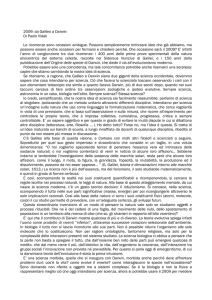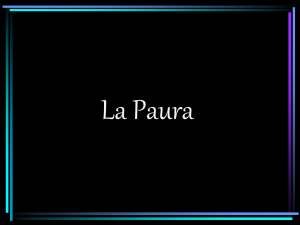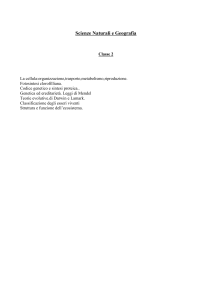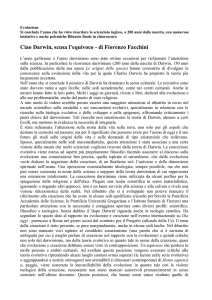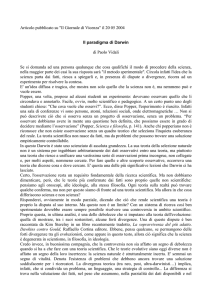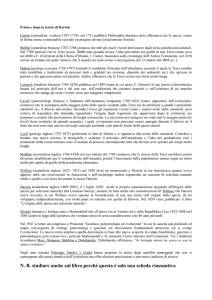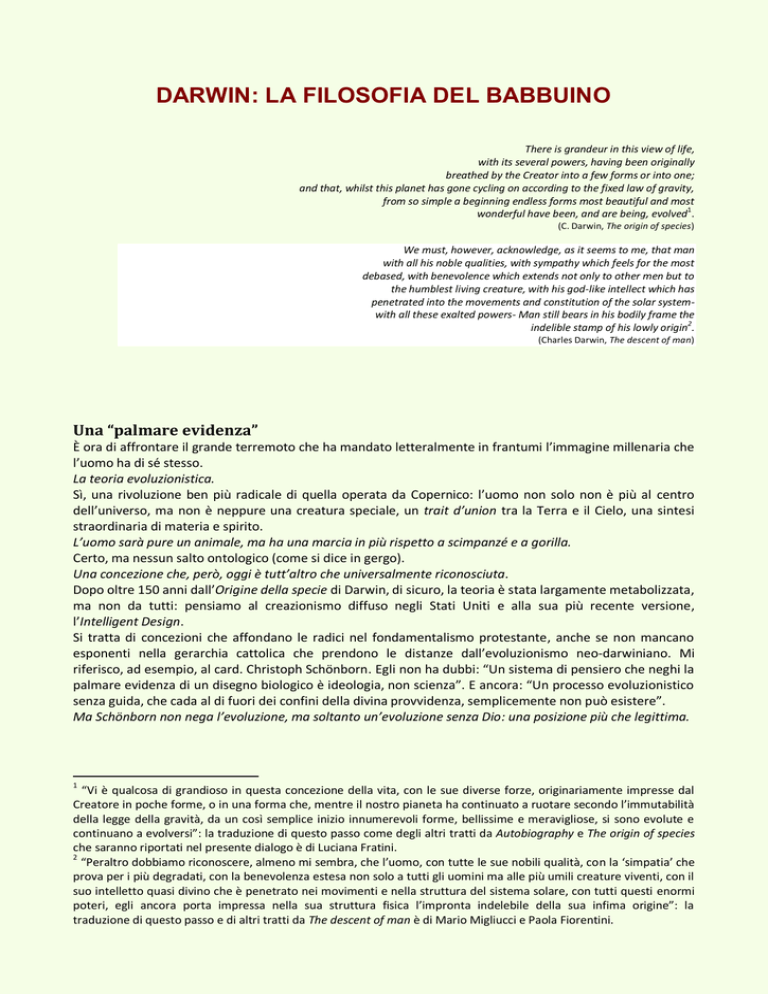
DARWIN: LA FILOSOFIA DEL BABBUINO
There is grandeur in this view of life,
with its several powers, having been originally
breathed by the Creator into a few forms or into one;
and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity,
from so simple a beginning endless forms most beautiful and most
wonderful have been, and are being, evolved1.
(C. Darwin, The origin of species)
We must, however, acknowledge, as it seems to me, that man
with all his noble qualities, with sympathy which feels for the most
debased, with benevolence which extends not only to other men but to
the humblest living creature, with his god-like intellect which has
penetrated into the movements and constitution of the solar systemwith all these exalted powers- Man still bears in his bodily frame the
indelible stamp of his lowly origin2.
(Charles Darwin, The descent of man)
Una “palmare evidenza”
È ora di affrontare il grande terremoto che ha mandato letteralmente in frantumi l’immagine millenaria che
l’uomo ha di sé stesso.
La teoria evoluzionistica.
Sì, una rivoluzione ben più radicale di quella operata da Copernico: l’uomo non solo non è più al centro
dell’universo, ma non è neppure una creatura speciale, un trait d’union tra la Terra e il Cielo, una sintesi
straordinaria di materia e spirito.
L’uomo sarà pure un animale, ma ha una marcia in più rispetto a scimpanzé e a gorilla.
Certo, ma nessun salto ontologico (come si dice in gergo).
Una concezione che, però, oggi è tutt’altro che universalmente riconosciuta.
Dopo oltre 150 anni dall’Origine della specie di Darwin, di sicuro, la teoria è stata largamente metabolizzata,
ma non da tutti: pensiamo al creazionismo diffuso negli Stati Uniti e alla sua più recente versione,
l’Intelligent Design.
Si tratta di concezioni che affondano le radici nel fondamentalismo protestante, anche se non mancano
esponenti nella gerarchia cattolica che prendono le distanze dall’evoluzionismo neo-darwiniano. Mi
riferisco, ad esempio, al card. Christoph Schönborn. Egli non ha dubbi: “Un sistema di pensiero che neghi la
palmare evidenza di un disegno biologico è ideologia, non scienza”. E ancora: “Un processo evoluzionistico
senza guida, che cada al di fuori dei confini della divina provvidenza, semplicemente non può esistere”.
Ma Schönborn non nega l’evoluzione, ma soltanto un’evoluzione senza Dio: una posizione più che legittima.
1
“Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue diverse forze, originariamente impresse dal
Creatore in poche forme, o in una forma che, mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l’immutabilità
della legge della gravità, da un così semplice inizio innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e
continuano a evolversi”: la traduzione di questo passo come degli altri tratti da Autobiography e The origin of species
che saranno riportati nel presente dialogo è di Luciana Fratini.
2
“Peraltro dobbiamo riconoscere, almeno mi sembra, che l’uomo, con tutte le sue nobili qualità, con la ‘simpatia’ che
prova per i più degradati, con la benevolenza estesa non solo a tutti gli uomini ma alle più umili creature viventi, con il
suo intelletto quasi divino che è penetrato nei movimenti e nella struttura del sistema solare, con tutti questi enormi
poteri, egli ancora porta impressa nella sua struttura fisica l’impronta indelebile della sua infima origine”: la
traduzione di questo passo e di altri tratti da The descent of man è di Mario Migliucci e Paola Fiorentini.
Legittima, sì, ma non in ambito scientifico: la scienza, in quanto tale, non può ricorrere all’ipotesi di Dio. È lo
stesso Darwin che ne fa a meno proprio perché l’evoluzione si può spiegare grazie a meccanismi puramente
naturali.
Un disegno intelligente, però, è palese: nel mondo della vita tutto è funzionale a dei fini.
Così appare, ma questo non autorizza a passare dalla sfera naturale a quella della trascendenza.
È un fatto, tuttavia, che la teoria evoluzionistica è rifiutata anche da uomini di scienza: Giuseppe Sermonti,
ad esempio, punta il dito contro una dottrina che è diventata di fatto una religione di Stato.
La scienza è sempre un sapere in fieri, mai un dogma assoluto.
Neppure, allora, l’evoluzionismo.
L’evoluzionismo di Charles Darwin si è a sua volta… evoluto: non è un caso che oggi si parli di neodarwinismo. Siamo già anzi alla terza generazione del darwinismo.
Si tratta, quindi, di una semplice teoria, di una mera congettura che, in quanto tale, non dovrebbe più
inquietare nessuno.
Una teoria, certo, ma ben fondata e che si è arricchita nel tempo grazie alle nuove acquisizioni scientifiche,
dalla genetica alla paleontologia.
Eppure fa ancora discutere.
Tutto previsto. Così Darwin in una lettera indirizzata nel 1871 a Thomas Huxley: “Sarà una lunga battaglia
anche quando saremo morti da tempo […] Tanto efficace può essere l’opera di travisamento”.
Vediamone l’autore.
Un vorace collezionista
Dopo una lunga permanenza in Germania, una capatina in Danimarca e in Francia, torniamo in Inghilterra,
la patria di giganti del pensiero quali Francis Bacon, John Locke, David Hume.
E anche di Isaac Newton e di Adam Smith.
Tutti uomini di cultura che segnano l’avventura culturale di Darwin. Come la segna un altro economista
inglese: Robert Malthus.
Il nostro si definirà un “induttivista baconiano” e sarà decisamente influenzato sia da Hume che dagli
economisti Smith e Malthus. Egli poi, dirà di sé di essere a suo modo un nuovo Newton.
Siamo in presenza di un giovane che, senza dubbio, avrà avuto condizioni di partenza particolarmente
favorevoli.
Certamente: sia il padre che la madre hanno alle spalle famiglie benestanti. Il padre è un medico rinomato
(specializzato nelle malattie mentali). Il nonno paterno, Erasmus, è un personaggio di spicco: medico
personale del sovrano (Giorgio III), filantropo, inventore, autore di un saggio proto-evoluzionista.
L’evoluzionismo, quindi, il nostro lo respira in famiglia.
È vero. Possiamo dire anche che la cultura è di casa: ricchissima, ad esempio, è la biblioteca del padre che
Charles, dopo essere stato educato dalla sorella maggiore, Caroline, in seguito alla morte precoce della
madre, frequenta con grande curiosità.
Sarà stato, immagino, il primo della classe a scuola.
Tutt’altro. A nove anni entra quale convittore nella scuola del dott. Butler a Schrewsbury, la sua città
natale, ma gli studi, di indirizzo prevalentemente umanistico, lo annoiano: l’unico piacere lo riceve da
alcune odi di Orazio (The sole pleasure I ever receveid from such studies, was from some of odes of Horace,
which I admired preatley). Molti anni dopo scriverà che tale scuola è stata per lui “assolutamente priva di
valore educativo”. Attribuisce, poi, ad essa la responsabilità di non essere stato capace in tutta la vita di
servirsi “perfettamente di una qualsiasi lingua”.
Gli studi lo annoiano perché ha altri interessi che lo catturano di più.
È così. Una passione (che nell’Autobiography definisce very strong e clearly innate) lo divora: il
collezionismo. Colleziona conchiglie, coleotteri, farfalle, uova, minerali… Altre passioni: la pesca e la caccia.
Passioni che preoccupano il padre che un giorno lo rimprovera aspramente: “Non fai altro che andare a
caccia, occuparti di cani, catturare topi, e sarai una disgrazia per te stesso e per tutta la tua famiglia” (You
care for nothing but shooting, dogs, and ratcatching, and you will be a disgrace to yourself and all your
family). Per questo lo sottrae presto ai suoi ozi e lo manda a studiare medicina a Edimburgo, in Scozia. È
qui, in un clima particolarmente stimolante (Edimburgo è chiamata l’“Atene del Nord”), legge con voracità
libri di Hume da cui assimila una concezione laica e antimetafisica. Nello stesso tempo si immerge con la
medesima voracità nel saggio del nonno Erasmus. Ma la sua passione principale non si spegne per niente:
egli dedica gran parte del suo tempo a raccogliere insetti, coralli, spugne, molluschi. Gli interessi
naturalistici lo spingono a frequentare un corso di geologia grazie al quale impara a leggere gli strati delle
rocce.
Non studia, quindi, medicina.
Molto poco: tra l’altro, prova disgusto durante le lezioni di anatomia e alla stessa vista del sangue. Non a
caso dopo due anni (Charles ha 18 anni) torna a casa senza avere concluso nulla. Da qui la profonda
delusione del padre che decide di avviarlo alla carriera di pastore evangelico, mandandolo a Cambridge,
decisione ben accolta dal figlio (I liked the thought of being a country clergyman).
Una seconda delusione per il padre.
Questa volta il figlio si laurea, convinto che solo prendendo i voti sacri sia in grado di intraprendere una
carriera nelle scienze naturalistiche. Ma non sono gli studi ecclesiastici a conquistarlo: egli continua a
coltivare la sua passione, stimolato anche dalla lettura di un best-seller, la Natural Theology del reverendo
William Paley. Nella sua Autobiografia così scriverà Darwin: “Ma a Cambridge nessuna occupazione
m’interessò tanto e mi dette tanto piacere quanto la raccolta degli insetti (But no pursuit at Cambridge was
followed with nearly so much eagerness or gave me so much pleasure as collecting beetles)”.
Sotto il profilo strettamente accademico, però, i tre anni trascorsi a Cambridge sono completamente persi,
sprecati. Ma sotto un altro punto di vista sono i più belli (the most joyful) della sua vita felice, anni in cui le
condizioni di salute sono eccellenti e l’entusiasmo è alle stelle. Nel frattempo, poi, si costruisce una sua
cultura parallela, anche grazie al supporto di alcuni istruttori: impara a tradurre con una certa facilità dal
greco sia la versione greca della Bibbia che le opere di Omero. Legge poi numerosi libri di cui due hanno su
di lui un’influenza importantissima: i Ricordi personali di Humboldt e Introduzione allo studio di Herschel.
Una leggenda da sfatare
È nell’ambiente conservatore di Cambridge che il nostro trova le occasioni giuste della sua vita. Tramite il
brillante botanico S. Henslow (un altro reverendo) conosce uno dei più qualificati geologi inglesi, Adam
Sedgwick che lo coinvolge in una spedizione geologica nel Galles, spedizione che gli apre gli occhi sulla
effettiva durata della Terra. Sempre tramite l’intermediazione di Henslow riceve l’invito che gli cambierà la
vita e che lo condurrà alla “rivoluzione” che conosciamo: l’invito ad associarsi all’equipaggio del brigantino
“Beagle” in procinto per partire per un viaggio intorno al mondo con scopi scientifici.
Un’occasione del tutto casuale, fortuita. Un vero e proprio colpo di fortuna.
Infatti. È quanto accade a ciascuno di noi: sono le circostanze fortuite che spesso ci portano a percorrere
una strada invece che un’altra.
Ma certe opportunità si hanno con le conoscenze giuste: Darwin le ha.
Amicizie giuste, ma non solo. Come dice un altro grande scienziato, Pasteur, “Le hasard favorise l’ésprit
preparé”.
Cioè?
La fortuna favorisce lo spirito preparato. E il nostro è indubbiamente pronto a cogliere al volo la fortuna.
Non è, è vero, un geologo e neppure un naturalista di professione, ma a 22 anni ha delle carte da giocare: la
passione di un vorace collezionista in ambito naturalistico, studi di geologia, la capacità di leggere gli strati
rocciosi che ha affinato nella spedizione nel Galles, la curiosità scientifica e il suo acuto spirito di
osservazione. Così intraprende un viaggio affascinante, ma anche pericoloso che durerà ben cinque anni:
l’evento più importante (the most important event) della sua vita.
È nell’arcipelago Galàpagos che ha il colpo di genio che lo porta a intuire la teoria che scuoterà il mondo.
È questa una vera e propria leggenda, creata dalla iconografia darwiniana, che va sfatata. Darwin, durante
le cinque settimane che trascorre alle Galàpagos non ha alcuna illuminazione. Alla teoria dell’evoluzione
giungerà gradualmente, dopo la conclusione del viaggio. E vi giungerà mediante un secondo viaggio,
stavolta mentale, che effettuerà esaminando scrupolosamente gli esemplari da lui raccolti durante la
circumnavigazione del globo.
“Forze stupefacenti”
Esemplari di che tipo?
Esemplari di ben oltre 1500 specie differenti molte delle quali (alcune centinaia) del tutto ignote in Europa:
sono questi che - spediti in Inghilterra nel periodo del viaggio - lo rendono presto celebre ancor prima del
suo rientro.
Uno studioso a metà tra il geologo e lo zoologo.
Etichettare Darwin non è agevole. La teoria dell’evoluzione ha a che vedere con l’ambito strettamente
biologico, ma egli si considera in primo luogo un geologo.
Quale il nesso tra i due ambiti?
Sono proprio le trasformazioni della superficie terrestre esplorate dalla geologia che fanno da sfondo alla
sua teoria.
Trasformazioni che rappresentano lo scenario delle trasformazioni della flora e della fauna.
Infatti. La presenza di fossili di conchiglie sulla cordigliera delle Ande, ad esempio, ne è una prova. Siamo in
presenza di sollevamenti provocati da vulcani. Darwin prova una straordinaria ammirazione per le “forze
stupefacenti” che hanno sollevato la catena montuosa. A lui la geologia offre “le stesse idee sublimi che
l’Astronomia ci dà dell’Universo”.
Lo stesso stupore provato da Kant.
Sì. Stupore che in Darwin si intensifica perché le trasformazioni in questione svolgono un ruolo
fondamentale nella diversificazione delle specie: sono le catene montuose e gli stessi bracci di mare che
risultano dai movimenti della Terra che creano delle barriere naturali che separano specie di vegetali e
animali, contribuendo così alla loro diversificazione.
Come nasce un genio
Darwin è sorpreso dalla grande varietà che si registra pur in ambienti geologicamente simili: nelle isole
Galàpagos, ad esempio, nota differenze significative in testuggini marine (Galàpagos significa appunto
testuggini) e in fringuelli.
Ovunque arriva, il nostro osserva, raccoglie e scrive. A Rio della Plata riesce a realizzare una collezione
pressoché completa di rettili, uccelli e mammiferi. Nella Patagonia trova crani e ossa di un animale
preistorico. Sempre in Argentina scopre dei fossili di un cavallo. In qualunque area, si trova in presenza di
varianti: dalle lucertole acquatiche ai tordi beffeggiatori e ai fringuelli, varianti che individua anche
all’interno del mondo vegetale.
Un osservatore formidabile.
Nell’Autobiografia Darwin dirà che il suo successo come uomo di scienza è dovuto, tra l’altro, alla “gran
diligenza nell’osservare e raccogliere dati di fatto” e un’“infinita pazienza nel riflettere lungamente su ogni
argomento (unbound patience in long reflecting over any subject-industry in observing and collecting
facts)”. È quanto emerge dai celebri taccuini il primo dei quali (taccuino rosso) lo inaugura quando è ancora
a bordo del Beagle. Si tratta di testi che non sono di facile lettura perché di natura privata: a volte si
trovano in essi ragionamenti non conclusi, frasi per nulla lineari. I taccuini, comunque, costituiscono la
testimonianza fresca della creatività di un genio, creatività che, come abbiamo anticipato, non si esprime
con un lampo, ma attraverso una ridda di domande, di ipotesi, di obiezioni (è lui stesso che formula
obiezioni), di ripensamenti.
Un andamento tipico della ricerca scientifica.
Indubbiamente. Darwin si interroga su due generi di dati empirici: da un lato i fossili e, dall’altro, la
distribuzione geografica delle specie. Dati su cui rifletterà a lungo quando, dopo alcuni anni trascorsi a
Londra, si trasferirà a Down House nel Kent dove rimarrà fino alla sua morte (dal 1842 al 1882). Ecco una
considerazione: “Quando uno vede i capezzoli sul petto di un uomo, non dice abbiano un qualche uso, ma
che il sesso non sia stato determinante. Lo stesso per le ali inutilizzate sotto le elitre dei coleotteri […]. Se si
trattasse di una semplice creazione, di certo sarebbero nati senza” 3.
C’è già qui in nuce quanto dirà nelle sue opere.
3
La traduzione dei passi tratti dai Taccuini è di Isabella C. Blum.
Sì. Parlando poi dell’uomo e degli animali Darwin li definisce “compagni, fratelli in dolore, malattia, morte e
sofferenza e pena” che condividono un progenitore comune, idea che svilupperà ne L’origine dell’uomo del
1871.
“Qualcosa che potrebbe ribaltare l’intera metafisica”
Man mano maturano le sue convinzioni, egli le condivide con un gruppo ristretto di persone, tra cui la
moglie Emma, una donna colta e “saggia consigliera” della sua vita. La sua non è una scelta dettata soltanto
dal timore di esporsi, ma anche dall’esigenza di trovare ulteriori conferme. Non c’è dubbio, comunque, che
è ben consapevole della portata della sua teoria. Non a caso nei taccuini parli di “qualcosa che potrebbe
ribaltare l’intera metafisica”.
La tesi secondo cui l’uomo è un animale evoluto.
Una tesi sicuramente sconvolgente per la tradizionale interpretazione della Bibbia.
Egli si affretta ad affermare che “quando parliamo di ordini superiori, dovremmo sempre dire
intellettualmente superiori”.
Ma è proprio questo che stacca notevolmente l’uomo dagli animali superiori: anche lo scimpanzé più
sviluppato è lontanissimo dall’avere la potenza intellettiva dell’uomo.
Certo, ma questo non autorizza l’affermazione secondo cui l’intelligenza dell’uomo è il fine dell’universo.
Così Darwin scrive: “Ma chi, al cospetto della Terra ricoperta da splendide savane e foreste, oserebbe dire
che l’intelletto è l’unico scopo di questo mondo?”
Il finalismo, tuttavia, nella natura è evidente. Basti pensare a quella meraviglia funzionale che è l’occhio”.
Il nostro lo riconosce: la perfetta organizzazione dell’occhio, forse, è “la più rande difficoltà” di tutta la sua
teoria (taccuino C), un problema di fronte al quale sente un “brivido freddo”.
Un segno di onestà intellettuale.
Certamente. Così egli si esprime: “Supporre che l’occhio […] possa essersi formato per selezione naturale,
sembra, lo ammetto francamente del tutto assurdo” (To suppose that the eye […] could have been formed
by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree)”. Nello stesso tempo, però, in
privato considera “sciocchezze” certe tesi della teologia naturale.
La creazione di ogni specie da parte di Dio.
Sicuramente. Il 16 agosto 1838, due anni dopo il rientro in Inghilterra, così scrive: “Non è all’altezza della
dignità di Colui che si presume abbia detto ‘Sia fatta luce’ e luce fu immaginare che Egli abbia creato una
lunga successione di vili animali molluschi”. In particolare è dell’avviso che la teologia naturale non sia in
grado di spiegare come mai una stessa specie abbia così tante varianti in ambienti del tutto simili.
È convinto, cioè, che Dio non c’entri.
Infatti: egli ritiene che sia le varianti (anche la presenza in America latina di due specie di nandù) che la
derivazione di specie animali da un antenato comune abbiano una spiegazione naturale.
La mano invisibile
Quando ha l’intuizione della “selezione naturale”?
L’espressione “selezione naturale” sarà usata solo nel 1842, ma già diversi anni prima egli non ha dubbi che
ci sia una competizione all’interno della specie ed è questa competizione che ha un compito selettivo.
Per competere c’è bisogno di avere qualche carta in più da giocare.
È così: sono le varianti spontanee che accadono in natura che rendono alcuni individui più competitivi
rispetto ad altri.
Qui troviamo la competizione di cui parla l’economista Adam Smith.
Di sicuro: Smith, nella sua Ricchezza delle nazioni, fa della competizione il motore del cambiamento. Darwin
è influenzato da Smith, ma anche, ancor di più, da un altro economista inglese, Robert Malthus (di cui legge
nel 1838 l’opera più importante: Essay on the Principle of Population) secondo cui l’incremento spontaneo
della popolazione presenta un andamento geometrico (1, 2, 4, 8…), mentre l’andamento della produzione
di risorse alimentari è di tipo aritmetico (1, 2, 3, 4…).
Si ha quindi una lotta per la sopravvivenza.
Sopravvive chi è più idoneo.
È questa la selezione naturale.
Sì. Si tratta di comprendere bene in che misura Darwin si distingue da Lamarck. Prendiamo il classico
esempio delle giraffe: secondo il francese è l’ambiente (un habitat in cui per sopravvivere occorre brucare
le foglie degli alberi) che determina l’allungamento del collo, mentre secondo Darwin è in natura che
nascono giraffe che, avendo un collo più lungo delle altre, acquisiscono un vantaggio nella lotta per la
sopravvivenza.
Siamo in presenza di una selezione analoga a quella che effettuano gli allevatori che, grazie a degli incroci,
realizzano dei nuovi esemplari.
Certo, mentre però la selezione “artificiale” ha una durata brevissima, quella “naturale” richiede migliaia o
addirittura milioni di anni.
È il fattore tempo che consente l’evoluzione.
Darwin non utilizza il termine “evoluzione” (neppure nel suo capolavoro L’origine della specie del 1859):
questo perché nella sua epoca il termine indica solo l’evoluzione individuale che procede verso un fine
(l’uomo adulto), mentre l’evoluzione della specie non registra alcuna finalità. Precisa che lo stesso termine
“selezione”, “nel senso letterale della parola” è erroneo: non esiste, infatti, alcuna volontà consapevole di
operare una selezione.
Sgombra cioè il campo da una possibile personificazione della natura.
Una personificazione - puntualizza - che è difficile da evitare. Del resto anche in chimica - prosegue - si parla
di “affinità elettive” degli elementi. Si tratta di “espressioni metaforiche” che sono quasi necessarie per
ragion di brevità”. Per natura egli intende nient’altro che “l’azione combinata e il risultato di numerose
leggi naturali”.
Siamo nel cuore della teoria.
Sì. Darwin rimarca anche la tesi secondo cui la “selezione naturale” è stata “l’agente principale, ma non
unico, della modificazione”.
Mette le mani avanti.
Sì, uno scienziato non può chiudersi nella sua teoria.
Più riflette, comunque, più è convinto che in natura, non opera alcuna mano divina: le forze della natura,
quando sprigionano la loro potenza distruttiva, non guardano in faccia a nessuno.
È il punto di vista che abbiamo incontrato nell’Etica di Spinoza: la natura procede in modo necessario e sono
gli uomini che si sono messi in testa di essere il fine dell’universo.
In Darwin troviamo non soltanto la necessità, ma anche la casualità: le varianti che si colgono in natura
accadono casualmente.
Se non c’è la mano divina, c’è la “mano invisibile” di cui parla Smith.
In effetti, alcune varianti, offrendo dei vantaggi nella lotta per la sopravvivenza, diventano un fattore di
selezione.
Una evoluzione che - lo sappiamo a posteriori - crea un progresso: un conto è lo scimpanzé e un conto
l’uomo.
Vi sono, però, specie che sono rimaste invariate – pensiamo ai batteri – anche dopo miliardi di anni.
Perché sono ben adatte al loro ambiente.
È così: non esiste negli animali alcuna tendenza innata a progredire.
Una presa di distanza, anche per questo aspetto, da Lamarck.
Infatti. La teoria lamarckiana, tra l’altro, si fonda su un presupposto che si è dimostrato senza fondamento:
l’ereditarietà dei caratteri acquisiti.
Menti “teleologiche”
Darwin, quindi, nella… competizione con Lamarck, vince.
Sì, ma egli non sa nulla delle cause delle varianti (la genetica avrà uno sviluppo impetuoso nel Novecento e
Darwin probabilmente non conosceva neppure la teoria di Mendel, pur coevo). Vi è poi dell’altro che non
quadra: la durata della Terra allora nota (circa 30 milioni di anni) è del tutto insufficiente a spiegare i tempi
lunghi dell’evoluzione, tempi che, secondo lo stesso Darwin, dovrebbero essere almeno dieci volte
superiori. Un problema, questo, che per lui costituirà un cruccio fino alla sua morte. Ma le acquisizioni della
geologia già note al suo tempo gli sembrano sufficienti a indicare la strada da percorrere. Lo dice
chiaramente: “La credenza che le specie fossero immutabili fu quasi inevitabile finché si ritenne che la
storia del mondo fosse di breve durata (of short duration)”.
Non quadra, neppure, la perfetta organizzazione dell’occhio.
Il nostro è convinto che se non si potessero scoprire le numerose modifiche che tale occhio ha registrato
nel tempo, tutta la sua teoria cadrebbe.
Modifiche che non si sono trovate.
Si cercano ancora oggi, ma Darwin non ha dubbi che si troveranno.
Una fiducia, questa, che non ha nulla di scientifico.
Il nostro è ben consapevole della difficoltà del problema. Così si esprime: “niente può sembrare più difficile
che credere che i più complessi organi e istinti si siano perfezionati […] per l’accumulazione di innumerevoli
variazioni (by the accumulation of innumerabile slight variations), ciascuna utile al loro possessore
individuale”.
Già, ma queste variazioni vanno trovate.
Darwin ritiene di avere, comunque, già alcuni indizi seri in proposito: “in natura osserviamo tante strane
gradazioni, che dovremmo essere estremamente cauti ad affermare che un organo o un istinto, o un’intera
struttura, non possono aver raggiunto il loro stato attuale attraverso numerose tappe graduali (by many
graduated steps)”.
Ma anche lui dovrebbe essere cauto, in assenza di “fatti”, ad affermare una tesi così impegnativa.
Egli è talmente convinto che utilizza lo stesso discorso anche a proposito della derivazione di specie da
altre: “la causa principale della nostra riluttanza ad ammettere che una specie abbia dato origine a altre e
distinte specie, dipende dal fatto che siamo lenti ad ammettere grandi cambiamenti di cui non vediamo i
gradi”.
Ma lui è certo che prima o poi tutti i casi apparentemente inspiegabili saranno spiegati in modo naturale
come effetto di piccole e numerose modificazioni. Sa che non sarà facile anche perché, secondo lui, noi
uomini abbiamo delle menti teleologiche, siamo portati cioè a pensare all’occhio come una sorta di
telescopio, vale a dire un manufatto artificiale costruito intenzionalmente dall’uomo.
Non quadra, poi, il fatto che nei lunghi processi dell’evoluzione di specie da altre mancano spesso gli anelli.
Anche in questo caso egli ha fiducia che prima o poi la paleontologia li troverà.
Nel 1842 scrive un breve riassunto di sole 35 pagine. Nell’estate, poi, del 1844 sintetizza la sua teoria in un
testo di 230 pagine, testo corredato da una lettera per la moglie con l’indicazione precisa di aprirla solo
nell’eventualità di una morte improvvisa.
In questo modo, però, tenendo tutto segreto, rischia di perdere la competizione con un altro naturalista,
Wallace, che nel 1858 gli fa pervenire un testo di venti cartelle che presenta una teoria del tutto simile alla
sua (così scriverà nell’Autobiografia: this essay contained exatly the same theory as mine).
Un colpo per Darwin.
Certo. La sua teoria l’ha tenuta nel cassetto per 21 anni ed ora rischia di farsela soffiare da un naturalista
dilettante. Il nostro confessa sconsolato al naturalista Lyell: “Se Wallace avesse avuto il mio abbozzo
manoscritto, redatto nel 1842, non avrebbe potuto farne un riassunto migliore”. È Lyell che suggerisce una
soluzione onorevole che toglie Darwin dall’imbarazzo: propone che le due teorie vengano presentate
contemporaneamente in una riunione straordinaria della Linnean Society. Così accade il primo luglio 1858:
sono resi pubblici il saggio di Wallace, il manoscritto di Darwin del 1844 e il testo Natural Selecion che il
nostro aveva fatto pervenire al botanico americano Asa Gray.
È questo fatto, quindi, che accelera la pubblicazione del capolavoro di Darwin.
Sì: L’origine della specie per selezione naturale (500 pagine) viene pubblicato il 24 novembre 1859.
Un successo editoriale, immagino.
La tiratura non ha nulla a che vedere con le tirature di successo di oggi: si tratta di 1250 copie che vengono
esaurite in pochissime ore a un prezzo tutt’altro che popolare (14 sterline, all’incirca un quarto del salario
medio di un lavoratore). Escono poi altre edizioni. Anche numerose traduzioni (perfino in boemo, polacco,
russo). Nel 1876 – lo scrive egli stesso nella sua Autobiografia – ne ha vendute 16.000 copie. Sono tutte
edizioni riviste e aggiornate da lui stesso. L’espressione “sopravvivenza del più adatto”, suggerito dal
filosofo Herbert Spencer, appare nel 1869. L’ultima modifica viene apportata nel 1872 quando il nostro
darà il titolo che rimarrà definitivo: The origin of species (il titolo originario: On the origin of species by
means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life).
“Disapprovazione generale”
Le reazioni?
La sua teoria è largamente accettata dalla comunità scientifica (I found that many naturalists fully accepted
the doctrine of the evolution of species) e osteggiata duramente dagli ambienti religiosi paladini del
creazionismo. Osteggiata ancor di più quando Darwin nel 1871 pubblica L’origine dell’uomo (The descent of
man). Una reazione che il nostro si aspetta. Così confida a Mivart: “Mi rendo conto che quando pubblicherò
il mio libro andrò incontro alla disapprovazione generale, se non all’esecrazione. La verità è difficile da
conquistare, per quanto si possa tentare di farlo”.
Una reazione più che legittima: che l’uomo abbia una marcia in più – l’abbiamo già detto – rispetto a uno
scimpanzé o a un gorilla è un dato di fatto.
Secondo Darwn, tuttavia, non esistono qualità esclusivamente umane: vi sono animali che di sicuro hanno
un qualche grado di coscienza, altri che hanno una memoria prodigiosa e capacità imitative; altri ancora che
sanno ingannare, addirittura simulare la propria morte; altri infine che hanno una coesione sociale di gran
lunga superiore a quella degli umani.
Certo, egli non nega che le facoltà mentali dell’uomo differiscono “moltissimo” da quelle degli animali, ma
si tratta - sottolinea - pur sempre di una differenza non di “genere”, ma di “grado” (the mental faculties of
man and the lower animals do not differ in kind, although immensely in degree). Ricorda, anzi, che la
differenza tra l’intelligenza di una formica rispetto a quella di cocciniglia è di gran lunga maggiore.
È la formica che vince in questa gara.
Di sicuro. La femmina della cocciniglia si attacca ancora giovane a una pianta, “ne succhia la linfa […] viene
fecondata e depone le uova: questa è tutta la sua vita”. Le formiche, invece, comunicano tra loro, sanno
riconoscere le compagne “dopo mesi di assenza” […] costruiscono grandi edifici, li chiudono la sera […]
costruiscono sia strade che tunnel sotto i fiumi […] raccolgono cibo per la comunità…”.
Ma tutto questo lo fanno per istinto.
Si tratta, comunque, di una forma di intelligenza: Darwin parla dell’istinto come di una ragione
“dimenticata”. È la stessa organizzazione del corpo - sviluppo embrionale, ossa, muscoli, nervi… - che,
secondo il nostro, mette in evidenza la straordinaria somiglianza che esiste tra l’uomo e altri animali. Così
Darwin si esprime: “Se l’origine dell’uomo fosse stato del tutto diverso da quella di altri animali, queste
varie somiglianze sarebbero soltanto vuoti inganni, ma una simile ammissione è incredibile” (if the origin of
man had been wholly different fron that of all other animals, these varoius appearences would be mere
empty deceptions; but such admission is incredible).
Ma questo non prova che l’uomo sia un’evoluzione di scimmie antropomorfe.
Il nostro parla di “primitivi progenitori” comuni (oggi si ritiene che l’antenato comune a noi uomini e agli
scimpanzé sia esistito in Africa 6 milioni di anni fa).
Vi è chi trova disgustosa questa idea.
È lo stesso Darwin ad affermare che tale concezione può “ripugnare al nostro orgoglio” (revolt our pride).
Egli, però, mette in guardia dal “cadere nell’errore di supporre che il primitivo progenitore di tutto il ceppo
delle scimmiadi, incluso l’uomo, fosse identico (identical), o anche strettamente somigliante (closely
resembled) , a qualche scimmia superiore o inferiore esistente”.
A me pare che Darwin accentui troppo le somiglianze e sottolinei troppo poco le differenze. Pensiamo ai
sentimenti che sono squisitamente umani.
Egli, in un’opera del 1872, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali (The expression of the
emotions in man and animals), riprendendo delle considerazioni scritte in un taccuino del 1838, affronta
questo tema per dire che, anche sotto questo profilo, vi è una continuità tra animali e uomo: tutti gli esseri
senzienti condividono non soltanto il piacere e il dolore, ma anche emozioni quali la paura, l’ira, la gelosia,
lo stesso amore.
Ma non c’è paragone tra la povertà delle emozioni di un scimpanzé e la ricchezza di quelle tipicamente
umane.
Senz’altro, ma si tratta pur sempre di una differenza di gradi: non esiste nulla nell’uomo che sia un
patrimonio esclusivamente suo.
Il linguaggio.
Ma anche gli animali comunicano tra loro. Gli animali domestici, poi, riescono a comunicare benissimo con i
loro padroni umani. Lo stesso discorso vale per l’intelligenza - ne abbiamo già parlato - e per il senso
morale. Darwin non si limita a fotografare le affinità, ma ne individua le cause nella lunga storia evolutiva.
Nel taccuino M arriva a dire che “Colui che comprende il babbuino darà alla metafisica molto di più di Locke
(He who understands baboon would do more towards metaphysics than Locke)”.
Ma sono ambiti del tutto distinti.
In linea di principio, sì, ma è un fatto che Darwin manda all’aria montagne di libri di metafisica. Saranno poi
le crescenti acquisizioni delle neuroscienze a mettere in discussione lo stesso concetto tradizionale di
“anima”. Darwin ha aperto la strada nella direzione di un approccio squisitamente naturalistico, approccio
che negli ultimi anni si è particolarmente sviluppato.
Darwin, però, ha costruito un edificio - quello della sua teoria - senza fondamento: non è in grado di
spiegare le cause della enorme variabilità individuale che vi è in natura, variabilità senza la quale non vi
sarebbe l’evoluzione.
La variabilità sarà perfettamente spiegata dalla genetica.
Rimane, però, pur sempre il mistero del finalismo: così, almeno, appare ai più.
Darwin non riesce a vedere questo finalismo: non riesce a immaginare come un Dio infinitamente buono e
onnipotente abbia previsto e consentito tanta sofferenza; non riesce a immaginare come un Architetto
divino abbia progettato un’evoluzione legata a una serie di circostanze casuali, a eventi del tutto
accidentali. Così scrive: “Mi sembra che ci sia troppa sofferenza nel mondo. Non riesco a convincermi che
un Dio benevolo e onnipotente possa aver creato di proposito gli Icneumonidi con l’esplicita intenzione che
si alimentassero all’interno di corpi ancora vivi dei bruchi”.
Che cosa sono gli icneumonidi?
Sono vespe che non uccidono gli insetti, ma li paralizzano, bloccando con il pungiglione i loro gangli nervosi.
Vi depongono poi le uova in modo da consentire alle larve di nutrirsi degli organi interni.
Ma si tratta di casi molto rari.
Non proprio tanto rari. La sofferenza nel mondo animale è maggiore di quanto immaginiamo. Così scrive
Darwin il 12 marzo 1839 in un taccuino: “È difficile credere nella guerra, terribile e silenziosa, che ha luogo
fra esseri organici nei boschi tranquilli e nei prati ridenti”.
L’“estrema difficoltà” di concepire l’universo come prodotto del “mero caso”
Il nostro non crede nel finalismo. Non crede nella presenza di una provvidenza divina. Siamo in presenza di
un ateo?
Ateo, no. Scrivendo nel 1879, tre anni prima di morire, a John Fordyce, confessa di essere, man mano che
invecchia, un “agnostico” (anche se puntualizza “non sempre”). La fede, comunque, la perde già al tempo
del suo celebre viaggio. Sempre più si convince che il Vecchio Testamento non meriti “più fede dei libri sacri
degli indù o delle credenze di qualsiasi barbaro (no more to be trusted than the sacred books of the Indoos,
or the beliefs of any barbarian)”.
È paradossale che un giovane avviato alla carriera ecclesiastica non creda nella Bibbia.
Darwin precisa di non credere, in primis, nel “Vecchio Testamento” che descrive una “storia dell’universo
manifestamente falsa” e che attribuisce a Dio i “sentimenti di un tiranno vendicatore”. E, naturalmente,
non crede nei miracoli.
Mette in discussione, quindi, lo stesso Nuovo Testamento.
È vero: secondo lui “soltanto le prove più palesi potrebbero convincere un uomo sano di mente a credere
nei miracoli su cui si basa la fede cristiana”. E aggiunge: “quanto più conosciamo le leggi della natura, tanto
più è difficile credere nei miracoli” (the more we know of the fixed laws of nature the more incredible do
miracle do).
Non crede, dunque, nella rivelazione.
Sì. È lui stesso che lo scrive nell’Autobiografia: “Persi gradualmente la fede nella religione cristiana in
quanto verità rivelata” (I gradually came to disbelieve in Christianity as a divine revelation).
È stato perciò un percorso graduale.
Sì: un processo lento, tanto lento da non provocare sofferenza. Darwin, tuttavia, non nega di essere stato
“riluttante (very unwilling)” a rinunciare alla fede. L’incredulità poi ha preso il sopravvento ed è diventata
totale, un’incredulità rafforzata dalla sua convinzione che una religione che preveda la punizione per
l’eternità di uomini privi di fede (tra cui suo padre, suo fratello e molti dei suoi amici) sia una “odiosa
dottrina (damnable doctrine)”.
Ma, a prescindere dalla fede cristiana, sono le bellezze della natura che dovrebbero condurre a un Essere
superiore.
Darwin confessa di essere stato affascinato dalle “grandiose visioni naturali” (in particolare dalla foresta
brasiliana), visioni che ha connesso intimamente “con la fede in Dio”, ma aggiunge che un conto sono i
“sentimenti” e un conto la “prova dell’esistenza di Dio” (“sentimenti analoghi” sono suscitati dalla musica).
Ma l’universo non può essersi generato da se stesso.
Il nostro ammette “l’estrema difficoltà, l’impossibilità quasi, di concepire l’universo, immenso e
meraviglioso, e l’uomo, con la sua capacità di guardare verso il passato e verso il futuro, come il risultato di
un mero caso o di una cieca necessità” (the extreme difficulty or rather impossibility of conceiving this
immense and wonderful universe, including man with his capability of looking far backwards and far into
futurity, as the result of blind chance or necessity)”.
Una chiara ammissione di teismo.
Senza dubbio. Si tratta di una convinzione che rimane radicata in lui fino al tempo in cui scrive l’Origine
della specie, ma che poi “si è gradualmente indebolita (it has very gradually with many fluctuations become
weaker)”. Non a caso la celebre conclusione del suo capolavoro in alcune edizioni contiene la parola
“Creatore”, in altre no. Secondo Darwin è l’educazione che abbiamo avuto fin da bambini a rendere
“difficile liberarsi dalla fede in Dio, così come è difficile per una scimmia liberarsi dalla paura e dall’odio che
nutre istintivamente per il serpente (difficult for them to throw off their belief in God, as for a monkey to
throw off its instinctive fear and hatred of a snake)”.
È questo che lo conduce all’agnosticismo.
Sì. Il nostro è chiaro: “Non è mia pretesa far luce su questi astrusi problemi (such abstruse problems). Il
mistero del principio dell’universo è insolubile per noi (insoluble to us), e perciò, per quel che mi riguarda,
mi limito a dichiararmi agnostico”. Ecco perché nella seconda metà della sua vita si è sviluppato in lui “un
atteggiamento scettico e razionalista (scepticism or rationalism)”. Secondo lui, parlare di “piano della
creazione” e di “unità di disegno” è soltanto un modo per “nascondere la nostra ignoranza (to hide our
ignorance)”.
Conferme
Darwin dedica l’ultima sua opera ai lombrichi (1881). Egli è convinto che anche i lombrichi, pur nella loro
umiltà, abbiano delle qualità mentali: ecco perché li sottopone a una serie di stimoli (la luce, il suono delle
note del pianoforte) al fine di verificarne le reazioni. Il messaggio che può provenire da loro - lui non ha
dubbi - vale di più di qualunque filosofia costruita a tavolino.
Il nostro muore il 19 aprile 1882 e viene sepolto nell’Abbazia di Westminster vicino alla tomba di Isaac
Newton.
Sono passati più di 150 anni dall’Origine della specie, un lungo periodo in cui le scienze hanno registrato una
vera e propria esplosione. Che cosa rimane di quella teoria?
Oggi, grazie alla scoperta della radioattività, sappiamo che la Terra ha ben 4 miliardi e mezzo di anni e che
le prime testimonianze della vita risalgono a 3.800 milioni di anni fa.
Uno scenario che rallegrerebbe Darwin.
È indubbio: solo i tempi lunghi che oggi conosciamo possono dare un fondamento effettivo alla sua teoria.
Grazie alla genetica, poi, abbiamo scoperto ciò che è all’origine delle varianti (oggi per lo più chiamate
“mutazioni”) che si riscontrano negli esseri viventi: in ogni replicazione cellulare viene commesso almeno
un errore. E questo in condizioni ottimali: in presenza di radiazioni ultraviolette, di sbalzi di temperatura e
di sostanze inquinanti, il numero degli errori si moltiplica.
Non si tratta, allora, di variazioni casuali.
Si conosce, è vero, il meccanismo che vi è alla base. Nella misura però in cui le mutazioni avvengono senza
una direzione, senza un fine specifico, possiamo chiamarle casuali. Una causa, comunque, c’è sempre:
siamo noi che, a proposito delle singole variazioni, non la conosciamo o riteniamo non utile conoscerla. Già
Darwin ha tenuto a precisare che l’espressione “a caso” non è per nulla esatta, ma ha solo lo scopo di
evidenziare l’ignoranza umana.
Altre acquisizioni della scienza?
Le specie attuali - che sono ameno 10 milioni - rappresentano solo una parte infinitesima (decimillesima)
delle specie che hanno popolato la Terra.
Non sono quindi soltanto gli individui che soccombono nella lotta per la sopravvivenza, ma anche intere
specie.
È la natura che provvede alla selezione, ad esempio, con eventi catastrofici.
Penso alla caduta di un meteorite che ha provocato la scomparsa di animali che hanno dominato per oltre
100 milioni di anni, i dinosauri.
Si tratta di un’ipotesi verosimile. La scomparsa di specie è la condizione della comparsa di altre: la specie
animale da cui è derivato l’Homo sapiens, probabilmente, non avrebbe potuto sopravvivere in presenza di
dinosauri.
Darwin aveva colto nel segno: sono i cambiamenti strutturali della superficie terrestre lo scenario che
consente l’evoluzione delle specie.
Un fatto è certo: perché ci sia spazio (e risorse) per nuove specie, occorre che delle vecchie scompaiano. Lo
stesso discorso vale anche per gli individui di una stessa specie: è necessario che vi siano ostacoli alla loro
crescita (i discendenti di un batterio, in assenza di freni, nell’arco di 3-4 giorni arriverebbero a coprire
l’intera superficie terrestre!).
Acquisizioni specifiche emerse dalla rivoluzione genetica?
Sono gli stessi geni (frammenti del patrimonio genetico) che narrano l’evoluzione: chi nega l’evoluzione,
dimostra di non sapere nulla del genoma.
Vi troviamo, ad esempio, la stretta parentela tra l’Homo sapiens e le scimmie antropomorfe.
Infatti. E questo è un’ulteriore conferma della teoria darwiniana: gli organismi che oggi popolano la Terra
provengono in ultima analisi da pochi organismi semplici.
E in questa evoluzione l’ambiente svolge un ruolo importante. Così, di fatto, Darwin rivaluta Lamarck.
È l’ambiente che fornisce più opportunità di vivere e di procreare a chi è dotato di caratteristiche
particolari, ma non è esso a determinare queste caratteristiche. La sua funzione, comunque, è essenziale:
se due popolazioni molto simili tra loro dovessero, per qualche evento catastrofico, vivere separate per
molto tempo, alla lunga, grazie alle mutazioni che si registrano, diventano due specie diverse.
Una forte obiezione
Nessuna obiezione seria alla teoria darwiniana?
Sì: ad esempio, il cosiddetto saltazionismo.
Cioè?
Si è scoperto che, nel lungo processo di evoluzione della vita sulla Terra, vi sono periodi in cui si registra una
vera e propria esplosione di variazioni evolutive ed altri in cui sembra che tutto sia spento. Pensiamo alla
cosiddetta “esplosione del Cambriano” - 600 milioni di anni fa - i cui nell’arco di appena 20 milioni di anni
sono nate quasi tutte le tipologie di animali oggi esistenti.
In contrasto con l’idea darwiniana secondo cui l’evoluzione procede in modo graduale.
Il neo-darwinismo, però, oggi l’ha incorporata: l’evoluzione procede sia gradualmente che a salti.
Un procedere a salti che sarà arduo spiegare.
In qualche misura la spiegazione emerge dalla scoperta di una gerarchia all’interno dei geni: ci sono, ad
esempio, geni architetti e geni semplicemente esecutori. La cosa curiosa è che i geni che svolgono il ruolo
più importante sono pressoché identici in tutte le specie.
Una prova in più della parentela comune e della stessa evoluzione.
Certo, e anche la spiegazione dl saltazionismo: una mutazione dei geni regolatori - geni che controllano
l’attività di altri - può generare eventi del tutto discontinui.
Possiamo dire che i grandi cambiamenti accadono raramente, mentre quelli graduali sono costanti.
Non siamo, però, ancora arrivati a comprendere l’evoluzione dell’occhio.
Oggi vi è chi, tra gli scienziati, ha introdotto il termine “preadattamento”: un occhio, ad esempio, che non
ha ancora la capacità di vedere.
Ma un tale organo non costituisce alcun vantaggio nella lotta per la sopravvivenza.
Infatti: si tratta di un organo che non è stato selezionato, ma semplicemente tollerato. Le stesse ali degli
insetti solo 350.000 anni fa hanno acquisito la funzione di volare, mentre prima svolgevano un altro
compito, quello di tenere l’insetto in equilibrio. Così la vescica natatoria dei pesci che, col tempo, è
diventata il polmone dei vertebrati.
Ma l’ipotesi secondo cui tutto sarebbe accaduto casualmente mi pare poco convincente. Siamo infatti in
presenza di una varietà infinita di casi: penso alle zampe del trampoliere, alla pelliccia della foca, ala coda
del castoro... Tutto è funzionale alla perfezione. E questo vale anche per le condizioni che rendono possibile
la vita. Pensiamo solo alla fotosintesi clorofilliana: se le piante non avessero il privilegio di cibarsi della luce
del sole, noi non potremmo sopravvivere.
È vero, ma dobbiamo liberarci da una lettura finalistica dei fenomeni. Il darwinismo e il neodarwinismo ci
invitano, come Spinoza, a sbarazzarci da questo a priori. Un a priori che utilizziamo, ad esempio, quando
giudichiamo “spietata” la lotta per la sopravvivenza nel mondo animale: in natura (sempre Spinoza docet)
non esiste il bene, come non esiste il male. I valori sono una creazione dell’uomo. Non possiamo
pretendere di stigmatizzare il comportamento del leone che sbrana un’antilope: il leone si comporta da
leone.
È più che legittimo, però, voler spiegare perché ci troviamo di fronte ad organi così meravigliosamente
funzionali.
Sì, ma è pur sempre un punto di vita dell’uomo.
Il “razzismo”
Altre obiezioni?
Lo stesso Sermonti che abbiamo incontrato all’inizio della presente conversazione così scrive: “A parte la
disperazione che il darwinismo ha prodotto nei fedeli, privati del loro Dio, della loro anima, della loro fede,
dell’aldilà, di tutte le loro virtù (tra cui quella di non opprimere i deboli), rimasti senza bellezza, senza
speranza e significato, a parte tutto questo, nessuno si è curato della legittimazione che il darwinismo offre
al razzismo, alla sopraffazione, all’egoismo”.
In realtà, nella lotta per la sopravvivenza, vi è chi vince perché è più dotato e chi è destinato a soccombere.
È vero, ma il cosiddetto darwinismo sociale, l’applicazione cioè a individui umani e gruppi, è sviluppato da
altri.
Darwin, comunque, un contributo in tale direzione lo dà: ad esempio, quando parla di nazioni civili che
sterminano quelle barbare, di persone inadatte che risultano perdenti nella battaglia per la sopravvivenza
sociale.
È influenzato da Malthus.
Sì. In sintonia con Malthus, in particolare, sottolinea il rischio che potrebbe derivare da un eccesso di
assistenza.
Quale rischio?
Che vengano attenuati gli effetti positivi della lotta per la sopravvivenza, inducendo nelle persone assistite
indolenza.
Non è forzato, quindi, il giudizio severo di Sermonti.
È il caso, però, di inquadrare questi passi nella concezione generale di Darwin: è lui che mette in evidenza
come tra le qualità più elevate dell’uomo vi siano la simpatia e la compassione.
Sulla lunghezza d’onda di Hume.
Sì. È il cugino di Darwin, Francis Galton, invece, che formulerà, dal 1883, delle proposte finalizzate
all’attuazione di misure “eugenetiche”.
Sulla scia dell’ultimo Platone.
Sì, ma in Galton troviamo pretese scientifiche. Si tratta di misure che, purtroppo, saranno tradotte in
provvedimenti legislativi.
Nella Germania nazista.
Sì, ma anche nella civilissima America.
L’alternativa al “fattore caso”
Torniamo al Darwin naturalista. A mio avviso è la “casualità” della selezione naturale (seppure nel senso
chiarito prima) a provocare la diffidenza in molte persone.
Certo, però l’alternativa al caso non è per nulla la libertà, ma il determinismo assoluto.
Ma accettare il caso non significa per nulla salvare il libero arbitrio.
È vero: è indubbio tuttavia che man mano si sale a livello di complessità, gli animali si trovano nelle
condizioni di ampliare progressivamente la gamma delle reazioni possibili a degli stimoli: un cane ne ha di
più di un insetto, uno scimpanzé di più di un cane e, naturalmente, l’uomo di più di uno scimpanzé o di un
gorilla.
Ma sarebbe arduo spiegare il libero arbitrio con un approccio puramente naturalistico.
Darwin è chiaro: sono coloro che sanno poco sono convinti che un determinato problema non sia risolvibile
dalla scienza. Pensiamo alla sintesi chimica dell’urea che è stata realizzata in laboratorio nel 1828: è stata la
prova che ciò che è organico non ha nulla di speciale in quanto è costituito dagli stessi atomi come qualsiasi
altra cosa inorganica.
Un conto, però, è una molecola organica e un conto la cellula. Noi non abbiamo ancora scoperto come ha
avuto origine la prima cellula.
Certo, ma non è per nulla escluso che un domani lo scopriremo, anche se non sarà agevole perché la
scienza ha a che vedere solo con fenomeni riproducibili. Lo stesso Darwin così si è espresso su tale tema:
“Non è obiezione valida il fatto che la scienza non ha finora fatto luce sul problema di gran lunga superiore
dell’essenza o dell’origine della vita. Chi può spiegare qual è l’essenza della forza di gravità? Nessuno oggi
rifiuta di accettare i risultati conseguenti a questo ignoto elemento della forza, nonostante che Leibniz
abbia in passato accusato Newton di introdurre ‘qualità occulte e miracoli in filosofia’”.
Ma nel caso del libero arbitrio non stiamo parlando di cellule, ma della facoltà più complessa di cui è dotato
l’uomo.
Per risolvere i problemi più complessi, dobbiamo metterci nell’ottica che l’uomo non è solo un organismo
biologico, ma anche culturale.
Ciascuno di noi ha lo stesso genoma degli uomini di 150.000 anni fa (il periodo in cui è comparso l’Homo
sapiens), ma è la lunga fase della formazione che è tipica dei cuccioli dell’uomo che fa di questi degli esseri
umani in senso proprio. L’evoluzione culturale, è vero, non incide sul genoma, ma è determinante: siamo
uomini in quanto non siamo solo l’esito finale di una lunghissima evoluzione biologica, ma anche e
soprattutto un… prodotto culturale. È grazie a questo che possiamo dire che la materia si è ripiegata su se
stessa.
L’ultimo mistero
Ma la materia non può rispecchiarsi.
Oggi sappiamo che la realtà non è riducibile alla materia: accanto ad essa vi sono l’energia e l’informazione.
L’approccio naturalistico di Darwin e del neodarwinismo, dunque, non può essere tacciato
semplicisticamente di concezione materialistica.
L’informazione è data dal DNA.
Sì, si tratta delle istruzioni contenute nel genoma.
Ma un conto è il genoma e un conto sono la mente e la stessa coscienza.
Qui stiamo affrontando un problema che è tutt’altro che risolto. Ciò che si sa è che il cervello umano è
costituito da circa 100 miliardi di neuroni e che le loro connessioni (sinapsi) sono un milione di miliardi. È in
queste connessioni (una sorta di “armonia prestabilita” alla Leibniz) che si sprigiona - dicono alcuni
scienziati - la scintilla della coscienza.
Mi pare una forzatura bella e buona: far scaturire la coscienza da una congerie di elettroni, protoni e
neutroni! Mi sembra una evidente caduta nella trappola del riduzionismo, nella pretesa cioè di ridurre ciò
che è complesso ai suoi componenti elementari.
Ma qui non vi è alcuna riduzione: la mente ha a che vedere non direttamente con gli atomi e tanto meno
con i suoi componenti, ma con neuroni e sinapsi. Del resto è noto che quando una determinata area
cerebrale subisce una profonda lesione, si ha la perdita della coscienza.
La connessione tra corteccia cerebrale e coscienza c’è, ma non è un caso che tra gli studiosi della mente vi
sia chi sostiene che la coscienza rappresenti l’ultimo “mistero”.
Già, molto è stato scoperto, ma molto ancora dovrà essere svelato.
Una conclusione?
Potremmo concludere con una citazione dello stesso Darwin: “le più serie obiezioni si riferiscono a
questioni sulle quali abbiamo confessato la nostra ignoranza: né sappiamo bene quanto essa sia profonda
(nor do we know how ignorant we are)”
Un’ignoranza che non riguarda solo la coscienza e l’autocoscienza, ma anche, e soprattutto, il libero
arbitrio.
Si tratta, comunque, di problemi che in qualche misura non riguardano solo la specie umana, ma anche
animali superiori. La marcia in più che ha l’uomo è solo di grado (Darwin è rimasto fedele al motto antico,
ripreso da Leinbiz, Natura non facit saltus), marcia in più che può essere spiegata non più solo con
l’evoluzione “biologica”, ma anche - come abbiamo appena detto - con l’evoluzione “culturale”, in primo
luogo con quel miracolo che è il linguaggio simbolico. Possiamo dire, anzi, che l’uomo è un “animale
simbolico”. Le qualità dell’uomo - scrive Darwin a chiusura de L’origine dell’uomo - sono “nobili”, il suo
intelletto addirittura è “quasi divino”, ma non dobbiamo vergognarci di avere impressa nella nostra
struttura fisica “l’impronta indelebile (the indelible stamp)” della nostra “infima origine (lowly origin)”.
Dovremmo, semmai, sentirci orgogliosi di essere l’apice di un’evoluzione durata milioni di anni.
Orgogliosi, ma anche sgomenti: tutto questo sarebbe accaduto come effetto di una serie di eventi
accidentali!
Darwin, l’abbiamo visto, è ben consapevole della estrema difficoltà di concepire l’universo, compreso
l’uomo, come the result of blind chance or necessity.
È legittima, allora, la posizione di chi ritiene che l’evoluzione sia stata guidata da Dio.
Più che legittima. Ma la scienza ha un altro compito. E finora ha già scoperto una miriade di indizi che
provano che quelle forme “bellissime e meravigliose” di cui parla Darwin altro non sono che il risultato di
una evoluzione del tutto naturale.
Ma ancora immenso è l’enigma che circonda l’uomo.
Una teoria che spiegasse tutto e in tutti i dettagli non sarebbe scientifica, ma una fede. Del resto, anche
determinate teorie cosmologiche non sono verificabili nel loro complesso, eppure sono riconosciute da
tutti come scientifiche.
Scientifiche, ma l’uomo ha diritto di volare oltre l’orizzonte meramente scientifico.