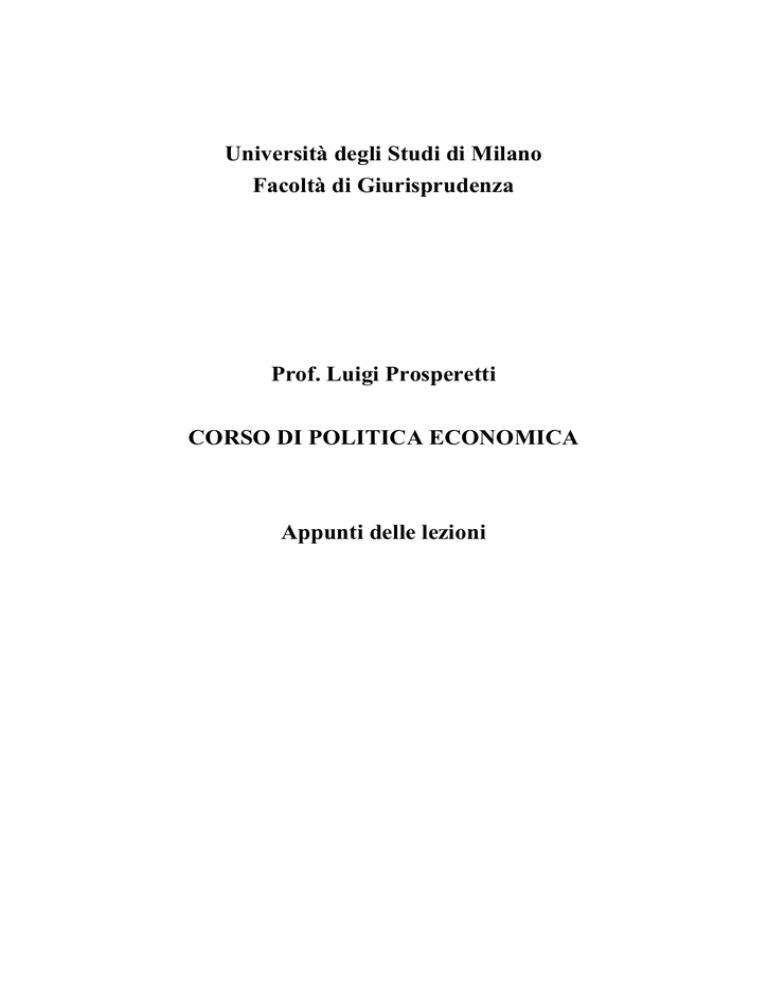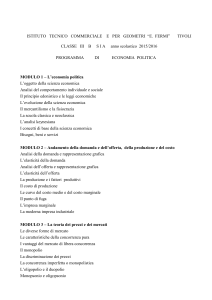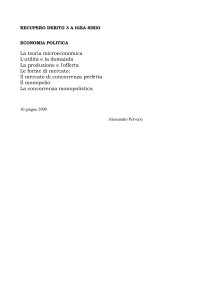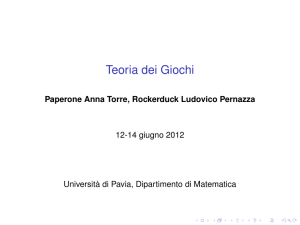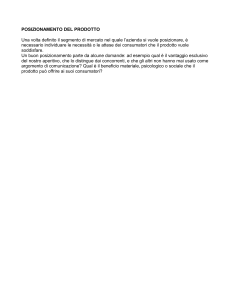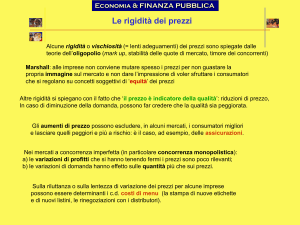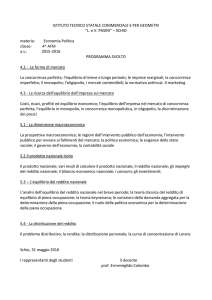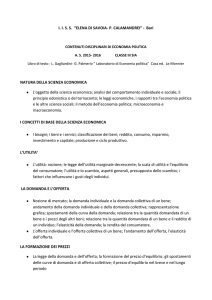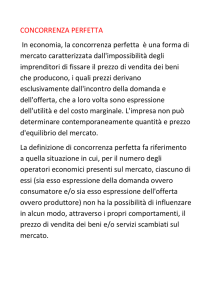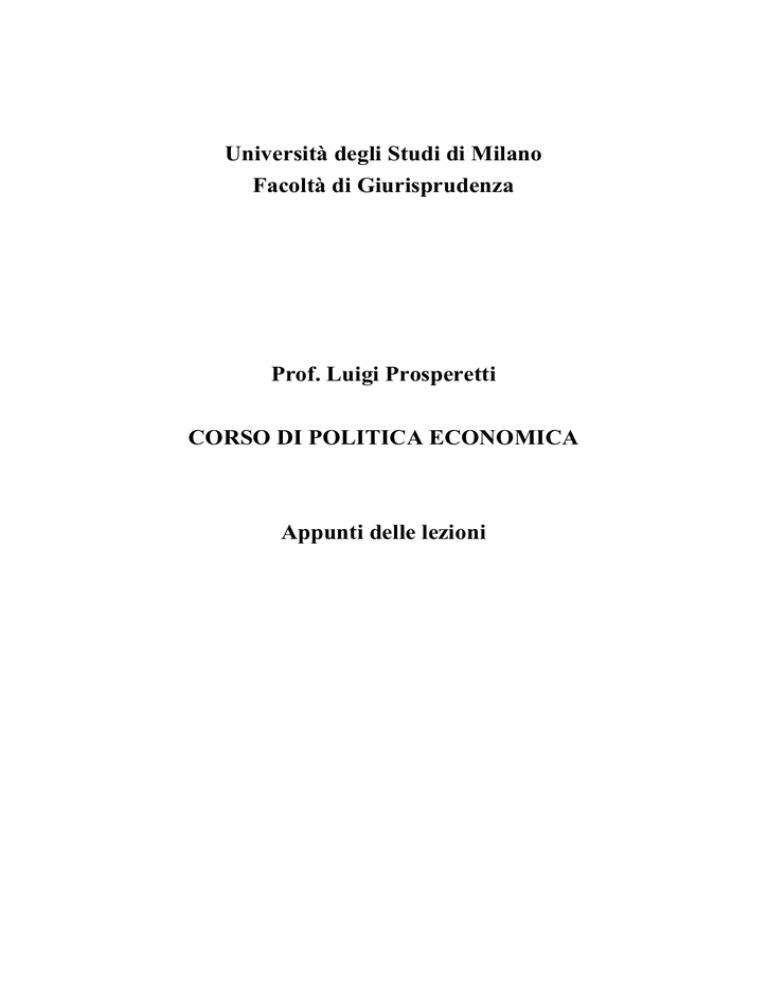
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Luigi Prosperetti
CORSO DI POLITICA ECONOMICA
Appunti delle lezioni
SOMMARIO
INTRODUZIONE ......................................................................................1
PARTE I – NOZIONI INTRODUTTIVE ................................................3
1.
PRODUZIONE, DOMANDA, BENESSERE: RICHIAMO DI
ALCUNE NOZIONI-BASE ...............................................................4
1.1 La domanda .........................................................................................4
1.2 L’offerta ..............................................................................................6
1.3 Mercato e benessere ..........................................................................10
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
CONCORRENZA,
MONOPOLIO,
OLIGOPOLIO
E
POLITICHE ANTITRUST ..............................................................12
Concorrenza perfetta .........................................................................12
Monopolio .........................................................................................14
Oligopolio .........................................................................................17
I costi del monopolio.........................................................................22
COMPLICANDO IL QUADRO: ESTERNALITA’, COSTI DI
TRANSAZIONE E RAZIONALITA’ .............................................23
3.1 Esternalità..........................................................................................24
3.2 Costi di transazione ...........................................................................26
3.3 Ma i soggetti sono davvero razionali? ..............................................27
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
POLITICA ECONOMICA: FINALITA’ E LIMITI .....................30
Finalità della politica economica ......................................................30
Politica economica e Diritto ..............................................................35
Politica economica e gruppi di interesse ...........................................38
Conclusioni .......................................................................................39
POLITICA INDUSTRIALE: FINALITA’ E LIMITI ...................40
Esternalità positive ............................................................................40
Esternalità negative ...........................................................................41
Una politica industriale per l’innovazione delle piccole imprese? ...42
Indivisibilità ......................................................................................44
Campioni nazionali ...........................................................................47
Conclusioni .......................................................................................50
PARTE II – POLITICHE ANTITRUST ...............................................52
6.
LE POLITICHE PER LA CONCORRENZA: OVERVIEW.......53
7.
LE POLITICHE ANTITRUST: CAMPO DI APPLICAZIONE,
MERCATO RILEVANTE E MISURAZIONE DEL POTERE DI
MERCATO ........................................................................................57
7.1 Il campo di applicazione ...................................................................57
7.2 Il mercato rilevante ...........................................................................61
7.3 Il mercato rilevante del prodotto .......................................................62
7.3.1 La sostituibilità dal lato della domanda ...................................64
7.3.2 Sostituibilità dal lato dell'offerta e concorrenza potenziale .....67
7.4 Il mercato rilevante geografico .........................................................69
7.5 Problemi specifici nella definizione del mercato rilevante ...............71
7.5.1 Prodotti differenziati ................................................................71
7.5.2 Mercati primari e mercati secondari ........................................74
7.5.3 Mercati bilaterali (two-sided markets) .....................................75
7.6 Potere di mercato...............................................................................76
7.6.1 Quota di mercato e potere di mercato ......................................76
7.6.2 Struttura del mercato ................................................................78
7.6.3 Altri fattori ...............................................................................80
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
LE INTESE, GLI ACCORDI E LE PRATICHE CONCORDATE84
Introduzione ......................................................................................84
Accordi e pratiche concordate ...........................................................85
Fattori strutturali e creazione del cartello..........................................89
Come rendere stabili i cartelli ...........................................................92
‘Collusione tacita’ .............................................................................95
Costi e benefici di partecipazione ad un cartello ..............................96
Intese verticali ...................................................................................97
LA POSIZIONE DOMINANTE E I COMPORTAMENTI
ABUSIVI ..........................................................................................101
La nozione di posizione dominante.................................................102
La nozione di abuso di posizione dominante ..................................103
Comportamenti abusivi per sfruttamento ........................................104
Comportamenti abusivi escludenti basati su politiche non di prezzo106
9.4.1 Rifiuto di contrarre .................................................................106
9.4.2 Rifiuto di fornire un’infrastruttura essenziale
(essential facility) ............................................................................107
9.4.3 Proprietà intellettuale come infrastruttura essenziale ............110
9.4.4 Vendite abbinate: tying e bundling ........................................112
9.5 Comportamenti abusivi escludenti basati su politiche di prezzo ....115
9.5.1 Prezzi predatori ......................................................................115
9.5.2 Discriminazione di prezzo .....................................................118
9.5.3 Sconti fidelizzanti ..................................................................120
9.5.4 Margin squeeze e price squeeze .............................................123
10. LE CONCENTRAZIONI ...............................................................126
10.1 Effetti unilaterali, o non coordinati ................................................128
10.2 Effetti coordinati.............................................................................129
10.3 Potere di contrasto di concorrenti e acquirenti ...............................130
10.4 Potenziali effetti verticali ...............................................................133
10.5 Effetti di efficienza.........................................................................134
10.6 Rimedi ............................................................................................136
PARTE III - POSIZIONI DOMINANTI E POLITICHE DI
REGOLAZIONE .............................................................................138
11. POSIZIONI DOMINANTI E REGOLAZIONE DEI PREZZI
FINALI .............................................................................................139
11.1
11.2
11.3
11.4
Regolazione del livello dei prezzi finali.........................................140
Regolazione della dinamica dei prezzi finali .................................146
Regolazione della qualità ...............................................................147
Conclusioni ....................................................................................147
12. REGOLAZIONE E CONCORRENZA: IL CONTROLLO DEI
PREZZI DI ACCESSO ...................................................................149
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Introduzione ...................................................................................149
Un caso emblematico: le telecomunicazioni ..................................151
Tipologie di rete, regolazione e concorrenza .................................153
I prezzi di accesso ..........................................................................156
La separazione strutturale ..............................................................157
13. BENEFICI E COSTI DELLA REGOLAZIONE: PROBLEMI DI
AGENZIA E GRUPPI DI INTERESSE .......................................159
13.1 Introduzione ...................................................................................159
13.2 Il problema di agenzia ....................................................................159
13.3 Gruppi di interesse .........................................................................161
14. BENI PRIVATI, BENI PUBBLICI E ASSETTI PROPRIETARI
164
14.1 Introduzione....................................................................................164
14.2 Beni pubblici ..................................................................................164
14.3 Produzione privata di beni pubblici ...............................................165
14.4 Ci sono eccezioni?..........................................................................166
14.5 Produzione pubblica di beni privati ...............................................167
15. SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE:
UNA PROSPETTIVA ECONOMICA ..........................................170
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
Introduzione ...................................................................................170
L’ambigua nozione di servizio pubblico ........................................171
L’interesse pubblico in una prospettiva economica .......................172
Gli obblighi ....................................................................................175
SIEG e gruppi di interesse..............................................................176
SIEG, normative sulla concorrenza ed aiuti di Stato .....................177
16. 16. LA REGOLAZIONE DI PREZZI E SALARI .......................180
16.1 Premessa.........................................................................................180
16.2 Il controllo dei prezzi .....................................................................180
16.3 Il salario minimo ............................................................................182
16.4 Effetti economici di un salario minimo..........................................184
16.5 Mercato del lavoro segmentato: imprese diverse ...........................188
16.6 Mercato del lavoro segmentato: lavoratori diversi.........................189
16.7 Una nota di cautela: evitare spiegazioni semplicistiche .................190
PARTE IV – ESTERNALITÀ, INFORMAZIONE IMPERFETTA E
PROBLEMI DI DISEGNO DEI MERCATI ................................192
17. INFORMAZIONI ASIMMETRICHE, RAZIONALITA’ E
REGOLAZIONE DEI MERCATI ................................................193
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
Informazione imperfetta sulla qualità dei prodotti/servizi .............193
Come ridurre l’asimmetria informativa? ........................................195
Auto-regolamentazione dei mercati ...............................................196
Asimmetrie informative ed ordini professionali ............................198
Asimmetria informativa sui prezzi .................................................199
18. LE POLITICHE AMBIENTALI ...................................................202
18.1 Costo privato, costo sociale e tragedia dei commons ....................202
18.2 Coase non funziona, e neppure la giustizia civile ..........................203
18.3 Chi inquina paga (‘polluter pays principle”) ..................................204
18.4 Le imposte ambientali ....................................................................205
18.5 I permessi di emissione ..................................................................208
18.6 Limiti amministrativi .....................................................................210
18.7 Conclusioni ....................................................................................213
19. LA REGOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA:
ORARI, SALUTE, SICUREZZA ..................................................214
20. LA REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI ................217
20.1 Le banche .......................................................................................217
20.2 I mercati mobiliari ..........................................................................219
20.3 Intermediari non bancari ................................................................221
20.4 I prodotti derivati............................................................................224
21. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E POLITICHE PER
L’INNOVAZIONE ..........................................................................228
21.1 Marchi ............................................................................................228
21.2 Copyright .......................................................................................229
21.3 I brevetti .........................................................................................231
21.4 Le politiche per l’innovazione .......................................................235
22. ECONOMIA DELLE SCELTE PUBBLICHE ............................238
1
INTRODUZIONE
Questo testo sintetizza le lezioni del Corso di Politica Economica.
La politica economica è una branca dell’Economia che studia strumenti ed
effetti dell'intervento dei pubblici poteri sull’attività economica, volti ad
indurre o a modificare le scelte degli agenti economici 1, allo scopo di
regolare o modificare il funzionamento dei mercati, o del sistema
economico, così da realizzare obiettivi prestabiliti.
La politica economica può essere distinta in due grandi aree: politica
macroeconomica (il Governo, ad esempio con la Legge Finanziaria, riduce
le imposte per aumentare la domanda aggregata nell’economia) e politica
microeconomica (il Ministero dello Sviluppo Economico offre incentivi
alle imprese che introducano particolari innovazioni tecnologiche; il
Parlamento approva normative ambientali per indurre le imprese a ridurre
l’inquinamento).
Com’è evidente, nell’uno e nell’altro caso, la politica economica può
sostanziarsi in una grande varietà di interventi, basati su un ampio registro
di strumenti normativi (leggi nazionali o regionali; regolamenti; atti
amministrativi di varia natura), ed essere attuata da molteplici istituzioni,
nazionali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Autorità indipendenti, Banca
D’Italia, e molte altre), e sovranazionali (come il Parlamento Europeo, la
Commissione Europea e la Banca Centrale Europea).
Lo studio della politica economica copre quindi un’area molto vasta, ma qui
ce ne occuperemo considerando soltanto le principali politiche
microeconomiche.
Una motivazione evidente di questa scelta, è che i laureati delle Facoltà di
Giurisprudenza sono poco frequentemente coinvolti professionalmente su
tematiche macroeconomiche.
Ma vi è una motivazione più specifica, e più importante: come meglio
vedremo nel corso, infatti, la politica microeconomica non si limita ad
interventi ex post su un mercato (ad esempio: il mercato del lavoro), volti
ad influenzare il comportamento degli agenti economici (ad esempio:
riducendo gli oneri sociali che le imprese pagano sui dipendenti più giovani,
per incentivarne l’assunzione). Spesso (anzi: più spesso) le decisioni più
importanti di politica economica sono quelle che vengono assunte mediante
interventi ex ante di disegno del mercato (ad esempio: prevedendo che il
contratti collettivi di lavoro abbiano validità erga omnes): dato che questi
1
Con questo termine si indicano tutte le persone, fisiche o giuridiche, che compiono scelte
economiche: consumatori, risparmiatori, imprese, ma anche (in alcuni casi) la pubblica
amministrazione, sono dunque agenti economici.
2
hanno sempre natura normativa, è dunque importante che un giovane
giurista abbia gli strumenti per comprendere le implicazioni economiche di
queste misure normative, tanto più che in alcuni casi – come vedremo – esse
possono presentare effetti molto diversi da quelli che ci si aspettava.
Per questo, l’area disciplinare di cui ci occuperemo in questo corso è meglio
descritta come politica microeconomica e regolamentare, anche se - per
brevità – da qui in poi ci riferiremo ad essa semplicemente come ‘politica
economica’.
Il Corso – e questi Appunti- sono organizzati nel modo seguente: dopo
alcuni capitoli preliminari nei quali sono contenuti i richiami di
microeconomia che è indispensabile che lo studente padroneggi in questo
corso, prima vengono discusse le politiche antitrust; nella parte seconda,
vengono quindi analizzate le politiche di regolazione, utilizzate in mercati
molto diversi tra loro: telecomunicazioni, energia, ma anche – come
vedremo – anche nei confronti di vari aspetti del mercato del lavoro. La
Parte terza sarà invece dedicata a discutere i problemi di disegno dei
mercati che la politica economica deve affrontare in vari casi, per ridurre
gli effetti negativi dell'informazione imperfetta, dei costi di transazione, e
delle esternalità.
3
Parte I – Nozioni introduttive
4
1. PRODUZIONE, DOMANDA, BENESSERE: RICHIAMO DI
ALCUNE NOZIONI-BASE 2
Questo capitolo contiene, con il successivo, un rapido richiamo alle
principali nozioni microeconomiche che utilizzeremo in questo corso,
relative principalmente alle variabili che determinano le decisioni di offerta
delle imprese (quanto produrre e a che prezzo vendere), le decisioni di
domanda dei consumatori (quanto acquistare e a quale prezzo), nonché le
principali forme di mercato che rilevano dal punto di vista delle aree di
politica economica che ci interessano in questo corso: concorrenza perfetta,
monopolio e oligopolio.
Coerentemente con tale circoscritto obiettivo, le pagine che seguono si
limitano a una rapida rassegna di alcuni concetti fondamentali, rinviando ad
altri e più specifici testi per i necessari approfondimenti. 3
1.1 La domanda
Il consumatore sceglie tra tutti i beni che può acquistare in base al suo
reddito, ai suoi gusti e ai loro prezzi. L’economia ipotizza che tale scelta
avvenga massimizzando l’utilità che il consumatore si aspetta di ritrarre dal
consumo dei diversi beni: in equilibrio, il consumatore comprerà scarpe fino
a quando l’utilità che egli deriva da un paio di scarpe addizionale (utilità
marginale) sarà uguale al prezzo delle scarpe 4.
La quantità domandata di ciascun bene dipenderà dunque dal reddito del
consumatore, dall’utilità che il consumatore può trarre dal bene 5, dal suo
prezzo, e da quello di tutti gli altri beni: se il reddito e il prezzo degli altri
beni non cambiano, quando il prezzo delle scarpe sale, la domanda di scarpe
da parte del consumatore si ridurrà, mentre aumenterà quando il prezzo si
riduce. La sensibilità della quantità acquistata rispetto al prezzo è misurata
2
Questo capitolo è in parte basato sui materiali contenuti nel volume di L. Prosperetti, M.
Siragusa, M. Beretta e M. Merini (2006), Economia e Diritto Antitrust. Un’introduzione,
Carocci, Roma.
3
Tra i vari testi disponibili, si segnala in particolare D.W. Carlton, J.M. Perloff (2005),
Organizzazione industriale, McGraw-Hill, Milano, testo esauriente ma di relativamente
agevole lettura, cui rinvieremo di frequente. Per un’introduzione più concisa si veda L.M.B.
Cabral (2000), Introduction to Industrial Organization, MIT Press, Cambridge (MA), cap.
3. Una presentazione particolarmente chiara della teoria economica antitrust, peraltro opera
di un illustre giurista, è disponibile (in inglese) in H. Hovenkamp (2001), Federal Antitrust
Policy – The Law of Competition and its Practice, West Publishing, St. Paul (MIN), cap. 1.
4
Infatti se l’utilità è superiore al prezzo, egli continuerà a comprare scarpe, ed invece le
venderà nel caso contrario.
5
Per essere più precisi, dall’utilità che egli trae da un’unità addizionale di prodotto o, in
altre parole, dall’utilità marginale del prodotto.
5
dalla elasticità della domanda rispetto al prezzo, ovvero dal rapporto tra
variazione percentuale della quantità e variazione percentuale del prezzo del
bene. Poiché la relazione tra prezzo e domanda è inversa, questa elasticità è
sempre negativa.
Se l’elasticità della domanda è molto bassa, il consumatore non cambierà la
quantità acquistata al cambiare del prezzo. Diciamo in questo caso che la
domanda è inelastica rispetto al prezzo
Questo è il caso di beni di assoluta necessità: anticamente, il sale aveva
questa caratteristica, perché consentiva di conservare gli alimenti. Per
questo i governi lo hanno per lungo tempo tassato. Per altri beni, l’elasticità
è molto elevata: se un produttore di zucchero alza il proprio prezzo,
probabilmente i consumatori compreranno sempre zucchero, ma di altri
produttori. Considerando il caso estremo, ad un piccolo aumento del prezzo
dello zucchero la quantità domandata a quel produttore cadrà a zero. In
questo caso diciamo che l’elasticità della domanda rispetto al prezzo è
infinita. Un caso intermedio interessante, è quello in cui ad una variazione
percentuale del prezzo, poniamo, del 10%, corrisponde una riduzione della
domanda esattamente del 10%. L’elasticità è pari a -1: la domanda di questo
bene ha dunque una elasticità unitaria.
Le relazioni tra la domanda rivolta a due beni sono misurate dalla elasticità
di sostituzione incrociata, misurata dal rapporto tra la variazione
percentuale della domanda del bene A e la variazione percentuale del prezzo
di B. Se, ad esempio, all’aumentare del prezzo della birra aumenta il
consumo di vino, vino e birra saranno sostituibili con una certa elasticità di
sostituzione. Presumibilmente, tuttavia, l’aumento del prezzo delle scarpe
non farà aumentare la domanda di vino: l’elasticità incrociata di sostituzione
tra vino e scarpe è dunque pari a zero.
Se i prezzi non cambiano, la domanda dipenderà soltanto dal reddito del
consumatore: per la maggior parte dei beni, la domanda aumenterà se il
reddito aumenta. Vi sarà quindi anche una elasticità della domanda rispetto
al reddito, misurata dal rapporto tra variazione della domanda del bene e
variazione del reddito. A differenza dell’elasticità di prezzo, questa elasticità
è un numero positivo per la maggior parte dei beni.
Le nozioni di elasticità di prezzo, elasticità incrociata ed elasticità di reddito
che abbiamo appena sviluppato riferendoci al consumatore, sono
perfettamente applicabili alla domanda di un fattore produttivo da parte di
un’impresa. Anche l’impresa potrà, almeno in alcuni casi, sostituire un
fattore produttivo il cui prezzo è aumentato (ad esempio, il lavoro) con un
fattore il cui prezzo non è aumentato (ad esempio, un macchinario). La
domanda di un fattore produttivo dipenderà poi dalla produzione
dell’impresa.
6
Frequentemente, è utile distinguere tra l’elasticità nel breve periodo, e
quella nel lungo periodo. Nel corso della crisi petrolifera del 1973-74, i
prezzi del petrolio aumentarono di circa quattro volte, e ciò determinò un
rapido aumento nel prezzo dell’acciaio, la cui produzione richiedeva molta
energia. Le industrie automobilistiche, grandi consumatrici di acciaio, non
potevano, data la tecnologia che utilizzavano, ridurne il consumo: nel breve
periodo, l’elasticità della domanda di acciaio da parte dell’industria
dell’auto era quindi prossima zero. Negli anni successivi, le case
automobilistiche ridussero rapidamente il contenuto di acciaio di un
autoveicolo, riducendo lo spessore delle lamiere, successivamente
utilizzando in misura crescente componenti in plastica. Nel lungo periodo,
l’elasticità della domanda di acciaio da parte dell’industria dell’auto divenne
elevata.
Questo è vero anche per i consumatori: viste le mie abitudini alimentari, se
sale il prezzo della carne la sostituirò inizialmente in piccola misura con
altri alimenti. Ma se l’aumento del prezzo della carne è sensibile e
permanente, le mie abitudini gradatamente cambieranno, e mangerò più
pesce e più verdure. Anche in questo caso l’elasticità di sostituzione cresce
con il passare del tempo.
Notiamo che, in questa analisi del consumatore, abbiamo ipotizzato che egli
sia perfettamente razionale e goda di perfette informazioni: queste sono
ipotesi utili per semplificare il problema. Come però vedremo più avanti,
questa è una stilizzazione, in alcuni casi alquanto lontana dalla realtà.
1.2 L’offerta
Le decisioni di offerta di un’impresa, relative cioè a quanto produrre,
dipendono da fattori interni (i costi di produzione) ed esterni (il prezzo di
mercato) 6.
Vediamo meglio i costi.
Per produrre un bene o un servizio, un’impresa sostiene diversi tipi di costo
che, a seconda degli obiettivi dell’analisi, possono essere analizzati e
inquadrati in diverse categorie. 7 Ai nostri fini, sono tuttavia necessarie
poche nozioni elementari.
Il costo totale di produzione è il costo complessivo che l’impresa sostiene
per realizzare la sua produzione in un dato periodo. All’interno del costo
6
Tali decisioni dipendono ovviamente anche dai prezzi ma, come vedremo nel prosieguo,
questi non sempre sono fattori esterni all’impresa.
7
Per un’analisi dei costi da un punto di vista aziendale si veda T.C. Horngren, G. Foster,
S.M.Datar (2002), Contabilità per la direzione, ISEDI-Prentice-Hall International, Torino,
cap. 1.
7
totale, alcune voci di costo (come materie prime, energia e componenti)
dipenderanno dalle quantità prodotte e sono dunque costi variabili; altre
(come ammortamenti, ricerca e sviluppo, spese amministrative) dovranno
essere comunque sostenute qualunque sia il livello di produzione e sono
dunque costi fissi. Quando parliamo di costi, quindi, i termini "fisso" e
"variabile" non hanno nulla a che fare con il tempo, ma con gli effetti sui
costi delle variazioni nelle quantità prodotte.
Quando l’impresa è monoprodotto, dividendo il costo totale per il numero di
unità prodotte otteniamo il costo medio, che in generale dipende sia da
fattori tecnici (quali, ad esempio, il tipo di prodotto, le sue caratteristiche e
quelle degli impianti necessari per produrlo) che da fattori economici
(principalmente, il costo degli input e il livello di produzione). 8
La relazione che lega il costo medio al livello di produzione, è nota come
curva di costo medio o, più semplicemente, curva di costo. In economia,
solitamente si ipotizza che essa abbia la forma della Figura 1.1.
Figura 1.1 – Curve di costo di breve periodo
Costo Prezzo
Costo
Marginale
Costo
Medio
Quantità
Per chiarire questo punto, consideriamo un’impresa manifatturiera, e
chiediamoci come vari il costo medio unitario al crescere del livello di
produzione. Se l'impresa produce pochi pezzi, essa deve comunque pagare i
8
Il costo medio è definibile anche per un’impresa che produca più prodotti, ma per farlo è
necessario risolvere complessi problemi di allocazione dei costi comuni, come ad esempio
l’affitto di un capannone dove l’impresa realizza più prodotti, che escono da i limiti della
nostra discussione in questa sede. Per un approfondimento si veda T.C. Horngren, G.
Foster, S.M.Datar (2002), Contabilità per la direzione, ISEDI-Prentice-Hall International,
Torino,cap. 4.
8
costi fissi, e quindi il costo medio unitario sarà elevato, perché questi costi
fissi si dovranno "spalmare" su un piccolo numero di pezzi: in altre parole,
sarà elevata la componente fissa del costo unitario.
D'altro lato, se l'impresa produce moltissimi pezzi, l’impresa dovrà
utilizzare molto gli impianti, che avranno guasti più frequenti e genereranno
costi di manutenzione più alti: anche in questo caso, dunque, il costo medio
unitario sarà elevato, in conseguenza di un livello elevato della componente
variabile del costo unitario. 9
Tra questi estremi il costo medio sarà più basso ed è ragionevole assumere
che vi sia un livello ottimale di produzione (generalmente quello per cui
sono stati disegnati gli impianti), in corrispondenza del quale il costo medio
sarà minimo.
Per molte decisioni aziendali, e anche ai nostri fini, è inoltre importante
sapere quanto costerebbe realizzare un dato incremento della produzione.
Questo è il costo incrementale che, a differenza delle nozioni precedenti di
costo, può assumere un diverso valore a seconda della grandezza
dell’incremento produttivo desiderato. Il costo per aumentare la produzione
di 100 o di 1000 unità sarà naturalmente diverso: è per questo utile riferirsi
al costo incrementale medio, che otteniamo semplicemente dividendo il
costo incrementale per l’incremento nelle unità prodotte. Un tipo particolare
di costo incrementale è il costo marginale, ovvero il costo necessario per
realizzare un incremento infinitesimo nel livello produttivo. A differenza
delle definizioni che precedono, questa misura di costo è puramente astratta
(gli incrementi infinitesimi di produzione esistono solo sui libri, ed in ogni
caso è praticamente impossibile calcolarne il costo con sufficiente
precisione). Tuttavia, essa è un’utile semplificazione perché ci permette di
costruire facilmente la curva di offerta dell’impresa.
Per farlo, notiamo che è ragionevole assumere che il costo marginale di un
dato impianto abbia, almeno al di sopra di un certo livello di produzione, un
andamento crescente, nel senso che produrre un’unità addizionale costerà
tanto più quante più sono le unità totali che già vengono prodotte: l’impresa
dovrà pagare straordinari, effettuare manutenzioni più frequenti, e così via.
Se l’impresa non è in grado di influenzare il prezzo di mercato, che per essa
è quindi una variabile esogena (come vedremo, ciò si verifica solo in un
mercato perfettamente concorrenziale), l’impresa deciderà quanto produrre
confrontando il suo costo marginale con il prezzo di mercato.
9
In realtà, in questo caso, anche alcuni costi variabili aumenteranno, dato che i dipendenti
chiederanno la corresponsione di straordinari, e il ramo destro della curva dei costi medi
sarà frequentemente più inclinato del ramo di sinistra.
9
Per massimizzare i profitti 10, se il prezzo è superiore al costo marginale,
all’impresa converrà aumentare la produzione, e ridurla in caso contrario:
essa raggiungerà il massimo profitto in corrispondenza di un livello di
produzione che eguaglia esattamente prezzo e costo marginale, e produrrà
quindi, nell’esempio della Figura 1.2, la quantità Qa.
A quel livello di produzione il suo costo medio è CMa, che risulta inferiore
al prezzo di mercato P: l’impresa ottiene dunque un profitto pari ad AB per
ciascuna unità venduta, e un profitto complessivo pari all’area ombreggiata
della Figura 1.2.
Figura 1.2 - Costo medio, costo marginale e profitto dell’impresa
Costo,
Prezzo
Costo Marginale
Costo
Medio
A
P
CMa
B
Qa
Quantità
Poiché evidentemente al crescere del prezzo sarà razionale per l’impresa
aumentare la sua produzione, la curva del costo marginale rappresenta anche
la curva di offerta dell’impresa 11, ovvero esprime la quantità che l’impresa
10
L’economia normalmente ipotizza che l’impresa miri a massimizzare il proprio profitto.
Nel caso che stiamo considerando, poiché l’impresa non può influenzare il prezzo del suo
prodotto, massimizzare il profitto è equivalente a minimizzare i costi.
11
La curva del costo marginale interseca la curva del costo medio nel punto più basso di
quest’ultima. Se in un’aula entra uno studente alto, l’altezza media degli studenti nell’aula
aumenta e naturalmente essa diminuisce se entra uno studente basso. L’altezza media
rimane invariata solo se lo studente incrementale è alto come la media. È possibile
10
in un mercato di concorrenza perfetta sarà pronta ad offrire ad ogni livello
del prezzo di vendita.
Come vedremo, quando l’impresa opera in mercati imperfettamente
concorrenziali (monopolio, oligopolio) la determinazione della quantità da
produrre dipende anche da altre variabili.
1.3 Mercato e benessere
La Figura 1.3 schematizza il funzionamento del mercato di un prodotto
generico, in cui il segmento S rappresenta la curva di offerta di mercato,
ottenuta aggregando, o sommando, le curve di offerta di ciascuna impresa
che, come spiegato nel paragrafo precedente, indicano la quantità che
ciascuna di esse è pronta ad offrire in corrispondenza di ciascun prezzo di
mercato. Il segmento D rappresenta la curva di domanda di mercato
ottenuta aggregando le curve di domanda di ciascun consumatore, che
esprimono la quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare a
ciascun prezzo di mercato. Il punto E rappresenta il punto di equilibrio del
nostro ipotetico mercato e il prezzo pe è il prezzo di equilibrio, in
corrispondenza del quale viene scambiata una quantità qe.
Figura 1.3 – Mercato e benessere
Costo,
Prezzo
S
K
A
E
pe
B
D
Z
qe
Quantità
dimostrare (qui non lo faremo, rinviando al corso introduttivo di Istituzioni di Economia)
che per le curve di costo questa eguaglianza, che naturalmente implica l’intersezione tra la
curva del costo marginale e quella del costo medio, si verifica nel punto di minimo di
quest’ultima.
11
Se tutto il prodotto viene scambiato al prezzo pe, i consumatori che
sarebbero stati disposti a pagare un prezzo superiore a quello di equilibrio
(che dunque esprimono la domanda tra il punto K e il punto E della curva di
domanda) registreranno un surplus del consumatore pari alla differenza tra
il prezzo pagato e quello che sarebbero stati disposti a pagare (detto prezzo
di riserva). Simmetricamente, i produttori che sarebbero stati disposti a
vendere a un prezzo più basso di pe (sono quelli che esprimono l’offerta tra i
punti Z ed E della curva di offerta) registreranno un surplus del produttore,
pari alla differenza tra il prezzo effettivamente incassato e quello al quale
essi sarebbero stati disposti a vendere (anche questo è un prezzo di riserva).
Soltanto il consumatore che voleva comprare esattamente a pe e il produttore
che voleva vendere esattamente a pe non otterranno alcun surplus.
Alla luce di quanto discusso, è evidente che il triangolo A nella figura
misurerà il surplus dei consumatori, e il triangolo B quello dei produttori.
La somma dei due triangoli rappresenterà il beneficio, o benessere sociale,
che la collettività dei venditori e dei compratori otterrà dallo scambio sul
mercato al prezzo di equilibrio E.
Ripetendo questa analisi per tutti i mercati che esistono nel sistema
economico, potremo così calcolare il benessere sociale.
12
2. CONCORRENZA,
MONOPOLIO,
POLITICHE ANTITRUST
OLIGOPOLIO
E
Dopo aver richiamato nel capitolo precedente i principali aspetti del
comportamento degli agenti economici che generano, in qualsiasi mercato,
la domanda e l'offerta, in questo capitolo completiamo i richiami di
microeconomia discutendo le principali forme di mercato, ovvero i modi in
cui gli agenti economici interagiscono tra di loro: come vedremo queste
dipendono da una pluralità di fattori.
2.1 Concorrenza perfetta
Il modello di concorrenza perfetta è un’astrazione e nella realtà soltanto
alcuni mercati (come quelli di talune commodities) 12 presentano
caratteristiche simili. Come meglio vedremo nel prossimo capitolo, in
economia esso ha però un ruolo centrale, perché consente di mostrare come,
se tutti i mercati sono in concorrenza perfetta, viene massimizzato il
benessere sociale. Per differenza, il modello consente anche di cogliere
quali sono i costi che il monopolio impone alla collettività. Esso è dunque
molto importante per comprendere le fondamenta economiche dell’azione
antitrust.
Consideriamo un mercato nel quale venga scambiato un prodotto
omogeneo, e vi sia una pluralità di consumatori e di produttori, che
impiegano tutti la medesima tecnologia. Le caratteristiche del prodotto sono
note a tutti i partecipanti al mercato, nessuno dei quali è abbastanza grande
per influenzare, attraverso le proprie decisioni di acquisto e di vendita, il
prezzo di mercato (in altre parole, la concorrenza è atomistica). Supponiamo
inoltre che qualunque impresa possa liberamente entrare nel mercato 13 e
che, decidendo di uscirne, non si trovi a sostenere costi irrecuperabili (a
volte detti anche sunk costs o costi affondati). 14 In altre parole, supponiamo
che questo mercato sia perfettamente contendibile.
12
Il termine commodity individua generalmente dei beni industriali o agricoli indifferenziati
e di qualità più o meno uniforme, come grano, rame o petrolio.
13
Supponiamo quindi che nel mercato non vi siano barriere all’entrata, né di tipo
tecnologico né di natura legale.
14
In generale, se un’impresa cessa la produzione essa potrà rivendere i suoi fabbricati e
buona parte dei suoi macchinari. Per alcuni tipi di impianti, come quelli molto specializzati
(che sono utilizzabili solo per produrre prodotti particolari) o di dimensioni molto grandi
(difficili da smontare e da trasportare) l’impresa non riuscirà a recuperare che una piccola
frazione del loro valore, sostenendo quindi un costo irrecuperabile, nel caso decidesse di
uscire dal settore. In alcuni casi, anche le spese di pubblicità possono costituire un costo
irrecuperabile, ad esempio, se esse non si riflettono pienamente nel valore del marchio.
13
La domanda e l’offerta determineranno, come abbiamo appena visto, un
prezzo di equilibrio su questo mercato. Se ne analizziamo (Figura 2.1) i
rapporti con le curve di costo di una generica impresa che opera in questo
mercato, otteniamo tre risultati molto interessanti.
Figura 2.1 – Equilibrio dell’impresa in concorrenza perfetta
Costo,
Prezzo
Curva di domanda
Costo marginale
Ec
Costo
medio
pc
qc
Quantità
Nel punto di equilibrio, il prezzo (pc) è uguale al costo marginale. Infatti, se
il prezzo fosse superiore al costo marginale, l’impresa espanderebbe
l’output, e lo ridurrebbe se il prezzo fosse inferiore al costo. In equilibrio,
dunque, l’impresa sceglierà di produrre quel livello di output in
corrispondenza del quale il costo marginale eguaglia il prezzo di mercato. In
concorrenza perfetta si realizza quindi l’efficienza allocativa, nel senso che
il bene viene venduto quando il prezzo che i consumatori sono disposti a
pagare per una unità addizionale è esattamente uguale al costo che l’impresa
sostiene per produrla.
Il prezzo è inoltre uguale al costo medio. Se fosse superiore, l’impresa
registrerebbe un profitto. Ma, poiché è possibile entrare liberamente nel
mercato, molte imprese entrerebbero per godere anch’esse di quel profitto.
Ciò tuttavia farebbe aumentare l’offerta e scendere il prezzo, vanificando il
profitto stesso. Specularmente, qualora il prezzo fosse inferiore al costo
medio, le imprese uscirebbero dal settore, l’offerta diminuirebbe e il prezzo
salirebbe. Ecco perché, in equilibrio, il prezzo dovrà eguagliare esattamente
il costo medio. Poiché poi, come abbiamo appena visto, anche il costo
marginale è uguale al prezzo, in equilibrio avremo anche l’uguaglianza tra
costo medio e costo marginale. Come abbiamo visto sopra, però, questa
14
uguaglianza può verificarsi soltanto in corrispondenza del minimo della
curva dei costi medi. Concludiamo quindi che, in equilibrio, la produzione
ha luogo al minor costo medio possibile: in concorrenza perfetta abbiamo
dunque anche efficienza produttiva.
Nel modello di concorrenza perfetta nessuna impresa potrà quindi realizzare
un profitto economico positivo. Questo risultato può apparire sorprendente
se si considera che l’obiettivo delle imprese è quello di massimizzare i
profitti. In realtà, tale conclusione dipende dalla definizione di costo di
produzione, che in economia è più ampia di quella contabile normalmente
utilizzata dalle imprese e comprende – oltre ai costi in senso stretto
(materiali, lavoro, ammortamenti, etc.) – anche la remunerazione del
capitale investito, a un tasso medio di mercato. 15
Per maggior chiarezza, potremmo dunque dire che, in equilibrio, nel
modello di concorrenza perfetta nessuna impresa può ricavare un sovraprofitto, ovvero un profitto a un tasso superiore a quello medio di mercato. 16
2.2 Monopolio
La Figura 2.2 presenta l’equilibrio in un mercato monopolistico, nel quale
esiste un solo produttore e l’entrata di altre imprese è impossibile, per
l’esistenza di barriere all’entrata molto elevate, che possono essere di varia
natura: tecnologiche (almeno fino a qualche anno fa, Microsoft aveva,
grazie alla sua tecnologia, un virtuale monopolio nei sistemi operativi per
personal computer), economiche (come abbiamo visto, una rete di trasporto
del gas comporta costi fissi talmente rilevanti da costituire un monopolio
naturale) o legali (la normativa italiana riserva la gestione di numerosi
servizi postali a Poste Italiane. 17
Questo mercato è molto diverso da quello perfettamente concorrenziale
discusso nel paragrafo precedente: c’è una sola impresa e, quindi, non solo
la curva di offerta di mercato coincide con la curva di offerta dell’impresa,
15
Questa definizione discende naturalmente dalla nozione di costo opportunità: dato che gli
investitori potrebbero impiegare i loro capitali altrove nell’economia, se decidono di
impiegarli nell’impresa devono ricevere una remunerazione almeno pari a quella che, in
media, otterrebbero investendo altrove. Questa remunerazione è dunque un costo che
l’impresa deve sostenere per attrarre gli investitori.
16
Quella sopra presentata è la versione più elementare del modello di concorrenza perfetta,
che può essere reso più realistico, ad esempio, supponendo che le imprese abbiano
differenti tecnologie, e dunque differenti costi medi e marginali: in questo caso, è solo
l’impresa marginale, ovvero l’ultima impresa il cui prodotto è necessario a soddisfare la
domanda di mercato, quella per cui i (sovra) profitti si annullano. Le conclusioni sostanziali
cui sopra siamo giunti rimangono tuttavia egualmente valide.
17
Naturalmente queste motivazioni spesso si combinano, e la concessione di un monopolio
legale sancisce spesso sul piano normativo un monopolio che esiste per motivi economici.
15
ma la curva di domanda che il monopolista si trova a confrontare è la curva
di mercato che ha, come abbiamo visto, un’inclinazione negativa.
Questo fatto ha una conseguenza importante. Diversamente dall’impresa che
opera in regime di concorrenza, il monopolista non decide quanto produrre
basandosi sulla regola costo marginale = prezzo. Se l’impresa in
concorrenza vende un’unità addizionale di prodotto, il ricavo che essa trae
da tale unità addizionale (o ricavo marginale) è infatti uguale al prezzo di
mercato che essa ottiene (l’unità addizionale in questione è troppo piccola
per influenzare, da sola, il prezzo di equilibrio del mercato). Ma un
monopolista, per vendere un’unità in più, deve abbassare leggermente il
prezzo, poiché per lui la curva della domanda di mercato è inclinata
negativamente. Il monopolista, per decidere quanto produrre, si baserà
dunque sulla regola decisionale: costo marginale = ricavo marginale; egli
produrrà quindi la quantità qm e la venderà al prezzo che il mercato sarà
disposto a pagare per quel livello di produzione, e dunque al prezzo pm.
Figura 2.2– Equilibrio dell’impresa in monopolio
Naturalmente, se il mercato fosse stato concorrenziale e la curva dei costi
marginali rappresentasse la sommatoria delle curve dei costi marginali di
tutte le imprese presenti sul mercato, la quantità venduta sarebbe stata quella
in corrispondenza della quale il prezzo eguagliava il costo marginale, e
quindi qc. Il prezzo sarebbe di conseguenza risultato pari a pc, e uguale sia al
costo medio che al costo marginale, per i motivi discussi nel paragrafo
precedente.
16
Come possiamo vedere, la monopolizzazione del mercato riduce la quantità
venduta (da qc a qm) e aumenta il prezzo pagato dai consumatori (da pc a
pm). Il monopolio, quindi, non è efficiente né in senso allocativo (il
prodotto viene venduto al di sopra del suo costo medio di produzione), né in
senso produttivo (dato che la produzione non avviene al costo minimo
possibile). Il monopolista ottiene un profitto di monopolio (cui a volte ci si
riferisce come rendita di monopolio), ovvero un profitto molto superiore a
quello di mercato.
Il monopolista è dunque inefficiente e le aree tratteggiate B e C misurano le
risorse distrutte dall’esistenza del monopolio, ovvero gli acquisti (area B) e
le vendite (area C) che avrebbero avuto luogo se il prezzo di mercato fosse
stato pari o superiore al prezzo concorrenziale pc, ma che non vengono
effettuati al prezzo di monopolio. Esso è spesso indicato come deadweight
loss, o perdita secca derivante dall’esistenza del monopolio.
L’area A rappresenta invece una porzione di surplus del consumatore che,
in monopolio, viene accaparrato dal monopolista, che riesce così a godere di
un extra-profitto. A differenza della deadweight loss queste non sono risorse
distrutte, ma risorse trasferite dai consumatori al monopolista: si potrebbe
quindi sostenere che la loro esistenza non dovrebbe rilevare particolarmente
da un punto di vista antitrust.
Tuttavia, le principali autorità di concorrenza assumono ormai
costantemente un punto di vista “consumeristico”. 18 Esse combattono
pertanto i monopoli per evitare non solo una distruzione di risorse (le aree B
e C), ma anche il trasferimento di reddito dai consumatori al monopolista (il
rettangolo A) generato dal potere di mercato di questo.
Una ulteriore fonte di perdita di benessere, che il grafico non evidenzia, è
quella che deriva dalla bassa efficienza produttiva del monopolista. Non
dovendo infatti fronteggiare alcun concorrente, il suo management e i suoi
dipendenti non hanno incentivi razionali a minimizzare i costi di produzione
(prova evidente di questo fatto è che, a parità di mansione lavorativa, le
retribuzioni nei settori monopolistici sono mediamente assai più alte che
non nei settori esposti alla concorrenza): se i suoi costi aumentano, il
monopolista li scaricherà semplicemente sui consumatori 19.
Il monopolio crea inoltre altre tipologie di costo a carico della collettività
che, a differenza di quelle fino a qui considerate, hanno natura dinamica.
18
Tanto la Commissione europea quanto la Federal Trade Commission americana hanno
spesso esplicitamente indicato che il proprio ruolo è quello di difendere gli interessi dei
consumatori.
19
Questo tipo di inefficienza associata al monopolio è nota, dal lavoro di Leibenstein
(1966) come X-inefficiency.
17
In primo luogo, il monopolista sarà pronto a spendere risorse anche
considerevoli per mantenere la propria posizione di monopolio. Queste
saranno pari come minimo ad A, poiché questo è l’ammontare degli extraprofitti di cui gode il monopolista. Dato che queste risorse sono destinate a
mantenere una posizione inefficiente, esse sono certamente sprecate dal
punto di vista sociale.
In secondo luogo, è probabile che un monopolista abbia, a parità di altre
condizioni, un incentivo a introdurre innovazioni di processo inferiore a
quello di un’impresa in concorrenza: quest’ultima, se riesce ad abbassare i
suoi costi al di sotto di quelli dei concorrenti, può sperare infatti di
espandere le sue vendite fino a conquistare l’intero mercato. Il monopolista
invece possiede già l’intero mercato e quindi l’incremento di profitto che
egli può attendersi è inferiore. 20
In terzo luogo, appare probabile (almeno in base all’esperienza offerta dai
settori tecnologicamente più innovativi) che un monopolista sia più lento a
introdurre anche innovazioni di prodotto. Il monopolista non ha infatti alcun
particolare incentivo a battere la concorrenza offrendo ai consumatori
prodotti che incorporano una tecnologia più avanzata. Anzi, se non ha
ancora finito di ammortizzare gli impianti che producono un determinato
prodotto, ha un preciso interesse a non introdurre un prodotto innovativo.
Il monopolio impone quindi rilevanti costi – statici e dinamici – alla
collettività. Per questo motivo, come vedremo nel seguito del volume,
buona parte dell’attività antitrust è dedicata a impedirne la creazione e a
rendere difficile il loro perpetuarsi
2.3 Oligopolio
Un mercato nel quale opera un numero limitato di imprese è detto
oligopolistico. La presenza di poche imprese può dipendere da vari fattori:
tecnologici (la costruzione di aerei civili di grandi dimensioni è un’attività
nella quale le elevate spese di ricerca generano economie di scala così
importanti che vi sono ormai, nel mondo, solo due produttori);
regolamentari (in ciascun Paese europeo solo pochi operatori radiomobili
sono stati autorizzati ad operare dai rispettivi governi); o di mercato (ad
esempio, per i prodotti ove la pubblicità è molto importante, come per le
bibite gasate, il livello degli investimenti pubblicitari è così elevato da
generare economie di scala). Quindi, non vi è in generale nulla di
particolarmente sinistro nell’assetto oligopolistico di mercato e, a seconda
dei casi, potremo avere sia oligopoli concentrati (la produzione di grandi
20
Questa è in realtà solo una spiegazione intuitiva. Per una presentazione più dettagliata si
veda, ad esempio, o D.W. Carlton, J.M. Perloff (2005), Organizzazione industriale,
McGraw-Hill, Milano, cap. 14.
18
aerei civili), che oligopoli poco concentrati (quali, ad esempio, alcuni
mercati assicurativi).
Da un punto di vista economico, la caratteristica principale di mercati di
questo tipo è l’interdipendenza che lega le imprese che vi operano: mentre
in una situazione di concorrenza perfetta ciascuna impresa è troppo piccola
rispetto al mercato, e dunque le sue scelte non sono rilevanti per le scelte
delle altre imprese, in un oligopolio si verifica il contrario. Così, ad
esempio, quando un produttore di automobili europeo deve decidere il
prezzo di un nuovo modello, esso considererà non soltanto i propri costi e i
prezzi dei modelli di altri produttori già sul mercato, ma dovrà anche
formarsi delle aspettative sulle probabili reazioni di questi ultimi al lancio
del proprio modello.
Lo studio degli oligopoli è quindi molto complicato, e si serve di strumenti
matematici – come la teoria dei giochi – alquanto complessi. Ai nostri fini è
però sufficiente una sintesi semplificata, che esamini le due grandi strategie
che i membri di un oligopolio possono intraprendere (colludere o
competere) e discuta le principali situazioni di equilibrio cui può giungere
un mercato oligopolistico. Per semplificare la discussione, ci riferiremo al
tipo più semplice di oligopolio, il duopolio, e supporremo che i prodotti
siano omogenei. 21
Figura 2.3 - Colludere o competere?
B sceglie un prezzo:
Alto
Alto
100,100
Basso
0,150
A sceglie
un prezzo:
Basso
21
150,0
50,50
Il caso dei prodotti differenziati è piuttosto complesso e può essere approfondito, ad
esempio, consultando D.W. Carlton, J.M. Perloff (2005), Organizzazione industriale,
McGraw-Hill, Milano, cap. 7.
19
Quando due imprese duopoliste colludono, coordinando le scelte relative
alle quantità prodotte e ai prezzi praticati, esse danno vita a un cartello
perfetto, nel senso che si comportano come un monopolista, e sono quindi in
grado di ottenere profitti di monopolio.
È sufficiente questo fatto per concludere che in un oligopolio le imprese
tenderanno sempre a colludere piuttosto che a competere?
La risposta a questa domanda è negativa, come possiamo vedere
considerando la Figura 2.3 Questa indica il livello del profitto che possono
attendersi due duopolisti che, accingendosi ad esempio a introdurre un
medesimo nuovo prodotto, debbano ciascuno decidere se fissare un prezzo
alto, o fissare un prezzo basso. Naturalmente, il profitto di ciascuno
dipenderà sia dalla propria scelta che dalla scelta dell’altra impresa, poiché i
consumatori risponderanno alle scelte di entrambi. Così, se ambedue le
imprese scegliessero, colludendo, di praticare prezzi alti, il profitto di
ciascuna sarebbe pari, nell’esempio, a 100.
L’impresa A, tuttavia, se decide di fissare un prezzo alto deve tenere conto
che B, anziché colludere guadagnando 100, potrebbe decidere di fissare un
prezzo basso, per cercare di conquistare l’intero mercato e ottenendo un
profitto pari a 150, e dunque più elevato di quello che otterrebbe
colludendo: B ha, in altre parole, un incentivo razionale a non colludere,
perché - così facendo - spera in un profitto ancora più elevato di quello che
otterrebbe colludendo. Ma se A si attende che B fissi un prezzo basso,
conquistando l’intero mercato, non potrà che fissare anch’essa un prezzo
basso per il nuovo prodotto: se non lo facesse, essa non venderebbe
alcunché. Poiché anche l’impresa B farà il medesimo ragionamento,
l’equilibrio di mercato si realizzerà in corrispondenza di un prezzo basso
per ambedue le imprese. In questa situazione, ciascuna di esse guadagnerà
50, vale a dire molto meno di quanto non avrebbe guadagnato se fosse
riuscita a colludere stabilmente senza dover temere il più che probabile
tradimento dell’altra. Ma appunto la soluzione collusiva (100,100) non
sarebbe stata stabile perché, come abbiamo visto, ciascuna delle due
imprese avrebbe avuto un incentivo razionale a tradire l’accordo collusivo. 22
Perché possa realizzarsi un comportamento collusivo stabile tra due o più
imprese sono dunque necessari altri fattori in grado di rendere stabile
l’equilibrio collusivo che la presente analisi introduttiva non può
considerare, ma che saranno discussi dettagliatamente nei capitoli che
seguono.
22
La soluzione (50,50) è invece stabile, poiché ciascuna delle due imprese adotta la
strategia che considera ottimale, ipotizzando (com’è razionale fare) che l’altra impresa
persegua anch’essa una strategia ottimale: questo è un esempio di equilibrio di Nash.
20
Un oligopolio non collusivo, detto anche oligopolio competitivo, è dunque
perfettamente possibile anche in un mercato fortemente concentrato come
un duopolio. Esso può raggiungere vari tipi di equilibrio, a seconda delle
caratteristiche della domanda e, in particolare, della variabile sulla quale le
imprese si fanno concorrenza, ovvero il prezzo di vendita o la quantità
venduta.
Se infatti tendiamo istintivamente a identificare la nozione di concorrenza
con quella di concorrenza sui prezzi, le imprese possono farsi concorrenza
anche in altri modi: ad esempio quando una variazione del prezzo di
vendita comporta tempi e costi significativi (perché in ipotesi essa deve
essere annunciata sui listini e comunicata a una estesa rete di vendita),
oppure quando le decisioni sulla capacità vengono prese molto tempo prima
di quelle sui prezzi (come ad esempio nel settore della costruzione di grandi
aeromobili civili), le imprese possono farsi concorrenza offrendo maggiori o
minori quantità di prodotto.
È intuitivo che le strategie delle imprese e i risultati, in termini di quantità,
prezzi, o profitti, saranno alquanto differenti nei due casi.
Consideriamo dapprima il caso in cui le imprese competono sui prezzi,
vendendo un prodotto omogeneo a tutti gli acquirenti a uno stesso prezzo, e
supponiamo che la loro capacità produttiva non abbia vincoli: in un caso
simile, è probabile che la concorrenza faccia scendere il prezzo fino al limite
più basso, ovvero al costo marginale. Infatti, partendo da un qualsiasi prezzo
superiore al costo marginale, ciascuna impresa sa che le sue vendite
aumenteranno fino a coprire tutto il mercato se essa ridurrà il prezzo al di
sotto di quello del concorrente. Ma naturalmente, poiché il concorrente
conosce le caratteristiche del mercato, egli reagirà abbassando ulteriormente
il prezzo. Nel mercato si scatenerebbe dunque una guerra di prezzo che
avrebbe termine soltanto quando il prezzo fosse caduto fino al costo
marginale. Nella teoria dell’oligopolio, un equilibrio di questo genere è noto
come equilibrio di Bertrand, o equilibrio quasi-concorrenziale, perché in
esso si realizza quell’eguaglianza tra costo marginale e prezzo che, come
abbiamo visto, caratterizza il modello di concorrenza perfetta.
Un esito così peculiare si realizza però solo nel caso elementare che
abbiamo ipotizzato. In primo luogo, infatti, qualora esistano limiti alla
capacità di produzione delle due imprese, nessuna di esse potrà ambire a
catturare l’intera domanda di mercato e abbasserà il prezzo solo fino al
punto che le consentirà di saturare la propria capacità produttiva. Lo stesso
farà l’altra, e il prezzo cesserà di scendere ben prima di aver raggiunto il
costo marginale.
In secondo luogo, il modello di Bertrand presuppone un’omogeneità di
prodotto che è difficile registrare in pratica, al di fuori dei mercati delle
commodities e di pochi altri. Se i prodotti delle due imprese sono
21
differenziati, l’impresa che riduce i prezzi avrà certamente un aumento di
domanda, ma non così grande da consentirle di soddisfare con il suo
prodotto l’intera domanda, dato che una parte dei consumatori continuerà a
preferire i prodotti dell’altra impresa. Anche in questo caso, dunque, i prezzi
non scenderanno fino al costo marginale.
Il modello di Bertrand, nel quale le imprese si fanno concorrenza solo sul
prezzo, può dunque condurre a soluzioni diverse e solo nella sua forma più
semplice esso porta a un equilibrio nel quale tutti i profitti sono nulli, come
nel caso della concorrenza perfetta. Da un punto di vista empirico, è
probabile che – nelle sue diverse varianti – esso offra una descrizione
ragionevole degli equilibri che si formano in molti mercati oligopolistici.
Vi sono poi altri modelli di oligopolio rilevanti. Di questi, l’unico che ci
interessa menzionare in questa discussione introduttiva è il modello di
Cournot, nel quale la concorrenza non avviene sui prezzi, ma sulle quantità
offerte. Questo modello, che descrive abbastanza fedelmente le modalità di
concorrenza nelle industrie in cui i livelli produttivi devono essere decisi
molto tempo prima che il prodotto sia effettivamente disponibile per la
vendita, porta a concludere che il mercato troverà un equilibrio in una
situazione intermedia tra quella della concorrenza perfetta e quella del
monopolio: i prezzi saranno dunque più alti, e la quantità prodotte più basse,
che in una situazione di concorrenza.
Sia il modello di Cournot che quello di Bertrand (tranne il caso elementare
in cui quest’ultimo degenera, come abbiamo visto, in un mercato quasiconcorrenziale) prevedono, in equilibrio, prezzi più alti e quantità inferiori
rispetto al caso della concorrenza perfetta. Il benessere sociale è quindi
inferiore a quello del caso di concorrenza perfetta, ma è superiore a quello
che si registrerebbe nel caso in cui gli oligopolisti, invece di competere,
colludessero. 23
Questi modelli sono stati ulteriormente sviluppati negli anni più recenti
utilizzando la teoria dei giochi, adottando ipotesi più verosimili circa la
natura delle interazioni tra le imprese (non più statiche, ma dinamiche), la
loro frequenza, la loro sequenza, le informazioni di cui ciascuna dispone e
così via. I risultati così ottenuti sono molto complessi, e non sempre di
grande utilità pratica, quanto meno in un’ottica antitrust: ai fini del presente
volume, sono sufficienti dunque le semplici sintesi dei modelli “classici”
sopra riportate. 24
23
Questa conclusione si applica anche al modello di Stackelberg che descrive mercati nei
quali vi è un’impresa leader e un’impresa follower, che adegua le sue scelte a quelle
dell’impresa leader.
24
Per una esposizione più approfondita dei quali, si veda ad esempio D.W. Carlton, J.M.
Perloff (2005), Organizzazione industriale, McGraw-Hill, Milano, cap. 6.
22
2.4 I costi del monopolio
Al termine di questa breve sintesi introduttiva, è bene dare al lettore una
misura quantitativa dei costi del monopolio. Per quanto riguarda il suo costo
in termini di deadweight loss, le stime più recenti condotte con riferimento a
interi sistemi economici lo collocano, per gli Stati Uniti, tra il 4 e il 13% del
PIL e, per la Francia, al 7,4% 25. Si tratta, intuitivamente, di valori alquanto
significativi: ogni punto percentuale del PIL statunitense vale infatti circa
120 miliardi di dollari, e ogni punto di PIL francese circa 20 miliardi.
Poiché stime aggregate di questo genere non possono che essere alquanto
approssimative, 26 è utile considerare anche l’evidenza disponibile circa gli
aumenti dei prezzi derivanti dall’esistenza di cartelli: poiché, come abbiamo
visto, cartelli e monopoli si comportano in modo assai simile, questi dati
forniscono una misura indiretta degli aumenti di prezzo praticati dai
monopoli. Secondo uno studio recente, che passa in rassegna oltre 600
casi, 27 i cartelli aumentano i prezzi da un minimo del 43% ad un massimo
del 72%: l’attenzione dell’antitrust nei confronti di monopoli e cartelli – che
nel prossimo capitolo inquadreremo in una prospettiva più ampia - è quindi
del tutto giustificata.
Si vedano K Bowling, D.C.Műller (1978), The Social Costs of Monopoly, in “Economic
Journal”, 88 e F. Jenny, A.P.Weber (1983), Aggregate Welfare Loss due to Monopoly
Power in the French Economy, Some Tentative Estimates, in “The Journal of Industrial
Economics”, 32.
26
Dalla Figura 1.6 risulta evidente come esse si basino su ipotesi circa i parametri delle
curve di domanda e delle curve di costo marginale dei settori monopolizzati.
27
Cfr. J.M. Connor (2004), Price-fixing Overcharges: Legal and Economic Evidence.
Discussion Papers, Purdue University, West Lafayette (IN).
25
23
3. COMPLICANDO IL QUADRO: ESTERNALITA’, COSTI DI
TRANSAZIONE E RAZIONALITA’
Il quadro della microeconomia elementare fornito dal corso di Economia
Politica, e che abbiamo rapidamente qui ripercorso, è utile per ottenere
risultati chiari relativamente semplici, ma è d’altra parte forzatamente
semplificato, in quanto omette vari aspetti della realtà che possono risultare
rilevanti: anzi, come vedremo, alcuni di questi sono talmente rilevanti da
determinare l’esistenza stessa di alcune tipologie di politiche economiche,
ed altri da determinarne varie loro caratteristiche.
Dobbiamo in particolare riesaminare tre ipotesi semplificatrice.
Le analisi della microeconomia elementare sono caratterizzati in primo
luogo dall’ipotesi implicita che gli effetti di una transazione tra due o più
agenti economici (una compravendita, la produzione di un bene) abbia
effetti soltanto su di essi. In alcuni casi, tuttavia, gli effetti ricadono anche
su altri soggetti, che non erano parte della transazione in questione. Come
vedremo tra breve, l’esempio più semplice di questo problema delle
esternalità è fornito dall’inquinamento. È intuitivo che ciò provochi
problemi di politica economica, nel senso che sarebbe opportuno trovare un
modo per far sì che gli agenti economici che intervengono nelle transazioni
necessarie per produrre una tonnellata di acciaio si trovino a sopportare
anche i costi sociali che, attraverso l’inquinamento, quella produzione
genera in capo ad altri soggetti. Dobbiamo dunque valutare se e come sia
possibile tramite la politica economica fare sì che i produttori di acciaio
compiano scelte che altrimenti non avrebbero compiuto: come ricorderete,
questa è la semplice definizione operativa di politica economica che
adottiamo in questo corso.
In secondo luogo, nelle discussioni introduttive di microeconomia, si
ipotizza, ancora tacitamente, che non vi siano costi rilevanti
nell’effettuazione delle transazioni tra gli agenti economici. Questa è una
ipotesi ragionevole se la transazione è relativamente semplice (spiegheremo
poi tra breve come interpretare questo aggettivo), ma è intuitivo che i costi
da sostenere per effettuare l’acquisto di 1 kg di pomodori siano molto
diversi da quelli da sostenere per acquistare 1 kg di perle.
Non ci stiamo qui naturalmente riferendo al prezzo del bene, ma ai costi che
l’acquirente deve sostenere per effettuare la transazione. Tra questi, nel caso
delle perle, ci saranno rilevanti costi di informazione, che sarà necessario
sostenere per accertarsi della qualità delle perle, dato che essa influenza in
modo enorme il loro valore. Problemi di qualità ci sono certamente anche
per i pomodori, ma questi sono in genere rapidamente risolvibili per
24
un’accorta massaia che tasterà il pomodoro, e lo annuserà con discrezione,
mentre per le perle saranno necessarie perizie gemmologiche.
Dunque comprare perle comporta costi di transazione più elevati del
comprare pomodori. Come vedremo, una parte rilevante di questi costi
dipendono da asimmetrie informative, ovvero dal fatto che il venditore ha in
genere informazioni molto più dettagliate sulle caratteristiche del bene che
non il compratore. Anche qui la politica economica può avere un ruolo,
appunto nel riequilibrare queste asimmetrie informative: è intuitivo (anche
se la realtà, come vedremo, è più complicata) che ridurre le asimmetrie
informative renderà più fluido il mercato, e in genere tenderà ad abbassare i
prezzi.
In terzo luogo, nelle discussioni introduttive si ipotizza, questa volta
esplicitamente, che tutti gli agenti economici siano razionali. Questa ipotesi
è probabilmente ragionevole per le imprese, che hanno meccanismi
organizzativi interni che tendono ad eliminare le decisioni non razionali, ma
è certamente un’approssimazione discutibile per molte decisioni delle
persone fisiche. Naturalmente, non ci interessa qui il fatto che alcune
decisioni siano irrazionali, ma il caso in cui alcune decisione siano
sistematicamente irrazionali, nel senso che un complesso di fattori può
spingere i consumatori (o i risparmiatori, naturalmente) a comportarsi in
modo non confacente ai propri razionali interessi. Anche qui, come
vedremo, vi è ricca materia per interventi di politica economica.
3.1 Esternalità
Il modo più semplice di spiegare la nozione di esternalità è considerare il
problema dell’inquinamento: la mia acciaieria produce fumi che sporcano il
bucato della lavanderia vicina. Questa è una esternalità negativa, ma
possiamo però avere anche esternalità positive: la mia centrale elettrica
scarica in mare acqua tiepida che può essere utilizzata per far crescere più
rapidamente i pesci di un allevamento.
Le esternalità poi non derivano soltanto dalla produzione ma anche dal
consumo: se faccio ridipingere la mia casa l'aspetto della mia strada
migliorerà, e presumibilmente questo si rifletterà sul prezzo delle altre case;
se prendo invece lezioni di batteria, posso disturbare i miei vicini.
Ciò che accomuna questi casi, a prima vista così diversi, è che mentre in
genere i costi ed i benefici delle scelte di un agente economico (comprare un
paio di scarpe, produrre una pizza) ricadono sull’agente stesso, in questi casi
le scelte private generano costi o benefici in capo ad altri agenti: insomma
costi o benefici sociali. Le conseguenze delle esternalità sono molto
importanti.
25
Seguendo nell’esempio, se il produttore di acciaio non paga gli effetti
sociali del suo inquinamento, ad esempio indennizzando la lavanderia,
produrrà tutto l’acciaio che riuscirà a vendere sul mercato
Figura 3.1 Costo privato e costo sociale
C
costo marginale
sociale
offerta (o costo
marginale
privato)
Domanda
Q
Come mostra la Figura 3.1 - la quantità di acciaio che deciderà di produrre
sarà data dall'intersezione della curva di domanda di acciaio con la sua
curva di offerta, che dipende unicamente dai suoi propri costi marginali
privati di produzione.
Dal punto di vista sociale, tuttavia, la curva del costo marginale deve avere
un’ordinata maggiore, cioè essere traslata verso l’alto, poiché essa include
non soltanto il costo marginale di produzione, che è un costo privato, ma
anche il costo marginale sociale che l'inquinamento genera per altri agenti
economici (la lavanderia dovrà lavare due volte): se l’esternalità non viene
in qualche modo internalizzata, la produzione di acciaio sarà dunque
ottima per l’impresa, ma eccessiva dal punto di vista sociale.
Questo è un risultato del tutto generale: se vi sono esternalità negative che
derivano da una transazione, ignorare i costi sociali genererà un numero di
transazioni eccessivo dal punto di vista del benessere sociale. E’ vero anche
il contrario: in una piacevole calle veneziana popolata di case scrostate dalla
salsedine, verrà ridipinto a cura dei proprietari un numero di case inferiore a
quello ottimo dal punto di vista sociale (ovvero del complesso dei
proprietari di case di quella via), in quanto ciascuno di essi godrà certamente
del beneficio privato che deriva dal restauro della propria casa, ma non
26
riuscirà a godere del beneficio sociale che restaurarla genererà, aumentando
il valore delle altre case della calle.
La politica economica quindi può avere un ruolo di rilievo nel gestire le
esternalità, cercando di far sì che chi genera esternalità negative ne sopporti
in qualche modo i costi, e così razionalmente i limiti la sua produzione di
esternalità negative; simmetricamente, la politica economica potrà cercare di
far godere i generi esternalità positive di una parte dei propri frutti, così
facendo incoraggiandone la produzione.
3.2 Costi di transazione
Come abbiamo visto, i costi di transazione sono quei costi che operatori
economici devono sostenere per effettuare una transazione.
Vi sono molti fattori che determinano l’esistenza di costi di transazione:
anche il consumatore che va a comprarsi una banana sopporta evidenti costi
in termini di tempo per effettuare la transazione (quello che utilizza andando
da casa propria al negozio potrebbe essere utilizzato altrimenti). Costi di
questo genere tuttavia non ci interessano particolarmente sotto il profilo
della politica economica, in quanto in genere sono troppo contenuti per
avere effetti di qualche rilievo sul funzionamento dei mercati 28.
Ci interessano quindi principalmente i casi in cui i costi di transazione
possono essere sufficientemente elevati da riflettersi sul prezzo del bene che
viene scambiato, e quindi indirettamente sul volume delle compravendite, o
sul funzionamento stesso del mercato. Questi costi consistono
principalmente in:
a. costi di ricerca ed elaborazione di informazioni. Ad esempio, un
mobilificio che intenda acquistare legno, sopporta tipicamente costi
volti ad accertare le caratteristiche dei prodotti ed i prezzi offerti da
diversi fornitori. Una volta che esso ha raccolto tutte queste
informazioni, deve destinare risorse ad elaborarle per decidere cosa
e da chi acquistare;
b. costi di contrattazione: una volta stabilito cosa comprare e da chi, il
mobilificio deve stipulare un contratto di fornitura, sopportando
costi (ad esempio, costi legali) ulteriori;
c. costi volti ad assicurare l'effettiva esecuzione del contratto, ad
esempio per accertare che la qualità del prodotto sia quella pattuita,
28
A meno di casi particolari: ad esempio un disabile deve sopportare costi di transazione
presumibilmente elevati anche per comprare una semplice banana, e questo è un problema
meritevole di considerazione dal profilo che ci interessa (a titolo esemplificativo: istituiamo
un servizio che porti la spesa a casa al disabile? Gli forniamo uno sgravio fiscale per
coprire i costi che deve sostenere per farsele recapitare?).
27
ed eventualmente ulteriori costi legali in caso di incompleta
esecuzione del contratto di fornitura.
Varie misure di politica economica volte a ridurre tali costi possono quindi
migliorare il funzionamento del mercato, e per questa via avere un effetto
rilevante sul benessere dei consumatori. In casi particolari, ma in pratica
molto importanti, i costi di ricerca ed elaborazione delle informazioni
possono essere così significativi da rendere sostanzialmente impossibile
l’esistenza di un particolare mercato. Ce ne occuperemo nei capitoli che
seguono.
3.3 Ma i soggetti sono davvero razionali?
Nel modello microeconomico di base, abbiamo supposto che i consumatori
siano perfettamente razionali nelle loro decisioni, ed esercitino liberamente
la propria volontà perseguendo unicamente il proprio interesse.
Vari studi psicologici indicano come la razionalità degli agenti economici
trovi almeno tre tipi di limitazioni.
In primo luogo la razionalità è limitata (bounded rationality), nel senso che
gli agenti non dispongono di perfette informazioni (confrontano invece costi
di transazione nell'acquisizione di informazioni), e non hanno a loro
disposizione l'infinita capacità di calcolo dell'utilità o del profitto che
suppone la teoria economica elementare (ottimizzare è un'attività anch'essa
costosa, nel senso che richiede risorse). I soggetti quindi in molte situazioni
tendono a seguire regole del pollice, e questo si verifica in molti campi,
certamente non soltanto in economia 29.
Tecnicamente, queste si chiamano soluzioni euristiche, o euristiche. Nella
Ricerca Operativa (branca della matematica applicata) un’euristica è una
tecnica che è in grado di fornire buone soluzioni ammissibili, ad un costo
computazionale accettabile, senza tuttavia poter garantire l’ottimalità di tali
soluzioni. Le procedure euristiche rappresentano quindi un compromesso tra
la qualità della soluzione ottenuta e la rapidità con la quale viene raggiunta.
In altre parole, si rinuncia alla certezza di ottenere una soluzione ottima, a
29
Ad esempio, un giocatore di baseball che cerca di afferrare una palla colpita da una
mazza, non cerca infatti di risolvere in pochi secondi l'enorme sistema di equazioni
matematiche che governano la traiettoria della palla; più semplicemente, egli segue la
regola del pollice di correre sul campo tenendo costante l'angolo con il quale la palla si
presenta al suo sguardo. Con la geometria elementare, si dimostra che questa regola del
pollice è sufficiente per portarlo esattamente ad intercettare la palla. In altri campi, come ad
esempio la medicina nei reparti di urgenza, all'arrivo di un soggetto che presenti forti dolori
toracici i medici non hanno tempo di fare tutti i test che possono rivelare con elevato livello
di confidenza la presenza di un infarto; applicano un albero decisionale molto semplificato
(fast and ready decision tree), che presenta tuttavia un tasso di successo superiore al 95%.
28
favore della possibilità di ottenere una soluzione ammissibile in tempi
ragionevoli.
Se i soggetti ricorrono a regole decisionali di questo tipo, in quanto le
informazioni costano sono difficili ed elaborare, possono commettere errori
di giudizio.
In secondo luogo, la razionalità è limitata anche nel senso dell'esercizio
della volontà (bounded willpower): un fumatore sa benissimo che fumare fa
male, ma non riesco a smettere, così come un giocatore d'azzardo sa che si
sta rovinando, ma non riesce a smettere.
In terzo luogo, la razionalità è limitata nel senso che le persone spesso non
seguono, come ipotizza la teoria economica, esclusivamente il proprio
interesse (bounded self-interest), non necessariamente nel senso che sono
altruisti, ma che nel decidere che cosa fare spesso tengono conto in qualche
misura degli interessi altrui.
Un risultato classico qui è il gioco dell'ultimatum, nel quale due soggetti
devono decidere come dividere una somma di denaro che è data loro. Il
primo soggetto fa una proposta, che il secondo può accettare o rifiutare. Se
la rifiuta, la somma viene ritirata, e nessuno dei due soggetti riceve
alcunché. Il gioco viene giocato una sola volta, quindi non ci sono problemi
relativi a possibili vendette.
È intuitivo che, in un caso del genere, al primo giocatore converrebbe offrire
al secondo una cifra molto piccola; a questi converrebbe sempre accettarla,
perché se la rifiuta otterrebbe una cifra pari a zero. Nella realtà, tutti gli
esperimenti condotti dagli psicologi dicono che questo risultato non viene
mai ottenuto, ma anzi si verifica frequentemente che il primo giocatore offra
all'altro una somma vicino a 50% del totale; qualora l'offerta del primo
giocatore sia invece molto bassa, è frequente che il secondo giocatore la
rifiuti. Nessuno di questi due risultati è coerente con la semplice ipotesi
economica che ciascun soggetto persegua esclusivamente il proprio
interesse.
Una discussione degli studi psicologici in questi campi, e di come questi
trovino interessanti riscontri ed estensioni nelle neuroscienze esce
dall'ambito di questo corso 30. Basta qui però rilevare come il
comportamento delle persone sia molto più complesso di quello che ipotizza
la teoria economica elementare.
Dal punto di vista di questo corso, i fattori comportamentali che influenzano
la scelta di consumatori risparmiatori che ci interessano sono principalmente
tre:
30
Consiglio caldamente, a chi fosse interessato, la lettura del magnifico volume Pensieri
lenti e veloci di Daniel Kahnemann, Mondadori 2012.
29
• l’avversione alla perdita: le persone preferiscono non perdere
piuttosto che non vincere;
• la distorsione ottimistica: i soggetti sottostimano sistematicamente la
probabilità di un evento sfavorevole;
• il ricorso a punti di riferimento psicologicamente importanti
nell’euristica: le persone possono decidere di seguire il
comportamento degli altri, oppure essere avversi ad un cambiamento
dello status quo, oppure ancora assegnare un valore
sproporzionatamente elevato a quanto posseggono, rispetto a quanto
potrebbero possedere. Possono infine reagire in maniera molto più
incisiva ad alcuni stimoli apprezza (ad esempio quelli visuali)
rispetto ad altri.
Si noti come questi fattori portano a conclusioni diverse più complesse di
quelle cui conducono le ipotesi del modello microeconomico di base,
all’interno del quale il mancato percepimento di una somma viene di
frequente considerato come equivalente all’esborso di quella somma, e
pertanto si ipotizza che i consumatori tengano pienamente conto del costoopportunità delle loro scelte.
Come vedremo più sotto, questa ipotesi è probabilmente ragionevole
applicata delle organizzazioni (le imprese) che nella maggior parte dei casi
prendono le loro decisioni in modo razionale. È più dubbio che questa
ipotesi sia una corretta rappresentazione del processo decisionale delle
persone fisiche.
Ma se consumatori e risparmiatori sono soggetti, nelle loro scelte, a questi
fattori comportamentali, fattori che possono essere efficacemente sfruttati
dai soggetti che vengano loro prodotti e servizi, ed in particolare quelli con
riferimento ai quali queste distorsioni decisionali possono aver un ruolo più
importante, allora in alcuni casi può esservi un ruolo significativo della
politica economica volta a proteggere, per così dire, consumatori e i
risparmiatori da sé medesimi.
30
4. POLITICA ECONOMICA: FINALITA’ E LIMITI
4.1 Finalità della politica economica
Quali sono le finalità della politica economica?
Per rispondere a questa domanda assumiamo prima una prospettiva
normativa 31, chiedendoci quali dovrebbero essere queste finalità;
procederemo poi ad una indispensabile prospettiva positiva, chiedendoci
quali, nei fatti, siano queste finalità.
Da un punto di vista normativo, la politica economica è basata sul Primo
Teorema fondamentale dell’economia del benessere. Questo teorema, che
qui non dimostriamo, ma assumiamo semplicemente come vero, insegna che
il normale funzionamento di un mercato perfettamente concorrenziale
consente di raggiungere un equilibrio complessivo del sistema economico in
cui le risorse (beni di consumo, fattori di produzione) sono allocate in
maniera ottimale tra tutti gli agenti economici. L’allocazione è ottimale nel
senso che non è possibile redistribuire le risorse in maniera tale da
incrementare il livello di utilità di almeno un agente economico, senza
ridurre quello di almeno un altro agente economico: questa situazione detta
ottimo Paretiano.
Questo criterio di ottimalità è evidentemente molto stringente, e certamente
di difficile applicazione pratica: come vedremo, esso è però utile per
definire, in senso normativo, gli obiettivi fondamentali della politica
economica.
Prima di discutere questo punto, vediamo quali sono le condizioni
necessarie che devono verificarsi perché un tale equilibrio sia possibile.
Come avete visto nel corso-base di Economia, perché vi sia concorrenza
perfetta su un dato mercato, nel quale venga scambiato un prodotto
omogeneo:
31
•
deve esservi una pluralità di produttori e di consumatori, nessuno
dei quali è abbastanza grande per influenzare, attraverso le proprie
decisioni di acquisto e di vendita, il prezzo di mercato: in altre
parole, la concorrenza deve essere atomistica;
•
le caratteristiche del prodotto devono essere note a tutti i produttori
ed a tutti i consumatori: deve quindi esservi perfetta informazione;
•
qualunque impresa può liberamente entrare nel mercato, perché non
vi sono particolari barriere all’entrata, e se decide di uscirne essa
In senso filosofico, naturalmente.
31
non si trova a sostenere costi irrecuperabili: il mercato è dunque
perfettamente contendibile.
Se queste condizioni sono rispettate, la domanda e l’offerta determineranno
un prezzo di equilibrio su questo mercato tale che:
•
il prezzo è uguale al costo marginale: le imprese producono quindi
la quantità di prodotto in corrispondenza del quale esse
massimizzano il profitto;
•
il prezzo è inoltre uguale al costo medio più basso che la tecnologia
consente.
Poiché il prezzo è anche pari – come abbiamo visto - all’utilità marginale
dei consumatori, in concorrenza perfetta il mercato è efficiente sia in senso
allocativo (i consumatori massimizzano l’utilità, le imprese massimizzano il
profitto), che in senso produttivo (il bene viene prodotto al costo più basso
possibile).
L’esistenza di concorrenza perfetta richiede però due ulteriori condizioni
necessarie, talvolta non discusse nei corsi introduttivi di Economia Politica,
che ci assicurano che.
•
non vi siano costi in grado di limitare gli scambi sul mercato. Se ad
esempio l’acquisto di pomodori richiedesse la stipula di un contratto
complesso, redatto da competenti legali, e dunque alquanto costoso,
è probabile che la domanda di pomodori sarebbe inferiore a quella
che altrimenti si registrerebbe. E’ importante sottolineare che ciò
non dipenderebbe dal prezzo dei pomodori, ma dai costi che
l’acquirente dovrebbe sopportare ben prima di pagare il prezzo dei
pomodori: questi sono appunto, in economia, costi di transazione,
termine con cui si indicano in generale tutti quei costi che devono
essere sostenuti per effettuare una transazione. E’ intuitivo (ma
naturalmente dimostrabile) che l’esistenza di costi di questo tipo
riduce gli scambi: se vi sono costi di transazione rilevanti, neppure
un mercato perfettamente concorrenziale può generare un equilibrio
efficiente;
•
che non vi siano agenti economici che non prendono parte ad una
transazione (ad esempio: l’acquisto di una tonnellata di acciaio), la
cui utilità venga tuttavia influenzata da quella transazione (coloro
che abitano vicino all’acciaieria, e ne sopportano l’inquinamento).
Come meglio vedremo nel seguito, un modo alternativo di definire
questa condizione è di dire che il prezzo della transazione deve
riflettere pienamente i costi ed i benefici, non solo privati, ma anche
sociali, derivanti dalla transazione stessa: non vi siano, in altre
parole, esternalità.
32
Queste condizioni 32 sono evidentemente restrittive, e non vi sono sistemi
economici reali ove esse siano tutte rispettate. Ma esse hanno una validità
asintotica, nel senso che si ritiene generalmente probabile che quanto più
esse sono rispettate, tanto più elevato è il benessere sociale: per questo, un
approccio normativo alla politica microeconomica è utile a fornirci un
quadro di riferimento, perché esso fornisce una motivazione razionale
alquanto cogente alla politica microeconomica, che dovrebbe dunque in
primo luogo essere finalizzata a prevenire o a rimediare quelle situazioni in
cui la violazione di una delle condizioni necessarie sopra indicate generi una
market failure (fallimento del mercato), ovvero un cattivo o mancato
funzionamento nell’operatività dei meccanismi competitivi tale da non
consentire – come sarebbe possibile, in base al Teorema fondamentale
dell’economia del benessere – la massimizzazione del benessere sociale.
Avremo così, ad esempio, politiche antitrust volte a prevenire la creazione
di monopoli, o di strutture (i cartelli) che hanno effetti analoghi distorsivi
sulla concorrenza perfetta; politiche volte a ridurre le asimmetrie
informative, di cui possono soffrire in alcuni casi gli agenti economici, ed
in particolare di quelli (i consumatori) che – per motivi intuitivi, ma che
discuteremo analiticamente nel seguito del corso – possono avere accesso ad
informazioni più scarse e meno precise che non le imprese; politiche volte a
risolvere i problemi generati dalle esternalità, e così via, come
discuteremo nel seguito del corso.
Ma il novero delle politiche economiche è ancora più ampio, poiché esse
non rispondono soltanto alle motivazioni di efficienza sociale che abbiamo
fin qui discusso.
In primo luogo, infatti, il criterio di Pareto che abbiamo fin qui utilizzato ha
carattere statico, e non considera gli effetti intertemporali: ad esempio,
costringendo tutti gli studenti italiani ad imparare perfettamente l’inglese,
certamente non si massimizzerebbe la loro utilità di oggi, ma
presumibilmente aumenterebbe il loro reddito domani, e – a livello sociale –
si attrarrebbero maggiori investimenti esteri in Italia, aumenterebbe
l’occupazione e così via: l’esempio è impreciso (né la crescita né
l’occupazione, di per sé, indicano necessariamente efficienza), ma chiarisce
come un criterio intertemporale suggerisca politiche non necessariamente
identiche a quelle suggerite da un criterio statico.
Abbandonando la prospettiva normativa (a cosa dovrebbe servire la politica
economica) per una prospettiva positiva (a cosa serve concretamente la
politica economica), individuiamo rapidamente tre ulteriori – e
frequentemente meno nobili – motivi ispiratori della politica economica.
32
Vi è in realtà un’ulteriore condizione, che tuttavia non ci interessa approfondire in un
corso introduttivo come questo, ovvero che i diritti di proprietà devono esser definiti per
tutti i beni.
33
Prima di discutere questi aspetti, chiediamoci però: come nascono le
decisioni di politica economica?
Come meglio vedremo nei capitoli successivi, dietro all’astratta figura
giuridica del “Legislatore” stanno infatti frequentemente potenti gruppi di
interesse, che cercano in vari modi di far assumere decisioni di politica
microeconomica nell’interesse del proprio gruppo, che spesso è ben lontano
da qualunque definizione ragionevole di interesse generale. Non tutte le
decisioni di politica economica rispondono naturalmente all’interesse di
gruppi specifici di agenti economici, dato che – tipicamente in parlamento –
gli interessi degli uni si contrappongono a quelli degli altri, ed è così spesso
possibile giungere a decisioni più prossime all’interesse generale, che a
quello di gruppi specifici.
L’area principale nella quale la politica economica evidenzia il mescolarsi di
finalità generali e di finalità particolaristiche, è quella delle politiche
redistributive, generalmente proposte in nome di un criterio di equità.
Prima di analizzare la politica economica da questa prospettiva, occorre
sottolineare come la nozione di equità sia estremamente complessa.
Semplificando, e guardandola solo dal punto di vista economico, dovremmo
anzitutto definire se con equità si voglia intendere una uguaglianza delle
opportunità (dare a tutti lo stesso punto di partenza?) oppure una
uguaglianza dei risultati (dare a tutti lo stesso punto di arrivo, ad esempio
in termini di reddito o di capacità di consumo?)33.
Avendo in qualche modo risposto a questa domanda, occorrerà poi decidere
se, nell’elaborazione della politica economica, si intenda assegnare al
benessere di ciascun individuo lo stesso peso (come implicitamente fa il
criterio di Pareto), o meno.
La risposta a questo quesito non è, in molti casi, facile, ma da essa dipende
in modo cruciale la scelta della politica economica da attuare.
Per capire l’importanza del problema consideriamo la Figura 4.1, che
rappresenta le curve di indifferenza tra carne e pesce di Robinson Crusoe
(consumatore A, a sinistra) e di Venerdì (consumatore B, al centro). Nella
sua parte destra, la figura combina le curve di indifferenza di ambedue gli
abitanti dell’isola (attenzione: il grafico di Venerdì è stato capovolto e
sovrapposto all’altro), e mostra come siano possibili almeno tre equilibri
diversi 34, aventi caratteristiche diverse.
Consideriamoli. Sia E che F sono punti di equilibrio (sia Robinson che
Venerdì sono su una propria curva di indifferenza), ma in F Venerdì ha
33
La distinzione è di Norberto Bobbio.
In realtà, poiché le curve di indifferenza, come si ricorderà dall’economia elementare,
sono praticamente infinite, infiniti saranno anche i punti di equilibrio: ma ciò non ci deve
qui preoccupare.
34
34
maggiori quantità di ambedue i beni rispetto a Robinson, ed il contrario si
verifica in E. I due punti rappresentano dunque ambedue configurazioni
efficienti, ma che sono molto diverse sotto il profilo distributivo. Se
riteniamo equo (per qualche motivo) che Robinson e Venerdì abbiano un
medesimo livello di utilità, E ed F ci saranno egualmente sgraditi, perché ad
essi preferiremo un equilibrio come G, nel quale ciascun abitante dell’isola
ha una simile quantità di beni ed un simile livello di utilità.
Figura 4.1. Situazioni di ottimo e distribuzione del reddito
Consumatore A
Consumatore B
Bene 2
Bene 1
Bene 1
B
Bene 1
F
G
E
Bene 2
Bene 2 A
Bene 1
Bene 2
Se, lasciata l’isola, torniamo ai problemi della politica economica, è
evidente quindi che cercheremo di formularla così da raggiungere sia un
obiettivo di efficienza, sia un obiettivo di equità, perseguendo quest’ultimo
attraverso una qualche politica redistributiva.
La principale politica economica redistributiva è quella fiscale: le imposte
sul reddito sono, ad esempio, ad aliquote crescenti (i redditi più alti pagano
proporzionalmente imposte più alte), ma il loro studio esce dall’area di
questo corso, e rientra in quella del corso di Scienza delle Finanze.
Come vedremo, tuttavia, alcune politiche microeconomiche perseguono
anche finalità redistributive: ad esempio, il prezzo pagato per un kilowattora
(KWh) dalle famiglie che consumano poca elettricità sono state per decenni
così basse da non coprire il costo di fornitura di quel KWh. Questo sbilancio
veniva finanziato da altri consumatori, che pagavano un prezzo molto
superiore al costo di fornitura: questo, naturalmente, è un classico caso in
cui una scelta di politica microeconomica è stata assunta sotto la spinta di
potenti gruppi di interesse (le organizzazioni sindacali, in questo caso).
Oltre ad efficienza ed equità, vi è un terzo motivo che spesso ispira in
pratica la politica economica, ovvero la finalità di assicurare la fornitura di
alcuni beni o servizi, per qualche motivo considerati come meritori, nel
35
senso che il loro consumo deve essere incoraggiato perché socialmente
‘meritorio’ 35: queste motivazioni sono spesso avanzate, ad esempio, a
sostegno di misure volte a sostenere la fornitura universale di qualche
servizio, come la pubblica istruzione o l’assistenza sanitaria. Come meglio
vedremo più oltre nel corso, questo punto è assai più complesso di quanto
non possa apparire, ma per il momento ci è sufficiente registrare questa
ulteriore motivazione per alcuni interventi di politica economica.
Nella pratica, dunque, la politica microeconomica persegue una pluralità di
obiettivi: rimediare, o prevenire, i principali fallimenti del mercato,
promuovere l’efficienza dinamica, e infine, talvolta, intervenire
modificando la distribuzione del reddito. Essa è perciò spesso influenzata
dai gruppi di pressione, che cercano di far sì che i provvedimenti adottati
favoriscano i propri aderenti, anziché l’interesse generale. Il compito della
politica economica è dunque complesso, e spesso – per evitare i fallimenti
del mercato – si incorre in fallimenti della politica economica, nel senso
che le politiche adottate sortiscono effetti ben diversi da quelli attesi: nel
seguito, vedremo molti esempi di casi del genere.
4.2 Politica economica e Diritto
La discussione che precede evidenzia chiaramente come la politica
economica di cui qui ci occuperemo ha un’ovvia dimensione giuridica, per
almeno due principali motivi.
In primo luogo, e banalmente, perché tutti i suoi interventi si attuano
mediante norme, regolamenti ed altri atti amministrativi: il nostro campo
d’indagine ha quindi vari punti di contatto con vari corsi di Diritto
(Commerciale, Ambientale, del Lavoro, Amministrativo, dei Mercati
Finanziari, e molti altri).
Ma la politica microeconomica ha un’importante dimensione giuridica per
una seconda ragione, meno evidente ma più importante: perché, quando essa
si esplica mediante un intervento regolamentare ex ante sulle modalità di
funzionamento di un mercato, essa è volta a prevenire, o comunque a
rendere meno frequente, il ricorso alla giustizia civile da parte di operatori
economici di cui i legittimi interessi vengano su quel mercato danneggiati.
Perché infatti intervenire ex ante sui mercati? Non sarebbe forse meglio
lasciare che gli agenti economici si coordinino liberamente, lasciando alla
giustizia civile il compito di liquidare eventuali danni privati, e limitando
35
Naturalmente, esistono anche i beni non-meritori, il cui consumo va scoraggiato, ad
esempio mediante la tassazione (bevande alcoliche), la tassazione unita a divieti di
consumo in molte circostanze (il tabacco), il divieto (in teoria, almeno) assoluto (le
sostanze stupefacenti).
36
l'intervento dello Stato alla somministrazione ex post di multe e penalità in
caso di comportamento socialmente dannoso?
Per chiarire questo punto è utile introdurre la nozione statistica di valore
atteso. Per definirla, partiamo da una semplice domanda: se vi offrono di
partecipare una lotteria che ha un unico premio di € 100, e nella quale
vengono venduti soltanto 50 biglietti, quanto sareste disposti a pagare per un
biglietto?
La risposta è facile. Ogni biglietto ha una probabilità su 50 di vincere
ovvero: 1:50= 0,02 (quindi il 2%). Se il premio è € 100, e siete razionali, e
neutrali rispetto al rischio (cioè non lo amate né odiate particolarmente),
sarete disposti a pagare non più del valore atteso del biglietto, ovvero 100
x 0,02 = € 2 36.
Il valore atteso di una data somma è dunque pari al prodotto tra la somma e
la probabilità che essa venga percepita. Naturalmente, possiamo fare un
esempio analogo dal lato dei costi: il valore di atteso di un costo è pari
all’esborso previsto, moltiplicato la probabilità che esso si verifichi.
Supponiamo adesso che un agente economico razionale, ma amorale, ad
esempio un produttore di autovetture 37, debba decidere se compiere un
illecito antitrust, partecipando ad un cartello con altri costruttori che
innalzerebbe i prezzi delle auto, oppure rifiutarsi. Se egli partecipa,
naturalmente godrà di un profitto rilevante, ma se il cartello viene scoperto,
le autorità Antitrust commineranno una sanzione amministrativa, che
genererà un costo complessivo (poniamo) prevedibile in € 150 milioni.
Se, sulla base del track record dell’Antitrust è possibile stimare che solo il
15% dei cartelli venga scoperto, il costo atteso derivante dalla
partecipazione al cartello sarà di € 150 x 0,15 = € 22,5 milioni, ed il
costruttore parteciperà al cartello solo se il profitto addizionale atteso dalla
partecipazione al cartello sarà almeno superiore a € 22,5 milioni 38.
Torniamo ora al problema da cui siamo partiti: perché intervenire ex ante, e
non invece affidarci alla giustizia civile? La risposta, come mostreremo, è
36
Per essere più precisi, se siete indifferenti tra pagare € 2, o non partecipare alla lotteria,
siete neutrali rispetto al rischio; se siete disposti a pagare il biglietto soltanto meno di € 2,
siete avversi al rischio; se siete disposti a pagarlo più di € 2, siete amanti del rischio.
37
L’esempio, naturalmente, è del tutto fittizio: l’industria dell’auto è in genere ferocemente
competitiva.
38
Notiamo incidentalmente (il punto sarà sviluppato più oltre), che – conoscendo il profitto
addizionale e la probabilità che il cartello venga scoperto – potremo facilmente calcolare la
sanzione ottimale, ovvero quel livello di sanzione amministrativa che sarà sufficiente a
scoraggiare efficacemente il produttore di auto dal partecipare al cartello. Se il profitto
addizionale è pari (poniamo) a € 100 milioni, essa sarà ottenuta risolvendo la
diseguaglianza: sanzione x 0,15 > € 100 milioni, da cui ricaviamo facilmente che la
sanzione ottimale sarà pari a 100 : 0,15 = 666 milioni.
37
che frequentemente l’autore di un illecito confronta un costo atteso ben
inferiore al profitto che egli può attendersi dall’illecito.
Il verificarsi dell’esborso dipende infatti dalla probabilità che si verifichino
congiuntamente due eventi:
1. la vittima, o le vittime, instaurano un giudizio civile;
2. il giudizio si conclude con una condanna al risarcimento del danno
provocato.
Il calcolo delle probabilità insegna (ma, del resto, ciò è intuitivo) che la
probabilità che si verifichi un evento congiunto è pari al prodotto delle
probabilità che si verifichi ciascun evento preso singolarmente 39.
Supponendo che ambedue questi eventi siano molto probabili – e quindi che
ci sia una probabilità del 70% che il danneggiato promuova il giudizio, ed
ancora una probabilità del 70% che questo si concluda interamente a suo
favore - la probabilità che il danneggiante venga costretto effettivamente a
liquidare il danno inflitto sarà pari soltanto a 0,70 x 0,70 = 0,49, cioè a
meno del 50%.
Ciò rende alquanto attraente compiere l’illecito, a meno che ambedue le
probabilità siano ben più elevate del 70% ipotizzato, oppure che l’esborso
complessivo, per sanzioni e danni, sia molto elevato. Compiere l’illecito,
spesso, dunque conviene, tanto più che dal punto di vista del danneggiato
promuovere un giudizio può non essere una prospettiva attraente.
La probabilità di vittoria, nell’esempio, è infatti elevata (70%), ma
difficilmente il danno liquidato sarà pari al danno subito, perché il Tribunale
applicherà standard giuridici alquanto stringenti sotto il profilo della
causalità e della prova del danno; inoltre, in caso di vittoria le spese legali
saranno rimborsate, ma questo rimborso potrà non essere completo, ed in
ogni caso non sarà rimborsato tutto il tempo che il daneggiato avrà speso per
preparare e seguire il contenzioso. Queste due voci – la quota di danno non
liquidato e la quota di costi subiti non rimborsata – sono costi fissi che il
danneggiato deve sopportare se decide di promuovere il giudizio: egli – e
questo è il punto analitico rilevante – lo farà in genere quindi soltanto se il
danno subito è molto consistente, così che il valore atteso della liquidazione
del danno sia superiore al costo atteso dell’azione civile.
L'effetto combinato di quanto sopra discusso sarà che - in assenza di
qualche forma di regolazione ex ante – in molti mercati saranno frequenti
le azioni illecite, perché solo in pochi casi chi le commette dovrà rispondere
dei danni causati in sede civile 40.
39
La probabilità che mi rompa una gamba sciando è il prodotto della probabilità che io
vada a sciare, e della probabilità che – sciando – io mi rompa una gamba.
40
Naturalmente, un ragionamento analogo vale anche per i reati penali: a parità di altre
condizioni, ed ignorando evidenti considerazioni etiche, la probabilità che un individuo
38
Per questo, soprattutto nei sistemi giuridici che non conoscono istituti come
la class action, è socialmente più efficiente che vi sia un intervento di
politica economica volto a stabilire regole ex ante, piuttosto che lasciare la
tutela del mercato all'effetto ex post della giustizia civile.
Questo è dunque il secondo, importante, nesso, tra la politica
microeconomica e il Diritto.
4.3 Politica economica e gruppi di interesse
Finora abbiamo discusso di politica economica come se essa venisse messa
in atto da un ente astratto, che ha a cuore soltanto l’interesse sociale, e può
assumere le decisioni che meglio ritiene per perseguirlo. In economia, un
tale ente viene gustosamente indicato come il “dittatore benevolo”.
Ma naturalmente i dittatori benevoli non esistono, e le decisioni di politica
economica sono frutto di complicati processi decisionali, che vedono in
azione diversi gruppi di interesse. Ne discuteremo più avanti, ma qui è
utile anticipare che una spiegazione degli interventi di politica economica
alternativa a quella del “dittatore benevolo” è questi possono essere spiegati
come risposte alle richieste di tutela degli interessi che emergono da alcuni
gruppi (di consumatori, di imprese o altri ancora) che, organizzandosi
opportunamente, cercano di influenzarla 41.
La teoria dei gruppi di interesse appartiene all’insieme più vasto delle teorie
dell’interesse privato, secondo le quali esisterebbe un vero e proprio
“mercato” dove il bene scambiato sono specifiche misure di politica
economica. La domanda di tali misure è espressa dai gruppi portatori di
interessi organizzati, mentre l’offerta di queste misure proviene dai politici e
dai funzionari che ricevono in cambio voti e sostegni finanziari 42, o
naturalmente tangenti.
La politica economica diventa così uno strumento per ridistribuire il
reddito in favore dei gruppi più organizzati, piuttosto che per eliminare i
fallimenti del mercato o favorire comportamenti efficienti delle imprese.
Riprenderemo la discussione, ma per il momento concludiamo che questa
teoria è certamente molto importante perché coglie la complessità della
razionale commetta un reato dipenderà dalla probabilità di essere condannato, e dalle
caratteristiche della pena.
41
Inizialmente questo approccio venne formulato da politologi e sociologi che si
occupavano del ruolo dei gruppi di interesse nelle società democratiche moderne, ma queste
teorie sono poi state riprese in economia, a partire dal 1971, da Stigler in “The theory of
economic regulation”, che è diventata un riferimento fondamentale per tutta l’analisi
successiva.
42
La teoria della cattura del Regolatore, che abbiamo sopra discusso, è quindi un caso
classico di teoria dell’interesse privato.
39
formazione delle decisioni di politica economica. D’altro lato non possiamo
escludere che talvolta vengano decisi interventi di politica economica
esclusivamente considerando il beneficio sociale. La verità sta
verosimilmente nel mezzo, e la conseguenza analitica di questa
osservazione è che ogni volta che analizziamo interventi di politica
economica occorre sempre chiedersi se questi siano proporzionati rispetto
agli obiettivi sociali da raggiungere, oppure siano, in tutto o in parte,
influenzati da gruppi di interesse che perseguono naturalmente il loro
privato interesse.
4.4 Conclusioni
Avendo chiarito questo punto, tra breve entreremo in medias res,
proponendo una discussione dettagliata del rationale per varie tipologie di
interventi di politica economica.
Ci occuperemo in primo luogo, nel seguito di questa Parte I, delle politiche
a tutela della concorrenza, o politiche antitrust, considerando quelle che
colpiscono i cartelli, quelle che impediscono la formazione di monopoli (o
meglio, come vedremo, di posizioni dominanti), e quelle che vincolano le
azioni delle imprese che godano di una posizione dominante. Ci
occuperemo qui anche di una particolare forma di tutela della concorrenza
fra Stati, ovvero del divieto di ‘aiuti di Stato’: come vedremo, questo
aspetto, oltre che interessante di per sé, lo è a tratto più generale, perché
traccia un limite rilevante all’esercizio della politica economica da parte
degli Stati nazionali.
Nella Parte II ci occuperemo di un complesso di interventi regolamentari
che hanno luogo in settori nei quali le caratteristiche della tecnologia
rendono più efficiente la produzione da parte di un monopolista (come
vedremo, questi sono monopoli naturali), o in altri casi rilevanti nei quali
la politica microeconomica sia rivolta a limitare l’esercizio di una posizione
dominante da parte di uno o più agenti economici (tra questi, scopriremo
con qualche sorpresa, rientrano molti aspetti delle politiche del lavoro).
Ci occuperemo infine, nella Parte III, di vari problemi di disegno dei
mercati, nei quali la politica microeconomica interviene limitando
sensibilmente la potestà contrattuali delle parti, per risolvere ex ante
molteplici problemi in grado di generare perite di benessere sociale.
40
5. POLITICA INDUSTRIALE: FINALITA’ E LIMITI
Le considerazioni che sopra abbiamo sviluppato sulla politica economica
sono direttamente applicabili anche alla politica industriale. Questa è un tipo
particolare di politica economica, rivolta specificamente ad intervenire sulle
decisioni delle imprese: si chiama quindi politica industriale, ma in realtà
riguarda ogni tipo di imprese, nell’industria nei servizi.
Non riusciamo ad introdurre la politica industriale nello schema in cui
abbiamo discusso la politica economica, perché questo è uno schema
statico. Se la politica industriale parte anch’essa da nozioni che abbiamo già
introdotto, come esternalità e fallimenti del mercato, essa ne ricerca la
soluzione sotto il profilo dinamico. Non intende cioè tanto intervenire sulle
scelte di breve periodo delle imprese relative alla quantità da produrre (qui
intervengono politiche che abbiamo accennato, e che studieremo, ed in
primo luogo quelle antitrust e quelle volte alla regolazione dei mercati),
bensì sulle scelte dinamiche, relative agli investimenti e all’innovazione
tecnologica.
Ma perché mai dovremmo intervenire sulle scelte delle imprese in questo
campo? Dopotutto le imprese, se non investono e innovano, ben presto
spariranno, dunque la politica industriale è inutile.
Le motivazioni che vengono frequentemente offerte per gli interventi di
politica industriale sono legati a varie tipologie di fallimenti del mercato e di
esternalità: vediamole, con occhio critico, sinteticamente.
5.1 Esternalità positive
Si ritiene che, almeno in alcuni casi, l’impresa che avvia un progetto di
ricerca e sviluppo non riesce ad appropriarsi completamente dei frutti di
questo progetto. Ad esempio, sviluppandolo, essa avvierà progetti comuni
con un’università, addestrerà personale, e formerà ricercatori. Ma le
università potranno trarre idee dalla collaborazione con l’impresa, e in
seguito trasferirle ad altre imprese. Personale e ricercatori prima o poi se ne
andranno, e l’investimento in questo capitale umano effettuato dall’impresa
andrà perduto. Il programma di ricerche sviluppo avviato dall’impresa
genererà dunque delle esternalità positive. Una parte dei costi che l’impresa
sostiene non genereranno dunque frutti all’impresa stessa, ma ad altre
imprese. Questo naturalmente ridurrà la redditività attesa dello sviluppo del
programma di ricerca sviluppo, e renderà, a parità di altre condizioni, meno
probabile che l’impresa lo intraprenda.
41
Per una grande impresa, che presumibilmente intraprende programmi di
ricerca sviluppo ambiziosi, è probabile che questi effetti non siano
sufficientemente importanti da mettere a repentaglio la scelta di
intraprendere tali programmi. Inoltre, una grande impresa potrà spostare
personale e ricercatori al suo interno, rendendo meno probabile la perdita di
capitale umano. Questo non è necessariamente vero per le piccole imprese,
per le quali tipicamente l’investimento è rilevante rispetto alla capacità
finanziaria, ed il cui personale, per fare carriera, spesso cambia azienda.
Pertanto, vi sono diversi fattori che nelle piccole imprese possono portare ad
intraprendere meno programmi di ricerca e sviluppo di quanto altrimenti
non avverrebbe.
Questa è una delle tipiche giustificazioni che vengono fornite per il sostegno
alle attività di ricerca sviluppo delle piccole e medie imprese.
La politica industriale per il sostegno della ricerca sviluppo può servire
dunque a promuovere programmi che non sarebbero altrimenti intrapresi,
sia dalle piccole che dalle grandi imprese, per il ruolo rilevante che le
esternalità positive hanno per le attività di ricerca e sviluppo: questa è in
generale socialmente molto utile, ma non lo è necessariamente dal punto di
vista privato della singola impresa che deve sostenerne i costi.
5.2 Esternalità negative
Un altro gruppo di motivazioni fornito a sostegno di alcuni interventi di
politica industriale è basato sull’idea che l’ambiente in cui opera un’impresa
possa generare dei costi a suo carico che ne ostacolano lo sviluppo.
Questi fattori sono sostanzialmente di tipo ambientale, nozione che
possiamo considerare da diversi punti di vista:
• geografico, se l’impresa opera in una zona periferica, lontana dai
mercati in cui essa vende o può vendere il proprio prodotto;
• logistico, se l’impresa opera in un’area poco servita da ferrovie e
autostrade;
• della qualità dei fattori produttivi disponibili. Ad esempio, se
l’impresa opera in una zona in cui l’istruzione tecnica è scadente, o
lontana da poli universitari di materie scientifiche, essa troverà un
capitale umano di qualità inadeguata.
Potremmo fare altri esempi, ma quanto discusso è sufficiente a illustrare le
possibili motivazioni che possono essere apportate a sostegno delle politiche
industriali ambientali.
42
5.3 Una politica industriale per l’innovazione delle piccole
imprese?
Le imprese innovano continuamente: schematizzando, non appena
un’impresa introduce una innovazione essa è, in genere, in grado di godere
di profitti più alti dei suoi concorrenti, che possono derivare da innovazioni
di processo (una nuova tecnologia mi consente di ridurre i costi di
produzione, aumentando il margine sulle vendite), o da innovazioni di
prodotto (un nuovo prodotto mi consente di differenziarmi dalle altre
imprese, ed i consumatori sono disposti a pagare un prezzo maggiore per i
miei, differenti, prodotti). Allora, perché dovremmo incentivarle a fare
qualcosa che comunque esse farebbero egualmente?
Una risposta frequente a questa domanda, è che ciò è necessario, almeno per
un Paese come l’Italia, la cui struttura produttiva è caratterizzata da un
numero enorme di imprese molto piccole 43, perché tali imprese affrontano
ostacoli rilevanti nei processi di innovazione, attribuibili a costi di
transazione e ad informazioni incomplete: la politica industriale deve
quindi sostenere i processi di innovazione tecnologica delle piccole
imprese.
Ma anche nei programmi di ricerca e sviluppo, tipicamente realizzati dalle
grandi imprese, potrebbero verificarsi dei fallimenti di mercato: davanti a
programmi di ricerca rischiosi, il cui rendimento economico privato è
aleatorio, le grandi imprese potrebbero sviluppare un livello di investimenti
efficiente dal punto di vista privato, ma insufficiente sul piano sociale, e
sarebbe quindi necessario un finanziamento pubblico, almeno parziale, di
questi programmi. Questo è, naturalmente, un argomento basato sulle
esternalità positive.
Vi sono dunque diversi argomenti che è possibile avanzare a favore delle
politiche a sostegno dell’innovazione.
Per analizzarle, bisogna anzitutto distinguere tra propensione a produrre
innovazioni, e propensione ad introdurre innovazioni (da altri prodotte)
nella propria azienda.
Quanto alla propensione a produrre innovazioni, studi recenti, condotti su
un campione molto ampio di brevetti 44, mostrano come tale propensione
dipenda in primo luogo dall’investimento in ricerca e sviluppo, e in secondo
dalle modalità di incentivazione (monetarie, o di carriera) dei ricercatori.
Non vi è, invece, una relazione significativa tra dimensione d’impresa ed
attività innovativa. Quindi se, a parità di altre condizioni, la grande
43
Circa il 50% dei 16 milioni di addetti nell’industria manifatturiera italiana lavorano in
imprese con meno di 10 addetti.
44
Si veda, di A. Gambardella et al. The value of Patents, disponibile all’indirizzo:
http://www.alfonsogambardella.it/GHVValueofPatents.pdf.
43
dimensione può favorire, in alcuni settori, l’attività innovativa 45, questa non
è necessariamente una condizione necessaria: almeno in alcuni settori,
grandi progetti possono essere infatti intrapresi suddividendo adeguatamente
l’attività di ricerca tra molte imprese diverse 46. Ad esempio, buona parte
delle imprese che hanno fatto decollare il corrente ciclo tecnologico, basato
sulla microelettronica e sull'informatica, erano di piccola dimensione.
Anche se il problema è certamente complesso, possiamo comunque
sinteticamente concludere che soltanto in alcuni settori una grande scala
produttiva è necessaria per sostenere una forte attività innovativa: vi sono
molti altri casi nei quali ciò non è necessario. In secondo luogo, la
dimensione non è certamente l'unica variabile rilevante: la disponibilità
di capitale umano di elevata formazione scientifica; la disponibilità, a costi
ragionevoli, di capitale di rischio; l'accesso alla ricerca universitaria, sono
tutte caratteristiche estremamente importanti per favorire la produzione di
innovazioni.
Per quanto riguarda specificamente le attività di ricerca e sviluppo, i
(pochi) studi disponibili 47 non sembrano evidenziare l’esistenza di fallimenti
di mercato, ma anzi concludono che il rendimento lordo degli investimenti
in ricerca e sviluppodelle imprese innovatrici italiane è stato pari al 20%
all’inizio degli anni novanta, ed è salito al 22% verso la fine di quel
decennio. Inoltre, il tasso di rendimento degli investimenti in ricerca e
sviluppo risulta indipendente dalla localizzazione geografica, dalla
dimensione (ancora!) e dal settore di appartenenza delle imprese.
Quanto alle determinanti dell’adozione di nuove tecnologie, studi recenti,
riferiti alla microelettronica 48, mostrano come questa dipenda in generale da
due fattori:
a. la dimensione dell'impresa, che determina sia la probabilità che
un’azienda adotti nuove tecnologie, sia "quanto e quando" esse
vengano immesse nei processi aziendali: più è grande l'impresa, più
probabile è l'adozione e più intenso l'uso della nuova tecnologia che
si decide di farne;
45
Ad esempio, in settori come il farmaceutico, gli investimenti necessari per sviluppare un
nuovo farmaco sono in media pari a circa 1 miliardo di dollari, e dunque alla portata
soltanto di imprese aventi una scala adeguata a ‘spalmare’ questo investimento su ampi
volumi di vendite.
46
Ciò è frequente, ad esempio, nel settore aerospaziale.
47
Si veda: “Il tasso di rendimento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese
innovatrici italiane”, di Francesco Aiello e Valeria Pupo, in Politica Economica, 2004.
48
Si veda: Salvatore Rossi (curatore), La nuova economia: i fatti dietro il mito, il Mulino,
2003.
44
b. il livello del capitale umano disponibile: imprese con una
manodopera mediamente più istruita riescono più facilmente ad
introdurre innovazioni.
Vi sarebbe quindi forse spazio per incentivare l’adozione di nuove
tecnologie da parte delle piccole imprese, perché qui la dimensione
effettivamente è un fattore rilevante, ma naturalmente gli strumenti da
utilizzare dovrebbero essere tali da generare investimenti addizionali, nel
duplice senso di:
• convincere una data piccola impresa a fare investimenti che
altrimenti non avrebbe fatto;
• non avere effetti di sostituzione apprezzabili, scoraggiando gli
investimenti delle imprese che non ricevono l’incentivo.
I risultati delle politiche per l’innovazione nel nostro Paese non sono però
incoraggianti. Come mostra un recente studio della Banca d’Italia 49, la
principale legge di incentivazione italiana volta a favorire l’adozione di
nuove tecnologie da parte delle piccole imprese, che ha erogato tra il 1996
ed il 2003 la rispettabile cifra di € 16 miliardi, non ha avuto effetti netti
sensibili: le imprese che concorrevano per il contributo, rallentavano infatti
gli investimenti prima di fare domanda per il contributo, ed in ogni caso i
maggiori investimenti delle imprese che ottenevano il contributo
sostituivano in parte i minori investimenti di quelle che non lo ottenevano.
Possiamo quindi concludere che, anche se in teoria vi potrebbe essere
spazio per politiche volte a favorire l’introduzione di innovazioni da parte
delle piccole imprese, in pratica è estremamente difficile assicurare che gli
incentivi erogati con queste finalità diano luogo effettivamente ad
investimenti addizionali.
5.4 Indivisibilità
Alcuni programmi di ricerca e sviluppo richiedono un enorme investimento
iniziale, che probabilmente un’impresa, anche se grande, non sarebbe in
grado di finanziare. Le banche, infatti, considereranno la probabilità che
l’investimento non raggiunga i risultati sperati, e che dunque possa essere
difficile in futuro ottenere il rimborso dei crediti prestati. Per assicurarsi
contro tale rischio, esse come minimo chiederanno un tasso di interesse
elevato, ma spesso potranno anche risultare indisponibili a prestare i fondi
49
Si veda: R. Bronzini – G. De Blasio, Qual è l’effetto degli incentivi agli investimenti?
Una valutazione della Legge 488/92.
45
necessari per avviare l’investimento. Considerazioni analoghe saranno fatte
anche da fornitori di capitale di rischio, e pertanto un programma di
investimento socialmente utile potrebbe non essere in pratica realizzato in
quanto non sono disponibili adeguate risorse finanziarie per le attività
relative di start up.
Un esempio che viene frequentemente fornito è quello di Airbus: lo
sviluppo di aeromobili civili richiede investimenti talmente enormi in
ricerche sviluppo, che senza l’aiuto dei governi francese, tedesco e
britannico, Airbus non sarebbe mai nata. Essa al contrario si è vivacemente
sviluppata ed ormai contende alla Boeing il primato a livello mondiale.
Grazie questi investimenti, si sono create ricadute estremamente importanti
in altri settori produttivi, principalmente in questi tre paesi (ma non
esclusivamente: Finmeccanica in Italia partecipa ai programmi Airbus),
dalla meccanica di precisione, allo sviluppo di nuovi materiali,
all’elettronica ed al software.
Se in effetti si può ragionevolmente ritenere che nel settore aerospaziale i
meccanismi di funzionamento di mercato incontrino difficoltà ad affermarsi,
a causa della larga presenza di economie di scala e dell’importanza della
ricerca e sviluppo 50, non è in ogni caso chiaro se la scelta di creare Airbus
come campione europeo sia una scelta ragionevole.
Lo sviluppo di Airbus è stato certamente impetuoso, e la sua quota di
mercato degli aeromobili civili wide body ha superato, nel 2003, quella di
Boeing, raggiungendo nel 2004 il 54% 51. Anche la sua redditività è
aumentata in misura significativa, raggiungendo nel biennio più recente
livelli elevati (Figura 5.1).
Non sono però in alcun modo chiari i costi che i contribuenti europei hanno
dovuto sopportare per finanziare, in quasi quaranta anni, il decollo di
Airbus: l’impresa venne infatti strutturata nel 1970 come un Groupement
d’interet économique, e pertanto nessuna informazione è disponibile
sull’ammontare dei sussidi pubblici erogati alle aziende consorziate, almeno
fino all’esercizio 2001, anno in cui Airbus è diventata una normale società
per azioni.
50
Per una discussione sugli economics del settore, si veda Neven e Seabright (1995).
Boeing ha naturalmente attribuito questo netto capovolgimento ai sussidi governativi
ricevuti dalla Airbus. I sussidi nel settore della costruzione di grandi aeroplani sono regolati
da un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti stipulato nel 1992. Quell’accordo è stato
tuttavia sostanzialmente messo in crisi dal progetto Airbus di sviluppare il modello A350
per lunga tratta. Proprio nello scorso mese di maggio, gli americani hanno minacciato di
ricorrere al WTO a fronte di una richiesta di Airbus al governo inglese di ottenere un nuovo
sussidio (peraltro rimborsabile) di ammontare imprecisato. La Commissione Europea ha
annunciato di voler portare a sua volta la Boeing sul tavolo del WTO con l’accusa di
ricevere sussidi dalla NASA e dal Dipartimento della Difesa, attraverso contratti spesso
coperti dal segreto di Stato, e dallo Stato attraverso incentivi fiscali.
51
46
Figura 5.1. Principali dati economici di Airbus (anni 2003 e 2004)
Fonte: Presentazione di EADS agli analisti finanziari (febbraio 2005).
Le analisi disponibili sono dunque basate prevalentemente su modelli di
simulazione. La più dettagliata, anche se datata, da parte di Neven e
Seabright (1995), concludeva che l’entrata di Airbus – aumentando la
concorrenza – aveva avuto fino ai primi anni novanta un debole effetto
positivo sul surplus dei consumatori, ma ridotto l’attività innovativa da parte
degli altri produttori, le cui vendite attese si erano contratte per effetto
dell’entrata. Non era pertanto chiaro se la scelta di creare Asirbus come
campione europeo presentasse un beneficio netto.
Perplessità sul successo di Airbus sussistono in ogni caso in senso
prospettico, stante la dubbia redditività del lancio del SuperJumbo A380. A
fronte di un costo di sviluppo stimato in circa $12 miliardi, e di un prezzo di
vendita stimato in circa $ 220 milioni, nel caso Airbus riuscisse ad ottenere
un mark up sui costi variabili del 15%, essa dovrebbe vendere circa 360
unità prima di ripagare i costi di sviluppo. Questo obbiettivo di vendita è
però ambizioso, dato che il Boeing 747 ha venduto complessivamente, in 35
anni dal suo lancio, buona parte dei quali in posizione di monopolio, circa
1.400 unità. Tra il 2000 (anno della prima consegna) e la fine 2015 Airbus
aveva venduto solo 173 velivoli.
Un’analisi di simulazione, condotta da studiosi americani, mostra in effetti
come sia probabile che sia Airbus che Boeing registreranno una perdita se le
vendite totali di SuperJumbo si assesteranno, come appare realistico, tra i 30
e i 50 aerei all’anno 52.
Possiamo dunque concludere che, se la promozione di Airbus come
campione nazionale europeo ha prodotto esternalità positive (anche se non
ci sono noti studi in questo campo), non è in alcun modo chiaro se gli aiuti
52
Si veda Esty e Ghemawat (2002).
47
di Stato diretti (fondi per la ricerca e per il lancio di nuovi aerei) ed indiretti
(acquisto di aeromobili Airbus da parte dei paesi partecipanti al consorzio)
abbiano avuto un ritorno soddisfacente, sia in termini monetari che di
benessere.
5.5 Campioni nazionali
Una variante per così dire hard della teoria della politica industriale basata
sulla promozione di esternalità positive in presenza di significative
indivisibilità è quella nota come creazione promozione di “campioni
nazionali”. Politici e capitani d’industria tendono a ritenere che creare
campioni nazionali consenta di creare o rafforzare filiere produttive
fondamentali, facendo progredire l’economia, anche se gli economisti, per i
motivi che vedremo ora, sono assai più freddi.
Per definire i “campioni nazionali” è utile una definizione teleologica: un
campione nazionale è un’impresa che – per qualche motivo - gode di uno
speciale trattamento da parte dei pubblici poteri, che può consistere nella
concessione di aiuti di stato direttamente e non direttamente classificabili,
secondo la normativa europea, come tali, nell’attribuzione preferenziale di
contratti da parte della Pubblica Amministrazione, ed in altre misure volte
alla sua promozione.
Questa definizione, alquanto generale, è utile ai nostri fini, perché ha il
pregio di poter essere applicabile alle diverse (ed a volte inscrutabili)
imprese via via assurte allo status di campione nazionale (per limitarci alla
Francia: dalla siderurgia di Usinor, all’aerospaziale di Ariane, alla
televisione di Canal+).
La definizione ci permette anche di chiarire i rapporti tra politica industriale
e politiche a sostegno dei campioni nazionali: queste ultime sono sviluppate
utilizzando in modo coordinato varie leve della politica industriale, verticali
(politiche di procurement del settore pubblico, aiuti settoriali etc.) ed
orizzontali (aiuti regionali o alla ricerca etc.) 53.
Da un punto di vista economico, le motivazioni più frequentemente
avanzate a sostegno di queste politiche sono cinque:
53
-
la necessità di conseguire economie di scala nella produzione;
-
la necessità di acquisire economie di scala nelle attività di R&S;
-
le imperfezioni nei mercati finanziari, che renderebbero difficile
finanziare progetti particolarmente innovativi;
La questione è però dibattuta: Cabral (2001) identifica tout court la politica industriale
con le politiche per i campioni nazionali.
48
-
le esternalità positive, sotto forma di effetti di spillover, che
deriverebbero dall’esercizio di particolari attività industriali;
-
la necessità di difesa rispetto a politiche di promozione dei
campioni nazionali portate avanti da altri Paesi.
In un mercato mondiale che si globalizza, i campioni nazionali sarebbero
indispensabili ad un Paese per competere: realizzando economie di scala,
essi sono in grado di produrre a bassi costi; potendosi permettere elevati
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, essi risultano fortemente
innovativi. Per l’una e per l’altra via essi promuovono la competitività
dell'economia nazionale. Lo Stato deve dunque intervenire sostenendoli,
direttamente o indirettamente, o comunque facilitandone lo sviluppo.
Analizziamo queste motivazioni.
Quelle riferite alla scala produttiva sono spesso presentate all’interno di
analisi riferite ai risultati della strategic trade theory, secondo la quale
governi nazionalisti utilizzano vari strumenti per promuovere l’interesse
delle imprese nazionali, al fine di spostare all’interno del Paese le rendite
che esse ricevono dal potere di mercato di cui godono. In questi modelli, la
concorrenza tra Paesi è negativa, perché spreca risorse mondiali, ma
naturalmente il Paese che vince la gara accumula rendite 54.
Questi argomenti sono accattivanti, ma nella maggior parte dei casi si
rivelano errati, perché si basano su una caricatura delle caratteristiche dei
processi concorrenziali.
Le economie di scala nella produzione costituiscono infatti una fonte
rilevante di vantaggio competitivo soltanto in un numero limitato di settori
produttivi, che producono beni standardizzati ove il prezzo è la variabile
determinante per la domanda. In realtà, nella maggior parte dei mercati per
prodotti industriali e per servizi, vi sono ampi spazi per l'offerta di prodotti
differenziati, i quali in generale non richiedono necessariamente un'ampia
scala produttiva 55. L’argomento delle economie di scala mantiene qualche
pregio per i settori ad alta intensità di capitale (ad esempio centrali nucleari)
ma non va ovviamente confuso con quello delle dimensioni: in questo caso,
poiché la globalizzazione determina un rapido aumento della produzione di
prodotti scale intensive nei Paesi a bassi costi di lavoro, una politica volta a
sostenere le dimensioni d’impresa in questi settori nei Paesi sviluppati non
ha in generale molte prospettive di successo.
D’altra parte, l’idea che un’ampia scala sia necessaria per distribuire elevati
investimenti in R&S su un ampio volume di vendite, è ragionevole soltanto
in quei (pochi) settori nei quali vi sono elevate economie di scala all’interno
54
55
Si veda Besley – Seabright (1999).
Si veda Geroski (2005).
49
delle attività di R&S: come mostrano i grandi processi innovativi degli
ultimi trent’anni, nella maggior parte di casi (dall’industria chimica a quella
automobilistica, dalle biotecnologie alla microelettronica) gli investimenti di
ricerca e sviluppo possono efficacemente essere suddivisi tra imprese di
piccola e media dimensione, che sviluppano progetti diversi in vivace
concorrenza tra di loro. Le economie di scala nell’attività di R&S che
vengono così perdute sono più che compensate dai guadagni di efficienza
derivanti dalla concorrenza tra imprese innovatrici.
Una terza motivazione è quella dell’incapacità dei mercati finanziari a
finanziare progetti di ricerca e sviluppo particolarmente innovativi. Anche
questa non appare convincente alla luce del fatto che questi mercati sono
stati in grado – con strumenti molto diversi, dal credito al venture capital –
di finanziare nell’ultimo ventennio una delle maggiori ondate di innovazioni
della storia umana. Naturalmente sussistono differenze sensibili tra Europa e
Stati Uniti nella capacità dei mercati finanziari di finanziare l’innovazione;
ma il rimedio ai ritardi dell’Europa andrebbe ricercato in politiche di
integrazione efficace ed è qui che si registrano ritardi e “nazionalismi”
disarmanti: a distanza di sei anni dal progetto Action Plan la nuova
Commissione ha annunciato un Financial Services Policy Programme,
implicitamente denunciando il quasi fallimento degli obiettivi fissati nel
1999
La quarta motivazione – gli effetti di spillover – può essere in alcuni casi
ragionevole, ma naturalmente la sua validità dipende da un complesso di
fattori, tra i quali: la natura delle tecnologie e delle lavorazioni; le
caratteristiche del tessuto produttivo; le caratteristiche della mano d’opera
disponibile; l’esistenza di un sistema formativo in grado di sfruttare gli
effetti di spillover.
Un quinto argomento in favore del sostegno dei campioni nazionali è di
carattere difensivo, ovvero la necessità di contrastare politiche analoghe
messe in opera da altri Paesi. Anche questo argomento può essere valido in
alcuni casi, ma naturalmente a patto di dimostrare che non vi siano soluzioni
alternative disponibili, basate sui normali strumenti di tutela offerti
dall’Unione e dal WTO, e che una difesa fondata su un campione nazionale
abbia possibilità di successo.
Pertanto, poiché le argomentazioni più generali offerte in favore dei
campioni nazionali (scala, mercati finanziari) non sono in genere valide, lo
scope per politiche di questo tipo è alquanto limitato. Esse possono essere
giustificabili in alcuni casi, ma certamente soltanto dopo una normale
valutazione costi-benefici che è peraltro sempre rigorosamente assente.
Una tale valutazione è particolarmente importante quando si consideri, che
naturalmente, decidendo di favorire una data impresa, si decide nel
50
contempo di sfavorire i suoi concorrenti, e presumibilmente il favor
accordato all’impresa avrà effetti sia sui suoi fornitori che la sua clientela.
Per finire, i sostenitori dei campioni nazionali ignorano il potente ruolo
distorsivo che possono avere i gruppi di interesse, ed in particolare quelli
che trarrebbero beneficio dalla trasformazione di una certa impresa in un
campione nazionale: tra questi vi sono naturalmente gli azionisti, i manager,
ma anche i fornitori (che si troverebbero davanti un acquirente in qualche
modo protetto, e dunque meno orientato a minimizzare i costi) ed i
dipendenti stessi (che riuscirebbero con minor fatica ad ottenere
miglioramenti retributivi). Grazie alla loro influenza, molto frequentemente
il campione nazionale ingrassa e rallenta, è fortemente competitivo a casa
propria, ma registra frequenti disastri sui mercati internazionali dove deve
confrontarsi con veri concorrenti, e dopo alcuni anni comincia a registrare
perdite consistenti, richiedendo contributi pubblici per sopravvivere.
Un limite ulteriore di tutte le argomentazioni in favore dei campioni
nazionali è comunque il loro concentrarsi su un problema specifico, di
settore o d’impresa, considerando soltanto le esternalità positive
dell'intervento che viene proposto, ma ignorando le esternalità negative, che
possono essere molto importanti.
Se il campione nazionale che viene sostenuto non è in posizione di
monopolio, il suo sostegno mette in difficoltà le altre imprese, e dunque i
possibili guadagni di benessere sociale derivanti dalla politica di sostegno
proposta dovrebbero essere confrontati con la perdita di benessere derivante
dai problemi per le altre imprese. Se poi il campione nazionale è in
posizione di monopolio, la perdita di benessere come abbiamo visto è
garantita, ma questo fattore non viene praticamente mai considerato. Infine,
poiché il sostegno ad un campione nazionale trasferisce a questa impresa
rendite considerevoli in base a decisioni burocratiche, ciò evidentemente
crea forti incentivi alla corruzione.
5.6 Conclusioni
Considerando complessivamente le politiche economiche e quelle
industriali, possiamo concludere come da un lato l’immagine di un
“benevolo dittatore”, che persegue attraverso queste politiche soltanto il
pubblico interesse è in larga misura illusoria. Il pubblico interesse è sempre
presente nel dibattito di politica economica, ma a fianco ad esso hanno un
ruolo molto importante gruppi d’interesse.
Come regola approssimata, possiamo anche dire che il ruolo dei gruppi
d’interesse è tanto più forte quanto più è “mirato” l’obiettivo: se una politica
di miglioramento della qualità della forza lavoro attraverso (ad esempio)
l’erogazione di incentivi agli studenti che si scrivano ha facoltà scientifiche
51
sarà difficilmente preda di gruppi d’interesse (forse con l’eccezione dei
professori di queste università), una politica industriale volta a trasformare
l’Alitalia in un campione nazionale (che Dio ci protegga!) sarebbe facile
preda per tutti i gruppi d’interesse che ruotano intorno ad Alitalia.
Le politiche industriali sono quindi generalmente un inutile dispendio di
fondi pubblici, ed è molto più efficace la predisposizione di interventi
generalizzati di politica economica, che mirino a delimitare il terreno nel
quale si svolge il confronto concorrenziale, stabilirne le regole, e sanzionare
chi non li rispetti.
Questi sono appunto gli strumenti su cui ci concentreremo nella parte
rimanente di questo corso.
52
Parte II – Politiche antitrust
53
6. LE POLITICHE PER LA CONCORRENZA: OVERVIEW
Come abbiamo visto nel Capitolo 2, la presenza di un monopolio nel
mercato di un prodotto genera varie tipologie di perdite di benessere per i
consumatori; il danno è poi in realtà più vasto, perché la presenza di
monopoli diminuisce il benessere sociale, ovvero il benessere di tutti gli
agenti del sistema economico.
Questo, dal punto di vista economico, è il fondamento razionale delle
politiche antitrust. Queste, in realtà, più che al monopolio in senso stretto
sono rivolte più generalmente alle imprese in posizione dominante: come
vedremo più oltre, questa nozione giuridica è più ampia di quella economica
di monopolio, poiché comprende imprese che abbiano sì concorrenti, ma
che siano talmente potenti sul mercato da poterli ignorare, e comportarsi in
modo indipendente da essi, oltre che dai consumatori.
In particolare, sono necessarie politiche a tutela della concorrenza, al fine di:
1. evitare che le imprese coordinino il loro comportamento,
formando cartelli, in modo da cessare di competere tra loro, e
comportarsi come monopolisti. Questa è la logica sottostante
all’articolo 101 TFUE, e delle decisioni di policy molto
restrittive che portano ad imporre ingenti sanzioni contro i
cartelli e – in alcune giurisdizioni, particolarmente negli Stati
Uniti – sanzioni criminali contro i manager che organizzano
cartelli;
2. evitare che si creino monopoli o imprese in posizione dominante
attraverso fusioni o acquisizioni. Questa è la logica sottostante al
Regolamento della CE che fornisce le norme necessarie per
controllare quelle che vengono generalmente definite come
‘concentrazioni’;
3. evitare che le imprese che godono di una posizione di monopolio
o di una posizione dominante escludano i propri concorrenti,
effettivi o potenziali, dal mercato utilizzando strumenti
competitivi che sarebbe irrazionale utilizzare, se non per
escludere i concorrenti stessi., Questa è la logica sottostante
all’articolo 102 TFUE.
Ma siamo davvero sicuri che i cartelli ed i monopoli [o, per essere più
precisi, le imprese dominanti] debbano essere presi così seriamente, tanto da
costruire un corpus piuttosto complesso di norme di public policy per
trattarne?
54
Per i cartelli, la risposta è chiaramente positiva alla luce della nostra
discussione precedente. E’ vero che i cartelli non sono stabili, ma possono
essere resi stabili attraverso lo scambio di informazioni tra i membri, e
(come discuteremo in maggiore dettaglio nei prossimi paragrafi) adottando
politiche che rafforzino, per i membri che vi partecipano, le regole del
cartello. I cartelli sono estremamente dannosi per i consumatori e per la
collettività, e quindi anche se l’instabilità dovesse prima o poi prevalere, il
benessere pubblico potrebbe andare nel frattempo incontro a sostanziali
perdite. Per tutto ciò, è necessario che vi sia una politica contro i cartelli.
Tuttavia, ci sono visioni contrastanti sulle imprese dominanti, e vengono
date generalmente due motivazioni per invocare maggior laissez faire nei
loro confronti: in parecchi casi, persino un vero monopolista può
comportarsi effettivamente come un’impresa competitiva; in secondo luogo,
tutti i monopoli sono temporanei, e – prima o poi – i concorrenti entreranno
nel mercato del monopolista, e la concorrenza prevarrà. Così, non
dovremmo preoccuparci di limitare il potere di mercato delle imprese
dominanti: il mercato si prenderà cura di se stesso.
Questo punto di vista è storicamente molto importante, dal momento che ha
portato a politiche molto deboli a tutela della concorrenza negli Stati Uniti,
soprattutto durante i periodi di presidenza Reagan e Bush. Questo punto di
vista non è complessivamente corretto, ma contiene alcuni grani di verità, e
deve pertanto essere considerato.
Se un monopolista operasse nel mercato in cui non ci sono barriere
all'entrata, nel quale nuovi concorrenti potrebbero iniziare ad operare in un
ragionevole breve lasso di tempo, non sarebbe razionale per lui comportarsi
come prevede la teoria economica, e cioè diminuire l'output e aumentare i
prezzi. Se facesse così, il monopolista godrebbe di elevati profitti, ma tali
profitti attrarrebbero l'entrata di nuovi concorrenti i quali vanificherebbero
la strategia: la diminuzione dell'output del monopolista non porterebbe ad
un aumento dei prezzi, dal momento che essa sarebbe compensata da un
aumento dell’offerta da parte dei nuovi concorrenti entrati in questo mercato
perfettamente contendibile.
Questa teoria afferma un’importante verità: le decisioni di prezzo trovano
un limite nella minaccia di entrata da parte dei concorrenti. Come vedremo,
quando analizzeremo il mercato rilevante, dovremo considerare la
probabilità di entrata da parte di nuovi concorrenti. D'altra parte, i mercati
perfettamente contendibili sono davvero molto rari, dal momento che le
barriere all'entrata sono create da fattori esogeni come la tecnologia (in
molti settori industriali è impossibile costruire uno stabilimento sotto un
determinato livello di capacità produttiva), o da fattori endogeni, che
riflettono le strategie delle imprese dominanti (ad esempio, se un’impresa
dominante satura con i suoi messaggi la pubblicità televisiva, un
55
concorrente potenziale dovrà investire somme considerevoli in pubblicità,
non essendogli altrimenti possibile farsi largo tra i messaggi dell’impresa
dominante).
Pertanto, quest'osservazione è importante sotto il profilo teorico, ma non è
in pratica sufficiente per convincerci ad abbandonare gli strumenti della
politica antitrust nei confronti dei monopolio, o, più ampiamente, nei
confronti delle imprese dominanti, anche qualora esse operino in mercati
perfettamente contendibili.
D'altro lato, è vero che le posizioni dominanti spesso vengono erose.
Microsoft è stata la prima impresa a produrre un sistema operativo efficace
per i personal computer, e ha goduto per molto tempo di una posizione di
quasi-monopolio, ma Apple, e gli altri sistemi operativi basati su Linux,
hanno significativamente eroso la sua posizione di mercato, cosicché
probabilmente Microsoft oggi non è più dominante nei sistemi operativi per
i personal computer.
Anche i monopoli geografici possono essere erosi: per molti decenni, il
mercato del cemento in Sardegna era altamente concentrato, e i prezzi
divergevano da quelli del resto d'Italia. Gradualmente, sono state costruite
infrastrutture nei porti che permettevano lo scarico del cemento. Il mercato
sardo del cemento è diventato quindi contendibile, e i prezzi sono scesi.
Persino i monopoli legali, come i brevetti, possono essere erosi: la prima
generazione di telefoni cellulari lanciata sul mercato nei primi anni Ottanta
era protetta da molteplici brevetti, i quali sono stati rapidamente resi
obsoleti dal progresso tecnico.
Questa è una valida ragione per adottare un approccio tollerante nei
confronti delle imprese dominanti?
La risposta è no. La prima ovvia ragione è l'argomento precedente che
abbiamo sviluppato per i cartelli: il costo in termini di benessere che la
società sopporta nel periodo, che può essere molto lungo, prima che il
monopolio venga eroso dalla concorrenza, può essere molto significativo.
C'è tuttavia un ulteriore argomento: in alcuni casi speciali, ma molto
importanti, un monopolio può essere irreversibile, oppure resistere per un
lungo periodo di tempo.
Nella teoria microeconomica di base, si suppone generalmente che i
consumatori possono spostarsi da un prodotto di un altro senza incorrere in
alcun switching cost (detto anche costo di transizione). Ma questa,
ovviamente, è un'ipotesi molto semplificatrice: se io voglio smettere di usare
il mio Blackberry ed acquistare un iPhone, devo spendere alcune ore per
familiarizzarmi con il nuovo telefono, spostare i contatti della mia rubrica e
delle mie e-mail da un telefono all'altro, e così via. Questo è un semplice
esempio di switching cost per i consumatori.
56
Gli switching costs esistono anche per i produttori, e possono essere
significativi (si pensi alle modifiche che possono essere richieste nella
produzione di auto utilizzando la plastica anziché l'acciaio in un particolare
componente). Se gli switching costs sono rilevanti, un'impresa che crea una
posizione dominante nel mercato ne trarrà beneficio per un lungo periodo di
tempo, anche se nel mercato saranno presenti molti concorrenti, dal
momento che i questi dovranno offrire prodotti molto migliori, o molto più
economici, affinché per i consumatori sia ragionevole sopportare gli
switching costs. In presenza di costi di questo tipo, quindi, le posizioni
dominanti sono più difficili da erodere.
Altri effetti che possono portare alla creazione permanente di una posizione
di monopolio sono gli effetti di rete (network effects). Definiamoli.
Un consumatore di un bene normale (ad esempio, il gelato), registra un
aumento nella propria utilità dall'aumento della quantità di gelato
consumata, almeno fino ad un certo punto: questo è il motivo per cui egli è
disponibile a pagare un prezzo più alto per un gelato più grosso.
Questo è altrettanto vero per quanto riguarda le telefonate ad un amico: io
sono pronto a pagare di più se parlo di più. Ma questo non è tutto, dal
momento che la mia utilità come abbonato telefonico dipende dal numero
delle persone che si abbonano alla stessa rete: questo è vero per quanto
riguarda le reti fisiche (telefoni) ma anche per le reti logiche, come
Facebook e Twitter; o Microsoft Office (provate a utilizzare fogli elettronici
di operatori diversi e cercate di renderli interoperabili tra di loro, e vedrete la
difficoltà). È certamente anche il caso di servizi VOIP come Skype. In tutti
questi casi, una volta che l'operatore di rete raggiunge una massa critica di
utenti, diventa molto difficile per un'altra impresa competere.
Questa potrebbe essere una ragione sufficiente per azioni antitrust
particolarmente aggressive nei confronti di queste imprese, ma non è
necessario che la materia venga ulteriormente approfondita: la teoria
economica degli effetti a rete è materia complicata, e quanto abbiamo
brevemente detto finora dovrebbe essere sufficiente per chiarire che nei casi
in cui tali effetti sono rilevanti, le posizioni dominanti delle imprese
possono essere permanenti, o almeno durare molto a lungo.
Concludiamo quindi affermando che vi sono importanti motivi per
l'esistenza di politiche a tutela della concorrenza, e introduciamo ora una
discussione più tecnica delle modalità con cui tali politiche sono realizzate.
57
7. LE POLITICHE ANTITRUST: CAMPO DI APPLICAZIONE,
MERCATO RILEVANTE E MISURAZIONE DEL POTERE
DI MERCATO
Occupiamoci ora di capire con precisione quale sia il campo di applicazione
di queste politiche, e di discutere come venga definito, dalle autorità
antitrust, il mercato rilevante all'interno del quale si muovono le imprese:
come vedremo, la sua corretta delimitazione è di importanza fondamentale
per l'efficacia delle politiche antitrust. Vedremo infine come valutare il
potere di mercato delle imprese, che è uno strumento necessario per
valutare la capacità di un’intesa di alzare i prezzi, per analizzare possibili
comportamenti abusivi da parte di un’impresa dominante o, ancora, per
prevedere gli effetti sulla struttura del mercato derivanti da una
concentrazione.
7.1 Il campo di applicazione
I divieti di intese restrittive e abusi di posizione dominante, nonché il
sistema di controllo delle concentrazioni, si applicano esclusivamente alle
imprese. Il Trattato CE e la legge italiana sulla concorrenza non forniscono
una definizione di impresa. Il diritto della concorrenza accoglie una nozione
di impresa i cui contorni sono definiti facendo leva su criteri più sostanziali
ed economici che formali. La nozione antitrust di impresa è dunque in
genere più ampia di quella fatta propria da altre branche del diritto.
Come chiarito dalla CGCE nel caso Höfner, ai fini del diritto comunitario
della concorrenza un’impresa è qualsiasi soggetto, sia esso una persona
fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, cioè offra beni o servizi
su un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico o dal
modo in cui è finanziata 56. Può essere quindi attività d’impresa qualsiasi
attività che si presti, anche solo potenzialmente, a essere svolta in regime di
concorrenza 57. Non è necessario lo scopo di lucro: è sufficiente che l’attività
sia suscettibile di essere svolta a tale scopo.
Sono dunque certamente imprese, ad esempio, i soggetti che svolgono
attività economica in qualità di imprenditori individuali, professionisti (quali
56
Sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner, in Racc.
[1991] p. I-1979, § 21.
57
Sentenza del TPG del 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem, in Racc. [1991] p. II1623, § 235.
58
avvocati, consulenti, etc.), società di persone o capitali, cooperative, società
private a partecipazione pubblica o organizzazioni senza scopo di lucro.
Inoltre, anche le associazioni di imprese possono essere considerate
imprese, al fine di evitare che le imprese propriamente dette aggirino i
divieti imposti dal diritto della concorrenza utilizzando la forma associativa.
Per loro natura, invece, non rientrano nella nozione di impresa né i
lavoratori subordinati, che non sono esposti direttamente al rischio
d’impresa, né i consumatori in quanto tali, che nel mercato rappresentano il
lato della domanda.
Gli enti che svolgono attività tipicamente pubbliche, quali ad esempio il
governo o le autorità di regolamentazione di settore, non sono imprese.
Tuttavia, la natura pubblica del soggetto che svolge l’attività o il possesso di
poteri pubblicistici non sono elementi decisivi al riguardo. Infatti, in molti
casi, gli enti pubblici e privati svolgono al contempo attività economiche e
funzioni di interesse generale, con la molteplicità di forme tipicamente
assunta dall’intervento dello Stato nell’economia. Pertanto, distinguere in
concreto le imprese dalle pubbliche autorità non è sempre agevole 58.
Sotto altro profilo, in ossequio alla nozione economica di impresa, due o più
società distinte possono essere considerate come un’unica impresa quando
la loro condotta commerciale sia determinata da una comune controllante,
oppure quando una sia direttamente o indirettamente controllata dall’altra
(in tal caso si parla, nel gergo antitrust, di intese infra-gruppo) 59. Infatti, da
un punto di vista economico, l’impresa è un’organizzazione di beni e
persone riconducibile a un singolo centro decisionale, quale che sia la forma
legale assunta in concreto dagli elementi (o dalle divisioni) che la
compongono: è questa la teoria dell’unità economica.
58
Sono state considerate attività pubbliche, ad esempio, la prestazione di servizi di
previdenza sociale su base solidaristica, il controllo della navigazione aerea o
dell’inquinamento all’interno dei bacini portuali, nonché l’affidamento in concessione di un
servizio pubblico (quale la raccolta dei rifiuti urbani su superfici pubbliche) a imprese terze.
Viceversa, in considerazione della natura economica di tutte o alcune delle attività svolte,
sono state considerate imprese alcune amministrazioni pubbliche (come le agenzie di
collocamento o, in Italia, l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) e alcuni enti
privati muniti di poteri pubblicistici (come il consiglio nazionale forense o degli
spedizionieri doganali, nonché alcune organizzazioni senza scopo di lucro costituite per la
gestione di fondi pensione).
59
Per determinare se distinte società siano in effetti parte di un’unica impresa, occorrerà far
riferimento alla composizione del capitale azionario, ai diritti di voto, ai poteri di nomina
del consiglio di amministrazione ed in generale a qualsiasi elemento di fatto (quali contratti
commerciali, mezzi di finanziamento o altro), che sia suscettibile di attribuire a una società
(controllante) un’influenza decisiva sulla condotta commerciale di una o più società
controllate. Quando la controllante detiene il 100% del capitale azionario della controllata,
ad esempio, si presume (salvo prova contraria) che la controllata non goda di sufficiente
autonomia nel determinare la propria condotta commerciale.
59
Una delle conseguenze di questa teoria è che i rapporti tra le società che
costituiscono un’unica impresa cadono al di fuori dell’ambito di
applicazione dei divieti, in quanto non sono suscettibili di restringere la
concorrenza. Questo perché le società controllate, quando non sono libere di
determinare la propria condotta commerciale in modo autonomo, non
sarebbero in ogni caso in grado di comportarsi come concorrenti effettivi nei
rapporti reciproci o con la capogruppo. In tali circostanze, un’intesa
restrittiva o una condotta abusiva non sarebbero suscettibili di alterare le
dinamiche e la struttura del mercato.
Vi sono alcune imprese, tuttavia, che possono essere esentate, sia pure in
parte, dall’applicazione delle norme a tutela della concorrenza: sono quelle
che gestiscono servizi di interesse economico generale, nella misura in cui
sia effettivamente necessario per condurre le loro attività in condizioni
economicamente sostenibili. I servizi di interesse economico generale, di cui
ci occuperemo ancora nel capitolo 12, sono attività economiche dirette a
soddisfare un interesse generale della collettività, che la normativa richiede
debbano essere prestate con le caratteristiche dell’universalità, vale a dire a
chiunque ne faccia richiesta e a condizioni sostanzialmente uniformi. Un
classico esempio sono i servizi delle grandi industrie a rete, come trasporti,
servizi postali, energia e telecomunicazioni.
In questi casi, la normativa può attribuire a tali imprese diritti esclusivi
(cioè, forme di monopolio legale) su determinate attività, se la concorrenza
può ostacolare la prestazione di servizi con caratteristiche di universalità. In
effetti, le esigenze del servizio pubblico obbligano le imprese incaricate a
offrire i propri servizi alla clientela anche quando non siano interamente
remunerati. Di conseguenza, tali imprese devono compensare le eventuali
perdite subite in alcune attività con i ricavi provenienti da altre aree o
attività. Tuttavia, la concessione di diritti esclusivi deve essere assoggettata
ad un rigoroso test di proporzionalità. Nel caso dei servizi di interesse
economico generale, l'applicazione del testo di proporzionalità esclude
tuttavia tutti i diritti, speciali o esclusivi, concessi dagli Stati membri,
quando essi siano: (i) privi di correlazione con l'esigenza di garantire la
prestazione del servizio a condizioni economicamente sostenibili, oppure
(ii) palesemente eccessivi rispetto quanto necessario.
Un ottimo esempio nell'applicazione del principio di proporzionalità da
parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è rappresentato dal caso
Corbeau.
60
Proporzionalità e servizi di interesse economico generale: il caso Corbeau
Nella città di Liegi (Belgio) e nelle zone limitrofe, la società di Paul Corbeau forniva
un servizio postale consistente nella raccolta della corrispondenza al domicilio del
mittente e nel recapito della stessa entro le ore 12 del mattino seguente, a condizione
che i destinatari fossero ubicati all’interno dell’area predetta. Quando invece la
corrispondenza era diretta verso altre aree, la società di Corbeau si limitava a
raccogliere la posta e a curare il suo inoltro tramite il normale servizio postale.
L’attività di Corbeau era però manifestamente contraria alla legge postale belga, che
accordava alla Régie des postes, persona giuridica di diritto pubblico belga, il diritto
esclusivo di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza. La Régie des
Postes svolgeva un servizio d’interesse economico generale: tale servizio doveva in
effetti essere prestato a tutti gli utenti potenziali sull’intero territorio dello Stato belga,
a tariffe uniformi e a condizioni simili, indipendentemente dalle circostanze particolari
e dal grado di redditività di ciascuna singola operazione.
La Corte di Giustizia osservava che il Trattato “consente agli Stati membri di conferire
ad imprese, cui attribuiscono la gestione di servizi di interesse economico generale,
diritti esclusivi che possono impedire l’applicazione delle norme del Trattato in
materia di concorrenza, nella misura in cui le restrizioni della concorrenza sono
necessarie per garantire l’adempimento della specifica funzione attribuita alle imprese
titolari dei diritti esclusivi”. La logica di un servizio pubblico è proprio che esso, per
poter essere gestito a condizioni economiche accettabili, presuppone la possibilità di
compensare tra i settori di attività redditizi e settori meno redditizi. Pertanto, qualora
agli imprenditori privati non fosse stato impedito di fare concorrenza all’impresa
pubblica nei settori redditizi, questi ultimi avrebbero potuto concentrarsi solo su tali
settori, offrendo sistematicamente tariffe più basse dell’impresa pubblica che, dovendo
garantire un servizio “universale”, sarebbe stata svantaggiata dal fatto di operare
necessariamente anche in settori non redditizi. Così facendo, alla fine, l’impresa
pubblica non sarebbe più potuta restare sul mercato a condizioni economiche
accettabili.
La Corte applicava tuttavia il principio di proporzionalità, chiarendo che le restrizioni
della concorrenza, o l’esclusione di ogni forma di concorrenza all’interno di
determinati settori, si rendono necessarie solo nella misura in cui servono
effettivamente a consentire all’impresa incaricata di esercitare la sua funzione. Esse
non si applicano invece nel caso di servizi innovativi specifici, “scindibili dal servizio
di interesse generale, che rispondono ad esigenze specifiche di operatori economici e
che richiedono determinate prestazioni supplementari che il servizio postale
tradizionale non offre”, quali la raccolta a domicilio e il recapito entro tempi garantiti.
I servizi della società di Paul Corbeau fornivano, secondo la Corte, un effettivo valore
aggiunto rispetto al normale servizio postale, e pertanto la Corte, con la sua sentenza,
apriva alla libera concorrenza il settore dei servizi postali innovativi.
Sentenza della CGCE del 19 maggio 1993, causa C-320/91, Procedimento penale C.
Paul Corbeau, in Racc. [1993] p. I-2533.
61
7.2 Il mercato rilevante
In ciascun caso antitrust, il primo aspetto cruciale è quello di definire il
mercato rilevante. Come afferma la Commissione Europea, “la definizione
del mercato costituisce uno strumento per individuare e definire l'ambito
nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro. […] Scopo principale
della definizione del mercato è di individuare in modo sistematico le
pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate” 60.
I criteri per la definizione dei mercati, come vedremo in seguito, sono criteri
economici, che sono stati espressi efficacemente in termini legali, per
fornire una valutazione strutturata degli effetti competitivi delle
concentrazioni da parte delle autorità di concorrenza; essi sono stati in
seguito applicati anche a casi di cartelli e di comportamenti abusivi.
In pratica, la definizione di mercato possiede obiettivi differenti a seconda
dei problemi antitrust a cui si riferisce: nelle concentrazioni, essa permette
di identificare le pressioni concorrenziali a cui l'entità derivante dalla
concentrazione, e i suoi concorrenti, saranno sottoposti, in modo da
anticipare il loro comportamento futuro; nei casi di comportamenti abusivi,
essa permette in primo luogo di valutare se un'impresa possa essere
considerata come dominante, e in secondo luogo di valutare le conseguenze
della sua azione sui consumatori e possibilmente sui concorrenti; nei casi di
intese, essa rende possibile valutare se l'accordo debba essere considerato
come orizzontale, e, ancora, per valutare gli effetti del cartello.
Per definire correttamente il mercato rilevante, dobbiamo necessariamente
considerare tre tipi di sostituibilità, e precisamente: (a) la sostituibilità dal
lato della domanda, e cioè l'esistenza di beni che i consumatori possono
essere disposti a sostituire al bene che stiamo considerando; (b) la
sostituibilità dal lato dell'offerta e cioè l'esistenza di produttori che possono
rimpiazzare in un breve lasso di tempo, con la loro offerta, l'impresa
coinvolta nel caso antitrust, e (c) la concorrenza potenziale, cioè la
possibilità che, in un ragionevole prossimo futuro, nuove imprese possano
entrare nel mercato offrendo prodotti che i consumatori considerano come
sostituti.
La definizione di mercato rilevante basata sull'analisi della sostituibilità può
condurre a conclusioni molto differenti dalle altre definizioni di mercato,
come per esempio quelle utilizzate comunemente nell’ambito della strategia
aziendale o del marketing, le quali possono riflettere l'organizzazione
dell'impresa, le aree in cui lavora, o altri fattori, ma che non hanno nulla a
che vedere con l'esistenza della sostituibilità dal lato della domanda o
60
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 2.
62
dell'offerta: nel mercato del trasporto aereo, ciascuna rotta rappresenta - da
un punto di vista antitrust - un mercato rilevante distinto, perché i
passeggeri non possono sostituire un viaggio da Milano a Siviglia con un
viaggio da Milano a Madrid.
Questo probabilmente non è il modo in cui l'amministratore delegato della
linea aerea vedrebbe il mercato (egli penserebbe probabilmente al mercato
dei collegamenti tra Italia e Spagna): la definizione di mercato rilevante ai
fini antitrust è principalmente strumentale, dal momento che serve a
valutare un caso specifico.
Inoltre, la definizione di mercato può dipendere dalla natura dell'analisi
svolta dalle autorità di concorrenza: in caso di accordi e di comportamenti
abusivi le autorità analizzeranno il mercato come era nel momento in cui il
comportamento rilevante ha avuto luogo. Nella valutazione delle
concentrazioni, valuteranno invece gli effetti della concentrazione sulla base
di stime future sulla struttura e i comportamenti del mercato.
7.3 Il mercato rilevante del prodotto
Le fasi tipiche dell'analisi del mercato rilevante sono sostanzialmente tre:
• dal lato della domanda: valutare il grado di sostituibilità del prodotto
A con altri prodotti esistenti, dal punto di vista della domanda.
Questa fase viene solitamente svolta applicando il test del
‘monopolista ipotetico’, cioè cercando di stimare come i
consumatori - ad esempio - di pere reagiranno ad uno SSNIP 61, cioè
un incremento permanente dei prezzi piccolo ma significativo, che
solitamente corrisponde al 5-10%: se a fronte dell'aumento di prezzo
i consumatori di pere acquisteranno mele, le pere e le mele
apparterranno allo stesso mercato rilevante, se invece la maggior
parte dei consumatori continuerà ad acquistare pere, allora le pere
formeranno da sole un mercato rilevante (sostituibilità della
domanda);
• dal lato dell'offerta: valutare la possibilità che produttori di altri
prodotti reagiscano prontamente all'incremento dei prezzi offrendo
beni sostituti ad A (sostituibilità dell'offerta);
• ancora dal lato dell'offerta: valutare la possibilità che nuovi
produttori inizino ad offrire beni sostituti ad A in un ragionevole
breve lasso di tempo (concorrenza potenziale).
Solitamente, la sostituibilità dal lato della domanda viene considerata il
criterio fondamentale, mentre la sostituibilità dal lato dell'offerta come
61
Acronimo inglese per: Small but Significant Non-tranistory Increase in Prices.
63
criterio secondario. Ma “la concorrenza potenziale non viene presa in
considerazione all'atto della definizione del mercato, poiché la misura nella
quale la concorrenza potenziale eserciterà di fatto una pressione
competitiva può essere determinata solo da un'analisi dei fattori e delle
circostanze specifici che condizionano l'ingresso nel mercato. Se
necessaria, questa analisi viene effettuata solo in uno stadio successivo, in
generale quando la posizione delle imprese interessate sul mercato
rilevante è già stata accertata e dà effettivamente adito a problemi dal
punto di vista della concorrenza” 62.
Dal punto di vista dell'economista, questa gerarchia tuttavia è opinabile: non
è sempre valido il caso per cui i consumatori possono modificare più
velocemente la loro domanda, sopportando minori costi, rispetto a quanto i
produttori possono fare con l'offerta: da un lato, i consumatori possono
essere ostacolati dall'esistenza di switching costs, e dall'altro, in molti tipi di
attività economiche, l'entrata può essere molto veloce, attraverso il
commercio, l'utilizzo di canali di distribuzione esistenti o canali elettronici,
e pertanto gli entranti potenziali dovrebbero essere spesso inclusi nella
definizione del mercato rilevante. La loro tradizionale esclusione nella
prassi comunitaria a tutela della concorrenza probabilmente riflette una sorta
di ‘deriva manifatturiera’, cioè l'ipotesi che per entrare in un mercato siano
necessari grandi investimenti in stabilimenti produttivi: ma naturalmente
non è sempre così.
In pratica, questa analisi a due stadi della sostituibilità dal lato dell’offerta
può condurre a sottostimare il ruolo dei potenziali concorrenti. In ogni caso,
la velocità di entrata da parte dei nuovi entranti è meno importante delle
aspettative che si hanno sull'entrata di tali operatori: se il produttore del
bene A si attende razionalmente che, se praticasse un incremento
permanente nei prezzi, i produttori di B inizierebbero a produrre A nel giro
di tre anni, non aumenterà mai i prezzi. Una minaccia di entrata nel futuro
prossimo ha un effetto di disciplina nel presente: A e B appartengono già
oggi al medesimo mercato rilevante.
Pertanto, nella maggior parte dei casi è probabilmente meglio considerare la
pressione competitiva complessiva che deriva dalla sostituibilità dell'offerta
effettiva e potenziale nello stesso istante in cui le pressioni concorrenziali
derivanti dalla domanda e dai produttori esistenti sono considerate.
Vediamo in dettaglio ciascuna di queste tre fasi.
62
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 24.
64
7.3.1
La sostituibilità dal lato della domanda
La sostituibilità dal lato della domanda “costituisce il vincolo più immediato
ed efficace che condiziona i fornitori di un determinato prodotto, specie in
ordine alle loro decisioni in materia di prezzo” 63: se i consumatori possono
sostituire facilmente il prodotto considerato con altri, un'impresa non sarà in
grado di aumentare i suoi prezzi.
Per verificare questo punto, solitamente si utilizza il test del monopolista
ipotetico, o SSNIP test. Come abbiamo visto, l'acronimo SSNIP significa
incremento permanente nei prezzi, piccolo ma significativo. Questo test,
originariamente introdotto dalle Linee guida sulle concentrazioni orizzontali
adottate negli Stati Uniti, è basato su un esame dell'evidenza disponibile, e
stima il possibile comportamento dei consumatori a fronte di un incremento
dei prezzi piccolo, ma permanente, del 5% o 10%. Se, a seguito
dell'incremento dei prezzi i consumatori iniziassero immediatamente a
spostarsi verso altri prodotti, e la diminuzione nelle vendite fosse tale da
rendere non profittevole l'incremento dei prezzi allora il mercato rilevante ai
fini antitrust dovrebbe includere anche altri prodotti. Se, ad esempio, a
seguito di un aumento del 5-10% del prezzo dei branzini, i consumatori
rispondessero consumando una maggiore quantità di sardine, fino al punto
in cui l'incremento del prezzo dei branzini non sarebbe più conveniente per i
pescatori, allora il mercato rilevante del prodotto in senso antitrust dovrebbe
includere sia i branzini che le sardine. Naturalmente, questa conclusione non
richiede che tutti i consumatori percepiscano i branzini le sardine come
facilmente sostituibili. Questi prodotti dovrebbero tuttavia essere percepiti
come tali da un numero sufficientemente largo di consumatori, tale da
rendere non profittevole l'incremento dei prezzi dei branzini.
Allora, come definire il mercato rilevante in questo caso? Ovviamente, il
test deve essere ripetuto, analizzando le conseguenze di un incremento del
5-10% dei prezzi dei branzini e delle sardine. Se i consumatori
rispondessero acquistando una maggiore quantità di acciughe, allora è
evidente che i branzini, le sardine e le acciughe apparterrebbero allo stesso
mercato rilevante. Questo processo continuerà fino a che non venga
identificato un set di prodotti (nel nostro caso, probabilmente, il ‘pesce’) che
i consumatori non possano facilmente sostituire con altri prodotti (‘carne’).
Solo questo set di prodotti sarebbe, nel nostro esempio, un mercato rilevante
del prodotto, dal momento che contiene tutti i beni percepiti dai consumatori
come facilmente sostituibili tra loro, ed esclude quelli che non lo sono. Nel
‘mercato del pesce’ un ‘ipotetico monopolista’ potrebbe quindi aumentare
profittevolmente il prezzo di tutto il pesce, ma non sarebbe in grado di
aumentare con profitto il prezzo dei soli branzini.
63
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 13.
65
Naturalmente, nelle applicazioni pratiche, lo SSNIP test è utilizzato solo
considerando un piccolo numero di mercati potenzialmente alternativi: nel
nostro caso, esso sarebbe probabilmente applicato solo al mercato per i
branzini e al mercato del pesce in generale.
Come funziona l'approccio SSNIP in pratica?
Se abbiamo una quantità di dati sufficienti sul comportamento dei
consumatori, possiamo provare a stimare l'elasticità della domanda.
L’elasticità della domanda per un prodotto può essere definita come la
variazione percentuale della domanda a seguito di un aumento dell'1% dei
prezzi: se la riduzione della domanda è più grande dell'1%, allora diciamo
che la domanda di quel prodotto è elastica, mentre se la riduzione è inferiore
si dice che la domanda è anelastica, o rigida. Se la domanda di un prodotto è
anelastica, i consumatori non possono facilmente sostituire tale prodotto con
altri, ed è possibile che un aumento dei prezzi effettuato dall'ipotetico
monopolista sia profittevole.
Nella prassi, per stimare l'elasticità della domanda di un prodotto possono
essere utilizzate tecniche econometriche, che sono particolarmente utili nei
casi in cui ci sia un'ampia disponibilità di dati che permettono il
monitoraggio delle abitudini di consumo degli individui (per esempio, i
supermercati possiedono ampi set di dati sul comportamento dei loro
consumatori 64). Tuttavia, valutare la validità di un modello econometrico
può risultare molto difficile.
Fortunatamente, spesso è possibile evitare il ricorso ad essi, e utilizzare
approcci più semplici come la correlazione statistica: i prezzi dei due
prodotti che sono facilmente sostituibili dovrebbero avere un'elevata
correlazione nel tempo 65. Se essi hanno bassa correlazione, è probabile che i
due prodotti non siano facilmente sostituibili, e pertanto non appartengano
allo stesso mercato rilevante.
Un altro metodo ampiamente usato nella prassi per analizzare la
sostituibilità dal lato della domanda è quello di riferirsi alle preferenze dei
consumatori, considerando la loro fedeltà ad un prodotto attraverso ricerche
64
Un compito ambizioso sarebbe quello di costruire un modello econometrico per stimare
direttamente le elasticità incrociate della domanda (se la domanda per le mele aumenta
sostanzialmente a fronte di un aumento del prezzo delle pere, allora le pere e le mele
appartengono allo stesso mercato rilevante).
65
Questa tecnica è stata frequentemente utilizzata in casi antitrust: tra i casi in cui la
Commissione ha utilizzato il test di correlazione dei prezzi dei prodotti per identificare il
mercato rilevante, possiamo menzionare: il caso M. 315, decisione del 31 gennaio 1994,
Mannesmann / Vallourec/ Ilva, il caso M.190, decisione del 22 luglio 1997, Nestlè/Perrier,
in OJEC [1992] L3561, il caso M.619, decisione del 24 aprile 1996, Gencor/Lonrho, il caso
M.938, decisione del 15 ottobre 1997, Guinness/GrandMetropolitan, OJ [1998] L288/24.
66
di mercato. Come indica la Commissione66, gli studi di mercato svolti dalle
imprese nel passato possono fornire utili informazioni per definire il
mercato rilevante del prodotto. In alcuni casi, possono essere utilizzate
ricerche ad-hoc 67.
Lo SSNIP test può essere tuttavia fuorviante nel caso dei cartelli: mentre
infatti il test standard chiede che cosa succederebbe se un'impresa
aumentasse i prezzi del 5% o del 10%; ma vi è ampia evidenza che i cartelli
aumentano i prezzi di un ammontare ben più elevato, ragionevolmente
stimabile tra il 20% e il 30% 68. Pertanto, il test SSNIP standard può definire
mercati troppo piccoli: il consumatore non sostituirebbe le mele con le pere,
se il prezzo di queste ultime aumentasse del 10% (quindi i due tipi di frutta
sembrerebbero costituire due diversi mercati rilevanti), ma si comporterebbe
molto diversamente se il prezzo delle pere crescesse del 30%: dopo tutto,
quindi, le pere e le mele potrebbero essere nello stesso mercato.
Come già discusso, la definizione del mercato rilevante del prodotto è
principalmente basata su un'analisi della sostituibilità dal lato della
domanda. C'è un caso ulteriore in cui un uso meccanicistico dello SSNIP
test può condurre a risultati distorti, portando a definire un mercato rilevante
troppo ampio: la cosiddetta “cellophane fallacy”.
Lo SSNIP test richiede, come abbiamo visto, di misurare il comportamento
dei consumatori a seguito di un incremento ipotetico del 5-10% del prezzo
del prodotto. Tuttavia, la sostituibilità dei prodotti non è indipendente dal
livello dei prezzi: nel mercato concorrenziale del pesce, le sardine (facili da
pescare) sono più economiche delle aragoste (difficili da pescare);
supponiamo quindi che le aragoste siano quattro volte più costose delle
sardine. I consumatori considereranno, fino ad un certo punto, i due tipi di
pesce come beni sostituti, ma sarebbe necessario un considerevole aumento
del prezzo delle sardine per convincere un significativo numero di
consumatori a passare dalle sardine alle aragoste. Le autorità di concorrenza
potrebbero quindi concludere che, sulla base di uno SSNIP test, le sardine le
aragoste non appartengono allo stesso mercato rilevante, dal momento che
la loro elasticità di sostituzione è bassa.
Ma se, improvvisamente, il mercato delle sardine diventasse un monopolio,
e il prezzo delle sardine si avvicinasse a quello delle aragoste, ci sarebbe un
grande numero di consumatori che, a fronte di un significativo incremento
del prezzo delle sardine, passerebbero alle aragoste. Uno SSNIP test
suggerirebbe quindi che i due prodotti appartengono allo stesso mercato
66
Si veda la Comunicazione della Commissione, cit., par. 41.
Si veda, per esempio, il caso M.68, Decisione della Commissione del 19 luglio 1991,
Tetra Pak/Alfa-Laval, in OJEC [1991], L290/35.
68
Cfr. Connor, J.M. (2005), Price-fixing overcharges: Legal and economic evidence,
Purdue University Staff Paper.
67
67
rilevante, ma questa conclusione non è corretta, perché l'elevato grado di
sostituzione tra i due prodotti è la conseguenza della monopolizzazione del
mercato delle sardine.
Per evitare di trarre conseguenze errate dall'utilizzo di uno SSNIP test,
1'autorità antitrust dovrebbe quindi considerare che il prezzo dei prodotti
osservati non deve essere troppo lontano dal suo (teorico) livello
concorrenziale. Se invece lo è, dovrebbe essere necessario valutare in quale
modo i consumatori si comporterebbero se il prezzo non fosse
artificialmente stato innalzato dalla presenza di un cartello o dall'impresa
dominante.
7.3.2
Sostituibilità
potenziale
dal
lato
dell'offerta
e
concorrenza
Esiste sostituibilità dal lato dell'offerta se, a seguito di un incremento dei
prezzi di un determinato bene, altre imprese che lo producono reagiscono
aumentando la produzione e quindi riducendo (o addirittura annullando)
dell'incremento dei prezzi. Pertanto, vi è sostituibilità dal lato dell'offerta
quando - in risposta a modifiche piccole ma permanenti dei prezzi - i
produttori sono in grado, in un ragionevole periodo di tempo, di modificare
il loro processo di produzione per offrire sul mercato maggiori quantità del
prodotto il cui prezzo è aumentato, senza incorrere in significativi costi
incrementali.
La reazione dei concorrenti avviene naturalmente nella maggior parte dei
casi, ma la sua efficacia non è sempre comparabile a quella dei consumatori:
questi ultimi possono frequentemente e velocemente modificare le loro
scelte di consumo, ma le imprese richiedono tempo per modificare i loro
processi di produzione e la catena di distribuzione. Per questo motivo, nel
definire il mercato rilevante, la Commissione ha sinora considerato la
sostituibilità dal lato dell'offerta come il criterio rilevante per definire il
mercato solo in un ridotto numero di casi, in cui i produttori alternativi
erano ritenuti in grado di modificare rapidamente i loro processi produttivi
senza sostenere eccessivi costi di aggiustamento, dal momento che non
erano richiesti né investimenti addizionali, né complesse decisioni
strategiche.
In alcuni casi, l'aumento dei prezzi - in aggiunta alle reazioni dei
consumatori e dei concorrenti - può favorire rapidi processi di entrata nel
mercato rilevante, da parte di imprese che producono altri prodotti. In questa
situazione, un ‘monopolista ipotetico’ non sarebbe in grado di innalzare
profittevolmente il prezzo, dal momento che l'entrata di nuove imprese
condurrebbe ad un aumento dell'offerta e a una riduzione nei prezzi. Le
pressioni concorrenziali generate dalla concorrenza potenziale non sono
68
immediate, perché le decisioni di entrata di nuovi mercati sono, tipicamente,
scelte complesse, che dipendono da una varietà di fattori, e quindi possono
essere difficilmente determinate solo dall’aumento dei prezzi da parte
dell’‘ipotetico monopolista’.
La concorrenza potenziale viene quindi solo raramente considerata come un
fattore importante per la definizione del mercato rilevante. Tuttavia, come
abbiamo discusso, l'aspettativa dell'entrata sul mercato di un concorrente
può efficacemente dissuadere un'impresa dall'aumentare i propri prezzi.
A conclusione di questo paragrafo, vediamo un caso pratico di definizione
del mercato rilevante del prodotto, nel caso italiano che ha riguardato la
Coca Cola.
La definizione del mercato rilevante del prodotto: il caso Coca-Cola
Nel 1999, nel corso di un’istruttoria per presunti comportamenti abusivi da parte
delle filiali italiane del gruppo Coca-Cola, l’Autorità italiana doveva valutare se le
bevande analcoliche gassate al gusto di cola costituissero un mercato rilevante
separato da quello delle altre bevande gassate. La questione era fondamentale,
poiché la valutazione del comportamento abusivo dipendeva in larga misura da
come fosse stato definito il mercato rilevante del prodotto: se esso avesse incluso
tutte le bibite analcoliche, Coca-Cola non sarebbe più stata dominante.
Quindi, l’Autorità italiana ha analizzato le caratteristiche delle diverse bibite
analcoliche, sottolineando come le acque minerali, i succhi di frutta, le bevande a
base di latte, i reintegratori salini e le bibite per sportivi presentassero caratteristiche
organolettiche e un uso finale che le differenziavano notevolmente dalle bevande
gassate, e pertanto non potevano essere incluse nello stesso mercato rilevante della
Coca-Cola. Ma anche tra le bevande gassate, le bevande al gusto cola erano
percepite come differenziate dai consumatori, sia per il gusto particolare, sia per la
diffusione e la forza del marchio Coca-Cola. Anche l’analisi dei prezzi confermava
questo punto: le bevande al gusto cola venivano vendute a prezzi ben superiori a
quelli delle acque minerali e delle altre bevande gassate. Una ricerca di mercato
commissionata dall’Autorità evidenziava poi una forte fedeltà dei consumatori alle
bevande al gusto cola (il 48,5% dei consumatori, in assenza di offerta di bevande al
gusto cola, preferiva infatti rinunciare all’acquisto o cercare un altro punto vendita).
Infine, l’Autorità italiana osservava che i processi di produzione consentivano una
limitata sostituibilità dell’offerta: un produttore di acque minerali avrebbe potuto
imbottigliare bevande gassate, ma non sarebbe stato possibile l’inverso, in quanto,
per legge, le acque minerali devono essere imbottigliate alla fonte.
Pertanto, l’Autorità definiva un mercato rilevante del prodotto costituito dalle sole
bevande al gusto cola.
Provvedimento del 7 dicembre 1999, proc. A224, Pepsico Foods and Beverages
International-IBG Sud/Coca Cola Italia, in Bollettino n. 49/1999.
69
7.4 Il mercato rilevante geografico
Un mercato geografico rilevante è, per definizione, un'area in cui le
condizioni di concorrenza per un prodotto sono “sufficientemente
omogenee” 69. Naturalmente, questa omogeneità dipende anche dall'esistenza
di fenomeni di sostituzione: c'è sostituibilità in senso geografico se, a
seguito dell'aumento del prezzo di un bene in una determinata area, i
consumatori sono disposti a spostarsi in altre aree per acquistare il prodotto
in questione, oppure i produttori in altre aree geografiche sono disposti a
vendere i loro prodotti in quell'area.
Per esempio, supponiamo che il prezzo di una determinata marca di birra a
Milano aumenti del 5-10%. Se, a seguito di questo aumento del prezzo, i
consumatori sono disposti a viaggiare fino a Pavia per acquistare la birra,
oppure è profittevole per i grossisti di birra spostarsi da Pavia fino a Milano
per vendere la birra, è possibile concludere che Milano e Pavia
appartengono allo stesso mercato rilevante geografico della birra.
Questo test è analogo allo SSNIP test utilizzato per il mercato rilevante del
prodotto. Se esiste sostituibilità tra le due aree, allora entrambe sono parte
dello stesso mercato rilevante geografico, perché i grossisti di Milano non
saranno in grado di esercitare il loro potere di mercato aumentando i prezzi
della birra, dal momento che sono esposti a pressioni concorrenziali, sia da
parte dei consumatori, sia da parte dei grossisti localizzati in aree contigue.
Come si può vedere dall'esempio, l'estensione del mercato geografico
rilevante non dipende solamente dall'elasticità dell'offerta e della domanda,
ma anche dai costi di trasporto sostenuti dai produttori. I grossisti di birra di
Pavia viaggeranno fino a Milano solo se il prezzo a Milano è
sufficientemente elevato per coprire i loro costi di trasporto: altrimenti, essi
non riusciranno ad ottenere un margine di profitto ragionevole dalla vendita
di birra, e pertanto preferiranno rimanere a Pavia.
In generale, più elevata è l'incidenza dei costi di trasporto sul prezzo del
prodotto, più piccolo sarà il mercato rilevante geografico.
La Figura 7.1 mostra la variazione ipotetica dei costi di trasporto in
percentuale del prezzo della birra a Milano: fino ad un raggio di circa 60 km
da Milano, l'incidenza e la variazione di tali costi è molto bassa.
All'aumentare della distanza, l'incidenza cresce rapidamente (per esempio
perché è necessario ricorrere a furgoni più grandi e perché - oltre una certa
distanza - può essere effettuato un unico giro giornaliero di consegne).
Quindi, i grossisti con magazzini localizzati entro 60 km da Milano (che
69
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 8.
70
sono, tra gli altri, quelli di Pavia) possono reagire con profitto ad un
aumento del 10% nel prezzo della birra, dal momento che all'interno di
questa distanza i maggiori costi di trasporto sono ‘coperti’ dall'incremento
dei prezzi in posto dei grossisti di birra a Milano. Al contrario, l'entrata non
sarà profittevole per i grossisti localizzati a più di 60 km di distanza da
Milano. Nel nostro esempio, il mercato geografico rilevante per la birra sarà
limitato ad un'area con un raggio di 60 km attorno a Milano.
Figura 7.1 - Analisi dei costi di trasporto per i grossisti di birra 70
Costi di trasporto
in percentuale sul
120
prezzo
110
100
100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100
Km dal centro di Milano
Oltre all'analisi dei costi di trasporto, ci sono altre caratteristiche del
mercato che possono fornire informazioni utili sul mercato geografico
rilevante.
Una prima caratteristica riguarda l'esistenza di differenze tra mercati del
prodotto nazionali o regionali: l'esistenza di reti distributive differenti, o
barriere all'entrata possono significativamente ostacolare l'entrata di
concorrenti provenienti da differenti aree geografiche, e quindi limitare
l'estensione del mercato geografico rilevante. Ad esempio, i mercati
televisivi sono nazionali per ovvi motivi linguistici, i mercati assicurativi
sono più ristretti, a causa dell'esistenza di barriere regolatorie e di reti di
distribuzione specializzate.
70
Fonte: adattata da W.K. Viscusi, J.M. Vernon, J. E. Harrington (2000) Economics of
Regulation and Antitrust, MIT Press, Cambridge (MA), cap. 7.
71
Vediamo ora un esempio di applicazione pratica del mercato rilevante
geografico nel caso italiano di concentrazione tra Granarolo e Centrale del
Latte di Vicenza.
Un esempio di definizione di mercato geografico rilevante: il caso Granarolo/
Centrale del Latte di Vicenza
Nel 2001, Granarolo, società produttrice di latte e derivati, notificava all’Autorità
italiana il suo progetto di acquisizione della Centrale del Latte di Vicenza, società
attiva su base locale nella produzione di latte fresco.
Nel definire il mercato geografico rilevante, l’Autorità sottolineava l’esistenza di un
particolare quadro normativo, il quale impedisce agli operatori di commercializzare
latte fresco con scadenza superiore a 4 giorni dal confezionamento. Ciò implica che
gli operatori debbano distribuire il latte fresco entro tempi brevissimi, e attraverso la
catena del freddo. Ciò li costringe quindi ad operare in ambiti territoriali limitati,
circoscritti ad un’area di poche centinaia di chilometri dallo stabilimento produttivo.
Per valutare l’estensione del mercato, l’Autorità svolgeva test statistici sulla
correlazione dei prezzi, sulla base del principio dello SSNIP test: se due aree
facessero parte del medesimo mercato geografico, i prezzi registrati non
mostrerebbero andamenti dissimili nel tempo. I risultati del test mostravano come i
prezzi del latte fresco nella regione Vento si muovessero invece in modo
indipendente da quelli delle altre regioni contigue considerate (Trentino Alto Adige,
Emilia, Lombardia) e di altre regioni italiane (Piemonte, Liguria, Marche, Toscana,
Lazio, Campania e Puglia).
Alla luce di queste analisi, l’Autorità limitava la dimensione del mercato rilevante
geografico alla regione Veneto.
Provvedimento del 24 maggio 2001, Granarolo/Centrale del Latte di Vicenza, proc.
C4502, in Bollettino n. 21/2001.
7.5 Problemi specifici nella definizione del mercato rilevante
Alcuni mercati presentano problemi specifici: passiamoli brevemente in
rassegna.
7.5.1
Prodotti differenziati
L'esistenza di prodotti differenziati non pone problemi speciali nella
definizione del mercato rilevante, dal momento che anche in questo caso
possiamo utilizzare i diversi test di sostituibilità discussi in precedenza.
72
Prima di chiarire questo punto, è necessario un esame più accurato della
teoria economica dei prodotti differenziati. È ragionevole assumere che,
specialmente per beni complessi che i consumatori percepiscono come
differenti dagli altri, i consumatori esprimono una domanda di
caratteristiche. Pertanto, secondo questo approccio, non esiste - per esempio
- una domanda per i telefoni cellulari, ma una domanda per apparecchiature
che contengono un insieme di caratteristiche: per mettere comunicazioni
vocali cellulari, inviare SMS e MMS, utilizzare mobile social networks
come Facebook e Twitter, avere una certa durata della batteria, un certo
peso, ed altre caratteristiche ancora. Ora, mentre è certo che tutti gli
apparecchi possiedono la prima caratteristica (le comunicazioni vocali),
alcuni consumatori apprezzeranno i servizi MMS, mentre altri no. Alcuni
potrebbero apprezzare la lunga durata delle batterie, altri la leggerezza del
telefono, e così via.
La Figura 7.2 compara due telefoni cellulari, A e B, considerando per
semplicità solo due caratteristiche: la leggerezza e la vita della batteria. Il
telefono A è molto leggero, ma le sue batterie si scaricano velocemente (e
probabilmente sarà preferito da giovani studenti), mentre il contrario sarà
vero per il telefono B (che quindi sarà preferito da vecchi professori). Questi
prodotti sono differenziati orizzontalmente, dal momento che nessuno di essi
è presumibilmente “migliore” dell'altro, ma ciascuno soddisfa differenti
bisogni (dal momento che soddisfa la domanda di un differente insieme di
caratteristiche).
Quale dei due telefoni è il principale concorrente del telefono C? Come
mostrato nella figura, C sarà più un concorrente di A che di B. In altre
parole, una piccola modifica nel prezzo di A sarà sufficiente per convincere
molti consumatori - che avrebbero acquistato A - a comperare C; mentre
sarebbe necessario un significativo aumento del prezzo di B, per convincere
molti consumatori - che lo avrebbero acquistato - a comperare C.
Figura 7.2 – Caratteristiche dei telefoni cellulari
Leggerezza
A •
•C
•D
•B
Durata della
batteria
73
Anche il telefono D è differente dagli altri, ma - dal momento che le sue
batterie durano meno delle batterie del telefono A e il suo peso è maggiore –
D è senza dubbio peggiore di A, e sarà scelto solo dei consumatori che non
si possono permettere di acquistare il telefono A. Prodotti di questo tipo si
definiscono come differenziati verticalmente.
Consideriamo ora la definizione del mercato rilevante in cui i prodotti sono
differenziati orizzontalmente. In questo caso, è necessario applicare lo
SSNIP test: è quindi necessario stimare se il numero dei consumatori
marginali, che sono disposti a modificare le loro preferenze di consumo, è
sufficiente a rendere non profittevole l'aumento del prezzo di uno dei due
prodotti. La percentuale di consumatori che passa ad un prodotto differente
viene definita come diversion ratio o coefficiente di spiazzamento.
Per un’applicazione pratica, riferiamoci ad un classico caso preso in esame
dall'autorità antitrust italiana, in cui essa ha analizzato se esiste un ‘mercato
del latte’ che includa sia il latte fresco, sia il latte a lunga conservazione
(UHT).
Un esempio di mercato rilevante per prodotti differenziati: latte fresco e
latte a lunga conservazione
Nel caso, già citato, di concentrazione tra Granarolo e Centrale del Latte di
Vicenza, l’Autorità italiana doveva valutare anche se il latte fresco e il latte a
lunga conservazione (UHT) appartenessero al medesimo mercato rilevante
del prodotto.
Secondo l’Autorità, il latte fresco e il latte UHT (che hanno differenti
caratteristiche organolettiche e nutrizionali) sono caratterizzati da un elevato
grado di sostituibilità da parte dei consumatori in alcune occasioni di
consumo (preparazione di cibi, cappuccini, frullati), ma non in altre (come
bevanda, i consumatori preferiscono il latte fresco) o come scorta (in cui i
consumatori preferiscono il latte UHT). A causa del diverso grado di
deperibilità, le modalità di acquisto dei due tipi di latte da parte dei
consumatori erano risultate poi diverse. Pertanto, esistevano solo limitate
forme di sostituzione della domanda di latte fresco con latte a lunga
conservazione. Non vi era poi la possibilità di sostituire i due prodotti dal lato
dell’offerta, e le forme di concorrenza potenziale erano molto limitate.
In conclusione, l’Autorità definiva due mercati rilevanti distinti del prodotto:
uno per il latte fresco ed uno per il latte UHT.
AGCM, Provvedimento del 24 maggio 2001, Granarolo/Centrale del Latte di
Vicenza, proc. C4502, in Bollettino n. 21/2001.
74
Lo stesso schema analitico è utilizzato per i prodotti che sono caratterizzati
da una differenziazione verticale.
Si consideri nuovamente, per comodità, il mercato del latte fresco, in cui in
aggiunta al ‘latte fresco’ vi sia anche il ‘latte fresco di alta qualità’, prodotto
in impianti selezionati e con particolari qualità organolettiche. Per verificare
se il latte fresco normale e quello di ‘alta qualità’ appartengano allo stesso
mercato rilevante, sarebbe necessario condurre un'analisi della sostituibilità
dal lato della domanda. Sarebbe quindi necessario, a seguito di un aumento
nel prezzo del latte ad alta qualità, analizzare la quota di consumatori che
sarebbero disposti a sostituire il latte ad alta qualità con il latte normale, e se
tale quota è sufficiente per annullare i profitti derivanti dall'aumento del
prezzo.
In caso di prodotti differenziati verticalmente, potrebbe essere tuttavia
importante, in alcune circostanze, verificare se il comportamento del
consumatore è simmetrico: se il prezzo del latte ad alta qualità aumenta, è
probabile che pochi consumatori si sposteranno verso il consumo di latte a
qualità più bassa, così indicando l'esistenza di due mercati rilevanti separati.
Al contrario, se aumentasse il prezzo del latte fresco normale, è probabile
che diversi consumatori passi al consumo di latte di qualità più elevata,
portando alla conclusione che esiste un unico mercato rilevante.
Pertanto, il mercato rilevante del prodotto potrebbe essere definito in modo
diverso nei due casi.
7.5.2
Mercati primari e mercati secondari
Si può incontrare un ulteriore problema nella definizione dei mercati
rilevanti quando il prodotto in questione richiede prodotti o servizi
secondari. Per esempio, una lavastoviglie (il prodotto principale) richiede
anche servizi di assistenza (i prodotti secondari).
In casi come questi, il prodotto primario ed il prodotto secondario sono
complementi, e possono appartenere allo stesso mercato, oppure a mercati
differenti.
Il problema è molto rilevante, dal momento che molte imprese utilizzano
quello che è chiamato “Xerox pricing”, dal nome dell'impresa che - per
prima - ha iniziato a vendere macchine fotocopiatrici a prezzi economici, e
pezzi di ricambio e materiali di consumo a prezzi elevati.
L'appartenenza ad un medesimo mercato rilevante è più probabile quando i
consumatori prendono le loro decisioni di consumo sulla base dell'intera vita
del prodotto (whole life costing), come per esempio farebbero prima di
acquistare una nuova auto, controllando su una rivista specializzata quali
siano i probabili costi di manutenzione sull'intera vita ragionevole dell'auto.
75
In tali casi, se il produttore dell'auto aumentasse il prezzo dei pezzi di
ricambio, probabilmente vari consumatori passerebbero ad una marca
diversa, che pratica prezzi inferiori sui ricambi: l'auto e i ricambi
appartengono quindi chiaramente ad un unico mercato rilevante.
In altri casi, come ad esempio le stampanti laser e le cartucce di toner, i
mercati tendono ad essere separati, dal momento che - avendo acquistato
una stampante - i consumatori possono acquistare una cartuccia da molti
fornitori diversi. Quindi, se il produttore della stampante aumentasse il
prezzo della cartuccia di toner, i consumatori si sposterebbero altrove, e in
questo caso i prodotti primari e secondari apparterrebbero a mercati
differenti.
7.5.3
Mercati bilaterali (two-sided markets)
Quando si definiscono i mercati, è anche utile tenere conto in alcuni casi di
un risultato microeconomico (relativamente) recente: i mercati possono
avere due lati (two-sided).
Si consideri ad esempio l'industria italiana dell'editoria, per la quale è
possibile reperire un grande numero di decisioni antitrust da parte delle
autorità di concorrenza, le quali definiscono i mercati in modo molto
ristretto, sulla base della frequenza, del contenuto, dell'area geografica,
perché essi assumono (correttamente) che ci sia una sostituzione della
domanda molto bassa dal momento che i differenti media interessano a
differenti gruppi di lettori.
Ma pochi dirigenti dell'industria editoriale sottoscriverebbero a questo punto
di vista. Gli editori vendono sia le copie dei giornali ai consumatori, sia
spazi pubblicitari. Pertanto, se aumento il prezzo del mio giornale locale,
relativamente pochi lettori passeranno alla stampa nazionale. Ma la perdita
di lettori potrebbe essere sufficiente a causare una perdita sensibile di ricavi
pubblicitari.
Pertanto, un’impresa editoriale opera in due mercati altamente correlati,
oppure (come dicono gli economisti) in un two-sided market: per stare nel
business l’impresa deve sia vendere copie ai lettori (diciamo ad un prezzo
P), sia spazi pubblicitari (diciamo ad un prezzo S).
Una caratteristica fondamentale dei mercati two-sided è che non è possibile
fare alcuna valutazione sul potere di mercato o su eventuali comportamenti
abusivi, considerando solo uno dei due prezzi: P può essere alto o basso (è
addirittura zero per la ‘free press’, come ad esempio Metro, Leggo), S può
essere alto o basso (o pari a zero per le pubblicazioni che contengono solo
annunci economici, come ad esempio Secondamano): ciò che veramente
76
importa non è il livello dei prezzi, ma piuttosto la struttura dei prezzi sia di
P che di S.
In particolare, i test SSNIP applicati unicamente ad uno dei due ‘lati’ di
questi mercati spesso generano risultati non corretti: un giornale potrebbe
costituire un mercato a sé stante nella prospettiva dei lettori che ne
acquistano le copie, ma si trova probabilmente in un mercato più ampio,
two-sided, quando consideriamo che esso trae i suoi ricavi anche dalla
pubblicità.
Se dimentichiamo di considerare questo aspetto, i mercati rilevanti definiti
in base ai test che abbiamo discusso possono essere troppo piccoli; possono
essere identificate posizioni dominanti e comportamenti abusivi dove in
realtà non ne esistono.
7.6 Potere di mercato
Una volta che le autorità antitrust hanno definito il mercato rilevante, il
passo successivo nella valutazione, sia della capacità di un cartello di
innalzare i prezzi, che dell'esistenza di una posizione dominante, o degli
effetti potenziali futuri di una concentrazione, richiede una valutazione del
potere di mercato dell'impresa (o delle imprese) coinvolte.
In generale, il potere di mercato può essere definito come la capacità di
incrementare i prezzi al di sopra del livello che sarebbe prevalente in un
mercato concorrenziale. Se un'impresa ha potere di mercato, è in grado di
ridurre la produzione, vendere ad un prezzo più elevato, e conseguire profitti
più elevati che in una situazione concorrenziale.
Questa definizione è chiara dal punto di vista teorico, ma non è direttamente
applicabile, dal momento che è molto difficile stimare quale sarebbe il
prezzo in un mercato concorrenziale. Ancora, la definizione precedente è
ragionevole nel caso di prodotti omogenei, ma è troppo semplicistica da
utilizzare per prodotti differenziati, cioè nelle situazioni in cui i prezzi
rifletteranno la domanda di caratteristiche, domanda che non è possibile
osservare direttamente.
Pertanto, è necessario analizzare il potere di mercato da un punto di vista
empirico. A questo fine si considerano solitamente quattro fattori: la quota
di mercato dell'impresa; il numero dei concorrenti e le loro quote di
mercato; le barriere all'entrata; il potere di contrasto degli acquirenti.
7.6.1
Quota di mercato e potere di mercato
L'analisi delle quote di mercato è, in pratica, il fattore principale utilizzato
per determinare se un'impresa possiede potere di mercato. Come ha
affermato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, “l'esistenza di una
77
posizione dominante può risultare da diversi fattori che, presi isolatamente,
non sarebbero necessariamente determinanti; tuttavia, nell'ambito di detti
fattori la detenzione di cospicue quote di mercato è molto significativa” 71.
Secondo la Commissione Europea, “la definizione del mercato rilevante
consente, tra l'altro, di calcolare quote di mercato che forniscano
indicazioni significative sul potere di mercato, e quindi utili ai fini di
stabilire se esista o si prospetti una posizione dominante” 72.
Questa tradizione giuridica ha anche buone basi economiche.
Un monopolista possiede il massimo potere di mercato, ed una quota di
mercato del 100%. Un'impresa in un mercato perfettamente concorrenziale
non possiede potere di mercato e la sua quota di mercato è molto piccola.
Pertanto, il potere di mercato deve essere correlato alle quote di mercato,
anche se non è possibile dire se la relazione tra queste due variabili sia
proporzionale oppure no, né affermare con certezza quale ampiezza debba
avere la quota di mercato perché esista potere di mercato, o se esistano altri
fattori sistematici.
Come ha saggiamente sottolineato la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, “la detenzione di una quota di mercato notevole, come elemento
probante dell'esistenza di una posizione dominante, non è un dato assoluto,
e la sua importanza varia da mercato a mercato a seconda della struttura
dei medesimi, specie per quel che riguarda la produzione, l'offerta e la
domanda” 73.
In pratica, quindi, una quota di mercato elevata rappresenta una condizione
necessaria, ma non sufficiente, per provare l'esistenza di potere di mercato, e
sia la Commissione che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno
gradualmente costruito un sistema di presunzioni relative: se un'impresa
possiede una quota di mercato del 50%, si presume che essa goda di una
posizione dominante, in quanto è probabile che il ‘fattore dimensionale’
prevalga sugli altri fattori. Pertanto, l'onere di provare che non è dominante
ricade sull'impresa stessa. D'altra parte, una quota di mercato al di sotto del
25% è considerata generalmente insufficiente per provare l'esistenza di una
posizione dominante 74, ed una quota di mercato inferiore al 10% indica
l'assenza di dominanza 75.
71
Cfr. sentenza della CGUE del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche, in
Racc. (1979), par. 461, par. 39.
72
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 8.
73
Cfr. sentenza della CGUE del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche, in
Racc. (1979), par. 461, par. 40.
74
Si rimanda, a questo proposito, al Regolamento CE 1392004 del 20 gennaio 2004 relativa
al controllo delle concentrazioni tra imprese, in OJEC [2004] L24/1, considerando 32.
75
Sentenza del 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro, in Racc. (1986), p. 302, par. 85.
78
Tra il 25% e 50% non vi è alcuna presunzione, e le autorità di concorrenza
devono considerare altri fattori oltre la quota di mercato.
La presunzione dell’esistenza di potere di mercato può in ogni caso essere
rafforzata considerando anche altri fattori. Ad esempio, la stabilità delle
quote nel tempo, dal momento che le imprese che hanno quote stabili ed
elevate godranno più probabilmente di potere di mercato, rispetto a quelle
imprese le cui quote di mercato oscillano nel tempo: quest'ultima situazione
è infatti quella che ci si attenderebbe di vedere in un mercato
concorrenziale, in cui le imprese vedono cambiare rapidamente le proprie
posizioni.
Le quote di mercato possono essere calcolate sia con riferimento ai volumi
(numero di unità vendute), sia con riferimento al valore (fatturato) 76. Questi
metodi possono portare a differenti risultati per la stessa impresa 77: nella
pratica, le quote di mercato in valore sono preferibili dal momento che
riflettono più da vicino il prezzo che l'impresa è in grado di conseguire sul
mercato. In alcuni casi, tuttavia, possono essere utili anche le quote di
mercato in volume 78, o altri criteri 79.
Come vedremo tra breve, la quota di mercato fornisce quindi in pratica una
condizione necessaria per il potere di mercato, ma non una condizione
sufficiente.
7.6.2
Struttura del mercato
Il potere di mercato di un'impresa non è indipendente dal potere di mercato
dei suoi concorrenti.
Per verificare questo punto, è necessario considerare sia la dimensione che il
numero dei concorrenti, dal momento che avere un unico concorrente con il
76
Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 55.
77
Per esempio, se i prodotti sono differenziati, il prodotto che possiede un marchio celebre
può avere un prezzo più elevato: in questo caso, la quota di mercato di quell'impresa, in
valore, sarà più grande di quella calcolata secondo il volume delle vendite.
78
La Commissione Europea ha utilizzato questo criterio, ad esempio, in Procter &
Gamble/Schickedanz, decisione della Commissione del 21 giugno 1994, in GUCE (1994),
L 354/32, par. 118, nel valutare la posizione delle parti nel mercato dei prodotti per l'igiene
femminile.
79
In casi particolari, la Commissione ha utilizzato: la capacità produttiva, cfr. ad esempio il
caso M.986, decisione dell'11 febbraio 1998, Agfa Gevaert/Du Pont, in GUCE (1998)
L211/, par. 59; la capacità della flotta (nel mercato del trasporto aereo), o gli ordini ricevuti,
nei mercati in cui le imprese lavorano per commessa, come l'industria aeronautica e
ferroviaria, cfr. ad esempio il caso M.2220, decisione del 3 luglio 2001, General
Electric/Honeywell, in GUCE (2004), C31/05, par. 15.
79
30% di quota di mercato sarà presumibilmente differente dall'avere 10
concorrenti, ciascuno con una quota del 3%.
Si consideri l'esempio seguente. Nel mercato di un determinato prodotto son
presenti 10 imprese, ciascuna delle quali possiede il 10% del mercato. Se
un'impresa provasse a ridurre la propria produzione per aumentare il prezzo,
i consumatori si rivolgerebbero alle altre nove imprese, e l'aumento dei
prezzi non avrebbe successo, perché, complessivamente, la produzione non
calerebbe. Ma se quell'impresa avesse l'80% del mercato, i suoi aumenti di
prezzo potrebbero essere molto più facilmente profittevoli, dal momento che
le altre imprese non sarebbero in grado di aumentare la loro produzione in
modo tale da compensare la diminuzione effettuata dall'impresa principale.
Un modo efficace per considerare sia la dimensione che la numerosità dei
concorrenti è quella di guardare alla concentrazione di mercato, utilizzando i
rapporti di concentrazione, oppure l'indice di Herfindahl-Hirschmann (HHI).
I rapporti di concentrazione misurano la somma delle quote di mercato delle
prime n imprese. Per esempio, l'indice CR2 corrisponde alla somma delle
quote di mercato delle due imprese più grandi, mentre l'indice CR4
corrisponde alla somma delle prime quattro imprese. Quest’ultimo è il
rapporto di concentrazione più ampiamente utilizzato nella prassi, sebbene
in molti casi siano stati usati rapporti differenti. Un mercato è generalmente
definito come altamente concentrato se il suo CR4 è più elevato del 75%.
Tuttavia, l'utilizzo dei rapporti di concentrazione presenta due significative
lacune. In primo luogo, tali indici non considerano la grandezza relativa
delle imprese considerate: un mercato in cui le prime quattro imprese hanno
una quota del 20% avrà un CR4 pari all'80%, al pari di un mercato in cui le
prime quattro imprese possiedono quote di mercato rispettivamente del
55%, del 20%, del 4% e dell'1%. È però probabile che la concorrenza sia
meno efficace in questo secondo mercato. In secondo luogo, i rapporti di
concentrazione non considerano le quote di mercato delle imprese più
piccole: queste possono essere importanti se queste sono in grado di
aumentare velocemente la produzione, reagendo ad un aumento dei prezzi
da parte di un concorrente più grande.
L’HHI è quindi l'indice preferito, dal momento che considera tutte le
imprese presenti sul mercato, ed è calcolato sommando i quadrati di
ciascuna quota di mercato: se un'impresa possiede una quota di mercato del
40% e le altre due imprese sul mercato hanno una quota del 30% ciascuna,
l'indice HHI sarà pari a 402+302+302= 3.400 80.
80
Questo indice è stato utilizzato per la prima volta nel 1992 nell'analisi antitrust delle
Merger Guidelines statunitensi del 1992 ed è stato recepito successivamente anche nella
prassi della Commissione Europea (cfr., al riguardo, da ultimo, Orientamenti relativi alla
valutazione delle concentrazioni orizzontali, in GUCE, 2004, C 31/03).
80
La Commissione ha individuato alcune soglie significative per i valori
dell'indice HHI. Ad esempio, nell'ambito del controllo delle concentrazioni,
un mercato si definisce concentrato se il valore dell'indice superiore a 2.000,
mentre si definisce non concentrato se il valore dell'indice HHI è inferiore a
1.000. Valori di riferimento sostanzialmente simili si applicano in pratica
nell'analisi dei cartelli e dei comportamenti abusivi.
È opportuno rilevare che, data la metodologia seguita per il suo calcolo,
l'indice HHI dà proporzionalmente un maggior peso alle imprese con
maggiore quota di mercato. Così, in un mercato in cui fossero quattro
imprese con un rapporto CR4 dell’80%, ciascuna con una quota di mercato
del 20%, l'indice HHI sarebbe pari a 202+202+202+202 = 1.600, mentre in un
mercato in cui fossero sempre quattro imprese con un CR4 dell’80%, ma con
quote rispettivamente del 55%, del 20%, del 4% e dell’1%, l'indice HHI
sarebbe circa due volte più elevato, e pari a 552+202+42+12=3.442.
Quindi, nella prassi, l'indice HHI risulta generalmente preferibile ai rapporti
di concentrazione come CR4, in quanto esso sintetizza più accuratamente le
caratteristiche principali della struttura di mercato. Tuttavia, quando non si
hanno a disposizione le quote di mercato di tutte le imprese, non è possibile
calcolare l’HHI, ed è necessario utilizzare i rapporti di concentrazione.
7.6.3
Altri fattori
Nella misura del potere di mercato, è necessario considerare almeno altri
due fattori rilevanti.
Il primo è rappresentato dall'esistenza delle barriere all'entrata. Persino
quando un'impresa ha una quota elevata di mercato, potrebbe non godere di
potere di mercato, se non ci sono barriere all'entrata, cioè se il mercato è
perfettamente contendibile. In quel caso, se l'impresa aumenta i prezzi,
nuove imprese potrebbero entrare nel mercato rapidamente, attratte dagli
elevati profitti: ma naturalmente l’aumento dell'offerta ridurrebbe i prezzi.
In tale mercato, una quota elevata non è quindi indice di potere di mercato.
Ma questo è naturalmente un caso estremo. Nella prassi, un certo grado di
barriere all'entrata è presente nella maggior parte dei mercati. Tali barriere 81
possono derivare da molteplici fattori:
• economie di scala derivanti dalla tecnologia: se voglio iniziare a
produrre motori per auto, per motivi tecnologici ho necessità di
realizzare uno stabilimento con una capacità di oltre un milione di
81
La descrizione segue l'analisi classica delle barriere all'entrata fornita da Joe Bain nel
1956. Un’ulteriore analisi rilevante è stata fornita da Stigler, che ha ristretto la nozione
delle barriere all'entrata ai vantaggi di costo che un'impresa dominante possiede rispetto ai
nuovi entranti. La nozione di barriere endogene all'entrata è stata sviluppata da Sutton.
81
motori all'anno. Uno stabilimento più piccolo non godrà di
sufficienti economie di scala, avrà costi più elevati, e registrerà
perdite. Quindi, un nuovo entrante incontra una barriera all'entrata.
Non può iniziare con un piccolo stabilimento e allargarlo
successivamente: deve necessariamente iniziare con un grande
stabilimento;
• economie di scala derivanti da altri fattori. In Irlanda tutti bevono
Guinness, e la Guinness trasmette un ingente numero di spot
televisivi. Se una nuova impresa vuole promuovere la sua nuova
birra, deve avere un budget pubblicitario molto ampio, altrimenti le
sue pubblicità saranno sommerse da quelle della Guinness. Pertanto,
la pubblicità può rappresentare un’importante barriera all'entrata.
Allo stesso modo, i costi di ricerca e sviluppo possono essere
un'importante barriera all'entrata in alcune industrie, come l'industria
chimica o quella farmaceutica;
• particolari vantaggi di costo, dovuti alla localizzazione dello
stabilimento, che permette un accesso facile ai materiali grezzi o i
mercati finali, i quali non possono essere conseguiti dai nuovi
entranti.
La descrizione precedente mostra come le barriere all'entrata possono
derivare da fattori strettamente esogeni (ad esempio la tecnologia), ma
possono anche derivare da fattori endogeni, come la pubblicità.
Un'ulteriore importante fonte di barriere all'entrata endogene è dato dalla
differenziazione del prodotto. In un famoso caso antitrust riguardante i
cornflakes, si è dimostrato che Kellogg’s - il marchio americano più
importante - produceva una gamma molto ampia di cornflakes lievemente
differenti tra loro, al fine di costruire una barriera all'entrata. Se Kellogg’s
producesse solo cornflakes normali, senza crusca, o All-Bran cornflakes
(cioè, cornflakes di crusca al 100%), un concorrente potrebbe entrare nel
mercato offrendo cornflakes con un contenuto di crusca pari al 30%. Ma se
Kellogg’s iniziasse a vendere cornflakes con un contenuto di crusca pari al
30%, oltre a quelli normali e quelli al 100%, l'entrata sul mercato
risulterebbe più difficile.
In ogni caso, esistono pochissimi mercati in cui non ci sono barriere
all'entrata, ma è raro trovare mercati in cui le barriere all'entrata siano così
elevate da prevenire efficacemente l'entrata (il più delle volte, questo è il
caso in cui esistono monopoli legali).
Nella prassi, quindi, ciò che importa è analizzare quanto difficile possa
essere l'entrata dei concorrenti in un determinato mercato rilevante, e quanto
tempo sia necessario ai concorrenti per entrare sul mercato. Questa è la
domanda sostanziale a cui rispondere, e questo è il motivo per cui è
82
necessario analizzare le barriere all'entrata nella valutazione del potere di
mercato.
Un secondo fattore che può limitare la capacità di un'impresa di innalzare i
propri prezzi al di sopra del loro livello concorrenziale è il potere di mercato
degli acquirenti, o potere di contrasto degli acquirenti (countervailing
buying power) 82. I consumatori hanno potere di mercato nei confronti dei
fornitori se possono credibilmente minacciare di andare altrove. A parità di
altre condizioni, la credibilità sarà più elevata quando:
• l'acquirente sopporterebbe bassi costi di transizione (switching costs)
nel caso scegliesse un altro fornitore;
• il venditore è molto importante per l'acquirente, ad esempio quando
fornisce componenti per un processo industriale just-in-time;
• il fornitore non possiede un particolare know-how, che potrebbe
risultare difficile da sostituire.
D'altra parte, quando gli effetti di rete sono rilevanti, il potere
dell'acquirente sarà più basso: la Coca-Cola è una grande impresa, ma se
smettesse di utilizzare prodotti Microsoft Office potrebbe avere difficoltà
nelle transazioni con i suoi fornitori e con i suoi clienti. Gli effetti di rete
diminuiscono quindi il potere di negoziazione di Coca-Cola nei confronti di
Microsoft.
Pertanto, il potere di mercato dell'acquirente può limitare fortemente il
potere di mercato del venditore, sebbene non siano frequenti i casi in cui
esso sia sufficientemente grande perché il potere del venditore sia diminuito
in misura significativa.
Nella pratica antitrust, il countervailing buying power è particolarmente
importante nella valutazione delle concentrazioni. Può inoltre essere
82
Si veda ad esempio il caso M.42, Decisione della Commissione del 12 aprile 1991,
Alcatel/Telettra (in cui è stato posto in risalto il contropotere di Telefonica, allora unico
acquirente di apparati per telecomunicazioni in Spagna, ove entrambe le parti erano
presenti); il caso M.527, decisione del 2 dicembre 1994, Thomson/Deutsche Aerospace AG
(in cui lo Stato era l’unico acquirente di prodotti per la difesa); caso M.580, decisione del
18 ottobre 1995, ABB/Daimler Benz (in cui la fusione tra i due produttori di veicoli
ferroviari è stata autorizzata, sia pure con condizioni, in considerazione del fatto che l’unico
acquirente fosse Deutsche Bahn). Si veda anche il caso M.938, decisione della
Commissione del 15 ottobre 1997, Guinness/Grand Metropolitan ( in cui la Commissione
ha preso atto dell’esistenza di un significativo countervailing power in capo agli acquirenti
più grandi della grande distribuzione); il caso M.1225, decisione del 25 novembre 1998,
Enso/Stora, in GUCE (1999), L 2549 (in cui è stata autorizzata un’operazione di
concentrazione tra due operatori che – nel mercato europeo dei cartoni per imballaggio di
liquidi, avrebbero avuto una quota di mercato nettamente superiore al 50%, in
considerazione del fatto che il principale acquirente del mercato era Tetra Pak, la quale
acquistava oltre il 60% dell’offerta complessiva del mercato).
83
rilevante nella valutazione dell’esistenza di una posizione dominante in
procedimenti relativi a violazioni dell'articolo 102 del TFUE.
Esistono vari altri fattori specifici che possono generare potere di mercato,
come la disponibilità di tecnologie superiori, un’elevata integrazione
verticale (ad esempio, quando un importante produttore possiede anche
un’estesa rete commerciale), la reputazione raggiunta da un'impresa (per
esempio attraverso costose e sistematiche campagne pubblicitarie e
promozionali), oppure la proprietà di diritti di proprietà intellettuale come
marchi e brevetti. Il ruolo di tali fattori va concretamente valutato in
ciascuna situazione specifica.
Da ultimo, osserviamo che, in alcuni casi, le autorità antitrust possono
cercare direttamente di trovare una condizione sufficiente per valutare
l'esistenza del potere di mercato, osservando i comportamenti passati: se
l'impresa che viene analizzata è stata in grado di traslare ai consumatori un
aumento esogeno nei prezzi di produzione, e/o aumentare - lungo un
significativo orizzonte temporale - il suo prezzo rispetto a quello di alcuni
prodotti considerabili prima facie come sostituti, e/o godere di un saggio di
profitto (ad esempio rispetto al capitale investito) che risulta
permanentemente superiore a quello delle imprese comparabili,
possibilmente in altri mercati geografici, e non ci sono altre spiegazioni
ragionevoli per queste evidenze, allora è possibile presumere una
condizione di dominanza.
84
8. LE INTESE, GLI
CONCORDATE
ACCORDI
E
LE
PRATICHE
8.1 Introduzione
Come abbiamo visto, le imprese possono avere un incentivo razionale a
colludere, particolarmente in un mercato oligopolistico, riducendo la
produzione e aumentando i prezzi a un livello ben superiore a quello che
prevarrebbe in un mercato concorrenziale. In tal modo, esse realizzano
quelle che – in termini legali – sono definite come intese orizzontali, e – in
termini economici – cartelli.
I cartelli, dunque, sono dannosi e, per questo motivo, una parte notevole
dell’attività delle autorità antitrust è finalizzata alla loro repressione. Come
vedremo, però, l’azione a tutela della concorrenza in questo campo è
particolarmente complessa: se infatti è evidente che l’esistenza di un
accordo scritto di determinazione dei prezzi configura un cartello, come
comportarsi davanti a imprese che – pur in assenza di un simile formale
accordo – si muovono comunque all’unisono, variando insieme i prezzi, o
evitando di entrare in mercati nei quali un’altra impresa sia già presente?
Simili comportamenti possono essere talvolta indice di un’illecita
collusione, ma in altri rappresentare semplicemente un razionale
adattamento al comportamento delle altre imprese: distinguere tra
comportamenti leciti e illeciti non è quindi sempre agevole.
Inoltre, non è detto che un’intesa sia stabile: come abbiamo visto nel
Capitolo 2, ogni partecipante ha un incentivo razionale a tradire il cartello,
vendendo un quantitativo maggiore di quello assegnatogli o praticando
segretamente prezzi più bassi di quelli concordati, al fine di sottrarre clienti
agli altri partecipanti al cartello. Per prevenire comportamenti
opportunistici, quindi, i partecipanti al cartello devono dunque disporre di
abbondanti informazioni sul comportamento di ciascun altro partecipante,
ed essere in grado di punire in modo efficace le eventuali deviazioni. In
assenza di tali presupposti, Il cartello sarebbe talmente instabile, che non
verrebbe neppure creato.
Dobbiamo poi considerare che non tutte le intese sono distorsive: alcune
possono invece contribuire ad aumentare il benessere sociale. Si pensi, ad
esempio, al caso in cui più imprese si accordano per combinare le proprie
strutture di ricerca e sviluppo. Un simile accordo può favorire l’innovazione
e, in ultima analisi, permettere ai consumatori di usufruire di prodotti nuovi
o migliori. Lo stesso potrebbe darsi nel caso in cui più imprese riducano i
costi di produzione mettendo in comune le proprie strutture produttive e
trasferiscano ai consumatori una parte sostanziale dei risparmi così ottenuti.
Queste forme di cooperazione, anche se poste in essere da imprese
85
concorrenti (si parla in tal caso di cooperazione orizzontale), possono quindi
generare benefici per la collettività che giustificano una loro positiva
valutazione da parte delle autorità di concorrenza, pur in presenza di
clausole che restringono la libertà di manovra delle imprese che ne sono
parti.
Un discorso a sé stante meritano poi le intese verticali, vale a dire gli
accordi fra imprese che operano in stadi diversi del processo produttivo o
distributivo, come quelli relativi alla distribuzione commerciale (ad
esempio, il franchising). In genere, gli accordi di questo tipo sono
considerati meno nocivi per la concorrenza di quelli tra imprese concorrenti,
dato che spesso possono incrementare l’efficienza economica nell’ambito di
una catena produttiva o distributiva, contribuendo a ridurre i costi delle
transazioni commerciali e di distribuzione delle parti, o consentendo un
livello ottimale degli investimenti e delle vendite.
In questo capitolo discutiamo in qualche dettaglio questi problemi.
8.2 Accordi e pratiche concordate
Il diritto della concorrenza italiano (art. 2 della Legge n. 287/90) e quello
comunitario (art. 101 TFUE) vietano le intese restrittive della concorrenza.
Tali norme colpiscono, con disposizioni quasi identiche, tutti gli accordi,
pratiche concordate o decisioni associative tra imprese che abbiano per
oggetto o effetto di restringere la concorrenza in modo significativo.
La portata del divieto è molto ampia, poiché può ricadervi qualsiasi intesa
capace di distorcere in modo significativo gli equilibri competitivi del
mercato. Le intese vietate sono nulle di pieno diritto 83, nonché sanzionate
con pesanti ammende pecuniarie dalle autorità di concorrenza e suscettibili
di dar vita a responsabilità sul piano civilistico.
83
In base agli artt. 81, comma 2 del Trattato CE, e 2, comma 3, della Legge 287/90.
86
Art. 101 TFUE (già art. 81 Trattato CE)
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto
e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
-
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
-
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
-
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori
una congrua parte dell’utile che ne deriva,
ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Le definizioni di accordo e pratica concordata sono caratterizzate da un
certo grado di flessibilità, che implica inevitabilmente un certo margine di
discrezionalità nell’analisi del mercato e nell’apprezzamento dei fatti,
87
nonché il ricorso a ragionamenti induttivi 84. Tutte le forme di intesa vietata
presentano comunque un minimo comune denominatore, che consiste nella
collusione tra le imprese, la quale conduce a comportamenti diversi da
quelli che sarebbero normalmente dettati dalla struttura del mercato.
La nozione di accordo è molto più ampia della tradizionale nozione fatta
propria dal diritto civile, in quanto rappresenta la comune volontà delle
imprese di attuare una politica, di perseguire un obiettivo o di adottare un
preciso comportamento nel mercato, a prescindere dal modo con cui si sia
manifestata la volontà delle parti 85. Rientrano quindi in tale nozione anche
gli accordi che sarebbero normalmente privi di efficacia giuridicamente
vincolante: gentlemen’s agreements, vincolanti di norma solo sul piano
morale; accordi tra responsabili di area o delle divisioni commerciali di
imprese diverse, che coordinino tra di loro le future condotte sul mercato
delle imprese di appartenenza, pur essendo privi del relativo potere di
rappresentanza.
Anche in assenza di un accordo, i comportamenti delle imprese possono
comunque configurare una pratica concordata vietata dalle norme a tutela
della concorrenza. Quest’ultima viene definita come una forma di
coordinamento dell’attività delle imprese che, senza essere stata spinta fino
all’attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole
collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza 86.
L’ipotesi classica di pratica concordata è quella in cui le imprese concorrenti
(i) stabiliscono dei contatti, anche indiretti, tra di loro, volti a scambiare
informazioni per eliminare eventuali incertezze circa il proprio
comportamento futuro sul mercato, e (ii) adottano successivamente una
condotta coordinata sul mercato. Si pensi, ad esempio, a un mercato nel
quale vi sia un’impresa leader e diversi concorrenti. L’impresa leader non si
accorda con i propri concorrenti per aumentare il prezzo. Tuttavia, essa
comunica agli altri in anticipo, via fax o con altri mezzi (un bollettino
pubblicato dall’associazione di settore, un’intervista a riviste specializzate,
etc.), la propria intenzione di aumentare i prezzi a un certo livello e a una
84
La decisione di associazioni di imprese è di gran lunga la nozione meno problematica
delle tre e ad essa non sarà dedicata specifica attenzione nel testo. In particolare, costituisce
una decisione di associazioni di imprese qualsiasi atto, inclusa una raccomandazione non
vincolante, che miri al coordinamento del comportamento futuro sul mercato dei membri
dell’associazione.
85
Cfr. TPG sentenza del 26 ottobre 2000, causa T-41/96, Bayer AG c. Commissione, in
Racc., p. II-3383, § 173.
86
Cfr. Corte di Giustizia sentenze del 14 luglio 1972, cause riunite 48-57/69, ICI e altri c.
Commissione (Materie Coloranti), in Racc., p. 619, §§ 64-65; del 16 dicembre 1975, cause
riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Suiker Unie e altri c. Commissione, in Racc., p.
1663, § 26; e del 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e altri c. Commissione, in Racc., p.
I-1307, § 63.
88
certa data. Gli altri concorrenti si adeguano e, alla data specificata,
aumentano anch’essi il proprio prezzo in modo simile. La collaborazione si
ripete con modalità analoghe nel tempo. Occorre però fare attenzione: ciò
che è vietato non è l’adozione di comportamenti identici da parte delle
imprese, ma la loro collaborazione consapevole. Infatti, il diritto della
concorrenza non nega il diritto degli operatori economici di reagire
intelligentemente ai comportamenti noti o presunti dei propri concorrenti.
Esso esige però che le imprese decidano autonomamente la propria condotta
sul mercato. Pertanto, è vietato - in quanto pratica concordata - qualsiasi
contatto diretto o indiretto avente l’oggetto o l’effetto di influire sul
comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale. 87
Da ciò scaturiscono due conseguenze. In primo luogo, la pratica concordata
sussiste sin dal momento in cui le imprese abbiano scambiato tra di loro
delle informazioni suscettibili di influenzare il reciproco futuro
comportamento, e non è necessario che le imprese abbiano poi
effettivamente posto in essere una condotta coordinata sul mercato. 88
In secondo luogo, il semplice comportamento parallelo dei concorrenti sul
mercato non prova di per sé l’esistenza di una pratica concordata, se esso
può essere spiegato razionalmente, in modo alternativo, dall’analisi del
contesto economico e fattuale. Se però, alla luce di tale analisi il
comportamento parallelo continua a rimanere anomalo, allora si è in
presenza di un serio indizio di pratica concordata.
Come si è visto, le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per
effetto la restrizione della concorrenza. Le due condizioni non sono
cumulative: se un’intesa è vietata a causa dell’oggetto, non è necessario
analizzarne anche gli effetti.
In linea generale, si ritiene che un’intesa abbia un oggetto restrittivo quando
è per sua natura destinata a restringere la concorrenza. Per individuare
l’oggetto di un’intesa, occorre valutare quali siano gli scopi da essa
perseguiti, sulla base di un’analisi obiettiva dei suoi contenuti (da
distinguere rispetto alle mere intenzioni delle parti), alla luce del contesto
economico rilevante.
In pratica, gli oggetti per loro natura restrittivi sono un numero alquanto
ristretto. Tra questi, nel caso di intese orizzontali, figurano principalmente la
fissazione dei prezzi di vendita, la ripartizione dei mercati e la limitazione
della produzione. 89
87
Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 16 dicembre 1975, cause riunite 40 a 48, 50, 54
a 56, 111, 113 e 114/73, Cooperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. e altri c. Commissione,
in Racc. [1975] p. 1663, § 26.
88
Cfr. sentenza Hüls, cit., §§ 161-164.
89
La fissazione dei prezzi, in particolare, è vietata in qualsiasi forma, anche perché il
prezzo è normalmente il principale strumento di concorrenza. Oltre alla fissazione diretta
89
Come scrive la Commissione, “queste restrizioni sono considerate le più
dannose, poiché interferiscono direttamente con il risultato del processo
concorrenziale. La fissazione dei prezzi e la limitazione della produzione
hanno come conseguenza diretta il fatto che i consumatori devono pagare
prezzi più elevati o non ottengono le quantità volute. La ripartizione dei
mercati o dei consumatori riduce la scelta di cui i consumatori dispongono,
portando così a sua volta a prezzi più alti o ad una riduzione della
produzione. È quindi da presumere che queste restrizioni esercitino
esclusivamente effetti negativi sul mercato; per questo, sono quasi sempre
vietate” 90.
8.3 Fattori strutturali e creazione del cartello
Colludere stabilmente, come si diceva, è difficile. In alcuni casi, la
collusione è però facilitata da alcune caratteristiche del mercato o del
processo produttivo.
La presenza di barriere all’entrata è di regola necessaria per l’efficacia di
un’intesa. Quando questa riesce ad aumentare i prezzi, infatti, se l’entrata
sul mercato è agevole, molte nuove imprese entrerebbero attratte dai prezzi
elevati, e ciò naturalmente deprimerebbe i prezzi e vanificherebbe l’intesa.
Una seconda caratteristica rilevante è l’alta concentrazione del mercato. Se
poche imprese hanno una quota complessiva elevata del mercato, esse
potranno più facilmente coordinarsi e controllarsi reciprocamente (per
scoprire l’eventuale esistenza di politiche di quantità e di prezzo difformi da
quelle stabilite nell’intesa) e dunque imporre sul mercato un prezzo elevato.
Anche l’esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra le imprese può
facilitare la realizzazione e la tenuta di un’intesa 91.
Varie caratteristiche produttive delle imprese possono essere rilevanti.
Imprese di dimensione simile o aventi caratteristiche produttive e strutture
di costi alquanto omogenee troveranno più agevole colludere, poiché
ciascuna di esse sarà più facilmente in grado di interpretare il
comportamento delle altre.
dei prezzi di vendita o rivendita (e dei relativi aumenti), sono considerate vietate le
limitazioni alla concessione di sconti, la fissazione dei margini per la rivendita, gli accordi
sui prezzi minimi, e la creazione di organizzazioni per la vendita congiunta dei prodotti.
90
Cfr. Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato CE agli accordi di
cooperazione orizzontale, in GUCE [2001] C 3/2, § 25.
91
Questi collegamenti possono assumere varie forme, tra le quali i casi più evidenti sono
rappresentati da partecipazioni incrociate di quote azionarie, controllo congiunto di imprese
comuni, e rappresentanti di un’impresa che siedono anche nei consigli di amministrazione o
di gestione di altre imprese operanti sullo stesso mercato rilevante (interlocking
directorships).
90
Inoltre, se un’impresa ha un costo marginale molto inferiore al prezzo di
cartello, l’incentivo a deviare sarà maggiore. Se infatti il prezzo è fissato a
€100, e il costo di produzione di un’unità addizionale è pari a €10, la
decisione di deviare dal cartello darà un profitto notevole (sino a un
massimo di €90). Ma se il costo marginale è €85, la deviazione potrà
fruttare al massimo €15. Questo meccanismo aiuta per esempio a capire
come mai il cartello dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) sia
particolarmente tormentato: il costo marginale di estrazione di un barile che
può essere venduto sui mercati internazionali per $50 – 100 non è infatti
superiore, per molti di questi Paesi, a $10. Questa considerazione spiega
d’altronde anche perché molti cartelli esistano nelle industrie di processo,
nelle quali il costo marginale è tipicamente piuttosto basso.
Anche la possibilità per i partecipanti all’intesa di punire in modo efficace
un’eventuale deviazione dai comportamenti stabiliti, può avere un notevole
effetto di stabilizzazione dell’intesa. Tipicamente, la punizione di un
comportamento deviante rispetto alle regole dell’intesa - ad esempio, la
concessione di sconti rispetto al prezzo fissato o la vendita di quantitativi
superiori a quelli stabiliti - avviene mediante una riduzione coordinata dei
prezzi, o un aumento coordinato delle quantità, da parte dei partecipanti
all’intesa. In tal modo, essi sacrificano una parte degli extra-profitti che
avrebbero conseguito continuando a praticare il prezzo di cartello, e
‘tollerando’ il comportamento deviante: tale sacrificio, peraltro, può essere
un ragionevole prezzo da pagare per ristabilire le regole del cartello,
richiamando all’ordine l’impresa deviante.
La possibilità di infliggere una punizione efficace dipende da vari fattori. Le
imprese devono anzitutto essere in grado di accertare rapidamente
l’esistenza di una deviazione, e dunque di disporre di informazioni accurate
e tempestive sul comportamento altrui (di questo aspetto ci occuperemo nel
paragrafo che segue). Inoltre, esse devono avere un livello di capacità
inutilizzata sufficiente ad aumentare la produzione in misura significativa.
Infine, l’aumento di produzione deve essere effettivamente in grado di far
cadere i prezzi, ciò che si verifica tanto più facilmente quanto più i clienti
considerano omogenei i prodotti dei diversi partecipanti all’intesa. Prodotti
omogenei e capacità inutilizzata sono dunque le due variabili principali che
consentono un’efficace punizione delle imprese che deviano dal normale
corso del cartello.
Infine, la collusione può essere facilitata anche dalle caratteristiche della
domanda di mercato. Se essa è stabile, o evolve lentamente, i partecipanti
all’intesa troveranno meno difficile accordarsi sulle quote produttive di
ciascuno. Se la domanda è rigida rispetto al prezzo, sarà più facile imporre
un aumento dei prezzi. Infine, se i clienti sono numerosi, e dunque se la
concentrazione degli acquirenti è molto inferiore alla concentrazione dei
venditori, questi ultimi troveranno meno resistenze nei confronti degli
91
aumenti dei prezzi. Per contro, una domanda particolarmente elastica può
produrre effetti contrapposti: da un lato, essa aumenta l’incentivo per le
imprese ad abbassare i prezzi e, quindi a deviare dall’intesa; dall’altro, essa
rende più temibili le punizioni consistenti in sensibili riduzioni dei prezzi,
che i partecipanti a un eventuale cartello possono mettere in atto nei
confronti dell’impresa che abbia deviato.
I fattori strutturali che abbiamo sintetizzato possono facilitare scelte
collusive. Tuttavia, come abbiamo visto, le intese sono strumenti instabili,
costosi da realizzare e da mantenere: per questo, non vi è nessuna relazione
meccanica tra la presenza dei fattori discussi e l’effettiva esistenza di intese.
Detto in altri termini, la presenza di uno o più di questi fattori rende
semplicemente più probabile - a parità di altre condizioni - la conclusione (e
la “tenuta”) di un’intesa.
Il caso Vitamine, sanzionato in procedimenti separati nell’Unione Europea,
negli Stati Uniti e in Canada, rappresenta forse l’esempio più importante di
cartello internazionale degli ultimi anni.
Il caso Vitamine
Nel 2001 la Commissione Europea ha sanzionato otto produttori mondiali di
vitamine per aver dato vita per quasi un decennio ad accordi anticoncorrenziali in
otto differenti mercati di vitamine e prodotti connessi . Le imprese coinvolte
rappresentavano quasi l’80% dei mercati interessati a livello mondiale. L’insieme
degli accordi ha avuto durata quasi decennale (dal settembre 1989 al febbraio
1999).
Le imprese partecipanti avevano concluso una serie di accordi volti alla
ripartizione dei mercati e alla fissazione in comune dei prezzi. A tal fine, esse
avevano elaborato un complesso sistema di monitoraggio e controllo del rispetto
dell’accordo, attuato tramite riunioni periodiche cui partecipavano a vari livelli le
funzioni aziendali di volta in volta interessate.
Gli accordi venivano realizzati mediante la determinazione delle quote di mercato
spettanti a ciascuna impresa, stabilizzando così la posizione di ciascuna. Inoltre,
essi prevedevano meccanismi sanzionatori: se, alla fine di ciascun anno, una o più
imprese avessero ecceduto la quota fissata, avrebbero dovuto acquistare le
vitamine dagli altri partecipanti al cartello, per compensare le mancate vendite di
questi ultimi.
Le imprese partecipanti concordavano altresì i prezzi di “listino”, i prezzi minimi e
gli aumenti di prezzo dei propri prodotti. Alcuni accordi specificavano persino le
modalità con le quali attuare gli aumenti di prezzo: uno dei produttori
“annunciava” per primo l’aumento attraverso un giornale di categoria o con una
comunicazione diretta ai principali clienti, in modo che gli altri potessero
procedere ad adeguare i propri prezzi al prezzo “annunciato”.
Il meccanismo di fissazione dei prezzi è stato molto efficace nell’innalzare i prezzi
delle vitamine: come si può notare nella figura seguente, durante il periodo in cui
l’intesa ha avuto luogo (evidenziato in grigio), i prezzi sono cresciuti
notevolmente, diminuendo rapidamente e sensibilmente subito dopo che l’intesa
era stata scoperta.
92
La Commissione ha descritto questo caso come “la serie di cartelli più dannosi” mai
condannati nella storia del diritto comunitario della concorrenza. Essa ha inflitto
sanzioni pecuniarie per un totale di € 855 milioni, di cui ben € 462 milioni alla sola
Hoffmann-La Roche, colpevole di essere stata la principale istigatrice (e maggiore
beneficiaria) dei cartelli.
Decisione della Commissione Vitamine del 21 novembre 2001, in GUCE [2003] L 6/1
8.4 Come rendere stabili i cartelli
Ma i cartelli sono così instabili come risulta dal nostro semplice modello del
Capitolo 2?
Il modello che abbiamo utilizzato per mostrare che la collusione è instabile
è alquanto semplicistico, dal momento che assume che il tradimento sia una
strategia molto semplice: l'altra impresa non è a conoscenza del fatto che
l'accordo sia per essere rotto, e non può fare nulla per scoraggiare il
tradimento. Abbiamo inoltre considerato le scelte delle imprese dal punto di
vista statico, cioè considerando un caso in cui una sola decisione debba
essere presa.
Nella realtà, le imprese sono in concorrenza tra loro sul mercato giorno
dopo giorno, si conoscono bene, e ricordano i comportamenti passati: i
concorrenti interagiscono ripetutamente. Quindi, se un'impresa tradisce un
93
cartello oggi, deve considerare il rischio che gli altri membri della
puniranno nel futuro per il tradimento stesso. Un comportamento di questo
tipo - per esempio, l'offerta di prezzi più bassi o la vendita di quantità più
elevate di quelle fissate dal cartello - può essere, come abbiamo visto,
solitamente punito dagli altri membri del cartello attraverso una riduzione
coordinata dei prezzi, e/o attraverso un aumento coordinato nelle quantità.
Naturalmente, per punire il tradimento, è necessario scoprire il traditore:
quindi, l'informazione è cruciale per i cartelli. Dal momento che ciascun
partecipante possiede un incentivo razionale per deviare dall'accordo, è
essenziale, per ciascun membro del cartello, avere informazioni sulle
quantità prodotte dei prezzi praticati da ciascuno degli altri partecipanti.
Solo in questo caso un membro del cartello può valutare se una diminuzione
inaspettata nelle sue vendite dipende dal ciclo economico o dal tradimento
di uno degli altri partecipanti.
Per questo motivo, l'azione antitrust contro gli scambi di informazione tra
concorrenti è particolarmente vigorosa, e proibisce lo scambio di
informazioni di natura strategica e confidenziale. Tra questi vi sono, per
esempio, i dati sulle quantità prodotte, i prezzi, gli sconti e le condizioni di
vendita, dal momento che la loro circolazione può portare i concorrenti a
modificare il loro comportamento sul mercato. Tuttavia, dati non recenti, o
che si riferiscono ad un insieme aggregato di imprese non presentano
criticità dal punto di vista antitrust.
Se i dati non sono scambiati privatamente tra concorrenti, ma sono resi
pubblici, possono esservi effetti contrastanti. Da un lato, se i consumatori
hanno informazioni dettagliate sul prezzo delle condizioni di mercato, può
esserci un effetto positivo sulla concorrenza. La trasparenza può aumentare
l'elasticità della domanda, diminuire i prezzi e rendere i cartelli più instabili,
perché aumenta l'incentivo a deviare dal normale corso del cartello.
Tuttavia, ciò può anche scoraggiare potenziali deviazioni dall'accordo, dal
momento che rende più facile per i partecipanti punire l'impresa traditrice,
diminuendo i loro prezzi 92.
Vediamo ora un caso di pratica concordata, basata sullo scambio di
informazioni, sanzionata dall’Autorità italiana nel 2000: il caso RC Auto.
92
Gli effetti controversi della trasparenza sulla stabilità dei cartelli sono illustrati molto
chiaramente in una recente decisione dell'autorità antitrust italiana (si veda la decisione del
30 settembre 2004, Ras-Generali/Iama Consulting, nel Bollettino 40/2004, par. 166, poi
cancellata dal Tar del Lazio il 28 aprile 2005).
94
Il caso RC Auto
Nel 2000, l’Autorità italiana ha sanzionato 39 compagnie di assicurazione per aver
messo in opera un “pervasivo” scambio di informazioni tra numerose imprese
relativo a prezzi, sconti, incassi, costi dei sinistri, attraverso i servizi resi dagli
osservatori realizzati da una società di consulenza specializzata, a cui
partecipavano solamente imprese di assicurazione.
Le informazioni scambiate attraverso tali osservatori riguardavano le tariffe delle
imprese monitorate, per un numero estremamente elevato di profili tariffari;
inoltre, l’andamento degli incassi e dei sinistri su base geografica molto
particolareggiata e per ogni mese. Lo scambio di informazioni permetteva quindi,
secondo l’Autorità, alle imprese appartenenti agli osservatori di conoscere le
previsioni a medio/lungo termine del mercato ed effettuare confronti tariffari circa
il posizionamento relativo sul mercato. Grazie a tale scambio, le imprese potevano
attuare comportamenti paralleli nella fissazione delle tariffe sul mercato, le quali
risultavano allineate tra compagnie. Secondo l’Autorità, inoltre, le quote di
mercato risultavano cristallizzate.
Va rilevato che, per la normativa italiana, le tariffe assicurative RC auto devono
essere esposte al pubblico con un anticipo di sessanta giorni rispetto alla loro
entrata in vigore. Inoltre, le imprese di assicurazioni possono scambiarsi alcuni tipi
di informazioni sugli andamenti dei sinistri, in quanto tali dati statistici sono
necessari per valutare correttamente la probabilità che – in futuro – si possa
verificare un sinistro: probabilità che è alla base della determinazione della tariffa.
Per l’Autorità italiana, tuttavia, lo scambio di informazioni attuato dalle imprese di
assicurazione trascendeva queste finalità, e non si limitava allo scambio di dati
pubblici, ma era relativo alle scelte strategiche che ciascuna impresa dovrebbe
adottare individualmente, e che ovviamente non dovrebbe rivelare ai concorrenti.
Infatti, lo scambio riguardava informazioni attuali, frequenti, non pubblicamente
disponibili nella loro interezza, tali da consentire l’identificazione delle imprese, e
avveniva all’interno di un osservatorio, i cui membri potevano essere unicamente
imprese di assicurazione.
Pertanto, l’unica spiegazione possibile del parallelismo di comportamenti
osservato sul mercato era l’eliminazione del rischio commerciale connesso alla
determinazione delle tariffe: lo scambio configurava quindi una pratica concordata
con oggetto anticoncorrenziale.
AGCM, Provvedimento di chiusura istruttoria I377 del 28 luglio 2000.
Un altro comportamento che può facilitare la collusione è l'adozione di
clausole contrattuali che incoraggiano i concorrenti a comportarsi in modo
simile, rendere il mercato molto ‘trasparente’ e così rendere più facile per
ciascuna impresa capire il comportamento dei concorrenti.
Tra queste figurano le cosiddette clausole inglesi (con le quali il fornitore si
obbliga verso i propri clienti a pareggiare le eventuali offerte migliorative
95
dei concorrenti, a patto di essere favorito a parità di condizioni), o le most
favoured client clauses (con le quali il fornitore si impegna a riconoscere al
singolo acquirente gli eventuali sconti praticati agli altri, ovvero garantisce
che il prezzo dell'acquisto appena concluso è in assoluto il più basso tra
quelli praticati ai propri clienti).
Queste clausole incentivano l'uniformità dei prezzi degli sconti praticati: nel
primo caso, i concorrenti saranno disincentivati dal praticare condizioni
migliorative, nella consapevolezza che ciò non sarà sufficiente a sottrarre il
cliente al concorrente; nel secondo caso, i fornitori tenderanno a non
concedere condizioni di particolare favore, per evitare di doverle poi offrire
a tutti. Inoltre, ambedue i tipi di clausola inducono i clienti ad acquisire
informazioni circa i prezzi praticati sul mercato e a portarle a conoscenza
dei propri fornitori, agevolando in tal modo la scoperta di eventuali
comportamenti devianti dei partecipanti all'intesa. Altre clausole possono
essere rilevanti in settori specifici 93.
8.5 ‘Collusione tacita’
Ma come definiamo esattamente un cartello? Le imprese in oligopolio
troveranno sempre un equilibrio: come abbiamo visto, ciascuna di esse
considererà le reazioni dei concorrenti tutte le volte che prende una
decisione, ad esempio riguardo ai prezzi per un nuovo prodotto. Dal
momento che le imprese interagiscono ripetutamente, anche se non creano
un cartello, esse raggiungeranno certamente una sorta di modus vivendi, e
prezzi non varieranno molto nel tempo a meno che non si registrino
variazioni della domanda o dei prezzi degli input.
Talvolta questo fenomeno viene definito ‘collusione tacita’. La legge
antitrust dovrebbe proibirlo?
Se lo facesse, ciò sarebbe irragionevole, dal momento che da una parte le
imprese non possono essere forzate ad entrare in concorrenza tra loro, e
dall'altro lato, come ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, “
ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta
che egli intende seguire sul mercato comune […] Se è vero che non esclude
il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al
comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di
autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano
93
Un esempio classico è costituito dalle clausole basis point, storicamente frequenti nei
mercati dell'acciaio delle automobili del cemento e dello zucchero, con le quali il prezzo del
trasporto è determinato con riferimento ad un unico punto base, indipendentemente dal
luogo di effettiva spedizione dei beni. In tal modo, la componente del prezzo relativa al
trasporto diviene più omogenea e trasparente, e si impediscono sconti sul prezzo del
prodotto “mascherati” da bassi costi di trasporto.
96
luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di influire sul
comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale,
ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha
deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato” 94.
Il confine tra la collusione e l'adattamento intelligente al comportamento
atteso dei concorrenti che è stato tracciato dalla Corte è ragionevole dal
punto di vista economico. Non saremo mai in grado di decidere se le
imprese i cui prezzi sono molto simili e che si comportano in modo simile
siano parte di un accordo collusivo illecito, o se esse siano solamente
reagendo intelligentemente alle condizioni di mercato e alle reazioni degli
altri concorrenti, e abbiano trovato un equilibrio del tutto lecito.
Pertanto, la public policy ha scelto un approccio prudente, attribuendo
un'importanza molto alta esattamente al fattore che abbiamo visto essere
fondamentale per la stabilità del cartello: gli scambi di informazioni. Se gli
scambi di informazioni sono attivamente scoraggiati dalla politica antitrust,
i cartelli saranno più instabili. Naturalmente, utilizzare un approccio
prudente potrà avere come effetto la possibilità che alcuni cartelli non
vengano scoperti. Tuttavia, se fosse adottato uno standard più stretto, la
politica antitrust perseguirebbe sicuramente, almeno in alcuni casi, un
comportamento puramente razionale da parte delle imprese considerate. È
certamente inefficiente scoraggiare il comportamento razionale delle
imprese.
Tuttavia, come abbiamo visto nel capitolo introduttivo, un oligopolio che
raggiunge qualche forma di collusione tacita comporterà prezzi più elevati e
minori quantità rispetto al caso in cui non riuscisse a raggiungere tale
equilibrio, e in cui le imprese continuassero a concorrere vigorosamente tra
loro. Questo è il motivo per cui, nella valutazione delle concentrazioni,
come vedremo in seguito, viene valutato il rischio che la concentrazione
potrebbe incoraggiare le imprese a raggiungere qualche forma di collusione
tacita. Discuteremo questo aspetto in seguito.
8.6 Costi e benefici di partecipazione ad un cartello
Da un punto di vista puramente economico, “colludere” o “competere” è
una decisione razionale.
Il beneficio atteso è pari agli extra-profitti che l'impresa si attende dalla
partecipazione cartello, cumulati per il numero degli anni in cui essa ritiene
che il cartello possa operare.
94
Sentenza della CGUE del 16 dicembre 1975, cause riunite da 40 a 48,50, da 54 a 56, 111,
113 e 114/73, Suiker Unie e altri c. Commissione, in Racc. (1975), p. 1663, par. 173-4.
97
Il costo atteso è composto da due componenti principali: (i) i costi di
organizzare e mantenere il cartello e (ii) la punizione attesa, nel caso in cui
l'intesa venga scoperta e sanzionata dalle autorità antitrust. Quest'ultima
componente dipende evidentemente da due fattori, ovvero dalla probabilità
che l'intesa venga scoperta e dal costo complessivo della sanzione.
Questo costo, a sua volta, dipende dalla sanzione amministrativa pecuniaria,
dall'eventuale danno di immagine che può subire l’impresa e da altre
possibili voci di danno.
Il costo atteso di un cartello, pertanto, dipenderà dalla legge antitrust, e da
quanto vigorosamente essa sia applicata. In Europa, gli illeciti antitrust sono
puniti essenzialmente con sanzioni amministrative, essendo ad oggi ancora
abbastanza rari i casi in cui partecipanti ad un'intesa sono chiamati davanti
ai tribunali civili a risarcire il danno causato. Al contrario, negli Stati Uniti,
le azioni risarcitorie promosse dai concorrenti e dei clienti danneggiati
possono generare costi notevolmente superiori per le imprese partecipanti a
un'intesa, rispetto alle eventuali sanzioni amministrative comminate dalle
autorità antitrust. Molti illeciti possono inoltre dare luogo a danni punitivi, e
le class actions (che permettono ai concorrenti e ai consumatori di unire le
loro richieste - diminuendone i costi - in un'unica azione risarcitoria di
elevato ammontare) sono assai diffuse. Negli Stati Uniti, inoltre, sono
frequenti sanzioni penali contro i manager coinvolti nell'organizzazione nel
mantenimento dei cartelli.
In conclusione, il costo atteso di un cartello è molto più elevato negli Stati
Uniti che in Europa, sebbene l’aumento progressivo delle azioni risarcitorie
in Europa può portare ad una riduzione della differenza tra i due sistemi.
8.7 Intese verticali
La tesi che le intese orizzontali tra concorrenti possono avere effetti negativi
sulla concorrenza è certamente ragionevole, così come è ragionevole la tesi
opposta con riferimento alle intese verticali, cioè gli accordi tra imprese che
operano a livelli differenti di una filiera di produzione: nella maggior parte
dei casi, le efficienze che derivano dalle intese verticali superano
ampiamente i loro possibili effetti negativi.
Due imprese concorrenti nello stesso mercato, che offrono prodotti sostituti,
possono avere un incentivo razionale, come abbiamo visto, ad accordarsi
per aumentare il prezzo. Al contrario, un produttore e un distributore
offrono prodotti complementari: così, se il distributore (o il produttore)
aumenta il suo prezzo di vendita, i consumatori ridurranno i loro acquisti, e
questo ridurrà anche le vendite del produttore (o del distributore). In
conclusione, produttori e distributori hanno un incentivo razionale ad evitare
che l'altra parte innalzi i suoi prezzi, piuttosto che colludere per aumentarli.
98
Per questa ragione, da un punto di vista strettamente economico, gli accordi
di distribuzione verticale dovrebbero essere rilevanti da un punto di vista
antitrust solo in due casi principali: quando incoraggiano la collusione tra
concorrenti nel mercato a monte o nel mercato a valle (ma questo è un
problema di intese orizzontali), o quando essi permettono ad un'impresa con
potere di mercato di escludere i suoi concorrenti (e questo è un problema di
comportamenti abusivi).
Vediamo come le intese verticali possono risolvere due problemi economici
di base nella relazione produttore/distributore: l'esistenza di un doppio
mark-up, e le esternalità.
Supponiamo che un'impresa farmaceutica venda il suo farmaco, coperto da
brevetto, per mezzo di una farmacia che gode di un significativo potere di
mercato in una determinata area. Se il prezzo del farmaco è fissato
liberamente dall'impresa, essa applicherà la regola del prezzo di monopolio,
scegliendo la quantità che dovrà essere prodotta alla luce del suo costo e del
ricavo marginale, e imponendo il prezzo più elevato che il mercato è in
grado di sopportare. Se la farmacia possiede un monopolio nella sua area
geografica, essa applicherà la stessa regola partendo da un costo marginale
che include il costo di acquisto del farmaco. Il prezzo finale di vendita al
dettaglio del farmaco sarà così molto elevato, dal momento che include due
profitti di monopolio, sia il mark-up del produttore che quello del
distributore. Questo ridurrà la domanda dei consumatori, e così il produttore
non riuscirà a massimizzare il suo profitto.
Quindi l'impresa farmaceutica imporrà alla farmacia un prezzo massimo di
vendita al dettaglio, al fine di costringere la farmacia a vendere la quantità
di farmaco che effettivamente massimizza i suoi profitti. Questa decisione
non ha effetti negativi per i consumatori, ma anzi comporta benefici. Così,
questa è una restrizione verticale che non pone particolari problemi
antitrust.
Consideriamo il problema delle esternalità. Come meglio vedremo nei
capitoli che seguono, i contratti tra produttore distributore sono un tipico
esempio di quello che la teoria economica definisce come il problema
principale-agente: il principale dà mandato all’agente di agire per proprio
conto, dal momento che il principale non è disposto (o non è in grado) di
svolgere una determinata attività per conto proprio. Questo è un tipo di
contratto molto frequente. Tuttavia esso presenta problemi interessanti dal
momento che, solitamente, (i) gli obiettivi dell’agente sono differenti da
quelli del principale (ad esempio, quest'ultimo vuole che il prodotto sia
venduto un basso prezzo per incrementare le vendite, mentre il distributore che possiede potere di mercato in una certa area - vuole vendere meno, ma
ad un prezzo più elevato), e (ii) le informazioni a disposizione dell’agente
(ad esempio sulle condizioni di mercato) sono molto più estese dettagliate di
99
quelle disponibili al principale. Per evitare il primo problema, il principale
solitamente cerca di monitorare dettagliatamente l'attività della gente, ma
l'esistenza del secondo problema rende difficile condurre tale monitoraggio.
Questo è il motivo fondamentale che dà luogo ad una varietà di clausole
negli accordi verticali: clausole sui prezzi di vendita sulle quantità, sulle
vendite e sui servizi post vendita, forniture esclusive riguardanti alcuni
prodotti o alcune aree geografiche, e così via. Queste clausole solitamente
disciplinano gli interessi divergenti delle parti e non possiedono effetti
anticoncorrenziali.
Si consideri ad esempio l'attività di promozione di un prodotto nell'ambito
di un accordo di distribuzione. Il produttore sosterrà un determinato
investimento pubblicitario, ma chiederà ai distributori di promuovere il
prodotto nei mercati locali, ad esempio facendo pubblicità sulla stampa
locale, collocando il prodotto nel punto più visibile del negozio, oppure
offrendo servizi addizionali ai clienti. Queste attività sono naturalmente
costose per il distributore, il quale sarà tentato di non adempiere
completamente a queste obbligazioni contrattuali. Dal momento che è
costoso per il produttore verificare ogni violazione di tali clausole, esso
cercherà di introdurre incentivi razionali affinché il distributore si comporti
esattamente come il produttore vorrebbe.
L'ovvio incentivo è dato dal livello di profitto, e quindi il produttore offrirà
incentivi, come ad esempio sconti correlati al raggiungimento di determinati
volumi di vendita. Questi incentivi possono non essere sufficienti per
scoraggiare comportamenti opportunistici. Per esempio, comportandosi
come un tipico free-rider, il distributore potrebbe decidere di risparmiare
denaro sui costi di promozione locale - che avrebbe dovuto sostenere
secondo il contratto - contando sugli effetti delle campagne pubblicitarie che
il produttore sta svolgendo a livello nazionale, e sugli sforzi promozionali
degli altri distributori (ad esempio, pubblicità in aree geografiche contigue).
In tal caso, il distributore godrebbe di tali esternalità positive.
Altre incentivi possono dare un diritto esclusivo al distributore in termini di
area geografica o di consumatori da servire, oppure in termini di fissazione
di un volume minimo di vendita.
Questo tipo di clausole limita indubbiamente la concorrenza intrabrand,
cioè la concorrenza tra differenti distributori della stessa marca, ma
solitamente aumenta la concorrenza inter-brand, cioè la concorrenza tra
differenti marche: se un produttore è in grado di utilizzare favorevolmente
tali restrizioni per limitare il problema di free riding dei distributori, questi
ultimi promuoveranno con forza il loro prodotto e quindi aumenterà la
concorrenza tra marche. È quindi difficile desumere che queste clausole
verticali non riducono il benessere del consumatore: esse solitamente non
pongono pertanto particolari problemi antitrust.
100
Lo scenario è molto diverso se la restrizione verticale consiste nel fissare un
prezzo minimo di vendita; questa fattispecie è denominata anche come
resale price maintenance. Nonostante possano esservi ragionevoli motivi
per una tale clausola (ad esempio quella di evitare danni all'immagine del
prodotto se il prezzo è troppo basso), e nonostante sia ragionevole sostenere
che un prezzo minimo sia un altro strumento per scoraggiare un
comportamento da free rider dei distributori, sia in Europa che negli Stati
Uniti questo genere di clausola viene generalmente vietata, dal momento
che essa può limitare la concorrenza interbrand e quindi danneggiare i
consumatori. Inoltre, se il produttore fissa un prezzo minimo, può rendere
più probabile un'intesa tra distributori: questi ultimi, territorialmente dispersi
e in numero elevato, avrebbero notevoli difficoltà a organizzare un'intesa
orizzontale, che invece potrebbe essere indirettamente promossa attraverso
l'imposizione di un prezzo minimo da parte del produttore.
D'altra parte, è permessa la fissazione dei prezzi massimi o prezzi di
riferimento, a patto che questa pratica non limiti la possibilità dei
distributori di effettuare sconti.
101
9. LA POSIZIONE DOMINANTE E I COMPORTAMENTI
ABUSIVI
L’Articolo 102 TFUE, a livello comunitario, e l’Articolo 3 della Legge
287/90, a livello nazionale, vietano l’abuso di una posizione dominante da
parte di una o più imprese.
Art. 102 TFUE (già art. 82 Trattato CE)
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su
una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od
altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti
stessi.
Un’impresa detiene una posizione dominante, come vedremo, se il suo
potere economico le permette di operare sul mercato in maniera del tutto
autonoma e indipendente, vale a dire senza tenere conto della reazione dei
concorrenti o dei consumatori intermedi o finali.
Il divieto di abuso di posizione dominante ha la finalità sostanziale di
evitare che un’impresa rafforzi il significativo potere di mercato di cui già
disponga con azioni abusive nei confronti dei concorrenti. Vietando ad essa
azioni che invece non sono vietate ai concorrenti, la norma rafforza poi la
posizione di questi nei confronti dell’impresa dominante.
Detenere una posizione dominante non è di per sé illecito, se frutto
dell’efficienza o della capacità innovativa dell’impresa stessa. Le imprese
efficienti sono infatti gestite proprio con l’obiettivo di conquistare i mercati
e riescono talvolta a raggiungere anche significative posizioni di mercato.
102
L’art. 102 TFUE colpisce dunque solo il comportamento dell’impresa
dominante che utilizzi indebitamente il proprio potere di mercato al fine di
ostacolare la concorrenza ovvero danneggiare i consumatori.
Nel seguito, illustreremo dapprima le caratteristiche principali delle nozioni
di posizione dominante e abuso; procederemo poi ad una disamina sintetica
delle principali fattispecie di abuso.
9.1 La nozione di posizione dominante
La posizione dominante è definita tradizionalmente nell'Unione Europea
come “una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che
la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza
effettiva sul mercato in questione, e alla possibilità di tenere comportamenti
alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima
analisi, dei consumatori” 95.
Questa definizione solleva alcune perplessità, se interpretata in senso
letterale, dal momento che nessuna impresa può comportarsi in modo
veramente indipendente dai propri clienti: anche un monopolista vedrà
ridursi le proprie vendite se alza i suoi prezzi. Oltretutto, solo un
monopolista può comportarsi indipendentemente dai suoi concorrenti (dato
che non ne ha), mentre gli oligopolisti ovviamente interagiscono tra loro.
Inoltre, l'altro elemento enunciato dalla Corte - la “capacità di ostacolare la
persistenza di una concorrenza effettiva” - è di dubbia utilità pratica, non
essendo chiaro come tale capacità possa essere verificata.
Tuttavia, come abbiamo visto nel Capitolo 7, il potere di mercato può essere
valutato sulla base della quota di mercato dell'impresa, quelle dei suoi
concorrenti, l'analisi delle barriere all'entrata e del potere di contrasto dei
clienti, nonché di altri fattori. Se interpretiamo in senso più ampio la
definizione della Corte, essa risulta dunque ragionevole. Letteralmente, essa
può essere applicata solo ad un monopolista, ma in pratica la definizione
cattura le caratteristiche di qualsiasi impresa dominante.
La Commissione e le corti comunitarie hanno progressivamente individuato
una serie di indizi dell’esistenza di una posizione dominante: come abbiamo
visto nel Capitolo 7, la detenzione di una quota di mercato elevata per un
periodo sufficientemente prolungato è considerata in genere un indice
importante dell’esistenza di una posizione dominante 96.
95
Sentenza della CGUE del 14 febbraio 1978, causa 27 / 76, United Brands, in Racc.
(1978), p. 207, par. 65.
96
Sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro, in Racc.
[1985] p. 3021, § 85.
103
Come discusso, rilevano poi in generale la struttura complessiva del
mercato, l’esistenza di barriere all’entrata ed il potere di contrasto degli
acquirenti. In casi particolari, altri fattori possono conferire una posizione
dominante, come una elevata integrazione verticale (che può, ad esempio,
sussistere quando un importante produttore di un bene disponga anche di
una capillare rete commerciale); una particolare reputazione e immagine che
un’impresa sia riuscita a conquistare per i propri prodotti (ad esempio,
attraverso costose e sistematiche campagne promozionali e pubblicitarie); la
titolarità di diritti di proprietà intellettuale, quali marchi e brevetti.
La posizione dominante può essere detenuta da una sola impresa
(dominanza unilaterale), ma anche congiuntamente da due o più imprese
(dominanza collettiva o congiunta). Quest’ultima situazione si verifica
quando più imprese, pur essendo legalmente ed economicamente
indipendenti, si presentino o agiscano su un dato mercato rilevante come
una sola entità. A questo proposito, l’esistenza di legami strutturali tra le
imprese interessate non è indispensabile per l’esistenza di una posizione
dominante collettiva. Infatti, le imprese indipendenti possono trovarsi ad
agire come un’unica entità collettiva anche in virtù di legami economici.
9.2 La nozione di abuso di posizione dominante
Assumiamo che un'impresa sia stata identificata come dominante: quando il
suo comportamento risulta abusivo in base all'articolo 102 TFUE? Il testo
dell'articolo che abbiamo sopra richiamato non è molto utile, dal momento
che contiene una lista (puramente) indicativa.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha in parte chiarito la questione,
stabilendo che l'impresa in posizione dominante possiede una ‘speciale
responsabilità’, ma tale responsabilità non può essere definita in senso
generale. Dal punto di vista economico, sono stati proposti vari criteri, che
non è il caso di discutere in questa sede.
Ai fini di una discussione introduttiva possiamo comunque ricordare un
criterio di massima: un comportamento, che sarebbe irrazionale se non
avesse come unico o principale obiettivo quello di eliminare uno o più
concorrenti, viene considerato generalmente abusivo.
Naturalmente, il problema è come determinare se un determinato
comportamento possiede questa caratteristica, senza aspettare che il
concorrente fallisca. Nella prassi antitrust, si adotta in alcuni casi una regola
per se, secondo la quale un determinato comportamento da parte di
un'impresa dominante è sempre proibito (come ad esempio l'adozione di
clausole inglesi o la concessione di sconti retroattivi: si veda più sotto), e in
altri casi una rule of reason, cercando di accertare gli effetti concreti di un
comportamento che potrebbe, o non potrebbe, essere abusivo.
104
È utile distinguere tra due tipi di condotte abusive: azioni che hanno un
effetto diretto sui consumatori (abusi per sfruttamento), e quelli che hanno
un effetto indiretto sui consumatori, dal momento che escludono concorrenti
dal mercato (abusi escludenti).
Questi ultimi possono essere inoltre distinti in due gruppi: abusi escludenti
derivanti da politiche non di prezzo, e abusi escludenti derivanti da politiche
di prezzo.
9.3 Comportamenti abusivi per sfruttamento
Considerando che un'impresa dominante (ricordiamo il caso del monopolio)
aumenterà sempre i suoi prezzi al di sopra di quelli che si osserverebbero in
un mercato competitivo, si potrebbe concludere che i casi di prezzi eccessivi
dovrebbero essere relativamente frequenti. Ciò non è tuttavia vero, per due
ragioni. In primo luogo, non è facile trovare un test adatto per applicare in
pratica la formulazione generale dell'articolo 102 TFUE che proibisce prezzi
“non equi”. D'altra parte, i prezzi possono essere molto più elevati dei costi
per molte ragioni, che non integrano necessariamente un comportamento
abusivo.
In teoria, l’equità dei prezzi potrebbe essere accertata confrontando i prezzi
con il livello dei costi (includendo un ragionevole margine di profitto), ma
le stime dei costi possono risultare estremamente complesse. La teoria della
contabilità non offre un'unica modalità corretta per calcolare i costi: ci sono
molti metodi, la cui applicazione può portare a risultati differenti,
specialmente nei casi in cui un'impresa multiprodotto utilizza input comuni
(come impianti, o spese di ricerca e sviluppo) per produrre prodotti diversi.
Infine, è piuttosto difficile anche definire quale sia un ragionevole margine
di profitto: solitamente, i margini variano ampiamente tra settori economici,
e nel tempo. Come capire se sono “ragionevoli”?
In alternativa, almeno da un punto di vista teorico, potremmo verificare
l'esistenza di prezzi non equi analizzando la redditività dell'impresa
dominante, e ipotizzando l'esistenza di prezzi eccessivi se tale redditività
risulta costantemente più elevata della redditività media del mercato. Ma
anche questa soluzione non è applicabile in modo semplice: in primo luogo,
le imprese dominanti sono spesso multiprodotto e in questi casi non è facile
stabilire una connessione tra la loro redditività e il prezzo di uno specifico
prodotto; in secondo luogo, elevati tassi di rendimento possono riflettere
l'esistenza di un “premio di rischio” che l'impresa ottiene legittimamente sul
mercato come ricompensa per gli investimenti rischiosi che ha effettuato.
Inoltre, se l'impresa ha investito per sviluppare invenzioni brevettabili o
marchi apprezzati, la sua redditività sarà elevata, ma solo perché essa
include legittimamente la remunerazione di questi beni immateriali.
105
Dal punto di vista empirico, si potrebbe pensare di stimare se i prezzi sono
‘equi’ riferendoci ad alcuni ‘prezzi di mercato’, cioè effettuando un
confronto tra i prezzi dello stesso bene in mercati diversi. Questo è stato
l'approccio utilizzato dalla Commissione nel caso United Brands.
Il caso United Brands
United Brands Company (UBC) era attiva nella produzione, trasporto e
distribuzione di banane (con il marchio “Chiquita”) all’interno della Comunità
Europea. La Commissione contestava a UBC, ritenuta dominante sul mercato
delle banane, una serie di violazioni dell’art. 82 CE, tra cui il fatto che i prezzi
praticati da UBC in Germania, Danimarca, e Benelux erano eccessivi.
Per dimostrare questo punto, la Commissione notava come i prezzi praticati da
UBC in Irlanda erano i più bassi in assoluto, e comunque remunerativi. Essi
erano di oltre il 50% inferiori a quelli praticati ai distributori negli altri Paesi.
Pertanto, la differenza tra i prezzi praticati ai distributori irlandesi e quelli
praticati ai distributori in altri Stati membri poteva fornire una misura dei profitti
realizzati da UBC, che, nell’opinione della Commissione, erano elevatissimi ed
esagerati. La Commissione condannava dunque la condotta delle UBC e le
ingiungeva di ridurre del 15% i prezzi praticati in Stati membri diversi
dall’Irlanda.
A seguito di ricorso presentato da UBC, la Corte di Giustizia annullava però
questa violazione, in quanto la Commissione non aveva dimostrato che il prezzo
delle banane fosse effettivamente “eccessivo”, e cioè
“privo di ogni
ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita”. Per
questo, la Corte riteneva invece necessario procedere ad un’analisi, sia pure
complessa, dei costi di produzione (non svolta dalla Commissione: la quale
avrebbe dovuto in particolare valutare analiticamente “se vi [fosse] un’eccessiva
sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente
richiesto e, in caso affermativo, accertare se [fosse] stato imposto un prezzo non
equo, sia in assoluto sia rispetto ai concorrenti”. La Commissione, invece, non
solo non aveva effettuato alcuna analisi della struttura dei costi di produzione di
UBC, ma si era altresì astenuta dal richiedere a UBC i dati relativi alla
composizione dei suoi costi.
La Corte concludeva perciò che la Commissione non aveva sufficientemente
provato l’esistenza di prezzi eccessivi praticati da UBC.
Decisione della Commissione del 17 dicembre 1975, Chiquita, in GUCE [1976]
L 95/1; sentenza della Corte di Giustizia del 14 febbraio 1978, causa 27/76,
United Brands, in Racc. [1978] p. 207.
106
Non è quindi affatto sorprendente che la Commissione stessa abbia concluso
come “nei procedimenti contro le pratiche abusive consistenti nel praticare
prezzi eccessivamente elevati, è difficile decidere se in ciascun caso
specifico sia stato effettivamente fissato un prezzo abusivo, poiché non
esiste un modo obiettivo per stabilire esattamente quale prezzo copra i costi
oltre ad un ragionevole margine di profitto” 97.
9.4 Comportamenti abusivi escludenti basati su politiche non di
prezzo
Un'impresa dominante può cercare di prevenire l'entrata di nuovi
concorrenti o forzare l'uscita di concorrenti esistenti (entrambe le strategie
sono chiamate foreclosure), attraverso due categorie principali di
comportamenti: il rifiuto di contrarre (refusal to deal), particolarmente nei
casi in cui l'input è essenziale (come vedremo nel seguito), e/o adottando
varie forme di vendite abbinate (tying), che impongono agli acquirenti del
bene A di acquistare anche il bene B.
Tuttavia, un rifiuto di contrarre può essere giustificato dalla necessità di
recuperare gli investimenti sostenuti in passato, e il tying può essere visto
favorevolmente dai consumatori, ed è pertanto difficile sostenere che
danneggi il benessere. Quindi, per valutare il comportamento dell'impresa
dominante è spesso necessaria un'analisi degli effetti economici di tali
comportamenti.
9.4.1
Rifiuto di contrarre
Un irragionevole rifiuto di contrarre da parte di un'impresa dominante può
costituire un abuso se esclude un concorrente dal mercato, o ne impedisce
l'entrata 98.
Il rifiuto deve tuttavia essere irragionevole, nel senso che è invece
perfettamente lecito rifiutare una fornitura ad un concorrente che abbia
fatture insolute, o perché anche l'impresa dominante smette
contemporaneamente di produrre il bene richiesto. Quindi, in prima istanza
sarà più facile provare l'irragionevolezza di un rifiuto di contrarre un bene
che era già fornito al concorrente nel passato.
Il rifiuto deve inoltre essere escludente, cioè il concorrente deve trovare
impossibile, estremamente difficile, e/o estremamente costoso acquistare
altrove il prodotto.
97
Commissione Europea, Quinta relazione sulla politica di concorrenza, par. 2.
Sono considerati rifiuti di contrarre non soltanto dei rifiuti tout court, ma anche le
forniture a condizioni di fatto inaccettabili per l'acquirente (constructive refusals).
98
107
Vi è un caso relativamente frequente di rifiuto di contrarre, che è relativo ad
infrastrutture essenziali. Di questo ci occupiamo qui dunque
prevalentemente.
9.4.2
Rifiuto di fornire un’infrastruttura essenziale (essential
facility)
Il bene venduto dall'impresa dominante è solitamente utile per un
concorrente. Ma come possiamo stabilire quando esso è veramente
essenziale?
Questo problema è particolarmente rilevante nel caso delle reti, dal
momento che il rifiuto di accesso ad una rete può davvero escludere i
concorrenti. D’altra parte, però, l'apertura delle reti alla concorrenza è stata a partire dagli anni Ottanta - un obiettivo di policy così importante in
Europa, che la Commissione e le Corti hanno gradatamente sviluppato una
dottrina (imperfetta) sulle infrastrutture essenziali (essential facility
doctrine) 99, secondo la quale un'impresa che possiede un'infrastruttura - il
cui uso è essenziale per la concorrenza nei mercati a valle, come ad esempio
i porti, aeroporti o le reti di comunicazioni elettroniche - non può rifiutare
l'accesso ad essa ai propri concorrenti, a condizioni eque e non
discriminatorie, a meno che non vi sia una giustificazione obiettiva.
La ‘dottrina’ cerca di trovare un equilibrio - nell'ambito delle considerazioni
di public policy - tra gli opposti interessi del proprietario della rete e quelli
dell'impresa che richiede l'accesso. Le infrastrutture sono sviluppate dalle
imprese, sostenendo investimenti rischiosi. Rendere obbligatorio l'accesso ai
concorrenti rappresenta un’ovvia interferenza con i diritti di proprietà
dell'infrastruttura e può scoraggiare la costruzione di nuove infrastrutture, o
il miglioramento e la manutenzione dell'infrastruttura esistente, dato che il
proprietario dell'infrastruttura non potrà pienamente godere dei vantaggi
degli investimenti effettuati, dal momento che sarà obbligato a condividere
questi benefici con i concorrenti che non hanno sostenuto gli stessi rischi e
gli stessi oneri finanziari. Inoltre, se un diritto di accesso può essere
facilmente ottenuto da un concorrente, nessun concorrente svilupperà
infrastrutture proprie, dal momento che potrà accedere all'infrastruttura di
qualcun altro senza sostenere i relativi rischi e costi di sviluppo.
99
La dottrina sulle infrastrutture essenziali è stata applicata per la prima volta in Europa
all'inizio degli anni Novanta con riferimento ad un'infrastruttura portuale nel caso Sea
Containers/Stena Sealink. Diversamente dalla Commissione e dalle Autorità nazionali di
concorrenza, comunque, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non si è mai
esplicitamente riferita alla essential facility doctrine, anche se alcune sue sentenze
sembrano applicarla implicitamente.
108
Così, l’introduzione di un obbligo indiscriminato di accesso aumenterebbe
la concorrenza nel mercato a valle nel breve periodo, ma la ridurrebbe nel
lungo periodo: solo un'analisi specifica delle condizioni necessarie per
applicare la dottrina delle essential facilities può bilanciare questi interessi
divergenti.
Per applicare la dottrina, è necessario in primo luogo accertare che
l'infrastruttura costituisca un mercato rilevante in senso antitrust. È
ragionevole, ad esempio, dire che esiste un mercato per la fornitura di
servizi di trasporto dell'energia elettrica, separato dalla fornitura di energia
elettrica ai clienti (se avete dubbi, ricorrete ad uno SSNIP test). Così, il
trasporto di energia elettrica costituisce un mercato rilevante, e l'impresa che
possiede l'infrastruttura di trasporto è dominante e non può rifiutare
l'accesso. La vendita di libri su Internet, d'altra parte, probabilmente non
costituisce un mercato rilevante (ancora, si usi lo SSNIP test), ma solamente
una parte del mercato rilevante complessivo dei libri. Se è così, allora
Amazon non è un'impresa dominante, e può rifiutarsi di vendere i libri di un
dato editore.
Successivamente, è necessario verificare che l'infrastruttura sia veramente
essenziale per operare nel mercato a valle (trasporto di elettricità e fornitura
di elettricità).
Per distinguere i casi in cui l'uso dell'infrastruttura sarebbe conveniente per
il concorrente (questo accade naturalmente molto spesso) dai casi in cui essa
sarebbe veramente essenziale, non sarebbe corretto vedere il problema dal
punto di vista del concorrente: tutti i nuovi entranti sono piccoli, mentre i
proprietari di infrastrutture sono in genere imprese molto grandi. E’ quindi
facile per un concorrente mostrare che i propri costi sarebbero enormemente
più elevati di quelli del proprietario dell'infrastruttura se dovesse costruire
l'infrastruttura stessa. Se dunque si ponesse dal punto di vista del
concorrente, l’antitrust porterebbe ad imporre frequenti obblighi di fornitura
per i proprietari di infrastrutture, e ciò naturalmente porterebbe ad una
diminuzione della propensione a investire in infrastrutture, dal momento che
esse diventerebbero così meno redditizie.
Per trovare un qualche equilibrio di questi interessi economici divergenti, le
corti solitamente valutano l'essenzialità riferendosi a una concorrente
ipotetico che abbia la dimensione e le caratteristiche del proprietario
dell'infrastruttura. In altri termini, occorre dimostrare che la duplicazione
dell’infrastruttura non sarebbe economicamente sostenibile neanche per un
concorrente di dimensioni analoghe a quelle del titolare dell’infrastruttura
esistente. Pertanto, per qualificare come essenziale un’infrastruttura non è
sufficiente che l’accesso alla medesima renda più vantaggiosa la posizione
dei concorrenti del titolare dell’infrastruttura: occorre, invece, che esso
109
costituisca l’unica possibilità per entrare e rimanere attivi sul mercato a
valle. In questo modo, la valutazione dell'essenzialità diventa oggettiva.
Questi principi sono stati chiariti dalla Corte di Giustizia nel caso Oskar
Bronner.
La dottrina delle essential facilities: il caso Bronner
La Oskar Bronner, editrice austriaca, aveva chiesto al concorrente Mediaprint di
concederle l’accesso, dietro corrispettivo, al proprio sistema di distribuzione porta
a porta di quotidiani. Per Bronner, il sistema di distribuzione giornaliero creato da
Mediaprint era l’unico avente copertura nazionale e in grado di assicurare una
consegna dei quotidiani nelle prime ore del mattino: la consegna a mezzo posta
non avrebbe rappresentato un’adeguata alternativa, e, stante l’esiguo numero di
abbonati al suo quotidiano, non le sarebbe stato economicamente possibile creare
un suo efficiente sistema alternativo di distribuzione. Mediaprint, operatore
dominante, aveva rifiutato l’accesso e Bronner si era rivolto in Tribunale,
affermando che avrebbe dovuto essere applicata la dottrina delle essential
facilities.
Il tribunale austriaco investito della questione si era rivolto alla Corte di Giustizia
affinché questa si pronunciasse in via pregiudiziale sul fatto se ciò costituisse
abuso di posizione dominante.
La Corte escludeva che Mediaprint fosse tenuta a garantire a Bronner l’accesso
alla propria rete di distribuzione. Il sistema di distribuzione della Mediaprint non
rivestiva infatti carattere “essenziale”, posto che Bronner aveva a disposizione
numerosi sistemi alternativi di distribuzione, pur se non efficienti quanto quello
creato da Mediaprint. Inoltre, le quote di mercato di Bronner erano incrementate
notevolmente nell’ultimo anno, sia in termini di abbonati che di raccolta di
pubblicità, circostanza, questa, che comprovava il carattere non “essenziale” della
rete distributiva del concorrente Mediaprint. Quanto, poi, alla possibilità per
Bronner di duplicare il sistema distributivo della Mediaprint, l’affermazione
secondo cui gli investimenti necessari sarebbero stati eccessivi per Bronner era
vera solo se apprezzata nel breve periodo: la scelta di creare un sistema
distributivo concorrente a quello di Mediaprint avrebbe dovuto invece essere
valutata da Bronner in una prospettiva di lungo termine e in un’ottica di
espansione delle proprie attività al fine di arrivare a competere su un piano di
uguaglianza con Mediaprint.
Pertanto, avrebbe potuto esservi abuso solo qualora “il diniego del servizio
costituito dal recapito a domicilio [potesse] eliminare del tutto la concorrenza sul
mercato dei quotidiani da parte della persona che richiede il servizio”, e “non
[fosse] obiettivamente giustificabile”, e qualora detto servizio fosse “di per sé
indispensabile per l’esercizio dell’attività […], nel senso che non esiste alcun
modo di distribuzione che possa realmente o potenzialmente sostituirsi al predetto
sistema di recapito a domicilio”.
A giudizio della Corte di Giustizia, tali presupposti non ricorrevano nel caso in
esame.
Sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 1998, causa C-7/97, Oskar
Bronner c. Mediaprint, in Racc. [1998] pag. 7791.
110
9.4.3
Proprietà intellettuale come infrastruttura essenziale
I diritti di proprietà intellettuale conferiscono un monopolio legale. Possono
quindi essere considerati come una sorta di infrastruttura essenziale e quindi
dare luogo ad un obbligo di fornitura?
In effetti, l'essenza stessa di un diritto di proprietà intellettuale consiste nel
diritto di escludere chiunque altro dall'utilizzo e sfruttamento dell'oggetto
del diritto di proprietà intellettuale. Partendo da questa premessa, la
posizione originaria della giurisprudenza comunitaria è stata quella di
escludere la possibilità di applicare i principi che governano il rifiuto di
contrarre ai diritti di proprietà intellettuale, anche se essa ammetteva che
alcune modalità di esercizio dei diritti di libertà intellettuale possono
costituire un comportamento abusivo: ad esempio, il rifiuto di fornire pezzi
di ricambio brevettati, costruiti da un produttore di macchine a officine di
riparazione indipendenti 100.
Gli sviluppi successivi negli orientamenti giurisprudenziali hanno
sostanzialmente esteso l'applicabilità della dottrina dell'infrastruttura
essenziale, stabilendo il principio che un rifiuto di accesso a un diritto di
proprietà intellettuale essenziale è considerato abusivo solamente se
ricorrono tre condizioni cumulative. Il rifiuto sul mercato A (quello in cui il
proprietario del diritto di proprietà intellettuale gode di monopolio): (i)
impedisce la creazione nel mercato B di un nuovo prodotto per il quale vi
sia una domanda effettiva o potenziale, (ii) non sia giustificato da
considerazioni oggettive e (iii) comporti la completa eliminazione della
concorrenza nel mercato del prodotto B 101.
Una pronuncia fondamentale in questo senso è rappresentata dalla sentenza
della CGCE nel caso Magill, 102 che ha ritenuto illegittimo il rifiuto di
comunicazione dei propri palinsesti da parte di tre emittenti televisive a una
società, la Magill, che intendeva realizzare una guida televisiva settimanale.
A giudizio della CGCE, nel caso di specie ricorrevano le circostanze
precedentemente menzionate, dal momento che il rifiuto di cedere tali
informazioni a Magill (1) non era supportato da alcuna giustificazione
oggettiva, (2) permetteva alle tre emittenti televisive di riservarsi il mercato
derivato delle guide televisive settimanali non generali, escludendo ogni
concorrenza alle proprie guide settimanali, e (3) ostacolava altresì
l’emergere di un prodotto nuovo (una guida settimanale “generale” dei
100
Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 ottobre 1988,
Volvo/Veng, causa 238/87, in Racc. [1988], p. 6211, par. 8.
101
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 aprile 1995 nei casi riuniti
C-/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, in Racc. (1995), p. 743. Si veda anche
IMS Health v. NDC Health, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, in Racc. (2004), pp.I5039.
102
Sentenza della CGCE del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e
ITP c. Commissione, in Racc. [1995], p. 743.
111
programmi televisivi) che le emittenti non offrivano e per il quale esisteva
una domanda potenziale da parte dei consumatori.
Questa impostazione è stata confermata, sia pure con alcune precisazioni,
nel successivo caso IMS Health.
Proprietà intellettuale e diritto antitrust: il caso IMS Health
La società IMS Health forniva alle imprese farmaceutiche in Germania dati sulle
vendite regionali di prodotti farmaceutici, disaggregati sulla base di una struttura
comportante 1860 aree del territorio tedesco. La struttura ad aree di IMS è
divenuta nel tempo uno standard corrente, al quale i clienti hanno adeguato i
propri sistemi informatici e di distribuzione. Una società, NDC Health, la cui
attività consisteva anch’essa nel vendere dati sulle vendite regionali di prodotti
farmaceutici in Germania, cercava in un primo tempo di classificare i dati in base
a una propria struttura, articolata su 2201 aree. Tuttavia, data la riluttanza
manifestata da potenziali clienti verso questa classificazione, essa iniziava a
lavorare con una classificazione molto vicina a quelle utilizzate da IMS.
Quest’ultima citava quindi in giudizio NDC, chiedendo che le fosse vietato l’uso
della struttura a 1860 aree (e di strutture da questa derivate). Secondo il giudice,
la struttura a 1860 aree di IMS era una banca dati, tutelabile ai sensi della legge
tedesca sul diritto d’autore, ma non avrebbe potuto rifiutare la concessione di una
licenza per l’uso della struttura a NDC se il suo comportamento fosse stato
qualificabile come abuso di posizione dominante. Il giudice investiva quindi la
Corte di Giustizia di tre questioni pregiudiziali, con le quali sostanzialmente
chiedeva se e a quali condizioni si poteva qualificare come sfruttamento abusivo
in violazione dell’art. 82 CE il rifiuto da parte di un’impresa dominante, titolare
di un diritto di proprietà intellettuale, di concedere a terzi accesso a un prodotto o
servizio protetto dal diritto di proprietà intellettuale.
La Corte ha ribadito che un siffatto rifiuto può essere qualificato come abusivo
soltanto se sono integrate le seguenti condizioni cumulative: 1) il prodotto o
servizio, protetto dal diritto di proprietà intellettuale, sono indispensabili per
esercitare una data attività; 2) il rifiuto di accesso costituisce ostacolo alla
comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei
consumatori; 3) il rifiuto è idoneo a escludere qualsiasi concorrenza su un
mercato derivato, presupponendo che si possano identificare “due diversi stadi di
produzione tra loro collegati in quanto il prodotto a monte è un elemento
indispensabile per la fornitura del prodotto a valle”; 4) il rifiuto non è sorretto da
obiettiva giustificazione.
Sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, IMS Health c. NDC Health,
causa C-418/01, in Racc. [2004] p. 5039
112
9.4.4
Vendite abbinate: tying e bundling
Spesso i beni vengono venduti insieme: scarpe e lacci, una nuova auto e i
suoi pneumatici, e così via. Quando un'impresa dominante nel mercato per il
bene A vende in modo abbinato altri prodotti,c'è comunque il rischio che
stia cercando di ‘trasferire’ al mercato di B la sua posizione dominante nel
mercato di A.
Per vedere se questo sia il caso, dobbiamo distinguere tre casi:
•
(i) tying in senso stretto, cioè la vendita del prodotto B (il prodotto
abbinato) solo ai clienti che acquistano anche il prodotto A (il
prodotto principale), che può tuttavia essere acquistato
indipendentemente da B (ad esempio, scarpe e lacci);
•
(ii) bundling, e cioè la vendita di A e B in modo sempre abbinato tra
loro (tali prodotti non possono essere acquistati separatamente, come
la scarpa destra e la scarpa sinistra), e
•
(iii) mixed bundling, in cui l'acquirente può acquistare solo il
prodotto A, solo il prodotto B, oppure A e B insieme, ma in
quest'ultimo caso il prezzo di A+B è inferiore alla somma dei prezzi
dei prodotti acquistati singolarmente (ad esempio, panino e CocaCola, in molti bar).
Tutte queste strategie possono avere valide giustificazioni. Anzi, il tying può
essere efficiente: se i lacci non fossero venduti insieme alle scarpe, o
glipneumatici insieme alle auto nuove (due classici esempi di tying), o le
scarpe destre insieme alle scarpe sinistre (un ovvio caso di bundling), gli
acquirenti dovrebbero comperare i due prodotti separatamente, sostenendo
significativi costi di transazione.
In altri casi, l'obiettivo del tying può essere quello di aumentare il valore del
bene per l'acquirente: una stampante fotografica è solitamente venduta
insieme alle cartucce d'inchiostro e alla carta fotografica che permettono di
utilizzarle immediatamente (questo è naturalmente ancora un caso di tying);
un computer molto sofisticato è venduto solamente con un sistema operativo
(questo è un caso di bundling), che permette di ottimizzare il suo
funzionamento. Il tying, specialmente nella forma di mixed bundling, può
aumentare le vendite con un effetto positivo sul benessere del consumatore.
In alcuni casi, il bundling può avere un obiettivo anticoncorrenziale. Il
numero di questi casi, tuttavia, è più limitato di quello che ci si possa
aspettare, perché il profitto derivante dalla vendita del bundle può essere più
113
elevato del profitto sulla vendita di uno solo dei due beni, solo se l'impresa è
dominante in entrambi i mercati 103.
Questo risultato, tuttavia, è vero solo in un contesto statico, come è evidente
se si considerano le strategie di bundling operate da Microsoft. Una delle
caratteristiche storiche della strategia di business di questa impresa è stata
quella di fornire i programmi applicativi abbinati al sistema operativo
Windows. La costanza di questa scelta strategica suggerisce che essa non
dipende tanto da considerazioni sui livelli di profitto di breve periodo ma su
considerazioni dinamiche, derivanti da una strategia di estensione della
dominanza Microsoft anche ai nuovi mercati, creati dalle innovazioni
introdotte dai suoi concorrenti. Questa, almeno, è stata la conclusione della
Commissione Europea nel caso Microsoft, che ha condannato quest’ultima
per abuso di posizione dominante.
Un esempio di pratiche leganti (tie-in): il caso Microsoft
Dopo un’indagine durata più di cinque anni, nel 2004 la Commissione
concludeva che Microsoft aveva abusato della propria posizione di quasi
monopolio sul mercato dei sistemi operativi per personal computer (PC) (i
sistemi operativi sono software di sistema, che controllano le funzioni di base
del PC, permettendo all’utente di utilizzarlo e di fruire delle applicazioni
software). Di conseguenza, la Commissione comminava a Microsoft l’ammenda
più alta mai comminata a una singola società per infrazioni antitrust (497
milioni di euro). Inoltre, la Commissione imponeva a Microsoft una serie di
misure correttive, volte a ristabilire eque condizioni di concorrenza all’interno
dei mercati interessati dai comportamenti abusivi.
103
Questa conclusione, a prima vista sorprendente, è uno dei risultati più interessanti della
scuola di Chicago e può essere spiegata intuitivamente come segue. Supponiamo che
un'impresa sia monopolista sul mercato del prodotto B, che vende a € 100, prezzo che
massimizza il suo profitto; l'impresa ora entra sul mercato del prodotto A, e decide di
vendere A e B solo in un bundle. Il mercato del prodotto A è perfettamente concorrenziale e
il suo prezzo è un euro. Se il bundle è venduto a € 110, dal momento che ci sono molti
produttori che continueranno a vendere il prodotto ha al suo prezzo concorrenziale di un
euro, i consumatori che acquisteranno il bando alla € 110 saranno solo coloro i quali
avrebbero acquistato B. anche al prezzo più elevato di € 110 - € 1 = € 109. Ma questo
prezzo non massimizza i profitti del monopolista, i quali, come abbiamo visto, sono
massimi al prezzo di € 100. Ripetendo questo ragionamento per tutti i prezzi possibili,
possiamo concludere che il solo prezzo del bundle che massimizza i profitti e € 101 e
pertanto non vi è un extra profitto nella vendita abbinata: nelle parole di Bork, “there is
only one monopoly profit to be made”. Pertanto, il profitto sulla vendita dei due singoli
prodotti sarà più elevato solo se impresa possiede il potere di mercato su entrambi prodotti,
in modo che non vi siano concorrenti che vendono a prezzi inferiori in nessuno dei due
mercati. Non vi è pertanto il rischio di trasferire la dominanza dell'impresa dal mercato B al
mercato A.
114
Secondo la Commissione, Microsoft aveva: (i) rifiutato di fornire alcune informazioni
sulle interfacce di Windows, necessarie per permettere ai sistemi operativi di server per
gruppi di lavoro, prodotti dai concorrenti di Microsoft, di dialogare efficacemente con
Windows; e (ii) incorporato il proprio programma media player (software in grado di
riprodurre sul PC contenuti audio e video in forma digitale), denominato Windows
Media Player (WMP), all’interno del sistema Windows con una tipica politica di tying.
Con specifico riferimento a quest’ultima, la Commissione partiva dal presupposto per
cui una politica di tying è abusiva quando ricorrano quattro condizioni cumulative: (i)
l’impresa deve detenere una posizione dominante all’interno del mercato del prodotto
“legante”; (ii) il prodotto “legante” e quello “legato” devono essere due prodotti distinti;
(iii) l’impresa non deve lasciare alcuna scelta ai propri clienti, se non quella di acquistare
i due prodotti congiuntamente; e (iv) la condotta di tying deve avere l’effetto di ridurre la
concorrenza all’interno del mercato del prodotto “legato”.
Secondo la Commissione, Microsoft era assolutamente dominante nel mercato dei
sistemi operativi per PC, del quale deteneva una quota, stabile nel tempo, del 90-95%. In
secondo luogo, a giudizio della Commissione, i sistemi operativi per PC erano da
considerarsi un mercato rilevante distinto da quello dei media player. In terzo luogo,
secondo la Commissione, i clienti finali non avevano la possibilità di ottenere una
versione di Windows che non includesse anche WMP. Quest’ultimo, infatti, era preinstallato su tutte le versioni di Windows e non poteva essere agevolmente rimosso.
Infine, la Commissione rilevava che il tying di Windows e WMP aveva garantito a
quest’ultimo una presenza “ubiqua” su tutti i PC a livello mondiale, non replicabile da
parte dei media player concorrenti. Proprio questa ubiquità induceva i fornitori di
contenuti e gli ideatori di software a supportare WMP a discapito degli altri media
player, in quanto il primo garantiva un mercato potenziale di gran lunga più ampio.
Conseguentemente, i consumatori sarebbero stati a loro volta incentivati a servirsi
esclusivamente di quest’ultimo. A riprova, la Commissione ha constatato che il trend del
mercato negli ultimi anni era nettamente a favore di WMP: ciò avveniva, tuttavia, non a
causa delle migliori performance di WMP rispetto agli altri media player, bensì proprio
dalla strategia di Microsoft volta a distorcere la struttura del mercato attraverso il tying.
La Commissione ha inoltre escluso che sussistessero giustificazioni oggettive per la
condotta di Microsoft, quali il raggiungimento di determinate efficienze nella
distribuzione dei media player, o particolari esigenze di funzionalità del sistema
Windows.
Per rimediare agli effetti restrittivi generati dal tying, la decisione imponeva a Microsoft
di offrire ai produttori di PC, entro 90 giorni dalla notifica della decisione, una versione
del sistema operativo Windows senza WMP. Microsoft, dal canto suo, conservava il
diritto di offrire sul mercato anche una versione del sistema operativo Windows con
WMP, ma avrebbe dovuto astenersi dal praticare qualsiasi condizione commerciale,
tecnologica, o contrattuale che avesse l’effetto di rendere la versione di Windows non
abbinata a WMP meno interessante o meno funzionale.
Decisione della Commissione del 24 marzo 2004, Microsoft.
115
9.5 Comportamenti abusivi escludenti basati su politiche di
prezzo
9.5.1
Prezzi predatori
Il comportamento predatorio è una strategia in due fasi posta in opera da
un'impresa in posizione dominante. Nella prima fase, essa abbassa i prezzi
fino a costringere i propri concorrenti a uscire dal mercato. Nella seconda,
essa innalza i prezzi al livello di monopolio, recuperando l'eventuale perdita
sofferta nella prima fase e godendo - da quel momento in poi - di profitti di
monopolio.
Naturalmente, non è così facile intraprendere una simile strategia. Nella
prima fase, per convincere i propri rivali ad abbandonare il mercato,
l'impresa dovrà ridurre i suoi prezzi al di sotto del costo, e soffrirà perdite
che saranno più elevate di quelle dei concorrenti: per diminuire i prezzi,
infatti essa dovrà aumentare significativamente la produzione. Altrimenti,
dato che i suoi rivali ridurranno o cesseranno la produzione per ridurre le
perdite, l’offerta complessiva diminuirà ed i prezzi torneranno ad
aumentare. Così l'impresa predatrice sosterrà, nella prima fase, perdite
molto elevate.
Quindi, in pratica, una strategia predatoria può essere efficace soltanto se
l'impresa dominante ha costi sensibilmente inferiori a quelli dei propri rivali,
dal momento che ciò permetterà di ridurre le perdite iniziali, e se l'impresa
dominante è ‘ricca’ rispetto alle altre, e dunque riesce a sopportare più
facilmente tali perdite iniziali.
In ogni caso, il mercato deve essere protetto da barriere all'entrata, in modo
tale che i rivali che vengono esclusi durante la prima fase, quando i prezzi
scendono, non siano in grado di rientrare nel mercato durante la seconda
fase, quando i prezzi salgono.
Naturalmente, 1'impresa dominante può avere ragioni legittime per
diminuire i prezzi: rispondere al riduzioni dei prezzi dei concorrenti, reagire
a una fase ciclica negativa dell'economia stimolando la domanda, smaltire
scorte di magazzino in eccedenza, e così via.
Per identificare le riduzioni dei prezzi realmente in grado di avere effetti
negativi sulla concorrenza, è dunque necessario condurre un'analisi
economica.
Storicamente, il test utilizzato a questo fine (chiamato test di AreedaTurner) è basato su elementari principi di microeconomia, secondo i quali
un'impresa continuerà a produrre anche se registra profitti negativi, fino al
116
punto in cui essa è in grado di coprire i propri costi variabili 104: fino a che
l'impresa è in grado di pagare le materie prime e il lavoro necessari a
produrre un'unità addizionale di prodotto, essa rimarrà in attività, sperando
che un aumento dei prezzi le permetta in futuro di ricostituire i propri
margini di profitto. Solo quando i prezzi scendono al di sotto dei costi
variabili, essa sarà costretta a interrompere la produzione e uscire dal
mercato, perché non potrà pagare fornitori e maestranze. Tuttavia,
un'impresa dominante continuerà razionalmente a produrre - se non è in
grado di coprire i suoi costi variabili - solo se si attende che sarà in grado di
innalzare significativamente i prezzi nel futuro cioè sarà in grado di
condurre con successo una strategia predatoria. Pertanto, i prezzi al di sotto
del costo variabile sono considerati solitamente una condizione sufficiente
per dimostrare l'esistenza di un comportamento predatorio.
Il test di Areeda-Turner fornisce quindi un limite inferiore per i prezzi di
un'impresa dominante. La Corte di Giustizia, a partire dal caso Akzo 105, ha
tuttavia aggiunto un criterio ulteriore: se i prezzi sono al di sotto dei costi
medi totali - che includono sia i costi fissi che i costi variabili - e sono al di
sopra dei costi medi variabili, il comportamento può essere considerato
predatorio se è possibile dimostrare l'esistenza di una strategia più ampia
finalizzata ad eliminare la concorrenza. Pertanto, se un prezzo è inferiore al
costo variabile il comportamento predatorio è automaticamente integrato; se
è superiore ad esso ma inferiore ai costi medi totali, può esservi
comportamento predatorio in presenza di ulteriori indizi dell'esistenza di un
disegno escludente. In pratica, solo vendendo a prezzi superiori ai costi
medi totali un'impresa dominante può trovarsi del tutto al riparo da accuse
di politica predatoria 106.
104
I costi variabili sono quelle voci di costo che variano con il variare del volume di
produzione, tipicamente correlate al lavoro e alle materie prime.
105
Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Akzo Chemie v. Commissione, sentenza del
3 luglio 1991.
106
La giurisprudenza comunitaria in materia di benchmark di costo per l'identificazione di
pratiche predatorie si è venuta gradualmente evolvendo, introducendo due nuovi criteri di
costo: il costo medio evitabile (AAC) e il costo medio incrementale di lungo periodo
(LRAIC). L’AAC comprende sia i costi variabili, sia i costi affondati, ovvero gli
investimenti specifici sostenuti per acquisire la capacità produttiva necessaria per realizzare
la strategia predatoria. Poiché quindi l’AAC può essere soltanto uguale o superiore al costo
medio variabile, utilizzando l’AAC il test di Areeda-Turner è stato reso più stringente: è
infatti più difficile per il prezzo risultare superiore al costo evitabile, che non risultare
superiore al costo variabile. Il test è stato modificato anche abbassando la soglia oltre la
quale si deve presumere il carattere non predatorio di un prezzo: esso è oggi spesso
identificato con il LRAIC, definito come la differenza tra i costi totali sostenuti
dall’impresa quando produce tutti i propri prodotti, compreso quello oggetto di indagine, e i
costi totali dell’impresa quando la quantità del prodotto oggetto di indagine è posta pari a
zero. Pertanto, il LRAIC include, oltre ai costi evitabili, anche l’incremento nei costi
comuni che è attribuibile al prodotto in questione. Da un test di predatorietà basato sul
costo medio variabile e sul costo medio totale, si è dunque passati ad un test basato sul
117
Il test del caso Akzo è utile, tuttavia esso può risultare impreciso per due
motivi principali: (i) molte imprese dominanti sono multiprodotto e può
essere difficile determinare accuratamente, in tali casi, i costi relativi ad uno
specifico prodotto; (ii) le decisioni di cessare la produzione di un particolare
prodotto sono prese dalle imprese considerando un ampio insieme di
variabili, e non solo i costi e i ricavi relativi al prodotto.
Ad esempio, un'impresa potrebbe continuare la produzione di un
determinato bene anche se non riesce a coprire i suoi costi variabili, perché
considera che sia importante avere quel prodotto nel suo portafoglio per
mantenere la sua presenza in un particolare segmento di clientela; per
mantenere un know-how specifico in un settore che si svilupperà
probabilmente nel futuro, e così via. In ogni modo, nel modo reale spesso le
imprese non decidono di uscire da un mercato considerando solamente i
costi di breve periodo. Inoltre, dal momento che la scelta di intraprendere
una strategia predatoria produce un costo immediato per l'impresa (una
perdita), a fronte di un flusso di profitti incerti nel futuro, una decisione di
questo genere è essenzialmente molto simile ad una decisione di
investimento, e dovrebbe essere valutata comparando i costi di un
comportamento predatorio con il valore attuale dei suoi benefici futuri.
In pratica, tuttavia, le Autorità Antitrust continuano ad utilizzare il test di
Areeda-Turner, come mostra un caso recente, relativo alle tariffe dei
traghetti sullo stretto di Messina.
Prezzi predatori e costi incrementali: il caso Diano/Tourist-Caronte
Fino all’estate del 1998, il servizio di trasporto marittimo sullo stretto di
Messina era offerto esclusivamente dal gruppo Tourist-Caronte e da Ferrovie
dello Stato, che operavano soltanto sulla rotta Messina-Villa San Giovanni. Su
tale rotta vi erano elevate barriere all’entrata, sia di tipo infrastrutturale (ad
esempio, gli approdi), sia di tipo amministrativo (difficoltà nell’ottenimento
delle necessarie concessioni demaniali e diritti di attracco).
A seguito dell’avvio, da parte di Diano, di un nuovo collegamento sulla vicina
rotta Messina-Reggio Calabria, anche il gruppo Tourist-Caronte attivava un
servizio di trasporto su tale rotta, applicando tariffe sostanzialmente inferiori
alle tariffe applicate sulla rotta Messina-Villa San Giovanni. Inoltre, il gruppo
Tourist-Caronte fissava gli orari delle proprie corse sulla Messina-Reggio
Calabria in modo da sovrapporsi sistematicamente alle corse del concorrente
Diano.
costo medio evitabile e sul costo medio incrementale di lungo periodo. Non sono però
cambiati i criteri: un prezzo inferiore all’AAC è considerato ex se predatorio; un prezzo
superiore all’AAC, ma inferiore al LRAIC, ha carattere predatorio soltanto in presenza di
altri fattori che individuino un disegno escludente.
118
A causa di tale strategia, Diano subiva consistenti perdite e rischiava di uscire dal
mercato. Di contro, i risultati economici del gruppo Tourist-Caronte per il servizio
di traghettamento attraverso lo stretto di Messina evidenziavano sostanziali
profitti: infatti, Tourist-Caronte aveva ampiamente compensato le perdite subite
sulla nuova rotta Messina-Reggio Calabria con gli ampi profitti realizzati sulla
rotta Messina-Villa San Giovanni, che rappresentava, tra l’altro, il 90% dell’intero
mercato rilevante, in cui il gruppo Tourist-Caronte deteneva una posizione di
assoluto dominio.
Per verificare se la strategia di Tourist-Caronte fosse predatoria, l’Autorità ha
effettuato un’analisi delle tariffe applicate e dei costi sostenuti dal gruppo TouristCaronte sulla rotta Messina-Reggio Calabria, per verificare se i costi (del
collegamento Messina-Villa San Giovanni) fossero stati coperti dai ricavi ivi
realizzati.
Per questo, l’Autorità ha utilizzato i due criteri di costi incrementali di breve
periodo (cioè, i costi evitabili) e di lungo periodo, concludendo che che le tariffe
praticate dal gruppo Tourist-Caronte sulla rotta Messina-Reggio Calabria erano
inferiori ad entrambi i criteri: era quindi dimostrato il carattere predatorio della
politica tariffaria del gruppo Tourist-Caronte, che avrebbe consentito a
quest’ultima di crearsi la reputazione di incumbent aggressivo e, quindi, di
scoraggiare l’ingresso di potenziali ulteriori concorrenti. In tal modo, una volta
eliminato il concorrente, Tourist-Caronte avrebbe potuto rialzare il livello delle
proprie tariffe e recuperare così i costi sopportati.
Provvedimento dell’AGCM del 17 aprile 2002, caso A267, Diano/Tourist Ferry
Boat-Caronte Shipping-Navigazione Generale Italiana, in Bollettino n. 16/2002.
9.5.2
Discriminazione di prezzo
La discriminazione di prezzo, in pratica, avviene quando un'impresa vende
un prodotto identico, ad acquirenti differenti, a prezzi differenti, per ragioni
che non sono correlate con i costi di produzione e di consegna. Se la
discriminazione è effettuata da un'impresa dominante, può essere illecita.
Ma quando, esattamente, la discriminazione diventa un'offesa antitrust?
Vediamo, prima, le condizioni in cui può esistere una discriminazione di
prezzo.
Un'impresa dominante può discriminare tra i suoi clienti solo se è in grado
di valutare accuratamente la disponibilità a pagare di ciascun consumatore o
di ciascun gruppo di consumatori. In aggiunta. deve essere in grado di
prevenire fenomeni di arbitraggio, che hanno luogo quando i consumatori
che pagano un prezzo più basso per un bene non lo rivendono ad altri
consumatori, chiedendo loro di pagare un prezzo più elevato. L'arbitraggio
può essere reso impossibile dalla natura del prodotto o del servizio,
119
ostacolato dalla presenza di elevati costi di transazione o di trasporto, o può
essere evitato o reso difficile da speciali clausole contrattuali che
proibiscono (o rendono nulla) la garanzia fornita dal costruttore in caso di
rivendita.
La discriminazione può assumere differenti forme: differenze nei prezzi
ufficiali (le tariffe aeree possono variare a seconda del numero dei giorni
che intercorre tra la partenza e il ritorno), sconti in ragione della quantità
(volume acquistato) o fattori qualitativi (ad esempio, biglietti per gli
studenti), la concessione di premi in denaro o in natura (che dal punto di
vista economico è equivalente agli sconti), l'applicazione di prezzi non
lineari (ad esempio, il prezzo incorpora una parte fissa e una parte variabile,
che è proporzionale al numero di unità effettivamente acquistato come ad
esempio nel caso dell'energia elettrica o della telefonia fissa), e molti altri.
In pratica ci sono due tipi principali di discriminazione di prezzo, che sono
rilevanti per la nostra discussione:
• le imprese possono imporre prezzi differenti a consumatori che
hanno differenti caratteristiche (ad esempio, studenti);
• l'impresa ha informazioni sufficienti per segmentare i clienti in
gruppi, e offrire a ciascuno di essi uno schema di prezzo differente:
per esempio i turisti che sono in grado di pianificare in anticipo il
loro viaggio possono pagare prezzi più bassi rispetto ai viaggiatori
per motivi di lavoro, i quali sono disponibili a pagare prezzi più
elevati per assicurarsi orari flessibili di partenza e di arrivo
(cosiddetti passeggeri time-sensitive). Si noti che in questo caso
l'impresa non necessita di avere informazioni sulle caratteristiche di
ciascun consumatore: i consumatori si autoselezionano, scegliendo
essi stessi un particolare schema di prezzo. Così, i biglietti a basso
prezzo, per voli non modificabili, a metà giornata, saranno comprati
dai turisti, quelli a prezzo elevato, con date flessibili, e in orari ad
inizio e fine giornata saranno comprati dalla clientela affari.
La discriminazione di prezzo può rappresentare un'offesa antitrust solo se
implica un abuso di sfruttamento o un abuso escludente. Come abbiamo
discusso in precedenza, gli abusi di sfruttamento sono molto difficili da
provare nel caso più semplice di prezzi eccessivi, e quindi sono ancora più
difficile da trovare in casi di discriminazione di prezzo. In pratica, gli abusi
di sfruttamento non possono essere provati in questi casi. Questa non è una
grande perdita dal punto di vista economico, dal momento che non è chiaro
in generale se la discriminazione abbia effetti positivi o negativi sul
benessere 107.
107
Per esempio, gli sconti quantità possono aumentare la domanda, e la produzione. In
generale, un aumento della produzione aumenterà il benessere, e quindi questi sconti
120
Inoltre, nelle infrastrutture di rete, come l'energia elettrica, i trasporti o le
telecomunicazioni, l'imposizione di prezzi più elevati ai consumatori che
richiedono l'accesso alla rete durante i periodi di maggiore utilizzo è in
generale socialmente efficiente. La rete deve avere capacità adeguata per
soddisfare la domanda nei periodi di picco, e attraverso uno schema di peakload pricing, gli ammortamenti e i costi di investimento per la capacità
necessaria in un periodo di picco sono pagati da coloro che utilizzano
effettivamente la rete in quel momento.
D'altra parte, la discriminazione di prezzo può costituire un abuso
escludente, e questa è certamente la linea dell'articolo 102 TFUE, paragrafo
c), che proibisce la discriminazione di prezzo solo se pone alcuni clienti
dell'impresa dominante in ‘svantaggio competitivo’ rispetto ad altri108.
Quindi, la discriminazione di prezzo dovrebbe essere considerata abusiva
solo se essa è: (i) adottata nei confronti di clienti che sono in concorrenza tra
loro, e (ii) così grave da avere effetti materiali sulla posizione
concorrenziale dei clienti coinvolti.
Tuttavia, le autorità di concorrenza europee hanno spesso proibito la
discriminazione di prezzo, senza riguardo dell'effettiva esistenza di uno
svantaggio competitivo nel mercato a valle, a meno che l'impresa dominante
non sia in grado di provare che le differenze nei prezzi trovano
giustificazione in differenze nei costi. Pertanto, la discriminazione di prezzo
rappresenta una delle aree nell'antitrust in cui si osserva una significativa
divergenza tra il pensiero economico e quello giuridico.
9.5.3
Sconti fidelizzanti
Gli sconti sono una forma di discriminazione di prezzo, che può dare origine
sia ad una distorsione della concorrenza tra i clienti (discussa nel paragrafo
precedente), sia ad effetti escludenti nei confronti dei concorrenti, dato che
gli sconti possono essere congegnati in modo da dissuadere i clienti dal
sostituire i prodotti dell'impresa dominante con quelli di uno dei suoi
concorrenti. D'altra parte, se gli sconti riflettono risparmi ottenuti
dall'impresa dominante a causa delle caratteristiche dell'ordine non sono
considerati abusivi: ad esempio, ad un ordine molto grande che genera
risparmi di costo può essere certamente accordato uno sconto.
I principali tipi di sconti che possono più probabilmente essere considerati
abusivi sono: (a) sconti che impongono ai clienti a soddisfare tutto il loro
fabbisogno presso l'impresa dominante; (b) sconti connessi all'acquisto di
possono risultare positivi. Biglietti economici per gli studenti sono resi possibili
dall'esistenza di biglietti molto cari per i professori, e così via.
108
Questa forma di discriminazione è definita negli Stati Uniti secondary-line price
discrimination.
121
altri prodotti dell'impresa dominante; (c) sconti concessi quando il cliente
raggiunge certe soglie di acquisto, ma applicati retroattivamente su tutte le
quantità già acquistate dal cliente in un periodo di tempo sufficientemente
lungo 109; (d) sconti concessi se il cliente aumenta la sua domanda e
finalizzati ad incoraggiare il cliente ad acquistare principalmente
dall'impresa dominante.
Il caso Hoffman-La Roche illustra molto chiaramente tali questioni.
Gli sconti come pratiche escludenti: ancora il caso Hoffman-La Roche
Le relazioni commerciali tra Hoffman-La Roche (HLR), importante produttore di
vitamine destinate all’alimentazione umana e animale e all’uso farmaceutico, e i
suoi più importanti clienti erano disciplinate da contratti negoziati che avevano in
comune alcuni elementi essenziali.
In primo luogo, alcuni di essi prevedevano espressamente l’obbligo per il cliente di
acquistare la totalità, o comunque la maggior parte, del proprio fabbisogno di
vitamine (o di determinate vitamine) da HLR.
Quasi tutti i contratti di vendita in questione, poi, prevedevano la concessione da
parte di HLR di cosiddetti “sconti fedeltà” agli acquirenti dei propri prodotti. In
particolare, HLR si impegnava a versare, su base annuale o semestrale, una somma
di denaro (calcolata sotto forma di sconto percentuale sui prezzi fatturati)
all’acquirente di vitamine il quale, a sua volta, si impegnava a rifornirsi per la
totalità o per la maggior parte del proprio fabbisogno di detti prodotti da HLR.
L’entità della somma versata da HLR a ciascun acquirente variava a seconda del
cliente, anche se, generalmente, si trattava di un ammontare compreso tra l’1% e il
5% del totale degli acquisti in vitamine di detto cliente da HLR. L’aliquota per
ciascun cliente, poi, poteva essere fissa ovvero progressiva, ossia crescente quanto
più la quantità di vitamine acquistate dal cliente da HLR si avvicinava al
fabbisogno totale stimato (generalmente su base annua) di detto acquirente. Lo
schema degli “sconti fedeltà” messo a punto da HLR prevedeva, inoltre, che il
mancato rispetto da parte del cliente dell’obbligo di approvvigionamento esclusivo
(o prevalente) presso HLR, avrebbe comportato la perdita da parte dell’acquirente
del diritto allo “sconto fedeltà” non solo per quella parte del proprio fabbisogno di
vitamine che questi aveva acquistato presso un altro fornitore, ma per la totalità dei
suoi acquisti di vitamine da HLR.
Infine, e in aggiunta a quanto sopra, alcuni contratti prevedevano anche una
“clausola inglese” ai sensi della quale il cliente che riceveva da un concorrente di
HLR un’offerta a prezzi inferiori a quelli praticati da HLR era tenuto a informare
di ciò quest’ultima. Il cliente avrebbe quindi potuto rifornirsi presso detto
concorrente solo nel caso in cui HLR, una volta informata, non dichiarava la
propria disponibilità a ridurre i prezzi al livello di quelli offerti dal concorrente. In
tal caso, il cliente manteneva inoltre il diritto a ricevere lo “sconto fedeltà” sulla
totalità dei propri acquisti di vitamine passati e futuri da HLR.
109
Si veda la Decisione della Commissione del 14 luglio 1999, British Airways, in GUCE
(2000), L30/1.
122
Il 9 giugno 1976, la Commissione decideva che HLR aveva abusato della
propria posizione dominante. In particolare, la Commissione considerava che i
contratti di vendita da essa adottati avevano l’effetto di obbligare, mediante un
impegno espresso di esclusiva, o di stimolare, mediante la previsione di “sconti
fedeltà”, i clienti di HLR ad approvvigionarsi presso di essa per la totalità - o per
una parte essenziale - del proprio fabbisogno di vitamine. La Commissione
concludeva che, in tal modo, i clienti di HLR erano di fatto privati della
possibilità di scelta delle loro fonti di approvvigionamento e che la concorrenza
tra i produttori di vitamine era dunque pregiudicata: la cospicua porzione di
domanda rappresentata dai clienti dell’impresa dominante era infatti “protetta”
da ogni possibile aggressione dei produttori concorrenti e dunque sottratta al
libero gioco della concorrenza.
HLR proponeva ricorso in annullamento dinanzi alla CGCE la quale, tuttavia,
fatta eccezione per alcuni punti secondari, confermava, nel suo complesso, la
decisione della Commissione, sancendo in particolare il carattere abusivo sia
delle clausole che imponevano ai clienti di HLR di approvvigionarsi in via
esclusiva o prevalente presso HLR, sia delle clausole che prevedevano gli
“sconti fedeltà”.
Sentenza delle CGCE del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman-La Roche, in
Racc. (1979), p. 461.
Questo atteggiamento sostanzialmente negativo nei confronti degli sconti
fidelizzanti è certamente giustificabile alla luce di una politica antitrust volta
a rendere difficile, per le imprese dominanti, conservare la propria posizione
di mercato, e a facilitare nel contempo la crescita di concorrenti attuali e
potenziali.
Tuttavia, le autorità antitrust europee e i tribunali sono probabilmente troppo
restrittivi in questo senso, dal momento che è molto frequente che gli sconti,
concessi per una serie di ragioni di business del tutto razionali, prendano
una forma che potrebbe essere considerata come un'offesa antitrust.
Pertanto, si potrebbe concludere che gli orientamenti giurisprudenziali non
rispettano il criterio di base evidenziato all'inizio di questo capitolo, e cioè
che un comportamento dovrebbe essere considerato un'offesa antitrust solo
se ad esso non può essere attribuita una motivazione razionale, a parte
l'obiettivo di eliminare un concorrente.
Per ovviare a questo problema, è essenziale effettuare un'analisi economica
dettagliata delle caratteristiche dello sconto. Si prenda il caso di uno sconto
che viene normalmente considerato lecito dalle autorità antitrust europee,
cioè uno sconto-quantità. Per valutare se esso è razionale dal punto di vista
del business, si confronta solitamente la riduzione del prezzo con la
riduzione del costo unitario medio. Ma ciò non è corretto, dal momento che
123
lo sconto accordato per (ad esempio) un ordine di 1000 unità dovrebbe
essere confrontato col costo addizionale che l'impresa deve sostenere per
produrre 1000 unità. Nella maggior parte dei casi, questo costo incrementale
sarà minore del costo medio, dal momento che tipicamente la quantità
addizionale aumenta il grado di utilizzazione dello stabilimento produttivo,
e quindi in genere il costo incrementale è inferiore al costo medio.
Un'autorità antitrust che confrontasse lo sconto con la riduzione del costo
medio unitario, tenderebbe quindi a concludere che lo sconto è eccessivo, e
pertanto illecito dal punto di vista della concorrenza. Ma questo sarebbe un
errore.
Un'ulteriore questione rilevante in questo caso è il trattamento degli sconti
antitrust, concessi dalle imprese dominanti per contrastare le offerte dei loro
concorrenti (questa è spesso definita meeting competition defence).
Consideriamo un'impresa dominante sul mercato nazionale, che vende un
prodotto a € 100 sull'intero territorio, e deve confrontarsi con un nuovo
concorrente in un mercato regionale, che vende lo stesso bene a € 90 110.
L'impresa dominante può reagire riducendo i suoi prezzi su base nazionale
oppure riducendo i prezzi solo nella regione in cui ha necessità di
contrastare l'attività del concorrente. Assumendo che il prezzo scontato
offerto dall'impresa dominante non sia inferiore al costo, quali sono le
implicazioni antitrust delle due strategie?
Sfortunatamente, non c'è una risposta chiara a questo problema. In pratica,
una riduzione complessiva del prezzo non sarebbe considerata illecita, dal
momento che sarebbe considerata come parte di un processo concorrenziale
naturale. Se il concorrente è altrettanto efficiente quanto l'impresa
dominante, sarà in grado di rimanere sul mercato; se è meno efficiente, a
seguito della reazione dell'impresa dominante, uscirà dal mercato.
D'altra parte, riduzioni selettive di prezzo sono una strategia molto più
rischiosa dal punto di vista antitrust. Sebbene esse possono essere
giustificate da una molteplicità di ragioni di business, un'autorità antitrust
sospetterà sempre che il loro vero obiettivo sia solo quello di eliminare un
concorrente: le imprese dominanti devono essere molto caute nei confronti
degli sconti selettivi.
9.5.4
Margin squeeze e price squeeze
Abbiamo già discusso il problema delle infrastrutture essenziali dal punto di
vista del rifiuto di contrarre, considerando i problemi relativi all’accesso. Se
non vi fosse alcun regolatore che fissa il prezzo per l'accesso 111 il
110
La nostra discussione in questa sede segue, in parte, i contributi di Slater e Waelbroek
(2004).
111
Come esiste nella realtà in molte industrie a rete.
124
proprietario di un'infrastruttura (ad esempio, un gasdotto) e che fornisce
inoltre nel mercato a valle il servizio prodotto per mezzo dell'infrastruttura
(vendita di gas ai consumatori finali) potrebbe fornire l’accesso ai
concorrenti, ma con politiche di prezzo che hanno in realtà l'obiettivo di
eliminarli.
In pratica, potrebbe: (i) fissare un prezzo molto elevato per l'accesso alla
rete, in modo che i costi dei suoi concorrenti siano elevati, e questi ultimi
siano incapaci di competere nelle vendite di gas: questo è noto come margin
squeeze (Figura 9.1); (ii) alternativamente, utilizzare i profitti che consegue
vendendo l'accesso per diminuire significativamente sui prezzi sul mercato
del gas a valle, in modo tale che i concorrenti siano incapaci di replicarli:
questo è noto come price squeeze 112 (Figura 9.2).
Figura 9.1 Esempio di margin squeeze
112
Sebbene ci stiamo riferendo qui per semplicità ai settori infrastrutturali, è importante
notare che fattispecie di margin squeeze e price squeeze possono emergere in ciascun
settore. I casi risalenti a livello europeo riguardano infatti settori come lo zucchero (si veda
la Decisione della Commissione del 18 luglio 1988, Napier Brown/British Sugar, in GUCE
[1988] L384/41), e metalli (si veda il caso del tribunale di primo grado del 30 novembre
2000, Industrie des Poudres Sphériques SA /Commissione, T-5/97, in Racc. (2000), p. II3755.
125
Figura 9.2 Esempio di price squeeze
L'esistenza effettiva di una strategia di squeeze è difficile da accertare.
Quando i prezzi a valle dell'impresa dominante sono più bassi di quelli dei
suoi concorrenti, questi ultimi sosterranno che l'impresa dominante sta
intraprendendo una strategia di squeeze, ad esempio facendo pagare alle
proprie divisioni commerciali un prezzo inferiore per l'accesso rispetto
quello pagato dei concorrenti. D'altra parte, l'impresa dominante replicherà
che il prezzo di accesso è uguale per tutti, e che i concorrenti non sono in
grado di raggiungere profitti soddisfacenti solo a causa della loro
inefficienza.
Per accertare l'esistenza di un margin (o price) squeeze, le autorità antitrust
utilizzano solitamente un test in due fasi, costruito per valutare se il prezzo
richiesto dall'operatore dominante è (a) più elevato dei propri costi e (b)
replicabile da un concorrente egualmente efficiente, cioè da un concorrente
che ha esattamente gli stessi costi dell'impresa dominante. La prima fase del
test verifica che l'impresa dominante non stia intraprendendo una strategia
predatoria. La seconda fase verifica che i prezzi praticati dall'impresa
dominante nel mercato a valle possano essere effettivamente replicati da un
concorrente efficiente. La logica economica di questi test è chiara. La
politica antitrust non dovrebbe sussidiare concorrenti inefficienti, ma punire
comportamenti che risultano irrazionali da un punto di vista del business,
dal momento che sarebbe sicuramente irrazionale per un'impresa dominante
vendere a prezzi inferiori ai propri costi (primo test), o che sono più elevati
dei propri costi, ma che non le permettono di ottenere un ragionevole
profitto (secondo test).
126
10. LE CONCENTRAZIONI
La nozione di concentrazione, nel diritto della concorrenza, copre tutte le
operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese
interessate e che, pertanto, si risolvono in un cambiamento della struttura del
mercato. Rientra così in tale nozione una serie di operazioni alquanto
differenti tra loro, quali la fusione di due o più imprese indipendenti,
l’acquisizione del controllo di un’impresa indipendente da parte di un’altra
impresa (o da parte di persone fisiche che controllano altre imprese) e la
creazione di imprese comuni (joint ventures) che esercitano stabilmente
tutte le funzioni di un’entità economica operante autonomamente sul
mercato (nel linguaggio tecnico antitrust, le cosiddette imprese comuni a
pieno titolo 113).
Dal punto di vista economico, queste diverse fattispecie hanno un medesimo
effetto sostanziale, vale a dire una modifica duratura della struttura del
mercato: le acquisizioni e le fusioni tra imprese indipendenti modificano
infatti la struttura del mercato concentrando in un unico agente economico il
potere decisionale che prima risiedeva in due (o più) agenti, mentre la
costituzione di un’impresa comune determina anch’essa una modifica della
struttura del mercato, comportando la creazione di un vincolo strutturale
permanente tra l’impresa e gli agenti economici che ne acquisiscono il
controllo congiunto.
Le concentrazioni sono un fenomeno molto frequente nel sistema
economico. Attraverso di esse, le imprese cercano di aumentare la propria
dimensione produttiva per conseguire economie di scala, ampliare le proprie
linee di prodotto conseguendo economie di gamma o di varietà, 114
assicurarsi il controllo di input produttivi o di canali di distribuzione.
Ci possono essere tre tipologie principali di concentrazioni: il proprietario di
una piantagione di banane può acquistare una seconda piantagione, in
questo caso si ha una concentrazione orizzontale. La piantagione di banane
può acquistare una compagnia di navigazione specializzata nel trasporto del
banane (o, al contrario, una compagnia armatrice specializzata nel trasporto
di banane può acquistare una piantagione), e queste sarebbero entrambe
concentrazioni verticali. Una piantagione di banane può acquistare una
piantagione di palme da cui ricavare olio di palma, e questa sarebbe invece
113
Cfr. “Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che
esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del Regolamento n.
4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese”,
in GUCE [1998] C66/1.
114
Per un’azienda che produca due prodotti, A e B, le economie di varietà sono le riduzioni
del costo medio del prodotto A che si ottengono aumentando la scala produttiva per il
prodotto B (e viceversa, naturalmente).
127
considerata una concentrazione conglomerale. Tutti e tre i tipi di
concentrazioni possono far nascere questioni antitrust. Tuttavia, le
concentrazioni orizzontali sono quelle in cui tali questioni sono più
probabili, e pertanto in questa sede discuteremo solo di esse.
Le concentrazioni orizzontali possono ostacolare la concorrenza effettiva in
due modi, e precisamente:
a) eliminando significative pressioni competitive su una o più imprese,
e quindi aumentando il loro potere di mercato (effetti unilaterali o
non coordinati);
b) modificando la natura della concorrenza tra le imprese in modo tale
da rendere più probabile un coordinamento del comportamento delle
imprese sul mercato, che potrebbe condurre ad un aumento dei
prezzi (effetti coordinati).
Entrambe le tipologie di effetti potrebbero materializzarsi in tempi brevi
dopo la concentrazione, e dare luogo a riduzioni di benessere
potenzialmente significative: tuttavia, l’azione antitrust nei loro confronti
richiederebbe risorse e tempi rilevanti, e potrebbe risultare poco efficace,
soprattutto per quanto riguarda il punto (b), come discusso nel paragrafo
dedicato alla colluttazione tacita.
Per questo motivo, le concentrazioni sono oggetto di una forte attenzione
preventiva nella pratica antitrust: quando una concentrazione coinvolge
imprese aventi caratteristiche (in genere dimensionali) tali da rendere
concreto il rischio di significativi effetti anticompetitivi, la sua efficacia è
condizionata all’ottenimento di un’autorizzazione dell’autorità di
concorrenza, che può concederla, concederla a condizione che la merged
entity assuma determinati impegni, oppure negarla.
Il criterio principalmente utilizzato è la valutazione dei possibili effetti sui
prezzi della concentrazione. Ciò per due motivi principali: da un punto di
vista teorico, la scienza economica offre un preciso quadro concettuale
proprio dei rapporti tra potere di mercato, aumento nei prezzi, e riduzione
del benessere dei consumatori; da un punto di vista empirico, l’esperienza
antitrust conferma che il peggioramento delle caratteristiche non price dei
prodotti accompagna (e solo raramente sostituisce) la forma più classica di
esercizio del potere di mercato, ovvero l’aumento dei prezzi.
A livello comunitario, il criterio sostanziale di valutazione delle
concentrazioni considera sia gli effetti unilaterali sia quelli coordinati,
vietando le concentrazioni che ostacolino la concorrenza effettiva in modo
significativo, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di
128
una posizione dominante 115. Nella valutazione dell’esistenza di un eventuale
danno alla concorrenza effettiva, occorre valutare i fattori che limitano
l’esercizio del potere di mercato da parte dell’entità risultante dalla
concentrazione: nei capitoli precedenti, abbiamo discusso come definire i
mercati rilevanti, come valutare l'esistenza del potere di mercato, e
l'esistenza di cartelli. Come vedremo, l'analisi delle concentrazioni utilizza
esattamente gli stessi strumenti.
10.1 Effetti unilaterali, o non coordinati
L'effetto più diretto di una concentrazione orizzontale è costituito
dall'indebolimento delle pressioni competitive. Si consideri un mercato
rilevante con tre imprese, A, B, e C. Prima della concentrazione, se A
avesse aumentato i prezzi, i clienti si sarebbero spostati verso i prodotti di B
o di C. Dopo la concentrazione, se l'entità derivante dalla fusione
aumentasse i prezzi, i clienti potrebbero solo rivolgersi a C. Così, qualsiasi
concentrazione diminuisce le pressioni competitive sulle imprese restanti
del mercato, ma ovviamente tale riduzione dipende da due fattori: la quota
di mercato dell'entità derivante dalla fusione, e le quote delle altre imprese.
Abbiamo già discusso la complessa relazione che esiste tra quote di mercato
e potere di mercato, e pertanto possediamo tutti gli strumenti necessari per
valutare il potere di mercato della entità derivante dalla fusione.
Tipicamente, dovremo svolgere a questo fine un semplice SSNIP test, se il
mercato rilevante è composto da prodotti omogenei. Se i prodotti sono
invece differenziati, gli effetti di una concentrazione dipendono da quanto
tali imprese producono beni più o meno direttamente sostituibili dal punto di
vista dei consumatori: se tali beni non sono percepiti come sostituti, è
difficile che una concentrazione possieda effetti distorsivi, anche se le quote
di mercato delle società coinvolte possono essere rilevanti; se essi sono
considerati come sostituti molto vicini, la quota di mercato cumulata deve
essere considerata invece molto più attentamente.
In pratica per valutare gli effetti della concentrazione, le autorità antitrust
analizzeranno:
115
Cfr. Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo
delle concentrazioni tra imprese, art. 2, comma 3. Questa formulazione del criterio di
valutazione sostituisce il test precedente, per il quale erano vietate le concentrazioni “che
creano o rafforzano una posizione dominante in grado di ostacolare in modo significativo e
duraturo una concorrenza effettiva”. Il nuovo criterio pone quindi l’accento sulla
limitazione della concorrenza, senza rendere più necessaria la prova della creazione o del
rafforzamento di una posizione dominante. Sulla definizione di posizione dominante si
veda il precedente Capitolo 6.
129
i.
le quote di mercato delle imprese che partecipano alla
concentrazione, possibilmente con qualche aggiustamento per tenere
in debita considerazione possibili cambiamenti futuri come, per
esempio, fenomeni di uscita o di entrata di imprese dal mercato,
oppure il tasso di crescita del mercato stesso;
ii.
il grado di concentrazione del mercato rilevante. La struttura
complessiva del mercato è valutata sulla base dell'indice di
concentrazione HHI. Normalmente, è improbabile che la
concentrazione ponga problemi antitrust se, una volta effettuata, il
livello dell'indice HHI: (a) è inferiore a 1000; (b) e tra 1000 e 2000,
ma l'incremento dell'indice dovuto alla concentrazione è inferiore a
250; (c) è più elevato di 2000, ma con un incremento inferiore a 150
punti.
Questi sono, naturalmente, criteri empirici, e in alcuni casi possono essere
rilevanti altre considerazioni, come per esempio quando la concentrazione
implica la ‘sparizione’ di un nuovo entrante, oppure di una impresa
“maverick” cosiddetta perché si comporta sistematicamente in modo
aggressivo. In questi casi, la distorsione della concorrenza può essere più
grande di quello che possa essere suggerito dall'analisi delle quote di
mercato e degli indici di concentrazione. Analogamente, se la
concentrazione ha luogo in un mercato in cui ci sono relazioni strutturali tra
le imprese, come l'esistenza di partecipazioni incrociate, queste dovranno
essere prese in considerazione.
10.2 Effetti coordinati
Nei mercati dove esistono poche imprese, l'eliminazione di un concorrente
attraverso una concentrazione può, in determinate circostanze, facilitare il
coordinamento delle imprese restanti, che potrebbero così aumentare il
prezzi.
Il coordinamento può assumere molte forme, dalla collusione esplicita alla
collusione tacita. Nel primo caso, il comportamento collusivo sarà
sanzionato sulla base della legislazione relativa ai cartelli. Ma quando il
coordinamento non fosse cos’ esplicito, ma il risultato, semplicemente, di un
parallelismo spontaneo di comportamenti (nel cui caso, come abbiamo visto,
si parla di collusione tacita), facilitata dalla concentrazione, gli strumenti per
la repressione dei cartelli costituirebbero una politica antitrust alquanto
debole.
Questo è il motivo per cui nella valutazione delle concentrazioni, quando il
numero delle imprese nel mercato è limitato, le autorità antitrust dedicano
una particolare attenzione alla valutazione degli effetti coordinati. Ancora
una volta, gli strumenti che sono utilizzati per tale analisi sono esattamente
130
gli stessi che abbiamo passato in rassegna quando abbiamo discusso di
cartelli: le autorità antitrust controlleranno quindi se la natura del mercato
rende gli scambi di informazioni facili o difficili, e se permette di porre in
essere efficienti meccanismi di punizione. Quando entrambe queste
condizioni sono soddisfatte, è probabile che la concentrazione venga vietata.
10.3 Potere di contrasto di concorrenti e acquirenti
Nella valutazione dell’esistenza di un eventuale danno alla concorrenza,
occorre valutare i fattori che limitano l’esercizio del potere di mercato da
parte dell’entità risultante dalla concentrazione e dunque, in primo luogo, la
capacità di reazione di acquirenti e concorrenti.
Come abbiamo visto, il potere di contrasto degli acquirenti (countervailing
buyer power) dipende dalla facilità con cui essi possono reagire a un
aumento dei prezzi rivolgendosi a un altro fornitore in tempi ragionevoli, o
rifiutandosi di comprare altri prodotti del fornitore o, specie nel caso di beni
durevoli, rinviando gli acquisti. Naturalmente, se i prodotti sono
differenziati, un cambiamento di fornitore può comportare per il cliente
significativi costi di cambiamento (switching costs): ciò indebolisce la
capacità di reazione degli acquirenti.
Anche i concorrenti presenti sul mercato possono rappresentare una
rilevante forza di contrasto nei confronti dell’eventuale esercizio del potere
di mercato da parte dell’impresa risultante dalla concentrazione. In molti
casi, può inoltre essere rilevante il countervailing power esercitato anche da
potenziali entranti (tipicamente imprese attive in mercati contigui sotto il
profilo delle tecnologie e/o dei prodotti) i quali, osservando l’aumento dei
prezzi determinato dall’impresa post-merger, potrebbero decidere di entrare
sul mercato per conquistare la porzione di domanda non disposta a pagare
l’aumento dei prezzi.
Per costituire un valido limite all’operare dell’impresa risultante dalla
concentrazione, la minaccia di entrata deve in ogni caso essere probabile,
tempestiva, e in grado di esplicare un sufficiente effetto sui prezzi:116
esaminiamo queste tre condizioni.
La probabilità di entrata è tanto maggiore quanto più è elevato il profitto
che il nuovo operatore può attendersi entrando sul mercato rilevante. Esso
dipende dalle caratteristiche del mercato e dalla reazione che il potenziale
entrante può attendersi da parte dell’impresa post-merger. Un mercato può
poi presentare, come abbiamo visto, barriere all’entrata per diversi
116
La definizione di queste tre condizioni, contenute originariamente nelle già citate U.S.
Merger Guidelines, è stata fatta propria dalla Commissione nelle Linee Guida sulle
concentrazioni orizzontali (cfr., in particolare, §§ 69-75).
131
motivi: 117 ostacoli normativi che limitano il numero dei partecipanti al
mercato; caratteristiche tecnologiche che rendono importanti le economie di
scala, e dunque consentono di entrare sul mercato soltanto realizzando
impianti aventi grande capacità produttiva (che richiedono nella maggior
parte dei casi tempi e costi significativi di realizzazione); ovvero vantaggi in
capo alle imprese già insediate non replicabili da parte dei nuovi entranti.
Questi ultimi possono derivare: dalla disponibilità di infrastrutture essenziali
o di altre infrastrutture (come alcuni canali di distribuzione) le quali, pur
non avendo in carattere di essenzialità in senso stretto, non sono replicabili
dall’entrante in tempi ragionevoli; dall’accesso a risorse naturali scarse o a
tecnologia particolarmente rilevanti; dall’accumulazione di rilevanti
investimenti in ricerca e sviluppo o pubblicitari; dall’esperienza o
reputazione consolidate; dall’elevata fedeltà dei consumatori al marchio.
I medesimi fattori possono evidentemente influenzare anche la tempestività
dei processi di entrata: la minaccia di entrata è in grado di avere un impatto
effettivo sul comportamento dell’impresa risultante dalla concentrazione
solo se l’entrata sul mercato da parte di nuovi concorrenti può verificarsi in
un periodo di tempo ragionevolmente breve (negli Stati Uniti e in Europa
viene solitamente considerato un orizzonte biennale).
Infine, l’entrata deve avere caratteristiche tali da risultare sufficiente a
limitare o annullare gli effetti anticoncorrenziali del potenziale esercizio del
potere di mercato; l’entrante potenziale dovrà avere dunque una scala
produttiva adeguata a contrastare l’impresa post-merger, ed essere in grado
di offrire prodotti che la clientela consideri come sufficientemente
sostituibili a quelli dell’impresa in questione.
Vediamo ora l’applicazione dei concetti sopra espressi in un caso
interessante di valutazione antitrust di un’operazione di concentrazione tra
due produttori italiani di latte fresco, Granarolo e Centrale del Latte di
Vicenza.
117
Sulla nozione di barriere all’entrata si veda, ad esempio, Carlton-Perloff [2005], cap. 3.
132
Il caso Granarolo/Centrale del Latte di Vicenza
Nel 2001, Granarolo, produttore di latte, notificava all’Autorità italiana l’intenzione
di acquistare il 100% della Centrale del Latte di Vicenza.
Per l’Autorità, il mercato rilevante del prodotto era costituito dal latte fresco,
separato da quello del latte a lunga conservazione, in ragione delle differenti qualità
organolettiche e nutrizionali del prodotto; il mercato geografico rilevante era quello
della Regione Veneto. Tale mercato era caratterizzato da una sostanziale omogeneità
del prodotto venduto, da un andamento stagnante della domanda nel tempo, nonché
dalla presenza di barriere all’entrata, dovute alla necessità di disporre di un impianto
produttivo all’interno del mercato, a causa della deperibilità del prodotto.
In tale mercato rilevante erano presenti due operatori nazionali (Granarolo e
Parmalat), mentre tutti gli altri operatori erano locali (Tavola 1). Gli operatori
nazionali possedevano maggiore potere di mercato (infatti, le loro quote di mercato
in valore erano superiori a quelle in volume). Inoltre, gli operatori locali non erano
in grado di competere aggressivamente con le strategie commerciali di Granarolo e
Parmalat.
Tavola 1. Principali quote di mercato del latte fresco in Veneto, 2000
Parmalat
Granarolo
Lattebusche
Centrale del Latte di Vicenza
Latterie Soligo
Fatturato (%)
30-33%
15-18%
11-14%
9-12%
8-11%
Volumi (%)
29-32%
14-17%
11-14%
9-12%
8-11%
Secondo l’Autorità, tale concentrazione avrebbe avuto effetti concorrenziali
negativi, sia unilaterali che coordinati:
- per quanto riguarda gli effetti unilaterali, essa avrebbe ridimensionato la
concorrenza effettiva sul mercato, facendo scomparire uno tra i più grandi operatori
locali, e rafforzando un operatore nazionale (Granarolo, che sarebbe passato al 2528%), nei confronti del suo principale concorrente (Parmalat). Inoltre, la somma
delle quote dei due operatori nazionali sarebbe arrivata al 59%;
- per quanto riguarda gli effetti coordinati, dal momento che i due operatori
nazionali perseguivano simili strategie di crescita ed erano presenti nelle stesse
regioni italiane, l’avvicinamento delle loro quote di mercato poteva costituire un
incentivo a colludere tacitamente.
L’operazione è stata quindi vietata.
AGCM, Procedimento C 4502, 2001.
133
10.4 Potenziali effetti verticali
Una concentrazione orizzontale può avere significativi effetti verticali, nella
misura in cui crea o rafforza il potere di mercato dell'entità derivante dalla
fusione come acquirente di input dai fornitori, e ove essa potrebbe ora essere
in grado di ottenere prezzi più bassi di quelli che prevarrebbero su un
mercato competitivo 118. Naturalmente, non è detto che ciò sia negativo sotto
il profilo del benessere sociale: se i mercati a monte non sono
sufficientemente competitivi, l’aumento del potere di mercato dell’impresa
post-merger come acquirente potrebbe essere positivo, riequilibrando il
potere di mercato altrui.
In altri casi, invece, l’impresa risultante dalla concentrazione potrebbe
utilizzare il suo potere di mercato anche per ostacolare l’accesso ad alcuni
input essenziali da parte dei suoi concorrenti. In pratica, gli effetti verticali
possono risultare rilevanti quando la concentrazione crea un sensibile
squilibrio tra la dimensione dell’acquirente dopo la fusione e quella dei
venditori nel mercato a valle.
Vediamo, a questo proposito, il caso europeo NewsCorp/Telepiù, che ha
autorizzato la concentrazione che ha portato alla nascita di Sky Italia.
L’accesso a inputs fondamentali da parte di concorrenti quale garanzia di
mantenimento di un adeguato livello di concorrenza: il caso
NewsCorp/Telepiù
Nel 2002, NewsCorp annunciava che avrebbe acquisito il controllo dell’insieme
delle televisioni a pagamento italiane Telepiù S.p.A. e Stream S.p.A., dando vita
ad un’unica piattaforma satellitare per la diffusione di programmi televisivi a
pagamento, cioè Sky Italia. L’operazione avrebbe creato un quasi monopolio nel
mercato italiano della televisione a pagamento.
Per la Commissione la priorità fondamentale era quella di lasciare ‘aperto’ alla
concorrenza il mercato italiano dei servizi di televisione a pagamento. In altri
termini, le attività della nuova entità avrebbero dovuto essere esposte alla
concorrenza degli operatori via cavo, degli operatori digitali terrestri, di altri
canali televisivi satellitari. Era quindi indispensabile rendere accessibili i film di
grande richiamo, le partite di calcio e altri contenuti premium, in quanto sono
proprio questi contenuti a indurre i telespettatori a sottoscrivere un abbonamento
pay-TV.
118
L’impresa godrà, in altre parole di un potere di monopolio come acquirente, o di un
potere di monopsonio.
134
Pertanto, la Commissione autorizzava l’operazione solo dopo che NewsCorp si era
obbligata, per nove anni (fino al 31 dicembre 2011):
(i) a rinunciare ai diritti esclusivi relativi ai contenuti premium per la
trasmissione non satellitare: gli operatori via cavo, DTT e Internet potranno
così acquisire i contenuti direttamente dai proprietari dei diritti quali
produttori cinematografici, club calcistici, altri proprietari di diritti sportivi;
(ii) a vendere i propri contenuti premium attraverso una “offerta all’ingrosso”
basata sul cosiddetto principio del “retail minus” (prezzo all’utente meno una
determinata percentuale);
(iii) a non acquistare solo diritti di prima visione di film di grande richiamo,
impedendo nel contempo a concorrenti potenziali di acquistare diritti di
seconda visione.
Caso M.2876, decisione della Commissione del 2 aprile 2003, NewsCorp/Telepiù.
10.5 Effetti di efficienza
Le imprese effettuano operazioni di concentrazione poiché si attendono da
esse effetti positivi, tipicamente sotto il profilo dell’efficienza. Questi effetti
sono in genere effetti privati, nel senso che di essi beneficiano le imprese in
questione. In alcuni casi, peraltro, è ragionevolmente ipotizzabile che tali
effetti positivi possano essere traslati sui consumatori: essi dovrebbero
dunque essere presi in qualche misura in considerazione nella valutazione
dei probabili effetti di una concentrazione.
Per chiarire questo punto, consideriamo il caso di un’impresa che, prima di
realizzare un’acquisizione, vende una quantità pari a Q1 al prezzo
concorrenziale P1, che eguaglia il suo costo di produzione C1. In seguito
all’acquisizione, l’impresa è in grado di produrre a un costo più basso pari a
C2, ma nel contempo acquisisce potere di mercato ed è dunque in grado di
ridurre la quantità venduta fino a Q2, spuntando un prezzo pari a P2
superiore al prezzo concorrenziale. Nella Figura seguente, il triangolo A1
rappresenta la “perdita secca” per la collettività che deriva, come abbiamo
visto in precedenza, dall’aumento del potere di mercato. D’altro lato, i costi
totali necessari per la produzione del quantitativo Q2 sono diminuiti
sensibilmente grazie all’aumento di efficienza, e così le risorse consumate
per la produzione del bene si sono ridotte di un ammontare pari all’area
rettangolare tratteggiata A2. In questo caso, dovremo dunque concludere
che, nel complesso, la collettività ha tratto beneficio dalla concentrazione,
poiché gli effetti di efficienza hanno più che compensato la perdita di
benessere derivante all’esercizio dell’aumentato potere di mercato.
135
Figura 10.1 – Perdite di benessere ed effetti di efficienza
Questa conclusione ha, a prima vista, una validità alquanto generale: dato
che il miglioramento di benessere è rappresentato da un rettangolo e la
perdita di benessere da un triangolo, sono relativamente rari i casi in cui la
differenza algebrica tra queste componenti può dare un risultato negativo.
Muovendo da questo presupposto, si potrebbe essere tentati di concluder che
quasi tutte le concentrazioni andrebbero autorizzate. Ma per giungere a una
tale decisione, un’autorità antitrust dovrebbe accertarsi che le seguenti
condizioni siano cumulativamente presenti, vale a dire che i miglioramenti
di efficienza:
(i) saranno effettivamente traslati sui consumatori (diversamente,
l’impresa post-merger verrebbe a godere, privatamente, dei frutti sia
dell’aumento del proprio potere di mercato che del miglioramento
dell’efficienza: il saldo netto per il benessere dei consumatori sarebbe in
questo caso certamente negativo),
(ii) possono essere ottenuti soltanto attraverso la concentrazione e non
anche tramite altre vie (e dunque senza l’aumento dei prezzi che
discende dalla concentrazione) e
(iii) e siano verificabili e dimostrati in concreto dalle imprese che
partecipano alla concentrazione.
In particolare, la probabilità che gli incrementi di efficienza vengano
effettivamente traslati sui consumatori dipende da due fattori principali: il
tipo di impatto che essi hanno sui costi e la struttura di mercato.
136
Infatti, come abbiamo visto nel Capitolo 1, è il costo marginale a guidare
l’impresa nella sua scelta del livello di produzione, mentre è la differenza tra
costo medio e prezzo di mercato a determinare il margine di profitto. Un
incremento di efficienza molto frequente nelle concentrazioni, vale a dire la
riduzione dei costi fissi ottenuta tramite la riduzione dei costi generali
derivante dall’eliminazione delle strutture che risultano duplicate dopo la
concentrazione, riduce i costi medi ma non necessariamente i costi
marginali, e non dà quindi particolari garanzie di avere effetti benefici per la
collettività.
Al contrario, un aumento di efficienza che riduca i costi marginali dovrebbe
spingere l’impresa ad aumentare la produzione, e questo effetto potrebbe
essere socialmente positivo, a patto che il livello di concorrenza sul mercato
risulti sufficiente a generare una riduzione dei prezzi: se non lo è, l’impresa
riuscirebbe a tenere a suo proprio esclusivo beneficio i guadagni di
efficienza conseguiti.
Concludendo, l’effettiva rilevanza dei miglioramenti
di efficienza
all’interno della valutazione antitrust di una concentrazione non dipende
tanto dalla loro portata, quanto dalla possibilità che essi portino a una
riduzione dei costi marginali, e dall’esistenza di una concorrenza effettiva
sul mercato anche dopo la concentrazione, dato che evidentemente
l’incentivo a trasferire ai consumatori gli incrementi di efficienza sussiste
solo quando vi sia una pressione concorrenziale da parte dei concorrenti
attuali o potenziali. È quindi altamente improbabile che una concentrazione
che dia luogo a una posizione di mercato prossima al monopolio, o che porti
a un livello molto elevato di potere di mercato, possa essere dichiarata
compatibile con le regole di concorrenza grazie agli effetti di efficienza.
10.6 Rimedi
Alla fine della sua valutazione l'autorità antitrust può: (i) autorizzare la
concentrazione; (ii) proibire la concentrazione; (iii) autorizzarla,
subordinandola a determinate misure correttive, normalmente definite come
rimedi.
Questi possono essere strutturali o comportamentali, e sostanzialmente
cercano di diminuire le distorsioni concorrenziali generate dalla
concentrazione, riferendosi sia agli effetti unilaterali che a quelli coordinati.
Un rimedio comune per gli effetti unilaterali e la riduzione della capacità
produttiva dell'impresa dopo la fusione attraverso la vendita di una
controllata, o di una business unit. Per diminuire il rischio di effetti
coordinati, le autorità antitrust potrebbero accettare la vendita di quote
azionarie di minoranza di concorrenti possedute dall'impresa post fusione.
137
Questi sono tutti esempi di rimedi strutturali. Meno frequentemente, anche
rimedi comportamentali possono essere accettati (le autorità antitrust sono
riluttanti ad accettarli, dal momento che essi implicano una forma di
monitoraggio, che riduce le risorse che le autorità stesse possono dedicare
alla applicazione delle politiche antitrust). Un tipico rimedio
comportamentale, quando le imprese coinvolte possiedono infrastrutture
essenziali, è costituito dall'obbligo di fornitura a terze parti di diritti di
accesso all'infrastruttura posseduta dalla entità derivante dalla fusione.
Un caso interessante, a questo proposito, è dato dalla autorizzazione, con
rimedi, alla concentrazione tra Wind e Infostrada notificata all’Autorità
italiana nel 2001.
Il caso Wind/Infostrada (Enel/France Telecom/New Wind)
Nel 2000, Wind – allora società telefonica del gruppo Enel – acquisiva Infostrada,
altro operatore di telecomunicazioni. Nel valutare l’operazione di concentrazione,
l’Autorità italiana rilevava problemi non nel mercato delle telecomunicazioni, ma
nel mercato elettrico, ed in particolare nel mercato italiano della fornitura di energia
ai grandi clienti industriali. Infatti, in tale mercato, Enel era all’epoca largamente
dominante e stava perseguendo una strategia di business che l’avrebbe portata a
diventare una multiutility, in grado di fornire una molteplicità di servizi (energia,
gas, acqua, telecomunicazioni): secondo l’Autorità, i vantaggi competitivi derivanti
da un’offerta combinata di servizi consistevano nella riduzione di una serie di costi
operativi ed amministrativi (un’unica bolletta, un’unica lettura, meno personale nei
call center), la possibilità di profilare la clientela nonché la possibilità di sfruttare
un marchio molto conosciuto.
Pertanto, gli effetti in capo ad Enel dell’acquisizione di Infostrada sarebbero stati
tali per cui Enel avrebbe avuto un maggior numero di clienti business telefonici e
Internet che contemporaneamente erano clienti elettrici. Pertanto, il 25%-45% del
totale dei grandi clienti industriali sarebbe stato contemporaneamente cliente di
Enel, la quale avrebbe potuto fidelizzare la clientela e raggiungere economie di
scala e di gamma non duplicabili.
Ciò avrebbe rafforzato la posizione dominante di Enel nel mercato elettrico: ma
Enel era dominante anche nella produzione di energia elettrica. Pertanto, la
combinazione di queste due posizioni dominanti avrebbe permesso a Enel di fissare
il prezzo dell’energia all’ingrosso a prezzi non concorrenziali e di attuare politiche
di prezzo indipendenti nel mercato della fornitura. Da ciò sarebbe conseguito un
effetto escludente nei confronti dei concorrenti e una riduzione durevole e
sostanziale del livello concorrenziale del mercato.
Al fine di autorizzare la concentrazione, l’Autorità imponeva quindi ad Enel la
cessione di varie centrali elettriche. Ma la Decisione dell’Autorità veniva annullata
dal Consiglio di Stato, in quanto il rimedio strutturale imposto non era relativo al
mercato rilevante, e non risultava proporzionato rispetto ai possibili effetti
anticoncorrenziali della concentrazione.
AGCM, Procedimento C 4438, 2001.
138
Parte III - Posizioni dominanti e politiche di
regolazione
139
11. POSIZIONI DOMINANTI E REGOLAZIONE DEI PREZZI
FINALI
Come abbiamo visto, l’esistenza di imprese che godano di una posizione
dominante genera market failures, ed una riduzione del benessere
collettivo.
Per risolvere i problemi generati da tali situazioni, a volte possiamo basarci
sulle normative antitrust. Dopo tutto, se il monopolista alza i prezzi,
potremo cercare di perseguirlo per abuso di posizione dominante. Poi, i
consumatori che hanno pagato un prezzo troppo elevato, potrebbero a loro
volta intentare azioni civili contro il monopolista, ripetendo il danno da essi
subito. Ma questa soluzione è efficace nei casi in cui i comportamenti
abusivi siano relativamente rari, dato che le autorità antitrust non hanno
risorse illimitate. Nei casi in cui, per motivi che discuteremo tra breve, le
posizioni dominanti siano molto solide, e non sia ragionevole attendersi che
esse vengano progressivamente erose dalla concorrenza, le autorità antitrust
dovrebbero continuamente vigilare, con un rilevante dispendio di risorse.
Inoltre, - come abbiamo visto nel Capitolo 3 - non è ragionevole attendersi
che gli agenti economici che siano danneggiati da azioni illecite instaurino
azioni per danno con frequenza sufficiente ad ottenere adeguati effetti
dissuasivi nei confronti di chi sia propenso ad adottare azioni del genere.
Per questi motivi, è spesso opportuno prevedere interventi normativi ex
ante, che dettino regole di comportamento, più o meno dettagliate, alle
imprese in posizione dominante: questa, naturalmente, è una delle più
frequenti motivazioni per l’esistenza di prezzi amministrati.
Prima di proseguire, è importante sottolineare come il monopolista,
nell'esempio che abbiamo sopra sviluppato, non cercherà soltanto di
aumentare il livello dei prezzi in un dato momento del tempo, ma cercherà
probabilmente anche di influenzare la dinamica dei prezzi, facendoli ad
esempio crescere più velocemente dell'inflazione complessiva del sistema
economico. Inoltre, la posizione dominante del monopolista potrebbe essere
utilizzata non tanto, o non soltanto, nei confronti dei prezzi, ma anche in
quelli della qualità del prodotto. La regolazione del monopolista dovrà
dunque occuparsi sia del livello che della dinamica dei prezzi, sia della
qualità, e in questa lezione ci occuperemo di tutti e tre questi aspetti.
Naturalmente, come qualsiasi altra azione umana, queste attività di
regolazione possono portare benefici, ma generano anche dei costi: in
questa lezione ci occupiamo dei primi, e discutiamo specificamente quali
regole possano essere tracciate per evitare che un’azienda in posizione
dominante restringa la produzione ed alzi i prezzi. Nella lezione seguente ci
occuperemo invece dei costi della regolazione, illustrando in particolare due
140
problemi economici molto importanti: il problema di agenzia, e il ruolo dei
gruppi di interesse.
11.1 Regolazione del livello dei prezzi finali
Supponiamo che in un particolare mercato dell'economia vi sia per qualche
motivo, che non ci interessa approfondire, un monopolio. Come mostra il
primo teorema fondamentale dell'economia del benessere, l'esistenza di
questo fallimento del mercato diminuisce il benessere dei consumatori, e ciò
può fornire una motivazione ragionevole per intervenire sul comportamento
del monopolista, in modo da evitare che questi si comporti come la teoria
economica prevede, riducendo le quantità ed aumentando i prezzi: questa
tipologia di interventi è il primo capitolo di quella che definiamo
regolazione del monopolio, ed in particolare regolazione tariffaria (la
tariffa è un prezzo massimo, fissato autoritativamente).
Consideriamo un caso particolarmente semplice (Figura 11.1), in cui i costi
medi sono costanti, e dunque la curva dei costi medi è piatta e coincide con
quella dei costi marginali. Il modo più semplice di intervenire in questa
situazione, per evitare che il monopolista aumenti il prezzo fino a PM, è
quello di imporgli una tariffa che approssimi il prezzo che prevarrebbe se il
mercato fosse pienamente competitivo, ovvero PC: in questo modo, il
triangolo ombreggiato che rappresentava il benessere dei consumatori, che
sarebbe stato dissipato dal monopolista, viene preservato.
Figura 11.1 – Regolazione di un monopolista
Prezzo
Domanda
PM
Prezzo = costo marginale
= costo medio
PC
Ricavo
marginale
Quantità
141
La questione è più complessa in quei casi in cui la produzione presenta
sensibili economie di scala, e quindi ove il costo medio di produzione
scende al crescere della dimensione produttiva. I settori nei quali vi sono
rilevanti infrastrutture, come reti energetiche, di telecomunicazione,
ferroviarie, gasdotti, sono casi tipici in cui le economie di scala sono
importantissime.
Considerate ad esempio una rete di distribuzione gas, che trasporti quantità
crescenti di metano. Se la rete trasporta poco metano, il costo medio che
verrà sostenuto per il trasporto sarà enorme, perché tutti i costi fissi della
rete (tra cui quelli di ammortamento, in casi del genere molto elevati)
saranno ‘spalmati’ su un piccolo quantitativo trasportato. Ma se la rete
trasporta quantitativi crescenti, il costo medio di trasporto di un metro cubo
scenderà continuamente e continuerà a scendere (la rete è sempre quella,
indipendentemente dalla quantità di metano che essa trasporta), almeno fino
a quando essa avrà capacità di trasporto disponibile: ci riferiamo a questi
casi con il termine di monopolio naturale.
In casi del genere, come insegna la microeconomia elementare, la curva dei
costi medi e marginali non coincidono, ma hanno la forma presentata nella
Figura 11.2.
Figura 11.2 – Regolazione di un monopolio naturale
prezzi
Domanda
costo medio
costo marginale
quantità
In questo caso, chi deve fissare il prezzo amministrato (chiamiamolo
semplicemente regolatore) dovrebbe porlo pari al costo marginale, poiché è
questo quanto accadrebbe, almeno tendenzialmente, in un mercato
concorrenziale, ma non è in generale per nulla facile capire quali siano – in
pratica - i costi marginali: questi sono una nozione astratta (nessuna impresa
è particolarmente interessata nel calcolare quanto costerebbe aumentare la
142
propria produzione di una quantità infinitesima). Anche la nozione di costo
nella contabilità aziendale ad essi più vicina (i costi variabili unitari) è in
genere molto difficile da misurare se non si è all'interno dell'azienda:
guardando il bilancio di un produttore di cemento, posso infatti capire con
relativa facilità quanto gli costi in media produrre una tonnellata di cemento,
ma mi è del tutto impossibile calcolare quanto gli costi produrre una
tonnellata in più di cemento rispetto a quanto non stia già facendo. Questo
in genere lo sa soltanto il cementiere. In altre parole, vi sono rilevanti
asimmetrie informative tra il regolatore e l'azienda regolata: come
vedremo, questo è un problema di carattere generale, su cui avremo ancora
da dire.
Inoltre, come risulta evidente dalla figura, i prezzi fissati pari al costo
marginale sarebbero inferiori al costo medio, e quindi l’impresa dominante
registrerebbe una perdita. Poiché questa risulterebbe dal fatto che il costo
marginale non comprende i costi fissi, dovremmo quindi stabilire modalità –
certamente complesse – per aumentare il prezzo in modo da consentire la
loro copertura.
È pertanto in pratica assai frequente che il regolatore fissi direttamente i
prezzi con riferimento ai costi medi, senza cercare di valutare i costi
marginali. Naturalmente, come vediamo chiaramente dalla Figura 8.2 questa
non è una regola di decisione ottimale, perché i consumatori preferirebbero
pagare un prezzo ancora inferiore, pari al costo marginale, e pagando il
costo medio rinunciano al piccolo triangolo di surplus ombreggiato in
grigio: tuttavia questa è spesso l'unica soluzione concretamente praticabile,
ed è quella in pratica utilizzata in molti settori, dall'energia elettrica al gas,
dal trasporto ferroviario al servizio postale.
Anche avendo deciso di ricorrere ai costi medi, anziché ai costi marginali, la
vita della regolatore non è però facile. Se infatti il management dell'azienda
sottoposta a regolazione sa che le tariffe vengono fissate con riferimento ai
costi medi, esso non avrà un particolare incentivo a contenere questi costi:
come ha scritto efficacemente John Stigler “the best of monopoly profits is
quiet life”. Egli potrà dunque facilmente incorrere in costi non necessari (in
America si parla in questi casi di goldplating), oppure non opporsi con
particolare vigore a richieste di aumenti dei prezzi dei fornitori o dei salari
dei dipendenti: le aziende sottoposte a regolazione tariffaria hanno quindi,
nella maggior parte dei casi, problemi di efficienza.
Questo punto, che non ha ricevuto fino a tempi recenti, come vedremo nel
prossimo paragrafo, un'attenzione particolare, è realtà molto importante per
il benessere collettivo: come mostra la Figura 11.3, dove torniamo per
semplicità espositiva al caso elementare della curva dei costi piatta che
abbiamo già utilizzato nella Figura 11.1.
143
Figura 11.3 : Il monopolista regolato inefficiente
Prezzi
pM
Livello inefficiente
dei costi medi
Livello efficiente
dei costi medi
pC
Domanda
Ricavo marginale
Quantità
Il monopolista non regolato, come abbiamo già discusso, praticherebbe un
prezzo pari a pM, e la regolazione, se non ci fossero problemi di efficienza,
riuscirebbe ad imporgli un prezzo pari a quello concorrenziale pC. Se egli
persegue, tenendo razionalmente conto del meccanismo di regolazione che
gli è imposto, una quiet life, i suoi costi saranno però superiori a quelli di
una corrispondente azienda efficiente, ed il regolatore non riuscirà quindi a
far sì che egli pratichi ai consumatori il prezzo pC, bensì – come vediamo
dal grafico – un prezzo ben più elevato.
Il controllo dell'efficienza dell'azienda regolata è quindi un problema
cruciale da risolvere, se si vuole evitare che i consumatori – invece di
finanziare i sovra-profitti del monopolista – ne finanzino comunque le
inefficienze.
La nostra discussione, fino a questo punto, è stata condotta supponendo che
l'azienda regolata produca un solo prodotto, ma in pratica naturalmente
questo è un fatto assai raro: poste, ferrovie, aziende elettriche e del gas,
producono molti servizi diversi, sotto il profilo della tipologia stessa del
servizio (lettere ordinarie e raccomandate) e sotto quello della clientela cui il
servizio è rivolto (trasporto passeggeri a breve distanza, trasporto passeggeri
a lunga distanza, trasporto merci).
Per questo, la regolazione tariffaria delle aziende in posizione dominante
deve risolvere un secondo problema molto importante oltre a quello del
livello della tariffa, ovvero quello della struttura della tariffa.
144
Questo problema è suscettibile di una soluzione economica relativamente
semplice: supponiamo che il monopolista regolato (le poste, per esempio)
produca due soli servizi, corrispondenza ordinaria e pacchi. Quanto abbiamo
sopra detto sulla regolazione tariffaria del monopolista monoprodotto indica
immediatamente come il prezzo di ciascun servizio dovrebbe essere uguale
al costo medio che il monopolista sostiene per fornire quel servizio: se il
prezzo del servizio di corrispondenza (ad esempio) fosse inferiore ai costi, e
quello dei pacchi superiore, i clienti del servizio pacchi finanzierebbero, in
parte, il servizio di corrispondenza, ed avremmo un classico caso di sussidi
incrociati: come vedremo nel prossimo capitolo, questi casi sono molto
frequenti, ed hanno una spiegazione molto interessante.
Il principio che abbiamo appena illustrato ci consente anche di chiarire un
tipo particolare di tariffazione che è frequente in molti settori, che non
necessariamente vedono la presenza di un monopolista: le tariffe di
picco 119.
Figura 11.4 – La curva di durata della capacità di trasporto di
elettricità in Italia
119
Come vedremo più oltre, questo problema si presenta anche quando si debba valutare
l’eventuale rilevanza antitrust dell’offerta, da parte di un’impresa in posizione dominante,
di prezzi diversi per beni o servizi tra loro (almeno in apparenza) similari.
145
Consideriamo il caso della rete elettrica nazionale, che deve assicurare il
trasporto, in ogni istante, dell’energia richiesta da imprese e famiglie. I costi
di questa rete sono in larga misura costituiti dagli ammortamenti e dagli
interventi di manutenzione, che evidentemente sono proporzionali alla
dimensione della rete stessa: come fissare i prezzi del servizio di trasporto,
in un caso del genere? Per rispondere, dobbiamo capire come funziona la
domanda di questi servizi. La Figura 11.4 mostra come vari in un anno la
capacità di trasporto richiesta in Italia (sull’asse verticale, in MegaWatt, o
MW). Come possiamo vedere, la capacità massima richiesta (circa 55.000
MW), o capacità di picco, è in realtà richiesta per pochissime ore, meno –
nell’anno – di 100, tipicamente in corrispondenza delle giornate più fredde
o, per l’aumento nell’uso degli impianti di condizionamento, in quelle più
calde; al contrario, la domanda di capacità fuori picco è molto più bassa, e
risulta pari a circa 20.000 MW per tutto l’anno 120.
Per semplificare il problema di come fissare il prezzo del servizio di
trasporto, supponiamo che la rete elettrica offra solo due servizi, ovvero il
trasporto in picco e il trasporto fuori picco. Supponiamo che inizialmente la
rete decida di far pagare il trasporto esattamente lo stesso prezzo, in picco e
fuori picco, facendo quindi sì che i clienti che chiedono il trasporto fuori
picco (chiamiamole, per semplicità, le famiglie) sussidino quelli che lo
chiedono in picco (per semplicità, le imprese), dato che evidentemente la
rete è stata dimensionata proprio per sopportare il carico richiesto da questi
ultimi, e sono essi che dovrebbero sostenere i costi (ad esempio quelli di
ammortamento) della rete così dimensionata.
In queste condizioni, è molto probabile che le imprese aumentino la loro
domanda di trasporto di elettricità in picco, visto che il prezzo di questo
servizio è molto basso, e presto la capacità della rete dovrà essere
aumentata, mentre le famiglie ridurranno, nei limiti del possibile, la loro
domanda di trasporto off peak. L’applicazione di un prezzo unico sarà
quindi inefficiente perché stimolerà la domanda di picco (quando la rete è
praticamente satura), mentre scoraggia la domanda fuor di picco (quando la
rete è sotto-utilizzata). In realtà, l'unico modo di fissare i prezzi in modo
efficiente in un caso del genere sarà quello di discriminare i prezzi,
facendo pagare alle imprese tutti i costi (di ammortamento e di
manutenzione, e così via) che la rete elettrica ha dovuto sostenere per
garantire la capacità necessaria a coloro che chiedono servizi di trasporto
nelle ore di picco, e facendo invece pagare alle famiglie prezzi prossimi allo
zero, poiché la loro domanda di servizi di trasporto non genera costi
apprezzabili.
120
Le ore in un anno sono circa 8.800.
146
11.2 Regolazione della dinamica dei prezzi finali
Supponendo di aver risolto i problemi, non facili come abbiamo visto, della
fissazione del livello dei prezzi di un'azienda sottoposta a regolazione
tariffaria, in tutti i sistemi di regolazione si pone il problema di come
determinare la dinamica dei prezzi nel tempo: i costi dell'azienda regolata
variano infatti nel tempo, per due ordini altri motivi principali. Per cause
esogene all'impresa (l'aumento dei prezzi nell'economia provoca richieste di
aumenti salariali da parte dei dipendenti, o aumentano i prezzi dell'energia e
delle materie prime), e per cause endogene all'impresa (l'introduzione di
nuove tecnologie può ridurre i costi di produzione, mentre una gestione
inefficiente dell'impresa può farli aumentare; il management può d'altra
parte decidere di aumentare o ridurre alcune spese totalmente discrezionali,
come la pubblicità, determinando per questa via fluttuazioni nei costi medi
sostenuti dall'impresa). Per questi motivi, vi è sempre una dialettica
complicata tra azienda regolata ed autorità di regolazione, che può
degenerare in una costante discussione circa l'ammissibilità, o meno, di
particolari voci di costo, o l’efficacia delle scelte del management.
Una soluzione frequentemente utilizzata per evitare situazioni di questo
genere è quella di consentire all'azienda regolata di recuperare i costi da essa
sostenuti, e di remunerare, in qualche misura ritenuta "equa", il capitale da
essa investito.
Questo sistema, detto negli Stati Uniti rate-of-return regulation, è però
frequentemente inefficiente, perché l'azienda regolata non ha alcun
incentivo razionale ad aumentare, o anche semplicemente a mantenere, il
proprio livello di efficienza: proprio come abbiamo visto discutendo i
problemi nella fissazione del livello tariffario, la perenne tentazione di
vivere una quiet life porta il monopolista, presto o tardi, ed in misura
maggiore o minore, a lasciar lievitare i propri costi, dato che esso non solo
gode della sicurezza di vederli coperti dalle tariffe, ma anche della certezza
che, in ogni caso, gli verrà riconosciuto un rendimento adeguato del capitale
investito.
Per questo, a partire dagli anni 80, in molti settori sono stati adottati
meccanismi tariffari incentivanti, nei quali l’evoluzione temporale della
tariffa è determinata da meccanismi di price cap: la tariffa cresce, ogni
anno, di quanto cresce l’inflazione dell’economia, meno un fattore X che
rappresenta il tasso di crescita annuale dell’efficienza che il Regolatore si
aspetta che sia conseguito dall’impresa regolata. Questa, se riesce ad
aumentare l’efficienza più di X avrà i costi unitari che crescono meno della
tariffa, e quindi i suoi utili cresceranno. In caso contrario, gli utili
scenderanno, e pertanto l'azienda regolata avrà un incentivo razionale a
conseguire guadagni di efficienza almeno pari ad X.
147
In sistemi di questo tipo, il fattore X viene fissato generalmente con cadenza
almeno triennale, in modo da assicurare che l'impresa regolata possa
effettivamente godere dei frutti di aumenti di efficienza particolarmente
elevati, da essa conseguibili: se infatti il fattore X venisse fissato con
cadenza più ravvicinata, ad esempio annuale, l'effetto incentivante
sparirebbe immediatamente, poiché l'azienda saprebbe che qualunque
aumento di efficienza le sarebbe rapidamente sottratto l'anno successivo,
aumentando opportunamente il fattore X.
11.3 Regolazione della qualità
Mentre, come abbiamo discusso, un monopolista tenderà in generale a
ridurre le quantità e ad aumentare i prezzi, non è possibile fare previsioni
altrettanto chiare per quanto riguarda il livello di qualità che sarà prescelto
dal monopolista. E’ possibile dimostrare, ma qui non lo faremo, che un
monopolista potrà offrire o una qualità troppo alta o una qualità troppo
bassa, a seconda della specifica domanda di qualità della sua clientela, e dei
costi di fornitura dei diversi livelli di qualità.
Nel caso però il monopolista venga regolato con un meccanismo di price
cap, che come abbiamo appena visto è per molti versi uno schema efficiente
di regolazione, è possibile affermare con certezza che il monopolista
razionale fornirà livelli di qualità troppo bassi: se infatti esso viene regolato
soltanto con riferimento ai prezzi, una volta che il regolatore fissa il fattore
X, il monopolista avrà una motivazione razionale per aumentare la sua
efficienza almeno ad un tasso annuale pari ad X, ed il perseguimento di
questo obbiettivo sarà frequentemente reso più agevole lasciando deteriorare
i livelli qualitativi.
Per questo, è in generale indispensabile prevedere anche meccanismi di
regolazione della qualità negli schemi di price cap. Questi possono
assumere forme diverse, come la fissazione amministrativa di livelli di
qualità minimi, al di sotto dei quali il monopolista viene penalizzato
mediante sanzioni pecuniarie (questo è ad esempio il sistema adottato
nell'energia elettrica e nel gas in Italia).
11.4 Conclusioni
E’necessario sottolineare come, in molti casi, i problemi della regolazione
del monopolio siano molto più complessi di quanto non li abbiamo sopra
rappresentati: nei casi che abbiamo appena citato (elettricità, gas, ferrovie,
ma naturalmente anche nelle telecomunicazioni) non vi sono più monopoli
verticalmente integrati, ovvero aziende monolitiche che assicurano (ad
esempio) dalla produzione al trasporto alla distribuzione di elettricità. Nel
corso degli ultimi venti anni, con un processo che discuteremo parlando di
148
alcuni di questi settori, le attività che presentano caratteri di monopolio sono
state infatti gradatamente separate dalle attività che possono essere svolte da
più operatori economici, in concorrenza tra di loro. Così, la distribuzione di
elettricità è ancora un monopolio, perché è certamente un monopolio
naturale, ma la produzione di elettricità è un'attività che viene svolta tra
diverse imprese generatrici, in concorrenza tra di loro. Queste imprese, per
vendere l'elettricità che producono, devono però accedere alla rete di
distribuzione, le condizioni di accesso alla quale sono perciò fondamentali:
ce ne occuperemo nelle prossime lezioni.
149
12. REGOLAZIONE E CONCORRENZA: IL CONTROLLO DEI
PREZZI DI ACCESSO
12.1 Introduzione
La nostra discussione della regolazione dei prezzi è stata finora condotta
facendo riferimento esclusivamente ai prezzi finali, ovvero a quelli pagati
dalla clientela dell’azienda regolata.
I prezzi finali sono di ovvia rilevanza. In molti settori, tuttavia, sono ormai
molto importanti i prezzi intermedi ai quali un’azienda che possiede o
controlla un’infrastruttura a rete ne offre l’utilizzo ad altri concorrenti,
consentendo loro di accedere alla clientela finale. Si pensi ad esempio al
trasporto ferroviario, o all’energia elettrica e al gas: ciascun concorrente
deve poter accedere alla medesima infrastruttura (rete ferroviaria,
elettrodotti, gasdotti) per poter fornire il proprio servizio alla clientela
finale.
Questo problema non era rilevante fino agli anni Ottanta: storicamente,
infatti, i settori caratterizzati dalla presenza di reti infrastrutturali erano
caratterizzati dalla presenza di imprese verticalmente integrate (si pensi alla
SIP, all’ENEL, oppure alle Poste e alle Ferrovie dello Stato), in genere a
proprietà pubblica, che godevano di un monopolio legale. Progressivamente,
vari fattori indebolivano però questa struttura di mercato:
•
il progresso tecnologico, che in alcuni casi (le telecomunicazioni,
come vedremo) cambiava completamente la struttura dei costi delle
reti, aumentandone enormemente la capacità, e consentendo così che
esse venissero usate da una pluralità di operatori, oppure (le
telecomunicazioni mobili) consentivano di duplicare sostanzialmente
le reti, senza incorrere nei costi tipici di monopolio naturale;
•
ancora il progresso tecnologico, che in casi come l'energia elettrica,
consentivano una gestione della generazione di energia e della sua
trasmissione da parte di operatori diversi, senza incorrere nei
problemi di coordinamento tra produzione domanda di elettricità che
fino a pochi anni prima avrebbero reso una tale gestione separata
estremamente complesso;
•
la generale insoddisfazione degli utilizzatori nei confronti dei livelli
di efficienza e di qualità degli operatori monopolisti verticalmente
integrati;
•
la necessità di ridurre il debito pubblico attraverso progressive
privatizzazioni.
150
Questo complesso di fattori, pur con notevoli differenze da settore a settore,
spingeva comunque questi mercati verso modelli più competitivi,
caratterizzati tipicamente da forme più o meno concentrate di oligopolio.
Con il progressivo sviluppo concorrenziale di questi mercati, si poneva
prepotentemente il problema di come consentire ai concorrenti l'accesso a
tali infrastrutture, che nella maggior parte dei casi continuavano ad essere
delle vere e proprie essential facilities, e ciò poneva problemi complessi di
regolazione delle condizioni di accesso a tali infrastrutture, ed in particolare
dei prezzi di accesso.
Se infatti, come abbiamo visto, la normativa antitrust europea ed italiana
dispone un obbligo di fornitura in questi casi, sarebbe stato certamente poco
efficiente se la politica economica si fosse basata soltanto su tali previsioni
per consentire ai concorrenti l'accesso a queste infrastrutture: sarebbe infatti
stato necessario attendere che si verificasse un rifiuto abusivo di accesso,
per aprire quindi un procedimento, al termine del quale sanzionare
l'operatore dominante. Intervenendo così ex post, certamente però il
concorrente non sarebbe sopravvissuto, e dunque era necessario disporre di
interventi ex ante: diventava quindi fondamentale sviluppare un sistema di
regolazione dei prezzi di accesso alle infrastrutture essenziali.
Quali criteri applicare nella fissazione di tali prezzi? In primo luogo, è
necessario distinguere tra vere e proprie infrastrutture essenziali (i cui prezzi
devono essere orientati ai costi) e infrastrutture non essenziali (il cui prezzo
d’accesso non deve essere regolato); in secondo luogo, come abbiamo visto,
nella determinazione del prezzo si devono bilanciare con attenzione gli
interessi contrapposti dei soggetti che richiedono e che concedono l’accesso.
Da un lato, infatti, prezzi troppo bassi possono incentivare l’entrata sul
mercato dei concorrenti, ma disincentivare la costruzione di infrastrutture
alternative e la manutenzione dell’unica rete esistente; prezzi troppo elevati
possono – al contrario – disincentivare l’entrata sul mercato e diminuire
l’incentivo razionale alla sua manutenzione, al suo ampliamento, ed al suo
sviluppo tecnologico.
Vediamo come tali problemi sono stati affrontati in un caso emblematico: le
telecomunicazioni.
Prima di proseguire con la regolazione dei prezzi di accesso, riteniamo
tuttavia opportuno richiamare brevemente nei prossimi due paragrafi,
rispettivamente, la definizione di monopolio naturale e la evoluzione
tecnologica nel caso delle telecomunicazioni, che ha fatto nascere,
storicamente, il problema della regolazione dei prezzi dell’accesso.
151
12.2 Un caso emblematico: le telecomunicazioni
Il settore europeo delle telecomunicazioni è stato caratterizzato, fino agli
anni Ottanta, da una struttura monopolistica: ad un operatore, solitamente
pubblico anche in virtù degli interessi strategici che si riteneva le
telecomunicazioni rivestissero per la sicurezza nazionale, venivano concessi
diritti esclusivi per la gestione del servizio. I confini del monopolio erano
molto estesi, e giungevano a coprire, oltre a tutti i servizi, anche la fornitura
di apparecchi telefonici.
Un tale assetto di mercato era giustificato, tra l’altro, dalle fondamentali
economie di scala derivanti dalla tecnologia 121: le reti di telecomunicazione
di allora erano costituite da cavi in rame come mezzo di trasmissione, e cioè
un materiale costoso e con capacità trasmissiva non molto elevata, nonché
dalla presenza di tecnologie analogiche per la commutazione, cioè
l’instradamento di una chiamata attraverso la rete. I centralini telefonici
erano costituiti da enormi apparecchiature meccaniche che potevano
tranquillamente occupare molte stanze delle sedi dell’operatore storico.
A quell’epoca, quindi, era chiaro che l’intera rete di telecomunicazioni
fosse un monopolio naturale: erano infatti del tutto evidenti le ingenti
economie di scala, che rendevano economicamente impossibile creare una
seconda rete di telecomunicazioni in concorrenza a quella dell'operatore
storico. Le telecomunicazioni erano quindi un monopolio naturale regolato:
l’unico obiettivo della struttura tariffaria era quello di garantire la copertura
dei costi complessivi dell’operatore, senza riguardo ai prezzi di ciascun
singolo servizio offerto 122.
Nel corso degli anni Ottanta, le telecomunicazioni venivano interessate da
radicali innovazioni tecnologiche: l’introduzione dei cavi a fibra ottica
riduceva (di circa 10.000 volte) i costi della trasmissione a lunga distanza;
quella dei sistemi di commutazione digitale faceva sì che le funzioni degli
enormi centralini elettromeccanici ricordati in precedenza fossero sostituite
da personal computers, con evidenti risparmi di costo (di oltre 10 volte)
anche per questa funzione. La digitalizzazione, inoltre, permetteva di
migliorare significativamente la trasmissione dei dati attraverso la rete
telefonica, espandendo sensibilmente la gamma dei servizi offerti.
121
Oltre a ciò, esso era giustificato anche dalla volontà politica di conseguire un elevato
grado di universalità del servizio telefonico: le telecomunicazioni erano dunque un tipico
merit service. Vedremo questo punto più approfonditamente nel Capitolo 11, parlando di
regolazione del servizio universale.
122
Al contrario, per favorire la diffusione del servizio, spesso il monopolista offriva
volutamente alcuni servizi in perdita (ad esempio, le chiamate urbane), e riequilibrava i
propri costi alzando i prezzi molto sopra ai corrispondenti costi per i servizi rivolti ad utenti
con maggiore capacità di spesa o minore elasticità della domanda rispetto al prezzo (come
le utenze affari), oppure per i servizi a domanda maggiormente rigida (come le chiamate a
lunga distanza, nazionali ed internazionali).
152
Il mutamento tecnologico comportava anche una rivoluzione degli
economics delle telecomunicazioni:
•
con l’introduzione della fibra ottica, il costo di una telefonata non
dipendeva più dalla distanza (si parlò, allora di ‘morte della
distanza’). Pertanto, il costo di una telefonata da Milano a Roma o da
Milano a New York era simile. Ma nella vecchia rete in rame non era
certo così;
•
la fibra ottica e l’utilizzo della tecnologia digitale permettevano una
capacità (e velocità) trasmissiva enormemente più elevata rispetto alle
vecchie reti in rame e alle tecnologie elettromeccaniche.
Con le nuove tecnologie era quindi possibile trasmettere grandi volumi di
traffico su grandi distanze a costi molto bassi: ciò faceva abbassare
enormemente i costi dei servizi a lunga distanza, favoriva una vera
esplosione del traffico dati, ed innescava una crescente "fame di banda" da
parte delle aziende, che iniziarono a richiedere servizi sofisticati per
trasmettere volumi sempre maggiori di dati.
Inoltre, il cambiamento nel livello e nella struttura dei costi non consentiva
più di considerare l’intero settore come un monopolio naturale;
l’eliminazione dei vincoli di capacità permetteva l'offerta di nuovi servizi, e
non vi erano più sufficienti motivazioni tecnologiche o economiche per
impedire l'entrata di nuovi operatori che fossero in grado di fornirli.
Pertanto, la public policy si orientava quindi gradatamente verso la
liberalizzazione dell'entrata e della fornitura di servizi di telecomunicazione,
in particolare per i servizi a lunga distanza 123: sulla scorta di quanto
accaduto negli Stati Uniti 124, in Gran Bretagna si creò un duopolio nel
mercato delle telecomunicazioni a partire dal 1984. In seguito, si avviò
anche a livello comunitario un processo di liberalizzazione dei servizi di
telecomunicazioni, che veniva considerata come una parte fondamentale del
processo di completamento del mercato unico europeo 125.
Una parte fondamentale di questa politica fu l'imposizione agli operatori
storici di un obbligo di fornitura di una rete aperta (Open Network
123
Nelle reti cittadine, infatti, continua a prevalere l’utilizzo delle reti in rame (il filo
telefonico – detto doppino – che ancora oggi entra nella maggior parte delle case italiane è
costituito da questo materiale), e quindi possono sussistere elementi di monopolio naturale.
124
Nel 1982, il monopolista americano AT&T – a seguito di una sentenza - venne
smembrato in sette società (dette Baby Bells), che continuavano a godere di un monopolio
nella telefonia locale (in cui continuava a prevalere il monopolio naturale),e in un operatore
a lunga distanza che avrebbe operato in concorrenza con altri operatori. L'impatto di questo
cambiamento strutturale delle telecomunicazioni americane fu molto profondo: le tariffe del
traffico long distance si ridussero rapidamente, entrarono nuovi operatori, nuovi servizi
vennero offerti, la qualità aumentò sensibilmente.
125
Il quale si sarebbe attuato a partire dal 1992.
153
Provison): per accelerare il dispiegarsi della concorrenza, più che
promuovere lo sviluppo di reti alternative, la cui costruzione avrebbe
richiesto periodi estesi, venne scelto un modello di service-based
competition. Il quadro regolatorio risultante, indubitabilmente complesso,
non privo di contraddizioni e di lentezze realizzative, fu nondimeno un
grande successo, e trasformò in pochi anni le telecomunicazioni europee.
L'accesso alle reti doveva poi avvenire a prezzi equi, trasparenti e non
discriminatori; gli operatori storici, avevano in particolare l'obbligo di
pubblicare un listino dei prezzi di accesso, e le autorità di regolazione
nazionali dovevano verificarne l'orientamento ai costi. Visto che il settore
era stato investito, come discusso, da drastici cambiamenti tecnologici, i
costi da prendere in considerazione nella fissazione dei prezzi di accesso
non dovevano essere i costi medi, ma i costi medi incrementali di lungo
periodo (LRAIC) 126, ovvero i costi complessivi (comprensivi della
costruzione di infrastrutture, se necessario) da sostenere per consentire un
determinato aumento dei livelli di traffico.
Questo approccio, sviluppato nel corso degli anni Ottanta, è rimasto in
vigore con contenuti aggiustamenti fino al 2003, anno in cui è stato
introdotto un nuovo quadro regolamentare, la cui principale novità è quella
di riconoscere come in molti servizi di telecomunicazione la concorrenza si
sia ormai sviluppata a tal punto da consentire il graduale abbandono delle
attività regolamentari consistenti nella fissazione di regole ex ante, essendo
ormai sufficiente ricorrere all'intervento ex post, basato sulla normativa a
tutela della concorrenza, quale garanzia di tutela dell'interesse pubblico
contro abusi di posizione dominante.
L’abbandono dei criteri di regolazione è avvenuto più rapidamente per
quanto riguarda i prezzi finali, mentre procede con maggiore lentezza nel
caso dei servizi intermedi (come l’accesso), proprio a causa dell’essenzialità
di questo input per la fornitura dei servizi finali alla clientela da parte dei
concorrenti.
12.3 Tipologie di rete, regolazione e concorrenza
Tornando ad una discussione generale, possiamo individuare due principali
tipologie di reti cui – come vedremo – corrispondono diverse modalità di
accesso: one-way e two-way. Quest’ultima tipologia di accesso viene anche
definita interconnessione.
La prima modalità si verifica nel caso in cui un’impresa A (Figura 12.1)
abbia il monopolio di una essential facility, che risulta indispensabile ad
126
Si veda, a questo proposito, la definizione di costi medi incrementali di lungo periodo
che abbiamo dato nel Capitolo 6, parlando di prezzi predatori.
154
altre imprese (B1 e B2) per vendere un proprio servizio ai consumatori.
Tuttavia, l’impresa A non ha bisogno delle altre imprese per vendere il
proprio servizio, mentre le altre imprese hanno bisogno di A.
Questo modello di accesso è diffuso, ad esempio:
- nel settore del gas o dell’elettricità, in cui una società venditrice deve
avere accesso alla rete di gasdotti (o elettrodotti) per consegnare
l’energia ai propri clienti;
- nel settore ferroviario, in cui i vari operatori che gestiscono treni devono
accedere alla rete infrastrutturale.
Le reti one-way costituiscono il primo caso con riferimento al quale sono
state storicamente analizzate le tematiche relative all’accesso.
Figura 12.1 L’accesso one-way
Impresa A
Impresa B1
Impresa B2
Impresa A
Fonte: Armstrong [1998].
L’accesso two-way, o interconnessione (Figura 12.2), si verifica invece
quando tutte le imprese presenti sul mercato possiedono, in tutto o in parte,
proprie infrastrutture, e quindi per fornire il servizio alla clientela finale
ogni impresa interessata deve chiedere, ma nel contempo concedere,
l’accesso alla propria infrastruttura.
155
Figura 12.2 L’accesso two-way
Impresa A1
Impresa A2
Impresa A3
Fonte: Armstrong [1998]
Il modello di accesso two-way è il modello prevalente nelle
telecomunicazioni fisse (si pensi a Telecom Italia, Wind e Fastweb) o
mobili (si pensi a Tim, Vodafone, Wind e 3). Ma esso è rilevante anche per
le grandi reti energetiche nazionali. In questo caso, tipicamente, chi è
connesso alla rete dell’impresa A1 può voler comunicare (o comprare, o
vendere energia) con chi sia connesso ad A2 o ad A3, e viceversa.
Le relazioni tra le due reti possono essere di concorrenza o di non
concorrenza (o, meglio, di complementarietà):
• il primo caso è tipico degli operatori nazionali di telecomunicazioni
che devono utilizzare la rete di un operatore concorrente per
permettere ai propri utenti di comunicare con gli abbonati di
quest’ultimo. Perché un abbonato Wind possa chiamare un abbonato
Telecom Italia è infatti necessario che le reti siano tra loro
interconnesse, e che Telecom Italia conceda a Wind la possibilità di
accesso alla sua rete per concludere favorevolmente (più
tecnicamente ‘terminare’) la chiamata. Ma è vera anche la situazione
inversa;
• il secondo caso riguarda, ad esempio, il roaming internazionale dei
cellulari (ad esempio TIM utilizza la rete di T-Mobile per consentire
agli utenti italiani di comunicare con quelli tedeschi e viceversa, ma
i due operatori non sono direttamente in concorrenza tra loro), o
156
l’energia, nel caso in cui le reti appartengano a produttori o
consumatori.
Come traspare dagli esempi proposti, la distinzione tra l’accesso one-way e
l’accesso two-way (interconnessione) non è legata alle caratteristiche dei
servizi 127 offerti, ma al grado di complementarietà tra le reti possedute dai
diversi operatori.
La distinzione tra le due modalità di accesso ha importanti conseguenze:
• nel caso one way, la regolazione ex ante delle tariffe di accesso
garantisce l’allocazione efficiente delle risorse, impedendo
all’operatore dominante di fissare condizioni eccessivamente
onerose che blocchino l’entrata dei nuovi concorrenti;
• nell’interconnessione non è invece, in teoria, indispensabile regolare:
poiché le imprese hanno bisogno di accedere l’una alla rete
dell’altra, un comportamento escludente non è in generale razionale.
Tale comportamento è tanto meno razionale quanto più i concorrenti
hanno dimensioni simili tra loro: tuttavia, se un operatore risulta
dominante nel mercato, la regolazione dell’accesso è in pratica
necessaria. D’altra parte, se invece gli operatori avessero potere di
mercato molto simile tra loro, potrebbero verificarsi casi in cui è
necessario ricorrere alle normative antitrust per impedire a questi
operatori di concludere accordi collusivi.
12.4 I prezzi di accesso
In linea di principio, la determinazione dei prezzi di accesso risponde ai
medesimi criteri di quella dei prezzi finali: come si è visto nel precedente
capitolo 8, la regola teorica preferibile sarebbe quella del prezzo pari al
costo marginale, anche se in pratica essi vengono spesso fissati (nelle reti
elettriche, in quelle del gas, e nelle reti ferroviarie) con riferimento ai costi
medi.
Soltanto nel settore delle comunicazioni elettroniche viene attualmente
utilizzato un principio simile a quello del costo marginale, e cioè il costo
medio incrementale 128. Esso viene poi riferito al lungo periodo (come si
ricorderà, in economia il lungo periodo è quel periodo di tempo che
127
A questo proposito, è utile sottolineare che il grado di complementarietà tra i servizi è
legato all’evoluzione tecnologica e, in quanto tale, è destinato a modificarsi nel tempo a
seconda degli sviluppi tecnologici che si verificheranno nel settore.
128
Il costo marginale fa riferimento ad un incremento infinitesimale nella produzione, che
tuttavia non è stimabile dal punto di vista contabile. Per questo, nella teoria della
regolazione si fa riferimento al costo incrementale, che è il costo addizionale relativo ad un
dato incremento (sia pure piccolo) della quantità prodotta.
157
consente di cambiare il dimensionamento degli impianti). In questo modo, si
tiene conto quindi non soltanto dei costi marginali di breve periodo (che
spesso sono trascurabili: il costo per far transitare sulla rete di Telecom
Italia un minuto di conversazione addizionale è praticamente pari a zero),
ma anche del costo che il proprietario della rete sopporterebbe per adeguare
le dimensioni della rete a fronte di un aumento permanente di traffico, in
base alle migliori tecnologie attualmente disponibili.
Negli altri settori le tariffe di accesso sono fissate in base al costo medio.
12.5 La separazione strutturale
Come abbiamo discusso, per motivi storici, gli operatori dei servizi
infrastrutturali – elettricità, gas, telecomunicazioni, trasporto ferroviario –
hanno storicamente assolto una duplice natura: quella di gestore della rete
infrastrutturale, e quello di produttore di servizi che la utilizzano.
Quando i concorrenti chiedono l'accesso alla rete, come abbiamo visto, è
socialmente efficiente introdurre una qualche forma di regolazione del
prezzo di questo accesso.
Per determinare il prezzo dell’accesso è come minimo necessaria una
qualche forma di separazione contabile tra i costi e i ricavi che, da un lato,
l’impresa dominante ritrae dalla gestione dell’infrastruttura, e – dall’altro –
essa ricava dall’offerta dei servizi alla clientela finale. In pratica, con la
separazione contabile, l'autorità di regolazione richiede all’azienda regolata
di tenere una contabilità separata per ciascun business oggetto di
separazione 129.
Se tale separazione contabile non fosse effettuata, il proprietario
dell’infrastruttura potrebbe infatti realizzare sussidi incrociati tra servizi
diversi, utilizzati per ostacolare l’entrata di nuovi concorrenti: ad esempio,
potrebbe mantenere i prezzi di accesso ben al di sopra dei costi e utilizzare
tali maggiori profitti per ridurre i prezzi alla clientela finale.
Ma la separazione contabile può non essere sufficiente a garantire, in certi
casi, un accesso a condizioni eque e non discriminatorie alla rete
dell’operatore storico:
• per le inevitabili imprecisioni in cui incorre la separazione contabile,
a causa dei molteplici problemi connessi all’allocazione dei costi
129
Dato che l’oggetto di attenzione del Regolatore sono i costi, ciascun business viene così
a disporre di un proprio Conto Economico; non necessariamente, però, di un proprio Stato
Patrimoniale, la cui preparazione è comunque particolarmente complessa nel caso vi siano
assets rilevanti condivisi da più attività.
158
comuni e congiunti;
• per i problemi che possono porsi sotto il profilo della qualità del
servizio di accesso (ad esempio, un operatore delle
telecomunicazioni costretto a fornire ai concorrenti l'accesso alla
propria rete, potrebbe cercare di fornire loro centralini o linee
difettose);
• per la possibilità, frequente in alcuni casi, che l'operatore storico
ammetta in opera molteplici strategie ostruzionistiche.
In questi casi, può essere necessario ricorrere a forme di separazione più
incisiva, ad esempio imponendo che venga costituita una separazione
divisionale o societaria (si pensi, rispettivamente, al caso della Divisione
OpenAccess di Telecom Italia o di RFI, gestore dell’infrastruttura
ferroviaria), in modo che la società che possiede la rete sia diversa da quella
che offre i servizi alla clientela finale. In alcuni ulteriori casi, si può arrivare
alla separazione proprietaria, in cui la proprietà della società che possiede la
rete deve essere in capo a soggetti diversi da quelli che offrono il servizio
sulla rete stessa (ad esempio, Terna è il gestore della rete elettrica nazionale,
è quotato in Borsa ed ha azionisti diversi dall’operatore storico (Enel).
Tutte queste soluzioni presentano costi e benefici, che possono essere molto
diversi da settore a settore.
Tipicamente, una separazione proprietaria garantisce una totale
indipendenza della società che possiede la rete, i cui manager si
prodigheranno per facilitare l'utilizzo della rete da parte dei concorrenti
dell'operatore storico, perché così facendo aumenteranno il proprio fatturato;
tuttavia, una gestione totalmente separata della rete tende ad indebolire
anche le economie di coordinamento.
Queste possono assumere forme diverse: ad esempio, nelle ferrovie, le ruote
dei vagoni possono essere disegnate con la finalità di aumentarne la
velocità, o con quella di ridurre il consumo della rotaia derivante dall'attrito,
e questo è certamente un argomento che favorisce uno stretto
coordinamento tra gestione dell'infrastruttura e gestione del servizio. In
secondo luogo, nelle reti di telecomunicazione, la scelta degli apparati di
rete non è indipendente dalla scelta dei servizi che devono essere offerti
sulla rete. In terzo luogo, se il proprietario della rete non offre anche servizi
finali, potrebbe avere un incentivo razionale a contenere gli interventi di
manutenzione, dato che non gli competeranno, in prima istanza, i problemi
di continuità ed affidabilità del servizio alla clientela finale.
La questione delle forme di separazione tra rete e servizio è dunque molto
complessa, e deve essere valutata con riferimento al caso concreto di cui ci
si deve occupare
159
13. BENEFICI E COSTI DELLA REGOLAZIONE: PROBLEMI
DI AGENZIA E GRUPPI DI INTERESSE
13.1 Introduzione
Nelle lezioni precedenti abbiamo discusso come, in certe condizioni, può
essere adottata la decisione di regolare un settore, e come una tale scelta
spesso generi complessi problemi riguardanti i prezzi finali, quelli di
accesso e – in taluni casi – l’universalità del servizio. Una tale scelta ha
evidenti implicazioni istituzionali. È infatti possibile utilizzare per la
regolazione un’ampia gamma di soluzioni, comprese tra i due estremi della
gestione diretta da parte della mano pubblica dell’attività in questione (la
proprietà è, in fondo, la forma più radicale di regolazione!) e della gestione
privata, ma sottoposta a regole ed interventi amministrativi.
Entrambe le soluzioni presentano diverse varianti possibili. Per quanto
riguarda la prima, lo Stato può gestire direttamente un’attività commerciale
(fino al 1993 130 il servizio postale in Italia era gestito da una Direzione del
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni), farlo attraverso un Ente
pubblico economico (la soluzione adottata fino al 2000 per le Poste), oppure
attraverso una società di capitali posseduta in via totalitaria (Rete
Ferroviaria, ANAS), maggioritaria (Terna), o con una minoranza sufficiente
ad assicurare il controllo di fatto sulla società (ENEL, ENI).
Alternativamente, lo Stato può decidere di regolare per via amministrativa il
comportamento di imprese private nei casi in cui esso – per l’esistenza di
fallimenti del mercato, o per altri motivi – abbia rilevanza sotto il profilo del
pubblico interesse (cui la Corte Suprema americana si riferisce,
efficacemente, con il termine business affected with public interest).
Le differenze tra le diverse soluzioni sono molteplici, se esse si considerano
dal punto di vista del Diritto Amministrativo. Tuttavia, dal punto di vista
economico esse presentano una caratteristica comune: sono un problema di
agenzia.
13.2 Il problema di agenzia
Un problema di questo genere si presenta ogni qualvolta un agente
economico (il mandante, o – all’inglese – il principale) offre ad un altro (il
mandatario, o agente) un contratto per l’esecuzione di un incarico più o
meno complesso. Questa relazione è quasi sempre di difficile gestione per
tre motivi principali, che possiamo spiegare con semplicità riferendoci ad
un caso ipotetico, come quello di una fabbrica di ombrelli di Napoli che
130
La trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente
pubblico economico è stata disposta dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.
160
assuma un venditore assegnandogli un dato quartiere di Milano, per un
compenso fisso mensile.
Ora, poiché è evidente che gli ombrelli si vendono meglio in caso di
maltempo che con il sole, sarà interesse del produttore che l’agente venda
ombrelli con particolare alacrità quando piove e tira vento. L'agente,
tuttavia, preferirà vendere ombrelli quando il clima non è così inclemente. Il
primo problema di qualsiasi contratto di agenzia, è dunque che gli obiettivi
del mandante e del mandatario sono diversi.
Questo problema è complicato dal fatto che non solo il mandatario ha
obiettivi diversi, ma egli conosce molto meglio del mandante il quartiere in
cui opera, le abitudini dei suoi abitanti, la disponibilità di portici e mezzi
pubblici, oltre che naturalmente la meteorologia: il secondo problema di
qualsiasi contratto di agenzia, è quindi che il mandatario, che ha obiettivi
diversi da quelli del mandante, ha anche migliori informazioni del
mandante. Il mandante deve quindi sopportare rilevanti costi di
monitoraggio per controllare le attività del mandatario.
In casi come quelli descritti dall'esempio, questo problema può essere risolto
facilmente, facendo dipendere una parte della retribuzione del mandatario
dalle vendite: in questo modo, viene costruito un meccanismo incentivante
che opera un riallineamento degli obiettivi del mandatario con quelli del
mandante. Ma in problemi come quelli di cui ci occupiamo in questo corso,
ciò non è in generale possibile.
I problemi di agenzia sono poi in questi casi particolarmente complessi.
Schematizzando, infatti, il problema di agenzia è qui triplice: i politici
operano come agenti degli elettori, che agiscono da principale; il Regolatore
opera come agente dei politici, che agiscono da principale; l’impresa
regolata opera come agente del Regolatore, che agisce da principale.
A ciascuno dei livelli di questa catena di problemi di agenzia, esattamente
come nel caso degli ombrelli, il comportamento dell’agente può deviare,
anche significativamente, da quello che il principale desidererebbe per la
diversità delle funzioni-obiettivo. Così, ad esempio, i politici possono
voler utilizzare il servizio postale per assumere dipendenti nei propri collegi
elettorali: ciò aumenta i costi del servizio, e quindi non corrisponde
certamente ad un obiettivo della clientela, ma aumenta la probabilità di
essere rieletti, obiettivo di indubbia importanza per un politico.
Il Regolatore potrebbe poi, ad esempio, cercare di ridurre le tariffe di
un’azienda pubblica, perché le considera troppo elevate, ma ciò potrebbe
contrastare con un obiettivo del Governo di privatizzare l’azienda in
questione realizzando un introito elevato, obiettivo che sarebbe messo a
repentaglio da un intervento troppo severo sulle tariffe. Infine, un’impresa
161
regolata potrebbe aumentare alcune delle sue voci di costo per convincere il
Regolatore ad accordarle una tariffa più elevata.
Un secondo problema deriva dalla difficoltà incontrata dal principale nel
definire un ragionevole meccanismo regolatorio, stante i vantaggi
informativi posseduti dall’agente. A titolo di esempio, si pensi alle
difficoltà incontrate dal Regolatore nel definire i prezzi di un servizio
qualora non conosca con esattezza i costi sostenuti dall’impresa e la sua
funzione di domanda. In questo caso un’errata stima dei costi potrebbe
consentire all’impresa di conseguire extra profitti, oppure delle perdite.
In generale, l’efficacia e i costi delle politiche regolamentari dipendono
dalla natura del rapporto di agenzia: al primo livello (cittadini-politici) essa
riflette le caratteristiche del sistema politico; al secondo (politici-regolatori)
dipende dal rapporto più generale tra potere politico e funzioni
amministrative dello Stato, ed in particolare il grado di indipendenza del
Regolatore dal potere legislativo ed esecutivo; infine il terzo (Regolatore impresa regolata) rispecchia l’efficienza del Regolatore, ed in particolare la
sua capacità/volontà di ottenere informazioni adeguate a svolgere
efficacemente il suo compito.
Quest’ultimo aspetto è spesso discusso sotto il profilo della cattura del
Regolatore da parte dell’azienda regolata. Questa, grazie alle asimmetrie
informative a suo favore - particolarmente forti quando essa, godendo di un
monopolio sul mercato, goda anche di un quasi-monopolio sulle
informazioni relative al mercato stesso - e grazie ad un’azione efficace di
lobbying, può gradualmente spingere il Regolatore ad agire in suo favore,
anziché in difesa del pubblico interesse.
Nonostante siano in effetti reperibili casi (o sospetti) che confermino questa
ipotesi, è più probabile che le azioni poste in essere dall’azienda regolata
giungano raramente ad una vera e propria “cattura” del Regolatore, ma ne
riducano frequentemente il grado di efficienza e la qualità delle decisioni.
I problemi sono dunque molteplici, ed in realtà la probabilità che gli
obiettivi dei cittadini vengano nella pratica perseguiti non è molto elevata:
oltre al pericolo di una market failure, l’interesse pubblico corre un pericolo
di regulatory failure, ovvero che le politiche economiche in campo
regolamentare siano inefficaci o anzi – come ora discuteremo – possano
rivelarsi nel complesso dannose, perché distorte, da potenti gruppi di
interesse, verso finalità particolari.
13.3 Gruppi di interesse
Fino ad ora, abbiamo supposto che il Regolatore sostituisca la mano
‘invisibile’ della concorrenza con quella ‘visibile’ della regolazione, e che
162
scopo unico della regolazione sia quello di garantire risultati socialmente
desiderabili quando la concorrenza non è in grado di produrli.
Ancora oggi la tutela dell’interesse pubblico costituisce la principale
giustificazione all’intervento regolatorio nell’economia anche se varie
ricerche empiriche hanno evidenziato come la regolazione possa favorire,
anziché disincentivare, scelte distorsive nell’impiego dei fattori produttivi:
nel settore aereo americano, l'eliminazione avvenuta all'inizio degli anni 80
di una regolazione pervasiva, faceva esplodere la concorrenza, cadere i
prezzi e aumentare enormemente il numero di passeggeri trasportati.
La riflessione su fatti di questo tipo ha alimentato lo sviluppo di
interpretazioni teoriche alternative, tra le quali la principale è la teoria dei
gruppi di interesse. Secondo questa teoria è possibile spiegare gli interventi
di regolazione come risposte alle richieste di tutela degli interessi che
emergono da alcuni gruppi (di consumatori, di imprese o altri ancora) che,
organizzandosi opportunamente, cercano di influenzare il comportamento
del Regolatore 131.
La teoria dei gruppi di interesse appartiene all’insieme più vasto delle teorie
dell’interesse privato, secondo le quali esisterebbe un vero e proprio
“mercato” dove il bene scambiato è la regolazione. La domanda è espressa
dai gruppi portatori di interessi organizzati, non solo dei produttori ma
anche dei consumatori, mentre l’offerta proviene dai politici e dai funzionari
che ricevono in cambio voti e sostegni finanziari 132.
La regolazione diventa così uno strumento per ridistribuire il reddito in
favore dei gruppi più organizzati, piuttosto che per eliminare i fallimenti
del mercato o favorire comportamenti efficienti delle imprese. Imponendo
vincoli all’entrata e controlli sui prezzi lo Stato limita, di fatto, la
concorrenza e tutela gli interessi delle imprese regolate generando delle
rendite per gli operatori, in termini di maggiori profitti. Costoro assumono, a
loro volta, dei comportamenti diretti al perseguimento della rendita (rentseeking behaviour) che li portano ad investire risorse per aumentare la
rendita stessa invece che per raggiungere una maggiore efficienza.
È importante sottolineare che, al pari della teoria dell’interesse pubblico,
anche nelle teorie dell’interesse privato, la regolazione deriva dalla scelta
razionale di agenti economici massimizzanti. Tuttavia, mentre nel primo
caso è frutto delle decisioni di un Regolatore benevolente, che massimizza il
131
Inizialmente questo approccio venne formulato da politologi e sociologi che si
occupavano del ruolo dei gruppi di interesse nelle società democratiche moderne, ma queste
teorie sono poi state riprese in economia, a partire dal 1971, da Stigler in “The theory of
economic regulation”, che è diventata un riferimento fondamentale per tutta l’analisi
successiva.
132
La teoria della cattura del Regolatore, che abbiamo sopra discusso, è quindi un caso
classico di teoria dell’interesse privato.
163
benessere sociale, nel secondo caso scaturisce dalla massimizzazione degli
interessi privati del Regolatore e delle imprese regolate. Queste ultime
richiedono allo Stato (politici ed amministratori) l’attuazione di interventi
regolatori che accrescono il loro benessere e non quello collettivo. Dal canto
suo lo Stato, che può concedere benefici a gruppi o individui poiché dispone
del potere di coercizione di cui la regolazione è l’espressione in campo
economico, beneficia a sua volta dei favori delle imprese regolate.
Come sovente succede, i diversi modelli teorici – presi singolarmente - non
sono capaci di spiegare molti aspetti nella realtà. Come le teorie
dell’interesse pubblico non riescono a spiegare per quale motivo la fine
della regolazione del trasporto aereo americano si sia risolta in un
sostanzioso calo dei prezzi dei servizi di trasporto, le teorie dell’interesse
privato non danno conto dei pur numerosi casi in cui il Regolatore ha ridotto
i prezzi e, contenendo profitti eccessivi, spinto all’aumento nel grado di
efficienza, come si è ad esempio verificato nelle telecomunicazioni europee.
Presi nel loro complesso, i diversi contributi hanno, comunque, arricchito e
resa più complessa la riflessione sui problemi della regolazione. La teoria
dell’interesse pubblico, giustificando la regolazione unicamente in termini
di intervento destinato a curare i fallimenti del mercato, aveva, infatti,
trascurato di rispondere alle domande più generali sugli obiettivi che i
politici e i burocrati attribuiscono alla regolazione.
Si può giungere così ad una sintesi delle diverse interpretazioni analitiche
in termini dinamici: gli interventi regolatori vengono visti come tappe
successive di un continuo processo di bilanciamento tra interessi diversi, che
porta ad attribuire al Regolatore il ruolo sia di difesa e promozione
dell’interesse pubblico, sia di mediatore nella negoziazione tra soggetti o
gruppi portatori di interessi diversi.
Alla luce di quanto discusso in questa lezione, non è purtroppo possibile
dare per scontato che la regolazione sia sempre efficace nel risolvere i
problemi di market failure, o uno strumento sempre adeguato a perseguire
altri obbiettivi di politica economica: la regulatory failure, ed i suoi costi, è
un esito certamente possibile.
164
14. BENI PRIVATI, BENI PUBBLICI E ASSETTI PROPRIETARI
14.1 Introduzione
Nelle lezioni precedenti abbiamo discusso come la market failure derivante
dall’esistenza di posizioni dominanti possa essere, in alcuni casi, risolta
mediante appropriate politiche regolamentari. Di queste, abbiamo tuttavia
mostrato anche gli evidenti limiti, che rendono tutt’altro che raro il
verificarsi di regulatory failures.
Perché allora non ricorrere alla proprietà pubblica? La risposta a questa (più
che legittima) domanda richiede, preliminarmente, di chiarire quale
dovrebbe essere – almeno in teoria – il ruolo dello Stato nella produzione di
beni e servizi nell’economia.
Per questo, è anzitutto necessario definire il concetto di bene pubblico,
illustrarne le caratteristiche, e valutare i principali problemi di politica
economica connessi alla loro produzione.
Prima di cominciare è essenziale sottolineare che la nozione di bene
pubblico, di cui qui ci occuperemo, non ha nulla a che fare con quella di
Bene Pubblico (scritto con iniziali maiuscole), frequentemente utilizzata nel
diritto. I beni di cui ci occupiamo sono beni in senso economico, e non in
senso etico (una dose di droga è un bene in senso economico, ma non in
senso etico). In secondo luogo, pubblico per noi è qui semplicemente un
modo per indicare una particolare modalità di godimento dei beni di cui ci
occupiamo (come vedremo, Mediaset produce beni pubblici, anche se è
privata).
14.2 Beni pubblici
Una torta e la difesa nazionale hanno tra loro molte differenze, ma per un
economista le differenze veramente importanti sono le due seguenti:
•
se io mangio la torta, nessun altro può mangiarla. Il mio consumo
della torta ed il consumo altrui sono consumi rivali. Invece, se io
godo della difesa nazionale, di questa può godere anche il mio
vicino: in termini tecnici, diciamo che la difesa nazionale è un bene
per il quale non vi è rivalità (non-rival good);
•
nessuno può mangiare la mia torta, a meno che io non gliela venda, o
gliela regali. In altre parole, io posso escludere altri dal godimento
della mia torta. Nessuno può però essere escluso dal godimento della
difesa nazionale: la difesa nazionale è quindi un bene non escludibile
(non-excludable good).
165
Le differenze tra queste caratteristiche possono sembrare poco chiare, ma
vedremo rapidamente come esse si combinino a coppie in quattro possibilità
diverse, la cui analisi riserva alcuni utili insegnamenti.
I beni e servizi di cui si occupa la microeconomia elementare sono beni
privati, perché vi è sia rivalità nel loro consumo, sia possibilità di
esclusione del consumo altrui: l’esempio della torta è del tutto evidente.
All’opposto stanno quelli che in economia chiamiamo beni pubblici puri
(in un’accezione, sottolineiamo ancora, diversa da quella utilizzata dal
diritto), per i quali non vi è rivalità nel consumo né è possibile escludere
altri dal loro godimento: oltre che la difesa nazionale, esempi classici sono
la televisione terrestre e l’illuminazione pubblica. Vi sono poi due
combinazioni incrociate – tra escludibilità e rivalità – alquanto interessanti.
La prima è quella dei beni per i quali vi è rivalità nel consumo, ma ove è
difficile, o estremamente costoso, escludere altri dal loro godimento: l’aria
pulita (contesa tra diversi usi, alcuni dei quali estremamente inquinanti), e
molti altri ‘beni ambientali’, come l’acqua, i pesci nel mare, e molti altri.
Questi beni, che generalmente possiamo chiamare risorse comuni (common
pool resources), sono frequentemente soggetti a quella che viene
efficacemente chiamata in lingua inglese the tragedy of commons (i
commons in Inghilterra erano quei prati posseduti dalla collettività nei quali
tutti erano liberi di far pascolare le proprie pecore e dunque l’erba –
pubblica – non era spesso sufficiente per i molti animali – privati -), nel
senso che la non escludibilità nel consumo fa sì che questo sia eccessivo
rispetto alla disponibilità: le risorse comuni si depauperano facilmente. Di
questi beni ci occuperemo nel seguito del corso, parlando in particolare di
politiche economiche ambientali.
Vi sono poi beni per i quali non vi è rivalità nel consumo, ma ove è
possibile escludere un agente economico dal loro consumo, e questi sono
club goods, come la televisione satellitare, diversi tipi di servizi di
telecomunicazione, e – forse sorprendentemente, per giovani giuristi – il
diritto d’autore. Anche di questi ci occuperemo nel seguito del corso.
Tornando alla distinzione beni privati/beni pubblici, il motivo principale per
cui questa distinzione economica ci interessa in questo corso, è che essa ci
permette di focalizzare un importante fallimento del mercato: come
vedremo, infatti, la produzione di beni pubblici puri affidata ad agenti
economici privati, è sempre inefficiente.
14.3 Produzione privata di beni pubblici
La produzione privata di beni pubblici è in generale inefficiente per un
semplice motivo: come ricorderete dall’economia elementare, un produttore
166
razionale (di un bene privato, aggiungiamo adesso) sceglie la quantità da
produrre eguagliando il suo costo marginale al prezzo.
Ora, se il bene o il servizio prodotto è un bene pubblico puro, nel senso
tecnico in cui lo abbiamo sopra descritto, non sarà mai possibile per lui
recuperare il suo costo marginale, perché gli sarà impossibile escludere chi
non voglia pagare dal godimento del servizio stesso: escludere, cioè, i free
rider, termine con cui indichiamo in generale colui che consuma un bene o
un servizio senza pagarne, o senza pagarne pienamente, il corrispettivo,
come si verifica nel caso di qualcuno che si aggrappi all’esterno di un
autobus in corsa, facendosi trasportare senza pagare il biglietto
(naturalmente questa è l’immagine che ha dato il nome alla fattispecie).
Un operatore privato razionale non produrrà quindi mai un bene pubblico
puro: se con una prossima legge finanziaria un qualche governo decidesse di
abolire l’esercito per ridurre la spesa pubblica, nessun operatore privato
offrirebbe questo servizio, dato che nessun cittadino sarebbe disposto a
pagare per goderne, sapendo che comunque il beneficio di questo servizio,
pagato da qualcun altro, gli sarebbe esteso senza alcun costo da parte sua.
Poiché ognuno avrà un incentivo razionale a comportarsi come un free
rider, il beneficio marginale privato che il produttore può trarre dalla
produzione di beni pubblici puri sarà pari a zero, o comunque sempre
inferiore al beneficio marginale pubblico che la collettività ne trae: ma se
la produzione privata di un bene per il quale esiste una domanda non è
sufficiente, siamo certamente in presenza di un caso di fallimento del
mercato 133.
Questo è il motivo economico che spiega come la produzione di molti beni
pubblici puri (come la difesa) sia effettuata non dalla mano privata ma dalla
mano pubblica.
14.4 Ci sono eccezioni?
L’analisi che precede sembra contraddetta dall’esistenza del cosiddetto terzo
settore, che produce spesso privatamente beni pubblici, come ad esempio
servizi di assistenza sanitaria, o dall’offerta su Internet di un crescente
numero di beni pubblici puri offerti da privati, come Wikipedia, (un’ottima
enciclopedia gratuita, che consiglio a tutti, specie nella sua edizione inglese)
e i blogs.
133
Vi sono naturalmente delle eccezioni: come rileva Coase, l'offerta ai naviganti da parte
di un porto gestito da privati di un servizio di faro per la navigazione, è spiegabile con il
fatto che il porto così facendo attira navi a cui vende servizi, ed il ricavo serve in parte a
pagare i costi del faro.
167
In alcuni casi, quello dei blogs ad esempio, è però probabile che chi ne
metta uno in rete tragga un beneficio, ad esempio in termini di notorietà, che
è difficile misurare, ma probabilmente ragguardevole: conosco professori di
economia che tengono, scrivendolo generalmente di notte, un blog, e si
rallegrano dei contatti professionali che la notorietà così acquisita loro
genera. Una spiegazione analoga vale probabilmente per il software Linux,
inventato da un giovane programmatore scandinavo, ma poi enormemente
ampliato ed alimentato da una comunità globale di programmatori. In questo
caso, il privato che offre un bene pubblico puro copre i suoi costi mediante i
ricavi che ottiene – o che spera di ottenere – altrove, che risultano maggiori
di quanto non sarebbero se egli non producesse il bene pubblico.
In altri casi, come quello di Wikipedia, l’offerta di beni pubblici è stata
avviata da un atto di liberalità privato, e un numero enorme di persone ha
gradualmente contribuito allo sviluppo dell’enciclopedia. Poche di esse
possono essere guidate da qualche forma di tornaconto privato, perché gli
articoli dell’enciclopedia sono del tutto anonimi (anche se, in qualche caso,
nella bibliografia raccomandata sono indicati con evidenza scritti del suo
autore).
Questo è quindi, e ciò è incoraggiante da un punto di vista etico, un caso in
cui la produzione di un bene pubblico puro è sostenuta da un sano spirito
pubblico. Se dobbiamo certamente apprezzarlo, con tutte le altre forme di
volontariato, la relativa rarità di casi come quello che stiamo discutendo
deve essere sufficiente a convincerci che una produzione privata efficiente
di bene pubblico puro può talvolta darsi in natura, ma è così poco frequente
da rendere sostanzialmente corretta l’affermazione cui siamo giunti
inizialmente, ovvero che la produzione privata di beni pubblici puri, in
generale, non è (quasi mai) efficiente.
In questi casi, è dunque efficiente una produzione pubblica, anche se
naturalmente qui si applicano tutti problemi relativi al rapporto mandantemandatario, ed al ruolo dei gruppi di pressione, che abbiamo discusso nella
precedente lezione.
14.5 Produzione pubblica di beni privati
Mentre, come abbiamo visto, la produzione pubblica di beni pubblici puri è
spesso efficiente, la produzione pubblica di beni privati – contro la quale
non vi sono a priori così forti come quelli esistenti per la produzione privata
di beni pubblici – si rivela, nei fatti, quasi sempre inefficiente.
Su questo punto vi è un’ampia esperienza internazionale, perché,
storicamente, la proprietà pubblica è stata una soluzione ampiamente
adottata dalla politica economica per i fallimenti del mercato derivanti
dall’esistenza di monopoli. La proprietà pubblica deve quindi essere vista
168
come una forma (estrema) di regolazione: invece di lasciare ai privati la
produzione di beni privati, cercando – mediante le politiche regolatorie – di
evitare che vari tipi di fallimenti del mercato ledano il benessere sociale, lo
Stato acquisisce direttamente il controllo del produttore.
In pratica, scelte di questo tipo sono state storicamente adottate per due
principali ordini di motivi:
a) l’esistenza di preminenti motivi di interesse nazionale, sotto il profilo
militare (da cui discende, ad esempio, la proprietà pubblica delle linee
aeree, preziosi vivai di piloti) o di servizi molto complessi la cui
continuità è considerata fondamentale (elettricità);
b) la eccessiva rischiosità degli investimenti necessari (ad esempio, lo
sviluppo, almeno nelle fasi inziali, delle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale o la costruzione di centrali nucleari, che
avrebbe probabilmente scoraggiato gli investitori privati).
Per rimediare ai fallimenti del mercato, si sono però dovuti pagare costi
crescenti per i fallimenti della produzione pubblica, derivanti da quella
complicata catena di relazioni principale-agente, di cui abbiamo studiato la
fragilità ed i problemi connessi: le aziende pubbliche facevano infatti più gli
interessi dei politici (loro mandanti diretti), che non quelli dei cittadini (loro
mandanti ultimi). Inoltre, disponendo di mezzi ben più ampi di quelli dei
ministeri al cui controllo esse erano (in teoria) assoggettate, le aziende
pubbliche – con un meccanismo classico – catturavano i funzionari
ministeriali che avrebbero dovuto controllarle.
E ancora, qualora il management di un’impresa privata sia inefficiente, esso
determina una riduzione del valore di mercato dell’impresa, esponendola
alla possibilità di scalate. Questa eventualità rappresenta un potente
incentivo per i managers che, dopo la scalata, potrebbero essere licenziati
dalla nuova gestione, in quanto ritenuti responsabili delle inefficienze
dell’impresa. Una tale possibilità di fallimento non sussiste però per
un’impresa pubblica, e ciò riduce ogni incentivo al suo management di
massimizzare l’efficienza. Infine, l’azionariato pubblico rende queste
aziende particolarmente vulnerabili alle richieste salariali dei dipendenti,
che frequentemente si fanno più pressanti quando siano imminenti scadenze
elettorali, in prossimità delle quali i costi che i politici devono pagare in
termini di consenso, in caso di scioperi, sono più elevati.
L’esperienza storica quindi mostra come l’ipotesi che managers di aziende
pubbliche e cittadini abbiano la stessa funzione-obiettivo, risulta essere
eccessivamente ottimistica. La inevitabile divergenza tra gli interessi dei
cittadini e quelli del management fa sì che quest’ultimo, avendo una
funzione di utilità indipendente dalla massimizzazione del benessere sociale,
dedichi scarsa attenzione alla riduzione dei costi, ai miglioramenti
169
qualitativi e agli incrementi di efficienza realizzabili tramite investimenti e
innovazioni tecnologiche. 134
L’impresa pubblica viene invece strettamente controllata dai politici sotto
il profilo degli effetti redistributivi delle politiche aziendali: tipicamente ciò
si traduce nella produzione di servizi non giustificabili economicamente,
(come molti “rami secchi”, ovvero tratte di servizio del tutto
antieconomiche, del trasporto ferroviario) ed in strutture di prezzi favorevoli
ai gruppi di interesse cui sono più sensibili i politici.
Da ultimo osserviamo che – stante la struttura e le caratteristiche del
problema di agenzia – la proprietà pubblica finisce, nella maggior parte dei
casi, per replicare nelle aziende i pregi, ed i difetti, del sistema politico: un
medesimo assetto proprietario potrà dunque generare esiti assai diversi, in
periodi e Paesi diversi, a seconda del contesto politico-sociale in cui è
inserito.
Alla luce di queste osservazioni, è possibile concludere che la proprietà
pubblica dell’impresa, intesa come forma estrema di regolazione non è
certamente priva di costi: infatti i cittadini non conoscono lo sforzo
compiuto dai managers, dato che questi ultimi possiedono una funzioneobiettivo diversa dalla massimizzazione del benessere sociale, la proprietà
pubblica può disincentivare la riduzione dei costi, nonché gli investimenti in
nuove tecnologie e i miglioramenti qualitativi. Inoltre, come ben mostra il
caso delle telecomunicazioni, l’evoluzione della tecnologia può ben
consentire di raggiungere le finalità dettate dall’interesse pubblico mediante
soluzioni diverse dalla proprietà pubblica.
Per questo, a partire dagli anni 80, in tutti i Paesi europei – ma non solo – è
iniziato un complicato processo di privatizzazione, con il quale la mano
pubblica è progressivamente uscita dalla produzione di un novero crescente
di beni e servizi privati.
134
Ampliando il quadro, occorre peraltro sottolineare come sia possibile, in alcune fasi
storiche, che le funzioni-obbiettivo del management si avvicinino a quelle dei cittadini,
come si è probabilmente verificato - ad esempio – nell’Italia del primo e secondo
dopoguerra, quando IRI ed ENI hanno avuto un ruolo trainante dell’economia italiana,
dotandola, in tempi molto brevi, di un ampio patrimonio di infrastrutture.
170
15. SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI DI INTERESSE
GENERALE: UNA PROSPETTIVA ECONOMICA
15.1 Introduzione
Sulla scorta dei capitoli precedenti siamo ora in grado di chiederci quale sia
la sostanza economica della nozione giuridica di "servizio pubblico".
Come vedremo, il problema è rilevante almeno per quattro motivi:
•
la nozione giuridica di servizio pubblico è alquanto confusa, e
conviene anzitutto ricondurre il problema alle più chiare (o meno
confuse) nozioni comunitarie di servizio di interesse generale e di
servizio di interesse economico generale;
•
l'esistenza di un interesse generale, in base al quale una particolare
attività possa o meno essere considerata di interesse (economico)
generale, può essere valutata alla luce della nostra discussione nei
capitoli precedenti, riconducendola a due casi fondamentali
(l'esistenza di beni meritori e quella di fallimenti del mercato), il che
è senz'altro utile per evitare una attribuzione troppo estesa di tale
connotato;
•
un approccio economico al problema consente di analizzare, in
applicazione del criterio di proporzionalità, se ed in quale misura gli
obblighi che vengano imposti in capo ad un servizio di interesse
economico generale siano o meno ragionevoli;
•
un'analisi in chiave economica consente di cogliere più chiaramente
il ruolo fondamentale che possono rivestire i gruppi di interesse
all'interno di servizi aventi queste caratteristiche.
Prima di procedere, occorre sottolineare come (e questa è spesso una
difficoltà per gli studenti di giurisprudenza) non vi è alcuna relazione
particolare tra la nozione economica di bene pubblico ("bene" naturalmente
qui è inteso in senso generale, ed include i servizi) e la nozione giuridica di
servizio pubblico. Dalla discussione che precede sulla definizione
economica di bene pubblico discende infatti chiaramente come attività
normalmente considerate come "servizi pubblici" (come la fornitura di
energia elettrica o quella dell'acqua, o ancora poste e telecomunicazioni)
non siano certamente beni pubblici in senso economico, poiché esse sono
caratterizzate sia da rivalità nel consumo che da escludibilità.
Molte attività economiche che tradizionalmente nel dibattito giuridico
vengono considerate come servizi pubblici, non sono dunque beni pubblici
dal punto di vista economico, ma beni privati.
171
15.2 L’ambigua nozione di servizio pubblico
La nozione giuridica di servizio pubblico è alquanto confusa. Come ben
evidenziato dalla voce ‘servizio pubblico’ nel Glossario della Commissione
Europea: “La nozione di servizio pubblico ha un duplice senso: può
designare l'ente che produce il servizio, ovvero la missione d'interesse
generale ad esso affidata. E' al fine di favorire o permettere l'assolvimento
della missione di interesse generale che specifici obblighi di servizio
possono essere imposti dall'autorità pubblica all'ente che produce il
servizio, ad esempio nel campo dei trasporti terrestri, aerei o ferroviari,
ovvero, nel campo energetico, obblighi che possono essere esercitati a
livello nazionale o regionale. Da notare che spesso si confonde a torto
servizio pubblico con settore pubblico (ivi compresa la funzione pubblica)
ossia missione e statuto, destinatario e proprietario.”
La definizione soggettiva di servizio pubblico (il “proprietario”) cui si
riferisce il Glossario è la più antica, e le sue origini sono rintracciabili
all'inizio del ‘900: è un servizio pubblico qualunque attività che un pubblico
potere decida di assumere e di gestire. Questa definizione (régalienne come
si direbbe in Francia, che ancora oggi sostanzialmente la adotta) non ha
naturalmente alcun senso dal punto di vista economico: applicandola,
dovremo infatti concludere che l'erogazione del gas è un servizio pubblico
quando è effettuata direttamente dal Comune, o da una società da esso
controllata, ma non è un servizio pubblico quando è effettuata da privati,
giungendo a conclusioni analoghe per gli asili o le università, servizio
pubblico quando sono in mano pubblica ma non servizio pubblico quando
gestiti da privati. Questa non è una categoria analitica utile.
La definizione si è nel tempo evoluta, passando ad una poco meno ambigua
definizione oggettiva. Il comma 1 dell'articolo 112 del testo unico enti
locali, dal titolo Servizi pubblici locali recita ad esempio: "Gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali”. Una tale impostazione, dato che le “rispettive
competenze” sono molto ampie parrebbe consentire agli enti locali (ma
naturalmente ciò è generalizzabile allo Stato) di esercitare ampi poteri (dalla
gestione diretta, all'imposizione di obblighi di vario tipo) nei confronti di
un'ampia gamma di attività economiche, poiché sono davvero poche quelle
che in qualche modo non "promuov[ono] lo sviluppo economico e civile
delle comunità".
172
In questa materia ha fatto, almeno parzialmente ordine la Commissione
Europea, che ha gradualmente costruito 135, non senza ripensamenti e
contraddizioni, una ‘prassi comunitaria’, che può essere così sintetizzata:
•
i “servizi di interesse economico generale … sono servizi di natura
economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati
membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio
pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale
riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di
rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione.
Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività
economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico” 136;
•
i “servizi di interesse generale” [sono] un’espressione più ampia di
“servizi di interesse economico generale” e riguardano sia i servizi
di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche
considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi
di servizio pubblico” 137.
Gli elementi comuni alle due categorie sono dunque l’esistenza di un
interesse pubblico, e l’imposizione di obblighi particolari.
Di norma, i servizi di interesse economico generale sono servizi "di
mercato", nel senso che chi li offre (pubblico o privato, quale che ne sia la
forma giuridica) si comporta come si comporterebbe normalmente
un'impresa, vendendo quindi i propri servizi a prezzi che gli consentono,
almeno globalmente, il recupero dei costi di produzione. I servizi di
interesse generale, sono invece di regola considerati "non di mercato"
perché vengono forniti gratuitamente, oppure a prezzi fortemente inferiori ai
costi, e dunque l'offerta è resa possibile soltanto dall'esistenza di
trasferimenti da altri enti o imprese, o dalla fiscalità generale.
15.3 L’interesse pubblico in una prospettiva economica
Una precedente Comunicazione della Commissione aiuta a chiarire meglio
quali possano essere gli interessi pubblici da perseguire mediante
l’imposizione degli obblighi. Essa indica che i servizi di interesse generale
sono quelli che “contribuiscono in maniera rilevante alla competitività
generale dell’industria europea e alla coesione economica, sociale e
territoriale” 138. I servizi di interesse economico generale “si differenziano
135
Si veda, per una sintesi, la recente Guida in SEC (2010) 1545. Ben più articolato è il
Libro Bianco della Commissione sui servizi di interesse generale (COM/2004/0374).
136
Libro Bianco, cit.
137
Ibidem.
138
Comunicazione della Commissione “I servizi d’interesse generale in Europa” [2001/C
17/04], par. 8.
173
dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche ritengono che
debbano essere garantiti anche quando il mercato non sia sufficientemente
incentivato a provvedervi da solo” 139.
Questa definizione è senz'altro faticosa, ma ha il merito di poter essere in
larga parte ricondotta alla discussione che abbiamo sviluppato nel corso fino
a questo punto: sono in primo luogo servizi di interesse generale quelli che
si ritiene abbiano per qualche motivo un carattere meritorio, e per i quali, in
assenza dell'imposizione di qualche obbligo, l'offerta disponibile sarebbe
insufficiente.
Condizione necessaria perché un servizio possa essere considerato di
interesse generale, è dunque che esso, per qualche motivo, si è considerato
un servizio meritorio. Come abbiamo brevemente discusso nella parte
introduttiva del corso, la meritorietà è caratteristica assegnata in base a
considerazioni di carattere extra-economico: così nei paesi sviluppati si
ritiene comunemente che la pubblica istruzione sia un bene meritorio,
perché tutti devono sapere leggere e scrivere, ma che non lo sia - ad
esempio- la pubblica istruzione musicale: non tutti devono saper suonare
uno strumento. Ancora, la nozione di meritorietà dipende da vari fattori
tecnologici, e da scelte politiche, che possono evolvere nel tempo: ad
esempio, la telefonia fissa è ancora considerata come un servizio di interesse
economico generale, nonostante il fatto che ormai il numero degli abbonati
alla telefonia radiomobile abbia ampiamente superato quello dei cittadini
residenti; di converso, nonostante l'evidente importanza dello sviluppo di
Internet per la competitività e per la coesione sociale, la fornitura di banda
larga non è ancora esplicitamente considerato come un servizio di interesse
economico generale. La nozione di interesse generale basata su un criterio
di meritorietà è quindi, e non potrebbe essere altrimenti, una nozione
storicamente determinata, dalla tecnologia, e dalle decisioni collettive
della società.
Si noti che una valutazione di meritorietà è condizione necessaria, ma non
sufficiente: certamente il latte fa bene ai bambini, e la fornitura di latte
potrebbe essere considerata un bene meritorio. Solo in pochi paesi, tuttavia,
viene fornito latte gratuito alle famiglie che abbiano bambini piccoli.
La definizione della Commissione peraltro suggerisce come possano esservi
altre caratteristiche che forniscono condizioni necessarie per l’esistenza di
un interesse pubblico da tutelare. Anche se il riferimento alla "coesione
economica, sociale e territoriale " appare senz'altro alquanto vago, essa
nondimeno indica come alcuni servizi possano soddisfare interessi generali
in quanto essi favoriscono una ragionevole redistribuzione del reddito.
Ad esempio, la scuola favorisce una più equilibrata distribuzione
139
Ibidem, par.14.
174
intertemporale del reddito, dando la possibilità che anche ai figli delle
famiglie più disagiate di ricevere un'educazione.
In secondo luogo, il riferimento alla nozione di "coesione territoriale",
potrebbe essere razionalizzata come riferimento all'esistenza di una ulteriore
condizione necessaria, ovvero che in alcuni casi la fornitura di un servizio
possa generare importanti esternalità positive. Questo è ad esempio il caso
delle ferrovie, che riducono l'inquinamento e possono facilitare il trasporto
di merci dalle aziende produttrici ai consumatori, ma anche di altri servizi
come l’elettricità o le telecomunicazioni.
Servizi meritori, che favoriscono una più equilibrata distribuzione del
reddito, o che generano esternalità positive, devono essere disponibili alla
generalità dei cittadini: in questi casi deve esservi, in altre parole, l'offerta di
un servizio universale.
In generale, se una determinata attività viene ritenuta di interesse generale
(ma non necessariamente se è di interesse economico generale), essa viene
gravata di un obbligo di fornitura universale, che può essere riferito ad un
profilo geografico (ad esempio: fornire telecomunicazioni o elettricità in
tutto il Paese), e/o con riferimento a "fasce deboli" della popolazione, le
quali devono poter accedere al servizio a "condizioni abbordabili" 140.
In qualche caso l'offerta di questo servizio deve avere carattere gratuito (ad
esempio la scuola dell'obbligo), mentre in altri deve essere fornito a
pagamento, ma a prezzi contenuti in modo da favorirne il consumo da parte
delle fasce più deboli della popolazione, che altrimenti non ne
usufruirebbero, in modo da favorire la "coesione sociale" .
La discussione dei capitoli precedenti, evidenzia peraltro come vi sia un
caso ulteriore, o di grande importanza, in cui l'offerta di un servizio possa
risultare insufficiente rispetto alla domanda, anche nei casi in cui il servizio
non sia ritenuto meritorio, e questo è evidentemente il caso del monopolio,
ed in particolare del monopolio naturale.
Come abbiamo infatti discusso, i monopoli naturali non sono eliminabili;
d'altro lato, se lasciati a se stessi, i monopolisti naturali si comportano da
monopolisti, riducendo la produzione al fine di aumentare i prezzi.
Vi sono dunque, in una prospettiva economica, quattro principali motivi
per i quali alcune attività economiche possono essere considerate di
140
Naturalmente, declinare nella pratica tali obbligazioni non è sempre agevole, ed infatti
chi risieda in una casa isolata deve tipicamente corrispondere all'azienda distributrice di
elettricità un elevato contributo a copertura dei costi di posa delle linee elettriche
necessarie, e neppure chi abbia un reddito prossimo allo zero può godere di servizi gratuiti
di telecomunicazione o di fornitura di elettricità, nonostante questa sia l'unica modalità di
fornitura per lui "abbordabile".
175
pubblico interesse: il fatto che esse forniscano beni o servizi meritori; che
abbiano rilevanza sotto il profilo della distribuzione del reddito; che
generino importanti esternalità positive; che esse siano caratterizzate da
monopolio naturale e pertanto, non regolate, produrrebbero un volume di
output insufficiente.
15.4 Gli obblighi
Il secondo elemento comune alle varie definizioni di SIG o SIEG che
abbiamo visto è l’esistenza di obblighi particolari in capo alle imprese che li
forniscono: tra questi, come abbiamo discusso, ha un ruolo di rilievo
l'obbligo di fornire il servizio universalmente, a chiunque ne faccia richiesta.
Tale obbligo può derivare sia da motivazioni di "meritorietà" (se il servizio
è meritorio tutti devono poterne godere se lo richiedono) ma può anche
derivare dall'esistenza di un monopolio. Poiché monopolista, per innalzare i
prezzi, riduce la quantità prodotta, introducendo un obbligo di fornitura gli
si impedisce, o quantomeno si ostacola, tale riduzione di produzione.
Tradizionalmente, l'introduzione di un obbligo universale di fornitura veniva
accompagnato dalla concessione di un diritto esclusivo, nella presunzione
che i profitti di monopolio che l'operatore che forniva i servizi in questione
realizzava con riferimento ad alcuni utenti o ad alcune tipologie di utenza,
fossero utilizzati per fornire gli utenti che altrimenti non sarebbe stato
economico fornire, realizzando pertanto un sussidio incrociato tra le due
tipologie di utenti.
Così, per due terzi circa del secolo scorso, nelle telecomunicazioni in tutti i
paesi del mondo venivano praticati prezzi molto superiori ai costi per le
chiamate vocali a lunga distanza (servizio più frequentemente usato dalle
imprese), e i margini così ottenuti erano utilizzati per vendere a prezzi
inferiori ai costi le chiamate locali (servizio più frequentemente usato dalle
famiglie).
Naturalmente – come abbiamo visto nel caso Corbeau – può benissimo darsi
che ciò sia necessario, ma la necessità deve essere provata, e non può essere
soltanto presunta: le esigenze di interesse generale possono dunque
benissimo essere una condizione necessaria per dichiarare una data attività
di pubblico interesse, ma non sono certamente una condizione sufficiente per
la concessione di un diritto esclusivo. Questo punto è stato peraltro
dimostrato ad abundantiam nel corso degli anni novanta, proprio a partire
dalle telecomunicazioni, ove l'universalità del servizio è stata assicurata
anche riequilibrando i prezzi ai costi, sia nella lunga distanza che nella
telefonia locale, costituendo un fondo per il servizio universale, alimentato
da contributi versati da tutti gli operatori che, in concorrenza tra loro,
offrivano servizi di telecomunicazione in un mercato ormai liberalizzato.
176
Così, nello spirito di Corbeau, i sussidi incrociati sono stati resi espliciti,
obiettivamente quantificabili e non distorsivi dei meccanismi concorrenziali.
15.5 SIEG e gruppi di interesse
Nel decidere quali attività siano da considerarsi di interesse pubblico, come
abbiamo visto, occorre riferirsi ad alcuni criteri generali. Questi però sono
alquanto flessibili, ed almeno uno di loro - la meritorietà - fortemente
discrezionale.
L'esercizio di tale discrezionalità è dunque terreno fertile per l'opera dei
gruppi di interesse, che possono essere molto favorevoli ad una
dichiarazione di pubblico interesse per motivi che nulla hanno a che fare
naturalmente con il pubblico interesse. Ad esempio, storicamente
l’operatore gravato di obblighi di fornitura di un servizio di interesse
(economico) generale veniva “ricompensato” con l’attribuzione di un diritto
di monopolio, ed in molti casi questo risultava un monopolio appetibile, sia
perché nel complesso assicurava consistenti profitti, sia per altri motivi,
frequentemente di tipo politico (i dipendenti di tali aziende, lo vedremo
meglio più avanti, costituiscono naturalmente elettori molto motivati a
sostenere chi prometta loro dei benefici).
La nozione di servizio di interesse generale, meglio se declinata nella più
generica ed elastica definizione (come abbiamo visto) di "servizio pubblico”
è dunque una delle leve preferite anche da chi voglia monopolizzare il
mercato, o difendere il mantenimento di un diritto esclusivo di cui si trovi a
godere. Ad esempio, il termine “servizio universale” è stato storicamente
coniato dal presidente dell'americana AT&T negli anni trenta, quando
questa stava comprando le centinaia di piccole aziende telefoniche allora
esistenti negli USA, ed il suo presidente doveva convincere il congresso
americano a non intralciare una tale politica di monopolizzazione.
D'altro lato, poiché abbiamo visto nei capitoli che precedono come
l'esistenza di monopolio renda quasi sempre inevitabile una qualche forma
di regolazione dei prezzi, un secondo importante ruolo che svolgono i
gruppi di interesse nei servizi di interesse generale, è quello di tentare di
distorcere le decisioni regolamentari, ed in particolare quelle riguardanti i
prezzi, in proprio favore. Così, non sono rari i casi in cui essi cercano di
imporre alle aziende che forniscono tali servizi obblighi di fornitura anche
qualora esso non sia configurabile come in qualche modo ”essenziale”
(come il mantenimento di una linea ferroviaria, poco utilizzata, tra località
ben collegate dalla rete stradale), oppure di fornirlo a prezzi inferiori ai costi
medi per alcuni segmenti di clientela.
177
Figura 15.1. Una stilizzazione dell’andamento delle tariffe e dei costi
per diversi livelli di consumo.
Tariffa
elettrica,
costi
tariffa
costo medio
consumi
Ad esempio, la Figura 15.1, che stilizza la forma della curva delle tariffe
elettriche in vigore fino a tempi molto recenti in Italia e di quella dei costi
medi di fornitura al crescere dei consumi, evidenzia come, sia le famiglie
con bassi livelli di consumo che le imprese “energivore”, paghino l’energia
ricevuta meno del suo costo di produzione e di fornitura al cliente. Questi
gruppi di utenti, difesi da potenti gruppi di pressione (rispettivamente
sindacati e associazioni imprenditoriali), vengono finanziati nei loro
consumi elettrici dalle piccole e medie imprese, nonché dalle famiglie ad
alto consumo di elettricità, che non hanno lobbies così efficienti.
15.6 SIEG, normative sulla concorrenza ed aiuti di Stato
Il trattato istitutivo dell’Unione Europea prevede che le regole di
concorrenza debbano essere valide anche per le imprese che forniscono
servizi di interesse generale. L’articolo 102.2 TFUE recita infatti “Le
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del
presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in
cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata”.
D’altro lato, a tali imprese si applica anche la normativa che vieta aiuti di
Stato, ed in particolare l'articolo 107.1, che recita: “salvo deroghe
contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
178
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza”.
La sentenza nel caso Corbeau, che abbiamo sopra citato, fornisce i
parametri fondamentali per tracciare il limite tra la restrizione della
concorrenza e lo svolgimento di attività nel pubblico interesse.
I limiti che lo Stato deve rispettare nel fornire risorse a chi svolga in perdita
servizi di interesse economico generale sono individuabili nella
giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Altmark 141. Non si è in
presenza di aiuti di Stato quando 1) gli obblighi di servizio pubblico sono
definiti in modo chiaro; 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la
compensazione sono definiti in modo obiettivo e trasparente; 3) la
compensazione per il servizio pubblico si limita a coprire i costi con un
margine di utile ragionevole; e 4) quando la scelta dell’impresa viene
effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di
selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la
collettività, o il livello della compensazione è determinato sulla base di
un’analisi dei costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente, nel
settore interessato.
Se una di tali condizioni cumulative non è soddisfatta, l’intervento può
essere considerato un aiuto di Stato e deve, in linea di principio, essere
notificato alla Commissione Europea e da essa valutato.
Gli aiuti di Stato possono assumere forme molto diverse tra loro: il
denominatore comune è rappresentato dal fatto che lo Stato, o un’Autorità
pubblica regionale o locale, o un’impresa pubblica, devono conferire un
beneficio significativo, mediante risorse statali, impossibile da ottenere,
oppure ottenibile a condizioni molto più onerose, in normali condizioni di
mercato. Alcuni esempi possono essere rappresentati da concessioni fiscali,
ribassi tariffari, facilitazioni sulle linee di credito, tassi di interesse
agevolati, o altri tipi di vantaggi.
Per valutare se sussista la fattispecie di aiuto di Stato, la Commissione
Europea fa ricorso al cosiddetto criterio dell’investitore privato. In base ad
esso, si configura un aiuto di Stato quando lo Stato attribuisce un beneficio
ad un’impresa, o a gruppi di imprese, in condizioni e circostanze che un
investitore privato non accetterebbe, operando alle normali condizioni di
mercato.
Il divieto si applica anche agli SGEI, come mostrano il caso che segue.
141
Causa
C-280/00,
Altmark
Trans
GmbH
e
Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, pag. I-7747.
179
Gasunie - Il caso Paesi Bassi - Commissione Europea del 2 febbraio 1988
Il caso riguarda gli aiuti, sotto forma di tariffe preferenziali, conferiti dal governo
olandese
16. agli orticoltori olandesi, attraverso l’operatore Gasunie. L’Olanda è leader
europeo dell’orticoltura in serre riscaldate, in cui il combustibile è utilizzato per
riscaldare la serra e permettere le coltivazioni anche con temperature esterne basse.
Fin dal 1974, visto il grado elevato d'inquinamento atmosferico prodotto dall'impiego di
gasolio in orticoltura, il governo olandese aveva deciso di agevolare l'impiego del gas
naturale in tale settore. Nel 1985 il consumo di questo gas rappresentava più del 95 % del
consumo totale di energia nell'orticoltura olandese.
Nel mercato olandese il trasporto, l'importazione, l'esportazione e la vendita diretta ai
principali clienti collegati alla rete di distribuzione erano effettuati dalla società Gasunie,
che, pur essendo una società di diritto privato, era posseduta per il 50% dallo Stato
Olandese. Quest’ultimo aveva inoltre il diritto di approvare i prezzi di vendita e le
condizioni di fornitura e di approvare il programma di erogazione del gas. Il ministro
degli Affari Economici disponeva, inoltre, del potere di vietare la fornitura di gas naturale
all'interno o all'esterno dei Paesi Bassi ad un prezzo inferiore a quello da lui stesso fissato
e di fissare prezzi diversi per diverse categorie di gas.
Nell’ottobre del 1981, venne applicata una tariffa preferenziale agli orticoltori olandesi,
che venne definita dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il
mercato comune. In seguito a negoziati, la tariffa orticola fu allineata alla tariffa
industriale con una maggiorazione del prezzo che tenesse conto della media dei prezzi
correnti. Nel 1984, tuttavia, fu concluso un nuovo contratto che prevedeva il blocco del
prezzo del gas per l'orticoltura al livello medio dell'anno 1983; la Commissione
intervenne nuovamente bollando le tariffe come aiuti di Stato, in quanto avevano ridotto i
costi di produzione (dato che il riscaldamento incide per un 25-30% sui costi di
produzione degli ortaggi e fiori coltivati in serre riscaldate), e determinando quindi una
distorsione della concorrenza incompatibile con il mercato comune, in quanto il divario
tra questa tariffa e quelle praticate ad altri clienti industriali non erano giustificate da
criteri oggettivi.
Secondo la Commissione, una tariffa è da considerarsi preferenziale “quando possiede le
tre seguenti caratteristiche: avvantaggia alcune imprese o alcune produzioni che siano in
concorrenza con imprese o produzioni di altri Stati ed i cui prodotti siano oggetto di
scambi intracomunitari, è stata imposta dall'autorità pubblica, dà luogo ad un
versamento compensativo alla società distributrice da parte dello Stato membro o ad una
riduzione delle entrate statali”.
Si configura quindi un aiuto di Stato poiché “agendo in questo modo, lo Stato olandese
rinuncia a delle entrate che potrebbe incamerare tramite la sua partecipazione alla
Gasunie, per concedere agli orticoltori un vantaggio finanziario. Tale vantaggio
proviene dalle risorse dello Stato e la misura deve essere considerata quindi come un
aiuto[…]. Anche se i costi variano notevolmente per i diversi prodotti considerati e per i
singoli Stati membri, la produzione olandese ha un'entità abbastanza grande perché
anche un lieve vantaggio a livello di questi costi abbia un'incidenza sul prezzo alla
produzione. La produzione orticola olandese, quindi, usufruisce di un vantaggio che
incide necessariamente sugli scambi intracomunitari, tanto più che la maggior parte
della produzione olandese è esportata verso altri Stati membri”.
180
16. LA REGOLAZIONE DI PREZZI E SALARI
16.1 Premessa
I casi in cui lo Stato cerca di controllare i prezzi sono assai frequenti. In
alcuni casi – ad esempio, se c’è una forte inflazione – esso può cercare di
fissare per un certo periodo i prezzi di molte merci: il primo tentativo del
genere di cui si abbia traccia certa risale a Diocleziano, che nell’anno 301
fissò i prezzi di circa 1.000 prodotti sull’intero territorio dell’impero,
introducendo la pena di morte per i commercianti che non lo rispettassero.
In altri casi, lo Stato può cercare di fissare il prezzo di una particolare merce
per periodi di tempo assai lunghi: come vedremo, questo è il caso del
lavoro, merce il cui prezzo è regolamentato, in una forma o nell’altra, nella
maggior parte dei Paesi avanzati. In questa lezione cerchiamo di capire in
quali casi un controllo dei prezzi sia ragionevole, e cosa succede nei mercati
in cui esso venga applicato.
16.2 Il controllo dei prezzi
Vi sono due ordini di motivazioni che vengono offerte a giustificazione di
politiche volte al controllo dei prezzi.
La prima è di carattere macroeconomico: in periodi nei quali si manifesti
una forte inflazione, gli operatori economici si attendono che questa si
perpetui, e le loro aspettative, per un complesso di motivi che qui non
possiamo discutere, tendono ad essere self-fulfilling, o auto-realizzanti. In
questi casi, almeno secondo alcuni, introdurre un controllo dei prezzi
nell'economia può avere l'effetto di "raffreddare" le aspettative
inflazionistiche. La discussione di questa prospettiva appartiene più un
corso di taglio macroeconomico, e quindi qui ci basta osservare come
raramente queste politiche abbiano un effetto concreto: una volta scaduto il
blocco dei prezzi, questi aumentano, così da recuperare la fase in cui essi
sono stati bloccati.
La seconda prospettiva, che qui ci interessa, e che può contribuire anche a
spiegare il fallimento delle politiche macroeconomiche, è invece di
carattere microeconomico: quando i venditori, in uno o più mercati, si
trovano a possedere un potere contrattuale estremamente forte nei confronti
degli acquirenti, vi potrebbe essere, almeno secondo alcuni, la necessità di
un blocco dei prezzi volto ad evitare che questo potere di mercato venga
esercitato senza limiti: è quindi agevole osservare la congruenza di questa
motivazione per il controllo dei prezzi con quella di altre politiche volte al
controllo delle tariffe, di cui ci siamo già occupati. Come vedremo, vi sono
però alcune differenze importanti.
Consideriamo l'ipotetico mercato descritto dalle curve di domande di offerta
nella Figura 16.1 (supponiamo che sia il mercato del pane), e chiediamoci
181
che cosa succederebbe se cercassimo di fissare, a qualche livello, il prezzo
massimo a cui è consentito vendere e comprare pane. È evidente che nel
caso tale prezzo fosse superiore al prezzo di equilibrio, non ci sarebbe alcun
problema, perché tutti gli operatori si scambierebbero pane al prezzo di
equilibrio PE; il controllo dei prezzi sarebbe totalmente inutile. Egualmente
inutile sarebbe il controllo dei prezzi, qualora venisse fissato un prezzo
minimo esattamente pari al prezzo di equilibrio.
Ma cosa succederebbe se, ad esempio per combattere l'inflazione,
Diocleziano fissasse un prezzo massimo PMAX, inferiore al prezzo di
equilibrio PE?
Figura 16.1. Il controllo dei prezzi
P
Offerta
PE
PMAX
Domanda
Offerta a PMAX
QE
Domanda a PMAX
q
Eccesso di domanda
A quel prezzo, come indicato nella figura, la quantità di pane domandata
sarebbe superiore a quella domandata in equilibrio, poiché il prezzo basso
stimolerebbe la domanda. Specularmente, la quantità offerta di pane sarebbe
inferiore a quella offerta in equilibrio, perché il prezzo troppo basso
scoraggerebbe l'offerta. Si creerebbe pertanto immediatamente un eccesso di
domanda di pane: non ci sarebbe pane sufficiente per tutti gli acquirenti,
che formerebbero code davanti ai negozi 142.
142
In questo modo, invece di allocare l'offerta esistente tra i possibili compratori in base al
prezzo che ciascuno di essi è disposto a pagare per il pane (questo è il modo in cui
funzionano i mercati, naturalmente), l'offerta viene allocata mediante un meccanismo di
code: dal punto di vista economico, questi due meccanismi svolgono la medesima funzione,
ovvero quella di razionare l'offerta disponibile tra i compratori potenziali. Naturalmente, il
meccanismo di mercato privilegia i compratori che assegnano al pane un valore più alto,
182
Qualora il blocco dei prezzi venisse mantenuto per un certo tempo, le
imprese reagirebbero in vari modi, ad esempio riducendo la produzione
dei beni il cui prezzo è controllato, in modo da indirizzare gli acquirenti
verso beni il cui prezzo non sia controllato 143, oppure facendo diminuire la
qualità dei prodotti. Esse inoltre, prima o poi, ridurrebbero gli
investimenti nella produzione di pane, poiché naturalmente la redditività di
questa attività è stata ridotta dalla fissazione dei prezzi: nel corso del tempo,
il pane si farà sempre più scarso, e di qualità sempre peggiore.
Questi effetti sono universali, ed infatti il primo a sperimentarli fu
l’imperatore Diocleziano, e sono da ultimo risultati del tutto evidenti nelle
economie pianificate nel corso del ‘900.
Concludiamo che il controllo dei prezzi mediante l'imposizione di prezzi
massimi inferiori al prezzo di equilibrio, è in generale una politica del tutto
errata, che viene rapidamente vanificata dalla reazione dei mercati: anche
se essa può sembrare una politica economica ragionevole, magari agli occhi
di un politico, essa è votata al sicuro fallimento.
16.3 Il salario minimo
Dal punto di vista della scienza economica, il lavoro è una merce come tutte
le altre, anche se certamente esso riveste, dal punto di vista individuale e
collettivo, valenze molto complesse sotto il profilo psicologico, etico, e
sociale. Ad esso dunque si applicano gli strumenti dell'analisi economica,
anche se certamente non soltanto questi strumenti: dal punto di vista del
nostro corso ciò comunque comporta che le politiche volte a controllare il
prezzo del lavoro possono essere valutate in quanto politiche economiche.
Queste politiche sono molto diffuse internazionalmente, e prevedono
generalmente la fissazione di un salario minimo. L'Italia, con pochi altri
paesi, si è invece data un sistema diverso, nel quale sindacati ed associazioni
datoriali fissano il salario minimo contrattando tra loro, e quanto da loro
concordato assume carattere di inderogabilità, e di validità erga omnes.
Questo è però un caso specifico, ed iniziamo la nostra discussione
considerando quello più frequente, ovvero la fissazione normativa di un
salario minimo.
mentre il secondo privilegia i compratori che hanno il tempo per aspettare in coda
l'assegnazione di pane.
143
Ad esempio, a metà degli anni 70, i produttori di pasta alimentare italiani reagirono ai
controlli dei prezzi introdotti dal governo dopo la crisi petrolifera riducendo la produzione
dei tipi di pasta il cui prezzo era controllato, ed aumentando la produzione dei tipi per i
quali il prezzo era libero. Il governo reagì aumentando il novero dei tipi di pasta di cui
controllava i prezzi, ma naturalmente i produttori non fecero fatica a inventare nuovi tipi e
formati, riuscendo così a vanificare la politica governativa.
183
Nel mercato del lavoro, la domanda e offerta di lavoro (L) variano con il
salario (w). Come evidenziato dalla Figura 16.2 la curva di domanda di
lavoro (Ld) è inclinata negativamente, in quanto un’impresa razionale
assumerà lavoratori fino a quando il margine apportato dal nuovo lavoratore
(o valore della produttività marginale del lavoro) sarà almeno pari al suo
costo. In altre parole, una fabbrica di scarpe assumerà un nuovo lavoratore
che produce 100 paia di scarpe al giorno, sulle quali la fabbrica riesce ad
avere un margine complessivo pari a € 70, soltanto se il costo giornaliero di
quel lavoratore sarà inferiore a € 70.
Pertanto, a parità di altre condizioni, tanto più elevato è il costo del lavoro,
tanto minore sarà il numero di lavoratori domandati: la curva di domanda
sarà inclinata verso il basso.
Figura 16.2 Domanda e offerta di lavoro
w
Ls
Salario di
equilibrio we
Ld
Le
Piena occupazione
L
Passiamo ad analizzare l’offerta di lavoro.
Il singolo lavoratore può scegliere quanto tempo dedicare al lavoro, e
quanto ad altre attività, come ad esempio la pesca. Lavorare stanca (e quindi
genera disutilità) mentre pescare è un’attività piacevole (genera utilità).
La scelta tra lavoro e tempo libero dipenderà evidentemente dall’utilità
marginale del salario e dalla disutilità marginale del lavoro. Il lavoro è
disutile perché il tempo è una risorsa scarsa suscettibile di usi alternativi
(pescare è più divertente) 144. Se il salario offerto è basso, il lavoratore sarà
144
Un modo alternativo di esprimere lo stesso concetto è che l'offerta di lavoro dipenderà
dal costo-opportunità del tempo libero: se il salario è basso, andando a pescare non devo
rinunciare a molto reddito, e quindi pescherò volentieri. Se il salario è alto, ogni ora passata
pescando mi costringerà a rinunciare ad un reddito considerevole, quindi sarò propenso,
almeno entro certi limiti, a lavorare un numero di ore più elevato.
184
propenso ad andare a pescare; se invece il salario è elevato, il lavoratore sarà
disposto a sacrificare ore di pesca per andare a lavorare. Quindi la curva di
offerta del singolo lavoratore cresce al crescere del salario.
Una spiegazione alternativa può essere data pensando al mercato del
lavoro in termini aggregati: se il salario è molto basso, sceglieranno di
lavorare solo i lavoratori che hanno molto bisogno di lavorare. Al crescere
del salario, entreranno nel mercato del lavoro gruppi via via più ampi di
lavoratori 145, ed a salari molto elevati anche i pensionati vorranno tornare a
lavorare. La curva di offerta di lavoro, sia individuale che collettiva, è
dunque inclinata positivamente.
Prima di proseguire, è importante osservare come, al salario di equilibrio we,
ci sarà piena occupazione, nel senso che tutti i lavoratori che erano disposti
a lavorare ad un salario inferiore o eguale a we, potranno farlo. I lavoratori
che erano disposti ad accettare soltanto un salario superiore a we non
lavoreranno, ma non potranno essere considerati come disoccupati dal punto
di vista economico 146.
16.4 Effetti economici di un salario minimo
Supponiamo che, per qualche motivo (ci occuperemo tra breve di questi
motivi) venga fissato per legge un salario minimo wMIN, superiore al salario
di equilibrio we 147, come evidenziato dalla Figura 16.3.
E’ facile vedere come un salario minimo di questo tipo generi
disoccupazione. Ad un livello di salario pari a wMIN, un numero di lavoratori
pari a LMAX vorranno lavorare, perché il salario è elevato; ma le imprese
saranno disposte ad assumere, per i motivi che abbiamo sopra discusso,
soltanto LMIN lavoratori.
145
Questa non è una ipotesi teorica. Ci sono numerosi studi che dimostrano come le
giovani madri entrano sul mercato del lavoro solo se lavorando e pagando una baby-sitter
per i figli hanno comunque un reddito residuo positivo.
146
Vi è quindi un’importante differenza tra una nozione economica di disoccupazione, e
nozioni utilizzate in altri contesti, secondo le quali c'è piena occupazione quando lavorano
tutti quelli che vogliono lavorare, nel senso che ciascuno è in grado di trovare un lavoro che
offra il salario che egli desidera.
147
Esattamente per gli stessi motivi discussi più sopra considerando i prezzi, se il salario
viene fissato al di sotto del livello di equilibrio, o esattamente al livello di equilibrio, non vi
sono effetti apprezzabili.
185
Figura 16.3. Salario minimo
w
Ls
wMIN
we
Ld
LMIN
Le
LMAX
L
Un salario minimo, fissato ad un livello superiore a quello di equilibrio, crea
quindi una disoccupazione pari alla differenza tra (LMAX – LMIN), per due
motivi:
•
le imprese assumono meno lavoratori di quelli che avrebbero
assunto con il salario di equilibrio we: il salario elevato riduce la
domanda;
•
più lavoratori sono disposti a lavorare, rispetto a quelli che
lavorerebbero con il salario di equilibrio: il salario elevato aumenta
l’offerta.
Per quale motivo, allora, si fissa il salario minimo?
Se il salario minimo esplica effetti così fortemente distorsivi, dunque,
dobbiamo avere dei motivi assai cogenti per adottare una simile politica
economica. Vediamo quali essi possano essere.
Il motivo principale per cui si ritiene opportuno fissare un salario minimo è
che il datore di lavoro ha nei confronti del lavoratore un forte potere di
mercato, e ha cioè un forte potere di monopsonio (chiamiamo così il potere
di monopolio dal lato della domanda).
Per capire come funzioni un mercato monopsonistico, è utile affiancarlo ad
un mercato monopolistico: in quest'ultimo (si osservi il lato sinistro della
Figura 16.4) il monopolista sceglie la quantità da produrre non eguagliando
il suo costo marginale al prezzo, ma eguagliandolo al ricavo marginale. Egli
quindi pratica il prezzo più alto che il mercato è in grado di tollerare per
acquistare quel quantitativo.
Simmetricamente, il monopsonista non decide quanto lavoro comprare
eguagliando la produttività marginale del lavoro (che determina la sua curva
186
di domanda) con il salario, bensì eguagliando la produttività marginale del
lavoro con la spesa marginale in salari. Il monopsonista comprerà quindi LM
unità di lavoro, e le pagherà il salario più basso che il mercato riesce a
tollerare, che è pari nel grafico a wM.
Figura 16.4. Domanda e offerta con monopsonio
Monopolio
P
Monopsonio
w
Ricavo
marginale
Spesa marginale
PM
Offerta
Offerta
wE
PE
Domanda
wM
Domanda
QM
QE
Q
LM
LE
Se il mercato del lavoro è effettivamente caratterizzato da una situazione di
monopsonio come quella illustrata dalla figura, sarebbe in effetti
ragionevole cercare di fissare il salario ad un livello più alto di quello che il
monopsonista sarebbe disposto a pagare: così come nel monopolio possiamo
cercare di fissare un prezzo massimo in modo che il monopolista non
eserciti il suo potere di mercato, nel monopsonio possiamo cercare di fissare
un prezzo minimo, e in questo caso quindi un salario minimo, per evitare
che il monopsonista eserciti il suo potere di mercato, pagando solo wMPS i
suoi dipendenti. Fissando il salario minimo esattamente al livello wE, si
eviteranno le distorsioni derivanti dal monopsonio, ed il mercato funzionerà
come se vi fosse concorrenza perfetta.
Questa è la ragione storica dell’imposizione di un salario minimo, introdotto
in vari Paesi a partire dalla fine dell’Ottocento, quando ci fu un grosso
impulso alla meccanizzazione e si creò una situazione in cui l’offerta di
lavoro era elevata, ma le imprese assumevano relativamente poco grazie alla
tecnologia, arrivando ad avere un fortissimo potere nel mercato del lavoro.
Il salario minimo si estese poi ulteriormente dopo la crisi del 1929.
Prima di proseguire è importante osservare come, sia fissando un prezzo
massimo nel monopolio, che un salario minimo nel monopsonio, stiamo
evidentemente cercando di rimediare ad un fallimento del mercato.
187
Esiste però un’importante differenza tra i due casi, sotto il profilo della
pratica possibilità di identificare un livello adeguato per la fissazione del
prezzo: nel caso del monopolio, il prezzo sarà in pratica fissato in
corrispondenza del costo medio del produttore, variabile relativamente
facile da conoscere. Nel caso del salario, la fissazione del salario minimo
richiede invece di conoscere sia la curva di domanda che quella
d’offerta, ed è quindi compito estremamente complesso, nel quale è assai
probabile sbagliare: come abbiamo visto, se l’errore consiste nel fissare un
salario troppo basso, non vi sono conseguenze negative, ma se il salario
minimo è troppo alto, si genera disoccupazione.
E se il salario minimo viene fissato con una contrattazione collettiva?
Dal punto di vista economico, fissare un salario minimo con una
contrattazione collettiva, e non per legge, è in generale una soluzione
sbagliata sotto il profilo del benessere sociale, perché genera una sorta di
monopolio bilaterale, ovvero un monopolio sia dal lato della domanda che
dell’offerta.
A differenza di un salario wMIN fissato per legge, che solitamente riflette
criteri di equità, un salario minimo così fissato riflette soltanto gli interessi
privatistici dei lavoratori e delle imprese, e la forza contrattuale delle due
parti. Se, nel momento della contrattazione collettiva, i sindacati dei
lavoratori sono più forti, il salario sarà quindi ad esempio wMON. Se invece
sono più forti i sindacati dei datori di lavoro il salario sarà wMPS. Nessuno di
questi livelli salariali è ottimale dal punto di vista della collettività.
Figura 16.5. Salario minimo contrattuale
w
Ls
MON
wMON
wMPS
MPS
Ld
LMPS
LMON
L
Dal punto di vista economico, quindi, fissare un salario minimo per via
legislativa può forse soddisfare l’esigenza pubblicistica di contenere un
188
potere di mercato, ma ciò certamente non si verifica quando il salario
minimo viene fissato attraverso la contrattazione collettiva.
In Italia questa argomentazione risulta ancora più convincente se si pensa al
fatto che i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ben lungi
dall’associare, rispettivamente, la maggioranza dei dipendenti o delle
imprese, ma ciò nonostante le clausole dei contratti che essi stipulano sono
inderogabili, ed aventi valenza, come già ricordato, erga omnes.
16.5 Mercato del lavoro segmentato: imprese diverse
Il mercato del lavoro non è però formato da imprese omogenee, come
abbiamo fino ad ora ipotizzato, bensì da imprese diverse, che hanno un
valore diverso di produttività marginale del lavoro (diversa tecnologia,
diverso prezzo dei prodotti). Questo vuol dire che esistono curve di
domanda diverse.
Ipotizziamo, ad esempio, che nel settore tessile esistano due tipologie di
imprese: le piccole e le grandi imprese tessili, con due diverse curve di
domanda, come da Figura 16.6. Supponiamo inoltre (per ora) che i
lavoratori siano identici. Le grandi imprese impiegano tecnologie più
avanzate e hanno bisogno di assumere operai specializzati. Quindi la
produttività marginale di ogni singolo lavoratore è molto alta e si riflette
nella loro capacità di pagare un salario elevato. Le piccole imprese non
hanno una produttività del lavoro così elevata, la produzione è basata su
tecnologie meno sofisticate e quindi il salario che esse sono disposte a
pagare è più basso.
Figura 16.6. Mercato del lavoro segmentato: imprese diverse
w
Domanda da
grandi imprese
Offerta di
operai tessili
wG
wP
Domanda da
piccole imprese
LP
LG
L
189
Dato che i sindacati delle grandi imprese sono più forti di quelli delle
piccole imprese, in un sistema in cui il salario è fissato attraverso i contratti
collettivi, è molto più probabile che esso venga determinato vicino al livello
di equilibrio delle grandi imprese, wG, piuttosto che vicino al livello di
equilibrio delle piccole imprese, wP.
Per un livello di salario così elevato, le grandi imprese assumeranno LG
dipendenti, ma saranno pochissime le piccole imprese che potranno
assumere, ed esse impiegheranno un numero di lavoratori pari a LP, numero
molto più piccolo di quelli che esse avrebbero assunto con un salario di
equilibrio wP.
Si verificherà quindi una situazione in cui molte piccole imprese
chiuderanno, oppure parte di esse entrerà nell’economia sommersa, dove
avranno costi (di lavoro e non) più bassi, perché non pagano le imposte e i
contributi sociali, e neppure il salario minimo stabilito dal contratto
collettivo.
16.6 Mercato del lavoro segmentato: lavoratori diversi
Nel mercato del lavoro esistono anche lavoratori diversi, oltre che imprese
diverse. Supponiamo ora quindi che la domanda di lavoro sia unica, ma che
esistano due offerte di lavoro: i lavoratori bianchi, disposti a lavorare ad un
salario più elevato, e i lavoratori neri, disposti a percepire un salario più
basso. Avremo quindi due diverse curve di offerta di lavoro, come
evidenziato nella Figura 16.7.
Se sono più forti i sindacati che rappresentano i lavoratori bianchi il salario
minimo fissato dai contratti collettivi sarà alto (wB) e ci sarà equilibrio nel
mercato del lavoro dei lavoratori bianchi.
Figura 16.7. Mercato segmentato: lavoratori diversi
w
Bianchi
Neri
wB
wN
Domanda
LB
LN
L
190
A questo livello di salario, se le imprese preferiscono, per qualche motivo, i
lavoratori bianchi, tutta la domanda di lavoro è soddisfatta da lavoratori
bianchi. Ci sarà quindi il pieno impiego nel mercato dei bianchi, e totale
disoccupazione nel mercato del lavoro dei neri.
In questa situazione i lavoratori neri scelgono o di emigrare o di uscire dal
mercato del lavoro legale e accettare salari inferiori a wB. Se invece il
mercato del lavoro funzionasse liberamente, esso raggiungerebbe un salario
di equilibrio wE, e lavorerebbero LB bianchi, ed (LE – LB) neri.
Figura 16.8 Mercato segmentato: lavoratori diversi senza fissazione di
wB
w
Bianchi
Neri
Bianchi
e Neri
wE
Domanda
LB
LN
LE
L
Naturalmente la stessa analisi è applicabile alla disoccupazione giovanile.
Se in un sistema economico, come certamente è quello italiano, nelle
organizzazioni sindacali hanno un peso preponderante i lavoratori anziani,
queste cercheranno di fissare un livello di salari che generi un equilibrio sul
mercato dei lavoratori anziani. I lavoratori giovani sono in genere molto
meno esperti degli anziani, e dunque le imprese sono pronte a riconoscere
loro un salario più basso. Per questo, un salario minimo elevato fissato con
riferimento ai lavoratori anziani tenderà a generare disoccupazione tra i
lavoratori più giovani.
16.7 Una nota di cautela: evitare spiegazioni semplicistiche
Per finire necessaria una parola di cautela. La struttura logica con cui
abbiamo affrontato i problemi della determinazione dei salari è molto
semplificata, e dunque non deve essere applicata meccanicamente. L’analisi
191
economica mette in risalto alcune relazioni fondamentali che sono spesso
ignorate, ma le relazioni fondamentali da sole spesso non bastano.
In particolare, la discussione sulla disoccupazione giovanile che precede ha
carattere esemplificativo, e la sua funzione didattica è quella di rendere
evidente come la fissazione di un salario minimo sia una politica economica
complessa da realizzare, soprattutto quando vi sia una forte eterogeneità di
lavoratori e di imprese.
A titolo puramente illustrativo, la Figura 16.9 presenta le determinanti della
disoccupazione giovanile italiana secondo un recente studio del professor
Tiraboschi: non abbiamo parlato di molte delle variabili che sono qui
indicate, e dunque è indispensabile tenere presente che la discussione in
questo corso è orientata a fornire un’introduzione alle diverse leve della
politica economica, ed ai loro fondamenti economici. Non, quindi, a
presentare analisi complessive.
Figura 16.9 - Le determinanti della disoccupazione giovanile italiana
secondo un recente studio
Fonte: http://aei.pitt.edu/44478/1/20120618-010420_tiraboschi_n91-2012intpdf.pdf
192
Parte IV – Esternalità, informazione imperfetta
e problemi di disegno dei mercati
193
17. INFORMAZIONI ASIMMETRICHE,
REGOLAZIONE DEI MERCATI
RAZIONALITA’
E
Nel modello microeconomico classico, tutti gli agenti economici hanno
informazioni perfette o complete e conoscono le caratteristiche e i prezzi di
tutti i prodotti.
La realtà è però più complicata e l’informazione è spesso imperfetta. Questo
genera, in alcuni casi, dei fallimenti di mercato (market failures) che devono
essere corretti attraverso particolari interventi di regolazione .
Ci sono, in generale, due problemi economici principali da risolvere:
•
in primo luogo, alcuni agenti economici hanno informazioni migliori
di altri sulla qualità dei prodotti/servizi e quindi c’è una forte
asimmetria informativa, in genere a favore dei venditori.
•
in secondo luogo, l’informazione è incompleta su una particolare
variabile chiave nel processo di scelta operato sui mercati, cioè il
prezzo, e quindi gli acquirenti spesso non conoscono il prezzo
praticato dai diversi venditori.
17.1 Informazione imperfetta sulla qualità dei prodotti/servizi
Per analizzare gli effetti sul funzionamento del mercato della presenza di
informazione incompleta circa la qualità dei beni, consideriamo, ad
esempio, il mercato delle auto usate, nel quale – semplificando –
ipotizziamo che esistano alcuni agenti economici che hanno informazioni
incomplete sulla qualità. Su questo mercato esistono due tipi di auto: quelle
di elevata qualità e quelle di bassa qualità (i cosiddetti “bidoni”). Un’auto
usata di buona qualità vale 1.000 €, mentre una di bassa qualità vale 200 €.
Il venditore ha un’informazione completa e cioè sa perfettamente qual è la
qualità della propria auto. Al contrario, un potenziale acquirente non
conosce la qualità dell’auto che intende comprare.
Per semplificare, supponiamo che la probabilità di acquistare sul mercato
un’auto di buona qualità sia del 40%, mentre quella di acquistare un’auto di
bassa qualità sia del 60%. Se l’acquirente non sa distinguere tra auto di alta
e bassa qualità, egli sarà disposto a pagare un prezzo pari al valore atteso
dell’auto, che sarà pari a 1000 con una probabilità pari a 0,4, ed a 200 con
una probabilità pari a 0,6, cioè nel complesso pari a:
(0,4*1.000) + (0,6*200) = 520 €
194
In pratica l’acquirente è disposto a pagare di più una macchina di bassa
qualità perché sa che potrebbe essere di elevata qualità, ma non è disposto a
pagare l’intero valore di un’auto di alta qualità (1.000 €) perché è
consapevole del fatto che l’auto potrebbe essere un “bidone”: le auto di
elevata qualità sono quindi sottovalutate, mentre quelle di bassa qualità sono
sopravvalutate dal mercato.
Che effetto ha questo risultato?
Se un venditore possiede un’auto di buona qualità che vale almeno 1000 €,
sa che la venderà al massimo per 520 € e quindi sarà restio a vendere l’auto,
perché non riuscirà a realizzare tutto il suo valore. Al contrario, il venditore
di un’auto di bassa qualità sa che dalla vendita realizzerà un importo
superiore al valore della propria auto, e quindi sicuramente venderà.
Ciò vuol dire che le auto di bassa qualità spiazzano quelle di elevata
qualità. In un mercato del genere, verranno venduti molti “bidoni” e poche
auto di buona qualità. Non esisterà quindi un mercato delle auto usate di
elevata qualità, ma solamente un mercato delle auto usate di bassa qualità.
Questo è un fallimento del mercato, in quanto esistono una domanda e
un’offerta potenziale delle auto usate di elevata qualità, ma il mercato non
esiste, a causa della grave asimmetria informativa.
L’esempio è volutamente estremo, ma in tutti i mercati in cui c’è
un’asimmetria informativa, la qualità dei prodotti/servizi scambiati è
inferiore alla qualità dei beni e servizi che sarebbe scambiata nel caso in cui
le informazioni non fossero asimmetricamente distribuite tra chi vende e chi
compra.
Questo problema è molto serio, soprattutto per alcuni tipi di beni e servizi.
Per capire meglio questo punto, introduciamo una definizione utile che
distingue tra:
•
search goods: beni o servizi dei quali, attraverso un’accurata ricerca,
è possibile conoscere la qualità. Prendiamo come esempio un’auto
nuova. Attraverso riviste, giornali specializzati, internet e così via, è
possibile stabilire quali siano le caratteristiche e quale sia la
performance dell’auto che si intende comprare;
•
experience goods: beni o servizi per i quali è molto difficile
determinare la qualità prima di averli consumati. Essa si può
apprendere solo con l’utilizzo. Se voglio sapere quale sia il gusto di
una mela, devo assaggiarla ma, se non mi piace, difficilmente il
venditore la riprenderà indietro. Avvocati, economisti e medici
forniscono dunque experience services.
Da questa semplice distinzione è facile comprendere che nei mercati in cui i
prodotti o servizi scambiati sono experience goods, il problema
195
dell’asimmetria informativa diventa molto serio e difficile da risolvere. Nel
caso di un search good, attraverso la ricerca, l’informazione, le riviste
specializzate si riesce a riequilibrare, almeno in parte, l’asimmetria
informativa iniziale.
Concludendo, il problema dell’asimmetria informativa è sempre importante,
ma riveste un ruolo fondamentale nel caso degli experience goods.
17.2 Come ridurre l’asimmetria informativa?
Nei mercati in cui c’è una forte asimmetria informativa, i fallimenti di
mercato possono essere molto gravi. Ad esempio, in Birmania esistono dei
villaggi posti a 10 chilometri da importanti miniere di pietre preziose. Se i
turisti le comprassero sul posto, le pagherebbero un decimo di quanto
pagherebbero a Milano. Ma nessun turista compra, perché la probabilità di
comprare un pezzo di vetro è del 95%. Se i minatori riuscissero a far
distinguere le pietre di elevata qualità dai pezzi di vetro avrebbero un
enorme fonte di reddito. Ma non riescono a riequilibrare questa asimmetria
informativa.
E’ dunque necessario eliminarle, o quanto meno ridurle, e ciò può essere
fatto in vari modi.
In alcuni casi, quando le caratteristiche qualitative sono permanenti e facili
da determinare, è possibile ricorrere a norme giuridiche. Questo è il caso, ad
esempio, della normativa in materia di pesi e misure, la quale fa sì che
l’acquirente non abbia incertezza circa il peso effettivo della merce che
acquista. Dal punto di vista economico, introducendo normative di questo
tipo, il mercato funziona in modo molto più rapido. Se il compratore
dovesse portare la bilancia da casa, o discutere ogni volta la correttezza
della bilancia del venditore, egli avrebbe costi di transazione elevati, e
comprerebbe certamente di meno. Una normativa di questo genere, che per
noi è ovvia, è dunque in realtà un efficace intervento pubblico volto a
correggere un fallimento di mercato.
Esistono poi delle norme di legge che recepiscono delle normative tecniche
fissate da enti para-pubblici, i cosiddetti enti di normazione. Questi
organismi stabiliscono le caratteristiche tecniche minime che devono avere
determinati prodotti (ad esempio, le normative UNI, oppure le normative
ISO) e possono esigere che i produttori rivelino informazioni sui propri
prodotti 148. Soluzioni di questo tipo vengono adottate quando le
caratteristiche tecniche di un prodotto cambiano nel corso del tempo: in
questi casi, la norma di legge stabilisce infatti unicamente un principio
148
Ad esempio, possono esigere che i produttori di elettrodomestici rivelino informazioni
sul consumo elettrico del bene prodotto.
196
generale di conformità – giuridicamente vincolante per tutti i produttori - dei
beni o dei servizi alle specifiche tecniche dettate dagli organismi di
normazione, che possono invece essere modificate nel tempo.
17.3 Auto-regolamentazione dei mercati
Un secondo modo per risolvere i problemi dell’asimmetria informativa sui
mercati è quello di normative ad opera dei soggetti che organizzano il
mercato stesso.
Ad esempio, in Europa, chi vende o compra rame, deve necessariamente
rivolgersi alla London Metal Exchange, che gestisce il più ampio ed
organizzato mercato in Europa. Per poter vendere su questo mercato, il rame
deve necessariamente avere determinate caratteristiche fisiche ed elettriche,
fissate da specifiche tecniche, che stabiliscono il tenore di rame di una barra:
ovviamente, il rame che non possiede tali specifiche tecniche non può essere
venduto. In questo modo, gli acquirenti possono essere certi che il rame che
acquistano alla London Metal Exchange è in possesso dei requisiti stabiliti:
gli organizzatori hanno infatti strutturato il mercato in modo tale da azzerare
le asimmetrie informative sulla qualità del prodotto.
Un altro esempio significativo è quello del mercato dei purosangue in
America. I cavalli da corsa vengono comprati e venduti all’età di tre anni, e
vengono utilizzati nelle corse fino a quando ne hanno dieci. Comprando un
cavallo, quindi, un acquirente sta quindi scommettendo non solo sulla sua
qualità, ma anche sulla sua capacità di svilupparsi atleticamente. Quanto
abbiamo imparato nel mercato dei ‘bidoni’ ci dice che, in assenza di
interventi, si svilupperebbe soltanto il mercato dei cavalli da corsa di cattiva
qualità, perché questi ultimi spiazzerebbero i purosangue di elevata qualità.
In America questo non si verifica, in quanto i cavalli vengono venduti in
due tipologie di aste, quelle non certificate e quelle certificate.
Nel primo caso i cavalli da vendere non devono avere requisiti particolari di
qualità. Per accedere ad un’asta di cavalli certificati, invece, i venditori
devono versare un importo ragguardevole alla Casa d’Aste, a fondo perduto,
ed autorizzare la Casa d’Aste ad effettuare una serie di analisi sul cavallo, in
modo tale da verificarne l’effettiva qualità. Nel caso in cui esso non
raggiunga gli standard qualitativi richiesti, la Casa d’Aste è autorizzata a
non metterlo in vendita.
Non sorprendentemente, il prezzo dei cavalli non certificati è molto più
basso di quello dei cavalli certificati, dato che questo sistema riduce le
asimmetrie informative per l’acquirente. La qualità dei cavalli è infatti
certificata dalla Casa d’Aste, che così mette a rischio la propria reputazione.
Con questo tipo di certificazione non è più la reputazione del venditore che
viene messa a rischio, ma appunto quella della Casa d’Aste, che ha
197
analizzato il cavallo. In questo modo si rimedia all’informazione
incompleta, mettendo in moto un processo di selezione efficace.
In alcuni casi, in particolare se non è possibile adottare soluzioni normative
ai fallimenti del mercato che derivano da una informazione asimmetrica
sulla qualità, possono essere le imprese stesse a cercare di prevenire questi
fallimenti.
Consideriamo, a titolo di esempio, ancora il caso delle automobili usate, ma
questa volta dal punto di vista di un concessionario di auto di gamma alta
(Mercedes, ad esempio), che ritira dai propri clienti auto usate,
generalmente di buona qualità. Questo concessionario, per i problemi che
abbiamo prima discusso, non riuscirà a farsi riconoscere dagli acquirenti
delle auto usate che porrà sul mercato il loro effettivo valore commerciale:
questi ultimi si attenderanno infatti che le auto siano di bassa qualità, e
quindi saranno disposti a pagare un prezzo relativamente basso. Ma se il
concessionario cominciasse a vendere auto usate, di qualsiasi marca, come
‘usato Mercedes’, spiegando che prima di essere vendute con tale marchio
le auto vengono accuratamente controllate per verificarne le condizioni, egli
riuscirebbe a spuntare sul mercato un prezzo più elevato. Questa soluzione
risolve il problema del fallimento del mercato derivante dall’esistenza di
esternalità.
In altri casi, invece di usare la propria reputazione, è possibile utilizzare, a
certe condizioni, la reputazione altrui. Le linee aeree di alcuni paesi in via di
sviluppo, cercano - ad esempio - di tranquillizzare i turisti circa le
condizioni di manutenzione dei loro aerei, facendo effettuare la
manutenzione a compagnie aeree molto note, e dando ampia pubblicità a
questo fatto: così, quando Ethiopian Airlines affida la manutenzione dei suoi
aerei a Lufthansa, sta utilizzando un brand e la reputazione di un’altra
compagnia, per dare informazioni ai propri clienti potenziali circa la qualità
dei propri servizi di trasporto aereo.
Queste soluzioni, che abbiamo esaminato, ai fallimenti del mercato derivanti
da asimmetrie informative sulla qualità sembrano assai diverse, ma hanno in
realtà evidenti punti di contatto, che risultano particolarmente chiari se
osserviamo come la vendita di un prodotto di alta, oppure di bassa, qualità,
generi delle esternalità nel mercato. Ogni volta che qualcuno vende
un'automobile usata di bassa qualità, genera degli effetti privati, che hanno
luogo tra il venditore e l'infelice compratore. Con questa transazione, il
venditore genera però anche degli effetti esterni, perché l'acquirente
informerà le persone che conosce della qualità insoddisfacente dell’auto
acquistata, e così facendo - con i meccanismi che abbiamo discusso genererà l'aspettativa che molte delle macchine usate vendute siano di bassa
qualità.
198
Questa è dunque una esternalità, perché gli effetti della transazione non si
esauriscono tra le parti della transazione stessa, ma influenzano anche altri
agenti economici, ed è una esternalità positiva se la qualità dell'auto
venduta è superiore alla qualità media, mentre è una esternalità negativa
nel caso contrario. Quando qualcuno vende una macchina di bassa qualità,
non sopporta le conseguenze della qualità di ciò che vende (incassa € 520
invece di € 200), e riversa quindi sul mercato una esternalità negativa.
Specularmente, chi vende ad € 520 un’auto di alta qualità che vale € 1000
genera sul mercato una esternalità positiva.
Come meglio vedremo quando ci occuperemo di politiche ambientali, vi
sono in generale due soluzioni a problemi di questo genere: l'esternalità
può essere limitata per via normativa (è per questo che sul mercato del
rame si può commerciare soltanto rame avente precise caratteristiche
chimiche e fisiche), oppure si può internalizzare l'esternalità (il
concessionario Mercedes, utilizzando il suo brand, a certe condizioni, su
macchine usate anche di altre marche, riesce a monetizzare, almeno
parzialmente, quella che sarebbe un’esternalità positiva che egli avrebbe
altrimenti ceduto al mercato).
17.4 Asimmetrie informative ed ordini professionali
Una delle funzioni degli ordini professionali è quella di ridurre le
asimmetrie informative di cui soffrono gli acquirenti di alcuni servizi. Essi,
infatti, certificano che chi è membro di un particolare ordine è in possesso di
alcuni requisiti minimi di scolarità e formazione, tali da garantire un
minimo di qualità del servizio.
Tuttavia, attraverso l’imposizione di questi requisiti è anche possibile per gli
stessi Ordini restringere l’entrata alla professione. Ad esempio, se gli esami
di ammissione vengono fatti a distanza temporale molto ampia, e solamente
per rimpiazzare il numero di professionisti andati in pensione o deceduti, si
controlla l’entrata sul mercato.
Così si comporta, ad esempio, l’Ordine dei Notai. Quindi, se la domanda di
notai cresce, ma l’offerta non aumenta, il prezzo dei servizi notarili sale.
Un ordine professionale ha quindi un effetto positivo nel diminuire
l’asimmetria informativa, ma anche un effetto negativo sul benessere
sociale, se restringe l’entrata sul mercato. Esso può avere un ulteriore effetto
negativo se, pur non restringendo l’entrata sul mercato, fissa il prezzo delle
prestazioni e si comporta quindi come un cartello, dove nessun membro
può lavorare a condizioni inferiori a quelle fissate dall’Ordine stesso.
Il risultato, del tutto simile a quello che abbiamo presentato analizzando gli
effetti del salario minimo, è che se il cartello fissa un prezzo minimo elevato
199
superiore a quello di equilibrio, ci sarà troppa offerta di avvocati (punto B),
come da Figura 17.1, e poca domanda di avvocati (punto A), perché il
prezzo dei loro servizi è elevato.
Figura 17.1. Domanda e offerta di servizi legali
prezzo
pMIN
A
Offerta di
avvocati
B
pe
Domanda di
avvocati
qMIN
qe
qMAX
quantità
avvocati disoccupati
Dal punto di vista economico concludiamo quindi che:
•
gli ordini professionali sono indispensabili, per garantire un livello
minimo qualitativo ai clienti e quindi per ridurre i problemi derivanti
da asimmetrie informative;
•
tuttavia, non è in genere giustificata nessuna restrizione nei confronti
dell’entrata nell’Ordine di nuovi professionisti;
•
la fissazione di tariffe minime non ha, in generale, effetti compatibili
con il pubblico interesse.
17.5 Asimmetria informativa sui prezzi
L‘asimmetria informativa può riguardare non soltanto la qualità, ma anche i
prezzi: anche se ci sono molti venditori e molti acquirenti, qualora questi
ultimi debbano sopportare dei costi di ricerca significativi per acquisire
informazioni sui prezzi praticati dai venditori, non è più vero - come
vedremo - che in un tale mercato prevalga un prezzo di concorrenza
perfetta.
Supponete che un professore milanese debba fare dei lavori edili in una
villetta che ha acquistato in Umbria, da realizzarsi sulla base di un progetto
200
che ha fatto preparare dal suo architetto di fiducia. Ci sono diverse imprese
edili nella zona che egli può contattare per realizzare il lavoro, ma non
conosce quale prezzo ciascuna di esse potrà offrirgli: egli soffre dunque di
una asimmetria informativa. Inoltre, egli deve sostenere costi di ricerca
considerevoli (viaggio da Milano, albergo, ecc.), pari ad un ammontare c,
per andare a trovare ciascuna impresa cui chiedere un preventivo. Pertanto,
egli pagherebbe costi di ricerca pari a c se assegnasse il lavoro alla prima
impresa, a 2c se lo assegnasse alla seconda impresa che visita, a 3c alla
terza, e così via.
Supponiamo che il prezzo che il professore potrebbe pagare se il mercato
fosse perfettamente competitivo sia pari a p, e questo lo sanno bene tutti gli
imprenditori edili.
Chiedetevi adesso: se voi foste uno di questi imprenditori, quale prezzo
offrireste per i lavori? Per rispondere, basta ricordare che se il professore
commissiona la costruzione alla prima impresa che egli visita, il costo che
sosterrà sarà pari a p1 + c (p1 è il prezzo che l’impresa gli chiede per
effettuare il lavoro); se invece decide di visitare una seconda impresa, e in
seguito di affidare ad essa il lavoro, il costo sarà invece pari a p2 + 2c, e così
via. Quindi un imprenditore razionale offrirà un prezzo pari a p* < p + c ,
ovvero appena inferiore alla somma del prezzo concorrenziale e del costo di
una singola ricerca.
Se vi è dunque informazione imperfetta riguardo ai prezzi, e i compratori
devono sostenere costi di ricerca, i prezzi, nel mercato, saranno più alti di
quelli di un mercato concorrenziale, indipendentemente dalla numerosità di
compratori e venditori. Questo risultato, insieme ad altri che qui non
presentiamo per la loro complessità, ci suggerisce come - a parità di altre
condizioni – per i consumatori la disponibilità di dettagliate informazioni
sui prezzi offerti dai diversi produttori sia, di per se stessa, in grado di far
scendere i prezzi.
Questa è dunque la motivazione economica che rende in generale benefiche
tutte quelle misure che aumentino il grado di trasparenza dei prezzi. Essa
spiega altresì naturalmente come siano dannose le misure che la
impediscano o la limitino, come ad esempio quelle che fino al 2000
vietavano in Italia ogni forma di pubblicità comparativa diretta, come
certamente è il confronto tra i prezzi.
Comunque, anche se i consumatori sono ben informati, essi possono
commettere errori. Come mostra infatti un recente studio sul mercato
elettrico inglese, anche nel caso in cui il mercato sia privo di asimmetrie
informative, la scelta dei consumatori non è sempre quella corretta:
un’analisi dei consumatori che hanno cambiato fornitore elettrico in Gran
Bretagna negli ultimi due anni dimostra che il 40% dei consumatori finisce
per spendere più che in precedenza. Questo è un risultato interessante
201
perché in un mercato del genere, una volta che sia nota la potenza e il livello
di consumo, la bolletta elettrica è determinabile in modo ovvio. Non c’è
nessun problema di asimmetria informativa sulla qualità del prodotto. Ma
nonostante ciò, il cliente sbaglia con una frequenza molto alta.
E’ un problema di razionalità limitata che abbiamo discusso nel Capitolo 3
che consiglio di rivedere.
202
18. LE POLITICHE AMBIENTALI
18.1 Costo privato, costo sociale e tragedia dei commons
Come si è detto in precedenza, le esternalità sono gli effetti derivanti dalle
scelte di un operatore economico che ricadono su altri operatori economici,
senza che questi siano stati parte di qualche transazione con l’operatore in
questione.
L’esistenza di forme di esternalità è molto significativa per le politiche
ambientali. Come abbiamo visto, un esempio classico di esternalità negativa
è dato dall'inquinamento: la mia acciaieria produce fumi che sporcano il
bucato della lavanderia vicina. Una scelta privata determina quindi un costo
sociale.
Questo costo non viene pagato dal produttore di acciaio, che razionalmente
quindi produrrà tutto l’acciaio che riesce a vendere, tenendo conto, come
abbiamo visto nella parte introduttiva di questo corso, del prezzo di mercato
e del proprio costo incrementale. Egli considererà in altre parole solo il suo
costo privato, ed ignorerà il costo sociale derivante dalla produzione di
acciaio.
Come mostra la Figura 18.1, la quantità di acciaio che deciderà di produrre
sarà pari ad A, e sarà data dall'intersezione della curva di domanda di
acciaio con la sua curva di offerta, che dipende unicamente dai suoi costi
marginali di produzione.
Figura 18.1. Costo privato e costo sociale
costo marginale
sociale
C
offerta (o costo
marginale privato)
Domanda
B
A
Q
203
Dal punto di vista sociale, tuttavia, la curva del costo marginale deve avere
un’ordinata maggiore, cioè essere traslata verso l’alto, poiché essa include
non soltanto il costo marginale della produzione di acciaio, ma anche il
costo marginale che l'inquinamento genera per altri agenti economici (la
lavanderia dovrà lavare due volte). Se il produttore di acciaio tenesse conto
di ciò, la produzione ottimale non sarebbe A, ma una quantità inferiore, pari
a B.
Notiamo come il livello di produzione B non elimini l’inquinamento, ma
generi un livello socialmente ottimo di inquinamento.
Notiamo ancora come il produttore di acciaio, se fosse in qualche modo
costretto a pagare anche il costo sociale (vedremo poi come) non si
troverebbe a pagare il danno ambientale provocato dall’emissione di un
quantitativo socialmente ottimale, ma limiterebbe solo l’emissione di
sostanza inquinante.
L’esempio che abbiamo fatto è naturalmente un caso di “risorse comuni”
come le abbiamo definite più sopra nel capitolo 14. Come abbiamo visto,
questi sono tipicamente beni per i quali vi è rivalità nel consumo, ma ove è
difficile, o estremamente costoso, escludere altri dal loro godimento. Questa
caratteristica genera un consumo eccessivo rispetto alla disponibilità: le
risorse comuni si depauperano facilmente. E’ un classico caso di ‘tragedia
dei commons’.
Esternalità e “risorse comuni” sono dunque i “motori” delle politiche
ambientali.
18.2 Coase non funziona, e neppure la giustizia civile
Vi sono diversi modi di risolvere un’esternalità negativa come quella che è
stata qui discussa.
La prima soluzione, basata sul teorema di Coase, è basata sull'osservazione
che il problema posto dall'esternalità in realtà deriva da una allocazione
errata dei diritti di proprietà: se il proprietario dell'acciaieria e quello della
lavanderia si incontrassero e stabilissero un meccanismo di compensazione,
quella che prima era una esternalità diventerebbe una transazione di
mercato, e il proprietario dell'acciaieria produrrebbe un quantitativo di
acciaio ottimale, perché considererebbe tra i costi di produzione anche quelli
che egli deve sostenere per compensare il proprietario della lavanderia.
Questa è un’osservazione interessante dal punto di vista teorico, ma priva di
validità pratica. Per funzionare, il produttore di acciaio dovrebbe concludere
una miriade di contratti con tutti coloro che patiscono gli effetti del suo
inquinamento. Ma questo è impossibile, in primo luogo per gli elevati costi
204
di transazione, tra i quali hanno un ruolo rilevante le asimmetrie
informative.
Non possiamo peraltro escludere che una soluzione di questo genere sia
praticabile in qualche caso specifico (TIM può offrire al mio condominio
qualche migliaia di euro per compensare i condomini per l’inquinamento
elettromagnetico di una nuova antenna), ma essa non è certamente una
soluzione di carattere generale. Occorre quindi disegnare qualche strumento
di politica ambientale che abbia validità generale.
Un secondo punto che è necessario discutere è se – non potendo applicare
Coase – il ricorso alla giustizia civile possa controllare l’inquinamento. Ad
esempio, se il produttore d'acciaio teme che il proprietario della lavanderia
gli possa fare causa per danni, egli considererà le spese legali e la
liquidazione del danno nelle sue decisioni di produzione, e sarà quindi
indotto a produrre una quantità inferiore a quella che avrebbe altrimenti
prodotto.
Il punto non è soltanto teorico, perché in vari paesi, prima che venissero
introdotte specifiche normative ambientali, i problemi dell'inquinamento
venivano affrontati nel diritto civile. Negli Stati Uniti, ad esempio, per una
lunga fase storica i tribunali costruirono normative ambientali basandosi
sulla nozione di nuisance della common law, che tuttavia richiedeva ai
giudici di valutare – per la gioia degli avvocati - se la produzione che veniva
realizzata in una data località era irragionevole, date le caratteristiche
dell'area, se l'interferenza con i diritti di proprietà dei vicini fosse
sostanziale, e di tenere anche conto degli effetti di un eventuale divieto
sull'impresa responsabile dell'inquinamento.
Le normative ambientali vennero gradatamente sviluppate quando apparve
chiaro come le liti in materia ambientale fossero lunghe e costose, poiché
richiedevano di accertare fatti scientifici complessi, e ponevano
frequentemente problemi di nesso causale tra attività inquinante e danno
reclamato. Quindi, pochi erano i danneggiati che le instauravano, e - dal
punto di vista sociale - questo riduceva il costo atteso per gli inquinatori .
Le politiche ambientali sono quindi necessarie perché i costi di transazione
da sostenere perseguendo soluzioni privatistiche sono troppo elevati.
18.3 Chi inquina paga (‘polluter pays principle”)
Prima di passare alla discussione degli strumenti, è importante sottolineare
come sia ormai (in teoria) relativamente pacifico, almeno all’interno
dell’Unione Europea e nei principali paesi industrializzati, che le politiche
ambientali debbano basarsi sul principio-base che il prezzo di un bene o di
un servizio dovrebbe riflettere fedelmente il suo costo totale di produzione,
205
comprendendo sia il costo di risorse private che di quelle ambientali. In altre
parole, sul principio “chi inquina paga”.
Applicandolo, evidentemente vengono internalizzate le esternalità.
18.4 Le imposte ambientali
Alla luce della Figura 18.1 che precede, e del principio ‘chi inquina paga’, è
evidente l’attrattiva intellettuale esercitata dall’introduzione di una pollution
tax, ovvero di un’imposta a carico del produttore di acciaio, il cui
ammontare sia grosso modo equivalente ai costi ambientali che questi
genera.
Come mostra la Figura 18.2, l'imposta – se riuscissimo a determinarne
correttamente la grandezza - aumenterebbe il costo di produzione
dell'acciaio fino a quando la curva di offerta dell’acciaieria non rifletterebbe
più il costo marginale privato, bensì il costo marginale sociale: la
produzione di acciaio, se l'ammontare di questa imposta ambientale è
determinato in maniera corretta, produce quindi un livello di inquinamento
ottimo sotto il profilo sociale.
Figura 18.2. L’imposta ambientale
costo marginale
sociale
C
offerta
Pollution
Tax
QS
Domanda
QP
Q
Quando passiamo dalla teoria alla pratica, le imposte ambientali incontrano
evidenti problemi.
Vi è in primo luogo quello della determinazione dell’imposta, che come
abbiamo visto dovrebbe rappresentare il costo ambientale della produzione
di un’unità di acciaio. Determinarlo è un problema complesso, perché
206
naturalmente ci saranno acciaierie diverse, con tecnologie diverse, e quindi
con costi ambientali tra loro diversi. Non bisogna però ingigantire questo
problema, perché anche un’imposta approssimata avrebbe probabilmente
effetti ambientali positivi. E’ vero che, qualora l’imposta fosse troppo alta
verrebbe prodotta una quantità socialmente troppo bassa di acciaio, ma in
pratica l’operare dei gruppi di interesse è talmente efficace nelle democrazie
moderne che la probabilità di un’imposta eccessiva è molto bassa. È invece
molto più elevata la possibilità che l’imposta sia troppo contenuta rispetto al
livello che essa dovrebbe teoricamente assumere, ma potremmo
ragionevolmente argomentare che un’imposta troppo bassa sia comunque un
passo avanti rispetto a una situazione in cui non vi sono imposte che
internalizzino le esternalità negative derivanti dalla produzione di acciaio.
Vi è in secondo luogo un problema distributivo. L’acciaieria, infatti, traslerà
una certa quota dell’imposta ambientale che si troverà a pagare sugli
acquirenti di acciaio. È possibile determinare con una certa precisione quale
parte dell’imposta sarà traslata, ma ai fini di questo corso ci basta
evidenziare che la traslazione sarà tanto maggiore quanto più la domanda è
rigida, ovvero tanto più è difficile per i consumatori sostituire l’acciaio con
altri materiali. Se invece l’acciaio è facilmente sostituibile, la sua domanda
avrà un’elevata elasticità, e quindi la traslazione sarà minima, perché se
fosse più elevata la domanda di acciaio crollerebbe.
Il problema distributivo nasce dunque dal fatto che non solo sarà l’acciaieria
a pagare l’imposta, ma anche gli acquirenti di acciaio verranno a pagarne
una parte, e così, via via, verso valle: gli acquirenti di un’automobile, che
contiene acciaio, si troveranno quindi a pagare anch’essi una parte
dell’imposta ambientale.
Se ciò sia giusto o meno sotto il profilo della distribuzione del reddito non è
una questione che si possa decidere dal punto di vista economico. Però
l’economia suggerisce come questa soluzione sia efficiente perché scoraggia
sia la produzione eccessiva di acciaio (una parte dell’imposta la paga
l’acciaieria) sia il consumo eccessivo di acciaio (chi usa beni ad alto
contenuto di acciaio pagherà un’imposta più alta di chi ne usa a basso
contenuto di acciaio). L’imposta ambientale avrà quindi un effetto di
riduzione della domanda e di riduzione della produzione di acciaio, che è
esattamente quello che la riduzione dei costi ambientali richiede.
Un punto molto più delicato è che, se le imposte ambientali sono applicate
solo alla produzione (poniamo) di acciaio in Italia, i produttori italiani
saranno fortemente svantaggiati nei confronti dei produttori internazionali,
che potranno esportare acciaio in Italia senza pagare l’imposta alla
207
produzione 149. Applicare imposte all’importazione per risolvere questo
problema ne genererebbe di molto complessi e sarebbe fortemente
problematico sotto il profilo dell’applicazione degli accordi GATT, e
certamente incontrerebbe enormi resistenze da parte di quei Paesi (in primo
luogo naturalmente la Cina) ove i costi ambientali della produzione sono in
larghissima misura trascurati. Nonostante vari dibattiti nell’ultimo
ventennio, nessun Paese – non sorprendentemente - ha cercato di introdurre
imposte di questo tipo. Rimane il fatto che, senza imposte ambientali anche
sulle importazioni, l’imposizione di un’imposta ambientale sulla produzione
domestica ha soltanto l’effetto di far migrare verso altri paesi le attività
inquinanti. Come vedremo, questo è esattamente quanto è successo in
seguito all’applicazione nel 2005 di un sistema europeo di permessi di
emissione per l’anidride carbonica.
Naturalmente, l’imposta ambientale potrebbe essere introdotta non a carico
dei produttori, ma dei consumatori, perché non è eccessivamente complicato
calcolare il contenuto (poniamo) di acciaio di un’autovettura.
Il problema di questa soluzione è che l’inquinamento dipende sia dalla
domanda (i consumatori possono scegliere beni che è più o meno
ambientalmente costoso produrre) sia dall’offerta (i produttori dello stesso
bene, ad esempio l’acciaio, possono scegliere tecnologie di produzione e
depurazione aventi effetti ambientali molto diversi). Tassando il consumo, è
probabile che ci siano effetti sensibili sulla domanda, ma effetti molto più
deboli sull’offerta, ma è naturalmente l’offerta, cioè la produzione,la fase in
cui adottando tecnologie appropriate può essere minimizzato il consumo di
risorse ambientali. In altre parole, un’imposta ambientale sul consumo
genera incentivi deboli alla riduzione dell’inquinamento nella fase della
produzione.
D’altro lato, almeno per alcuni prodotti, le imposte sul consumo hanno un
effetto straordinario. E’ questo il caso delle buste in plastica il cui consumo
è enorme: circa 300 milioni di cittadini americani ne consumano ogni anno
100 miliardi.
In vari Paesi, l’introduzione di una piccola imposta ambientale (più
frequentemente introdotta come obbligo per i dettaglianti di far pagare un
prezzo minimo per ciascuna busta) ha avuto un effetto enorme. In Irlanda,
ad esempio, l’introduzione di un prezzo obbligatorio pari a € 0,15 nel 2002
ha ridotto in cinque mesi del 90% l’uso di buste di plastica.
Un secondo risultato interessante che possiamo ottenere dal caso delle buste
di plastica, riguarda l’effetto relativo di un’imposta e di un sussidio. In
149
Questo problema, come vedremo tra poco, ha avuto un effetto di estremo rilievo nel
determinare la sostanziale inefficacia anche della politica basata sui “permessi di
emissione” adottata in Europa,
208
teoria, se i consumatori sono razionali, un’imposta ambientale di € 0,10
sull’uso di buste di plastica a perdere, dovrebbe avere esattamente gli stessi
effetti di un bonus di € 0,10 quando il consumatore si serve di una busta
riutilizzabile.
Un interessante studio recente 150, dimostra come questo non sia
assolutamente vero: dopo l’imposizione dell’imposta, la frazione di
consumatori che utilizza borse a perdere è scesa dall’82% al 40%; un bonus
di ammontare identico a quello dell’imposta non ne ha ridotto per contro in
misura apprezzabile il consumo.
Notiamo, senza approfondire, come questo risultato sia perfettamente
congruente con l’economia comportamentale, che predice come gli
individui siano molto più sensibili a penalizzazioni (in questo caso,
l’imposta sulle buste) che non ai premi per il loro utilizzo 151.
18.5 I permessi di emissione
Il sistema dei permessi di emissione è stato introdotto in Europa nel 2005,
ed ha dunque ormai un buon decennio di esperienza alle spalle. Esso
prevede la fissazione di un tetto massimo alle emissioni di anidride
carbonica consentite ai settori più inquinanti (in particolare industria pesante
e generazione di energia) durante periodi di tempo prefissati. Una certa
quantità di “permessi di emissione” equivalente a tale massimo viene
distribuita, in genere gratuitamente, ai principali inquinatori, che possono
poi scambiarli con altri soggetti (industriali e finanziari) partecipanti al
mercato. L’impresa più inquinante si troverebbe così ad avere una quantità
di permessi insufficiente rispetto alle proprie emissioni, e dovrebbe
acquistarne sul mercato da quelle meno inquinanti, sopportandone il prezzo.
Essa così sarebbe incentivata ad adottare tecnologie volte a ridurre le
emissioni.
Il sistema non ha mai funzionato adeguatamente, in quanto le lobbies
industriali hanno fatto sì che vi fosse (con modalità diverse nel decennio,
150
Si veda la sintesi in: http://www.plasticpollutioncoalition.org/pft/2015/11/23/do-bagfees-affect-consumer-behavior.
151
Per completezza, notiamo come – per motivi diversi – neppure la soluzione, che viene
talvolta proposta, di incentivare le imprese a introdurre meccanismi per ridurre
l’inquinamento, offrendo loro contributi che coprano una parte dei costi relativi, sia
ragionevole. Gli investimenti necessari a ridurre l'inquinamento sono per esse un puro
costo: un imprenditore razionale, investirà quindi nella depurazione o nella riduzione delle
emissioni soltanto se l'intero suo costo sarà pagato dal contributo statale. Assegnare
contributi inferiori al 100%, in assenza di altre misure, è dunque perfettamente inutile: ma
perché dovremmo regalare, a chi inquina, gli impianti di disinquinamento e coprirne i costi?
209
che qui non ci interessa approfondire 152) sempre una quantità eccessiva di
permessi in circolazione.
Il risultato di questa strutturale eccesso di disponibilità di permessi di
emissione ha determinato un andamento quasi costantemente cedente del
loro prezzo tra il 2007 e il 2014. Come possiamo vedere dalla Figura 18.3, il
prezzo di un permesso di emissione di una tonnellata di CO2 è sceso in
Europa dai circa € 25 all’atto dell’introduzione del sistema a circa € 4 di
fine 2014, ed è oggi (febbraio 2016) pari a 5.
Figura 18.3 - Prezzo dei permessi di emissione di CO2 in Europa, 20072014
Fonte: The Economist, http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21576388failure-reform-europes-carbon-market-will-reverberate-round-world-ets.
Livelli così depressi del prezzo dei permessi vanificano naturalmente la
ragione prima dell’intera costruzione, che era quella di fornire alle imprese
dei “segnali di prezzo” di questo particolare tipo di emissioni inquinanti,
così da rendere per loro razionale intraprendere investimenti in tecnologia
per ridurle. A livelli così bassi dei prezzi (per confronto, ricordiamo che il
prezzo attuale di permessi di emissione in California è di circa € 13) il
152
Si veda la discussione in: http://www.carlocarraro.org/argomenti/politicheclimatiche/dieci-anni-di-mercato-europeo-delle-emissioni/.
210
segnale che viene fornito alle imprese è esattamente di segno opposto: non
conviene investire in tecnologie che riducano queste emissioni.
Il sistema è dunque probabilmente fallito, anche se vi sono potenti interessi
che favoriscono una sua rianimazione, che dal punto di vista del settore
finanziario sarebbe certamente in grado di fornire significative occasioni di
profitto agli operatori più accorti, anche se l’obiettivo fondamentale
dell’intera costruzione (la riduzione delle emissioni) venisse in larga misura
mancato 153.
18.6 Limiti amministrativi
Una soluzione meno elegante, ma ampiamente applicata, di politica
ambientale consiste nell'imporre all'impresa di rispettare un livello massimo
ammissibile per le emissioni, abbattendo (ad esempio) i suoi fumi fino ad un
livello prefissato, e disponendo sanzioni economiche nei casi di mancato
rispetto.
Questa soluzione, dal punto di vista operativo, è più facilmente attuabile dei
sistemi di tassazione ambientale o di commercio di permessi di
inquinamento, poiché le soglie ammissibili possono essere determinate sulla
base di analisi ambientali e studi clinici relativamente semplici, ed i costi di
monitoraggio sui comportamenti delle imprese da parte della pubblica
amministrazione sono relativamente contenuti.
Dal punto di vista delle imprese, una soluzione basata su limiti
amministrativi genera incentivi molto chiari agli investimenti per ridurre
l’inquinamento: se non spende per gli investimenti, l’impresa spenderà per
le sanzioni. Inoltre, il livello degli inquinanti ammessi può essere ridotto
gradualmente nel tempo, graduando lo sforzo di investimenti richiesti alle
imprese.
Limiti amministrativi di questo genere sono un buon esempio delle
brightline rules relativamente frequenti nel sistema giuridico americano,
ovvero di regole comportamentali chiaramente definite, che lasciano poco o
nessuno spazio interpretativo. Il dibattito sul tema e complesso, ma vi è
certamente consenso sul fatto che regole di questo genere producono
risultati prevedibili e tra loro consistenti. Esattamente quanto abbiamo
bisogno in campo ambientale.
Anche questa classe di soluzioni soffre, come le precedenti, dei problemi
derivanti dal commercio internazionale: potremmo cioè imporre limiti
severi alle emissioni italiane, ma così facendo non avremmo alcun effetto
153
Si veda la discussione critica in http://www.economist.com/news/finance-andeconomics/21576388-failure-reform-europes-carbon-market-will-reverberate-round-worldets.
211
sulle emissioni di paesi che non sono particolarmente orientati a preservare
l’ambiente.
Tuttavia, il fatto che questo problema sia rilevante qualunque sia la
soluzione proposta, induce a concludere che l’unica strategia ambientale
ragionevole sia quella perseguita a livello nazionale, o da associazioni di
Paesi dotate di strumenti cogenti di politica ambientale (come l’Unione
Europea).
Nonostante tutti noi vorremmo che vi fosse uno sforzo a livello planetario in
questa direzione, se non altro per quanto riguarda le emissioni di CO2, la
realtà degli accordi internazionali che sono stati tentati in questi anni è del
tutto deludente.
Il Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997 ed entrato in vigore solo nel 2005,
per la riduzione delle emissioni di gas-serra (in sostanza, di anidride
carbonica), nonostante la grande enfasi mediatica, non ha avuto particolari
effetti, dato che esso non è stato sottoscritto o ratificato da Stati Uniti, Cina
e India, cioè da tre delle nazioni maggiormente responsabili dell’emissione
di questi tipi di gas a livello planetario, nonché, come mostra la figura, da
molti altri Paesi.
Figura 18.4. Protocollo di Kyoto - Paesi con limiti alle emissioni dei gasserra nel 2007
Fonte: Wikipedia, voce ‘Kyoto Protocol’.
212
Inoltre, esso non è mai riuscito ad introdurre alcun sistema di penalità. Le
riduzioni che vi sono state negli anni più recente di gas-serra sono infatti da
attribuire in larghissima parte agli effetti del rallentamento dell’economia
mondiale negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008, e non
certamente al Protocollo.
Alla luce della discussione del free riding che abbiamo sviluppato nel corso,
nessuno dovrebbe essere sorpreso dal suo scarso impatto, né ignorare le
dolorose previsioni della tragedy of commons nel progressivo
deterioramento di quelle risorse che abbiamo definito “risorse comuni” nella
nostra discussione dei beni pubblici puri. Come si ricorderà, abbiamo così
indicato quei beni per i quali vi sia rivalità nel consumo, ma non sia
possibile escludere alcuno dal consumo.
Questo è appunto l’ambiente: nonostante i molteplici messaggi che il
cambiamento climatico invia alla nostra civiltà, una sua riduzione che passi
attraverso virtuosi accordi internazionali appare molto poco probabile: il
quadro rimane quello, preoccupante, della figura che segue.
Figura 18.5. Emissioni di anidride carbonica da combustibili fossili a
livello globale, 1900-2015
Fonte: Boden, T.A., Marland, G., and Andres R.J. (2015).Global, Regional, and National
Fossil-Fuel CO2Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge
National Laboratory, U.S. Department of Energy, doi 10.3334/CDIAC/00001_V2015.
213
18.7 Conclusioni
Tutti gli strumenti di politica ambientale che abbiamo discusso soffrono del
limite fondamentale di essere utilizzabili all’interno del Paese che se ne
serve, ma di non riuscire ad avere effetti anche in altri paesi, e ciò rende
sempre presente il rischio di “esportazione” delle produzioni inquinanti.
Come abbiamo visto, di questo problema soffre anche il sistema dei
permessi di emissione commerciabili.
Ciò naturalmente apre la possibilità di “free riding” ai paesi che non siano
particolarmente interessati alla conservazione del proprio ambiente, ma
invece pongano un valore estremamente elevato al successo in campo
economico: questo naturalmente è un aspetto importante della politica
cinese dell’ultimo ventennio.
Come abbiamo visto, la “tragedia dei commons’ nasce appunto
dall’impossibilità di evitare comportamenti da free rider quando vi siano
risorse comuni e vi sia una rivalità nel consumo di questa risorsa. È dunque
probabile che le problematiche ambientali possano essere temperate da
intelligenti politiche nazionali, ma è difficile ipotizzare che esse vengano
risolte. Possiamo migliorare la situazione ambientale nel nostro Paese, o
forse in un’area economico e politica più ampia come la UE, ma è molto
difficile migliorarla a livello globale.
Quanto agli strumenti utilizzabili all’interno di una politica ambientale
nazionale, alla luce della discussione che precede è evidente come non vi sia
un unico strumento uniformemente superiore agli altri.
Probabilmente, nella misura in cui l’esperienza dei sacchi di plastica è
generalizzabile, piccole imposte sui consumatori hanno un effetto molto
sensibile, in applicazione dei principi dell’economia comportamentale che
sopra ricordavamo.
La tassazione ambientale sulla produzione è un problema molto complesso,
e come abbiamo visto le soluzioni complicate ed eleganti dal punto di vista
teorico (permessi di emissione) sono in pratica risultate inefficaci. È forse
ragionevole applicare in questo caso strumenti amministrativi certamente
rozzi, come l’imposizione del rispetto di limiti alle emissioni inquinanti, ma
che hanno bassi costi di monitoraggio.
214
19. LA
REGOLAZIONE
DELLA
PRESTAZIONE
LAVORATIVA: ORARI, SALUTE, SICUREZZA
Nelle lezioni precedenti abbiamo dimostrato come la presenza di asimmetrie
informative, costi di transazione, ed esternalità possa creare dei fallimenti
del mercato, risolvibili in vari modi.
In questa lezione applichiamo un simile schema concettuale allo studio di
problemi apparentemente molto lontani da quelli di cui ci siamo appena
occupati, che riguardano la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Queste considerazioni ci porteranno a capire perché esistono, nella maggior
parte dei paesi, normative in tal senso, e ci aiuteranno anche a comprendere
le conseguenze economiche di tali normative.
Le regole a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rispondono
certamente in parte a motivi non economici: la salute è, per usare un termine
che abbiamo imparato a conoscere, un bene meritorio (merit good), e
infatti parliamo normalmente di “diritto alla salute”, che è meritorio per
motivi etici, sociali, ed altri ancora. Come vedremo, vi sono anche buoni
motivi economici che rendono efficiente l’introduzione di normative di
questo tipo.
In un mondo ideale, nel quale tutti gli agenti economici fossero
perfettamente informati, e non esistessero costi di transazione, le imprese
investirebbero per adottare precauzioni volte a migliorare la sicurezza e la
salute dei propri dipendenti fino a quando il costo marginale delle
precauzioni non superasse i costi che esse dovrebbero altrimenti sopportare,
e cioè:
•
i salari più elevati che i lavoratori richiederebbero a copertura dei
rischi che sopporterebbero in assenza di precauzioni;
•
i costi, per assenze, cure mediche, e possibili liti, che le aziende
sopporterebbero in seguito ad un infortunio.
Di conseguenza, il problema della sicurezza e della tutela alla salute sarebbe
risolto con un certo livello di investimento da parte delle imprese per
migliorare la sicurezza e la tutela della salute, ed un certo premio per il
rischio pagato ai lavoratori come componente del loro salario. I lavori più
rischiosi attrarrebbero i lavoratori relativamente amanti del rischio (tutti noi
abbiamo visto la celeberrima fotografia di Lewis Hine che immortala degli
operai in pausa pranzo su una putrella sospesa a grande altezza durante la
costruzione dei grattacieli di New York).
215
La realtà è però ben diversa: molti studi, condotti negli Stati Uniti,
dimostrano inequivocabilmente come i premi per il rischio corrisposti per le
occupazioni più rischiose siano troppo bassi rispetto al costo atteso in
termini di perdite di reddito, cure mediche ed altre spese, che un dipendente
deve affrontare in caso di malattia o incidente.
Questa inadeguatezza riflette essenzialmente un’asimmetria informativa:
infatti, i lavoratori dispongono di informazioni molto più scarse, e di minor
qualità, sulla effettiva rischiosità di un dato posto di lavoro, di quanto non
dispongano le imprese. Pertanto, la razionalità dei lavoratori (come quella
dei consumatori del resto, come abbiamo discusso all’inizio del corso) è
dunque una razionalità limitata, nel senso che le scelte occupazionali
vengono fatte tra un numero relativamente basso di alternative. Inoltre, sono
spesso i lavoratori meno qualificati a soffrire di più di questa asimmetria
informativa, ma d’altra parte sono proprio questi lavoratori ad avere un
minor potere contrattuale nei confronti delle imprese.
C’è però un importante fattore ulteriore, che spiega come una soluzione
privatistica al problema della salute e sicurezza non sia possibile: l’impresa
non sopporta infatti interamente i costi che derivano dagli infortuni e le
malattie dei suoi dipendenti. Tali costi sono sopportati dalla collettività, che
paga i costi per le cure necessarie in maggiore o minor misura, a seconda dei
paesi, e può pagare pensioni di invalidità nei casi più gravi.
Ricordando quanto abbiamo detto sull’ambiente, questo è dunque un caso
classico di esternalità negativa: il produttore, che non debba sostenere
pienamente i costi delle sue scelte in materia di salute e sicurezza, sottoinvestirà nelle misure di precauzione.
In assenza di regole sulla salute e sicurezza vi sarebbe poi un altro
problema, che è una variante del problema dei ‘bidoni’ che abbiamo già
visto.
I lavoratori in cerca di impiego sarebbero infatti ben coscienti che sul
mercato ci sono due tipi di imprese, quelle che offrono adeguate protezioni e
quelle che offrono protezioni insufficienti. Poiché per i lavoratori non è
possibile distinguere facilmente le imprese nei due gruppi, essi tenderanno
comunque a chiedere un premio per il rischio nel loro salario, di entità
media. Questo renderà particolarmente profittevole assumere il lavoratore
per le imprese che sotto-investono in sicurezza, mentre lo renderà
particolarmente antieconomico per le imprese che, avendo già investito per
abbassare il rischio, si troveranno a dover pagare un premio per il rischio
che non corrisponde all’effettiva rischiosità della prestazione lavorativa
presso di loro.
Per questi motivi, l’imposizione di livelli di minimi di sicurezza sul lavoro
risolve una serie particolarmente ampia di fallimenti del mercato, che
216
dipendono dall’esistenza di costi di transazione, di esternalità, e di
informazioni asimmetriche.
Occupiamoci adesso di un diverso tipo di regolazione della prestazione
lavorativa, che riguarda gli orari di lavoro. In tutti i Paesi, esistono
normative che regolano la durata massima della prestazione lavorativa in
vari modi: può essere infatti determinato un numero massimo di ore
settimanali, un numero massimo di ore giornaliere, un numero minimo di
ore di riposo tra la fine di una prestazione lavorativa e l’inizio di quella
seguente, oppure una qualche combinazione di tali previsioni regolamentari.
L’interpretazione economica dell’esistenza di normative di questo genere è
immediata qualora ci si riferisca al modello del monopsonio che abbiamo
discusso quando ci siamo occupati di regolazione del salario: se l’impresa
gode di una posizione dominante nei confronti dei lavoratori, essa richiederà
orari di lavoro ben più gravosi di quelli che i lavoratori sarebbero disposti ad
offrire, e regolando l’erogazione della prestazione lavorativa, attraverso gli
orari, l’esercizio di questo potere monopsonistico viene quindi limitato
La regolazione degli orari di lavoro è nata, storicamente, proprio per questo
motivo: nell’Ottocento, le ore di lavoro giornaliero potevano arrivare a 16,
per 6 giorni settimanali; successivi interventi regolamentari hanno portato,
all’inizio del Novecento, a ridurre le ore giornaliere ad 8.
Oggi, quindi, il potere di mercato datoriale è stato riequilibrato dalla
normativa; oltre a questo, sia la domanda di lavoro che l’offerta di lavoro
sono ormai ben diverse da quelle dei primi decenni del Novecento. Le
imprese industriali sono infatti organizzate con cicli produttivi meno rigidi
di una volta, ed in ogni caso il numero degli occupati nei vari settori dei
servizi (in cui il ciclo produttivo è in genere poco rigido, e quindi riesce ad
accomodare varie tipologie di prestazione lavorativa) è ormai molto
superiore a quello dei settori manifatturieri.
Concludiamo quindi che ulteriori misure regolamentari sugli orari non
trovano, almeno nei Paesi industriali, adeguata giustificazione economica.
217
20. LA REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
I mercati finanziari sono contraddistinti da molti fallimenti di mercato: gli
acquirenti di un'azione o di una obbligazione soffrono di forti asimmetrie
informative rispetto ai venditori, e devono sopportare elevati costi di
transazione per far valere i propri diritti. Eventuali crisi sui mercati
finanziari possono esplicare esternalità negative sul sistema economico al
suo complesso. Inoltre, frequentemente su questi mercati si pongono
problemi distributivi. Non ci sorprende pertanto osservare come questi
mercati siano oggetto frequente di interventi di politica economica, volti a
disegnarli ed a regolarli. In questa lezione, consideriamo quindi i principali
mercati finanziari, ed analizziamo - in ciascuno di essi - la ratio economica
di questi interventi.
20.1 Le banche
Uno dei principali soggetti che operano all’interno dei mercati finanziari è
costituito dalle banche, la cui funzione economica principale è quella di
intermediare i flussi di risparmio che le famiglie creano convogliandolo
(sono unità economiche che generalmente incassano più di quanto
spendono, e risparmiano per il futuro) alle imprese (che sono unità
economiche strutturalmente in deficit, perché investono).
Le banche non sono naturalmente sempre necessarie, dato che - ad esempio
- un risparmiatore può direttamente prestare soldi ad un'impresa,
acquistandone le obbligazioni. In tal caso, tuttavia, il risparmiatore non
diversifica il proprio investimento, e sopporta un rischio elevato e soffre di
elevate asimmetrie informative. Si pensi ad esempio ai risparmiatori che –
nel recente passato – hanno investito in obbligazioni Cirio o Parmalat.
Le banche quindi hanno, per i risparmiatori, una prima funzione
fondamentale, che è quella di selezionare e diversificare il rischio. Dato
che raccogliere informazioni è un'attività costosa, e caratterizzata da
economie di scala, le banche - grazie alla loro dimensione elevata - possono
conoscere le caratteristiche e l'andamento delle aziende che chiedono prestiti
in maniera molto più efficiente del singolo risparmiatore. Inoltre, le banche
prestano il risparmio che raccolgono presso i risparmiatori ad una pluralità
di imprese, e così sono in grado di diversificare efficacemente il rischio.
Ma le banche, oltre alla funzione privatistica che abbiamo appena descritto,
hanno importanti funzioni pubblicistiche: grazie alla loro attività, le banche
forniscono liquidità al sistema economico; inoltre, esse forniscono servizi
di transazione all'economia, della quale gestiscono il sistema dei
218
pagamenti; infine, esse sono dei canali di trasmissione della politica
monetaria, con cui la Banca Centrale aumenta o diminuisce la disponibilità
di credito, ed il suo costo, al sistema economico.
Per questi motivi, le banche sono imprese fortemente regolate.
Per quanto riguarda la loro prima funzione fondamentale, le banche sono
regolate perché i risparmiatori soffrono di asimmetria informativa quando
affidano i propri risparmi ad una banca, senza sapere a chi e a quali
condizioni la banca concederà dei crediti. Pertanto, alcune regole imposte
alle banche sono rivolte a ridurre tale asimmetria informativa lungo tre
direttrici:
•
regolando l’entrata sul mercato: l’apertura di una banca è infatti
vincolata al rispetto di requisiti dettagliati di dotazione patrimoniale, di
disponibilità di strutture umane e tecnologiche adeguate e ad altri
vincoli, il rispetto dei quali dovrebbe assicurare i risparmiatori che la
nuova banca possa essere effettivamente in grado di selezionare i rischi
in modo efficiente;
•
regolando le attività che la banca può svolgere: ad esempio
limitandone le tipologie di investimento (ad esempio, le banche non
possono assumere il controllo di imprese non finanziarie), e limitando
quindi l’assunzione di rischi troppo elevati;
•
regolando l’ammontare dei crediti che la banca può concedere, che
non deve essere concesso a clienti troppo rischiosi, concentrata in
misura eccessiva a favore di un piccolo numero di clienti, né
complessivamente superare un multiplo dei fondi propri e dei depositi di
cui essa dispone, una parte dei quali deve quindi rimanere come riserva
obbligatoria nella disponibilità della banca 154.
L’esistenza di una riserva obbligatoria ha anche una valenza pubblicistica,
in quanto è correlata alla funzione delle banche di creazione di liquidità nel
sistema.
Per capire questa funzione, è necessario schematizzare il funzionamento del
credito nell’economia. Supponiamo che un risparmiatore depositi 1.000
euro in una banca, che la banca ne trattenga 100 euro come riserva
obbligatoria, e che presti i rimanenti 900 euro ad un’impresa, di cui ha
sufficienti informazioni positive.
154
Questa misura regolamentare risulta particolarmente importante quando si consideri che
il management di una banca, se presta a creditori molto rischiosi, chiederà un interesse
elevato e quindi - sempre che naturalmente il creditore rimborsi il debito alla scadenza otterrà profitti elevati. Se però il creditore non rimborsa il debito, le conseguenze principali
sarebbero sostenute dai depositanti, che perderebbero il loro depositi. In assenza di regole,
quindi, il management della banca avrebbe una motivazione razionale ad assumere rischi
eccessivi.
219
Se l’impresa, per qualsiasi motivo, non impiegasse immediatamente tale
somma, ma la depositasse presso un’altra banca, il sistema bancario avrebbe
creato moneta, fornendo liquidità all’economia. Infatti, il risparmiatore
avrebbe ancora 1.000 euro depositati presso la prima banca, che potrebbe
ritirare in qualsiasi momento, ma anche l’impresa avrebbe 900 euro
depositati presso un’altra banca, che potrebbe anch’essa ritirare in qualsiasi
momento. E’ quindi anche per questo motivo che le banche sono tenute a
mantenere un certo livello di riserva obbligatoria, sufficiente a coprire le
richieste di prelievo dei propri risparmi che possono essere avanzate dalle
famiglie. Naturalmente, è virtualmente impossibile che tutte le famiglie
vogliano ritirare tutti i loro depositi da una data banca contemporaneamente,
e quindi la banca può tenere come riserva solo una piccola frazione dei
depositi che essa riceve. Se però tale eventualità si presentasse, come
tipicamente potrebbe verificarsi se le famiglie perdessero fiducia nelle
banche, come è successo nel Regno Unito nella vicenda della banca
Northern Rock, le conseguenze sul sistema economico sarebbero disastrose.
Nei sistemi bancari c’è quindi sempre un rischio di liquidità, l’esistenza del
quale fornisce una ulteriore giustificazione per regolare l'attività bancaria in
modo particolarmente dettagliato 155. In altre parole, la stabilità del sistema
bancario è un bene pubblico, nel senso in cui abbiamo utilizzato questo
termine nelle lezioni precedenti, perché sarebbe impossibile, e comunque
non desiderabile, escludere qualche banca dal godimento di questo
particolare bene: ma, come abbiamo visto, la produzione di un bene
pubblico da parte di privati è sempre insufficiente. Senza regolazione, non
vi sarebbe una ‘produzione’ sufficiente di questo particolare ‘bene’.
Inoltre, le banche sono una componente essenziale del sistema dei
pagamenti, ovvero quella complessa infrastruttura dell'economia che serve
a trasferire la moneta da un operatore all'altro, la cui operatività sarebbe
compromessa nel caso vi fossero rilevanti crisi bancarie. Anche la stabilità
del sistema dei pagamenti è un bene pubblico nel senso sopra richiamato, e
pertanto fornisce un'ulteriore motivazione economica razionale per la
regolazione del settore bancario.
20.2 I mercati mobiliari
Ma le banche sono solo uno dei canali con cui il risparmio delle famiglie
viene trasferito alle imprese: accanto ad esso, vi è la sottoscrizione di azioni
e quella di obbligazioni.
Dal punto di vista economico, le azioni forniscono un diritto di proprietà ad
un flusso - teoricamente infinito - di dividendi che, almeno nel medio
155
Tipicamente imponendo, oltre alla riserva obbligatoria, anche un’assicurazione
obbligatoria dei depositi, almeno fino ad un certo ammontare.
220
periodo 156, sono correlati agli utili conseguiti dall'impresa.
Conseguentemente, il valore di un'azione dipende dalle aspettative circa
questo flusso futuro di dividendi, e può variare significativamente quando
tali aspettative vengano a modificarsi. Quindi, dal possesso di un'azione,
possiamo ottenere un reddito (i dividendi) ma anche un guadagno o una
perdita in conto capitale (le variazioni nel prezzo dell'azione).
Poiché un'azione incorpora le aspettative circa i futuri andamenti reddituali
dell'impresa, le asimmetrie informative sono un problema
particolarmente grave per questo tipo di titoli.
Un esempio può aiutare a chiarire questo aspetto. Supponiamo che venga
costituita una società per azioni per lanciare catene di ristoranti thailandesi
in Italia, e offrano azioni ai risparmiatori. Questi ultimi, tuttavia, al contrario
del management della Società, non sono esperti di cucina thailandese, né
delle specificità del mercato italiano della ristorazione (agli Italiani piace la
cucina thailandese?). Pertanto, i risparmiatori dovrebbero, con fatica, e
sostenendo costi ulteriori, ricercare delle informazioni, che ogni caso
saranno quasi sempre di qualità inferiore a quelle di cui dispongono i
promotori di questa nuova società. Per i risparmiatori, quindi l'investimento
sarà quindi particolarmente rischioso, perché sarà per loro difficile valutare
se il prezzo a cui vengono vendute le azioni è congruo rispetto ad una
ragionevole attesa circa i flussi futuri di reddito della catena di ristoranti. Se
i risparmiatori non sono particolarmente amanti del rischio 157, quindi, non
accetteranno questa offerta di investimento, ed in generale saranno restii ad
accettare proposte di investimento che siano riferite anche ad altre società
già in attività, perché per ciascuna di esse esisteranno simili asimmetrie
informative.
Con un meccanismo del tutto analogo al mercato delle auto usate (i
cosiddetti 'bidoni'), nonostante vi sia un mercato per il finanziamento di
buone idee imprenditoriali, in pratica le buone idee non risulterebbero
finanziate correttamente. Dal punto di vista dell'economia nel suo
complesso, quindi, le asimmetrie informative riducono l'offerta di
capitale di rischio.
Per questo, esattamente come nel caso dei cavalli purosangue che abbiamo
sopra discusso, sono stati – nel tempo 158 - sviluppati mercati
regolamentati, come la Borsa, nei quali sono scambiate le azioni di imprese
156
Nel breve periodo i dividendi di un'impresa possono riflettere anche altri fattori, ma nel
medio periodo un'impresa che guadagna darà dividendi elevati e un'impresa che non
guadagna ne darà pochi o non ne darà alcuno.
157
Vari studi convengono nel concludere come sia ragionevole ritenere che la maggior
parte dei risparmiatori siano avversi al rischio, o al massimo neutrali rispetto al rischio.
158
Nel 1602 la East India Company Olandese realizza la prima emissione azionaria sulla
Borsa di Amsterdam. Mercati similari esistevano già almeno dal 1200 per lo scambio di
quelli che chiameremmo oggi titoli del debito pubblico.
221
che offrano particolari requisiti agli investitori, e sul cui funzionamento
esistono organismi pubblici dotati di ampi poteri di vigilanza e controllo (in
Italia, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB) 159.
La CONSOB in Italia, la Securities Exchange Commission (SEC) negli
USA, ed organismi analoghi in altri Paesi, vigilano sul buon funzionamento
di questi mercati, ed hanno ampi poteri regolamentari che consentono loro
- tra l’altro - di sospendere o escludere le azioni di una società dalla
quotazione, di imporre a società il cui andamento appaia preoccupante, la
comunicazione della loro situazione patrimoniale su base mensile.
Così, nella Borsa Italiana sono ammesse alla quotazione azioni di imprese
che svolgano un'attività capace di generare ricavi, che abbiano depositato i
bilanci degli ultimi tre esercizi, di cui almeno l'ultimo sia anche certificato,
si impegnino a comunicare trimestralmente al mercato l’andamento dei loro
conti, che abbiano una capitalizzazione di mercato prevedibilmente
superiore ad una certa soglia, e le cui azioni siano liberamente trasferibili e
sufficientemente diffuse fra il pubblico.
Questi requisiti sono finalizzati a ridurre le asimmetrie informative
sull’andamento delle imprese, che sono tenute a far certificare da una
società specializzata ed indipendente il loro bilancio, nonché a comunicare
al pubblico trimestralmente, in modo sintetico, e semestralmente ed
annualmente, in modo dettagliato, conto economico e stato patrimoniale.
Altri requisiti richiesti (la capitalizzazione, la trasferibilità) sono invece
finalizzati ad assicurare la liquidità dell’investimento, ovvero la possibilità
per il risparmiatore di vendere liberamente, su un mercato sufficientemente
liquido, l’azione.
20.3 Intermediari non bancari
Sui mercati regolamentati, una parte della domanda proviene da singoli
investitori, ma la quota più ampia è espressa da investitori istituzionali, che
raccolgono il risparmio delle famiglie e lo investono in una pluralità di titoli,
ripartendo così il rischio.
Questi investitori, di cui il tipo più frequente è quello dei fondi comuni
d’investimento, hanno una dimensione enorme rispetto a quella del singolo
investitore, essi sono quindi meno svantaggiati di questo dai costi di
raccolta delle informazioni, e possono quindi effettuare più agevolmente il
monitoraggio delle imprese nelle quali essi investono.
159
Il mercato delle obbligazioni nasce per motivi del tutto analoghi a quello delle azioni,
ed è anch’esso sottoposto alla regolazione di CONSOB. Insieme al mercato azionario è
spesso indicato come mercato mobiliare.
222
I fondi di private equity sono simili ai fondi comuni d’investimento, dai
quali però si differenziano perché richiedono un investimento iniziale
elevato; investono in un numero relativamente contenuto di imprese (da 7 a
25, in genere), aiutandole a sviluppare nuovi prodotti, facilitandone
l’acquisto da parte del management o di altri investitori, ed
accompagnandole, se non già quotate, alla quotazione in Borsa. Le loro
quote non sono commerciabili su mercati regolamentati e prevedono una
scadenza, in corrispondenza della quale il fondo si scioglie, distribuendo
l’attivo ai suoi finanziatori 160. Dal punto di vista che qui ci interessa, tali
fondi, investendo in un numero limitato di imprese, riescono a risolvere i
problemi del monitoraggio in modo ancora più efficace di quanto non
possano i fondi comuni.
La popolarità di questi fondi è in rapido aumento, stanti i notevoli tassi di
rendimento che essi hanno saputo, almeno negli ultimi anni, assicurare.
Inoltre, non essendo sottoposti a particolari forme di regolamentazione, essi
hanno una grande flessibilità nel reperire finanziamenti, e non debbono
sottostare ad obblighi di informazione nei confronti del pubblico: queste
caratteristiche ne hanno probabilmente ulteriormente aumentato l’appeal, in
una fase storica nella quale, come abbiamo visto, il peso della
regolamentazione sui mercati mobiliari è invece nettamente aumentato.
A differenza dei fondi comuni d'investimento, che tradizionalmente
investono, prevalentemente in azioni, con un orizzonte di investimento
medio-lungo, gli hedge funds hanno strategie di investimento molto
flessibili, caratterizzate da vendite allo scoperto (un fondo si impegna a
vendere titoli che non possiede, scommettendo quindi su una caduta del loro
prezzo) e da acquisti allo scoperto (un fondo si impegna ad acquistare titoli
che non possiede, scommettendo quindi su un aumento del loro prezzo).
Per finanziarsi, questi fondi fanno ampio ricorso al credito, ed hanno dunque
una elevata leva finanziaria 161. Conseguentemente, essi sono molto
rischiosi, poiché - qualora l'investimento che è stato realizzato facendo
ricorso al debito generasse delle perdite - essi dovrebbero assorbire le
perdite e restituire il credito ottenuto. Naturalmente, il ricorso a capitale di
prestito consente di ottenere, se l'investimento genera degli utili, profitti
molto elevati con un piccolo impiego di capitale proprio. Per questo, in vari
Paesi, ed in particolare negli Stati Uniti, all'investimento in questi fondi
possono accedere soltanto “investitori sofisticati”, che dovrebbero soffrire di
asimmetrie informative in misura molto minore dei comuni investitori: di
160
Dal punto di vista societario, questi fondi sono strutturati come Limited Partnership
negli USA, e come Società in Accomandita per Azioni in Italia.
161
La leva finanziaria è in generale, per qualsiasi impresa, il rapporto tra debito e
patrimonio netto. Più questo rapporto è elevato, più l'impresa è in grado di finanziare ai
propri investimenti con mezzi di terzi.
223
conseguenza, gli hedge funds non sono sottoposti a particolari norme
regolamentari.
Fondi di questo genere, con denominazioni varie, siano sempre esistiti, ma
nell'ultimo quindicennio essi hanno conosciuto una enorme crescita, dato
che il livello storicamente molto basso dei tassi di interesse ha stimolato gli
investitori a cercare strategie di investimento che offrissero, naturalmente
con maggiori rischi, rendimenti più elevati. Dopo una rapida crescita tra il
2000 e il 2007 vi è stato un breve rallentamento, e a fine 2014 questi fondi
amministravano a livello globale fondi per 3.100 miliardi di dollari.
Figura 20.1 Fondi amministrati a livello globale dagli hedge funds
Fonte: UK Financial Condict Authority, Hedge Finds 2015.
Poiché questi fondi si finanziano in larga misura con il debito, assumono
rischi molto elevati, e spesso si muovono di conserva, seguendo strategie di
investimento tra loro assai simili, nel caso tali strategie si rivelassero errate,
oppure i loro finanziatori richiedessero, per qualche motivo, la liquidazione
delle loro quote, il fallimento di qualche hedge fund (intermediario non
regolato) potrebbe avere effetti a catena nel sistema finanziario, e quindi
anche sugli intermediari regolati che finanziano tali fondi: temendo la
crescita di questo rischio sistemico le autorità monetarie, europee ed
americane, hanno quindi moltiplicato i segnali di preoccupazione 162 almeno
162
Nella sua Financial Stability Review, del dicembre 2005, la Banca Centrale Europea ha
affermato “As the hedge fund industry keeps on growing, its expansion continues to raise
questions about capacity constraints and the impact of hedge funds’ largely unconstrained
investment strategies on financial markets. In addition to potentially high leverage, the
increasingly similar positioning of individual hedge funds within broad hedge fund
investment strategies is another major risk for financial stability which warrants close
224
da un decennio, senza però che vi siano stati interventi regolamentari di
qualche intensità.
Il forte sviluppo di intermediari finanziari diversi dalle banche ha
enormemente complicato la funzione di regolazione nel corso degli ultimi
due decenni, rendendo i nostri sistemi economici, come vedremo,
fortemente esposti ai rischi derivanti da fallimenti della regolazione. Questi
rischi sono stati moltiplicati dallo sviluppo di prodotti derivati, di cui adesso
ci occupiamo.
20.4 I prodotti derivati
I prodotti finanziari derivati hanno significativamente aumentato i rischi di
instabilità del sistema finanziario. Come abbiamo visto, questi hanno origine
all’interno del sistema bancario in senso stretto, perché le banche,
strutturalmente, prestano (ovvero realizzano impieghi) pari ad un multiplo
dei depositi che essi ricevono dai risparmiatori. Le banche sono, quindi,
intrinsecamente instabili, e questa instabilità è stata accresciuta
dall’innovazione finanziaria, ed in particolare dallo sviluppo di un’ampia
gamma di prodotti derivati 163.
Con questo termine indichiamo in generale prodotti finanziari il cui valore
derivi dall’andamento del valore di un’attività sottostante. Le attività
possono essere beni fisici (oro, petrolio, succo d’arancia surgelato), o altri
prodotti finanziari (azioni, obbligazioni).
I prodotti derivati sono utilizzati, come vedremo, da operatori diversi con
finalità diverse: ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente
(finalità di copertura o di hedging), per assumere esposizioni al rischio al
fine di conseguire un profitto (finalità speculativa), o per conseguire un
profitto attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da
cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).
Vediamo le prime due di queste tre finalità (che qui ci interessano
particolarmente) mediante un semplice esempio.
Per la finalità di copertura, consideriamo il caso di un produttore di cavi di
rame che concorra per assicurarsi un grosso ordine, con consegna a 12 mesi.
L’acquirente richiede la fissazione del prezzo, ma naturalmente le
quotazioni del rame possono variare significativamente nell’arco del
periodo. Per questo, il produttore può comprare dei prodotti finanziari
monitoring despite the essential lack of any possible remedies. This risk is further
magnified by evidence that broad hedge fund investment strategies have also become
increasingly correlated, thereby further increasing the potential adverse effects of
disorderly exits from crowded trades” (p.142).
163
Nonché di prodotti strutturati, ma la loro analisi esce dai limiti di questo corso.
225
derivati detti futures, che gli danno la possibilità di comprare, entro 12
mesi, il rame necessario ad un prezzo prefissato. Così facendo, egli si libera
del (o si copre dal) rischio finanziario derivante dall’andamento del prezzo
del rame.
Questo rischio invece viene assunto da chi gli vende questi futures, la cui
finalità sarà dunque speculativa. Prima di procedere dobbiamo qui
sottolineare come il termine “speculativo” non assume in economia alla
connotazione negativa del parlar comune. Speculatore è colui che decide di
assumersi un rischio, è nell’esempio che stiamo facendo la presenza di uno
speculatore consente una transazione che crea benessere nell’economia, in
quanto il produttore di cavi si libera di un rischio che non desidera correre,
vendendolo ad un operatore che invece è disposto a correrlo. Quest’ultimo,
che è tipicamente un operatore finanziario, assumerà poi molti altri rischi,
vendendo e comprando futures su molti altri prodotti 164
Questo operatore si troverà dunque disporre di un gran numero di prodotti
derivati, e potrà quindi combinarli tra loro in “pacchetti” il cui prezzo
deriverà dai derivati sottostanti 165. Oltre a moltiplicare la quantità di prodotti
finanziari disponibili nell’economia, questa sintesi operata dagli operatori
finanziari ha il rimarchevole effetto di costruire prodotti finanziari a basso
rischio a partire da prodotti sottostanti ad alto rischio.
Supponiamo che i mercati immobiliari su base locale di un grande paese, ad
esempio gli Stati Uniti, seguano andamenti tra loro molto diversi: il mercato
del lavoro americano è estremamente fluido quindi è facile aprire nuove
imprese come è facile chiuderle. Storicamente, quindi, l’America vede
notevoli flussi geografici di famiglie che tendono a seguire la geografia
della domanda di lavoro che si trasforma nel tempo. Supponiamo anche sia
molto debole la regolazione a tutela dei mutuatari, cui pertanto banche ed
altri operatori finanziari possono vendere mutui per importi che ben
difficilmente il mutuatario sarà in grado, in base al proprio reddito, di
restituire.
Avremo in questo caso un portafoglio di mutui estremamente rischiosi in
una città (poniamo: Houston), ed un altro portafoglio di mutui estremamente
rischiosi per una città da questa molto distante (poniamo: San Francisco),
combinando i quali sarà però possibile costruire un portafoglio di mutui il
cui rischio è inferiore alla rischiosità dei due portafogli componenti, sempre
che si verifichi il caso che a fluttuazioni negative dell’industria petrolifera
164
Anche finanziari: ci sono futures sui tassi di cambio, sui tassi di interesse, sui valori
mobiliari, e su molti altri prodotti finanziari.
165
Per una descrizione dei principali tipi di prodotti derivati, la cui discussine esula dai temi
analizzati nel corso, si veda:
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/principalicat
egorie_prodottiderivati.html.
226
(di cui una parte significativa è basata Houston) facciano riscontro
fluttuazioni positive nei settori di alta tecnologia (di cui una parte
significativa è localizzata nella Bay Area di San Francisco). È possibile
dimostrare semplicemente questo punto, ma ai fini di questo corso è
sufficiente usare la vostra intuizione: invece di mettere tutte le mie uova in
un paniere, le metto in due panieri diversi, sperando naturalmente che non
mi cadano ambedue.
Come vedremo tra breve, l’evento scatenante della crisi finanziaria del 2008
è stato appunto che i panieri sono caduti tutti e due, ovvero che il mercato
immobiliare americano si è contratto in modo generalizzato, e pertanto
portafogli di titoli rischiosi all’interno dei quali si riteneva che oscillazioni
positive e negative avrebbero potuto, almeno in qualche misura,
compensarsi, hanno generato perdite estremamente consistenti.
Esamineremo più avanti come questo problema, inizialmente riguardante
soltanto un settore dei prodotti derivati, abbia avuto effetti sistemici
catastrofali. Per ora, osserviamo come il caso dei mutui immobiliari
americani evidenzi come possa essere estremamente difficile calcolare la
rischiosità di un prodotto derivato, il cui prezzo futuro dipenderà non solo
dall’andamento dei prodotti (fisici o finanziari) sottostanti, ma da come
questi andamenti si combineranno tra di loro. Semplificando, non è
possibile valutare in modo preciso la rischiosità dei prodotti complessi,; lo si
fa con modelli di simulazione, che possono generare risultati errati se sono
errate le ipotesi su cui essi si basano. Naturalmente, questo è stato il caso dei
mutui fondiari americani, perché essi venivano valutati in base all’ipotesi
che i valori fondiari in aree diverse del paese non si sarebbero mossi in
modo sincrono. È stata la sorprendente loro sintonia a generare perdite di
valore molto consistenti, è del tutto inattesa, dei prodotti derivati aventi
come sottostante questo genere di mutui.
Un punto molto rilevante è che una parte consistente dei prodotti derivati
non è trattata sui mercati regolati, ma è over the counter, (OTC) nel senso
che la compravendita avviene tra due contraenti, al di fuori di un mercato
organizzato.
Ciò pone rilevanti problemi di politica economica in quanto da un lato il
volume di questi strumenti finanziari è enorme (a fine 2009, secondo la
Banca dei Regolamenti Internazionali, vi erano circa 600 trilioni di dollari
di contratti derivati, a fronte di un prodotto interno lordo mondiale di circa
60 trilioni), e dall'altro transazioni bilaterali di questo tipo sono soggette ad
un elevato rischio di controparte.
Vediamo perché: se Tizio vende un prodotto derivato a Caio, e usa il
ricavato per comprare un altro prodotto derivato da Sempronio, se per
qualche motivo Caio non riesce a pagare Tizio, Tizio non avrà fondi per
pagare Sempronio: il default di Tizio, genererà il default di Sempronio,
227
anche se nessuna compravendita è avvenuta direttamente tra Tizio e
Sempronio. Per ridurre questo rischio di controparte, i tre partecipanti al
mercato possono chiedere ad un altro operatore di fungere da intermediario:
così Tizio non venderà il prodotto direttamente a Caio, ma lo venderà
all'intermediario, che lo venderà a Caio; Sempronio si comporterà
analogamente. In questo caso, se l'intermediario è saggio nel prevedere i
rischi, ed ha un patrimonio sufficiente, l'insolvenza di Tizio non determinerà
l'insolvenza di Sempronio, ma soltanto una perdita per l'intermediario, che
questo appunto potrà coprire con il suo patrimonio. Ma se l’intermediario
non riesce a far fronte alle perdite, non saranno soltanto Tizio, Caio, e
Sempronio a patirne, ma anche tutti i gli altri operatori che usavano i servizi
dell'intermediario.
L'esempio è semplificato, ma è molto realistico: è infatti questo il motivo
per cui la bancarotta di Lehman Brothers del 2008 ha avuto effetti
estremamente sensibili sui mercati finanziari mondiali, ed il governo
americano, nello stesso anno, ha pilotato il salvataggio di AIG, una
compagnia di assicurazione, che faceva da intermediario per un enorme
volume di scambi di prodotti derivati OTC.
Nonostante vari tentativi, nonostante la crisi del 2008 non si è ancora riusciti
a risolvere il problema degli OTC, ad esempio centralizzandone gli scambi
in mercati organizzati, per la vivace resistenza opposta dai gruppi di
pressione: questo è un altro esempio, naturalmente, di fallimenti della
regolazione.
Questo è esattamente quello che si è recentemente verificato con la crisi dei
mutui subprime statunitensi, cioè mutui altamente rischiosi, che venivano
concessi da parte delle banche statunitensi a clienti privi delle adeguate
garanzie, e quindi con alta probabilità di non ripagare il mutuo. Le banche
hanno coperto i propri rischi attraverso la stipula di contratti derivati, spesso
molto complessi. La crisi immobiliare degli Stati Uniti ha avuto dunque un
effetto diretto sulla capacità dei risparmiatori di ripagare i mutui, ma questo
ha avuto enormi effetti indiretti a catena in tutto il sistema creditizio
mondiale, a causa dell'elevatissima diffusione dei contratti derivati su tali
mutui.
228
21. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
L’INNOVAZIONE
E
POLITICHE
PER
Il termine giuridico proprietà intellettuale accomuna tre fenomeni
economici - marchi, copyright, brevetti – molto diversi tra loro quanto ad
origini, problematiche, e quadro regolamentare.
21.1 Marchi
Schematizzando, i marchi nascono storicamente (probabilmente nell’antico
Egitto, ove tegole, mattoni e vasi della Prima Dinastia, nel 3.000 A.C., erano
talvolta marchiati) come carattere atto a segnalare al consumatore l’origine
di un prodotto. Senza un marchio, una tegola è un prodotto indifferenziato,
sulla cui qualità un acquirente non ha informazioni particolari. Una tegola
recante il marchio di un noto produttore, offre invece informazioni maggiori
al suo acquirente 166. Ricordando quanto discusso nelle lezioni precedenti, un
marchio serve quindi anzitutto al produttore di un bene (o un servizio) di
alta qualità per internalizzare esternalità positive che andrebbero
altrimenti disperse sul mercato: il produttore di tegole dell'antico Egitto
aveva dunque alcuni problemi in comune con il concessionario Mercedes di
cui ci siamo occupati nella lezione 14, e li risolveva in un modo assai simile.
Inoltre, dato che la domanda di un prodotto indifferenziato, realizzato da
molte imprese, è generalmente molto elastica, il produttore non riesce ad
alzare il prezzo al di sopra del livello di concorrenza perfetta. Ma se egli
riesce a far percepire il suo prodotto come diverso dagli altri, potrà
aumentarne – almeno entro certi limiti – il prezzo rispetto a quello dei suoi
concorrenti, perché, con la differenziazione, la domanda del suo prodotto
diventa meno elastica 167.
Queste sono le due motivazioni economiche che spiegano come mai i
marchi hanno un valore, che può essere talvolta molto elevato (ad esempio,
quello del marchio Coca-Cola, a metà 2005, è stato stimato in $ 67,5
miliardi).
Naturalmente, vi sono anche altre motivazioni che spiegano il valore dei
marchi: indossare blue jeans di una marca ben nota è presumibilmente
vissuto come uno status symbol rassicurante, e quindi i consumatori sono
166
Ciò naturalmente spiega i requisiti giuridici del marchio, ovvero la sua capacità
distintiva, originalità e novità, senza le quali esso non potrebbe rivestire la sua funzione di
informare l’acquirente circa l’origine del prodotto.
167
Un mercato in cui tutte le imprese si comportano in questo modo è noto come
concorrenza monopolistica.
229
pronti a pagare per quei jeans un prezzo ben più alto di quello che non
pagherebbero, per dei jeans molto simili, su una bancarella.
La protezione dei marchi è dunque importante per coloro che li posseggono
(se tutti copiano il mio marchio, esso perde ogni valenza informativa per la
clientela, e perde quindi gran parte del suo valore), ma non richiede
particolari interventi di disegno regolamentare.
21.2 Copyright
Il copyright, che in italiano traduciamo come diritto d’autore, nasce
piuttosto come diritto dell’editore di impedire copie non autorizzate dei
volumi da esso pubblicati. La sua origine storica è in Gran Bretagna, ove nel
1556 entrava in vigore lo Stationer’s Act, che sanciva il monopolio perpetuo
di uno stampatore sui manoscritti da egli acquistati. Una tale privativa però
non aveva motivazioni principalmente economiche, bensì di ordine
pubblico, perché nel contempo restringeva il numero dei soggetti che
potevano stampare libri ed opuscoli, consentendo così un più facile
controllo da parte dello Stato sulla produzione di testi politici.
Solo molto più tardi, ed in seguito a numerose controversie giudiziali, con il
Copyright Act del 1710, il diritto di proprietà dell’opera letteraria veniva
posto in capo al suo autore. Lentamente 168, questo diritto si espandeva
internazionalmente, fino ad essere sancito dalla Convenzione di Berna, del
1887.
Il copyright, da un punto di vista economico, è un diritto di monopolio, che
inizialmente è stato conferito agli stampatori, per rendere più agevole il
controllo dello Stato su cosa venisse pubblicato, ed in seguito – anche grazie
ai progressi nelle tecniche di stampa – è rifluito sul titolare della vera risorsa
scarsa: la creazione artistica.
Dal punto di vista economico, i problemi più interessanti del copyright sono
due: la sua durata, e la sua gestione, in particolare da quando la tecnologia
elettronica ha azzerato il costo marginale di produzione di una copia.
La durata del copyright venne originalmente fissata in Gran Bretagna dal
Licensing Act in 14 anni, rinnovabile per altri 14 anni nel caso l’autore fosse
ancora in vita. Questa clausola indica come, originariamente, questo diritto
di privativa sia stato disposto per assicurare all’autore il diritto di godere dei
frutti della sua opera. In misura limitata, viste le scadenze previste, potevano
goderne anche i suoi eredi.
168
Mozart, celeberrimo, moriva nel 1791, ma veniva sepolto in una fossa comune perché la
sua vedova non poteva permettersi una sepoltura più degna, in quanto la sua immensa
produzione musicale non era tutelata dal diritto d'autore.
230
Nel tempo, la durata della tutela è stata progressivamente estesa, fino a
raggiungere – per impulso degli USA, che nel 1998, con una legge che salvò
i diritti della Walt Disney che si avviavano a scadenza, ed è perciò
irriguardosamente nota come Mickey Mouse Protection Act – i 70 anni dopo
la morte dell’autore.
Pertanto, l’originale finalità di consentire agli autori di godere del frutto del
loro lavoro nell’arco della loro vita, si è gradualmente trasformata in una
tutela all’incirca secolare. Il motivo principale di questa trasformazione è
che i diritti di proprietà, con il forte sviluppo dell'industria editoriale nel
corso del ‘900, sono in larga misura tornati agli editori (i moderni
stampatori), e dunque la vita dei diritti non ha più alcun necessario legame
con la vita degli autori. Naturalmente, lo sviluppo di altre forme di
espressione artistica (come il cinema) che richiedono, oltre alla creazione
artistica, anche investimenti considerevoli, ha sostenuto questa transizione.
Questo non è necessariamente un male: se un mio preveggente bisnonno
avesse investito, nel 1882, acquistando i diritti d'autore per Pinocchio, oggi,
essendo tali diritti scaduti, il suo investimento risulterebbe vanificato; se
invece avesse comprato un piccolo appartamento, l'investimento avrebbe
registrato un notevole incremento di valore.
Poiché, almeno da un punto di vista economico, non vi sono motivi
particolarmente convincenti per spiegare come mai l'investimento nel diritto
d'autore debba essere intrinsecamente sempre meno redditizio di un
investimento in qualsiasi altro bene, concludiamo che non vi sono motivi
economici particolare per limitare temporalmente l'esercizio di questo
particolare diritto di proprietà 169. Come vedremo più oltre, occupandoci
di brevetti, questa considerazione è valida soltanto nella misura in cui una
durata molto lunga di un diritto di privativa non costituisce un ostacolo
rilevante nella produzione di nuove opere dell'ingegno, che possiamo
ragionevolmente assumere recherebbero un beneficio alla società.
Del resto, è la tecnologia che si è occupata efficacemente di limitare il
godimento di questi diritti, dapprima abbassando drasticamente (con le
fotocopiatrici) i costi di riproduzione dei testi scritti. Una misura del suo
impatto è fornito dalla differenza del prezzo dei libri tra i Paesi nei quali è
possibile senza grossi problemi fotocopiare interamente libri di testo, e Paesi
ove questo non è possibile. Nei primi, gli editori sono costretti a vendere i
libri ad un prezzo di poco superiore al costo di fotocopiatura: ad esempio, il
prezzo del volume Economia Industriale di Carlton e Perloff negli USA è di
$ 99, ma quello della sua traduzione italiana (che quindi dovrebbe scontare i
169
Naturalmente, è invece ragionevole che ciascun autore possa scegliere se, e in quale
misura, godere di questa proprietà intellettuale, ad esempio rinunciando alla tutela offerta
dal copyright, per adottare modelli che invece favoriscono la disseminazione della sua
opera, come quello detto ‘creative commons’ (si veda il sito www.creativecommons.it).
231
maggiori costi derivanti sia dai diritti di traduzione che dalle minori
economie di scala, visto che poche persone al mondo parlano italiano), è
solo di € 26.
La digitalizzazione ha poi consentito un sostanziale azzeramento del costo
marginale delle copie, sia dei testi scritti che di qualsiasi altro tipo di
contenuto (audio, video), ed ha così ulteriormente rafforzato i vincoli
all’esercizio del potere di mercato dei titolari dei diritti di copyright: come
mostra la Figura 21.1, il prezzo medio di cassette e CD negli USA è
diminuito del 25% circa, tra il 1997 ed il 2005: tenendo conto
dell’inflazione, il prezzo in termini reali di questi beni è diminuito di circa il
47% in otto anni, con buona pace del Mickey Mouse Protection Act.
Figura 21.1. Indice dei prezzi di cassette e CD negli USA, 1998 - 2005
Fonte: Wikipedia.
21.3 I brevetti
Il terzo tipo di proprietà intellettuale, che è qui quello che ci interessa
maggiormente, è il brevetto. Da un punto di vista economico, un brevetto è
un diritto di monopolio concesso, sotto certe condizioni, a chi inventi una
soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un
prodotto o un processo, un metodo o un procedimento.
La ratio della concessione di un tale diritto non è soltanto quella di
consentire all’inventore di godere dei frutti della sua invenzione, come nel
caso del copyright: l’investimento necessario a produrre un’innovazione
232
significativa è infatti in genere enormemente superiore a quello necessario
per produrre un’opera artistica. Mentre in quel caso l’investimento è spesso
pari al solo costo-opportunità del tempo che l’autore dedica alla sua
creazione, le innovazioni richiedono, oltre al tempo dell’aspirante inventore,
investimenti considerevoli in laboratori ed attrezzature, molti dei quali – nel
caso non si ottenessero invenzioni utili – sarebbero irrecuperabili.
Se non esistessero i brevetti, quindi, ogni invenzione utile conferirebbe
esternalità positive considerevoli alla collettività, ma proprio perché il
reddito potenziale sarebbe pari a zero, la ricerca che conduce al brevetto non
verrebbe intrapresa. In altre parole, un’invenzione, in assenza di brevetto,
sarebbe un bene pubblico, poiché non sarebbe desiderabile, né possibile,
escludere alcuno dal suo godimento.
Un inventore razionale investirà quindi nella ricerca di una nuova
invenzione soltanto se il valore atteso dell’invenzione risulterà superiore al
costo complessivo del programma di ricerca: se non vi fossero i brevetti,
quindi, il costo sarebbe quasi sempre superiore al valore atteso
dell’invenzione, e vi sarebbero ben poche innovazioni.
Non sorprendentemente, nonostante forme di tutela analoghe ai brevetti
esistessero già a Venezia nel ‘400, il perfezionamento del meccanismo
brevettuale, e l’avvio della crescita nel numero dei brevetti, si avvia nella
seconda metà del ‘700 con la rivoluzione industriale, per poi accelerare la
crescita: come mostra la Figura 21.2 verso il 1850 negli USA venivano
depositati poche decine di brevetti all’anno, ma nel 2005 i depositi avevano
raggiunto le 170.000 unità.
La tutela del brevetto risponde quindi anche ad una finalità sociale: poiché
la sua esistenza rende più probabile l'introduzione di innovazioni, e buona
parte delle innovazioni finiscono per avere risultati positivi sul benessere
collettivo, l'innovazione deve essere promossa, e questa è una cogente
motivazione di politica economica a favore dei brevetti.
Poiché tuttavia un brevetto conferisce un diritto di monopolio, e ben
sappiamo quanto i monopoli possano essere dannosi, la concessione di un
brevetto avviene (o meglio, come vedremo, dovrebbe avvenire) sotto
condizioni alquanto stringenti: il trovato oggetto dell'invenzione deve essere
nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica; inoltre,
esso deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una
persona esperta del ramo, non deve risultare in modo evidente dallo stato
della tecnica 170.
170
Vi sono poi limitazioni alla brevettabilità, che è in ogni caso esclusa per le teorie
scientifiche, i metodi matematici, i principi e i metodi per attività intellettuali (e quindi per
il software), i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
233
Figura 21.2. Numero di brevetti depositati annualmente negli USA
Fonte: Wikipedia.
Inoltre, per meglio perseguire l’interesse pubblico, la concessione stessa di
un diritto di privativa viene accompagnato dall’imposizione di un obbligo
alla divulgazione dei progetti, o delle caratteristiche, del prodotto cui viene
concesso il brevetto: se è quindi vietato copiare l’invenzione brevettata, è
del tutto possibile accedere ai progetti che ne spiegano il funzionamento.
Questa apparente contraddizione riflette una duplice finalità di politica
economica: da un lato, quella di favorire, come discusso, l’innovazione
concedendo una privativa sui suoi risultati; dall'altro, quella di favorire lo
sviluppo di altre innovazioni mediante la pubblicità dei metodi e dei
progetti su cui è basata l’invenzione cui la privativa è concessa.
Una motivazione alquanto simile spiega la durata relativamente breve della
tutela brevettuale, generalmente pari a 20 anni, e dunque molto inferiore a
quella assicurata dal diritto d'autore: molto frequentemente, una invenzione
rende possibili molte altre invenzioni. Molte tra queste sono dipendenti dalla
prima invenzione, e pertanto se la privativa fosse molto estesa
temporalmente, il flusso di innovazioni disponibili per la collettività
potrebbe risultare inferiore. Problemi di questo tipo, nelle opere
dell’ingegno, sono evidentemente molto meno verosimili.
234
Naturalmente, il brevetto non è l'unica soluzione per chi voglia tutelare la
proprietà intellettuale di un'innovazione, poiché è possibile ricorrere alla
normativa civilistica a tutela del segreto aziendale. Dal punto di vista del
titolare del diritto, questa soluzione offre in teoria una minore protezione
(poiché deve essere dimostrato in un eventuale giudizio il carattere segreto
dell’informazione), e dal punto di vista sociale essa tutela il diritto
esclusivo, ma non offre alla collettività (com’è invece assicurato
dall’obbligo di divulgazione dei progetti, cui è condizionata la concessione
di un brevetto), la possibilità di utilizzare la conoscenza del processo che ha
portato all’innovazione, per la realizzazione di altre innovazioni.
La maggior tutela privata offerta da un brevetto è poi in molti casi relativa,
poiché gli uffici brevetti, sopraffatti dal numero di domande che essi
ricevono (si veda ancora la figura), non sono più in grado di verificare con
la necessaria cura la presenza del requisito di originalità, e pertanto
possedere un brevetto non fornisce più un livello di tutela elevato come un
tempo.
Questo problema è particolarmente grave nei Paesi, come l'Italia, dove gli
uffici brevetti tendono ad effettuare un esame alquanto rapido della
domanda di brevetto, e nei quali pertanto – assai spesso – la tutela deve
essere comunque ottenuta per vie legali.
La crescente complessità tecnica dei giudizi civili in materia di brevetti, ha
determinato in vari Paesi la costituzione di corti specializzate.
I brevetti, dunque, sono necessari per favorire le innovazioni. Ciò non
comporta naturalmente che la tutela brevettuale sia sufficiente ad assicurare
che nel sistema economico venga generato un flusso di innovazioni
"sufficiente" secondo un qualche criterio di benessere collettivo. Se teniamo
poi conto che, frequentemente, le innovazioni hanno carattere complesso, e
richiedono investimenti molto considerevoli, è ragionevole attendersi che
sistemi produttivi caratterizzati da grandi imprese siano intrinsecamente più
portati ad introdurre innovazioni.
Come vedremo, questo può essere vero. Tuttavia, prima di valutare questo
punto. è necessario sottolineare – da un lato - come anche se una grande
dimensione produttiva è in grado di favorire l'innovazione tecnologica, ciò
non è più vero quando contemporaneamente, la grande impresa produttrice è
anche un monopolista.
235
21.4 Le politiche per l’innovazione
Le imprese innovano continuamente: schematizzando, non appena
un’impresa introduce una innovazione essa è, in genere, in grado di godere
di profitti più alti dei suoi concorrenti, che possono derivare da innovazioni
di processo (una nuova tecnologia mi consente di ridurre i costi di
produzione, aumentando il margine sulle vendite), o da innovazioni di
prodotto (un nuovo prodotto mi consente di differenziarmi dalle altre
imprese, ed i consumatori sono disposti a pagare un prezzo maggiore per i
miei, differenti, prodotti). Allora, perché dovremmo incentivarle a fare
qualcosa che comunque esse farebbero egualmente?
Una risposta frequente a questa domanda, è che ciò è necessario, almeno per
un Paese come l’Italia, la cui struttura produttiva è caratterizzata da un
numero enorme di imprese molto piccole 171, perché tali imprese affrontano
ostacoli rilevanti nei processi di innovazione, attribuibili a costi di
transazione e ad informazioni incomplete: la politica industriale deve
quindi sostenere i processi di innovazione tecnologica delle piccole
imprese.
Ma anche nei programmi di ricerca e sviluppo, tipicamente realizzati dalle
grandi imprese, potrebbero verificarsi dei fallimenti di mercato: davanti a
programmi di ricerca rischiosi, il cui rendimento economico privato è
aleatorio, le grandi imprese potrebbero sviluppare un livello di investimenti
efficiente dal punto di vista privato, ma insufficiente sul piano sociale, e
sarebbe quindi necessario un finanziamento pubblico, almeno parziale, di
questi programmi. Questo è, naturalmente, un argomento basato sulle
esternalità positive.
Vi sono dunque diversi argomenti che è possibile avanzare a favore delle
politiche a sostegno dell’innovazione.
Per analizzarle, bisogna anzitutto distinguere tra propensione a produrre
innovazioni, e propensione ad introdurre innovazioni (da altri prodotte)
nella propria azienda.
Quanto alla propensione a produrre innovazioni, studi recenti, condotti su
un campione molto ampio di brevetti 172, mostrano come tale propensione
dipenda in primo luogo dall’investimento in ricerca e sviluppo, e in secondo
dalle modalità di incentivazione (monetarie, o di carriera) dei ricercatori.
Non vi è, invece, una relazione significativa tra dimensione d’impresa ed
attività innovativa. Quindi se, a parità di altre condizioni, la grande
171
Circa il 50% dei 16 milioni di addetti nell’industria manifatturiera italiana lavorano in
imprese con meno di 10 addetti.
172
Si veda, di A. Gambardella et al. The value of Patents, disponibile all’indirizzo:
http://www.alfonsogambardella.it/GHVValueofPatents.pdf.
236
dimensione può favorire, in alcuni settori, l’attività innovativa 173, questa non
è necessariamente una condizione necessaria: almeno in alcuni settori,
grandi progetti possono essere infatti intrapresi suddividendo adeguatamente
l’attività di ricerca tra molte imprese diverse 174. Ad esempio, buona parte
delle imprese che hanno fatto decollare il corrente ciclo tecnologico, basato
sulla microelettronica e sull'informatica, erano di piccola dimensione.
Anche se il problema è certamente complesso, possiamo comunque
sinteticamente concludere che soltanto in alcuni settori una grande scala
produttiva è necessaria per sostenere una forte attività innovativa: vi sono
molti altri casi nei quali ciò non è necessario. In secondo luogo, la
dimensione non è certamente l'unica variabile rilevante: la disponibilità
di capitale umano di elevata formazione scientifica; la disponibilità, a costi
ragionevoli, di capitale di rischio; l'accesso alla ricerca universitaria, sono
tutte caratteristiche estremamente importanti per favorire la produzione di
innovazioni.
Per quanto riguarda specificamente le attività di ricerca e sviluppo, i
(pochi) studi disponibili 175 non sembrano evidenziare l’esistenza di
fallimenti di mercato, ma anzi concludono che il rendimento lordo degli
investimenti in ricerca e sviluppodelle imprese innovatrici italiane è stato
pari al 20% all’inizio degli anni novanta, ed è salito al 22% verso la fine di
quel decennio. Inoltre, il tasso di rendimento degli investimenti in ricerca e
sviluppo risulta indipendente dalla localizzazione geografica, dalla
dimensione (ancora!) e dal settore di appartenenza delle imprese.
Quanto alle determinanti dell’adozione di nuove tecnologie, studi recenti,
riferiti alla microelettronica 176, mostrano come questa dipenda in generale
da due fattori:
c. la dimensione dell'impresa, che determina sia la probabilità che
un’azienda adotti nuove tecnologie, sia "quanto e quando" esse
vengano immesse nei processi aziendali: più è grande l'impresa, più
probabile è l'adozione e più intenso l'uso della nuova tecnologia che
si decide di farne;
173
Ad esempio, in settori come il farmaceutico, gli investimenti necessari per sviluppare un
nuovo farmaco sono in media pari a circa 1 miliardo di dollari, e dunque alla portata
soltanto di imprese aventi una scala adeguata a ‘spalmare’ questo investimento su ampi
volumi di vendite.
174
Ciò è frequente, ad esempio, nel settore aerospaziale.
175
Si veda: “Il tasso di rendimento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese
innovatrici italiane”, di Francesco Aiello e Valeria Pupo, in Politica Economica, 2004.
176
Si veda: Salvatore Rossi (curatore), La nuova economia: i fatti dietro il mito, il Mulino,
2003.
237
d. il livello del capitale umano disponibile: imprese con una
manodopera mediamente più istruita riescono più facilmente ad
introdurre innovazioni.
Vi sarebbe quindi forse spazio per incentivare l’adozione di nuove
tecnologie da parte delle piccole imprese, perché qui la dimensione
effettivamente è un fattore rilevante, ma naturalmente gli strumenti da
utilizzare dovrebbero essere tali da generare investimenti addizionali, nel
duplice senso di:
•
convincere una data piccola impresa a fare investimenti che
altrimenti non avrebbe fatto;
•
non avere effetti di sostituzione apprezzabili, scoraggiando gli
investimenti delle imprese che non ricevono l’incentivo.
I risultati delle politiche per l’innovazione nel nostro Paese non sono però
incoraggianti. Come mostra un recente studio della Banca d’Italia 177, la
principale legge di incentivazione italiana volta a favorire l’adozione di
nuove tecnologie da parte delle piccole imprese, che ha erogato tra il 1996
ed il 2003 la rispettabile cifra di € 16 miliardi, non ha avuto effetti netti
sensibili: le imprese che concorrevano per il contributo, rallentavano infatti
gli investimenti prima di fare domanda per il contributo, ed in ogni caso i
maggiori investimenti delle imprese che ottenevano il contributo
sostituivano in parte i minori investimenti di quelle che non lo ottenevano.
Possiamo quindi concludere che, anche se in teoria vi potrebbe essere
spazio per politiche volte a favorire l’introduzione di innovazioni da parte
delle piccole imprese, in pratica è estremamente difficile assicurare che gli
incentivi erogati con queste finalità diano luogo effettivamente ad
investimenti addizionali.
Quanto abbiamo discusso più sopra circa il ruolo dei gruppi di interesse
nella politica economica, ci dovrebbe inoltre suggerire come sia probabile
che queste politiche di incentivazione vengano rapidamente trasformate in
politiche di sussidio alle imprese.
177
Si veda: R. Bronzini – G. De Blasio, Qual è l’effetto degli incentivi agli investimenti?
Una valutazione della Legge 488/92.
238
22. ECONOMIA DELLE SCELTE PUBBLICHE
Nel corso abbiamo discusso vari tipi di politiche economiche, e molte
ancora ne potremmo discutere: ma cosa determina la scelta di perseguire
una politica economica, e quale ruolo hanno gli elettori in questa scelta?
Abbiamo già parzialmente discusso questo problema, quando ci siamo
occupati di gruppi di pressione, ma qui assumiamo, concludendo il
corso,una prospettiva più ampia, chiedendoci cioè come si vengano a
formare le scelte collettive. Il problema può sembrare futile, poiché siamo
normalmente abituati a ritenere che una votazione a maggioranza sia il
modo migliore per realizzare una scelta collettiva: questo è, però, come
vedremo, vero soltanto in alcuni casi, ma non in tutti.
Consideriamo l'esempio seguente. Tre amici devono decidere quale film
andare a vedere insieme. La città è piccola, e quindi ci sono soltanto tre film
in programmazione, A, B, e C. Gli amici decidono che ciascuno dovrà
esprimere le sue preferenze in ordine decrescente, per poi procedere ad una
democratica votazione. Tizio dichiara di preferire, nell'ordine, A, B e C.
Caio invece preferisce C, A e B. Sempronio invece preferisce B, C ed A.
Viene quindi messo ai voti il film A contro quello B, e naturalmente vince A
con i voti di Tizio e di Caio. Viene poi posto ai voti il film A contro C, e
vince quest'ultimo, con i voti di Caio e Sempronio.
Dunque, poiché, nelle votazioni, C è risultato preferito ad A, che a sua volta
è risultato preferito a B, C dovrebbe essere il film vincente, ma
evidentemente non è così: se infatti confrontiamo direttamente C contro B,
vediamo facilmente come sia B a vincere. Questo risultato è noto come il
paradosso del voto: la scelta collettiva dipende dall'ordine in cui le diverse
alternative sono contrapposte.
Ma in realtà comporre le preferenze individuali in una scelta collettiva non è
soltanto difficile, ma addirittura impossibile. Il teorema dell'impossibilità
di Arrow mostra infatti come un sistema di votazioni non è mai in grado di
soddisfare in ogni circostanza quattro caratteristiche assolutamente
ragionevoli 178. Questo risultato ci fa capire come mai spesso il
comportamento dello Stato possa apparire incoerente: nei sistemi di
178
E cioè essere dotato di transitività, e così se A è preferito a B e B è preferito a C, A
dovrebbe essere preferito a C; non produrre un esito dittatoriale; non far dipendere la scelta
tra A, B e C, da alternative irrilevanti; funzionare sempre, indipendentemente dalle
alternative tra cui si deve scegliere.
239
votazione aventi caratteristiche ragionevoli, spesso le decisioni dipendono
dalla particolare coppia di alternative che viene messa ai voti.
Questo naturalmente non vuol dire che i sistemi di voto a maggioranza siano
sempre instabili: in alcuni casi, essi possono infatti produrre degli equilibri
stabili. Questo si verifica, ad esempio, se le preferenze degli elettori sono
relativamente semplici (ad esempio, tra un alto livello di spesa pubblica e un
basso livello di spesa pubblica ogni elettore ha una chiara preferenza), e
quindi il sistema elettorale riesce a combinarle stabilmente.
In questi casi è possibile dimostrare come l’esito del voto sia determinato
dall’elettore mediano. Per illustrare questo punto consideriamo una
votazione in cui gli elettori sono soltanto tre. Il primo vuole una spesa
pubblica, ad esempio per l’istruzione, elevata; il secondo vuole una spesa
pubblica bassa, e il terzo vuole un livello di spesa pubblica né troppo alto né
troppo basso. In un sistema di voto a maggioranza, è quest’ultimo elettore,
con la sua scelta, a determinare se la maggioranza del corpo elettorale
decide una alta spesa pubblica oppure una bassa spesa pubblica. Questo
ragionamento può essere esteso a qualunque numero di elettori, e pertanto è
intuitivo concludere come, nei sistemi elettorali a maggioranza, sia
l’elettore, o più propriamente siano gli elettori mediani a determinare l’esito
della votazione.
Il problema più generale, ma che - come vedremo - si interseca con vari
argomenti che abbiamo discusso nel corso, è il motivo per cui gli individui
vadano a votare. Poiché la probabilità che il voto di un singolo elettore sia
determinante ai fini del risultato è praticamente zero, se gli elettori sono
tanti, un elettore razionale non dovrebbe mai andare a votare. In realtà, gli
elettori vanno a votare soprattutto perché molti di loro sono mossi da
motivazioni non strettamente economiche, perché ritengono che un sistema
politico efficiente sia un beneficio per la collettività.
Altri elettori però vanno a votare per proteggere i propri interessi. Un uomo
politico milanese sa ad esempio che, con assoluta certezza, tutti i tassisti e le
loro famiglie andranno a votare a favore di chi protegge il sistema vigente,
nel quale le licenze sono troppo poche, i milanesi hanno la possibilità di
usufruire di pochi taxi, e molto cari, e quindi ove ogni licenza di taxi vale
centinaia di migliaia di euro. Il politico, però, non è sicuro che chi è
favorevole alla liberalizzazione andrà a votare: in teoria la maggioranza
della popolazione può quindi essere favorevole alla liberalizzazione del
settore dei taxi, in pratica la maggioranza dei votanti è probabilmente
invece contraria.
Questo è uno dei motivi che rende politicamente potenti i gruppi di
interesse, ma ve ne sono altri. In primo luogo, i politici che vengono eletti,
non hanno spesso il tempo, le capacità, o le risorse per acquisire le
informazioni che sono loro necessarie per esercitare il loro mandato. I
240
gruppi di interesse dedicano quindi ampie risorse a fornire loro informazioni
accuratamente selezionate e naturalmente non particolarmente obbiettive.
Un ulteriore modo con cui i gruppi di interesse possono influenzare il
comportamento dei politici è mediante forme più o meno dirette di
corruzione. Questa può assumere aspetti penalmente rilevanti, con la
corresponsione di tangenti o benefici in natura, ma spesso assume forme più
sfumate, ma non per questo meno rilevanti; almeno sotto il profilo del
pubblico interesse, come la concessione di favori, come l’assunzione di
persone indicate dai politici. Per costoro, questo è un favore rilevante perché
consolida gli elettori fedeli, la cui importanza è tanto superiore quanto più
bassa è la propensione dei cittadini a recarsi alle urne: il peso dei clientes, in
questo caso, può essere molto importante.