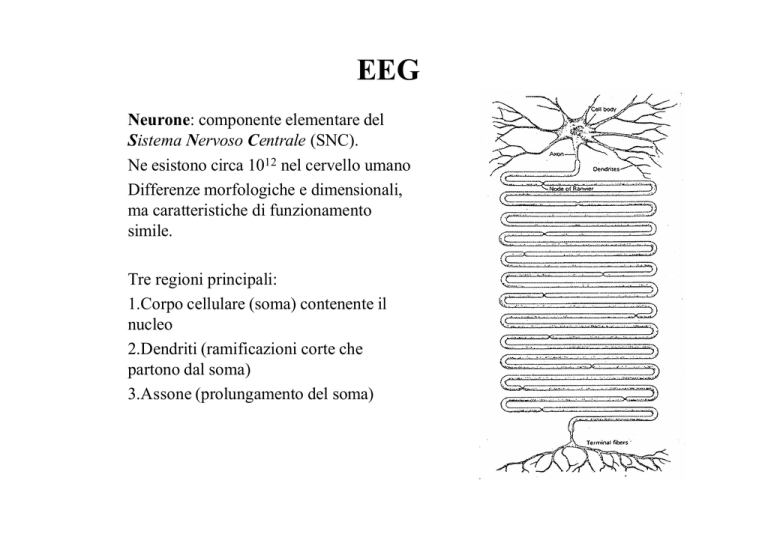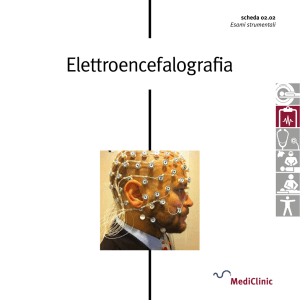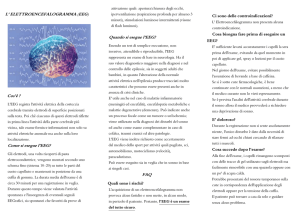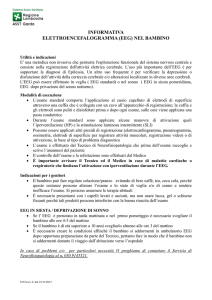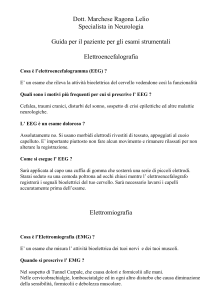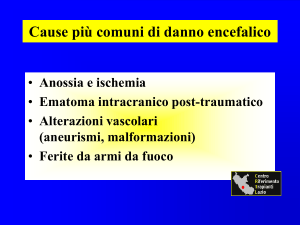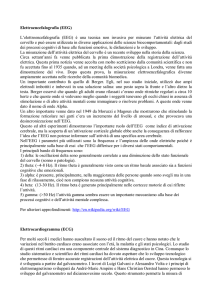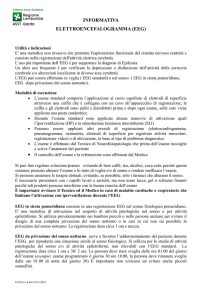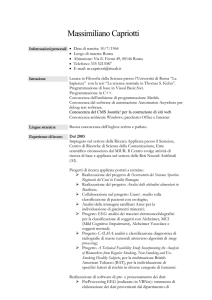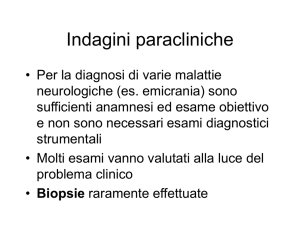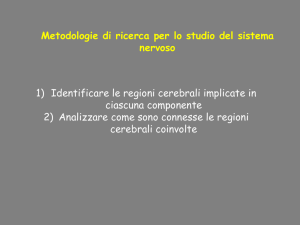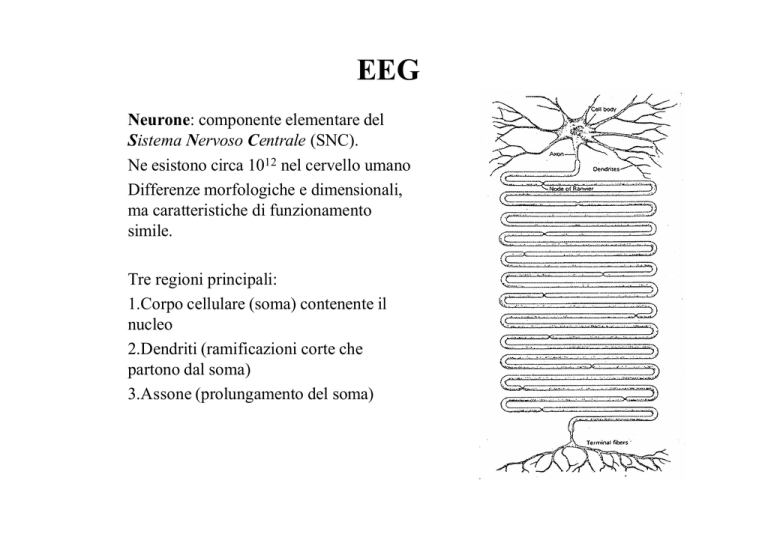
EEG
Neurone: componente elementare del
Sistema Nervoso Centrale (SNC).
Ne esistono circa 1012 nel cervello umano
Differenze morfologiche e dimensionali,
ma caratteristiche di funzionamento
simile.
Tre regioni principali:
1.Corpo cellulare (soma) contenente il
nucleo
2.Dendriti (ramificazioni corte che
partono dal soma)
3.Assone (prolungamento del soma)
EEG
L’assone è un canale di trasmissione del segnale
elettrico da un neurone ad un altro
Lunghezza da pochi mm a circa 1m
Larghezza da 1 a 20 µm
Velocità di conduzione fino a 100 m/s nelle fibre
assoniche più grandi
Ricoperti di una sostanza isolante (mielina),
interrotta ad intervalli regolari (punti di Ranvier)
I dendriti ed il soma sono in contatto con le
terminazioni degli assoni di altri neuroni che
presentano rigonfiamenti detti bottoni sinaptici
Trasmissione unidirezionale: dall’assone di un
neurone al dendrite od al soma di un altro. Può
avere carattere eccitatorio o inibitorio
Ogni neurone può avere fino ad un migliaio di
contatti sinaptici e riceverne altrettanti
EEG
Segnali elettrici: tensioni variabili nel tempo (‘potenziali’) dovute a d.d.p. tra
interno ed esterno delle cellule nervose.
Segnali in ingresso (si propagano passivamente e si attenuano velocemente,
ridotti ad 1/3 dopo circa 1mm):
Potenziali recettori: trasformano uno stimolo sensoriale in un
segnale elettrico
Potenziali sinaptici: segnali elettrici inviati dai neuroni
circostanti attraverso i contatti sinaptici.
I potenziali in ingresso convergono verso una zona neuronica in cui vengono
algebricamente sommati.
Il risultato di tale somma può portare alla generazione, da parte del neurone, di
una risposta: il potenziale d’azione.
Tale risposta viene propagata attivamente lungo tutto l’assone e raggiunge le
terminazioni sinaptiche dove interagisce con altri neuroni.
EEG
Rappresentazione funzionale del neurone: quattro componenti.
EEG
All’interno ed all’esterno della
cellula nervosa si trovano ioni
positivi e ioni negativi.
Spessore della membrana (insieme
di lipidi e proteine) da 8 a 10 nm.
All’interno soprattutto K+ e altri
anioni organici, all’esterno
soprattutto Cl- e Na+.
In condizioni di riposo la
differenza di potenziale tra esterno
ed interno è di circa 60mV con
l’interno negativo rispetto
all’esterno.
Diffusione passiva per gradiente di
concentrazione e meccanismo
attivo, pompa sodio-potassio,
mantengono l’equilibrio.
EEG
Nella membrana esistono proteine (canali ionici) capaci di lasciare passare
solo un particolare ione.
I canali sodio, in condizioni di riposo, sono praticamente chiusi (bassa
permeabilità della membrana).
Se ‘stimolata’ la membrana può aprire i canali del sodio à gli ioni Na+
entrano à il potenziale interno viene perturbato à passa da negativo a
positivo à cambia permeabilità al potassio à gli ioni K+ escono à il
potenziale tende a ritornare alle condizioni di riposo.
Tutto ciò avviene
all’inizio dell’assone, poiché
il corpo cellulare
non ha canali sodio
controllati dal potenziale.
EEG
Chi fornisce la stimolo?
Tutte le connessioni sinaptiche
dei dendriti causano piccole
variazioni del potenziale
elettrico all’interno della
membrana.
Se le quantità di eccitazioni
sinaptiche sono sufficienti da
far sì che il potenziale interno
raggiunga un valore di soglia si
aprono i canali sodio à si
genera il potenziale d’azione.
Comportamento ON-OFF del
neurone.
EEG
Come avviene la propagazione lungo l’assone?
EEG
Sinapsi: Insieme di membrana pre-sinaptica (bottone sinaptico), membrana postsinaptica (punto di contatto con il soma o i dendriti), spazio sinaptico.
Può essere di due tipi: chimica o elettrica. Nei mammiferi maggioranza di chimica.
Vescicole sinaptiche contenenti trasmettitore chimico per comunicazione
(acetilcolina o acido gamma-ammino burritico GABA)
EEG
Sinapsi attiva à le vescicole liberano il loro contenuto nello spazio sinaptico à il
neuro-trasmettitore si fissa su molecole recettrici su esterno membrana post-sinaptica
à apertura di canale ionico.
Effetto eccitatorio:
apertura dei canali sodio
Effetto inibitorio:
apertura dei canali cloro
Depolarizzazione della membrana
dendritica à cambiamento di
potenziale locale à generazione
di corrente all’interno della cellula
à se somma correnti sufficienti
à generazione potenziale d’azione.
Una volta generato, l’impulso nervoso percorre tutto l’assone (la velocità può essere
diversa)
EEG
Il SNC, il cui componente fondamentale è il neurone, può essere suddiviso in:
midollo spinale (contenuto nella colonna vertebrale) ed encefalo (contenuto nel cranio).
Encefalo:
•Tronco cerebrale o tronco encefalico(composto da midollo allungato, ponte e
mesencefalo)
•Cervello (composto da diencefalo e telencefalo che consta dei due emisferi cerebrali) è
avvolto da tre membrane protettive (meningi)
•Cervelletto
EEG
Due emisferi cerebrali:
ciascuno controlla il lato
opposto del corpo.
Sono connessi fra loro da
una banda di 300 milioni di
fibre nervose.
Ciascun emisfero è
composto da più strati.
Il più esterno, composto da
un denso insieme di cellule
nervose appare grigio
(materia grigia), è spesso
qualche mm, ed è chiamato
corteccia cerebrale.
EEG
La corteccia è molto convoluta e consiste di gyri (dorsali) e sulci (solchi). I
solchi più profondi sono chiamati fessure.
Gli strati profondi degli emisferi consistono di assoni (materia bianca) e corpi
cellulari (nuclei)
EEG
La corteccia di ciascun emisfero è divisa in quattro aree (lobi):
Lobo frontale (pianificazione, processo decisionale, comportamento intenzionale)
Lobo parietale (informazioni sensoriali)
Lobo occipitale (in parte dedicato alla visione)
Lobo temporale (udito, percezione, memoria, ecc.)
EEG
Registrazione dell’andamento temporale dei potenziali elettrici generati
dall’attività cerebrale
•ElettroEncefaloGramma (EEG): registrazione con elettrodi posti sullo scalpo
•ElettroCorticoGramma (ECoG): registrazione con elettrodi posti sulla
superficie esposta della corteccia cerebrale
•Registrazione profonda: registrazione con sottili elettrodi ad ago inseriti nel
tessuto neurale del cervello
Indipendentemente dal tipo di registrazione rappresentano la sovrapposizione
dell’effetto di vari generatori neuronali.
Utilizzi dell’EEG:
Valutazione stato neurologico del soggetto
Indicazione della profondità dell’anestesia (anello di retroazione)
Alternativa a ECG in interventi chirurgici a cuore aperto
EEG
Attività elettrica continua ed oscillante: onde cerebrali.
Intensità sullo scalpo: fino a 300 µV
Intensità sulla corteccia: fino a qualche mV
Contenuto di frequenza: 0.5 – 100 Hz
Le caratteristiche delle onde cerebrali dipendono dal grado di attività della
corteccia à notevole differenza tra sonno e veglia.
Andamento molto irregolare, ma in alcuni
Momenti, si evidenziano particolari pattern.
Alcuni stati patologici forniscono pattern
particolari
I normali pattern vengono classificati come:
onde alfa, beta, theta, delta.
EEG
Onde ALFA
Frequenza: 8-13 Hz
Stato di veglia, ma di riposo assoluto
Più intense in regione occipitale, ma possono apparire in zona parietale e
frontale
Ampiezza: 20-200 µV
Scompaiono completamente durante il sonno
EEG
Onde BETA
Frequenza: 13-22 Hz, ma possono arrivare fino a 50 Hz con attività mentale
particolarmente intensa
Più intense in regione parietale e frontale
Ampiezza: 20-200 µV
Si dividono in:
Beta I – comportamento simile alle ALFA, ma frequenza doppia
Beta II – intensa attività cerebrale
EEG
Onde THETA
Frequenza: 4-8 Hz
Più intense in regione parietale e temporale dei bambini. Nell’adulto per
stress, frustrazioni, delusioni
Ampiezza: 20-200 µV
EEG
Onde DELTA
Frequenza: inferiore a 4 Hz
Durante il sonno, nell’infanzia, per gravi disturbi organici del cervello
EEG
Attività cerebrale registrata dipende da posizione in cui l’elettrodo è posto à necessità di
regole standard per il posizionamento degli elettrodi.
Sistema standard proposto dalla International Federation of EEG Societies, denominato 1020.
Utilizza precisi riferimenti anatomici.
Indipendente dalle dimensioni della scatola cranica.
Ciascun elettrodo viene identificato da una sigla che ne specifica la localizzazione.
Le posizioni standard vengono identificate con una lettera ed un numero
Le lettere sono:
F = frontale
T = temporale
C = centrale
P = parietale
O = occipitale
A = orecchio
I numeri pari si riferiscono all’emisfero destro, i dispari al sinistro
Z indica la linea centrale
A1 ed A2 sono in corrispondenza dei lobi delle orecchie e sono usati come riferimento.
EEG
Posizionamento antero-posteriore:
partendo dal vertice si misura distanza tra nasion e inion e si calcolano le
distanze come percentuale della totale
Posizionamento nel piano coronale:
Distanza tra i punti pre-auricolari destro e sinistro
EEG
EEG
Esistono tre tipi di connessione: unipolare, bipolare, riferita alla media.
Unipolare: un elettrodo è preso come riferimento comune per tutti gli altri.
Potenziale variabile à elettrodo lontano à lobo di un orecchio o unione dei due
La traccia assume la sigla dell’elettrodo da cui ha origine
EEG
Riferita alla media: tutti gli elettrodi vengono collegati tra loro con una rete
resistiva. L’uscita della rete è presa come riferimento.
La traccia assume la sigla dell’elettrodo da cui ha origine
EEG
Bipolare: non si usa alcun riferimento. Si utilizzano le differenze di tensione tra
coppie di elettrodi.
Localizzazione più precisa delle zone di attività.
La traccia assume la sigla dei due elettrodi su cui viene effettuata la differenza
EEG
Schema a blocchi encefalografo
EEG
Pre-amplificatore: amplificare il segnale il più vicino possibile alla sorgente serve
per limitare azione di rumori esterni ulteriori. Sono già eventualmente presenti
artefatti (per esempio attività muscolare del collo e del viso: f = 0.5-100Hz).
Alta impedenza di ingresso (2-10 MΩ)
Protezione al paziente con circuito di isolamento
Limitazione della banda allo stretto necessario (S/N)
Guadagno complessivo molto elevato (1000 e più)
Ingresso differenziale con alto CMRR
Calibrazione del segnale (confronto con segnale noto)
Uscita con le caratteristiche necessarie a pilotare uno strumento di registrazione.
EEG
Elettrodi utilizzati:
solitamente Ag-AgCl
(buona stabilità e basso rumore:
5-50 µV)
Necessità di bassa impedenza di
contatto (<5-10 kΩ)
EEG
Registratori a carta
EEG
EEG
Stati di sonno
EEG
Stati patologici
EEG
EEG
EEG
EEG
EEG
EEG
Mappe di potenziali
Importante la disposizione spaziale degli elettrodi oltre che l’andamento
temporale dei segnali.
Difficile confronto visivo
tra tracce di andamenti
temporali.
Passaggio a rappresentazione
topografica
EEG
Rappresentazione a linee equipotenziali
Sequenza di mappe di misure effettuate in
istanti successivi forniscono una visione
diretta della dinamica.
Costruzione linee di livello à utilizzo di
algoritmi distinti in due classi: globali e
locali.
Algoritmi globali più onerosi, ma
garanzia di interpolazioni senza punti
angolosi che potrebbero aversi con quelli
locali.
Dimensione non infinitesima dei punti di
registrazione, allargamento area attiva a
causa di tessuti interposti tra sorgente ed
elettrodi, integrazione spazio-temporale
del sistema visivo à sufficiente
algoritmo locale
EEG
Rappresentazione a
mappe tridimensionali.
La terza dimensione è
l’ampiezza del segnale.
Informazione solo
qualitativa
EEG
Mappe a colori o a livelli di
grigio
Molto efficaci
Presentazione in sequenza
(es. 3Hz) à visione chiara e
precisa di evoluzione spaziotemporale
MEG
MagnetoEncefaloGrafia (MEG):
tecnica di registrazione non invasiva dei piccolissimi campi magnetici
emessi dal cervello.
Emissione associata alle onde alfa approssimativamente 0.1 pT a 5 cm
dallo scalpo. Campo magnetico terrestre ~50 µT.
Necessità di:
•stanza schermata da pesantissimi schermi ad altissima permeabilità
magnetica.
•bobine di superconduttori mantenuti a circa 4 °K.
Ciò permette di indurre una corrente nelle bobine che a loro volta
inducono un campo magnetico in uno speciale magnetometro:
Superconducting Quantum Interference Device (SQUID).
MEG
Sensibilità di 0.01 pT.
Tecniche particolari consentono l’eliminazione del campo magnetico di
fondo (terrestre e ambientale): 10-100 nT.
Il sistema contiene 2 x 37 SQUID (canali di registrazione) che consentono
di determinare la distribuzione spaziale della sorgente di campo magnetico
A differenza di TAC e NMR che danno informazioni di tipo anatomico è
in grado di fornire informazioni funzionali, come PET e fNMR, con la
stessa risoluzione spaziale, ma una superiore definizione temporale (1 ms)
Elevatissimi costo à pochissime unità
Usi: soprattutto ricerca (es.: mappatura della corteccia somatosensoriale e
motoria)