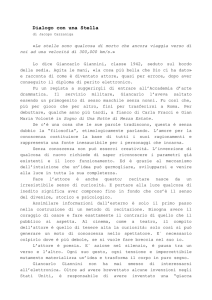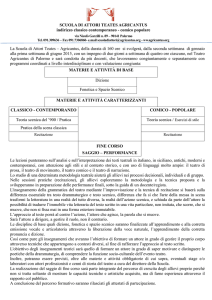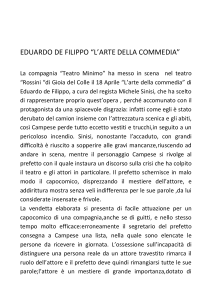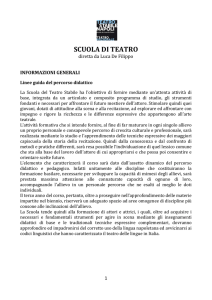Luciano Mariti
Energia e ritmo. Dalla scrittura di Vittorio Alfieri alla teoria della
recitazione di Giovanni Emanuele Bideri
La critica più recente ha ormai definitivamente superato l'idea di un Alfieri "poeta lirico", quasi
incurante del teatro, per avvalorare quella di un poeta che scrive per la scena e che è integrale uomo
di teatro1.
La novità più rilevante della drammaturgia alfieriana rimane, comunque, la conquista di una
teatrale artificialità della scrittura, attraverso una nuova organizzazione prosodica. La ricerca di una
nuova vita ritmico-energetica del testo, aderente alla trasfigurazione del mondo borghese in
tragedia, fu l'ossessione di Alfieri. La stessa autobiografia, mobile nella sua superficie, è
solidamente bloccata intorno al problema del fare versi2, che poi è il problema tecnico del
drammaturgo che scrive per la messa-in-voce del testo.
E' nota la personalissima tecnica della scrittura alfieriana, ma è opportuno riavvicinarla,
soprattutto per individuarne le potenzialità recitative che qui ci interessano.
Nella sofferta ascesa al verso tragico, condotta nell'invasamento per le lingua morte e le forme
dei poeti primari (da Virgilio a Seneca a Dante all'Ossian cesarottiano), Alfieri si muove nella
lucida prospettiva di «creare una giacitura di parole, un rompere sempre variato di suono, un
fraseggiare di brevità e di forza che venissero a distinguere assolutamente il verso sciolto tragico
da ogni altro verso sciolto e rimato sì epico che lirico»3. E' la ricerca, più che di novità lessicali e di
soggetti inediti («nessuno - dichiara - ne ha inventato meno di me»4), di un «parlar breve, nobile e
vibrato» da cui deriva «l'energico»5: di un verso scabro e disadorno che eviti ogni contagio fonico
con il cantabile, slobato, verso metastasiano di cui teme quella fiacchezza («vero delitto capitale
dell'autor tragico»") e quella fluidità «per cui le parole sdrucciolano di penna a chi le scrive, di
bocca a chi le recita e, colla stessa facilità, dagli orecchi di chi le ascolta»6. Nella lotta contro le
insidie del melodramma e nel tentativo di allontanarsi dal conversevole e dal "triviale" della lingua
ordinaria - inefficaci sulla scena tragica - Alfieri smonta e riagregga l'endecasillabo, lo libera dalla
rima, dal decoro arcadico, dalla falsariga melodica di derivazione francese sperimentata nella prima
prova drammatica, Cleopatra, lo dilata con forti enjambements (verso inarcato simile allo straddled
vers shakespeariano), lo contrae e lo frattura per una musicalità dissonante in cui non risuoni
alcun'eco prosastica. Come testimoniano gli stessi scritti teorici del poeta, nonché le infinite
operazioni di restauro verso a verso e di riassetto correttorio (durato ben 14 anni per il Filippo),
Alfieri cerca una lingua "straordinaria", teatralmente artificiale ma viva per intrinseca energia,
architettando uno spartito vocale ricco di interne tensioni e dinamico. Tecnicamente il tentativo è
attuato, come è noto, attraverso un'arditissima reinvenzione della sintassi, di cui stravolge l'ordine
naturale. Alla ricerca di una «non comune collocazione delle parole», sposta, traspone, inverte le
tessere del periodo, compone montaggi per destabilizzare automatici percorsi di senso, per orientare
l'attenzione verso contraddittori nuclei semantici. Mentre distorcendo il giro sintattico, scheggiando
1 Si vedano, soprattutto, E. RAIMONDI, Le pietre del sogno. Il moderno dopo il sublime, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 17-89, e
l'Introduzione di S. Romagnoli a V. ALFIERI, Tragedie, Torino, Einaudi, 1993, tomo primo, pp. VII-LCXV.
2 Si veda, anche per un'analisi delle soluzioni tecniche, G. L. BECCARIA, I segni senza ruggine. Alfieri e la volontà del verso tragico,
in "Sigma", IX, 1976, n. 1-2, pp. 107-51.
3 V. ALFIERI, Vita scritta da esso, ed. critica a cura di L. Fassò, Asti, Casa d'Alfieri, 1951, parte I, epoca IV, cap. II, p. 194.
4 Parere dell'Autore su le presenti tragedie, in V. ALFIERI, Parere sulle tragedie e altre prose critiche, testo definitivo e redazioni
inedite a cura di M. Pagliai, Asti, Casa d'Alfieri, 1978, p. 144.
5 Lettera a G. Tiraboschi del 18 giugno 1785, in V. ALFIERI, Epistolario, a cura di L. Caretti, vol. I (1767-88),
Asti,
Casa
D'Alfieri, 1963, p. 285.
6 Risposta dell'Autore alla Lettera di Ranieri De' Calsabigi all'Autore sulle quattro sue prime tragedie, in V. ALFIERI, Parere sulle
tragedie e altre prose critiche, ed. cit., p. 234.
l'unità discorsiva per una condensazione energetica del senso nella forma-frammento, può
drammatizzare ulteriormente l'enunciato e sottoporre la paratassi dei segmenti dialogici a un
andamento teso, accelerato e progressivamente contrastivo.
Intimamente collegata a questa torturata sintassi è la costruzione ritmica, che costituisce
l'impegno più profondo del poeta che scrive per l'attore. Per conseguire «un rompere sempre variato
di suono» (peraltro scoperto nei giambi di Seneca e studiato sugli Estratti dell'Ossian cesarottiano),
si vale soprattutto di una pausazione che, nello sviluppo delle varianti, si fa sempre più fitta e
sempre più accortamente segnalata all'attore dall'interpunzione e da appositi segni grafici. Una
pausazione funzionale all'accostamento e al salto di ritmi diversi, alle repentine inversioni e
mutamenti di tono, marcata da cesure durissime (la più forte fra due ictus consecutivi, l'uno che
chiude, l'altro che apre i due emistichi del verso7) o molto ardite (come le monosillabiche rifuggite
dai lirici) e sempre arricchita dalla inedita disposizione e varietà delle pause lunghe, delle
semipause vibrate, degli intervalli.
Ne deriva una viva mobilità dell'endecasillabo, ulteriormente rilevata dalla moltiplicazione degli
accenti secondari, che dispone il verso ad accogliere l'impeto del ritmo nel mezzo (la prediletta
accentazione di quarta o di sesta), all'inizio o alla fine (con frequenti spezzature dopo la seconda o
la terza sillaba o dopo l'ottava e la nona) e lo rende pronto a scindere la propria tensione in più
battute consecutive.
L'effetto d'insieme è, insomma, quello della varietà dei periodi ritmici, di un mobilissimo
reticolo di impulsi e controimpulsi, di sospensioni (segnalate dalla sigla grafica che ricorre, per
esempio nel Filippo 298 volte nella terza edizione, la Didot 1789, contro le 67 della terza
versificazione8), con le quali il poeta mima l'incalzare dei pensieri e regola il métro émotif (per dirla
con Céline, altro grande maestro della sospensione) segnando un tracciato ritmico alla recitazione.
Con questi e altri artifici, ampiamente rilevati dalla critica, Alfieri compone una complessa
tessitura ritmica che, ha scritto Raimondi9, è ricerca «di ciò che è l'antidecadenza dentro la
musicalità» canonizzata del verso drammatico: strana musica di fratturati silenzi in cui si esprime il
fondo notturno del dramma, in cui trovano voce gli stati di lacerazione, il muto orrore e il doloroso
stupore, la ghiaccia disperazione e la perplessità, i vuoti dell'attesa e le domande senza risposta che
i personaggi rivolgono a se stessi, sospendendo il giudizio sulla verità, torturandosi nel sospetto e
nella colpa senza sciogliersi e senza toccarsi. Una trama di silenzi che insidia la luce fredda delle
parole e dei significati come un'eco sorda che la dizione - netta e insieme contratta, morsa,
addentata - deve esaltare. Un tacere che è «radiografia misteriosa delle forze distruttive»10, l'altro
racconto, il vuoto che è il nemico con cui nel tragico si istaura il conflitto e quindi il motore segreto
anche del dramma alfieriano.
E' tuttavia ormai acquisito come questa nuova scrittura tragica, nel cui processo compositivo
cadono anche le memorie di Alfieri spettatore e autor comico11, sia nata nell'officina di un poeta
teso alla conquista di una concreta lingua teatrale, programmata per vivere sulla scena e per non
essere dalla scena annientata. E perciò più volte sottoposta alla verifica della recitazione e alle
performances dello stesso poeta-attore, al fine di calibrarne e ratificarne la tenuta scenica, come
dimostrano le riflessioni di Alfieri sull'ormai più volte indagato esperimento dell'Antigone
rappresentata a Roma nel 1782 nel teatro privato del Duca Grimaldi: « [...] avendola io recitata scriverà nel Parere sulla stessa - ne ho osservati molti e diversi effetti, che dell'altre non potrei
individuarne così per l'appunto, benché io tra me stesso gl'immagini»12. Se è arduo stabilire fino a
7 G. G. FERRERO, La conquista dello stile in Alfieri, Torino, Chiantore, 1945, p. 8.
8 L. S. NOWÉ, Dall'idea alla tragedia. Nascita della forma tragica nel "Filippo"alfieriano, Padova, Liviana, 1976, p. 138, n. 149.
9 E. RAIMONDI, op. cit., p. 83.
10 Ivi, p. 99.
11 Stefano Geraci, nel saggio Alfieri in sala prove (di prossima pubblicazione) rivaluta giustamente le esperienze di Alfieri spettatore
e autore comico, definendo le tragedie "commedie impazzite", con espressione già coniata dagli antialfieriani della prima ora, ad
indicare come il materiale linguistico provenisse dalla drammaturgia letteraria e il suo uso dalla commedia.
12 V. ALFIERI, Parere sulle tragedie e altre prose critiche, ed. cit., p. 93. Sull'episodio romano si vedano E. RAIMONDI, op. cit., pp.
17-64, e S. ROMAGNOLI, op. cit., pp. XL-XLIX, che fa ampio riferimento anche alle letture e alle recite private organizzate
dall'Alfieri.
2
che punto si sia spinta tale verifica scenica, comunque invocata per sciogliere dubbi di
composizione13, è indubbio che la parola venga formandosi commisurata al suo destino recitativo.
E' per questo che Alfieri non lavora sul colore, ma sulla dimensione della parola quale corpo
plastico che conquista lo spazio attraverso il valore sonoro e ritmico. Scolpita dalla voce, calibrata
nel suo peso e nel suo tragitto temporale, la parola alfieriana non è né decorativa, né descrittiva, né
figurativa («dir cose che non sono né immagini né descrizioni» 14), ma ha la traiettoria del gesto
rigoroso e necessario. Affidata a personaggi che agiscono l'immobilità, come chiusi dentro bare di
ghiaccio, bruciata senza calore, sbiancata dal laser, non si dilata melodrammaticamente al fuoco
degli affetti, non si dispiega nella metafora, ma è autoriflessiva e ferma su se stessa e richiede, come
voleva il poeta, una dizione netta e cruda che la carichi di tensione bloccandola nello spazio per
farla vibrare nel tempo.
Per voler essere tutto, la parola è condannata, sulla nuda scena, a produrre in sé il ritmo di un
movimento che non si vede, di un gesto che non si compie, a condensare in sè l'energia dell'azione.
Ed è tale la tensione della scrittura, perché frutto di una drammaturgia generata dalla sistematica
ricerca del conflitto, da quella retorica del contrasto «che diventa davvero il potenziale filtro di una
grande resurrezione poetica»15 e che permea tutto il mondo del poeta. Il che è evidente nelle antitesi
di cui si nutre il tema ideologico (libertà-tirannia, ecc.), come nel sistema di relazione oppositive fra
i personaggi16 i quali, come menadi, si muovono alla ricerca di un legame con l'altro continuamente
spezzato e disattivato; o che è riscontrabile, ancora, nel rapporto conflittuale del personaggio con se
stesso, incapace di possedersi in un unico senso, sempre in fuga da se stesso, lacerato, nella
perplessità e nel sospetto, dal contrasto delle proprie forze emotive: esemplare Saul che assorbe in
sé le contraddizioni di tutte le figure del despota e che, in dubbio verso se stesso, esprime le stesse
contraddizioni di Alfieri verso il tiranno.
Ma se questa dimensione conflittuale, oltre che essere un portato della tradizione scenica (non
esclusa quella metastasiana o quella esperita in vivo da Alfieri nei teatri), rientra in qualche modo
nell'economia più elementare della composizione drammatica, l'intento di conquistare una più alta
qualità della tensione drammatica si realizza soprattuto nell'esaltazione di quella «energia della
struttura letteraria» che - scrive Lotman - è sempre avvertita dal lettore, anche se non viene
menzionata «nelle teorie della letteratura»17. Energia, a cui Alfieri fa continuamente appello, e che
si rivela sostanzialmente nella tendenza ad accentuare il legame conflittuale fra i princìpi costruttivi
che, presi a sé, hanno una diversa funzione. Come, ad esempio, le divisioni di parola che tendono a
disturbare l'ordine ritmico del verso, oppure le intonazioni sintattiche che tendono ad entrare in
conflitto con quelle ritmiche. E' questa reciproca tensione fra i princìpi costruttivi che elimina gli
automatismi e genera quella rete di accostamenti semantici, di parallelismi e opposizioni che
determinano l'aspetto "straordinario" di questa scrittura, tanto più barbara quanto più entra in
contrasto con la lingua ordinaria e prosastica. Da qui l'impressione di una lingua drammatica
autonoma che ha l'umiltà e la crudeltà di dichiararsi artificialmente teatrale, mai prima pronunciata,
che detta via via da sé le proprie regole e che dice mentre si dice.
In sintesi, Alfieri, scopriva una nuova potenzialità drammatica attraverso un'inedita "musicalità"
recitativa (che, non immemore del melodramma, ricercherà invano anche nelle "mostruose"
tramelotragedie). Se il paragone non è azzardato, Alfieri aveva laboriosamente trovato quello che
Joyce confesserà di aver cercato: «La tecnica della deformazione per raggiungere un'armonia che va
contro la nostra intelligenza come la musica»18.
13 Già nel Parere sul Filippo, prima vera tragedia "alfieriana", riguardo alla catastrofe scriveva:
«Bisognerebbe ch'io la vedessi
ottimamente recitata più volte per ben giudicarne» (in V. ALFIERI, Parere sulle tragedie e altre prose critiche ed. cit., p. 86).
14 Cfr. la citata Risposta dell'Autore alla Lettera di Ranieri De' Calsabigi (Ivi, p. 235).
15 F. FERRUCCI, Il silenzio di Mirra, in Addio al Parnaso, Milano, Bompiani, 1971, p. 43.
16 Nel citato Parere sull'Antigone, Alfieri ammoniva: «siano [ i personaggi ] contrastanti fra loro, che n'abbiano a ridondare delle
sospensioni terribili» (in V. ALFIERI, Parere sulle tragedie e altre prose critiche, ed. cit., p. 90).
17 J. M. LOTMAN, La struttura del testo poetico, Milano, Mursia, 1993, p. 224.
18 La dichiarazione di Joyce è riportata da E. SETTANNI, James Joyce e la prima versione italiana del "Finnegan's Wake", Venezia,
edizioni del Cavallino, 1955, p. 30.
3
Si deve proprio a questa nuova dimensione musicale, a questo ritorno intenso della lingua
drammatica al suo fondo musicale invisibile, alla sua segreta dinamica di attese e rivelazioni, lo
choc prodotto nell'attore dallo spartito oratorio alfieriano.
Già alla prima lettura, il nuovo attore alfieriano capì, arrestandosi come all'ascolto di un fiume
che scorre sotterraneo alle parole, la capacità del poeta di dare valore musicale e note esatte a
questo flusso. Attraverso la dinamica del ritmo, si lasciò capire dalla parola e il suo corpo scenico
sperimentò una diversa logica drammaturgica, i molteplici modi di plasmare il divenire dell'energia
drammatica.
Quando Alfieri dichiarava che la propria scrittura era nata «per forza di struttura»19 e agli attori
diceva che di fronte a una vera letteratura drammatica si sarebbero formati da sé «per forza di
natura»20, forse pensava già che l'attore si sarebbe trovato naturalmente disposto ad aprirsi a una
nuova intelligenza del corpo e quindi pronto a rinunciare ai logori schemi interpretativi. E proprio
per questo chiedeva un attore colto, capace di comprendere a fondo il funzionamento della sua
scrittura per farsi "artista drammatico" così come lui si era fatto "poeta drammatico".
La scrittura alfieriana lanciava implicitamente una sfida all'attore - e anche per questo poteva
legittimamente dichiararsi teatrale. Intanto perché obbligava l'interprete all'assoluto rigore,
costringendolo ad accordarsi all'articolazione barbara del suo linguaggio, a tener testa alla carica
impulsiva della sua implicita vocalità, a procedere, a muoversi, a girare nel tracciato programmato
di un ritmo preciso e calibrato, con accelerazioni che bruscamente decelerano, tempi
improvvisamente sincopati, svolte di boa, ingorghi sillabici, spezzature che tagliano le parole in
bocca, pause caricate, silenzi dinamici, scatti nel vuoto... mantenendo costante la tensione di un
andamento che Alfieri voleva «d'incessante caldissima rapidità», dato che ogni rilassamento e
riposo è «notabile minoramento di passione», è freddezza e non può provocare intensità
d'attenzione nello spettatore21. Con il suo fitto reticolo di tensioni e di conflitti emotivi, con la sua
controllata marcatura ritmica, quel perfetto organismo drammatico, di cui è difficile tagliare un
verso e facile tradire un tempo, costituì per l'attore un rischiosissimo percorso22.
Ma se apparve come una costruzione imperiosa, al punto da indurre Pagani-Cesa a scrivere, nel
1825, che il verso alfieriano aveva obbligato «quasi col morso in bocca» gli attori23, non per questo
ne limitò l'autonomia recitativa. Al contrario, costrinse l'attore, che sulla nuda scena non aveva
altro, nemmeno il programma di un sottotesto, cui aggrapparsi, a uno sforzo senza rilassamenti, ad
un confronto inevitabile ed estremo. Lo costrinse a reagire alla propria inerzia recitativa. E proprio
perché fu un fattore di rischio, l'esperienza alfieriana valse di più, per gli attori, della corretta e
ovvia recita illustrativa del testo. Implicò, per l'attore che avesse voluto tenere il passo del poeta,
che esperisse le regole interne della dinamica drammatica, i molteplici modi di dare qualità e forza
di struttura all'energia dell'azione, che imparasse a tradurre, come il poeta, il ritmo del pensiero
nella precisione spazio-temporale del suo corpo-mente, per trasporre il dramma in vita così come,
analogamente, il poeta aveva tradotto la vita in dramma. L'attore incontrando, come analoga alla
propria, la disposizione del poeta alla scrittura scenica, ne poté catturare i segreti vitali. E nel
trovare soluzioni ai problemi innescati da una lingua da recitarsi, si abilitò a nuove tecniche vocali e
mimiche, di condotta ritmica, di montaggio e composizione dell'azione: ai processi di
condensazione e di sintesi, di montaggio per salti, propri della poesia; a individuare e rilevare
fonicamente, in base alla ricchezza e mobilità dei tracciati sintattici alfieriani, inediti fuochi
semantici; a spaziare, con la dizione articolata e precisa, le parole lucidamente come sulla pagina
tipografica; a tessere disegni ritmici, dosando con precisione le appoggiature della voce, le pause e
le enfasi, i volati, le legature e le spezzature per rendere vive le sospensioni e viva parola il silenzio.
19 V. ALFIERI, Vita scritta da esso, ed. cit., parte I, epoca IV, cap. VII, p. 221.
20 Parere su l'arte comica in Italia, in V. ALFIERI, Parere sulle tragedie e altre prose critiche, ed. cit., p. 241.
21 Ivi, p. 145.
22 Scrive Alfieri nel Parere sul Polinice:
«un mezzo verso, anche una parola sola in un modo o nell'altro recitata, in un modo o
nell'altro collocata, può ottenere i due effetti i più direttamente opposti nella mente degli uomini;cioè il terribile ed il risibile» (Ivi, p.
89).
23 G. U. PAGANI-CESA, Sovra il teatro tragico italiano, Firenze, Magheri, 1825, p. 135.
4
Ma soprattutto, sperimentando la natura della "straordinaria" scrittura alfieriana, l'attore imparò,
come era accaduto al poeta, a bloccare la sua mente "ordinaria" e a far agire una mente drammatica
- base di ogni tecnica - per gestire l'imprevisto di altre drammaturgie, per attraversare con altro
passo altre storie.
Per quegli attori che vissero l'esperienza alfieriana in modo superficiale, come un aspetto seriale
del repertorio, essa si esaurì nella replica di maschere verbali e gestuali, di gran pose, di passi
solenni, di pause affossate, di battute piantate come vessilli. Condusse a quella «falsa maniera del
tipo unico di recitazione tragica [...] che voleva i recitanti fossero fantasime sui trampoli,
spauracchi» che Gustavo Modena, nel 1841, stigmatizzava24. Ma altri attori che non vollero
superficialmente intonarsi alla voce del poeta, che seppero intuire, come vedremo, l'analogia di
certe leggi profonde che accomunano livello linguistico e performativo, seppero anche ripercorrere
in modo equivalente, fisicamente metabolizzato e personalizzato, quel processo compositivo che
Alfieri così descriveva:
«m'inondai il cervello di versi [...] convinto in me stesso, che il giorno
verrebbe infallibilmente, in cui tutte quelle forme, frasi, e parole d'altri mi tornerebbero poi fuori
dalle cellule di esso miste e immedesimate coi miei propri pensieri ed affetti»25.
Per questi attori l'esperienza alfieriana continuò ad esistere nella memoria del corpo scenico
come un a priori per l'elaborazione di partiture recitative, come continuato appello al risveglio del
ritmo del pensiero e delle tensioni organiche, e come riserva di cellule e forme drammatiche, di
patterns performativi. E tutto ciò non poté che aumentare l'impegno all'acquisizione o al
perfezionamento, alla trasmissione didattica di una strumentazione tecnica che funzionasse a
prezioso correttivo per la trasformazione in poesia della prosa recitativa.
La prova del sapere tecnico, conquistato attraverso la drammaturgia alfieriana, ci viene non tanto
e non solo dalla scarse testimonianze sulla recitazione di una nuova generazione di attori26, quanto
dall'importanza che tale drammaturgia assunse nella trattatistica, nei manuali e negli studi sulla
recitazione, fin oltre la metà del secolo, quale strumento assolutamente previlegiato per la
formazione e l'addestramento fisico-mentale dell'attore e quale stimolo orientativo alle riflessioni
teoriche su quell' «arte di recitare di cui finora - scriveva Alfieri nel 1785 - non si sa neppure i
principij»27.
Non è infatti un caso se in Italia l'esigenza di una pedagogia attorica, nonché le prime organiche
formulazioni di una teoresi sulla recitazione nascano dalla pratica e dalle riflessioni di quegli attori
alfieriani (da Bideri a Morrocchesi a Canova a Righetti, per citare solo i primi di una lunga serie)
che avevano scelto il poeta come guida e maestro e che per primi avvertirono l'esigenza di una
scuola in cui trasmettere un sapere tecnico finora assorbito empiricamente sulle scene.
E' con essi che nascono in Italia le prime scuole di recitazione, rette da professionisti. E' per loro
merito che la nuova coscienza ideologica del teatro italiano, impersonata da Alfieri, trova la sua
risoluzione sul versante teorico e tecnico.
Fra queste esperienze pedagogiche, la più nota è quella condotta da Antonio Morrocchesi - attore
colto e capostipite della generazione alfieriana - che, abbandonate le scene, si dedicherà
all'insegnamento presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, mettendolo poi in bella copia nelle
Lezioni di declamazione e d'arte teatrale pubblicate nel 183228. Un trattato famoso, su cui non ci
soffermeremo se non per sottolineare, dati gli equivoci che ha prodotto il voler ridurre tutto al
paradigma neoclassico, come la didattica di Morrocchesi, informata alla propria personale
esperienza, abbia lo scopo di far rilevare e far provare all'allievo, attraverso testi alfieriani,
l'importanza di due valori fondamentali nella recitazione: quelli dell'energia e del ritmo, che
Morrocchesi chiama "anima di vigore" e "musica della declamazione" e a cui dedica le lezioni
24 Lettera a Zanobi Bicchierai, da Ripafratta del 6 giugno 1841, in Epistolario di Gustavo Modena (1827-1861), a cura di T. Grandi,
Roma, Vittoriano, 1955, p. 34.
25 V. ALFIERI, Vita scritta da esso, ed. cit., p. 196.
26 Cfr. S. GERACI, Comici italiani: la generazione alfieriana, in "Teatro e storia", IV, ottobre 1989, n. 7, pp. 215-43.
27 Lettera a Pietro Zaguri, da Pisa, 7 marzo 1785, in V. ALFIERI, Epistolario, ed. cit., vol. I, p. 242.
28 A. MORROCCHESI, Lezioni di declamazione e d'arte teatrale, Firenze, Tipografia All'insegna di Dante, 1832 (ed. anastatica: Roma,
Gremese, 1991).
5
centrali e più interessanti. Due aspetti che sono esemplificati nella parte iconografica che ha reso
famoso il trattato: nella sequenza di un brano dell'Oreste di Alfieri - il falso racconto della morte di
Oreste fatto da Pilade davanti a Clitennestra ed Egisto - i cui versi sono accompagnati da tavole
litografiche che illustrano movimenti fisici e attitudini (22 pose per 16 versi).
L'iconografia di questa rarissima testimonianza di una sequenza recitativa ha indotto ad
interpretare il brano "spazialmente", come una parata di pose neoclassiche, producendo non pochi
equivoci interpretativi. In realtà non si tratta di una messa-in-posa del testo, ma di una sua messain-musica. Il brano è dichiaratamente scelto per l'allievo «siccome un pezzo applauditissimo di
scelta musica»29, per allenarlo a segmentare il testo, a saper focalizzare l'attenzione dello spettatore
su snodi e direzioni di senso, e per indurre una sapienza ritmica con cui riprodurre e rivitalizzare
fisicamente il presunto senso poetico, liberando in nuove figure ritmiche il significato, calato in
convenzioni metriche vincolanti30.
Il demone ritmico alferiano, con cui il poeta dava pulsioni di vita alla prosa e alle lingue morte,
si propone, insomma, all'attore come un'equivalente tecnica di drammatizzazione che investe il
corpo scenico, modellando l'azione attraverso tracciati ritmici.
Ma l'esperienza fisica dell'energia del verso alfieriano, fu la base per un salto ulteriore. Quella
sapienza ritmica, combinata con altre suggestioni di carattere psicofisico, che venivano dalle nuove
"positive" scienze dell'uomo, dalle concezioni del vitalismo in particolare, consentì riflessioni
teorico-pragmatiche sulla recitazione di straordinaria attualità.
Mi riferisco al trattato L'arte di declamare, pubblicato a Napoli nel 1828-29 da Giovanni
Emanuele Bideri, un altro attore e capocomico della generazione alfieriana (tutta alfieriana è
l'esemplificazione didattica del trattato) che fu - oltre che drammaturgo, scenografo, librettista di
Donizetti e teorico del melodramma - maestro di recitazione in scuole, fra le prime in Italia, da lui
fondate, a Napoli nel 1830 e poi a Palermo nel 185031.
L'arte di declamare, è il primo fra i trattati italiani scritti da attori-pedagoghi. Composto quattro
anni prima delle più famose Lezioni di Morrocchesi, e pur godendo, unico fra i trattati di recitazione
ottocenteschi, di più edizioni, è stato completamente ignorato dalla storiografia teatrale32.
Anche Bideri è impegnato nella costruzione di una "scienza della recitazione", secondo il
modello teorico che veniva dalle Ideen zu einer Mimik (1785-86) del lessinghiano Johan Jakob
Engel, tradotte in Italia da Giovanni Rasori nel 1818-19, e che avranno un'influenza determinante
sulla trattatistica ottocentesca italiana, e non solo italiana33. Una trattatistica fondata su uno stesso
29 Ivi, p. 256.
30 Sugli equivoci intepretativi del brano iconografico ha fatto luce F. Taviani, per il quale «ciò che l'attore qui mostra al lettore sono
le basi della propria lingua energica, che egli ha articolato e sfaccettato costruendosi prima una catena di pose statuarie studiate in
ogni dettaglio e poi percorrendola sempre più fluidamente fino a farla coincidere con la musica della dizione» (F. TAVIANI, Immagini
rivoltate, in "Biblioteca teatrale", n. 37-38, gennaio-giugno, 1996, pp. 46-52).
31 Giovanni Emanuele Bideri, o Bidera (Palermo 1787 - Palermo 1858), a 18 anni abbandona la famiglia per farsi attore e
capocomico. Nel 1830, ritiratosi dalle scene, apre una scuola di recitazione a Napoli (visitata dal Settembrini che ne parla in
Ricordanze della mia vita). Diviene poi librettista, per consiglio di Felice Romani, al Teatro San Carlo di Napoli collaborando con
molti musicisti e fornendo, fra l'altro, a Donizetti la Gemma di Vergy e il Marin Faliero. Nel 1850, inviato in soggiorno obbligato a
Palermo, per la partecipazione ai moti del 1848, apre di nuovo una scuola di recitazione presso la sua abitazione e si dedica a
ricerche di linguistica e filosofia (la Triade e quattro Dialoghi fra Timeo e Platone). Nel 1853 estende al canto le sue teorie sulla
recitazione nell'Euritmia drammatico-musicale. Dichiarata per le leggi fisiche della caduta dei gravi e del quadrato delle distanze.
Lettere di Emmanuele Bidera a Madamigella Sofia, Palermo, Stabilimento Tipografico dell'Armonia, 1853. Le sue numerose
composizioni drammatiche sono raccolte nel volume Teatro edito e inedito, Napoli, Stabilimeto Tipografico di Giuseppe Cataneo,
1854 (ed. riveduta e corretta). Fra le altre opere di vario genere, ricordo la Passeggiata per Napoli e contorni. Usi e Costumi, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1966 (I ed. : Napoli, Manuzio, 1844), esempio dei suoi interessi romantici verso il pittoresco e il
primitivo, ricca di notizie biografiche; e Quaranta secoli. Racconti sulle Due Sicilie del pelasgo Matn-Eer, Napoli, Manuzio, 1846.
Per altre notizie sulla vita e le opere, cfr. L. V. BIDERI, Vita avventurosa di Giovanni Emanuele Bideri, Napoli, 1986; E. CIONE,
Napoli romantica 1830-1848, Napoli, Morano, 1957, pp. 298, 303, 317; L. MIRAGOLI, Il melodramma italiano nell'Ottocento, Roma,
Maglione, 1924, pp. 156-57.
32 G. E. BIDERI, L'arte di declamare ridotta a principii per uso del foro, del pergamo e del teatro, Napoli, Tipografia Palma, 182829, voll. 2. L'opera fu di nuovo edita, riveduta e corretta, nel 1856 a Napoli, e ancora, ridotta a piccolo manuale (Compendio
dell'arte di declamare) nel 1842 e nel 1846. Dall'ed. del 1828-29 traggo la maggior parte delle citazioni indicando nel testo il
numero del volume e delle pagine.
33 Si veda J. J. ENGEL, Lettere intorno alla mimica, a cura di L. Mariti, Roma, Editori & Associati, 1993, che ripropone in anastatica
la traduzione di G. Rasori.
6
presupposto teorico: il concetto di espressione intesa come trasparente corrispondenza fra
emozioni, sentimenti, passioni ed esteriorità corporea, e quindi come leggibilità, nel linguaggio del
corpo, degli stati d'animo e dell'attività psichica. Un concetto di espressione aderente a quel
paradigma espistemologico - la visibilità fisica dell'invisibilità psichica - che le nuove "positive"
scienze dell'uomo, dalla nascente psicologia alla medicina clinica, avevano posto alla base delle
loro ricerche. L'adozione di questo modello teorico nelle analisi sull'uomo-attore, pur avendo
creato le condizioni di possibilità, per la prima volta in Occidente, di un discorso sull'attore, aveva
però confinato la trattatistica e gli studi sulla recitazione nei limiti di una scienza mutuata, più
interessata, attraverso l'analisi dell'attore, ai processi psicofisici dell'uomo che non ai concreti
processi operativi dell'attore. Il criterio spazializzante, che è proprio di ogni scienza, costretta ad
astrarre il tempo dall'evento, aveva condizionato la riflessione, limitandola alla classificazione
tassonomica e alla codificazione dei segni esteriori delle passioni: ad un catalogo di ritratti fisici
offerti all'attore come modelli recitativi, senza tener conto del carattere temporale dell'evento
performativo34.
Già nella prefazione, Bideri, che struttura il trattato in una parte teorica e una pratica, denuncia
l'inefficacia pragmatica degli studi sulla recitazione. Tutta la teoria sulla recitazione ha fallito,
perché non ha fatto altro che invitare l'attore «ad imitare varii atteggiamenti [...]. E poi quali sono i
mezzi che ne propone, onde imitare la altrui passioni per farle credere proprie? Non è forse questo
lo stesso, che condurre un giovane allievo in una galleria di quadri, indicandogli le varie mosse ed
espressioni delle figure, e pretendere, che, di là uscito, divenga pittore, senz'avergli dapprima dato
alcun idea di tela, di colori, di pennelli e di matita?».
La critica è rivolta non solo al puro sapere dei teorici, da Quintiliano ad Engel35; ma anche agli
scritti degli attori che non sono altro che «monumenti della loro celebrità». Gli uni, confinati nel
loro sapere, non conoscono che «l'uomo morale», gli altri, in ragione del loro fare, conoscono solo
«l'uomo fisico», che comunque è il vantaggio «che suol avere anche il cattivo artista sopra l'uomo
di lettere affatto ignaro di queste cognizioni» (I, 127). Ma nemmeno l'esperienza pratica è
sufficiente all'attore, perchè lo illude di essere nel possesso definitivo dell'arte e gli impedisce di
rinnovarsi, liberandosi da convenzioni e clichés specie «se abitudini anteriori abbiano avuto tempo
di prender posto e radicarsi» (I, 127)36. Dunque una vera scienza della recitazione è valida se può
essere praticamente utilizzata, se non si limita a descrivere, ma riesce a trasformare il teatro. E' in
tal senso che Bideri ne proclama la legittimità ed esige che venga «ridotta a princìpi», cioè né a
precetti che tendono a descrivere convenzioni recitative già in atto e «non giungono mai a formare
dei sistemi» (I, II), né ad astratte cognizioni scientifiche meccanicamente applicate all'arte. Punto di
vista pragmatico e teorico si fondono dandosi una prospettiva operativa, rispetto alla quale l'apporto
di altre scienze e discipline è puramente strumentale.
La necessità di un sapere pragmatico risponde alla necessità di dare risposta a una ineludibile
domanda: come e secondo quali orientamenti teorici e quali processi operativi, l'attore traduce il
dramma in vita scenica.
Il presupposto da cui parte Bideri è che il corpo dell'attore è un corpo organico in situazione
artificiale, un corpo che finge per produrre un effetto di realtà, ma che "vive" la finzione. Per cui il
fine del trattato è individuare metodo e tecniche per ricreare l'organicità di un corpo che finge. Chi
confonde la finzione con la realtà si comporta come «il volgo che confonde spesso l'effetto con la
causa; crede, che gli artisti di Teatro si dolgano davvero, perché lo commuovono; e quel, ch'è strano
34 Su queste problematiche cfr. Tra scienza dell'uomo e scienza dell'attore, saggio introduttivo di L. Mariti a J. J. ENGEL, op. cit.,
pp. VII-LXXIX.
35 In realtà Engel (Ivi, vol. II, pp. 47-50), pur in contraddizione con il proprio criterio analitico, aveva "intuito" tale limite e avvertito
la necessità di considerare la recitazione come "musica", cioè, secondo l'antico modello greco, come «forza in azione nel tempo
percepibile sensorialmente», arrivando a prospettare una «teoria generale delle arti energiche» (recitazione, danza, musica, canto e
aspetti prosodici della poesia). Una prospettiva, come vedremo, che Bideri non mancherà di seguire.
36 L'attore «baldanzoso della cognizione del materiale di quest'arte sdegna sovvente qualunque avviso, perché colui che gle lo porge
conoscendo la parte teorica, non conosce la parte parte pratica: e l'uno spesso agli occhi dell'altro, sotto un certo rapporto, diviene
ignorante: ed entrambi in certo modo avranno ragione. Si unisca dunque la duplice cognizione [...] : l'artista e il filosofo avranno un
linguaggio comune per intendersi scambievolmente. Allora il teatro, acquisterà maggior splendore» (I, 127).
7
molti commedianti istessi sono tratti in questo errore, senza avvertire quanto di studio e di arte costi
loro di far credere vero quello che in realtà tale non può essere [...]. Su questo errore, che porta ad
assurde conseguenze, appoggiano quasi tutti i trattati di declamazione» (I, XIV, n. 1)37. La
sensibiltà, dice Bideri che non conosce Diderot, non è la base dell'arte attorica perché è
indipendente dalla volontà e sulla scena non si possono rivivere sensazioni in modo
"esclusivamente" naturale.
Tolto di mezzo ogni psicologismo («sono paroloni di teatro viscere, sentimento, verità, fuoco,
etc.» - I, 5, n.1), in base al presupposto che l'attore è un «essere vivente in azione» e che l'azione è
un campo di forze vitali conflittuali, Bideri propone un criterio di analisi assolutamente nuovo: un
criterio energetico.
Se l'espressione è «l'atto che risulta da una forza vitale sia che questa agisca per nostra volontà
sia che reagisca contra una forza esterna» (I, p.15), allora l'attore per esprimere dovrà badare alla
forza psicofisica e non alla forma che di essa è il prodotto: «Si ha un bel gridare: Imitate la natura!
...Il genio...L'ispirazione! ecc. Ma che vuol dire ciò? - La natura siete voi stessi? Dunque imitate voi
stessi, non nelle forme, ma nelle forze. Le forme sono accidentali»38.
L'intelligenza dell'attore creatore non è nell'imitazione dei modelli espressivi, degli stili
(l'imitazione del risultato che conduce al cliché, come insegnerà Stanislavskij), ma nella conoscenza
dei princìpi che regolano l'uso di quell'energia vitale che l'attore impegnerà di volta in volta per dar
vita alle "forme accidentali" delle sue varie interpretazioni. Sia perché, in quanto essere vivente in
azione, deve mettere in processo la sua forza vitale, sia perché, dovendo imitare, deve saper
riconoscere l'intensità e la qualità dell'energia che è nella forma dell'oggetto imitato. In quanto
«espressione dell'espressione»39, la recitazione «non è che l'arte d'interpretare e di conoscere
perfettamente dove è posta la forza suddetta, perché da noi si possa per mezzo del gesto e della
voce trasmettere nell'animo altrui» (I, 7).
Rispetto alle esigenze dell'attore, il testo scritto esiste in quanto contiene l'impronta dell'energia
con la quale è stato concepito e composto. Nell'individuare e valutare la sua tessitura ritmicoenergetica consiste il primo passo, analitico, dell'interpretazione.
Solo se il testo scritto - e qui la lezione alfieriana è evidente - sarà trattato dall'attore come un
organismo che ha le sue cellule, le sue innervature e i suoi tracciati di energia, sarà traducibile in
azioni fisiche e permetterà all'attore d'impostare un processo compositivo.
Attraverso la segmentazione del testo, per la quale è strumentale la conoscenza grammaticale e
sintattica, l'attore, anzitutto, dovrà individuare quello che Bideri chiama ipomocleo o accento
drammatico: il punto di massima tensione a cui devono corrispondere tutte le parti dell'espressione
e che rende attiva ed efficace l'azione40.
Dato che ogni singola azione vocale e mimica ha un punto in cui consiste tutta la sua forza (per
esempio, l'accento nella singola parola) e che un'azione, essendo reazione, non può formarsi senza
che la potenza vinca la forza di resistenza, l'ipomocleo è il punto in cui la potenza «supera il punto
della massima resistenza» immaginata o reale (II, 27)41.
37 Bideri giustamente precisa che l'aforisma oraziano
«Dolendum est primum ipsi tibi», da cui derivano le false idee
sull'immedesimazione dell'attore, va inteso come «il dolersi per arte» poiché i Telefo e Peleo a cui Orazio si riferisce «non sono,
che due attori di teatro, che fingono il vero Telefo e Peleo. Se finte sono le persone, finte ancora debbono essere tutte le sensazioni»
(I, XIV).
38 G. E. BIDERI, Euritmia drammatico-musicale, ed. cit., p. 17.
39 La declamazione è «espressione dell'espressione» in quanto l'uomo non può non esprimere. Imitazione quindi del suo linguaggio
espressivo: il «linguaggio di azione» (che può essere naturale o artificiale, composto cioè «di segni maturali e involontari» o di
«segni volontari e istituiti») e il linguaggio «convenzionale della lingua parlata o scritta» (I, 8).
40 A proposito dell'uso espressivo dell'accento, ricordiamo le indicazioni di Stanislavskij all'attore Toporkov: «così la battuta perde
tutta la sua vitalità. L'idea risulta più chiara se in una battuta, per quanto lunga essa sia, c'è soltanto un accento, [...] faccia in modo
che l'accento dell'intera frase cada solo su quella parola» (V. O. TOPORKOV, Stanislavskij alle prove. Gli ultimi anni, a cura di F.
Malcovati, Milano, Ubulibri, 1991, p. 61).
41 E' utile ricordare che proprio la necessità di accentazione del movimento, onde sviluppare il potenziale espressivo, condurrà
Mejerhol'd all'elaborazione di quell'accento ben più complesso che è l'otkaz (movimento di rifiuto). Anche se nell'ipomocleo di
Bideri non c'è l'idea di controimpulso, già il fatto stesso di concepire l'azione come resistenza a una forza contraria implica il
8
E' la chiave di volta di ogni azione; ma anche il punto certo che l'attore deve individuare come
"punto d'appoggio" (ipomocleo è neologismo da µοχλεω: muovere da sotto con la leva), perché
solo rapportandosi a questo punto di massima resistenza può definire l'estensione temporale e i
gradi di temperatura dell'energia da impegnare in ogni azione.
Il testo, pertanto, non è considerato quale morta struttura. La segmentazione non è una divisione
in pezzi, ma in unità organiche che Bideri nell'Euritmia drammatico-musicale definisce "periodi"
(con allusione al senso etimologico - ridurre in circolo - e all'uso grammaticale e musicale) per
connotarne la compiutezza di senso e il valore di durata temporale. Il principio che deve guidare
l'attore è unico: «la legge è sempre l'istessa, tanto della semplice parola, quanto della proposizione,
che del periodo; cioè tutto s'innalza gradatamente e uniformemente sino all'apogeo, donde ricade
con la ragione istessa con cui si è alzato; ma nello ascendere e nel discendere è mestieri graduare la
forza agli oggetti, e non tralasciare di compiere l'oggetto principale, ch'è il periodo. Ciò io chiamo
climax o scala energetica»42. L'azione vocale trova la sua efficacia non solo nell'intensità con cui la
parola viene pronunciata, ma anche nella precisione e coerenza del montaggio ritmico e nella
qualità delle sue risonanze: dalla microazione fino al grande periodo, alla «grande curva del
dramma».
L'analisi ritmico-energetica del testo è quindi fondamentale per l'attore e, confessa Bideri,
potrebbe essergli d'aiuto solo l'analoga sapienza ritmica di un drammaturgo che «fosse valente
declamatore, e conoscesse l'espressione fisica» come Alfieri, che coerentemente viene assunto a
modello esemplificativo43.
Bideri, in sostanza, tenta di mostrare come la logica del discorso e delle azioni possa essere
dinamizzata da una sintassi ritmica e come il ritmo, semantizzato, possa svolgere una funzione
drammaturgica. L'oggetto dell'insegnamento è la interna prosodia (le regole ad cantum) e l'euritmia
dell'azione. E l'intento pedagogico è far sì che l'attore, confrontandosi con la forma e il pensiero del
testo che gli oppongono resistenza, entrando nel dinamica dei contrasti, possa costruirsi una
partitura ritmica, segnata da pause (passaggi da un'azione all'altra) e accenti drammatici, da una
danza di istanti pregnanti (come li avrebbe chiamati il Lessing del Laocoonte) la cui fluida
pulsazione dia precisione e consistenza alla vita del corpo scenico, catturando sensorialmente lo
spettatore44.
Ma il lavoro analitico sul testo non si limita all'individuazione dell' «accento drammatico», che
in fondo non è altro che l'accento di pensiero dell'autore che aiuta il formarsi di un accento di
pensiero dell'attore. Entra in gioco un altro aspetto dell'«intelligenza» dell'attore: la sua capacità di
saper individuare o suscitare in sé l'idea motrice dell'azione, l'idea «che spinge a fare».
Se nell'ipomocleo l'attore ha il suo punto d'appoggio, nell'idea motrice trova la spinta interiore
all'azione. E' la motivazione che ha mosso la drammatizzazione dell'autore e che, analogamente,
l'attore deve ritrovare in sé quale mezzo per la sua drammatizzazione.
Nella composizione psicofisica
tutto consiste nel saper risvegliare la forza motrice, che dalla sua sede governa tutte le azioni sottoposte alla nostra
volontà. Da questa potenza motrice nasce l'espressione delle finte sensazioni, essa sola regge i nostri movimenti, con
più o meno energia, essa dà il tono alle parole, rendendole ora gagliarde e forti, ora lente e sommesse, or aspre, ora
dolci, ora rapide, e violente, tali che seguono sempre la natura dell'idea e il calcolo dell'intelligenza; essa potenza infine
è la sola ministra, il mezzo, onde l'animo può palesare ogni suo movimento (I, IX-X).
momento di arresto, di frenata, di stop carico di energia. Sull'otkaz cfr. B. PICON-VALLIN, Mejerhold, Paris, CNRS ("Les voies de la
création théâtrale", 17), 1990, p. 113.
42 G. E. BIDERI, Euritmia drammatico-musicale, ed. cit., p. 48. Per l'esemplificazione all'allievo si veda l'analisi del monologo di
David dal Saul (a. II, sc. 1) alle pp. 77-80.
43 G. E. BIDERI, L'arte di declamare, ed. del 1856, p. 65, n. 1 e p. 66, in cui è esemplificato, attraverso brani tratti dal secondo atto
del Saul, come la scrittura alfieriana, tramite la punteggiatura e altri segni accessori, aiuti l'attore a marcare con precisione la ritmica
del testo e «il linguaggio d'azione».
44 «C'è un'ipotesi limite - sostiene acutamente Franco Ruffini -, e cioè che tra l'azione drammatica scritta nel testo e l'azione
drammatica agita nel corpo dell'attore esista una identità di fondo. Non nella materia, certo, ma in qualcosa di comunque solido e
concreto: un ritmo, diremo, una forma» (F. RUFFINI, Teatro e boxe. L' "atleta del cuore" nella scena del Novecento, Bologna, Il
Mulino, 1994, p. 17).
9
Compito dell'attore, una volta sezionato il testo, è conoscere qual è l'idea motrice di ogni singola
microazione fino al formarsi «una giusta idea dello scopo della grande azione» che è «l'unico
mezzo per conoscere se le parti corrispondono all'oggetto prefisso dell'autore, ed in quale relazione
esse parti vi corrispondono, e con quanta forza; locché rende facile l'apprestare ad esse la più
energica, proporzionata e confacente espressione» (I, 59).
Non si tratta quindi di individuare semplicemente il valore semantico del testo, esprimerne con
chiarezza e diligenza i significati. Quello che conta è che l'idea sia motrice, e che diventi una
motivazione potente per l'attore, recuperabile sotto la forma logica ed espressiva del testo, in modo
da imprimere innervazioni vitali all'azione. Dato che la forza vitale «accorre necessariamente ove vi
è il maggior stimolo»(II, 18), le idee motrici, sono lo stimolo o il compito, invisibile allo spettatore,
che l'attore si dà in rapporto costante con «lo scopo della grande azione»45 e dettano la coerenza
logico-ritmica dell'interpretazione.
Sono evidenti le affinità col processo di attivazione dell'interpretazione di Stanislavskij
(compito, supercompito e linea trasversale), tanto più che identiche sono alcune modalità tecniche
di individuazione del compito nel testo scritto: se per Bideri «il verbo è ciò che esprime una azione»
(I, 57-58), per Stanislavskij «sarà un verbo, che definirà un compito vivo e attivo e non
semplicemente una rappresentazione statica, un concetto come succede con i sostantivi»46.
In Bideri è assente la fonte di attivazione prodotta dalla memoria emotiva o dal sottotesto (la cui
finalità è però identica a quella dell'idea motrice: «Il sottotesto è ciò che ci costringe a dire le parole
della parte»47). Non c'è in lui quella raffinatezza stanislavskiana nell'analisi del carattere delle
motivazioni, nell'insegnare all'attore come costruirsi un racconto interiore. Non c'è, certamente,
l'ampiezza, l'altezza, la complessità del magistero di Stanislavskij. Ma ciò che importa è il principio
generale: lo stabilire un rapporto stretto, al di là di ogni idea di immedesimazione, fra la partitura
delle azioni fisiche e una sorta di subpartitura costituita dai punti di appoggio che producono la
mobilitazione interna dell'attore.
A Bideri va comunque ascritto il merito di aver aperto la strada all'analisi piscofisica dell'attore,
in base all'assunto di «conoscere l'influenza del morale sul fisico dell'uomo, e del fisico sul morale
per saperlo imitare»48, e di aver iniziato a parlare, con solida concretezza e con grande anticipazione
storica, di azioni fisiche.
Sono questi gli argomenti che affronterà nel secondo volume del trattato, dedicato alla pratica,
cioè alla traduzione fisica delle operazioni mentali dell'attore, «dato che nessuno finora si è dato lo
studio, per darne dei precetti, di riunire l'espressione intellettuale all'espressione fisica» (I, 125). E'
la parte in cui dichiara di servirsi dei contributi della Fisiologia, mentre nella prima, dedicata alle
operazioni analitiche dell'attore, ha utilizzato le osservazioni dell'Ideologia49.
E anche qui Bideri non manca di sorprenderci.
L'approccio rimane pragmatico e pedagogico, sostanziato anche da indicazioni di esercizi
psicofisici.
«Tutto - scrive Bideri - è azione, o intellettuale, o fisica» e l'azione non è altro che uno scontro di
forze. Ogni essere è dotato di un'energia vitale e per conservarla deve resistere a una forza
contraria. Ma nella dinamica di attrazione-repulsione con gli oggetti interni (idee ed affetti) ed
45 Come l'idea principale muove un periodo dell'azione, cosi una idea-madre muove il dramma intero: «il concepirne l'estensione
istantaneamente, vagheggiarla, conoscere i più lontani e sublimi rapporti, trovarne il contrasto, è cosa di una mente gigante sì nel
piccolo che nel grande componimento. Senza questa concezione, senza un fisso proponimento, si può cominciar bene, progredire
mediocremente e finire pessimamente» (Ivi, p. 112).
46 K. S. STANISLAVSKIJ, Il lavoro dell'attore, a cura di G. Guerrieri, Bari, Laterza, 1985, p. 166.
47 Ivi, p. 465.
48 G. E. BIDERI, L'arte di declamare, ed. del 1856, p. 71.
49 Come si deduce anche dalle citazioni nel testo, le referenze scientifiche più determinanti riguardano il pensiero degli Idéologues,
in particolare di Destutt de Tracy, fondatore dell'Ideologia (che definiva «analisi delle sensazioni e delle idee») e del medico-filosofo
Cabanis, il più impegnato nella costruzione di una science de l'homme, citato da Bideri nell'Euritmia drammatico-musicale (p. 59) a
proposito della forza vitale. Fonte di ispirazione è anche, come vedremo, il De motu animalium (1680-81) di Giovanni Alfonso
Borrelli, summa del sapere biologico del tempo in cui, come è noto, per la prima volta il metodo sperimentale venne applicato ai
fenomeni viventi.
10
esterni, l'uomo può conoscere la propria forza fisica e intellettuale solo nel momento in cui si mette
«in opposizione ad un'altra forza fisica e intellettuale» (II, 7). L'espressione è la differenza di
potenziale prodotta dall'opposizione.
Date queste premesse, il principio orientativo per l'attore è quello stesso utilizzato per la
progettazione dell'azione vocale: crearsi punti di resistenza e punti di sostegno (ipomoclei) per
poter impegnare la propria forza vitale e per poter reagire non solo all'opposizione di corpi reali
(oggetti, interlocutori, situazioni); ma, dato che simula, anche «all'impressione di un corpo
immaginato, sia fisico, sia morale [...] o reagire sopra una simulata sensazione interna» (II, 60).
L'azione fisica, non meccanica, è dunque una danza di tensioni generate dagli sforzi prodotti dal
gioco di opposizioni. Opposizioni che anzitutto coinvolgono il corpo: sia rispetto alle sue varie parti
che dovranno contrapporsi fra loro, sia rispetto alla forza di gravità: «Tutti i gesti serbino insomma
questa legge, cioè che la forza di gravità del nostro corpo, sia contrapposta alla forza vitale, dove
succede l'impressione, e questa sia in equilibrio coll'oggetto che la cagiona, sia finto, sia reale» (II,
57).
L'azione, sia essa attiva o passiva, è sempre movimento50 e i movimenti nello spazio sono tante
vittorie riportate dalla forza vitale sulla forza di gravità51.
Tecnicamente si tratterà, dunque, di cercare la posizione del corpo più solida, il giusto equilibrio
per gestire il disequilibrio che tanto più produce «sforzi muscolari» quanto più viene limitata la
base di sostegno del corpo (II, 51). L'azione nello spazio non è altro che «equilibrio in movimento»,
costante variazione del punto di perfetto equilibrio che richiede calcolo ed economia di forza
vitale52.
Pertanto Bideri non indica all'allievo figure mimiche da imitare, ma posizioni di base (otto per la
precisione) per imprimere la giusta direzione e la massima energia all'azione, per orientare
l'impulso di partenza di ogni movimento trasformando, per così dire, la massa in energia; e dispone
una serie di esercizi che abilitino l'allievo a variare dimensioni e posizione della base di sostegno
per variare l'azione, nella sua complessità mimico-vocale, conservando l'equilibrio53.
Nel trattato non c'è, come potrebbe sembrare, un'idea puramente meccanicistica e fisicistica
dell'azione. Bideri dà priorità all'azione fisica, a un disegno di movimento preciso e fissato, ma per
vivere in esso, senza adattarsi al suo puro dinamismo, ritiene necessaria l'emozione, o meglio quella
forza vitale che è legame organico fra corpo, mente e psiche.
L'attore alterna azioni interiori ed esteriori e, data la biunivoca corrispondenza fra azione
psichica e fisica, è possibile, come aveva già accennato Lessing, attraverso l'azione fisica indurre il
sentimento. Rifiutando qualsiasi psicologismo o autoanalisi o idea di immedesimazione, Bideri
scrive: « [...] e chi può comandare all'animo di sentire ciò che egli non prova realmente? Ma è facil
cosa per noi, modificando l'esterno volontariamente in una o in altra figura, con queste esterne
modificazioni del corpo, di far credere vero il patimento o il godimento dell'anima» (II, 68). Ed è
evidente, precisa acutamente Bideri, come il ritmo della respirazione, con le sue fasi passiva e
50 L'azione è passiva se è necessaria e se «dalla periferia, cioè dai sensi, va al centro o all'anima; è volontaria, se dal centro va alla
periferia. Nell'una e nell'altra maniera non produce che movimento» (E. BIDERI, Euritmia drammatico-musicale, ed. cit., p. 25).
51 L'idea si ritrova nel noto saggio filosofico sul teatro di marionette di Kleist, che Bideri non sembra conoscere. Se si considera che
queste tesi troveranno pratica applicazione nelle nuova tecnica del balletto inaugurata nel 1827 da Bournonville e due anni dopo
dalla Taglioni, si capisce anche l'importanza innovativa che avrebbero potuto avere, anche nella danza, le idee di Bideri. Cfr.
HEINRICH VON KLEIST, Sul teatro delle marionette, in Santa Cecilia o la potenza della musica, Firenze, Passigli, 1990, pp. 81-94.
52 L'equilibrio mimico e vocale esige sempre, come nella realtà, un calcolo della forza nello spazio e una strutturazione temporale
per periodi: «L'equilibrio in movimento [...] forma l'armonia della natura, e l'uomo, come una forza della medesima, agisce sempre
equilibratamente nella realtà delle cose. Se scaglia un sasso, egli colpisce l'oggetto di cui con la sua vista ha misurato la distanza; se
spicca un salto, egli lo ha prima bilanciato; se chiama una persona, egli estende la sua voce, passando da un tono più basso ad uno
più alto a tenore della distanza. L'uomo dunque è una potenza, che armonizza con le forze della natura; ma la sua forza vitale è
terminata; e comunicandola ad altri corpi, gli è mestieri che la riacquisti col riposo perduta che l'abbia; quindi si desume ch'egli
agisce per periodi» (G. E. BIDERI, Euritmia drammatico-musicale, ed. cit., pp. 8-9). Sul "principio dell'equilibrio del gesto", Bideri
dichiara (Passeggiata per Napoli e contorni, ed. cit., p. 139) di aver preso spunto dal citato De motu animalium di Borrelli, il quale
per primo, discostandosi dal meccanicismo cartesiano, si era occupato dei movimenti "organici", attribuendoli a combinazioni
chimiche tra fluido nervoso e sangue.
53 Sull'equilibrio dell'espressione, cfr. le lezioni X e XIII nel II vol. dell'Arte di declamare. Riguardo alle variazioni da imporre
all'azione mimico-vocale si veda, fra le altre, l'esemplificazione sul brano dell'Oreste di Alfieri alle pp. 92-93.
11
attiva, metta in moto la relazione psicofisica, per cui solo agendo volontariamente sulla parte
«semiautomatica dell'apparecchio respiratorio, qual è il diaframma» per contrarlo o decontrarlo,
l'attore potrà già modificare il suo stato d'animo54. Mentre le emozioni che prova lo spettatore, non
sono altro che "l'effetto" della tensione psicofica dell'attore, di quello sforzo che, diceva Diderot,
rende stanco l'attore e commosso lo spettatore.
Questo non significa che l'attore sia freddo. L'azione ha le sue batterie psichiche e non solo
psichiche, ma anche mentali.
Bideri dà infatti estrema importanza anche all'immaginazione dell'attore che considera «l'anima
di quest'arte» (II, 77). Un lavoro mentale che, però, è del tutto particolare perché è quello di un
uomo in situazione di finzione.
Come può l'attore, quest'uomo così singolare da essere costretto a rivivere anche i tormenti di chi
muore, reagire e quindi impegnare la sua forza vitale in una situazione artificiale ?
Lo spazio ed il tempo con le sue leggi invariabili ed eterne dunque armonizzano l'uomo[...]. Nella realtà delle cose
tutto è equilibrio in lui: egli tende a contrastare con forza equilibrata contro le forze che agiscono su lui; egli conosce
per lunga abitudine le distanze di luogo e di tempo: ma passando dal campo della realtà a quello della immaginazione,
trova tal disordine nella sua mente, ch'egli in questa natura fittizia non sa più agire equilibratamente, egli non sa più
piangere, pregare, ec., poiché mancandogli la presenza degli oggetti reali, gli mancano la loro gravità, la loro distanza,
ec. sicché gli è necessario di fingerli simili al vero per potere agire su di essi. Ma con quali mezzi ?55.
Se l'attore non può, come l'uomo ordinario, agire-reagire in un contesto di realtà, gli sarà
supremamente necessaria un'arte del sentire e dell'immaginare. Se l'espressione è reazione
all'impressione e all'emozione, sarà la potenza e la qualità dell'immaginazione a decidere la potenza
e la qualità della sua espressione.
In assenza di un ambito di realtà, l'attore dovrà quindi mettersi in «posizione fantastica, come se
gli oggetti immaginati, realmente esistessero, egli dee vederli, toccarli, lottare coi medesimi; e per
questa lotta il reale punto d'appoggio, è il piano dove il suo corpo in realtà sussite, sono l'aria ch'egli
respira, e la sua forza vitale» (II, 55).
Da tali considerazioni ne nasce l'idea di una « vera ginnastica» fisico-mentale che alleni l'allievo
a trattare l'immagine mentale come se fosse reale, in modo da attivare ed eccitare la «contrattilità»
(la proprietà per cui la parti fisiche si restringono, si dilatano e si muovono) degli organi del corpo
soggetti a quell'impressione. Dato che la forza vitale
accorre necessariamente ove vi è il maggior stimolo, noi possiamo nel caso finto concentrarla alla vista, all'udito, al
tatto ecc. e con tale intensità o attenzione come se realmente ne occupasse la vista di un oggetto, come se veramente
ascoltassimo un grave rumore, o un piacevole suono, come se fossimo tocchi da un ferro rovente o da un corpo gelido
[...], come infine se bramassimo ardentemente di avvicinare un oggetto, di fuggirlo, o avvicinarsci ad esso con amore,
o di fuggirlo con orrore o spavento (II, 18).
Immaginare che un oggetto ideale offra la resistenza di un oggetto reale, per potervi reagire
fisicamente, significa tradurre l'azione mentale in reale. Significa sperimentare l'energia vitale come
qualcosa di materiale che può essere manipolato e modellato. Ma ciò che diventa efficacemente
operativo per l'attore è anzitutto l'azione mentale del come se.
Per questa via Bideri arriva a concepire la necessità per l'attore di un'azione invisibile allo
spettatore ed equivalente a quella trasmessa dal testo, come il pedagogo mostra attraverso esempi
ed esercizi. Così, per interpretare questi versi di Alfieri: «Ah meco fosse l'invincibil destra / Di Dio
possente!», l'attore agirà, dopo aver assunto la giusta posizione di equilibrio, come chi desidera
tirare a sé, dall'alto al basso, un corpo con la massima intensità di forza, dando all'azione la tensione
e la concretezza che richiede (II, 59). Oppure, potrà eseguire un movimento mimico-vocale
applicandovi il dinamo-ritmo di un'azione fisica equivalente: recitare, ad esempio, un brano «come
uno schermitore che porta tutta la contrattilità nel braccio facendo tal movimento da ferire, da
54 G. E. BIDERI, Euritmia drammatico-musicale, ed. cit., pp. 171, 173.
55 Ivi, pp. 16-17.
12
difendersi, di restar ferito e proferire intanto alcune frasi, che ha mandato a memoria, che a tali
operazioni convengono, e intanto non aver né spada, né avversario» (II, 19).
L'azione, non eseguita nella sua dimensione originale, tende a trovare un dinamismo fisico
attraverso un dinamismo mentale, diventa ritmo del pensiero.
Come si può notare, si tratta di esercizi equivalenti56, non dissimili da quelli proposti da
Stanislavskij e testimoniati da Toporkov57.
In genere Bideri offre all'allievo esempi di composizione recitativa applicata a testi, come il
dialogo di Saul con l'ombra di Samuele o il brano dell'Ugolino dantesco (II, 95-109), scelto in
chiusura del trattato per illustrarne tutti i princìpi operativi. Ma se qui l'allievo sperimenta la sua
capacità e libertà espressiva confrontandosi il testo, con la sua tessitura semantica e prosodica, con
il suo interno dinamismo; tuttavia, nel corso del trattato, più volte Bideri indica all'allievo esercizi
assolutamente slegati dal testo. Esercizi, sicuramente adottati nel suo laboratorio, quali: sentire il
corpo percosso da colpi virtuali, immaginare di avvertire un senso di freddo o di caldo, di essere
abbagliati da una luce, gravati da un peso virtuale, ecc. O immaginarsi di essere in un campo
circondati da persone vicine e lontane da richiamare o allontanare comandando, pregando,
piangendo per imparare a calcorare l'estenzione, la durata e la potenza d'azione della "parola fisica"
nello spazio. Ed altri ancora per allenare l'allievo al gioco di contrazioni e decontrazioni, di
opposizioni, a conservare l'equilibrio in azione, a produre cambiamenti di stato d'animo attraverso
inspirazioni ed espirazioni58.
Si tratta di esercizi che servono non solo a tenere semplicemente in efficienza l'apparato fisico,
ma, per quanto astratti possano sembrare, a tradurre in reale ogni azione mentale. L'idea che li
ispira, coerentemente ai princìpi del trattato, è creare ostacoli concreti al corpo-mente dell'allievo
perché sperimenti duttilità di immaginazione e acquisisca ritmo, qualità e temperature di energia
diverse. Perché, in fondo, capisca con quale uso del corpo-mente si raggiunge un risultato e sappia
poi, sulla scena, attingere a un ricco bagaglio di elementi vitali in modo da non offrire un'ovvia
illustrazione delle parole dell'autore.
Bideri, sia chiaro, non offre esercizi dotati di una complessa partitura di azioni in sé conclusa,
architettata per fasi organiche, che considera piuttosto esperibile attraverso brani testuali; ma il fatto
stesso che si parli di esercizi e di questa tipologia e che siano pensati anche indipendentemente
dallo spettacolo, costituisce l'annuncio di una pedagogia assolutamente diversa da quella del suo
tempo, fatta di precetti o basata sulla neutra imitazione di memorie recitative offerte all'allievo
dall'attore-maestro, e sempre finalizzata all'esecuzione del testo e in vista dello spettacolo.
Anzi, possiamo qui osservare i prodromi di un fenomeno che riguarda la pedagogia novecentesca
e che Eugenio Barba ha chiamato «la deriva degli esercizi»59. Un fenomeno "paradossale" che ha
inizio con Stanislavskij, con la nascita di quegli studi e laboratori che diventeranno il cuore stesso
del teatro, con il progressivo distacco dal mondo delle prove fino alla pratica di un training che
promette all'attore autonomia e indipendenza, in cui l'esercizio presuppone - specifica Barba - dietro
la coerenza dell'azione esterna della partitura, la coerenza di una sottopartitura, d'una «foderapensiero» che l'attore imbastisce per sé, costituita da immagini circostanziate, da regole tecniche, da
racconti e domande a se stessi o «da ritmi, da modelli dinamici o da situazioni vissute o
ipotetiche»60. Una via, come è noto, che condurrà Grotowski a saltar via da tutto ciò che riguarda
lo spettacolo, per concentrarsi sulle azioni fisiche come lavoro dell'individuo su di sé.
56 «La capacità di costruire equivalenti conservando però lo stesso sangue è il primo segno del mestiere» (E. BARBA, La canoa di
carta. Trattato di Antropologia Teatrale, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 231).
57 Fra i tanti, si può ricordare quello in cui Stanislavskij, nella messinscena de Le anime morte di Gogol', invita Toporkov, nel ruolo
di Cicikov, che non riesce ad impostare l'inchino al governatore, dal cui favore dipendono i suoi affari, ad immaginare che una
goccia di mercurio gli scorra lentamente lungo il corpo (V. O. TOPORKOV, op. cit, p. 12).
58 Bideri al riguardo riporta un significativo aneddoto relativo alla prova del Saul di un valente attore alfieriano,
svoltasi alla
presenza del poeta che, non potendo con varie ragioni convincere l'attore al rapido e necessario passaggio di espressione, lo
trattenne per la chioma, procurando l'ispirazione necessaria necessaria per emettere il famoso grido della terza scena del quinto
atto:«Ah! Chi da tergo. . . », poi egregiamente imitato (II, 64, n. 1).
59 Cfr. E. BARBA, op. cit. , pp. 164-170.
60 Ivi, p. 176.
13
Il complesso di pratiche della pedagogia di Bideri non delinea ancora un orizzonte privato
dell'attore, ma offre già all'attore un terreno su cui poggiare i piedi della sua autonomia artistica.
Il valore straordinario dell'Arte di declamare, di questo rigoroso e coerente progetto pedagogico,
che per ragioni di spazio abbiamo analizzato per linee generali, consiste soprattutto nel criterio
adottato. E' il criterio energetico che fa del trattato il capostipite di una linea pedagogica che in
Occidente, se si esclude Delsarte (che adotterà lo stesso presuposto di corrispondenza tra "funzioni
spirituali" e "funzioni del corpo") verrà decisamente intrapresa nel Novecento. Una navigazione che
ha avuto numerosi e diversificati approdi, ma ancora in corso nelle ricerche teorico-pragmatiche
della più alta pedagogia contemporanea. Il trattato di Bideri è la testimonianza che questa linea è
già avviata agli inizi dell'Ottocento e proprio nel momento in cui si comincia ad elaborare, con
ritardo rispetto all'Oriente, una "scienza della recitazione" e una pedagogia.
Sono evidenti le affinità di alcuni princìpi operativi di Bideri con quelli sviluppati, certo in modo
più complesso, da Stanislavskij soprattutto nella fase finale della sua teorizzazione, quando porrà
attenzione più alle "azioni fisiche" che non ai meccanismi psicologici: il concetto di azione come
reazione che procede da un'immaginazione concretissima e non dall'analisi astratta di situazioni e di
sentimenti, la necessità che l'attore si dia una forte motivazione, il procedimento di segmentazione,
la grande attenzione al ritmo61, la consapevolezza che il metodo (che «è dentro di noi») sia già nella
natura organica dell'uomo-attore, ma che la finzione comporti una tecnica, perché il recitare cessi di
essere un sistema e diventi una seconda natura organica. In Stanislavskij c'è una maggiore
attenzione alle condizioni e alle fonti del processo creativo, e l'azione fisica non è, come in Bideri,
manifestazione periferica del corpo, ma il prodotto di una più complessa e personale tessitura
dell'attore. Tuttavia in Bideri la considerazione prestata al ritmo non è minore; degna piuttosto di
Mejerhol'd per il quale il ritmo è «il fulcro di ogni azione scenica» e, come lo sarà anche per
Ejzenštein, il fondamento di ogni movimento62.
Non è difficile, d'altra parte, anche sulla base di ciò che abbiamo detto, ritrovare nell'analisi del
trattato primottocentesco problematiche che sono all'attenzione dell'Antropologia Teatrale
sviluppata, su basi inter e transculturali da Eugenio Barba e dall'ISTA (l'International School of
Theatre Antropology, che raccoglie attori, registi e storici del teatro). Basterà qui ricordare quelli
che Barba chiama princìpi-che-ritornano, simili in attori (attori di teatro, mimi, danzatori) di tempi
e tradizioni diverse, orientali e occidentali, con cui l'attore mette in vita un corpo-mente
extraquotidiano: l'alterazione dell'equilibrio (l'equilibrio in movimento di Bideri), la danza degli
opposti (implicita in Bideri nel concetto di azione fisica come opposizione di forze), il principio di
equivalenza (usato da Bideri nel lavoro sul testo e negli esercizi extratestuali)63. Tecniche che per
Barba caratterizzano però la pre-espressività, la vita dell'attore «prima ancora che questa vita
cominci a voler rappresentare qualcosa»64, mentre Bideri tende a muoversi, come i successivi
trattatisti, nell'ambito della teoria espressiva, pur tentando di superarne i limiti. Ma anche, e non da
ultimo, si scopre identica la necessità di un sapere pragmatico che al teorico o allo storico, scrive
Barba, dia «consapevolezza delle pratiche artigianali» e liberi l'artista «chiuso negli angusti confini
61 E' noto come Stanislavskij invitasse gli attori a dividere il testo in battute musicali. «Voleva - testimonia Toporkov - che lo
spettacolo risuonasse potente, vigoroso, musicale fin dall'inizio. A questo aveva mirato fin dalle prove preliminari. Ci teneva a
saturare le nostre azioni di ritmi intensissimi» (p. 63). Si veda «il modo di condurre alla giustificazione interiore del ritmo» e di
impostare secondo «movimenti musicali» l'azione nella scena de "il ballo e la cena dal governatore" de Le anime morte e nella scena
"alla stazione" de I dissipatori di V. Kataev (V. O. TOPORKOV, op.cit., pp. 41-4, 99-100).
62 Cfr. V. E. MEJERCHOL'D, L'attore biomeccanico, a cura di F. Malcovati, Milano, Ubulibri, 1993, p. 27 ss., pp. 37 ss., pp. 53 ss.
Anche sulla base di nuovi inediti, si è riconosciuta l'importanza che Ejzenštein, assimilata la lezione meiercholdiana, assegnava al
ritmo sia in teatro che in cinema (cfr. la postfazione di O. CALVARESE, Il teatro del corpo estatico, in S. M. EJZENSTEIN, Il
movimento espressivo. Scritti sul teatro, a cura di P. Montani, Venezia, Marsilio Editori, 1998, pp. 263-66). Mejerhol'd dichiara di
aver iniziato a parlare di ritmo «perché noi uomini abbiamo dimenticato ciò che gli animali non hanno dimenticato [. . . ]. Tutti i
loro movimenti sono costruiti in base alle leggi del ritmo» (p. 53). Anche Bideri, come già detto, trae ispirazione, per il movimento
organico, dal De motu animalium di Borrelli.
63 Cfr. E. BARBA, op. cit., pp. 27-60.
64 Ivi, pp. 32, 158.
14
della sua pratica»65, che anche Bideri, quasi con le stesse parole, pone a fondamentale premessa dei
suoi studi e della sua pedagogia.
Quelli di Bideri sono prolegomeni, naturalmente, cenni che indicano una direzione e che
possiamo intendere come tali e disseppellire in ragione dei risultati oggi conseguiti.
I paragoni potrebbero sembrare indebiti. Ma servono a capire che se, al di là delle differenze, c'è
parentela tra i princìpi operativi, tra la lingua di lavoro di Bideri (così nuova che è costretto ad
inventarsi neologismi) e quella dei futuri grandi pedagoghi, è perché le ossessioni sono le stesse. E
identica è la domanda centrale che decide le risposte: come permettere all'attore di agire un'azione
reale, perché ciò che non è vissuto sulla scena non può che restare inerte, meccanico, inorganico,
inespressivo.
Se l'analisi di questo ignorato maestro è così avanzata, non dobbiamo dimenticare il punto di
partenza: lo choc prodotto dalla difficile pratica del testo ritmico alfieriano, che, a partire da Bideri
e per gran parte dell'Ottocento, rimarrà il principale oggetto di riflessione e modello di
esercitazione della trattatistica italiana. Fu probabilmente quella "musica", combinandosi con
cognizioni che venivano dalle scienze dell'uomo, l'idea motrice che indusse Bideri - librettista di
melodrammi e teorico musicale66- a comporre il trattato, fino a capire che è il ritmo, ordine
dell'energia nel tempo, a trasformare in processo organico il lavoro del corpo-mente dell'attore.
L'idea che la musica, arte del tempo e perciò sorella (incestuosa) del teatro, godesse di una teoria
ben definita dalle sue leggi scientifiche e che il musicista, al contrario dell'attore, conoscesse gli
elementi della sua arte e avesse a disposizione una quantità di esercizi e studi per esercitarsi, fu il
primo movimento verso un sapere pragmatico. Come lo sarà ancora per molti altri maestri
pedagoghi del Novecento: «Noi non conosciamo - dirà Stanislavskij - gli elementi della nostra arte.
Non abbiamo le scale, gli studi, gli esercizi, non sappiamo in che cosa esercitarci. E la cosa più
incredibile è che pochi sembrano preoccuparsene. Anzi si dice che proprio in questo consista il
fascino della nostra arte: lo sviluppo e il destino del teatro non sono affidati a un'imbarazzante
teoria che sa di matematica. No, noi siamo nelle mani di Apollo!»67.
Ma questo richiamo costante alla musica, all'energia e al ritmo, non è solo un fatto tecnico. Se la
musica è la più alta forma di mediazione fra immaginario e realtà, fra sensibile e intelligibile,
l'equivalenza fra teatro e musica sta forse per dire che il teatro non è solo un modo di copiare o
rifare la vita, ma anche un mezzo per resistere o forse per difendersi da quella cosa pericolosa che
spesso, per l'uomo, è il suo pensiero sul mondo.
65 Ivi, p. 26. Si veda anche il volume nato dalle esperienze della sesta sessione pubbblica dell'ISTA del 1990: Tecniche della
rappresentazione e storiografia. Materiali della sesta sessione dell'ISTA, (Teatro eurasiano n° 2), a cura di G. Guccini e C. Valenti,
Bologna, Biblioteca Universale Synergon, 1992.
66 Bideri, prolifico librettista, nella citata Euritmia drammatico-musicale, applicò i suoi princìpi anche al canto, tentando, in modo
anche bizzarro, di determinare matematicamente la scala energetica dell'espressione cantata, di «misurare con le leggi della forza e
con quelle del tempo l'azione musicale, e rendere al suo giusto valore ogni periodo per divenire naturale e percio armonico» (pp. 1213). L'opera nasce dalla constatazione che «la musica da per se non è che matematica; ma nell'applicazione al dramma errava senza
misura senza legge e senza freno» (p. 118) e dalla convinzione che «se la musica drammatica deve essere una musica applicata
all'azione, non basta al maestro la conoscenza della sola musica, egli deve essere conoscitore delle leggi dell'azione» (p. 20).
Riguardo alla sua posizione nella polemica sui rapporti fra parola e musica, cfr. G. E. BIDERI, Passeggiata per Napoli e contorni, ed.
cit., pp. 55-58.
67 V. O. TOPORKOV, op. cit., p. 145.
15