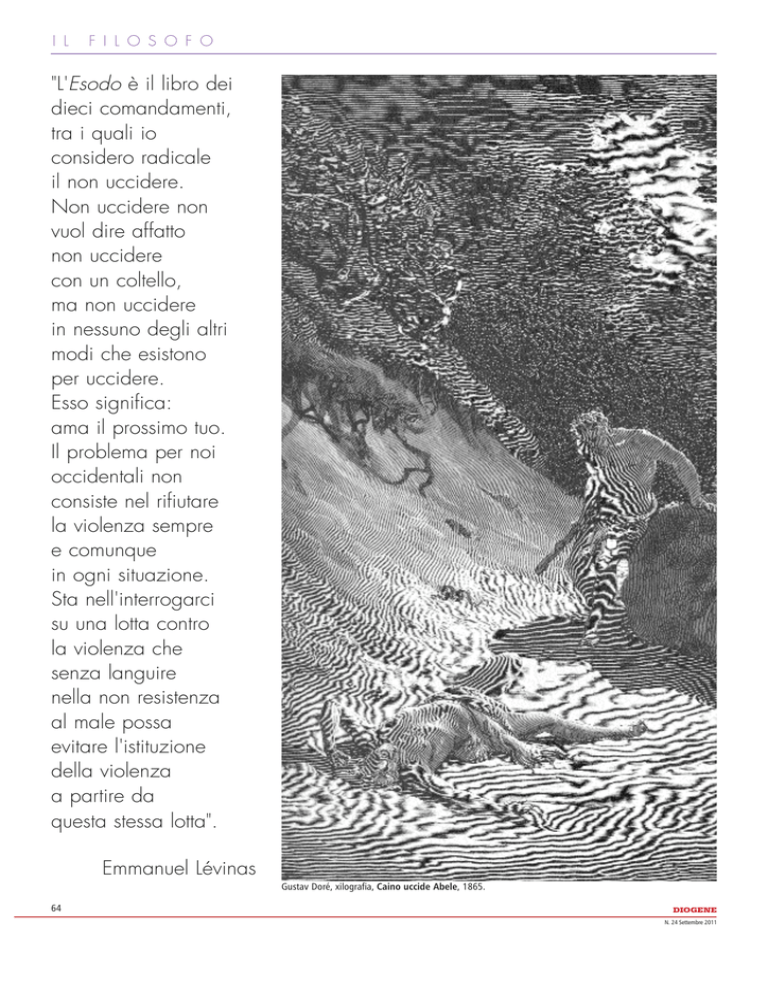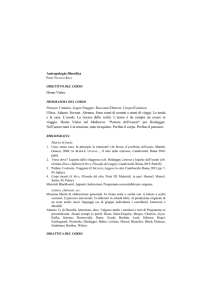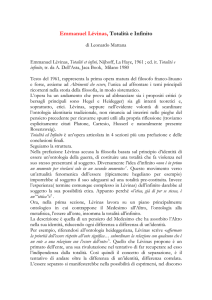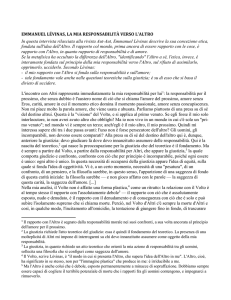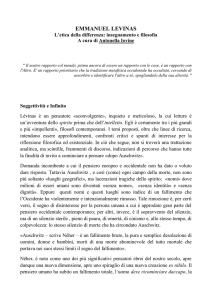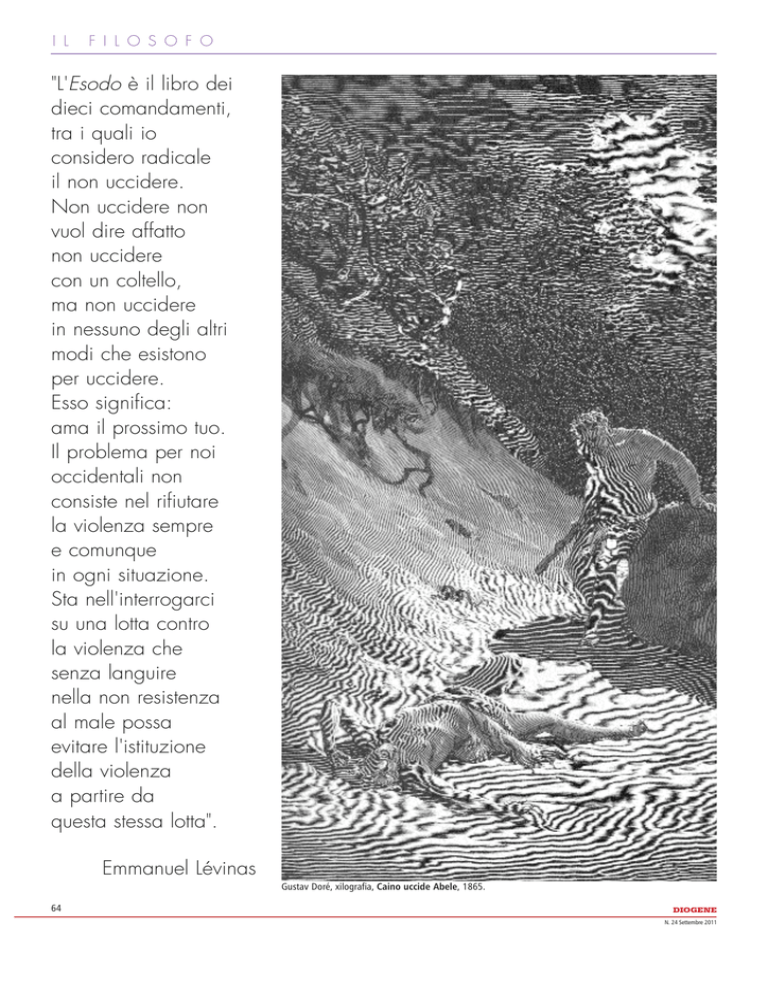
I L
F I L O S O F O
"L'Esodo è il libro dei
dieci comandamenti,
tra i quali io
considero radicale
il non uccidere.
Non uccidere non
vuol dire affatto
non uccidere
con un coltello,
ma non uccidere
in nessuno degli altri
modi che esistono
per uccidere.
Esso significa:
ama il prossimo tuo.
Il problema per noi
occidentali non
consiste nel rifiutare
la violenza sempre
e comunque
in ogni situazione.
Sta nell'interrogarci
su una lotta contro
la violenza che
senza languire
nella non resistenza
al male possa
evitare l'istituzione
della violenza
a partire da
questa stessa lotta".
Emmanuel Lévinas
Gustav Doré, xilografia, Caino uccide Abele, 1865.
64
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
F I L O S O F O
Il filosofo che
ha cercato
non l’amore per
la conoscenza
ma la conoscenza
prodotta dall’amore.
Emmanuel Lévinas
L
K Ubaldo Nicola
Direttore di Diogene.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
eggere i testi di Emmanuel Lévinas, il filosofo francese di origine
lituana morto nel 1995 cui dedichiamo questa sezione, non è un
impresa facile. Formatosi intellettualmente negli anni Trenta attraverso un serrato confronto con il
pensiero di Husserl e Heidegger, anche
dopo aver maturato pesanti critiche a
questi autori egli mantenne sempre il
gusto per uno stile di grande spessore
concettuale, la propensione all’interrogazione del linguaggio, all’ascolto delle
parole, se così si può dire, e alla loro
scomposizione nei più semplici termini
significanti (con i famosi “trattini”, assunti a simbolo di un modo un po’ elitario, di filosofare).
Un autore difficile, quindi, poco adatto
a una rivista di divulgazione popolare.
Se abbiamo comunque accettato la
sfida è per l’originalità (anzi, unicità) e
l’attualità del suo pensiero. Che se volessimo riassumere in una sola frase, starebbe tutto in questa semplice
domanda: “Chi è l’altro?”
Dai greci ad Heidegger la filosofia ha
cercato la risposta nella conoscenza, co-
struendo metafisiche fondate sulle idee
di essere, soggetto, ragione e così via.
L’altro, in questa tradizione, diventa
così un oggetto, fra i tanti che compongono il mondo: può essere conosciuto,
tollerato e rispettato; può diventare
partner di un contratto sociale o di un
progetto di pacificazione mondiale.
Ma non è sufficiente: anche la migliore
filosofia parte sempre da un distacco,
una separazione fra il soggetto e l’altro
che è più che mai necessario superare.
Gli altri esseri umani non sono enti ma
persone, sono il tu rispetto all’io, sono
volti, ognuno con la propria unicità e
infinitezza. Prima ancora di rispettarli e
conoscerli bisogna amarli, preoccuparsi
per loro, averne cura, andare oltre il
principio di reciprocità, sentirsi in ogni
caso e in ogni modo colpevoli per le
loro sofferenze. In breve, bisogna ribaltare l’intera tradizione filosofica e porre
l’etica a fondamento della metafisica,
non il contrario. E che ciò si possa fare
recuperando il significato universale del
monoteismo ebraico è un ulteriore motivo di interesse, un stimolo in più per
una lettura difficile ma feconda. K
65
I L
F I L O S O F O
Una religione da adulti
A torto si considera quella ebraica una religione nazionale, mentre
contiene un messaggio universale: un’idea desacralizzata di Dio che
per valorizzare l’uomo accetta persino la sfida dell’ateismo.
S
K Emmanuel Lévinas
66
arebbe una specie di paradosso
della storia se l’antropologia filosofica della più antica fra le
religioni monoteistiche fosse
considerata defunta. Lo sembra
per la sua stessa antichità; lo sembra a
causa del suo essere insegnata dal popolo ebreo, che si tiene ai margini della
storia politica del mondo di cui ha il
privilegio morale di esser vittima. In realtà si pensa generalmente che i valori
del giudaismo siano entrati da molto
tempo in sintesi più vaste, mentre presi
in se stessi non rappresentano che balbettii, rispetto all’espressione in spirito
e verità ch’essi hanno ricevuto nelle religioni generate dal giudaismo.
Ci si permette quindi di presentare il
giudaismo ostinandosi a rifiutare queste nuove formulazioni, come un “fossile”, come un modo superstizioso di
pensare e vivere proprio di comunità
avvilite dalla loro misera condizione di
vittime nei ghetti. Avviene così che la
voce d’Israele non è ascoltata nel
mondo, se non, nella migliore ipotesi,
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
come la voce di un precursore, quella
dell’Antico Testamento che noi giudei,
come ha detto il teologo Martin Buber,
non abbiamo alcuna ragione di considerare né come testamento né come
antico, e che non collochiamo nella prospettiva del Nuovo.
La voce di Israele è universale
Esiste anche un altro modo d’esporre il
giudaismo. Da qualche tempo lo si rivela al mondo moderno in certe opere
che richiamano troppo facilmente l’attenzione dei cristiani perché restano a
livello di aspetti generali alquanto generosi, seducenti e declamatori, ingannatori e vaghi. Li si accoglie troppo
spesso come il mistero e il messaggio
d’Israele. Ma ciò prova a qual punto la
generosità elementare della fede giudaica sia ignorata dal grande pubblico.
Affinché l’unione fra uomini di buona
volontà che io auspico non si faccia nell’astratto e nel vago, mi permetto qui
appunto d’insistere sulle vie particolari
del monoteismo giudaico.
La loro particolarità non compromette,
bensì promuove l’universalismo. Perciò
questo monoteismo dev’essere cercato
nella Bibbia irrigata dalle fonti nelle
quali, comune alla tradizione giudaica
e cristiana, essa mantiene la sua fisionomia specificamente giudaica.
Ho citato la tradizione esegetica orale
che si è cristalizzata nel Talmud e nei
suoi commentari. La modalità che questa tradizione ha istituito costituisce il
giudaismo rabbinico. Quali che siano gli
argomenti storici che ne provano l’alta
antichità, ed essi sono molto seri, il canone biblico, così come il mondo l’ha
recepito, è stato fissato dai difensori di
questa tradizione.
Il giudaismo che ha una realtà storica (il
giudaismo semplicemente) è rabbinico.
Le vie che conducono a Dio in questo
giudaismo non attraversano gli stessi
paesaggi delle vie cristiane. Se voi doveste esserne scossi o stupiti, sareste
scossi o stupiti che noi siamo ancora
giudei davanti a voi. Per il giudaismo, il
fine dell’educazione consiste nell’istituire un rapporto fra l’uomo e la santità
di Dio e nel mantenere l’uomo in questo rapporto. Ma tutto il suo sforzo
(dalla Bibbia alla conclusione del Talmud nel secolo VI e attraverso la mag-
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
F I L O S O F O
“
L'altro, per essere tale, non può essere
ricondotto né alla conoscenza che io ne ho
né all'amore che parte da me
e intende abbracciarlo.
Emmanuel Lévinas
gior parte dei suoi commentatori della
grande epoca della scienza rabbinica)
consiste nel comprendere questa santità
di Dio in un senso che esclude il significato numinoso del termine, come appare nelle religioni primitive in cui i
moderni hanno voluto spesso vedere la
sorgente di ogni religione.
La sacralità che nuoce all’uomo
Per questi pensatori il possesso dell’uomo da parte di Dio, l’entusiasmo,
sarebbe la conseguenza della santità o
del carattere sacro di Dio, l’alfa e
l’omega della vita spirituale. Il giudaismo ha disincantato il mondo, ha
escluso questa pretesa evoluzione delle
religioni a partire dall’entusiasmo e dal
sacro. Il giudaismo resta estraneo a tutti
i ritorni offensivi di queste forme di elevazione umana, anzi le denunzia come
l’essenza dell’idolatria.
Il numinoso o il sacro avvolge e trasporta l’uomo al di là dei suoi poteri e
voleri. Ma un’autentica libertà resta offesa da queste eccedenze incontrollabili. Il numinoso annulla i rapporti fra
le persone, facendo partecipare gli esseri, sia pure nell’estasi, a un dramma
di cui questi esseri nulla hanno voluto,
a un ordine in cui si inabissano. Questa
potenza in certo modo sacramentale
del divino appare al giudaismo tale da
ferire la libertà umana, contraria all’educazione dell’uomo, che resta
azione su un essere libero.
Non che la libertà sia un fine a se stesso:
essa però resta la condizione di ogni valore che l’uomo possa raggiungere. Il
sacro che mi ingloba e mi trasporta è
violenza. Il monoteismo giudaico non
esalta una potenza sacra, un numen che
trionfi su altre potenze numinose, ma
che partecipi ancora della loro vita clandestina e misteriosa.
Il Dio dei giudei non è sopravvivenza
degli dèi mitici. Secondo un apologo,
Abramo, il padre dei credenti, sarebbe
stato figlio di un mercante d’idoli. Approfittando dell’assenza di Teher, li
avrebbe tutti spezzati, risparmiando il
più grande di essi per attribuirgli, agli
occhi del padre, la responsabilità del
massacro. Ma Teher al suo ritorno non
può accettare questa versione fantastica: egli sa che nessun idolo al mondo
potrebbe distruggere gli altri. Il monoteismo segna una rottura con una certa
concezione del sacro; non unifica né gerarchizza gli dèi numinosi e numerosi, li
nega. Rispetto al divino ch’essi incarnano, non è altro che ateismo.
Su questo punto il giudaismo si sente
estremamente vicino all’Occidente, voglio dire alla filosofia. Non è semplicemente un caso che la via verso la sintesi
fra rivelazione giudaica e pensiero greco
fosse magistralmente tracciata da Maimonide, cui si richiamano i filosofi giudei e musulmani; che un profondo
rispetto per la sapienza greca riempisse
già i sapienti del Talmud; che l’educazione per il giudeo si confonda con
l’ispirazione e che l’ignorante non possa
essere realmente religioso!
E sono frequenti curiosi testi talmudici
che cercano di presentare la natura
della spiritualità d’Israele come costituita dalla sua eccellenza intellettuale:
non certo per orgoglio luciferino della
ragione, ma perché l’eccellenza intellettuale è interiore, e i “miracoli” ch’essa
67
I L
F I L O S O F O
rende possibili non feriscono la dignità
dell’essere responsabile, come invece fa
la taumaturgia; ma soprattutto perché
non deteriorano le condizioni dell’azione e dello sforzo. Da ciò deriva in
tutta la vita religiosa giudaica l’importanza dell’esercizio dell’intelligenza,
certo, applicata in primo luogo al contenuto della rivelazione, alla Torah. Ma
la nozione di rivelazione è destinata ad
ampliarsi rapidamente, sino a comprendere tutto il sapere essenziale.
tria: ignorare il vero Dio è infatti solo
un male a metà; l’ateismo è già meglio
della pietà votata ai mitici dèi in cui Simone Weil distingue già gradi e simboli
della vera religione. Il monoteismo oltrepassa e include in sé l’ateismo, ma
non è accessibile a chi non ha raggiunto
l’età del dubbio, della solitudine e della
rivolta. La difficile via del monoteismo
si congiunge con la strada dell’Occi-
dente. Ci si può chiedere infatti se lo
spirito occidentale, se la filosofia, non
sia in ultima analisi l’affermarsi di
un’umanità che accetta il rischio dell’ateismo, che va corso e superato, come
prezzo della sua maggiore età. K
Tratto da: E. Lévinas, Difficile libertà, La
Scuola, Brescia, 1986.
Solo gli uomini capiscono Dio
Un apologo rabbinico rappresenta Dio
che insegna agli angeli e a Israele; in
questa scuola divina gli angeli (intelletti
senza debolezze ma senza malizia) domandano a Israele, posto in prima fila, il
senso della parola divina.
L’esistenza umana, malgrado l’inferiorità del suo rango ontologico, a causa di
questa inferiorità, di ciò ch’essa implica
di tormentato, d’inquieto e di critico, è
il vero luogo in cui la parola divina incontra l’intelletto e perde il resto delle
sue virtù che si pretendono mistiche.
Ma l’apologo intende anche insegnarci
che la verità degli angeli non è di specie
diversa dalla verità degli uomini, che gli
uomini hanno accesso alla parola divina
senza che l’estasi debba strapparli alla
loro essenza, alla loro natura umana.
L’affermazione rigorosa dell’indipendenza umana, della sua presenza intelligente a una realtà intelligibile, la
distruzione del concetto numinoso del
sacro, implicano il rischio di ateismo: è
un rischio che bisogna correre, perché
solo con esso l’uomo si eleva alla nozione spirituale del trascendente.
È grande gloria del Creatore aver costituito un essere che lo afferma dopo
averlo contestato e negato nelle illusioni del mito e dell’entusiasmo; è
grande gloria di Dio aver creato un essere capace di cercarlo e di capirlo da
lontano, partendo dalla separazione, e
quindi dall’ateismo.
Un testo del trattato Taanith commenta
il versetto di Geremia 2,13: “Poiché il
mio popolo ha commesso due iniquità:
hanno abbandonato me, fonte d’acqua
viva, e hanno scavato delle cisterne, cisterne screpolate, che non trattengono
l’acqua”. Esso insiste sulla duplice trasgressione che si commette con l’idolaGustav Doré, xilografia, La nascita di Eva, 1865.
68
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
F I L O S O F O
Dov’è Dio? Nella relazione
morale con l’altro uomo
L’essenza della religione sta in un rapporto con gli altri fondato sull’etica
e sulla giustizia. Ma è anche utile l’osservanza dei riti e dei precetti.
I
K Emmanuel Lévinas
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
n qual modo il giudaismo, geloso
della sua indipendenza ma assetato
di Dio, concepisce l’umano? Come
può integrare l’esigenza di una libertà pressoché vertiginosa con il
suo desiderio di trascendenza?
Avvertendo la presenza di Dio nella relazione con l’uomo. La relazione etica
appare al giudaismo come relazione eccezionale: in essa il contratto con un essere esterno, anziché compromettere la
sovranità umana, la istituisce e le dà
quindi l’investitura.
In senso contrario alla filosofia, che fa
del se stesso l’ingresso nel regno dell’assoluto, e che annuncia con le parole di
Plotino che “l’anima non andrà verso
altro che se stessa, ma verso sé” e “che
essa non sarà dunque in null’altro che
in sé, ma in se stessa”, il giudaismo ci insegna una trascendenza reale, una relazione con Colui che l’anima non può
contenere e senza il Quale essa neppure
può tenersi in se stessa.
Nella sua solitudine, l’io si trova in uno
stato di smembramento e di squilibrio.
Ciò significa che si ritrova come colui
che è già empio verso gli altri, arbitrario
e violento. La coscienza di sé non è
un’inoffensiva constatazione che un io
fa del suo essere, ma è inseparabile dalla
coscienza della giustizia e dell’ingiustizia. La coscienza della mia ingiustizia
naturale, del danno causato ad altri a
partire dalla mia struttura di “Ego”, è simultanea alla mia coscienza di esser
uomo: esse coincidono.
L’inizio del Genesi è, per un commentatore del II secolo meno sollecito di ciò
che l’uomo può sperare che di ciò che
deve fare, oggetto di stupore: perché la
rivelazione inizia con il racconto della
creazione mentre solo i comandamenti
di Dio importano all’uomo? Questo
stupore è ancora il medesimo di Rachi,
commentatore del secolo XI, tramite il
quale, da mille anni, i giudei del mondo
intero hanno accesso alla Bibbia. E l’antica risposta che Rachi ci propone consiste nel sostenere che è importante per
l’uomo (al fine di possedere la terra
promessa) sapere che Dio ha creato la
Terra: poiché se non lo sapesse affatto, il
suo possesso sarebbe una usurpazione.
Un io senza diritti
Nessun diritto può dunque discendere
dal semplice fatto che la persona ha bisogno di spazio vitale: la coscienza del
mio io non mi rivela alcun diritto, la
mia libertà si scopre arbitraria. Essa fa
appello a un’investitura. L’esercizio
“normale” del mio io, che trasforma in
“mio” tutto quanto può raggiungere e
toccare, è messo in questione; possedere
è sempre un ricevere.
La terra promessa non sarà mai, nella
Bibbia, una “proprietà” nel senso romano del termine, e il contadino, al momento delle primizie, non penserà ai
legami eterni che lo connettono con il
terreno, ma al figlio d’Aram, suo antenato, che fu errante.
Non è per noi qui importante invocare
lo statuto legale, tanto singolare, della
proprietà terriera nell’Antico Testamento, ma piuttosto la coscienza di sé
che in esso domina: coscienza in cui la
scoperta dei propri poteri non è separabile dalla scoperta della loro illegittimità. La coscienza di sé si coglie
inevitabilmente in seno a una coscienza
morale: questa non si aggiunge a quella,
ma ne è la modalità elementare. Essere
69
I L
F I L O S O F O
per sé è già sapere il mio errore commesso verso altri. Ma il fatto che io non
mi ponga questioni circa il diritto dell’altro indica paradossalmente che
“altri” non è una riedizione dell’io; nella
sua qualità di “altri” esso si situa in una
dimensione di altezza, idealità, divinità,
e tramite la mia relazione con altri, io
sono in rapporto con Dio.
L’essenza umana sta nella moralità
La relazione morale riunisce dunque insieme coscienza di sé e coscienza di
Dio. L’etica non è il corollario della visione di Dio, essa è questa stessa visione: l’etica è un’ottica, cosicché tutto
quanto io so di Dio e tutto quanto
posso comprendere della sua parola e
dirgli ragionevolmente deve trovare
un’espressione etica.
Nell’Arca Santa dalla quale Mosè intende la voce di Dio, non vi sono altro
che le tavole della legge. La conoscenza
di Dio che possiamo avere e che si
enuncia, secondo Maimonide, in forma
di attributi negativi, assume un senso
positivo nella prospettiva della morale.
“Dio è misericordioso” significa “Siate
misericordiosi come lui”: gli attributi di
Dio sono dati non all’indicativo, ma all’imperativo. La conoscenza di Dio ci
raggiunge come comandamento.
Conoscere Dio è sapere quel che si
deve fare: qui l’educazione (l’obbedienza alla volontà altrui) è l’istruzione
suprema, la conoscenza di quella volontà stessa che è al fondamento di ogni
realtà. Nel rapporto etico “altri” si presenta insieme come assolutamente
altro, ma questa alterità radicale in rapporto a me non distrugge, non nega la
mia libertà, come pensano i filosofi.
La relazione etica è antecedente all’opporsi delle libertà, alla guerra che, secondo Hegel, dà inizio alla storia. Il
volto del mio prossimo ha un’alterità
che non è allergica, che apre l’aldilà; il
Dio del cielo è accessibile senza perdere
nulla della sua trascendenza, ma senza
negare la libertà del credente. Questa
sfera intermediaria esiste. Il Talmud lo
dichiara in quel linguaggio apparentemente infantile che gli fa attribuire, agli
occhi di tanti troppo rapidi lettori, la reputazione di unire complicazioni irresolvibili a una disarmante ingenuità:
“Dio non è mai sceso sul Sinai, mai
Gustav Doré, xilografia, La torre di Babele, 1865.
70
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
“
Nessuno in questo momento
può dire: ho fatto tutto il mio dovere.
Emmanuel Lévinas
Mosè è salito in cielo. Ma Dio ha piegato il cielo come una coperta, e con
essa ha ricoperto il Sinai, trovandosi
così in terra senza mai lasciare il cielo”:
v’è in ciò una dissacrazione del sacro.
A Dio attraverso l’uomo
La giustizia resa al mio prossimo mi dà
di Dio una prossimità insuperabile. Essa
è altrettanto intima quanto la preghiera
e la liturgia, che senza la giustizia sono
nulla. Dio nulla può ricevere da mani
che hanno commesso violenza. Il pio è
il giusto: giustizia è il termine che il giudaismo preferisce ad altri termini più
evocanti sentimenti: poiché l’amore
stesso richiede la giustizia, e la mia relazione col prossimo non potrebbe restare estranea ai rapporti che questo
prossimo ha con i terzi. Il terzo è pure
mio prossimo.
La legge rituale del giudaismo costituisce la severa disciplina che tende verso
questa giustizia. Può riconoscere il
volto altrui soltanto colui che ha saputo
imporre una severa regola alla sua propria natura. Questa legge non assume
in alcun momento il valore di un sacramento. In un notevole passaggio talmudico, in seguito alla richiesta dei suoi
allievi circa le ragioni dei riti relativi all’acqua lustrale dei Numeri, Rabbi Yohanan Ben Zakai si rifugia dietro
l’autorità del comando divino. Ma egli
aggiunge che, senza questo comando,
“né il contatto del morto rende impuri,
né l’acqua lustrale purifica”; nessun potere intrinseco è concesso al gesto rituale, ma senza esso, l’anima non
potrebbe elevarsi a Dio.
La via che conduce a Dio conduce dunque ipso facto all’uomo, e non per soprappiù; e la via che conduce all’uomo
ci riconduce alla disciplina rituale, all’educazione di noi stessi. La sua grandezza è nella sua regolarità quotidiana.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
Ecco un passo in cui sono enunciate tre
opinioni: la seconda indica il modo in
cui la prima è vera e la terza indica le
condizioni pratiche della seconda.
Ben Zommaha detto: “Ho trovato un
versetto che contiene tutta la Torah:
Ascolta Israele, il Signore è il nostro
Dio, il Signore è Uno”. Ben Nanas ha
detto: “Ho trovato un versetto che contiene tutta la Torah: amerai il prossimo
tuo come te stesso”. Ben Pazi ha detto:
“Ho trovato un versetto che contiene
tutta la Torah: sacrificherai un agnello
al mattino e un altro al crepuscolo”. E
Rabbi loro maestro si alzò e decise: “La
legge è secondo Ben Pazi”.
La legge è sforzo. La fedeltà quotidiana
al gesto rituale richiede un coraggio più
calmo, più nobile e più grande di quello
del guerriero. È nota l’evocazione profetica d’Israele fatta da Bilaam: “Guardate! Questo popolo si leva come un
leopardo, si alza come un leone”. Il talmudista non esita a confrontare questo
risveglio regale alla potenza sovrana
d’un popolo capace di praticare il rito
quotidiano.
Osservare leggi e riti
Fremito del leopardo che si leva, ma
che non si alza sotto un giogo: la legge
per il giudeo non è mai un giogo. Essa
implica una sua gioia di cui si nutre una
vita religiosa e tutta la mistica giudaica.
Nei Salmi, in cui così intimamente si
accordano gli appelli più nostalgici e la
presenza paterna di Dio, la pienezza di
questa presenza consolante e salvifica
cui “nulla manca”, e la glorificazione
della sua regalità, della sua giurisdizione, della sua legislazione e legge, i
giudei non si sentono al di qua degli
orizzonti aperti dai Vangeli.
L’accordarsi di tanta bontà e di tanto legalismo costituisce la nota originale del
giudaismo. Il Talmud misura con luci-
F I L O S O F O
dità l’altezza e l’apparente opposizione,
ma anche la reale interdipendenza dei
principi che lo producono.
Non possiamo analizzare qui l’ordine
ontologico che lo rende possibile, ma
nulla sembra più semplice né più autentico del loro confondersi nello stesso
versetto. Il salmista associa in modo sorprendente la sua miseria umana più
profonda a un appello al comandamento divino, alla Mitzwab, alla legge:
“Io sono straniero su questa terra, non
nascondermi i tuoi comandamenti”;
così egli unisce lo slancio intimo dell’anima assetata di Dio alla visione severa della giustizia divina: “La mia
anima si spezza di desiderio per i tuoi
giudizi a ogni istante”. K
Tratto da: E. Lévinas, Difficile libertà, La
Scuola, Brescia, 1986.
A P P R O F O N D I R E
I testi di Lévinas sono numerosissimi.
Indichiamo quindi i più importanti.
K
La traccia dell’altro, Pironti, Napoli,
1979.
K
Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano, 1980/2006.
K
Quattro letture talmudiche, Il Melangolo, Genova, 1982.
K
Dell’evasione, Elitropia, Reggio Emilia, 1983.
K
Nomi propri, Marietti, Genova, 1984.
K
Etica e infinito. Il volto dell’altro come
alterità etica e traccia dell’infinito,
Città Nuova, Roma, 1984.
K
Umanesimo dell’altro uomo, Il Melangolo, Genova, 1985.
K
Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1997.
K
Difficile libertà, La scuola, Brescia,
1986.
K
Dall’esistenza all’esistente, Marietti,
Genova, 1986.
K
Il tempo e l’altro, Il Melangolo, Genova, 1987.
K
Trascendenza e intelligibilità, Marietti, Genova, 1990.
71
I L
F I L O S O F O
Essere l’uno per l’altro
In cosa consiste la capacità di sostituirsi agli altri? E come si conciliano
la responsabilità primaria verso ogni singolo uomo e l’obbedienza
alle leggi dello Stato? Un’intervista al filosofo lituano.
K Augusto Ponzio
Docente di Filosofia del linguaggio
e Linguistica generale alla
Università di Bari.
72
Augusto Ponzio. Credo che una nozione centrale nella sua concezione
della relazione con altri sia quella di sostituzione. Questa nozione ci permette
di concepire un’identità posta, come lei
dice, immediatamente all’accusativo, e
dunque di comprendere la relazione
con altri nella forma dell’uno per l’altro, e infine di giungere a una “considerazione inattuale” dell’umanesimo,
all’umanesimo “dell’altro uomo”. Vuole
spiegare l’importanza della nozione di
sostituzione in rapporto alla critica del
privilegiamento, nella tradizione occidentale, del teorico, della rappresentazione, del sapere, del soggetto?
Emmanuel Lévinas. La nozione di sostituzione è connessa alla nozione di responsabilità. Sostituirsi non consiste nel
mettersi al posto dell’altro uomo per
sentire ciò che egli sente, in maniera
che l’uno diventi l’altro e, anche nel
caso in cui questi sia bisognoso e disperato, nel coraggio di una tale prova.
Sostituirsi è portare conforto associandosi a questa debolezza ed essenziale finitezza d’altri, sopportarne il peso
sacrificando il proprio interessamento e
la propria compiacenza-a-essere, che si
trasformano in responsabilità per altri.
Nell’esistere umano, come per interrompere e superare la sua vocazione ad
essere, vi è un’altra vocazione: l’esistere
d’altri, il suo destino.
L’avventura esistenziale del prossimo
importerebbe all’io prima della propria,
cioè porrebbe l’io immediatamente
come responsabile di quest’alterità
nelle sue prove, come se il sorgere dell’umano nell’economia dell’essere capovolgesse il senso e l’intreccio
dell’ontologia. Tutta la cultura dell’umano mi sembra orientata dal nuovo
intreccio in cui l’in-sé dell’essere-chepersiste-a-essere si supera nella gratuità
del fuori di-sé per l’altro, nel sacrificio o
nella sua possibilità, nella santità.
Lei parla spesso della relazione con
altri come di una relazione “faccia a
faccia”. Questa espressione ha causato
malintesi suggerendo un’opposizione
tra linguaggio parlato e linguaggio
scritto. Ciò a torto, credo, poiché lei
non accetta la diffidenza che Platone
dimostra nei confronti della scrittura.
Il “faccia a faccia” non è la dichiarazione
di guerra all’altro, né un orgoglio che si
pone dinanzi a un altro orgoglio. Bisogna ricordare ciò che affermo a proposito del volto. Esso è linguaggio prima
ancora di fissarsi in rappresentazione,
appello alla devozione che devo ad altri.
Il dis-interessamento di cui parlo è precisamente il concretarsi dell’incontro
del volto d’altri.
L’io sospende la sua persistenza-aessere, il suo conatus essendi nel suo assoggettamento ad altri, come se l’io
fosse “colpevole” nei riguardi del prossimo. Strano tipo di accusa: colpevolezza senza colpa, “indebitamento”
senza prestito.
Obbligo di responsabilità alla quale
nessun altro può sostituirsi, debito che
nessuno può pagare al posto dell’io e
così, per l’io (moi), il concretarsi della
propria unicità d’io (je). Di questa unicità dell’io (je) è correlativo il prossimo
nella responsabilità rispetto alla quale
(come nell’intimità dell’amore) è
“unico al mondo” nel suo volto. L’amore
non ha inizio nell’erotismo. Nell’amore
senza concupiscenza, nell’amore disinteressato della responsabilità, l’amato è
“unico al mondo” per colui che ama.
L’io (je) e 1’altro, nella loro unicità, non
sono più semplici individui di un genere, punti anonimi nell’estensione logica di un concetto.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
F I L O S O F O
“Noi siamo tutti, nei confronti di tutti,
colpevoli, e io più di chiunque”, dice un
personaggio di Dostoevskij nei Fratelli
Karamazov, esprimendo anche questa
“costituzione originaria”, dell’io (je) o
dell’unico in una responsabilità per il
prossimo o per l’altro e l’impossibilità
di sottrarvisi o di farsi sostituire. Impossibilità di sottrarsi che non è servitù ma
elezione. Le religioni che fanno ricorso
al termine di elezione vi ritrovano la dignità suprema dell’umano.
Qual è il rapporto tra responsabilità e
giustizia? La responsabilità nei riguardi
dell’altro dipende forse da una società
organizzata come Stato? O, al contrario, possiamo dire che le istituzioni e le
procedure giuridiche non solo sono
fondate sulla responsabilità per altri,
ma, in qualche modo, la limitano?
Un anonimato si instaura necessariamente nella realtà sociale interrompendo la responsabilità tra l’io e l’altro,
riconducendo 1’unicità dell’io e dell’altro all’individualità dell’individuo nell’estensione d’una specie. Reificazione
dell’umano nella molteplicità sociale!
L’eccezionale posizione dell’io, in
quanto l’unico che possa rispondere ad
altri, si trova così intesa a partire dalla
generalità delle leggi del Codice che si
applicano a tutti.
Infatti nella molteplicità sociale noi non
siamo due con il prossimo, di cui l’io è
tenuto a rispondere, ma siamo con il
terzo e il quarto, ecc. Ciascun io è un
altro! La relazione esclusiva dell’io con
il prossimo è modificata. Infatti, come
rispondere di tutti? Per me chi è primo
fra tutti? Ambiguità essenziale tra l’ordine etico della responsabilità per altri e
l’ordine giuridico al quale, tuttavia, l’ordine etico fa appello.
Poiché avvicinandosi nella carità al
primo venuto, l’io corre il rischio di
mancare di carità nei riguardi del terzo
che è anche il suo prossimo. È necessario il giudizio, la comparazione. È necessario acconsentire a comparare gli
incomparabili, gli io, tutti unici; è necessario poter far entrare la loro unicità
in un genere senza vincolarli a esso! È
necessario lo Stato, sono necessarie leggi
genera1i, ci vogliono istituzioni per formulare i giudizi. Ci vuole tutta l’opera
della politica e della giustizia. Ordine
Gustav Doré, xilografia, La distruzione di Sodoma, 1865.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
73
I L
F I L O S O F O
negatore della misericordia, ma chiamato tuttavia dalla misericordia, anche
nella preoccupazione di riconoscere
tutti gli altri della molteplicità umana.
Ordine che forse nella democrazia rivelerà la sua origine caritatevole. La giustizia e lo Stato giusto costituiscono la
maniera in cui può esservi carità nella
molteplicità umana. Concezione opposta a quella di Hobbes in cui l’uomo è
lupo per l’altro uomo e in cui lo Stato
significaca limitazione della crudeltà
naturale. Per noi, al contrario, provenienti da una certa limitazione della carità, ma ancorati nell’amore, lo Stato
può sempre rivedere le proprie leggi e
la sua giustizia. Questa preoccupazione
di riconsiderare (di migliorare) la legge,
non è infatti l’essenza della democrazia
e dello Stato liberale, segni della misericordia e della carità che respirano in
esso? Sforzo in vista di una legge sempre migliore! Miglioramento e rinnovamento che non si ottengono attraverso
una semplice deduzione logica di una
dottrina che diventa sempre più precisa, ma che esigono, invece, uno sforzo
morale dell’umano.
Quando lo Stato fa appello a un’invariabile giustizia logicamente dedotta,
bisogna sospettare stalinismo o fascismo. Lo Stato in cui la giustizia non è
separata dalla misericordia è una società
in cui, dopo l’enunciato del verdetto,
resta spazio per la manifestazione nell’opinione e nell’animo (nei migliori) di
un pensiero favorevole a colui che ha
avuto torto. Girarsi verso il volto del
condannato! “Non guardate in faccia
alle persone nel giudicare”, enuncia il
Deuteronomio 1, 17. Che in ebraico
suona così: “Non riconoscerete i volti
nel giudicare”. Ma la Bibbia dice anche:
“Rivolga il Signore a te il suo volto”
(Numeri 6, 26). Contraddizione tra
queste due affermazioni?, si chiede il
Talmud, per rispondere immediatamente: “L’una prima del verdetto, l’altra
dopo”. E forse attraverso questa eccedenza di carità rispetto alla giustizia
(ma la carità che giunge al momento
giusto, dopo l’esercizio della giustizia)
Dio viene all’idea nell’umanità occidentale. Il giudaismo (a mo’ di parabola) arriva al punto di attribuire a Dio
una preghiera che l’Eterno rivolge in
qualche modo a se stesso: “Possa la mia
Gustav Doré, xilografia, Adamo ed Eva cacciati dall’Eden, 1865.
74
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
carità superare la mia collera, cioè i rigori della mia giustizia” (Trattato talmudico Berakhoth 7a). Attraverso la
carità o la misericordia per la quale
l’uomo creato a immagine di Dio può
“altrimenti che essere” (autrement
qu’être), cioè può far passare l’esistenza
d’altri prima della sua, ed ecco che la
mia espressione umanesimo dell’altro
uomo acquista significato. Non è l’affermazione della natura umana nei suoi
diritti, ma nei suoi obblighi. Ciò è più
vicino a Kant che a Hegel e, di conseguenza, è la contestazione del fatto che
Kant conduca a Hegel.
Nel suo libro L’au-delà du verset,
1982, lei parla di “scrittura prima della
lettera”. Questo perché non v’è senso
letterale, a causa della metaforicità essenziale del linguaggio e perché la parola rinvia “lateralmente ad altre
parole”, come lei dice in Umanesimo
dell’altro uomo. Quali sono le conseguenze teoretiche rispetto alla concezione della realtà che derivano da
questo rinvio infinito per il quale il significato e l’esperienza stessa sono una
lettura, una esegesi, un’ermeneutica?
Questa visione della realtà non dà
forse un valore di verità (a livello metodologico ed esegetico) alla letteratura, la quale dimostra che è errato
concepire come primordiali i significati
che abitualmente si attribuiscono alle
parole, come se servissero a esprimere
le esperienze immediate e sensibili?
Nella nostra cultura del libro (nella misura in cui la scrittura non si limita all’informazione appartenente al pragmatismo dei nostri affari quotidiani,
delle ambizioni tecniche e dei calcoli
scientifici) l’esegesi allarga e rinnova
continuamente il senso testuale dello
scritto e “lo eleva alla verità”.
Come se nella sua preoccupazione di
esporre attraverso segni invariabili le
idee che una voce interiore suggerisce,
la scrittura si trovasse ispirata nello
scritto, sconvolta dallo Spirito, portando
un messaggio, una “poesia” la cui esegesi, continuamente, eleva alla verità il
senso ovvio. Meraviglia della scrittura in
cui viene contestato il famoso parallelismo noetico-noematico di Husserl e in
cui il Dio cartesiano infinito trova posto
a sufficienza nell’idea del finito! Come
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
se lo scrittore (il poeta) percepisse dall’esterno e leggesse in sé ciò che credeva
inventare soltanto con la sua penna; o
come se, poetica nella sua essenza, la
scrittura fosse dettata. Sante scritture?
Ma le letterature nazionali della nostra
civiltà restano nelle possibilità infinite
dell’ermeneutica (e il Faust di Goethe,
le tragedie di Shakespeare, la Divina
Commedia, Racine, Corneille, Molière).
Ma non solleverò oggi tutti i problemi
dello spirito che, al di là della luce del
conoscere, sollecitano, secondo il mio
parere, la riflessione a partire dall’interumano, dal rapporto con il volto in cui
Dio viene all’idea.
Lei considera l’insegnamento filosofico
degli scrittori della letteratura: Rimbaud, per esempio, sa bene che i contenuti sonori sprovvisti di senso, come
le vocali, hanno una “nascita latente”
nei significati; e anche Baudelaire in
Correspondances “attesta”, come lei afferma, “che i dati sensibili eccedono,
con i loro significati, l’elemento in cui li
si ritiene rinchiusi” (ibidem). Questi riferimenti alla scrittura profana e non
soltanto alla scrittura sacra attestano
che la scrittura letteraria (sacra o profana che sia) rende possibile il superamento del sapere. Perché questo
superamento?
Lei ritorna ai problemi ultimi che rinviavo nella frase finale della mia ultima
replica. Non me ne voglia dunque se rispondendole mi limito ad alcune brevi
considerazioni molto generali che
spesso risuonano come domande.
Nel nostro dialogo, si è mostrata da
parte mia una diffidenza nei confronti
del sapere concepito come senso ultimo
della spiritualità umana. Convinzione
che può sembrare tanto più dubbia, in
quanto questa riserva nei confronti del
sapere si esprimeva pur sempre sotto
forma di proposizioni teoretiche.
Non ho alcuna intenzione di rivendicare l’ignoranza come fondamento
della filosofia. Ma continuo a domandarmi se ogni sapere non sia tenuto,
nella ricerca della verità che è il suo
senso, alla sospensione della ipseità del
vivente interessato, immediatamente
preoccupata di essere chi la porta, per
ritornare al disinteressamento della
prossimità o della pace con altri, in cui
F I L O S O F O
questo dis-inter-essamento concretamente è possibile. Dis-inter-essamento
che, nella mia fenomenologia, si esplicita come responsabilità per altri, come
santità in cui l’io (moi) si costituisce
unicità di un io (je ) irriducibile, nell’impossibilità etica o santa di cercarsi
un sostituto.
Non ritornerò alla “fenomenologia” del
volto che mi sembra importante nell’itinerario che evocavo; non ritornerò
al rapporto con altri, che non è tematizzazione del sapere, ma a un fuori-disé dinanzi al volto, fuori-di-sé che si
ritrova nel linguaggio, che appartiene
già alla conoscenza nella sua tensione
fuori-di-sé, verso il pensiero che è immediatamente sulle nostre labbra e,
anche qui, già dinanzi ad altri. Mi sono
spesso domandato se l’inizio della verità, la prima verità cartesiana (il cogito), prima di tutte le possibilità che
esso racchiude di ricondurre un giorno
a Dio, non sia già preghiera gridata dal
fondo di una solitudine di dubbio. K
Parigi, in casa di Lévinas, 20 novembre
1988.
Tratto da:“Athanor, Semiotica, Filosofia,Arte,
Letteratura”, XXI, 13, 2010-11, Incontri di
parole, a cura di Augusto Ponzio, 2010-2011,
Meltemi, Roma, 2011. Il testo francese è
stato pubblicato in A. Ponzio, Sujet et altérité.
Sur Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Parigi
1996.
A P P R O F O N D I R E
K
A. Ponzio, Responsabilità e alterità in
Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano, 1995
K
A. Ponzio, Sujet et altérité. Sur Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Parigi,
1995
K
A. Ponzio (in coll. con Susan Petrilli e
Julia Ponzio), Reasoning with Emmanuel Lévinas, Legas, Ottawa, 2005.
K
A. Ponzio, Tra Bachtin e Lévinas, Palomar, Bari, 2008.
K
A. Ponzio, Emmanuel Levinas, Globalisation, and Preventive Peace, Legas,
Ottawa, 2009.
K
A. Ponzio, Rencontres de paroles, Alain
Baudry, Parigi, 2010.
75
I L
F I L O S O F O
“
L'altro è
soggettività
che trascende
la totalità.
Il rapporto
con l'altro non
è immediato,
ma è mediato
dall'Infinito.
Emmanuel Lévinas
K Augusto Ponzio
76
Totalità e infinito
Oltre le categorie della tradizione filosofica.
I
l più importante testo di Lévinas,
Totalità e infinito, prende l’avvio
dalla considerazione del rapporto
fra ontologia, politica e morale. L’essere, nel suo divenire, nella sua “essenza” come venire a essere, come
conatus essendi, come dialettica fra essere e non-essere, inscrivibile in un percorso narrativo, in una storia, si rivela in
tutta la sua evidenza allo sguardo realistico della politica. In quanto visione totalizzante e organizzazione funzionale,
in quanto atteggiamento aderente alla
realtà, alla storia e mediazione dell’interesse fra soggetti individuali e collettivi, la politica è legata all’ontologia.
Come amministrazione razionale della
durata, come economia del perdurare,
del persistere, del progredire nell’essere,
a qualsiasi costo, la politica prevede la
guerra, come extrema ratio: la guerra è
inscritta nel reale quale si rivela alla visione della politica, come arte di prevedere e di vincere (nel senso di avere la
meglio, ma anche di tenere a bada, di
sedare) la guerra.
Totalità e infinito parte proprio dalla individuazione del nesso fra ontologia,
storia, politica, guerra. Il concetto di totalità, a cui Lévinas oppone quello d’infinito, è strettamente collegato con la
visione della politica in quanto ragione
del reale, e tutta la riflessione di Lévinas di Totalità e infinito concerne la possibilità di un sovrappiù irriducibilmente
esterno alla totalità, di una trascendenza (espressa nel concetto d’infinito)
nei confronti della totalità e nei confronti della politica che della totalità
manifesta la ragione.
La questione che Lévinas affronta è se
si debba ammettere il primato della politica, cioè dell’ontologia, cioè della
guerra, e fondare la morale sulla politica facendo derivare l’escatologia della
pace messianica dall’ontologia della
guerra, la pace finale (come senso ul-
timo di cui gli individui sono portatori)
dalla ragione che fa il suo gioco nella
guerra; oppure se sia plausibile una metafisica che non accetta l’ontologia della
totalità e della guerra, non si adatta alla
visione teleologica della totalità, che
non rientra nel senso della storia, ma
che pone in relazione con ciò che è al di
là della totalità e della storia e, al tempo
stesso, non meno originario di esse e interno a esse, malgrado l’irriducibilità
alle loro categorie (è l’idea cartesiana,
più volte richiamata da Lévinas, dell’infinito nel finito, del più nel meno, dove
l’in dell’infinito significa al tempo
stesso non e dentro).
Totalità e infinito mostra la possibilità
della metafisica, di una escatologia al di
là del senso ultimo della storia, di una
morale non fondata sulla politica e di
una pace non derivata dalla guerra.
E individua la rottura della totalità e
l’eccedenza rispetto all’ontologia, che
producono l’infinizione, il rapporto con
l’infinito, non in un sapere, in una rappresentazione, in un’operazione conoscitiva, ma nel rapporto etico imposto
dalla trascendenza dell’altro, di ciascuno in quanto altro nei confronti di
una visione totalizzante e rispetto a una
omologazione a un medesimo.
La rivelazione dell’infinito avviene nel
rapporto con l’altro, col volto dell’altro,
come ciò che ha un senso per sé, che
non attende l’intenzionalità conoscitiva,
la visione totalizzante, la comprensione
del senso della storia, per essere significante. E la ri-velazione dell’infinito
comporta il primato della morale e
delle sue categorie, implica la responsabilità che va al di là del legale e obbliga
al di là del contratto, impone la non-indifferenza e la discrezione, non solo
come atteggiamento soggettivo, ma
anche come oggettiva e insuperabile separazione di singolarità per la quale ciascuno è irriducibilmente altro. K
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
“
La carezza
consiste nel
non impadronirsi
di niente...
In un certo senso
esprime l’amore
ma soffre per
un’incapacità
di dirlo.
Emmanuel Lévinas
F I L O S O F O
Cos’è una carezza
Un modo per incamminarsi verso l’infinito.
L
a carezza come il contatto è
sensibilità. Ma la carezza trascende il sensibile. Questo non
significa che essa senta al di là
del sentito, più profondamente
dei sensi, non significa che essa si impadronisca di un cibo sublime, pur conservando, nella sua relazione con questo
sentito ultimo, un’intenzione di fame
che si dirige sul cibo che si promette e
si dà a questa fame, la scava, come se la
carezza si nutrisse della propria fame.
La carezza consiste nel non impadronirsi di niente, nel sollecitare ciò che
sfugge continuamente dalla sua forma
verso un avvenire (mai abbastanza avvenire) nel sollecitare ciò che si sottrae
come se non fosse ancora.
Essa cerca, fruga. Non è un’intenzionalità di svelamento, ma di ricerca: cammino nell’invisibile. In un certo senso
esprime l’amore ma soffre per un’incapacità di dirlo. Ha fame di questa
espressione stessa, in un continuo incremento di fame. Va dunque
al di là del suo termine, è
tesa al di là di un ente,
anche futuro, che, appunto in quanto
ente, bussa già
alla porta dell’essere. Nella
sua soddisfazione, il desiderio
che
l’anima rinasce, alimentato in
qualche modo da ciò che non è ancora,
e ci riporta alla verginità, eternamente
inviolata, del femminile.
Questo non significa che la carezza cerchi di dominare una libertà ostile, di
farne il suo oggetto o di strapparle un
consenso. La carezza cerca al di là del
consenso o della resistenza di una libertà (ciò che non è ancora), qualcosa
che è “men che nulla” che sta come rinchiuso e sopito al di là dell’avvenire e,
quindi, sopito in modo completamente
diverso dal possibile che si offrirebbe all’anticipazione.
La profanazione che si insinua nella carezza risponde in modo adeguato all’originalità di questa dimensione
dell’assenza. Assenza diversa dal vuoto
di un niente astratto: assenza che si riferisce all’essere, ma vi si riferisce a
modo suo, come se le “assenze” dell'avvenire non fossero avvenire, tutte allo
stesso livello e uniformemente.
L’anticipazione comprende dei possibili; ciò che è ricercato, dalla carezza
non si situa in una prospettiva e nella
luce del comprensibile. Il carnale, tenerezza com-mossa per eccellenza e correlativo alla carezza, l’amatax, non si
confonde né con il corpo-cosa del fisiologo, né con il corpo proprio dell’io
posso, né con il corpo-espressione, assistenza alla propria manifestazione, o
volto. Nella carezza, rapporto ancora,
per un verso, sensibile, il corpo si spoglia già della sua stessa forma, per offrirsi come nudità erotica. Nel carnale
della tenerezza, il corpo abbandona lo
statuto dell’ente. K
Tratto da: E. Lévinas, Totalità e infinito,
Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano,
2006.
K Emmanuel Lévinas
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
77
I L
F I L O S O F O
L’allergia all’alterità
Una filosofia e una religione fondate sull’Altro devono attivamente
impegnarsi nella lotta per la giustizia e contro ogni forma di oppressione.
I
K Augusto Ponzio
78
n Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, pubblicato nel 1934 all’indomani dell’arrivo di Hitler al
potere, Lévinas anticipa le considerazioni che saranno poi sviluppate
nel 1935 nel saggio intitolato L’évasion.
Individua infatti nel nazismo la filosofia dell’asservimento all’essere, della sua
accettazione incondizionata, della repressione di qualsiasi esigenza di evasione, ottenuti attraverso l’appello
all’appartenenza, all’identità, all’eredità, al passato, al sangue, attraverso
l’idea di una società a base consanguinea, di uno Stato monoetnico (lo stato
monoetnico, inesistente e irrealizzabile,
alla stessa maniera del libero mercato, è
un fantasma che ricompare spesso,
come abbiamo visto anche di recente,
ed è sempre ben accolto dalla politica
del divide et impera).
La filosofia dell’hitlerismo, dice Lévinas,
è rudimentale, limitata, ma proprio per
questo fa leva su una forza elementare,
è un risveglio di sentimenti elementari,
e della filosofia che essi racchiudono, in
quanto esprimono l’atteggiamento primario di fronte al reale, prefigurano il
senso del rapportarsi al mondo. “Così la
filosofia dell’hitlerismo scavalca la filosofia degli hitleriani”. Essa non è solo un
pericolo o il pericolo del liberalismo e
della democrazia: “Il cristianesimo
stesso è minacciato, malgrado i riguardi
particolari e i concordati di cui, all’avvento del regime nazista, godono le
Chiese cristiane “.
Nello Stato nazista, i legami con la comunità in cui l’individuo deve riconoscersi, cui deve aderire, lo vincolano ad
essa in maniera indissolubile, perché
scaturiscono dal suo sangue, dal suo
passato, dalla sua razza. L’io aderisce a
ciò che ritiene essere se stesso, la vera
realizzazione di se stesso. Inoltre, la ve-
rità cui aderisce, ha, come Verità, valore
universale; mentre il fatto che, dato il
suo carattere razzista, non può essere
accettata da tutti, diventa il segno della
sua appartenenza esclusiva alla comunità superiore che la diffonde, e tale diffusione non può che essere concepita in
termini d’imposizione, di espansione, di
conquista, divenendo così violenza,
guerra e sterminio.
Nazismo e identità
Il nazionalsocialismo fa leva sull’idea
dell’essere proprio ed esclusivo di una
comunità in considerazione della sua
genealogia, della sua appartenenza a
una presunta origine; l’essere proprio
ed esclusivo che costituisce la propria
identità, la propria differenza, e che bisogna dunque affermare, far valere, imporre con ogni mezzo necessario,
perché esso non è altro che l’essere vero
delle cose, l’essere stesso secondo cui la
realtà impone inesorabilmente le sue
leggi e la storia realizza il suo percorso.
La filosofia dell’hitlerismo, come Lévinas osserva nella prefazione del 1990
alla traduzione inglese del suo testo del
1934, non è un’anomalia contingente.
Al contrario, essa si inscrive, come una
stabile minaccia, nella filosofia o, forse
meglio, in ciò che possiamo chiamare
l'ideologica occidentale (ossia l’ideologia che si presenta come la logica
stessa della “realtà”, dell’“essere delle
cose”), affetta com’è da una vera e propria allergia all’alterità.
Senza il superamento di tale “allergia”,
il liberalismo e la democrazia non possono nulla contro questa minaccia,
dato che essi, pur essendo stati provocati dalla responsabilità per Altri, si
sono costituiti fondamentalmente per
la difesa dei diritti dell’io, piuttosto
che di quelli dell’altro; dell’identico,
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
F I L O S O F O
Gustav Doré, xilografia, Abramo nella terra di Canaan, 1865.
piuttosto che del diverso; del consimile
piuttosto che dell’estraneo, dello straniero, si sono attestati a difesa degli appartenenti, dei comunitari, con
l’esclusione dei non appartenenti, degli
extracomunitari, degli Altri (il riconoscimento dei quali generalmente non
si è spinto oltre alla dichiarazione della
propria disponibilità alla tolleranza).
L’essere determina la coscienza
Il saggio sulla filosofia dell’hitlerismo riveste, come si vede, anche una particolare importanza rispetto alla questione
dell’essere, a cui Lévinas è, fin dall’inizio della sua ricerca, particolarmente
attento. A tale proposito, nel breve ma
rigoroso excursus storico delle diverse
concezioni del rapporto tra coscienza
(e, dalla stessa parte, anche libertà, ragione) ed essere, egli dedica una particolare attenzione al marxismo per il
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
fatto che, “per la prima volta nella storia del pensiero occidentale”, esso contesta il primato della coscienza.
Il marxismo “prende in contropiede la
cultura europea”, afferma Lévinas,
“rompe la curva armoniosa del suo sviluppo”. La coscienza e la ragione non
determinano l’essere ma ne sono determinate. Tuttavia il marxismo non abbandona totalmente la prospettiva del
liberalismo. L’ineludibile determinazione da parte dell’essere non toglie che
la coscienza determinata dall’essere non
possa reagire su di esso e modificare la
situazione che la determina. “Prendere
coscienza della propria situazione sociale è per Marx stesso affrancarsi dal
fatalismo che essa comporta”.
La coscienza individuale, benché determinata dall’essere, può tuttavia rompere questa specie di “incantesimo
sociale” riconoscendone il carattere alie-
nante rispetto alla sua essenza. Perciò,
dice Lévinas, una concezione veramente opposta a quella europea è
quella in cui la situazione in cui l’esistente umano è inchiodato (rivé) non si
aggiunge a lui ma costituisce il fondamento stesso del suo essere.
L’hitlerismo è questa concezione. L’essenza dell’uomo non è nella libertà ma
proprio nell’”incatenamento”, riconosciuto come originale e ineluttabile.
L’individuo riconosce di non poter sfuggire a se stesso e si identifica con l’essere, trova nel suo incatenamento
all’essere la propria identità. Il sangue,
le origini, l’eredità, il passato, costituiscono l’io, sono la sua identità, e ne assicurano l’appartenenza alla comunità
(Gemeinschaft) in cui ciò che accomuna
è la base consanguinea. “E allora, se la
razza non esiste, bisogna inventarla!”. K
79
I L
F I L O S O F O
Il femminile e la politica
lasciata a se stessa
Pace e giustizia sono certamente importanti, ma non sufficienti a giustificare
la politica. Solo il femminile può garantire una “pace preventiva”.
K Julia Ponzio
Insegna Semiotica del testo nella facoltà di Lingue e Letterature straniere
dell’Università di Bari.
80
Nei suoi scritti Lévinas usa il termine
femminile senza evidenti connessioni
con la differenza sessuale. Che cosa intende quindi?
Bisogna partire dalla distinzione posta
da Lévinas fra il riconoscimento intersoggettivo e il riconoscimento di una
posizione in una comunità socio-politica. Il primo è avviene entre nous, è la
relazione fra due persone, nella quale
l’altro è sempre un tu, riconosciuto
come tale non per il ruolo che ricopre
nella società, né per i suoi diritti politici, né per ciò che possiede, ma per se
stesso, per la sua insostituibile alterità.
Non è il terzo che chiede giustizia, che
reclama i propri diritti e il riconoscimento del suo posto nella società, ma,
appunto, il femminile, che è l’alterità
insostituibile nella relazione d’amore,
oppure, per usare le parole di Lévinas,
“questa cosa inaudita nell’umano per la
quale si afferma il fatto che senza di me
il mondo ha un senso”. Così inteso, il
femminile si presenta come una possibilità dell’umano, non in relazione con
la differenza sessuale biologica.
Secondo Lévinas, l’incontro con il femminile precede il linguaggio, l’identità,
la totalità, la storia e la giustizia, la cui
costituzione è determinata dall’incontro con l’altro come terzo.
Il fatto che il femminile sia a un livello
in cui l’interiorità non ha ancora
un’identità, una lingua e un posto riconosciuto nella società è stato interpretato da Simone de Beauvoir e Luce
Irigaray come una subordinazione, l’impossibilità della partecipazione politica
e del riconoscimento del femminile. Ma
l’entre nous e la giustizia non sono, per
Lévinas, due dimensioni alternative e
separate fra le quali si ponga una scelta:
sono profondamente legate, e il femminile è esattamente la possibilità di questo legame. Egli non relega il femminile
in una dimensione che precede la totalità, la giustizia, il riconoscimento sociopolitico perché il femminile è proprio
la condizione di possibilità della relazione fra la totalità e il suo “al di là”,
della relazione fra il riconoscimento
socio-politico e il riconoscimento nella
condizione dell’entre nous. In breve, ciò
che Lévinas chiama femminile non è
uno stato d’essere che possa essere
posto all’interno o al di là della totalità,
è invece la possibilità della relazione
della totalità con il suo oltre.
Tenendo conto di questa distinzione
dell’altro in un “tu” relazionale e un
“terzo” socio-politico, come si pone la
possibilità del perdono?
L’unico luogo in cui il perdono è possibile è quello spazio intimo definito da
Lévinas in Totalità e infinito spazio della
dimora, che è poi la dimensione del
femminile. Per questo motivo la possibilità del perdono segna il confine fra la
relazione all’altro come femminile e all’altro come terzo.
L’interiorità non può rimanere indifferente alla richiesta del terzo di una giustificazione del posto che essa occupa
nel mondo. La risposta a questa domanda è un racconto in cui l’interiorità
costituisce la propria identità giustificando se stessa e la propria richiesta di
riconoscimento. Dal momento in cui
questa risposta viene data, in cui questo racconto viene proferito, il perdono
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
non è più possibile. L’apparizione del
terzo determina la costituzione di
quella che Lévinas chiama la società
reale, il luogo della giustizia, in cui il riconoscimento dell’altro deve avere una
giustificazione.
Così l’altro ha un doppio ruolo: da una
parte, nell’entre nous è il femminile, che
è la possibilità stessa del perdono, dall’altra è il terzo che costituisce la società
reale chiedendo giustificazioni e giustizia. L’altro come terzo rompe il silenzio dell’intimità con la sua richiesta:
chiede all’interiorità di giustificarsi, di
raccontare una storia in cui essa si
ponga nel tempo economico in modo
che il suo posto, i diritti, il ruolo, la proprietà, ma anche la sua colpa, possano
essere giustificati. Costituendo la società reale l’altro come terzo determina
l’impossibilità del perdono.
Per essere perdonato io devo riconoscere la mia colpa, ma in una società
reale, l’altro, il terzo, può essere vittima
indiretta di un mio atto, anche se non
lo riconosco più come mio. In una società reale posso essere colpevole nei
confronti di qualcuno il cui volto io non
ho mai visto. Il terzo determina quindi
una separazione fra l’intenzione dell’atto e il suo risultato oggettivo. Se
questo si discosta dalle mie intenzioni,
non è perdonabile.
Nella società reale, dice Lévinas: “io non
sono più, propriamente, un io, porto
una colpa che non si riflette nelle mie
intenzioni. Io sono oggettivamente colpevole e la mia pietà non può purificarmi”. In breve, la colpa di cui sono
accusato dal terzo è fuori dalla sfera del
perdono: non posso chiedere perdono
per ciò che non era nelle mie intenzioni
ma che ha provocato ripercussioni indirette, o per ciò per cui sono stato giudicato colpevole, anche se innocente.
l’incontro etico con il volto come sua
condizione di possibilità. Ha quindi il
suo posto in una totalità separata dalla
relazione con l’altro, incapace di andare
oltre se stessa. Ma non coincide con la
politica in generale, perché può esservi
anche una politica non lasciata a se
stessa. Consiste nella possibilità della
relazione fra la totalità e il suo oltre, il
suo altrimenti, cioè fra la totalità e la relazione all’altro come sua condizione di
possibilità, cioè, ancora, fra perdono e
giustificazione. Non si trova né sul
piano dell’essenza, che è il piano della
F I L O S O F O
giustizia, né al livello dell’etica; consiste, invece, nell’operazione di rivoltare
la totalità e l’essenza, per scoprire l’incontro etico con l’altro come il rovescio
della giustizia.
In questa prospettiva, l’operazione politica per eccellenza è l’esposizione
della posizione. Se assumiamo questa
definizione della politica, un ruolo politico per eccellenza deve essere assegnato al femminile, perché esso è la
possibilità umana della posizione esposta, cioè del riconoscimento senza giustificazione che è il perdono. Esporre
In Totalità e infinito Lévinas afferma:
“La politica lasciata a se stessa porta
con sé una tirannia. Essa deforma l’io
e l’Altro che l’hanno fatta nascere, poiché li giudica secondo le regole universali e, per ciò stesso, quasi in
contumacia”. Qual è il suo commento?
La “politica lasciata se stessa” dimentica
la relazione con l’altro e dunque non è
più capace di risalire a una situazione
in cui la totalità si rompe, mostrando
Gustav Doré, xilografia, Ezra e le tavole della legge, 1865.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
81
I L
F I L O S O F O
l’essenza, in questo senso perdonarla, riconoscere che essa non ha in se stessa
le proprie giustificazioni, significa la
possibilità di sottoporla a critica, di un
dialogo che non sia ratifica di una posizione. Significa la possibilità di domande che non contengano al loro
interno la propria risposta: è questo lo
spazio della politica. Come atto in cui
la totalità viene rivoltata ed esposta, ma
non negata, la politica diviene così una
politica di pace.
Affrontiamo quindi i temi della guerra
e della violenza.
La guerra è l’esperienza della chiusura
nella totalità, la situazione in cui non vi
è più nulla da dire se non dichiarare la
propria appartenenza all’essere, ad un
ordine oggettivo e il proprio ruolo all’interno di esso, in relazione alle leggi
da cui esso è regolato.
Coincide dunque con la politica lasciata
a se stessa, che è già di per sé una politica di guerra. Ciò che essa chiama pace
non è che l’imposizione di una concezione del mondo in cui il diverso sia accomunato e accordato, lo straniero
assimilato, conciliato con l’identità in
cui ciascuno per astrazione può essere
ridotto al suo sostituibile ruolo.
È questa la pace prodotta dalla guerra,
diversa soltanto perché sua extrema
ratio; la pace della saggezza greca, patrimonio costitutivo dell’umanità europea, dell’Occidente, e del suo
umanesimo dell’identità: la pace come
ritorno dalla molteplicità all’unità, fondata sull’ottenimento del consenso
anche senza coartazione e senza esercizio della forza, sulla possibilità di governo e di assembramento anche senza
costrizione e senza lotta. Pace ottenuta
attraverso il discorso e le arti psicogogiche che permettono di convincere invece che di vincere, e di dominare senza
violenza, così come tramite il calcolo e
l’abilità tecnica si possono dominare gli
elementi ostili della natura. Questa idea
di pace inerente all’ideale europeo dell’umanità è fondata sullo Stato inteso
come raggruppamento di coloro che la
pensano alla stessa maniera, che per
quanto possano manifestare posizioni e
interessi diversi, sono accomunati dalle
stesse verità ideali, di cui fa parte questa pace stessa, concepita come tranquillità che assicura lo scambio tra
simili, uniti per coesione concettuale e
per l’interesse che li costringe a rapporti
di scambio, ma reciprocamente indifferenti e separati nella loro identità.
Questa pace, espressione di libertà e solidarietà, garanzia della sicurezza e del
benessere, fondata sulla Verità, sul Sapere e sulla Ragione, ha come complementari scenari di guerra, imperialismo,
genocidio, sfruttamento e terrorismo,
oltre ai crimini del fascismo e del na-
Gustav Doré, xilografia, Eliezer e Rebekah, 1865.
82
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
zionalsocialismo, al paradosso del capovolgimento della difesa dei diritti
umani in stalinismo, al ricorso in nome
della pace alla distruzione atomica e
agli interventi “necessari” della guerra
“preventiva”.
E in nome di questa pace, la cattiva coscienza che tali crimini producono
viene convertita in buona coscienza,
non appena la tranquillità e il riposo
sono ripristinati e confermati. Questa è
la pace della politica lasciata a se stessa,
della tranquilla serenità dell’identico,
della conferma dell’identità, in cui il
movimento verso l’alterità è solo una
momentanea uscita in funzione del ritorno poiché ubbidisce alla logica dello
scambio e non riconosce altre relazioni
se non quelle strettamente reciproche.
In che cosa consiste quindi, secondo
Lévinas, la natura della vera pace?
È la situazione in cui l’essere ritrova
come proprio rovescio ciò che lo
espone ad altro e che precede e determina la sua costituzione. La pace di una
politica non lasciata a se stessa, ma capace di rivoltare la totalità e l’essenza
per scoprire l’incontro etico con l’altro
come il rovescio del discorso, del sapere,
dello scambio, della reciprocità, della
giustizia. È la pace dell’operazione politica intesa come esposizione della posizione, in cui l’alterità non è più
considerata resto, sporgenza, scarto,
semplice deficienza o privazione, limite
dell’unità, ma possibilità stessa dell’atto
politico, che è relazione all’altro, posizione di domande, possibilità di dire
oltre il detto, ascolto, accoglienza.
Questo significa ritrovare, al di sotto
dell’identità, un’interiorità non semplice, non chiusa bensì già in una relazione d’amore con l’altro: non una
situazione passiva, ma già l’azione di
una messa a rovescio che è condizione
di possibilità del rapporto con l’altro
come terzo e, dunque, della giustizia.
Rispetto alla totalità, allo Stato giusto
che assegna un ruolo e un’identità, la
relazione con l’amato, la relazione con
l’unico e con l’insostituibile, è la relazione in cui l’interiorità non assimila
l’altro e non lo riduce ad una categoria,
ma al contrario l’interiorità viene perdonata ed esposta. Insomma, la relazione di pace in cui la politica non è
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
lasciata a se stessa, è una situazione precedente, preventiva. In un senso non
abusato e non abusivo della parola
amore, questa pace “preventiva” rispetto alla guerra è la pace come amore,
dove l’alterità dell’altro non è l’illusione
soggettiva dell’innamorato, ma proprio
l’irriducibilità a qualsiasi illusione soggettiva, a qualsiasi idea, pensiero e rappresentazione dell’altro, è un’alterità
assoluta, la cui prossimità è fuori dallo
spazio geometrico e dalle sue unità di
misura, ed è fuori dallo spazio logico
della somiglianza coesiva dei concetti e
dei generi. È la prossimità dell’amato,
che si presenta in termini di non indifferenza, di rapporto di unico a unico.
La non-indifferenza dell’altro come
unico nel rapporto d’amore e non certamente la sua differenza indifferente
come individuo nel rapporto conoscitivo eccede dalla pace come conferma
dell’identità rispetto alla quale qualsiasi
alterità è pericolosa, dalla pace come
tranquilla serenità dell’identico, che è
inevitabilmente collegata con la violenza e con la guerra, come extrema
ratio del realismo della politica e della
fede nelle risorse persuasive del discorso. L’altro come unico del rapporto
di non indifferenza si dà come attualmente amato; l’altro come individuo
del rapporto conoscitivo si dà come potenzialmente odiato: da una parte la
pace del rapporto di unico a unico, “tra
noi”, fondata sull’amore, dall’altra la
pace del rapporto di individui che se
quel fondamento dimentica e abroga
sfocia nell’odio.
Accenniamo infine al tema forse più celebre del pensiero di Lévinas: il volto.
La relazione con l’unico, che Lévinas
designa con il termine di amore, il rapporto di non-indifferenza che squarcia
l’orizzonte dell’indifferenza conoscitiva
e in cui il pensiero non è pensiero dell’altro, pensare l’altro, ma pensiero per
l’altro, essere in pensiero per lui, ha la
sua epifania nell’altro come volto. Il
rapporto con l’assolutamente altro la
cui epifania originaria non si dà tramite
la donazione di senso della coscienza
intenzionale, nella visibilità di una presenza, nello svelamento di una verità,
ma nella “presentificazione” di una assenza, nella ri-relazione sempre di
F I L O S O F O
nuovo di un senso per sé, ha nel volto
dell’altro la sua espressione metonimica
e metaforica. Il volto con la sua unicità
dice della relazione con l’altro nella sua
alterità logicamente indiscernibile, irriducibile a una differenza ultima che si
aggiunge a un genere.
Risveglia l’io dalla tranquilla serenità,
dal riposo, dal sonno dogmatico della
pace come conferma e rassicurazione
dell’identità, della buona coscienza; dall’intorpidimento della politica giustificata da una visione realistica e
disponibile all’accettazione della guerra
riconosciuta come “l’evidenza stessa del
reale”, come “dura realtà”, “ordine oggettivo ”, come espressione ultima dell’essere stesso in quanto tale, della
“politica come arte di prevedere e di
vincere in tutti i modi la guerra”.
Il risvegliarsi alla nudità del volto dell’altro, nella sua unicità indiscernibile al
sapere, è il risvegliarsi alla nudità dell’altro non travestito da individuo, non
racchiuso in un genere o un’identità logica, non valutato rispetto a un piano,
non situato nel mondo; ma come unico,
eccedente, nella sua estrema esposizione senza difese, nella sua precarietà.
Sicché la sua morte, malgrado la sua deduzione dal giudizio universale “tutti gli
uomini sono mortali”, pre-occupa anticipatamente e comporta lo stare in pensiero per lui. Fa scandalo come se
accadesse per la prima volta.
Ecco dunque la pace su cui riposa la
politica non lasciata a se stessa, della
prossimità come amore che espone alla
responsabilità dell’io per l’altro. A differenza della pace che garantisce l’identità e la buona coscienza, non è riposo,
ma assenza di quiete, inquietudine per
l’altro, preoccupazione per lui, dedizione e cura; una continua messa in
questione della propria identità, libertà
e potenza. K
A P P R O F O N D I R E
K
J. Ponzio, Il presente sospeso. Alterità e
appropriazione in Heidegger e Lévinas,
Cacucci, Bari, 2000.
K
J. Ponzio, Il ritmo della scrittura.
Tempo, alterità e comunicazione,
Schena, Fasano (Bari), 2005.
83
I L
F I L O S O F O
Il mitico incontro
con Chouchani,
un eccentrico
talmudista clochard,
suggerì a Lévinas
di approfondire
lo studio della
tradizione ebraica.
Oltre la filosofia:
il Talmud
S
K Shmuel Wygoda
Docente presso la Hebrew University
and Herzog College di Gerusalemme.
84
ebbene fosse nato a Kovno, in
Lituania, un centro di studi talmudici fra i più importanti in
Europa, e sebbene in più occasioni avesse ripetuto di “aver
imparato l’alfabeto ebraico prima di
quello cirillico”, Emmanuel Lévinas
non ricevette alcuna seria educazione
talmudica durante tutta la giovinezza
trascorsa nell’Est europeo.
Certamente affrontò alcuni testi in lingua ebraica, ma queste letture si limitarono alla Bibbia e a qualche opera
basilare del giudaismo. Sarà perché
quando aveva undici anni, a causa della
Prima guerra mondiale, la sua famiglia
dovette scappare a Kharkov, in Ucraina,
dove le opportunità di studi talmudici
erano scarse, sarà per qualche altra ragione, rimane il fatto che in tutta la sua
gioventù Lévinas non ebbe alcuna seria
occasione d’incontrare il Talmud. Anzi,
sulla base di mie ricerche, posso affermare che per molti anni non dimostrò
alcun particolare apprezzamento per
questo genere di studi, anche se ciò non
significa affatto che non apprezzasse il
giudaismo in generale e quello tradizionale in particolare.
È interessante raccontare come avvenne
l’incontro. Nel 1945 un suo caro amico,
il dottor Henri Nerson, ebreo e ostetrico di professione, gli parlò di uno
strano individuo che aveva conosciuto
nella zona di Vichy durante gli anni
della guerra. Il personaggio era così
fuori dal normale che persino il suo
vero nome era sconosciuto. Si faceva
chiamare Chouchani, ma questo era
solo uno pseudonimo. Il suo aspetto era
piuttosto sgradevole, secondo alcuni addirittura ripugnante. Ciò nonostante,
secondo Nerson, la sua conoscenza era
veramente fenomenale.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
Un bizzarro talmudista
Noto per la sobrietà con cui trattava
persone e situazioni, Nerson era chiaramente in uno stato di grande eccitazione, come l’adepto di una setta. Ma
nonostante le sue forti pressioni perché
incontrasse Chouchani, Lévinas si rifiutò di farlo per due anni. Dopo tutto,
egli aveva studiato filosofia con Maurice Pradines (1874-1958), psicologia
con Charles Blondel (1876-1939), filosofia classica con Henri Carteron
(1891-1927), un autorevole esperto di
Aristotele e Tommaso d’Aquino, sociologia con Maurice Halbwachs, fenomenologia con Edmund Husserl e con
Martin Heidegger, suo discepolo e oppositore. Logico che Lévinas non avesse
alcuna fiducia di poter apprendere
qualcosa da un clochard.
Finalmente, nel 1947, il filosofo accettò
d’incontrare il misterioso Chouchani.
Di quel colloquio sappiamo in realtà
molto poco, anche se esiste un mito, secondo il quale i due parlarono per una
notte intera finché alla mattina, congedandosi da Nerson, Lévinas disse all’amico: “Non so dire ciò che lui sa,
tutto ciò che so dire è che tutto ciò che
io so lui lo sa”. Anche se fosse una leggenda, rimane il fatto che da allora in
poi Lévinas si dimostrò interessato allo
studio del Talmud al punto da dedicarvi
gran parte del suo tempo libero.
A questo punto, però, vorrei separare il
mito di Chouchani dalla reale esperienza intellettuale che il filosofo ebbe
con questo bizzarro individuo. E facendolo rimango fedele alla testimonianza
dello stesso Lévinas, che in diversi incontri, alla richiesta di approfondire le
eccentricità di Chouchani, mi rispose
che “questi aspetti rocamboleschi non
erano affatto essenziali”.
In ogni caso, nei cinque anni seguenti
Lévinas studiò a lungo con Chouchani,
sia da solo sia partecipando a un gruppo
di studio settimanale assieme a Nerson
e a un piccolo gruppo di amici.
Nel 1952 Chouchani lasciò la Francia,
andò a vivere per quattro anni in
Israele, e dopo essere tornato per sei
mesi, nel 1957, lasciò definitivamente
l’Europa per il Sud America, dove rimase sino alla morte, nel 1968. Il
gruppo di studio continuò però i suoi
lavori anche dopo la partenza del mae-
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
F I L O S O F O
“
Il monoteismo è un umanesimo.
Solo gli sciocchi poterono trasformarlo
in aritmetica teologica.
Emmanuel Lévinas
stro, fino a che, nel 1957, lo storico del
giudaismo Edmond Fleg decise di
creare un forum per presentare ai giovani intellettuali francesi un approccio
alla religione ebraica diverso da quello
fornito nelle sinagoghe. È da questa
esperienza che nacquero le Quattro letture talmudiche pubblicate nel 1968.
La Torah come alternativa
Il Talmud è stato per Lévinas un mezzo
per dire ciò che non può essere detto in
greco. È questo un tema cruciale delle
sue Letture, e mi riferisco proprio alla
possibilità di tradurre la Torah in greco,
cosa che spesso è presentata come un
mera soluzione didattica.
Ovviamente, sebbene esprima le credenze, i valori e le norme di una particolare nazione, la Torah deve essere
tradotta in greco, cioè a dire nell’universale dibattito intellettuale, se la si
vuole rendere accessibile a chi non padroneggi le fonti ebraiche.
Ma secondo Lévinas la questione va
ben oltre. Questa traduzione, infatti, si
rende a suo avviso necessaria per riuscire a esprimere in greco ciò che la cultura greca non è riuscita a esprimere.
Sin dall’inizio, infatti, la filosofia ha sostenuto che la metafisica deve essere
fondata sull’ontologia. E a sua volta
l’ontologia ha tradizionalmente sostenuto, con diversi argomenti, la sua supremazia sulle altre forme di pensiero.
Il problema dell’essere è quindi diventato fondamentale, oscurando quello
della presenza di altri esseri umani.
Anche senza passare in rassegna l’intera
storia del pensiero occidentale, basta citare qualche caso. Hobbes sviluppò il
principio del diritto naturale in un
modo che non prevede la presenza di
altri con gli stessi diritti, e dovette
quindi risolvere il contrasto sostenendo
la necessità di uno Stato oppressivo.
Spinoza mise a fuoco l’idea di conatus
essendi, ovvero l’aspirazione di ogni essere a persistere nel suo stato, indipendentemente dalla presenza di altri. E
questa indifferenza rimane anche nelle
maggiori correnti filosofiche del Novecento, nonostante il loro interesse per
la questione della responsabilità verso
gli altri. Non è certo il caso di ricordare
l’impatto di Heidegger e delle sue nozioni di Essere e di Esserci (Dasein)
sulla filosofia continentale del Novecento, ma va ricordato che, sebbene Essere e tempo, il capolavoro di Heidegger,
non sia indifferente all’esistenza degli
altri (il Mitsein, l’essere-assieme), il primato del Sé heideggeriano non può essere scalfito dalla presenza di altri.
Ebbene, il Talmud fornì a Lévinas la
possibilità di dimostrare che la preoccupazione per l’altro non è un mero
esercizio retorico. Attraverso le sue Letture, cominciò ad analizzare le situazioni umane come appaiono nel
Talmud ma esprimendole in termini filosofici, riuscendo così a individuare vie
sconosciute alla tradizione metafisica.
Un’occasione per polemizzare con l’ontologia, così come era intesa allora.
La cenere della giovenca rossa
Ecco un esempio delle sue riflessioni
tratto dalla Lettura del dicembre 1989.
Il rito di purificazione ebraico della giovenca rossa si basa sia su una prescrizione divina contenuta nel Libro dei
Numeri, sia su un passaggio del Trattato
di Hulin, in cui si elogia Abramo per
aver affermato “Io sono polvere e cenere” (Genesi:18,27). Commentando
85
I L
F I L O S O F O
questa situazione, Lévinas mette a
fuoco due aspetti. Il primo è che le ceneri di una giovenca rossa erano usate,
nel tempio di Gerusalemme, per purificare coloro che erano entrati in contatto con un cadavere. Lévinas ricorda
come questa prassi sia tradizionalmente
definita un chok, ossia una prescrizione
religiosa di cui ci sfugge qualsivoglia
motivazione razionale, tanto da essere
inserita nell’agenda di Satana fra quelle
degne di scherno per chi le osserva.
Abramo e la morte
Ma il filosofo suggerisce anche un’altra
lettura, memore dei temi più cari alla
filosofia del Novecento: “Il contatto con
i morti è sempre un’esperienza più che
sufficiente per ricordare la morte stessa,
nella sua negatività senza distinzioni o
esclusioni; morte che è sempre la mia
morte. Le nozioni di purezza e impurità si sono imposte al pensiero, libere
da ogni reminiscenza mistica o superstiziosa. L’impurità è il nome di un
egoismo sordido, cui la morte, la mia
morte, conferisce una saggezza
estrema”. E la vera purezza degli esseri
veramente umani, di cui Abramo è
padre, consiste proprio nel fatto che la
sua consapevolezza d’essere “polvere e
cenere” non lo porta a disinteressarsi
degli altri, vicini o lontani che siano. Per
Abramo ciò che ha valore rimane tale
nonostante la morte, per la quale ogni
cosa vale l’altra.
Lévinas, infatti, fa notare che Abramo
in questo passo del Genesi discute con
Dio stesso non in proprio vantaggio ma
in favore nientemeno che degli abitanti
di Sodoma, di cui la Bibbia racconta
quanto fossero perversi e peccatori di
fronte a Dio.
Verso la fine della Lettura, Lévinas confronta il comportamento di Abramo,
Mosè, Aronne e Davide, che umiliarono
loro stessi sino ad autodefinirsi con
espressioni di nullità, con quello degli
intellettuali pagani, usi a magnificare il
proprio orgoglio d’esistere. E si spinge
sino a sostenere la superiorità di Mosè e
Aronne, che si posero la domanda “Che
cosa siamo noi?”, rispetto ad Abramo,
che ancora ragionava in termini di polvere e cenere.
Il filosofo conclude riportando l’insegnamento del rabbino Ila’a: “Il mondo
86
continua a esistere solo per i meriti di
coloro che nel corso di una polemica
continuano a considerarsi nullità”, in
lingua ebraica: “Bolem azmo beshaat meriva”. Come dire: “Egli tiene sospesa la
terra sopra il nulla (belima)” (Giobbe,
26,7). Il rabbino Abbahou ha affermato: “Il mondo vive per i meriti di coloro che si paragonano al nulla.
E fuori da ciò rimangono solo le armi
del mondo”. Commentando questo
passaggio in un colloquio sul tema del
Sé, Lévinas si dimostra perfettamente
consapevole della “libertà ermeneutica”
usata dal Talmud nel suggerire che belima, un termine che letteralmente significa “contenimento, restrinzione,
limitazione”, possa essere riletto come
“belima”, ossia “senza qualunque cosa”,
un’interpretazione che suggerisce non
una filosofia ancorata al proprio essere,
anche se capace di preoccuparsi per gli
altri, ma una filosofia in cui la preoccupazioni per se stessi è completamente
assente: “La pace come significato di
ogni ontologia… forse il caos da cui
l’essere emerge, espresso in una lotta
originale”.
Che filosofia! Non più Spinoza e il suo
Conatus essendi, non più Nietzsche e la
sua volontà di potenza senza fine, non
più Hegel e il suo implacabile storicismo, non più Heidegger e la sua idea di
Esserci come Essere per la morte. In
tutte queste filosofie l’uomo non può
essere genuinamente interessato all’altro. Deve sopravvivere, guadagnare potere, e la ricerca della sopravvivenza è
quasi per definizione solipsistica. La lettura levinasiana del Talmud distilla una
filosofia completamente opposta.
L’uomo è capace di porsi verso il suo
prossimo non come un lupo, ma umanamente, ossia di preoccuparsi del suo
benessere al punto da anteporre volentieri il suo interesse al proprio. Questo
è ciò che insegna il Talmud sul mondo
e sul ruolo dell'uomo in esso. K
Tratto da: S. Wygoda, Lévinas as reader
of Talmud, 6 marzo 2001, http://ghansel.free.fr/.
Traduzione di Francesca Nicola.
La giovenca rossa
Il rito ebraico della giovenca rossa si
basa su un passaggio del libro dei
Numeri (19,1-6),in cui il Signore
disse ancora a Mosè e ad Aronne:
“Questa è una disposizione della
legge che il Signore ha prescritta: Ordina agli israeliti che ti portino una
giovenca rossa, senza macchia, senza
difetti, e che non abbia mai portato il
giogo. La darete al sacerdote, che la
condurrà fuori del campo e la farà
immolare in sua presenza. [...] Poi si
brucerà la giovenca sotto i suoi occhi;
se ne brucerà la pelle, la carne e il
sangue con gli escrementi. [...] Un
uomo mondo raccoglierà le ceneri
della giovenca e le depositerà fuori
del campo in luogo mondo, dove saranno conservate per la comunità
degli israeliti per l'acqua di purificazione: è un rito espiatorio. [...] Chi
avrà toccato un cadavere umano sarà
immondo per sette giorni”.
Secondo la tradizione questo rito di
purificazione fu eseguito solo nove
volte nel periodo da Mosé sino alla
distruzione del secondo tempio nel
70 d.C., anche per l’oggettiva difficoltà di reperire animali con tutte le
numerose caratteristiche richieste.
D’altra parte, solo dopo essersi purificati in questo modo diventerà possibile, secondo la tradizione, la
ricostruzione del tempio.
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
I L
F I L O S O F O
Prigionia, silenzio, parola
I primi due volumi delle Œuvres di Lévinas in corso di pubblicazione
K Augusto Ponzio
I
l piano generale delle Opere complete
di Lévinas, di cui sono apparsi nel
2009 i primi due volumi, è così configurato: i primi tre volumi raccolgono testi inediti, i volumi IV-VII i
testi pubblicati da Lévinas. Di questi i
primi due contengono i testi filosofici e
gli altri due quelli sull’ebraismo, la politica, la critica letteraria e quelli costituiti da conversazioni.
Il primo volume, che raccoglie gli scritti
di Lévinas del periodo 1937-1950, contiene essenzialmente quelli dei cinque
anni di prigionia (1940-1945), i Carnets
de captivité (Scritti sulla prigionia): appunti su temi diversi ma che si presentano come un tutto unitario e che
possono essere considerati opera non
soltanto di un filosofo ma anche di un
grande scrittore. Come osserva Jean
Luc-Marion nella sua Prefazione: “Letteralmente Lévinas non dice la Shoah
che appena, perché dire la pena, questa
pena, esige appena un detto, il minor
detto possibile per manifestare la pena
infinita del dire, del dire che fu così negato e disdetto”.
Il primo volume si divide in tre parti:
Scritti sulla prigionia (1940-1945);
Omaggio a Bergson e Note filosofiche diverse. Negli appunti del periodo della
prigionia troviamo, tra l’altro, nelle sue
riflessioni, diversi riferimenti concernenti la letteratura l’Orlando furioso
dell’Ariosto, Edgar A Poe, Proust, Dostoevskij, Dante, Goethe, Conan Doyle,
Nerval, Baudelaire, oltre che considerazioni specificamente filosofiche come
quelle relative a Jankélévitch o che anticipano motivi e temi delle sue pubblicazioni successive a partire da De
l’existence à l’existant (1947), come
quelle concernenti la sua nozione di “il
DIOGENE
N. 24 Settembre 2011
y a”, e che trovano ulteriore sviluppo
nelle Note filosofiche diverse.
Il secondo gruppo di scritti contiene
quattro testi: Captivité, La spiritualité
chez le prisonnier israélite, L’experience
juive du risonnier, e Ommage a Bergson
(del 1946), in cui Lévinas racconta che
Bergson, che nel 1937 aveva scritto “ho
voluto restare tra coloro che saranno
domani i perseguitati”, nel 1940, già
ammalato, si presentò umilmente al
commissariato di polizia del suo quartiere per farsi schedare come ebreo.
“Morì poco dopo”, aggiunge Lévinas, “e
Auschwitz gli fu risparmiato”.
Il secondo volume, come dice il suo titolo, contiene Parole et Silence e altre
conferenze inedite del periodo 19471964 al Collège Philosophique, creato
da Jean Wahl.
Fra quelle pubblicate la più celebre è Il
tempo e l’Altro. I temi di quelle inedite
sono: Parola e Silenzio, I Nutrimenti, Gli
Insegnamenti; Lo Scritto e l’Orale; Il Volere; La Separazione; Al di là del possibile; La Metafora.
Il periodo 1948-1962 è particolarmente
importante perché è quello della genesi
dell’opera fondamentale di Lévinas (insieme a Altrimenti che Essere, 1974, cui
prelude la conferenza intitola La Metafora), Totalità e Infinito (1961).
L’ampia prefazione di Rodolphe Calin e
Catherine Chalier è dedicata proprio,
come dice il titolo al rapporto LévinasWahl-Collège philosophique.
Particolarmente interessante è, di Parole
et Silence, il paragrafo dedicato alla Dialettica della parola sia per la critica rivolta ad Heidegger facendo notare che
il mondo della parola non coincide con
il mondo del quotidiano heideggeriano,
non rappresenta una caduta, sia perché
in esso risulta l’importanza che Lévinas,
come Michail Bachtin, annette all’opera
di Dostoevskij proprio per ciò che riguarda la raffigurazione della parola e
delle sue potenzialità. In Dostoevskij, il
personaggio non ha una sua propria parola, una parola che gli appartenga, non
si identifica con “la parola sua”, non si
riconosce interamente in essa, ma dalla
parola detta prende le distanze ricorrendo a un’altra parola, per non lasciarsi
trovare in essa e identificarsi con essa.
Si mostra qui che “vi è nella parola
un’impossibilità di sincerità che costituisce l’unica sincerita”. Qui dunque
chi parla non si conforma a un personaggio predefinito, a un ruolo, un’identità, un’immagine fissata nello specchio
che lo storia gli offre, non parla iniziando le sue frasi con “noi altri”.
Il volume contiene inoltre due appendici: la prima consiste nella conferenza
intitolata La Signification (del 28 febbraio 1961), di cui si trovano più manoscritti anziché uno solo che
corrisponda con certezza al testo effettivamente letto da Lévinas. La seconda
presenta la lista delle conferenze tenute
da Lévinas al College philosophique. K
A P P R O F O N D I R E
K
Emmanuel Lévinas, Œuvres, I, Bernard Grasset/Imec, Parigi, 2009.
Vol. I Carnets de captivité et autre
inédites, a cura di Rodolphe Calin e
Catherine Chalier, Prefazione di
Jean Luc Marion.
Vol. 2 Paroles et silence et autres conférences inédites, a cura di Rodolphe
Calin e Catherine Chalier.
87