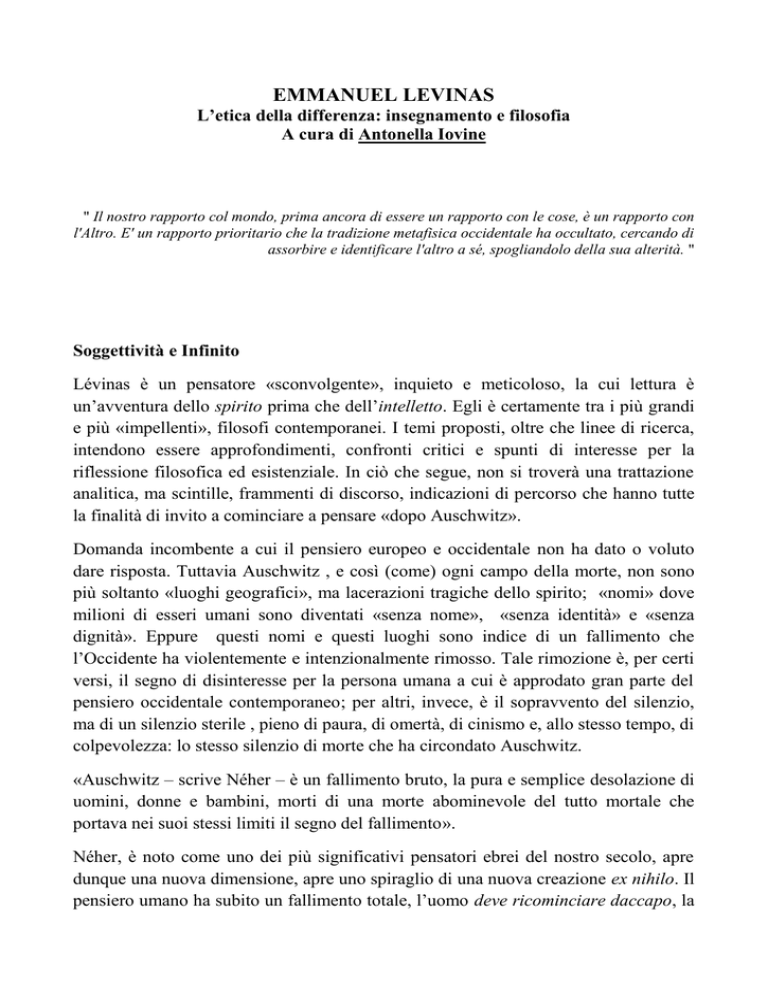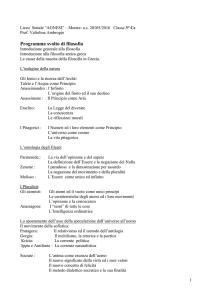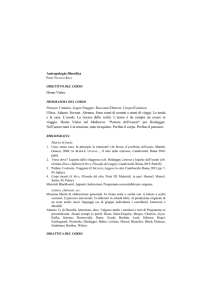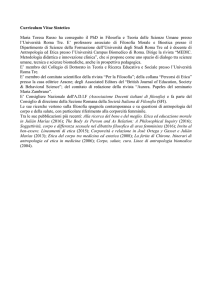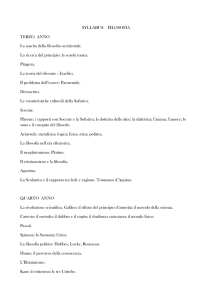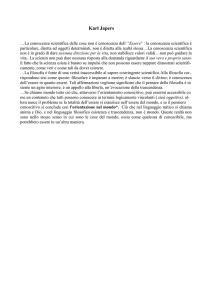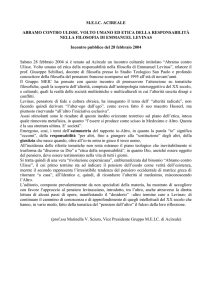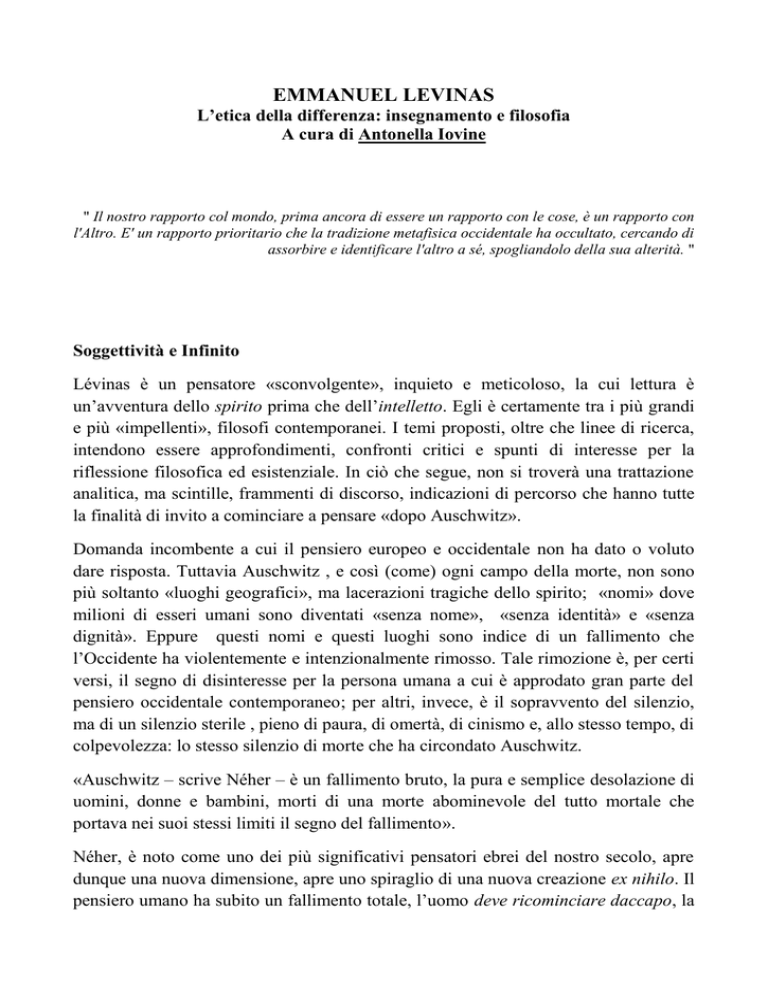
EMMANUEL LEVINAS
L’etica della differenza: insegnamento e filosofia
A cura di Antonella Iovine
" Il nostro rapporto col mondo, prima ancora di essere un rapporto con le cose, è un rapporto con
l'Altro. E' un rapporto prioritario che la tradizione metafisica occidentale ha occultato, cercando di
assorbire e identificare l'altro a sé, spogliandolo della sua alterità. "
Soggettività e Infinito
Lévinas è un pensatore «sconvolgente», inquieto e meticoloso, la cui lettura è
un’avventura dello spirito prima che dell’intelletto. Egli è certamente tra i più grandi
e più «impellenti», filosofi contemporanei. I temi proposti, oltre che linee di ricerca,
intendono essere approfondimenti, confronti critici e spunti di interesse per la
riflessione filosofica ed esistenziale. In ciò che segue, non si troverà una trattazione
analitica, ma scintille, frammenti di discorso, indicazioni di percorso che hanno tutte
la finalità di invito a cominciare a pensare «dopo Auschwitz».
Domanda incombente a cui il pensiero europeo e occidentale non ha dato o voluto
dare risposta. Tuttavia Auschwitz , e così (come) ogni campo della morte, non sono
più soltanto «luoghi geografici», ma lacerazioni tragiche dello spirito; «nomi» dove
milioni di esseri umani sono diventati «senza nome», «senza identità» e «senza
dignità». Eppure questi nomi e questi luoghi sono indice di un fallimento che
l’Occidente ha violentemente e intenzionalmente rimosso. Tale rimozione è, per certi
versi, il segno di disinteresse per la persona umana a cui è approdato gran parte del
pensiero occidentale contemporaneo; per altri, invece, è il sopravvento del silenzio,
ma di un silenzio sterile , pieno di paura, di omertà, di cinismo e, allo stesso tempo, di
colpevolezza: lo stesso silenzio di morte che ha circondato Auschwitz.
«Auschwitz – scrive Néher – è un fallimento bruto, la pura e semplice desolazione di
uomini, donne e bambini, morti di una morte abominevole del tutto mortale che
portava nei suoi stessi limiti il segno del fallimento».
Néher, è noto come uno dei più significativi pensatori ebrei del nostro secolo, apre
dunque una nuova dimensione, apre uno spiraglio di una nuova creazione ex nihilo. Il
pensiero umano ha subito un fallimento totale, l’uomo deve ricominciare daccapo, la
marcia percorsa è approdata a un vicolo cieco, senza uscita: il vicolo della morte.La
ricerca del «del senso della vita» continua, deve continuare, ma in altre direzioni, in
altri percorsi, per altre strade.
Adorno nelle sue«meditazioni sulla metafisica» afferma che, con ciò che è successo,
la metafisica ha perso l’unificabilità del pensiero speculativo e il motivo dialettico
del trasformarsi da quantità in qualità. La morte, con l’assassinio burocratico di
milioni di persone, è diventata qualcosa che non era stata mai tanto da temere.
L’individuo viene spossessato dell’ultima e più preziosa, impagabile e unica cosa che
gli era rimasta: la vita. Nei campi di concentramento non moriva più l’individuo, ma
l’«esemplare umano», il cammino verso il quale si stava muovendo la storia era
l’indifferenza della vita di ogni singolo in un mondo la cui legge era disinteresse per
l’altro e vantaggio individuale universale.
Dopo Auschwitz vi è posto soltanto per un «pensiero di vigilanza», insonne, attento
capace di lasciarsi pro-vocare dai traumi della storia e dalle lacerazioni dell’umano
(esiste ormai una filosofia e teologia dell’olocausto, che cerca di muoversi secondo
queste nuove coordinate).
Il pensiero del filosofo francese, di appartenenza ebraica, Emmanuel Lévinas sorge
come modalità di risposta, più che di memoria e interrogativo. La testimonianza di
Lévinas si nutre della sua profonda sensibilità ai «traumi» della storia umana, agli
shock, allo sterminio, al genocidio da cui ha origine la filosofia come chiave di
risposta. Risposta alla pro-vocazione, alla chiamata, al bisogno che comunque e
dovunque mi perviene, mi giunge da un altro uomo. Lévinas, a seguito di una
complessa opera di analisi, è giunto alla constatazione che la violenza, la guerra e
ogni forma di usurpazione, nascono dal pensiero della totalità, della uni-identità, del
sistema, della sintesi egologica, dove l’altro si annulla identificandosi nel medesimo
attraverso un’operazione del sapere, sapere dell’essere che è «adeguazione»,
«alienazione», dove il risultato diventa un modo di essere, prima che di pensare
concettualmente saper essere. Pensare dopo Auschwitz può significare soltanto
un’inversione di questo modo, un altrimenti che essere, appunto, diverso dall’unitotalità dell’identificazione dell’identità dell’io a cui si sostituisce un pensiero
dell’Infinito, di un individuo come persona, nel senso giudaico-cristiano del termine.
Tutta l’opera di Lévinas può essere letta come il tentativo di articolare questo «nuovo
pensiero», sempre in cammino, sempre frammentario, fortemente refrattario ad ogni
chiusura sistematizzante e identificante. Il suo è un pensiero nomade, che cerca una
verità nomade: Adamo a confronto di Ulisse (al mito di Ulisse che ritorna ad Itaca si
vuole contrapporre la storia diAbramo che lascia per sempre la sua patria per una
terra ancora sconosciuta e che proibisce al suo servo di ricondurre perfino suo figlio a
quel punto di partenza). L’evasione non è sinonimo di fuga, di disimpegno, di
allontanamento, di evasività; ma indica il bisogno «aver ragione dell’essere», uscire
dall’essere, senza ancora sapere come, senza ancora sapere verso dove:
semplicemente uscire. L’evasione è allora il bisogno di uscire da se stessi, cioè che
l’io è se stesso. Uscire dall’essere significa quindi uscire dalla propria identità di una
visione egologica. La risonanza che questa affermazione ha sulla bocca un
«greco»non è la stessa che evoca se pronunciata da un «ebreo». Il deserto, l’esodo, il
passaggio, la separazione sono categorie quasi totalmente assenti nel pensiero
identificante del primato del Logos.
La maggior parte dei titoli delle opere di Lévinas, per quasi sempre «raccolte di
saggi», indicano un dinamismo che è poi imperativo: evadere! Nuovo imperativo
etico del soggetto che, evadendo dai «buchi dell’essere», sfuggendo al neutro,
spaventoso e anonimo, al conformarsi con l’ordinario, giunge all’esistente;
liberandosi dalla totalità si scopre «pensiero che pensa più di quanto pensi» nell’idea
dell’Infinito. Il soggetto, così, sradicato dall’essenza, si ritrova senza fondamento e
quindi non più un principio anarchico, ma si scopre al volto dell’altro che chiama e
significa «nella responsabilità-per-l’altro». Da qui ha inizio il cammino filosofico di
Lévinas, le analisi che egli prospetta a primo impatto affascinanti, suggestive e
coinvolgenti, sono invece estremamente complesse, difficili, dure, mai
immediatamente evidenti e tendono continuamente alla destrutturazione fin nello
stesso linguaggio adoperato della «venerabile tradizione filosofica» dell’Occidente.
Non è stato autore di grandi citazioni, ma certamente di grandi pensieri e ciò
costituisce la sua grandezza. In occasione del conferimento del suo dottorato,
rispondendo ad alcune domande, Lévinas ebbe da dichiarare: «La mia
preoccupazione è proprio di tradurre il non ellenismo della Bibbia in termini ellenici
e non di ripetere le formule bibliche nel loro senso ovvio…Non c’è nulla da fare: la
filosofia si parla in greco. Ma non bisogna pensare che il linguaggio modelli il senso.
La lingua greca – la lingua secondo la sintassi – permette probabilmente di presentare
il senso». Scrivere e parlare in greco, pensando in ebraico. Potremmo dire che
Lévinas "legge" l’identità dell’essere, il primato dell’ontologia, l’uni-totalità di
essere e pensiero, il primato della soggettività e della sua tematizzazione di
comprendente con l’ottica dell’esodo. Guardare Ulisse con gli occhi di Abramo
significa scoprire che Itaca non è la "patria" ritrovata, e soprattutto che la «terra
promessa» non appartiene al dominio, che è poi predominio, della comprensione e
del sapere come ricordo e come ritorno.La «terra promessa»è al di là di Itaca, è un
luogo sempre al di là, un non-luogo. Il solo modo autentico di pensare Lévinas nelle
sue opere è quello di pensare-con lui per pensare-oltre cercando di afferrarlo dentro
un discorso "coerente", da suscitare il desiderio di un incontro faccia-a-faccia per
tradurre l’esperienza di pensiero che ne deriva in una esperienza di vita, in una
conversione che è ciò che conta quando i termini in gioco sono soggettività e infinito.
Non tuttavia conversione come ritorno in sé, bensì come uscita da sé verso l’altro,
verso l’estraneo che è colui che ci viene incontro per primo. Abram diviene Abraham
e si mette in cammino verso l’ignoto della «terra promessa».
Lévinas guarda volentieri a tre momenti della storia del pensiero occidentale che
ritornano continuamente nel suo scrivere: l’idea del Bene al di là dell’idea dell’Essere
di Platone; l’assolutezza dell’Uno di Plotino; l’idea dell’Infinito Descartes. Questi
momenti vengono intesi come emergenze di disequazioni, ricerca di valori
all’interno del pensiero totalizzante, come elemento di rottura di un equilibrio che si
voleva definitivo.
Lévinas e l’ebraismo
Forse è improprio parlare di ebraismo, trattandosi di una situazione esistenziale,
prima ancora che di una cultura o di una religione. Situazione che si identifica con la
condizione della diaspora, tanto che si è potuto parlare di «concetto trascendentale
della diaspora», di una cultura che si trova unita nella dispersione. La presenza
ebraica è una non-presenza, è esodo, separazione, nomadismo ed insieme
consapevolezza di elezione, come è evidente. L’ebraismo in questo senso è la
negazione della filosofia, come vincolo al sapere o anche sapere che guida una
condotta morale. L’ebreo sa che la Torah è «prima del sapere» che è fonte di senso
etico ed esistenziale. L’ebraismo allora più che una filosofia è un’esperienza che
ispira una particolare forma mentis, esperienza esistenziale che è però insieme
culturale e storica. E’ probabilmente sintomatica la solida presenza dell’ebreo nella
cultura contemporanea; sintomo del bisogno di recuperare una matrice della nostra
civiltà, perduta o per lo più latente. Spesso emerge un’umanità lacerata che è
certamente l’indice di una particolare sensibilità a cogliere le assenze, le debolezze e
la fragilità dell’umano. Bisogna riscoprire un modo diverso di porsi di fronte
all’uomo e al mondo. Il senso di creaturalità è essenziale all’ebreo, assente nella
teoresi greca, mentre è relazione dialogica di figliolanza nella tradizione cristiana.
Per l’ebreo è la pienezza del senso, cosa che suggerisce una radicale eteronomia,
dipendere dall’altro, creaturalità. La nozione di creazione, e quella conseguente di
creaturalità, porta con sé quello di separazione e di alterità. Il rapporto con Dio si
esplica a tre livelli diversi e complementari: il rapporto tra Dio e mondo è creazione,
tra Dio e l’uomo è rivelazione, tra uomo e mondo è redenzione. Nella concezione
ebraica, Dio, l’unico Dio, «dà dei comandamenti che sono validi come leggi per tutti
gli uomini a cui è dovuta l’obbedienza. Dio non può rimanere isolato nel suo Olimpo,
ma come creatore dell’uomo e di tutta la terra deve rivelare, prescrivere i suoi
comandamenti all’uomo come leggi per la loro vita. Il comandamento è un ordine
isolato, la legge, invece, intende essere valida come fondazione del mondo morale.
La legge perciò è preminentemente chiamata insegnamento; essa non è un ordine
soggettivo, ma un’istruzione teoretica che può perciò diventare un dovere per l’uomo,
dove il solo punto di referenza della legge è l’uomo stesso. Tuttavia, la legge non si
riferisce mai all’essere di Dio e altrettanto poco diviene un simbolo per la
deificazione della natura. Soltanto l’uomo è l’oggetto e lo scopo della natura, egli non
diverrebbe Dio, ma dovrebbe divenire e rimanere sempre più uomo». Questo passo di
Cohen (Religion of Reason), dove si avverte l’influenza del pensiero kantiano,
potrebbe essere sottoscritto anche da Lévinas, che considera l’autentico pensiero
ebraico in termini di primato della morale. Questo primato però non è né nel senso di
una filosofia né in quello di una teologia, ma è come un legare, stringere un legame
tra Dio e l’uomo. La relazione etica è relazione religiosa e in questo senso
«contrariamente alla filosofia che fa di se-stessa l’ingresso del regno dell’assoluto, il
giudaismo ci insegna una trascendenza reale, una relazione dell’anima con colui che
l’anima non può contenere e senza il quale essa non può, in qualche modo, restare se
stessa». Nella concezione ebraica l’individuo si definisce come io soltanto per la
relazione che lo lega a un tu, l’io è io nella e per la relazione sociale. Lévinas sostiene
che la relazione morale è coscienza di sé e coscienza di Dio, l’etica non è il corollario
della visione di Dio, è questa visione stessa. L’etica è un’ottica che deve trovare
un’espressione etica, cioè la «via che conduce verso Dio, conduce ipso facto verso
l’uomo». Questo andare verso l’uomo è la responsabilità personale che neppure Dio
può annullare e che il rapporto con il divino attraversi il rapporto con gli uomini e
coincida con la giustizia sociale, ecco tutto lo spirito della Bibbia ebraica. Mosè e i
profeti non si preoccupano dell’immortalità dell’anima, ma del povero e della
vedova, dell’orfano e dello straniero. Il rapporto con l’uomo dove si realizza il
contatto con il divino, non è una semplice relazione di amicizia spirituale, ma dove si
manifesta, si prova e si realizza in una economia giusta e di cui ogni uomo è
pienamente responsabile. Questa responsabilità, iscrivendosi nella giustizia, appare
come un rapporto assoluto. La coscienza della giustizia è per l’ebreo nel contesto
veterotestamentario sia come sinonimo stesso di Dio, sia come sinonimo del giusto,
dell’uomo che teme Dio, dove il timore di Dio è la paura di allontanarsi da Dio. Il
termine ebraico che definisce la giustizia è lo stesso che significa rettitudine e santità,
così, come la «rettitudine morale» del volto (la giustizia) di Lévinas ha qui la sua
chiarificazione concettuale e la sua contestualizzazione più veritiera.
Autonomia o eteronomia etica
L’eteronomia è stata considerata dalla filosofia nel senso negativo, come dipendenza,
mancanza di libertà e quindi possibilità di scelta, da cui discenderebbe una
impossibilità di valutazione positiva dell’atteggiamento morale. Presupposto
ineliminabile dell’etica è sempre stato considerato un fondamento metafisico da cui
fosse possibile dedurre e quindi giustificare la norma di un comportamento pratico.
La nozione di autonomia si è sviluppata nel tempo come soggettività,
autodeterminazione, libertà, umanità, come capace di darsi delle norme universali da
parte dell’uomo. Un cambiamento si ha con l’avvento della centralità del cogito, dove
l’autonomia si trasforma in egonomia. La fondazione di tipo metafisico o teologico
garantiva infatti una normativa da cui derivano le regole del comportamento pratico.
Ma nel momento in cui si scopre che la metafisica è un campo di lotte senza fine,
come afferma Kant, che cioè la metafisica non è più gnoseologicamente significante
se non come ideale regolativo e che l’io trascendentale è il «legislatore universale».
Le espressioni più autorevolial riguardo possiamo trovarle nello stesso Kant, ma per
altri versi in Hegel e implicitamente in Husserl, da cui muove, come è noto, la
cosiddetta «etica materiale dei valori» di Scheler. L’auto-riflessione e la
responsabilità che esprimono l’autodeterminazione teoretica dell’ego trascendentale
in Husserl, si rivelano come immediato richiamo della normativa pratica che Kant ha
tematizzato nella Critica della Ragion pratica e soprattutto nella Fondazione della
metafisica dei costumi, dove egli, dopo aver presentato le varie formulazioni delle
massime, scrive: «L’autonomia della volontà è quella sua costituzione per la quale
essa è legge a se stessa (indipendentemente da ogni qualità dei suoi oggetti). Il
principio dell’autonomia è dunque: non scegliere in modo che le massime della scelta
siano, nello stesso volere, concepite anche come legge universale. Che questa regola
pratica sia un imperativo categorico (tu devi), che cioè ad essa come condizione sia
necessariamente legata la volontà di ogni essere ragionevole in sé e che detto
principio dell’autonomia sia l’unico principio della morale,da cui si può benissimo
dimostrare con la semplice analisi dei concetti della moralità» (Fondazione della
metafisica dei costumi).
L’uomo nella sua accezione di soggetto trascendentale, l’umanità come razionalità, è
il legislatore universale. Autos-nomos, colui che detta legge a se stesso, che è legge a
se stesso. Il fondamento di questo dato primario sta nella formulazione del principio
di identità come autocoscienza che è hegelianamente libertà, libertà morale o libertà
etica. Per la prima volta Hegel scrive: «Il volere soggettivo è moralmente libero in
quanto queste determinazioni vengono poste interiormente come le sue, e volute da
esso. La sua manifestazione effettiva, con questa libertà, è azione; nella cui esteriorità
essa riconosce come suo, e si lascia imputare, solo quel tanto che ha saputo in sé ed
ha voluto». Questa libertà soggettiva o morale è soprattutto quella che si chiama, nel
significato europeo: libertà. A motivazione del diritto alla libertà, l’uomo deve
possedere propriamente una conoscenza della differenza del bene e del male in
genere: le determinazioni etiche, come le religiose, non debbono esigere di essere
eseguite solo come leggi esterne e precetti di un’autorità; ma debbono avere adesione,
riconoscimento o anche fondamento nel suo cuore, nella sua disposizione d’animo,
nella sua coscienza e intelligenza. La soggettività del volere in se stesso è scopo a sé;
ed è un momento assolutamente essenziale. La libertà vera è, in quanto eticità,
questo: che il voler non ha per suoi scopi un contenuto soggettivo, cioè egoistico, ma
scopo ultimo è riempirsi del suo concetto,cioè fare della libertà la sua determinatezza,
dominio di sé, sostanza propria dell’esistenza, ossia contenuto universale. Una
impostazione di carattere fenomenologico, dove il valore assume una valenza eidetica
per tradurli in una pragmatica. La nozione accomunante di queste diverse posizioni è
quella di coscienza trascendentale, ma in un orizzonte di una relazione che giustifica
il «diritto» dell’alterità personale. Si comincia a parlare di azione morale come azione
transitiva, dove il senso dell’agire morale e dei soggetti corporalmente incarnati, non
sono più ricondotti all’assoluta e pura sfera trascendentale, ma il potere
dell’autocoscienza trema davanti all’altro da sé. Si pensi alle suggestive pagine della
Fenomenologia dello Spirito di Hegel dedicate alla didattica servo-padrone, dove
l’indipendenza è dipendenza e viceversa, dove il tema centrale è il «riconoscimento».
Abbiamo visto come Lévinas articola la propria posizione capovolgendo il primato
della coscienza e di conseguenza dell’autonomia etica. Il suo discorso sembra
urgente, soprattutto per le ansie e le difficoltà dell’uomo contemporaneo. La sua
risposta metafisica si situa nella crisi della metafisica, ma soprattutto in quella che
dopo Nietzsche e Freud (e Lacan) siamo abituati a chiamare, a considerare crisi (o
fine?) della soggettività. L’analisi accurata del soggetto, antecedente e al di là del
soggetto, ha rimosso e deposto il re Io a cui, in fondo, era comodo obbedire. Il
problema dell’alteritàera divenuto ossessivo negli ultimi decenni: sorgeva dalla
necessità teoretica di «giustificare» l’esistenza prima e la presenza poi di un altro da
me. Ciò implica una revisione totale dell’abituale e del consueto modo di pensare, di
porre e di porsi nel rapporto umano nella dimensione etico-morale, relazionaleaffettiva, politico-sociale. Reinventare la politica, l’economia, la società in una
nuova ottica e un nuovo programma.
Dall’etica della responsabilità all’etica come responsabilità
Lévinas orientando la sua indagine sulla soggettività come passività la coglie come
responsabilità per l’altro, dove questa responsabilità per l’altro uomo o l’altro nel
medesimo è la definizione stessa della soggettività. La responsabilità della comune
accezione del termine nasce dall’identità di un soggetto coinvolto in particolari
situazioni e a cui, dopo la presa di coscienza, deve dare una risposta adeguata in
termini di azione. Questo dinamismo caratteristico e peculiare, costituisce
l’autonomia del soggetto morale: autonomia che è fondata su una precisa costituzione
ontologica e del soggetto e del reale, dove l’etica è una conseguenza.
L’ontologia, con il suo primato anonimo, ha generato violenza e disumanità, questo
l’approccio critico; per ritrovare l’uomo occorre uscire dall’essere e, invertendo i
termini, porre la relazione etica come relazione (correlata) originaria. L’etica è la
filosofia prima, è metafisica, è l’ottica per eccellenza, in cui l’alterità dell’altro non è
risultante come alter ego a cui viene assegnato un valore di umanità per analogia, ma
è l’originarietà che non«fonda», bensì «ordina» la moralità.
L’etica della responsabilità si pone come valutazione, l’etica come responsabilità è
giustificazione; l’una è richiesta di valore, l’altra esigenza di giustizia e di santità.
Ordinare alla moralità significa eteronomia, ma non alienazione, bensì obbedienza
alla trascendenza dell’ordine che mi parla attraverso l’altro.Naturalmente dietro
queste affermazioni c’è tutta la complessità del capovolgimento dell’opera di
Lévinas, non essendo abituati a pensare in questi termini. Infatti, mentre nell’etica
della responsabilità c’è ancora la centralità dell’identità dell’io (Ingarden) portatore
della responsabilità, nell’etica come responsabilità è presente il senso di
irrecusabilità, di incontestabilità che rende il soggetto secondario nella sua
primogenitura di «eletto»: paradosso metafisico. L’etica della responsabilità può
ancora prescindere dal riferimento metafisico, potendosi fondare sulla nozione
trascendentale di «umanità»; l’etica come responsabilità invece è metafisica, poiché
la responsabilità è radicata (pur producendo sradicamento) nella creaturalità ed è la
continua e crescente insoddisfazione e inadeguazione di fronte all’idea del Bene
inattingibile e trascendente. Operare il bene significa ampliare il desiderio di bontà
che è «esigenza di santità».
Franz Rosenzweig: il «nuovo pensiero»
L’espressione «nuovo pensiero» è di Franz Rosenzweig, che scrive: «Mentre il
pensiero tradizionale si poneva il problema di sapere se Dio è trascendente o
immanente, il nuovo pensiero si sforza di determinare in quale maniera e quando, da
lontano, Dio diviene vicino, e all’inverso, quando e come vicino, si allontana di
nuovo. Mentre la filosofia tradizionale pone l’alternativa determinismo o
indeterminismocon una specifica indagine dell’essenza, e non richiede che risposte
tautologiche, di ragionamento: Dio è soltanto divino, l’uomo umano, il
mondomondano. Il nuovo pensiero segue il cammino dell’azione, partendo dalle
determinazioni del carattere, dalla situazione delle cause e dei moventi che generano
grovigli, accompagnato da un momento di grazia, luminoso e unico, in cui avviene la
scelta, per sfociare su una necessità situata al di là di ogni libertà. La nuova filosofia
qui non fa niente di meno che erigere il metodo del senso comunerispetto al metodo
del pensiero rigoroso. La filosofia tradizionale, cioè la filosofia dello "stupore
filosofico" – stupirsi significa meraviglia, essere pietrificato, fissità – pianta le sue
fondamenta in un oggetto che non si vuole lasciare finché non sia stato pienamente
contemplato. Il segreto che costituisce tutto il sapere della nuova filosofia è il buon
senso il quale sa guardare oltre, sa continuare a vivere, non ha pretese, non ha "idee
fisse", sa che tutto arriva al momento dovuto per chi sa attendere.»
Rosenzweig affronta la questione dell’essenza di Dio, dell’uomo e del mondo i quali
non rivelano mai altro che se stessi; ciò vale per ciascuno di essi nella stessa misura.
Il concetto di Dio non gode, come si potrebbe credere, di una posizione particolare, in
quanto concetto non è meno inaccessibile del concetto di uomo o di mondo. Al
contrario: l’essenza dell’uomo e quella del mondo, non sono più facilmente
accessibili dell’essenza – l’essenza! – di Dio. Ne sappiamo altrettanto su ciascuna di
esse, cioè molto poco, tutto e niente contemporaneamente. Grazie al sapere intuitivo
della nostra esperienza, sappiamo nella maniera più precisa ciò che propriamente
"sono" Dio, l’uomo e il mondo. Se non lo sapessimo come potremmo parlarne e come
potremmo, due a due,"ridurli" l’uno all’altro oppure contestare ogni volta le due altre
possibilità di "riduzione"! Ma ignoriamo totalmente ciò che Dio, il mondo e l’uomo
potrebbero essere di diverso.
Al contrario, in quanto entità Dio, il mondo e l’uomo sono ugualmente trascendenti
l’uno rispetto all’altro ed è impossibile dire che cosa "sono" le loro realtà, si può
soltanto "raccontarli". La filosofia come racconto, è un approdo importante che egli
recupera dalle posiziono dell’ultimo Schelling. Nell’orizzonte del "nuovo pensiero",
e si guardi la filosofia di Rosenzweig comincia ad essere studiata solo ora, nonostante
la sua luminosità ispiratrice. Il "nuovo pensiero" ha presupposti in Feuerbach,
Nietzsche, e in particolare in Kierkegaard. Più vicini a noi possiamo far rientrare in
questa orbita Jaspers, Marcel o Heschel e tutte quelle filosofie dell’uomo, in
particolare di ispirazione personalistica, che nel Novecento hanno fatto proprie le
parole di Ebner: «Dobbiamo imparare a dire certe parole soltanto in senso profondo e
attraverso la vita. Per esempio: con Dio noi uomini non possiamo dare gioia a Dio;
noi, possiamo e dobbiamo, invece, recare gioia all’altro uomo e così farlo uomo con
noi. E allora la gioia per la gioia dell’altro è la gioia che Dio c’è».
Lévinas pensa indubbiamente sulla scia di Rosenzweig e del nuovo pensiero, come
egli stesso riconosce. Da questo punto di vista teoretico il percorso è ancora più
affascinante e può essere descritto con una densa trattazione di Rosenzweig che
anticipa Lévinas. «Generalmente – scrive Rosenzweig – si crede di poter conoscere le
cose ultime in modo intemporale. Ciò che Dio ha fatto, che fa, che farà; ciò che è
successo al mondo e ciò che succederà; ciò che accade all’uomo, ciò che farà – niente
di tutto ciò può essere dato dalla sua temporalità in modo che si possa conoscere, per
esempio, il regno di Dio a venire, a guardare lo stesso modo la creazione e il Regno
futuro. I momenti della realtà non possono essere confusi; come la realtà nel suo
insieme, ogni avvenimento singolare ha il suo presente, il suo passato e il suo
avvenire senza i quali esso non potrebbe essere conosciuto o lo sarebbe solo in modo
distorto. Anche la realtà ha un passato, un avvenire – un passato perpetuo e un
avvenire eterno. Conoscere Dio, il mondo e l’uomo, significa comprendere le loro
azioni nel corso di questi momenti della realtà o conoscere ciò che succede loro, le
loro azioni l’uno verso l’altro, cosa succede all’uno a causa dell’altro. Si propone qui
che il loro "essere" è distinto, senza di che non potrebbero agire l’uno sull’altro; se
l’altro fosse "fondamentalmente" identico a me, io non potrei amarlo, amerei soltanto
me. Se Dio fosse in me o se fosse che il mio io superioreciò non sarebbe soltanto una
formulazione inutilmente oscura di un rapporto per altro chiarissimo; ma
implicherebbe che questo Dio difficilmente avrebbe qualcosa da dirmi, poiché io so
già ciò che il mio io superiore vuole comunicarmi. E se un uomo fosse divino, la via
che conduce a Dio, aperta ad ogni uomo, gli sarebbe chiusa. Ecco perché è
importante presupporre una separazione dell’"essere". In seno alla realtà, la sola di
cui noi abbiamo esperienza, questa separazione è realizzata e tutto ciò di cui noi
facciamo esperienza, non è che esperienza di simili congiunzioni. Dio stesso si
nasconde quando vogliamo comprenderlo, l’uomo, il nostro io si chiudono, il mondo
diviene visibile enigma. Dio, l’uomo e il mondo si palesano soltanto nelle loro
relazioni: nella creazione, la rivelazione, la redenzione» (citazione dalla traduzione
francese di DasNeueDenken, in AA. VV., Franz Rosenzweig, Paris 1982, pp. 45-50).
Tempo e temporalità
I termini "creazione, rivelazione e redenzione" costituiscono la temporalizzazione del
tempo; siamo di fronte a una trasformazione del tempo che nasce dal rovesciamento
della struttura intenzionale della soggettività.
Intenzionalità e tempo, come Husserl ha insegnato, sono interdipendenti, diventano
una correlazione costante di ogni filosofia rappresentativa, che fa necessariamente
della rappresentazione anche una ripresentazione. Il tempo è una struttura formaletrascendentale, a priori (Kant), necessario come tessuto connettivo dell’esperienza.
Fin dalla descrizione agostiniana nelle Confessioni, in cui il tempo è stato misurato
come intentio, come coscienza del tempo, coscienza del presente o coscienza presente
e presentificante: Lebendige Gegenwart (Husserl).
Per Lévinas il tempo è "la relazione stessa del soggetto con altri" e non più fatto di un
soggetto isolato. Il tempo è la trascendenza come la trascendenza è il tempo. E’
presente una radicale storicità che caratterizza il pensiero ebraico per il quale Dio o la
trascendenza è un "Dio che passa", che si può vedere soltanto in quanto passato,
assolto. La concezione del tempo a cui siamo abituati è legata alla strutturazione di
una coscienza soggettiva che dà il tempo ai"propri vissuti". Se scompare questa
soggettività, come in Lévinas, salta la concezione del tempo come possibilità della
rappresentazione e si manifesta invece la "pazienza" del tempo (che non è la durata di
Bergson), ma l’attesa obbediente, il tempo messianico, di chi nega l’infinità del
tempo, in nome del suo compimento. Neanche l’essere-per-la-morte di Heidegger,
come possibilità ultima di tutte le possibilità, può definire il tempo, perché la morte
non si avvicina come una(la) fine d’essere, ma come un’incognita che in quanto tale
sospende il potere e diventa il fine. La costituzione dell’intervallo che libera l’essere
dalla limitazione del destino richiede la morte; il niente dell’intervallo-un tempo
morto-è la produzione dell’infinito. La risurrezione costituisce l’evento principale del
tempo, non c’è quindi continuità nell’essere: il tempo è discontinuo, un istante non
esce dall’altro senza interruzione, un’estasi. L’istante nella sua continuazione trova
una morte e risuscita: morte e risurrezione costituiscono il tempo. Certamente, una
struttura formale di questo tipo presuppone la relazione dell’Io con Altri e, alla sua
base, la fecondità attraverso il discontinuo che costituisce il tempo. Discontinuità del
tempo, quindi, e rivalutazione dell’istante ( si veda in proposito l’ipostasi) che
Cartesio ritrova sulla sua strada.Come si può osservare già da queste affermazioni, il
tema del tempo è uno dei più complessi e intrigati del filosofare levinasiano e forse,
più in generale, è uno dei nodi del pensiero contemporaneo. In questa prospettiva si
potrebbero leggere le opere di Husserl, Heidegger, Bergson, Sartre e di altri ancora,
come altrettanti modi di caratterizzare il tempo e la temporalità dell’uomo. Per
contrapposizione, si potrebbe leggere Rosenzweig come un primo tentativo di
destrutturare, scomporre il tempo per cogliere la "temporalitàcome evento" che non si
inserisce nella continuità del tempo, ma che invece lo qualifica specificandolo.
Essere e Dio, ovvero Dio senza l’essere
Questa proposta di ricerca va vista in connessione e quasi come compimento delle
ultime due: Il nuovo pensiero e Tempo e temporalità. Questi temi risultano essere
impegnativi e di grande complessità, le cui ricerche sono divenute le più avvincenti e
più decisive per il futuro della filosofia. Fin da Parmenide, pensare ha significato
pensare l’essere, ma ora la domanda implicita è, si può pensare a Dio? Cogliamo
veramente Dio quando ne facciamo il principio dell’analogia dell’essere? O, invece,
al massimo approdiamo a un "concetto" di Dio che in quanto concetto è ancora
nell’immanenza? Dopo il nichilismo quali possono essere le alternative per la
"pensabilità" di Dio? Fenomenologicamente una teleologia della ragione e della storia
che, proprio in quanto teleologia, "manifesta" soltanto l’irraggiungibile?
In questa luce allora non si tratta più di pensare, ma di esperire. L’esperienza di Dio,
dove il genitivo si carica della duplice valenza di soggetti e oggettivo, è però meno
problematica della sua pensabilità? L’esperienza indica sempre il movimento di un
soggetto a un’alterità, che presuppone la temporalità della rappresentazione,
dell’intenzionalità. Come assicurare a Dio la sua trascendenza? Ma questa domanda è
ancora equivoca, poiché non siamo noi che assicuriamo Dio, semmai il contrario.
Nell’orizzonte della differenza ontologica di Heidegger, riusciamo a muoverci più
agevolmente o, in fondo, ancheil movimento di questa è circolare?
L’approccio a Dio deve e può muovere, soltanto dalla presa di coscienza, crisi della
stessa presa di coscienza, circa la dimostrabilità di Dio. Provare Dio è la tentazione
dell’uomo radicato nell’autosufficienza del suo mondo e del suo sapere. Dio è l’aldilà
della prova e della dimostrazione. Quando siamo sicuri di averlo dimostrato,
indicato, compreso, lo abbiamo in realtà già perso. E ciò non per uno sterile
scetticismo nominalistico , ma proprio perché cogliamo il vuoto di un’essenza a
discapito di un Nome. La denominazione è più complessa della dimostrazione.
Quest’ultima si svolge nel solipsismo del sapere, l’altra instaura una dialogicità che
non è pura e semplice relazione. Forse è questo il senso del comandamento biblico
"non nominare il nome di Dio invano". Ma che significa "nominare Dio"? Viene qui
in mente l’esperienza di Cratilo che non è in grado di nominare il fiume in cui è
immerso e che scorre, raccordandola con quella di Mosè descritta nel libro
dell’Esodo, dove Dio è quando non è più. L’assolutezza di Dio è la sua assoluzione,
ma questa assoluzione non è la neutralità assoluta dell’Atto puro aristotelico o la
stessa idea del Bene platonica, bensì preoccupazione di Dio per l’uomo, «Adamo
dove sei?», «Caino dov’è tuo fratello Abele?», dove poi risuona la parola di Cristo
riferita da Giovanni «se non amate i fratelli che vedete, come potete amare Dio che
non vedete?». Siamo però di fronte a uno spostamento di piani che filosoficamente è
ancora tutto da pensare. Una tentazione e una sfida: pensare filosoficamente Dio a
partire dall’escatologia, dove il compimento del senso si carica del peso dell’esercizio
di una responsabilità. Forse saremo meno preoccupati a dimostrare Dio e più solleciti
verso il «povero, l’orfano, la vedova »; meno loquaci e più giusti. Nella
responsabilità, nell’amore della prossimità, nella giustizia, Dio manifesterà il suo
volto che è poi il senso totale dell’uomo. Oggi il richiamo alla prossimità, come
origine della giustizia, può apparire anacronistico; ma in realtà la richiesta di bontà è
attualmente così prepotente che ci costringe non a ripensare, ma a pensare per la
prima volta un pensiero della pace che è ancora tutto da inventare: una «filosofia
della pace». La pace a partire dunque dalla verità, dalla verità di un sapere dove ciò
che è diverso invece di opporsi si accorda o si unisce, dove l’estraneo si assimila e
l’altro si concilia con l’identico. La pace dunque come ritorno del molteplice all’unità
si conforma all’idea platonica o neoplatonica dell’uomo. La pace a partire dalla verità
che, meraviglia delle meraviglie, comanda gli uomini senza forzarli né combatterli,
che li governa, che li assembla, senza però asservirli. Questa storia di una pace, di
una libertà e di un benessere promesso, che un sapere universale potrebbe proiettare
sul mondo e sulla società stessa e persino sui messaggi religiosi che cercavano auto
giustificazioni in quelle verità del sapere. Questa storia non si riconosce nei due
millenni di lotta fratricida politica e sanguinaria, di imperialismo, di disprezzo
umano, di sfruttamento sino al nostro secolo con le guerre mondiali, il genocidio,
l’olocausto ed il terrorismo, della disoccupazione e della miseria, della miseria
continua del terzo mondo, delle dottrine senza pietà e delle crudeltà del fascismo e di
un nazionalsocialismo e persino nel supremo paradosso del nostro secolo dove la
difesa dell’uomo e dei suoi diritti si rovesciò in stalinismo. La questione è politica,
ma di una politica che per essere mutata ha bisogno di un radicale capovolgimento
che prima che politico è culturale e soprattutto etico. Una cultura della pace deve
rimuovere i presupposti totalitari, perfino quelli impliciti nella nozione stessa di
pluralismo. Lévinas forza a mettere in discussione questa nozione di pace che è poi
quella che oggi viviamo come equilibrio. E’ compito urgente uscire da queste
categorie per ricominciare a pensare l’altro, il diverso, l’altra cultura o polis, in
termini di alterità, cioè salvaguardare la stessa alterità dell’altro. Pensare la pace
come punto di partenza e non più come risultato di una politica o di una cultura.