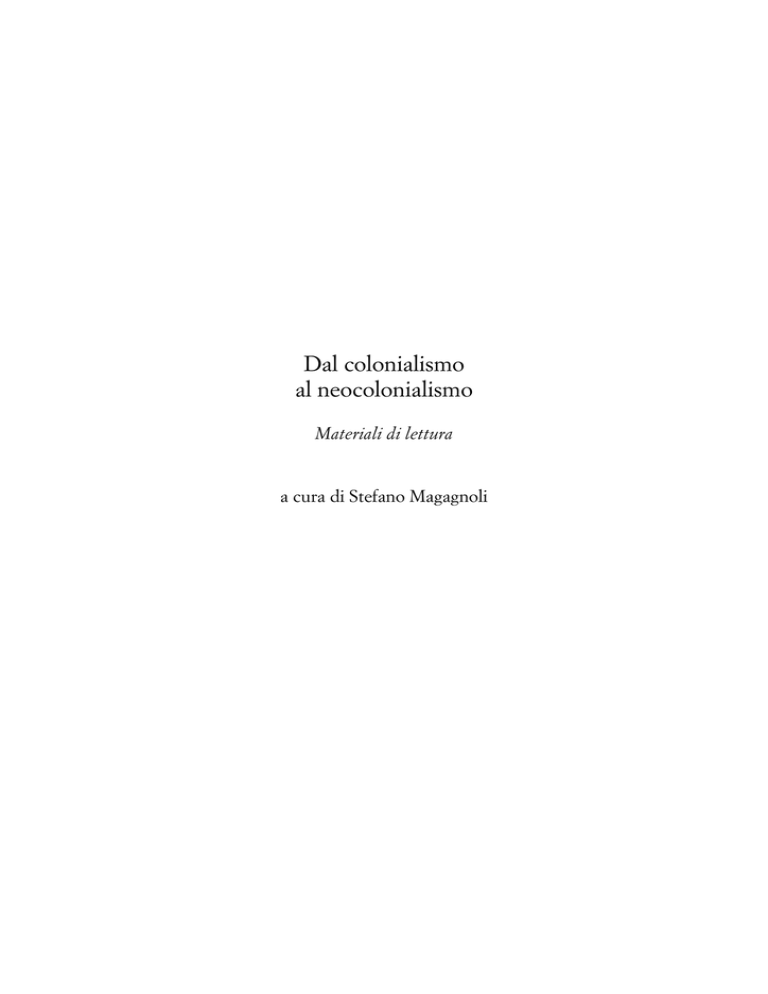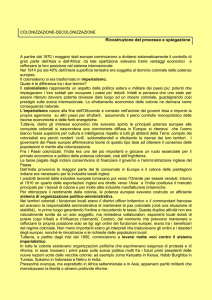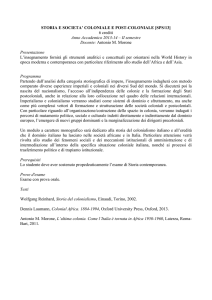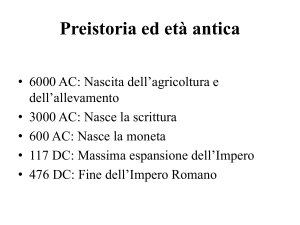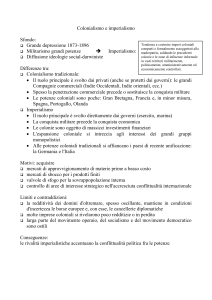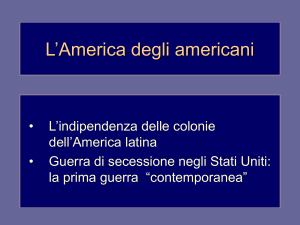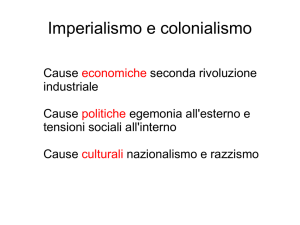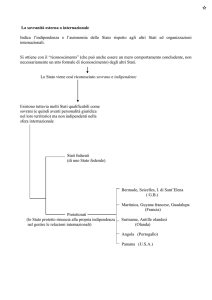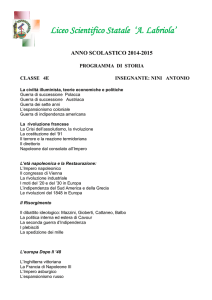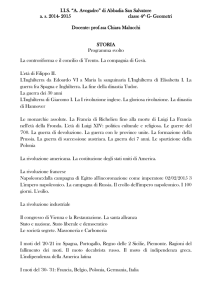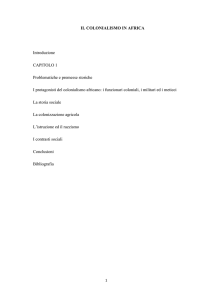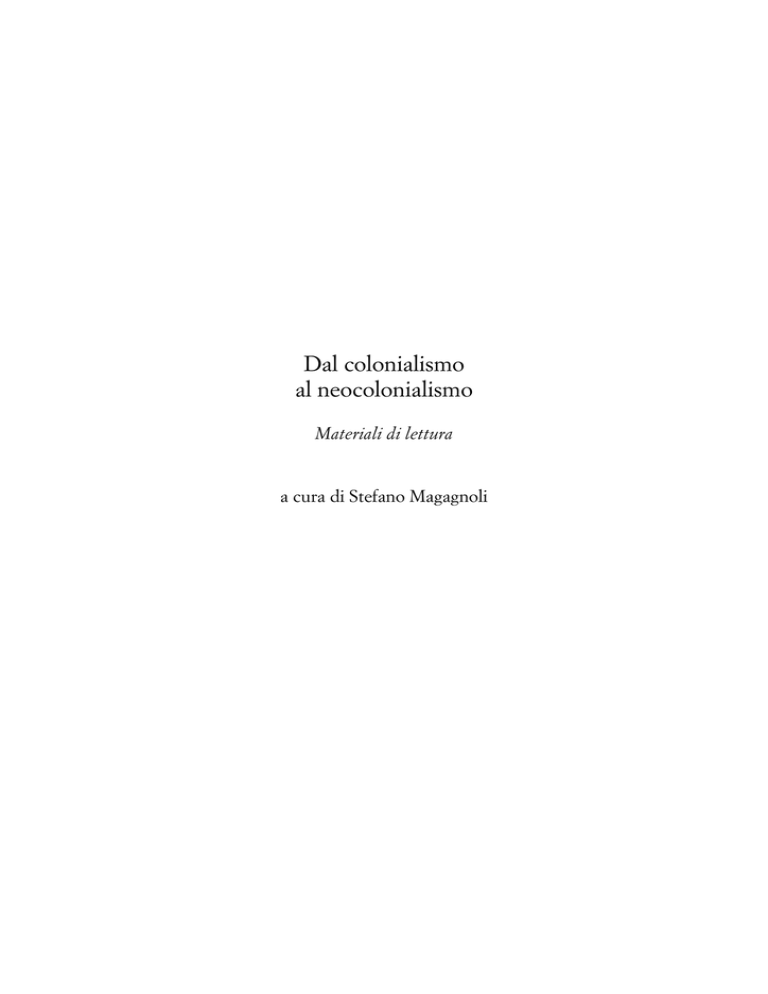
Dal colonialismo
al neocolonialismo
Materiali di lettura
a cura di Stefano Magagnoli
1.
Il colonialismo
Che cos’è il colonialismo?
Il concetto di “colonialismo” – spesso associato a quello di “imperialismo” – ha conosciuto
una stagione politica in cui si è sovraccaricato di valenze connotative (prevalentemente
negative), divenendo spesso uno slogan della lotta sociale e politica.
Più propriamente – ma non per questo senza implicazioni valutative – il concetto di
“colonialismo” sta a indicare il dominio esercitato da una nazione su un’altra nazione (o di
un popolo su un altro popolo) mediante lo sfruttamento economico, politico e ideologico
del differente grado di sviluppo esistente tra le due.
Il concetto di “imperialismo” (che vi è strettamente connesso) è riconducibile a due
interpretazioni: una più ristretta (d’impronta marxista-leninista) che definisce dai primi anni
del Novecento il presunto ultimo stadio del capitalismo, sull’orlo del suo disfacimento; una
più ampia che comprende tutte le forme di volontà espansionistica ed egemonica di una
data comunità.
Più concretamente, possiamo anche dire che il termine “imperialismo” rappresenta
l’estensione dinamica del concetto – in sé più statico – di “colonialismo”. Con
“imperialismo”, in questo senso, possiamo indicare tutte le iniziative che hanno l’obiettivo
di realizzare un rapporto di dominio coloniale.
All’interno di questo quadro concettuale assolutamente fondamentale è la definizione degli
elementi di estraneità e differente grado di sviluppo.
Per essere colonialista la dominazione deve essere percepita come estranea, perché, ad
esempio, sottolinea la differenza linguistica, culturale, razziale, ecc.
Tuttavia, non tutte le egemonie o i domini stranieri possono definirsi “colonialisti”: la
discriminante concettuale tra ciò che è dominio coloniale e ciò che non lo è, infatti, va
anche ricercata nell’esistenza – o meno – della categoria del differente grado di sviluppo.
L’utilizzo di questa chiave di lettura permette infatti di differenziare tra imperi coloniali
(esemplificati dai tipici rapporti tra Europa e Terzo Mondo) e non coloniali (ad esempio, la
dominazione russa sulla DDR nel secondo dopoguerra può essere attribuita a questa
seconda categoria).
Il concetto di differente grado di sviluppo va ovviamente utilizzato con grande cautela e
consapevolezza, giacché rischia di apparire, da un parte, come un’impostazione
sostanzialmente razzista, e dall’altra come una deformazione “eurocentrica” dell’ipotetica
esistenza di un’unica modalità di sviluppo.
È quindi necessario considerare questo concetto in modo assolutamente descrittivo
(necessario per descrivere le condizioni che si stanno analizzando), e rigorosamente
avalutativo (cioè astenendosi da giudizi di valutazione delle differenze).
In altre parole, l’utilizzo corretto di questo concetto esclude l’esistenza di un sentiero
obbligato per lo sviluppo dell’umanità (alla cui sommità troneggia l’Occidente cristiano),
così come nega che sia più “evoluto” e “pregevole” possedere le armi atomiche invece delle
asce o degli archi.
2
L’unica implicazione che deriva dalla definizione di simili differenti gradi di sviluppo è che
da essi discendano delle precise conseguenze storiche.
Il colonialismo trae i propri presupposti logici dai concetti di colonia e colonizzazione (di
derivazione romana). Il termine colonizzazione, in senso proprio, identifica semplicemente
il processo di fondazione di colonie, mentre con il termine colonia si indica la realizzazione
di un nuovo insediamento, che può essere realizzato sia autonomamente, sia sotto il
controllo del territorio d’origine dei coloni. In senso traslato, il termine colonia indica
invece qualsiasi possedimento separato dalla madrepatria, specie se si tratta di un
possedimento d’oltremare.
Il concetto di colonia è ovviamente molto esteso, e si articola in gradi diversi: da quello
minimo (insediamento o dominio) a quello massimo (insediamento e dominio, e anche
quest’ultimo concetto può distinguersi in differenti livelli).
Nell’esperienza storica si possono così determinare tre modelli fondamentali di colonia, a
loro volta soggetti a numerose varianti:
1. Colonie d’appoggio: hanno normalmente fini prevalentemente economici (commercio),
possono rispondere alla necessità di assicurare una presenza militare, o assolvere a entrambi
gli obiettivi. Si possono citare quali esempi le colonie commerciali dei mercanti italiani del
Medioevo nelle città del Levante; la rete mondiale di basi d’appoggio create dagli Inglesi; le
colonie commerciali create soprattutto dal Portogallo lungo le coste dell’Oceano Indiano.
2. Colonie d’insediamento: rappresenta il prototipo della colonia. Una quota crescente di
persone proveniente da altri territori “popola” un dato territorio. È un concetto antico,
biblico, ma che fa normalmente i conti col fatto che – al momento della fondazione delle
colonie, ad esempio in Asia, Oceania e America – ben poche terre erano “spopolate”, e che
nella maggioranza dei casi erano invece abitate da altre popolazioni, meno “sviluppate”,
costrette ad abbandonare le proprie terre, o a essere ridotte in schiavitù. Di norma sono
popolazioni di cacciatori, raccoglitori e nomadi che vengono scacciati dall’arrivo di
agricoltori stanziali, che impongono forme più avanzate di coltivazione della terra,
accompagnate dalla sanzione del diritto privato di proprietà. Esempi emblematici – che
hanno comportato l’allontanamento o il genocidio delle popolazioni indigene – è quello
inglese in Oceania e nel Nord America.
3. Domini coloniali: in questo caso la colonizzazione non è limitata all’acquisizione di basi
d’appoggio commerciali, ma si estende al controllo diretto dell’intero paese, senza tuttavia
nessun obiettivo di ripopolamento integrale. Tale tipologia – che caratterizza tutta la prima
fase della colonizzazione ispanica delle Americhe – rivela numerose analogie con il modello
coloniale d’insediamento: un gruppo numeroso di emigrati si insedia in modo permanente,
fondando però la propria esistenza sull’assoluto assoggettamento della maggioranza
indigena, cui viene lasciata la propria forma originaria di economia. Una delle principali
varianti di questo modello di dominio (caratteristica dell’India britannica) è rappresentato
dall’enorme squilibrio numerico tra i dominatori (pochi, e quasi mai residenti in
permanenza) e gli indigeni (che sono la preponderante maggioranza). In ogni caso,
l’efficace funzionamento di queste tipologie di colonialismo è reso possibile unicamente
dall’esistenza di una solida base di collaborazione da parte di elementi indigeni, che di solito
rappresentano l’élite sociale e culturale.
Nel XVI secolo, dopo la scoperta delle Americhe, iniziò la grande espansione degli europei
nel mondo e la formazione degli imperi coloniali. Furono dapprima gli Spagnoli, richiamati
3
dalle enormi quantità di minerali preziosi del Sud America, a fondare delle basi coloniali.
Distrussero i grandi imperi Inca, Maya e Azteco e resero schiave le popolazioni locali
impegnandole nell’estrazione di oro e argento di cui poi caricavano i loro galeoni diretti in
Europa, o utilizzandole come manodopera nelle grandi piantagioni. Olandesi, Portoghesi e
Inglesi avevano invece stabilito le loro basi in Asia, ma inizialmente si limitarono a rapporti
di tipo commerciale. L’America del Nord venne colonizzata prevalentemente da inglesi e
francesi che vi si stabilirono coltivando le terre e sfruttando le miniere. Dall’Africa
arrivavano invece gli schiavi: le navi negriere approdavano sulle coste africane e caricavano
migliaia e migliaia di persone, vendute come schiavi nelle grandi piantagioni americane.
Nel corso dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento gli Stati europei si erano
divisi il mondo: Inghilterra, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo e in minor misura
Belgio, Italia e Germania avevano occupato militarmente gran parte di quello che oggi
noi chiamiamo Terzo Mondo. Erano spinti da ambizioni di potenza, da una certa
pressione demografica interna, ma soprattutto dalla volontà di sfruttare le risorse
economiche delle colonie (minerali, prodotti agricoli, schiavi) e di trovare uno sbocco
alla sovrapproduzione manifatturiera creatasi nel frattempo in Europa.
Tutti i paesi che subirono la colonizzazione furono profondamente condizionati nel loro
sviluppo proprio perché la crescita economica rispondeva solo ai bisogni dei
colonizzatori. Vennero create piantagioni specializzate in prodotti come il caffè, il cacao
e il the, che erano richiesti in Europa, mentre per le colture di sussistenza delle
popolazioni locali vennero adibiti piccoli appezzamenti poco produttivi. L’artigianato
locale venne sottoposto alla dura concorrenza dei prodotti delle industrie europee e nel
giro di poco tempo andò scomparendo. Poco fu fatto per alleviare le pessime condizioni
di vita della stragrande maggioranza della popolazione, che anzi spesso peggiorarono: in
alcuni casi, come nell’America del Sud e del Nord, gran parte della popolazione fu
sterminata militarmente, o morì a causa dei maltrattamenti e di malattie infettive come il
morbillo e il vaiolo contro cui non aveva anticorpi.
Gli imperi coloniali incominciarono a sgretolarsi solo negli anni Venti del XX secolo,
ma gli ultimi atti di indipendenza risalgono a un periodo ancora più recente, che va
dagli anni Cinquanta ad oggi. Attualmente le colonie sono quasi tutte scomparse, ma
in molti di questi Paesi permane una forte dipendenza economica aggravata spesso
dalle prepotenze della nuova classe dirigente locale. Divenuti indipendenti si sono
infatti trovati di fronte al compito di promuovere il proprio sviluppo economico e,
non avendo a disposizione capitali e personale tecnico specializzato, sono stati
costretti a chiedere aiuto al mondo sviluppato, originando una nuova subordinazione
economica, il cosiddetto neocolonialismo.
Il colonialismo antico
La colonizzazione, cioè la fondazione di colonie su territori diversi e, spesso, lontani
dalla madrepatria, è un fenomeno che risale ai Fenici e ai Greci, che in gruppi
numerosi si spostavano dalle terre d’origine e andavano a vivere nei territori vicini e,
successivamente, nelle regioni del Mediterraneo occidentale.
Questo primo tipo di colonizzazione, determinato soprattutto da carestie, lotte
politiche o ragioni di espansione commerciale, per il rifornimento di materie prime di
4
cui la madrepatria era carente, prevedeva la fondazione di insediamenti stabili nei
quali i cittadini che immigravano trasferivano il loro modo di vita, la loro civiltà, che si
fondevano con quella delle popolazioni locali, dando origine a centri che sarebbero
diventati fiorenti città.
Diverse sono invece le forme del colonialismo romano, che è prevalentemente
politico-militare, più che economico o demografico.
L’espansione, attuata attraverso annessioni o sottomissioni, è determinata dall’esigenza
di controllo dei confini, dell’acquisizione di terre da distribuire ai veterani e, solo in
periodo imperiale, per motivazioni economiche e di ripopolamento dei territori
conquistati, rimasti spopolati per il fenomeno dell’inurbamento.
Già dal III secolo a.C., con le guerre puniche, Roma sottomette popolazioni non
italiche, fondando via via un impero che, al suo massimo fulgore, si espande dalla
penisola iberica al Reno, dal Marocco al Mar Nero.
Il colonialismo in età moderna (secoli XIV-XVIII): la scoperta e la conquista
L’espansione coloniale – di cui, dopo la Spagna e il Portogallo, sono protagoniste
l’Olanda, l’Inghilterra e la Francia – è destinata ad acquistare importanza decisiva nella
storia. Dopo le scoperte, le conquiste e l’apertura di nuove rotte marittime, l’attività
mercantile e finanziaria europea si svolge infatti in uno spazio geografico assai più vasto
e può usare, sulla base dell’assoggettamento politico ed economico delle regioni
produttrici, nuove e immense risorse. Il colonialismo è quindi il fattore fondamentale
della creazione di un nuovo sistema mondiale di scambi e di rapporti economici
dominato dagli Stati europei e da forti gruppi di mercanti e operatori finanziari. Le sedi
dei traffici, le città, attraversano una nuova fase di sviluppo, sostenuta anche dalla
crescita contemporanea delle istituzioni pubbliche e delle strutture culturali.
La formazione dell’impero spagnolo in America è la vicenda più clamorosa ed
esemplare di tutto il colonialismo della prima età moderna. Gli aspetti più
sorprendenti sono senza dubbio la rapidità con cui la conquista è realizzata e l’esiguità
di mezzi e di uomini impiegati. L’insediamento dei primi coloni ha inizio con il
secondo viaggio compiuto da Colombo nel 1493, l’anno successivo a quello della
“scoperta” dell’America. Circa 1.200 uomini iniziano la costruzione di fattorie
agricole, danno avvio a ricerche minerarie e avviano la costruzione della prima città
(Santo Domingo, 1496-1497) nell’area caraibica interessata dalle prime fase della
conquista. Privi di regolari contatti con la Spagna, i coloni affrontano nel primo
periodo in modo autonomo i problemi dell’insediamento.
Nel 1502, con la spedizione di Nicolás de Ovando, viene istituita una vera e propria
rappresentanza del governo spagnolo. Il problema fondamentale è rappresentato dal
bisogno di manodopera per sfruttare le risorse agricole e minerarie locali. Lo stesso
Colombo introduce il sistema delle encomiendas, in base al quale uno o più villaggi
indigeni (encomiendas) vengono assegnati a ogni colono (encomendero) che è
autorizzato a riscuotere tributi dalla popolazione sotto forma di prodotti agricoli e
manifatturieri o di lavoro coatto non retribuito. La popolazione indigena, già esigua, si
riduce rapidamente per le violenze cui è sottoposta, per le malattie, le fughe e lo
sfruttamento spietato: già nel 1510 essa è quasi completamente scomparsa. La
5
mancanza di manodopera ostacola gravemente l’utilizzazione delle risorse americane,
proprio quando esse si rivelano corrispondenti alle attese dei colonizzatori. Si cerca di
fronteggiare questo inconveniente con la tratta degli schiavi neri che ha inizio nel 1503
per poi intensificarsi sino a diventare uno dei più importanti settori del traffico
sull’Atlantico, contribuendo a mutare la struttura razziale della popolazione di alcune
zone latino-americane (oggi, ad esempio, la popolazione di Haiti è costituita per il 90
per cento da neri).
L’esigenza di uomini, oltre che di terre da sfruttare, spiega l’indirizzo che prendono le
ulteriori conquiste, in un continente che offre spazi vuoti immensi ai pochi coloni
emigrati dall’Europa. Mentre è in atto la colonizzazione delle isole del Mar dei
Caraibi, comincia la penetrazione nell’interno del continente.
Una spedizione di modeste dimensioni (600 uomini e 11 navi) muove verso le coste
messicane nel 1519, guidata da Hernán Cortés. È questa l’impresa che pone la prima
solida base dell’impero spagnolo nel Nuovo Continente. Sbarcato nei pressi
dell’attuale Vera Cruz, Cortés si trova di fronte a un compito assai difficile. La
numerosa popolazione azteca abitante il vasto territorio del Messico non è
disorganizzata e dispersa come le tribù incontrate nelle isole dai primi coloni. Gli
aztechi hanno un’organizzazione statale, che fa capo alla città di Tenochtitlan, e un
esercito regolare, condotto dal sovrano Montezuma. Cortés punta direttamente verso
la capitale dello Stato. Durante la marcia dalla costa verso l’interno egli può rendersi
conto del malcontento esistente nei villaggi contro i signori aztechi e contro
l’amministrazione pubblica e riesce a sfruttarlo a proprio vantaggio, giungendo sino a
stringere alleanze con importanti forze ribelli. L’insediamento di Cortés nella capitale
è dapprima relativamente pacifico; impressionati dalle armi da fuoco e dai cavalli
spagnoli – cose del tutto sconosciute – gli Aztechi non oppongono resistenza. Ma
quando gli spagnoli cominciano a distruggere i templi e imporre tributi molto onerosi,
la popolazione si ribella. Montezuma, sino a questo momento tollerante verso gli
stranieri, viene ucciso dagli insorti, e Cortés è costretto a rifugiarsi nel territorio
alleato di Tlaxcala. Di qui le sue truppe, rafforzate da un contingente di soldati venuto
da Cuba, muovono poco dopo contro la capitale e, dopo un lungo assedio, la
conquistano e la distruggono.
Finisce così l’impero azteco, caduto nelle mani di un pugno di conquistadores animati
da una grande sete di ricchezza e da uno straordinario spirito di avventura. La
riorganizzazione politica ed economica viene avviata dallo stesso Cortés, che
distribuisce agli uomini del suo seguito i villaggi con la forma dell’encomienda,
spodestando l’antica aristocrazia terriera locale.
Contemporaneamente, la conquista si sviluppa verso il sud. La notizia dell’esistenza di
un altro popoloso impero che si estende in una regione comprendente gli attuali
territori dell’Ecuador, del Perù e una parte del Cile muove un altro gruppo di
conquistadores capeggiati da Francisco Pizarro, un colono già possessore di
un’encomienda nella zona di Panamá. L’organizzazione sociale degli Inca è basata
sulla proprietà comune della terra; essi hanno un fiorente artigianato, specializzato in
modo particolare nella fabbricazione di oggetti d’oro. Come gli Aztechi, non
conoscono il cavallo né l’uso della ruota. Le scarse capacità militari di queste
popolazioni rendono facile l’impresa di Pizarro, partito con meno di 200 uomini e soli
27 cavalli. Egli però sa approfittare di una crisi dinastica che sta lacerando l’impero
6
degli Inca, e riesce a fare prigioniero il sovrano. Nel saccheggio dell’antica capitale
Cuzco, i conquistadores realizzano un bottino immenso, aumentato dall’oro che il
sovrano consegna sperando di riuscire a riconquistare la libertà.
Pizarro fonda nel 1535 una nuova capitale in un luogo diverso, vicino alla costa,
l’attuale Lima. I problemi più difficili li incontra tuttavia nell’amministrazione dei
nuovi territori. A parte le rivolte degli indigeni e le difficoltà di stabilire rapporti con
essi, Pizarro si trova coinvolto in una serie di lotte feroci tra i conquistadores,
provocate anche dal suo stesso comportamento, scarsamente leale e privo di dirittura
morale. Egli infatti non potrà godere a lungo dei frutti delle sue imprese, poiché sarà
ucciso nel 1541.
In questo modo si è costituito il corpo fondamentale dell’impero ispano-americano,
un territorio immenso comprendente gli Stati degli Aztechi e degli Inca, ai quali si
aggiungono via via nuovi territori (Messico meridionale, Guatemala, Honduras),
strappati alle popolazioni Maya.
In tutta la vicenda della conquista e nel successivo svolgimento dei rapporti tra la
Spagna e le colonie, la presenza di missionari cattolici ha un ruolo importante. La
distruzione, da parte dei conquistadores, dell’antica organizzazione religiosa e
spirituale, lascia nelle popolazioni indigene un vuoto spirituale e psicologico, che i
missionari riescono almeno in parte a colmare. In questo modo, seppure in condizioni
molto difficili (la loro opera è violentemente contraddetta dallo sfruttamento e dal
saccheggio operato dai coloni), essi stabiliscono un legame robusto tra conquistatori e
popolazione autoctona.
L’azione della corona ha invece diverse motivazioni rispetto a quella ecclesiastica. Col
suo tentativo di limitare il potere dei conquistadores nelle colonie, il sovrano spagnolo
mira soprattutto a impedire che i nuovi territori si sottraggano alla sua autorità. Viene
così creato un apparato politico-amministrativo che, poco a poco, sostituisce ai
conquistadores un gruppo di funzionari fedeli, stipendiati dallo Stato. Il potere è
affidato a governatori e successivamente, quando i territori coloniali raggiungono
estensioni vaste, a viceré.
In alcune colonie (Santo Domingo, Messico e Panamá) sono creati centri di
amministrazione giudiziaria e civile (audiencias) sul modello di quelli esistenti nella
madrepatria. Quest’organizzazione politico-amministrativa si diffonde poi in tutte le
colonie. In Spagna, nel Consiglio di Castiglia (organismo collegiale di governo che
tratta gli affari generali della corona) viene costituito un comitato permanente per le
Indie, in seguito trasformato in Consiglio autonomo, con la funzione di Corte
suprema e di ministero per gli affari coloniali.
Si conclude così l’epoca in cui i conquistadores hanno concentrato nelle loro mani
tutto il potere (politico, economico, militare) senza alcun controllo. La maggior parte
di essi sono privati della loro autorità, e rimangono semplici encomenderos. Alcuni
non accettano facilmente l’operazione e danno vita a episodi di rivolta che ricordano,
sebbene su un piano diverso, le tendenze anarchiche della feudalità europea.
Meno efficace è invece l’azione della monarchia per impedire che, attraverso il sistema
della encomienda, si formi nelle colonie una nuova grande feudalità. I tentativi di
negare l’ereditarietà delle encomiendas e di limitare il potere degli encomenderos non
hanno successo. Da allora si viene dunque formando nell’America Latina una
struttura di tipo feudale, caratterizzata dalla concentrazione della ricchezza e della
7
terra, da fortissimi squilibri sociali, da una divisione profonda tra i detentori della
ricchezza e la massa dei lavoratori.
Caratteri diversi, rispetto a quella spagnola, ha l’espansione coloniale portoghese, che
non mira alla conquista di vasti domini territoriali ma alla creazione di scali, porti e
piazzeforti specialmente in Africa e in India. Vasco de Gama crea una base
permanente a Calcutta nel 1502; subito dopo Albuquerque organizza scali portoghesi
sulla costa araba e nel Golfo Persico. Goa, nel territorio indiano, è conquistata nel
1510 e diviene il più importante centro commerciale del Portogallo in Oriente. I
successivi insediamenti nei punti strategici del traffico nell’Oceano Indiano danno ai
Portoghesi la possibilità di monopolizzare il commercio marittimo con l’Oriente. Essi
penetrano in Malesia e da lì si spingono sino in Cina, dove ottengono di creare un
insediamento a Macao, all’entrata della baia di Canton (1530). In Africa si installano
già nel corso del ’400 e possono perciò diventare i principali protagonisti della tratta
degli schiavi quando aumenta la loro richiesta nel mercato americano. La fragilità
dell’impero portoghese deriva dalla sua stessa struttura: esso è infatti costituito da
scali commerciali senza trasferimenti di popolazione e senza una permanente
attrezzatura difensiva locale. Per questi motivi le postazioni portoghesi in Asia
saranno successivamente scalzate con relativa facilità da Spagnoli e Olandesi.
Un carattere più duraturo ha invece il dominio portoghese in Brasile (raggiunto nel 1500
dal navigatore Pedro Alvarez Cabral). L’immensa regione, popolata da tribù primitive, ha
all’inizio interesse commerciale quasi esclusivamente per il legname da tintura, il brasil, da
cui prende nome il paese. La necessità di difendere il territorio da Francesi e Spagnoli
spinge poi il sovrano portoghese nel 1530-1540 a estendere l’occupazione del Brasile, che
rimane però a lungo limitata ad alcune zone della fascia costiera. Il territorio è diviso nel
1533 in dodici circoscrizioni ripartite tra proprietari che avrebbero dovuto colonizzarle.
In seguito si sviluppano le piantagioni di canna da zucchero, nelle quali la manodopera è
costituita in gran parte da schiavi importati dall’Africa.
Prime ripercussioni dell’espansione coloniale
Una parte cospicua della ricchezza prodotta nelle colonie americane viene trasferita
nella madrepatria attraverso gli scambi commerciali, dei quali la Spagna si riserva il
monopolio, e soprattutto attraverso il prelievo dei prodotti minerari. Oltre le miniere
delle Antille e del Messico, il centro più importante di produzione dell’argento
diventano le miniere peruviane di Potosí, scoperte nel 1545. Lo sfruttamento avviene
attraverso il sistema del lavoro forzato degli indios, già praticato nell’organizzazione
economica degli Inca. Per sovrintendere all’intenso traffico tra la madrepatria e le
colonie viene istituita a Siviglia sin dal 1503 la Casa de Contratación, un’istituzione
che ha il compito di riscuotere i dazi sul commercio coloniale (che passa
obbligatoriamente per il porto di Siviglia) e riceve per conto della corona i metalli
preziosi delle miniere americane.
A loro volta, le colonie costituiscono un mercato di esportazione per i prodotti
europei. Esse abbisognano di armi, tessuti, utensili vari, vino, olio e schiavi: prodotti
che la Spagna è in grado di fornire solo in parte. Le richieste coloniali sono quindi
8
soddisfatte in parte attraverso il contrabbando, esercitato dapprima dai Portoghesi e
successivamente da Francesi, Inglesi e Olandesi.
L’aspetto di gran lunga più importante del traffico col Nuovo Mondo è l’importazione
in Spagna di un’ingente quantità di metalli preziosi. Per la monarchia spagnola –
impegnata in diversi teatri di guerra e tesa ad affermare la propria egemonia politicomilitare sull’Europa – questo apporto finanziario ha un valore assai elevato. Essa
preleva infatti una tassa del 20 per cento sui metalli importati, la cui quantità è molto
elevata (tabella 1).
Tab. 1. Importazioni di metalli preziosi, 1503-1530 (valori in pesos, equivalenti a 42,29
grammi di argento).
1503-1505
1506-1510
1511-1515
371.055,3
816.236,5
1.195.553,5
1516-1520
1520-1525
1525-1530
993.196,5
134.170,0
1.038.437,0
Negli anni successivi, peraltro, l’importazione aumenta notevolmente sino a toccare la
punta massima di circa 35 milioni di pesos nell’ultimo decennio del secolo.
Le conseguenze sono molteplici: accenniamo qui solamente l’aumento dei prezzi
(iniziato all’incirca nel 1520) che si verifica non solo in Spagna ma in tutti i paesi
europei, la cui economia, direttamente o indirettamente, è legata a quella spagnola.
Più a fondo, tuttavia, operano altro fattori: il commercio internazionale non soltanto
amplia il suo orizzonte, ma cambia la sua stessa natura. Ai prodotti di lusso, le
tradizionali spezie, che hanno costituito la base principale del commercio
intercontinentale dell’età medievale, si affiancano prodotti coloniali meno preziosi ma
di più largo consumo (tabacco, zucchero, cacao, ecc.). Nascono perciò nuove e assai
più numerose possibilità di arricchimento e quindi anche di trasformazione delle
strutture sociali; la concorrenza tra le nazioni si fa più intensa; in Europa, infine,
accanto ai conflitti tradizionali, si cominciano a profilare nuovi contrasti provocati
dall’espansione coloniale.
In sintesi:
Fase caratterizzata prevalentemente da un colonialismo mercantile, più interessato agli scambi
commerciali che al vero dominio politico. Fa eccezione la colonizzazione Spagnola in America del Sud.
• 1488 – Bartolomeo Diaz (P) doppia Capo di Buona Speranza.
• 1492 – Cristoforo Colombo (E) scopre l'America.
• 1519-1522 – Vasco De Gama (P) compie la circumnavigazione del mondo.
XVI secolo – Gli Spagnoli conquistano quasi tutta l’America Latina istituendo dei viceregni e
distruggendo le civiltà Maya, Inca e Atzeca. Gli Spagnoli in America tendono ad assimilare e
9
sottomettere le popolazioni locali utilizzando diversi sistemi. La Spagna “importa” dall’Africa schiavi
per farli lavorare nelle piantagioni.
Nei secoli XVII-XVIII l’Inghilterra inizia a utilizzare gli Stati Uniti, prima, e l’Australia, poi, anche
come colonie di popolamento. Nel XV sec. Spagna e Portogallo finanziano viaggi di esplorazione in
Africa e nelle Indie. Il Portogallo pratica un colonialismo commerciale costituito in tutto da una
dozzina di basi mercantili fortificate dislocate in Africa e in Asia.
• 1585 – Viene fondata la Virginia, prima colonia inglese in Nord America.
• 1600 – Viene fondata la Compagnia inglese delle Indie Orientali.
• 1602 – Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie Orientali.
Gli Olandesi si sostituiscono gradualmente ai Portoghesi, la Compagnia delle Indie Orientali inizia a
controllare anche la produzione dei centri, non limitandosi più al semplice commercio.
• 1608-1642 – La Francia colonizza il Canada.
• 1621 – Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie Occidentali, che si limita però alla pirateria
contro la flotta spagnola.
• 1640 – Il Portogallo si impossessa del Brasile.
• 1660 – Dopo una fase d’arresto ricomincia la colonizzazione inglese, in particolare da parte delle sette
protestanti: puritani e quaccheri.
• 1770 – James Cook scopre e prende possesso per conto della corona inglese dell’Australia.
• 1776 – Gli Stati Uniti proclamano la loro indipendenza dall'Inghilterra.
• 1795 – Gli Inglesi conquistano Città del Capo strappandola agli Olandesi, che vi avevano praticato
anche una colonizzazione di popolamento.
Dalla lotta per la supremazia coloniale alla formazione dell’impero britannico in Oriente
Alla metà del Seicento, l’Olanda gode in Europa di un indiscusso predominio
economico, fondato sulla supremazia della propria flotta commerciale e sul ruolo
centrale di Amsterdam nella finanza internazionale. In quest’epoca la flotta olandese
conta ben diecimila navi, la cui stazza complessiva è superiore di dieci volte a quella
inglese e di venti volte a quella spagnola; le due grandi compagnie delle Indie
detengono il monopolio dei commerci delle spezie asiatiche, dei metalli preziosi, del
legname e del cotone americano.
Amsterdam, inoltre, è il centro finanziario più importante del tempo; lì è possibile
chiedere denaro a prestito per le iniziative più audaci e reinvestire i propri capitali. Al
commercio internazionale e alle attività finanziarie si unisce poi lo sviluppo
dell’agricoltura dovuto alle opere di ingegneria idraulica e di bonifica e alla
sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione.
Sin dalla metà del Seicento, però, si fa sentire la concorrenza dell’Inghilterra, indirizzata
decisamente verso una politica di sviluppo economico e di espansione sui mari ai danni
dell’Olanda. Nel 1651 viene emanato l’atto di navigazione, che riserva alle navi inglesi il
commercio con le colonie dell’America settentrionale e proibisce l’accesso ai porti
britannici alle navi straniere che non provengano dai paesi produttori dei beni
commerciati. Così facendo si pongono le basi per l’egemonia marittima inglese, a danno
del principio della libertà di commercio. Ben presto il conflitto commerciale angloolandese si trasforma in scontro militare. Le tre guerre – del 1652-54, 1665-67 e 1672-74
– si concludono con la vittoria dell’Inghilterra, che conquista anche la base americana di
Nuova Amsterdam, presto ribattezzata New York.
Nella prima metà del Settecento, la Francia rappresenta per l’Inghilterra una rivale
temibile, capace di farle concorrenza in tutto il mondo. È un grande paese, con una
10
popolazione doppia rispetto all’Inghilterra, in grado di approntare grandi eserciti, con
un’economia più arretrata, ma dotata di notevoli potenzialità.
I traffici francesi interessano tutti i paesi europei, soprattutto l’area tedesca, dove i
prodotti coloniali sono distribuiti dal porto di Amburgo, e quella mediterranea,
attraverso il porto di Marsiglia.
Nei Caraibi, i francesi contrastano gli inglesi nella produzione del caffè, del tabacco e
soprattutto dello zucchero, che esportano in tutta Europa e persino nelle colonie
inglesi del Nord America. Queste sono circondate dai domini del re di Francia, il
Canada, l’Illinois e la ricca Lousiana, che minacciano di soffocare l’espansione dei
coloni inglesi. I porti francesi della costa atlantica, Bordeaux, Nantes e Le Havre, si
sviluppano molto rapidamente grazie al commercio oceanico sino a fare concorrenza a
Londra, Bristol e Liverpool. Nel settore asiatico, la concorrenza tra inglesi e francesi è
particolarmente accanita in India, mentre, sul commercio del tè con la Cina,
l’Inghilterra mantiene saldamente il monopolio sino al 1750.
Negli anni Quaranta, durante la guerra di secessione austriaca, Francia e Inghilterra si
affrontano in Europa e nelle colonie, ma senza rilevanti conseguenze. Molto più
importanti sono invece gli esiti della guerra dei Sette anni (1756-1763), durante la quale
Francia e Austria, tradizionali avversarie nelle guerre dei Sei-Settecento, si schierano
assieme alla Russia contro la Prussia, alleatasi precedentemente con l’Inghilterra.
Dopo una prima fase in cui inglesi e francesi si fronteggiano sul continente,
l’Inghilterra decide una condotta di guerra a tutela degli interessi commerciali degli
inglesi. Il confronto si sposta così dall’Europa alle colonie.
In India, il governatore francese ha concepito già prima del 1756 il grandioso piano di
creare un impero finanziariamente indipendente dalla madrepatria assicurandosi il
controllo della regione di Madras, ma la superiorità navale inglese ha sempre frustrato
le sue ambizioni. All’inizio della guerra dei Sette anni riprendono le ostilità francoinglesi, che hanno come esito la conquista per mano inglese di tutte le piazzeforti
precedentemente tenute dai francesi.
Nello scontro in Nord America la Francia oppone maggiore resistenza, grazie anche
all’alleanza con le più bellicose tribù indiane; gli inglesi si giovano però di una
schiacciante superiorità numerica e di una maggiore forza navale. Questi due fattori
risultano perciò decisivi e assicurano la vittoria agli inglesi anche in Nord America.
Il trattato di Parigi del 1763, che sancisce la fine della guerra, lascia immutato il
quadro geopolitico europeo, ma rivoluziona l’assetto delle colonie a vantaggio
dell’Inghilterra: la Francia perde tutti i territori nordamericani e parte delle Antille,
mentre in India riottiene alcuni scali occupati dagli inglesi, che ne proibiscono però la
fortificazione. Di fatto, dopo la conquista del Bengala del 1765, l’Inghilterra resta
l’unico arbitro europeo del subcontinente indiano. L’egemonia inglese sull’India porta
allo sviluppo di una rete commerciale destinata a rafforzarsi sempre più negli anni
successivi. L’India diviene così la via maestra per la penetrazione economica e politica
degli europei in Estremo Oriente.
Lo scontro coloniale con l’Inghilterra è così definitivamente perso per la Francia e a
nulla vale l’appoggio fornito successivamente ai coloni americani ribelli durante la
rivoluzione americana. Sconfitta dall’Inghilterra, dissestata finanziariamente dalle
spese di guerra e con un sistema politico refrattario a qualsiasi riforma, la Francia
sarebbe sprofondata dopo alcuni anni nella rivoluzione. L’Inghilterra, al contrario, si
11
impone come massima potenza coloniale, ruolo che avrebbe mantenuto per circa due
secoli, nonostante che la rivoluzione americana la priverà di lì a poco delle colonie
americane settentrionali.
Sino alla metà del Settecento la penetrazione occidentale in Asia è quasi
esclusivamente di tipo economico: in genere le potenze europee si accontentano di
assumere il controllo dei traffici e dei commerci, creando avamposti commerciali e
militari in punti chiave delle rotte marittime o impadronendosi di porti e città di
particolare rilevanza economica. Le uniche eccezioni di rilievo sono rappresentate
dalle Filippine, cadute sin dalla seconda metà del XVI secolo sotto la dominazione
spagnola, e dai possedimenti olandesi di Ceylon, Sumatra, Giava e Borneo.
Nella seconda metà del XVIII secolo gli Stati europei, e in particolare l’Inghilterra,
iniziano ad assumere direttamente l’amministrazione degli Stati asiatici costituendo un
vero e proprio impero coloniale. La guerra dei Sette anni rappresenta un momento
fondamentale nella storia dell’espansione europea in Asia: la sconfitta della Francia
lascia di fatto mano libera all’Inghilterra che, grazie anche alla crisi della Spagna e alla
diminuita presenza dei mercanti portoghesi e olandesi, riesce nel corso di un secolo a
creare un vasto impero coloniale.
Oggetto delle mire inglesi è soprattutto il subcontinente indiano, che alla fine del
Settecento è suddiviso tra l’impero Moghul, una dinastia turca di religione islamica, e
gli Stati dei Maratha, una confederazione di cinque regni induisti dell’India centrosettentrionale. Gli inglesi sanno approfittare dei conflitti che oppongono i Moghul alle
popolazioni induiste e già durante la guerra dei Sette anni riescono a limitare la
presenza francese in India e ad assumere il controllo della ricca regione del Bengala,
imponendo un nababbo di loro gradimento. Nei decenni seguenti l’opposizione alla
penetrazione britannica si polarizza attorno agli Stati dei Maratha che sono
defnitivamente sconfitti solo dopo tre conflitti, l’ultimo dei quali, terminato nel 1818,
si conclude con l’annessione di tali territori ai possedimenti coloniali britannici.
La conquista delle nuove colonie non è intrapresa direttamente dalla corona inglese, ma
viene affidata, sotto il controllo del Parlamento, a una compagnia privata – la East India
Company – che sui possedimenti indiani ha pieni poteri amministrativi e militari.
Il colonialismo inglese ha pesanti ripercussioni sulla società indiana: sino a questo
momento, malgrado il rigido controllo britannico, il saldo commerciale tra India e
Inghilterra è nettamente a favore della prima. Mentre le esportazioni inglesi in India
sono pressoché nulle, dai porti indiani partono alla volta dell’Europa navi cariche di
spezie, tè, porcellane e cotonate.
A partire dagli anni Venti dell’Ottocento la piena affermazione della rivoluzione
industriale rende per la prima volta competitivi i prodotti tessili europei rispetto a
quelli indiani. Grazie anche a un sistema di tariffe doganali che ostacola l’esportazione
delle cotonate indiane nel Regno Unito e che lascia invece indifesa l’India di fronte
alla penetrazione dei prodotti inglesi, nel giro di pochi anni la produzione artigiana
locale di prodotti tessili viene praticamente azzerata. L’economia indiana è così
costretta a orientarsi verso l’esportazione di prodotti non lavorati come il tè o il
cotone grezzo che sarebbe poi stato reimportato dall’Inghilterra sotto forma di
prodotto finito.
Nei primi decenni dell’Ottocento gli inglesi consolidano la propria presenza in Asia
ponendo un protettorato sul Nepal (1816), fondando la città portuale di Singapore
12
(1819) e annettendo la bassa Birmania (1826) e il Punjab (1849). Alcune di queste
acquisizioni avvengono in maniera quasi casuale, profittando delle lotte interne a
questo o quel paese. In genere, però, a orientare le scelte politiche dell’Inghilterra è la
volontà di creare attorno all’India degli Stati cuscinetto e di controllare le rotte
commerciali che collegano la madrepatria con le colonie asiatiche.
Il tramonto dell’impero coloniale spagnolo
All’inizio dell’Ottocento l’America Latina è divisa tra possedimenti portoghesi –
limitati al solo ma immenso Brasile – e spagnoli, che si estendono su quasi tutta la
parte centrale e meridionale del continente, su Cuba, Portorico e Messico.
Indipendente è invece, dal 1804, la repubblica di Haiti. Questi vasti territori sono
abitati da circa diciannove milioni di abitanti. A causa dei flussi migratori dalla
Spagna e della tratta degli schiavi di colore, la popolazione dell’America Latina è
diventata multietnica: nelle colonie spagnole a fianco di circa 200.000 emigrati iberici,
si contano tre milioni di creoli (bianchi nati da genitori spagnoli residenti nelle
colonie), cinque milioni tra mulatti (nati da matrimoni tra bianchi e neri) e meticci
(nati dall’incontro tra neri e indi), oltre sette milioni di indios nativi e circa un milione
di neri. Nell’enorme Brasile vivono appena tre milioni di uomini, la metà dei quali
schiavi di colore.
Alle differenze etniche corrispondono profonde disparità sociali. Il possesso della
maggior parte delle terre è concentrato nelle mani della minoranza creola, gelosamente
arroccata a difesa dei propri privilegi, e che, nel nome di una supposta superiorità
razziale, rifiuta ogni legame con meticci e mulatti. Specie nella seconda metà del
Settecento, tra i creoli, si afferma un’élite economica e culturale che ha esteso i propri
interessi al settore commerciale e che cerca un riscontro al proprio ruolo economico in
un parallelo aumento di peso politico. I mulatti e i meticci lavorano nei settori del
commercio o dell’artigianato, mentre la popolazione di colore e gli indios sono
impiegati, in condizioni di schiavitù o semischiavitù, nei grandi latifondi appartenenti al
demanio regio, agli enti ecclesiastici o ai possidenti creoli.
Nel 1808 l’occupazione della Spagna da parte delle truppe napoleoniche costituisce la
spinta decisiva verso lo sfaldamento dell’impero coloniale iberico. I possidenti creoli
assumono di fatto il potere creando delle giunte provvisorie ed esautorando i
rappresentanti della corona. Il primo paese a proclamare la propria indipendenza
dalla Spagna è il Venezuela dove, il 5 luglio 1811, il generale Miranda proclama la
nascita della Repubblica. Questo esempio è presto seguito in altre aree sottoposte al
dominio spagnolo: nella parte meridionale del paese, corrispondente all’attuale
Argentina e al Cile, le forze dei rivoltosi sono organizzate da un ex ufficiale spagnolo
José de San Martín; nelle province settentrionali, corrispondenti al Venezuela e alla
Colombia, la guida dell’esercito è assunta da Simón Bolívar.
In questa prima fase della lotta di liberazione i paesi latino-americani possono contare
sull’appoggio degli Stati Uniti e dall’Inghilterra che intravedono nello sfaldamento
dell’impero coloniale spagnolo l’occasione per accrescere la propria penetrazione
economica nel Sud America.
13
Nato a Caracas nel 1783, Simón Bolívar trascorre molti anni in Europa, dove è stato
mandato dalla famiglia a studiare e da dove ritorna definitivamente nel 1810 per
schierarsi a fianco dei rivoluzionari venezuelani. Grazie ad alcune vittorie militari,
Bolívar riesce a liberare Caracas ma la controffensiva spagnola lo costringe a riparare
nei Caraibi. Di lì egli diffonde il suo programma che prevede la nascita di una
confederazione, una repubblica degli Stati Uniti del Sud, che rappresenti per
l’America Latina ciò che gli Stati Uniti rappresentano per l’America settentrionale.
Nel 1816 riprende la lotta contro gli spagnoli radicalizzando le proprie posizioni
politiche e riuscendo così ad accrescere la base sociale della rivolta: la messa al bando
della schiavitù guadagna a Bolívar l’appoggio degli indios e degli schiavi liberati,
alcune riforme sociali gli valgono il sostegno dei piccoli contadini e degli strati
inferiori della società. Grazie anche all’aiuto dell’Inghilterra e allo scoppio dei moti di
Spagna che impediscono alla corona di inviare nuove truppe in America Latina, egli
riesce a sconfiggere più volte l’esercito spagnolo, a liberare i territori che
corrispondono agli attuali Venezuela, Ecuador e Colombia e a dare vita alla
Repubblica federale della Grande Colombia. Negli anni successivi anche Perù, Bolivia
(così chiamata in onore di Bolívar) e Uruguay ottengono l’indipendenza.
Contemporaneamente, nella parte meridionale del continente, i ribelli cileni e
argentini, guidati rispettivamente da Bernard O’Higgins e San Martín, riescono ad
avere la meglio sulle truppe spagnole.
Un percorso diverso è invece quello seguito dal Messico. Qui, a differenza che nel
resto del Sud America, i primi a iniziare la guerra di liberazione dagli spagnoli sono le
popolazioni indios e meticce delle campagne che danno alla rivolta una chiara
connotazione sociale chiedendo la redistribuzione delle terre. Il pericolo spinge i
creoli e gli spagnoli ad accantonare le divergenze reciproche e a far fronte comune.
Una volta stroncata la sollevazione dei contadini, contrasti tra creoli e corona portano
allo scoppio di una ribellione di orientamento conservatore guidata dal generale
Augustín de Itúrbide, che, nel 1822, si fa proclamare imperatore del Messico. Il
tentativo autocratico ha tuttavia vita breve: nel 1823 Itúrbide è destituito da un colpo
di Stato, cui fa seguito la proclamazione di una repubblica federale modellata
sull’esempio costituzionale nordamericano.
Un percorso ben diverso da quello del resto dell’America Latina è quello seguito dal
Brasile. Nel 1807, in seguito all’invasione del Portogallo da parte delle truppe
napoleoniche, la casata regnante dei Braganza trova rifugio nella colonia sudamericana.
Nel 1821 lo scoppio, in patria, dei moti liberali costringe re Giovanni VI a fare ritorno in
Europa. In Brasile resto il figlio Pietro che, nel 1822 e in sostanziale accordo con il padre,
proclama l’indipendenza del paese facendosi nel contempo incoronare imperatore.
Nel 1826 a Panamá è convocato un congresso degli Stati latino-americani che, nelle
intenzioni di Simón Bolívar, avrebbe dovuto portare alla nascita di una repubblica
federale comprendente, se non tutta, almeno gran parte dell’America Latina. Il
congresso si chiude con un sostanziale fallimento: i particolarismi e le tradizioni locali
non solo impediscono la costituzione dello Stato vagheggiato da Bolívar ma, anzi,
portano allo sfaldamento della Grande Colombia e delle altre repubbliche federali
nate nei mesi successivi all’indipendenza.
Bolívar sogna uno Stato democratico nel quale i contadini godano di condizioni di
vita migliori di quelle nelle quali hanno vissuto sino a quel momento, ma il suo
14
progetto naufraga. All’interno dell’élite creola protagonista della lotta contro la
Spagna permane, infatti, una forte divisione tra i ceti urbani, impiegati nei commerci,
e i grandi proprietari terrieri, contrari a ogni riforma sociale. A risultare vincenti sono
gli interessi dei proprietari, sicché il passaggio all’indipendenza non comporta nessun
miglioramento per le popolazioni delle campagne. Anzi, sebbene la schiavitù sia stata
formalmente abolita nella maggior parte degli Stati, di fatto i contadini continuano a
vivere in condizioni di semilibertà.
Le mancate riforme sociali o la loro esigua portata rendono fragili le istituzioni
democratiche che, sul modello americano, quasi tutti i nuovi Stati si sono date al
momento dell’indipendenza. Di contro cresce l’importanza dei generali che,
protagonisti della guerra di liberazione, nel corso della lotta contro la Spagna hanno
spesso aggiunto ai poteri militari anche quelli civili. Contrari alla democrazia, essi si
arrogano il diritto di intervenire direttamente nella vita pubblica al fine di dirimere le
contese politiche. Questo atteggiamento è quindi alle origini del clima di instabilità
politica, accompagnato da guerre civili e dittature militari, che caratterizza, in parte
ancora oggi, la storia dell’America Latina.
Cronologia
In tutto il Sud America iniziano le guerre d’indipendenza, in particolare sotto la guida di Simon Bolìvar nel
1810-24 Nord del Sud America (Venezuela) e nei Caraibi (Colombia, Equador) e di José de San Martin nel Sud
(Argentina, Cile, Perù, Bolivia). Al diretto dominio coloniale spagnolo subentrano la pressione economicofinanziaria inglese e la subalternità politica agli Stati Uniti.
1818
La Compagnia inglese delle Indie Orientali ottiene il controllo diretto dell’India. Inizia a nascere un
regime coloniale basato sul disprezzo della società indigena e sulla volontà di trapiantare istituzioni e
sistemi economici occidentali con essa incompatibili.
1821
Il Brasile si proclama indipendente.
1830
L’Olanda impone alle colonie indonesiane il “sistema di coltivazione”, impone cioè colture per
l’esportazione a danno di colture per la sussistenza.
1833
La Gran Bretagna abolisce la schiavitù.
1834
L’Algeria diviene un possedimento coloniale della Francia, che deve però combattere a lungo contro la
resistenza locale (fino al 1847). La Francia punta ad assimilare i nuovi territori direttamente entro il
proprio sistema politico-amministrativo.
1842
La Gran Bretagna stabilisce una forma di protettorato sulla Cina.
1850-70 L’Olanda si estende nelle isole del Borneo.
1858-70 La Francia occupa tutta l’Indocina.
1864
Napoleone III proclama imperatore del Messico Massimiliano d’Asburgo.
1865
Gli Stati Uniti aboliscono la schiavitù.
1867
La resistenza messicana guidata da Benito Juarez costringe alla ritirata Massimiliano d’Asburgo che
viene catturato e fucilato.
1869
L’Italia acquista la baia di Assab per mezzo della società Rubattino di Genova.
Il nuovo colonialismo imperialista e la spartizione dell’Africa
Diretta conseguenza della crescita dell’economia internazionale e dello sviluppo
industriale è l’emergere, a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, di forti tensioni
politiche tra le principali potenze europee. Lo sviluppo industriale aumenta a
dismisura la loro forza economia, facendo crescere la competizione per l’allargamento
15
delle sfere di influenza, e trasforma i caratteri del colonialismo europeo. Da un lato, i
territori colonizzati, che sino a ora hanno assicurato la fornitura di materie prime e
assorbito la popolazione in sovrannumero, diventano importanti anche come mercati;
dall’altro, una crescente presenza militare e politica è considerata una condizione
necessaria per la tutela degli investimenti.
L’espansione coloniale si trasforma così in uno dei fattori decisivi delle relazioni
internazionali, e parallelamente si intensificano le sue ripercussioni sulla politica
interna dei paesi colonizzatori. Sull’esempio della Gran Bretagna, che dal 1877 ha
rafforzato i legami politici e istituzionali con i suoi domini d’oltremare, tutte le
potenze europee puntano a dare un assetto “imperiale” alle loro relazioni con i paesi
extraeuropei nei quali hanno in precedenza conquistato possedimenti o acquisito un
forte potere di influenza a scopi economici o strategico-commerciali. Tale tendenza
comporta ovunque l’esaltazione dei sentimenti di potenza nazionale e di superiorità
della razza bianca; in numerosi casi la conquista coloniale viene giustificata come
“missione civilizzatrice”. Il carattere decisivo che distingue l’età dell’imperialismo
(1880-1914) dal periodo precedente non va dunque individuato semplicemente
nell’inedita estensione geografica raggiunta dall’espansione coloniale, che pure giunge
a interessare quasi la metà della superficie terrestre, ma piuttosto nelle nuove forme
assunte dal dominio coloniale stesso. Da questo punto di vista, la caratteristica
principale dell’imperialismo è la tendenza da parte delle potenze europee a pianificare
la spartizione del mondo e ad accordarsi a tavolino sulla creazione di sfere di
influenza, nel tentativo di risolvere sulla base di negoziati diplomatici gli immancabili
conflitti derivanti dal sovrapporsi delle rispettive direttrici di espansione coloniale.
La manifestazione più eclatante delle tendenze imperialistiche interessa l’Africa. Ancora
intorno al 1840 la conoscenza del continente africano da parte degli europei è assai
imprecisa, e del tutto ignota risulta la maggior parte delle zone interne. Negli anni tra il
1850 e il 1870 una serie di spedizioni geografiche – guidate da esploratori come David
Livingstone ed Henry Stanley – hanno consentito di individuare le sorgenti del Nilo e il
percorso dei fiumi Congo, Niger e Zambesi. Frizioni sulla conquista delle regioni
africane cominciano a emergere nel 1877, quando il governo britannico della provincia
del Capo, nell’Africa del Sud, decide di annettere lo Stato minerario e diamantifero del
Transvaal, governato da coloni boeri (di origine olandese); il conflitto anglo-boero
sancisce, nel 1881, la sconfitta inglese e il riconoscimento dell’autonomia del Transvaal,
che diviene repubblica Sudafricana.
Tensioni ancora più aspre si sviluppano nel 1882 tra Gran Bretagna e Francia in
seguito all’occupazione dell’Egitto da parte di truppe del governo di Londra; la
creazione di un protettorato militare britannico sul paese, giustificato dalla necessità
di sedare la rivolta della popolazione egiziana contro le pesanti interferenze straniere,
pone fine al controllo congiunto anglo-francese sulle finanze egiziane e soprattutto sul
canale di Suez. La penetrazione francese dell’Algeria (conquistata nel 1830), in
Tunisia e dal Senegal verso il Niger, l’ingresso di altre potenze nella competizione
coloniale (il Belgio afferma il proprio dominio sul bacino del Congo scontrandosi col
Portogallo, mentre la Germania acquisisce il controllo del Togo e del Cameroun, e poi
del Tanganica in una zona che ha già visto affermarsi il dominio britannico su Kenya e
Uganda) moltiplica le aree di frizione. Per evitare un conflitto, il governo tedesco si
propone come arbitro delle rivalità internazionali, convocando nel 1884-85 la
16
conferenza di Berlino. Questa si conclude con un accordo che fissa le regole per la
spartizione dell’Africa, e sancisce la libertà di navigazione sui fiumi Congo e Niger. La
conferenza pone in tal modo fine agli effetti destabilizzanti che l’espansione coloniale
in Africa minaccia di avere sulle relazioni internazionali. Non mancano in seguito
episodi di tensione, soprattutto nel Sudan, sconvolto nel 1885 dalla violenta
insurrezione antibritannica e antiegiziana della setta musulmana dei dervisci. Il paese
è lentamente riconquistato dagli inglesi, che finiscono però per scontrarsi con le
ambizioni di penetrazione francese nella regione dell’Alto Nilo.
Anche dopo la conferenza di Berlino rimangono però sul tappeto nodi irrisolti, che
corrispondono a una situazione molto fluida in cui la “concorrenza” sul fronte
coloniale da parte delle maggiori potenze europee appare quanto mai dinamica.
È quella frenetica “corsa” dei diversi paesi alla colonizzazione militare ed economica
del mondo, durata sino a tutto il primo decennio del Novecento, ricordata dagli
storici come “età dell’imperialismo”.
Con tale definizione si evidenziano due rilevanti fenomeni: da una parte lo
spostamento delle tensioni e dei conflitti d’interessi europei fuori dell’Europa, con il
parallelo tentativo di ristabilire gli equilibri di potenza attraverso la spartizione del
mondo e la competizione coloniale tra le grandi nazioni industriali; dall’altra la
trasformazione del concetto stesso di colonialismo, che da sistema di egemonia
prettamente commerciale passa a indicare il controllo politico diretto sulle colonie e lo
sfruttamento massiccio delle loro risorse.
Le regioni sottoposte al controllo europeo diventano colonie, oppure protettorati, con
locali governi-fantoccio sostenuti dal paese dominante, la “madrepatria”. La ricerca di
nuovi mercati non è più limitata solamente a imprese e compagnie, ma diventa una
politica nazionale sostenuta fortemente dagli Stati centrali, finanziata con fondi
pubblici e gestita da appositi apparati amministrativi. Ovunque, gli europei investono
somme crescenti di denaro, ricavano quantità sempre maggiori di materie prime,
impongono i loro modelli culturali e politico-istituzionali, guidando la politica
economica e la vita interna dei paesi dominati. Gli obiettivi economico-produttivi
dell’imperialismo europeo si confondono peraltro molto spesso con l’affermazione di
una presunta “missione civilizzatrice” dei bianchi, che avrebbe dovuto portare la
civiltà alle popolazioni indigene, ritenute ben lontane dal raggiungerla.
In sintesi:
Il colonialismo in età contemporanea – 2 (1874-1914)
Fase imperialista volta a garantire prestigio internazionale, a formare delle aree di mercato privilegiate
per raggiungere l’autarchia e per esportare capitali e conseguente spostamento della concorrenza tra gli
Stati dal piano economico a quello politico-militare nelle zone extraeuropee. Sviluppo dell’ideologia di
una missione civilizzatrice e protettrice nei confronti di civiltà “barbare”, i cui componenti sono simili a
fanciulli. L’imperialismo si realizza in tre forme: attraverso il controllo diretto (colonie), attraverso il
controllo indiretto, attraverso cioè organi locali (protettorati) e attraverso lo sfruttamento economico
(come la colonizzazione “informale” dell’America Latina da parte degli Stati Uniti).
L’evoluzione del colonialismo ottocentesco: l’imperialismo
L’affermarsi del modello di produzione capitalistico, in Europa e negli USA, basato sulla proprietà
privata dei mezzi di produzione, sul sistema salariato e sul primato del valore di scambio, accentua e
impone la logica del profitto: l’intero mondo diviene un unico mercato manipolato dagli imprenditori-
17
proprietari di fabbriche, terre e denaro, che possono realizzare enormi ricchezze a condizione che i
costi di produzione rimangano bassi, si amplino i mercati di vendita e le aree di investimento dei
capitali accumulati.
Vendendo a prezzi elevati e comprando a prezzi bassi, come sarà consentito dai trattati imposti a molti paesi,
monopolizzando i commerci e le risorse dei paesi colonizzati, o appropriandosi delle loro ricchezze col
sistema delle imposte, Gran Bretagna, Francia e Olanda, potranno finanziare il proprio sviluppo e il proprio
bilancio statale, costituendosi, nello stesso tempo, come polo dell’economia mondiale, mentre la periferia
sembra sempre più condannata alla dipendenza totale e all’impoverimento senza rimedio.
Per tutto l’Ottocento i domini coloniali si ampliano e si rafforzano: l’interesse è ormai spostato
definitivamente sulla conquista territoriale e gli stessi Stati si preoccupano di acquisire, anche con le
armi, nuove aree del mercato europeo. Questa nuova fase del colonialismo, caratterizzata da uno stretto
intreccio di fattori economici e militari, è più propriamente detto imperialismo.
L’Africa è l’area che ne fa maggiormente le spese. La Conferenza di Berlino (1884-1885), si svolse sotto
l’ideologia che assegnava solo alle potenze europee e ai popoli bianchi d’oltreoceano il diritto alla
sovranità: le altre aree erano considerate territori vuoti liberamente occupabili e spartibili. La divisione del
continente africano fu fatta sulla base di una terribile violenza geografica e ideologica, seguendo cioè le
coordinate geografiche o il corso dei fiumi e l’orografia, ma non tenendo minimamente conto delle
caratteristiche storiche, culturali, antropologiche, economiche dei popoli che vi abitavano. Intere
formazioni nazionali vennero così smembrate, mentre altre, da sempre rivali, vennero costrette a
convivere, scatenando contrasti sanguinosi che stanno alla radice dei conflitti del nostro secolo. L’Africa
diventò uno spazio tedesco, francese inglese e belga.
L’Asia, nondimeno, vide in quegli anni il completamento dell’espansione coloniale già avviata in
precedenza dalle potenze europee. L’Inghilterra occupò la Birmania (1886). La Francia completò
l’occupazione dell’Indocina (1893). Ma è sulla questione della Cina – Il Celeste Impero – che si
concentrarono gli appetiti delle potenze imperialiste. L’immensa popolazione costituiva un ricco mercato
e l’Impero era ormai in decadimento, incapace di mantenere il controllo sugli ampi territori. La Manciuria
venne minacciata dalla Russia. La Corea venne strappata con la guerra del 1894-95 dal Giappone. Nel
1900, infine, la rivolta dei Boxer (movimento nazionalistico per la cacciata degli stranieri) offrì l’occasione
alle potenze europee per allestire una spedizione punitiva internazionale che intervenne militarmente in
Cina. Sconfitti i Boxer, la Cina fu costretta a una politica di servilismo a porte aperte, garantendo la più
ampia penetrazione commerciale all’Occidente. La competizione economica innescatasi tra le potenze
imperialistiche europee, divenne ben presto competizione politico-militare, divenendo ben presto una
delle cause predominanti della prima guerra mondiale.
Il colonialismo in età contemporanea – 3 (1914-1945)
Fase di trasformazione del sistema coloniale, tramonta l’ideologia della missione civilizzatrice e
protettrice della colonizzazione precedente e si profila un nuovo modello di penetrazione economica
senza responsabilità politiche né coinvolgimento militare, una forma di controllo indiretto che
garantisce i vantaggi della dominazione coloniale abbattendone al contempo i costi: il neocolonialismo.
Vengono seguite tre diverse politiche coloniali: i paesi di antica industrializzazione (Regno Unito,
Francia, Olanda) cercano di mantenere le colonie come mercato per le proprie merci e fonte di materie
prime; quelli di più recente industrializzazione (Germania, Italia, Giappone) perseguono una politica di
espansione; gli Stati Uniti sviluppano invece una politica di dominio neocoloniale.
I due imperi coloniali che escono vincitori dalla Prima Guerra Mondiale (Francia e Gran Bretagna)
confermano il loro ruolo in sede di regolazione postbellica. Permane forte il preconcetto che la loro
potenza dipenda in larga parte dai territori coloniali.
D’altra parte proprio dagli anni Venti prendono corpo i movimenti che si battono per l’indipendenza.
Guidati da persone formate nelle università degli Stati coloniali i movimenti si ispirano sia ai principi
democratici delle tradizione europea sia alla necessità di recuperare un’identità nazionale annullata dal
processo di colonizzazione (Ghandi, Burghiba, Ho Chi-minh).
Dagli anni Trenta i movimenti sono particolarmente attivi in India e in Tunisia. Subito alla fine della guerra il
processo di indipendenza parte approfittando della debolezza degli Stati coloniali e delle opportunità
suggerite dalla contrapposizione Est-Ovest. Alcuni leader assumono l’iniziativa, come Sukarno, che
proclama l’indipendenza dell’Indonesia nell’agosto del 1945 e come Ho Chi-minh che il mese dopo
proclama quella del Vietnam.
18
D’altra parte nei paesi coloniali (Olanda, Belgio e soprattutto Francia) l’opinione pubblica percepisce
come troppo costoso il mantenimento del sistema. Sulla scena internazionale, poi, le grandi potenze
favoriscono il processo di indipendenza. Soprattutto gli USA che fin dalla fine della prima Guerra
mondiale raccomandavano che le rivendicazioni di indipendenza fossero accolte.
Nella Carta atlantica (1942) USA e GB si impegnano a promuovere in pieno l’autodeterminazione dei popoli.
Dal 1947 la linea USA si fa più cauta a causa della radicalizzazione dei rapporti con URSS; spesso devono
prendere il posto dei vecchi paesi coloniali per impedire l’espansione dell’influenza comunista (Taiwan, Corea e
Vietnam del Sud).
Anche l’URSS – come più tardi l’ONU – si esprime contro il colonialismo.
Cronologia
1876
1885
La Gran Bretagna proclama la formazione dell’Impero 1878 Congresso di Berlino: le potenze europee
si dividono l’Africa Settentrionale.
Conferenza di Berlino: si sancisce la spartizione delle aree coloniali “vuote” tra le potenze europee.
Non più controllo economico ma militare, il contrasto tra le potenze nelle aree extraeuropee funge da
valvola di sfogo delle tensioni europee e posticipa di fatto lo scoppio di una guerra in Europa.
1890-1910 Gli Stati Uniti praticano la politica del “big stick”, imponendo diverse forme di controllo nell’America
del Sud.
1890
L’Eritrea diventa colonia italiana.
1896
Diatriba sul trattato di Uccialli. L’Etiopia rompe le relazioni diplomatiche con l’Italia. La parola passa
agli eserciti. Ad Adua l’esercito italiano viene sconfitto. Pace di Addis Abeba: l’Italia mantiene la
colonia Eritrea.
1898
Finita la conquista della frontiera Occidentale, gli Stati Uniti cominciano una politica estera
espansionistica con la guerra ispano-americana che permette di acquisire il controllo su Cuba,
Filippine e Puerto Rico.
1899-1902 Guerra anglo-boera in Sud Africa.
1911-12
Guerra italo-turca e conquista delle coste della Tripolitania e della Cirenaica.
19
2.
Decolonizzazione
e neocolonialismo
Il processo di decolonizzazione
Dopo la fine della seconda guerra mondiale prende il via una delle più importanti e
profonde trasformazioni che abbiano caratterizzato la storia mondiale del XX secolo:
il tramonto definitivo degli imperi coloniali e la conquista dell’indipendenza da parte
dei popoli sino ad allora soggetti alle potenze europee. Le origini di questa
trasformazione epocale risalgono agli anni tra le due guerre, ma è solo dopo il
secondo conflitto mondiale che la decolonizzazione entra nella sua fase più
importante. È allora che i molti popoli sottoposti a dominio coloniale conquistano,
come ha scritto l’economista francese Alfred Sauvy, “facoltà di parola” per la prima
volta nella storia.
Il processo di decolonizzazione si realizza in fasi successive, lungo l’arco del primo
trentennio che segue la seconda guerra mondiale, e con modalità sostanzialmente
diverse da paese a paese.
La crisi del dominio coloniale europeo affonda le sue radici nel rapido
peggioramento, negli anni tra le due guerre, della situazione economica dei paesi
colonizzati. Le tensioni sociali e politiche che si scatenano in tutti i paesi coloniali, e
che danno luogo a movimenti che propugnano l’indipendenza nazionale, hanno alla
loro origine diverse cause.
La colonizzazione, ufficialmente lo sfruttamento per portare progresso e
civilizzazione, è stata in realtà una grande operazione di sfruttamento. Ha distrutto la
società tradizionale, ha modificato un’agricoltura pensata per il consumo interno con
piantagioni di prodotti destinati all’esportazione. I miglioramenti sanitari hanno
determinato esplosioni demografiche non compensate da politiche di generale
sviluppo economico. Le popolazioni autoctone percepiscono ormai che il proprio
impoverimento è frutto dello sfruttamento metropolitano, una consapevolezza che
sviluppa un sentimento di ostilità che si traduce in vere e proprie forme di resistenza.
La distruzione della comunità locale produce la nascita di borghesie locali interessate
alla ricchezza e al potere. Impoverimento e imborghesimento trovano un humus ideale
nel processo di urbanizzazione violento e rapido. Calcutta, che non esisteva ancora nel
Settecento, è oggi una delle più grandi città del mondo. All’interno della borghesia
locale si fa avanti un ceto intellettuale che combina ideologie occidentali
(nazionalismo, marxismo) ai valori tradizionali. Sono questi intellettuali che si
pongono a capo dei movimenti di liberazione pronti se necessario ad aprire guerre
rivoluzionarie. I movimenti nazionalisti sono già presenti tra le due guerre e il loro
sviluppo si collega alle vicende europee. Basti ricordare come lo smembramento, nel
1918, dell’impero austro-ungarico è compiuto in nome del diritto di
autodeterminazione dei popoli dell’Europa centrale. Così, i colonizzati possono
disporre di argomentazioni appartenenti ai colonizzatori. Talora il nazionalismo
20
sostiene l’abolizione del colonialismo. Dopo il 1945 il prestigio sovietico, il diffondersi
del comunismo e l’alleanza tra USA e potenze coloniali portano all’avvicinamento tra
comunisti e nazionalisti. Così la Francia in Indocina si scontra con Ho Chi-minh,
alleato della Cina e dell’URSS. In regime di guerra fredda il comunismo internazionale
ha interesse a sostenere movimenti che destabilizzano i paesi europei occidentali.
D’altra parte non tutti i movimenti nazionalisti sono comunisti, mentre nei paesi
islamici si collegano a movimenti religiosi.
La crisi degli anni Trenta aveva messo in serie difficoltà le colonie, a causa del crollo
dei prezzi delle materie prime, sulla cui esportazione si basava prevalentemente, in
certi casi in maniera esclusiva, l’economia di queste regioni. In molti paesi
l’importazione di beni manufatti aveva impedito lo sviluppo di industrie locali e la
maggior parte dei terreni coltivabili era utilizzata per produrre beni da esportare in
Occidente. Ciò contribuisce a spiegare perché nei nuovi nazionalismi l’aspirazione
all’indipendenza politica si accompagna alla lotta contro lo sfruttamento economico.
Un altro elemento di crisi è rappresentato da una crescita demografica estremamente
rapida: la popolazione dei paesi in via di sviluppo cresce infatti di oltre un miliardo
dal 1940 al 1970, passando dal 64 al 72 per cento dell’intera popolazione mondiale.
Causa di questa vera e propria esplosione demografica è essenzialmente il drastico
abbassamento del tasso di mortalità, reso possibile dall’introduzione di nuovi ritrovati
medici (soprattutto gli antibiotici) in società in cui si continua a registrare un elevato
tasso di natalità (tabella 2).
Al rifiuto della dipendenza economica si accompagna anche il rifiuto
dell’assoggettamento culturale. In molti paesi le religioni tradizionali – come
l’induismo (nel caso dell’India) e soprattutto l’islamismo – svolgono un ruolo
importante nella diffusione dei movimenti di emancipazione e come espressione del
rifiuto di uniformarsi alla cultura occidentale. Sin dagli inizi del secolo, del resto, la
religione musulmana era in rapida espansione, aveva conquistato e convertito le
popolazioni di vaste regioni dell’Africa e dell’Asia, presentandosi come elemento
ostile all’Europa e al suo potere coloniale.
Tabella 2. L’esplosione demografica del Terzo Mondo (in milioni).
Epoca
1750
1800
1850
1900
1950
1970
Mondo
Paesi sviluppati
791
978
1.262
1.650
2.506
3.621
201
248
347
573
857
1.084
Paesi in via di sviluppo
590
730
915
1.077
1.649
2.537
All’affermazione dei movimenti di emancipazione contribuisce peraltro anche
l’atteggiamento “non colonialista” delle due superpotenze, USA e URSS, conseguenza
del fatto che queste non avevano possedimenti coloniali.
21
Nel 1941 la Carta Atlantica proclama solennemente il diritto di tutti i popoli a
scegliere autonomamente la propria forma di governo, e gli americani incoraggiano
con decisione, in Asia e in Africa, lo sviluppo di movimenti nazionalistici. A sua volta
l’URSS considera da sempre la liberazione dei popoli oppressi come uno dei
principali obiettivi della lotta contro l’imperialismo, e nel dopoguerra appoggia, in
sede ONU, le rivendicazioni delle colonie.
L’insieme di questi fattori politici, economici e socio-culturali è all’origine della
nascita e della diffusione, in numerosi paesi, di agguerriti movimenti politici che
contestano il dominio coloniale e rivendicano una piena indipendenza. La guida di
questi movimenti viene assunta ovunque da minoranze di formazione europea, che
riconoscono la validità di valori occidentali come il principio di autodeterminazione
dei popoli, il progresso economico e il benessere sociale. A questa impostazione di
matrice razionalistica, si affiancano in certi casi elementi religiosi. L’obiettivo
principale dei nazionalismi è in primo luogo la modernizzazione dell’economia e la
formazione di strutture politiche ispirate al modello occidentale e per questo motivo,
al di là delle differenti inclinazioni (dal nazionalismo autoritario a un generico
democraticismo, sino all’aperto richiamo alle idee del movimento comunista
internazionale), tutti condividono l’idea che spetti allo Stato promuovere lo sviluppo
economico e tecnico, estromettendo il capitale straniero e sostituendosi ad esso con la
nazionalizzazione delle risorse, creando un’industria nazionale e diversificando la
produzione agricola.
Dal canto loro le potenze coloniali prendono coscienza dell’impossibilità di
sopportare ancora a lungo i gravami militari e finanziari della dominazione coloniale
diretta e dell’irresistibile ascesa delle idee favorevoli al processo di indipendenza.
Tuttavia, le grandi potenze liberali hanno più che mai bisogno di conservare i propri
possedimenti, soprattutto dopo che il loro spazio economico si è bruscamente ridotto
in seguito alla semi-chiusura di un mercato di quasi un miliardo di persone (URSS,
Cina e democrazie popolari europee).
Questa necessità impone dunque la trasformazione della vecchia politica coloniale di
controllo diretto, cercando di fare leva sui movimenti nazionalisti conservatori.
Questa nuova politica consiste nel riconoscere l’indipendenza o l’autonomia dei
governi, conservando però basi militari e vantaggi economici, e mantenendo sul posto
missioni di consiglieri e di tecnici che, di fatto, continuano a governare indirettamente
il paese.
Rinunciando al rapporto coloniale si fa ricorso a metodi di espansione meno evidenti,
come l’esportazione di capitali e investimenti nei settori-chiave dell’economia. E
siccome i territori coloniali che passano all’autonomia o all’indipendenza mancano
effettivamente di tecnici e di capitali – che possono essere forniti solo dalle vecchie
potenze – la contropartita di questi aiuti consiste spesso in concessioni che
permettono di continuare a esercitare un certo controllo sulla vita economica del
paese: privilegi fiscali o doganali, libertà di esportare capitali e profitti, controllo degli
investimenti, ecc.
La vita politica agitata e spesso tumultuosa dei paesi “giovani” dove ancora tutto è da
organizzare, l’inesperienza del nuovo personale dirigente e la mancanza di maturità
politica delle masse hanno dato vita a vari partiti politici che, con le loro lotte
appassionate, offrono numerose occasioni di intervenire nella vita interna dei nuovi
22
Stati, sino al punto di provocarvi – questo è il caso soprattutto dell’America Latina –
opportune quanto pilotate rivoluzioni.
L’estrema miseria delle popolazioni, ignoranti, denutrite, esposte a tutte le malattie e
soprattutto prive di qualsiasi speranza, rappresenta un terreno molto favorevole per la
diffusione della propaganda comunista. Per allontanare questo pericolo e per aiutare
questi territori a restaurare un’economia stabile, ma anche per assicurarsi quei mercati
di cui gli USA hanno bisogno per procurarsi materie prime destinate alla loro
industria in espansione, nel 1949 viene varato dal presidente Truman il primo piano di
aiuto ai paesi in via di sviluppo. Non si tratta di una novità assoluta per la politica
estera statunitense, ma con Truman diviene un intervento di portata universale, che
comporta una pianificazione e un impegno anche economico di entità rilevante.
Per fronteggiare i problemi del sottosviluppo asiatico, nel 1947 l’ONU crea una
Commissione economica per l’Asia e l’Estremo Oriente, una sorta di “ministero
economico” della regione, il cui compito è lo studio delle condizioni dell’economia e
l’elaborazione di raccomandazioni per migliorare la situazione alimentare attraverso lo
sviluppo della produzione agricola e una lenta e progressiva industrializzazione.
Le pressioni dirette e indirette cui sono sottoposti i paesi in via di sviluppo spiegano
come essi accolgano le offerte di aiuto con molte riserve, sospettando l’esistenza di
moventi politici e militari a lunga scadenza, rischi di interferenze nei loro affari
interni, e tentativi per impedire loro di porsi il più rapidamente possibile sulla via
dell’industrializzazione. Le popolazioni dominate, mano a mano che prendono
coscienza delle possibilità di reale indipendenza, oppongono rifiuti sempre più decisi
ad essere “rappresentati” dalle grandi potenze “bianche”: questo risveglio della piena
coscienza della propria forza e delle proprie possibilità è l’elemento dominante e più
importante della Conferenza afro-asiatica riunitasi a Bandung nel 1955, la prima
conferenza internazionale dei popoli di colore nella storia dell’umanità.
A tale conferenza – alla quale non è stata invitata nessuna potenza bianca – prendono
parte i rappresentanti di 29 paesi asiatici e africani, abitati da più della metà della
popolazione della terra, che sino a dieci anni prima erano colonie o semicolonie
dipendenti da Stati europei.
Le risoluzioni della Conferenza di Bandung – tappa importantissima sulla strada della
decolonizzazione – tracciano una ferma condanna del colonialismo, del razzismo e
della politica di segregazione e discriminazione tra le razze, che hanno gli stessi doveri
e gli stessi bisogni, soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza economica e sociale.
Coerentemente con quest’ultima considerazione la Conferenza enuncia i principi di
una politica d’indipendenza economica che dovrà mettere fine all’egemonia del
mondo bianco: cooperazione economica tra le potenze asiatiche e africane per
scambio di assistenza tecnica e finanziaria, incoraggiamento alla creazione di industrie
nazionali, trasformazione sul posto delle materie prime sinora acquistate ai prezzi
stabiliti dal mercato occidentale, creazione di banche indigene, ecc.
Sul terreno della politica internazionale, la Conferenza proclamò che gli Stati asiatici e
africani rifiutavano di essere trascinati in una guerra per l’una o l’altra delle due
grandi potenze mondiali: posizione “neutralista” importante in quella congiuntura
politica, ma più importante ancora perché contiene l’affermazione di una politica
ormai indipendente da parte di quelle nazioni asiatiche e africane che sino a questo
23
momento hanno sempre visto le potenze bianche disporre liberamente dei loro
destini.
In sintesi, si può affermare che il processo di decolonizzazione si verifica per i seguenti fattori:
• La partecipazione dei paesi colonizzati alla seconda guerra mondiale, che si configura come lotta
contro la tirannide e per i diritti dei popoli oppressi.
• Divisione del mondo in due blocchi egemonizzati da due potenze non coloniali: USA e URSS.
• Perdita della legittimità morale e della necessità economica di mantenere dei possedimenti coloniali.
• Costi per adottare delle riforme nelle colonie e per reprimere i movimenti indipendentisti.
• Inferiorità numerica delle popolazioni occidentali.
• Élite locali educate nelle nazioni occidentali colonizzatrici ai valori di libertà, uguaglianza,
democrazia, ecc.
L’evoluzione generale dei nuovi Stati
Pressappoco dovunque, in Asia come in Africa, i nuovi governi seguono una
evoluzione identica, e il ritmo della trasformazione è più o meno rapido a seconda
delle circostanze o della forza delle tradizioni. In linea generale, anche quando la
rottura con la potenza dominante avviene con la violenza, il nuovo Stato si costituisce
all’interno delle frontiere – talvolta artificiali – degli antichi territori coloniali, di cui
conserva la struttura, i quadri amministrativi e le istituzioni giudiziarie esistenti.
D’altra parte, il personale che prende in mano il governo e l’amministrazione è
composto nella quasi totalità di antichi funzionari e di professionisti di formazione
europea, spesso cristianizzati, e che hanno dunque adottato le concezioni e le maniere
di vita della civiltà europea.
Tuttavia, diviene evidente assai presto che le istituzioni liberali di stampo occidentale,
elaborate lentamente nel XIX secolo in funzione di strutture sociali ed economiche
radicalmente differenti da quelle dell’Asia e dell’Africa, sono del tutto inadeguate per
affrontare i problemi dei nuovi Stati.
Le élite che prendono in mano le sorti dei nuovi Stati, formata da intellettuali
occidentalizzati, si trovano di fronte a enormi masse rurali che è stato facile sollevare
contro la dominazione straniera, ma che non di meno vivono ancora nel cuore di un
universo materiale e morale che nulla ha in comune con uno Stato moderno.
Queste popolazioni sono del tutto estranee alla nozione di coesione nazionale, sono
ancora rette da un sistema comunitario di relazioni quasi feudali – paragonabile a
quello dell’Europa medievale – basate su una relazione da padrone a cliente. Esse
praticano una stretta solidarietà nel quadro limitato del villaggio, del clan o dell’etnia,
ma ignorano tutto ciò che non appartiene al gruppo. Si tratta di società nient’affatto
integrate, composte di somme di comunità locali, e mancano quindi di quel minimo di
omogeneità necessario per formare una nazione.
L’insufficienza del personale aggrava peraltro lo stato di inadeguatezza delle
istituzioni. Tranne che in qualche possedimento britannico, dove l’autorità coloniale
aveva incominciato a reclutare nella popolazione autoctona anche i funzionari di
livello superiore, i funzionari coloniali sono sostituiti quasi immediatamente da un
24
personale spesso incompetente e incapace di assumersi responsabilità. Rapidamente si
forma una classe di politici professionisti, che tentano di trarre da questo ruolo quanti
più vantaggi è possibile, e che praticano massicciamente lo spoil system. Questo
moltiplicarsi di funzionari si può spiegare col prestigio della funzione pubblica
ereditato dall’era coloniale, ma anche col fatto che i settori principali dell’attività
economica sono spesso ancora monopolizzati da minoranze straniere. Il funzionariato
e la politica sono dunque le sole carriere aperte alle élite dei paesi in via di sviluppo.
In breve tempo questi paesi si trovano dotati di un apparato burocratico del tutto
spropositato, elemento che genera sprechi scandalosi. Inoltre, questa borghesia
amministrativa forma una casta privilegiata e pletorica, una nuova aristocrazia del
denaro che distoglie dal circuito produttivo risorse umane e finanziarie considerevoli.
Essa percepisce stipendi considerevoli, uguali a quelli degli antichi funzionari
coloniali, ai quali si aggiungono le residenze di lusso, i domestici, l’automobile e gli
autisti pagati con risorse pubbliche. È un’élite spesso corrotta, alla ricerca di facili
guadagni nelle pieghe della corruttela, che cerca di accaparrarsi le funzioni più
“remunerative”: la polizia e la dogana, i lavori pubblici e la difesa nazionale.
Quest’insieme di situazioni portano spesso a respingere come lusso inutile e freno
pericoloso le istituzioni democratiche, la libertà dell’opposizione, il pluralismo dei
partiti. Per organizzare le masse e dare loro il senso di identità nazionale, per
mobilitare e ottenere da loro la disciplina e i sacrifici necessari per la realizzazione dei
piani di lavoro, per disciplinare gli interessi e i conflitti, per trasformare le strutture
sociali in modo da agevolare lo sviluppo economico controllando al contempo
l’ordine pubblico, l’unica strada che viene praticata è quella di una forte e salda
autorità. Un’autorità sociale e politica che non può però contare sul reale appoggio
delle masse se non coniugandosi a una mistica altrettanto radicata: il nazionalismo
asiatico, o, nel caso dell’Africa, la mistica dell’africanità o della negritudine. Miscela –
nello stesso tempo – di credenze del presunto mito dell’età dell’oro precoloniale e di
rivendicazioni del diritto a uno sviluppo immediato, di sentimenti di frustrazione e di
sfida ai paesi sviluppati, volontà di distinguere tra una modernizzazione capace di
integrare la tradizione e un’occidentalizzazione vista come nuova forma di alienazione.
Sempre più sovente si profila una nuova categoria di dirigenti nazionalisti: i militari,
che si propongono di combattere la corruzione e difendere la nazione contro la
disintegrazione. Generalmente antifeudali e ostili all’aristocrazia, come nell’America
Latina e nel Vicino Oriente, si propongono di promuovere lo sviluppo dell’economia,
ma la loro indole antidemocratica li porta a essere molto raramente costruttori di
qualcosa; la loro ossessione di “difendere l’ordine” li porta spesso a frenare ogni
occasione di crescita e a disvelare la loro identità conservatrice.
Il problema dell’indipendenza economica
Le potenze coloniali rimangono presenti non soltanto nel campo politico e
amministrativo, ma soprattutto in quello economico. Da una parte, tutto il sistema dei
trasporti, ferrovie, strade, porti, l’orientamento delle correnti commerciali organizzate
in funzione degli interessi del colonizzatore non possono essere modificati con un
semplice tratto di penna. D’altra parte i paesi colonizzati si scontrano con ostacoli
25
considerevoli per lo sviluppo di un’economia autonoma: penuria di capitale
autoctono, deficienza di tecnici competenti e manodopera qualificata. Circostanze che
aggiungono nuove difficoltà a quelle già esistenti, e che obbligano i governi dei nuovi
Stati a stipulare onerosi accordi finanziari e politici con gli antichi colonizzatori.
La divisione internazionale del lavoro (che è una parte di eredità del patto coloniale) e
la stretta dipendenza dalla congiuntura pongono così le antiche colonie in una
situazione molto sfavorevole: esse sono produttrici di uno o di qualche prodotto
grezzo i cui costi sono molto instabili e hanno tendenza al ribasso. Ma per la maggior
parte di questi prodotti, sono in concorrenza le une con le altre, dipendono quindi
dalle grandi potenze industriali che possono scegliere tra i loro clienti, e sono, nello
stesso tempo, i fornitori dei beni strumentali indispensabili.
In termini generali (ma il concetto verrà ripreso in seguito) si assiste a un progressivo
degrado dei termini dello scambio a spese dei paesi esportatori di prodotti agricoli, e
importatori di prodotti industriali dei paesi occidentali. Il fatto è che questi prodotti
di base sono controllati da monopoli e da cartelli internazionali che, come è stato
affermato, sono “autentiche potenze coloniali” (la Unilever in Africa, la United Fruit
nell’America Centrale, la Alucam nel Cameroun, le compagnie petrolifere nel Medio
Oriente, ad esempio). Queste grandi unità economiche interterritoriali, il cui centro è
sempre localizzato in un grande paese industriale, possono possedere importanti
sfruttamenti nei paesi ex coloniali, ma non li integrano mai nell’economia nazionale,
subordinano interamente la loro attività alla propria politica generale senza nessun
vincolo con l’economia locale, controllano la produzione, giocano sulla concorrenza
dei diversi paesi senza preoccuparsi della loro crescita e del loro interesse, e, quasi
mai, reinvestono i profitti sul posto.
La necessità di fare appello ai capitali stranieri, come pure la partecipazione a una
“zona monetaria” (le ex colonie francesi, ad esempio, continuano a vendere i propri
prodotti anche dopo l’indipendenza in larga misura nell’area del franco),
contribuiscono a mantenere i vincoli di dipendenza mentre l’impianto di aziende
straniere limita l’efficacia degli sforzi tentati per affrancarsi. Ne consegue perciò una
situazione di vassallaggio cui solo un processo di industrializzazione potrebbe
permettere di sfuggire. Inoltre, alla mancanza di capitali e tecnici, deve aggiungersi la
concorrenza delle merci europee o americane, e la ristrettezza del mercato interno
conseguenza del frazionamento territoriale, che rende impossibile la messa in opera di
una produzione redditizia.
A questi elementi di debolezza si aggiungono peraltro la progressione di un settore
terziario improduttivo smisurato, un ventaglio dei salari molto aperto (che genera
ineguaglianze stridenti), gli esorbitanti costi dell’indipendenza che assottigliano
enormemente i bilanci nazionali.
Questi vincoli con i paesi industrializzati creano quindi rapporti di dipendenza che
derivano dall’ineguaglianza delle strutture economiche tra i diversi paesi. Essi fanno
apparire anacronistici gli interventi armati alla maniera di un tempo, all’infuori che nei
casi estremi, come quelli che avvengono nel Gabon, nell’Africa Orientale e nel Congo
belga, come pure nel Kenya, in Uganda e in Tanzania.
Gli investimenti privati sono di norma insufficienti e di mediocre utilità, perché sono
preoccupati di ottenere profitti rapidi e immediatamente esportabili. Sono dunque gli
investimenti statali quelli che predominano, gravati dai vincoli degli accordi
26
economici bilaterali, che prevedono sempre delle pesanti contropartite. Lo stesso
avviene per gli aiuti e prestiti di cui beneficiano i nuovi Stati, costretti a concedere
concessioni che permettono di esercitare un certo controllo sulla loro economia:
privilegi doganali e fiscali, impegni di effettuare determinati livelli di acquisti nei paesi
creditori, rinuncia a effettuare nazionalizzazioni, libertà all’esportazione di capitali e
profitti.
Si tratta di quello che è stato convenzionalmente definito il “colonialismo del
dollaro”, un comportamento praticato da tutte le potenze industriali. Molto spesso
vengono anche imposte condizioni politiche: si tratta nel più frequente dei casi di
impedire a un nuovo Stato di “pendolare” nel campo avversario (è il caso della gran
parte degli aiuti militari e finanziari offerti dagli USA), di ottenere l’appoggio
internazionale degli ex paesi coloniali, particolarmente con il loro voto all’ONU.
In quanto alla cooperazione tecnica che si realizza sia con l’invio di esperti, di
ingegneri, di medici, di professori, sia con la concessione di borse che attirano gli
studenti nelle università straniere, il loro scopo è di diffondere la lingua del paese
industriale, di diffonderne i prodotti (export follow experts, secondo l’espressione
inglese), di acquistare un influsso sui quadri autoctoni.
Se è vero che molti Stati appartenenti all’area dello sviluppo partecipano alle diverse
forme di questi aiuto, quelli di cui l’importanza è maggiore sono evidentemente gli
Stati Uniti da una parte, l’URSS e la Cina dall’altra. L’ammontare degli aiuti americani
è di gran lunga il più elevato, ma questo aiuto è il meno efficace: disperso tra un gran
numero di paesi principalmente in funzione degli interessi strategici della geopolitica,
è sovente sprecato o è destinato a investimenti o acquisti improduttivi, di esclusivo
appannaggio delle élite dirigenti, una circostanza che rende ancora più marcate le
ineguaglianze sociali. L’aiuto “orientale” è per converso assai meglio coordinato,
comporta solo raramente aiuti a fondo perduto, e prevede di norma la concessione di
mutui a lungo termine (12 o anche 25 anni) a basso interesse (dal 2 al 3 per cento) e
restituibili in valuta o in prodotti locali.
In ogni modo, i paesi che hanno raggiunto recentemente l’indipendenza preferiscono
gli accordi multilaterali a quelli bilaterali. L’allargamento della cerchia dei clienti e dei
fornitori consente meglio di sfuggire alle pressioni che la potenza dominante esercita
su di essi.
La dissoluzione degli imperi coloniali europei in Asia: il caso dell’India
Oltre alla Cina, due grandi colonie occidentali in Asia, l’India britannica e il Vietnam
francese, conquistano l’indipendenza, sebbene con modalità estremamente diverse. Di
fronte all’impossibilità di mantenere con la forza i possedimenti coloniali,
l’atteggiamento della Gran Bretagna fu in generale più flessibile e pragmatico di
quello della Francia. Pur facendo uso in varie occasioni di violente misure di
repressione, i governi britannici evitano infatti di impegnarsi in lunghe e costose
guerre e finiscono per accettare come fatto inevitabile la conquista dell’indipendenza
da parte delle colonie, purché esse accettino di negoziare con Londra i modi e i tempi
della loro emancipazione e di mantenere i legami politici – e soprattutto economici –
con la ex madrepatria.
27
Viceversa, il processo di emancipazione delle colonie francesi si scontrò a Parigi con
una concezione molto rigida dell’indivisibilità dell’impero e con una difesa strenue
della grandeur nazionale, anche quando l’instabilità dei governi e le difficoltà
economiche consiglierebbero un atteggiamento più conciliatorio. La Francia di
conseguenza non è capace di evitare alcuni sanguinosi conflitti coloniali (soprattutto
in Algeria), dai quali esce solamente grazie all’intervento americano o a prezzo di
gravissime crisi politiche interne.
Simbolo del pragmatico equilibrio tra repressione e liberalismo sono le vicende che
portano all’indipendenza dell’India, vero centro nervoso dell’impero coloniale
britannico. Paese interessato da una enorme crescita demografica, l’India annovera
anche significative risorse industriali (soprattutto nel settore tessile) che hanno
consentito la formazione, nei principali centri urbani, di una moderna classe operaia
organizzata in sindacati e di un vasto ceto impiegatizio.
Alla principale forza politica del nazionalismo indiano, il Partito del congresso, di
orientamento moderato, si è aggiunta un’ala nazionalista radicale e socialista, guidata
da Jawaharlal Nehru, che oltre all’indipendenza propugnava anche l’emancipazione
sociale delle classi inferiori. Tuttavia, il massimo ispiratore e vero capo spirituale del
nazionalismo indiano è Mohandas Karamchand Gandhi, più noto come Mahatma
(Grande anima). La sua dottrina – detta satyagraha (abbraccio della verità) – si
ispirava al tradizionalismo religioso e si basava sul rifiuto della violenza (Appendice 2)
e sulla non-collaborazione con il potere coloniale. Agli scioperi, alle marce di protesta
e alle campagne di disobbedienza civile organizzate dal movimento indipendentista
(come nel caso del boicottaggio dei prodotti britannici o del rifiuto di pagare le
imposte) partecipano milioni di indiani, e il diffondersi della non-collaborazione nella
burocrazia e nella polizia mette in seria difficoltà il potere coloniale inglese. La
politica di Gandhi, favorevole alla conservazione di una società ordinata in caste,
lascia tuttavia insoddisfatte le più profonde esigenze di rinnovamento sociale,
divenendo perciò il bersaglio dell’opposizione del nazionalismo più radicale. Egli
inoltre fallisce nei suoi tentativi di favorire la cooperazione tra la grande maggioranza
degli indiani induisti e la minoranza musulmana, il cui separatismo è invece
appoggiato dalla Gran Bretagna con l’obiettivo di dividere e indebolire il movimento
nazionalista.
La Lega musulmana si afferma gradualmente come la forza politica più
rappresentativa nelle province orientali a prevalente religione islamica e radicalizza
progressivamente le proprie posizioni autonomiste, mentre gli scontri tra oltranzisti
indù e musulmani diventano sempre più violenti e sanguinosi. Ciò rende inevitabile la
divisione del paese: quando nel 1947 la Gran Bretagna accetta di riconoscere
l’indipendenza dell’India, vengono così costituiti due Stati autonomi, l’India (a
maggioranza induista) e il Pakistan (a maggioranza musulmana) da cui in seguito
(1971) si sarebbe staccato il Bangladesh.
Gli effetti della divisione sono però drammatici. L’esodo incrociato di 6 milioni di
indù e di 8 milioni di musulmani da un paese all’altro provoca infatti massacri
spaventosi, e lo stesso Gandhi cade vittima di un attentato da parte di un fanatico
indù, convinto che il Mahatma abbia acconsentito alla spartizione del paese, contro la
quale egli, in realtà, si oppone sino all’ultimo.
28
Negli anni successivi i due paesi conoscono evoluzioni profondamente diverse:
l’India, sotto la guida di Nehru, sviluppa un’agricoltura e un’industria moderne e
istituzioni democratiche sufficientemente solide (nonostante qualche breve parentesi
autoritaria), condizioni che garantiscono uno sviluppo robusto che pure non risolve i
problemi dell’approvvigionamento alimentare; il Pakistan, al contrario, dopo
l’improvvisa morte del leader carismatico della Lega musulmana, Jinnah, cade
rapidamente sotto il controllo di violente dittature militari. Ancora oggi vecchie
tensioni religiose e nuovi conflitti etnici (con la nascita di movimenti estremisti
indipendentisti, tra cui quelli delle popolazioni sikh del Punjab e tamil nel sud del
Paese) continuano a minacciare la pace sociale dell’immenso subcontinente indiano e
la stabilità delle sue istituzioni.
L’indipendenza delle colonie francesi: Indocina e Nord Africa
L’indipendenza del Vietnam è conseguita solo dopo una sanguinosa guerra che
impegna senza successo le truppe francesi dal 1946 al 1954. In Indocina il regime
coloniale francese – particolarmente duro e iniquo- tenta inutilmente di piegare
militarmente l’agguerrito movimento comunista del Viet Mihn (Fronte per
l’indipendenza del Vietnam), già protagonista della resistenza contro i giapponesi,
che, alle richieste di indipendenza, unisce decise rivendicazioni sociali a favore dei
contadini.
Iniziato come guerra di liberazione dal dominio coloniale, dopo la vittoria comunista
in Cina (1949) lo scontro si trasforma rapidamente, diventando uno degli scenari del
conflitto che vede contrapporsi il blocco occidentale e quello socialista. L’esercito
Viet Mihn è infatti sostenuto, addestrato e rifornito di armi dai cinesi, mentre le
truppe francesi godono del massiccio appoggio militare degli Stati Uniti, che
sostengono anche la maggior parte dell’onere finanziario della guerra.
Solo le pesanti sconfitte militari subite dalla Francia per mano dell’esercito vietnamita
di Ho Chi-mihn inducono il governo di Parigi a trattare la pace. Gli accordi, che si
concludono a Ginevra nel 1954, stabiliscono la completa ritirata dei francesi
dall’Indocina e la sua spartizione in tre Stati: Laos, Cambogia e Vietnam. Per
quest’ultimo viene decisa la separazione lungo la linea provvisoria del 17° parallelo, in
attesa che elezioni generali consentano l’unificazione del paese. In realtà, la divisione
diviene presto definitiva: a nord si instaura il regime socialista della Repubblica
democratica del Vietnam, a sud un regime di ispirazione cattolica e filoamericano, nel
quale trovano rifugio oltre un milione di cattolici vietnamiti in fuga dalle regioni
settentrionali.
La disfatta politico-militare in Vietnam accelera in maniera decisa il tramonto del
colonialismo francese in Nord Africa, soprattutto nei protettorati di Tunisia e
Marocco, nei quali, a differenza dell’Algeria, non era particolarmente consistente la
presenza di coloni europei. Qui i movimenti nazionalisti, già rafforzatisi negli anni
dell’anteguerra, traggono ulteriore forza dagli errori e dalle oscillazioni del governo
francese che, dopo avere promesso l’indipendenza, nel 1953 depone con un maldestro
colpo di mano il re del Marocco che richiedeva l’indipendenza e tenta inutilmente di
reprimere con la forza il movimento nazionalista tunisino, guidato dal partito Destur
29
di Habib Bourguiba. Di fronte alla sollevazione popolare e all’intensificarsi della
spirale terroristica, nel 1956 il governo di Parigi è costretto infine a concedere la piena
indipendenza a entrambi i paesi. Sia la Tunisia – guidata dal 1957 al 1987 dal
presidente Bourguiba – che il Marocco – retto dal 1961 dal re Hassan II – danno vita
a sistemi politici autoritari e di fatto monopartici, mantenendo una politica
sostanzialmente filo-occidentale.
La rapida diffusione dei movimenti nazionalisti e l’estendersi della guerra fredda in
Asia convince i governi di India, Pakistan e Indonesia della necessità di creare una più
forte unità politica tra i paesi dell’Asia e dell’Africa. A questo scopo viene convocata
la Conferenza di Bandung, alla quale partecipano, come s’è detto, 29 paesi, tra cui
anche la Cina e alcuni paesi africani indipendenti (Egitto, Etiopia e Libia). La
Conferenza si conclude con la condanna di ogni forma di colonialismo e la
proclamazione di una serie di principi-guida, tra i quali, giova ricordarlo, il
riconoscimento dell’integrità territoriale, della reciproca non-aggressione, della noningerenza nelle questioni interne di altri Stati e dell’intensificazione degli scambi
economici tra i paesi partecipanti.
La Conferenza di Bandung costituisce inoltre il presupposto per la creazione del
movimento dei cosiddetti paesi non-allineati, cioè di quelli che, dichiarandosi neutrali
rispetto allo scontro Est-Ovest, rifiutano la logica dei blocchi e privilegiano obiettivi
di disarmo, sicurezza collettiva e autonomia politica.
Promosso dall’iniziativa comune dell’indiano Nehru, dell’egiziano Nasser e dello
jugoslavo Tito, il movimento dei non-allineati nasce ufficialmente nel 1961 nel corso
della Conferenza di Belgrado, ma il suo limite è quello di non riuscire mai a
presentarsi sulla scena internazionale come una forza unita e un’alternativa reale alla
politica dei blocchi. Profondamente diverse sono infatti le posizioni di coloro che
intendono il non-allineamento come una politica finalizzata ad allentare le tensioni tra
Est e Ovest e i sostenitori di un aperto schieramento a fianco dei movimenti di
indipendenza contro l’imperialismo e il neo-colonialismo occidentale. Per di più, aspri
conflitti sia per questioni territoriali (come nel caso delle tensioni tra India e Cina e
India e Pakistan), sia in merito alle relazioni con URSS e Cina, causano un’ulteriore
frattura all’interno del movimento.
Le origini della crisi del Medio Oriente e del conflitto arabo-israeliano
La principale conseguenza a livello internazionale della conquista dell’indipendenza
da parte dei paesi coloniali consiste senza dubbio nella sua carica destabilizzante. Il
processo di decolonizzazione in effetti si traduce nella creazione di nuovi focolai di
tensione internazionale: India e Pakistan giungono ripetutamente allo scontro
militare, mentre la divisione del Vietnam, come già quella della Corea, è destinata a
sfociare in una grave crisi regionale dalle conseguenze decisive per l’intero Occidente.
Analogamente, con la fine del protettorato britannico e francese sulle monarchie
arabe del Medio Oriente, la regione diviene un’area di crisi permanente.
L’affermazione del nazionalismo arabo costituisce sin dagli anni tra le due guerre una
delle manifestazioni più forti dell’aspirazione all’indipendenza del mondo colonizzato
e la più diretta minaccia alla tradizionale supremazia europea. Le potenze europee
30
riescono tuttavia a mantenere intatta la propria influenza sino al secondo dopoguerra.
La Gran Bretagna, in particolare, che nel 1936 ha dovuto concedere l’indipendenza
all’Egitto, continua a presidiare militarmente il canale di Suez e considera il
mantenimento della sua influenza nella regione un obiettivo essenziale per garantire la
sicurezza delle comunicazioni con i suoi possedimenti in Estremo Oriente, ma
soprattutto per controllare le vie di accesso agli immensi giacimenti petroliferi della
regione del Golfo Persico.
Nonostante il forte sentimento di unità culturale diffuso tra tutte le popolazioni di
cultura araba e di religione islamica, le aspirazioni all’emancipazione dalla tutela
occidentale sfociano in iniziative spesso disordinate, talora in tumulti sanguinosi, ma
dalle scarse conseguenze politiche. Forti tensioni interessano anche i sostenitori
dell’universalismo islamico – che aspira a riunire tutti i paesi islamici in un’unica
“nazione araba” – e i numerosi e agguerriti particolarismi locali, spesso incoraggiati
dalle potenze coloniali.
Il nazionalismo arabo resta quindi per lungo tempo frammentato in diverse fazioni,
alimentate dalla rivalità tra le grandi e piccole dinastie feudali dell’area. Esso
costituisce quindi un fenomeno facile da reprimere, da circoscrivere e talvolta
addirittura da corrompere a opera delle potenze “mandatarie”. La sola parziale
eccezione è costituita dall’Egitto, indipendente dal 1936 e principale centro culturale
del risorgimento arabo.
L’ambigua politica britannica non riesce a mitigare le tensioni nazionaliste, che
finiscono per rendere, sin dagli anni tra le due guerre, la Palestina (vale a dire l’area
approssimativamente compresa tra il Libano a nord, il fiume Giordano a est e la
regione del Sinai a sud – uno dei maggiori focolai di guerra del pianeta. Da un lato,
infatti, la collaborazione degli inglesi con il sionismo – il movimento nazionalista
ebraico – all’indomani della prima guerra mondiale ha portato alla nascita in Palestina
di un Centro nazionale ebraico e alla proliferazione di numerose colonie di immigrati
di origine ebraica: i kibbutzim, villaggi che fungono contemporaneamente da
comunità sociale, unità produttive agricole e postazioni militari. Dall’altro, i
mandatari britannici non hanno smesso di promettere agli arabi di Palestina la
formazione di uno Stato indipendente a prevalenza araba. La crescita massiccia
dell’immigrazione ebraica in seguito alle persecuzioni antisemite scatenatesi in Europa
(la comunità ebraica passa da 85.000 abitanti nel 1920 a circa 450.000 alla vigilia della
seconda guerra mondiale, ossia da un decimo a un terzo del totale della popolazione
palestinese) e la crescente organizzazione statuale assunta dagli insediamenti ebraici,
vengono avvertite perciò dagli arabi palestinesi – la maggioranza della popolazione –
come una minaccia (tabella 3). Queste tensioni sono all’origine di periodiche rivolte
degli arabi palestinesi, duramente represse dalle truppe britanniche.
Nel 1939 gli inglesi, per non perdere l’appoggio degli arabi del Vicino Oriente –
corteggiati, talvolta con successo, dalla Germania nazista con l’offerta di aiuti
economici e di sostegno politico alla causa nazionalista – dapprima propongono la
costituzione di due Stati separati, poi, di fronte al netto rifiuto di entrambe le parti,
decidono di limitare l’immigrazione ebraica (che però continua clandestinamente) e
promettono di riconoscere entro dieci anni l’indipendenza della Palestina. Di
conseguenza durante la seconda guerra mondiale il sionismo assume posizioni
violentemente antibritanniche, inasprite ulteriormente dal fatto che alla fine della
31
guerra molti immigrati clandestini, sfuggiti ai lager nazisti, vengono inviati nei campi
di prigionia britannici nell’isola di Cipro. Nel 1947 le Nazioni Unite, approvano un
piano in base al quale il paese avrebbe dovuto essere diviso tra arabi e israeliani. La
proposta viene però respinta dai palestinesi e dagli Stati della Lega araba.
Tab. 3. L’immigrazione in Israele, 1945-1954.
19 5 4
46.000
98.000
19 5 3
91.000
19 5 2
19 5 1
51.000
174.000
19 5 0
170.000
19 4 9
235.000
19 4 8
101.000
19 4 7
86.000
19 4 6
19 4 5
54.000
La nascita dello Stato d’Israele
Durante il secondo dopoguerra, in Palestina si inasprisce lo scontro tra la comunità
ebraica e quella araba, reso ancora più violento dall’emergere al loro interno di
agguerrite formazioni terroristiche.
Falliti i tentativi di mediazione elaborati da britannici e americani, tocca all’ONU
approvare nel 1947 un piano per la spartizione della Palestina in due Stati indipendenti,
uno ebraico (pari al 55 per cento dell’intero territorio palestinese) e uno arabo, e
l’istituzione di un protettorato internazionale sulla città santa di Gerusalemme.
Questa soluzione di compromesso viene tuttavia respinta dai principali paesi arabi
(Egitto, Transgiordania, Libano, Siria, Iraq) riuniti dal 1945 nella Lega araba, e dagli
arabi palestinesi; il 15 maggio 1948 (scadenza del mandato britannico) le truppe inglesi
abbandonano il territorio palestinese lasciandolo privo di amministrazione e di difesa.
Contemporaneamente il Consiglio nazionale ebraico, il cui presidente è Davide Ben
Gurion, proclama unilateralmente la nascita dello Stato di Israele (immediatamente
riconosciuto da USA e URSS) mentre truppe della Lega araba occupano varie zone
della Palestina.
Tra il maggio 1948 e il gennaio 1949 si svolge il primo conflitto tra le truppe arabe e
l’esercito israeliano: la guerra si protrae per diversi mesi, tra scontri, temporanee
tregue e tentativi di mediazione dell’ONU (il cui inviato è assassinato da terroristi
sionisti) e si conclude con la vittoria israeliana. Dopo l’armistizio (firmato nel 1949), il
32
nuovo Stato di Israele controlla quasi l’80 per cento del territorio dell’ex Palestina
britannica. Nonostante la sconfitta, l’Egitto ottiene il controllo della striscia costiera di
Ghaza e la Transgiordania l’annessione della Cisgiordania.
Per quasi vent’anni tale situazione rimane immutata. Lo Stato di Israele – nato,
secondo un’efficace definizione, come “una piccola isola in un mare di ostilità” –
diventa una democrazia parlamentare solida ed efficace, con un’articolata vita politica
dominata per quasi trent’anni dal Partito laburista di orientamento socialista.
Nonostante le difficoltà di integrazione culturale e religiosa tra immigrati provenienti
da realtà enormemente diverse e una gerarchia sociale fortemente segnata dal
prevalere dei ricchi e colti ebrei “europei” su quelli giunti dalle regioni medioorientali e dal Nord Africa, poveri e spesso analfabeti, la società israeliana –
largamente organizzata secondo principi cooperativistici e comunitari – è capace di
sviluppare un forte spirito di coesione, rafforzato dalla condizione di stato d’assedio
permanente in cui si svolge la vita del paese.
Questa situazione implica non solo il mantenimento di un esercito efficiente, dotato di
armi modernissime (negli anni Sessanta Israele verrebbe anche in possesso di armi
atomiche), ma anche una crescente “militarizzazione” di tutti i cittadini.
Nonostante il boicottaggio commerciale organizzato ai suoi danni dagli arabi, il paese
conosce uno sviluppo economico eccezionale, grazie anche ai massicci aiuti inviati dal
governo degli Stati Uniti, ai fondi versati dalla Germania occidentale come
risarcimento per le persecuzioni naziste, e al sostegno finanziario della ricca comunità
ebraica internazionale.
Tuttavia, occorre ricordare che il “miracolo israeliano” viene realizzato sulla
segregazione di fatto della minoranza araba rimasta in Israele (a metà degli anni
Cinquanta, su una popolazione di 1.700.000 abitanti, appena il 10 per cento è costituito
da arabi palestinesi, mentre nel 1945 c’erano 1.250.000 arabi e 555.000 ebrei) e
sull’espulsione di quasi 800.000 arabi palestinesi, costretti dopo la guerra ad
abbandonare tutte le loro proprietà. I loro agrumeti, oliveti, terreni, case, aziende e
negozi in tal modo fanno la fortuna dei cittadini israeliani e dei nuovi immigrati affluiti
dopo la guerra. Viceversa, solo a una piccola parte dei profughi palestinesi viene
consentito di integrarsi nei paesi arabi nei quali si rifugiano. In massima parte, infatti,
essi sono costretti a vivere nei campi profughi allestiti a Ghaza, in Giordania, in Siria e
nel Libano meridionale, in condizioni di estrema miseria e deprivazione sociale.
Tutto ciò rende inevitabile l’accumularsi, soprattutto nelle generazioni più giovani, di
sentimenti di frustrazione, di odio e di rivincita, che vanno ad alimentare le fila di
movimenti di guerriglia, come quello dei fedayin, talvolta strumentalizzati dai governi
arabi della regione a vantaggio dei propri interessi. Le incursioni di guerriglieri
palestinesi all’interno del territorio israeliano, e le violente rappresaglie dell’esercito di
Tel Aviv, spesso rivolte contro i villaggi palestinesi sorti ai confini del paese, diventano
da allora in poi il tragico sviluppo del conflitto tra i due popoli.
La modernizzazione dell’Egitto e la crisi del canale di Suez
La sconfitta araba nella guerra del 1948 contro Israele provoca il crollo della debole
monarchia egiziana, minata dalla corruzione e politicamente sempre più sottomessa alla
33
Gran Bretagna. La radicalizzazione del movimento nazionalista e la ripresa di sommosse e
tumulti popolari, diretti a ottenere l’espulsione del contingente britannico dal canale di
Suez, sfociano nel luglio 1952 in un colpo di Stato effettuato da un gruppo di militari
guidato da Gamal Abdel Nasser, che un anno più tardi proclama la repubblica e instaura
un regime autoritario. Il nuovo regime nazionalista vara una riforma agraria, seppure
parziale, e in politica estera mantiene una posizione anticolonialista e si avvicina all’URSS,
con la quale avvia un programma di collaborazione militare.
Per la sua politica decisionista e il suo grande carisma, Nasser diviene rapidamente un
simbolo del nazionalismo arabo; la sua immagine è visibile in tutto lo scacchiere
mediorientale. Il fatto però di essere considerato un eroe era anche ragione di
maggiori pericoli e responsabilità, per le aspettative suscitate nel mondo arabo.
Abbracciando la causa del neutralismo nella guerra fredda, Nasser attira inoltre su di
sé l’ostilità degli Stati Uniti. Nel contempo Israele comincia a guardare all’Egitto come
al principale rivale esterno.
In politica interna i suoi obiettivi principali sono la modernizzazione di un paese sino
a questo momento male amministrato e la rapida crescita della produzione agricola
per fare fronte a una esplosione demografica senza precedenti. Significativo a questo
proposito è il progetto della diga di Assuan, con il quale il nuovo regime nasseriano
intende sbarrare parzialmente il corso del Nilo per creare un enorme bacino idrico in
grado di produrre l’energia elettrica necessaria al paese e di irrigare, rendendoli
coltivabili, più di 800.000 ettari di deserto. Dopo che gli USA rifiutano un prestito
attraverso la Banca Mondiale, Nasser proclama la nazionalizzazione del canale di Suez
(26 luglio 1956) con l’intenzione di utilizzarne gli immensi profitti derivanti
essenzialmente dal trasporto del petrolio (tabella 4) – andati sino ad ora a beneficio
degli azionisti della compagnia proprietaria del canale, prevalentemente britannici –
per finanziare la costruzione della diga.
Tab. 4. Provenienza e destinazione delle merci in transito dal canale di Suez (dati
percentuali 1966).
Paesi di origine
Kuwait
Arabia Saudita
Iran
Iraq
%
Paesi di destinazione
43,0
26,2
25,5
5,3
Italia
Gran Bretagna
Francia
Olanda
Belgio
Germania Ovest
Stati Uniti
Altri paesi
%
35,5
16,0
17,2
10,4
7,6
7,2
5,8
0,3
Alla nazionalizzazione del canale i governi di Gran Bretagna (le cui truppe hanno
lasciato il canale un anno prima), Francia e Israele (quest’ultimo accusa Nasser di
appoggiare i terroristi palestinesi della striscia di Ghaza e teme la crescita della forza
militare egiziana) reagiscono organizzando un attacco che punta a infliggere un duro
34
colpo al regime di Nasser. L’esercito israeliano occupa a sorpresa la regione del Sinai
(29 ottobre 1956), mentre truppe aviotrasportate francesi e britanniche sono
paracadutate nella zona di Suez, ufficialmente per riportare la pace tra israeliani ed
egiziani, in realtà per riconquistare il controllo del canale.
L’iniziativa è però duramente condannata sia dagli Stati Uniti che dall’Unione Sovietica.
Le due superpotenze infatti non hanno alcuna intenzione di venire coinvolte
nell’eventuale escalation di un conflitto arabo-israeliano e impongono perciò il ritiro
(l’URSS ricorre anche al monito nucleare) di francesi e inglesi dall’Egitto, mentre il
confine israeliano-egiziano viene presidiato da truppe dell’ONU. L’Egitto mantiene così
il controllo del canale, mentre il progetto di Assuan viene finanziato grazie ai prestiti
concessi da URSS, USA e altri governi occidentali.
In politica estera, Nasser prosegue la lotta contro Israele, mantenendo un
atteggiamento neutrale verso le grandi potenze, che per molti occidentali diviene
sinonimo di “filosovietismo” a causa degli accordi economici che l’Egitto stipula con i
paesi dell’area socialista. Nel 1956, i rapporti tra Egitto e paesi occidentali registrano
un netto deterioramento, in quanto questi ultimi non accolgono la richiesta di
armamenti avanzata da Nasser, il quale si rivolge allora, con successo, alla
Cecoslovacchia e all’URSS.
Gli anni tra il 1956 e il 1959 segnano l’apice del nasserismo. Il suo ascendente sugli
arabi – soprattutto della nuova generazione – è notevole, tanto da essere considerato
un moderno “saladino” che avrebbe unito il popolo arabo per cacciare gli israeliani
dal Medio Oriente. Parallelamente Nasser si dedica all’edificazione di uno Stato a
propria misura: nel giugno 1956 viene promulgata la nuova costituzione repubblicana,
che dichiara l’Islam religione di stato e riconosce l’Egitto come appartenente alla
“nazione araba”.
Nasser è confermato presidente con un mandato di sei anni e i partiti politici sono
sostituiti da un’organizzazione politica unica, l’Unione nazionale. Tuttavia, nonostante
la diffusione del nasserismo in tutto il Medio Oriente, rivalità personali e una serie di
colpi di Stato in Siria e in Iraq all’inizio degli anni Sessanta allontanano la prospettiva
della creazione di una “nazione araba”. Il conflitto con Israele viene così “congelato”:
il suo riaccendersi dieci anni più tardi (1967: terza guerra arabo-israeliana, la
cosiddetta “guerra dei sei giorni”) sarebbe però stato destinato a influire
pesantemente sulle vicende politiche ed economiche mondiali.
La guerra d’Algeria e la decolonizzazione in Africa
Tra il 1956 e il 1965 in Africa si assiste al rapido smantellamento degli imperi coloniali
costruiti dagli Stati europei e alla nascita di trentacinque nuovi paesi indipendenti. Sin
dall’immediato dopoguerra Francia e Inghilterra avevano indetto nelle colonie
africane consultazioni elettorali, che avevano visto il successo dei partiti e dei
movimenti indipendentisti.
I partiti autonomisti, che incarnano le aspirazioni all’emancipazione delle emergenti
borghesie locali e la protesta anticoloniale dei ceti popolari, hanno dato vita a un vasto
movimento panafricano, che si propone di abbattere le frontiere coloniali, tracciate
artificialmente, senza tenere conto delle distribuzioni etniche, e di realizzare l’unità di
35
tutti i popoli del continente. Questa tendenza si concretizza soprattutto nell’Africa
francese, dove i partiti indipendentisti hanno dato vita all’Unione democratica
africana. La decolonizzazione in Africa ha nel suo complesso un carattere pacifico e si
realizza prevalentemente attraverso la collaborazione dei partiti africani con i governi
delle rispettive madrepatrie.
Esistono tuttavia eccezioni – drammatiche eccezioni – soprattutto nei paesi dove più
estesi sono gli insediamenti di coloni occidentali e più forti gli interessi economici
delle potenze europee. L’Algeria francese è la prima, e la più importante, delle colonie
nelle quali l’indipendenza viene conquistata solo a prezzo di una guerra sanguinosa.
Qui, nonostante le promesse di “assimilazione” – ossia di parificazione giuridica,
compreso il diritto al voto – fatte alla popolazione locale, il Parlamento viene eletto in
base a un sistema che assegna agli europei (meno di 1 milione su 8 milioni di abitanti)
la metà dei rappresentati, mentre la comunità francese si oppone duramente a ogni
tipo di riforma. Inoltre, l’intenso sviluppo postbellico dell’economia algerina è andato
a quasi esclusivo beneficio della minoranza francese, mentre la popolazione
musulmana ha subito un progressivo impoverimento a causa di una crescita
demografica eccezionale, e soprattutto della massiccia espropriazione di terre a favore
dei coloni francesi.
Tutto ciò favorisce sia la diffusione tra le classi medie e gli intellettuali di un
nazionalismo estremista, già radicato nei ceti popolari, sia il rafforzamento dei gruppi
sostenitori dell’insurrezione armata. Tra questi si distingue il Fronte di liberazione
nazionale (FLN), sostenuto e armato dall’Egitto di Nasser e dagli altri Stati arabi, che
tra il 1954 e il 1956 organizza una lunga serie di attentati, sommosse e operazioni di
guerriglia. Il governo di Parigi risponde con la repressione (la cosiddetta “battaglia di
Algeri” del 1956-57), impiegando l’esercito e ricorrendo a ogni mezzo: arresti in
massa, segregazione della popolazione e torture.
Solo dopo l’avvento al potere del generale Charles De Gaulle il governo francese, vista
l’impossibilità di ogni margine di mediazione anche per l’intransigente posizione dei
coloni, si piega a riconoscere il diritto del popolo algerino all’autodeterminazione. In
questo clima difficile sono così avviati i negoziati con il Fronte di liberazione
nazionale, che approdano nel 1962 al riconoscimento dell’Algeria come Stato sovrano.
Questi accordi sono ratificati in seguito a un referendum vinto con margini
schiaccianti dai sostenitori dell’indipendenza. Alla prospettiva di un’Algeria libera si
oppongono tuttavia con violenza i francesi d’Algeria e una parte dell’esercito,
spalleggiati da un’organizzazione di ispirazione fascista, l’OAS (Organizzazione
armata segreta), che si rende protagonista di ripetuti attacchi terroristici contro la
popolazione musulmana.
Quasi tutti i coloni francesi, temendo rappresaglie, lasciano intanto il paese. Ha così
fine una guerra costata 35.000 morti ai francesi e circa 400.000 agli algerini. La nuova
Algeria, governata da un regime a partito unico di orientamento socialista, procede
rapidamente alla nazionalizzazione delle materie prime (metano e petrolio
soprattutto) e delle principali industrie e, tra i paesi di nuova indipendenza, è quello
in cui l’industrializzazione guidata dallo Stato ha maggiore successo.
Allo scopo di evitare l’apertura di un secondo fronte di conflitti, il governo francese
concede il suffragio universale ai cittadini delle colonie dell’Africa occidentale ed
equatoriale, favorisce l’ingresso di funzionari africani nelle pubbliche amministrazioni,
36
e, dopo avere inutilmente tentato di costituire una Comunità federale franco-africana,
rinuncia a tutte le sue colonie nel 1960.
Nell’Africa britannica, la rivolta dei contadini di etnia kikuyu in Kenya (paese
ricchissimo di risorse agricole e minerarie, con una estesa colonia europea), guidata da
Jomo Kenyatta e dal movimento dei Mau Mau (1952-56) è violentemente repressa
dalle truppe inglesi. Ciò contribuisce ad accelerare da parte di Londra l’abbandono
della politica del “dominio indiretto” (basato sul controllo delle classi dirigenti
nazionali) e il riconoscimento del principio dell’autogoverno delle colonie.
Instabilità e neocolonialismo nell’Africa postcoloniale
Nel processo di decolonizzazione le originarie aspirazioni panafricaniste e federaliste
lasciano rapidamente il posto a tendenze sempre più nazionaliste, che fomentano
divisioni e conflitti. Nonostante molti paesi abbiano sottoscritto la “carta africana” e
sia stata creata l’Organizzazione per l’unità africana (1963), finalizzata alla
cooperazione e assistenza reciproca, ben presto si manifestano profonde diversità
ideologiche, spesso semplice copertura di rivalità etniche e tribali.
Scoppiano così violenti scontri di personalità e di interessi economici, rivendicazioni
territoriali tra governi di orientamento conservatore ed esponenti del cosiddetto
“socialismo africano”, che rendono l’Africa indipendente un continente assai
turbolento. L’illusione di potere istaurare regimi costituzionali solidi creati sul
modello della madrepatria (parlamentare nell’Africa britannica, presidenziale in
quella francese) tramonta perciò molto rapidamente di fronte a una realtà
contrassegnata da una endemica instabilità, scandita da ripetuti colpi di Stato militari,
dalla prevalenza di tendenze autoritarie, dal predominare di sistemi a partito unico e
dalla nascita di regimi dispotici, spesso controllati dalle élite militari.
In molti paesi, la prevalente connotazione etnica assunta dai partiti, comporta una
radicalizzazione degli scontri tra etnie, spesso fomentati dai potenti interessi
economici dei paesi occidentali, che continuano a sfruttare le risorse di molti Stati
africani e a dominarne l’economia secondo un rapporto di tipo neocoloniale. Più
drammatica è la situazione del Congo belga (ribattezzato Zaire nel 1967), paese della
immense ricchezze minerarie in mano a multinazionali belghe, britanniche e
americane. Qui le popolazioni, in passato, sono state sottoposte a un duro
sfruttamento senza nessuna preoccupazione, nemmeno formale, della loro
emancipazione. Il Belgio, cosciente della forza raggiunta dai movimenti nazionalisti
del Congo, offre loro l’autonomia, negando però ogni forma di indipendenza.
Intanto nel 1958, Patrice Lumumba, un impiegato dell’amministrazione coloniale,
fonda l’MNC (Movimento nazionale congolese), con un programma decisamente
indipendentista. Dopo le elezioni del 1960, che vedono la vittoria dei partiti
nazionalisti, il Belgio concede l’indipendenza e Lumumba diviene primo ministro.
I problemi del Congo indipendente risultano però subito gravissimi: nel luglio 1960
Moise Ciombé, dietro il quale sta la Union Minière (una società che ha il monopolio
delle miniere di rame), proclama l’indipendenza della ricchissima regione mineraria
del Katanga. Si apre così una crisi ai vertici dello Stato sulle prospettive future del
Congo: da una parte la linea continuista e vicina alla madrepatria belga, dall’altra
37
quella di Lumumba, favorevole a un regime rivoluzionario socialista che rompa ogni
contatto con l’esperienza colonialista.
L’uccisione di Lumumba nel 1961 da parte delle milizie di Ciombé apre la strada a
una violenta guerra civile, che precipita il paese nel caos, al quale cerca di porre un
freno l’ONU, con un intervento militare nel 1963. L’attivismo dell’Organizzazione
delle nazioni unite nella crisi congolese incontra tuttavia la forte opposizione di
Belgio, Francia e Inghilterra. Dopo il ritiro delle truppe ONU nel 1964, al termine di
una serie di colpi di Stato e destituzioni, la crisi si conclude con la definitiva presa del
potere da parte del generale Mobutu, che instaura un regime militare filo-occidentale.
Negli stessi anni la Nigeria viene sconvolta da una sanguinosa guerra civile che vede il
durissimo scontro tra il Nord del paese, povero e di religione musulmana, e il Sud,
ricco di risorse e dominato dalle etnie ibo e yoruba, in larga parte di religione
cristiana. Lo scontro conduce, nel 1967, alla secessione del Biafra, regione ricchissima
di petrolio e dominata dagli ibo, e allo scoppio di una guerra tra il governo centrale
nigeriano e quello biafrano. La guerra civile si protrae per tre anni e dà vita a una
tragedia immane che provoca un milione di morti e si conclude con la capitolazione
incondizionata del Biafra nel 1970 e con la riunificazione del paese.
Un altro fronte si apre nel 1974 nell’Africa orientale, dove la crisi del regime etiopico
del negus Hailé Selassié, provocata dalla guerra contro la secessione dell’Eritrea (ex
colonia italiana annessa all’Etiopia come provincia nel 1962) e dalla rivolta di altri
gruppi etnici (come i somali della regione dell’Ogaden, sostenuti dal governo somalo),
porta all’instaurazione di un regime nazionalista-marxista guidato dal sanguinario
colonnello Menghistu e sostenuto dall’Unione Sovietica.
In tal modo l’Etiopia, tradizionale alleato degli USA, si trasforma in un caposaldo
dell’influenza sovietica in Africa, e il Corno d’Africa – sconvolto da ripetute guerre tra
Etiopia e Somalia (quest’ultima tradizionale alleato dell’URSS ma passata successivamente
al campo occidentale) – diviene uno dei punti caldi dello scontro Est-Ovest.
Mentre nel resto del continente il dominio coloniale europeo può dirsi sostanzialmente
tramontato nel corso degli anni Sessanta, esso resiste ancora a lungo nei paesi dell’Africa
australe. Nelle colonie portoghesi (Angola, Mozambico e Guinea) ricchissime di risorse,
la politica di discriminazione nei confronti della popolazione nera e di violenta
repressione dei movimenti politici sfocia nel 1961 in una lunga e sanguinosa guerra tra
l’esercito portoghese (sostenuto dagli Stati Uniti) ei locali movimenti nazionalisti, guerra
destinata a concludersi col raggiungimento dell’indipendenza solo nel 1975, dopo il crollo
del regime autoritario di Salazar in Portogallo.
L’indipendenza, che porta alla formazione di regime di stampo socialista a partito
unico – il Movimento popolare di liberazione (MPLA) guidato da Agostinho Neto in
Angola e il Fronte di liberazione del Mozambico (FRELIMO) di Samora Machel –
sostenuti finanziariamente e militarmente dall’URSS e da Cuba, è immediatamente
seguita dall’esplosione di una guerra civile tra i nuovi regimi e i guerriglieri di
orientamento filo-occidentale, armati e finanziati dagli Stati Uniti e dal Sud Africa. Il
conflitto, durato sino al 1988 in Angola e sino al 1990 in Mozambico, fa dell’Africa
australe una fonte costante di tensione nelle relazioni USA-URSS. Questa situazione,
tra l’altro, favorisce la sopravvivenza del regime razzista del Sud Africa, che agli occhi
degli Stati Uniti rappresenta il principale baluardo contro l’espansione sovietica e
cubana nell’Africa australe.
38
Il focolaio del Medio Oriente: il conflitto arabo-israeliano
Gli anni Sessanta vedono anche la violenta recrudescenza del conflitto araboisraeliano, che trasforma il Medio Oriente in uno dei principali scenari periferici del
confronto USA-URSS. Gli aiuti militari concessi dall’Unione Sovietica all’Egitto di
Nasser nel 1956 e il sostegno sovietico al nazionalismo arabo hanno fortemente
allarmato il governo di Washington, che vede nella potenziale alleanza tra Unione
Sovietica, nasserismo e movimenti nazionalisti arabi una potenziale minaccia in una
regione altamente strategica, in quanto porta d’accesso al Golfo Persico e ai suoi
immensi giacimenti petroliferi. Per questo motivo gli USA adottano in Medio Oriente
una politica di intervento diretto, economico e militare, giustificandola conla necessità
di contrastare l’espansionismo sovietico e allo stesso tempo intensificarono il sostegno
allo Stato di Israele. La prima occasione per l’applicazione di questa nuova strategia –
battezzata “dottrina Eisenhower” – è l’invio nel 1958 dei marines americani in Libano
in appoggio al governo filo-occidentale di Beirut – città che all’epoca rappresenta un
importantissimo centro finanziario, tanto da meritare l’appellativo di “Svizzera del
Medio Oriente” – minacciato dall’insorgere di un movimento nazionalista sostenuto
dalla Siria.
Nonostante il conflitto medio-orientale sia uno dei principali terreni dello scontro tra i
due blocchi, i fattori locali sono sempre prevalenti e la partecipazione attiva di USA e
URSS si limita negli anni successivi al piano diplomatico e all’assistenza militare ai
propri alleati, senza che le due potenze si impegnino in un intervento militare diretto. È
così per il conflitto arabo-israeliano del 1967, il terzo, detto “guerra dei se giorni” a
causa della sua durata. La guerra, scatenata da un attacco israeliano per rappresaglia
contro il blocco delle navi a Suez decretato dall’Egitto (appoggiato dall’URSS), costa
agli Stati arabi una sconfitta disastrosa: in soli sei giorni l’efficiente esercito israeliano
travolge le truppe egiziane, siriane e giordane e assume il controllo dei territori egiziani
del Sinai e di Ghaza, della Cisgiordania e delle alture siriane del Golan.
A questo punto gli Stati Uniti esercitano pressioni sul governo di Tel Aviv per arrestare
l’avanzata israeliana in Siria, ed evitare così un coinvolgimento diretto nella guerra di
Mosca. In tale occasione l’URSS si dimostra incapace di tutelare adeguatamente i suoi
alleati, fatto che provoca una profonda incrinatura nelle sue relazioni con i governi arabi.
Anche per questo motivo, negli anni successivi, Washington tenta, senza successo, di
convincere il governo israeliano a restituire i territori occupati nel 1967 ai paesi arabi
confinanti: Tel Aviv, al contrario, accelera la colonizzazione delle zone occupate e rifiuta
l’ipotesi di uno Stato arabo in Cisgiordania.
Gli arabi, insieme all’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) guidata
da Yasser Arafat, respingono a loro volta una risoluzione dell’ONU che chiede il ritiro
israeliano e afferma il diritto di tutti gli Stati della regione a vivere in pace entro
confini “sicuri e riconosciuti”, in quanto implicherebbe il riconoscimento dello Stato
di Israele. Alle tensioni provocate dall’occupazione israeliana dei territori egiziani e
siriani si aggiunge infine, dal 1970, l’intensificarsi degli attacchi terroristici dell’OLP,
con attentati rivolti contro obiettivi israeliani e dirottamenti aerei.
Dopo la morte di Nasser e l’ascesa al potere di Sadat, l’Egitto prende le distanze
dall’Unione Sovietica e assume posizioni sempre più moderate. Ma nel timore che il
prolungamento dell’occupazione israeliana in seguito alla guerra dei sei giorni si
39
tramuti in annessione, Egitto e Siria attaccano a sorpresa le truppe israeliane nel Sinai
e nel Golan, il 6 ottobre 1973, mentre è in corso la festa di Yom Kippur (giorno
dell’espiazione). Il conflitto che ne segue (il quarto arabo-israeliano) è noto, per
questo motivo, come guerra del Kippur. Dopo alcuni iniziali successi arabi, gli
israeliani sferrano una controffensiva che rovescia la situazione e consente alle truppe
di Tel Aviv di cominciare ad avanzare in territorio egiziano. Il rischio di allargamento
del conflitto viene evitato grazie alle pressioni di Washington sugli israeliani per il
raggiungimento di una tregua con l’Egitto (11 novembre 1973).
La storica conferenza di pace organizzata a Ginevra da USA e URSS (dicembre 1973)
si risolve tuttavia in un totale fallimento. La successiva azione diplomatica americana
per la soluzione del conflitto consegue risultati solo marginali, ottenendo però il
risultato di estromettere completamente i sovietici dalle trattative di pace per il Medio
Oriente.
Merito dell’azione diplomatica statunitense è anche la distensione ufficiale delle
relazioni tra Israele ed Egitto, sancita dagli accordi di Camp David del 1979, in base ai
quali, grazie all’energica opera di mediazione del presidente americano Carter, i due
paesi si accordano per il ritiro delle truppe israeliane dal Sinai. Tuttavia, la questione
palestinese, ovvero il diritto di questo popolo a una patria indipendente, resta irrisolto
e continua ad affollare anche oggi le agende della diplomazia internazionale.
La guerra dello Yom Kippur del 1973 non rappresenta soltanto il culmine di tensioni
decennali nei rapporti arabo-israeliani, ma segna anche una svolta fondamentale per
l’economia di tutti i paesi occidentali.
Il petrolio, nei decenni precedenti, ha infatti sostituito il carbone come principale
fonte di energia per il riscaldamento, i trasporti e le attività produttive, rendendo, a
partire dagli anni Cinquanta, i paesi industrializzati, e soprattutto l’Europa e il
Giappone, sempre più dipendenti dalle forniture provenienti dagli immensi
giacimenti del Medio Oriente. Sin dal dopoguerra il mercato petrolifero mondiale è
stato dominato da sette grandi compagnie multinazionali (le americane Esso, Mobil,
Chevron, Texaco, Gulf, la britannica BP e la anglo-olandese Shell), organizzate in un
forte cartello internazionale che mantiene artificialmente elevati i prezzi. Le “sette
sorelle”, così sono anche chiamate, controllano i giacimenti dei principali paesi
produttori del Golfo Persico sulla base di accordi per loro molto vantaggiosi, che
lasciano ai governi locali soltanto la metà degli enormi profitti ricavati.
I principali paesi produttori di petrolio – Arabia Saudita, Iran, Iraq e Kuwait, oltre al
Venezuela – per difendersi dallo strapotere delle multinazionali fondano, nel 1960,
una nuova organizzazione, l’OPEC (Organizzazione dei paesi produttori di petrolio),
alla quale aderiscono successivamente altri paesi tra cui anche l’Algeria e la Libia, i cui
governi hanno proceduto alla nazionalizzazione dei pozzi petroliferi. Il principale
obiettivo dell’OPEC è di ottenere una ripartizione più favorevole dei profitti e di
sottrarre alle “sette sorelle” il controllo della produzione e dei prezzi; la coesione
all’interno dell’organizzazione è però debole e soltanto dal 1970 l’OPEC riesce a
presentarsi con un fronte compatto e a ottenere consistenti aumenti del prezzo del
greggio. Sempre più consapevoli della propria forza (tabella 5), allo scoppio della
guerra arabo-israeliana del 1973 i paesi dell’OPEC decidono di utilizzare il petrolio
come arma di rappresaglia nei confronti dei paesi occidentali. Vengono così sospese le
forniture di greggio agli USA e agli altri paesi che hanno fornito sostegno militare a
40
Israele, viene ridotta la produzione e pressoché quadruplicato il prezzo del petrolio. È
quest’ultimo provvedimento, mantenuto anche dopo la revoca dell’embargo (blocco
totale degli scambi economici e commerciali) e il ritorno alla normalità, ad avere
conseguenze determinanti per l’economia mondiale, mettendo in difficoltà i paesi più
industrializzati e ancor più quelli in via di sviluppo.
Oltre a dover fare fronte alle conseguenze del conflitto tra israeliani e arabi, dalla fine
degli anni Sessanta i paesi dell’area medio-orientale e del Golfo devono fronteggiare
un nuovo fattore di instabilità e tensione: l’emergere nei paesi islamici di agguerriti
movimenti di opposizione di ispirazione religiosa. In Egitto, Siria e Iraq, e persino in
Turchia (alleata occidentale, e dal 1952 membro della NATO), i partiti nazionalisti al
governo, sebbene artefici di una politica di impronta laica e socialista, perdono la
propria credibilità per l’incapacità di uscire dalla logica dei blocchi e di avviare uno
sviluppo e una riduzione delle enormi sacche di povertà e di miseria. In questi paesi i
movimenti islamici, duramente ostili ai gruppi dirigenti del nazionalismo arabo e
sostenitori di una rigida applicazione del codice di comportamento musulmano
(shariah), diventano i rappresentanti del fondamentalismo religioso. In questo modo
guadagnano un fortissimo seguito di massa, talvolta anche attraverso attività
terroristiche, e assumono un ruolo politico di spicco, anche se il più delle volte sono
violentemente repressi dai vari governi.
Tab 5. Percentuali di produzione di petrolio, 1930-1974.
USA
URSS
Venezuela
Romania
Iran
Arabia Saudita
Kuwait
1930-34
1962-1966
1974
61,1
11,1
9,5
3,7
3,5
-
26,9
15,9
12,3
(non disp.)
6,4
7,3
15,0
17,7
4,8
10,4
14,5
4,1
L’America Latina dopo la decolonizzazione: tra dittature e rivoluzione
La seconda guerra mondiale rappresenta anche per l’America Latina un’occasione di
sviluppo, favorendo le esportazioni e assicurando i capitali necessari per liberarsi dalla
dipendenza dall’Occidente. I processi di modernizzazione che investono il continente
non riescono tuttavia a superare i limiti strutturali della società latino-americana:
l’industria pesante rimane fragile e l’urbanizzazione ha più il carattere di fuga dalla
miseria contadina che di corsa verso il lavoro industriale. Eccetto il Messico, dove la
riforma agraria assicura una parziale redistribuzione della terra, le campagne
continuano a essere dominate dal grande latifondo, nelle mani delle antiche oligarchie
terriere. I vecchi ceti possidenti, uniti ora alle nuove ristrette borghesie industriali,
continuano a detenere buona parte della ricchezza e a esercitare il potere. Dal punto
41
di vista politico il secondo dopoguerra fu segnato dall’affermazione di movimenti
populistici, caratterizzati da un forte leader (Perón in Argentina e Vargas in Brasile),
da uno stile di governo autoritario, dal nazionalismo, dall’interventismo statale in
economia e dalla mobilitazione delle masse e dei sindacati per ottenere il consenso.
Nonostante per certi versi il populismo, tradizionalmente, tenti di essere appannaggio
della sinistra, esso viene generalmente accettato dalle oligarchie possidenti come
garanzia d’ordine e stabilità.
Negli anni Sessanta le ripercussioni della guerra fredda si estendono anche
all’America Latina, che gli Stati Uniti si sono abituati a considerare come area
esclusiva del loro dominio economico e politico.
Il dopoguerra è stato per molti paesi latino-americani, esportatori di materie prime
(petrolio e rame soprattutto) e di prodotti agricoli (cotone, zucchero e caffè), un
periodo di forte sviluppo economico, che ha notevolmente rafforzato i regimi
dell’area, tutti più o meno ispirati a modelli autoritari di presidenzialismo, come ad
esempio il Brasile, sotto la guida, sino al 1954, di Getulio Vargas, e l’Argentina,
guidata sino al 1955 da Juan Domingo Perón.
Si tratta di regimi di orientamento populista, spiccatamente nazionalisti, di ispirazione
autoritaria, con qualche tratto di analogia con l’esperienza del fascismo europeo, che
puntano a modernizzare l’economia soprattutto attraverso la nazionalizzazione dei
settori fondamentali – come quello petrolifero – e l’intervento diretto dello Stato nel
processo di industrializzazione. Essi sono inoltre caratterizzati da una forte
mobilitazione delle masse popolari, dalla repressione anche violenta delle opposizioni e
da strumenti di organizzazione del consenso tipica dei regimi autoritari.
La caduta di Vargas e Perón a opera di colpi di Stato militari, ispirati da gruppi
conservatori e sostenuti in vari modi dalla CIA americana, apre la strada a una lunga
fase di instabilità, rafforzata anche dalla diffusione nel continente di numerosi gruppi
di guerriglia rurale e urbana, di matrice marxista e rivoluzionaria.
Per contrastare la crescente influenza dell’esempio rivoluzionario cubano, il
presidente americano Kennedy lancia nel 1961 il programma della “Alleanza per il
progresso”, che prevede la concessione di aiuti ai governi latino-americani in cambio
di una serie di riforme democratiche e di provvedimenti economici volti ad attenuare
le profonde diseguaglianze sociali.
Questa politica incontra però forti resistenze e non ottiene alcun risultato di rilievo.
Nel corso degli anni Sessanta perciò l’America Latina, stretta tra continui colpi di
Stato militari (più o meno ispirati e sostenuti dagli Stati Uniti) e l’emergere di
aspirazioni rivoluzionarie, vede progressivamente allontanarsi sia la democrazia sia la
stabilità politica, mentre il deterioramento delle condizioni economiche di numerosi
paesi alimenta il malessere e la rivolta sociale.
In questo quadro il Cile rappresenta a lungo una fortunata eccezione. Qui le
istituzioni democratiche sono sopravvissute agli sconvolgimenti degli anni tra le due
guerre e alle tensioni del secondo dopoguerra, e si sono addirittura rafforzate durante
la presidenza del democratico-cristiano Eduardo Frei (1964-1970). Anche la
democrazia cilena tuttavia entra in crisi nel 1970, dopo l’elezione alla presidenza della
repubblica del socialista Salvador Allende, a capo di un’ampia coalizione tra Partito
socialista, ala riformista della Democrazia cristiana, e movimenti radicali dell’estrema
sinistra. I primi provvedimenti adottati dal nuovo governo – nazionalizzazione delle
42
miniere di rame (controllate da decenni da multinazionali americane) e dei servizi
telefonici (sino a ora in mano alla multinazionale IT&T), e riforma agraria –
contrastano direttamente con gli interessi economici degli USA, che temono siano il
segnale dell’imminente instaurazione di un regime socialista e costituiscano
un’evidente espressione della minaccia comunista in America Latina.
L’amministrazione Nixon esercita perciò forti pressioni sulle forze politiche moderate
(liberali e democristiane) affinché il Parlamento cileno non ratifichi l’elezione di
Allende, e successivamente sospende ogni collaborazione tecnica e finanziaria col
governo di Santiago. Da parte sua la CIA cerca in ogni modo di destabilizzare il paese,
sostenendo le azioni terroristiche di gruppo paramilitari e incoraggiando i piani golpisti
di alcuni ambienti militari.
La coalizione di Allende è inoltre gravemente indebolita dalla fuga massiccia di
capitali all’estero, dalla crescente inflazione, da contrasti tra moderati e rivoluzionari e
da una crescente spirale di scioperi (alimentati sia dalla sinistra radicale, sia dalle
associazioni di imprenditori dei trasporti e del commercio). Tutto ciò porta infine alla
paralisi del paese e al sanguinoso colpo di Stato del generale Augusto Pinochet dell’11
settembre 1973, che provoca la morte del presidente Allende. Il regime militare
cileno, protagonista di una politica di spietata repressione, che causa migliaia di
vittime tra i dirigenti e i militanti dei partiti democratici e dei sindacati, provvede
immediatamente a ripristinare la grande proprietà latifondista e a restituire alle
multinazionali americane i loro tradizionali privilegi, ottenendo in cambio ingenti
prestiti dagli USA e dalle organizzazioni finanziarie internazionali.
Riassumendo:
• I paesi colonizzati dalle grandi potenze europee credono che una volta raggiunta l’indipendenza avrà
inizio un’era di prosperità e giustizia. Ma lo sviluppo economico e sociale è subordinato
all’industrializzazione, per la quale mancano le condizioni essenziali: capitali, manodopera e
infrastrutture.
• Occorrono pertanto ingenti finanziamenti, perciò i governi che si trovano alla testa dei “paesi nuovi”
(gli stati africani, asiatici, ecc.) devono ricorrere alla collaborazione delle ex potenze coloniali e
stringere con esse accordi. Si ricrea così la “soggezione ai vecchi padroni” nel campo finanziario,
tecnico e culturale.
• Esaminando il problema, bisogna dire che all’origine del neocolonialismo vi sono ragioni
economiche, politiche e ideologiche. La motivazione economica più importante: uno Stato cerca di
dominarne altri per reperire materie prime, forza lavoro e trovare mercati per la propria produzione.
Secondo tale politica, la volontà di espandere la propria influenza può nascere dal desiderio di
acquisire potere e prestigio, dalla ricerca della sicurezza nazionale o di vantaggi diplomatici.
• Il parametro con cui normalmente si misurano gli effetti del neocolonialismo rimane sempre quello
economico: gli investimenti occidentali, i prestiti, le politiche commerciali e i programmi di “aiuto”
hanno lo scopo di proteggere gli interessi politici e strategici degli imperialisti e di mantenere
economicamente deboli i paesi in via di sviluppo e farli quindi dipendere dal neocolonialismo.
• Questa situazione si aggrava quando il governo locale è formato da esponenti della borghesia e della
piccola borghesia, i quali preferiscono, in nome del proprio interesse, che il proprio paese resti debole e
dipendente delle potenze capitalistiche, piuttosto che avviarsi verso il socialismo.
43
Alcuni interrogativi:
• Perché le risorse naturali non si traducono in ricchezza?
• Limiti e tragedie dei movimenti di liberazione.
• Le contraddizioni politiche e il ruolo delle multinazionali.
• La lotta contro il neocolonialismo.
• Perché le risorse naturali non si traducono in ricchezza?
I paesi ex coloniali solitamente si trovano in condizioni di miseria estremi. Economie fragilissime, in
genere senza industrie e con agricolture distorte. Alla precarietà economica si aggiunge l’analfabetismo
e a questi la fame e la sottoalimentazione, con la conseguenza di malattie endemiche e un alto tasso di
mortalità. Eppure questa povertà diffusa non ha ragion d’essere. Quei paesi dispongono di immense
ricchezze. I paesi arabi forniscono gran parte del petrolio con cui funziona l’industria occidentale,
l’Indonesia fornisce il caucciù, l’Angola ha l’oro e i diamanti, il Brasile il caffè, lo Zambia il rame, il
Ghana il cacao, e così via. Ebbene, per quale motivo queste ricchezze non si traducono in benessere per
i popoli che le possiedono? Perché l’indipendenza politica non diventa la leva per migliorare le
condizioni di vita dei popoli: costruire scuole e ospedali, impiantare industrie, produrre alimenti
sufficienti?
Sono queste, le domande che i popoli cominciano a porsi, qualche anno dopo aver conquistato
l’indipendenza. L’esperienza che si delinea tra il 1960 e il 1970 è infatti la seguente: non solo la
liberazione dal colonialismo non ha migliorato il tenore di vita dei popoli fino a ieri oppressi, ma anzi in
generale i paesi ex coloniali sono diventati più poveri, mentre quelli ricchi sono diventati più ricchi. La
“forbice” tra sviluppo e sottosviluppo si è allargata, le condizioni sono diventate più disperate.
Il sottosviluppo ha una motivazione molto precisa e una logica facilmente individuabile: il Ghana è
stato trasformato dal colonialismo in un’immensa piantagione di cacao, ma il cacao non serve ai ghanesi
e quindi deve essere venduto sul mercato internazionale. I prezzi del cacao sono fissati dalle Borse di
Londra, Parigi, New York, sulla base della domanda del mercato e quali che essi siano, il Ghana è
obbligato a vendere quel cacao che non gli serve per nutrire i suoi abitanti. L’economia ghanese è così
in balia di altre forze che rispondono ad altri interessi. E questo è il primo aspetto del problema, l’altro
aspetto è il seguente: il Ghana non ha industrie per trasformare il cacao in cioccolato, il cacao viene
esportato, lavorato altrove, e quando un ghanese vuole comprare una tavoletta di cioccolato deve
importarla dall’estero, pagandola naturalmente in valuta pregiata e al prezzo imposto dall’industria che
produce il genere.
• Limiti e tragedie dei movimenti di liberazione
I movimenti nazionali di liberazione giungono all’indipendenza sulla base di una lotta unitaria,
nazionale appunto. Ma tutte le forze che vi concorrono non hanno gli stessi interessi. Vi è, anche in
questi paesi, una divergenza tra classi sociali e le scelte decisionali possono essere diverse.
Dipendentemente dalla classe sociale che detiene il potere si deciderà se nazionalizzare le ricchezze
nazionali oppure no, se rompere con la monocoltura o no, se fare o no quelle riforme agrarie che
spezzano il legame tra monocoltura e proprietari feudali locali. Vi sono infatti in Asia, in Africa, in
America Latina le borghesie locali che si inseriscono nel rapporto neocoloniale e facendone parte ne
ricavano privilegi, divenendo a loro volta sfruttatori della maggioranza del loro popolo. E su questa
base quindi diventano i sostenitori e difensori del meccanismo neocoloniale.
Dopo la conquista dell'indipendenza politica, insomma, si apre una seconda fase di lotta che questa
volta non ha solo dei nemici esterni, ma anche nemici interni. Questione nazionale e questione sociale
vengono cioè a intrecciarsi profondamente. Questo tipo di scontro percorre tutto il periodo che va dal
1960 ai nostri giorni, con momenti esemplari che ne riassumono le caratteristiche, in un alternarsi
continuo di vittorie e di sconfitte.
Uno dei grandi momenti di sconfitta è offerto dalla tragedia congolese del 1960. In quell’anno il Belgio
concesse l’indipendenza alla sua grande colonia, confidando nel fatto che un movimento nazionale
ancora debole avrebbe permesso con facilità il proseguimento della sua presenza imperiale in Africa.
L’indipendenza in altri termini doveva essere, per usare le parole di Amilcar Cabral (un grande africano
assassinato dai colonialisti portoghesi), “una bandiera, un finto parlamento, una guardia presidenziale e
44
null’altro”. Accadde invece che il Congo trovasse in Patrice Lumumba un leader molto fiero e attento
ai contenuti reali dell’indipendenza, ossia attento al recupero delle ricchezze nazionali che si trovavano
in mani straniere. Furono allora promossi movimenti scissionisti, Lumumba venne assassinato e
s’instaurò la dittatura militare del generale Mobutu che consentì agli stranieri, in particolare ai belgi, di
proseguire indisturbati lo sfruttamento delle risorse congolesi. Una vicenda analoga, ma dalle
proporzioni di sangue ben più drammatiche, è accaduta in Indonesia, dove il nazionalismo di Sukarno
stava evolvendo verso forme sociali più avanzate come la ridistribuzione agraria.
• Le contraddizioni politiche e il ruolo delle multinazionali
Un colpo di Stato e un terribile massacro (si calcola che siano state uccise circa mezzo milione di
persone, ma alcune fonti parlano di un milione) hanno posto, nel 1965, una battuta d’arresto a quella
evoluzione, consentendo alle grandi compagnie multinazionali di continuare il loro saccheggio (il
nuovo presidente, generale Suharto, restituisce subito le proprietà ai vecchi possessori stranieri e cerca
appoggi politici ed economici in Occidente).
In questo senso, non molto diversa risulta l’esperienza cilena, dove le forze di sinistra arrivano al potere
il 24 ottobre 1970 con una vittoria elettorale, sulla base quindi di uno svolgimento democratico
classico, la loro politica investe subito i problemi cruciali del sottosviluppo e dell’indipendenza
economica con la nazionalizzazione di alcune miniere di ferro e di rame, ma un feroce colpo di Stato
diretto dalla CIA e dalla multinazionale nordamericana ITT porta a una dittatura sanguinaria l’11
settembre 1973 che durerà per 17 anni, il tempo necessario per eliminare fisicamente le avanguardie
popolari, distruggere la cultura rivoluzionaria e quindi, ritornare beffardamente al formalismo della
democrazia borghese.
L’esempio cileno è certamente quello che mostra più chiaramente come l’imperialismo se ne infischia
della democrazia quando i suoi interessi concreti sono colpiti e rimessi in discussione. Tuttavia il fatto
più emblematico del neocolonialismo resta l’intervento americano nel Vietnam. Qui si ritorna ad una
guerra coloniale classica (l'invio di un corpo di spedizione) per impedire ad una rivoluzione nazionale
di ispirazione socialista di giungere a compimento dimostrando ai popoli come i problemi del
sottosviluppo possano essere risolti nello stretto intreccio tra questione nazionale e questione sociale. In
realtà gli Stati Uniti avvertono consapevolmente le novità della situazione apertasi nei tre continenti ex
colonizzati, tutti ormai in fermento. Il neocolonialismo infatti può sì frenare i movimenti di
emancipazione, ma non può risolvere la contraddizione di fondo in cui i popoli vivono: indipendenza
più sottosviluppo. E i popoli ne stanno prendendo coscienza.
• La lotta contro il neocolonialismo
In quegli anni la rivoluzione cubana si è trasformata in rivoluzione socialista. L’Algeria ha conquistato
la sua indipendenza nel 1962 (il Fronte di liberazione nazionale aveva cominciato a combattere nel
1954) e ha proceduto alla nazionalizzazione delle sue ricchezze minerarie nel 1966. Il nasserismo
egiziano procede sempre più sulla via dell'indipendenza economica con la “Carta nazionale dei princìpi
socialisti” di Nasser, del 1962. In Siria e in Iraq sono stati abbattuti regimi neocoloniali e si tentano
nuove strade (riforma agraria in Siria nel 1958, nazionalizzazioni nel 1963 e nel 1965; nazionalizzazione
delle banche in Iraq nel 1964). Una guerra popolare divampa nelle colonie portoghesi e i movimenti di
liberazione che ne sono alla testa (Fronte popolare di liberazione dell’Angola, Fronte di liberazione del
Mozambico) non nascondono di non voler percorrere, al momento dell’indipendenza, il cammino
neocoloniale di tanti altri regimi africani. A questo punto il Vietnam diventa, per l’imperialismo, un
banco di prova decisivo, un esempio da dare per far intendere che se la fine degli imperi coloniali è
stata tollerata, non lo sarà la lotta contro l’assetto neocoloniale. Ma è proprio questo significato dato
alla guerra in Vietnam che si rovescia contro il neocolonialismo. I vietnamiti vincono infatti la loro
seconda guerra di liberazione e la vincono contro la più grande e ricca potenza imperialista, gli Stati
Uniti, i quali si ritirano sconfitti sul piano militare ma lasciando purtroppo un paese devastato, al quale
non verrà mai corrisposto nessun indennizzo di guerra, impossibilitato così, malgrado tremendi sforzi,
ad uscire da quella immane distruzione, sì che questo tremendo peso si ripercuoterà successivamente in
modo determinante. Comunque, come nel 1954, la vittoria del Vietnam dà un nuovo impulso allo
scontro in atto per infrangere le forme di dominio neocoloniale: l’Africa, infatti, compie un nuovo
scatto in avanti con l’accesso all’indipendenza dell’Angola, del Mozambico, della Guinea Bissau. Il
Laos e la Cambogia vedono l’avvento di nuovi regimi più radicali sul terreno economico e sociale. Ma
45
soprattutto esplode la prima grande rottura dell’ordine neocoloniale: nel 1973 i paesi produttori di
petrolio decidono di essere loro a fissare i prezzi del prezioso prodotto, sulla base dei loro interessi e
non di quelli dei paesi importatori.
Anche nel continente latino americano si susseguono le rivolte: in Messico, a Panama, nella Repubblica
Dominicana, in Bolivia, Colombia, Venezuela; fioriscono i Movimenti di Liberazione Nazionale in
molti paesi di tutto il continente, tra i quali spiccano i Tupamaru in Uruguay, il Farabundo Martí di
Liberazione Nazionale in Salvador, ed altri come in Guatemala ed in Perù, nel 1979 il Fronte
Sandinista prende il potere in Nicaragua e da quel momento il popolo nicaraguense deve subire ogni
sorta di boicottaggio economico, provocazioni belliche e attacchi mercenari finanziati e guidati
direttamente dagli Stati Uniti d’America, sì che dopo dieci anni di speranze, anche il sogno
nicaraguense si infranse.
Ad una ad una tutte le speranze che hanno sollevato “i dannati della Terra” e che li hanno visti eroici
protagonisti del loro riscatto, si sono spente. Poiché in una guerra non vince chi ha la ragione ma chi ha
la forza; lo strapotere militare, tecnologico ed economico dei paesi imperialisti è riuscito, ancora una
volta, a martirizzare la maggior parte dell’umanità e ad umiliare le masse dei cittadini dei propri paesi,
assegnandogli il ruolo di supini consumatori, spogliati di ogni pur minima conoscenza delle infamie di
cui sono inconsapevoli sostenitori, immemori che in quegli anni di grande speranza e dignità per il
mondo intero, milioni di lavoratori e studenti in grandi manifestazioni politiche e di solidarietà, in
Francia, in Italia, in Belgio e negli Usa, unendosi idealmente alla volontà di liberazione degli oppressi,
dimostrarono che anche nel ventre dell’impero è possibile un risveglio.
Ma le condizioni che hanno generato le rivolte dei popoli oppressi non sono scomparse, e non è
possibile soffocare gli ideali di libertà e dignità. La resistenza di Cuba, a 90 miglia dal colosso
nordamericano che tenta in ogni modo di strangolarla, lo sta dimostrando concretamente a tutti.
Continua ad essere un faro di speranza per tutti gli oppressi del mondo e una nuova possibilità di
riscatto delle masse dei paesi capitalistici che decidessero di smettere la recita del ruolo di utili
irresponsabili di false democrazie. Il compito minimale che ci compete è di riprendere l’iniziativa
attraverso la solidarietà, nell’ottica più genuina e popolare, non vista attraverso gli occhiali deformanti
della borghesia che, necessariamente, la manipolano e la trasformano in un nuovo strumento
generatore di profitti e di divisione dei popoli.
46
Appendici
Appendice 1. Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali (adottata
dall’Assemblea generale).
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 14 dicembre 1960, senza alcun voto contrario,
una “Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali”, in cui ha
proclamato solennemente “la necessità di porre rapidamente ed incondizionatamente fine al
colonialismo in ogni sua forma ed in ogni sua manifestazione”. Con tale risoluzione dell’Assemblea
generale, che riconosce “l’appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte
decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all’indipendenza” le Nazioni Unite hanno
conferito un nuovo slancio al processo storico di sviluppo che, dalla nascita dell’Organizzazione, ha visto
accedere all’indipendenza e alla sovranità nazionale oltre cinquanta territori dipendenti. Altri territori
sono in procinto di conseguire gli stessi obiettivi. Tuttavia, malgrado i profondi cambiamenti verificatisi
nel corso di questi ultimi anni, alcuni milioni di persone vivono ancora in territori non autonomi,
politicamente dipendenti da altri paesi.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della Dichiarazione:
L’Assemblea generale,
Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello statuto delle Nazioni Unite, a
riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell’Uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e a
promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,
Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e
amichevoli fondate sul rispetto dei princìpi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione di
tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
Riconosciuto l’appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi
popoli hanno nella loro accessione all’indipendenza,
Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla,
conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,
Considerata l’importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento
verso l’indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,
Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua
manifestazione,
Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica
internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone
all’ideale di pace universale delle Nazioni Unite,
Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse
naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata
sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,
Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi,
bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo
accompagnano,
Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla
libertà e all’indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si
manifesta nei territori non ancora acceduti all'indipendenza.
Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all’esercizio della propria
sovranità e all’integrità del loro territorio nazionale,
Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in
ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;
E, a questo fine,
47
Dichiara quanto segue:
La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un
diniego dei diritti fondamentali dell’Uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette
la causa della pace e della cooperazione mondiale.
Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del
proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell’insegnamento non
deve mai esser preso come pretesto per ritardare l’indipendenza.
Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro
i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro
diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l’integrità del loro territorio nazionale.
Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non
ancora acceduti all’indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle
popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai
loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di
consentire loro di godere di un’indipendenza e di una libertà complete.
Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l’unità nazionale e l'integrità
territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite.
Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle
Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e della presente Dichiarazione, sulla
base dell’uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani
e dell’integrità territoriale di tutti i popoli.
Appendice 2. Gandhi, I pensieri del Mahatma.
La non violenza è la forza più grande di cui disponga l’umanità. È più potente della più potente arma di
distruzione escogitata dall’ingegnosità dell’uomo […]. La resistenza passiva è il metodo di
salvaguardare i diritti mediante la sofferenza personale; è l’opposto della resistenza armata. Quando
rifiuto di fare una cosa che ripugna la mia coscienza uso la forza dell’anima […]. Devo continuare a
discutere fino a convertire gli avversari o ammettere la sconfitta. Infatti la mia missione è di convertire
ogni indiano, ogni inglese, infine il mondo alla non-violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano essi
politici, economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di essere troppo ambizioso, mi confesserò
colpevole. Se mi si dice che il mio sogno non potrà mai attuarsi, risponderò che è “possibile” e
proseguirò per la mia strada […]. Se l’India fa suo il credo della violenza ed io sopravvivo, non
m’importerebbe di lasciare l’India. Cesserebbe di ispirarmi qualsiasi fierezza. Il mio patriottismo è
soggetto alla mia religione.
48
Cronologie
Asia
India
1885
Nasce il Congresso Nazionale Indiano, partito nazionalista che mira all’indipendenza dal Regno Unito.
Mohandas KaraMchand Gandhi, leader del Congresso guida la lotta per l’indipendenza predicando la
1920-30 non violenza, la disobbedienza civile, la non cooperazione con i colonizzatori e il boicottaggio
economico.
1921
Il governo Britannico ammette rappresentanti indigeni nelle amministrazioni locali.
1935
Viene firmato l’Indian Act che estende il diritto di voto e concede ampia autonomia amministrativa.
1947
Viene concessa l’indipendenza all’India che si divide in due entità statali, l’Unione Indiana, a
maggioranza Indù e il Pakistan a maggioranza Musulmana.
1948
Gandhi, che ha tentato invano la pacificazione e la riunificazione in un unico Stato laico di Indù e
Musulmani, viene assassinato da un estremista Indù.
Javaharial Nehru si trova ad affrontare l’arretratezza economica e l’incremento demografico vertiginoso,
1948-64 i conflitti religiosi e l’abolizione reale delle caste. In politica estera sostiene il “non allineamento”
nonostante segua una politica economica d’ispirazione socialista (riforma agraria, piani quinquennali).
Indonesia
1912
Nascita del partito comunista Indonesiano guidato da Sukarno.
1945
Dichiarazione d’indipendenza.
1965
Colpo di Stato militare guidato da Suharto.
1975
L’Indonesia occupa l’isola di Timor Est, che ha appena proclamato la sua indipendenza dal Portogallo.
Filippine
1946
Indipendenza dopo l’occupazione giapponese.
1965
Colpo di Stato di Marcos.
Cambogia
1945
Proclamazione d’indipendenza sotto la guida di re Sihanouk.
1970
Colpo di Stato di Lon Nol che instaura un regime filoamericano.
1975
Colpo di Stato dei Khmer rossi, guidati da Pol Pot, che instaurano un regime maoista trasformando la
Cambogia in una immensa comune agricola e deportando la popolazione dalle città costringendola a
sottostare a condizioni di lavori forzati e sterminando oltre un milione di persone nei killing fields.
1978
Il Vietnam invade la Cambogia imponendo un governo amico.
Vietnam
1941
Convergenza tra tutte le forze antigiapponesi nel Vietminh egemonizzato dal Partito comunista di Ho
Chi-minh.
1945
Alla fine della guerra Ho Chi-minh proclama la Repubblica Democratica del Vietnam con capitale Hanoi.
1946
La Francia non riconosce l’indipendenza e inizia la guerra contro il Vietnam.
1954
I Francesi vengono sconfitti a Dien Bien Phu.
1954
Con gli Accordi di Ginevra il Vietnam viene diviso in repubblica Democratica del Vietnam a Nord del
17° parallelo con presidente Ho Chi-minh e capitale Hanoi e Repubblica del Vietnam nel Sud con
capitale Saigon guidata dal cattolico anticomunista Diem, stabilendone l’unione l’anno successivo.
49
1955
Gli Stati Uniti si oppongono alla riunificazione in funzione anticomunista.
1960
Nascita del Fronte nazionale di liberazione del Vietnam del Sud di ispirazione comunista (Vietcong).
1963
Caduta del regime di Diem, voluta dalla maggioranza buddista del Paese.
1965
Scoppia la Guerra del Vietnam: gli USA bombardano la “pista Ho Chi-minh” (che rifornisce i Vietcong
attraverso Laos e Cambogia) e successivamente anche le città del Nord.
1973
Gli USA firmano un patto di parziale ritiro delle truppe (anche per le pressioni dell’opinione pubblica
internazionale).
1975
Conquista di Saigon da parte dei Vietcong e nascita della Repubblica Socialista del Vietnam.
Cina
1941
A causa della guerra con gli USA il Giappone riduce l’occupazione in Cina.
1945
Gli USA appoggiano il Kuomintang in funzione anticomunista.
1947-49 Offensiva comunista che si conclude con la conquista di Pechino e la fuga di Chiang-Kai-Shek sull’isola
di Formosa.
Medioriente
1920
Mandato della Gran Bretagna sulla Palestina.
1921
Proclamazione dell'indipendenza dell’Iraq dalla Gran Bretagna e alleanza con la Gran Bretagna.
1921
Proclamazione dell’indipendenza della Transgioradania dalla Gran Bretagna e alleanza con la Gran
Bretagna.
1921
Proclamazione dell’indipendenza dell’Afghanistan dall’India inglese.
1925
Proclamazione dell’indipendenza del Libano dalla Francia.
Emigrazione degli ebrei in Palestina a causa della persecuzione nazista, appoggiato dalle potenze
1933-48 occidentali dopo la scoperta dei lager da parte degli alleati.
1947
Risoluzione dell’ONU delibera che sia Ebrei che Palestinesi hanno diritto a una loro nazione.
1948
Ben Gurion proclama la repubblica d’Israele.
1948-49 Scoppio della prima guerra arabo-israeliana che si conclude con la divisione della Palestina tra Israele e
Cisgiordania.
1956
Invasione della penisola del Sinai (seconda guerra arabo-israeliana).
1967
Guerra dei sei giorni (terza guerra arabo-israeliana).
1973
Guerra dello Yom Kippur (quarta guerra arabo-israeliana).
50
Africa
Egitto
1936
Protettorato Francia e Gran Bretagna sul Canale di Suez.
1951
La Francia concede basi militari agli USA e sfrutta la rivalità tra Berberi e Arabi.
1952
1952 Rivoluzione del movimento nazionalista degli “ufficiali liberi” guidati da Nasser che rovescia la
monarchia filoccidentale, caccia le potenze coloniali, nazionalizza le industrie e fa una riforma agraria.
1956
Nazionalizzazione del canale di Suez, Israele invade il Sinai con l’appoggio di Francia e Gran Bretagna
ma l’Unione Sovietica impone il ritiro.
1956
Il Marocco e la Tunisia proclamano l’indipendenza con il consenso della Francia.
1958
Repubblica Araba Unita con la Siria Marocco e Tunisia.
1976
Il Marocco invade il Sahara occidentale che ha appena ottenuto l’indipendenza. Il Fronte Polisario
inizia la guerriglia per l’indipendenza del popolo saharawi.
Algeria
1950
Nasce il Fronte di Liberazione Nazionale guidato da Ahmed Ben Bella.
1954-62 Guerra di liberazione.
1957
Battaglia di Algeri: guerriglia urbana nella capitale in cui le truppe francesi usano tutti i mezzi della
guerra totale: rastrellamenti e arresti di massa, torture, controterrorismo.
1958
Viene fondato Comitato di Salute Pubblica dai civili e militari francesi.
1962
De Gaulle concede l'indipendenza.
1965
Colpo di stato del Consiglio rivoluzionario guidato dal colonnello Boumedienne.
Libia
1946
La Libia diviene, secondo il trattato di pace di Parigi, protettorato dell’Italia per 10 anni a partire dal 1951.
1969
Golpe militare di giovani ufficiali guidato da Gheddafi.
1973
Gheddafi proclama la teoria del socialismo islamico.
Africa Equatoriale
1952
In Kenia nasce il movimento indipendentista dei Mau Mau.
1957-64 Le colonie francesi e inglesi ottengono l’indipendenza.
1957
Il Ghana (ex Costa D’Oro) ottiene l’indipendenza.
1958
La Guinea ottiene l’indipendenza.
1960
1960 – Camerun, Congo Brazzaville, Dahomey (poi Benin) , Gabon, Ciad, Repubblica Centrafricana, Togo, Costa
d'Avorio, Alto Volta, Niger, Senegal, Mauritania, Madagascar, Mali, Nigeria e Somalia ottengono l’indipendenza.
1960
Il Congo belga, guidato dall’intellettuale marxista Lumumba, ottiene l’indipendenza. I paesi occidentali
favoriscono la scissione della regione più ricca, il Katanga, in funzione antisovietica.
1961
Sierra Leone, Tanganica e Zanzibar (che si uniscono nella Tanzania) ottengono l’indipendenza.
1962
L’Uganda, il Ruanda e il Burundi ottengono l’indipendenza.
1963
Il Kenia ottiene l’indipendenza.
1966
Dopo sei anni di guerra civile viene instaurato il regime filoccidentale di Mobutu, mentre continua la
guerriglia marxista appoggiata anche da Che Guevara.
1974
Mengistu fa un colpo di stato in Somalia deponendo Ailé Sellassié. Inizia la Lotta indipendentista dell’Eritrea.
1974
La Guinea Bissau ottiene l’indipendenza dal Portogallo.
Africa Australe
1948
Il Sud Africa, membro del Commonwealth, inasprisce il regime di Apartheid già presente sin dagli inizi del
secolo, contro cui ha combattuto anche Gandhi.
1964
Il Malawi e lo Zambia ottengono l’indipendenza.
51
1965
La Rodhesia ottiene l’indipendenza sotto la guida di Ian Smith. La nuova costituzione garantisce diritti
politici solo alla minoranza bianca.
1974
Rivolta di Soweto quartiere nero di Johannesburg, in Sudafrica.
1974
Il Mozambico ottiene l’indipendenza dal Portogallo ma al potere del Frelimo (Fronte di liberazione di
sinistra) si oppone il Renamo (Fronte Nazionale del Mozambico) appoggiato dal Sudafrica.
1975
1980
1990
L’Angola ottiene l’indipendenza dal Portogallo ma al Movimento Popolare di Liberazione dell’Angola
(MPLA) appoggiato da Cuba si oppongono il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) finanziato dallo
Zaire e l’Unione Nazionale per l’Indipendenza (UNITA) filosudafricana.
Le potenze occidentali favoriscono la transizione del potere della maggioranza nera in Rodhesia, che prende il
nome di Zimbabwe. L’Apartheid sopravvive invece in Sudafrica a causa del forte radicamento della
popolazione boera che si considera ormai africana, a causa della ricchezza del paese e dei contrasti all’interno
del movimento di liberazione nero.
Nelson Mandela è rilasciato dalle carceri sudafricane, sono indette le prime elezioni a suffragio universale e Mandela
è il primo presidente nero del Sudafrica.
52
Cronologia generale
Anno
Nome attuale
Nome della colonia
Appartenenza
1932
Iraq
Inghilterra
1936
Egitto
Inghilterra
1946
Giordania
1946
Libano
1946
Siria
Francia
1947
India
Inghilterra
1948
Israele
Palestina
Inghilterra
1948
Myanmar
Birmania
Inghilterra
1948
Sri Lanka
Ceylon
Inghilterra
1949
Indonesia
Indie Olandesi
1953
Cambogia
Transgiordania
Inghilterra
Francia
Olanda
Francia
1953
Laos
Francia
1954
Vietnam
Francia
1956
Sudan
Inghilterra
1956
Marocco
Francia
1956
Tunisia
Francia
1957
Ghana
Costa d’Oro e Togo Britannica
Inghilterra
1957
Malaysia
Malesia
Inghilterra
1958
Israele
Palestina
Inghilterra
1958
Guinea
1960
Rep. Dem. Congo
Francia
Congo belga
Belgio
1960
Cipro
Inghilterra
1960
Nigeria
Inghilterra
1960
Somalia
1960
Bénin
1960
Burkina Faso
Somalia britannica
Inghilterra
Alto Volta
Francia
Congo
Francia
Francia
1960
Camerun
1960
Rep. del Congo
Francia
1960
Costa d’Avorio
Francia
1960
Gabon
Francia
1960
Madagascar
Francia
1960
Mali
Francia
1960
Mauritania
Francia
1960
Niger
1960
Rep. Centroafricana
1960
Senegal
Francia
1960
Ciad
Francia
Francia
Ubangui-Chari
Francia
1960
Togo
Francia
1961
Sudafrica
Inghilterra
1961
Camerun
Inghilterra
1961
Kuwait
Inghilterra
1961
Sierra Leone
Inghilterra
1961
Tanzania
Tanganica e Zanzibar
Inghilterra
1962
Burundi
Ruanda-Urundi
Belgio
1962
Ruanda
Ruanda-Urundi
1962
Jamaica
Belgio
Inghilterra
1962
Uganda
Inghilterra
1962
Trinidad e Tobago
Inghilterra
1962
Algeria
Francia
53
1963
Kenya
1964
Malawi
1964
Malta
Inghilterra
Nyasaland
Inghilterra
Inghilterra
1964
Zambia
1965
Gambia
Rhodesia del Nord
Inghilterra
1965
Isole Cook
Inghilterra
1965
Maldive
Inghilterra
1965
Singapore
Inghilterra
1965
Zimbabwe
1966
Barnados
1966
Inghilterra
Rhodesia
Inghilterra
Botswana
Bechuanaland
Inghilterra
1966
Guyana
Guyana britannica
Inghilterra
1966
Lesotho
Basutoland
Inghilterra
1967
Yemen
Yemen del Sud
1968
Mauritius
Inghilterra
Inghilterra
Inghilterra
1968
Nauru
Inghilterra
1968
Swaziland
Inghilterra
1968
Guinea Equatoriale
Fernando Poo
Spagna
1969
Irian Jaya
Nuova Guinea Occid.
Olanda
1970
Figi
1970
Tonga
Inghilterra
Inghilterra
1971
Bahrein
Inghilterra
1971
Emirati arabi uniti
Inghilterra
1971
Oman
Inghilterra
1971
Qatar
Inghilterra
1973
Bahamas
Inghilterra
1974
Granata
Inghilterra
1974
Guinea Bissau
Portogallo
1975
Comore
Francia
1975
Suriname
1975
Angola
1975
Capo Verde
Portogallo
1975
Mozambico
Portogallo
1975
Sao Tomé e Príncipe
Portogallo
1976
Seychelles
Inghilterra
1976
Sahara Occidentale
Sahara spagnolo
1977
Gibuti
Territori francesi degli Afars e degli Issas
1978
Domenica
1978
Isole Salomon
1978
Tuvalu
Isole Ellice
1979
Kiribati
Isole Gilbert
1979
Santa Lucia
1979
Grenadine
San Vincenzo
Inghilterra
1980
Vanuatu
Nuove Ebridi
Inghilterra
1981
Antigua e Barbuda
1981
Belize
1983
San Kitts e Nevis
Inghilterra
1984
Brunei
Inghilterra
1997
Hong Kong
Inghilterra
Guyana Olandese
Olanda
Portogallo
Spagna
Francia
Inghilterra
Inghilterra
Inghilterra
Inghilterra
Inghilterra
Inghilterra
Honduras britannico
54
Inghilterra