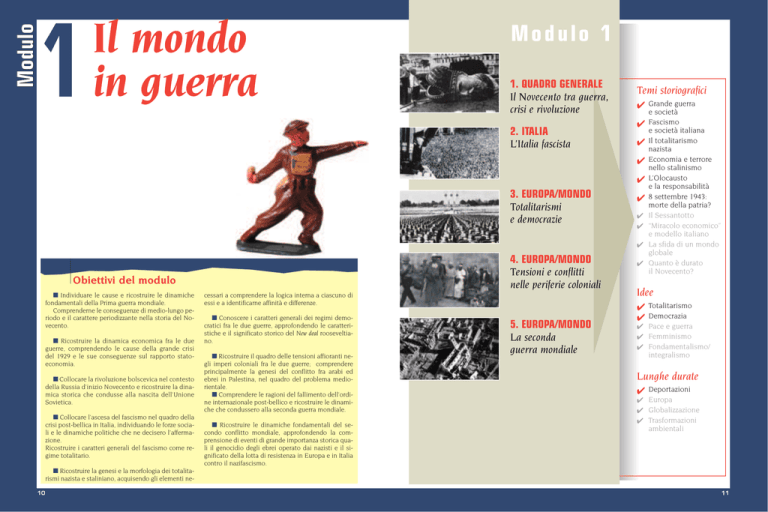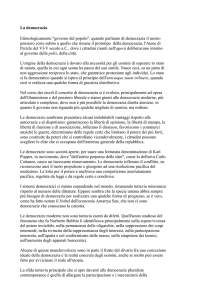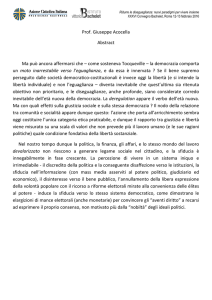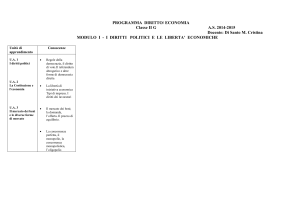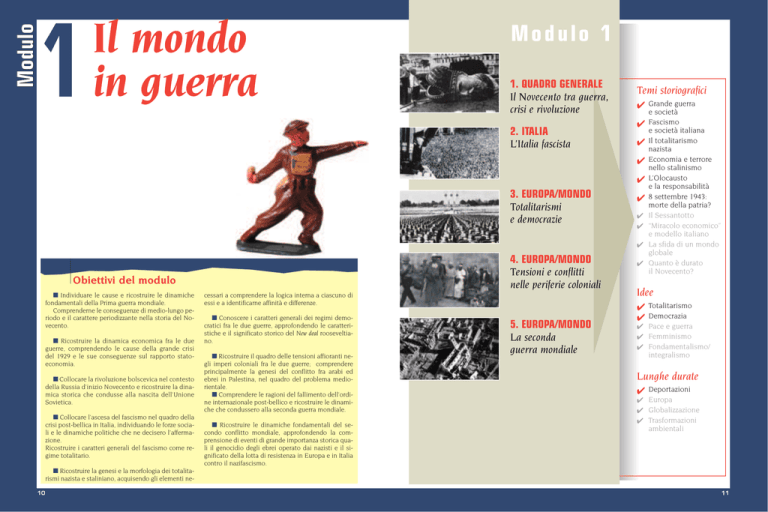
Modulo
1
Il mondo
in guerra
Modulo 1
1. QUADRO GENERALE
Il Novecento tra guerra,
crisi e rivoluzione
2. ITALIA
L’Italia fascista
Temi storiografici
✔
✔
✔
✔
✔
3. EUROPA/MONDO
Totalitarismi
e democrazie
✔
✔
✔
✔
4. EUROPA/MONDO
Tensioni e conflitti
nelle periferie coloniali
Obiettivi del modulo
■ Individuare le cause e ricostruire le dinamiche
fondamentali della Prima guerra mondiale.
Comprenderne le conseguenze di medio-lungo periodo e il carattere periodizzante nella storia del Novecento.
■ Ricostruire la dinamica economica fra le due
guerre, comprendendo le cause della grande crisi
del 1929 e le sue conseguenze sul rapporto statoeconomia.
■ Collocare la rivoluzione bolscevica nel contesto
della Russia d’inizio Novecento e ricostruire la dinamica storica che condusse alla nascita dell’Unione
Sovietica.
■ Collocare l’ascesa del fascismo nel quadro della
crisi post-bellica in Italia, individuando le forze sociali e le dinamiche politiche che ne decisero l’affermazione.
Ricostruire i caratteri generali del fascismo come regime totalitario.
■ Ricostruire la genesi e la morfologia dei totalitarismi nazista e staliniano, acquisendo gli elementi ne10
cessari a comprendere la logica interna a ciascuno di
essi e a identificarne affinità e differenze.
■ Conoscere i caratteri generali dei regimi democratici fra le due guerre, approfondendo le caratteristiche e il significato storico del New deal rooseveltiano.
■ Ricostruire il quadro delle tensioni affioranti negli imperi coloniali fra le due guerre; comprendere
principalmente la genesi del conflitto fra arabi ed
ebrei in Palestina, nel quadro del problema mediorientale.
■ Comprendere le ragioni del fallimento dell’ordine internazionale post-bellico e ricostruire le dinamiche che condussero alla seconda guerra mondiale.
■ Ricostruire le dinamiche fondamentali del secondo conflitto mondiale, approfondendo la comprensione di eventi di grande importanza storica quali il genocidio degli ebrei operato dai nazisti e il significato della lotta di resistenza in Europa e in Italia
contro il nazifascismo.
5. EUROPA/MONDO
La seconda
guerra mondiale
✔
Grande guerra
e società
Fascismo
e società italiana
Il totalitarismo
nazista
Economia e terrore
nello stalinismo
L’Olocausto
e la responsabilità
8 settembre 1943:
morte della patria?
Il Sessantotto
“Miracolo economico”
e modello italiano
La sfida di un mondo
globale
Quanto è durato
il Novecento?
Idee
✔
✔
Totalitarismo
Democrazia
✔ Pace e guerra
✔ Femminismo
✔ Fondamentalismo/
integralismo
Lunghe durate
✔
Deportazioni
✔ Europa
✔ Globalizzazione
✔ Trasformazioni
ambientali
11
U. 1
Il Novecento
fra guerra,
crisi
e rivoluzione
Unità
1
Il Novecento
fra guerra, crisi
e rivoluzione
Capitolo
La prima
1 guerra mondiale
1.
La prima
guerra
mondiale
QUADRO
GENERALE
EUROPA
E MONDO
ITALIA
Una guerra europea
Per circa un secolo, dopo il congresso di Vienna, l’Europa conobbe un periodo di sostanziale pace: i pur
numerosi conflitti che ebbero luogo conservarono sempre un carattere circoscritto nell’ampiezza e nella
durata. Ma l’equilibrio che aveva caratterizzato i rapporti fra le potenze nel corso dell’Ottocento andò
rapidamente incrinandosi con il nuovo secolo, fino a crollare nel 1914. Dall’estate 1914 all’autunno 1918,
infatti, l’Europa fu pesantemente devastata da un conflitto di immani dimensioni, quale l’umanità non
aveva mai conosciuto. Un conflitto che si accese – scrivono Mario Isnenghi e Giorgio Rochat – «per decidere quale nazione o gruppo di nazioni avrebbe avuto un ruolo dominante in Europa e, in prospettiva,
nel mondo, data la supremazia che gli stati europei esercitavano allora su gran parte del globo». La
Grande guerra fu dunque un conflitto per l’egemonia in Europa, in cui tutte le nazioni si mossero in una
logica di potenza; un conflitto che si usa definire “mondiale” perché coinvolse anche nazioni non europee, ma che fu in realtà profondamente europeo nelle sue origini e nel suo svolgimento.
Conflitti egemonici e crisi degli equilibri
Questa guerra infrange tutte le barriere
riconosciute in tempo di pace.
Abbatte quanto trova sulla sua strada
con una rabbia cieca e come se dopo
non dovesse più esservi un avvenire e una pace
tra gli uomini.
Sigmund Freud, in C. Musatti,
Il discorso della civiltà e altri saggi, Boringhieri
12
L’analisi delle cause della prima guerra mondiale deve riferirsi a molteplici fattori economici, politici, diplomatici e anche culturali. Può servirci da guida lo storico e politologo Gian Enrico Rusconi, il
quale ha efficacemente indicato tre dati di fondo della situazione internazionale in cui maturò la guerra: «a) una condizione permanente di tensione
tra due sistemi egemonici o blocchi plurinazionali organizzati in strette alleanze militari; b)
l’instabilità di aree regionali o prossime (geograficamente o politicamente) ai due blocchi,
con l’emergenza di fenomeni particolarmente
difficili da trattare (nazionalismi e terrorismi); c)
livelli elevatissimi di armamento guidati da
strategie e da tecnologie militari dall’affidabilità mai pienamente sperimentata e collocati in
una disposizione fondamentalmente offensiva». La crescente conflittualità fra le grandi
potenze sul terreno economico e coloniale
nasceva dal fatto che lo spazio disponibile per
l’espansione era stato in gran parte occupato,
ma mentre la Gran Bretagna e, in minore misura,
la Francia disponevano di enormi imperi coloniali, la Germania si trovava ad avere possedimenti
assai più ridotti ed economicamente meno vantaggiosi (l’impero coloniale tedesco era un decimo di quello britannico). Questo squilibrio era in
contraddizione con i nuovi rapporti di forza economici maturati negli ultimi decenni dell’Ottocento: la Germania aveva accresciuto enormemente la propria potenza industriale e mer■ L’interno di una fabbrica di cannoni a Coventry, in Inghiltercantile e ormai minacciava il primato econo- ra; la prima guerra mondiale fu un conflitto fra economie, oltre che fra eserciti.
mico della Gran Bretagna.
M. 1 Il mondo in guerra
13
U. 1
Il Novecento
fra guerra,
crisi
e rivoluzione
... e delle coscienze
Instabilità regionali
Dal punto di vista politico, l’impero guglielmino aveva abbandonato la politica di equilibrio dettata da Bismarck orientandosi decisamente a svolgere una politica di potenza su scala mondiale (la
cosiddetta Weltmachtpolitik, da Welt, “mondo” e Macht, “forza”), che implicava l’espansione coloniale
in Africa ma soprattutto la volontà di costruire un’egemonia tedesca nell’Europa centrale e orientale, anche ai danni della Russia in Polonia e nell’area baltica. La collocazione della Germania al
centro dello scenario europeo delineava un contrasto di portata mondiale con la Gran Bretagna,
che guardava con timore alla sempre più forte concorrenza economica e politica della Germania:
una minaccia che si fece drammaticamente concreta quando i tedeschi, grazie alla costruzione accelerata di una potente flotta da guerra, si misero per la prima volta in condizione d’insidiare il secolare primato della marina britannica.
D’altra parte la Francia coltivava dalla sconfitta del 1870 una forte ostilità antitedesca, che si appuntava in particolare sulla questione dell’Alsazia-Lorena, che i tedeschi si erano annessi dopo la vittoria di Sedan. Al montante contrasto fra Germania da un lato, Gran Bretagna e Francia dall’altro,
si sommava poi la tradizionale contrapposizione fra Austria e Russia, entrambe interessate all’area
balcanica e ai territori dell’agonizzante impero ottomano: ambizioni che si intrecciavano con le tensioni nazionalistiche e le aspirazioni di potenze regionali, come la Serbia. Dal canto suo, l'Italia
aveva come propri obiettivi il recupero delle terre “irredente” ancora soggette al dominio austriaco
(Trento e Trieste) e l'affermazione della propria influenza nell'area adriatica e balcanica. Queste rivalità strategiche avevano condotto, come abbiamo visto nel volume precedente, a sostituire il fragile equilibrio costruito da Bismarck (il “concerto” delle potenze), con un sistema di contrapposte
alleanze politico-militari, la Triplice alleanza (Austria, Germania e Italia) e la Triplice intesa (Gran
Bretagna, Francia e Russia).
La militarizzazione delle economie...
Accanto alle cause internazionali del conflitto, emergono anche quelle relative alla politica interna e
al clima ideologico prevalenti nei paesi europei. Il processo di sviluppo industriale legato alle forniture militari conobbe un balzo in avanti nel primo decennio dell’Ottocento. Mentre si esauriva la corsa
alle colonie, si accendeva quella agli armamenti: la Gran Bretagna, per esempio, rispose colpo su colpo
alla crescita della marina tedesca. Ma tutta l’Europa si andava militarizzando e il legame fra il potere
politico e i gruppi di pressione economica e militare si fece sempre più stretto ✔ DATI. All’interno delle
classi dirigenti dei diversi paesi presero forza i settori che guardavano con favore a un eventuale conflitto: soprattutto i grandi gruppi industriali, che vi scorgevano un gigantesco affare economico, e le
gerarchie militari, desiderose di consolidare il prestigio conquistato nella fase dell’espansione coloniale. Nelle classi dirigenti s’incominciò anche a guardare alla guerra come a un mezzo per consolidare
l’unità nazionale e arginare i conflitti sociali, recuperando unanimità di consensi.
Sotto tutti questi aspetti la Germania guglielmina fu in prima fila: ma dappertutto in Europa il potere
esecutivo (governi e gerarchie militari) guadagnò sempre maggiore spazio e autorità, riducendo il ruolo
di controllo politico dei parlamenti e rendendo perciò difficile l’opposizione al conflitto da parte di chi
voleva esercitarla (vedremo in proposito il caso dell’Italia).
✔
Dati
14
spese militari pro capite
(marchi per abitante)
spese militari assolute
(in milioni di marchi)
Germania
Luglio 1914: lo scoppio del conflitto
Quanto abbiamo detto non deve farci pensare che un conflitto delle proporzioni e della distruttività di
quello che seguì fosse lucidamente perseguito dai governi, dagli stati maggiori, dalle forze industriali.
In realtà, la Grande guerra fu il risultato delle tensioni che si accumularono in quegli anni e che infine
esplosero, trascinando i contendenti in uno scontro generalizzato che andò al di là delle aspettative e
delle previsioni anche dei più accaniti sostenitori delle soluzioni di forza.
Il terreno sul quale divampò il conflitto fu quello dell’annosa questione d’Oriente, e in particolare dei
Balcani, considerati la vera “polveriera d’Europa”. Il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip, uno studente
bosniaco di nazionalità serba appartenente a un’associazione nazionalista, uccise a Sarajevo (capitale
della Bosnia) l’erede al trono d’Austria, l’arciduca Francesco Ferdinando. L’attentato si inseriva nel
quadro dell’opposizione nazionalista contro l’annessione della Bosnia-Erzegovina all’Austria, risalente
al 1908. Vienna attribuì al governo serbo una corresponsabilità nell’attentato e, dopo essersi consultata con Berlino, il 23 luglio inviò alla Serbia un ultimatum assai pesante e lesivo della sovranità di quello stato. Il governo di Belgrado accettò l’ultimatum, salvo la clausola che prevedeva la partecipazione
di funzionari austriaci alle indagini sull’attentato. L’Austria allora, intenzionata a sfruttare l’occasione
per sconfiggere la Serbia e probabilmente non valutando le conseguenze a livello internazionale, il 28
luglio dichiarò guerra alla Serbia, con l’appoggio del kaiser Guglielmo II. Lo zar, tradizionale “protettore” della Serbia, ordinò la mobilitazione generale dell’esercito. In risposta la Germania, il 1° agosto,
dichiarò guerra alla Russia, provocando la mobilitazione generale della Francia. Berlino dichiarò guerra alla Francia e l’esercito tedesco invase il Belgio: la Gran Bretagna, a sua volta, entrò allora in guerra contro la Germania (4 agosto). Il Giappone aprì le ostilità contro la Germania, mirando ai possedimenti tedeschi in Estremo Oriente (23 agosto). L’Italia si mantenne neutrale. L’impero ottomano,
temendo di essere aggredito dalla Russia, si schierò a fianco di Germania e Austria (ottobre 1914).
Dalla guerra breve alla guerra di logoramento
La corsa agli armamenti
La spesa militare raddoppia sia in
Germania che in Russia tra il 1905 e il
1913, ma in rapporto alla popolazione
totale sono la Germania, la Gran Bretagna e la Francia a guidare la “corsa
agli armamenti”.
Per esempio, il governo inglese e la
Royal Navy vararono, nel 1906, la
Dread-nought, una corazzata di navi da
battaglia con armi più veloci di qualsiasi altra nave del tempo.
Quanto al clima ideologico, va detto che il consenso alla prospettiva e all’idea della guerra si andava
diffondendo anche fra le popolazioni, non solo a opera dei gruppi nazionalisti più aggressivi, sovente
appoggiati dalla grande stampa, ma anche all’interno della stessa classe operaia. Il richiamo del “patriottismo”, l’affiorare di rivalità secolari, il timore di venire soffocati economicamente e militarmente fecero
presa su larghe masse, specialmente nelle città. È significativo il fatto che il movimento socialista internazionale si divise sull’atteggiamento da tenere di fronte alla guerra. Fino al 1912 la Seconda internazionale si era espressa unanimemente in senso pacifista, giudicando la guerra un “affare” per i capitalisti e uno strumento di ulteriore sfruttamento e oppressione dei lavoratori. Ma allo scoppio del conflitto
la maggior parte dei partiti socialisti si schierò con i rispettivi governi, votando a favore dei “crediti di
guerra”. Si trattò di una scelta drammatica, che determinò tra l’altro la fine della Seconda internazionale: tutta la tradizione pacifista del movimento socialista ne usciva clamorosamente smentita; le ragioni
della “solidarietà nazionale” prevalsero di fatto su quelle dell’internazionalismo. Influirono su tale orientamento il clima di violenza antipacifista (nel 1914 il deputato socialista francese Jaurès venne assassinato dopo un discorso contro la guerra), il timore di venire emarginati politicamente, di essere additati
come “disfattisti” e di perdere il contatto con la volontà popolare, o anche l’effettiva condivisione delle
ragioni portate dai sostenitori del conflitto. “Comunità d’agosto” è stato battezzato lo spirito di unanimità e di entusiasta concordia nazionale che attraversò le popolazioni europee – Russia inclusa – nell’estate 1914. In quel momento, in Europa, era difficile pensare e schierarsi contro la guerra.
1905
1913
1064
2110
1905
1913
Germania
17
31
Austria-Ungheria
459
720
Austria-Ungheria
10
14
Francia
991
1326
Francia
25
33
Gran Bretagna
1263
1491
Gran Bretagna
29
32
Russia
1068
2040
Russia
7
11
Su entrambi i fronti si pensava a una guerra breve, di pochi mesi o un anno al massimo, poco più di
una parentesi che non avrebbe alterato il normale svolgimento della vita economica: business as usual
(“affari come al solito”), prometteva il governo britannico agli imprenditori timorosi dello sconvolgimento economico della guerra. Questa previsione si rivelò drammaticamente errata: gli stati maggiori, legati ancora a una visione ottocentesca della guerra, non prevedevano che i nuovi armamenti via via perfezionati e impiegati nel corso del conflitto (potenti artiglierie, mitragliatrici, carri armati, sommergibili, aerei, gas asfissianti) lo avrebbero reso non solo più distruttivo, ma anche più equilibrato, più difficile da risolvere secondo le tradizionali strategie offensive. Inoltre, tutti erano convinti che la guerra sarebbe durata poco perché il sistema economico mondiale non avrebbe potuto
sopportare un’interruzione troppo lunga degli scambi internazionali: al contrario, la guerra mobilitò
M. 1 Il mondo in guerra
15
1.
La prima
guerra
mondiale
QUADRO
GENERALE
EUROPA
E MONDO
ITALIA
energie industriali e produttive impensate, che resero possibile il suo prolungamento. Per la
Germania, costretta a combattere su due fronti, una guerra rapida rappresentava una scelta in qualche modo obbligata, l’unica possibilità di vittoria (vedremo che il problema si riproporrà nella seconda guerra mondiale). Questo giustificò, agli occhi dello stato maggiore germanico e del governo di
Berlino, una scelta che indignò l’opinione pubblica internazionale: l’invasione del Belgio neutrale
con un esercito di 1,6 milioni di uomini, le sette armate del generale von Moltke, che consentì ai
tedeschi di marciare su Parigi, mentre il governo francese abbandonava la capitale ✔ SPAZI.
U. 1
Il Novecento
fra guerra,
crisi
e rivoluzione
La situazione sui due fronti
Sanguinose e senza esito si rivelarono invece le offensive francesi in Lorena. Ma l’offensiva tedesca
perse progressivamente slancio, anche a causa della difficoltà di realizzare efficaci collegamenti tra la
linea del fronte e le retrovie: all’inizio del settembre 1914, sul fiume Marna, i francesi, coadiuvati dagli
inglesi, riuscirono a respingere, a prezzo di centinaia di migliaia di vite, l’attacco nemico. La situazione
sul fronte occidentale – una linea di trincee lunga ottocento chilometri, dalla Manica al confine svizzero – entrò da quel momento in una lunga fase di stallo. Lo stesso accadeva sul fronte orientale, dove
i tedeschi erano riusciti a bloccare l’avanzata russa con le battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri,
nella Prussia orientale (agosto-settembre 1914), mentre l’Austria non riusciva ad avere ragione della
resistenza serba. Nel Mediterraneo, un’offensiva anglo-francese, con un forte contingente australiano e neozelandese, per conquistare i Dardanelli si risolse in una disfatta (200 000 caduti) a opera dell’esercito turco a Gallipoli.
✔
I fronti della guerra
FINLANDIA
S V E Z I A
Oslo
m a r e
d e l
Copenaghen
N o r d
GRAN
BRETAGNA
Riga
mar Baltico
Tilsit
Königsberg
Vilna
OLANDA
Lille
Amiens
BELGIO
laghi
Masuri Brest-Litovsk
Varsavia
I M P E RO G E R M A N I C O
Verdun
Epinal
Strasburgo
Danubio
Belfort
SVIZZERA
FRANCIA
IMPERO
RUSSO
Berlino Tannenberg
Anversa
Bruxelles
Trento
Milano
Venezia
Praga
POLONIA
Cracovia Tarnovo
Leopoli
BOEMIA
Vienna
Roma
Przemysl
Gorlice
Budapest
Caporetto
AUSTRIA
Trieste
Belgrado
SERBIA
MONTENEGRO
ROMANIA
Bucarest
Sofia
ALBANIA
16
principali offensive dell’Intesa
principali offensive degli imperi centrali
e dei loro alleati
fronti nel 1915
fronti alla fine del 1918
fronte russo del 1917
Salonicco
GRECIA
IMPERO
OTTOMANO
Atene
Una guerra per l’egemonia. La prima guerra mondiale ebbe molteplici cause di natura economica, politica, diplomatica e culturale. Alla sua origine, sta la crescente tensione fra le potenze europee per il primato economico e politico. Tensioni accentuate dall’espansione imperialistica, che saturò le aree di potenziale colonizzazione e alimentò l’aggressività delle nazioni escluse, soprattutto della Germania.
La “polveriera balcanica”. La miccia s’infiammò in uno dei settori più critici dell’equilibrio europeo, i Balcani. Qui, nel primo decennio del Novecento, l’indebolimento dell’impero ottomano aveva fatto emergere rivendicazioni etnico-nazionaliste e aveva alimentato le ambizioni espansionistiche di Austria,
Germania, Russia e Italia. La rivoluzione dei “giovani turchi” del 1908, la guerra di Libia (1911) e le due
guerre balcaniche del 1912-13 misero in crisi l’equilibrio regionale, indebolendo Turchia e Austria e candidando la Serbia al ruolo di maggiore potenza regionale. La competizione fra Austria e Serbia per il
controllo dell’area fu la causa prossima dello scatenarsi del conflitto.
mar Nero
BULGARIA
stati neutrali nel 1914
■ Soldati francesi in una trincea nei pressi
del fiume Mosa.
Lo scoppio del conflitto. L’assassinio di Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, a opera di un nazionalista serbo (Sarajevo, 28 giugno 1914), convinse l’Austria di poter regolare i conti con l’ingombrante presenza serba nei Balcani. La dichiarazione di guerra austriaca alla Serbia innescò un processo
a catena e in una sola settimana, per il meccanismo delle alleanze, quasi tutte le potenze europee, eccetto l’Italia, si trovarono coinvolte nella guerra; a fronteggiarsi erano due schieramenti: da un lato gli
Imperi centrali (Austria e Germania), dall’altro l’Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia).
UNGHERIA
Sarajevo
I TA L I A
imperi centrali e alleati
QUADRO
GENERALE
EUROPA
E MONDO
ITALIA
L’Europa si militarizza. Il clima in cui maturò la crisi del 1914 fu quello di una crescente militarizzazione
delle economie e delle coscienze. La “corsa agli armamenti” non fu solo il sintomo più evidente della
crisi che maturava, ma anche un elemento di impulso per le economie e per gli interessi dei grandi
gruppi industriali. Al nazionalismo aggressivo si unì un patriottismo esasperato che, nonostante il
pacifismo socialista, fece presa sulle masse; a esso corrispose uno spostamento degli equilibri politici interni a favore delle forze politiche favorevoli al conflitto e delle gerarchie militari.
Helsinki
Stoccolma
NORVEGIA
o
Ren
La carta mostra lo schieramento dei
paesi belligeranti e i fronti principali.
La condotta di guerra della Germania
si ispirò al “piano Schlieffen”, elaborato nel 1905, che prevedeva lo sfondamento a Occidente, attraverso il
Belgio neutrale, per costringere la
Francia alla resa. Ciò avrebbe permesso ai tedeschi di affrontare da
una posizione di forza il confronto a
Oriente con la Russia, giudicata – a
ragione – in ritardo dal punto di vista
militare. A sua volta, lo stato maggiore francese seguì il “XVIII piano”, che
prevedeva lo sfondamento nell’Alsazia-Lorena.
La realtà della guerra di posizione
emerge dall’osservazione delle linee
dei fronti, che rimasero sostanzialmente statiche per tutta la durata del
conflitto (salvo i notevoli successi
degli imperi centrali a est).
alleati del'Intesa
«È questa una guerra di miserabile infrattarsi. Uomini-pigmei
che si imbucano sottoterra pregando di scampare ai colpi di
maglio del gigante che scuote la terra con cieco furore». Così
scriveva alla madre un soldato britannico, quando ormai la speranza di una guerra breve aveva lasciato il passo alla realtà
della guerra di logoramento e il mito dell’offensiva si era dissolto nella quotidianità di una guerra essenzialmente difensiva, dominata dall’artiglieria. Gli eserciti si fronteggiavano lungo
le trincee martellandosi con i mortai; venivano lanciati sanguinosi quanto inutili attacchi, senza che nessuno riuscisse a
infliggere al nemico colpi decisivi o neppure significativi.
Migliaia, a volte anche decine di migliaia di uomini, cadevano
per conquistare pochi chilometri di terreno, che sarebbero poi
stati persi con sacrificio di altrettante vite umane. Gli alti
comandi costruivano sulla carta strategie che alla prova dei
fatti si rivelavano capaci di produrre solo nuove carneficine. La
situazione rimase così bloccata per anni, con enormi costi
umani ed economici: i soldati nelle trincee erano sottoposti a
uno sfibrante logoramento fisico e morale.
1.
La prima
guerra
mondiale
Sintesi
Spazi
Triplice Intesa
La guerra di trincea
La guerra di trincea. Gli stati maggiori degli eserciti, sulla base di una concezione ancora ottocentesca della guerra, basata sull’artiglieria e sul movimento delle fanterie, ritenevano che essa si sarebbe risolta in poche settimane. Accadde invece il contrario: il mancato sfondamento tedesco sul fronte occidentale e il blocco tedesco all’avanzata russa sul fronte orientale trasformarono l’illusione
della “guerra lampo” nella cruda realtà della “guerra di logoramento”, combattuta lungo migliaia di
chilometri di trincee.
M. 1 Il mondo in guerra
17
Grande guerra e società
Grande guerra e società
Leed
1. L’entusiasmo del volontario, la frustrazione del veterano
IL TEMA
TEMI
La ricerca storiografica sulla Grande guerra si è
storiografici
mossa a lungo su binari prevalentemente politicomilitari, indagando prima sul tema della responsabilità, poi su quello delle “cause” del conflitto. Negli
ultimi decenni, tuttavia, si sono aperti nuovi filoni di
ricerca, che ruotano tutti intorno al concetto di “modernità” della guerra e al suo significato nella storia
IDEE
della società novecentesca.
Servendosi di fonti molto diverse da quelle diplomatiche e militari tradizionali – dai diari di guerra alle
lettere di soldati e prigionieri, dalla fotografia al cinema – questa nuova storiografia ha messo in luce
l’esperienza vissuta della guerra, al fronte e presso le
popolazioni, la sua influenza sulla mentalità e sui
LUNGHE costumi, i suoi riflessi economici e sociali.
DURATE
PERCORSO
STORIOGRAFICO
La Grande guerra, per il suo carattere “totale” e
tecnologico, ha segnato una profonda rottura anche
nei modi di vivere e nella visione stessa del mondo:
muovendo da questa ipotesi due studiosi americani,
Paul Fussel (La Grande guerra e la memoria moderna,
1975) ed Eric J. Leed (Terra di nessuno. Esperienza bellica
e identità personale nella prima guerra mondiale, 1979), hanno analizzato la percezione e la memoria che del
conflitto ebbero combattenti e civili. Il primo ha studiato lo sconvolgimento portato dall’esperienza della guerra nell’elaborazione culturale della realtà, mostrando fra l’altro come al fronte si sia costituita,
presso un’intera generazione di maschi giovani, una
modalità assolutizzante di pensare l’“altro” nei termini esclusivi di amico/nemico. Leed ( testo 1) ha
interpretato l’esperienza della guerra come una frattura dell’ordine sociale e della vita quotidiana caratteristici della società industriale: da qui ebbero origine sia l’esaltazione collettiva dell’agosto 1914, sia
la frustrazione dei reduci di fronte alla scoperta che
la guerra non solo li aveva sottoposti a violenze indicibili e all’esasperato dominio della tecnologia,
ma riconsegnati a una società ancora più spietata di
quella che avevano sperato di lasciare.
È forte, in queste ricerche, l’interesse a cogliere il significato della guerra per i drammatici e conflittuali
decenni che la seguirono e, più in generale, per la
formazione di una moderna società di massa, con i
suoi riti, i suoi modelli mentali, i suoi simboli. Un
grande studioso del mondo simbolico legato all’inserimento delle masse nella vita dello stato-nazione, George L. Mosse (La nazionalizzazione delle masse,
1974), ha studiato non solo il modo in cui l’esperienza della guerra è stata manipolata al fine di
rafforzare il consenso di massa (Le guerre mondiali dalla tragedia al mito dei caduti, 1990), ma anche per quali
vie la guerra contribuì a rinforzare modelli antropologici e visioni del mondo etnocentrici o addirittura
razzisti ( testo 2).
Anche la storiografia italiana più recente ha imboccato la via dell’indagine sul rapporto guerra-società,
in particolare analizzando il rapporto fra guerra e
classi popolari: per la verità, i primi studi in questa
direzione, dovuti a Pietro Melograni (Storia politica
della Grande guerra, 1969) e Mario Isnenghi (I vinti di
Caporetto nella letteratura di guerra, 1967; Il mito della
Grande guerra da Marinetti a Malaparte, 1970), precedono le ricerche citate di Fussel e Leed. Fra i molti temi di ricerca, segnaliamo quello del vissuto dei contadini/fanti (non degli entusiasti volontari oggetto
dello studio di Leed) di fronte alla guerra tecnologica di massa, un misto fra estraneità e rassegnazione
(Antonio Gibelli, L’officina della guerra: la grande guerra e
le trasformazioni del mondo mentale, 1991, testo 3);
quello della mobilitazione autoritaria, da parte dello
stato, dell’intero sistema economico e dei lavoratori
( testo 4); quello delle trasformazioni indotte dalla
guerra nel mondo femminile e del modo in cui esse
vennero percepite ( testo 5).
Leed descrive il passaggio dall’esaltazione del 1914 alla grande
delusione del conflitto vissuto.
come completo
rovesciamento
la condizione
sociale
per superare
LETTURE
CONSIGLIATE
Il testo di Leed, Terra di nessuno, pubblicato in Italia
dall’editore il Mulino nel 1985, costituisce una lettura impegnativa ma di grande interesse e ricca di testimonianze e citazioni. Un quadro aggiornato sulla
guerra, in particolare sulla situazione italiana, è offerto dalla recente opera di M. Isnenghi e G. Rochat, La
grande guerra 1914-18 (La Nuova Italia, Firenze 2000):
testo ampio, ma facilmente utilizzabile anche per letture parziali di tipo tematico.
Per tantissimi, l’agosto del 1914 rappresentò l’ultima grande incarnazione del «popolo» come entità
morale unitaria. I giorni d’agosto sarebbero stati universalmente ricordati come quelli «vissuti più
profondamente» nelle vite individuali dei partecipanti alla guerra, e comunque della generazione di
guerra: giorni che non sarebbero mai stati dimenticati, né che si sarebbero più ripetuti. Il senso
comunitario, che spinse le folle nelle strade delle città d’Europa e legò gente fino allora completamente estranea con una sorta di magica coesione, ben di rado aveva un movente intellettuale. [...]
La guerra fu vista in opposizione assoluta alla vita sociale e come antipode alla normale esistenza
nella moderna società industriale. L’assunzione di questa polarità fra guerra e pace permise ai contemporanei di sentire la dichiarazione di guerra come il momento di passaggio da una vita normale, familiare, ad un’esistenza alternativa, differente in modo essenziale dalla società borghese. [...]
Questa antitesi fu alla base dei temi dominanti della esperienza d’agosto: l’esperienza della comunità e la fuga da tutto ciò che era connesso alla nozione di moderna società industriale.
L’esperienza comunitaria fu dominata dalla sensazione che la guerra alterasse le relazioni fra uomini e classi sociali; e, logicamente, nell’accantonare il mondo sociale strutturato in base alla ricchezza, allo status, alla professione, all’età, al sesso, si diede per scontato che anche i singoli individui fossero mutati. La spesso citata descrizione di Zweig delle folle mobilitate dalla guerra riunisce molti particolari del senso comunitario dell’agosto 1914. «Centinaia di migliaia di persone sentivano allora come non mai quel che esse avrebbero dovuto sentire in pace, di appartenere cioè ad
una grande unità. Una città di due milioni di abitanti, un paese di quasi cinquanta milioni, capirono
in quell’ora di partecipare alla storia del mondo, di vivere un istante unico, nel quale ciascun individuo era chiamato a gettare nella grande massa ardente il suo io piccolo e meschino per purificarsi da
ogni egoismo. Tutte le differenze di classe, di lingua, di religione erano in quel momento grandioso
sommerse dalla grande corrente della fraternità. Estranei si rivolgevano amichevolmente la parola per
strada, gente che si era evitata per anni si porgeva la mano, dovunque non si vedevano che volti fervidamente animati. Ciascun individuo assisteva ad un ampliamento del proprio io, non era cioè
più una persona isolata, ma si sapeva inserito in una massa, faceva parte del popolo, e la sua
persona trascurabile aveva acquisito una ragion d’essere. [...]»
La convinzione della polarità tra pace e guerra fu, nel 1914, il principale ingrediente della diffusa acclamazione della guerra come mezzo per trascendere le contraddizioni sociali ed economiche. Ma la disillusione che accompagnò l’accorgersi dell’intima analogia fra le società industriali e le guerre che queste conducono – qualcosa che è ormai un luogo comune per noi – contorse,
inaridì, e confuse la logica su cui erano basati il significato morale della guerra e la figura del guerriero. La «guerra totale» altro non fu che la negazione dell’esistenza di due realtà diverse, due diversi insiemi di regole, due diversi livelli su cui la vita potesse essere vissuta ed esperita: in guerra i
combattenti appresero che esiste soltanto un mondo industriale, la realtà del quale plasmava il loro
essere in guerra molto più che in tempo di pace. Nelle trincee i soldati appresero che la distruzione
tecnologica e la produzione industriale sono immagini speculari l’una dell’altra.
da E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale,
il Mulino, Bologna 1985, pp. 59-61
Guida alla lettura
✔
✔
✔
✔
M2
TEMI
Come fu percepita, secondo l’autore, l’entrata in guerra?
In quali sensi la guerra rappresentò la speranza di evadere dalla società borghese?
In quale modo la guerra avrebbe superato l'ndividualismo e i conflitti sociali?
Perché, nei combattenti, all’entusiasmo subentrò la delusione?
M3
storiografici
IDEE
LUNGHE
DURATE
Grande guerra e società
Mosse
2. Miti di guerra e mentalità razzista
Gibelli
3. La guerra, i fanti/contadini, lo stato
La guerra non creò il razzismo, ma il terreno per la sua diffusione.
TEMI
storiografici
IDEE
LUNGHE
DURATE
l’esaltazione quasi
religiosa della
nazione
in Italia si
chiamarono Arditi
La prima guerra mondiale, il cui scoppio fu accolto con eguale entusiasmo patriottico dagli ebrei
dell’Europa e dai gentili, doveva essere il preludio dell’orribile attuazione in Europa della politica
razzista. La dottrina della razza [...] aveva fatto presa sulla coscienza popolare, ma furono la guerra
e le sue conseguenze a trasformare la teoria in pratica. Gli ebrei, dato che costituivano la più importante minoranza vivente in Europa, erano ormai diventati per il pensiero razzista il nemico; ora, a
causa della guerra [...] divennero molto più visibili e cominciarono ad essere isolati e perciò più facilmente perseguitati. In effetti quella stessa violenza che dagli anni della guerra si era protratta nel
mondo postbellico costituì un’altra condizione necessaria per il trionfo del razzismo. La mentalità
prodotta dalla guerra e dal caos postbellico e così pure dalle rivoluzioni degli anni 1918-20 aprì la
strada al futuro. In genere la guerra favorì aspirazioni al cameratismo, all’attivismo e all’eroismo
sempre nel quadro della mistica nazionale, e da essa il nazionalismo uscì rafforzato qualsiasi fossero stati il suo passato e le sue mire, sia che si fosse trattato di cogliere la vittoria sul nemico, sia di realizzare la liberazione nazionale. L’unità nazionale proclamata in tutte le nazioni allo scoppio della guerra si era però spesso dissolta persino negli anni del suo svolgimento per le accuse di vigliaccheria mosse
agli ebrei o per le tensioni tra gruppi rivali impegnati nell’Europa orientale nella lotta per la liberazione
nazionale. Alla fine, l’assuefazione alle uccisioni in massa aggiunse alle conseguenze della guerra anche
il fatto di aver reso più spietata la coscienza europea, anche questo un dato indicativo del futuro.
Nessuna tra queste conseguenze della guerra aveva necessariamente un carattere razzista, ma ognuna
sarebbe stata aperta alla penetrazione razzista allorquando i tempi fossero diventati maturi. [...]
La guerra di trincea aveva dato nuovo impulso a siffatta mentalità, perché per il combattente in
prima linea la guerra fu un’esperienza totale, fu trovarsi costantemente faccia a faccia col nemico,
sempre sotto il suo tiro. Questo tipo di guerra incoraggiò lo spirito di cameratismo di quegli uomini che trascorrevano insieme i giorni e le notti nelle trincee affondate nel fango e portò anche all’esaltazione [...] di quelle truppe d’assalto (come furono chiamate) che balzavano dalle trincee sotto
il micidiale fuoco del nemico. [...] L’esaltazione del cameratismo, dell’eroismo e di una nuova razza
di uomini avveniva in tempi di stermini mai visti in precedenza e ai quali era necessario far fronte.
Il risultato fu una sorta di brutalizzazione delle coscienze, frutto non solo dell’accettazione dell’inevitabile, ma anche di tentativi di venire a patti con una simile carneficina mediante la sua glorificazione. Fu detto che la morte in guerra dava nuovo significato alla vita; che cementava ulteriormente i legami di cameratismo tra coloro che avevano rifiutato la volgarità dell’esistenza quotidiana per
andare incontro all’ultimo sacrificio. [...] Siffatte idee sulla morte promettevano una sicura rinascita
entro la mistica nazionale per coloro che avevano compiuto il loro dovere, e vista in questa prospettiva la morte diventava meno terrificante. Ma al nemico era negato questo conforto: egli doveva essere ucciso e non sarebbe mai più tornato. Vi era un tipo di morte riservato a chi aveva combattuto per
la nazione e un altro al nemico. Per molti i corpi mutilati e i volti contratti dei morti sui campi di battaglia tornarono in vita attraverso i libri illustrati allora in voga, e, lungi dal provocare repulsione,
suscitando in un gran numero di giovani, che erano nati troppo tardi per partecipare al conflitto, il
rimpianto di avere perduto questa sfida alla virilità. Questi giovani avrebbero certo consentito con
quel sacerdote tedesco che dichiarò che Dio benedice chiunque uccide un nemico.
La guerra come momento di mobilitazione delle masse contadine,
che per la prima volta percepiscono in modo totalizzante l’autorità
dello stato.
nel senso che
una simboleggia
l’altra
libere
nel senso
di oggettivo,
generale
TEMI
storiografici
Nella Grande Guerra le classi subalterne sperimentano per la prima volta in forma tanto estesa,
profonda e totalizzante la presenza di quella potenza estranea che è lo stato. Specialmente per i contadini, esperienza della guerra e esperienza dello stato, intendo dire dello stato in fase di modernizzazione, si identificano in modo sempre più stretto appunto a partire dall’epoca della Grande Guerra:
epoca di affermazione della guerra totale, di mobilitazione di massa, potremmo dire più in generale di affermazione della società di massa. Stato e guerra si presentano ora come sinonimi e come
metafore l’uno dell’altra; come potere che dispone della vita e della morte in modo totalmente arbitrario e insindacabile.
Non che un’esperienza del genere fosse mancata in passato. Ma è la sua intensità, e quindi la sua
qualità ad apparire nuova. Prima, lo stato era estraneo ma anche lontano; si presentava occasionalmente a regolare e a sconvolgere la vita e l’economia private, non era insediato stabilmente al loro
interno, lasciava spazi di autonomia e zone sociali franche, si accontentava di esigere periodicamente dei “tributi”. Era una minaccia permanente ma una presenza saltuaria. Ora è vicino e invadente: il suo arbitrio prende la forma della necessità, la sua azione non è più soltanto negativa, di
esclusione e controllo, ma diventa positiva, di coinvolgimento e promozione. Il campo del suo intervento si dilata, il territorio della sua competenza si allarga. [...]
Ed ecco un primo aspetto della “modernità” legato all’esperienza di guerra: da allora in poi lo stato
non abbandonerà più la gente comune, diverrà una presenza costante, ineliminabile, interna alla
vita di ciascuno.
Ma c’è un altro aspetto, non meno importante, per il quale la prima guerra mondiale è “grande”, e
la sua esperienza coincide con la prima esperienza generalizzata della modernità, specie per i ceti
contadini: vale a dire il fatto che si tratta della prima guerra tecnologica, industrializzata, un vero
trionfo della moderna tecnologia. E quando si dice guerra industrializzata non ci si riferisce tanto
alla natura delle armi e dei mezzi di supporto, ma all’organizzazione della macchina bellica complessiva e al governo delle masse, potremmo dire all’organizzazione del lavoro di guerra: in sostanza alle tecniche di mobilitazione, controllo e movimentazione di grandi masse umane militarizzate.
La guerra appare in questo senso come massimo dispiegamento del superiore, impersonale potere della tecnologia, come macchina automatica indipendente dalla volontà dei singoli. [...]
Nel quadro della carneficina industrializzata, anche la morte diventa un fenomeno nuovo, come
morte anonima di massa, prodotta in serie dai meccanismi automatici della guerra. Possiamo anzi
dire che la prima esperienza generalizzata della società di massa, della produzione di massa, sia
stata, per milioni di uomini, proprio quella della morte di massa, standardizzata, prodotta in grande serie, organizzata. In definitiva, un mondo mentale e immaginario largamente nuovo, terribilmente moderno, si profila nei campi di battaglia della Grande Guerra, da cui anche gli appartenenti alle classi subalterne escono, per così dire, rigenerati, diversi da come vi erano entrati.
da A. Gibelli, Per una storia dell’esperienza di guerra dei contadini,
in “Movimento operaio e socialista”, n. 1, 1986
da G.L. Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all’Olocausto, Laterza, Bari 1994, pp. 185-89
Guida alla lettura
✔ Perché la guerra, secondo Mosse, rese «più spietata la coscienza europea»?
✔ L’autore individua un punto di contatto fra nazionalismo e razzismo: in che cosa consiste?
✔ Diversi studi sono stati dedicati a un tema cui accenna Mosse, quello che la guerra produsse
una «nuova concezione della morte» e un suo «uso pubblico»: che cosa sostiene l’autore
in proposito?
M4
Guida alla lettura
✔ Che cosa significa l’affermazione dell’autore che «stato e guerra si presentano ora come
sinonimi e come metafore l’uno dell’altra»?
✔ Quale novità presenta la Grande guerra rispetto ai conflitti, pur importanti, del passato?
✔ Gibelli rileva due aspetti di “modernità” della Grande guerra: quali sono?
✔ Che rapporto c’è fra la guerra e la società industriale tecnologica?
M5
IDEE
LUNGHE
DURATE
Grande guerra e società
Procacci
4. Mobilitazione e militarizzazione del lavoro
Isnenghi-Rochat
5. Le donne e la guerra
L’autrice riflette sull’esperienza italiana, caratterizzata da una crescita del potere dell’esecutivo e delle gerarchie militari rispetto al
parlamento anche nella vita civile.
TEMI
storiografici
IDEE
LUNGHE
DURATE
obbligatorio,
forzato
soluzione in base
a un accordo
sistema di
retribuzione
proporzionale
alla produttività
Alle autorità militari fu affidata la gestione dell’intero settore economico bellico, dagli approvvigionamenti all’organizzazione della produzione e delle relazioni industriali. La necessità di fronteggiare una guerra di resistenza impose infatti un intervento massiccio dello Stato in ambito economico
e sociale: e per attuare tali nuovi compiti fu necessario dar vita a organismi e a strumenti operativi
del tutto originali. Avvenne così che i mutamenti più rilevanti che il conflitto determinò in tutti i
paesi belligeranti nell’ambito dell’interventismo statale – riguardanti i rapporti di lavoro e il controllo sociale – vennero realizzati in Italia sotto la direzione delle autorità militari, all’interno pertanto di una concezione di tipo autoritario e gerarchico, la quale concordava pienamente con le aspirazioni degli ambienti politici della destra interventista – conservatrice e nazionalista – e dell’industria di guerra. [...]
Del tutto innovativo rispetto alla tradizione liberale, ancor più di quello in ambito economico, fu l’intervento dello Stato nel campo delle relazioni industriali, attuato attraverso la Mobilitazione industriale (MI), istituto creato per realizzare un pieno controllo del lavoro nelle fabbriche dichiarate
ausiliarie, istaurato per decreto nel giugno 1915, e il cui regolamento fu approvato in agosto. [...]
Il nuovo regime si basava su due princìpi: la manodopera veniva fissata in modo coatto al luogo di
lavoro, in virtù della proibizione per l’operaio non solo di scioperare, ma anche di dare le dimissioni. Le vertenze venivano decise attraverso un sistema arbitrale, in base al quale venivano sottoposte a commissioni (installate presso i comitati regionali) le controversie tra imprenditori e lavoratori che non trovavano una diretta composizione, purché attenessero alla sfera economica: quelle
disciplinari, e in generale tutte quelle riguardanti l’organizzazione del lavoro, rimasero infatti escluse dall’interferenza delle commissioni.
Il secondo principio riguardava il regime disciplinare. La coazione al posto di lavoro era realizzata
attraverso la militarizzazione della classe operaia, comprese donne e fanciulli. L’allontanamento non
autorizzato dal luogo di lavoro veniva pertanto equiparato alla diserzione, e punito con la detenzione (la dottrina giunse anche a discutere se fosse giuridicamente corretta la fucilazione!). Ma tutta la
vita all’interno della fabbrica seguiva le regole militari: la disciplina infatti veniva imposta da sorveglianti militari, che controllavano orari di entrata, ritmi, produzione, e soprattutto comportamento.
In base alla motivazione patriottica, la vita in fabbrica veniva regolata come quella nelle caserme; e
come i soldati, gli operai e le operaie erano soggetti, per le loro mancanze disciplinari (di cui dovevano rispondere anche nei confronti dei superiori tecnici civili), al codice penale militare. Tuttavia la
MI costituì anche un esempio di intervento modernizzatore [perché] istituì il principio che il potere
industriale privato poteva incontrare dei limiti, imposti dallo stato per motivi che riguardavano il
superiore interesse della collettività. Vennero così seppur parzialmente sottratte all’arbitrio padronale, e per la prima volta sottoposte a una contrattazione controllata dallo stato, la definizione dei
livelli salariali, dei cottimi e degli orari, e venne istituzionalizzato a partire dal 1917 il ruolo dei sindacati, sebbene a essi fosse riservata una funzione subalterna.
da G. Procacci, L’Italia nella Grande guerra, in Storia d’Italia, 4, Guerre e fascismo,
a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 45-48
La guerra crea figure femminili anomale per la mentalità corrente.
modificazione dei
ruoli tradizionali:
maschile/lavoro,
femminile/cura
e famiglia
abituale, normale
colpiscono
violentemente la
mentalità
tradizionale
la gerarchia della
fabbrica riflette
quella della
società
il ruolo di
accudimento
tradizionalmente
proprio della figura
femminile e materna
cioè tra genere
femminile e
genere maschile
Una classe dirigente che solo alle soglie della conflagrazione si è risolta a riconoscere il diritto di voto
alle classi popolari maschili – e che rimane lontana dal concepire un’analoga maturità delle proprie
figlie, mogli e sorelle, per non parlare della donna di ceto popolare nutrita di ancor più parchi studi
– si ritrova d’improvviso di fronte a una diffusa e variegata tipologia dell’emancipazione femminile.
[...] In ciascun ambito sociale lo stacco si manifesta secondo modalità proprie. Una figura itinerante
del nuovo è la donna tramviera e con essa la portalettere. Per la natura stessa del loro lavoro, esse
costituiscono un segno mobile delle innovazioni in corso: viste dal vero in azione, come può accadere a tutti i cittadini, o conosciute anche solo in fotografia, queste figure femminili in divisa alludono
palesemente al movimento e a una trasformazione di ruolo. [...] Tramviera, postina, telefonista,
impiegata – ovviamente, da più tempo, maestra e ora, per estensione, addetta agli uffici di propaganda –, tutto ciò può suscitare reazioni diverse: apparire volta a volta progressivo, nobile, o solo grazioso, curioso, contingente. L’allarme per lo scambio dei ruoli può restare in sospeso, venire sostanzialmente rinviato al dopoguerra, quando ci si può rassicurare pensando che la “normalità”, con il
ritorno degli uomini dalle trincee ai loro posti di lavoro, verrà restaurata e le donne riprenderanno la
canonica via di casa.
Ma ci sono altri luoghi, forme e figure dell’accesso delle donne al “mondo degli uomini” che
violentano l’immaginario, destando inquietudini più gravi e preoccupazioni immediate. Sono le contadine inurbate, le molte decine di migliaia di donne e ragazze, spesso giovanissime, che arrivano per
la prima volta in fabbrica. Costituiscono un elemento di lacerazione nei due mondi, di partenza e di
accesso, e cioè sia nell’universo familiare e nel tessuto della società contadina e paesana da cui muovono, sia negli assetti consolidati della fabbrica: dove le classi sociali si rispecchiano in simmetrie
gerarchiche messe a rischio da quella presenza imprevista e difforme di manodopera industrialmente analfabeta e senza un passato omogeneo, capace con la sua anomalia di dare impaccio sia alle
norme padronali sia a quelle operaie. Le nuove venute danno il nerbo e il tono alle manifestazioni
per il caroviveri, inedita folla vociferante per le strade, più difficile da contenere che le dimostrazioni
maschili del tempo di pace. Di fronte a quel femminile nuovo e disinibito, gli apparati repressivi ma
anche mentali maschili appaiono inibiti e sulla difensiva. [...] L’accesso delle donne alla sfera pubblica si manifesta in maniera pervasiva soprattutto in quegli ambiti che maggiormente attengono alla
cura e al maternage di massa. Servizi, dunque, lavori domestici – tagliare, cucire, lavorare a maglia,
preparare calze, guanti, indumenti caldi per i soldati esposti al freddo e all’umido delle trincee – che
si possono fare sia individualmente, nella propria casa, sia in forme associative e di gruppo. È l’esaltazione dei tipici ruoli e lavori femminili, la conferma di un modello tradizionale di donna che assiste
e si prende cura dell’uomo: questa volta non più solo del “suo” uomo, ma per così dire – in un rapporto da genere a genere – dell’intera categoria maschile, sotto la specie eminente del combattente, e – ancor più in stile – del combattente ferito, del quale urge cauterizzare le ferite fisiche e psicologiche restituendo il disarmato alle armi. Una grande metafora iperrealista dei rapporti di genere.
L’alacre cucitrice di maglie di lana estende a questo punto la propria pietosa consegna di assistenza
ai maschi della patria facendosi infermiera o dama di carità e porgendo conforto e aiuto nei treni
ospedale e nei reparti medici. È un passo in più, naturalmente, poiché in questa versione l’incombenza tutta femminile della cura comporta di necessità l’uscire di casa [...] e il vivere a contatto con
una moltitudine di maschi, combattenti e borghesi, ammalati e sani.
da M. Isnenghi-G. Rochat, La grande guerra 1914-18, La Nuova Italia, Firenze 2000, pp. 327-29
Guida alla lettura
✔
✔
✔
✔
Quale tesi l’autrice sostiene nelle prime righe del testo antologizzato?
Quale organismo diresse la mobilitazione industriale in Italia e come era composto?
Su quali princìpi si basava il nuovo regime industriale?
Quali caratteristiche ebbe la «militarizzazione» del lavoro?
M6
Guida alla lettura
✔ Perché, secondo gli autori, l’emancipazione femminile fu «indotta» dalla guerra?
✔ Quali conseguenze ebbe il fenomeno delle «contadine inurbate»?
✔ In che modo viene modificata anche «l’incombenza tutta femminile della cura»?
M7
TEMI
storiografici
IDEE
LUNGHE
DURATE
Democrazia
D
EMOCRAZIA
La sovranità da esercitare
TEMI
STORIOGRAFICI
a Democrazia, cioè il “potere del popolo” (dal
greco démos, “popolo”, e kràtos, “potere”) è un
ideale antico. Nel corso dei secoli, però, esso ha più
volte cambiato contenuto e forma, dando vita a più
di una interpretazione dell’ideale democratico. È
possibile delegare l’esercizio della sovranità?
L
IDEE
LUNGHE
DURATE
Oppure la sovranità popolare, per essere tale, deve
essere sempre esercitata direttamente?
Queste e altre fondamentali domande hanno
costellato la lunga storia del pensiero democratico,
a partire dai tempi della Grecia classica fino a
quelli a noi contemporanei.
La democrazia diretta,
dal modello greco al Sessantotto
Un primo, classico problema della democrazia contemporanea sorge dalla distinzione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. In regime di democrazia diretta, le decisioni più importanti vengono assunte da un’assemblea cui partecipano di diritto tutti i cittadini. Il modello storico a cui fanno riferimento i sostenitori di questa forma di regime democratico è quello della pólis
(la città-stato dell’antica Grecia), in particolare di quella ateniese, dove nel corso del V secolo a.C.
la partecipazione all’attività politica era stata estesa anche ai cittadini più poveri (benché ne rimanessero esclusi gli schiavi, gli stranieri residenti ad Atene e le donne).
Al modello ateniese e a quello dei piccoli villaggi della nativa Svizzera guardò anche il fondatore del pensiero democratico moderno, il filosofo e pensatore ginevrino Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778). Nella partecipazione all’assemblea di tutti i cittadini egli vide l’espressione più
genuina della sovranità popolare.
Nel Novecento, la democrazia diretta è spesso stata la parola d’ordine dei movimenti rivoluzionari e di contestazione. Basti ricordare il rilievo assunto nel 1917 e negli anni immediatamente
seguenti dai soviet, cioè dai consigli degli operai e dei contadini russi; o, in Italia, durante l’occupazione delle fabbriche del 1920, il dilagare dei consigli operai, in cui Antonio Gramsci, sulla
rivista l’”Ordine nuovo”, indicava il nucleo della nascente democrazia operaia.
All’esaltazione della espressione diretta della volontà popolare i movimenti rivoluzionari associavano la critica del parlamentarismo, cioè dell’idea, sostenuta, per esempio, dai liberali e
dagli stessi partiti socialdemocratici, che riforme politiche e miglioramento delle condizioni di
vita delle masse lavoratrici potessero essere ottenuti attraverso la lotta parlamentare, cioè delegando l’esercizio della sovranità ai deputati eletti dal popolo (da tutto o da una parte, a seconda che il suffragio fosse universale o ristretto).
Nella seconda metà del Novecento, modelli organizzativi ricollegabili a forme di democrazia
diretta, esplicitamente contrapposti alle organizzazioni politiche e sindacali tradizionali, hanno
caratterizzato sia i movimenti operai e studenteschi del Sessantotto in Occidente, sia i movimenti che a partire dagli anni ottanta hanno provocato nell’Europa orientale la crisi e il successivo crollo dei regimi comunisti.
Le forme della democrazia rappresentativa
L’unica forma di democrazia che abbia dato prova di reggere al compito di realizzare la sovranità popolare nelle grandi nazioni moderne è tuttavia quella rappresentativa.
Le dimensioni territoriali degli stati moderni, la complessità dei problemi che lo stato democratico deve affrontare e risolvere, la necessità di gestire grandi apparati burocratici sono
infatti altrettanti fattori che sembrano impedire l’affermarsi di forme dirette di governo o, per
lo meno, il loro impiego esclusivo.
Nei regimi democratici rappresentativi però – è bene chiarirlo – non viene delegata la sovranità, che è e rimane prerogativa del popolo; è piuttosto l’esercizio della sovranità che viene
attribuito a organi e istituzioni che rappresentano il popolo.
Nel mondo occidentale, esistono differenti modelli di democrazia rappresentativa, tutti conM74
trassegnati dalla divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e dal riconoscimento del diritto di voto a tutti i cittadini (suffragio universale). Ciò per cui essi si differenziano
sono, da un lato, i ruoli e pesi diversi assegnati dalle vigenti costituzioni agli organi in cui si
articola il potere statale; dall’altro, la diversa distribuzione dei poteri tra organi centrali e
organismi periferici.
Quanto al primo aspetto, la distinzione principale è quella che riguarda le democrazie parlamentari e quelle presidenziali.
Le democrazie parlamentari – che prevalgono nettamente in Europa – assegnano un ruolo
centrale al parlamento, unico organo eletto direttamente dai cittadini: al parlamento spetta
non solo di fare le leggi, ma anche di sostenere e controllare il governo, il quale infatti entra e
resta in carica sulla base della fiducia espressa dalle assemblee parlamentari.
Nelle democrazie presidenziali invece – come, in primo luogo, quella statunitense – non solo
chi esercita il potere legislativo, ma anche il capo dell’esecutivo, il presidente appunto, è eletto direttamente dal popolo. Il governo non dipende in questo caso dalla fiducia del parlamento, anche se quest’ultimo (almeno negli Usa) conserva un fortissimo potere di controllo sugli
atti del governo presidenziale, cui può negare l’assenso.
Quanto al secondo aspetto, la distinzione principale è quella tra democrazie caratterizzate da
un prevalente potere centrale e democrazie federali.
Tra le prime ricordiamo la Francia, che vanta una secolare tradizione di centralizzazione statale risalente ai tempi della monarchia assoluta del “Re Sole” (fine XVII secolo) e a quelli dell’impero napoleonico d’inizio Ottocento. Per quanto riguarda le democrazie federali, invece, –
tra le quali ricordiamo, oltre a quella americana, la repubblica federale tedesca – un gran
numero di competenze sono sottratte al potere centrale e vengono decentrate agli stati membri (parliamo allora di federalismo dualistico) oppure vengono gestite cooperativamente dal
centro e dalla periferia (si parla in questo caso di federalismo cooperativo).
Anche nei sistemi federali più spinti, tuttavia, alcune competenze rimangono saldamente nelle
mani del potere centrale. La politica estera, di difesa e quella relativa al controllo della moneta nazionale, per esempio, non vengono mai delegate agli organismi federati, ma continuano
a essere gestite dal centro.
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
Il referendum
Se nei grandi stati contemporanei prevale la democrazia rappresentativa, ciò non significa che
siano del tutto scomparse forme istituzionalizzate di democrazia diretta.
Il ricorso diretto al giudizio popolare si verifica, per esempio, nel caso dei referendum, in cui
gli aventi diritto al voto sono chiamati a decidere intorno a quesiti traducibili in una domanda, sui quali l’elettore può esprimersi con un sì o con un no.
Proprio in quanto manifestazione diretta della volontà dell’elettorato, l’istituto del referendum
viene concepito da alcuni come strumento per eccellenza di partecipazione politica e di esercizio della sovranità popolare.
L’esperienza storica, però, ha messo in luce non pochi dubbi e perplessità in merito al ricorso
al referendum. In situazioni nelle quali non sia effettivamente garantito il pluralismo delle
opzioni politiche, infatti, il referendum può rivelarsi uno strumento insidioso, solo formalmente democratico ma in realtà gravido di imprevedibili pericoli antidemocratici.
In particolare, si è evidenziato un pericolo “plebiscitario”. È accaduto infatti più volte nella
storia che, attraverso il ricorso al plebiscito, i cittadini siano stati chiamati a esprimersi sulle
proposte di uomini forti o di dittatori (come Napoleone e Mussolini).
Costoro, disponendo di tutti gli strumenti di propaganda, riuscivano facilmente a condizionare in senso favorevole alla propria politica l’espressione del consenso popolare, accreditandosi come leader forti di vasti consensi tra le masse e consolidando in tal modo il proprio potere personale e autoritario.
Proprio per scongiurare questo rischio, la Costituzione italiana – elaborata alla fine della
seconda guerra mondiale, dopo un ventennio di dittatura fascista – prevede che il referendum
sia solo abrogativo, serva cioè a cancellare in tutto o in parte leggi esistenti, e non ad approvarne di nuove. Questo compito, per la Costituzione , spetta in via esclusiva al parlamento.
M75
Democrazia
Pluralismo politico e principio di maggioranza
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
Un secondo problema fondamentale della democrazia è quello che riguarda l’equilibrio tra il
principio di maggioranza, sulla base del quale nei sistemi democratici vengono assunte le
decisioni, e il riconoscimento del ruolo e del valore delle posizioni espresse dalla minoranza;
è consuetudine designare la necessità di tale equilibrio come principio pluralistico, che affonda le sue radici nel pensiero liberale. Secondo il politologo Giovanni Sartori lo sviluppo di un
atteggiamento tollerante e pluralistico è la precondizione per la nascita delle democrazie
moderne, che sono per questo democrazie liberali. Al principio di maggioranza potrebbe infatti non accompagnarsi il principio pluralistico. Ciò accade quando chi ottiene la maggioranza
dei consensi elettorali confonde il diritto-dovere di governare la cosa pubblica (che ne consegue in virtù del principio maggioritario) con un passaporto per occupare ogni potere dello
stato, riducendo o addirittura eliminando il diritto della minoranza a svolgere efficacemente il
proprio ruolo di opposizione, di stimolo, di controllo. Ciò è avvenuto in Italia nel 1924-25
quando Mussolini fece leva sull’ampia maggioranza parlamentare ottenuta dal suo "listone" –
peraltro con brogli e intimidazioni di ogni genere contro avversari del fascismo – per smantellare le fragili strutture dello stato liberale postunitario, eliminare ogni opposizione e
garanzia costituzionale e imporre agli italiani vent’anni di regime totalitario.
Sartori
Il fondamento della democrazia
Nel brano che segue, il politologo Giovanni Sartori afferma che alla base delle
democrazie moderne – che sono democrazie liberali – vi è storicamente lo sviluppo di un atteggiamento tollerante e pluralistico.
La genesi ideale delle democrazie liberali è nel principio che la differenziazione e non l’uniformità costituisce il lievito e il più vitale alimento del convivere.
Questa idea si è venuta plasmando nell’età della
Riforma e al cospetto delle terribili devastazioni e crudeltà delle guerre di religione, tra il 1562 e il 1648. Fino
a quel tempo, si era sempre guardato alla diversità
come causa della rovina degli stati, come fonte di
discordia e di disordine, e si pensava che l’unanimità
fosse il necessario fondamento dei governi. Da allora
si cominciò a pensare l’opposto, a guardare con
sospetto l’unanimità e a pregiare il dissent, la varietà. È
su questa rivoluzionaria inversione di prospettive che
si è andata costruendo a pezzi e bocconi la civiltà liberale; ed è per questo tramite che si arriva alle attuali
democrazie. L’autocrazia, i dispotismi, le vecchie e
nuove dittature sono il mondo tutto di un colore; la
democrazia è un mondo multicolore. Si badi: non la
democrazia antica, che fu anch’essa monolitica. E’ la
liberal-democrazia che viene strutturata sulla diversità. Siamo noi e non i greci ad aver scoperto come
costruire un ordine politico attraverso il molteplice e
le differenze.
Chi ha scoperto il pluralismo? Nessuno in particolare.
Siccome l’idea emerge nell’età della Riforma, è abbastanza ovvio che lo sguardo si fissi sui riformatori, e
specialmente sulle sette puritane. […] I meriti dei
puritani nel creare il sistema di valori e di credenze che
ha a sua volta generato la civiltà liberale sono indubM76
bi; ma sono largamente da ascrivere a conseguenze
impreviste, a esiti preterintenzionali.
Invece di cercare paternità difficili da trovare, fermiamo i punti caratterizzanti. Primo, il pluralismo deve
essere concepito come una credenza di valore. Anche
la frammentazione medievale potrebbe essere dichiarata pluralistica; ma quel pluralismo era di strutture,
non di credenza (e dunque non era tale). Il mondo
medievale fu policentrico nell’organizzazione, ma
monocromatico nella sua visione del mondo. Secondo,
il pluralismo presuppone e comporta tolleranza: è
negato dal fideismo e dal fanatismo, e si afferma negandoli. Si badi, tolleranza non è relativismo; è riconoscere
il diritto di credi diversi dal proprio. Terzo, il pluralismo
richiede che la Chiesa sia separata dallo stato e che la
società civile sia autonoma nei confronti di entrambe.
(Anche la scoperta della società come sfera autonoma
di sponte acta, di attività innovative e spontanee, è
recente). Il pluralismo è minacciato sia dallo stato che
è braccio secolare di una Chiesa, sia dallo stato che
politicizza la società. A Dio quel che è di Dio, a Cesare
quel che è di Cesare, e alla società civile quel che non è
né di Dio né di Cesare: in distillato, questa è la visione
del mondo che porta al liberalismo e poi alla democrazia liberale. Una visione del mondo che a tutt’oggi resta
tipicamente occidentale […].
da G. Sartori, Democrazia. Cosa è, Rizzoli,
Milano 1993
I sistemi democratici e il problema
della stabilità di governo
Quanto detto sui rischi che il governo di maggioranza si trasformi in una «tirannia della maggioranza» (secondo la celebre espressione del pensatore francese d’inizio Ottocento Alexis de
Tocqueville) non deve farci dimenticare che compito di un regime democratico è risolvere –
democraticamente e, dunque, a maggioranza – i problemi di società complesse e che questo
comporta stabilità di governo e capacità di decisione.
Ciò avviene di norma nei principali paesi occidentali, dove funzionano quelle che il politologo
Gianfranco Pasquino definisce «democrazie maggioritarie»: cioè democrazie in cui «il governo decide su materie precisamente limitate e l’opposizione controlla, critica e contropropone.
Dopodiché, entrambi responsabilmente si sottopongono al giudizio dell’elettorato che, periodicamente, impone l’alternanza tra opposizioni e governi».
Per ottenere questo risultato si richiedono, secondo Pasquino, le seguenti condizioni:
«1. Un sistema elettorale maggioritario oppure proporzionale, ma fortemente corretto, che
elegge un parlamento prevalentemente monocamerale con un numero contenuto di rappresentanti;
2. Un sistema rappresentativo organizzato intorno a due poli, oppure meglio, a due partiti;
3. L’investitura popolare del governo, dotato di un mandato elettorale;
4. L’alternanza tra coalizioni contrapposte;[…]
6. Organizzazioni, prevalentemente partitiche, radicate sul territorio nazionale, che si candidano al governo e che garantiscono la responsabilità collettiva delle loro promesse, dei loro programmi, del loro operato. Naturalmente, non è detto che queste caratteristiche si ritrovino allo
stato puro e tutte insieme».
Il sistema elettorale maggioritario favorisce la creazione di ampi schieramenti, due o tre al
Pizzorusso
I problemi delle democrazie
Presentiamo due brevi testi tratti dal saggio Minoranze e maggioranze del costituzionalista Alessandro Pizzorusso. Nel primo, egli sintetizza le difficoltà connesse
all’uso del referendum. Nel secondo, Pizzorusso affronta il problema della conciliazione tra principio di maggioranza e tutela della minoranza nella formazione
delle decisioni collettive.
[Le difficoltà del referendum] derivano, oltre che dal
suo alto costo e dall’inopportunità di ricorrere a esso
per decisioni che implichino scelte numerose e complesse, anche dalla possibilità che esso sia strumentalizzato da coloro che detengono il potere per fare
apparire l’esistenza nei loro confronti di un consenso
maggiore di quello realmente esistente (dando luogo
così a forme di “plebiscito”), oppure da gruppi minoritari i quali ricorrano a esso per ragioni di carattere
tattico, che vanno al di là della deliberazione cui il
referendum si riferisce. [...] Queste ragioni di carattere generale, insieme con altre legate alla storia dei
singoli paesi, fanno sì che il referendum venga impiegato, al livello degli ordinamenti giuridici statali, [...]
soltanto in ipotesi relativamente eccezionali.
L’impiego del principio maggioritario per la formazione delle deliberazioni collettive presuppone che fra
gli appartenenti a una determinata comunità esista
un’affectio societatis [sentimento di solidarietà] tale da
indurre chi si trovi ad assumere il ruolo di componente di una minoranza ad accettare le decisioni
adottate dalla maggioranza, e corrispondentemente,
una cultura della tolleranza tale da indurre i componenti della maggioranza a consentire di continuare a
sostenere liberamente i propri punti di vista. Nei
sistemi politici a carattere democratico è interesse di
tutti che qualunque opinione od orientamento ideologico possano venir liberamente espressi, affinché
dal confronto di essi possa emergere la soluzione
migliore. Donde la conseguenza che il ricorso al principio maggioritario non va inteso come tendente
all’individuazione dell’unica soluzione conforme a
verità, bensì come un espediente pratico per decidere sul da farsi [...]. E donde il riconoscimento della
massima possibile tutela alla libertà d’opinione, nel
suo duplice aspetto di libertà di pensiero e di libertà
di espressione.
A. Pizzorusso, Minoranze e maggioranze,
Einaudi, Torino 1993
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
Democrazia
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
massimo, in competizione tra loro per la vittoria. Effetti analoghi si ottengono con un sistema
proporzionale corretto, cioè un sistema in cui i voti vengano ripartiti proporzionalmente ma
con un premio (in termini di seggi) alla coalizione vincente o con uno sbarramento per i partiti minori, cioè una soglia minima di consensi al di sotto della quale un partito non ha diritto
di sedere in parlamento.
In entrambi i casi, si pone comunque il problema della compattezza delle maggioranze elette,
le quali – se unificate solo dalla necessità di competere con l’opposto schieramento e non
anche dall’adesione a un programma politico e a ideali comuni – potrebbero in seguito rivelarsi molto fragili e incapaci di governare in modo coeso.
Questa è la ragione della preferenza accordata da Pasquino ai partiti rispetto alle coalizioni: i partiti – e soprattutto quelli con un forte radicamento di massa – sono per Pasquino le organizzazioni maggiormente attrezzate per assumere e mantenere precisi impegni con gli elettori.
Inoltre, essi sembrano essere gli unici soggetti in grado di lavorare alla ricostruzione di quel rapporto di fiducia fra i cittadini e la politica che in tempi recenti è venuto sempre più incrinandosi e
che invece, per molti anni, ha rappresentato un elemento forte e vitale della nostra democrazia.
Alcune parti politiche hanno sostenuto che il modo più efficace per riavvicinare governati e
governanti sia quello di procedere all’investitura elettorale dell’esecutivo: la scelta popolare di
chi governerà concretamente il paese – sia diretta sia attraverso un’indicazione degli elettori
al presidente della repubblica e al parlamento –, mira infatti a rafforzare il governo, garantendone la stabilità.
Bobbio
Democrazia e libertà
Il seguente testo è dedicato all’analisi tra le idee fondamentali del pensiero
democratico (come, in primo luogo, il suffragio universale) e la tradizione del
liberalismo.
[…] Identificata la democrazia propriamente detta,
senz’altra specificazione, con la democtazia diretta, che
era poi l’ideale rousseauiano, si venne affermando
attraverso gli scrittori liberali, da Constant a
Tocqueville, a John Stuart Mill, l’idea che la sola forma
di democrazia compatibile con lo stato liberale, cioè
con lo stato che riconosce e garantisce alcuni diritti fondamentali, quali i diritti di libertà di pensiero, di religione, di stampa, di riunione, ecc., fosse la democrazia
rappresentativa o parlamentare, ove il compito di fare le
leggi spetta non a tutto il popolo riunito in assemblea
ma a un corpo ristretto di rappresentanti eletti da quei
cittadini a cui vengano riconosciuti i diritti politici. In
questa concezione, che si può chiamare liberale, della
democrazia, la partecipazione al potere politico, che è
sempre stata considerata l’elemento caratterizzante del
regime democratico, viene risolta anch’essa in una delle
tante libertà individuali che il cittadino ha rivendicato e
conquistate contro lo stato assoluto, e ridefinita come
la manifestazione di quella particolare libertà che,
andando oltre il diritto di esprimere la propria opinione, di riunirsi o di associarsi per influire sulla politica
del Paese, comprende anche il diritto di eleggere rappresentanti al parlamento e di essere eletti.
Anche se questa libertà è concettualmente diversa dalle
libertà civili, in quanto queste sono mere facoltà di fare
M78
o non fare mentre quella implica l’attribuzione di una
capacità giuridica specifica, onde le prime sono dette
anche libertà negative mentre la seconda è detta libertà
positiva, il fatto stesso che il diritto di partecipare se
pure indirettamente alla formazione del governo venga
compreso nella classe delle libertà, mostra che nella
concezione liberale della democrazia l’accento viene
posto più che sul mero fatto della partecipazione, come
avviene nella concezione pura della democrazia (che
viene anche chiamata “partecipazionistica”), sull’esigenza che questa partecipazione sia libera, cioè sia una
espressione e un risultato di tutte le altre libertà: Da
questo punto di vista, se è vero che non può chiamarsi
propriamente liberale uno stato che non riconosca il
principio democratico della sovranità popolare, sia
pure limitatamente al diritto di una parte, anche ristretta, di cittadini, a dar vita a un corpo rappresentativo, è
ancor più vero che secondo la concezione liberale dello
stato non vi può essere democrazia se non là dove
siano riconosciuti alcuni diritti fondamentali di libertà
che rendano possibile una partecipazione politica guidata da un’autonoma determinazione della volontà di
ciascun individuo.
Democrazia politica, sociale, economica
Fino a questo punto ci siamo soffermati soprattutto sulle procedure democratiche o, in altri termini, sulle condizioni
e i metodi che permettono a un regime democratico di funzionare.
Vi è ora da sviluppare un ultimo aspetto, legato a quelli che potremmo definire i contenuti o gli scopi della democrazia. Con la realizzazione della democrazia politica, con la progressiva affermazione del suffragio universale, soprattutto nel XX secolo, entrano in scena anche le classi lavoratrici e i ceti meno abbienti, che prima erano tenuti ai margini
del processo politico. Per questi settori della società, alle loro organizzazioni politiche, la democrazia è stata e continua a essere lo strumento e l’occasione per riformare – attraverso il controllo popolare delle istituzioni statali – la
società e l’economia, in modo da renderle più corrispondenti alle proprie aspettative di riscatto sociale e di miglioramento delle condizioni di vita.
Perché la democrazia possa davvero realizzarsi – affermano sia i democratici, sia i socialisti, sia i movimenti d’ispirazione cattolica – è necessario che le decisioni democratiche investano non solo la sfera politica e istituzionale ma
anche i rapporti sociali e l’economia. Si tratta di un’idea molto controversa, che da ormai due secoli scalda gli animi
degli intellettuali e dei militanti politici: la teoria liberale classica, infatti, sostiene proprio il contrario e cioè che le
istituzioni pubbliche non debbano mai intervenire nella sfera economica, la quale, per funzionare correttamente (e
quindi soddisfare il maggior numero di bisogni individuali e sociali), dev’essere lasciata libera di autoregolarsi in
base alle leggi del mercato, senza essere sottoposta ad alcun vincolo politico. A questa tesi, il pensiero democratico, quello socialista e il cattolicesimo sociale – ciascuno muovendo da presupposti diversi e spesso contrastanti –
controbattono che una società veramente democratica può ritenersi tale solo se è in grado di ridurre (o tendenzialmente di eliminare) le disuguaglianze economiche e sociali caratteristiche della società contemporanea. Se, per
esempio, è capace di offrire a tutti i suoi membri un lavoro e un reddito decorosi, una formazione scolastica che
valorizzi le abilità di ciascuno, a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia, un’assistenza medica adeguata anche a chi non guadagna abbastanza per procurarsela, servizi per gli anziani e per i settori più deboli della
società. Ciò è del resto quanto prevede la Costituzione italiana del 1948. Essa appare particolarmente sensibile a
queste esigenze, delle quali erano portatrici, nell’Italia del secondo dopoguerra, le forze politiche antifasciste, che
collaborarono nell’Assemblea costituente alla sua stesura. La Costituzione è dunque molto attenta ad associare la
garanzia delle libertà civili e dei diritti politici con l’indicazione di precisi obiettivi di ordine sociale ed economico,
come si evince – oltre che dai Principi fondamentali – anche dalla lettura dei titoli relativi ai “Rapporti etico-sociali” e ai “Rapporti economici”.
Esercizi
✔ Distingui tra democrazia diretta e rappresentativa.
✔ Richiama situazioni storiche nelle quali si sperimentarono forme di democrazia diretta.
✔ Sintetizza le caratteristiche delle democrazie rappresentative occidentali moderne.
✔ Distingui tra democrazie parlamentari e presidenziali.
✔ Quella statunitense è una democrazia diretta o rappresentativa? Parlamentare o presidenziale?
✔ Quali caratteristiche ha il referendum nell’ordinamento costituzionale italiano?
✔ Distingui principio di maggioranza e principio pluralistico.
✔ Quali sistemi elettorali garantiscono secondo Pasquino stabilità di governo?
✔ Quali obiettivi democratici si propone la Costituzione italiana?
da N. Bobbio, “Democrazia”, in Aa.Vv, Dizionario di Politica,
Utet, Torino 1990
M79
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
Materiali
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
Lunghe durate
LUNGHE
DURATE
233
Globalizzazione
La ferita dei Balcani
LUNGHE DURATE
TEMI
STORIOGRAFICI
Ascoltando la televisione o leggendo i giornali vi sarà spesso
capitato di incontrare il termine
“balcanizzazione”. I giornalisti, i
politici e gli studiosi lo usano per
indicare un processo di frazionamento territoriale;
IDEE
LUNGHE
DURATE
Sopre, madre
e figlio attraversano il ponte
provvisorio di Mostar. a
Sopre, madre
e figlio attraversano il ponte
provvisorio di Mostar. a
Sopre, madre
e figlio attraversano il ponte
provvisorio di Mostar. a
G
lobalizzazione e storia dell’espansione economica
occidentale
Il termine globalizzazione, nel suo significato economico, è usato per designare la tendenza all’unificazione su larga scala dell’economia contemporanea, affermatasi nei decenni finali del XX
secolo sotto la spinta espansiva dell’economia occidentale. I confini dell’economia occidentale –
il cui fulcro è rappresentato da quella statunitense – tendono ormai a coincidere con quelli del
mondo: di qui appunto “globalizzazione”.
Se, dunque, in senso proprio si parla di globalizzazione in relazione ai movimenti economici degli
ultimi vent’anni, è però tutt’altro che recente la tendenza dell’economia occidentale all’espansione, all’inclusione di regioni via via più estese del globo, all’integrazione reciproca tra le diverse
aree coinvolte.
Tale tendenza, anzi, dura da secoli, durante i quali ha conosciuto solo brevi periodi di rallentamento: senza considerare l’espansione medievale, infatti, già nel corso dell’età moderna i commerci europei si ampliarono in conseguenza delle scoperte geografiche, fino a raggiungere alcune tra le regioni più remote del pianeta. L’espansione mondiale dell’economia europea, in altre
parole, è – per usare un’espressione coniata da Fernand Braudel – un processo storico di lunga
durata, del quale la globalizzazione propriamente detta rappresenta solo l’ultima fase in ordine di
tempo.
Considerare l’espansione dell’economia europea nell’arco di cinque secoli, dal XVI al XX, ci permette di osservare caratteri costanti e aspetti variabili, che specificano ciascuna fase rispetto alle
altre. Per cogliere alcune della principali costanti, può essere utile avvalerci della nozione di “economia-mondo”. Con essa, gli storici intendono uno spazio economico unitario, proprio di una
certa area geografica, costituito da zone economiche tra loro collegate, ciascuna diversamente
specializzata.
234
Tra queste aree è possibile distinguere un centro – le zone economicamente più forti e dinamiche,
che rappresentano il cuore del sistema – e zone periferiche, più arretrate ed economicamente
subordinate al centro.
All’inizio del periodo da noi considerato, oltre all’economia-mondo europea ne esistevano altre,
di peso e dimensioni più o meno rilevanti, nelle diverse aree del mondo (per esempio, in India e
in Cina). Dal XVI secolo – e questa è una prima costante significativa – assistiamo a un allargamento dei confini dello spazio economico europeo, ampliamento che comporta la riduzione dello
spazio economico di altre economie-mondo, che vengono progressivamente assorbite e integrate in quella europea.
Un'altra costante è lo spostamento del centro dell’economia mondo europea: in questi secoli,
mentre l’economia europea si espandeva e tendeva ad assimilare altre economie-mondo prima
autonome, mutavano geograficamente le zone di essa più dinamiche e cambiavano i suoi centri
nevralgici (dall’area mediterranea si spostavano verso quella atlantica).
Ciò significa che in ogni fase storica variano non solo le dimensioni dell’economia-mondo europea, ma anche i rapporti economici tra le parti e la loro reciproca integrazione: zone prima centrali, si trovano sospinte alla periferia; aree marginali assumono viceversa crescente importanza
economica, fino a collocarsi, per una certa fase, al centro del sistema economico europeo.
L’esempio dell’Inghilterra è illuminante: questo paese, scarsamente popolato e marginale all’inizio del Cinquecento, alla metà del Settecento si trova già al centro del l’economia mondo europea, posizione che manterrà fino alla prima guerra mondiale, quando sarà soppiantato dalla
potenza economica e politica degli Stati Uniti. ✔
Tra le variabili, oltre alla crescente estensione dell’economia mondo-europea e al differente
disporsi al suo interno delle diverse aree economiche tra centro e periferia, devono esserne ricordate anche altre, come per esempio il mutare del peso relativo dei differenti settori economici: la
penetrazione europea fu guidata in una prima fase da interessi prevalentemente commerciali ma
in seguito, come vedremo, la dimensione finanziaria è venuta assumendo un peso sempre maggiore. Una ulteriore variabile – tutt’altro che trascurabile – è rappresentata dal peso politico e militare degli stati e dalle politiche economiche (mercantilismo, liberismo e liberoscambismo, protezionismo) messe in atto dai governi delle principali potenze; tali politiche si sono storicamente
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
Immanuel Wallerstein
Perchè nel Settecento si affermò la centralità inglese
nell’economia del mondo europea?
In questi due brevi testi (a e b), lo storico dell’economia Immanuel Wallerstein
richiama alcune delle condizioni che portarono nel XVIII secolo al centro dell’economia mondo europea l’Inghilterra, e non la Francia che costituiva allora il
principale competitore degli inglesi. Ciò, va ricordato, in un contesto segnato dal
mercantilismo e dunque da un forte peso dello stato nell’economia.
a) Nel commercio verso occidente nella prima metà del
XVIII secolo, veniva al primo posto lo zucchero ed al
secondo gli schiavi che rendevano possibile il primo.
L’Inghilterra dominava chiaramente il commercio mondiale dello zucchero nel 1700, ma nel 1750 la supremazia era passate alla Francia. […] Questo significa che la
Francia stava superando l’Inghilterra? No davvero, perché […] mentre il commercio estero francese si “americanizzò” nel XVIII secolo, il commercio estero inglese si
“universalizzò” Ciò che l’Inghilterra perdette con il commerciò dello zucchero, lo riguadagnò altrove e in primo
luogo nel commercio degli schiavi. […] .
diminuì quella della Francia, perché lo stato francese
non era forte come quello inglese. Il nostro problema è
in che modo lo stato inglese diventò tanto più forte di
quello francese. […]Uno stato è forte nella misura in cui
quelli che governano possono imporre la propria
volontà a quella di altri all’esterno o all’interno dello
stato. Usando tale criterio, riteniamo che lo stato inglese avesse chiramente superato quello francese all’inizio
del XVIII secolo [ossia dopo la Glorious revolution e il
consolidarsi del compromesso con cui essa si era concluso]. Il vero stato forte raramente ha bisogno di
mostrare il pugno di ferro.
b) Col passare del XVIII secolo, la centralità finanziaria
dell’Inghilterra nell’economia-mondo aumentò. Mentre
Immanuel Kant, Per la pace perpetua.
Un progetto filosofico (1795), Trad. di N.Merker, Roma,
Editori Riuniti, 1985, pp.16-19
235
La ferita dei Balcani
mostrate in grado – di volta in volta con effetti diversi – di accelerare o di rallentare i processi di
integrazione reciproca delle diverse aree dell’economia mondiale e, dunque, di determinare il suo
livello di internazionalizzazione. Consideriamo ora brevemente, alla luce di quanto detto, le principali tappe dell’espansione dell’economia mondo occidentale.
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
L
’economia-mondo europea diventa economia mondiale
(XVI-XVIII secolo)
Alla fine del XV secolo, l’economia-mondo europea aveva al suo centro le zone dove lo sviluppo
medievale era stato più intenso e tale si era mantenuto dopo la crisi del Trecento (Italia centro
settentrionale, oltre alle Fiandre); essa si estendeva a parti del continente europeo e ad alcune
delle regioni limitrofe.
Nel corso dei successivi duecentocinquant’anni, lo spazio economico europeo giunse a comprendere i mercati più accessibili di tutti i continenti, da quelli del nuovo mondo americano agli
empori asiatici. Il centro dell’economia-mondo migrò nello stesso periodo dall’Italia dei banchieri, cioè dal Mediterraneo, verso l’Olanda (XVII secolo), per stabilirsi poi in Inghilterra. Uscita
rafforzata dai processi rivoluzionari che nel corso del XVII secolo ne investirono società, economia
e istituzioni, proprio l’Inghilterra riuscì nel Settecento ad affermarsi come la potenza egemone sui
mari di tutto il mondo, difendendo con la forza della flotta la penetrazione delle proprie compagnie monopolistiche: tra Seicento e Settecento le guerre valsero a piegare i mercanti olandesi; alla
metà del Settecento, le vittorie militari in nord America e in India ridimensionarono le ambizioni
della Francia sul controllo delle rotte, degli scali e dei più importanti territori coloniali. La debolezza delle potenze iberiche e le loro difficoltà a mantenere gli imperi coloniali acquistati in
America aprirono infine agli inglesi enormi spazi commerciali.
All’inizio dell’Ottocento, l’economia-mondo europea aveva ormai raggiunto dimensioni mondiali, anche se ciò non significa che tutte le aree economiche del mondo vi fossero stabilmente integrate: basti pensare a stati come il Giappone e la Cina, che ancora per lunga parte dell’Ottocento
continuarono a respingere la penetrazione dei prodotti europei e americani e che solo con la forza
sarebbero stati indotti, dopo la metà del XIX secolo, ad aprire i propri mercati all’interscambio con
l’Occidente.
L
’integrazione dell’economia mondiale: dalla rivoluzione
industriale alla prima guerra mondiale (XIX secolo)
Il diffondersi dell’industrializzazione contribuì all’intensificarsi dei rapporti commerciali tra centro
e periferia del sistema economico costruito nei secoli precedenti, e all’integrazione reciproca delle
diverse aree dell’economia mondo europea: sia perché la produzione industriale assorbiva a ritmi
crescenti materie prime provenienti in Europa dalle periferie coloniali; sia perché si trattava di
rifornire di prodotti industriali la popolazione (crescente) delle colonie e delle aree periferiche
europee non ancora industrializzate. L’Inghilterra, dove si era sviluppata la rivoluzione industriale, continuò ancora per tutto il XIX secolo a rappresentare il nucleo dell’economia mondiale,
intorno al quale si disponevano a cerchi concentrici le altre aree europee e il nord America, investite con tempi diversi dai processi di modernizzazione della struttura produttiva.
Dopo la sconfitta di Napoleone, e in particolare durante il ventennio 1850-1870, l’integrazione dei
mercati venne accentuandosi a causa dell’impetuoso sviluppo dei mezzi di trasporto (dalle navi
di grandi dimensioni alle ferrovie, che favorivano lo spostamento su larga scala delle merci); essa
fu assecondata anche dalle politiche liberistiche dei governi europei dell’epoca e da una spinta al
libero scambio delle merci, non ostacolata neppure dalle guerre.
Dopo la “grande depressione” (1873-1896), l’espansione capitalistica fu accelerata – nell’età dell’imperialismo – dalla corsa alla conquista degli spazi geografici, soprattutto africani, che ancora
si sottraevano al dominio europeo, e dalla spinta al controllo territoriale, e non più solo economico, delle colonie da parte delle potenze europee e degli Stati Uniti. Il peso economico e politico di questi ultimi si accrebbe in questa fase storica, come si evince dal seguente dato: il reddito pro capite di un cittadino statunitense – che era pari nel 1870 all’80% di quello di un inglese –
236
nel 1913 era salito al 120%.
Al tradizionale intescambio tra madrepatria e colonie (prodotti finiti verso le colonie, materie
prime verso la madrepatria), si aggiunse in questa fase un ulteriore flusso: quello dei capitali che
lasciavano ciascuna potenza diretti verso i domini coloniali, alla ricerca di migliori condizioni d’investimento. Nemmeno la competizione in ambito coloniale, le tensioni tra le grandi potenze, le
politiche protezionistiche con le quali ogni stato difendeva il proprio mercato dai prodotti esteri,
le resistenze nazionalistiche furono sufficienti – almeno fino alla prima guerra mondiale – ad arrestare la tendenza alla crescita dell’interscambio commerciale tra i diversi paesi, che raggiunse il
suo massimo proprio nel 1913, proprio alla vigilia del conflitto.✔
C
TEMI
STORIOGRAFICI
risi e ripresa del processo di unificazione del mercato
mondiale nel Novecento
IDEE
La Grande guerra rappresentò un momento di forte caduta dell’interscambio, che però riprese
negli anni venti, in pieno boom dell’economia fordista, fino a recuperare nel 1929 il livello raggiunti negli anni dieci.
Con la grande crisi iniziata nel 1929 e protrattasi negli anni trenta, tuttavia, si registrò un nuovo e
ancor più brusco arresto dell’interscambio mondiale, causato dalle politiche protezionistiche
messe in atto da quasi tutti i governi per difendere le proprie economie, dall’aggravamento dei
rapporti internazionali in conseguenza dell’espansionismo hitleriano e, infine, dalla seconda guerra mondiale.
La conseguenza fu che negli anni trenta e quaranta il mercato mondiale andò frammentandosi in
una molteplicità di rapporti bilaterali, condizionati dagli interessi politici e strategici delle diverse potenze.
Nella seconda metà del Novecento, dalla fine della guerra in poi, la tendenza all’unificazione del
mercato mondiale conobbe una intensa ripresa sulla base dagli accordi di Bretton Woods del
LUNGHE
DURATE
Karl Marx, Friedrich Engels –
La ricerca di mercati spinge la borghesia per tutto il globo
In questa famosa pagina del Manifesto, Marx ed Engels descrivono con ammirazione le trasformazioni del mercato mondiale prodotte dalla rivoluzione industriale borghese, della quale viene evidenziata - già nel secolo scorso - la spinta “globalizzante”, che investe non solo la vita materiale, ma anche quella culturale.
Il bisogno di sbocchi sempre più estesi per i suoi prodotti spinge la borghesia per tutto il globo terrestre.
Dappertutto essa deve ficcarsi, dappertutto stabilirsi,
dappertutto stringere relazioni.
Sfruttando il mercato mondiale la borghesia ha reso
cosmopolita la produzione e il consumo di tutti i paesi.
Con gran dispiacere dei reazionari, ha tolto all’industria
la base nazionale. Le antichissime industrie nazionali
sono state e vengono, di giorno in giorno, annichilite.
Esse vengono soppiantate da nuove industrie, la cui
introduzione è questione di vita o di morte per tutte le
nazioni civili – industrie che non lavorano più materie
prime indigene, bensì materie prime provenienti dalle
regioni più remote, e i cui prodotti non si consumano
soltanto nel paese, ma in tutte le parti del mondo. Al
posto dei vecchi bisogni, a soddisfare i quali bastavano
i prodotti nazionali, subentrano bisogni nuovi, che per
essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei
climi più lontani. In luogo dell’antico isolamento locale
e nazionale, per cui ogni paese bastava a se stesso,
subentra un traffico universale, una universale dipendenza delle nazioni l’una dall’altra. E come nella produzione materiale, così anche nella spirituale. I prodotti
spirituali delle singole nazioni diventano patrimonio
comune. La unilateralità e la ristrettezza nazionale
diventano sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali esce una letteratura mondiale.
Col rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate,
la borghesia trascina nella civiltà anche le nazioni più
barbare. I tenui prezzi delle sue merci sono l’artiglieria
pesante con cui essa abbatte tutte le muraglie cinesi, e
con cui costringe a capitolare il più testardo odio dei
barbari per lo straniero. Essa costringe tutte le nazioni
ad adottare le forme della produzione borghese se non
vogliono perire; le costringe a introdurre nei loro paesi
la cosiddetta civiltà, cioè a farsi borghesi. In una parola,
essa si crea un mondo a sua immagine e somiglianza.
da Manifesto del partito comunista, Editori riuniti,
Roma 1960
237
La ferita dei Balcani
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
1944, che avevano fatto del dollaro americano la valuta di riferimento per saldare attivi e passivi
negli scambi multilaterali tra le diverse economie.
Neanche l’impetuoso movimento di decolonizzazione del secondo dopoguerra poté rallentare la
tendenza all’integrazione dei mercati: mentre, infatti, molti paesi conquistavano l’indipendenza
politica, i rapporti di dipendenza economica dalla potenze ex-coloniali spesso rimanevano sostanzialmente immutati. Così, nei trent’anni successivi agli accordi di Bretton Woods (1945-75), si
ebbe un periodo caratterizzato da tassi di crescita molto sostenuti (5% annuo), al quale diedero
un contributo determinante l’internazionalizzazione dell’economia e la crescita degli scambi. A
questi due fattori, naturalmente, occorre aggiungere altri fattori: l’assenza di conflitti in Europa, la
diffusione del modello fordista a tutte le economie industriali e la crescita della domanda di beni
di consumo durevole nella società dei consumi di massa.
L
a globalizzazione: libera circolazione dei capitali
e decentramento delle produzioni
LUNGHE
DURATE
La globalizzazione, dunque, ha una storia antica. Essa però si afferma completamente alla fine del
XX secolo. Mai fino agli anni ottanta e novanta – scrive lo storico Valerio Castronovo – «neppure
nelle fasi di grande espansione economica, come quelle intercorse durante il primo quindicennio
del secolo e nel secondo dopoguerra, s’era delineata una così densa ed estesa trama di interrelazioni fra comunità e regioni ancorché lontane tra loro o molto differenti per culture e istituzioni».
Un ruolo determinante ebbe l’attenuazione dei vincoli nazionali allo spostamento dei capitali. Ciò
introdusse un elemento nuovo e specifico della globalizzazione contemporanea, perché le fasi
precedenti di espansione del capitalismo si erano avvantaggiate dalla libera circolazione delle
merci, ma non di quella dei capitali, sui cui veniva invece esercitato un certo controllo da parte
degli stati nazionali.
La finanza è divenuta così il settore di punta dell’economia globalizzata. Il venir meno dei vincoli
legislativi, e la possibilità tecnica di trasmettere ordini di acquisto o di vendita in tempo reale,
hanno consentito una straordinaria velocità di movimento dei capitali investiti in azioni.
Le imprese multinazionali ne hanno derivato la spinta a decentrare produzioni e servizi, dai paesi
sviluppati verso regioni del mondo caratterizzate da costi della manodopera e da politiche fiscali
più leggere, studiate proprio per favorire gli investimenti stranieri.
La tendenza al decentramento è favorita anche dall’esigenza di trasferire tecnologie e produzioni
mature nei paesi in via di sviluppo per avvicinarli ai mercati di sbocco. Ciò vale almeno nel caso
di alcuni prodotti, di cui i mercati tradizionali sono in via di saturazione, come per esempio le
automobili, e per cui invece è crescente la domanda nei paesi emergenti.
I
l ruolo dei media e la globalizzazione dei consumi
e degli stili di vita
Se il termine “globalizzazione” ha una valenza prevalentemente economica, dalle trasformazioni
economiche dipendono altri aspetti che richiameremo qui brevemente.
Vi è innanzitutto la tendenza alla omogeneizzazione dei consumi, delle abitudini di vita e della
cultura. Da questo punto di vista, un ruolo fondamentale hanno svolto e svolgono i mezzi di
comunicazione di massa, che si avvalgono di tecnologie sempre più raffinate ed efficaci, dalle trasmissioni televisive mediante satellite alla diffusione sempre più capillare degli accessi alla rete
Internet. L’impatto di questi media ha avuto come effetto la diffusione dell’inglese come lingua di
comunicazione internazionale e dello stile di vita statunitense come modello universale di riferimento. La tendenza all’integrazione culturale tra le più distanti parti del mondo non è tuttavia un
processo “a senso unico”. Infatti, ci sono elementi della civiltà globalizzata che hanno una matrice non statunitense. Si pensi alla diffusione della pizza, o dei ristoranti cinesi; o allo status universalmente riconosciuto ai telefoni cellulari scandinavi, alle automobili tedesche, ai vini francesi (ormai anche italiani), alla moda parigina e milanese.
238
Ricchezza e povertà, globale e locale
Se nei paragrafi precedenti abbiamo descritto la globalizzazione nei suoi termini fondamentali,
ora spostiamo l’attenzione su alcuni problemi che ne derivano.
Un problema chiave è rappresentato dagli effetti della globalizzazione sulle condizioni di vita in
differenti aree del mondo: la globalizzazione, infatti, avvantaggia soltanto i paesi ricchi. Da questo
punto di vista, i dati disponibili non sembrano confortanti, se si pensa che tra il 1989 e il 1998 la
quota del reddito mondiale lordo a disposizione del quinto più povero della popolazione del pianeta è sceso dal 2,3 all’1,4% (anche se alla perdita di reddito in termini relativi, corrisponderebbe
una certa crescita in termini assoluti).
Questi dati sono alla base delle contestazioni contro la globalizzazione e contro la liberalizzazione dei mercati che la favorisce. Vi è chi propone per designare i fenomeni che stiamo studiando,
il termine “triadizzazione” in alternativa a “globalizzazione”. Tale denominazione mette polemicamente in rilievo come la globalizzazione avvantaggi in realtà soltanto le tre aree forti dell’economia mondiale (Stati Uniti e, in misura minore, Europa e Giappone, cui potrebbe aggiungersi l’est
asiatico): in effetti, soprattutto tra queste aree si concentra per ora l’aumento degli scambi e il
dinamismo economico vantaggioso che ne deriva, mentre le aree deboli del mantengono una
posizione marginale e sembrano condannate a un impoverimento, almeno in termini relativi (si
confermerebbe così l’efficacia della nozione di economia-mondo e della sua articolazione in aree
diversamente specializzate: centrali, semicentrali e periferiche).
Di fronte a questi dati, alcuni sostengono il ritorno a forme di protezionismo e di tutela delle economie dei paesi poveri, penalizzate dall’apertura al mercato internazionale, e chi invece sostiene
che tale rimedio aggraverebbe ulteriormente lo svantaggio delle economie povere.
Altri problemi sorgono dalla difficoltà di conciliare la tendenza all’unificazione di mercati e stili di
consumo con l’opposta spinta che porta le comunità locali a preservare le proprie tradizioni, le
proprie produzioni e consumi.
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
Come governare la globalizzazione?
Sul piano politico, infine, vi è il problema di come possano esser governati, a vantaggio di tutti,
Jurgen Habermas
Oltre lo stato nazionale, da La costellazione postnazionale,
In questo brano il filosofo tedesco J. Habermas riflette sulla divaricazione tra mercato globale e stati nazionali. Questi ultimi, a suo giudizio, sembrano sempre
meno capaci di imporre delle regole a un mercato ormai transnazionale, per
governare il quale servono soggetti politici nuovi, all’altezza della sfida di un’economia globalizzata.
Fino al diciassettesimo secolo vediamo formarsi in
Europa degli stati che – caratterizzati da un potere di
sovranità su un certo territorio – si rivelano superiori
(nella loro capacità di controllo) alle più antiche formazioni politiche come i vecchi imperi o le città-stato.
Come stato amministrativo funzionalmente specializzato, lo stato moderno si differenzia da un mercato giuridicamente istituzionalizzato. Nello stesso tempo però
esso diventava dipendente, in quanto stato fiscale, dall’economia capitalòistica. Nel corso dell’Ottocento si
apriva come stato nazionale alle forme democratiche di
legittimazione. In alcune regioni privilegiate, e nelle circostanze favorevoli del dopoguerra, questo stato nazionale (ormai diventato un modello sul piano mondiale)
poteva trasformarsi in stato sociale attraverso una regolazione delle economie nazionali (lasciate tuttavia libere nel funzionamento dei loro meccanismi interni di
autocontrollo). Oggi proprio questa riuscita combinazione viene minacciata nella misura in cui l’economia
globalizzata si sottrae all’intervento di questo stato
regolatore. Le funzioni finora assolte dallo stato sociale
potrebbero ancora essere realizzate nelle stesse proporzioni solo se potessero trasferirsi dallo stato nazionale
a unità politiche che si mettessero per così dire al passo
con una economia transnazionalizzata.
Da J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato
globale, nazioni, democrazia, Milano Feltrinelli 1990
239
La ferita dei Balcani
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
processi economici, che tendono ormai a sfuggire al controllo delle istituzioni politiche nazionali.
Il problema è anche, se non essenzialmente, democratico: molte scelte economiche ad altissimo
impatto sulla vita delle popolazioni avvengono infatti al di fuori degli ambiti democratici, cioè dei
parlamenti e dei governi nazionali. L’unica via per governare la globalizzazione sembra quella di
attribuire più ampi poteri a organismi democratici sopranazionali, in grado di far fronte alla
dimensione globale dei problemi.
Il rafforzamento dell’Onu e la costruzione dell’Europa trovano oggi in questa esigenza una delle
loro fondamentali giustificazioni. E così anche la democratizzazione di istituzioni economiche
come il Fondo monetario internazionale (FMI) e il WTO. Alle politiche seguite ultimamente da
questi istituti, volte alla liberalizzazione a oltranza di tutti i mercati, compresi quelli dei paesi più
fragili, vengono imputate le conseguenze più negative del processo di globalizzazione. ✔
TEMI
STORIOGRAFICI
IDEE
LUNGHE
DURATE
LUNGHE
DURATE
240
241