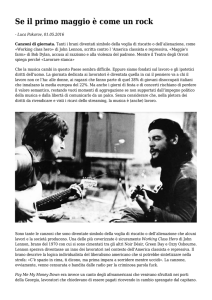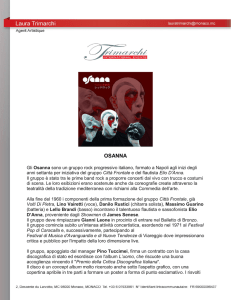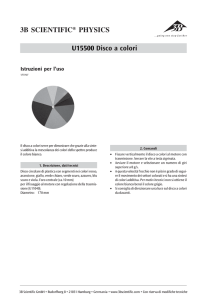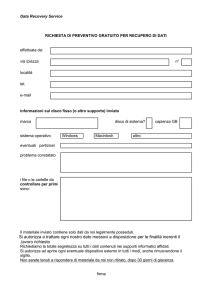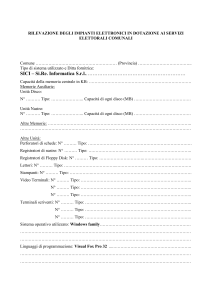digital magazine aprile 2011
N.78
Pearls Before Swine
Basile
Benvegnù
Parente
Cantautorato Rock
The Dodos
Discodeine
Frankie & the Heartstrings
Stearica
Mogwai
Erland and the Carnival
Tim Hecker
Cathedral Electronic Music
Kode9
& the Spaceape
black sun of dubstep
p. 4
Turn On
The Dodos, Discodeine, Frankie & the Heartstrings, Stearica
p. 12
Tune IN
Mogwai, Erland and the Carnival
sentireascoltare.com
p. 20
Drop Out
Cesare Basile/Paolo Benvegnù/Marco Parente
Kode9
Tim Hecker
p. 50
Recensioni
p. 114 Rearview Mirror
.
Pearls Before Swine
Rubriche
p. 106
p. 108
p. 110
p. 122
p. 123
Gimme some inches
Reboot
China Files
Campi Magnetici
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico e Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco
Staff: Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca
Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra
Copertina: Aucan (foto di Giordano Garosio)
Guida spirituale: Adriano Trauber (1966-2004)
Turn On
The Dodos
—Indie-rock in bianco
e nero—
Quarto album per la coppia di
coriacei folk singer. Sempre con quel
suono inconfondibile e in continua
ricerca. Qualche passo indietro per
guarare avanti. Ne abbiamo parlato
con Logan Kroeber
4
L
a storia dei Dodos, già Dodo Bird ai tempi in cui
Meric Long e Logan Kroeber si conobbero tramite
un amico comune divenendo duo da progetto solista
del primo, arriva in questi giorni al suo quarto capitolo. Il nuovo disco si chiama No Color e ci riconsegna il
gruppo in ottima forma, ancora padrone del proprio
caratteristico sound che al finger-picking del bravo
Meric incrocia un suono indie-rock figlio dei migliori
anni ‘90 e una sempre alta qualità del songwriting.
Ma il buon risultato di questi nove brani pare anche merito di una serie di riflessioni: come se il duo di
San Francisco, nel tirare avanti e sperimentare qualche
inedita soluzione, si fosse anche guardato indietro e
avesse recuperato solo quegli elementi che sembrava avessero funzionato meglio nei precedenti lavori.
Scelte oculate che crediamo verranno ripagate, se non
dalle classifiche di vendita, quantomeno da quelle di
fine anno; e che ci è sembrato doveroso approfondire,
in una veloce chiacchierata con un evidentemente impegnato Logan Kroeber.
Iniziamo dal titolo dell’album, qual è la filosofia
dietro a No Color?
Il titolo proviene da un discorso affrontato da me
e Meric durante il mixaggio del disco. Personalmente
vedo sempre determinati colori e immagini quando
suoniamo certe canzoni, e mentre lavoravamo a queste nuove le immagini che ho visto erano tutte grigie e
polverose. Questa percezione è cambiata un po’ adesso, un minimo di colore si sta intrufolando, ma in quel
momento sembrava un buon modo per incapsulare i
contenuti del disco. Nessuna filosofia, quindi, più che
altro il frutto di un mio punto di vista.
Dopo Time To Die avete voluto nuovamente
John Askew come produttore del nuovo album.
Come mai? Siete insoddisfatti di quel disco?
In realtà lo stile di scrittura di Time To Die è il medesimo di questo nuovo disco, anzi penso e spero che in
questo senso No Color aiuterà la gente a capire meglio
Time To Die. Per cui non vogliamo prendere affatto le
distanze da quel lavoro. Però è vero che c’erano certi
esperimenti in quel disco che non volevamo ripetere
nel nuovo lavoro, come ad esempio suonare su una
click track.
Dove avete incontrato Neko Case, e quando avete deciso di collaborare per questo nuovo disco?
Abbiamo conosciuto Neko Case andando in tour
con i New Pornographers l’estate scorsa. Ci siamo trovati molto bene sia con lei che con il resto del gruppo
e durante le ultime date lei ha cantato sul palco con
noi qualche volta. Così Meric ha pensato di chiederle
se voleva cantare anche nel nostro disco, e per nostra
fortuna è stata ben felice di accettare. E’ già il secondo
colpo fortunato di Meric con le voci femminili, dopo
Laura Gibson che cantava insieme a lui in alcune tracce di Visiter.
Un altro importante elemento nel disco è la chitarra elettrica. Avete dichiarato di essere stati influenzati dai riff di certi dischi degli anni 90, come quelli
degli Smashing Pumpkins.
Sì, lo confermo. In realtà credo che queste influenze
siano da sempre nella testa di Meric, perchè ha sempre
ascoltato gli Smashing Pumpkins e ha sempre amato il tipo di crescita che ha avuto quel gruppo; però
questa volta, a differenza del passato, abbiamo avuto
il tempo e la pazienza di ritagliare qualcosa in più da
quell’approccio e inserirlo nel nostro lavoro.
Il vostro stile è sempre riconoscibile, ma il suono è
più ‘epico’ stavolta. Siete in cerca di un profilo più
alto?
Ti dirò, abbiamo sempre mirato a un suono epico, fin
dal primo giorno, ma a giudicare dai nostri live attuali
direi che non siamo pronti per grossi palchi rock come
quelli degli Arcade Fire. In parole semplici: non abbiamo abbastanza pubblico! Detto questo non siamo assolutamente refrattari a ‘un profilo più alto’: se arriva,
sarà il benvenuto.
Ciò che ho apprezzato di più nel disco è il contrasto
apparente tra la musica, profondamente energica,
e i testi, profondamente malinconici, Sembra che
vogliate divertirvi e reagire ai momenti tristi che
descrivete, come una sorta di esorcismo.
Non scrivendo i testi in prima persona non posso risponderti con estrema certezza; posso dirti però che
concordo in pieno sulla tua sensazione. Mentre scriviamo la musica io per primo sono eccitato perchè le
energie e le melodie mi sembrano così esaltanti, poi
invece sento i testi e sono così tristi! Ma se ci pensi
in fondo la vita stessa è così, di tanto in tanto siamo
costretti a metterne a confronto i lati negativi e quelli
positivi.
Simone Madrau
5
Turn On
Discodeine
—Haunted 2011 Funk—
Assuefazioni alternative a Ed Banger
e Kitsuné. Dalla Dirty arriva la disco
di sintesi dei francesissimi Discodeine
sbancato le piste di mezzo mondo e che nel giro di
pochi mesi avrebbe fatto cambiare la testa di Thomas
Bangalter, consegnandogli su un piatto d’argento l’atmosfera pop per l’elaborazione di un mostro del calibro di Discovery.
Benjamin ha fatto inoltre parte del duo France Copland con Krikor Kouchian. La collaborazione con il
musicista elettronico alt-touch inizia nel 2002 e vede
l’elaborazione di uno strano ghettotech influenzato
dal suono di Detroit (da parte di Pentile) e dalle sperimentazioni del cervellotico istituto IRCAM (la patria
accademica dei musicisti elettronici francesi, invocata
dal pazzoide Krikor). I due danno alle stampe due EP
oggi introvabili: Pute Et Mac EP (con una grande rivisitazione di Vangelis nell’electro progressiva a 8 bit di
Rutgerhauer Song) e The Great French Institution.
Per chiudere la veloce carrellata dei progetti anteDiscodeine, Pentile collabora tuttora con Suzanne Thoma al gruppo Octet, che ha stampato nel 2004 l’album
Cash And Carry Songs (sempre su Diamond Traxx) e
che nel 2005 ha pure remixato il singolo di Beck Girl.
I due (inizialmente accompagnati anche da Francois
Goujon) propongono un pop che ricorda le visioni dei
Broadcast tagliate con arrangiamenti orchestrali à la
Badalamenti, il tutto condito da una sensibilità affine
agli Everything But The Girl, soprattutto per la somiglianza della voce di Suzanne con quella di Tracey
Thorn. Attualmente il progetto è in stand by, ma da
voci di corridoio dovrebbe essere pronto a breve un
secondo album.
P ilooski
P
entile e Pilooski sono due personaggi del giro french-touch con una carriera di tutto rispetto, codificata per i
circoli più fumosi e improbabili della capitale francese. Il loro percorso artistico li ha già portati a bazzicare le
stanze di personaggi e manager culto del genere dancey gallico. Oggi approdano al disco sulla lunga distanza, già
anticipato da vari singoli, che hanno fatto sentire aria di nuovo quando si sono presentati in studio personaggi del
calibro di Jarvis Cocker, che presta la voce in Synchronize (stampato l’anno scorso su DFA), e Mathias Aguayo in
Singular (su Dark & Lovely, l’etichetta del collettivo Dirty, cui fanno parte gli stessi P & P, che li ha lanciati nel 2008
con il singolo dance Joystick).
Chi sono in realtà le nuove leve dell’alt-dance french? Andando a cercare in qua e in là, si scopre di come l’eterogeneità dell’esordio non sia casuale. Il risultato è una foto onirica di mondi che collidono e che danno origine
ad un ibrido che anche dopo numerosi ascolti non stanca, anzi, cresce e con orgoglio tipicamente gallico si fa
sinuoso, sexy e personalissimo. Due che hanno trovato la loro voce.
Pentile
Pentile - al secolo Benjamin Morando - all’inizio della sua carriera, cioè nel lontano 2001, ha stampato sulla patinatissima etichetta di Benjamin Diamond un singolo di house sciccosa (Single Bell) che i fan di quei suoni sicuramente ricorderanno: in quegli anni la Diamond Traxx odorava infatti del successo con cui gli Stardust avevano
6
Anche Pilooski aka Cédric Marszewski conosce bene
gli studi della Diamond Traxx. In passato ha utilizzato
i moniker di Eddyee’s Time e C. Denner, due strade alternative che gli hanno permesso di esplorare territori
hip hop, funk (vedi il singolo su Diamond Traxx Can’t
There Be Love del 2006), jazz o new wave, sempre con
il piglio ritmico in testa, dato che suona beats dall’età
di 14 anni.
La sua è la mano del remixatore e dell’archeologo:
l’uomo è famoso infatti per numerosi re-edit di vecchi
successi anni sessanta, tagliati e cuciti per l’orecchio
contemporano (tra gli altri sono passati sotto le sue
mani di forbice i Can, Morricone e gli Yello) e pubblicati in limitatissimi singoli su Dirty nella serie degli
Edits. Ultimamente ha suonato anche al festival Nuit
Sonores di Lyone, connettendosi guardacaso alla sensibilità di un’altra meteora dance off-Paris: Sébastien
Devaud, in arte Agoria.
D iscodeine
Sia Pilooski che Pertile fanno parte - con Clovis Goux
e Guillaume Sorge - del progetto collettivo/label Dirty
Sound System. Goux e Sorge sono due dei più famosi selezionatori musicali della capitale francese. Dalla
fine degli anni Novanta la coppia di talent scout cerca
nuove voci e idee in giro per i club più in di Parigi: in
breve tempo sono diventati un punto di riferimento
grazie anche al loro visitatissimo blog Alain Finkiel
Krautrock, pozzo senza fondo per nuove direzioni del
suono da club all’ombra della torre Eiffel, raccolte saltuariamente nelle compilation di culto Dirty Diamonds (ovviamente oggi tutte in sold out).
In un’intervista velocissima - quasi uno scambio in
chat - chiediamo ai due se si sentono di appartenere al french touch: a parte essere francesi non sentiamo nessuna connessione con quel suono. Qualcosa
c’è comunque, dato che i due vivono a Parigi. Tra gli
artisti più vicini alla loro estetica riconoscono esserci
Joakim, Tigersushi e Versatile, mentre non sembrano
essere molto legati alla Ed Banger di Busy P, confessando pure che la scena di Parigi rimane arroccata su
posizioni di chiusura incomprensibili, tanto che nemmeno al suono Daft Punk sembrano dedicare molto
spazio. Ci dicono infatti che non tutti i lavori dei due
robot li aggradano... spocchia? Ma no, i due alla fine
percorrono un sentiero dreamy, che più che connettersi a Guy-Man e Thomas sembra guardare alle strade
della psichedelia.
Se gli chiediamo di definire il loro suono ci rispondono: Haunted 2011 Funk. Se gli chiediamo quali sono
i loro produttori preferiti rispondono: Anthony Shakir,
DJ Koze, Errorsmith, Zongamin, Caribou e Maurice
Fulton. Se gli chiediamo quali sono i loro progetti futuri ci rivelano che stanno già iniziando a registrare
un secondo album e che stanno ultimando il live. Due
che hanno esordito su Dark & Lovely con un 12” in stile
100% disco (le tracce erano Joystick e Homo-compatible), oggi sono la punta di diamante della Dirty e possono vantare remix delle loro tracce di Simian Mobile
Disco e Ivan Smagghe. Dirty è la prima concorrente
di Ed Banger e Kitsuné. Si fa presto a diventare dipendenti dalla codeina... basta aggiungerci la disco.
Marco Braggion
7
Turn On
Frankie
& The
Heartstrings
— No Redemption—
Rockabilly filtrato giovane Scozia,
Postcard sound e tanto amore per
Morrisey. Frankie Francis ci racconta
i suoi Heartstrings e la sa più lunga di
quel che non sembrerebbe...
D
ietro l’angolo c’è la tentazione di scivolare in uno dei grandi luoghi comuni della musica britannica di tutto
il Novecento, una di quelle dicotomia che hanno fatto la storia stessa del pop della terra d’Albione: il Nord
dell’Inghilterra e la Scozia versus Londra, la swinging, la fashionable, la città nella quale le mode stesse, le tendenze (e si sa quanto contano i trend nella musica pop) vengono create.
Frankie & The Hearstrings vengono da uno di quei luoghi di provincia, Sunderland, che ha sempre - necessariamente - subito il fascino della metropoli, della grande città, ma ha contemporaneamente voluto affermare
orgogliosamente la propria identità. Lo ricorda anche lo stesso Frankie Francis, raggiunto al telefono per quattro
chiacchiere: veniamo da una delle città meno trendy, meno fashionable dell’Inghilterra, mentre a Londra le cose
stanno su un piano diverso, perché ci sono un sacco di persone, moltissimi posti dove c’è ogni sera un concerto,
un reading, qualcosa che accade.
La metropoli può essere un eldorado per mettere in prospettiva le proprie aspirazioni e per qualcuno, e la storia è piena di esempi in questo senso, può essere anche la fine di un percorso, perché se c’è molto fermento, aumenta anche la competizione. Non così se accetti al provincia e ne fai il tuo trampolino di lancio: “da dove veniamo
noi, invece, le cose sono più facili”. Non è detto che questo sia per forza un bene, perché bisogna darsi molto da
fare, costruirsi una credibilità a livello locale, magari affrontando le diffidenze di chi ti conosce da sempre e mostra
8
tutti i suoi scetticismi. Ma se la qualità delle tue canzoni e la stoffa che sta dietro a quello che è comunque
un prodotto commerciale (si parla pur sempre di ‘pop
music’, intendendo ‘musica per le masse’, non certo per
colte élite salottiere) non la stessa di tutti i gruppi che
cercano il loro raggio di luce, allora le cose possono
funzionare.
Non si tratta, però, solo di questo, perché per noi è
sempre importante ricordarci da dove veniamo, qual
è il nostro posto, dove sono le nostre radici. Ritorna,
misto a un sentimento di appartenenza di altri tempi,
anche un orgoglio, lo stesso che ha dato forza a molti
gruppi targati Postcard e “suono della giovane Scozia”.
Al di là del solito riferimento a gruppi come gli
Orange Juice e Josef K (ma ci sarebbe da aggiungere almeno i Dexys Midnight Runners), un nome che
ritorna spesso sulle colonne dalla stampa quando si
parla di Frankie Francis e dei suoi Heartstrings è Morissey. Un po’ perché sembra che sul palco, come afferma
chi li ha visti live durante il fortunato tour di spalla ai
Futureheads (altra band del nordest inglese), il giovane cantante dal look rockabilly sia capace di calamitare con il proprio carisma qualsiasi tipo di pubblico, facendo sembrare ogni gig un evento unico e speciale.
Un po’ perché i riferimenti alla musica anni Cinquanta
(crooning compreso), con quelle chitarre jingle-jangle
e quelle melodie blue eyed soul appiccicose e spesso
sbarazzine, fanno del materiale di Hunger una delle
migliori scuse in circolazione per muover i piedi e le
anche a ritmo, come accadeva per gli Smiths. Morrisey è sempre un paragone che lusinga, che fa piacere.
Soprattutto se sei un fan, se ti piace quello che ha realizzato con la sua band.
Nella voce di Frankie, però, nonostante la sicurezza
che ostenta per tutto il resto delle nostre chiacchiere,
qui compare qualche esitazione, quasi che comunque
il pensiero di mettersi nella stessa scia, di affrontare
l’ombra di colui che è sicuramente stato una delle ultime vere star prodotte nel Regno Unito abbia un peso
superiore a tutte le preoccupazioni che una band
all’esordio, per quanto coccolata dalla stampa e dalla
blogosfera, possa avere.
I riferimenti musicali dichiarati della band non si
fermano qui, ma comprendono anche Prefab Sprout
(sono un band molto importante, specialmente per
gente come noi, che viene dalla provincia. Secondo
me hanno prodotto tra le cose più belle nel pop di tutta la storia della musica pop), Echo And The Bunnymen e Talking Heads: durante le chiacchiere da pub
che abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti abbia-
mo scoperto che sono due band che piacciono a tutti
noi. È anche per questo che abbiamo deciso di formare la band. A proposito dei primi bisogna dire che
di Killing Moon c’è più di una traccia nei brani meno
energetici di Hunger e che il crooning di Frankie devo
qualcosa a Ian McCulloch. Con i secondi è più difficile
individuare eredità dirette, ma di sicuro li accomuna
un nervosismo generale e tutto sommato il giro di chitarra di Ungreatful non è così lontano dalle abitudini
di Byrne e sodali.
Con la band newyorkese, però, sembrano più che
altro condividere un interesse sociale non secondario,
testimoniato anche dalla scelta di usare per tutte le
cover di album e singoli foto di Keith Pattinson, il cui
libro No Redemption è una documentazione attentissima del famoso sciopero dei minatori britannici del
1984. Le sue foto, seppur non nello stile, evocano però
lo stesso immaginario da working class e da provincia di una copertina come Steve McQueen dei Prefab
Sprout. Insomma, si guarda a certe sottotrame degli
80s, quelle che rileggono i 50s edulcorandoli e cromandoli, e lasciando da parte slanci lisergici o (retro)
futuristi.
L’attività live nel nordest del paese deve avere cementato fortemente la band e quando si parla dell’importanza della dimensione live, emerge un po’ di
quello spirito sbruffone ma simpatico che spesso si
riscontra nelle giovani band con quell’aria cazzuta che
il mondo anglosassone ha sempre prodotto. Il palco
è una dimensione importante per la musica, ma non
si tratta solo del piacere di suonare insieme. I live set
permettono un contatto diretto con l’energia della
gente che ti viene a sentire e, in quelle situazioni, mi
sento molto a mio agio, ho fiducia nelle mie capacità e
in quelle della band: la fiducia nelle tue capacità, nelle
tue canzoni, nei tuoi mezzi.
È una forza che bisogna avere se vuoi provare la
strada del pop, se vuoi davvero provare a diventare
una sensation e poi, chissà, inseguire Morissey sulla
strada della celebrità. Questo lo dirà solo il tempo.
Marco Boscolo
9
Turn On
Stearica
—Stearica invade il
mondo—
Frantumano stili e codici tra
elettricità ed elettronica. Italiani per
provenienza, ma internazionali per
ambizioni e riferimenti ci parlano
della propria weltanschauung
10
S
ono italiani, ma non sembra. Non che abbiano
particolari tratti somatici o nomi strani. I torinesi
Francesco Carlucci (chitarre, basso, farfisa, piano, vibrafono, loops), Davide Compagnoni (batteria, piano,
marimba, loops) e Luca Paiardi (basso, piano elettrico, synth), nome in codice Stearica, hanno dimostrato sin dai primi e ormai remoti passi di sentirsi stretti
addosso i confini nazionali. A giudicare da etichette e
partnership, collaborazioni e ospitate varie nel corso
dei dieci anni e più di vita del progetto, il respiro internazionale è più che giustificato. Se Dälek, Octopus e
Amy Denio, tanto per fare dei nomi, partecipavano al
loro primo album Oltre, il comeback Stearica Invade
AMT vede addirittura gli psycho-rockers capitanati da
Kawabata Makoto pronti a dividere palchi (il tour europeo di più di 30 date) e sessioni di registrazione in
modalità impro per un album a “n” mani.
Una stima guadagnata sul campo, senza fossilizzarsi su confini o limiti, nè di genere nè tant meno geografici come ci ricorda Francesco: Facciamo musica
dal ‘97 e non appena abbiamo sentito l’esigenza di
farci ascoltare, siamo partiti senza bussola o geografia.
I confini stanno spesso solo nella mente, specie se ad
appena un centinaio dalla tua città si parlano lingue
diverse. Così abbiamo spedito subito le prime registrazioni ovunque capitasse, infatti pensa che una delle
nostre prime uscite è stata alla volta dei Paesi Baltici!
L’intensa attività on stage non solo ha rodato il
progetto nel corso degli anni ma ha significato anche
stringere una serie di contatti umani prima che professionali: Riguardo ai musicisti che citavi, sono tutti
amici conosciuti in tour, collaborazioni nate dopo aver
condiviso lo stesso palco o dopo una cena consumata
scherzando e trovando sintonia e umanità. Insomma
gli ingredienti che riteniamo fondamentali per suonare insieme.
Questo atteggiamento di completa apertura mentale si ripercuote sulle musiche del terzetto. Inclassificabili nel loro mélange a cavallo tra post-rock, sonorità
90s e psych dura che unisce muscoli a macchine, elettricità ad elettronica (Il nostro suono è frutto di anni
trascorsi suonando negli scantinati sino a notte fonda…abbiamo imparato a suonare con una moltitudine di strumenti acustici, elettrici o elettronici), esse
hanno un pregio raro di questi tempi: il potersi dire
realmente personali. A me piace questa componente personale, prosegue Francesco. Non siamo fan dei
modelli preconfezionati, ma in Italia si cerca la tranquillità di ascolti rassicuranti. Non dico che chiunque
sperimenti sia un eroe, ma sicuramente apprezzo di
più chi ci prova ed è curioso, rispetto a chi, invece, è
idolatrato riproponendo noiosamente sempre la solita minestra…rancida.
La curiosità e la voglia di sperimentare seppur
sempre in ambiti rock non mancano ai tre. Oltre, disco d’esordio tutt’altro che acerbo, li vedeva muoversi
onnivori tra distorsioni e chiaroscuri emozionali, visionarietà e leggerezza rievocando più che un suono,
un immaginario collettivo. Quello della natale Torino,
città dalle mille sfaccettature, esoterica e romantica,
punk dentro e ricercata fuori.
Il comeback Stearica Invade Acid Mothers Temple
– una unica session post ultimo concerto registrata
all’Ortosonico di Pavia in cui i sette del gruppo misto
hanno “invaso un pezzo di storia gli uni degli altri” – li
mostra invece padroni della situazione, tanto che sembrerebbero loro ad aver preso il sopravvento sui più
quotati colleghi. Segno di grossa personalità e stima
da parte di Makoto & co.: La decisione comune di lasciare a me la produzione artistica ha inevitabilmente
portato un accento sul nostro suono nonostante abbia cercato di mantenere lo spirito di quelle riprese. Ci
saremmo aspettati che fosse Makoto ad occuparsi del
mix e di realizzare il master, così come ha sempre fatto
per qualunque lavoro degli AMT. Quella sera stessa, invece, nel corso della cena al termine delle registrazioni, mi ha proposto di produrre quel materiale. È stata
la sua maniera per ringraziarci della splendida esperienza vissuta nel corso di quel lungo tour che stava
appunto terminando con la registrazione della jam da
cui è nato l’album. Era chiaro che così facendo ci stava
dando una grossa occasione e dal canto nostro siamo
stati davvero onorati.
La grossa occasione è stata colta al volo, se è vero
che a breve parteciperanno per la seconda volta alla
prestigiosa compilation di The Wire, The Wire Tapper
(Warp Lag, il pezzo selezionato dal magazine inglese)
dopo il primo lascito targato 2008 (Occhio, la prescelta
all’epoca). Poi i tre ritornerà nella sua dimensione ideale. A calcare i palchi di tutta Europa, compreso quello prestigioso del Primavera Sound. Vogliamo ancora
parlare di rock italiano?
Stefano Pifferi
11
Tune-In
L’hardcore non morirà mai ma tu sì, urlò il ragazzo dalla
strada. Stuart Braithwaite in diretta dall’Alcatraz ci
racconta i Mogwai, Glasgow e il settimo album...
Mogwai
C
—(Un)happy hardcore—
Testo: Simone Madrau
12
hecchè si possa dire dei vari Slint, i Mogwai rimangono probabilmente il gruppo post-rock per
eccellenza, quantomeno sul piano dei numeri. Ancora
oggi la band di Glasgow è un caposaldo per tutti gli
appassionati del genere, un nome in grado di catalizzare attenzioni e presenze sotto il palco anche dopo
le ultime controverse uscite. La più recente di queste,
Hardcore Will Never Die, But You Will è lo spunto per
una chiacchierata con Stuart Braithwaite in persona, in
una saletta riservata dell’Alcatraz, in occasione della recente data milanese del gruppo.
Il nostro fa il suo ingresso nella stanza già sorridente e visibilmente smanioso di dare il proprio meglio
sul palco. A dispetto di un’affabilità che non avremmo
dato per scontata, non è facile ottenere risposte molto
eloquenti; emerge però con chiarezza come quel giovane indie-rocker scozzese sia rimasto tale, nei modi
oltre che nei fatti: consapevole magari dello status raggiunto dal suo gruppo ma ancora refrattario a qualsivoglia sensazionalismo e totalmente focalizzato sulla
sua musica.
I titoli dei vostri dischi hanno sempre delle storie
curiose alle spalle. Riguardo a questo nuovo, so che
il termine hardcore si riferisce alla happy hardcore:
un genere che credevo passato di moda negli anni
90. Ma so anche che c’è di mezzo un ragazzino di
Glasgow...
Hai ragione sulla happy hardcore e in realtà non sta tornando di moda neanche a Glasgow: eppure, soprattutto nelle fasce più giovani, c’è chi è ancora assuefatto a
questo genere che noi invece troviamo estremamente
noioso. Nel caso specifico abbiamo sentito pronunciare
questa frase dal ragazzino che hai citato. Voleva comprare dell’alcol in un negozio ma il titolare si rifiutava
di venderglielo, così lui gli ha urlato questa frase ed è
scappato. Il suono di questa espressione ci ha colpito e
da lì abbiamo estrapolato il titolo dell’album.
Per la registrazione e la pubblicazione di questo
nuovo disco avete impiegato pochi mesi. Cosa mi
dici circa la creazione delle nuove canzoni, ci è voluto molto tempo per comporle?
Abbiamo lavorato ai demo delle nuove canzoni ciascuno per conto nostro, poi una volta incisi i demo delle
singole parti li abbiamo provati tutti insieme e infine
siamo entrati in studio a registrarli. Non abbiamo mai
impiegato troppo tempo per lavorare su un nuovo disco. Quando decidiamo che è il momento di comporre
nuovo materiale ci mettiamo all’opera, e finchè il disco
non è finito non ci concediamo alcuna pausa, anzi programmiamo ogni cosa in modo che niente intervenga
nel mezzo: solo lavoro, lavoro, lavoro.
Nonostante il fatto che siate tornati a farvi produrre da Paul Savage, l’album suona molto diverso da
Young Team. Suonate come un gruppo che va molto più dritto al sodo rispetto al passato.
E hai ragione, infatti. Però ci tengo a dire che non è
qualcosa di intenzionale: quando siamo in studio ci
concentriamo semplicemente sulla realizzazione dei
brani, ragionando molto poco su cosa vogliamo o su
quanto vogliamo cambiare rispetto a questo o a quel
disco. Anch’io la penso come te, davvero, e come me
credo tutto il gruppo: ma sono considerazioni a cui
arriviamo solo una volta che riascoltiamo il materiale
finito.
Durante una carriera musicale così lunga, le vostre
vite private sono sicuramente cambiate. Quanto
del vostro vissuto influenza i vostri lavori?
Bè ora ho 34 anni e dieci anni fa ne avevo 24. E’ una
fascia di età in cui per forza di cose molti aspetti della
tua vita cambiano. Questo però ha poco a che fare con i
cambiamenti sul piano strettamente tecnico: se i dischi
sono diversi, è ovviamente solo perchè abbiamo voluto sperimentare nuove strade. Una questione di testa,
diciamo. E lo stesso dicasi, in realtà, anche sul piano dei
contenuti: cerchiamo di emozionare chi ci ascolta ma
durante il lavoro in studio non siamo emozionati, non
dalle nostre esperienze personali almeno. Quando lavoriamo sulle canzoni cerchiamo di isolarci e pensare
solo alla musica: probabilmente poi non ci riusciamo
davvero del tutto ma posso assicurare che, se c’è un
condizionamento da parte del nostro vissuto, esso avviene a livello puramente inconscio.
Rano Pano ha questa andatura che la rende la cosa
più cantabile che abbiate mai composto. Un po’ la
vostra Seven Nation Army.
E’ una canzone piuttosto insolita per noi, con una me13
lodia molto forte di cui siamo effettivamente molto
soddisfatti. Piuttosto antemica, è vero. Anche se non
riesco a immaginare migliaia di persone che la cantano in coro. Non che mi dispiacerebbe, anzi, ma quella
melodia in crescendo mi fa venire in mente qualcosa di
più epico e solitario, alla Ennio Morricone per intenderci. Un autore che inevitabilmente amiamo.
Mexican Grand Prix è di fatto una canzone. Qualcuno la paragona ai Neu, qualcun altro agli Stereolab,
nessuno ai Mogwai.
In effetti è un altro brano lontano dai nostri standard.
John (Cummings, altra chitarra dei Mogwai) ha riversato lì tutta la sua passione per il kraut-rock, certamente,
e in particolare per i Kraftwerk e i Neu. Le parti di batteria invece le dobbiamo ai Suicide, un altro dei nostri
gruppi preferiti. Ma a parte questo abbiamo cercato di
personalizzare il brano, soprattutto con l’implemento
della voce, successivo alla versione che avevamo sul
demo. Ha reso tutto più imponente. Siamo felici del
risultato.
In You’re Lionel Richie c’è un recitato in italiano. Da
dove arriva?
E’ opera di Dr Kiko, un dj italiano che è anche nostro
amico di vecchia data. Avevamo registrato queste parti vocali che fanno da intro a George Square Thatcher
Death Party in gaelico, giapponese, italiano e francese.
Kiko aveva fatto la parte italiana e questo per lui è stato
una specie di test, siccome l’avevamo registrato al telefono e intendevamo fare lo stesso anche con il racconto
che recita in You’re Lionel Richie. Ci pareva che l’effetto
finale si adattasse bene all’atmosfera del brano.
Vi considerate una band hardcore in qualche misura?
In senso musicale certamente no, e tantomeno in sen-
so umano o attitudinale. Ci sentiamo casomai vicini
al mondo hardcore in termini di estrazione e di modo
di intendere la musica, nel senso che proveniamo da
quello stesso genere di sottocultura diy che è elemento di congiunzione tra gruppi indie-rock come il nostro
e gruppi hardcore veri e propri.
Cosa pensi delle molte altre band in giro che vengono generalmente connesse ai Mogwai o che si dichiarano per prime influenzate dal vostro lavoro?
Credo che ci siano un sacco di band che vengono connesse a noi o vengono paragonate tra loro senza avere
di fatto molto in comune. Notoriamente non amiamo
le categorizzazioni e tantomeno ci piace essere considerati i capi di qualcosa. Però, per quanto suoni banale,
nel momento in cui sono i gruppi stessi a dichiararsi
influenzati dal nostro lavoro, lo apprezziamo. Lo apprezziamo eccome.
Per finire: che mi dici della vostra etichetta, la Rock
Action Records? E cosa ci dici circa l’undergorund
della tua città in questo momento? Ci sono dei nomi
che vale la pena di tenere d’occhio?
Per quanto riguarda Rock Action abbiamo in uscita il
secondo album dei Remember Remember, il terzo degli Errors e l’esordio di Blank Mass, side-project di Ben
dei Fuck Buttons. Direi che stiamo attraversando un
buon periodo. Per quanto riguarda Glasgow non saprei
farti un nome in particolare nell’underground attuale:
certo è che ci sono un sacco di gruppi interessanti, la
scena cittadina è sempre attiva. Magari mancano una
linea comune, un genere o una scuola di riferimento
in particolare, ma d’altra parte non c’erano nemmeno
quando abbiamo cominciato noi.
si con
e
m
i
i
t
t
u
azine
tal mag
il digi
in pdf
nto è t
e
m
a
t
n
L’appu
orni su
i
.com rofondimenti
g
i
e
i
r
t
t
a
u
t
l
et
o
sc
a
t, app
e
s
r
i
e
t
t
n
n
o
c
e
www.osncerti, recensioni,
News, c
TIS
14
RA
tutto G
click
n
u
i
d
ata
e a port
anche su
15
Tune-In
Trad-folk, letteratura, magia sporcata di psichedelia ed
elettronica. Intervista a Erland Cooper per il sophomore
del suo carnevale: un disco che mancava alla terra
d’Albione
Erland And
the Carnival
“S
—Psych folk dal ventre della nave—
Testo: Marco Boscolo
ono sul treno, sto raggiungendo il resto della band negli studios della BBC a
Manchester. Se cade la linea, richiamami: spero non succeda troppo spesso”. La voce all’altro
capo del telefono è quella di Erland Cooper, il cui nome
sta circolando di bocca in bocca tra gli appassionati di
folk britannico (e non solo) assieme a quello di Simon
Tong e David Nock. Insieme rispondono alla sigla sociale di Erland and the Carnival e il loro secondo disco,
Nightingale, uscito il mese scorso, ci ha sorpreso positivamente, andando a riempire un vuoto, quello del
folk magico-psichedelico, rimasto per qualche tempo
senza nessuno che lo riempisse. È una tradizione che
all’interno del panorama britannico ha radici profonde
e che è emersa in superficie soprattutto con il revival
degli anni Cinquanta e Sessanta, grazie a personalità
come Davey Graham, il Bert Jansch solista o nella sua
formazione più nota, i Pentangle (“Jansch ha avuto
l’inestimabile pregio di far conoscere a un’audience
molto più vasta di quella degli appassionati la tradizione folklorica della musica britannica”, ci fa sapere dal
suo cellulare Erland). Non sono ovviamente che la superficie di un intero filone musicale. Molti altri saranno
i nomi da aggiungere alla lista, nomi che in un fase leggermente successiva amplieranno ancora il discorso,
ma Jansch e Graham sono quelli che poi ricorreranno
nella conversazione con Cooper.
E rland
and
The Carnival
A mettere insieme i tre ci ha pensato il comune amore
per la musica, seppure declinato in storie e con personalità molto diverse, che li ha portati a registrare assieme alcuni tradizionali scozzesi e inglesi. Ci si trova
bene, ci si ritrova per suonare insieme e nella migliore
tradizione serendipica, ci si ritrova con un disco tra le
mani, l’esordio omonimo: una mistura personalissima
di acid folk e amenità pysch varie, prese dalla tradizione ma anche da quello che offre il contemporaneo.
È il 2010 e, nemmeno dodici mesi dopo, ci rigiriamo tra le mani l’opera seconda, che per intensità lirica,
complessità e raffinatezza di arrangiamenti, atmosfere
oscure e haunting style rappresenta un salto in avanti
notevole. Alcuni storceranno il naso, adducendo che
16
non si tratta più di trad-folk, che i tre si sono lasciati
prendere la mano e che hanno deviato pesantemente
dalla strada dei padri. Può sembrare così per gli innesti
elettronici e l’accentazione ancor più psichedelica che
hanno preso le composizioni, ma l’animo della band rimane legato alla tradizione. Non solo quella musicale
dei già citati Graham e Jansch, ma anche quella letteraria, con testi che pescano dalle pagine di politica e
cronaca dei quotidiani, dal Libro Egizio dei Morti, dalla
letteratura e dalla poesia. Musicalmente si ritrovano
nel solco (splendente) dei primi Coral e di quel progetto estemporaneo che è stato The Good The Bad And
The Queen.
Un progetto, quello che vedeva alla voce il sempre
attivissimo Damon Albarn (che ha prestato il proprio
studio per le session dell’esordio), al quale ha partecipato uno dei due veterani del gruppo, quel Simon Tong
che è noto per il suo passato con i Verve. Anche la sezione ritmica e il sound engeneering non sono affidati
a un ragazzino, ma a David Nock, batterista di lusso per
McCartney (con i Fireman) e con una parentesi anche
negli Orb. Erland, invece, è più giovane e meno noto,
ma mosso da grande passione per lo studio e la ricerca
di trascrizioni di antiche canzoni e melodie. Le sue radici affondano nelle isole Orkney, a nord della Scozia,
un luogo che già per la sua collocazione spinge a suggestioni bucoliche. Cooper, però, non pare lo trasformi
in un luogo particolare, un locus amoenus letterario, e
nella nostra conversazione non le citiamo nemmeno.
Però lasciateci almeno scrivere che viene spontaneo
associarle ad altre isole, le Aran, disposte come vertebre di un animale gigantesco poco fuori dal golfo di
Galway, in Irlanda, un luogo in cui la musica, e la musica folk, è parte della stessa aria che si respira.
S tudio
matto e appassionato
E se le isole sono luogo d’ispirazione par excellence,
ricordiamoci sempre che l’intera Gran Bretagna è un
arcipelago di isole, alcune molto grandi, ma pur sempre isole. Un pensiero che deve aver attraversato anche la mente di Ralph Vaughan Williams, compositore
e musicista britannico, che nella prima metà del secolo
scorso si mette in strada per andare a raccogliere un
17
patrimonio musicale e canzonistico popolare che può
essere fatto risalire addirittura al periodo dei Sassoni.
Delle sue attività da, diremmo oggi, etnomusicologo,
più che ad Alan Lomax, Williams è accostabile a Béla
Bártok e Zoltán Kodály, che insieme girano l’attuale Romania e Ungheria (allora parte dell’Impero Austroungarico) per raccogliere e trascrivere melodie e ballate. Di
questa esperienza Williams ha lasciato una collezione
che riempie almeno un museo a sud di Londra e la Vaughan Williams Memorial Library nella capitale: “magari
non ci ho passato due anni come si legge in giro. Il fatto
è che si tratta di un’istituzione importante per la storia
della musica britannica, perché ne conserva una grande fetta di tradizione. Quattro o cinque anni fa il mio
interesse per questo genere di cose si è fatto più serio,
proprio quando ho scoperto che vicino a dove abitavo,
tra Londra e Brighton, c’è questa enorme collezione di
manoscritti, registrazioni sul campo, edizioni complete
e altri tesori della tradizione. Quello che ho fatto è stato
semplicemente di andarci il più spesso possibile”.
Accanto ai repertori folk che “ti permettono di conoscere nuovi artisti semplicemente seguendo l’evolversi
delle interpretazioni magari di una sola canzone”, Erland
Cooper e il suo carnevale psichedelico sembrano aver
forti interessi anche nella tradizione letteraria britannica. Solo a raccogliere le allusioni e le citazioni contenute
nelle canzoni di Nightingale, c’è da riempire un volume
di storia della letteratura: Charles Dickens, soprattutto
per quanto riguarda la Londra vittoriana descritta in Oliver Twist; Lewis Carrol (se non è un viaggio psichedelico
quello di Alice nel paese delle meraviglie, che cosa lo è?)
e la poesia di Thomas Stearns Eliot. “Ma non voglio sembrare intelligente o che so io. Quello che mi interessa, e
che interessa anche gli altri membri della band, è che i
testi suonino bene, che vadano a braccetto con la musica. Carrol o Dickens sono solo argomenti di cui è capitato di parlare assieme, ma dove poi ognuno di noi vada a
scovare la propria ispirazione quando scrive, questo è un
altro discorso”. Ragionamento che viene contraddetto
qualche interruzione telefonica più tardi: “mi piace che
i testi delle canzoni siano ben scritti e che possano essere letti autonomamente, come se fossero vere e proprie
poesie”. Oppure a quando ci racconta di perché hanno
deciso di musicare una parte del testo di Dream of the
Rood, un poema antichissimo, scritto in una lingua che
assomiglia di più al sassone di Ivanohe che all’inglese di
oggi. In una classica situazione da nerd e secchioncelli,
“ci siamo chiesti quale fosse la più antica canzone della
tradizione britannica di cui ci fosse rimasta traccia. E da
lì siamo arrivati obbligatoriamente a quel testo”. Quindi
qualche ambizione anche in questo senso c’è, o no? L’im18
pressione generale, dovuta anche al fatto che il disco sta
andando molto bene in Gran Bretagna e il tour alle porte,
è che Cooper non voglia apparire pubblicamente come
quello che la sa troppo lunga. Un genere di personaggi, quello dei saputelli, che raramente ha fatto scaturire
grandi innamoramenti del pubblico.
Tornando alla canzone, l’oscuro autore del testo originale racconta di essere rapito in sogno dall’apparizione di un angelo del cielo. Ecco, il sogno, un elemento
importante per tutte le composizioni della band. “Sì,
credo che effettivamente ci sia una connessione, nemmeno troppo oscura, tra la dimensione del sogno e la
psichedelia”. In entrambi i casi si tratta di aperture verso dimensioni altre e le due esperienze, quella onirica
e quella psichedelica, sono accomunate dalla cifra del
viaggio, una delle grandi metafore dell’arte, basti pensare al ruolo che ha il viaggio nelle favole e nei romanzi
di formazioni. Ma Erland Cooper sogna per fuggire dalla realtà? “Non credo che si tratti di fuga, di escapismo.
Credo più che altro che fare musica sia mettere insieme
parole e suoni per creare qualcosa di nuovo che prima
non c’era”. Non un semplice viaggio, ma un vero atto di
creazione di un mondo intero. Nel loro caso racchiuso
nei pochi minuti di una canzone.
Il
evocativi. Sono suoni che in parte sono finiti nel disco”.
U ne
touche de électronique
Qualche computer, una stiva e lo studio è fatto. Ma la
ricerca di Erland Cooper e compagni ha fatto prendere decisioni ben precise sui suoni. “Abbiamo usato il
computer solo per registrare, mentre quasi tutto il resto è prodotto da noi. Abbiamo preferito usare vecchi
sintetizzatori che adesso si comperano per pochi soldi
piuttosto che usare suoni prodotti da un software. La
mia tastiera preferita, e la uso moltissimo nel disco, è
un vecchio modello della Yamaha che ho comperato
su eBay per 99 sterline. Ha un suono che mi fa pensare
subito agli anni Ottanta e in più è unico, fatto che conferisce anche alla nostra musica una personalità precisa, non assimilabile ad altro”. Mentre la linea cade per
l’ennesima volta e Erland oramai si è stufato di parlare
a singhiozzo, mentre il suo treno sta entrando nella periferia di Manchester, dall’altro capo del telefono non
possiamo che dirci d’accordo. Chissà se ci ha sentito.
ventre della nave
Il disco è stato registrato in una nave attraccata sul Tamigi, in pieno centro a Londra, ma dando l’impressione
alla band di stare completamente in un altro posto. “È
capitato quasi per caso di poter avere in prestito il posto, ma ha avuto il grande vantaggio che ci ha permesso
di registrare e suonare quando meglio credevamo, senza doverci preoccupare troppo di orari e costi di affitto
di uno studio vero e proprio. Uscivamo, andavamo ai
concerti e se avevamo voglia di suonare nel cuore della
notte sapevamo che potevamo farlo”. Eh sì, oramai basta un laptop per registrare adeguatamente la musica
ed è un attimo immaginarsi questi pirati moderni prendere possesso del loro vascello durante la notte, quando i broker della City e i turisti di passaggio sono oramai
rinchiusi nei pub o rincitrulliti davanti alla televisione, e
cominciare un viaggio/sogno nella musica.
L’ambiente in cui è stato registrato Nightingale non
ha, però, fornito solo comodità e ispirazione, ma ha
messo il proprio marchio sulle registrazioni. “È vero, nel
disco ci sono un sacco di riverberi naturali, dovuti al fatto che stiamo in mezzo al fiume nel ventre di una nave,
che hanno contribuito in modo determinante all’atmosfera di molti dei pezzi. Ma il contributo della venue non
si è fermato qua. Abbiamo anche registrato voci di passanti, rumori vari, che percepiti da lì dentro erano strani,
19
Cesare Basile
Paolo Benvegnù
Marco Parente
20
—L’insostenibile pesantezza
del cantautorato rock—
Drop Out
Tre dischi alieni piovuti nel volgere di pochi giorni sullo scenario
rock italiano. A rammentarcene
l’intensità perduta. Tre interviste
per scavare nel vivo.
Testo: Stefano Solventi,
Fabrizio Zampighi
I
n ordine di apparizione su questo sciagurato pianeta: Cesare
Basile, Paolo Benvegnù e Marco Parente, rispettivamente
classe ‘64, ‘65 e ‘69. Il primo esordisce coi Candida Lilith sul finire
degli Ottanta, Benvegnù avvia l’avventura Scisma nel ‘93, Parente
debutta in solitario nel ‘97 dopo alcune eccellenti collaborazioni
(coi CSI, ad esempio). Storie diverse le loro, come diversa è la calligrafia. Eppure hanno molto in comune, oltre al fatto d’essere nati
nei Sixties e di aver fatto uscire i nuovi lavori in queste settimane.
Nella diversità delle premesse e degli esiti, la loro musica definisce
un’interazione profonda tra testo e suoni, persegue un’intensità
che esige dall’ascoltatore una forte partecipazione emotiva ed
intellettuale. In conseguenza di ciò, lo stile acquista una peculiarità inconfondibile: per la forma e la struttura delle canzoni, per le
tematiche trattate e lo sviluppo delle argomentazioni, per il timbro e le inflessioni canore. C’è, insomma, un fare perno sul proprio
21
quid poetico, sull’unicità del proprio manifestarsi, che di per sé rappresenta
elemento cardine dell’espressione.
Pur rischiando la trappola della generalizzazione, è evidente lo scarto rispetto alle generazioni successive dei cantautori rock, la cui missione sembra semmai quella di incarnare un pensiero debole che ama presentarsi con
le sembianze del passato. Gli anni Zero dei Bugo, dei Dente, dei Brunori
Sas, dei Vasco Brondi e via discorrendo, sembrano impegnati a resuscitare
fantasmi del passato più o meno remoto (una più o meno definita poltiglia Battisti, Gaetano, Tenco ibridata all’uopo con modalità lo-fi, hip-hop,
noise...), aggiornandone e distorcendone il verbo, vestendosene come un
alibi, mascherandosi d’un linguaggio altrimenti irreperibile. E’ come se da
un certo punto in avanti fosse venuto a mancare il coraggio d’essere pienamente e soltanto se stessi. Come se il presente soffrisse d’incompletezza
rispetto a ciò che è stato. Come se l’incidenza del rock nelle questioni di
fondo dell’esistere - dall’impegno politico alla riflessione poetico/filosofica
- rappresentasse un evento inopportuno e a tratti persino illecito. Anche il
più “impegnato” e impegnativo Brondi AKA Le luci della centrale elettrica, a ben vedere non fa altro che abbozzare quadri folgoranti pennellando
slogan come schiaffi, esaurendo la critica nella pratica - nella tecnica - della
rappresentazione.
Non è certo nostra intenzione gettare la croce sulle nuove leve, che anzi
riflettono puntualmente la diversità delle premesse in cui si trovano ad agire. Lo spazio vitale del rock - da sempre minoritario però storicamente fiero nel suo porsi come alternativa critica al nazionalpopolarismo - ha visto
progressivamente ridursi le quote di partecipazione alla centrifuga dello
shobiz, vittima impotente dei criteri di selezione delle playlist e incapace di
guadagnarsi più che squarci sottilissimi ed equivoci di attenzione televisiva. Con la polverizzazione della cultura antagonista, ormai priva di leader
autorevoli anzi riconoscibili, espulsa come corpo estraneo dalle dinamiche istituzionali, il rock è rimasto ideologicamente solo. Si è trovato nella
posizione di dover lottare per camminare sulle proprie gambe, e quindi
ha sgomitato per recuperare un aspetto appetibile, intrigante, capace di
guadagnarsi fettine di palinsesto. Alternativo sì, ma non troppo profondo,
casomai bizzarro ma pur sempre leggero e comunque potabile, ché altrimenti nessuno ti sopporta, nessuno è disposto a concederti ascolto. Impatto sulla quotidianità prossimo allo zero, ma almeno sei un tipo divertente,
arguto, con un tot di serate garantite e forse pure l’intervista alla radio.
Non è più tempo, non è più un mondo, per “dischi che ti cambiano la vita”
o che falliscono provandoci. Non si cresce più con questa eventualità come
compagna di viaggio: il disco, fenomenologia obsoleta, format espressivo
dalle premesse decadute, è un vezzo a perdere. Un passatempo casomai
arguto, a tratti e con moderazione. Pensarlo latore di massimi sistemi suona come una velleità risibile. Ecco perché i tre dischi di cui ci occupiamo
questo mese e i loro autori fanno un po’ la figura degli alieni, appaiono tanto desueti quanto affascinanti, come una trasmissione radio da un mondo
sul punto di estinguersi. Intendiamoci, è normale che esistano dischi così,
perché nel consueto divenire delle cose il trapasso non avviene per cesure
ma con un sovrapporsi di modalità e forme: lo ieri prosegue nell’oggi come
un’onda lunga che si ostina residua fin nel domani. Tuttavia, la loro contemporanea apparizione ha la pregnanza di un monito, o di un colpo di coda.
Dare loro ascolto è anche un esercizio di (r)esistenza. Siano benvenuti.
22
Cesare B asile :
la rivolta del dolore
Il titolo, innanzitutto. Si può spiegare un titolo come Sette pietre per
tenere il diavolo a bada?
Un titolo del genere può essere raccontato in mille modi diversi e tutti affascinanti, più semplicemente è uno scongiuro, un’esorcismo, la formula di
un rituale quotidiano.
Hai scritto “vale ancora la pena di perdersi per ritrovarsi con un gran
disco fra le mani”. E’ andata proprio così? E’ un disco nato senza un
vero progetto?
Sì. Canzoni scritte e registrate in circa due anni, senza sapere bene dove
stessi andando a parare. Due anni difficili, pieni di confusione, voglia di
smettere, scoramento, con le canzoni che continuavano a venire nonostan-
23
te tutto. E le canzoni hanno vinto e mi hanno salvato... Almeno per questo
giro.
Dopo tre album affidati a nomi come Hugo Race, John Bonnar e John
Parish, torni ad essere il principale produttore di un tuo disco. Sbaglio
a leggerci la voglia d’indagarti più a fondo, senza filtri o interferenze?
Anche questa non è stata una scelta. Diciamo che la genesi del lavoro mi ha
portato naturalmente a fare a meno di un produttore, visto che non ci sono
stati dei tempi di lavorazione programmati e quindi non potevo chieder a
nessuno di stare dietro alle mie paturnie. Ho prodotto questo disco in maniera istintiva, sul momento, affiancato da persone come Guido Andreani,
Luca Recchia e Lorenzo Corti che mi hanno seguito nel disordine dei miei
appunti.
Anche la lista dei collaboratori sembra riflettere il desiderio di non giocare sull’appeal da “ospite d’onore”. Parliamo pur sempre di musicisti
d’eccezione, come Lorenzo Corti, Roberto Angelini, Rodrigo D’Erasmo
degli Afterhours e i due Mariposa (tra le altre cose) Alessandro Fiori ed
Enrico Gabrielli. Quanto sono stati funzionali alle tue esigenze espressive, e quanto hanno contribuito a determinare l’aspetto definitivo
del disco?
Non sono mai stato affascinato dall’appeal dell’ospite d’onore, ho sempre
avuto amici a suonare nei miei dischi. Condividere le mie canzoni con persone che stimo mi aiuta a distaccarmi dalle canzoni stesse, a non coltivare il
mio ego dentro quelle canzoni. E ognuno di quelli che hai citato se n’è preso un pezzo di canzone e l’ha fatta sua rendendo suo anche tutto il disco.
Tra folk cantautorale, blues mediterraneo e afflato orchestrale balcanico, è difficile definirlo un album rock. Eppure è senza dubbio un album rock. Sei d’accordo?
Il rock è guardarsi intorno, ascoltare, prendere cose alla rinfusa, sbatterle
dentro un scatola, agitarla e ributtare tutto su un tavolo da gioco. Credo di
aver fatto questo. E’ un disco di rock.
Elon lan ler è stata incisa a Skopje, con l’Orchestra della Radio Televisione Nazionale Macedone, per la colonna sonora di My world is upside
down, film-documentario sul musicista macedone Frane Milenski Jezek, che per la verità non conosco affatto. Come hai finito per esserne
coinvolto?
Mi ha contattato Petra Salisker, una documentarista slovena che aveva deciso di raccontare la vita di questa sorta di funambolo del palcoscenico,
Jezek appunto. Ho scoperto un personaggio poliedrico che passva dallo
scrivere canzoni al mettere in scena spettacoli per bambini, piuttosto che show televisivi e iniziative contro il governo per le quali è finito diverse volte in carcere. Era uno che sapeva raccontare e aveva capito che il racconto
è il cuore dell’arte e che l’arte può essere mortale per il cuore del Potere.
Petra ha chiesto a diversi musicisti della scena internazionale, tra cui Robert Fisher, Hugo Race e Chris Heckman, di riscrivere e reinterpretare nelle
rispettive lingue alcune fra le canzoni di Jezek a dipanare il filo della sua
vita. E’ stata un’esperienza molto forte e formativa e in questo sono stato
affiancato da John Bonnar che ha scritto gli arrangiamenti d’orchestra.
Uno dei momenti emotivamente più forti del programma coincide con
La Sicilia havi un patruni, pezzo firmato Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri. Una canzone del ‘78, se non erro. Però sembra di mille anni fa, o
di domani. C’è un motivo particolare per cui l’hai inclusa nell’album?
24
Perchè questa canzone parla di una Sicilia offesa e sfruttata, spesso anche
accondiscendente verso i suo mali, una Sicilia che oggi come allora ha bisogno di piazza, di coscienza civile, di ritrovare una identità oltraggiata da
150 anni di asservimento allo Stato Italiano e ai poteri mafiosi.
A proposito di Sicilia, farai un tour tutto siciliano su iniziativa de L’Arsenale, Federazione Siciliana delle arti e della musica. Nelle note stampa ne parli come una sorta di atto dovuto, di una maledizione, di un
legame con la tua terra che non c’è modo di spezzare. Che sapore ha
portare la tua musica ai siciliani?
E’ un legame con il quale mi sono riconciliato, mi sono arreso all’amore che
ho per la mia terra e in questo tempo in cui nessuno vuole fare la sua parte
ho deciso di farla la mia parte insieme ad altri uomini e donne che sognano per la Sicilia un presente diverso, una cultura dell’appartenenza fatta di
scelte e di dignità.
Tempo fa Dori Ghezzi ha rilasciato una dichiarazione del tipo “Vasco
Rossi è l’erede di Fabrizio De André”. Ti confesso, mi ha sconcertato,
anzi mortificato. Magari se ascoltasse canzoni come Lo scroccone di
Cioran, Il sogno della vipera o E alavò, avrebbe due o tre cose su cui
ponderare. A parte questo, quanto c’è di Faber, più o meno consapevolmente, nella tua musica?
Ha ascoltato suo marito per tanti anni, non credo abbia bisogno di ascoltare le mie canzoni per rendersi conto di certe enormità. Mah, a volte penso
che De Andrè sia una sorta di tavola imbandita attorno alle quale si siedono
troppe persone. Per quanto mi riguarda le sue canzoni mi fanno venire voglia di scrivere le mie, la stessa cosa che mi succede con Leonard Cohen.
Hai un metodo, o comunque c’è una modalità ricorrente con cui componi e realizzi le tue canzoni?
Forse ho un’abitudine più che un metodo. Mi metto lì e aspetto che arrivino
con la chitarra in braccio.
Due parole sulle tue... parole. Spesso l’elemento atavico, o archetipo, è
centrale. Le pulsioni primarie dirigono la danza. Tradizioni e superstizioni sembrano farsi beffe della civiltà. La morte tira le fila e l’amore è
al più una consolazione, un’ossessione o una dolce condanna. E’ cantando la cupezza che si può costruire la speranza?
L’elemento archetipo ha una riconoscibilità immediata e parla al sangue,
aggira il cervello, non ti lascia ragionare, ti costringe alla scomodità e azzera
la civilizzazione. Credo nel racconto del dolore come rivolta.
Appartieni alla generazione dei musicisti pre-internet, formati musicalmente su vinili e magari su audiocassette. Sono nato anch’io nei
Sessanta, so che esisteva una difficoltà oggettiva nel reperire dischi,
soprattutto certi dischi e fuori da certi circuiti. Credi che l’attuale accessibilità dello scibile musicale sul web rappresenti una risorsa per il
musicista del terzo millennio?
C’era un’esigenza che educava alla ricerca, e questo dava un valore diverso, un’emozione unica ad ogni scoperta letteraria o musicale, una parola
piuttosto che un suono. Se c’è un limite nella rete è che rende tutto troppo
facile e questo, per i più, determina una perdita di valore della scoperta. Di
contro la possibilità di veicolare notizie e controinformazione ha cambiato
per sempre la comunicazione ed emancipato voci che altrimenti non potremmo sentire.
Cosa significava fare un disco ai tempi del tuo debutto, quasi un quar25
to di secolo fa, coi Candida Lilith? E cosa significa oggi?
Io scommetto oggi come allora. Forse oggi è l’educazione alla scommessa
che manca, sembra che tutto sia dovuto, soprattutto il successo, e non si
capisce che fare dischi, scrivere, raccontare è di per sè una avventura meravigliosa, che il processo creativo è fatto di disciplina e non di posto fisso.
Sulla nostra webzine abbiamo affrontato l’argomento della crisi della
discografia, intesa come passaggio da un’epoca - coi suoi meccanismi,
i codici, i rituali... - ad un’altra ancora da decifrare. Quanto ti preoccupa come professionista e come artista il momento che sta vivendo
l’industria discografica?
Non me ne frega niente. Comincerò a preoccuparmi solo quando non si
scriveranno più canzoni. L’industria discografica è una cloaca a cielo aperto,
va ricoperta di calce viva.
Hai suonato un po’ ovunque, e continui a farlo. Mi giunge voce che sia
in corso una fioritura di spazi dedicati al rock, soprattutto in determinate zone (in Emilia, ad esempio). Altrove, invece, pare che regni la
consueta desolazione. Per quantità ed ovviamente anche per qualità,
qual è la tua sensazione riguardo allo stato dei locali da concerto in
Italia?
Suonare e ascoltare implica una condivisione del rischio fra artista, pubblico e proprietario di locale. Ricreando questa sorta di interazione si può
ricostruire un circuito fatto di condivisione e partecipazione.
La musica invece a quanto pare non conosce crisi. Dal basso soprattutto, dal calderone dei cosiddetti emergenti, arrivano segnali di vitalità
che autorizzano a ben sperare. Dalla Sicilia, ad esempio. Uno di questi
segnali è anche l’ottimo Mellon Collie And The Infinite Power, tributo
al celebre album dei Pumpkins organizzato dagli Albanopower che ha
coinvolto numerose realtà sicule. Tu hai contribuito con una eccellente
Bullet With Butterfly Wings. Roba da andarne fieri, no?
In quella canzone ho suonato solo le percussioni, il grosso del lavoro è stato
fatto dai Feldmann e dalla splendida interpretazione di Micol Martinez .
Guarda, c’è così tanta gente che investe energia, soldi, emotività e sacrificio
che basterebbe per anni. Il problema è la mancanza di rispetto per il cuore
di ognuno di loro.
M arco Parente :
fiori da un altro pianeta
La riproduzione dei fiori arriva a cinque anni dalla doppia uscita di Neve
Ridens. Cosa è successo a Marco Parente nel frattempo?
Questi cinque anni sono stati propedeutici e protettivi. Li ho passati a proteggere il mio istinto e a spegnere alcuni riflettori non troppo grandi, ma
per me ingombranti. Tutto quello che stava succedendo non mi piaceva.
Naturalmente questo ha portato a delle scelte radicali nella mia vita, pagate anche a caro prezzo. Ho preservato l’istinto, nel senso che ho continuato
a fare ricerca condividendola con altri, quasi fossi un solo lato di un binario.
Ho continuato a scrivere, ho suonato tantissimo da solo, ma ho anche avuto bisogno di prendere le distanze da quello che poteva essere il mettere in
moto i meccanismi che comporta fare un disco. C’è stata la parentesi Proiettili Buoni, il duo Betti Barsantini con Alessandro Fiori e allo stesso tempo ho gettato le basi per un lavoro bi-lingue che dovrebbe uscire il prossimo anno in condivisione con un songwriter di Portland, Ryland Bouchard
(The Robot Ate Me). In seguito ho portato in giro lo spettacolo teatrale Il
26
Diavolaccio, che ho messo in piedi un anno e mezzo fa con la persona che
poi mi ha spinto anche a registrare materiale nuovo per il disco, Pierluigi
Fontana. Mi è piaciuta l’idea di tornare a incidere, mettere i puntini sulle
“i”, fare il disturbatore. Cosa che in realtà sono sempre stato, nonostante le
varie “scene” in cui si è cercato di rinchiudermi, anche perchè propongo da
sempre musica che non è difficile ma certamente poco rassicurante.
Una musica, la tua, che forse prevede una certa “interpretazione” da
parte di chi ascolta...
Interpretazione che per me è in realtà “abbandono”, ovvero non porsi troppe domande e lasciarsi andare a quello che si ascolta. Se sei nella predisposizione mentale giusta puo’ anche essere che tu ti diverta e che ti piaccia,
senza che ci sia un motivo ben preciso. Questo “non sapere il perchè”, per
me, è abbastanza fondamentale...
Mi spieghi il titolo del disco? Nel brano omonimo pare di capire che
la contrapposizione tra i Fiori del male baudelairiani e i Fiori del bene
“parentiani” sia una metafora. Come se il messaggio che il brano vuole
trasmettere avesse a che vedere con la riscoperta di una felicità individuale (“fatti il bene, fotti il male”). In questo senso parli di riproduzione?
È un concetto che tende a una sottile ironia, quello del mal di fiori. Qui si
sta parlando di un modo fashion di approcciare la poetica di Baudelaire che
è un travisare continuo. La facilità del lasciarsi cullare dal negativo, il cro27
giolarsi nelle contraddizioni. Sono
abbastanza stanco da questo modo
di vedere le cose. Il vivere bene di
cui si parla nella canzone può essere
una buon antidoto a questo tipo di
mentalità. Il concetto di “riproduzione” ha a che fare con il fiore. Il fiore
si riproduce simbolicamente in maniera autonoma. Mi piaceva il fatto
del produrre bellezza senza doverla
spiegare con il pensiero o con il linguaggio.
Possiamo definire La riproduzione dei fiori un disco ottimista in
un periodo in cui essere ottimisti
diventa sempre più difficile?
Non mi piace la parola “ottimista”
perchè penso che l’ottimismo, come
del resto il pessimismo, non esita.
Esiste invece la consapevolezza, l’essere chiari e sinceri con sè stessi, il
darsi un senso. Il farsi delle domande
per cui spesso non ci sono risposte.
Direi che potrebbe essere definito
“positivo”, più che “ottimista”. Anche
perchè tutte le canzoni del disco,
anche quelle più blu come Sempre
(dedicata a Nick Drake) hanno sempre un risvolto positivo. Nel caso di
Sempre è l’accordo in maggiore.
Personalmente trovo che nei tuoi
dischi risiedano sempre due anime. Quella legata ai testi, riconoscibile, in un certo senso familiare
e fors’anche seriale. Nel senso che
in molti brani ci sono elementi che
ritornano, come ad esempio l’antitesi tra individuo e mondo, bene
e male, niente e tutto. E quella
legata alle musiche, sempre più
trasversali e aperte alla contaminazione. Sbaglio se dico che il
mondo di Marco Parente nasce
dal giusto equilibrio tra questo
senso di riconoscibilità e una decisa apertura a livello musicale?
Mi sembra un’analisi corretta. Le
parole hanno a che fare con il linguaggio, la musica non si sa. E’ un
linguaggio anch’esso ma molto misterioso. Io tendo sempre dalla par28
te della musica, perchè credo che sia il suono che conferisce il vero significato
al tutto. Anche alle parole. Per quello scrivo canzoni e non libri. A metterle
nero su bianco, a mio modo di vedere, le parole muoiono. E invece la parola
deve vivere grazie alla voce e aquistare significato dal suono. Nel cantautorato classico non mi è mai piaciuta la pigrizia del voler giustificare tutto con
delle belle parole. E’ importante che invece, prima di tutto, arrivi la musicalità
delle parole. Con questo ovviamente non voglio dire che il testo in sè non sia
importante.
Un elemento piuttosto interessante de La riproduzione dei fiori è il citazionismo che emerge da alcuni brani: Sympathy For The Devil degli
Stones che salta fuori nella coda de L’omino patologico, L’Hurricane di
Dylan tra le righe di C’era una stessa volta, i Radiohead suggeriti da La
grande vacanza. In un disco che fa della mescolanza stilistica (non per
forza prevedibile, non certo incoerente) un elemento fondante. C’è una
progettualità dietro o è tutto un divenire non legato a uno schema ben
preciso?
La citazione degli Stones è progettualità, nel senso che la canzone in cui è
inserita parla dell’atto creativo e per me l’atto creativo d’eccellanza nel rock
è quel pezzo degli Stones. Il divertimento che si porta dietro. Poi ci sono anche citazioni non direttamente connesse con l’ambito musicale. Nel caso de
L’omino patologico la citazione vuole rendere comprensibilie il brano. Vuole
sfogare. É una sorta di esempio di quello di cui parlo nel brano. Le altre citazioni che hai riportato sono suggestioni e patrimonio di ognuno. Una sorta di
condivisione.
Il tuo primo disco risale al 1998. Cosa è rimasto nel 2011 del Marco Parente degli esordi?
Non mi guardo mai troppo indietro. Ho capito però che la storia va per cicli.
Cicli sempre più stretti, tra l’altro. In ogni disco che faccio c’è sempre qualcosa
che mi riallaccia a quelli fatti prima. Il modo in cui lo registro, le persone che
frequento. Questo disco credo che abbia molta attinenza proprio con il mio
disco d’esordio, Eppur non basta. Credo che abbia a che vedere con lo stato
di grazia di quel primo disco, un entusiasmo che difficilmente capita due volte
in una carriera. Forse il fatto di essermi fermato così tanto prima di registrare
un disco nuovo ha generato un meccanismo di questo genere. É un po’ una
ripartenza, non con una virgola o con un due punti ma con un bel punto.
Tu, Paolo Benvegnù e Cesare Basile rappresentate tre artisti con una personalità estetica molto forte. Da un certo punto di vista, slegata dall’attualità musicale ma forse anche dalla velocità di fruizione che le rivoluzioni tecnologiche sembrano voler imporre a chi ascolta musica oggi.
Come ti poni nei confronti dei cambiamenti che ci sono stati negli ultimi
anni (mp3, peer to peer, ipod...) ma anche del rapporto tra fans e artista
(web, social network...)?
Io ho sempre accettato di buon grado le innovazioni tecnologiche, anche se
non le ho mai volute prendere in mano in prima persona. Anche perchè le
innovazioni tecnologiche si possono sempre usare in due modi e noi di solito
scegliamo il peggiore: quello che ci porta a impigrire. In generale credo che
sia cresciuta la testa di chi le innovazioni tecnologiche le ha programmate ma
non di chi le usa, anche perchè la tendenza è trattarle come si tratterebbe un
phon. Per me invece quella gocciolina di sudore, quel meccanismo di fatica,
continua a essere una parte importante e necessaria. La tecnologia la uso soprattutto per velocizzare i tempi in sala di incisione. Per quanto riguarda la
29
perdita di identità del supporto, non la trovo negativa. Sono ancora convinto che se un disco piace a una persona, quella persona lo comprerà fisicamente. In questo senso, il peer to peer è vantaggioso dal punto di vista del
marketing. Dall’altro lato c’è stata la barbarie dei social network (ma con cui
alla fine dobbiam convivere) in cui nessuno si puo’ più fare i fatti suoi. Devo
dire che cerco di tenermi a una certa distanza da tutto questo, anche se
non faccio l’eremita. Diciamo che collaboro con persone che usano abitualmente questo tipo di tecnologie e lo faccio per divulgare contenuti. Senza
per questo esserne troppo dipendente.
Pensi che il concetto di “condivisione” nato dalla rete in maniera poco
ortodossa possa adattarsi ad ambiti sociali più pratici portando con sè
elementi positivi?
Diciamo che siamo al limite. La condivisione è positiva per l’arte e per la
musica, ma quando si sfiora il patologico non mi trova più d’accordo. Condividere un suono è una cosa, condividere la vita personale in maniera eccessiva è un’altra. Poi il collegamento via internet abbatte molte barriere,
senza dubbio. Non sono bacchettone, in questo senso. Credo che quando
le cose succedono sia una massa a volerle e a farle muovere. E non si possono fermare. Siamo in un flusso e in quel flusso dobbiamo capire come stare
a galla. Per questo dico che nonostante tutto, non mi sento di muovere una
critica troppo severa a tutto questo.
Paolo B envegnù :
il talento dello stupore
Da dove nasce un disco come Hermann? La storia del manoscritto che
si legge nelle note stampa è l’espediente che sembra o c’è sotto qualcosa di concreto?
Hermann è un po’ un disco di letteratura e in quanto tale si avvale di espedienti letterari (come appunto quello del manoscritto). L’idea non era quella di gettare tranelli quanto ripetere quello che in passato hanno fatto scrittori come Victor Hugo.
In che senso il disco è “la storia dell’uomo e della sua evoluzione (involuzione)” ?
Il tema è unico: l’uomo che parla dell’uomo. Una volta soddisfatto il bisogno del cibo l’individuo sposta la sua attenzione sull’armonizzare sè stesso con il mondo esterno. Ognuno di noi cerca di farlo per stare meglio,
per fuggire dal dolore. E forse anche dal concetto stesso di fuga. Si parla
sempre degli stessi temi dalla notte dei tempi e così sarà finchè avremo la
volontà di porre uno sguardo verso l’esterno.
E’ in questo che Hermann si differenzia dai tuoi dischi precedenti, forse maggiormente legati a una dimensione personale?
Decisamente. Prima di questo disco non riuscivo ad avere quell’apertura
verso l’esterno perchè non comprendevo neanche me stesso. Adesso, almeno parzialmente, ci riesco e così ho deciso di spostare il fuoco sull’esterno. Ho pensato che fosse arrivato il tempo di farlo, anche grazie all’aiuto
degli amici che suonano con me.
Mi pare che Hermann sia molto più diretto rispetto a Le Labbra...
Per certi versi è così. Anche se in realtà Le labbra è più un disco “di pieno
vortice” mentre Hermann gode delle stilizzazioni tipiche del romanzo. E’
affrontato come se fosse narrativa o un film. C’è una parte dedicata al Novecento che è stilizzata come stilizzato è stato lo stesso Novecento, ma c’è
anche una prima parte che è antica e nella maggior parte dei casi è suonata
30
in 6/8 o 3/4. Esteticamente Hermann potrebbe essere fuorviante rispetto
a un disco come Le labbra, dove in realtà di estetica ce ne era veramente
poca.
Pochi giorni dopo l’uscita del tuo nuovo disco sono usciti anche quelli
di Marco Parente e Cesare Basile. Magari non avete molto in comune,
le vostre calligrafie sono diverse, eppure sembra unirvi una personalità intensa, il gusto di scavare in profondità e portare il discorso al limite, fino a farsi inconfondibile. Non sarà dovuto alla vostra formazione
musicale, al fatto di essere “cresciuti” quando un disco significava molto più di adesso?
Mi associ a due artisti che stimo moltissimo, artisticamente ma anche a livello umano. Cesare per tutto il mistero cromosomico che si porta dietro.
La sua terra, il fatto che è un viaggiatore generoso. Marco per la brillantezza
dell’uomo leggero e denso che ha. Io ho il talento del bove, dell’impegno.
Un’uomo che ha l’aratro e continua a tirarlo. Alla fine non è proprio un gran
talento, se ci pensi. Talvolta questo talento si focalizza nella maniera giusta,
altre volte no. Per cui il paragone in questo senso mi onora. Detto questo
io, Cesare e Marco siamo forse ancora uomini del Novecento, veniamo da
un’altra generazione. Siamo gente che dà ancora a un disco la stessa importanza che darebbe a un libro o a un film. Nella pratica, questo significa non lesinare in impegno quando viene il momento di incidere e farlo
come se fosse l’ultima cosa che si fa nella vita. Ovviamente questo non vuol
dire che poi i dischi vengano fuori sempre meravigliosi, quantomeno nel
caso di Paolo Benvegnù. Anche se il tempo alla fine è un gran setaccio. Così
come ci sono voluti tanti anni per capire certe cose degli Scisma o un disco
come Piccoli fragilissimi film, ce ne vorranno altrettanti per comprendere
Hermann.
Credi che l’attuale accessibilità dello scibile musicale sul web rappresenti una risorsa per il musicista del terzo millennio? E come giudichi
l’evoluzione che c’è stata a livello tecnologico?
Non saprei. E’ vero che tecnologicamente lavoriamo per essere sempre più
31
veloci ma è anche vero che il ritmo dell’essere umano è sempre quello. Le
innovazioni tecnologiche dovrebbero tenere conto del fatto che noi siamo
sempre uguali e abbiamo sempre gli stessi pensieri (l’amore il controllo, il
possesso, l’indignazione, ecc..). Al progresso tecnologico dovrebbe corrispondere uno sviluppo dal punto di vista etico, sociale, mentale, che forse
però ancora non c’è. Ovviamente il fatto che si possano fare dischi a un
decimo del prezzo a cui li si faceva una volta è un fatto positivo. Il fatto che
anche un ragazzo che non ha mai fatto musica possa iniziare a suonare grazie a un microfono e a un computer è positivo. Per il resto, credo che a noi
non servano servizi che ci fanno andare a mille all’ora per fare l’aperitivo,
ma soluzioni per risolvere problemi seri.
Hai scritto canzoni d’amore toccanti. Quanto ti senti vicino, in questo
senso, alla tradizione melodica italiana, tu che comunque hai prestato
brani ad artisti come Giusi Ferreri, Marina Rei, Irene Grandi, Mina?
Il fatto di aver prestato le mie canzoni ad altri non puo’ che rendermi felice. E’ quasi un miracolo, se ci pensi. Tu sei lì che scrivi la tua musica in un
sottoscala e alla fine arriva una come Mina che ti chiede di cantarla. Del
resto sarebbe un miracolo anche se la cantasse un ragazzo in una qualsiasi
sala prove. Come è un miracolo che tu e io siamo quà a parlare o che io a
quarantasei anni vada ancora in giro a suonare ed abbia ancora delle idee
come uomo e come musicista. Per me è tutto stupore, credimi. Per il resto,
io scrivo canzoni in Italia e le scrivo con quello che sento proprio perchè
vivo qui. Non è tanto un discorso stilistico. Noi italiani abbiamo una complessità che deriva dal fatto che questo è un Paese colonizzato da sempre
e che nei rari casi di coraggio, ha dovuto usare l’autodeterminazione come
forza personale. Penso quindi che l’autodeterminazione di un Tenco o di un
De Gregori o di un Endrigo alla fine sia in qualche maniera vicina alla mia.
Hai un metodo, o comunque c’è una modalità ricorrente con cui componi e incidi la tua musica?
Ultimamente l’idea è quella di scrivere la musica e poi di aggiungere le parole. La cosa bella di questo disco è che alla scrittura hanno partecipato
anche gli altri musicisti, da Guglielmo Ridolfi ad Andrea Franchi. Un allargamento che è anche una bella deresponsabilizzazione per me. Quello che
ho fatto io è stato formare un contenitore. E in base a quello abbiamo scritto tutti cercando di scegliere le cose più significative. Cose che andassero
a costituire un disco in qualche modo cronologico, che parlasse dell’individuo nel tempo. Fino ad arrivare all’ipotesi di un individuo futuro legato magari a una sobrietà esistenziale lontana dalla glorificazione dell’apparenza
che ci ha caratterizzati fino ad ora. Un’esistenza che non dia per scontata
l’esistenza stessa e il valore dell’altro.
Il rock italiano ha fornito molti epigoni di Marlene Kuntz e Afterhours,
ma si fa fatica a trovare qualcosa di paragonabile agli Scisma. Colpa della tua ex band, dal linguaggio troppo periodizzato o complesso, oppure
è la nostra scena che non ha saputo - non sa - osare abbastanza?
I Marlene Kuntz e gli Afterhours sono stati qualcosa di davvero importante, probabilmente più degli Scisma. Scisma che alla fine sono stati un
gruppo che soprattutto agli inizi ha fatto i suoi compromessi e forse non ha
osato fino in fondo, pur cercando di produrre buona musica. Detto questo
credo che per chi suona oggi l’unica maniera per farcela sia proprio osare,
cercando di arrivare ai limiti della propria creatività e della propria immaginazione.
32
E’ in corso una fioritura di spazi dedicati al rock, soprattutto in determinate zone (in Emilia, ad esempio). Altrove, invece, pare che regni la
consueta desolazione. Dal tuo punto di vista, com’è suonare dal vivo
in Italia?
Suonare in Italia e bellissimo. E lo è perchè in ogni città percepisci una grande diversità che è molto legata all’indole delle persone che ci abitano. E’ la
complessità di cui ti parlavo prima. Se suoni a Cuneo o se suoni a Palermo
ti trovi davvero in due situazioni completamente diverse, sia dal punto di
vista tecnico che dal punto di vista della risposta del pubblico. Personalmente io preferisco i posti in cui riesci a percepire di essere ben voluto, al
di la del fatto strettamente tecnico, forse perchè sono in generale un uomo
che cerca accoglienza e che al tempo stesso spera di riuscire a darne. La
presenza o meno di spazi in cui suonare credo che sia importante anche
per i gruppi giovani, che in questa maniera si sentono motivati a formare
nuove esperienze e ad esprimersi.
33
Kode9
34
—Under the big) Black Sun (of dubstep—
Drop Out
Torna Kode9 su album ed è l'occasione perfetta per fare il punto
della situazione sui tanti fili intrecciati dal mastermind Hyperdub. E sulla sua musica. Lo abbiamo incontrato.
Testo: Gabriele Marino
Edoardo Bridda
S
teve Goodman aka Kode9 è, fuori da ogni retorica, uno dei
personaggi chiave della musica degli ultimi anni. La sua label Hyperdub il faro di una scena e di un genere che, tra
mille sottocorrenti e sfumature avant, si è imposto come una delle declinazioni privilegiate - l’altra è il wonky - di una una koiné
elettronica internazionale sempre alla ricerca dell’equilibrio, tra
cristallizzazione del linguaggio e suo rinnovamento. La cosa, per
una volta, vale anche qui da noi: si veda il sorprendente enciclopedismo appunto wonky/steps di After Silkworm di Planet
Soap.
Di queste convergenze di suoni, e prima ancora di estetiche
ed intenti, avevamo parlato nel nostro maxi-riepilogone sullo
stato delle cose hip hop 2009. Seguendo le principali tappe di
un percorso che, dall’affermazione del genere su scala mondiale,
alla mezza-rivoluzione dell’hip hop strumentale, bianco e wonky
35
di metà anni Duemila, ha portato ad una terza generazione di producer a
cui non interessano opposizioni di genere o dicotomie del tipo suonato/
prodotto e campionato/di sintesi, avevamo sottolineato tutta una serie di
contatti, incontri, scambi, intrecci che da allora non hanno fatto che rafforzarsi e ingrandire il proprio raggio d’influenza e la propria visibilità.
D ubstep
e dintorni :
2009-2011
Il nostro discorso su e attorno a Kode9 riparte allora proprio da quel 2009
che è stato l’anno delle celebrazioni per il lustro di vita Hyperdub: con una
compilation ascolto obbligato per tutti e uscite chirurgiche come i singoloni Black Sun (Kode9) e Wind It Up (di quel Mark Pritchard che poco tempo
prima, su Warp, aveva pubblicato come Harmonic 313 un lavoro fortemente influenzato dal Dilla elettronico e di quel Om’Mas Keith che è il cuore
club-funk del trio afrofuturista Sa-Ra). 2009 anno dell’affermazione nella
scena delle prime girls Cooly G e Ikonika (l’ottimo Contact, Love, Want,
Hate, trait d’union tra ritmiche steps e suoni wonky, sarebbe uscito a inizio
dell’anno successivo), del debutto lungo dei King Midas Sound di Kevin
Martin (pioniere dubstep a nome The Bug), della joint venture con la Brainfeeder (tra live alla Redbull Music Academy e contributi su Five Years Of
Hyperdub firmati Samiyam e ovviamente Flying Lotus). Appena fuori da
Hyperdub, altra “relazione pericolosa” e segnale forte di convergenze forse
36
anche inaspettate, lo split Burial/Four Tet, che declinava i rispettivi specimen (soulstep e IDM) in salsa housey.
Il 2010 si è aperto in maniera programmatica con Sonic Warfare, denso
saggio - con solide basi nell’intellighenzia post-marxista post-sessantottina
- firmato proprio da mr. Steve Goodman e pubblicato nientemeno che da
MIT Press che indaga appunto la “guerriglia sonica”, e cioè la manipolazione
di ambienti e persone attraverso un uso politico delle frequenze (in contrapposizione alle espressioni contemporanee - post-techno - dell’afrofuturismo;
che invece, attraverso le frequenze, cercano di tenere unite le persone). Tra i
ringraziamenti del libro: Kevin Martin, Simon Reynolds, Wil Bevan (Burial),
Raz Mesinai (Badawi), la Brainfeeder, la storica radio pirata Rinse, il locale
chiave della scena di East London FWD>>. E si è chiuso con due uscite importanti e perfettamente complementari nel descrivere le trasformazioni del
catalogo della label, sempre meno interessata a focalizzare un genere o una
tendenza e sempre più attenta a mettere il proprio marchio su singole grandi
personalità, vecchie o nuove che siano, stilisticamente anche molto distanti
tra loro: Terror Danjah, ovvero il modern classic (il più grande produttore grime secondo Reynolds) che sfoggia - aggiornandolo - il suo enciclopedismo
black, street e dancefloor, e Darkstar, protagonisti dei nuovi venti dubstep
a base di cantabilità pop, riscoperta della voce, appeal indie. Kode9, secco: “Il
suono muta sempre e io sto seguendo la musica che mi interessa”.
In mezzo, lontano da Hyperdub, ma sempre al cuore della scena elettronica nei suoi fermenti now, le eleganti geometrie di Scuba, i tribalismi di
uno Shackleton mai così sciamanico, l’ampio ventaglio di contaminazioni
bassy della compila Future Bass, l’asciuttissimo wonky di Lukid e quello
glitchato e “suonato” di Dimlite, la rilettura in salsa USA degli steps UK fatta da Starkey, l’addizione Lotus+Tet di Teebs, le prove tecniche di spacey
ragga di Africa Hitech e, ovviamente, la superfusion dello stesso Flying
Lotus (che ospita il suo fan Thom Yorke) e la riscoperta trip-hop dei Mount
Kimbie, volano ideale per ulteriori evoluzioni del genere e vera e propria
anticipazione delle uscite chiave dell’anno successivo.
Il 2011 che ruota attorno al dubstep è infatti, a più di dieci anni dalla
nascita del genere (prendiamo come riferimenti El-B, Loefah & Co.), l’anno del post-dusbtep. L’alfiere è ovviamente James Blake, bruciatosi in una
manciata di EP come produttore puro (puntando sempre più verso un freddo ed elegante camerismo) per dare voce alla sua anima soul nel debutto
omonimo. Nel dubstep post-Burial e quindi post-se-stesso, seguono a ruota artisti tra loro diversissimi come Magnetic Man (il supergruppo chart
oriented dei veterani Benga e Skream, affiancati da Arthur Smith/Artwork),
Joy Orbison, Ramadanman e Floating Points (tre giovani ancora in attesa del debutto su lp, ma già nomi di riferimento della scena), quel Jamie
Smith affrancatosi come solo producer dai suoi xx (We’re New Here, per Gil
Scott-Heron) e una vera selva di “super-giovani” il più interessante dei quali,
non fosse altro che per la prematura sponosorizzazione di Gilles Peterson,
è Lewis Gordon aka Koreless.
Attorno al dubstep, alle sue evoluzioni e - termine banale, abusatissimo,
ma qui davvero inevitabile - contaminazioni, ruotano alcune uscite chiave
(a livello di estetica, strategie di posizionamento e di comunicazione, ancora prima e ancor più che di efficacia artistica) di questi primi mesi 2011.
I Radiohead di The King of Limbs sono la divulgazione indie-blinking dei
suoni laptopistici e sotto sotto dubstep (si pensi al gusto noir e ai detriti
37
ambient di Los Angeles) di Flying Lotus; Thom Yorke ha fatto comunella
con Four Tet (fresco di split con un altro nome importante a livello di sintesi elettrofile come Dan Snaith aka Caribou) e Burial; e quest’ultimo, è
proprio notizia dell’ultima ora, è tornato con un solo work, un 12” pollici di
tre pezzi, dopo 4 anni di quasi completo silenzio. Notare come tutte queste
uscite super-hype corteggino sottilmente quello che sarebbe davvero l’incontro/scontro del secolo: mettere assieme Burial e Flying Lotus. Come, del
resto, già proprio nel 2009 si era cercato di fare, malinterpretando a tutti i
costi un semplice, per quanto suggestivo, montaggio Burial + Dimlite fatto
da FlyLo e uploadato sul suo Myspace.
Ecco, inutile dire che di questo continuum extra-Reynoldsiano Kode9 è
uno dei protagonisti over e soprattutto under ground. Forse proprio per
questo, coerentemente con una strategia di comunicazione veramente
ninjesca, che costruisce l’hype sotto la cenere, tra mascheramenti, reticenze e coup de theatre improvvisi, una strategia a ben vedere tutto fuorché
2.0 (ma aspettiamo il lancio - finalmente - di un sito ufficiale Hyperdub che
non si limiti a consigliare l’iscrizione alla mailing list), quando incontriamo
Kode9 e Spaceape qualche ora prima del live al Bronson di Ravenna (19
marzo, per la Hyerpdub Night - ci saranno anche i King Midas Sound - organizzata dal quarto Transmissions Festival), il discorso non sfiora neppure
di striscio tutto questo buzz, consegnandoci invece un artista interamente
concentrato a spiegare dove sta andando la sua musica: “Quando facciamo
le nostre cose, dobbiamo disinteressarci completamente di tutto quello che
succede intorno”. Si capisce subito che i due non sono solo parte di un pro-
38
getto musicale, ma sono amici veri, la complicità è forte, ridono e scherzano, rilassati come due compagni di college.
Kode 9:
un profilo
Scozzese di Glasgow, centro geograficamente lontano dal fermento londinese, ma con un underground elettronico vitalissimo tra club, etichette e
crew (città da cui provengono infatti anche Rustie, Hudson Mohawke e
Ghost-Simon Williamson, per non dire degli Shamen), classe 1974, il giovane Steve Goodman si appassiona subito ai ritmi e si mette ad ascoltare
tutto quello che gli capita sotto tiro, reggae, breaks, hip hop, jazz, funk,
house, ma anche l’electro-wave dei concittadini Associates (anni dopo inserirà la loro Message Oblique Speech in un suo mix). A sedici anni comincia
a fare il dj e una sera, sul dancefloor, arriva per lui improvviso “the most important musical event of my life”: la folgorazione jungle. “Della jungle non mi
interessano necessariamente i suoni, ma soprattutto l’energia che sprigiona”.
Steve si muove tra Edinburgo (è qui che avviene l’epifania), Warwick (qui
conseguirà un master in filosofia nel 1999) e Coventry, approfondisce l’hardcore, studia Timbaland e l’r’n’b dei primissimi Novanta, prima di trasferirsi
definitivamente a Londra nel 1997. Si immerge nella scena di East London,
fa lo speaker per radio Rinse, tiene set nei locali - compreso il FWD>> - e nel
2001 fonda una webzine specializzata in UK garage, battezzandola Hyperdub. Come producer, il primo lavoro di rilievo, già a nome Kode9, sono due
pezzi su Tempa (2002) a quattro mani con Ben Garner/Ben III, l’indianeggiante Fat Larry’s Skank e l’asciutto breakbeat di Tales From The Bass Side. E’
già dubstep, anzi, molto più dubstep di quanto non sarà per lui in seguito.
A fine 2003 Kode decide di trasformare Hyperdub nella label con cui fare
viaggiare la propria musica. La prima uscita, numero di catalogo HYP001, è
una lenta e irreale cover version di Sign O’ the Times di Prince, Sign Of The
Dub (2004; b-side la minimalista Stalker). Lo stile si è fatto già molto più
personale, Kode comincia ad esplorare le atmosfere dilatate, profonde e
siderali che ne contraddistingueranno il suono in tutte le uscite successive. Alla voce c’è Daddy Gee, e cioè quello Stephen Samuel Gordon che nel
2005 cambierà nome in Spaceape.
Kode9 è il pigmalione del ragazzo senza nome che si fa chiamare Burial e che nel 2005 esordisce con un 12” di quattro pezzi, South London
Boroughs (prima uscita Hyperdub di un altro artista), e l’anno successivo
pubblica l’omonimo album di debutto, disco dell’anno per The Wire. Sempre nel 2006, esce anche Memories of the Future, primo album di Kode9 e
Spaceape. I semi sono gettati. E la raccolta non tarda neppure troppo ad
arrivare, visto che il secondo album di Burial, Untrue, esce già a novembre
2007, diventando in breve tempo un vero caso internazionale (e segnando
di fatto lo sdoganamento del dubstep fuori dai soliti circuiti dei club UK),
anche e soprattutto per il mistero che avvolge il produttore, che riuscirà a
rimanere anonimo fino a metà 2008 (si scoprirà così che William Bevan aveva frequentato la Elliott School negli stessi anni di Kieran Hebden/Four Tet).
L’ambient sporca e drammatica, i legnosi breakbeat e soprattutto la palpabile - per quanto fantasmatica - tensione soul delle voci di Burial creano
uno standard che scavalca le dancefloor track e i melmosi pezzi chetaminici che dominano la scena e fanno di Untrue una pietra miliare del tramonto
dei Duemila. Il “Salinger del dubstep” ritorna nella sua tana e si chiude in un
silenzio quasi completo.
39
Kode9 invece, come abbiamo visto, si rimbocca le maniche e svolge il
ruolo di capoccia con uno scrupolo e un’intelligenza che ne spiegano alla
perfezione - assieme all’attività accademica - la produttività piuttosto ridotta e spalmata su tempi lunghi. Assistente a Warwick già prima di conseguire il master, dal 2006 in pianta stabile alla University of East London (guarda
un po’...) come “Lecturer in Music Culture” e coordinatore di un programma
di Sonic Culture, specializzato in “Cybernetic Culture, Diasporic futurisms,
Abstract Materialism”, Steve/Kode insegna attulmente materie relative ai
rapporti tra suono e immagine.
Afrofuturism
for the masses
Non abbiamo aspettato così tanto per stampare il secondo album intenzionalmente. Semplicemente, ci abbiamo messo molto per realizzarlo. Siamo
stati molto distratti... dalla vita, dal lavoro per l’etichetta. E poi non ci piace
fare le cose di fretta: quando un lavoro è pronto, lo facciamo uscire. Black Sun
è molto diverso da Memories. C’è molta più energia, a livello ritmico e nei testi,
ed è molto più synth-driven; il primo era - come dire - più slow. E’ un lavoro
che si è costruito live dopo live, nel corso degli anni (Black Smoke risale almeno
a due-tre anni fa), provando versioni sempre diverse degli stessi brani, fino a
raggiungere il feel, l’impatto che volevamo. Ci sono tre canzoni propriamente
house e sono tutte sorelle di Black Sun [il singolo 2009].
Space scrive i testi, io le musiche, poi cerchiamo di mettere assieme le due
cose. Dietro Black Sun c’è un concept, ma è nato a posteriori, dopo avere finito
il disco, anche grazie alla grafica della copertina [in stile giappa-Hokusai], dalle
coerenze che abbiamo riscontrato nei testi e nelle musiche e che ci è sembrato giusto fare emergere. Ironia della sorte - visti i tempi - il concept riguarda un
evento radioattivo che investe la popolazione e la muta geneticamente. L’album
parla di come i diversi gruppi della popolazione rispondono alla cosa. Le liriche
raccontano le loro storie. Black Sun, ad esempio, “parla” dell’eclissi radioattiva.
Nella vostra musica, nel vostro progetto, al di là delle evoluzioni interne
del vostro suono, ci sono sempre due componenti: la voce afrofuturista di
Spaceape e le basi elettroniche di Kode9. Per me l’afrofuturismo è la musica
più interessante venuta fuori negli ultimi 50 anni. E’ elettronica, ma ha radici
organiche. Va oltre le definizioni e gli stereotipi street, roots, hip hop, dubstep,
grime, techno, house. E’ la cosa che in qualche modo riempie il gap tra queste
definizioni e le riunifica tutte. Anche King Midas Sound è un progetto afrofuturista. Conosciamo Kevin da anni. Spaceape ha lavorato con lui su London
Zoo e in altri progetti [Cult Of The 13th Hour]. Il suo lavoro è sempre stato per
noi fonte di ispirazione. I nostri progetti, per quanto diversi, sono in qualche
modo comparabili. Direi anche che siamo complementari quando ci troviamo
sullo stesso palco. Ed entrambi impariamo e sperimentiamo molto a partire
dai nostri live.
Black Sun parla di “guerriglia sonica”? In senso lato sì. Nel libro ho cercato,
anche attraverso esempi presi dalla politica e da contesti bellici, dei possibili
background per spiegare certi meccanismi della scena bassy, della dance basata sulle frequenze. Mi interessa capire come le frequenze possono unire o
dividere le persone, ovviamente anche in maniera del tutto inconsapevole, oltre che manipolatoria. Le diverse sfumature musicali del disco spiegano come
queste persone, di volta in volta, si possono aggregare o si dividono. Tutto è
ritmo: la musica, il metabolismo degli esseri viventi, il moto dei pianeti... il traffico... i miei ritmi circadiani incasinati.
40
Prossime uscite Hyperdub in cantiere? Abbiamo appena messo sotto contratto Hype Williams per un EP. C’è un bel progetto di remix sui King Midas
Sound, sarà un album intero. Poi c’è l’album di Morgan Zarate, con il suo electrosoul, quello di Cooly G e nuovi pezzi dei Funkysteps e di D.O.K..
Meno sonicamente violento di quello di Martin/King Midas, meno graffiante, più deep, il live di Kode9 e Spaceape al Bronson conferma le parole del
duo su un album nato nei live e pensato per i live, facendo esplodere il potenziale dancefloor delle produzioni. Il rappato di Spaceape è ancora più fisico
rispetto al disco, i suoi spoken e il suo lento rapping nutrito di ascolti reggae
si fa più incisivo e allo stesso tempo più cinetico. La gente, insomma, balla, in
un riuscitissimo aggiornamento, in chiave afrofuturista, della logica dei soundsystem tanto cari a Martin e al prof. Goodman. Con uno spettacolo così e con
la fama post-burialiana che Hyperdub si è guardagnata negli anni, Kode9 può
tranquillamente puntare ad allargare sensibilmente il proprio pubblico di riferimento, tanto presso l’utenza indie che quella “discotecara”. Senza rinunciare
agli elevati standard qualitativi che finora ha sempre garantito.
41
Tim
Hecker
—Cathedral Electronic Music—
Drop Out
L'ultimo album dello schivo canadese è il più importante lavoro
ambient dai tempi di 'Disintegration Loops' di William Basinski.
Ne abbiamo approfondito retroscena e prodromi...
Testo: Antonello Comunale
Edoardo Bridda
I don’t want to make a document that’s the master statement of ambient,
or glitch, or whatever else. I’m interested in a hybrid of things, and making
new hybrids, and respecting people who’ve done other hybrids. I see hybrids
where people usually see static forms, like “ambient,” but I find it limiting as
a title.
M usica come ibridazione
Fa un certo effetto vedere il plebiscito di pubblico e critica investire
in pieno una figura che fino ad ora si era conservata nel ristretto circolo degli affezionati di settore. Quando un profilo elitario e a suo
modo schivo come quello di Tim Hecker finisce sulla bocca di tutti,
capisci che oltre alla qualità del disco si addensano sul personaggio i meriti storici di uno che non ha mai voluto far parte di nessun
circolo alla moda. Come sempre in questi casi, si riceve in ritardo il
credito pagato in anni di militante carriera oltranzista.
42
43
E’ dal 2003 che Tim Hecker è oggetto di forti attenzioni da parte della
stampa specializzata. In quell’anno, il popolare magazine The Wire, sulla
china estrema dell’era glitch, considera il secondo album del sound artist
come un album chiave dell’annata musicale. Radio Amor del resto, è - assieme ai Rechenzentrum di Directors Cut e al Living Vicariously Through
Burnt Bread di Twerk - l’ultima pubblicazione della Mille Plateaux nella sua
prima (e autentica) incarnazione, etichetta che ha rappresentato, a sua volta, il meglio in quanto a ambient, noise e psichedelica nell’era del digitale.
Mentre il glitch nella sua accezione d’estetica clicks’n’cut implode, l’ambient che ne ingloba i detriti, sembra più di una via ma l’autentico paradigma successivo e se vogliamo la maturazione di un linguaggio che retrocedeva dall’ondata digitale e nel contempo recuperava l’analogico (il tape
to tape reel) e gli indimenticati trucchi di scuola John Cage. Del resto, nei
due anni precedenti a Radio Amor sugli scaffali dei morenti negozi di dischi
specializzati in elettronica e avant- si posizionavano campali i Disintegration Loops di William Basinski e Endless Summer di un Fennesz via via
più sintetico e magistrale che forse è il più interessante segno dei tempi. La
ricerca dell’austriaco tanto quanto quella dell’amico londinense Peter Rehberg, ovvero Pita, è fortemente imperniata su una pasta sonora ancestrale,
mistica, dal sapore storico. Senza tanti giri di parole, nell’era della morte del
tempo, è l’eterno il moloch, il monolite nero, il totem in nome del quale,
salutata la civiltà, ci si avventura nell’ignoto.
I can’t say that naturalism is some over-arching interest of mine at all.
Più che con la natura o la narrativa, Tim Hecker ha a che fare con l’eterno. Un flusso di coscienza che si serve della manipolazione di artefatti che
possono essere piano, chitarra, synth o suoni naturali. Fisico e allo stesso
tempo psichico, paragonabile alla sinfonica glitch di Fennesz, o ai field recording ritrovati del newyorchese, o ai layer d’elettronica su field recording
di Keith Fullerton Whitman, la musica del canadese è un misto di correnti
alternate calde e fredde, presenti ma soprattutto lontane. E’ come sorvolare
un territorio, ha notato qualcuno, oppure assomiglia alle crepe dei fiordi
attraversate dall’oceano. Ma sono osservazioni dall’esterno, dell’ascoltatore. Abitare una cattedrale di suono rende invece meglio l’idea del requiem
particolare celebrato in Ravedeath, 1972, ovvero l’addio al suono che fu.
Un pianoforte nell’attimo prima del lancio da un edificio è infatti lo scatto
presente nella copertina dell’album, un lavoro che inaspettatamente è il
migliore inciso finora, nonché l’album di ambient noise più convincente
dai tempi di Lisbon di Whitman. Ma non era iniziata così.
I suoi primi passi musicali Hecker li muoveva in tutt’altro ambiente.
Sono i primi anni ’90 della minimal techno di Jetone, nome d’arte con cui
il canadese pubblica i primi lavori pensati al laptop e per il laptop. Sono
gli anni di dischi di genere come Autumnumonia e Ultramarin, che non
fosse per la fin troppo facile sapienza ex post, parrebbero già denunciare
tutta la maestria atmosferica del sound artist, anche se si parla pur sempre
di una musica dal pressante e canonico appeal ritmico, del tipo che infatti non sfigura nel catalogo di etichette di regime come Pitchcadet, Force
Inc e Tigerbeat6. Il gusto per la melodia ficcante e nascosta, per la texture
sonora fumosa e stordente e l’alternarsi tra stasi (apparente) e confusione
(evidente), sono tutte caratteristiche che troviamo già in Haunt Me, Haunt
44
Me, Do It Again (Substractif, 2001) per una sub label della Alien8 Recordings. Accantonato per il momento lo pseudonimo di Jetone, Hecker firma
senza filtri i venti frammenti d’ambiente che compongono il suo primo e
vero lavoro ambient.
Su venti, solo nove composizioni hanno titolo, ma lo scarto all’udito è
inesistente perché il lavoro è di una coloritura unica seppur assai distante
dall’essere monocorde. Dell’esperienza Jetone vengono qui conservate le
arricciature elettroniche, che agitano continuamente il droning sound del
laptop. Music For Tundra che apre qui le danze, esemplifica al meglio lo
stile dei brani: aperture gotiche di organo, frequenze impazzite al laptop,
sali e scendi emotivo tra lande desolate e frastuoni tuonanti nella biosfera.
Quella di Hecker non è certamente ambient per aeroporti, né tanto meno
per sedute new age di yoga, piuttosto si allinea lungo le coordinate elettroacustiche contemporanee di altri grandi poeti dell’atmosferico digitalizzato, primi fra tutti Fennesz e Keith Fullerton Whitman.
Il riscontro di Haunt Me, Haunt Me, Do It Again presso la critica specializzata va dall’entusiastico all’ottimo. Tim Hecker viene visto come un abilissimo ingegnere del suono capace di manipolare i sentimenti e l’immaginazione oltre che le manopole. Il disco successivo corrobora ancora di più
questa fama e stabilisce definitivamente Hecker come un nuovo standard
d’eccellenza della musica elettronica contemporanea. Oltre alla proposta
intriga anche l’azzardo d’artista. Dopo il disco di debutto si dà alle stampe
My Love Is Rotten to the Core (Substractif, 2002), un vero e proprio tour de
45
force del taglia e cuci, in cui vengono fatti convivere scampoli di interviste,
voci prese chissà dove, e suoni presi da concerti live dei Van Halen, il tutto
per meno di venticinque minuti di fragore digitale.
I don’t think that Walter Benjamin was entirely right about certain aspects of
the “aura.” Aura has shifted into things we can copy.
Il successivo Radio Amor (Mille Plateaux, 2003) è il disco della consacrazione, non solo del suo nome, ma soprattutto del suo stile. Alleggerita la
prassi ultratecnica dei primi due dischi, il nuovo lavoro trova il fulcro delle
proprie visioni intorno ad un piccolo villaggio da pesca dell’Honduras di cui
fa esperienza Hecker stesso. E’ un modo molto sottile e ironico di sottolineare la pretenziosa e supponente concettualizzazione che sta dietro a tanta
musica elettronica moderna. Far finta che ci sia un concept a guidare l’idea
di un disco senza che poi ci sia davvero niente più di una traccia dentro cui
muovere le proprie visioni. E’ con atteggiamenti come questo che Hecker si
allontanerà a lunghe falcate dalla moda imperante di inizio decade, quella
cioè di assemblare lavori certosini di un’elettronica spesso più dedita alla
forma che alla sostanza. Radio Amor segue le tracce lasciate dal marinaio
Jimmy nei perigliosi flutti del mar dei Caraibi, ma è appunto una falsa idea
di concept. Per Hecker conta molto di più la suggestione che affascina piuttosto che lo svolgimento di un poema.
L’afosa atmosfera tropicale si stempera e si riflette nelle mareggiate dronate di brani come Song Of The Highwire Shrimper, 7000 Miles, (They Call
Me) Jimmy. Il tipico “clashing sound” di Hecker, dove le frequenze elettroniche sembrano collidere l’un l’altra e disegnare nuove geometrie armoniche
si arricchisce qui di riflessi caldi ed evocativi. The Stair Compass vive di vampe elettroniche alla Fennesz, che bruciano lentamente fatati barocchismi
minimal come nemmeno Colleen. I dieci minuti di Azure Azure potrebbero
essere invece i più avventurosi del suo repertorio, tra voci di capitani persi
nella tormenta e apocalissi atmosferiche per burrascose tempeste di suono
da cui non si esce come prima. Radio Amor eccelle nella prassi visionaria e
trova per il suo autore una cifra stilistica unica e immediatamente riconoscibile.
Un anno più tardi Hecker torna sugli scaffali di dischi con un disco nuovo
per Alien8 Recording: Mirages (Alien8 Recording / Wide, 2004). Il canadese
cerca di bissare il colpo di Radio Amor e la press release è suggestiva: “Taking inspiration from Italian partigiani and the counter-attack of the antiVichyists, Hecker has issued a salvo against all tourists of melancholy, from
trustafarian pseudo-leftists to the Ikea nihilists of the bobist rive droite. …
With its motifs of eroticism and torture, militancy, and ecstatic pain, Mirages also points backwards towards the Viking penchant for fighting and
feasting.” Addirittura un disco che si muove in un contesto politico, come
denuncia di uno modernismo squallido e inconcludente se paragonato agli
“eroi della seconda guerra mondiale e alla loro risolutezza”. Stiamo sempre
li. Una traccia flebile di contorno. E’ la confezione. Dentro il tecnicismo diventa lussuregiante.
L’iniziale Acephale mostra subito un sound levigato, che rispetto al precedente Radio Amor graffia maggiormente lambendo territori quasi noise. Le note di un piano vengono disturbate dal riverbero intermittente del
laptop nella successiva Neither More Nor Less. In definitiva, Mirages è un
lavoro che gioca amabilmente con i due cliché dell’Hecker sound: da un
lato gli avventurosi scontri di suono, che, visto anche il romanticismo generale, assumono fragranze quasi shoegaze, dall’altro l’ambient minimale
disturbata dall’elettronica trattata al pc.
Alla prima categoria appartengono brani come Aerial Silver, The Truth
Of Accountants, Kaito, Balkanize-You. Alla seconda, invece, si iscrivono
Celestina, Counter Attack, Aerial Light-Pollution Orange, Non Mollare. La
splendida Incurably Optimistic che chiude il lavoro, riassume entrambe le
posizioni. Mirages è un disco meno di cuore e più di cervello, ma il risultato
finale è poco meno che ottimo, anche se inferiore a Radio Amor
Nel 2005 Hecker dà il suo contributo alla serie Mort Aux Vaches della
Staaplaat, elaborando un unico brano fiume di 40 minuti dove il suono parte evocativo e minimale, sfocia in un frastuono digitale dai riflessi doom,
ritorna nella calma, si anima di una vaga melodia in lontananza che sciama
nel sottosuolo… insomma un film a occhi aperti di cui non va rivelato il
finale.
First and foremost, I’m a studio musician. My main skill is making studio artifacts.
Arrivati al 2006 i tempi sono ormai maturi perché Tim Hecker cominci ad
alzare lo sguardo oltre un orizzonte di settore, che comincia oggettivamente a stargli stretto. Le icone di genere, anni 2000, ovvero Basinski e Fennesz sono ormai così diventati paradigmatici per un disco che non riescono
a replicare (The Disintegration Loops per il primo, Endless Summer per il
secondo) che la loro stessa carriera diventa un continuo termine di para-
46
47
gone con il passato. Hecker può permettersi più di qualche turning point.
La sua non è una sensibilità pop, ma realmente avanguardista, per questo
ha lo spazio e le spalle sufficientemente larghe per affermare che “Fennesz,
nel corso degli anni, si è concentrato su una sensibilità prettamente pop
nei suoi lavori in studio (al contrario il suo approccio live è molto diverso),
come in opposizione ai suoi primi lavori più concreti come Plus Forty Seven
Degrees…”.
Il metodo di Hecker di contro è una metodica improvvisazione dettata
da regole interne rigidissime. Descrivendo l’ispirazione che stava dietro al
brano Acephale, il musicista canadese dimostrava di avere uno spirito avventuroso e soprattutto una base rock che è quella che fa la differenza: “Il
mio processo creativo è di sviluppare una melodia o qualcosa del genere
anche li dove non sembrano esserci gli elementi sufficienti per far nascere niente. E’ come uno sperimentalismo forzato in termini più pop e goth.
Acéphale è stata sviluppata partendo da un campionamento dei Blur; ci
ho suonato sopra la chitarra e ci ho lavorato sopra fino a quando non ha
preso una vita propria. Ad essere chiari comunque non esiste uno standard
per la composizione. Ogni pezzo ha dietro il proprio fungo sotterraneo che
lavora “.
Il grande turning point arriva quindi con la firma di un contratto con
l’etichetta americana di culto Kranky. Un matrimonio deciso all’inferno e
che produce come primo risultato uno dei migliori dischi del sound artist:
Harmony In Ultraviolet. Il passaggio all’etichetta chicagoana, dopo anni
di laborioso peregrinare di label in label, sembra ai più la dimostrazione
che due rette parallele hanno deciso ad un certo punto di congiungersi.
Hecker di contro, rimane come sempre schivo e pragmatico: “E’ difficile
mettersi a pensare all’etichetta giusta per la tua musica, soprattutto perchè
non sono molto addentro alla musica contemporanea, nel senso che non
ho cognizione di cosa ogni label stia facendo. Kranky però è un’etichetta
che ho cercato per un bel po’ e quindi è veramente appagante che ci sia
trovati qui a lavorare insieme”. Il risultato del disco è un Hecker che vira
ancora di più sul crinale inaugurato timidamente da Mirages. Un disco che
spiega l’attenzione che il suo autore ha per le geometrie cosmiche, le nebulose d’ambiente ispide e nervose, gli effetti rumorosi e stordenti. Tutto
il contrario quindi dei canoni classici dell’ambient d’aeroporto e parecchio
più in là in direzione di un’avanguardia elettronica tutta personale. Qui si
cambia anche registro in merito alle durate dei brani, tanto languidamente
estese nei lavori precedenti, quando circoscritte in mini variazioni di pochi
minuti nel presente. Harmony in Blue esemplifica al meglio in nuovo corso
del musicista, mostrando in quattro frammenti, altrettanti modi di piegare
l’elettronica alle fantasie visionarie del suo autore. La sapienza tecnica si è
evoluta al punto di siglare brani masterpiece come Chimeras e Dungeoneering, che andrebbero studiati nei master di musica elettronica tenuti da
Fred Frith.
Dopo tanta effettistica il successivo An Imaginary Country (2009) sembra quasi un ritorno sui propri passi, un ripiegarsi su stesso, cercando un
approccio più pastorale e luminoso. Hecker pensa all’utopia di Debussy ma
sembra arrivato a un punto morto e la stasi quasi shoegaze di Borderlands
sta lì a dimostrarlo. L’idea di sintesi noise fennesziana è un canto di sirena, un abbraccio mortale. Il suo è un soundscape tridimensionale (Utropics / Paragon Point) che risente evidentemente anche della collaborazione
48
dell’anno precedente con il connazionale Aidan Baker, Fantasma Parastasie, ma quello che funziona con quest’ultimo, ovvero un lavorio di fino
verso un’effettistica liquida e molto lieve, non sortisce lo stesso risultato
nelle mani di uno che di contro ha sempre avuto una visione più magniloquente e wagneriana.
“Ricordo di aver visto le immagini di qualcuno con il volto ricoperto di
sangue in qualche reportage giornalistico su qualche apocalisse rave avvenuta lo scorso anno. Non so in che modo tutto questo sia entrato nella mia
testa, ma è avvenuto in qualche strano modo”. E’ la microstoria che sta dietro a Ravedeath, che si pone quindi come il disco migliore del musicista e
capo d’opera di inizio decade. Lavoro che si pone oltre la dialettica digitale
versus analogico dei primi Duemila, lontando dalle short wave estetizzanti
e dalle scene noisey più sub-bassi firmate Mille Plateaux, via dall’IDM più vicina ai Tangerine Dream, in uno spazio tutto suo dove tutti questi elementi
li ritroviamo con la forza e lo scarto determinanti al superamento. L’altezza
verticale del drone, la stordente potenza dell’organo collegano Satie a Klause Shultze, la sonata alla cosmica krauta. Un gioco di engineering e produzione. Presa diretta per l’incisione e successivo lavoro di editing invisibile
che deve parecchio a Ben Frost, l’ultimo signore dei ghiacci in grado di
sottoscrivere un marchio di fabbrica autografo nella recente scena elettronica post Pan Sonic. E’ lui a prestare idee soniche dal suo disco di debutto
Steel Wound, lui ad ingabbiare la mistica drone del canadese in una spessa
nebbia di layer densi e impenetrabili. Da qui lo scarto dell’organo processato e il riverbero monastico di Rekjavik che rendono Ravedeath un disco
non solo di sapienza tecnica, ma anche di lirismo umorale e struggimento
malinconico, consegnando il suo autore, finalmente, all’accettazione del
pubblico pop che, non a caso, apprezza ed elogia.
49
Recensioni
— cd&lp
highlight
A Red Cat In The Doghouse - Life Under The
Chemtrails (Ropeadope, Ottobre 2010)
Genere: beats / funk
Il romano Aldo De Sanctis, classe ‘74, polistrumentista e
produttore (di mestiere tecnico del suono), dà seguito
alla prima prova Night On LegHorn (2009) con un buon
album sostanzialmente downtempo (spiccatamente,
l’intro orchestrale, la cadenza reggae e i tocchi etno di
Home Growth; il quasi-rock di Deep Water), con dentro
esercizi funk (il dittico dedicato alla B-movie Funky Star,
che si ricollega a un pezzo del primo disco), dub (la
leggera e dondolante Dub Grown) ed elettronici (l’incedere minaccioso della spacey Black Moon Rising; le
rarefazioni ambient-noise di Ghost Town e della lunga
conclusiva Debunk This!). Un pezzo su tutti ha la marcia
in più e vale anche da solo l’ascolto del disco: l’iniziale
Citylights (con la sua companion Nightshifting, quasi in
chiusura), sospeso tra dubstep, glitch e Radiohead (le
tastiere).
(6.4/10)
Gabriele Marino
AA. VV./Geddes/Tom Demac - nofitstate
(Murmur, Marzo 2011)
Genere: deep house
Una compilation doppia di deep che si situa sulla
lunga teoria a basso voltaggio di cassa professata da
Wolf + Lamb, Deniz Kurtel e gli altri DJ che stanno
alimentando con classe, buon gusto e personalità il
nuovo corso dell‘house di questi ultimi mesi. Geddes
è il patron dell‘etichetta murmur e dei parties Mulletover londinesi. Tom MacDonald è il ragazzo di bottega
che vive sommerso nel suono della label. Il maestro e
l‘apprendista, tanto per intendersi. Un disco a testa per
spaziare in mondi subacquei, visioni calde che non tagliano il tempo con filtraggi anomali, ma che vivono di
calore e soul.
La selecta di Geddes parte subito in quarta con le positive vibrations ereditate da Stevie Wonder di Maceo
Plex (Vibe Your Love), per passare poi dentro un tunnel
di vocals blackissime trasudanti clubbismo deep da
tutti i pori. I nomi più cool restano i big: Marco Passarani (Colliding Bonus Star), la già menzionata Kurtel
50
(Trust), Seth Troxler (Miles in Aphrika con Lawrence)
e una serie di artisti dell‘etichetta che oltrepassano le
mode e suonano già classici, in particolare James What
e il remix di Glimpse per Lewie Day.
Il secondo disco è lo one man show di Demac: presenta infatti tutti i singoli di maggior successo dell‘uomo
usciti per la label. La sua proposta esce dal nero e si infatua di macchine vintage detroitiane: 808 e 909 sono
la base macchinica (Lose That Tape This) per un suono
che cita nelle vocals collezioni di dischi funk, soul e
r‘n‘blues (Idea Without A Name) e che ama forgiarsi con
tecniche di cut-and-paste e citazionismi squadratoanalogici da club Novanta (Slip Slop Slap).
Un doppio che crea un‘atmosfera calda, piacevole e
sensuale. Due nomi da appuntare nella lista dei VIP dello spinning. Murmur. Il futuro della deep passa anche
da qui.
(7.3/10)
Marco Braggion
AA. VV./Uxo/Digi G’Alessio/Planet Soap/
Smania Uagliuns - Dolphyn Surround
(passionjunkies.it, Marzo 2011)
Genere: beats
Come recitano le note stampa, Dolphyn Surround è la
prima compilation di materiali esclusivi prodotta dal
sito Passion Junkies, dedicato al mondo dei ritmi (con
interessanti podcast) e curato del napoletano Fabio Festa. Focus su Eric Dolphy, primo di una serie di tributi
a musicisti di culto che hanno influenzato in maniera
diversa il beatmaking, è un memorial barbecue con
dentro molti dei nomi della scena italiana che abbiamo
imparato e stiamo imparando a conoscere.
La scaletta si divide tra brani atmosferici e rarefatti e
track più solide, costruite attorno ad un loop preciso:
lo sketch stomp-hop jazz di Johnny Boy ed Manuele Atzeni (dalla crew toscana di Digi, OverKnights), il
grime di Kappah, il mystery shuffle di thegodfatherExperience & Alice, il gioco di accenti su tonalità scure di Uxo, la folktronica slackerlanguida di Bain Mass,
la batteria immersa in ambient noise di Balbio (in duo
con Robot Kaard su un altro brano), l’ambient di Grovekingsley, il lick fiatistico con sirene Mantronix di Planet
Boxcutter - The Dissolve (Planet Mu Records, Aprile 2011)
Genere: glo step
Salvo una personale passione e continuità per lo sci-fi e la robotica firmata Autechre, Barry Lynn è uno
che ha sempre cercato una sintesi tra trend consolidati e proposte innovative (altrui) nei propri lavori,
posizionandosi, nel corso dell‘ultimo lustro, come un barometro privilegiato della vivacità e continua
mutazione dell’UK continuum.
Nel secondo album Glyphic, attraverso un percorso di convergenze parallele al Pinch di Underwater
Dancehall (dello stesso anno, il 2007), esplorava il lato rastafariano dello stepping etnico e dubbato
di scuola Tempa (vedi le reminiscenze Horsepower Productions) senza
farsi mancare certe intuizioni a contorno (post-jazz Miles Davis via Squarepusher e Skream!); nel successivo Arecibo Message (2009) spaziava qui
e là riprendendo lezioni garage (via Burial di Untrue) ‘ardkore e house (via
Actress) acid (via Luke Vibert) e così via, catalizzandoli in uno spettro analogico pre-IDM, accarezzando anche sonorità 80s.
Nel 2011 del post-hypnagogic, in pieno recupero di spezie black 70s (funk,
fusion, jazz, Herbie Hancock), nuove e vecchie loungerie, dei Bibio di Mind
Bokeh e dei Toro Y Moi di Underneath The Pine, Caribou e Discodeine,
Lynn si riconferma ancora l’ago della bilancia elettro-brit, consegnando alle stampe forse il suo miglior
lavoro.
The Dissolve oltre a sintetizzare il dubstep e la fu IDM in nuove e convincenti tracce (Factory Setting
e Adele gli splendidi esempi che bazzicano intorno al mondo electro brit tra garage, dubstep, afro,
drum‘n‘bass, ‘ardkore), affonda completamente il colpo nella solarità e nel disimpegno nu disco caraibico now: da una parte, il funk (Zabriskie Discodegna di Bjørn Torske) dall‘altra il soul (All To Heavy, The
Dissolve e Ufonik, tutte con Brian Greene alla voce), in mezzo, la mano, un solido impasto suonato con
batterie, bassi slap e persino chitarre newagey Settanta (Passerby, Tv Troubles) mescolate a scintillanti
tastiere vintage spaziali.
Il disco è un album a due lune, una chiara e l’altra scura, entrambe focalizzate a dovere. L’irlandese non
è uno che innova, ma incarna l’artigianato che assimila e restituisce con grande capacità ed efficacissima variazione sul (già) detto. Gli manca ancora tanto così per diventare il Caribou o Four Tet. Noi ci
crediamo.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Soap, il loop zappiano di Knobuttons, l’esotismo di
Digi G’Alessio e il mood goodbyeporkpiehat-iano degli
Smania Uagliuns (forse il pezzo più riuscito della raccolta).
Un po’ di fisiologica altalena qualitativa tra i pezzi, ma
iniziativa molto interessante (soprattutto se farà da
apripista per una intera serie) e ulteriore testimonianza
del fermento e - speriamo anche - di una sempre mag-
giore unità d’intenti all’interno della scena.
(6.9/10)
Gabriele Marino
Adele - 21 (XL, Marzo 2011)
Genere: soulwriting
In un periodo in cui quella cofana irrequieta di Amy Winehouse non sembra in grado di reggere il peso della
51
scena, Joss Stone sembra essersi dimostrata una meteora durata giusto lo spazio dell’esordio e mentre Duffy
sembra spingere la propria musica verso altri lidi, Adele
sembra avere tutte le carte in regole per prendersi lo
spazio che la sua voce cavernosa e potente da soul singer si merita.
Dopo un esordio di grande successo commerciale, 19
(numero che indicava anche la giovane età dell’artista),
Adele ha aspettato quasi tre anni per affrontare il sophomore, tenendosi adeguatamente lontana dai pericoli che potevano insidiare una carriera ancora tutta da
costruire. Si è ritirata oltre oceano, in questi Stati Uniti
da soul country nei quali tanto affondano le radici della
sua arte (Dusty Springfield, sì, ma anche Wanda Jackson), e in quel di Malibu, in compagnia di una vecchia
volpe come Rick Rubin, ha messo insieme questo 21. L’impressione generale è che in un potenziale ancora
tutto da scoprire, le carte per durare ci siano. Il dittico
iniziale del singolo Rolling In The Deep e di Rumors Has
It lascia senza fiato per lo stomp efficace, per la forza
dell’interpretazione, per la cura dei dettagli. La liquida
He Won’t Go sembra superare la Winehouse proprio
sul suo terreno, Take It All è la più classica delle ballate pianistiche, quelle che resero grande Peggy Lee, ma
anche una buona schiera di cantanti afroamericane
degli anni d’oro del jazz. Ci sono episodi meno riusciti
(Turning Tabels, ad esempio, si salva solo per gli archi, la
cover di Lovesong dei Cure in salsa bossanova convince
fin là), ma dobbiamo scrivere il nome di Adele tra quelli
da seguire nel prossimo futuro.
(7.1/10)
Marco Boscolo
Adventure - Lesser Known (Carpark,
Aprile 2011)
Genere: synth-pop
Anche se non ha mai voluto riconoscersi in tale veste,
il primo album di Benny Boeldt (Adventure, 2008) era
di fatto un perfetto esempio del cosiddetto chiptune,
ovvero l’arte di far musica home-made col solo utilizzo
dei suoni prodotti dai primi videogiochi anni ‘90. Nello
stesso anno in cui 4mat, uno dei padrini del genere,
torna con Surrender a ridare lustro e classe all’estetica
nintendo-oriented, Adventure si svincola dalle regole
della chip music approdando in territori più decisamente (synth)pop. Lesser Known non perde comunque lo
spirito giocoso né una certa nostalgia degli anni passati, prendendo posto nel percorso evolutivo post-glo-fi
proprio accanto agli ultimi Miami Horror. In altre parole: l’amore per gli eighties è confermato a viso aperto, ma l’attitudine lo-fi viene meno in favore di una più
52
marcata componente dancey. Stavolta però, più che la
lezione di Washed Out e Memory Tapes, ad emergere
è ancora una volta la devozione per i protagonisti degli
‘80, con menzione speciale per New Order (i riconoscibili loop di synth in Meadows e Open Door), Pet Shop
Boys (l’energy dance di Lights Out e Relax The Mind),
perfino Culture Club (il canto mellifluo di Boy George
ripreso in Smoke And Mirrors). Gli spunti più fantasiosi
si limitano dunque a un paio di brani: Electric Eel, col
suo divertente dialogo tra vocoder e spasmi noise, e
Rio, un vivacissimo gioiellino electro pop su misura per
le vacanze estive. Preso atto delle sue abilità, va detto
che il ragazzo può ancora migliorarsi, maturando un
proprio stile personale. Sufficienza e pacca di incoraggiamento.
(6.3/10)
Carlo Affatigato
Agatha - Goatness (Wallace Records,
Aprile 2011)
Genere: noise-sludge
Ridurre un power-trio elementare ad un duo, fare a
meno della bocca di fuoco per eccellenza delle musiche rock e rendere il tutto possibilmente più heavy.
Questa la missione non scritta delle due Agatha superstiti, Pamela a basso e voce e Claudia alla batteria.
Riduzionismo di matrice noise-sludge con armamentario di effettistica varia e batteria mobile a rendere corposo un suono che non conosce soste o fa prigionieri:
pesantezza slowcore e slabbrature metal-noise tra un
doom alla Sunn O))) ma più dinamico (AutunnO)))),
uno sludge paludoso alla EyeHateGod e certe efferatezze sonore del post-hc primi 90s quando flirtava col
metal (Earth Crisis, Snapcase et similia) ma senza fondamentalismo se si eccettua quello targato diy (Punk
Explained To My Mother). Ad aggiungersi alla proposta
del neo-duo, un notevole senso dell‘umorismo citazionista e autoironico: titoli come Slayer Vs Morrissey, The
Hard Life Of Last Minute Lyric Writers o Take Care Of My
Carogna dicono di musiciste non solo padrone del versante strumentale ma anche dotate della sempre più
rara capacità di non prendersi troppo sul serio.
(7/10)
Stefano Pifferi
Alela Diane - Alela Diane & Wild Divine
(Rough Trade, Aprile 2011)
Genere: folk
La parabola di Alela Diane prosegue nel segno di una
pienezza sonora sempre più rivolta al folk-rock della
cuspide tra Sessanta e Settanta. Nel suo rinnovato con-
formismo, la cantautrice di Nevada City riesce comunque a ritagliarsi una dimensione propria, in un non meglio definibile punto d’equilibrio tra spirito e carne, tipo
una Sandy Denny resa sanguigna da particelle Janis
Joplin o una Grace Slick redenta Joan Armatrading.
Sembrano quindi accantonati quei riflessi esoterici, la
ricerca delle suggestioni fantasmatiche che l’avevano
inizialmente accomunata al filone prewar-folk assieme
alla concittadina Joanna Newsom.
Sopravvive, certo, nelle nuances di una voce dall’intensità non comune, capace di esaltarsi nel sound allestito dalla nuova band, i Wild Divine, ovvero i chitarristi
Tom Menig e Tom Bevitori, rispettivamente padre e
marito di Alela, più il bassista Jonas Haskins ed il batterista Jason Merculief. Trilli fragranti di mandolino,
tepori d’organo, cartigli di lap-steel, un prodigarsi ora
delicato e ora turgido alla bisogna: è la band complice, duttile e sensibile di cui Alela aveva bisogno, perciò
non stupisce che il titolo le renda omaggio. Neppure
sorprende, visti i trascorsi, l’ispirazione che sostiene le
tracce in scaletta, ballate che spacciano enfasi asciutta,
calda inquietudine ed elastica risolutezza.
Degne di nota una Suzanne che coglie il punto di fusione tra il Bob Dylan di Desire e quello di John Wesley
Harding, una Elajah dalla balsamica trepidazione, quella Heartless Highway che sfarfalla jazzitudine e spersa
acidità. Abbiamo forse perso un’interprete insolita, ne
abbiamo guadagnata una che potrebbe dare una bella
rinfrescata alla tradizione.
(7/10)
Stefano Solventi
Alessi’s Ark - Time Travel (Bella Union,
Aprile 2011)
Genere: indie-folk
Poco più che ventenne, Alessi Laurant-Marke deve il
suo nome proprio all’omonimo, italianissimo brand di
design. Cresciuta a Londra, debutta per Bella Union, ma
ha alle spalle già una cospicua discografia fatta di EP,
spit e singoli che rendono l’ipotesi di seguirne a ritroso
le tracce operazione per lo meno impegnativa. La fortuna le arride quando, nemmeno maggiorenne, viene
notata nella giungla My Space e messa sotto contratto
dalla Virgin. Il connubio produce Notes from the Treehouse, ma qualcosa fa pensare alla giovane cantantautrice che è meglio rescindere il contratto dopo solo
un disco e accasarsi presso un’etichetta più in linea con
la sua estetica.
Così arriviamo al 2011 e a Time Travel, con la voce da
gattina di Alessi che mette in fila dodici brani eleganti
e suadenti. Viene in mente Cat Power, ma anche Jo-
hanna Newsom. Di quest’ultima, in particolare, la giovane londinese sembra possedere la stessa esuberanza creativa, testimoniata dalla composizione copiosa e
dal fatto che oltre alla musica, si dedichi anche all’arte
illustrata. In questo sguardo al folk al femminile targato
USA, Alessi sforna alcune chicche, come la rivisitazione
Americana della title track, il crescendo scanzonato à
la Feist di The Robot (giù apparsa, insieme a The Bird
Song sull’EP Soul Proprietor, antipasto del disco dello scorso anno), le ascendenze rock 60s/70s di Must’ve
Grown.
Il risultato complessivo è un lavoro maturo, molto più
di quanto non dica la carta d’identità, per un’autrice
che ha tutte le carte in regola per posizionarsi tra i migliori prospetti futuri del genere.
(7/10)
Marco Boscolo
Alex Turner - Submarine (Domino, Marzo
2010)
Genere: mellow brit rock
Da quando, nel 2008, diede vita ai Last Shadow Puppets è stato subito chiaro che Alex Turner potesse,
presto o tardi, imboccare la via solista. L’occasione ideale si è presentata dunque con la colonna sonora del
debutto cinematografico dell’amico Richard Ayoade regista di molti videoclip degli Arctic Monkeys - per
cui confezionare i cinque brani di questo EP di debutto.
Dalla beatlesiana Stuck On The Puzzle e al pop midtempo di Piledriver Waltz fino all’intimismo acustico di Hiding Tonight e It’s Hard To Get Around The Wind, Turner
dipinge quadri malinconici e trasognati che non si allontanano troppo dai Monkeys di Secret Door e Cornerstone (Humbug). Ad emergere però concorrono i testi:
la migliore dimostrazione di una scrittura maturata che
da John Lennon ai Verve porta fino al Turner di oggi,
la cui cifra stilistica è ancora tutta in divenire ma già
poggia su un qualche evanescente eppur solido basamento.
Prima di sbilanciarci bisognerebbe aspettare un album
vero e proprio, ma viste le ottime recensioni ricevute
dal film al Sundance Film Festival - lo hanno definito
addirittura il Trainspotting della propria generazione possiamo desumere che Submarine come colonna sonora possa funzionare, anche se preso a sé ci mostra un
Turner in parte già sentito e abbastanza monotono.
(6/10)
Alberto Lepri
53
Alexander Rishaug - Shadow Of Events
(Dekorder, Marzo 2011)
Genere: Ambient, drone
Poco conosciuto e altrettanto sfuggente, Alexander
Rishaug, è stato tante cose, in primo luogo un sound
artist in proprio, poi un musicista impiegato in vari progetti impro e noise (ha fatto parte del collettivo ARM
con Arne Borgan e Are Mokkelbost, dal 1996 al 2006,
ha collaborato con Lasse Marhaug, Ole Henrik Moe,
Erik Skodvin e Tape), infine un producer e un remixer.
Guardando alle origini della sua produzione in solitaria
torniamo al 1998, anno cruciale per il clicks’n’cut: in quei
giorni Alexander è un ortodosso produttore di glitch e
microwave music. Quattro anni più tardi, per Smalltown
Supersound, esce il debutto, Panorama, un pout pourri
di tecnologie fritte e saltate nello stile di Oval e lezioni
minimaliste (Terry Riley) applicate all’era digitale (Raster Noton). Poi, con Possible Landscape per Asphodel, il
tiro s’aggiusta assestandosi sull’ambient di derivazione
glitch. Rishaug polverizza gli errori digitali, contempla la
field music in modalità più campestre e si converte lentamente al suono maturo degli artisti Mille Plateaux.
E così arriviamo quest’anno a Shadow of Events, terzo
lavoro a suo nome e un passaggio alla chamber drone pienamente compiuto: il norvegese dipinge caldi
human landscape, quadretti d’elettroacustica folk dai
mood nipponico-umbratili accodandosi così a tante
produzioni di settore ambient-noise dell’ultimo lustro.
Come nei due album precedenti, Rishaug approda su nicchie sonore oramai esplose dallo sfruttamento di orde di
nerd ed electoheads. La sua proposta non presenta quindi
alcuna novità e neppure brilla per ispirazione o fascino.
(5.5/10)
Edoardo Bridda
Annie Hall - Annies (Quasi Mono, Marzo
2011)
Genere: acute indie-pop
L‘ultimo anno è stato foriero di novità per questa brillante formazione bresciana. Innanzitutto l‘amichevole
forfait del bassista Giorgio Marcelli, nella line-up sin
dall‘inizio; poi, la loro Ghosts‘ Legs finita nello spot pubblicitario di una nota compagnia telefonica. Soddisfazioni e momenti che hanno lasciato un segno come
l‘essere in giro da un lustro con la mente da “trenta e
qualcosa”. Così che si avverte subito in questo terzo album che qualcosa è cambiato, che la formula dei dischi
precedenti (all’incirca: una personale sintesi di Eels e
Wilco, Grandaddy ed Elliott Smith) poteva rimanere
valida solo se sottoposta ad aggiustamenti di rotta che
tenessero conto del vissuto.
54
Parlano allora chiaro un titolo e uno scatto di copertina
che suggeriscono un fare quadrato, ma soprattutto la
sicurezza con cui il quartetto prosegue a sintetizzare
tra loro i modelli di cui sopra nel mentre ne indaga i
rispettivi padri. Da qui una maggiore elettricità, quel
jingle-jangle muscolare alla Big Star che - pur non
adombrando l‘anima acustica: si vedano il country
crepuscolare Merry-Go-Round e la gemma Suitcase, un
Brian Wilson folk-rock - pervade diversi brani (la secca
apertura For You, una Beautiful Mind di ruvida emotività, la trascinante Place To Hide) e fa bel paio con l‘innesto di Gabriele Ponticiello, strumentista eclettico e raffinato. Reazioni che profumano di cambiamento nella
continuità come la produzione arguta di Giovanni
Ferrario e la pienezza raggiunta da scrittura e cantato.
Non da tutti, infatti, la sfoglia chiltoniana Meanigless, con
un refrain splendido per come rende naturale la complessità, e una commovente Shooting Star da George
Harrison ale prese col dylaniano Oh Mercy (l‘ombra di
Daniel Lanois si stende anche altrove, sullo strumentale
Homestead e su certi toni traslucidi); altrimenti, la sensazionale articolazione di una Airstrip Zero in continuo
ondeggiare tra luci e ombre e la conclusiva, visionaria
Grand Avenue, sintesi di stile e insieme ponte verso il futuro. Maturità, ti accogliamo a braccia aperte. E chissà
che qualcuno non presti orecchio anche all‘estero.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Apes On Tapes - Foreplays (Homework
Records Netlabel, Febbraio 2011)
Genere: wonky downtempo
Ancora ottimi segnali dalla scena. Apes On Tapes è il
duo formato a Bologna nel 2005 da Luca Garuffi aka
Lagàr e Giordano Dini aka Antani, folgorati dall’ascolto dell’hip hop strumentale di Prefuse 73. Questa è la
loro terza prova dopo un EP (2006) e un album (2008)
sempre su Homework.
Il loro è un trip hop screziato di etno-esotismi (i cuts
di voci in delay che si muovono sinuose fin dall’iniziale
Les e dalla sua naturale prosecuzione Quarter Punder
with Jazz), tagliato con gusto wonky e tocchi spacey.
Senza dimenticare la lezione dilliana (Neat Meat Friend,
Verbal Leprosy), le radici electro (Big Wordz Big Wizard) e
qualche puntata sulla battuta dubstep (smerigliata alla
Dimlite, Not That Ready).
Un disco di raffinata ed evoluta downtempo, perfettamente inquadrato da un pezzo bello, ed eloquente fin
dal titolo, come Atarassic.
(7.1/10)
Gabriele Marino
highlight
Cat’s Eyes - Cat’s Eyes (Downtown, Aprile 2011)
Genere: Lounge goth pop
“Sapevamo che se ci fossimo riusciti, nessuno sarebbe stato in grado di copiarci” dicono oggi compiaciuti.
E ci mancherebbe! Una band che inizia la propria carriera concertistica a San Pietro (la basilica vaticana,
non una qualche sconosciuta fiera di paese) ha come unico limite le stelle.
Retorica a parte, che Faris Badwan fosse l’anima meno garagistica e più eclettica all’interno del collettivo Horrors si era capito. Più difficile sarebbe stato immaginare che le derive sarebbero state quello di
un pop cinematico e altamente suggestivo come quello prodotto dai Cat’s Eyes.
Insieme al giovane soprano canadese Rachel Zeffira ha allestito un progetto che si abbevera tanto al
pop dei girl groups, quanto agli score exotici di Piero Umiliani e Bruno Nicolai. Attenzione però a
considerare come marginale il contributo della Zeffira. E’ dalle sue abilità di polistrumentista, nonchè
dai suoi soggiorni italiani (a Verona, infatti, ha perfezionato gli studi lirici) che i Cat’s Eyes traggono
spunto.
Il loro esordio è perciò un disco calato nei 60s più oscuri e bohemien, sia
quando i due si avventurano nel beat kraut della title track, sia quando
forniscono la loro personale interpretazione dei duetti fra la bella e il tenebroso (più Hazelwood/Sinatra che Gainsbourg/Bardot) sempre virati su
tonalità dark. Trovano infine la loro specificità nel Morricone crepuscolare
di Bandit e Over You, o negli esotismi in Super 8 di Not A Friend.
Piace molto la misuratezza degli arrangiamenti, così come il modo in cui
Rachel dosa la voce calandosi nel ruolo della chanteuse. Il resto lo fa una
produzione che garantisce la giusta patina vintage e un gustoso languore psichedelico.
Badwan e la Zeffira ci tengono a far sapere che i Cat’s Eyes sono una band a tutti gli effetti, per questo
sarà interessante constatare la resa dei brani alla prova del live, quando i due saranno accompagnati da
un vero ensemble di musicisti. Ciò non toglie che il loro sia un progetto decisamente affascinante che
non mancherà di proiettare la propria lunga ombra sul prossimo imminente lavoro degli Horrors.
(7.3/10)
Diego Ballani
Arbe Garbe - Arbeit Garbeit (CPSR, Aprile
2011)
Genere: patchanka-free
Agropunk freenoise: gli Arbe Garbe abitano un limbo
che è solo loro, fatto di una musica eclettica à la Primus
mixata a una patchanka nomade e multilingue. Quasi
a unire dimensione popolare e concettualità ai confini
con l’avanguardia, in un suono insolitamente bandistico che macina ottoni, chitarre elettriche, batteria, accordion e chissà cos’altro.
Se il precedente The Great Prova - pubblicato in comproprietà con il chitarrista americano Eugene Chadbourne - era servito a istituzionalizzare agli occhi degli
ascoltatori più smaliziati una band che non sarebbe stato giusto confinare nel calderone del folk danzereccio
più generalista, questo Arbeit Garbeit sintetizza bene la
contemporaneità del gruppo. Fatta di un suono girovago ma anche di episodi trasversali e meno prevedibili (Il
volo della Paloma, Une Bugade Di Vint).
E’ in questa veste che li preferiamo, nonostante un giudizio sul disco complessivamente positivo.
(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Architecture in Helsinki - Moment Bends
(Modular, Aprile 2011)
Genere: Indie-Pop
Furbi gli Architecture In Helsinki a far uscire il nuovo
album alle porte della bella stagione: il suono già tradizionalmente solare del gruppo tradisce oggi ancora più
voglia d’estate. E’ una delle poche sfumature avvisabili
in una ricetta per lo più immutata dai tempi di quell’In
Case We Die che potremmo definire, se non capitale,
quantomeno importante nel definire il mondo indiepop nella sua accezione più colorata.
Nessuna svolta, insomma, e del resto sarebbe sciocco
55
pretenderne da un gruppo del genere, ma ancora una
manciata di brani divertenti (la corale Yr Go To, con tanto di campane, o la ballabilissima Escapee) e anche un
po’ di malinconia da tramonto sulla spiaggia (la dolce
W.O.W., la Desert Island che apre il disco in lieve levare).
Nella seconda metà della tracklist l’album, del resto,
mostra il fianco: Denial Style e Everything’s Blue suonano obiettivamente meno convinte, e come se non bastasse Sleep Talkin’ gioca col solito synth-pop anni ‘80
con I Know Deep Down a strizzare l’occhio agli Wham.
Per un gruppo che ha puntato tutto sulla centrifuga di
influenze piuttosto che sui rimandi diretti, questo è decisamente un difetto.
In definitiva Moment Bends è un disco dal fiato corto.
Un peccato dato che quel che c’è di buono funziona
davvero.
(6/10)
Simone Madrau
Austin Peralta - Endless Planets
(Brainfeeder, Febbraio 2011)
Genere: fusion
Giovanissimo astro del piano (un mentore d’eccezione
come Alan Pasqua, due dischi per la Sony/CBS pubblicati quando aveva appena 16 anni; sul primo suona
Ron Carter), Austin Peralta (1990) rappresenta una
sorta di contraltare USA alla funambolica giapponese
Hiromi Uheara (con la quale peraltro ha collaborato),
come lei con Chick Corea in testa e sulla punta delle
dita. Dopo session per gente del giro nuovo-afrofuturista come Erykah Badu e Shafiq Husayn (Sa-Ra),
esordisce adesso sulla Brainfeeder di Flying Lotus e
si capisce subito perché. Il ragazzo è cresciuto ascoltando quella fusion avanzata di cui lo stesso FlyLo si è
nutrito per Cosmogramma e una fusion di quelle che
fa perdere la testa agli hip hop-heads di nuova generazione - opportunamente immersa in un immaginario
spacey - restituisce.
Chiama l’amico Strangeloop a girare qualche cursore
e premere qualche pulsante lungo la tracklist, ma francamente l’intervento si sente poco; come pure passa
in secondo piano il cameo della Cinematic Orchestra.
Endless Planets è piuttosto lo showcase jazzistico di
Austin e dei suoi accompagnatori: Zane Musa-sax alto,
Ben Wendel-sax tenore e soprano, Hamilton Pricebasso, Zach Harmon-batteria. Si sente l’influenza di Hiromi in certi momenti, per esempio nel bel groove e
nel tema serpentino e accattivante di Capricornus; ma
manca quella freschezza alla fine funk/pop che riscatta
la giapponese dagli onanismi standard nel post-Corea.
In cui invece il biondissimo sguazza.
56
Austin non ci sembra insomma il visionario fusion di
cui parla FlyLo, ma un impeccabile (il disco è elegante,
suonato da dio, e ci mancherebbe) tecnico armato di
buon gusto. Puro stile e pura forma, l’album manca di
quella incisività che si deve pretendere oggi da chi ha
un pedigree come il suo. Non siamo tra quelli che pensano che la fusion sia roba vecchia e per vecchi, però
questo qui è proprio un disco conservatore.
(6.4/10)
Gabriele Marino
Babalot - Non sei più (Aiuola, Marzo 2011)
Genere: Indie, Italiana
Babalot è un piccolo progetto folle, iniziato in gruppo, con il punkpop lo-fi di Che succede quando uno
muore (2003) e proseguito in seconda battuta in veste
solista dal frontman Sebastiano Pupillo, con il malinconico e naif Un segno di vita (2005). Babalot, oggi, è di
nuovo una band, e torna per la fida Aiuola dischi - appunto aiuola felice per il bel pop nostrano - con Non
sei più.
Non si perde occasione, in ognuno di questi otto brani,
di ricordarci che non servono mai grandi mezzi per fare
qualcosa di rilevante e stratificato, con un buon numero di piani di interpretabilità. Non sei più, infatti, come
del resto gli episodi che lo hanno preceduto, non è solo
pop - autoironico, a tratti noir, glassato di electro da cameretta - ma nasconde, in una seconda battuta, una
buona dose di analisi folleggiante del nostro presente,
del nostro intimo più onirico, desiderante, spaventato.
Queste canzoni sono cavalcate pop, divise tra folk chitarra e voce, mood western e punk, a volte minimali,
talvolta in esplosione beatlesiana ma armate sempre e
comunque di intuizioni, anche e soprattutto nei testi,
irresistibili. Non una sola direzione ma mille sguardi:
da quello a Vinicio Capossela in Gattonero a quello,
persistente, all’Alessandro Fiori solista nello splendido incubo-sogno Andiamo a mare e ancora in Paperino
e Maggio. C’è tutta una nuova direzione cantautorale
di finto nonsense e genio travestito da follia, in questo
senso, il nome di Babalot, insieme a quello di Fiori e a
quello meno incisivo di Dino Fumaretto, è prospettiva
essenziale e pienamente riuscita.
(7.1/10)
Giulia Cavaliere
highlight
Colourmusic - My _____ Is Pink (Memphis Industries, Aprile 2011)
Genere: pop obliquo
La Colourmusic non è una novità. È l‘output di una coppia di amici che si conoscono dal college e che
metà dei Duemila, ormai, fanno musica ispirandosi a temi cromatici. My ____ is Pink esprime fino in
fondo l‘espressionismo timbrico di cui Ryan Hendrix, Nick Turner e compagni sono capaci.
Conoscevamo la band dai tempi quando apriva per Flaming Lips e British Sea Power qualche anno
fa. E proprio ai primi li accosteremmo per quella che ci sembra la caratteristica principale di Colourmusic, ovvero l‘approccio: un metodo che ha a
che fare con il recupero non revivalistico, l‘astrazione, la produzione. C‘è
molto Brian Eno che accompagna come meglio può gli U2, in My ____ is
Pink, ma si sentono parecchio anche le corde e le idee tese degli Wire (Jill
& Jack (A Duet)), e, facendo zoom out, una modalità di riapprocciare le cose
del passato che è molto vicino a quel periodo.
Da un lato My ____ is Pink è un disco pienamente post-00, fatto di un uso
dello studio, della stratificazione proprio dei nostri anni, persino di un‘anima collettiva (We Shall Wish (Use Your Adult Voice)); nel rosa c‘è però anche un tentativo di andare oltre,
passare allo step successivo riabbracciando, riprendendo in mano alcune cose che probabilmente dovremo riaffrontare nei prossimi anni: abbiamo detto Flaming Lips, ma anche Mercury Rev, e tutto quel
passaggio di inizio anni Novanta e quel tipo di psichedelia che, insieme al pop produttivo Achtung
Baby, la Colourmusic innesta sulla generazione Animal Collective.
Accade perciò che Dolphins & Unicorns sia un‘entità abbastanza strana, una ritmica che ci fa sentire i Novanta meno intellettuali ma anche un‘obliquità di questi anni, e che ancora una volta gode del lascito
del revival del post-punk quell‘assenza di rettitudine che è anche spirito di astrazione percussiva, acida
e sanguigna nel tempo stesso, nutrita della materia tipica dell‘indie rock: distorsioni di chitarra e basso
affiancate dalle batteria. Un altro esempio: la successione tra The Beast With Two Backs e la lunga The
Little Death (In Five Parts), dove si passa da un esercizio di decomposizione alla 154 a una traccia con
percussività - anche se non poliritmica - alla Mahjongg, con lunga coda di psichedelia cosmica.
Se ci abbiamo visto giusto, il rosa shocking della musica di Hendrix e Turner potrebbe diventare un
precedente nei prossimi anni.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Bachi Da Pietra/Massimo Volume - Split EP
(La Tempesta Dischi, Aprile 2011)
Genere: rock
Ce lo auspicavamo tempo fa accoppiandoli in un nostro speciale sull‘uso dell‘italiano nel rock. Poi quella
unione si è materializzata su un palco comune in occasione del tour di Cattive Abitudini e Quarzo. Ora è la
volta di una appendice discografica, nata proprio durante quel tour.
Questo split vinilico nasce infatti in accordo con La
Tempesta, il Circolo degli Artisti di Roma e il ravennate Bronson (dal cui deus ex machina Chris, sembra
sia partita l‘idea) e reitera la collaborazione sfruttando l‘abusata formula dello split con prestito di canzo-
ne. Sul lato A i bolognesi prendono la vibrante Morse
dall‘ultimo Quarzo e la ingentiliscono smussandone le
asperità “petrose” senza però perdere nulla della drammaticità originaria. Poi aggiungono un inedito, Un Altro
Domani, memore degli intrecci chitarristici che hanno
rappresentato il marchio di fabbrica dei Massimo Volume sin dagli esordi.
Dall‘altro lato il duo Dorella/Succi rende il favore con
una Litio, estratta da Cattive Abitudini, resa scheletrica
e nevroticamente rock, tutta spigoli e distorsioni, cui
si aggiunge l‘inedita Stige 11. Vera e propria sorpresa
del lotto, mostra i Bachi Da Pietra saturi e sconvolti,
aggressivi e dilanianti come mai li avevamo ascoltati
prima, in grado di cavalcare un mid-tempo rock incen57
diario con furore e padronanza. Cosa che ci fa ben sperare per futuri risvolti.
Una ottima sorpresa che neanche i fan più accaniti si
sarebbero aspettati.
(7/10)
Stefano Pifferi
Bancale - Frontiera (Ribéss Records,
Aprile 2011)
Genere: talkin’ noise
Frontiera è la linea di demarcazione tra l’incantesimo
del vivere e la consapevolezza del ciclo vitale. Forse
l’unico confine reale, perciò rimosso, simbolicamente
dissimulato in un ordito di codici e rituali che ne stemperano - ne equivocano - il senso. Che pure resta, come
un brontolio ai margini del frastuono. La morte quindi
- evento biologico, cronologico e culturale, ingranaggio e carburante di vita - è la nota dominante di questo
album di debutto dei Bancale, trio lombardo formato
nel 2006 dal “nostro” Luca Barachetti (voce) e dal chitarrista Alessandro Rossi, raggiunti poi dal percussionista
Fabrizio Colombi.
Già l’omonimo ep del 2009 ebbe modo di colpirci per
l’intensità dei reading immersi in ordigni noise-blues,
il “metodo” Massimo Volume portato ad un livello di
esasperazione inedito, tra vibrazioni terrigne e visioni febbrili che semmai scomodavano punti di contatto coi Bachi Da Pietra. In occasione del presente full
lenght di debutto, quella calligrafia compie un significativo balzo in avanti, alza la temperatura dell’ossessione blues fino al delirio controllato del post (echi palpabili For Carnation) accogliendo turbamenti slow-core
(tipo dei Codeine scorticati) aprendosi poi a suggestive ancorché livide palpitazioni folk (dalla pregnante
afflizione Will Oldham/Jason Molina).
E’ tangibile il contributo di Xabier Iriondo, che del
disco è produttore artistico: cartigli scabri di chitarra,
elettroniche frastagliate, insomma la tipica calligrafia
disturbante messa al servizio del sound, che arricchisce senza prevaricare. Tra i dieci episodi in scaletta,
spiccano Megattera col suo ondeggiare tumultuoso,
l’impeto sanguigno di Calolzio, la struggente inquietudine di Suonatore cielo e la torbida trepidazione della
title-track. Una bella conferma.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Basement Freaks - Something Freaky
(Jalapeno, Febbraio 2011)
Genere: disco funk
Quando, ad inizio 2010, venne alla luce la hit Disco Life,
58
era difficile immaginare che il nuovo corso di George
“Basement Freaks” Fotiadis potesse avere una portata
così ampia. L’orientamento nu-funk l’avevamo sì scoperto nell’esordio di Urban Jungle ma, da allora ad oggi,
lo scarto è notevole: Something Freaky fa finalmente
esplodere le micce groove del talento greco coniugando classicità e nuove espressioni.
Il punto di partenza è il funk delle origini: James Brown
(già remixato da Fotiadis in Mind Power, un paio d’anni
addietro) e chitarrine frizzanti annesse, ma anche i filmacci di serie B della blaxploitation anni ‘70, il vocoder
pop, la mutant disco e Prince. Niente che non possa
attecchire con una certa facilità nei nostalgici giorni
d’oggi, tanto più che la mistura si porta dietro tutto ciò
che è intercorso nel frattempo: tra il big beat evoluto a
partire dai Groove Armada più radiofonici (Get Down
Boogie), la nu-disco irriverente di Calvin Harris (Get Ready) e il p-funk targato DFA sullo sfondo; si aggiungono, impietosi generosi affondi electro (Makes Me Wanna Scream), afro-funk da corrida (Ade Bantu in Make
Money) e, perché no, lo stile canoro di un Justin Timberlake sempre più sdoganato (Something Freaky).
Il troppo stroppia, ma c’è sempre l’eccezione...
(6.8/10)
li violino e flauto: tutto è organizzato alla perfezione,
come se la musica fosse la colonna sonora di un film
la cui trama è enunciata nelle liriche, sempre ispiratissime. A mettere il punto su queste progressioni interviene dunque il quasi-funk di America!, all’insegna di
un groove pressochè costante ma disturbato da riff di
chitarra che sporcano tutto come nelle migliori pagine
dell’indie-rock anni 90: è l’apice del disco, già ora tra i
brani più eccitanti del 2011.
La seconda metà dell’album è al contrario più pacata
e regala un altro gioiello, Riding For The Feeling, ballata di rara suggestione emotiva che al solito fa scattare
l’inevitabile paragone tra il nostro e Kurt Wagner dei
Lambchop. Appena inferiori sono invece i nove minuti
della conclusiva One Fine Morning che, lavorando appena di più sulla melodia, non avrebbe sfigurato fra i
cataloghi di Nick Drake o Tim Buckley.
Apocalypse è un’uscita che magari verrà sottovalutata, complice l’anzianità sulle scene del suo autore in
contrapposizione al sempre più frenetico sbocciare di
gruppi nuovi: non credete agli hype, qui c’è un musicista che non solo non molla la presa ma si ripresenta in
uno stato di forma invidiabile.
(7.4/10)
Carlo Affatigato
Simone Madrau
Bill Callahan - Apocalypse (Drag City,
Aprile 2011)
Genere: Folk
Birds Of Passage - Without The World
(Denovali, Aprile 2011)
Genere: drone intimistico
Le ultime due prove di Bill Callahan, solari e decisamente più composte, vedevano l’autore noto come
Smog abbandonare le radici lo-fi che ne avevano fatto un nome di culto nel decennio precedente: ne risultavano brani meglio confezionati in cui tuttavia la
maggior pulizia del suono sembrava tenere a freno
estro e ispirazione. Oggi Bill è appena più introverso e
cupo ma non così tanto da giustificare un titolo come
Apocalypse, scelto invece per raccogliere sette nuove
canzoni che di catastrofico hanno nulla e che si fanno
apprezzare per qualità ancor prima che per atmosfere.
Piacerebbe evitare il solito elenco, giudicare invece
il disco nel suo complesso ed elogiarlo per la sua ormai usuale raffinatezza, ma sarebbe un peccato tacere
dell’incedere dritto e solenne delle chitarre che portano a trionfo la timbrica inconfondibile del nostro in
Drover, così come non si può non menzionare i singulti
delle stesse in Baby’s Breath: è un dittico di apertura in
cui subito traspare il consueto gran gusto nel pensare
canzoni come fossero suite. I crescendo, gli stacchi, le
accelerazioni improvvise, i cambi di tempo, l’efficacia
di elementi solo apparentemente di contorno qua-
Memorie personali, particolari e sfuggevoli atmosfere,
brevi attimi di una vita, tutto ciò che può contenere l’album di ricordi che ognuno di noi conserva dentro sé.
Di questa impalpabilità è fatta la musica di Alicia Merz,
la responsabile unica dietro la sigla Birds of Passage:
un diario segreto fatto da collage di ritagli dalla propria
intimità tenuti insieme dall’esilità di atmosfere plumbee dove soundscape e microdroni richiamano alla
mente voci lontane e spettrali dal passato.
Un lavoro altamente introspettivo, a tal punto da risultare inestricabile e inesplicabile per chiunque fatta
eccezione per la sua autrice. Senza la maestria necessaria per creare empatia nell’ascoltatore nella messa in
scena del proprio microcosmo - si prenda ad esempio
l’ultima uscita di casa Six Organs Of Admittance - Without The World risulta piatto e privo di una carica emotiva, fallendo proprio là dove avrebbe dovuto colpire.
Invece che suscitare sentimenti ed emozioni produce
un’assenza di esse, uno stato di torpore generalizzato
che si riverbera anche sul giudizio finale.
(5/10)
Black Devil Disco Club - Circus (Lo
Recordings, Aprile 2011)
Genere: disco electro
Bernard Fevre chiama a raccolta una serie di nomi di
richiamo: Jon Spencer, Faris Badwan degli Horrors,
Michael Lovett, addirittura Nancy Sinatra e Afrika
Bambaataa. Ma la sua miscela disco, qui pesantemente virata electro, appare fiacca ed impacciata come non
mai. Non mancano momenti godibili (She Flees The Silence) o singoli dettagli interessanti, ma in generale,
dall’iniziale Fuzzy Dream (un motivetto infiorettato da
percussioni) alla conclusiva Magnetic Devil (uno stereotipo portato alla noia), è tutta la stessa marmellata di
sottofondo, trasparente, inoffensiva. Anzi no, a tratti
anche irritante.
(5/10)
Gabriele Marino
Blessed Child Opera - Fifth (Seahorse
Recordings, Marzo 2011)
Genere: folk-wave
Quel che spicca della produzione di Paolo Messere a
nome Blessed Child Opera - perché ormai di progetto
solista si parla, pur con tutta una costellazione di collaboratori che orbita attorno al padrone di casa - è la
qualità media. Nessun disco che sembri un vezzo gratuito del musicista-produttore napoletano e tutti a fare
bella mostra di una poetica che lavora da sempre sulle
atmosfere, sui colori, sulla personalità del suono. Fifth
decide che è venuto il momento del folk, con dodici
brani in gran parte acustici contaminati da quella componente wave analogica e decadente che ormai è un
marchio di fabbrica di Messere. Tra il crooning di Never
To Return On Your Steps e una Falling che ricorda i Tindersticks, il mood ombroso di Reflection After Nothing
e gli archi di Between Us, la voce e chitarra di Lonely
Friend e gli accenni free di Promised Circle.
Alla fine la cifra stilistica dei Blessed Child Opera è anche il limite maggiore del progetto, se di limite si può
parlare. Nel senso che da un disco di Paolo Messere
sai quasi sempre cosa aspettarti e alla resa dei conti
quell’eleganza impeccabile che ci trovi dentro fa un po’
la figura del diamante in vetrina: brillante, prezioso, ricercato ma indirettamente anche autoreferenziale nel
suo involontario ruolo di status symbol.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Francesco Asti
59
Blow Monkeys (The) - Staring At The Sea
(Fod, Aprile 2011)
Genere: folk soul pop
Tornati sorprendentemente nel 2008 con Devil’s Tavern, dopo un silenzio durato quasi vent’anni, i Blow
Monkeys ribadiscono oggi il rinnovato estro col settimo album Staring At the Sea. Val bene ricordare ad uso
dei più giovani che questo quartetto inglese conobbe
qualche anno di celebrità effervescente nella seconda
metà degli Eighties, quando si svincolarono dalla matrice new wave per prodigarsi in un funk-pop-soul arguto e satinato piuttosto affine a quello dei coevi Style
Council, sposando infine la causa di una dance tutta
spigoli e raffinatezza che non sopravvisse al sopraggiungere dei Novanta. Riferiamo della carriera solista
del leader Bruce Robert Howard - meglio noto come
Dr. Robert - giusto per inquadrarne le sempre più
spiccate aperture folk, palpabili in queste undici nuove
tracce, in prevalenza ballate con una certa attitudine
per l’epica accorata di stampo Paul Weller (vedi quel
che accade in Face In The Rock e The Killing Breeze).
I nostalgici di mezza età troveranno motivi per sgranchire le giunture con Seventh Day e col northern soul
dell’iniziale Steppin’ Down, mentre una One Of Us Is
Lying riesce persino a sprimacciare gradevoli rimembranze rocksteady. Una malinconica ricercatezza pervade gli arrangiamenti orchestrali di All Blown Down, la
morbida declinazione flamenco della title track e una
Prayin’ For Rain che addita trepidazioni gospel e country-blues con solennità persino eccessiva. Fa meglio la
conclusiva A Lasting Joy, che azzecca un ibrido folksoul con aspersioni cameristiche come potrebbe un liberi di stupirvi - Tim Hardin in fregola Terry Callier.
L’impressione complessiva gradevole, anche se a ben
vedere non si va oltre una onesta, sentita competenza.
(6.5/10)
Stefano Solventi
Blue Van (The) - Love Shot (Iceberg
Records, Aprile 2011)
Genere: Garage pop
Fa impressione vedere l’assoluto sincronismo con cui
tanti rock act emersi nella prima parte del decennio
scorso, ai tempi in cui NME sbandierava l’assurdo tag di
New Rock Revolution, abbiano assecondato la rivincita
dei synth sulle chitarre, introducendo elementi electro
pop nel proprio sound.
Nel caso del nuovo lavoro dei Blue Van, band danese
che aveva suscitato un certo interesse ai tempi dell’esordio hard garagistico, la cosa è evidente sin dalle prime
note. Nell’opener Mama’s Boy, i sostenuti accordi sinte60
tici fanno le veci di quella che in altri momenti sarebbe
stata una chitarra ritmica.
E’ pop che usa la sintassi del rock, ma dai connotati inevitabilmente contraffatti ed edulcorati. Una volta preso
atto di ciò ci si può lasciare andare alla sfacciataggine
glam della title track, ai Led Zeppelin manierati di Hole
In The Ground o al Marc Bolan cromato e sculettante di
Run To The Sun.
Il ritornello killer è sempre dietro l’angolo, talvolta più
sinuoso e sofisticato (è il caso del godibilissimo power
pop di Evil), talaltra di grana decisamente più grossa.
Un sound con mascara e lustrini che punta alle grande
platee, ma si accontenta di finire nella colonna sonora
di qualche telefilm adolescenziale, come già è accaduto a diversi brani dei loro precedenti lavori.
Si batte piacevolmente il piedino per tutto il tempo
della sua durata, ma ci se ne dimentica alla velocità
della luce una volta che la musica è finita.
(6/10)
Diego Ballani
Bob Corn - The Watermelon Dream
(Fooltribe, Febbraio 2011)
Genere: folk
Nel mito del “buon selvaggio” Bob Corn ci ha sempre
sguazzato, col suo folk della porta accanto metafora
barbuta e sorridente di un’epopea instancabile fatta di
mille strade percorse. Un hobo voce e chitarra disperso nel tempo, lontano dalla comunicazione capillare di
un’epoca aliena e irrispettosa di quella madre terra da
cui invece parte tutta la sua musica. Non possiamo dargli torto, visti i frutti raccolti fin dagli esordi in termini
di consensi e attestati di stima. Sull’onda emotiva di dischi che pur non discostandosi molto l’uno dall’altro, di
quella umanità istintiva sono sempre stati una fedele
rappresentazione. Oltre che un prodotto perfettamente in linea con l’indie lillipuziano (nei mezzi, non nelle
aspirazioni) di casa nostra.
The Watermelon Dream è l’ennesimo tassello del Tiziano Sgarbi/Bob Corn pensiero: cantore rurale e quasi
drakeiano (You The Rainbow, Call Me My Name ), bluesman ad libitum (Lost & Found), insospettabile amante
di un gospel solitario e intimo (Love turns around (Don’t
look back)). Impegnato a districarsi da una ragnatela di
fragili equilibri che dosa con cura particolari e accenti,
sottolineando l’estrema sensibilità di un artista da sempre ripiegato su sé stesso.
(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
highlight
Dennis Coffey - Dennis Coffey (Strut Records, Aprile 2011)
Genere: ultra-funk
Quando si dice “venie da lontano per arrivare lontano”: Dennis Coffey è una leggenda di Detroit che,
tra i tanti, ha prestato la sua fumigante sei corde ai Funkadelic, ai Temptations della svolta acid-soul e
all‘Edwin Starr di War. Se aggiungete che ricoprì un ruolo chiave nell‘introdurre l‘uso del wah-wah “pesante” nel soul e nell‘r&b di fine dei ‘60 e che lungo il decennio successivo si
dava alla blaxploitation e alla produzione con Mike Theodore, sapete cosa
attendervi da un suo nuovo disco.
Da un lato, cosmico però tellurico hard-fuzz (ben esemplificato nell‘apertura di 7th Galaxy come nelle successive Knockabout - roba da Big Chief,
per chi li ricorda
- e Space Traveller) straripante della funkitudine di George
Clinton e Jimi Hendrix; dall‘altro, una souledelia robusta e sferzante odorosa di scenari urbani seventies che dici attualissimi. Nessuna forzatura o
pretesa di attualità, ma competenza in materia e passione che mostrano
uno stile mai invecchiato, che sottolineano la differenza tra datato e databile poggiando salde su ospiti
che ruotano attorno alla “Detroit connection” contemporanea.
Ha così una logica perfettamente compiuta che la stella di casa Stones Throw Mayer Hawthorne si
misuri da campione con il classico dei Parliament All Your Goodies Are Gone e Mick Collins dei Dirtbombs si unisca a Rachel Nagy (Detroit Cobras) per l‘oscuro martellamento Funkadelic di I Bet You.
Oppure che Fanny Franklin degli Orgone rispolveri la possente Don‘t Knock My Love appartenuta a
Wilson Pickett e Lisa Kekaula dei Bellrays guidi l‘esaltante cavalcata Somebody‘s Been Sleeping. Persino
una nullità come Paolo Nutini convince alle prese con Only Good For Conversation del “culto” Rodriguez: merito sempre dell‘esperienza e dell‘energia profuse nell‘operazione, della quale beneficiano
anche i Kings Go Forth della ribollente Miss Millie. Come insegna Maestro Clinton, liberate il posteriore
e la mente lo seguirà. A spaccarveli entrambi provvederà questo disco.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
Bodi Bill - What? (Sinbus, Aprile 2011)
Genere: Electro, Indie-Rock
Al contrario di quanto l’opinabile ragione sociale potrebbe far credere, i tedeschi Bodi Bill rientrano in
quella schiera di gruppi magari eternamente minori
ma interessanti per il modo in cui padroneggiano e mescolano le sonorità del loro tempo. Sarebbe facile liquidare la faccenda dicendo di un perfetto equilibrio tra le
claustrofobie degli Xx e gli ampi respiri dei White Lies:
tale è del resto l’effetto che suscita la Paper in apertura
di questo terzo lavoro. Invece col proseguire dell’ascolto si esce sempre più dai binari all’inseguimento di un
suono via via meno identificabile, e già con Pyramiding
le orecchie si drizzano davvero: certi echi tenebrosi
fanno pensare a un Burial con gli steroidi ma lungo il
finale le origini kraute dei nostri emergono in pieno,
ed ecco omaggiati insieme tanto i Kraftwerk quanto
i Notwist.
Non è tutto, anzi: benchè l’elettronica rimanga l’ele-
mento chiave del progetto, è quando quest’ultima
diviene comprimaria al pari degli altri strumenti che
il gruppo fa uscire i frutti migliori. Parla chiaro la title
track che non dispiacerebbe a Twin Shadow o ancor
di più l’ottima The Net, che incrocia beats e pianoforte
su una melodia epico-decadente in perfetta continuità
con quelle dei vari David Bowie e Placebo: peccato
solo sentirla scorrere via così veloce, anzichè dilatata
allo stremo come meriterebbe. Il tiro si rialza poi con
i tunnel electro di Hotel, nobilitati da un cameo breve
ma eccellente firmato Fever Ray, e con una Friends che
paga tributo ai Depeche Mode, sfocia in una brillante
coda di synth e lascia posto a una ghost track senza
voce, che chiude le danze anche in senso letterale.
Di What? piacciono le intenzioni, l’approccio ‘intelligente’ alla materia electro, il buon gusto che caratterizza il progetto, l’innegabile creatività e la voglia di osare.
Purtroppo il gioco del rifuggire la melodia ad effetto
per inseguire l’idea spiazzante non funziona sempre, e
61
viceversa il gruppo appare più abile a padroneggiare i
brani con una struttura definita piuttosto che quelli in
cui spariglia le carte. Ma questo influisce poco sul giudizio finale.
(7.1/10)
Simone Madrau
BvDub - Tribes at the Temple of Silence
(Home Normal, Febbraio 2011)
Genere: ambient, techno-dub
Se ci sono musicisti che dalla techno passano all‘ambient senza ritorno - vedi Tim Hecker - ce ne sono altri che partono proprio dalle ultime conquiste in fatto
di sintesi ambientali (drone, chamber, shoegaze, neo
classical) per riconsegnarle nuovamente al ritmo.
Lo abbiamo visto con Pantha Du Prince (anche se lì il
discorso era più eclettico e pop) e lo vediamo nell’austero Brock Van Wey, un americano trapiantato in Cina
non proprio di primo pelo (è un ‘74).
Finora la sua carriera è oscillata tra ambient techno
come discorso d‘ambienti (su Echospace, la sua Quietus
e l‘italiana Glacial Movements) e incursioni in zona dancefloor a bpm rallentati (per Meanwhile e la blasonata
Kompakt). Dopo il successo di critica di The Art Of Dying
Alone - un album sirena fatto di droni per non droneisti - il musicista ha deciso d’insistere su quest’ultimi,
proponendosi come una sorta di William Basinski
post-techno, senza tape loop e effetti vintage.
Tribes at the Temple of Silence amplia lo spettro d’indagine rispetto alla pretenziosa prova precedente, ma i
risultati, anche questa volta, deludono. Mentre Morning Rituals, unico brano in cassa, pasticcia tra folate
ambient e deep house, The Past Disappears mostra tutti
i limiti del caso: Wey non è Emanuele Errante e né qui
né da altre parti riesce a mixare la matrice drone agli ingredienti aggiunti all’intingolo - che siano essi soulfull
vocali, shoegaze o etno new age. Una prova fallita.
(4.7/10)
Edoardo Bridda
Caparezza - Il sogno eretico (Universal,
Marzo 2011)
Genere: crossover pop / rap
Il sogno eretico è forse il più esplicito e “agit-prop” tra i
dischi del riccio capelluto: i testi sono più didascalici, il
rappato meno funambolico, quindi più intellegibile (lui
è al solito bravissimo a costruire le rime). La parte musicale, con giusto un paio di eccezioni, è colorata ma insipida come sempre e più che mai. Nessun dorma, dice
Capa, perché il sonno della ragione genera mostri (si vedano la copertina e l’interno di copertina in stile Char62
les Burns - il fumettista americano, non il personaggio
dei Simpson - opera di Squez) e oggi è sicuramente più
pornografico pensare con la propria testa che sfogliare
le riviste zozze.
Dopo un siparietto un po’ alla Elio, in romanesco, Michele/Capa se la piglia con il mercato discografico e
con le riviste, con la scena hip hop che lo dissa (non li
cita, ma si riferisce a Fabri Fibra e Bassi Maestro) e con i
social network (Chi se ne frega della musica). Rockettino
hard alla Kashmir, tra una intro in vocoder e un insertino reggae, contro l’ingenuità di chi non si preoccupa di
verificare le “verità supposte” che gli vengono propinate dall’alto (Il dito medio di Galileo). Intro alla Chieftains
e riffettini funky/Pink Floyd per parlare di Giordano
Bruno e di altri martiri eretici messi a tacere (Sono il tuo
sogno eretico). In forma di quiz, ecco i controsensi del
sistema Italia (Cose che non capisco); l’Italia della fuga
dei cervelli e con un futuro sempre più arido davanti a
sé protagonista dell’hit single Goodbye Malinconia, con
il bel refrain retroKitsch cantato da Tony Hadley degli
Spandau Ballet.
Rockettino anni Cinquanta per il qualunquismo e i bassistinti del popolino, messo a paragone con lo stereotipico mondo disneyano (La marchetta di Popolino). Discopop da boyband per parlare dell’ecologismo (La fine
di Gaia). Ma non siamo al sicuro neppure dentro casa:
attenzione agli incidenti domestici e ai pericoli anche
psicologici che si annidano tra le quattro mura (House
credibility). Musica hollywoodiana alla Mission Impossible per il mega-spoilerone intestato a Kevin Spacey (e
ispirato probabilmente a un famoso video che gira sul
Tubo). Divertente, come la successiva tirata anti-Berlusca, spammatissima su Facebook, che non propone
tanto di legalizzare “la maria” (e parte subito il reggae),
quanto piuttosto di ratificare la già avvenuta legalizzazione del premier, a cui tutto si perdona e si perdonerà
(Legalize the Premier). Bel riff punk-rock/hard per lo sfogo di Dio, che si lamenta del tartassamento quotidiano
che subisce dall’uomo (Messa in moto). Mood epico nel
compitino da bravo allievo di Frankie-Hi-Nrg contro i
politici e lo Stato che ci ritroviamo (Non siete Stato voi)
e intro epic metal - e a seguire il solito rockettino caparezziano - per dire ancora una volta viva la rivoluzione
(ancora Frankie a modello, quello di Sanremo 2008) e
bacchettare una opposizione addormentata incapace
di proporsi come vera alternativa (La ghigliottina).
Un po’ di vera grinta musicale, finalmente, arriva proprio in chiusura (Ti sorrido mentre affogo): un incalzante
post-hardcore in salsa proggie - con inserti di tastierine
videogame alla Squarepusher - per dire che a Capa non
interessa più di tanto essere capito; lui vuole semplice-
mente dire quello che pensa e continuare per la propria strada. Noi non ci crediamo ma, viste le premesse,
ci accontentiamo.
(5.6/10)
Gabriele Marino
Capillary Action - Capsized (Natural
Selection, Aprile 2011)
Genere: avant-pop
Non è male la metafora dei vasi comunicanti, che dà il
nome ai Capillary Action. È un buon modo per descrivere la necessità di equilibrio - costantemente disattesa e comunque ricercata - tra gli elementi che compongono chimicamente il sound del quintetto di musicisti
statunitense.
Il principale tassello dell‘identità superficiale espressa
in Capsized, più che la cultura del crossover a tutti i
costi che permeava Fragments e So Embarrassing, è
l‘esecuzione cameristica delle partiture, fuori dal tempo
nel pop, anche se avant. È l‘anima della strumentazione classica, unicamente acustica, che allestisce colpi di
scena cinematici alla The Prisoner. Ma è solo uno degli
universi dentro cui si muovono i Capillary Action. C‘è la
vocalità eccessiva, che ce li fa immaginare “ambientati”
al Cabaret Voltaire di Zurigo. E poi, come una sorpresa
- ma neanche troppo imprevista - fioccano i poliritmi
tropicali di Feeding Frenzy e Tenderloin, che sono un po‘
una marcia di Odradek - o spiriti maligni - che li accompagnano sulla cattiva strada.
Tutti mondi che stanno insieme a forza, come una via
di mezzo barocca tra Hella e Parenthetical Girls, via
Dead Science - specialmente per le scelte vocali. Si arriva a tanto così dalla stucchevolezza, che però - e qui
sta la bravura - Jonathan Pfeffer e soci sventano, grazie
appunto alla comunicazione tra vasi, che dosa i passaggi e modifica a gran velocità tonalità e umori. Esemplare la metamorfosi interna alla finale Life of Luxury,
microcosmo che come in un frattale riflette l‘insieme.
In realtà, dietro all‘apparenza si nasconde il precedente dei Red Crayola di Mayo Thompson (periodo postSettanta), che sembra il compositore ex machina delle
musiche. Sarà grazie all‘educazione che ci ha impartito
l‘ex collaboratore dei Pere Ubu che Capsized, da disco
certamente estenuante, faticoso, ci risulta infine avvincente. Chi ha la passione e tempo per le stranezze si
affezionerà. Chi non ha pazienza, uscirà pazzo.
(7.1/10)
Gaspare Caliri
Casa del mirto - 1979 (Mashhh!, Marzo
2011)
Genere: glo-fi downtempo
Questione di ghiribizzi mnemonici, mostriciattoli struggenti usciti dal vaso di Pandora dei ricordi. Cortometraggi sgranati e sovraesposti, i colori dileguati come
sogni dietro le palpebre. Tu chiamalo, se vuoi, glo-fi.
Nessuna ricetta, semmai una disposizione dell’anima. Marco Ricci, ad esempio, conduce su tali sentieri
la sua idea chiamata Casa Del Mirto, già sugli scaffali
lo scorso anno con l’apprezzato The Eternal EP, cui fa
seguito oggi l’esordio lungo 1979, dodici fatamorgane che restituiscono imprinting anni Ottanta (versante synth-pop, electro-soul e italo disco) inseminato di
suggestioni ambient, chill-out e downtempo. Del tipo:
i Pet Shop Boys opacizzati Boards Of Canada, gli Imagination sinterizzati Royksopp, Mike Francis glassato
Toro Y Moi, tanto per dire e via discorrendo.
Niente formule, non uno stradario da seguire, solo un
pescare tra palpiti e retaggi, secondo gli stimoli e gli
inneschi. Tra cui distingui omaggi sfacciati quali l’incipit di Thriller in Fairy Tales For Moonwalkers o inusitate
somiglianze come quella Pain In My Hands che ammicca (eufemismo) Daydream degli Smashing Pumpkins.
Tanto vale prendere atto, che ad ognuno toccano scorie di vita imponderabili, e quindi lasciarsi cullare dalla
risacca dance bradipa e pastellata spacey di The Haste
e Killer Haze, dai cromatismi guizzanti di White Chapel,
dall’ipnotica giocheria di The Right Way.
Si segnala la contemporanea uscita (digitale e vinilica)
di 1979 Remixed, che vede calibri sparsi come Populous, Brothertiger, Luminodisco e Death In Plains
manipolare in varie salse (post-punk, house, ambient,
afro...) il suddetto programmino.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Caso - Tutti Dicono Guardiamo Avanti (Que
Suerte!, Febbraio 2011)
Genere: Folk, Pop
Accompagnato da chitarra, armonica e nient’altro, Andrea Casali, alias Caso, affina in questo secondo lavoro
qualche urgenza punk-rock in favore di un approccio
appena più folk ma non alza il tiro di un Dieci Tracce che
già poneva basi interessanti. Co-prodotto e distribuito
da ben quattro indie-labels (Que Suerte!, Klasproduction, In Limine, Fiumaio) Tutti Dicono Guardiamo Avanti
si candida come prima e più di prima ad essere il vero
tra palco e realtà, un abbattere steccati tra musicisti e
persone, un proporsi come diario di uno spettatore di
concerti ancor prima di uno che sui palchi ci suona: con
63
highlight
Cass McCombs - Wit’s End (Domino, Marzo
2011)
Genere: folk rock
Egyptrixx - Bible Eyes (Night Slugs, Marzo 2011)
Genere: UK continuum
Nel marasma delle etichette di dance UK / wonky / bass o derivativi del continuum sempre più sdoganato verso il dancefloor, la Night Slugs è una delle next big thing da tenere appuntate sul bloc notes,
allo stesso livello di LuckyMe e delle visioni di Joy Orbison (che prima o poi pubblicherà il suo tanto
atteso esordio). Dopo l‘uscita di una compilation che fa il verso alle storiche Allstars della Tempa (Night
Slugs Allstars Volume 1, uscita qualche mese fa) con nomi di giovani DJ
come Mosca, L-Vis, Girl Unit, Bok Bok e molti altri nerd dell‘ibridazione
dance, oggi esce il primo full di uno dei vermi notturni di punta.
Il produttore di Toronto David Psutka ci va di stupore e di positività off-balearic. Egyptrixx riesce a formulare un suono fresco, hi-fi di qualità per ballare col sorriso e per una volta si toglie di dosso l‘oscurità di molte derive
dark del nuum, approdando a una visione futuristico-spacey che definisce un prima e un dopo senza sbavature, puntando sul lato più techy della
questione. La nuova musica dance targata UK può quindi partire da qui,
una sensazione che avevamo già sentito con qualche compilation su Soul Jazz e su Fabric, rivisitando
i padrini Autechre meno austeri, scompaginando le carte del cut-and-paste e inserendo variazioni sul
tema bbreaking che in pezzi come Liberation Front, Naples e Recital coniugano le anime della minimal
con la melodia e la spazializzazione illuminata. In più, con la bella voce di Trust in Chrysalis Records e in
Fuji Cub, c‘è pure qualche puntatina per la sperimentazione in odore di trip-hop stralunato e fumoso.
Riparte da qui ancora una volta il baraccone del continuum. Una teoria che dopo quasi vent‘anni sta
ancora in piedi e che non teme scossoni. Egyptrixx sostiene le colonne della main room. Uno dei nomi
su cui puntare per il prossimo futuro.
(7.5/10)
Marco Braggion
Due anni fa Catacombs raffreddò gli entusiasmi di chi
scorgeva in Cass McCombs prospettive importanti in
chiave pop-rock cantautorale. La fiamma sembrava
smorzata, girava a vuoto attorno a poche idee neanche troppo lucide. Il nuovo lavoro Wit’s End, ahinoi, non
smentisce quella china discendente, fornendo semmai
ulteriori motivi di rammarico. Il primo e principale arriva fin dall’iniziale County Line, punta di diamante del
programma e mirabile esempio di equilibrio tra effluvi country rock Harry Nilsson, languori obliqui John
Lennon e fatamorgane inquiete Elliott Smith, il tutto
imbevuto di piacevolissimi umori soul e particelle Kinks depotenziate. Un piccolo grande prodigio che non
trova però riscontro nel resto della scaletta, composta
perlopiù da teatrini più dimessi che estatici, all’insegna
di melodie che cincischiano su scale in minore col piglio smorto di chi non riesce ad azzeccare il giusto grado di malinconia.
Ossessioni senza nerbo (Buried Alive), lungaggini ingiustificate (A Knock Upon the Door) ed incantesimi posticci (The Lonely Doll) sono le note storte che il sobrio
tepore degli arrangiamenti non è in grado di assolvere.
Alla fine ti sembra il fratellino apatico di Ryan Adams o
- se preferite - un cuginastro depresso di Badly Drawn
Boy. Peccato.
(5.7/10)
Stefano Solventi
le macchinate, gli amici, le storie e tutto il resto. Emozioni dirette, insomma, con impennate di rilievo già al
volgere della seconda traccia, una Fiato Corto che in
mano a gente più blasonata sarebbe già hit da canzoniere italiano anni 10.
A fare da cornice per questi quadretti di vita vissuta è
un songwriting dolceamaro e una strenua ricerca di
identificazione con chi può capire, condividere e dunque cantare a sua volta. Suona disilluso, Andrea, amaro
(‘le frasi migliori che penso le dicono gli altri’, afferma
in Balena Bianca) ma sempre meravigliosamente autoironico e in qualche misura positivo: quanto basta da
far sorridere il suo ancora piccolo ma affezionato pubblico, anche quando da ridere non ci sarebbe. Nessuna
sparata universale nell’opera del nostro, al massimo
qualche dichiarazione di indi(e)pendenza, urlata ma
udibile solo fra quelli che se la cantano e se la suonano
(Hopper): lo sfondo è quello messo per inciso più avanti in Aranciata Amara ovvero la lotta forse ingenua ma
ostinata contro dei mulini a vento chiamati di volta in
volta gestori di locali o vicinato, dove la facile retorica
64
viene schivata mescolando il punto di vista con l’esperienza personale.
C’è lo stesso calore dei racconti della sera prima in queste canzoni, le confidenze di una persona che si racconta per come è, messe in note con capacità ma pur
sempre esposte da uno che potrebbe essere il nostro
vicino di casa o il nostro migliore amico; è quest’ultima
la miglior qualità di Caso, ciò che crea davvero lo scarto
con certi big names del nuovo cantautorato italiano.
Uno scarto che non è sinonimo di confronto, ma di differenza: in termini di stile, di percorso e inevitabimente
anche di successo. Se poi i singalong di massa arriveranno, bene; ora come ora c’è una conferma per quanti
già conoscevano, e un secondo motivo di curiosità per
tutti gli altri.
(7/10)
Simone Madrau
Citizen Fish - Goods (Alternative
Tentacles, Aprile 2011)
Genere: ska-punk
Immaginario e sonorità non possono che essere quelle
care a Jello Biafra e alla sua Alternative Tentacles. Copertina in modalità collage (alimenti di base ridotti a
merci a simboleggiare trust, friends, beauty, love, truth,
ecc.), booklet in b/n in stile crassiano, sonorità punk virate verso lo ska, testi arguti e anti-consumismo.
Una vera e propria manna per mr. Eric Reed Boucher,
noto ai più come Jello Biafra, integerrimo nel proseguire la storia della sua Alternative Tentacles a suon
di true punk e militanza estrema. Questi Citizen Fish
sono dunque allievi ideali, nonostante siano un combo
sulla breccia da anni. provenienti da Bath (UK) e con in
formazione alcuni personaggi dello storico giro inarcopunk targato Subhumans. Goods, nonostante l‘impegno del sestetto, rimane ancorato ad un mondo, quello
dello ska-punk, ormai quasi reazionario nel suo rimanere circoscritto in un perimetro di invariabile ripetiti-
vità. Coinvolgente, ben suonato, arrabbiato il giusto e
divertente con giudizio, ma troppo datato e fermo su
se stesso, al punto che non è più neanche il caso di dire
che sia “just for fun”. Sorry.
(5.5/10)
Stefano Pifferi
Cold Cave - Cherish The Light Years
(Matador, Aprile 2011)
Genere: Synth pop
Se ve li ricordavate artefici di un synth pop primitivo,
oasi digitale all’interno dell’arcipelago lo-fi newyorkese, sappiate che questa volta Wesley Eisold ha deciso di
dare una sferzata al proprio algido sound.
Per annunciarlo ha scelto il barbarico grido di The Great Pan Is Dead: un inferno di chitarre in loop, ritmiche
squadrate, un cantato emotivamente destabilizzante e
tastiere che aprono distese infinite. Un’approccio più
diretto, sicuramente più rock e meno claustrofobico rispetto al recente passato, che mette definitivamente
da parte l’immagine dei Cold Cave come sperimentatori, figli di un’era paleo tecnologica.
Non che l’electro wave di brani come Confetti o Icons
Of Summer abbia spostato di molti anni in avanti il loro
revivalismo. E’ come se il progetto fosse approdato
all’alba del technopop. Il 1981 è l’anno di riferimento: il
romanticismo dei New Order e la fisicità degli Human
League, con un Weisold che, indossati i panni del frontman a tempo pieno, sembra sempre più simile ad una
versione espressionista di Phil Oakey.
Con Pacing The The Church, scorrazzano pericolosamente nei territori di quella pop wave che ha fatto
la fortuna degli Editors. Ne scampano grazie ad una
produzione ruspante che, seppur lontana dal minimalismo degli esordi, evita la pomposità di Tom Smith e
compagni.
Cherish The Light Years è l’album che trasforma il progetto solista di Eisold in una vera e propria band; lo fa
mantenendo la barra dritta verso un pop sintetico naif
ed avvincente, forse meno concettuale e stimolante rispetto al passato ma, in fin dei conti, decisamente più
godibile.
(7/10)
Diego Ballani
Colin Stetson - New History Warfare
Vol.2: Judges (Constellation Records,
Marzo 2011)
Genere: impro
Sbarca su Constellation il secondo volume di New History Warfare di Colin Stetson. Lasciati momentanea65
highlight
Crystal Stilts - In Love With Oblivion
(Fortuna Pop!, Aprile 2011)
Genere: gloomy wave
Erland and the Carnival - Nightingale (Full Time Hobby, Marzo 2011)
Genere: psych-folk-pop
Dire davvero cosa significhi la parola ‘folk’ oggi è un’impresa complessa, forse impossibile. In un genere/
non genere che prima dell’era pop designava quello che non era musica colta, ma che aveva una matrice folklorica, spesso locale e legata alla trasmissione orale, oggi invece troviamo tanto il cantautorato
delicato di Devendra Banhart, gli spruzzi pop di tutte le band indie-folk
che circolano a tutte le latitudini, il recupero della tradizione come fa, per
citare qualcuno di casa nostra, Riccardo Tesi. E ci stanno pure gli Erland
and the Carnival, che riescono a recuperare tanto il folk britannico quanto una psichedelia conturbante e rock, oltre a qualche sfumatura world.
Già nel primo disco omonimo targato 2010, il gruppo prendeva brandelli
folk e li aggiornava alla propria sensibilità, fatta di urgenza comunicativa e
una forte personalità. Oggi il discorso si amplia, prendendo ispirazione da
testi oscuri, che possono essere tanto articoli di giornale quanto brani di
romanzi d’inizio Novecento o discorsi politici, in un immaginario che pesca da una fila di nomi lunga
così: Ennio Morricone, Bert Jansch, Joe Meek, tanto per citarne alcuni.
Dietro alla ragione sociale si nascondono il chitarrista e cantante folk Erland Cooper, Simon Tong (The
Verve) e David Nocky (già batterista per il progetto Fireman di Paul McCartney), che si sono incontrati
quasi per caso, hanno fatto una jam session e lì, su due piedi, hanno deciso di formare una band, che
tutto sommato si erano divertiti a suonare insieme. Il sound che esce da questo lavoro è davvero debitore di quella cultura musicale molto londinese (e in generale proprio britannica 100%) che ha fatto
scaturire quel supergruppo nel quale ha militato anche lo stesso Tong, ovvero The Good, the Bad &
the Queen, il cui cantante, un certo Damon Albarn, è il proprietario dello studio dove si è registrato
l’esordio dello scorso anno.
L’album è stato registrato nella stiva di un imbarcazione ancorata sulle rive del Tamigi: immaginatevi un
sabbah psichedelico moderno in cui convivono le rivisitazioni dei The Coral via Bert Jansch (Map of Englishman), gli accenti doorsiani (This Night, I’m Not Really Here), folk in salsa shoegaze (la titletrack, Emmeline), melodie appiccicosamente pop (Springtime). Rispetto al debutto, Nightingale è un’affascinante
virata verso uno psichedelia oscura e inquietante dai testi colti e gusto tipicamente retro-pop che guarda giù nei sottoscala del teatro inglese. E’ un lavoro terribilmente affascinante. Culto istantaneo.
(7.4/10)
Marco Boscolo
Che sia una dichiarazione d‘intenti il titolo del comeback dei newyorchesi? Non lo sapremo mai, ma di
sicuro i quattro Crystal Stilts devono aver fatto tabula rasa di tutti i complimenti ricevuti per la doppietta
Crystal Stilts / Alight Of Night che un paio di anni addietro li scaraventò dall‘anonimato al palco del Primavera
Sound senza passare dal via.
Non si spiegherebbe altrimenti un disco che, se possibile, surclassa il già stupefacente esordio lungo, redefinendolo dall’interno. I quattro smussano lievemente
le asperità ma senza perdere un grammo in attacco,
aggiustano il tiro sul versante della scrittura ma non si
addolciscono, frullano citazioni e riferimenti con una
nonchalance invidiabile senza risultare pedissequi o
estremamente citazionisti: in poche parole, mettono
a segno il punto definitivo. Quello che annienterà le
eventuali ultime resistenze dei critici.
Nessuno stravolgimento, sia chiaro. Dentro In Love With
Oblivion troverete sempre garage-rock psichedelico
targato 60s (da Barrett ai Velvet, passando per gemme
misconosciute come gli Standells), pop-noise anni ‘80
(di qua e di là dall‘oceano, con puntatine nel nuovissimo mondo), sonorità cavernose e vintage (il mood
sempre oscuro e apparentemente fuori moda) e lo-fi
d‘ordinanza.
A far la differenza, questa volta, sono le canzoni: se
Alight Of Night colpiva per immaginario e compattezza, il sophomore stupisce in maturità e screziature. Che
siano il pop yè-yè super-zuccheroso di Silver Sun, i 60s
disorientanti dell‘opener Sycamore Tree o le profondità
malate di Alien Rivers, cambia poco. Resta sempre una
certezza: hanno fatto centro, di nuovo.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
mente i compagni della Bell Orchestre e degli Sway
Machinery, presosi una pausa dal lavoro di sessionman di lusso, il sassofonista/polistrumentista del Michigan torna a ritagliarsi uno spazio tutto suo.
New History Warfare Vol.2: Judges è un oggetto non
identificato nel cielo della musica contemporanea: un
disco che mischia avanguardia e improvvisazioni cerebrali con una fisicità materica del suono e una capacità
d‘intrattenere tipiche del rock. Sorprende ancor di più
il fatto che Stetson sia un uomo solo col suo strumento, in grado di tirar fuori una gamma espressiva vasta e
convincente grazie a capacità tecniche notevoli.
Ricorrendo all’uso della respirazione circolare e di altri
espedienti tecnici (ben 24 differenti posizioni per i mi66
crofoni), Stetson ottiene un linguaggio che passa con
disinvoltura da paesaggi ambient (All Days I’ve Missed
You) a strutture ritmiche spigolose (Red Horse) fino a un
elettronica fatta senza l’uso di loop e macchine, ma con
la forza dei polmoni e la conoscenza dei mezzi espressivi (Home). A impreziosire il tutto un paio di magistrali
cameo vocali targati Laurie Anderson (A Dream of Water) e Shara Worden dei My Brightest Diamond.
Sperimentale e ostico, ma sicuramente ammaliante e pieno di fascino, il secondo capitolo solista di Colin Stetson è
una lotta da affrontare con coraggio, fisicità, accortezza e
astuzia. Un’esperienza intensa e gratificante.
(7.4/10)
Francesco Asti
Danielson - Best of Gloucester County
(Sounds Familyre, Marzo 2011)
Genere: psych folk
L’ultima scorribanda di Daniel Smith col moniker Danielson risale a ben cinque anni fa. Ships era di quei
dischi che non si dimenticano, non tanto per gli esiti
artistici quanto per quel senso di happening mistico
capace di coagulare attorno all’estro visionario di Mr.
Smith una trentina di musicisti, tra cui ovviamente i
consanguinei della famiglia Danielson ed amici quali
Sufjan Stevens ed Emi Nikolaisen dei Serena Maneesh. Questi ultimi li ritroviamo anche tra i credits del
nuovo Best of Gloucester County, assieme a new en-
try quali Jens Lekman, Mark Shippy degli US Maple e
Glen Galaxy dei Soul-Junk.
Simile l’entusiasmo effervescente, la ricchezza compulsiva e la versatilità balzana della proposta, ma il
risultato è sensibilmente diverso, come se la freakeria
folk-pop avesse fatto il nido sul fruttuoso alberello del
power pop (capricciosamente deragliato glam, vedi le
palpitazioni sfrigolanti di But I Don‘t Wanna Sing About
Guitars e Grow Up), sia pure sferzato da folate psych
che non disdegnano siparietti allampanati (la marcetta in levare di Lil Norge, il vaudeville cabarettistico
di Peolple’s Partay) ed impressionismi sonici (Hovering
Above That Hill). In tale contesto le antiche attitudini riaffiorano in germogli quali The Day Is A Loaf e Olympic
Portions, non lontani dal luminoso fervore Elephant 6,
di cui il lirismo bucolico di Hosanna In The Forest e You
Sleep Good Now rappresenta il controcanto quieto. Un
delizioso baraccone dalle molte fragranze ed altrettante idee.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Dead Cat In A Bag - Lost Bags (Viceversa,
Marzo 2011)
Genere: art folk rock
In origine erano un duo folk con spiccata attitudine per
i minimi termini. Col tempo i Dead Cat In A Bag sono diventati un’accolita di musicisti con le coordinate sperse
da qualche parte tra messico, balcani e certi non luoghi
universali quali bettole fumose ed interni senza sbocco. Li abbiamo assaggiati alle prese con In The Arms Of
Sleep nel tributo a Mellon Collie And The Infinite Sadness allestito dalla benemerita 42 Records, e ci erano
sembrati meravigliosamente fuori luogo, un miraggio
sabbioso di cianfrusaglie e peyote. Esordiscono con
questo Lost Bags che in quattrodici tracce pennella
tutto il loro immaginario struggente e sconsolato, un
carosello di teatrini dimessi, deliri tetri e ombre in subbuglio.
Ballate che impastano l’irrequietezza cedevole degli
Howe Gelb, dei Tindersticks, degli Smog (I Can‘t Row
No More, No Lust Left, Wither), sguardi gettati a spazzolare deserto come dei Calexico ora crespuscolari (Dawn)
e ora ingrugniti (The Stow-Away Song), ipotetiche ibridazioni tra Xiu-Xiu e Yann Tiersen (The Gipsy Song),
ebbrezza primaria Tom Waits (Old Dog) e Bob Dylan
basico (Wateground Of Your Lips). In mezzo a tutto ciò,
come a mantecare di estro arty, sbocciano fiorellini allucinati quali il siparietto espressionista di Leapiz o il
talkin’ brumoso della title track. Ad un armamentario
formidabile di strumenti “analogici” (dobro, lap steel,
67
banjo, mandolino, bouzouki, vibrafono, organo, violino, tromba, flicorno, contrabbasso, armonica, melodica, melodeon, concertina, harmonium, fisarmonica...)
fa da sponda la presenza mai meno che suggestiva di
tastiere e campioni, ambiti narrativi che la voce di Luca
Swanz Andriolo satura di fosca, intima, rauca irrequietezza.
Le ospitate di Massimo Ferrarotto dei Feldmann, Liam
McCahey - vocalist dei disciolti Cousteau - e Cesare
Basile sono un attestato di qualità che non fatichiamo
a sottoscrivere e sottolineare.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Doormen (The) - The Doormen
(Autoprodotto, Marzo 2011)
Genere: Post punk
Bella sorpresa quella dei nostrani The Doormen, gruppo che dice la propria in campo wave rock, con una
personalità ed una autorevolezza che non sapevamo
essere di casa in Italia. E italiani i Doormen li sono per
davvero, tanto da aprire il loro esordio con il brano Italy,
uno schiaffo all’esterofilia che in bocca ad altri sarebbe
suonata indulgente o retorica; loro invece lo ne fanno
un’opener lirica e intensa sul modello dei migliori episodi dei primi Interpol.
Il paragone con il combo newyorkese, in verità, ritorna
spesso nel corso dell’album, vuoi per lo stile del cantante Vincenzo Baruzzi, a tratti simile a quello di Paul
Banks, vuoi per la progressione melodica di buona parte dei brani. Fortunatamente non di mera oleografia è
fatto il loro esordio.
Brani come New Season hanno la loro peculiare cifra
stilistica nelle sferzate garage, in un sound pugnace e
senza posa che non si limita a seguire pedissequamente gli stilemi post punk, ma fa dell’indole schiettamente rock il proprio punto di forza.
L’ottimo lavoro chitarristico si fa apprezzare particolarmente in brani come 24 e Here Comes That Bitch la cui
vena psichedelica e la cui portentosa epicità si riallaccia a quella degli ingiustamente dimenticati Chameleons.
(6.9/10)
Diego Ballani
Dorothi Vulgar Questions - Against
Myself (Sun Play, Marzo 2011)
Genere: wave rock
Tre anni sono passati da L’equilibrio, album d’esordio
che li vide confermare quanto già di buono espresso
nell’ep DVQ. Con Against Myself i toscani Dorothi
68
Vulgar Questions erano quindi chiamati a ribadire il
carattere e quel bel po’ di talento sul fronte d’un waverock tosto ma non privo di aperture melodiche, una
creaturina palpitante insomma in differita dagli eighties ed irrobustitasi a strali psych e grunge. L’imprinting è appunto wave, con tutto il corollario di asprezza
e obliquità pop che t’immagini sbocciare tra periferie
dimesse ma combattive, poche le magnifiche sorti da
perseguire ma le antenne sempre sintonizzate e l’anima pure.
Evaso il piglio teso un po’ Killing Joke e un po’ The
Sound con Fight For Yourself, Everything Is Not Forever
e Only One Will Survive, distribuite cupezze e inquietudini con In Your Bedroom (dei Bauhaus letargici in bagno acido sixties), la title track e l’iniziale Somewhere
(sussulti Ultravox! in una melma quasi Soundgarden),
ecco il quintetto prestarsi a certo trasporto accorato
tipo i Wire più melodici (Winter Light) o addirittura non
lontano da certi Go-Betweens sintetizzati Notwist
(Keep Away From Me).
Allargare lo spettro e non perdersi, anzi continuare a
sembrare un calderone di energia e buone intenzioni,
è il loro merito principale. Chapeau.
(7/10)
Stefano Solventi
Driver&Driver - We Are The World
(Staatsakt, Marzo 2011)
Genere: Cabaret elettropunk
Con il Tubo pieno dei loro video incendiari tra audio
ignobile e riprese epilettiche, un culto studiato ad hoc
è già stato creato, proprio come ai bei vecchi tempi del
situazionismo punk. E’ la premessa ideale a un debutto intitolato icasticamente We Are The World nel quale
i Driver&Driver, fantomatico duo di Berlino, tentano
di porsi come un ideale punto d‘incontro tra Suicide,
D.A.F. (Deutsch-Amerikanische Freundschaf ) e perché
no gli Sparks dai quali ereditano il baffo e un tocco di
kabaret.
Il bello dell’operazione è una formula eccessiva e cafonissima, indirettamente ironica e maledettamente
banale: immaginatevi gli Art Brut tragicomici di Eddie
Argos in trip elettro punk, oppure la parte maschile e
tedesca degli Stereo Total in un mix di Bloody Beetroots. Naturale che We Are The World sia una miscela instabile, uno Sturm und Drang dell‘assurdo tra gag
sfilacciate (Hello, Hello, Back to LA) e attacchi industrial
techno (Der Kleine Ernst), elettrock (quella Kutchen tra
Kraftwerk e autoparodie della lingua tedesca) e rasoiate oi!
Irresistibili questi due, specie quando calcano i territori
più D.A.F., quando cioè EBM e techno veicolano i teatrini più corrosivi con Sicherheitsschrankenmann, Kampf
im Kulturkaufhaus e Fluch Nach Vorn, Umtausch a rappresentare le hit sotterranee da pogo istantaneo e Farmer In Pajama, l‘anthem cow electro punk del caso. Sul
lato nascosto della faccenda: troviamo infine una serie
di declinazioni avant, da musiche per teatro e balletto per capirci, che trovano nei Residents degli esordi
(campionati in We Got You Babe) un eccellente dialogo
a distanza (e nel tempo).
Cafone, situazionista, cretino e strafalcione. Il debutto
di Patric Catani & Chris Imler è un autentico spasso.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
duke Garwood - Dreamboatsafari (Fire
Records, Marzo 2011)
Genere: post-blues
Quando pensi al blues e all‘Inghilterra, vengono in
mente i nomi che nei ‘60 rilessero appassionatamente
la tradizione per conservarla e nel contempo rinnovarla. Fungendo, come nel caso di Alexis Korner e John
Mayall, da sublimi mentori per un‘intera generazione
di talenti che impressero una svolta al rock. Materia
storicizzata che sotto l‘aspetto strettamente stilistico
non vale per questo londinese, giunto al terzo lp e propenso a restituire delle dodici battute la concezione
“beefheartiana” che ne hanno Tom Waits e i Califone.
Magari gettando nella mistura un interesse per la musica africana (il ragazzo ha in programma un disco con
i marocchini Master Musicians Of Joujouka
) e tenendosi vicina l‘ombra di Mark Lanegan (in precedenza
compagni di tour, i due: anche qui è previsto un lavoro
a quattro mani) per muoversi dentro un‘avanguardia
che oggi profuma di classicità. Il risultato persuade e
mostra un artista in progresso, forte di sonorità solide
ed essenziali (Duke fa quasi tutto da solo con il batterista Paul May) e una penna che attinge sapiente dai
nomi di cui sopra (Summer Gold, Gengis, Jesus Got A
Gun).
Offrendo per il resto cinque minuti di inutile baccano
low-fi, ma soprattutto gustose contaminazioni con Suicide (Gold Watch), free-jazz (Tapestry On Mars) e una
psichedelia venata di world music (Flames Of Gold, Larry). In attesa di ulteriori sviluppi, un nome da appuntare sul taccuino.
(7.1/10)
Giancarlo Turra
Dutch Uncles - Cadenza (Memphis
Industries, Aprile 2011)
Genere: Indie, XTC
Le caratteristiche per farsi notare dalla stampa di settore questi cinque le hanno tutte. Il Times li ha recentemente inseriti negli Ones To Watch descrivendoli
“ragazzi cresciuti alle complesse partiture temporali
degli XTC aggiornate ai Talking Heads e al math-pop”,
il Guardian li ha spottati nella sezione Band Of The Day
chiamando in causa l’ennesima rinascita, questa volta mancuniana, con Hurts, Everything Everything and
Delphic, Wikipedia chiude in bellezza il negozio di dolci con riferimenti quali Smiths, King Crimson e Steve
Reich.
Nessuna bugia, i Dutch Uncles usano tempi complessi,
jingle-janglano circolari come Fripp negli 80s, ritmano
secondo serialità prestabilite, ma erano (c’è un omonimo del 2009 su Tapete) e rimangono una indie band
dalle dubbie capacità melodiche. Come dei Field Music con canto byrniano edulcorato,
o dei Battles scarburati folk-pop, i cinque sembrano
una bella sportiva uscita di fabbrica ma senza un driver vero. Il rodaggio è roba da poco ma la personalità
è quello su cui Duncan Wallis deve, in primis, lavorare.
Le sue strofe e ritornelli sono quasi sempre inefficaci e
alla band tutta sembra mancare l’urgenza e l’orgoglio
di cotanto passato chiamato in essere.
Accattivanti e forse qualcosa in più gli zii olandesi ma,
per ora, il loro gioco dura poco.
(6.4/10)
Edoardo Bridda
Elbow - Build A Rocket Boys! (Fiction,
Marzo 2011)
Genere: indie wave prog
Ho sempre avuto problemi a gestire l’enfasi sconsolata degli Elbow, con quel sovraccarico emotivo speso
a definire fondali e lineamenti d’una malinconia più
perniciosa che esistenziale, capace di affascinare giusto finché non inciampa in una spirale di turgida, monocorde costernazione. Eppure devo concedere loro il
merito d’una coerenza che ha saputo dimostrarsi robusta e in grado di consolidarsi negli anni. Tanto che oggi
possiamo parlare di un Elbow-sound, una dimensione
espressiva fatta di trasporto, apprensione, una mesta
fierezza che sa fare i conti con la memoria e proiettare
le inquietudini in una prospettiva coinvolgente.
Lontani i tempi in cui potevi scambiarli per una versione abbacchiata dei Coldplay: il loro indie non insegue
chissà quale grandeur, persegue una comunicatività
intensa e potabile ma allo stesso tempo tenta di sca69
varsi dentro profondità spacey e vibrazioni oblique, di
rendere tangibili e radianti le irrequietezze e i sussulti emotivi. Una calligrafia spesso didascalica ma quasi
sempre efficace, non sottile ma onesta. Comunque capace di tenersi in equilibrio tra modulazioni stilistiche
anche complesse, vedi la naturalezza con cui Jesus Is a
Rochdale Girl bazzica palpitazioni tenui Jim O’Rourke
o quella Lippy Kids che immerge l’acme emotivo dell’album in una scenografia eterea Brian Eno.
Se la cavano bene quando alzano la temperatura guardando al pop-prog di stampo Peter Gabriel innervato di romanticismo wave (With Love, High Ideals, Open
Arms) e non sono affatto male quando spediscono uno
struggimento Smiths tra evanescenze angeliche Sigur
Ros (Open Arms), così come è apprezzabile quel modo
di sclerotizzare gospel ottenendo una strana solennità
apolide (The Birds, The River). Resta però dietro l’angolo
il rischio della litania autoreferenziale (vedi la pur valida The Night Will Always Win), perché la maturità cambia molte cose ma la natura, si sa, è un osso duro.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Emanuele Errante/Dakota Suite - The
North Green Down (Lidar, Marzo 2011)
Genere: Ambient
La collaborazione tra il leader dei Dakota Suite - una
delle più ispirate formazioni della realtà del slow
core britannico di cui segnaliamo Waiting For The Dawn
To Crawl Through And Take Away Your Life per testi e
miniature elettroacustiche - e il compositore italiano
risale già al 2009, precisamente alla rielaborazione
del brano Second Hand Light contenuto in The Night
Just Keeps Coming In, il remix album di The End Of
Trying. A consacrare ulteriormente l‘affinità stilista
tra i due questo The North Green Down, uscito quasi in
contemporanea alla prova solista di Emanuele Errante,
e contenente ottanta minuti di composta malinconia
dedicate alla compianta cognata di Hooson.
Parallelamente a Time Elapsing Handheld, il napoletano continua a vestire a puntino gli abiti da ambient
artist, mentre Hooson gli si affianca con notazioni intimiste per piano e chitarra. Parola d‘ordine è l‘uso
discreto dell‘elettronica, manipolata da Errante come
sempre con incredibile delicatezza ed unita a strumenti tipicamente acustici. Il tutto confluito nelle radici di
commosse riflessioni a cui ci si avvicina da principio tra
i tasti di The North Green Down e Leegte. Materie palpabili che, inevitabilmente, restituiscono le sfumature a
modo di un Keith Kenniff nei primi minuti di Famous
Places.
70
Il resto non è un facile dialogo di cordoglio ma un‘appresa coscienza d‘assenza, assimilabile ed evidente
nell‘acustica di A Hymn o nel respiro armonico arricchito dal cello di A Worn Out Life - che rimandano per
affinità, suono narrativo ed esecuzione, ai duetti di un
Francesco Dillon ed Emanuele Torquati. Aliena ma alleata - rispetto all‘impianto sommesso ma cameristico
di A Loveless Moment, l‘elettronica dell‘ouverture di No
Greater Pain che con i suoni organici di Nobody Is Ever
Safe e i pulviscoli stratificati ed eterei di Wat We Kwijt
Zijn sottolineano il calore delle macchine di Errante.
Oltre alla creatività reciproca e alla fantasia timbrica, a
tenere il filo per questi ottanta minuti di micro sinfonie
è l‘equilibrio tra la poesia sospesa di Hooson e le sostenute texture di Errante che con i frangenti ambient si
fanno spina dorsale allontanando il progetto da facili
percorsi elettroacustici. Materia e uomini tutt‘altro che
invisibili.
(7/10)
Sara Bracco
Eric Legnini - The Vox (Discograph, Marzo
2011)
Genere: jazz soul
Agile, sinuoso, urbano, cerebrale, appassionato, dinamico. Il jazz di Eric Legnini - pianista parigino di origine belga - respira tradizione in un coté decisamente contemporaneo e globale, lascia che a sgranare la
pannocchia siano gli umori compositi e coesi della
sua band, gli Afro Jazz Beat (un bassista funk belga,
un chitarrista congolese già al lavoro con Fela Kuti, un
batterista ed un contrabbassista francesi) cui va ad aggiungersi per metà dei brani la voce calda e flemmatica
della statunitense Krystle Warren.
Il tocco di Legnini possiede una morbidezza guizzante
e sensibile come un Esbjorn Svensson meno pensoso,
sa essere urbano e spirituale, frequenta con disinvoltura indole latin-tinge, estro afro-beat, sussulti funk e
turgore soul (oltre al piano si presta al Fender Rhodes e
all’Hammond). E’ la sensibilità dorsale di un sound che
cerca le proprie radici nei seventies, cui rimandano le
timbriche frementi e vellutate. Gran bel disco.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Faresoldi - Casotto EP (Riot Maker, Marzo
2011)
Genere: electro/discofunky
Ancora EP Faresoldi. Con il solito armamentario di
kitscherie rese con suoni e arrangiamenti sempre impeccabili. Cinque pezzi per ribadire la via post-Sappia-
highlight
Falty Dl - You Stand Uncertain (Planet Mu Records, Aprile 2011)
Genere: Retro house, 2 step
Drew Lustman era partito fin troppo cauto con l‘esordio Love Is A Liability, poi però la strada per lui
è stata tutta in salita: prima è arrivato un eppì come The Bravery che testimonivava l’assorbimento
di una lezione fondamentale come quella Luke Vibert-iana; poi una serie di pubblicazioni per Ramp e Rush Hour, con ancora Luke nel taschino,
evidenziavano un sapiente tocco House in salsa garage (Party), oppure in
downtempo (Meta-Cognist), oppure ancora ispirato ai classici Mr Fingers,
Coco Steel And Lovebomb (la bomba All InThe Place).
In questi ultimi due anni, tra dj set e podcast, Drew si è mosso talmente
bene che arrivato a You Stand Uncertain doveva soltanto metter giù tutto
quello che aveva imparato dal continuum hardcore e restituircelo, intatto,
nella massima espressione groove-step.
Il moniker Falty Dl non è mai stato sinonimo di dubstep producer e neppure di specialista della sotto nicchia now on (Future Garage o Uk Funk); piuttosto è l’alias di un musicista
elettronico newyorchese follemente innamorato del suono UK, di un ragazzo che non ha mai distinto
tra i cataloghi IDM, d’n’b e quelli più dance.
Nessuna sorpresa se nell’album troviamo vent’anni di step, citazioni early house e rave con un taglio
che parallelamente all‘ultimo Kode9 (anticipato dal suo Endeavour per Planet Mu) lo vede calibrare
smalti black (Gospel Of Opal), sponde soulfull e tocchi etno via Boxcutter (e quindi, indietro, Horsepower Production).
L‘ondata glo, tagliata da un altro spirito affine come Bibio in senso funk, lo trova dunque sul lato balearico della faccenda, quella con più affinità rave e jungle: nella splendida Lucky Luciano la citazione a
Pacific State degli 808 State e a A Guy Called Gerald è evidente quanto, in generale, l‘album è da una
parte giocato sulla chill (l‘opener Gospel Of Opal), dall’altra temporalmente sincronizzato tra ambient
house 92 (Voyager) e jungle 93 (The Pacifist).
A contorno, le specialità: post-idm e spezie lounge-jazz (Open Space), 2 step + house (Brazil con Lily MacKenzie), IDM lato primi Autechre tagliati Actress (You Stand Uncertain), ancora jungle (Eight Eighteen
Ten) e gran finale vibertiano (Waited Patiently).
Per chi ama l’elettronica UK, questo è un album da antologia.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
mo dove abiti e cioè quella di un act ormai internazionalizzato che punta a un suono più corposo, tattile,
gommoso. In una parola, da dancefloor. Pasta e Luka
insomma lontani anni luce da canzoni agrodolci come
- la bellissima - Primi baffi.
Cassa Forte mette assieme electro Ottanta e post-fidget, glo/chill e stomp&go garage; Party Posse ha una
bassline superkunfky slap semplicemente contagiosa,
e ci appiccica sopra una demenziale voce declamatoria; Volluto è uno stop&go funkyhouse con tocchi
wonky; All You Need Is LOL è un po’ Jim Avignon (un
giorno qualcuno scoprirà/riscoprirà quest’uomo), un
po’ Todd Rundgren, un po’ Toro scanzonato; Sabbiadoro, dopo una intro con elettroniche alla Xevious, parte
disco superfunky. Le loro specialties.
Stringendo: trascinanti, irresistibili, FS possono anche
andare avanti così all’infinito. Quindi, invece, noi li
aspettiamo con un nuovo album.
(7/10)
Gabriele Marino
71
Federico Squassabia Walkabout Songlines (Parade, Ottobre 2010)
Genere: avant-jazz
Dopo essere cresciuto in quella fucina di talenti che
è Improvvisatore Involontario, Federico Squassabia
approda a Parade - costola sperimentale di Trovarobato - con questo Songlines. Nella pratica nulla cambia,
nel senso che l’universo del pianista continua ad essere
fatto di una materia flessibile, meditativa, contaminata,
in equilibrio tra jazz, classica e contemporanea.
La formazione è minimale: Nelide Bandello alle percussioni e Danilo Gallo al basso/contrabbasso, a giocare con un concetto di viaggio che ambienta ogni
brano in un luogo (fisico o dell’anima) diverso. Con il
groove dispari di The Jellyfish Meal (Amsterdam) e le
ampie aperture di C’era una volta (The Wild Wild West
And Sergio Leone), le aspirazioni atonali di Don Durito
Y Marcos (Mexican Walk & Subcomandante) e i fraseggi di piano scapicollanti di Una passeggiata ai giardini
pubblici (Bologna) che svelano un’opera stratificata,
obliqua e a suo modo narrativa. Avant-jazz avventuroso e immaginario, alla stregua delle vie dei canti degli
aborigeni australiani a cui il disco idealmente s’ispira. E
uno Squassabia come al solito a ottimi livelli.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Fratelli Calafuria - Musica Rovinata
(Massive Arts, Aprile 2011)
Genere: elettrock
Non cala affatto la furia dei Fratelli Calafuria stando a
quanto si ascolta nell‘opener Pezzo Giallo: 2 minuti e
poco più di furia cieca fatta di ampli al rosso e vocals
in modalità screamo meets nonsense lirico e suburbano. A ruota, Fare Casino, ovvero l‘electro-rock iper-vitaminizzato dei dimenticati Death From Above 1979:
stesso frullatone di analogico e digitale e stessa forsennata corsa a superare ogni possibile limite, messi però
al servizio di un anthem da chiamata alle armi tardoadolescenziale al grido di “bisogna fare casino!”.
Adrenalina a pacchi e atteggiamento tra l‘amara disillusione e il sarcastico nei confronti del mondo esterno (in
stretto ordine alfabetico ci fanno sapere i due che i testi
parlano di “amore, cassette, cose complicate, disordine,
disastri, giallo, luoghi comuni, Milano, radio fm”) fanno di Musica Rovinata uno spietato e folle sguardo lucido/ludico sull‘attualità. I due fratelli (Andrea Volontè
e Paco Vercelloni) mischiano e stratificano punk, funk,
jazz, noise, no wave, electrock con una predisposizione
collagistica e massimalista che fa il paio con le aperture
melodiche delle vocals, sempre sul filo del calembour
72
pesante o dello scazzo in modalità ironico-giovanilistico. Che alla fin fine non si capisce bene se ci facciano o
stiano semplicemente prendendoci tutti per il culo.
Probabilmente la seconda, ma cambia poco: Musica Rovinata è una centrifuga di rock alto e basso alla maniera di un Patton sanbabilino o di uno Zappa sboccato e
punkish cresciuto nell‘ovattato e sopravvalutato mondo del rock fichetto italiano. È tutto eccessivo, tirato ai
massimi livelli, pronto allo strappo, ironico, schizzato e
crudo nella musica dei Calafuria bros. Cosa che ci piace
assai.
(7/10)
Stefano Pifferi
Gatto Fritto - Gatto Fritto (International
Feel Recordings, Aprile 2011)
Genere: space nu disco
Gatto Fritto è Ben Williams che già avevamo incontrato
nell‘ottimo 12‘‘ Illuminations con il moniker di Hungry
Ghost, un duo (con Sam Weaver) house declinata nudisco, che tra i remix illustri portava anche il nome del
re della cosmic Daniele Baldelli.
Ben sta sulla scena da un sacco di anni: nei Novanta si
è fatto le ossa con la techno suonando all‘Analog City
londinese, nei Duemila, tra alterne fortune, ha organizzato party e cambiato interessi sonici passando da
Detroit a Chicago per poi approdare alla space disco
proveniente dalla Norvegia (Lindstrøm). Nel frattempo, ha fatto il commesso alla Reckless records (e in un
videostore) e stretto diversi contatti che, a partire dal
2007, si trasformano in release.
Gatto Fritto esordisce quindi nel 2007 per la londinese
Dissident con Invisible College, uno dei brani che ritroviamo in questo omonimo long playing, emblematica
testimonianza della sua mano: lineari progressioni di
synth cosmici, battuta disco e citazionismi 70s a contorno.
Nel corso degli ultimi quattro anni, rispetto a Lindstrøm
(quasi plagiato in The Hex), Gatto Fritto ha spostato
l‘interesse verso gli 80s sintetici di Com Truise ed ha
aperto pure un’etichetta, la Fritto Morto. Quest‘esordio,
su International Feel Recordings (proprio come Hungry Ghost) è una raccolta di materiale vecchio e nuovo,
buona space disco e interessante nu. In un momento
di sintesi dance eterodossa come quello attuale (vedi
su altri lidi i Discodeine) la mossa ci sta tutta, anche se
l’approccio è ancora troppo calligrafico. Il meglio, verrà
con l‘esordio lungo del duo...
(7/10)
Edoardo Bridda
Gentless3 - I’ve Buried Your Shoes Down
By The Garden (Wild Love, Marzo 2011)
Genere: post-slow-folk
Quanti frutti insipidi e ammuffiti siano stati colti negli
ultimi anni dall’albero del post-rock e dello slowcore
è cosa tristemente nota. Era ovviamente questione
di attendere la stagione e l’innesto giusti. Come pure
conta il terreno da cui le radici succhiano sostanze ed
energia. E quanto in profondità. Carlo Natoli da Ragusa
- nel curriculum una gavetta da fonico e collaborazioni
in entità quali Albanopower e Tapso II - ha coltivato
bene la propria attitudine organizzando i Gentless3,
quartetto (chitarra baritono, chitarra elettrica, piano
elettrico e batteria) che riarticola l’incedere costernato
di certo post-rock con l’incandescenza dimessa dello
slowcore, puntellando l’emotività con un romanticismo noir di stampo alt-folk.
Ascolti queste melodie indolenzite ma appassionate,
questo croonerismo sospeso tra selvatica indolenza e
afflizione, ed è come quell’impasto di Slint, Unwound,
Codeine e Black Heart Procession che hai sempre più
o meno consapevolmente desiderato. Il patema fiero
venato di jazz fumoso di On Busting The Sound Barrier,
la gravità risoluta di Comeback From (omeopatie Red
House Painters nel ritornello) e la cinematica apprensione di Since ‘98 sono l’apice di un programma stringato (solo sette tracce) ma intenso e credibile.
(7/10)
Stefano Solventi
Grails - Deep Politics (Temporary
Residence, Aprile 2011)
Genere: psych post-rock
La cosa che spiace di più nell’ascoltare i Grails è il senso di incompiutezza, un retrogusto amaro dato dalle
grandi possibilità che concretamente non riescono a
realizzarsi in pieno.
Il tentativo di portare avanti le intuizioni dei Neurosis
e degli Isis sposandole con un misto di post-rock, folk e
sonorità psych liquide, rimane infatti soltanto nelle intenzioni. Una volta messo in pratica infatti sembra più
una forzatura che una evoluzione fluida e omogenea,
sfociando in un manierismo stucchevole (All The Colors
Of The Dark) o in tirate prog abbastanza noiose (Deep
Politics). Ed è un peccato perché i momenti buoni non
mancano, come quando filano via lisci e diretti facendosi apprezzare per una buona varietà stilistica: il trip-hop
etnico di Corridors Of Power o le folkeggiantiAlmost Grew
My Hair - sicuramente la migliore del lotto - e I Led Three
Lives sono testimonianza di una discreta padronanza di
mezzi e abilità nell‘amalgamare stati d‘animo differenti.
Deep Politics è dunque un lavoro mezzo riuscito nel suo
essere troppo pretenzioso e poco coeso e si fa apprezzare soprattutto nei pochi momenti in cui i Grails trovano un punto di equilibrio. Verrebbe da definirlo un
buon primo lavoro che fa ben sperare per il futuro, se
non fosse che sono tutto tranne che una band di novizi.
(6.2/10)
Francesco Asti
Green like july - Four-legged fortune
(Ghost Records, Febbraio 2011)
Genere: indie, folk
Si apre guardando al Bob Dylan di Highway 61 reviseted
questo Four-legged fortune, secondo ottimo lavoro dei
Green like july. Un po’ di Pavia e un po’ di Alessandria,
Andrea Poggio, Nicola Crivelli e Paolo Merlini, hanno
registrato agli ARC studios di Omaha, Nebraska, luogo
centrale nella realizzazione e produzione degli album
dei Bright Eyes e della Saddle Creek tutta. Niente di
più azzeccato, è chiaro, visto che è proprio da un brano
di Fever and mirrors che arriva il nome della band.
Appoggiati, a partire dai demo, da Jake Bellows dei
Neva Dinova e sostenuti, durante la lavorazione, dal
supporto dei fratelli Mogis, i tre ragazzi escono con un
album pieno, denso di riferimenti, citazioni, sguardi,
eppure capace di non risultare mai, pur con una forte connotazione di genere, la copia di qualcosa di già
noto. Che si sentano, e non poco, Conor Oberst, gli Okkervil River e una serie di infiniti affondi nella musica
folk più statunitense e antica possibile, è cosa evidente, tuttavia Four-legged fortune mantiene con forza la
propria originalità. Se nel precedente May This Winter
Freeze My Heart si accusavano infatti i colpi dell’amore
per un certo mood sonoro e vocale, qua il pericolo è
scampato. Testi di forte intimità e ironia che raccontano un immaginario capace di aderire perfettamente ai
suoni e alla vocalità di Poggio.
Non siamo di fronte a un disco che ne ricalca altri ma
a un lavoro nato, cresciuto e sviluppato nel luogo a lui
più adatto, nel suo spazio più naturale, accanto alle sue
stesse fonti d’ispirazione. Brani come Jackson e, soprattutto, il piccolo capolavoro A perfect match sono vere e
proprie rarità. Eccellente la cura dei dettagli: una produzione di alto livello e un artwork di folk art raffinatissimo e quantomai adatto, nato da un’idea della talentuosissima illustratrice Olimpia Zagnoli. Bravissimi. (7.4/10)
Giulia Cavaliere
73
highlight
all‘ascoltatore con sonorità e immaginario iconografico. Grey History prende le sue posizioni e di questo
gliene va reso merito.
(7/10)
Josh T. Pearson - Last Of The Country Gentlemen (Mute, Aprile 2011)
Genere: post-songwriting
Stefano Pifferi
L‘unico difetto di questo disco è una copertina fuorviante e poco significativa. Nient‘altro. In queste
sette canzoni - mediamente assai lunghe, costruite attorno a silenzi e una chitarra acustica, al violino
dell‘amico Warren Ellis dei Dirty Three e tantissime parole - Pearson ha
inserito un decennio dallo sbando alla salvezza tramite l‘auto-isolamento.
Tanto basterebbe per rispettarlo: per amarlo bisogna scavare negli avvenimenti precedenti le due notti in uno studio berlinese che ne hanno testimoniato la genesi. Solo così si può capire come ci si trovi al cospetto di
qualcosa che ha condotto l‘autore fuori da un deserto dell‘anima.
Un tempo leader dei Lift To Experience, il ragazzo faceva in tempo a pubblicare il cult The Texas-Jerusalem Crossroads e ricevere elogi da John Peel,
dopo di ché il gruppo si sbriciolava a contatto con lo showbiz e per via di
alcune tragedie personali. Josh reagiva con una ricerca di sé nella provincia del Texas, lavorando quel
tanto che bastava a una vita decente, senza smettere di scrivere canzoni nel mentre Lift To Experience
diventavano materia mitica.
Si spostava poi a Berlino e Parigi, andando incontro alla catarsi in alcuni spettacoli dal vivo tenuti senza
un piano preciso. Senza davvero voler tornare sulle scene, piuttosto scrollandosi di dosso il passato
con umiltà e nuovi argomenti. Non fosse stato per il riscontro positivo di alcuni concerti di spalla giustappunto ai Dirty Three nel 2009, non avremmo mai ascoltato questa ipotesi di Leonard Cohen che
si abbevera alla scuola dei cantautori texani, però consapevole della catatonia di Mark Kozelek e dello
slancio di Micah P. Hinson.
Capace, al posto di un romantico cinismo, di porgere cose commoventi come Honeymoon Is Great, I
Wish You Were Her e il folk dall‘afflato gospel Drive Her Out aprendo il cuore su un piatto d‘argento; di
toccare un vertice sublime in una Country Dumb da Townes Van Zandt in transito dal border al paradiso. Perché ha compreso che, se qualcosa è onesto e sincero, deve abbandonare il solipsismo e trovare
l‘altrui riscontro. Perché l‘Arte è comunicazione, e benché si tratti di un disco refrattario e scontroso,
basterà un‘ora al giorno per trovare un amico che accomapgni al di là delle miserie di ogni giorno, non
soltanto delle musichette che si dimenticano a una settimana dall‘uscita. Ci vuole coraggio e talento
per questo.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
Grey History - All Dead Stars (Radical
Matters, Febbraio 2011)
Genere: harsh-noise
Riprende il discorso esattamente da dove lo aveva
lasciato con Lucifer Over Disneyland, il duo Gianluca
Becuzzi/Fabio Orsi. All Dead Stars - sempre in cd-r in
cartonato 7” dall‘iconografia potente e politicamente
scorretta - è il gemello diverso dell‘esordio e si nutre
della stessa, infame materia: harsh noise e power electronics sul versante musicale e immaginario pop-iconoclasta e humour nerissimo, su quello visivo.
Il declamare icastico di Becuzzi sul tappeto industrial74
noise dell‘opener All Children Are Fascists, il glitch subacqueo e imputridito di Put Pregnant And Leave Is Very
R‘n‘R, il noise granuloso e ispido delle due parti di Cocaina Toilettes Tour, l‘ebm malevola in bassa battuta di
Nietzsche Fucks Christ e i droning montanti della conclusiva Girls Usually Bleed, sono esempi del procedere
musicale estremo del duo.
La chiave di volta per comprendere a fondo il portato
del progetto Grey History risiede però nello humor cattivo e nerissimo, nella filosofia anti-politically correct,
contro il finto buonismo di fine millennio e l‘incapacità
di prendere posizioni nette che i due sbattono in faccia
Gurun Gurun - Gurun Gurun (Home
Normal, Aprile 2011)
Genere: indietronica
Gurun Gurun è la creatura poliglotta e transcontinentale di tre polistrumentisti (Tomas Knoflicek, Jara Tarnovski, Federsel) che rimbalzano tra l‘est-Europa, l‘Asia
e il Nuovo Continente. Il trio, affiancato da una manciata di amici musicisti, affida a un disco omonimo un
esordio che ci fa tornare senza interferenze agli anni
dell‘indietronica Morr con qualche picco di ricerca (sui
rumori di fondo) alla The Books.
Sia all‘orecchio che ha attraversato quell‘onda, sia a
quello digiuno, appare evidente l‘eccessivo affidarsi a
una formula-canzone dilatata ma fermamente ancorata alla melodia eterea della vocalità. Le voci - e i testi
- sono esclusivamente giapponesi (le ospiti più evidenti in casa Gurun Gurun, ossia Sawako, Moskitoo, Aki
Tomita), il tappeto strumentale un piccolo archivio di
micro-suoni, punteggiato qui da tocchi melodici di chitarra, là da accenni di ottone (ai fiati sono impegnate le
altre comparse dell‘album). C‘è però troppo miele, facili
emozioni, dentro alle canzoni.
In linea di massima, il sottofondo di piccoli frammenti,
concretismi, residui Books-iani è più originale della media del genere. L‘ossatura tronica arriva persino in qualche occasione (Io) a lambire l‘impro elettroacustica, o a
perturbare in maniera non scontata (Kúkó) la trasognata delicatezza delle melodie vocali, ma non abbastanza
da giustificarne l‘uso senza possibilità di alternativa. È
la pesantezza di un gusto, che si vuole paradossalmente molto delicato, a fare che questi “eppure” diventino
“nonostante”.
(5/10)
Gaspare Caliri
Harps Of Fuchsia Kalmia/Dora Bleu - Echo
Palace Of Finitude (Three Legged Cat,
Marzo 2011)
Genere: minimal-folk
L‘ultima manifestazione sonora di Harps Of Fuchsia
Kalmia prima della dismissione della sigla si avvale del
prezioso apporto di Dora Bleu, agitatrice del sottobosco americano (From Quagmire su tutti) e da qualche
tempo chanteuse dreaming in solitaria. La voce ammaliante ed evocativa di Dorothy Geller, questo il vero
nome dell‘americana, ben si allinea con le prospettive
sonore architettate da Salvatore Borrelli nella sua ennesima incarnazione dopo (etre) e Wondrous Horse.
Al primo ascolto identificabili col calderone post weirdfolk - poiché è da quella macro-area che i due protagonisti grossomodo provengono - le musiche di Echo
Palace Of Finitude sono invece più eteree e esoteriche
rispetto al canone di genere, caricandosi di una vena
darkish non comune se non volgendo lo sguardo ad
Albione. Spesso accomunabili a paesaggi ambientali di
matrice chamber-folk (la varia strumentazione usata da
Borrelli, in questo caso, aiuta molto), esse sono drammaticamente e teatralmente accese anche e soprattutto dalla voce della cantante, finendo con lo sfiorare così
atmosfere orchestrate e minimali alla Amber Asylum
o certo minimal-folk inglese di respiro pienamente bucolico e acustico.
Animi affini quelli di Harps/Borrelli e Dora/Geller in
grado di far scattare magiche e vibranti interazioni che
fanno di Echo Palace Of Finitude una raccolta lirica e
struggente come un sussurro ancestrale.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Harshcore - Ponytail, Ponytales (Lisca
Records, Aprile 2011)
Genere: experimental
Negli Harshcore di Luca Sicurtà e Tommaso Clerico c‘è
la stessa attrazione ludica nei confronti del rumore che
era tipica dei Throbbing Gristle. Paragone altisonante
ma evidente se si approfondisce l‘ascolto dei mille rivoli in cui il duo di Biella sparpaglia la propria personale
weltanschauung rumorosa.
Dismessi i panni dei rumoristi incompromissori e legati
all‘industrial da un approccio naif - da cui traeva ispirazione anche la scelta del moniker - i due elaborano
un caleidoscopio che si muove agile e sboccato tra experimental-sound (Clusterfuck) ed elettronica weird (le
increspature post-glitch di Divar), dark-ambient deformata (Neko Case In The Bluegrass o la Ponytail, Ponytales
Pt. 2 impreziosita dalla voce fantasmatica di Madame
P) e industrial-beat spastica (Taping Bones), non disdegnando squarci da contemporanea meets no-wave (Fable Cutoff) o loop e ritmi spezzati da hip-hop claudicante alla Consolidated (U Smilin‘).
C‘è però in questa apparente eterogeneità di forme e
contenuti, una coesione di fondo legata ad un linguaggio sardonico e pungente, autoironico e grottesco, circense a tratti nelle movenze, che si avvicina al senso
ultimo dei padri dell‘industrial citati in apertura.
Si obietterà che la nutrita messe di ospiti - To Live And
75
Shave In LA, Zeek Sheck, Bologna Violenta, Madame
P, IOIOI e molti altri ancora - possa aver detto la sua
in questo melting-pot stranito e straniante, ma così
facendo non si renderebbe giustizia ai titolari della
sigla. Esperti musicisti, sperimentatori indefessi e mai
domi esploratori di lande sonore periferiche ed entusiasmanti.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Head And The Heart (The) - Eyes Only (Sub
Pop, Aprile 2011)
Genere: americana
E‘ una felice casualità ad aver riunito quella che, da più
parti, è additata come una delle “sensazioni” dell‘annata. Correva l‘estate 2009 quando, nei sobborghi di
Seattle, Josiah Johnson e Jonathan Russell mettevano assieme i propri talenti di songwriter. Entro breve li
raggiungevano il tastierista Kenny Hensle, la cantante
e violinista Charity Rose Thielen e la sezione ritmica di
Tyler Williams (batteria) e Chris Zasche (basso). A inizio
2010 entravano in studio per mettere mano a un disco
dopo averne rodate le composizioni con un‘intensa - e,
stando alle cronache, notevole - attività “live”. Ne stampavano poche copie da vendere giustappunto ai concerti, esaurite mentre il cicaleccio si espandeva lungo
la costa Ovest.
Finché, a novembre, la Sub Pop non li metteva sotto
contratto ri-registrando Sounds Like Hallelujah e aggiungendo un paio di brani più recenti. I quali, come il
resto del programma, posseggono l‘urgenza emozionale di un Conor Oberst meno verboso e privo dell‘afflato emo. Che preferisce osservare le radici country e
folk e la loro trasfigurazione lungo i decenni per poi
dire la sua con attitudine sincretica. La scrittura poggia
però più sul pianoforte, su intrecci vocali perfetti e una
tavolozza strumentale ricca ma che valorizza le canzoni invece di appesantirle.
La penna è di caratura elevata e già matura: complessa
però brillante (i cambi di passo in Honey Come Home, la
festosa, beatlesiana Ghost) oppure di una malinconia
gioiosa (Coeur d‘Alene, la policroma title track); altrove
intrisa di dolcezza crepuscolare (accorate e robuste, Rivers And Roads e Down In The Valley) e capace di sparigliare le carte con disinvoltura (Heaven Go Easy On Me:
gli Eagles che, a lezione da The Band, raccolgono per
strada un gusto pop britannico e un finale cameristico;
le venature soul di Lost In My Mind). Materia appassionata e mai scontata, insomma, bastante a srotolare il
tappeto rosso per accogliere altri “nuovi tradizionalisti”.
Non una contraddizione in termini, casomai il miglior
76
complimento che ci sentiamo di esprimere.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Holy Ghost! - Holy Ghost! (DFA, Aprile 2011)
Genere: synth pop 80
Lo spirito santo degli anni Ottanta ritorna ancora una
volta, stavolta incarnato in due ragazzi di Brooklyn, al
secolo Nicholas Millhiser and Alexander Frankel. La DFA
di James Murphy non ha mai celato l‘amore per quella
decade di brillantini e il gruppo di nerd dei synth - che
per noi italo hearts potrebbero essere avvicinati alle
tamarrate intelligenti della Scuola Furano (Riotmaker
come DFA de noantri?) - ha da sempre trovato pane per
i suoi denti nell‘arte del remix nelle stanze hyper-cool
dell‘etichetta che ha alimentato il nu-rave.
Inevitabilmente le riletture andavano di pari passo con
quello che ribolliva nella mente del cantante degli LCD
Soundystem: e quindi pacchi di sonorità patinate à la
Hot Chip prima maniera, Hercules And Love Affair
e Juan MacLean, con cui hanno collaborato in studio
e in tour. Più che creatori, Nick e Alex hanno da sempre sgobbato come remixers. La raccomandazione di
James li ha portati a toccare punte di hype che i nerd
dei sobborghi di Manhattan sognano: Moby, MGMT,
Phoenix e altri vip del giro giusto nu-disco. Ma oggi,
al debutto, come suonano? Il nerdismo è la loro arma
fondamentale.
Concentrati in un recupero di tastierine, echi e altri FX
di quegli anni suonano come se il tempo non fosse
passato. O meglio, dato che da poco abbiamo capito
che i nonni di quegli anni stanno tornando in massa
per sbancare i botteghini con tonnellate di nostalgia
soporifera (Human League, Duran Duran e OMD, tanto per citare i più recenti), la domanda nasce spontanea: che hanno di meglio gli Holy Ghost! dei matusa
incartapecoriti in riciclo continuo? Il tiro, il sorriso nerdy, la voglia di mettersi in gioco e di far divertire. In una
parola la freschezza necessaria a rivangare un passato
e a scagliarlo nel futuro.
Tra le altre muse ispiratrici obbligatora è la citazione dei
New Order, di cui qualche tempo fa hanno celebrato
la hit Confusion con il singolo I Will Come Back, Giorgio Moroder (Wait And See), i Depeche Mode (Hold
My Breath) e tornando al presente la Kitsuné (Hold On è
già apparsa in una compilation della maison francese).
Crogiolarsi nel retrofuturismo può essere deleterio, ma
per ora gli Holy Ghost! non hanno ancora saturato le
aspettative. Buon proseguimento.
(7/10)
Marco Braggion
Howe Gelb - Alegrias (Fire Records, Marzo
2011)
Genere: folk rock
Ideato e pubblicato solo per il mercato spagnolo, questo Alegrias ha avuto lo scorso anno un successo tale
da meritarsi oggi la distribuzione internazionale. E’ il
caro vecchio Howe stregato dall’atmosfera di Cordoba,
accompagnato da una band flamenca di ascendenze
tzigane (i Band Of Gypsies) e prodotto nientemeno
che da John Parish. Un pugno di tracce nuove ed il resto del programma (in tutto 13 pezzi) impegnato a rivisitare il repertorio con la flemma torbida e la malinconia stropicciata d’un mariachi stanco, ferma restando la
dimensione gelbiana di cui ben sappiamo - amandole
- le malie narcotizzate, la devozione spersa, le visioni
sospese tra fervore e stramberia.
Ebbene sì, ci ritroviamo pur sempre sprofondati nella
stessa poltrona che da Hisser a The Listener passando
da Confluence ci contiene e consola ricordandoci la
struggente finitezza delle cose, il polverizzarsi dei sogni nel mortaio del disincanto. Messa quindi in conto
una certa inerzia, o se preferite un’ombra di morbida
autoindulgenza, va detto che stiamo parlando di un disco prezioso, perché in esso l’immaginario desertico di
Gelb si coniuga d’Andalusia riverberando suggestioni
latine meravigliosamente apolidi, come rumbe sciroppose tra miraggi bossanova, come fremiti gitani strattonati country-rock.
Particolarmente riuscite le riletture di Cowboy Boots on
Cobble Stone (benedetta dalla chitarra virtuosa di Raimundo Amador), 4 Doors Maverick e Uneven Light of
Day. Tra le canzoni di nuovo conio, notevole The Ballad
of Lole y Manuel e la breve Lost Like a Boat Full of Rice
con l’accorato rigurgito da pianista “felonious”.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Human League (The) - Credo (Wall Of
Sound, Marzo 2011)
Genere: synth pop
L‘ultimo disco della lega umana risale al 2001. E anche
se siamo in pieno revival anni Ottanta (vedi i ritorni di
Orchestral Manoeuvres In The Dark, Duran Duran
e dell‘iconografia di quel decennio nel glo), di dischi
che rifanno solo il passato non se ne sente proprio il
bisogno. All’inizio degli anni zero aveva infatti un certo
senso estetico/politico riportare in primo piano quelle
sonorità synth-based; oggi invece i riciclati entrano nel
meccanismo di vendita e cercano di arraffare (senza alcuna velleità estetica) fino all’ultimo quattrino, sia dal
pubblico che li adorava trent’anni fa che dalle nuove
leve che assistono stupite ad epifanie impolverate.
Anticipato dal singolo Night People, che ricorda i Depeche Mode più marziali ed elettronici (periodo Some
Great Reward per intenderci), l‘album è una carrellata di
ricordi pop che Philip Oakey tenta di ringiovanire con
qualche effetto speciale e con l‘aiuto delle sempreverdi
vocals di Susan Ann Sulley e Joanne Catherall.
Il risultato è un memorabilia che non coinvolge, passando dal synth pop più squadrato e prevedibile (Sky),
al vocoderismo attualizzato now, che però stride con
le tastiere di vent‘anni fa (lo spettro di Cher incombe in
modo imbarazzante sul secondo singolo Never Let Me
Go). Le tensioni da club-dark (Egomaniac, Single Maniac) e le progressioni à la Moroder (nell‘onesto Electric
Shock) e gli occhiolini al synth pop più glitterato che
mai completano un quadretto da dimenticare.
Fra dieci anni probabilmente uscirà un altro disco degli HL. Speriamo che nel frattempo si siano stancati di
riproporre le loro fotografie di gioventù, magari considerando l‘idea di prendere qualche strada nuova, o in
alternativa di ritirarsi a godere di una meritata pensione.
(4/10)
Marco Braggion
Ignaz Schick/Dawid Szczesny - Live In
Geneva (Zarek, Marzo 2011)
Genere: elettroacustica
Non è la prima volta che i nomi di Ignaz Schick e Dawid Szczesny si compongono per una pubblicazione
a duo. Successe già con The View Underneath, uscito
per la Non Visual Objects tre anni fa. E anche Live In
Geneva vive dello stesso contrasto tra l‘attitudine ai
suoni/rumori forniti dagli oggetti di Schick, oltranzista
dell‘analogico, e i droni elettronici di Szczesny.
Di fatto, il concerto cui si allude nel titolo non è così
recente da giustificare una sostanziale evoluzione da
quella prima esperienza: testimonia infatti una performance congiunta del novembre di tre anni fa, avvenuta appunto a Ginevra, al Cave 12/L’Ecurie. Per di più, al
risultato del live non è stato applicato nessun lavoro di
afterediting. Non ci sono overdubs o tagli; quello che
sentiamo è l‘intero act del duo tedesco/polacco. Eppure tra Ignaz e Dawid si sente una capacità notevole di
creare con la propria musica lo spazio per quella altrui.
Nei cinque movimenti, l‘elettronica sibila e lascia che il
protagonismo degli oggetti salga (Movement 2), il drone cerca armonie sostenendosi ai rumori ritmici (Movement 3), il computer allestisce l‘arena cosmica per i
timbri più perforanti (Movement 4).
In realtà Schick è sempre di più un nodo nella rete elet77
troacustica tedesca, fatto documentato dalla curatela
del Echtzeitmusik Festival 2010. Dove “Echtzeitmusik”
vuol dire real time music, e dunque impro. Ma è la collaborazione, la co-progettazione, la messa in sintonia
tra i compositori (o improvvisatori) come fossero strumenti di una meta-composizione a diventare sempre
più la chiave della scena, in Italia come negli angoli di
Kreuzberg. È il metodo odierno di declinazione dell‘eccellenza.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Insane Warrior (The) - We Are The
Doorways (RJ’s Electrical Connections,
Marzo 2011)
Genere: electro-funk-fiction
Accantonati per un momento i territori indie-hop del
recente The Colossus, il produttore-musicista dell’Ohio
Rjd2 cambia pelle, e con il moniker The Insane Warrior mette in scena We Are The Doorways, dieci brani
electro-psych-funk interamente strumentali, ispirati dalla passione per i film horror-sci-fi in salsa ‘70s. In
pratica?
In pratica il lavoro si muove tra avanzi di new jazz, soprattutto nel campionario di basi breakbeat-downtempo che ricordano le produzioni Tru-toughts da Stonephace ai Belleruche, e synth funkeggianti che spesso
citano i Goblin e odorano di moog, minimoog e vocoder. Ecco allora, e tra i momenti migliori, il lounge-funk
ispirato di The Water Wheel, oppure Then You Hear A Footstep, duetto di trombe e tastiere sugli unici barlumi
hip-hop del lotto, e ancora il synth-spacing frenetico di
Whitin The Maze per finire conla ninna nanna tintinnante di Saint Ignatius Bellse.
Ogni tanto, specie nella seconda metà dell’album, c’è
spazio per qualche sbadiglio quando gli svolazzi psych
esagerano fuori controllo (Trail Of Fire un esempio su
tutti), ma nel complesso l’originalità della proposta di
Rjd2 colpisce nel segno. Rimane un disco di nicchia che
non interesserà a molti, e per certi versi sarà un peccato.
(6.8/10)
Stefano Gaz
Iroha - Iroha (Denovali, Aprile 2011)
Genere: heavy-shoegaze
Muri di feedback, passo cadenzato e rallentato, cantato
sovrastato dal suono degli strumenti, tastiere circolari,
tutti gli stilemi dello shoegaze a cui va aggiunta un’evoluzione melodica post metal. Questo in sunto ciò che si
può rintracciare nell‘esordio lungo degli Iroha, nuovo
78
progetto di Andy Swan (Final) approntato con vecchie
glorie del giro post-industrial inglese (Diarmuid Dalton
dei Cable Regime e Dominic Crane già coi Rumblefish).
Insomma, un mix sulla carta interessante di paesaggi
ambientali tra il sogno ristoratore e l’incubo post-atomico, per molti versi affine alle ultime evoluzioni targate Justin K. Broadrick (Jesu su tutte) che, non a caso,
nel secondo disco bonus si occupa di un personale mixaggio dell’intero album.
Lasciando passare l‘utilità di questa ultima operazione,
Iroha è un disco su cui si posano molte riserve. Quando il gioco ad incastro tra rudi pesantezze da slowness
pos-industriale e celestiali aperture quasi-dreaming
funziona, il risultato è sicuramente coinvolgente come
in Last Day Of Summer, Watercolours o Reminisce, lontane dall‘essere originali. Molto più spesso però è un
retrogusto troppo evidente di deja-vu che non lascia
mai il segno fino in fondo e si unisce alla sensazione,
nemmeno troppo sbagliata, di ascoltare sempre lo
stesso pezzo.
(6/10)
Francesco Asti
Jaruzelski’s Dream - Jazz Gawronski
(Clean Feed, Marzo 2011)
Genere: avant-jazz
L‘immaginario iconografico di per sé dovrebbe bastare
a rimandare ad una dimensione ludica e a un approccio
non serioso alla materia del jazz. Moniker, titolo dell‘album e dei 12 pezzi che compongono Jazz Gawronski
sono calembour linguistici tra il surreale e il pastiche
disseminati dal terzetto italiano per suggerire finalità
e attitudine.
Non a caso composto da membri provenienti dai poli
attrattivi più interessanti del (neo)jazz italiano - El Gallo
Rojo e Improvvisatore Involontario - il progetto Jaruzelski’s Dream è l’esatta somma dei singoli elementi
in gioco: una vulcanica eruzione di follia strumentale,
giocosa attitudine demistificatoria, irregolarità avventurose e, paradossalmente, coesione interna rese con
leggerezza e (auto)ironia.
Piero Bittolo Bon (sax alto, smartphone) e Stefano Senni (contrabbasso), entrambi da El Gallo Rojo, insieme
al batterista extraordinaire Francesco Cusa (colonna
portante di Improvvisatore Involontario) inanellano discorsi di jazz free-form in modalità first take attraversati
da un senso del groove profondo e irresistibile: ritmico
e forsennato, silente e sussurrato, l‘avant-jazz inteso dai
tre è pari alla attitudine iconoclasta e altamente ironica
che li porta a firmare pezzi con titoli come The Mastel-
highlight
Kode9/Spaceape - Black Sun (Hyperdub Records, Aprile 2011)
Genere: dubstep house
Il secondo album di Kode9 e Spaceape arriva a cinque anni dall’esordio Memories of the Future
(7.2/10), titolo che più afrofuturista di così si muore e lavoro pre-Untrue che infatti proponeva una visione dubstep ancora lontana dall’esplosione e - tutto sommato - dalla conseguente ortodossia Burialiana. Più che dubstep infatti, Memories era propriamente un dub minimalista e siderale, privo del rullante anticipato così
caratterizzante per il genere. C’era lo spokenragga ipnotico di Spaceape, si
sentivano forti le eredità downtempo, trip hop e - soprattutto - della miscela noir del primissimo The Bug. Atmosfere notturne e claustrofobiche,
ma anche un suono “intellettuale”, stilizzato, profondo e cremoso, che ne
faceva un disco in qualche modo da sottofondo (9 Samurai a parte).Kode9
ha prodotto poco da allora, ma si è mosso tantissimo all’interno della scena
(basti guardare alla “riforma” del catalogo Hyperdub degli ultimi due anni e alle relazioni intrecciate con
la Brainfeeder lotusiana), tanto che era lecito aspettarsi un disco anche molto attento ai fermenti now
e - passateci il termine osceno - sperimentale. E invece Kode sorprende con un album che continua in
coerenza il suo discorso, iniettando nella miscela originale una bella dose di energetiche suggestioni
tech-house (le stesse attorno a cui ruotava il Dj Kicks uscito a metà 2010), irrobustendo la ritmica e i
cantati, ora più fisici, in un tripudio di synth, controtastierine laser e mini breakbeat (sarà interessante
confrontarlo con l’imminente Africa Hitech). Ne viene fuori un lavoro che, pur elegante e incapace di
nascondere certi tratti anche cerebrali (nelle stilizzate figure break, nelle stratificazioni delle trame tastieristiche), vuole soprattutto far muovere il sedere in pista.Tolti un intermezzo a base di accordi liquidi
di tastiere fusion (Hole in the SKy, fascinoso ma che andava sviluppato), un semplice esercizio di ritmi
spezzati su tappeto synth (Otherman) e la delusione totale del feat con Flying Lotus (un nulla ambient/
noise-cameristico che mette assieme tastiere da chiesa e crepitii da falò; è la traccia conclusiva), il resto
è tutto materiale di altissima qualità. I tribalismi poliritmici di Black Smoke e Bullet Against Bone, la sospesione pulsante di Promises, l’assalto street di Am I; ma, soprattutto, il trittico con i feat della vocalist
Cha Cha: la cavalcata deephouse in odor di Cooly G Love Is the Drug (primo singolo), la rarefazione
house tagliata secca da rullante e inserti di tastiere che si muovono come archi sinistri Neon Red Sign,
l’assalto funkysoul trasfigurato street di The Cure. E l’anthemico dittico oldskool tech-house (“potete
sentirlo?”) Black Sun (remix della bomba sganciata nel 2009)/Green Sun (il pezzo migliore del lotto?).
Un secondo lavoro che rifugge il sensazionalismo sonoro e cerca una via personale per mettere assieme, con stile, testa, atmosfera e dancefloor.
(7.4/10)
Gabriele Marino
la Variations, Zibibboniek, The Amazing Kaczinski Twins,
Soulidarnosc.
Vere e proprie gioie per chi ascolta e l‘ennesima dimostrazione dell‘effervescenza del jazz informale e atipico
che gira da tempo in Italia.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Jim Jones Revue (The) - Burning Your
House Down (Pias, Febbraio 2011)
Genere: r ’n’r
Se nell‘ultima manifestazione sonora (Here To Save
Your Soul - Singles Volume One del 2009) i cinque Jim Jones Revue garantivano la musica adatta a
smuovere “any house party till the roof falls in”, ora col
comeback vero e proprio la casa la vogliono proprio
dare alle fiamme.
Il bello è che non mentono affatto, a giudicare dal79
la cover e dall‘alto tasso di pura energia incendiaria
messo in scena.
Il comeback del quintetto capitanato dall‘ex Thee Hypnotics Jim Jones è un vero e proprio cataclisma che
prende il rock‘n‘roll dei primordi, quello vergato a sangue dal ribellismo alla Jerry Lee Lewis e dall‘anticonformismo del secondo Elvis, e lo rovescia dal di dentro.
Chitarre selvagge e un piano posseduto dallo spirito
iconoclasta del killer della Louisiana, accendono la luce
nell‘opener Dishonest John per spegnerla una mezzora
dopo con Stop The People.
In mezzo un florilegio di melodie urlate dalla voce graffiante del frontman, stomp-rock assassino, riff rubati di
peso al blues del delta e riletti ora in chiave rock, ora
hard, batteria che è un carrarmato e basso-caterpillar
a serrare le fila di un suono che rinverdisce i fasti dei
reietti del garage-rock. Da quelli passati a miglior vita,
Sonics e MC5 su tutti, a quelli che invece hanno fatto
del rock uno stile di vita, vedi alla voce Jon Spencer.
A predominare, in Burning Your House Down, è sempre
la musica del diavolo, ma da un demone del rock come
Jim Jones cos‘altro ci si poteva aspettare?
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Julia Stone - The Memory Machine (Pias,
Aprile 2011)
Genere: 60’s folk-pop
Figlia di musicisti, Julia Stone si è ritagliata con il fratello Angus un piccolo spazio dalle nostre parti tramite
Big Jet Plane, brano che - estrapolato dal loro secondo lp Down The Way - ha chissà come goduto di una
certa esposizione radiofonica. Additando il nome a
Giorgio Armani, che del duo sceglieva un altro pezzo
per accompagnare le sue sfilate. Al di là del gossip, la
sostanza restituiva un passabile folk-pop che avrebbe
rimandato l‘ascolto di questo album solista di Julia.
Talento invece più che discreto, la ragazza porge una
manciata di confetti mai melensi con modi da signorina per bene, con una voce da bambola di porcellana
su fondali di batterie spazzolate e chitarre acustiche, di
pianoforti leggeri e archi svolazzanti.
Fa pensare a una Hope Sandoval che preferisce Claudine Longet ai Velvet Underground e alla psichedelia (This Love, la title-track). Altrimenti una Isobel Campbell rimasta nei Belle & Sebastian e refrattaria alle
avance di Lanegan la frizzante Catastrophe!). Ancora,
una Joanna Newsome metropolitana e pertanto priva di tentazioni classicheggianti (una Winter Weekend
a metà strada tra Where The Wild Roses Grow e Famous
Blue Raincoat; il notturno incanto jazzato Lights Inside
80
This Dream; il minuetto Where Does The Love Go?). Arrangiato con misurata eleganza e forte del traslucido
apice Maybe, The Memory Machine non sfigura vicino
all‘esordio di Anna Calvi e al nuovo capolavoro di P.J.
Harvey. Conquista senza strafare, come una studentessa straniera - colta, bella, un poco timida - incontrata
per caso a una festa movimentata.
(7.1/10)
Giancarlo Turra
Kilimanjaro Darkjazz Ensemble - From
The Stairwell (Denovali, Aprile 2011)
Genere: cinematic
L’idea che sta alla base dei Kilimanjaro Darkjazz Ensemble è tutta fuorchè originale. Il collettivo di polistrumentisti europei (ma di stanza in Olanda) nasce,
infatti, col preciso intento di realizzare colonne sonore
per film mai realizzati, mettendo dalla loro una potente
forza evocativa e una notevole varietà strumentale in
grado di far apparire agli occhi dell’ascoltatore immagini in movimento. Non è casuale che i due fondatori
Jason Köhnen e Gideon Kiers abbiamo musicato, reinterpretandoli, capisaldi del cinema muto come il Nosferatu di Murnau o Metropolis di Lang.
Il loro è un linguaggio fatto di jazz, trip hop, ambient,
post-rock, meno elettronico e più umanizzato rispetto agli esordi, capace di descrivere scene fortemente
caratterizzate da tinte noir e atmosfere fumose e impalpabili. Un clima soffuso che, però, crea anche una
sfuggevolezza della musica: non riesce, in definitiva, a
lasciare il segno ma tende a svanire allorché cessano le
immagini da essa evocate. From The Stairwell è un lavoro compatto e monocromatico, ricco di dettagli che riescono ad accrescere la qualità dell’ascolto e non farlo
cadere nella mediocrità. Purtroppo però non sufficienti
di per sé a farlo spiccare molto al di sopra.
(6.5/10)
Francesco Asti
Kills (The) - Blood Pressures (Domino,
Aprile 2011)
Genere: wave pop
Un bel sospiro e via, avanti col nuovo The Kills. Il quarto
in otto anni, giuro che non ci avrei scommesso. Invece,
rieccoli più civettuoli che mai malgrado s’impegnino
a fare i maudit con la solita imperterrita disperazione.
L’immagine ha poteri cosmetici pressoché illimitati,
ci vuole poco a sembrare figliocci del lato selvaggio
del marciapiede. Il suono invece no, è roba che svela.
Perciò ci son sempre parsi quella fuffa che anche questo Blood Pressure conferma all’ennesima potenza,
il deprecabile anello di congiunzione tra Royal Trux e
Roxette, la patina new wave spalmata a dissimulare il
piglio piacione.
Ma è un giochino fin troppo scoperto, è tutta una strategia pop di rinterzo: cos’altro ti dicono la brama costante di espedienti adesivi, tutti quei trilli acuminati, la
chirurgia di effetti (tremolo, phaser, flanger...), l’intrigo
pervicace dei corettini... Materiale di riporto sulla scorta
del cool d’inizio millennio azzeccato da White Stripes
e Yeah Yeah Yeahs, saltando a pié pari la fase dell’immediatezza (che tanto si esaurisce subito, come nei casi
sopraccitati). Canzoni che ti solleticano senza neanche
prendersi la briga di disturbare, blues liofilizzati a pulsare tra marcette acidule, fregole post punk e ghigni
glam(our).
Un autentico carosello dell’insulsaggine di cui VV e Hotel si stanno rivelando maestri: è giusto rendergliene
merito.
(5/10)
Stefano Solventi
Kurt Vile - Smoke Ring For My Halo
(Matador, Marzo 2011)
Genere: Folk
A due anni dall’ultimo Childish Prodigy si riaffaccia sulle scene Kurt Vile. Smoke Ring For My Halo non cambia
rotta rispetto ai precedenti lavori dell’ex War On Drugs,
ma ne fa nuovamente risaltare le doti creative.
Anche questa volta ci ritroviamo così a tirare in ballo
nomi di paragone piuttosto distanti da quel folk che
pure rimane struttura portante per le sperimentazioni
del nostro: la melodia limpida di Baby’s Arms, ad esempio, appoggiata su un seducente amalgama di chitarra
acustica, elettronica e psichedelia, giustifica la partecipazione al prossimo ATP gestito dagli Animal Collective; mentre On Tour, andatura sommessa ma decisa, è
un numero degno dei vari Go-Betweens e Mojave 3.
Ma ancora di più è opportuno spendere parole su Society Is My Friend, brano di punta del lavoro intero: da
un lato l’innegabile riconciliazione con l’americana più
epica, dall’altro un connubio di chitarre e synth che crea
veri e propri paradossi temporali, come ad esempio dei
New Order altezza Get Ready coverizzati con enfasi da
stadio dal Bruce Springsteen degli anni 80.
Il resto della tracklist non è altrettanto imprescindibile ma rimane mediamente gradevole, oltre che più
orecchiabile di quanto potrebbe pensare il neofita. Per
quanto particolare, lo stile di Kurt non rinnega infatti la
melodia ma anzi fa da insolita cornice per quest’ultima.
Il vero contrasto, casomai, è quello tra la cura per gli arrangiamenti e un songwriting che, per quanto ancora
discreto, sembra aver perso qualche colpo nel corso degli anni: un difetto che non compromette più di tanto il
disco, ma impedisce di classificare il nostro come autore di prima grandezza.
(6.7/10)
Simone Madrau
London Sinfonietta/Micachu & The Shapes
- Chopped & Screwed (Rough Trade, Marzo
2011)
Genere: acute pop
Arduo per Micachu & The Shapes stupire, dopo questa collaborazione con l‘ensemble orchestrale London
Sinfonietta. Registrata dal vivo nel maggio londinese di
due stagioni or sono, ispirandosi - chiaro in ciò il titolo
- alla tecnica del chopping and screwing dell‘hip-hop texano dei Novanta, che consisteva nel dimezzare il tempo di battuta fino a ottenere un senso di stordimento e
ottundimento. Logico, pensando a un DJ Screw che la
metteva a punto in quel di Houston grazie alla passione
per uno sciroppo contro la tosse che rallenta la percezione della realtà da parte dei neuroni.
Se a premesse tra loro diverse quanto polo ed equatore aggiungete gli strumenti auto-costruiti dal trio Mica
Levi/Mark Pell/Raisa Khan per fare tabula rasa in fase
compositiva, il quadro non vi sarà chiaro ed eccolo, il
pregio del lavoro tutto. Una imprevedibilità al riparo
da superbia e approssimazione, ottenuta imponendosi
mezz‘ora di sagace e oppiacea revisione dello stile “onice e assenzio” appartenuto alla 4AD più aurea. Indovinati goth-pop cameristici come Not So Sure e Everything
fanno infatti pensare ai This Mortal Coil mai esistiti,
strafatti di codeina e dotati di perverso umorismo.
A seduttori seduti comodamente su una ragnatela d‘archi e percussioni che al primo ascolto inquieta e, nel
giro di pochi passaggi, avvince come edera (l‘ambient
subacquea Medicine Drank; le movenze scivolose di Unlucky) anche quando cerca d‘intimorire (Low Dogg: una
Siouxsie alle erbe?). Ragioni d‘essere di un‘opera acuta,
che scompone con un sorriso l‘autocompiacimento di
troppa avanguardia.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Loves (The) - ...Love You (Fortuna Pop!,
Marzo 2011)
Genere: indie-pop
Introdotto da una copertina sinceramente tra le più
brutte circolate negli ultimi anni, l‘epitaffio targato The
Loves è in realtà un godibilissimo disco di indie-pop
meets 60s per il terzo millennio. Il marchio Fortuna Pop!
81
aiuta a fissare coordinate e riferimenti generici - tweepop rumoroso ed eterogeneo come da catalogo - ma il
collettivo inglese ruotante intorno a Simon Love va di
eclettismo poppy come di rado capita.
Tanto che i non meglio precisati musicisti presenti alla
registrazione di questo commiato discografico trasformano
Love You in una summa definitiva del proprio
sentire musicale e un perfetto omaggio ai fan prima
della dipartita ufficiale.
Twee-pop twangy (I Want Love & Affection (Not The
House Of Correction)), garage-bubblegum-pop citazionista (Bubblegum), blues‘n‘roll velvettiano (King Kong
Blues), il brit-pop spocchioso e liverpooliano (WTF? (Or
How I Realised I‘d Wasted My Life)) clangori spectoriani,
slanci beat e aperture al fifties sound (gli intrecci vocali
di December Boy), offrono una visuale caleidoscopica e
onnivora di una band indubbiamente minore ma non
per questo da dimenticare. Specie in queste giornate
d‘inizio primavera, il sound fresco dei The Loves ha il
suo fascino.
(6.2/10)
Stefano Pifferi
Low - C’mon (Sub Pop, Aprile 2011)
Genere: slow rock
Mai i Low avevano fatto passare quattro anni tra un
album e l’altro, perciò era lecito aspettarsi una discontinuità di qualche tipo. In effetti, C’mon interrompe
l’espansione prima rockista e quindi pop perseguita
dai precedenti due lavori, recuperando in gran parte
l’antico idioma messo a punto e consolidato nel 2002
con Trust (non a caso si sono recati nello stesso studio
d’incisione, una chiesa sconsacrata conosciuta come
Sacred Heart Studio). Nonostante ciò, riesce a non
sembrare un’operazione nostalgia mirata a compiacere i fan più stagionati (anche se in parte, ovviamente, lo
è), ottenendo una sorta di status neutro, atemporale.
Quel che affiora nelle dieci nuove tracce è infatti una
nervatura, una pulsazione, un mood che potremmo
definire classico o - se preferite - tradizionale. Una vena
folk-rock di stampo seventies, qualcosa di riconducibile al lirismo CSN&Y, alla mistica inafferrabile Gram
Parsons o ai Fairport Convention invaghiti d’America.
Una vena che a ben vedere pulsa fin dagli esordi, anche quando era meno facile avvertirla, sepolta sotto il
tumulto brumoso anni Novanta. In un certo senso, questo disco chiarisce come i Low siano sempre stati una
band Americana dalla calligrafia intensificata, distorta
e trasfigurata nel/dal caos contemporaneo. Ripensi alle
loro tipiche ballate, liturgie dalla estenuante incandescenza, per scoprirle perfettamente inserite nel lungo
82
solco espressivo di chi da generazioni esplora frontiere
emotive, civili e spirituali.
Oggi come e più di ieri: la reiterazione minimale e ossessiva di Nothing But Heart, il valzer incantato di You
See Everything, la processione onirica di Majesty/Magic,
l’incedere accorato di Witches e la trepidazione assieme
carnale ed eterea di Especially Me sono forse i momenti
migliori di una scaletta più fresca, ispirata e attuale di
quanto potessimo oggettivamente attenderci.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Luciano Maggiore/Francesco “fuzz”
Brasini - Chàsm Achanès (Boring
Machines, Marzo 2011)
Genere: drones
Nell‘ostico panorama droning nazionale e internazionale si è assistito negli ultimi anni ad una fioritura di
esperimenti e progetti, più o meno intelligibili e tollerabili, da far sembrare naturale parlare di textures,
droning, elettroacustica e feedback anche in circuiti
meno carbonari di quelli di solito appartenenti a certe
manifestazioni sonore. Non è il caso di Chàsm Achanès,
punto d‘incontro tra due sperimentatori dell‘area bolognese (quella che si muove tra il Raum e Sant‘Andreadegliamplificatori) che prende a prestito il titolo
da Parmenide per evidenziare il pozzo senza fondo di
devastante e struggente forza.
Luciano Maggiore e Francesco “fuzz” Brasini, in collaborazione col tecnico del suono Mattia Dallara, architettano un lavoro ostico e dall‘alto tasso creativo: un unico
take da 35 e passa minuti, registrato in presa diretta
all‘Officina 49, che difficilmente supererà la soglia dei
più devoti ascoltatori di musica sperimentale.
Ed è un peccato perché gli echi tombali e i riverberi
spettrali dell‘installazione sonoro-architettonica dei
due (chitarre elettriche per Brasini, nastri e dispositivi
elettronici per Maggiore, Dallara a supervisionare l‘ambiente acustico) si distribuiscono nei fondali oscuri di
drone magmatici e ambientazioni fantasmatiche, con
un ciclico procedere che porta da subito l‘ascoltatore
all‘abbandono al flusso e alla trascendenza. Un ininterrotto fluire per accumulazione e circolarità che, pur nella estrema pulizia della produzione, lascia il rammarico
per non aver assistito alla sonorizzazione live. Lasciarsi
avvolgere dalle volute di drones ascendenti sarebbe
stata una esperienza non da poco.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
highlight
Mariposa - Semmai semiplay (Trovarobato, Marzo 2011)
Genere: wave prog pop
I Mariposa portano ancora più avanti il discorso avviato con l’omonimo di due anni orsono e finiscono
col rigirare se stessi come calzini, scoprendo il lato reversibile di colori più sgargianti ma ugualmente
insidiosi, distopici, storti. Questo Semmai Semiplay potrebbe passare legittimamente per il loro definitivo coming out pop, ma in ogni canzone si
nasconde un virus, le melodie sono accattivanti ma infingarde come le alghe di Wanna Marchi, come un sorriso di Jesus Quintana, come una favola
di Terry Gilliam.Il suono è scoppiettante ma acido, pesca in un immaginario
deliziosamente affollato di retaggi sixties (il beat para-battistiano trasfigurato glitch di Santa Gina, la filastrocca barocca sbilanciata Canterbury di
Ma solo un lago) così come di wave guizzante e ipercromatica (il synth-rock
radente di Tre Mosse, gli Stranglers fumettistici di Chambre, i Talking Heads giulivi di Paesaggio indoor).
Tastiere, chitarre, flauti, percussioni, archi: la stratificazione sonora non cede di un millimetro, esaltandosi in un rinnovato equilibrio tra estro, preziosismi ed asciutta efficacia. E quanto siano bravi a spremere malsana incongruenza tra il canto pseudo-serafico di Fiori, i testi (ibridati alla bisogna con frasari
inglesi e francesi) e la musica neanche stiamo a ribadirlo: vedi il disimpegnarsi grottesco di Pterodattili
(frullato di Battisti panelliano e Dalla allucinato con guarnizione post-moderna Flaming Lips), la sordidezza etno-cinematica di Black Baby Hallucination (i Calibro 35 strattonati Pretty Things?), la squinternata esuberanza di Con grande stile (battente fregola folk-psych) e l’ineffabile trepidazione di Come
un cane (Bruno Lauzi in un soffice sudario electro-folk).
E’ un disco divertente nel senso che ti sbalza dalla consuetudine, ti spettina le coordinate, ti regala dubbi e pruriti mentali. E’ un disco straordinario.
(7.6/10)
Stefano Solventi
Lykke Li - Wounded Rhymes (LL Recordings,
Marzo 2011)
Genere: Pop
Meno suggestioni nordiche nella seconda prova
Wounded Rhymes: una scelta decisa per Lykke Li,
che dopo essersi fatta notare con l’esordio di un paio di
anni fa, Youth Novels, ha scelto per queste nuove registrazioni di muoversi dalla sua Svezia verso la più calda
Los Angeles. A uno sguardo sommario gli esiti dicono,
se non di un’atmosfera più solare, quantomeno di un
pop ora liberato dal suffisso ‘indie’, di un’opera meno
sommessa in cui la nostra lascia briglia sciolta alla propria voce e tenta approcci più diretti, urlati, aggressivi.
Partendo da ciò che già sapevamo ecco che l’interazione tra voce e percussioni, quasi un leit-motiv del
precedente lavoro, si fa più imponente: il beat sopravvive solo in un episodio comunque brillante quale è I
Follow Rivers, ma il resto sacrifica l’elettronica in favore
di ritmiche suonate. Una partenza come Youth Knows
No Pain sarebbe già indicativa ma nel merito a primeggiare è sicuramente Get Some, dirompente singolo che
non è sfuggito all’attenzione e alle conseguenti cure di
un remixer di lusso come Beck. Dopodichè la nostra
sceglie di prendersi ulteriori libertà e, con l’aiuto alla
console del Bjorn di Peter Bjorn And John, arricchisce
il disco di sfumature inedite: si ascolti la I Know Pain che
sembra ballad acustica come tante e all’ultimo minuto lascia posto a una coda dream-pop che semplifica
gli Slowdive più ambientali, o la Unrequited Love che
ipotizza le CocoRosie in salsa gospel; la Rich Kids Blues
che tenta la via di un’epica wave da Horrors ripuliti, o
la Love Out Of Lust che nell’omaggiare quasi plagia Atmosphere dei Joy Division.
L’idea è quella di un album ad ampio respiro, sospeso
tra echi 80, mainstream ‘intelligente’, (chill)wave e tutta
una serie di riferimenti entro cui la voce della nostra
dovrebbe fare da collante. In questo senso il gioco funziona: l’ispirazione non sembra costante e si oscilla tra
83
alti e bassi ma il disco ha una sua compattezza nonchè
una gradevolezza sufficiente a farsi riascoltare. Semplicemente manca ancora a Lykke Li una presa netta
di posizione, quel ‘capire cosa vuoi fare da grande’ che
crea lo scarto tra un’artista riconoscibile e possibilmente influente e una voce nel coro che tra le influenze
altrui si crogiola. Così, anche se quella formula pop a
360° varrebbe sulla carta il confronto con i primi dischi
di Bjork, la personalità per affrontare certi testa a testa
latita ancora: e i termini di paragone più verosimili per
qualità rimangono ora come ora Bat For Lashes o Florence And The Machine.
(6.7/10)
Simone Madrau
Marco Carola - Play It Loud! (Minus
Records, Febbraio 2011)
Genere: tech house deep
Il ritorno al disco dopo 8 anni vede il DJ napoletano alle
prese con un tribalismo denso di bassi e con una techno che si scosta dalle sue produzioni più dritte di qualche tempo fa per incunearsi in una deep da suonare
a volume altissimo. Avvolgente, pensato ovviamente
per il club (magari ibizenco, dato che il nostro suona da
anni nell‘isola, selezionando e mixando all‘Amnesia), il
disco si presenta come un mix continuo e senza tante
sbavature, come è ovvio che sia, dato che è stampato
sulla minus di Richie Hawtin. Bassi da panico, camere
blindatissime, ossessività condita con un savoir faire
che in coda senti avere il DNA mediterraneo.
Senza tagli nordici, il suono di Marco è una visione calda e pompante, mai barocca, un cono di luce strobo
che non finisce di pompare casse, rullanti, shaker e tutte le altre diavolerie ritmiche obbligatorie per approdare in pista. Nessun vocalismo, se non per qualche cut
qui e là: il monolite che ci offre il ragazzo è un prendere
o lasciare. A dispetto di tutto quello che sta succedendo nell‘house, sempre più virata verso la coolness, qui
si parla un dialetto antico, fatto di spostamenti lievissimi dal quattro, tagli trasversali applicati sulla pelle, tatuaggi indelebili per serate al fulmicotone che starebbero bene nei set di Plastikman, Loco Dice o Ricardo
Villalobos, sezioni mutanti in loop definitivi.
Con questa bombetta Carola mette in discussione tutto
un mondo che si specchia su se stesso e torna a parlare
di realness, cose che senti nei DJ set di Tania Vulcano,
Onur Ozer e pochi altri intriganti nomi provenienti dalla
comunità balearica. Deeppissimo nelle soluzioni, magmatico nello stile, senza equivoci di sorta sul risultato:
una tavolozza spalmata sui denti e sulla pancia tutta
da ballare, ovviamente col sorriso. Coniugare l‘anima
84
squadrata della mitteleuropa con il sanguigno balearico non è da tutti. Marco ce la fa alla grande. Seguitelo
e alzate il volume.
(7.2/10)
Marco Braggion
Marta Sui Tubi - Carne con gli occhi
(Venus, Marzo 2011)
Genere: art folk rock
Quarto album in otto anni, un processo di espansione
nella continuità che coinvolge anche - di conseguenza? - l’organico, dal momento che l’ex-duo è oggi un
quintetto, considerato l’ingresso in pianta stabile del
violoncellista Mattia Boschi. Un acquisto che determina ulteriore ispessimento della trama, indirizzata verso
una ricchezza carica di tensione, una gravità che pesca
nell’imprinting del folk mediterraneo per poi andare ad
incendiarsi rock (quella specie di grunge a spine staccate disposto a vampe e sfuriate psych). L’innesco è il
solito, ovvero il concitato dinamismo che intercorre tra
la chitarra ipercinetica di Carmelo ed il canto ventrale di Giovanni, quel loro fare disanima a sangue caldo
dello stare al mondo, dell’essere pervicacemente umani tra i rapporti di forza tragicomici della società degli
uomini.
Virtuosismi complementari corroborati da un senso
vivo della performance e un utilizzo delle liriche sempre
in bilico tra la sagacia e la rivelazione. Le dodici tracce
di questo Carne con gli occhi - prodotto dall’esperto
Tommaso Colliva - non deludono, ribadendo l’ispirazione che ha sostenuto i lavori precedenti, prediligendo
una più diffusa intensità alle tipiche scorribande genialoidi (che pure non mancano, vedi il cabaret psicotico
di Camerieri ed il facinoroso carosello di Muratury). Sarà
la maturità, sarà che hanno voglia di fare sul serio e di
farsi prendere sul serio più di quanto non sia finora
accaduto, probabilmente a causa di una calligrafia sì
insolita, originale ed esuberante, ma a gioco lungo il
laccio che ti fa cavalcare in cerchio.
Gli echi folk-studio di Cromatica, l’enumerazione filosofeggiante di Di vino, l’art-folk animoso de Il traditore,
l’impeto furibondo di Al guinzaglio e gli aromi palpitanti di Coincidenze sono gli episodi più riusciti di una
scaletta che sembra voler allentare la cavezza. E magari
- chissà - saltare il recinto.
(7/10)
Stefano Solventi
Matt And Kim - Sidewalks (Pias, Novembre
2010)
Genere: Indie-Pop
E’ una brusca discesa quella imboccata dagli ultimi
Matt And Kim. Un potenziale di produzione, di pulizia
e ricerca del suono e in generale di ‘forma’ come quello
dispiegato per questo Sidewalks (in regia c’è Ben Allen,
già visto con P. Diddy, Gnarls Barkley e gli ultimi Animal Collective) suona come un vero spreco se paragonato all’assenza pressochè totale di brani un minimo
rilevanti. Non solo: manca in toto anche quell’aspetto,
così comune ai progetti indie-pop più leggeri, che consiste di ritornelli non memorabili ma memorizzabili:
facilmente canticchiabili, insomma; e coinvolgenti, se
non sulla lunga distanza, almeno nell’immediato.
I Matt And Kim del terzo disco fanno venire in mente un improbabile supergruppo formato dai B52’s più
caciaroni che prendono in voce un Joey Ramone e
cercano di aggiornare la lezione del pop di allora. Peccato che quegli storici nomi avessero piena coscienza
di cosa fosse una melodia, avendone scritte nella loro
carriera di micidiali; e, se è vero che non si pretende
di raggiungere gli stessi livelli, pure sembra lecito
chiedere qualcosa di più al duo newyorchese. Perchè
si può fare sicuramente meglio di una Good For Great,
davvero insipida, o della stessa Northeast, ballata che
vorrebbe proporsi come l’asso nella manica del disco e
invece non regala sussulto alcuno. Quel poco di buono
si trova in un’intro come Block After Block e in una chiusura discreta come Ice Melts. Il problema sta nel mezzo:
non bastano i cori Ramones di AM / FM Sound, non basta la marcetta di Cameras, non basta qualche synth in
più del solito e qualche accenno di hip hop a salvare
l’ascoltatore dalla monotonia.
(5/10)
Simone Madrau
Matthewdavid - Outmind (Brainfeeder,
Aprile 2011)
Genere: psych ambient
Matthew McQueen aka Matthewdavid, giovane pupillo Dublab/Brainfeeder (e fondatore dalla label Leaving
Records), arriva al debutto su long dopo la solita trafila: talentscoutizzato da FlyLo, mini, collaborazioni, podcast. Undici frammenti brevi e una traccia conclusiva
lunga quasi sette minuti che sono la migliore (perché
peggiore) dimostrazione di come l’estetica lotusiana
sia da maneggiare con la massima cautela.
Qui è proprio tutta la stessa roba, una ambient a falde
larghe sporcata a botte di laptop e glitch, un’orgia di
stratificazioni polverose e sfrigolanti che si rigirano su
stesse senza portare da nessuna parte, nebbie di voci
lontane che si avviluppano attorno alle suggestioni
now del glo (l’abbastanza superdrogata International).
Quando c’è un ritmo che timido prende corpo è una
via di mezzo tra un wonky diluito e scassato e altrettanto diluiti ed estemporanei breakbeat. Nel migliore dei
casi non si va oltre l’epigonismo lotusiano (lo sfarfallare
siderale di Like You Mean It; la nebulizzazione di un motivetto facile facile in Cucumber-Lime).
Lo definiscono “post-psychedelic” e “sound collage artist”, ma a noi, ora come ora, per definirlo pare più calzante il termine incolore.
(4.5/10)
Gabriele Marino
Mauve - The Night All Crickets Died (Face
Like A Frog, Aprile 2011)
Genere: indie noise
Tre anni dopo il buonissimo esordio lungo Kitchen
Love, i Mauve da Verbania ci concedono il sophomore. Va detto subito che non delude questo The Night
All Crickets Died, anzi conferma in pieno la grinta
agile e intensa del loro indie rock, modellato a partire da spasmi wave, particelle shoegaze e turbe noise.
Piace la disinvoltura con cui producono urgenza ad un
tempo lieve e nervosa, capace di tumulto adrenalinico e rarefazioni fiabesche: Grasshopper In Your Hands
ipotizza gli Interpol tra perturbazioni Primal Scream,
Ludovico stempera subbuglio Arcade Fire e putiferio
Sonic Youth, Decay ed Hang_Over - vuoi anche per la
voce della batterista Elda Belfanti - giocano con palpiti e rarefazioni un po’ Scisma e un po’ Grimoon, Black
Dogs è un frutto colto da qualche parte tra i Pixies più
imbronciati ed i Verdena meno facinorosi.
Canzoni che prediligono la ricercatezza all’impatto, ma
che pure impattano con energia insidiosa, vedi le due
parti di The Solitude Of The Ship, apertura e chiusura di
programma dalle nuances psichedeliche e spacey. Un
buon ritorno.
(7/10)
Stefano Solventi
Mazes - A Thousand Heys (Fat Cat, Aprile
2011)
Genere: lo-fi pop
Un tuffo al cuore, non ci sarebbe neanche bisogno di
aggiungere altro. Soprattutto se, come il sottoscritto,
siete cresciuti studiando le traiettorie sbilenche dei Pavement come l‘abbecedario.
Dei Mazes, peraltro, avevamo già parlato esattamente
un anno fa, in occasione dello speciale sul DIY britanni85
highlight
Mirrors - Lights And Offerings (Skint, Marzo 2011)
Genere: synthpop
Ehi, che succede? Che il pop britannico ne abbia avuto abbastanza di lasciarsi calpestare dall‘infame
tacco colonizzatore dell‘indie yankee (o yankee-oriented, stile Mumford & Sons) e stia finalmente rialzando la testa? Cerchiamo un po‘ di capire come siamo arrivati a questo punto. Non che l‘output sia
mai venuto meno: l‘industria in UK non ha mai subito la benché minima flessione, in barba alla crisi. È
una questione di qualità: fatti salvi l‘hype pitchforkiano di band in stile xx o
These New Puritans da un lato e la rivoluzione dubstep dall‘altro, sembra
che negli ultimi due o tre anni Albione non sia stata in grado di tenere il
passo, o meglio di regalare realtà genuinamente brit che potessero dar vita
a una nuova stagione pop come si deve. Foals? Ma per piacere. White Lies?
Sì, ma dipende dalla vostra età. E sinceramente, i barocchismi prog-oriented di Everything Everything o degli ultimi Klaxons sono roba un tantino
spinta per essere considerati puramente pop. In sostanza, dopo gli Arctic
Monkeys, niente. Quindi, che succede?
Succede che a inizio 2011 ti escono a distanza ravvicinata un paio dischi
che suonano come due sonori schiaffoni, brusco ma necessario risveglio dopo una stagione di - pur relativo - torpore pop. Detto che i Chapel Club di Palace sono una delle cose più belle accadute dai tempi
di
(riempite pure voi lo spazio), questi Mirrors da Brighton hanno chiaramente intenzione di riscrivere
la storia del britpop anni ‘10 a suon di cari, vecchi synth. Come dite? Gli Hurts? No, un po‘ troppo mainstream. Piuttosto, l‘anno scorso non c‘erano stati quei Delphic che, benché più sbilanciati sul versante
New Order, erano già sull‘ottima strada? Verissimo, peccato che ce ne siamo accorti giusto in quattro.
Tempi forse non ancora maturi per capire che qualcosa si stava muovendo: perché sotto l‘assodato
ammodernamento di sonorità eighties si muove tutta un‘onda fatta di grandi canzoni. Erano quelle a
latitare, e quindi eccole finalmente emergere per annunciare la nuova alba del pop inglese. Beh, se si
ha un debole per OMD (non a caso mentori del gruppo dai loro primi passi), gli Ultravox più romantici,
i Depeche Mode di Speak & Spell (Searching In The Wilderness sembra proprio sfornata da Vince Clarke)
e - ovvio! - Kraftwerk è certo più facile innamorarsi all‘istante di quattro ragazzi che sin dalla copertina
ammiccano con ironia all‘eleganza teutonica di Trans Europe Express, riprendendo peraltro nelle primissime battute del disco l‘infinita spirale di Europe Endless (o magari di Baba O‘Riley, quando non di Terry
Riley stesso).
Ma è altrettanto certo che Fear Of Drowning ha quell‘incedere da anthem che fa grande un singolo
(esattamente come Surfacing dei sunnominati Chapel Club), e lo stesso dicasi per Somewhere Strange,
Into The Heart, Ways To An End, Hide And Seek. Come da onorevole tradizione sintetica c‘è sì da ballare e
da godere di melodie istantanee e architetture solide ed intelligenti, ma nel nostro caso c‘è soprattutto
da gustare di un songwriting e di un canto che poco ha dell‘algido declamare del synthpop originario
e più del crooning accorato di un, mettiamo, Billy MacKenzie (Write Through The Night, Something On
Your Mind) quando non - per avvicinarci ai nostri tempi - di Win Butler, la cui ecumenicità è l‘obiettivo
finale. 2011: the year britpop broke. Again.
(7.5/10)
Antonio Puglia
co, anche se l’esordio sulla lunga distanza mostra una
capacità di scrittura che all‘epoca potevamo solo auspicare.
Riepilogando: John Cooper e compagni (la cui cittadinanza è divisa fra Londra e Manchester) sono artefici
86
di un pop fieramente lo-fi che guarda ai Novanta con
una abbondante dose di carattere (se non di originalità). Bastano un paio di pezzi pubblicati sul loro blog
per consegnarli all’attenzione delle minuscole etichette dell‘underground londinese, nella fattispecie della
Italian Beach Babes che li fa uscire come singolo.
Di quei due brani, uno si fa notare per il titolo curioso
(Painting Of Tupac Shakur), l‘altro (Bowie Knives) fra testi
nonsense e un andamento caracollante, rilegge in chiave glam la slackness di tanti anti eroi dei 90s. Insomma,
una delizia. Tanto che una Bowie Knives appena più
composta costituisce l’ombelico concettuale del loro
primo album; un disco che guarda all‘America scazzata
di Sebadoh e Pavement, ma lo fa con una sensibilità
tutta britannica.
Bastano i primi accordi dell‘opener Go-Betweens per
svelarne il segreto: schitarrata college rock (circa primi
REM), distorsione calda alla Dinosaur Jr. e tonnellate
di glassa melodica che solo gli inglesi quando fanno
il verso agli americani riescono a produrre. Dopo due
minuti è tutto finito. La successiva Surf & Turf è un po‘
più didascalica nel seguire i precetti di Lou Barlow ma
non meno azzeccata nella melodia. Cenetaph e Boxing
Clever tornano a parlare il linguaggio di Bowie con lo
slang di Steven Malkmus.
Alla fine (sorpresa!) i tredici frammenti si gustano tutto
d‘un fiato senza skippare niente, neppure i ventisette
secondi dell‘haiku Eva. Se non è un esordio coi fiocchi,
questo!
(7.3/10)
Diego Ballani
Moritz Von Oswald/Vladislav Delay/Max
Loderbauer - Moritz Von Oswald Trio
- Horizontal Structures (Honest Jon’s
Records, Marzo 2011)
Genere: ambient, jazz, etno
Pensavamo che i tre del Moritz Von Oswald di Vertical
Ascent e del Live In New York avessero inaugurato un
side project di lusso più che qualcosa di concreto e
continuativo. Eppure nulla, per il momento, vieta loro
di sfornare dischi tanto frequentemente quanto i cugini jazzisti, unendo esplorazione e affiatamento.
Horizontal Structures viene pubblicato ancora una volta dalla Honest Jon‘s di Damon Albarn ed è un lavoro
che innanzitutto risponde al mancato effetto sorpresa
attraverso il due elementi preziosi nell’economia del
sophomore: la chitarra blues psych silenziata di Paul
St Hilaire (aka Tikiman) apre magnifici ponti con l‘estetica bucolico new agey dell‘accoppiata David Gilmour
e Orb di Metallic Spheres (Structure 1), mentre il double bass di Marc Muellbauer (del giro ECM) introduce
chiaroscuri post-wave à la Bill Laswell perfettamente amalgamati nell‘ossatura ambient dub voluta da
Oswald, personaggio, ahinoi, sempre più evanescente
e auto confinato al missaggio e ai delay.
Altra caratteristica interessante - e la si nota in Structure
2 - è l‘esplorazione ancor più consapevole ed accurata
di quella terra di mezzo tra il sempre fondamentale My
Life In The Bush Of Ghosts di Brian Eno e David Byrne e i quartomondismi del proverbiale Jon Hassell, a
cui s‘uniscono il giro post-punk del basso e una chitarra
fusion balearica sullo sfondo.
L‘incursione funky spezzata della Structure 3 - con un
essenziale Louderbauer al synth dub/reggae - rileva
qualche pericolo di autoreferenzialità che ritroviamo pure nella successiva suite di 20 minuti (Structure
4), metà techno-dub metà kosmische tedesca con le
percussioni di Ripatti (non più in 4/4) e il funk acustico dell‘ottimo Muellbauer. La quinta traccia, disponibile nella sola versione in download, affonda ancor di più
nell‘esotico/esoterico dei 70s fino a perdersi nel mare
di Java.
Un più che discreto seguito con almeno due momenti
ottimi a inizio scaletta (Structure 1 e Structure 2) e della buona qualità nelle restanti tracce. È evidente: sono
stati i contributi degli ospiti ha dare linfa e sfumature
fondamentali a un lavoro che avrebbe potuto immaginarsi più ardito, a partire dall’autorappresentazione di
sé come ensemble aperto e non più come trio. Moritz,
del resto, assomiglia sempre più al Miles Davis deus
ex machina dei Settanta (Cobblestone Jazz prendete pure appunti). Se l’esordio era in verticale, perché
esplodeva della carica intrisa di novità, questo seguito
è in orizzontale: una meditazione rilassata ma pienamente cosciente su cosa sia l’elettronica now. E non è
poco.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Morning Telefilm - O time (Canebagnato,
Novembre 2010)
Genere: experimental, indie
Emanuele Gatti è una figura decisamente centrale nella piccola scena indipendente pavese. Già con Emily
plays e News for Lulu, consolida, con questo O Time, il
suo progetto solista Morning telefilm.
L’idea di fondo pare essere un progetto pop che non si
forza però di rispondere a certi dettami di omogeneità
tra i pezzi. Si comincia con un omaggio ai primi Arcade
fire con la splendida Billion billiards per poi recuperare un sound tutto acustico in Something within me e
abbandonarsi a ricordi glitch in The meaning of these
scarps o Provers and sobs.
La realtà è che la forza di un album come questo è
quella di riuscire a raccogliere brani non troppo annodati alla tradizione: O Time scivola da sé in zone nuove,
87
inesplorate, talvolta avvolte da sonorità rarefatte, antiche, e in altri casi, quasi anarchiche, futiristiche. Se Wax
è malinconia e Morganology, unico brano in italiano,
sembra d’ironia d’amore, una più classicheggiante e
l’altra più sperimentale, in ambedue sentiamo ugualmente forte la cifra stilistica di questa band.
Un lavoro solido, insomma, a dimostrare un’originalità
di raro spessore.
(7/10)
Giulia Cavaliere
Mostly Other People Do The Killing - The
Coimbra Concert (Clean Feed, Marzo 2011)
Genere: jazz
Se qualcuno avesse bisogno di fare un ripasso tutto di
un fiato della storia del jazz, dando, al contempo, uno
sguardo al futuro del genere, The Coimbra Concert sarebbe senz’altro il disco più indicato.
I Mostly Other People Do The Killing sfornano, infatti,
un doppio live che è un enciclopedia jazz messa in un
frullatore e poi rincollata con maestria pezzo per pezzo, senza rispettare affatto l’ordine iniziale.
Fatta d’improvvisazioni anarchiche tenute sotto pieno
controllo, la musica del quartetto è una metastasi benigna nel corpo del jazz: ne prende le cellule e le ricombina in forme cangianti e mai banali. Merito del bassista
Moppa Elliott (già con Puttin’ On The Ritz), i cui temi
portanti vengono presi dagli altri tre componenti - Peter Evans alla tromba, Kevin Shea (Talibam!) alla batteria e Jon Irabagon al sax - e dissezionati con irruenza,
sventrandone la struttura in mille pezzi. L’abilità maggiore dei quattro risiede però nella capacità ricombinatoria tra le parti, a volte anche in maniera oppositiva,
che dona loro una nuova luce: le melodie conflagrano
ma trovano sempre la strada per rimettersi sui binari
iniziali.
Con una particolare e mai irrispettosa irriverenza, un
notevole gusto per la parodia (ricorda qualcosa la copertina?) e un’energia invidiabile, i MOPDtK riescono
nel miracolo di far risultare estremamente divertenti e
godibili tutti i 100 minuti e oltre che compongono The
Coimbra Concert. Se pensavate che il jazz fosse noioso,
forse è bene che facciate un salto da queste parti.
(7.2/10)
Francesco Asti
Mount Fuji Doomjazz Corporation Anthropomorphic (Denovali, Marzo 2011)
Genere: impro-drone-jazz
È una strana creatura questo terzo lavoro dei Mount
Fuji Doomjazz Corporation, alter ego live-impro del
88
Kilimanjaro Darkjazz Ensemble. È un magma scuro
che si sparge lento lungo gli albori dell’umanità, a ripescare radici sonore ancora naturali per trasformarle in
un suono umano, in un elemento antropomorfo.
Questo unico, lungo flusso in 4 atti - registrato dal vivo
nel corso di tre diversi concerti tra Utrecht, Breslavia
e Mosca - è un qualcosa di sconosciuto, nascosto in
penombra in una parte non ben definita della storia
dell’uomo. Qualcosa di atavico e irrazionale risvegliato
dai lunghi droni e dall’ambientazione dark provenienti
dalle sorgenti sonore. Al contempo, però, è moderno e
ragionato come il trombone jazz di Hilary Jeffrey o le
note provenienti dal violino di Sarah Anderson.
Anthropomorphic sta in un territorio all’incrocio tra
ambient, jazz, elettronica, doom: impossibile darne
un resoconto preciso. Per spiegarlo si può accostare ai
passaggi più oscuri dei Supersilent, o rappresentarlo attraverso le immagini di David Lynch; certo è che
l’unico modo per capirlo è abbandonarsi ad esso.
(7/10)
Francesco Asti
Mountain Goats - All Eternals Deck
(Tomlab DE, Aprile 2011)
Genere: folk rock
Album numero tredici, se abbiamo fatto bene i conti,
per il trio californiano - ma attualmente domiciliato in
North Carolina - dei Mountain Goats. Senza contare le
cassette e gli EP che il buon John Darnielle - l’uomo che
tira le fila del progetto - iniziò a sfornare giusto venti
anni fa. Ogni volta tocca spendere le stesse parole, la
stessa stupefatta ammirazione per una calligrafia che
sa essere tesa, lirica, toccante, contemporanea senza
inventare nulla, limitandosi cioè a spacciare alt-folk irrequieto, ballate frementi, lo-fi facinoroso e accorato
retrogusto indie-rock.
C’è come un fuoco che brucia nel petto di Darnielle ed
il suo principale merito è saperlo impacchettare in un
flusso di versi febbrili, visionari, indocili, espettorati con
la penetrante concitazione d’un Mike Scott, d’un Robyn Hitchcock, d’uno Springsteen giovane. E ancora:
a momenti ti sembra un Daniel Johnston con gli ingranaggi (ancora) a posto, un Mark Everett senza nevrastenia, un Dan Bejar stradaiolo, un Gordon Gano
indolenzito. E’ insomma l’outsider della porta accanto,
così lontano così vicino dal nostro quieto vivere, un altro ordine di percezioni e sensibilità oltre quel pianerottolo socchiuso.
La chitarra, una batteria decisa ma frugale, tocchi di piano e tastiere discrete, giusto un soffio d’archi: questi i
pochi ingredienti di siparieti intensi come la palpitante
highlight
Pains Of Being Pure At Heart - Belong (Fortuna Pop!, Aprile 2011)
Genere: dream-pop
Bisogna ammetterlo. C‘era una grossissima attesa per questo comeback e l‘attesa, per una volta, viene pienamente ripagata. Belong propone il quartetto
newyorchese al suo zenith, in grado di mostrare maturità e consapevolezza
non solo dei propri mezzi ma anche del ruolo ormai assegnato al progetto
Pains Of Being Pure At Heart nell‘universo musicale odierno.
I quattro non si smuovono di un centimetro, ma la loro formula - rodata a dovere sui palchi di mezzo mondo e raffinata per mano di Flood (alla produzione) e Alan Moulder (al missaggio) - è semplicemente perfetta per equilibrio
e cognizione. Belong offre twee-pop rumoroso e dreaming ai suoi massimi livelli, saturo, dolciastro,
melodico e godibilissimo sia nei momenti più “irruenti” (The Body, Girl Of 1000 Dreams, Heart In Your Heartbreak), sia in quelli più tipicamente shoegazing e delicati (Anne With An E, Strange) e inanella gemme
su gemme in grado di passare in heavy rotation nelle discoteche alternative così come rimanere intrappolate negli i-pod di un seguito sempre più nutrito e - perché no? - intergenerazionale.
Scozia e Inghilterra, 80s e 90s, college-rock e Velvet, Nuova Zelanda e C-86, Smiths e fratelli Reid, Washington fine ‘80 e Williamsburg d‘oggi. Nel sophomore dei quattro si mescola tutto in un andirivieni
spazio-temporale che cattura dal primo ascolto e annienta le (eventuali) ultime difese. Un grande centro.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Damn These Vampires, le trasognate Age Of Kings e Outer Scorpion Squadron, la mesta Sourdoire Valley Song, le
trafelate Estate Sale Sign e Prowl Great Cain. Il momento
più insolito coincide con quella High Hawk Season che
affida la solenne trepidazione ad un coro “barbershop”,
con effetto straniante e confortevole ad un tempo. Ennesimo bel disco di un grande songwriter.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Mushy - Faded Heart (Mannequin Records,
Aprile 2011)
Genere: dreaming cold-wave
Mushy, ovvero l‘ennesimo gioiello gelosamente custodito dal sottobosco italiano. Non una novità vera e propria l‘esordio lungo della sigla dietro cui si nasconde
Valentina F., responsabile in solitaria di Mushy e personaggio noto nell‘ambiente musicale non solo italiano.
Le apparizioni live (una su tutte, il PRE fest con Current
93 ed altri), le manifestazioni via tapes e cd-r (per Cold
Current, Three Legged Cat, ecc) o le collaborazioni con
nomi hype come Mater Suspiria Vision - senza contare il talento grafico messo a disposizione delle release
Mannequin - stanno lì a dimostrarlo.
L‘appena uscito Faded Heart, però, chiarisce molto,
mostrando il perché di tanto interesse. Moderna chanteuse romantica e struggente, non lontana da certe sopravvalutate moaning stars (vedi alla voce Zola Jesus),
si muove leggiadra e sognante su una architettura sonora fatta di tappeti di synth, loops di drum-machines
analogiche, effettistica povera varia e una fluttuante
e droning chitarra acustica a quattro corde. Strumentazione minimale per costruire landscapes spettrali e glaciali atmosfere reminiscenti in egual misura di
Dead Can Dance e Cocteau Twins, minimal cold-wave
e esoterismo folkish e visionario made in Albione, impreziosito dalla heavenly voice dell‘artista romana. Calibrata su toni malinconici e evocativi, emotivamente
chiaroscura e drammatizzata è in grado di trascinare
l‘ascoltatore in un deliquio onirico segnando la cifra
stilistica più evidente di Faded Heart. Oltre ad essere il
vero scarto che separa la nostra da altre frequentatrici
di lande simili. Ottimo esordio.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
89
Noah and the Whale - Last Night On Earth
(Mercury, Marzo 2011)
Genere: rock/folk
Terzo disco per una delle band infilate in quel calderone giornalistico che è andato sotto il nome di nu-folk,
qualsiasi cosa abbia mai voluto dire mettere insieme il
pop/folk/rock raffinato di Noah and The Whale con le
nostalgie Seventies di Mumford & Sons. D’altra parte, soprattutto in ambito anglosassone, ci sono ancora delle riviste patinate da riempire di etichette e finti
scandali. Per cui, forse, un senso tutto questo ce l’ha.
Last Night On Earth arriva dopo First Days of Spring e
l’esordio di qualche anno prima. Siamo di fronte a una
band che con il terzo album vuole affrancarsi anche da
queste etichette e tracciare la propria strada nel music
business. Ci provano prendendo il materiale dei primi
due dischi, quello che affondava le radici nel folk britannico, e lo tingono di world (Life Is Life, L.I.F.E.G.O.E.S.O.N.),
di sentimenti americani in pieno stile Bruce Springsteen (Paradise Star, Give It All Back). Le melodie sono quasi sempre appiccicose e nel suo complesso Last Night
On Earth è un disco piacevole, che troverà spazio in
un airplay non strettamente legato al mondo indie. La
pecca è che provare a battere nuove vie compositive
ti riesce reinterpretando del gospel in chiave moderna (Old Joy), ma altre volte si scivola nell’imitazione dei
Coldplay (Waiting For My Chance To Come).
Un disco che conferma la buona vena melodica del
gruppo di Fink e soci e che è anche un tentativo apprezzabile di non riscaldare sempre la stessa minestra.
Ci sono cadute, anche se non così gravi, ma c’è sostanza sufficiente per costruire un futuro, con un sound che
ha preso al suo interno i sintetizzatori e guarda tanto
alle cose di casa propria (il Brit folk, Brian Eno), quanto dall’altra parte dell’oceano (il già citato Springsteen,
ma anche alla vena melanconica di certo cantautorato
americano).
(6.5/10)
Marco Boscolo
N_sambo - Sofà Elettrico (Snowdonia,
Febbraio 2011)
Genere: Electro psych
Tra rock sintetico, astrazioni psych, sogni androidi
kraut e brume pastorali folk, il livornese N_sambo confeziona un disco di debutto prontamente intercettato
da Snowdonia, che lo divulga col consueto spirito refrattario a mode e consuetudini. Questo Sofà Elettrico è in effetti album che sfugge alla trama di flussi e
riflussi contemporanei, deliziosamente fuori dai tempi,
abitato da visioni espanse in una combinazione pecu90
liarissima che gli consente di bazzicare electro-house
contagiata etno (Tre), ambient-pop digitale à la Boards
Of Canada (Edizione straordinaria), deliri radenti Syd
Barrett (Zappaterra) e ballate caliginose col petto pieno di nostalgia (Drake).
Molto sintetizzatore, chitarre, percussioni, effetti e campionamenti, ma anche flauti, organo, piano e tromba a
comporre un puzzle sonoro sì artefatto però insospettabilmente organico, come visioni colte ancora calde
da un immaginario senza preclusioni, si tratti di catturare nel retino le rarefatte geografie Jean Michel Jarre
(Sofà) o sgranare irrequietezze synth-rock vagamente
Cansei De Ser Sexy (Novembre). Notevole.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Orchestre Poly-Rythmo - Cotonou Club
(Strut Records, Marzo 2011)
Genere: africana
Senza tema di smentite “la più grande band del Benin”.
Oppure, come si prefissano i diretti interessati, l‘onnipotente. Giustificata guasconeria a parte, a contare è il
ritorno discografico dell‘Orchestre Poly-Rythmo dopo
più di vent‘anni sotto forma di un festoso biglietto da
visita destinato all‘Europa. Responsabile una Strut che,
seria come d‘abitudine, accoglie questi arzilli vecchietti
dopo un anno di concerti prestigiosi e il recente ripescaggio da parte di etichette come Soundway e Analog
Africa di brani di un repertorio ampissimo. Cose di una
fedeltà stereofonica non elevata ma artisticamente esaltanti, che mostravano un ensemble partito nel ‘64 come
Groupe Meloclem e giunto alla definitiva ragione sociale quattro primavere più tardi. Che nel decennio 69-79
segnalava un talento capace di spaziare da ritmi vodoun
al funk tramite la salsa e l‘afro-beat, vantando collaborazioni con Manu Dibango e le lodi di Fela Kuti.
Era nondimeno grazie all‘interessamento della giornalista transalpina Elodie Maillot che se ne scopriva la
grandezza: persasi dentro i loro album, si recava a intervistarli e fungeva da supporto alla preparazione di
questo lavoro che, registrato a Parigi con calde tonalità
analogiche avvalendosi di ospiti “influenti” (Angelique
Kidjo per il rutilare di Gbeti Madjro; Nick Mc Carty dei
Franz Ferdinand per la sensazionale afro-disco secondo i Talking Heads Lion Is Burning) alterna - senza cali
qualitativi - episodi del passato a materiale di più fresca
composizione. Echi caraibici e screziature soul, fiati pingui ma squillanti, un guizzare di chitarre tra tribalismi e
arguzie da cui non vorresti mai separarti.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
highlight
R.E.M. - Collapse Into Now (Warner Music Group, Marzo 2011)
Genere: pop rock
Se con questo album i R.E.M. avessero voluto compiacere se stessi e lo sterminato esercito di fans non necessariamente in quest’ordine - direi che ci sarebbero riusciti in pieno. Di più: col quindicesimo
album in carriera, affidato all’ormai sodale Jacknife Lee, hanno eretto un monumento al proprio fare
musica, un tour pressoché completo nel loro repertorio, opportunamente profuso e dissimulato nelle
dodici tracce in scaletta. Come se avessero semplicemente preso atto della preponderanza del passato,
accettandolo come strada percorribile in chiave futura. Non a caso si propone come un disco circolare,
o se preferite il loro tardivo ma non (ancora) senile perfect circle. Ballate struggenti ed assalti entusiastici si alternano tanto più prevedibili quanto più sostanzialmente riusciti, in virtù del mestiere e di quel
certo ingrediente magico altrimenti definibile fattore umano.
Prendi il valzer mesto e accorato di Oh My Heart, con la fisarmonica struggente e le naunce gospel apolidi, oppure quella Every Day Is Yours To Win che
ammicca la sdolcinatezza onirica di Love Is All Around e Find The River: ci vanno spudoratamente di pilota automatico, eppure l’azzeccano con un’efficacia
disarmante, come i lavori di bottega degli artisti rinascimentali. Viene da dire:
artigianato d’alto profilo. Considerazioni simili per All The Best, col suo saturare gli spazi d’impeto accattivante e caramelloso, ovvero come ti riciclo a
dovere glam, hardcore e college rock per compensare una certa pedanteria
melodica. Casomai metteteci pure quello scherzetto di Mine Smell Like Honey, tutto ruvidità intenerita
altezza New Adventures In Hi-Fi, e ancora il divertissement a fuoco alto di Alligator Aviator Autopilot
Antimatter, con l’espediente azzannaclassifica di Peaches nei cori.
Altri segnali inequivocabili: Uberlin che celebra una possibile via di mezzo tra l’era Automatic For The
People e quella Around The Sun; It Happened Today intenta a riprocessare con aria festosa una mischia
Shaking Through e Half A World Away, con Eddie Vedder partecipazione omeopatica tra i cori del ritornello; la conclusiva Blue che incede come una processione pari pari Country Feedback, il talkin effettato
di Stipe contrapposto all’intervento ieratico di Patti Smith prima di andare a spegnersi riesumando le
pennate squillanti e stoppose dell’iniziale Discoverer, innescando così la suddetta circolarità che è forse
il senso profondo del tutto. Praticamente in ogni episodio avverti la presenza assieme confortante e
fastidiosa dell’auto-clonazione, andazzo cui sfuggono per la sbrigliata agilità indie-wave la breve That
Someone Is You - tipo dei Go-Betweens anfetaminizzati - e una Walk It Back dall’incedere claudicante
non lontano dal teatrino amarognolo Wilco. Non è tutto, ma più o meno ci siamo.
Collapse Into Now è episodio ridondante nella lunga carriera dei R.E.M., caparbiamente ispirato e
prodotto con una cura ai limiti della leziosità. Ed è anche - malgrado gli anni implacabili, la fama debordante, i dollari a vagonate - una bella dimostrazione di persistenza nella dimensione entusiastica del
pop-rock. Ci sarebbe quel retrogusto stantio, ok, ma è sensazione quasi trascurabile.
(6.3/10)
Stefano Solventi
OvO - Cor Cordium (Supernatural Cat
Records, Aprile 2011)
Genere: sludge/doom
Quella degli Ovo è una parabola musicale ormai nota a
chiunque si occupi di musica in Italia. Storia di musica
e di vita, fatta di impegno, dedizione e passione, svisceratasi in centinaia e più concerti, collaborazioni ad ogni
latitudine, dischi d‘ogni formato per le etichette più
oltranziste del pianeta e progetti collaterali eccitanti
quanto il gruppo madre stesso. Con una identità sonora talmente evidente e fattasi classica che verrebbe
quasi da identificare gli OvO con se stessi e nulla più.
L‘ascolto di Cor Cordium - la nuova prova dell‘accoppiata Pedretti/Dorella, questa volta targata SupernaturalCat - sposta ancor di più il limite sonoro del progetto,
suggerendoci uno slittamento di significato: quella del
91
duo è etimologicamente musica doom. Non limitata,
cioè, a ripetere musicalmente i pesanti e lenti cliché
del genere estremo (seppur mischiato con avant-noise,
sludge, experimental e altro ancora), quanto a rimandare ad un immaginario da colonna sonora del giorno
del giudizio.
Cor Cordium è infatti un turbinio di emozioni estreme
da fine-vita, una sonorizzazione del trapasso, un deliquio di sofferenza e dolore mentre colonne di fumo e
cumuli di macerie fanno da scenografia ad un laico, infernale e maledetto doomsday. Di una lentezza esacerbante o ritmicamente accese, dalle vocals possedute o
dalle corde maltrattate, le dieci canzoni di Cor Cordium
sprizzano malessere e sofferenza da ogni poro.
Non è un caso che l‘album sia ispirato dalla figura di
Percy Shelley, maledetto e sfortunato protagonista di
un personale inferno in Terra.
(7.4/10)
Stefano Pifferi
Panda Bear - Tomboy (Paw tracks, Aprile
2011)
Genere: pop
È un campione dell‘arrangiamento d‘effetto, Panda
Bear. Conosce le nostre orecchie e sa su cosa puntare,
come allestire una forma canzone per appagarle. Del
resto - per quanto si possa discutere della qualità in
senso assoluto della produzione - agli Animal Collective non si può certo negare di aver costruito un gusto,
oltre che stilemi, appassionati, qualche detrattore e
una carovana di band tese all‘emulazione o a cogliere i
frutti del collettivo. Un po’ come successe per i Talking
Heads, se ci pensiamo.
Tomboy - a partire dalla title-track - è un condensato di
polpa Collective: crea melodie semplici e la sa amplificare con layer di ambiente stratificati. Person Pitch stupiva i più per la sperimentazione di studio. In Tomboy
c’è invece un gusto del montaggio che ha l‘obiettivo
della semplicità, della messa a fuoco dello strumento.
Ne perde la psichedelia e l’obliquità dell‘insieme, ma
ne esce in chiaro tutta la personalità per le masse di
Panda. A partire dalla voce, ovviamente, specchio mai
quanto per Noah dell‘anima, fino alla pratica musicale
della ripetizione (Slow Motion), quasi mantrica, dentro
a canzoni che non sono né più né meno che loro stesse.
Prendiamo Last Night At The Jetty: si gioca con i livelli
sovrapposti della voce, un coro interno che riempie lo
spazio tra le pareti, ma senza che il sound ne esca ostico. Potremmo anzi dire che questo è pop che trascende le scene (e i Beach Boys), che ha una classicità pal92
pabile, dove Lennox si propone come il Phil Spector
del passaggio tra anni Zero e anni Dieci. È lo studio che
fa la differenza (Scheherazade), finendo con il colmare
brillantemente anche alcune scelte meno felici (Friendship Bracelet). Si coglie la serenità con cui Panda ha lavorato nel suo studio di Lisbona, costruendo Tomboy.
Ma, fuori dalla biografia personale, ci sentiamo un percorso che parte da Brian Eno, e che si manifesta nelle
note infinite di tastiera (Drone), trasposte dall‘ambient
alla classifica ormai post-indie dell‘orsetto.
Tutti personaggi che hanno spostato l‘asticella del
benchmark nella storia della musica. È inutile nascondersi a cosa punti Lennox. A fissare un nuovo standard
della classicità indie-pop odierna, del cantautorato che
si annida in essa, dello studio che vale (concetto ormai
antichissimo) che vale più di una seicorde. La sfida con
Avey Tare - e con tanti altri - è apertissima, e i più punteranno i propri soldi scommettendo sull‘orso con l‘occhio cerchiato.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Peter Bjorn And John - Gimme Some
(Cooking Vinyl UK, Marzo 2011)
Genere: Pop
Un gruppo che è anche un insieme di teste pensanti
distinte e attive su diversi fronti quello di Peter Bjorn e
John da Stoccolma. Per dire, Bjorn Yttling si è dedicato
alla produzione artistica di numerosi colleghi svedesi
tra cui Lykke Li, mentre Peter Mòren si è già aperto una
strada in solo con The Last Tycoon (del 2008). Del resto,
la formazione, che con il presente lavoro arriva alla sesta prova in studio, non ha mai perseguito un modello
o un’idea di progetto artistico vincolante: il popolare
Writer‘s Block (quello con il singolo Young Folks, per
capirci) era fatto della più riconoscibile pasta indiepop, il successivo Seaside Rock pasturava uno scuro
instrumental folk, mentre il precedente Living thing
(del 2009) proiettava i tre su varie direzioni tra le quali
il binario wave tropicalista che tanto andava di moda
qualche anno fa.
Gimme Some è l‘album rock, o per meglio dire power
pop, quello che da un lato risposa il cosidetto mainstream e dall‘altro i soliti Beatles ma nell‘accezione dei
primi XTC (le anfetamine Mod di Black Book) o il più
ampio paradigma indie per il grande pubblico promulgato dai R.E.M. elettrici (Tomorrow Has To Wait).
Infine, c‘è tanto e di tutto dell‘immaginario pop in queste compresse canzoni in media di tre minuti, dagli
ovvi Sixties (Eyes, Dig A Little Deeper), fino al glam (Second Chance, (Don’t Left Them) Cool Off), dal punk-rock
highlight
Sean Rowe - Magic (ANTI-, Marzo 2011)
Genere: folk-rock-blues
Il ragazzo viene da Albany, stato di New York, e ha cominciato a calcare i palchi con la sua chitarra all’età
di tredici anni. Nella sua saccoccia tutte le strade senza fine dell’America, i monti Appalacchi, le lumberjack dei boscaioli, le camicie a quadri della working class che si ritrova in un diner, il whisky a buon
mercato, Henri David Thoureau e tutto il suo succhiare il midollo della vita.
Il ragazzo scrive canzoni che sono storie, perché la musica è la sua vita, è la Vita. Incide un po’ di canzoni, magari direttamente
nello stanzone sopra il ristorante di famiglia, in solitudine, baciato in fronte dal sole al crepuscolo, mentre i fantasmi di tutte le persone di cui parla si affollano nella mente, si insinuano tra le note, prendono
consistenza. La sua voce baritonale ha un timbro particolare, pieno e caldo, capace di dare vita alle
parole che canta. Ma ancora nessuno se n’è accorto. Che importa: si suona e canta per il gusto di farlo,
per la musica stessa. Il ragazzo ha questo pugno di canzoni pronte e levigate, custodite gelosamente
da chi le ha incontrate, e solo dopo un limbo nel sottobosco USA, un’etichetta vera, di quelle che hanno
ancora i talent scout con le orecchie aperte, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice: “Ehi, pubblicheremo
la tua roba”. Il ragazzo, con un sorriso timido, si fa accogliere da quelle ali protettive e ce lo ritroviamo
nello stereo. Quello che accade dentro a Magic è un continuo dialogo tra Sean Rowe, questo il nome
del newyorkese con la voce che ti stende, e una serie di padri nobili della musica che sta all’incrocio tra
il country, il folk e il blues: la storia stessa della musica americana. Ci si ritrova
tutti, da Bruce Springsteen a Steve Earle passando per Gil Scott-Heron e
scia blues a seguire. Partecipano al simposio anche alcuni ospiti venuti da
lontano, a cominciare da quell’irlandese testa calda di Van Morrison, quel
signore di Leonard Cohen e quel satanasso di Nick Cave. A stendersi come
un tappeto sotto alle storie di Rowe la chitarra (perché capita che il ragazzo
sappia anche suonare, oltre che cantare e scrivere) e molti altri strumenti (violoncello, xilofono, pianoforte, sintetizzatore, percussioni) spesso usati solo
per dare senso a piccoli dettagli e rendere così grandi le canzoni.
Il ragazzo adesso non sta più
dentro a una foto sbiadita in bianco e nero. Oggi il ragazzo ha preso la chitarra, se l’è messa in spalla e si
è messo in viaggio. Ha salutato gli amici/maestri e ha le spalle abbastanza larghe per mostrarsi a tutto
il mondo. Certo, ha ancora bisogno che qualcuno gli dia qualche consiglio, che qualcuno di tanto in
tanto gli metta una mano sulla spalla. Ma quando attacca una qualsiasi delle dieci canzoni che qui ha
voluto contenere, riesce a parlare direttamente al cuore di chi lo ascolta. Questa è la sua grande capacità: saper veicolare emozioni, e non vergognarsene, anzi trarne la forza per inchiodarti alla sedia. Non
è forse tutto quello che cerchiamo nella musica?
(7.6/10)
Marco Boscolo
(Breaker Breaker) al wave pop (la chitarra e basso primi
U2 di May Seem Macabre). Il tutto infiocchettato senza
fronzoli e grossi hit, con un gusto solare e positivo di
lungo corso, dolcezze e anfetamine al passino. Onestamente pop rock. Bravi.
(7/10)
Edoardo Bridda
Poisucevamachenille Poisucevamachenille (Outline Records,
Agosto 2010)
Genere: weird (-folk)
Il pescarese Ezio Piermattei esordisce con uno studio
solo project che farà la gioia degli appassionati di musiche weird. Poisucevamachenille (nome costruito secondo la regola delle parole-valigia di Lewis Carroll), 31
minuti senza soluzione di continuità, comincia infatti
93
highlight
Songs For Ulan - The Globe Has Spun And We’re All Gone (Stout Music, Aprile
2011)
Genere: folk blues rock
Cinque anni sono tarscorsi da You Must Stay Out, un lustro pieno per covare le dieci tracce che compongono The Globe Has Spun And We’re All Gone, album lungo numero tre per Songs For Ulan,
moniker dietro cui agisce Pietro De Cristofaro, napoletano classe ‘70. Alla produzione troviamo ancora
Cesare Basile, ed è una presenza pregnante, tanto quanto è palpabile la premeditazione, la densa brusca raffinatezza portata in dote da tutto il tempo speso a far nascere, crescere,
irrobustire e smerigliare queste canzoni. Ognuna un episodio vivo, intenso,
particolare. Dall’arrendevole risolutezza Jeff Buckley di Like TV all’asprezza
terrigna di Hook (prossima alla PJ Harvey più basale), il folk blues di De Cristofaro possiede la fisionomia cruda e penetrante di chi mette in gioco sentimenti reali, assolvendo ogni tetraggine con la vibrazione insopprimibile della
tenerezza, lasciando sempre aperto uno spiraglio tra fatalismo e speranza.
Ai blues ingrugniti e sordidelli di stampo Mark Lanegan (What Good Can Tell)
e al tumulto velenoso Nick Cave (From The Borders) rispondono quindi diafane processioni Black Heart Procession alleviate da un incanto dolciastro Devendra Banhart (la stupenda The Bed), narcosi
livide e iridescenti come un sogno trip-hop di Howe Gelb (You Only Love) e valzer enigmatici come
ambasce dEUS tra peregrinazioni Calexico (She’s A Ghost). Corde scorticate e incandescenti, fremiti di
contrabbasso, fisarmonica e xilofono alla bisogna, organi che pennellano sfondi noir, il drumming sospeso tra pulsazione frugale ed astrazione cinematica, sobri ma cruciali interventi sintetici (come nella
spettrale acidità di A Promise e nel rigurgito Sparklehorse di The New World): questi gli elementi di un
ordito su cui la voce ricama melodie indolenzite ma tenaci, vulnerabili e irrequiete.
In chiusura, la morbida rilettura della If It Be Your Will di Leonard Cohen - col sabbioso controcanto di
Dave Muldoon - sigilla alla perfezione il programma. Nel suo genere, uno dei più convincenti dischi
italiani degli ultimi anni.
(7.8/10)
Stefano Solventi
un po’ alla Third Ear Band, con percussioncine e archi che stridono maltrattati. Costruisce poi, sopra una
pulsazione percussiva di base (ma è tutto il disco ad
essere fortemente percussivo), una serie di alternanze
e di stratificazioni: un vociare tra Magma, free-folk e
giapponeserie psych-prog; zoppicanti e giocosi siparietti di un minuto o poco più (un oboe, un carillon); filastrocche bucolico-lisergiche. Attorno ai 14:00: reset. E
si riprende con una canzone praticamente power-pop
(eredità dell’esperienza nei Levis Hostel?), tutta piano,
chitarra ed effetti (e che se ci fosse la batteria potrebbe
anche essere dei Dandy Warhols). Il crescendo del pezzo non si risolve, ma diventa una giostrina da luna park
che non sarebbe dispiaciuta al Todd Rundgren glam e
smanettone. Si continua così, cazzeggio avant in grande spolvero, fino al minuto 26:00, quando inizia il gran
finale: incedere sinistro e atmosfera inquietante, con
un occhio - anzi un bulbo - ai cari vecchi Residents. Un
94
lavoro che si posiziona, come ammette lo stesso Ezio,
in un ambito “un tantinello inflazionato”, ma costruito
con cognizione e gusto del divertimento.
(6.8/10)
Gabriele Marino
Professor - Madness (Naive, Aprile 2011)
Genere: reggae
Lodevole il presupposto a monte del progetto solista
di Harrison Stafford, cantante di quei Groundation
che intanto ingannano l‘attesa del prossimo disco con
la stuzzicante raccolta The Gathering Of The Elders. Da
anni trapiantato nella madrepatria del reggae e accettato dalla comunità col soprannome di “Professor”,
l‘uomo si recava in visita nei “territori occupati” tra Israele e Palestina, affrontando la spinosa questione dal
punto di vista palestinese incurante del seguito che la
sua band ha a Tel Aviv. Accompagnato da un‘attivista
francese, trascorreva dieci giorni tra Hebron, Ramallah
e Nablus confrontandosi con la gente.
La sera, rifletteva canticchiando motivi dentro il telefonino e, tornato a St. Ann‘s Bay, vergava otto brani
registrati in una settimana assieme a sodali del calibro
di Leroy “Horsemouth” Wallace e Flabba Holt e invitando a cantare, tra gli altri, U-Roy e Ashanti Roy dei
Congos. Occupandosi inoltre di produzione e mixaggio, infine affidando a un amico californiano le riuscite
“dub version” che integrano la scaletta. La quale non risente dei rischi insiti in simili operazioni, come l‘eccesso di enfasi e il populismo che spesso affossano vena
melodica e comunicatività.
Non in questo gesto di profondo rispetto, dove - nonostante titoli potenzialmente didascalici come Intifada
e East Jerusalem - il “messaggio” è articolato con partecipazione e disinvoltura e senza prevaricare il “mezzo”,
cioè il reggae d‘impronta roots anni ‘70 - classico ma
dotato di personalità - proposto con il gruppo madre.
E, quel che più conta, persuadendo come di rado fuori
dai confini giamaicani.
(7/10)
la colonna sonora pianistica del Nosferatu di Murnau
(e tornano qui come da menù MAM certe influenze
cross/emo, nell’inciso con voce femminile alla Linkin
Park). C’è una chitarra spagnoleggiante e un motivetto
pop ma come farebbero pop gli gnometti del bosco in
Down Is Up e questa atmosfera un po’ da fiaba malata
torna anche in The Prose. Altri elementi (imp)ortanti,
un’ispirazione di sapore soul (Speechless Sentence) che
in alcuni casi diventa proprio gospel (il singolo New
York Town) o si vaporizza in puro mood epico (i supertimpani e l’inciso corale di Background, Foreground; la
lenta Louder Than Bombs contro la guerra). E coloriture elettroniche che da una parte strizzano molto bene
l’occhio alla nowness internazionale (wonky/glochill;
Bog) e dall’altra appaiono pretestuosamente noize (Taste Of Poland).
(6.7/10)
Giancarlo Turra
Dall’acerbo, avventuroso esordio in coppia con il dj
John Ward a nome Sub Dub (1993; tra i protagonisti
della scena soundscape/”illbient” di metà anni Novanta), al debutto come Badawi e alle sperimentazioni
insistite su un dub etnico, percussivo, collagistico e iterativo (Bedouin Soundclash, 1996), fino ai dischi elettroacustici/classico-contemporanei pubblicati su Tzadik
(che cercano di mettere assieme folk del Medio Oriente
e contemporanea europea), il lungo - 18 dischi finora percorso di Raz Mesinai (Gerusalemme, 1973) si è fatto sempre più complesso, ma anche meno dispersivo,
più affinato, focalizzato.
Axiom ne sintetizza la visione dubstep, riuscendo
nell’impresa di proporre una - chiamiamola così - “ambient da dopo-bomba”, sporca e noise (tra radici electro, nuovo camerismo e desolazione dubstep; Demdike Stare, Vex’d, Richard A. Ingram), che non sia
pensata esclusivamente per gli audiofili o gli esoteristi
specializzati e che metta di nuovo sul tavolo l’elemento
pulsazione.
Questi cinque pezzi (più due remix della title track a
opera di Andy Stott e Vaccine, in chiave deep) parlano
con gli echi del dub e si nutrono di un’ossatura techno
superminimale, dipingendo scenari urbani da contatore Geiger, tutti polveri sottili, sirene e radar. E trovando nella traccia conclusiva, Anlan 7, la loro massima
espressione, squassata da bordate dubnoise.
(7.3/10)
Quakers and Mormons - Evolvotron (La
Valigetta, Aprile 2011)
Genere: hip hop pop
Maolo e Mancho, con l’assistenza di Rico (Uochi Toki),
in libera uscita dai My Awesome Mixtape per mettere
a fuoco le pulsioni più hip hop che animano la band.
In un mezzo-delirio di proclami filosofico-linguistico-esistenziali tra il serio e il faceto. Su basi con ritmi
impostati da batterie e percussioni legnose e campioni - molto discreti - che più che vintage si direbbero
proprio oldie, si sviluppano i motivetti a presa rapida
che abbiamo imparato a conscere coi MAM, con quella
prosodia, quelle cadenze immediatamente riconoscibili, scandite, filastroccose, super-americane nel senso
del power-pop delle college band. Virate su toni scuri,
come impongono nome, liner notes e immagini promozionali che strizzano l’occhio ai Sunn O))). Brani molto simili tra loro, non fosse altro che per il rappato declamatorio di Maolo, sempre tutto uguale; ma la ricetta
funziona sorprendentemente bene, merito di un profilo produttivo asciutto e variegato, tra arrangiamenti
azzeccati, ammiccamenti elettronici, campioni-trovate
e incisività (hip) pop.
Dancing In The Mud è un uptempo Tom Waits-iano
(percussioni tribali, fiati pomposi, chitarra stonata) cantato in maniera quasi espressionista ed espressionista
è l’ispitazione della lullabesca Moldova, che campiona
Gabriele Marino
Raz Mesinai - Badawi - The Axiom EP (The
Agriculture Records, Febbraio 2011)
Genere: doom dub ambient
Gabriele Marino
95
Ringo Deathstarr - Colour Trip (Club AC30,
Marzo 2011)
Genere: Psycho pop
C’è shoegaze e shoegaze. C’è chi si limita a sfoggiare un
pò di effettistica dream pop per dare smalto a brani altrimenti incolore, e chi, come i Ringo Deathstarr, scolpisce melodie da blocchi di rumore grezzo. Che poi il
risultato sia simile a quello dei My Bloody Valentine è
solo un elemento che gioca a loro favore. Non così strano, peraltro, visto che Kevin Shields e compagni hanno
codificato una maieutica del pop rumoroso che i texani,
non fanno che seguire diligentemente. Certo, è impossbile ascoltare Imagine Hearts, la traccia
che apre il disco, e non pensare a qualche outtake da
Loveless. Con quelle melodie che sembrano provenire
da una pellicola Super 8 in procinto di liquefarsi, la voce
della bella Alex Gehrin che si fa strada fra la glassa noise
e che ricorda una Bilinda Butcher appena più sveglia.
Poi però, dalla seconda traccia, il loro pop prende corpo e sostanza. Siamo dalle parti dei Jesus And Mary
Chain più urgenti, con una melodia 60s sciorinata a colpi di fuzz che si insinua e dimostra quanto il loro non sia
solo un lavoro di pedaliere.
Colour Trip è un grande omaggio allo psycho pop britannico degli anni 80, al punto che per ogni brano è
possibile individuare con una certa oggettività la band
shoegaze-C86 di riferimento (i Talulah Gosh per So
High, i Lush nella successiva Two Girls, gli Slowdive per
Kaleidoscope e si potrebbe proseguire).
Colour Trip, d’altro canto, è anche un ottimo album di
pop tout-court, con canzoni che si farebbero apprezzare anche senza la loro soffice corazza di feedback e distorsioni. Sembra banale, ma sta tutta qui la differenza
con il 90% del pop psichedelico odierno.
(7/10)
Diego Ballani
Sandwitches - Mrs Jones Cookie (Empty
Cellar, Marzo 2011)
Genere: indie-country-folk
Secondo album per i The Sandwitches, trio di San Francisco composto da Grace Cooper Heidi Alexander e
Roxy Brodeur, che debutta su Empty cellar con un disco
programmatico fin dal titolo, Mrs Jones Cookies.
Da copione quindi eccoci proiettati in un country-folk
al femminile che non si misura solo con i cliché indie
alla Cat Power (comunque sempre presente come in
Joe says), ma cerca di allargare il respiro a una tradizione
americana tout-court, tanto nel pop delle Shangri-Las
da cui riciclano l’uso massiccio di coretti-sixties e un onnipresente cantato a più voci, quanto nei lavori di Roky
96
Erickson. Ad uscirne è un disco di “canzoni” nella stessa
accezione che potrebbe darne un dizionario, giocato
su atmosfere contrapposte: Summer of love, My heart
does swell e Lightfoot sono il lato country e sereno, ma
ci sono anche le sferzate rock di Black Rider con più di
una reminiscenza di Pj Harvey, o il lancinante mantra
blues di Heviest head in the west; e volendo continuare
la lista non può mancare all’appello la ballata struggente, Miracle me, con un arrangiamento equilibratissimo
nel dosare strumenti e voce, prima di giungere al finale
retrò e malinconico di Heavy times che sembra mimare
una crisi esistenziale di Buddy Holly.
Insomma il rischio di rimanere invischiati nel limbo grigiastro dell’indie folkettino era alto (e si annusava anche
dall’artwork di copertina...), invece i The Sandwitches
vincono la partita nel modo più semplice possibile: con
una manciata di canzoni ben scritte, che scaldano e avvolgono. Non si chiede di più ai grandi, non vedo perché farlo con loro.
(7.3/10)
Stefano Gaz
Seun Kuti - From Africa with Fury: Rise
(Because, Aprile 2011)
Genere: africana
Si fa sempre fatica a parlare dei “figli d‘arte”, del loro
cognome ingombrante che finisce per creare speranze
esagerate e in sostanza ingiuste. Considerazioni che in
questo caso non è possibile accantonare, perché se ti
chiami Seun Anikulapo Kuti e ti metti a capo di quei
Egypt 80 già a suo tempo capeggiati da babbo Fela, i
casi sono due: 1) sei un incosciente; 2) sai benissimo il
significato di quanto stai facendo. E hai fegato, ragazzo
mio, oltre a un talento che non è solo questione di DNA.
Già il tuo debutto del 2008 Many Things era un bel sentire e portare avanti messaggio ed eredità di chi sai tu.
Oggi, From Africa With Fury: Rise racconta che stai cercando una tua possibile identità guardandoti indietro,
come chiunque oggi fa.
Ci piace che di là dal vetro si siano alternati in tanti e tra
costoro Brian Eno e tuo fratello Seun; ci piace l‘energia
che trasuda da sei brani e il lasciarci tirare il fiato nella
sublime, tesa ipnosi Rise; ci piacciono gli impasti vocali,
le scorribande fiatistiche guidate dall‘alto sax di Lekan
Animashaun, lo stratificato rutilare ritmico. Perché ci
fanno sentire a casa e, sì, ricordano l‘afrobeat ma pure
i Talking Heads, e allora come la mettiamo? Così: che
non sei un Jeff Buckley, ma nemmeno un Jacob Dylan; che sei bravo, ed è questo che conta.
(7/10)
Giancarlo Turra
Slug Guts - Howlin’ Gang (Sacred Bones,
Febbraio 2011)
Genere: Blues Post Punk
Ancora una volta l‘Australia segna un punto a suo favore sullo scacchiere internazionale del (post)punk. Dopo
UV Race e Deaf Wish ecco una nuova formazione in
grado di superare i patri confini tanto da firmare per la
famigerata label newyorkese. Come molti altri gruppi
del Nuovissimo Continente, anche gli Slug Guts fanno
man bassa della tradizione locale di Birthday Party e
Lubricated Goat e c‘è poco da fare quando i riferimenti
sono così chiari ed inequivocabili: prendere o lasciare.
Dopo il primo Down On The Meat (su Stained Circles),
Howlin’ Gang torna ad insistere su territori minati da
Telecaster pericolose come rasoi arrugginiti, percussionismo isterico vagamento jazzato, cantato posseduto,
baritonale e ossessivo. Tredici pezzi rudi e crudi, totalmente devoti a ricreare quel mood cimiteriale tipico del
blues-punk degli anni d‘oro. E se quando parte Howlin’
viene da chiedersi se per caso non si stia ascoltando i
Chrome Cranks, beh siamo sicuri che gli Slug Guts
prenderebbero questo dubbio come il più grande dei
complimenti.
(7/10)
Andrea Napoli
Sonic Youth - Simon Werner A Disparu (Syr,
Aprile 2011)
Genere: soundtrack
Il numero 9 della collana Perspectives Musicales che la
gioventù sonica affida alla personale label SYR è assai
distante dai precedenti. Meno sperimentale e avanguardistico rispetto alle altre uscite, Simon Werner A
Disparu è la colonna sonora dell‘omonimo film del francese Fabrice Gobert e fotografa la band nel suo mood
attuale, proprio come era successo anni fa per Made In
Usa (e in maniera misura per Demonlover, del 2002).
Se all‘epoca la gioventù sonica ben si rispecchiava in
quella soundtrack del 1986 scoppiettante e frantumata, Simon Werner A Disparu si adagia sui Sonic Youth più
ectoplasmici e (tra)sognanti, estatici e sospesi. Quelli
dell‘ultimo periodo, per capirsi: meno irruenti ed esplosivi (eccettuati un paio di episodi, tra cui Chez Yves e la
daydreamiana Alice Et Simon) ma altrettanto disturbanti
e insidiosi. La formula a tre chitarre utilizzata dal quartetto (l‘ex-membro Jim O‘ Rourke è presente al basso
solo nella fluviale Theme D‘Alice) incide sul risultato finale, spostando ancor di più l‘ago della bilancia sulle
stratificazioni e sui dialoghi chitarristici (Theme De Laetitia, Escapades), ma non mancano momenti più rarefatti
(Dans Les Bois/M. Rabier)e addirittura inconsueti duetti
Ranaldo-Moore al piano (Les Anges Au Piano).
Considerato che il film dovrebbe essere un noir, le elucubrazioni tra sogno e realtà, psych e rumore inscenate
dai quattro dovrebbero ben sposarsi con le atmosfere
filmiche. Per ora non possiamo che accontentarci di
una delle migliori prove fornite dai SY da qualche anno
a questa parte.
(7/10)
Stefano Pifferi
Squadra Omega - Squadra Omega (Holidays
Records, Dicembre 2010)
Genere: kraut/psychnoise
L‘esordio della Squadra Omega, tanto atteso, per chi ha
visto il gruppo in azione dal vivo, o ne conosce i componenti, vive di una questione di taglio dentro a un flusso,
di sartoria che separa i pezzi dal tessuto e dà loro vita
autonoma.
Supergruppo è una formula che non spiega del tutto
quello che accade, anche se all‘apparenza ha una buona pertinenza giornalistica. Come tenere insieme - criticamente - schegge del post-With Love, e di Mojomatics,
Movie Star Junkies, Apoteosi del Mistero e Be Maledetto
Now, senza ricorrere a questa formula un po‘ demodé,
ma sempre fascinosa? Una via è possibile, serve passare dal risultato più che dalle premesse, tener presente
l‘amicizia e le esperienze precedenti di Andrea Giotto e
compari ma ritrovarla solo nell‘esito musicale.
Squadra Omega non è un criterio di composizione, ma
un modo di stare insieme sul palco e in studio, di articolare un‘empatia. E tale stato d‘animo congiunto non
può che diventare, se messa in musica, una interminabile jam session. Ciò che comunica il self-titled, primo
long playing (con 7” in aggiunta al 33 giri) firmato dai
trevigiani, è questo: e il fatto che l‘output suoni spesso krauto e free-jazz crea legami fenomenologici interessanti, che ricorda le comunità (o comuni) hippy dei
tedeschi di fine Sessanta e le ricollega a un gruppo di
persone nell‘odierno Veneto, che si coagulano attorno
all‘aggregatore musicale, all‘ascolto e all‘esecuzione in
free form di una materia che le prove e i concerti perfezionano, fino ad arrivare su LP.
Il sound di Squadra Omega è krauto come può esserlo
una musica che mantiene caratteri della cosmica (l‘acida suite di Murder in the Mountains) eppure conserva
una sua rudezza. Motorizzata in memoria dei Neu!,
evidentemente, ma con un linguaggio e uno sguardo
odierno (la doppia batteria post-nineties di The Mistery
of the Deep Blue Sea). La Squadra Omega è sicuramente
una creatura meta-, che si prende la briga di risuonare tanta musica nota e di riprodurne l‘enunciazione, di
97
ri-enunciarla, rimetterla in pasto a chi già la conosce (i
musicisti stessi, anzitutto). Il prodotto è quasi apocalittico, nell‘ambiguità funzionale che porta i membri della
band a vestire una tunica e tingersi la faccia di nero prima dei live. Tattica e strategia. Più che un supergruppo,
siamo di fronte una squadra, senza allenatore, con la
regia affidata a un metodo - free form - che procede per
sintonia tra i componenti. È detto tutto.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Steve Mackay - Sometimes Like This I Talk
(Polyglot, Marzo 2011)
Genere: jazz rock
Instancabile, febbrile, cazzone, capace di aspro lirismo
e anarchica intensità, Steve Mackay è un sassofonista,
anzi - per i rockettari impenitenti - QUEL sassofonista
che sta fra i credits di Fun House, il formidabile secondo album degli Stooges. Tanto folgorante quel capitolo
da mettere in ombra tutte le succesive voci curricolari,
che pure sono disparate, annoverando collaborazioni
con Jello Biafra, Violent Femmes, Dirtbombs e persino i nostrani Zu. Il qui presente Sometimes Like This
I Talk - terzo album a suo nome - ci offre uno spaccato
della propensione ad allestire combo più o meno (Radon Ensemble, Carnal Kitchen...) estemporanei per
sbrigliare l’estro in bilico tra ipotesi free, rockaccio inacidito e cavalcate visionarie.
Nelle tredici tracce in scaletta, tutte registrate live,
Mackay compare da solo, in duo, terzetto, quartetto e
via andare fino al nonetto (tra Mingus e l’hard rock) di
Song For Baghdad. Un vero e proprio calderone di musicisti tra i quali ricorrono più spesso di altri i nomi del
polistrumentista giramondo Kamilsky e del vecchio
bucaniere della quattro corde Mike Watt. Peregrinazioni sordide e pensose (la splendida The Prisoner), motorismi psichici (gli Stereolab scorticati di Lament For The
Leaving Of The Isle Of Lewis), rumbe erratiche (Lost In The
Fog), boogie caciaroni (Dead Chevys), cabaret beffardi
(Stradivarius’ Cat) ed esotismi elusivi (Rue Interdit d’Afficher), sono lo spettacolo d’arte varia di questo scellerato dinosauro che non ha perso il gusto di azzardare.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Steve Wynn - Wynn Plays Dylan (Interbang
Records, Marzo 2011)
Genere: alt country rock
Deve essere stata davvero una bella serata, quel 13 agosto 2009 all’Hana-Bi di Ravenna, quando Steve Wynn ed
un manipolo di amici/colleghi (il sodale Chris Cacavas
98
all’organo, la violinista Vicki Brown, la batterista nonché compagna Linda Pitman, il bassista Rigo Righetti
ed il chitarrista Antonio Gramentieri) misero in piedi
un tributo all’incommensurabile Bob Dylan. Mi chiedo: come si può, in pieno ventunesimo secolo, suonare
ancora Dylan in maniera tanto convinta e convincente? Una possibile risposta ce la offre lo stesso Wynn nel
bel documentario realizzato da Alessandro Quadretti,
venti minuti di interviste ai protagonisti del concerto in
questione, organizzatori compresi, scaricabile dal sito
dell’etichetta grazie ad un codice fornito al momento
dell’acquisto.
L’ineffabile Steve, sollecitato a proposito dell’ars musicandi di Sua Bobbità, sostiene che uno dei principali e
inossidabili motivi di fascino risiede nella capacità di
escogitare testi e melodie con implicazioni molto profonde, per poi suonarle come se non gliene fregasse un
cazzo. Con entusiasmo sgarbato, espettornado il cuore
con tutti i graffi e la sporcizia del caso. Perché appunto
la vita che t’ispira non è cosa - per così dire - edulcorata. Anzi, è una formidabile bastarda, quintali di veleno e
immondizia per ogni grammo di bellezza. E questo, più
o meno, spiega perché le nove tracce di questo Wynn
Plays Dylan suonano tanto vive. Al punto che - rischiando la bestemmia - hai quasi la sensazione di non averle
mai sentite accendersi con tale intensità.
Sentitevi la travolgente Gotta Serve Somebody, una Isis
satura d’irrequietezza o una deliziosamente infervorata Just Like A Woman. E che dire di quella The Groom’s
Still Waiting At The Altar - dal controverso Shot Of Love
- scudisciata di febbrile acidità contry blues? Alla fine
l’episodio meno convincente è la conclusiva Knocking
On Heaven’s Door, che vede gradito ospite Mr. Robyn
Hitchcock nientemeno: difficile evitare il retrogusto
didascalico con un pezzo tanto metabolizzato nell’immaginario collettivo, e a poco serve il piglio altrettanto
genuino. Peso specifico altissimo in ogni caso per un
disco che, mentre ribadisce doverosa devozione per il
Bardo di Duluth, sottolinea la grandezza dell’ex sindacalista onirico.
(7.5/10)
Stefano Solventi
Strokes (The) - Angles (Rough Trade,
Marzo 2011)
Genere: pop-rock
Angles arriva dieci anni dopo quel fulminante esordio
che fu Is This It e a cinque anni di distanza dall’ultima
prova della band, il moscissimo First Impressions Of
Earth. Sarebbe anche troppo facile allora liquidare la
faccenda come un goffo tentativo di tornare in pista
highlight
Tu Fawning - Hearts On Hold (City Slang, Marzo 2011)
Genere: art-rock
Se riuscite ad immaginare una sorta di dark mood cameristico alla Black Heart Procession con teatrali
voce male-female spesso in falsetto e paesaggi ritmici che rimandano anche al trip-hop, non siete lontani dai Tu Fawning.
Collettivo avant-rock da Portland composto da Joe Haege (31Knots, Menomena) e Corrina Repp, più
i neo-arrivati polistrumentisti Toussaint Perrault e Liza Rietz, i Tu Fawning sono una bella sorpresa per
chi ami trasversalmente la teatralità meno cabarettistica di Tom Waits, certe aperture cameristiche
sempre d‘ambito “rock” (alla Rachel‘s, ma senza l‘afflato post- ), tappeti ritmici da art-rockers in scia
Williamsburgh e echi di atmosfere mitteleuropee (s‘aggira lontano, come un padre spirituale, lo spettro di Kurt Weill). Il tutto sempre condito da una spessa coltre di dark mood,
variazioni arty su schema-canzone e strutture di base e un interessantissimo
lavoro percussivo tra digitale e umano.
Dal lavoro certosino dei quattro esce un album umorale, non ordinario, mai
lineare; fatto di spigoli dolci, curve a gomito e splendide canzoni in cui l‘incessante ricerca e sperimentazione su mood, atmosfere e suoni si stratifica
creando gemme multistrato. In questo senso, aiuta la capacità strumentale
dei quattro, abili polistrumentisti in grado di variare e scambiarsi un quantitativo infinito di strumenti tra i più vari - dai fiati al piano, dal violino all‘organo oltre al quadrilatero rock
per antonomasia - che contribuiscono alla eterogeneità della proposta. Con almeno due o tre capolavori (l‘ipnotica Multiply A House, Sad Story, la portisheadina I Know You Now) e un livello medio molto al
di sopra della normalità, Hearts On Hold è l‘esordio che molti gruppi hanno solo sognato. Di diritto nella
top-ten annuale.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
con la scusa di mettersi in gioco. Ma altrettanto sbagliato. Perché qui gli Strokes si impegnano davvero, ci
credono, provano sul serio a smarcarsi da se stessi (pur
mantenendo fortissima la cifra della loro riconoscibilità; la voce di Casablancas, le chitarrine sgrattuggine
ma in fondo pulite) e a maturare come gruppo creativo
(con quello che infatti è il più collettivo dei loro album;
Hammond Jr. e Fraiture forti delle rispettive esperienze solistiche). Una strada quasi obbligata per una band
che, salvo un momento di ispirazione speciale, non poteva più limitarsi a riproporre la fotocopia del proprio
suono e dei propri modi. Sommariamente meno rock
e più pop, meno essenziale e più sfaccettato, il disco
mette in scena un (impossibile) ritorno alla spontaneità
che fu, nutrendosi però di suggestioni diverse: richiami
all’elettro-pop Ottanta più melodico (sui quali era tutto costruito il Casablancas solista); strizzatine d’occhio
al folk e alla psichedelia; tentativi di inspessimento del
suono che orecchiano certo glam-prog enfatico alla
Muse (vero punto debole di tutta l’operazione).
I ragazzi riescono bene allora quando miscelano orecchiabilità immediata (l’opener Machu Pichu, reggaettino Ottanta nelle strofe e inciso strumentale che guarda a mondi latin tra Babe Ruth e Santa Esmeralda) e
pop-rock con abiti casual (lo scanzonato uptempo del
singolo Under Cover Of Darkness; la diafana ballad per
“amanti moderni” Life Is Simple). Sono divertenti quando affondano nella naivete New Romantics (Two Kinds
of Happiness, Games), giocano a sperimentare come
possono (Call Me Back, intro con chitarrina quasi bossanova e finale lennoniano con valzerino deformato)
o dicono di credere ancora nel R’n’R (il quadretto oldie
soft-rollingstoniano Gratisfaction). Annoiano invece a
morte quando si autoplagiano (il riempitivo firmato Valensi Taken For A Fool) e si fanno letteralmente odiare
quando cercano di proporsi scuri e minacciosi - risultando invece solo monocromi e monotoni - andando
giù di arpeggini, giri di basso e ritmiche pestate che
imitano Muse e simili (la claustrofobica You’re So Right,
annunciato secondo singolo; la schifosa - ci passate il
99
tecnicismo? - Metabolism).
Siamo i primi a non amare quelle recensioni che concludono paternalisticamente con un “Non gli si può davvero chiedere di più”: ma è proprio questo il nostro caso.
(5.9/10)
Gabriele Marino
Subsonica - Eden (EMI, Marzo 2011)
Genere: synth-rock
Sesto disco per la band torinese ovviamente superatteso dai fan e perché no, anche dalla critica. I Subsonica
restano, infatti, una delle band 90s più longeve nel panorama italico, e il lavoro precedente (L’eclissi) riusciva
a coniugare rock e dance, proponendo qualche buona
riflessione intimista che si accostava - mutatis mutandis
- alla maturità over 30 degli Amari di Scimmie d’amore.
Mixato da Mauro Pagani (tanto per non sbagliare), il
nuovo disco, che segue una consolidata prassi di piccole rivoluzioni arrangiative, oscilla tra la collezione di singoli pronti per la radio e un vago leit motif sul paradiso
perduto. Gli stessi Subsonica hanno dichiarato di avere
avuto idee diverse all’inizio della lavorazione del disco.
Le anime e le vocazioni del gruppo si sentono tutte: la
vocalità melodiosa di Boosta, il quattro dritto di Samuel
(che milita anche nei Motel Connection), il dubstep di
Ninja e Max e l’indie di Vicio.
Tra affondi nel drum’n’bass (Il diluvio), esperimenti autoironici di composizione collettiva (il testo del veloce
electro-punk di Benzina Ogoshi è stato scritto assieme
ai fan sul sito della band e ha per ritornello la frase “Non
siete riusciti a bissare Microchip emozionale”), innocue
prese di posizione contro il sistema finanziario (Prodotto
Interno Lurido), il singolone marchio di fabbrica in midtempo (Istrice) e il sorprendente featuring retrò Ottanta
dei Righeira (La funzione), il disco si assesta però su un
livello medio che non esplode nè affonda.
La professionalità non si discute, ma per il futuro, oltre
che a rileggere e remiscelare il passato (vedi la presenza dell’anima reggae in più punti), sarebbe opportuno
pensare a costruire una seconda parte di carriera più in
linea con l’età media del gruppo, per non declamare un
giovanilismo fuori tempo massimo. Per adesso, lasciamo che si divertano e facciano divertire i fan.
(6/10)
Marco Braggion
TBA (Natalie Beridze) - Forgetfulness
(Monika Enterprise DE, Marzo 2011)
Genere: Electro pop
I tempi di Annulé sono lontani. Dal misto di pop e strappi avant di quello splendido lavoro, troviamo oggi Na100
talie Beridze alle prese con un umbratile e insapore
deutsch pop minimale solo sporadicamente piroettato
sul fortunato mix di trip-hop, cyber e minimal techno
che l‘aveva resa un caso nel 2005.
Se Laurie Anderson e AGF rimangono le muse ispiratrici, TBA tenta la strada del confidenziale d‘autore. I fine
‘80 brit di Tanita Tikaram e le umbratilità dream in coda
al dream dei ‘90 sono i nuovi riferimenti ma a mancare
sono purtroppo gli elementi fondanti del discorso, forza e ispirazione.
Forgetfulness scorre lento e scialbo, fallendo sia nei
momenti più intimisti sia in quelli ritmati e pop (The
Face We Choose To Miss). E‘ un lavoro che tenta di evidenziare un mood personale professando invece solo
un post-twee per trentenni depresse, nascoste dietro a
un dito arty.
(4.5/10)
Edoardo Bridda
Thank You - Golden Worry (Thrill Jockey,
Gennaio 2011)
Genere: avant rock
Terrible Two era riuscito a decostruire il proprio universo di riferimento, e di fatto aveva fatto dei Thank You
da subito un punto di riferimento per altre band e i critici. Le staffilate erano rese oblique da toni inaspettati
di tastiera. Gli ingredienti non sono cambiati in Golden
Worry. Ci sono le note vintage dei tasti bianconeri, le
escursioni delle chitarre, il drumming costante. Manca
- e questo non sempre lo si riesce a spiegare - la quadratura del cerchio magistralmente palpabile nell‘album
precedente.
La Thrill Jockey ci parla di loro come di coloro che meglio rappresentano l‘ambiente di Baltimore. In effetti si
sente anche lo spirito (e non solo in Birth Reunion) di un
altro protagonista della scena locale, il pluriapprezzato
Dan Deacon. Non si riesce però a creare quello scarto
che esca dall‘avant per essere di forza trascendente, o
semplicemente per perforare le barriere di genere musicale.
Il pubblico di Golden Worry è ancora quello del postmath e avant massimalista. La batteria è tra i responsabili della “normalizzazione”. Più per la facilità di essere
incasellata in uno stile che per le qualità - indiscusse - di
Emmanuel Nicolaidis, che anzi già all‘indomani di Terrible Two venne in aiuto di Jeffrey McGrath e Michael
Bouyoucas (compagno di band nei More Dogs) e fece
le veci del transfugo e neo-berlinese Elke Wardlaw.
Né si può negare che i tre sappiano trascinare e mantenere una qualità elevatissima dell‘output (magistrale e
ancora piena di inventiva la chiusura di Pathetic Magic,
l‘apertura immediatamente successiva di Continental
Divide, con un urlo di battaglia soffiato al flauto, eppoi
tutto lo sviuppo del brano). Manca solo il guizzo e la
capacità di sintesi. Che si traduceva in una maestria di
costruire e gestire al meglio un thrilling. Quella tensione che oggi è un brillante “saper fare”.
(6.7/10)
Gaspare Caliri
Times New Viking - Dancer Equired (Wichita
Recordings, Aprile 2011)
Genere: slacker-gaze
Times New Viking, ovvero c‘era una volta lo shitgaze. A
dimostrazione di come certe sigle e definizioni abbiano vita breve, ecco Dancer Equired. Le quattordici gemme per mezzora di musica del comeback del quartetto
dell‘Ohio spostano ancora di un passo il baricentro delle musiche di Adam Elliott, Beth Murphy, Jared Phillips
e Dustin White. Sempre meno rovinate e rovinose, più
inclini alla forma canzone ripulita, virano verso paesaggi a tratti da americana o tradizionalmente indie-rock a
stelle e strisce.
Merito della riduzione dello shit- di cui parlavamo in
apertura, quell‘insozzare le melodie che era insieme il
tratto caratteristico e la necessaria virtù di tutta l‘ondata che dai Psychedelic Horseshit arrivava agli Eat Skull
passando per una serie sterminata di bands. Ciò che
resta è una indolenza tipicamente americana mista
allo scazzo tardo-adolescenziale che sembra la cifra stilistica predominante in molti gruppi rock attuali. Quel
rotondo autocompiacimento nell‘ammirare la propria
sconclusionatezza e nel sentirsi pieni nell‘autodefinizione di “romantic nihilism”. Della serie, prendete pezzi
come Ways To Go o Want To Exist e ditemi che non ci
sono Pavement et similia dentro.
Un passo deciso, quello compiuto dalla band di Columbus. Oltre ciò che erano i TNV fino a Born Again Revisited
e verso quel qualcosa che ci auspicammo trovassero.
Che sia nato lo slackergaze?
(7/10)
Stefano Pifferi
Tormenta - La Ligne Âpre (Africantape,
Febbraio 2011)
Genere: math-noise
Una insana passione per lame e coltelli e un nome che è
tutto un programma. Si presenta così l‘ennesima band
alla conquista del mondo in nome della scena mathnoise strumentale francese: chitarre affilate come le
lame dei coltelli distribuiti copiosamente nell‘artwork e
una tempesta di suoni strumentali a ipotizzare un incro-
cio tra Melvins e Hella. Dei primi riprendono stazza del
suono, incedere pachidermico e svisate metal-oriented; dei secondi strutture mobili, florilegio strutturale e
drumming da ossessione in cattività.
Vertiginosi e circolari, tesi e vibranti, Vincent Beysselance (batteria, cello, basso), Jeff Grimal (chitarra, basso) e
Esteban Rodiére (chitarra, basso) si infilano alla grande
nella recente tradizione math d‘oltralpe - da Chevreuil
a Passe Montagne, Marvin, Papaye, partendo da quegli
Cheval De Frise dove alla chitarra agiva proprio Beysselance - fatta di energiche e originali aperture, momenti
di pausa pneumatica ed esplosioni strumentali fragorose. Tutto in questo esordio si sviluppa sempre in nome
di elaborate architetture mathy e di un suono che spesso e volentieri sconfina su territori metallosi: l‘iniziale
Pagan (stop‘n‘go, scale vertiginose, cambi di ritmo da
forsennati) o L‘Arche Interne, con quello spessore di chitarra che farebbe invidia a molti lungocriniti axemen,
sono paradigmatiche di un suono possente e, per quel
che consente il genere, piuttosto instabile e creativo.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Trent Reznor/Atticus Ross - The Social
Network (The Null Corporation,
Settembre 2010)
Genere: electro, ambient
Con questa colonna sonora del premiato - ma non
premiatissimo - film di David Fincher su Mark Zuckerberg e sulla nascita di Facebook, Trent Reznor corona
la propria ventennale carriera con un Golden Globe e
un Oscar. E’ una consacrazione che sviluppa in maniera
assolutamente coerente il percorso iniziato con i Nine
Inch Nails, e cioè la solita storia: da fenomeno di culto
a fenomeno e basta.
Il disco, firmato a quattro mani con l’ormai fido Atticus
Ross (produttore inglese cointestatario con Reznor e
la moglie Mariqueen Maandig degli How To Destroy
Angels; ha iniziato la carriera al fianco di Barry Adamson), ha due anime che sono le facce della stessa medaglia: una ambient pianistica, romantica, e una electro
ondosa, iterativa, ora dark, ora solare, che pesca - ovviamente - dai Kraftwerk fino all’electro-pop dei Depeche Mode. A un estremo troviamo quindi Sakamoto
(la conclusiva Soft Trees Break the Fall) e all’altro tastiere
kraut psych (Complication With Optimistic Outcome) che
hanno più di un punto di contatto con il Tron dei Daft
Punk. Il concetto di sviluppo è relativo (siamo in un disco post-minimal e post-electro, che per giunta è una
colonna sonora), in una suite chiaroscurale dove contano invece le oscillazioni della materia e il dosaggio di in101
highlight
Tune-Yards - Whokill (4AD, Aprile 2011)
Genere: pop
Un talento puro, Merrill Garbus, a.k.a. tUnE-yArDs. Lo era e lo rimane. Questa è la sostanziale conferma
di Whokill, secondo album della montrealina oggi residente a Oakland, California. Un cambio di contesto e di everyday life che non può che riflettersi nella musica di colei che aveva fatto della “focolare”
della stanzetta e della quotidianità un catalizzatore di musica con l‘anima e
col sorriso.
Primo risultato: il banjo è appoggiato al muro, e al suo posto compaiono
l‘elettricità delle chitarre e una nuova aggressività tutta positiva che mordicchia l‘ascoltatore coi denti più affilati, ma giocosi di un gatto urbanizzato.
Ma anche con una musica che è diventata ancor più black dell‘esordio, forse
per il contrasto maggiormente tangibile tra il calore della voce di Merrill e il
controllo dell‘output strumentale.
Il collante è come spesso avviene una percussività trascinante e certosina
(Gangsta), già tratto potenziale di Bird-Brains. Esiste però anche un metodo con cui perseguirla, una
focalizzazione precisa, che sfonda in Whokill. C‘è, dietro alle canzoni, una grande coesione costruttiva,
che non finisce mai di stupire nella Garbus, ma anche l‘altra principale variazione di contesto rispetto
a due anni fa: il lavoro in studio. Oggi Merrill ha uno studio professionale - che peraltro la 4AD non ha
mancato di documentare, con video di Tune- all‘opera su microfoni e tracce - e un ingegnere che la segue, Eli Crews. Gli spunti di progressione minimalista di Bird-Brains possono quindi diventare ciò che
sono oggi, costrutti di produzione che non perdono una virgola - almeno nella prima parte dell‘album
- di efficacia, anzi ci rapiscono al primissimo ascolto.
Nell‘innesto tra le nuove dinamiche urbane e quelle produttive Merrill tesse un filo sotto al testo. Non
solo le chitarre sostituiscono il banjo, ma a tratti si fanno quasi atonali (Es-so), escono i riff di fiati da
Contorsion-isti (My Country) e in generale un sottotesto di riferimenti alla NYC mutante (Killa), che si
alternano alla trasognata rassegnazione dei pezzi sottovoce (Wooly Wooly Gong). E sono solo due dei
mondi possibili, analizzati scientificamente e di testa, oltre che di cuore. In questo sta la scommessa
che puntiamo su Merrill: è il potenziale di sovrapporre la ricerca e il lavoro che sta sotto alle canzoni al
talento su cui contiamo e continueremo a contare.
(7.4/10)
Gaspare Caliri
gredienti sempre diversi per insaporire la comune base
di partenza: l’acqua versata di 3:14 Every Night, il riffone
elettrorock di Carbon Prevails, la parossistica versione
de Nell’altro del re della montagna, la cavalcata percussiva di Magnetic, lo scandire metronomico con il piano in
controtempo di Almost Home.
Un ottimo bignamino di electro atmosferica e un ottimo prodotto, costruito per piacere ai fan del post-NIN
ma anche alle platee hollywoodiane tra smoking e pellicce.
(7.2/10)
Gabriele Marino
102
Vaccines (The) - What Did You Expect From
The Vaccines (Columbia Records, Marzo
2011)
Genere: britpop ‘10
Ci pensate? Si sono formati appena nove mesi fa, i Vaccines, e oggi debuttano al quarto posto in classifica.
Cose dell‘altro mondo - quel mondo aldilà della Manica,
dove i dischi si vendono ancora, i concerti sono affollati
e frequenti, le riviste di settore sono lette (e persino tenute in considerazione, incredibile). Un piccolo miracolo anche di questi tempi, a ben vedere, se pensiamo che
proposte omologhe e non meno valide come Chapel
Club e Mirrors hanno avuto riscontri inferiori di pubblico e critica (il culto, si sa, è altra faccenda). Questi quattro ragazzi di Londra hanno dalla loro un‘immediatezza
e un impatto che non sono sfuggiti né alla Columbia né
a quelli della BBC, che sulla spinta di un solo singolo li
hanno prontamente segnalati come “il” nome del 2011.
Ad ascoltare quel singolo, Wreckin‘ Bar (Ra Ra Ra), viene
proprio da dargli ragione: un minuto e ventidue (!) di
Ramones / Phil Spector in salsa garage-shoegaze, con
un canto a voce piena che niente ha a che vedere con
le declinazioni wave a cui l‘indie albionico - e non - ci
ha sin troppo assuefatti. Questo perché il frontman, Justin Young, fino all‘altroieri era un cantautore new-folk
e si faceva chiamare Jay Jay Pistolet. Approccio da songwriter dunque (un po‘ alla Billy Bragg, alla lontana),
ed è questo che fa davvero la differenza e rinvigorisce
il carattere di un progetto che altrimenti si reggerebbe
esclusivamente su un paio di intuizioni molto efficaci,
certo, ma destinate inevitabilmente a soffrire la lunga
distanza.
Cosa che in parte avviene perché What Did You Expect
From The Vaccines, pur veloce e digeribile nella sua
mezzoretta di durata, vive di alti e bassi: ci piacciono
molto le schegge adolescenziali punk-pop come Norgaard (occhio alla storia sulla modella diciassettenne
svedese) If You Wanna e Wolf Pack, così come le chitarre
rumorose che guardano all‘America di Blow It Up; un po‘
meno certe vocazioni innodiche alla Glasvegas (e che
un fulmine ci colga se nella ballata All In White non fa
capolino Chris Martin). La formula alterna le coordinate
sopraccitate, in un potenzialmente infinito gioco di rimandi che però riconduce a un‘identità assolutamente
riconoscibile. È certo un bene. E le canzoni? Sulla base
della hit indie Post Break-Up Sex (gli Interpol fronteggiati da John Grant su parole di Jarvis Cocker?) e dei bei
lentoni Wetsuit e Family Friend (hidden track compresa),
non possiamo che constatare che c‘è trippa per gatti, e
il meglio può (deve!) ancora venire. Non ci stracciamo le
vesti, no - ci limitiamo a stappare una bottiglia di buon
vino per i bei segnali che continuano a provenire dal
Regno in questo primo scorcio di anni ‘10.
(7/10)
Antonio Puglia
Valentina Gravili - La balena nel Tamigi
(Autoprodotto, Aprile 2011)
Genere: pop d’autore
A dieci anni dal premio Ciampi vinto per il miglior disco d’esordio con Alle ragazze nulla succede a caso, torna
Valentina Gravili, portando in dote la consueta leggerezza. Un piede nella tradizione popolare e uno in un
cantautorato pop immediato e poetico, oltre le facili
analogie - i rimandi a Cristina Donà e Carmen Consoli
ci sono ma quasi non si vedono - e verso una formula
sempre più riconoscibile. Merito di una scrittura puntuale ma anche dell’ottimo lavoro di Max Baldassarre,
Silvio Trisciuzzi e dell’ex Lula/Lotus Amerigo Verardi.
Fondamentali in sede di produzione artistica nell’arricchire il materiale con una gamma di colori che aggiorna il “melodico” della Gravili donandogli naturalezza e
personalità.
Synth, chitarre elettriche, percussioni, certi fondali stratificati ai confini con la psichedelia (La malafede), dei
Baustelle declinati in salsa Sufjan Stevens (La balena
nel Tamigi): la Gravili rimane sempre in bilico tra serietà
e atmosfere giocose, un po’ come faceva con le parole
quel Gianni Rodari che viene in mente leggendo l’insolito titolo del disco (ripreso invece da un fatto realmente accaduto). Fuori dai giri “giusti” ma alla fine capace
di mettere l’anima in un disco che conferma la statura
artistica di una musicista sensibile e trasparente.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Van Der Graaf Generator - A Grounding in
Numbers (Esoteric, Marzo 2011)
Genere: prog
Diamo un po’ di numeri: sei anni dopo l’inattesa reunion,
tre dal discreto predecessore Trisector, arriva l’album
numero dodici per l’accolita Van Der Graaf Generator,
ridotta a trio ma pur sempre di membri originali (il leader Peter Hammill, il bassista e organista Hugh Banton
ed il batterista Guy Evans). Inoltre, la data di uscita del
disco (il 14 marzo) non è affatto casuale, essendo stata
scelta per riferirsi alle prime tre cifre della costante π
(pi greco, per gli amici). C’è poi il titolo, A Grounding
In Numbers, e ci sono tracce in scaletta intitolate Mathematics e 5533. Ok, stiamo scherzando, ma neanche
troppo, perché coi vecchi progster il lambiccato è una
norma, ne costituisce la poetica profonda e l’effervescenza superficiale.
Da sempre campioni nel conciliare questi due livelli
dell’espressione, i VDGG ci propongono oggi un lavoro
sì complesso ma accomodante, all’insegna del lirismo
perentorio di Hammill (l’intatta prestanza della voce
ha un che di prodigioso) e d’un piglio rockista turgido
ancorché arzigogolato di sincopi, ruggiti acidi, bordoni
cosmici, spasmi preterintenzionali e gorghi misterici.
Non stupisce certo il dominio gagliardo di timbri e dinamiche, la ricchezza essenziale degli arrangiamenti (non
l’avrei detto, ma l’assenza dei fiati di David Jackson non
rappresenta affatto un handicap). Sorprende semmai
l’ostinazione entusiastica di un verbo tanto obsoleto,
che fa sembrare freschi pezzi come Mr. Sands, Bunsho,
Medusa o Highly Strung, altrettante gradevoli ucronie
103
per chi non ha mai perdonato alla Storia la disfatta delle
traiettorie progressive.
Un buon disco per appassionati del genere: banale
uscirne così, ma vero.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Vickers (The) - Fine For Now (Foolica,
Marzo 2011)
Genere: brit-rock
La bandiera inglese stampata sui boxer ritratti in copertina qualcosa vorrà pur dire. Nessuna sorpresa, dunque,
se questo Fine For Now ribadisce che i Vickers sono uno
dei gruppi più brit della scena nostrana e non aggiunge
quasi nulla a quanto già sapevamo. Del resto su certe
forme di fedeltà al modello inglese formazioni come gli
A Toys Orchestra hanno costruito una carriera - pur con
le evidenti differenze di stile - e sarebbe ingiusto penalizzare i Nostri per aver seguito la lezione alla lettera.
Anche perché il terzo disco dei Vickers - l’ultimo era
l’Ep Sofa Sessions - rassicura e conferma. In primis che
la fiducia che avevamo concesso alla band ai tempi di
Keep Clear era ben riposta e poi che il praticantato delle nostre band all’estero passa soprattutto per produzioni come questa. Tanto che in Fine For Now mettono
lo zampino figure di primo piano come Steve Orchard
(Paul McCartney, Pulp, U2) e John Astley (Stereophonics), per un suono cristallino che cita i Libertines e spara
fuori piccole gemme pop come Chem Dream.
Va bene così per ora, ci comunica la band. Noi sottoscriviamo, in attesa di un eventuale cambio di rotta che potrebbe regalare ottimi spunti di riflessione.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Walter Beltrami - Paroxysmal Postural
Vertigo (Auand, Maggio 2011)
Genere: jazz rock
Tra i chitarristi emergenti più apprezzati in ambito jazz,
Walter Beltrami vanta già tre dischi a suo nome prima
del presente Paroxysmal Postural Vertigo, titolo che
si riferisce ad una patologia di cui ha sofferto realmente
nel periodo che lo ha visto comporre nove delle dieci
tracce in scaletta (essendo Unexpected Visit frutto improvvisato, non lontano dalle astrazioni del Wayne
Shorter più sperimentale). La vertigine è quindi l’elemento chimico che fa precipitare i pezzi tra groove
funk-rock serrati (Seamont’s Manoeuvre) e tensioni quasi art-wave (BPPV), concedendosi tregua pensosa con le
suggestioni misteriche di What Is (minimalismo atmosferico, ipnotiche reiterazioni, struggimenti incrociati di
104
chitarra, sax e violoncello) e la malinconia cinematica
di You See.
Giusto ricondurre al leader anche i meriti della band,
un quintetto che annovera tra gli altri un ispiratissimo
Francesco Bearzatti (al sax tenore e clarinetto) ed un
sontuoso Vincent Courtois al violoncello. Detto che
Lilienthal è l’episodio più intrigante con le sue convulsioni mingusiane e le scaramucce free, occorre riferire
di una #2 che azzarda curiosa ibridazione tra incalzante
riff hard ed un mesto binario sax-cello solcato di vampe
portentose, costrutto un po’ forzato però alla resa dei
conti efficacissimo. Disco godibile con picchi di superbo lirismo.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Yelle - Safari Disco Club (Downtown,
Marzo 2011)
Genere: Pop, Dance
Julie Budet, in arte Yelle, è una pop singer francese salita alla ribalta in patria grazie a MySpace e poi atterrata
anche all’estero quattro anni fa con l’esordio Pop Up.
Questo secondo Safari Disco Club perfeziona e impreziosisce la formula dell’esordio con una produzione più
imponente e una propensione netta verso l’electropop:
un territorio in cui la voce della nostra si muove con sicurezza, donando un po’ di colore al fantasma di una
Vanessa Paradis e impartendo più di una lezione alla
meteora Alizèe.
Difficile comunque immaginare che i fasti commerciali
possano essere i medesimi: troppo di genere la proposta, troppo poco incisivi i brani per abbordare le classifiche, troppo poco personale lei per un mainstream
sempre più a caccia di icone riconoscibili. E anche guardando al lavoro in sè, non siamo di fronte a qualcosa per
cui rimanere a bocca aperta: Safari Disco Club è niente
più e niente meno di ciò che il titolo dichiara, ovvero
un treno dance-pop che procede a velocità costante
dall’inizio alla fine. Nessun cambio di atmosfera anche
vago, niente che risollevi l’ascoltatore dalla monotonia
che si fa gradualmente largo traccia dopo traccia. Fatto salvo il singolo Que Veux Tu non si incontra in tutto
l’album un solo vero guizzo, nè in senso strettamente
musicale nè in senso qualitativo.
E’ un peccato: anche perchè, prestando bene orecchio,
si capisce che c’è comunque un lavoro notevole dietro
a questi brani, frutto di una buona conoscenza di tutto
ciò che va dal primo synth pop degli anni 80 al revival
electro degli anni 00. Mancando però il coinvolgimento
emotivo ecco che l’unico contesto funzionale diventa
quello di un dancefloor, magari dei più frivoli: allora sì
che episodi come Unillusion o Comme Un Enfant troverebbero facile spazio, magari tra un brano di Goldfrapp
e uno di Ladyhawke.
(5.2/10)
Simone Madrau
Young Knives - Ornaments From The Silver
Arcade (Gadzook, Aprile 2011)
Genere: Indie rock
Next Big Thing nel 2006 con l’esordio Voices of Animals
and Men (nominato Mercury) e rappresentanti dell‘indie più genuino nel sophomore Superabundance, gli
Young Knives sono stati dei tardivi nerd dell’angular.
Non hanno mai avuto nulla da invidiare a Wombats e
altri fenomeni mid-2000, ma senza un leader che che
ne catalizzasse l’immaginario (vedi per dire Eddie Argos
degli Art Brut) e le giuste tempistiche, rischiavano seriamente d’implodere con gli stessi noughties.
Il nuovo, Ornaments From The Silver Arcade, terzo disco
prodotto da Nick Launay (già al lavoro con Arcade Fire,
Nick Cave e molti altri) è dunque un banco di prova
molto importante per il terzetto: pena la retrocessione,
o peggio, lo scioglimento.
In tempi di wave e sintetiche spinte, gli YK scelgono coraggiosamente di rimanere dentro ai binari del guitar
pop concedendosi alla contemporaneità con giusto
qualche tocco elettronico (senza gli archi della prova
precedente) e regalandoci una manciata di pop ottimamente confezionato.
L’agrodolce Sister Frideswide, i momenti power pop
(Glass House), le marcette sarcastiche (Love My Name),
i tocchi wave (Everything falls into place), le complicazioni (Vision Of Rag con cambi tempo, siparietti, cori e
controcanti) e persino le incursioni in territori Muse-y
(Storm Clouds) formano un caleidoscopio di grande pop
britannico, di quello che non cerca clamori ma va dritto
al cuore della faccenda. Per chi ama la qualità nella musica inglese prima di tutto, un gran bell’album.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Zabrisky - Fortune Is Always Hiding
(Shyrec Records, Marzo 2011)
Genere: rock
Gli Zabrisky mostrano una cifra stilistica popular e condivisa analoga a quella dei Gurubanana di Giovanni
Ferrario (qui presente nel ruolo di produttore) e Andrea
Fusari, sospesa com’è tra un citazionismo marcato e la
capacità di rimanere sul pezzo senza ammiccamenti
gratuiti. Tanto che quello che a una qualsiasi altra formazione non perdoneresti, il fatto cioè di apparire fin
troppo didascalica nell’opera di rielaborazione del proprio scibile rock, negli Zabrisky ha tutto l’aspetto del
punto centrale del discorso. La base affettiva da cui partire per rendere credibile un suono altrimenti fin troppo
identificabile.
E’ così che nel disco convivono i Jesus & Mary Chains
di Summer Is Always Grey e i Beatles di Calling Home,
i Libertines di Getting Better So Far e i Byrds di Stone
Inside, i Dandy Warhol di Good Company e i R.E.M. di
Better Times. Compressi in brani da due minuti e mezzo, proiettati in un simposio di chitarre jingle-jangle e
irresistibili armonie vocali, nobilitati da una psichedelia
decodificabile e tutto sommato rassicurante. La vera
differenza in questo caso la fa la scrittura, non la ricerca
forzata di un linguaggio che magari non ti apparterrebbe nemmeno. Quella si, perfettamente a fuoco nel suo
dinamismo nomade e folgorante.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Zzolchestra - Zzolchestra (Parade,
Novembre 2010)
Genere: jazz-rock
Di orchestra a tutto tondo si tratta, con tanto di sezione
fiati (sax tenore, cornetta e baritono), vibrafono, basso,
batteria, theremin, piano, violoncello, chitarra. Costruita
attorno al responsabile del progetto Alberto Danielli,
docente di biologia evoluzionistica qui nelle vesti di un
direttore dei lavori creativo e capace.
Elementi dei Mariposa (Enzo Cimino, Valerio Canè)
si mescolano a musicisti di diversa estrazione (Alberto Polese, Andrea Rigatti, Elena Maestrini, Giovanni Gonano, Massimiliano Gollini, Antonio Sodano,
Paolo Bottacin, Gianbattista Tornielli) per dar vita a
una misticanza di linguaggi: quelli “classici” di Archie
Shepp, Charles Mingus e del Liberation Music Orchestra di Charlie Haden, ma anche quelli di un rock-blues
contaminato (le chitarre elettriche di Seicinque, le dodici battute al vibrafono di Alblues) e di un funk rielaborato in tono orchestrale (Romeo).
Bella la familiarità che riesce a trasmettere il disco, lontana dai virtuosismi fini a sè stessi e tesa verso una coralità di sostanza e assolutamente convincente.
(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
105
Gimme Some
Inches #15
Nuovo mese, nuovi giri di vinile grandi e piccoli, con sconfinamenti anche sul terreno del cd-r. Mi Ami, Lettera 22, Big’n, Lost
Tribe, Welles, Guinea Pig e chi più ne ha più ne me metta.
I tempi d’oro del noise-rock a stelle e strisce sembrano sul punto di
ritornare. Quanto si tratti di mero
revival à la page o genuina rinascita di un suono viscerale e claustrofobico, figlio dei tempi caliginosi e
grami, lo dirà la storia. Per ora accontentiamoci della musica. Del
10” ep dei Big’n, Spare The Horses, ad esempio. Pubblicato molti
anni dopo la dipartita della band e
come “unfinished business” grazie
all’appoggio di una sempre più vinilica AfricanTape – a breve vedranno la luce il 12” Bon Sauvage dei
Ned, due ep gemelli targati Oxes il 7” degli svizzeri Honey For Petzi – il vinile vede distribuiti quattro
pezzi tra lato a e lato b. Tra avvitamenti da blues deformato (Assholes & Elbows) e tribalismo spastico
(Long Pig) reminiscente Butthole
Surfers, stop’n’go killer, vocals al vetriolo e bassi pachidermici (Like A
Killer), il trio chicagoano mostra di
non essere mero comprimario sulla
scena noise-post di fine millennio.
106
Ottimo anche l’album di b-sides e
rarità Dying Breed da poco uscito
sempre per la label di Julien Fernandez.
Chi invece sembra allontanarsi dal chitarrismo isterico e postpunk degli esordi sono i nostri
cari Mi Ami. Perduto per strada
un pezzo (il bassista Jacob Long) e
non si sa se sostituito o meno, l’ex
trio losangelino sembra essere influenzato sempre più dalle svisate
techno-vintage del suo leader Daniel Martin-McCormick, già passato
per queste pagine col suo progetto
Ital. Se i 12” Cut Men e Techno mostravano il fascino per l’elettronica,
ora Dolphins, un quattro pezzi targato Thrill Jockey, vira decisamente
verso l’elctro con un concentrato di
“dystopian refraction of left-field
new age, lush soundscapes and Italo daydreams” che a noi, amanti del
suono nevrotico e convulsamente
rock degli esordi lasciano un po’ di
amaro in bocca.
Saltando a piè paro da un sup-
porto ad un altro, segnaliamo la
meritoria operazione targata Bloody Sound Fucktory. L’etichetta
marchigiana non paga di immettere sul mercato dischi sempre più
focalizzati sul concetto di rumore
rock, inaugura una nuova serie.
“Ectoplasmi” è dedicata a dischi
maledetti, perduti, dimenticati o
mai usciti ma meritori di menzione.
Prime uscite, i prime-movers Guinea Pig col noise-rock alieno di 2,
e due solo-projects: Welles, sigla
che nasconde Massimo Audia (Tutelo, Satantango) e Mr. Whore aka
Francesco Villotta. In mezzora i Guinea Pig mostrano di essere stati un
combo seminale per il rumore di
quelle zone, a furia di noise mai irruento, cosmico, alienato, ossessivo
e inclassificabile. Menzione d’onore
per la sguaiata XXX e la sboccata
In The Court Of The Burger King. A
ruota Mr. Whore con la sua paranoia per chitarra acustica. Un Alfabeto è sgembo e irrituale, enigmatico
ed evanescente (blues)rock non
convenzionale, ma anche un po’
acerbo nel songwriting. A chiudere
il progetto di modernariato rock di
Massimo Audia, aka Welles, il cui
Radical Shit è un caleidoscopio di
follie rock-oriented da cameretta.
Electro e rock, stranezze zappiane
e memorabilia post-moderna scritta con gusto e classe, ma anche
con tanta autoironia. Dei tre, forse
quello che meriterebbe maggiore
visibilità. Siamo anche sicuri però
che è quello a cui importa meno.
Nella nostra eterna azione
di setaccio dei fondali più luridi
dell’underground virtuale ci siamo
imbattuti in una delle scoperte più
gustose di questo mese: i Lost Tribe di Richmond. Formati da membri di gruppi crust a stelle&strisce
come SSR, Syndrome e Aghast, i
ragazzi in nero della Virginia hanno
già da qualche mese rilasciato una
cassetta autoprodotta, sfuggitaci di
primo acchito ma oggi saldamente
nelle nostre mani. The Dawn vomita cinque pezzi di pesante caratura dark-punk, intrecciando incubi
in perfetto equilibrio tra T.S.O.L.,
Christian Death e i primissimi Killing Joke, tra tensione hardcore e
macabro lirismo goth. Un debutto
sorprendente, una band da seguire. Tornando alla nostra safe european home troviamo ad attenderci
Kim Larsen e il nuovo singolo di Of
The Wand And The Moon. Shine
Black Algiz consta di due pezzi inediti che introducono The Lone Descent, il prossimo album del danese, sul quale però non figureranno.
Il primo una preghiera sommessa,
il secondo una ballata contagiosa. Come è logico attendersi dalle
pubblicazioni di area brown&grey,
grande cura del packaging con il 7”
in edizione picture e la copertina
con incisione dorata a sbalzo. Più di
così…
Nei patri confini invece ci da il
bentornato una pioggia di rumore
targata Second Sleep e A Dear Girl
Called Wendy, label dedite al noise
più intransigente, rispettivamente
da Vittorio Veneto e Milano. La prima ha appena licenziato una nuova infornata che comprende tapes
per gli svedesi Negative, duo in
stile CCCC con l’immancabile Dan
Johansson di Sewer Election e Ättestupa, e i danesi Alleypisser provenienti dal giro della Posh Isolation e
artefici di due foschi episodi a base
di organo e tape loops, e un 12
pollici one-sided a nome Endless
Sea, uno dei vari progetti con cui
Matteo Castro, tenutario della stessa etichetta, si diletta in assalti di
elettronica arrugginita, condita da
scarti concreti e sporcizia industriale. Dei Lettera22, duo che coinvolge il sopra citato Matteo e il sodale
Riccardo Mazza, si occupa invece A
Dear Girl Called Wendy, che proprio
in questi giorni rilascia True Form,
LP introdotto dal distintivo artwork
a collage divelto e contenente due
lunghe tracce per immancabili feedback, clangori, overload, stridori,
frastuoni e tutto il necessario per
farsi male alle orecchie. Un modo
appropriato per salutare l’arrivo
della bella stagione.
Stefano Pifferi
107
Re-Boot
#14
Un mese di ascolti
emergenti italiani
è deliziosamente schizofrenico questo inizio primavera. E’ un ribollire di stili e umori. Il nostro consueto setaccio mensile tra le
emergenze italiche.
Nati da una costola degli Ojm – il
link tra le due formazioni è Alessandro Tedesco – Glincolti sono
un quartetto chitarra elettrica,
batteria, synth e basso. Pochi dubbi in merito al genere proposto:
jazz-prog-rock-blues strumentale
con qualche velleità psichedelica
rubata ai Quicksilver Messenger
Service e a Jimi Hendrix (Ferma
un momento). La grafica del disco
contestualizza il gruppo come un
figlioccio de Il banco del mutuo
soccorso o degli Osanna, ma in
realtà il suono di Visti e imprevisti
(6.9/10, Go Down Records) stà più
dalle parti dei King Crimson (Fili
scoperti). Aggiornati grazie a una
nervatura funk che finisce per personalizzare il tutto nella giusta maniera e senza suonare stucchevole.
Cantautorato al femminile di
scuola americana per Giulia Millanta. I Novanta di Ani Di Franco
(Right Between The Eyes) sublimati
da un folk trasversale che dialoga
108
col jazz (Dropping Down), omaggia
Jeff Buckley (The Tunnels Of My
Brain), suona un blues pop che sarebbe piaciuto anche ai Beatles (A
Long Dark Road). Spregiudicatezza
di chi è sicura dei propri mezzi ma
anche arrangiamenti ben calibrati
(organo, violino, sax, chitarre, basso
e batteria la strumentazione) fanno
di Dropping Down (6.7/10, Ugly
Cat) un disco con molte potenzialità e pochi difetti. Tra questi ultimi,
una rilettura di Paranoid dei Black
Sabbath a cui forse manca il coraggio di osare fino in fondo.
Suggestioni soffici di chitarra
acustica e sospiri, per il primo lavoro di Ed, A Quick Goodbye (autoprodotto; 6,4/10). Quattordici
brani, in devoto omaggio a Ellioth
Smith, Beatles, Bright Eyes e tutto
quel sound vellutato di un cantautorato appeso fra malinconico e sognante. Tuttavia, a riuscire meglio
in questo esordio sono gli innesti
più duri e decisi di chitarra elettrica
o organo hammond, suonati con
tipico appiglio Sixties, sempre sul
pezzo, mai fuori le righe. Consigliato a tutti i malinconici, i nostalgici
o semplicemente a chi ha voglia di
tuffarsi in un clima retrò, chiudere
gli occhi e lasciarsi andare.
Nuovissimo e freschissimo il
secondo Ep degli Antenna Trash,
dal titolo Ded Comes For Ded (autoprodotto, 7.0/10). Il quartetto
veronese propone una manciata
di canzoni dall’attitudine electropunk e dai rigurgiti da dance floor.
Fra synth con derive psichedeliche
e vortici di distorsioni frizzanti, tengono alto il nome del nu rave, personalizzandolo con uno stile per
nulla scontato che a tratti si accosta
alla new wave più godibile. Dall’asse Depeche Mode-Editors vengono fuori i brani più accattivanti, con
delle contorsioni vocali che, pur se
oscure e profonde, non rinunciano
alla melodia. Da tener d’occhio.
Ecco a voi un duo smoderatamente orgoglioso di annunciare il
proprio esordio. Parliamo dei Farewell To Heart And Home ovvero
Diego Boboli e Una, entrambi po-
listrumentisti, il secondo alle prese
pure col canto, e del loro The Domestic EP (autoproduzione, 6.9/10),
quattro tracce che escogitano indie
romantico e ombroso, smaccatamente british ma disposto a suggestioni mitteleuropee. Immaginatevi
un ibrido tra Jens Lekman, i dimenticati Venus e Patrick Wolf, e più o
meno ci siamo. Volendo allargare e
zoomare all’indietro, possiamo rilevare echi Depeche Mode, Smiths e
Scott Walker, tanto per abbozzare
una mappa di tutto rispetto. Molto
curati gli arrangiamenti, interpretazioni intense senza strafare, manca
forse un po’ di adrenalina e qualche
goccia di sangue. Ma è un signor
biglietto da visita.
Trio a gestione familiare quello
dei The Perris, due fratelli - i cantanti e chitarristi Amedeo e Nicola - più
la bassista Simona (coniugata ad
uno dei suddetti). Reggio Emilia è
la base di questa cospirazione indie
wave in corso da una decade sotto
diverse incarnazioni e finalmente
sfociata nell’esordio Hic Sunt Leones (Youthless Fanzine Rec, 6.7/10),
cinque tracce a base di chitarre in-
grugnite, tastiera e drum machine,
le melodie tra il suadente, l’arguto
e il morboso, mischia di suggestioni Blur, Afghan Whigs, New
Order, dEUS. Disinvolti nella cura
del dettaglio così come della sporcizia dell’impatto, devono semmai
lavorare sull’intensità che l’ascolto
passa come un’effervescenza gradevole ma effimera. Li attendiamo
con curiosità sulla prova lunga.
Pochissime note biografiche accompagnano Le donne per bene
distruggono il mondo, EP a firma
Teatro Musicato Cosciente pubblicato dalla net-label ViVeriVive
(7.1/10). Sotto la sigla TMC troviamo il cantautore Sergio Dal Cin,
provenienza Vittorio Veneto, Treviso. Nel mini di 5 pezzi , Dal Cin rivede la forma canzone cantautorale,
ibridandola con una veste musicale
punkeggiante e testi graffianti e ironici. CCCP i referenti che emergono
maggiormente, il tutto realizzato
in forma acida e una verve ispirativa molto buona. Presupposti che
fanno ben sperare per un proseguimento fervido. È uscito intanto
anche un album a nome TMC di cui
sicuramente diremo in seguito.
Malo è un progetto cantautorale tosco-romano basato a Roma;
il quartetto così denominato si
presenta con un EP (autoprodotto,
6.9/10), Il bene e il malo contenente sei canzoni. Tanto songwriting
oriented che riprende le ultime
wave di casa nostra, si veda Dente,
Le luci della centrale elettrica ma
anche i classici, a partire da Tiromancino fino ai Diaframma. Una
buona vena melodica e compositiva rendono questo mini piacevole
all’ascolto e foriero di ulteriori sviluppi. Bene.
Fabrizio Zampighi, Teresa Greco,
Stefano Solventi, Nino Ciglio
109
China PUNK!
China underground#5
Brain Failure, Carsick Cars,
Hang on the Box
Breve storia degli sviluppi, dagli anni Novanta a oggi, di uno dei
generi che maggiormente infiammano la scena musicale cinese...
Se l’apertura cinese al mondo esterno ampiamente promossa da Deng
Xiaoping dal 1978 fosse cominciata un decennio prima, è probabile
che la scena musicale asiatica come
la conosciamo oggi si sarebbe sviluppata in maniera radicalmente
diversa. Soprattutto per quanto riguarda quelle frange più estreme
del caleidoscopio post rock and roll,
che generalmente prendono le macronomenclature di metal, punk e
alternative, funzionando invariabilmente da definizioni ombrello per
contenere decine e decine di sottogeneri, sottoculture e stili musicali.
Queste definizioni hanno da tempo
raggiunto una chiara demarcazione
nel mondo musicale occidentale,
mentre creano ancora confusione
nell’identificazione delle relative
trasposizioni asiatiche.
Soprattutto in Cina, nazione così
vasta e dal recente passato storico
complesso e rapidamente in evoluzione, lo sviluppo e il consolida110
mento di stili musicali alternativi e
relative sottoculture è stato segnato
da una storia curiosa, rapida come
la definizione della società post-maoista e decisamente spiazzante. Il
punk rock ha specialmente infettato la Cina con la sua anima ubriaca,
putrida e purtroppo anche filtrata
dai commercialismi a stelle e strisce,
creando un fenomeno musicale e
culturale che trova correntemente
la sua massima espressione artistica
tra i fumi grigi della macrocapitale
Pechino e i locali del quartiere studentesco di Wudakou.
P unk , C ina
e il suo
perché
La domanda spontanea che viene
all’ascoltatore medio osservando
i corpi sudati di questi dediti perfomers cinesi è di chiedersi perché
in Cina il punk ha trovato così tanti
fedeli tra i giovani. La prima considerazione viene da una differenza
storica: se la tradizione punk occi-
dentale viene da un trentennio di
storia della musica rock che è passato dalla concezione e trasformazione del rock and roll da “musica del
diavolo” ad accettatissimo strumento economico di etichette discografiche nei floridi e complicati anni ’70
(post blues, post cultura hippy, post
eccessi di morrisoniana memoria,
coltelli di Hell’s Angels che scintillano ad Altamont, Rolling Stones, cocaina, Black Sabbath e iniziazione
del metal), la nascita di una cultura
punk in Asia e in Cina arriva solo di
seconda mano, importata, trapiantata. Senza un supporto storico e
culturale pronto a difendere le proprie differenze.
Nei primi anni ‘90, le idee con cui
i musicisti cinesi si confrontavano
venivano prevalentemente dal mercato nero di CD e cassette piratate,
fortemente saturo di classici rock
and roll o heavy metal americani.
Con il cambio di direzione del mainstream americano e l’arrivo in scena
del grunge (essenzialmente i Nirvana), il materiale che lentamente
permetteva ai cinesi di conoscere
la cultura occidentale e abituarsi
ai suoi nuovi modelli cambiò rotta
verso la semplicità e l’immediatezza
di quel suono grunge pesantemente influenzato dal garage degli anni
‘60 e dal punk. Entro la fine del 1995,
i Nirvana avevano raggiunto uno
status di successo asiatico di ledzeppeliniana memoria, e costituivano la prima fonte di ispirazione per
centinaia di band underground.
Dopo il grunge, la nuova evoluzione della musica alternativa
americana fu la rinascita del punk,
quello di matrice più commerciale;
di conseguenza, il mercato nero
musicale cinese cominciò a riempirsi di Green Day, Fugazi, Sex
Pistols, Ramones, Rancid, NOFX
e purtroppo anche di artisti decisamente poco punk come i Blink 182.
Se il punk in Cina sembrava molto
infantile, troppo ancorato ai classici settantasettini, e a volte privo di
quella personalità tutta asiatica che
gli avrebbe dato dei caratteri più
definiti, il motivo sono queste prime
influenze. Parlando di punk, in occidente si distingue ampiamente tra
un mainstream blasonato e criticato
e una forte scena underground, che
è il motore di definizione delle mode
e dell’autenticità del movimento. Al
contrario, pare che in Cina il punk
sia nato ricalcando a carbone gli stili
e le suggestioni di gruppi famosi legati al punk americano e inglese più
mediatico, senza potere andare più
a fondo e capire le radici e il senso
del movimento.
P rimi
fuochi della
rivolta :
P echino
brucia
In America e in Europa, la musica
punk e hardcore nasce e si sviluppa in un underground dominato da
pubblicazioni indipendenti, concerti
in centri sociali e club, circoli di persone che definiscono il movimento
e la sua direzione. Di conseguenza,
quella stessa influenza underground
che fatica a entrare in contesti ben
Underbaby
più liberali di quelli asiatici (in Europa, ad esempio), in Cina ci arriva
solo quando qualcuno ce la porta:
lo sviluppo del punk cinese ha dunque sperimentato la partecipazione
chiave della musica punk istituzionalizzata, che dal mainstream occidentale veniva piratata e venduta
sulle bancarelle pechinesi; d’altro
canto si è poi esposto all’ondata di
stranieri che, chi per studiare il cinese, chi per insegnare l’Inglese, chi
per lavorare, arrivavano in una Cina
dai confini fisici e mentali sempre
più aperti e curiosi verso “l’ignoto
straniero”. Pechino, come da copione, fu la prima città cinese ad essere
aperta e quindi “invasa” da queste
idee rivoluzionarie.
Indicativa della doppia tendenza
è la nascita della prima scena punk
pechinese nel 1995: Underbaby,
la prima vera ‘punk’ band spilloni e
creste, e Catcher in the Rye, la prima pop-punk band. Pur distinguendo un background culturale e ideologico, il suono delle due band era
totalmente antitetico, un po’ come
tra i Sex Pistols e Blondie: marci,
veloci e rancidi i primi, melodici,
poppeggianti e a cappella i secondi.
Anche la scelta di un nome di pari
passo preso dal classico romanzo di
formazione postmoderno america-
no di J.D. Salinger la dice lunga sulle
influenze, e pare sia stata suggerita
da un professore straniero di lingua
inglese.
Nel 1997, Pechino è pronta per
una nuova generazione di punk
che si raduna ai concerti del celeberrimo Scream Club: non solo
ormai le influenze si sono fatte più
variegate e più storicamente accurate, pescando anche dal calderone
dell’hardcore di metà anni ’80 (band
americane come Fugazi, Operation
Ivy, Misfits, NOFX, Bad Brains etc.),
ma anche l’età dei fans si abbassa di
molto, includendo ragazzini dai 16
anni in su, a differenza della prima
ondata di punk, che aveva generalmente scoperto questa nuova cultura alternativa nei 20 anni avanzati. È
da questa generazione che nascono
le band più significative del movimento: Brain Failure, 69, Reflector
e Anarchy Boys. Una compilation
con queste quattro band testimonia
la prima vera uscita discografica del
punk cinese, il doppio CD album rilasciato da Jing Wen Records e rapidamente esaurito. Ed è appunto in
questi anni e soprattutto nel 1998, a
seguito dell’arrivo e del successo di
band come Qiutian de chongzi (Autumn Bug) e Niuqu de jiqi (Twisted
Machine) –le prime ad usare costu111
Joyside
mi di scena ed effetti speciali di Marylin Mansoniana memoria- che la
stampa straniera si interessa al punk
cinese e Pechino diventa un esempio di libertà culturale e musicale,
attirando musicisti, fans e studenti
da tutte le parti della Cina.
Questo è il periodo in cui, stando
alle parole di David O’Dell, studente
di Cinese texano e uno dei “laowai”
(stranieri) chiave nell’ambito dello
sviluppo e informazione della scena
punk cinese, band e concerti abbondano, e non è raro poter scegliere
tra una quindicina di band che suonano in tre o quattro locali diversi
nella stessa serata. Un fermento
incredibile, una scheggia impazzita che si è guadagnata l’attenzione
della stampa internazionale in vari
paesi, tra cui celeberrimi reportage
su Newsweek, Time Magazine, CNN
e MTV. La miccia del punk era accesa, e la bomba pronta a esplodere.
Ma proprio con l’arrivo del nuovo
millennio, l’atmosfera cambia: Pechino è satura di musicisti e pronta
a scrollarsi di dosso il passato per
lanciarsi nel nuovo. Il punk cinese,
quasi spodestato, non vuole morire
e decide invece di prendersi una vacanza al sole, infettando tutto quel112
lo che trova sul suo cammino.
H olidays I n
migrazione
S un :
punk a S ud
the
delle nuvole
Per due anni, la scena musicale pechinese si destabilizza e si sposta. Il
clima cittadino del nuovo millennio
è inquinato da troppe band e competizione, ma prima di soccombere si cercano altri territori. La scelta
ricade sullo Yunnan, meravigliosa
provincia meridionale incastonata tra la cultura tibetana e quella
del Sud-est asiatico, ricca di luoghi
idilliaci dove i turisti stranieri si fermano rapiti; lì la vita costa meno, la
marijuana cresce selvatica e viene
venduta per pochissimi yuan. Insediandosi nei caffè di Dali e Lijiang, i
punk pechinesi iniziano a suonare e
a influenzare centinaia di altri giovani cinesi che fino ad allora non
avevano mai potuto venire a contatto con queste forme di ribellione
musicale. Nel frattempo, in una Pechino scremata di punk, una nuova
scena rap metal –influenzata dal
nuovo giro di vite del mainstream
americano chiamato Korn- si insidia
creando distinzioni e mutando la
direzione dei locali cosiddetti punk,
che perlomeno apprezzavano il
fatto che queste nuove rock band
fossero più edulcorate, non lanciassero bottiglie di birra sul pubblico
e suonassero in maniera molto più
commerciale e “controllabile”.
Quando nel 2000-2001 gli spiantati punk pechinesi, finiti soldi e sogni di successo yunnanesi ritornarono a Pechino, l’inevitabile cambio
di tendenze modificò nuovamente la scena. Rabbia, creste e stivali
erano stati lentamente sostituiti
da barbette emo e chitarre a sette
corde –probabile retaggio culturale del post esilio nello Yunnan-, lasciando la prima violenza punk da
parte, e condividendo palchi, ideologie e serate con gli altrimenti inconciliabili rap metallari. Nel giro di
pochi anni, quello che in occidente
è successo nel corso di tre decenni,
in Cina ha preso la superstrada temporale e si è modificato così rapidamente da lasciare un vuoto, e cambiare faccia.
10
anni in corsia di
sorpasso...
Concludere un’introduzione alla
storia rocambolesca del punk cinese è un po’ come prendere alcune
centinaia di dischi fondamentali
scelti tra le varie decine di sottogeneri del rock e del metal degli ultimi
trent’anni, metterli in un frullatore
e lasciare tritare per alcuni minuti.
Il risultato è distillato in tanti nomi
di band che hanno rappresentato
le prime imitazioni cinesi di gruppi
occidentali più famosi, senza mai dimenticare le “caratteristiche cinesi”.
Le spille e le creste colorate rimangono, ma altri generi si consolidano: i ragazzi cinesi iniziano a portare canottiere bianche da rockabilly
e a sfoggiare grossi tatuaggi sulle
braccia, le ragazze punk esibiscono minigonne da urlo e calze a rete
bucate (e anche i primi tatuaggi), i
più malinconici si crogiolano nelle
nuove correnti emo rock e vestono
come intellettuali alternativi pescati da un incubo rimbaudiano.
L’epicentro della scena rimane sempre Pechino, ma anche la vibrante
Shanghai –più propensa alla disco
e a trance acide- per non parlare
della progressista Wuhan, dello studentato di Tianjin, della balneare
Qingdao e della fumeggiante Dali,
tra le tante. I locali sono decine, se
non centinaia. Il punk, seppure non
sulla cresta dell’onda e nascosto agli
occhi meno attenti, è una scena ormai fervente.
La corsia di sorpasso temporale
cinese ha creato molte band interessanti che è doveroso citare: i Joyside, gli Hedgehog e i Carsick Cars,
ovvero i tre punti saldi della pechino
punk post Yunnan, gruppi che sono
stati anche in grado di affrontare
tour europei e americani, portando
la “giallo punk mania” all’infuori dei
confini della Repubblica popolare.
Le Hang on the Box, uno dei primi
gruppi punk tutti al femminile, ispirati dalle correnti Riot Grrrl americane care a Kathleen Hanna e alle sue
Bikini Kill, nonché autrici di uno
scordato punk da tre accordi e voce
da bambina lisergica. Gli Angry Jerks da Nanjing, nati nel 2000 come
hardcore band e ad oggi trasformatisi nella prima e unica psychobilly
band cinese, con tanto di bassista
donna in qipao e autoreggenti da
pin-up dei ‘50, pettinature ingellate
alla Elvis Presley, e dadi e fiamme
tatuati sulle spalle.
È interessante considerare come
grazie al sempre maggior numero di ingressi di stranieri in Cina e
all’incremento delle opportunità
che i ragazzi cinesi hanno di studiare nei paesi occidentali, il punk
cinese abbia fatto passi da gigante,
segnato da un notevole riflusso di
idee e proposte musicali oramai a
dieci anni esatti dal ritorno dei punk
a Pechino. Le influenze rimangono
straniere, ma i punk e gli alternativi cinesi hanno grinta da vendere e
qualcosa da insegnare anche ai modelli occidentali a cui si sono ispirati:
la passione. Una grande, rinomata
passione che ormai ha consolidato la propria versione rossa a stelle
gialle del punk rock, e che non si
trova più in quei modelli occidenta-
li. Il futuro? Ancora tutto da scrivere,
ma a questi ritmi, non sarebbe stupefacente trovarsi di fronte a una
vera e propria rivoluzione musicale
nel corso dei prossimi cinque o dieci anni. Punk a caratteri cinesi? Se il
ritmo della corsa rimane costante, la
risposta è sicuramente sì. Preparatevi ad aggiungere nuovi classici dagli
occhi a mandorla tra i vostri prossimi acquisti musicali.
*Marco Ferrarese ha suonato per
10 anni nei The Nerds Rock Inferno,
una delle poche punk rock bands
italiane capaci di infiammare i palchi di Europa e Stati Uniti. Dal 2007,
incuriosito dall’Asia, si trasferisce in
oriente. Ha vissuto in Europa, Cina,
Stati Uniti ed Australia, e viaggiato
in circa 40 paesi. Al momento vive,
scrive e lavora a Penang, Malesia. Il
suo sito è www.monkeyrockworld.
com. China Files è un’agenzia di
stampa di base a Pechino composta
da giornalisti, videomaker, fotoreporter e sinologi di diverse nazionalità.
www.china-files.com.
Marco Ferrarese
Carsick Cars
113
Rearview Mirror
—speciale
Pearls Before
Swine
Gotico folk,
sgranando le perle dell’underground
Il folk esoterico a nome Pearls Before Swine, il country parnassiano negli Anni ‘70 e il ritiro dalle scene, ad alimentare le
ipotesi più stravaganti; Tom Rapp si racconta e la magia torna
a brillare.
114
Testo: Filippo Bordignon
L’acid folk dei Pearls Before Swine è stato uno dei principali fenomeni cult emersi dai sixties; figlio della psichedelia acustica ma solo per vaghe generalità, il progetto ha attinto quasi esclusivamente alla polimorfica
personalità del suo autore e cantante, quel Tom Rapp
dal pronunciato sigmatismo che oggi può bearsi al raccolto di una semina neppure tanto prolifica dalla quale è derivata però, con l’aiuto del tempo, una nutrita
schiera di estimatori intenzionati a proseguire il discorso artistico dei Pbs, nella speranza di superarlo.
Tanti gli artisti che ne hanno riconosciuto la grandezza: dal regista Julien Temple allo scrittore Thomas
Pynchon (leggere per credere il Vizio di forma), passando per il chitarrista del Patty Smith Group Lenny
Kaye, Julian Cope, Genesis P-Orridge, Cul de Sac e
Ivo Watts-Russell che rese tributo a Rapp con una cover di The Jeweller nel secondo imperdibile episodio
della trilogia dark-pop dei This Mortal Coil, Filigree &
Shadow.
Conosciuta quasi esclusivamente per i primi due album di fine Anni ’60, la carriera artistica di Rapp è proseguita con una manciata di lavori ammantati da un
delicato torpore bucolico, degna evoluzione umanista
dei celebrati One Nation Underground e Balaklava.
Il nuovo millennio, con la rinascita dalle ceneri dello
psych-indie-freak folk grazie a personaggi estrosi quali
Devendra Banhart e Joanna Newsom, ha decretato
giocoforza un’occasione di rispolvero per la storia del
buon Tom, qui raccontata grazie allo studio della discografia e con il contributo diretto del compositore
statunitense.
Inizieremo dunque, citando niente meno che Gesù
Cristo nel Vangelo secondo Matteo (Capitolo 7, Versetto 6):
“Non date ciò che è santo ai cani, né gettate le vostre
perle davanti ai porci, affinché non le calpestino coi loro
piedi e voltandosi non vi sbranino”.
Con un pizzico di grandiosità, ma sopratutto in virtù di quello humour che in pochi sapranno intravedere nelle opere lì a venire, il giovane Thomas Dale Rapp
(classe 1947) conia il nome della sua band, adducendo
la previsione di una carriera alla mercé di un pubblico
poco riconoscente. Nativo del North Dakota (Bottineau)
ma trasferitosi ancora ragazzino coi genitori insegnanti nel Minnesota (siamo sempre al confine col Canada
dell’amato Leonard Cohen), egli dimostra ‘orecchio’
fin dalla tenera età, imparando i rudimenti di ukulele e
chitarra e ‘componendo’ il primo pezzo a sei anni (una
ballata su un cowboy prossimo alla morte, secondo il
suo vago ricordo). Leggenda vuole che a un concorso
per nuovi talenti la terza posizione fosse tributata pro-
prio a Rapp, mentre un imberbe ‘Bobby Zimmerman
da Hibbing’ (non ancora battezzatosi Dylan) si fermò al
quinto posto. Gli spostamenti dei Rapp però non sono
finiti: sarà la volta della Pennsylvania e dunque dell’assolata Melbourne in Florida, dove il nostro compie gli
studi superiori e, insieme ad alcuni compagni di scuola,
dà vita alla prima e unica formazione stabile dei Pearls
Before Swine, nel 1965.
L’ascolto dell’album omonimo dei Fugs, prodotto
per la oggi leggendaria Esp Disk (promotrice di icone
jazz quali Albert Ayler, Patty Waters e Sun Ra), suggerisce alla band di spedire un demo all’ufficio newyorkese dell’etichetta, chiedendole senza troppi giri di parole di metterla sotto contratto. Possiamo immaginare
dunque la sopresa dei ragazzi, ricevuta la richiesta di
recarsi nella Big Apple per registrare il loro esordio.
Per arrivare alla lunghezza delle due facciate, Tom &
Co. terminano di elaborare la tracklist durante il viaggio
in aereo; One Nation Underground (Esp Disk, 1967) verrà registrato in soli quattro giorni, ottenendo un isperato
successo di vendita (200.000 copie) che ai nostri frutterà
– come da tradizione underground – ricompensi economici quasi nulli. In apertura, la delicata Another Time ripercorre l’episodio di un incidente nel quale Rapp venne
sbalzato fuori dall’auto di cui era passeggero (una Austin
Healy Sprite cabriolet, a essere precisi), cavandosela solo
con un taglio al sopracciglio. Sotto un profilo musicale,
il brano è manifesto di uno stile che, pur attingendo ai
manierismi del proprio decennio, si colloca in un limbo
di autentica unicità, grazie al timbro impalpabile della voce di Rapp e alla scelta della strumentazione (con
stranianti incursioni di vibrafono, clavicembalo, celesta e
clavioline). Se Playmate scimmiotta la cantilena del Dylan Blonde On Blonde e I Shall Not Care non si distacca
di molto dallo psychedelic rock del tempo, numeri quali
Morning Song e Regions of May, suonate con la rassegnazione di un’anima pronta al distacco dal corpo, danno la misura di una sensibilità cresciuta e sviluppatasi nei
territori crepuscolari di un intimismo universale. Ballad
To An Amber Lady proietta l’ascoltatore in un’altra epoca, merito del polistrumentista Roger Crissinger, qui
responsabile di un testo di struggente malinconia tardo
romantica: “Madama dell’Ambra/ sedeva al clavicembalo
di velluto vestita/ nella stanza delle meraviglie orientali/
fissando la veranda fiorita/ ammantata com’era di seta
e tristezze// Rebecca singhiozzava tormentandosi all’arpa/ Leila invece, si donava a uno sconosciuto/ nei campi
riarsi da un sole cinereo”. La chiusa è affidata alla spettrale The Surrealist Waltz, abbandono mortale in formato
pop e gemma esoterica d’indescrivibile efficacia.
Balaklava (Esp Disk, ’68) affina le migliori intui115
zioni dell’esordio, palesando il proprio mood a partire
dalla copertina, dettaglio dal Trionfo della morte del
pittore fiammingo Pieter Bruegel. Concept incentrato
sull’orrore della guerra, Balaklava è raccolta di incisioni toccanti e sapientemente arrangiate, perfetta dalla
prima all’ultima traccia. L’incipit con Translucent Carriages (il brano più richiesto dell’intero repertorio) proietta in una dimensione atemporale, persa tra i fumi
dei sixties e il post-battaglia del 1854, a Balaclava, durante la guerra di Crimea, salvo risvegliare l’ascoltatore
nel paradiso maomettano di Images Of April, animato
da cinguettii ed echi di pifferi fiabeschi. Persa la formazione originale (salvo il banjo di Wayne Harley) lo stupore estatico di Rapp prosegue tra leggiadri clangori
percussivi e archi arrangiati con elegante emotività in I
Saw The World e Lepers And Roses. Pure non mancano
episodi di arrendevole semplicità, come la spoglia dolcezza cantautorale There Was A Man e il sentito tributo
a Cohen con una delle migliori versioni dell’arcinota
Suzanne. Guardian Angels, unico picco di stravaganza,
consiste nella riproduzione di un gracchiante 78 giri
del 1929, sul quale è intonata una torch song di ironico patetismo. Il congedo, Ring Thung, vestirà i panni
della morte violenta, con l’incedere trascinato di una
pastoia medievale interrotta da un vorticoso giochetto di nastri.
L’entusiasmo della critica specializzata spinge Rapp
a tentare un contratto con la Reprise, nella speranza di
allargare il proprio bacino di ascoltatori al di fuori degli
States. Ma il Cristo inquietante ritratto dal nostro Giovanni Bellini nella copertina di These Things Too (Reprise, ’69) paga lo scotto di un parziale distaccamento
116
col nuovo repertorio del gruppo (ridotto praticamente ai soli Harley, un tale Jim Fairs, Rapp e la neo-sposa
Elisabeth ai cori). Album di transizione verso liriche
dall’approccio più narrativo e un’apparente standardizzazione del songwriting, These Things Too flirta qua e
là con blues e country, pervenendo a miniature come
dal pennello di un Townes Van Zandt parnassiano; oltre a una maggiore qualità esecutiva, l’opera si spoglia
degli orpelli già di maniera dei lavori trascorsi, concedendo soavi tenerezze (Look Into Her Eyes, Man In the
Tree, Wizard Of Is) e una spontaneità ‘back to roots’ che
non sarebbe dispiaciuta alla Band di Music From Big
Pink (I’m Going To The City).
Trasferitosi per alcuni mesi con la moglie in una pittoresca cittadina dei Paesi Bassi, il cantautore trova ispirazione per del nuovo materiale, che incide in soli tre
giorni al suo ritorno negli States, utilizzando sessionmen di Nashville e una piccola orchestra d’archi e legni.
The Use Of Ashes (Reprise, ‘70) dimostra un’ulteriore
maturazione compositiva, elargendo alcuni dei migliori
numeri a catalogo (The Jeweller, God Save The Child,
Riegal) e ispirando al paroliere Bernie Taupin il soggetto per uno dei suoi capolavori indiscussi in coppia
con Elton John (Rocket Man). Il successivo City Of Gold
(Reprise, ’71) rischia, sotto un profilo stilistico, una pericolosa overdose di Americana, imitando il Dylan svagato in Nashville Skyline e coverizzando Judy Collins,
Jaques Brel e il solito Cohen.
…Beautiful Lies You Could Live In (Reprise, ’71),
inspiegabilmente, risale la china di un estro insabbiato con una manciata di irrinunciabili malinconie, su
tutte quella Snow Queen circondata di gabbiani che le
intimano cripticamente “Nella nostra cecità, dobbiamo pur sfiorarci tra noi”. Ma vanno anche investigate,
con tutta calma, le eteree esecuzioni di Island Lady (…
Signora dell’isola, a volte dio si manifesta, e se anche
fossero solo menzogne, ti prometto bugie meravigliose con cui poter vivere”), Butterlies, Freedom e l’acquerello tracciato appositamente per la voce di Elisabeth,
Epitaph.
Il non autorizzato Familiar Songs (‘72) a nome Tom
Rapp, raccoglie canzoni già note ai fan rubate da una
session particolarmente riuscita e sancisce l’abbandono definitivo dalla Reprise. I tentativi solisti Stardancer
(Blue Thumb, ’72) e Sunforest (Blue Thumb, ’73) sono
testimonianze di un pop-rock vagamente psichedelico
e ormai fuori tempo massimo, pur contenendo alcune tracce di pregevole fattura (For The Dead In Space,
Stardancer, Blind River). La seconda metà dei seventies,
archiviata la Guerra in Vietnam e con essa lo spirito vitale che animò la controcultura, suggerisce a Rapp un
drastrico abbandono dello showbiz (qualcuno lo avvisterà, a torto, in Italia, nelle vesti di becchino). La realtà
è ovviamente più prosaica: egli riprende gli studi laureandosi in economia, si separa da Elisabeth e sceglie
la strada dell’avvocatura, raccontata nell’intervista a
seguire.
La re-entry, nei nineties, avviene un po’ per volta:
prima con la partecipazione in sordina all’esordio del
Terrastock festival nel 1997 a Providence, poi con la
progressiva ripubblicazione dell’intero catalogo, integrato da compilation trascurabili, ‘tribute’ di insospettata validità artistica (i tre volumi For The Dead In Space, Secret Eye, ’97), raccolte di demo e inediti (il doppio
The Wizard Of Is, Water, 2003) e un live particolarmente ispirato del ‘71 (Live Pearls, Wild Cat 2008) . C’è spazio persino per un nuovo capitolo da studio a proprio
nome, prodotto dagli ex Galaxy 500 Damon Krukowski e Naomi Yang: A Journal Of The Plague Year (Woronzow, ’99) ripropone tali e quali profumi e sapori dei
sixties, passando inosservato nei 10 minuti dell’acid
Dylan Shoebox Symphony ma toccando i vertici emozionali dei lavori più noti nell’immediatezza acustica
di The Swimmer e Silver Apples II (dedicata all’amico
Simeon Coxe, col quale il nostro condivise il palco nel
rientro al Terrastock festival del ‘97).
Letta nella sua interezza, l’avventura creativa di
Tom Rapp è situata in quella nicchia del mercato discografico popolata da outsider che al business musicale finiscono per preferire la straordinarietà di una vita
‘ordinaria’. Per tirare le somme di tanto valore artistico,
chiuderemo citando il Borges dei Frammenti di un
Vangelo apocrifo:
“Da’ quel ch’è santo ai cani, getta le tue perle ai porci;
quel che importa è dare”.
L’intervista
Tom, iniziamo dalla tua ultima fatica da studio: cosa
ti inorgoglisce di A Journal Of The Plague Year?
È stato un piacere lavorare fianco a fianco con Damon
e Naomi, i quali avevano appena inaugurato il loro studio di registrazione a Cambridge, nel Massachussets.
L’album rappresenta la loro prima produzione ufficiale.
Mi sono limitato ad affidargli alcuni brani che tenevo
nel cassetto dal 1973. Eppoi devo evidenziare l’ottimo
lavoro di Adrian Shaw e l’ospitata di Nick Saloman, rispettivamente bassista e compositore nell’indie rock
band Bevis Frond. Tutta bella gente.
A Journal Of … è da considerarsi il tuo album conclusivo o c’è dell’altro?
Sto lavoricchiando coi The Late Cord per il loro nuovo
album. Ho alcune canzoni da parte e di tanto in tanto
mi piglia la tentazione di lavorarci su e registrarle. Chissà…
E ora il passato. Togliamoci subito il pensiero: che
ricordi delle registrazioni di Balaklava?
Eh, ci è voluto un anno per realizzarlo. Avevamo composto arrangiamenti diversi per quasi ogni canzone.
117
Fu solo dopo Balaklava che provai la marijuana (e a
quel punto sì che aspiravo alla grande!). Il precedente
One Nation Underground, a esempio, al contrario di
quanto ipotizzò la critica, fu registrato in un’atmosfera
assolutamente sobria e ‘pulita’. Diciamo che mi sentivo
psichedelico ancor prima di venire a contatto con qualsivoglia tipo di droga. C’è quel pensiero di Abbie Hoffman secondo il quale chi abbia ricordi degli Anni ’60
vuol dire che non li ha vissuti veramente. Da parte mia
rammento il profondo stato di trance, assolutamente
naturale, in cui precipitai appena terminata di incidere
la mia versione di Suzanne.
La critica sembra concorde nel tributarti onori quasi esclusivamente per i tuoi primi due album; non
trovi seccante questo atteggiamento, il quale pone
in ombra lavori successivi, tipo The Use Of Ashes?
I lavori che preferisco, oltre a One Nation Underground
e Balaklava sono appunto The Use of Ashes ma anche
Stardancer. Forse, a influenzare il mio giudizio sono le
condizioni in cui ricordo che sono stati realizzati e il fatto che ci siamo divertiti un sacco per inciderli. Questi
quattro titoli hanno toccato il cuore a un sacco di persone. Pensa che nei Paesi Bassi c’è perfino un gruppo
che si chiama The Use Of Ashes e sono pure bravi.
Dalle copertine dei tuoi album traspare una predilezione per l’arte medievale e, più generalmente,
per un’estetica grottesca…
Beh, ho sempre adorato Hieronymus Bosch e Bruegel
il Vecchio ma, al contempo, la mia estetica abbraccia
anche la cinematografia horror Anni ’30 della Universal (e allora vai di film come Frankenstein, Dracula, La
mummia, L’uomo lupo) così come certe pellicole dei
118
’50-’60 prodotte dall’inglese Hammer Film. E poi mi
hanno sempre affascinato film come Il mastino dei
Baskervilles (consiglio la versione del ’39 con Basil Rathbone nella parte di Holmes) e il Macbeth di Orson
Welles. Una delle prime canzoni che ho composto da
bambino si intitolava “Sherlock Holmes e le tre streghe”; non ricordo come faceva ma mi pare fosse un
pezzo particolarmente complicato.
E nella letteratura, cosa ti ha segnato?
Non ho dubbi: leggetevi The hollow men di Thomas
S. Eliot.
Eccezion fatta per la prosa di Burroughs e la poesia
di Ginsberg non trovi che la letteratura beat sia tra
i fenomeni culturali più sopravvalutati del ventesimo secolo?
Adoro Ginsberg e Burroughs ma non scordiamoci Kerouac! Ancor oggi assaporo la bellezza di Mexico city
blues; senti che meraviglia questo estratto dalla strofa
211:
“La ruota della carne tremante - il concepimento - gira
nel vuoto catapultando esseri umani, porci, tartarughe, rane, insetti, pulci (...) orribili innominabili pidocchi d’avvoltoi (...) tutto l’infinito concepimento di esseri
viventi (...) Vorrei essere libero/ da quell’incatenante
ruota di carne/ e salvo, in un cielo morto”.
Sfortunatamente la loro poetica si è prestata a facili manierismi ma il fulcro della letteratura beat riesce
a fondere l’aspetto estatico con il rigore di un testo
obiettivamente ben scritto. Oggi leggo molto volentieri David Tibet e un poeta canadese poco conosciuto
ma che mi sento di consigliare, tale Marc Creamore.
Chi è il giudice più importante: l’artista o il pubblico?
Crei sempre per te stesso e, contemporaneamente, per
quell’ascoltatore di cui non sai nulla se non il fatto che
è davvero interessato a capire ciò che hai scritto e, talvolta, ha bisogno di essere confortato dalla tua musica.
Non sai quante persone mi hanno riferito che la mia
musica li ha aiutati a desistere da pensieri suicidi. Pensa
che durante la seconda edizione del Terrastock festival,
a Londra, mi sono trovato davanti un fan con il viso interamente ricoperto di bende. Disse che stava morendo di cancro e mi chiedeva il permesso per mettere di
sottofondo un brano dei Pbs al suo funerale. Due mesi
dopo se n’è andato. Che dire? Cose del genere sono
talmente commoventi! Ti fanno capire che ciò che hai
fatto nella tua vita ha avuto un senso, un ruolo importante in quella degli altri. Molto semplicemente, realizzi che sì, sei riuscito a entrare in contatto con qualcuno
e ad aiutarlo.
Uno dei tuoi pezzi più recenti, The Swimmer, è dedi-
cata a Cobain: te ne frega davvero dei Nirvana o hai
solo omaggiato un giovane artista morto prematuramente?
La morte di Kurt Cobain e tutta la questione concernente il suicidio hanno suscitato in me una reazione
che si è poi tradotta in The Swimmer. Credo davvero
che la sua perdita, oltre a essere un fatto obiettivamente triste, abbia significato per noi la privazione di un
talento che poteva dare ancora molto in termini musicali.
E oggi? Qualche nome di rilievo tra le nuove leve
dello psych folk, gente come Devendra Banhart?
Ascolto molto volentieri gli album in duo dei miei amici Damon & Naomi. Poi vediamo: Black Forest/Black
Sea, Dave Pearce, Kitchen Cynics (cioè Alan Davidson), Prydwyn e gruppo annesso, Timothy Renner
e i suoi tanti progetti paralleli, i giapponesi Ghost,
Alastair Galbraith, Spacious Mind. Fanno tutti bella
roba.
Nel 1997 il tuo ritorno ufficiale ‘on stage’ dopo più
di vent’anni d’assenza…
Tutto grazie a Phil McMullen, editore della rivista Ptolemaic Terrascope. È stato il primo a venirmi a cercare,
agli inizi degli Anni ’90. A quanto pare la maggior parte di quelli che apprezzavano i Pbs erano convinti che
fossi morto e sepolto. Ha insistito affinché partecipassi
alla prima edizione del festival indie organizzato dalla
rivista, a Providence. Visto che anche mio figlio David
avrebbe suonato lì coi suoi Shy Camp mi sono fatto
forza e ho accettato. Solo che non avevo più toccato
una chitarra da un sacco di tempo ed è stato necessario esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi. Ho dovuto dannarmi a ritrovare gli accordi delle mie stesse canzoni,
non ricordavo neanche le parole. Eppoi non avevo più i
calli sui polpastrelli perciò le dita mi sanguinavano alla
grande. Molto fico comunque.
La formazione originale dei Pbs non sembrava particolarmente interessata a suonare dal vivo…
Poi però esibirsi nei primi Anni ’70 sì rivelò un’esperienza affascinante: ho conosciuto gente come John
Lennon, Tim Hardin, Jerry Garcia dei Grateful Dead e diviso il palco con mostri sacri quali Odetta, Chuck
Berry e i Pink Floyd. Cosa potevo chiedere di più a
quel punto? Il rovescio della medaglia era che avvertivo una pressione costante e di soldi ne giravano assai
pochi perciò talvolta c’era davvero poco per cui stare
allegri.
Quanto successo può tollerare un uomo prima di
perdere contatto con la realtà?
È una questione, quella della ‘fama’, che tratto in un
brano ancora inedito, dal titolo Every Change Is A Re-
lease. Sono assolutamente felice della mia vita e della
piega che ha preso in questo momento. Sono in armonia con le persone che mi circondano, con il sobrio stile
di vita che conduco. Se un giorno dovessi rimuginare
rispetto alle occasioni sprecate o ai progetti naufragati beh, mi basterebbe pensare che se la mia vita fosse
andata diversamente, con buona probabilità ora non
sarei appagato come sono.
Arriviamo ai giorni nostri: “Chi controlla il passato
controlla il futuro: chi controlla il presente controlla
il passato”. C’è del vero?
George Orwell ci vedeva giusto il più delle volte. La
questione oggi è che una piccola percentuale della
popolazione si è accaparrata la maggior parte delle
risorse disponibili; inoltre la disparità di guadagno tra
le diverse classi sociali non fa che aumentare, senza
controllo. Stati Uniti e Inghilterra stanno facendo del
loro meglio per vanificare anni e anni di lotte per ottenere un livello minimo di benessere sociale. Citando la
Genesi, Capitolo 4, Versetto 9: “Sono forse il custode di
mio fratello?”, la risposta del partito repubblicano è un
secco: “Cavolo, no!”.
Qual è il tuo bilancio dopo tre anni di presidenza
Obama?
Obama è troppo cauto quando fronteggia repubblicani e teabaggers. Ma dico io: visto che non gli piacerai
mai a prescindere (non so se te l’ho detto che Obama è
nero…) perché non prenderli a calci sul culo e passare
ad altro?
Qual è il pericolo più imminente che stiamo correndo?
L’ambiente e la salvaguardia del pianeta, sono le que119
stioni principe. Negli States la fazione di destra se ne
frega del riscaldamento globale: vorrebbero farci credere si tratti di inutili allarmismi. E vorrebbero pure che
credessimo alla loro buonafede in questa convinzione…
Blowin’ In The Wind t’ha convinto a diventare cantautore; il Dylan di oggi, quello di Modern Times o
Together through Life, lo trovi ancora efficace?
Un atteggiamento ingeneroso, il tuo. È come dire: ok,
Dylan ha inventato la ruota ma poi che ha fatto? Quando l’ho incontrato si è dimostrato una persona gentile
e generosa, completamente avvolta dalla propria travolgente creatività. Amerò tutto quello che vorrà ancora donarci per il resto della sua vita, che mi auguro duri
almeno un centinaio d’anni.
Allora è Dylan la tua influenza principale?
Mettiamola così: lui ha inventato l’alfabeto che noi
tutti abbiamo adoperato. Però l’autore che più mi ha
influenzato è Leonard Cohen. La sua poetica mescola
sapientemente Amor Sacro e Amor Profano. Sai, ero un
ragazzino cattolico al tempo, perciò conoscevo bene
queste due forze in eterna collisione. Quel genere di
tensione si è trovata uno spazio all’interno di molte mie
canzoni.
Che hai fatto negli Anni ’80?
Nel 1979 mi sono reiscritto a scuola pur avendo trovato
120
un lavoro a tempo pieno: fino al 1982 credo di aver dormito per una media di cinque ore a notte. Nell’84, conseguita una laurea presso la University of Pennsylvania
Law School, decisi di restare a Filadelfia, per esercitare a tutela dei diritti civili e contro quelle leggi che ci
discriminano in merito alla razza, l’età, l’orientamento
sessuale ecc.. Ho lavorato in una piccola società gestita
da un uomo straordinario, Alan Epstein, una persona
che si è battuta davvero contro le ingiustizie del governo, a tutela di vedove e bambini. Un paio dei nostri casi
si sono spinti fino alla Corte Suprema. So che sembra la
trama di un film ma ricordo che avevamo questo caso
entusiasmante di un giovane e brillante avvocato, silurato per aver contratto l’Hiv. Poco prima che la giuria
rientrasse in aula per esprimere il verdetto la grande
società che l’aveva licenziato patteggiò un’importante
somma di denaro. Soddisfazioni. Trasferitomi in Florida
nel 2001 lavorai per alcuni anni nell’ufficio legale della
contea in cui stavo.
Sei ancora operativo come avvocato civilista?
Mi sono ritirato nel 2008 e adesso vivo sulla costa est
della Florida con Lynn, mia moglie da venticinque anni,
e con Atticus e Lucy, due cani assolutamente indisciplinati. Ti prego di specificare che sono raggiungibile
all’indirizzo email [email protected]. Beh, chiaro: astenersi stalker psicotici con tendenze assassine!
Keats azzardava: “Se la poesia non vi arriva con la
naturalezza della foglia sull’albero è meglio che
non nasca nemmeno”. Mai avuto un blocco creativo?
Le canzoni sono solite sgorgarmi fuori con una certa
scioltezza; notizie che leggo sui quotidiani o fatti di cui
vengo a conoscenza o che mi toccano riesco a tramu-
tarli facilmente in canzoni. Riegal l’ho scritta dopo aver
letto nell’International Herald Tribune del ritrovamento di una nave da guerra tedesca affondata nel 1944
dagli inglesi, circostanza che causò la morte dei 400
prigionieri in essa detenuti. Ho acceso il registratore
incidendo tutto, parole in rima e musica, in cinque minuti. Il processo è stato talmente immediato che ho dovuto riascoltare il nastro per trascrivere gli accordi che
avevo suonato. Chiaramente anche la location aiuta:
nel mio caso aver abitato, per alcuni mesi del 1969, in
una casetta circondata di rose con vista sul un lago meraviglioso popolato dai cigni (e con un bunker nazista
a pochi metri, aggiungerei) sai… vorrei poter scrivere
più musica in quelle stesse condizioni…
Qualche inciampo musicale che non ti perdoni?
“Non, je ne regrette rien”.
Sei credente, in qualche modo?
Non proprio. Credo piuttosto che gente come Martin
Luter King abbia rappresentato la mano salvifica di
dio, una possibilità concreta per aggiustare le nostre
diatribe terrene. Scelgo, giorno dopo giorno, di credere
nella giustizia e nell’amore.
Cos’è allora, la religione?
Una speranza tutta umana in merito a qualcosa che
sta al di là di noi e che utilizziamo come infrastruttura
per raggranellare un po’ di speranza nei giorni difficili.
Qualcuno ha detto meglio di me che dio, per ‘funzionare’, non deve necessariamente esistere.
Senti questa di Confucio: “L’uomo che commette un
errore e non tenta di porvi rimedio commette un altro errore”…
Sì ma certi errori sono irreparabili e tentare di correggerli sarebbe uno sbaglio ulteriore. Questa l’ha detta,
sempre Confucio, un anno dopo della tua!
Qual è l’aspetto più straordinario dell’essere un artista?
Ti risponderei col verso di una canzone: “Money for
nothin’ and chicks for free” (“Soldi facili e pupe a volontà”)… no aspetta, questo è di un altro autore. Credo
che gli artisti e tutti quelli implicati in ogni genere di
attività creativa siano immersi costantemente in un lavorio di rielaborazione della realtà che poi propongono agli altri, affinché la percezione di ciò che li circonda
divenga più nitida e consapevole.
121
CAMPI MAGNETICI #3
classic album rev
Lucio Battisti
Stereolab
Cosa succederà alla ragazza (Columbia Records,
Ottobre 1992)
TRANSIENT RANDOM-NOISE BURSTS WITH ANNOUNCEMENTS
(Elektra, novembre 1993)
Correva il 1992 quando vide la luce Cosa succederà
alla ragazza, quarto titolo per il connubio sconcertante
tra Pasquale Panella, paroliere, ed un sempre più eclissato Lucio Battisti. I tre lavori precedenti sembravano
obbedire ad una strategia di negazione, uno spostare il
confine di ciò che è assodato, normale. Il contrario del
tipico smarrimento dell’ispirazione, del banale appassire, dello spegnersi crepuscolare nel pulviscolo fiacco
di polvere di stelle. Tutt’altro: c’è una determinazione
lucidissima nell’ultimo Battisti. Una convinzione premeditata. Affidarsi a Panella fu il colpo di genio, l’aggiustamento di rotta dopo i buoni ma non eccelsi risultati
ottenuti con Velezia (ovvero sua moglie Grazia Letizia
Veronese) in E già (1982). Rispetto al lirismo straordinariamente potabile di Mogol, Panella rappresenta una
sorta di algido dark side, fautore di disanime cubiste,
di simbologie algoritmiche e scambi di senso incrociati
che pure mettono nel mirino - mutatis mutandis - la
vita emotiva, le turbe sentimentali ed il rapporto tra individuo e società.
Giochi di parole che guadagnano il senso alla fine
del labirinto, rivelando l’insensatezza perniciosa del
formulario quotidiano. Un percorso che andava coperto con flemma da analista, con calcolo da laboratorio,
da cui lo sconcertante disin-canto dell’interpretazione,
perché il canto non è più libero se non nella dimensione distaccata di un punto d’osservazione intangibile. Il
Battisti panelliano compie una necessaria confutazione di sé e (quindi) di tanto rassicurante codice melodico, introducendo nel salottino del pop-rock italiano un
veleno alieno. Ok, certo, nessuna invenzione: nulla che
post-punk e new wave non avessero già ampiamente
sperimentato. E che pure il nostro Paese non aveva metabolizzato in una concreta dimensione/diffusione popolare. Di nuovo, è possibile stabilire un parallelo con
quanto fatto da Lucio nei sessanta, quando aveva innestato l’RnB a pieno titolo nell’immaginario collettivo.
Il metodo di lavoro avviato con Don Giovanni
(1986) - prima le musiche, poi i testi - fu ribaltato con
122
L’apparenza (1988) e La sposa occidentale (1990), riverberando nella sublime freddezza delle musiche. Nel
successivo CSAR il processo creativo sembra raggiungere un punto di equilibrio superiore (meglio di come
farà due anni più tardi il pur notevole canto del cigno
Hegel): malgrado la netta accentuazione ritmica - in
chiave funky dance con qualche tentazione techno:
produce Andy Duncan, già Pet Shop Boys, Frankie
Goes To Hollywood e New Order - le melodie tornano
a gonfiare il petto, sembra cioè che Battisti abbia stabilito una padronanza nuova anzi rinnovata. Si prenda
Ecco i negozi - il rap finto mansueto delle strofe come
trampolino per il setoso trasporto del ritornello - o l’allusiva gaiezza di La metro eccetera, oppure l’incalzante
palpitazione di Cosa farà di nuovo.
Ed è proprio questo stare sul pezzo con la tensione
delle grandi occasioni a rendere possibile episodi quali
Così gli dei sarebbero (saturo di affabili insidie ed emblematiche esegesi) o la straordinaria title-track, tirata
d’allegorie sinistre, livide reiterazioni e sferzanti simbolismi. Canzoni che non smettono di germinare sensi
rispetto ai propri tempi e che pure messi in prospettiva
non scherzano affatto, continuando a ghignare il loro
sberleffo pungente. Appostatissime nell’aria.
Stefano Solventi
L’incontro fatale avvenne sul finire degli Eighties. Lui,
Tim Gane, polistrumentista inglese appassionato di
kraut rock e wave sperimentale. Lei, Laetitia Sadier, vocalist francese col pallino della chanson sbilanciata pop.
L’intesa operò il miracolo, attivando forze incognite che
frutteranno una sintesi sconcertante. A quel punto la
coppia si espanse in sestetto, ché altrimenti non sarebbe stato possibile dare vita ad un costrutto sonoro a
base di stratificazioni magmatiche d’organi (Farfisa e
Vox) e sintetizzatori (Moog), di chitarre e percussioni.
Si era ormai nei Novanta, girava qualcosa nell’aria, una
forte spinta a ridefinire sostanza e finalità del rock. Il
post-rock non fu, ovviamente, un genere, ma un sentimento generazionale che esigeva porre in discussione
le consuetudini e i rituali fin nel profondo.
Da par loro, gli Stereolab colsero nell’aria il bisogno
di riorganizzare l’esperienza di composizione e ascolto: le
canzoni come sezioni di flussi sonori, la reiterazione come
dimensione dell’esperienza emotiva, l’improvvisazione
come variazione organica del ciclo meccanico, il timbro
analogico della strumentazione vintage come segno
esoterico prima che stilistico, quasi che nella sporcizia
delle vibrazioni armoniche, nella ruvidità delle distorsioni
pre-digitali, si celasse una sublime mostruosità, il rifiuto
programmatico dell’ottimizzazione indotta dalle logiche
industriali. Quanto alla componente melodica, anziché
annullare il canto come usarono compagini-cardine quali Slint, GY!BE e Tortoise, gli Stereolab optarono per una
sua ricollocazione e - in un certo senso - reinvenzione,
immergendo la melodia in una zuppa acida formalmente
ostile ma sorprendentemente fertile.
Se al centro del progetto sembra esserci il tentativo
di aggiornare i raga lisergici dei sixties rispetto ai codici dei neo-fricchettoni della rave-generation (un po’
come similmente/diversamente avevano fatto i Primal
Scream nel ‘91 con l’epocale Screamadelica), si trattava in ogni caso di sottrarsi al logoro schematismo
della forma canzone per accogliere ed enfatizzare le
capacità evocative - o genuinamente psichedeliche -
del rock: per far questo guardarono principalmente al
kraut di Can e Faust, alla contro-psichedelia dei Velvet
Underground, al minimalismo estatico di Steve Reich,
alle congetture soniche di Jesus & Mary Chain e My
Bloody Valentine, alle allucinazioni atmosferiche
dei Cocteau Twins, al massimalismo fiabesco dei Mercury Rev, ovunque insomma fossero stati edificati
“altrove” musicali nei quali si esaltassero le possibilità
ammalianti - e totalizzanti - del suono.
L’entusiasmo suscitato dall’esordio Peng! (Too Pure,
1992) non tardò a suscitare gli interessi della Elektra che
pose il marchio al secondo lavoro lungo Transient Random-Noise Bursts With Announcements, già apice artistico della band. Tra le linee melodiche pigre e dolciastre
(cantate da una Sadier flemmatica, quasi algida, sorta di
nipotina sintetica di Nico), gli stridori siderali delle tastiere, le pulsazioni battenti ed i clangori scomposti delle corde si innesca una compenetrazione ipnotica, suadente,
penetrante e tentacolare. E’ pop come somma di esperienze pop, la rumorosità come sfondo inevitabile, tumulto percettivo, sovraccarico di sensazioni auditive attorno
alla ramificazione tenue ma tenace della melodia. Fu così
che, in un certo senso, il post-rock partorì l’iper-pop. Con
fantasmatiche guarnizioni più o meno riconoscibili: l’evidente parafrasi NEU!della suite Jenny Ondioline, l’indolente impudenza Modern Lovers in I’m Going Out Of My
Way, l’estro anarcoide Red Crayola via Suicide in Analogue Rock, omeopatie George Harrison - un cui sample
era presente nella versione originale, poi tolto per evitare
noie legali - in Pack Yr Romantic Mind, sordidezza Royal
Trux in Golden Ball, e via discorrendo.
La targa di retro-futurismo è simpatica e attagliata ma
rischia di prestarsi all’equivoco: val bene sottolineare che
la musica degli Stereolab rappresentò puntualmente le
pulsioni profonde del proprio tempo, alba di un’epoca
che vedrà rimettere totalmente in gioco lo scibile rock alla
stregua di un repertorio accessibile, disponibile e simultaneo secondo i nuovi codici imposti dall’avvento del web.
Stefano Solventi
123
sentireascoltare.com