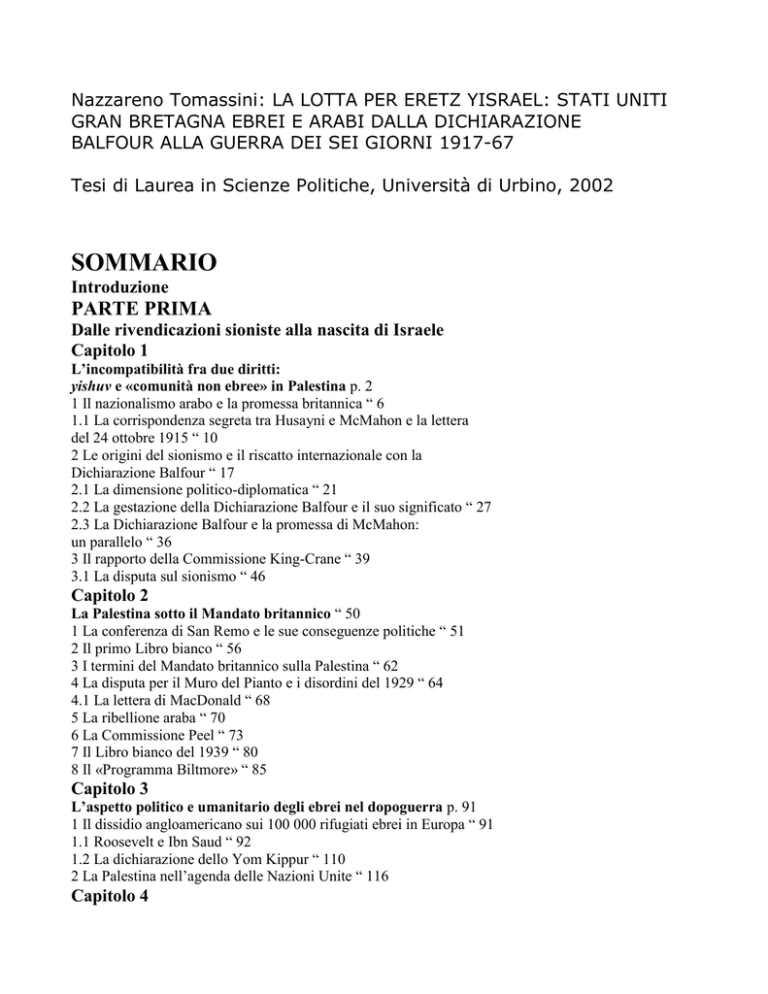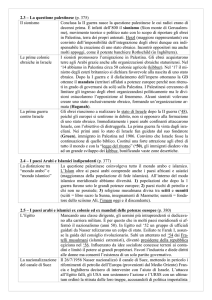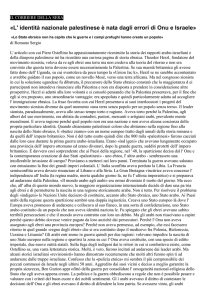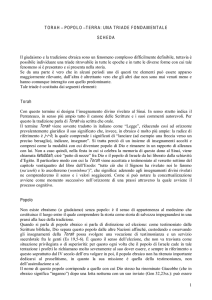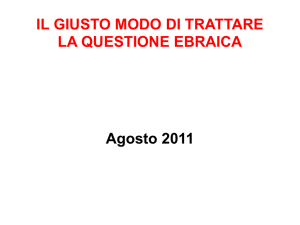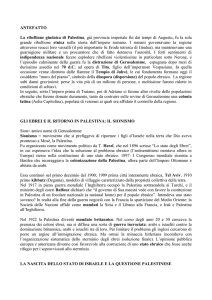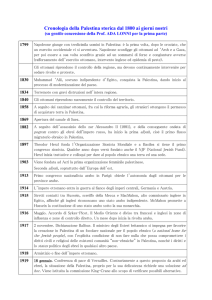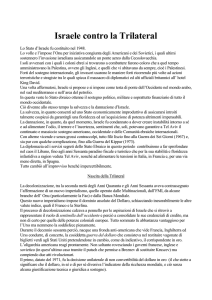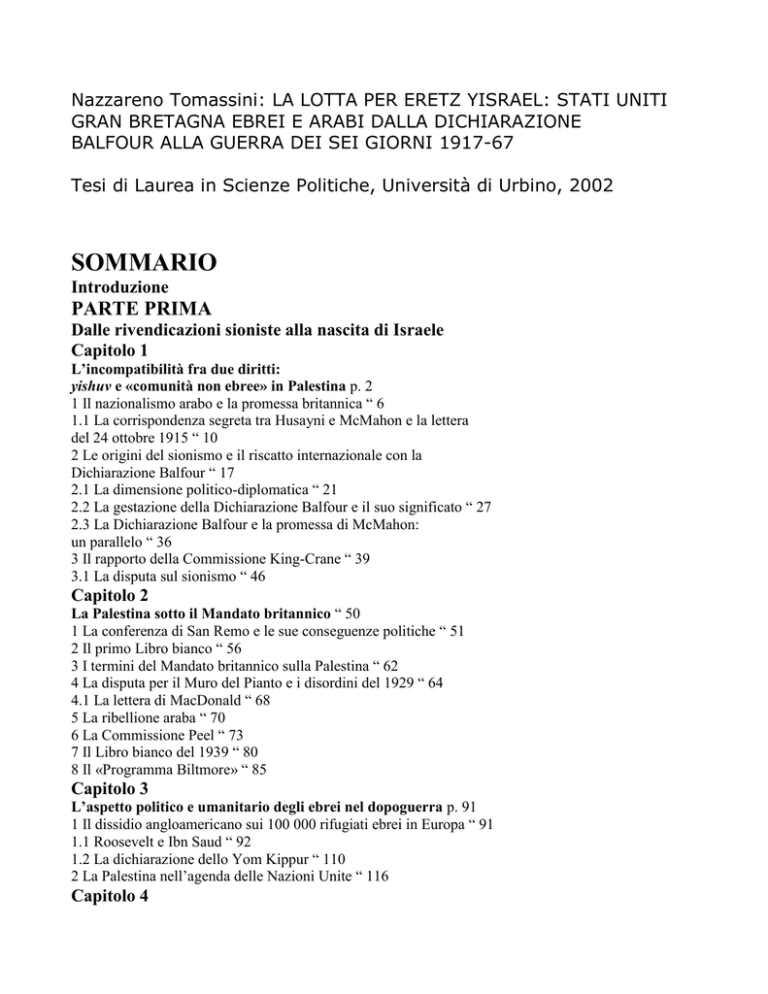
Nazzareno Tomassini: LA LOTTA PER ERETZ YISRAEL: STATI UNITI
GRAN BRETAGNA EBREI E ARABI DALLA DICHIARAZIONE
BALFOUR ALLA GUERRA DEI SEI GIORNI 1917-67
Tesi di Laurea in Scienze Politiche, Università di Urbino, 2002
SOMMARIO
Introduzione
PARTE PRIMA
Dalle rivendicazioni sioniste alla nascita di Israele
Capitolo 1
L’incompatibilità fra due diritti:
yishuv e «comunità non ebree» in Palestina p. 2
1 Il nazionalismo arabo e la promessa britannica “ 6
1.1 La corrispondenza segreta tra Husayni e McMahon e la lettera
del 24 ottobre 1915 “ 10
2 Le origini del sionismo e il riscatto internazionale con la
Dichiarazione Balfour “ 17
2.1 La dimensione politico-diplomatica “ 21
2.2 La gestazione della Dichiarazione Balfour e il suo significato “ 27
2.3 La Dichiarazione Balfour e la promessa di McMahon:
un parallelo “ 36
3 Il rapporto della Commissione King-Crane “ 39
3.1 La disputa sul sionismo “ 46
Capitolo 2
La Palestina sotto il Mandato britannico “ 50
1 La conferenza di San Remo e le sue conseguenze politiche “ 51
2 Il primo Libro bianco “ 56
3 I termini del Mandato britannico sulla Palestina “ 62
4 La disputa per il Muro del Pianto e i disordini del 1929 “ 64
4.1 La lettera di MacDonald “ 68
5 La ribellione araba “ 70
6 La Commissione Peel “ 73
7 Il Libro bianco del 1939 “ 80
8 Il «Programma Biltmore» “ 85
Capitolo 3
L’aspetto politico e umanitario degli ebrei nel dopoguerra p. 91
1 Il dissidio angloamericano sui 100 000 rifugiati ebrei in Europa “ 91
1.1 Roosevelt e Ibn Saud “ 92
1.2 La dichiarazione dello Yom Kippur “ 110
2 La Palestina nell’agenda delle Nazioni Unite “ 116
Capitolo 4
Gli Stati Uniti e la creazione dello Stato d’Israele “ 129
1 Truman e la Risoluzione 181 di spartizione della Palestina:
dall’appoggio passivo all’intervento determinante per l’approvazione “ 129
2 Il ritiro del piano di spartizione e il ripiego del Dipartimento di Stato
sull’iniziativa dell’Amministrazione fiduciaria “ 149
3 Il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte della Casa Bianca “ 162
PARTE SECONDA
La politica mediorientale di Washington da Truman a Johnson
Capitolo 5
Diplomazia sterile e forza dei fatti “ 179
1 Il piano Bernadotte “ 180
2 Prove di espansionismo “ 190
Capitolo 6
Dal secondo mandato di Truman all’amministrazione Eisenhower:
un ritorno graduale alla politica di neutralità “ 195
1 Nasser alla ricerca di armi “ 197
2 La crisi di Suez “ 205
3 Le conseguenze diplomatiche di Suez: il vuoto di potere in
Medio Oriente presupposto per una nuova politica statunitense “ 213
Capitolo 7
La debole pausa durante la presidenza Kennedy “ 220
1 Un diverso approccio nei confronti di Nasser e in generale
del nazionalismo arabo “ 222
2 Kennedy e Israele “ 226
Capitolo 8
Il trionfo del sionismo: Johnson e la conquista israeliana
di Eretz Yisrael nella guerra dei Sei giorni p.234
1 Verso la guerra “ 238
1.1 La posizione dell’amministrazione americana di fronte
alla crisi del maggio-giugno ’67 “ 244
2 Il capovolgimento della politica di Eisenhower adottata a Suez “ 252
3 Tra diplomazia e armi “ 255
3.1 La Risoluzione 242: analisi e interpretazione “ 255
3.2 Armi per Israele “ 270
3.3 ...e per la Giordania “ 280
Conclusioni
Il linguaggio della forza: una “pace” dettata da Israele “ 283
La politica espansionista aggressiva nei confronti del popolo palestinese “ 283
Fonti e bibliografia “ 301
Documenti
Testo del Mandato britannico sulla Palestina (24 luglio 1922) “ 314
La Dichiarazione Tripartita (25 maggio 1950) “ 319
La Risoluzione di Khartoum (1 settembre 1967) “ 320
Risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza ONU (22 novembre 1967) “ 321
Risoluzione 338 del Consiglio di Sicurezza ONU (22 ottobre 1973) “ 323
Risoluzione 446 del Consiglio di Sicurezza ONU (22 marzo 1979) “ 324
Risoluzione 465 del Consiglio di Sicurezza ONU (1 marzo 1980) “ 326
Risoluzione 1397 del Consiglio di Sicurezza ONU (12 marzo 2002) “ 328
Appendice iconografica
Capitolo 1
L’incompatibilità fra due diritti:
yishuv e «comunità non ebree» in Palestina
Con la conquista da parte della dinastia militare turca degli ottomani dell’Egitto e della Siria nel
1517, le popolazioni del Medio Oriente dettero l’obbedienza politica e religiosa al sultano e all’autoproclamato califfo, grazie a un discutibile diritto di conquista, piuttosto di aderire all’eredità
tradizionale araba secondo la quale il Califfo, capo e guida politica e spirituale della comunità dei
credenti (“umma”), doveva discendere o dalla tribù del Profeta, Qurayshita (alla quale appartengono la
maggioranza dei musulmani, detti sunniti, da sunna, “consuetudine”, “tradizione”) o dalla sua famiglia
(segue questa credenza, perlopiù in Iraq e in Iran, la minoranza musulmana degli sciiti, da shī‘a,
“partito”, “fazione”).
La fondamentale fedeltà dei musulmani arabi era verso l’Islam (“abbandono [sottomissione] alla
volontà di Dio”), benché, con un differente linguaggio e una identità culturale distinta, essi fossero
separati dai loro padroni turchi.
Dal sedicesimo secolo, mentre sull’Europa si abbatterono numerosi e importanti mutamenti
politici, religiosi e culturali, come la disintegrazione del sistema feudale, la Riforma (e la controriforma
cattolica), il Rinascimento, la scoperta del Nuovo Mondo che diede il via alle colonizzazioni e l’uscita
dai ristretti ambiti territoriali europei, e portarono alla centralizzazione del potere del nuovo Stato
moderno europeo, il Medio Oriente ristagnò e lentamente declinò fino al XX secolo con il tracollo
definitivo dell’impero ottomano durante la Prima guerra mondiale. Grandi progressi tecnici, economici,
politici e militari, diedero la potenzialità al Vecchio continente, agli inizi del Novecento, di sfogare la
propria forza fino all’autodistruzione.
Già con le prime conquiste, nel nord Africa, in Spagna, Portogallo e in Sicilia, gli arabi avevano
tessuto i rapporti con l’Europa occidentale, ma i principali beneficiari di questo scambio culturale di
relazioni fra i due mondi furono gli europei. Gli arabi consideravano l’Europa come le «tenebre esterne
della barbarie da cui l’assolato mondo islamico aveva poco da temere e ancora meno da imparare», un
continente cristiano e quindi infedele, anche se con qualche attenuazione.1
Punto di svolta fu l’invasione della Francia di Napoleone, nel 1798, dell’Egitto. L’importanza
della spedizione risiede nel fatto che questa fu la prima incursione armata di un Paese europeo nel
Vicino Oriente dal tempo delle Crociate.
Infatti, fino al XIX secolo, la penetrazione militare, oltre alla consolidata penetrazione
commerciale, nel mondo musulmano e mediorientale si era limitata ai confini settentrionali dell’impero
Austro-Ungarico e della Russia zarista, con l’avanzamento costante nei Balcani. Per di più, non furono
gli egiziani e tantomeno gli ottomani a cacciare i francesi dall’Egitto, ma un’altra potenza europea
rivale: la Gran Bretagna, nel 1801.
La facilità con la quale l’esercito di Napoleone soggiogò le forze indigene e il primo impatto
ravvicinato fra le due culture mise in forte crisi l’opinione, armai assodata, della superiorità del mondo
Cfr. Bernard Lewis, Gli arabi nella storia, Roma – Bari, Laterza, 1998 (tit. or.: The Arabs in History, Oxford, Oxford
University Press, 1993), p. 175.
1
islamico rispetto a quello occidentale. L’incontro fra la società tradizionale islamica e il nazionalismo
occidentale secolarizzato, uno dei prodotti della Rivoluzione francese e dello Stato nazionale europeo,
fece nascere le prime tensioni.
Come avrebbero reagito i musulmani alla crescente influenza dei valori occidentali, formatisi con
la Rivoluzione francese, di cui, uno su tutti, minava un punto cardine della società islamica:
separazione fra Stato e Chiesa, liberalismo? L’idea europea di nazionalità, insieme al crescente
risentimento arabo verso la dominazione turca e alla pressante diffidenza per l’Occidente estraneo e
invadente (in una parola sola, il nazionalismo arabo), minò alla base il movimento panislamico e la
fedeltà al califfo di Costantinopoli, simbolo dell’unità islamica, che riusciva a tenere unito il variegato
mondo islamico.2
L’imperialismo europeo avanzava prepotentemente nel nord Africa, dove la Francia occupò
l’Algeria nel 1830 e la Gran Bretagna Aden, situato in un punto strategico, nel 1839; ma fu
quest’ultima potenza a occupare l’Egitto nel 1882, centro del mondo arabo, nonché islamico, dando
una spinta al nascente movimento nazionalista. Il catalizzatore di questo processo fu la Rivoluzione dei
giovani turchi nel 1908, con la matrice del nazionalismo turco, che, inevitabilmente, provocò una
reazione nazionalista araba.3
Il nuovo gruppo al potere, il CUP (Committee of Union and Progress) riaprì il parlamento e
reintrodusse la Costituzione e la libertà di stampa. Gli arabi, cosi come gli ebrei della Palestina,
credevano che le promesse di progresso pronunciate dalla dirigenza indicassero una maggiore
autonomia dei territori arabi e più ampi diritti civili. Allentando le redini della censura, nacquero
giornali e partiti politici, di cui uno, fondato al Cairo, era denominato eloquentemente Partito del
«L’introduzione di ideologie nazionaliste straniere [e liberali] e più in particolare il recupero di rispettati termini religiosi
con un nuovo significato nazionalista, quindi implicitamente non religioso, non mancò di scatenare l’opposizione di coloro
che giudicavano idee disgregatrici e distruttrici», vedi in Bernard Lewis, Le molte identità del Medio Oriente, Bologna, il
Mulino, 2000 (tit. or.: The Multiple Identities of the Middle East, London Weidenfeld & Nicolson, 1998), p. 95.
3
Cfr. Bernard Lewis, Gli arabi nella storia, op. cit., pp. 177-178; 183-186.
2
decentramento ottomano, facendo trasparire in modo chiaro il suo obiettivo politico (maggior uso della
lingua araba, più lavoro per gli arabi nelle loro province).
Nel contempo però, i Giovani turchi intrapresero una politica di «turchificazione» per
salvaguardare l’impero e la loro etnia, facendo diventare sempre più esasperante il clima antiarabo che
si stava diffondendo nelle stanze del potere. Allo scoppio della Prima guerra mondiale prevaleva
ancora il sentimento dell’appartenenza e dell’identità musulmana (lealtà alla famiglia, al villaggio e al
Sultano-Califfo), il Panislamismo, ma un gruppo di intellettuali sollecitò una secessione (completa)
araba dall’impero ottomano.
1 Il nazionalismo arabo e la promessa britannica
L’iniziale presa di coscienza nazionale araba prese lo slancio dopo la Rivoluzione dei Giovani
turchi nel 1908. Le aspirazioni prendevano la forma di società segrete che svolgevano apertamente
attività patriottiche, richieste pressanti a Costantinopoli e una più generale propaganda in città come Il
Cairo, Damasco e Beirut. Il promotore e la guida di questo dinamismo fu lo sceriffo Husayni,
tradizionale custode dei due luoghi più sacri all’Islam, la Mecca e Medina, nella provincia dello
Hegiāz.4
Le quattro città sante dell’islam sono, in ordine di crescente importanza, Hebron, Gerusalemme,
Medina e La Mecca; le quattro città sante dell’ebraismo, sempre nello stesso ordine, sono Tiberiade,
Safed, Hebron e Gerusalemme. Le ultime due sono in comune, e si trovano rispettivamente la prima
nella Cisgiordania a circa trenta chilometri l’una a sud dell’altra. Gerusalemme, capitale dello Stato
ebraico, è rivendicata politicamente per la parte orientale, sede di luoghi santi di tutte e tre le religioni
monoteistiche, dall’Autorità palestinese come la futura capitale di uno Stato arabo in Palestina. Hebron
è sacra agli ebrei perché è il luogo di nascita e nel 1010 a.C. vi venne unto Re Davide, capo della tribù
di Giuda, alla guida della monarchia unita di Israele. Rimase capitale per otto anni prima che Davide la
lasciasse per recarsi a conquistare Gerusalemme e di lì il Monte Moria (o Monte del Tempio). È
ritenuta l’ubicazione di sepoltura dei patriarchi israeliti, ossia Abramo, Isacco, Giacobbe e le loro
mogli. Per i musulmani è il luogo dove il profeta Abramo, fondatore del monoteismo (secondo questi,
Abramo, pur essendo un semita, non era né ebreo né cristiano ma un hanīf, ossia un monoteista), il
primo e il vero musulmano e l’antecedente di Maometto, trascorse la maggior parte dei suoi anni.
Gerusalemme (il nome deriva da “Shalom” ossia pace, “Urusalin” in cananeo e “Yerushalaim” in
ebraico che significa città della pace) è la Città Santa per eccellenza per gli ebrei, essendo la vecchia
capitale del regno unito di Davide e il sito del primo Tempio di Salomone (955 a.C. e distrutto per
mano dei babilonesi nel 586 a.C.), sede del Sancta Sanctorum, l’ambiente all’interno del quale veniva
4
Il movimento per l’emancipazione politica delle province arabe dell’impero portò al raduno di
questi gruppi nel giugno 1913 a Parigi nel primo congresso arabo-siriano, per pubblicizzare le richieste
in occidente, ossia: riforme radicali al fine di consentire agli arabi di esercitare i diritti politici e
«rendant effective leur participation à l’administration centrale del l’Empire», senza reclamare la
secessione; un regime decentralizzato; l’uso ufficiale della lingua araba, accanto al turco, nel
custodita l’Arca dell’Alleanza, la più sacra e venerata reliquia religiosa, che custodiva le due tavole di
pietra del Decalogo. Inoltre è il luogo del secondo Tempio voluto da Erode il Grande (iniziato nel 19
a.C. e completato il 27 d.C.) di cui rimane ancora oggi solo l’estrema parte del muro occidentale,
denominato inizialmente come «Luogo del pianto» nel XIX secolo per lamentare la perdita del tempio
e delle passate glorie di Israele; in seguito il nome fu cambiato in «Muro del pianto» e dopo la
conquista israeliana della parte orientale della città, riunendola, avvenuta nel 1967, divenne
semplicemente «Muro occidentale».
Con l’avvento degli arabi nel VII secolo e del loro dominio incontrastato fino alla fine della Prima
guerra mondiale, salvo un intervallo di ottantanove anni nel XII secolo dovuto alla conquista di
Gerusalemme da parte dei crociati europei, la città (denominata al-Quds, “la Santa”) cambiò aspetto e
nell’area dove erano sorti i due tempi ebraici, l’Haram al-Sharif (che significa il “sacro o nobile
recinto,” chiamata anche Spianata delle Moschee), vennero edificati la Cupola della Roccia (in arabo
Qubbat as-Sakhra) e più a sud, a qualche decina di metri, la moschea al-Aqsa (“la distante, la remota”).
In particolare, la Cupola della Roccia sovrasta una lastra naturale di pietra calcarea, facendo della
roccia, nota come sakhra, la terza reliquia per importanza dell’islam, dopo la Ka‘ba della Mecca e
Medina (Yathrīb), la città del Profeta (al-Medinat al-Nabi). Da questo luogo, identificato dai
musulmani come il centro esatto della terra e la porta per il cielo, Maometto, secondo una tradizione
islamica maggioritaria, dopo un viaggio notturno partito dalla Ka‘ba della Mecca a cavallo del
miracoloso cavallo alato Būrāq, era asceso in paradiso attraverso le sette sfere della rivelazione divina.
In aggiunta, questa nuda roccia è venerata sia da musulmani sia da ebrei perché, secondo il Corano e la
Bibbia, per i secondi si tratterebbe del luogo dove Abramo stava per immolare il figlio Isacco, mentre
secondo la versione musulmana il figlio che Abramo intendeva immolare a Dio era Ismaele.
È evidente la cruciale importanza religiosa e storica di questa piattaforma, dove sono racchiusi e,
secondo alcune teorie e scavi archeologici, sovrapposti santuari dell’ebraismo e islamismo. Condivido
pienamente il giudizio dell’Economist sull’arte dell’archeologia in Israele/Palestina: «Archaeology can
seriously damage your health. If you’re working in a politically sensitive country, it can kill you. It
establishes history, and the past is a powerful weapon in present disputes over rights and claims.
…this biblical archaeology serves the Israelis too, appearing to justify claim to Israel» (in “The
Economist”, Digging for Truth, 21 luglio 2001, p. 72).
Per approfondimenti vedi Richard Andrews, Il Monte del Tempio, Milano, Sperling & Kupfer, 2001 (tit. or.: Blood on the
Mountain, 1999); per il viaggio notturno di Maometto a Gerusalemme cfr. la sura diciassette e il relativo commento in Il
Corano, introduzione, traduzione e commento di Alessandro Bausani, Milano, Rizzoli, 1996 (1988, 1° ed.), p. 201 e ss., p.
581 e ss..
parlamento ottomano e nelle province arabe; maggior possibilità per l’impiego di consiglieri non
ottomani; un servizio militare regionale.5
La risposta della Sublime Porta fu deludente, spingendo i membri dell’élite politica araba verso
l’idea della completa separazione, ed è proprio quello che accadde con la Prima guerra mondiale, dove
si presentava l’opportunità propizia di staccarsi dal governo di Costantinopoli, ma diversamente questa
lo era anche per gli ebrei.
Nei primi mesi del 1914, il figlio dello Sceriffo Husayni, ‘Abdullah, fece tappa al Cairo prima di
recarsi a Costantinopoli e partecipò a due colloqui riservati con l’Alto Commissario britannico in
Egitto, Lord Kitchener. Nell’ultimo incontro, in particolare, vennero affrontati importanti temi politici.6
I problemi dell’interlocutore arabo non erano tanto, o meglio, non solo gli imminenti e crescenti dissidi
fra lo Sceriffo e il capo politico (Vali) nominato dal governo turco, che rischiava di sfociare in una
destituzione imminente del primo, quanto «the future of the other Arab provinces of the Ottoman
Empire».
Una profonda svolta nel rapporto tra gli arabi dell’impero e i turchi era vicina e Abdullah
chiedeva apertamente l’appoggio britannico in un eventuale scontro con Costantinopoli. Il contesto
storico non era favorevole, ancora, a una risposta positiva da parte di Kitchener, poiché la Gran
Bretagna aderiva rigidamente dal 1840 alla “politica orientale” di sostegno all’impero ottomano («the
sick man of europe») con il fine di scoraggiare le ambizioni degli altri Stati europei (Francia,
Germania, Austria-Ungheria) e in primo luogo dell’impero russo. A Londra stava particolarmente a
cuore la stabilità della regione dell’Hegiāz, nella penisola arabica, per assicurare la sicurezza e le
5
Vedi British Imperial Connexions to the Arab National Movement, 1912-1914; Lord Kitchener, the Emir Abdullah, Sir
Mallet—the Case of Aziz Ali, 1914, in Volume X, Part II: The Last Years of Peace (British Documents on the Origin of the
War, 1898-1914, GP Goop and Harold Temperly, eds. With the assistance of Lillian M. Penson, PhD, 1938), pps 824-838, o
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1914m/arabetuk.html.
6
Il primo il 5 febbraio, il secondo il 7 febbraio nell’appartamento privato di Abdullah.
comodità durante il pellegrinaggio annuale alla Mecca, dove si radunavano i musulmani da ogni parte
del mondo, con un interesse speciale per quelli provenienti dal continente indiano e dall’Egitto.7
Tuttavia, la politica estera britannica passò dal sostegno all’integrità dell’impero ottomano ai
progetti per accelerarne la dissoluzione con lo scoppio della Grande Guerra e con l’entrata nel conflitto
a fianco degli imperi centrali del governo di Costantinopoli.
Nell’autunno del 1914 (tardo ottobre), Lord Kitchener, diventato ministro della Guerra
nell’agosto precedente, fece comunicare a Husayni che se gli arabi avessero aiutato la causa alleata,
come ricompensa veniva avanzata la promessa del Califfato, autorità spirituale e potente simbolo
dell’unità islamica.8 L’interpretazione di Husayni dell’iniziativa britannica comprendeva anche, e
soprattutto, un pieno appoggio militare e politico per concretizzare l’offerta, e ciò accelerò il sogno di
un grande Stato arabo indipendente sotto la dinastia Hascemita, visto che il tempo per una grande
rivolta araba anti-ottomana non era maturo, per il timore delle rappresaglie turche.9
Alla fine del maggio 1915, a Damasco, culla del movimento nazionalista arabo, alcuni gruppi
compilarono il c.d. Programma di Damasco, che in sostanza invocava il riconoscimento di uno Stato
arabo indipendente entro i confini, abbastanza vaghi, della Grande Siria. Husayni lo adottò come
obiettivo ultimo delle aspirazioni del popolo arabo e della sua famiglia.
In un possibile crollo dell’impero turco, si prevedeva una dura rivendicazione dei musulmani indiani per il possesso del
Califfato, un problema in più da tenere in considerazione per il governo britannico. Brevemente, vengono ricordati i cinque
pilastri dell’Islam (arkan al-Islam): la professione o testimonianza di fede (shahadah), la preghiera (Salat o Salah),
l’elemosina rituale (Zakat), il digiuno nel mese di Ramadan (Sawm), il pellegrinaggio alla Mecca (Hajj) almeno una volta
nella vita.
8
Vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, Berkeley – Los Angeles – Oxford,
University of California Press, 1987, pp. 11, 12. In modo abbastanza più sfumato viene riportato nel libro di Morris,
secondo cui «gli arabi dovevano aspettare e non fare niente contro gli ottomani [aiuto passivo e non attivo], né ostacolare
l’impegno bellico britannico», Benny Morris, Vittime, Milano, Rizzoli, 2001 (tit. or.: Righteous victims, 1999), p. 93.
9
La dinastia Hascemita rivendica la diretta discendenza da Hāshim ibn ’Abd Manāf, appartenente alla tribù qurayshita e
considerato il nonno di Maometto. Sicuramente è di grande valore presentare questa caratteristica per un pretendente califfo
come lo era Husayni.
7
1.1 La corrispondenza segreta tra Husayni e McMahon e la lettera del 24 ottobre 1915
Nel 1915 la cosa certa era che, con il Programma di Damasco, una limitata (circoscritta) élite
nazionalista araba, non avendo ancora avuto il modo per coinvolgere la massa della popolazione ancora
lontana da una cultura e da un impegno attivo politico, avanzava formalmente e pubblicamente la
richiesta della separazione dall’impero ottomano in favore di uno Stato arabo indipendente. Questa fu
la base della prima lettera indirizzata da Husayni all’Alto commissario britannico per l’Egitto, Sir
Henry McMahon, il 14 luglio 1915, contenente le già citate priorità: definire il territorio entro il quale
sarebbe sorta l’entità araba, la ricerca di un accordo con il governo di Londra per la proclamazione di
un Califfato arabo per l’intero Islam, ricordandosi del suggerimento avanzato da Kitchener nel tardo
ottobre dell’anno passato.
Erano chiaramente concessioni di vasta portata, che non potevano neanche essere prese in
considerazione dal governo britannico, in un momento in cui un effettivo aiuto militare in guerra era
poco più che una vaga promessa. In aggiunta, c’erano degli interessi strategici e le pretese, oltre che di
Londra, della Francia in Libano e in Siria, che in una eventuale vittoria alleata sarebbero emerse nel
dopoguerra. Il secco rifiuto di McMahon alle richieste arabe fu difficile da accettare.
Ma fu il deterioramento delle posizioni militari alleate nella campagna dei Dardanelli che
catalizzò soprattutto due elementi, i quali avrebbero portato a una risposta positiva alle domande di
Husayni: l’urgenza di separare le forze arabe da quelle turche e la testimonianza di un disertore arabo,
al-Faruqi che, in breve, riferì che gli arabi intendevano schierarsi dalla parte britannica, ma, in
mancanza di un segno favorevole, sarebbero stati obbligati a combattere a fianco della Germania.
Perciò, un interesse di guerra tangibile portò a un radicale cambiamento della politica verso gli arabi,
rappresentato dalla lettera chiave di McMahon del 24 ottobre 1915 in risposta alle insistenze di
Huseyni.10
Nel documento, anzitutto non vengono specificati i confini del territorio arabo e si rimanda al
vago progetto individuato nella lettera di Husayni di luglio. Anzi, vengono rese esplicite le aree che
non faranno parte dell’entità araba, dividendole in tre categorie ben distinte: in base alla popolazione,
dove la Gran Bretagna considera escluse le regioni abitate non completamente da arabi; in base agli
interessi dell’altra potenza europea, la Francia, che non rendeva libero di agire il governo britannico; in
base ai vincoli internazionali (trattati, accordi) di cui Londra è parte con i capi arabi e non può
pregiudicare i precedenti impegni.
È di cruciale importanza riuscire a capire quali territori sono suscettibili di appartenere alla prima
categoria. Il testo della lettera all’inizio afferma: «The two district of Mersina and Alexandretta and
portions of Syria lying to the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo cannot be
said to be purely Arab, and should be excluded from the limits demanded», e i diversi significati della
parola “district” (in turco vilayet, adattamento della parola araba wilāyah) ci portano a differenti
conclusioni.
10
Egualmente un interesse prettamente di guerra sarà motivo per emanare la Dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917. Il
testo della lettera si trova in Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, pp. 139, 140; sul sito
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1916/mcmahon.html, The Husain-McMahon Letters (excerpt), oppure in The Israel-Arab
Reader. A Documentary History of the Middle East Conflict, Laqueur Walter and Rubin Barry editors, Sixth Revised
Edition, New York – London – Ringwood (Australia) – Toronto – Auckland, Penguin Books, 2001, pp. 11-12.
In una prima ipotesi, questa può corrispondere a unità amministrativa e il distretto di Damasco
equivale all’intera regione del distretto della Siria, dato che l’uso arabo del termine attribuiva
frequentemente lo stesso nome al distretto o provincia e alla città capoluogo.11 Di conseguenza la linea
che passa dal nord di Hama, per Homs, Damasco fino a giungere all’estremo sud con la città di Aqaba
è quella indicata nella lettera, e chiaramente la Palestina12 è a ovest di questa linea e perciò esclusa
dall’area promessa agli arabi, anche se non viene fatto nessun riferimento esplicito. Ma allora perché
vengono citate, oltre a Damasco e alle città di Mersina, Alexandretta e Aleppo, i «distretti» di Homs,
Hama?
Appare più accettabile la spiegazione secondo la quale la parola “district” è intesa nel più ampio
e generale significato, ossia di periferia, dintorni, vicinato. Secondo questa ipotesi, la regione a ovest di
queste città corrisponde grossomodo al Libano e alla fascia costiera della Turchia meridionale. Inoltre,
prendendo come base le stime della popolazione locale, divisa in differenti territori, dal rapporto della
Commissione King-Crane13 del 1919, risulta che nella zona sotto l’Amministrazione militare francese,
OETA14 occidentale che equivale a grandi linee al Libano attuale, i musulmani sono il 54,7%, i
cristiani il 36,6%, i drusi 5,5%, gli ebrei il 1,4%, in sintonia con la condizione richiesta nella lettera di
McMahon per separare quest’area dal futuro Stato arabo.15
Viceversa, la popolazione dell’OETA meridionale, sottoposta all’Amministrazione militare
britannica e che comprende all’incirca la Palestina, era distribuita nel 79,6% di musulmani, 9,6% di
11
Cfr. Bernard Lewis, Le molte identità del Medio Oriente, op. cit., p. 77.
Il nome Palestina (in ebraico significa terra dei filistei) nella sua forma corrente nasce nella cultura greca per poi transitare
nel linguaggio amministrativo romano. Inizialmente il termine nasce come aggettivo, non come sostantivo, per indicare la
parte meridionale della Siria («Siria Palestina») che in precedenza era stata parzialmente conquistata e colonizzata dai
filistei, popolo da lungo tempo scomparso. Il nome ufficiale Palaestina è stato introdotto dai Romani dopo gli avvenimenti
del 132-135 d.C. al posto del tradizionale Iudaea, proprio per questo respinto in ambienti ebraici. Ricomparve in Europa e
divenne parte del linguaggio politico occidentale nel corso dell’Ottocento, senza diffondersi nella regione interessata.
L’espressione, infine, venne adottata dalla Gran Bretagna quale denominazione del territorio sotto mandato costituito dai
distretti più meridionali delle province ottomane di Damasco e Beirut e dal distretto separato di Gerusalemme. Cfr. Bernard
Lewis, Le molte identità del Medio Oriente, op. cit., pp. 74-75.
13
Vedi http://www.cc.ukans.edu/~kansite/ww_one/docs/kncr.htm, oppure
http://www.unu.edu/unupress/unuobooks/80859e/80859E05.htm.
14
Occupied Enemy Territory Administration.
15
L’area in questione «cannot be said to be purely Arab».
12
cristiani e 10% di ebrei: nel complesso una chiara e schiacciante maggioranza di arabi (musulmani e
cristiani), quindi in grado di rientrare nella promessa britannica fatta a Husayni. Era inequivocabile che
un’area doveva rimanere sotto l’esclusiva zona d’influenza anglo-francese, se non altro come
ricompensa politica per gli sforzi fatti in guerra dalle due maggiori potenze europee, ma la Palestina
non veniva menzionata e su questo punto si scatenò negli anni a venire una feroce disputa sulla
interpretazione della lettera.
Finora è stato esaminato il testo della lettera di McMahon, ma è più importate riuscire a capire le
vere intenzioni (e i motivi) che hanno portato a impegnare Londra con gli arabi. I britannici, compreso
McMahon, e i sionisti, sostenevano che la Palestina era a ovest di Damasco e delle altre città, e con ciò
era implicitamente esclusa dal futuro predominio arabo. Secondo gli arabi, non essendo stata lasciata
fuori esplicitamente e trovandosi non a ovest ma a sud-ovest di Damasco, doveva obbligatoriamente
rientrare nell’ipotetico Stato arabo. Forse McMahon non si era espresso apertamente sulla Palestina per
timore della suscettibilità dei francesi, dopo aver riservato il Libano e la costa siriana nordoccidentale,
incluse parti della Turchia meridionale (Mersina e Adana) alla zona d’influenza «non araba», ma è
ormai assodato che il Foreign Office di Londra «cercava di escludere la Palestina dalla futura entità
araba indipendente».16
Un altro punto da capire riguarda la promessa dell’indipendenza araba, la sua sostanza e valore.
Nella lettera del 24 ottobre 1915 è affermato che la Gran Bretagna «is prepared to recognize and
support the independence of the Arabs in all the regions within the limits demanded by the Sherif of
Mecca» dopo la guerra, e dichiarava che il governo di Sua Maestà avrebbe assicurato al nuovo Stato
consigli e assistenza, in modo da divenire il solo Paese europeo intimamente legato con la regione
mediorientale.
16
Vedi Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 94.
In poche parole, la volontà era sì di concedere l’indipendenza dei territori arabi dell’impero
ottomano da Costantinopoli, ma un’indipendenza non piena secondo Londra e si prospettava una forma
di autonomia, o protettorato, sotto la tutela di quest’ultima. Per la questione della Palestina, quasi
certamente ci fu un errore di traduzione della parola vilayet nel redigere la lettera; ma il significato
della promessa di uno Stato arabo indipendente, vago già nelle delimitazioni territoriali, deve essere
considerato come un generico modo per trascinare la parte araba fuori dal campo turco, e di persuaderla
a impegnarsi per la causa alleata.
La Gran Bretagna si era impegnata e aveva accettato il principio dell’indipendenza araba, ma già
dopo la Dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, che assegnava determinati diritti agli ebrei nella
regione, le prime smentite pubbliche dell’inclusione della Palestina nell’area destinata al futuro Stato
arabo vennero emesse, proprio quando la causa sionista stava diventando una questione diplomatica
internazionale.
Se la corrispondenza fra McMahon e Husayni poteva portare a intraprendere negoziati
maggiormente impegnativi e approfonditi, ciò non accadde principalmente per due ragioni: la prima fu
che l’auspicata grande rivolta degli arabi, proclamata il 10 giugno 1916 alla Mecca, non si materializzò
come sperava la Gran Bretagna e si risolse nell’impiego di uno sparuto numero di arabi irregolari, quasi
completamente beduini,17 abituati ad attività di guerriglia e senza contribuire efficacemente allo sforzo
bellico; la seconda era che il contesto di avvenimenti e situazioni del 1915 già nel 1916, e più ancora
negli anni seguenti, era mutato sensibilmente18 a causa del cosiddetto «accordo Sykes-Picot»19 (maggio
17
Vedi http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1917/27arts.html, The 27 Articles of T.E. Lawrence, The Arab Bulletin, 20
August 1917: «They [gli arabi] are meant to apply only to Bedu [bedouins]; townspeople or Syrians require totally different
treatment».
18
Nel gennaio 1916, nell’ultima lettera della serie, McMahon mette in guardia Husayni dai possibili cambiamenti futuri
della situazione attuale, vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, op. cit., p. 25.
19
I negoziati che portarono a questo accordo segreto fra le due principali potenze europee impegnate in guerra, erano una
diretta conseguenza della corrispondenza fra McMahon e Husayni, perché Londra doveva contemperare i suoi impegni con
gli arabi e le mire territoriali in Medio Oriente della Francia. In sostanza, si stabiliva che la zona a ovest delle famose
quattro città (Damasco, Homs, Hama e Aleppo) rientrava nell’area del controllo diretto francese, fino al porto di Haifa
escluso (riservato ai britannici), l’area delle province mesopotamiche di Baghdad e Bassora sotto il controllo diretto della
1916), della Dichiarazione Balfour (novembre 1917), delle crescenti pressioni della Francia circa le
rivendicazioni territoriali in Siria e Libano, e anche per il diminuito interesse del governo di Londra
rispetto all’ipotesi di concretizzare ulteriori concessioni agli arabi.
Durante la Rivolta araba contro l’impero ottomano, la principale azione degli arabi, guidati da
T.E. Lawrence, passato alla storia come «Lawrence d’Arabia», fu quella di sabotare la ferrovia
dell’Hegiāz.20 Ma se il contributo arabo nella campagna militare del Medio Oriente, condotta con armi
moderne, era stato modesto, bisogna dire che, durante l’invasione britannica della regione, i soldati non
incontrarono alcuna seria resistenza o atteggiamento ostile da parte della popolazione locale, e questa
sorta di neutralità araba trova le ragioni o nel timore di repressioni da parte degli ottomani, o nell’attesa
di un’esaltante rivolta araba contro Costantinopoli, oppure di qualche vantaggio da Londra.
2 Le origini del sionismo21 e il riscatto internazionale con la Dichiarazione Balfour
La rivoluzione francese, con l’enorme portata di principi e idee liberali che avrebbero condotto a
un cambiamento radicale della convivenza civile in Europa, produsse come conseguenza positiva
un’emancipazione politica di molte componenti del tessuto sociale. Anche gli ebrei ne trassero
benefici, perché furono riconosciuti come cittadini con pieni diritti, e vennero rimosse le vecchie
Gran Bretagna, con il rimanente territorio, destinato teoricamente a uno «Stato arabo indipendente o a una confederazione di
Stati arabi indipendente», diviso a sua volta in due sfere d’influenze. L’indipendenza araba era certamente soggetta a una
sorta di protettorato delle due potenze («the British and french government, as the protectors of the Arab state, …»). Il
resto, vale a dire la Palestina da Acri a Gaza fino al fiume Giordano, era riservato a un astratto condominio francobritannico-russo (terza firmataria dell’accordo). Nella parte finale del documento si fa esplicito riferimento alle
rivendicazioni territoriali dell’Italia in Turchia, formulate nell’articolo 9 del trattato segreto del 26 aprile 1915 tra Roma e
gli Alleati, il prezzo dell’Italia per l’entrata in guerra, seguito da un altro trattato, sempre segreto, dell’aprile 1917.
Per il testo dell’accordo Sykes-Picot vedi in Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, pp.
141, 142, oppure su http://www.yale.edu/lawweb/avalon/sykes.htm, The Sykes-Picot Agreement: 1916.
20
La ferrovia dell’Hegiāz, costruita tra il 1900 e 1908, collegava il capoluogo del distretto della Siria, Damasco, alla Mecca
e Medina. Fu costruita dal governo dei Giovani Turchi sia per unire territori arabi lontani da Costantinopoli, soprattutto per
avere un controllo politico più saldo delle due città sacre dell’Islam, e in generale sul suo capo spirituale, lo Sceriffo
Husayni.
21
Il termine “sionismo” fu coniato dallo scrittore viennese Nathan Birnbaum nel 1885 e prende il nome da “sion”, il nome
cananeo della collina dove sorgeva l’antica Gerusalemme, sulla quale era situato il palazzo reale del Re David (1010-970
a.C.), centro del governo e del culto ebraico. Dopo la distruzione di Gerusalemme e del primo tempio da parte dei
babilonesi e il conseguente esilio degli ebrei nel 586 a.C., sion divenne impressa nell’animo e nello spirito di ogni ebreo.
Durante i secoli, specialmente nell’età contemporanea, acquistò la connotazione di patria ebraica e venne adottato nel
diciannovesimo secolo per indicare la volontà politica di ricreare uno Stato ebraico in Palestina.
restrizioni legali al vivere comune. In sostanza, l’innaturale condizione di minoranza oppressa della
Diaspora, sempre osteggiata, discriminata ed emarginata politicamente, stava per essere lasciata da
parte come una pagina oscura del passato, guardando al futuro con speranza e fiducia. Gli ebrei
uscirono dai loro ghetti per partecipare alle scelte politiche su un piano di parità con tutti gli altri
cittadini, con la volontà di assimilarsi e integrarsi in ogni Stato in cui si trovavano.22
Gli ebrei europei erano sparsi ovunque nel continente, ma la maggior parte di loro viveva nella
Russia europea, nella cosiddetta «Regione degli insediamenti», tra Memel (oggi Klaipeda, porto lituano
sul Baltico) a nord e la Crimea a sud.
Il sionismo, vale a dire il movimento politico, culturale e religioso che ha come obiettivo il
ritorno degli ebrei alla biblica terra dei Patriarchi, Eretz Yisrael, in un’unica sede nazionale per ricreare
un’entità statale ebraica (uno Stato o un centro nazionale) dopo la Diaspora di quasi duemila anni fa,23
ebbe i suoi primi teorici nell’Ottocento, prima dello scoppio dei pogrom russi.24 Infatti, questi
intellettuali prospettavano un ritorno a Sion non come sostituto all’emancipazione che godevano in
Europa, ma piuttosto come un complemento e un progresso rispetto a esso. Ma questi richiami ebbero
una risonanza modesta e rimasero senza risposta, proprio perché nessuno era ancora disposto a
22
Il termine ghetto deriva dal nome di una zona di Venezia dove era situata una fonderia, che in veneziano era chiamata
gheto, propriamente «getto», “colata di metallo fuso”. Fin dall’antichità le comunità ebraiche manifestarono la tendenza a
isolarsi in quartieri, soprattutto per salvaguardare l’individualità della loro fede e del culto. Ciò si ritorse loro contro,
diventando la parola sinonimo di emarginazione sociale, politica e culturale. L’istituzione dei ghetti come dimore coatte
degli ebrei risale a Venezia nel 1516. L’obbligo vigente nelle grandi e medie città di riunire tutti gli ebrei in un quartiere
chiuso risale a una bolla del papa Paolo IV del 12 luglio 1555, l’anno della pace di Augusta.
23
Nel 70 d.C. il figlio dell’Imperatore romano Vespasiano, Tito, assediò Gerusalemme e la distrusse, e con essa il secondo
Tempio, costruito da Erode il Grande, causando una catastrofe di dimensioni inimmaginabili, poiché non vi era più un luogo
che rappresentasse il centro del popolo ebraico. La definitiva, e più radicale, Diaspora è datata nel 135 d.C., con la sconfitta
della seconda rivolta giudaica da parte dei romani, che devastarono l’intero Paese, cambiando perfino il nome di
Gerusalemme in Aelia Capitolina, in onore dell’imperatore Publio Elio Adriano (Aelia) e degli dei di Roma (Capitolina).
Cfr. Dan Cohn-Sherbok e Lavinia Cohn-Sherbok, Breve storia dell’ebraismo, Milano, il Mulino, 2001 (tit. or.: A Short
History of Judaism, Oxford, Oneworld, 1994), pag. 49-55; Paolo De Benedetti, Introduzione al giudaismo, Brescia,
Morcelliana, 1999, pag. 24: «Proprio la perdita del territorio e delle istituzioni connesse fa’ si che raccontare la storia degli
ebrei dall’età postbiblica alla metà del sec. XX significhi, in gran parte, raccontare non solo una storia di successive
migrazioni, stanziamenti, espulsioni, persecuzioni, massacri, ma anche, in positivo, una storia di maestri e di scuole».
24
Rabbi Zvi Hirsch Kalischer (1795-1874), rabbi Yehuda Alkalai (1798-1878) e Moshes Hess (1812-1875), un ebreo
tedesco che esercitò un’influenza intellettuale su Marx ed Engels.
sacrificare la speranza dell’assimilazione nelle società occidentali per uno sconosciuto e incerto futuro
in un’arretrata regione dell’impero ottomano.
Più dell’80% degli ebrei risiedeva nell’impero russo, in condizioni nettamente differenti rispetto a
quelle dei grandi Stati nazionali europei. Tuttavia, lo Zar Alessandro II promosse un vasto piano di
riforme che cambiò notevolmente i rapporti economici, politici e sociali della popolazione, con
l’intento di convertire la Russia verso la monarchia costituzionale sul modello occidentale. Ciò
nonostante, queste innovazioni nel medio e lungo periodo, in un contesto di aspettative crescenti dove
le aspirazioni degli individui sopravanzavano il progresso delle reali condizioni di vita, portarono alla
nascita di gruppi radicali, che facevano appello alla rivoluzione, delusi dall’attesa di una
trasformazione rapida e drastica che tardava ad arrivare.25
Queste frange della popolazione russa non rifuggivano dal terrorismo politico e nel marzo 1881
Alessandro II venne assassinato da un gruppo di estremisti (“Volontà del popolo” Narodnaja volja), e
questa fu la scintilla iniziale dello scoppio di un’ondata antisemita nella regione, dove le violenze
contro i sudditi di origine ebraica erano all’ordine del giorno. Ai pogrom seguì negli anni una serie di
leggi e decreti che istituzionalizzarono la discriminazione degli ebrei, con restrizioni e angherie
amministrative particolarmente dure e penose.
All’indomani delle manifestazioni antisemite nell’impero russo, Leo Pinsker, medico ebreo russo,
analizzò i fatti accaduti e giunse alla conclusione che gli ebrei non potevano più vivere, senza pericoli,
in terre straniere: occorreva abbandonare l’Europa per una «terra promessa». L’antisemitismo non era
Le grandi riforme della Russia zarista sotto la direzione di Alessandro II vengono inaugurate con l’emancipazione dei
servi (19 febbraio 1861), poi fu riorganizzata l’amministrazione locale (1864), entrò in funzione un nuovo sistema
giudiziario (1864) sullo stile di quelli dell’Europa occidentale, progressivo e liberale, e l’ultima riforma, di fondamentale
importanza, fu l’introduzione del servizio militare universale obbligatorio e di breve durata (1874). Le quattro riforme del
regno di Alessandro II, possono essere considerate, nel breve periodo, come altrettanti straordinari successi, specialmente se
si pensa che furono l’opera di un governo conservatore e in un Paese relativamente arretrato e povero. Grazie a esse, la
Russia compì un balzo immenso sulla via che doveva metterla al passo con il mondo occidentale in via
d’industrializzazione. È indubbio che queste riforme avviarono una trasformazione sociale in profondità senza
sconvolgimenti, senza violenza né crisi nell’immediato. Ma se le si guarda a distanza, e se ne osservano i risultati dopo
qualche decennio, il giudizio deve farsi più prudente perché al successo iniziale seguirono gravi difficoltà. Vedi Marc Raeff,
La Russia degli Zar, Roma – Bari, Laterza, 1992² (tit. or.: Comprendre l’ancien régime russe, Paris, Editions du Seuil,
1982), pp. 168-177.
25
più un anacronismo, un residuo dell’oscura età medioevale, ma avrebbe sempre reso insicuri gli ebrei
negli altri Stati, «ospiti ovunque, padroni di casa in nessun luogo», 26 perciò la soluzione, avanzata nel
suo libro Autoemancipazione: un avvertimento alla sua gente da parte di un ebreo russo, era quella di
una rinascita nazionale e la riunione in una patria, non necessariamente la Palestina, nella quale
colonizzare le terre gradualmente e ottenere lo status di nazione, riconosciuto dai “gentili”.27
Dopo i pogrom del 1881-1882 gli ebrei abbandonarono il sogno e la speranza dell’assimilazione,
di una piena uguaglianza e integrazione con l’occidente, e dalla «Regione degli insediamenti»
iniziarono a emigrare senza organizzazione né direttive. Molti vedevano negli Stati Uniti la «terra
promessa» prospettata da Pinsker, una meta che entro il 1914 avrebbe raccolto due milioni e mezzo di
emigranti, altri diressero la loro attenzione verso la Palestina.
Questi rappresentavano un piccola minoranza degli ebrei dell’Europa orientale che avevano
aderito al sionismo (3%), e appartenevano a società clandestine come Chovevei Zion (Coloro che
amano Sion), movimenti come Chibbat Zion (Amore per Sion), gruppi come Bilu.28 Diedero inizio alla
prima ‘aliyah29 (1882-1903), che portò in Palestina da 20 000 a 30 000 persone, e la loro attività,
denominata «sionismo pratico», consisteva nel perseguire l’ideale sionista concretamente, giorno per
giorno, colonizzando le terre gradualmente, in contrasto con il progetto politico-diplomatico di
costituire uno Stato ebraico garantito e riconosciuto da un accordo internazionale.30
2.1 La dimensione politico-diplomatica del sionismo
26
Vedi Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 29.
In questa accezione, la parola viene usata con riferimento ai cristiani e in generale ai pagani, in contrapposizione agli
ebrei.
28
Iniziali di Bet Ya‘akov Lekw ve-Nelkah: «Casa di Giacobbe, vieni camminiamo» (Isaia 2,5).
29
In ebraico la parola significa «salita» e indica le diverse ondate, in totale sei e prima della creazione dello Stato di Israele
nel maggio 1948, dell’immigrazione ebraica in Palestina. Alla fondazione del nuovo Stato ebraico, la popolazione era di
circa 710.000 abitanti. Vedi Dilip Hiro, Dictionary of the Middle East, New York, St. Martin’s Press, 1996, p. 12.
30
Tuttavia, all’ottavo Congresso sionista del 1907, Weizmann avanzò un nuovo termine, “sionismo sintetico”, con il quale i
due movimenti di pensiero si potevano integrare, e rappresentare in effetti due aspetti della stessa medaglia.
27
Quest’ultimo aspetto venne portato alla ribalta da Theodor Herzl (1860-1904), scrittore e politico
austro-ungherese. La sua conversione al sionismo fu catalizzata dall’affare Dreyfus, ebreo e capitano
d’artiglieria dell’esercito francese, accusato di alto tradimento il 15 ottobre 1884, giudicato colpevole il
22 dicembre e condannato all’ergastolo da scontare presso l’isola del Diavolo.31 Ma fu anche una
reazione all’imperante antisemitismo nella sua città natale,32 Vienna, dove proprio una visita nel
settembre 1895 ispirò la stesura del famoso pamphlet programmatico: Der Judenstaat.33
Come i pogrom russi del 1881-1882 rappresentarono uno spartiacque nelle menti degli ebrei
dell’Europa orientale, già poc’anzi ricordato, così l’ondata di antisemitismo conseguente all’affare
Dreyfus lo fu per gli ebrei dell’Europa occidentale. Come si potevano tollerare le violenze subite dagli
ebrei in uno degli Stati guida europei, la Francia, la patria della emancipazione politica e del progresso,
la culla della democrazia e dei diritti individuali?
Herzl giunse alla conclusione che in nessun luogo al mondo gli ebrei potevano stare sicuri, che
l’antisemitismo ci sarebbe sempre stato, proponendo uno Stato ebraico come soluzione definitiva. Nel
suo scritto, pubblicato nel 1896, egli tracciò una serie di incisive elaborazioni sul problema ebraico,
sull’ineluttabilità, come rimedio, di uno Stato ebraico o in Argentina o in Palestina. Persino le potenze
europee cristiane avrebbero goduto per questa scelta, perché potevano liberarsi una volta per tutte degli
ebrei, facendo sì che l’antisemitismo divenisse funzionale al progetto di Herzl. Ma per trasformare «a
portion of the globe large enough to satisfy the rightful requirements of a nation», questi necessitava
dell’appoggio e della difesa di qualche potenza europea, la Germania, la Turchia oppure la Gran
Bretagna.
Herzl rifiutava la strategia dei piccoli passi, praticata dalle piccole comunità già in Palestina.
L’impresa sionista su piccola scala già operante, caratterizzata dall’immigrazione sporadica e
Malgrado le mobilitazioni e le prove in favore dell’ufficiale, la condanna venne definitivamente cancellata solo nel 1906.
Vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, op. cit., pp. 34-35.
33
Per alcuni estratti del libro vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, op. cit., pp.
134-137.
31
32
dall’assenza dell’appoggio delle grandi potenze, non sarebbe mai riuscita a esercitare sulle autorità
ottomane la pressione adatta a dar vita a uno Stato.34 Insomma, quello che era fondamentale per Herzl
si riassumeva in un sostegno politico internazionale al suo piano di uno Stato ebraico o nella garanzia
internazionale per una massiccia immigrazione in questa entità. Era necessario trovare capitali e chi li
finanziava, ma le personalità illustri di ricchi ebrei erano riluttanti verso il progetto di Herzl e non lo
sostennero economicamente per vari motivi.35
Questa delusione provocò lo spostamento della sua attenzione verso la massa ebrea, convocando
per il 29-31 agosto 1897 a Basilea il primo Congresso sionista internazionale, con l’istituzione
dell’Organizzazione sionista mondiale e una piattaforma programmatica per lanciare gli ambiziosi
obiettivi, primo fra tutti la definizione di «casa» (o «dimora», Heimstätte) ebraica in Palestina.36
Quindi, avendo chiare le idee, il primo e principale interlocutore con il quale intavolare la
discussioni al riguardo fu il Sultano ottomano Abdulhmid II, ma questi rifiutò di concedere benefici
agli ebrei per non compromettere le già precarie relazioni con gli arabi, sebbene fosse allettante la
(finta) proposta di concedere prestiti ebraici alle vuote casse dell’impero. Analoga risultò la reazione
dell’imperatore tedesco, il Kaiser Guglielmo II, che non aveva di certo l’intenzione di rovinare i
Un significativo passo del testo di Herzl su questo aspetto, dove è chiara l’opposizione al metodo e all’ideologia del
sionismo («pratico») di costituire lentamente uno Stato ebraico basato sulla colonizzazione e sul lavoro delle terre, afferma:
«In both countries [Argentina e Palestina] important experiments in colonization have been made, though on the mistaken
principle of a gradual infiltration of Jews. An infiltration is bound to end badly. It continues till the inevitable moment when
the native population feels itself threatened, and forces the Government to stop a further influx of Jews. Immigrations is
consequently futile unless we have the sovereign right to continue such immigration [le ulteriori immigrazioni degli anni
’20 e ’30 saranno proprio basate sulla Dichiarazione di Balfour]». Cfr. Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the
Arab-Zionist Conflict, op. cit., pp. 35, 39 e anche Benny Morris, Vittime, op. cit., pp. 36-37.
35
Un emigrazione di massa degli ebrei in un Palestina sotto il protettorato di una potenza europea avrebbe potuto aggravare
l’ostilità della autorità turche verso l’impresa sionista e verso lo yishuv (“insediamento”, la comunità ebraica in Palestina
prima della fondazione dello Stato di Israele nel maggio 1948), infiammare il (proto) nazionalismo arabo, provocare dei
probabili scontri fra le colonie ebraiche e i pellegrini cristiani.
36
In nessun Congresso sionista fu utilizzato il termine “Stato” per indicare il fine ultimo di questo organismo, sebbene
Herzl confidò nel suo diario subito dopo la chiusura del congresso: «at Basel I founded the Jewish State. If I said this out
loud today, I would be answered by universal laughter. Perhaps in five years, and certainly in fifty, everyone will know it».
Citato in Avi Shlaim, The Iron Wall. Israel and the Arab World, W. W. Norton & Company, 2001, p. 3 e cfr. Benny Morris,
Vittime, op. cit., p. 36.
Solamente nel maggio 1942, il Congresso straordinario sionista americano riunitosi a New York si pronunciò, per la prima
volta e in modo ufficiale e pubblico, in favore di uno “Stato ebraico” nell’intera Palestina («Palestine be established as a
Jewish Commonwealth», v. oltre).
34
rapporti con Costantinopoli, futura alleata in guerra. All’interno del movimento sionista, erano attive
fazioni contrarie ai metodi di Herzl, fra cui spiccava il più numeroso gruppo russo con a capo il
chimico Chaim Weizmann, ma non mancava largo appoggio per i suoi tentativi diplomatici.
Falliti i tentativi di Costantinopoli e di Berlino, Herzl rivolse le speranze alla Gran Bretagna. Il
ministro delle Colonie, Joseph Chamberlain, al ritorno dall’Africa orientale nell’aprile del 1903,
propose per la prima volta qualcosa di concreto: il “piano ugandese”, che in realtà si riferiva a una
striscia di territorio all’interno dell’odierno Kenya, rifiutando nel contempo di offrire la zona di al‘Arish, situata nella penisola del Sinai e nettamente favorita dai sionisti per la sua vicinanza alla
Palestina, vista la risposta negativa al riguardo delle autorità egiziane.
Il dibattito accese subito gli animi tra i sionisti: da una parte una «minoranza territoriale» (tra cui
Herzl) era a favore della decisione britannica, forse anche accettata come una misura d’emergenza
(temporanea) ai nuovi pogrom russi, più gravi di quelli degli anni ’80 del secolo precedente, per
permettere agli ebrei di sottrarsi alle violenze; dall’altra vi era una maggioranza, in particolare i russi,
che manifestava una chiara e categorica opposizione alla creazione di una patria ebraica in Uganda. Per
questi attivisti esisteva solo la Palestina. In effetti, il settimo Congresso sionista riunitosi a Basilea nel
luglio 1905, scartava ufficialmente qualsiasi proposta alternativa alla Palestina, e quest’ultima divenne
l’obiettivo finale dell’attività sionista.
Herzl era morto il 3 luglio 1904, nel pieno delle furiose discussioni sull’offerta di Londra, e non
era riuscito nell’impresa di vincolare una grande potenza europea del tempo, tramite un accordo
diplomatico, alla creazione delle condizioni adatte per formare un’entità statale ebraica riconosciuta
internazionalmente, che avrebbe consentito l’immigrazione senza ostacoli. La valutazione del suo
operato deve essere compiuta non solo sulla base dei successi mancati, seppur commessi agli obiettivi
centrali del suo sforzo, ma anche in riferimento alle conseguenze positive del suo lavoro di
sensibilizzazione della questione ebraica ad alto livello. I frutti si sarebbero visti qualche decennio
dopo: Herzl aveva trasformato gli sforzi del sionismo intrapreso da pochi individui in un movimento
politico centralmente organizzato, presente in diversi paesi.37
Si è già accennato alla seconda ondata di pogrom nell’impero russo che prese il via a Kišinev,
capitale dell’odierna Repubblica della Moldavia durante la Pasqua ebraica (19-20 aprile) del 1903.
Persecuzioni sempre più cruente si verificarono nel 1905 sulla scia della guerra russo-giapponese e
della rivoluzione, dove il regime zarista abilmente incanalò il malcontento popolare nei confronti della
monarchia sugli “stranieri” ebrei.
I pogrom del 1903-1906 che si abbatterono sugli ebrei, in primis quello di Kišinev (Chisinau),
segnarono un punto di svolta nella mente della vittime: se in precedenza i soprusi subiti venivano
accettati in modo passivo, come una fatalità, ora alle violenze si rispondeva con l’azione e l’autodifesa,
uno dei pilastri della nuova ideologia portata in Palestina con la seconda ‘aliyah (1904-1914) . Questo
nuovo afflusso, composto prevalentemente da ebrei russi, diventò, più ancora della precedente,
un’espressione di rivolta contro l’umiliazione e l’impotenza della vita nella Diaspora, e ne fecero le
spese, soprattutto negli anni seguenti, gli arabi, considerati i nuovi “gentili”. Nelle parole di Herzl, il
sionismo doveva far nascere un «nuovo ebreo» che avrebbe recuperato l’onore e il rispetto e si sarebbe
scrollato di dosso la vergogna e il disprezzo che erano stati i marchi della Diaspora. Le nuove
caratteristiche sarebbero state la fermezza, la fierezza e anche l’aggressività, e dovevano essere
rappresentanti di un «ebraismo muscoloso».38
Dopo la morte di Herzl, il movimento sionista si concentrò nel consolidare gli sforzi della
colonizzazione in Palestina, visto il ristagno politico fino alla vigilia della Prima guerra mondiale. Sarà
proprio questo cataclisma ad aprire nuove possibilità non solo agli ebrei ma anche agli stessi arabi.
37
Vedi Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 40: «Il sionismo sorse circa un quarto di secolo prima del nazionalismo arabo: un
vantaggio iniziale in termini di consapevolezza politica e organizzazione che si sarebbe rivelato cruciale per i successi
ebraici e gli insuccessi arabi negli scontri dei decenni seguenti».
38
Vedi Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 34.
2.2 La gestazione della Dichiarazione Balfour e il suo significato
Il terremoto politico al vertice del governo britannico, con l’assunzione della carica di Primo
ministro il 7 dicembre 1916 da parte di Lloyd George, simpatizzante per la causa sionista, e di James
Balfour come ministro degli Esteri, anch’egli pro-sionista, provocò un cambiamento di strategie sulle
future mosse militari alleate in guerra.
A differenza del precedente premier, Heberth Asquith, convinto sostenitore di un impegno
militare prioritario concentrato sul fronte europeo, il Medio Oriente, con la nuova amministrazione
governativa in carica, divenne un’area di tutt’altra importanza. Lloyd George era intenzionato a
sfruttare la parte più debole degli imperi centrali, il «ventre molle», per prendere alle spalle l’impero
austro-ungarico: la resa della Germania sarebbe stata una questione di tempo.
In questo modo, la Palestina assumeva una posizione chiave di enorme rilevanza. Inoltre,
l’accordo Sykes-Picot, con la sua spartizione territoriale del Medio Oriente ottomano, era considerato
sproporzionato, nel senso che Londra aveva concesso troppi privilegi alla Francia, come il condominio,
con la Russia zarista, della Palestina. Il nuovo premier britannico cercava di escludere i francesi dalla
Terrasanta.39
Nel 1917, l’anno peggiore della guerra per gli Alleati con le varie rivoluzioni nell’impero russo
seguite dalla umiliante sconfitta con l’esercito tedesco e dalla disonorevole imposizione di una pesante
pace separata, solidi interessi di guerra e ragioni strategiche, cioè motivazioni analoghe a quelle che
Vedi nota 19. La previsione nell’accordo di un’Amministrazione internazionale della Palestina fra Gran Bretagna, Francia
e Russia è coerente con le affermazioni della maggior parte dei funzionari governativi di Londra, in quanto questi, a parte
qualche voce dissonante contraria, sebbene eminente, ritenevano la Palestina non facente parte del territorio indipendente
arabo, oggetto della promessa britannica nella lettera del 24 ottobre 1915, quantomeno perché violava gli interessi francesi
nell’area («Great Britain is free to act without detriment to the interest of her ally, France», dalla lettera di McMahon a
Husayni del 24 ottobre 1915, vedi sopra). A rigor di logica, entrambi i punti di vista possono essere validi e legittimi: i
britannici (e i sionisti) possono rivendicare la continuità e la non contraddizione dell’accordo Sykes-Picot con la
corrispondenza di Londra con Husayni, gli arabi possono contestare la rottura della promessa britannica con i contenuti
dell’accordo Sykes-Picot.
39
avevano condotto il governo britannico ad assumere un atteggiamento conciliante con gli arabi nel
1915, spinsero Londra a cercare i primi contatti con esponenti del sionismo nel febbraio 1917.
Portare l’Organizzazione sionista, sin allora ufficialmente neutrale,40 a schierarsi con gli Alleati,
avrebbe prodotto vantaggi notevoli: avrebbe favorito un impegno più incisivo degli Stati Uniti nella
lotta agli imperi centrali dato la presenza in America di una numerosa e influente comunità ebraica, ma
soprattutto, interesse prettamente britannico, avrebbe dato a Londra la possibilità di districarsi
dall’impegno con l’accordo Sykes-Picot. In effetti, una dichiarazione di buone intenzioni in favore
degli ebrei, contrastava le rivendicazioni territoriali francesi in Palestina, perché questa veniva in
appoggio al sionismo e si candidava a garante dell’autodeterminazione ebraica, legittimando la
presenza inglese nella regione mediorientale.
Parigi non sarebbe stata in grado di accusare la Gran Bretagna per aver rotto un accordo
internazionale (peraltro segreto), con lo scopo di difendere strenuamente i suoi interessi di potenza
imperialista. In aggiunta, il presidente americano Wilson sarebbe stato certamente soddisfatto
dell’impegno di Londra per far ritornare nell’antica terra biblica della Palestina l’antico popolo ebreo,
lasciando da parte le collaudate mire espansionistiche. Così, si promuoveva l’impresa sionista e si
rendeva sempre più concreta la visione del recupero per gli ebrei della terra di Palestina, concepita nel
nuovo ordine mondiale auspicato da Wilson.
Il nuovo movimento politico sionista, strutturato e ben organizzato da Herzl, poteva influire
sull’opinione pubblica internazionale, in un anno, il 1917, dominato dal timore che Mosca stesse per
concludere una pace separata con la Germania, che gli ebrei dominassero il movimento rivoluzionario
russo, ma soprattutto che gli Stati Uniti stessero negoziando una pace separata con l’impero
L’Organizzazione sionista era presente in territorio alleato ma anche negli imperi centrali. Infatti, non bisogna
dimenticare che molti ebrei erano o provenivano dalla Germania, Austria, Ungheria o Romania, e che diversi ambienti
internazionali ebraici osteggiavano la Russia per il suo antisemitismo. C’era il potenziale rischio che Berlino battesse sul
tempo la Gran Bretagna nell’accaparrarsi la simpatia dei sionisti con una dichiarazione in loro favore.
40
ottomano.41 D’altra parte, quando ancora gli Stati Uniti non erano ufficialmente entrati in guerra a
fianco degli alleati,42 alcune personalità di origine ebraica dell’Amministrazione di Washington vicine
al Presidente (consiglieri, assistenti, funzionari burocratici) erano apertamente schierate a favore del
sionismo e possedevano un significativo potere di influenza sulle scelte politiche governative. In poche
parole, l’opinione pubblica in questi due paesi chiave avrebbe giocato un ruolo decisivo sugli sviluppi
futuri della guerra, e l’ascendente ebraico era un elemento da non sottovalutare.
Così come al-Faruqi fu un elemento chiave per far cambiare agli inglesi atteggiamento nei
confronti degli arabi nell’ottobre del 1915, Ronald Graham, capo del Dipartimento orientale del
ministero degli Esteri inglese, mise in guardia la dirigenza del paese che i sionisti potevano essere
attirati da una dichiarazione di simpatia tedesca se il governo di Londra non avesse preso
provvedimento adeguati e celeri.
Oltre a motivi prettamente militari, associati a progetti imperiali di lungo termine, furono
determinanti forti ragioni interne. La fuga nell’occidente europeo degli ebrei russi dal regime zarista
nel 1904-1905, a seguito dell’intensificazione della politica di discriminazione e di russificazione,
provocò tensioni sociali e persino reazioni anti-semitiche nella libera e progredita Inghilterra. Molti
erano dell’idea che, dando la concreta possibilità ai sionisti di guardare verso un focolare ebraico ben
determinato, si sarebbero potuti evitare, o attenuare, molti problemi della società britannica, sempre
tenendo conto anche dell’impatto religioso di un progetto per restaurare gli ebrei nella loro antica terra,
la Palestina.
Nel maggio 1917, ci fu una spaccatura politica fra i sionisti, aumentati di numero grazie alle
decine di migliaia di immigrati russi, e la comunità ebraica britannica, formata essenzialmente da
È molto interessante, per quest’ultimo aspetto, vedere Peter Grose, Israel in the Mind of America, New York, Alfred A.
Knopf, 1983, pp. 60-62. Una pace separata fra gli Stati Uniti e Costantinopoli andava contro gli interessi e i disegni
imperiali della Gran Bretagna sui territori mediorientali, così come minacciava le aspirazioni di liberazione dal giogo
ottomano dei diversi gruppi nazionali, arabi, ebrei e armeni.
42
Lo faranno il 6 aprile 1917, dichiarando guerra alla sola Germania a seguito di quest’ultima di rinunciare alla guerra
sottomarina illimitata, e cercando di arrivare a un pace separata con l’impero turco.
41
politici e personalità di grande spicco. Questi ultimi manifestavano la loro opposizione a ogni teoria
che indicava gli ebrei come una nazionalità senza casa, avendo timore che un appoggio da parte del
governo britannico alla creazione di un’entità nazionale ebraica in Palestina, avrebbe minato la
condizione degli ebrei inglesi, i quali si sarebbero potuti sentire definitivamente marchiati come
stranieri nelle loro terra nativa.43 Il contrasto degli ebrei non-sionisti fu di cruciale influenza sia sulle
pretese dei sionisti inglesi sia sulla stesura della famosa risoluzione di Londra, sulla quale il consenso
in generale era stato raggiunto.
Il 18 luglio 1917, i sionisti, dopo un lungo dibattito interno, avevano ottenuto l’accordo nel
sottoporre al governo il disegno di una richiesta modificata, nella quale si chiedeva il riconoscimento
della (intera) Palestina come «the National Home of the Jews people and the right of the Jews people
to build up its National life in Palestine under a protection».44 Certo è, che si può dedurre la forte
incidenza della comunità sionista in Inghilterra, e in generale del sionismo internazionale come
movimento politico organizzato e ben strutturato, dove questa si era spinta persino a suggerire i termini
della dichiarazione al governo britannico.
Alla fine, Londra adottò il progetto finale della dichiarazione il 31 ottobre, un testo di
compromesso messo a punto da due sionisti, l’inglese Lord Milner e l’americano Leo Amery, passata
al vaglio del ministro degli Esteri Balfour, che cercava di contemperare i desideri delle varie parti in
gioco: si tentò di evitare, per quanto possibile, un’opposizione araba che sarebbe stata apertamente
abbastanza dura, si concedeva una garanzia agli ebrei non-sionisti inglesi, si limitavano, con un gioco
L’unica personalità politica all’interno del gabinetto britannico, capace di contrastare le richieste dei sionisti, fu l’ebreo
Edwin Montagu, Segretario di Stato per l’India, il quale si chiedeva, in modo colorito, come avrebbe potuto rappresentare
l’opinione del governo britannico nella sua imminente visita in India se lo stesso governo avesse dichiarato che il suo
focolare nazionale era in un territorio turco. Vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict,
op. cit., p. 52.
44
L’originale domanda della comunità sionista inglese era a favore della ricostituzione della Palestina in uno Stato ebraico,
un’espressione molto più diretta. Per il testo della formula sionista ufficiale del 18 luglio 1917 vedi Michael J. Cohen, The
Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, op. cit., p. 143.
43
di parole e lasciando inalterato la sostanza delle affermazioni, gli obiettivi della comunità ebraica
sionista in Palestina.45
Il seguente testo in inglese della Dichiarazione Balfour, indirizzato sotto la forma di una lettera al
leader della Federazione sionista britannica Lord Lionel Walter Rothschild, viene riportato in forma
integrale, per facilitare una migliore comprensione e analisi dei termini impiegati:
«November 2nd, 1917
Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you on behalf of his Majesty’s Government, the following declaration of
sympathy with Jewish Zionist aspiration which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
“His Majesty’s Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish
people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood
that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities
in Palestine, or the rights and political status enjoyed by the Jews in any other country.”
I should be grateful if you would bring this declaration to knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerely,
Arthur James Balfour».
La prima fondamentale modifica rispetto alla richiesta ufficiale della comunità ebraica inglese
avanzata nel luglio precedente, dove era espressamente indicato il riconoscimento britannico della
«Palestine as the national home of the Jewish people», riguarda l’inserimento della preposizione in che
indica come solo una parte, peraltro non definita e soggetta ai futuri fattori politici e militari della
regione, sarà oggetto dell’istituzione del focolare nazionale («national home») ebraico. Per
quest’ultima espressione chiave rimane invariata la dizione, un eufemismo palese per
«Commonwealth» o «State».
«It was written by those to whom it was addressed» in http://www.russgranata.com/fraud.html, The Fraud of Zionism –
Part I, dove vengono espresse ulteriori critiche sulla Dichiarazione Balfour. In aggiunta, la formulazione del linguaggio del
Mandato britannico sulla Palestina, con cui si riconosce la legittimità internazionale della Dichiarazione, è del sionista e
professore di giurisprudenza all’università di Harvard Felix Frankfurter.
45
Continuando con l’analisi letterale della Dichiarazione, si nota che gli impegni e le facilitazioni
nel raggiungere gli obiettivi del sionismo da parte del governo di Londra sono condizionati al rispetto
dei diritti civili e religiosi della popolazione indigena, non del tutto chiari. È stato sottolineato il fatto
che la presenza araba in Palestina, inclusi gli ebrei palestinesi, venga ignorata nella Dichiarazione,
usando in modo sprezzante il termine più generico di comunità non-ebraiche, e non vengono presi in
esame i diritti politici di queste.46 L’ultima disposizione salvaguarda i diritti di tutti gli ebrei sparsi nel
mondo, ed è chiaramente una concessione alle pressioni degli ebrei non-sionisti inglesi, come Edwin
Montagu.47
Indubbiamente, la Dichiarazione di Balfour rappresenta un punto di svolta di grandissima
rilevanza sia nella lunga storia del popolo ebreo sia, conseguentemente, nel futuro della Palestina.
Questo scarno comunicato di poche righe, visto come «il più importante riconoscimento internazionale
del sionismo», «la più importante presa di posizione internazionale»48 in favore degli ebrei, evidenzia
come per la prima volta questi siano passati dalla condizione di minoranza oppressa, oggetto di
discriminazione e di bruta violenza, a quella di un popolo soggetto di diritti di stabilimento in Palestina,
sotto la tutela della maggior potenza coloniale di allora: la Gran Bretagna.
L’obiettivo ultimo di Herzl, come detto precedentemente, era uno Stato ebraico riconosciuto
internazionalmente dalle grandi potenze europee, essendo contrario alla colonizzazione strisciante della
Palestina delle prime comunità di immigrati ebrei, che non avevano una precisa strategia. Nel suo libro
egli considera questa immigrazione senza un fine politico «unless we have the sovereign right to
continue such immigration», e si può ritenere che questo diritto venne rappresentato dalla
46
Il testo della Dichiarazione Balfour è stato a lungo studiato, preparato ed esaminato attentamente da sionisti americani e
inglesi, prima di essere ratificato dal governo britannico il 31 ottobre ed emesso a nome del ministro degli Esteri della
Corona, Arthur Balfour. Di conseguenza, l’esito di questo lavoro rispecchia la volontà dei suoi curatori e niente è lasciato al
caso nel testo: ogni frase o parola vaga si riflette in un’intenzionale indeterminatezza.
Vedi http://www.russgranata.com/fraud.html.
47
Vedi nota 43.
48
Cfr. Benny Morris, Vittime, op. cit., pp. 99, 101.
Dichiarazione Balfour, nel momento in cui essa fu approvata e ratificata dalla Conferenza di pace di
Parigi, che la incluse nel Mandato britannico sulla Palestina.49
La Grande Guerra era riuscita a concedere ai sionisti questa preziosissima dichiarazione sulla
quale basare le successive ondate di immigrazioni, intervallate dalle sempre più frequenti agitazioni e
rivolte arabe, dato che era ancora prematuro parlare di uno Stato ebraico e solo con la Seconda guerra
mondiale essi sarebbero riusciti a realizzare, grazie anche a delle condizioni particolari come
l’Olocausto, l’antica aspirazione di formare uno Stato ebraico nella “loro” antica terra.
Il governo britannico, con all’interno ebrei o comunque simpatizzanti della causa sionista, tra i
quali Lloyd George, Arthur Balfour e Herbert Samuel, aveva dato ai sionisti di tutto il mondo una
grande e unica occasione che verrà sfruttata a dovere, contenendo, e alla fine sconfiggendo,
l’opposizione araba. Ma con la Dichiarazione Balfour vennero gettati anche i semi di un conflitto tra i
più difficili e complessi da risolvere, e che si protrae quotidianamente nei giorni nostri.
Londra credeva, o sperava, che gli impegni assunti con la Dichiarazione di Balfour sia con gli
ebrei (sostegno all’istituzione del focolare domestico), sia verso gli arabi autoctoni (difesa dei diritti
civili e religiosi) fossero compatibili.
A parere di chi scrive, gli impegni erano inconciliabili e già si poteva presupporre che un
immigrazione continua sotto l’egida inglese, associata all’acquisto di terre, avrebbe portato a una
situazione insostenibile e a un inevitabile scontro fra le due comunità. Uno Stato ebraico sarebbe potuto
sorgere solo quando la popolazione ebraica fosse diventata numericamente superiore a quella araba, o
addirittura prossima all’equilibrio. Nei due censimenti effettuati dai britannici nel 1922 e nel 1931,
notiamo che la percentuale della popolazione ebraica affluita grazie alla Dichiarazione Balfour era
49
Vedi nota 34.
passata dall’11,4% al 16,9%, e quella araba dal 78,3% al 73,5%; nel 1942 saranno rispettivamente
29,9% e 61,4% prima dell’arrivo dei sopravvissuti alla carneficina nazista.50
La Dichiarazione Balfour non solo è ambigua ma anche inevitabilmente vaga, non essendo
specificato quale parte della Palestina (e i suoi confini) sarà riservata al “focolare nazionale” ebraico, o
menzionato quale struttura sarà creata allo scopo di “facilitare” lo sviluppo e il progresso dei diritti
della comunità ebraica.51 Evidentemente, si trattava di una dichiarazione programmatica o di intenti, e
il suo unico ma fondamentale significato fu quello di aprire la Palestina alle nuove possibilità sioniste,
trasformando lo status internazionale degli ebrei da stranieri del mondo in una comunità, ufficialmente
riconosciuta, a cui venivano concessi per la prima volta certi diritti.
2.3 La Dichiarazione Balfour e la promessa di McMahon: un parallelo
Entrambi i documenti furono emessi sotto la responsabilità del governo britannico e per reali
interessi di guerra.52 L’intento era quello di mobilitare e guadagnare il sostegno di due quasi
insignificanti alleati, ma preziosi nel contesto dell’evolversi del conflitto, in particolare modo le
simpatie del movimento sionista, sparso in tutto il mondo, organizzato e influente.
Nella Dichiarazione Balfour, il testo si focalizza sulla Palestina, sebbene in una indeterminata
parte di essa; nella lettera di McMahon si fa riferimento a una promessa di “indipendenza” di un molto
più indefinito territorio abitato principalmente da popolazioni arabe, con la disputa nel far rientrare o no
il territorio della Palestina. Naturalmente, dopo essersi impegnata nella dichiarazione di simpatia verso
gli ebrei, Londra era assai riluttante ad ammettere l’incompatibilità con la promessa araba,
avvalorando, perciò, la sua insistenza sull’esclusione della Palestina.
50
Vedi http://www.unu.edu/unupress/unuobooks/80859e/80859E05.htm, oppure su
http://domino.un.org/UNISPAL.N…/a682cabf739febaa052565e8006d907c!OpenDocument.
51
Vedi nota 45 o 46.
52
«On behalf of his Majesty’s Government» nella Dichiarazione Balfour, «in the name of the Government of Great Britain»
nella lettera di McMahon a Husayni.
Una differenza chiave fra i due documenti era che la corrispondenza McMahon-Husayni rimase
segreta, non tanto per la paura britannica di rivelare il coinvolgimento con gli arabi, quanto per una
prevedibile reazione negativa della popolazione musulmana dell’India viste le probabili rivendicazioni
sul califfato qualora l’impero ottomano fosse uscito sconfitto dalla guerra.53
Al contrario, la Dichiarazione Balfour venne immediatamente largamente pubblicizzata, essendo
ciò funzionale innanzitutto per mobilitare il sostegno ebraico internazionale a fianco degli alleati, ma
anche per mettere al corrente le intenzioni del governo inglese del futuro della Palestina
significativamente a Stati Uniti, Francia e Russia. Non fu divulgata solamente in Palestina, fino a dopo
la conferenza di San Remo, dove l’amministrazione militare britannica aveva il timore che avrebbe
potuto provocare dei disordini da parte degli arabi.
Infine, mentre la promessa araba di McMahon non si è concretizzata in un accordo vincolante,
pur rimanendo sempre un impegno generico del governo inglese preso durante lo sviluppo
(svolgimento) della guerra, la Dichiarazione Balfour fu un atto unilaterale di intenti da parte del
governo londinese, al quale venne seguita alla Conferenza di San Remo del 24 luglio 1920 la decisione
di incorporarla nel testo del mandato britannico sulla Palestina, ratificato del Società delle Nazioni il 24
luglio 1922. In sostanza, si trattava ed era diventata la Dichiarazione, un obbligo internazionale sotto la
salvaguardia della Società delle Nazioni, e ci si poteva appellare ogni qual volta si violavano i termini
di attuazione.
Tra i due impegni, incompatibili a mio avviso, ha prevalso quello in favore dei sionisti nel lungo
termine, guidati a Parigi nel 1919 da Chaim Weizmann, il quale era riuscito persino a far inserire nel
preambolo del mandato il riconoscimento dei diritti storici degli ebrei in Palestina.54
53
La Gran Bretagna pubblicò i testi della corrispondenza solo nel 1939 sotto insistente richiesta degli arabi, presenti a
Londra alla conferenza sulla Palestina per sostituire il Libro bianco del 1922.
54
«Whereas recognition has thereby been given to the historical connexion of the Jewish people with Palestine and to the
grounds for reconstituting their national home in that country».
Resta il fatto che la Gran Bretagna aveva tradito l’alleato in guerra arabo, benché il suo
contributo fosse poi marginale nel conflitto, non rispettando le legittime aspirazioni di un popolo e
perpetuando il sistema coloniale delle potenze europee vincitrici sotto le sembianze del nuovo istituto
del mandato internazionale, anche se bisogna ricordare l’anticipazione di certi principi della
decolonizzazione là dove vengono affermate le priorità dei diritti dei popoli soggetti al mandato.
3 Il rapporto della Commissione King-Crane55
La commissione King-Crane presentò delle considerazioni molto interessanti per quanto riguarda
la natura e la portata dei fatti al momento del crollo, ormai consumato nel 1919, dell’impero ottomano,
e delle decisioni in merito alla Conferenza di Pace a Parigi fra i “quattro grandi”. Pochissimi autori
dedicano un’analisi esauriente al documento, ed è per questo motivo se ne approfondisce lo studio.
L’istituzione della Commissione, con poteri solo consultivi, nasce dalla proposta del presidente
statunitense Woodrow Wilson nell’ambito della Conferenza parigina sulla pace nel marzo 1919, con il
fine di testimoniare direttamente la situazione sul campo e di portare le richieste e i desideri delle
popolazioni locali in relazione al futuro politico della regione. Il tutto è permeato dal principio di
autodeterminazione (n° 5) proclamato da Wilson davanti al Congresso americano l’8 gennaio 1918,
dove furono elencati i famosi “14 punti”, vale a dire una struttura generale sulla quale fissare il nuovo
Per il testo del Mandato vedi The Israel-Arab Reader, op. cit. pp. 30-36, oppure su
www.lib.byu.edu/rdh/wwi/1918p/sanremo.html. Cfr. anche Giampaolo Calchi Novati, La decolonizzazione, Torino,
Loesher, 1983, p. 108.
55
Per il testo integrale vedi http://www.cc.ukans.edu/~kansite/ww_one/docs/kncr.htm, The King-Crane Commission
Report, August 28, 1919.
ordine internazionale e la futura pace, discostandosi nettamente dalla tradizionale politica di potenza
europea.56
Gran Bretagna, Francia e Italia accettarono l’idea americana in linea di principio, un’antica e
preziosa frase della (vecchia) diplomazia, che in questo caso si tramutò in un’opposizione all’atto
pratico; soprattutto Parigi era fermamente contraria a questo strumento atto ad accertare le vere
condizioni in questi territori.57 Di conseguenza, soltanto il governo di Washington nominò i suoi
rappresentanti, che nel giugno arrivarono a Giaffa, in Palestina, per iniziare il lavoro di raccolta delle
informazioni dalle varie realtà locali, con il fine di presentare ai lavori di Parigi un rapporto sulla
Siria.58
L’accoglimento della delegazione americana in Medio Oriente, nella quattro zone in cui, dopo la
guerra, il territorio della Siria era stato diviso, 59 è stato molto caloroso da parte della popolazione
locale, e un motivo molto significativo è dato dal fatto che gli Stati Uniti erano rappresentati
universalmente come una grande potenza che non avrebbe mai cercato ingrandimenti territoriali,
testimoniato soprattutto dall’entrata in guerra senza mire imperialistiche e con la carica ideale di
Per il testo del discorso dei “14 punti” vedi Giampaolo Calchi Novati, La decolonizzazione, op. cit., pp. 48-49,
oppure sul sito http://www.seas.edu/nsarchive/coldwar/documents/episode-1/14_points.htm. In sostanza, le
raccomandazioni contenute in questo documento programmatico, se risvegliarono l’attenzione dei popoli colonizzati, furono
intese però come applicabili solo ai paesi europei.
57
Quasi certamente, la riluttanza a collaborare con le altre potenze vincitrici per concretizzare l’iniziativa di Wilson, è
dovuta al fatto che la Francia era consapevole della forte avversione degli arabi in Siria e in Libano in un suo impegno come
potenza mandataria. Vedi nota 65 più avanti.
58
Qui il nome di Siria indica il distretto amministrativo (vilayet) retta da un governatore (wali) residente a Damasco, che
comprendeva la provincia di Beirut, con all’interno lo speciale sangiaccato del Libano, la provincia di Aleppo e lo speciale
sangiaccato di Gerusalemme, il quale capo, dal 1887, dipendeva, più che da Damasco, direttamente da Costantinopoli. In
termini attuali, si può dire che la Siria ottomana equivale grossomodo alla Siria contemporanea, alla Giordania, al Libano, a
Israele, inclusi i “territori occupati”, oltre ad alcune aree dell’odierna Turchia meridionale (la Grande Siria). Inoltre cfr.
Benny Morris, Vittime, op. cit., pp. 17-18 e Bernard Lewis, Le molte identità del Medio Oriente, op. cit., p. 77. Per
approfondimenti sulla disputa circa l’interpretazione della lettera chiave di McMahon a Husayni del 24 ottobre 1915 (la
promessa britannica) vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict, op. cit., pp. 19, 20, 22.
Bisogna ricordare che, oltre al territorio mediorientale dell’ex impero ottomano a cui si concentra esclusivamente lo studio,
la commissione King-Crane ha lavorato anche su quelle regioni ottomane di lingua non araba, ossia la Turchia in senso
stretto e l’Armenia.
59
L’OETA (Occupied Enemy Territory Administrations) meridionale sotto l’Amministrazione militare britannica (Gaza,
Hebron, Betlemme, Giaffa, Nazareth, Gerusalemme, Nablus, Ramallah, Tel Aviv, Haifa, sono le città più importanti),
l’OETA orientale sotto l’Amministrazione militare araba (Aleppo, Amman, Damasco, Hama, Homs), l’OETA occidentale
sotto l’Amministrazione militare francese (Alessandretta [Antiochia o oggi Antakia], Beirut, Tebe, Sidone, Tiro, Tripoli),
l’OETA settentrionale sotto l’Amministrazione sempre francese (Adana, Mersina, Tarso).
56
Wilson, i quali principi stavano a cuore ai popoli colonizzati, sfruttati e oppressi dalle potenze
europei.60
Tutto ciò ha favorito indubbiamente la sincerità delle opinioni espresse e la buona riuscita del
compito della commissione americana. Questo consisteva nel ricevere, nelle varie città e villaggi in cui
la Commissione faceva tappa, gruppi politici, religiosi, economici e sociali, ma anche individui,
autorità, e ottenere ogni petizione, richiesta, rimostranza, in modo da metterla nelle migliori condizioni
per avanzare alla Conferenza di pace le precise volontà della maggioranza delle popolazione.
Ovviamente il rapporto menziona le interferenze, soprattutto da parte delle Amministrazioni delle
quattro zone, durante lo svolgimento del lavoro, ma anche pressioni e influenze esercitate dalla
propaganda «which was entirely legitimate as well as natural and inevitable».61
La relazione della Commissione americana include, nella forma di un testo integrale, le richieste
del primo Congresso arabo siriano riunitosi a Damasco significativamente il 2 luglio 1919, proprio
mentre la delegazione si era fermata nella città per raccogliere le testimonianze.62 Ovviamente
l’importanza di questo documento è elevata se si pensa che rappresenta la volontà della maggioranza
della popolazione, araba (musulmana e cristiana), ma anche rappresentanti cristiani erano presenti e
mancavano solo gli ebrei.
Questo primo congresso richiedeva senza mezzi termini: la piena e assoluta indipendenza
politica della Siria (la Grande Siria); una monarchia costituzionale sotto la guida dell’emiro Faisal, con
In verità, gli Stati Uniti, con la guerra ispano-americana del 1898, guadagnarono Cuba, che subì un’incisiva egemonia
statunitense fino all’instaurazione del regime rivoluzionario di Castro, con la deposizione dell’ultimo dittatore appoggiato
da Washington, Fulgencio y Zaldivar Batista, nel gennaio 1959, e le Filippine, che furono sottoposte al regime coloniale
fino all’indipendenza, dopo la Seconda guerra mondiale, il 12 giugno 1946.
61
Nella regione sottoposta al regime dell’Amministrazione militare britannica, la Palestina occidentale, i funzionari si
comportavano come se il loro controllo dovesse rimanere in modo permanente, ad esempio costruivano strade, ferrovie,
porti, e progettavano la crescita della città. D’altra parte, alcuni manifestavano il desiderio che fossero stati gli Stati Uniti a
portare l’onere del mandato, concesso dalla nascente Società delle Nazioni.
Si era coscienti che se la Francia non avesse rinunciato alla Siria come territorio sotto il suo mandato, questa avrebbe dovuto
usare le maniere forti per ottenere il controllo, con il rischio abbastanza probabile di un'altra guerra e un altro bagno di
sangue. Cfr. Confidential Appendix in http://raven.cc.ukans.edu/~kansite/ww_one/docs/postkc.htm.
62
Il testo della Risoluzione del primo Congresso arabo siriano, benché non integrale (mancano il quinto e il sesto punto del
programma), è anche su Giampaolo Calchi Novati, La decolonizzazione, op. cit., pp. 51-52.
60
un ampio decentramento dei poteri e delle garanzie per i diritti delle minoranze (cristiani ed ebrei); la
dura opposizione contro l’articolo 22 della Società delle Nazioni, base giuridica per costituire il regime
dei mandati internazionali, insistendo sull’eguale trattamento con le altre nazionalità europee nate dal
crollo dell’impero Austro-Ungarico (bulgari, serbi, greci, romeni), vale a dire la diretta concessione
dell’indipendenza;63 l’assistenza tecnica ed economica da parte di una potenza esterna, gli Stati Uniti,
per un massimo di venti anni, con, nell’eventualità che l’America non fosse in grado, per qualsiasi
motivo, di accettare questa responsabilità, la possibilità di rivolgersi alla Gran Bretagna come seconda
scelta, a condizione di non mettere a repentaglio la completa indipendenza e unità del paese; 64 la dura e
netta intransigenza contro ogni diritto della Francia sul territorio siriano;65 la ferma opposizione contro
le pretese del sionismo internazionale di creare uno Stato ebraico nella parte meridionale della Siria, la
Palestina, contro l’immigrazione ebraica diretta nei territori arabi, considerata un grave pericolo per il
popolo arabo e musulmano;66 la completa indipendenza della Mesopotamia (l’Iraq); la non separazione
di nessuna parte o frazione del territorio della Siria, ossia la Palestina, il Libano, la zona litorale
occidentale; infine, non ultimo per importanza, la protesta nei confronti di trattati, e il loro scontato
annullamento, che avessero come oggetto la spartizione del paese siriano a vantaggio di altre potenze,67
e contro ogni impegno privato finalizzato alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina.
63
Valgono le stesse considerazioni della nota 56.
Questo punto del Programma è il quinto, ed è stato approvato da una larga maggioranza di delegati, mentre tutti gli altri
punti ebbero il consenso unanime dei rappresentati, come viene riportato esplicitamente.
65
L’estrema avversione che gli arabi provavano nei confronti della Francia era dovuta a diversi elementi. La prima e
maggiore accusa era diretta alla politica di colonizzazione, attuata in quasi tutti i suoi possedimenti nell’Africa subsahariana e settentrionale, nel sudest asiatico e in America centrale. A differenze degli inglesi che adottarono per le loro
colonie l’indirect rule (governo indiretto), utilizzando le strutture di potere preesistenti, un metodo per controllare i sovrani
o l’autorità tradizionale lasciando il più difficile compito di mantenere l’ordine tra la massa della popolazione (cooperazione
con i sovrani locali), e promuovendo consigli legislativi locali che aiutassero a elaborare leggi locali adatte, Parigi scelse un
sistema di governo centralizzato e autoritario con una capillare struttura di controllo, in cui l’obiettivo ultimo era
l’assimilazione alla cultura e alla civiltà francese, e di questo, come è facile immaginarlo, gli arabi avevano una grande
paura. Altro motivo del risentimento arabo fu l’intensa propaganda a favore di un “Grande Libano”, da Tripoli a Tiro,
separato e indipendente dalla Siria sotto mandato francese, e il trattamento nettamente preferenziale verso i cristiani e i
cattolici a discapito dei musulmani e altre sette.
66
Gli ebrei dovevano godere degli stessi diritti e avere le stesse responsabilità di ogni altro cittadino, all’interno di uno Stato
arabo, secondo le regole della maggioranza (araba).
67
L’affermazione è chiaramente riconducibile al trattato segreto “Sykes-Picot”, con il quale la Siria diventava bottino di
guerra da dividere fra la Gran Bretagna e la Francia, secondo dei confini ben stabiliti.
64
Questa richiesta si basa sulla condanna esplicita dei trattati segreti, come pratica usuale della
vecchia diplomazia europea, presentata dal presidente americano Wilson come il primo dei suoi 14
punti, anche se non viene trattata la natura, segreta appunto, della corrispondenza con la quale l’Alto
Commissario per l’Egitto Henry McMahon promise a Husayni, vagamente, la costituzione di uno Stato
arabo indipendente dopo la Prima guerra mondiale.68 La risoluzione del Congresso siriano cita spesse
volte il presidente americano, i suoi principi a favore dei popoli colonizzati, mettendo in evidenza i
fatti, le aspirazioni delle popolazioni interessati, perseguendo la volontà e il «consenso dei governati»,
piuttosto che seguire gli intrighi diplomatici. Wilson ha incarnato per il Medio Oriente la voglia di
riscatto dopo secoli di decadenza sotto il dominio turco.69
Tenendo presente le eterogenee volontà delle popolazioni interessate, e dopo la fine del lavoro
che ha impegnato la delegazione americana dal 10 giugno fino al 21 luglio, le raccomandazioni
espresse rispecchiano fedelmente il principio della maggioranza. Anzitutto è messo in chiaro, dopo
aver insistito sulla necessità di una potenza che si assuma la responsabilità di avviare alla futura
indipendenza il paese in questione, sotto l’egida della Società delle Nazioni, il fine precipuo di agire
nell’interesse esclusivo delle popolazioni locali, garantendo la prosperità e lo sviluppo economico,
68
«Pubblici trattati di pace, pubblicamente conclusi, dopo i quali non vi saranno più accordi internazionali segreti di alcun
genere, ma la diplomazia procederà sempre francamente e alla vista di tutti» pronunciò Wilson. Un dura accusa verso l’uso
della diplomazia segreta, fonte di sfiducia, corruzione e conflitti, si trova nell’introduzione alla relazione della Commissione
sul sito http://raven.cc.ukans.edu/~kansite/ww_one/docs/prekc.htm.
69
Cfr. Confidential Appendix in http://raven.cc.ukans.edu/~kansite/ww_one/docs/postkc.htm. Le ragioni per le quali la
quasi totalità della popolazione musulmana della Siria (4/5 del totale) avanzò la richiesta di sostenere gli Stati Uniti come
potenza mandataria, quantunque per assistere in campi economici e tecnici, erano le seguenti: la profonda fiducia in Wilson;
la convinzione che l’America non fosse entrata in guerra per motivi egoistici e con secondi fini; gli Stati Uniti non erano
una potenza coloniale di vecchio stampo, e cercano il benessere della persone e non lo sfruttamento del Paese, anche se ci
sono, come ho già richiamato, gli esempi di Cuba e delle Filippine da tenere presente; la ricchezza del continente capace di
sostenere e di fornire mezzi adatti a un rapido sviluppo economico del paese arabo, fonte principale per la stabilità e
l’avanzamento politico della società, con l’obiettivo ultimo di ottenere l’indipendenza piena e reale nel più breve tempo
possibile; l’opportunità di estendere il modello di istruzione americano a discapito di quello britannico e, soprattutto,
francese; il giudizio che il Paese statunitense sarebbe stato imparziale e giusto nei rapporti fra le differenti sette della
regione, mentre i francesi avrebbero favorito i cristiani, in special modo la Chiesa cattolica romana e gli inglesi gli arabi.
Perfino molti funzionari britannici, fra i quali rientrava il generale Allenby, consideravano come migliore soluzione quella
di affidare il mandato sull’intera Siria a Washington, con la rinuncia di Londra e Francia di tutte le rivendicazioni
territoriali, evitando nel contempo i dissidi e i contrasti fra le due potenze europee. Per le divergenze fra il potere politico in
Gran Bretagna, che appoggiava una linea di continuità verso la Dichiarazione Balfour, e la il potere dell’Amministrazione
militare in Palestina, l’OETA, che seguiva una politica distensiva verso gli arabi, cfr. Benny Morris, Vittime, op. cit., pp.
117, 118, 124, 128, 129.
sociale, politico, culturale, rifiutando i vecchi sistemi delle Amministrazioni coloniali che erano
finalizzate all’esclusivo sfruttamento del paese sottomesso.
La seconda raccomandazione riguarda l’unità della Siria, manifestata con la più larga percentuale
delle petizioni (80,4%), allontanando la divisione del paese di parti come la Palestina o il Libano,
avvalorato dal fatto che anche il Programma di Damasco afferma, al punto due, la volontà di aderire a
un ampio principio di decentramento del nuovo Stato siriano, garantendo i diritti alle minoranze
(religiose, etniche).70
Per quanto riguarda la potenza mandataria da designare, il suggerimento della commissione
King-Crane è di designare un solo Stato, che presenti i requisiti necessari; d’altronde viene di
conseguenza il consiglio per una Siria unita. La scelta scontata cadde sugli Stati Uniti, che avevano
avuto più del 60% delle richieste per la prima scelta come Stato mandatario (3,05% per il mandato e
57% per l’assistenza).71 Come seconda scelta, la Commissione propose la Gran Bretagna, con grande
esperienza nei rapporti con popoli meno sviluppati e dotata di grandi risorse (punto quinto del
Congresso di Damasco). Anche attraverso i risultati dei sondaggi eseguiti, la scelta per «un’assistenza»
britannica, nell’eventualità che la Conferenza parigina non concedesse a Washington il mandato,
ottenne il 55,3% delle petizioni presentate alla Commissione. Viceversa, il 60,5% si espresse
energicamente contro un mandato francese nei territori arabi.
L’ultima presa di posizione del Rapporto riguarda la scelta dell’Emiro Faisal come Re dell’intera
Siria (59%), all’interno di una struttura monarchica costituzionale (59,3%), adatta al popolo arabo per il
loro tradizionale rispetto verso i capi, non vedendo migliore personalità adatta a rappresentare
simbolicamente la forza del nuovo Stato. Figlio dello Sceriffo della Mecca Husayni, condusse la rivolta
Già il Libano disponeva di un certa autonomia all’interno dell’impero ottomano.
La maggioranza della popolazione si è espressa per «l’assistenza» di una potenza esterna perché l’aspirazione prioritaria
era per la completa indipendenza («absolute independence»), che ricevette la seconda percentuale più alta delle petizioni: il
73,5%. Secondo punto cardine del programma di Damasco, dopo quello per l’unità della Siria, fu sostenuto genericamente
da tutte le delegazioni musulmane.
70
71
araba contro gli imperi centrali ed entrò per primo trionfante a Damasco il 3 ottobre 1918, sotto
esplicito ordine del Generale Allenby, «per evitare che l’occupazione “cristiana” adirasse la
popolazione musulmana».72
3.1 La disputa sul sionismo
Nell’affrontare l’acuto problema del sionismo, la relazione americana è chiara, sia per le
premesse sia per le soluzioni che propose, come, d’altronde, è chiara la volontà della gente locale.
L’opposizione al programma sionista, ovvero l’appoggio a una politica coerente con i diritti e i fini
della Dichiarazione Balfour, raccolse il 72,3% delle richieste, la terza più alta percentuale dopo quelle
in favore dell’unità della Siria e della sua completa indipendenza. 73 Addirittura, gli anti-sionisti arabi
erano particolarmente forti in Palestina, sotto il controllo britannico, dove arrivarono all’85,3%.74
Non condivido affatto il giudizio che Morris dà della Commissione americana in relazione al
sionismo, in quelle poche righe dedicate al compito svolto da questa.75 Avendo esaminato a lungo il
documento, mi sento nella condizione di affermare che, nell’affrontare la complessa questione, i
membri della Commissione siano stati guidati dall’equilibrio, dall’oggettività e soprattutto dalle
condizioni reali che hanno trovato durante il loro lavoro. I fatti sono quelli che ho poc’anzi citato e la
raccomandazione, nelle stesse parole del rapporto e con una incisiva e straordinaria preveggenza, si
concentra su una «serious modification of the extreme Zionist program for Palestine of unlimited
immigration of Jews, looking finally to making distinctly a Jewish State».
Cfr. Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 104. Per un’altra ragione dell’ordine britannico di lasciare entrare per primo a
Damasco l’esercito arabo sotto la guida di Faisal, vedi Michael J. Cohen, The Origins and Evolution of the Arab-Zionist
Conflict, op. cit., p. 27, dove questa mossa tattica è stata vista come un sostegno di Londra ai diritti e alle rivendicazioni
arabe contro la Francia «by maintaining that the Arabs had indeed fulfilled their part of the agreement and earned the area of
the four towns [Damasco, Homs, Hama e Aleppo] by conquest».
73
In sostanza, il programma sionista era a favore della costituzione di un focolare nazionale in Palestina («national home»,
in poche parole uno Stato ebraico nel prossimo futuro) e di un’estensiva immigrazione ebraica nel territorio, con la
possibilità di acquistare terreni senza limitazioni, sotto la tutela di un mandato britannico in una separata Palestina; richiesta
ovvia e scontata.
74
I punti sette, otto e dieci del Programma di Damasco manifestano chiaramente il fermo rifiuto ai propositi del sionismo.
75
Cfr. Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 121: «si espressero [i membri della Commissione] in modo sprezzante sul
movimento nazionalista ebraico».
72
Senza perifrasi, viene affermato che creare le condizioni adatte per istituire uno Stato ebraico
(gradualmente) in Palestina minerebbe e abuserebbe dei diritti delle popolazioni locali visto che «the
Zionist looked forward to a practically complete dispossession of the present non-Jewish inhabitants of
Palestine, by various forms of purchase».76 I diritti storici e religiosi del popolo ebraico, rivendicati dai
sionisti, non hanno nessun fondamento e non vengono considerati dalla Commissione nel suo esame.
Secondo le raccomandazioni finali, il progetto di istituire, in un futuro prossimo, uno Stato
ebraico («Jewish commonwealth») deve essere abbandonato e l’immigrazione diretta in Palestina
assolutamente limitata; in pratica sconfessare la nuova politica di Londra, incarnata nella Dichiarazione
Balfour durante la guerra, di sostenere e facilitare gli obiettivi dei sionisti. La Palestina deve essere
incorporata nella Siria in quanto unico territorio sotto un’unica potenza mandataria.
Tutte le esortazioni della delegazione americana furono ignorate da Gran Bretagna e Francia, ma
soprattutto i sogni di un indipendenza araba, accarezzata dopo la guerra e ritenuta legittima con lo
sforzo militare a fianco degli Alleati, seppur modesto, venivano cancellati in un sol colpo a causa del
rifiuto americano di aderire alla nascente Società delle Nazioni e di avere quel giusto peso di
responsabilità, indispensabile per la ricostruzione, non solo materiale, ma anche politica del
dopoguerra.
La lotta per avere l’approvazione del Senato del progetto di pace da lui stesso proposto il 14
febbraio 1919 e sottoscritto il 28 luglio, condusse Wilson a viaggiare, tenere discorsi e conferenze, in
lungo e in largo per gli Stati dell’Unione, affrontando l’opposizione repubblicana e problemi fisici. Il
19 novembre 1919, il Senato americano respinse il trattato di pace originale (38-53) e anche il trattato
76
Al contrario della convinzione di Balfour, nella sua Dichiarazione, di far convivere allo stesso tempo sia le aspirazioni
sioniste con i diritti dei popoli gentili, non ravvedendo nessuna contraddizione insita.
comprendente le quattordici riserve del senatore Lodge (39-55), rendendo inevitabile il ritiro della
delegazione americana dalla Conferenza di pace a Parigi nel mese successivo.77
Il rapporto della Commissione King-Crane perse enormemente di importanza, e questa
circostanza diede il via libera, senza intralci, alla spartizione del Medio Oriente fra le due potenze
coloniali europee, secondo il vecchio canone dell’imperialismo, con delimitazioni e confini disegnati
sulla carta, senza tenere nella giusta importanza le richieste delle popolazioni, vale a dire l’intero lavoro
del compito assegnato alla Commissione americana, che fu pubblicato solamente il 2 dicembre 1922,
quando già molti avvenimenti in Medio Oriente erano accaduti.
L’accordo per istituire la Società delle Nazioni e il trattato di pace concluso con gli Stati sconfitti nella guerra erano
vincolate, ossia si ratificava l’intero trattato compreso dell’accordo per istituire la Società, altrimenti se respinta una, l’altra
subiva automaticamente la medesima sorte.
Alcune delle riserve applicate al trattato, le più significative, erano le seguenti: nel caso di ritiro dalla Società delle Nazioni
(secondo l’art. 1), gli Stati Uniti sarebbero stati gli unici giudici nel valutare che i loro obblighi internazionali siano stati
adempiuti; gli Stati Uniti non si assumeranno nessun impegno vincolante per salvaguardare l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica di qualunque altro Stato (l’articolo chiave 10, poiché solo il Congresso ha il potere di dichiarare
guerra); nessun mandato sarà accettato dagli Stati Uniti (art. 22), esigendo in tal caso la volontà del Congresso; gli Stati
Uniti si riservano il diritto esclusivo di decidere quali questioni rientrano nella domestic jurisdiction; gli Stati Uniti non
dovranno essere obbligati a sostenere e contribuire a qualunque spesa della Società delle Nazioni, ma solamente il
Congresso ha il potere di stanziare determinati fondi; gli Stati Uniti si riservano il diritto di aumentare gli armamenti senza
il consenso del Consiglio della SdN ogniqualvolta siano minacciati da un invasione o dal pericolo imminente di una guerra
(cfr. art. 8).
77
Capitolo 4
Gli Stati Uniti e la creazione dello Stato d’Israele
1 Truman e la Risoluzione 181 di spartizione della Palestina: dall’appoggio passivo all’intervento
determinante per l’approvazione
Il presidente Truman aveva mantenuto il silenzio sulla questione palestinese dalla dichiarazione
dello Yom Kippur dell’ottobre 1946, e continuò questo atteggiamento durante l’intera fase di
elaborazione della commissione speciale dell’ONU. All’interno dell’Amministrazione americana vi
erano punti di vista contrastanti su come e quale posizione politica aderire nei confronti dei progetti
raccomandati dall’UNSCOP, e pronti al dibattito davanti all’Assemblea Generale, tenendo ben presente
che la proposta di maggioranza era favorevole all’idea della spartizione, in coerenza con il contenuto
sostanziale della dichiarazione di Truman del 4 ottobre 1946, universalmente ritenuta come un impegno
verso quest’ultima.
Il Dipartimento di Stato valutava positivamente la scelta per un proseguimento del controllo
internazionale sulla Palestina sotto le vesti di un’Amministrazione fiduciaria; la Casa Bianca, con i
diversi consiglieri filosionisti propendeva per la separazione politica in due Stati indipendenti.
La battaglia burocratica ebbe luogo nelle nomine della delegazione statunitense, che avrebbe
dovuto avere il compito di dibattere le soluzioni dell’UNSCOP ed esprimere l’atteggiamento americano
in riguardo. Furono chiamati a questo compito Loy Henderson, capo della divisione del Dipartimento
di Stato del Vicino Oriente, George Wadsworth, ambasciatore in Iraq, Turchia e Arabia Saudita
(entrambi contrari a una spartizione della Palestina), Eleanor Roosevelt (sostenitrice delle Nazioni
Unite), il vicesegretario di stato Robert Lovett, il repubblicano John Foster Dulles, il capo della
delegazione e il vice rappresentate alle Nazioni Unite Herschel Johnson, Dean Rusk e l’ambasciatore
americano alle Nazioni Unite Warren Austin. Infine, fu considerata una nomina chiave quella con cui
Truman, sotto forte insistenza del consigliere David Niles, aveva designato il generale John Hilldring,
fidato sostenitore di uno Stato ebraico e collegato direttamente con la Casa Bianca. Esisteva il ben
fondato timore dei sionisti che il Dipartimento di Stato sarebbe riuscito a interferire e a far passare le
sue tesi a detrimento delle loro aspirazioni.
Nel frattempo, nel settembre, l’Assemblea Generale si era costituita in un Comitato ad hoc per
occuparsi della questione palestinese, con un dibattito generale.
La Lega Araba si espresse subito contro il piano di spartizione e l’Alto Comitato arabo
palestinese lo condannò come una reiterata ingiustizia per la Palestina e un’evidente violazione dei
diritti naturali degli arabi nel loro paese:
«The case of the Arabs of Palestine was based on the principles of international justice; it was that of a
people which desired to live in undisturbed possession of the country where Providence and history had placed
it. The Arabs of Palestine could not understand why their right to live in freedom and peace, and to develop their
country in accordance with their traditions, should be questioned and constantly submitted to investigation...
The Zionists were conducting an aggressive campaign with the object of securing by force a country
which was not theirs by birthright. Thus there was self-defence on one side and, on the other, aggression. The
raison d'être of the United Nations was to assist self-defence against aggression... The struggle of the Arabs of
Palestine against Zionism had nothing in common with anti-Semitism. The Arab world had been one of the rare
havens of refuge for the Jews until the atmosphere of neighbourliness had been poisoned by the Balfour
Declaration and by the aggressive spirit which the latter had engendered in the Jewish community...
The solution lay in the Charter of the United Nations, in accordance with which the Arabs of Palestine,
who constituted the majority were entitled to a free and independent State»78
L’Organizzazione sionista approvò il progetto maggioritario dell’UNSCOP anche se avrebbe
preferito maggior territorio, e metteva in risalto sia la pericolosità dei confini proposti sia il non
gradimento della soluzione approntata per Gerusalemme. In ogni modo, era consapevole della storica
78
Vedi http://www.un.org/Dept/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_2.htm.
opportunità che si presentava al sionismo mondiale e a tutto il popolo ebraico della Diaspora, e
l’Agenzia ebraica affermò la sua posizione:
«While hoping that nations would welcome displaced persons who wished to emigrate to countries other
than Palestine, the Jewish Agency considered that it would be unjust to deny the right to go to the Jewish
national home to those who wanted to do so.
Recommendation... to the effect that any solution for Palestine could not be considered as a solution of the
Jewish problem in general, was unintelligible ... The Jewish problem in general was none other than the age-old
question of Jewish homelessness, for which there was but one solution - that provided for by the Balfour
Declaration and the Mandate - the reconstitution of the Jewish national home in Palestine.
...the plan proposed by the minority of the Special Committee ... was unacceptable; though it called them
States, it actually made provision only for semi-autonomous cantons or provinces. Palestine would be an Arab
State with two Jewish enclaves. The Jews, who would be frozen in the position of a permanent minority in the
federal State, would not even have control over their own fiscal policies or immigration; the latter, with many
other matters of fundamental importance, would be left in the hands of the Arab majority». 79
La Gran Bretagna, potenza mandataria, aveva accettato i tre principi unanimi che erano stati
stilati dalla commissione speciale dell’ONU, ma volle sottolineare la responsabilità internazionale nei
confronti dei rifugiati europei, come per slegare questo problema dal futuro politico della Palestina:
«With regard to... Jewish displaced persons, the United Kingdom was of the opinion that the entire
problem of displaced persons in Europe, Jewish and non-Jewish alike, was an international responsibility and
one demanding urgent attention... The United Kingdom Government was ready to assume the responsibility for
giving effect to any plan on which agreement was reached by the Arabs and the Jews. If the Assembly were to
recommend a policy which was not acceptable to the Jews and the Arabs, the United Kingdom Government
would not feel able to implement it. It would then be necessary to provide for some alternative authority to
implement it.
It had been suggested that the United Kingdom should carry the full responsibility for the administration
of Palestine and for enforcing changes proposed by the United Nations during an indefinite transitional period
until independence was attained... The United Kingdom would in no case accept responsibility for enforcement,
either alone or in the major role. ...the illegal immigration into Palestine undertaken with the connivance and
assistance of some Governments ... was a question which aroused bitter feelings in Palestine; proposals for a
change in the status quo should not lightly be put forward by those who had no responsibility for the
consequences»80
Gli Stati Uniti vollero mantenere inizialmente un basso profilo sul dibattito alle Nazioni Unite,
anzitutto per evitare di apparire come un garante della spartizione, ma Marshall, il 17 settembre, di
fronte al Comitato ad hoc sulla Palestina, pronunciò un discorso che propendeva per la soluzione della
spartizione, sebbene fosse alquanto vago:
79
80
Vedi http://www.un.org/Dept/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_2.htm.
Vedi http://www.un.org/Dept/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_2.htm.
«while the final decision of the Assembly must properly await the detailed consideration of the report, the
Government of the United States gives great weight not only to the recommendations which have met with the
unanimous approval of the Special Committee, but also to those which have been approved by the majority of
that Committe».81
Era quasi impossibile, però, per il presidente americano non approvare il piano maggioritario
dell’UNSCOP, perché altrimenti avrebbe sconfessato l’impegno assunto verso la spartizione con la
dichiarazione del Yom Kippur nell’ottobre 1946 e si sarebbe suicidato politicamente per le elezioni
presidenziali del 1948, perdendo gran parte dell’elettorato ebraico. Inoltre, sarebbe andato incontro alla
volontà del Congresso, dei media, dello stesso partito democratico, e avrebbe irrimediabilmente
compromesso il prestigio delle Nazioni Unite, nate appena da due anni e giunte al primo vero e
complesso problema internazionale.
Solo gli esperti funzionari del Dipartimento di Stato e il nuovo Segretario della Difesa, James
Forrestal,82 erano maggiormente sensibili a non far irritare il mondo arabo per motivi di interesse
nazionale, che preoccupati di guadagnare il consenso dei sionisti americani, necessario per ragioni di
politica interna (i funzionari del Dipartimento di Stato non erano ovviamente assillati dalle scadenze
elettorali come lo erano la Casa Bianca e i partiti).
Con la ripresa delle intense pressioni organizzate dei sionisti americani e con l’afflusso di diverse
lettere firmate da membri del Congresso che invocavano il pieno sostegno al rapporto di maggioranza
dell’UNSCOP, ai primi di ottobre Truman diede istruzioni a Marshall di rendere pubblico e in modo
chiaro l’appoggio americano, in linea di massima, alla spartizione della Palestina. L’annuncio ufficiale
venne dato l’11 ottobre da Herschel Johnson davanti all’Assemblea Generale riunita come Comitato ad
hoc sulla Palestina.
Ecco alcuni passi scelti della dichiarazione:
81
Vedi Michael J. Cohen, Truman and Israel, op. cit., p. 154 e Fraser T. G., The USA and the Middle East Since World War
2, New York, St. Martin’s Press, 1989, p. 28.
82
James Forrestal raccomandò fino all’ultimo nel 1948 a Truman di non riconoscere lo Stato di Israele, in modo da non
provocare l’ostilità del mondo arabo e trovare maggiori ostacoli per l’accesso americano al petrolio mediorientale. Vedi
“The Economist”, The unblessed peacemakers, 6 ottobre 2001, p. 19.
«The United States Delegation feels that the urgency of the problem is so great that the General Assembly
must recommend a solution at this session. The degree of urgency has been brought to our attention by continued
violence in Palestine by the context of the Special Committee's report, and by the statement of the delegate from
the United Kingdom regarding the recommendations of the Committee and future British responsibilities in
Palestine.
… The United States Delegation supports the basic principles of the unanimous recommendations and the majority plan which provides for partition
and immigration. It is of the opinion, however, that certain amendments and modifications would have to be made in the majority plan in order more
accurately to give effect to the principles on which that plan is based. My delegation believes that certain geographical modifications must be made.
For example, Jaffa should be included in the Arab State because it is predominantly an Arab city.
… Any solution which this Committee recommends should not only be just, but also workable and of a nature to command the approval of world
opinion.
The United States Delegation desires to make certain observations on the carrying out of such
recommendations as the General Assembly may make regarding the future government of Palestine.
The General Assembly did not, by admitting this item to its agenda, undertake to assume
responsibility for the administration of Palestine during the process of transition to independence.
Responsibility for the government of Palestine now rests with the mandatory power. The General
Assembly, however, would not fully discharge its obligation if it did not take carefully into account
the problem of implementation.
Both the majority report and the statement of the United Kingdom representative in this Committee raise
the problem of carrying into effect the recommendations of the General Assembly. We note, for example, that the
majority report indicates several points at which the majority thought the United Nations could be of assistance.
It was suggested that the General Assembly approve certain steps involved in the transitional period, that the
United Nations guarantee certain aspects of the settlement concerning Holy Places and minority rights, that the
Economic and Social Council appoint three members of the Joint Economic Board, and that the United Nations
accept responsibility as administering authority of the City of Jerusalem under an international trusteeship.
… The recommendations reached by the GA will represent the collective opinion of the world. The
problem has thus far defied solution because the parties primarily at interest have been unable to reach a basis of
agreement. This is a problem in the solution of which world opinion can be most helpful».83
Non era certamente un assegno in bianco in favore della divisione politica della Palestina, perché
si faceva esplicitamente riferimento alla necessità e al dovere di proporre emendamenti e modifiche
territoriali al rapporto dell’UNSCOP, in modo da andare incontro alle rivendicazioni arabe e da
mitigarne il risentimento.84
83
Per il testo della dichiarazione vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad164.htm, United States Position on
Palestine Question, Statement by Herschel V. Johnson, United States Deputy Representative to the United Nations, October
11, 1947.
84
«Certain amendments and modifications would have to be made… certain geographical modifications must be made».
Ad esempio, veniva prospettata l’assegnazione al futuro Stato arabo della città di Giaffa, proprio
a causa della netta maggioranza araba, e la stessa sorte si prevedeva sarebbe toccata alla regione
desertica del Negev, non menzionata nella dichiarazione, che la commissione speciale aveva destinato
alla parte ebraica, ma era quasi completamente abitata da arabi beduini. Inoltre, è utile considerare
come il governo statunitense abbia più volte insistito sul far apparire il piano di spartizione
maggioritario dell’UNSCOP una soluzione delle Nazioni Unite (e non di Washington), senza utilizzare
pressioni sulle altre delegazioni.
Era questa la strategia del non intervento del Dipartimento di Stato che Truman, fino a un certo
punto, assecondava. Subito dopo l’annuncio ufficiale della delegazione americana in seno all’ONU, un
consiglio di emergenza sionista americano descrisse acutamente la situazione dei fatti, e si pronunciò,
giustamente, in questi termini:
«We had won a great victory, but under no circumstances should any of us believe or think we had won
because of the devotion of the American Government to our cause. We had won because of the sheer pressure of
political logistic that was applied by the Jewish leadership in the United States».85
Dopo aver chiarito la posizione della delegazione americana, in favore della spartizione della
Palestina, il vero problema dei sionisti non era più quello di assicurare l’appoggio
dell’Amministrazione Truman a uno Stato ebraico, ma riuscire a ottenere dalla Casa Bianca l’uso della
sua influenza alle Nazioni Unite.
Il 13 ottobre la delegazione sovietica, che già nel maggio precedente aveva alluso a un timido
appoggio per il piano di spartizione, nel caso in cui una soluzione che mantenesse l’unita della
territorio palestinese si rivelasse impraticabile, rese noto l’appoggio alla proposta di spartizione
dell’UNSCOP in questi termini:
«The essence of the question was the right of self-determination of hundreds of thousands of Jews and
Arabs living in Palestine; the right of the Arabs as well as the Jews of Palestine to live in freedom and peace in a
State of their own. It was necessary to take into consideration all the sufferings and needs of the Jewish people,
85
Vedi Michael J. Cohen, Truman and Israel, op. cit., pp. 158-159.
whom none of the States of Western Europe has been able to help during their struggle against the Hitlerites and
the allies of the Hitlerites for the defence of their rights and their existence. The Jewish people were therefore
striving to create a State of their own and it would be unjust to deny them that right. The problem was urgent
and could not be avoided by plunging back into the darkness of the ages.
Every people - and that included the Jewish people - had full right to demand that their fate would not
depend on the mercy or the good will of a particular State. The Members of the United Nations could help the
Jewish people by acting in accordance with the principles of the Charter, which called for the guaranteeing to
every people of their right to independence and self-determination».86
Quindi, appena due giorni dopo l’approvazione in linea di principio da parte degli Stati Uniti
dell’idea della spartizione, Mosca seguì sulla stessa linea. Con la stessa posizione politica di entrambe
le superpotenze riguardo alla questione palestinese, si poteva supporre che il Comitato ad hoc avrebbe
deciso positivamente sulla proposta di maggioranza dell’UNSCOP. Malgrado tutto, furono istituiti due
sottocomitati con il compito di elaborare i due piani dell’UNSCOP, con la possibilità di fare qualche
modifica, e riferire il tutto davanti al Comitato ad hoc.87
Sotto la spinta del Dipartimento di Stato, il primo sottocomitato iniziò a lavorare sulla
sistemazione di confini più favorevoli al futuro Stato arabo. Sulla questione del Negev, ci fu una
proposta da parte della delegazione americana di giungere a un compromesso, raccomandando il
trasferimento di gran parte della regione desertica allo Stato arabo palestinese (la parte meridionale,
inclusa Aqaba), poiché la quasi totalità degli abitanti erano arabi beduini. Inoltre, si scongiurava in
questo modo la discontinuità territoriale del mondo arabo.
Viceversa, la proposta mise in grande allarme i leader sionisti, che ritenevano la posizione
strategica del Negev indispensabile per il nuovo Stato ebraico in costruzione. Era assolutamente da
evitare il mancato accesso al golfo di Aqaba, e da questo al Mar Rosso e all’Oceano Indiano. Grazie a
Niles, personaggio chiave all’interno della Casa Bianca per i sionisti, si organizzò in fretta un incontro
86
Vedi http://www.un.org/Dept/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_2.htm.
Il sottocomitato n° 1 era composto da Canada, Cecoslovacchia, Guatemala, Polonia, Unione Sudafricana, Venezuela,
Ungheria, Unione Sovietica, Stati Uniti, e doveva analizzare, facendo le dovute modificazioni, il piano di maggioranza
dell’UNSCOP. Facevano parte del sottocomitato n° 2 Afghanistan, Colombia, Iraq, Libano, Pakistan, Arabia Saudita, Siria,
Yemen con il compito di descrivere gli argomenti favorevoli a una Palestina unita (il piano di minoranza dell’UNSCOP).
Venne creato anche un terzo sotto-comitato informale con l’intenzione di promuovere l’avvicinamento fra le posizioni arabe
e sioniste ma con nessun risultato di rilievo.
87
segreto fra Truman e l’anziano e malato Chaim Weizmann il 19 novembre, pochi giorni prima della
cruciali votazioni all’ONU, e quest’ultimo riuscì nell’impresa di persuadere il presidente americano
all’idea di mantenere l’intero Negev nella parte ebraica. Truman trascrisse alla delegazione americana
l’ordine di non presentare la proposta di trasferirlo agli arabi.
La vicenda risultò in un vero e proprio successo dei sionisti, benché circoscritto e di breve durata.
Truman ancora una volta, dopo aver ordinato ai primi di ottobre l’annuncio ufficiale in favore del piano
di spartizione dell’UNSCOP, prevaleva sul Dipartimento di Stato.
Tuttavia, ancora egli volle mantenere la politica di non esercitare pressioni sulle delegazioni di
Stati piccoli e fortemente dipendenti dagli Stati Uniti. Certamente, gli intrighi diplomatici segreti
avevano portato a decidere sul futuro politico di un territorio, senza tenere conto minimamente della
volontà degli abitanti e contro i “quattordici punti” di Wilson. Si ritornava indietro di anni, fino alla
Prima guerra mondiale e all’imposizione di confini geografici dall’alto, artificiali e di conseguenza
forieri di futuri conflitti, come se dalle recenti lezioni della storia quasi nessuno avesse imparato.
I rapporti di entrambi i sottocomitati furono presentati al Comitato ad hoc sulla Palestina il 24
novembre 1947. Il rapporto del sottocomitato n° 2, riguardante la raccomandazione per uno Stato
palestinese unificato indipendente fu respinto.
Il sottocomitato n° 1 sottopose un piano di spartizione significativamente cambiato dall’originale
progetto dell’UNSCOP in questi ambiti: a) la proposta del periodo di transizione di due anni fu
drasticamente ridotta; la Gran Bretagna avrebbe continuato a governare la Palestina fino al 1° agosto
1948, data del ritiro definitivo, ma non sarebbe stata responsabile per l’applicazione di qualunque
decisione da parte dell’ONU; sarebbe seguito un periodo di transizione di due mesi, controllato da una
commissione delle Nazioni Unite di cinque membri scelti dall’Assemblea Generale che doveva
rispondere al Consiglio di Sicurezza; i due Stati avrebbero conseguito l’indipendenza il 1° ottobre
1948; b) la città araba di Giaffa, assegnata dall’UNSCOP al futuro Stato ebraico, avrebbe costituito
un’enclave appartenente allo Stato arabo; c) il Negev, come sopra ricordato, rimaneva destinato alla
parte ebraica.
Il progetto di spartizione così modificato venne approvato dal Comitato ad hoc il 25 novembre
1947, contando su 25 voti favorevoli, 13 contrari, 17 astenuti e 2 assenti.88 In questa sessione era
necessaria una maggioranza semplice per questo singolo voto, ma una volta davanti all’Assemblea
Generale plenaria era essenziale una maggioranza di due terzi degli Stati partecipanti al voto decisivo.
Solido contro la divisione politica della Palestina era il gruppo di cinque Stati arabi: Arabia
Saudita, Egitto, Siria, Libano e Iraq. L’India era un caso speciale perché, se la numerosa popolazione
musulmana si poteva identificare con la causa araba, il governo indù di Nuova Delhi era ugualmente
riluttante ad accettare la spartizione come soluzione del problema, avendo proprio nell’estate
precedente sofferto della separazione del territorio indiano con il Pakistan (occidentale e orientale) e il
conseguente dramma dei massicci trasferimenti coatti. Due membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza, la Francia e la Cina, si erano astenuti durante la votazione, perciò potevano essere oggetto di
pressioni future.
Ma l’esito della votazione del 25 novembre mise in evidenza il relativo ampio numero delle
astensioni e la possibilità di concentrare gli sforzi delle lobbies ebraiche sugli Stati dell’America latina
per accaparrarsi qualche voto per la loro causa, dato che ogni voto poteva essere cruciale. Si poteva
supporre che alcuni di questi paesi avrebbero potuto seguire la posizione degli Stati Uniti, così come la
Bielorussia, l’Ucraina e altri governi dell’Europa orientale influenzati dal comunismo sovietico (ad
esempio la Cecoslovacchia e la Polonia) si erano comportati nella stessa maniera con Mosca.
Comunque, la politica del Dipartimento di Stato, ancora appoggiata dal presidente americano, era di
88
In favore: Australia, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Canada, Cile, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Islanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Perù, Polonia, Svezia, Ucraina, Unione
Sudafricana, Unione Sovietica, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
Contrari: Afghanistan, Cuba, Egitto, India, Iran, Iraq, Libano, Pakistan, Arabia Saudita, Siam, Siria, Turchia, Yemen.
Astenuti: Argentina, Belgio, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Francia, Grecia, Haiti, Honduras, Liberia, Lussemburgo,
Mexico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Jugoslavia.
Assenti: Paraguay, Filippine.
non esercitare pressioni o costrizioni sulle altre delegazioni affinché imitassero l’atteggiamento
americano alle Nazioni Unite.
Il giorno seguente, il 26 novembre, si svolse il dibattito generale davanti Assemblea Generale, al
termine del quale si sarebbe dovuta svolgere la votazione decisiva.
Ecco le posizioni di alcune delegazioni:89
a) Gran Bretagna:
«It is with deep regret that my Government recognizes that an acceptable settlement has still not been
found. I do not say that in any spirit of criticism. My Government would be the last to minimize the difficulty of
the task, as it is the first to appreciate the efforts that have been made. The fact remains that we are obviously
confronted with a failure to arrive at a settlement based upon consent. My delegation would have failed in its
duty if it had not emphasized from the beginning of the session the consequent need for the General Assembly to
consider the situation which is likely to arise upon the removal of the forces which at present ensure law and
order in Palestine. Their departure will leave a gap, and it has been the most difficult part of the General
Assembly's task to find means of filling this gap…
I am... instructed to repeat explicitly that the United Kingdom Government cannot allow its troops and
administration to be used in order to enforce decisions which are not accepted by both parties in Palestine»
È importante mettere in rilievo come, per l’ennesima volta, il governo londinese ribadisce a
chiare lettere il rifiuto di applicare la Risoluzione dell’Assemblea Generale a causa del mancato
appoggio di entrambe le comunità.
b) Stati a sostegno del piano di spartizione della Palestina:
Polonia
89
Gli estratti selezionati sono presenti nel sito http://www.un.org/Dept/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_2.htm, Official Records of the
General Assembly, Second Session, Plenary Meetings, vol. II.
Alla fine del dibattito generale 11 delegazioni dichiararono esplicitamente il proprio appoggio per la spartizione (Belgio,
Brasile, Canada, Guatemala, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Svezia, Unione Sovietica, Stati Uniti, Uruguay), 13
delegazioni si erano espresse contro la proposta (Colombia, Cuba, Egitto, Grecia, Haiti, Iran, Iraq, Libano, Pakistan,
Filippine, Arabia Saudita, Siria, Yemen), la posizione della Francia era incerta, la Gran Bretagna aveva dichiarato la sua
intenzione di astenersi, così come fecero la Cina e l’Etiopia.
«What is the solution we want? The answer is simple. The Arab people of Palestine, as well as the Jewish
people of Palestine, want national independence. They want a discontinuation of the Mandate and of the present
situation, and the establishment of their national States.
My delegation and my Government believed for a time, and hoped, that these national aspirations might
find their expression in one Palestinian State in which both Arabs and Jews would be equal partners, free to
develop their national life. The situation, however, is such that this aim cannot be achieved, at least not at the
present stage. We therefore have to establish two States, an Arab State and a Jewish State, to provide for the
national aspirations of the two communities which live in Palestine. There is no other way out, and anyone
anxious to do justice to the national aspirations of both Jews and Arabs must support this proposal».
Brasile
«the matter involves substantial changes in the political status quo of an important region, changes which
would radically affect juridical principles and vested interests.
It is presented to us today, however, as a fait accompli, since the promise contained in the so-called
Balfour Declaration and the subsequent creation of a mandate of the League of Nations with the express purpose
of constituting a "Jewish national home", have resulted in the migration into Palestine of considerable numbers
of individuals of the Jewish race, who have become permanently established there and have created large
interests and have constituted a homeland which has rapidly developed to the point of presenting at this time the
characteristics of a State».
Stati Uniti
«the proposal of partition with economic union which we are considering is genuinely a United Nations
plan. It has been evolved as a result of a special session of the United Nations and the work of a United Nations
Special Committee, in addition to the work of the present session of the General Assembly...
Much has been said during the course of these debates on the desirability and necessity of presenting to
the General Assembly a plan which would command the agreement of both the principal protagonists in this
situation. I think there is no delegation here which does not know that no plan has ever been presented, either to
this Assembly or to the Mandatory Government during its long years of tenure, or in any other place, which
would meet with the acceptance of both the Arabs and the Jews. No such plan has ever been presented, and I do
not believe that any such plan will ever be presented. If we are to effect through the United Nations a solution of
this problem it cannot be done without the use of the knife. Neither the Jews nor the Arabs will ever be
completely satisfied with anything we do, and it is just as well to bear that in mind.
...It is the sincere belief of the United States delegation that the partition plan recommended by the Ad Hoc
Committee on the Palestinian Question, with all its imperfections admitted, provides for the people of Palestine
in that land the best practicable means at the present time by which these high objectives may be obtained».
Unione Sovietica
«We may ask why it is that the overwhelming majority of the delegations represented in the General
Assembly adopted this solution and not another. The only explanation... that can be given is that all the
alternative solutions of the Palestinian problem were found to be unworkable and impractical. In stating this, I
have in mind the project of creating a single independent Arab-Jewish State with equal rights for Arabs and
Jews. The experience gained from the study of the Palestinian question, including the experience of the Special
Committee, has shown that Jews and Arabs in Palestine do not wish or are unable to live together. The logical
conclusion followed that, if these two peoples that inhabit Palestine, both of which have deeply rooted historical
ties with the land, cannot live together within the boundaries of a single State, there is no alternative but to
create, in place of one country, two States - an Arab and a Jewish one. It is, in the view of our delegation, the
only workable solution».
(c) Stati contrari al piano di spartizione:
Filippine
«The Philippine Government has come to the conclusion that it cannot give its support to any proposal for
the political disunion and the territorial dismemberment of Palestine.
We have assessed the legal arguments and found that they are not the decisive factors in shaping a just and
practical solution. Whatever the weight we might choose to assign to the arguments of the one side or the other,
it is clear to the Philippine Government that the rights conferred by mandatory power, even if subsequently
confirmed by an international agreement, do not vitiate the primordial right of a people to determine the political
future and to preserve the territorial integrity of its native land.
We hold that the issue is primarily moral. The issue is whether the United Nations should accept
responsibility for the enforcement of a policy which, not being mandatory under any specific provision of the
Charter nor in accordance with its fundamental principles, is clearly repugnant to the valid nationalist aspirations
of the people of Palestine. The Philippine Government believes that the United Nations ought not to accept any
such responsibility».
Libano
«To judge by the press reports which reach us regularly every two or three days, I can well imagine to
what pressure, to what manoeuvres your sense of justice, equity and democracy has been exposed during the last
36 hours. I can also imagine how you have resisted all these attempts in order to preserve what we hold dearest
and most sacred in the United Nations, to keep intact the principles of the Charter, and to safeguard democracy
and the democratic methods of our Organization. My friends, think of these democratic methods, of the freedom
in voting which is sacred to each of our delegations. If we were to abandon this for the tyrannical system of
tackling each delegation in hotel rooms, in bed, in corridors and ante-rooms, to threaten them with economic
sanctions or to bribe them with promises in order to compel them to vote one way or another, think of what our
Organization would become in the future. Should we be a democratic organization? Should we be an
organization worthy of respect in the eyes of the world? At this supreme juncture, I beg you to think for a
moment of the far-reaching consequences which might result from such manoeuvres, especially if we yielded to
them».
Colombia
«The plan of partition was adopted by the Ad Hoc Committee by 25 votes to 13 with 17 abstentions. We
hear and we read that the same vote in the General Assembly would be one short of the two-thirds majority
required by our rules. However, in our view, there is no mistaking the fact that the plan has failed to find the
support of 32 delegations. In other words, as it stands, it is really a minority proposal. It will remain a minority
proposal in our minds. It will not lose that character even if it succeeds in securing the votes of three or four
more delegations; and the scanty strength of the proposal becomes all the more evident if we consider the great
international importance of the problem and the distinction that this solution enjoys of having the joint backing of
the United States and the USSR. It would seem to all unprejudiced observers that, but for that all-powerful
backing, the proposal would never have made its way to the General Assembly. Here it may eventually be
adopted, but we submit that reluctant votes, recruited with irrelevant eleventh-hour appeals, will not improve its
position in the opinion of the outside world...
Under the circumstances, we suggest that the General Assembly would be well advised in postponing a
decision».
Pakistan
«How is Palestine to be independent? What sort of independence? What is the solution that we are invited
to endorse and to attempt to carry through? In effect, the proposal before the United Nations General Assembly
says that we shall decide - not the people of Palestine, with no provision for the self-determination, no provision
for the consent of the governed - what type of independence Palestine shall have. We shall call Palestine
independent and sovereign, but Palestine shall belong to us and shall be, not the apple of our many and in
different-direction-looking eyes, but shall become the apple of discord between East and West, lest, perchance,
the unity which our name so wistfully proclaims may have a chance to establish itself.
We shall first cut the body of Palestine into three parts of a Jewish State and three parts of an Arab State.
We shall then have the Jaffa enclave; and Palestine's heart, Jerusalem, shall forever be an international city. That
is the beginning of the shape Palestine shall have.
Having cut Palestine up in that manner, we shall then put its bleeding body upon a cross forever. This is
not going to be temporary; this is permanent. Palestine shall never belong to its people; it shall always be
stretched upon the cross.
What authority has the United Nations to do this? What legal authority, what juridical authority has it to
do this, to make an independent State forever subject to United Nations administration?...
Our vote today, if it does not endorse partition, does not rule out other solutions. Our vote, if it endorses
partition, bars all peaceful solution. Let him who will shoulder that responsibility. My appeal to you is: do not
shut out that possibility. The United Nations should seek and strive to unite and bring together rather than to
divide and put asunder».
A causa delle lunghe dichiarazioni a favore del piano di spartizione, al quale seguirono quelle
degli oratori arabi, non si tenne la votazione finale e vennero sospesi i lavori dell’Assemblea Generale
per due giorni, essendo il 27 il giorno del Ringraziamento. Il tempo era cruciale per persuadere alcuni
Stati che si erano espressi il giorno prima o contro la spartizione o per l’astensione e rimanevano
solamente quarantott’ore.
Il 27 novembre la Casa Bianca annullava la politica passiva del Dipartimento di Stato nei
confronti delle altre delegazioni all’ONU, ed entrò decisamente in campo per ottenere l’approvazione
del piano di spartizione, con la parte preponderante svolta direttamente da Truman. D’altronde, i
consiglieri del presidente americano erano convinti che, se il piano non fosse passato al vaglio
dell’Assemblea Generale, sia l’ONU sia la politica di Truman mantenuta coerentemente per più di anno
dalla dichiarazione dello Yom Kippur (4 ottobre 1946) avrebbero perso prestigio e credibilità.
Gli obiettivi di questa intensa pressione erano primariamente quattro Stati: Filippine, Liberia,
Haiti e Grecia, tutti più o meno influenzabili da Washington.
Le Filippine, l’ex colonia statunitense, che si era dichiarata palesemente contraria la spartizione,
sotto la minaccia di revocare il pacchetto di aiuti finanziari in attesa di essere definito dal Congresso
americano, capovolsero repentinamente il proprio orientamento di voto.
La Liberia, che il 25 novembre si era astenuta, era fortemente dipendente dall’esportazione della
gomma che le grandi multinazionali americane richiedevano (ad es. la Firestone). Sotto il timore di un
boicottaggio, fatto presente al governo e al presidente liberiano William Tubman, la delegazione a New
York fu convinta verso un voto positivo.
Haiti, anch’essa astenutasi ma con l’intenzione di opporsi al piano di spartizione durante le
dichiarazioni di voto del 26, fu spinta a modificare la sua posizione per un voto favorevole. Infatti,
venne espressa al presidente Dumarsais Estimé la volontà della Casa Bianca di un voto positivo da
parte della sua delegazione.
Solo con la Grecia, i tentativi dei sionisti e dei consiglieri di Truman non sortirono l’effetto
desiderato, ossia di guadagnare un voto positivo vista l’astensione del 25. Forse, il governo di Atene
non aveva il timore di perdere l’appoggio economico e militare degli Stati Uniti, concesso grazie alla
“Dottrina Truman” del marzo 1947 e ratificato dal Congresso americano nel maggio seguente, e si
espresse addirittura contro il piano di spartizione.
La Francia, stretta dalla necessità di mantenere un ottimo rapporto con Washington, soprattutto
per beneficiare del sostegno finanziario americano essenziale per la ripresa economica del dopoguerra,
e ansiosa rispetto alla prospettiva di una reazione negativa degli Stati arabi nordafricani e dei suoi
protettorati (Marocco e Tunisia), era combattuta da interessi concorrenti. Dalla precedente astensione,
Parigi si spostò verso un appoggio al piano di spartizione, grazie alle pressioni dell’ex premier
socialista, l’ebreo Léon Blum, che aveva presieduto il primo governo di coalizione del Fronte popolare
dal giugno 1936 al giugno 1937.
Questa campagna di intense pressioni fu promossa sia dalla Casa Bianca sia dalle organizzazioni
sioniste, con metodi e strumenti, come la corruzione e le minacce verso le altre rappresentanze
governative, alquanto criticabili.90
Il 29 novembre 1947, i 5691 Stati membri dell’Assemblea Generale partecipanti alla votazione si
divisero su queste linee: 33 favorevoli (due più del necessario), 13 contrari, 10 astensioni.92
La storica Risoluzione n° 181 che raccomandava la spartizione della Palestina era approvata; la
Palestina, che dopo il primo conflitto mondiale era stata separata dalla Siria dalle potenze vincitrici
senza tenere conto della volontà della popolazione, era ulteriormente smembrata.93
Come esattamente trenta anni prima Balfour promise un riconoscimento internazionale per
l’istituzione di un «focolare nazionale del popolo ebraico» in Palestina, aprendo di fatto la strada a una
divisione e alla conseguente creazione di due Stati separati in futuro, così un organo
dell’organizzazione mondiale maggiormente apprezzata sanzionò il diritto della comunità ebraica in
Palestina a uno Stato ebraico. Non era stato facile ottenere la maggioranza necessaria alle Nazioni
90
Sono pienamente condivisili i contenuti della dichiarazione di voto della delegazione libanese del 26 novembre durante il
dibattito finale davanti all’Assemblea Generale, più sopra riportati.
91
La delegazione della Thailandia (Siam dal 1856 al 1939 e dal 1945 fino al 1949) sembrava propensa ad astenersi, mentre
durante la votazione nel Comitato ad hoc si era espressa contro il piano di spartizione. Al momento della votazione finale
partì da New York senza partecipare al voto.
92
In favore: Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Canada, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica
Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Haiti, Islanda, Liberia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua,
Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Svezia, Ucraina, Unione Sudafricana, Unione Sovietica, Stati Uniti,
Uruguay, Venezuela.
Contrari: Afghanistan, Cuba, Egitto, Grecia, India, Iran, Iraq, Libano, Pakistan, Arabia Saudita, Siria, Turchia, Yemen.
Astenuti: Argentina, Cile, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Honduras, Messico, Gran Bretagna, Jugoslavia.
93
Per la Risoluzione dell’Assemblea Generale vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm, oppure
http://domino.un.org/unispal.nsf.
Frase chiave all’inizio del testo, che sarà poi ripresa nella dichiarazione d’Indipendenza di Israele nel maggio del 1948,
faceva appello agli «inhabitants of Palestine to take such steps as may be necessary on their part to put this plan into
effect».
Il territorio della Palestina fu diviso in 8 parti: tre furono assegnate allo Stato ebraico e tre allo Stato arabo. La settima,
Giaffa, era un’enclave araba in territorio ebraico, e l’ottava parte era la città di Gerusalemme (inclusa Betlemme)
amministrata dal Consiglio di amministrazione fiduciaria dell’ONU come un corpus separatum secondo un regime speciale
internazionale.
Unite: l’attività lobbistica, le pressioni, gli allettamenti e gli intrighi prima della votazione avevano
messo a dura prova l’abilità diplomatica del movimento sionista. Per la prima volta si apriva la strada
verso la realizzazione del sogno sionista.
I sionisti e i loro alleati furono ovviamente soddisfatti dell’esito, mentre gli Stati arabi
dichiararono di non sentirsi vincolati dalla raccomandazione dell’Assemblea Generale perché era
considerata contraria alla Carta delle Nazioni Unite e perciò totalmente priva di validità legale.
Gli arabi non comprendevano, come qualunque osservatore imparziale avrebbe ricavato, perché il
33% della popolazione avesse ottenuto circa il 56,47% del territorio (del quale aveva posseduto fino a
quel momento solo il 9,38%), contro il 42,88% destinato alla maggioranza araba. 94 In altre parole, «i
palestinesi non capivano perché si facesse pagare a loro il conto dell’Olocausto… non capivano perché
fosse ingiusto che gli ebrei restassero minoranza in uno Stato palestinese unitario, e invece fosse giusto
che quasi metà degli arabi palestinesi – la popolazione autoctona, che abitava il paese da secoli –
diventasse dalla sera alla mattina una minoranza soggetta a un potere straniero».95
2 Il ritiro del piano di spartizione e il ripiego del Dipartimento di Stato sull’iniziativa
dell’Amministrazione fiduciaria
Ma, in sostanza, che cosa hanno voluto esprimere le Nazioni Unite con la ratifica della divisione
politica del territorio palestinese?
La maggioranza di un organo internazionale, un voto (positivo), esprime e verbalizza un
principio, un concetto, un’idea, un convincimento che può o meno essere riscontrato nella realtà delle
cose; letteralmente una vera e propria raccomandazione che attende di essere posta in esame sulla
94
95
I dati sono stati raccolti dal sito http://www.nad-plo.org/maps/hiscomp.html, The Palestinians’ Historic Compromise.
Vedi Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 238, dove la frase riportata appartiene a uno storico palestinese, Walid Khalidi.
concretezza dei fatti. La storica Risoluzione ONU sulla spartizione della Palestina era stata presa a
Flushing Meadows, sobborgo di New York, mentre l’oggetto di questa si situava a quasi 12 000
chilometri di distanza e la realtà era un’altra cosa, come lo fu l’atmosfera.
Immediatamente, scoppiò una guerra civile tra le organizzazioni militari ebraiche e gli arabi
palestinesi, sostenuti da uomini e materiale bellico dei paesi arabi limitrofi, e tutto ciò era inevitabile,
anche se all’Assemblea Generale fosse risultato un voto negativo.96
Il Dipartimento di Stato aveva imposto il 14 novembre (reso pubblico solamente il 5 dicembre),
quindi due settimane prima del voto finale all’ONU, in precauzione a qualsiasi esito, l’embargo sugli
armamenti diretti nell’area mediorientale, ossia a entrambi i contendenti sul terreno, in modo da
prendere una posizione di equidistanza fra le parti ed eludere accuse e critiche di partigianeria. Questa
azione della burocrazia governativa, in sostanza, provocò i veementi attacchi dei sionisti, poiché
andava tutto a svantaggio dello yishuv dato che gli arabi potevano fare affidamento sui rifornimenti
militari direttamente dalla Gran Bretagna, più o meno alla luce del sole.
Gli ebrei, o meglio, i sionisti di tutto il mondo e i loro leader, si erano rallegrati, avevano pianto
per il conseguimento di una Risoluzione internazionale che sanciva il diritto riconosciuto a un nuovo
Stato ebraico in Palestina, in una parte dell’antica e biblica terra dei Patriarchi, anche se esistevano
sionisti che non erano soddisfatti del piano di spartizione e non gioivano.97
Con la decisa opposizione da parte della Gran Bretagna a qualsiasi tentativo da parte dell’ONU di
applicare la decisione dell’organo internazionale, palesemente espressa in varie dichiarazioni
96
Yitzhak Sadeh, il padre della Haganah, poco prima del voto finale del 29 novembre 1947 disse: «if the vote is positive,
the Arabs will make war on us, and if the vote is negative, then is we who will make war on the Arabs». Vedi Peter Grose,
Israel in the Mind of America, op. cit., p. 256.
97
«Even among Jews there is dissatisfaction over the partition plan» (Rapporto della CIA, contraria alla spartizione). Begin,
comandante dell’Irgun, braccio armato del movimento revisionista, commentò susseguentemente al passaggio della
Risoluzione 181 sulla spartizione della Palestina: «the homeland has not been liberated, but mutilated… Eretz Israel will be
restored to the people of Israel. All of it. And forever». Un’annunciatrice di una radio clandestina ebraica a Tel Aviv
affermò: «a Jewish state without Jerusalem, without Hebron and Bethlehem, without the Gilead or the Bashan or the lands
beyond the Jordan» (Gilead è una regione a est del fiume Giordano, corrispondente all’area nordoccidentale dell’odierna
Giordania; Bashan è un territorio nell’attuale Siria). Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of America, op. cit.,
rispettivamente pp. 259, 256.
pubbliche, e con il desiderio di non contare ulteriori caduti in una causa che oramai era persa, vista la
decisione di abbandonare la Palestina il 15 maggio 1948 (presa all’inizio di dicembre), era chiara a tutti
che la violenza sarebbe stata la vera vincitrice di tutto il processo.
Nell’Amministrazione americana, di fronte a uno svolgersi dei fatti abbastanza prevedibile, già
nel dicembre 1947 si svilupparono opinioni differenti alla spartizione che era passata alle Nazioni
Unite.
Il Dipartimento di Stato aveva perso una battaglia importante all’ONU, ma ci si rese conto che a
causa della guerra civile che infuriava in Palestina, la Risoluzione di spartizione non poteva essere
attuata, eccetto con l’uso della forza, in poche parole imponendola alle parti. Forrestal volle
combattere, durante l’inverno 1947-948, la sua battaglia personale contro il piano di spartizione
rilevando l’incompatibilità degli interessi vitali degli Stati Uniti in Medio Oriente con l’appoggio a uno
Stato ebraico. Questa crociata solitaria aveva lo scopo di persuadere la maggior parte dei membri del
Congresso e altre personalità influenti alle sue idee, cercando di scardinare la questione palestinese
dalla politica interna americana (potenti gruppi ebraici finanziatori dei partiti politici, preoccupazioni
elettorali), ma gli valse soltanto l’etichettatura di strenuo oppositore della politica delle Nazioni Unite
sulla Palestina e in generale contro le azioni dei sionisti.98
Si è ricordata la strenua opposizione da parte del presidente Truman alla prospettiva di impiegare
contingenti militari statunitensi per la questione palestinese, della grande smobilitazione americana
dopo la fine della guerra, e di altri teatri più a rischio che imponevano priorità, come l’Europa. Il colpo
di Stato comunista contro il governo legittimo cecoslovacco il 29 febbraio 1948, l’inizio susseguente
del blocco di Berlino e la divisione anche fisica dell’Europa orientale da quella occidentale dominata
98
«I said I would rather lose those states in a national election than run the risks which I felt might develop in our handling
of the Palestine question. …[It] a most disastrous and regrettable fact that the foreign policy of this country was determined
by the contributions a particular bloc of special interests might make to the party funds. …It was about time that somebody
should pay some consideration to whether we might not lose the Unites States». Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of
America, op. cit., pp. 260-261. James V. Forrestal servì gli Stati Uniti come Segretario della Difesa dal settembre 1947 al 29
marzo 1949 dove si dimise dall’incarico. Morì due mesi dopo suicida, ufficialmente, vittima di una estrema depressione.
da Mosca facevano temere uno scontro con Stalin, ancora militarmente forte sul terreno in Stati come
la Germania e la Polonia. Inoltre, l’opinione pubblica americana rifiutava fermamente l’invio di altri
militari in una probabile guerra.
Il 19 gennaio 1948, si riunì alla Casa Bianca il nuovo Consiglio per la Sicurezza Nazionale (NSC)
per avviare un riesame fondamentale della politica americana in Palestina e per cercare di proporre una
evoluzione delle scelte alternative.99 Di cruciale importanza fu la relazione di George Kennan, capo del
nuovo Policy Planning Staff (a cui era affidata la preparazione e la stesura dei documenti del NSC) ,
che affermava come gli Stati Uniti avessero ricevuto un durissimo colpo con l’approvazione del piano
di spartizione all’ONU, che non poteva essere eseguito senza l’uso della forza, ma soprattutto
sottolineava come gli interessi vitali americani nel Medio Oriente andassero esplicitamente contro un
continuato appoggio alla spartizione, e raccomandava di non impegnarsi ulteriormente in favore della
decisione dell’Assemblea Generale e di continuare l’embargo sugli armamenti diretti nella regione.
Per il Dipartimento di Stato, il contenuto del resoconto di Kennan fu la base per un ripiego
definitivo e un rinnegamento (minando l’autorità e la credibilità dell’ONU) della decisione degli Stati
Uniti di sostenere la Risoluzione 181 fatta nel novembre 1947, non ritenendo la spartizione una
soluzione pratica e riportando in auge la vecchia proposta dell’Amministrazione fiduciaria.
Un memorandum del Dipartimento di Stato fu presentato a Truman il 21 febbraio contenente
severi avvertimenti sulla situazione presente in Palestina:
99
Il Consiglio Nazionale per la Sicurezza, creato con la National Security Act del 26 luglio 1947, è il centro del sistema di
coordinamento della politica estera americana, ma anche in affari domestici e militari, ed è composto, sotto la presidenza del
capo della Casa Bianca, dal Segretario di Stato e della Difesa come membri chiave, dal vicepresidente degli Stati Uniti, il
Segretario al Tesoro e il Consigliere speciale del Presidente, “una creatura del Presidente” con nessun’altra base di potere (il
presidente Eisenhower istituì il 23 marzo del 1953 la figura dell’Assistente speciale al Presidente per gli affari della
sicurezza nazionale, Kennedy mutò il nome in Consigliere speciale). Inoltre, svolgono la funzione di consigliere e
partecipano alle riunioni il capo degli Stati Maggiori riuniti e il direttore della CIA.
Strumento per promuovere la cooperazione fra i dipartimenti governativi e mezzo a disposizione del presidente americano
per controllare e dominare la loro concorrenza, questo organo si è evoluto e mutato uniformandosi alle necessità,
inclinazioni e stili di ogni Presidente. Durante il mandato presidenziale, Truman, con una non adeguata esperienza in
politica estera, tanto da essere sovrastato dal Dipartimento di Stato e della Difesa, partecipò alla prima riunione il 26
settembre 1947, ma in seguito rimase assente per la maggior parte delle sessioni.
Per approfondimenti vedi http://www.whitehouse.gov/nsc/history.html.
«we are deeply involved… in a situation which has no direct relation to our national security, and where
the motives of our involvement lie solely in past commitments of dubious wisdom and in our attachment to the
UN itself. …If we do not effect a fairly radical reversal of the trend of our policy to date, we will end up either
in the position of being ourselves militarily responsible for the protection of the Jewish population in Palestine
against the declared hostility of the Arab world, or of sharing that responsibility with the Russians and thus
assisting at their installation as one of the military powers of the area. In either case, the clarity and efficiency of
a sound national policy for that area will be shattered».100
I funzionari del Dipartimento di Stato mostrarono al presidente americano, nella maniera più
chiara possibile, la necessità di compiere un capovolgimento basilare dell’atteggiamento politico
adottato nell’Assemblea Generale il 29 novembre, verso la proposta dell’Amministrazione fiduciaria.
Truman approvò il punto di vista della burocrazia governativa «in principle», con la condizione, per
comprensibili ragioni di politica interna, di non discostarsi dall’appoggio al piano di spartizione, e il 22
febbraio diede il via libera al testo della dichiarazione del rappresentante degli Stati Uniti all’ONU,
Warren Austin, pronunciata il 24 davanti al Consiglio di Sicurezza.
Sostanzialmente, il contenuto della nota del Dipartimento rendeva chiara l’opinione degli Stati
Uniti secondo i quali non esisteva nessuna esplicita disposizione nello Statuto delle Nazioni Unite che
autorizzasse l’uso della forza, sancito dal Consiglio di sicurezza, per imporre una raccomandazione
dell’Assemblea Generale.101 In poche parole, Washington non avrebbe aiutato a imporre la spartizione
(Risoluzione 181) con la forza, prioritaria preoccupazione del presidente Truman, e soprattutto non
esisteva alcuna controproposta o ritiro dell’appoggio della spartizione da parte del Dipartimento di
100
Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of America, op. cit., p. 258.
Lo scoppio della guerra civile fra la comunità arabo-palestinese e lo yishuv, qualunque siano state le cause, o
l’approvazione della Risoluzione 181 sulla spartizione o la sua applicazione, autorizzava il Consiglio di Sicurezza a usare
tutti gli strumenti operativi d’intervento a sua disposizione, quindi anche la forza, per ripristinare e mantenere condizioni di
pace e tranquillità (articolo 42 dello Statuto ONU). Non si trattava di imporre e attuare in modo coercitivo la decisione
dell’Assemblea Generale ma di affrontare una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale (articolo 39) che poteva
quasi certamente coinvolgere gli Stati (arabi) limitrofi. Il tutto avvalorato dal fatto che il territorio della Palestina è stato
amministrato dalla Società delle Nazioni, tramite la Gran Bretagna, e di conseguenza, da chi ne ha rilevato l’eredità
istituzionale, vale a dire le Nazioni Unite.
101
Stato. Si serabbe evitato, nel contempo, di concedere anche la più piccola possibilità all’Unione
Sovietica di essere coinvolta, anche militarmente, nell’area mediorientale.102
Per quasi tre mesi dal voto decisivo dell’Assemblea Generale, i sionisti esercitarono pressioni di
ridotta intensità sul presidente americano. Infatti, dopo essere riuscito a guadagnare la spartizione della
Palestina all’ONU, con metodi più o meno leciti da parte dei consiglieri della Casa Bianca, Truman era
talmente infastidito e irritato di ulteriori pressioni delle comunità ebraiche americane da non ammettere
più incontri privati del genere, fino al marzo 1948, lasciando la questione palestinese nella mani del
Segretario di Stato Marshall e delle Nazioni Unite, senza ulteriori intromissioni.
La lotta politica fra il Dipartimento di Stato e i sionisti americani, tramite le forti pressioni
esercitate da alcuni consiglieri chiave della Casa Bianca (ad es. Niles, Hilldring, e in ultimo Clifford)
sul presidente Truman, si era sempre risolta sostanzialmente a favore dei secondi, come testimoniato
dalla proposta Morrison-Grady, dall’assegnazione del Negev agli arabi e dall’atteggiamento passivo
precedente alla votazione nell’Assemblea Generale del piano di spartizione; ma all’inizio di febbraio si
era rimessa in funzione la macchina sionista, vista la preoccupante posizione della burocrazia
governativa, che spingeva per una sostanziale inversione della politica americana all’ONU in favore di
un’Amministrazione fiduciaria.
Il 3 febbraio 1948 si riunirono a Washington eminenti ebrei americani ed emissari dell’Agenzia
ebraica. Ne risultarono le seguenti istruzioni pratiche: premere sui meriti e sulla legittimità della
decisione assunta dall’ONU il 29 novembre 1947, sottolineando la concordanza di questa con gli
interessi nazionali americani nel lungo periodo (sfidando sullo stesso tema la propaganda di Forrestal);
L’Unione Sovietica, come superpotenza uscita dal secondo conflitto mondiale, avrebbe rivendicato, giustamente, la sua
responsabilità in ogni decisione del Consiglio di Sicurezza, anche in una ipotetica Risoluzione che autorizzasse l’uso di
contingenti militari esclusivamente dell’ONU in qualsiasi parte del mondo, anche in Palestina (pertinenti sono gli articoli
43, 44, e 45, 46, 47, mai applicati, della Carta delle Nazioni Unite), con l’ovvia forte preoccupazione del governo
statunitense, in un contesto, quale quello del 1947-1948, di rottura definitiva dell’alleanza di guerra fra i due paesi e di
concreto pericolo di scontro militare in Europa.
102
esercitare un’intensa campagna di sensibilizzazione sui danni, in chiave elettorale, che un rifiuto
ufficiale degli Stati Uniti al sostegno del piano di spartizione avesse potuto provocare.
Inoltre, Weizmann era riuscito ad incontrare Truman, dopo un’attesa di circa un mese e mezzo e
grazie al decisivo ed estremo intervento andato a buon fine da parte dell’amico d’infanzia Eddie
Jacobson. Svoltosi nel più stretto riserbo, tanto da non essere comunicato neppure ad Dipartimento di
Stato, il colloquio non espresse nuove informazioni o prese di posizione da parte di Truman non
coerenti con le precedenti, ma proprio la contestualità temporale giocò un ruolo fondamentale che
provocò uno dei più seri imbarazzi dell’Amministrazione Truman.
Infatti, il giorno seguente a questa conversazione segreta, il 19 marzo, era in programma la
dichiarazione di Warren Austin di fronte alla sessione del Consiglio di Sicurezza, sulle iniziative da
adottare in merito al ritiro definitivo della Gran Bretagna dalla Palestina (15 maggio 1948). Ecco alcuni
brani del discorso, preparato da Loy Henderson e Dean Rusk, che evidenziano in nuce la nuova politica
che il governo statunitense si accingeva a intraprendere:
«The plan proposed by the General Assembly was an integral plan which would not succeed unless each
of its parts could be carried out. There seems to be general agreement that the plan cannot now be implemented
by peaceful means. From what has been said in the Security Council and in consultations among the several
members of the Security Council, it is clear that the Security Council is not prepared to go ahead with efforts to
implement this plan in the existing situation.
…The Security Council now has before it clear evidence that the Jews and Arabs of Palestine and the
mandatory power cannot agree to implement the General Assembly plan of partition through peaceful means.
The announced determination of the mandatory power to terminate the mandate on 15 May 1948, if carried out
by the United Kingdom, would result, in the light of information now available, in chaos, heavy fighting and
much loss of life in Palestine. The United Nations cannot permit such a result.
…the Security Council is determined not to permit the situation in Palestine to threaten international peace and, further, that the Security Council
should take further action by all means available to it to bring about the immediate cessation of violence and the restoration of peace and order in
Palestine.
Under the Charter, the Security Council has both an inescapable responsibility and full authority to take
the steps necessary to bring about a cease-fire in Palestine and a halt to the incursions being made into that
country. The powers of articles 39, 40, 41 and 42 are very great, and the Security Council should not hesitate to
use them - all of them - if necessary to bring about peace.
In addition, my Government believes that a temporary trusteeship for Palestine should be
established under the Trusteeship Council of the United Nations to maintain the peace and to afford the
Jews and Arabs of Palestine, who must live together, further opportunity to reach an agreement
regarding the future government of that country. Such a United Nations trusteeship would, of course,
be without prejudice to the character of the eventual political settlement, which we hope can be
achieved without long delay. In our opinion, the Security Council should recommend the establishment
of such a trusteeship to the General Assembly and to the mandatory power. This would require an
immediate special session of the General Assembly, which the Security Council might call under the
terms of the Charter [articolo 20]. Pending the meeting of the special session of the General
Assembly, we believe that the Security Council should instruct the Palestine Commission to suspend its
efforts to implement the proposed partition plan».103
In poche parole, il rappresentante americano affermava l’impossibilità di applicare la Risoluzione
dell’Assemblea Generale sulla spartizione della Palestina con mezzi pacifici e avanzava la proposta di
una temporanea Amministrazione fiduciaria, senza pregiudicare un eventuale accordo di compromesso
fra le due comunità. Ma è di estrema importanza la volontà del governo americano di sospendere i
tentativi da parte del Comitato sulla Palestina (istituito dalla Risoluzione 181) di applicare il piano di
spartizione, in attesa che si riunisse nell’immediato, sotto la richiesta del Consiglio di Sicurezza
(articolo 20, secondo l’articolo 27, par. 2, essendo la questione di natura procedurale e non sostanziale),
una sessione speciale dell’Assemblea Generale.
Ma come si arrivò allo scardinamento, se si può chiamare in questo modo, della politica
americana sulla Palestina, ossia al passaggio dal grande sforzo e impegno per ottenere il piano di
spartizione dall’ONU all’appoggio per una temporanea Amministrazione fiduciaria? Occorre fare un
breve passo indietro.
L’8 marzo, Truman si incontrò con Marshall e Lovett, e approvò oralmente la proposta del
Dipartimento di Stato dell’Amministrazione fiduciaria, qualora il Consiglio di Sicurezza non potesse
giungere a un accordo per concretizzare il piano di spartizione, e, il giorno seguente, diede il via libera
all’abbozzo del discorso che Austin avrebbe presentato all’ONU. 104 Il 16 marzo, Marshall, timoroso di
iniziative impreviste da parte dell’Unione Sovietica, e preoccupato dal peggioramento della situazione
sul campo in Palestina, che poteva portare a un necessario intervento militare delle Nazioni Unite,
103
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad166.htm, United States Position on the Palestine Problem,
Statement by Ambassador Warren R. Austin, United States Representative in the Security Council, March 19, 1948,
(Excerpts) oppure Department of State Bulletin, March 29, 1948, pp. 402, 403.
104
Spiegel L. Steven, The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to Reagan, op.
cit., p. 33.
incaricò Austin di annunciare il 19 davanti al Consiglio di Sicurezza il ritiro dell’appoggio americano
al piano di spartizione, proponendo l’Amministrazione fiduciaria.
Il 18 marzo, lo stesso giorno in cui Truman incontrò Weizmann, il Comitato delle Nazioni Unite
sulla Palestina annunciò il suo fallimento nel comporre le divergenze tra arabi ed ebrei e concluse: «
[to] reach an agreement between the interested parties regarding the future government of Palestine.
…[to which end] A temporary trusteeship for Palestine should be established under the Trusteeship
Council of the United Nations». 105 In questo modo, il Dipartimento di Stato valutava questa
raccomandazione come il presupposto che avrebbe incontrato la clausola di Truman dell’8 marzo, vale
a dire che il Consiglio di Sicurezza avrebbe dovuto sospendere gli sforzi circa la spartizione prima di
ogni iniziativa americana sull’Amministrazione fiduciaria.
Forte dello svolgersi dei fatti, e senza ulteriori consultazioni o conferme dalla Casa Bianca,
Austin annunciò la proposta americana dell’Amministrazione fiduciaria, il cui discorso era stato
approvato dal presidente il 9 marzo e che causò enormi ripercussioni politiche interne, con accuse e
forti critiche dalla stampa sulla nuova politica.
Perché ci fu una lacerante frattura fra il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca su un documento
che lo stesso Truman aveva approvato a grandi linee davanti al Segretario di Stato Marshall, anche se
non fu messo al corrente fin nei piccoli dettagli?
Le differenze e i contrasti non riguardavano di certo i contenuti della dichiarazione di Austin, ma
la sfavorevole scelta del momento per la diffusione fatta dal Dipartimento di Stato e la mancanza di
coordinamento con la Casa Bianca. Proprio il non aver avvertito in anticipo il presidente americano di
questa mossa gettò in una grave crisi di fiducia le due istituzioni.
Truman era assillato da quello che poteva aver pensato Weizmann, dopo le assicurazioni fatte il
giorno precedente, ma il Dipartimento di Stato era completamente all’oscuro. Forse, i funzionari
105
Michael J. Cohen, Truman and Israel, op. cit., p. 190.
governativi non avevano atteso un voto formale del Consiglio di Sicurezza che licenziasse il piano di
spartizione, come ci si poteva attendere dalla condizione di Truman posta l’8 marzo, data
l’impossibilità di attuarlo pacificamente. Tuttavia, la relazione dei cinque membri permanenti era
abbastanza chiara in merito al fatto che il Consiglio di Sicurezza avrebbe sospeso il piano
dell’Assemblea Generale.106
Uno dei più profondi contrasti fra il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca era dato, senza ombra
di dubbio, dall’incompatibilità politica della prima con i forti legami e interessi politici di Truman e del
partito democratico.
Il presidente americano, dopo essere stato investito da furenti attacchi sull’atteggiamento politico
della Casa Bianca circa la questione palestinese, intraprese una mossa di ripiego, programmando per il
25 marzo 1948 una conferenza stampa in cui avrebbe rilasciato una dichiarazione ufficiale e pubblica,
con il fine di rettificare il discorso che Austin aveva pronunciato al Consiglio di Sicurezza:
«…This country vigorously supported the plan for partition with economic union recommended by the
United Nations Special Committee on Palestine and by the General Assembly. We have explored every
possibility consistent with the basic principles of the Charter for giving effect to that solution. Unfortunately, it
has become clear that the partition plan cannot be carried out at this time by peaceful means. We could not
undertake to impose this solution on the people of Palestine by the use of American troops, both on Charter
grounds and as a matter of national policy.
The United Kingdom has announced its firm intention to abandon its mandate in Palestine on May 15.
Unless emergency action is taken, there will be no public authority in Palestine on that date capable of
preserving law and order. Violence and bloodshed will descend upon the Holy Land. Large-scale fighting among
the people of that country will be the inevitable result. Such fighting would infect the entire Middle East and
could lead to consequences of the gravest sort involving the peace of this Nation and of the world.
These dangers are imminent. Responsible governments in the United Nations cannot face this prospect
without acting promptly to prevent it. The United States has proposed to the Security Council a temporary
United Nations trusteeship for Palestine to provide a government to keep the peace. Such trusteeship was
proposed only after we had exhausted every effort to find a way to carry out partition by peaceful means.
Trusteeship is not proposed as a substitute for the partition plan but as an effort to fill the vacuum soon to be
created by the termination of the mandate on May 15. The trusteeship does not prejudice the character of the
final political settlement. It would establish the conditions of order which are essential to a peaceful solution.
106
La Risoluzione 42 del Consiglio di Sicurezza istituiva un gruppo formato dai cinque membri permanenti con lo scopo di
consultare e informare il Consiglio in relazione alla tragica situazione della Palestina, e fare raccomandazioni «regarding the
guidance and instruction which the Council might usefully give to the Palestine Commission with a view to implementing
the resolution of the General Assembly. The Security Council requests the permanent members to report to it on the results
of their consultations within ten days».
Per il testo della Risoluzione vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres042.htm, United Nations Security Council
Resolution 42; March 5, 1948, oppure http://domino.un.org/unispal.nsf.
If we are to avert tragedy in Palestine, an immediate truce must be reached between the Arabs and Jews of
that country».107
Il testo fu preparato da Clifford, e, da questo momento in avanti, i consiglieri della Casa Bianca
riguadagnarono il controllo della politica palestinese, a discapito degli esperti funzionari del
Dipartimento di Stato, preparando la svolta del 14 maggio.
Truman mise subito in chiaro che la proposta americana dell’Amministrazione fiduciaria non
costituiva un surrogato del piano di spartizione, che rimaneva la soluzione politica finale prioritaria di
convivenza civile fra le due comunità. Infatti, se facciamo un parallelo fra le due dichiarazione,
notiamo che anche quella di Austin conteneva l’iniziativa di un’Amministrazione fiduciaria
temporanea, ma poteva essere interpretata, come fecero prontamente i sionisti americani, come un
completo abbandono del piano di spartizione per il quale essi si erano duramente battuti.
Si poteva mettere in discussione quello che i sionisti, aiutati dalla Casa Bianca, erano riusciti a
ottenere con i loro tradizionali metodi (pressioni, propaganda, minacce, raggiri, corruzione), e una delle
ultime frasi del discorso di Austin sicuramente alimentava questo timore.108
Il presidente americano, dal canto suo, con il ritocco espresso il 25 marzo, manteneva
esplicitamente ferma la Risoluzione del piano di spartizione votata dall’Assemblea Generale, e valutò
come provvisorio e secondario il piano dell’Amministrazione fiduciaria, finalizzato a riempire il vuoto
di potere con l’uscita di scena della Gran Bretagna, e alla ricerca di una tregua fra le parti che doveva
stare nei binari di una divisione politica della Palestina, ormai decisa e ratificata dalla comunità
internazionale e diventata un caposaldo per i futuri negoziati.
107
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad167.htm, United States Proposal for Temporary United Nations
Trusteeship for Palestine, Statement by President Truman, March 25, 1948, oppure Department of State Bulletin, vol. 18,
No. 457, April 4, 1948, p. 451.
108
«Pending the meeting of the special session of the General Assembly, we believe that the Security Council should
instruct the Palestine Commission to suspend its effort to implement the proposed partition plan».
3 Il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte della Casa Bianca
L’episodio imbarazzante dell’iniziativa della diplomazia americana, con la correzione repentina
fatta dal presidente americano, fece scendere paurosamente la sua popolarità, nel momento in cui
diverse personalità del Partito democratico erano intenzionate a puntare su un altro candidato per la
corsa presidenziale del novembre successivo. Truman aveva deciso di intraprendere la sfida elettorale
proprio perché desiderava essere un Presidente eletto e non più nominato, e nel frattempo le pressioni
sioniste stavano gradatamente aumentando.
La proposta dell’Amministrazione fiduciaria riscosse poco entusiasmo all’ONU, in primo luogo a
causa dell’opposizione di arabi, ebrei e di altri importanti Stati, ma soprattutto perché se gli Stati Uniti
non erano disposti a impiegare truppe in Palestina per imporre il piano di spartizione,109 anche per
l’Amministrazione fiduciaria era parsa più che chiara la necessità di un intervento militare esterno,
sotto l’egida delle Nazioni Unite, per far osservare quest’altra opzione temporanea.
I leader sionisti erano convinti che la sorte di un’entità statale ebraica in Palestina sarebbe stata
decisa non dalle parole, ma dagli eventi sul terreno: gli ebrei stavano lottando per creare il loro Stato de
facto e i dibattiti senza fine a New York apparivano più accademici e sempre meno attinenti con la
realtà.
Dalla fine di marzo gli equilibri militari, che avevano visto un vantaggio consistente dei
combattenti arabi, sostenuti dai paesi vicini, mutarono a causa dell’invio clandestino dalla
Cecoslovacchia e dagli Stati Uniti110 (nonostante fosse in vigore l’embargo, ma tramite i soliti metodi)
di partite di armi pesanti a favore della comunità ebraica.
Constatata la ferma volontà di Washington di non schierare i propri militari in Palestina,
prendeva sempre più credito la proclamazione unilaterale dello Stato ebraico: perdevano
109
Discorso di Austin del 24 febbraio e dichiarazione di Truman del 25 marzo («we could not undertake to impose this
solution on the people of Palestine by the use of American troops, both on the Charter grounds and as a matter of national
policy»).
110
Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of America, op. cit., pp. 279-280.
immediatamente d’importanza le questioni della spartizione o del piano di Amministrazione fiduciaria,
e il vero problema era se (e quando) il governo degli Stati Uniti lo avrebbe o meno riconosciuto. Gli
sforzi dei sionisti si indirizzarono verso il vero fine, il riconoscimento americano, ossia mettere
l’Amministrazione Truman di fronte ad un fait accompli, abbinato a un’effettiva difesa del territorio
assegnato dall’Assemblea Generale allo yishuv.111
Il 1° aprile, il Consiglio di Sicurezza emanò due Risoluzioni: la n° 43 convocava l’Agenzia
ebraica e l’Alto Comitato arabo con lo scopo di ordinare una tregua; la n° 44 richiedeva, in conformità
con l’articolo 20 della Carta delle Nazioni Unite, di convocare una sessione speciale dell’Assemblea
Generale per dibattere sul problema del futuro governo in Palestina, visto che l’evacuazione britannica
era irreversibile.112 Infatti, con la fine di marzo, i combattimenti aumentarono d’intensità e le
organizzazioni militari ebraiche passarono all’offensiva.
Il 9 aprile, a Deir Yassin, villaggio della Giudea a circa cinque chilometri a ovest da
Gerusalemme e situato nel territorio all’interno del quale era previsto un corpus separatum sottoposto a
un regime internazionale, venne scritta una delle pagine più brutte nella storia del conflitto fra arabi ed
ebrei: approssimativamente 250 abitanti arabi furono massacrati e trucidati da bande militari dell’Irgun,
capeggiato dal futuro Primo ministro Menachem Begin, e del Lehi. 113 Questo fu il commento
all’episodio di un esponente militare israeliano:
«We suffered a reverse of a different nature on April 9 when combined Etzel [Irgun] and Stern Gang units
mounted a deliberate and unprovoked attack on the Arab village of Deir Yassin on the western edge of
Jerusalem. There was no reason for the attack. It was a quiet village, which had denied entry to the volunteer
Ben Gurion, in risposta all’iniziativa di un’Amministrazione fiduciaria, si pronunciò in questi termini: «it is we who will
decide the fate of Palestine. We cannot agree to any sort of trusteeship, permanent or temporary – the Jewish state exists
because we defend it». Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of America, op. cit., p. 275.
112
Per i testi delle Risoluzioni vedi rispettivamente http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres043.htm, United Nations
Security Council Resolution 43; April 1, 1948 o http://domino.un.org/unispal.nsf;
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres044.htm, United Nations Security Council Resolution 44; 1 April 1948 o
http://domino.un.org/unispal.nsf.
113
Israele ha avuto Primi ministri che furono responsabili di inauditi crimini di guerra e contro l’umanità: Menachem Begin
(1977-1984; nel 1978 gli venne assegnato il Premio Nobel per la Pace, assieme con il leader egiziano Anwar Sadat, per i
notevoli passi avanti nel processo di pace fra i due paesi, conclusosi nel marzo 1979 con la firma del trattato), e Ariel
Sharon (2001- attuale) che autorizzò la milizia falangista libanese, alleata dello Stato ebraico, a compiere il massacro di
rifugiati palestinesi nei campi profughi di Shatilla e Sabra, sobborghi di Beirut, nel settembre 1982.
111
Arab units from across the frontier and which had not been involved in any attacks on Jewish areas. The
dissident groups chose it for strictly political reasons. It was a deliberate act of terrorism... Women and children
had not been given time enough to evacuate the village, although warned to do so by loudspeaker, and there
were many of them among the 254 persons reported by the Arab Higher Committee as killed.
The event was a disaster in every way. The dissidents held the village for two days and then abandoned it.
They earned the contempt of most Jews in Jerusalem, and an unequivocal public repudiation by the Jewish
Agency. But they gave the Arabs a strong charge against us, and the words 'Deir Yassin' were used over and
over again both to justify their own atrocities and to persuade Arab villagers to join the mass flight which was
now taking place all over Palestine».114
Deir Yassin, oltre a essere un simbolo dell’aggressività ebraica, rimase un punto di riferimento
nel conflitto fra le due comunità per il controllo della maggior parte della Palestina, poiché la tattica
psicologica delle organizzazioni militari e terroristiche ebraiche ebbe effetto, con l’inizio dell’esodo
palestinese, caratterizzato dalla massiccia fuga della popolazione civile o dall’espulsione forzata
diretta.
Certamente, essa agevolò il piano militare e politico dello yishuv, di spopolare le città e i villaggi
rientranti nello Stato ebraico (e non solo) definito dalla Risoluzione 181 di arabi, ripopolandoli con la
popolazione e gli immigrati ebrei. Circa 200 000 arabi non aspettarono altro tempo, visti gli efferati
metodi ebraici che indubbiamente potevano essere interpretati come un esempio che poteva ripetersi, e
scapparono dalle loro case e terreni.115 Deir Yassin diventò un catalizzatore dell’esodo arabo
palestinese grazie alla «psicosi della fuga» rafforzata dal «fattore atrocità». 116
Il 17 aprile, significativamente dopo i fatti di Deir Yassin, il Consiglio di Sicurezza votò la
Risoluzione 46 che, oltre a esigere dalle parti in conflitto di astenersi dall’importare o acquistare
materiale bellico, richiedeva di «refrain, pending further consideration of the future Government of
114
Vedi http://www.un.org/Dept/dpa/qpal/dpr/DPR_pp_2.htm.
Per ulteriori approfondimenti guarda http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Dayr-Yasin/.
115
Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of America, op. cit., p. 281.
116
Pronta e immediata fu la risposta delle forze irregolari arabe il 13 aprile, dove un convoglio che trasportava infermieri e
medici ebrei diretto a Gerusalemme cadde in una imboscata, e rimasero uccisi più di 70 persone. Vedi Benny Morris,
Vittime, op. cit., pp. 267, 323.
Palestine by the General Assembly, from any political activity which might prejudice the rights, claims,
or position of either community».117
Le Nazioni Unite, e al loro interno la delegazione americana, dopo aver appoggiato il piano di
spartizione con la Risoluzione 181 e la proposta di Amministrazione fiduciaria, ripiegarono
ulteriormente per una “semplice” tregua provvisoria, decisa dalla Risoluzione 48 del Consiglio di
Sicurezza in cui veniva istituita una commissione di armistizio con il precipuo compito «to assist the
Security Council in supevising the implementation by the parties of its resolution 46».118
Per i sionisti e lo yishuv era solamente un’altra formula, l’ennesima, per ritardare la situazione
senza via d’uscita della Palestina all’ONU, e la prima settimana di maggio i dibattiti all’interno del
Consiglio esecutivo dell’Agenzia ebraica si svilupparono con la decisione di dichiarare unilateralmente
l’indipendenza del nuovo Stato ebraico immediatamente con la partenza dei britannici, programmata
per il 15 maggio. Questo stallo diplomatico andava tutto a svantaggio della comunità ebraica in
Palestina, potendo potenzialmente sfociare in un mutamento del piano di spartizione o altro.
L’8 maggio, in un incontro fra Lovett, Rusk, Moshe Shertok e Marshall, quest’ultimo mise in
chiaro, dopo aver espresso forti dubbi sulla riuscita militare ebraica, che gli Stati Uniti non avrebbero
fornito nessun tipo di aiuto militare e lasciava l’intera responsabilità, come la piena libertà di decidere
qualsiasi azione, sulla spalle dei leader sionisti: un’anticipazione del “semaforo giallo” concesso da
Lyndon Johnson a Israele nel ’67 («Israel will not be alone unless it decides to go alone»).
Con l’impasse diplomatica a New York e l’evolversi dei fatti reali in Palestina favorevoli agli
ebrei, gli Stati Uniti iniziarono a considerare seriamente l’eventualità di riconoscere il nuovo Stato
ebraico: soprattutto la Casa Bianca, spinta dai consiglieri presidenziali filosionisti.
117
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres046.htm, United Nations Security Council Resolution 46; April 17,
1948 o http://domino.un.org/unispal.nsf.
118
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres048.htm, United Nations Security Council Resolution 48; April 23,
1948 o http://domino.un.org/unispal.nsf.
Il momento decisivo e, per certi versi, paradossale fu l’incontro, il 12 maggio, fra Clark Clifford,
David Niles, Matt Connelly e rappresentanti del Dipartimento di Stato, Marshall, Lovett, Fraser
Wilkins, Robert McClintock, presieduto dal presidente americano (con l’assenza notevole, non a caso,
di Loy Henderson). Clifford sostenne che la politica della diplomazia americana nel cercare un accordo
fra arabi ed ebrei per una tregua temporanea fosse del tutto non realistica, e suggerì a Truman di
riconoscere il nuovo Stato ebraico nella conferenza stampa del giorno seguente (13), già in programma,
in modo da anticipare la medesima mossa da parte dell’Unione Sovietica.119 Per avvalorare
maggiormente la tesi, il consigliere della Casa Bianca sottolineò la necessità che il riconoscimento
fosse coerente con la politica palestinese adottata dagli Stati Uniti negli ultimi tre anni: una linea,
questa, che avrebbe recuperato e salvato il prestigio della Nazioni Unite, e, quanto alle elezioni
presidenziali del novembre prossimo, cosa assai sensibile per i funzionari del Dipartimento di Stato,
avrebbe ripristinato la posizione del Presidente nei confronti dell’elettorato ebraico.
In sostanza, quello che suggeriva Clifford era un riconoscimento in anticipo di uno Stato prima
della sua costituzione e senza nessuna richiesta o domanda ufficiale in merito, cosa estremamente
curiosa. In questi termini si pronunciò il vicesegretario di stato Robert Lovett, contrario soprattutto a
collegare motivi di politica interna, come lo erano le elezioni presidenziali e il peso del voto ebraico,
alle decisioni di politica internazionale; in aggiunta, un riconoscimento anticipato poteva solamente
provocare gravissimi danni agli sforzi della delegazione americana nella sessione speciale
dell’Assemblea Generale in corso.
Il Segretario di Stato George Marshall reagì in questa maniera:
«I remarked to the President that, speaking objectively, I could not help but think that the suggestions
made by Mr. Clifford were wrong. I thought that to adopt these suggestions would have precisely the opposite
effect from that intended.
119
Clifford aveva redatto il testo della dichiarazione che Truman avrebbe dovuto annunciare nella conferenza stampa del 13
maggio, in cui era affermata l’intenzione degli Stati Uniti di riconoscere sia lo Stato ebraico sia lo Stato arabo in Palestina,
se e quando fossero stati dichiarati. Vedi Peter Grose, Israel in the Mind of America, op. cit., p. 290.
…The transparent dodge to win a few votes would not in fact achieve this purpose. The great dignity of
the office of President would be seriously diminished. The counsel offered by Mr. Clifford was based on
domestic political considerations, while the problem which confronted us was international».120
Truman aveva constatato le posizioni più che mai ferme del Dipartimento di Stato e soprattutto di
Marshall, contrarie al riconoscimento in anticipo del nuovo Stato ebraico, e fece cadere il suggerimento
di Clifford. Infatti, per il presidente americano lo scopo della riunione era proprio quello di persuadere
il generale alle idee dei suoi consiglieri (Clifford e Max Lowenthal), ma non essendo riuscito
nell’impresa non voleva rompere politicamente con Marshall, elemento chiave, proprio a due mesi
dalla Convention del Partito Democratico e a sei dalle elezioni presidenziali, nelle quali sembrava un
sicuro perdente.
Ma un elemento degno di nota scaturito da questa riunione politica di alto livello fu il seguente: il
Dipartimento di Stato non aveva preso posizione sulla questione se il riconoscimento dello Stato
ebraico dovesse essere rifiutato o meno dopo una richiesta ufficiale indirizzata al governo degli Stati
Uniti. In questo modo, i consiglieri della Casa Bianca si misero subito all’opera, mettendosi in contatto
con personalità ebraiche, tra le quali Chaim Weizmann, che però non ricopriva nessuna posizione
ufficiale nello yishuv.
Come seconda scelta, venne avvisato la mattina del 14 maggio Eliahu Epstein, il rappresentante
dell’Agenzia ebraica a Washington, informandolo della possibilità che il nuovo Stato ebraico poteva
essere riconosciuto dal presidente degli Stati Uniti, nella condizione che fosse arrivata un’appropriata
richiesta ufficiale dai rappresentati del governo provvisorio in tal senso.
Il testo arrivato alla Casa Bianca era il seguente:
«MY DEAR MR. PRESIDENT: I have the honor to notify you that the state of Israel has been proclaimed
as an independent republic within frontiers approved by the General Assembly of the United Nations in its
Resolution of November 29, 1947, and that a provisional government has been charged to assume the rights and
duties of government for preserving law and order within the boundaries of Israel, for defending the state against
external aggression, and for discharging the obligations of Israel to the other nations of the world in accordance
120
Vedi Fraser T. G., The USA and the Middle East Since World War 2, op. cit., p. 47 e Peter Grose, Israel in the Mind of
America, op. cit., p. 291.
with international law. The Act of Independence will become effective at one minute after six o'clock on the
evening of 14 May 1948, Washington time.
With full knowledge of the deep bond of sympathy which has existed and has been strengthened over the
past thirty years between the Government of the United States and the Jewish people of Palestine, I have been
authorized by the provisional government of the new state to tender this message and to express the hope that
your government will recognize and will welcome Israel into the community of nations.
Very respectfully yours,
ELIAHU EPSTEIN
Agent, Provisional Government of Israel».121
Dopo aver ottenuto il tacito assenso di Marshall la mattina del 14, non esisteva più nessun
ostacolo di fronte al riconoscimento ufficiale della Casa Bianca dello Stato ebraico. Il problema chiave,
come lo era stato per la proposta dell’Amministrazione fiduciaria avanzata dal Dipartimento di Stato
nel marzo precedente, era diventato la scelta del momento più opportuno per rendere pubblico
l’importantissimo documento politico.
Clifford, altamente sensibile della politica domestica, riteneva cruciale riconoscere il nuovo Stato
il più presto possibile e precedere in questo l’Unione Sovietica, mentre le pressioni sioniste
aumentavano repentinamente. Dal suo canto, Lovett protestò vivamente contro questa immotivata
urgenza e chiese di prorogare di qualche giorno, giusto il tempo di informare i funzionari americani alle
Nazioni Unite e i governi britannico e francese; inoltre, si stava svolgendo propri il pomeriggio del 14
la sessione speciale dell’Assemblea Generale, su insistenza del governo americano, per esaminare la
situazione in Palestina con il fine di raggiungere una tregua temporanea.122
Alle 16:00 ora in Palestina (ore 10:00 di Washington), del 14 maggio 1948 (il 5° di Iyar, l’ottavo
mese del calendario ebraico, 5708), Ben Gurion, fondatore del Mapai (acronimo di Mifleget Poalei
Israel, Partito dei lavoratori di Israele) e capo dell’Agenzia ebraica (1935-1948) lesse davanti al
121
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad169.htm, Independence of Israel, Letter From the Agent of the
Provisional Governmental of Israel to the President of the Unites States, May 14, 1948, o Department of State Bulletin of
May 23, 1948, p. 673. Il testo della richiesta ufficiale di riconoscimento arrivò alla Casa Bianca attorno a mezzogiorno (ora
di Washington) del 14 maggio (le 18:00 in Palestina).
122
In riguardo a questa frenetica situazione, Lovett scrisse: «my protest against the precipitate action and warnings as to
consequences with the Arab world appear to have been outweighed by considerations unknow to me, but I can only
conclude that the President’s political advisers, having failed last Wednesday afternoon [12 maggio] to make the President a
father of the new state, have determined at least to make him the midwife». Vedi Michael J. Cohen, Truman and Israel, op.
cit., p. 219.
Consiglio nazionale provvisorio riunitosi a Tel Aviv l’atto di costituzione dello Stato di Israele. La
proclamazione avvenne poco prima del ritiro delle ultime truppe britanniche dalla Palestina,
esattamente dal porto di Haifa. Eccone alcuni stralci:
«The land of Israel [Eretz Yisrael] was the birthplace of the Jewish people.
…In the year 1897 the First Zionist Congress, inspired by Theodor Herzl's vision of the Jewish
State, proclaimed the right of the Jewish people to national revival in their own country.
This right was acknowledged by the Balfour Declaration of November 2, 1917, and re-affirmed by the Mandate
of the League of Nations, which gave explicit international recognition to the historic connection of the Jewish
people with Palestine and their right to reconstitute their National Home.
The Nazi holocaust, which engulfed millions of Jews in Europe, proved anew the urgency of the
re-establishment of the Jewish state, which would solve the problem of Jewish homelessness by
opening the gates to all Jews and lifting the Jewish people to equality in the family of nations. The
survivors of the European catastrophe, as well as Jews from other lands, proclaiming their right to a life
of dignity, freedom and labor, and undeterred by hazards, hardships and obstacles, have tried
unceasingly to enter Palestine.
In the Second World War the Jewish people in Palestine made a full contribution in the struggle of the
freedom-loving nations against the Nazi evil. The sacrifices of their soldiers and the efforts of their
workers gained them title to rank with the peoples who founded the United Nations.
On November 29, 1947, the General Assembly of the United Nations adopted a Resolution for the
establishment of an independent Jewish State in Palestine, and called upon the inhabitants of the country to take
such steps as may be necessary on their part to put the plan into effect. This recognition by the United Nations of
the right of the Jewish people to establish their independent State may not be revoked. It is, moreover, the selfevident right of the Jewish people to be a nation, as all other nations, in its own sovereign State.
ACCORDINGLY, WE, the members of the National Council, representing the Jewish people in Palestine
and the Zionist movement of the world, met together in solemn assembly today, the day of the termination of the
British mandate for Palestine, by virtue of the natural and historic right of the Jewish and of the Resolution of
the General Assembly of the United Nations, HEREBY PROCLAIM the establishment of the Jewish State in
Palestine, to be called ISRAEL.
THE STATE OF ISRAEL will be open to the immigration of Jews from all countries of their dispersion;
will promote the development of the country for the benefit of all its inhabitants; will be based on the precepts of
liberty, justice and peace taught by the Hebrew Prophets; will uphold the full social and political equality of all
its citizens, without distinction of race, creed or sex; will guarantee full freedom of conscience, worship,
education and culture; will safeguard the sanctity and inviolability of the shrines and Holy Places of all religions;
and will dedicate itself to the principles of the Charter of the United Nations.
THE STATE OF ISRAEL will be ready to cooperate with the organs and representatives of the United
Nations in the implementation of the Resolution of the Assembly of November 29, 1947, and will take steps to
bring about the Economic Union over the whole of Palestine.
We appeal to the United Nations to assist the Jewish people in the building of its State and to admit Israel
into the family of nations.
…Our call goes out the Jewish people all over the world to rally to our side in the task of immigration and
development and to stand by us in the great struggle for the fulfillment of the dream of generations - the
redemption of Israel».123
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/israel.htm, Declaration of Israel’s Independence 1948.
I 37 firmatari, membri del Consiglio di Stato provvisorio erano: David Ben-Gurion, Daniel Auster, Mordekhai Bentov,
Yitzhak Ben-Zvi, Eliyahu Meir Berligne, Perez (Fritz) Bernstein, Rabbi Wolf Gold, Meir Grabovsky (Argov), Yitzchak
123
Nella dichiarazione d’Indipendenza israeliana ci sono alcuni passi che meritano di essere
approfonditi.
In primo luogo, come di consueto in vari documenti ufficiali sionisti e non, veniva ribadito il
riconoscimento internazionale del legame storico del popolo ebraico con la Palestina. Poi, si cercava di
legittimare il nuovo Stato e le esigenze dell’impresa sionista facendo riferimento all’Olocausto nazista
e al sacrificio dei soldati ebrei nel Secondo conflitto mondiale.124
Era ripetuta la frase della Risoluzione di spartizione del novembre 1947, che chiedeva agli
abitanti della Palestina di intraprendere le iniziative necessarie per attuare il piano, e si menzionarono il
diritto naturale e storico del popolo ebraico di ricostituire uno Stato proprio. Inoltre, vi era un richiamo
all’apertura delle porte del nuovo Stato d’Israele agli immigrati ebraici provenienti da ogni paese della
Diaspora, alla piena uguaglianza sociale e politica a tutti i cittadini (quindi anche agli eventuali arabi
che ricadevano entro i confini israeliani, determinati dall’Assemblea Generale dell’ONU, e nei territori
sotto il controllo militare israeliano).
Gruenbaum, Dr. Abraham Granott (Granovsky), Eliyahu Dobkin, Meir Vilner-Kovner, Zerah Warhaftig, Herzl Vardi,
Rachel Cohen, Rabbi Kalman Kahana, Saadia Kobashi, Rabbi Yitzchak Meir Levin, Meir David Loewenstein, Zvi Lurie,
Golda Meir (Myerson), Nachum Nir-Rafalkes, Zvi Segal, Rabbi Yehuda Leib Hacohen (Fishman), David Zvi Pinkas,
Aharon Zisling, Moshe Kol (Kolodny), Eliezer Kaplan, Abraham Nissan (Katznelson), Pinhas Rosen (Felix Rosenblueth),
Moshe David Remez, Berl Repetur, Mordekhai Shattner, Ben Zion Sternberg, Behor Shalom Shitrit, Moshe (Hayyim)
Shapira, Moshe Sharett (Shertok).
124
Su questo tema è molto utile il libro dello storico Tom Segev da cui è tratto questo passaggio: «in realtà l’Olocausto
segnò la sconfitta del sionismo, il suo fallimento. In sostanza non era riuscito a convincere la maggioranza degli ebrei
d’Europa a recarsi in Palestina finché erano ancora in tempo. Poi, nel momento del bisogno, il movimento era stato troppo
debole per aiutarli davvero. L’Olocausto affossò anche il sogno del pioniere sionista, il sogno di un ebreo diventato
«nuovo» per scelta e ideologia e non sotto la spinta della necessità e della fuga. …con la loro [le vittime dell’Olocausto
morte avevano sabotato il sogno sionista». Certamente, i leader della comunità ebraica in Palestina e il sionismo
internazionale furono gravemente danneggiati dallo sterminio ebraico in Europa soprattutto a causa di due fattori: il primo,
con l’ingente numero di morti massacrati, poteva far diventare sterile tutta la propaganda sionista della necessità di uno
Stato ebraico per i milioni della Diaspora; il secondo era il fondato timore che la maggior parte dei superstiti voleva restare
in Europa o in altri paesi, ma non ambivano la meta della Palestina. I capi dello yishuv, Ben Gurion in testa, avevano come
priorità la costruzione dello Stato ebraico a scapito di tutto il resto, e secondariamente il salvataggio di vite umane dalla
carneficina nazista. Vi era un profondo contrasto fra gli ebrei in Europa, vittime dell’Olocausto, e gli ebrei della Palestina.
Vedi Tom Segev, Il settimo milione. Come l’Olocausto ha segnato la storia di Israele, op. cit., pp. 89-91, 94, 110-113. Vedi
inoltre Zeev Sternhell, Nascita di Israele. Miti, storia, contraddizioni, Milano, Baldini&Castoldi, 1999 (tit. or.: The
Founding Myths of Israel, Princeton, Princeton University Press, 1998), pp. 437-439, dove l’autore afferma che «il sionismo
si basava su una negazione della diaspora».
Particolare impegno ad assumersi da parte della nuova dirigenza degli obblighi derivanti
dall’appartenenza alle Nazioni Unite, dove si esprime che lo Stato d’Israele «will dedicate itself to the
principles of the Charter of the Unites Nations. …will be ready to cooperate with the organs and
representatives in the implementation of the Resolution of the Assembly of November 29, 1947».
Con un giudizio a posteriori, si vede inequivocabilmente la violazione da parte israeliana di
numerose Risoluzioni, del Consiglio di Sicurezza come dell’Assemblea Generale, concernenti il ritiro
dai territori occupati del ’67, gli insediamenti illegali di coloni in queste zone, ecc.., ma ha, in modo
opportuno e nei tempi dovuti (a loro favorevoli), rivendicato il valore della Risoluzione 181.
Tuttavia, senza andare troppo lontano nei tempi, basti pensare che il mediatore svedese Conte
Folke Bernadotte, nominato il 20 maggio dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza in
virtù della Risoluzione 186125 dell’Assemblea Generale con il compito di esercitare «his good office
with the local and community authorities in Palestine to… promote a peaceful adjustment of the future
situation of Palestine» (in pratica, cercare una soluzione permanente attraverso
negoziati con i
belligeranti), è stato assassinato, secondo la versione ufficiale del governo di Tel Aviv,
dall’organizzazione terroristica Lehi, che aveva stretti contatti con l’Haganah e, di conseguenza, con i
leader dello yishuv.126
Infine, la proclamazione unilaterale dello Stato di Israele vìola gravemente la Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza 46, per motivi espressi in precedenza («refrain, pending further consideration of
the future Government of Palestine by the General Assembly, from any political activity which might
prejudice the rights, claims, or position of either community»), poiché quest’ultimo, in situazioni di
minaccia per la pace come lo era la Palestina nel 1948, detiene «la responsabilità principale del
125
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/gres186.htm, U.N. General Assembly Resolution 186, Appointment and
terms of reference of a Unites Nations Mediator in Palestine; May 14, 1948 oppure http://domino.un.org/unispal.nsf.
126
Non ha valore affermare che l’omicidio del Conte Bernadotte è stato compiuto da uno sparuto gruppo di terroristi ebraici,
completamente estraneo dalle autorità ufficiali dello yishuv prima e dello Stato israeliano poi, visto che, per esempio,
nell’eccidio di Deir Yassin, le organizzazioni terroristiche dell’Irgun e del Lehi ebbero «l’assistenza della Haganah», il
futuro esercito israeliano (IDF). Vedi Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 264.
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» (art. 24, par. 1, e il corollario della norma
sancita dall’art. 12, par. 1) e che «qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione
deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale» (art. 11, par. 2).
In altre parole, l’esecuzione del piano di spartizione non era più invocabile dalle autorità ufficiali
dello yishuv, perché la situazione sul campo in Palestina aveva tutti i presupposti per ricadere sotto il
cap. VII della Carta dell’ONU, in cui il Consiglio di Sicurezza ha la competenza esclusiva, a discapito
dell’Assemblea Generale che ha un incompetenza piena e assoluta in merito.
Alle 18:11 di Washington del 14 maggio 1948 (00:11 del 15 maggio in Israele), appena dieci
minuti dall’entrata in vigore della proclamazione d’Indipendenza di Ben Gurion, la Casa Bianca emise
una dichiarazione stampa con cui veniva concesso il riconoscimento internazionale de facto al governo
provvisorio del nuovo Stato di Israele in questi termini:
«this Government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine, and recognition has been requested by the provisional
government thereof.
The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new State of
Israel».127
Con questo atto, il governo statunitense approvò, in pratica, il sabotaggio israeliano verso gli
sforzi per una tregua temporanea, danneggiando irrimediabilmente i tentativi che la delegazione
americana stava facendo alla sessione speciale dell’Assemblea Generale, in corso proprio il 14 maggio;
violò, come i leader della comunità ebraica in Palestina, la Risoluzione 46 del Consiglio di Sicurezza e
quella n° 48. Alle Nazioni Unite, molti delegati rimasero sbalorditi della mossa presidenziale, e persino
lo staff americano rimase ignaro quasi del tutto, perdendo in credibilità.
Il 15 maggio 1948, iniziava la prima di una lunga serie di guerre fra israeliani e arabi: per i primi
si trattava della guerra d’Indipendenza,128 i secondi la qualificarono come al-nāqba, “la catastrofe”, per
Il riconoscimento de iure venne dato dal governo americano il 31 gennaio 1949, con l’instaurazione dell’Assemblea
Costituente il 25 gennaio a seguito delle prime elezioni generali. In contemporanea venne riconosciuta, sempre di diritto,
anche la Transgiordania, il principale cliente della Gran Bretagna nel Medio Oriente assieme all’Egitto.
127
identificare la perdita della maggior parte della Palestina e la (prima) diaspora palestinese verso i paesi
arabi vicini.
La Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale mutuava il principio della divisione politica del
territorio mandatario della Palestina dal piano Peel del 1937, con due importanti modifiche:
approssimativamente il Negev era assegnato allo Stato ebraico e la Galilea a quello arabo, anche se le
raccomandazioni del piano Bernadotte129 del settembre 1948 tornavano, in sostanza, alle proposte del
piano Peel; ma soprattutto non si faceva menzione, eufemisticamente, del «trasferimento di
popolazioni».
Di fatto, l’assenza di questa disposizione avallò il ricorso, quasi essenzialmente da parte ebraica,
a una violenza sistematica per obbligare la popolazione civile araba alla deportazione dalle zone sotto il
suo controllo. Nasceva, nel modo più tragico, il dramma di centinaia di migliaia di profughi arabopalestinesi, ancora oggi lontano dall’essere risolto: il maggiore ostacolo, forse, assieme alle colonie
israeliane nei “territori occupati” e alla questione di Gerusalemme, nei negoziati fra le parti in causa.130
Vedi “The Economist”, Peace out of war, 20 ottobre 2001, pp. 13-14. Interessanti sono le prime righe dell’articolo che
brevemente analizzano il fattore della guerra sulla storia di Israele e sull’impresa diplomatica per crearlo: «war has
fashioned Israel. The wars against its unfriendly Arab neighbours of course, but also the world wars of the past century. The
Balfour Declaration, a product of the first world war, pointed the way for a Jewish state in Palestine; the UN partition
resolution at the end of the second world war divided the land; the Madrid conference, after the Gulf war, set the scene for
Israeli-Palestinian talks».
129
Vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad170.htm, Conclusions From Progress Report of the United
Nations Mediator on Palestine, September 16, 1948 oppure in U.N. doc. A/648 (part one, p. 29; part two, p. 23 and part
three, p. 11), September 18, 1948; Department of State Bulletin of October 3, 1948, pp. 436-440.
130
La legalità e la legittimità del diritto dei palestinesi a rientrare in patria derivano dalla Risoluzione 194 dell’Assemblea
Generale, votata l’undici dicembre 1948, ma anche da tutti i princìpi dei diritti umani e dai trattati internazionali
consuetudinari. La Risoluzione stabilisce che «the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their
neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the
property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or
in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible; instructs the Conciliation Commission to
facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of
compensation».
Per il testo vedi http://domino.un.org/unispal.nsf.
128
179
Capitolo 5
Diplomazia sterile e forza dei fatti
Il contributo essenziale degli Stati Uniti alla nascita del nuovo Stato ebraico
non deve essere interpretato come decisivo o determinante. L’Amministrazione
americana, con il suo immediato riconoscimento de facto, il forte peso politico e il
prestigio, concesse a Israele legittimità internazionale. Tuttavia, dopo l’istituzione
del Mandato britannico e il diritto garantito alla comunità ebraica (yishuv) di far
affluire una determinata quantità annuale di immigrati, si era arrivati a un punto
critico per il futuro politico della Palestina, poiché era diventato maturo il
momento in cui gli ebrei avrebbero rivendicato il possesso (e il diritto) di una
parte del territorio mandatario in ambito internazionale. E questa pressione, prima
demografica e poi politica, sarebbe potuta sfociare in una guerra fra i protagonisti,
i quali erano del tutto consapevoli di questo eventuale sviluppo tragico.
La dichiarazione d’Indipendenza del governo provvisorio israeliano poneva
le diplomazie mondiali, che tentavano di scongiurare un imminente conflitto, di
fronte a un “fatto compiuto”: la stessa tattica che poi impiegata abilmente dai
governi israeliani nei primi anni di vita del nuovo Stato e, per altri aspetti, fino ai
giorni nostri. Già dai primi mesi di lotta militare, intervallati da brevi tregue
180
avallate dalle Nazioni Unite, ci si rendeva sempre più conto che gli ebrei
avrebbero mantenuto la loro indipendenza politica con la questione centrale
riguardante la dimensione territoriale che avrebbero potuto controllare.1
Il fatto estremamente importante fu che, con l’invasione di cinque eserciti
arabi in Palestina, Egitto, Transgiordania, Siria, Libano e Iraq, il 15 maggio 1948,
i primi due Stati erano legati strettamente alla Gran Bretagna con accordi di
protettorato o comunque che includevano una forte ingerenza in politica interna e
soprattutto nella relazioni esterne. Si prospettava minacciosamente, in questo
modo, una situazione impensabile e teorica che i due Stati anglosassoni legati da
una special relationship, Stati Uniti e Gran Bretagna, avrebbero rifornito e aiutato
due piccoli Stati nemici in un grave conflitto.
1 Il piano Bernadotte
La politica di neutralità fra arabi ed ebrei che caratterizzò la condotta della
Gran Bretagna nei confronti del problema palestinese, venuto alla ribalta proprio
con la rinuncia unilaterale al Mandato nel febbraio 1947, necessitava di una svolta
in favore di un’attiva presa di posizione, ora che la guerra metteva a rischio le
relazioni dell’occidente con l’intero Medio Oriente. La nomina del mediatore
1 «Since
1948, cease-fires in the Arab-Israeli wars have been utilized to prepare for the next round
of fighting. Exhausted troops have time to rest, equipment is repaired, ammunition supplies are
replenished, and new firing positions and plans are drawn up, all under the cover of a diplomatic
initiative and temporary halt to the fighting. The question following each episode is which side
was more successful in taking advantage of the relative period of quiet». Vedi Gerald M.
Steinberg, The End of the Pseudo Cease-Fire, The Internet Jerusalem Post, July, 18 2001,
http://www.jpost.com/Edition/2001/07/18/News/News.30707.html.
181
Conte Folke Bernadotte con il compito di trovare una soluzione durevole al
conflitto venne sfruttata a dovere dalle grandi potenze per imporre un accordo
finale sotto le vesti un piano ONU, evitando eventuali critiche. D’altronde, era
necessario un peso politico non indifferente, vale a dire un deciso sostegno al
rapporto finale del mediatore delle Nazioni Unite da parte di Washington e
Londra, perché tale piano fosse credibile e attuabile.
Il Dipartimento di Stato ebbe contatti con il governo britannico durante
l’estate del 1948 con lo scopo di presentare, sotto l’egida delle Nazioni Unite, un
piano che avrebbe preso in considerazione le differenti situazioni di fatto e realtà
militari in atto in Palestina, rispetto al contesto politico in cui era stata approvata
la Risoluzione di spartizione del precedente novembre. Truman era impegnato ad
affrontare la prima campagna elettorale presidenziale e, se il primo obiettivo era
quello di conquistare il secondo mandato, questa volta popolare, rimase sempre al
corrente degli sviluppi diplomatici che riguardavano l’area calda mediorientale,
anche se non fin nei dettagli. Si stava delineando fra le burocrazie governative di
Washington e Londra la convinzione della necessità di un drastico allontanamento
dalla mappa geografica prodotta dalla Risoluzione 181 dell’ONU, proprio come il
primo piano Bernadotte consegnato ai belligeranti il 27 giugno proponeva.2
2 Questo
primo schema di proposte avanzate dal mediatore ONU Bernadotte, consisteva, in
sostanza, in una federazione fra Giordania e Israele, con i secondi che dovevano rinunciare a
favore dei primi sia dell’intero Negev e Gerusalemme, e, come contropartita, ricevere buona parte
o l’intero territorio della Galilea, che verrà quasi completamente occupata militarmente
dall’esercito israeliano nel luglio, dopo che con la fine della «prima tergua» seguirono le ostilità
dei «dieci giorni» (8-18 luglio). Le reazioni delle autorità arabe ed ebree a queste iniziative furono
categoricamente negative da entrambe le parti, e diventarono oggetto di scherno. Come potevano
gli ebrei accettare la rinuncia di Gerusalemme e del Negev, per il quale avevano lottato duramente
alle Nazioni Unite (soprattutto nelle stanze della Casa Bianca)? Come potevano gli arabi accettare
lo schema e l’idea generale della spartizione, rimasta tale ed estranea dal loro orizzonte politico?
182
Il secondo piano venne reso pubblico il 16 settembre e, qui di seguito, se ne
menzionano alcuni passi significativi:
«SEVEN BASIC PREMISES
Return to peace
(1) Peace must return to Palestine and every feasible measure should be taken to ensure
that hostilities will not be resumed and that harmonious relations between Arab and Jew
will ultimately be restored.
The Jewish State
(2) A Jewish State called Israel exists in Palestine and there are no sound reasons for
assuming that it will not continue to do so.
Boundary determination
(3) The boundaries of this new State must finally be fixed either by formal agreement
between the parties concerned or failing that, by the United Nations.
Continuous frontiers
(4) Adherence to the principle of geographical homogeneity and integration, which
should be the major objective of the boundary arrangements, should apply equally to
Arab and Jewish territories, whose frontiers should not, therefore, be rigidly controlled by
the territorial arrangements envisaged in the resolution of 29 November.
Right of repatriation
(5) The right of innocent people, uprooted from their homes by the present terror and
ravages of war, to return to their homes, should be affirmed and made effective, with
assurance of adequate compensation for the property of those who may choose not to
return.
Jerusalem
(6) The City of Jerusalem, because of its religious and international significance and the
complexity of interest involved, should be accorded special and separate treatment.
International responsibility
(7) International responsibility should be expressed where desirable and necessary in the
form of inter-national guarantees, as a means of allaying existing fears, and particularly
with regard to boundaries and human rights.
The following conclusions, broadly outlined, would, in my view, considering all the
circumstances, provide a reasonable, equitable and workable basis for settlement:
… (b) The frontiers between the Arab and Jewish territories, in the absence of agreement
between Arabs and Jews, should be established by the United Nations… with the
following revisions in the boundaries broadly defined in the resolution of the General
Assembly of 29 November in order to make them more equitable, workable and
consistent with existing realities in Palestine.
(i) The area known as the Negev… should be defined as Arab territory;
… (iii) Galilee should be defined as Jewish territory.
(c) The disposition of the territory of Palestine not included within the boundaries of the
Jewish State should be left to the Governments of the Arab States in full consultation with
Una cosa era certa per i leader israeliani: i futuri sviluppi politici sarebbero stati dipesi dell’esito
dei combattimenti (strategia del “fatto compiuto”) vincolati direttamente alle decisioni del nuovo
Stato ebraico, e non da estranei piani promossi o dall’ONU o dalle grandi potenze.
183
the Arab inhabitants of Palestine, with the recommendation, however, that in view of the
historical connection and common interests of Transjordan and Palestine, there would be
compelling reasons for merging the Arab territory of Palestine with the territory of
Transjordan.
… (e) The port of Haifa, including the oil refineries and terminal and without prejudice to
their inclusion in the sovereign territory of the Jewish State or the administration of the
city of Haifa, should be declared a free port.
(f) The airport of Lydda should be declared a free airport.
(g) The City of Jerusalem, which should be understood as covering the area defined in the
resolution of the General Assembly of 29 November, should be treated separately and
should be placed under effective United Nations control with maximum feasible local
autonomy for its Arab and Jewish communities, with full safeguards for the protection of
the Holy Places and sites and free access to them, and for religious freedom.
(i) The right of the Arab refugees to return to their homes in Jewish controlled territory at
the earliest possible date should be affirmed by the United Nations, and their repatriation,
resettlement and economic and social rehabilitation, and payment of adequate
compensation for the property of those choosing not to return, should be supervised and
assisted by the United Nations conciliation commission.
(j) It should also lend [the Palestine conciliation commission] its good offices, on the
invitation of the parties, to any efforts toward exchanges of populations with a view to
eliminating trouble some minority problems, and on the basis of adequate compensation
for property owned».3
In poche parole, le conclusioni finali del rapporto di Bernadotte suggerivano
l’assegnazione della Galilea allo Stato ebraico,4 il deserto del Negev annesso alla
Transgiordania, la conferma di Gerusalemme sotto il controllo delle Nazioni
Unite, ma soprattutto che l’ONU avrebbe imposto e garantito i nuovi confini, in
mancanza di un accordo fra le parti. Accenni, ma egualmente importanti,
riguardavano la conferma dell’esistenza del nuovo Stato ebraico d’Israele in
Palestina, il diritto di ritorno per i civili costretti a fuggire dalle loro case (poi
trasfuso nella Risoluzione 194 dell’Assemblea Generale dell’11 dicembre 1948
3 Vedi
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decad170.htm, Conclusions From Progress
Report of the United Nations Mediator on Palestine, September 16, 1948
oppure in U.N. doc. A/648 (part one, p. 29; part two, p. 23 and part three, p. 11), September 18,
1948; Department of State Bulletin of October 3, 1948, pp. 436-440.
4 Ricordiamo
che la maggior parte della Galilea era già stata conquistata e occupata militarmente
dall’esercito israeliano nel luglio 1948, e che, secondo il piano di spartizione dell’Assemblea
Generale, era stata assegnata allo Stato arabo.
184
con la determinante modifica della parola «at the earliest possible date» in «at the
earliest practicable date»), e il richiamo alle parti di perseguire un accordo per
uno scambio di popolazioni, una reminiscenza dell’idea di trasferimento
contenuta nel piano Peel.
A uno sguardo generale, il secondo piano Bernadotte era simile alla
proposta che il Dipartimento di Stato tentava di avanzare davanti alle Nazioni
Unite nel novembre 1947, prima dell’intervento decisivo di Weizmann sul
presidente Truman (19 novembre), ma rassomigliava inoltre al piano Peel del
1937.
La reazione israeliana fu subito chiara e si manifestò con l’uccisione del
mediatore dell’ONU il 17 settembre a Gerusalemme, mentre la parte araba, ancora
una volta, respinse l’iniziativa sulla base dell’illegalità dello Stato di Israele.
Truman, per la sua opportunità politica, ribadì nella piattaforma politica del
Partito Democratico (luglio 1948) il sostegno a rimanere fedelmente legato alle
Risoluzione di spartizione dell’Assemblea Generale relativa ai confini di Israele,
rifiutando di aderire al principio di omogeneità incluso nelle raccomandazioni di
Bernadotte, e di fatto negando frontiere «more equitable, workable and consistent
with existing realities in Palestine».
Al contrario, e in modo stridente con le intenzioni del presidente americano,
prima il Dipartimento di Stato e poi il governo di Londra trovavano il consenso
per appoggiare le conclusioni finali del mediatore dell’ONU all’apertura annuale
dei lavori dell’Assemblea Generale a Parigi. Il 21 settembre Marshall emise la
seguente dichiarazione:
185
«The US considers that the conclusions contained in the final report of Count
Bernadotte offer a generally fair basis for settlement of the Palestine question. My
government is of the opinion that the conclusions are sound and strongly urges the parties
and the General Assembly to accept them in their entirety as a the best possible basis for
bringing to a distracted land».5
Il giorno successivo, il ministro degli Esteri britannico Bevin sostenne
apertamente e per la prima volta, davanti alla Camera dei Comuni, la spartizione
politica della Palestina delineata dal piano Bernadotte come soluzione permanente
della questione palestinese, prendendo una ferma posizione politica al riguardo,
con tutte le sue conseguenze.
Com’era prevedibile, le parole di Marshall a sostegno del piano Bernadotte
infiammarono una tempesta politica interna, con feroci critiche indirizzate a
Truman a causa dell’incompatibilità di vedute nell’Amministrazione governativa:
il Segretario di Stato aveva «energicamente» («strongly») esortato le parti in
causa ad accettare le soluzioni proposte dal mediatore dell’ONU, il presidente
americano aveva ribadito di non allontanarsi dalla Risoluzione 181, con i suoi ben
definiti confini. Sembrerebbe una riedizione dello scontro politico fra il
Dipartimento di Stato e la Casa Bianca sulla dichiarazione di Austin davanti al
Consiglio di Sicurezza del 19 marzo precedente, che avanzò la proposta di
Amministrazione fiduciaria come soluzione temporanea alla questione
palestinese, provocando già le ire di Truman.
Questa volta, il contesto temporale, a poco più di un mese dalle elezioni
presidenziali, e politico, con la forte presenza di un nuovo Stato in Palestina che
5 Vedi
Michael J. Cohen, Truman and Israel, op. cit., pp. 238-239 e Steven Spiegel L., The Other
Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to Reagan, op. cit., p.
186
aveva sconvolto le previsioni delle diplomazie mondiali, in primis quella
americana, cambiava bruscamente le carte in tavola. Inoltre, Truman aveva
approvato in anticipo l’idea del Dipartimento di Stato di intraprendere con
l’esecutivo londinese consultazioni per valutare uno scambio del Negev con la
Galilea. Aveva Truman la forza necessaria per imporre la sua volontà per la
seconda volta, mettendo in cattiva luce i rapporti all’interno dell’Amministrazione
di fronte agli elettori, ma, nel contempo, conquistando il voto della comunità
ebraica?
Il governo israeliano, come detto, respinse immediatamente la proposta di
un baratto del Negev con la Galilea e di qualsiasi revisione della Risoluzione 181:
era riuscito a ottenere un territorio sotto l’egida delle Nazioni Unite, benché
frazionato, ma questo doveva rappresentare la base di partenza per ulteriori
espansioni nella regione, come leader sionisti avevano predetto a suo tempo, tra
cui Ben Gurion. Questo fu il presupposto della crescente pressione degli ebrei
americani su Truman allo scopo di sconfessare l’uscita pubblica di Marshall il 21
settembre. Ma un altro danno politico provocato dal discorso di quest’ultimo, fu
l’opportunità (politica) che era scaturita per il candidato repubblicano, Thomas E.
Dewey, di sfruttare a suo favore la situazione imbarazzante dell’avversario,
rinnegando gli sforzi fra i due massimi partiti tesi per una linea politica bipartisan
su Israele, che dovevano tenere fuori la questione palestinese dalla campagna
elettorale.6
40.
6 Subito dopo il riconoscimento de facto dello Stato di Israele da parte dell’Amministrazione
Truman, si svilupparono dibattiti durante i mesi estivi sui bisogni urgenti di questo: il
187
Alla concessione da parte di Dewey del pieno riconoscimento allo Stato
ebraico con i confini sanzionati dalle Nazioni Unite e il sostegno al prestito
americano, il 25 ottobre Truman manifestava in una dichiarazione rilasciata alla
stampa l’appoggio per il piano di spartizione dell’Assemblea Generale, dichiarava
che eventuali modifiche dovevano essere pienamente accettate dal governo
israeliano e, infine, aggiungeva che il piano Bernadotte doveva essere considerato
come una base di negoziazione, suscettibile di ulteriori e future modificazioni.7
Ma il presidente americano fece di più tre giorni dopo al Madison Square
Garden di New York, a cinque giorni dalle elezioni presidenziali, quando espresse
un chiaro e forte sostegno allo Stato ebraico in questi termini:
«It is my desire to help build in Palestine a strong, prosperous, free, and
independent democratic state. …It must be large enough, free enough, strong enough to
make its people self-supporting and secure».8
Si trattava, senza ombra di dubbio, di una dichiarazione di enorme
importanza, che avallava la politica militare di Israele, proprio mentre lo Stato
ebraico aveva attaccato il 15 ottobre l’esercito egiziano per ottenere il controllo
del Negev. Ancora una volta, si cercava di creare una nuova situazione sul campo
che avrebbe delegittimato e reso obsoleto il piano Bernadotte, rendendo di fatto
riconoscimento de iure, il sostegno finanziario per circa 100 miliardi di dollari, l’appoggio
americano alla domanda (di ammissione) di Israele di fare parte delle Nazioni Unite.
Sostanzialmente, sia il Partito democratico sia quello repubblicano erano favorevoli a queste
richieste, mentre le opinioni differivano solamente per i tempi della loro messa in pratica.
Ovviamente, un accordo bipartisan era l’ultima cosa che i sionisti americani e il governo
israeliano volevano.
7 In contrasto con il contenuto del discorso di Marshall tenuto davanti all’Assemblea Generale,
dove si sollecitava ebrei e arabi palestinesi ad accettare le raccomandazioni di Bernadotte «in their
entirety».
8 Vedi Michael J. Cohen, Truman and Israel, op. cit., p. 254 e Steven Spiegel L., The Other ArabIsraeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to Reagan, op. cit., p. 43.
188
sterile l’azione delle Nazioni Unite, fino a un futuro ed eventuale ordine
dell’Amministrazione americana. Con il discorso elettorale di New York, Truman
riafferrava direttamente la condotta politica sul problema palestinese, ma
paradossalmente la conquista del secondo mandato presidenziale alla Casa Bianca
registrava una diminuzione del sostegno elettorale ebraico al Partito democratico.9
Come risposta alla ripresa dei combattimenti del 15 ottobre, questa volta fra
l’esercito israeliano e quello egiziano, che manteneva il controllo sul Negev, il
Consiglio di Sicurezza approvava significativamente il 4 novembre (dopo i
risultati elettorali) una Risoluzione 61 che minacciava sanzioni contro lo Stato
ebraico, reo di aver violato il “cessate il fuoco”, ribadendo con fermezza che «if
the truce was subsequently repudiated or violated by either party or by both, the
situation in Palestine could be reconsidered with a view to action under Chapter
VII of the Charter of the United Nations», che riconosceva al Consiglio di
Sicurezza, almeno in teoria, un ruolo centrale e la capacità operativa
d’intervento.10
Inoltre, la Risoluzione si appellava «to withdraw those of their forces which
have advanced beyond the positions held on 14 October», mantenendo di fatto il
Negev in mani egiziane. Una chiara presa di posizione da parte dell’organo
9 La
vittoria di Truman il 2 novembre 1948 sul candidato repubblicano Dewey fu uno dei più
grandi sconvolgimenti della storia politica americana. Contro ogni benevola previsione, il
presidente americano ottenne il 49,6% del voto popolare (a fronte del 45,1% di Dewey) e 303 del
determinante voto elettorale (189). Truman perse i voti elettorali di Stati come New York,
Pennsylvania, e Michigan dove era concentrata un’alta percentuale dell’elettorato ebraico, ma
riuscì a tamponare le perdite aggiudicandosi la California (uno degli Stati chiave, con un alto
numero di elettori considerata l’elevata popolazione), l’Ohio e l’Illinois. Vedi David Mauk and
John Oakland, American Civilization. An introduction, London and New York, Routledge, Second
Edition, 1997, p. 153.
189
“esecutivo” delle Nazioni Unite di estrema importanza, ma gli Stati Uniti
possedevano la volontà politica di attuare misure per far indietreggiare l’esercito
israeliano dall’iniziale conquista del Negev, peraltro assegnato dalla Risoluzione
181 dell’Assemblea Generale agli ebrei, o addirittura per espellerlo da Giaffa e
dalla Galilea, territori occupati destinati sempre dalla stessa Risoluzione
all’identità politica araba?
La linea del governo americano post-elettorale, lontana dalle dichiarazioni
generali emesse per puri interessi elettorali, tornava in sintonia con il Foreign
Office e con il piano Bernadotte: appoggiava, cioè, lo schema di spartizione
territoriale del novembre 1947, ma implicava che, se Israele avesse voluto
mantenere la conquista della Galilea, avrebbe dovuto avanzare “sue” concessioni
territoriali, magari proprio su parti del Negev. Una flessibilità, imposta da un
conflitto che si stava evolvendo e mutava la realtà del ‘47, che però implicava un
qui pro quo alle parti in causa.
Nel contempo, Truman non ebbe la volontà e la forza politica per intimare
al governo israeliano di rispettare la volontà dell’ONU, espressa tramite le
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e la prospettata soluzione secondo lo
schema Bernadotte. Certamente, la politica tollerante unilateralmente accordata a
una parte del conflitto diventò un elemento davvero prezioso e un vantaggio per lo
Stato ebraico, adatta a continuare una politica dei fatti basata sulla guerra: un
implicito sostegno americano a favore dei rapporti di forza.
10 Vedi
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres061.htm, United Nations Security Council
190
2 Prove di espansionismo
Un’inversione di tendenza dell’Amministrazione americana nei confronti
del comportamento di Israele si ebbe a seguito della violazione della frontiera
internazionale fra Egitto e la Palestina mandataria da parte delle forze israeliane, il
28 dicembre, ritenuta dal leader Ben Gurion «un’operazione tattica».11 Come si è
ricordato, questi due belligeranti potevano mettere in crisi le relazioni
angloamericane e portare sul teatro dello scontro militare la Gran Bretagna, legata
all’Egitto da un trattato difensivo del 1936.
Premuto da Londra e dal cupo scenario che stava delineandosi in Medio
Oriente, Truman lanciò un severo monito a Tel Aviv, con lo scopo di far ritirare
immediatamente le forze armate israeliane dal territorio egiziano, e minacciò di
riconsiderare l’intero atteggiamento americano verso il nuovo Stato ebraico.
L’azione israeliana rendeva alquanto difficoltosa per Washington promuovere
l’ingresso alle Nazioni Unite di quest’ultimo, poiché l’offensiva militare non
permetteva di considerare Israele come un “peace-loving state”.12
I leader israeliani recepirono il monito di Washington come un ultimatum,
consapevoli di aver superato il limite della politica di sostegno accordato
dall’Amministrazione Truman al nuovo Stato ebraico. Quest’ultimo cedette alle
Resolution 61; November 4, 1948.
11 Vedi Michael J. Cohen, Truman and Israel, op. cit., p. 265.
12 I requisiti basilari che deve ottemperare un Stato per essere ammesso alle Nazioni Unite sono, in
base all’articolo 4 dello Statuto ONU: essere amante della pace, accettare gli obblighi della Carta
ONU, essere capace e, soprattutto, disposto ad adempiere detti obblighi. È necessario rilevare che
l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza hanno il pieno potere discrezionale in ordine
all’esistenza di questi requisiti («a giudizio dell’Organizzazione»). Lo Stato di Israele, secondo la
procedura ammissione, è diventato parte delle Nazioni Unite con la decisione dell’Assemblea
Generale l’11 maggio 1949 (Risoluzione 273 III) conformemente alla raccomandazione del
Consiglio di Sicurezza del 4 marzo 1949 (Risoluzione 69).
191
forti pressioni americane e britanniche, e il 6 gennaio 1949 acconsentì a un
immediato e incondizionato “cessate il fuoco” mediato dall’americano Ralph
Bunche, sostituto di Bernadotte, seguìto dall’apertura di negoziati diretti fra Egitto
e Israele allo scopo di giungere a un armistizio, come recitavano le Risoluzioni 62
e 66.13
Il governo israeliano siglò gli accordi di armistizio anzitutto con l’Egitto,
forte e minaccioso grazie al potente esercito, il 24 febbraio 1949; con il Libano il
23 marzo; con la Transgiordania il 3 aprile; e con la Siria il 20 luglio.14 Fra la
firma dell’armistizio con l’Egitto e quella con la Transgiordania,
significativamente l’esercito israeliano completò l’occupazione del Negev senza
scontrarsi con alcuna forza militare.
La prima guerra araboisraeliana, o, secondo lo Stato ebraico, la guerra
d’Indipendenza, veniva etichettata come una travolgente vittoria di Israele e
un’umiliante disfatta araba. Lo Stato d’Israele, che grazie alla Risoluzione di
spartizione del novembre 1947 aveva ottenuto il 55-56% della Palestina
mandataria, conquistò territori destinati allo Stato arabo di un altro 21,47%,
ratificati e legittimati dagli accordi di armistizio del 1949, per un totale di circa il
13 Vedi
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres062.htm, United Nations Security Council
Resolution 62; November 16, 1948 e http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/scres066.htm, United
Nations Security Council Resolution 66, December 29, 1948. La prima si allontanava
sostanzialmente dalla Risoluzione 61, perdendo la forza insita, benché non veniva abrogata, e
chiamava che «the parties directly involved in the conflict in Palestine, as a further provisional
measure under Article 40 of the Charter, to seek agreement forthwith, by negotiations conducted
either directly or through the Acting Mediator, with a view to the immediate establishment of the
armistice». Nella seconda, i futuri negoziati erano vincolati dall’attuazione «without further delay
resolution 61 (1948) of 4 November 1948 and the instructions issued by the Acting Mediator in
accordance with sub-paragraph of the fifth paragraph of that resolution».
14 Non ci fu nessuna trattativa diretta fra Israele e Iraq né fu mai sottoscritto alcun armistizio
separato.
192
78%. I restanti territori, la striscia costiera di Gaza e la Cisgiordania, il cuore della
Palestina araba, furono rispettivamente amministrati dall’Egitto e annessi dalla
Transgiordania. Già la lunga linea di confine fra la West Bank e Israele, stabilita
con l’armistizio giordano, era tortuosa, ma, soprattutto, innaturale, con la
numerosa popolazione nelle zone di confine, aumentata dall’ammasso dei primi
profughi e dalle famiglie palestinesi divise da questa artificiale separazione.
A uno sguardo politico generale, possiamo riassumere che se la questione
palestinese aveva come base la Risoluzione di spartizione garantita dalle Nazioni
Unite, per certi versi criticabile, con l’evolversi della situazione militare,
nettamente favorevole all’esercito israeliano, gli Stati Uniti (ma non la Gran
Bretagna!) erano riluttanti a imporre alle parti in conflitto una soluzione
quantomeno equa e giusta. La giovane organizzazione internazionale veniva
messa da parte lasciando il campo ai puri rapporti di forza, che nel gennaio
risultarono vantaggiosi per Israele (nel gennaio Israele raccolse il frutti della sua
superiorità militare).
Nel novembre 1948, proprio davanti all’Assemblea Generale gli Stati Uniti
appoggiavano l’idea di opporsi a qualsiasi riduzione del territorio dello Stato
d’Israele senza il consenso di questo, ma, cosa di notevole importanza, se Tel
Aviv voleva territori che erano stati assegnati agli arabi dall’ONU, avrebbe
dovuto negoziarli (come poi fece, da una posizione di forza, legittimando la
riduzione dell’ipotetico Stato arabo).
Grazie all’implicito appoggio americano, il governo israeliano cercò
strenuamente di giungere a uno stato de iure di non belligeranza, inevitabile prima
193
o poi, in posizione di forza, per guadagnare sul piano diplomatico i frutti delle
azioni militari e dello status quo territoriale che si era creato. E per gli Stati
sconfitti negoziare significò “cedere” sostanzialmente territori assegnati dall’ONU
a uno Stato arabo, anche se, certamente, sia l’Egitto sia soprattutto la
Transgiordania ottenevano il controllo del resto.
Il gennaio 1949 fu uno spartiacque sia per Israele sia per la condotta politica
di Stati Uniti e Gran Bretagna nei suoi confronti. Lo Stato ebraico aveva firmato
accordi di “cessate il fuoco” con i paesi arabi limitrofi, presupposto per
guadagnare ulteriori territori grazie ai futuri armistizi; il riconoscimento de iure
sia da parte dell’ex potenza mandataria, la Gran Bretagna (il giorno 29)15, sia degli
Stati Uniti (il 31, con inclusa l’approvazione del prestito finanziario); e infine
Washington, con la decisiva rivalutazione in senso geopolitico dell’area
mediorientale da parte del Dipartimento di Stato, e Londra concordarono sul
vantaggio strategico che Israele era riuscita a costruirsi agli occhi degli
occidentali, come baluardo per i loro interessi.
Lo Stato d’Israele si era impiantato fermamente e stabilmente in Medio
Oriente, riconosciuto dalle maggiori potenze dell’epoca, e aveva ottenuto e
conquistato circa il 78% della Palestina mandataria. A questo stupefacente trionfo
mancava però il controllo della Cisgiordania, ossia dei territori biblici della
Giudea e Samaria, con la cruciale importanza di città come Gerusalemme Est, con
15 Al
tempestivo riconoscimento de facto del nuovo governo provvisorio di Israele, seguirono
rapidamente Guatemala, Uruguay e Nicaragua. Il 17 maggio era la volta dell’Unione Sovietica e,
di seguito, Polonia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Sud Africa.
194
i principali luoghi sacri musulmani, ebraici e cristiani, Hebron e Nablus (Sichem).
Durante la guerra d’Indipendenza israeliana, il problema principale per
l’esercito di Tel Aviv era stato l’Egitto, anziché la Transgiordania, anche se, il 26
settembre 1948, il leader Ben Gurion propose al governo provvisorio di
conquistare la Giudea (comprese città quali Hebron, Latrun, Ramallah,
Gerusalemme Est, Betlemme e Gerico) ma per diverse ragioni l’esecutivo
respinse di stretta misura l’iniziativa.16
Ora, per il nuovo Stato ebraico, provato dalla prima guerra araboisraeliana
ma uscitone nel modo migliore, la priorità era per un rafforzamento della struttura
politica, economica e, soprattutto, demografica, con l’afflusso di ebrei da ogni
parte del mondo.17 Per quanto riguarda l’espansionismo israeliano, le occasioni
propizie non sarebbero mancate di certo, con lo scopo principale di recuperare
sotto la stella di Davide la West Bank del Giordano, simbolo oltreché territoriale,
anche di profonde radici storiche e religiose.
16 «Ben
Gurion avrebbe più volte incolpato quel voto (discolpando implicitamente se stesso) della
“perdita” di Gerusalemme, uno smacco di cui intere generazioni si sarebbero rammaricate». Vedi
Benny Morris, Vittime, op. cit., p. 308.
17 Nei primi anni di vita dello Stato ebraico, i leader israeliani erano consapevoli, a ragione, che
una determinata consistenza demografica fosse indispensabile per la sopravvivenza del paese.
Come preannunciato dalla Proclamazione d’Indipendenza il 14 maggio 1948 («The state of Israel
will be open to the immigration of Jews from all countries of their dispersion… Our call goes out
the Jewish people all over the world to rally to our side in the task of immigration and
development and to stand by us in the great struggle for the fulfillment of the dream of generations
- the redemption of Israel»), il 5 luglio del 1950 la Knesset, il parlamento unicamerale israeliano,
approvò la cosiddetta “Legge del ritorno”, con la quale veniva garantito che «every Jew has the
right to immigrate to the country» e otteneva il certificato d’immigrazione, tranne quelle persone
che perseguono attività contro la nazione e il popolo ebraico o possono minacciare la salute
pubblica o la sicurezza dello Stato. È specificato la retroattività di questa disposizione legislativa.
Nel 1954 un’altra eccezione venne estesa agli ebrei con un passato criminale. Durante i primi venti
anni di applicazione della legge, approssimativamente 1 290 800 ebrei della diaspora entrarono in
Israele.
195
Per il testo della legge vedi The Israel-Arab Reader, op. cit., p. 87.
Capitolo 8
Il trionfo del sionismo: Johnson e la conquista israeliana di
Eretz Yisrael nella guerra dei Sei giorni
L’occupazione militare e il controllo di vasti territori pronti da colonizzare, e l’unificazione di
Gerusalemme come capitale eterna e indivisibile di Israele, rappresentano il punto culminante dei
sogni, delle speranze del popolo ebraico, del sionismo, sia laico sia religioso. Saranno questi i frutti
politici e territoriali che la presidenza di Johnson porterà allo Stato ebraico.
È doveroso dire infatti, che mentre dal 1950 (con la Dichiarazione Tripartita) fino alla fine della
Presidenza Kennedy, gli Stati Uniti erano riusciti ad acquisire una qualifica di attori imparziali e
relativamente giusti fra i contendenti della disputa mediorientale, grazie soprattutto al significativo
comportamento adottato da Eisenhower durante la crisi di Suez che aveva dato un forte segnale ai
regimi arabi moderati circa la volontà americana di non schierarsi apertamente con nessuna parte, con
l’assunzione dei poteri presidenziali da parte di Johnson abbiamo un punto di svolta dei rapporti che
Washington intrattiene sia con Israele, sia con i paesi arabi.131
Durante gli anni della carica di Johnson come inquilino della Casa Bianca era scontato che la
guerra in Vietnam occupasse la prima priorità della sua Amministrazione.132 Ci fu un maggior impegno
Dal punto di vista israeliano, la guerra del ’67 fu giudicata come uno dei capitoli maggiormente positivi della Presidenza
Johnson, pronunciato in modo significativo nelle parole del ministro degli Esteri Abba Eban: «we had involved them [gli
americani] very deeply», in contrasto con la crisi di Suez del 1956 «when the United States refused to speak to us». Citato
in George Lenczowski, American Presidents and the Middle East, op. cit., p. 113.
132
Durante la presidenza Nixon la disputa araboisraeliana era ritenuta da questi persino più pericolosa della conflitto
americano in Vietnam. Cfr. Public Papers of the Presidents of the United States, Richard Nixon, 1971, Radio Address about
Second Annual Foreign Policy. Report to the Congress. February 25, 1971, p. 285: «Vietnam is our most anguishing
problem. It is not, however, the most dangerous. That grim distinction must go to the situation in the Middle East with its
vastly greater potential for drawing Soviet policy and our own into a collision that could prove uncontrollable». Nelle sue
memorie Nixon considerava il conflitto insanabile fra arabi e israeliani come un pericolo altamente potenziale: «…an
international powder keg, that, when it exploded, might lead not only to another war between Israel and its neighbors, but
131
a gestire la crisi vietnamita, dove l’escalation militare, con l’invio di truppe direttamente impegnate in
Indocina dopo la svolta politica (e militare poi) dell’estate 1964, assumeva livelli preoccupanti.
Per quanto riguarda il capitolo mediorientale, la politica di Johnson non differiva sostanzialmente
dalla precedente amministrazione. La condotta politica dell’Amministrazione americana dal 1964 fino
alla crisi del maggio’67 si identificava nel rafforzare i regimi pro-statunitensi dell’area (coltivando le
alleanze con l’Iran, la Turchia, Grecia e Pakistan, e con i regimi arabi conservatori e pro-occidentali,
Arabia Saudita, Libia, Marocco, Libano, Tunisia e Giordania, importanti Paesi produttori di petrolio i
primi due) minacciati dal panarabismo di Nasser, e nell’incrementare l’assistenza militare a Israele per
bilanciare l’aiuto di Mosca verso i paesi arabi radicali. Più specificamente, la questione araboisraeliana
non fu oggetto di nessuna nuova iniziativa capace di scardinare l’immobilismo determinatosi dopo la
guerra di Suez nel 1956, soprattutto in seguito all’entrata della rivalità e della competizione bipolare
nella regione, dove permaneva la debole e fragile situazione di ‘non pace, non guerra’. Soprattutto in
questo periodo, Washington mostrò la volontà di evitare impegni e iniziative in ambito diplomatico.
Nella primavera del 1964, Johnson ricevette Levi Eshkol. Fu la prima visita ufficiale a
Washington di un Primo ministro di Israele, opportunamente programmata per le elezioni presidenziali
del novembre successivo. Il governo israeliano cercava insistentemente di intavolare trattative per un
accordo diretto di vendita di un’arma per lo più ritenuta offensiva: i carri armati. Johnson rassicurò il
suo interlocutore: se non avesse trovato fonti europee (Germania, Gran Bretagna) gli Stati Uniti
avrebbero sopperito alla necessità bellica direttamente.
Un’altra preoccupazione per la burocrazia governativa statunitense restava la posizione della
Giordania, ricettiva alle influenze sia del Cairo sia di Mosca. Quest’ultima già riforniva di materiale
also to a direct confrontation between the United States and the Soviet Union». Vedi Richard Nixon, RN: The Memoirs of
Richard Nixon, New York – London – Toronto – Sydney – Tokyo – Singapore, Simon & Schuster, 1978, 1990, p. 343.
Inoltre, cfr. in Steven Spiegel L., The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to
Reagan, op. cit., p. 151, dove viene riportato nel dicembre 1968 il discorso di Eugene Rostow, sottosegretario di stato, alla
biblioteca Johnson, e disse che il presidente americano «feels in many ways it’s [the Middle East] a more dangerous crisis
than Vietnam, because it can involve a confrontation with the Russians, not the Chinese».
l’Egitto, la Siria e l’Iraq e se fosse diventata partner militare di Re Hussein, il cui Stato confinava sulla
lunga linea calda della West Bank, sarebbe diventato una minaccia reale per Israele, circondato
totalmente da paesi arabi radicali.133
Alla fine, l’Amministrazione americana decise di aumentare la vendita di armi in favore di
Amman, e, prudentemente, inviò il sottosegretario di Stato per gli affari politici, Averell Harriman, per
informare il governo di Tel Aviv del provvedimento all’inizio del 1965. Con riluttanza Israele accettò
la fornitura militare da parte degli Stati Uniti a un potenziale futuro nemico Stato arabo; ma quando
non poté ottenere dall’Europa occidentale gli aerei e i tank tornò a esercitare forti pressioni per un
impegno diretto degli Stati Uniti. Le discussioni su questo tema specifico si protrassero per diversi
mesi, ma alla fine, nel febbraio 1966 (reso pubblico nel successivo maggio), l’accordo militare venne
raggiunto: gli Stati Uniti avrebbero consegnato 48 bombardieri Skyhawk, ai quali andavano aggiunti i
170 carri armati dell’anno precedente.
Fu un cambiamento radicale che portò Washington a procurare materiale bellico e assistenza a
diversi Stati amici dell’area mediorientale in modo esponenziale, allo scopo di eguagliare l’aiuto
militare sovietico ai Paesi arabi radicali. Durante l’Amministrazione Johnson, il costo di questa
collaborazione esterna lievitò dai 44,2 milioni di dollari nel 1963 fino a toccare la quota di quasi un
miliardo di dollari nel 1968.134
Si potrebbe osservare, in merito, che quando si alimenta il circolo vizioso della corsa alle armi, da
entrambe le parti, senza mettere in moto proposte politiche credibili per la risoluzione delle
controversie internazionali, allora l’altra strada, quella militare, prende il sopravvento sulle altre
opzioni, fino a divenire pressoché inevitabile.
133
Fra Israele e la Giordania esisteva un disputa sulle risorse idriche. La seconda minacciava di dirottare le sorgenti di acqua
situate all’interno del suo territorio in modo da ridurre l’approvvigionamento idrico di Israele. Anche questo fu un motivo
che spinse il governo israeliano alla guerra nel giugno 1967, occupando l’intera West Bank e le alture del Golan, territori
relativamente ricchi di acqua.
134
Vedi Steven Spiegel L., The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to
Reagan, op. cit., p. 135.
Gli Stati Uniti incrementarono il sostegno economico agli avversari dell’Unione Sovietica e dei
suoi clienti, ma il costo era minimo in comparazione alle somme che l’Indocina drenava alla casse
statali americane. A mio parere, si è voluto mantenere lo status quo nella questione mediorientale fra
arabi e israeliani distribuendo armi come deterrente, mentre la tragedia vietnamita iniziava ad attirare le
preoccupazione dell’Amministrazione Johnson, senza riuscire a percepire che il Medio Oriente stava
dirigendosi verso una seria crisi.
1 Verso la guerra
Prima di arrivare ad analizzare la crisi che scoppiò nel maggio del 1967, occorre soffermarci
principalmente su due fatti premonitori dei successivi sviluppi.
Nel novembre 1966, Israele intraprese una massiccia e sproporzionata ritorsione militare in un
villaggio della West Bank, Samu, in risposta all’uccisione di tre soldati durante l’ottobre precedente,
provocata dalle infiltrazioni di palestinesi dalla Giordania. Furono distrutte 125 case e un reparto
ospedaliero, e vennero ammazzati 18 soldati giordani.135 Le Nazioni Unite condannarono l’azione
israeliana poiché essa era contraria agli obblighi previsti dagli accordi di armistizio del 1949, e fu
considerata controproducente, visto che aumentava pericolosamente le tensioni ed esacerbava le
rivalità con il mondo arabo.
La strategia di eccessive rappresaglie del governo di Tel Aviv, iniziata nel febbraio 1955 con
l’incursione su Gaza, venne utilizzata coerentemente ai primi dell’aprile successivo, quando una serie
di incidenti di confine con la Siria provocò la dura risposta dell’esercito israeliano che abbatté sei aerei,
di cui uno sopra i cieli di Damasco. Susseguentemente, dichiarazioni minacciose di un’imminente
135
Vedi Norman Finkelstein G., Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, op. cit., p. 124.
guerra alla Siria furono rilasciate nel maggio 1967 da importanti esponenti israeliani, come il capo di
stato maggiore dell’esercito generale Yitzak Rabin e il Primo ministro Eshkol.
Certamente, questa escalation terroristica ai danni di Israele si può associare all’ascesa in Siria
dell’ala più intransigente del partito Baath nel febbraio del 1966. Infatti, il governo siriano appoggiava
gli attacchi contro Israele ed era la mente strategica di quasi tutte le operazioni terroristiche e delle
incursioni in territorio israeliano, ma, per il timore di subire dure rappresaglie da parte dell’esercito di
Gerusalemme nel suo territorio, molte di queste partivano dal Libano o dalla Giordania.
Ma, cosa più importante, la situazione si deteriorò nel confine fra lo Stato ebraico e quello
siriano, a causa della graduale presa di controllo delle zone demilitarizzate da parte israeliana. Secondo
gli accordi del 1949, venivano create fra i due paesi delle aree nelle quali non potevano sostare
apparecchiature o personale militare.
L’occupazione israeliana armata e aggressiva, intrapresa grazie al principio di sfruttare ogni parte
dell’antica terra di Israele, portò di conseguenza alla distruzione dei villaggi arabi in queste terre e
all’espulsione degli abitanti. Le azioni dei siriani, che bombardavano dalle alture del Golan contro
l’usurpazione violenta israeliana, erano strettamente collegate alle severe reazioni punitive, compresi
gli attacchi aerei.
Lo status quo delle zone demilitarizzate si alterò sempre in una direzione, a favore dello Stato
ebraico, e dimostrò quali fossero le reali intenzioni del governo israeliano: anzitutto creare fatti sul
terreno, e poi aggravare il tono di sfida nei confronti della Siria e del mondo arabo. Il leader di
quest’ultimo, Nasser, si sentì quasi obbligato a rispondere concretamente e ad aumentare le tensioni
con mosse avventate e assai discutibili sul piano politico.
Infatti, la natura e le dimensioni delle azioni di rappresaglia israeliane contro la Siria e la
Giordania avevano lasciato il presidente egiziano senza alcuna scelta eccetto quella di difendere la sua
immagine e prestigio verso l’intero mondo arabo. Inoltre, egli doveva dimostrare l’operatività del patto
militare di difesa che nel novembre del 1966 l’Egitto aveva stretto con la Siria, con la leadership del
comando militare nelle mani dei generali del Cairo.
A seguito di una erronea (voluta o in buona fede) notizia data dall’Unione Sovietica il 13 maggio
alla Siria e all’Egitto, in cui si riportava la mobilitazione dell’esercito israeliano lungo il confine
siriano, il primo gesto intimidatorio di Nasser fu quello di inviare truppe nella penisola del Sinai il
giorno successivo. Si presume che le intenzioni egiziane non fossero dirette a un attacco preventivo ai
danni di Israele, anche perché furono inviate solamente due divisioni.136
L’ulteriore passo avanti della crisi venne fatto il 16 maggio con la richiesta formale egiziana,
indirizzata al Segretario Generale, di rimuovere completamente le forze ONU (UNEF I) 137 che
stazionavano dal 1956 nel Sinai, in territorio egiziano, poiché Israele si era rifiutata in modo risoluto di
permettere che ciò avvenisse entro i suoi confini nazionali.138
All’istanza di Nasser, il Segretario Generale dell’ONU U Thant rispose immediatamente (il 18
maggio) in modo positivo, dando ordine alla forza multinazionale di evacuare dal suolo egiziano.
136
Una divisione era formata approssimativamente da 12-20 000 uomini.
Inoltre vedi “Egyptian President Gamal Abdel Nasser: Speech at UAR Advanced Air Headquarters (25 maggio 1967)” in
The Israel-Arab Reader, op. cit., pp. 96-98: «peace, peace, international peace, international security. Why is it that no one
spoke about peace, the UN and security when on 12 th May the Israeli premier and the Israeli commanders made theirs
statements that they would occupy Damascus, overthrow the Syrian regime, strike vigorously at Syria, and occupy a part of
Syria? …Talk of peace is heard only when Israel is in danger. But when Arab rights and the rights of the Palestinian people
are lost, no one speaks about peace, rights, or anything like this. …The Jews threaten war. We tell them you are welcome,
we are ready for war. …When we said that we were ready for the battle we meant that we would surely fight if Syria or any
Arab state was subjected to aggression».
137
Durante la guerra di Suez, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite votò il 5 novembre 1956 una Risoluzione che
creava, per la prima volta, un forza internazionale incaricata di operare per il mantenimento della pace (UNEF I).
Richiamandosi alla sua Risoluzione n. 377/V (‘Uniting for Peace’) del 3 novembre 1950, emanata durante la crisi coreana e
nel periodo più acuto della guerra fredda, l’Assemblea Generale ha il potere di raccomandare misure collettive in caso di
rottura della pace, di un atto di aggressione o conflitto armato, per ovviare alla situazione di paralisi del Consiglio di
Sicurezza, causata da un reiterato utilizzo del veto da parte dei membri permanenti.
Parte della dottrina internazionalista è concorde nel definire la delibera illegittima, motivandola sull’incompetenza piena e
assoluta dell’Assemblea Generale di decidere e di raccomandare sanzioni (ex art. 41) e/o misure implicanti l’uso della forza
(ex art.42), per la ragione che «qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al
Consiglio di Sicurezza…» (art. 11, par. 2). Vedi Benedetto Conforti, Le Nazioni Unite, op. cit., p. 211 è ss..
Quella del ’56, comunque, è stata l’unica operazione di rilievo svolta dall’Assemblea Generale in tema di mantenimento
della pace.
138
Le forze di peace-keeping operation dell’ONU devono avere il consenso dello Stato, dove verranno in seguito dislocate.
È una condizione che il più delle volte viene a mancare dall’inizio o durante le operazioni, in situazioni di guerre civili o di
anarchia, dove un vero sovrano, come punto di riferimento, non esiste (es. le guerre civili in Congo nel 1960-1961, e in
Somalia nel 1994).
Con l’allontanamento della forze ONU dal Sinai, tutti (americani e israeliani) avevano il ben
fondato timore che la successiva mossa di Nasser sarebbe stata la chiusura dello stretto di Tiran alla
navigazione internazionale, con evidenti ripercussioni per i traffici militari e, più in generale, per
l’economia dello Stato ebraico. Infatti, dopo alcuni giorni, forse per scandagliare le reazioni americane
al suo precedente gesto (che non ci furono), il 22 maggio Nasser, con un discorso di poche parole,
annunciava la chiusura alla navigazione sul golfo di Aqaba attraverso lo Stretto di Tiran, comprensivo
del naviglio israeliano da e per il porto di Eilat, all’estremità settentrionale del golfo di Aqaba, facendo
diventare la minaccia (peraltro scontata) un reale pericolo per la pace nel Medio Oriente.
Per la prima volta, lo Stato ebraico doveva confrontarsi con un fatto compiuto imposto con la
forza dall’Egitto, che portò un cambiamento dello status quo nella regione mediorientale a scapito di
Israele. Quest’ultimo, fin dalle primissime colonizzazioni nel XIX secolo, era stato guidato dal
principio del sionismo di creare fatti concreti sul terreno, soprattutto con un graduale sviluppo degli
insediamenti fino alle prove di forza militare con i paesi limitrofi. Ora, l’identica arma veniva utilizzata
da Nasser.
L’obiettivo del presidente egiziano era impedire il traffico navale che trasportasse petrolio e
materiale bellico, che poi sarebbero serviti per le ulteriori reazioni militari dell’esercito israeliano
contro la Siria e la Giordania.
Un’altra ragione del gesto fu il risoluto rifiuto da parte di Israele di onorare le risoluzioni ONU
che si appellavano al riconoscimento e all’operatività del diritto dei rifugiati palestinesi espulsi nel
1948 di ritornare nelle loro case e terreni.139
Vedi “Egyptian President Gamal Abdel Nasser: Speech at UAR Advanced Air Headquarters (25 maggio 1967)” in The
Israel-Arab Reader, op. cit., pp. 96-98. Alcuni passi in riferimento alle diverse risoluzioni delle Nazioni Unite ignorate da
Israele: «…does peace mean ignoring the rights of the Palestinian people because of the passage of time? Does peace mean
that we should concede our rights because of the passage of time? Nowadays they speak about a UN presence in the region
for the sake of peace. Does UN presence in the region for peace mean that we should close our eyes to everything? The UN
has adopted a number of resolutions in favor of the Palestinian people. Israel has implemented none of these resolutions.
This brought no reaction from the UN».
139
Per Israele, l’apertura dello Stretto di Tiran ai traffici marittimi, fino al porto di Eilat nel golfo di
Aqaba, unico sbocco sul Mar Rosso e quindi sull’oceano Indiano, rappresentava il solo guadagno
concreto strappato dalla guerra di Suez nel 1956. Il “libero” e “innocente” passaggio su queste acque
internazionali era affermato anche dagli Stati Uniti che, in un memorandum non ufficiale dell’11
febbraio 1957, si impegnarono verso Israele a mantenere questa situazione.
Ora, una sua chiusura costituiva un atto di guerra, un evidente casus belli menzionato
esplicitamente proprio in questo memorandum dall’allora Segretario di Stato John Foster Dulles, che
sanciva il diritto dello Stato ebraico di usare la forza, in conformità all’art. 51 della Carta delle Nazioni
Unite, contro un arbitrario e forzato atto di chiusura dello stretto. Questa mossa azzardata del
presidente egiziano, foriera di ulteriori guai, spinse il governo israeliano a ordinare la mobilitazione
generale delle forze armate.
1.1 La posizione dell’amministrazione americana di fronte alle crisi del maggio-giugno ’67
L’atteggiamento americano di fronte alle crisi del maggio-giugno era ambivalente: da una parte
Johnson non voleva un’altra guerra, trattenendo Israele dall’agire unilateralmente e preventivamente, e
cercando di costruire un appoggio internazionale per fare pressioni ad un ritorno allo status quo (flotta
multinazionale a tutela del diritto di navigazione su vie d’acqua internazionali da impiegare sul golfo di
Aqaba, dichiarazioni pubbliche, ecc.); dall’altra, con conversazioni riservate della CIA e del
Pentagono, la consapevolezza che la superiorità militare israeliana era schiacciante e che gli ambiti di
manovra dell’Amministrazione americana era ristretti, si cercò di sfruttare la situazione per avere la
possibilità concreta di rovesciare i regimi radicali arabi, soprattutto la guida del panarabismo socialista
di Nasser.
La definizione del comportamento degli Stati Uniti fu esplicitata pubblicamente il 23 maggio dal presidente Johnson: il risoluto impegno a favore e a
garanzia dell’indipendenza politica e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi dell’area, la ferma opposizione a ogni atto di aggressione. In sostanza, si
trattava della politica americana mediorientale sviluppata fin dal 1950, con la Dichiarazione tripartita; ma essa aggiunse che il golfo di Aqaba era una
via d’acqua internazionale, quindi aperta alla navigazione libera e innocente di ogni Stato, e che il blocco alle navi israeliane era illegale.
Il 24 maggio si riunì il Consiglio Nazionale per la Sicurezza, e, in breve, fu deciso di lavorare attraverso le Nazioni Unite e nel contesto multilaterale,
ossia di costituire nel più breve tempo possibile e con la massima partecipazione una flotta militare multinazionale che avrebbe riaperto lo stretto di
Tiran. Bisognava presentare a Israele un’alternativa concreta e credibile se si voleva scongiurare una soluzione militare al problema.
L’opinione pubblica e il Congresso appoggiavano un’azione multilaterale, e Johnson necessitava del più ampio sostegno nazionale proprio mentre la
controversia sulla partecipazione americana nel conflitto asiatico infuriava. Il Presidente americano era consapevole che l’incidente nel Golfo del
Tonchino140 nel 1964 aveva ampliato i suoi poteri sul problema del sud-est asiatico, proprio grazie ad una Risoluzione del Congresso, che conferiva al
Presidente il potere di prendere iniziative in Vietnam ogni volta che lo avesse ritenuto necessario, ma successivamente fu accusato di aver abusato
della autorità, conducendo l’America in una logorante guerra senza fine.
Essenziale per la situazione mediorientale era, perciò, un forte sostegno a ogni decisione intrapresa dall’Amministrazione, e difficilmente il Congresso
americano avrebbe avallato un’avventura militare unilaterale (un’altra, dopo l’impresa vietnamita), «even in support of Israel».141
Il 25 maggio Abba Eban, ministro degli Esteri israeliano, giunse a Washington per scandagliare gli umori americani e avere risposte concrete alla crisi
in atto, memore della lezione di Suez del 1956, quando l’incursione militare congiunta di Israele, Francia e Gran Bretagna contro l’Egitto di Nasser,
era stata decisa senza la benedizione degli Stati Uniti (anzi, con la loro netta disapprovazione). Il problema che agitava gli israeliani non era più il
blocco dello Stretto di Tiran, ma un imminente attacco egiziano, secondo le informazioni riservate di cui disponeva Tel Aviv.
Eban cercava insistentemente una dichiarazione ufficiale da parte dell’Amministrazione americana, con la quale dichiarare che un attacco contro
Israele sarebbe stato giudicato come un attacco agli Stati Uniti, una richiesta abbastanza impegnativa per Washington (che infatti non accettò), e che
avrebbe esposto palesemente la parte che Johnson sosteneva.
Alla base di questa richiesta si situavano differenti interpretazioni dell’impegno statunitense assunto nel memorandum del 1957: secondo il punto di
vista del governo israeliano, Dulles si era impegnato a usare la forza militare americana se fosse stata necessaria per riaprire lo stretto di Tiran;
secondo l’Amministrazione Johnson, Dulles aveva solamente riconosciuto il diritto di Israele di rispondere militarmente in conformità con l’articolo
51 della Carta ONU.
All’incontro del 26 maggio, Johnson reiterò a Eban la superiorità militare israeliana su qualsiasi coalizione araba, basata sulle elaborazioni dei servizi
segreti della CIA e DIA (Defense Intelligence Agency), a prescindere dalla parte che avesse attaccato per prima.142 Disse di avere varie volte definito il
blocco dello Stretto di Tiran illegittimo e che stava lavorando a un piano per il ripristino dello status quo. Aggiunse di non avere autorità ad asserire
Nel 1964 gli Stati Uniti si trovarono di fronte una soluzione obbligata: rendere più efficace e consistente l’impegno
americano nell’Indocina. Erano tormentati anche dal dubbio se continuare la politica di Kennedy di intervento indiretto o
partecipare direttamente alle azioni militari. L’occasione favorevole arrivò il 2-3 agosto 1964 nelle acque internazionali del
golfo del Tonchino, dove due navi americane vennero attaccate da torpediniere del Vietnam settentrionale. L’incidente
(voluto e provocato dagli Americani, secondo alcuni) fu sfruttato a dovere dall’Amministrazione americana che riuscì a far
approvare una Risoluzione quasi all’unanimità dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti. Johnson in questo modo
godeva del massimo appoggio del Congresso, e di conseguenza dell’opinione pubblica americana, ottenendo un ampia
legittimità per le sue successive decisioni politiche e militari. La svolta era consumata.
141
Vedi William Quandt B., Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, op. cit., p. 28
142
Vedi Finkelstein Norman G., Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, op. cit., p. 135. La stima degli esperti
militari americani della durata di un conflitto araboisraeliano era approssimativamente tra i sette e dieci giorni in favore di
Israele.
140
che un attacco a Israele equivaleva a un attacco nei confronti degli Stati Uniti; la sua Amministrazione, per intraprendere qualsiasi iniziativa (in special
modo in politica estera) doveva avere il necessario e indispensabile sostegno del Congresso.
Infine, il presidente americano spiegò chiaramente all’interlocutore israeliano, utilizzando la famosa frase coniata dal Segretario di Stato Rusk, che
«Israel will not be alone unless it decides to go alone», formulazione ambigua e soggetta a diverse interpretazioni, fra le quali quella di un consenso
implicito se Israele avesse agito preventivamente, poiché gli Stati Uniti erano riluttanti o incapaci a usare la forza per riaprire lo stretto di Tiran (il
‘semaforo giallo’).
Diversi esponenti del governo israeliano giudicarono la frase di Johnson non come una proibizione assoluta a iniziare il conflitto, insistendo sul fatto
che un ipotetico attacco israeliano non avrebbe né sorpreso più di tanto, né sconvolto gli americani, i quali sapevano delle implicazioni del
memorandum di Dulles del 1957. La paura di una ripetizione del trauma sofferto nel 1956-57, quando il presidente Eisenhower aveva difeso senza
sconti il principio del ritiro incondizionato dell’esercito israeliano dalla penisola del Sinai, si stava dissolvendo.
Certamente, era ormai assodato che se Israele avesse acceso la miccia mediorientale con un
attacco preventivo, Washington non sarebbe corsa in aiuto del piccolo paese ebraico nell’eventualità
che si trovasse in difficoltà. Ma gli Stati Uniti se ne sarebbero stati in disparte, senza fornire un
adeguato sostegno politico in una probabile battaglia diplomatica nel dopoguerra?
Un’altra via tentata per evitare l’opzione militare nella crisi mediorientale, fu quella di inviare
l’ex ambasciatore in Siria Charles Yost al Cairo per trattare direttamente con Nasser. Il rappresentante
americano avanzò l’idea di sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia la disputa sullo stretto di
Tiran, ossia se il diritto di libero e innocuo passaggio di navi israeliane in queste acque fosse stato
violato dall’azione unilaterale di Nasser. Il presidente egiziano si dimostrò propenso a questa proposta
e concordò l’invio del vice-presidente Mohieddin nella speranza di trovare una sistemazione
diplomatica in alternativa alla guerra o alla forza navale multinazionale.
Il governo israeliano ritenne impossibile da accettare la prospettiva di dirimere la controversia
con una sentenza di diritto internazionale, anche perché avrebbe richiesto del tempo, un fattore decisivo
per lo scoppio del terzo conflitto araboisraeliano. A prescindere dal contenuto del memorandum
bilaterale del 1957, il blocco dello stretto di Tiran non costituisce un attacco armato, e il diritto
internazionale di autodifesa, menzionato dell’articolo 51 della Carta ONU (tassativamente «nel caso
che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite»), non legittimava un inizio
della ostilità contro l’Egitto o qualsiasi altro Stato arabo da parte di Israele.
Oltre a questo tentativo, all’interno dell’amministrazione governativa si continuava a sostenere la
carta della flotta militare multilaterale, sebbene Washington non riuscisse a catalizzare l’appoggio di
molti Paesi all’iniziativa, mostrando sia agli israeliani sia agli arabi pericolosi segni di debolezza.
Ovviamente, se la forza navale fosse apparsa concreta ed efficace agli occhi israeliani, quindi con il
sostegno di paesi importanti e quasi subito impiegata nella regione, Tel Aviv avrebbe frenato un attacco
unilaterale preventivo, avendo in mente la recente campagna del Sinai del ’56.
La principale causa del fallimento del progetto della flotta navale si collegava peraltro alle
divisioni all’interno dell’Amministrazione Johnson. Infatti, il Pentagono e i suoi esperti militari si
opponevano a qualsiasi attività militare americana nell’area mediorientale, a un intervento unilaterale
così come a un impegno nella flotta multinazionale. La preoccupazione era il Vietnam, poiché forze
civili e militari sarebbero stato tolte dall’indispensabile teatro asiatico, mentre ricerche ottimistiche dei
servizi segreti prospettavano una facile vittoria di Israele nell’eventualità di un conflitto regionale.
Anche il Congresso era, per la maggior parte, contrario a ogni intervento militare.
Tutti questi segni del governo statunitense, vale a dire azioni indecise e dichiarazioni prudenti,
rivelavano, soprattutto agli israeliani, la passività, l’impotenza e il senso di ineluttabilità
dell’Amministrazione nell’approccio alla crisi. Si cercava di evitare la guerra fra Israele e gli Stati
arabi, ma allo stesso tempo si tentava di evitare con maggiore determinazione un coinvolgimento
militare unilaterale di Washington. La ragione profonda era l’atmosfera politica creata dal Vietnam che
inibiva ogni azione militare, anche se limitata.
Un mutamento sostanziale del quadro militare arabo, un altro considerevole punto di svolta nella
situazione mediorientale, si ebbe il 30 maggio, quando, premuto con insistenza dalla corrente principale
del nazionalismo arabo interna, Re Hussein di Giordania sottoscrisse un Trattato di mutua difesa con
Nasser, al Cairo, che consentiva di dirigere le operazioni belliche sotto il comando unificato egiziano e,
conseguentemente, di inviare reparti militari in Giordania. L’escalation di tensioni e minacce stava
arrivando al culmine e, per Israele, la situazione stava diventando insostenibile e inaccettabile.
Israele, convinta di aver guadagnato il tacito assenso americano all’azione militare unilaterale, e
di aver evitato il pericolo di un coinvolgimento della Corte Internazionale di Giustizia, anticipando
probabilmente gli sviluppi politici che sarebbero scaturiti dall’incontro tra il vicepresidente egiziano e
gli esponenti statunitensi (programmato per il 7 giugno a Washington), intraprese dunque un attacco
preventivo contro Egitto, Giordania e Siria la mattina del 5 giugno. La frenetica attività diplomatica,
durata per tutta la crisi di maggio-giugno nonostante le azioni sul terreno dei protagonisti, aveva fallito.
Furono necessari appena sei giorni per trasformare in profondità il quadro politico-diplomatico e
geografico della regione mediorientale. Il Medio Oriente non sarebbe stato mai più lo stesso. Israele
aveva conquistato l’intera penisola del Sinai, la West Bank (Cisgiordania), la striscia di Gaza, le alture
del Golan e la parte orientale di Gerusalemme (quella araba), inclusa la “Città Vecchia”.
Subito, questi guadagni acquisirono lo status di “territori occupati”, sottoposti temporaneamente
alla giurisdizione militare dall’esercito straniero israeliano, il quale era tenuto a rispettare la IV
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (12 agosto 1949),
firmata e ratificata da Israele.
L’esercito israeliano aveva conquistato un’area di circa tre volte e mezzo più grande d’Israele
stesso (quella racchiusa nei confini di armistizio del 1949), abitata da oltre un milione di palestinesi:
una vittoria strategica che permetteva allo Stato ebraico di disporre delle relativamente cospicue riserve
idriche della West Bank, e addirittura del petrolio nel Sinai.
Di questi “territori”, la Knesset decretò e legittimò, neanche un mese dopo la fine delle ostilità,
l’annessione unilaterale (unificazione amministrazione) di Gerusalemme Est, nonostante il 4 luglio
all’Assemblea Generale venisse votata la Risoluzione 2253 di forte condanna, con una maggioranza
schiacciante.143 La stessa linea politica verrà attuata in riguardo alle alture del Golan, annesse
formalmente il 14 dicembre 1981.
2 Il capovolgimento della politica di Eisenhower adottata a Suez
La situazione che si presentava nell’immediato dopoguerra, sul fronte egiziano, era identica a
quella del ’56, con l’importante differenza dell’Amministrazione Johnson, la quale, memore della
soluzione di Eisenhower adottata a suo tempo, volle cambiare l’approccio strategico alla questione.
Durante la crisi di Suez i leader arabi arrivarono all’affrettata conclusione che gli Stati Uniti non
avrebbero tollerato mutamenti territoriali a favore di Israele.
Johnson considerava un errore il ritiro forzato di Israele nel ’56 dalla penisola del Sinai, senza
nessuna contropartita (a parte la promessa di truppe di peacekeeping dell’ONU); cercò, quindi, di
creare una struttura per una composizione pacifica durevole, capace di produrre delle basi sicure dove,
una volta preparati gli Stati arabi a negoziare con Israele, potevano essere possibili degli accordi di
pace con lo scambio di territori. Questa condizione non significava, certo, l’indefinito controllo
israeliano di territori appartenenti agli arabi.
Le idee del presidente americano furono presentate con chiarezza nel discorso del 19 giugno
1967, nel quale egli affermò l’intenzione americana di non fare pressioni per il ritiro israeliano dai
territori occupati senza pace. Era in sostanza ribadita la sua fondamentale concezione, ossia che con la
nuova struttura di pace non si sarebbe più dovuti tornare alla condizione della fragile tregua del dopo
Vedi la Risoluzione 2253 dell’Assemblea Generale in http://domino.un.org/unispal.nsf, dove vigorosamente si deplorano
le misure adottate da Israele atte a cambiare lo status della città, si sottolinea che tali misure sono nulle e si richiama lo Stato
ebraico «to rescind all measures already taken and to desist forthwith from taking any action which would alter the status of
Jerusalem».
Gli Stati Uniti si astennero al momento della votazione, affermando che la Città Santa non avrebbe dovuto essere mai più
divisa, rinnegando il precedente impegno di Washington, espresso col piano di spartizione del novembre ’47, a favore del
regime internazionale.
143
’49 e alla frettolosa sistemazione del 1957 perché, dopo quasi venti anni, non si era riuscita a costruire
la pace, ma anzi, la situazione era andata deteriorandosi sempre più.
Johnson elencò le linee fondamentali per una soluzione globale del conflitto mediorientale:
-
il disimpegno e il ritiro della forze armate (in favore degli arabi)
-
il diritto riconosciuto all’esistenza nazionale, in pace e in sicurezza (in favore di Israele)
-
l’indipendenza politica e l’integrità territoriale con confini riconosciuti per tutti gli Stati della
regione (in favore di Israele)
-
una giusta ed equa soluzione per il problema dei rifugiati (in favore degli arabi)
-
un libero e pacifico passaggio attraverso le vie d’acqua internazionali, il canale di Suez e
golfo di Aqaba inclusi (in favore di Israele)
-
limitazioni alla corsa agli armamenti
Questi principi furono incorporati in sostanza nella Risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, eccetto il richiamo alla limitazione agli armamenti.
Sul piano diplomatico, si osservi, Washington non condannò pubblicamente il comportamento di
Israele, dando adito alle forti critiche del mondo arabo. Questo elemento, unito all’accusa di Nasser
seconda la quale gli Stati Uniti avrebbero partecipato direttamente all’attacco aereo sferrato da Israele
contro l’Egitto,144 provocò la rottura diplomatica di sei Stati arabi con Washington. Tuttavia, la mossa
Nel discorso di dimissioni come presidente dell’Egitto, Nasser lanciò forti accuse su come si era sviluppata la guerra, e in
particolare contro Stati Uniti e Gran Bretagna, affermando che «it became very clear from the first moment that there were
other powers behind the enemy, they came to settle their accounts with the Arab national movement. …There is clear
evidence of imperialist collusion with the enemy, an imperialist collusion, trying to benefit from the lesson of the open
collusion of 1956, by resorting this time to abject and wicked concealment. Nevertheless, what is now established is that
American and British aircraft carrier were off the shore of the enemy helping his war effort». Vedi “Egyptian President
Gamal Abdel Nasser: Resignation Broadcast (June 9, 1967)” in The Israel-Arab Reader, op. cit., pp. 103-105.
Quando la guerra scoppiò, il sostegno statunitense era chiaramente dalla parte di Israele, nonostante l’iniziale affermazione
del Dipartimento di Stato per una neutralità ufficiale. È significativo su questo fatto che, alle minacce sovietiche di un
intervento anche militare, causate dalla violazione israeliana del cessate il fuoco sul fronte siriano negli ultimi due giorni dei
combattimenti, Johnson, come risposta, avrebbe dato disposizioni di mettere in stato di allerta la Sesta flotta nel
Mediterraneo orientale, e non di fermare con determinazione Israele.
144
degli arabi rifletteva la loro convinzione che gli Stati Uniti non erano neutrali nel conflitto e che
parteggiavano per Israele.145
L’interruzione delle relazioni diplomatiche fra gli Stati Uniti e parte del mondo arabo ebbero forti
ripercussioni negli anni del dopoguerra. Una volta che i rappresentanti arabi chiave furono assenti da
Washington, l’influenza politica dei loro Paesi ne risentì enormemente, e questo stallo diplomatico
andò tutto a favore di Israele.
L’Amministrazione americana non accusò apertamente Israele di aver intrapreso una guerra
preventiva a danno dei paesi arabi, e Johnson spiego nelle sue memorie i motivi di questa presa di
posizione:
«…I did not accept the oversimplified charge of Israeli aggression. Arab actions in the weeks before the
war started – forcing UN troops out, closing the Port of Aqaba, and assembling forces on the Israeli border –
made that charge ridiculous».146
3 Tra diplomazia e armi
3.1 La Risoluzione 242: analisi e interpretazione
Come conseguenza della guerra del giugno 1967, l’attenzione si concentrò dal campo di battaglia
verso l’arena diplomatica.
Anche l’Unione Sovietica interruppe le relazioni diplomatiche con Tel Aviv.
Citato in Steven Spiegel L., The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to
Reagan, op. cit., p. 149.
145
146
Si radunò il 17 giugno la quinta sessione speciale di emergenza dell’Assemblea Generale su
richiesta dell’Unione Sovietica vista l’impasse al Consiglio di Sicurezza, e nel complesso, il maggior
punto di accordo unanime emerso fra tutte le delegazioni al Palazzo di Vetro, il principio che la
conquista di territori per mezzo della guerra era inammissibile e contraria alla Carta dell’ONU.147
Anche perché, se fosse prevalso un qualsiasi timido compromesso sul tema, le Nazioni Unite avrebbero
subito gravi conseguenze di credibilità e aperto con questo precedente un varco per l’uso della forza
nelle controversie internazionali.
Il fattore che divideva i rappresentanti governativi risiedeva nella questione se il ritiro delle forze
militari israeliane dai territori occupati dovesse essere automatico o condizionato al riconoscimento del
mondo arabo del diritto all'esistenza, alla pace e alla sicurezza di Israele. Inoltre, esistevano contrasti se
il ritiro doveva essere per tutti i territori conquistati e in modo totale. L’Unione Sovietica condannò
l’aggressione di Tel Aviv ed esigeva un ritiro immediato e incondizionato dai territori arabi.
Gli Stati dell’America latina si pronunciarono a favore di un accordo globale che abbracciava
tutte le questione rimaste insolute. Presentarono un progetto di Risoluzione che richiedeva
urgentemente a Israele «to withdrawal all its forces from all the territories occupied by it as a result of
the recent conflict».
Più dura fu la proposta degli Stati non allineati che pretendevano, senza nessuna condizione, il
ritiro immediato allo status quo ante del 5 giugno. Entrambe queste iniziative, come altre ce ne furono,
non riuscirono a ottenere la maggioranza di dueterzi dell’Assemblea Generale. 148 La Gran Bretagna,
per bocca del ministro degli Esteri George Brown, era contraria a ogni ingrandimento territoriale come
esito delle operazioni belliche di giugno.
147
Il precedente di aggirare il Consiglio di Sicurezza in favore di un più ampio corpo internazionale fu la Risoluzione 377/V
dell’Assemblea Generale (3 novembre 1950), emanata durante la crisi coreana e caldeggiata dagli Stati Uniti. Più tardi
venne usata nel risolvere questione spinose come la crisi ungherese e di Suez nel 1956.
148
La delegazione israeliana votò contro il testo dei paesi non allineati e si astenne sul progetto degli Stati dell’America
latina.
Eban, nella dichiarazione del 19 giugno, difese strenuamente le ragioni dello Stato ebraico,
affermando che il diritto di Israele alla pace, alla sicurezza, alla sovranità, allo sviluppo economico e
alla libertà marittima era stato violentemente attaccato. 149 Questa aggressione, di cui il principale
imputato era il presidente egiziano Nasser, era stata attuata con l’imposizione del blocco degli stretti di
Tiran, un evidente atto di guerra che aveva obbligato Tel Aviv a un attacco preventivo e unilaterale:
una reazione e non un’iniziativa.
La mattina del 5 giugno, secondo il ministro degli Esteri israeliano, «when Egyptian forces
moved by air and land against Israel’s western coast and southern territory, our country’s choice was
plain. The choice was to live or perish, to defend the national existence or to forfeit it for all time».
Infine, dopo aver accusato l’Unione Sovietica di svolgere la parte di provocatore nella disputa
mediorientale e di elemento non costruttivo all’interno dell’ONU e soprattutto del Consiglio di
Sicurezza, Eban delineò la visione di una pace futura e le condizioni israeliane:
«In free negotiation with each of our neighbours we shall offer durable and just solutions redounding to
our mutual advantage and honour. The Arab states can no longer be permitted to recognize Israel’s existence
only for the purpose of plotting its elimination. They have come face to face with us in conflict. Let them now
come face to face with us in peace».150
Era chiara la volontà del governo israeliano di insistere in negoziati indipendenti con tutte le parti
coinvolte, senza l’ingerenza esterna di mediazioni da parte di altri Stati, essendo la parte forte uscita
dalla guerra dei Sei giorni, con la quale i Paesi arabi avrebbero dovuto dialogare per riottenere i territori
perduti. Soprattutto si cercava di inserire questo principio in un’eventuale risoluzione dell’ONU
menzionando le trattative dirette, simbolo dell’accettazione araba della legittimità di Israele come
Stato, ma senza successo.151
149
Per il testo vedi The Israel-Arab Reader, op. cit., pp. 105-110.
Vedi The Israel-Arab Reader, op. cit., p. 110.
151
Solo con la guerra dello Yom Kippur nell’ottobre del ’73, il Consiglio di Sicurezza approverà la Risoluzione 338 (22
ottobre) richiamando esplicitamente l’idea di negoziati diretti: « [il Consiglio di Sicurezza] decides that, immediately and
concurrently with the cease-fire, negotiations shall start between the parties concerned under appropriate auspices aimed at
establishing a just and durable peace in the Middle East».
150
Infatti, il documento finale approvato al vertice della Lega Araba a Khartoum sancì i principi
prioritari ai che gli Stati arabi erano tenuti a rispettare, ossia i famosi tre rifiuti a Israele, «no peace with
Israel, no recognition of Israel, no negotiations with it».152
Nel frattempo, il 27 giugno una legge della Knesset autorizzava l’annessione unilaterale di
Gerusalemme Est, inclusa la Città Vecchia con tutti i luoghi santi. Tale atto provocò una profonda
preoccupazione e indignazione internazionale, proprio nel momento in cui alla Nazioni Unite si
insisteva nell’affermare in modo unanime che nessun vantaggio avrebbe guadagnato uno Stato tramite
l’uso della forza militare. L’azione non fu comunque riconosciuta da alcun membro della comunità
internazionale.
Il 12 luglio, dopo una sospensione, ripresero i dibattiti all’Assemblea Generale e l’asse Stati
arabi-Unione Sovietica si rese conto che la richiesta di un ritiro immediato di Israele senza nessuna
corrispondente azione dei primi non avrebbe avuto nessuna probabilità di successo nel guadagnare i
necessari voti sia all’Assemblea Generale sia nel Consiglio di Sicurezza.
Alla sessione regolare dell’Assemblea Generale, riunitasi il 21 settembre, non ci fu alcuna nuova
notizia di sostanza che potesse sbloccare le posizioni dei principali attori: la responsabilità di trovare la
Il testo della Risoluzione 338 è presente nella sezione “Documenti” di questo lavoro.
152
Per il testo delle Risoluzioni vedi http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/khartoum.htm, The
Khartoum Resolutions; September 1, 1967, oppure nella sezione “Documenti” di questo lavoro.
Sebbene la dichiarazione di Khartoum dimostrò che non erano maturi i tempi per un compromesso
araboisraeliano, la conferenza fu una vittoria per i paesi arabi moderati, con in testa la Giordania di Re
Hussein, che cercarono di conseguire un ritiro israeliano attraverso mezzi politici e non militari.
Significativo è il seguente passaggio: «the Arab Heads of State have agreed to unite their political
efforts at the international and diplomatic level to eliminate the effects of the aggression and to ensure
the withdrawal of the aggressive Israeli forces from the Arab lands which have been occupied since the
aggression of June 5». Il rifiuto alla pace con Israele era interpretato dai portavoce arabi non come un
rigetto totale di uno stato di pace, il no ai negoziati diretti non come un rifiuto a colloqui attraverso
terze parti, e il no al riconoscimento de iure non equivaleva al rifiuto dell’esistenza de facto di Israele
come Stato. Inoltre, pur riconoscendo la potenzialità della risorsa petrolifera, che disponeva la maggior
parte del mondo arabo, come arma politica di pressione nella disputa mediorientale, viene decisa la
ripresa delle esportazioni del greggio.
giusta formula per risolvere il conflitto araboisraeliano, ulteriormente complicato e aggravato dalla
guerra di giugno, venne affidata al Consiglio di Sicurezza.
Il rappresentate britannico alle Nazioni Unite Lord Hugh Caradon, che aveva migliori relazioni
con il Cairo di quanto ne avessero gli Stati Uniti, sottopose un progetto di risoluzione nella speranza di
raggiungere un accordo unanime sul testo, in modo da sostenere un forte segno politico internazionale
per la soluzione mediorientale. Infatti, proprio così andarono le cose il 22 novembre con l’approvazione
della Risoluzione 242, pietra miliare per un compromesso politico fra terra e pace, avendo la meglio
sulle altre proposte sponsorizzate rispettivamente dai Paesi non allineati, dagli Stati dell’America
latina, dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica.
La struttura della Risoluzione 242 consiste in un preambolo dove vengono spiegate le ragioni e i
motivi che hanno portato alle decisioni, le quali sono incorporate in quattro paragrafi operativi. Di
seguito vengono analizzate alcune delle frasi più importanti, principi o decisioni, che hanno dato adito
a differenti interpretazioni e contrasti fra le parti interessate.
«The inadmissibility of the acquisition of territory by war». Questo importante principio cardine
del diritto internazionale consuetudinario e delle Nazioni Unite intende significare che l’occupazione
militare di uno o più territori, sebbene non condanni quella temporanea, non conduce all’acquisizione
di un diritto di proprietà; non può portare al suddetto diritto persino quando il cambiamento viene
sanzionato da un trattato internazionale come risultato della conquista.153 Inserito intenzionalmente nel
preambolo, dove sono stabiliti gli obiettivi fondamentali (di fondo) della Risoluzione e alla luce del
153
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (adottata il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980)
nell’art. 52 (« coercion of a State by the threat or use of force») afferma che «a treaty is void [nullo] if its conclusion has
been procured by the threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the
United Nations». Ma anche l’art. 2 par. 4 della Carta ONU sostiene questo principio.
Per il testo integrale vedi http://www.greenpeace.org/~intlaw/vien-tr.html.
quale tale documento deve essere interpretato, rafforza la disposizione operativa sul ritiro delle forze
armate israeliane (vedi oltre).
Il testo sovietico usa al posto della parola “acquisition” il più colorito ed efficace termine di
“seizure” [conquista, cattura], mentre in quello statunitense lo stesso punto non compare.
Il governo israeliano e i suoi sostenitori hanno sostenuto che l’uso della forza nel giugno 1967
fosse legittimo e non illegale come risposta a una minaccia alla sicurezza dello Stato ebraico, e
conseguentemente il principio in esame si riferirebbe solo a una conquista territoriale come risultato di
una guerra di aggressione, come disse l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Gideon Rafael. La
questione è irrilevante poiché se anche l’operazione militare fosse stata un’azione difensiva
conformemente all’art. 51 della Carta ONU, Israele deve cessare ogni attività «fintantoché il Consiglio
di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».
In altre parole, lo Stato ebraico è obbligato ad attenersi alle disposizioni della Risoluzione 242 senza
tenere conto della natura difensiva o aggressiva della guerra.
«Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict». Il primo
paragrafo operativo fece nascere forti controversie sull’interpretazione esatta della disposizione fra il
blocco filo-arabo e quello filo-israeliano. Lo strumento che ci viene in aiuto è la già citata Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati agli artt. 31-33.154
Partendo dall’analisi letterale, separata dall’intero documento, come del resto è evidenziato
nell’art. 31 par. 1 di Vienna, notiamo come a seconda della lingua con cui è redatto il testo della
Risoluzione si arrivi a conclusioni diverse.
154
Una premessa è obbligatorio eseguirla poiché le norme di diritto internazionale di questa convenzione dovrebbero essere
applicate esclusivamente a trattati stipulati fra Stati (art. 1 «the present Convention applies to treaties between States») e
all’art. 4 sanziona l’irretroattività della presente convenzione («… the Convention applies only to treaties which are
concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States»). Tuttavia quest’ultima
può essere utilizzata per analogia in riferimento alle Risoluzioni ONU che necessariamente non sono dei trattati ma degli
atti di diritto internazionale adottati da un organo consiliare di una organizzazione. Molte norme di questa convenzione
furono una codificazione dell’esistente diritto internazionale consuetudinario.
Nella versione inglese, la deliberata omissione dell’articolo determinativo “the” rende la frase
vaga e indefinita, lasciando aperta l’interpretazione sia per un ritiro israeliano da alcuni ma non
necessariamente da tutti i territori occupati, sia per la possibilità implicita di un riferimento alla totalità
di questi.
La versione francese risolve ogni ambiguità del testo poiché esige che «retrait des forces armées
israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit», dove, senza ombra di dubbio, domanda un
ritiro completo da tutti i territori occupati.155
Quindi, se accettiamo la versione francese del testo come la più precisa e accurata, se
consideriamo le formulazioni inglese e francese non come incompatibili, se tutto questo è avvalorato
anche dal testo spagnolo della Risoluzione («retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios
que ocuparon durante el reciente conflicto»), ma soprattutto se si collega la clausola
dell’inammissibilità dell’acquisizione di territori con la guerra, si giunge ad affermare che la “clausola
sul ritiro” si interpreti come un totale abbandono dei tutti i territori occupati.
L’art. 33 par. 1 di Vienna rafforza questo punto di vista poiché respinge la preferenza di un testo
originale (nel nostro caso in inglese) sugli altri egualmente ufficiali e autorevoli, e il par. 4 dispone che,
salvo il caso in cui un testo determinato sia destinato a prevalere, «when a comparison of the authentic
texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the
meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be
adopted».
Un altro metodo di interpretazione è il ricorso ai documenti ufficiali preparatori che hanno
anticipato l’adozione della Risoluzione.156 Dai dibattimenti sia all’Assemblea Generale sia al Consiglio
155
Nel 1967 il Consiglio di Sicurezza utilizzava 5 lingue ufficiale per redigere i suoi documenti (inglese, francese, spagnolo,
russo e cinese), delle quali inglese e francese erano anche le lingue di lavoro. Non esiste l’articolo determinativo nella
lingua russa e cinese e, di conseguenza, non può esserci alcuna distinzione fra “withdrawal of Israel armed forces from
territories” e “ withdrawal of Israel armed forces from the territories”.
di Sicurezza, emerge con chiarezza che il principio di un completo ritiro, a prescindere dall’eventualità
di condizionarlo ad alcune concessioni da parte del mondo arabo, è stato il comune denominatore di
tutti i membri delle Nazioni Unite. Inoltre, non ci fu alcun rifiuto esplicito contro l’interpretazione di
totale ritiro.
«Secure and recognized boundaries». Dopo aver introdotta la richiesta della conclusione di ogni
rivendicazione o stato di belligeranza, questa frase è stata citata come prova definitiva per affermare
che a Israele non fosse richiesto il ritiro militare da tutti i territori arabi occupati. In breve, il pieno ritiro
non era automatico o incondizionato né totale.
Alla luce dell’analisi della “clausola del ritiro” che poc’anzi è stata fatta, non sembra che fino a
quando Israele, in modo unilaterale, non si sente sicura nei suoi confini del 1949 abbia il diritto di
rimandare indefinitamente il ritiro dai territori, senza svuotare la sostanza del preambolo della
Risoluzione e della versione francese (e spagnola) della stessa. La difendibilità di una linea di confine è
solo un aspetto della sicurezza. Infatti, parole come “secure” e “recognized” comportano che la
sicurezza dei confini è il prodotto di un riconoscimento vincolante internazionalmente tramite accordo
e di un’assenza di minacce e atti di forza, piuttosto di una situazione difendibile militarmente.
In breve, questa espressione non giustifica il mantenimento da parte d’Israele di qualsiasi
territorio occupato.
L’art. 32 di Vienna afferma che «recourse may be had to supplementary means of interpretation,
including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to
confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the
interpretation according to article 31 a) leaves the meaning ambiguous or obscure or b) leads to a result
which is manifestly absurd or unreasonable». Secondo la comune dottrina internazionalista, non è
ammesso valersi dei lavori preparatori se il testo di un documento è sufficientemente chiaro, nemmeno
se questi lo contraddicono apertamente. I lavori preparatori devono generalmente confermare e
rafforzare l’interpretazione ottenuta con gli altri metodi.
156
«Territorial integrity… territorial inviolability and political independence of every State in the
area». Principio che conferma l’interpretazione della “clausola sul ritiro”, ma che sostenitori
filoisraeliani hanno avanzato due contro argomenti.
Il primo sostiene che l’integrità territoriale si applica solo dopo aver ridisegnato i confini secondo
i canoni di sicurezza e di consenso fra le parti, ma è contraria al senso comune della Risoluzione.
La seconda rivendicazione risiede nel fatto che nei territori occupati nessun Stato arabo ha un
valido titolo legale internazionale. Circa la penisola del Sinai e le alture del Golan il ragionamento è
infondato, poiché l’impero ottomano ha rinunciato formalmente all’Egitto (incluso la penisola del
Sinai) nel 1923, mentre il trasferimento delle alture del Golan dalla Palestina mandataria alla Siria è
avvenuto tramite un accordo franco-britannico del 1923 sanzionato dal Consiglio della Società delle
Nazioni.
Per quanto riguarda i territori della striscia di Gaza, della quale l’Egitto ha continuato ad
amministrarla fino alla guerra dei Sei giorni ma mai annessa, e la Cisgiordania dove l’annessione
ufficiale al regno hascemita (4 aprile 1950) risulta di dubbia validità legale, la situazione è complessa e
coinvolge, inter alia, il piano di spartizione dell’Assemblea Generale dell’ONU e il principio di
autodeterminazione dei popoli.157
«A just settlement of the refugee problem». Dure proteste da parte dell’intero mondo arabo per
questa proposizione, in particolare perché tralasciava e ignorava il popolo palestinese e il diritto di
avere uno Stato.
Durante il discorso tenuto il 19 giugno 1967, il presidente americano Johnson mancò di
qualificare i rifugiati nell’accenno che fece, e venne confluito esattamente nella Risoluzione 242
nell’identico modo. Senza essere maestri esoterici, la voluta mancata menzione dell’aggettivo
L’incorporazione della West Bank da parte della Giordania è stata energicamente contrastata dalla Lega araba, e soltanto
la Gran Bretagna e il Pakistan riconobbero de iure questo atto.
157
‘palestinese’ può soltanto essere interpretata in una maniera: significa la non riconoscenza del
problema palestinese, dell’identità nazionale di questo popolo e della sua aspirazione ad avere una
propria terra, come sancisce il diritto internazionale di autodeterminazione.
L’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP, nata il 29 maggio 1964) e il suo popolo
venivano trattati solo come “profughi” e non come una “nazione” con dei diritti. Era sì, e continuava a
essere, un problema umanitario (impegno per la costruzione di campi profughi, assistenza ai rifugiati)
ma non politico, e i palestinesi venivano considerati come oggetti e non come soggetti che disponevano
di qualche diritto fondamentale.
Sicuramente un grave errore delle Nazioni Unite, ma soprattutto degli Stati Uniti. Per questi
motivi, l’unico paese che pubblicamente respinse la Risoluzione 242 fu la Siria, e solo nel maggio 1974
venne accettata dal regime di Damasco assieme alla Risoluzione 338, sempre del Consiglio di
Sicurezza.
Come la Dichiarazione Balfour nel 1917 aveva fatto riferimento al rispetto dei diritti civili e
religiosi ma non politici delle comunità non-ebraiche in Palestina non riconoscendo la popolazione
indigena, così, cinquanta anni dopo e con gran parte della decolonizzazione già avvenuta, si cercava
ostinatamente di soffocare le legittime aspirazioni di un popolo, che, proprio come conseguenza della
guerra dei Sei giorni, accelererà la coscienza nazionale per resistere all’occupazione militare israeliana.
«Designate a Special Representative… in order to promote agreement and assist efforts to
achieve a peaceful and accepted settlement». Il terzo paragrafo operativo consente al Segretario
Generale delle Nazioni Unite di nominare un Rappresentante speciale con l’obiettivo di stabilire,
facilitare e mantenere i contatti con gli Stati interessati.
In questo ambito, poiché Israele richiedeva insistentemente la formula di negoziati diretti con gli
Stati arabi sconfitti in guerra, esisteva il timore che i “buoni uffici” si trasformassero in mediazione o
addirittura in arbitrato, con un grado di ingerenza esterna inaccettabile per lo Stato ebraico. La prima
versione della proposta britannica, secondo Eban, attribuiva al Rappresentante Speciale dell’ONU il
potere di dettare un accordo, ma la formulazione del testo finale della Risoluzione 242 (“promote”,
“assist”) spuntava la sua forza per limitarla a una missione di cooperazione, insufficiente per la
risoluzione di un così grave problema.
La Risoluzione 242 deve essere inserita in quegli atti dell’ONU che presentano diverse
caratteristiche: il preambolo e i primi due paragrafi operativi descrivono principi e richieste necessarie
sulle quali poter basare i termini di un accordo globale (secondo l’art. 37 ONU), i paragrafi operativi
tre e quattro stabiliscono procedure o metodi di accomodamento (secondo l’art. 36). In pratica, anche se
non esiste un’esplicita citazione al capitolo VII o VI della Carta ONU, è certo che la Risoluzione 242
ricada entro le disposizioni di quest’ultimo, trattandosi di raccomandazioni (ma anche di decisioni) per
la soluzione pacifica delle controversie.
Essere riusciti a premere per un testo finale votato all’unanimità nel quale la portata e la
dimensione erano lasciati nel vago (nella versione inglese), rappresenta una delle più grandi vittorie
diplomatiche a favore dello Stato ebraico. Secondo Eban, ciò dette a Israele la possibilità per una
revisione territoriale («territorial revision») proprio perché il principio (o la clausola) sul ritiro non era
applicabile a tutti i territori coinvolti, quindi il ritiro poteva non essere completo a discrezione del
governo israeliano, appellandosi al diritto di Israele di avere «confini sicuri e riconosciuti». 158
Israele resistette a ogni sforzo per non far introdurre nella Risoluzione un completo ritiro delle
proprie forze militari, e fece forti pressioni sul governo statunitense affinché non accettasse al
Consiglio di Sicurezza un testo preciso in riguardo, perché era impensabile un ritorno alla vecchia linea
158
Vedi Norman Finkelstein G., Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, op. cit., p. 145.
di armistizio (“Linea Verde”). In effetti, fin dall’inizio dei dibattiti alle Nazioni Unite, Washington
aveva preferito dichiarazioni meno chiare sul ritiro israeliano.159
L’ambasciatore statunitense all’ONU Arthur Goldberg era consapevole che secondo la
Risoluzione 242 Israele doveva ritirarsi da tutti i territori occupati, ma dichiarò che minori e reciproci
aggiustamenti territoriali nella West Bank erano necessari per ragioni di sicurezza in cambio della pace.
Washington appoggiava la posizione israeliana di una revisione territoriale.
Nella “clausola sul ritiro”, Lord Caradon spiegò l’omissione dell’articolo determinativo «the» nel
testo inglese come una necessità data dal fatto che i confini antecedenti al 5 giugno fossero irregolari, e
il Segretario di Stato americano Dean Rusk riteneva che il lungo confine fra Israele e la West Bank
andasse razionalizzato.160
Per ricapitolare l’interpretazione che qui viene prospettata, la risoluzione 242 nel suo complesso
esige il ritiro totale da qualsiasi territorio posto sotto l’occupazione militare dell’esercito israeliano,
poiché la “clausola del ritiro” è strettamente vincolata con il “principio di non ammissibilità della
conquista territoriale per mezzo della guerra”, a prescindere della legittimità internazionale dell’attacco
militare.
L’ambiguità fra la forma inglese e quella delle altre lingue autentiche in ambito ONU, viene
superata dal fatto che queste ultime chiarificano e precisano (e non contraddicono) la suddetta
interpretazione sulla “clausola sul ritiro”. In aggiunta, i lavori preparatori avvalorano questo principio.
Il riferimento ai confini sicuri e riconosciuti può essere interpretato in diversi modi, ma senza
confutare il principio prioritario del pieno ritiro. Qualsiasi minore modificazione delle linee di confine
159
Il testo della proposta americana del 7 novembre 1967 afferma la necessità per un «withdrawal of forces from occupied
territories». Un espressione alquanto generale, sebbene il ritiro fosse chiaramente riconducibile alle truppe israeliane, ma
con il primario scopo di lasciare aperto la natura e l’estensione di questo. Vedi Sidney Bailey D., The Making of Resolution
242, Dordrecht – Boston – Lancaster, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, pp. 146, 148.
160
Vedi Norman Finkelstein G., Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, op. cit., pp. 146-148.
del 1949 a Gaza e nella West Bank deve essere raggiunta tramite negoziati diretti specifici che siano
equilibrati e soprattutto reciproci, senza violare questo principio.161 La Risoluzione 242 è stata accettata
dall’Egitto dopo diverse settimane, da Israele formalmente nel maggio 1968, anche se Golda Meir
appoggiò la risoluzione pubblicamente nel maggio 1970, dalla Siria dopo più di sei anni (maggio 1974,
un ritorno al tavolo delle trattative dal lontano 1949, con gli accordi di armistizio), e l’OLP la accettò
solamente nel 1988 (14 dicembre).
Molti addetti ai lavori hanno creduto che la Risoluzione 242, adottata all’unanimità con principi,
decisioni e procedure allo scopo di giungere a una pace globale, terminava una questione che fino ad
allora era ancora aperta, anzi, la ferita si era aperta e lacerata ulteriormente con la guerra dei Sei giorni.
Le verità è che ogni decisione delle Nazioni Unite risulta essere spesso solo un primo passo per
iniziare a risolvere problemi reali e complessi, e un’azione internazionale vigorosa è necessaria per
convertire un accordo espresso con una formula verbale a New York in realtà. Per i diplomatici la
Risoluzione 242 sembrava la fine di un processo, invece i tentativi di Jarring per facilitare un accordo
ricevette un insufficiente sostegno da parte della grandi potenze, non all’altezza della grave questione
su cui dovette impegnarsi.
161
Un giusta interpretazione della Risoluzione 242 è incorporata nel piano Rogers, Segretario di Stato americano durante la
presidenza Nixon fino al settembre 1973, dove proprio nel punto riguardante la questione territoriale fra Israele e gli Stati
arabi limitrofi dichiarò ufficialmente l’11 dicembre 1969: «noi riteniamo che se è vero che i confini politici riconosciuti
debbono essere stabiliti e accettati dalle parti, tuttavia nessuna delle modificazione nelle linee di confine preesistenti dovrà
recare il marchio della vittoria; ciascuna modificazione dovrà limitarsi alle rettifiche di poco conto richieste dalle esigenze
di mutua sicurezza. Noi non tolleriamo l’espansionismo. Crediamo alla necessità del ritiro delle truppe conformemente alla
risoluzione [242]. Ci sta altrettanto a cuore la sicurezza di Israele quanto la sicurezza degli Stati arabi». Citato in Henry
Kissinger A., Gli Anni della Casa Bianca, SugarCo, 1980 (tit. or.: White House Years, Boston, Little, Brown and Company,
1979), p. 301. Questa iniziativa era stata ideata specificamente per risolvere la disputa fra Egitto e Israele, ma il 18 dicembre
successivo fu avanzato un altro piano dal Dipartimento di Stato in linea con il precedente e indirizzato questa volta al fronte
orientale, tra Israele e Giordania. Il 22 dicembre 1969 arrivò il netto e irrevocabile rifiuto da parte del governo di Tel Aviv.
In questo caso, l’opposizione a cedere anche un minima parte del territorio illegalmente occupato della Cisgiordania, era più
intenso: oltre a secondari problemi di sicurezza, la Samaria e la Giudea rappresenta per gli israeliani la biblica terra e culla
dei Patriarchi; un aspetto, quello religioso, che sarà quasi impossibile estirpare dalla mente di gran parte della società
ebraica.
È significativo notare l’impressione che ebbe Nixon del Primo ministro laburista israeliano Golda Meir durante la visita di
questa a Washington il 25 settembre 1969, appena due anni dopo la guerra dei Sei giorni: «in Israeli terms she was a
“hawk”, and a hard-liner opposed to surrendering even an inch of the occupied territory Israel had won in the 1967». Vedi
Richard Nixon M., RN. The Memoirs of Richard Nixon, op. cit., p. 478.
Ogni errore può essere un fattore determinante per un futuro errore, e ancora oggi, dopo quasi 35
anni di distanza, la Risoluzione 242 per la maggior parte non è stata applicata.
3.2 Armi per Israele
Nel tardo settembre 1967, gli Stati Uniti assicurarono agli israeliani che le consegne di aerei
Skyhawks pattuiti nel 1966 sarebbero state eseguite senza ritardi, così come, nel tardo ottobre, la
fornitura di attrezzature militari a cinque Stati arabi moderati e filo-occidentali ordinati prima dello
scoppio della guerra dei Sei giorni. L’ondata di radicalismo arabo esplosa in seguito alla conquista di
vasti territori da parte dell’esercito israeliano fornì all’Amministrazione americana il timore che Mosca,
con la sua massiccia ricostruzione degli eserciti dei suoi clienti, poteva creare uno squilibrio di potere
nell’area mediorientale.
Nel campo degli aiuti militari che gli Stati Uniti potevano concedere a Israele, diversi fattori
diedero a quest’ultimo e ai suoi sostenitori una più energica posizione di quella che poteva avere
nell’arena diplomatica:
L’impegno americano per un equilibrio di potere regionale (idea esplicitata poi con la “Dottrina
Nixon” nel luglio 1969 e ufficialmente pronunciata davanti al Congresso nel febbraio
1970)162 significava che l’argomento per le armi era più potente (e impellente) di altri
problemi, come quello delle disposizioni territoriale o su una sistemazione pacifica della
questione mediorientale
Con il cambiamento politico francese sulla regione, lo spostamento vicino alle posizioni arabe,
e in sostanza la chiusura alle armi di Parigi, gli Stati Uniti rappresentavano l’unica meta che
poteva rifornire gli arsenali israeliani di materiale altrettanto sofisticato
162
Vedi Public Papers of the Presidents of the United States, Richard Nixon 1970 “First Annual Report to the Congress on
United States Foreign Policy for the 1970’s”, February 18, 1970, p. 118 e ss., p. 126 e ss..
È sempre stato più facile per i sostenitori americani dello Stato ebraico fare una campagna per
l’assistenza materiale rispetto al sostegno diplomatico, particolarmente perché il Congresso è
depositario del potere e della responsabilità, costituzionalmente garantite (Art. 1, sezione 8°),
di assegnare i fondi finanziari (e Capitol Hill è notoriamente filoisraeliana)
Una richiesta in tal senso (“arms issue”), fatta dal governo israeliano, allerta membri del campo
pro-Israele e inizia la discussione. Possono sollecitare il sostegno del Congresso o di alcuni
simpatizzanti del Pentagono, appellarsi direttamente al presidente americano ogni qual volta c’è
un’opposizione dai vertici del Dipartimento di Stato e/o di Difesa.
Sulle questioni diplomatiche (“diplomatic issue”), i fautori delle posizioni israeliani non riescono
a venire a conoscenza delle iniziative del Dipartimento di Stato fino a quando è troppo tardi per
incidere e influenzare il processo decisionale all’interno della struttura burocratica. Non rimane che
reagire passivamente.163 Su questioni diplomatiche intricate, inoltre, il presidente ascoltava gli esperti
di politica estera più che i gruppi d’interesse.
L’atmosfera politica creata dalla guerra del Vietnam ha reso più favorevole la vendita di
armamenti a Israele, poiché la politica di intervento delle forze militari americane in altri teatri, come lo
era il Medio Oriente, fu totalmente scartata, a favore di una politica indiretta di sostegno alla sicurezza
di Stati regionali cardini, ad esempio la stessa Israele, Iran, Giappone.
Di notevole importanza fu il contributo che Israele, con la vittoria schiacciante nella guerra dei
Sei giorni, dette alla sicurezza degli Stati Uniti; infatti, grazie all’esperienza del conflitto e alla cattura
di attrezzature e apparecchiature sovietiche, fornì rilevanti informazioni militari che poi saranno
163
Una dimostrazione eloquente è stato proprio la presentazione pubblica del (primo) Piano Rogers il 9 dicembre 1969,
dove il governo israeliano non ricevette nessuna parola, ufficiale o non ufficiale, in anticipo del discorso; neanche dai
sostenitori del paese ebraico nel Congresso. Cfr. Seymour M. Hersh, The Price of Power. Kissinger in the Nixon White
House, op. cit., p. 220. Un altro esempio riguarda la proposta di Rusk avanzata nell’ottobre 1968 al ministro degli Esteri
egiziano, che conteneva sette punti per un possibile accordo di pace tra Israele ed Egitto ma «without apprising Jerusalem of
the contents or even the existence of a plan». Vedi Steven Spiegel L., The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s
Middle East Policy, from Truman to Reagan, op. cit., pp. 157-158.
sfruttate dall’esercito americano in Indocina. Anche la chiusura del canale di Suez impedì il
rifornimento militare di Mosca alla volta del Vietnam.
Il nuovo equilibro delle forze interne della società americana fu messo alla prova con la richiesta
israeliana di acquistare gli aerei Phantom. Il governo israeliano premeva sugli Stati Uniti per mantenere
e incrementare la superiorità militare per neutralizzare qualsiasi attacco sferrato dai paesi arabi
limitrofi, In particolare la sua attenzione era concentrata su un tipo di aereo offensivo, il
cacciabombardiere F-4 Phantom dotato di alta tecnologia. Considerati gli eventi della guerra dei Sei
giorni, era indispensabile per Tel Aviv garantire la sicurezza controllando i cieli.
Il 7-8 gennaio 1968 ebbe luogo un incontro nel ranch del presidente Johnson in Texas con alcuni
esponenti israeliani, tra cui il Primo ministro Eshkol e l’ambasciatore Avraham Harman. Scopo
principale per il governo israeliano era la richiesta pressante ed esplicita di 50 F-4 Phantom, visto il
repentino recupero da parte dell’Egitto (UAR) della sua temerarietà militare grazie all’enorme e rapido
afflusso di materiale bellico sovietico. Priorità era la sicurezza di Israele e il deterrente militare andava
certamente bene.
La politica di Tel Aviv sostanzialmente era di perseguire negoziati diretti che avrebbero condotto,
in un non determinato futuro, ai trattati di pace con tutti i paesi arabi limitrofi alla sue condizioni. Per
fare ciò, Israele doveva assolutamente aumentare, o quantomeno mantenere, la sua posizione negoziale
e aspettare, senza forzare i tempi, il riconoscimento internazionale dei suoi interlocutori per aprire la
strada alla pace.164
Johnson indicò come condizione alla spedizione degli aerei, la mancata intesa con l’Unione
Sovietica circa un accordo sulla limitazione degli armamenti nella regione e, per l’eventualità di
onorare la promessa, diede ordine di mettere in produzione 50 Phantom. Privatamente fornì della
Nell’intervento di apertura, Eshkol rivendica addirittura che «the Six-Day War blocked the taking over of the Middle
East by the Soviet Union». Vedi FRUS, 1964-1968, Vol. XX, Arab-Israeli Dispute, 1967-1968, doc. 39, Memorandum of
Conversation, National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1967-69, POL ISR-US. Secret; Nodis.
164
rassicurazioni ancora più significative. Il comunicato ufficiale rilasciato alla fine dell’incontro
testimoniava la stretto ed intimo rapporto fra i due Paesi, con l’impegno americano di mantenere la
sicurezza di Israele sotto controllo e con la ferma dichiarazione di aumentare gli accordi nell’area.
Mentre la Casa Bianca, con in testa il presidente Johnson, era favorevole alla vendita dei
Phantom, la burocrazia governativa, comprese le sue varie agenzie, era nella quasi totalità contraria
all’operazione:
-
Il Dipartimento di Stato, in special modo l’ufficio per il Vicino Oriente, considerava la
risposta positiva di Johnson un ostacolo ai rapporti con gli Stati arabi (nel momento in cui
alcuni di essi avevano rotto i rapporti diplomatici con gli USA, come conseguenza della
guerra dei Sei giorni), protestando che questi costi politici non sarebbero stati compensati da
nessun beneficio per gli Stati Uniti. Molti funzionari sottolineavano il fatto che Israele non
aveva bisogno dei Phantom perché le sue forze militari erano già grandemente superiori a
quelle arabe, e la dimostrazione erano stata data con il conflitto del giugno ’67. 165 Altri si
opposero alle stime che Israele aveva fatto delle spedizioni di armi sovietiche agli arabi;
diversi affermavano che avrebbero intralciato i negoziati diplomatici, già enormemente
difficili avendo creato la guerra dei Sei giorni un abisso fra le parti. Alcuni funzionari
diffidavano di Israele, che non cooperava con il mediatore ONU Jarring e aveva ritardato
l’esplicita accettazione della Risoluzione 242. Infine, qualche funzionario voleva il ritiro
totale dai territori occupati nel giugno del 1967 come condizione per ricevere i jet.
-
Il Dipartimento alla Difesa era convinto che l’accordo militare fra Israele e gli Stati Uniti
fosse un fattore destabilizzante nell’equilibrio dei poteri regionali: il Paese ebraico non
necessitava di armi di difesa (ricordiamo che il Phantom è un velivolo offensivo). Alcuni
165
Al contrario, si può supporre che il governo israeliano necessitava una maggiore forza militare per mantenere il controllo
sui territori conquistati e su una popolazione ostile, e doveva tenersi pronto per una scontata reazione militare da parte dei
Paesi arabi (anche se non si aspettava di certo una guerra a larga scala e a breve scadenza), tenuto conto soprattutto del
fattore sovietico per il recupero della forza degli eserciti arabi.
dirigenti erano dell’idea di negare o trattenere il pacchetto di aerei fino a che Israele non
avesse aderito al trattato sulla non proliferazione nucleare,166 una questione assai importante
per la politica estera americana. Tel Aviv era riluttante a firmare e a ratificare il trattato e alla
fine non lo fece.
-
Anche la CIA non credeva che Israele avesse bisogno di armi da difesa e tantomeno quelle
offensive: l’agenzia, tuttavia, non rifletteva una posizione politica ma soltanto amministrativa
e burocratica.
Nell’affrontare la quasi compatta opposizione della burocrazia governativa, i sostenitori di Israele
usarono tutti i loro mezzi a disposizione per influenzare, convincere, fare pressioni al fine di spuntarla
nel confronto politico interno. L’AIPAC167 (American Israel Public Affairs Committee) era molto
attiva e riuscì ad avere dichiarazioni di appoggio alle vendita dei Phantom da entrambi i candidati
presidenziali e dibattiti sulla questione in ogni convention di partito.
Agli inizi del 1968, il governo israeliano inviò come ambasciatore a Washington Yitzhak Rabin,
capo di Stato Maggiore delle forze israeliane durante la guerra dei Sei giorni nel giugno del 1967,
credendo che un emissario con alle spalle un’ottima esperienza militare potesse meglio persuadere il
governo americano a vendere i Phantom. La Casa Bianca aveva lasciato intendere che il Presidente
166
NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, trattato multilaterale sottoscritto e ratificato da Stati Uniti, Regno Unito, Unione
Sovietica e altri Stati, e firmato il 1° luglio 1968 per impedire la diffusione di armi nucleari e assicurare che i programmi
nucleari pacifici di Stati che non hanno lo status di potenza atomica, passino alla produzione militare. Si trattava
ovviamente di un trattato diseguale poiché sanciva l’egemonia permanente delle potenze nucleari. Il suo significato politico
era evidente: gli Stati Uniti rinunciavano per sempre al riarmo atomico della Germania federale in cambio della condanna
sovietica del riarmo atomico cinese. Infatti, sia la Francia di de Gaulle sia la Cina di Mao Tzetung rifiutarono di firmare il
trattato ed entrambe causarono degli affetti politici, differenti nella misura: Parigi si distaccò dalla NATO (dissociazione
organizzativa e non politica) , più formale e psicologico che sostanziale; Pechino si scontrò con i reparti dell’esercito
sovietico sull’isola Ussuri nel marzo e agosto 1969.
Pochi giorni dopo, precisamente nella notte fra il 20 e il 21 agosto, i carri armati del Patto di Varsavia invadevano e
stroncavano nel sangue la “primavera di Praga”, facendo evaporare il clima di fiducia creato dalla firma del NPT. Solo con
l’avvento della nuova Amministrazione di Nixon si potrà riallacciare, con il grande disegno della distensione (“détente”,
“linkage”, “negotiation”, “structure of peace”) le file di un dialogo a tutto campo, a iniziare fra le due superpotenze, che
produrrà enormi cambiamenti mondiali (politici e militari). Nel maggio del 1995, il trattato di non proliferazione nucleare
divenne permanente.
167
L’indirizzo internet del sito dell’AIPAC è http://www.aipac.org/.
esigeva una preventivo sostegno del Congresso per procedere all’autorizzazione della vendita, anche se
nessuna azione del ramo legislativo era necessaria per la vendita di armi.
Senza sorprese, sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato la maggior parte dei politici
americani si schierò dalla parte di Israele. Alla metà di luglio, una modifica alla legge, il Foreign
Assistance Act, fu discussa alla Camera dei Rappresentanti e il deputato Lester Wolff di New York
praticamente ordinò, con un emendamento, al presidente americano di vendere non meno di 50
Phantom a Israele. L’emendamento passò come parte del Foreign Aid Bill. Wolff aveva agito senza
consultare l’AIPAC, i suoi colleghi al Congresso o i leader ebraici, sfidando l’autorità dei Johnson e
obbligandolo persino nel numero degli aerei da consegnare.
Al Senato, Frank Church escogitò un cambiamento all’emendamento che era stato votato alla
Camera, indicando il sostegno congressuale alla vendita di aerei supersonici a Israele, senza specificare
il numero. Questo secondo emendamento passò al Senato il 31 luglio 1968 come la versione del
Foreign Aid Bill, e, con il sostegno dell’Amministrazione e dei filoisraeliani, la conferenza del
comitato misto Camera-Senato approvò l’emendamento del senatore Church prima della sospensione
per le convention dei partiti democratico e repubblicano.
L’8 settembre 1968, i due candidati presidenziali, Humphrey e Nixon, rilasciarono dichiarazioni
di sostegno alla vendita dei Phantom, ma il presidente Johnson, qualche giorno dopo, mise l’accento
sulla ricerca di un accordo con l’Unione Sovietica sulla limitazione degli armamenti da inviare in
Medio Oriente, senza fare nessun accenno agli aerei Phantom. Il New York Times riportò queste
indiscrezioni creando apprensioni nella comunità ebraica in America, ma Johnson raffreddò gli animi,
definendo l’articolo del giornale “completely inaccurate” (totalmente inesatto) e dichiarando che non
aveva ancora deciso sulla questione; ma soggiunse che il comunicato ufficiale di gennaio era ancora
operativo.
Quando il Congresso fu riconvocato a metà settembre, la nuova versione del Foreign Assistance
Act, con l’emendamento Church, venne approvata rapidamente da entrambe le Camere. Il 9 ottobre
1968, Johnson firmò la legge, prendendo nota del buon senso del Congresso americano e diede ordine
al Segretario di Stato di iniziare i negoziati con la controparte israeliana che cominciarono appena
cinque giorni dopo, il 14 ottobre.
Coerentemente con la politica fissata nel gennaio precedente nel suo ranch, il presidente
americano agì solo dopo che gli incontri fra Gromyko e Rusk avevano manifestato chiaramente
l’intenzione sovietica di non ricercare, per ovvie ragioni di opportunità politica, un accordo sulla
limitazione delle armi nell’area.
I fattori che pesarono sulla decisione di Johnson furono:
-
Dopo l’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia (21 agosto
1968), era più difficile instaurare un proficuo dialogo persino ad alti livelli fra le due
superpotenze
-
Entrambi i candidati alla presidenza americana e una larga maggioranza nel Congresso
avevano appoggiato la richiesta israeliana per la vendita di Phantom da parte di Washington
-
La consapevolezza di Johnson che la scelta filoisraeliana sulla questione della armi, avrebbe
dato al vicepresidente in carica e candidato alla presidenza Humphrey credito politico nei
confronti della potente lobby ebraica in America, anche se Nixon annunciò dichiarazioni della
stessa natura
Nella soluzione di questo difficile problema, Johnson si comportò nello stesso modo in cui aveva
affrontato la crisi del maggio-giugno 1967: era necessario il sostegno politico del Congresso.
L’approvazione della vendita dei Phantom fu data al governo israeliano il 7 novembre e il contratto di
fornitura venne firmato il 28 dicembre 1968 con l’annuncio che i primi aerei sarebbero arrivati nel tardi
1969.
La burocrazia168 fece l’ultimo tentativo per ritardare l’operazione. Un funzionario del
Dipartimento della Difesa, Paul Warnke, assistente al Segretario, pretendeva alcune condizioni alla
vendita degli Phantom, ovvero l’impegno, tramite un accordo vincolante, per Israele di autorizzare la
presenza di personale americano per supervisionare e monitorare ogni installazione militare finalizzata
alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di ordigni nucleari, con il precipuo obiettivo di non
introdurre armi atomiche nel Medio Oriente.
La frase interpretata vagamente da Rabin, vale a dire che Israele non doveva essere il primo
Paese a testare tali armi, necessitò l’intervento di Warnke con una lettera indirizzata sempre
all’ambasciatore Rabin, nella quale veniva esposto chiaramente che la non introduzione di armi
nucleari significava la non produzione di installazioni nucleari.169 Ma questo tentativo andò a vuoto.
3.3 …e per la Giordania
Un non nuovo problema da affrontare per il governo americano riguardava la Giordania di Re
Hussein, Paese arabo moderato, ma suscettibile di cambiamenti politici, proprio ora che doveva subire
la seconda ondata di profughi dalla West Bank del fiume Giordano.
Infatti, in seguito alla guerra dei Sei giorni, la Giordania si trovò nella condizione imbarazzante di
recuperare le perdite militari volgendo lo sguardo a Washington, e allo stesso tempo resistere alle
pressioni dell’Unione Sovietica che miravano a soppiantare le tradizionali fonti di armamenti
occidentali, inclusa la Gran Bretagna. La preoccupazione era che la Giordania potesse rivolgersi a
Mosca sia per l’appoggio diplomatico, sia per l’aiuto economico e militare di cui necessitava. Era
urgente mantenere Re Hussein lontano dai Sovietici.
168
Secondo Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato (dal settembre 1973) durante la presidenza
Nixon, «la burocrazia, di cui è nota la capacità di tirare per le lunghe l’esecuzione delle direttive poco gradite, riesce a
dimostrare una solerzia stupefacente nel mettere in atto le istruzioni che approva e di cui teme una revoca». Vedi Henry
Kissinger, Gli Anni della Casa Bianca, op. cit., p. 302.
169
Cfr. William Quandt, Peace Process, op. cit., pp. 57-58, e Seymour M. Hersh, The Price of Power. Kissinger in the
Nixon White House, op. cit., p. 214.
Ai primi di dicembre 1967, l’ambasciatore statunitense ad Amman, Symmes Harrison M.,
informava il Dipartimento di Stato del pericolo di una missione sovietica, programmata per la fine del
mese, che avrebbe potuto pregiudicare sia la possibilità di riprendere le relazioni militari fra i due paesi
sia il generale sostegno verso il regno hascemita.
Il 30 dicembre, Re Hussein inviò un messaggio orale al presidente Johnson nel quale, in sostanza,
affermava che se gli Stati Uniti non avessero sopperito alla esigenze militari (e quindi, di conseguenza,
politiche) del suo Paese, la frustrazione dei generali avrebbe reso reale la possibilità che la Giordania si
rivolgesse alla potenza sovietica.170 Era di estrema importanza una chiara posizione in riguardo da parte
del governo statunitense, almeno prima della riunione del vertice arabo programmato per il 17 gennaio
1968. Hussein propose l’invio del capo di Stato Maggiore, generale Khammash, a Washington per
degli incontri con le autorità americane. Johnson rispose positivamente, affermando che gli Stati Uniti
erano preparati «in principle» per riprendere le forniture militari.171
Un abbozzo di accordo proposto dal Dipartimento della Difesa al generale giordano provocò le
fredda e deludente reazione di Hussein, poiché non si soddisfacevano pienamente le legittime richieste,
militari e politiche di Amman. Dopo varie settimane di intense trattative, il 28 marzo 1968 le due parti
firmarono un Memorandum of Understanding, in cui Washington si impegnava a fornire alla Giordania
materiale bellico (18 aerei caccia F-104 e 100 carri armati) mostrando una certa flessibilità ad andare
incontro ai bisogni del regno hascemita.172
170
Johnson Library, National Security File, Country File, Jordan, Vol. IV, Cables, 5/67-2/68. Sempre il 30 dicembre, in un
colloquio fra Symmes e Hussein, questi sottolineò che «there is the seriously deteriorating morale of the Jordan army to be
considered», e si oppose recisamente contro un’eventuale via libera del governo americano alla richiesta israeliana di aerei
F-4 Phantom. Vedi FRUS, 1964-1968, Vol. XX, doc. 29, Telegram From the Embassy in Jordan to the Department of State,
National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1967-69, DEF 19-8 US-JORDAN. Secret; Immediate;
Nodis.
171
FRUS, 1964-1968, Vol. XX, doc. 37, Telegram From the Department of State to the Embassy in Jordan, National
Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1967-69, DEF 19-6 US-JORDAN. Secret; Immediate; Nodis.
172
Nella lettera trasmessa a Johnson agli inizi di marzo e mentre l’accordo per la vendita di armi era a buon punto, Re
Hussein fece queste osservazioni: «I have become extremely disheartened by what appears to be lack of genuine interest in
a just and durable peace by the Israelis. It is unfortunate that their victory should direct them to follow a very narrow and
short-sighted approach. For though the Israelis have won a battle they seem unable to appreciate the fact that they have not
won a war. This is manifested in their lack of clarity over the acceptance of the Security Council's resolution under the
Infatti, il principale obiettivo della vendita era rafforzare la legittimità di Re Hussein (e del suo
esercito) nei confronti del proprio popolo e verso l’intromissione di truppe irachene del Re Faisal.173
283
mandate of which Ambassador Jarring is pursuing his mission; in their arbitrary actions in defiance of a semi-unanimous
United Nations resolution on Jerusalem; in their continuing actions aiming at major alterations in the city. …Israel has
persisted in the use of brutal force and has constantly attacked our people on the East Bank of Jordan, inflicting heavy losses
of life and property. Her ridiculous and totally incomprehensible excuse for doing all this is that I am not fulfilling my socalled duty of ensuring the safety and security of her forces which occupy a good portion of my country. Israel seems
unwilling to understand that so long as she remains in such occupation she will be met by mounting resistance by the people
under occupation and who are victims of her aggression». Vedi FRUS, 1964-1968, Vol. XX, doc. 99, Telegram From the
Embassy in Jordan to the Department of State, National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 19671969, DEF 12-5 JORDAN. Secret; Priority; Exdis.
173
FRUS, 1964-1968, Vol. XX, doc. 125, Action Memorandum From the President's Special Assistant (Rostow) to
President Johnson, Johnson Library, National Security File, Country File, Jordan, Vol. V, Memos, 3/68-1/69. Secret.
Conclusioni
Il linguaggio della forza: una “pace” dettata da Israele
La politica espansionista aggressiva nei confronti del popolo palestinese
Terra e aspirazioni territoriali sono sempre stati il cuore della lotta che ha
visto confrontarsi a lungo ebrei e arabi in Palestina. Tuttavia, le cause del conflitto
araboisraeliano appaiono più profonde della semplice disputa di territori.1
Con una valutazione a posteriori delle vicende che vanno dal 1917 al 1967,
prima dello yishuv e poi dello Stato israeliano, possiamo giungere alla conclusione
che il ruolo di occupante che Israele iniziò a svolgere con la sconvolgente vittoria
nel giugno 1967, non era il frutto di una guerra intrapresa per difendere l’esistenza
dello Stato ebraico (come, del resto, era convinto Eban: «the choice was to live or
perish, to defend the national existence or to forfeit it for all time»),2 ma
implicava una nuova fase delle ambizioni del sionismo.
Queste erano iniziate con l’accettazione da parte dei leader della comunità
ebraica in Palestina del piano di spartizione ONU del novembre 1947, un gesto
1 Nelle
dichiarazioni finali alla Conferenza mondiale contro il razzismo tenutasi a Durban
(Sudafrica, 31 agosto – 7 settembre) l'8 settembre 2001, il vice primo ministro e ministro degli
Esteri belga, parlando in rappresentanza dell'Unione Europea, affermò che «the long-running
tragedy was primarily a territorial dispute».
Vedi http://www.un.org/WCAR/pressreleases/rd-d45.htm, Call to eradicate discrimination and
intolerance marks conclusion of world conference against racism, 8 September 2001.
284
che esprimeva non tanto il sincero desiderio di raggiungere un compromesso
razionale con il movimento nazionale arabo-palestinese, quanto una soluzione di
ripiego di fronte a problemi contingenti più urgenti e impellenti (immigrazione,
rafforzamento della struttura statale e dell’apparato di sicurezza). Ben Gurion era
convinto che lo Stato ebraico dovesse essere inserito nelle cartine e nella storia,
perché le frontiere, ancora oggi non permanenti e suscettibili di mutamenti,
sarebbero state dettate dal potenziale militare piuttosto che dal diritto
internazionale.
Mentre agli occhi dell’opinione pubblica internazionale del tempo, la guerra
che ha portato alla nascita di Israele era considerata giusta, o quantomeno
moralmente accettabile, viste le sofferenze e persecuzioni che il popolo ebraico
aveva subito durante la Seconda guerra mondiale, il conflitto del ’67 appariva in
una luce completamente diversa. Vi era una differenza morale tra la conquista di
territori strappati agli arabi con la guerra d’Indipendenza e quelli occupati (e in
piccola parte annessi unilateralmente) durante la guerra dei Sei giorni: le
motivazioni erano completamente differenti. Mentre le conquiste ottenute del
1949 rappresentavano la base e condizione essenziale (e inevitabile) per la
fondazione del nuovo Stato ebraico, il tentativo di conservare e ampliare i territori
esclusivi nella West Bank e a Gaza aveva un forte sapore di espansione imperiale.
Per il sionismo, e per la sua ideologia di liberazione, era più che legittimo e
giustificato dalla storia e dalla Bibbia (sinonimi per gli ebrei), cercare di riscattare
l’intera area di Eretz Yisrael, conseguendo i diritti del popolo ebraico nella propria
2 Vedi
pp. 256-257 e nota 19 del capitolo 8.
285
patria biblica. Proprio questo diritto storico sulla Palestina, abilmente sfruttato
come propaganda e argomento di politica internazionale, fu invocato e rivendicato
con il fine di assicurarsi un rifugio, considerate le condizioni che gli ebrei avevano
dovuto sopportare all’inizio del XX secolo dopo i reiterati pogrom nell’impero
russo. Fu l’abilità diplomatica di Chaim Weizmann che fece inserire nel testo del
Mandato britannico il legame storico degli ebrei con la Palestina.3
La percezione che grazie alla vittoria schiacciante (per alcuni “troppo”
schiacciante) riportata nel giugno ’67 si fosse “liberata” quasi l’intera Eretz
Yisrael, fece rinascere tutte quelle forze nella società israeliana, soprattutto
movimenti religiosi, che avevano lo scopo di colonizzare le nuove terre
conquistate e persino annetterle allo Stato ebraico.
Un influente movimento ideologico fondato immediatamente dopo la
guerra, WLIM (Whole Land of Israel Movement), formato principalmente da
militanti del Partito laburista al governo, proponeva la massima estensione
territoriale della sovranità ebraica. Sul piano pratico ciò si traduceva in
insediamenti come mezzo per determinare i futuri confini politici. Certo, era
rischioso dare inizio a una politica di colonizzazione nella West Bank, cuore della
Palestina araba, ma allo stesso tempo era un territorio intriso di memorie bibliche
e gesta di eroi, che costituivano il centro di quella grande terra in cui i Patriarchi e
le Matriarche, i Re, i Giudici e i Profeti erano vissuti e avevano agito.
Ma cosa fare dei civili palestinesi che abitavano questa terre, soprattutto
nella Cisgiordania (più di un milione nel 1967) e a Gaza? Diversamente dalla
3 «Recognition
has thereby been given to the historical connexion of the Jewish people with
286
guerra d’Indipendenza israeliana dove furono espulsi e/o fuggirono 700-800 000
arabi, durante la guerra dei Sei giorni la maggior parte rimase nelle loro case
(eccetto circa 300 000 palestinesi). Prevalse all’interno del governo laburista la
scelta in favore di un «compromesso funzionale», volto a confiscare gradualmente
territori arabi senza annettere la popolazione, sottoposta a un’occupazione
militare.4 Questa politica non contraddiceva uno dei principi fondamentali del
sionismo, che voleva mirare sempre a “più terra e meno arabi,” così da mantenere
una schiacciante maggioranza ebrea dal punto di vista demografico.5
Un’altra idea funzionale al nuovo teatro geopolitico uscito dalla guerra dei
Sei giorni, era il sostegno crescente della società israeliana al “trasferimento” dei
palestinesi, soluzione non nuova, poiché era datata nel XIX secolo, che
permetteva di risolvere le ambizioni territoriali sioniste e il problema demografico
arabo.
Questo concetto era sostenuto dai più importanti leader sionisti come David
Ben Gurion, Theodor Herzl, Zeev Jabotinsky, Moshe Sharett, Chaim Weizmann;
un eufemismo, tradotto in vari modi (“scambio di popolazione”, “risistemazione”,
Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country».
4 Vedi Zeev Sternhell, Nascita di Israele. Miti, storia, contraddizioni, Milano, Baldini&Castoldi,
1999 (tit. or.: The Founding Myths of Israel, Princeton, Princeton University Press, 1998), p. 452,
dove l’alternativa era per un «compromesso territoriale» che prevedeva l’annessione di aree
relativamente non popolate. Inoltre vedi Hersh Seymour M., The Price of Power. Kissinger in the
Nixon White House, New York, Summit Books, 1983, p. 219: «the disposition of the issue of the
West Bank required not only a political decision by Israel’s leaders but a religious and
philosophical decision about Israel’s future territorial and ideological claim».
5 Vedi Nur Masalha, Imperial Israel and the Palestinians. The Politics of Expansion, op. cit., pp.
217, 226, 227. Oltre al prioritario dovere di colonizzare la terra d’Israele, i politici israeliano hanno
una vera a propria ossessione per la “bomba” demografica araba sia nei territori occupati sia
all’interno della Linea Verde. È sempre stato uno dei problemi maggiormente dibattuti quello del
mantenimento del carattere ebraico-giudaico dello Stato. È strettamente collegato a questo
problema l’idea di espulsione degli arabi, di creare sistematicamente condizioni di sofferenza tali
287
“emigrazione”, “rimpatrio”), che implicava un’organizzata rimozione della
popolazione palestinese verso i limitrofi Paesi arabi, forzata o attuata
volontariamente. In altri termini si trattava di una pulizia etnica o espulsione di
massa. I politici di Tel Aviv non trovavano niente di immorale in questa proposta,
e per giustificare (se non legittimare) il loro punto di vista fornirono dei
precedenti simili, come ad esempio il trasferimento di greci e turchi, indiani e
pakistani.
La praticità di questa misura appariva dubbia, ma sia l’utilizzo di azioni
militari nei territori occupati (prendendo come pretesto una guerra di “difesa”
contro le organizzazioni terroristiche palestinesi) sia la deliberata creazione di
disagi economici potevano fornire l’occasione per l’espulsione.6
Un altro importante elemento della politica israeliana nei confronti dei
palestinesi residenti nei territori occupati dopo il 1967 è stato l’uso della forza,
della coercizione e della violenza, per di più arbitraria, essenzialmente con
l’obiettivo di stroncare qualsiasi resistenza palestinese nei confronti della politica
territoriale aggressiva israeliana e continuare la confisca e la colonizzazione di
terre arabe. Senza ombra di dubbio, la politica di colonizzazione intrapresa senza
remore dall’esecutivo israeliano laburista nel 1967-68 poteva essere sostenuta
solo con la repressione effettuata da un forte esercito (l’IDF).
da indurre i palestinesi a emigrare “volontariamente” dai territori occupati, oppure sfruttare
(future) situazioni di guerra con l’obiettivo di un obbligatorio “trasferimento”.
6 È condivisibile il giudizio secondo il quale il massacro di Deir Yassin non sia stato né una
punizione né un deterrente, bensì uno strumento politico progettato per accelerare l’ondata di
profughi palestinesi: logica e ragionevole conclusione della politica che punta all’annessione di
territori arabi.
288
Nelle parole del leader revisionista Jabotinsky, pronunciate negli anni venti,
si percepisce chiaramente la volontà di ignorare i legittimi diritti nazionali dei
palestinesi e che un accordo con questi ultimi non era né desiderabile né
necessario, mentre, al contrario, un confronto appariva inevitabile e naturale e
sarebbe stato risolto con la creazione di un impenetrabile muro di ferro, vale a dire
una aggressivo e compatto Stato ebraico sostenuto da un potente esercito:
«Zionist colonisation, even the most restricted, must either be terminated or carried
out in defiance of the will of the native population. This colonisation can, therefore,
continue and develop only under the protection of a force independent of the local
population – an iron wall which the native population cannot break through. This is, in
toto, our policy [del sionismo revisionista] towards the Arabs. To formulate it any other
way would be a hypocrisy.7
In sostanza, questo concetto del “muro di ferro” come presa di posizione nei
confronti dei palestinesi, rimane tutt’ora un principio guida dell’attuale governo di
unità nazionale capeggiato dall’ex generale Ariel Sharon e leader del Likud.
Dopo un decennio dalla fine della guerra de Sei giorni, periodo di impasse
diplomatica nel corso del quale nessun Stato arabo aveva allacciato relazioni
ufficiali con Israele, permettendo a Tel Aviv di sfruttare il tempo per aumentare
gli insediamenti permanenti illegali nei territori occupati secondo il principio del
fatto compiuto, per la prima volta una coalizione di partiti di destra guidati da
Menachem Begin a capo del Likud vinsero le elezioni generali. Coerentemente
con il suo passato e le sue idee, la missione prioritaria del Primo ministro fu quella
7 Citato
in Nur Masalha, Imperial Israel and the Palestinians. The Politics of Expansion, op. cit.,
p. 56. Vedi anche Avi Shlaim, The Iron Wall. Israel and the Arab World, op. cit., pp. 12-16.
Durante gli anni venti del ‘900 il sionismo laburista aveva come obiettivi per la costruzione dello
Stato ebraico l’immigrazione e la colonizzazione delle terre e dava una priorità secondaria alla
creazione di un forte esercito, ma durante la seconda guerra mondiale i suoi leader e persino Ben
289
di cercare l’integrità territoriale di Eretz Yisrael sotto il dominio israeliano,
tramite l’uso della forza.
La permanenza della destra alla guida del paese durò, in sostanza, fino al
1992, con il ritorno al potere dei laburisti di Rabin. All’inizio di questo lungo
periodo Begin diede inizio a una imponente campagna di colonizzazione nella
West Bank (soprattutto), a Gaza e a Gerusalemme Est e annetté unilateralmente le
alture del Golan (14 dicembre 1981). L’aumento del numero delle colonie e della
popolazione fu intenzionalmente pianificato dal Likud in modo da rendere
difficoltoso, o addirittura impossibile, per i futuri governi israeliani rimuovere
(anche con la forza) gli insediamenti, in un qualsiasi ipotetico accordo con gli
arabi, e nel contempo negare il territorio a un eventuale Stato palestinese.
Il governo di Begin ha applicato alla West Bank e a Gaza la formula di
un’annessione de facto, con una strisciante integrazione allo Stato d’Israele grazie
a una continua politica di colonizzazione, alla sistematica confisca di terre arabe,
al controllo delle risorse idriche, restringendo contemporaneamente la
popolazione palestinese in città-enclave o bantustan, controllati a distanza
dall’apparato militare israeliano.
L’invasione israeliana del Libano (“Operazione pace per la Galilea”)
intrapresa da Begin e Sharon per delegittimare l’OLP ha tratti sorprendentemente
simili alla politica attuale del governo di Tel Aviv, attuata con incursioni militari
nelle zone e città autonome palestinesi nel marzo e aprile 2002, per delegittimare
Gurion si avvicinarono gradualmente e fecero propria l’idea di Jabotinsky secondo la quale una
forte e potente struttura militare ebraica sarebbe stata un fattore chiave nella lotta per uno Stato.
290
e distruggere fisicamente l’Autorità palestinese, nata con gli accordi di Oslo (13
settembre 1993).
Proprio in riferimento alla guerra del Libano, il biografo di Begin scrisse nel
1982 sulla rivista americana Foreign Affairs:
«Begin and Sharon share the same dream: Sharon is the dream’s hatchet man. That
dream is to annihilate the PLO, douse any vestiges of Palestinians nationalism, crush PLO
allies and collaborators in the West Bank and eventually force the Palestinians there into
Jordan and cripple, if not end, the Palestinian nationalist movement. That, for Sharon and
Begin, was the ultimate purpose of the lebanese war».8
Insediamenti israeliani e diritto internazionale
La politica portata avanti dal 1967 in poi da qualsiasi governo israeliano
infrange diverse disposizioni di trattati di cui Israele è parte contraente.
Il diritto internazionale umanitario stabilisce norme e regole che si devono
applicare in tempo di guerra e occupazione militare da parte di una potenza
straniera, e significativamente la quarta Convenzione di Ginevra per la protezione
delle persone civili in tempo di guerra adottata il 12 agosto 1949, afferma
all’articolo 49 par. 6 che «the Occupying Power shall not deport or transfer parts
of its own civilian population into the territory it occupies».9
Con questa disposizione si è voluto impedire pratiche adottate nel periodo
della Seconda guerra mondiale, quando porzioni di popolazione (con la forza o
volontariamente) furono trasferite in territori per ragioni politiche e razziali.
Inoltre, l’obiettivo di questa clausola non riguarda (solo) il fatto che il volontario
trasferimento di coloni non deve implicare la deportazione dei residenti locali, ma
8 Citato
in Nur Masalha, Imperial Israel and the Palestinians. The Politics of Expansion, op. cit.,
p. 83.
291
il fine principale è di proteggere la popolazione nativa dei territori contro un’altra
popolazione straniera che si insedia sulla stessa terra, con tutti i danni che possono
derivare da tale colonizzazione, ad esempio lo sfruttamento delle risorse naturali
(acqua, terra, ecc.), restrizioni alla sviluppo economico locale, trasformazione
demografica dei territori.
Durante la presidenza Carter, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approvò la
Risoluzione 446 (22 marzo 1979), che, oltre a riaffermare l’applicazione della
quarta Convenzione di Ginevra del 1949 ai territori occupati da Israele dal 1967,
decideva la non validità legale della politica di colonizzazione poiché «constitute
a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the
Middle East». Essa qualificava Israele come “potenza occupante” e lo richiamava
«to rescind its previous measures and to desist from taking any action which
would result in changing the legal status and geographical nature and materially
affecting the demographic composition».10 Quasi un anno dopo, il 1 marzo, lo
stesso organo delle Nazione Unite, adottò la Risoluzione 465, con il voto
favorevole degli Stati Uniti, che si esprimeva in termini simili alla 446.11
9 Il
testo della 4° Convenzione di Ginevra si può trovare nel sito delle Croce Rossa internazionale
all’indirizzo http://www.icrc.org/eng.
10 Per il testo della Risoluzione 446 vedi http://domino.un.org/unispal.nsf, oppure nella sezione
“Documenti” di questo lavoro. Nella votazione gli Stati Uniti si astennero, insieme a Gran
Bretagna e Norvegia.
11 Per il testo della Risoluzione 465 vedi http://domino.un.org/unispal.nsf, oppure nella sezione
“Documenti” di questo lavoro. Ecco alcuni passi: «Strongly deploring the refusal by Israel to cooperate
with the Commission and regretting its formal rejection of resolutions 446… Deploring
the decision of the Government of Israel to officially support Israeli settlement in the Palestinian
and other Arab territories occupied since 1967… Determines that all measures taken by Israel to
change the physical character, demographic composition, institutional structure or status of the
Palestinian and other Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, or any part
thereof, have no legal validity and that Israel's policy and practices of settling parts of its
population and new immigrants in those territories constitute a flagrant violation of the Fourth
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War and also
292
La nuova Corte Internazionale criminale permanente, che inizierà a
funzionare dal prossimo primo luglio 2002, visto che è stata superata la soglia di
60 ratifiche, afferma all'articolo 8 par. 2b (viii) che «the transfer, directly or
indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the
territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population
of the occupied territory within or outside this territory» è un crimine di guerra,
alla pari di torture, deportazioni, uccisioni deliberate e ingiustificate, attacchi
contro la popolazione civile.12 Naturalmente, Israele (assieme agli Stati Uniti) ha
firmato lo Statuto il 31 dicembre 2000, ma ha esplicitamente espresso la propria
volontà di non ratificarlo (sempre assieme agli Stati Uniti) poiché la Corte avrà
giurisdizione sui crimini commessi dai cittadini di Stati che hanno ratificato il
trattato, o che si trovino nei territori degli stessi Stati, un fatto che lede la piena
sovranità di Israele.
La vittoria nel 1967 ha risvegliato forze già presenti nella società israeliana
inclini a non ricercare un onesto compromesso con il popolo palestinese e i suoi
rappresentanti, determinati ad affermare la nozione che gli ebrei sono il popolo
eletto e gli arabi minacciano con la loro presenza in Eretz Yisrael, il processo di
redenzione messianico. Sulla base della Torah13 ogni ebreo deve onorare il
constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle
East».
12 Il testo integrale della Corte Internazionale criminale permanente è presente su
http://www.un.org/law/icc/index.html. Possono essere giudicati solo individui (non Stati, riservati
esclusivamente al lavoro della Corte Internazionale di Giustizia), a prescindere dallo status
militare o civile oppure dalla posizione ufficiale che si ricopre (ministro, Capo del governo,
Presidente, ecc.). Vengono perseguiti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio.
13 Voce ebraica che significa “legge”, “dottrina”, e con la quale nel giudaismo si indica il
Pentateuco, nome dato ai primi cinque libri della Bibbia (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri,
Deuteronomio).
293
comandamento (“mitzvah”) divino di colonizzare Eretz Yisrael a ogni costo,
anche tramite la guerra; così come c’è la proibizione di cedere qualsiasi porzione,
anche minima, della biblica terra d’Israele. La destra, gli estremisti radicali come
il Partito nazionale religioso (Mafdal), Moledet, Tzomet, i diversi movimenti tra i
quali annoveriamo Gush Emunim (“Blocco della fedeltà”, fondato nel 1974) e il
Kach (di chiari contenuti razzisti), considerano più che mai la guerra come
processo purgativo, un segno di prova, di forza e un mezzo necessario attraverso il
quale è esercitata la volontà divina. Di fatto, proprio l’incessante, pianificato e
sistematico aumento degli insediamenti israeliani nei territori occupati si può
paragonare, senza esagerazione, a una strisciante campagna militare nei confronti
del popolo palestinese.14
L’atteggiamento politico di Washington nei confronti della concreta e
incessante politica del fatto compiuto tramite lo sviluppo delle colonie, incentivata
e promossa finanziariamente da ogni governo israeliano, è stata ambigua e
contradditoria nel complesso.
L’Amministrazione Carter rimase fedelmente attaccata all’illegalità degli
insediamenti, in primo luogo perché violavano la quarta Convenzione di Ginevra.
Al contrario, il presidente Reagan si distaccò da questa linea politica e proclamò
14 Il
Rabbino Shlomo Aviner sostenne nel 1982: «even if there is a peace, we must instigate wars
of liberation in order to conquer additional parts of the Land of Israel». Citato in Nur Masalha,
Imperial Israel and the Palestinians. The Politics of Expansion, op. cit., p. 114. Per molti leader
estremisti votati alla politica espansionista territoriale e figure religiose, il conflitto ideologico con
gli arabi-palestinesi ha le sue radici nell’ordine biblico concernente gli Amaleciti (I Samuele 15,23). I palestinesi sono gli Amaleciti di oggi che profanano la terra d’Israele. Questa frase biblica è
stata interpretata da diversi rabbini per giustificare non solo l’espulsione dei palestinesi locali ma
anche l’uccisione di civili arabi in caso di guerra. Dalla narrazione biblica, principalmente in libri
come Esodo, Deuteronomio e Giosuè la pulizia etnica non solo viene presentata legittima ma
anche come una richiesta divina («il Signore degli eserciti»).
294
la loro legalità, in contrasto con la precedente politica americana, mentre tutte le
successive amministrazioni non presero alcuna posizione sull’argomento, sebbene
considerarono la politica di colonizzazione come un «ostacolo alla pace» o più
semplicemente «di nessun aiuto» per risolvere pacificamente la questione
araboisraeliana.
Nel 1990-91, con lo smembramento dell’Unione Sovietica, ci fu
immigrazione di massa di ebrei russi verso il piccolo Stato ebraico che mise in
apprensione la comunità palestinese per la minaccia, sempre più potenziale,
dell’applicazione del concetto del trasferimento dai territori occupati. Con
l’accordo di Oslo, anch’esso una conseguenza della guerra del Golfo del 1991, la
dirigenza della OLP riconobbe ufficialmente lo Stato d’Israele (e viceversa),
accettando dolorosamente un futuro Stato palestinese pari al 22% della Palestina
mandataria e la fine della lotta armata. Iniziava un vero processo di pace tra le due
parti, ma graduale, rimandando problemi fondamentali e spinosi come la
questione degli insediamenti, la sovranità su Gerusalemme o il problema dei
profughi alle trattative finali permanenti.
Questo intervallo di tempo diede la possibilità ai governi israeliani di
aumentare notevolmente gli insediamenti illegali. In altre parole, mentre la
diplomazia discuteva la varie fasi applicazione dell’accordo programmatico di
Oslo, la popolazione dei coloni israeliani raddoppiava: nella West Bank e a Gaza
nel 1972 la popolazione dei coloni era 1500, nel 1983 29090, nel 1992 109784 e
alla fine del 2001 213672, con la tendenza ad aumentare; a Gerusalemme Est nel
1972 i coloni erano 6900, nel 1992 141000 e nel 2000 170400; nelle alture del
295
Golan attualmente vivono 17000 coloni.15 Queste trattative non basate sulla buona
fede e la lealtà hanno portato il popolo palestinese a sollevarsi contro la forza dei
fatti nel settembre 2000, con l’intifada al-Aqsa.
Uno studio eseguito dall’organizzazione israeliana per i diritti umani nei
territori occupati, B’Tselem, intitolato «Land Grab: Israel’s Settlement Policy in
the West Bank» (maggio 2002), rivela che, mentre solo il 1.7% della West Bank è
coperto dalle costruzioni di insediamenti, la totale area “controllata” da Israele
arriva fino al 41,9%, poiché i confini municipali nei progetti nazionali (inclusi le
aree già edificate) equivalgono al 6,8% e le terre che ricadono sotto la
giurisdizione dei consigli locali e regionali (terre riservate) corrispondono al
35,1%.16
Questi fatti avvalorano la tesi dell’annessione di fatto dei territori occupati
da parte di Israele, inasprendo la frustrazione dei palestinesi e la paura di fronte a
questa politica espansionistica, visto che Israele non ha mai definito in modo
permanente i suoi confini, sempre suscettibili di cambiamento in una sola
direzione. Gli insediamenti, inoltre, sono indispensabili per i leader politici
israeliani al potere, poiché senza di essi non potrebbero mantenere un esercito
straniero nei territori occupati.
Israele ha creato nei territori occupati palestinesi un regime di separazione
basato sulla discriminazione, applicando due sistemi separati di legislazione nella
stessa area e fondando i diritti della popolazione in base alla loro cittadinanza (e
nazionalità), dove il complesso delle leggi israeliane viene applicato ai coloni e
15 I
dati sono disponibili in http://www.fmep.org/, Foundation for Middle East Peace.
296
agli insediamenti, mentre la popolazione civile palestinese resta sottoposta alla
legislazione militare.17 Sotto tale regime, Israele persevera nella confisca di terre
palestinesi per costruire incessantemente nuovi insediamenti, isole esclusive per
soli ebrei, cosi come lo sono le strade che li collegano.
Contemporaneamente, Israele proibisce di usufruire di queste terre e usa gli
insediamenti, la loro sicurezza e altri pretesti, per giustificare le numerose
violazioni dei diritti umani dei palestinesi come il diritto all’abitazione, o il diritto
alla libertà di movimento. Il risultato dopo 35 anni di occupazione militare,
abbinata a una sistematica politica del fatto compiuto da parte di tutti i governi
israeliani che si sono succeduti, è il drastico cambiamento della mappa della West
Bank che impedisce fisicamente, a causa della mancanza di una significativa
contiguità territoriale, la reale possibilità di istituire uno Stato palestinese
indipendente, come parte del più ampio diritto di autodeterminazione.
I coloni beneficiano di tutti i diritti di cui dispongono i cittadini israeliani
che risiedono all’interno della Linea Verde, e in diversi casi sono destinatari anche
di privilegi maggiori. Infatti, non dobbiamo dimenticare il grande sforzo compiuto
dai governi israeliani (anche per un guadagno elettorale) nella politica di
colonizzazione, in termini finanziari, legali e burocratici, trasformando le colonie
in enclave civili permanenti, in un area soggetta al controllo militare, in cui lo
status di colono è prioritario e separato. Ed è proprio su tali governi che ricade la
principale responsabilità per la violazione dei diritti umani dei palestinesi, perché
16 Il
testo integrale del Rapporto si trova in http://www.btselem.org/.
sistema politico che richiama alla mente il regime dell’apartheid in Sudafrica.
17 Un
297
hanno sempre fornito il sostegno politico, economico e organizzativo e
incoraggiato la loro continua crescita.
Grande responsabilità politica risiede anche sugli Stati Uniti, gli alleati
informali di Tel Aviv e gli unici al giorno d’oggi, che possono imporre, tramite
pressioni o minacce di sospendere (o ipoteticamente bloccare) aiuti finanziari,
privati e pubblici, e militari, una vera politica, che porti verso una giusta pace per
entrambe le parti.18
Soprattutto a causa dell’uso sconsiderato e irresponsabile del potere di veto
in seno al Consiglio di Sicurezza per bloccare risoluzioni di condanna aperta alla
politica di Israele o, più recentemente, per impedire la formazione e l’invio di
osservatori internazionali ONU (e non una forza multinazionale) nei territori
occupati.19 Washington non riconosce (in buona o in mala fede) che la violenza
palestinese e il terrorismo all’interno della Linea Verde contro i civili inermi e
18 Ricordiamo
la forte pressione del presidente americano Eisenhower, abbinata e sostenuta con
misure concrete di influenza, per ottenere da Ben Gurion l’incondizionato ritiro delle truppe
israeliane dalla penisola del Sinai nel marzo 1957, in seguito alla crisi di Suez. Ogni leader
politico israeliano è fedele al principio secondo il quale «non si abbandona mai una posizione o un
territorio a meno che non si sia costretti da una forza superiore», citato in Zeev Sternhell, Nascita
di Israele. Miti, storia, contraddizioni, op. cit., p. 442.
Israele riceve dagli Stati Unti annualmente circa 3 miliardi di dollari di aiuti economici e militari
per mantenere la sicurezza e il diritto di esistere. In realtà, l’assistenza americana viene utilizzata
per sostenere la politica militare nei territori occupati. I maggiori aiuti degli Stati Uniti iniziarono
proprio dopo la guerra dei Sei giorni. Per approfondimenti vedi http://www.fpif.org/ e
http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm.
19 La prassi di opporsi alle risoluzioni che in qualche modo ostacolano gli interessi d’Israele è
iniziata sotto l’Amministrazione Nixon. Qui di seguito vengono riportate le date nelle quali la
rappresentanza diplomatica americana al Consiglio di Sicurezza ha esercitato il veto: 10 settembre
1972, 24 luglio 1973, 5 dicembre 1975, 23 gennaio 1976, 24 marzo 1976, 29 giugno 1976, 28
aprile 1980, 19 gennaio 1982, 1 aprile 1982, 20 aprile 1982, 8 giugno 1982, 25 giugno 1982, 6
agosto 1982, 1 agosto 1983, 6 settembre 1984, 11 marzo 1985, 12 settembre 1985, 17 gennaio
1986, 29 gennaio 1986, 6 febbraio 1986, 15 gennaio 1988, 29 gennaio 1988, 14 aprile 1988, 6
maggio 1988, 14 dicembre 1988, 17 febbraio 1989, 8 giugno 1989, 6 novembre 1989, 30 maggio
1990, 17 maggio 1995, 7 marzo 1997, 21 marzo 1997, 26 marzo 2001, 14 dicembre 2001. Il totale
dei veti fino alla fine del 2001 è di 34, ed è degno di nota che gli Stati Uniti sono stati i soli a
298
innocenti, è una diretta conseguenza di 35 anni di occupazione, la più lunga
occupazione militare straniera dopo quella giapponese in Corea, e dell’ostinata
negazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese e dell’irreversibile
politica territoriale aggressiva israeliana.
La Risoluzione 247 approvata dal Senato americano («Expressing solidarity
with Israel in its fight against terrorism») il 2 maggio 2002 con la schiacciante
maggioranza di 94 voti favorevoli contro 2, mette sullo stesso piano il terrorismo
che portò l’attacco alle Twin Towers di New York, con il “terrorismo” palestinese
che resiste all’occupazione militare israeliana, senza percepire le macroscopiche
differenze di fondo.20
Esiste da sempre un’enorme asimmetria di potere fra la dominante
maggioranza israeliana e la controparte palestinese, politicamente controllata e
economicamente dipendente, che non deve essere ignorata. Non può e non deve
essere lasciata all’attuale governo Sharon la carte blanche alla politica militare nei
territori occupati, ma la comunità internazionale, con in prima linea gli Stati Uniti,
l’Unione Europea, la Russia e le Nazioni Unite, è obbligata a riportare giustizia
votare in modo negativo in tutti i progetti di risoluzione. Per i testi di questi ultimi vedi:
http://domino.un.org/unispal.nsf.
20 Sempre il 2 maggio 2002, la stessa Risoluzione di solidarietà a Israele contro il terrorismo è
stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti con il risultato dell’enorme maggioranza a favore
di 352 (194 repubblicani, 157 democratici, 1 indipendente) contro 21 (4 repubblicani e 17
democratici).
Per il testo della Risoluzione vedi http://www.aipac.org/documents/solidaritytext.html. Vengono
riportate alcune parti criticabili: «the United States and Israel are now engaged in a common
struggle against terrorism and are on the frontlines of a conflict thrust upon them against their
will… the Senate stands in solidarity with Israel, a frontline state in the war against terrorism, as it
takes necessary steps to provide security to its people by dismantling the terrorist infrastructure in
the Palestinian areas; remains committed to Israel's right to self-defense; will continue to assist
Israel in strengthening its homeland defenses; …demands that the Palestinian Authority fulfill its
commitment to dismantle the terrorist infrastructure in the Palestinian areas».
299
lungo le direttive della recente Risoluzione 139721 (12 marzo 2002) del Consiglio
di Sicurezza proposta dalla delegazione americana, una pace obbligata dalla
presenza di due Stati, Israele e Palestina, in una coesistenza pacifica fianco a
fianco.
È più che necessario istituire una forza multinazionale ONU nei territori
occupati, capace di garantire il “cessate i fuoco”, proteggere la popolazione
palestinese dall’arbitrarietà del regime militare israeliano, impedire l’entrata degli
attentatori suicidi sia nel territorio israeliano ma anche contro i coloni, vigilare la
ricostruzione delle basilari istituzioni di uno Stato palestinese, ma soprattutto
monitorare il graduale smantellamento di quasi tutti gli insediamenti. Un lavoro
complesso che richiederebbe molto tempo, forse anni; una soluzione sperimentata
positivamente in Bosnia e nel Kosovo, la cui applicabilità spetta alla forte volontà
politica in primis degli Stati Uniti.
Le chiavi per la praticità di questo piano dipenderà in buona misura anche
dalla società civile israeliana, se vincerà il desiderio di pace o se prevarrà una
scelta ideologicamente incompatibile con il compromesso a ogni costo.22
Se invece vincerà (ancora una volta) l’inerzia, trionferà lo status quo, a tutto
vantaggio di Israele, che si tradurrà nella continuazione dell’occupazione militare
israeliana, la confisca di terre arabe, l’espansione degli insediamenti, la
repressione. In una sola parola: alla politica territoriale aggressiva si contrapporrà
21 Per
il testo vedi nella sezione “Documenti” di questo lavoro, o http://domino.un.org/unispal.nsf,
dove, per la prima volta da parte del Consiglio di Sicurezza, si afferma «a vision of a region where
two States, Israel and Palestine, live side by side within secure and recognized borders».
300
come conseguenza naturale la resistenza palestinese, la violenza di gruppi radicali
in aumento, gli attacchi suicidi.
Questa è la storia della lotta per Eretz Yisrael che inesorabilmente continua
nei giorni nostri a uccidere israeliani e palestinesi, è la vera guerra santa ebraica
che si combatte in Israele/Palestina, perché come disse il rabbino capo Tzvi
Yehuda Kook (1865-1935), figura di primo piano del sionismo religioso che
considerava sacra la riconquista della patria ancestrale da parte del movimento
laburista, «the Land was chosen before the people».23
22 «In
effetti la pace rappresenta un pericolo mortale per il sionismo di sangue e terra, un sionismo
che non può immaginare la volontaria restituzione di nemmeno un metro del territorio sacro della
terra di Israele». Citato in Zeev Sternhell, Nascita di Israele. Miti, storia, contraddizioni, p. 457.
23 Citato in Nur Masalha, Imperial Israel and the Palestinians. The Politics of Expansion, op. cit.,
p. 106.
301
Fonti e bibliografia
Documenti ufficiali
Public Papers of the Presidents of the United States: Richard M. Nixon
(anni 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974)
United States Foreign Policy 1971. A report of the Secretary of State
United States Foreign Policy 1972. A report of the Secretary of State
Monografie e saggi
AlRoy Gil Carl, The Kissinger Experience. American Policy in the Middle East,
New York, Horizon Press, 1975.
Ambrose Stephen E., Eisenhower. Soldier and President, New York – London –
Toronto – Sydney – Tokyo – Singapore, Simon & Schuster, 1990.
Andrew Richard, Il monte del tempio, Milano, Sperling & Kupfer Editori, 2001
(tit. or.: Blood on the Mountain, 1999).
Bailey Sidney D., The Making of Resolution 242, Dordrecht – Boston – Lancaster,
Martinus Nijhoff Publisher, 1985.
Bell Coral, The Diplomacy of Detente. The Kissinger Era, New York, St. Martin’s
Press, 1977.
302
Bright John, Storia dell’antico Israele. Dagli albori del popolo ebraico alla
rivolta dei Maccabei, Roma, Newton & Company, 2002 (tit. or.: A History of
Israel, 4th edition, Westminster Knox Press, 2000).
Bryson Thomas A., American Diplomatic Relations With the Middle East, 17841975: A Survey, New York, The Scarecrow Press, 1977.
Bundy William, A Tangled Web. The Making of Foreign Policy in the Nixon
Presidency, New York, Hill and Wang, 1998.
Calchi Novati Giampaolo, La decolonizzazione, Torino, Loescher, 1983.
Cohen Michael J., The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict,
Berkeley – Los Angeles – Oxford, University of California Press, 1987.
Cohen Michael J., Truman and Israel, Berkeley – Los Angeles – Oxford,
University of California Press, 1990.
Cohn-Sherbok Dan, Atlas of Jewish History, London – New York, Routledge,
1994.
Cohn-Sherbok Dan e Cohn-Sherbok Lavinia, Breve storia dell’ebraismo,
Bologna, il Mulino, 2001 (tit. or.: A Short History of Judaism, Oxford, Oneworld,
1994).
Conforti Benedetto, Le Nazioni Unite, Padova, Cedam, 1996.
De Benedetti Paolo, Introduzione al giudaismo, Brescia, Morcelliana, 1999.
303
Dowty Alan, Middle East Crisis. U.S. Decision-Making in 1958, 1970, and 1973,
Berkeley – Los Angeles – London, University of California Press, 1984.
Ehrlichman John, Witness to Power. The Nixon Years, New York, Simon &
Schuster, 1982.
Finkelstein Norman G., The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of
Jewish Suffering, with a new Foreword and a new Postscript, London and New
York, Verso, 2001.
Finkelstein Norman G., Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict,
London and New York, Verso, 2001.
Fraser T. G., The USA and the Middle East Since World War 2, New York, St.
Martin’s Press, 1989.
Ghanayem Ishaq I. and Voth Alden H., The Kissinger Legacy. American-Middle
East Policy, New York – Toronto – Eastbourne, UK – Hong Kong – Tokyo –
Sidney, Praeger, 1984.
Grose Peter, Israel in the Mind of America, New York, Alfred A. Knopf, 1983.
Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere, A cura di Roy Gutman e
David Rieff, Roma, Contrasto Internazionale, 1999 (tit. or.: Crimes of War, New
York, WW Norton, 1999).
Handel Michael I., The Diplomacy of Surprise: Hitler, Nixon, Sadat, Harvard
Studies in International Affairs, Number 44, Center for International Affairs,
Harvard University, 1981.
304
Hersh Seymour M., The Price of Power. Kissinger in the Nixon White House,
New York, Summit Books, 1983.
Hiro Dilip, Dictionary of the Middle East, New York, St. Martin’s Press, 1996.
Hoff Joan, Nixon Reconsidered, New York, BasicBooks, 1994.
Israeli Raphael with Bardenstein Carol, Man of Defiance. A Political Biography
of Anwar Sadat, New Jersey, Barnes & Noble Book, 1985.
U.S. Foreign Policy in a Changing World. The Nixon Administration, 1969-1973,
Edited by Alan M. Jones, Jr., New York, David McKay Company, 1973.
Kaufman Burton I., The Arab Middle East and the United States. Inter-Arab
Rivalry and Superpower Diplomacy, New York, Simon & Schuster MacMillan,
1996.
Kissinger Henry A., Gli anni della casa bianca, SugarCo, 1980 (tit. or.: White
House Years, Boston, Little Brown and Company, 1979).
Kissinger Henry A., Years of Upheaval, Boston, Little Brown and Company,
1982.
Kissinger Henry A., L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer Editori,
1996 (tit. or.: Diplomacy, 1974).
Kissinger Henry A., Years of Renewal, New York, Simon & Schuster, 1999.
Laqueur Walter, A History of Zionism, New York, MJF Books, 1972.
305
The Israel-Arab Reader. A Documentary History of the Middle East Conflict,
Laqueur Walter and Rubin Barry editors, Sixth Revised Edition, New York –
London – Ringwood (Australia) – Toronto – Auckland, Penguin Books, 2001.
Lenczowski George, American Presidents and the Middle East, Duke, Duke
University Press, 1990.
Lewis Bernard, Gli arabi nella storia, Roma – Bari, Laterza, 1998 (tit. or.: The
Arabs in History, Oxford, Oxford University Press, 1993).
Lewis Bernard, Il Medio Oriente. Duemila anni di storia, Milano, 1999 (tit. or.:
The Middle East, 1995).
Lewis Bernard, Le molte identità del Medio Oriente, Bologna, il Mulino, 2000
(tit. or.: The Multiple Identities of the Middle East, London, Weidenfeld &
Nicolson, 1998).
Litwak Robert S., Détente and the Nixon Doctrine. American Foreign Policy and
the Pursuit of Stability, 1969-1976, Cambridge, Cambridge University Press,
1984.
Mangold Peter, Superpower Intervention in the Middle East, New York, St.
Martin’s Press, 1978.
Masalha Nur, Imperial Israel and the Palestinians. The Politics of Expansion,
London – Sterling (Virginia, USA), Pluto Press, 2000.
Morris Benny, Vittime, Milano, Rizzoli, 2001 (tit. or.: Righteous victims, 1999).
306
Nixon Richard M., RN. The Memoirs of Richard Nixon, New York – London –
Toronto – Sydney – Tokyo – Singapore, Simon & Schuster, 1978, 1990.
Quandt William B., Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli
Conflict since 1967, Berkeley and Los Angeles, University of California Press,
The Brookings Institution, 1993.
Raeff Marc, La Russia degli Zar, Roma – Bari, Laterza, 1992² (tit. or.:
Comprendre l’ancien régime russe, Paris, Editions du Seuil, 1982).
Sachar Howard M., A History of Israel. From the Rise of Zionism to Our Time,
Second Edition, Revised and Updated, New York, Alfred A. Knopf, 2001.
Schulzinger Robert D., Henry Kissinger. Doctor of Diplomacy, New York,
Columbia University Press, 1989.
Segev Tom, Il settimo milione. Come l’Olocausto ha segnato la storia di Israele,
Milano, Mondadori, 2001 (tit. or.: The Seventh Million. The Israelis and the
Holocaust, 1993).
Shlaim Avi, The Iron Wall. Israel and the Arab World, W. W. Norton &
Company, 2001.
Soggin Alberto J., Storia d’Israele. Dalle origini a Bar Kochbà, Brescia, Paideia,
1984.
Spiegel Steven L., The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle
East Policy, from Truman to Reagan, Chicago and London, The University of
Chicago Press, 1985.
307
Stein Kenneth W., Heroic Diplomacy. Sadat, Kissinger, Carter, Begin, and the
Quest for Arab-Israeli Peace, New York – London, Routledge, 1999.
Sternhell Zeev, Nascita di Israele. Miti, storia, contraddizioni, Milano,
Baldini&Castoldi, 1999 (tit. or.: The Founding Myths of Israel, Princeton,
Princeton University Press, 1998).
Tessler Mark, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, Bloomington and
Indianapolis, Indiana University Press, 1994.
Tschirgi Dan, The American Search for Mideast Peace, New York – Westport,
Connecticut – London, Praeger, 1989.
Wasserstein Bernard, Divided Jerusalem. The Struggle for the Holy City, New
Haven and London, Yale University Press, 2001.
Zucconi Mario, Il conflitto arabo-israeliano e il sistema del secondo dopoguerra,
Napoli, Editoriale Scientifica, 1987.
308
Articoli
Benvenisti Eyal and Zamir Eyal, Private Claim to Property Rights in the Future
Israeli-Palestinian Settlement, “The American Journal of International Law”,
Volume 89, 1995, pp. 295-340.
Buehrig Edward H., The UN, the US and Palestine, “The Middle East Journal”,
Volume 33, N° 4 Autumn 1979, pp. 435-443.
Cordesman Antony H., Peace in the Middle East: The Value of Small Victories,
“The Middle East Journal”, Volume 38, N° 3, Summer 1984, pp. 515-520.
Ferrari Silvio, La S. Sede e la questione di Gerusalemme da Madrid A Camp
David, “Rivista di studi politici internazionali”, Anno LXVIII, n. 1, GennaioMarzo 2001, pp. 65-78.
Hudson Michael, The Palestinian Arab Resistance Movement: Its Significance in
the Middle East Crisis, “The Middle East Journal”, Volume 23, N° 3, Summer
1969, pp. 291-307.
Korn David A., The US-Soviet Negotiations of 1969 and the Rogers Plan, “The
Middle East Journal”, Volume 44, N° 1, Winter 1990, pp. 37-50.
Kuniholm Bruce R., Retrospect and Prospect: Forty Years of US Middle East
Policy, “The Middle East Journal”, Volume 41, N° 1, Winter 1987, pp. 7-25.
Lewis Samuel W., The United States and Israel: Evolution of an Unwritten
Alliance, “The Middle East Journal”, Volume 53, N° 3, Summer 1999, pp. 364367.
309
Micelli Caterina, Il processo di pace israelo-palestinese dal 1993 al 1996, “La
Comunità Internazionale”, vol. LV, N. 1, primo trimestre 2000, pp. 63-81.
Miller Aaron D., The Arab-Israeli Conflict, 1967-1987: A Retrospective, “The
Middle East Journal”, Volume 41, N° 3, Summer 1987, pp. 349-360.
Perry Glen, Security Council Resolution 242: The Withdrawal Clause, “The
Middle East Journal”, Volume 31, N° 4, Autumn 1977, pp. 413-433.
Radley Kurt R., The Palestinian Refugees: The Right to Return in International
Law, “The American Journal of International Law”, Volume 72, 1978, pp. 586614.
Stevens Georgiana G., 1967-1977: America’s Moment in the Middle East?, “The
Middle East Journal”, Volume 31, N° 1, Winter 1977, pp. 1-15.
Urquhart Brian, The United Nations in the Middle East: A 50 Years Retrospective,
“The Middle East Journal”, Volume 49, N° 4, Autumn 1995, pp. 572-581.
310
INTERNET
Si elencano qui di seguito i principali siti on-line consultati:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/mideast.htm
The Avalon Project at the Yale Law School, Palestine 1916-2002: A
Documentary Record
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/meres.htm
Documents Pertinent to the Middle Eastern Issue
http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/index.html
Question of Palestine at the United Nations
http://domino.un.org/unispal.nsf
UNISPAL, United Nations Information System on the Question of Palestine
http://www.economist.com/
Economist.com
http://www.nytimes.com/
The New York Times on the Web
http://www.haaretzdaily.com/
Ha’aretz, il più antico e autorevole quotidiano israeliano
http://www.jpost.com/
Israel News From the Jerusalem Post Internet Edition
http://www.pna.net/
The Official Website of the Palestinian National Authority
http://www.israel.org/mfa/home.asp
The Israeli Government’s Official Website, by the Ministry of Foreign Affairs
http://www.palestinecenter.org/
Palestine Center – News and information from the Jerusalem Fund and the Center
for Policy Analysis on Palestine
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/
U.S. Department of State – Foreign Relations of the United States
http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/mideast/
CNN.com In-Depth Specials – Mideast struggle for peace
311
http://www.foreignaffairs.org/
Foreign Affairs Magazine
http://www.palestine-info.com/index_e.htm
The Palestinian Information Center
http://www.crimesofwar.org/
Crimes of War Project
http://www.hrw.org/
Human Rights Watch – Defending Human Rights Worldwide
http://www.amnesty.org/
Amnesty International – Working to Protect Human Rights Worldwide
http://mondediplo.com/focus/mideast/
Le Monde diplomatique – Middle East: the faultline
http://www.gush-shalom.org/english/
Gush Shalom – Israel Peace Bloc
http://www.mepc.org/
The Middle East Policy Council
http://www.wrmea.com/
Washington Report on Middle East Affairs
http://israelinsider.com/
Israel’s daily online news magazine
http://www.fmep.org/
Foundation for Middle East Peace
http://indictsharon.net/
Justice for the Victims of Sabra & Shatila
http://www.btselem.org/
B’Tselem, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
Territories
http://electronicintifada.net/new.html
The Electronic Intifada – A Resource for Countering Myth, Distortion and Spin
from the Israeli Media War Machine
312
http://www.pchrgaza.org/
Palestinian Centre for Human Rights
http://www.peacenow.org.il/English.asp
PEACE NOW!
http://www.aipac.org/
AIPAC – The American Israel Public Affairs Committee: America’s Pro-Israel
Lobby
http://www.icrc.org/eng
International Committee of the Red Cross (ICRC)
http://www.fpif.org/
A Think Tank without Walls – Foreign Policy in Focus