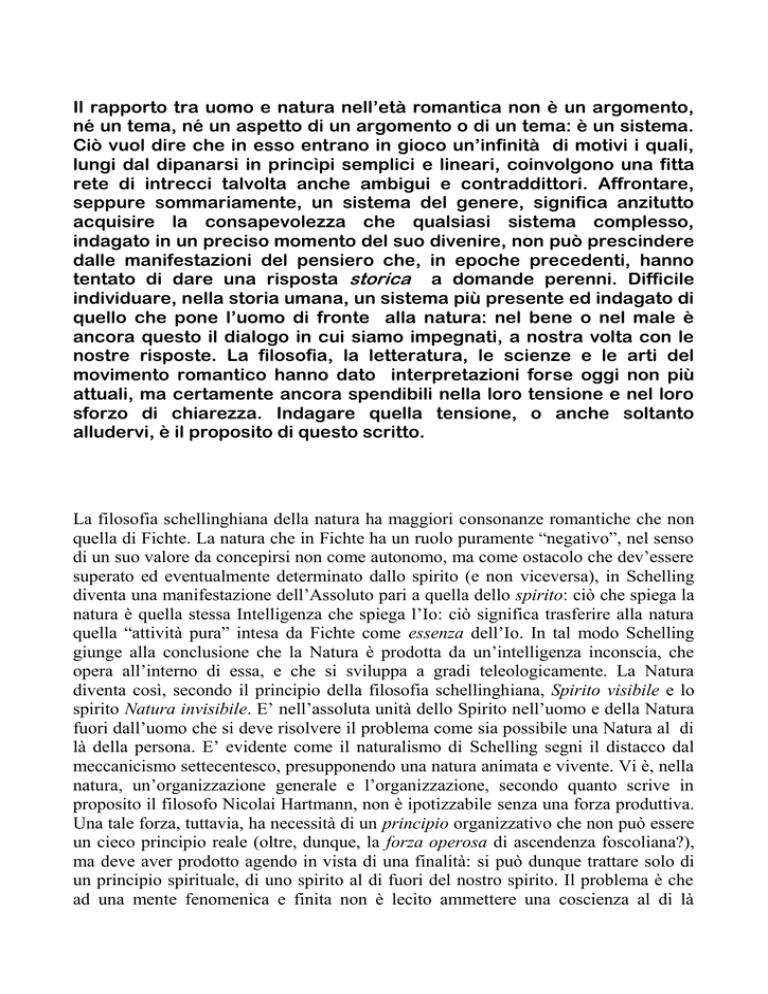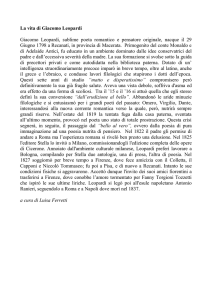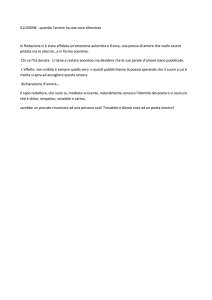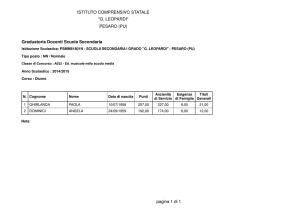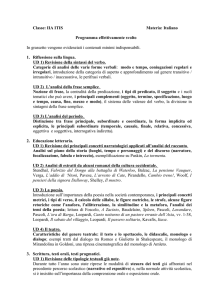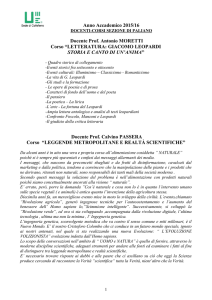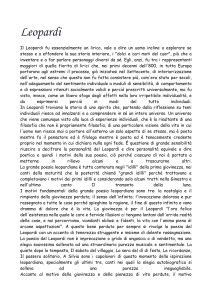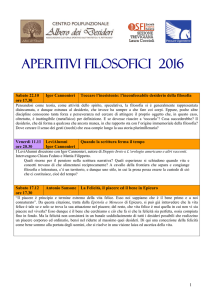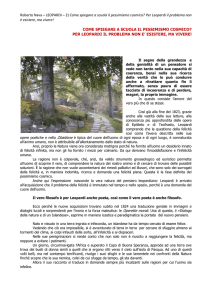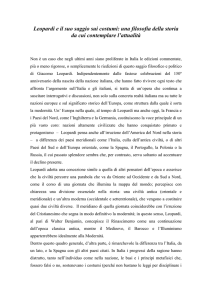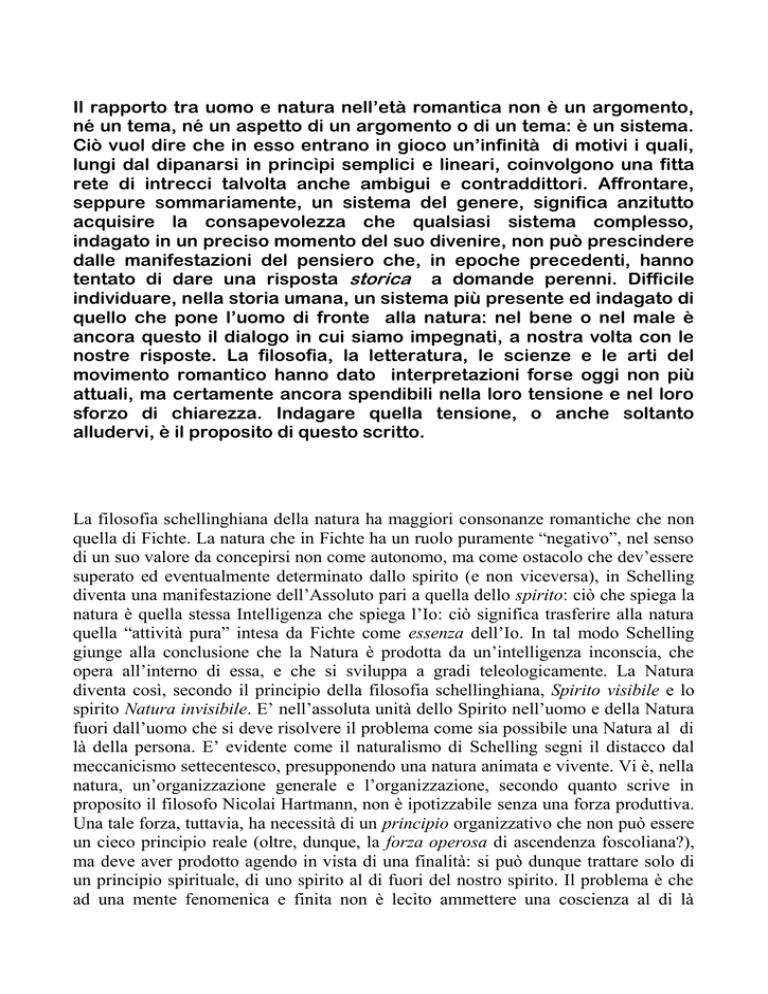
Il rapporto tra uomo e natura nell’età romantica non è un argomento,
né un tema, né un aspetto di un argomento o di un tema: è un sistema.
Ciò vuol dire che in esso entrano in gioco un’infinità di motivi i quali,
lungi dal dipanarsi in princìpi semplici e lineari, coinvolgono una fitta
rete di intrecci talvolta anche ambigui e contraddittori. Affrontare,
seppure sommariamente, un sistema del genere, significa anzitutto
acquisire la consapevolezza che qualsiasi sistema complesso,
indagato in un preciso momento del suo divenire, non può prescindere
dalle manifestazioni del pensiero che, in epoche precedenti, hanno
tentato di dare una risposta storica a domande perenni. Difficile
individuare, nella storia umana, un sistema più presente ed indagato di
quello che pone l’uomo di fronte alla natura: nel bene o nel male è
ancora questo il dialogo in cui siamo impegnati, a nostra volta con le
nostre risposte. La filosofia, la letteratura, le scienze e le arti del
movimento romantico hanno dato interpretazioni forse oggi non più
attuali, ma certamente ancora spendibili nella loro tensione e nel loro
sforzo di chiarezza. Indagare quella tensione, o anche soltanto
alludervi, è il proposito di questo scritto.
La filosofia schellinghiana della natura ha maggiori consonanze romantiche che non
quella di Fichte. La natura che in Fichte ha un ruolo puramente “negativo”, nel senso
di un suo valore da concepirsi non come autonomo, ma come ostacolo che dev’essere
superato ed eventualmente determinato dallo spirito (e non viceversa), in Schelling
diventa una manifestazione dell’Assoluto pari a quella dello spirito: ciò che spiega la
natura è quella stessa Intelligenza che spiega l’Io: ciò significa trasferire alla natura
quella “attività pura” intesa da Fichte come essenza dell’Io. In tal modo Schelling
giunge alla conclusione che la Natura è prodotta da un’intelligenza inconscia, che
opera all’interno di essa, e che si sviluppa a gradi teleologicamente. La Natura
diventa così, secondo il principio della filosofia schellinghiana, Spirito visibile e lo
spirito Natura invisibile. E’ nell’assoluta unità dello Spirito nell’uomo e della Natura
fuori dall’uomo che si deve risolvere il problema come sia possibile una Natura al di
là della persona. E’ evidente come il naturalismo di Schelling segni il distacco dal
meccanicismo settecentesco, presupponendo una natura animata e vivente. Vi è, nella
natura, un’organizzazione generale e l’organizzazione, secondo quanto scrive in
proposito il filosofo Nicolai Hartmann, non è ipotizzabile senza una forza produttiva.
Una tale forza, tuttavia, ha necessità di un principio organizzativo che non può essere
un cieco principio reale (oltre, dunque, la forza operosa di ascendenza foscoliana?),
ma deve aver prodotto agendo in vista di una finalità: si può dunque trattare solo di
un principio spirituale, di uno spirito al di fuori del nostro spirito. Il problema è che
ad una mente fenomenica e finita non è lecito ammettere una coscienza al di là
dell’Io, sicché lo spirito che opera nella natura dev’essere uno spirito inconscio. E’
qui che risiedono, allo stesso tempo, sia il punto di contatto che quello di divisione da
Fichte. La Dottrina della scienza presupponeva il sorgere della Natura
dall’immaginazione produttiva dell’Io (in modo solo idealistico), Schelling invece,
pur mantenendo questo operare privo di coscienza, lo trasferisce nella realtà
oggettiva, dal momento che il principio che vi opera spiritualmente non è per lui l’Io,
ma qualcosa al di fuori di esso. E’ in sostanza un principio del reale che è esterno alla
coscienza ed in questa misura la filosofia schellinghiana della natura, rapportata alla
Dottrina della scienza è assolutamente realistica; si tratta tuttavia di un principio
spirituale e pertanto, di conseguenza, di un principio ideale, contemporaneamente
ideale e reale (il "real-idealismo”, infatti, del quale parla Hartmann). Ma vi è un’altra
conseguenza che investe, a titolo speculativo, la temperie romantica: se Spirito e
Natura derivano da un medesimo principio, allora nella Natura deve riscontrarsi
quella dinamica della forza che si espande e di un limite che le si contrappone che già
si può riscontrare in Fichte e nella dottrina dell’Io. Ma l’opposizione del limite (tema
carissimo al risvolto poetico della filosofia, soprattutto leopardiana) non arresta che
momentaneamente la forza espansiva, la quale torna ad espandersi fino al limite
successivo e così via. A ciascuna di queste fasi espansive corrisponde la produzione
di un grado e di un livello della natura progressivamente più elevato (e
gerarchizzato): il primo incontro tra forza d’espansione e forza di limite dà luogo alla
materia. Tutto il processo successivo si configura pertanto come un meccanismo
universale, un processo dinamico che Schelling dimostra come vero ricorrendo al
manifestarsi delle forze, della loro polarità, del magnetismo, dell’elettricità, dei
fenomeni chimici che per lui sono una visione pre – scientifica, quasi rinascimentale
e campanelliana e per i quali, tuttavia, non nasconde l’essenzialità della scienza
galileiana pur ritenendola insufficiente. L’identico schema di ragionamento vale a
spiegare il livello più alto della Natura, che è il livello “organico”, dal quale si giunge
all’uomo, “l’ultima e la più alta riflessione”, il livello nel quale si accende la
coscienza e l’intelligenza raggiunge la sua consapevolezza. Si comprende così come
Schelling abbia potuto presentare di nuovo l’antico concetto di “anima del mondo”,
figura teoretica antichissima e molto famosa da Platone in poi, che il filosofo tedesco
interpreta come intelligenza inconscia in grado di produrre e reggere la natura ma che
solo con la nascita dell’uomo si apre alla coscienza. E proprio l’uomo, che
considerato nell’infinitudine del cosmo appare ben poca cosa (“[…]ed io che sono?”
è la domanda che il pastore errante dell’Asia pone, senza aspettative di risposta, all’
“infinito seren”), risulta, per contro, essere il fine ultimo della Natura, poiché in lui si
ridesta lo spirito, assopito in tutti gli altri gradi della natura. Appare evidente, pur
nella differenza sostanziale degli approcci, la consonanza con le posizioni kantiane
della Critica del giudizio (nel dimensionamento dell’essere fra “cielo stellato” e legge
morale), per le quali proprio quell’uomo fenomenico e finito appare poi
effettivamente votato all’infinito, in virtù di una sorta di metafisica che si accinge a
trascendere gli orizzonti dell’illuminismo per giungere al romanticismo ed alla sua
pulsione (poetica e filosofica) proprio verso l’infinito. Certo sarebbe interessante
pensare ora alle posizioni del tutto differenti di Hegel, il quale non mostra alcuna
simpatia per la Natura. Se gli sono estranee le concezioni rinascimentali, molto più
estranee sembrano essergli le posizioni di molti romantici. Holderlin, anzitutto: si
pensi alla divinizzazione della Natura, intesa come origine di tutto e, in particolare, si
pensi al personaggio di Iperione, il protagonista del romanzo Iperione o l’eremita in
Grecia. Di fronte al crollo dell’illusione storica e davanti alla delusione d’amore (due
temi, questi ultimi, ben noti al Foscolo), Iperione si rifugia nella divina Natura per
trovar pace. L’inno alla Natura, con cui termina l’Iperione, è, non a caso, una delle
espressioni più cospicue del naturalismo romantico. L’idea che soltanto la natura viva
davvero, che solo in essa risieda la bellezza del mondo e la giovinezza perenne e che,
infine, un solo ritorno sia possibile all’uomo in direzione della felicità, e cioè il
ritorno alla Natura, sono posizioni che può condividere Schiller, non Hegel. Alla tesi
secondo cui un piccolo evento naturale possono farci intuire Dio e la Verità, Hegel
contrappone l’idea secondo cui il più piccolo evento dello Spirito ci fa conoscere la
Verità e Dio in modo incomparabilmente migliore, e che perfino il male che l’uomo
compie è incomparabilmente superiore a qualsiasi astro del cielo ed a qualunque
fenomeno naturale per quanto bello, terribile, prodigioso o grande, in quanto il male è
un atto di libertà e la libertà costituisce l’essenza dello spirito. Hegel è molto chiaro
in proposito, lui che, solitamente, è invece difficile e talvolta oscuro nel pensiero e
nella scrittura: “La natura, contemplata nel rispetto della sua esistenza determinata
per la quale appunto essa è natura, non è da divinizzare” ; ed ancora: “[…] i fatti
spirituali in genere sono stimati meno delle cose naturali e le opere dell’arte umana
sono posposte alle cose naturali per la ragione che il loro materiale deve essere tolto
dall’esterno, e che non sono viventi. Come se la forma spirituale non contenesse una
più alta vitalità, e non fosse più degna dello spirito che non la forma naturale […]”.
Le divisioni della filosofia hegeliana della Natura rispecchiano esattamente quelle
della Logica, e non potrebbe essere altrimenti. Fra le molte ed interessanti
particolarità che ne derivano, una appare pertinente al nostro discorso: la Natura,
concepita come un sistema ascensivo di gradi, in realtà non si evolve (con buona pace
di Schelling), perché non si evolvono le forme, ma si evolve lo Spirito che vive sotto
queste forme. Qui sta non solo il superamento di Schelling, ma anche quello di
Goethe. E’ vero che, più di una volta, Goethe condanna le escrescenze patologiche
del fenomeno romantico, ma per quanto riguarda le tematiche specifiche non va
dimenticato che la concezione goethiana della Natura alimenta, in un certo senso,
l’esperienza romantica. La natura è tutta viva, fin nei minimi particolari (che nulla
impressionano Hegel)e la totalità dei fenomeni è interpretata come organica
produzione della “forma interiore”. Una polarità di forze (ancora contrazione ed
espansione) dà luogo alle diverse formazioni naturali, che segnano un accrescimento
e producono un'elevazione progressiva. Né si dimentichi che lo stesso concetto di
genio (carissimo ai romantici) si risolve per Goethe in una formula che condensa,
come meglio non si potrebbe, la sua vicinanza alle istanze romantiche: il “genio” è
natura che crea e l’arte è attività creatrice e creazione come la natura, e addirittura al
di sopra della natura. E’ facile, a questo punto, giungere a consonanze schilleriane,
ma la via che conduce all’unione di poesia e filosofia (posizione molto leopardiana, a
giudicare l’annotazione di Zibaldone, 3382-3387) parte, ancora una volta, da
Schelling. Se il sistema schellinghiano, infatti, è definito idealismo oggettivo, esso è
anche connotato quale idealismo estetico: l’arte diventa il supremo organo della
filosofia, poiché per suo tramite si raggiunge pienamente l’identità originaria
rappresentata dal connubio spirito – natura. E’ nella creazione estetica che ritroviamo
la sintesi del momento inconscio (natura) e di quello cosciente (spirito): mentre la
filosofia non riesce concretamente a cogliere l’identità perché il pensiero è
necessariamente scisso (pensante – pensato) , l’emozione estetica coglie
istantaneamente, prima di ogni distinzione, l’Assoluto come identità. Non la ragione
astratta, quindi, (filosofia), ma la creazione estetica coglie la vera natura del principio
primo ed è per tale ragione che il poeta si configura anche come il vero filosofo.
Posizione vagamente leopardiana, fatto salvo il concetto di principio sul quale
Leopardi non concorderebbe, ma posizione assolutamente non manzoniana, dato che
l’idea di creazione artistica non ha valore per il Manzoni ed è sostituita da quella di
invenzione. Ciò va ricordato, si potrebbe dire, ante rem, vista l’importanza delle
posizioni manzoniane riguardo all’estetica romantica. Del resto nel dialogo
Dell’Invenzione (1850) il Manzoni rifiuta nettamente il concetto di “creazione”
poetica quando esso sia inteso come “la finzione isolata e arbitraria dell’uomo che si
richiude nel suo studio per fabbricare pezzetti di storia secondo il suo bisogno e il suo
gusto”. Ispirandosi piuttosto alla filosofia del Rosmini, egli ritiene che l’invenzione
poetica non consista nell’inventare, ma nell’invenire, cioè nel trovare, in Dio (che è
l’unico Principio), la verità profonda celata dietro le apparenze. Secondo
l’ontologismo rosminiano, infatti, l’intuizione certissima ed immediata dell’Essere
costituisce la base di tutto il sapere: è da Dio che deriva la comprensione della realtà
nella sua complessa globalità. Quell’artista che Schelling vorrebbe incendiato
dall’intuizione geniale dell’identità assoluta, percorre secondo il Manzoni una strada
diversa: attraverso Dio giunge alla verità e l’invenzione, così concepita, diviene la
chiave di volta in grado di conciliare “vero storico” e “vero poetico”. Certamente
Schiller dà alimento a posizioni assai diverse. Il suo saggio Sulla poesia ingenua e
sentimentale fonda la fortuna di una distinzione non ignota al Leopardi. La poesia
antica era ingenua, perché l’uomo antico agiva come unità armonica e naturale e
“sentiva naturalmente”: l’antico poeta era natura egli stesso e quindi immediata
espressione di natura. Il poeta “sentimentale”, cioè il poeta moderno, non è ma sente
la natura, o, meglio ancora, riflette sul sentire ed è su questo che fonda la
commozione poetica. Ne deriva che il poeta sentimentale si sente, così, separato
dall’ideale degli antichi e, allo stesso tempo, proteso (con la sua Sehnsucht) verso di
esso: ancora una volta è la condizione della separazione a rendere possibile la
riappropriazione. I fermenti romantici sono evidenti. Non può non tornare alla mente
il Discorso di un Italiano sulla poesia romantica del Leopardi. Sebbene in questo
scritto ancora giovanile il poeta mostri di apprezzare quasi esclusivamente il senso
del patetico elaborato dalla scuola romantica (e si dichiari invece in toto ammiratore
degli antichi), poco più tardi, in correlazione con la sua maturazione filosofica, egli fa
sua la distinzione tra poesia di immaginazione (propria degli antichi) e poesia di
sentimento (propria dei moderni). Vera poesia diventa così solo quella ingenua e
spontanea del mondo (vichianamente) ancora fanciullo, ancora a stretto contatto con
la Natura: la poesia primitiva, omerica, classica. All’uomo moderno, nutrito di
cultura, anestetizzato nello sviluppo civile dei sensi, assuefatto non ad una prima e
vera natura, ma ad una seconda (chiamata infatti da Leopardi, non a caso, proprio
assuefazione), è possibile solo una poesia di sentimento, con la quale addentrarsi
nell’intimo della coscienza ed analizzare la sua condizione di fronte alla natura ed
alla società. E’ necessariamente, si capisce, una poesia “riflessa” che può esistere solo
quando il poeta torni ad avvicinarsi agli antichi o riacquisti, recuperandola nella
memoria, la propria fanciullezza, riacquistando un poco di naturalezza e spontaneità.
Va sottolineato un punto, tuttavia, che può apparire piuttosto equivoco. Laddove
Schiller presuppone una riappropriazione nata dalla separazione dall’ideale antico,
Leopardi oppone, invece, l’impossibilità di qualsiasi recupero che esuli dal senso
dell’infinito e dalla poetica della rimembranza. L’itinerario leopardiano parte da una
visione confortante della natura: solo la natura eccita i sentimenti profondi ed è
quindi la vera fonte della poesia (cfr. Zib., 15), solo la natura, nella sua grandezza, ha
compensato la mancanza di piaceri reali infiniti con le illusioni e con l’immensa
varietà delle cose (cfr. Zib., 167), solo la natura non conosce il male, poiché il male
non fa parte del suo ordine e del suo sistema, ma è “come un’eccezione, un
inconveniente, un errore accidentale nel corso e nell’uso di detto sistema” (Zib., 364366). Quello che i critici hanno designato come pessimismo storico di Leopardi, si
basa su una prima fondamentale antitesi: natura / ragione. Essa, com’è noto,
caratterizza la fase che va dalla “conversione letteraria” alla crisi degli anni 1819 –
’22 ed è espressione di una delusione storica per la situazione dell’Europa e dell’Italia
nell’età della restaurazione. E’ doveroso, tuttavia, chiarire che istanze storico –
politiche in Leopardi hanno un valore eminentemente di pretesto, né più né meno
come le prime canzoni cosiddette civili e patriottiche che preparano, più che altro, il
classicismo peregrino del Bruto minore e dell’ Ultimo canto di Saffo. Importante
appare, caso mai, il concetto di infelicità come opera degli uomini i quali,
allontanatisi dalla natura, hanno perso il linguaggio della natura stessa a causa del
dominio della ragione. Qui è forte il richiamo al Rousseau e, sotto parecchi aspetti,
anche legittimo, ma va aggiunto che l’ultimo Leopardi si attesterà a conclusioni
antitetiche rispetto a quelle di Rousseau. Il male viene dall’uomo, aveva scritto il
filosofo, e non dalla natura che è ordine: la natura è certamente ordine, risponderà
Leopardi, ma ordine fondato sul male (Zib., 4510-4511). E non si ferma a questo la
divergenza tra i due. Il fatto è che Rousseau vive ante rem e Leopardi post rem, e
questa cosa, decisiva non solo per loro, è stata la Rivoluzione francese. Rousseau
aveva aperto, in un certo senso, sia la strada alla Rivoluzione che al Romanticismo,
ma Leopardi, che vive nell’età romantica, non si abbandona alle sollecitazioni etiche
e politiche che da quella età provengono. La storicità del suo pessimismo starà
dunque in questo dissidio per il quale la ragione, la ragione settecentesca che
Leopardi condanna, è anche quella che egli ama, l’unica che egli riconosce e
riconoscerà fino al termine del sistema, quella che aveva prodotto la filosofia
razionalistica e materialistica nel ‘700 accendendo speranze che Leopardi non poteva
non vedere deluse. Per ora, tuttavia, la natura appare come sorgente unica di vera
grandezza, vitalità, illusioni, risorse artistiche. C’è, in Leopardi, il vagheggiamento di
una società primitiva ricca di magnanime illusioni sentimentali che lo porta a
scindere definitivamente gli antichi, ancora vicini alla natura e perciò “vivi”, dai
moderni, nutriti di ragione e condannati al tedio: si approfondisce la visione
materialistica, ogni concezione metafisica è ripudiata a vantaggio di un orientamento
sempre più antiprovvidenzialistico ed antiteistico. A partire dal 1823, come
documentano in modo perfetto lo Zibaldone e le Operette morali, Leopardi enuncia la
teoria del piacere, secondo la quale la felicità dell’uomo non può essere una felicità
spirituale ed ultraterrena, ma una felicità materiale esperibile dai sensi: secondo
l’annotazione di Zib., 3835, la vera “somma e sostanza ultima” della felicità è solo il
piacere. Edonè aveva già detto Epicuro: per natura l’uomo cerca il piacere e fugge il
dolore e se il piacere è un bene, il dolore è senz’altro un male. Aristippo aveva
considerato il piacere un movimento leggero, il dolore un movimento violento
dell’anima. Epicuro corregge Aristippo e distingue tra “piacere in movimento” (per
Leopardi il moto è già uno stato di felicità) e “piacere catastematico” o “piacere in
riposo”. Ogni piacere è un bene, anche quello in movimento, ma il piacere in
movimento è turbato, è mescolato di dolore, perché intimamente legato ad un
bisogno, ad un desiderio. Il piacere catastemico, invece, è puro e deriva dall’assenza
o dalla cessazione del dolore. Del resto per Epicuro, ma potremmo dire per l’uomo
ellenistico in generale, la filosofia ha un fine essenzialmente pratico: indirizzare gli
uomini alla felicità. La scienza ha valore solo in quanto contribuisce a rendere gli
uomini felici: la grande opera epicurea Sulla natura (ben trentasette libri) non dà peso
a geometria, dialettica, storia o astronomia intese come fondamenti della felicità. Ha
senso, invece, la teoria della conoscenza: per Epicuro prima fonte di ogni nostra
conoscenza sono i sensi e la sensazione è il fondamento di qualunque scienza. A
giudicare dagli sviluppi successivi del pensiero, questa rivalutazione della sensazione
come fondamento del mondo dello spirito è una parte veramente vitale della filosofia
epicurea, più ancora del concetto di “prolessi”, altro criterio di verità basato, com’è
noto, sull’osservazione che, ripetendosi le percezioni, la memoria conserva certe
immagini comuni a più oggetti. Anche le “prolessi” nascono dalle sensazioni, ma a
formarle contribuisce il ragionamento, che fa i confronti e scorge le analogie. E’
certamente difficile non pensare a Lucrezio ed al suo De rerum natura: più in
particolare ancora difficile non pensare allo splendido inno a Venere genitrice con il
quale il poema si apre. La Venus lucreziana è stata ricondotta all’Afrodite
empedoclea, ed effettivamente nell’inno di Lucrezio essa è il simbolo del
concepimento universale, è la possente energia creatrice e ordinatrice di ogni
bellezza, è insomma la Natura epicurea da cui ha origine il tutto, anche l’armonia del
canto e la pace degli uomini, perché la forza naturale dell’amore è l’unica in grado di
vincere gli aspri costumi dell’odio e della guerra. Ma Venus non è, in senso classico,
una divinità: nel mondo lucreziano non c’è posto per gli dèi e sole, cielo, terra, mare,
luna non sono divinità, perché sono esseri inanimati. Tutto ciò che è è mortale, tutti i
concilia atomici sono mortali e con loro il mondo, che è una summa rerum. L’uomo
non è che una piccolissima parte del mondo e, come tale, è soggetto alle medesime
leggi meccanicistiche che regolano l’universo. Il cosiddetto progresso civile, la
melior res reperta (libro V, 1412-1435), non apporta nessun vantaggio, ma solo un
ingiusto disprezzo per cose un tempo apprezzate e godute: così nasce l’infelicità, non
per la necessità dell’esistenza, ma per colpa del genere umano che non conosce i
limiti delle ricchezze, né gli alimenti della vera felicità e si sfibra dalla tensione verso
un desiderio e verso un altro ancora. E la natura ci ha messo del suo, creando l’uomo
e rendendolo il più disgraziato fra i viventi: artefice di tutto, la Natura, benigna
provveditrice di tutto, per ogni essere animato, fuorché per l’uomo. In tal senso,
ancora, si cancella qualsiasi idea di natura come divinità provvidenziale: bella, ma
inesorabilmente lontana. La ragione è lo strumento di cui la natura ha dotato l’uomo
perché si difenda contro la natura stessa. Essa, madre e matrigna, ha creato nell’uomo
la sua vittima e il suo trionfatore; lo ha messo in condizione di conseguire la felicità o
di volere il contrario e precipitare nell’abisso di ogni miseria. Homo artifex perché
libero e questa libertà (che per Lucrezio è data dalla scienza) è anche strumento di
maledizione. D’altra parte questo raggiungimento della felicità è forse altro da un
risultato di una battaglia incessante contro il dolore? In tale appello alla sapienza
contro la stoltezza è tutta la tragedia dell’umanità: la tanta culpa della Natura, la
forza cieca che annulla in un istante le fortune umane, si risolve alla fine del De
rerum natura in un memorabile quadro di dolore e furore (il mortifero aestus che
ammorba Atene), su cui la morte scende liberatrice. Lucrezio ripete da Epicuro il
detto che la scienza rende l’uomo felice e pareggia il conto con la forza della natura,
ma già il Virgilio della Georgica dimostra di non credere più a questa possibilità. Il
riferimento a Virgilio non è ozioso: egli aveva frequentata, nella prima giovinezza, la
scuola epicurea ed aveva avvertito il fascino di Lucrezio. Il fatto è che Virgilio non
può restare a lungo seguace di una dottrina negatrice dell’eternità dell’anima e della
divinità. Nelle Bucoliche l’insegnamento epicureo persiste e nell’ecloga sesta Virgilio
è ancora lo scolaro di Sirone; ma già l’ecloga quarta aveva fatto intravedere una netta
inclinazione verso il misticismo orfico-pitagorico. Nella Georgica passa, ogni tanto,
un soffio della grande poesia di Lucrezio (si pensi al libro III ed al concetto d’amore
avvertito come forza universale), ma Virgilio non crede più all’ideale epicureo della
felicità. Egli diventa, piuttosto, un “sacerdote” della natura: la terra è il grande
scenario, fatto di luci e di ombre, dove agiscono le piante e gli animali, fra l’assiduo
travaglio delle opere umane. La terra riempe l’anima e l’immaginazione del poeta e
tante volte egli solleva lo sguardo contemplativo verso le Muse dulces ante omnia
(Georg. II, 475) chiedendo loro di poter seguire il cammino degli astri. Ma proprio
qui Virgilio si separa definitivamente da Epicuro, da Lucrezio ed anche da Leopardi:
nel suo panteismo di poeta georgico rapito dalla natura, in religioso contatto con tutte
le cose, egli non sente il mistero dei mondi al di là del mondo degli uomini, non ha il
senso poetico dell’infinito che invece ha, ad esempio, Seneca, allorché di fronte alla
terra oscura ed addormentata esclama: “Che immense cose accadono nel silenzio di
questa notte!” (De beneficiis, IV, 23). Virgilio conosce, è vero, l’incanto della notte
(varrà la pena ricordare che le grandi domande leopardiane alla natura si inscrivono,
spesso, in illimitati scenari notturni), ma non sospetta quali misteri l’infinito, o
l’indefinito, nascondano alla fenomenica mente degli uomini. Virgilio non si stanca
mai della terra, né delle opere umane, per naufragare, come Lucrezio, nell’estatica
oppure turbinosa visione dell’universo: in lui il rapporto tra uomo e natura si risolve
in un’aspirazione ad un mondo di uomini umili, senza sapienza filosofica, che
lavorano in concordia sulla terra feconda e benedetta dal cielo. In tal senso la
Georgica appare il massimo monumento ad una natura perennemente animata e
benevola: nessun piacere sembra poter derivare da qualcosa che sia al di fuori della
natura. Nulla di più lontano dalle posizioni di un Leopardi che va ad elaborare la sua
seconda antitesi come antitesi natura / uomo. L’aspirazione al piacere, che nell’uomo
è continua, è destinata a restare insoddisfatta, dato che la natura umana comporta
malattie, vecchiaia, fugacità del piacere. La dimensione del piacere è dunque, allo
stesso tempo, una dimensione di dolore ed anche quel piacere che, eventualmente,
l’individuo giunge a provare non è altro che la momentanea cessazione di una
consueta dimensione di sofferenza. L’irrealizzabilità del desiderio, la costante
tensione verso un fine pressoché inattingibile è già dolore: il concetto di natura si
approfondisce, Leopardi si accorge della sua ostilità nei confronti degli uomini (i soli
che sanno di soffrire e di morire) e giunge ad una rivalutazione della ragione stessa,
l’unica che gli abbia consentito di demistificare il concetto di natura. La consonanza
più suggestiva ad emergere, è quella in direzione di Schopenhauer. Difficile non
riscontrare nel pensiero del filosofo tedesco echi leopardiani. Del resto è
Schopenhauer ad osservare che la vita oscilla fra bisogno e dolore. Se il bisogno
viene soddisfatto, allora si piomba nella sazietà e nella noia: “il fine, in sostanza, è
illusorio: con il possesso svanisce ogni attrattiva; il desiderio rinasce in forma nuova
e, con esso, il bisogno; altrimenti ecco la tristezza, il vuoto, la noia, nemici ancor più
terribili della noia”. Dei sette giorni della settimana sei sono dolore e bisogno, il
settimo è noia: non è strano sentire in queste osservazioni note provenienti dal Sabato
leopardiano. Ma c’è di più. Come si può “cessare di volere”? Non è, forse, il
naufragio nel mare dell’essere la cessazione del desiderio? Secondo Schopenhauer ci
si può liberare dal dolore e dalla noia attraverso l’arte e l’ascesi. Nell’esperienza
estetica, infatti, l’individuo si stacca dalle catene della volontà, si allontana dai suoi
desideri, annulla i suoi bisogni. L’uomo nell’esperienza estetica si annienta come
volontà e si trasforma in “puro occhio del mondo”, si immerge nell’oggetto e
dimentica il dolore (dolce, non si dimentichi, è il naufragare nel mare dell’infinito). Il
piacere estetico è proprio questo immergersi nello stato di pura contemplazione,
liberandoci (momentaneamente) da ogni desiderio e preoccupazione, è il divenire
inconsapevoli di noi stessi ma consapevoli degli oggetti intuiti (la fictio dell’ Infinito
leopardiano): l’esperienza estetica è, in breve, l’annullamento temporaneo della
volontà e quindi del dolore. L’arte - che dall’architettura (la quale esprime l’idea
delle forze naturali), alla scultura, alla pittura ed alla poesia giunge alla tragedia, la
forma più alta dell’arte - oggettiva la volontà e chi contempla ne è, in certo qual
modo, fuori. Così la tragedia (sarà Nietzsche a rovesciare l’immagine romantica della
civiltà classica ne La nascita della tragedia, del 1872) esprime ed oggettiva il dolore
senza nome, “l’affanno dell’umanità, il trionfo della perfidia, la schernevole signoria
del caso e il fatale precipizio dei giusti e degli innocenti”; ed è in tal modo che essa ci
permette di contemplare la natura del mondo. Tra le arti, poi, la musica non è che
esprima le idee, cioè i gradi dell’oggettivazione della volontà, ma la volontà stessa: la
musica è pertanto l’arte più universale e più profonda. Ripensando a Pitagora,
verrebbe da dire anche più matematica (assolutamente incapace di scoprire qualcosa
di poetico secondo Leopardi, Zib., 3242, ma necessaria all’uso della ragione, ivi,
2213). Non va dimenticato che proprio un’intuizione musicale (il celebre episodio del
suono dei martelli sulle incudini, narrato da Giamblico nella sua Raccolta di dottrine
pitagoriche) permette a Pitagora di formulare quel legame fra matematica e natura
che costituisce una delle scoperte più profonde e feconde dell’intero pensiero umano.
Dall’osservazione e dall’esperimento, in perfetto stile scientifico, Pitagora deduce la
sua teoria, secondo la quale esistono tre tipi di musica: quella strumentale
propriamente detta, quella umana e quella mondana suonata dal cosmo. La
sostanziale coincidenza dei tre tipi è responsabile da un lato dell’effetto emotivo
prodotto, per risonanza, dalla melodia sull’uomo, e dall’altro della possibilità di
dedurre leggi matematiche dell’universo da quelle matematiche. Poiché nelle leggi
dell’armonia scoperte da Pitagora intervengono soltanto numeri frazionari, detti
anche razionali, ed i rapporti armonici corrispondono perfettamente a rapporti
numerici, il grande matematico può così enunciare, in una massima famosa, che tutto
è numero (razionale). “Ragione”, in pratica, non sarebbe altro che capacità di
esprimere concetti mediante un rapporto numerico, come testimonia l'uso dello stesso
vocabolo per entrambi i termini sia in greco (logos) che in latino (ratio). Visto che
poi, per i greci, logos indica anche l’idea stessa di “parola”, il vocabolo finisce per
esprimere la triplice coincidenza fra linguaggio, razionalità e matematica. Questa
coincidenza è tuttora alla base della filosofia ed il Tractatus di Wittgenstein ne è
l’ultima formulazione riveduta e corretta. L’aspetto esoterico della teoria pitagorica,
tramandato da Platone nel Timeo, è rimasto per secoli il punto di riferimento per la
cosmologia, tanto che ancora Keplero, nel 1619, lo utilizza nella descrizione delle
leggi musicali che regolano il moto dei pianeti (come non pensare al Paradiso di
Dante?), specificando che nella sinfonia celeste Mercurio canta da soprano, Marte da
tenore, Saturno e Giove da bassi, Terra e Venere da alti. Senza considerare che, nella
terza delle tre famose leggi di Keplero, ricompare proprio il rapporto di quinta: il
quadrato del periodo di rotazione di un pianeta attorno al sole è proporzionale al cubo
della sua distanza da esso. E’ su queste basi che Newton dimostra come anche la
legge della gravitazione universale sia implicita nelle leggi dell’armonia pitagorica:
non generica matematizzazione della natura. Varrà la pena ricordare che Leopardi,
dei tre generi fondamentali della poesia (epico, tragico e lirico) riconosce, almeno a
partire dal 1828, la poesia lirica come vera poesia, come canto di affetti spontanei,
senza intromissione di elementi intellettualistici e culturali, “espressione libera e
schietta di qualunque aspetto vivo e ben sentito dell’uomo”: in un’annotazione dello
Zibaldone (pagg. 3208 – 3224) egli non a caso si sofferma sugli effetti profondi e
l’elevata funzione morale e sociale della musica greca, opera di poeti. A partire dal
1823, per tornare alla storia del pessimismo leopardiano, il poeta approfondisce,
sulla base di considerazioni filosofiche, la sua idea di dolore universale, scoprendo
l’inganno di una natura che è madre di parto e di voler matrigna. Qui risiede, in gran
parte, l’ambivalenza insita fin dall’inizio nel concetto leopardiano di natura. E’
chiaro, infatti, che il poeta debba necessariamente rendersi conto, prima o poi, che
quella stessa Natura che aveva concesso all’uomo le care illusioni, gli ha concesso
anche la ragione destinata a dissolverle. Nella prima fase del pensiero di Leopardi,
come si è già avuto modo di mettere in luce, la Natura pietosa nasconde all’uomo,
proprio mediante le illusioni, l’amara verità della sua condizione: ma ciò porta a
scoprire che neppure lo stato originario dell’umanità era stato di una felicità obiettiva,
ma piuttosto di una felicità velata. In questo risiedono l’inganno (“perché di tanto /
inganni i figli tuoi”, A Silvia, vv. 38-39) e la desolata consapevolezza del dolore come
appartenente non solo all’uomo, ma a tutto ciò che è (cfr. il Canto notturno). L’ultima
fase del pessimismo leopardiano è generalmente definita pessimismo eroico, o
titanismo. Il poeta non cerca più conforto neanche nella memoria ed assume un
impegno “morale”, proponendosi agli uomini con un invito alla solidarietà contro la
comune “inimica”, la Natura (cfr. La ginestra). Come la ginestra che, pur sapendo di
poter essere travolta dalla furia distruttrice della lava, non abbandona “i deserti” ed
anzi li consola spandendo intorno il suo delicatissimo profumo, così il poeta non
abbandona il “gran deserto del mondo”, ma offre agli altri uomini il conforto della
sua poesia. E’ evidente, allora, che non di titanismo si tratta (il titanismo, di matrice
più alfieriana che non leopardiana, ha qualcosa di irrazionalmente furente) ma di
magnanimità: è la magnanimità che consente agli uomini di scoprirsi simili, e dunque
solidali, e di poter riconoscere nella Natura la sola vera nemica. Quale distanza,
ormai, dall’esaltazione romantica della natura! Torna alla mente, quasi per
coincidentia oppositorum, l’opera del pittore Giacomo Trecourt, Lord Byron sulle
sponde del mare ellenico (olio su tela). Il grande poeta è immaginato seduto
(“sedendo e mirando” scrive il Leopardi dell’Infinito, ed ancora, riferendosi alla
ginestra, “tu siedi, o fior gentile” - La ginestra, v. 34 -, e “seggo la notte”, - ivi, v.
161, di fronte al desolato spettacolo vesuviano): una luce arcana rende opalescenti le
due figure a metà dello sfondo, il cielo sembra raccogliere i pensieri di Lord Byron,
mentre il movimento dell’acqua tremola fra gli scogli ed attualizza, vivificandola,
l'intera scena. La corrispondenza tra natura ed animo sembra veramente fuori
discussione, in questa che resta una delle pochissime rappresentazioni del
romanticismo pittorico italiano volto non tanto all’esegesi di un colloquio intimo fra
uomo e natura, quanto ad un impegno prevalentemente politico e sociale, oltreché
storico. Invano cercheremmo la sostanza di quel colloquio in autori quali Hayez,
Antonio Caimi, Cherubino Cornienti o Gaetano Turchi, presi da altro che non
dall'interesse per il rapporto che pure lega indissolubilmente l'individuo al mondo
della natura. Ciò risiede, anzitutto, nel carattere particolarissimo, storicista e
risorgimentale, del nostro romanticismo, al quale sono estranee le esaltazioni che
possiamo invece ravvisare in Girtin, per esempio, con il suo The rocking stone (solito
motivo rovinista del castello su sfondo di un cielo enigmatico), oppure, con forza
maggiore, in Elias Martin, Paesaggio romantico (Stoccolma, Nationalmuseum) in cui
tutti i motivi fondamentali dell’oscura forza della natura (la roccia, il cielo quasi
apocalittico, lo sforzo degli alberi fra i quali impressiona l’enorme abete inclinato
dall’erosione) paiono sintetizzare un elogio del caos primigenio e dell’ignoto
sconosciuto ed inconoscibile. E’ pertanto evidente che il dialogo fra uomo e natura al
di fuori del romanticismo italiano ha interpretazioni particolari, non rapportabili alla
critica cui esso è sottoposto dai nostri autori. Neppure per un istante, in sostanza,
sarebbe possibile comparare la luna di Casper Friedrich, Moon, con la luna del Canto
notturno leopardiano. In Friedrich il grande tema della luna attraversa le simbologie,
talvolta cimiteriali, delle rovine invase dall’edera e giunge, nel celeberrimo dipinto, a
rischiarare una natura inquietante, fatta di radici in forma di artigli che alla fine
s’imprimono con più forza che non le due figure umane colte di spalle; in Leopardi la
luna diventa dimensione esistenziale e filosofica, non disgiunta da un elemento
illuministico ignoto sia a Friedrich che agli altri pittori romantici tedeschi ed inglesi.
Si potrebbe osservare che già Parini, e poi anche Foscolo, per non dire di Cesarotti e
la sua traduzione delle Notti dello Young (non dispiaciuta al Leopardi), hanno dato il
proprio contributo ad un certo gusto del buio e dell’oscurità: osservazione senz’altro
vera, come però è vero che in loro quel gusto non è stato che una tappa, e neanche
fondamentale, verso temi ed accenti di illimitato respiro.