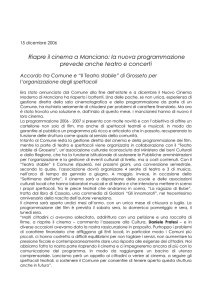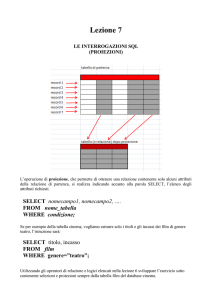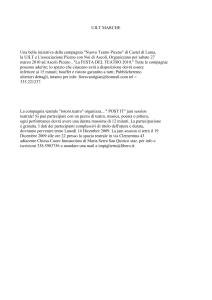7. ANDRÉ BAZIN
Teatro e cinema1
Se per la critica è diventato relativamente comune rimarcare le affinità fra il cinema e il
romanzo, il «teatro filmato» è ancora spesso considerato come un’eresia. Fino a che è
stato difeso ed esemplificato soprattutto dalle dichiarazioni e dall’opera di Marcel
Pagnol, si poteva ritenere che i suoi rari successi fossero dovuti a malintesi risultanti da
congiunture eccezionali. Il teatro filmato restava legato al ricordo retrospettivamente
comico del «Film d’arte» o all’irrisorio sfruttamento dei successi di boulevard secondo
lo «stile» Berthomieu.2 Ancora durante la guerra, il fallimento della riduzione per lo
schermo di un dramma eccellente come Le voyageur sans bagages, il cui soggetto
avrebbe potuto passare per cinematografico, dava alla critica del «teatro filmato»
argomenti apparentemente decisivi. Si è dovuti arrivare alla serie dei recenti successi
che vanno da Piccole volpi [1941] a Macbeth [1948], passando per Enrico V [1944],
Amleto [1948] e I parenti terribili [1948], per dimostrare che il cinema era in grado di
adattare validamente le più diverse opere drammatiche.
In verità il pregiudizio contro il «teatro filmato» non avrebbe da invocare forse tanti
argomenti storici quanti si può credere se ci si fondasse solo sugli adattamenti da opere
teatrali riconosciuti come tali. Bisognerebbe, in particolare, riprendere in
considerazione la storia del cinema non più in funzione dei titoli ma delle strutture
drammatiche della sceneggiatura e della regia.
Un po’ di storia
Mentre condannava senz’appello il «teatro filmato», la critica infatti prodigava i suoi
elogi a forme cinematografiche in cui una più attenta analisi avrebbe dovuto rivelare
delle metamorfosi dell’arte drammatica. Accecata dall’eresia del «Film d’Arte» e dei
suoi seguaci, la dogana lasciava passare sotto l’etichetta «cinema puro» i veri aspetti
del teatro cinematografico, a cominciare dalla commedia americana. A guardar da
vicino, questa non è meno «teatrale» dell’adattamento di una qualche pièce de
boulevard o di Broadway. Edificata sull’effetto comico di una battuta o di una
situazione, spesso non ricorreva ad alcun artificio propriamente cinematografico; la
maggior parte delle scene sono in interni e il découpage usa quasi unicamente il campo
e il controcampo per valorizzare il dialogo. Bisognerebbe qui diffondersi sui retroscena
sociologici che hanno permesso il brillante sviluppo della commedia americana per una
decina d’anni. Ritengo che essi non infirmino minimamente un virtuale rapporto fra il
teatro e il cinema. Il cinema ha in qualche modo dispensato il teatro da una reale
esistenza preliminare. Non ce n’era più bisogno, poiché gli scrittori in grado di scrivere
drammi potevano venderli direttamente per lo schermo. Ma questo è un fenomeno del
tutto accidentale, storicamente in rapporto con una congiuntura economica e
sociologica precisa e, sembra, in via di sparizione. Da quindici anni vediamo,
parallelamente al declino di un certo tipo di commedia americana, moltiplicarsi gli
adattamenti del teatro comico che ha riportato successo a Broadway. Nel campo del
dramma psicologico e di costume un Wyler non esita a riprendere puramente e
semplicemente il dramma di Lillian Hellman Piccole volpi e a portarlo «in cinema» in
una scenografia quasi teatrale. In America infatti non c’è mai stato alcun pregiudizio
contro il teatro filmato. Ma le condizioni della produzione hollywoodiana non si sono
presentate, almeno fino al 1940, allo stesso modo che in Europa. Si trattava piuttosto di
1
Da André Bazin, Il cinema e le altre arti (1951), in Che cos’è il cinema?, Garzanti, Milano 1973, pp.
142-90.
2
Incomprensibile eccezione del cinema parlato solo l’indimenticabile Jean de la Lune.
un teatro «cinematografico» che si limitava a generi ben precisi e che aveva, almeno
durante la prima decade del parlato, ben poco da prendere dal palcoscenico. La crisi di
soggetti di cui soffre oggi Hollywood l’ha già spinta a ricorrere più spesso al teatro
scritto. Ma, nella commedia americana, il teatro, invisibile, era virtualmente presente.3
È vero che in Europa, e specialmente in Francia, non potremmo invocare un successo
paragonabile a quello della commedia americana. Eccezion fatta per il caso
particolarissimo e che meriterebbe uno studio speciale, di Marcel Pagnol, l’apporto del
teatro di boulevard al cinema è stato disastroso. Ma il teatro filmato non comincia con
il parlato: risaliamo un po’ più su e precisamente all’epoca in cui il «Film d’Arte»
accentra già l’attenzione sul proprio fallimento. Allora trionfava Méliès, che ha visto in
fondo nel cinema solo un perfezionamento del meraviglioso teatrale; il trucco è per lui
il prolungamento della prestidigitazione. La maggior parte dei grandi comici francesi e
americani viene dal music-hall o dal boulevard. Basta guardare Max Linder per capire
quanto della sua arte egli deve alla sua esperienza teatrale. Come la maggior parte dei
comici dell’epoca, recita deliberatamente «al pubblico», strizza l’occhio alla sala, la
prende a testimone dei suoi imbarazzi, non esita dinanzi all’«a parte». Quanto a
Charlot, anche indipendentemente dal suo debito verso il mimo inglese, è evidente che
la sua arte consiste in una messa a punto, grazie al cinema, della tecnica della comicità
da music-hall. Qui, il cinema supera il teatro, ma continuandolo e quasi sbarazzandolo
delle sue imperfezioni. L’economia della gag teatrale è subordinata alla distanza tra la
scena e la sala, e soprattutto alla durata delle risate che spingono l’attore a prolungare
l’effetto fino alla loro estinzione. La scena lo incita dunque, persino lo costringe,
all’iperbole. Solo lo schermo poteva permettere a Charlot di raggiungere quella perfetta
matematica della situazione e del gesto, in cui il massimo di chiarezza si esprime nel
minimo tempo. […]
Del resto quando ci si riporta alla storia dei personaggi, delle situazioni e dei
procedimenti della farsa classica, è impossibile non vedere come il cinema comico non
rappresenti altro che la sua improvvisa e sfavillante rinascita. Genere in via
d’estinzione dopo il XVII secolo, la farsa «in carne ed ossa» non si ritrova quasi più
che, estremamente specializzata e trasformata, al circo e in certe forme di music-hall.
Cioè proprio dove i produttori di film comici, soprattutto ad Hollywood, sono andati a
reclutare i loro attori. Ma la logica del genere e dei mezzi cinematografici ha esteso
immediatamente il repertorio della loro tecnica: permettendo i Max Linder, i Buster
Keaton, i Laurel e Hardy, i Chaplin; fra il 1905 e il 1920, la farsa ha raggiunto uno
splendore unico nella sua storia. Intendo proprio la farsa di cui si è perpetuata la
tradizione da Plauto e Terenzio e persino dalla Commedia dell’Arte con i suoi temi e le
sue tecniche. Prenderò un solo esempio: il tema classico della tinozza del bucato si
ritrova spontaneamente in un vecchio Max Linder (1912 o 1913) in cui si può vedere il
brillante Don Giovanni, seduttore di una tintora, obbligato a sprofondarsi in
una
tinozza piena di tinta per sfuggire alla vendetta del marito becco. In un caso
simile non si tratta certo né di influenze né di reminiscenze, ma del riallacciamento
3
Nel suo libro di memorie sui suoi cinquant’anni di cinema, Il pubblico non ha mai torto, Adolphe
Zukor, creatore dello star-system, mostra anche come in America più ancora che in Francia forse, il
cinema ai suoi inizi impiegasse la sua coscienza nascente a tentare di saccheggiare il teatro. Il fatto è che
allora la celebrità e la gloria in materia di spettacolo erano sul palcoscenico, Zukor, avendo capito che
l’avvenire commerciale del cinema dipendeva dalla qualità dei soggetti e dal prestigio degli interpreti,
acquistò quanto più poteva diritti per adattamenti drammatici e corruppe le notorietà del teatro d’allora.
Le sue paghe relativamente elevate per l’epoca peraltro non sempre avevano ragione delle loro reticenze
a compromettersi in questa industria fieraiola e disprezzata. Ma ben presto, a partire da queste origini
teatrali, si sviluppò il fenomeno particolarissimo della «star», il pubblico fece la sua scelta fra le
celebrità del teatro e gli eletti acquistarono rapidamente una gloria senza paragone con quella del
palcoscenico. Parallelamente, le trame teatrali degli inizi venivano abbandonate per lasciare il posto a
storie adeguate alla mitologia che andava costituendosi. Ma l’imitazione del teatro era servita da
trampolino.
spontaneo di un genere alla sua tradizione.
Il testo, il testo!
Vediamo da queste brevi citazioni che i rapporti del teatro e del cinema sono più
antichi e più intimi di quel che non si pensi generalmente, e soprattutto che non si
limitano a quello che viene ordinariamente e in senso peggiorativo definito come
«teatro filmato». Vediamo inoltre che l’influsso, così inconscio come inconfessato, del
repertorio e delle tradizioni teatrali, e stato decisivo per determinati generi
cinematografici, ritenuti come esemplari per purezza e «specificità». [...]
Da qualunque parte la si affronti, l’opera teatrale, classica o contemporanea, è
irrevocabilmente difesa dal suo testo. Per «adattarlo» bisognerebbe rinunciare all’opera
originale per sostituirla con un’altra, forse superiore, ma che non è più l’opera teatrale.
Operazione fatalmente limitata, del resto, agli autori minori viventi, poiché i capolavori
consacrati dal tempo ci impongono come un postulato il rispetto del testo. Tutto ciò è
confermato dall’esperienza degli ultimi dieci anni. Se il problema del teatro filmato
ritrova una singolare attualità estetica, lo deve ad opere come Hamlet, Henry V,
Macbeth, per il repertorio classico, e, per i contemporanei, a dei film come The Little
foxes di Lillian Hellman e Wyler, I parenti terribili, Occupati d’Amelia, Rope... Jean
Cocteau aveva preparato prima della guerra un «adattamento» dei Parents terribles
[1938]. Riprendendo nel 1946 il suo progetto, vi ha rinunciato e si è deciso a
conservare integralmente il testo. Vedremo più avanti che ha praticamente conservato
persino la scenografia teatrale. Americana, inglese, o francese, che riguardi opere
classiche o moderne, l’evoluzione del teatro filmato è sempre la stessa: la caratterizza
una fedeltà sempre più imperiosa alla cosa scritta, come se le diverse esperienze del
cinema parlato si unissero su questo punto. In altri tempi, la prima preoccupazione del
cineasta sembrava quella di camuffare l’origine teatrale del modello, di adattarlo, di
dissolverlo nel cinema. Ora non solo sembra rinunciarvi, ma tende a sottolinearne
sistematicamente il carattere teatrale. Né può essere altrimenti dal momento che si vuoi
rispettare l’essenziale del testo. Concepito in funzione delle virtualità del teatro, il testo
le porta già tutte in sé. Determina dei modi ed uno stile di rappresentazione; è già. in
potenza, il teatro. Non si può decidere allo stesso tempo di essergli fedeli e di sviarlo
dall’espressione alla quale tende.
Nascondete questo teatro che non posso vedere!
Ne troveremo la conferma in un esempio preso dal repertorio classico: una pellicola
che infierisce forse ancora adesso nelle scuole e nei licei francesi e che pretende di
essere un tentativo di insegnamento della letteratura attraverso il cinema. Si tratta del
Medico per forza portato sullo schermo, con l’aiuto di un professore di buona volontà,
da un regista di cui taceremo il nome. Questo film ha già un voluminoso archivio di
lettere, elogiative quanto deprimenti, di professori e di presidi di liceo entusiasti delle
sue doti. In realtà il film non è altro che un’inverosimile sintesi di tutti gli errori
suscettibili di snaturare il cinema come il teatro, e Molière per giunta. La prima scena,
quella delle fascine, ambientata in una foresta vera, inizia con una carrellata
interminabile lungo il sottobosco, visibilmente destinata a far apprezzare gli effetti del
sole sotto i rami, prima di scoprire due personaggi clowneschi occupati senza dubbio a
cogliere funghi : il disgraziato Sganarello e sua moglie i cui costumi di teatro hanno
qui l’aria di un travestimento grottesco. La scenografia realistica continua per tutto il
film, per quanto possibile: l’arrivo di Sganarello per il consulto dà occasione di
mostrare un piccolo maniero di campagna del XVII secolo. Che dire del découpage:
nella prima scena si passa dal «semitotale» al «primo piano», naturalmente cambiando
di inquadratura ad ogni battuta. Si sente che se il testo non avesse dato, suo malgrado,
una certa misura al film, il regista avrebbe reso «la progressione del dialogo» con un
montaggio sul tipo di quello di Abel Gance. Così com’è, il découpage permette agli
allievi di non perdere niente, coi «campi» e «controcampi» in primo piano, della
mimica degli attori della Comédie Française, che, come c’è da aspettarsi, ci riporta ai
bei tempi del «Film d’Arte».
Se per cinema si intende la libertà dell’azione in rapporto allo spazio, e la libertà del
punto di vista in rapporto all’azione, portare sullo schermo un’opera teatrale
significherà dare alla scenografia l’ampiezza e la realtà che il palcoscenico non poteva
materialmente offrirle. Significherà inoltre liberare lo spettatore dalla costrizione della
sua poltrona e valorizzare col cambiamento di inquadratura la recitazione dell’attore.
Dinanzi ad una «messa in scena» simile bisogna convenire che tutte le accuse contro il
teatro filmato sono valide. Ma il fatto è che appunto non si tratta di messa in scena.
L’operazione è consistita soltanto nell’iniettare a forza del «cinema» nel teatro. Il
dramma originale, e a più forte ragione il testo, vi si trovano fatalmente spaesati. Il
tempo dell’azione teatrale non è evidentemente lo stesso di quello dello schermo, e il
primato drammatico della parola è sfasato in rapporto al supplemento di
drammatizzazione dato alla scena dalla macchina da presa. Infine e soprattutto, una
certa artificiosità, una trasposizione troppo spinta della scenografia teatrale è
rigorosamente incompatibile con il realismo congenito al cinema. Il testo di Molière
assume il suo senso solo in una foresta di tela dipinta, e lo stesso si può dire della
recitazione degli attori. Le luci della ribalta non sono quelle di un sole d’autunno. Al
limite, la scena delle fascine potrebbe essere recitata davanti ad un sipario, non esiste
più ai piedi di un albero.
Il fallimento di questo film illustra abbastanza bene quella che si può considerare come
la maggiore eresia del teatro filmato: la preoccupazione di «fare cinema». Più o meno è
questo il problema delle riduzioni cinematografiche abituali delle opere teatrali di
successo. Se l’azione si svolge sulla Costa Azzurra, gli amanti invece di chiacchierare
sotto un pergolato si baceranno al volante di un’auto americana sulla strada della
Corniche, con in «trasparente», sul fondo, le rocce del Cap d’Antibes. Quanto al
découpage, in Les Gueux au Paradis per esempio, i contratti equivalenti di Raimu e
Fernandel ci valgono un ugual numero di primi piani a beneficio dell’uno e dell’altro.
I pregiudizi del pubblico del resto non fanno che confermare quelli dei cineasti. Il
pubblico non pensa gran che sul cinema, ma lo identifica alla grandiosità della
scenografia, alla possibilità di mostrare un ambiente naturale e di far muovere l’azione.
Se non si aggiungesse all’opera teatrale un minimo di cinema, si considererebbe
derubato.
Il cinema deve necessariamente «essere più ricco» del teatro. Gli attori non
possono essere che celebri e tutto quello che somiglia alla miseria o all’avarizia dei
mezzi materiali è, si scrive, un fattore negativo. Il regista e il produttore che
accettassero di andare contro i pregiudizi del pubblico su questi punti dovrebbero avere
un certo coraggio. Soprattutto se anche loro non hanno fede nell’impresa. Al fondo
dell’eresia del teatro filmato sta un complesso ambivalente del cinema di fronte al
teatro: complesso d’inferiorità riguardo ad un’arte più antica e più letteraria, che il
cinema risolve con la «superiorità» tecnica dei suoi mezzi, confusa con una superiorità
estetica.
Teatro in conserva o surteatro?
Si vuole la controprova di questi errori? Ci viene fornita senza ambiguità da due
successi come Enrico V e I parenti terribili.
Quando il regista del Medico per forza cominciava il suo film con una carrellata nella
foresta, aveva l’ingenua e forse inconscia speranza di farci inghiottire poi la disgraziata
scena delle fascine, come una pillola zuccherata. Tentava di costruirvi intorno un po’ di
realtà, di prepararci una scaletta per salire sul palcoscenico. I suoi goffi espedienti
ottenevano disgraziatamente l’effetto contrario: di accusare definitivamente l’irrealtà
dei personaggi e del testo.
Vediamo ora come Laurence Olivier ha saputo risolvere nel suo Enrico V la dialettica
del realismo cinematografico e della convenzione teatrale. Anche questo film comincia
con una carrellata, ma che ci porta fin dentro il teatro: il cortile della locanda
elisabettiana [in realtà il teatro Globe]. Non pretende di farci dimenticare la
convenzione teatrale ma, al contrario, la denuncia. Il film non è direttamente e
immediatamente Enrico V, ma è la rappresentazione di Enrico V. Ciò è evidente,
giacché questa rappresentazione non si propone di essere attuale, come a teatro, ma di
svolgersi ai tempi stessi di Shakespeare. Difatti ci vengono mostrati gli spettatori e le
quinte. Non c’è dunque possibilità di errore, per godere dello spettacolo non è richiesto
l’alto di fede dello spettatore davanti al sipario che si alza. Non ci troviamo veramente
di fronte ad un’opera di teatro, ma ad un film storico sul teatro elisabettiano, cioè ad un
genere cinematografico perfettamente lecito e a cui siamo più che abituati.
Ciononostante godiamo del dramma, il nostro piacere non ha niente a che fare con
quello che ci potrebbe procurare un documentario storico, è esattamente il piacere
stesso di una rappresentazione di Shakespeare. La strategia estetica di Laurence Olivier
non era infatti che un espediente per eludere il miracolo del sipario. Facendo
del
teatro cinema, denunciando in precedenza per mezzo del cinema la recitazione e le
convenzioni teatrali invece di cercare di camuffarle, ha eliminato l’ipotesi del realismo
che si opponeva all’illusione teatrale. Una volta assicuratesi queste assise psicologiche
nella complicità dello spettatore, Laurence Olivier poteva permettersi sia la
deformazione pittorica della scenografia sia il realismo della battaglia di Azincourt; e
Shakespeare lo invitava a farlo, col suo esplicito appello all’immaginazione del
pubblico: anche in questo caso il pretesto era perfetto. Lo sviluppo cinematografico,
difficile da far accettare se il film fosse stato solo la rappresentazione dell’Enrico V,
trovava il suo alibi nella stessa opera teatrale. Restava naturalmente da mantenere
l’impegno preso. Sappiamo che lo è stato. Diciamo solo che il colore, che si finirà forse
per considerare come un elemento essenzialmente non realista, contribuisce a rendere
accettabile il trapasso all’immaginario e, nell’immaginario stesso, a permettere la
continuità dalle miniature alla ricostituzione «realistica» di Azincourt. In nessun
momento Enrico V è veramente «teatro filmato»; il film si situa in qualche modo da
una parte e dall’altra della rappresentazione teatrale, al di qua e al di là del
palcoscenico. Shakespeare comunque resta prigioniero e così il teatro, accerchiati da
tutti i lati dal cinema.
Il moderno teatro di boulevard non sembra ricorrere con altrettanta evidenza alle
convenzioni sceniche. Il «Teatro Libero» e le teorie di Antoine hanno perfino potuto
far credere un tempo all’esistenza di un teatro «realista», a una specie di pre-cinema.4
4
Un commento a questo proposito non sarà forse superfluo. Riconosciamo prima di tutto che in seno al
teatro, il melodramma e il dramma si sforzarono effettivamente di introdurre una rivoluzione realista:
l’ideale stendhaliano dello spettatore preso nel gioco che tira un colpo di pistola sul traditore (Orson
Welles a Broadway farà mitragliare le poltrone di platea). Un secolo dopo, Antoine porterà alle estreme
conseguenze il concetto di realismo della messa in scena. Non è per caso che Antoine ha fatto più tardi
del cinema. Così che se si guarda la storia da un punto di vista generale, si può convenire che un vasto
tentativo di «teatro-cinema» ha preceduto quello del «cinema-teatro». Dumas figlio e Antoine hanno
preceduto Marcel Pagnol. Si potrebbe anche affermare che la grande ripresa del teatro dopo Antoine è
stata assai facilitata
dall’
esistenza del cinema, che ha deviato su di se l’eresia del realismo così che le
teorie di Antoine si sono limitate a compiere il salutare effetto di una reazione contro il simbolismo.
L’azione svolta dal Vieux Colombier nella rivoluzione del Théâtre Libre (lasciando il realismo
al
Grand Guignol), per cui si è arrivati al punto di riaffermare il valore delle convenzioni sceniche, non
sarebbe forse stata possibile senza il concorso del cinema. Concorso esemplare, che rendeva in ogni caso
Un’illusione di cui nessuno oggi può essere più vittima. Se esiste un realismo teatrale,
non è altro che un sistema di convenzioni più segrete, meno esplicite, ma altrettanto
rigorose. La «tranche de vie» non esiste a teatro. O, almeno, il solo fatto di essere
esposta sulla scena la separa dalla vita, per farne un fenomeno in vitro, che ancora
partecipa parzialmente della natura, ma che è già profondamente modificato dalle
condizioni dell’osservazione. Antoine può anche mettere dei veri quarti di carne sulla
scena, ma non può certo come il cinema farvi sfilare un gregge. Per portare sulla scena
un albero, bisogna tagliargli le radici e in ogni caso si deve rinunciare a mostrare
realmente la foresta. Così che il suo albero appartiene ancora alla tradizione del fondale
elisabettiano e non è in fin dei conti che un elemento indicatore. Ricordate queste
verità poco contestabili, si dovrà ammettere che la riduzione cinematografica di un
«melodramma» come I parenti terribili non suscita problemi tanto diversi da quelli
della riduzione di un’opera classica. Quello che viene qui chiamato realismo non porta
affatto il dramma sullo stesso livello del cinema, non abolisce la ribalta.
Semplicemente, il sistema di convenzioni a cui obbedisce la messa in scena, e quindi il
testo, resta in un certo senso di primo grado. Le convenzioni tragiche, con il loro corteo
di inverosimiglianze materiali e di alessandrini, non sono che maschere e coturni che
accusano e sottolineano la convenzione fondamentale del fatto teatrale.
È quello di cui si è ben reso conto Jean Cocteau portando sullo schermo Les parents
terribles. Se anche il dramma è apparentemente dei più «realisti», Coctcau cineasta ha
capito che non bisognava aggiungere niente alla scenografia, che il cinema non doveva
servire a moltiplicarla, ma ad intensificarla. Se la stanza diviene un appartamento,
questo sarà sentito, grazie allo schermo e alla tecnica della macchina da presa, come
ancora più esiguo della stanza sulla scena. L’essenziale era in questo caso il fatto
drammatico della segregazione e della coabitazione; il minimo raggio di sole, una
qualunque luce che non fosse quella elettrica avrebbero distrutto quella fragile e fatale
simbiosi. Così gli abitanti del «carrozzone» ai
completo possono andare all’
altro capo
di Parigi, da Madeleine; ma noi li lasciamo alla porta del loro appartamento per
ritrovarli sulla soglia dell’altro. Non si tratta più in questo caso dell’ellissi di
montaggio ormai classica, ma di un fatto positivo della regia, a cui il cinema non
obbligava affatto Cocteau, e che supera per ciò stesso le possibilità di espressione del
teatro; in teatro infatti, non essendoci altro modo di far spostare i personaggi, non si
poteva ottenere lo stesso effetto. Cento altri esempi potrebbero confermare che la
macchina da presa rispetta la natura della scenografia teatrale e si sforza soltanto
di
accrescerne l’
efficacia, guardandosi sempre dal modificare il suo rapporto con il
personaggio. Non tutte le inevitabili imposizioni del teatro sono indispensabili.
L’obbligo di mostrare sul palcoscenico ogni ambiente successivamente e di abbassare
il sipario fra l’uno e l’altro è incontestabilmente una servitù inutile. La vera unità di
tempo e di luogo viene introdotta dalla macchina da presa grazie alla sua mobilita. Ci
voleva il cinema perché il progetto teatrale si potesse infine esprimere liberamente e
perché Les parents terribles divenisse evidentemente una tragedia dell’appartamento,
in cui una porta che si socchiude può assumere maggior significato di un monologo su
un letto. Cocteau non tradisce la sua opera, resta fedele allo spirito del dramma,
rispettandone tanto meglio le servitù essenziali in quanto sa discernerle dalle
contingenze accidentali. Il cinema agisce solo come un rivelatore che fa apparire
completamente certi dettagli che la scena lasciava in bianco.
Risolto il problema della scenografia, restava il più difficile: quello del découpage. E
qui Cocteau ha dato prova della più ingegnosa immaginazione. La nozione di «piano»
arriva al punto di dissolversi. Sussiste solo l’ «inquadratura», cristallizzazione
passeggera d’una realtà di cui non si cessa di sentire intorno la presenza. Cocteau ama
irrimediabilmente derisorio il realismo drammatico. Nessuno potrebbe oggi sostenere che il più borghese
dei drammi da boulevard non partecipi di tutte le convenzioni teatrali.
ripetere di aver pensato il suo film in 16 mm. «Pensato» solamente, poiché avrebbe
certo avuto notevoli difficoltà a realizzarlo così in formato ridotto. Ciò che conta è che
lo spettatore prova la sensazione di una presenza totale dell’avvenimento, non più
come in Welles (o in Renoir), con la profondità di campo, ma per virtù di una rapidità
diabolica dello sguardo che per la prima volta ci sembra sposare il ritmo puro
dell’attenzione.
Senza dubbio ogni buon découpage ne tiene conto. Il tradizionale «campo controcampo» divide il dialogo secondo una sintassi elementare dell’interesse. Un
primo piano del telefono che suona nel momento più patetico equivale ad una
concentrazione dell’attenzione. Ma ci sembra che il découpage sia di solito un
compromesso fra tre sistemi di analisi possibili della realtà: 1) un’analisi puramente
logica e descrittiva (l’arma del delitto vicino al cadavere); 2) un’analisi psicologica
interna al film, cioè conforme al punto di vista di uno dei protagonisti di una data
situazione (il bicchiere di latte - forse avvelenato - che deve bere Ingrid Bergman in
Suspicion, o l’anello al dito di Teresa Wright in L’ombra del dubbio); 3) infine
un’analisi psicologica in funzione dell’interesse dello spettatore; interesse spontaneo o
provocato dal regista proprio grazie a questa analisi: il pomo della porta che gira
all’insaputa del criminale che si crede solo («attento!» gridano i ragazzi a Guignol che
sta per essere sorpreso dal poliziotto).
Questi tre punti di vista, la cui combinazione costituisce la sintesi dell’avvenimento
cinematografico nella maggior parte dei film, sono sentiti come unici. In realtà essi
implicano un’eterogeneità psicologica e una discontinuità materiale. Le stesse in fondo
che si concede il romanziere tradizionale e che valsero a François Mauriac i ben noti
fulmini di Jean-Paul Sartre. L’importanza della profondità di campo e
dell’inquadratura fissa in Orson Welles o in William Wyler deriva proprio da questo
rifiuto dello spezzettamento arbitrario a cui essi sostituiscono un’immagine
uniformemente leggibile che costringe lo spettatore a fare da se stesso una scelta.
Pur restando tecnicamente fedele al découpage classico (il suo film comporta persino
un maggior numero di inquadrature della media), Cocteau gli conferisce un significato
originale utilizzando praticamente solo inquadrature della terza categoria; cioè: il punto
di vista dello spettatore e quello solo; di uno spettatore straordinariamente perspicace e
messo in grado di vedere tutto. L’analisi logica e descrittiva, così come il punto di vista
del personaggio, sono praticamente eliminati; resta quello del testimone. Si realizza
finalmente la «macchina da presa soggettiva», ma all’inverso, non come in La donna
del lago grazie ad una puerile identificazione dello spettatore col personaggio tramite il
movimento della macchina da presa, ma al contrario per la spietata esteriorità del
testimone. La macchina da presa finalmente è lo spettatore e nient’altro che lo
spettatore. Il dramma ridiventa pienamente spettacolo. Cocteau ha detto che il cinema
era un avvenimento visto dal buco della serratura. Della serratura resta qui
l’impressione della violazione di domicilio, la quasi-oscenità del «vedere».
Prendiamo un esempio assai significativo di questo partito preso dell’esteriorità: una
delle ultime immagini del film, quando Yvonne de Bray avvelenata si allontana
camminando all’indietro verso la sua stanza, guardando il gruppo affaccendato intorno
a Madeleine felice. Una carrellata all’indietro permette alla macchina da presa di
accompagnarla. Ma questo movimento di macchina non si confonde mai, per quanto la
tentazione fosse grande, con il punto di vista soggettivo di «Sofia». L’effetto della
carrellata sarebbe certamente più violento se fossimo al posto dell’attore e vedessimo
con i suoi occhi. Ma Cocteau si è ben guardato da un simile controsenso, conserva
Yvonne de Bray «come esca» e indietreggia, un po’ in ritirata, dietro di lei. L’oggetto
dell’inquadratura non è ciò che lei guarda, e nemmeno lo sguardo; è: guardarla
guardare. Al di sopra della sua spalla, certo; ed è questo un privilegio cinematografico,
ma che Cocteau si affretta a restituire al teatro.
Cocteau si riallacciava così al principio stesso dei rapporti fra lo spettatore e il
palcoscenico. Mentre il cinema gli permetteva di cogliere il dramma da molteplici
punti di vista, egli sceglieva deliberatamente di non servirsi che di quello dello
spettatore, solo denominatore comune al palcoscenico e allo schermo.
Così Cocteau conserva alla sua opera l’essenziale del suo carattere teatrale. Invece di
tentare, al seguito di tanti altri, di dissolverla nel cinema, utilizza al contrario le risorse
della macchina da presa per denunciare, sottolineare, confermare le strutture sceniche e
i loro corollari psicologici. L’apporto specifico del cinema potrebbe essere definito in
questo caso solo come un sovrappiù di teatralità.
In ciò è d’accordo con Laurence Olivier, Orson Welles, Wyler e Dudley Nichols, come
è confermato dall’analisi di Macbeth, di Amleto, di Piccole volpi e del Lutto si addice
ad Elettra, per non parlare di un film come Occupati d’Amelia in cui Claude AutantLara attua sul vaudeville un’operazione paragonabile a quella di Laurence Olivier su
Enrico V. Tutti i successi così caratteristici di questi ultimi quindici anni servono ad
illustrare un paradosso: il rispetto del testo e delle strutture teatrali. Non si tratta più di
«adattare» un soggetto. Si tratta di mettere in scena per mezzo del cinema un’opera di
teatro. Dal «teatro in conserva» ingenuo o impudente a questi recenti successi, il
problema del teatro filmato è stato rinnovato radicalmente. Abbiamo cercato di capire
in che modo. Ancor più ambiziosi, arriveremo a dire perché?
2
Il leit-motiv dei contemporanei del teatro filmato, il loro argomento ultimo e
apparentemente inespugnabile resta il piacere insostituibile che si attribuisce alla
presenza fisica dell’attore. «Quel che vi è di specificamente teatrale,» scrive Henri
Gouhier in L’Essence du Théâtre, «è l’impossibilità di staccare l’azione dall’attore». E
inoltre: «Il palcoscenico accoglie tutte le illusioni tranne quella della presenza; l’attore
vi compare sotto il suo travestimento con un’altra anima e un’altra voce, ma è là e, con
la sua presenza, lo spazio ritrova la propria esigenza e la durata il proprio spessore». In
altri termini, e inversamente: il cinema accoglie tutte le realtà fuor che quella della
presenza fisica dell’attore. Se è vero che in questa consiste l’essenza del fenomeno
teatrale, il cinema non potrebbe in alcun modo pretendervi. Se la scrittura, lo stile, la
costruzione drammatica sono, come debbono essere, concepiti rigorosamente per
ricevere anima ed esistenza dell’attore in carne ed ossa, l’impresa di sostituire all’uomo
il suo riflesso o la sua ombra appare radicalmente vana. L’argomento è irrefutabile,
nessuna sostituzione dei valori è possibile se il fenomeno teatrale ha le sue radici al di
là dell’estetica e della psicologia, sul piano dell’ontologia addirittura. I successi di
Laurence Olivier, di Welles o di Cocteau non possono allora che essere contestati (ma
ci vuole della malafede) o inspiegabili: una sfida all’estetica e al filosofo. Così non ci
se ne può dar ragione altrimenti che rimettendo in questione questo luogo comune della
critica teatrale: «l’insostituibile presenza dell’attore».
La nozione di presenza
Si imporrebbe anzitutto una prima serie di osservazioni per quel che riguarda il
contenuto del concetto di «presenza», giacché ci sembra sia proprio questa nozione,
quale poteva essere intesa prima della comparsa della fotografia, che il cinema viene
appunto a mettere in causa.
L’immagine fotografica, e particolarmente cinematografica, può essere assimilata alle
altre immagini e, come quelle, distinta dall’esistenza dell’oggetto? La presenza si
definisce naturalmente in rapporto al tempo e allo spazio. «Essere in presenza» di
qualcuno significa riconoscere che è nostro contemporaneo e constatare che rimane
nella zona accessibile naturalmente ai nostri sensi (cioè alla vista e, nella radio,
all’udito). Fino all’apparizione della fotografia e poi del cinema, le arti plastiche,
soprattutto nel ritratto, erano il solo intermediario possibile fra la presenza concreta e
l’assenza. La giustificazione era data dalla rassomiglianza, che eccita l’immaginazione
e aiuta la memoria. Ma la fotografia è tutt’altra cosa. Non è affatto l’immagine di un
oggetto o di un essere, ma molto più esattamente la sua traccia. La sua genesi
automatica la distingue radicalmente dalle altre tecniche di riproduzione. Il fotografo
procede, con l’intermediario dell’obiettivo, ad una vera presa d’impronta luminosa: a
un calco. Come tale, porta con sé qualcosa di più che la rassomiglianza, una specie di
identità (la carta d’identità è concepibile solo nell’era della fotografia). Ma la
fotografia è una tecnica inferma nella misura in cui la sua istantaneità la obbliga a
cogliere il tempo solo di taglio. Il cinema realizza lo strano paradosso di ricalcarsi sul
tempo dell’oggetto e di prendere oltre a ciò l’impronta della sua durata.
Il XIX secolo, con le sue tecniche oggettive di riproduzione visive e sonore, ha fatto
apparire una nuova categoria di immagini; i loro rapporti con la realtà donde esse
procedono esigerebbero di essere rigorosamente definiti. Anche se i problemi estetici
che ne derivano direttamente non potrebbero essere posti convenientemente senza
questa operazione filosofica antecedente, è piuttosto imprudente trattare antichi fatti
estetici come se le categorie che essi interessano non fossero state per nulla modificate
dall’apparizione di fenomeni assolutamente nuovi. Il senso comune - forse miglior
filosofo in queste materie - l’ha ben capito quando ha creato un’espressione per
significare la presenza di un attore aggiungendo al manifesto: «in carne e ossa». Per
esso infatti il termine di «presenza» si presta oggi all’equivoco e un pleonasma non è
mai di troppo al tempo del cinematografo. In tal modo non è mai così sicuro che non ci
sia nessun intermediario concepibile fra la presenza e l’assenza. È sempre sul piano
dell’ontologia che l’efficacia del cinema prende origine. È falso dire che lo schermo sia
assolutamente impotente a metterci «in presenza» dell’attore. Lo fa alla maniera di uno
specchio (di cui si ammetterà che restituisce la presenza di quello che vi riflette), ma di
uno specchio dal riflesso differito, la cui foglia di stagno trattenga l’immagine. 5 È vero
che a teatro Molière può agonizzare sulla scena, e noi avere il privilegio di vivere nel
tempo biografico dell’attore; ma nel film Manolete assistiamo all’autentica morte del
celebre torero, e se la nostra emozione non è altrettanto forte come quella che avremmo
provato se fossimo stati nell’arena in quel momento storico, tuttavia è della stessa
natura. Quanto perdiamo di testimonianza diretta, non lo riguadagnamo forse grazie
all’artificiosa prossimità che permette l’ingrandimento della macchina da presa? Tutto
si svolge come se nel parametro tempo-spazio, che definisce la presenza, il cinema non
ci restituisse effettivamente che una durata indebolita, diminuita ma non ridotta a zero,
mentre la moltiplicazione del fattore spaziale ristabilirebbe l’equilibrio dell’equazione
psicologica.
Non potremmo comunque opporre il cinema e il teatro su questa sola nozione di
presenza, senza renderci prima conto di quel che sussiste sullo schermo e che filosofi
ed esteti non hanno ancora potuto chiarire. Non tenteremo qui l’impresa, poiché
neppure nell’accezione classica, attribuita a questo concetto da Henri Gouhier, e da
altri, la «presenza» ci sembra in ultima analisi racchiudere l’essenza ultima del teatro.
Opposizione e identificazione
Un’introspezione sincera dei piaceri teatrali e cinematografici, in quel che essi hanno
di meno intellettuale, di più diretto, ci costringe a riconoscere nella gioia che ci lascia il
palcoscenico, abbassato il sipario, un non so che di maggiormente tonico e,
confessiamolo, di più nobile - o forse bisognerebbe dire di più morale - della
soddisfazione che segue un buon film. Sembrerebbe che se ne tragga una migliore
5
La televisione viene naturalmente ad aggiungere una varietà nuova alle «pseudo-presenze» derivanti
dalle tecniche scientifiche di riproduzione inaugurate dalla fotografia. Sul piccolo schermo, nelle
trasmissioni «in diretta», l’attore è stavolta anche temporalmente e spazialmente presente. Ma la
relazione di reciprocità attore-spettatore è interrotta in un senso. Lo spettatore vede senza essere visto:
non c’è movimento di ritorno. Il teatro televisivo sembrerebbe dunque partecipare sia del teatro che del
cinema. Del teatro per la presenza dell’attore rispetto allo spettatore, ma del cinema per la non-presenza
dei secondo rispetto al primo. Tuttavia questa non-presenza non è vera e propria assenza, poiché l’attore
di televisione ha coscienza dei milioni di occhi e di orecchie virtualmente rappresentati dalla telecamera.
Questa presenza astratta viene rivelata in particolare quando l’attore si inceppa sul suo testo. Questo
incidente, già penoso in teatro, è intollerabile in TV, dato che lo spettatore che non ci può far niente
prende coscienza della solitudine contronatura dell’attore. Sul palcoscenico, nelle stesse circostanze, si
crea una certa complicità con la sala che viene in aiuto dell’attore in difficoltà. Questo rapporto di
ritorno è impossibile in TV.
coscienza. In un certo senso, per lo spettatore, è come se tutto il teatro fosse
corneilliano. Da questo punto di vista, si potrebbe dire che ai migliori film «manca
qualche cosa». È come se un inevitabile abbassamento di corrente, un misterioso corto
circuito estetico ci privasse al cinema di una certa tensione decisamente propria del
palcoscenico. Per quanto sottile, questa differenza esiste, persino fra una cattiva
interpretazione filodrammatica e la più brillante interpretazione cinematografica di
Laurence Olivier. Constatazione che non ha niente di banale; e la sopravvivenza del
teatro dopo cinquant’anni di cinema e dopo le profezie di Marcel Pagnol ne fornisce
già una prova sperimentale sufficiente.
All’origine del disincantamento che segue il film si potrebbe certamente individuare un
processo di spersonalizzazione dello spettatore. Come scriveva nel 1937 Rosenkrantz
in Esprit, in un articolo profondamente originale per la sua epoca, «i personaggi dello
schermo risultano naturalmente degli oggetti di opposizione mentale, in quanto la loro
presenza effettiva dà loro una realtà oggettiva, così che a trasferirli in oggetti di un
mondo immaginario deve intervenire la volontà attiva dello spettatore, la volontà di far
astrazione dalla loro realtà fisica. Tale astrazione è frutto di un processo
dell’intelligenza che non si può richiedere che ad individui pienamente coscienti». Lo
spettatore di cinema tende ad identificarsi con il protagonista per un processo
psicologico che ha per conseguenza di costituire la sala in «folla» e di uniformare le
emozioni: «Come in algebra, se due grandezze sono rispettivamente uguali ad una
terza, sono uguali anche fra di loro, si potrebbe dire: se due individui si identificano ad
un terzo, essi si identificano l’uno con l’altro». Prendiamo l’esempio abbastanza
significativo delle girls sul palcoscenico o sullo schermo. Sullo schermo la loro
apparizione soddisfa delle aspirazioni sessuali inconsce; e quando il protagonista viene
a contatto con loro soddisfa il desiderio dello spettatore nella misura in cui questi si è
identificato con il protagonista. Sulla scena, le girls destano i sensi dello spettatore
come lo farebbe la realtà. Non si produce perciò l’identificazione con il protagonista, il
quale diviene oggetto di gelosia e di invidia. Insomma, Tarzan non è concepibile che al
cinema. Il cinema placa lo spettatore, il teatro lo eccita. Il teatro, anche quando fa
appello agli istinti più bassi, impedisce fino ad un certo punto la formazione di una
mentalità di folla,6 ostacola la rappresentazione collettiva nel senso psicologico, in
quanto esige una coscienza individuale attiva, mentre il film non chiede che
un’adesione passiva.
Queste considerazioni gettano una nuova luce sul problema dell’attore. Lo fanno
discendere dall’ontologia alla psicologia. È nella misura in cui il cinema favorisce un
tale processo di identificazione che si oppone al teatro. Così posto, il problema non
sarebbe più radicalmente insolubile, giacché è noto che il cinema dispone di
procedimenti di messa in scena che favoriscono la passività o al contrario eccitano più
o meno la coscienza. Inversamente, il teatro può cercare di attenuare l’opposizione
psicologica fra lo spettatore e il protagonista. Teatro e cinema non sarebbero dunque
più separati da un abisso estetico insuperabile, ma tenderebbero solamente a suscitare
due atteggiamenti mentali su cui i registi mantengono un vasto controllo.
Ad un’analisi più accurata, il piacere teatrale non si opporrebbe solo a quello del
cinema, ma anche a quello del romanzo. Il lettore del romanzo, fisicamente solitario
come lo è, psicologicamente, lo spettatore delle sale cinematografiche, si identifica con
i personaggi,7 ed infatti prova anch’esso, dopo una lunga lettura, la medesima ebbrezza
di una strana intimità con gli eroi. Incontestabilmente nel piacere del romanzo, come
del cinema, c’è una compiacenza in se stessi, una concessione alla solitudine, una
specie di tradimento dell’azione tramite il rifiuto di una responsabilità sociale.
L’analisi del fenomeno d’altronde può essere facilmente ripresa da un punto di vista
psicanalitico. Non è significativo che lo psichiatra abbia ripreso il termine aristotelico
di catharsis? Le ricerche pedagogiche moderne relative allo «psicodramma» sembrano
aprire degli orizzonti fecondi sul processo catartico del teatro. Si utilizza infatti
6
Folla e solitudine non sono antinomici: il pubblico di un cinema costituisce una folla di individui
solitari. Folla deve essere qui intesa come il contrario di una comunità organica, volontariamente scelta.
7
Cfr. Cl.E. Magny, L’Age du roman américain (Ed. du Scuil).
l’ambiguità ancora esistente nel bambino fra le nozioni di recitazione e di realtà per
portare il soggetto a liberarsi, nell’improvvisazione teatrale, delle rimozioni di cui
soffre. Questa tecnica porta a creare una specie di teatro impreciso, in cui la recitazione
è seria e l’attore è anche spettatore. L’azione che vi si svolge non è ancora scissa dalla
ribalta, che è evidentemente il simbolo architettonico della cesura che ci separa dalla
scena. Noi deleghiamo Edipo ad agire in vece nostra dall’altra parte di quel muro di
fuoco, quella ardente frontiera del reale e dell’immaginario che autorizza i mostri
dionisiaci e ci protegge da loro.8 Le sacre belve non usciranno da quella gabbia 9 di
luce, fuori della quale essi sono ai nostri occhi incongrui e sacrileghi (la specie di
rispetto inquietante che ancora circonda di un’aureola l’attore truccato quando andiamo
a visitarlo nel suo camerino, come una fosforescenza). Che non si obietti che il teatro
non sempre ha avuto una ribalta. Essa non è che un simbolo, prima del quale ce ne
sono stati altri, fin dal coturno e la maschera. Nel XVII secolo, l’accesso dei
marchesini al palcoscenico non negava la ribalta, ma la confermava piuttosto con una
specie di violazione privilegiata, così come oggi a Broadway, quando Orson Welies
sparpaglia degli attori nella sala per tirare dei colpi di pistola sul pubblico, non
annienta affatto la ribalta, passa semplicemente dall’altra parte. Le regole del gioco
sono fatte per essere violate, ci si aspetta che certi giocatori barino.10
In rapporto all’obiezione della presenza, e a quella sola, il teatro e il cinema non
sarebbero dunque essenzialmente opposti. Entrano in causa piuttosto le due modalità
psicologiche dello spettacolo. Il teatro si costruisce sulla coscienza reciproca della
presenza dello spettatore e dell’attore, ma ai fini della recitazione. Esso agisce in noi
attraverso la partecipazione ludica11 ad un’azione, attraverso la ribalta e come sotto la
protezione della sua censura. Al cinema, al contrario, restiamo dei contemplatori
solitari, nascosti in una camera oscura, attraverso delle persiane socchiuse, di uno
spettacolo che ci ignora e che partecipa dell’universo. Niente viene ad opporsi alla
nostra immaginaria identificazione al mondo che si agita davanti a noi, che diviene il
Mondo. Non è più sul fenomeno dell’attore, in quanto persona fisicamente presente che
si ha interesse a concentrare l’analisi, ma sull’insieme delle condizioni della
«recitazione teatrale» che strappa allo spettatore la sua partecipazione attiva. Vedremo
che si tratta allora molto meno dell’attore e della sua «presenza» che dell’uomo e della
scenografia.
Il retro della scenografia12
Non c’è teatro che dell’uomo, ma il dramma cinematografico può fare a meno di attori.
Una porta che sbatte, una foglia al vento, le onde che lambiscono una spiaggia possono
raggiungere il massimo potere drammatico. Alcuni dei capolavori del cinema si
servono dell’uomo solo come accessorio: come una comparsa, o un contrappunto della
natura che costituisce il vero personaggio centrale. Anche se in Nanook [Nanook of the
8
Cfr. P.A. Touchard, Dionysos (Ed. du Seuil).
Nell’originale si legge page, pagina, probabile refuso per cage, gabbia. (n.d.t.).
10
Un ultimo esempio prova che la presenza costituisce il teatro solo nei limiti in cui si tratta di
recitazione. Ognuno ha sperimentato a sue spese o a quelle degli altri la penosa situazione che consiste
nell’essere osservati a propria insaputa o semplicemente suo malgrado. Gli innamorati che si baciano
sulle panchine sono uno spettacolo per i passanti che però non ci fanno caso. La mia portinaia, che ha il
senso della parola giusta, dice guardandoli che «si è al cinema». Ognuno si è qualche volta trovato
nell’obbligo impellente di compiere davanti a un testimone un’azione ridicola. Ci prende allora una
rabbiosa vergogna che è tutto il contrario deIl’esibizionismo teatrale. Colui che guarda dal buco della
serratura non è a teatro; Cocteau ha appunto dimostrato in Le sang d’un poète che era già al cinema.
Eppure si tratta proprio di spettacoli, i protagonisti sono davanti a noi in carne ed ossa, ma una delle due
parti non sa niente o lo subisce suo malgrado: «Non è recitazione».
11
Si tenga presente che in questo paragrafo, come altrove, si è tradotto, restrittivamente, l’originale jeu
(gioco, finzione, recitazione) con «recitazione». (n.d.t.)
12
Abbiamo tradotto, a seconda dei casi, décor con «ambiente» o «scenografia»; il termine francese
racchiude entrambi i sensi, si riferisce cioè sia a uno spazio esterno non ricostruito che a quello interno,
ricostruito o no in teatro di posa o sul palcoscenico. (n.d.t.)
9
North, di Robert Flaherty, 1922] o Man of Aran [stesso regista, 1934] soggetto del film
è la lotta dell’uomo e della natura, non ci potrebbe essere paragone possibile con
un’azione teatrale, in quanto il punto d’appoggio della leva drammatica non è
nell’uomo, ma nelle cose. Come ha detto, credo, Jean-Paul Sartre, a teatro il dramma
parte dall’attore, al cinema va dall’ambiente all’uomo. Tale inversione dei poli
drammatici è di un’importanza decisiva e interessa l’essenza stessa della regia.
In ciò bisogna vedere una delle conseguenze del realismo fotografico. Certo, se il
cinema utilizza la natura, è perché può farlo: la macchina da presa offre ai regisi tutte
le risorse del microscopio e del telescopio. Le ultime fibre di una corda che sta per
cedere come tutt’un esercito che prende d’assalto una collina, sono avvenimenti ormai
alla nostra portata. Le cause e gli effetti drammatici non hanno per l’occhio della
macchina da presa dei limiti materiali. Essa libera il dramma da ogni contingenza di
tempo e di spazio. Ma questa liberazione dai poteri drammatici tangibili ancora non è
che una causa estetica secondaria che non spiegherebbe radicalmente il ribaltamento
dei valori fra l’uomo e l’ambiente. Può capitare infatti che i cinema si privi
volontariamente dei ricorsi possibili all’ambiente e alla natura - ne abbiamo visto
l’esempio in I parenti terribili - mentre il teatro, al contrario, si serve di un
meccanismo complesso per dare allo spettatore l’illusione dell’ubiquità. La passione di
Giovanna d’Arco [1928] di Carl Dreyer, tutta composta di primi piani con una
scenografia quasi invisibile (e d’altronde teatrale) di Jean Hugo, è forse meno
cinematografica di Ombre rosse? È quindi evidente che la quantità. non ha a che fare
con il problema, più di quanto non abbia a che fare una certa somiglianza con le
scenografie teatrali. Lo scenografo non potrà concepire in modo sensibilmente diverso
la stanza di La Dame aux Camélias per il palcoscenico e per lo schermo. È vero che al
cinema avremo forse dei primi piani dei fazzoletto macchiato di sangue. Ma un’abile
regia teatrale saprà, anch’essa, servirsi della tosse e del fazzoletto. Tutti i primi piani di
I parenti terribili sono, infatti, ripresi dal teatro ove la nostra attenzione li isolava
spontaneamente. Se la regia cinematografica non si distinguesse da quella teatrale che
in quanto autorizza una maggior vicinanza della scenografia e un suo sfruttamento più
razionale, non ci sarebbe veramente più nessuna ragione di continuare a fare del teatro,
e Pagnol sarebbe un profeta; giacché vediamo bene che i pochi metri quadrati della
scenografia di Vilar per La Danse de Mort costituiscono per il dramma un apporto
simile a quello rappresentato dall’isola ove fu girato il film, peraltro eccellente, di
Marcel Cravenne.
Il problema infatti non consiste nella scenografia in se stessa, ma nella sua natura e
funzione. Dobbiamo a questo punto chiarire una nozione specificamente teatrale:
quella del luogo drammatico.
Non potrebbe esistere teatro senza architettura, sia esso il vestibolo della cattedrale, le
arene di Nimes, il palazzo dei papi, il palco da fiera, l’emiciclo, quasi opera di un
Bérard13 in delirio, del teatro di Vicenza, o l’anfiteatro rococò di una sala dei
boulevard. Gioco o celebrazione, il teatro non può per essenza confondersi con la
natura, sotto pena di dissolversi in essa e di cessare di esistere. Fondato sulla coscienza
reciproca dei partecipanti presenti, esso ha bisogno di opporsi al resto del mondo come
la recitazione alla realtà, la complicità all’indifferenza, la liturgia alla volgarità
dell’utile. Il costume, la maschera o il trucco, lo stile del linguaggio, la ribalta
concorrono più o meno a questa distinzione, ma il segno più evidente ne è il
palcoscenico, la cui architettura ha variato senza cessare però di definire uno spazio
privilegiato, realmente o virtualmente distinto dalla natura. È in rapporto a questo
luogo drammatico localizzato che esiste la scenografia; essa contribuisce
semplicemente, e più o meno, a distinguerlo, a specificarlo. Ma, quale che sia, la
scenografia costituisce le pareti di quella scatola a tre lati, aperta sulla sala, che è il
palcoscenico. Quelle false prospettive, quelle facciate, quei boschetti hanno un
rovescio fatto di tele, di chiodi e di legno. Nessuno ignora che l’attore che si «ritira nei
suoi appartamenti» - dalla parte del cortile o dalla parte del giardino - va in realtà o
13
Christian Bérard, noto scenografo francese, particolarmente famoso per i contributi di prim’ordine dati
ad alcuni film di Jean Cocteau (La belle et la bête, in particolare). (n.d.t.:.)
togliersi il trucco nel suo camerino; quei pochi metri di luce e di illusione sono
circondati di meccanismi e di quinte i cui labirinti nascosti, ma conosciuti, non
impacciano affatto il piacere dello spettatore che sta al gioco.
La scenografia teatrale, in quanto non è che un elemento dell’architettura scenica, è
dunque un luogo materialmente chiuso, limitato, circoscritto, le cui sole «aperture»
sono quelle a cui acconsente la nostra immaginazione. Le sue apparenze sono rivolte
verso l’interno, verso il pubblico e la ribalta; essa esiste tramite il suo rovescio e la sua
assenza di al di là, come la pittura tramite la cornice.14) Come il quadro non si
confonde con il paesaggio che rappresenta, e non è neppure una finestra su di un muro,
il palcoscenico e la scenografia in cui si svolge l’azione sono un microcosmo estetico
inserito a forza nell’universo, ma essenzialmente eterogeneo alla Natura che li
circonda.
Nel cinema invece il principio è quello di negare ogni frontiera all’azione. Il concetto
di luogo drammatico non solo è estraneo, ma essenzialmente contraddittorio con la
nozione di schermo. Lo schermo non è una cornice, come quella del quadro, ma un
mascherino segreto che non lascia scorgere che una parte dell’avvenimento. Quando
un personaggio esce dal campo della macchina da presa, siamo disposti ad ammettere
che esso sfugge al campo visivo, ma per noi continua ad esistere identico a se stesso in
un altro punto della scena, che ci è nascosto. Lo schermo non ha quinte, non potrebbe
averne senza distruggere la sua specifica illusione, che è di fare di una pistola o di un
viso il centro stesso dell’universo. Al contrario di quello del palcoscenico, lo spazio
dello schermo è centrifugo.
Dato che l’infinito di cui il teatro ha bisogno non potrebbe essere spaziale, esso può
essere solo quello dell’anima umana. Circondato da questo spazio chiuso, l’attore è nel
fuoco di un doppio specchio concavo. Dalla sala e dalla scenografia convergono su di
lui i fuochi oscuri della coscienza e le luci della ribalta. Ma il fuoco di cui egli brucia è
anche quello della propria passione e del suo punto focale; egli accende in ogni
spettatore una fiamma complice. Come l’oceano nella conchiglia, l’infinito
drammatico del cuore umano romba e si ripercuote fra le pareti della sfera teatrale. Per
questo tale drammaturgia è di essenza umana, l’uomo ne è la causa e il soggetto.
Sullo schermo, l’uomo cessa di essere il punto focale del dramma per divenire
(eventualmente) il centro di un universo. L’urto della sua azione può sviluppare le sue
onde all’infinito; la scenografia che lo circonda partecipa dello spessore del mondo.
Perciò, come tale, l’attore può anche essere assente poiché l’uomo non gode qui di
nessun privilegio a priori sull’animale o sulla foresta. Tuttavia niente esclude che esso
sia la molla principale e unica del dramma (come nella Giovanna d’Arco di Dreyer) e
in ciò il cinema può benissimo sovrapporsi al teatro. In quanto azione, quella di Fedra
o di Re Lear non è meno cinematografica che teatrale, e la vista della morte di un
coniglio in La règle du jeu ci commuove come quella, raccontata, del gattino di
Agnese.
Ma se Racine, Shakespeare o Molière non sopportano di essere portati al cinema con
una semplice registrazione plastica e sonora, è perché il trattamento dell’azione e lo
stile del dialogo sono stati concepiti in funzione della loro eco sull’architettura della
14
L’illustrazione storica ideale di questa teoria dell’architettura teatrale nei suoi rapporti col
palcoscenico e la scenografia ci è fornita dal Palladio col suo straordinario teatro olimpico di Vicenza
che riporta l’antico anfiteatro, ancora a cielo scoperto, a un puro trompe-l’oeil architettonico. Perfino
l’accesso stesso alla sala costituisce già un’affermazione della sua essenza architettonica. Costruito nel
1590, all’interno di una ex caserma offerta dalla città, il Teatro Olimpico offre allo spazio esterno solo
dei grandi muri nudi di mattoni rossi, cioè un’architettura puramente utilitaria e che si potrebbe dire
«amorfa» nel senso in cui i chimici distinguono lo stato amorfo dallo stato cristallino di uno stesso
corpo. Il visitatore che entra come attraverso un buco nella roccia non crede ai suoi occhi quando si
trova d’un tratto nella straordinaria grotta scolpita che costituisce l’emiciclo teatrale. Come quei geodi di
quarzo e d’ametista che sembrano dall’esterno dei volgari ciottoli ma il cui spazio interno è fatto di un
viluppo di puri cristalli segretamente orientati verso l’interno, il teatro di Vicenza è concepito secondo le
leggi di uno spazio estetico e artificiale esclusivamente polarizzato verso il centro.
sala. Ciò che queste tragedie hanno di specificamente teatrale non è tanto la loro azione
quanto la priorità umana, quindi verbale, data all’energia drammatica.
Il problema del teatro filmato, almeno per le opere classiche, non consiste tanto nella
trasposizione di un’«azione» dalla scena allo schermo, quanto nella trasposizione di un
testo da un sistema drammatico ad un altro, conservando tuttavia la sua efficacia. Non
è quindi essenzialmente l’azione dell’opera teatrale che resiste al cinema ma, oltre i
modi dell’intreccio che forse sarebbe facile adattare alla verosimiglianza dello
schermo, la forma verbale che le contingenze estetiche e i pregiudizi culturali ci
obbligano a rispettare. È proprio questa che si rifiuta di lasciarsi prendere nella finestra
dello schermo. «Il teatro» dice Baudelaire, «è il lampadario». Se si dovesse opporre un
altro simbolo all’artificiale oggetto cristallino, brillante, multiplo e circolare, che
rifrange le luci intorno al suo centro e ci tiene prigionieri nella sua aureola, diremmo
che il cinema è la piccola lampada della maschera che attraversa come un’incerta
cometa la notte del nostro sogno ad occhi aperti: lo spazio diffuso, senza geometria e
senza frontiere, che circonda lo schermo.
La storia dei fallimenti e dei recenti successi del teatro filmato sarà dunque quella
dell’abilità dei registi riguardo ai modi di mantenere l’energia drammatica in un
ambiente che la rifletta o, almeno, le dia sufficiente risonanza perché essa sia ancora
percettibile dallo spettatore di cinema. Cioè di una estetica non tanto dell’attore, quanto
della scenografia e del découpage.
Si capisce quindi come il teatro filmato sia radicalmente votato al fallimento quando si
riporti, da vicino o da lontano, ad una fotografia della rappresentazione scenica, anche
e soprattutto quando la macchina da presa cerca di farci dimenticare la ribalta e le
quinte. L’energia drammatica del testo, invece di tornare all’attore, va a perdersi senza
eco nell’etere cinematografico. Si spiega così come un’opera di teatro filmata possa
rispettare un testo, essere ben recitata in una scenografia verosimile, e sembrarci
totalmente annientata. È il caso, per riprendere un esempio concreto, del Voyageur
sans bagages. Il dramma giace davanti a noi, apparentemente identico a se stesso, ma
svuotato di ogni energia, come un accumulatore scaricato da un’invisibile presa di
terra.
Ma, al di là dell’estetica della scenografia, sulla scena e sullo schermo, vediamo bene
che in ultima analisi il problema posto è quello del realismo. E questo è il punto a cui si
torna sempre quando si parla di cinema.
Lo schermo e il realismo dello spazio
Dalla natura fotografica del cinema, infatti, è facile concludere col suo realismo.
L’esistenza di un meraviglioso o di un fantastico del cinema, lungi dall’infirmare il
realismo dell’immagine, ne è invece la più probante riprova. L’illusione non si fonda al
cinema, come a teatro, su convenzioni tacitamente ammesse dal pubblico, ma al
contrario sul realismo imprescindibile di quello che gli viene mostrato. Il trucco deve
essere materialmente perfetto: l’«uomo invisibile»15 deve portare un pigiama e fumare
la sigaretta.
Se ne deve concludere che il cinema è votato alla sola rappresentazione, se non della
realtà naturale, almeno della realtà verosimile di cui lo spettatore ammette l’identità
con la natura, quale egli la conosce? Il relativo fallimento estetico dell’espressionismo
tedesco confermerebbe questa ipotesi, proprio perché vediamo come Caligari [Il
gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, 1919] ha voluto sottrarsi al realismo
della scenografia sotto l’influsso del teatro e della pittura. Ma ciò sarebbe apportare
Allusione a un famoso film fantastico, The invisible man (L’uomo invisibile, 1933) di James Whale.
(n.d.t.).
15
una soluzione semplicistica ad un problema che ammette delle risposte più sottili.
Siamo pronti ad ammettere che lo schermo si apre su un universo artificiale purché
esista un denominatore comune fra l’immagine cinematografica e ìl mondo in cui
viviamo. La nostra esperienza dello spazio costituisce l’infrastruttura della nostra
concezione dell’universo. Trasformando la formula di Henri Gouhier: «Il palcoscenico
accoglie tutte le illusioni, salvo quella della presenza», si potrebbe dire: «Si può
svuotare l’immagine cinematografica di ogni realtà, salvo una: quella dello spazio».
Ogni realtà è forse dir troppo, poiché non si potrebbe senza dubbio concepire una
ricostruzione dello spazio pura di ogni riferimento alla natura. L’universo dello
schermo non può giustapporsi al nostro, vi si sostituisce necessariamente poiché il
concetto stesso di universo è spazialmente esclusivo. Per un certo tempo, il film è
l’Universo, il Mondo, o, se si vuole, la Natura. Si deve riconoscere che tutti i film che
hanno cercato di sostituire una natura fabbricata e un universo artificiale al mondo
della nostra esperienza non ci sono riusciti. Ammessi i fallimenti di Caligari e dei
Nibelunghi [di Fritz Lang, 1924], ci si domanda donde viene l’incontestabile successo
di Nosferatu [di Murnau, 1922] e di La passione di Giovanna d’Arco (criterio di
successo restando il fatto che questi ultimi film non sono invecchiati). Sembra tuttavia,
a prima vista, che i procedimenti della regia appartengano alla stessa famiglia estetica,
e che, sotto le variazioni di temperamento o d’epoca, si possano classificare questi
quattro film, nella direzione opposta a quella del «realismo», in un certo
«espressionismo». Ma se si guarderà più da vicino, ci si accorgerà che esistono fra di
essi delle differenze essenziali. Sono evidenti per quel che riguarda R. Wiene e
Murnau. Nosferatu è ambientato per lo più in ambiente naturale, mentre il fantastico di
Caligari si sforza di nascere dalle deformazioni della luce e della scenografia. Il caso
della Giovanna d’Arco di Dreyer è ancora più sottile, perché la parte della natura
sembra a tutta prima inesistente. Pur essendo più discreta, la scenografia di Jean Hugo
non è quasi meno artificiale e teatrale di quella utilizzata per Caligari; l’uso
sistematico del primo piano e di angolazioni insolite è fatto apposta perché finisca col
distruggere lo spazio. I frequentatori dei cineclub sanno che non si manca mai di
raccontare, prima della proiezione del film di Dreyer, la famosa storia dei capelli della
Falconetti, tagliati realmente per le necessità della causa, e che si fa inoltre menzione
della mancanza di trucco per gli attori. Ma tali richiami storici non superano mai in
genere l’interesse dell’aneddoto. Mi sembra invece che in essi si celi il segreto estetico
del film; ciò che gli vale la sua perennità. Per essi l’opera di Dreyer cessa di avere
qualcosa in comune con il teatro e, si potrebbe addirittura dire, con l’uomo. Più Dreyer
ricorreva esclusivamente all’espressione umana, più doveva riconvertirla in natura.
Che non ci si inganni su questo punto; quel prodigioso affresco di teste è il contrario
stesso del film d’attori: è un documentario di facce. Non è importante che gli interpreti
«recitino» bene; invece la verruca del vescovo Cauchon o le macchie rosse sulla pelle
di Jean d’Yd sono parte integrante dell’azione. In questo dramma visto al microscopio,
la natura intera palpita sotto ciascun poro della pelle. Lo spostamento di una ruga, un
labbro che si contrae sono le scosse sismiche e le maree, il flusso e riflusso di questa
scorza umana. Ma la suprema intelligenza cinematografica di Dreyer mi piace vederla
nella scena di esterni che chiunque altro non avrebbe mancato di girare in studio. La
scenografia costruita evoca sicuramente un Medio Evo di teatro e di miniature. In un
certo senso niente è meno realistico del tribunale nel cimitero o del portale col ponte
levatoio, ma tutto è illuminato dalla luce del sole e il becchino getta nella fossa una
palata di terra vera.16 Sono questi dettagli «secondari» e apparentemente contrari
all’estetica generale dell’opera che le conferiscono però la sua natura cinematografica.
Se il paradosso estetico del cinema consiste in una dialettica del concreto e
dell’astratto, nell’obbligo dello schermo di significare solo per il tramite del reale, tanto
16
In questo senso considero gravi errori di Laurence Olivier la scena del cimitero e quella della morte di
Ofelia in Amleto. Avrebbe avuto l’occasione di introdurre il sole e la terra in contrappunto alla
scenografia di Elsinore. Ne aveva intravista la necessità con la vera immagine del mare durante il
monologo di Amleto? L’idea, eccellente in sé, non è, da un punto di vista tecnico, perfettamente
sfruttata.
più importante appare discernere gli elementi della regia che confermano la nozione di
realtà naturale e quelli che la distruggono. Ora, è assolutamente grossolano subordinare
la sensazione di realtà alla quantità di fatti reali accumulati. Les dames du Bois de
Boulogne può essere considerato un film eminentemente realistico, anche se tutto o
quasi tutto vi è stilizzato. Tutto: salvo il rumore insignificante di un pulisci-vetro, il
mormorio di una cascata o il cadere della terra che sfugge da un vaso rotto. Sono
rumori d’altronde accuratamente scelti per la loro indifferenza all’azione, e che ne
garantiscono la verità.
Essendo il cinema per sua essenza una drammaturgia della natura si sostituisce
all’universo invece di essere ad esso incluso. Lo schermo non potrebbe darci l’illusione
di questa sensazione di spazio senza ricorrere a certe garanzie naturali. Ma si tratta non
tanto della costruzione di una scenografia, di un’architettura o di una immensità quanto
dell’isolamento di un catalizzatore estetico, che potrà essere sufficiente introdurre a
dosi infinitesimali nella regia, perché questa precipiti totalmente in «natura». La foresta
di calcestruzzo dei Nibelunghi tenta inutilmente di apparire infinita, noi non crediamo
al suo spazio; mentre il fremito di un solo albero di betulla al vento, sotto il sole,
potrebbe bastare a evocare tutte le foreste del mondo.
Se tale analisi è fondata, vediamo che il problema estetico principale, nella questione
del teatro filmato, è quello della scenografia. La scommessa che deve sostenere il
regista è quella di riconvertire uno spazio orientato verso la sola dimensione interna,
dallo spazio chiuso e convenzionale della recitazione teatrale a una finestra sul mondo.
Nell’Amleto di Laurence Olivier, e ancora meno nel Macbeth di Welles, il testo non
appare superfluo o diminuito dalla parafrasi della regia; così appare invece
paradossalmente nelle regie di Gaston Baty, proprio in quanto quest’ultimo si è
ingegnato a creare sulla scena uno spazio cinematografico, a negare il retro della
scenografia, riducendo in tal modo la sonorità del testo alle sole vibrazioni della voce
dell’attore, privata della sua cassa di risonanza come un violino ridotto alle sole corde.
Non si può negare che l’essenziale a teatro è il testo. Concepito per l’espressione
antropocentrica del palcoscenico e impegnato a supplire da solo alla natura, non può,
senza perdere la sua ragion d’essere, dispiegarsi in uno spazio trasparente come il
vetro. Il problema che si pone al cineasta è quindi di rendere alla sua scenografia
un’opacità drammatica, sempre rispettando il suo realismo naturale. Risolto questo
paradosso dello spazio, il regista, lungi dall’aver timore di trasportare sullo schermo le
convenzioni teatrali e le servitù del testo, ritrova al contrario la libertà di appoggiarsi
ad esse. A partire da ciò, non si tratta più di fuggire tutto quello che «fa teatro», ma
eventualmente anzi di accusarlo con il rifiuto di facili soluzioni cinematografiche,
come ha fatto Cocteau ne I parenti terribili e Welles nel Macbeth, o anche col
sottolineare la parte teatrale, come Laurence Olivier nell’Enrico V. L’evidente ritorno
al teatro filmato a cui assistiamo da dieci anni si iscrive essenzialmente nella storia
della scenografia e del découpage; è una conquista del realismo; non, ben inteso, del
realismo del soggetto o dell’espressione, ma di quel realismo dello spazio senza il
quale la fotografia animata non fa il cinema. [...]
Morale
Tanto la pratica (certa) come la teoria (possibile) di un teatro filmato realizzato con
successo, mettono in evidenza le ragioni dei vecchi fallimenti. La pura e semplice
fotografia animata del teatro è un errore puerile, riconosciuto dopo trent’anni, su cui
non vale la pena d’insistere. L’«adattamento» cinematografico ha messo più tempo a
rivelare la sua eresia, continuerà ancora a fare delle vittime, ma sappiamo oramai dove
conduce: a dei limbi estetici che non appartengono né al teatro né al film, ma a quel
«teatro filmato» giustamente denunciato come il peccato contro lo spirito del cinema.
La vera soluzione, finalmente intravista, consisteva nel comprendere che non si trattava
di portare sullo schermo l’elemento drammatico - interscambiabile da un’arte all’altra di un’opera teatrale, ma, inversamente, la teatralità del dramma. Il soggetto
dell’adattamento non è quello dell’opera teatrale, ma l’opera stessa nella sua specificità
scenica. Precisata tale verità, potremo infine concludere su tre proposizioni che
apparivano inizialmente paradossali e che divengono, alla riflessione, evidenti.
1) Il teatro in aiuto del cinema
La prima di queste proposizioni è che, lungi dal pervertire il cinema, il teatro filmato,
concepito in modo giusto, non può che arricchirlo ed elevarlo. Quanto al fondo prima
di tutto. È fin troppo certo, ahimè, che la produzione cinematografica media è
comunque intellettualmente molto inferiore, se non alla produzione drammatica attuale
(perché ad includervi Jean de Létraz e Henry Bernstein...), almeno al patrimonio
teatrale sempre vivo. Non fosse che in ragione dell’anzianità di quest’ultimo. Il nostro
secolo può essere considerato il secolo di Charlot come il XVIII secolo quello di
Racine e Molière, ma alla fin fine il cinema ha solo un mezzo secolo di vita mentre la
letteratura teatrale ne ha venticinque. Che sarebbe oggi il palcoscenico francese se,
come lo schermo, non desse praticamente asilo che alla produzione degli ultimi dieci
anni? Poiché difficilmente si può contestare che il cinema traversa una crisi di soggetti,
non rischia gran che ad assumere soggettisti come Shakespeare o anche Feydeau. Non
insistiamo, la causa è troppo chiara.
Molto meno chiara può sembrare per quel che riguarda la forma. Se il cinema è un’arte
maggiore, e possiede le sue leggi e il suo linguaggio, cosa può guadagnare a
sottomettersi a quelle di un’arte diversa? Molto! E proprio quando, finendola con dei
trucchi vani e puerili, si propone veramente di sottomettersi e di servire. Per
giustificare pienamente questa sottomissione, bisognerebbe situare il suo caso in una
storia estetica degli influssi nell’arte. Si metterebbe così in evidenza, riteniamo, un
commercio decisivo fra le tecniche artistiche, almeno ad un certo stadio della loro
evoluzione. Il nostro pregiudizio dell’«arte pura» è una nozione critica relativamente
moderna. Ma l’autorità stessa di questi precedenti non è indispensabile. L’arte della
regia, di cui abbiamo precedentemente tentato di rivelare il meccanismo in qualche
grande film, più ancora che le nostre ipotesi tecniche, presuppone, da parte del
realizzatore, un’intelligenza del linguaggio cinematografico che non ha l’uguale che in
quella del fatto teatrale. Se il «Film d’arte» ha fallito dove Laurence Olivier e Cocteau
sono riusciti, ciò è dovuto prima di tutto ai fatto che questi ultimi avevano a loro
disposizione un mezzo d’espressione molto più evoluto, ma anche al fatto che hanno
saputo servirsene ancora meglio dei loro contemporanei. Dire dei Parenti terribili che
è forse un film eccellente, ma che «non è cinema» con il pretesto che esso segue passo
per passo la messa in scena teatrale, è una critica insensata. In quanto proprio per
questa ragione è cinema. È il Topaze (ultima maniera) di Marcel Pagnol a non essere
cinema proprio perché non è più teatro. C’è più cinema, e grande cinema, nel solo
Enrico V che nel novanta per cento dei film tratti da soggetti originali. La poesia pura
non è affatto quella che non vuol dire niente, come ha ben fatto rilevare Cocteau; tutti
gli esempi dell’abate Bremond dimostrano il contrario: «La fille de Minos et de
Pasiphaé»17) è una scheda di stato civile. Ma vi è comunque un modo,
disgraziatamente ancora virtuale, di dire questo verso sullo schermo che sarebbe
cinema puro in quanto se ne rispetterebbe il più intelligentemente possibile la portata
teatrale. Più il cinema si proporrà di essere fedele al testo, e alle sue esigenze teatrali,
più necessariamente dovrà approfondire il linguaggio che gli è proprio. La miglior
traduzione è quella che testimonia la più profonda intimità con il genio delle due lingue
e la loro maggiore padronanza.
17
Famoso verso della Fedra di Racine. (n.d.t.).
2) Il cinema salverà il teatro
Perché il cinema restituirà senza avarizia al teatro quel che gli avrà preso. Se anche non
è già avvenuto.
Se infatti il successo del teatro filmato presuppone un progresso dialettico della forma
cinematografica, esso implica reciprocamente e a fortiori una rivalutazione del fatto
teatrale. L’idea sbandierata da Marcel Pagnol, secondo cui il cinema verrebbe a
rimpiazzare il teatro mettendoio in conserva, è completamente falsa. Lo schermo non
può soppiantare il palcoscenico come il pianoforte ha eliminato il clavicembalo. [...]
Il cattivo «teatro in conserva» ha aiutato il vero teatro a prendere coscienza delle sue
leggi. Il cinema ha ugualmente contribuito a rinnovare la concezione della messa in
scena teatrale. Sono, questi, risultati ormai ben acquisiti. Ma ce n’è ancora un terzo che
il buon teatro filmato permette di intravedere: un progresso formidabile, nel senso
dell’estensione come in quello della comprensione, della cultura teatrale del gran
pubblico. Cos’è un film come l’Enrico V? Per prima cosa Shakespeare per tutti. Ma
anche e soprattutto una luce smagliante proiettata sulla poesia drammatica di
Shakespeare. La più efficace, la più abbagliante delle pedagogie teatrali. Shakespeare
esce dall’avventura doppiamente scespiriano. Non solo l’adattamento dell’opera
drammatica moltiplica il suo pubblico virtuale, come gli adattamenti di romanzi fanno
la fortuna degli editori, ma il pubblico è preparato molto meglio di prima al godimento
teatrale. L’Amleto di Laurence Olivier non può evidentemente che allargare il pubblico
dell’Amleto di Jean-Louis Barrault, e sviluppare il suo senso critico. Come fra la
migliore riproduzione moderna di un quadro e il piacere di possedere l’originale
sussiste una differenza irriducibile, così la visione di Amleto sullo schermo non può
sostituire l’interpretazione di Shakespeare data, mettiamo, da una compagnia di
studenti inglesi. Ma ci vuole una vera cultura teatrale per apprezzare la superiorità della
rappresentazione reale da parte di dilettanti, cioè per partecipare alla sua recitazione.
Ora, più il teatro filmato è riuscito, più approfondisce il fatto teatrale per meglio
servirlo, e più si rivela l’irriducibile differenza fra lo schermo e il palcoscenico. È al
contrario il «teatro in conserva» da una parte e il mediocre teatro di boulevard dall’altra
che mantengono la confusione. Les parents terribles non tradisce il suo mondo. Non è
su un piano meno efficace del suo equivalente scenico, ma nemmeno su un piano che
non faccia implicitamente allusione all’indefinibile supplemento di piacere che mi
avrebbe dispensato la rappresentazione reale. Non ci potrebbe essere per il vero teatro
miglior propaganda che il buon teatro filmato. Verità ormai indiscutibile tanto che
potrebbe apparire ridicolo l’essermici attardato così a lungo se il mito del «teatro
filmato» non sussistesse troppo spesso sotto forma di pregiudizi, di malintesi e di
conclusioni già predisposte.
3) Dal teatro filmato al teatro cinematografico
La mia ultima proposizione sarà, lo riconosco, più azzardata. Abbiamo fin qui
considerato il teatro come un assoluto estetico, a cui il cinema si avvicinerebbe in
maniera soddisfacente, ma di cui sarebbe, a buon motivo e nel migliore dei casi,
l’umile servitore. Tuttavia la prima parte di questo studio ci ha già permesso di
riconoscere nelle comiche la rinascita di certi generi drammatici praticamente spariti,
come la farsa e la Commedia dell’arte. Certe situazioni drammatiche, certe tecniche
storicamente hanno ritrovato nel cinema, prima di tutto il concime sociologico di cui
hanno bisogno per esistere, e ancor meglio le condizioni per uno sviluppo integrale
della loro estetica che il palcoscenico manteneva congenitalmente atrofizzata.
Attribuendo allo spazio la funzione di protagonista, lo schermo non tradisce lo spirito
della farsa, dà soltanto al senso metafisico del bastone di Scapin le sue dimensioni
reali: quelle dell’Universo. La comica è anzitutto, o anche, l’espressione drammatica di
un terrorismo delle cose, di cui Keaton ancor più di Chaplin ha saputo fare una tragedia
dell’Oggetto. Ma è vero che le forme comiche costituiscono nella storia del teatro
filmato un problema a parte, probabilmente perché il riso permette alla sala di cinema
di costituirsi in coscienza di se stessa e di prendervi appoggio per ritrovare qualcosa
dell’opposizione teatrale. In ogni caso, e per questo non abbiamo spinto più lontano il
nostro studio, l’innesto fra il cinema e il teatro comico si è operato spontaneamente, ed
è stato così perfetto che i suoi frutti sono stati sempre considerati come il prodotto del
cinema puro.
Oggi che lo schermo sa accogliere, senza tradirli, altri teatri oltre quello comico, niente
impedisce di pensare che esso possa ugualmente rinnovarli sviluppando certe loro
virtualità sceniche. Il film non può, né deve essere, l’abbiamo visto, che una modalità
paradossale della messa in scena teatrale, ma le strutture sceniche hanno la loro
importanza, e non è indifferente recitare Giulio Cesare all’arena di Nimes o all’Atelier;
ora, certe opere drammatiche, e non fra le minori, soffrono praticamente da trenta o
cinquant’anni di un disaccordo fra lo stile di messa in scena da esse richiesto e il gusto
contemporaneo. Penso particolarmente al repertorio tragico, ove l’handicap è dovuto
soprattutto alla estinzione della razza del tragico tradizionale: i Mounet-Sully e le
Sarah Bernhardt, spariti ai primi del secolo come i grandi rettili alla fine dell’era
secondaria. Per un’ironia della sorte, proprio il cinema ha conservato i loro resti
fossilizzati nel «Film d’arte». È ormai divenuto un luogo comune attribuire questa
sparizione allo schermo per due ragioni convergenti: l’una estetica, l’altra sociologica.
Lo schermo infatti ha modificato il nostro senso della verosimiglianza
nell’interpretazione. Basta vedere precisamente uno dei brevi film interpretati da Sarah
Bernhardt o da Le Bargy per capire che quel tipo d’attore ancora virtualmente vestiva i
coturni e la maschera. Ma la maschera diviene irrisoria, quando il primo piano può
farci annegare in una lacrima, e il portavoce ridicolo, quando il microfono fa tuonare a
volontà l’organo vocale più deficiente. Così ci siamo abituati all’interiorità nella natura
che lascia all’attore di teatro solo un margine di stilizzazione ristretto al di qua
dell’inverosimiglianza. Il fattore sociologico è forse ancora più decisivo: il successo e
l’efficacia di un Mounet-Sully erano senza dubbio dovuti al suo talento, ma sorretti
dall’assenso complice del pubblico. Era il fenomeno del «mostro sacro», oggi quasi
completamente ricaduto sul cinema. Dire che i concorsi del Conservatorio non
producono più tragici non significa affatto che non nascono più delle Sarah Bernhardt,
ma che l’accordo fra l’epoca e le loro doti non esiste più. Così Voltaire si spolmonava
a plagiare la tragedia del XVII secolo perché credeva che solo Racine fosse morto, e
non la tragedia. Ai nostri giorni, quasi non vedremmo alcuna differenza fra MounetSully e un cattivo filodrammatico di provincia, perché saremmo incapaci di
individuarla. Nel «Film d’arte», rivisto da un giovane d’oggi, il mostro rimane, il sacro
non c’è più.
In queste condizioni, non ci si deve stupire che la tragedia di Racine, in particolare,
subisca un’eclissi. Grazie al suo senso conservatore, la Comédie Française è in grado,
fortunatamente, di conservarle un modo di vita accettabile, ma non più trionfale.18 E
poi è solo con un interessante filtraggio dei valori tradizionali, col loro delicato
adattamento al gusto moderno, e non con un rinnovamento radicale a cominciare
dall’epoca. Quanto alla tragedia antica, se può commuoverci di nuovo lo dobbiamo in
modo paradossale alla Sorbona e al fervore archeologico degli studenti. Ma proprio in
queste esperienze dilettantesche bisogna vedere la reazione più radicale contro il teatro
di attori.
Ora, non è naturale che se il cinema ha totalmente volto a suo profitto l’estetica e la
È appunto il caso dell’Enrico V, grazie al cinema a colori. Si vuole in Fedra un esempio di virtualità
cinematografica: il racconto di Théramène, reminiscenza verbale della tragi-commedia macchinosa,
considerato come un pezzo letterario drammaticamente fuori posto, ritroverebbe, realizzato visivamente
al cinema, una nuova ragion d’essere.
18
sociologia del mostro sacro di cui viveva la tragedia sulla scena, può anche
restituirgliele se il teatro viene a cercarle? Basti pensare a un’Athalie girata da Jean
Cocteau con Yvonne de Bray.
Ma certo non sarebbe solo lo stile dell’interpretazione tragica a ritrovare sullo schermo
la sua ragion d’essere. Si può concepire una rivoluzione corrispondente della messa in
scena che, senza cessare di essere fedele allo spirito teatrale, gli offrisse delle nuove
strutture in accordo con il gusto moderno, e soprattutto in proporzione ad un grande
pubblico di massa. Il teatro filmato attende un Jacques Copeau che ne faccia un teatro
cinematografico.
Così, non solo il teatro filmato è ormai fondato esteticamente di diritto e di fatto, non
solo sappiamo d’ora in avanti che non ci sono opere teatrali che non possano essere
portate sullo schermo, quale che ne sia lo stile, purché si sappia immaginare la
conversione dello spazio scenico nei dati della messa in scena cinematografica, ma
anche che è possibile che la sola messa in scena teatrale e moderna di certe opere
classiche non sia ormai realizzabile che al cinema. Non è per caso che alcuni dei più
grandi cineasti del nostro tempo sono anche dei grandi uomini di teatro. Welles o
Laurence Olivier non sono venuti al cinema per cinismo, snobismo o ambizione, e
nemmeno, come Pagnol, per volgarizzare il loro sforzo teatrale. Il cinema non è per
loro che una forma teatrale complementare: la possibilità di realizzare la messa in
scena contemporanea, quale essi la sentono e la vogliono.
(1951)