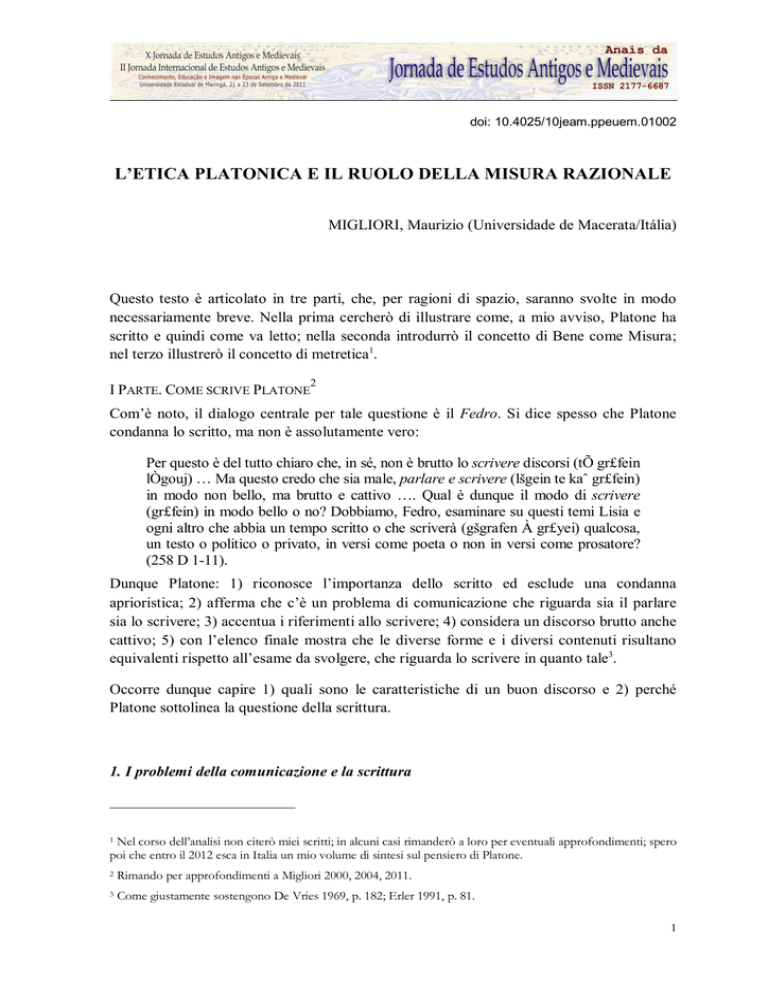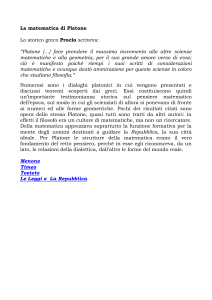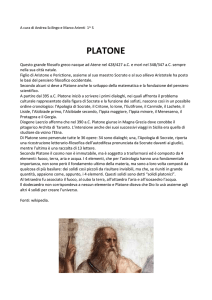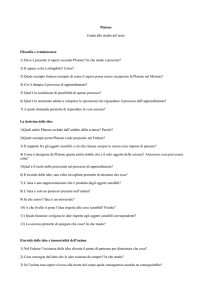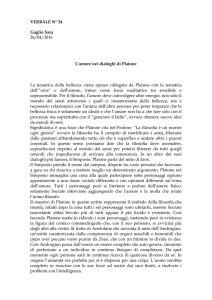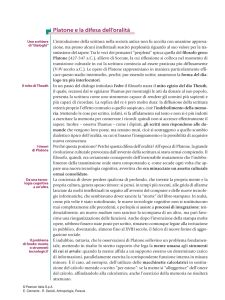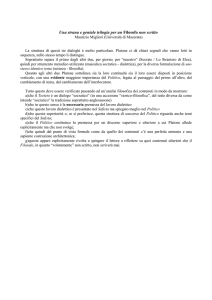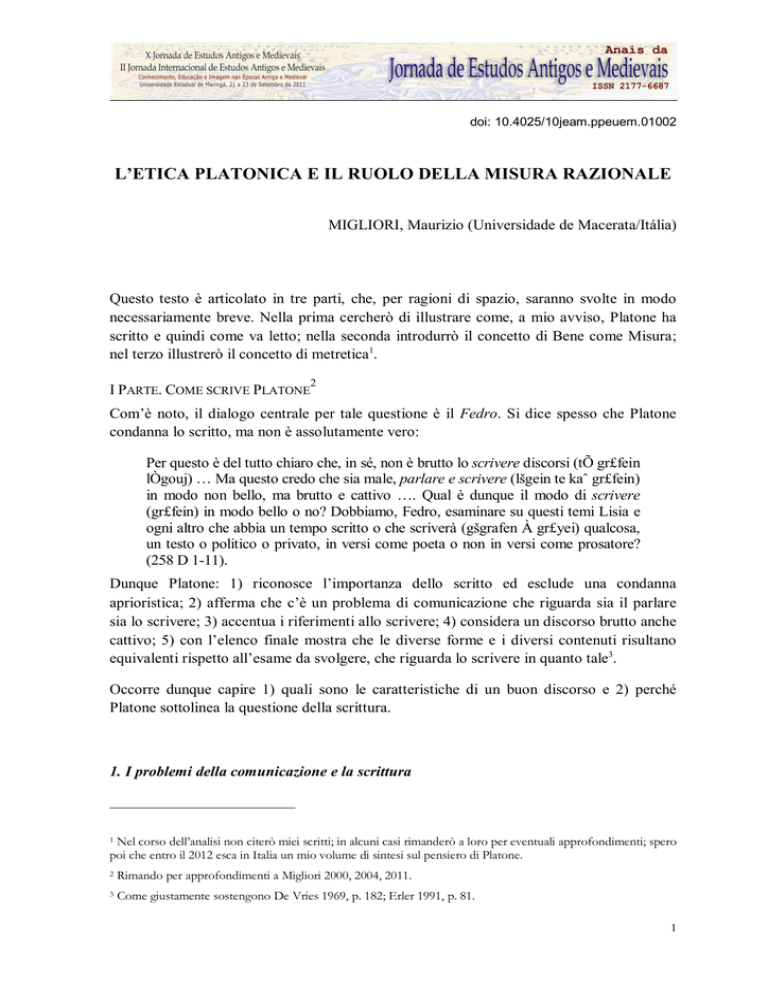
doi: 10.4025/10jeam.ppeuem.01002
L’ETICA PLATONICA E IL RUOLO DELLA MISURA RAZIONALE
MIGLIORI, Maurizio (Universidade de Macerata/Itália)
Questo testo è articolato in tre parti, che, per ragioni di spazio, saranno svolte in modo
necessariamente breve. Nella prima cercherò di illustrare come, a mio avviso, Platone ha
scritto e quindi come va letto; nella seconda introdurrò il concetto di Bene come Misura;
nel terzo illustrerò il concetto di metretica1.
2
I PARTE. COME SCRIVE PLATONE
Com’è noto, il dialogo centrale per tale questione è il Fedro. Si dice spesso che Platone
condanna lo scritto, ma non è assolutamente vero:
Per questo è del tutto chiaro che, in sé, non è brutto lo scrivere discorsi (tÕ gr£fein
lÒgouj) … Ma questo credo che sia male, parlare e scrivere (lšgein te kaˆ gr£fein)
in modo non bello, ma brutto e cattivo …. Qual è dunque il modo di scrivere
(gr£fein) in modo bello o no? Dobbiamo, Fedro, esaminare su questi temi Lisia e
ogni altro che abbia un tempo scritto o che scriverà (gšgrafen À gr£yei) qualcosa,
un testo o politico o privato, in versi come poeta o non in versi come prosatore?
(258 D 1-11).
Dunque Platone: 1) riconosce l’importanza dello scritto ed esclude una condanna
aprioristica; 2) afferma che c’è un problema di comunicazione che riguarda sia il parlare
sia lo scrivere; 3) accentua i riferimenti allo scrivere; 4) considera un discorso brutto anche
cattivo; 5) con l’elenco finale mostra che le diverse forme e i diversi contenuti risultano
equivalenti rispetto all’esame da svolgere, che riguarda lo scrivere in quanto tale3.
Occorre dunque capire 1) quali sono le caratteristiche di un buon discorso e 2) perché
Platone sottolinea la questione della scrittura.
1. I problemi della comunicazione e la scrittura
1
Nel corso dell’analisi non citerò miei scritti; in alcuni casi rimanderò a loro per eventuali approfondimenti; spero
poi che entro il 2012 esca in Italia un mio volume di sintesi sul pensiero di Platone.
2
Rimando per approfondimenti a Migliori 2000, 2004, 2011.
3
Come giustamente sostengono De Vries 1969, p. 182; Erler 1991, p. 81.
1
Per il primo punto Platone nel Fedro indica tre caratteristiche. Chi compone discorsi deve
prima di tutto conoscere il vero riguardo a ciò di cui tratta (259 E - 260 E); in secondo
luogo deve curare la forma: ogni discorso deve essere composto come un essere vivente,
con le parti scritte in modo conveniente l’una rispetto all’altra e rispetto all’intero (264 C);
infine deve conoscere la natura dell’anima (270 E - 271 D) cui si rivolge. Tutto questo
sottende un giudizio: chi parla o scrive è responsabile dell’azione che compie, tanto che
deve considerare i suoi discorsi come figli (278 A), con tutte le responsabilità che questo
determina.
Dopo aver fornito queste indicazioni che riguardano la comunicazione, Socrate affronta il
problema della scrittura, tematizzandolo esplicitamente, cosa che dimostra la sua
rilevanza:
SOCRATE: Rimane solo da trattare l’opportunità e la non opportunità di scrivere, a
che condizioni sia bello e a quali non sia opportuno farlo (274 B 6-7).
Il problema viene affrontato sulla base di un mito (274 C - 275 C). Secondo una tradizione
egiziana il dio Theuth inventò molte cose: l’aritmetica, la geometria, l’astronomia, il gioco
dei dadi e la scrittura. Egli volle poi mostrare al re d’Egitto Thamus queste sue scoperte per
convincerlo a insegnarle agli egiziani. Arrivati alla scrittura, Theuth la elogia chiamandola
farmaco, in quanto secondo lui aiuta la sapienza e la memoria di tutti gli uomini. Ma il re è
di parere contrario e illustra i limiti di questo medium. Quando alla fine Fedro evidenzia
che si tratta di una storia inventata e ambientata in un paese straniero (275 B), Socrate
ribatte che non è importante chi la riferisce e quale ne sia la fonte, quanto piuttosto che
essa dica il vero4. Dunque le cose vere che il mito dice sono le seguenti:
1.
lo scritto non rafforza la memoria, ma la indebolisce, perché gli individui
1.1. fidandosi dello scritto, non si eserciteranno più come prima;
1.2. si abitueranno a fare affidamento non su quello che hanno dentro, ma su segni
esterni;
infatti questo produrrà oblio nelle anime di coloro che lo impareranno per mancanza
di esercizio mnemonico, perché, fidandosi della scrittura, non ricorderanno essi
stessi dall’interno da se stessi (oÙk œndoqen aÙtoÝj Øf’aØtîn), ma dal di fuori,
attraverso segni estranei (275 A 2-5);
2.
lo scritto serve per richiamare alla memoria di chi già sa (275 A, 275 C-D; 276 D);
3.
lo scritto non offre il vero sapere, ma solo l’apparenza (275 A 6; cfr. 276 C), per cui
3.1. i lettori, avendo molte informazioni senza insegnamento (275 A 7), si crederanno
dotti, mentre non sapranno nulla;
3.2. sarà difficile discutere con costoro che sono portatori di opinioni invece che sapienti
(doxÒsofoi … ¢ntˆ sofîn, 275 B 2);
4
«L’esposizione di questa concezione sotto una maschera straniera disturba solo uno spirito non filosofico»
(Szlezák 1988, p. 54).
2
come accade ad un dipinto5, lo scritto sembra vivo ma non lo è (275 D-E); infatti:
è incapace di rispondere a una domanda;
ripetete sempre la stessa cosa;
rotola nelle mani di chiunque;
non sa quando parlare e quando tacere;
non sa come difendersi, ma ha sempre bisogno del soccorso del padre, dell’Autore
(275 E; 276 C);
5.
poiché è uno strumento debole si presta a fraintendimenti; solo un ingenuo può
pensare di tramandare o ricevere con uno scritto qualche conoscenza stabile (275 C 6;
cfr. anche 277 D 8-9).
In sintesi, i primi due punti riguardano i rischi che corre il lettore sul piano della memoria,
il terzo quelli che corre sul piano del sapere, che non può consistere solo nell’apprendere
meccanicamente quello che si legge; il quarto sottolinea i limiti intrinseci della scrittura; il
quinto trae le conseguenze: visti i rischi che questo medium fa correre alla teoria che gli
viene affidata, né lo scrittore né il lettore devono farsi illusioni.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Socrate aggiunge subito che c’è, però, un altro discorso, “fratello legittimo” (¢delfÕn
gn»sion, 276 A 1-2) di quello scritto, ma migliore e più potente (276 A 2-3). Tale discorso
è 1) scritto con scienza 2) nell’anima di chi impara, 3) sa difendersi da solo e sa con chi
parlare e con chi tacere. In sintesi, è
il discorso di chi sa, vivente e animato (zînta kaˆ œmyucon), del quale quello
scritto può dirsi, a buona ragione, immagine (e‡dwlon) (276 A 8-9).
C’è uno strano gioco di legame e di opposizione: la differenza appare profonda:
Il discorso scritto
il discorso orale
1.
sembra vivo, ma non lo è
è vivente e animato cioè sa rispondere e variare
2.
comunica apparenza di sapere
proprio di chi sa ed è scritto con scienza
3.
rotola nelle mani di chiunque
in un’anima
4.
solo
ha bisogno del soccorso dell’Autore
è
è
scritto
sa difendersi da
5
Il confronto tra scrittura e pittura era facile per un greco, in quanto il verbo grafe‹n nel greco arcaico significava
sia scrivere che dipingere (Brisson 1989, p. 232); lo stesso termine gr£mma, significa sia lettera sia disegno o
pittura; infine, gli strumenti per la scrittura (papiro, tavolette di cera, stilo) erano usati anche per disegnare (Sève
1980, p.154).
3
5.
non sa quando parlare e tacere;
con chi parlare e con chi tacere
sa
È impossibile sottovalutare questa puntuale contrapposizione, che evidenzia una differenza
di fondo e non accidentale. Tuttavia sarebbe altrettanto errato dimenticare che si tratta di
due fratelli legittimi, per cui non possono essere contrapposti come il bene e il male.
Dunque, dobbiamo accettare l’evidente debolezza dello scritto senza trasformarla in una
condanna o, peggio, in un rifiuto: è un fratello più fragile e più debole, quindi da curare
molto e con qualche apprensione. Per questo ha bisogno di essere soccorso dall’autore, se
possibile, o da un altro scritto, se restiamo in questo ambito. Infatti, «i dialoghi, essendo
immagini dei discorsi vivi di “colui che sa” (cfr. Fedro 276 A), possono anche raffigurare
ciò che caratterizza l’attività orale del dialettico, cioè il portar “soccorso” al proprio logos»
(Szlezák 1991, p. 85).
Platone chiarisce il suo pensiero attraverso l’immagine dei giardini di Adone. In occasione
della festa di quella divinità gli Ateniesi organizzavano una grande infiorata, utilizzando
semi appositi che garantivano una rapida fioritura in pochi giorni, in modo che tutto fosse
pronto per la processione in onore di Adone; naturalmente queste pianticelle morivano poi
in poco tempo. Non c’è nulla di male in quei grandi vasi di fiori, belli ma effimeri, che si
preparano per la festa del dio; tuttavia, con i semi importanti il saggio agricoltore farà una
cosa diversa: cercherà un terreno adatto e aspetterà il frutto per mesi. Non stupisce,
dunque, che il discorso culmini in un’esaltazione della comunicazione orale, che ribadisce i
punti già evidenziati:
credo che sia molto più bello l’impegno serio (spoud¾) su queste cose, quando
usando l’arte dialettica e prendendo un’anima adatta, si piantino e seminino
discorsi con scienza (met’™pist»mhj), capaci di soccorrere (bohqe‹n) se stessi e
chi li ha piantati, non sterili, ma portatori di seme, dal quale nascano in altri
uomini altri discorsi, che siano capaci di rendere questo seme immortale e che
rendano felice chi lo possiede, nella misura più grande possibile per un essere
umano (276 E 4-277 A 4).
Si ribadiscono i punti precedentemente enucleati: 1) questo discorso è vivo, non è sterile e
infatti è capace di riprodursi all’infinito, tanto da poter divenire immortale; 2) è scritto con
scienza in un’anima adatta, il che spiega la capacità di durare e riprodursi, dialogando con
altre anime; 3) sa difendersi da solo. Platone poi qui aggiunge la felicità, offerta all’essere
umano che apprende questi discorsi filosofici.
Infine Socrate ripropone i due elementi necessari per una buona comunicazione: occorre
1) conoscere il vero (tÒ te ¢lhq j, 277 B 5) intorno alle cose di cui si parla o scrive (lšgei
À gr£fei, 277 B 6); 2) capire la natura dell’anima a cui ci si rivolge per poi fare un discorso
adeguato, semplice per un’anima semplice, complesso per una complessa (277 B-C).
4
Senza questo non c’è arte retorica, cioè capacità di insegnare e persuadere, sia oralmente
sia per scritto (tÕ lÒgouj lšgein te kaˆ gr£fein, 277 D 1-2). Dunque, anche se le regole di
base sono le stesse, nel caso della scrittura bisogna fare i conti con ulteriori pesanti limiti.
Ma Platone dice tra le righe una cosa molto importante: pur avendo sottolineato il valore di
aiuto al recupero di un ricordo che lo scritto fornisce a chi già sa, aggiunge un elemento
ulteriore: chi scrive procede
accumulando ricordi sia per se stesso, per la vecchiaia che porta l’oblio, se mai
giunga, sia per chiunque segua la medesima pista (276 D 3-4).
Dunque, Platone stesso indica una duplice possibile funzione dello scritto, una su cui si
dilunga enfaticamente e una appena accennata: si scrive anche per fornire elementi a chi
segue le nostre orme, cioè per coloro che vengono dopo di noi, per amici lontani, nello
spazio e nel tempo. Senza questa aggiunta quasi inavvertibile la quantità degli scritti
platonici sarebbe inspiegabile e Fedro e Lettera Settima ci porrebbero di fronte ad un
assurdo. Non c’è infatti dubbio che molti dialoghi non possono essere considerati solo
promemoria per coloro che già sanno. Inoltre, se il filosofo non affida allo scritto le cose di
maggior valore, per difenderle dai travisamenti, tuttavia trasmette con i dialoghi sempre
qualcosa di valore, anche se minore.
2. Lo scritto come gioco
Se lo scritto ha i limiti che abbiamo cominciato a vedere, ci troviamo di fronte ad una serie
di problemi. In primo luogo, l’Autore che è preoccupato del valore delle cose che scrive,
che vuole poter soccorrere il suo scritto sottraendolo ai possibili fraintendimenti, non
metterà nel testo tutto quello che pensa, ma agirà con molta cautela e si riserverà le cose di
maggior valore, come strumento con cui soccorrere in seguito il suo stesso testo (Fedro
278 C-E).
A conferma della lucidità con cui Platone fece questa scelta, egli stesso definisce tale
attività come “non seria”, come un “gioco”6: chi ha la conoscenza del giusto, del bello e del
buono sarà saggio come il contadino intelligente che non spreca i suoi semi:
Allora non le scriverà seriamente (spoudÍ) nell’acqua nera, seminandole mediante
la cannuccia con discorsi che non possono discorsivamente difendersi da soli e che
non possono insegnare in modo adeguato il vero… Ma egli, a quanto pare, li
seminerà nei giardini di scritture e li scriverà, quando scriva, per gioco (paidi©j)
(Fedro 276 C 7-D 2).
6
Questo in realtà può emergere fin dal modo con cui Platone presenta le invenzioni di Teuth; Vegetti 1988, p.
204, sottolinea che l’ambiguità della scrittura appare confermata se poniamo le invenzioni di Teuth in ordine per
complessità; la scrittura «si colloca dunque al limite tra la serie dei giochi, di cui fa parte <corsivo nostro>, e quella
dei saperi produttivi di verità».
5
Tutti i testi scritti sono solo giochi. Certo, si tratta di giochi non futili, anzi molto belli
(Fedro 276 E); Platone non solo non li disprezza, ma giunge a dire che sono così
importanti e impegnativi da potervi dedicare tutta la vita (Fedro 276 D): difficile che
abbia scritto questo senza pensare ai tanti dialoghi che già aveva “pubblicato”. Questa
visione dello scritto è così importante che il gioco diviene la caratteristica del filosofo, il
quale è
colui che ritiene che in un discorso scritto su qualunque argomento vi è
necessariamente molta parte di gioco (paidi£n… poll¾n) e che non è mai stata
scritta un’opera in versi o in prosa7 degna di molta serietà (meg£lhj ¥xion
spoudÁj) (Fedro 277 E 5-8).
Subito dopo, questa critica a tutte le forme di scrittura viene confermata con il riferimento
a Lisia e a tutti gli scrittori di discorsi, a Omero e a tutti i poeti, a Solone e a tutti i
legislatori (278 C)8: se uno qualsiasi di costoro
ha composto queste opere conoscendo la verità ed essendo in grado di soccorrerle
(bohqe‹n) quando viene messo alla prova sulle cose che ha scritto, e se parlando è
capace di dimostrare la debolezza degli scritti, costui non deve essere denominato
con un qualche nome tratto da quelli, ma da ciò cui si è dedicato… Chiamarlo
sapiente (sofÒn), Fedro, mi sembra eccessivo e adatto solo a una divinità, ma
amante della sapienza (filÒsofon) o qualcosa di simile, sarebbe più adatto a lui e
più moderato (Fedro 278 C 4-D 6).
Platone qui indica i dati che costituiscono il discrimine tra i filosofi e gli altri scrittori: la
caratteristica propria del “filosofo che scrive” consiste 1) nella conoscenza della verità e
nella capacità 2) di soccorrere lo scritto e 3) di dimostrarne parlando la debolezza. In
sintesi, fermo restando che l’essere umano è sempre e solo amante del sapere (filo-sofo) e
mai sapiente come Dio, il filosofo è colui che scrive su diversi temi, non importa quali,
avendo cose di maggior valore con cui soccorrere le più deboli affermazioni che affida alla
scrittura e sapendo perfettamente il limite dell’operazione che compie.
Quanto all’altra forma di scrittura, in questo contesto essa è proposta con una formula
quasi irridente, che enfatizza un lavoro tecnico, quasi manuale, non necessariamente
intelligente:
Invece, colui che non ha cose di maggior valore (timiètera) di quelle che ha
composto o scritto, girandole in su e in giù per tutto il tempo, sia incollandole tra
7
L’affermazione di Platone è perentoria: «poiché non esiste niente di scritto che non sia né poesia né prosa, è
ozioso chiedersi se i dialoghi propri di Platone siano in qualche modo esclusi da questo giudizio» (Szlezák 1988,
p. 65).
8
«L’oratoria, la poesia, la legislazione, simboleggiate ciascuna da una figura storica, che viene caricata di valore
archetipico» (Cerri 1992, p. 283).
6
loro sia tagliando9, non lo chiamerai, a ragione, poeta o scrittore di discorsi o
legislatore? (278 D 8-E 2).
Dunque un testo scritto come gioco dal filosofo manca sempre della cosa più importante.
Occorre però che i termini non siano presi in senso assoluto: «il fatto che quanto è stato
scritto si riveli debole (faulon) per mezzo del soccorso dell’autore, non vuol dire che esso
venga dichiarato sbagliato e nemmeno che esso sia brutto o di valore scadente; dal
comparativo maggior valore (timiotera) va desunto un significato relativo anche per
debole» (Szlezák 1988, pp. 66-67). In sintesi le cose di maggior valore ad un certo livello
conoscitivo possono essere le Idee, ad un altro livello le relazioni tra Idee, ad un altro
ancora la struttura dei Principi. Nel testo scritto, quindi, si trova filosofia, ma sempre di
livello inferiore rispetto al necessario. E poiché per Platone deve sempre esserci un
contenuto ulteriore e superiore, un soccorso che è rinviato e lasciato all’intelligenza del
lettore, il fondamento ultimo non potrà mai in nessun caso essere affidato ai testi: rimarrà
una dottrina allusa e indicata, ma non scritta. A questo si aggiunge una ulteriore
motivazione, che vedremo meglio sulla base della Lettera settima.
3. La Lettera settima
Dunque, Platone nel Fedro ha distinto tre tipi di attività: 1. il gioco che non vale niente, il
puro trastullo; 2. il gioco dello scrivere, che è un gioco importante; 3. il rapporto serio e
diretto con l’anima del discepolo, che richiede una relazione vis-à-vis: solo nei discorsi
intorno al giusto, al bello e al bene nel contesto di un insegnamento, scritti nell’anima
dell’interlocutore, c’è chiarezza, compiutezza e serietà (spoudÁj, Fedro 278 A 5).
Finora ho utilizzato come fonte solo questo dialogo per evitare l’accusa di una fonte dubbia
come la Lettera settima. In realtà non esiste alcuna credibile dimostrazione che giustifichi
questi dubbi: le informazioni e il taglio filosofico di quel testo non possono che essere di
Platone stesso10. Dunque adesso posso sottolineare che tutto quello che abbiamo detto sulla
9
«Qui si fa allusione allo scrittore che maneggia i rotoli di carta dei libri in su e in giù, avanti e indietro con
l’incollare e col tagliare» (Gaiser 1990, p. 63).
10
Cito solo due grandi studiosi, a proposito della autenticità: «Dimostrarla ancora una volta, se ne corresse
l’obbligo, richiederebbe piuttosto tempo che sforzo mentale; converrebbe, anziché escogitare argomenti nuovi,
chiamare a raccolta quelli messi così spesso innanzi in questi ultimi tempi, nella loro assoluta negatività persuasivi,
e mostrare quanto inverosimile sia la figura di un falsario che non dipinge né un santo né uno scellerato, quali
sogliono essere gli eroi delle falsificazioni, ma un uomo buono consapevole di gravi responsabilità, che si è
assunte con successo non in tutto favorevole, e di errori, che confessa sì ma un po’ a denti stretti; la figura di un
falsario che, non con altro fine se non rendersi più difficile l’impresa, introduce nella lettera prevalentemente
politica e autobiografica un tratto filosofico, che anche allora non poteva riuscire intelligibile se non a chi
conoscesse bene tutta l’evoluzione del pensiero del più tardo Platone, mentre doveva riuscire incomprensibile ai
più» (Pasquali 1967, p. 42). Il secondo ci consente di ricostruire un paradossale percorso delle mode
ermeneutiche: «Le Lettere platoniche nel XIX secolo decaddero per la maggioranza degli studiosi a livello di una
falsificazione o invenzione novellistica, nonostante l’opinione contraria di George Grote... Da 50 anni sono di
nuovo oggetto dell’interessamento e dello studio più vivaci» (Friedländer 2004, p. 269). Dunque, «pare che si
possa ritenere che l’autenticità della Lettera VII e della VIII è ora generalmente riconosciuta. Ma non è passato
ancora molto tempo da quando si è tentato di considerare le tredici lettere come un romanzo epistolare, di
composizione unitaria, redatto intorno al 300 da qualche membro della scuola platonica» » (p. 269). Friedländer
ricorda poi Robin, il quale «ha considerato la autenticità non definitivamente dimostrata. Definitivamente
7
base del Fedro è confermato e arricchito nella Lettera Settima, testo in cui troviamo
l’affermazione più netta e più shockante:
su queste cose non c’è un mio scritto e non ci sarà mai (Lettera Settima 341 C 45).
Questa infatti ci obbliga a porci un’ulteriore questione: visto che Platone ha scritto tanto,
bisogna capire perché e come lo abbia fatto. Ma procediamo con ordine.
Prima di fare questa affermazione Platone racconta che Dionigi II, tiranno di Siracusa,
dopo alcuni incontro con lui aveva scritto un testo di filosofia platonica attribuendoselo. Il
filosofo non si lamenta del furto delle sue idee, ma allarga il giudizio, criticando coloro che
hanno scritto su queste realtà affermando di conoscere ciò di cui lui si occupa seriamente
(341 C), mentre non lo hanno capito affatto. Segue poco dopo una condanna dello scritto
perentoria quanto nel Fedro:
Perciò, ogni uomo serio (spouda‹oj) non deve proprio scrivere cose serie
(spouda…wn) per non esporle all’avversione e all’incapacità di capire degli
uomini. In breve, bisogna logicamente riconoscere che, quando si vede qualcuno
che ha scritto opere, siano leggi di un legislatore o scritti di qualche altro genere,
queste non erano per lui le cose più serie (spoudaiÒtata), se egli è serio
(spouda‹oj), perché quelle restano riposte nella sua parte più bella; se invece ha
messo per scritto queste prendendole come cose serie (™spoudasmšna), «allora
certamente» non gli dèi, ma i mortali «gli hanno tolto il senno» <Omero, Iliade
VIII, 360; XII, 234> (344 C 1-D 2).
Dunque un uomo serio non scrive le cose serie, per difenderle dai possibili fraintendimenti,
riservandole al rapporto diretto, di anima con anima. Poco dopo ribadisce che chiunque, a
partire da Dionigi, abbia scritto “sulle realtà superiori e prime della natura” (344 D 4-5)11
non ne ha una buona concezione, perché altrimenti le avrebbe rispettate e non le avrebbe
messe per iscritto a disposizione di un pubblico inadatto. Platone precisa inoltre che non
serve nemmeno scrivere un tale testo come promemoria, in quanto queste concezioni
dimostrata? No certo. Io ripeto il principio metodologico di August Boeckh che soltanto la inautenticità e non
mai la autenticità può essere dimostrata in maniera convincente – beninteso se mancano ragioni esteriori» (pp.
269-270). E conclude: «chi si preoccupa ancora di questo, invece di cimentarsi nella interpretazione? E chi ha
propriamente “dimostrato” l’autenticità? Così tentiamo qui di dimostrare che importanti questioni concernenti le
Lettere si possono porre e forse risolvere anche senza che si decida pro o contro la autenticità; anzi che spesso
proprio il concentrarsi sul problema dell’autenticità limita lo sguardo e mette piuttosto in pericolo l’intelligenza
serena del documento» (p. 270).
11
Data la forza dell’espressione, Tulli 1989, p. 40, cerca di attenuarla, anche perché «nei dialoghi non si afferma
per tÕ ¥kron e tÕ prètwn un significato specifico». Tuttavia, questa osservazione può essere anche usata in
modo esattamente opposto: sarebbe ben strano se a partire dai dialoghi fosse possibile dare una calibrazione
esatta a questi due termini: vorrebbe dire che 1) l’atteggiamento in una lettera agli amici di Dione è lo stesso di
testi rivolti sostanzialmente a tutti; 2) i dialoghi sono trasparenti, privi di giochi e quindi facilmente utilizzabili
anche per testi lontani e/o diversi. Gadamer 1983b, p. 264, al contrario, trova questa espressione così
emblematica da fargli quasi supporre che si tratti del titolo dell’opera di Dionigi. In realtà, ciò appare improbabile,
visto che Platone parla di Dionigi e anche di altri, migliori o peggiori di lui, quindi non fa riferimento ad un’opera
specifica.
8
sono espresse nelle frasi più brevi di tutte (344 E 2).
Da questo punto di vista potrebbe anche sembrare che è meglio non scrivere affatto,
mentre Platone ha scritto molto. Questo è il punto da spiegare.
Abbiamo già visto che Platone dedica molta attenzione alla questione dell’anima. Le anime
sono di diversi tipi, quindi diversi sono gli esseri umani, quindi diversi sono anche i
discorsi che ad essi vanno rivolti. Ogni bravo maestro deve tener conto di questo, sapendo
anche quando è il caso di parlare e quando è il caso di tacere. In tal modo è possibile fare
un discorso adeguato, cioè semplice per un’anima semplice, complesso per una complessa
(Fedro 277 B-C). Il problema diventa maggiore se l’insegnamento è di natura filosofica. In
questo caso, una comunicazione diretta non consente la ricerca e la scoperta personale, un
dato socratico che rimane centrale nella concezione di Platone, come mostra tutta la serie
di dialoghi scritti e come egli stesso esplicita in quei passi in cui spiega perché non ha mai
messo per iscritto la sua filosofia:
Infatti, questa non è affatto comunicabile (¸htÕn12) come le altre conoscenze
(maq»mata), ma, dopo molte discussioni fatte su questi argomenti, e dopo una
comunanza di vita, all’istante, come luce che scocca da un fuoco crepitante, nasce
da sé nell’anima e da se stessa subito si alimenta (Lettera Settima 341 C 5-D 2).
Dunque Platone afferma che 1) tra le scienze c’è quella che noi chiamiamo filosofia; 2)
egli possiede una tale conoscenza, cioè esiste una filosofia platonica; 3) questa però, a
differenza delle altre, non è comunicabile, cioè non viene appresa, come le altre, per
insegnamento diretto da parte di un docente. La filosofia va socraticamente praticata in
comune perché vive di discussione; soprattutto è lavoro personale, è la scoperta che un
soggetto fa riflettendo sulle aporie che la realtà e/o la discussione gli pongono davanti;
questa scoperta è scoperta di un paradigma interpretativo che, come tale, è in grado di
procedere e di incrementarsi con ulteriori verifiche.
Siamo di fronte al problema centrale: un filosofo, se vuole essere maestro, non deve
comunicare le soluzioni, perché ciò impedisce all’allievo di compiere la scoperta; piuttosto
deve aiutarlo a cercarle e trovarle. Ciò vale sia nello scritto sia nell’orale, anche se sono
ovvi i maggiori limiti della scrittura. A scanso di equivoci, Platone continua affermando
che egli è certo che, se dovessero essere messe per iscritto o essere dette (grafšnta À
lecqšnta, 341 D 2-3), nessuno potrebbe farlo meglio di lui, anzi se fosse convinto che
vanno scritte e comunicate adeguatamente ai più (graptša q’ƒkanîj e nai prÕj toÝj
polloÝj kaˆ ¸ht£, 341 D 5), non avrebbe potuto fare nulla di più bello nella vita che mettere
per iscritto (gr£yai, 341 D 7) una dottrina che è utile agli esseri umani e che chiarisce la
natura delle cose.
12
Tulli 1989, p. 21, svolge un’attenta analisi del termine ¸htÕn per concludere che 1) il termine «copre l’area delle
possibilità espressive» e 2) «è assurdo concludere che Platone, per la sua filosofia, le neghi del tutto». Qui però la
negazione va posta in relazione alle altre conoscenze, che possono essere insegnate con una comunicazione diretta,
cosa che non vale per la filosofia, che ha bisogno di ricerca: la negazione non è assoluta, ma resta forte e crea uno
iato, collocando la filosofia in un luogo peculiare, come confermano le osservazioni sulla scrittura come gioco.
9
Si notino l’insistenza e anche alcuni particolari: la comunicazione di cui si parla è quella
adeguata e per i più; soprattutto bisogna valorizzare il fatto che, se fosse convinto della
utilità di questa operazione, Platone scriverebbe la sua dottrina, a conferma che 1) tale
dottrina, utile e capace di spiegare la realtà, c’è; 2) egli è convinto della forza dello scritto.
Comunque, questa difficoltà riguarda i più; infatti si può procedere per i pochi portati alla
filosofia attraverso qualche stimolo fatto di poche indicazioni:
Ma non credo nemmeno che comunicare l’argomentazione su questi temi sia una
cosa buona per gli uomini, se non per quei pochi che sono capaci di trovare
soluzioni da soli sulla base di poche indicazioni, mentre gli altri si riempirebbero,
alcuni di uno scorretto disprezzo, assolutamente non conveniente, altri di una
eccessiva e vana fiducia, come se avessero imparato cose splendide (Lettera
Settima 341 E 1-342 A 1).
È sbagliato fornire direttamente le conoscenze filosofiche: si rischia di rovinare l’anima
dell’interlocutore che potrebbe diventare superficiale e borioso; invece può essere utile
stimolare quei pochi che possono fare buon uso delle indicazioni fornite13 per svolgere la
loro ricerca. Tale distinzione sarà ripetuta e rafforzata poco dopo (343 E-344 A) come
distinzione tra chi ha buona natura e i più che l’hanno cattiva sia nei confronti delle
conoscenze sia nei confronti dei costumi. Per svolgere questo lavoro occorre natura affine
agli oggetti, facilità di apprendere e memoria. Inoltre, la comunicazione filosofica, scritta
ed orale, rimanda ad un percorso molto lungo che solo un certo tipo di individuo può fare.
Questo allievo deve essere una persona eccezionale, tanto da poter essere qualificato di
natura divina; infatti l’adesione alla filosofia comporta una scelta di vita, che richiede una
grande costanza e pieno autocontrollo. Pertanto, occorrono individui particolari, disposti a
impegnarsi sapendo quanta fatica li attende (Lettera Settima 340 B-D).
Queste indicazioni educative valgono sia nella comunicazione orale sia in quella scritta,
solo che in quest’ultima incontrano difficoltà molto maggiori. D’altra parte, un maestro si
trova di fronte ad un problema: i pochi che possono essere aiutati con poche indicazioni
sono in prima istanza coloro che, essendo casualmente vicini nello spazio e nel tempo,
possono ascoltare quella dottrina; tra gli esclusi, però, ci sono anche coloro, e sono tanti,
che hanno le caratteristiche adeguate e quindi potrebbero trarne beneficio, ma che vivono
lontani, nello spazio e nel tempo. Questo secondo gruppo può essere raggiunto solo con la
scrittura. Ecco perché Platone ha scritto tanto. Ma bisogna rispettare le indicazioni
precedenti: riuscire a fornire stimoli e aiuti; non comunicare la soluzione; selezionare il
lettore in modo da rivolgersi a quei pochi per i quali è utile, evitando un intervento su
soggetti inadatti; salvaguardare le cose di maggior valore.
13
Tulli 1989, p. 24: «il sapere si tramanda per mezzo di una smikr¦ Ÿndeixij e ogni discepolo, invece di prenderne
atto, la conquista (341 E). Sono rinvii al poihtikÕn pr©gma dell’Accademia, nonché ai dialoghi spesso governati
dal vario procedere per cenni».
10
Questo implica una grande attenzione e quella che possiamo definire “reticenza
comunicativa” da parte del maestro. Se non si ammette questo atteggiamento educativo nei
confronti della scrittura, visto che Platone ha scritto dialoghi filosofici, come si possono
giustificare giudizi perentori come quello in cui Platone sottolinea i limiti della nostra
conoscenza
a causa della debolezza dei discorsi; per questo motivo nessuno che pensi oserà
affidare i propri pensieri a tale strumento e questi ad un mezzo immobile, come
accade a opere scritte con dei segni (Lettera Settima 343 A 1-4).
Dunque, Platone è convinto della radicale debolezza comunicativa degli esseri umani, che
si accentua nella dimensione immobile dello scritto; nondimeno, crede nella necessità di
comunicare con tutta la prudenza del caso e in forme particolari, ribadendo che la difficoltà
riguarda tutti gli strumenti, cioè affermazioni fatte
in discorsi, o in opere scritte, o in risposte a domande (™n lÒgoij À gr£mmasin À
¢pokr…sesin, 343 D 4-5).
In sintesi, volendo scrivere rispettando il suo quadro teorico-educativo, Platone ha
inventato una tecnica di scrittura che gli permette di affrontare i due problemi maggiori: la
crescita individuale del soggetto e la difesa del contenuto che l’Autore mette a disposizione
del lettore. Egli da una parte non mette nello scritto le cose di maggior valore rispetto ai
problemi affrontati, dall’altra provoca, con trucchi, omissioni, problemi e altro, in sintesi
con giochi, il lettore, in modo da costringerlo a pensare per rispondere ai problemi che il
testo impone. I dialoghi platonici sono un gigantesco protrettico, nel senso che l’Autore
propone via via nella successione dei dialoghi sempre ulteriori elementi del suo pensiero in
modo che il lettore sia portato a fare filosofia.
Sembra incredibile? Ma se per Platone la visione di un corpo bello può dar inizio ad un
processo che porta all’Idea del bello, se con una conduzione sapiente, ma del tutto
eterodiretta, uno schiavo può essere portato a risolvere, sulla base della reminiscenza, un
problema di geometria, è così assurdo che scritti proposti in successione e svolti con una
tecnica del tutto particolare si propongano di risvegliare nel lettore analoghi processi? E se
non fosse così, perché un autore convinto della radicale debolezza degli scritti dovrebbe
dedicare a questo bellissimo gioco l’intera vita (Fedro, 276 D)?
4. Un’ultima considerazione
Platone opera in un momento cruciale in cui inizia il passaggio dalla cultura orale a quella
scritta14, passaggio che Platone coglie e rilegge da filosofo con molta acutezza. Egli tenta
14
Su questo decisivo tema, cfr. Havelock 1983; Reale 1998, pp. 15-72, valorizza la posizione di Havelock proprio
perché colloca la scrittura platonica all’interno di questa grande rivoluzione culturale, ma nel contempo lo critica
perché riconduce totalmente la posizione del filosofo a questa trasformazione delle forme della comunicazione.
Così si perdono sia gli elementi specifici della critica alla comunicazione e alla scrittura di Platone sia l’intreccio
con la sua posizione filosofica. Come ha giustamente detto Sini 1994, pp. 74-75: «Havelock e Detienne possono
ben parlare della scrittura nel modo in cui ne parlano, svolgendo in proposizioni razionali una sorta di
11
di porre un argine ai limiti che, ai suoi occhi, la scrittura ha sui due versanti del recettore e
della ricerca, non opponendosi ad uno strumento di cui coglie le potenzialità, ma
proponendone un uso che espanda le capacità del fruitore e che rispetti il contenuto
proposto. Noi sappiamo che combatte una battaglia senza speranza. Come mostra già il
dibattito accademico, la forza della scrittura è tale che la pretesa di un uso diverso cade
quasi subito: lo scritto comunica e per questo soprattutto, se non unicamente, viene
utilizzato. Ma, a riprova che i processi non sono quasi mai lineari, questa è stata anche la
fonte del suo intramontabile ed eccezionale successo. Se Platone ha scritto con l’intento di
portare il suo interlocutore a pensare, a fare filosofia, non c’è dubbio che ci sia
perfettamente riuscito. Tramite i dialoghi non è passata, come lui certamente sperava, la
sua filosofia. Ma se maestro è colui che non vuole indottrinare, ma che si impegna ad
aiutare il proprio allievo per favorirne la crescita, Platone con i suoi dialoghi è stato
certamente sommo maestro. L’Occidente deve moltissimo alla sua geniale invenzione
letteraria. Da questo punto di vista nessun altro, né filosofo né letterato, può essergli posto
a fianco.
5. Due esempi di giochi
Devo al lettore scettico alcuni esempi di questi giochi. Dei tanti che potrei proporre (e che
sono in parte contenuti negli scritti segnalati all’inizio) ne offro due, diversi e semplici.
Il gioco dell’Eutifrone
In questo dialogo si cerca la definizione di osion, termine che possiamo poco correttamente
tradurre con “santo” o rendere con la pietas latina. Una prima discussione che parte da una
risposta di Eutifrone, poi corretta da Socrate, porta ad una proposta: santo è ciò che tutti gli
dèi amano, empio ciò che odiano (9 D-E). Tale definizione viene messa in crisi con una
lunga trattazione (10 A-11 B), centrata sulla domanda: “santo è ciò che è amato dagli dèi o è
amato dagli dèi in quanto santo?”. La conclusione è che l’essere amato non dice nulla della
natura del santo, in quanto è una caratteristica estrinseca, una conseguenza: il santo è
amato dagli dèi per quello che esso è. Ma che cos’è? Essendo arrivati ad un punto morto,
Socrate – che, secondo la visione tradizionale, si limiterebbe, soprattutto nei primi
dialoghi, a fare domande – cerca di far uscire la riflessione dall’impasse proponendo la
questione del rapporto tra giusto, concetto più ampio, e santo. Abbiamo in sostanza una
diairesi: si distingue la parte del giusto che si prende cura degli esseri umani da quella che
si prende cura degli dèi, che è appunto la santità. Questo secondo tipo di intervento non
antropologia o sociologia della cultura, una “storia” della scrittura... Ma noi, noi filosofi, possiamo noi ragionare
cosi?». La sottolineatura è importante perché in un dibattito confinato nella sfera sociologica è possibile una
posizione che veda Platone non come un interprete degli effetti che sullo stesso pensiero, e quindi sulla filosofia, ha
l’affermazione della scrittura, ma come uno che «non si accorge che la sua nuova verità, critica e dialettica, ha
bisogno della scrittura e dell’incipiente diffusione libraria del sapere. È questo, per grandi linee, l’orizzonte
tematico nel quale si colloca la riflessione di vari studiosi, quali ad esempio E. A. Havelock, B. Gentili, M.
Vegetti» (Cerri 1991, p. 118).
12
migliora colui che viene curato, cosa impossibile nel caso degli dèi, ma collabora al
progetto di quello, come avviene nel rapporto servo-padrone. Emerge allora la domanda
centrale: qual è il progetto cui gli uomini devono collaborare perché la loro azione sia
santa? Quali sono i fini che la divinità persegue e per i quali può avvalersi dei nostri
servigi?
Eutifrone, portato in un contesto lontano dalla sua tradizionale visione religiosa, non sa che
cosa dire. Qui il dialogo si blocca:
SOCRATE: Che dire, allora, dei molti e bei risultati che gli dèi realizzano? Qual è il
cuore del loro operare?
EUTIFRONE: Ti ho detto anche poco fa, Socrate, che è un notevole impegno
apprendere con esattezza come stanno tutte queste cose. Tuttavia, ti dico
semplicemente questo, che, se uno è capace di dire e di fare cose gradite agli dèi,
con preghiere e sacrifici, queste sono azioni sante, quelle che salvano le case dei
privati e i beni comuni delle città, le azioni contrarie a quelle gradite agli dèi sono
quelle empie, che sovvertono e rovinano ogni cosa (14 A 9-B 7).
Eutifrone è tornato esplicitamente a una definizione precedente, data “poco fa”: fare e dire
cose gradite agli dèi con preghiere e sacrifici. In sostanza egli ribadisce che santo è ciò che
gli dèi amano, dimenticando che questo nulla ci dice della natura del santo. Il testo
dimostra così la radicale impotenza della visione tradizionale degli dèi. Ma, a riprova che
c’è ben altro, Platone aggiunge subito una sconcertante frase di Socrate:
Se tu lo avessi voluto, Eutifrone, in modo molto più breve avresti potuto chiarirmi
il punto centrale della mia domanda, ma è evidente che non sei disposto ad
insegnarmi. Infatti anche ora, mentre eri sul punto di farlo, ti sei ritirato. Se tu
avessi risposto15, avrei ormai imparato da te in modo adeguato che cos’è la santità.
(14 B 8-C 3).
Per capire che cosa sta succedendo, qui e sempre in Platone, dobbiamo fare una operazione
tanto elementare quanto decisiva: sottrarci alla magia del dialogo e distinguere fiction e
realtà. Nella realtà non esistono né Socrate né Eutifrone, ma solo l’Autore che, pensando
al lettore, scrive sia l’errore di Eutifrone sia il rimprovero di Socrate. Platone ci dice che
quello che proprio lui ha scritto, attribuendolo ad Eutifrone, non va bene, che andava data
un’altra risposta, e che questa avrebbe chiarito in modo adeguato la definizione di santità.
Ciò comporta che (nella fiction) Socrate (in realtà Platone) sa qual è la risposta16,
altrimenti non potrebbe affermare che 1) l’indovino si è trattenuto e 2) che, se fosse stata
detta (nella fiction, cioè se nella realtà Platone l’avesse scritta) egli avrebbe saputo (nella
fiction, e quindi nella realtà il lettore avrebbe letto) che cos’è la santità. Ma l’Autore non
15
L’espressione insistita di Socrate mostra che Platone intende fornire un «avvertimento esplicito rivolto al lettore
che ormai si uscirà di strada» (Reale 1991, p. 20 n. 30).
16
Si noti che la scena non funziona bene nemmeno come fiction. Socrate, che è già intervenuto in modo propositivo,
impostando la diairesi del giusto, potrebbe, visto quel che sta dicendo, dare la risposta. Non facendolo ha deciso (=
Platone ha deciso) il destino del dialogo, che infatti non conclude. Ma tale esito aporetico è determinato dalla risposta
di Eutifrone, dichiarata errata da Socrate, che però non la corregge.
13
lo ha voluto fare17, limitandosi a indicarci dove è stato fatto l’errore che ha impedito la
soluzione del problema. Se usciamo dalla finzione scenica e ci poniamo di fronte
all’autore, se cioè leggiamo il dialogo come un messaggio filosofico rivolto ai lettori,
vediamo che Platone ci ha messi di fronte ad un problema che ha segnalato. È il lettore che
deve andare alla ricerca della risposta.
In questa sede non è importante la soluzione che si potrebbe proporre, ma il fatto che
siamo di fronte ad una situazione che presenta una struttura formale particolare: la
soluzione c’è, tanto che si indica il luogo teorico in cui andrebbe collocata, ma non è
scritta, va trovata. Ora, se in una delle prime opere Platone costruisce un tale gioco,
possiamo ipotizzare che egli abbia continuato anche negli altri dialoghi a provocare il
lettore in modo analogo, rendendo via via più complessa la ricerca della soluzione18.
Il Sofista
Il secondo esempio è più tecnico, legato ad un famoso e importante passo del Sofista.
Platone, per far vedere il rapporto che c’è tra Idee somme, ne prende in esame alcune tra
quelle più importanti (254 C). In questo senso il numero di questi generi sommi non è
rilevante, perché non siamo affatto - per dichiarazione dell’Autore - di fronte ad un elenco
completo e significativo. Si tratta di cinque Meta-idee: Essere (=E), Quiete (=Q),
Movimento (=M), Identico (=I) e Diverso (=D). Tutto appare chiaro. La stranezza è che
Platone continua a contare queste metaidee, insistendo sul dato numerico per dire cose del
tutto irrilevanti.
Nel breve passo 254 D 7 - 254 E 5, Platone ricorre a valori numerici 7 volte, e per di più
senza alcuna plausibile ragione, perché non dice nulla: si parte da E, Q e M. Si precisa che
2, Q e M, non possono mescolarsi tra loro, mentre E si relaziona con entrambi; i generi
sono quindi diventati 3. Ognuno è diverso dagli altri 2 e identico a sé; in tal modo abbiamo
altri 2 generi, I e D, ulteriori rispetto ai 3 precedenti. Dobbiamo dunque svolgere l’indagine
su 5 generi e non su 3. Che senso ha tutto questo? Che senso ha in un’opera così difficile
precisare che 2 + 1 = 3 e che 2 + 3 = 5? Ancora, poco dopo (255 C-256 D) si dirà che l’I
è la IV idea oltre alle 3 e il D è la V, giudizio del tutto inutile, ma subito dopo ribadito una
seconda volta; poi si parla ancora di 5 generi e della diversità del D sia dalle 3 prime forme
sia dalla IV, in quanto si è riconosciuto che in tutto sono 5, poi ci sono altri quattro
riferimenti numerici ; poco dopo troviamo un riferimento isolato a 255 E 8, e ancora tre
numeri in tre righe (256 C 11 - 256 D 1). Se si legge ad alta voce, come si dovrebbe fare
17
Cfr. Reale 1991, p. 19-20 n. 29: l’Autore «volutamente, non rende esplicita la risposta, che il lettore deve saper
trarre da solo... Platone darà, peraltro, una chiara e inequivoca indicazione allusiva a p. 15 A, in modo che il
lettore attento non esca di strada insieme ad Eutifrone».
18
Così anche Kahn 2008, pp. 180-181: «noi lettori abbiamo potuto vedere che questa è la funzione dell’aporia in
generale, e dei dialoghi aporetici in particolare: eliminare la falsa credenza che questi siano argomenti semplici,
facilmente comprensibili e instillare un desiderio per la ricerca successiva. Dal momento che i dialoghi aporetici
sono anche tutti protrettici, ci spingono a fare filosofia».
14
sempre con i testi degli antichi, si resta colpiti da questo uso sovrabbondante e spesso
imbarazzante per la sua assoluta inutilità di riferimenti numerici.
A me sembra che Platone voglia attirare la nostra attenzione sul numero di queste
metaidee, per farci scoprire che non sono 5, come lui ripete, ma almeno 6 (perché il non
essere è il centro del ragionamento, anche se viene “dimenticato” nell’elenco) o meglio 8
(la conclusione è che si hanno due sensi di non essere e quindi due sensi di essere). In
effetti Teeteto, intervenendo in modo del tutto inutile, dice che è impossibile che il loro
numero sia inferiore a cinque (256 D 3-4), espressione maliziosissima, perché non esclude
che siano di numero superiore a cinque.
Di nuovo, non mi interessa che si accetti la mia conclusione. Quello che conta è che qui
Platone gioca con il lettore, che deve riflettere su qualcosa che nel testo c’è (come
esigenza e problema) e non c’è (come esplicita risposta).
6. Conclusione
Se si accetta quello che Platone dice, cioè che un uomo serio scrive solo per gioco, se si
leggono i dialoghi come giochi protrettici proposti per aiutare il lettore a fare filosofia,
molte delle stranezze dei dialoghi platonici acquistano senso: l’evidente volontà di esporre
in modo complicato anche tesi che potrebbero essere presentate in modo semplice, la
sequenza perfetta di dialoghi che divengono via via più difficili sia nei contenuti sia nelle
metodologie proposte, gli accenni sviluppati e chiariti solo in dialoghi successivi, etc. etc..
Chiudo con brevi riferimenti a due ultime questioni. La prima è la tecnica platonica del
rinvio. Il più eclatante esempio di questa tecnica riguarda il Bene: Platone rifiuta di
svolgere la trattazione e preferisce 1) parlare non del Padre (del Bene) ma del “figlio del
Bene e somigliantissimo a lui”, 2) non pagare il debito ma limitarsi ai soli interessi
(Repubblica 506 D-507 A), 3) dichiarare che ci informa sulla sua casa (Filebo 61 A-B),
avvicinandosi poi fino ad arrivare “nei vestiboli del Bene e della sua dimora” (Filebo 64
C). Poiché a questo tema dedicheremo una certa attenzione, non lo approfondiamo ora:
mostreremo che anche in questi casi Platone avrebbe molto da dire (come si può affermare
che un figlio è “somigliantissimo” al padre se non si conosce quest’ultimo? Come si
possono calcolare gli interessi se non si conosce la cifra del debito?) ma che lascia spazio
alla ricerca del lettore. Ciò conferma che siamo di fronte a tecniche di scrittura e non alla
ignoranza, comunque qualificata, dello scrittore.
La testimonianza aristotelica
L’altro tema è quello della testimonianza aristotelica, che qui non posso affrontare in modo
adeguato. Mi limito dunque ad accennare la questione centrale. Come tutti sappiamo
Aristotele ci parla esplicitamente di agrafa dogmata, dottrine non scritte. Credo che sia
impossibile ignorare questo brano e che anzi ci si debba porre una domanda che gran parte
della critica dimentica: perché Aristotele qui e solo qui cita le “dottrine non scritte”?
15
Perciò anche Platone nel Timeo dice che la materia e lo spazio (la Chora) sono la
stessa cosa; infatti il Ricettacolo e lo Spazio sono una sola e identica cosa. Egli,
pur definendo qui il Ricettacolo in modo diverso da come fa nelle cosiddette
“Dottrine non scritte”, ha comunque identificato il luogo (tÒpon) e lo spazio
(cèran) (Fisica IV, 2, 209 b 11-16).
Cerchiamo di capire il contesto e l’operazione che lo Stagirita sta facendo. Aristotele sta
parlando del luogo, quello in cui sono tutti i corpi, ed ha appena detto che esso sembra
essere da un certo punto di vista la forma di ogni cosa, da un altro la materia, tesi che poi
dimostrerà impossibile (209 b 17-210 a 13). Il suo tentativo è di portare anche il maestro
sulla seconda posizione, sulla base della terminologia usata nel Timeo. Qui infatti,
secondo Aristotele, 1) egli ha identificato luogo e spazio, quindi, 2) poiché la Chora, lo
spazio, è il Ricettacolo stesso, 3) e il Ricettacolo è materiale, 4) per Platone il luogo è
materiale;
Non è il momento di approfondire questo specifico tema: in realtà, anche se ci sono nel
Timeo espressioni ambigue che consentono ad Aristotele di fare questo tentativo, la sua è
una vera forzatura del testo per identificare Chora e Ricettacolo. Il problema è che tutti gli
allievi di Platone, presenti in Accademia e nello stesso Liceo, sapevano benissimo che il
filosofo ateniese nelle sue conversazioni aveva sostenuto una tesi diversa da quella qui
attribuitagli da Aristotele, che quindi non può tacere questo dato, pena essere accusato di
mentire. Quindi egli ricorda quanto Platone sosteneva, ma insiste che quando il maestro ha
scritto ha dovuto assumere quella posizione errata. Questo spiega perché qui egli cita le
dottrine non scritte per la prima e ultima volta: lo Stagirita non può far finta di ignorare
che il filosofo presentava il Ricettacolo in modo diverso, per cui risultava non
identificabile con la Chora; tuttavia, egli coglie, nella formulazione del Timeo il segno di
una inevitabile identificazione dei due termini. Così involontariamente egli conferma che
la sua è una forzatura del testo, perché è possibile dimostrare che Platone nel Timeo
sostiene la diversità tra i due concetti, proprio come, secondo la testimonianza aristotelica,
egli faceva anche nelle lezioni.
La cosa più importante, dal nostro punto di vista, deve però essere un’altra: Aristotele, nel
momento in cui è costretto a parlare delle “lezioni” platoniche, non usa le espressioni
ovvie che dovremmo aspettarci, magari legate alla vita dell’Accademia, ma parla di
“Dottrine non scritte”, un termine che evidentemente doveva risultare chiaro al suo
uditorio. E se le parole hanno un senso, vuol dire che il suo uditorio sapeva che c’erano
delle teorie che Platone non aveva messo per iscritto, esattamente come abbiamo capito dal
Fedro e dalla Lettera settima, che ci offrono anche le ragioni filosofico-educative che sono
alla base di questa decisione.
19
II PARTE. LA TRATTAZIONE DEL PRINCIPIO PRIMO, UNO, BENE, MISURA
19
Per questo tema rinvio a Migliori 2002.
16
Il dialogo che maggiormente ci avvicina alla concezione platonica dei principi e quindi alla
sua visione del Bene è il Filebo, uno degli ultimi dialoghi, che tratta della vita buona e
quindi non può ignorare tale tema, proponendocelo all’interno di una serie di giochi.
1.
Il gioco sui Principi del Filebo20
C’è un grande gioco che costituisce l’asse teoretico del dialogo. Platone presenta due
trattazioni metafisiche apparentemente slegate, ma in realtà intimamente connesse.
Anticipiamo in sintesi: nella prima parte abbiamo due principi, Limite e Illimitato, che
danno luogo ad una terza realtà, un Misto, in forza di un quarto dato, una Causa esterna
intelligente, il Nous. È la migliore presentazione scritta della teoria dei Principi platonica,
espressa però in linguaggio pitagorico, da cui invece, secondo la testimonianza aristotelica,
Platone si è distaccato, parlando di Uno e di Grande-e-piccolo. Questa visione sembra del
tutto dimenticata nel resto del dialogo, con scandalo di tanti interpreti che si chiedono il
senso di una trattazione, che non sembra aver nessuna relazione con il tema del dialogo.
Poi, nella parte finale, per giudicare la vita buona, Platone deve parlare del Bene; in questo
contesto mette in gioco una serie di elementi che rimandano alla Misura, che però, con un
classico passo di omissione, non viene mai esplicitata. Se a questo punto si pongono in
relazione le due parti, si scopre che i due ragionamenti, pur presentati con un linguaggio
del tutto diverso, sono perfettamente coerenti: se li mettiamo insieme, cominciamo a
vedere delinearsi il Principio positivo platonico, che è definibile ugualmente come Uno,
come Bene, come Misura, anche perché è principio gnoseologico, ontologico e assiologico.
Vediamo molto rapidamente la prima parte. Platone pone subito quella che è la premessa
di fondo: il reale è sempre uni-molteplice. Ogni cosa è ad un tempo sia uno sia molteplice e
sbaglia chi sostiene solo una delle due affermazioni. Questo dato viene poi giustificato:
tutto è misto, frutto dell’azione di un limite, Peras, su un illimitato, Apeiron, in forza di
una Causa (efficiente) divina, che utilizza il Peras come concausa. Ciò è vero per le realtà
semplici come per quelle più complicate, per un vivente come per il cosmo e le stagioni.
Il Peras agisce come principio d’ordine, che dona alla realtà tutto ciò che ha di bello, dalla
salute dei corpi alle molte cose belle che sono nell’anima: conoscenze, virtù e via dicendo.
Tuttavia Platone appare come in difficoltà a definirlo. Socrate affronta il tema in modo
sbrigativo, lavorando solo sulla contrapposizione: appartengono al genere limite le realtà
che accettano tutte le caratteristiche contrarie (25 A 5-6) a quelle attribuite all’illimitato:
20
Per questo dialogo, rinvio a Migliori, 1993, 1996, 2007, 2010, 2010a.
17
in primo luogo l’uguale e l’uguaglianza, dopo l’uguale il doppio e tutto ciò che è
numero in rapporto ad un numero o misura in rapporto ad una misura (mštron Ï prÕj
mštron) (25 A 6-8).
Si noti che questa presentazione assegna il primato ad una dimensione concettuale,
l’uguale, che, come vedremo parlando di metretica, si presenta come ciò che è intermedio
tra gli estremi dell’eccesso e del difetto; solo dopo vengono le determinazioni quantitative
e numeriche. All’interno di questo elenco appare la misura, staccata dai numeri.
Ciò che sconcerta è che Socrate pare volersi limitare a questa indicazione in negativo e
procedere subito oltre, a parlare del misto: (25 B 5-6). Sembra che Platone abbia deciso di
non approfondire il tema, mentre fa esattamente il contrario, per di più avvertendo il
lettore. Socrate comincia a descrivere la mescolanza: si prendono le realtà poste
nell’illimitato e
dopo queste cose, mescola ad essa la progenie del limite (toà pšratoj)… Quella di
natura limitata, che anche prima dovevamo ricondurre ad unità, così come
abbiamo ricondotto ad unità quella dell’illimitato, e non l’abbiamo fatto. Ma forse,
proprio ora, mettendo insieme entrambi i generi, otterrai tale risultato, di chiarire
anche questa (25 D 2-9).
Platone avverte che non si è fatto ciò che si doveva e afferma che, lavorando sul misto, si
chiarirà anche il limite. La cosa risulta ovvia se ci fermiamo a riflettere: se “limite” vale
come “limitante”, cioè come la forza agente che “limita” l’illimitato, solo nel misto lo si
può vedere davvero come “un Principio che agisce”. Questi primi dati trovano conferma
nella successiva presentazione del genere del limite:
quello dell’uguale e del doppio, e quanto fa cessare i rapporti di opposizione
reciproca fra i contrari, rendendoli proporzionati e coordinati (sÚmmetra d kaˆ
sÚmfwna) con l’introduzione del numero (25 D 11-E 2).
Qui vediamo confermata l’importanza dell’uguale e il ruolo del numero; emerge inoltre la
natura “attiva” del peras che agisce su una realtà indeterminata determinandola, e
introduce il numero rendendo relazionabili i contrari stessi. Platone chiarisce con una
figura mitica che questo non avviene per una forza autonoma del Peras: la Dea interviene
(causa efficiente) in quanto vede che le cose indeterminate sono cattive, che l’ordine è
buono e che si può realizzarlo per l’azione del limite (26 B 7-C 1). Tale immagine,
confermata con una trattazione approfondita del Nous causa divina (28 B-30 D), mostra
che la forza è esterna e che il Peras è il vero Bene. In sintesi, l’azione ontologica di Peras
ha anche una valenza assiologica.
Aggiungo solo un dato che dà la misura di come Platone operi: in tutta la trattazione del
rapporto tra Apeiron e Peras il testo usa pochissimo questo ultimo termine (pitagorico),
sostituendolo continuamente con sinonimi come uno, telos, poson e metrion.
Sulla seconda parte dobbiamo essere meno sbrigativi, perché qui il tema del Bene appare
in modo esplicito, anche se è evidente la volontà platonica di non chiarirlo del tutto.
18
La “non-definizione” del Bene nel Filebo
Partiamo da un dato di fatto: non solo il testo, ma la stessa logica della costruzione del dialogo porta
necessariamente verso la “casa” del Bene. La questione si propone, con chiarezza, nel momento in
cui si decide che la vita felice non può essere né quella di puro piacere né quella di pura
conoscenza, ma va individuata in una vita mescolata di entrambi gli elementi. Il confronto si sposta
sulla ricerca di quale dei due termini “puri” possa aggiudicarsi il secondo posto. Ciò dipende dalla
possibilità di individuare chi tra piacere e pensiero ha una maggiore affinità rispetto al Bene (22
C-E); in seguito si ribadisce che per assegnare il secondo posto occorre avere la nozione
precisa del Bene o almeno una qualche traccia (61 A 4-5). Infine, il dialogo culmina in una
classificazione finale dei beni (66 A-C), il che, in assenza di un Bene cui riferirsi, sarebbe assurdo.
Tuttavia, come nella Repubblica, Platone ostenta la volontà di non fornire la definizione
del Bene, che pure mostra di conoscere. Infatti Socrate sostiene che, dovendo trovare il
Bene, si comporterà come chi, cercando una determinata persona, si informa sulla sua casa
(61 A-B). Poi, quando afferma di essere nei vestiboli della casa del Bene, si limita a
indicare che occorre trovare una Causa che realizzi misura e proporzione (64 D-E), che
sono i principali effetti del Bene, ma non dice qual è. Inoltre, alla fine, quando la ricerca
sembra finita con la vittoria del pensiero e Socrate chiede di essere lasciato andare,
Protarco lo blocca:
Rimane ancora, Socrate, una piccola cosa (smikrÕn): poiché tu non vorrai certo
ritirarti prima di noi, ti ricorderò quanto resta (67 B 11-13).
Qui finisce il dialogo, troncato dopo un’affermazione che, a questo punto, diviene
straordinariamente pregnante, in quanto dà luogo ad una situazione paradossale: nella
fiction Protarco dice giustamente che Socrate non può ritirarsi prima di aver completato il
discorso con la piccola cosa mancante, ma Platone nella realtà lo fa! L’Autore ci dice che
manca una cosa, ma sembra tanto deciso a non dirci qual è che, per così dire, lascia cadere
la penna. Questo dimostra che non si tratta di un argomento banale di cui avrebbe potuto
anche scrivere. In effetti la trattazione non è finita, perché il lettore non sa che cos’è il
Bene, quale sia il complesso rapporto tra Bene e le sue manifestazioni, o tra Bene e Nous.
È proprio del Bene che ormai bisogna parlare, visto che siamo stati condotti fino ai
vestiboli della sua dimora e che Socrate non ha mai rifiutato di svolgere questo tema. Ma
Platone interrompe il suo canto ed evidenzia il suo silenzio.
Qualsiasi altra ipotesi lascia questa brutale chiusa inspiegata e si scontra con un dato: sul
piano drammaturgico la sospensione della scena è uno strumento estremo. Nel linguaggio
teatrale contemporaneo questa scelta corrisponde a quella estrema provocazione dello
spettatore che consiste nel calare il sipario con la scena non conclusa. Nelle forme della
drammaturgia platonica qui troviamo estremizzata la tecnica del rinvio che costituisce un
procedimento classico dei dialoghi, quando si giunge di fronte ad argomenti cruciali, come
quello del Bene. Nel Filebo, Platone ha detto il massimo che si sentiva di scrivere sulla sua
dottrina dei Principi e dunque i suoi giochi divengono complicati: egli segnala in modo
19
drammatico e senza nessuna necessità interna alla fiction, che queste piccole cose lui non
le scriverà mai.
2. La presentazione del Bene
Tuttavia, come sempre, il dialogo allude a molte cose, a partire dal fatto che il Bene è
conoscibile e conosciuto quanto basta per porsi “vicino a casa sua”. Inoltre, e soprattutto,
Platone svolge, all’inizio e alla fine del dialogo, due diverse e articolate trattazioni del
Principio. Dunque, è ancora più evidente che Socrate sa di che cosa parla; infatti, per
accenni e allusioni, apporta importanti elementi a chiarimento di questo concetto, sia sul
tipo di causalità sia sulla stessa natura del Bene.
Socrate anticipa presto quella che è la soluzione della domanda sulla vita felice e buona:
Mi ricordo, ora, di alcuni discorsi ascoltati una volta, molto tempo fa, in sogno o
forse anche da sveglio, sul piacere e sul pensiero, di come nessuno dei due è il
bene (t¢gaqÒn), che è invece una terza realtà, diversa da questi e migliore di
entrambi (20 B 6-9).
Platone non vuole lasciarci dubbi: si tratta di una invenzione, visto che Socrate non sa
nemmeno se questo discorso lo ha ascoltato da sveglio o in sogno. Per procedere occorre,
però, convenire su alcune cose minori (20 C 8). Queste cose minori in realtà sono la prima
indicazione di tre caratteristiche del Bene alla luce delle quali decidere qual è la vita buona.
Sono quelle classiche21: 1) è compiuto (tšleon, 20 D 1; teleètaton, 20 D 3); 2) è adeguato
(ƒkanÕn, 20 D 4), anzi proprio in questo è superiore a tutti gli altri (20 D 5-6); 3) chi lo
conosce lo desidera e trascura tutto il resto; questa anzi è la cosa più necessaria (20 D 7) da
dire. Si tratta di determinazioni formali: nulla viene detto della natura del Bene, mentre si
indicano alcuni elementi che ne segnalano la presenza. Tuttavia si tratta di elementi
importanti tanto che nella parte finale Socrate ricorda che all’inizio nessuno dei due
modelli di vita puri era apparso sufficiente e adeguato (ƒkanÕn, 60 C 11), cioè
compiuto e degno di scelta da parte di tutti, e buono in assoluto (tÒ ge tšleon kaˆ
p©sin aƒretÕn kaˆ tÕ pant£pasin ¢gaqÕn, 61 A 1-2).
Poco dopo si ribadisce che nessuna delle due vite proposte era apparsa adeguata ƒkanÒn67
A 3), entrambe erano risultate
prive di autonomia e della potenza che manifesta l’autosufficienza e la
compiutezza (aÙtarke…aj kaˆ tÁj toà ƒkanoà kaˆ telšou dun£mewj, 67 A 7-8).
Queste prime determinazioni costituiscono, in effetti, una base sufficiente per escludere
che un tipo di vita unilaterale, fatto di solo pensiero o di solo piacere, possa essere
21
Si ritrovano anche in Aristotele, Etica a Nicomaco I, 7, 1097 A 15-B 21: il bene dell’uomo deve essere compiuto,
sufficiente, oggetto universale di desiderio.
20
adeguato, compiuto e degno di scelta (ƒkanÕj oÙd aƒretÕj, 22 B 1; ƒkanÕj kaˆ tšleoj
kaˆ… aƒretÒj, 22 B 4-5), per cui si comincia a lavorare sull’ipotesi di una vita fatta di
piaceri e pensiero. Ma anche questa scelta ripropone la questione: visto che il primo
premio è stato attribuito alla vita mescolata, a chi spetta il “secondo”, al piacere o al
pensiero? Ma Socrate fa subito una dichiarazione che può sembrare paradossale:
Su questo terreno combatterei anche di più contro Filebo, per sostenere che,
qualunque sia l’elemento acquisito nella vita mista che l’ha resa insieme degna di
scelta e buona, a questo è più affine e simile non il piacere, ma l’intelligenza (noàj)
22 D 5-8).
In questo modo Platone ci costringe a riflettere sul perché questo “secondo” posto meriti
una lotta maggiore, cioè sia più importante, del “primo”. In effetti, si tratta di individuare
ciò che rende buona la vita scelta: il “secondo posto” non comporta un processo
discensivo, ma ascensivo, verso la causa della bontà della vita buona, cioè verso il Bene
stesso. Ci si muove, dunque, su un piano superiore, che giustifica un maggiore impegno.
3. Il Bene e le sue manifestazioni
Per decidere tra i due contendenti si procede a fare una buona mescolanza: il nous prima
accetta tutte le conoscenze, poi blocca l’accesso a molti piaceri, cosa necessaria
se si vuole vedere un’amalgama ben mescolata, che sia la più bella e la più stabile,
nella quale cercare di comprendere che cosa sia per natura, nell’uomo e nel tutto
(tù pantˆ), il Bene, e quale Idea („dšan) bisogna intuire (manteutšon) di attribuirgli
(63 E 8-64 A 3).
Occorre sottolineare alcuni dati:
1. l’orizzonte dell’indagine non è quello antropico, ma riguarda il Tutto;
2. si parla di attribuire l’“Idea” di Bene, il che conferma la sua conoscibilità;
3. ma si afferma che si opererà con una sorta di mantica, di intuizione profetica.
Dunque, questa trattazione non sarà adeguata, ma ci darà una sorta di presagio della
trattazione completa che, non riguardando solo l’uomo, ma il tutto, porta al Bene-principio.
A conferma, dopo che il Nous ha realizzato la mescolanza, quell’ordine ideale, quel cosmo
incorporeo, kosmos asomatos (64 B 7) destinato a governare bene la nostra vita, Socrate dichiara
che siamo ormai giunti nella dimora del Bene, siamo cioè prossimi al Bene stesso. In effetti, la
realizzazione di una “buona” mescolanza implica che il Bene sia già operante. Si tratta di
capire come ciò è avvenuto. Socrate dichiara ripetutamente che è facile individuare ciò che rende
un qualsiasi misto molto apprezzabile: tutti infatti sanno
che ogni mescolanza, qualunque sia e comunque sia fatta, se non ha realizzato la
misura e la proporzione (mštrou kaˆ summštrou), determina necessariamente la
rovina dei suoi componenti, e ancor prima di se stessa. Infatti, non è neppure una
vera mescolanza, ma risulta ogni volta un puro insieme non amalgamato, che rovina
le realtà che lo contengono in sé (64 D 9-E 3).
Tale affermazione incontra l’approvazione totale di Protarco, che la considera verissima.
21
Bisogna sottolineare la pluralità di piani qui messi in gioco:
1. si ribadisce con forza che quanto si sta dicendo vale per qualsiasi tipo di mescolanza,
quindi stiamo parlando del Tutto;
2. si pongono come centrali misura e proporzione, senza le quali non si dà vera
mescolanza;
3. su questa base si può distinguere tra una vera mescolanza e un puro insieme;
4. misura e proporzione sono dunque la radice dell’ordine che la divinità con il peras
vuole imporre alle cose per evitarne la rovina;
5. la rovina, a conferma della natura uni-molteplice della visione platonica, riguarda
5.1. l’aggregato, la mescolanza stessa, l’insieme (es. una vita umana felice);
5.2. le componenti della mescolanza, le parti dell’insieme (es. il piacere di mangiare, di bere);
5.3. ciò in cui l’insieme è, la realtà in cui si colloca (es. l’individuo distrutto dai vizi).
La potenza del Bene e il Bello
Il primo risultato che Socrate trae da questa affermazione è che la potenza del Bene si nasconde
nella natura del Bello:
Ora la potenza del Bene (¹ toà ¢gaqoà dÚnamij) si è rifugiata nella natura del Bello
(e„j t¾n toà kaloà fÚsin:); infatti, la giusta misura e la proporzione (metriÒthj g¦r
kaˆ summetr…a) vengono a realizzare, dovunque, bellezza e virtù (k£lloj kaˆ
¢ret¾) (64 E 5-7).
Questo inserimento del bello appare del tutto “immotivato”, il che deve farci supporre che
Platone voglia farci riflettere sj qualcosa di rilevante: la potenza del Bene. In effetti qui il
nesso è giocato sulla differenza tra natura e potenza22: quelle che sono le caratteristiche
del bello esprimono la potenza del Bene. Dunque il Bene ha un primato ontologico rispetto
al Bello, che non ha potere, cioè non modifica la struttura ontologica del reale, mentre il
Bene sì; il ruolo “secondario” del Bello viene poi confermato nella sua collocazione al
secondo posto nell’elenco finale dei beni (66 B).
Ma la cosa importante è che il Bello è una forte manifestazione dello stesso Bene, «ossia
della Misura suprema, attraverso un policromo rifrangersi, in vari sensi, della Misura e
dell’Ordine nelle diverse forme del misurato e dell’ordinato, e in questo senso è la
visibilità dell’Uno» (Reale 2003, p. 492). In effetti, se la prima manifestazione del Bene
sono la giusta misura e la proporzione, che costituiscono la bellezza e che caratterizzano la
virtù23, potremmo dire, usando quel linguaggio preciso che Platone sembra voler evitare,
che c’è una Misura che agisce e un misurato che ne manifesta la potenza. Questo spiega
22
Anche se molti autori, come Souilhé 1919, p. 122 e Kucharski 1949, p. 87, li considerano dei puri sinonimi, il
fatto che qui i due termini vengano messi in relazione fa sì che la differenza risalti.
23
Termine straordinario per la sua assenza in questo dialogo. In effetti, l’assenza della virtù è un segno forte di
quanto sia riduttivo leggere questo testo in una chiave esclusivamente etica. Tuttavia Platone non può rinunciare
a ricordare, sia pure di passaggio, la virtù che esprime l’armonia dell’anima (63 E). Ma che si tratti di una sorta di
citazione “dovuta”, lo prova il fatto che poi questo termine non rientra nelle manifestazioni del Bene con cui ci si
confronta nella parte conclusiva del dialogo.
22
perché Platone possa dare in tanti dialoghi enfasi al ruolo del bello e al legame tra questi
due concetti. La bellezza non coincide con il Bene, ma lo esprime in modo del tutto
peculiare. Infatti, il Bello ha «il privilegio di essere visibile con gli occhi anche in
dimensione fisica» (Reale 2003, p. 491), per cui possiamo considerarlo il trasparire
dell’invisibile nel visibile; ciò non comporta affatto identità: il Bello non coincide col
Bene, anche se «è in sommo grado affine ad esso e ne differisce solamente nel modo in cui
si manifesta» (Reale 2003, p. 489). Nello stesso tempo lo nasconde perché noi vediamo il
bello e possiamo non renderci conto che quell’ordine che ci attira e conquista è il segno
dell’azione del Bene-Misura.
Bene e verità
C’è un altro dato da sottolineare: Platone aggiunge “dogmaticamente e per tre volte” la
verità nella mescolanza e lo fa in modo ridondante:
Ma, senza dubbio, anche questo è necessario, altrimenti nulla potrebbe mai
generarsi … Ciò a cui non mescoleremo verità, non potrà mai veramente
generarsi, nel presente come nel passato (64 A 7-B 3).
Qui Platone ci sconcerta collegando la presenza della verità alla generazione delle cose,
cioè dandole una valenza ontologica (64 A-B). L’Autore qui va oltre la concezione
tradizionale che essere e conoscere sono strettamente legati, l’affermazione è molto più
forte: la Verità è condizione dell’esistere delle cose generate. Per questo può essere posta
come una delle manifestazioni fondamentali del Bene, insieme a Bello e Misurato.
Comunque tale necessaria presenza della verità nel misto viene poi ribadita, con un
esplicito richiamo:
E abbiamo detto che anche la verità è amalgamata con esse nella mescolanza (64 E
9-10).
La successiva trattazione enfatizza il ruolo della verità, che si trova in tutte e due le terne
che presentano le caratteristiche fondamentali del Bene (65 A-B); ciò vuol dire che, per
Platone, questo tema doveva essere inserito nello svolgimento.
Un unico Principio con una polivalente funzione causale
A questo punto si potrebbe avere l’impressione che non esista un Bene, ma tre principi diversi e
separati: bellezza, proporzione e verità. Proprio per evitare un simile equivoco, Platone aggiunge
alcune affermazioni perentorie.
Dunque, se non possiamo cogliere il Bene in una sola Idea, dopo averlo colto con
tre, ossia bellezza, proporzione e verità (k£llei kaˆ summetr…v kaˆ ¢lhqe…v),
diciamo che attribuiamo giustamente a questo, preso come un uno (oŒon n), la
causa delle realtà che sono nella mescolanza, e che la bontà della mescolanza
deriva da questo, in quanto esso è Bene (æj ¢gaqÕn ×n) (65 A 1-5).
23
Si prendono le tre idee che abbiamo trovato riflettendo sulla natura buona della mescolanza
e che esprimono la potenza del Bene, le unifichiamo come se fossero un’unità, le
riconduciamo ad uno: abbiamo la causa di tutto. Questo elemento unitario è infatti
1. causa ontologica, come viene esplicitato a proposito delle realtà che costituiscono la
mescolanza (qualunque mescolanza);
2. causa assiologica, come viene esplicitato, in quanto questo Principio è il Bene; in
questo senso il Bene agisce come causa formale, principio d’ordine, che organizza le
cose rendendole misurate e buone;
3. implicitamente causa gnoseologica, visto che più volte Platone ci ha costretto ad
aggiungere la verità; questa ci sembra la spiegazione adeguata dell’inserimento del
vero: se la causa è unica si capisce perché Platone abbia voluto e potuto dire che nulla
si genera o vive se non c’è la presenza del Vero.
È rilevante che si parli di una realtà una in senso forte, un Uno, di cui si evidenzia la
polivalenza funzionale e la molteplicità di piani: lo stesso Principio è alla base della
conoscenza come della realtà, un oggetto esiste perché si trova inserito in una dimensione
insieme ontologica e gnoseologica, che rinvia al Bene, quindi anche assiologica
4. Il Bene e la Misura
Indicazioni rilevanti sull’importanza della misura emergono nel momento in cui Platone
distingue i piaceri normali, mescolati ai dolori, da quelli “puri” (50 E), un genere divino
(51 E), tanto differente dall’altro che bisogna dire che siamo di fronte a due Idee (e‡dh
dÚo, 51 E 5) diverse di piaceri. Ciò comporta una distinzione:
attribuiamo col ragionamento ai piaceri intensi la mancanza di misura (¢metr…an)
e a quelli non intensi, al contrario, la giusta misura (™mmetr…an). E quelli che
accolgono il grande, l’intenso, che divengono tali “frequentemente” e “raramente”,
consideriamoli membri di quel genere (gšnouj) dell’illimitato (toà ¢pe…rou), che
circola, ora più ora meno, attraverso il corpo e l’anima, mentre quelli contrari
mettiamoli nel genere delle realtà misurate (tîn ™mmštrwn) (52 C 3-D 1).
Va notato l’intreccio dei linguaggi e la ridondante presenza di riferimenti alla misura. La
prima contrapposizione è tra “assenza di misura” e “giusta misura”. La cosa più
interessante è che qui Platone mescola le due trattazioni contrapponendo agli elementi del
genere illimitato, apeiron, non il limite, il peras, ma la misura, e definisce “genere delle
realtà misurate” quello che nella trattazione precedente era il genere delle “realtà limitate”.
Tuttavia, non deve sfuggire l’effetto del procedimento per “omissione”. Platone parla di un
Principio, ma non dice che cos’è. Noi sappiamo solo che è la potenza alla base della
bellezza, che si manifesta nel misurato e proporzionato, o che possiamo coglierlo in
bellezza, proporzione e verità. La Misura in sé sembra scomparsa. Anche nel successivo
giudizio per decidere quale dei due, piacere e pensiero, è più affine al Bene, ci si rivolge
alle tre idee che lo manifestano e insieme lo nascondono, bellezza, verità e misurato al
massimo grado (k£llouj kaˆ ¢lhqe…aj kaˆ metriÒthtoj pšri, 65 B 8). Quest’ultima
espressione merita una riflessione: qui Platone usa metriotes come sinonimo di simmetria,
dunque indica il proporzionato, cioè una manifestazione nella forma superlativa, subito
24
ribadita: questa realtà perfettamente misurata (t¾n metriÒthta, 65 D 4) viene messa in
gioco come seconda con un esito scontato:
credo, infatti, che non si può trovare nessuna realtà che abbia per natura meno
misura (pefukÕj ¢metrèteron) del piacere e del godimento e nessuna più misurata
(™mmetrèteron) dell’intelligenza e della scienza (65 D 8-10).
Il piacere di cui si parla è quello “normale” mescolato al dolore, che infatti appartiene al
genere dell’illimitato, perché il piacere puro ha una natura opposta. Questo è del tutto
sprovvisto di misura, mentre la scienza è segnata dalla misura. Ovviamente, nella prima
parte avremmo detto che è segnata dal limite. Limite e misura appaiono di nuovo quasi
sinonimi o comunque intercambiabili.
Finita l’analisi, segue l’enfatico proclama che fornisce una elencazione dei cinque più
importanti beni emersi da tutta l’analisi. I primi due elementi sono accomunati in una
formulazione simile e quindi devono essere valutati insieme:
Pertanto, proclamerai ovunque, Protarco, mandandolo a dire tramite messaggeri e
dichiarandolo tu stesso ai presenti, che il piacere non è il primo bene e neppure il
secondo, ma che il primo è in qualche modo nei pressi della misura e del misurato
e conveniente (pV perˆ mštron kaˆ tÕ mštrion kaˆ ka…rion) e di tutto ciò che,
essendo tale, deve essere pensato di natura eterna (66 A 4-8).
Il secondo è nei pressi di ciò che è proporzionato e bello, di ciò che è compiuto e
adeguato (perˆ tÕ sÚmmetron kaˆ kalÕn kaˆ tÕ tšleon kaˆ ƒkanÕn), e di tutto ciò
che appartiene alla stessa famiglia (66 B 1-3).
Il secondo termine dell’elenco è chiaro: la presenza del bello mostra che si tratta di realtà
dipendenti, quelle che manifestano la potenza del Principio. Qui ritroviamo infatti anche
quelle caratteristiche di compiutezza e adeguatezza che erano state considerate fin
dall’inizio come elementi formali che caratterizzano il Bene, quelli che ne costituiscono
una manifestazione sia pur secondaria.
Quanto al primo posto troviamo il misurato, cioè quelle entità matematiche che
evidentemente sono superiori al bello. Ma è la formulazione che deve attrarre la nostra
attenzione: questi beni rinviano ad altro, in quanto sono definiti come ciò che è nei pressi
della misura, e poi di tutto il resto.
Facciamo qualche considerazione. In primo luogo, questo è quello che Socrate ha
preannunciato, nel momento in cui aveva trovato la strada per raggiungere la casa del
Bene,
in modo da avere un grande aiuto per trovare ciò che cerca (61 B 1-2);
Socrate non cerca di raggiungere il Bene (nella fiction, perché nella realtà è Platone che
non vuole dircelo), ma solo di trovarsi nei pressi di questo; in effetti, il primo posto della
classificazione dei Beni ci porta vicino alla Misura, ma non alla Misura. Ma la cosa più
rilevante è che, stante questo testo, la misura non è uno dei beni che si offrono all’essere
umano, nemmeno in quella sfera superiore che qui è in esame. Ci troviamo di fronte a tre
25
possibilità: 1) o la misura non è affatto un bene; 2) o è tanto inferiore da risultare nei posti
successivi al quinto, 3) oppure la Misura è quel Bene superiore che non può essere
nell’elenco dei beni, in quanto ne è la fonte prima: causa ontologica, gnoseologica e
appunto assiologia. Le prime due possibilità sono del tutto assurde e contraddicono tutta la
precedente trattazione. Dobbiamo quindi pensare che l’essere fuori dalla classificazione
dipende proprio da questa superiorità: la Misura non è un bene classificabile essendo quel
Bene che classifica. La “piccola cosa” che secondo Protarco manca, sembra proprio questa
definizione: l’Uno Bene è, in ultima istanza, Perfetta Misura.
Concludo con una curiosità aristotelica tratta da Siriano, su cui Reale ha spesso
richiamato l’attenzione, quasi a sottolineare come l’Allievo sembri conservare più di un
ricordo dell’insegnamento platonico: «Aristotele, proprio in un dialogo intitolato Politico e
quindi ispirato a questo dialogo platonico (purtroppo andato perduto, ma di cui ci sono
pervenuti frammenti) ci dice a chiare lettere» che
il Bene è la misura più esatta di tutte le cose (p£ntwn g¦r ¢kribšstaton mštron
t¢gaqÒn ™stin) (In Aristotelis Metaphysica = Politico, fr. 2 Ross).
Le due trattazioni a confronto
Possiamo ora mettere a confronto le due trattazioni metafisiche di questo dialogo. I punti
che ci interessa sottolineare sono le somiglianze e, nel contempo, alcune significative
differenze tra le due trattazioni. Le somiglianze riguardano il ruolo del Principio
ordinatore, in quanto il Bene-Misura svolge nella seconda parte del dialogo la funzione che
nella prima ha svolto il Peras.
1.1. Il Peras è una potenza che agisce sull’indeterminato, un limitante che pone fine
all’azione dei contrari, rendendoli commisurabili e compatibili attraverso
l’introduzione del numero, è il Principio che rende possibile l’esistenza stessa del
misto; ciò vale per tutti gli aspetti della realtà, dalle cose concrete fino alle molte
cose belle che esistono nell’anima;
1.2. il Bene della seconda trattazione rende buona la realtà ordinandola con le misure;
1.3. in sintesi, entrambi agiscono come causa formale, principio d’ordine.
1.1. Il Peras, causa ontologica, ha una funzione valoriale: la Dea (causa efficiente) vede
che le cose indeterminate sono cattive, che l’ordine è buono e lo realizza per azione
del peras; ad opera di una Causa superiore il peras crea un ordine che è buono, il che
consente di salvare le cose;
1.2. il Bene è ovviamente causa assiologica, ma è anche causa ontologica;
1.3. in sintesi, l’azione ontologica di Peras ha una valenza anche assiologica;
analogamente, il Bene-Misura, in quanto principio di ordine, è anche causa
ontologica.
3.1. nella prima parte la presentazione dei Principi serve in relazione al tema etico:
capendo la polivalenza strutturale del reale non ci si stupisce di scoprire due Idee di
piacere e una vita frutto di una mescolanza di cose molto diverse;
26
3.2. la seconda parte chiarisce come la trattazione dei Principi serva per la nostra
esistenza, permettendoci di individuare la struttura della vita buona, inserendola in un
quadro che l’Uno-Bene-Misura proietta nel cosmo.
Ci sono poi alcune differenze, importanti perché comportano e consentono un fertile
intreccio. La prima esposizione ha un carattere descrittivo, mentre nella seconda la
questione decisiva è quella del Bene e dell’ordine necessario all’esistenza degli aggregati;
dunque, mentre all’inizio del dialogo la scelta a favore di una vita di piaceri e conoscenze
viene fatta su base empirica e buonsensista, per le scelte che gli esseri umani fanno, la vera
giustificazione si ha nella seconda parte del dialogo, sulla base delle caratteristiche del
Bene-Misura, che chiarisce la natura di quel cosmo incorporeo, kosmos asomatos, che
guida l’azione dell’uomo buono e felice; solo la seconda trattazione spiega perché il
Principio ordina, in quanto esso si rivela come Misura, il che conferma i vari accenni alla
misura e al numero che già trapelano nella prima parte: il processo descritto nella prima
parte, l’azione del nous attraverso il limite che impone ordine e misura, si spiega perché il
Peras è la Misura stessa
Se colleghiamo le due parti del dialogo senza lasciarci fuorviare dalla differenza
terminologica, vediamo che per Platone c’è un Principio limitante, polifunzionale, che
agisce su un Principio di infinitezza per dar luogo ad un cosmo misto in forza dell’azione
di una causa esterna al processo. Esattamente come troviamo confermato nel Timeo.
24
III PARTE. MISURA E METRETICA
Quanto abbiamo detto sul ruolo decisivo della Misura trova conferma in molti passi
platonici, ma il luogo teorico in cui si coglie meglio la centralità di questo concetto è
certamente la metretica, l’arte della misura.
1. La metretica nei primi dialoghi
La metretica, non come struttura matematica, ma come strumento da utilizzare sul piano
etico e filosofico, viene fatto “affiorare” da Platone piuttosto presto nelle sue opere scritte.
Già nell’Eutifrone è possibile trovare un interessante spunto. Nel criticare la definizione di
santo come ciò che è caro agli dèi, Socrate riprende il tema del contrasto tra le divinità per
approfondirlo da un punto di vista più generale. Se un disaccordo riguarda i numeri, per
superarlo basta ricorrere al calcolo (7 B 8); analogamente per le grandezze e per le realtà di
questo tipo si procede alla misurazione (™pˆ tÕ metre‹n, 7 C 4). Invece sul giusto e
l’ingiusto, il bello e il brutto, il buono e il cattivo è più difficile giungere ad una decisione
unanime, per cui nascono contrasti (7 D). Platone stabilisce una distinzione tra due sfere
della realtà, quella matematico-quantitativa e quella etico-estetica: solo per la prima c’è il
24
Su questo tema rinvio a Migliori 2007a.
27
rimando a quella che verrà poi qualificata come metretica. Ma anche se la questione non
viene approfondita, è lecito chiedersi come mai Platone sottolinei questa differenza, tanto
più che ci sono due ulteriori dati.
In primo luogo, Socrate rifiuta (6 A-C) la tradizionale visione di contrasti tra gli dèi;
dobbiamo quindi pensare che esista, almeno per le divinità, un unico criterio oggettivo,
cioè che almeno loro siano in possesso di una metretica che si occupa dei valori etici e che
fornisce un unico criterio di giudizio.
In secondo luogo il confronto tra queste due dimensioni, matematica ed etica, è un dato
stabile del pensiero di Platone. Ad esempio nel Gorgia, in un dialogo in cui gran parte
dell’argomentazione è giocata sulla contrapposizione tra vita intemperante e vita ordinata,
e in cui mancano del tutto riferimenti alla misura, troviamo tuttavia un’affermazione quasi
sconcertante per il suo esplicito riferimento alle matematiche:
Dicono i sapienti, Callicle, che cielo, terra, dèi e uomini sono tenuti insieme
dall’associazione (koinwn…an), dall’amicizia, dall’ordine, dalla saggia
temperanza e dalla giustizia, ed è per questo, amico mio, che designano tale intero
(tÕ Ólon) con la parola cosmo <ossia ordine>, e non con un termine che indichi
disordine o assenza di regole. Ora, mi sembra che tu non presti attenzione a queste
cose, pur essendo tanto colto, e dimentichi che l’uguaglianza geometrica ha grande
potere sia fra gli dèi sia fra gli uomini. Tu credi, invece, che bisogna perseguire
l’eccesso: infatti, trascuri la geometria (507 E 6-508 A 8).
In questo brano vanno sottolineati:
1. l’intreccio tra dimensioni diverse, la possibilità di passaggi non solo tra individuo e
stato, ma tra umano e divino, tra umano e cosmico;
2. la dimensione di ordine e proporzione che caratterizza la realizzazione di un tutto
ordinato di parti, che qualifica le virtù;
3. il senso di questo ordine che non viene lasciato in ombra, in quanto si contrappone la
misura matematica all’eccesso teorizzato da Callicle.
4. una serie di termini, come koinonia e ordine, e soprattutto uguaglianza geometrica,
vengono contrapposti all’eccesso, ma è facile dire che il termine migliore come opposto
ad eccesso è il “misurato”.
Il Protagora
Nel Protagora troviamo una situazione simile a quella dell’Eutifrone, con l’aggiunta di un
esplicito rimando alla metretica come criterio di giudizio.
Siamo all’interno della lunga trattazione del piacere svolta da Socrate, che sembra
preoccupato di sottolineare che, dal punto di vista della gente, non c’è altro criterio di
giudizio sulle azioni che il piacere (356 A). Ciò gli consente di avere una singola unità di
misura e quindi di ragionare come in una operazione di peso: si mettono sui piatti della
bilancia, oltre ai piaceri e ai dolori, anche la vicinanza e la lontananza temporale, in modo
28
da poter scegliere il risultato più piacevole e meno doloroso. Si è così imposta la necessità
di un’attenta valutazione, in quanto una grandezza può apparire diversa a seconda della
distanza. Se per agire bene bisogna valutare che cosa è grande e piccolo, la salvezza della
nostra vita sta nella metretica (metrhtik¾ tšcnh, 356 D 4) e non nelle sensazioni, che ci
ingannano.
Invece la metretica toglie valore a questa illusione e, avendoci fatto scoprire la
verità (tÕ ¢lhq j), assicura all’anima una tranquillità stabilita sulla verità (™pˆ tù
¢lhqe‹) e salva la nostra vita (356 D 7-E 2).
Ma tale metretica, che ci mette a contatto con la verità e che ci salva, è essa stessa un
problema. Se la nostra salvezza dipendesse dalla scelta del pari e del dispari, del più e del
meno, nel loro rapporto reciproco e in se stessi, siano essi vicini o lontani, la vita
dipenderebbe da una scienza matematica, una tecnica metretica capace di misurare
l’eccesso e il difetto (ØperbolÁj te kaˆ ™nde…aj, 357 A 2). Tuttavia, visto che la nostra
vita dipende dalla giusta scelta di piaceri e dolori con una valutazione esatta di quali sono
più o meno numerosi, più grandi o più piccoli, più lontani o più vicini, è chiaro che anche
questo tipo di indagine è un’arte e una scienza (tšcnh kaˆ ™pist»mh, 357 B 5) metretica.
Emerge dunque che, come nell’Eutifrone,1) si esalta la metretica matematica, 2) si
sottolinea che qui siamo in un ambito differente, mettendo in campo i concetti
fondamentali del modello trinario cui stiamo avvicinandoci, cioè eccesso, difetto e
eguaglianza reciproca; in tutti i casi 3) si afferma che quella di cui abbiamo bisogno è
comunque una metretica. A questo punto si rinviano ulteriori chiarimenti:
Quale arte e quale scienza sia, lo vedremo un’altra volta; per la dimostrazione che
io e Protagora dobbiamo darvi in risposta alle vostre domande è sufficiente che sia
una scienza (™pist»mh) (357 B 5-C 1).
In sostanza, Platone affida tutto alla metretica, ma “non volendo” determinare questo
concetto, rinvia la soluzione e si limita ad affermare che occorre scienza, episteme,
opponendosi alla opinione dei più, che non credono alla forza del sapere. Tuttavia,
malgrado il voluto rinvio, l’affermazione della capacità direttiva che la conoscenza deve
avere non resta generica ma viene precisata come metretica:
Infatti anche voi eravate d’accordo che quelli che sbagliano lo fanno per difetto di
scienza (™pist»mhj) nella ricerca dei piaceri e dei dolori – che sono i beni e i mali
– e non genericamente di scienza (™pist»mhj), ma di quella che prima eravate
d’accordo a definire arte della misura (metrhtikÁj) (357 D 3-7).
Infine, la metretica viene presentata in termini generali ma corretti, in quanto si dice che
è una tecnica dell’eccesso e del difetto (ØperbolÁj te kaˆ ™nde…aj) (357 A 1-2).
Dunque, anche se rinvia il chiarimento, Platone ci ha già detto che il modello è triadico e
non binario: la metretica individua la giusta misura in quanto è scienza dell’eccesso e del
difetto, cioè dei due estremi che bisogna evitare:
29
Dal momento che la salvezza della nostra vita ci è apparsa consistere nella scelta
corretta del piacere e del dolore, del più e del meno, del maggiore e del minore, del
più lontano e del più vicino, non è chiaro in primo luogo che, in quanto è ricerca
sull’eccesso, sul difetto e sull’uguaglianza reciproca (ØperbolÁj te kaˆ ™nde…aj
… kaˆ „sÒthtoj prÕj ¢ll»laj), non può non essere una scienza della misura? (357 A
5-B 3).
Il Parmenide
Questo riferimento (volutamente) impreciso all’uguaglianza come mediano tra eccesso e
difetto ci consente di fermarci brevemente sul Parmenide, dialogo in cui la coppia
uguaglianza-disuguaglianza è presentata in un modo molto particolare, in quanto già nella
seconda tesi si trasforma in una terna (149 D-151 B).
L’uguale impone che il diseguale sia posto come Grande e come Piccolo (si noti la
terminologia), che ne costituiscono la natura vera; ma questi a loro volta risultano anche
precondizione dell’esistenza dell’Uguale, che è l’elemento che stabilisce un giusto mezzo
negando i due estremi opposti e intervenendo tra i due processi di ingrandimento e di
rimpicciolimento. Nessuno dei tre termini può dunque essere posto senza gli altri due e
tutti e tre devono essere ontologicamente sullo stesso livello. Ciò è esplicitamente detto
nella Quinta tesi (161 C-E), in cui Platone qualifica l’uguaglianza come intermedia tra
grandezza e piccolezza:
Ma grandezza e piccolezza sono sempre distinte tra loro…Vi è dunque sempre
qualcosa in mezzo tra loro… Puoi indicare qualcos’altro che possa essere
intermedio tra loro oltre alla uguaglianza (À „sÒthta)?…Quindi, ciò che ha
grandezza e piccolezza ha anche uguaglianza, che è intermedia tra queste due (161
D 4-8).
Lo schema è necessariamente triadico: la disuguaglianza rinvia a due termini, che
definiscono il grande-più grande e il piccolo-più piccolo, tra i quali va collocata
l’uguaglianza che è intermedia tra i due estremi.
2. Le due metretiche del Politico
Finalmente il Politico (283 B-287 B) consente di fare un salto di qualità, in quanto esplicita
la presenza di due modelli di metretica. Con uno dei soliti giochi Platone affronta il tema in
modo apparentemente casuale, per la difficoltà che si incontra nel giudicare lungo o breve
il discorso appena fatto sulla tessitura. In questo quadro si afferma l’esistenza di due
metretiche, una binaria e una trinaria. La prima è basata sulla semplice contrapposizione di
due termini,
secondo il rapporto reciproco di grandezza o piccolezza (283 D 7-8),
30
cioè secondo una logica tutta interna ai soli elementi in gioco, senza alcun criterio di
giudizio sulla relazione stessa. Questa forma ha un carattere quantitativo e coinvolge le
tecniche che misurano il numero, la lunghezza, l’altezza, la larghezza e la velocità rispetto
ai loro contrari. Il secondo tipo di metretica è trinario perché rapporta gli estremi, il più e il
meno, al giusto mezzo, alla misura e al misurato.
Si tratta di una distinzione che avevamo vista già accennata nel Protagora, che dunque
manifesta su questo specifico terreno un pensiero “maturo” anche se oggetto solo di
“allusioni”. La differenza è radicale ed assume una grande rilevanza teoretica. Infatti,
questa metretica trinaria:
1. è «secondo l’essenza necessaria alla generazione» (283 D 8-9), cioè ha una rilevanza
ontologica;
2. consente la distinzione tra buono e cattivo, cioè ha una rilevanza assiologica (283 E);
3. richiede che si costringano gli estremi a relazionarsi alla misura (284 B);
4. esigerebbe una trattazione lunghissima, che qui non può essere svolta (284 C);
5. andrà ripresa nel momento in cui si dovrà spiegare che cos’è l’Esattezza in sé (aÙtÕ
t¢krib j, 284 D 2).
Troviamo qui tre elementi rilevanti:
1. troviamo di nuovo la classica tecnica del rinvio, che caratterizza sempre temi di grande
rilievo;
2. incontriamo di nuovo l’intreccio tra dimensione ontologica e dimensione assiologica,
riferito ad un procedimento che rimanda come criterio ultimo alla misura stessa, che
conferma l’orizzonte di pensiero visto nel Filebo; solo in quanto è “misurata” una cosa,
una sedia come un’azione umana, è buona e realizza se stessa e la propria virtù; per
questo la indeterminatezza della coppia del primo tipo di metretica, sul modello
grande-piccolo, non permette di definire nulla in modo ontologicamente esatto e
dunque nemmeno di esprimere un vero giudizio.
3. la questione filosofica, rinviata certamente al Filosofo, il terzo testo non scritto della
trilogia annunciata all’inizio del Sofista (217 A-B), è l’Esattezza in sé; la scelta di
questo termine è un evidente gioco linguistico per non dire il più ovvio e già tanto
citato “Misura in sé”; se questo è il rimando, si spiega molto bene perché Platone non
ha mai scritto tale dialogo, in cui avrebbe dovuto esplicitare i vertici della sua filosofia.
Nel Politico, invece, si può fermare, non perché il problema sia stato trattato in modo
adeguato, ma perché
quanto abbiamo detto è sufficiente per questi temi <politici> e per eccessi e difetti.
Facciamo mente locale solo al fatto che, a questo proposito, sono stati trovati due
generi della metretica, e ricordiamoci quali abbiamo detto che sono (285 B 6-C 1).
Platone in seguito si sforza di evidenziare che la determinazione della “giusta misura” non
deve dipendere da un modello astratto e aprioristico. Ciò emerge dallo stesso fatto che
questa determinazione procede «secondo l’essenza (oÙs…an) necessaria alla
generazione». Se non si coglie l’ousia, se non si rispetta la realtà, non si produce nulla di
31
buono, né un vaso né un comportamento politico corretto. Infatti Platone afferma subito
che di questa metretica fanno uso tutte le tecniche non puramente quantitative che
operano in rapporto alla giusta misura, al conveniente, all’opportuno, al dovuto, e
a tutto quello che tende al mezzo tra gli estremi (prÕj tÕ mštrion kaˆ tÕ pršpon kaˆ
tÕn kairÕn kaˆ tÕ dšon kaˆ p£nq’ÐpÒsa e„j tÕ mšson ¢pJk…sqh tîn ™sc£twn)
(284 E 6-8).
Se qualcuno volesse negare l’esistenza di questo tipo di scienza dovrebbe negare anche
l’esistenza delle tecniche e quindi della politica:
Ma con questo ragionamento non distruggeremo le tecniche stesse e tutte le loro
opere e, in particolare, non elimineremo la politica, che stiamo ora cercando, e la
tessitura di cui abbiamo parlato? Infatti, tutte le tecniche di questo tipo, in qualche
modo, nella loro attività, si guardano dal più e dal meno rispetto alla giusta misura
(toà metr…ou), non come da cosa che non esiste, ma come da cosa che è nociva
per la loro attività e, in questo modo, salvando la misura (tÕ mštron), producono
opere tutte buone e belle (284 A 5- B 2).
Da questo brano, possiamo trarre tre conseguenze:
1. questa trattazione era necessaria ai fini della politica e non è affatto casuale; infatti la
questione della lunghezza espositiva appare del tutto dimenticata e risulta secondaria
rispetto a quanto qui affermato;
2. il fatto che tutte le tecniche operano in rapporto alla giusta misura spiega la facilità con
cui Platone passa da un livello di discorso ad un altro: non si tratta di un procedimento
analogico, ma di una sorta di somiglianza sistemica, che sottende una visione unitaria
del reale;
3. in questo testo si aggiunge l’affermazione che il più e il meno, cioè l’eccesso e il
difetto, sono realmente esistenti. Platone sembra temere che la condanna assiologica si
riverberi in modo lineare sul piano ontologico: per questo lo Straniero sente il bisogno
di ricordare che sono “esistenti”. Se la misura consente la produzione di opere “tutte
buone e belle”, il diseguale è nocivo da tutt’e due i punti di vista, ma nulla di più: un
brutto vaso, una sedia mal fatta, un comportamento scorretto, esistono, non sono il
“vero” essere di quella specifica cosa, ma sono, sia pur “brutti e cattivi”.
È soprattutto nel momento di applicare questo discorso a quello che è stato lo spunto della
trattazione, la lunghezza dello scritto, che Platone chiarisce che la stessa giusta misura
deve fare i conti con la realtà cui si applica. Infatti la misura di un discorso e/o di un
ragionamento non va rapportata al piacere (se non come un elemento accessorio) e
nemmeno alla semplicità e alla eleganza della soluzione, cosa che va apprezzata ma solo
come “secondo bene”: Come primo va invece considerato il metodo di dividere secondo le
Idee, cioè la dialettica stessa, senza dare importanza alla lunghezza dei discorsi. Quello che
conta è che essi devono rendere più abili nella dialettica (286 B-287 A).
La realtà ci pone di fronte a diverse alternative, cui sono riconducibili comportamenti
diversi. Esiste una “giusta misura” rispetto al piacere, come anche rispetto al
procedimento, così come, infine, rispetto alla dialettica. E lo Straniero non ha dubbi
32
nell’affermare l’ordine di importanza che, nel presente contesto filosofico, hanno i diversi
elementi.
L’importanza del modello trinario
L’importanza della metretica trinaria appare ovviamente soprattutto nel momento in cui
Platone, come abbiamo già visto nel Protagora, l’applica al comportamento umano.
Platone non sopravvaluta la funzione della conoscenza e non sottovaluta il peso delle
passioni e della tendenza all’egoismo che agisce su tutti. Al contrario, egli ne è
perfettamente consapevole, come mostra la sua analisi dell’uomo politico:
La natura mortale lo spingerà sempre ad avere di più e a curare il proprio interesse;
fuggendo in modo irragionevole il dolore e cercando il piacere, anteporrà questi
due sentimenti a ciò che è più giusto e più buono e, suscitando in se stesso
oscurità, alla fine riempirà se stesso e l’intero stato di ogni male (Leggi 875 B 6-C
3).
Malgrado questo evidente limite umano, il controllo razionale appare necessario per
ottenere ciò che realmente si vuole:
Credi che sia un bene fare ciò che pare meglio a uno che non ha conoscenza? E
questo tu lo chiami un grande potere? (Gorgia 466 E 9-11).
La conoscenza è alla base del potere e lo è perché, come abbiamo già visto, c’è un nesso
intimo tra Bene, ordine e misura. Se il vero potere consente di ottenere ciò che uno vuole
(cioè il bene), un’azione considerata in sé non dice nulla sul potere di colui che la compie,
perché non ci dice se il fine è stato conseguito o no. Chi fa ciò che gli pare, ma non riesce a
ottenere il bene cui pure aspira, non può essere ritenuto detentore di un grande potere.
Ma la sua applicazione maggiore avviene su un altro terreno: nella Repubblica Platone
sottolinea che il vero guardiano deve avere in sé due virtù opposte. La cosa sembra quasi
impossibile per il principio di non contraddizione. Nella Repubblica non si esce da questa
difficoltà per via teorica, cioè cercando di capire come ciò sia possibile, ma presentando un
esempio che mostra che è possibile: si ricordano i cani da guardia, che sono docili con i
padroni e feroci verso gli estranei (375 D-E). Così dev’essere anche il guardiano. Il fatto è
che non si tratta di un caso limite, come potrebbe apparire, visto che Platone afferma che
bisogna che ogni uomo sia irruente e calmo quanto più è possibile (Leggi 731 B 34);
per questo diciamo che l’uomo giusto deve essere necessariamente irruente e
calmo (Leggi 731 D 4-5).
Tali opposte virtù sono necessarie nella vita politica, che ha bisogno a volte di coraggio, a
volta di temperanza e riflessione. Queste, pur essendo entrambe parti della virtù
sono, in certo qual modo, in grave inimicizia reciproca e si contrappongono in
molti degli enti (Politico 306 B 9-11).
33
L’una valorizza prontezza, velocità, forza, l’altra esalta calma, mitezza, assennatezza e così
via. Tutte queste qualità sono belle, malgrado la loro contrarietà: infatti noi lodiamo le
due virtù in quanto, pur essendo opposte, sono entrambe positive, tanto che una politica
ordinata ha bisogno di entrambe. Il problema per il vero politico allora quello di come far
collaborare tra loro uomini virtuosi temperanti e uomini virtuosi audaci. La risposta di
Platone è netta: occorre legare tra di loro con un filo divino la parte delle diverse anime che
ha natura eterna, cioè quella razionale. Solo il vero politico può riuscire in questa
operazione, che consiste nell’infondere nelle anime
un’opinione vera e fondata (¢lhqÁ dÒxan met¦ bebaièsewj) sul bello, sul giusto,
sul bene e sui loro contrari (Politico 309 C 5-7).
Molto realisticamente, Platone punta sulla presenza dell’opinione vera perché ci si rivolge
agli uomini virtuosi che non necessariamente devono essere filosofi. La conoscenza del
Bene e delle sue prime manifestazioni consente al coraggioso di accettare il temperante e
viceversa, perché entrambi sanno valutare rispetto alla realtà concreta qual è la giusta
misura da applicare evitando l’eccesso e il difetto. C’è la situazione che richiede coraggio
ed è virtuoso esserlo, mentre in quel caso quella che in altri momenti si chiamerebbe
correttamente temperanza è viltà; c’è il tempo per la riflessione e in quel caso quello che in
altre situazioni chiameremmo coraggio è irrazionale audacia. Il coraggioso che conosce il
Bene e la metretica sa quando è il suo momento e quando è il tempo in cui deve operare
l’uomo temperante, e viceversa.
Questo vale sul piano politico come su quello etico. Colui che sa cos’è la Misura l’applica
continuamente alle situazioni in cui è posto, situazioni che posso anche richiedere
interventi di segni opposto. Sostanzialmente il modello platonico anticipa quello
aristotelico della medietà e può essere così reso:
(+) Eccesso
Giusta misura applicata alla realtà (=)
Difetto (-)
Risolutezza – Pacatezza
Eccesso di risolutezza
Eccesso di pacatezza
Folle superbia
Virtù
Viltà/fiacchezza
Questo modello consente di individuare almeno tre tipi diversi di opposizione:
1. quella tra due termini positivi, le diverse virtù, che possono/devono avere tra loro un
rapporto positivo in quanto sono entrambe misurate; questa non è una vera
contrapposizione, perché siamo all’interno di un genere comune; Platone la considera
34
rilevante perché comporta il rischio di conflitto tra buoni, tra i virtuosi che invece
devono collaborare.
2. quella tra i due estremi cattivi e privi di misura, tra i vizi; neanche questa è una vera
opposizione, anche se tra i termini c’è una distanza massima, in quanto essi
rappresentano semplicemente le varie forme del male;
3. quella tra ciò che è buono e misurato e ciò che non lo è; si tratta dell’opposizione tra
virtù e vizi, contrasto radicale perché basato su presenza e assenza di misura.
Ovviamente eccesso e difetto, come tutte le cose sottoposte al dominio dell’apeiron
smisurato, hanno infinite varianti, infiniti più e meno. Si capisce allora perché Socrate nel
momento in cui ha raggiunto un punto panoramico da cui vede meglio tutto dice
una è la forma della virtù, infinite quelle del vizio (Repubblica 445 C 5-6).
L’unità delle diverse virtù è data dal fatto che tutte affermano, su terreni diversi, lo stesso
ordine, caratterizzato dall’applicazione della misura. Sotto la guida del pensiero, esse
riconducono le tensioni connesse all’esistenza umana, sul piano sociale, emozionale e
fisico, al loro ordine intrinseco. Infatti fin dal Gorgia Platone ha sottolineato che questo
caratterizza tutti coloro che operano bene, qualunque sia il terreno della loro attività: porre
gli elementi in ordine in modo che l’intero sia armonico. Tutti, tecnici, pittori, architetti,
costruttori di navi, pongono le cose secondo un certo ordine (t£xin, 503 E 6) in modo da
avere un oggetto ordinato; così fanno anche coloro che si occupano del corpo, maestri di
ginnastica e medici. Questol vale sempre, anche per l’anima che è buona se ha ordine e
armonia (t£xeèj te kaˆ kÒsmou, 504 B 5). La virtù costituisce l’applicazione sul piano
umano della costante riaffermazione dell’ordine in una realtà caratterizzata dal disordine.
Si tratta dunque di un lavoro e di uno sforzo che merita di essere svolto: cercare la giusta
misura che placa e annulla gli eccessi e soddisfa l’essere vivente in quelli che sono i suoi
desideri fondamentali. Infatti la misura è connessa a tutto ciò che è positivo:
tutto ciò che è buono è bello, ciò che è bello non è privo di misura (¥metron)
(Timeo 87 C 4-5).
35
REFERÊNCIAS
BRISSON L., (1989) Platon, Phèdre, traduction inédite, introduction et notes par L. Brisson,
2
suivi de J. Derrida, La Pharmacie de Platon, Flammarion, Paris 1989, 2000 .
CAPRA A., (1997) La tecnica di misurazione del Protagora, «Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa», Classe di Lettere e Filosofia, IV, 2 (1997), pp. 273-327.
CERRI G., (1991) Platone sociologo della comunicazione, Milano, Il Saggiatore, 1991, II
edizione con aggiunte Lecce, Argo, 1996.
CERRI G., (1992) Il ruolo positivo della scrittura secondo il Fedro di Platone, in Rossetti
1992, pp. 280-284.
de Vries A., (1969) A Commentary on the Phaedrus of Plato, Amsterdam 1969.
DORNSEIFF F., (1939) Echtheitsfragen anti-griechischer Literatur, Rettungen des
Theognis, Phokylides, Hekataios, Choinlos, Berlin 1939.
ERLER M., (1991) Il senso delle aporie nei dialoghi di Platone. Esercizi di avviamento al
pensiero filosofico, Vita e Pensiero, Milano 1991; traduzione italiana di C. Mazzarelli di
Der Sinn der Aporien in den Dialogen Platons, Übungsstücke zur Anleitung im
philosophischen Denken, Berlin-New York 1987.
FRIEDLÄNDER P., (2004) Platone, Bompiani, Milano 2004; traduzione italiana di A. Le
Moli di Platon, 3 vv., Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 1964-1975.
GADAMER H. G., (I, 1983; II, 1984) Studi platonici, (una raccolta di testi, tradotti da G.
Moretto), 2 vv., Casale Monferrato 1983-1984.
GADAMER H. G., (1983a) Etica dialettica di Platone, traduzione italiana di G. Moretto di
Platos dialektische Ethik und andere Studien zur platonische Philosophie, Felix Meiner
2
Verlag, Leipzig 1931, 1968 , in Gadamer 1983, pp. 1-184.
GADAMER H. G., (1983b) Dialettica e sofistica nella Settima Lettera di Platone,
traduzione italiana di G. Moretto di Dialektik und Sophistik im siebenten platonischen Brief,
Sitzungsberichte der Heidelberg Akademie der Wissenschaften, Philosophische-historische
Klasse, Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg 1964, in Gadamer 1983, pp. 237-268.
GAISER K., (1990) L’oro della sapienza, Vita e Pensiero, Milano 1990; traduzione italiana di
G. Reale di Das Gold der Weisheit. Zum Gebet des Philosophen am Schluss des Phaidros,
«Rheinisches Museum für Philologie», 132 (1989), pp. 105-140.
HAVELOCK E. A., (1983) Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone,
2
Bari, LATERZA, 1973, 1983 ; traduzione italiana di M. Carpitella di Preface to Plato,
Cambridge, Massachussetts, Harvard University Press, 1963.
KAHN CH., (2008) Platone e il dialogo socratico. L’uso filosofico di una forma letteraria,
Introduzione di M. Migliori, Vita e Pensiero, Milano 2008, traduzione italiana di L.
Palpacelli di Plato and the Socratic dialogue. The philosophical use of a literary form,
3
Cambridge University Press, Cambridge 1996, 1999 .
KUCHARSKI P., (1949) Les chemins du savoir dans les derniers dialogues de Platon,
Paris 1949.
MIGLIORI M., (1993) L’uomo fra piacere, intelligenza e Bene. Commentario storico2
filosofico al Filebo di Platone, Vita e Pensiero, Milano, 1993, 1998 .
MIGLIORI M., (1996) Lo sviluppo tempestoso di un gioco compatto: la struttura del
Filebo, in AA.VV. Il Filebo di Platone e la sua fortuna, Atti del Convegno di Napoli 4-6
novembre 1993, a cura di P. Cosenza, M. D’Auria Editore, Napoli 1996, pp. 353-373.
36
MIGLIORI M., (2000) Tra polifonia e puzzle. Esempi di rilettura del “gioco” filosofico di
Platone, in Casertano G. (a cura di), La struttura del dialogo platonico, Loffredo, Napoli
2000, pp. 171-212.
MIGLIORI M., (2002) Sul Bene. Materiali per una lettura unitaria dei dialoghi e delle
testimonianze indirette, in Reale-Scolnicov 2002, pp. 115-149.
MIGLIORI M., (2004) Comment Platon écrit-il? Exemple d’une écriture à caractère
“protreptique”, in Fattal 2001-2005, II, pp. 83-118; versione in italiano: Come scrive
Platone. Esempi di una scrittura a carattere “protrettico”, «Annali della Facoltà di Lettere
e filosofia dell’Università di Macerata», 37 (2004), pp. 249-277, pubblicata poi anche in
«Educaçao e Filosofia», 20 (2006), pp. 41-80.
MIGLIORI M., (2007) Due giochi danno unità e struttura ad un dialogo tempestoso: il
Filebo, «Rivista di filosofia neo-scolastica», 99 (2007), pp. 375-440.
MIGLIORI M., (2007a) Alcune riflessioni su misura e metretica (il Filebo tra Protagora e
Leggi, passando per il Politico e il Parmenide), «Ordia Prima», 6 (2007), pp. 19-81
MIGLIORI M., (2010) Uni-molteplicità del reale e dottrina dei Principi, in J. Dillon - L.
Brisson (Eds.), Plato’s Philebus, Selected Papers from the Eight Symposium Platonicum,
Academia Verlag, Sankt Augustin 2010, pp. 292-306.
MIGLIORI M. (2010a) Philebus and Timaeus: Plato “suggests” reading these two dialogues
together, in A. Bosch-Veciana and J. Monserrat-Molas, Philosophy and Dialogue. Studies
on Plato’s Dialogues, v. II, Barcelonesa d’Edicions, Societat Catalana de Filosofia,
Barcelona 2010, pp. 115-139.
MIGLIORI M., (2011) A filosofia não se aprende! Platão verdadeiro mestre e o escrito
como alusão protréptica, «Archai. Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento
Ocidental», 2011, pp. 35-43.
PASQUALI G., (1967) Le Lettere di Platone, Le Monnier, Firenze 1938, Sansoni, Firenze
1967.
6
REALE G.(a cura di), (1991) Platone, Tutti gli scritti, Milano 1991, 1997 (traduzioni di M. L.
Gatti, M. T. Liminta, C. Mazzarelli, M. Migliori, R. Radice, G. Reale); tale testo è stato
riproposto, in forme diverse, da Bompiani, Milano 2000.
REALE G., (1998) Platone. Alla ricerca della sapienza segreta, Milano, Rizzoli,1998.
REALE G., (2003) Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei
grandi dialoghi alla luce delle “Dottrine non scritte”, CUSL, Milano 1984, Vita e
21
Pensiero, Milano 1987, 2003 .
ROSSETTI L. (a cura di), (1992) Understanding the Phaedrus, Proceedings of the II
Symposium Platonicum, Academia Verlag, Sankt Augustin 1992.
SEVE B., (1980) Phèdre de Platon, Commentaire, Édition Pédagogie Moderne, Paris 1980.
SINI C., (1994) Filosofia e scrittura, Laterza, Bari 1994.
SOUILHE J., (1919) Étude sur le terme dynamis dans les dialogues de Platon, Paris 1919.
SZLEZÁK T. A., (1988) Platone e la scrittura della filosofia. Analisi di struttura dei
dialoghi della giovinezza e della maturità alla luce di un nuovo paradigma
3
ermeneutico, con una introduzione di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1988, 1992 ;
traduzione italiana di G. Reale di Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie.
Interpretation zu den frühen und mittleren Dialogen, De Gruyter, Berlin 1985.
SZLEZÁK T. A., (1991) Come leggere Platone, Rusconi, Milano 1991, Bompiani, Milano
2004.
TULLI M., (1989) Dialettica e scrittura nella VII Lettera di Platone, Giardini Editori, Pisa
1989.
37
38