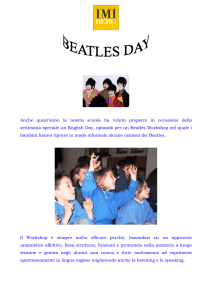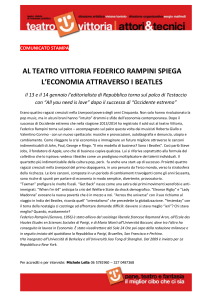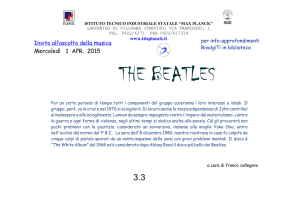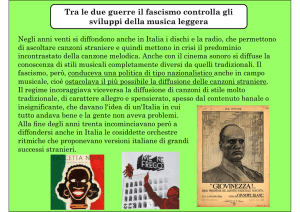Carta canta
Rickie Lee Jones
ugola pericolosamente gentile
A febbraio l’inedito «The Sermon on Exposition Boulevard»
di Luca Ragagnin
S
ul retro di copertina di Blue Valentine, sesto disco di Tom Waits, appoggiata di schiena al cofano di un macchinone scassato, una ragazza dalle lunghissime chiome bionde sta soccombendo all’imponenza diabolica del cantante, che la osserva con inequivocabili intenzioni, mentre lei continua a scivolare,
e per non cadere appoggia una mano sul suo fianco. È
il 1978, la ragazza ha 24 anni, e anche nella sua vita privata le cose non cambiano di molto rispetto alla copertina. Si chiama Rickie Lee Jones, e alcune cose che la riguardano, ancor prima di esplodere nel mondo musicale losangeselino dapprima e in quello globale in pochi anni, sono già leggendarie: la sua relazione triangolare e tormentata con Waits e l’amico comune Chuck E.
Weiss, le scorribande d’alcol e sigari al leggendario albergo Tropicana, un carattere non troppo accomodante e femminile.
L’esplosione vera avviene nei tre anni successivi e sono sufficienti due dischi, l’omonimo del 1979 e Pirates
del 1981. Sono raccolte di canzoni perfette, e dentro
c’è veramente tutto quel mondo in cui è cresciuta: barrios chicani, banditi e gang di quartiere, caratteri malati, cronicità disperate di uomini e donne nascosti in un
tessuto urbano, ma anche dolcezze inaspettate in salsa
jazz e swing. Canzoni come «Last chance Texano», dal
disco d’esordio e «Skeletons» e «We belong together»
da Pirates.
È come se Joni Mitchell, Laura Nyro, Randy Newman
e Jack Kerouac si fossero fusi tutti insieme in quel sembiante e dentro quell’ugola pericolosamente gentile.
Ma tra la prima e la seconda coppia di dischi succede
qualcosa. Bisogna attendere tre anni per The Magazine
che, pur con ottime composizioni, rimane un disco inferiore, e altri cinque per Flying cowboys, raffinatissimo e
fin troppo corretto contenitore pop: immaginatevi Janis Joplin rediviva che va in tour con gli Steely Dan.
Durante quei cinque anni di buio artistico pare che la
luminosità si fosse ridotta anche nella vita privata: sentimenti e alcolismo, come avveniva in molti personaggi
delle sue prime canzoni.
Se potessimo parlare di suddivisione in periodi come si fa con i pittori, la prima fase artistica di Rickie
Lee Jones terminerebbe nel 1991, con un quinto disco
di sole cover, Pop Pop, elegantissima elaborazione jazz e
acustica (con tre mostri sacri come Charlie Haden al contrabbasso, Dino Saluzzi al bandoneon e Joe Henderson al sax) di un repertorio che dal jazz si allontana fino a
raggiungere i cieli alti di «Up from the
skies» di Jimi Hendrix.
È Leo Kottke, un altro chitarrista
musicalmente distante dalla nostra,
l’artefice principale del lavoro successivo. Sulla sua chitarra folk,
tecnicamente perfetta e rarefatta, è imbastito Traffic from
Paradise che del disco precedente di cover mantiene l’aura delicata e acustica, e che contiene una versione sospesa dell’inno bowiano «Rebel Rebel».
Così, dopo questi ultimi due album, nessuno si stupisce se nel 1995 la Jones decide per un solitario florilegio
live del suo catalogo, Naked songs – Live and Acoustic, in
cui è chiaro come sia chiaro anche all’artista che il meglio sembra arrivare dal profondo passato.
Negli ultimi dieci anni Rickie Lee Jones ci ha regalato un altro live, più frizzante e swingante (Live at Red
Rocks, 2001), un altro album di cover anomale – Beatles, Traffic, Marvin Gaye, gli Steely Dan per davvero… (It’s like this, 2000) e due lavori, Ghostyhead del 1997
e The Evening of My Best Day del 2003, che vengono generalmente considerati rispettivamente tra gli abissi e
le vette della sua arte, secondo me a torto in entrambi i casi.
Ghostyhead è un lavoro coraggioso, di sterzata stilistica, elettronico e tecnologico, lontanissimo dall’humus
della cantante, eppure pieno di fascino e di grazia. A
mio parere, un disco da riscoprire e rivalutare.
Ora, a distanza di 4 anni, Rickie Lee Jones torna in
attività.
Dopo un breve tour americano, a febbraio uscirà un
nuovo lavoro di canzoni inedite ispirate agli insegnamenti di Gesù, The Sermon on Exposition Boulevard.
Negli USA il cd sarà pubblicato
dalla New West Records e sarà affiancato da una versione con due dischi, un
dvd che documenta le sessioni di registrazione e
un cd che conterrà mix
ad alta risoluzione e file
pronti ad essere trasferiti sui lettori digitali
portatili.
39
Carta canta
Nuove e vecchie avventure pop
per i Sonic Youth
di John Vignola
È
una stanza distrutta, il «nuovo» album dei Sonic Youth.
Una raccolta di rarità e lati b, a titolo, appunto, The
Destroyed Room, che mette assieme i lavori in corso di un decennio, quelli spesi mentre il mito della band di Kim
Gordon e Thurston Moore si assestava, per i fan più accesi in maniera abbastanza preoccupante. Dalla metà dei Novanta al nuovo secolo, quindi, passando da Experimental Jet Set, Trash
And No Star, per atterrare su Sonic Nurse e Rather Ripped e sul piano del pop, puro e semplice. Una brutta sorpresa,
per chi li ha conosciuti all’epoca di Bad Moon Rising (1985)
o Daydream Nation (1988), vedendo nella band newyorchese
la frontiera più avvincente dell’indie-rock rumorista e sperimentale? Semplicemente, un’altra evoluzione per non ripetere se stessi,
che nel cd appena pubblicato diventa motivo di riflessione: i pezzi proposti, scartati dalla discografia maggiore, dimostrano che le
tensioni artistiche dei Sonic Youth sono ben lungi dallo spegnersi.
Si tratta di un archivio dove c’è posto per una ballata ipnotica ed
espansa come «Fire Engine Dream», o addirittura per il folk sui
generis di «Razor Blade». Abbiamo avuto l’occasione di chiedere a Moore proprio qualche considerazione sulle ultime avventure
della sua creatura. Ecco cosa ha risposto.
sioni discografiche e via così. Abbiamo tenuto duro e
siamo arrivati ad oggi, senza tradirci. Abbiamo scoperto che ci piacciono altre cose, che la sperimentazione fine a se stessa rimane sterile. Abbiamo accettato le melodie, il concetto di bella canzone. Possiamo, insomma,
divertirci senza essere sempre arrabbiati.
Comunque, il rapporto suono/rumore del passato si è spostato a
favore del primo dei due termini.
Era inevitabile e fisiologico. Però abbiamo approfondito percorsi che si avvicinano al jazz, partendo dal
punk. Una cosa che è successa pure dopo, alla generazione degli anni Novanta, di cui fa parte pure Jim
(O’Rourke, NdI). L’incontro con lui, con la scena di
Chicago, è stato importante per rimettere in circolazione nuove idee.
Accettate di aver virato verso il pop, da Washing Machine
(1995) in avanti?
Beh, prima di tutto pop è una bella parola. Chi la identifica con la musica di serie degli ultimi anni fa un errore linguistico. Il pop è popolare, semplice, intrigante, bello. Oggi c’è tanta musica di plastica: questo è il
problema. Tutto viene prodotto in
serie. Non so però quanto ci sia di
vero pop nelle nostre canzoni: noi
siamo, volenti o nolenti, imperfetti. Di questa caratteristica abbiamo
fatto un cavallo di battaglia, un segno distintivo. Chissà se la storia ci
ha dato ragione, forse sì. Certo che
fare rock a cinquant’anni rimane
un’esperienza straniante.
Perché?
Perché comunque si tratta di un
genere che invecchia assieme a noi.
Non è come la classica o il jazz. Il
suo futuro vero è ancora incerto.
Esattamente come il nostro.
Cosa le manca, artisticamente, per essere felice?
Tutto e niente. Mi creda, per me
il punto fondamentale è esprimere sensazioni, dare un senso politico a quello che suono… (momento di silenzio) Beh, diciamo civile,
almeno. Non posso che essere soddisfatto di quello che mi è accaduto, e nello stesso tempo sono ancora alla ricerca.
Chiudendo il cerchio, allora, perché pubblicare The Destroyed Room?
Perché gli appunti di viaggio servono, sia a chi li fa,
sia a chi li ascolta. Nei bozzetti usati per le opere maggiori, scusi la presunzione, si può intravedere il piano di
chi li ha tirati giù. Insomma, sempre meglio che spiegarli a parole, non le pare?
Sembra che ai Sonic Youth interessi ancora sperimentare. È
questo il senso della pubblicazione di The Destroyed Room?
Sì e no. La musica rappresenta il nostro modo di essere vivi. Nel corso del tempo, e a sorpresa, è diventata
anche una fonte di sostentamento. Mi creda, negli Ottanta non lo sognavamo proprio. Viaggiavamo senza
rete, eravamo come degli innamorati. Avere successo
è stato un sogno e un incubo: le responsabilità, le pres-
42
Carta canta
La rivincita
del quinto Beatle
di Eleanor Rigby
I
cinici e i tromboni d’ogni età avranno storto il naso all’uscita di Love, l’ultimo lavoro discografico di
George Martin, domandandosi se c’era davvero bisogno di un’altra occasione per spremere quel poco che
restava dalle mammelle della vacca sacra del pop per
antonomasia, i Beatles. E invece, come in ogni favola
che si rispetti, anche questa volta ai «biechi blu» è stata resa la pariglia dall’inossidabile smalto dei fab-four,
o meglio dei fab-five, come questo «nuovo» disco vuole dimostrare. Già, perché ciò che emerge di inedito in
questo lavoro è il punto di vista di George Martin sull’intera vicenda musicale dei Beatles, il suo straordinario contributo umano e artistico alla leggenda. Love nasce dalla collaborazione di G.M. e Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil e amico di George Harrison, con l’idea di coniugare le scenografie oniriche del
celebre spettacolo circense con la musica dei Beatles;
un’opera multimediale in cui G.M., avvalendosi della collaborazione degli artisti e dei designer del Cirque
du Soleil, assume contemporaneamente il ruolo di regista, sound engineer e musicista tout court. Ne emerge una
sorta di affresco psichedelico in cui il pittore-sciamano
usa con disinvoltura e grande maestria una tavolozza di
colori fatta di frammenti di canzoni, refusi di studio,
versioni scartate e sovrapposizioni di tracce, ottenendo un risultato caleidoscopico sorprendente anche per i
più esausti e smaliziati esegeti dell’opera beatlesiana. E
con una prorompente vis ludica che è sempre stata il
tratto distintivo del being Beatles. Anche dal punto
di vista del materiale discografico utilizzato si
percepisce la prospettiva originale di questa produzione: mai sino ad ora una
collection dei Beatles aveva in-
cluso brani «difficili» come «Glass Onion», «I Am The
Walrus», «Being for the Benefit of Mr. Kite», o «Tomorrow Never Knows», frutto del momento creativo
più fervido della mente di John Lennon, nel periodo
che va dal 1966 al 1969. Allo stesso periodo risalgono
quasi tutte le altre canzoni del disco. Il tratto che le accomuna è il ruolo di primo piano assunto dal «quinto Beatle», sia negli elaborati arrangiamenti musicali
che nelle sonorità davvero pionieristiche per la tecnologia di quarant’anni fa. Tant’è che il lavoro di re-mixaggio, sovrapposizione e sovraincisione delle tracce è stato possibile grazie alla straordinaria qualità del sound
originale.
Le parti più interessanti di Love sono quelle in cui il rimaneggiamento degli originali è più ardito e cioè quando dalle sovrapposizioni di tracce di canzoni distinte si
arriva al limite della creazione di un nuovo brano. Così, sul penetrante ritmo di «Tomorrow Never Knows»,
canzone di Lennon manifesto della cultura psichedelica, si snodano i fraseggi modali del sitar e la voce di
George Harrison, tratti da «Within You Without You»,
brano ispirato alla musica classica indiana.
E ancora, «Being for the Benefit of Mr Kite», una delle gemme di Stg. Pepper, si trasforma, dopo il famoso bridge suonato con le balalaike, nella straziante coda di
«I Want You/She’s so Heavy», il capolavoro dell’album
Abbey Road, mentre, contemporaneamente, in sottofondo, salgono le urla sataniche di «Helter Skelter».
Dunque G. M. ha preso la sua personale rivincita, affermando definitivamente la sua grandezza attraverso
quella dei Beatles. In Love sono esaltati infatti i momenti più alti della carriera musicale
della band, quelli che marcano ancora oggi
la distanza siderale fra i Beatles, ciò che li ha
preceduti e ciò che li ha seguiti fino ai giorni nostri, in quel misto di geniale creatività e fiuto per il successo che hanno
fatto, in definitiva, la differenza. O
magari si sta solo esagerando, presi
alle spalle ancora una volta dalla foga
e dall’entusiasmo adolescenziali che pervadono quando si sente la musica degli
Scarafon i. Ma n o n è
colpa nostra. È
colpa loro. Beep
beep ‘n’ beep
beep yeah!
43
Carta canta
I primi 25 anni
della Compagnia de Calza «I Antichi»
In volume la storia del vitalissimo gruppo veneziano
U
Ma se il gioco e lo scherzo sono gli
elementi salienti del gruppo, serissimo è invece il lavoro di ricostruzione (iconografica, giornalistica e documentaria) di questi
venticinque anni di storia della Compagnia, che i tre autori – Roberto Bianchin, Luca
Colferai e Jurubeba Bomfin, rispettivamente Gran
Priore, Procurator Grando e Priore ad vitam – hanno condotto con rigore e
garbo e che ha dato vita a
una pubblicazione preziosa e puntuale, edita da I antichi Editori, braccio editoriale della stessa Compagnia
che vanta un catalogo di tutto rispetto (cfr. www.iantichieditori.it). (l.m.)
iB
aff
oe
la l
a pid
e di M
o za r t
na grande folla ha riempito le
Sale Apollinee della Fenice
in occasione della presentazione del libro Storia de I Antichi. Venticinque anni di Compagnia
de Calza, ironica e divertita
«autocelebrazione» di 25 anni di inesausta e gioiosa attività della Compagnia, che
ha contribuito a rivitalizzare i vari Carnevali in laguna (e non solo) ed è riuscita a esportare anche all’estero la propria estrosa arte. La cifra che si coglie sin da subito è ben riassunta in un motto fatto proprio dal gruppo, «divertirsi divertendo», che ben si addice a questa compagine dalla spiccata propensione teatrale
che attraverso veri e propri spettacoli – alcuni dei quali memorabili
– ha svolto anche l’importante funzione di restituire costumi, tradizioni e abitudini di una Venezia antica e fascinosa, contrapponendoli alla sempre più dilagante opacità del gadget indistinto. Il tutto con un grande, nobile obiettivo,
ridere e far ridere, attraverso un sapiente utilizzo dell’ironia, del «parlar basso» in funzione parodica e anche apotropaica, un po’ a mo’ di scarrozzanti dell’arte
di un tempo… E così, in cinque lustri di vita, tra persone che scompaiono, come il fondatore Paolo Emanuele
Zane Cope Zancopè, e nuove personalità che fioriscono, si delineano con nitidezza anche le linee essenziali
di una città magica (anche se costantemente in pericolo) come Venezia.
Dell’importanza culturale della Compagnia de Calza
si erano rese conto già da tempo anche alcune istituzioni, come la Biennale, che, soprattutto con la direzione artistica di Maurizio Scaparro, aveva più volte voluto instaurare una collaborazione. Tra gli episodi più recenti di ricordano ad esempio le esilaranti Primarie tra
Gozzi e Goldoni, che – ultimo tassello di un genere
fortunato per la Compagnia, quello appunto delle «Primarie» – avevano il loro posto all’interno del festival
delle scene veneziane l’anno passato (cfr. VeneziaMusica e dintorni, n. 11, p. 55).
ir
L o sp
ito
Z
di
or
z
Alcune parole chiave
Costituzione
Nel breve atto costitutivo della Compagnia de Calza I
Antichi, datato 12 dicembre 1980, è scritto: «senza fini di
lucro» (sottolineato) e «l’opera degli aderenti è gratuita e la
partecipazione volontaria». Questo il tripode su cui si basano
venticinque anni di attività. Lascia ampia possibilità a chi non
è d’accordo di restare comodamente a casa senza rimetterci.
Figuranti e comparse
Ci sono persone che usano sfilare per le calli e i campi
di Venezia o le vie e le piazze delle altre città del mondo
indossando costumi e venendo per questo ricompensate
in moneta. Alcune volte altre o le stesse persone dietro
compenso uguale o diverso indossano costumi o abiti agli
ordini di altre persone che ne vogliono ritrarre l’immagine
con vari mezzi all’uopo concepiti, per poi fare commercio di
dette immagini. Appare evidente che noi non rientriamo in
queste definizioni.
Democrazia
La Compagnia de Calza I Antichi, retta sugli antichi statuti
e basata sull’amore fraterno, è regolata al suo interno
con decisioni prese a maggioranza democraticamente.
Il Gran Priore ha il diritto e la facoltà di votare contro la
maggioranza: in tal caso vale il voto del Priore.
Idee
Qualunque cosa voi inventiate, noi l’abbiamo già inventata;
qualunque cosa voi facciate, noi l ’abbiamo già fatta;
qualunque cosa voi copiate, noi l’abbiamo già copiata. E
meglio. Le idee sono le uniche cose che abbiamo, se ce le
rubano ce ne vengono delle altre.
dall’estraduzione di Luca Colo de Fero Colferai
Procurator Grando de I Antichi
Roberto Bianchin, Judith Bomfim, Luca Colferai,
Storia de I Antichi. Venticinque anni di Compagnia de Calza,
prefazione di Maurizio Scaparro,
intervento storico introduttivo di Sebastiano Giorgi,
I Antichi Editori, Venezia 2006, euro 48.00
45