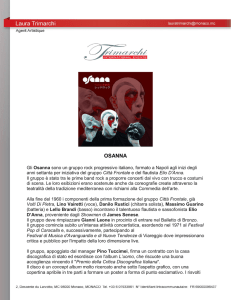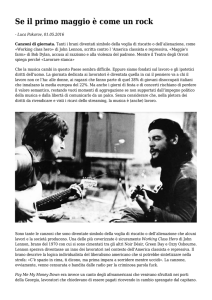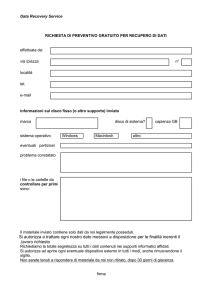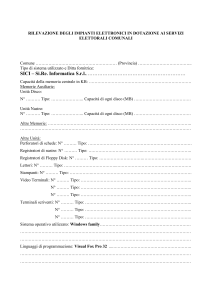digital magazine Settembre 2009
N.59
Vladislav
Delay
Post - Jazz
Joakim - Mochipet - The Clean
Brunori Sas - Os Mutantes
Sleeping States - Jesus Lizard
Julien Temple
Tropical rain
washed my brain
Sentireascoltare n.59
Turn On
p. 4
Joakim
5
Mayer Hawthorne
6
Mochipet
8
Ryan Bingham
10
Little Claw
12
Ultimo attuale corpo sonoro
Rubriche
Tune In
136
Giant steps
14 The Clean
137
Classic album
18
Brunori Sas
138
La sera della prima
24
Os Mutantes
150
I cosiddetti contemporanei
26
Sleeping States
Drop Out
30
Tropical Punk washed my brain
38 Vladislav Delay
Recensioni
46
Bibio, Clark, Ghost, Graham Coxon, Moritz Von Oswald/Delay/Loderbauer
Rearview Mirror
126
Jesus Lizard, Cluster, Chrome Cranks, Daniel Johnston...
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Daniele Follero, Stefano Solventi, Antonello Comunale, Teresa Greco
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo,
Luca Colnaghi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali,
Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra,
Fabrizio Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
Vladislav Delay
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza
autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Mayer Hawthorne
Joakim
Disco rock stellare
A Soul Arrangement
Da Parigi si smuovono le acque del
french touch a ritmo di rock. Novità o
perenne mutazione?
L
’ultima creazione di Joakim, Milky Ways
ci parla da un punto alieno dell’electro. L’uomo
non inserisce della cruda sintesi nel verbo french,
ma complica le cose con bordate di krautrock, postpunk e lo-fi, anzi, a conferma di una strategia 2.0
quanto mai lungimirante, l’album esce a ridosso di
una compila retrospettiva dello scorso anno dove
a venir remissati erano i protagonisti della scena ftouch (My Best Remixes). Al telefono, tra uno
shooting e l’altro, gli chiediamo se in qualche modo
sia vicino al krautrock o alla prog: mi sento più vicino
al krautrock che alla progressive. La progressive è noiosa. È una musica fatta da bravi musicisti che suonano
per ascoltare il loro stesso suono, mentre il krautrock
è più musicale. Non mi piace la ‘musica dei musicisti’,
penso sia noiosa.
Il nuovo lavoro è stato registrato e mixato nello
studio casalingo Paris-based, la vecchia e mai decaduta DIY-ness rimpolpata con l’aiuto di una band. E
le tentazioni deep? Più che un cambio, penso che sia
un’evoluzione. Ho sempre pensato al rock. Adesso posso
suonare con una band, ma anni fa avevo solo il mio
computer e quindi ero costretto a suonare quel tipo di
musica sintetica. L’evoluzione strumentale ha fatto cambiare anche la mia musica. Certe tracce sono suonate
live, senza overdubs, quasi in presa diretta. Certe altre
4
Turn On
Andrew Mayer Cohen, l’uomo che ha stravolto le
politiche interne della Stones Throw.
Pelle bianca, cuore nero. Il soul del nuovo millennio
ha di che rallegrarsi.
sono state rimaneggiate in studio con i soliti tools di
editing.
Non è solo lui ad accorgersi di questa tendenza. Dopo aver assistito alle variazioni in casa Warp
(vedi Bibio e Grizzly Bear) gli domandiamo banalmente se la musica elettronica stia compiendo
una metamorfosi verso il rock. Penso che non si possa parlare di musica elettronica in questi termini, perché oggi qualsiasi musica è elettronica. La distinzione
tra rock ed electro sta cambiando. Anche nella dance si
usa molto questa mistura. Pensa agli Animal Collective,
metà elettronica, metà folk. La gente che naviga in rete
non percepisce questa differenza. Non penso che sia
importante catalogare per generi.
Già. Ben detto. Il nuovo lavoro fa del melting uno
schiaffo in faccia all’ascoltatore. Si parte doom poi
si naviga all’impazzata tra post-punk, noise, lounge,
funk, disco e pop 80. Un calderone sfacciato che
salendo ti riempie i polmoni di quell’aria Animal
Collective e un po’ MGMT, che fa tanto camp,
ma strafatto rock.
Per il nostro, già lanciato con il precedente Monsters e Silly Songs, si prepara una stagione di fuoco.
L’importante ora è che non si monti troppo la testa.
Marco Braggion
N
on parleremo di originalità, meglio essere
chiari dal principio. Semmai di emotività, quella sì, quanta ne volete. Parleremo di Andrew Mayer
Cohen, il nuovo rampollo di casa Stones Throw,
e del suo debutto a nome Mayer Hawthorne. Un
lavoro colmo di groove e rimandi, A Strange Arrangement, che di contro al titolo ha poche stranezze
da svelare. Anzi, mai suono fu più familiare per chi
conosce, consumato e immagazzinato la Motown
dersquo;antan e il soul licenziato tra il 1966 e il
1974. Retrò, per farla breve, ma che goduria.
Nato nel Michigan, Ann Arbor, a pochi passi da
Detroit: Classe 1978 e un destino, per chi cresce in
quelle terre, già segnato. Poteva avvicinarsi, viste le
origini, agli Stooges o magari alla techno; e invece,
iniziato dal padre, sceglie il soul. Un bianco in territorio nero, Mayer. “Al primo ascolto non avevo capito.
Ero indeciso se considerarle nuove composizioni oppure dei re-edit di vecchio materiale riemerso da qualche archivioerdquo;, dice Peanut Butter Wolf,
il boss della Stones Throw, dopo averne udito, su
consiglio di Noelle Scaggs (cantante dei Rebirth e
collaboratrice, tra i tanti, di Black Eyed Peas e Quantic), appena un paio di tracce. Stupore. Tramutatosi
accettazione quando, guardandolo la prima volta
negli occhi e notando il colore della pelle, scopre
che cotanta roba è frutto di un bianco del Michigan.
Epilogo:“Mayer è l’unico artista che ho ingaggiato dopo
lersquo;ascolto di due sole canzoni”
Queste, presumibilmente Just Ain’t Gonna Work
Out - secondo lersquo;autore, crasi tra The Tracks
of My Tears di Smokey Robinson e Fall in Love di
J Dilla - e When I Said Goodbye, ovvero il singolo dersquo;esordio Mayer Hawthorne per Stones
Throw, suonano gustosamente fuori tempo massimo. Un numero errebì perfetto da canticchiare e
una ballad soul dallersquo;elevata cifra sensuale. A
stupire, oltre il mood reazionario, la voce. “Chi mi
conosce sa che amo cantare. Mi viene naturale, anche
se non mi considero un cantante dotato. Marvig Gaye,
quando era al suo massimo, una volta disse di voler
diventare un grande cantante, un giorno o l’altro. Lavoro
per migliorarmi” Accantonando la modestia, il Nostro è padrone di un registro versatile che fa del
falsetto, mutuato tanto da Gaye quanto da Curtis
Mayfield, lersquo;arma in più di un personaggio
prossimo a contendere a Jamie Lidell lo scettro
di soulsinger del nuovo millennio.
Quindi, etichettatelo pure retrò (“La gente può
definirmi come vuole, non è affar mio. Essere creativo,
questo mi interessa) ma lasciate perdere I pregiudizi,
altrimenti rischiate di perdervi uno dei dischi più
eccitanti della stagione.
Gianni Avella
Turn On
5
D
Mochipet
Girls Love Mochipet
avid Wang aka Mochipet, taiwanese di
nascita, californiano d’adozione (e probabilmente per vocazione), ha cominciato a pasticciare
con aggeggi elettronici da piccolissimo. Il minimo,
con un padre incarnazione dei sogni proibiti di
qualsiasi bambino: ingegnere aerospaziale. Scienziato
pazzo insomma. Quando David ha scoperto che con
l’elettronica ci si poteva pasticciare anche la musica,
ha imboccato la via del non ritorno. Adolescenza a
base di heavy metal, jazz e hip-hop commerciale, e
trafila da smanettone d’oggi, internauta (e web designer), dj in radio e per set festaioli, compilatore, produttore. Ha cominciato REGALANDO cdr e inviandoli per posta in cambio delle spese di spedizione,
poi, visto il successo, si è convertito all’ortodossia
distributiva, sempre autogestendosi però, attraverso la Daly City Records (dal nome della cittadina della
Bay Area dove si è trasferito). David si è velocemente costruito la fama di wonky-produttore genialoide
e giocherellone (secondo alcuni, addirittura, miglior
act elettronico del 2008) e, considerando che il primo cdr risale al 2002, di produttore prolificissimo,
con una decina di long e altrettanti mini, non contando ovviamente le produzioni, i remix, i progetti
extra-discografici (musiche per videogiochi e video
sportivi) e le collaborazioni sparse (su disco, due
nomi, Ellen Allien e Daedelus).
on che musica si è fatto conoscere Mochi? Un
pastiche elettronico, preferibilmente uptempo,
di breakbeat (santificato in dischi come Randbient
Works, 2002, Feel My China, 2005, e ovviamente
Girls Love Breakcore, 2007, il disco della definitiva emersione dall’underground), hip-hop e derivati
(e derive, tipo contaminazioni ragga), techno (fino
a tamarri gabberismi e cose alla Atari Teenage
Riot, ma leggermente più morbide) e videogame,
con campioni onnivori (segnaliamo la sua ossessione per la polka) e un approccio ludico alla Ween o
They Might Be Giants (e qualcuno ha scomodato anche Zappa, ma non è il caso) come percussivamente frullati, come uno Squarepusher meno
stilizzato e un Hudson Mohawke immerso nella
naïveté, il tutto sempre e comunque spruzzato di gas
esilarante. Su Combat (2003) ha giocato a fare il
bastard pop, sempre in salsa breakcore, esplicitando le fonti sonore dei suoi mishmash postmoderni: Nomeansno, Justin Timberlake, Captain Beefheart, Johnny Cash, Aphex Twin
(ebbè). Ma non di solo breakcore vive l’uomo, e
quindi piano piano ecco il nostro tastare e testare
territori altri. L’ambientglitchbreakgame di Uzu-
C
Nerd, cazzone, eterno teenager, ostentatamente
simpatico, tecnicamente dotato. Mochipet si è fatto
conoscere per il suo breakcore straludico e ora cerca
la legittimazione come produttore tout court
6
Turn On
maki (2004), ad esempio, l’electro-IDM di Disko
Donkey (2006), ottimi, fino alla svolta di Microphonepet (2008), disco infarcito di feat vocali e
praticamente hip-hop sensu latu, preludio al pacioso
eclettismo produttivo di Bunnies and Muffins
e alla gametronica monumentale e minacciosa, ma
in fondo sempre giocosa, di Master P on Atari
(entrambi 2009).
avid è bravo e simpatico, e ci piace, ma abbiamo come l’impressione che non si sia ancora
espresso al massimo, che non sia ancora maturo
sotto il profilo della gestione di se stesso e delle
proprie (grandi) capacità. Vogliamo allora spaccare
il capello in quattro, e chiudere con due indizi, con
due dubbi. Il nome d’arte scelto, qualcosa come
“cucciolo (fatto) di mochi”. Il mochi è una varietà di
dolcetti giapponesi, diffusi anche a Taiwan, a base di
pasta di riso, variamente farciti, conditi, decorati, colorati. A parte l’immagine pacioccosa e teneramente
nerd (parola chiave questa, ma lo si era capito) che
il nome evoca (ma bastano da sole le foto con quei
buffi costumi, preferibilmente da dinosauro), il mochi è anche una piccola chiave di lettura del modus
musicandi di Mochipet. Per David la musica sembra
essere come quella pasta di riso lì: una materia da
modellare, da stravolgere, con cui giocare, con cui
creare miniature, ma con la quale non ci si sazia,
lui come pure l’ascoltatore. E questa insaziabilità, e
qui parte il secondo indizio, porta ad una bulimia
produttiva (detto altrimenti, dispersività). La Press Bio
disponibile sui siti legati a Mochi è in tal senso illuminante. Manca la data di nascita, occhei (ma chi se
ne frega, avrà tipo 25 anni), ma manca soprattutto
QUALSIASI indicazione discografica: non un solo
titolo di un disco che sia uno. Il che è francamente
allucinante, visto che a tuttoggi, purtroppo o per fortuna, la carriera di un artista si pesa ancora sulla sua
produzione discografica, sulla musica fissata su supporto. Allucinante, ma in fondo anche ragionevole,
se si pensa alla mole di roba partorita e alla sua sostanziale omogeneità qualitativa (come pure a tutte
le menate sulla musica oggi e sulla musica in rete).
D
Gabriele Marino
Turn On
7
Ryan Bingham
La stella solitaria
Mai troppo tardi per celebrare un “nome (semi)
nuovo”. A maggior ragione se - dopo un folgorante
debutto - il secondo disco ne conferma il valore e lo
dice disposto a osare.
A
quanti capita di inciampare o, addirittura, cadere con un sonoro tonfo già alla seconda prova matura,
per non parlare del sospirato primo disco? A troppi, ecco: colpa di un mercato che, velocissimo e famelico, tutto tritura e banalizza, mente ci vorrebbero più tempo e frusta per soppesarli bene, i dischi e i relativi
autori. Colpa anche di questi ultimi, che si sentono pronti a spaccare il mondo quanto farebbero meglio ad
aspettare. A non assecondare la frenesia e diventare grandi preferendo l’istinto.
Ryan George Bingham, in questo panorama, è un’eccezione che conferma la regola. Da quando si presentò al mondo con un esordio classico come Mescalito (Lost Highway, 2006; 8,0/10), LP tra i più intensi
e azzeccati dell’ultimo lustro di “Americana”, ne abbiamo amato ogni caratteristica. Il talento compositivo
8
Turn On
e l’aspetto da tenebroso, il passato drammatico e il
futuro dorato.
Un “quasi trentenne”, costui, che non fatichi a
pronosticare nome che resterà, forte di un vissuto
che lo ha sì bersagliato, ma in dote ha lasciato correttezza e semplicità, sommate a una fiera determinazione - da texano testardo - a non lasciarsi incasellare: In qualche modo sono stato segnato dalla scena
country più integralista. Poiché indosso un cappello da
cowboy, la gente pensa che siamo una band da balera
mentre non è affatto così. Voglio essere considerato un
artista versatile; uno che attinge da diversi aspetti della
realtà e racconta storie diverse. Lo commettiamo tutti, l’errore di pensarlo e/o chiamarlo il “nuovo Tizio”
o il “prossimo Caio”: d’accordo che significherebbe
un’ulteriore maniera di confermarne la statura, ma
si rivelerebbe più che altro una zavorra da legargli
sulle spalle per non lasciarlo andare dove davvero
vuole.
Del resto, è lui a raccontarsi bravo da guadagnarsi il ruolo di contemporaneo anello della catena
che dal capostipite Townes Van Zandt si snoda
lungo nomi iscritti negli annali come Guy Clark,
Terry Allen, Joe Ely e Steve Earle. Al pari di
alcuni di lor, il ragazzo ha consumato i primi anni di
vita sfangandosela da solo nel mondo, bruciandosi
l’adolescenza tra un rodeo e un pavimento su cui
riposare le ossa; vivendo da sradicato e condensando notti fredde e polverosi dì in una manciata di
canzoni favolose.
Prima delle quali c’è un apprendistato di chitarrista, l’educazione sentimentale a base di Bob Dylan e una sceneggiatura casuale ordita da un regista
nascosto chissà dove. Sentite qui: dopo aver lasciato
una disfunzionale famiglia e aver a lungo girovagato, Ryan si stabilisce in Texas presso uno zio; una
sera il proprietario di un locale lo ascolta suonare per caso e, folgorato, gli propone una residency
fissa. Utile per affinare il repertorio e l’esecuzione,
convincersi di potercela fare sul serio mentre raduna quei Dead Horses - prima famiglia di amici,
poi musicisti - che tutt’ora lo accompagnano. Due
cd-r autoprodotti, Lost Bound Rails e Wishbone Saloon, servono a fermare il momento mentre il primo
approccio a un disco professionale fallisce in una
Nashville plastificata e meccanizzata.
Allorché le speranze sono al lumicino, uno dei
dischetti di cui sopra plana sul tavolo della Lost Highway. Poiché da quelle parti posseggono un palato
fino assai, finanziano subito le registrazioni di quel
che diverrà Mescalito, alla cui ottima riuscita contri-
buisce la regia preziosa di Marc Ford, ex chitarrista dei Black Crowes.
Il risultato parla la lingua solida e convincente dei
capolavori, non solo di genere: El Borracho Station la
vorresti da un Mark Lanegan in gita sul border
e Take It Easy Mama dai Rolling Stones dei primi
‘70; Ghost Of Travelin’ Jones ospita Terry Allen in un
plausibile passaggio di consegne e perle come Ever
Wonder Why o l’innodica Southside Of Heaven fanno
ipotizzare un Bruce Springsteen giovane e sudista alle prese con blues e country’n’roll. Roba che
ha mandato in visibilio critica e pubblico, cagionato
a Bingham un tour nazionale a fianco dei DriveBy Truckers, diverse esaltati date europee come
attrazione principale e spalancato le porte degli studi televisivi di Conan O’Brien e Jay Leno.
In mezzo a cotanta giostra e al nuovo lavoro Roadhouse Sun, Ryan ha affrontato l’oculata gestione di
sé stesso e un trasferimento in California per amore,
il duro e quotidiano lavoro su scrittura e arrangiamenti. Poiché squadra che vince non si cambia, della
partita sono ancora i fidi Cavalli Morti - vieppiù affiatati e potenti grazie all’attività live - e Ford. Quali
le differenze, allora, oltre un effetto sorpresa non
più ripetibile? Influenze dei Byrds maneggiate con
arguzia, tanto per cominciare (Dylan’s Hard Rain), e
la maggiore complessità esibita in Change Is, tutta
cambi di registro e atmosfera non distanti da Micah P. Hinson, e Day Is Done, maturo saliscendi
emotivo di furia e intimismo. Un sentire rockista in
più, anche, che talvolta prende la mano e nuoce alla
ricercatezza rude - no, non è un ossimoro - che contraddistingue il Nostro. Perdonato da qui all’eternità, nondimeno, quando butta su piatto quell’ugola a
metà tra Bruce e Steve Earle, per affidare loro un
pugno di crepuscolari ballate acustiche.
Che dire del domani di Bingham, se non che, in
base a quanto mostrato finora, abbiamo la certezza
che imboccherà la strada scelta per lui dall’istinto e
che sarà, di conseguenza, quella più giusta. Senza alcunché da dimostrare, che si evolva: noi saremo con
lui a osservarlo decidere la misura del passo: Credo
che da giovane avessi più di un motivo per odiare la società. Sono cresciuto povero e arrabbiato per questo. Ma
a un certo punto capisci di non poter essere incazzato
per sempre: devi provare a combinare qualcosa di positivo, e il nuovo disco è la mia maniera di farlo. Andrà
lontano, ne siamo sicuri.
Giancarlo Turra
Turn On
9
S
Little Claw
Piccoli artigli crescono
In occasione dell’uscita del nuovo Human Taste, diamo un piccolo sguardo ad una delle sensazioni più
out dell’underground americano.
10
Turn On
ono tra i favoriti di Art For Spastics, il programma radio/blogzine/bibbietta underground
gestita da dj Ricks, oltre che di molti altri trapanatori di suoni dell’underground americano. Non solo,
vengono da due città tra le più rumorose d’America: una per tradizione (la Detroit del nostro speciale), l’altra d’attualità perenne (Portland, chi sennò?).
Dalla prima provengono fisicamente i fondatori e
l’asse portante della band - la chitarrista Kylinn Lunsford e il bassista/chitarrista Heath Heemsbergen,
mentre nella seconda si sono trasferiti da qualche
tempo per affinità diciamo elettive, dato il clima
sperimentale della città cara a Palahniuk. Pardon,
trasferiti o trasferite, dato che l’ingombrante presenza di Kylinn – prototipo della bambina cattiva
metà Lydia Lunch, metà Joan Jett la riottosa –
finisce spesso per identificarli come una girl-band,
pure se 2 terzi (o quattro quinti stando alle ultime
news) sono maschi. Pazienza. Un terzetto si diceva,
almeno nella prima incarnazione di base a Detroit.
Per primi si incontrano Kylinn e Heath. Avviene
durante il “Great Eastern Seaboard blackout” del
2003. Iniziano a strimpellare le acustiche e a cantare
al buio, nell’oscurità, un aspetto particolare questo
che sembra caratterizzare da subito le musiche del
trio. Poi arriva il terzo, un forsennato e una vecchia conoscenza dei palchi americani: Jamie “Jimbo”
Easter che abbiamo imparato a conoscere nelle
scorribande passate (Piranhas), presenti (Druid Perfume) e sicuramente prossime (Timmy’s
Organism). I tre Little Claw sono pronti. Esordiscono nel 2005 con un album sottotraccia, borderline come piace a noi.
L’ellepì è omonimo ed esce per Ypsilanti, minuscola label dell’omonima località del Michigan. Tiratura microscopica per un 8 pezzi sul crinale tra
blues deforme, la wave più NO e il post-punk più
abrasivo. In poche parole, deragliamenti avant-garage in paradossale modalità semi-acustica e zero
tolleranza per i suoni di moda. I pezzi sono scomposti (il blues semiacustico di She Wolves), ubriachi
(Wife), ipnoticamente rock (Ice Age) e afasicamente
no-wave (i fiati malati di Freshwater Beach e della
conclusiva Shoplifting Cart) e non basterebbe mischiare Teenage Jesus & The Jerks, L7, Slits,
Royal Trux e Sonic Youth per chiuderli in un
recinto. Moss Has Fang (questo anche il nome
con il quale l’omonimo è conosciuto) presenta una
band senza cazzi né mazzi.
Il tempo di far uscire un 7” split con Michael
Yonkers su X! Records – giusto per non tagliare i
ponti Detroit – e la formazione si sposta a Portland,
perde per strada Jimbo e lo sostituisce con Hendrik Deherder. Spit And Squalor Swallow The
Snow ne è il risultato. L’underground americano
inizia a filarseli, e non è solo merito della Ecstatic
Peace. L’album stratifica la formula, la decomprime
senza togliere nulla all’ossessione primigenia.Anzi, la
nenia ghost-folk che lo inaugura (Hobo Baby Zeus) fa
accapponare la pelle così come l’incedere minimale
di Prickly Pear e Lake Crescent Freeway, quello drogatissimo e free di Domestication Of Manchild o le
ossessioni ectoplasmiche della reprise di Shoplifting
Cart Pt.2. Portland ha influenzato positivamente i ragazzi: meno volume e più paranoia con esiti psych
malati iniettati di reiterazioni blues.
Non ce ne voglia Heath, ma è lei, Kylinn, la leader.
Le sue fusa, le pose da chanteuse, i suoi graffi da
pantera, e ancora l’ossessione per Nico, la frangetta
scomposta, la presenza scenica sul palco fanno di lei
l’epicentro indiscusso del suono targato Little Claw.
Human Taste, il nuovo lavoro, non è che la sublimazione del suo talento e dell’affiatamento della
band, perfetto condensato delle brutture del primo
lavoro e delle dilatazioni sonore del secondo, tra gli
eccessi disturbanti e rumorosi dell’esordio e l’inquietante paranoia post-Velvet Undergrounde-tutto-ciò-che-segue del comeback.
Non da meno lo iato biennale tra i due dischi
durante il quale il trio ha incamerato un secondo
batterista, Adam Svenson, e il percussionista/tastierista Damon Sturdivant e battuto spesso i sentieri
del vinile corto: Why, Why Not? su Physical Sewer;
Race To The Bottom per Siltbreeze; Prickly Pear su Columbus Discount e il consigliatissimo e introvabile volume 6 di The World Is Lousy With Ideas della
Almost Ready Records, diviso con Eat Skull e
Psychedelic Horseshit. Per comprendere i Little Claw e l’humus sul quale sono germogliati, però,
bisogna ricordare Shiftless Decay: New Sounds
Of Detroit, il manifesto detroitiano di cui abbiamo
già parlato. Se non avete quello, iniziate da lì.
Stefano Pifferi
Turn On
11
C
Ultimo Attuale Corpo Sonoro
La violenza della memoria
Poesia e intransigenza: Pier Paolo Pasolini, Nazim
Hikmet e Arthur Rimbaud nella musica degli Ultimo
Attuale Corpo Sonoro
12
Turn On
apita anche questo. Di incontrare lungo la
strada qualcuno ancora capace di dare il giusto peso alle parole. A quelle affilate o in versi di
chi ha saputo convergere verso un processo creativo irreprensibile, antagonista, fuori dagli schemi.
Ma soprattutto alle proprie, celebrative certo, ma
anche parte attiva del necessario riaffiorare di una
coscienza civile ormai dimenticata. Quest’ultima
scomoda e fuori moda, come il post-rock immaginifico che fa da perfetto contraltare ai testi declamati
dagli Ultimo Attuale Corpo Sonoro. Capace tuttavia
di accrescere l’impatto emotivo di un atto d’amore
lontano dalle sabbie mobili dell’ideologia più utilitaristica e denso di etica e profondo senso di appartenenza.
Tutto inizia con un’intervista al gruppo. Che si
trasforma in una riflessione involontaria. La destinazione è poco chiara: forse riscoprire e rivendere un
patrimonio culturale forte e condiviso di cui ora più
che mai si sente il bisogno. Il contenuto che prende
il sopravvento sullo spot pubblicitario, il significato che costringe all’angolo un modo di intendere
la musica – e l’esistenza - spesso troppo di superficie. Campioni drogati dal marketing contro paladini
dell’insofferenza e del disagio. Perché è impossibile
non provarne, oggi, di disagio.
E allora un disco come Memorie e violenze
di Sant’Isabella. Necessario fin dalla concezione,
perché la “scandalosa forza rivoluzionaria del passato”
non vada persa e foraggi, invece, un “attivismo intimo
e quotidiano” contro chi della memoria e della storia vorrebbe fare carta straccia. Musica che diventa
lettera, poesia, violenza della parola. Nella pratica il
lavoro si trasforma in un omaggio a tre punti cardinali del pensare libero, capaci di far coincidere la
propria arte con ideali e vita stessa: Pier Paolo Pasolini, Nazim Hikmet, Arthur Rimbaud, ovvero “l’esule
in patria, l’esule all’estero e l’esule da se, rassegnato e
anarchico fino al midollo”. Per un percorso che “parte
dall’impegno sociale e, con rassegnazione, giunge alla
disillusione” lasciando, tuttavia, un segno profondo in
chi condivide la condizione – metaforica e non - di
esule suo malgrado.
Il verbo è lineare: è la narrazione e non la melodia
ad indicare la via. Tanto che per osmosi, nel circolo
delle analogie, viene da citare anarchici esemplari,
narratori borderline, nostalgici del Patto di Varsavia come CCCP, Massimo Volume e Offlaga
disco Pax. In realtà il tiro è leggermente più preciso: “Nella cerchia dei nostri ascolti è innegabile che i
progetti di Ferretti abbiano un notevole peso specifico.
Penso che a livello attitudinale i CCCP, i CSI e gli stessi
PGR siano molto vicini a ciò che cerchiamo di proporre,
per energia, oltranzismo e tensione sociale.” Dei PGR
le trame raffinate, dei CCCP l’impatto emotivo, anche se è degli Ultimo Attuale Corpo Sonoro e solo
loro quel prendere la memoria per passarci attraverso, riviverla per conservarla. Narrativa visuale
che nel trittico dedicato all’autore di Petrolio e
in particolare in Empirismo eretico trova forse la sua
massima espressione: “È un brano emblematico. [...]
Sferra un cazzotto allo stomaco dell’ascoltatore sussurrando mezze verità e sbraitando parole vere di notte e
false di giorno. È un brano che fa riflettere e rischia di
portare alla commozione più sincera anche l’orecchio
dell’ascoltatore meno avvezzo. È popolare senza essere
populista.”
È da qui che si parte per intendere oltre i soliti clichè il ruolo dell’artista. Al pari di Pasolini critico feroce e schierato oltre il perbenismo di un
vivere inebetito dal benessere formale o semplice
intrattenitore?: “Non abbiamo ricette e nemmeno la
presunzione di voler spiegare cosa dovrebbe essere o
cosa dovrebbe fare l’artista post-moderno. Ci limitiamo
a suggerire che sarebbe il caso di ripartire da zero dalle
proprie, intime e personali, contraddizioni, accettandole.
L’artista dovrebbe essere il primo a fare tabula rasa. A
capire come la schizofrenia possa portare terapeuticamente a trasformare il male, la depressione e la disillusione in qualcosa che assomigli al bene”. Perdersi per
ritrovarsi, insomma. Mettersi in gioco calpestando
le proprie, apparenti, sicurezze per scovare quell’attimo di lucidità necessario a vedere le cose nella
giusta prospettiva. Per dare un nome ad ogni causa
e un cognome ad ogni conseguenza.
Fabrizio Zampighi
Turn On
13
I
The Clean
La possibità di un’isola
I The Clean furono un’anomalia nel già anomalo kiwi rock dei primissimi eighties.
Tanto trasversali, acuti e intensi da sfuggire alla presa. Quello che si dice un culto.
Finalmente in espansione.
- Stefano Solventi
14
TUNE IN
fratelli Hamish e David Kilgour, batterista il primo,
chitarrista e cantante il secondo, nacquero e crebbero in quel di Dunedine, nel sud dell’isola sud della
Nuova Zelanda. Erano i seventies e bruciava forte in
loro la passione per il rock, con particolare predilezione per il garage e i Velvet Underground. I due
non si perdevano un concerto delle grandi star inglesi e americane che passavano da quelle parti (Lou
Reed, Talking Heads, The Cure...), uscendone
sempre più esaltati. Quanto alla scena neozelandese,
in quel periodo non era particolarmente vivace. Certo, le scorribande del punk imperversavano selvatiche, ma il subbuglio più significativo era provocato
da due band della vicina (si fa per dire) Australia, i
Radio Birdman e i The Saints. Quel loro rock
surfeggiante e scellerato fu però la goccia che convinse i Kilgour a fondare il proprio gruppo.
Battezzatisi The Clean, scelsero una quadratura classica, contando sulla chitarra di Peter Gutteridge e sul basso di Robert Scott. Entrarono negli
anni ottanta con baldanza formidabile e l’intenzione
di uscirne vivi, convincendo la gloriosa Flying Nun
Records - vero e proprio ricettacolo del kiwi rock
alternativo (del cui roster faranno parte The Verlaines e Dead C) - a scritturarli. Fu l’inizio di un
rapporto ventennale ancorché discontinuo, che ha
dato vita ad un repertorio non copioso però ad
altissimo peso specifico, punteggiato da intuizioni
spesso considerevoli e talora - senza tema di esagerare - sconvolgenti.
A partire dall’intrigante singolo d’esordio Tally
Ho! (Flying Nun, 1981, 7.0/10), un sette pollici stringato, battente, robotico, la scansione minimale come
una drum machine giocattolo, l’organo puntuto e la
chitarrina arricciata, la melodia mossa da un entusiasmo sbracato. Insomma, sembra il parto garrulo di un
Brian Eno colto da fregole bubble gum stradaiole.
Qualcosa di strano si agita tra queste vibrazioni contagiose, un voltarsi all’indietro che condanna il gesto
ad un presente incarognito, la voglia di pop strozzata in culla dalle tossine della contemporaneità, come
ben testimonia il lato B Platypus, presa live brumosa e
arcigna di spettri elettrici noise, la flemma motoristica e minimale del drumming scossa da spasmodiche
accelerazioni punk, la tensione lirica ad alzo zero dei
Sonic Youth ed il piglio da marciapiede quale gentile lascito dei Velvet Underground.
Gli elementi si affrontano e si fondono con fluido stridore: Hamish picchia su pelli e piatti con la
risolutezza tarfelata e selvatica di una Moe Tucker, è gesto vitale puro, arcaica scansione; Scott
introduce tremori dark wave conducendo il basso
con tarcotanza arcigna, pastosa e inesorabile; le chitarre e l’organo giocano a stuzzicarsi con scherzetti
acuminati garage psych salvo poi deragliare verso la
rumorosità sgranata e incandescente del coevo hardcore, mutuato dalle propaggini estreme del garage
psych (13th Floor Elevators, Blue Cheer)
più che dall’avanguardia targata Glenn Branca da
cui invece discenderanno i Sonic Youth (al debutto
con Confusion Is Sex nel 1983).
Ridotti a trio con la dipartita di Gutteridge, nel
settembre dello stesso anno decisero di incidere un
ep che da solo basterebbe a garantirgli un posto
ben illuminato con vista panoramica nel pantheon
dei migliori, se solo vivessimo in un mondo - diciamo così - meno distratto (il che vale ovviamente
anche per il sottoscritto). In effetti, Boodle Boodle Boodle (Flying Nun Records, gennaio 1982,
7.8/10) sbocciò speciale fin dal booklet, un fumetto di sedici pagine disegnato dalla stessa band con
l’aiuto di alcuni amici. Ma è nelle cinque tracce che
il discorso si fa serio. Segnano una decisa definizione del sound in chiave power pop con implicazione
garage e surf episodi come Thumbs Off (cantata da
Robert Scott - che del reso fungeva da chitarrista
e cantante nel suo progetto parallelo The Bats),
sintonizzata tra sberleffo ghignante The Who e
beat turgido Small Faces, e Sad Eyed Lady col suo
caracollare sordido e gracchiante benedetto dal backing vocals saettante di Chris Knox (leggendario
reduce della stagione punk di Dunedine - avvenuta
senza ritardi, anno 1977 - in sella ai suoi Enemy)
tra l’altro anche co-produttore dell’ep.
Se Anything Could Happen dimostra una disinvoltura folk rock declinata bluesy non distante dai
Rolling Stones altezza Between The Buttons, l’iniziale Billy Two è una giga folk tesa e accorata, col ritornello capace di un coretto suadente e
gagliardo e persino un accenno di chitarre in reverse, roba che ti figuri dei Kinks dimessi e strattonati
dall’estro scorbutico Velvet Underground. Cimenti
meritevoli perché frutto di un equilibrio inconsueto, trasversale eppure solido, sorretto da un impeto
fragrante e forse un po’ naif ma conmvinta fino in
fondo dei mezzi utilizzati e della direzione intrapresa.Tuttavia, è Point That Thing Somewhere Else che fa il
botto vero: cantata da un oppiaceo Hamish Kilgour,
si dipana motoristica e noise wave, quelle chitarre effettate sono un vento sonico radioattivo, rapimento oppiaceo da Sonic Youth narcolettici ante
litteram, un ponte tra noccioline psichedeliche 13th
TUNE IN
15
Floor Elevator e glassa malmostosa My Bloody
Valentine mentre sotto scorre il fiume siderale
Hawkwind.
Controlli e ricontrolli le date, e quasi non ci credi:
era appena il 1981 porco cane. Provi a spiegartelo
come ad una lunga decantazione di scelleratezze garage psych e azzardi sonici new e post wave, il siero
distillato dalla brodaglia Electric Prunes, Blue
Magoos, Vanilla Fudge, Velvet Underground,
Seeds, Stranglers, Neu!, Joy Division, Kluster... Un processo compiuto nella cameretta sonora dei Kilgour spersa nel vasto isolamento dello stato
oceanico, giunto ad esiti straordinariamente affini epperò dissimili da quelli delle avanguardie newyorkesi,
forse più vicine per la basilarità dell’approccio ai primi
Flaming Lips, tolto però l’estro allucinato e nevrastenico (per non dire furioso) di Coyne e compagni.
Ed è infatti a questi ultimi, in particolare all’estasi
visionaria e sguaiata che informerà Hit to Death
in the Future Head (Warner, 1992), che fa pensare la splendida Slug Song, contenuta nel successivo ep
Great Sounds Great, Good Sounds Good,
So-So Sounds So-So, Bad Sounds Bad,
Rotten Sounds Rotten!! (Flying Nun, 1982,
7.4/10). Titolo fluviale per sei tracce che ribadiscono il solco garage psych avendo cura di ammorbarlo
con la verve beffarda d’un John Lydon e l’intransigenza primitiva dei Velvet Underground (Side On),
senza disdegnare fughe motoristiche tra il blando e
il torvo (Flowers) e aspersioni di dolciastra adrenalina
Kinks (On Again/Off Again) che finiscono per tirare in
ballo quei Go-Betweens all’epoca impegnati a seminare singoli nell’orticello della vicina (come sopra,
si fa per dire) Australia. Per non dire di quella Beatnik
che si fa largo garrula e beffardella come potrebbero
i nipotini scellerati dei Blues Magoos.
Il repertorio fino a quel momento, visto da oggi,
sembra il tipico trampolino di lancio verso una gloriosa seppur altrenativa carriera. Acadde invece che
il progetto The Clean fu messo in soffitta. I fratelli
Kilgour avviarono un nuovo progetto (dalla geniale
egida Great Unwashed) assieme a Gutteridge,
mentre Scott impegnava sempre più estro ed entusiasmo coi suoi Bats. Prima Odditties (Flying
Nun, 1985, 7.2/10) e poi Compilation (Flying Nun,
1988, 7.0/10) raccolsero quanto catturato durante
incisioni decisamente lo-fi (alcune su un due piste
prestato loro dai Dead C). Il beat wave e garagista,
brumoso e motorizzato di At The Bottom, l’innodia
aspra e pettoruta (tra Seeds e The Move, poniamo) di Odditty, l’andirivieni brutale e onirico (tra i
16
TUNE IN
Velvet più ruvidi e certe caligini Big Star) di Quickstep, soprattutto il piglio hard noise illanguidito da
sbuffi di tromba e un malanimo che diresti The Cure
di Getting Older, alimentano il rimpianto per ciò che
avrebbe potuto essere e non fu.
Intanto che i progetti si squagliavano (Great Unwashed) e altri più o meno paralleli ed estemporanei sbocciavano (Stephen, Bailter Space),
capitò che nel 1989 i tre organizzassero una rimpatriata in quel di Londra, un concerto secco - da cui
fu ricavato il ficcante 12 pollici In-A-Live (Flying
Nun, 1989, 6.9/10) - che provocò un rigurgito d’intesa. Effimero ma fruttuoso. Inciso negli studi londinesi Blackwing nel luglio 1989 con la regia di un
tecnico del suono come Alan Moulder (già al lavoro
con Jesus And Mary Chain), Vehicle (Flying
Nun, 1990, 7.1/10) sfrondò ovviamente il sound dal
bozzolo lo-fi mettendo altresì in mostra una attitudine più pop, stemperando i fantasmi beat e motorik tra emulsioni madreperlacee d’organo e arguzie
chitarristiche che cuciono nostalgie jingle jangle e
tremori wave psych. Se The Blue esala dolcezza attonita di stampo Robyn Hitchcock, e se Diamond
Shine stuzzica arguzie wave pop à la Cure sul nastro
trasportatore Can, c’è una Big Soft Punch che azzecca l’equilibrio perfetto tra dinamismo incessante
e struggimento sperso, con certi guizzi omeopatici
surf che forniranno più di uno spunto agli Yo La
Tengo (tra l’altro conosciuti l’anno precedente in
una data tedesca del tour europeo), mentre Drawing
To A Hole corre sul filo con passo febbrie e accigliato innescando una gradevole trepidazione R.e.m..
Vuoi per la latitanza di quel successo che avrebbero meritato, vuoi per le imperscrutabili circostanze della vita, la band si sfaldò nuovamente: Hamish
se ne andò a New York per avviare con la moglie i
Mad Scene, mentre David intraprese una a quel
punto opportuna carriera solista (debuttando con
l’eccellente Here Come The Cars nel ‘92).
Ma per i Clean non era finita, forze centrifughe
e centripete si alternavano attorno a questa entità
così effimera e significativa: prima il singolo Late Last
Night nel 1994 - il soffice piglio psychomotoristico, il
canto sornione e minimale, l’organo un ricamo acidulo - poi l’album Modern Rock (Flying Nun, 1995,
7.3/10) riportano a casa la band. Fu infatti in New
Zealand che le incisioni ebbero luogo, impreziosite
dal non piccolo aiuto di Alan Starrett a fisarmonica,
mandolino ed archi. È un disco molto bello, ancora
più stiepidito in direzione pop, a partire dal singolo
Outside The Cage che, in una glassa psichedelica d’or-
gano, tastiera e basso radiante, con quel canto allampanato e il chiacchiericcio sullo sfondo, imbastisce
un’ipnosi che ibrida i Wire più soft e i Beta Band
(che esordiranno tre anni più tardi). Se ballate come
Do Your Thing e Safe In The Rain scomodano il rapimento abbacinato e lunare di Mike Scott e Robyn
Hitchcock, Secret Place e Too Much Violence azzeccano
la formula definitiva wave-psych, con le tastiere argute da Stranglers narcotizzati, l’inquietudine dolciastra
delle chitarre, quelle melodie tese e dolciastre. Ben
poco da invidiare insomma rispetto al lavoro dei coevi Yo La Tengo, alle prese all’epoca col non imprescindibile Electr-O-Pura (ma in procinto - due anni
più tardi - di sfornare il capolavoro I Can Hear
the Heart Beating as One).
A quel punto, pur se distratti dalla ridda di progetti paralleli, i fratelli Kilgour e il buon Scott capirono che il ferro era caldo e andava opportunamente
battuto: Unknown Country (Flying Nun, 1996,
7.5/10) vide all’opera la stessa formazione, Starrett
compreso, per un quasi quartetto con la stessa idea
pop eterea, irrequieta e allampanata, portata però ad
un livello di ulteriore sofisticazione. Se Clutch si snoda
bucolica tra slide miagolanti come un divertissement
tra Rem e Hidden Cameras, Chumpy zompetta
robotica ed esotica in una cospirazione di violino e
tastiere come ti aspetteresti da una versione cameristica dei Wire. Quanto a Twist Pop, è il singoletto beat
affacciato sul terrazzino della wave poppettara, retrogusti nostalgici e tutto, mentre Indigo Blue ci ricorda
la confidenza dei tre coi raga oppiacei.A sorprendere
davvero sono Balkans, che tra frinire di violino e chitarra acustica si produce appunto in una escursione
strumentale dai sapori gitani, e quella Franz Kafka At
The Zoo che spalma un talkin’ vaporoso su una caligine di basso e tastierina che diresti quasi Air.
Due colpi consecutivi di tal fatta avrebbero dovuto aprire porte che invece si socchiusero appena,
e il progetto finì di nuovo nel freezer per un lustro buono. A riscaldarlo pensarono quelli di Merge
Records, che nel 2000 li accolsero nel roster marchiandone l’album del rientro Getaway (Merge,
2001, 7.0/10), in cui trovano cittadinanza tanto le
brume kraute quanto l’agro folk-psych post-Syd
Barrett (Golden Crown), impastandole con elettricità scabra un po’ Sonic Youth e un po’ Crazy
Horse (Aho, Stars), alternate ad aciderie dinoccolate e friabili (Circle Canyon), spunti Scott Walker
(Poor Boy) e spasmi country rock (E Motel). È insomma il lavoro della maturità (e ci sarebbe da stupirsi
del contrario), animato da un’autorevolezza a fari
bassi, dall’estro di chi ormai vive l’attitudine con
disincanto, seduto su un repertorio di intuizioni,
esperimenti e - massì - espedienti che definiscono
una calligrafia assieme soffice e misteriosa, arguta
e affabile. Finalmente apprezzabile e apprezzata aggiungerei, ora che Sonic Youth, Yo La Tengo, Flaming
Lips, Beta Band, Crystal Stilts e ci metterei pure
Low e Blonde Redhead, hanno in qualche modo
allenato l’auditorio a gustare certe commistioni,
reso standard ciò che prima poteva apparire come
(formidabile) stranezza. Condannando così e altresì
i Clean ad un’aura di irrimediabile ritardo. Che lo
splendido doppio Anthology (Flying Nun/Merge,
2002, 7.6/10) ed il nuovo, eccellente Mister Pop
(Merge, 2009, 7.3/10) fanno somigliare ad una piacevolissima rivalsa.
TUNE IN
17
Brunori Sas
Il mare d’inverno
- Teresa Greco
Ordinarietà e straordinarietà del quotidiano, con un’urgenza e una emotività che lasciano tracce ben visibili intorno, per ulteriori declinazioni del cantautorato made in Italy.
I
n fondo molti la provincia se la portano dentro,
con la sua voglia prepotente di evadere, lo scazzo
e la noia quotidiana dei lunghi pomeriggi passati
ad ascoltare musica e a fantasticare su altre geografie possibili. Capita anche di andarsene e poi di
tornare, dove tutto ha avuto inizio, pronti per nuove
ripartenze, che danno probabilmente un senso al
percorso già fatto fin lì.
18
TUNE IN
Prendiamo il caso di Dario Brunori, dalla provincia di Cosenza, titolare della ditta musicale Brunori
SAS, all’esordio con Vol.1 (in recensioni) su Pippola Music. Un passato dreamglitchpop nei toscani Blume (In tedesco vuol dire fiore, 2006),
prima ancora la partecipazione al collettivo virtuale
Minuta, il rientro alla base nel 2007 per occuparsi
dell’azienda di famiglia e in seguito la decisione di ri-
manere. Nel frattempo, la composizione dell’album,
nato emotivamente da voce e chitarra come frutto
della rielaborazione sedimentata di un ampio periodo, dai ricordi d’infanzia all’adolescenza tra “il mare
d’inverno e le cotte di agosto” e oltre. Un’urgenza
espressiva e formale che sa di cantautorato italiano dei Sessanta (Tenco, Piero Ciampi, Sergio
Endrigo, gli “urlatori”), Settanta (Battisti, Gaetano, Ivan Graziani) ma anche Caputo, Battiato, Bugo, per le liriche cinematiche e l’ironia
graffiante che si fa anche ritratto sociale. In questo
non disssimilmente da altri cantori odierni coetanei
del nostro, da Dente a Le luci della centrale
elettrica fino ai Maisie.
L’imperativo è cantare, monitorandola, l’ordinarietà della vita, cogliendone aspetti non immediatamente visibili e dissacrandola, il tutto con spontaneità e autenticità nella scrittura, scrittura che
risulta immediata e fresca. Di questo e di molto
altro abbiamo parlato con Dario in uno stream a
tutto campo.
È evidente la differenza tra Blume e
Brunori SAS, ma quanto è rimasto di
quell’esperienza?
A livello umano tantissimo, perché i tre anni in cui
ho preso parte al progetto mi hanno dato modo di
stringere rapporti con persone con cui condivido
una certa visione del mondo e che oggi fanno parte
della mia vita. Dal punto di vista artistico ho avuto
la possibilità di sperimentare un’altra maniera di affrontare l’aspetto compositivo. Di solito tendo ad
urlare e in quel contesto invece le cose andavano
sussurrate.
Quali sono i tuoi cantautori italiani preferiti e perché?
Da piccolo amavo molto Battisti, che è una grande
passione di mia madre. In quegli anni in casa girava
un cofanetto di audio-cassette con il meglio dei cantautori italiani: da De Andrè a Guccini, da De Gregori a Vecchioni fino a Branduardi e appunto Battisti.
Successivamente ho avuto grandi amori stagionali,
come De Andrè, Battiato, Piero Ciampi, Gaetano e
Ivan Graziani.
Altre influenze, musica di formazione?
Sono ultimo di tre figli maschi e ciò rappresenta
una grande fortuna, perché dai tuoi fratelli erediti un sacco di dischi, oltre che libri, film e fumetti.
Erediti anche il ruolo di raccattapalle e di portiere
fisso nelle partite di calcio in cortile. Ma ne vale
davvero la pena. Anni ‘80: Prince, tantissimo, tutta
la discografia, quasi un’ossessione in camera nostra,
poi Culture Club, Spandau Ballet, Duran Duran, Tears For Fears, Dire Straits, e tutto il ballabile in voga
in quegli anni. Disco ricordo: Purple Rain. Anni
‘90: molta roba “pesante”. Sono stato un chitarrista
heavy e all’epoca ero molto affascinato dalla tecnica
e dal virtuosismo. Amavo anche Hendrix e il rock
anni ‘70, il grunge in auge a quei tempi e l’alternative rock italiano. Disco ricordo: Vs. dei Pearl Jam.
Anni ‘00: mi sono innamorato dell’aspetto tecnico
musicale, della registrazione e della produzione del
suono, per cui tanta elettronica, in particolare quella di stampo Morr Music e in ambito folk Sufjan
Stevens e Bon Iver. Disco ricordo : Neon Golden
dei Notwist, ma anche Come on Feel the Illinoise di Sufjan Stevens. In questi ultimi mesi sto
ascoltando gli artisti della Tiger Sushi, e gli italiani
DID, Le Rose e i The Gentlemen’s Agreement.
La provincia e la voglia di evadere ma anche il suo richiamo, il ritorno e il confronto con se stessi, con quanto si è cambiati
se si è cambiati. Anche se il tuo è stato un
ritorno piuttosto forzato…
Sì e no. Sono tornato in seguito alla perdita di mio
padre, ma non ero obbligato a rimanere, anzi i miei
hanno spinto molto perché rientrassi in Toscana,
dove ho passato quasi 11 anni della mia vita tra università e calvari interinali. Sono rimasto giù perché
in quei mesi ho avuto la percezione (paradossale
visti gli eventi) di star meglio, di aver ritrovato alcune cose che credevo perse. A volte quando sei
eccessivamente concentrato su un particolare non
riesci a guardare il quadro nella sua interezza. Tornare ha ampliato la mia visione e mi ha rimesso in
contatto con una parte di mondo che ignoravo da
troppo tempo. Non è stata comunque una scelta
razionale, ma impulsiva ed emotiva, un po’ come la
stesura del disco.
In provincia c’è di che cantare? Se sì l’arrangiamento qual è?
Io l’ho cantata quasi tutta in Sol e l’arrangiamento
dalle nostre parti è giocoforza essenziale.
Ma vale ancora la pena di fare distinzioni
tra città e provincia secondo te?
Non ho mai vissuto in una vera città, se non per
periodi molto brevi, e quindi non amo parlare di
ciò che non conosco. Se la domanda è tesa ad evidenziare l’ influenza della provincia sull’ispirazione
artistica, sono convinto che nel mio caso abbia giocato un ruolo importante, soprattutto nella prima
parte della mia vita: la noia del mare d’inverno aguzza l’ingegno, e passare 8 ore al giorno a suonare e
TUNE IN
19
ad ascoltare musica incide inevitabilmente. La città
ha il pregio di metterti in contatto più rapidamente
con le novità e di assistere ad eventi che in provincia non passeranno mai. Ma in provincia “succedono
cose che voi cittadini non riuscite neanche ad immaginare”.
Il disco è fatto di musica emotiva, empatica, di getto nella forma, voce e chitarra,
ma si sente la rielaborazione sedimentata di un ampio periodo, dai ricordi d’infanzia all’adolescenza e oltre. Racconti
come è nato?
Tra gennaio e febbraio 2007 mi sono di colpo ritrovato in un’altra vita. Ho lasciato Siena, ho chiuso
i miei progetti musicali e mi son messo a lavorare
nel posto che era stato di mio padre fino a quel
momento. È ovvio che di questo risenta il disco, sia
negli aspetti amari e malinconici, sia nei passaggi ironici e diretti. Spesso di sera mi trovavo a suonare la
chitarra sul divano, abbozzando i brani, senza avere
un progetto musicale da portare avanti, senza apparecchiature per registrare, senza l’idea di un disco,
esattamente come mi succedeva 15 anni prima più
o meno nelle stesse stanze. Poi ovviamente il rivivere nei posti dell’infanzia e dell’adolescenza ha
tirato fuori ricordi ed istantanee degli anni passati,
un po’ come la madeleine di Proust o come i Gran
Premi di Prost. Avrei potuto intitolare questo disco
Il ritorno, citando il meraviglioso film di Andrei
Zvyagintsev, ma Volume Uno è perfetto perché
lascia intravedere un seguito.
Come sono nate le collaborazioni con
Annie Hall (Di così) e Camera 237 (Guardia 82)?
Con gli Annie il primo incontro è avvenuto a Fidenza durante un loro concerto ed è stato amore
a prima vista. Sono meravigliosi sotto tutti i punti
di vista: i migliori Annie della nostra vita. Loro fan
parte della scuderia di Pippola per cui è sembrato
ovvio collaborare, visto il feeling e la natura del brano. Io li definisco “CalaBresciani” perché hanno il
corpo lombardo, ma il cuore meridionale. I Camera
237 sono invece arrivati in zona Cesarini, quasi alla
chiusura dell’album. Anche loro dal vivo sono davvero d’impatto, roba da spettinare i capelli a Kojak. Gli
ho proposto di vestire un abito diverso e calarsi nei
panni di una band da balera anni ‘60 e penso ci siano
riusciti egregiamente. Meritano molta attenzione e
credimi hanno un live che, come dicono i giovani
d’oggi, “spakka”.
Mi racconti com’è secondo te la scena co20
TUNE IN
sentina e dell’hinterland?
Qui succede una cosa curiosa. Sono lontane alcune dinamiche e i musicisti si sentono un po’ tagliati
fuori dalla “scena che conta”, quasi che la SA - RC
rappresenti un limite non solo per i turisti ma anche per gli artisti. Al contempo germogliano realtà
davvero all’avanguardia e c’è un attenzione ed una
voglia di novità che non ho riscontrato in altri luoghi. La lista sarebbe lunga, ma potrei citare il Partyzan che ha portato a Cosenza negli ultimi anni il
meglio della scena indie nazionale e internazionale,
Radio Ciroma la radio alternativa storica cosentina e poi gli artisti : i già citati Camera 237, Shirt
vs T-Shirt, Captain Quentin, Kyle,Vinsent, Gripweed,
Appleyard College, La Soluzione, Red Basica e non
ultimi i Maisie che pur essendo siculi hanno tra le
loro fila fior di musicisti calabri. Nel mio piccolo sto
cercando di fare rete e stimolare la scena sia con
l’attività del mio studio di registrazione Picicca, sia
mediante la realizzazione di un contenitore web di
prossima pubblicazione, che tenderà a valorizzare le
realtà artistiche locali e ad evidenziare quel che di
buono si fa da queste parti. Si chiamerà “ OlioDaLive” ed avrà un taglio decisamente ironico e giocoso.
A me piace molto chi fa sul serio senza prendersi
troppo sul serio.
Affinità e divergenze con autori contemporanei e coetanei, Dente, Luci della centrale elettrica, Maisie, la provincia italiana in generale…
Affinità : la spontaneità, la scrittura autentica, l’aderenza tra ciò che si canta e ciò che si veicola “dal
vivo”. Divergenze : - Dente: non è ancora venuto
in concerto a Cariati (paese vicino Cosenza) e mi
piacerebbe leggere su una locandina: “Dente a Cariati”; -Le Luci delle Centrale Elettrica: una sera ho
provato a lavarmi i denti con le antenne della televisione e mi sono scheggiato un canino; -
Maisie:
abbiamo lo stesso batterista, intravedo un potenziale conflitto d’interessi. Fuor di battuta hai citato tre
splendidi esempi di scrittura fresca e innovativa. Al
di là delle questioni di gusto, loro stanno cercando
davvero una via nuova per la canzone italiana e mi
pare che i risultati siano evidenti.
Nelle canzoni del disco emerge anche
l’ironia che graffia, i tanti luoghi comuni,
nei ritratti come in Paolo affresco piccolo
borghese cattolico qualunquista, in terza
persona; i bozzetti sociali e le difficoltà
e assurdità dell’oggi, la precarietà, non
dissimilmente da quanto faceva Gaeta-
no a fine 70. E d’altra parte viene fuori
la distanza dagli “Italian Dandy”… Tra i
provinciali cantati dai Baustelle e il Bugo
dell’esordio (La prima gratta) tu come ti
collochi?
La mia dimensione umana, oltre che artistica, è sicuramente più vicina a quella del Bugo degli esordi,
nell’attitudine a cantare storie ordinarie, sia come
sorridente provocazione verso alcuni eccessi poetici, sia per scovare lo straordinario dove apparentemente non c’è. D’altro canto amo i dischi dei Baustelle, in particolare Il sussidiario illustrato
della giovinezza. Subisco inevitabilmente il fascino di personaggi come Bianconi, per quella capacità di incarnare in modo credibile non solo un
personaggio, ma un immaginario fuori dal tempo.
Sono però cresciuto in campagna ed ho nel sangue
l’ironia cinica e “spoeticizzante” dei piccoli paesi del
sud. Italian Dandy è dunque al contempo un tributo
ed una canzonatura, una duplice veste che la rende
adorabile ai miei occhi.
Cos’è per te la normalità di cui parli nel
disco?
È il mio quotidiano e quello delle persone con cui
sono stato in contatto nel periodo in cui ho scritto
le canzoni. I muratori che fischiettano nei cantieri,
gli agenti di commercio col sorriso a comando, gli
impiegati di banca grigi, le signore petulanti in macelleria, il barista sempre allegro, il meccanico con
San Francesco di Paola e le donnine nude attaccati
sulla stessa parete. Io me l’ero perso un po’ questo
mondo, e l’ho trovato così vero e genuino, nelle sue
mille contraddizioni, che mi sembrava giusto farne
un quadretto, un piccolo acquerello da tenere sul
comodino.
Chi odi? La techno?
A proposito di techno, dovrei farti conoscere un
mio amico che è davvero un gran personaggio: punkabbestia casalingo, che sabato va ai rave e domenica
prepara gli gnocchi fatti in casa. Ma questa è un’altra
storia… Sull’odio e l’odiare posso solo dirti che da
un paio d’anni ho imparato una lezione: “fuggi dalle
emozioni negative”. Non solo sono inutili, ma spesso dannose. A volte basta fermarsi dieci secondi,
non rispondere immediatamente alle sollecitazioni,
per cambiare il corso delle
La poesia all’epoca del cinismo è una balla?
La poesia è sempre una balla, è immaginazione priva di sostanza, inspiegabile in termini razionali. Per
questo è così affascinante.
Essere canzone senza forma canzone è
possibile?
Io adoro la forma canzone, adoro proprio la geometria semplice della struttura strofa-ritornello. Penso che le canzoni debbano volare leggere. Quando
ascolto un brano il meccanismo inconscio è: “ mi
piace o non mi piace”. Questa rapidissima considerazione avviene molto, ma molto prima che il
cervello possa spiegarmene le ragioni. È altrettanto
vero però che ci sono esempi meravigliosi di canzoni / noncanzoni. Adius di Piero Ciampi ad esempio,
basta e avanza..
E i Settanta di Rino, le BR, la P2, le battaglie sociali, erano meglio perché erano
più veri?
Mi chiedi un parere su qualcosa che non ho vissuto
di persona e che non ho approfondito, per cui rischierei di dire cose banali o inesatte. Mi sento solo
di dire che oggi avverto forte la mancanza di luoghi genuini di aggregazione, di posti in cui si possa
comunicare spontaneamente, dove si possa entrare
in relazione in (con) tutti i sensi. Vedo tanti recinti,
troppe case e molta gente chiusa dentro ad aspettare.
Un nuovo impegno politico è anacronistico ma un nuovo disimpegno Novanta è
assassino?
È un terreno che non mi è congeniale quello della politica. Io faccio parte della famigerata schiera
di quelli che leggendo il giornale s’indignano per
un quarto d’ora e poi passano alla pagina sportiva.
Non mi sento disimpegnato nella misura in cui vedo
nell’attività artistica un modo alternativo di fare politica. Devo dire che non amo particolarmente le
canzoni politicamente impegnate, e ad ogni modo
non mi sentirei affatto nella posizione di scriverne
una. Almeno ad oggi.
Un commento a questo elenco: Bugo e la
sua provincia schizofrenica cantata da un
quindicennio a questa parte, Rino Gaetano e la sua musica “sociale” e graffiante,
Ivan Graziani e il suo senso dell’immaginifico, Beck e la sua rielaborazione folk,
blues, rock, elettronica e le sue tematiche postmoderne.
Tutto perfetto. Manca solo: Brunori Sas, la piccola
impresa e il “meridione che rugge”. Andare, camminare, lavorare.
TUNE IN
21
Os Mutantes
il giardino elettrico
Os Mutantes tornano con
un disco nuovo di zecca in
cui l’unica cosa che non
stupisce è l’elevata qualità.
Sergio Dias Baptista al
telefono con SA.
22
TUNE IN
A
mmettiamolo pure, che male non fa: pochissime riapparizioni di band del passato hanno
offerto risultati di rilievo o sono stati qualcosa di più che patetici teatrini di gente imbolsita e
schiacciata da uno ieri ingombrante. Per non dire di
chi - ed è tendenza degli ultimi anni - risuona “live”
da cima a fondo un suo album particolarmente rilevante col senno della mezza età. Non sarebbe a quel
punto meglio spingersi in territori nuovi che restare
ancorato a fare la cover band di sé stessi, a perdersi
nel raccontare e raccontarsi di come eri bravo e
bello da giovane? Così sì che restiamo intrappolati
nel vicolo cieco di un falso presente che - artisticamente immortale: il punto, però, non è questo - distoglie dalla contemporaneità. Che quest’ultima sia
di regola meno interessante, è altra faccenda.
Qualcuno, nondimeno, è riuscito a sottrarsi alla
regola e Os Mutantes sono, pur non toccando i
vertici dei Faust, tra costoro. Probabilmente perché la loro storia ha sempre tenuto lontana la convenzionalità e - come ogni Tropicalista che si rispetti
- di luoghi comuni e norma i fratelli Baptista hanno costantemente fatto cartaccia. È che sin dai primi giorni, il trio formato a metà dei ‘60 da Sergio
e Arnaldo con Rita Lee lavorava (come i sodali
Gilberto Gil, Tom Zé e Caetano Veloso)
sperimentando in musica la voglia di libertà in uno
stato dittatoriale, in un ambiente sociale ricco sì ma
di spirito e cultura, ambedue stratificati e complessi.
Raccontarsi orgogliosamente originali reinterpretando la cultura occidentale, scrivendo regole nuove e del tutto particolari, da questa poi raccolte fu
una mossa geniale il cui senso è oggi lampante.
Senza farsi colonizzare anche in questo e - più
disinvolto di Pelé - mescolando psichedelia e pop,
musica concreta e folk autoctono, il Tropicalismo
anticipava il crossover “totale” che ci circonda oggi.
Affermare che Os Mutantes - nome tratto dal romanzo di fantascienza L’impero dei mutanti del francese Stefan Wul - abbiano recitato un ruolo fondamentale in ciò non è un azzardo; significa piuttosto
collocare nella giusta prospettiva un gruppo fenomenale, con in carniere almeno un tris di caleidoscopici splendori (tra l’omonimo debutto, la risposta Mutantes e A Divina Comédia Ou Ando
Meio Desligado fatichi a scegliere “il” Capolavoro: perché dovresti, poi?) più l’eccellente Jardim
Elétrico a tirare la volata tra ’68 e ’71. Solo l’anglocentrismo della critica ha, di fatto, impedito che
potessimo dapprima scoprire e poi capirli. Dopo un finale in sordina, esauriti gli stimoli nel
1976 si chiudevano i battenti con due opere piuttosto appannate. Per trentacinque anni, Dias e sodali non entreranno assieme in sala d’incisione, nel
mentre un parterre di Re ne magnificava le gesta.
Dalle parole ai fatti: il 2006 testimoniava una riunione che - e deve aver fatto riflettere Sergio Dias,
averlo persuaso che la clessidra, con la sua musica,
era stata clemente assai. Il tempo è un galantuomo, talvolta. Da par suo, Baptista autentico signore
- acuto, spiritoso, disponibile - lo è stato per tutta
la mezz’ora abbondante passata chiacchierando con
noi al telefono.
Sergio, la prima domanda è piuttosto ovvia: cosa vi ha spinto a tornare con un disco totalmente nuovo?
Beh, da che ci sciogliemmo non si era mai pensato né discusso di riformarci, nonostante le offerte
non fossero mai mancate e tra queste perfino una
proviene dalla Virgin Records. Il problema era che
le circostanze non erano quelle giuste: ho sempre
creduto che ci saremmo ritrovati in modo naturale;
che, se fosse accaduto, sarebbe stato con un paio
di telefonate tra noi, con la spontaneità di quando
eravamo più giovani. Succede a un certo punto che
il Barbican Center di Londra allestisce una mostra
dedicata al movimento Tropicalia e il curatore pensa
che non aveva senso escludere l’aspetto musicale e
in special modo la nostra band, benché non fossimo
più attivi. In qualche modo la cosa è presto trapelata
alla stampa e ho incominciato a ricevere chiamate
da persone entusiaste del fatto che tornassimo a
suonare in Inghilterra. Io rispondevo “ah, sì? E quando?” [ride; N.d.A.].
Una cosa del tipo “perché sono l’ultimo a
sapere le cose”
Più o meno sì. D’improvviso le cose hanno preso a
mettersi in moto per conto loro, in un modo strambo, al punto che una radio brasiliana sosteneva che
io e mio fratello fossimo già in studio a provare,
quando in realtà ne avevamo a malapena discusso.
A quel punto abbiamo affrontato la cosa e Zinho, il nostro batterista, disse che ci sarebbe stato.
È stato a quel punto che ho pensato che la faccenda fosse seria: sai, Zinho non aveva più toccato lo
strumento in trenta anni… Questo mi ha restituito
la misura dell’impegno, il fatto che dovevamo giocarci una chance. per di più abbiamo una certa età
e, insomma, non è che rimanesse molto tempo…
Abbiamo suonato nel mio studio e, benché facessimo schifo, la “vibrazione” c’era ancora. Si capiva
che, impegnandoci, ce l’avremmo potuta fare. Da lì a
TUNE IN
23
24
suonare a Londra, al Pitchfork Festival di Chicago e
ad aprire per i Flaming Lips all’Hollywood Bowl
è stata una strada in discesa. Ciò che mi piace di più
è che vi sia una generazione pronta a conoscere la
nostra musica; che ai concerti non vi fossero solo i
nostalgici.
Cattura lo spirito del nostro esordio. Non per
quanto riguarda il suono, ma lo spirito è lo stesso.
Sei riuscito ad ascoltarlo?
A questo proposito ritieni che la vostra
musica possieda un valore moderno in
grado di travalicare gli steccati generazionali?
Beh, mantengo un atteggiamento molto umile in
proposito, poiché credo che la musica prenda forma da sé e che noi non siamo altro che dei veicoli.
In ogni caso è bellissimo quando ciò che fai resiste
nel tempo. Adesso cavalchiamo la stessa onda degli
anni ’60, ma con gli occhi aperti e possiamo goderci tutto in maniera consapevole. Mi sento davvero
fortunato…
Vedi una sorta di linea stilistica comune sviluppatasi
da voi fino ai grandi nomi d’oggi che riconoscono
pubblicamente la vostra influenza? Per l’appunto
Flaming Lips, oppure Beck e gli Stereolab…
Non siamo mai stati dei messia o delle guide [ride;
N.d.A.] Os Mutantes sono stai una cosa magica e
sono stato un privilegiato a farne parte. Se qualcosa
ha raggiunto gli artisti da te citati, è stata senz’altro
l’onestà, il fatto che non siamo mai scesi a compromessi.
Cioè che siete rimasti sempre fedeli al
vostro ideale originario. Come del resto
è anche Haih, il vostro nuovo lavoro. Cosa
significa il titolo?
Innanzi tutto non è una parola portoghese, ma il
termine che nella tribù pellerossa Shoshone significa “corvo”. Il che si ricollega alla copertina del cd,
una foto che ho fatto fatica a scattare: ci sono volute ore perché quel corvo si girasse a guardarmi con
quegli occhi. Credo si possa affermare che, con la
sua figura così aperta a diverse interpretazioni (la
magia, l’opera di Edgar Alla Poe etc.) sia un’azzeccata rappresentazione di noi Mutantes. “Amortecedor”, invece, è una canzone che non compare sul cd
ma si può scaricare da internet ed è stata scritta da
Tom Zé. Se la dividi, ottieni diverse altre parole in
portoghese, ad esempio l’articolo/interiezione “a”,
oppure “amor” e “tecedor”, che vuol dire tessitore.
Come dire “il tessitore dell’amore”, nascosto dentro questo vocabolo che, in realtà, possiamo tradurre con “ammortizzatore”.
E quale vostro altro album credi somigli
di più per stile e spirito a Haih?
Si capisce che si tratta di voi ma allo stesso tempo suona contemporaneo: non è
una copia di Os Mutantes con stampato sopra la data 2009, bensì un disco dei Mutantes come sono oggi. è “tradizionale”
nel senso che è esattamente quello che
ci aspettiamo da voi, a prescindere dalla
data di uscita.
Perfetto. Tieni conto che volevamo un lavoro che
fosse “i Mutantes nel XXI secolo”, altrimenti tutta la
cosa avrebbe avuto ben poco significato. Per quanto
mi riguarda, credo sia totalmente coerente con la
nostra carriera.
Avete adottato un approccio metodologico diverso dal solito?
No, non più di tanto. La tecnologia è stata impiegata senza abusare. Poco computer e molto suono
diretto.
TUNE IN
Sì.
E cosa ne pensi?
In merito all’etichetta: nel roster della Anti
fate un’ottima figura, visti i “non allineati” che
ospita. Come ci siete finiti?
Tramite un percorso un po’ tortuoso. Terminato il
disco, Sean Lennon ne ha ascoltato alcune tracce e lo voleva per la Chimera Music. Poi s’era fatto
avanti anche Mike Patton, e la Light In The Attic
era interessata. Ci serviva però una struttura in grado di gestire ogni cosa e la Anti ci ha proposto un
contratto ufficiale soddisfacente sotto ogni punto
di vista.
Credi che la “cultura del meticciato” tipica del tuo paese e del movimento tropicalista possa essere considerata in qualche modo un’antesignana dell’attuale
“crossover” totale?
Senza dubbio: Tropicalia fu una sorta di risposta alla
controcultura inglese e americana dei Sessanta. Solo
che ce n’arrivava notizia attraverso i dischi, in modo
frammentario, e del “flower power” abbiamo afferrato soltanto la componente “flower”… Assimilavamo tutto ciò che potevamo, ed ecco perché la musica degli Os Mutantes è una specie di caleidoscopio
in cui trovi pezzi e frammenti di tutto ciò che ci ha
influenzato.
Ecco perché incarna splendidamente ciò
che è stato il Tropicalismo, ovvero prelevare elementi di altre culture e assemblarli in qualcosa di personale e unico.
Vero, per quanto non vi fosse alcunché di pianificato.
Volevamo soltanto suonare come Sly & The Family Stone e i Beatles. Nondimeno, col nostro
accento pesantemente brasiliano, cantare “I Wanto
To Hold Your Hand” sarebbe stata una presa in giro,
pertanto decidemmo di cantare nella nostra lingua madre. Considerando le esigenze commerciali
avremmo dovuto cantare in inglese, specialmente
per quanto riguardava l’album nuovo. Non era nostra intenzione, poiché la forza dei testi così è amplificata, suona bene. Il disco è nato così e sarebbe
stato innaturale tradurlo in un’altra lingua.
C’è un’ultima riflessione che mi piacerebbe fare con te sui Mutantes: sono sempre
stato dell’idea che la vostra forza risiedesse nell’unione tra libertà, sperimentazione e una serie di peculiari regole da
rispettare. E che questo sia il vostro inse-
gnamento più importante.
Certamente. Penso che restiamo una rock band anche se ci piacciono Picasso, Matisse o John Cage;
siamo sempre stati pieni di senso della melodia nelle nostre radici musicali - samba, bossanova… - e,
inoltre, mia madre era una pianista classica. Perciò
tutti questi aspetti sono parte di noi. La melodia e
i cambi repentini d’atmosfera e stile dei nostri brani sono elementi predominanti di ciò che facciamo;
cerchiamo di inserire su di essa qualcosa che non
abbia un temine di paragone preciso o immediato.
Il che, se sei d’accordo, è una cosa estremamente “brasiliana”
Assolutamente sì. Non ci piace restare incollati al
passato, desideriamo essere sempre in movimento.
È il nostro modo d’essere e di rispettare il pubblico.
TUNE IN
25
“Quando una canzone che viene fuori dal nulla finisce
per essere la tua preferita dell’anno ti senti veramente
spiazzato. Quando ho visto il video di The River è stato
proprio così. Amore a prima vista …e un primo posto
nella mia playlist di fine anno”. Ed Droste
parte le amicizie di cui vi diremo alla fine,
ammettiamo che l’aspetto che più ci piace
di Markland Starkie è il più semplice
e, se vogliamo, anche il più banale. Ci ha sempre
stuzzicato l’idea di una one man band come punto
di partenza per l’indie. Un moniker che, attraverso
delle regole ascritte (e successivamente disdette),
intraprende un cammino nell’oscurità sempre più
telematica d’oggi. Del resto, la pratica è la più comune tra i bedroom artist 2.0. Che siano di stanza
a Londra, Berlino, Portland o New York, poco importa. È un cliché ma pure l’aspetto più grande della
faccenda: nel piccolo (piccolissimo) e nello spazio
stretto (strettissimo) di una stanza c’è sempre qualcosa di eccitante, soprattutto se con tempo e registrazioni le cose s’allargano e arriva un momento
preciso nel quale gli equilibri si realizzano. L’indie
miracolo si compie.
È il punto a cui il ragazzo in questione è arrivato
e per giunta nel più classico dei modi, con il terzo
album. Un crocevia emozionale dove le atmosfere
acustiche lo-fi e il crooning sonnolento dagli accenni Fifties arrivano a un punto di sintesi, e dove
l’aplomb dimesso di Starkie porta fiori scuri e rigogliosi mettendo così il manico a quell’arma a doppio
taglio che sono gli abiti indie.
Il contesto è quanto mai cruciale per capire i modi
e le modalità. Mettendola con i soliti confronti della critica, ci viene naturale paragonare Markland a
quell’Owen Ashwort che tante soddisfazioni ha
regalato al mercato indipendente. Il ragazzone è il
personaggio che più si avvicina al britannico originario delle midlands che ora vive a Bristol, città dove
si è trasferito forse per amore, forse per saturazione londinese. E dunque Owen e Marlkland partono
dagli stessi presupposti: all’individualismo imperante
contrappongono un individualismo “differente” con
un Exit door che si chiama moniker e sotto il presidio del quale si stabiliscono regole e si disegna un
immaginario. Owen sceglie Casiotone For The
Painfully Alone. Canzoni tristi di chi è appena
stato mollato. Solitarie narrazioni cinematografiche
poi rese autobiografie. Starkie invece opta per Sleeping States, rifondandosi narratore zuccheroso
dai testi inevitabilmente agrodolci. L’immaginario
anni ‘50 scarnificato in un folk esistenzialista. Morbi-
A
Sleeping States
Lune Blu
Markland Starkie ha appena pubblicato un
piccolo grande manifesto di zuccherosa solitudine. Vi sveliamo tutto ciò che ci sta dietro e
non potrete più fare a meno di lui
- Edoardo Bridda
26
TUNE IN
do il timbro e claustrofobico il contesto/contrasto
di sola chitarra pronta ad accompagnarsi al noise, un
aspetto quest’ultimo ereditato dall’esperienza con
i Kaito (band che registrò un album, Band Red, su
Mute nel 2004), e sprazzi di minimalismo ereditati
dagli studi di Sound Art.
There The Open Spaces, la prima raccolta ufficiale
pubblicata nel 2007 dalla Tome, è l’oscura pietra angolare di cui, già al tempo, il Pitchfork, vicino alle
wav(v)es del caso, si accorge e strombazza. Nel frattempo, Starkie, di strada, ne fa parecchia: alle prese
con le solite cose dell’every indie kid, pubblica, su
svariate DIY label (Kontra Punkte, Homocrime e
Undereducated), sette pollici e casette, e ne mette
in circolazione una del 2004, uscita per la prima delle etichette appena citate.
È Distances Are Great, un album fedelissimo, di sola
chitarra e voce, a tratti persino a cappella, e non
c’è miglior spunto con il quale misurare la distanza
artistica con la nuova prova In The Garden Of The
North, uscita per Bella Union mentre vi parliamo. Se
gli inizi erano puramente indie folk le nuove canzoni
portano a destinazione le fascinazioni esotiche da
teen idol dei primi Sessanta a lungo covate. Parliamo
dell’American Graffitti, dell’Elvis cinematografico,
delle serenate Doo Wop e di tutto un immaginario
esotico che nella corde di Starkie si trasforma in un
manifesto di zuccherosa solitudine. In pratica è come
se avessimo a che fare con un Patrick Wolf rinunciatario del sempiterno amore Marc Almond
per i modi dell’Elvis di Blue Moon, oppure, un Jens
Lekman escapista e ligio sui Cinquanta delle radio.
E un talento così non poteva rimanere segreto nelle
maglie dell’ultra DIY a lungo. Amici come Simon
Taylor-Davis dei Klaxons e Ed Droste dei
Grizzly Bear lo hanno spinto in più di un occasione in questi tre anni, sia attraverso Pitchfork sia
con vere e proprie dichiarazioni d’amore. In particolare ci è piaciuto riportare in attacco quanto detto da Ed; a noi è successo lo stesso.
Se potessi scegliere, quali dischi porteresti in una mitica isola deserta? E dato che
la tua musica mi ricorda molto la fuga,
qual’è la tua escape song preferita?
Innanzitutto i dischi Evol - Sonic Youth, Book
of Sounds - Hans Otte, Rumours - Fleetwood Mac, Live at Filmore West - Aretha Franklin,
World of Echo - Arthur Russell. Per quanto riguarda la fuga ...fammi pensare. La prima che mi viene in mente è California di Joni Mitchell. Credo
TUNE IN
27
parli del desiderio di tornare a casa in verità, ma il
suo è comunque un desiderio di fuggire da dov’è. E
è una canzone deliziosa.
I dischi che hai scelto mi sorprendono.
Non è che mi aspettassi una rosa di crooner, eppure pensavo di trovarci almeno
una cantante degli anni ‘60 endash; o meglio endash; degli anni ‘50. C’era Aretha,
ok. E qualcuno potrebbe pensare che da
lei hai preso il soul… ma gli altri? Devo
dedurre che i tuoi gusti personali sono
diversi da quelli artistici?
28
TUNE IN
Hai chiesto i dischi che porterei sull’isola deserta e non
da quali dischi Sleeping States
è stato influenzato! È vero,
amo davvero tanto la musica di quegli anni, il Doo wop
e il Rock’n’Roll, i Flamingos, Frankie Lymon, Del
Shannon. Quel genere di
cose. Infatti, con quella musica sono cresciuto. Mio padre
ne era proprio un grande appassionato. Tuttavia devo contestarti: hai ragione fino a un
certo punto quando dici che il
mio gusto privato è diverso da
quello artistico, almeno in relazione a Sleeping States.
Una delle regioni per le quali ho scelto quel nome è circoscrivere area da esplorare.
E poi, riguardo a quei dischi,
vedo legami e influenze nel
maggior parte di loro. Certamente Arthur Russell e, nei
momenti più tranquilli, Evol
dei Sonic Youth.
Ho appreso dalla stampa che non sei di Londra
e quando vivevi lì ti sentivi solo. Il tuo ultimo
lavoro era quello di un
cuore solitario. Dove sei
nato e dove hai abitato dai vent’anni in poi?
Sono cambiati molto i
tuoi gusti da allora?
Sono cresciuto in un villaggio
vicino a un paese piuttosto
piccolo chiamato Stratford-on-Avon, situato sul
confine a Nord di Cotswolds, nel Midlands. Shakespeare è nato là e quindi è una cittadina molto turistica e come tutte le cittadine fatte in quel modo
era una noia mortale per un’adolescente grungey
come lo ero io. Mi sono trasferito a Norwich per
studiare, e dopodiché, dopo la laurea, a Londra, per
circa 6 anni. Lo scorso anno mi sono trasferito a
Bristol. Londra è stata meravigliosa ma, come tanti,
ho sempre provato odio/amore per lei. Ho avuto
bisogno di un cambiamento ma anche sono sicuro
che ci tornerò.
Per quanto riguarda il mio gusto musicale ha sicuramente visto grandi cambiamenti nei miei tardi teens, innanzitutto perché dove sono cresciuto avevo
davvero poco accesso alla musica. Ero molto appassionato ma era così difficile trovare qualcosa che
non fosse nelle charts. Frequentando l’Università
ho finalmente trovato la scena underground inglese e ho messo in moto la mia ossessione per l’indie rock americano. I miei gusti sono ripartiti da lì.
Dimenticavo, mentre abitavo a Londra, ho studiato
Sound Art entrando nel mondo della esperimentale,
da Tony Conrad ai sound artist come Raymond
Murray Schafer... Così suppongo di essere stato influenzato anche da loro.
Certo, il minimalismo spunta ogni tanto
nei tuoi arrangiamenti, la polpa ha molto a che fare con Tin Pan Alley e il Doo
Wop, specie nel tuo nuovo disco. Poi, dal
precedente, The River, mi fa pensare a
una versione b/w di Jonathan Richman.
E la differenza, infine, rispetto ai generi
storici, è che il tuo è folk stream, come se
il format di partenza venisse calato in un
flusso di coscienza…
Gardens Of The South è stata sicuramente influenzata
dal Doo Wop. Mi sentivo davvero romantico il giorno in cui l’ho scritta e, mentre scrivevo, pensavo a
quali fossero le mie love-song preferite. Le canzoni
erano tutte appartenenti a quei favolosi anni: I Only
Have Eyes For You, Smoke Gets In Your Eyes, canzoni
così, infinitamente kitsch ma, al tempo stesso, meravigliose e sincere.
A proposito di kitsch pensa a “Back To
The Future”. Le strofe Mr Sandman send me
a dream che accompagnano l’arrivo di MJ
Fox nella piazza... In fin dei conti, Back
To The future è un film sulla fuga…
Eh eh le mie canzoni spesso riguardano la fuga. Non
desidero di qualcosa migliore o diverso. È un approccio più aperto e fondamentalmente fantasia.
E anche nostalgia, certo, fantasia e nostalgia. Se c’è
un periodo di cui sono particolarmente nostalgico
quello riguarda la mia prima infanzia, la meta degli
anni ‘80 e i primi ‘90. L’underground americano di
quel tempo. Penso sia piuttosto normale per la gente riesaminare il periodo in cui è cresciuta, specie
quando l’età ti dà una maggior comprensione della
tua cultura e torni indietro a riappropriartene. Poi, è
vero, non sono più ossessionato come lo ero qualche anni fa, e non so se la musica contenga qualche
legame eighties. Del resto, ricevo ogni tanto parago-
ni con i Pavement, per cui…..
A proposito, ho letto che i Cocteau Twins
erano (sono?) la tua band preferita. Non li
vorresti nell’isola? Certamente c’è qualcosa di wave nel tuo disco precedente..
Loro sono sicuramente una delle mie band preferite. Non credere, ho fantasticato di portarli sull’isola
e se lo avessi fatto, avrei portato Head Over Heels, il
disco che preferisco. Alla fine non li ho inclusi perché quel disco è così intenso. Non potrei gestirlo
emozionalmente sull’isola deserta, mi sentirei troppo solo. I Cocteau Twins sono stati una grande
influenza per Sleeping States. I vocalismi della Fraser, ma soprattutto gli accordi di Robin Guthrie. La
gente parla sempre dalla voce di Liz come marchio
della band, eppure le chitarre di Robin avevano un
suono così caratteristico e autonomo.
Jens Lekman, Joan Baez, Elvis Presley,
Sondre Lerche, Patrick Wolf, Casiotone
For The Painfully Alone... a quale di questi ti senti più legato?
Ho suonato con Casiotone For The Painfully
Alone qualche anno fa ed è stato divertente ma
non conosco nessuno individualmente. Penso però
che la maggior parte di loro abbia una concezione
romantico malinconica di loro stessi. Fanno musica
che sembra profondamente rammaricata. Elvis? Che
paragone bizzarro!
Trovo il tuo modo di cantare molto particolare. Se suoni Morrisey in slow motion
forse troveremmo qualche legame ma la
cosa più importante è il fatto che tutti gli
artisti detti finora usano una percentuale
maggiore di mascolinità, un percentuale
più alta di glamour nell’accento. La cosa
più particolare del tuo timbro è che viene
fuori la parte femminile...
È interessante, in realtà da sempre preferisco le
cantanti femminili. Liz Fraser naturalmente, poi
Kate Bush, Stina Nordenstam, Patty Waters, Joni
Mitchell ...c’è qualcosa di speciale in quelle voci.
Penso sia difficile per gli uomini approcciare uno
stile più emozionale, femminile, senza dar l’idea di
esagerare. Ovviamente non è impossibile: pensa a
Arthur Russell o a Scott Walker per citarne alcuni. Eppure è vero. Sono più attratto dalle cantanti
femminili e non ho mai pensato che il mio canto lo
esprimesse. Sono molto contento che lo hai colto.
TUNE IN
29
S
Tropical rain
washed my brain
Quando anche l’Italia dell’estate 2009 sembra essere ormai sulla via del
monsone, tra afose ondate di calore e bruschi rovesci torrenziali, un nuovo
fenomeno si affaccia nell’underground americano...
- Stefano Pifferi, Antonello Comunale
30
DROP OUT
arà capitato spesso nell’ultimo periodo, anche agli ascoltatori/lettori meno attenti alle
evoluzioni del sottobosco musicale americano (ma non solo), di imbattersi in un termine
accostato alla proposta musicale di nomi sempre più
sulla cresta dell’onda. Di cosa stiamo parlando? Ma
del termine che da il nome a questo nostro scritto:
tropicale, ovviamente.
È successo un annetto fa quando qui a SA tentammo di investigare la scena/non scena ruotante
intorno allo Smell, locale losangelino, fulcro irrinunciabile per chi ama le musiche meno ortodosse della west-coast e non. A quel tempo, nemmeno troppo per caso, visto che partimmo proprio dal loro
Skeleton per la nostra indagine, ci imbattemmo nel
tropical-punk degli Abe Vigoda, quartetto ibrido
ispano-americano con un nome dal sapore cinematograficamente minore e dal melting-pot musicale
letteralmente da sballo. Quasi nello stesso periodo, ma virati verso tutt’altre coordinate spaziotemporali, facevano un limitato botto underground
- stavolta dall’altra parte degli Usa, costa est, NYC
guarda caso - i Vampire Weekend. L’upper west
side soweto music del quartetto newyorchese brillava come un caleidoscopico mesh-up tra solare
indie-rock e suggestioni afro-beat, imbevuto fino
al midollo di input che toccavano reggae, aperture
soul, slanci afro-pop; tutte sensazioni altre rispetto
ai canoni di genere che rappresentavano la marcia
in più di un quartetto giustamente magnificato un
po’ ovunque.
Questa sorta di trasversale e bislacca tendenza
al tropicalismo eterodosso sembra essere riemersa ultimamente nell’underground americano più
oscuro e carbonaro; quello, per intendersi, del diy
2.0 che si nutre di cd-r serigrafati e microetichette
home-based, hype da blogosfera e tirature limitatissime, oltre che di una certa predilezione per formati desueti ma sempre affascinanti (i 7” vinilici e le
cassette ne sono un perfetto esempio). Un sentire
comune - differenze stilistiche a parte - che ha evidenziato (come nel caso di Hexlove, approfondito
nel numero estivo di SA) una particolare e, in alcuni
casi, travolgente fascinazione per ambientazioni a
metà tra psichedelia pop e suggestioni equatoriali,
pronto a dilagare in maniera tentacolare in ogni direzione musicale.
In molti casi, sono le assolate spiagge estive piuttosto che le intricate e selvagge giungle tropicali
ad essere omaggiate. Dimostrazione palpabile di
questo atteggiamento è la compilation low-cost - e
relativo mini festival in quel di NY - della Underwater Peoples il cui programmatico titolo Summertime Showcase rende appieno l’idea di vera e propria
bibbietta senza pretese di completezza; una compila che inanella una serie vincente di proposte tutte ruotanti intorno ad una specie di rendition del
Beach Boys sound sporcato da attitudine lo-fi e
depravazione post esplosione punk, in altre parole
il decantato beach-pop di Real Estate, la California guasta di Frat Dad, la pop-delia liofilizzata di
Family Portrait, gli immancabili abbozzi multiformi di Ducktails; tutti a offrire quadretti pop
da cocktail con ombrellino, palme ombreggiate e
droghe leggere. Ad inaugurare la compilation un altro personaggio niente male: Julian Lynch, sorta
di cantautore weird già avvezzo alle frequentazioni
“tropicali” (un 7” su Underwater Peoples spartito
con Ducktails), piuttosto incline alla ballata triste da
tramonto sulla spiaggia e dall’immaginario inacidito,
capace di alternare brevi pop-song ad aperture più
dilatate sul versante psych. Se ne riparlerà un po’
ovunque, vedrete.
Anche le derive più weird del suono weird non
sono rimaste immuni dall’esplosione colorata del
nuovo tropicalismo, in questo caso (semi)digitale.
Rainbow Arabia, ad esempio. Duo californiano
che mette sul piatto electro distopie in salsa afro
non lontane da Animal Collective: un mix di
dancey sound e world music andata a male che rimanda, sin dal nome, a un immaginario orientaleggiante. Le comparsate fotografiche al limite del fake
terrorismo stanno attirando su di loro attenzioni
anche extramusicali. Sulla falsariga dei due californiani si muove Truman Peyote, altro duo stavolta from Massachusetts caratterizzato da un nome al
limite del fantastico e da un taglio sonoro insieme
più infantile e synthetico, qualcosa che fa venire in
mente l’idea di un “rave in cui non si balla” e insieme
quella di una ludoteca di Brazzaville presa d’assalto
da un’orda di imberbi musicisti.
Questa breve e limitata carrellata per dirvi che
ce n’è per tutti i gusti, a dimostrazione del fatto che
la generazione del terzo millennio non la smette di
cercare una fusione suprema con la natura attraverso macchine e cavi, gingilli e tecnologia. Quello
che a noi interessa è però come l’aspetto “tropicale” trovi la sua perfetta messa a fuoco in un humus
più prettamente psycheweird; non tanto per provenienza - il circuito è quello e spesso e volentieri,
ehm, cortocircuita con presunte “scene” limitrofe
- quanto proprio per messinscena musicale: più diDROP OUT
31
latata, aperta, trance-inducing, insieme iridescente e
volubile. In grado di evocare i mille contrastanti stati
d’animo che il trovarsi a contatto con la natura, con
quella natura, può provocare.
Giunti a questo punto sarebbe lecito chiedersi
cosa mai possa essere questo “suono tropicale”.
Beh, cominciamo col dire che non di un suono si
tratta, bensì di una sorta di suggestione che rimanda a questioni di meridiani e paralleli, anzi, ad esser
precisi all’area che delimita il parallelo più lungo in
assoluto del pianeta.
Nel tentativo di trasporlo in musica, c’è nelle
musiche dei gruppi che prenderemo in questione
una forte suggestione che rimanda proprio all’equatore e agli equidistanti tropici del cancro a Nord
e del capricorno a Sud: che sia quello amazzonico
rigoglioso e variopinto o quello misteriosamente
intriso di alterità del sud-est asiatico, quello pregno
di selvaggio misticismo delle civiltà precolombiane
o ancora quello oscuro, materno e insieme minaccioso dell’Africa nera, poco importa.
Certo, i precedenti per questa fascinazione non
mancano, anche limitandosi alle chitarre o saltando
a piè paro tutto il jazz spirituale che da lì viene e lì
ha sempre cercato di ricondursi. Se però si dovesse pensare all’attrazione per le musiche tribali e/o
genericamente afro-percussive che fece la (limitata)
fortuna di certo post-punk made in England, o al
terzomondismo arty di band come Talking Heads e via imitando, si sarebbe perso di vista il vero
obbiettivo dei progetti qui trattati. O per lo meno
lo si sarebbe ristretto alquanto. I suoni dei presenti
infatti, non rimandano ad un mood africofono (ché
spesso se non sempre al parlare di tropicale viene
in mente solo il continente nero) né si riallacciano
a musiche da lì provenienti limitandosi a risemantizzarle a seconda del gusto dominante. Quelle in
questione puntano dritte dritte proprio al suono
della natura più rigogliosa e selvaggia, quello che si
incontra per l’appunto in una foresta pluviale amazzonica. Un coacervo di suoni e colori che sembrano
impazzire in ogni dove, provenire e al tempo stesso dirigersi verso ogni direzione, rimandando a una
dimensione panica, di comunione con la natura, di
alterità ricercata e sognata.
Così, tra correnti in continuo mutamento, sempre sul crinale della weirdness più oscura - più per
produzioni e circolazione che per suoni, in verità abbiamo eletto qualche nome che crediamo possa
simboleggiare questa trasversale tendenza al “suono
tropicale”. Due piuttosto noti, stante una discogra32
DROP OUT
fia ormai sostanziosa e un apprezzamento crescente, e altri due alle prime armi, ma non per questo
inferiori: Sun Araw e Ducktails da una parte, e
Universal Studios Florida e High Wolf, l’ala
in ascesa dall’altra. Luoghi di provenienza e traiettorie personali piuttosto diverse, ma una comune
sensibilità tropicale. (SP)
Sun Araw - Tropic Of Beach
Non è lo “Stallone Italiano” dei vecchi film di Rocky,
quello cresciuto inseguendo le galline nei cortili e
prendendo a pugni i quarti di manzo appesi dal macellaio. Cameron nelle sue vene le ha le influenze
mediterranee, bisogna però cercarle nella poltiglia
chimica con cui è venuto su… tra hashish e marijuana e qualcos’altro... In più mettici i baffetti da
messicano e il quadro di un perfetto deragliato dei
nostri tempi è completo.
Uno che manco a farlo apposta si è costruito
gran parte del suo credito nella fitta rete dei blog.
È questa la vera fama 2.0 o comunque un indice
preciso dei nomi da hype da (s)caricare, seguire e
maledire. Cameron si era comunque già fatto notare nei Magic Lantern formazione psichedelica
californiana non a caso approdata sulle sponde sicure e ormai carismatiche della Not Not Fun, a cui
fa seguito il progetto solista Sun Araw. Il Nostro lo
avvia quasi di nascosto. Un discorso musicale che, se
pure deve qualcosa alla classica psichedelica chitarristica del suo gruppo, se ne discosta poi per tutta
una serie di motivi. È un profilo assai diverso quello
di Sun Araw, progetto solare già a partire dal nome,
dove quello che rimane delle sacre reliquie del suono californiano viene inacidito fino a livelli inauditi,
andando a parare a due passi dalla drone music. Non
a caso, può essere inserito comodamente nella moderna ondata drone folk: suono della chitarra che
vibra su effetti elaborati per durare un’eternità del
tutto apparente, il tutto unito ad una generale aria
di stasi onirica. Cameron è uno che contamina, mischia, miscela le varianti più desuete e anomale per
il settore che si è scelto e quindi riesce a suonare
originale o quanto meno particolare. Come dire…è
uno che si fa notare nella mischia. Il risultato inizialmente è ancora timido. The Sphinx, primo parto
discografico ufficiale, è ancora largamente ancorato
al taglio classico dei Magic Lantern, salvo allontanarsene quando il piglio da drone project prende il
sopravvento. Cita Syd Barrett e Skip Spence
come fari del progetto, ma è con la successiva release che, togliendosi di dosso paragoni ingombranti,
sun Araw
riesce a quadrare il cerchio. Trattasi di Boat Trip
un minimal ep su Woodsist che in solo due pezzi
traccia il profilo del “tropical drone”, un’etichetta di
comodo per dire sin da subito dell’aria afosa che si
respira tra questi brani e del taglio estivo/assolato
che possiede la musica. L’immagine di copertina fa
gioco di sponda e restituisce il profilo di una musica che potrebbe andare bene tanto nel più fumoso
coffee shop di Amsterdam, quanto nella più scassata
e funesta capanna di una spiaggia ai tropici. I riflessi dub e gli echi metafisici alla Horace Andy si
innestano su una musica che non respira altro che
aria viziata, vittima di una chitarra che non è mai
men che effettata e di un quadro tropical-caraibico
che stride non poco con il piglio dark di altri act
del drone-folk 2000. Il progetto Sun Araw si codifica
così sulle coordinate solari del vicinissimo secondo
disco pubblicato su Not Not Fun che, a scanso di
equivoci, si chiama Beach Head. Il taglio della chitarra non potrebbe essere più personale, mentre la
maggioranza dei risvolti dub dell’ep lasciano il posto a contorni più liquidi e sognanti. Cameron si
fa in qualche modo prendere la mano. Sa di avere
le capacità per produrre atmosfere ipnotiche senza
ricorrere al solito immaginario di settore e riesce a
produrre gioielli come Horse Steppin, congegno ad
orologeria dello Stallones pensiero: chitarre liqui-
de che mimano un raggae iper drogato, mareggiate
onomatopeiche d’organo, ritmiche che procedono
per passi felpati e una voce effettata che fa il verso
a decenni di suoni giamaicani. Messi da parte Syd e
Skip stavolta i fari verso cui tendere sono piuttosto
Scientist e Lee “Scratch” Perry. Da qui in
poi Sun Araw innesta una sorta di pilota automatico
guidato dal codice che si è autocostruito. È sempre
riconoscibilissimo, sia quando dà una mano ai Vibes con una passata di organo, sia quando, insieme
a Bobb Bruno, allarga la visione delle Pocahaunted nel recente Passage.
E siamo agli ultimi sussulti in ordine di cronologia: Heavy Deeds recentissimo terzo disco lungo che
si muove su coordinate più smaccatamente funk,
sulla scia tanto del progetto Vibes, quanto su quelle dei recenti Sunburned Hand Of The Man
prodotti da Four Tet, il tutto ovviamente riletto
alla maniera di Sun Araw, quindi con irrefrenabili riverberi da sogno e con i wah-wah virati al sogno di
un’estasi tropicale. (AC)
D ucktails H ypnagogic S ummer
Non più tardi un mese fa sulle pagine di Wire, David Keenan diffondeva per il mondo il nuovo verbo
dell’Hypnagogic Pop, strambissima e sconclusionata
DROP OUT
33
etichetta di settore, che da un lato tenta di inquadrare un gruppo di musicisti sotto uno stesso ambito e dall’altro cerca, neppure tanto velatamente, di
ripetere il successo di passate definizioni come Post
Rock e New Weird America. David non ha dubbi su
cosa sia l’hypnagogic pop: “È pop music riflessa attraverso il ricordo di un ricordo. Prende la sua forza dalla
cultura pop degli anni ‘80, anni in cui molti dei musicisti
del genere sono cresciuti, e che adesso investe la musica
underground come un’influenza spettrale. I regni hipnagogici sono quelli tra la veglia e il sonno, zone limite in
cui sussurri e allucinazioni concorrono alla formazione
dei sogni”. E dopo cotanto excursus teorico ecco
pronta la lista degli esponenti del genere, secondo
il suo inventore: in primis gli Skaters di Spencer
Clark e James Ferraro con tutti i loro progetti collaterali, e poi Pocahaunted, Emeralds, Zola
Jesus e tra gli altri anche i Ducktails o comunque
tutti i progetti di Matthew Mondanile.
Per quest’ultimo l’omaggio agli anni giovani
è insito già nel nome della band che fa il verso al
cartone animato della Disney epoca 1987-90, chiamato per l’appunto Ducktales. Secondo le teorie
di Keenan quella di Mondanile sarebbe una visione
espressamente post-Skaters, forse riducendo però
un po’ troppo il discorso. Trattasi di un giovanotto
post epoca arcade che vive in un’apparente estate
perenne. Da qui sviluppa tutto il suo immaginario
caraibico-tropicale che si anima su minimal beat
elettronici da videogame atari anni ‘80. Le sue sono
tutte musichette possibili di estati impossibili o ormai metabolizzate sulla lunga distanza, ergo una pesante cappa di nostalgia che illividisce anche ariette
in apparenza gioiose. Il primo disco ufficiale, pubblicato manco a farlo apposta su Not Not Fun vede
la luce nella primavera del 2009, ma altro non è che
un raccoglitore / compilation di una discografia già
ricca di episodi, per lo più in tono minore, ovvero su
cassette e cdr limitati. Di contro il primo disco vero
e proprio a firma Ducktails è in procinto di essere
pubblicato proprio in questi giorni su Olde English
Spelling Bee con il titolo di Landscapes. Per inquadrare l’orizzonte visivo e il background che muove
le musiche dei Ducktails basta scorrere un elenco
qualsiasi dei brani: Beach Point Pleasant, Pizza Time,
Tropical Heat, Let’s Rock The Beach, Boating, Island Flavor. E si procede di questo passo anche con l’estetica di corredo degli artwork, con l’ormai celebre
e riconoscibilissima foto della palma californiana a
fare da contorno: “La foto della palma sulle pubblicazioni dei Ducktails fu scattata da me quando ero in
tour in California. C’è l’altra foto che ho fatto di questa
ducktails
palma finta e che fu fatta mentre ero in questa festa
ad Amsterdam. Credo che sia stato un modo per avere
come un’immagine o un simbolo, perché non significano
molto per me, ma mi piacciono per come appaiono esotiche ai miei occhi”.
Mondanile divide gran parte delle sue visioni con
il compagno d’arme Julian Lynch, fresco fresco di
un disco autonomo e in proprio sotto l’egida della
Olde English Spelling Bee e ribattezzato Orange You
Glad. Di contro il Nostro ha già dato ampia prova
di non voler essere conosciuto solo attraverso il
progetto Ducktails. Suoi sono anche i suoni che si
nascondono dietro l’appellativo di Predator Vision, che di recente ha pubblicato uno split ep di
tropicalismo dronato con Sun Araw e che deve il
suo appellativo “alla visione del film Predator mentre
ascoltavo soft-rock di Fleetwood Mac, Paul Simon e
Todd Rudgren”. Altro progetto da tenere sott’occhio
è quello dei Real Estate, dal piglio molto più canonicamente indie-rock, che se per il momento non
ha prodotto molto al di là di un paio di ep e di 7”
potrebbe fare un discreto successo una volta approdato ad una release ufficiale sulla lunga distanza.
Infine, giusto per strizzare l’occhiolino agli Skaters
e ai loro infiniti progetti collaterali, ecco l’ultimo in
ordine cronologico, quello dei Parasails che hanno pubblicato una recentissima cassetta intitolata
Skylife che così viene descritta nelle note stampa
di presentazione: “Come Join us 500 feet above the
Atlantic Ocean for the 1982 Summer Season. Enjoy the
views of your favorite Beaches and wave to your friends
below as you check out schools of Sealife. Parasails is
a new project from purveyor of feel-good tunes, Matt
Mondanile (Ducktails, Real Estate). More of the lo-fi,
tropical nostalgia his fans have come to expect, but this
time instead of sitting on the beach sipping on margaritas, this tape takes you for a dream-like flight above the
coastline”. (AC)
U niversal S tudios F lorida C inematografie tropicali
Il primo tra i progetti più giovani del lotto prende
in prestito il nome dal parco di divertimenti a tema
cinematografico di Orlando, Florida per l’appunto,
pur provenendo esattamente dall’opposto estremo
degli Usa, Seattle. Sono in due e amano il digitale.
Sono weird e su questo pochi dubbi. I loro nomi di
battesimo sono Jason Baxter e Kyle Hargus, e per
dar vita a Universal Studios Florida non usano molto
più dei propri laptop e qualche pedale/effetto (Kyle
un mac e Jason un pc, tengono a far sapere sul loro
34
DROP OUT
myspace), eppure imbastiscono un suono realmente
denso sia di direzioni musicali, sia di riferimenti più
o meno espliciti. Un vero caleidoscopio che esplode
letteralmente in una selva di suoni legati gli uni agli
altri nell’ottimo Ocean Sunbirds, dal procedere
cumulativo (e per stratificazione) non così lontano
dalla vecchia conoscenza di SA, Zac Nelson a.k.a.
Hexlove. Quando chiediamo loro di presentarsi
ai lettori italiani, ecco cosa ci rispondono: Siamo
due studenti dell’Università di Washington di Seattle, entrambi lavoriamo alla radio del campus, la Rainy Dawg
Radio. Abbiamo iniziato a lavorare seriamente sulla musica in duo poco meno di un anno fa…. Insomma, per
farla breve, tipiche storie da (post)adolescenza a
stelle e strisce: prima amici, poi compagni di stanza
all’università, infine colleghi di lavoro e finalmente
duo sull’onda delle affinità elettive in campo musicale. Sì, perché i due USF sono molto giovani, ma
anche piuttosto lucidi. Sia per quello che riguarda il
terreno su cui lasciar germogliare la propria sensibilità musicale, sia per le potenzialità elaborative su
un suono abusato come quello psycheweird. Ammiriamo molto la musica che esplora la densità sonica,
come Our Sleepless Forest e Tortoise. Graceland di
Paul Simon è stata una immensa influenza per ciò che
riguarda melodia e suoni di chitarra, così come Sea
Lion di Ruby Suns. Siamo anche grandi fan di Brian
Eno, in particolare per gli album di ambient textures
come Ambient 4. Un ottimo disco dello scorso anno
è stato l’omonimo debutto di High Places; hanno un sacco di fantastiche tecniche per creare suoni percussivi
unici.
Chiediamo poi se esista una assonanza tra questo magma indefinibile che abbiamo per comodità
chiamato “tropical sound” e il loro primo full-length
Ocean Sunbirds: È stato orientativamente a metà
del nostro percorso creativo che ci siamo resi conto che
stavamo assemblando un album “tropicale”, quindi ci
fa piacere che sia stato notato; volevamo fortemente
costruire un mood lungo tutto il disco, qualcosa di naturale e nostalgico, e rimpolpare quel tipo di idee che
cercavamo di esplorare già nel nostro ep….
Alla base di un disco organico e coeso come Ocean Sunbirds vi è l’idea di un continuum “naturale e
nostalgico”. I due lo ribadiscono più volte durante la
nostra chiacchierata: la loro è la ricerca di un suono
che sia globale, magmatico, onnivoro e cangiante, in
una parola, quello della natura. Questa idea di suono
è rintracciabile in forma embrionale già nell’omonimo ep di debutto, edito anch’esso da Little Furry
Things. Il cd-r, seppur non pienamente focalizzato,
DROP OUT
35
ha il pregio di mettere in luce quegli aspetti che verranno successivamente elaborati nell’esordio lungo:
una musica evocativa creata sul crinale tra digitale e
analogico che rimanda a quiete distese lagunari nello stesso modo in cui evoca maelstrom synthetici
da dancehall in disfacimento. L’ep era essenzialmente
una collezione di idee e canzoni che si sono evolute in
maniera naturale. Per il primo disco invece volevamo
fare qualcosa di veramente coeso, canzoni che suonassero più connesse e legate. I nostri sforzi iniziali andavano verso la direzione di jam stratificate e così volevamo
sviluppare quelle sensazioni in modi differenti, mixando
elementi di generi diversi per ottenere un effetto cumulativo. Abbiamo cercato di creare un’aura intorno ai suoni che credevamo essere troppo lineari nei pezzi dell’ep,
bilanciando le melodie principali con sottofondi più ampi.
Mano a mano i suoni della natura hanno cominciato ad
affacciarsi nella nostra musica e abbiamo finito con lo
scegliere il titolo Ocean Sunbirds per sottolineare
le atmosfere liquide e le melodie ondeggianti.
L’effetto è assicurato. La forte impronta digitale avvicina il suono dell’album certe volte ad una
glitchtronica d’ambiente, mai invasiva eppure lussureggiante, altre volte a intricati e devastanti frattali
sonori in cui convivono ritmi a bassa battuta ballabili in comunione col paesaggio naturale. E sembra di
vederli, due sbarbati americani buttarsi a peso morto
sui delay (DD-20 Boss GigaDelay Pedals, precisano
orgogliosi) per costruire live loop circondati da un
vorticare di fronde e da improvvisi stormi di uccelli variopinti volare via in mille direzioni diverse. Se
riuscite ad immaginare il suono di una sala chill-out
abbandonata e completamente avvolta dalla vegetazione, beh, non siete poi così lontani dall’universo
di USF. (SP)
H igh W olf - A lla
dell ’A ltrove
ricerca
È alquanto paradossale che la nostra indagine sul
nuovo tropicalismo weird prenda le mosse dall’ultimo arrivato High Wolf, ma è così. Più precisamente da Tropical Rain Washed My Brain, traccia iniziale
dell’omonimo cd-r su Winged Sun. O forse, come
vedremo più avanti, non lo è.
Ma chi è High Wolf? Non solo l’ennesimo soloproject trattato in questo speciale - dimostrazione
vivente che lavorare da soli riesce meglio, specie in
ambito freak o weird - ma anche l’unico non americano tra i progetti presi in considerazione. Well
I’m from France…living in France… risponde laconico l’unico responsabile della sigla: Max, cognome
36
DROP OUT
sconosciuto come da almanacco del nascondismo
2.0, amicizie altolocate e conoscenze nei giri weird
giusti oltre che numerose esperienze alle spalle (altrettanto ignote, se ve lo stavate chiedendo). Beh,
ho avuto qualche altro progetto, roba droney, musica
psichedelica…ma non voglio mescolarli e preferirei rimanere anonimo. Penso sia meglio per chi ascolta focalizzarsi unicamente sulla musica. Comunque sia ho
cominciato a suonare da adolescente, prevalentemente
col computer per poi, passo dopo passo, comprare e
stratificare strumenti ed effetti.
Malgrado l’overdose da “animale nel nome della
band” possa risultare letale, scommettere su HW
non si rivela una mossa sbagliata. Il ragazzo - armato
di synth analogici, tablas, chitarra, voce, drum machine e tanti, tantissimi effetti - ci sa fare e sembra avere idee piuttosto chiare in quanto a progettualità e
ottime capacità creative. A dimostrarlo l’aver partorito in pochi mesi - in formati desueti, obviously - una
manciata di release interessantissime per etichette
quali Not Not Fun e Stunned, suonato live (poco in
verità) con Pocahaunted e Sun Araw spalleggiato da
pezzi grossi come Jani Hirvonen (Uton) e Ben Reynolds e collaborato con mostri sacri del sottobosco
americano (uno per tutti, Neil Campbell aka Astral
Social Club con cui è in uscita un vinile a quattro
mani). Niente male vero?
Influenzato da “lupi e spiagge, totem e spiriti, pacifismo ed eclissi” tanto quanto dalla scena weird americana (da Skaters a Emeralds e Animal Collective, li
cita tutti) e da mostri sacri ovvi quanto imprescindibili come Sun Ra e Miles Davis, il suono di HW parte
sostanzialmente da una base molto psichedelica per
poi muoversi in mille direzioni contemporaneamente. Reiterato e sognante, evocativo e percussivo, rigoglioso e tropicale, ovviamente. Questo in soldoni
ciò troverete avventurandovi nell’ascolto del nastro
Animal Totem - nomen omen, verrebbe da dire - col
quale ha da poco esordito per Not Not Fun. L’unica, ossessiva melodia degli 8 minuti dell’opener The
Boto immette in un vortice sensoriale in cui il forte
retrogusto sciamanico e trance-inducing si materializza in intricate visioni di foreste tropicali, coloratissime e lussureggianti. Il successivo cd-r omonimo
- sull’etichetta personale Winged Sun - raggruppa
registrazioni precedenti al disco per NNF e ne reitera la raffinata e intricata psichedelia semi-mistica.
L’immaginario tropicale è evocato sin dai titoli: la
citata Tropical Rain Washed My Brain, Red Ants Around
My Neck, Aztec Pyramids procedono ondivaghe lungo
i tropici rimbalzando tra le foreste pluviali amazzoni-
che e centroamericane e quelle del sud-est asiatico,
quasi a rievocare ipotetiche linee di continuità tra le
varie civiltà che si sono succedute nell’area dei tropici nel corso dei secoli. A strettissimo giro di posta
altre release hanno poi confermato la bontà della
sue proposta: innanzitutto la doppia cassetta Essential
Elemens (su Stunned) condivisa con Altar Eagle,
Caligine e Pillars Of Heaven, ma soprattutto
l’altra tape per Winged Sun, Gabon: 3 brani per una
mezz’ora scarsa che rovesciano la prospettiva sonica
di Animal Totem. What’s the difference between
Amazonian and African jungles? When we live in the wild,
with percussions and tribal singing, wère all the same…,
questa la chiave di lettura suggerita da HW/Winged
Sun nella presentazione del nastro per collocare i 3
lunghi pezzi sempre sul filo dell’equatore, ma traslandoli verso il cuore dell’africa nera, quella più sinistra
e insieme materna. A venire esaltato è il battito ancestrale nella reiterata percussività del lato A. Almeno
in apparenza HW si accoda alla lunga scia della psych
più stramba e fuori di testa prodotta negli States da
un buon lustro a questa parte. C’è però qualcosa che
ce lo fa preferire ad altri nomi, nonostante la giovane età e non solo per l’ovvia vicinanza ai modelli di
riferimento, spesso e volentieri citati in questo articolo. Sun Araw è stata ovviamente una grande scoperta
perché mi ha dimostrato come fare musica psichedelica
come una one-man band […] Anche Magic Lantern hanno avuto la loro influenza, così come la scoperta di Astral
Social Club: il suo modo di usare loop ritmici, di mischiare
beats con suoni sperimentali è una cosa nuova, che supera i confini e crea un nuovo sentiero che cerco e spero di
seguire. Quella di HW è musica che nasce, però, dalla
reale frequentazione di mondi altri rispetto a quelli
occidentali: Il principale scopo della mia vita è viaggiare,
l’anno scorso sono stato in Asia per alcuni mesi e credo
che questo sia stato l’evento principale che ha portato
alla nascita di HW. Tutta quella musica che ho ascoltato
in India, tutti quei nastri nei bus in Nepal, i colori e gli odori di ogni posto, gli orizzonti tropicali dalla Malaysia alla
Tailandia, il cibo…Mi ha definitivamente cambiato.
HW possiede un sentire musicale lucido unito ad
una riflessione filosofica non di poco conto. Ci piace quando tira in ballo, a mo’ di pietra angolare per
le sue musiche, la bellissima opera di Henri Michaux, Altrove (Quodlibet, 2005). Quella di HW non
è propriamente musica tropicale, ma suona esotica per
una serie di ragioni. Un poeta e scrittore francese piuttosto famoso, Henri Michaux ha scritto alcuni diari di
viaggio molto interessanti durante i suoi viaggi in Asia e
sud America. Ha però scritto anche un favoloso libro dal
titolo Ailleurs che è un finto diario di viaggio in cui egli
inventa luoghi, etnie e tribù con rituali specifici. Mi piace
pensare a HW nello stesso modo. Ascolto un sacco di
musica occidentale e non, cercando di mescolare le due
influenze, consciamente o inconsciamente, per creare
una musica globale moderna per un paese o una tribù
immaginaria. Mi piacerebbe essere l’Omar Souleyman di
una civiltà perduta o proveniente da un altro pianeta.
La ricerca spasmodica di nuovi mondi, reali o immaginari che siano; la necessita di fuggire dalla propria
quotidianità, la capacità di confrontarsi con l’alterità
si manifestano nella forza creatrice che spinge ogni
artista a modellare un mondo possibile anche attraverso i suoni. La chiosa di questa limitata indagine
non può che spettare a lui: In definitiva credo che
questa tendenza tropicale sia il bisogno di essere creativi e nello stesso tempo in fuga dal quotidiano.Vivendo in
città fuggo spesso con la mente verso giungle, spiagge,
montagne; se vivessi in un’isola deserta forse farei musica industriale! In definitiva, è il significato più esatto della definizione “tropicale”. (SP)
high wolf
DROP OUT
37
Vladislav
Delay
Post Jazz
Dodici anni di carriera dieci dei quali
passati chino sul laptop. Ora Sasu
Ripatti dal suo eremo di Oulu volta
pagina. E a computer (quasi) spenti.
- Edoardo Bridda
L’amore per il Jazz, e per Miles Davis in particolare, non è un segreto per chi segue Sasu Ripatti negli
svariati alias, specie con quello di Vladislav Delay. Eppure un aspetto meno noto della biografia del
musicista finlandese emerge con forza proprio ora che il mercato accoglie Tummaa, lavoro di svolta non
drastica ma decisa, album il cui shifting riguarda il suonato piuttosto che il suono: in sostanza un progetto
gruppo.
Non è poco per un musicista elettronico definitosi da sempre antisociale. Note sono le dichiarazioni che da
almeno un paio di anni circolano nei magazine e sulla rete: “Il prezzo della libertà e della perfezione è un sound
riconducibile a un plug in. Lo stesso che tutti utilizzano” (Resident Advisor, 2007), ergo l’antidoto ha per forza a
che fare con l’imperfezione, per così dire, di gruppo, la via da percorrere un “glitch vissuto”. Tutto chiaro, o
quasi, e ci ritorneremo, ma se ripercorressimo la storia daccapo alla luce delle informazioni dei ben informati della All Music Guide? Tutto inizia dalla frustrazione di non essere riuscito a formare una band. Illuminante.
Ma siamo nei pieni Novanta, non dimentichiamolo. Il boom digitale. Internet. Ricordate le promesse fatte dai
media, addirittura moltiplicate in campo musicale? Ok Computer fammi diventare il Dio suono, fammi cam38
DROP OUT
pionare qualsiasi cosa e distruggerla, assemblarla, moltiplicarla. Sovrainciderla. Soprattutto
fammi spendere poco. E possibilmente real time, come nel telefilm 24. In pratica, nel ’96 Sasu
ha vent’anni e il famoso click and cut nato dalle cose di Oval è al massimo del cool, specie
nel Nord Europa. E se ci imbarcassimo in una delle nostre solite divagazioni? La formazione
avrebbe sicuramente contemplato macchine e strumenti, proprio come andava di moda a
Berlino (To Rococo Rot, Tarwater, Barbara Morgenstern, la Scape Records ecc.).
Residenza inforcata giusto due anni dopo, ma ora a Helsinki e prima a Oulu è tutto un riff di
Black Metal e chitarre al vento stile Air (e non parliamo della band). Non c’è verso di metter
in piedi un progetto così cosmopolita, da squat e mostra con installazione multimediale.
Inoltre Sasu ama il jazz e vuole provare una cosa che lui chiama post jazz. Nel mix ci vuole
anche il dub e tanti ritmi, cassa dritta e pure della world. A lato, ricordiamo che essere indie
in Finlandia significa cose diverse rispetto ad altre parti del globo. L’indie, l’underground, è
unicamente nella capitale e il farne parte significa techno e non la cricca pop o rock che
sia. Sähkö Recordings, residente nella capitale finnica, è la risposta. Cassa in quattro ultra
minimal, brand che l’intellighenzia europea sta già apprezzando (vedi Wire). Inoltre, c’è una
piccola scena rave tra i ghiacci di Helsinki, mi ricorda Ilpo Väisänen. Al tempo è lui stesso
a organizzarne qualcuno, e l’amico Mika Vainio incide per proprio per loro sotto l’alias
Ø. È il pre-Pan Sonic, roba da uscire pazzi, battito glaciale, claustrofobico, sound che per
le orecchie di Ripatti rappresenta uno degli aspetti della propria terra dove “niente accade
veramente” (Väisänen cit.) e il ritmo quotidiano veglia/sonno è pesantissimo.
Eppure per il futuro Vladislav Delay il suono infinito è un continuo stimolo all’addizione. Un
batterista jazz studiato fin dalla preadolescenza come lui non può prescindere dalla voglia di
lavorarlo, puntellarlo e riprenderlo continuamente ai fianchi. E questa volontà è anche viaggiare: attraverso numerosi viaggi, il drummer scopre sapori e particolarità del percuotere,
tutte esperienze peraltro assimilabili al connazionale Lassi Lehto / Jimi Tenor. In comune
tra i due la voglia di sapori caldi, di soul e funk, una rarità per i musicisti nordici, specie elettronici. Per Sasu è il risuonare della singola battuta, la restituzione del timbro, l’unità minima
del desiderio. Brasile, Cuba, Giamaica e Africa sono le mete preferite e così pure i terreni
del suonato prediletti, tutti ricollegati al modello jazz per eccellenza, Philly Joe Jones, il
batterista preferito di Davis che già dai quattordici anni è anche il suo.
Jones è noto come Machine Gunner per via della precisione e di una rara capacità di suonare
forte senza perdere in timbrica. Il sound di quelle bacchette sulle pelli, i rintocchi che potenti
risuonano nei dischi di Miles, sono i sample dell’anima. Il minimo comune denominatore da
riprodurre con le macchine.Vi stiamo raccontando tutto questo a mo’ di prequel. Il finale del
corto coincide con la prima del Nostro, intitolata guarda caso The Kind of Blue. L’anno è
il 1998 e l’etichetta la Huume, o meglio, è un’autoproduzione come ne arriveranno altre negli
anni a venire. E citando questa, Ripatti risponde alla prima domanda di una lunga intervista.
La mente va ancora a Tummaa, un lavoro di una squadra dove s’improvvisa e si seguono
partiture concordate; pur con modalità non convenzionali, si suona come in una band. Ai margini pattern e
layer.
Gli aspetti sottesi alla svolta sono chiari, ma si disveleranno completamente quando apprendiamo di microfoni particolari appiccicati a svariati tool-percussivi; Sasu suona senza curarsi di monitor e di plug in e
davanti a lui, ci assicura, si aprono possibilità concrete. La libertà è una parola grossa, l’immediatezza ne è
sicuramente il fondamento, ma tutto ciò va guadagnato nel tempo. La personale pocket revolution si realizza in tre anni, due dei quali passati on stage accanto al signor Basic Channel, Maurizio, Moritz Von
Oswald, dove appunto suonava, seppure seguendo il groove e la battuta in 4 del quadratissimo leader del
Trio di Vertical Ascent.
Il cerchio aperto più di dieci anni fa si chiude. E il prossimo passo? Già pensato: il Vladislav Delay Quartet,
un progetto a quattro che vede Mika Vainio (metà Pan Sonic, uno anti-digital da sempre), Lucio Capece
(presente anche in Tummaa) e Derek Shirley al double bass. Ripatti nel frattempo ha cambiato vita: è
tornato in Finlandia. Non ne poteva più della pioggerellina berlinese, del dover fare il label manager di se
DROP OUT
39
stesso (con la Huume), di aver a che fare con tutti quei contatti. Lo spostamento gli ha giovato non
poco. Soprattutto i risultati sono frutto di un gruppo di menti, proprio come voleva e fantasticava già
nel ’97. Di più sono musicisti/amici che gli gravitano
attorno da sempre. E sono cresciuti, si godono una
seconda giovinezza. È gente ben sopra i trenta, oltre
i fondamentalismi di gioventù, ma che proprio da
quelli si è messa in gioco. L’ombrello filosofico di
quest’incontro di sensibilità - tra techno, ambient,
dub, pulviscoli industrial, l’immancabile kraut rock
e ritmi etnici - è diretto verso un nuovo Fourth
World, chissà se Jon Hassell apprezzerà.
La cosa più curiosa è che gli ingredienti sono
quelli sui quali Sasu lavora da sempre. Gli stessi che
hanno reso Entain e Anima dei piccoli capolavori
d’ambient music. Detto questo non c’è dunque miglior momento per farci raccontare tutto questo e
molto di più proprio da lui…
Moritz Von Oswald Trio è un progetto
incredibile. Impossibile non citarlo
parlando del tuo nuovo lavoro. Cosa ha
cambiato nel tuo modo di lavorare l’aver
suonato con altri musicisti dal vivo?
Il trio live ha cementato la mia voglia di suonare
percussioni e batteria. Da un po’ desideravo suonare pattern ritmici con altre persone, ma farlo continuativamente on stage ha reso naturale proseguire
questa direzione anche in studio con il mio solo
project. In passato, inoltre, a parte qualche collaborazione come vocalist, non ero mai riuscito a trovare questo tipo di alchimie. Ora che le ho trovate
vorrei continuare a farlo. Sono sicuro che darà pure
più respiro ai miei lavori. Anche Tummaa è il risultato di un lavoro a tre.
Per cosa si caratterizzano i tuoi ritmi in
questo lavoro rispetto all’altro?
I pattern sono piuttosto differenti nei due approcci.
Comunicano sicuramente tra loro ma rispondono
a due logiche differenti: in Tummaaa le percussioni non sono per nulla dritte e basate sui groove
mentre in Vertical Ascent sono sempre 4/4 e groove
based. Poi non argomenterei che da una parte sono
più jazz rispetto all’altra. Il jazz non esiste più.
È questa la tua definizione di jazz?
Sì. Il jazz per come lo concepiamo è morto. Prendi
il quartetto con il quale uscirò in autunno: è un ulteriore tentativo di suonare musica con delle persone con strumenti acustici e per me di suonare la
batteria e altresì creare ritmi che non ho bisogno
di programmare ma soltanto suonare. Alcuni per
40
DROP OUT
esempio non li potrei programmare comunque. Sto
cercando di creare qualcosa di diverso dalle passate
produzioni Delay. E lo voglio fare con persone in
carne ed ossa invece di macchine.
Se è ancora vero quel che dicevi a
proposito del moniker Delay (che in
quelle vesti eri più te stesso) cosa è
cambiato dal te stesso degli esordi da
quello attuale?
Sicuramente le cose sono cambiate da dieci anni a
questa parte e se questo da una parte è fantastico,
dall’altra sono fondamentalmente lo stesso, pure se
il sound Delay è piuttosto differente da Anima al più
recente, oppure da Whistleblower a Multila… Quello
che voglio dirti è che non mi piace ripetermi e suonare “in sicurezza”. Dormire tranquillo pensando
di aver fatto qualcosa di già sedimentato. C’è una
sorta di agenda nascosta per tutta la musica che
compongo. Mi aiuta allo stesso tempo a viaggiare
sia tecnicamente sia musicalmente. Delay è un tipo
di musica che va al di sotto delle strutture musicali
e degli idiomi. C’è una inner vision o meglio un feeling inspiegabile a parole, neppure a me stesso. So
quando le cose vanno in quella direzione e quando
questo non accade faccio di tutto per portarle in
quel posto. L’agenda segreta è probabilmente puro
istinto.
Facciamo un passo indietro. Mi racconti
delle Anima Session?
Anima è stata una jam recording di due giorni.Vedevo sul monitor il film e sentivo l’audio composto di
soli dialoghi e su quella base suonavo live quel che
sentivo di dover aggiungere. Ho suonato 8 o 9 volte
l’intero album. Poi ho aggiunto un’altra manciata di
layer su quelli già incisi.
Torniamo ora ai due trio. Avevi delle
strategie? Cosa è venuto prima, il ritmo
o il groove? Si partiva suonando o da
un’idea?
Nel trio con Moritz il drumming era potentemente
pianificato. Oswald spesso possiede questa visione
del ritmo nella sua testa e a me non rimane che aggiustarmi attorno a quell’idea. Con le mie cose soliste tutto è meno determinato. E pure i ritmi hanno
minore importanza. Molte song di Tummaa iniziano
con dei beats ma, bit dopo bit, terminano fregandosene beatamente dei ritmi. La filosofia risiede nel
sentire quello che è meglio per la musica.
Tummaa significa oscurità, tenebre. Ha
per caso a che fare con un periodo scuro
della tua vita?
DROP OUT
41
Direi l’opposto, anche se fisicamente ti rispondo di
sì. Sono tornato a vivere nel Nord della Finlandia
dove è molto buio per gran parte della giornata e
per la maggior parte dei mesi invernali (anche se in
quelli estivi la situazione si capovolge). Ho composto l’album proprio durante il Kaamos, ovvero quel
che la gente del posto chiama il periodo scuro. E
l’ho amato. Perché è bello gustarsi il freddo vero e
l’inverno più pesto. Ho passato troppo tempo nella
triste pioggia berlinese mentre qui la combinazione
di freddo, neve, cieli puliti, la luna e un poco di sole
sono le basi per far accadere qualcosa di magico.
Naturalmente l’album è molto influenzato da questo contesto.
Secondo te c’è qualcosa di primordiale
e di magico nel percuotere le cose?
Quando hai avuto per la prima volta
quest’impulso percussivo?
Credo di essere un fanatico dei ritmi dall’età di
cinque anni. E non mi sono ancora scocciato. È
come qualcosa di profondamente radicato in me e
nell’uomo. Ti mantiene sano. Ed è un linguaggio che
mastico con più naturalezza delle parole. Infine mi
fa sentire bene. È il sale della vita.
La fisicità del ritmo mi fa pensare alle
lezioni di Throbbing Gristle e Pan
Sonic. Il loro approccio è famoso per
l’attacco fisico. Attacco che poi produce
conseguenze emozionali e psicologiche
ma pur sempre di attacco si parla…
L’aspetto primitivo del ritmo è sempre quel che viene prima nella mia musica. Anche quando apparentemente non c’è alcun ritmo. È un modo di sentirlo
dentro piuttosto che un qualcosa che ti sta investendo come un bulldozer.
Alla domanda “cosa ti manca di più quando stai per
molto fuori dalla tua terra” Ilpo Väisänen mi ha
risposto le tempeste di neve. Howe Gelb, che è di
Tucson, le tempeste di sabbia. Non so cos’è ma c’è
qualcosa in comune tra le due esperienze…
Fuori dalla Finlandia mi mancavano la neve, la solitudine e pure qualche tipo di cibo. Soprattutto mi
mancava il modo con il quale le cose accadono. È
più semplice che altrove. Poi posso fare a meno delle tormente ma non dell’acqua. Ho vissuto accanto
all’oceano tutta la mia vita ed è fondamentale averlo
vicino.
Pensi di poter stendere delle top 5 di
album distinguendole per alias? Non so,
Uusitalo ne mette cinque d’elettronica,
Vladislav Delay cinque di jazz… oppure
42
DROP OUT
ognuno di “loro” inserirebbe gli stessi
ascolti?
Non capisco la domanda. Ascolto enormi quantità
di musica. Africana, classica, hip hop, metal ma quando l’ascolto per motivi miei mi limito a Bill Evans,
Miles Davis, qualche cosa giamaicana, forse qualcosa di Chet Baker.
Se parli di jazz non posso non incuriosirmi sulle relazioni tra jazz e elettronica.
Ne ho individuate due negli ultimi anni:
ci sono coloro che riducono il jazz a una
sorta di marmellata mettendoci sopra un
letto di sci-fi (Planet Mu, Warp) e coloro che suonano jazz, metti l'abusato Gill
Evans, calandolo però in un tipico scenario post moderno fatto di glitch e altri
suoni sintetici (pensa ai Tied & Tickled
Trio o a molta musica per teatro).
Da parte mia non cerco neppure di andarci vicino al
jazz. È vero, ascolto jazz e dub. Pure il quartet a cui
stiamo lavorando può essere inteso come jazz, ma
soltanto nel senso che improvvisiamo. Voglio starmene molto lontano dai solo, o dall’avvicendarsi di
tema-solo-tema, tipici del genere. Per dirla tutta mi
annoia anche l’idea di aggiungere qualcosa all’idioma
jazz, pure quando lo fanno i più grandi musicisti viventi quali Wayne Shorter o Branford Marsalis.
Eppure una volta dichiarasti che il jazz
era “the main thing”…
Il jazz lo è nella misura in cui è ispirazione. Ed è
pure un qualcosa di importante da quando avevo
quattordici anni. E le cose non sono cambiate molto
da allora ad oggi. Ovviamente, i miei dischi non sono
jazz di per sé, ma quando incisi il mio primo 12’’,
The Kind Of Blue, e non avevo mai sentito nulla
di propriamente elettronico, pensavo di fare qualcosa che avesse a che fare con il jazz eseguendolo con
le macchine. Post-jazz.
La tua definizione di post-jazz?
Espanderlo oltre i confini. Creare qualcosa di nuovo
che non è ancora stato creato.
C inque
e trino
in uno .
+ 2
O
meglio , uno
Vladislav Delay produce ambient, Uusitalo
techno e Luomo house. Altri due, dismessi praticamente sul nascere, raccolgono le prime produzioni (Conoco) e degli esperimenti minimal (Sistol).
Sasu Ripatti non è il primo ad aver assunto svariati
alias nella sua più che decennale carriera. Nel mon-
do elettronico sono una consuetudine, servono
soprattutto per pubblicare di più e di conseguenza
farsi conoscere velocemente, e i più famosi ad abusarne, Richard D. James e Luke Vibert, ne
hanno sempre goduto.
Differente la sorte del finlandese a cui, specie
all’inizio, sembrano portare sfortuna e portarsi appresso pregiudizi del pubblico e critiche poco lusinghiere. Gli album finivano nelle mani sbagliate con
il primo Uusitalo a casa di chi mal sopportava la
techno, o ancor peggio, Luomo a far salire sospetti
nella produzione Vladislav Delay. Con quest’ultima
sigla, la prima a uscire sul mercato e la più importante per il musicista, i problemi erano inoltre legati al
genere stesso. Il mercato del cosiddetto clicks and
cut stava saturando e, sebbene il punto di non ritorno non era ancora arrivato (sarà il 2002), era dura
non venir etichettati come i minori di una scena
piuttosto che il contrario. Specie se si esordiva per
l’(allora) australiana Sigma Edition di due preparati,
per roster e qualità, ex Thela (ricordate il terzo?
L’osannato ai tempi Dean Roberts?).
Così, non furono in pochi, nel 1999, a sentire in
Ele (Sigma Ed., 7.5/10), un lavoro sì complesso ma
comunque à la page, prodotto fugace dell’ondata
microchip. E naturalmente si sbagliavano. Con i suoi
tre brani lunghi registrati live nel club Rainy Day di
Helsinki l’anno precedente, il lavoro, soprattutto nel-
le orecchie ripulite d’oggi, entra divinamente. Prima
di tutto perché è l’anteprima del primo capolavoro
del finlandese, Entain, in secondo luogo in quanto le
differenti versioni dei due brani in comune, Kohde
e Ele, sono da collezione, entrambe figlie legittime
del minimalismo di Terry Riley e dei tape experiment di Steve Reich. Nella primo la magia è
un discorso di dettagli etno, nell’altra un gioco di
lontani riverberi e modulazioni dub che pian piano
emergono dallo sfondo.
In entrambi domina l’immancabile manto dronico, un vento che spira sia dalle montagne di Twin Peeks (via Badalamenti), sia da quello altrettanto affine,
pure per gusto e scelte artistiche, a quello di Mark
Nelson / Pan American (che in quell’anno pubblica lo splendido 360 Business / 360 Bypass).
Facendo un doveroso passo indietro, c’è The Kind
Of Blue (Huume, 1997, 7.3/10) , la prima produzione Delay in assoluto che vede la luce nel 1997 per
la sua Huume. Le lunghe Siru e Kenno sono altrettanti esempi della già buona capacità del finnico nel
calare l’ascoltatore sottacqua (o in alternativa dentro una barca) e nell’avvicinargli progressivamente i
dettagli organici che pian piano iniziano a interagire
tra loro.
È comunque Entain (Mille Plateaux, 2000,
8.0/10) il lavoro che chiude, sublimandoli, quattro
anni d’esperimenti. Il passo successivo sarà una soDROP OUT
43
norizzazione, ma innanzitutto è ora di trattare sia la
sigla Uusitalo che quella Luomo. Per la prima esce
infatti un altro live, Vapaa Muurari (Force Inc,
2000, 6.0/10), un veloce spaccato della Helsinki
techno, ma anche un tipico esempio di come un non
frequentatore di club come lui registri un album “da
pasticca” che gli aficionados dei locali non amerebbero mai. L’album chiaramente non piace, i ragazzi
dei club non gli perdonano il tradimento della cassa
per continui amori dub, stop del tempo a base di
visioni ambient e peggio, dozzine di effetti e effettini,
glitch e percussioni. Sempre nel 2000, esce Livingstone 12’’ (Force Tracks, 2000, 6.0/10), l’apripista
per l’album Vocalcity (idem, 6.5/10), prova house
speziata sexy funk e soul firmata Luomo. Il singolo
Tessio, un retrò cantato scuola Chicago in coppia con
la futura compagna AGF, è subito un must a Berlino, mentre il resto si immerge in un’house super
easy, black ma bianchissima, qualitativamente media
ma farcita di bassi divini (Synkro). La vera novità è
però l’aver portato il regal glitch nella pistaccia da
ballo. A Ripatti è venuto perfettamente naturale, ma
per i suoi counter part dj era tutt’altro che scontato. E dunque punto accapo.
Il prossimo passo è in tutt’altra direzione: in
cantiere ci sono almeno due progetti, il primo per
un’etichetta che sicuramente lo ha ispirato in quanto a bass, la Chain Reaction per la quale esce Mul44
DROP OUT
tila a nome Vladislav Delay
(6.0/10), il secondo è la
summenzionata sonorizzazione sempre per lo stesso alias. Multila è un lavoro
vario, ma non portante, le
cui fondamenta si presteranno maggiormente per i
reading di AGF di Naima
(Staubgold 2002, 7.3/10),
registrato live all’Ars Electronica Klangpark nel 2001
e tra l’altro da annoverarsi
come il più sperimentale e Rastern Norton like
del Nostro. E in Naima c’è
molto più della compagna
che del suo. È altrove che
il cuore batte forte. Con
Anima (Mille Plateaux,
2001, 8.5/10), Ripatti entra
direttamente nella storia.
Con il suo impalpabile e
circolare tema badalamentiano ad entrare e uscire
dal campo auditivo, e il raffinato gioco di dettagli
sullo sfondo, l’album è il sunto amniotico delle passate produzioni con un pizzico di industrial ad aggiungersi al platter. In pratica, è lo step forward, la
quarta dimensione dove tempo e spazio collassano
mentre l’ascoltatore galleggia tra memoria e continue spinte ipnagogiche. Sicuramente è il primo dei
dischi Delay da acquistare.
Il secondo, se siete clubber, è The Present
Lover, un album totalmente party fatto di house
venata electro e wave. La formula ora ha carattere. E pure le canzoni. Fondando così un brand per
gli album futuri (il fischiato Paper Tigers, Huume
6.0/10, e il più fortunato e maturo Convivial, Huume, 7.0/10), sempre più in grande nella produzione e sempre più zeppi di ospiti più o meno famosi.
Con Luomo, Sasu farà praticamente il produttore
ma in The Present Lover scrive ancora tutte le lyrics
e vuole il controllo totale sugli aspetti del sound.
Capita così che la BMG, accortasi di lui già dal 2001
grazie al singolone Tessio, lo voglia, ma proprio con
quest’aspetto dovrà fare i conti, con esisti inappellabili. Il matrimonio con la major finisce puntualmente
dopo un anno. E malissimo. Il finnico non sopportava le pressioni sul proprio sound e soprattutto
le limitazioni alla distribuzione dei dischi basata su
fumosi criteri di aspettative di vendita.
E quell’anno, il 2003, pare proprio scalognato nei
rapporti con le label: pure le relazioni con la Mille
Plateaux s’incrinano. Sasu decide così di tornare in
proprio. Resuscita la Huume e pubblica Demo(n)
Tracks (Huume 2004, 6.8/10), un lavoro che vira
su track brevi, concentrato nello smembramento
dub-reggae, ma anche il primo a balenare una certa
maniera (e stile in repeat) che ne raffreddano l’estro.
The Four Quarters (Huume 2005, 6.5/10) seguirà lo stessa sorte e non lontano andrà Whistleblower (Huume 2007, 6.8/10), l’album di Vladislav Delay
che chiuderà la fase solitaria del Nostro.
Più interessanti pertanto, oltre che meglio accolti dalla critica, le produzioni cosiddette berlinesi
sotto la doppia firma AGF / Delay, compagna che
gli darà un figlio a breve e che in Explode - per
la sua AGF Producktion (2005, 7.0/10) - rinnova
sensibilmente il sound del finnico grazie a iniezioni
e idee electro auf Tarwater e compagnia Lippok
assortita. L’album è anche una sorta di manifesto anti-fashion (ascoltate A Distant View) nel quale il setting finlandese (dove è stato inciso) pare il perfetto
background per inviare fredde missive contro lo stile di vita borghese della capitale tedesca (people look
like rich and bored… …living only for the moment…
fashion on stage… …entertainment for the rich). Tre
anni dopo i due si trasferiranno a Oulu ma, nel frattempo, a Berlino, Sasu si fa in quattro per produrre
e promuovere i propri lavori, oltre naturalmente a
incidere con i soliti ritmi.
Interessante la rinascita, dopo sei anni, del techno beat firmato Uusitalo che con Tulenkantaja
(Huume, 2006, 7.0/10) trova finalmente un modo
di esistere ben oltre il club. L’anima è il piacere d’incastrare ritmi e linee a metà tra Tetris e lo sguardo
dell’architetto. In pratica il gioco e l’intelligenza nel
gestire gli spazi. Il gusto vero per questa sigla arriva però con il successivo Karhunainen (Huume
2007, 7.5/10), sorta di musique concrete techno driven che non disdegna né momenti groovey né field
recording, momenti suonati alle percussioni (vedi
intervista) e il loro utilizzo in loop. Ne salta fuori un
sound che per lui significa casa (Uusitalo, ci dichiara,
vuol dire nuova casa) e per noi è elettronica che
nasce fredda e viene servita calda, sound asciutto/
bagnato che profuma di fiordi, wilderness che vive
nel continuo lavoro sui ritmi, umani e di vita che
ogni tanto si concedono frazioni di secondo free.
Curiosità del primo dei due dischi, infine, è lo
svelamento dell’albero genealogico ripattiano. Il padre è scrittore conosciuto mentre la madre fu un
membro di un gruppo letterario radicale negli anni
’40. Ne parla il booklet attraverso foto e immagini
casalinghe e stralci di testi, un altro modo per dire:
“sto tornando a casa” ai genitori. Dicevamo delle
percussioni, Sasu aveva iniziato a utilizzarle diversamente dalla programmazione al laptop all’altezza di
The Dolls (Huume, 7.5/10), lavoro del 2005 con
la fedele AGF che si avvaleva dell’illustre presenza
di Craig Armstrong. La coppia aveva preparato un
tappeto percussivo ambientale sul quale l’ex arrangiatore degli archi per i Massive Attack doveva poi
suonare una base di piano nel suo stile jazzy. Il tutto
poi cantato da AGF (versione chanteuse). L’esperimento funziona egregiamente. Da queste parti Delay, come giustamente notano i ragazzi della All Music Guide, riesce proprio dove Demo(n) Tracks falliva,
ed è altrettanto vero che di quell’album lo scettro
sarà per lei, Greie che sicura e maturata al canto (e
senza i lavori di glitch cut up), darà un inconfondibile
marchio lirico e performativo al lavoro.
E così arriviamo a Symptoms (BPitch Control
2009, 7.2/10) e Tummaa (Leaf 2009, 7.0/10) e già
notiamo una piccola rivoluzione organizzativa. Entrambi i dischi escono su consolidate indie label, la
prima Bpitch della nota Ellen Allien con la quale
AGF ha già collaborato ampiamente, l’altra è la Leaf,
una delle più interessanti label degli ’00, attenta al
suono contaminato e alle novità di tali contaminazioni. Niente di più consono allora di un lavoro a tre
coordinato da un Delay percussionista che ritrova
l’intesa con il garbato piano jazzy dell’Armstrong di
The Dolls (Melankolia) e l’altrettanto lucida mano
di Lucio Capece negli smalti al clarino basso (si
ascolti l’uso etno dalle parti dei Popol Vuh in Kuula). A sorprendere tuttavia è l’approccio: un dinamismo inedito rompe parecchie (se non tutte) le
dinamiche del Delay solista, uno che, lo si diceva per
Entain, dapprima creava un fondale / sfondo e poi
faceva arrivare gli arrangiamenti in figura complicandone l’interazione.
E pure Sasu e Antye Greie, di nuovo in coppia,
danno segnali di freschezza e perfetto gioco dei
ruoli. Il secondogenito AGF / Delay è riuscito tanto
quanto se non più del primo e tutta questa ritrovata freschezza pare sia scaturita proprio da nuove
modalità del suonare e dal farlo con altra gente, entrambi aspetti trattati in dettaglio nell’intervista a
cui vi rimandiamo. Ora attendiamo il Vladislav Delay
Quartet e magari anche un’altra tournée con il Moritz von Oswald Trio.
DROP OUT
45
Recensioni::::settembre::::
►►►►
AA. VV. - Kitsuné Maison
Compilation 7 (Kitsuné Music,
Giugno 2009)
G enere : compil ation disco pop
Gli occhiali con la montatura grossa, i Ray Ban, i
leggings, i vestiti coloratissimi, le spalline e lo smalto
vistoso. Questi gli anni ‘80 catapultati oggi. Fashion
= Maison Kitsuné. E quindi il disco lo senti come un
vestito. Una cosa da passerella serale. Da struscio
uberposh. Il sentimento che caratterizza da sempre
la summa del pensiero french touch. Ma se nelle
ultime uscite i parigini non ci avevano stupito (anzi,
a dirla tutta ci avevano deluso), con questo settimo
volume il gruppo si riporta in carreggiata.
Facile direte voi con nomi del calibro di Phoenix,
La Roux, Autokratz (che qui remixati da Yuksek non perdono colpi) e altre ‘giovani promessè del panorama electrofidgeting. Si va dal quattro
acid-moroderiano di BeNi (Fringe Element), alla
progressione cosmica di Prins Thomas per il
remix balearico di James Yuill (This Sweet Love),
dalla deep melò di Delphic (Counterpoint) al trash
crookersiano di Maybb (Touring in NY).
Indicato per farsi un’idea di quello che succede nel
dancefloor più poshy che mai e per muovere il culo
in questa seconda metà di 2009. Per niente male.
(6.4/10)
Marco Braggion
AA. VV. - Utmarken (Release The
Bats, Luglio 2009)
G enere : bl ack ambient
C’è del marcio a Göteborg e questa compilation è
qui a testimoniarlo. La città svedese è infatti già nota
per l’attività della sua umbratile Release The Bats,
etichetta che da anni si incarica non solo di stampare le versioni in CD dei dischi di band come Woods,
Raccoo-oo-oon, Ducktails e Wet Hair, ma anche di
dar la giusta visibilità all’umido underground della
proprie lande.
Il disco di debutto di Ättestupa, pubblicato l’anno scorso, è una prova in tal senso e questa nuova
uscita intende portare avanti l’opera di testimonian46
recensioni
za in tempo reale. Un vinile 10 pollici, dunque, con
un brano a testa per quattro band, tutte gravitanti
attorno all’Utmarken, sala prove, negozio di dischi e
ufficio della label, da cui appunto il nome del disco in
questione. Oltre a già citati Ättestupa troviamo i
side-project Street Drinkers e White, rispettivamente di Viktor e Dan, e i Källarbarnen, in cui
suona lo stesso label-guy Matthias Andersson; ciò
che accomuna il tutto sono le atmosfere di algida
desolazione e ipnotica distanza che ricordano tanto
i Peaking Lights quanto i pezzi black-ambient
del Burzum di Filosofem (Daily Bread), quando
non danno vita a brani che si lanciano in lunghe cavalcate elettriche (Änglamakerskan). Forse quattro
pezzi sono pochi, ma Utmarken è comunque un
documento fedele di quanto succede negli anfratti
isolati della Svezia di oggi.
(7/10)
Andrea Napoli
AA. VV. - Volume 1 (Niente, Luglio
2009)
G enere : impro - noise
Niente Records, ovvero la deprivazione di ogni singolo, possibile orpello. Zero cover, zero tracklist,
zero info. Il niente assoluto, fatta eccezione per la
musica, che in fondo è ciò che interessa. Volume 1,
raccolta imbastita dalla Niente (etichetta di St.Ride),
tutto vuol esser tranne che un sampler, quanto piuttosto un manifesto fatto da gente che non ne ha
bisogno affatto di manifesti. Perché manda avanti la
propria musica in maniera fiera e incompromissoria,
fedele ad una linea che non c’è, vista l’eterogeneità
della proposta.
Nei 70 minuti di questa prima emissione, sfila tutta
la peggio gioventù (vecchia e nuova) delle musiche
off made in Italy, per quel che una definizione del
genere possa voler dire: Vonneumann, Nihil Is Me,
Harshcore, Lendormin, A Spirale, St. Ride, Jealousy Party e moltissimi altri che non si citano solo
per questione di spazio. Cosa aspettarsi insomma
da questo disco se non le musiche più fratturate,
sghembe, storte, umorali, rumorose, avanguardisti-
highlight
Brunori Sas - Vol.1 (Pippolamusic, Giugno 2009)
G enere : cantautorato
In copertina un bambino impertinente in canottiera mentre fa le facce all’obiettivo, perfetto biglietto di presentazione di Vol.1, esordio di Dario Brunori sotto la ragione cantautorale Brunori
SAS.
Un compendio di esperienze in cui convivono momenti di vita della provincia calabrese, ritratti
di bruciante precisione, resi con un’urgenza espressiva e un’emotività che ricorda il Bugo degli
esordi, insieme a coloriture di sapore Beck. Dietro ci sono referenti
di tutto rispetto, da Piero Ciampi ad Endrigo, fino a Rino Gaetano, Ivan Graziani, Sergio Caputo, per la capacità di rendere
cinematicamente momenti e caratteri, congelandoli in istantanee che
si fanno universali, con un’ironia lieve ma graffiante. Vengono dipinte
così situazioni e momenti della nostra contemporaneità, non dissimilmente da altri autori che stanno già percorrendo questa via, i Maisie
per citare un nome.
Vol.1 è fatto allora di chitarra, voce e minimo accompagnamento,
puntellato da fiati, per una serie di bozzetti, che vanno dalla presa in giro in fondo bonaria
dell’Italian Dandy, il poeta bohemien da Baustelle in giù, la curiosità della provincia, il ritratto
del piccolo borghese qualunquista (Paolo), il disagio di questi anni precari e post (Come stai, L’imprenditore), l’ordinario, la vita di provincia degli Ottanta e dei Novanta, le disillusioni, la normalità
dell’esistenza. Urlando il disagio ma con consapevolezza, senza rabbia. Di chi sa come vanno in
fondo le cose. Essenziale.
(7.3/10)
Teresa Greco
che, ludiche, ma sempre e comunque mentalmente
free e concettualmente colte d’Italia? Ce n’è veramente per tutti i gusti con quello spaziare dal freejazz in decomposizione alla musica concreta, dal
rumorismo d’accatto all’impro-luddismo radicale,
ma una personale preferenza va ai romani Vonneumann (molto post-rock da filiera, sulla scia
dell’ottimo Il De' Metallo), al progetto di Andrea
Giotto Nihil Is Me (derive spacey-chiesastiche
ultra-drogate), alle carezze alla cartavetrata dei
Lendormin (ortodossia rumorosa nelle speculari
Hated e Loved) e all’impro jazz ipotetico del quartet-
to live Cianfrini-Giust-Falascone con ospite
Bob Marsch. Scelta onestamente difficilissima tra
tanti e tali materiali. Insomma, enjoy il niente.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
AA. VV. - Even Dogs Like To Dance
(Canebagnato, Agosto 2009)
G enere : folk variabile
Abbiamo un debole per le antologie. Soprattutto
per quelle che raccolgono materiale proveniente
dal sottobosco indie di casa nostra; per quelle che
recensioni
47
non hanno la pretesa di suonare esaurienti o per
forza rivelatrici; per quelle che sono il frutto di una
visione musicale precisa, filtrata – perché no – dai
gusti personali. Canebagnato Records, avamposto
meneghino in trip da sempre per certo folk anglofono e “alternativo”, è una realtà che si diverte – e ci
diverte – pubblicando di tanto in tanto dischi compilativi sul genere. Come questo Even Dogs Like
To Dance, tributo/vetrina per alcuni tra i migliori
affezionati della chitarra acustica – ma non solo –
provenienti da etichette discografiche diverse. Tra
i tanti, Mauve, Margareth, Christian Alati,
Gabriel Sternberg, Ofeliadorme, Andrea
Liuzza, Casita Nuestra, impegnati a mescolare il verbo del folk con il jazz, il country e certo
pop malinconico. Ma anche Vanvera, Baby Blue,
Jean-Cristophe Potvin, Marvin, Lapingra,
Peter Kernel, sostenitori di una visione capace
di bypassare la tradizione grazie a un obliquità di
fondo o magari a una spruzzata di elettronica.
Avremo sicuramente dimenticato qualcuno nella
ridda di citazioni che per forza di cose si è costretti
a fare in queste occasioni, ma poco importa. Quel
che conta è la musica e quella contenuta in questo
disco non ha bisogno di ulteriori presentazioni.
(7/10)
Fabrizio Zampighi
AA. VV. - Horse Meat Disco (Strut
Records, Agosto 2009)
G enere : disco , funk , italo
“Horse Meat Disco è dedicato all’industria di felicità umana che tutte le domeniche sprigiona dal
club The Eagle London. È il party queer per tutti.
Omo ed etero, ragazzini, orsi, fashionistas, naturisti,
guerrilla drag queen…”
Horse Meat Disco è una serata disco e gay-friendly
ormai diventata di culto nella City; la novità è che
i dj e fondatori dell’iniziativa, James Hillard e Jim
Stanton, affiancati da Severino e Filthy Luka, hanno
deciso di celebrare quelle danze folli con una doppia compilation e una tournèe di dj-set come quelli
dell’Eagle domenicale da replicare in tutto il mondo.
I ritmi e le note sono quelli più classici della disco new-yorkese (del West Village, precisamente)
di metà-fine Settanta, con un po’ di italo e di funk.
Anzi, tanto funk, che scorre indefesso e felicemente
nei fluidi acustici di Disco Jam di Eddie Drennon
(con dentro un caparbio riff di archi) come sopra la
base poliritmica di Hupendi Muziki Wangu di K.I.D..
48
recensioni
Le atmosfere sono quelle ben descritte dal libro
You Should Be Dancing di Peter Schapiro,
anche se traslate di trent’anni; la piccola novità è
che l’etichetta che ha appoggiato l’iniziativa e l’ha
fatta diventare davvero un doppio CD è la solita
Strut, che per l’occasione non si è occupata di una
vera e propria ristampa – anche se poco ci manca,
visto i contenuti – ma di qualcosa che effettivamente è ancora possibile vedere (allo stato di dj-set)
nel 2009. L’anima della label emerge maggiormente
nel secondo CD, che contiene 14 delle 16 tracce
del primo ma allo stato “naturale”, cioè non mixate
dai curatori; eppoi c’è il booklet che accompagna la
musica, che contiene la storia del club e della serata
scritta dal giornalista del Guardian David Pascheck.
Tutti classici ingredienti Strut. E se i nuovi sono passatisti…
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Acoustic Ladyland - Living With a
Tiger (V2 Music, Agosto 2009)
G enere : J azz rock
Da Skinny Grin (che aveva visto la partecipazione di James Chance e Scott Walker nientemeno), gli Acoustic Ladyland di Pete Wareham
non si sono certo ammorbiditi, a dir il vero hanno
operato alcuni cambiamenti significativi alla già battagliera formula hard(anche very)free-rock-jazz.
Niente canto per il nuovo lavoro e in rimpiazzo tre
cavalli di razza pronti a correre: il bassita tellurigico Seb Rochford (Polar
Bear), il qui tastierista
Chris Sharkey (principalmente chitarrista) e
soprattutto una chitarra
prepotentemente extra
dry (e indisciplinatamente Fripp-iana) imbracciata dall’egregio Ruth
Goller. Tre nuove sponde per altrettante sfaccettature di sound ora più
che mai compatto, rock si direbbe, e dai Settanta ai
Novanta non si butta nulla, neanche nei momenti
più free.
Carichi di proteine come tacchini e di testosterone
da far schizzare i testicoli, i reietti del jazz londinese
usano gli strumenti come idranti per spegnersi l’un
l’altro piuttosto che fare a gara a chi danneggia di
più le linee di partenza.
Sono un team di psycho lucidi e spietati. Una SPA
senza scrupoli. Un’azienda della loro holding demoniaca chiamata F-ire. Correre in questa prova
significa passare dal core marca Zu all’hardcore
evoluto americano fregandosene completamente
d’ogni fighetteria e cosiddetto buon gusto borghese. E quando dico ogni, significa scrollare le spalle
a nomi grossi come Peter Brötzmann e Naked City, a loro pare dedicata con aria di sfida e
sberle newyorchesi, l’iniziale jazz trash anni Ottanta
Sport Mode, come dire un sacrilegio Scatman John
in versione garage hardcore (è da segno della croce
potete scommeterci!)
Del resto, il supergruppo allestito da Wareham, i
Final Terror, con lo stesso Chris Sharkey, Leo
Taylor degli Hot Chip e Kenichi Iwasa (Chrome
Hoof) ha preparato bene il terreno in questo senso: non c’è niente di meglio di quel marmocchio di
Chance per rovinare le feste ai circuiti jazz, anche
a coloro che si ritengono aperti alle nuove tendenze. Sicuro che l’accademia non gradirà il dialogo tra
sax, basso, chitarra qui proposti. E pure i puristi post
rock odieranno gli Acoustic Ladyland in pausa tra
Rodan (The Mighty Q) e For Carnation (Worry),
intenti a sporcare il mitico suono di Chicago.
Di nemici se ne sono fatti tanti e la cosa ci piace:
troppo funk rock per gli amanti del free, troppo predictable per gli stessi amanti del noise rock, troppo kitch per chi con il kitch così spinto s’incazza
proprio, troppo quelli che fanno troppo per tutti
gli altri.
Qualcosa ai più inquadrati Zu hanno sicuramente
da insegnarlo. E se nell’aria c’è pure il sentore che lo
sboccato Mike Patton avrebbe qualche remora a
scritturarli, gli Acoustic Ladyland diciamo che sono,
davvero, gli unici veramente punk della cordata. Coraggio che va premiato a tutti i costi.
(7/10)
Edoardo Bridda
Alasdair Roberts - Spoils (Drag
City, Luglio 2009)
G enere : folk
Lo scozzese di Germania ci riprova, si coltiva l’onirica ossessione con movenze sempre più autarchiche,
isolandosi in una nebbiolina un po’ maniacale ispirata alle caligini bretoni dei Fairport Convention
e alla polvere che si alza dai front porch di frontiera
che t’immagini immersi nelle impagabili nenie Will
Oldham. Ecco quindi il timido bardo-cowboy coi
suoi arcaicismi letargici e solenni, l’incedere vagamente giullaresco e il disincanto epico, i garruli eso-
tismi e l’attonita gravità, con la voce assieme lirica e
chioccia come del resto spesso la musica.
Guardi a lui - alle sue canzoni - come si guarda un
cortometraggio, dove più che la storia conta la situazione, e passi se l’artificio (il senso di) forza un po’ la
mano. Il vago sapore Nick Drake di You Muses Assist, il greve incedere di Ned Ludd’s Rant, il misticismo
rappreso di The Flyting of Grief & Joy e una Unyoked
Oxen Turn contagiata Paul Simon sono i momenti
più vivi di un disco che deliziosamente cigola come
un vecchio portone (di un film in costume).
(6.3/10)
Stefano Solventi
Ali Campbell - Flying High
(Jacaranda, Giugno 2009)
G enere : reggae pop
La musica rock è colma di visi pallidi che fanno finta
o vorrebbero essere neri, e a molti di loro dobbiamo parecchio in termini di evoluzioni stilistiche
e grandi canzoni. Inutile dire che Ali Campbell non
è tra questi, ma neppure lo puoi paragonare a un
indegno paraculo, un Mick Hucknall che ormai
pensa soltanto ai vigneti e al conto in banca perché
diventiamo tutti uomini di mezz’età e che vuoi farci. C’è stato nondimeno un tempo lontano in cui
quegli UB40 in cui il pacioccone Ali cantava proponevano reggae di vaglia
e classe, che fosse intinto
nel pop o propenso a
sperimentare. Costantemente schierato contro
l’Inghilterra conservatrice, seppe essere ecumenico senza perdere la faccia. Negli anni un successo
chiamò l’altro, portando seco trascurabili banalità e
persino una sigla di Nonsolomoda prima del tangolounge alla vaselina.
Dunque cosa puoi aspettarti oggi dal Campbell solista, accostandoti a lui il più possibile privo di pregiudizi? Una parata di stelle meno disastrosa del prevedibile (per gli specialisti c’è Lady Saw; al popolo
basteranno Craig David e Shaggy) e la sfilata
- che invece t’aspetti - di scorrevoli morbidezze in
levare; regolarmente screziate di fiati, di gospel e di
leggero dub poiché confezionate con mestiere, ma
sovente zavorrate da eccessi di saccarosio.
Se non si hanno troppe pretese, Flying High può
anche funzionare tra le onde FM orecchiate in piscina o nelle pause del weekend in riviera. Fatto sta
recensioni
49
che da queste parti siamo esigenti anche quando si
tratta di intrattenimento: vedete voi se si tratta di
pregio o difetto.
(5.5/10)
Giancarlo Turra
Amy Speace - The Killer In Me
(Wildflower, Luglio 2009)
G enere : A mericana
Protetta di Judy Collins, che l’ha voluta sulla sua
label Wildflower sin dal disco precedente Songs
for Bright Street (2006), l’ormai ex-attrice Amy
Speace prosegue sul suo canonico rootsrock USA,
non dissimilmente da una prima Lucinda Williams, il nome a cui più spesso è stata accostata.
La Speace possiede, arrivata al terzo album, una sua
personalità ormai ben definita, che partendo da un
approccio melodico, si esplica in un songwriting di
base rock, con elementi country, folk e pop in senso
lato nel senso di armonizzazioni.
Neil Young, The Band, Bob Dylan ma anche
tanto folk al femminile (la sunnominata Collins ma
anche Joan Baez, Joni Mitchell), country (da
Johnny Cash a Patsy Cline fino a Emmylou
Harris e Patty Griffin) e rock le sue ascendenze, per un album piuttosto crepuscolare, nato in solitudine sulle ceneri di un
matrimonio finito. Uno
stile asciutto e diretto,
una discreta capacità di
mixare gli ingredienti prima nominati a sua disposizione, una band solida
alle spalle (i Tearjerks),
una buona produzione e
l’apporto di Mitch Easter, nonché la partecipazione
vocale di Ian Hunter in un paio di brani, fanno di
The Killer In Me un disco che pur non dicendo
niente di nuovo nel genere di appartenenza, si distingue per equilibrio nella materia trattata.
(6.8/10)
Teresa Greco
Anals (The) - Total Anal
(Permanent, Luglio 2009)
G enere : paranoid post - punk
Estate di debutti per il sotto-mondo post-punk; non
solo nomi più altisonanti sono giunti in questi mesi
al primo album (vedi Zola Jesus e Cold Cave),
ma pure realtà minori, periferiche anche in senso
geografico, portano allo scoperto il proprio volto.
50
recensioni
È infatti da Metz, Francia, che arriva il gruppo in questione, in realtà uno dei tanti progetti paralleli (insieme a Plastobeton, Scorpion Violent, The Dreams)
degli A.H. Kraken debuttati da In The Red l’anno
scorso. Proprio con questi ultimi gli Anals hanno,
oltre ad alcuni membri in comune, diverse affinità;
i francesi suonano infatti un dopo-punk paranoico
ed ossessivo che alterna momenti simil kraut (Command Of Love, Wake Up You’re Dead) a nenie minimal
synth (Ditch) e svariate suite rumoristiche (I Married
A Slut, The Animals). Il tutto risulta volutamente ostico e claustrofobico, dando prova di come anche al
di fuori degli States si possano trovare, a ben vedere,
delle proposte radicali che meritano la giusta fetta
d’attenzione; non è dunque un caso che il suddetto
LP esca per la Permanent di Chicago.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Andrew Weatherall - A Pox on
the Pioneers (Rotters Golf Club,
Luglio 2009)
G enere : W ave
Sulle uscite dell’Andrew Weatherall abbiamo
già associato ottime recensioni elogiando la capacità dell’ex Two Lone Swordsmen di virare il
sound di quella ragione sociale verso un versatile
dance mix a cavallo tra Novanta e fine Settanta. Ricordiamolo: nessuno come Weatherall riesce a animare un dancefloor a base di post-punk e House,
ma qui parliamo di un vero esordio solista e c’è da
esaltarsi di fronte a un format rinnovato (e oltre lo
strobo).
A Pox On The Pioneers non è una riproposizione dei
gruppi madre, anzi, è come sentire dei Tarwater
ventenni, radiosi, urbani, eccitanti. E se è logico che
una connessione ci sia sempre stata (la base CurtisMorrison-iana) è comunque Berlino la ragione principale. La coolness filia direttamente dalla Capitale
come pure quel decantare da vampiro romantico
che all’uomo viene divinamente.
La traccia must? Privately Electrified ci troviamo un
gospel in bassa battuta con chitarrina tropical. È la
lezione indietronica insegnata ai ragazzi. Lo scappellotto ai Lippok e agli Schneider. Poi, chiaramente,
nel disco - giù per la china eighties - c’è un bel po’
di ottantume wave e figuriamoci, Weatherall ingrassa i circuiti a dovere: prendiamo Selective Walking,
giochetto da produttore scafato fatto di basso Two
Lone (qui si), cavalcata Morricone e chitarra The
Edge.
Cose base per un fuoriclasse che ha marchiato
Screamadelia, ma nel disco c’è di più, sentite Built
Back Higher: la scrittura c’è e spruzzata di luce presa
in prestito da Everything That Happens Will
Happen Today è davvero la mossa definitiva. Infine, Liar With Wings è per te, Patrick Wolf. Prendi
appunti. C’è Weatherall in da vampire-gospel-house.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Anti-Pop Consortium - Fluorescent
Back (Big Dada Recordings,
Settembre 2009)
G enere : electro - hop
L’intellighenzia dell’alt-hop si riunisce dopo aver
trascorso sei anni tra progetti in solitaria (Beans
con la Warp) o con altri combo (High Priest e
M Sayyid con Airborn Audio su Ninja). Invecchiati? Non molto da Arrhythmia ma è quanto
serve per dire la loro
Grazie al produttore Earl Blaize (ormai dentro
la cosa), risaltano subito all’orecchio la cupezza e
la superpompa nei bassi ereditata dal Wu Tang
Clan nell’opener Lay Me Down, i richiami gangsta di
Shine, le tastierine acide di C Thru U, gli accenni alla
dance nella collaborazione uberpop con il padrone
di casa Big Dada Roots Manuva (NY To Tokyo singolo da panico) e al grime nel pezzo che dà il nome
all’album.
I riempitivi non mancano ma la voglia di ritornare a
fare crew e di abbassare il tasso di poshyness rendono il concept fruibile. Pure per i non addetti (leggi
meno snob, più pop). Non cambia la maiuscola nel
Respect che il trio si merita da sue lustri, anzi, dopo
multipli ascolti il disco guadagna stabilità e spessore.
E con una Anticon storicizzata, riabituarsi a quella
Pre-Millennium Tension è mossa faticosa e gratificante.
La reunion vale la candela: la prossima volta però,
vogliamo i feat. di Madonna e Robbie Williams.
(7/10)
Marco Braggion
Arctic Monkeys - Humbug (Domino,
Agosto 2009)
G enere : P ost -P unk
Terzo album per le scimmie artiche. Come al solito
il post-post-esordio è la cartina tornasole. E se già
con i due precedenti non avevano stupito (pur aven-
do ottenuto un successo di vendite galattico), oggi
si mettono a fare le piccole deviazioni dal tracciato
della forma rock e tentano di svisare dal sentiero
che i gruppi p-funk hanno ormai cementato.
Allora qualcosa di buono la trovi ancora, grazie
magari alla produzione di Josh Homme (frontman
dei Queens of the Stone Age), alla voce e alle
storie narrate da Alex Turner (che in qualche punto
tenta l’affiancamento a Jim Morrison) a qualche effetto che aggiunge un po’ di patina barocca al sound
derivato da Klaxons, Maxïmo Park e affini. Ma
dopo qualche ascolto il risultato è la solita emulazione di un suono targato 2000 ormai d’antan. Boring.
(4.8/10)
Marco Braggion
Baaba Maal - Television (Because,
Settembre 2009)
G enere : etno - pop
Da che i Talking Heads e Paul Simon aprirono al mainstream la diga del “ritorno alla Madre
Africa”, legioni di artisti si sono gettati in quel varco
a cercare ispirazione e ancor più oggi, in pieno revival new wave. Lo sapete che stiamo parlando di
voi, vero, cari Vampire Weekend e Here We
Go Magic? Nondimeno può anche capitare che
dal Continente Nero si
guardi dalle nostre parti,
chi snaturando le radici
con la speranza di ampliare il bacino d’utenza
e chi, viceversa, mettendo a punto equilibrate
commistioni e chiudendo così il cerchio. Resta a
metà del guado Baaba
Maal, redivivo a otto stagioni dall’acustico e lieve
Missing You, non facendosi mancare nulla in termini d’intarsio e convivenza tra antico (il ricercato
apparato ritmico; l’evocatività della voce) e moderno (impegno sociale nei testi e un utilizzo frequente
dell’elettronica).
Porge infatti cose buone e pure ottime, principalmente una title track innodica e non facilona, il capolavoro di onirismo percussivo - da qualche parte
tra My Life In The Bush Of Ghosts e Nusrat
Fateh Ali Khan - A Song For Women, quelle venature latine nella sensuale Dakar Moon, la riflessione
crepuscolare Tindo Quando (superiore alla tediosa
gemella Tindo: in ambedue compare - cantando in
recensioni
51
un surreale italiano - Sabina Sciubba dei Brazilian
Girls). Altrove, sfortunatamente, gli ingredienti non
sono mescolati con altrettanta sapienza e il sapore
in bocca è dolciastro, innaturale.
Piacevolmente ecumenico benché talvolta eccessivamente salottiero, Televison andrà lontano quanto a vendite e - in considerazione di quanto spacciano per world music - meritandoselo in massima
parte. La via del cuore gli è nondimeno preclusa e,
pur con le eccezioni di cui sopra, dobbiamo tenerne
conto.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Barbara Morgenstern - BM
(Monika Enterprise DE, Novembre
2008)
G enere : C antautorato deutch
Ha lasciato in soffitta l’organetto con il quale s’accompagnava per il pianoforte, la Morgenstern. Per
Bm si è voluta sbarazzare di ogni tentazione indietronica marcatamente Berlin. Le canzoni sono al
piano. Gli arrangiamenti invisibilmente elettronici e
spuntano gli archi, in ombra, ma determinanti.
L’effetto chamber, assieme al mood fortemente mitteleuropeo, è sicuramente il tratto più caratteristico
del lavoro e del suo piccolo grande manifesto, Come
To Berlin, brano cruciale anche perché portavoce di
uno spirito deutch rinnovato, sempre asciutto e venato di piccole maliconie, ma più umano e nondimeno maggiormente libero. E c’è un nome dietro
a tutto questo: Robert Wyatt, il grande vecchio.
Finirà per influenzare l’intero platter sia per l’impronta lasciata in Camouflage (co-firmato), sia per la
comunanza che Barbara ha sempre sentito con lui e
che finalmente in BM si è realizzata. Pubblicato in diversi paesi Europei già a fine 2008
(ma non distribuito in Italia sin’ora), l’album testimonia un salto qualitativo importante per una certamente brava, ma mai decisiva, comunque da appassionati d’indietronica.
Il coraggio con il quale Barbara si presenta ora al
mondo (anche diventando madre nel frattempo
che scriviamo) è la mossa che va oltre. Soprattutto
quando l’equilibrio si fonda su piccoli umori slegati
dalle connotazioni totalmente tedesche. La ragazza
auf Berlin di The Operator si gioca in due episodi
la lingua internazionale per eccellenza. C’è ancora
della timidezza, davvero, ma i brani, differentemente
dal passato, usano l’inglese per comunicare e sono
sufficientemente articolati da far pensare a un lavo52
recensioni
ro futuro totalmente dedicato.
Barbara non vuole invecchiare suonando le cose
che faceva nel suo album preferito, Nichts Muss, e
neanche s’è messa in testa di diventare una barbosa
cantautrice crepuscolare. Lei è sempre quella di Der
Augenblick, ha soltanto un abito più adulto. Del resto
la maturità è una transizione. Il prossimo album - ci
dice - sarà dance, e non come quello di Madonna (7.1/10)
Edoardo Bridda
Beardfish - Destined Solitaire
(Inside Out Music, Luglio 2009)
G enere : N eo - progres sive
Per gli svedesi Beardfish, band attiva dal 2001 e approdata al quinto album in studio, sembra che la
grande stagione del rock progressivo degli anni
’70 non si sia mai chiusa. È difficile trovare, oggi, un
combo così tanto legato alle sonorità ampiamente
storicizzate e metabolizzate di Emerson Lake
& Palmer, Yes, Genesis e chi più ne ha più ne
metta. Ma la creatività di Rikard Sjöblom non si ferma alla pedissequa imitazione di modelli trapassati,
ma li filtra attraverso la lente del prog metal con
un’operazione di mixaggio lontana dal semplice accostamento stilistico.
Destined Solitaire è un album interessante, forse
troppo lungo, ma che fotografa una realtà in bilico tra passato e presente. Volendo semplificare ai
minimi termini il sound del gruppo, si potrebbe immaginare una jam session tra Keith Emerson e i
Dream Theatre: epiche cavalcate che oltrepassano i 10 minuti, complessità metriche degne del
prog più virtuosistico e una vena ironica che attenua il rischio di stucchevolezza. Difficile non perdersi nelle intricatissime trame della title track o nei 15
minuti di Until You Comply. Ma non è solo sulla lunga
distanza che i Beardfish riescono ad esprimersi al
meglio, sfornando anche brevi perle come In Real
Life There Is No Algebra. Non stupisce che i Dream
Theatre li abbiano invitati ad unirsi al Progressive
Nation 2009 tour. Fossi in loro, però, avrei un po’
paura di fare brutta figura, non riuscendo a reggere
il confronto con gli svedesi.
(7.2/10)
Daniele Follero
Béatrice Ardisson - Dylan Mania
(Naive, Maggio 2009)
G enere : C ompil ation di cover
La specialista Béatrice Ardisson, già curatrice delle
highlight
Luke Vibert - We Hear You (Mu Ziq, Agosto 2009)
G enere : bbreakztronica
L’ennesimo disco del Vibert è la conferma dal basso di un suono che
pian piano si insinua nel mainstream. Lui in sordina arriva oggi con un
mattone che sta lì quadrato e non lo sposti. Perché la gavetta l’ha fatta
e oggi non ha problemi a spaziare dall’Aphex Twin al dubstep, dalla
techno al math-hop. Solo che non è come i vecchioni impagliati di
casa Warp che viaggiano sulla loro cristallizazione, sull’alloro di chi ha
raggiunto l’olimpo. Luke si dà da fare e mescola il verbo hop di vecchia
data Ninja (Belief File, We Hear You) con l’hip-core da strada (De-Pimp
Act), il technostep (Hot Stick) con l’acid (Pretty Old Acid Music). Non è uno Zomby mordi e fuggi.
Vibert ci rinfranca con un discone che sta in piedi e ha l’aura del classico. Quelle cose di ghiaccio
che non si scioglievano manco con l’aria fumosa dei club 90. Oggi sono pochi quelli che possono
vantare un CV con i controcazzi come l’uomo in questione. Solo che lui non lo fa. E per questo,
massimum respect.
(7.7/10)
Marco Braggion
apprezzate raccolte di cover varie Paris Derniére, dedica ora un volume monografico a his Bobness
pescando tra quelle più recenti e/o meno sentite
nell’oceanum magnum delle cover di Dylan (che è
tale da quintuplicare -a tenersi stretti- la pur nutrita
discografia del cantautore).
Se infatti si eccettua la chiusura, affidata alla Knockin’
on Heaven’s Door che Antony aveva già disenfatizzato e riportato a casa sua nella colonna sonora di
I’m Not There, i nomi non sono granché noti; il
che rende questa compilation un favore fatto, appunto, ai dylan-maniaci risparmiando loro la fatica,
posto che ne avessero saputo l’esistenza, di andare
a recuperare questi ennesimi omaggi al Maestro.
I risultati però sono altalenanti: si apre con una Like
a Rolling Stone la cui frenesia r’n’b da cartolina si
risolve in un cantato ammazza-melodia e in un rullante raddoppiato che dovrebbe pompare e invece
risulta noioso (meglio il dream pop dell’altra versione, bonus solo per la versione digitale del disco)
mentre il funky-soul di Just Like A Woman è onesto,
ma anche qui la (splendida) melodia originale è sparita, come nella comunque più riuscita Ballad of a
Thin Man, tra JJJ e Mick Harvey.
Va meglio con una morbida Lay Lady Lay, con la
versione Devo di Subterranean Homesick Blues ad
opera dei Minuscule Hey (ma funziona anche
l’altra, il blues sfacciato degli Slumcats), col tecnopop degli Automatiq alle prese con I Want You e
quello folle dei Kimisolo che fanno Mr.Tambourine
Man a metà tra una samba e i Fiery Furnaces,
o con i Pixies virati tecnofunk di un altro bonus,
Tombstone Blues.
Spazio alle stranezze, dunque (il country è limitato
a To Ramona, il gruppo che la esegue non si chiama
These United States a caso, evidentemente) e
all’approccio irriverente.
E sono proprio questi momenti, in cui canzoni storiche ricevono un po’ di luce nuova, i migliori di un
disco che perde un po’ troppo spesso l’occasione
di essere ciò che era nato per essere: l’occasione di
riascoltare un repertorio di pregio che magari ci si
era stancati di ascoltare in versione originale.
(6/10)
Giulio Pasquali
Black Meteoric Star - Self Titled
(DFA, Settembre 2009)
G enere : electro acid house
Una volta, quando viveva a New York, suonava krautrock fuori tempo massimo (vedi il progetto Delia
Gonzalez & Gavin Russom), mentre oggi, stabilitosi a Berlino, nella terra dei corrieri cosmici, ripiega
nell’acid house. È Gavin Russom il trasformista, colui
recensioni
53
che vive l’ambiente circostante proiettato altrove,
nel suo personale gioco di specchi. Da novello Klaus
Schulze, ieri, a discepolo di DJ Pierre oggi.
Black Meteoric Star è il nuovo livello del Nostro.
Tetro, marziale, diretto.Tipo dei Justice al vetriolo,
o meglio il Carpenter di Fuga Da New York riletto,
appunto, da DJ Pierre. Quindi i Phuture, che poi
si legge Acid Trax. Dominatron la manda a memoria:
Darby Crash semmai avesse smanettato una macchina. Un pugno nello stomaco rigorosamente analogico, pertanto fisico. Irruente. Un synth vintage,
il Korg EX-800, seguito
da un sequencer di propria ideazione (Russom
è un esperto in materia)
e l’effetto, prossimo alla
mitologica 303 della Roland, è letale. Anthem è un
allucinante, viziosa trama
da guerriglia urbana. Death Tunnel e World Eater sono
- specie la seconda - funk d’assalto ideali per scenari
d’explotation.
L’immaginario è dark, la cadenza, satura e melmosa, non da tregua. Le tracce, mai al di sotto dei sei
minuti, pari - è doveroso ribadirlo - ad aggressioni
sonore. Nel finale, la catarsi: Dreamcatcher e Dawn,
una housey alla stregua dei giorni Trax Records
(e per rimanere in casa Dfa, contraltare sinistro di
Happy House di Juan MacLean), l’altra cosmic a
là Lindstrøm. Sommate, oltrepassano la mezz’ora.
E che mezz’ora! Black Meteoric Star, acid house fattanza.
(7/10)
Gianni Avella
Blitzen Trapper - Black River
Killer EP (Sub Pop, Agosto 2009)
G enere : pop rock psych
Trattasi di un EP che contiene il pezzo omonimo,
uscito sull’ultimo disco Furr (2008) e 6 canzoni finora disponibili su CDR venduti ai loro concerti.
La formula si assesta su un songwriting strutturato
con prevalenza di ballad, anche se non mancano le
virate psych, come nell‘acida Big Black Bird. La vena
melodica che li caratterizza fa bella mostra di sé,
questa volta con prevalenza pop, ricordando in più
momenti le rivisitazioni del migliore Beck, periodo
Sea Change (Shoulder Full of You, Preacher’s Sister’s Boy).
Black River Killer EP quindi niente aggiunge e
54
recensioni
Caetano Veloso - Zii e zie
(Universal, Luglio 2009)
G enere : post - cantautorato brasiliano
La chiave che meglio rivela l’essenza di questo nuovo lavoro del cantautore di Bahia sta tutta in due
scritte che compaiono sulla confezione esterna:
“transambas” sul fronte e, ovviamente, “transrock”
sul retro. Dici ovviamente ma non è poi così ovvio:
a invertire l’ordine dei fattori c’è il rischio che il
risultato cambi, visto che non siamo alle prese con
la matematica pura ma con la realtà.
Qui, inceve, significa che Veloso dapprima trasfigura
la tradizione del proprio paese (come se non l’avesse fatto a sufficienza: già questo basterebbe a farcelo
amare) e poi traffica con quella musica occidentale
che ha colonizzato il resto del mondo. Che, idem
come sopra, ha in passato di già restituito diversa da
come la si intende altrove. Solo che, nell’esito finale,
tutto si mescola perfetto e indistinguibile. Non ci
siete? Va bene: fuor di metafora, Zii e zie sta dalle
parti del suono elettrico che caratterizzava il predecessore Cê: medesima la banda di accompagnatori,
l’estro e l’inventiva. Così, affrontando l’asperità da
ambo i versanti - impossibile? non per costui - non
c’è modo di sbagliare: si prendono le radici e gli
si conferisce un’energica scossa, ci si cala nell’oggi
come si fa sin dall’inizio di una lunga e pressoché
immacolata carriera.
Non di trasformismo tocca allora parlare, semmai
di una qualità specifica che aleggia sopra una musica sublime e genuina a prescindere dalle forme che
adotta. Anche e soprattutto quando maneggia un’intellettualità serena e matura senza tracotanza pur
avendone tutto il diritto. Meglio lasciarla ai burattini,
quella, visto che non hanno pensieri e a qualcosa
dovranno pur ricorrere: noi preferiamo perderci
dentro il minimalismo da blues tropicale di A base de
Guantanamo, ammirare lo sviluppo chitarristico della fluviale Perdeu, la rilettura sapiente di Ingenuidade
e l’ineffabile Por quem? Ci soffermiamo per giorni
a indagare i meccanismi sottili di un disco al solito
ottimo, sfaccettato ma unitario, carezzevole e sferzante, uno e trino. Come accidenti fai, Caetano?
(7.4/10)
Casa - Un giorno il mio principe
verrà (Dischi Obliqui, Settembre
2009)
G enere : rock obliquo
I Casa sono persone che conoscono perfettamente
la destrutturazione; che vengono dall’ambiente dello
smontaggio rock; che sono cresciuti a pane e obliquità. Sono cólti e permeati dalla decostruzione del
blues e della psichedelica di fine Sessanta; dal gioco
coi mattoncini armonici e ritmici del post-punk di
fine Settanta - inizio Ottanta; e ovviamente dal postrock più cerebrale e meno emozionale dei Novanta. Per non parlare, fuori dal r’n’r, delle avanguardie.
Epperò i Casa hanno la necessità e pure il coraggio
di fare qualcosa. Si tratta della volontà di non essere
solo parte di esperienze di pars destruens del rock,
che hanno sicuramente avuto risultati eccezionali, di
cui tutti siamo ancora perdutamente innamorati, ma
che in molte forme, data 2009, hanno forse esaurito
il loro corso. I Casa non sono mai derivativi proprio
perché tentano una nuova via alla pars construens
del rock. In Un giorno il mio principe verrà
si percepisce proprio questo sforzo, fin dalla prima canzone, Nick Drake, un bozzetto percussivo alla
VU dove la voce di Bordignon, nei suoi eccessi di
“interpretazione”, si sarebbe detto una volta, riesce
a costruire dei collegamenti inediti. Il tentativo fa
emergere alcuni tic del suono dei Casa, ma anche
di fatto il loro stile inconfondibile (che intreccia armonie oblique, in alcuni punti fa primeggiare i tecnicismi della vocalità, si concentra su alcuni timbri
di chitarra e su brusii sintetici che saltuariamente ci
fanno pensare a Ravenstine…); d’altra parte lascia
ancora ampio spazio ai numeri astratti: Padre Nostro / Motoraduno è figlio sicuramente del free-jazz,
ma anche di quella Don Aman degli Slint che era
una perpetuazione all’infinito dell’inizio di un brano
rock, incartato ancora prima di maturare; e qui i
Casa perpetuano all’infinito l’intro di una canzone
per poi passare bruscamente alla sua conclusione.
La pars construens, in mezzo all’astrazione, si nota
anche grazie all’ancoraggio con il reale di P2, brano
sul doppio Stato e sul “sommerso” italiano - qualcosa di cogente, per nulla metaforico, sempre urgente
da mettere all’ordine del giorno. È però ascoltando
la paranoia di Non hai esterno - e soprattutto Climaterio - che chi scrive ha percepito di ascoltare
qualcosa che è già sul vertice di una montagna. Già
scalata.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Gaspare Caliri
niente toglie all‘economia del gruppo; di gran lunga
avremmo preferito che la loro vena anarcoide venisse fuori con più decisione.
(6.8/10)
Teresa Greco
Castanets - Texas Rose The Thaw
& The Beasts (Asthmatic Kitty
Records, Settembre 2009)
G enere : country rock
Gli artisti della categoria a cui appartiene Ray Raposa corrono sempre il rischio di avvitarsi su se
stessi nel tentativo perenne di affrancarsi dalla propria stessa formula, senza accorgersi di rimanervi
invece sempre più invischiati. Questo per dire, che
alle orecchie di chi scrive, sembrano anni che Raposa tenta di allontanarsi in tutti i modi dal modello
messo giù dal debutto di Cathedral, anni passati
a fare tentativi su tentativi, canzoni su canzoni,
cercando di modificare
quello che non si può
modificare.
Raposa non può fuggire
da se stesso e allora ogni
nuovo disco è sempre
un nuovo disco di Castanets, con qualcosa che in apparenza sembra
diverso ma in realtà non lo è. City Of Refuge era
il lavoro spartano di un animo solitario, che si rifletteva nel taglio minimale degli arrangiamenti? Ecco
che il nuovissimo Texas Rose fa l’esatto contrario.
Innanzitutto gran lavoro di produzione, come non si
sentiva dai tempi di Cathedral, appunto, e largo alle
guest stars, nelle persone di Jason Crane (Rocket
From The Crypt), David J (Bauhaus), Pall Jenkins (Black Heart Procession), Andy Robillard
(Gogogo Airhart) e ancora DM Stith, Gabriel
Sundy, Chris Cory e così di questo passo.
Si ottiene così un lavoro in qualche modo più corale
e definitivo, come una sorta di best of di Castanets,
con da un lato gli epici mantra country rock venati
di psichedelia, che lo hanno reso famoso (Rose, My
Heart, Thaw And The Beast, Dance dance), dall’altro le
stramberie indie su drum machine (Worn from the
fight, Lucky Old Moon), e dall’altro ancora i brani dal
taglio più cantautorale e rock (No Trouble, Down the
Line). Dire che sia un brutto disco sarebbe davvero
ingeneroso, ma come dire… è come ascoltare Cathedral parte 6°. Un sequel.
(6/10)
Antonello Comunale
Chihei Hatakeyama - Saunter
(Room40, Maggio 2009)
G enere : ambien / drones / elettroacustica
Qualcosa a suo tempo lo aveva già scritto Chihei
recensioni
55
Hatakeyama e qualcosa di buono.Tornano i drones, le sfumature sospese e i flussi di coscenza di
Minima Moralia (Kranky, 2006). Rituali ambient
a oggi più consapevoli nei dettagli d’elettroacustica
di Saunter e meno per quelli di August. (Under
The Spire, 2009).
Più ispirato il Hatakeyama in uscita Room40, per
struttura, sottile brezza melodica e suite di materiale (loop, effetti, corde sfiorate e field recording). Stili
a servizio di forma e paesaggio, quello più zen che
per familiarità e policromie di luce ed ombra ritorna
al tempo sosteso di Soundpostcards (Gianluca
Becuzzi, Fabio Orsi).
Restano comunque e per entrambi le questioni più
alte, estetica del silenzio, approcci all’ascolto ed i
microtoni e le tessiture infinitesimali dall’eredità
concreta. Da segnalare tra i più interessanti giovani
drone-master dell’ultimo anno.
(7.2/10)
Sara Bracco
Chihei Hatakeyama - August. (Under
The Spire, Giugno 2009)
G enere : ambient usic / drones
Qualcosa a suo tempo lo aveva già scritto Chihei
Hatakeyama e qualcosa di buono.Tornano i drones, le sfumature sospese e i flussi di coscenza di
Minima Moralia (Kranky, 2006). Rituali ambient
a oggi più consapevoli nei dettagli d’elettroacustica
di Saunter (Room40, 2009) e meno per quelli di
August (Under The Spire, 2009).
Più ispirato il Hatakeyama in uscita Room40, qui a
farsi spazio è l’ambient music più quieta e meditativa, quella dai lunghi ascolti, per circolarità e dileguate fonti più vicina alla recente prova del collega
Koji Saito.
Restano comunque e per entrambi le questioni più
alte, estetica del silenzio, approcci all’ascolto ed i
microtoni e le tessiture infinitesimali dall’eredità
concreta. Da segnalare tra i più interessanti giovani
drone-master dell’ultimo anno.
(6.6/10)
Sara Bracco
Chopigula - Sunshine over the
circus ep (Shadow Paradigm,
Luglio 2009)
G enere : E lectronic
Shade Slicer e Scott Charaund, rispettivamente
dall’India e dal Texas, si conoscono via soulseek un
po’ di tempo fa scambiandosi dei giga di musica. Gli
56
recensioni
Orb, Autechre, il catalogo Morr, l’elettroascustica,
i raga, gli Animal Collective e tutta la Paw Tracks.
A un certo viene naturale metter su un progetto
a distanza sotto la benedizione di Vishnu. Nasce
Chopingula la “musica che libera la mente” e nel
migliore dei casi pare di sentire proprio i vecchi
cheap freak degli Orb remissati dagli Autechre
di Gantz Graf (Womb). Altrove è un castrone di
layer in mulinello tipo lavello con i filtri che girano
una volta svuotato il portacenere.
Promettente nella misura in cui vi piaccia un versus tra Manitoba e Animal Collective, o una
compila bastard basata sulle loro scalette, la freschezza e bontà dell’eppì sono totalmente legati al
grado di eccitamento che questo tipo di laptopping
a distanza vi procuri. Il contenuto infatti è roba che
l’esperto di software per la musica te lo data alla
punto versione.
Aspetto l’omino dal futuro che mi spacci questo
sound e modo di lavoro come vintage e ci produca
un lavoro sopra.
(5/10)
Edoardo Bridda
Circuit Des Yeux - Sirenum (De
Stjil, Luglio 2009)
G enere : crimson wave
Dopo l’LP d’esordio, sempre su De Stijl, torna Haley
Fohr con il suo progetto solista (la ragazza suona
infatti anche nei Cro Magnon con l’amica Katie
Leming, a sua volta attiva singolarmente a nome
Bird).
Se il recente singolo Fruition su Dull Knife aveva fatto presagire una timida svolta in chiave pop/wave,
questo secondo album frena decisamente tale ipotesi, ristabilendosi sulle coordinate già tratteggiate
con il disco dell’anno scorso. Chi già ha avuto modo
di ascoltare le nenie claudicanti della ragazza di Lafayette, sa dunque cosa aspettarsi; a coloro invece che
non hanno tale familiarità basti sapere che la nostra
confeziona piccoli incubi sonori i cui principali ingredienti sono una voce atona ed infestata, corde di
piano pizzicate con una tronchesina e tanto, tanto
rumore come contorno. Se dunque la nuova uscita
non si sposta di molto da quanto precedente detto,
vi sono tuttavia un paio di novità che però, a ben vedere, risultano essere più aggravanti che attenuanti:
il maggior numero di pezzi e soprattutto la durata
mediamente superiore di questi sono entrambi fattori che appesantiscono la già non immediata digestione.
highlight
Neil Landstrumm - Bambaataa Eats His Breakfast (Planet Mu
Records, Agosto 2009)
G enere : 8 bit bleep - wonkytronica
Dopo il boom, il wonky perde peso. E restano pochi a professare il suo verbo: Zomby, Rustie e
Landstrumm. La trimurti che non molla. Il genere/non-genere su cui si discute animatamente è
ancora vivo? Con questo nuovo lavoro dell’uomo Neil si direbbe proprio di sì. E probabilmente c’è anche una direzione verso cui guardare.
Non è una svolta completa, ma si sente che i detriti d’incertezza se ne
stanno andando a favore di un’arrotata di lame.
In primo piano quindi (come al solito sul pianeta dello scozzese) la
tecnica, solo che stavolta si fa tutto in minisingoli, cose che in media durano 3 minuti. E ci si rende conto che l’attitudine alla brevità
(già perseguita nella pletora di signoli zombiani) è una delle possibili
strade. Come quasi 20 anni fa quando i bbreakers sfornavano tracce
alla speed of light, anche qui ci si imbarca in un minimalismo pieno di bleep ed effettini ereditati
dall’ardkore (SK1-The Damager), atmosfere gloomy direttamente dal grime (How Do You Feel?), la
street dell’hip-hop con il doppio featuring di Profisee e un sapore di cameretta e consolle nerdy
inevitabili (Schlump Funk).
La citazione nel titolo è comunque la chiave di lettura primaria. Ancora una volta il ritorno a quei
suoni vecchi, quegli 80 dei padri dell’elettronica fatta con poco, rimasticati dopo lo sballo E, dopo
la Warp e dopo l’IDM. Ma lo sguardo a ritroso nel tempo non si insabbia come nel caso della
minimal. Landstrumm sceglie le cose giuste al momento giusto senza strafare. Questa colazione è
il risveglio dei campioni dopo lo sballo degli esordi: gli ingrendienti immancabili (almeno per ora)
sono le spezie technoidi per riprendere forza e i fumi rilassanti dell’ambient meditativa. Buon
appetito.
(7/10)
Marco Braggion
Certo, non è un’assimilazione indolore il fine della
musica di Circuit des Yeux e l’intento di generare
alienazione e disorientamento in chi ascolta è pienamente sortito; ciononostante, non si può fare a
meno di notare come la formula cominci a manifestare sintomi di logorio. Sono per i fan più diehard.
(6.3/10)
Andrea Napoli
Clean (The) - Mister Pop (Merge,
Settembre 2009)
G enere : psych pop
Otto anni dopo quel The Getaway che ne festeggiava l’approdo in casa Merge e (quindi) ad un
pubblico più vasto, ecco l’ennesimo ritorno dei The
Clean. Una parentesi di “silenzio” per nulla silenzio-
so, vista la pubblicazione di antologie e album live
che hanno tenuto calda l’attenzione per questo trio
neozelandese con un grandissimo futuro dietro le
spalle.
Attivi dalla fine dei seventies, adorati da calibri
come Stephen Malkmus, Sonic Youth e Yo
La Tengo, possono vantare un repertorio non
corposo ma geniale, condotto sul filo di una sintesi
cangiante che ibrida garage e folk, psichedelia e new
wave, kraut e twee-pop, giocandosela d’anticipo
per molti aspetti sugli scenari noise dei Sonic Youth
(aapunto) e sulla visionarietà struggente e deragliata dei Flaming Lips. Hanno dovuto attendere il
nuovo millennio per raccogliere qualche briciolo di
successo in più, che il qui presente Mister Pop
potrebbe da par suo rinforzare.
Condotto col disincanto arguto di chi sa di non
recensioni
57
potersi più permettere rivoluzioni, ché troppi treni
son passati senza fermare alla stazioncina di periferia, ma sorretti dall’entusiasmo di chi vede infine
riconosciuti sforzi e meriti, è un disco energico e
denso, dall’andatura insolita lungo quel filo sottile e
arzigogolato con cui hanno tessuto tante formidabili trame. C’è la ballata elettracustica tra il frugale
e lo speziato, che s’arriccia acidula ripensando alla
psych bostoniana (Asleep In The Tunnel), c’è la raga
motoristica col bordone ipnotico, gli ansiti di violino
ed i feedback volatili (Moonjumper), c’è una strana
commistione tra kraut e wave ammorbata da tastiere soffici, arguzie Brian Eno e vocoder à la Air
(Tensile), e c’è l’incanto jingle pop coi coretti cremosi, l’estro amarognolo
Go-Betweens e l’incedere caparbio da Soft
Boys illanguiditi (In the
Dreamlife You Need a
Rubber Soul).
C’è insomma questo
muoversi affabile e insidioso, lo scarto visionario dietro la siepe nel giardinetto (vedi la suadente
Simple Fix, coi cinguettii, i gorgoglii, la bucolica serenità pizzicata di malinconia come potrebbero degli
Xtc estatici), la nostalgia tirata per la giacchetta per
ravvivarne i fantasmi (una Loog che mette in circolo gli Ultravox e i Doors più saltellanti, oppure i primi Rem di Back In The Day), il coraggio di
guardare attraverso la filigrana del pop fidando nella
sua consistenza, nel suo impalpabile e accattivanete
spessore.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Coalesce - Ox (Relapse, Giugno
2009)
G enere : post - hc
Dieci anni sono trascosi dal precedente album dei
Coalesce e da allora una nuova generazione di
punk si è invecchiata, in questo caso neanche troppo
male, tra famiglia (la figlianza del cantante Ingram) e
carriere universitarie (il PH.D. del chitarrista Steinenger). Quindi Ox, che rinuncia al massimalismo
compatto dei precedenti Coalesce, con un suono
meno oltranzista e riferimenti del gruppo tutti divenuti espliciti.
Iniziano citando se stessi: le controllate dissonanze di Functioning In Impatience, i riff 70s ultracompressati di Revolution In Just Listening, e indietro al
58
recensioni
blues/noise meccanico di Jesus Lizard e Dazzling Killmen. Poi momenti prog, che ricordano
le rivisitazioni di genere Usa Is A Monster, e
giù giù fino agli antenati, il country puzzolente delle
praterie americane, tra strumentali ballate spaghetti
western ad amplificatori spenti (Where Satir Sour,
We Have Lost Our Will) e perfino il bottle neck di
Wild Ox Moan.
Il gusto di ripescare le influenze ce lo avevano già
mostrato (un disco di cover di Led Zeppelin) e
anche questo Ox suona più come una rivendicazione
delle radici che come un tentativo di rinnovamento. Voler manifestare come al di là dalla dimensione
sovranazionale in cui si colloca solitamente la scena
hardcore, a suo modo Coalesce è un prodotto di
una certa terra, tra muggiti di vacche e nubi di polvere.
(6.2/10)
Leonardo Amico
Cold Cave - Love Comes Close
(Heartworm, Luglio 2009)
G enere : synth - pop
Dopo diversi vinili, un paio di tape e un Cd collection, il progetto di Wes Eisold arriva finalmente
all’album di esordio; album che non si esime certo
dal raccogliere i vari singoli sparsi lungo il cammino
finora percorso, come nella migliore tradizione (un
po’ ruffiana, forse) dell’industria discografica classica.
Bene dunque ha fatto chi ha aspettato questa uscita
per metter mano al portafoglio perché qui troverà
non solo la famigerata The Trees Grew Emotions And
Died (in pratica il pezzo che gli ha procurato le prime attenzioni), ma anche tutte le canzoni dei loro
ultimi EP 12’’: le tre di Etsel And Ruby, uscito per
il tour inglese, e quelle del più recente The Laurels
pubblicato dalla giapponese Big Love; se le versioni
non sembrano essere le stesse dei rispettivi singoli,
va però detto che le differenze sono davvero minime ed irrilevanti. Giusto un paio di tracce sembrano
rimanere appannaggio di questo album (Hello Rats,
Youth & Lust), ma ciò non toglie che, per chi già non
possiede i titoli sopracitati, questa uscita sia un’ottima occasione per aver su un unico disco tutte le hit
synth-pop in pieno stile Depeche Mode del combo
di Philadelphia.
(7.2/10)
Andrea Napoli
Crash Normal - Finger Shower
(Rijapov, Luglio 2009)
G enere : synth garage punk
Dopo una pausa di un paio di anni, torna il duo francese che fu tra i primi a spostare l’attenzione sul
versante garage dagli Stati Uniti verso i lidi del Vecchio Continente; chi tra gli affezionati era rimasto
dubbioso davanti alle sonorità troppo strettamente
garage di Heavy Listening avrà qui di che compiacersi. Il gruppo infatti rilascia questo 10 pollici
(insieme con qualche altro singolo) in cui infila sette
brani di garage-punk infettato da clangori meccanici (la title-track e Bikini Invaiders ne sono un ottimo
esempio) e stomp alieni (Chrome Cramps, nomen
omen nonché probabilmente il pezzo migliore del
lotto) che ricordano al pari i conterranei Cheveu
e i seminali A-Frames e Country Teasers di
cui, non a caso, coverizzano un classico come Hairy
Wine 2. Un ritorno di tutto rispetto anche se, vedendo la pletora di release uscite al contempo, vieni
da chiedersi se non fosse stato più sensato pubblicare un unico, nuovo LP, ma forse c’è una logica
anche dietro a bizzarrie come queste.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Dam-Funk - Toeachizown Vol. 1:
LAtrik (Stones Throw, Luglio 2009)
G enere : space - synth bl ack
Damon G. Riddick, sulla scena ormai da qualche
anno ma con pochi clamori, un uomo che ha nel
funk il suo orizzonte di vita, funk nell’accezione più
peanutbutterwolfiana, soprattutto a livello di suoni,
e cioè funk dal 1980 in avanti, dopo una serie di produzioni su piccola e media scala (un dodici pollici,
alcuni remix per Baron Zen e un mix assieme a
James Pants, un mini-LP che era il quarto volume della serie Rhythm Trax, davvero ottimo, e il
remix di Summertime Clothes degli Animal Collective), mette in cantiere un progetto mastodontico e in grande stile, un set di cinque vinili/compact
che dovrebbe vedere la luce in autunno, grande mosaico modern-funk dal nome Toeachizown (masticamento di qualcosa tipo “a ciascuno il suo”), che
lo stesso autore considera il suo primo vero album
solista. I singoli volumi intanto, una volta terminati, verranno messi in digital download sul sito della Stones Throw. Apre le danze, anticipato da un 12”
con due pezzi, questo LAtrik (altro masticamento,
“i trucchetti di Los Angeles”), sette pezzi, quaranta
minuti. Dam rimane fedele al suo motto estetico e
tecnico old school drum machines and early 80s analog synthesizers, without any loops or samples. Rallenta
la battuta, ammorbidisce il suono, ci mette qualche
affusolata voce femminile, un funk-r’n’b slow-disco
che guarda all’onnipresente Lil’ Louis, a Prince,
a Juan Atkins (clamorosamente, sulla title
track e nel pezzo successivo, entrambi già nel
12”). La lunga traccia finale è (intanto, un pezzo
space-house) un pezzo visionario (ma per capirci,
all’opposto del barocchismo di altri visionari come i Sa-Ra), un pezzo autistico, e, senza troppi giri di parole, un capolavoro.
Dam dice di stare cercando il funk del futuro (alla
lettera, il futuro del funk), e sembra dire, rivisitando
la tradizione con uno spirito contemporaneo, che il
futuro già ci guarda le spalle. Spacey shit that sounds
like the cover looks, diceva altrove, e qui la copertina,
volente o nolente, non può non fare pensare ad un
rovescio negro e ottantino del Moroder di From
Here to Eternity. Un disco asciutto, nebuloso,
raffinato, utopistico, che non si capisce subito, che si
deve non sentire (e cioé ascoltare) ma sentire. Forse
un disco addirittura incompromissorio, radicale, nel
suo essere testardamente fuori moda, soprattutto
perché anticontaminativo. Il trasporto alzerebbe il
voto, ma aspettiamo il cofanettone per le lodi sperticate.
(7.3/10)
Gabriele Marino
Dam-Funk - Toeachizown Vol. 2: Fly
(Stones Throw, Agosto 2009)
G enere : space - synth bl ack
Seconda release digitale del progetto Toechizown.
Dam persevera nel suo autismo old skool fatto di
drum machine e trame di synth con l’obiettivo dichiarato di creare un electric-space-funk da club. Perfetta autodescrizione. Siamo comunque un paio di
gradini sotto LAtrik, con tracce meno efficaci, forse semplicemente perché meno particolari, più trax,
ma slow, da sottofondo (o basi volano per lunghi
sdilinquimenti di synth, Burn Straight Thru U, ottima),
ma il grip è lo stesso, se non altro per l’originalità
della formula e la capacità di sgusciare fuori da una
estrema rigidità produttiva (autoimposta) grazie alla
freschezza dei motivi e alla cura degli arrangiamenti. Ma chissà quanto saprà mantenere alto il livello
recensioni
59
highlight
Oneohtrix Point Never - Zones Without People (Arbor, Settembre
2009)
G enere : synth trance
Quello di Daniel Lopatin, l’uomo che sta dietro la sigla Oneohtrix Point Never, paradossalmente potrebbe essere considerato come il suono che meglio incarna la contemporaneità. C’è
qualcosa, non solo nella filigrana sintetica delle sue produzioni, ma anche nella filosofia che sottende il progetto OPN che sembra rappresentare al meglio l’aria dei tempi, nello specifico gli anni
che chiudono il primo decennio del nuovo secolo e che sono stanti
anche fin troppo gravidi di suggestioni e ipotesi, tutte costantemente
riguardanti il passato.
Lopatin, va detto subito, è un esteta del suono sintetico, in una maniera
non lontana dai nuovi corrieri cosmici che in questo periodo affollano
gli scaffali dei negozi di dischi e di cui parlammo su SA in un indimenticato speciale di alcuni mesi orsono.Vista poi da un lato meno formale,
la sua musica ha una costante eco passatista e nostalgica, al punto che
ha destato non a caso l’interesse di David Keenan per tutto il suo discorso sull’hypnagogic pop. Lopatin è un figlio degli anni ’80 e la sua è
un’estetica retrò, ma senza andare a parare per le lande pericolose del kitch.
Un equilibrio più unico che raro, che viene rappresentato al meglio nel nuovo disco in uscita su
Arbor e che nelle intenzioni di Lopatin dovrebbe essere la seconda parte di una trilogia iniziata con Betrayed In The Octagon e che ruota intorno al concetto di interfaccia uomo/macchina.
L’estetica retrò anni ’80, si materializza con il lavorio di sintetizzatore valvolare di Computer Vision,
che porta Lopatin in una direzione vicina ad Alan Parsons Project, se non proprio ai Pink
Floyd di Dark Side Of The Moon. Costruzioni sempre progressive le sue, sia quando concorrono a costruire i paradisi zen di Format & Journey North sia quando disegnano gli asettici
panorami arcade nell’epica title track. Lopatin è raffinatissimo anche nella maniera, abusata dei
Jonas Reinhardt e degli Expo’70, di trafficare con la tecnologia valvolare per disegnare
soundtrack horror per inediti film di John Carpenter o George Romero (Learning To Control Myself, Disconnecting Entirely). Da qui alla new age posticcia venata di kraut il passo è finanche
troppo breve e il disco chiude giustamente sulle note dell’estasi, omaggiando Emil Cioran e i
videogame su commodore 64 (Hyperdawn).
Oneohtrix Point Never è il vecchio che avanza, la tecnologia che non si aggiorna, l’hardware che
non riusciamo a riciclare, in un epoca tra l’altro in cui anche il 2.0 comincia a mostrare le proprie
crepe. Prepariamoci per il dopo bomba. Lopatin ci sta già mandando le sue registrazioni comodamente nascosto nel suo rifugio antiatomico posizionato da qualche parte tra Zion e Tron.
(7.5/10)
Antonello Comunale
fino al quinto volume. I primi tre pezzi sono pensati
come tre momenti di una stessa Move Suite e infatti
hanno la stessa base ritmica. Candy Dance apre con
accordi di pianosynth che ricordano le progressioni
degli Steely Dan di Aja e poi si lancia in un motivetto funky-dance quasi da videogioco.
(7/10)
Gabriele Marino
60
recensioni
Dat Politics - Mad Kit (Chicks On
Speed, Gennaio 2009)
G enere : electropop fidget
Se è un rischio oggi fare electro pop dopo la lezione
dei padri Daft Punk, fare fidget lo è ancora di più,
dato il boom dei Crookers e della scuola Kitsuné.
Ci provano i Dat Politics a dire qualcosa di nuovo
con questi 45 minuti, ma la loro proposta è solo un
cliché di cose senza anima, giocattoli a 8 bit filtrati
con qualche effettino e qualche vocetta buona per
serate a vodka e red bull. No politics, no party.
(4/10)
Marco Braggion
David Sylvian - Manafon (Samadhi
Sound, Settembre 2009)
G enere : avantgarde
Che l’egocentrismo, e tanto più l’ambizione, faccia
parte del nuovo lavoro di Sylvian non è cosa inedita.
Le grandi opere dell’uomo lo sono sempre state
e questa non fa eccezione. L’ambizione era e resta
dato fondante.
E così è Mafolon, lavoro che, rispetto alle ultime
prove del Nostro, conserva la sola direttrice ambientale e spinge forze e mezzi verso un’inedita coralità. Blemish era un lavoro coraggioso, digitale
ma pur sempre un lavoro di dualità. Ora a balzare
all’orecchio è la sintesi sonica con Sylvian a seguire,
in punta di piedi, primo tra i pari forse per la prima
volta. Il cambiamento è marcato ulteriormente con
la firma in calce dell’ex japan. Non sceglie un nuovo
moniker Sylvian ma si firma, green-ianamente, come
manager di un combo d’elettroacustica improvvisata dichiarando di voler ottenere “una moderna forma di musica da camera. Intima, dinamica, emotiva e
democratica”.
Registrato tra Londra, Vienna e Tokyo, il disco si
apre con Small Metal Gods. Burkard Stangl, Werner
Dafeldecker e Michael Moser, ovvero 3/4 dei Polwechsel, rispettivamente alla chitarra, basso e cello; Fennesz alla chitarra e laptop e Otomo Yoshihide ai giradischi a disegnare un folk mutante o
forse un blues venusiano. Si odono scricchiolii che
paiono legna che schiocca in un ardente camino. La
chitarra in totale libertà e Sylvian, didascalico, che
enuncia “It’s the farthest place i’ve ever been, it’s a
new frontier for me” (“È il luogo più lontano dove sia
mai stato, una nuova frontiera per me”). Il mood istintivo e figlio dell’improvvisazione radicale trasfigura
il Neil Young di Will To Love. Poi abbiamo The Rabbit Skinner e Random Acts Of Senseless Violence, con il
sax di Evan Parker prima e la chitarra di Keith
Rowe poi. Figure stratificate quasi senza memoria. Ossessi flussi creativi dal quid istintivo e déjà
vu (Emily Dickinson) di un Sylvian novecentesco che
trova in Parker ciò che Jon Hassell rappresentò per
Brillant Trees. Ai tempi si parlava di quartomondismo, adesso non se ne ha idea.
Un album difficile, più di quanto lo fu Blemish che
artisticamente più in là del canto a picco non andava
(e pur sempre al pop - Late Night Shopping – s’aggrappava). Mafolon ambisce al sottopelle digitale.
All’essenza oltre dio e marx del 2.0. E per sparire, di
contro alla presenza dell’incontro scontro tra personalità forti di Blemish, bisogna essere assieme.
La vera rottura infatti è la grande assenza del canto.
È lo spirito di Sylvian che s’infonde non il registro.
Rivoluzionario David.
(7.5/10)
Gianni Avella
Dead Weather (The) - Horehound
(Sony BMG Music Entertainment,
Agosto 2009)
G enere : H ard R ock + W ave
Non starò ad annoiarvi con la storia del supergruppo. Quando c’è Jack la statua di cera, l’Elvis moderno, il discorso da fare è semmai un altro. Perché
non ci stupisce vederlo sempre più calato nei panni
insalubri della rock star, e neanche che i suoi nuovi
amici (anzi amichette) gli aprano le porte portandolo oltre l’ortodossia hard rock.
D’accordo, i Dead Weather aggiornano il blues
elettrificato con istanze di fine Settanta (il synth di
No Hassle Night) e persino Novanta (il crossover
Lollapalooza style di Treat Me Like Your Mother), pensa un po’. E la cosa riesce, vivida e ultra Rock come
piace al vecchio ragazzo uomo. Ma non ce ne importa. Davvero.
Non ci importa che piacciano o no queste nuove
canzoni. Che Jack suoni la batteria o la chitarra. Che
il guitar stomp à la Black Sabbath di New Pony
mi piaccia e che gli scimmiotti della Mosshart a mo
di Fiery Furnaces, differentemente da quelli coollissimi dei Kills, le giovino. Tutto questo, veramente,
non serve a nulla. Conta la smania. Lo sfregamento.
Che non ci credi fino in fondo che sei l’Elvis moderno. E nello sbatterti eccoti l’ologramma rock. Il
portale senza il trapasso tu che, nel portale 69-09,
a trapassare, ci giochi. Vuoi entrare, Jack. Perché dal
69, i miti tirano le cuoia e entrano in campo gli animali. Gente senza regalità vera però.
Lasciate perdere i Raconteurs. Sono un’altra cosa.
È l’attitutine. È la malattia. E non è il riff, il climax, la
posa, il fuoco a perderci. E no, neanche il lavoro. Che
si consuma. Che va giù. Come il burn con la cocacola. Ma farti un sorriso tra una tirata di eyeliner e
l’altra, Jack?
(6.5/10)
Edoardo Bridda
recensioni
61
Degada Saf - Without Religions
(Disco Dada Records, Settembre
2009)
G enere : electro - cl ash
Da Castelfranco Veneto (Treviso), band synth-drummachine-chitarra nata e morta nella prima metà
degli anni Ottanta. Album nell’84 (No Inzro, titolo, come già lo stesso nome Degada Saf, in uno
strano slang misto di italiano, inglese e cose senza
senso), un sette pollici due anni dopo e nel mezzo
l’apparizione su due compilation Materiali Sonori accanto a gente come Diaframma e Frigidaire
Tango (indizio importante, leggi new-wave italiana).
Nel 2005, a vent’anni dalla sparizione dalle scene,
i due componenti Fausto Crocetta aka Fausto
Degada (voce e tastiere) e Michele Piovesan,
aka M.J.Vox (tastiere), che avevano comunque continuato a collaborare, hanno deciso di rimettere in
piedi il progetto, aggiornandosi con suoni inevitabilmente più elettronici (ma altrettanto inevitabili
richiami wave) e testi in inglese. Non conosciamo
le loro produzioni storiche, ma in ogni caso questo
ritorno non convince.
Non si parte malissimo, con una title track efficace
e d’impatto, cantata da
Alessia Peruccon, ma
poi le basi si mangiano
presto e volentieri alcune
belle intuizioni (esempio,
il riff iniziale di Let Me Inside), e i pezzi cantati da
Fausto lasciano un po’
così, con quella vena filosofico-declamatoria, un po’ troppo caricati. Ci sono
anche tre strumentali, non danzerecci, forse i pezzi
meglio costruiti e meglio calibrati, vedi l’electronica
di White Body Love, la lenta e minacciosa DJ Blood
e la chiusura praticamente ultrasoft ambient 2080.
Cover della classica Blue Monday dei New Order,
degadizzata, e secondo pezzo cantato da salvare.
(5.4/10)
Gabriele Marino
Dodos (The) - Time To Die (Wichita
Recordings, Agosto 2009)
G enere : F olk P op
Time To Die ha tutte le classiche caratteristiche
per essere l’album della maturità, “ma anche” della
consacrazione, per questo giovane duo californiano. Il predecessore Visitor è, indiscutibilmente, una
sorta di piccolo classico per chi ci arrivò troppo
62
recensioni
tardi - come noi - e amen per chi non lo apprezzò.
Costui si perde qualcosa di importante al febbrile
crocevia di country e blues, tirati all’osso e foderati
di candore canoro - per capirci - à la Kings Of
Convenience
Possedeva un qualcosa di magico, quel disco: un senso del folk d’oltreoceano freschissimo pur con radici antichissime. Rapace e crudele, ecco. Tanto che
la parola folk assumeva significati attitudinali e non
di sostanza, trasformava le rime in anthem suadenti su ritmiche all’occorrenza tribali e finger picking
faheyiani al pari scorticanti. Come se si volesse convertire gli Animal Collective in una faccenda
acustica esasperandone le idee e la reiterazione del
suono. Solo che loop e stratificazioni, qui, si traducono in una fregola strumentale da angeli coi calli
alle mani. In tal senso Fools è manifesto programmatico: base di samba tiratissima e quel raccontare
placido ma veloce nel farsi spazio tra le rime, mai
scomposto. Un contrasto contagioso, un’intuizione
potente da poter rallentare in ballata o condurre
all’estremo, magari tra ritmi ancor più veloci e urla
liberatorie. A prescindere dalle svolte future, già testimonia una cifra stilistica che si fa largo potente
attraverso il tintinnare delle bacchette e gli smalti
country, il blues elettrico e il folk campestre.
Ardua dunque a superarsi, soprattutto laddove il
duo rinuncia proprio alla varietà di intrecci percussivi per abbracciare un più canonico indie americano.
E se in ragione di ciò convochi Phil Ek alla regia,
significa che punti certi Built To Spill e a una
scrittura maggiormente ordinata. In Time To Die
il battito resta dunque energico, benché il tribale sia
più canonico e figliato dal post-punk; vi si accodano le melodie, di conseguenza più pop ma non per
questo appiccicose. L’apertura Small Deaths suona
allora riassuntiva dell’intera operazione, inspessendo la scrittura con un arrangiamento a tre (chitarra, batteria e vibrafono del “terzo uomo” Keaton
Snyder) in cerca di uno svolgimento più corposo
che, nel complesso, smarrisce la freschezza. Fortuna vuole che i momenti convincenti non manchino
nemmeno a questo giro: Fables e The Strums (dall’ottimo contrappunto fiatistico) tengono in piedi da
sole la svolta melodica. A conti fatti, i Dodos danno
spago ai bravi ma non bravissimi Grizzly Bear:
se comunque tutto ciò non dovesse bastare, non
dimenticatevi da quali standard qualitativi i Nostri
partono.
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Ducktails - Backyard (Release The
Bats, Luglio 2009)
G enere : T ropical - psych
Mentre si è in trepidante attesa per l’uscita del nuovo Landscapes, la label svedese Release The Bats
impreziosisce il suo catalogo con la versione digitale
di Backyard. Come da titolo, i 21 pezzi qui raccolti
sono il passato della creatura di Matthew Mondanile, roba risalente addirittura a prima che il moniker
venisse scelto.
È facilmente intuibile dunque che la materia trattata
non sia così dissimile da quella incontrata nell’esordio Self Titled per Not Not Fun qualche mese fa
o nei mille pezzi sparsi tra compilation, piccoli vinili
e nastri in quantità. Proprio l’amore per la desueta
cassetta è il perno di questo Backyard, dato che
sono raccolti qui i due introvabili nastri editi in proprio col titolo 1992 Demo e Ducktails II oltre
ad altri pezzi spartiti in oscure split-tape.
I suoni, come sarà facile immaginare, sono più grezzi e lo-fi, meno rifiniti e curati rispetto alle prove
(ehm) “mature” ma il risultato non cambia affatto:
psichedelia chitarristica di matrice tropicale, ridondante e rigogliosa, spesso se non sempre in modalità strumentale che ha il grande pregio di rievocare
lunghe estati torride e rilassanti tramonti in riva a
mari lontani. Nulla di più, nulla di meno di ciò che
si conosce già ma che comunque ha sempre il suo
fascino.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Early Day Miners - The Treatment
(Secretly Canadian, Settembre
2009)
G enere : indie rock
L’ultima volta che li ho ascoltati - e recensiti - ne
rimasi ben impressionato ma in fondo poco speranzoso circa le possibilità di svincolarsi dal pantano
post-rock e dalle narcosi Red House Painters
in cui con gli anni avevano finito per sprofondare.
Una buona band, con le idee ancora vive, ma intrappolata nel proprio cul de sac. Col sesto album, ecco
lo strappo. Una svolta. Tanto netta che somiglia ad
un rinnegarsi, con quell’aria da Low ringalluzziti a
prozac tribal wave e viagra pop-prog (In The Fire),
tanto che ti sembrano ora dei Tv On the Radio
stemperati Elbow (The Surface of Things), oppure
un Peter Gabriel caduto nel pentolone del druido Brian Eno (The Zip), con U2 e Coldplay a
fare gli Asterix della situazione (Becloud).
Che ci crediate o meno, c’è anche un potenziale hit
radiofonico come So Slowly, nel quale si fanno sentire
più che altrove gli effetti della recente infatuazione
per il kraut-wave, come lo stesso Daniel Burton riferisce nel blog della band. Ora, non è facile crederci
fino in fondo, si avverte quel senso di artificio che
ti fa fermare sull’orlo del coinvolgimento, però in
fondo se la cavano con agilità, toccano corde giuste,
insomma: divertono. Bravi.
(6.8/10)
Stefano Solventi
East Rodeo - Dear Violence
(Trovarobato, Luglio 2009)
G enere : free / jazz / noise
Il primo contatto con gli East Rodeo è stato dal
vivo. E diciamo subito che è dalla loro espressività
e non banalità in chiave live che è nato il nostro
interesse, subito diretto poi a Dear Violence, album
registrato nel 2008 – e
coproduzione Kapa /
Trovarobato - che figura
come secondo a nome
East Rodeo, anche se di
fatto è il primo con la
formazione attuale.
Proprio
dall’organico
vogliamo partire, per
dare un criterio di lettura del disco. Gli East Rodeo
sono metà croati metà italiani. Questo fatto apre
un sistema di termini doppi che copre come filo
conduttore molti aspetti della loro esistenza musicale. Del resto il giano bifronte è parte della loro
essenza. Innanzitutto abbiamo il rimbalzo continuo
tra jazz-core e noise rockista, che a fine ascolto rimodula i due “estremi” in free-jazz e hard-core. C’è
poi il “doppio” tra spazi di riflessione e la violenza
dell’hard-core (filtrato dal math, o in generale dalle strutture angolari, e con rimandi emo-core nel
canto). Nei momenti di stasi c’è qualcosa che richiama anche le tonalità in minore, l’emozionalità,
non ultimo il canto, appunto, ma con un equilibrio
che raramente si trova in band simili. Senza eccesso,
ma con teatralità. E senza l’ansia di far esplodere il
umorismo in modo non banale.
Più in generale si percepisce una costante oscillazione tra prolissità e progressività. Ogni loro composizione sembra prendere e lasciare una visione di
insieme. I cambi repentini si alternano alla riproposizione di temi (Transiraniana). Ciò che sembra una
parentesi un po’ troppo allungata prende il suo porecensioni
63
sto, a volte col senno di poi, all’interno della composizione, come in Ultima Volta Che Il Pesce Abbocca.
Notiamo anche, tra le cose più convincenti di Dear
Violence, le potenzialità duettistiche tra elettronica
percussiva (per quanto nel disco sia soprattutto un
tappeto d’ambiente) e batteria. E, perché no?, tra
Balcani e Mediterraneo. Intendiamoci: nulla del loro
suono fa pensare direttamente a Croazia o all’Italia
(se non la produzione riconoscibile di Giulio Ragno Favero), e siamo tutti stufi di questi determinismi tagliati con l’accetta; eppure, come ammette
lo stesso Alen Sinkauz, bassista della band, in Croazia anche i cori degli ultrà hanno tempi dispari.
Se due indizi fanno una prova, dieci portano a raffinare il pensiero. E se “il doppio”, più che un piano deliberato, non fosse altro che il sano esercizio
dell’indecidibilità?
(7/10)
Gaspare Caliri
Elvis Costello - Secret, Profane
and Sugarcane (Hear Music,
Giugno 2009)
G enere : country - folk
Qualsiasi cosa abbia fatto Costello in qualsivoglia
genere nel corso della più che trentennale carriera,
dal jazz al country alla musica orchestrale e via elencando, non è risultata meno connotata delle altre. In
altre parole, con la sua forte impronta d’autore. In
questo ultimo caso, il musicista inglese pensa bene
di ripercorrere le sue tracce, sul versante country
folk e roots USA proseguendo il cammino già attraversato nel 1986 con il cospicuo King Of America.
Anche qui T Bone Burnett al fianco in produzione, e in acustica, per svolgere, in modo ancora
più ruspante del precedente, la “sua” storia della
musica in questo versante. Eccolo allora armato di
banjo e fiddle, nelle disadorne ballad che percorrono alla sua maniera, country, folk e Americana, emotivamente partecipate e sofferte, ad offrire un lato
di sé che non vedevamo da un bel po’, se non quasi
ormai nelle prove dei suoi epigoni, Micah P. Hinson in primis. Quando fa sua la materia allontanandosi dalla scolasticità che ogni genere ha in sé, allora
emerge l’autore di razza, presente in questo album
dolente e scheletrico. Anche se King Of America
è irraggiungibile.
Essenziale.
(7/10)
Teresa Greco
64
recensioni
Eric Copeland - Alien In A Garbage
Dump (Paw tracks, Agosto 2009)
G enere : C oll agetronica
Eric Copeland: un terzo dei Black Dice, metà
dei Terrestrial Tones. E hai detto tutto. E forse
sì. Perché di dischi come questo oggi se ne possono fare (e se ne fanno) a tonnellate, soprattutto
se sguazzi autocompiaciuto nel lo, nell’out, nel no,
nell’alt, nell’indie, nell’homemade, nella -tronica, eccetera. Che uno a un certo punto dice basta (ma vedi
l’Animal Crack Box del Collettivo) e vorrebbe
a tutti i costi poterci appicciare un bel 5. E invece
Eric è bravo. Bambino dada, più che bambino cattivo,
pasticcia con tutto quello che si trova sott’orecchio,
straniero in questa nostra discarica sonora-sonica
(il titolo?). La tecnica è facile, ma c’è gusto, e c’è
qualche brandello di senso. E quelli che probabilmente sono semplicemente quello che sembrano
essere, e cioè basement exercises, riescono a non
annoiare e perfino in qualche caso a intrigare. In
perfetta continuità col precedente Hermaphrodite. Il cd riunisce due EP, i primi sette pezzi (uno o
due inutili) dall’omonimo uscito lo scorso anno, gli
ultimi sei (meglio degli altri, e più giocosi) da un EP
in uscita in questi giorni per Catsup Plate, titolo Al
Anon. Musica sbriciolata, strapazzata, alla fine postResidentsiana. Di stratificazione (tutte le tracce)
e collagismi (ad esempio, la lunga Alien...). Deformazioni hip-hop, motivetti deformati, spettri di canzoni, spettri di country (Al Anon), microglam (Reptilian...), tribalismi, rumorini, pseudotechno come
solo dei Kraftwerk ammaccati (Auto Dimmer), un
mishmash di Super Collider e Half Japanese
(e Animal Collective; Wolfman, Muchas Gracias).
Alla fine non è neppure collagetronica: è la lounge
di oggi.
(6.8/10)
Gabriele Marino
Eterea Postbong Band - epyks 1.0
(Trovarobato, Settembre 2009)
G enere : toy rock - fusion
Degli Eterea conosciamo l’ottimo mini Tecnosald (che ce li aveva fatti scoprire), il long La chiave del 20, esperimento interessante ma non completamente riuscito in cui condivano con siparietti
dei loro alcuni pezzi degli Uochi Toki (sul tema
“serata in disco”), più tutti quei video su youtube
dove girano sopra un furgoncino vestiti da novelli
Devo, situazionisti e di provincia. Approdato opportunamente su Trovarobato, il quartetto di Schio
highlight
Sa-Ra - Nuclear Evolution: The Age Of Love (Ubiquity, Giugno 2009)
G enere : visione juicy - bl ack ultra
Quando si dice discone. The Hollywood Recordings (2007, su Babygrande) era stato un tappabuchi di lusso, compilazione di pezzi editi
ed inediti approntata contro la mancata uscita dell’attesissimo esordio su long, titolo Black Fuzz, programmato per la GOOD Music di
Kanye West. I tre Sa-Ra hanno poi continuato le loro cose, remix,
collaborazioni, produzioni (tracce importanti su New Amerykah di
Erykah Badu, di cui dovrebbe già essere pronto il secondo volume),
e si sono dedicati a progetti e attività, non solo musicali, personali (non
hanno comunque perso di vista West e la sua cricca).
L’album tutto inediti, tanto atteso, non si sa quanto ripensamento di Black Fuzz, arriva solo adesso
e arriva però su Ubiquity (nella versione deluxe, due ciddì, ci sono anche sei pezzi già pubblicati
altrove). Ed è una bomba atomica. Black siderale, acidissima, da anelli di Saturno, una marmellata
speziata fatta di funk r’n’b soul hip-hop dance electronica, suoni meravigliosamente gommosi
appiccicosi gelatinosi succosissimi ultralucidi, musica per un club con tasso di umidità sul 90%:
caldissimo, anelloni d’oro, anni Settanta&Ottanta, toppini TI$A MCM e culi dappertutto (il loro
è un papponismo sì spaccone ma gioioso e giocoso, non oppressivo). E soprattutto tantissima
plastica.
Spaventosa facilità nel bilanciare sporcizia e pulizia, semplicità pop e (quella che una volta si chiamava) malattia. E poi classe e gusto anche quando si sfiora il cattivo gusto (Double Dutch, una cosa
tipo slow-grime). E poi, come in una torta fatta bene, senti tutti gli strati quando mordi. Prince
cervellotico, l’aura di Sun Ra (fin dai titoli), certa prima house psych alla Lil’ Louis ma vestita
di nuovo (l’ultimo Two Sides), la lezione dei beat zoppicanti e spastici di J Dilla, le voci miagolanti alla (e della) Badu, persino venature latin cocktailbossasamba (il primo pezzo, con tanto
di accenni in spagnolo) e un breakbeat naiffissimo, giusto per fare muovere il sedere. E ancora, un
filino di reggae e un filino di jazz.
Il tutto scivola via così bene. Come diceva Frank Zappa (sulle sue contraffazioni doo-wop):
è così unto che non dovreste ascoltarlo, dovreste mettervelo sui capelli. Rispetto al già ottimo
Hollywood, si sente subito la marcia in più, l’impatto è più forte, il discorso più visionario, più lanciato, il suono più liquido, languido, lanquido. Meno rapping, meno vocoder, meno vocine pitchate,
e nella dialettica electronico (tanto di campioni quanto di suoni sintetici) vs. suonato pare (PARE)
pendere più il secondo piatto.
Il punto sulla loro arte, una visione personale di trent’anni di black vista con gli occhi del dopo
hip-(p)hop Duemila, e - soprattutto - una visione di una fetta di futuro musicale possibile. PS:
subito un rmx dancefloor di Souls Brothers.
(8/10)
Gabriele Marino
(Vicenza) resta fedele ad un rock “post”, inteso
come fusione giocosa e giocattolosa (ovviamente
filtrata da un immaginario Ottanta) di funky, dance
sensu latu, psichedelia, elettronica, colonne sonore.
Il disco, 12 pezzi per soli trenta minuti, si presenta
come primo capitolo di un dittico ispirato al mondo
dell’ICT, con skype (vedi titolo) e affini a farla da padrone. Solito piacevole pastiche, un pezzo dall’incedere quasi morriconiano (nel senso di un possibile
aggiornamento di Indagine su un cittadino...), e poi,
nell’ordine, con qualche approssimazione, ma tanto
per capirci, proggie post-hc, theremin-epic-western,
recensioni
65
funky-disco, cavalcata power-pop, fanfaresca fanfaronata circense, tango deviato, solare pezzo cartoonesco (col campione del fungo da Super Mario),
ninnananna-carillon di chiusura. Un (altro) ottimo
mini insomma, ma sempre con la sensazione dell’antipasto a qualcosa di grosso ancora di là da venire.
Oltre a quello di Rico degli Uochi, breve cameo
vocale (e dichiarazione di orgoglioso integralismo
analogico) anche per una delle colonne del jazzcore nostrano, Splatterpink e Testadeporcu,
Diego D’Agata.
(7/10)
Gabriele Marino
Fabio Orsi/Seaworthy - Near and
Faraway (Low Point, Luglio 2009)
G enere : ambient
Da una parte Seaworthy, progetto del trio elettroacustico di Cameron Webb, dall’altra le consolidate maestranze di Fabio Orsi, al centro gli
intenti in dronescapes di Near And Faraway a
mettere in luce affinità disarmanti.
I due artisti - complici per teorie in ambient e poetica evocativa - decidono qui di separare i ruoli, una
traccia per ognuno ed una, solo una, a consacrare le
arti collaborative.
Le prime soliste spettano a Fabio Orsi, sedici
minuti di stratificati e confortevoli svolgimenti - in
chitarre, effetti e field recording - che dimostrano, per risultato d’ordito,
abilità di scrittura.
Merito delle vicende, di
segno e dinamica timbrica che per Evening by
Evening acquistano brillante fierezza, senza mai
cadere in attitudini ma vestendosi anche per questa
occasione di un dolce e nuovo assemblaggio dalla
penetrante esperienza d’ascolto.
A Seaworthy invece le chiusure: Branch and Stone
intraprende universi paralleli al limite dell’ipnosi che
non abbandonano l’acustica di 1897 (12k) ma gli
concedono i bozzetti in coda mentre, al principio
più scultoreo, sono consegnati i giochi di tonalità e
riverbero.
Gli incontri infine per Near and Faraway, esatto anello di congiunzione dove emergono - per contenuto
e magmatica interferenza - echi in drone chitarristici, orizzonti granulari e desolati o digressioni rumoriste.
66
recensioni
Orsi dice: è musica che acquista significato non solo
nella narrazione ma anche nella suggestione e come
ben si sa anche questa ha origine dal profondo del nostro cuore.
Come dargli torto.
(7.5/10)
Sara Bracco
Fabio Orsi/(etre)/Gianluca Becuzzi
- So Far (Porter, Luglio 2009)
G enere : elettroacustica
Tre movimenti di eguale durata (16 minuti e 16
secondi) per la trimurti sperimentale italiana, accasatasi per l’occasione presso un marchio di sicura
affidabilità come la Porter.
So Far è un disco che trae il suo spunto creativo dalla concezione del field recording come persistente eco della memoria, o meglio come mezzo
che riapra spazi chiusi della memoria. Every recording
says to us what we were in another history, afferma Salvatore Borrelli aka (etre) nelle poetiche note contenute nel disco. E mai affermazione fu più vera visto che riecheggiano in questi tre lunghi movimenti
– fatti di frattali sonori evocativi e ambient estatica,
ricami elettroacustici e piccoli intarsi elettronici –
voci, memorie, immagini, ricordi che si rincorrono
e accavallano le une sulle altre come fermacarte
sull’eterno.
È sempre un piacere avere a che fare con artisti di
tale sensibilità, e se non ci si dilunga nelle descrizioni
è soltanto per non rovinare la sorpresa a chi voglia
cimentarsi con So Far.
(7/10)
Stefano Pifferi
Felice Brothers (The) - Yonder Is
the Clock (Team Love, Aprile 2009)
G enere : A mericana
Alla base della congrega Felice trovi l’onestà robusta di chi per davvero è partito dal basso. Autentici fratelli, Ian, James e Simone hanno alle loro
spalle la gavetta di due notevoli album e un passato
prossimo di “buskers”, di gente che ha suonato per
le strade e nella metropolitana per portare a casa,
se non il pranzo, almeno la cena. Sembra una storia
d’altri tempi e probabilmente lo è; un frammento di
un’era che credevamo sepolta e invece no, perché
al difficile terzo album i fratelli affermano forte e
chiaro di essere qui per rimanere.
Perché in loro assapori la medesima capacità di
affrontare il passato a testa alta rinnovandolo che
appartiene agli Wilco e che, per un po’, avevamo
scorto nei Grant Lee Buffalo: la “maniera” di
The Band, ecco (All When We Were Young riparte
da dove finiva I Shall Be Released: tutto dire). Quel
raccogliere da terra i tasselli della tradizione, soffiare loro via la polvere con vigore e accostarli in
configurazioni che, se non possono essere nuove
in assoluto giacché niente lo è da Elvis Presley
in poi, restituiscono un quadro d’insieme giammai
piatto o ammuffito.
Non sappiamo cosa pensi Greil Marcus di questa
formazione, ma non ci stupirebbe saperli in rotazione fissa sul suo stereo così come lo sono sul nostro:
perché è la conoscenza della Storia a permettere di
suonare Blonde On Blonde col senno dei Basement Tapes (Chicken Wire) e altrettanto con
Blood On The Tracks e Time Out Of Mind
(The Big Surprise, Boy From Lawrence County); oppure
strapazzare il cajun (Run Chicken Run) e - accantonato per un attimo il santino di Bob Dylan - scrivere la più bella canzone di Leonard Cohen da
chissà quanto tempo (Sailor Song). Solo così capisci
come si riesca a percorrere trasversalmente i decenni per recare gioielli come la dolente Ambulance Man e una crepuscolare Katie Dear, rinfrescare il
traditional Memphis Flu e gettarsi a testa bassa nella
festaiola Penn Station.
Buttando nel calderone la consapevolezza di vivere nell’Anno Domini 2009, anche, che emerge da
voci apparentate non solo all’onnipresente Bob ma
pure a Steve Earle e Micah P. Hinson, dagli
scricchiolii sparsi come fantasmi e nell’uso sapiente dello studio. Tratti distintivi che non istillano il
dubbio del revival senza causa: come potrebbero
esistere capolavori della profondità di Rise And Shine
e Cooperstown, altrimenti? Fuori e dentro il tempo,
acrobati su un filo e niente rete sotto, di Artisti così
ne incontri sempre meno.
(8/10)
Giancarlo Turra
Fine Before You Came - S F O R T U N
A (Tempesta Dischi, Giugno 2009)
G enere : S creamo , noise
Evidenziatisi nei primi anni del Terzo Millennio
come una delle band italiane che meglio interpretavano musicalmente l’ambiguo concetto “emocore”, restandone però loro malgrado impaludati,
oggi i Fine Before You Came sorprendono
non poco, rivoluzionando(si). E positivamente, nonostante il titolo del loro ultimo album S F O R T
U N A, volutamente scritto spaziato, faccia pensare
al peggio. Due sono i motivi principali di questa riuscita rivoluzione: la scelta di cantare in italiano e
il coraggio di mettersi a
nudo completamente.
I cinque ragazzi di stanza a Milano sono riusciti
a scrivere sette canzoni
viscerali, istintive, intime, sfrontate, “sentite”
e sferzanti, con un’umiltà
e un’autenticità non indifferenti. Parole urlate
che fuoriescono direttamente dallo stomaco, dalla
gola, dagli occhi, impastate con lacrime, saliva e succhi gastrici, in un mix emozionale di punk, hardcore
e post-rock. Ci sono un’urgenza, un’impulsività e
un’angoscia tutte adolescenziali (“io non mi sono
mai vestito da adulto”) dietro le sillabe, gli arpeggi
e le tempeste sonore, ma non si pensi a ciò come
a una mancanza di mauturità, anzi. Tutt’altro. Qui
i nomi che vengono in mente sono del calibro di
Fugazi, Slint e Mogwai ma anche di Altro e
Massimo Volume.
Colpisce eccome S F O R T U N A, fosse anche solo
per la bizzarra scelta della sua distribuzione: gratis
sul sito della band, in cd per La Tempesta, in vinile
per la nuova Triste e in musicassetta per Ammagar.
È paradossale sentirli cantare “ho chiamato i miei
insuccessi, sfortuna”. Qui di fallimenti neanche l’ombra, per F O R T U N A.
(7.7/10)
Andrea Provinciali
Flaming Lips - Embryonic Tour EP
(Autoprodotto, Luglio 2009)
G enere : rock - pop psichedelico
Tre pezzi in digitale, regalo per chi prenota un biglietto del tour estivo, anticipano l’annunciato doppio Embryonic in uscita a settembre (pare), a tre
anni da At War With The Mystics e dopo le
stravaganze b-scifi di Christmas On Mars (“il film
dei Flaming Lips”). Continua divertita, tra ricalco,
suggestione, allusione, citazionismo e reinvenzione,
l’esplorazione della giungla canzone rock-pop psichedelica. Se il resto del disco è su questo livello c’è
da essere contenti: con la maniera inevitabile che
serpeggia nelle cose dei Flaming, anche solo a livello di concept, (quasi) completamente dissimulata da
gusto, sapienza costruttiva e freschezza espositiva.
Psych che guarda agli Ottanta Convinced Of The Hex,
recensioni
67
highlight
Soul Junk - 1960 (Sounds Familyre, Agosto 2009)
G enere : psych power pop
Di sciroccati è pieno il mondo del rock’n’roll. Il difficile è (quindi) passare per degli sciroccati interessanti. Di certo il buon Glen Galloway da San Diego c’investe un bel po’ d’impegno e talento,
abbastanza da passare l’esame in souplesse. Sì, è un tipo interessante, il caro Glen. Va in giro a
raccontare che, mentre portava avanti l’attività di chitarrista negli psych-noise Truman Water,
venne chiamato dal Signore a diffondere il suo Verbo.
Correva l’anno 1993 quando Glen ricusò la band ed il proprio cognome fondando i Soul Junk
ed imponendosi lo pseudonimo di Glen Galaxy - o Glen Galaxalag,
quando gli gira. Con la nuova ragione sociale iniziò a snocciolare una
catena di ep e album (circa 25 in tre lustri) prodotti in frugale autarchia, ognuno intitolato con l’anno cui si ispirerebbe (tutti finora
compresi nel range tra il 1934 ed il 1959), i testi riadattati da stralci
biblici su orditi sonori eterogenei quali lo-fi folk, free jazz, hip-hop,
psichedelia e potabilissimo indie rock.
Adottato ben presto dalla Sounds Familyre della Danielson Family,
etichetta già parecchio “mistica” di suo, oggi finalmente il buon Galaxy approda all’album lungo numero undici, inaugurando con esso l’epocale decade dei sixties:
s’intitola infatti 1960 ed è un conglomerato di 22 tracce all’insegna di power psych dinoccolato
(Screaming Lobster), hard prog misterico (vedi il violino quasi High Tide ad esempio in Let The
Dead Bury...) ed escrescenze crossover (Hangtime), caracollando folk onirico specie nel finale
(dove talora - come in Zizzer - scomoda persino un’indolenza Giant Sand) e sfiorando la sordidezza appassionata d’un Greg Dulli (come nella splendida Forever O Lord Your Word Is Settled
In Heaven).
Ne esce un disco spettacolare, non tanto per il valore dei pezzi - sostenuti comunque da un estro
gagliardo e da parecchi spunti degni di nota - quanto per lo spettacolo (appunto) che allestisce:
fin dove può portare la bizzarra, formidabile, incontenibile devozione di un uomo.
(7.1/10)
Stefano Solventi
e ancora Ottanta nella space-ambient con voce vocoderizzata The Impulse, trionfo psych Sessanta (tipo
Byrds) il beat-garage Silver Trembling Hand, gustosa
alternanza incalzante/disteso. I Flaming ormai (ma
da mo’) sono dei classici.
(6.8/10)
Gabriele Marino
Flunk - This Is What You Get
(Beatservice Records, Agosto 2009)
G enere : downtempo / pop
Oslo, Norvegia. Il nord Europa è da diversi anni
all’avanguardia nell’ambito del pop più elettronico e di ricerca. Non fanno eccezione i Flunk che
al quarto album da studio sembrano aver trovato
68
recensioni
una formula accattivante che possa considerare la
melanconia della wave più trascendentale, il gusto
nell’arrangiamento tipico del downtempo ed una cifra pop solo apparentemente personale.
Folktronica? Non propriamente, una stucchevole Cigarette Burns dice che gli orizzonti cui guarda il gruppo sono quelli dell’inscatolata MTV, ragion per cui
le belle intenzioni messe in campo rimangono tali.
È musica anodina, priva di profondità, nonostante le
credenziali facciano pensare ad altro. Se Commonsense suona come un convincente ibrido tra Moloko e The Knife, in brani come Ride viene allestito
un tributo esangue e senza nerbo al dream pop dei
tardi ‘80. Una terra di mezzo in cui è facile affogare
e aldilà del mestiere i 4 norvegesi sembrano davve-
ro mettere ben poco in campo. Coverizzare Karma
Police dei Radiohead poi certo non aiuta... (5/10)
Luca Collepiccolo
Flying Lotus - L.A. EP 3 x 3 (Warp
Records, Agosto 2009)
G enere : ambientstephoptronica
Terzo di tre mini, i primi due antipasto al capolavoro
personale Los Angeles, questo a chiudere, contiene cinque remix fatti da altri e due inediti. Materiali
abbastanza interessanti, niente per cui impazzire, per
un’uscita dichiaratamente minore, tirata 2000 copie.
Endless White e Spin Cycles sono esercizi ambient,
nebbie lattiginose entrambe con la sensazione di chi
si sveglia confuso e rallentato dopo un sonno al mal
di testa. Denso e con suggestioni bucoliche il primo,
nebuloso e con sporcature glitch il secondo. Molto
intermezzo. I remix sono condotti con l’intelligenza
di chi considera la traccia originale allo stesso modo
di come il jazzman considera lo standard: un punto
di partenza per dire la propria. Vere e proprie riproduzioni allora.
Infinitum, by Dimlite (Dimitri Grimm), il pezzo di maggiore impatto, allunga e imbastisce un traballante scheletro ritmico sull’amniotico trip-hop
dell’originale, suonando come un robot (femmina)
di legno che arranca e cigola. Comet, by Matthew
David (che già aveva messo lo zampino in Los Angeles), accorcia, elimina le percussioni, lascia basso
e synth, ma come leggermente centrifugati. Parisian
Goldfish, by Take (Thomas Wilson), astrae e
accentua l’appeal da club, glitchando a (fuori)tempo
che è un piacere, per slow-ballerini elegantemente
spastici. Ottimi. Poi. Testament, by Breakage (James Boyle), vocoderizza il miagolio Billie Holiday-ano di Gonja Sufi e marzializza-ottantizza
la base, in origine molto Tricky/Nearly God.
Auntie’s Harp, by Rebekah Raff, allunga, rallenta,
dronizza, esotizza un pizzico.
Buono, ma Flying Lotus è oggi, fuori da facili sensazionalismi, uno dei produttori, e quindi aspettiamo
il suo 2010.
(6.4/10)
Gabriele Marino
Freeland - Cope (SRD, Giugno 2009)
G enere : E lettro , D ance , funk
Con quegli stomachevoli vocodering in apertura in
odor di Eiffel 65 (Cope), Freeland sembra uno dei
tanti progetti copia incolla elettro-rock del solito dj
wannaby James Murphy. E infatti, i dubbi te li levi
subito visto che il singolone è niente meno di una
versione MSTRKRFT dei Lcd Soundsystem
(Under Control). Inizi a grattarti la testa e a avvelenare la penna, salvo poi ritrovarti perlesso.
Altrove, nel fidgeting compulsivo, scopri cose sneaky
à la Miss Kittin cadaverizzate Depeche Mode
via Tiga (Strange Things), minimal dai vecchi sussurri
House in stile House Of God (Bring It), digital shoegazing Fuck Buttons (Mancry), punk convertito
pop à la Pretenders/Blondie/Billy Idol (Borderline), certo (kid) rock da Monclear ‘80 (Rock On),
roba synth pop primissimi Novanta (Silent Speaking)
ecc. ecc. niente di ché sia chiaro, ma in pratica, ascoltando l’umilissimo dandy (bravissimo a vendersi in
tutte le salse e con tutti i mezzi 2.0 possibili), hai per
le mani la cartina tornasole delle cose più modaiole
capitate in questi ultimi dieci anni.
Farne a meno o no è un dilemma inutile e da stupidi.
Il punto è: i primi Duemila sono riusciti veramente a
ricreare un fai da te simile a quello a base di one hit
wonder degli Ottanta, e ne sono pur sempre stati
“in derivata”. Il dilemma rientra: ti rendi conto che
una cosa aveva un peso soltanto quando in mano
te ne ritrovi una ancor più leggera. La DIY-ness del
punk alla fine è il prodotto più commerciale del
dopo guerra, nonché il più cheap in tutti i sensi. Più
del pop.
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Frigidaire Tango - L’illusione
del volo (La Tempesta Records,
Settembre 2009)
G enere : new wave
Se tra Settanta e Ottanta i Frigidaire Tango furono
tra i meritati traghettatori delle istanze punk del
Belpaese verso la nascente new wave, ora pochi si
ricordano di loro.Troppo differenti le estetiche a cui
si fa riferimento attualmente, troppo sotterranei e
intransigenti i Nostri, nonostante una musica vitale
e una biografia quasi decennale – l’anno di scioglimento è il 1986 - ricca di eventi. Tornano ora, dopo
una ventina d’anni, con un disco mixato da Giorgio Canali che vorrebbe recuperare un discorso lasciato in sospeso cercando, nel contempo, di
ampliarlo. Magari ibridando la formula originale con
la wave ferrettiana cosparsa di spezie etniche di Mescola le razze, le cadenze à la Giancarlo Onorato
di L’acqua pensa, il punk psichedelico di Dreamcity o
l’impeto programmatico della conclusiva New Wave
recensioni
69
Anthem. In gran parte l’operazione riesce, almeno
a giudicare da un disco che nasce dal “dopo punk”
ma che mostra pure una varietà di colori intrigante e insolita per i canoni del genere, grazie anche
all’apporto di ospiti illustri come lo stesso Canali e
Federico Fiumani.
Capaci assieme alla band originale, di evitare di scadere nell’effetto nostalgia e di mantenere alta la tensione, soprattutto negli episodi più “tirati” e in linea
con l’immaginario del gruppo.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Fruit Bats - The Ruminant Band
(Sub Pop, Agosto 2009)
G enere : folk rock
Una band che rumina in un mondo che morde,
sbrana e succhia: niente male come biglietto da visita. Così come l’immagine del pipistrello della frutta, con quegli occhietti dolciastri che sublimano la
minaccia vampiresca dell’aspetto. Insomma, siamo
qui a parlare del terzo album griffato Sub Pop per i
Fruit Bats, gruppo losangelino capitanato da Eric
D. Johnson, cantante, chitarrista e songwriter, già al
lavoro come sideman per gli Shins e Vetiver.
Questo The Ruminant Band è un disco che si
tiene alla larga dalle linee del fronte, si adagia in un
presente sospeso tra nostalgia e morbidezza, beandosi alla luce fragrante dell’alba e ad un venticello carezzevole, cavalcando marcette country folk, stomp
sbrigliati e aciduli languori variegati pedal steel.
Una voce a suo modo generosa, quella di Eric, però
come di cartapesta, versatile ma in qualche modo
incapace di raggiiungere una reale intensità.
Alla fine, che dire, si rivela adatta a questo regime
sonoro di poche pretese, in disinvolto disimpegno tra Al Stewart
e i Rolling Stones di
Exile On Main Street
(Tegucicalpa), con la fibra
friabile CSN strattonata
power pop (The Blessed
Breeze), col calore acustico un po’ stopposo e vagamente George Harrison (Beautiful Morning Light), con lo stomp brioso
come potrebbe uscire da una jam garrula tra Paul
Simon e la Band (The Hobo Girl), con le fregole
country dinoccolate da nipotini garruli di Traffic e
Grateful Dead (nella title track).
Permettendosi con nonchalance di citare Don’t Pass
70
recensioni
Me By - uno di quei siparietti beatlesiani affidati a Ringo Starr - in Being On Our Own, dove ovviamente
il canto di Johnson sta come un pisello nel baccello.
Come del resto nel bignamino soul Van Morrison
piano-voce più fruscii pseudo lo-fi della conclusiva
Flamingo.Tutto funziona, tutto scorre.Tutto si rumina.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Fukkk Offf - Love Me Hate Me Kiss
Me Kill Me (Coco Machete, Giugno
2009)
G enere : R ay B an fidgeting
La ripetizione diventa anthem. Ma ci vuole coraggio. Come i robot Kraftwerk e poi il loro seguito
Daft Punk. Sono pochi che restano a galla.Traslati
oggi, i figli di quell’estetica sono vestiti American Apparel e sempre più incarnano il ricordo ‘90. Ray Ban
che nascondono filtri dell’anthem We Are Your Friends. Il trucco è sempre nel pompare quel quattro,
nel nasconderlo e nel riproporlo con la vocina che
Miss Kittin ha sapientemente iconizzato (grazie
alle abili mani di The Hacker).
Questo ennesimo disco di fidgeting ripropone tutto
quello di cui siamo forse stanchi di parlare, ma lo fa
con uno stile che non annoia, con delle progressività sapientemente dosate e senza troppo spingersi
alla sperimentazione fa muovere il culo. Niente di
più, ma alle volte è difficile creare il riff che non
stanca. I Fukkk Offf (aka Bastian Heerhorst
from Hamburg, Germany) passano dall’acido di Rave
Is King alle camere blindate di Love My Shake, dalla
deep di I Give You Bass alle spirali cosmiche di The
Bottom, dal rock per i Justice di Famous all’omaggio
al vocoder di Air, Giorgio Moroder e compagnia bella (Pretend) senza perdere smalto.
Sarà un trompe l’oreille destinato a un sicuro oblìo,
ma per ora a noi fa muovere. Ben fatto.
(6.9/10)
Marco Braggion
Future Of The Left - Travels With
Myself And Another (4AD, Giugno
2009)
G enere : noise - rock
A stretto giro di posta dal live Last Night I Saved
Her From Vampires, eccoci di nuovo a parlare
degli ex McLusky Andy Falkous e Jack Egglestone
e del loro progetto Future Of The Left. E se qualche
mese fa ci lamentavamo del live come concetto, ma
non della potenza di fuoco sprigionata dal terzetto
gallese (l’ex Jarcrew Kelson Mathias al basso completa la formazione), ora non possiamo che alzare
le mani e plaudire alla capacità dei tre di sputare
(letteralmente) bile e veleno in forma di canzone.
In questa ottica è l’accoppiata che fa da attacco
dell’album a mettere subito i puntini sulle proverbiali i: Arming Eritrea è un furibondo assalto frontale
a base di stacchi vertiginosi in modalità stop’n’go,
farfugliare irascibile e aperture da anthem rock memorabile; a ruota segue Chin Music con un basso
caterpillar che si srotola fiero e sfrontato mentre
l’iroso cantato di Falkous raggiunge livelli da parossismo hc. Insomma, in nemmeno 5 minuti d’orologio i FOTL hanno già spazzato via l’eredità pesante
(in tutti i sensi) dei McLusky per proporsi come uno
dei pochi gruppi anglosassoni a giostrare a proprio
piacimento con la materia “rock pesante”.
Schizofrenici, ansiosi, furibondi, autoironici, ma soprattutto – particolare non indifferente – sempre
larvatamente melodici e attenti ad una forma di pop
non scontato per quanto malato. Come si diceva
al tempo di Curses è roseo eccome il futuro della
sinistra inglese; se non in politica, visti i recenti scandali legati ai whigs, per lo meno in campo musicale.
(7.4/10)
Stefano Pifferi
Georgia Anne Muldrow - Ms. One
& The Gang (Epistrophik Peach
Sound, Marzo 2009)
G enere : funk - hop - soul
Funk soul ‘n’b (Badu-style), hip-hop, produttori black
giro Stones Throw - i bacini sonori da cui attingere.
Lei lo chiama FONK. Free jazz caotico-esoterico
(Art Ensemble Of Chicago?) - l’immaginario
di riferimento, ideologico, estetico, estatico. Ritmi
narcotici e zoppicanti, cantati sbilenchi tra sdilinquimento soul e parlato-recitato come sotto ipnosi.
Georgia Anne Muldrow, 26 anni, losangelina,
ala radical della blackitudine musicale underground
d’oggi: talento.
Impossibile sintetizzare nello spazio di poche righe
il percorso di Georgia, fatto di dischi a nome proprio, collaborazioni prestigiose (Platinum Pied
Pipers, Sa-Ra, la stessa Erykah Badu, Madlib,
Mos Def), dischi sotto astrusi pseudonimi (e per
etichette minori), altri ancora in coppia col compagno di vita Dudley Perkins aka Declaime (col
quale gestisce l’etichetta Epistrophik Peach Sound).
Dischi quasi tutti affollati tra 2006 e 2007.
Possiamo dire che il suo capolavoro resta lo stra-
ordinario esordio su LP
Olesi: Fragments Of
An Earth (per Stones
Throw) e che tutte le
altre produzioni sono
come minimo molto
buone quando non ottime, davvero brava lei nel
replicare la sua vincente formula bastarda senza apparire riciclatrice, senza stancare. Lo stesso vale per
questo frullatone soul-rappuso di feat vocali tutto
orchestrato dalla nostra sotto il nome di Ms. One.
Né più né meno.
(7/10)
Gabriele Marino
Georgia Anne Muldrow - Umsindo
(Someothaship, Luglio 2009)
G enere : funk - hop - soul A frika
Neppure il tempo di metabolizzare Ms. One &
The Gang e spunta fuori il secondo album vero
e proprio di Georgia Anne Muldrow, attesissimo, in contemporanea con Holy Smokes di
Perkins/Declaime. Fin dall’iconografia e dal
titolo (“suono” in lingua Zulu), è una dichiarazione d’amore per la madre Afrika, terra madre della
musica, terra degli antenati, terra ancora schiava da
riscattare. Piglio militante, vedi il pezzo incipitario,
vedi Caracas (“I’m so ashamed of this country, I’m so
ashamed of this policy”).
è disco opportunamente legnoso e marrone, meno
accattivante, più opaco come suono delle sue ultime produzioni (vedi lo stesso Ms. One), quasi
cantautoriale. Ormai possiamo dire di avere intuito una possibile dicotomia: quando produce sotto
moniker, Georgia si sbilancia su hip-hop e più marcate contanimazioni electroniche, quando fa cose a
nome proprio o con Dudley, resta su un suono più
analogico e funk-soul.
E qui ripartiamo da Olesi, asciugando ancora di
più, centralità del basso (vedi, psichedelicheggiante,
Okra), batteria e piano (soprattutto verso fine disco). Alla voce afrofuturismo, Nsamanfo.
Echi soft-beefheartiani nelle chitarre di Seminole
Unity Chant e So Far. Disco bello nell’insieme, con alcuni pezzi presi singolarmente bellissimi, la lamentosa John The Conqueror, l’oscillante Daisies, Generation
(con una linea di voce molto anni Novanta, e anche
abbastanza vecchi Red Hot), Slice It, le pianistiche
Roses (fortemente voluta da Mos Def sul suo The
Ecstatic) e ESP, con quelle quattro note quasi sarecensioni
71
kamotiane. Disco maturo, non facilissimo, che
cresce con gli ascolti.
(7.4/10)
Gabriele Marino
georgias Horse - The Mammoth
Sessions (Fire Records, Settembre
2009)
G enere : country folk
Con un titolo del genere il richiamo ai Cowboy
Junkies (The Trinity Sessions) sembra possibile,
ma ad ascoltare la musica del disco ci si accorge
che la connessione con la band di Margo Timmins
è assolutamente inevitabile. I Georgias Horse
vengono dal Texas e sono una classica espressione
alternative folk che si muove proprio sulle coordinate tracciate dalla band canadese. A tessere i fili del
discorso oltre che a reggere tutto il peso del progetto è la chanteuse Teresa Maldonado che pende
un po’ troppo per il riverberato country, oltre che
per l’imitazione degli uggiosi sostenuti d’ugola di PJ
Harvey, dando sempre e costantemente un senso
di deja vu. Un disco del genere i suoi numeri li regala
pure, ma come un film di serie b senza pretese, può
andare bene giusto per una seratina e via.
(5.7/10)
Antonello Comunale
Giardini di Mirò - Il fuoco (Unhip
Records, Luglio 2009)
G enere : soundtrack post rock
A due anni da Dividing Opinions, esce il quarto
album dei Giardini di Mirò. Un disco vero e proprio,
come tengono a sottolineare essi stessi, malgrado la
tentazione di rubricare questo Il Fuoco tra i progetti collaterali, perché trattasi della sonorizzazione
dell’omonimo film del 1915 di Giovanni Pastrone
- il celebre regista di Cabiria e altri peplum ante
litteram - su commissione del Museo Nazionale del
Cinema di Torino (che lo scorso anno coinvolse
i Marlene Kuntz per Signorina Else di Paul
Czinner). E si sente. Per il senso di tensione scentrata, per le intersezioni sperse cui fatichi a tributare
senso svincolate dalle immagini, per il refrain (bello
anche se un po’ scontato, come spesso capita alle
soundtrack) che monta, si dilegua e riaffiora nella
prima delle tre parti che compongono il flusso sonoro (La favilla, La vampa e La cenere, specularmente alla pellicola). Consideratela un’avvertenza. Per il
resto, è un lavoro non geniale ma godibile, dove più
che le intuizioni conta la cura dei suoni (vibrazioni
72
recensioni
sintetiche, corde brumose, archi trepidi, tromba, vibrafono, pianoforte e ambientazioni concrete...) e
una bella convinzione tanto nel progetto che nei
propri mezzi, ciò che consente loro di procedere
con disinvoltura tra flutti cameristici, kraut-wave in
derapage electro-noise e infine di spegnersi in una
dimessa peregrinazione milonga che diresti quasi
Bachalov. Ad essere cattivelli, potremmo leggere
questo appoggiarsi a motivazioni “esterne” come
ad una scappatoia dalle secche del post-post-rock.
Scelta intelligente ed efficace. Ma: poi? (6.4/10)
Stefano Solventi
Girls - Album (Matador, Settembre
2009)
G enere : S ixties ball ad
Non c’è che dire, il video Hellhole Ratrace diretto da
Ben Chappell, ha catturato un bel immaginario. Baci,
droghe, risate e divertimento. Tutto fugacemente
tagliato e assemblato come certe cose epiche dei
R.E.M. (ma in questo caso a colori). Eppure il clip,
girato in una notte sotto - e tra le note - della classica ballad country americana aggiornata lo-fi ‘60, dice
anche un’altra verità: le Girls - che poi sono due maschi di San Francisco - preferiscono suonare in chiaro
e si concedono misuratamente a smalti dream, shoegaze e ovviamente psych. Pur con l’effetto radiofonico sporco Ariel Pink-iano, preferiscono dare risalto alle parole e al sound dell’acustica, anzi, per dirla
tutta, imparentati con le Vivian Girls e i Crystal
Stilts del caso, la loro musica, così caparbiamente
e testardamente innamorata del sogno americano, è
tra le più strafatte e bruciate degli ultimi anni. L’arpeggio super easy di Solitude (fiore all’occhiello del
demo e purtroppo assente qui), è una ballatona che
manco Bono Vox dopo la sbornia di Joshua Tree
poteva interpretare, il rockabilly ultra lo-fi di Big Bad
Mean Motherfucker l’avrebbe scartata pure l’Alan
Vega più molesto. Ed è vero. Alle volte ci vuole questo tipo di coraggio per vedere come va, e non è un
caso se Morning Light, il solo pezzo duro della cordata,
è puro Stooges garagista. serve gente che tira le fila
di un discorso fifties e sixties con questo tipo d’incoscienza. Perché l’immaginario collettivo è fatto anche
di eroi per caso, e delle relative Stoned & Dethroned
(Jesus And Mary Chain). Con le contigenze giuste, si può pure diventare dei classici ...come no.
(7/10)
Edoardo Bridda
highlight
Theoretical Girl - Divided (Memphis Industries, Agosto 2009)
G enere : P op
Mentre gli eighties synth a 2D di La Roux mettono a ferro e fuoco le charts britanniche, la
Memphies Industries ci prova con una tipa del Southend londinese già da tempo chiacchierata sui
soliti media 2.0 (my space, il tubo, molte zines brit e qualche comparsata sul satellite).
Lei è Theoretical Girl, al singolare. E con Glenn Branca non ha nulla a che vedere se non
per quel cospargersi di vago - e sempre più discutibile - DIY. Poi il portfolio si compila con le altrettanto consuete modalità: abita a Londra ma viene dall’Essex, usa un
fondotinta pesante e disegna vestiti che non porta; ed è attentissima
a queste cose, tanto quanto il disegnarsi attorno un’estetica bedroom
artist, arty (fuori) e semplice (dentro).
Dagli esordi allo scorso anno, s’è fatta conoscere (e apprezzare) sia
per una zuccherosa vena pop condita di drum machine e synth (anche
piuttosto agguerriti), sia per una più intima matrice folky (alla chitarra).
La scintilla sta però nell’aver cercato oltre l’art folk dilagante (vedi la
new york di My Brightest Diamond e co.) per una vita magica
dagli smalti eighties.
Theoretical girl punta un compasso disegnano un cerchio attorno a sé. La fugacità pop adolescenizale della Sarah Records, la svenevolezza fatalista degli Smiths, i modi wave pop delle signore
più adult (Kate Bush, Goldfrapp) e infine l’attenzione per la teatralità della forma, i modi più
francesi che inglesi, tutte caratteristiche che convivono egregiamente in Divided, un album che
sorprende sin dall’iniziale Rivals.
Scansa la formuletta indie per un veloce cambio di pelle la ragazza, dal synth da scarsità di mezzi,
passa a un chamber pop dalle tinte rinascimentali (in chiaro) e gotiche (in black), senza rinunciare
al denominatore comune di strofe e ritornelli immediati, leccati se volete, ma per nulla banali o da
pronto consumo. Pure quando gioca con il teen pop Sarah Records di The Biggest Mistake, sembra
il super io di Lily Allen, una versione matura della girl da TRL.
E il disco si struttura infatti con brani più cattivelli (e elettro-punk) come Rivals e The Hypocrite
(base drum machine Offlaga Disco Pax, quartetto d’achi e organetto vintage), nelle elegie zuccherose, ariose e teatrali di The Boy I Left Behind, o nelle vertigini glam sintetiche Blue Vertigo
di Dacehall Deceit e Green Mist, salvo poi riavvolgersi nel folk fiabesco di A Future Apart.
Fan della ragazza: Lightspeed Champion. Sua la cover di un suo brano, Listen to Another Fight
(la trovate in rete free). In comune tra i due: una certa idea romantica in musica. Abbiamo un
ottimo esordio qui.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Gnaw Their Tongues - All The
Dread Magnificence Of Perversity
(Crucial Blast, Luglio 2009)
G enere : drone bl ack metal
Incedere come per gravità. In questo Gnaw Their
Tongues, e l’olandese one-man-band che c’e dietro, ha molto in comune con la musica di Khanate:
quei gravi scenari di tensioni e rotture, percussio-
ni che non sostengono la musica, ma che piuttosto sono suoi crolli. Ma ai paesaggi desolanti della
band di Plotkin e O’Malley, GTT aggiunge livelli e
dimensioni: oltre agli ultrabassi d’ordinanza, samples
orchestrali, elettronica, macchinari e armamentari da film horror. Tutto a costituire una melmaglia
densissima, satura, raggiunta dopo notti intere spese
a cacciare nel mix ancora un ultimo pezzetto, che
recensioni
73
intorno ai 3000Hz c’è ancora spazio. Col risultato
che i crolli di cui prima sembrano divergere in ogni
direzione, piuttosto che nella sola verticale.
Secondo riferimento: il caos nero di Abruptum.
E in questo si rivela uno dei meccanismi in cui la
musica si evolve. L’essenza di Abruptum era la sua
immediatezza, una questione di corpi, eventualmente sodomizzati, torturati (racconta le leggenda) e
diretti a esprimersi in maniera del tutto fisica, tra
tamburi e chitarre. È il
processo quindi, al centro della composizione,
ma di cui è il solo effetto
che viene riprodotto in
GTT. In quanto niente è
più lontano da quell’immediatezza quanto fare
musica di fronte ad editor e sequencer al computer, con freccine e numeri per niente sensibili a qualunque espressività. Le
linee guida sono quindi stabilite, e data la lunghezza
del disco (e il tonnellaggio) bisogna masticarle bene
per poterlo apprezzare. Infine una nota letteraria:
The Gnostic Ritual Consumption Of Semen As Embodiment Of Wounds Teared In The Soul, è un titolo che a
me, puzza di Jodorowsky.
(7.2/10)
Leonardo Amico
Gossip - Music For Men (Columbia
Records, Giugno 2009)
G enere : indie white funk
Pare quasi concepita a tavolino la parabola Gossip
tanto è esemplare: origini provinciali dall’Arkansas
convertite nel moderno eden di Olympia; un lento
ma costante apprendistato underground con due
lavori discreti e uno belloccio assai, Standing In
The Way Of Control, che per gradi ne aumenta
la fama; il conseguente ascendere della matronale
front-woman Beth Ditto a icona degli intellettuali chic, con tanto di articoli patinati e presenzialismo mondano; l’immagine del trio, giocata su pruriti
omosex e transgender che - loro malgrado - un po’
di polverone ancora lo sollevano.
Troppo bello per essere vero, eppure lo è. Il problema semmai sorge quando siffatto alone distoglie dal
“sugo” della faccenda, cioè dalla musica. È comunque su quel terreno che si deve pur valutare Music
For Men, primo disco su major nel quale l’ampio
budget porta in regia Rick Rubin - secondo solo
a Steve Albini nell’arte di far “suonare” una band
74
recensioni
in studio - e incoraggia la voglia di colorare le canzoni con più sfumature di prima. Cosa, allora, non
funziona del tutto lasciando la formazione a metà
del guado?
La scrittura sostanzialmente poco incisiva (nessun
brano del livello di Coal To Diamonds, qui: ci va vicino
solo la Janis Joplin moderna e spogliata di pathos
in Dimestore Diamond), ecco cosa, inoltre vittima di
scelte produttive che smussano gli spigoli e alcune
idee sfocate. Perché è quanro i/le Gossip escono
dal seminato del rifarsi ai Gang Of Four placati
(buoni il singolo Heavy Cross e 8th Wonder) e degli
inchini alle ESG (Men In Love: gustosa; For Keeps:
inzuppata nel pop) che capitano disastri. Per l’apprezzabile Spare Me From The Mold di stampo No
Wave, ci sono la dance Love Long Distance che cita
Marvin Gaye girando a vuoto, il chitarrone di Vertical Rhythm che perde la faccia tra funk smargiasso
e rock da balera, un syth-pop come Four Letter Word
che sa iddio cosa c’entra.
Viene da pensare a un bicciere mezzo vuoto, se si
tiene conto che sono trascorsi tre anni dall’album
precedente e nel frattempo s’è ingannata l’attesa
con speculativi remix e live. L’impressione è che le
cose stiano scappando di mano ai tre, o che il calcolo vada consquistando la ribalta. A dispetto di tutte queste magagne, state pur certi che Music For
Men venderà parecchio per gli standard odierni. Se
meritatamente o meno, dipende dal vostro livello di
puritanesimo indie.
(6.6/10)
Giancarlo Turra
Greg Davis - Mutually Arising
(Kranky, Settembre 2009)
G enere : drone
Se non esistessero dischi così alla Kranky dovrebbero ordinarli su commissione. Detto che in un periodo di ultra-inflazione del genere, con la drone music
a dominare pressoché tutto lo spettro delle musiche rock-oriented (ma anche le “non oriented”)
degli anni 2000 uno come Greg Davis potrebbe
essere tranquillamente accantonato. Probabile che
ciò avvenga comunque e che a fine anno si ricordino di Mutally Arising soltanto gli appassionati
del genere, ma ciò non toglie che si sentiva anche
un po’ il bisogno di un disco così minimale e seriosamente accademico.
Stiamo parlando in pratica di due lunghissimi droni
di venti minuti e passa l’uno, costituiti da micro variazioni tonali, dalle cadenze testardamente e meti-
colosamente in crescendo. Il primo, Cosmic Mudra,
parte silenzioso ai limiti dell’udibile e cambia colore e timbrica a cadenze regolari. Il secondo, Hall Of
Pure Bliss, plana aereo e soffice, con modalità simili a
quelle degli Stars Of The Lid. I droni di Greg Davis conservano comunque sempre una qualità materica e tangibile. Non sono mai troppo impalpabili
o inconsistenti. Complice anche la strumentazione
che consiste in un paio di sintetizzatori (un Korg
Mono/Poly e un Crumar Stratus), e un computer
il tono generale dell’opera è molto monocorde e
uniforme.
Per qualcuno sarà certamente un mattone assai
poco digeribile, altri cercheranno di rintracciare i
lati positivi, nascosti nei suoi angoli più bui. La verità
probabilmente sta nel mezzo anche in casi come
questo.
(6.7/10)
Antonello Comunale
Heliocentrics (The) - Fallen Angels
- The Singles Collection (Now
Again, Agosto 2009)
G enere : psych - funk
Tre dodici pollici usciti tra 2007 e 2008, sempre per
la dependance vintage della Stones Throw, in totale
otto pezzi e mezz’ora di durata, vengono raccolti
in questo CD dal packaging stile mini-LP pensato
per il mercato giapponese. L’India sinistra di Distant
Star (nella versione cantata si passano il microfono Mf Doom e Percee P), di Sirius B (feat di
Vast Aire dei Cannibal Ox ed echi di Sun Ra
e Art Ensemble Of Chicago) e Vibration Of
The Fallen Angels (con tocchi come di uno Steve
Reich tribale); il latin funk nebuloso di The Oracle
e quello incalzante, alla Madlib/Yesterday New
Quintet, di The Gorn; il funk da colonna sonora di
Space Time Girl (protagonosta il violino) e di Before
I Die (feat di Guilty Simpson). Il tutto immerso
in un’atmosfera, come sempre per Catto (e vedi
anche il mini assieme a Mrr-Adm), torbidamente
psichedelica.Tutta roba buona in attesa di una nuova
release maggiore dopo i fasti del disco con Mulatu
Astatke. Rispetto alla versione in digital download,
il CD contiene due bonus, da un altro sette pollici
del 2007, e quindi dieci pezzi in tutto, lo slo-funk da
telefilm (anni Settanta, ovviamente) Dance of Dogons
e il funk esoterico, tribale e casinista (dominato dalla raganella) di Noise.
(7/10)
Gabriele Marino
Indukti - Idmen (Inside Out Music,
Luglio 2009)
G enere : A vant P rog M etal
Qualcuno doveva pur custodire l’eredità dei primi
Isis, ormai ridotti ad ombra sbiadita di se stessi.
Qualcuno doveva pur proseguire sulla strada del
progressive metal più ardito e aperto alla contaminazione, nato da band come i Cynic. Tecnica, attenzione agli arrangiamenti, varietà del colore timbrico
e predilezione per ritmiche irregolari e complesse.
Sembrano essere queste le prerogative stilistiche
che inseriscono di diritto Indukti nel mondo più
“progressivo” della nuova scena metal.
Idmen, secondo album della band e primo ad uscire
per l’etichetta tedesca Inside Out, è un lavoro che
dà l’idea di una certa completezza, relativa all’ottimo
amalgama di influenze e di soluzioni musicali. L’eclettismo compositivo dei
cinque strumentisti crea
una materia multiforme
e sempre imprevedibile,
muovendosi liberamente dai territori del metal
estremo a quelli della
musica etnica. I riff dei
Metallica di …And
Justice For All incontrano il suono spiazzante di
uno strumento come il dulcimer; violini e saz (un
liuto turco) si insinuano tra le massicce distorsioni,
ritagliandosi un ruolo di comprimari in un contesto
che gli è estraneo, proprio mentre una tromba davisiana si misura con sonorità tipicamente metal .
Nei lunghi brani, per lo più strumentali, brutali
esplosioni si alternano a momenti più introspettivi
, dando il giusto spazio alle esplorazioni timbriche,
elemento che contraddistingue più di altri lo stile
dei polacchi.
Cinque menti pensanti, cinque strumentisti che hanno scelto di tentare la carta del quintetto senza voce,
contattando, laddove opportuno, dei guest disponibili ad adattarsi ad un materiale già precomposto.
In questo caso è toccato a Nils Frykdahl (Sleepytime Gorilla Museum), Maciej Taff (Rootwater) e Michael Luginbuehl (Prisma) associarsi alle
idee della band.
Un peccato che, con tanto materiale messo in campo, a prevalere sia una componente metal un po’
troppo evidenziata . La volontà di tenere stretta
l’appartenenza al genere rischia di offuscare le interessantissime “deviazioni” di musicisti che riescono
a passare dagli Helmet alla fusion con la semplicità
recensioni
75
highlight
Vivian Girls - Everything Goes Wrong (In The Red Records,
Settembre 2009)
G enere : twee - pop
Ci vuole una bella faccia tosta ad affermare, proprio in copertina, che va tutto male. Soprattutto
se si è uno dei nomi più chiacchierati dell’underground americano, baciato in fronte da un successo limitato nelle dimensioni ma costante. Le tre Vivians però si sa, sono furbette e giocano di
sarcasmo; così nonostante i titoli dei primi tre pezzi (Walking Alone at Night, I Have No Fun, Can’t
Get Over You, ma anche i restanti non scherzano) la buttino un po’ sul pessimismo andante, Everything Goes Wrong risulta essere un concentrato irresistibile di melodie luminose e solari
come se ne sentono pochi.
Non che la materia differisca dall’omonimo esordio dell’anno scorso;
sempre di twee-pop chitarristico sporcato di garage-sound si tratta.
Fa però piacere notare qualche tentativo se non di evoluzione (piuttosto difficile in un genere così codificato) per lo meno di spostamento
in avanti: strutture (lievemente) più complesse, pezzi mediamente più
lunghi (si supera la mezzora stavolta), ventaglio di riferimenti più ampio (seppur di poco) vanno ad aggiungersi alla solita sensibilità pop
ad alta gradazione e a un pizzico di aggressività che non guasta mai,
soprattutto se si esce per In The Red.
È infatti proprio questa la miglior dote delle tre; il riuscire a infilare in ogni disco un quantitativo
strepitoso di potenziali hit insieme poppy (le melodie vocali) e rumorose (il pastone in distorsione dei suoni). Se nel precedente a ergersi sulla media erano pezzi come All The Time, Wild Eyes, I
Believe In Nothing, stavolta è il turno dell’esplosione garagey di I Have No Fun, del jingle-jangle di
Can’t Get Over You, della cavalcata post-Vaselines di Double Vision. Ci sentiamo perciò in dovere di
recuperare quel mezzo punto perso dall’esordio solo in virtù dei pochi pezzi originali.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
di un bambino. Ascoltare la conclusiva Ninth Wave
per credere.
(7.1/10)
Daniele Follero
J Dilla - Jay Stay Paid (Nature
Sounds, Giugno 2009)
G enere : dill a hip - hoptronica
Con la benedizione di Ma Dukes, Pete Rock pesca tra gli inediti di Dilla, tra minidisk e DAT, dagli
esordi fino ai primi giorni in ospedale (giorni ultimi),
chiama alcuni prestigiosi vocal guest a rappare sopra le selezioni e organizza il tutto, 28 pezzi brevi,
solo quattro sopra i tre minuti, con la forma del
radio broadcast. Siamo in territori Dilla elettronicosporco (se non come tecnica, sicuramente come
suono), Dilla post-Ruff Draft, come sempre ip76
recensioni
notico, spesso claustrofobico, spesso a lambire una
ballabilità plumbea e rallentata, anche giocoso all’occorrenza, con pezzi generalmente molto asciutti
(pulsazione di base e massimo due voci melodiche).
Non mancano comunque esempi più collagistici o
il solito funk-soul, come pure una dichiarazione di
weirdness come solo lui o Madlib, un campione
da Oh No di Zappa, versione mid-Seventies. Nonostante il carattere postumo e Dilla-celebrativo, i feat
sono (quasi) tutti davvero ottimi; seguendo la tracklist incontriamo: Blu, Lil Fame, Phat Kat, Danny
Brown, Constantine, Black Thought, Doom,
Diz Gibran, Havoc, Reakwon, Frank Nitty, Illa J,
Cue D.
Rock, uno dei miti di Dilla, rende omaggio all’allievo
dalle mani d’oro, e riesce a dare organicità a materiali di provenienza tanto eterogenea, di loro co-
munque già marchiati dall’intrinseca riconoscibilità
stilistica del nostro, esercizi interessanti e mai banali
di riduzione (a tratti sembra di ascoltare veri e propri studi sui bassi), con la sensazione che si tratti di
un session album e non di una collezione di ritagli e
scarti. Ricorrente e ossessiva la sirena ascoltata già
in tante produzioni di Dilla, dichiarazione d’intenti
presa dall’intro di King of The Beats dei Mantronix.
(7.3/10)
Gabriele Marino
James Yorkston - James Yorkston
& The Big Eyes Family Players –
Folk Songs (Domino, Agosto 2009)
G enere : folk
James Yorkston non sarà Pete Seeger ma ha dalla sua, comunque, la classe e il savoir faire dei migliori musicisti folk. Capacità che nel nostro caso si
esplicitano anche nel saper reinterpretare con stile
canovacci tradizionali – molti dei quali patrimonio
comune di certo folk revival dei Sessanta – riarrangiandoli senza snaturarli. Irlandese la provenienza di
molti degli episodi di Folk Songs – con qualche
puntata in Spagna – per un programma ovviamente
acustico in cui il padrone di casa e James Green
- con i suoi Big Eyes Family Players - lavorano di
cesello su arie intime, malinconiche e immediatamente fruibili.
Il fascino arriva dall’attualità retro’ di un passato
decisamente comodo rispetto a un presente musicale in fieri, carta vincente di ogni folk-man che si
rispetti. A patto di riservare al materiale da rivisitare dignità e spessore, oltre che la giusta riverenza.
Yorkston, in questo senso, è bravo e fortunato, dal
momento che porta a termine un lavoro apprezzabile sui suoni collezionando un programma che non
conosce cedimenti di sorta.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Jay Reatard - Watch Me Fall
(Matador, Settembre 2009)
G enere : pop - punk
Jay Reatard è uno fico. Anche se, al tempo stesso, è
pure un opportunista. Non che la seconda qualità
incida troppo sulla prima, anzi; l’essere fico, in certi
contesti, passa inesorabilmente anche per il saper
cogliere l’occasione, checché ne dica o pensi la blogosfera tutta. Un esempio di personaggio fico ma
non sveglio a tal punto da cogliere l’opportunità?
Nathan Williams aka Wavves, perfetto paradigma
dell’incapacità di capire cosa si sta facendo nonché
di scarsa lungimiranza (vedasi la ricca figura di merda del Primavera Sound…).
Jay Reatard invece è uno diverso. Uno rissoso, incompromissorio, oltranzista; ma che ha l’occhio lungo e sa che certi treni passano – forse – una volta
sola nella vita. Senza entrare nel merito di stupide
controversie legate a fantomatiche ed autoreferenziali coerenze da underground rumoroso, JR ha preso al volo il treno della Matador. Non una major, ma
per lo meno qualcosa molto più levigato e meno
catastroficamente low-budget rispetto ai lidi che
era solito frequentare. E soprattutto, un treno molto più visibile al (ehm) grande pubblico. I suoni di
questo Watch Me Fall (profetico? ironico? sicuramente icastico) sono – si sarà capito – più levigati,
più puliti, meno strozzati rispetto allo scatafascio in
cessofonia acuta in cui Jay era solito sguazzare.
I pezzi non cambiano però di una virgola il jayreatard-pensiero: pop-punk tirato affidato a melodie
affilate che si conficcano nel cervello al primo ascolto. Il ragazzo ci sa fare, non lo scopriamo noi ora, ma
Watch Me Fall si prefigura come uno dei migliori
dischi punk da un bel po’ di tempo a questa parte.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Joakim - Milky Ways (!K7,
Settembre 2009)
G enere : electro disco funk - rock cosmico
Se lo ascolti in velocità, il nuovo Joakim non lo
capisci. Che sta facendo quest’uomo? Chi si crede
di essere? Perché mette del rock blues sporco quasi
post-punk in un territorio che non è il suo e poi
c’aggiunge progressive dal taglio moroderiano che
fa modernariato electro? Al repeat ti chiedi se ci è
o ci fa. L’alternanza di momenti ottimi a momenti
interlocutori -che sembrano stare lì per caso- non
t’aiuta ad esprimere un giudizio. Ad un tratto capisci
che la forza delle 10 tracce sta proprio nel descrivere e testimoniare l’ambiguità dell’electro odierna. Il
tutto impacchettato in poco più di 50 minuti.
E allora che sia la l’electrolounge dei salotti à la Stereolab (Fly Like An Apple), il coro ubercosmic-deep
di Spiders (singolone che fa tremare Lindstrøm),
le vibrazioni a 8(0) bit di Medusa, l’electrofunky di
Love & Romance & A Special Person, la ballad slo-mo
shoegaze (King Kong Is Dead, che ricorda tra gli altri,
i nostri Giardini di Mirò) e l’omaggio ai primi
Depeche Mode in Travel In Vain va bene lo stesrecensioni
77
so, basta saltare di qua e di là, non sedimentarsi in
nessun genere e con questo trucchetto rivendicare
un’estetica che è piena di post-modernità e di relativismo.
Una delle possibili soluzioni per far galleggiare il barcone dell’electro french rock, sempre più decorato
con inutili barocchismi e sputtanato da quintali di
poshyness: il capitano Joakim ci traghetta senza batter ciglio lungo una rotta che tiene conto dell’eredità funk bianca e delle stelle della kosmische.Alziamo
gli occhi al cielo e contempliamo per un lungo attimo la via lattea joakimiana. Da sballo.
(7/10)
Marco Braggion
Joe Henry - Blood From Stars
(ANTI-, Agosto 2009)
G enere : modern american songwriting
Con Joe Henry, il gioco delle assonanze e dei rimandi funziona fino a un certo punto. Perché, d’accordo, può ricordare Elvis Costello, però non è
altrettanto cinico; va bene, certe atmosfere paiono
sottratte a Tom Waits, ma quello domiciliato
presso la Asylum; ok, concediamo anche che la penna evochi Randy Newman, sottolineando come
questo sia complimento tra i più belli per un cantautore d’oltreoceano. Però tutti costoro non sono
mai interamente presenti e li osservi intenti a darsi il
cambio sotto lo sguardo vigile dell’autore in canzoni
eleganti, colte, personali.
Insomma, quando sullo stereo gira qualcosa di Joe
te ne accorgi subito e idem se è un lavoro cui ha
messo le mani in sede produttiva. Sta lì buona parte
del talento suo, giacché aiutare gli altri a concretizzare quanto gira in testa serve ad averle di già chiare
le tue, di idee. Se non è di Giamaica o elettronica
che parliamo, sono pochissimi i produttori ad essersi cimentati con una brillante carriera autoriale di là
del banco: ricordiamo giusto Brian Eno e Daniel
Lanois, qui un riferimento per talune atmosfere
sospese e cinematiche.
Dunque con questo fanno più di vent’anni sulle scene e una sfilza di lavori mai banali o sfocati; almeno
un capolavoro (Scar, del 2001) e una ressa da non
credersi per la medaglia d’argento. Alla quale da oggi
partecipa Blood From Stars, a un’incollatura dal
podio in virtù della penna al solito scintillante di jazz
e country, di latinità e New Orleans; per la scrittura
puntuale e ogni stile restituito con personalità. Basta a farlo il gran disco che è, non vi fosse lo stuolo
di ospiti di rodata abilità e nuovi talenti come il fi78
recensioni
glio Levon - diciassette
anni e bel soffiare sax
soprano - o il pianista
Jason Moran, ognuno
che offre arti e cervello
a un talento cristallino.
Che mostra forza senza
limitarsi a citare ironicamente o ricalcare senza vergogna come i troppi
“vorrei ma non posso” odierni. Che allestisce un’ora
compatta di “american sound” trasversale e urbano,
blues della mente venato di jazz e prezioso di intarsi
e dettagli certosini. Più di tutto contribuiscono alla
sensazionale riuscita la risacca All Blues Hail Mary e
una The Man I Keep Hid dritta da Good Old Boys;
le missive dalla Louisiana Bellwether e Death To The
Storm; una serena Channel e il babà jazzato Over Her
Shoulder; quel sapore latino che emerge da This Is
My Favourite Cage e l’epopea filmica Suit On A Frame.
Vi paiono troppe e siete scettici? Sappiate che sono
solo le preferite di oggi e domani chissà. Poco da
stupirsi: Joe Henry è un patrimonio prezioso, tanto
più quando si rifiuta di dormire sugli allori.
(7.8/10)
Giancarlo Turra
John Zorn - Masada Quintet Stolas: The Book of Angels Volume
12 (Tzadik, Giugno 2009)
G enere : jazz
Dopo la fusion asciutta e solare dei motivetti di Alhambra Love Songs, sul mood del vecchio The
Gift, il nostro continua a esporre e sviscerare il
suo Book Of Angels, seconda infornata di composizioni destinante al progetto Masada. Qui affianca
ai tre Acoustic Baron, Cohen e Douglas il piano
di Uri Caine (già testato su Moloch, volume 6
della serie) e il sax tenore del veterano postbop
Joe Lovano (che pur essendo in qualche modo
un classico, ma soprattutto un classicista, in passato
ha già lavorato con gente come Bill Frisell e con
gli stessi Baron e Douglas).
Il risultato, sotto l’etichetta nuova di Masada Quintet,
è uno dei dischi meno scarmigliati del microcosmo
Masada, diciamo un “Masada soft”. Solite forti innervature jewish nei temi e nelle scale, qualche eccentricità sparsa, tocchi latin (nel senso di un festoso
barrio; Haamiah, Serakel), ma soprattutto ballad pianistiche e jazz sinuoso e avvolgente (Rikbiel, Psisya,
Tashriel, Tagriel, Rigal), con soli distesi e composti e
momenti assolutamente romantici. Il pezzo più ma-
sadiano (nel senso classico di kletzmer meets Ornette
Coleman) è Sartael. Zorn si concede un cameo in
Rahtiel, tema carico di pathos e impagabili momenti
ironici, quasi cartooneschi, negli intrecci di fiati.
Per le star assolute che ci suonano dentro, ci si sarebbe aspettati anche di più, qui siamo comunque in
ambito routine di classe e gusto di suonare per suonare, ma Zorn (in quanto regista del tutto) azzecca
sempre qualcosa, nel tema, nell’arrangiamento, nel
solo, che rende il disco meno da sottofondo, seppure sottofondo di lusso, di come sarebbe potuto
risultare. Un buon disco jazz suonato da ottimi musicisti (qui) jazz.
(6.9/10)
Gabriele Marino
John Zorn - O’o (Tzadik, Luglio
2009)
G enere : ( jazz ) lounge
Pallottoliere accanto giusto per tenere il conto,
Zorn torna ancora su The Gift (ormai, lo si è
capito, uno dei suoi dischi chiave), dopo The Dreamers e dopo, per quanto meno esplicitamente,
Alhambra Love Songs. Di The Dreamers questo
O’o (uccellino hawaiano dal canto melodioso, estinto a fine anni Ottanta), è il seguito ancora più exotico.
La formazione è la stessa, e cioè quella base della
Electric Masada (Baron, Baptista, Dunn,
Ribot, Saft e Wollesen), ma senza Zorn al sax
alto. Immersione in una lounge mossa e disinvolta,
con in primo piano il vibrafono di Wollesen, poi le
tastiere acquose di Saft e la chitarra di Ribot. È lo
Zorn più easy listening, e non ci dispiace affatto.
Latin (Miller’s Crake, da saloon, Solitaire, Piopio, Zapata
Rail, proggy, Magdalena, psych sambeggiante; in certi frangenti casinisti siamo a due passi dal Madlib
YNQ), fusion alla rugiada (Akialoa), iterazioni minimaliste (passione di sempre e ossatura di Alhambra,
Po’o’uli), rock blues psichedelico (con echi trip-hop,
Little Bittern, uno dei pezzi più interessanti in questo
contesto zorniano), jazz smooth (Mysterious Starling), exotica (Laughing Owl, Kakawahie, sofficemente
messicaneggiante), colonne sonore (desertica, sinistra, Archeopteryx).
(6.95/10)
Gabriele Marino
Julian Plenti - Julian Plenti is...
Skyscraper (Matador, Agosto 2009)
G enere : R ock
Paul Banks goes solo. Smesso il gessato Interpol,
lo ritroviamo a rimuginare nerd sotto le insegne del
vecchio moniker Julian Plenti, sorta di alter ego
da catalogo American Apparel con cui – erano i ’90
di mezzo – iniziò a bazzicare le scene underground
della Grande Mela. Uno stand by più o meno obbligato, chissà se e quanto dettato dall’accoglienza
– assai freddina, nonostante l’accasamento major e
l’immancabile hype – riservata all’ultimo Our Love
To Admire da pubblico e (soprattutto) critica.
Congegnato con il solo ausilio di un Logic Pro e il
contributo di qualche amico in fase di arrangiamento (l’ingegnere del suono nonché ex compagno di
college Charles Burst, Mike Stroud dei newyorkesi
Ratatat, il defilato Sam Fogarino), Skyscraper azzarda se non altro una possibile strategia di fuga,
un rimettersi in gioco nella penombra del proprio
disincanto, sia pure ricorrendo al solito campionario/immaginario dark wave intossicato di coolness e
inquietudini metropolitane.
Ecco allora questa dozzina di canzoni che non
sorprendono né deludono le attese, limitandosi a
graffiare la superficie quel tanto che basta (vedi le
manovre di basso e riff assassini, per quanto risaputi, del singolo Games For Days, l’enfasi Placebo
dell’iniziale Only If You Run, come pure i cambi ritmici
della notevole Unwind) a non farci rimpiangere le
tempeste emotive del passato. Tutto come da copione Interpol (senza gli Interpol), anche quando – e
accade spesso – l’impianto rock dei brani lascia spazio al (prevedibile) rinculo acustico, ovvero l’altro
lato della faccenda, il romanticismo solenne e irrequieto (Girl On The Sporting News), lo struggimento senza sbocco altezza
NYC (On The Esplanade,
cupo rimuginio di corde,
piano e voce impastata),
le avvisaglie Joy Division stemperate d’amarezza (Skyscraper, Madrid
Song), l’intimismo sconsolato e autoconsolatorio
(No Chance Survival) a conferma di una scrittura
sempre più in bilico fra emotività e maniera.
Ad uscirne, con tutto ciò, è un dischetto inevitabilmente accessorio, classico rito di transizione che
spalanca porte e lascia sospesi tutti i dubbi del caso.
In attesa di buone nuove sul fronte Interpol, comunque, un benefico coming out.
(6.8/10)
Nunzio Tomasello
recensioni
79
highlight
Yo La Tengo - Popular Songs (Matador, Settembre 2009)
G enere : pop - rock
Gli Yo La Tengo chiudono il quinto lustro di esistenza facendo quello che hanno sempre fatto:
continuando a fare propri settori della musica popolare. E mai come in Popular Songs – il titolo
non è per nulla casuale – l’attributo appena espresso è azzeccato. Il cibo di cui si nutre l’album
è la musica pop, persino easy-listening potremmo dire, quella dei “grandi successi” per le grandi
masse (anglosassoni) che troviamo a volte nelle mastodontiche compilation regalo.
Eppure, anche qui, come sempre, riproducendo questa musica per tutti, il trio suona qualcosa di diverso. Pensate al funk rilassato di Periodically Double Or Triple: Ira Kaplan si avvicina addirittura alle avventure
armoniche di Prince, ma sul finale emerge un divertissement arrangiativo che inserisce timidi coretti ritmici capaci di rendere eccezionale la
chiusa. E poi c’è quel fare percussivo che contraddistingue da sempre
la loro specificità più autentica; niente di meno che il tratto distintivo
della band che fa anche di queste canzoni pop dei capitoli trascinanti,
da farci un viaggio macinando chilometri in auto.
Non mancano momenti autoreferenziali (More Stars Than There Are In Heaven, del resto un pezzo
per nulla inutile) come la splendida e lunghissima meditazione finale di The Fireside. Anzitutto però
in Popular Songs fanno mostra di sé le ballate (delicatissima e memorabile I’m On My Way) e
pure il country più aquarellato (When It’s Dark, che sembra caldamente consigliarci di percorrere
una litoranea all’imbrunire).
Gli Yo La Tengo, come disse qualcuno, sanno a cosa un critico può appigliarsi per criticarli, e anziché evitare la sfida in questo album estraggono la carta più rishiosa, perché apparentemente facile.
Qui più che mai stanno giocando con noi. Sono arrivati a un tale livello di auto-consapevolezza – e
di bravura, certamente – da permettersi di confezionare il tutto per un doppio pubblico, dato che
davvero queste canzoni non hanno barriere all’ingresso, eppure creano rompicapo a chi ne voglia
analizzare le intenzioni profonde.
Sarà un delirio di onnipotenza, anzi una paranoia simile a quando ci si gira in continuazione,
mentre si cammina per strada, convinti di essere seguiti da qualcuno; ma queste canzoni popolari strizzano l’occhio alla nicchia di gente che li segue da sempre, e che vuole, costantemente,
testardamente, ingenuamente, capire dove vogliono andare a parare. E cosa vogliono farci dire e
pensare. E, in conclusione, ancora una volta, ci siamo cascati.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Karl Blau - 96 (K Records, Luglio
2009)
G enere : lo - fi
È curioso. Ma neanche troppo, se uno conosce la
storia. Karl Blau è ormai il tutto fare della K Recs,
dove registra album altrui (due esempi opposti: Arrington De Dionyso e Lake) e dà anche una
mano con voce e strumenti (altri due: Chain And
The Gang e Laura Veirs). Eppure continua con
la propria produzione che va senza dubbio nel segno del lo-fi. Insomma: è orecchio quando lavora
80
recensioni
per la label, testa senza tempo per rifinirne la messa
in musica quando lavora per sé. Del resto 96 è così
chiamato perché, oltre a uscire per la K, è anche la
produzione novantasei della Kelp Lunacy Advanced
Plagiarism Society, sorta di one-man-net-label, ente
musicale che Karl si è creato per seguire la propria ombra (e mettere gratuitamente a disposizione
MP3).
Dunque 96 è antitetico a Nature’s Got Away,
che invece di canzoni costruite e arrangiate in modo
più tradizionale – ma non banale – si componeva. E
ha come leit motiv una drum machine scazzata che
accompagna la voce rilassata e sonnolenta di Karl.
Niente di necessariamente negativo. E va detto che
non butteremmo quasi nulla di quello che Blau impacchetta casalingamente. Baby Alone dà prova della
sua capacità di costruire motivetti e arrangiamenti
con materie musicali diverse – qui una tromba, la
sua tromba che tanto ama, un basso e una batteria
secchissima da terzetto jazz. Ma normalmente la costruzione è meno a fuoco, diremmo “weird”, giusto
per qualificare, con un termine appena fuori moda,
la low-fidelity dell’album. Qualcosa di non troppo
distante da un Ariel Pink meno squilibrato (Go
Where I Like).
Tutto passa senza impegno, per noi, apparentemente anche per Karl, per i suoi strumenti e per
le nostre orecchie. Un disimpegno che però non
disdegna un secondo ascolto. Un terzo. Insomma un
parziale affiatamento con questa ennesima mattonella nell’edificio non da poco che negli anni Karl
Blau sta mettendo in piedi.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Kiddycar - Sunlit Silence (Rai
Trade, Settembre 2009)
G enere : electro pop
A due anni dall’apprezzato debutto Forget About,
attesa stemperata dall’ottimo split How This
Word Resounds con Christian Rainer, gli
aretini Kiddycar calano la carta del sophomore album forti dei molti riconoscimenti (invitati ad un
programma della BBC sono stati presentati come
una delle più interessanti nuove band europee) e
della fresca firma con l’etichetta Rai Trade. Sunlit
Silence gode infatti di una maggiore padronanza di
mezzi e direzione, una dozzina di tracce in accorto
e trepido equilibrio tra camerismo onirico ed electro pop, sentori seventies sdrucciolati negli electric
dreams degli ottanta, enfasi spacey e ombrosi subbugli french-touch.
Le trame sono calde e appassionate come sogni
androidi (in inglese e francese) appena sfornati in
un mondo che si ostina umano a partire dalla voce
flautata di Valentina Cidda, spalmata su apprensioni circa Lali Puna (Drop By Drop), sogni spersi
Radar Bros (Another Life) e fatamorgane Goldfrapp (Il Fait Jour). Spuntano talora retaggi cosmici
Air su enfasi post-prog (Hungry Sky Swins On The
Deep), altrove un synth à la Baba O’Riley introduce
incipiente ballad Notwist (C’est Drole, munita di
tromba, violino e tastierine eighties), riservandoci il
meglio col bolero folktronico di Purple Fish Wedding,
benedetto da un brividoso recitato iniziale (in italiano) della stessa Cidda, di cui val bene ricordare tra
le altre cose l’attività parallela di scrittrice e quella
passata di doppiatrice.
Disco indubbiamente valido, molto curato nei dettagli, arrangiamenti all’insegna di un’inventiva funzionale, timbri e dinamiche al guinzaglio, insomma: tutto
a posto. Malgrado ciò - o forse proprio per questo
- soffre di una certa rigidità formale, figlia forse del
volersi frutto perfetto da esporre sulle piazze più
esigenti. Non è per forza un difetto, ma il vermicello
si trova spesso nelle mele genuine. Quelle che non
sciupa, hanno più sapore.
(6.6/10)
Stefano Solventi
La Roux - La Roux (Polydor, Giugno
2009)
G enere : electro dancey pop
La Roux è la banana ingellata che riporta il pop 80
sulla pelle di questo 09 ormai contaminato e scottato da multipli fuochi. La Roux è Elly Jackson con
la sua voce pop lolita ma nel contempo roca e un
po’ nasale. Che la ami e la odi allo stesso tempo.
La Roux è il binomio di due singoli: In For The Kill e
Quicksand. Il primo che è patina 80 che non ti togli
di dosso. Non la squami. Il secondo è la ballad ritmata che sale nell’olimpo del pop.
La ascolti - questa dozzina di canzoni - e non capisci
che cosa ci sia di diverso dagli Yello, dagli Alphaville o dalla Ciccone dei primi 80 (Colourless Colour). Non molto. L’unica cosa è che ci sono più di 15
anni in mezzo: c’è stato il fidgeting, il french touch
e Sebastien Tellier, c’è stata la Kitzuné (che la
ospita nella settima compilation), c’è il retrofuturismo e ci sono i Ray Ban. E allora sarà solo furbizia?
Essere sullo scaffale giusto al momento giusto?
A una prima passata verrebbe da dire di sì, invece
poi ti accorgi che non riesci a staccarti da questi tre
quarti d’ora di kitch brillantinato. La forza del pop
e l’eredità un po’ B-52 un po’ Sabrina Salerno, la
pletora di tastierine depechemodiane e di coretti à
la Bangles, lo sculettamento vocale che sbianca il
banghra di Santogold e lo riporta a una waspness
rigorosa, la simulazione (ovviamente) incompleta di
Kylie.
Un anelito a voler essere la nuova icona UK per
i party harders che fuori dal dancefloor non sanno cosa ascoltare e per le lolite e i loliti che non
recensioni
81
sono stati ancora bruciati dall’acido. Ma anche per
chi non entra in un club dall’ottantacinque. Lacrime
e pelle d’oca assicurate.
(7.5/10)
Marco Braggion
Lady Sovereign - Jigsaw (Midget,
Aprile 2009)
G enere : G rime
Lady Sovereign è la ragazzina del grime che al
secondo disco s’insabbia. Se le promesse del precedente Public Warning c’erano tutte (anche se
dissimulate da un’età super giovane e da movenze
anche troppo scimmiottanti il gangsta-UK sbruffone), oggi la ragazzina Louise Amanda Harman diventa la brutta copia di M.I.A. e, lasciandosi travolgere
dal fashion, ci lascia perplessi.
Jigsaw è il tipico prodotto commerciale post
Spice Girls fatto di
fashion virato indie con
finalità - se possibile grimey pop. Tutto ovviamente orecchiabile. E
inutile. Come il rimescolamento dei sample della Close To Me dei Cure (So
Human è il primo singolone da radio), o cose che
ci ricordano la citata M.I.A. mescolata al Robbie
Williams del caso (I Got You Dancing).
Una tracklist buona per teen con un piede nell’hiphop londinese e l’altro nella dance commerciale
(vocoder, occhialoni neri con la montatura grossa,
catenoni e tanta fakeness...). E un peccato per chi,
come noi, c’aveva visto qualcosa in Louise. Cresci
bene che ritorniamo.
(6/10)
Marco Braggion
Legittimo Brigantaggio - Il cielo
degli esclusi (Cinico Disincanto,
Settembre 2009)
G enere : cantautorato rock
Sarebbe ozioso ribadire quanto il combat-ska
patchankato con venature irlandesi mi suoni ormai da anni tanto più blando quanto più animato
da presunte fregole impegnate (o addirittura rivoluzionarie), con tutto quel cantarsi addosso sdegni
nostalgici celebrando così un bel cerimoniale di appartenenza alla chiesa del non appartenere. E vai
con la liturgica sequela dei cliché.
82
recensioni
Dai laziali Legittimo Brigantaggio però accetto volentieri predicozzi e sacramenti, perché all’interno
del canone - non manca ovviamente la fisarmonica
e, quando è il caso, i violini - si permettono deviazioni eretiche parecchio gustose. A partire dall’incandescente Lo specchio del pastore, tra surf noise,
strali post wave e “rosco” acidella (che scomoda il
ricordo del Vasco Rossi di La strega), capace altresì di un certo piglio radiofonico (casomai ci fossero ancora in giro radio sensibili a certi input). Un
vizietto furibondo che strattona l’accorata Velluto
di pietra, i languori rumba di Canzone per Franco, il
piglio beffardo da Skiantos col turbo di La leva
infantile del ‘08 (che si divora d’amblé tutti i Caparezza in circolazione).
Detto della bella vena cantautorale che innerva Ad
occhi chiusi (storiella a due voci cantata assieme alla
rambler Betty Vezzani), tra nostalgie folk studio e
medievalismi Branduardi, e di quella Mi lamento
che rende adulti i Bandabardò, resta un senso di generosità genuina, l’attitudine per la melodia energica, il gusto per la narrazione e la poesia (tanto alle
musiche che alle liriche si alternano i fratelli Lestingi
e Andrea Ruggiero, più Elisa Casseri - Premio Pirandello - che ha scritto il testo de Il gioco del mondo)
che fanno di questo disco un buon esemplare di
cantautorato rock, solo occasionalmente “combat”.
(7/10)
Stefano Solventi
Lightning Dust - Infinite Light
(Jagjaguwar, Agosto 2009)
G enere : folk - pop
Si presenta fin da subito come un tipico “spin off” il
progetto Lightning Dust, con Infinite Light al secondo capitolo della sua breve storia. Iperattivo per
natura e cultura, il duo Amber Webber/Joshua
Wells che ne è anima e cuore (supportato in regia
dal “solito” John Congleton) non vuole infatti
saperne di starsene con le mani in mano e - benché già impegnato da Black Mountain e Pink
Mountaintops - si scava una nicchia lontana dagli
sguardi vigili di Stephen McBean.
Siccome trattasi di faccenda a metà tra la libera uscita e l’affermazione d’identità, ecco che le atmosfere
sono lontane da entrambi: più dalla Montagna Nera,
a dirla tutta, ché talune influenze di Opal e Mazzy Star (nomi mai così alla ribalta come nell’ultimo triennio...) possono richiamare il meraviglioso
Outside Love. Nondimeno collocate in un contesto orchestrale che inscena un folk intinto nel pop
e nelle favole talvolta propenso alla tensione, intessuto di archi e pianoforti spaziosi con la grandeur di
un moderno Spector e la leggiadria dei Mercury
Rev migliori. Del tipo capace di arrestarsi un passo
prima del kitsch, a farla breve. O quasi, perché se i Nostri sono autori persuasivi (Antonia Jane ha respiro coheniano) e gli arrangiamenti reggono, l’ugola di Amber snerva con voli
pindarici di un vibrato che fa del melodramma fastidio. Zavorra che composizioni come una “soulful”
Waiting On The Sun To Rise o Take It Home (splendida:
immaginate dei Portishead d’oltreoceano senza
funk...) non meritano, così come il personale omaggio a Kate Bush Never Seen e il classico sferragliare alla Suicide - in chiave pop - I Knew. Altrove,
però, lo slancio enfatico taglia le gambe e l’epica
manda in frantumi i buoni propositi, di conseguenza
tocca limitare gli entusiasmi. Non proprio un’occasione sprecata Infinite Light, semmai la dimostrazione di una tendenza attuale diffusa - quella al
suono “oceanico” - che in tanti inseguono, ma pochi
sanno sul serio maneggiare uscendone indenni.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Lil’ Louis - Two Sides to Every Story
(Autoprodotto, Gennaio 2009)
G enere : houserie / r ’ nb
Recupero doveroso, propiziato dall’estate, di un disco uscito mesi fa in sordina (annunciato a dicembre 2008 e disponibile da inizio anno sul solo traxsource, ma con la dicitura unreleased), importante
perché segna il ritorno di un grande classico di cui
da tempo si erano perse le tracce, uno dei padri
dell’house, Lil’ Louis, quello di French Kiss (quando
la genialità si fa semplice ed efficace). Il disco è il rovescio femmina del maschio A Man’s Diary, libroconfessione di un playboy all’eterna ricerca sempre
e solo di una cosa: l’amore, fisico e spirituale un
tutt’uno. Il progetto pare si completerà con un film.
Intanto, album doppio e bifronte, un disco dance e
uno r’n’b.
R’n’b essenziale e placidamente notturno, inevitabilmente imbevuto di soul nella misura in cui è trainato dalle voci femminili che ci cantano-sceneggiano
sopra, clubbistico nella misura in cui usa tastierine
jelly-glitchy (Scorned), pop nella misura in cui i motivetti si ficcano subito in testa (Pleasure suona come
Rock Your Body di Justin Timberlake). Batteria
datata (Don’t Judge Me) e tastiere cronologicamente
indefinibili, che lasciano il centro della scena al piano
in Absence, a una chitarrina sfiorata in Defensive, al
rimshot in Drummer Boy, a dei campanellini bosseggianti in Beautiful. Tutti gioiellini.
La parte dance all’inizio spiazza un po’, per l’audacia
della frizione voci-produzioni, le prime cantati ancora r’n’b-soul (ancora vincenti le melodie), le seconde
vagamente oldie-houserie, batteria naiffissima e certi
rigurgiti della freakeria che fu (Crazy). Ma basta stare
al gioco per apprezzarla appieno, cogliendone anche
l’umorismo. Lil’ Louis ribadisce , un po’ a sorpresa,
di starci ancora dentro, ma di essere, a modo suo,
sempre e comunque fuori.
(7.3/10)
Gabriele Marino
Little Claw - Human Taste (Ecstatic
Peace!, Agosto 2009)
G enere : waves
Sembra di entrare in un vortice quando ci si mette
all’ascolto di Human Taste. Si parte da un blues
ferino (la title track) e si arriva al suo doppio maledetto e affogato in una marea di rumore scarnificato (la sua versione Below The Tide). In mezzo si sale e
si scende in continuazione, come in un ottovolante
all’inferno. Trapassando (e lasciandosi trapassare da)
un trentennio fatto e finito di musiche rumorose,
ipnotiche, deviate, disturbanti.
Il percorso iniziato qualche anno addietro sembra
dunque essere giunto alla sua tappa più compiuta.
Le strutture si sono dilatate, vanno di largo respiro,
ma l’ossessività scarnificata che da sempre ne caratterizza le musiche resta lì, in tutto il suo meccanico
e reiterato livore. Che si tratti di coniugare il verbo
post-punk o quello blues,
poco importa.
Potrà sembrare la classica sparata da presuntuosi scribacchini di musica,
ma spesso e volentieri
sembra di sentire una
versione terzo millennio e ridotta ancora più
all’osso di una ipotetica formazione a tre dei Velvet Underground. Senza aiutini psicotropici o
pretese arty ma con un immaginario primitivista e
genuinamente raw bene in mente.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
recensioni
83
Lovvers - Ocd Go Go Go Girls
(Wichita Recordings, Settembre
2009)
G enere : garage - rock
Raddoppio di consonante come d’ordinanza e fuoco incrociato sull’asse chitarristico garage-rock ma
che non lesina passaggi e incursioni nelle strettoie
post-punk più abrasivo. Aggressivi, giovani, ribelli, incompromissori i quattro Lovvers vengono da Notthingam e sono considerate una delle sensazioni
rumorose d’Albione.
Immaginatene i Libertines cresciuti a pane
e In The Red o i compari Black Time ancor
più in fissa con l’immaginario sixties-garage a
stelle&strisce e avrete
una mezza idea di quello che è contenuto in Ocd
Go Go Go Girls. Certo, non è tirando in ballo nomi
come The Urinals o Real Kids come influenze
che si guadagna la patente dell’originalità – cosa che
non sembra proprio essere una priorità per i quattro – e il rischio omologazione dei pezzi è piuttosto elevato, ma l’energia e l’irruenza sono innegabili.
Diciamo un ottimo, giovanile, ruspante esercizio di
stile?
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Low Anthem (The) - Oh My God,
Charlie Darwin (Nonesuch, Luglio
2009)
G enere : folk rock , songwriting
Un ritorno alla semplicità rurale in musica, associato al darwinismo sociale dello scienziato inglese e
a un approccio estetico DIY alla materia “Americana”: il primo album della band di Providence è
ben racchiuso tra queste coordinate. Oh My God,
Charlie Darwin si avvicina abbastanza allora al
suo obiettivo, risultando volutamente grezzo, tra
l’acustico e i sentori roots music, un aggiornamento
all’oggi di The Band, la poetica del solito Bob
Dylan e in generale l’eredità del songwriting folk
USA a cavallo tra Sessanta e Settanta.
Quel che c’è di attuale, è - come si diceva - l’approccio alla materia, mediato dalla riflessione intorno alla musica, con il ritorno all’analogico in un
universo digitale, e l’uso di parecchi strumenti presi
anche dalla world music. In questo si avverte mas84
recensioni
sivamente l’influsso di uno come Tom Waits, sia
nelle ballad sbilenche che nelle rivisitazioni di anni
di popular music. Non a caso è presente una cover
della sua Home I’ll Never Be.
In sostanza dopo gli exploit di gruppi come Fleet
Foxes e altri a cui abbiamo assistito l‘anno scorso,
non può che farci piacere un approccio meditato
alla materia folk e Americana. Debutto di un gruppo
da seguire.
(6.8/10)
Teresa Greco
Luke Vibert - Rhythm
(SoundOfSpeed, Dicembre 2008)
G enere : K itchtronica + H ip H op
Raccolta di tre eppì usciti per la giapponese
SoundOfSpeed (nome che è tutto un omaggio al
noise pop dei Jesus e co. e invece è in super fissa
con l’IDM inglese), Rhythm è probabilmente in ristampa nel Regno Unito proprio ora e l’occasione è
delle migliori per ritornare a parlare dell’oramai ex
Wagon Christ.
Riesumiamo la vecchia sigla con la quale il Nostro
usciva nei Novanta proprio perché la compila sembra fatta con il medesimo estro (i campionamenti di
vecchie cassettazze, gli svolazzi sci fi, il climax fumato) seppure con un’attenzione maggiore alle cadenze hip hop. Differentemente però, il mix si svolge
con mano post Jean Jacques Perrey, incontro
dopo il quale il Nostro non sembra più lo stesso.
O Meglio, Luke Vibert pare aver completamente abbracciato la cosa. Cinismo manco per scherzo.
Felinità semmai. Completa e totale.
Con un hip hop così cheesy, i neri del ghetto potrebbero uccidere, ma è qui, nel dialogo - rigorosamente - a distanza, che la zampata funziona e il
furbastro stravince. Non a caso, gli eppì e l’album
uscivano - escono - a “casa” Pizzicato Five: il
saccheggio sixties, le vocals robotiche in ancheggio
blacksploitation (oppure sottoforma di trasmissioni del tutto-va-bene fifties USA) sono esattamente
quello per cui i mangia-sushi vanno matti.
From Cornovaglia With Love.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Matthew Sweet - Under The Covers
Vol. 2 (Shout! Factory, Agosto
2009)
G enere : indie rock
Che raramente i sequel siano all’altezza del primo
episodio è assioma che ogni cinefilo può dimostrare con fior di prove, sottolineando quanto i miracoli possano ripetersi solo se si cambia angolatura
e taglio; quando cioè riesci a donare alle seconde
puntate un’identità e un’anima che non brillano di
riflesso. Argomentazioni di simile fattura si possono applicare a quest’altro tomo di riletture di brani
altrui offerto da Matthew Sweet e dalla ex Bangles Susanna Hoffs. Di scena ora, dopo i favolosi
Sessanta, sono i seventies, decennio regolarmente
svergognato - spesso con ragione - almeno fino al
fatidico 1976. Sarà anche che gli sdoganamenti si
sono fatti sempre più improbabili per compensare
la frenetica e vana ricerca di novità, ma in ogni caso
ancora facciamo fatica a digerire Carly Simon
(con You’re So Vain, ovvio), i Bread o un pacchiano
medley degli Yes. Perché il finto rock di Rod Stewart era l’altra faccia della disperazione celata nei
Big Star; il dopo Beatles dei Lennon e degli
Harrison impattava la grandeur di Todd Rundgren e il “power pop” marca Raspberries si
riverberava dentro al Tom Petty di Here Comes
My Girl, allorché i faciloni Fleetwood Mac impazzavano ovunque. Questo furono, in sintesi, i ’70:
riflusso della controcultura ed eccesso che, a suo
modo, rispondeva alla crisi; più tardi tempesta punk
- qui totalmente ignorato dal duo - e macerie utili
a una splendida ricostruzione. Under The Covers
Vol.2 affronta i contrasti di cui sopra solo per la
prima metà cronologica, appiattendoli con la simpatia degli amici che suonano ciò che gli piace senza
prendersi sul serio. I risultati, va da sé, non possono
che essere gradevolmente superflui.
(6.4/10)
Giancarlo Turra
Max Richter - Henry May Long
(Mute Song, Marzo 2009)
G enere : soundtrack
Il prolifico Richter è da tempo impegnato su più
fronti. Oltre alle uscite su Fat Cat e alle varie produzioni e collaborazioni, negli ultimi tempi si è avvicinato al cinema: lo scorso anno ha curato la colonna
sonora di Walzer con Bashir, il documentario
d’animazione di Ari Folman sui conflitti che coinvolsero la Libia nei primi anni Ottanta. Poi è stata
la volta di From The Art of Mirrors, sonorizzazione di alcuni cortometraggi ultra rare di Derek
Jarman. Infine, a marzo, la Mute Song International
(label specializzata in musica per film, tv e pubblicità), ha pubblicato Henry May Long, colonna so-
nora pluripremiata in alcuni festival d’oltreoceano.
Probabilmente l’esordiente Randy Sharp deve
aver pensato che la naiveté algida ed elegante del
compositore tedesco ben si sarebbe prestata a sottolineare le vicende di un film ambientato sul finire
del XIX secolo tra New York e New Bedford. O
forse che la dolce ma misurata malinconia di piano e
archi sarebbe stata il tema ideale per Henry May ed
Henry Long, vecchi compagni di college separati da
una sorte che ha portato
il primo all’autodistruzione e il secondo a osservare da lontano l’ineluttabile declino dell’amico.
Ad un biglietto da visita
promettente, nonostante
l’immancabile personalità, Richter contrappone
pigrizia e ripetitività compositiva. Le quattordici
tracce si collocano a metà strada tra soundtrack
d’autore (decisivi gli inconfondibili violini) e mero
contrappunto alle immagini, sopravvivendo a stento
al di fuori del lungometraggio.
Si salva la sola A Candle and Half A Pear, certo lontana
dalla scrittura dei Blue Notebooks o dai migliori
episodi di 24 Postcards In Full Colour.
(6.5/10)
Francesca Marongiu
Mayer Hawthorne - A Strange
Arrangement (Stones Throw,
Settembre 2009)
G enere : soul
Il fratellino mai confessato di Jamie Lidell? Una
reliquia soul del secolo scorso? Persino il boss della
Stones Throw stenta a catalogarlo. Lui è Andrew Mayer Cohen, artisticamente noto come Mayer Hawthorne, un bianco di Ann Arbor, Michigan, dall’anima
nera - soul, giustappunto - e retrò che manco Lidell
stesso.
Multistumentista, produttore, cantante e arrangiatore, Mayer Hawthorne bagna il debutto su Stones
Throw, A Strange Arrangement, con una serie di
numeri vertiginosi. Maybe So, Maybe No rammenta
Curtis Mayfield e Marvin Gaye, per cui inutile
resisterle: vi prenderà lei. Your Easy Lovin’ Ain’t Pleasin’
Nothin’ è un Rhythm and Blues incalzante, Let Me
Know muove dalle parti di Otis Redding, Green
Eyed Love gioca su ritmiche in levare. Arte dell’arrangiamento e del suono mutuata da Holland–
Dozier–Holland (il team dietro molti successi di
recensioni
85
Marvin Gaye e The Supremes) e vocalità, invero, più
Mayfield che Gaye. Comunque, per chiarirci, tanta
Motown d’antan, sia in merito alle ballads - la title
track su tutte - che nei momenti trascinanti di cui
sopra.
Sempre Peanut Butter Wolf ha dichiarato che gli
sono bastate due sole canzoni per scritturarlo. Un
caso più unico che raro. “A volte”, dice, “basta solo
prendere la decisione migliore”. Cosa altro aggiungere…che The Ills suona come il Beck di Midnite
Vultures? Il nostro l’abbiamo fatto…
(7/10)
Gianni Avella
Metùo - Toy Shop (Black Candy,
Aprile 2009)
G enere : I ndie pop elettronico
Il titolo di questo esordio su lunga distanza del duo
fiorentino fa riferimento ai numerosi giocattoli
utilizzati per decorare le canzoni; il che nell’indie
odierno non è certo una novità, ma i Metùo sanno
coniugare con mano ferma questo aspetto giocoso
con una scrittura efficace e una produzione solida.
Amanti tanto della natura - i colori pastello di una
copertina in carta rigorosamente riciclata - quanto
della tecnologia - è sempre un disco di indie pop
elettronico fatto per lo più con campionatori, pc e
chitarra solo quando serve (Subway) - i due sembrano muoversi a loro agio tra contrasti apparenti.
Oltre a quelli detti, infatti, c’è anche una Quiet che
recupera le percussioni scorticate di Homogenic
ad accompagnare una melodia eterea; come tutte
quelle del disco, d’altronde, sostenute però in generale da un suono rotondo e casse per lo più in quattro, in un mix che in Shell Crumbs incalza sfiorando
qualche sincope di Prince-iana memoria e accelera ulteriormente nella title-track, dopo che Blum ha
stemperato e de-emotivizzato A Forest.
Non particolarmente nuovo, come detto, ma bello
sì; e dal vivo bisogna vederli.
(7/10)
Giulio Pasquali
MGZ - Ho visto tempi migliori
(Green Fog Records, Aprile 2009)
G enere : T echno - demenziale
Il così autoproclamatosi profeta non è uno che il
mercato lo inonda (né lo ama, peraltro): sette anni
tra il precedente, Non riesco più a starmene
tranquillo (2002) e questo sono da considerarsi,
visti i tempi, un suicidio.
86
recensioni
Ora però torna con una nuova cartucciera di caricature della vita contemporanea, a partire dal titolo
che insieme ironizza su quest’epoca, sui luoghi comuni da conservatori indignati e anche su se stesso.
Caricature sciorinate come sempre in un cantatorecitato grottesco su basi elettroniche a metà tra
cattiveria Prodigy e timbriche Subsonica (benché il gruppo - perché di tale in realtà si tratta facesse queste cose sia prima dei torinesi che di
Hewlett e soci).
C’è anche un po’ di reggae in scaletta (vedi Problemi
- poco a che fare coi Sex Pistols - e le riflessioni
in tono più serio di Quante volte), ma il produttore
Madaski, che già nel precedente limitava Kingston
a pochi inconfondibili tocchi timbrici, anche qui dimentica la Giamaica preferendo mettere in campo
la sua esperienza, la quale aiuta il disco a funzionare anche senza il notevole aspetto scenico (che è
parte non secondaria di tutto il progetto): dal proclama che annuncia Il ritorno, allo psicopop immalinconito dalla vuotezza del consumismo di Non basta
mai o dai desideri di fuga di Via via via; dall’inno Disco
paradise che ironizza funkeggiando sul divertimento
all’ammasso (nella sezione rom anche il bel video
che dà un’idea del live) a Brivido che vira sul grunge
apocalittico, la verve e il suono rotondo danno forza a una satira la quale, rispetto ai dischi precedenti,
si focalizza sui quadri d’insieme piuttosto che sui
distici fulminanti del passato.
Poco importano 2-3 brani minori e se magari le
aspettative erano superiori: la voce del technoprofeta sferza forte e chiara, pronta a trasformare
palchi e dance-hall illuminati nei suoi templi.
(7/10)
Giulio Pasquali
Mi And L’Au - Good Morning
Jockers (Borne, Luglio 2009)
G enere : C hamber - folk
I Mi and L’au si sono fatti attendere a lungo. Li avevamo lasciati in un tour mondiale seguito al fortunato
esordio su Young God, a coronare un idillio francofinlandese ambientato in una foresta del Nord Europa. Da allora ad oggi sono passati quattro anni e
les amants réguliers sono più svegli e smaliziati di
come li ricordavamo.
Il trasferimento in quel di Valencia, città dei fiori e
del sole, deve aver giovato alle atmosfere di Good
Morning Jockers e se l’inverno è ancora alle
porte nella maggior parte delle tracce, la naturale
evoluzione del sound porta con sé arrangiamenti
highlight
Yoko Ono - Between My Head And The Sky (Chimera Music,
Settembre 2009)
G enere : experimental singer
Una che ha sempre sconcertato, Yoko, e mai gratuitamente. Da prima che le “masse” la conoscessero come compagna di vita di John Lennon, già aveva lasciato una traccia profonda nel
movimento artistico Fluxus, tra le tante altre cose contribuendo a plasmare la scena dei “loft”
newyorchesi da cui germoglieranno, anni dopo, new e no wave. Le
quali faranno tesoro degli insegnamenti abrasivi e avanguardisti dei
suoi dischi, primo fra tutti quel Plastic Ono Band in cui si anticipa
la tecnica vocale di Diamanda Galás e certe squadrature tipiche
del rock “matematico”.
Come pretendere, dunque, che chi ha fatto del guardare avanti un
ideale possa ancora sorprendere alla tenera età di settantasei anni?
Eppure, dopo aver fatto trionfale ritorno sulle scene nei secondi ‘90,
nulla è cambiato dal punto di vista dell’attitudine: si deve soltanto contestualizzare in modo corretto il concetto di novità, tanto nel passato
della Nostra quanto in campo artistico. Dove, e gli esempi abbondano, se non è un’autentica
fantasticheria è fumo gettato negli occhi per nascondere l’incapacità di scrivere canzoni o trasmettere qualche emozione. Accade di conseguenza che Between My Head And The Sky dica la sua
su argomenti noti con eloquio autorevole e ragionamenti solidi; approcciando materiali sonori
multiformi - dal crossover alla canzone d’autore - attraverso le lenti di chi ne fu protagonista e li
vide nascere e svilupparsi.
Assistita in ciò dall’ennesima incarnazione della Plastic Ono Band (spiccano Cornelius, il figlio
Sean Lennon e, ovviamente, Yuka Honda) e ospiti di lusso della scena “impro” della Big Apple (Erik Friedlander, Shahzad Ismaily, Michael Leonhart…). Gli isterismi vocali della
Signora, quel suo piegare l’ugola a una sofferta espressività e all’urgenza comunicativa sono elemento fondante di strutture e arrangiamenti: che ci si trovi di fronte alla Sun Is Down che spedisce
al tappeto i CSS e a una Ask the Elephant tra Can e jazz metropolitano, a quella Calling che pare
un riassunto del krautrock e alle malinconie appese a un filo Memory Of Footsteps e Feel The Sand,
all’abrasiva Waiting For The D Train e allo squadrato funk della title track, la sostanza non cambia.
Ogni episodio è il risultato di Genio e disinvolta maestria e guai a ignorarlo. Un’Artista alle prese
con un brillantissimo sunto di carriera che, nonostante l’età, punta il domani. Da applaudire e
prendere a esempio per come sente il tempo che scorre rimanendo sempre se stessa.
(7.8/10)
Giancarlo Turra
più caldi. Pezzi come Dancing & Smiling o Bingo si
tingono di jazz nella variante free (la prima) e in
quella più classica (la seconda), suggerendo un tango stralunato nei bistrot della Parigi compianta da
Debord.
Il testimone più certo della crescita è però lo sconfinamento di genere, a metà tra folk intimista e
musica da camera (si ascoltino gli archi che accompagnano piano o chitarra in They Are Coming e Tran-
sparent). La voce di Mira è più sicura, vagamente
cangiante (tra Cat Power, Francoise Hardy e
la Jarboe di Children Of God) e danza in punta di piedi su più della metà delle tracce. Fanno da
contraltare gli episodi solisti di Laurent (The Bird,
Vampire), a stemperare il romance malinconico in
atmosfere late Sixties a metà fra Lou Reed e Leonard Cohen.
In generale si nota un’accentuazione del gusto arrecensioni
87
monico, ora dislocante, ora piuttosto lineare, laddove l’esordio era essenzialmente scarno e melodico.
La scrittura, toccante e misurata come in passato,
ha raggiunto le soglie della maturità (Spartan Dance sembra uscita dalla penna di Smog) e se si accantonano facili giudizi sul narcisismo bohemien è
probabile che si schiuda un piccolo universo che
brilla in fascino e intensità. Da segnalare la presenza
di Dance On My Skin in un filmato promozionale di
Chanel in uscita a settembre.
(7.5/10)
Francesca Marongiu
Milanese - Lockout (Planet Mu
Records, Giugno 2009)
G enere : D upstep guerrill a
Ai tempi di Extend (2006) e del successivo Adapt
(2007), Milanese ci aveva esaltato. Faceva dubstep
d’assalto per ballare e la sua formula era grottesca,
spugnosa, bituminosa, radioattiva con laser KLF,
spade, voci negroidi a girare attorno al magma. A
tratti pareva una versione darkcore dei Dälek opportunamente rallentata e zeppa di ganja, in altri era
puro voodoo, Mr. Oizo dato in pasto a dei guerriglieri somali.
Le copertine dei singoli rendevano perfettamente
quest’idea: bocce coi denti di squalo, ominidi e donne scimmia.Tutto rigorosamente b/w. Ed erano pure
i momenti caldi del dubstep, Londra in subbugglio
Benga, Pinch, Scuba ecc. Ora, 2009, il decennio
al termine, l’uomo si fa fotografare barbuto e vuole
di più. Snasato il vento mesh, rimette mano (proprio
come accadde per Alert) agli archivi remissando a
man bassa scienza del bass, dubstep e hip hop. La sfida è contare nei playground di gente come Toddla
T e rifondare il grime con una formula incompromissoria milanese style. Baby Blue con RQM e Oliver Grimball è l’entrata soft del disco, poi è horrorcarnival-step con pezzi tosti come Wonderful World
e B Sharpa, quest’ultimo con protagonista Sharpa
medesimo, la vera star. Altrove i difetti non mancano: troppe le versioni degli stessi brani, troppi autoindulgenti i momenti più autenticamente dubstep
e non mancano nemmeno i momenti deboli tout
court. Interessante senz’altro l’humus pre-Streets
che viene fuori e ti rientra sporco e cattivo dalla
porta di servizio. Rispetto per il Milanese claustrofobico che è un po’ come un Tricky grime step agli
inferi. Ma questa volta non ci siamo. (5.5/10)
Edoardo Bridda
88
recensioni
Minus 5 (The) - Killingsworth (Yep
Roc, Luglio 2009)
G enere : A mericana
Gli egregi Scott McCaughey e Peter Buck assieme ai sodali John Ramberg e Bill Rieflin - tornano con il progetto aperto Minus 5. E questa volta
sono ben quattro i membri dei Decemberists
(Colin Meloy, Jenny Conlee, Chris Funk, Nate Query), oltre ai soliti grandi del giro loro come Tucker
Jackson (divino alla pedal steel), Ken Stringfellow (dal super curricula The Posies, R.E.M., Big
Star 2.0) e The She Bee Gees (una che nei cori alza
la qualità non di poco).
Killingsworth è un classico album della cosiddetta Americana e non finisci mai di stupirti per quanto
mid tempo a passo d’uomo tipici del Neil Young
dei traditional come Ambulance Dancehall e The Long
Hell (per chitarra, canto, contrampo, slide e spazzole) suonino pesanti due tonnellate in mano a gente
come i Decemberists stessi o (peggio) i Calexico attuali.
È la penna di McCaughey, personaggione che ha insegnato a molti, Wilco compresi, la chiave di volta,
lui che sul cavallo Gram Parsons non ha paura di
nulla, neanche della britannicità: The disembowelers,
soprattutto, è vagamente McCartney, in The Lurking
Barrister c’è un po’di George Harrison, e in It
Won’t Do Any Good ci trovi i coretti Beatles... Sfumature di un cuore che pulsa comunque California e
le perle vere, infatti, le trovi lì: Vintage Violet e Big Beat
Up Moon. Quest’ultima infine, a proposito di isolani, con l’omaggio a un amico, Robyn Hitchcock.
Uomo che, tra l’altro, ha pensato bene di ricambiare
la militanza Venus 3 producendo l’altro progetto del
McCoi, i The Young Fresh Fellows, band più
tipicamente Sixties garage, anch’essa con un album
fuori, I Think This Is. Strancosigliato pure quello.
Anche per chi non mastica banjo e slide.
(7/10)
Edoardo Bridda
Mochipet - Bunnies and Muffins
(Daly City, Marzo 2008)
G enere : produzioni / hop - tronica
Abbandonati ormai gli estremismi breakcore degli
esordi, Mochi, avendone le capacità, vuole sdoganarsi
come produttore all purposes, meno umoristicamente connotato e deformante. Perde in riconoscibilità,
ma la scelta è giusta, anzi quasi doverosa. E il disco è
piacevole, i pezzi tutti carini, emerge pure una vena
riflessiva, se non malinconica, finora quasi sempre
nascosta nelle sue produzioni. Forse appunto
il risultato non brilla per
originalità. E forse anche
perché, come spesso piace al nostro, ma qui, in un
contesto meno scopertamente ludico e citazionista, i riferimenti sonori sono talmente palesi da
sfiorare l’omaggio esplicito o l’imitazione.
Anthem, chitarristicamente Daft Punk-iana, Spring,
assieme a Daedelus, Four Tet-iana (tra le cose
migliori), Pachyderm Pounce, grassa e con un temino
slow Squarepusher-iano, l’hop-esotismo di The
Erhu Song, con tanto di campione da L’Ultimo Imperatore, End Of Summer Song, tra tardi Pixies e
Blur, il piano Jon Hopkins e il crescendo emotivo Ghost-Simon Williamson della conclusiva
Roll Credits. Poi, il fiero spleen elettro-acustico di Prolonging Forever, l’hop-bossa con trombone e violino
di Memories, il funk flautistico di Fool, il soft-breakbeat jazzato, per slot-machine, di Underwater..., il
toy-electro-pop col sorrisone stampato sulla faccia
di Do Geese See God (titolo che è uno dei palindromi
usati da Weird Al Yankovic per la sua geniale
Bob), l’India tropicale di And So It Goes, le trip-hopistiche Oly e Tinker.
Un buon disco, ma sembra ancora non essere compiuto perfettamente l’assestamento post-breakcore.
Insomma, Mochi, puoi fare molto ma molto meglio.
(6.8/10)
Gabriele Marino
Mochipet - Master P on Atari (Daly
City, Aprile 2009)
G enere : darkgamehoptronica
Mochipet sviluppa qui una tendenza ben presente
nelle sue produzioni breaktroniche, in un album che
pure, come già Bunnies and Muffins, per quanto
in maniera opposta, ha la doppia faccia dell’esercizio di stile e della fuga dal breakcore a tutti i costi.
Ruffianerie lazer B sci-fi e da videogame oldie (Atari!), temini (e immaginario) molto Giapponesi (non
sempre riuscitissimi, e non sempre riusciti neppure
gli interventi della voce), bassi scuri, saturi, fuzzatissimi, pernacchiantissimi, residui industrial-techno,
sporcature noise, sopra breakbeat melmosi, come
l’Harmonic 313 di Cyclotron incatramato. Tranne qualche numero, le battute sono tenute piuttosto basse, con l’impressione di rendere ancora più
massiccia una produzione di per sé già megalitica.
Disco stracompatto, sicuramente un po’ lunghetto,
nel doppio senso della durata complessiva del cd
e dell’eccessivo stiracchiamento delle idee in brani
della durata minima di quattro minuti e con il picco
di tredici (l’ottima Turbo Thizz Petnation). Qualche
pezzo abbassa la media, ma l’impatto e l’impasto
sonoro di quelli più rocciosi, austeri, ottusi (riusciti), è comunque eccezionale. Mochi, devi essere più
oculato.
(6.6/10)
Gabriele Marino
Modest Mouse - No One’s First,
and You’re Next (Sony BMG Music
Entertainment, Agosto 2009)
G enere : P op
Doveva uscire a febbraio dello scorso anno, ma per
varie vicissitudini No One’s First and You’re
Next, l’eppì contenente alcune b side e altre outtake di Good News for People Who Love Bad
News (del 2004) e We Were Dead Before The
Ship Even Sank (del 2007), vede la luce soltanto ora, ad estate quasi conclusa. Non si conoscono
esattamente le motivazioni eppure le carte, finalmente scoperte, sono tutte rivolte a fan più accaniti
della band. Da segnalare comunque il bizzarro video
dell’anonimo singolo Satellite Skin, diretto da Kevin
Willis...
(6/10)
Edoardo Bridda
Most Serene Republic (The) - ...And
The Ever Expanding Universe (Arts
& Crafts, Agosto 2009)
G enere : I ndie P op
Giunto al terzo disco, il sestetto di Milton (Ontario)
ha pensato di contenere l’urgenza. O forse, ci ha
pensato Dave Newfeld, già al lavoro con i boss della
Arts & Craft Broken Social Scene, a tenerli a
bada. E non dubitiamo, dev’essere stata dura.
I Most Serene Republic sono la creatura con la
quale i ragazzi sono cresciuti e, a sei anni dall’esordio, ventiquattro primavere cadauno, di energia ce
n’è ancora. E buttare. Come capita spesso però, è
il verso cosa il problema. Conterà l’affiatamento, il
poter esprimersi tutti assieme, eppure questa gioia
- che nei loro dischi s’è sempre apprezzata - ha un
suo prezzo. È finita per convogliarsi (questa si) in
una traiettoria che, in verità, è un appellativo. Lì per
lì dev’essere suonato grandioso, poi sempre meno.
Diciamocelo: Broken Social Scene Jr è un’autentica
recensioni
89
sfiga. Condanna, se ogni benedetta volta che il pubblico ti ascolta finisce per pensare a loro. Senza appello se la critica addita l’eccessiva somiglianza dei
brani. È un bel problema, eppure ...And The Ever
Expanding Universe,
a discapito del titolo, ha
rimediato: apprendiamo
che Ryan Lenssen è diventato leader ufficiale
e Adrian Jewett autore
delle liriche (joyciane lui
dice pergiunta). E con le
gerarchie, anche interne,
tutto fila più ordinato. Neanche le frecce nell’arco mancano. Sono appuntite per giunta: un bel singoletto pop - Heavens To
Purgatory - per cominciare, bello pimpante e dai retrogusti Ottanta, deliziosamente giocato sia sul canto lui/lei sia in produzione (dove calibrati risultano
le bordate bass, la cassa 4/4 e l’impianto folk con
tanto di banjo), poi un bel intramezzo strumentale,
un balletto per la precisione, Patternicity, roba chessò tra Múm e Herry Potter. E funziona, a tutti i
livelli. Inoltre, abbiamo uno scherzetto happy techno, Don’t Hold Back, Feel A Little Longer: cassa dritta
veloce, zucchero a velo in contrasto e giochi di contrappunti tutti attorno.
Non una novità, ma Liberatorio sentirli uscire dal
seminato, pur nei soliti difetti che prima o poi arrivano come nodi al pettine. Questa volta, sono insiti
nel pop canadese tutto: in questo star a mezz’aria, o
nel proggheggiar leggiadri, i ragazzi macinano cliché
(Four Humours, Catharsis Boo) e stringono poco. In
sostanza, la sensazione è la medesima: non capisci
come mai. Sei stato bene. Ma non ricordi né nomi
né volti. Se vi basta così…
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Mount Eerie - Wind’s Poem (P.W.
Elverum & Sun, Settembre 2009)
G enere : slo - folk
Forse uno dei problemi maggiori di Phil Elvrum
è un’urgenza poco spiegabile di pubblicare. Ciò che
sembra invece urgente in Wind’s Poem non è
l’ansia da presenza nel mercato discografico. Va da
sé che ciò sottende una buona notizia.
Ciò che ci piaceva di Mount Eerie, nel senso del
disco dei Microphones, era la chimica che creava
nella stanza dell’ascoltatore, la capacità di modificarne l’assetto psicologico di ascolto. Non in noia,
90
recensioni
come purtroppo spesso è accaduto con i dischi
successivi a quell’importante mattone della carriera
di Phil, quelli a nome Mount Eerie che, appunto, anticipano l’album di cui vi parliamo ora. Semplicemente in una disposizione d’animo diversa; e
qualcuno direbbe che tale meccanismo non è altro
che il presupposto perché si parli di un disco di psichedelica.
La buona notizia di Wind’s Poem non si chiama
“cambiamento”, né riproduce quella chimica. Semmai ne propone un’altra, che colloquia con la tranquillità d’animo senza per forza produrre sbadigli.
Certo Elvrum va dritto per la sua strada, senza neanche un momento rinunciare ai suoi tratti distintivi: docili melodie che mai si possono dire riflettute,
ma che hanno la funzione di un fragilissimo stream
of consciousness delle corde vocali; strutture strumentali impalpabili e irrisolte, sia nei momenti di
maggiore volume violenza o distorsione (The Mouth
of Sky, Wind’s Dark Poem), sia in quelli più sussurrati.
Eppure l’album non sembra solo sommare esempi di
una stessa formula. Diciamo meglio: sono sì esempi,
ma semplicemente meglio riusciti che altrove (leggi:
gli ultimi EP) lassù sul Monte.
L’apice è la funzione liturgica di Through the Trees,
basata su una docile ma serena nenia vocale e su
un lunghissimo e reiteratissimo giro d’organo. Per
converso, episodi come Wind Speaks ci fanno rimpiangere ancora una volta i For Carnation. Ma
di Wind’s Poem rimarranno i suddetti momenti
migliori e qualche isolata piccola novità (Between
Two Mysteries e Ancient Questions, che risentono positivamente dell’amicizia e della collaborazione con
Karl Blau; oppure la segheria di Something). Quindi, se qualcosa ci ricorderemo del disco del 2009 di
Mount Eerie, non è sonnolenza.
Un passo avanti.
(6.2/10)
Gaspare Caliri
Movie Star Junkies - Junkyears:
Rarities And Farm Recordings
2005-2007 (Avant!, Luglio 2009)
G enere : punk - blues
A distanza di poco tempo dall’ottimo Melville
tornano i Birthday Party italiani. E sia chiaro,
l’accostamento col feroce gruppo australiano non
è un’esagerazione bensì un doveroso omaggio alla
carica sovversiva e insieme crudamente teatrale del
quintetto torinese.
Questo 12” vinilico recupera – come da sottotito-
lo – pezzi sparsi un po’ ovunque (su cassette e 7”)
oltre che inedite registrazioni home-made, anche
se, a voler esser precisi sarebbe meglio dire farmmade, dato che sono state realizzate nella fattoria/
studio di uno di loro. Junkyears rinnova i fasti di
un suono iconoclasta, lurido e nervoso che ha fatto
la fortuna di molti prima dei MSJ; di loro però i torinesi ci mettono una foga senza pari – vederne dal
vivo l’impressionante forza d’urto aiuta in questo
caso – oltre che un certo gusto nell’arrangiare e
stravolgere pezzi sommariamente punk-blues (giusto per capirsi) con elementi fuori contesto come
organo e sax.
In quest’album, insomma, troverete Oblivians, Birthday Party, Gun Club ma anche Devo, Brainiac,
rock’n’roll dei primordi, scazzo, ironia, blues viscerale, violenza e soprattutto, sempre Movie Star Junkies.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Mquestionmark - One For All
All For One (Bad Trip Records,
Settembre 2009)
G enere : indie wave
Al secondo album (contro quattro ep), gli emiliani Mquestionmark s’improvvisano moschettieri indie rock ed infilzano da par loro undici pietruzze
piuttosto folgoranti e fumiganti, confermandosi abili
manipolatori della materia a partire da fregole arty
Wire, carburazione Fugazi, spasmi Pixies, brume impellenti Joy Division, sfrigolii esagitati Primal Scream, arguzie squinternate Stranglers,
malmostosa irrequietezza Yo La Tengo e rapidi
disimpegni punk funk (tra Yeah Yeah Yeah’s e
The Rapture, più o meno).
La scaletta, formalmente divisa in side A e side B
per i nostalgici del vinilone, può contare su qualche
gioiellino come la robotica e serrata Banana Bee, la
nevrastenica Exhausted, l’esoticamente arguta Bomb
In A Hand, l’indocilmente inquieta My Friend e quella
Through The Billboard che se la tira un po’ da nipotina
di Every Breath You Take.
La formula dei due bassi, chitarra, synth e voci
(sbrigliata e versatile Laura, un po’ infeltrito con
l’inglese Luca) produce
un sound teso, scoppiettante, rotondo, a tratti
capace di escursioni fu-
turistiche niente male (gli sfondi Depeche Mode
di Dreams Of Carrot, l’emulsione sintetica in Horse
Anthem, il tagadà kraut-wave di Demolition Dailyplanner). Cui l’ingresso del quarto elemento Fabrizio
Rosi (il D’Artagnan del caso, alle prese con synth e
chitarre), avvenuto a missaggio concluso, non potrà
che fare del bene.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Múm - Sing Along To Songs You
Don’t Know (Morr Music, Agosto
2009)
G enere : F olk pop
I Múm del quarto album sono fautori di folk sempre
meno -tronici e più pop, in direzione squinternata e
arbitraria come insegnano i loro connazionali Sigur Rós quando s’imbizzarriscono di filastrocche
bucoliche e giocose (vedi il subbuglio nonsense di
Hullaballabalú e Kay-ray-ku-ku-ko-kex, quest’ultimo
invaghito di trip-hopperie quasi Eels). Oppure,
al contempo, coinvolti in un lirismo pastorale che
non puoi non ricondurre ai capisaldi Polyphonic
Spree (palpabili nella setosa Show Me, contagiati da
krauterie Stereolab nella ludica Sing Along).
Molto di questa (mezza) rivoluzione copernicana si
deve alla nuova vocalist Sigurlaug Gísladóttir, dotata
di timbro vellutato e impostazione ben più canonica
di chi l’ha preceduta.
Tanto che il frugale luccichio di If I Were A Fish finisce
per scomodare i Lali Puna più soft, mentre quella
specie di vaudeville-errebì di Prophecies & Reversed
Memories denuncia addirittura striscianti movenze
Belle And Sebastian (chiudendo in tal modo
strani cerchi... iconografici). I Mùm, ovvero i di loro
timonieri Gunnar e Örvar, hanno evidentemente
annusato l’aria e deciso per la sterzata salvifica, già
abbozzata nel più fervido e confuso Go Go Smear
My Poison Ivy, Let Your Crooked Hands Be
Holy di due anni orsono. Però, ahimé, non è il caso
di alimentare illusioni.
Questo disco sfoggia sì una sapienza sonora rispettabile, capace di giustapporre (gli archi sontuosi, la
tastiera Ryuichi Sakamoto e i palpiti bjorkiani
di A River Don’t Stop To Breathe, la bossa videogame
tra brume di moog e folate di violino in The Smell of
Today Is Sweet Like Breastmilk In The Wind) e minimizzare (il lirismo etereo di Ladies of the New Century, la
pastorale drakeiana di Last Shapes of Never), ma appunto non smette un istante di sembrare una parata
di espedienti e gradevoli intuizioni. Pop che simula
recensioni
91
profondità, struggimento, ispirazione. A tratti delizioso, ma implacabilmente a rimorchio dei tempi.
(6/10)
Stefano Solventi
Nate Young - Regression (Ideal
Recordings, Luglio 2009)
G enere : noise
Non fa notizia il fatto che un terzo di Wolf Eyes
abbia intrapreso (l’ennesimo a tentarla, in verità) la
via solista. Fa notizia invece che Regression sia un
gran bel disco, seppur nella sua inesorabile devastazione di matrice elettronica e per questo poco
commestibile da ascoltatori non avvezzi o “fuori dal
giro”.
Quasi ambientale e pressoché totalmente in modalità improvvisativa, l’album somma 7 pezzi per 35
minuti ed evidenzia il lato
terrificante,
prossimo
all’horror soundtrack, di
Young. Come classificare altrimenti le stasi di
synth di Dread o le due
parti di Sweating Sickness,
con la seconda lievemente più marziale e pirotecnica? Certo, persistono anche qui le escrudescenze rumorose e acide che sono peculiari al gruppo
madre, ma sembrano attutite, trattenute, represse.
Prendete il loop technoide della conclusiva Untitled:
esplode sul finire in lancinanti brutture soniche che
farebbero impallidire animi gentili come Aphex Twin,
ma vive di un beat alieno che scivola depravatamente sottotraccia per due terzi della durata.
Regression sembra, in definitiva, la perfetta colonna sonora per un horror ambientato in una casa di
cura. Quella dalla quale, molto probabilmente,Young
è scappato tanto tempo fa.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Neils Children - X.Enc.
(Structually Sound, Maggio 2009)
G enere : P ost -P unk
Combattutti tra due tendenze (anche di abbigliamento) opposte, i Neils Children esordiscono
dopo dieci anni con questo full lenght per il quale i
più sprovveduti già stanno gridando al miracolo.
Non parliamo di un autentico bidone: I’m Ill, dal cuore indie pop Pete & The Pirates (e indietro
Cure, Joy Division), è caruccia, e lo stesso dicasi
92
recensioni
per la faccia più dura e Horrors compliant della
band, Motorcar (i Bauhaus, i PIL) che, a ben vedere, prometterebbe anche qualcosa in più se questa
direzione fosse approfondita a dovere. Del resto, a due lustri dalla formazione presso l’Harlow College (Essex), non è pensabile che X.Enc.
rappresenti qualcosa di diverso dell’armadio impolverato che è. Cose buone, cose fuori fuoco, cose
inutili... Ma poi, domandiamocelo francamente: c’è
ancora da esaltarsi nello scoprire nuove band che
rifanno i miti post-punk come sono anni (anni!) che
altri li rifanno (e magari meglio)? Il famoso purismo
infine, non aiuta, specie se le tendenze al “tradimento” pop evidenziano confusione e ombre sul
futuro. Con i These New Puritans a fare della
coerenza un qualcosa di diverso dall’aritmetica e gli
Horrors a guardare allo shoegaze e, in generale,
oltre il look, i Neils Children sembrano nati ieri. Alla
faccia...
(5/10)
Edoardo Bridda
Noiseshaper - Satellite City (Cat ‘n
Roof Records, Agosto 2009)
G enere : R eggae dub
Vuoi vedere che così, di punto in bianco, ti spuntano
gli eredi della Thievery Corporation? Ascoltando questo dischetto di electro reggae, forse.
Perché è come nella migliore tradizione del duo di
Washington. Solo che qui siamo in Germania. L’eredità techno incombe, ma solo per quanto riguarda
le macchine. Dopo un decennio di onorata carriera
e di qualche remix ad opera di gente del calibro
di Kruder & Dorfmeister, Axel Hirn e Flo
Fleischmann ci propongono una selecta senza
infamia nè lode. Tra un tiro di ganja e l’altro, Satellite City spiana 10 tracce fresche e veloci spalmate
di dub. Il ricordo va ai Massive Attack quando
ancora erano positivi, We Rock It entra un attimo
nel discorso deep à la Thievery con quei bassi e
quelle percussioni che hanno fatto la storia della rinascita electro lounge, Got It Bad è il blues per i fan
di Moby, la ballad pop che non guasta.
Dunque niente acidi, state tranquilli anzi per finire
c’è un po’ di hip-hop slavato soul (Ghetto), il dub
che più dub non si può (Sod’s Law) e il resto è filler
come nelle serie tv più scarse. Quattro salti e atmosfera assicurati. Niente di più. I Thievery possono
stare tranquilli.
(6/10)
Marco Braggion
Nudge - As Good As Gone (Kranky,
Settembre 2009)
G enere : elettro psichedelia
Sembrava che il percorso dei Nudge fosse destinato ad interrompersi per via delle carriere soliste dei
suoi membri, sempre più avviati ad avere ciascuno
un proprio profilo ben delineato. Detto che i Nudge comunque nascevano in origine come l’unione
di tre personalità molto forti, ora nel 2009, con un
inaspettato nuovo disco, la sigla rinverdisce i fasti
del passato, facendo tesoro del tempo intercorso
tra un disco e un altro.
Il risultato è un album che raggiunge il suo scopo
senza nemmeno sforzarsi e dove la personalità dei
singoli membri vale comunque più della somma delle singole parti. Ergo Honey Owens domina incontrastata come una nouvelle Nico psichedelica e le
trame soft da elettro-arredo immaginate da Brian
Foote e Paul Dickaw traghettano le nenie umorali
della chanteuse in direzioni sempre più lunari.
Si snocciolano così , una dopo l’altra, passeggiate
ultraterrene ed estremamente stilose (musica di
arredo in tutti i sensi…) come Harmo, Two Hands,
Aurolac. Un certo retrogusto anni ’90 non fa male e
porta il trio in territori diafani ed eterei a metà tra
Seefeel e Laika.
A tratti si fanno anche prendere un po’ la mano e
la Owens addirittura sembra fare il verso alla Sade
dei bei tempi andati con gli echi e i riverberi sexy di
Tito. Il disco si chiude in pieno languore psichedelico con Dawn Comes Light ricordandoci comunque
che è pur sempre un disco targato Kranky.
(7.2/10)
Antonello Comunale
Ohbijou - Beacons (Bella Union,
Giugno 2009)
G enere : I ndie pop
Dopo aver dato vita al progetto Ohbijou nel 2004,
Casey Mecija ha deciso di trasferirsi a Toronto portandosi appresso la sorella Jennifer. Nella Capitale
le due hanno conosciuto Heather Kirby (basso e
banjo), James Bunton (tromba e batteria), Anissa
Hart (violoncello), Ryan Carley (piano, synth, glockenspiel) e Andrew Kinoshita (mandolino), dando
vita a una vera e propria band.
Al secondo disco, senza sganciarsi minimamente dai
cliché, i sette propongono un indepop lirico e leggero. La voce al miele di Casey in primo piano e alcune
semplici strutture abbellite (leggi compiaciute) d’archi (e pianola) a contorno. La ricetta è di quelle di
genere ma le frecce nell’arco sono pochissime. Anzi
una, Black Ice. (5.5/10)
Francesca Marongiu
Os Mutantes - Haih (ANTI-,
Settembre 2009)
G enere : tropicalismo moderno
Finisce spesso così: che ti frequenti di nuovo con
un pretesto banale, magari cogliendo un attimo e
l’occasione per riprendere la via del palco e vedere
l’effetto che fa. Noti che l’alchimia c’è ancora, che
le cose girano e ti cimenti con materiale nuovo. Un
pezzo tira l’altro e hai in mano un disco nuovo di
zecca. Che nella maggioranza dei casi si rivela una
boiata pazzesca da barbogi col lifting che non capiscono che adesso basta. Succede, se coi luoghi comuni hai trafficato anche in gioventù; mai quando hai
agito all’insegna della (disciplinata) libertà creativa.
Un po’ come con Yoko Ono, tenendo conto del
calendario possiamo sostenere che da Haih I Mutanti escono a testa alta. Al solito, anche questa è
una giostra col motore truccato, un’esperienza che
lascia in dote ubriachezza molesta e voglia di
applausi. Roba che non
ti spieghi come rigurgiti
e personalizzi idee sulla
spinta del “cannibalismo
culturale”
tropicalista
che anticipò il meticciato
culturale. Allora nessun
problema se Querida Querida vede Santana alle
prese col krautrock mentre sfida Prince a chitarristico duello; sulla carta puro abominio, la prova
dei fatti restituisce un colpo di genio. Teclar pizzica
corde in andirivieni tra malinconia ed esaltazione,
gustoso folk progressista favolistico, possente ed
essenziale. Le articolate Nada Mudou e 2000 E Agarrum inscenano vaudeville aciduli e ironici tra Beatles e Sly Stone, caleidoscopi caraibici infiorettati
di free-rock e carnevale. Bagdad Blues sbeffeggia le
dodici battute ondeggiando tra Parigi, Gershwin e
musical. Mica finita: Anagrama si muove sexy e pigramente brasiliana, Gopala Krishna Om da raga modernista come potevano farli gli ultimi Talking Heads e Neurociencia Do Amor ipotizza John Zorn e
Mike Patton che abbracciano il “prog” accompagnati da una mista Primus/Violent Femmes.
Nientemeno. Materia viva e pulsante che a quasi
tutti verrebbe fuori carbonizzata e decine d’altri inrecensioni
93
highlight
Young Fresh Fellows - I Think This Is (Yep Roc, Settembre 2009)
G enere : power pop
Se non abbiamo sbagliato i conti, questo è il quindicesimo album per gli Young Fresh Fellows, uno
dei quattro progetti in cui è coinvolto il caro Scott McCaughey, R.E.M. esclusi, tra cui quei Minus 5 sugli scaffali in contemporanea col buonissimo Killingsworth.
Prodotto da Robyn Hitchcock - che, lo ricordiamo per i distratti, da un pezzo si serve dei
Venus 3 (sempre McCaughey) come lussuosa backing band - questo
I Think This Is vedrà luce in Europa con un titolo diverso (I Don’t
Think This Is) e diversa tracklist (tre pezzi su tredici, tra cui la cover
della stoniana Gotta Get Away), perché i Nostri hanno di questi vezzi,
forse per riecheggiare quel che accadeva nei favolosi - o famigerati in
questo caso - sessanta, che volete farci.
Consoliamoci con un programma che non delude anzi ci carbura questi giorni di tarda estate con un pop rock ad alto tasso adrenalinico,
spiccato col piglio sferzante e gioioso d’uno Steve Wynn alle prese
con un beat Kinks (Betty Let the Good Times Crawl), coi Wilco strattonati in un teatrino spasmodico The Who (Shake Your Magazines), col passo acidulo e arguto di certi Badfinger (Used
to Think All Things Would Happen), con le irruenze Flamin’ Groovies (After Suicide), i rigurgiti
Tom Petty (Never Turning Back Again) e le cremosità John Lennon (The Guilty Ones).
Ok, come spiegarvi ora il senso di festa e urgenza, di freschezza ruspante che esala da questi
surf gagliardi, dalle scorribande power pop garrule e stradaiole? È un segreto per cui non c’è
ricetta, che pesca nello stesso specchio trepido e incantato di Tweedy e soci, nella sferzante devozione che spinse Wynn a mettre in piedi la combriccola Danny & Dusty, che muove il buon
Hitchcock sui sentieri della psichedelia più salace senza dare adito a retrogusti nostalgici. Bisogna
recuperare il senso della parola entusiasmo e riconsegnarlo vergine alle nostre orecchie per capire il valore di questi dischi, di queste band.
(7.4/10)
Stefano Solventi
del terzo LP per tramite di Young Marble
Giants e Orange Juice; materia per intenditori,
un sentire spartano asperso di dolce malinconia che
oggi conduce dentro alle stanze di Movietone e
Cryptacize. Insomma, lo stesso afflato e modus
operandi che scopri inalterati al settimo album in più
di venticinque anni (!).
E ciò malgrado qualche piccolo gesto sgraziato e
il fatto che Two Sunsets sia frutto di circostanze
colte al volo, una collaborazione stimolata dall’estatico duo nipponico Tenniscoats. Essendo che in
Giappone ogni stramberia diventa Mito, pare del
tutto logico che i Pastelli abbiano mietuto cuori anche là fungendo da vetrina - tramite la Geographic
- per interessanti artisti locali. Altrettanto sensato è
che questo lavoro abbia preso forma nel tempo con
la preziosa partecipazione di Gerald Love dei
Teenage Fanclub e del fiatista Bill Wells.
Perché in fondo si tratta di sfumature che non mutato granché l’esito, più tastieristico e spolverato di
jazzato acid-folk del solito e nondimeno tipicamente
Pastels.Valgano una Sodane cui per essere dei Belle
& Sebastian manca il testo in inglese (non fosse Stuart Murdoch arrivato dopo, e dunque…)
o Mou Mou Rainbow, sette minuti di zucchero filato che si disfa alla fioca luce del mattino. Quando,
a metà del programma, arriva una toccante e per
nulla calligrafica About You dei Jesus And Mary
Chain, il cerchio della scuola scozzese è chiuso. Si
faccia da parte la moltitudine di gruppetti twee, sin
troppo esili e privi di Arte, poiché per la via passano
i maestri.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
seguono per una vita senza sfiorare.
Ma: nonostante cotanto ben degli Dei, il voto resta
quello sotto riportato perché, ecco, dai primi della
classe pretendi sempre il massimo e avremmo preferito una riapparizione da appaiare sullo scaffale ai
Faust di Rien. Viceversa, di alcuni passaggi chiassosamente anni ’70 avremmo fatto a meno, idem di
certo rock banale e d’un paio di cartoline sforzate.
Però, per l’onestà intellettuale di averci risparmiato
pantomime e non averci annoiato all’ascolto, consideriamo il bicchiere pieno per tre quinti. Anche se il
cocktail è meno inebriante di una volta, obrigado!
(7/10)
Giancarlo Turra
94
recensioni
Pastels (The)/Tenniscoats - Two
Sunsets (Geographic, Settembre
2009)
G enere : low fi guitar pop
Fin dai primi passi alla corte di etichette gloriose
del guitar-pop d’oltremanica, ciò che abbiamo imparato ad amare dei Pastels è il senso di studiata
approssimazione e l’approccio artigianalmente casuale secondo, per ruvida brillantezza, solo ai Vaselines. Un’influenza altrettanto diffusa in ambito
indipendente, per di più, con l’unica discrepanza che
nessun Kurt Cobain ne ha riletto il repertorio
rendendoli altrettanto famosi.
Di loro puoi allora sottolineare un cospicuo ascendente sul low-fi americano dei ‘90, il proseguimento
del filone che riconduce ai Velvet Underground
Pere Ubu - Long Live Père Ubu!
(Cooking Vinyl UK, Settembre 2009)
G enere : pata - rock
Esiste un momento in cui si esce fuor di metafora. I
Pere Ubu di David Thomas vi entrarono quando
decisero di chiamarsi così, e di sposare, in modo
indiretto, tutta una serie di conseguenze: David era
perfetta riproduzione per massa corporea e qualia
grotteschi di quel Re Ubu inventato a fine Ottocento da Alfred Jarry (coi suoi compagni di collegio);
figura che da lì a poco produsse e increspò l’onda
lunga della patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie.
Ecco però; decisero di varare una danza moderna
che di quell’estetica prendevano l’atteggiamento, intelligentissimamente declinato nel rock, nella new
wave, nel grandguignolesco di un palco. Il loro pensiero laterale era una proiezione, una distanza intellettuale a un tempo mimetica e metaforica: la patafisica è anche nel rock, nei riff, nelle escandescenza
del brusio di un EML 400. Una citazione fatta di un
non detto impareggiabile.
Long Live Père Ubu! – terzo capitolo della saga
di concept album dei rinati Ubu, ma pure titolo
dell’annesso spettacolo teatrale - è invece idiot proof; apparecchia ed esplicita ciò che rimaneva tra le
righe dei brani dei Pere Ubu, cioè la derivazione delle intuizioni e del mondo fantastico di Jarry. A peggiorare la situazione c’è pure la Mere Ubu (interpretata da Sarah Jane Morris); il tutto diventa
un patetico tentativo di seguire la sceneggiatura già
pronta dei cinque atti di Ubu Roi. David nei panni
forzati di Padre Ubu non è altro che una pallida imitazione di quel tracotante personaggio teatrale. E sì
che è perfetto da sé, David, senza fare alcuno sforzo.
Ricordo il timore che mi fecero la sua stazza e il suo
sguardo quando lo vidi per la prima volta. Perché recidere i collegamenti parabolici? Non sarebbe stato
meglio fare ancora del pensiero laterale, che so io,
magari iscrivendosi come l’Ubu che si cela dietro a
Orson Welles?
Il significato dell’operazione per quel che mi riguarda è principalmente uno: un’immedesimazione banale dovuta a un calo (se non a un vuoto) di fantasia.
Mai definitivo, e per questo segnalabile senza troppe
preoccupazioni.
(5.8/10)
Gaspare Caliri
Phantogram - Eyelid Movies (BBE,
Agosto 2009)
G enere : digital dream pop
Stato di New York, ma senza la necessità concreta
di mettere in scena l’ennesima bagarre avanguardista, né tanto meno il desiderio di inerpicarsi sulla
collina indie più redditizia (oggi neo-garage, domani
wave, dopo-domani italo disco). Ovviamente l’origine ritmica del disco è sottoscritta dal marchio in
questione: BBE.
Josh Carter e Sarah Barthel lavorano ad un livello
inconscio, le loro fantasie retro-nuevo non hanno in
realtà molto a che spartire con le fronde europee
guidate da Stereolab, Broadcast e dagli autori
più esoterici del giro Ghost Box. C’è sì un recupero
della memoria, di un flavor se vogliamo pop lisergico, ma al servizio di strutture affatto evanescenti,
anzi ancorate ad un beat, ad un groove che più che
recensioni
95
solleticare parallelismi col downtempo, induce ad
un reverente sguardo all’arte di Madlib ed ai consociati di casa Stones Throw.
Se Slowdive e Breathless in qualche maniera
entrano nella scacchiera, l’arte dei due Phantogram è quella di stordire l’ascoltatore, con mosse repentine e stralci di romantica canzone quasi
francofona (alla voce 10,000 Claps). L’abilità dei due
– che si alternano anche alla voce – è dunque quella
di rifinire un’arte spesso inseguita da molti gruppi
indie folgorati sulla via di Damasco dal credo digitale. Futuristic Casket che si apre con un break degno
del miglior J Dilla, diviene poi un oggetto dream
pop che lo stesso Thom Yorke invidierebbe.
Bella anche l’apertura avant-hop di Mouthful Of Diamonds, che potrebbe far pensare a materia Anticon
in parte decontestualizzata. Il duo di Saratoga Springs
guarda alla big city senza in questo rinnegare la sua
origine bucolica, canzoni come docili giacigli.
(6.6/10)
Luca Collepiccolo
Phenomenal Handclap Band (The)
- The Phenomenal Handclap Band
(Friendly Fire, Settembre 2009)
G enere : disco funk rock
The Phenomenal Handclap Band, nome altisonante, impegnativo. Una dichiarazione d’intenti palese
e portata a termine. Otto individui - due donne e
sei uomini, per la precisione - che suonano in linea
di massima come i Traffic di The Low Spark
of High Heeled Boys rapiti da Stand! di Sly &
The Family Stone. Menti del progetto, Daniel
Collas (Organo, Synth) e Sean Marquand (clavicordo, effetti), visi pallidi della grande mela e noti dj
nella città che non dorme mai.
Dunque un rock prossimo alla negritudine, funk o
disco che sia, e funzionale al concetto di ballo. All
Of The Above, forte di un basso killer e ritornello
alla stregua di Sylvester, e Testimony - Jaleel
Bunton dei TV on the Radio e Aurelio Valle
dei Calla i guest - si levano sensuali e vertiginose,
come ossigeno inalato da un essere in agonia. La
prima parte del lavoro non concede tregua: Give It A
Rest è la sintesi di cui sopra, ovvero Steve Winwood
nella mantella fastosa di Sly Stone. Poco dopo, lo
spartiacque. You’ll Disappear è una Blind (Hercules
And Love Affair) dal tiro meno urgente ma comunque centrata; 15 To 20, invece, è la canzone che i
Css non scriveranno mai: Tom Tom Club e Esg
in rotta di collisione. Per di più si odono, subdoli,
96
recensioni
campanacci stile Blondie. Semmai diventassero famosi, sapremo il perché.
Di seguito, il milieu si fa più rock in senso stretto, diciamo classic. Dim The Lights è un boogie glam echeggiante Marc Bolan, I Been Born Again rammenta i
The Doobie Brothers, The Martyr e Tears addirittura i Free, e Baby - impreziosita da musicisti del
giro Daptone. E si sente! - scomoda lo spauracchio di Curtis Mayfield. Non un disco obbligato ma
un toccasana, da utilizzarsi, magari, in una di quelle
giornate nate dal verso sbagliato. Promossi.
(7/10)
Pierre Gerard - Plateaux (Koyuki
sound, Luglio 2009)
G enere : sintesi minimali
Ormai è chiaro che i semi più fertili della scena elettronica minimalista germinano ancora. Dalla nostrana Koyuki arrivano i trenta minuti di Plateaux
dell’artista belga Pierre Gérard.
Seguace della più radicale arte minimalista - quella
iniziata ai principi della scuola riduzionista di Richard Chartier - Gérard dispone le scritture
al minimo, richiamando i più nobili domini in fatto
di pratiche d’estetica, fisicità del suono e processi
all’ascolto. Egli si distingue però per l’astrazione e
l’orientata negazione del superfluo a favore d’impercettibili miniature sonore accuratamente scelte
per estremismo d’intervento e scala dell’udibile.
Se avevamo imparato ad impossessarci dello spazio
con il movimento e le supefici in stratificate texture,
in questo lavoro, a dettare le regole (in bit od elaborata elettroacustica), è la forma strettamente pura,
che agisce sull’attesa e quasi in ombra (o sul contrasto scultoreo del segno) a diventare testimonianza
di potenzialità sonora vs. silenzio.
Abbiamo un nuovo poeta del silenzio tra noi.
(7.3/10)
scansa i clichè anche nella temuta “reunion”.
Questi grossomodo i presupposti da considerare
prima di porsi sereni all’ascolto di questo disco dei
Polvo. Inoltre, occorre rilevare quanto il predecessore Shapes - ultimo
capitolo di un romanzo
senza cadute - si spingesse ben oltre il dignitoso e ricordare i progetti post-scioglimento
di Ash Bowie e Dave
Brylawski, in buona
sostanza interlocutori o
rimestanti il solco originario. Così ci si rende conto
che, in sostanza, per costoro trovarsi di nuovo a
suonare sia stato frutto di un’esigenza reale. Della
voglia di riallacciare i discorsi interrotti epperò validi, di far dialogare ancora quelle chitarre cubiste
che uncinavano e intrappolavano psicosi e psichedelia. Fresco di reclutamento il muscolare batterista
Brian Quast e competente l’ingegnere del suono Brian Paulson, bravi agli altri tre nel recitare se
stessi con la sobrietà degli uomini maturi che, senza
forzature, ti colgono di sorpresa.
Si muovono meno nevrotici e sfasati che in passato
offrendo più lusinghe melodiche; cosa logica e pure
legittima, se trattengono la spontaneità del gesto, la
normalità di aprire il rubinetto e aspettare l’acqua.
La quale scorre sicura ovunque e soprattutto nella
cantilena contorta ma orecchiabile Right The Relation, nell’ipnosi alla Television mediata da indolenza “slacker” D. C.Trails, dentro una City Birds prossima a degli Xtc sensuali e nelle articolate epopee
di acido modernismo - un minuto western e l’altro
urbano - Lucia e A Link In The Chain. Brani che riscaldano le orecchie come ciò che conosci ma non
puoi né tanto meno vuoi abbandonare, per paura di
perderti un asso nella manica.
(7/10)
Sara Bracco
Giancarlo Turra
Polvo - In Prism (Merge, Settembre
2009)
G enere : indie - mathedelic s
Un classico degli ultimi tre lustri di cronaca: una
band che ha raccolto poco pur lasciando un segno
nell’evoluzione del rock si riforma per alcuni concerti e poi, come niente fosse, piazza un disco nuovo
di zecca. Per fortuna mica tutti sono dei saltimbanchi qualsiasi e, se ognuno ha le proprie opinioni sul
senso di rifare oggi un passato glorioso, c’è pure chi
Portland Cello Project (The) - The
Thao & Justin Power Sessions (Kill
Rock Stars, Luglio 2009)
G enere : orchestral pop
Collettivo orchestrale da Portland come da denominazione, la formazione ospita in questo album
Thao Nguyen, che si è fatta conoscere nel 2008
per il suo folk pop insieme ai Get Down Stay Down
e il songwriter Justin Power.
Il disco è tripartito esattamente tra pezzi orche-
Gianni Avella
strali di cui deliziosi rifacimenti tra sacro e profano
mescolando alto e basso come da loro consuetudine (da un pezzo dei Pantera a un inno religioso, The
Lamb di John Tavener), e le canzoni dei due ospiti.
Ineccepibile l’accompagnamento, per un orchestral
pop che funziona bene nelle mani di Power, il quale
possiede un songriting ancorché acerbo ma dotato
di personalità, folk malinconico con echi di Nick
Drake, meno in quelli della Nguyen, dove di personalizzazione ne avvertiamo purtroppo pochina.
Peccato davvero che questo comprometta in parte
la riuscita dell’operazione, tutto sommato apprezzabile e alla quale il combo non è nuovo.
(6.5/10)
Teresa Greco
Pumajaw - Favourites (Fire
Records, Settembre 2009)
G enere : gothic folk
Quella dei Pumajaw è una storia iniziata nel 2000,
quando Pinkie Maclure (voce, synth, concertina,
campioni) e John Wills (chitarre, mandolino, synth,
campioni) sembravano emanazione di certe cose
Too Pure della prima ora. Il dub di Sorcery e il trip
hop di We Spin - dal debutto Memorial Crossing
- guardavano più ai Laika che non alle recenti derive folk. Stesso discorso valeva per Harbour Song (dal
successivo del 2003, This Day & Age). Il registro
però cambiava nel 2005, con Maclure a modulare la
voce alla stregua di una novella Nico e la musica
ad assumere contorni bucolici. The Bending Wood e I
Take The Long Way Round, estratti da Cat’s Cradle,
e Outside It Blows e Downstream dal successivo Becoming Pumajaw, sono emblematiche in questo
senso, viravano il sound verso il goth folk primordiale con layer di psichedelia sulle sponde Pink
Floyd e Jefferson Airplaine.
La raccolta Favourites termina qui. Curiosi invitati
ma mulla di sorprendente, beninteso.
(6/10)
Gianni Avella
Ramona Falls - Intuit (Barsuk,
Settembre 2009)
G enere : indie pop - rock
Solo project di Brent Knopf chitarra e voce e
un terzo degli eclettici Menomena, dalla fervida
Portland. Dal gruppo Knopf prende il nervoso miscuglio indie pop-rock psych funk che tanto era piaciuto a SA (Friend And Foe, 2007), associandolo a
una certa regolarità ritmica e a un più spiccato senrecensioni
97
so della melodia rispetto alla band di provenienza.
L’album è stato realizzato in low budget e DIY con
l’aiuto di parecchi amici della scena di Portland
(tra cui Helio Sequence, la band di Mirah, 31
Knots, Loch Lomond), e riflette la vena più
pop del nostro, mescolando acustico ed elettronico, oscillando tra ballad e cambi non esagerati di
ritmiche, tra psych rock alla Mercury Rev e acido Flaming Lips, echi di Beatles e Simon &
Garfunkel ma anche R.E.M. Ottanta, e variazioni tra l’epicità Arcade Fire e l’eclettismo TV On
The Radio, tutti elementi più o meno presenti nei
Menomena d’altra parte. Dalla sua Knopf mostra
un’introspezione e una omogeneità stilistica che
forse mancava in alcuni casi al miscuglio eterogeneo
e piuttosto sopra le righe dei Menomena.
Allora una prova decisamente positiva questa, mente attendiamo già da un bel po’ il nuovo disco della
band di provenienza.
(7.1/10)
Teresa Greco
Ryan Bingham - Roadhouse Sun
(Lost Highway Records, Giugno
2009)
G enere : americana
Il fatto è di quelli assodati e ampiamente storicizzati: la difficoltà non sta tanto nell’uscirsene con un
grande esordio, giacché in esso convogli tutta l’urgenza di ciò che è stato prima.Arduo è semmai convincere col seguito, dal momento che puoi rischiare
di annoiare con fotocopie un po’ sbiadite o lasciare
perplessi sperimentando nuove soluzioni.
Non fa fino in fondo né una cosa né l’altra il ventottenne - che di vita e blues però ne ha masticati eccome - Ryan Bingham allorché replica a Mescalito,
disco che nel 2007 raccoglieva consensi ovunque e
a pieno merito. Insomma, se i media e alcuni tuoi
miti ti eleggono a erede di una tradizione fulgida (la
scuola cantautorale texana, per capirci) sai di avere
davanti la strada spianata, ma con una certa quantità
di cecchini pronti a segarti le gambe se sbagli anche
solo un passo.
Saggiamente, in Roadhouse Sun il ragazzo si guarda attorno e, nella continuità, getta sul piatto qualche venatura rock in più, favorito dall’ulteriore affiatamento raggiunto con i fidi Dead Horses (un
versatile Corby Schaub alla chitarra; il bassista Elijah
Ford, figlio del produttore ed ex Black Crowes
Marc; dietro tamburi e piatti siede Matt Smith) attraverso l’intensa attività live.
98
recensioni
La voce resta a metà tra un giovane Bruce
Springsteen e Steve Earle, altrettanto fanno le
ballate crepuscolari conservando la polvere del
capostipite Townes Van Zant; da ascriversi viceversa a felici “lavori in corso” episodi come una
Dylan’s Hard Rain che raccorda agile Mr. Tambourine Man e Sweetheart Of The Rodeo,
una Change Is giocata su cambi d’atmosfera prossimi
a Micah P. Hinson (toh: un altro sradicato figlio
del Texas…) e l’apertura Day Is Done, che mostra
notevole maturità quanto a struttura e sviluppo.
Lo stesso non si può però dire di Hey Hey Hurray,
sincera ma vanamente fracassona e di un paio d’altri
momenti lievemente sfocati, dove i muscoli si flettono eccessivamente e si smarrisce la raffinatezza
severa e virile che è apprezzabilissimo tratto somatico di Ryan. Poco da lamentarsi e recriminare, in
ogni caso, se si considera il gesto coraggioso di chi
- alle spalle un vissuto e un album bastanti a considerarlo un Grande - potrebbe campare di rendita,
invece preferisce osare pur nei confini di uno stile
tra i più tradizionali che esistano.
Diteci quanti altri posseggono fegato e volontà
adatti alla bisogna e non si accontentano di sonnecchiare sugli allori. Ne vorresti di più in circolazione,
di personaggi siffatti, leali verso sé stessi, la propria
musica e il pubblico. E di dischi “di transizione” aurei
come questo, anche.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
Sally Shapiro - My Guilty Pleasure
(Permanent Vacation, Agosto 2009)
G enere : cheesy electro pop
Non si toglie di dosso la nomea di brava ragazza e di
lolita dell’electro-pop la Shapiro. Con Pleasure ci (e
si?) concede mettendosi in mostra con i motivetti
e le atmosfere rosa shocking paillettate che l’hanno
resa (ahinoi) famosa. Ma il popolo dell’electropop
è stanco dei singoletti usa e getta un po’ dalle parti
dell’ultima Kylie, un po’ Kitzuné e un po’ Ciccone.
Tanto fashion e poca sostanza. La reginetta del posh
non ci dice che le solite banalità sui soliti 4 battiti e sulle annoianti tastierine 80. Ben prodotto, ma
che importa? Perfetto per under 15 sognanti storie
d’amore precarie. Per gli altri prescindibile e scontato.
(4/10)
Marco Braggion
Sam Paglia - Electric Happiness
(Dejavu, Aprile 2009)
G enere : ( shaky ) lounge
Quinto album (album che ce lo fa scoprire) per
Sam Paglia alias Samuele Pagliarani, da
Cesenatico, classe ‘71, rotondo e baffuto come
Buscaglione (e Riz Samaritano), tastierista
dall’insopprimibile vena funk autore di una lounge
piacevolissima, solare, colorata, frizzante (dice tutto
la copertina): sottofondo sì, per niente da tappezzeria. Quasi tutto strumentale il disco, eccezion fatta
per i due brani che aprono e chiudono, cantati in inglese con sottile voce soul da Sandra Cartolari,
e per Una Donna Scimmia cantata in italiano dallo
stesso Sam (musicalmente molto Bandabardò,
pezzo però non eccezionale).
Funk(y) (sparso un po’
ovunque, programmatico in Greasy), latin (bossa in Bobsamnova, samba
in Mundial ‘70), tango
(esteuropeo in Hotel Ukraina, balero-padano in La
Nebbia Gratis), soul jazz (sparso), colonne sonore
(Bruno Nicolai e il Fred Bongusto di Un
Detective in Wandrè). Suonato benissimo, da chi
si capisce che ha macinato serate su serate, appeal
internazionale, musica generosa per orecchie avide
(d’estate?), e che davvero regala momenti di felicità
elettrica. Scivola che è un piacere come un cocktail
alla frutta.
Suoni vintage da locale sessantasettanta, orgogliosamente demodè, e per questo sempreverdi. Se non
masticate i revivalismi e la retroguardia, benché di
qualità, condotti con stile, gusto e freschezza, sono
cavoli vostri.
(7/10)
Gabriele Marino
Savath & Savalas - La Llama
(Stones Throw, Maggio 2009)
G enere : psych - folk - ambient
Persevera Guillermo Scott Herren, assieme
a Roberto Carlos Lange, new entry di origini
ecuadoriane, ed Eva Puyuelo Muns, spagnola di
Barcellona già su Apropa’t (2004), nelle sue canzoni folk per treni, alberi e miele. L’altra (ma neanche troppo) faccia della medaglia del suo discorso
electronica-cut-hop a nome Prefuse 73. Canzoni
tardopomeridiane, amniotiche, assonnate, evane-
scenti, ricordi etno-folk latini al ralenti, trasfigurati
in scenari praticamente ambient, venati da rumorismi (sparsi nel disco, concentrati in intro, outro
e traccia di mezzo) tra il desertico e l’industriale,
con evidente vena freak-psych che sa però non di
euforia ma di anestesia e trascinamento stanco. La
formula è sì in qualche modo facile, ma ben gestita e
piacevole, col tocco per così dire esotico del cantato in spagnolo, e il disco ha un suo fascino sinuoso.
Registrato in casa a budget zero, solo i tre intestari
più qualche amico “scroccato” alle percussioni. Assicura Herren, non più solo-project ma vero e proprio gruppo. Stones Throw sempre meno hip-hop-funk
only label, sempre più meticcia, electronica e folkie.
(6.9/10)
Gabriele Marino
Scratch Perverts - Beatdown
(Fabric, Giugno 2009)
G enere : ragga , step , bbreak
Tempa, Ninja Tune, Warp, Cheap Thrills: queste ed
altre le etichette in questa compilation dei maghi
del turntable che approdano su Fabric Records.
Come a dire: il meglio di quello che il sound targato UK può dare oggi al maniaco medio del ritmo. I
nomi? Benga, Digital Mystikz, Qemists, Skream, Flying Lotus, Zomby, Diplo e tanti tanti
altri.
Insomma, il gotha del sound post-grimey che vira
Kingston riunito in un’ora compressa e tirata. Ma
anche qualche sbirciatina al fidgeting di Kissy Sell
Out, all’hardcore di AC Slater, all’electro truzza di
Boy 8-Bit e alla jungle/d’n’b di Logistics e Sigma.
Un mix eclettico come non se ne sentivano da tempo. D’altronde dai maghi del giradischi non puoi che
aspettarti l’eccellenza. Sentire per credere.
(7/10)
Marco Braggion
Shannon Stephens - The
Breadwinner (Asthmatic Kitty
Records, Settembre 2009)
G enere : F olk cantautorale
Il caro Bonnie Prince Billy ha benedetto il suo
cammino coverizzandone I’ll Be Glad nel recente
Lie Down in the Light, pezzo che potete trovare
in versione originale nell’omonimo album d’esordio
(correva l’anno 2000) di Shannon Stephens, ragazza
originaria del Michigan, un passato nei peraltro effimeri Marzuki (due album tra il ‘96 e il ‘98) dove
tra l’altro militava un certo Sufjan Stevens. Disrecensioni
99
solta quella band, trasferitasi assieme alla famiglia
nella fatal Seattle, Shannon tentò quindi la carriera
solista convincendo la Asthmatic Kitty a scritturarla
in virtù di una calligrafia folk gentile e frugale, intensa e vellutata, contemporanea in quel modo un
po’ strano che ben conoscono i seguaci del caro
vecchio Oldham.
Da quel disco di debutto son passati nove anni, dedicati - secondo quanto da lei stessa dichiarato - a
curare la famiglia e le piante. Non stupisce quindi
che il qui presente sophomore The Breadwinner venga presentato come una sorta di tributo
all’amore che da domestico si espande universale,
nello specifico “per il marito, la figlia, il giardino ed il
pianeta”. Sia pure. Dieci ballate a passo folk come
potrebbe una Suzanne Vega senza spocchia intellettualoide, dalla dolcezza ferma e pastosa, vagamente narcotizzata Red House Painters e con
l’ebbrezza provocata da un bicchierino di jazz che
gradevolmente strascica il timbro e le emozioni.
La preferisco nel caracollare trepido e arguto di Hard Times Are Coming piuttosto che nelle
palpitazioni cameristiche di Poor Man’s Part, meglio la cremosa banalità country folk di Seems I’m
Never Tired Lovin’ You che la pensosa marcetta di
Song of the Breadwinner, mentre il languore fiero di More To Speak Of e le apprensive sottigliezze di In Summer in the Heat sono episodi in perfetto equilibrio tra semplicità, perfezione e calore.
(6.7/10)
Stefano Solventi
Simian Mobile Disco - Temporary
Pleasure (Wichita Recordings,
Settembre 2009)
G enere : D isco
Se col debutto avevamo gridato al miracolo postDaft, oggi dopo aver passato tante serate dietro
alla consolle James Ford e Jas Shaw si circondano
di amici che ‘fanno figo’. In particolare Beth Ditto
dei Gossip, Gruff Rhys dei Super Furry Animals e Alexis Taylor degli Hot Chip. La crema
della crema dell’indie-electro-pop modaiolo. Come
modaioli sono sempre stati pure loro. E allora che
dire? I ragazzi si son fatti furbi, usano le solite chicche progressive anni ‘80 (Off The Map), la tagliente
arte della minimal techno (bella la progressione di
1000 Horses Can’t Be Wrong, Synthesise, Ambulance
è la risposta ai Chemical) qualche richiamo al funkhop (Turn Up The Dial) e l’8 bit sempre d’obbligo (il
primo singolo Audacity Of Huge).
100
recensioni
Niente di sconvolgente, cose già sentite nelle varie
Kitsuné e nei vari Fabric. Il retrofuturismo che si
mescola con la techno non sorprende più come nel
p-funk targato 2000. La voglia di crescere li ha cristallizzati e la freschezza del sempreverde esordio
non c’è più. Peccato.
(4.8/10)
Marco Braggion
Simone White - Yakiimo (Honest
Jon’s Records, Giugno 2009)
G enere : folk
Album numero due per l’etichetta londinese a firma Simone White, ultimo indirizzo consciuto Venice, California. Come il precedente I Am The Man
è stato registrato a Nashville, TN, con l’assistenza
di Mark Nevers, l’uomo che ha ricreato la magia
attorno alla soul singer Candi Staton e che ha
praticamente consegnato ad Honest Jons il talento
della White. Siamo in piena area ‘americana’: batterie spazzolate, organo e fiddle (suonata magistralmente da Billy Contreras, rinomato session man del
giro country).
La White canta con un piglio sommesso, rivelando
a sorpresa una certa saudade sudamericana. Victoria Ann, Baby Lie Down With Me e la stessa titletrack rappresentano forse i punti più alti del disco,
semi-ballate che guardano ben oltre l’universo altcountry, introducendo con deferenza una soul music totalmente bianca. Un sentimento simile a quello
dell’ultimo Bonnie Prince Billy, che in verità si
affacciava in veste di ospite sul disco precedente,
con un desiderio ancor più lucido di arrivare all’essenza vera della musica pop attraverso arrangiamenti scarni, secolari invero.
Un penna originale ed un pacchetto di canzoni che
ha la proverbiale capacità di emozionare, con un paradossale rimando all’alternativa folk del primissimo
Arthur Russell.
(7/10)
Luca Collepiccolo
Six Organs Of Admittance Luminous Night (Drag City,
Settembre 2009)
G enere : psych folk
Notte luminosa quella che risplende sulle spalle di
Ben Chasny. Sempre più votato ad una classicità
quasi mitologica, non sorprenderà nessuno notare
in Luminous Night lo stesso disegno di insieme
che sottende, da un po’ di tempo, il progetto Six
Organs Of Admittance, ovvero la stessa architettura che si manifesta a partire da School Of
The Flower in poi. Quindi a voler esser pignoli,
niente di nuovo all’orizzonte e una naturale maturità d’artista che, come il più classico dei canovacci
indie, sotterra le asprezze visionarie degli esordi in
favore di un modus molto più pop.
In epoche ormai vetuste, Chasny sarebbe già stato lapidato da un paio
di album a questa parte
ma siamo nel 2009 e anche il giudizio critico su
musiche e artisti è (per
fortuna) diventata una
faccenda con meno bianchi e neri e molti più toni
di grigi. Questo per dire
che Chasny pur continuando a fare la stessa cosa da
almeno quattro album riesce a spostare il baricentro sempre quel tanto che basta per non suonare
fastidioso o ripetitivo, ma certo il discorso comincia
in ogni caso a deteriorarsi e ariette insipide come
Actaeon’s Fall (Against The Hounds) o l’esotismo da
cabaret di Bar-Nasha rischiano veramente di lasciare il tempo che trovano. Anzi, sembra quasi che
Chasny voglia scusarsi con i duri e puri della prima
ora dando loro in pasto zuccherini posticci come
il drone modello Kranky di Cover Your Wounds With
The Sky o la sceneggiata horror di Enemies Before
The Light messa in chiusura per fare l’occhiolino ai
fan dei Current 93. La vera essenza del disco (e
delle intenzioni di Chasny) sta però nelle serenate
per chitarra e voce, che se a qualcuno ricordano il
Roger Waters dei tardi Pink Floyd a me fanno
invece tanto venire in mente John Martyn o il
Neil Young meno arcigno. È questa la natura di
oggetti calibratissimi e orecchiabili come Anesthesia,
Ursa Minor, River of Heaven, The Ballad Of Charley
Harper. Insomma, parliamoci chiaro, Chasny sa essere uno scrittore di primissimo livello, uno scrittore
“classico” e pertanto il capolavoro della maturità è
pronto già da tempo. Deve solo smettere di girarci
intorno.
(7/10)
Antonello Comunale
SK Radicals - Urban Eclectiks
(Freestyle Records, Settembre
2009)
G enere : urban soul jazz
Oggi non va più di moda il fritto misto ‘80 davisiano
che cercava un compromesso tra jazz e rock, soul
e r’n’b. Una volta la chiamavamo fusion vero? E così
dischi come Urban Eclectiks ci spiazzano perché
non siamo più dentro il calore del soul tinto jazz. A
dir il vero, il ritorno di queste sonorità l’avevamo
sentito con Kissey Asplund, eppure, se nel suo
disco c’erano Sade e il nu soul, da queste parti si
riprende La lezione innestandola di breaking tempo
che fa ‘90.
Il gruppo di Sean Khan (multistrumentista al sax,
tastiere, voci e produzione) propone una scaletta
che ci va di standard da club fumoso, cose note e
stranote ma piene di anima. Lo slow con i falsetti
sciccosi di Troubled Times, l’uptempo di My Story, la
cassa dritta che ricorda i fasti della !K7 di Ursula
Rucker (Indifference Is The Enemy Of Love), il soul
elettrico e sinuoso di No I Can Do e le tastiere ciccione à la Medeski Martin & Wood di Guidos
Procrastination.
A cavallo tra la lounge e il jazz elettrico di Miles
Davis periodo Tutu, le movenze del gruppo, e la
bella voce di Susan Allotey, ci accolgono in un
salotto coi divani in pelle bordeaux, il rum e la coca.
Una bella scoperta.
(7/10)
Marco Braggion
Skygreen Leopards - Gorgeous
Johnny (Jagjaguwar, Luglio 2009)
G enere : acid folk
C’è una logica nel fatto che gli Skygreen Leopards - ovvero Glenn Donaldson e Donovan Quinn - provengano da San Francisco, e il
suo nome è folk acido. Attivi nel Jewelled Antler Collective (suo fondatore, Glenn, era/è in
Thuja, Blithe Sons e Ivytree; Quinn proviene
dai Verdure), prendono la vita con rilassatezza da
“vecchi freak” e da tre anni difatti tacevano. Un peccato, in considerazione del loro meditare psichedelico in chiave acustica, graziato da senso della misura
ed equilibrio rari tra le fila della weird America. Nel
senso che di rado - se non mai - i due si perdono
lungo tangenti troppo libere, nonostante il suono
bucolico frutto del momento, registrato in bassa fedeltà ma pur sempre curato, portatore sano di titoli
da sfattone temprati con sorridente pigrizia.
Un luogo comune, a raccontarlo così: tutt’altra cosa
l’evidenza, sorta di plausibile Incredible String
Band d’oltreoceano devota alla Madre Terra, cui
eleva odi a base di percussioni, banjo e svagate armonie vocali spesso indimenticabili come la circorecensioni
101
lare, vagamente drakiana Jehova Will Never Come o
una title-track che fa collidere Television Personalities e Byrds, però strafatti come mai lo
sono stati. È un piccolo mondo concentrato su se
stesso senza solipsismi, un girare attorno ad arbusti
sempreverdi ogni volta appagante e, stilisticamente,
Gorgeous Johnny non inscena rivoluzioni. Si discosta
dai predecessori per un’ulteriore benvenuta concisione, per l’attenzione al “succo” che riduce al minimo indispensabile i fronzoli; senza perdere di vista
la cura formale mentre preferisce la scrittura alle
atmosfere.
Ne trae forza il disco, con apici nel passo a metà
tra Syd Barrett e Opal che muove Margery e
Can Go Back, nelle più cadenzate Inland Towns e Dixie
Cups In The Dead Grass, in una SGL’s Et Al dolcemente
cianotica. Commuove per l’economia di mezzi e il
pensare in grande lasciandosi amare senza sforzo,
con la persuasività delle piccole gioie quotidiane.
Perfetta per le mattine di fine estate, quando tutto
è fresco e tranquillo.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Sleeping States - Gardens of the
North (Bella Union, Agosto 2009)
G enere : E xotic indie folk
A più di due anni di distanza da There the Open
Spaces, Markland ha cambiato città. Lasciata Londra per Bristol, s’è accampato presso la batterista
Rose Clark (Thanksgiving / Adrian Orange) e ha iniziato a incidere nuove tracce per il primo album veramente visibile della sua carriera.
Da un anno è approdato
a casa Bella Union, proprietà di colui che fu nel
gruppo che più adora, i
Cocteau Twins (lui
è naturalmente Simon
Raymonde) e dunque i
numeri della cabala sono
sul piatto. Gardens Of
The North, terzo lavoro sotto la sigla Sleeping
States, sarà ricordato come il lavoro con il quale
un promettente act dell’underground (Avant) folk
londinese si è misurato con quanto maturato fin’ora
uscendone con stile e personalità invidibali.
Sleeping States chiude un cerchio iniziato nel
2004 sbocciando da bedroom folkster a crooner
crepuscolare perso nel tempo tra qualche landa
del Post War Dream e l’immediatezza dei migliori
102
recensioni
folkster DIY della sua generazione. Il lavoro in sottrazione dell’ex pop-noiser Haiko ha dato i suoi
frutti: il novello bristoliano pare un Patrick Wolf
innamorato della Blue Moon dell’Elvis più cinematografico, un agrodolce Casiotone For The
Painfully Alone acustico, lo Jens Lekman più
ligio a Tin Pan Alley.
La chiave è comunque il doo wop, mondo Fifties
che rivisitato Markland è veicolo di molteplici smalti, assieme di nostalgia, magia e coraggio, anche nel
giocare con il cheesy.
Rinunciando a firmare un’altra Rivers (il suo anthem
personale) e limando le tentazioni arty (leggi noise,
wave) con i quali s’è fatto amici anche importanti,
la tracklist brilla per eleganza e limpidezza. Soprattutto è un lavoro essenziale, e perciò consigliabile
come tale.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Slow Club (The) - Yeah So (Moshi
Moshi, Luglio 2009)
G enere : folk pop
Sono in due. Lui suona la chitarra e canta, lei canta e
suona - suonicchia - la batteria. Casomai vi fossero
venuti in mente i White Stripes, beh, sappiate
che col famigerato duo di Detroit non c’azzeccano
molto, quasi per nulla in verità. Perché, a parte una
certa irrequietezza elettrica che monta improvvisa e volentieri, le canzoni di questi due ragazzi da
Sheffield - già assieme nei defunti The Lonely
Hearts - mirano certo folk brioso della cuspide
cinquanta-sessanta , assieme amarognolo e giulivo,
generosamente asperso di errebì, euforie bucoliche e glassa onirica, neanche fossero i nipotini dei
coniugi Felice e Boudleaux Bryant (autori di
alcuni clamorosi hit degli Everly Brothers).
Proiettati nel presente, finiscono per sembrare una
fresca via di mezzo tra palpiti & estrosità targate
Apples In Stereo e Tilly And The Wall
(non a caso a questi ultimi hanno recentemente fatto da opening band), riuscendo altresì a lusingare i
reduci del NAM e quanti non disdegnano le caligini
nostalgiche di M. Ward. Contagiosi se cantano in
duetto, agili in solitudine (quando Rebecca sembra
la sorellina pepata di Feist e Charles il nipotino
scaltro di Paul Simon), hanno tutta l’aria dei predestinati al successo. Difatti, alcuni pezzi estratti dai
singoli che hanno preceduto questo esordio lungo
hanno già accompagnato spot pubblicitari in Canada, Australia e persino USA.
Aggiungete la voglia di ‘leggerezza consapevolè che
gira intorno, qualcosa cioè che aiuti a galleggiare con
intelligenza e sensibilità sui flutti scuri della Grande
Crisi, e avrete un bel po’ di ragioni per attendervi
che gli Slow Club facciano il botto.
(6.4/10)
Stefano Solventi
Slumberwood - Yawling Night
Songs (A Silent Place, Marzo 2009)
G enere : psichedelia
È un trip in piena regola l’esordio degli Slumberwood. Roba che devi starci con la testa – o forse non
starci proprio – per seguirne lo scorrere irrequieto
in giro per lo spartito. Psichedelia dilatata e sulfurea
(Yahoo) che ti stordisce e si trasforma, prima in un
arpeggio folk rassicurante (Thru Crop Fields), poi in
un blues gorgogliante – nel vero senso della parola (Il verme solitario), poi in uno space-post rock in salsa
Jeff Buckley (Help Me Grandpa), poi in qualche
incubo da boogeyman kraut (Mr. Sandman). Come
dei Jennifer Gentle senza bussola, lontani dal
“dacci oggi il nostro garage quotidiano” e dispersi
in una miopia cosmica ai confini col demotape. Al
timone – uomo mixer e produttore – c’è Marco
Fasolo, detentore del marchio registrato di cui si
diceva due righe sopra, ma i punti di contatto degli
Slumberwood con la band padovana non finiscono
qui. Similare, infatti, è anche la concezione free e
mutevole della musica, materiale più o meno in linea
con la produzione degli esordi dei Jennifer Gentle
(pensiamo a certe parentesi di I Am You Are) e in
qualche caso, decisamente più estremo.
Insomma, le premesse ci sono tutte per prevedere
la sortita di un’altra Sub Pop in terra italica. Pregando che i ragazzi non si perdano per strada.
(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Sophia - There Are No Goodbyes
(City Slang, Maggio 2009)
G enere : P op , C antautore
Chi si è abituato al Proper-Sheppard cantautore
hi-fi, perdonandogli le svolte che ne hanno caratterizzato la vita (dai God Machine ai Sophia prima;
dall’idea minimale di questi ultimi a una loro mutazione “major indie” poi), non può che godere del
polposo e - scusate le mille parole chiave - wavechamber-pop-rock raggiunto dal Nostro.
“This gotta mean something... But nothing means
anything” ci/si dice Robin, il quale si piacerà sem-
pre un casino, ma perlomeno ha trovato una pelle
morbidissima sulla quale adagiare le proprie compiaciute amarezze adulte. E nel compiacersi il fu Dio
(Ex) Macchina è bravo, poiché a sostenerlo trovi
una naturalezza che mescola intimismo (Dreaming)
e narrazione, conquistata col sudore di tre album e
davvero invidiabile.
Come dire che, se c’è bisogno, lui dell’indie USA
“anni zero” - dai Built To Spill ai Death Cab
For Cutie, insomma sa come tirare fuori tre
accordi e una pennellata di voce che gli stanno
accanto senza baccare:
tanto di capello, perché
non è da tutti. E, se di
stelle e strisce parliamo,
neanche con il suono
Nashville più Lambchop se la cava male (Signs):
roba che basta davvero a sotterrare tutto il ciarpame letto e sentito dei Sophia che non arrivano al
cuore della gente (a proposito: caro Molko, ascolta
Portugal e impara come si fa).
Il controverso un po’ per tutti People Are Like
Seasons è oramai faccenda lontana. E come s’affermava per il precedente Technology Won’t Save
Us, del cantautorato di quest’uomo non si butta via
nulla.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Taken By Trees - East Of Eden
(Rough Trade, Settembre 2009)
G enere : songwriting , world
Sul modello di altri prima di lei, la svedese Victoria Bergsman per il secondo album con il moniker
Taken By Trees, ha scelto di uscire dall’occidente e
recarsi nel suo caso in Pakistan, dove ha registrato il disco quasi esclusivamente con musicisti del
luogo. L’ammirazione per leggende quali la cantante
Abida Parveen e Nusrat Fateh Ali Khan
l’hanno infatti portata sin laggiù.
“Naturalmente avrei potuto farlo in India, ma dov’era
il mistero in questo?”. Victoria ha infatti dovuto superare tutta una serie di difficoltà burocratiche e
soprattutto culturali essendo una donna in territori e ambiti prettamente maschilisti. East Of Eden
è stato registrato in loco con il fidato musicista e
recording engineer Andreas Soderstrom, e sa di sapori prettamente sufi, dove alle ballad si intrecciano
ipnoticamente i cantati iterativi, i flauti e le ritmirecensioni
103
che sovrapposte, i poliritmi e soprattutto il senso
del divenire prettamente locale. La nostra però non
è esattamente Paul Simon o David Byrne o
Damon Albarn (e qui ci potrebbe stare tutta
una vecchia polemica sull’”usare” la musica orientale, ma non la facciamo) e il risultato le prende un
po’ la mano, risultando piuttosto modesto e non
andando al di là di un omaggio sentito, ma piuttosto
scolastico.
Da segnalare la cover di My Girl degli Animal Collective, che qui diventa My Boy, mentre Noah partecipa alla voce in Anna. Ci era piaciuta la Bergsman
al debutto nel 2007 (Open Field) per il suo trattare la materia pop in modo personale. La aspettiamo
dopo la sbornia a est dell’Eden.
(6.4/10)
Teresa Greco
Talibam - Boogie In The Breeze
Blocks (ESP Disk, Giugno 2009)
G enere : impro free - jazz
C’è ancora da dire qualcosa sui Talibam!? Non se
ne è detto ancora abbastanza? O meglio, c’è ancora
qualcuno che non li conosce, che ha bisogno di sapere “chi sono” e “cosa fanno”? Beh, provvediamo
subito. I Talibam! sono due semidei e fanno l’universo mondo. Chiaro?
A ricordarcelo è Boogie In The Breeze Blocks,
ideale secondo album ufficiale in una discografia che
da corposa sta diventando spaventosamente immensa e tentacolare, spaziando tra cassette e vinili
di ogni forma e dimensione, spesso (se non sempre)
in modalità live-improvvisativa. Qui però, proprio
come succedeva in Ordination Of The Globetrotting Conscripts, le composizioni sono pensate e soppesate prima di essere sottoposte alla furia
destruttivista dei due e della solita e debordante
messe di ospiti. Che tutti insieme, chi più chi meno,
chi prima chi dopo, aggiustano il tiro di quell’album
virandolo verso una sorta di cabarettistica e gigionesca raccolta di canzoni senza per questo perdere un’oncia di potenzialità (schizo)compositive e di
resa furibonda.
È un passo oltre, Boogie In The Breeze Blocks.
Un patchwork vivente dell’onnivoro mondo di questi
due folli visionari reso blob metaforico dell’esistente, tagliuzzato e smembrato nelle sue fondamenta
per essere riproposto in mille, continuamente volatili, forme nuove. Funk, soul, jazz libero e spirituale, atmosfere da “polizziottesco”, be-bop, musica da
cabaret, swing, impro radicale, svolazzi di synth…un
104
recensioni
frullatore acceso come investigazione antropologica sull’oggi. Geni è dir poco.
(8/10)
Stefano Pifferi
Tamaru - Figure (Trumn, Marzo
2009)
G enere : drones
Nuove dal Sol Levante. Dall’etichetta di Hideho
Takemasa, il secondo album solista di Shuichi
Tamaru, Figure, sposa l’ambient più riduzionista all’improvvisazione, trasformando gli interessi
dell’artista in un vero e proprio manifesto d’intenti.
L’album è una sorta di mappatura sonora in otto
movimenti che ruotano intorno alla gamma di frequenza giocando con sfumatura, plasticità (Stream),
dissolvenza (Cathedral) o profondità di tono (Juju) il
cui effetto dato dalle stratificazioni (Thought) o dalle
fluidità (Plateau) in loop è imprevedibile ma consapevole. A impossessarsi del vuoto qui sono le formule più semplici - in variazioni di tempo e microtonali
armonie - votate al suono puro e chiamate a gestire
lo spazio attraverso sinusoidali forme sottili.
Di fronte a tanta essenzialità stupisce l’eleganza e
la qualità del droning riprodotto. Oltre, il gesto e la
teoria poi, Tamaru possiede il dono di sospendere il
tempo. Non è certo poco.
(7/10)
Sara Bracco
Telekinesis! - Telekinesis! (Merge,
Aprile 2009)
G enere : I ndie pop
Michael Lerner vive a Seattle e assomiglia tanto a
Colin Meloy. Meloy vive a Portland ed è amico
di Chris Walla. Walla ha prodotto ben due dischi
dei suoi Decemberists, e il chitarrista, anche lui
residente in Oregon, curato il fortunato Give Up
dei Postal Service e l’engineering dello splendida formula power punk-pop dei Thermals. Detto
che il missatore e producer è naturalmente quello
dei Death Cab For Cutie, il quadro si completa
e lo scacchiere dell’indie (indie?) pop che conta in
America tracciato. Nessuna sorpresa dunque, se il
nuovo alfiere Lerner, culo e camicia con Walla, al ritmo di una traccia al giorno, muove un intero canzoniere d’energiche, innamorate e “never look back”
song(s) facendo scacco alla regina al primo colpo - e
superando pure il maestro (Field Manual).
È l’immediatezza che ogni buon pop deve avere la
forza di Telekinesis!, più o meno one man band
highlight
Zola Jesus - The Spoils (Sacred Bones, Luglio 2009)
G enere : lo - fi industrial goth
Dà sempre un un po’ di fastidio dover parlare bene di qualcosa con così tanto hype su di se,
perché di solito l’effetto che si ottiene è sempre quello di istigare gli snob al di là della barricata,
quelli che poi ti rispondono: “certo ne parli bene ora che va di moda”. La prima regola di questo
difficile mondo indie parla chiaro: per quanto tu possa essere alternativo c’è sempre qualcuno più
alternativo di te, qualcuno che appena vede un leggero hype spara a
zero.Tutto sto po’ po’ di dissertazione serve per lo più per giustificare
il tono entusiasta con cui sto per descrivere il primo vero disco di
Zola Jesus, al secolo Nika Roza Danilova, che a dispetto delle origine europee indicate dal nome, arriva dal Midwest degli States.
Affiliata al giro della Sacred Bones e protagonista di un successo sotterraneo, con tanto di passaparola nel giro dei blog giusti, Zola Jesus è
una figura in qualche modo sovrapponibile a quella di Blank Dogs,
che ha seguito un percorso abbastanza analogo. Ciò che cambia è la
musica che nel caso della Danilova nasce lungo precise coordinate new wave, industrial e goth. Ha
fatto già parlare di sé con un po’ di ep (i micidiali Soeur Sewer e Tsar Bomba) ma The Spoils
è il primo vero disco di debutto pensato per lunga distanza e arriva a metà luglio per raffreddare
un’estate anche troppo calda (missione che condivide con Sirenum di Circuit Des Yeux, un
altro disco di mezza estate, avvicinabile a questo, anche se più estremo).
Zola Jesus altro non è che un’estrema filiazione della terrifica trimurti Diamanda Galas /
Lydia Lunch / Siouxsie. Ergo un generale senso di alienazione umorale e tipicamente femminile, aggravato da un’urgenza del tutto adolescenziale (stiamo parlando di una che ha passato
la maggiore età non da molto), e da un senso molto contemporaneo per l’erosione del suono,
ovvero un lo-fi come unica soluzione possibile. The Spoils suona un po’ come i primi Cocteau
Twins di Garlands imbruttiti e ingialliti. Le trame sintetiche, i beat elettronici a cadenza industriale, quel vociare uggioso, che a volte si fa etereo e fiabesco, in altre semplicemente stregonesco, il tutto costantemente calato in una nube tossica da suono in disfacimento.
Fuor di dubbio che la maggioranza dei nuovi eroi dell’underground ci giochino anche troppo con
la bassa fedeltà del suono, ma al di là di tutto è comunque un segno dei tempi se dischi del genere riescono a trovare il loro spazio. Zola Jesus in più ci mette anche una certa dose di glamour
che aiuta farla accettare a target non proprio abituati al lo-fi. Il suo è un gotico post-atomico. Da
dopo bomba. Condannato all’origine, ma con una grazia e uno stile tutti suoi. La sua vittoria sta
nel vivere su un crinale molto precario senza perdere l’equilibrio.
(7.6/10)
Antonello Comunale
di Lerner, dalla scrittura colorata di cielo e dalla
produzione ancor più smagliante. Lettere a Tokio
dal retrogusto Sixities, switch acustico/elettrici nelle cavalcate Thermals sulle coste della Carolina, freschezza Death Cab tra synth celestiali e chitarre in
goduria Dinosaur Jr (addomesticata), sono tutti
power pop dall’entusiasmano contagioso. Almeno
tre, i razzi alle stelle, singoli per l’estate garantiti, ep-
pure il mood costante da sorriso in faccia dall’inizio
alla fine è il valore vero dell’album. Ti fa dire basta
con ’sti laidi inglesi perché è ora della rivincita dei
nerd Portland pop (vedi anche alla voce Shins). Il
disco, ristampato Merge, è uscito in aprile negli USA
e sarà disponibile in Italia da settembre.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
recensioni
105
The Duke and the King - Nothing
Gold Can Stay (Loose Music, Luglio
2009)
G enere : folk rock , soul
Progetto solista di Simone Felice degli americani
Felice Brothers (usciti di recente con il secondo
album omonimo) insieme a Robert Chicken Burke,
The Duke and the King bypassa la connotazione
prettamente roots del gruppo madre per attestarsi
piuttosto su territori di cantautorato folk rock con
elementi di blue eyed
soul e psych.
Il disco si snoda infatti
attorno a una composita trama sonora che
partendo da umori Bob
Dylan passa con naturalezza attraverso spezie
tradizionali USA prettamente di marca The Band, dove le ballad si tingono di soul e blues. Altrove si avvertono echi di
Donovan e Cat Stevens e inflessioni glam che
rimandano al primo Marc Bolan. Dei contemporanei, The Duke and the King (a proposito, il nome
è preso da Huckleberry Finn di Mark Twain
e le tematiche rimandano all‘adolescenza perduta)
ricordano le ibridazioni e le misture di uno come
Rufus Wainwright, le languidezze country dei
Lambchop, il migliore Grant Lee Phillips, e
forse la maggiore ispirazione dei due, il Prince camaleontico delle ballate sussurrate (si ascolti Suzanne per esempio).
Un buon equilibrio tra gli ingredienti dell’album ne
fanno allora un più che apprezzabile esempio di
songwriting discreto e centrato.
(7.1/10)
Teresa Greco
They Might Be Giants - Here Comes
Science (Walt Disney, Settembre
2009)
G enere : pop - rock ( for children )
Quando esordirono 23 anni fa, si è detto anche
questo, giustamente. E a un certo punto, i They
Might Be Giants si sono messi a farla sul serio
la musica per bambini. Il primo passo nel 2002 con
No!, enhanced cd con video animati abbinati alle
canzoni. Poi l’audio-libro illustrato e le canzoni per i
cartoon channel. Nel 2005, il volume inaugurale della
serie didattica (siamo tra dei Residents-buoni e
Bruno Lauzi) Here Come..., cd+dvd prodotti da
106
recensioni
Throw Me The Statue Creaturesque (Secretly Canadian,
Agosto 2009)
G enere : pop rock
Secondo album per questa band di Seattle capitanata da Scott Reitherman, autore, cantante e multistrumentista, per l’occasione prodotta da quel Phil
Ek già dietro la consolle per band come Built To
Spill e Shins. Particolare non trascurabile quest’ultimo, perché proprio l’equilibrio spesso decentrato
e ondivago tra pop (di stampo più o meno wave,
electro e power) e folk rock, è il filo conduttore di
una scaletta sconcertante, di cui non è semplicissimo abbozzare le coordinate.
Diciamo che se esistesse una rotta percorribile tra
Beta Band, Phish, TV On The Radio, Casiotone for the Painfully Alone, Decemberist ed Elbow, ferma restando una leggerezza
emotiva capace di accogliere le freakerie degli ultimi
Sigur Ros, gli spasmi Bloc Party e - consentitemi - una certa setosità Paul Simon tra algori
Orchestral Manoeuvres in the Dark, beh,
sembrerebbe che i TMTS l’abbiano trovata e la vogliano percorrere. L’ascolto ne risulta assieme gradevole e straniante, suadente e dispersivo, ipnotico
ed effimero, come un lenitivo di cui non sai bene gli
effetti collaterali. Che probabilmente è innocuo e
forse non troppo utile. Buono a consolarti giusto
quella mezz’ora. (6.1/10)
Tinariwen - Imidiwan: Companions
(Independiente, Luglio 2009)
G enere : desert blues
Circostanza assai rara, un disco dei Tinariwen,
giacché chi scrive prova nel parlarne imbarazzo misto a inadeguatezza. L’uno causa della grandezza di
questo collettivo/formazione, autentico sogno che
congiunge fiera protesta sociale e canzoni misteriose, sferzanti e psichedeliche nel senso più profondo:
rivoluzionari che non trovate seduti in hotel a cinque stelle ma a lanciar bombe vere e non di carta.
L’altro derivante dal sentirsi incapaci a raccontarle,
la musica e la vicenda umana, tanto fanno risuonare
e vibrare corde dell’anima fino a mandare all’aria
senso critico e raziocinio. Ti senti ancora capace di
stupirti - anzi, no: di emozionarti - con un disco e, per
la miseria, da quanto non accadeva? Grossomodo
da prima della presunta “morte del rock” e, in seguito, da alcune sue ricorrenti resurrezioni. Adesso
ci siamo capiti, vero? Bene.
Arrivano oggi, i Tinariwen, al quarto atto di una vicenda meravigliosa che li ha visti progressivamente
uscire dai patri confini rivelando secolari vicende di
sofferenza, mentre lasciavano attonite le platee del
mondo occidentale; eccoli farsi largo tra un capolavoro già stantio la sera e la sensazione che dura un
giorno per spazzarle via, misere nullità, con la stessa
forza di quando la musica possedeva e maneggiava
una pienezza di significati che ne giustificavano esistenza, immortalità. Un vigore che in nessuna occasione schiaccia l’Arte. Un messaggio che sostiene e
non prevarica il mezzo lungo un poker di dischi tra
cui non sai scegliere, perché, semplicemente, non ha
alcun senso farlo.
Dunque non aspettatevi niente di nuovo nemmeno
da questo scrigno di blues del Sahara e di ipnosi
vocale, del John Lee Hooker echeggiato un momento prima che i Grateful Dead si uniscano
a jammare con lui. Alla musica nuova ci pensano i
cloni dell’ennesima “nuova onda” e gli stilosi paladini indie-disco, certo che sì. Dentro questi cinquantasette minuti, viceversa, (ri)trovate tutto quello
che ci ha fatto perdere la testa e come mancia uno
spiazzante drone ambientale; roba da custodire gelosamente e ringraziare perché esiste.Tredici motivi
di pari - elevatissimo, stellare - lignaggio che impongono l’acquisto. Tredici colpi al cuore da mandare al
tappeto chiunque. Ammirato, estasiato.
(7.7/10)
Stefano Solventi
Giancarlo Turra
mamma Disney, dedicato all’esplorazione delle lettere dell’alfabeto. L’anno scorso il secondo volume,
ed è toccato ai numeri. Arrivano adesso al terzo per
introdurre ai misteri della scienza: chimica, fisica,
biologia, astronomia.
Tanto power-pop, ma anche una ballad folkie arpeggiata, una lullaby, una caricatura country-rock, richiami Beatles-iani e percussioncine e tastierine a
condire. Inutile sprecare parole. Adorabili. Delizioso.
Inaspettatamente anche, ma come già le altre uscite della serie, una spanna sopra i loro ultimi dischi
“normali”. Ma poi, al punto dove siamo, molto meglio testi come questi (“fotosintesiiiiiii”), che le solite
varianti di sole-cuore-amore (non ce ne voglia Valeria
Rossi). E poi, si imparano anche un sacco di cose. Ps:
purtroppo non abbiamo visto il dvd.
(7/10)
Gabriele Marino
Toddla T - FabricLive 47 (Fabric,
Agosto 2009)
G enere : compil ation ragga -UK
Non si ferma il ragazzo di Sheffield. E se ne accorge
in un batter d’occhio pure il Fabric: questa compila
live è un documento veloce che cattura la sua mano
da turnatblista e da produttore (numerose infatti le
B-sides e i remix a suo nome). Sarà che il ragga è
l’ultima trovata del ritmo 09, sarà che il suo nome
sta girando in ogni rivista o blog musicale, ma i colpi
in canna sembrano esserci ancora tutti.
Anzi, il suono del giovane si spinge sempre più verso
le roots giamaicane e si contamina ancora una volta con il banghra-step acidificato dalle prove delle
varie cloni di M.I.A.. Un disco che raduna gli amici
più stretti, che abbiamo già visto protagonisti dell’album: Mr. Versatile, Serocee e Roots Manuva. La nuova e la vecchia generazione dell’MCing
targato UK. Più di un’ora che ci fa inevitabilmente
sudare e muovere il culo. Ben fatto Tom.
(7/10)
Marco Braggion
Tori Amos - Abnormally Attracted
to Sin (Universal Republic, Maggio
2009)
G enere : female songwriting
Con artisti che calcano le scene da molto tempo,
ritrovarsi assume le forme del rituale. Li attendi al
varco di un nuovo lavoro, soppesi le vicende che li
hanno condotti fin lì augurandoti che non si tratti di
un cartellino timbrato a onore del contratto. Con
la Amos e il suo tormentato intimismo abbiamo trascorso parecchi momenti felici, addirittura esaltanti:
il suo mettersi in gioco e a nudo con ogni canzone
resta da ammirare a prescindere dai risultati, fossero anche quelli piuttosto legnosi del predecessore
American Doll Posse.
Come quello, anche queste diciassette composizioni viaggiano sui binari di un “concept”, raccordate
stavolta dalla tematica del peccato (ne fa fede il libretto interno, Tori fotografata in interni borghesi
nelle vesti di dominatrice e colpevole, sirena oziosa
e sensualmente pigra…). Elementi che, lo confessiamo, non lasciavano presagire nulla di buono, aprendo
la via a ipotesi su concettualità eccessive e irrisolte.
È bastata invece l’apertura Give - trip hop bristoliano cupo che persuade, dentro tinte spagnoleggianti,
anche nel brano omonimo - a ratificare la rinnovata
verve, a confermare una penna policroma e gli arrangiamenti elaborati con equilibrata perizia come
recensioni
107
da tempo non ricordavamo. Non mancano gli episodi in cui il consueto marchio di fabbrica (distillato
personale e moderno dei Dna appartenuti a Joni
Mitchell, Laura Nyro e Kate Bush) si mostra
un investimento privo di rischi, nondimeno il livello
- sentire per credere Ophelia e Maybe California - è
tale da scansare stereotipi e fatica d’ascolto.
Guai a risparmiarsi, inoltre, perché ci vogliono
un’ora e dodici minuti a
percorrere Abnormally Attracted To Sin e
apprezzarne, sul compatto resto, le Fast Horse e
Welcome To England baciate da ritornelli perfetti e
strofe dolci ma sprezzanti, gli orientalismi di Strong
Black Veil e la sospensione di Flavor; piuttosto che
una contorta eppure contagiosa Police Me, una That
Guy trafitta d’archi tra cabaret e Tin Pan Alley, il folkpop favolistico 500 Miles. Quando a fine corsa giunge Lady In Blue, sensazionale ascesa verso empirei
jazz, comprendi la differenza tra il Genio di mezz’età
e la mestierante col futuro davanti. Ti persuadi che
queste ultime, di qui a vent’anni, un album siffatto
ancora lo sogneranno e basta.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
Toshiya Tsunoda/Luke Fowler
- Familial Readings (Edition. T,
Aprile 2009)
G enere : architetture sonore
L’esperienza insegna. A oggi, in fatto di registrazioni
di campo, il giapponese Toshiya Tsunoda può
essere considerato un maestro, testimoni i documenti delle opere passate e, non ultimi, i trenta
minuti di questo Familial Readings, che nasce
come sonorizzazione di una pellicola sperimentale
del film-maker scozzese Luke Fowler
Rilasciata dall’Edition T in sole 300 copie, l’opera è
una vera e propria colonna sonora del vuoto. L’artista intrappola eventi transitori evincendo spazi risonanti: si alternano semplici registrazioni di voci
- tratte in parte da letture di testi e coversazioni
telefoniche - a lunghe trame di silenzio, assertite da principio come nei titoli di coda - al fruscio, che
rimanda per similitudine di fondo alle registrazioni
su nastro di un vuoto suono d’ambiente.
La composizione anche qui - riportata a favore di un
realismo di riproduzione ed attraverso tecniche in
108
recensioni
cut-up - risulta tutt’altro che statica, l’ambient confortevole e l’attenzione viva, chiamata sempre alla
scoperta di singolari ombre sonore. Ad ogni modo,
per i fanatici più curiosi.
(6.5/10)
Sara Bracco
Tyondai Braxton - Central Market
(Warp Records, Settembre 2009)
G enere : cl as sic -B attles - meshup
Central Market è un’opera eccessiva in ogni senso. Ascoltando le prime battute – ma non necessariamente dall’inizio dell’album, visto che questo è
un disco che si può iniziare ad ascoltare in qualsiasi
punto e fa lo stesso effetto – ciò che sembra sovradimensionata è l’euforia di Tyondai Braxton. Il
suo divertimento è evidente, ma anche il desiderio
di trasmettere questo stato d’animo al prossimo.
L’intento primario dell’opera, dice il musicista e
compositore, è di avvicinare la musica classica alla
gente che ascolta rock o elettronica. Obiettivo ambizioso, lo sappiamo, e ambizione, insieme a divertimento, sono due parole chiave di Central Market.
Orchestrale è una terza, dato che compagno di viaggio della fatica è la Wordless Music Orchestra, ad
alcuni già nota per aver accompagnato un progetto
solista di Jonny Greewood. Ma la Wordless è stata
impegnata solo nell’esecuzione; tutto, in questo secondo album solista di Tyondai, è costruito e pensato dal Nostro. Trasuda della sua essenza.
Stilisticamente, l’atteggiamento con cui il Braxton
ha composto le tracce corteggia a lungo una sorta
di barocco, che non è il barocco musicale secentesco,
quanto la maniera basata sull’eccesso, la continua
piega che prende forma dalla piega precedente. Due
esempi: il bolero che aleggia dentro l’iniziale Opening Bell, piccolo manifesto “post-modern” - tocca
ammetterlo anche a chi non usa mai tale appellativo; oppure The Duck And The Butcher, dove si sente
pure una qualche vicinanza armonica con Robert
Fripp.
Non ha limiti, Tyondai, senza i compagni di band; ma
per certi versi i Battles risuonano in continuazione tra gli svolazzi di Central Market, in questo
molto diverso dal precedente e pre-Battles-iano
History That Has No Effect, del 2002. Sono
comunque riuscite le sincopi percussive in tutto e
per tutto Battles che fanno da contrappunto alla
costruzione orchestrale, specie nella suite centrale
del disco, Platinum Rows, che non appare altro in dati
momenti che un folle remix dei Battles fatto per
Battles e orchestra. Il punto è che i tic di Tyondai
(quelli che approssimano Uffes Workshop ai deliri
dell’ultimo Zack Hill) sono parte del suono distintivo della band madre. Di più: fa strano, in J. City,
sentire che Braxton “canta” anziché usare la sua
voce come staffilata percussiva in mezzo agli altri
strumenti. E forse avremmo apprezzato di più un
disco che sviluppasse questa “deriva”, piuttosto che
sfoggiare, talentuosissimamente, le proprie capacità. E poi, ultimo appunto: la musica classica con cui
interloquisce Braxton non esiste più. Sarebbe bello
vederlo, come in Unfurling, ma più massicciamente,
alla prova almeno col Novecento.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Valentina Dorme - La carne
(Fosbury, Giugno 2009)
G enere : P op
A quattro anni da Il coraggio dei piuma tornano i
Valentina Dorme – con alcuni cambi di formazione - dando alla luce il loro nuovo album, La carne. Per la precisione, il terzo disco di studio di una
carriera iniziata nel 1992 ma che vide la band trevigiana debuttare solo nel 2002 con Capelli Rame.
E quelle abrasioni soniche miste a digressioni elettroacustiche che ne caratterizzarono gli inizi si sono
man mano affievolite, seppur non del tutto, a favore
di una raggiunta maturità stilistica più vicina a certe
atmosfere cantautorali. L’unica cosa che non è mai
cambiata è l’elevata qualità letteraria dei testi di Mario Pigozzo Favero, il deus ex machina del gruppo. E
anche in La carne, estasianti e seducenti sono certi
passaggi lirici, sempre incentrati sull’amore ora con
violenza e cinismo, ora con arrendevolezza e malinconia. È un indie rock poetico, nervoso, languido e
trasognante a muovere questi undici bozzetti di vita
autentica. Per dare dei riferimenti potremmo citare
Fabrizio De André, Diaframma e Marlene
Kuntz, ma i Valentina Dorme sono riusciti a crearsi un proprio immaginario artistico ricco di suggestioni e segreti. Un pezzo di Italia da tutelare e
valorizzare. Indubbiamente.
(7/10)
Andrea Provinciali
Vladislav Delay - Tummaa (Leaf,
Agosto 2009)
G enere : P ost - techno
Quest’anno Sasu Ripatti è in forma smagliante: due
album non meno che indispensabili all’attivo, uno
di intrigante electro germanicità con Agf e l’altro
a dir poco enorme con sua maestà Moritz von
Oswald (nel famoso trio del missile).
Non è finita, ce ne sono altri due: il primo di cui
vi parleremo e il secondo che non vediamo l’ora
d’ascoltare, il Vladislav Delay Quartet con Mika
Vainio, Derek Shipley e Lucio Capece (uscirà a novembre). Dunque parliamo di Tummaa, album dal sigillo di garanzia firmato Leaf e collezione
che si presenta subito come la più acustica e jezzata
mai intrapresa dal nostro.
Evidentemente la voglia di suonato (e di percosso),
figlia diretta dalle possibilità apertesi con l’esperienza Vertical Ascent, ha dischiuso percorsi irresitibili
per la perenne riflessione dopo techno del moniker
Delay. Sicuramente, è il
terreno dal quale il nostro è partito per incidere un lavoro che, a conti
fatti, non si discosta molto dal free wierd decostruzionista ascoltato di
recente con Hex Love
e affini. E se questa è una
buona notizia, gli ottimi contributi del citato Lucio Capece (clarinetto e sassofono) e, soprattutto, della vecchia conoscenza Craig Armstrong
(piano e Rhodes), confluiti in un ambient space jazz
plastico (e dai vaghi tratti Miles Davis-iani), non
sono da meno.
A proposito: è proprio la grana filmica approtata da
quest’ultimo (compositore di soundtrack conosciuto ai tempi del progetto The Dolls) il legame (mica
tanto) fraterno con i flavour Mille Plateau, ovvero
l’interessante continuum con il passato del finnico
(per la label incise Entain nel 2000, e Anima nel
2001), coerenza peraltro portata a un livello differente ascoltato il maturato approccio ambient psicologico di cui Brian Eno fu santissimo padre.
Dunque un lavoro senza incertezze dalle incertezze
forse necessarie di cui sentiamo, un poco, la mancanza. L’eleganza delle decostruzioni avrebbe potuto godere di elementi sabotanti invece del fluire in
una perfettibilità che non si distagna affatto, ma pur
sempre perfettibilità rimane.
(7/10)
Edoardo Bridda
recensioni
109
We Insist! - The Babel Inside Was
Terrible (Exile On Mainstream
Records, Settembre 2009)
G enere : noise - rock
Li facevamo esordienti questi 5 francesi e invece
scopriamo che hanno alle spalle una sostanziosa discografia oltre che una attività decennale.
Non che questo cambi il giudizio su The Babel
Inside Was Terrible ma mette in evidenza ancor
di più alcuni pregi e difetti.Tra i primi, indubbiamente
la capacità di saper giostrare con esperienza le musiche rumorose di matrice chitarristica; tra i secondi, purtroppo, non si può non notare che nonostante questa esperienza i We Insist! suonano ancora
troppo dipendenti da modelli ben riconoscibili. A dimostrare appieno questo atteggiamento fin troppo
ossequioso è già l’opener Dejà Vu, piccolo bignami
nei cui 5 minuti scarsi si concentra tutto l’universo
dei cinque. Universo circoscritto, a ben vedere, tra
Jesus Lizard e Faith No More. Dei primi hanno infatti la tensione delle chitarre formato stiletto
senza però riuscire ad emularli nella originalità delle
costruzioni; dei secondi la vocalità debordante del
cantante/batterista Etienne Gaillochet e un certo
gusto per l’arzigogolo privo però della schizofrenia
compositiva che caratterizzava Patton e soci.
Insomma, non un brutto disco: potente, ben suonato, creativo a volte, scostante molto più spesso.
Giocare però sul terreno di simili mostri sacri se
da un lato fa apprezzare il coraggio, dall’altro può
risultare fin troppo rischioso.
(6/10)
Stefano Pifferi
We Were Promised Jetpacks - These
Four Walls (Fat Cat, Giugno 2009)
G enere : E mo
Dopo i Frightened Rabbits e Twilight Sad,
un altro debutto indie rock con “specchietto retrovisore” dalle chiare influenze emocore per la Fat
Cat. Dunque nessuna novità, eppure undici canzoni
dinamiche e vivaci con un retrogusto malinconico
che contagiano inesorabilmente, così come il cantato post-punk profondo e melodico (Gang Of
Four, Interpol), la circolarità indie rock che rimanda a certe derive emozionali dei Novanta (Dismemberment Plan), la tensione strumentale
sempre in crescendo (Hot Club De Paris) e un
buon dosaggio di pop (Coldplay meno banali).
(6.5/10)
Andrea Provinciali
110
recensioni
WHY? - Eskimo Snow (Anticon,
Settembre 2009)
G enere : ( indie ) pop
Yoni e i suoi WHY? pubblicano adesso altre dieci canzoni registrate durante le stesse session che
hanno portato ad Alopecia. Rispetto a quel disco,
vario e stratificato (e il più valido finora), Eskimo
è monocromo, pacato, asciutto. Ancora riuscito, ma
in maniera diversa. Nei pezzi più belli, la prima metà
del disco, dominano arpeggi di piano e di tastiere
(le stesse comunque che facevano capolino anche
lì, vedi A Sky For Shoeing Horses Under). Eskimo, forse inevitabilmente, ha un che di invernale, disco di
suoni campanellosi, quasi
natalizi, a tratti solenne,
epico ed enfatico (esempio, Even the Good Wood
Gone). Si ritorna all’assenza di rappato, e francamente non se ne sente
la mancanza. Piacevole,
(indie)pop punto e basta,
motivetti orecchiabili e
attacchi accattivanti (esempio, Into the Shadow of My
Embrace), un paio di suggestioni più spiccatamente
folkie (One Rose, Berkeley by Hearseback). Pezzi ben
scritti, arrangiati e suonati: ma perché lamentarsi?
(6.8/10)
Gabriele Marino
Wild Beasts - Two Dancers
(Domino, Settembre 2009)
G enere : art wave
Con Two Dancers, secondo disco a seguire Limbo Panto, vale quanto li affermato: gli inglesi Wild
Beasts si amano o si odiano. Sulla voce si gioca la
carta d’ingresso e così è. Anche questa volta perché
Hayden Thorpe, non le manda certo a dire, anzi le
recita in tutta la vena drammatica, glamour e kitsch
di cui è capace.
New wave e art pop in assoluta empatia. Associates, Parenthetical Girls, Talking Heads
e Divine Comedy in un sol colpo. Forse troppo,
è vero, ma si prendano come indizi e non prove.
Un pezzo come The Fun Powder Plot, ad esempio,
la si potrebbe interpretare come dei Talking Heads
placidi con Zac Pennington al microfono: Incastri ad
hoc tra basso e batteria, chitarra ipnotica e gusto
per l’arrangiamento, poiché ridurre tutto il fascino
dei Nostri al solo Thorpe sarebbe in ogni caso in
errore.
Manca un singolo della portata di Brave Bulging Buoyant Clairvoyant ma non l’impatto epidermico: il post
punk epico di Hooting & Bowling e We Still Got the
Taste Dancin’ on Our Tongues, il glam di Underbelly e
This Is Our Lot (questa, se non un singolo, sicuramente il pezzo migliore del lotto) si faranno odiare e/o
amare come da premessa. E poi c’è anche lui, Tom
Fleming, l’altro cantante, che dall’alto del suo virile e
baritonale timbro marca episodi non meno rilevanti
come Two Dancers i e i i, Empty Nest e All The King’s
Men in coppia col collega.
I Wild Beasts hanno le cosiddette qualità. Sanno
come scrivere una canzone e vivranno sempre tra
sentimenti discordanti. Meglio che passare inosservati, senza dubbio.
(7/10)
vinile, tra le quali capitano sapori sorprendenti tipo
il beat contagiato french-touch di I Feel Like Giving In
(The Delmonas) o la piano-ballad waitsiana di An
Image Of You (The Chatman Singers), passando dai Creedence Clearwater Revival sotto
benzedrina di Christmas 1979 (The MBEs) ai velluti asprigni psych-pop con tanto di voce effettata e
jingle jangle di Love Can Lose (The Milkshakes).
E via discorrendo. Più che uno scrigno di preziosi, è
un vaso di Pandora pieno di amabili demoni dietro
le cui fattezze ne scorgi sempre una, quella del caro
Wild Billy che si rivela appieno presentandosi nudo,
la voce soltanto, nella sequela di amare memorie di
The Bitter Cup. Laddove si conferma sovrano della
propria splendia ossessione.
(7.3/10)
Gianni Avella
Stefano Solventi
Wild Billy Childish - Archive From
1959 / The Billy Childish Story
(Damaged Goods, Luglio 2009)
G enere : punk rock
Cosa scrivere ancora intorno alla figura eroica di
Billy Childish, rocker a tutto tondo col vizietto del
punk, pittore, fotografo e poeta, integerrimo e generoso, indomito malgrado gli anni e la tenace mancanza di quei riconoscimenti (anche uno straccio di
successo alternativo) che avrebbe strameritato, un
uomo insomma da scappellarsi solo a pensarlo.
Il tardivo approdo sui palcoscenici internazionali (si
fa per dire) ha significato un benedetto profluvio di
stampe e ristampe, accolte coi favori del caso tanto
che Damaged Goods ha ben pensato di confezionare questo imponente seppur parziale scorcio sulla
carriera discografica del Nostro genialoide del Kent.
Iniziata in piena bufera punk e tuttora nell’occhio del
proprio integerrimo ciclone, scoperchiando tetti e
sciaguattando fiumi con diversi nomi e formazioni,
mutando il senso e la forza della scudisciata ma non
il suo scudisciare.La fluviale scaletta è dominata sì da
un piglio stradaiolo che diresti primordiale, asciutta
e veemente, il garage rozzo pulsante di adrenalina
in acido, il sangue che ribolle senza marcire grazie
al senso di rivalsa fiera. Tutto ciò ci raccontano le
scorribande Sonics-Kinks di You Make Me Die
(sotto l’egida The Mighty Cesar) e We Hate The
Fuckin’ NME (firmata Thee Headcoats) o i The
Who strattonati Sex Pistols di Archive From
1959 (ad opera dei The Buff Medways). Parliamo di 51 pezzi, mica noccioline. Anzi, sì: tante goduriose noccioline distribuite su due cd oppure triplo
Woman - Self Titled (Bang!, Agosto
2009)
G enere : noise - blues
Brucia in fretta l’esordio di questi 4 brutti ceffi travisati sotto un moniker al femminile (come sembra
andar di moda, ultimamente). Sono newyorchesi,
escono per una delle etichette più lerce del pianeta
(la basca Bang!) e dietro al bancone siede Martin
Bisi. Vi si sono drizzate le antenne? Bene, siete sulla
strada giusta per diventare estimatori dello sporco
swamp-noise-blues di Brett Schultz (voce, chitarra),
Kristian Brenchley (chitarra, voce) Skeleton Boy
(basso) e Alex Velasquez (batteria), noti come Woman ma che di femminile hanno veramente poco.
Infatti mai definizione fu più esatta come quella autoapplicata dal quartetto
al proprio sound: mano a
mano che ci si addentra
nel disco si ha realmente
la sensazione di scivolare in una sacca di sabbie
mobili; i suoni si impastano, le atmosfere si scuriscono, l’aria comincia a
saturarsi sino a diventare irrespirabile. E sotto sotto,
in fondo a quella melma ecco uscire fuori, rigurgitato ovviamente, tutto lo scibile rumoroso di NYC,
prossimo e remoto: blues deforme e cacofonia noise alla Pussy Galore, rock maltrattato e paranoia
urbano-esistenziale alla Swans, asperità chitarristiche e gusto per l’osceno alla Unsane. C’è però
poca violenza in senso stretto, quanto una perenne
disperazione nelle ossessioni su pentagramma dei
recensioni
111
quattro: prova ne siano i rimasugli sludge della conclusiva Icy Drone in cui confluiscono le scorie radioattive e gli avanzi indigeribili del suono targato NY.
Decisamente un ottimo esordio.
(7/10)
Stefano Pifferi
xx (The) - XX (XL Recordings, Agosto
2009)
G enere : electro indie pop
Quattro, giovani, inglesi di Londra (hanno fatto la
stessa Elliott School da cui sono passati Burial
e Four Tet), abbastanza insopportabili nel video
di Crystalised in circolazione da aprile. Solito hype
inglese, qualcuno cercherà anche di farne la NBT
eccetera, ma il disco è effettivamente carino. Un
pop minimalista che guarda a certa new-wave con
sensibilità (spleen) post nuovi romantici e in qualche
modo anche post grunge, dominato da una romanticheria stordita, in pezzi esili e trattenuti, intimisti, costruiti con piccoli tocchi, molto omogenei tra
loro, con le voci della chitarrista Romy Madley
Croft, spesso quasi sussurrata e con un certo
calore soul, e del bassista Oliver Sim, sempre abbastanza slacked,
fisicamente con qualcosa
del primissimo Frusciante, a guidare il tutto. Gli
altri due sono Baria
Qureshi, altra chitarra, e Jamie Smith, beat e
produzione. C’è qualcosa degli Young Marble
Giants nella essenzialità dei pezzi (spesso ritmati
ma spesso senza batteria), c’è una vena in qualche
modo folkie-cantautoriale e anche una certa diffusa
timidezza come bambinesca. I pezzi migliori sono i
due singoli, Crystalised, efficacissima, e Basic Space,
tra i più mossi del lotto, Islands e la conclusiva Stars.
Carini, ma per favore, niente Next Big Thing.
(6.8/10)
Gabriele Marino
Yim Yames - A Tribute To George
Harrison EP (Rough Trade, Agosto
2009)
G enere : folk psych
Nel dicembre del 2001 l’ineffabile Jim James, cantante e chitarrista dei My Morning Jacket, sentì
di dover spendere un po’ di tempo a smaltire la
tristezza per la morte dell’amato George Harri112
recensioni
son, avvenuta il 29 novembre. Niente di meglio che
una bella seduta d’incisione alle prese col repertorio del più giovane Beatles, dalla quale, dopo quasi
otto anni di decantazione, si è deciso a ricavare un
ep, sei tracce per ventisei minuti.
Valeva la pena di rispolverare quei nastri? Sì. Non
ci girerò intorno: c’è qualcosa di magico in queste
esecuzioni, costituite dalla sola chitarra acustica e
da quel popo’ di ectoplasma esotico che è la voce
di James quando si presenta nuda, o meglio avvolta
in una bambagia di eco e poche sovraincisioni ad abbozzare il controcanto. Dal misticismo impalpabile
e stordente di Long, Long, Long alla dolcezza spettrale di All Things Must Pass, passando per le inquietudini
speziate di Love You To, il sincretismo accorato di
My Sweet Lord e le palpitazioni trattenute di Behind
That Locked Door e Ballad Of Sir Frankie Crisp, è tutto
uno scorrere di brividi allibiti.
Aiuta non poco quel fare da John Martyn etereo,
fantasma tra fantasmi, inebriante tristezza aggiunta
alla serica malinconia. Un plauso per la scelta dei titoli, ché fare a meno di pesi massimi come Something
e While My Guitar Gently Sleep senza pagar dazio non
è cosa da tutti. Mi resta da capire il perché di quel
moniker:Yim Yames? Mah.
(7/10)
Stefano Solventi
Yoñlu - A Society In Which No Tear
Is Shed Is Inconceivably Mediocre
(Luaka Bop, Settembre 2009)
G enere : indie pop
Lo scorso marzo, parlammo diffusamente di Yoñlu,
l’adolescente brasiliano uccisosi nel 2006 a soli sedici anni. Oggi ritorniamo doverosamente a parlare
di lui con A Society In Which No Tear Is Shed
Is Inconceivably Mediocre, licenziato dalla Luaka Bop, e contenente materiale disseminato tra cd-r
mai pubblicati e svariati file mp3. Lo stupore si ripete.
Padrone della propria scrittura come uno scafato
cantautore, il ragazzo rapisce con canzoni ora sommesse (Phrygian e Suicide (…)) ora psichedeliche
(Katie Don’t Be Depressed) cantate in brasiliano o in
inglese, divagando in territori indietronici (Deskjet
potrebbe appartenere al registro di Casiotone
for the Painfully Alone) e/o collagistici (Boy
and the Tiger), oppure semplicemente, attraverso l’intimità di un mood per sola chitarra e voce (Estrela,
Estrema). Il disco è tra i più toccanti dell’anno.Vicino
a Elliot Smith (I Know What It’s Like, Little Kids) e
Nick Drake (la toccante Humiliation, attigua pure
all’idolo Vitor Ramil) declinati naturalmente bossa (Olhe por Nos).
Yoñlu era veramente speciale.
(7.5/10)
Gianni Avella
Yves de Mey - Lichtung (Line, Aprile
2009)
G enere : G litch / sintesi minimali
L’evoluzione artistica di Yves de Mey è avvenuta
in maniera piuttosto naturale: da ingegnere del suono a sound designer, dalle colonne sonore al teatro
contemporaneo.
Una vocazione quest’ultima da cui prende forma
il modulo minimalista di Lichtung, composizione
originariamente commissionata all’artista per la
performance di danza dei coreografi Antonie Effroy
ed Anna Rudelbach, successivamente uscita in supporto digitale per la nota Line.
Trentacinque minuti di austera partitura il cui tema
di fondo in statica materia dronica contribuisce a
sostenere la tessitura, che sia supportata da corde
di chitarra elettrica prima, o da sottili ed astratte
sovrapposizioni in rumorismo dopo.
Formula soffusa ma dinamica, il cui punto d’unione
tra fondale e stesura elettroacustica è lo svolgimento che non spetta ai volumi ma alla densità, mentre
al puntualismo sonoro è lasciato il cambiamento.
Pur da affinare, la materia per Lichtung si combina
in modo sottile traendo linfa dalle più preziose conoscenze, dal simbolismo timbrico, ai sensi di scala,
alle lezioni di sporadica introduzione all’elemento
di Steve Roden, passando per le superfci e l’abile
impadronirsi d’ascolto di Ralph Steinbruchel.
Insomma efficaci e buone premesse.
(6.6/10)
Sara Bracco
Zomby - One Foot Ahead Of The
Other EP (Ramp, Agosto 2009)
G enere : IDM
Ormai un anno dal discone che ha scosso il dubstep e ha sedimentato il wonky britannico. Zomby
come al solito si toglie di dosso le etichette e si
mette a fare qualcosina di nuovo, quatto quatto su
un’etichetta indipendente ma britannicissima come
la Ramp.
E il suo nuovo EP (sold out ovviamente in poche
settimane la versione in vinile) parla dalla sala giochi a 8 bit che i maniaci della cameretta conoscono
bene. Ma non è quella cosa pacchiana che troppi
continuano a propinarci (vedi Ital Tek). No, è un
nuovo salto nel buio e un nuovo atto di fede verso il
passato DIY. Buono solo per nerd? No. Lui è il campioncino del suono che viene da ieri per il domani.
Quindi lo ascoltiamo con interesse questo miscuglio di Kraftwerk, rave à la Kid 606 e
trip acido. E non siamo i soli, dato che anche
Mary Anne Hobbs lo pompa dai microfoni di Radio BBC 1 (l’inno per ora è Polka Dot).
Insomma. Lui ci piace ancora, in mezzo a quei megatornei di Tetris, quelle cose che stanno a metà
perfetta tra il raving e l’IDM di warpiana memoria.
Ortodosso ma duro, continua così Zomby, anche se
la candela forse sta finendo la cera
(7/10)
Marco Braggion
Zs - Music Of The Modern White
(Social Registry (The), Luglio 2009)
G enere : avant rock - noise
Dopo Arms e le sue esasperazioni di musica minimale nevrotica - reich&roll l’avevano definita su
Dusted Reviews - il nuovo disco degli Zs suona
piuttosto strano. In comune sicuramente è l’idea di
musica del trio, qualcosa che ha a che fare con la
mente ma in maniera scientifica, una sorta di psichedelia senza mistica. Ma le diverse espressioni sono
agli antipodi.
Se in Arms questo si manifestava in ripetizioni ossessive e tensioni senza pace nella maniera di Orthrelm, Music Of The Modern White è fatto
di feedback risonanti, strati e strati di sassofoni urlanti e chitarre sgretolate. Pura tortura atonale nel
primo lato, meno dissonante e pieno di piccoli suoni
e trucchi di studio sparsi nella seconda parte del disco. E se prima era tutto percussione epilettica, ora
è persino rara sentirla una batteria.
Music Of The Modern White è come una catarsi dialettica, l’antitesi agli Zs precedenti. Dopo
aver assemblato un minuzioso tracciato di microsuoni, con ogni variazione pianificata al dettaglio
(vedere le live performance coi 3 a perdere la vista
su spartiti musicali), esausti, rinnegare tutto. Bruciare le partiture per suonare ad occhi chiusi, votarsi
al rumore, recuperare spazio e tempo, sfogare gli
umori. Spalancare possibilità e incubare una successiva sintesi.
(7/10)
Leonardo Amico
recensioni
113
libri
The Filth And The Fury
J ulien T emple (I sbn edizioni )
Di Julien Temple si parla approfonditamente in altre parti della rivista, ma giocoforza
l’attenta retrospettiva del nostro Avezzù non può che citare en passant The Filth
And The Fury, pietra miliare per chi volesse davvero conoscere la storia dei Sex
Pistols e con essa l’humus socio-culturale in cui i 4 punks primigeni vennero allevati
fino a divenirne bubbone ributtante.
The Filth And The Fury – agile saggetto + dvd in stupenda edizione cartonata –
è il secondo dei tre film dedicati da Temple ai Pistols ed è quello che, lo vogliate o no,
risulta essere il più sincero per il semplice
fatto di essere quello più “vero”. Lontano
anni luce dalla truffa/fuffa che era La grande
truffa del rock’n’roll e altrettanto distante
dalla celebrazione fake del tour della reunion immortalato in There’ll Always
Be an England, Oscenità e furore
(questo finora il titolo in traduzione) ne è
liberatoria nemesi, riuscendo nell’intento
di rovesciarne la prospettiva celebrativa
incentrata, specie nel primo caso, più sulla
contorta personalità di McLaren piuttosto
che sui quattro giovani disadattati.
Il taglio documentaristico aiuta in questo
caso perché, grazie alla sovrapposizione (a
volte grottesca, come nei continui cut-up
dal Riccardo III di Olivier) tra spezzoni
d’epoca del gruppo e dei mass-media del
tempo, contestualizza l’esperienza Sex Pistols per quello che in realtà non è mai stato; la storia cioè di 4 drop-out che nonostante il manifesto No Future continuano a
far parlare di loro a distanza di decenni.
Nel libro 3 brevi ma approfonditi saggi;
inaugura Hugh Barker con Julien Temple. Un milione di storie, un racconto sentito con
spunti biografici di Temple e dei Pistols, che finisce inevitabilmente per indagare l’ambiguità dei rapporti tra Temple, i Pistols e il malefico burattinaio McLaren. Vaffanculo,
non vogliamo partecipare a nessun fottutissimo film è invece una confessione fluviale in
prima persona del regista che rievoca, tra aneddoti e un pizzico di nostalgia, il suo
avvicinamento al punk, il legame tra amore e odio con Lydon, le sue giovanili speranze mal riposte, la genesi del documentario, le emozioni provate nel girarlo (o meglio,
montarlo). A concludere il tutto uno scritto di Marco Philopat – Il cinepunk di Julien
Temple – contestualizza all’Italia del tempo il fenomeno punk 77ino, fatto di lontani
echi mediatici sulle provocatorie gesta dei punk e grosse delusioni per la Truffa architettata da McLaren.
The Desert Island Records
S tefano I. B ianchi / C hristian Z ingales (T uttle E dizioni )
Parafrasando le parole introduttive dei due curatori, protagonista di questo libro è il gioco più antico da
quando l’uomo inventò la musica registrata.
Quello cioè che, come anche i meno attenti avranno intuito, si nasconde nel titolo e che consiste nell’indicare i dischi del cuore da portarsi sulla proverbiale isola deserta. Se qualcuno tra i lettori non l’avesse mai
fatto, nemmeno una volta nella vita, in solitaria con gli
amici, beh, potrebbe anche smettere di leggere. Chi invece ha sempre avuto lo schiribizzo di compilare ipotetiche liste di dischi preferiti – pur senza raggiungere
le vette parossistiche dell’Hornby di Alta Fedeltà,
peraltro unico non-musicista qui presente – o di conoscere quelle dei suoi artisti preferiti apprezzerà sicuramente questo oggettino niente male.
In The Desert Island Records sono infatti raccolte tutte le puntate della ormai defunta rubrica di
Blow Up con l’aggiunta di una serie di liste inedite –
tra gli altri Aufgehoben, Amy Denio, Dorgon, Matt Elliott, Federico Fiumani, David Maranha, Xabier Iriondo,
Freak Antoni – che per una ragione o l’altra non erano
rientrate nella rubrica o che servono da cameo per
l’attuale raccolta. A scorrere in rigoroso ordine alfabetico è l’intera intellighenza nazionale e internazionale,
sia mainstream che dell’underground più profondo: da
Depeche Mode agli Assalti Frontali, da Charlemagne
Palestine a Dead C, dagli Orbital a Stan Ridgway, tutti
senza esclusione prendono carta e penna e stilano la
classifica dei dischi del cuore. Quelli coi quali condividerebbero una esperienze del limite come il vivere in
una isola deserta.
Ne esce una lettura piacevole, coinvolgente oltre che
ipoteticamente trasversale (quale sarà l’album più citato? e il gruppo più rappresentato?) che riesce però a
mettere in luce anche aspetti particolari non solo dei
gusti degli estensori ma anche delle proprie personalità. Ecco così che qualcuno decide di portare con sé un
anno, nello specifico il 1974 (Thymme Jones di Cheer Accident), qualcun altro solo un giorno (il 5 aprile
2002 e “solo quel giorno”) come fa Colin Newman (Wire), qualcuno ancora come Matthew Friedberger
(Fiery Furnaces) che aggiunge degli immaginari Desert Island Day-dream Records (Beethoven with Howard Grimes on drums, per capirsi) o qualcun’altro che scrive in maniera apparentemente deframmentata esattamente come produce musica: Thomas Brinkmann, autore di un vero saggetto di decomposizione
semantica in modalità locked groove.
Insomma, finiamola qui. The Desert Island Records è una piccola e agile bibbietta da consultare trasversalmente senza correre mai il rischio di annoiarsi.
Stefano Pifferi
Stefano Pifferi
114
recensioni
recensioni
115
live report
Dargen D’Amico/Cocorosie
F estival N arrazioni F ortezza M edicea (S iena )
4 luglio
Ottima location e inedita rivelazione per le Cocorosie. Il
nuovo corso è un successo chic freak senza indugi ...e
tanto hip hop.
Ai tempi del loro terzo album, The Adventures of
Ghosthorse e Stillborn, sono stato uno dei pochi a
difenderle. Non avevo certo apprezzato gli inserti
etnici derivativi Novanta (à la Dead Can Dance
quando cannano il disco per intenderci), e nemmeno avevo visto di buon occhio alcune influenze bjorchiane, eppure, un paio di ballate e uno scherzettomarcetta-per-bimbi m’avevano convinto: le sorelle
avrebbero tranquillamente tenuto un palco senza
alcuna incertezza o trepidazione, perché soltanto
poche strofe e note a contorno, erano lo specchio
di un sound spendibile oltre la soffitta e le atmosfere rubate dai dischi della mamma che le resero
celebri presso la critica specializzata.
Inoltre, in quel bistrattato disco, c’era l’hip hop,
aspetto coraggioso ma non primario, magari sembrava una trovata e niente più, ed invece è la chiave
di volta del nuovo corso per la quale si dovrà festeggiare un ottimo ritorno, in un’altrettanto imperdibile serata a Poggibonsi, Festival Narrazioni (evviva,
gratuito) che le accoglie in esclusiva per il Centro
Sud (al nord chi le ha viste era a Milano).
Portati a casa Casady i modi dell’hip hop diventano un ponte tra sé stesse e il futuro. Tra il genuino
e l’irrimediabilmente artefatto. L’incanto e il para116
recensioni
culo. Solo i fricchettoni più autentici (o i rom più
carismatici) reclamano così tanti odio/amore, ma
se questo è l’immaginario di contorno, la polpa è
una rapper vestita pure a tono (Sierra) e una solista
(Bianca) quanto mai incantevole. Una, la più anziana,
a condurre e l’altra a giocare, a seconda, o in contrappunto o in slancio lirico a mo’ di Goldfrapp ai
(bei) tempi degli Orbital.
Una Parentesi: ottima Bianca. D’altri tempi e di un
altro mondo. E per quello che ci interessa è cresciuta tantissimo. Non è più la stronza che era. L’ex
di Devendra Banhart, la bella snob della situazione. Ora è performer e con Sierra hip girl il bilanciamento dei contributi è finalmente raggiunto
in uno spettacolo che deve moltissimo anche alla
recitazione (i trucchi del teatro) e alla moda (per
niente banale la scelta degli abiti per i quali varrebbe
un paragrafo apparte). Tornando a Sierra, pure lei
diversissima: ieri l’altro giovane/vecchia ultra acqua
e sapone e ora irriconoscibile con i dread e tutto
il trucco. Del resto, quanto il passato con arpa e
strumenti giocattolo riaffiora, la voragine che il fan
s’aspetta non c’è.
Piuttosto affiora una coerenza puttana nondimeno
entusiasmante, perché nella metamorfosi organica (e senza punti accapo), le Cocorosie si sono
emancipate acquisendo pure sapori algerini che,
fortemente voluti a inizio concerto, rappresentano
il tanto bramato etnico ora finalmente funzionale
al loro sound. In questo senso, sono ben tre i brani completamente inediti tra un flauto tipico delle
zone e ritmi da pullman con i muezzin a tutto volume.
Il mix purtroppo non fa parte dell’eppì che circola
ai concerti delle sorelle: Coconuts, Plenty of Junkfood contenente 5 canzoni nuove, è una collezione
piuttosto deludente rispetto a quanto sentito oggi.
Soprattutto, va in direzione infantile à la Casiotone For The Painfully Alone e in quella più
canonicamente Antony And The Johnsons.
Tutto fondotinta e anche troppo semplice. Niente
a che fare con lo spettacolino totale a cui abbiamo
assistito. Aspettiamo l’album completo per stendere
un giudizio, soprattutto ci incuriosisce il produttore che si sceglieranno, il terreno, diciamo a questo
punto, che ci sarebbe. Discorsi che non valgono per
l’opener della serata Dargen D’amico, inattuale
lui proprio come, di converso, attuali loro.
Hop hop conquistato contro hip hop precotto. Ancora poche parole sul Dargen: la noia che si porta
dietro è un misto di pubblico completamente nonin-sintonia e un suo modo d’essere quel tipo-di-annoiato-arrivato-cool che rispetta la scuola del milanese rap da Jovanotti in avanti (e poco più sotto).
Del resto, le sue rime si reggono soltanto su una
manciata di mitomanie sulla droga e qualche tune
buono per una gita a San Donato-di-dove-voletevoi. Non si arriva nemmeno al blog come aggiornamento poetico-sociale e quindi perché dilungarci?
Edoardo Bridda
Ginevra Di Marco
D onna G inevra C as sero F ortezza P oggio
I mperiale (S iena ) 15 luglio
Rievocare la tradizione per scoprirla viva e attuale. Con
la naturalezza fiera e generosa che ben sappiamo. Una
data particolare per Ginevra Di Marco.
Ginevra appare floreale, materna, fiera. Addirittura
raggiante in mezzo alla triangolazione asciutta costituita da Andrea Salvadori (tzoura, chitarra e kazoo),
Luca Ragazzo (batteria) e dal compagno di vita e
avventure sonore Francesco Magnelli (tastiere, of
course).
Ognuno alla fine avrà riempito il proprio spazio ed
oltre, definendo un suono aspro, generoso ed evocativo. Della voce di Ginevra sappiamo bene, ormai
canta come se respirasse, come se allattasse, incarGinevra di marco
recensioni
117
nando con naturalezza ora fogge da popolana (La
malcontenta, La leggera), ora da rom (una trascinante Usti usti baba), per poi farsi carico di melismi inebrianti in albanese (nella magnifica Ali Pasha).
Passando per le trepidazioni in spagnolo del classico
Gracias a la vida (della cilena Violeta del Carmen
Parra Sandoval) e in francese con la magnifica Les
Tziganes (di Leo Ferré).
Canzone dopo canzone, Salvadori si ritaglia un ruolo da autentico co-protagonista, impadronendosi
del mood dei pezzi, sostenendoli con arpeggi dal
dinamismo mozzafiato e assolo formidabili, sfruttando alla bisogna pochi ma efficacissimi effetti (degno di nota l’e-bow applicato alla tzoura). Magnelli e
Ragazzo gestiscono le faccende ritmico/armoniche
con piglio turgido, donando all’insieme quell’impeto
senza troppi riguardi che invita al battimano e torna
parecchio utile al cortocircuito tra fregole taranta
e spurghi noise, come accade ne Le figliole, ancora
più devastante in versione live di quanto già non sia
su cd. Il bello sta proprio in questa capacità di far
incontrare inquietudini tradizionali e contemporanee senza snaturare le une e forzare le altre, come
quando la struggente Amara terra mia diventa una
processione che starebbe tranquillamente nel repertorio di Black Heart Procession o Giant Sand.
La serata - splendida su al Cassero, con le stelle
che stanno a guardare e ogni tanto ci regalano una
lacrimuccia - si conclude con un altro pezzo reso
celebre da Modugno, quella Malarazza che è sprone
viscerale e amaro, antico (il testo di Lionardo Vigo
risale alla metà dell’800) ma desolatamente attuale.
Dopo gli applausi, sorpresa: il pubblico intona gli auguri per il compleanno di donna Ginevra. Celebrarlo sul palcoscenico è un privilegio, un meritatissimo
regalo.
Stefano Solventi
Animal Collective/Tv On The Radio
B ands A part P iazza C astello (F errara ) 21
luglio
Tv On The Radio e Animal Collective
come dire l’evento del giro indie dell’estate. E infatti
non manca nessuno, dagli organizzatori (i Gandolfi
Unhip e i Croci l’Electricpriest) agli addetti ai lavori
vari, tra cui stampa (Pasini ecc. ecc.), musicisti (Enrico degli Offlaga disco pax, Jukka dei Giardini
di Mirò, Paolo Blake/e/e/e, Michele Mariposa, qualche Julie’s Haircut,Vasco Brondi endash;
Le Luci della Centrale Elettrica ecc. ecc.),
blogger e speaker radiofonici (ecc. ecc.). Tutti assie118
recensioni
e l’indifferente. Complice un soundcheck sfigato, la
chitarra si porterà via gran parte delle frequenze
medie con l’effetto appiattimento sull’intera performance. E pure il canto ha sofferto: Tunde Adebimpe
è scarico, la voce, nei momenti più punk, non è all’altezza del ritmo e, altra nota non da poco, i nuovi
brani dal vivo non catturano, non hanno sufficiente
personalità.
Sicuramente l’odore di band di razza i newyorchesi
la conservano, pur con le peggiori carte nel mazzo.
È innegabile che stiano cercando nuovi equilibri: i
momenti ruspanti sempre più ai margini e la voglia
di rifondare la personale blackness stampata in faccia. Sia come sia, tra le novità convincenti, il sax à la
Roxy Music che amplificava il sound nei momenti
tirati è stata la cosa che ha colpito di più.
Edoardo Bridda
animal collective
pati per il set campale del Ferrara Sotto Le Stelle
2009, lunghissimo per durata e puntualissimo per
via degli orari anti rumore.
Headliner e spalla suoneranno tre ore equamente
divise, prima i ragazzi di baltimore e poi i newyorchesi. Partono dunque gli animali, sfavoriti soltanto
per una questione di cachet (e in verità i più attesi
visti i fasti di critica di Merriweather Post Pavilion). Ed
è ancora luce.
Pessimo il contrasto visivo tra il palco con le 4 barre di led (intensità e colore regolabili come vanno
adesso in molti live set), la techno in bassa battuta
dei nostri e l’imbrunire. Il pubblico più ampio fatica
ad avvicinarsi e il climax amniotico tarda ad avvolgere i fan, ma è una questione di tempo. Basta un layer
di blu e sono in molti, presenti alla data Milanese
di questo inverno, a notare uno scarto di sound e
missaggio: gli Animal Collective, ci si accorge, non
hanno mai suonato così bene, o perlomeno così coesi. Sicuramente è il passo oltre l’indie-genza, verso
un sound più in grande e da grandi, verso la sintesi
e poco male.
Precedentemente, in quattro, puntavano alla jam
proprio come i Black Dice ma, al contrario di
loro (che perlomeno 1 su 2 la magia la creano), fallivano nell’affiatarsi e nel convincere i più attenti.
Erano una studio band e sicuramente l’essere stati
lontani geograficamente per gran parte dell’anno
non li aiutava. Ora abbiamo una maturazione, una
formula rinnovata e, senza il casco di Geologist, la
freakness è una questione interiore.
I tre, con praticamente sole macchine tornano bimbi tra i loop e una cascata di preghiere animal pagane lanciate al cielo. Quest’ultime non hanno più
nulla di infantile e l’aspetto notevole di tutto questo
è il canto: ne esce liberato, una Young Prayer che a
contrasto e sublimazione degli arrangiamenti risalta
in purezza e conduce in un mondo a che fare con
l’House Nation. È un’Ibiza alternative in frangiflutti
quella che si profila all’orizzonte, una chill out 2.0,
ancora fatta di cassa ma stracolma di libertà neofolk, la stessa dei Devendra Banhart e Cocorosie, di una generazione di spiriti uniti dalla ricerca profonda con la natura e incapaci di filtrarla
senza le macchine.
Macchine che, a loro volta, non sono più le arcigne
e cattive testimoni dell’alienazione ma scatole addomesticate e gracchianti, svelate nella loro natura
pre-digitale, amate nella veste anni ‘80. Un grande
set quello degli Animal Collective l’evidenzia che la
strada, d’ora in poi, si batterà in scrittura e un formato canzone.
A proposito di canzoni, Tv On The Radio, i
blackmen digital-punk abbacinati dal soul di Return To
Cookie Mountain convertono il set ai modi più r’n’b
dell’ultimo Dear Science, con risultati tra lo scarso
Gories/Oblivians
H ana B i (R avenna ) 17 luglio
Doppia reunion coi fiocchi per due leggende del
blues-punk fine anni ‘80/inizio ‘90 il cui tour tocca,
con un paio di date estive, anche la nostra penisola, per una volta preparata nel dare il proprio contributo in termini di fan. Da anni infatti i nomi in
questione sono oggetto di culto da parte di appassionati e neofiti, e non a sproposito, considerato il
giro di vite a base di massicce dosi di feedback e
registrazioni lo-fi che i nostri, assieme a poche altre
band (Cheater Slicks e Chrome Cranks su
tutti), seppero dare al garage-punk quasi due lustri
or sono.
Il trio di Detroit, padrino in questo senso di quello di Memphis, parte un po’ in sordina, penalizzato
anche da suoni effettivamente poco incisivi, ma ben
presto risale la china, come dimostra un’energica
versione di Thunderbird ESQ. Mick Collins comincia
a dimenarsi brandendo le Fender che tra le sue mani
di omone nero sembra quasi un giocattolo; Peggy
O’Neill è invece impassibile: seduta dietro la batteria, suona solo timpano e tom munito di cimbalino
senza battere ciglio, da vera Moe Tucker del genere
quale è; la macchina ormai gira a pieno ritmo e chiude col botto nel finale di Ghostrider e Nytroglicerine.
Un cambio palco tra i più rapidi a cui ho assistito
ultimamente non mi permette di avanzare fin dove
vorrei, ma sono comunque in seconda fila per gli
Oblivians che partono subito più carichi, anche grazie ad un pubblico giustamente esagitato. Danno il
meglio in pezzi come Mary Lou, Live The Life e il blues
assassino di Part Of Your Plan, con la voce di Greg che
recensioni
119
si riconferma essere una delle più belle degli ultimi
anni; benché da sempre considerati un gruppo garage, è il blues la vera chiave di volta di questa band.
Ciò nonostante anche vecchi anthem come She’s A
Hole, Jim Cole e Pill Popper pt.1e2 fanno comunque il
loro roboante effetto; unica nota dolente, i tre del
servizio d’ordine che, ottusamente allarmati dalla
foga di alcuni tra i più giovani del pubblico, pensano
bene di occupare metà palco per respingere la gioia
degli astanti e quasi ci scappa la rissa. A metà dello
show Greg passa dietro le pelli e Jack va in prima
linea, ma ormai il concerto è consacrato e tutto
scorre alla grande, bis compresi. Il giorno dopo Gories e Oblivians avrebbero raggiunto i loro alter
ego italiani a Torino, alias Movie Star Junkies e i Two
Bo’s Maniacs (questi ultimi riunitisi per l’imperdibile occasione), quasi a voler nuovamente rimarcare
l’influenza che esercitata dalle suddette band sul panorama garage nostrano.
Andrea Napoli
David Byrne
F errara S otto L e S telle (F errara ) 22 luglio
Un David in gran forma, non c’è che dire. Vestito
completamente di bianco, come i suoi ballerini, briz-
zolato ma asciutto, pronto a far parte delle coreografie con quei passi appena appena spastici che
tutti abbiamo visto nei filmati d’antan, se non endash; per i più fortunati endash; dal vivo quando i
Talking Heads esistevano ancora.
Un David sorridente e consapevole del bagaglio di
musica cui può attingere, ma forse meno attento
nell’evitare che l’ultima sua estetica, l’ultima sua
passione, fagociti tutto il resto. Ci può essere una
volontà dietro a tutto questo, ma non da come mi
è parso di vedere durante il lungo concerto di Ferrara Sotto le Stelle (due ore abbondanti, compresi
quattro bis, secondo un meccanismo francamente
snervante).
Oggi la musica di David ha il gospel dentro di sé,
nelle armonie, nella delicatezza solare, nell’assenza di negatività e nel depennamento dell’elemento
grottesco. Neanche la voce del protagonista ha più
quelle piccole psicosi o micro-epilessie che l’hanno
resa così fondamentale per tutta la new wave. Si
parlerebbe di normalizzazione. E parliamone.
David pesca per la serata da tutto il repertorio, ovviamente partendo dall’ultimo album con Brian
Eno, ma pigliando pure qualche momento di My
Life In The Bush Of Ghosts, risalendo persino a Fear
david byrne
Of Music e a More Songs About Buildings And Food. Il
funk endash; cognato del gospel, quanto meno per
estrazione sociale di partenza endash; scorre nelle
vene di tutti i presenti (batterista e percussionista,
bassista, la sei corde di Byrne, le coriste e i tre corpi
del corpo di ballo), e lo fa con una disinvoltura che
non ci stupisce, dato il curriculum di chi abbiamo
davanti.
Il grande assente della serata è però il poliritmo
etnico che, specie nella prima collaborazione con
Brian e in Fear Of Music, aveva un peso decisivo. Ne
risulta una I Zimbra scoppiettante ma per niente
schizzata e una ricerca etnica passata del tutto in
secondo piano (anche in vecchi brani nati da quelle
attenzioni).
Quel calore una volta tutto tecnologico s’appiattisce sul facile tepore del gospel per la cui passione
in realtà David ha dato dei segnali in tutta la sua
carriera. E lo show lo palesa con una naturalezza
imbarazzante: pensate a Road To Nowhere, singolone di Little Creatures, come ad altri mille pezzi con
voci femminili e corpose, basta un attimo per dare
la connotazione corale. Basta un niente per dar loro
the light of god.
La ciliegina, non me ne vogliate, sono i tre ragazzi
che ballano sul palco (scuola informale New York e
divertimento contagioso), ballerini che fanno pensare a un David organizza show e confeziona prodotti impeccabilmente organizzati (per quanto poco
urlati). Una volta si parlava di “art”, ora di show. E
noi consumatori post scuola di Francoforte, senza
retoriche, consumiamo sapendo di consumare, consapevoli che il grande vecchio non può continuare a
fare lo psycho killer a vita...
Gaspare Caliri
Banshee (The)/UltraviXen/
Albanopower/Hank/Nena/Granpa/
Famelika/Did
T emple R ock \’09 (A grigento ) 4-5 agosto
È tempo di bilanci, per l’agrigentino Temple Rock
Festival, arrivato quest’anno alla sua seconda edizione. La scelta coraggiosa di riunire, in un contesto
estivo per eccellenza - il concerto sulla spiaggia, in
questo caso alla terza spiaggia di S. Leone - una serie
di band indie italiane, in prevalenza provenienti dalla
regione siciliana, si è rivelata certamente vincente.
Bilancio positivo allora, sia per la meritoria organizzazione, che per la vivace scena regionale, che
ha visto in questi due anni l’alternarsi di band da
120
recensioni
segnalare, come nel 2008 gli agrigentini Eimog, e
poi Matildamay, Waines, Il Pan del Diavolo, The Second Grace, Marlowe.
Venendo a quest’edizione, la formula si è attestata
sui 4 gruppi per serata e ha visto la partecipazione di
numeroso pubblico, segno che la scelta abbastanza
eterogenea dei gruppi e il proseguimento dell’esperienza ha creato una base più ampia di ascoltatori.
Gli appassionati di questo genere non sono comunque numerosissimi da queste parti, c’è da dire, ma il
tono delle serate, da festa allargata sulla spiaggia, ha
contribuito a fare il resto.
Piuttosto eterogeneo il cast scelto, che ha visto innanzitutto il blues noise acido dei catanesi UltraviXen, su Wallace Records, che non hanno bisogno
di presentazioni per il pubblico di SA, con un live
energico e compatto, tra echi wave e post punk; poi
i siracusani Albanopower, altra nostra vecchia
conoscenza (vedi We Are Demo #12), che sono
apparsi dal vivo più interessanti e ben amalgamati
che su disco, con un insieme composito tra psych
pop, post rock ed elettronica. Da segnalare anche
gli Hank, da Palermo, con il loro pop wave ironico
cantato in italiano, l’art rock dei teatrali Famelika,
palermitani, già visti al concerto del Primo Maggio,
l’inglesissima wave dei veterani genovesi Banshee.
A chiudere il festival, i ritmi ipnotici e dance dei
torinesi DID che hanno fatto scatenare i presenti,
per poi vedersi chiudere dal service l’amplificazione
a notte inoltrata… Peccato davvero per il mancato prolungamento delle danze. D’altro canto sia i
palermitani Granpa, ancora acerbi che i bergamaschi Nena hanno convinto meno, i secondi dal pop
rock più commerciale, che sono apparsi non molto
in tema con il resto del cast, ancorché dotati di presenza scenica e appeal nei confronti del pubblico.
La speranza per questo festival è quindi che negli
anni possa diventare un punto di riferimento importante per la scena locale e non solo, così come
l’analogo affermato Ypsigrock di Castelbuono
(PA).
Teresa Greco
Robyn Hitchcock
S trade B lu (R avenna ) 14 agosto
Robyn Hitchcock è un ragazzino di cinquantasei
anni che pensa ancora alla musica come a un gioco.
Lo intuisci quando si presenta sul palco con indosso
una camicia dai colori impossibili e un paio di pantaloni viola shocking eccessivi anche per un Mick
Jagger periodo Their Satanic Majesties Request. Te ne
recensioni
121
robyn hitchcock
convinci quando alla fine di una Insanely Jealous tiratissima si lascia scappare un “questa è venuta bene”
quasi fosse un quattordicenne alle prime prove col
suo nuovo gruppo. Ne hai infine la certezza matematica a conclusione di un set che è anche covers
affezionate endash; una A Day In The Life dei Beatles
praticamente improvvisata e una Not Dark Yet di Bob
Dylan chitarra e voce - e non solo brani originali.
Mr. Hitchcock si diverte e noi gliene siamo grati,
anche perché era dal 2003 che non lo vedevamo
on stage. Il tour era quello di un Nextdoorland che ai
tempi celebrava un po’ la rinascita dei Soft Boys e i
compagni di viaggio rispondevano al nome di Kimberley Rew, Morris Windsor e Matthew Seligman.
Questa volta tra i crediti non v’è traccia dei “ragazzi
soffici” e nemmeno dei Venus 3 chiamati a raccolta
sull’ultimo Goodnight Oslo, visto che a dar man forte
al padrone di casa ci sono Jenny Adejayan, Rob
Ellis e Paul Noble. Musicisti dal background
tutt’altro che improvvisato, come ci accorgiamo con
il passare dei minuti grazie a un violoncello nervoso,
un battere preciso dietro ai tamburi e un basso creativo deformato da un perenne sorriso chimico.
Saturday Groovers, Goodnight Oslo, Up To Our Next si
succedono veloci dall’ultimo disco, assieme a qualche estratto dal precedente Olè Taràntula endash;
citiamo a memoria Museum Of Sex e Belltown Ramble - e a materiale solista proveniente dal passato
122
recensioni
remoto. Per una serata surreale oltre le aspettative.
Sotto il palco, infatti, siamo a metà strada tra una
festa di paese e un happening alternativo, con tanto
di audience composta in minima percentuale da fans
e in massima parte da over cinquanta, sessanta e
settanta in vacanza nei dintorni di Riolo Terme.
Alla fine dei giochi rimane una formula musicale capace di invecchiare con grazia pur suonando sempre
uguale a sé stessa. Un po’ come dei Rolling Stones
post Sticky Fingers, insomma, prigionieri di uno stile
negli anni a venire ma non per questo necessariamente poco efficaci. La differenza nel caso di Robyn
Hitchcock la fa la convinzione con cui il diretto interessato interpreta il ruolo di alfiere psichedelico
legato a Bob Dylan, Syd Barrett, Beatles e Byrds che
da sempre lo identifica, oltre a un songwriting che
non mostra cedimenti rilevanti.
Fabrizio Zampighi
Sparkle In Grey/Kula Shaker/
UltraviXen/Rakes (The)/Luminal/Jon
Hopkins/Albanopower
Y psigrock F estival - 13 a edizione C astelbuono (P alermo ) 7-9 agosto
Tolti i Rakes, Hopkins e Kula Shaker, non deludono, grazie a intelligenza strategica, mestiere, appeal intrinseco
della proposta. Il nome da appuntarsi in grande però è
piccolo, e brilla di luce propria: Albanopower.
Ypsigrock Festival tredicesima edizione, Castelbuono,
settanta chilometri da Palermo.
7 agosto. Betty Ford Center da Frosinone, trio
senza basso capeggiato da Lucia “Rehab” Conti, divertitamente incazzata, corpo tatuato col rossetto, portano in giro Poison For You. Grunge quadrato e asciutto (zero assoli di chitarra, forse giusto
uno), tocchi hard e botte noisy, cantato in inglese, un
pezzo dedicato allo squirting (pubblico stranamente poco ringalluzzito dalla cosa). Passatisti, grintosi.
Luminal (come la droga, il libro della Santacroce,
il film), romanideroma, quartetto guidato dai chitarristi Alessandra Perna e Carlo Martinelli,
esordio con Canzoni di tattica e disciplina prodotto
dal Santini dei Disciplinatha. New wave chitarristica consapevole dell’indie, del post, del cantautorato italiano. Il disco non ci ha esaltati, un po’ rigido,
un po’ datato, un po’ retorico, dal vivo va molto
meglio, ottima Transmission dei Joy Division e ottimo quello che è il loro pezzo migliore, Il sonno del
Coyote. La musica una spanna sopra i testi. I londinesi Rakes, con un cantante insopportabile come
solo certi cantanti inglesi, fanno un party’n’roll (punto e basta) che pesca da tutto l’albero genealogico
che ha per radici gli Strokes e per fronde ultime
gli Art Brut. Speravamo fossero meglio su palco
che su disco, e invece no. Ballare fanno ballare (si
scatena a un certo punto un inspiegabile pogo) ma
sono proprio ultraderivativi. Ma poi, fondamentali
nell’economia dei pezzi basso e batteria, e il bassista
combina un casino, sbaglia tutto quello che può sbagliare. Mitico invece il chitarrista sosia di un Austin
Powers nerd e non sporcaccione.
8 agosto. Takoma, duo out-folk sardo, chitarravoce e ukelele-percussioni-tastierine, tipico prodotto indiessimo myspaceano. Vessati da problemi
tecnici, ultimo dei quali la rottura di una chiavetta
della chitarra, arrancano, ingiudicabili. Ma si intuiscono (soprattutto sullo space) idee (fragili ma) carine.
Gli Sparkle In Grey di Matteo Uggeri/Hue,
Milano e dintorni, in questa forma in giro dal 2006,
su disco (A Quiet Place, 2008) interessanti, un
post tanto rarefatto che corteggia l’ambient, una
certa piacevolezza minimal elettronica. Su palco
aprono con un campione vocale tipo-antimafia davvero brutto che ce li fa andare subito in antipatia, e
poi scivolano soporiferi. Peccato. UltraviXen da
Catania: bomba. Va bene che il batterista impugna
le bacchette a metà, va bene che c’è puzza di Jon
Spencer (vedi anche l’uso di uno pseudo-theremin), ma spaccano, poco da fare. Incisivi, giocano su
impatto sonoro e controtempi. Soffre un po’ il cantato in inglese di Alessio “Edy” Grasso. L’album
è su Wallace, ma è ovvio che sono da vedere live.
Jon Hopkins, produttore londinese (magrissimo
come forse solo Martyn) definibile oggi come ambient’n’beats, comincia il suo set in duo col violinista
Davide Rossi. Tre pezzi o quattro e Jon capisce
che la piazza vuole ballare. Congeda il sodale, che
torna per il bis (l’ottimo dittico Vessel/Insides), e si
concentra sul suo repertorio (da Insides, disco ben
fatto ma poco personale e dispersivo) più “duro”
e danzereccio. In ordine, trip-glitch, crunchy noisy
downtempo, bigbeaterie, alla fine anche uptempi
quasi-house. E riprende la piazza, ottimamente. In
sintesi, delude con le cose più sue (che comunque
già di loro non ci fanno impazzire), sorprende con le
cose meno sue. Bravo.
9 agosto. Albanopower da Siracusa, lead vocal il
chitarrista Lorenzo Urciullo (l’unico non siracusano purosangue), per andare di sintesi, eccezionali.
Poprock chitarristico e chitarrismi post, accordini funky e momenti psichedelici, grande cura nella
costruzione dei pezzi, grande lavoro di batteria a
livello di arrangiamento. Cover del classico massiveattackiano Teardrop (più famosa la loro Love Will Tear
Us Apart) e bis natalizio, come nel loro stile crepuscolar-scazzato, White Christmas. Su disco, tra tante
cose sparse a gratis per il web, Maria’s Day per 42
Records. Per chi scrive, il gruppo di questa edizione.
Chiudono i Kula Shaker, e cioè il revival del revivalismo, miracolo o peccato di questi anni Duemila.
I loro due dischi classici sono appunto due classici
anni Novanta, non si discute, suonati bene, frizzanti,
furbi il giusto, eccetera, l’ultimo Strangefolk sa di
mestiere, eccetera, ma tutti questi discorsi dal vivo
scompaiono, e resta solo un concertone ROCK nel
senso più classico.Tolto il batterista che fa due tempi e ci sarebbe da ammazzarlo, resta un Crispian
Mills che scopriamo soprattutto come chitarrista,
impeccabile. Pubblico gasatissimo (applaude anche
il tecnico del suono salito sul palco per provare le
tastiere), inizio con enorme strategico (divistico) ritardo, saccheggiato K (sei o sette pezzi), qualche
inedito dal forthcoming (da due anni) Pilgrim’s
Progress, momenti da rito rock (assolo in crescendo al buio sdraiato sul palco), bis infinito col
matra-fiume Govinda: quando lo fai tanto bene che
non importa quello che fai. Ypsigrock 2009 sette
pieno.
Gabriele Marino
recensioni
123
WE ARE DEMO
#39
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati
dai vostri devoluti redattori di S&A.Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Banshee Nova - Soft As Knives,
Warm As Stone (Autoprodotto,
Luglio 2009)
G enere : electro ambient
Banshee Nova è Marco Cavadenti, o viceversa se
preferite. Uno che per diletto - parole sue - mette assieme un concept album d’esordio basandosi
su un’ipotetica Africa del 2100. Vi immaginate forse
brumose congetture electro, minimalismi post-tribali e atmosferiche derive pseudo prog? Nel caso,
complimenti, ci siete andati vicini: dagli Air sclerotizzati in The Day I Slept In The Water ai Massive
Attack strattonati Autechre e Deep Forest
di Monbasa passando per i ghigni techno-ambient di
Nero Cairo ed il Brian Eno colto da spasmi Future Sound Of London di Johannesburg, si scivola e precipita in un periplo di visioni suadenti e
insidiose.
Più che inventare, occorreva azzeccare il giusto dosaggio tra calligrafie così lontane così vicine: oserei
dire, missione compiuta.(6.9/10)
Stefano Solventi
Caso - Dieci tracce (Autoprodotto,
Settembre 2009)
G enere : folk d ’ autore
Di una cosa, ormai, siamo certi: Vasco Brondi e
il suo alter ego Le luci della centrale elettrica sono
diventati un termine di paragone “scomodo” per
chiunque si cimenti con una canzone d’autore poco
attenta alla forma ma ricca di significati. Anche per
Andrea Casali in arte Caso, che nel secondo
demo della sua storia personale ripercorre il cammino lo-fi, urlato, narrativo, dell’autore di Canzoni
da spiaggia deturpata collezionando dieci scarabocchi per chitarra acustica e voce. La somiglianza
col fratello maggiore talvolta rasenta il plagio, ma lo
spessore c’è e i contenuti musicali sembrano persino superiori.
Anche se asciugare e mettere ordine tra i quaderni
ci pare un imperativo categorico. (6.7/10)
Fabrizio Zampighi
124
recensioni
Davide - Self Titled (Autoprodotto,
Settembre 2009)
G enere : elettronica - pop
Semplicemente inclassificabile. Copertina in stile Brian Ferry “piacione”, titoli dei brani rubati
a qualche professionista sanremese in sbornia da
cuore-amore, musica che dici trip-hop ma anche il
Raiz solista, Mango e le “strippate” new age di
Enya. Insomma, tutto e il contrario di tutto. Si rimane come minimo spiazzati di fronte al demo di
Davide Vichi, tanto da non sapere se considerarlo opera degna o sommo castigo per le orecchie.
Alla fine prevale il “buonista” che c’è in noi, visto
e considerato che al secondo e al terzo ascolto la
noia ancora non fa capolino. (6.2/10)
Barbagallo - Floppy Disk (Autoprodotto, Luglio
2009)
G enere : psych rock
Detto dell’eclettico pedigree di questo under 25 siracusano nella recensione del precedente The Ep, veniamo al qui presente debutto
lungo che scompiglia le carte in tavola ispessendo la vena psych nella
quale scorre un estro sempre più denso e frizzantello. Qualcosa che
- in un patetico tentativo di farvi capire - ti aspetteresti da una jam
non propriamente sobria eppure lucida cui partecipassero Damon
Albarn, Syd Barrett, il caro Richard Swift, il smepiterno John
Lennon, lo sfuggente quanto amabile M. Ward e - last but not least - quel bel tipino di Morgan.
Rock acidulo, mollezze blues, pop erratico (vedi soprattutto l’ipnosi agra di Spectacle), fanno di
questo album un carosello “flessibile” e accorato di situazioni freak, fermo restando uno stile che
lambisce l’istrionismo pur obbedendo all’ansia sperimentatrice. Estroso dunque, umbratile, caldo,
febbrile, misteriosamente autorevole: lo diresti il fratello maggiore dei più zuzzurelloni Jennifer
Gentle, spuntato da una piega ignota dello spaziotempo a miracol mostrare. Cos’altro aggiungere... Evviva? (7.2/10)
Stefano Solventi
Fabrizio Zampighi
Fabulous Daddy - Do You Feel A
Wanderer? (Autoprodotto, 2009)
G enere : rockabilly
Rockabilly e dintorni senza troppe pretese. Tanto
più che la macchina del tempo punta direttamente
sull’America anni cinquanta/sessanta richiamando
oltre a un universo musicale ben preciso, immaginari retrodatati fatti di basette, ciuffo impomatato
e decapottabili “customizzate”. Echoes in stile Sun
Records e chitarrine surf fanno il resto, a cesellare
parti vocali concitate e a modellare quelle dodici
battute rubate al blues che costituiscono l’ossatura
di buona parte dei brani in scaletta. (6.4/10)
Fabrizio Zampighi
Nihil Est - Demo (Autoprodotto,
Luglio 2009)
G enere : prog psych
Il sestetto Nihil Est da Milano fa una cosa che potresti scambiare per progressive, con quel lirismo
carico d’enfasi accigliata, ma un attimo dopo somiglia a certa fusion attualizzata che sgomita per tirare in ballo tremori electro come tanto bene riesce
a Thom Yorke e compagni (William’s Macabrecomic Dream). Salvo poi tutto acquietare a passo
Red House Painters (Echoes), anche se c’è sia
il trucco che l’inganno e infatti vai col rinculo verso
l’estro Peter Hammill, che un cerchio chiuso è
pur sempre un cerchio chiuso, no? Insomma, finché
ci si limita all’idioma inglese, tanto tanto, vi dirò, siamo quasi all’ordinario. La diresti più devozione che
ispirazione, ecco. Invece, con Adrian si passa ad un
italiano lattiginoso che diresti colto dal giardinetto
più recondito (e serioso) dei Mariposa, concimato a Bruno Lauzi e Robert Wyatt diciamo, il
tutto benedetto da una fisarmonica e blande palpitazioni sintetiche che ci rimango a penna sospesa,
cullato dal narcotico incanto, se mi consentite. Meglio, molto meglio di un english che ben converrà al
mistero atmosferico ma inevitabilmente va ad inciampare nella pronuncia infeltrita, come è flagrante
nel caso della pur lodevole At Last. Ok, mi sembrava
valesse la pena spendere un consiglio non richiesto,
perché la proposta è meritevole.(6.9/10)
Stefano Solventi
Spread Your Legs - Demo
(Autoprodotto, Giugno 2009)
G enere : indie rock
Dal salento con le idee chiare, questo quartetto sta
sul pezzo solo dal 2007 ma dimostra già un amalgama invidiabile, che sta così bene addosso alle cinque tracce di questo demo d’esordio. Il loro è un
indie rock a presa rapida che ammicca punk wave
danzereccia neanche fossero dei nipotini benedu-
cati di John Lydon, oppure i cuginetti affabili dei
Rapture in ammollo nel torrente emo-tivo ringalluzzito dai recenti copiosi acquazzoni. Lo senti che
stanno nella parte con tutti e due (pardon: otto) i
piedi, sono agili, disinvolti, energici. Buona pure la
pronuncia inglese, che non danneggia così la buona
verve del vocalist. Quindi? Quindi, ok. Tuttavia, originalità è un optional. Sensazione di traino. L’imperativo del farci, anche se quando è fatto bene è ben
fatto. Ma che ve lo dico a fare. (6.3/10)
Stefano Solventi
Vidra - Conti su conti
(Autoprodotto, Settembre 2009)
G enere : pop - elettronica
Tra i Baustelle meno viscerali e la Nada cotonata punk-new wave di Amore disperato. Ovvero
synth e voci femminili che si intrecciano, elettronica elementare (i Kraftwerk della title track), toni
evocativo-autoriali, testi spericolati in bilico tra intellettualismi e autoanalisi. Di questo Conti su conti
piace soprattutto l’impianto musicale, solido benché palesemente derivativo, mentre qualche dubbio
nasce quando si passano in rassegna i significati. Ne
esce un profilo schizoide, in cui si mescolano versi
un po’ da pilota automatico e un po’ da creativo in
erba capace di slanci inaspettati. (6.5/10)
Fabrizio Zampighi
recensioni
125
I
Jesus Lizard
Don’t get me wrong
he’s a nice guy
Ancora pochi istanti prima del loro approdo sul suolo italiano. La parabola del gruppo
d’adozione chicagoana, che non ha saputo resistere ad una nuova - effervescente chiamata alle armi.
126
rearview mirror
- Luca Collepiccolo
l re lucertola che amava dimenarsi in pubblico
e finire bellamente tra le braccia della giustizia.
L’uomo che ancora una volta unisce sacro e profano danzando però spiritato alla ricerca di un qualche confronto diretto. Certo, David Lambeth Yow
non è mai stato un pugilatore, non ha mai impressionato per stazza fisica (come potrebbe ad esempio fare Eugene Robinson degli Oxbow), eppure
arrampicandosi con disinvoltura su qualche amplificatore è anche arrivato a sfondare il tetto di un
celebre locale londinese.
I miei occhi non possono certo testimoniarlo,
ma al Garage, noto club della capitale inglese, andò
proprio così. L’abbraccio della folla è l’estasi in cui
i Jesus Lizard bagnano le proprie esibizioni, proprio come si converrebbe ad una sgangheratissima
formazione post-liceale alle prese con un repertorio hard-rock o hardcore-punk.
A Chicago, i Jesus Lizard fecero la storia del rock
indipendente, siglando un accordo con Touch & Go
e divenendone uno dei gruppi simbolo. La loro musica è nota come loud rock, a loro stessa detta una
miscela infernale di effluvi seventies, riprogrammati
attraverso le esperienze formative del punk (e in
scala minore new wave). Col senno del poi, l’etichetta noise-rock può risultare oltremodo fuorviante.
Qui si parte dall’hard-rock ed è quella la pietra di
paragone, non solo per i Lizard, ma anche per le
numerose invenzioni di Steve Albini (o per la benemerita Amphetamine Reptile di Tom Hazelmyer).
Non sono i pachidermici riff di Ritchie Blackmore
o l’organo di Jon Lord, la musica di questi anti-eroi
degli eighties si fonda semmai sulle frustate di basso
di un John Paul Jones o sullo stomp di sua immensità
John Bonham. Loud rock appunto, è l’hard disossato,
sparato magari a vertiginose velocità – non necessariamente, dato che uno dei pezzi fondanti di questa musica è proprio Dazed And Confused dei Led
Zeppelin - privo di fronzoli (leggere alla voce assoli) e sicuramente ripulito da lustrini e paillettes.
Prima della windy city c’è però Austin, Texas, città
dove era più logico rimpinzarsi di anfetamine e birra piuttosto che attentare allo stato dell’arte. Non
erano dello stesso avviso gli Scratch Acid, in cui
troviamo un imberbe Yow, l’altro futuro Lizard David Wm. Sims (basso, chitarra e piano), il chitarrista
Brett Bradford ed uno dei migliori batteristi rock di
sempre: Rey Washam, che suonerà anche nei Big
Boys e, assieme allo stesso Sims, nei Rapeman di
Steve Albini (ad oggi la forma musicale più alta toccata dall’occhialuto produttore di Chicago). Il beat
primordiale di Washam, una sorta di Keith Moon
della blank generation, sottolinea per tutto il corso
delle operazioni lo stile degli Scratch Acid, profondamente malsano, un boogie & roll ad alto voltaggio
talmente atipico da poter scaturire da una forzata
addizione di Cramps e Birthday Party. Ma è
solo un’ipotesi, o una forzatura se volete.
La voce di Yow è poco più di un rantolo; ancora
non definito, il suo urlo convulso inizia a farsi largo
tra le maglie di un suono melmoso, ma già sufficientemente geometrico. Merito ancora una volta di Washam che presterà i suoi servigi anche ai locali Big
Boys (della serie: te lo do io il punk funk! Il gruppo
di Tim Kerr coverizzava i Kool & the Gang oltre
ad esibirsi in serpentine punk rock al fulmicotone)
in una parabola ascendente di musicista/turnista che
lo porterà addirittura ad esibirsi coi Ministry. Mosche bianche sotto il cocente sole texano – in buona compagnia degli stessi Big Boys e dei dirimpettai
Butthole Surfers (che arrivavano da San Antonio) – gli Scratch Acid ebbero un’esistenza musicale
compresa tra il 1982 ed il 1986. La loro intera discografia è raccolta nell’antologico Greatets Gift,
ovviamente pubblicato da Touch & Go.
Il primo a fare i bagagli con destinazione Chicago è Washam, che una volta giunto a destinazione mette in piedi i Rapeman (uno dei nomi più
confortanti della storia contemporanea...) con Albini, chiamando presto a sé il vecchio compagno di
ventura Sims (che a sua volta si fa accompagnare da
Yow per il viaggio). I Rapeman durano il tempo di un
extended play e di un album: i classici conflitti di ego
minano implacabilmente l’esistenza del gruppo.
Nel 1987, i Jesus Lizard sono realtà. Il terzo elemento è il signorile chitarrista Duane Denison,
proveniente dai Cargo Cult (anche loro texani),
formazione invero imbrigliata in maglie metal, punk
e generic rock. Si parte in trio, con una drum machine di scorta, che il ruolo di batterista è ancora
vacante. L’ep Pure non è che una timida introduzione allo stile del gruppo, un rock dai tratti quasi
industriali che inevitabilmente trova riscontro con
lo stile battagliero dei Big Black (produce Albini,
invogliando più di un paragone in merito). Pur se
immaturi, i 5 pezzi di Pure sembrano il presagio a
qualcosa di ben più tellurico, anche se gli scenari
claustrofobici del disco possono essere letti come
un preludio alle marziali prove in divenire di Head
Of David e Godflesh.
Correva l’anno 1989, di lì a poco il gruppo farà la
cosa giusta reclutando il giovane batterista Mac Mcrearview mirror
127
Neilly. E la musica cambia. Head è la prima pietra
d’angolo del gruppo, ovviamente per l’etichetta di
Corey Rusk, un sunto di quello che verrà. Il decennio si apre così con un stile tagliato chirurgicamente.
Rimpolpata la sezione ritmica, i Lizard prendono il
volo verso la mecca del suono bianco, aprendo i volumi e cimentando una cifra che d’ora in avanti sarà
unicamente la loro. Ogni singolo ingresso, ogni singolo riff porteranno il loro indelebile nome, quasi a
rivedere in una versione spietata e sufficientemente
cyber le dottrine hard-rock. Il pezzo manifesto per
il nuovo mondo che verrà si chiama Killer McHann. È
però nel 1991 che il gruppo dà alle stampe il capolavoro della prima parte di carriera: Goat. Rimbalzando dall’assurda e rocambolesca provincia americana
agli scenari urbani della big city in un mare di equivoci, psicodrammi e malattia liofilizzata, l’universo
di Yow è ancora animato da fantomatiche paranoie.
Pubblicità regresso. Il Fight Club dell’indie-rock. Ma
non sbandieratelo...
È Duane Denison ad uscire prepotentemente
ora, con un chitarrismo sempre ispirato e tagliente, capace di accorpare piccoli arabeschi e intime
rifiniture dark. Uno stile dunque più aperto, che distingue di primo acchito la band di Chicago dalla
masnada di musi duri del noise-rock che si agitano
in sottofondo. L’intelligenza di Duane si misura sia
nei riff a grana grossa – l’anthem Mouth Breather,
uno stomp zeppeliniano a 1000 all’ora – che nella
slide di Nub, rumore di ferraglia per un ballo scellerato. Con Seasick ci risiamo, l’antico sogno nefasto
del re inchiostro si manifesta in chiaroscuri da cinematografia horror. Inquietudine mascherata dall’interpretazione di Yow, tutt’altro che personalità alla
deriva. Spesso ci si interroga su quanto sia sottile
l’arte di questo piccolo gioco al massacro. Di certo,
le sue parole sono più nitide e, rispetto agli esordi,
il timbro meno ingarbugliato; non propriamente un
urlatore, semmai un caratterista destinato al grande
circuito underground. Rodeo In Joliet, ultimo brano
in scaletta, anticipa di gran lunga le supposizioni sul
delittuoso costume del post-rock. La sporcizia del
punk è riciclata in stereofonia progressiva con sussulti dark-wave coreografici. Molti artisti della consorella Quarter Stick sono partiti da qui.
Con Liar, del 1992, è evidente che qualcuno sedutosi appositamente dietro al banco di regia abbia
alzato i volumi. La macchina è più oliata, il suono
ancora più definito, un crunch collettivo che forse
rinuncia a qualche sfumatura di fondo per entrare con prepotenza nelle vostre case. Wall of sound,
128
rearview mirror
senza riserve su quale sia la merce di scambio favorita. L’apertura con Boilermaker mette al tappeto, poi
arriva Rope e la frustata finale con Dancing Naked
Ladies. Puss sarà di lì a poco inclusa nello split single coi Nirvana, dove quest’ultimi tagliano l’inedita Oh, The Guilt. Del resto Cobain stravedeva per la
band di David Yow e non ne ha mai fatto mistero.
Nel 1994, esce il primo disco major del gruppo.
Il profetico titolo Show certo non lascia adito ad
alcun dubbio. Registrato dal vivo presso il CBGB’s
di New York il 19 dicembre del 1993, il disco è un
quadro fedele del tipico assetto live del quartetto.
Una carrellata di 15 brani che pescano con il giusto
equilibrio nella discografia del gruppo anticipandone le mosse successive. Il disco è una co-produzione
Collison Arts/Giant Records, la distribuzione internazionale è curata dalla Warner.
Lo stesso anno, Touch & Go dà alle stampe
Down, l’altra inarrivabile vetta nella forsennata carriera artistica dei nostri. E qui, se il cambiamento
non è radicale, poco ci manca. Duane Denison ha
compiuto un ulteriore passo avanti incorporando elementi decisamente jazzy nel suo stile sublimando così l’avventura in parallelo con Denison
Kimball Trio (in realtà un duo col batterista Jim
Kimball, il cui primo disco Walls In The City è la
colonna sonora di un film indipendente incisa per
l’emergente Skin Graft).
Riascoltando un brano come The Accident - e
notando anche la maldestra evoluzione vocale di
Yow - sembra quasi dipanarsi un duetto tra Tom
Waits e Marc Ribot sull’orlo del precipizio. Anche i brani di più rapida presa come Fly On The Wall
e Queen For A Day trasmettono un’altra vibrazione,
scegliendo geometrie forse più morbide, senza per
questo perdere il colpo d’anca. Le fasi strumentali
di Low Rider puzzano lontano un miglio di western
soundtrack, mentre il vizioso organetto di Horse
odora di malsano sixties sound. Il ventaglio di possibilità sembra infinito, ma le tentazioni sono dietro
l’angolo, e con loro il desiderio - più o meno recondito – di cambiar vita.
All’epoca si parlava ancora di verbal agreement
(la famosa stretta di mano). I Jesus Lizard si separano consensualmente da Touch & Go per accasarsi
presso la Capitol. Ne deriva un disco contraddittorio come Shot (del 1996). Accompagnato da una
preventivabile coda polemica, l’album prodotto da
GGGarth (l’uomo dietro al primo Rage Against
The Machine) è ovviamente più rifinito e sensibile alle tentazioni del circuito alternative rock. I
Lizard, del resto, avevano fatto il ‘salto’, partecipando anche alla recente edizione del Lollapalooza e scrivendo un brano in esclusiva
per la colonna sonora del blockbuster indipendente Clerks.
A posteriori, non un disco da lasciare nel dimenticatoio, eppure
non c’è più nulla di urticante in questa musica. La voce smaniosa di
Yow, così in prima linea, fa quasi impressione. Di buono c’è Good Riddance (ancora la slide di Denison) e Skull Of A German, che nell’incedere pone in essere un paragone con gli Shellac e di conseguenza
con il boogie rock degli Zz Top.
Nel 1997, l’ottimo McNeilly abbandona la scialuppa, additando i
soliti – diplomatici – motivi personali. Dentro il veterano Jim Kimball, che ovviamente trovata l’intesa con Denison in DK3 ha modo
di rispolverare il suo curriculum post-punk, costruito in formazioni
culto come i Laughing Hyenas dell’ex Negative Approach
John Brannon ed i discepoli del più mefitico blues Mule (band del
futuro solista P.W. Long).
Per l’omonimo Ep a venire, c’è un cambio occasionale di etichetta.
La Jetset di New York è pronta a spalancar loro le porte e, per la
prima volta, nel titolo del disco non si scorge una parola di quattro
lettere. Jesus Lizard è un ovvio lavoro di transizione che non offre rigorosi spunti sul futuro indirizzo della band. Semmai è curioso
notare l’alternanza in consolle di tre diversi produttori: l’idolo Andy
Gill (chitarrista dei Gang Of Four), John Cale e addirttura Jim
O’Rourke.
Siamo nel 1998 e nello stesso anno solare esce Blue (ancora
Capitol e il solo Andy Gill in supervisione), un disco senz’anima,
che segna inevitabilmente il passo anticipando lo scioglimento del
gruppo ufficializzato con un ultimo live ad Umea, Svezia, il 27 marzo
del 1999.
Rimane solo il ramamrico di un lento declino per una formazione
che, nei successivi impegni, non riuscirà mai a ricreare il disscarante ed originale approccio al rock più nerboruto. Sono infatti poca
cosa i Tomahawk di Mike Patton (in cui troviamo Denison e l’exHelmet John Stanier alla batteria) ed i californiani Qui (ancora
per Ipecac) in cui sembra sollazzarsi il pur sempre irriverente Yow.
Tenere questo manipolo di bastardi lontani da un palcoscenico è
però un sacrilegio: dopo la reunion degli Scratch Acid per il 25nnale
della Touch & Go tocca agli stessi Lizard, che nell’estate del 2009
torneranno in scena con una serie di apparizioni esclusive nei più
importanti festival europei (l’ormai classico All Tomorrow’s Parties
e l’altrettanto solido Primavera Sound).
Li persi nel loro momento di massimo splendore, ma spesso alle
ragioni del cuore non si comanda. Tant’è che la loro performance
in quel di Barcelona (al Primavera per l’appunto) rimane uno degli
highlight della stagione in rock. La formazione originale è di nuovo
attiva ed il rombo è quello dei giorni migliori. Ci hanno preso il vizio
sapete? Guardate le date, questo settembre sarà anche all’insegna di
questi indomiti loud-rockers.
rearview mirror
129
Ristampe
Bizzy B - Retrospective (Planet Mu
Records, Luglio 2009)
G enere : dark - core
Dopo il 92 l’aria di sconfitta delle generazioni ‘ardkore inglesi ripega sui suoni cupi del cosiddetto
dark-core. Se l’inizio della scene era una cosa da ragazzini smanettoni, il proseguio dark diventa un trip
strafatto di MDMA che avrebbe portato alla jungle.
E Brian ‘Bizzy B’ Johnson è uno di quelli che
hanno creato quel suono. Prima esce su rari vinili
white labelled, poi - dopo la sbornia - finisce anche
lui per accasarsi su Planet Mu dal fido Paradinas. E
per smaltire l’overdose oggi pubblica questa raccolta.
Sarà sull’onda della moda ‘ardkore, sarà che da un
po’ non si sentivano segnali nuovi (a parte le solite copiature), ma queste 14 tracce ci piacciono per
l’ortodossia, la pesantezza e il non compromesso.
Come dire: sentite che cosa ci permettevamo di
ballare e suonare 15 anni fa. Altro che finezze e intellettualismi jungle, qui si va al sodo: vocette in elio,
accelerazioni dei bpm
da panico (Merder Style),
tastieroni laserizzati e
acidificati (Rubadub Syle),
sample da audio televisivo, e tanto trip oscuro:
tutte cose che oggi ritroviamo trasversalmente in
molti dei nuovi fenomeni
(vedi qualsiasi dubstepper, Toddla T o Crookers
di turno).
Una volta avremmo detto seminale. Oggi diciamo
fondamentale. Ovviamente solo per electroheadz.
(7.1/10)
Marco Braggion
Chrome Cranks - The Murder Of
Time (1993-1996) (Bang!, Luglio
2009)
G enere : noise - blues
Quando parte la slide distortissima dell’opener Driving Bad c’è poco da fare. Inutile opporre resistenza.
Si è subito prigionieri di un suono che rispedisce
immediatamente indietro nel tempo e nello spazio:
130
rearview mirror
ad almeno 3 abbondanti lustri fa e ad una città nota
per non dormire mai. Esattamente nel luogo (e nel
momento) in cui la musica del diavolo venne risemantizzata secondo i canoni della lectio rumorosa
figlia della no-wave più deleteria e quindi consona a
quelle latitudini.
I Chrome Cranks furono parte attiva della furia iconoclasta che a NY trovò terreno fertile per manifestare il proprio desiderio di fare scorribande
furibonde e rumorose nel terreno della tradizione:
Surgery, Mule, Honeymoon Killers e soprattutto Pussy Galore (comprese tutte le variabili
impazzite di quella formazione), tanto per fare qualche nome, erano compagni di merende più o meno
stretti dei nostri e su quelle stesse coordinate si
muovono i pezzi qui inclusi.
Non sarà tuttavia questo The Murder Of Time
– buona compila che raccoglie passi sparsi dai tre
album del gruppo + qualche estratto live e/o minore – a far cambiare il giudizio sul quartetto newyorchese o a riaccendere su di loro le (mai accese) luci
della ribalta. Allora verrebbe da chiedersi quale sia il
senso di questo disco. E la risposta è sorprendente:
The Murder Of Time infatti funge da preludio
alla reunion della band, cosa che a questo punto
solletica le nostre fantasie più nascoste lasciandoci
solo la possibilità di aspettare rumorose novità.
(7/10)
Stefano Pifferi
Cluster - Grosses Wasser
(Bureau-b, Giugno 2009)
G enere : kraut rock
Alla luce delle collaborazioni con Michael Rother prima e Brian Eno poi, i Cluster di fine
’70 erano, per così dire, alla terza giovinezza.
Grosses Wasser, il settimo disco della sigla se si includono le due uscite con Eno, vedeva Peter Baumann
- transfuga dai Tangerine Dream - alla produzione. Un lavoro nello stile di Moebius e Roedelius,
fatto cioè di quella melodia stranita figlia delle delicatezze di Zuckerzeit e Sowiesoso (il sinistro
vaudeville di Isodea, la melmosa e ambientale Breitengrad 20, la ninna nanna di Manchmal) e dell’esperienza assieme l’ex Roxy Music (Avanti). Si era
nel 1979, tempi in cui la creatura Cluster, navigata e
titolare di uno stile definito, veniva di pari passo alle
sortite in proprio sia di Roedelius, che esordì come
solista l’anno prima, sia di Moebius, che nel mentre pianificava Rastakraut Pasta con Conny Plank.
Tuttavia, per chi pensasse
ad un dispiego di energie riversato altrove, la
coppia era affiatata nonché capace, in Protese, di
aperture mutant disco
da intimorire qualsivoglia
giovincello di stanza Ze
Records. La title track
- un blob contenente ambient, gamelan e scorie
dell’esperienza Kluster - sanciva l’epilogo.
La ristampa, che rientra nel progetto della Bureau B
di riproporre buona parte del vecchio catalogo Sky,
non ha bonus track.
(7/10)
Gianni Avella
Hans-Joachim Roedelius - Durch
Die Wüste (Bureau-b, Luglio 2009)
G enere : kraut rock
Le sortite fuori dai confini Cluster di Hans Joachim Roedelius, esibivano, di contro al collega
Moebius, una scrittura che dal gruppo madre prendeva poco se non nulla.
Durch Die Wüste è datato 1979. Ad affiancare il Nostro c’è l’onnipresente Conny Plank. L’inizio non è
dei migliori, anzi: Am Rockzipfel è un rock dozzinale,
con chitarra elettrica tediosa e un suono privo di sostanza. Il registro cambia radicalmente nella traccia
successiva. Durch Die Wüste propone ambientazioni
sci-fi e vecchie memorie Kluster, come una versione
meno caustica di Conrad Schnitzler. Johanneslust e
Glaubersalz suonano così romantiche e progressive che sembrano acetati Genesis. Non il massimo.
La posta si rivitalizza nel finale con l’orientaleggiante Mr. Livingstone e la percussiva Regenmacher, che
ascoltata oggi la si potrebbe considerare preludio
alle strategie dei Gala Drop.
Un debutto discutibile. Una ristampa dispensabile.
(5.5/10)
Gianni Avella
Large Professor (The) - The LP
(Autoprodotto, Settembre 2009)
G enere : HIP-HOP
Will Mitchell aka The Large Professor è stato tra i membri fondatori dei rispettatissimi Main
Source, ha prodotto tanti big e artisti di culto
(Erik B. & Rakim, Busta Rhymes, A Tribe
Called Quest, Prince Po, Mobb Depp), ma
è rimasto famoso per aver scoperto il talento di
Nas. Coscia e culo con gente come Dj Premiere e Pete Rock, nel gotha dei produttori, è stato
sempre abbastanza defilato. E sfortunato.
Questo The LP infatti è il suo esordio da solista
registrato nel ‘95, pronto per essere stampato l’anno successivo dalla Geffen, ma arriva solo adesso alla
pubblicazione ufficiale (già a luglio su vinile, su cd da
settembre, per la sua Paul Sea Productions), dopo anni
di circolazione come bootleg, poi come bootleg autorizzato, infine come promo, ormai un piccolo classico carbonaro. Il Professore ha pubblicato intanto
altri due album e due raccolte di strumentali, ma
questo sembra essere il suo parto migliore, intriso di uno stilismo classicista che lo avvicina ai suoi
amici Premiere e Rock, magari senza certe genialate
del primo o l’eleganza del secondo, ma con quello
stesso amore artigianale per l’HH inteso come incisiva semplicità e culto della base. Le produzioni, tutte sue tranne due (cinque i pezzi in più rispetto ai
vari boot in circolazione), e così pure i rappati, sono
allora straclassiche, da materiali funk soul, asciutte
e compatte, tastiere scure, batteria secca, basso e
scratch, qualche fiato (vedi quelli grassamente funk
di Amaman, uno dei pezzi migliori). Nas ospite su
One Plus One. Un disco piacevolissimo (con almeno
metà dei pezzi ottimi), e una fotografia di un passato, come dire, faraway so close, che ancora fa scuola
e ancora non suona datato.
(7.1/10)
Gabriele Marino
Mr. Scruff - Keep It Unreal - 10th
Anniversary Edition (Ninja Tune,
Agosto 2009)
G enere : ristampa lounge bbreak hop
Il tempo passa ed è ora di storicizzare pure la Ninja.
Con questo doppio disco (uno il vero e unico, l’altro le solite B-sides e outtakes) si celebra il compleanno di Mr. Scruff, matador della Ninja e DJ che
contribuisce tutt’oggi a diffondere il verbo londinese del downtempo infarcito di hip-hop. Nel 1999
l’avevamo magari preso sottogamba, dato che c’era
un mondo in subbuglio che sfornava quelle sonorità
a ritmo di catena di montaggio (vedi Funky Porcini e Coldcut tra gli altri campioncini). In questo 09 ci accorgiamo invece che la sapiente
arte di fare dell’hip-hop una cosa da ascolto casalinrearview mirror
131
go a prescindere dal floor, non è stata poi così peregrina. Il ripescaggio oggi più che mai di quei suoni
analogici senza le voci da gangstaz lo dimostra e
probabilmente si continuerà a battere il chiodo ancora per un po’, dato che l’atmosfera è ancora calda. Bbreak quindi mescolato a vibrafoni jazz (Spandex Man), swing anni 40 per Nicola Conte (Get
A Move On), downtempo cool e sciccoso (Midnight
Feast), uptempo un po’ ragga un po’ soul (Honeydew
che chiama Sade) e la bella collaborazione con il
giovane (a quel tempo) Roots Manuva (Jus Jus).
Per chi non ha mai sentito il suono UK, per chi non
ha mai sentito parlare di Ninja Tune, per chi cerca
quello che tanto tempo fa chiamavamo nu-jazz, per
molti ma non per tutti, quasi obbligatorio.
(7.9/10)
Marco Braggion
Nisennenmondai - Destination
Tokyo (Smalltown Supersound,
Luglio 2009)
G enere : kraut - noise - rock
Finalmente arriva da noi anche Destination Tokyo, primo album delle Nisennenmondai ma,
fuori dal Giappone, di fatto seconda uscita dopo la
crasi di doppio eppì Neji/Tori. Anche in questo
caso, dell’uscita dal Sol Levante della creatura dei
tre scriccioli giapponesi se ne occupa la Smalltown
Supersound.
Per chi conosce già l’album, dunque, niente di nuovo.
Ma un gran piacere a risentire questo orologio metronimico che pulsa krautrock come se quel cuore
non conoscesse altro sangue. Ciò che il trio femminile riesce a creare come pochi altri sono ipnosi
percussive che risucchiano linfa dai Neu! quanto
dai This Heat (a cui, in tempi diversi, le Nisennenmondai hanno intitolato un brano, ma in una dedica
astratta e trasfigurata. La sostanza di Destination
Tokyo è composta da macchine morbide fatte di
motorik appena più veloci del solito che non finiscono mai; di paranoico procedere verso l’infinito;
di strumentazione rock e di metamorfosi Chrome-iane. Lenti cambiamenti su strutture che paiono sempre uguali. Perfetti per una guida in stato di
ebbrezza che cerca solo di focalizzare un pensiero.
Una storia vecchia come il cucco ma che ci esalta
quando ci ricorda i più recenti Oneida – quelli di
Each One Teach One, ovviamente, ma anche del
nuovissimo e meraviglioso Rated O.
Ciò che ci stupisce degli Oneida riassumendo con
l’accetta è il saper rifare senza copiare dei dogmi,
132
rearview mirror
quasi degli standard protratti oltre ogni previsione; la personalità di saper trascinare una struttura,
in una parola. Le Nisennenmondai seguono questa
strada, anche se, facendo zoom out, niente ci vieta
di considerarle l’ennesimo esempio della capacità
dei giapponesi di guardare a Occidente e riprodurre
con un tocco personale quello che vedono.
(7.3/10)
Gaspare Caliri
Spacemen 3 - Sound Of Confusion
(Fire Records, Luglio 2009)
G enere : psichedelia
Fu l’album con cui gli uomini dello spazio fecero la
loro comparsa sulla Terra. Un inizio banale come a
distanza di vent’anni può sembrare la loro formula,
magmatico marasma di chitarre-feedback-purezza
psichedelica che anela a uno sballo definitivo, benché ben riscaldato al fuoco dei classici del caso.
Eppure si può andare qualche riga più in là. Rianalizzare il motivo per cui di sette brani ben tre sono
cover (la mitica Rollercoaster dei 13th Floor Elevators, Mary Anne di Glen Campbell – sic! – e
Little Doll degli Stooges). Riuscire ad uscire dal circolo vizioso della teoria che sostiene la pochezza
di idee che stava dietro al suono Spacemen 3.
Iniziare a tirare le somme per capire l’entità – nella
sua fase aurorale - di uno dei progetti che in questi
mesi abbiamo più citato.
Sound Of Confusion è il primo capitolo, da cui
bisogna passare necessariamente, per pervenire alla
maturità Spacemen 3. In un certo senso è il disco
della tradizione, il più pachidermico del lotto Spacemen. Lo psych qui è palpabile e puzza del sudore
MC5 e Seeds. Epperò l’effetto ottico – incomprensibile negli Ottanta - era di prendere quella musica
vecchia e rallentarla ancor di più. Toglierla dal fuoco,
per quanto poco già in origine fosse dai confini netti. Il suono della confusione è condizione di possibilità
perché sgorghi la ricetta perfetta. Insomma, Sound
Of Confusion mette in chiaro i propri debiti ma
trasfigurandoli; e come fase uno del decollo espleta
il compito di rallentare il garage rock psichedelico
texano per rasentare il punto dell’incorporeo cui si
arriverà dopo. Ma prima bisogna dichiarare da dove
si proviene, e cosa si vuol fare diventare quel materiale alterato per menti alterate.
O.D. Catastrophe è il punto più alto di questa propulsione psichedelica, che lavora sul contrasto tra
lentezza/ripetitività del suono e velocizzazione del
battito cardiaco. Qui i feedback rasentano la satu-
highlight
Daniel Johnston - Continued Story + Hi, How Are you / Yip/Jump
Music / Welcome To My World (Feraltone, Agosto 2009)
G enere : low - fi songwriting
Un malinteso sta a monte dell’Arte di Daniel Johnston: che sia il solito “pazzo” vittima del rock
come ve ne sono - per fortuna: ma il punto non è questo - stati a decine. Che la sua eccentricità
sia il lasciapassare per mondi remoti che possiamo intravedere e lui, viceversa, conosce a menadito. Certo, c’è anche questo e, ovviamente, la relativa radice in un’esistenza drammatica e sofferta,
ma da sole non bastano a spiegare la tenerezza commovente di Canzoni che, se cantate da qualcuno più intonato, sarebbero hit milionarie del più fulgido e arguto pop di ogni epoca.
Così non è, purtroppo, e ci dobbiamo “accontentare” di una fugace apparizione su MTV nel 1986
e di attestati di stima (il solito, acutissimo Kurt Cobain; Mark Linkous, Tom Waits, gli Yo
La Tengo e decine d’altri; le innumerevoli cover e i dischi tributo succedutesi negli anni). Di tutti
quei tasselli, insomma, che compongono un quadro di culto per eccellenza e troveranno in eterno
spazio nelle nostre anime per lasciarci confusi e felici. A riprova della stima giungono dalla britannica Feraltone fresche ristampe digitali (ci pensò già a fine Ottanta la Homestead: si aggiungono il
remastering e una confezione sciccosa con note e testi) di Continued Story, Hi, How Are You
e Yip/Jump Music, editi originariamente solo su nastro lungo il biennio ‘83/’85 e incisi da Daniel
nello scantinato di casa su un registratore a cassette. Materiale che i fan
del periodo più “maturo” riterranno ostico e scontroso all’eccesso; o
forse no, altrimenti perché possiedono ancora Artistic Vice o Fear
Yourself? Tra tastiere giocattolo e percussioni altrettanto, chitarre
scordate e fedeltà sì ma solo alla melodia memorabile, sono molto più
che i primi passi di un Genio e la via indicata al low-fi di Sebadoh e
Smog (contenuti in tutto e per tutto dentro le The Dead Dog Laughing
In The Cloud e Ghost Of Your Love eseguite con i Texas Instruments).
Sono forzieri di brani splendidi e immensi, capaci di ragionare in modo
disarmante sui propri miti (The Beatles, Lennon Song, Casper The Friendly
Ghost, King Kong) e offrire una speranzosa via di fuga (Rocket Ship, Speeding Motorcycle, I Am A Baby
In My Universe); di esibire lucidità come una seduta psicanalitica mai potrà (Story Of An Artist, Sorry
Entertainer) e pronunciarsi - con una poetica penetrante e realistica da far male - circa i massimi
sistemi (God, I Live For Love, It’s Over). Sempre e comunque nei confini (in)finiti di una forma canzone
pura che canticchierai in men che non si dica, in barba alle stonature e alla cosiddetta “normalità”. E
a che ti serve, quest’ultima, se hai dalla tua Museum Of Love e True Love Will Find You In The End? I neofiti e/o temerari scelgano magari Welcome To My World, raccolta che saggia e agile compendia
i primi tempi del Nostro fino al 1990. Sappiano costoro che tutte le sue uscite ritraggono un Dan
lucido poiché inafferrabile e obliquo; che ti scruta da dietro quel sorriso amarognolo e scava dentro
con la maestria dei Grandi. Il desiderio di approfondire e procurarsi il resto della discografia non
tarderà, laddove gli esperti hanno capito che un Uomo capace di scrivere versi come “seppelliscimi
nel tuo cuore e là io rimarrò, senza cadere in decadenza” non può essere folle. È uno di noi, e la fatica
e il disagio che provi ad ascoltarlo stanno tutte nell’ammettere l’evidenza.
(8/10)
Giancarlo Turra
razione. Ed erano anni quelli in cui i Jesus And
Mary Chain avevano secondo alcuni sguardi miopi abusato della tecnica, al punto che chiunque pro-
ponesse simili abrasioni sonore andasse considerato
un seguito di quell’esperienza. Tale possibilità sembra assurda oggi, ma ci testimonia una cosa: la totale
rearview mirror
133
incapacità della metà degli Ottanta di accogliere una
musica a tal punto fuori dal tempo; e, ciononostante,
diremmo oggi, così lungimirante…
(7/10)
Gaspare Caliri
Spinal Tap - Back From The Dead
(The Label Industry, Giugno 2009)
G enere : arena - rock parody
Gli Spinal Tap (grafia bizzarra e irriproducibile,
con la “i” senza puntino e l’umlaut sulla “n”) sono
stati consacrati da This Is Spinal Tap, 1984, mockumentary che presentava proprio le gesta di questa fake-band inglese (in giro già da qualche anno e
composta in realtà da caratteristi-musicisti americani), parodia dello stardom e della mitologia rock. Musica: hard melodico come base e poi puntatine blues,
country-folk, metal, AOR, ballads. Il primo disco pubblicato era proprio la colonna sonora del film, ed era
un esperimento riuscito, anche per l’effetto sorpresa,
con la band entrata subito nell’immaginario USA, tanto da finire in un cameo dei Simpson. Per celebrare
il venticinquennale, esce adesso questo Back From
The Dead, prodotto ibrido CD+DVD. Nel primo,
19 tracce: gli undici pezzi dell’esordio risuonati
(in maniera impeccabile
e con un sound più robusto e definito), due di
questi opportunamente
riarrangiati (Sex Farm girata funky e Flower People reggae), più cinque inediti
(carini, particolarmente l’accappella di Celtic Blues, ma
non aggiungono nulla) e un ripescaggio dal film, mai
finito su disco, titolo Jazz Oddyssey, qui divisa in tre
movimenti (e strizzatina d’occhio alla fusion). Nel secondo, un video di un’ora circa con commento dei
musicisti traccia per traccia. Il tutto incartato in un
packaging meravigliosamente pacchiano, una sorta di
digipack pop-up/diorama. Ospiti di lusso (strategia
questa inaugurata col secondo, poco ispirato, Break
Like The Wind, 1992): il bravissimo Gregg Bissonette alla batteria, e poi Steve Vai, Keith Emerson e Phil Collen dei Def Leppard. Divertimento.
E molto meglio di certe reunion che sono parodie
(auto-) senza volerlo essere.
(6.8/10)
Gabriele Marino
134
rearview mirror
Tom Tom Club - Self Titled + Close
to the Bone (Island, Maggio 2009)
G enere : funk / new wave
Il recente approdo di David Byrne in Italia, per il concerto conclusivo di Ferrara Sotto le Stelle, rende la
ristampa del primo disco a nome Tom Tom Club
un po’ più sul pezzo. Non per altro: per il fatto che
di certo la reunion dell’altra faccia dei maturi (attempati) Talking Heads è passata in Europa (a Benicassim) senza avere la risonanza del leader. La storia
è nota; già dal 1980, mentre David giocava con Brian,
Tina (Weymouth) e Chris (Franz), la coppietta delle teste parlanti, iniziarono un progetto più leggero
rispetto alla via ben più complessa che stava intraprendendo il gruppo maggiore. L’album d’esordio
conteneva almeno una manciata di tracce che si ricordano anche oggi; i primi quattro brani sono infatti
tutti noti e canticchiabili da chi ha bazzicato le scene
funk della new wave: l’iniziale Wordy Rappinghood su
tutti, Genius Of Love, Tom Tom Theme ma anche L’Elephant, pezzo che sarebbe potuto essere una hit contenuta nelle raccolte Ze. E infatti qui sta il meglio e il
peggio; c’è un suadente funk screziato che odora di
Mutant, ma in ritardo sui tempi del groviglio newyorkese di quegli anni. E quindi si torna a quegli ambienti
onestamente un po’ stanchi, che però sono capaci di
inquadrare canzoni e di renderle impagabili momenti
di lasciva serenità. Uno svacco rilassato, ammiccante,
un po’ chill-out che ci ricorda i nostrani – cioè europei – Allez Allez, che però sembravano meno
un prodotto in provetta. Dimenticavamo che l’uscita
con cui – insieme ad altre - la Island ha festeggiato i
cinquant’anni non riguarda il solo Self Titled di Tina e
Chris; all’esordio, nel secondo CD di questo Deluxe,
è accompagnata la ristampa – per la prima volta su
CD – di Close to the Bone, secondo album sotto
la sigla Tom Tom Club. Il discorso rimane lo stesso, se
non fosse per alcune note positive che si assottigliano ancor più…
(6.6/10)
Gaspare Caliri
Turtles (The) - Save The Turtles.
The Turtles Greatest Hits (FloEdCo,
Aprile 2009)
G enere : P op - R ock ‘60
La storia dei Turtles, band californiana nata alle
soglie della British Invasion, nel bel mezzo della
moda del surf, è legata ad un lustro (il secondo degli
anni ’60) così importante per la storia della popular
music, da risultare ancora un punto di riferimento
stilistico. La nascita vera e propria del termine rock,
la stagione creativa dei Beatles, l’esplosione della controcultura e della psichedelia, la Woodstock
Nation, la svolta “progressiva” (per non parlare dei
cambiamenti sociali e politici che richiama la parola
Sessantotto): dovunque si peschi, in quegli anni, ci si
imbatte in cambiamenti epocali. In questi anni a dir poco “rivoluzionari” i Turtles,
pur non figurando mai come pionieri, sono riusciti
a lasciare la loro impronta ben visibile, non fosse altro che per aver soffiato il primo posto in classifica
a Penny Lane dei Beatles, con il loro più grande successo di sempre, Happy Together. Una gratificazione
concessa a pochi e della quale poter essere soddisfatti: un evento che da solo può cambiarti la vita. Nata con il nome di Crossfires, la band di Howard
Kaylan e Mark Volman, dopo una breve parentesi
surf, esordì con il nuovo nome sulla scia del successo del folk-rock dei Byrds. Non è un caso che
il primo successo del gruppo sia un brano di Bob
Dylan, It Ain’t me Babe. Ma i Turtles avevano un’attitudine poco votata alla politica e alla protesta sociale
e abbandonarono presto il territorio del folk-rock
per spostarsi verso il pop raffinato e orchestrale
dei tardi Beach Boys, cui è legato il loro stile più
riconoscibile. Il tentativo di inseguire i cambiamenti
repentini quanto radicali dell’epoca, spinse i Turtles
a tentare anche la via del concept album, divenuto, a
partire dal ’68, un modello di riferimento: ne nacque
un progetto interessante, The Turtles Presents
The Battle Of The Bands. Un album in cui la
band veste i panni di undici gruppi diversi, provando
anche ad imitare se stessa, nel brano Elenore (divenuto famoso in Italia nella traduzione interpretata
da Gianni Morandi, Scende La Pioggia).
L’uscita di questa raccolta, che contiene anche un
inedita (anche se poco significativa) Chevrolet Camaro Commercial, non è solo un’occasione, per chi non
lo avesse già fatto, di riscoprire una band un po’
sottovalutata, ma anche di contribuire alla raccolta
fondi da destinare al Turtle Hospital, una struttura
ospedaliera votata alla salvaguardia delle tartarughe
marine in Florida! Sembrerebbe uno scherzo, ma è
proprio così..
(7/10)
Daniele Follero
Wolfgang Riechmann - Wunderbar
(Bureau-b, Agosto 2009)
G enere : kraut rock
Storia spiacevole. Tragica. Wolfgang Riech-
mann, prime mover del rock teutonico, fonda nel
1965 gli Spirits Of Sound insieme a Michael Rother
e Wolfgang Fluer. Un sodalizio durato sei anni che
non porterà a nulla di concreto, tanto che nel 1971
ognuno prese la propria strada: Rother, dopo l’apprendistato in seno ai Kraftwerk, darà vita ai Neu!
d’accordo con Klaus Dinger, mentre Fluer raggiungerà gli stessi Hütter e Schneider nella stesura di
Autobahn. Riechmann, da par suo, dopo il transito
nei misconosciuti Phönix entrerà nei Streetmark
contribuendo alla realizzazione, nel 1977, di Eileen poi noto anche come Wolfgang Riechmann
and Streetmark e Dreams.
Frattanto, di pari passo all’impegno con gli Streetmark, Riechmann pianifica il debutto solista che
vedrà la luce nel 1978.
Licenziato sempre dalla
Sky, Wunderbar, purtroppo, uscirà postumo
poiché a tre settimane
dal rilascio ufficiale, il suo
autore, forse per sedare
una rissa o trovandosi malauguratamente nel posto
sbagliato al momento sbagliato, sarà vittima di un
balordo ubriaco che lo accoltellerà mortalmente
al torace. Sulla front cover, un istantanea in mezzo
busto del Nostro: sguardo austero, capelli sul grigiastro all’indietro, cravattino sottile e rossetto a
richiamare la chioma, camicia nera. Immagine simil
Kraftwerk - ai tempi fuori con The Man Machine - ma colori meno “pop”. Più cyborg-fantasma
(profetico…) che uomo macchina.
Cifra stilistica chiaramente kosmische, declinata secondo l’etica Klaus Schulze (Abendlicht, Weltweit)
e pregna di spleen euro (Silberland evoca il buio, dolore e passione dei cieli berlinesi). Un milieu dove il
motorik goliardico dei La Düsseldorf (Himmelblau,
con tanto di cantato a là Dinger) sposa sinistre andature folk mutanti (Wunderbar) per poi abbandonarsi in catarsi post atomiche (Traumzeit).
Un culto che rivive grazie alla Bureau B, che ristampandolo sia in cd che vinile aggiorna la nostra
memoria storica. I semi dei primissimi Human League, Gary Numan e di molta elettronica a venire
crebbero (anche) qui. Note interne a cura di Asmus
Tietchens.
(7/10)
Gianni Avella
rearview mirror
135
(GI)Ant Steps #30
classic album rev
Dexter Gordon
Genesis
Our Man In Paris (Blue note, Settembre 1963)
The Lamb Lies Down On Broadway (Charisma
Records, Novembre 1974)
Gordon il gigante, due metri di stazza al servizio del
sax tenore, forza senza tracotanza e nervosismo al
guinzaglio, un’autorevolezza naturale, da felino metropolitano, sornione eppure guizzante assieme, il
lay back come categoria dell’anima, e comunque lo
spasmo pastoso sempre in agguato. Ovvero: eleganza ombrosa e intensità malandrina. Non c’è virtuosismo che tenga. Perché “Long Tall Dexter” non
era un virtuoso,almeno non in senso birdiano. Non
sgranava cioè gragnole di note frullando formidabile, lirico e adrenalinico, come Parker appunto invece
sì.
Nato losangelino nel ‘23, Gordon ebbe modo di
farsi le ossa con Lionel Hampton, con Louis
Armstrong, con Billy Eckstine. Incrociò - massì - gli ottoni con Bird, ma il suo modello furono
più Coleman Hawkins e soprattutto Lester
Young, che pure declinò in maniera assai diversa dal contemporaneo John Coltrane, perché
diversa la ricerca e gli obiettivi. Quello di Gordon
era uno stare tra le note prendendosi il tempo e
lo spazio, addensandone il senso e il sapore, piegandole al proprio respiro con morbida fermezza.
Teneva conto di sé, spirito e fisico, corpo sonoro
col passo proprio, l’andatura di chi passa nel mondo
lasciando le tracce che deve, che può, che non può
non lasciare.
Se tanta disarmante padronanza il caro Dexter oltre
che alle virtù l’avesse applicata anche ai vizi, forse non
si sarebbe bruciato la piazza come in effetti accadde.
Al punto che, dopo aver sciorinato capolavori a proprio nome targati Blue Note (Doin’ Allright del
‘61 e Go! del ‘62 su tutti), ascoltò di buon grado le
sirene europee, imbarcandosi per un concerto londinese da cui uscì frastornato, tanto copioso, caldo
ed entusiastico fu l’affetto tributatogli dall’ambiente e dal pubblico. Capì che da quell’energia positiva
avrebbe tratto la linfa necessaria per ripartire, per
ricostruirsi malgrado alcool e droga. Si trattenne in
136
rearview mirror
Europa un po’ più del previsto, quindici anni, fino alla
metà dei seventies, facendo perno soprattutto su
Parigi. Dove nel maggio del ‘63 sfornò questo primo
colpo fondamentale, segnale d’orgoglio e amorosa
rivalsa rivolto alla ingrata patria di là dall’oceano,
ché quel “nostro” del titolo sembra pronunciato
dai pezzi in programma, altrettanti standard trainati letteralmente a nuova (più flemmatica) vita dalla
bradicardica prontezza del Nostro.
Tutto frutto del Caso, non crediate, ché la scaletta
avrebbe dovuto mettere in fila degli originali, ma la
defezione del pianista Kenny Drew obbligò ad un
drastico cambio di programma.Al suo posto fu chiamato un altro transfuga dagli States e di lì a non molto (tre anni, causa tubercolosi) dal mondo dei vivi:
il grandissimo Bud Powell, che mise a disposizione
quella calligrafia sfarfallante a pelo d’acqua ponendo
la condizione che si suonassero appunto standard,
e così fu. Un terzo uomo d’America come Kenny
Clarke - classe 1914 da Pittsburgh, tra gli inventori
della batteria be bop - e l’ottimo contrabbassista
francese Pierre Michelot, costituirono la sezione
ritmica puntuale e briosa della situazione.
Ne uscì quindi un disco-prodigio da naufraghi esistenziali che si scaldano al fuoco del talento, così
tanto e bene da sembrare nel pieno delle forze e
guarda un po’ forse è proprio così che stavano le
cose. Nessun timore reverenziale, figuriamoci: prendi A Night In Tunisia e tarpa le ali alla frenesia di Gillespie, oppure smussa il frullare isterico e gioioso di
Parker in Scrapple From The Apple, il risultato è una
metamorfosi audace, impasto tormentato di carne
e sogno, botta di vita sbruffona con la malinconia nel
taschino. Con quel cercarsi dentro che è comunque
un trovare, tipico del jazz gigante.
Stefano Solventi
Giunto alla soglia del giro di boa degli anni ’70, il
progressive rock comincia ad accusare segni di stanchezza. Esaurita la spinta propulsiva dei primi King
Crimson e Gentle Giant, il genere si barda
dietro una coltre di conservatorismo virtuosistico.
Il periodo “classico” sembra già lontano e si fanno
strada le pomposità tastieristiche del Rick Wakeman solista e degli Emerson Lake & Palmer del dopo Trilogy.
Gli anni tra il ’73 e il ’75 rappresentano una sorta
di bivio, dunque, per le band progressive: si tratta
di scegliere con quali strumenti affrontare la decadenza. Sono anni in cui i Genesis, all’apice del loro
successo dopo il notevole consenso raggiunto da
capolavori come Foxtrot e Selling England By
The Pound, si godono i bagni di folla italiani e, finalmente, anche il tanto sospirato riconoscimento
in patria. Tutto sembra andare per il meglio, una telefonata da Hollywood segna l’inizio della fine per la
storica formazione della band britannica.
Allettato dalle richieste del regista William Friedkin (L’Esorcista) che gli aveva proposto di adattare per il cinema il soggetto scelto per il nuovo
album, Gabriel chiede clamorosamente al gruppo
di sospendere le registrazioni del nuovo album per
“prendere una pausa”.
Sappiamo come è finita la storia:,prima di sfiorire e
di sfaldarsi a causa dei dissidi interni, i Genesis riescono a regalare al proprio pubblico l’opera più importante, il colpo di coda finale e decisivo. Un disco
da amare o da odiare, lungo, complesso. Rischioso,
nel suo tentativo di superamento degli stereotipi
del rock progressivo al culmine del suo percorso.
Basato su un soggetto di Peter Gabriel, autore solitario dei testi,The Lamb Lies Down On Broadway è
un concept album dalla trama ben definita, vicina al
modello della Rock Opera. La narrazione del mondo
di Rael, un portoricano che vive a New York, spesso
si distende su atmosfere oniriche e fantastiche che
cozzano con lo svolgimento della storia, donandole
un allucinato senso di mistero.
La musica sottolinea le immagini forti e impressionanti dei testi di Gabriel lasciandosi trasportare dagli incubi del protagonista e mostrando il suo lato
più drammatico e teatrale. Caso eccezionale per i
Genesis dell’epoca, nessun brano dell’album supera
i 7 minuti di durata e si riducono gli episodi musicali
costruiti su strutture ritmiche complesse.
Eppure non si ha l’impressione di avere a che fare
con materiale musicale “facile”. Si tratta soltanto di
un tentativo di spogliare il Progressive rock dai suoi
pesanti orpelli. Il carattere unitario di questo doppio album rende contestuali anche episodi lontani
dal tipico stile dei Genesis come il pop dei singoli
Counting Out Time e The Carpet Crawlers o brani più
sperimentali come The Waiting Room e Silent Sorrow
In Empty Boats. La grandezza di questo disco sta
proprio in questo suo equilibrio, capace di evitare
sia gli eccessivi virtuosismi, sia le cadute di stile nella
volgarità del pop da classifica. Due trappole nelle
quali inciamparono quasi subito i Genesis dopo l’abbandono di Gabriel, avviandosi verso il triste finale
(purtroppo ancora aperto) che tutti conosciamo.
daniele follero
rearview mirror
137
strumenti per il proprio gruppo. Dedica loro prima un cortometraggio: Sex Pistols Number 1,
con materiale d’archivio e interviste televisive. Poi è
l’ora di La grande truffa del rock‘n’roll (The
Great Rock‘n’Roll Swindle, 1980).
Julien Temple
Filmare e abitare la musica
- Giorgio Avezzù
Certamente, i Sex Pistols
La grande truffa del rock ‘n’ roll è un film
mitico, di quelli che vengono più volte citati che visti.
Non è esattamente un documentario, ma un grosso
pasticcio di filmati live, assurde sequenze di finzione, animazioni eccetera. Commissionato dal manager della band Malcolm McLaren, in buona sostanza
smaschera proprio la spregiudicatezza dell’operazione commerciale dei Sex Pistols. McLaren se ne
vanta cinicamente per tutto il film e elenca le dieci
regole fondamentali per truffare lo show-business
musicale. Visto oggi il film può sembrare modesto,
e il fatto che lo spirito demistificatorio tipicamente
punk venga qui indirizzato proprio verso il gruppo
punk per eccellenza confonde un po’ le cose.
In realtà Temple ama i Sex Pistols, e ricorda come
fantastica quell’estate in cui li conobbe per la prima
volta: “Far parte della scena punk era come partecipare alla Rivoluzione Francese”. I Sex Pistols non
erano semplici imbroglioni, non giocavano ad essere
trasgressivi, a “fare” i punk. D’altra parte, a ben guar-
dare, nello stile del film di Temple si può ritrovare
molto dell’irriverenza anarchica di Rotten e soci.
Soprattutto nel carattere eterogeneo e pasticciato
dei materiali assemblati: video, Super8, 16 millimetri,
35 millimetri, sequenze d’animazione – una caratteristica che si potrà trovare anche in altri film del regista. Per non parlare del fatto che in realtà Temple
doveva fare da assistente a Russ Meyer (il regista
sexploitation noto per film con ultramaggiorate) per
un film completamente diverso e su sceneggiatura
di Roger Ebert (critico e sceneggiatore premio Pulitzer), intitolato Who Killed Bambi?. Pare che
un cerbiatto ci abbia lasciato la pelle per davvero.
McLaren interrompe la produzione, e a Russ Meyer
non resta un bel ricordo di Julien Temple: “Io disprezzo Mr. Temple. È un perfido, infido figlio di puttana. Mi
ci sono voluti anni per riprendermi”. La grande truffa
del rock‘n’roll conserva comunque qualcosa del bad
taste che avrebbe dovuto avere Who Killed Bambi?,
non solo negli spezzoni che vennero effettivamente
girati e inseriti, ma anche ad esempio nelle scene
in Brasile in cui compare Ronnie Briggs, l’ideatore
della rapina al treno Glasgow-Londra del ’63 (che
partecipa a qualche registrazione con Steve Jones e Paul Cook), e un uomo in divisa vorrebbe
impersonare il criminale nazista Martin Bormann.
Musica come condizione di abitabilità. Il punto su Julien Temple:
trent’anni di film, documentari e video del regista londinese ossessionato dalla musica, dal punk al pop.
J
ulien Temple è un regista condannato a vedere il proprio nome legato a vita a quello dei Sex
Pistols. È vero, ha diretto tre film su di loro, ma la
sua è una figura più complessa, di cui si può dire di
più. Regista (quasi sempre) indipendente, ha fatto
molti altri film – alcuni dei quali davvero eccezionali
come i recenti Glastonbury (2006) e Il futuro
non è scritto - Joe Strummer (2007) – e ne ha
altri ancora in cantiere. Il suo nome, poi, spicca tra
quelli della prima ondata dei registi di video musicali.
Andiamo con ordine. Temple, classe 1953, è il
maggiore dei figli di una famiglia della middle-class
londinese, gente colta e molto di sinistra che decide
di vivere nelle case popolari. I suoi genitori rifiutano
di acquistare un televisore, perciò da bambino vede
138
la sera della prima
pochi film. Non è infatti la televisione che condiziona i suoi gusti estetici, ma la musica pop degli anni
Sessanta: “se eri un teenager inglese, vedevi il mondo
attraverso la musica pop. Era fonte di grande energia e
di orgoglio. Era tutto quello che avevamo, davvero. Tutto
il resto era solo un suono che scendeva giù per lo scarico: la spettacolare caduta dell’Impero inglese da uno
stato di grazia”.
La musica, non il cinema, è la sua ossessione. Studia architettura al King’s College di Cambridge e
non va spesso al cinema, ma Il disprezzo di JeanLuc Godard e i film di Jean Vigo lo convincono
ad iscriversi alla British National Film School nel ’76.
Ne esce una sorta di guerrilla film-maker che poco
più che ventenne ruba le macchine da presa per filmare i Sex Pistols, così come Steve Jones rubava gli
sex pistols
la sera della prima
139
Julien Temple
E siccome ci tocca, parliamo
subito degli altri film che Temple
gira sui Sex Pistols
A vent’anni esatti di distanza Julien Temple avrebbe avuto modo di dedicare alla band un secondo
lungometraggio, decisamente più tradizionale ma
forse migliore del primo. Sex Pistols – Oscenità e furore (The Filth and the Fury, 2000) rende
sicuramente più giustizia alla band di La grande
truffa del rock‘n’roll. La prospettiva è rovesciata e l’aspetto commerciale e manageriale sul quale
insisteva McLaren qui passa del tutto in secondo
piano. Oscenità e furore, che propriamente è
un documentario, parla infatti del contesto in cui i
Sex Pistols nacquero – nel quale furono inevitabili
e necessari. La Londra della fine degli anni Settanta
riempie lo schermo, con la disoccupazione giovanile, lo squallore cittadino e suburbano, le strade
piene di spazzatura per lo sciopero di netturbini, il
terrorismo dell’IRA, l’incombere dell’era Thatcher.
La mostruosità di Johnny Rotten, che mostra sorprendente lucidità quando viene intervistato (come
John Lydon) da Temple, viene accostata a quella del
Riccardo IIIdi Laurence Olivier (1955), e diverse
140
la sera della prima
scene del vecchio film vengono usate con funzione di contrappunto. Sex Pistols Oscenità e furore
storicizza finalmente il gruppo e evita il mitologismo più vieto: meno ostico di La grande truffa
del rock‘n’roll, è un film che merita di essere visto, almeno per capire la band (è stato pubblicato
quest’anno in edizione DVD + libro da ISBN).
Il terzo e ultimo film sui Sex Pistols è quello
che registra la reunion del 2007 e che si intitola
Therèll Always Be an England (2008). Temple
filma il concerto del 10 novembre alla Brixton Academy londinese. Lo filma e basta – non è che ci
metta molto di suo. Lo spettacolo dei Sex Pistols
inseniliti a trent’anni da Never Mind the Bollocks può intristire abbastanza, ma i punk (tutte le
generazioni) in sala sembrano divertirsi un mondo.
Il classico film “solo per appassionati” che qualcuno
potrebbe trovare penoso. Molto migliori invece gli
altri filmati di contorno a quello del concerto, visibili anche come extra nel DVD di Therèll Always
Be an England (Temple li ha commentati il giugno
scorso al Biografilm Festival di Bologna). The
Knowledge – The Pistols Guide to London e
John Lydon’s Open -Top Bus Ride sono una
bella occasione per vedere i Pistols alle prese con la
propria città. Lydon/Rotten che si improvvisa guida
di un bus turistico scoperto e inveisce contro i passanti e l’orrida, a suo dire, architettura ultramoderna londinese è davvero qualcosa di strepitoso.
Chiuso l’excursus, torniamo all’epoca di La
grande truffa del rock‘n’roll per precisare che
quel film non fu un caso isolato. Il movimento punk
era già stato al cinema: tre anni prima, nel ’77, Derek Jarman aveva girato Jubilee. E Don Letts,
figura cardine della scena punk inglese, nel ’78 assemblava pellicola Super8 per The Punk Rock
Movie. Dell’’80 è Rude Boy (Jack Hazan, David
Mingay), un quasi-documentario sui Clash, e anche
Breaking Glass (Brian Gibson), che per la verità
parla già più di New Wave che di punk. Un filmaccio
tardo e agiografico come Sid & Nancy (Alex Cox,
1986) non va tenuto in considerazione.
Video killed Bambi!
Quelli in cui Temple inizia a girare sono anni particolari, c’è qualcosa nell’aria. Il fermento sociale
e l’eccitazione punk da una parte, e la rivoluzione
elettronica del video dall’altra. Nel Regno Unito le
due cose riescono a trovare un felice punto di saldatura.
I primissimi anni Ottanta sono gli anni in cui il vi-
deo e l’immagine elettronica sconvolgono il mondo
del cinema e gettano nella disperazione generazioni di film-makers ancora affezionati alla pellicola di
celluloide. Registi cinematografici più o meno giovani tentano di fare il punto sull’ennesima crisi della
settima arte – alcuni più ottimisti, altri catastrofisti,
ma tutti sinceramente preoccupati. Per farsi un’idea
della situazione basta dare un’occhiata a Chambre
666 (Wim Wenders, 1982) e ascoltare le risposte
che danno i sedici registi interpellati da Wenders a
proposito del futuro del cinema.
Lo scenario rischia di essere apocalittico e allora c’è chi, tra gli autori, finge dimestichezza con i
nuovi mezzi e azzarda qualche sperimentazione, con
esiti esteticamente e/o economicamente disastrosi:
Il mistero di Oberwald (Michelangelo Antonioni, 1981) viene stroncato dalla critica e Un sogno
lungo un giorno (Francis F. Coppola, 1982) dissangua la casa di produzione Zoetrope.
Negli stessi anni c’è chi, senza troppe sottigliezze
teoriche, semplicemente i video li fa. E i nuovi videomaker, se vogliono sperimentare, lo fanno per trequattro minuti alla volta, con grande sollievo dello
spettatore che può risparmiarsi indigestioni elettroniche di due ore. In Italia passano ancora solo
su “Mister Fantasy” (Rai Uno), ma su MTV i promo
video sfondano velocemente. Se il cinema è malaticcio, questa invece è un’industria subito fiorente, e
presto diventa possibile individuare i nomi di alcuni
dei più promettenti registi di questa nuova forma
audiovisiva: ad esempio David Mallet (David
Bowie Ashes to Ashes), Russel Mulcahy (Duran Duran: Hungry Like the Wolf), Steve Barron
(Michael Jackson: Billie Jean).
Ma nel Regno Unito chi sperimenta l’immagine
elettronica non manca di animarla di una sensibilità
politica, o perlomeno fortemente sociale. L’eredità
degli angry young men di John Osborne e dell’impegnato free cinema inglese di tre decenni prima
viene infatti raccolta e rideclinata in accordo con
le nuove esigenze mediali da personaggi come, ad
esempio, Don Letts o Dave Robinson. L’anglo-jamaicano Letts, già dj del noto club “The Roxy”
e futuro fondatore di Big Audio Dynamite con
Mick Jones dopo lo scioglimento dei Clash, aveva
esordito nel ’78 col lungometraggio The Punk
Rock Movie, ma poi si dedica ai videoclip – soprattutto proprio per i Clash. Robinson è invece il
manager della Stiff Records, nonché regista e produttore di alcuni video dei Madness (Grey Day, Our
House).
In questo scenario si inserisce Julien Temple. Dirige più di un centinaio di videoclip, alcuni dei quali
diventano estremamente popolari, come Do You Really Want To Hurt Me per i Culture Club o Leave
in Silence per i Depeche Mode. Con quest’ultimo
Temple sperimenta pure qualche effetto elettronico,
sebbene non sia un fanatico degli effetti (e nemmeno della musica dei Depeche Mode, pare, stando
alle sue dichiarazioni). Ne dirige alcuni per i Kinks,
che sono uno dei suoi gruppi pop preferiti (i suoi
gusti vanno dal punk al cool jazz), e che ascoltava
sempre da ragazzino. La poetica dei Kinks, con le
sue venature nostalgiche, non è troppo lontana da
quella di Temple. Nel senso che anche l’arte di Temple, così come la musica dei Kinks, ha un carattere
fortemente situato dal punto di vista geografico –
molto inglese, insomma.
Non certo nell’accezione nazionalista, semmai in
senso sociale, Temple intende interrogarsi sul modo
in cui l’Inghilterra può essere abitata e vissuta in
un’epoca ormai ben lontana dai fasti dell’Impero.
Ecco allora che le storie d’amore ambientate nella
periferia londinese dell’immediato dopoguerra e nei
suoi vecchi locali da ballo fanno di Come Dancing
e Don’t Forget to Dance dei video particolarmente
riusciti. E Ray Davies si dimostra pure ottimo attore, tanto che il regista vorrà servirsene in altre
occasioni.
Julien Temple firma video per gli Undertones
(My Perfect Cousin), gli ABC (Poison Arrow), Billy
Idol (Don’t Need a Gun), David Bowie (DayIn Day-Out), i Rolling Stones (Undercover of the
Night), Sade (Smooth Operator), Janet Jackson
(Alright), Tom Petty (Learning to Fly, ma anche Into
the Great Wide Open, con Johnny Depp), Whitney
Houston (I’m Your Baby Tonight), Neil Young
(This Notes for You), i Blur (For Tomorrow), in tempi
più recenti i Babyshambles The Blinding), e innumerevoli altri ancora. This Notes for You per Neil
Young viene curiosamente bandito da MTV – è il
1988 – perché prende in giro le pubblicità del canale
musicale.
Ritorno al cinema, stavolta quasi
sul serio
Fino alla metà degli anni Ottanta Temple si dedica di fatto solo ai videoclip (con qualche parziale
eccezione, come il buon corto di venti minuti Jazzin’ for Blue Jean per il lancio della canzone di
David Bowie, nell’84). Ci crede fermamente, è un
modo per provare qualcosa di nuovo, ma anche per
la sera della prima
141
far soldi. Presto però molti videomaker decidono di
esordire nel cinema. Steve Barron realizza Electric
Dreams (1984), Russel Mulchay gira Razorback
(1984), e allora anche Temple finisce per rimettersi
in spalla la macchina da presa, ma per produzioni più
serie e tradizionali rispetto alla sua prima avventura
dell’’80 con i Sex Pistols. Certo, il video musicale
è divertente e all’avanguardia, ma il cinema è un’altra
cosa: “Mi sento imbarazzato quando la gente mi chiede
cosa faccio: io rispondo videoclip e mi sento… sporco.
Ora voglio fare dei veri film”, confessava nell’’84.
E sceglie il musical. È “la più elevata forma di cinema. Se si riuscisse a girare a Hollywood un musical di
puro entertainment’ con un discorso di tipo politico,
allora verrebbe fuori una cosa stupenda”. Ma per ora
resta in Inghilterra: nell’’86 dirige Absolute Beginners, con David Bowie, Patsy Kensit, Sade,
Ray Davies, e con arrangiamenti musicali di Gil
Evans, nientemeno. È l’adattamento di un romanzo
del ’59 di Colin MacInnes ambientato nella Londra
degli anni Cinquanta, in un’epoca di tensioni razziali e
inquietudini giovanili. L’eredità degli arrabbiati è evidente, mescolata con l’estetica del musical americano di Berkeley e Minnelli.Tecnicamente il film è
infatti molto buono, e il piano-sequenza iniziale è da
antologia, dopo il prologo della voce narrante: “Mi
ricordo quell’estate meravigliosa in cui il miracolo dei
giovani fiorì in tutto il suo splendore. Sembrava un’estate
come un’altra, e invece l’Inghilterra stava cambiando. Le
notti di Soho erano calde e tranquille, le strade piene di
luci e di musica, e non riuscivamo a credere che anche
noi giovani stavamo diventando dei protagonisti. Nessuno sapeva esattamente come, ma dopo tanti anni orrendi di bombe, di attacchi aerei, di lenta ricostruzione,
di rinuncia allo zucchero, alla marmellata, di mancanza
di qualsiasi forma di comunicabilità, di grigiore assoluto
che ormai sembrava irreversibile, all’improvviso la vita
era esplosa con tutti i suoi bei colori, tutto era così giovane e splendido che molta gente stentava a crederci”. Gli
scontri razziali del ’58 a Notting Hill, gli immigrati
di Little Napoli (la zona dei distretti W10 e W11), i
bordelli, i caffè, la musica di Soho, il quartiere del vizio – è chiaro che le rievocazioni angry ammiccano
a tensioni e entusiasmi più recenti, anche punk.
Il progetto di Temple è ambizioso, e piuttosto
costoso per essere il suo primo “vero” film. L’accoglienza di critica e pubblico però è tiepida, per
usare un eufemismo. In breve, la casa di produzione
Goldcrest Films va in rovina.
Ma inaspettatamente il mondo del cinema non
chiede la testa di Temple, anzi, stavolta lo chiama ad142
la sera della prima
the liberty of norton folgate
dirittura negli Stati Uniti. Cioè a Hollywood, cosa
strana per un regista che si direbbe culturalmente
antihollywoodiano: “Laggiù ci sono persone che non
sono esseri umani”, diceva. È la volta di Le ragazze della terra sono facili (Earth Girls Are Easy,
1988): tre alieni pelosi e colorati precipitano in una
piscina della San Fernando Valley. Nel film recitano
Geena Davis, Jim Carrey e Jeff Goldblum, e compare
pure Angelyne, una supermodella da poster senza
alcun talento che nel film “non fa assolutamente nulla,
ma a Hollywood c’è un sacco di gente nella sua posizione”. Continua Temple: “Mi piaceva l’idea di finire in
una cultura che non avevo mai conosciuto e fare un film
su degli alieni che devono sopravvivere in quella cultura.
Mi sembrava parallelo rispetto a quello che poteva capitare a me”. Le ragazze della terra sono facili
è una commedia musicale che, proprio per ironizzare su Hollywood e l’America, condensa una gran
quantità di luoghi comuni narrativi e iconografici e li
patina spudoratamente con un gusto perverso per
l’ultracolorata spazzatura pop. Nel film rimane certo
molto della mentalità da videoclip che Temple crede
stia alla base di una cultura audiovisiva del futuro (il
video di Planet Texas fatto per Kenny Rogers è alla
base di alcune idee del film). Ma si rintraccia anche
l’ispirazione di Frank Tashlin, regista di molte
commedie musicali in Technicolor degli anni ’50 (e
di Jerry Lewis), e si trova forse anche qualche affinità con un regista estremo come John Waters,
per una certa sensibilità quasi trash – Cry-Baby
(John Waters, 1990), ad esempio, è il prodotto di
un’operazione abbastanza simile.
È un gusto che si può rintracciare pure nei video
musicali di Temple (quelli americani soprattutto)
e che forse è più evidente oggi a distanza di anni
che all’epoca. Certo, come videomaker è stato in
parte responsabile della creazione di miti dell’industria culturale e musicale ma, come puntualizza,
ha sempre cercato (anche con le armi del trash) di
“complicare il mito”. L’ha fatto ad esempio in modo
evidente con David Bowie in Jazzin’ for Blue
Jean. L’integrità del regista indipendente e politicizzato è salva.
Nel frattempo Temple, come prevedibile per un
cineasta che non smette mai di flirtare con la musica, si cimenta anche con la trasposizione dell’opera
al cinema, e firma l’episodio “Rigoletto” per il film
collettivo Aria (Robert Altman, Bruce Beresford, Bill Bryden, Jean-Luc Godard, Derek Jarman,
Franc Roddam, Nicolas Roeg, Ken Russell, Charles
Sturridge, Julien Temple, 1987); un buon risultato
vicino al kitsch di Ken Russell e, nuovamente, alle
perversioni di John Waters.
Segue, in pieni anni Novanta, un film che tocca
davvero i vertici del trash più ridicolo (e che quindi rischia di diventare un cult prima o poi): Bullet
(1996), interpretato da Adrien Brody, Tupac Shakur
e Mickey Rourke. Quest’ultimo l’ha pure scritto (e
si sente), cucendosi addosso il personaggio del protagonista. Già sfatto e maciullato allora, ben prima di
The Wrestler. Periferia, droga, violenza, degrado,
crimine, pazzia, fallimento – gli ingredienti ci sarebbero, ed è poi sempre la poetica della marginalità
di Temple – ma il risultato è micidiale. Anche qui si
ritrova una certa tensione tra la crudezza e la sporcizia dei temi toccati e lo stile patinato e colorato
con cui vengono presentati sullo schermo, una tensione che a pensarci bene è una costante di molto
cinema di Temple oltre che di molti suoi videoclip. In
Bullet ha la meglio lo stile leccato, anche se viene
il sospetto che venga usato intenzionalmente con
una funzione straniante – non crediamo nemmeno
per un minuto nella verità della storia e dei personaggi mostrati, sembra un fumettone troppo brutto.
Temple non è Gus Van Sant e, nonostante i due
registi sembrino condividere più di qualche cosa, il
regista di Portland mostra negli stessi anni una finezza sconosciuta a quello londinese.
Qualcosa, di questo contrasto tra i contenuti e la
loro resa stilistica, si incontra nuovamente nel modesto Vigo – Passione per la vita (Vigo: Passion
for Life, 1999), dedicato ovviamente a Jean Vigo,
cineasta amato per quei soli due lungometraggi (e
due corti) che poté girare nei primi anni Trenta. La
morbidezza visiva fa stavolta da contrappunto alla
vita maledetta del regista incompreso, malato di tubercolosi e costretto al sanatorio. La giovinezza, la
trasgressione, l’eredità politica del padre anarchico
fanno del regista (condannato dalla malattia a una
morte prematura a soli 29 anni) il soggetto ideale
per un film di Julien Temple. Quasi un protopunk,
con ben più poesia però.
I film recenti
Con il nuovo secolo arrivano finalmente dei capolavori. Non tanto Pandaemonium (2000), che
è comunque una buona occasione che Temple coglie per mostrare il proprio amore per l’Inghilterra
– è la storia delle “Lyrical Ballads” di Wordsworth e
Coleridge, girata sulle Quantock Hills, nel Somerset.
E nemmeno una cosa abbastanza trascurabile come
il recente Eternity Man (2008), adattamento di
una buona opera da camera composta da Jonathan Mills con libretto di Dorothy Porter (da una
curiosissima storia vera) e ambientata in Australia,
la sera della prima
143
purtroppo però quasi indigeribile sullo schermo.
I capolavori sono ovviamente Glastonbury
(2006) e Il futuro non è scritto - Joe Strummer (Joe Strummer:The Future Is Unwritten, 2007).
Film gemelli, malgrado le apparenze. Glastonbury
mostra quarant’anni di uno dei festival più famosi
e longevi del mondo. È un affresco di quasi mezzo secolo di storia musicale e culturale della Gran
Bretagna, o piuttosto un collage di materiali di vario
formato: video e pellicole di diverse qualità, amatoriali e professionali – il lavoro di montaggio è stato
durissimo e l’effetto del pasticciato mosaico che ne
è uscito è emozionante. Più tradizionale e narrativo,
ma non meno coinvolgente, il documentario dedicato a Joe Strummer, alla sua vita e alla sua musica con
i 101’ers, i Clash, i Mescaleros, raccontate anche
con le parole di amici d’eccezione come Jim Jarmusch, Johnny Depp, Bono, Martin Scorsese,
John Cusack, Matt Dillon, Steve Buscemi, Flea,
Anthony Kiedis.
Un film descrive un fenomeno culturale di massa,
l’altro è il ritratto di un musicista. Ma Il futuro non
è scritto mostra pur sempre un uomo testimone
della propria epoca, un osservatore del proprio pa-
144
la sera della prima
ese. Anzi, qualcosa della dimensione comunitaria del
festival di Glastonbury la si può ritrovare, certo in
scala ben più ridotta, nel piccolo raduno di amici
che ricordano Strummer e strimpellano il passato
intorno al fuoco.
Cinema situato, musica da abitare
La chiave per capire il cinema di Temple sta
da qualche parte qui vicino. “Cineasta punk” è
un’espressione riduttiva e che spiega poco. Va intesa nel senso di “cineasta legato ad una scena”,
ad una cultura (non solo musicale), a dei luoghi e a
un’epoca. Il luogo è il Regno Unito, l’epoca sono i
sessant’anni che vanno dal secondo dopoguerra ad
oggi – va bene, soprattutto gli anni Settanta-Ottanta.
Julien Temple è un regista che ha sentito, magari poi
dando risultati di valore diverso, l’urgenza, la necessità di filmare, di legare con il cemento della musica
un luogo al modo in cui viene vissuto nella storia
dalle persone che lo abitano.
Musica come “condizione di abitabilità”, allora, o
(con le parole di un altro cineasta appassionato di
musica, Wim Wenders) come un modo di esprimere “il diritto di godere di qualcosa”, di qualche luogo
in una certa epoca. E anche la difficoltà ad ottenerlo,
questo diritto. Filmare la musica può essere dunque,
per Temple, il modo per problematizzare l’identità
culturale e l’appartenenza sociale.
L’interesse di Temple per una musica geograficamente “situata” rende immediatamente comprensibile la sua collaborazione col gruppo dei Madness.
Quest’anno ha ripreso un loro concerto-spettacolo
e ne ha fatto un film di un’oretta intitolato, come
l’ultimo album del gruppo, The Liberty of Norton Folgate(2009). È un ciclo di canzoni che parlano di Londra e di orgoglio londinese, e lo spettacolo fonde felicemente alcune suggestioni tradizionali
e popolari come quelle del music-hall e contenuti
contemporanei con una forte componente sociale.
Le riprese del concerto sono spesso inframmezzate da inquadrature girate nelle vie londinesi, e in
alcuni casi il regista proietta sui muri spezzoni dello
stesso film del concerto, in un tentativo fin troppo
esplicito di riappropriazione della città attraverso la
musica.
“Therèll Always Be an England” sembra dire il regista ad ogni film, come la canzone citata nostalgicamente dai Sex Pistols e da Temple nel film omonimo – la famosa canzone patriottica cantata nella sua
versione più celebre da Vera Lynn (e viene in mente il verso altrettanto straziante dei Pink Floyd, un
Temple al biografilm, bologna 2009
gruppo così lontano e così vicino a Rotten e compagnia: “Does anybody here remember Vera Lynn?”).
Si possono insomma ritrovare facilmente tracce
di “inglesità” in un gran numero di film di Temple. I
paesaggi di Pandaemonium, la scenografia e i costumi di alcuni video fatti per i Kinks (più di recente
anche quelli per Love You But You’re Green dei Babyshambles, altro gruppo col mito di Albione), la
toponomastica londinese di Absolute Beginners,
lo sfogo metropolitano di John Lydon’s OpenTop Bus Ride, tutto Glastonbury, la periferia
inglese (urbana ed esistenziale) di tanti suoi film più
o meno punk, la diffidenza verso gli USA di Le ragazze della terra sono facili. Tra parentesi, una
“costante narrativa” delicata e interessante da analizzare nei documentari sui gruppi inglesi – non solo
nei film di Temple – sarebbe proprio quella dell’“invasione britannica” in America. Nei documentari di
Temple vengono descritti gli sbarchi oltreoceano
dei Sex Pistols, dei Clash e dei Dr. Feelgood (il
regista ha mostrato a Bologna, a sorpresa, un bel
rough cut quasi definitivo del suo ultimissimo documentario appunto sul gruppo di Canvey Island: Oil
City Confidential – uscirà quest’anno, stiamoci
attenti).
Il cinema di Temple ci avverte allora di questo:
esistono dei luoghi, dei paesi e delle città (soprattutto), e con la musica le persone si preoccupano di
come abitarli.
Se l’attenzione del regista è sempre stata rivolta
al Regno Unito, egli sa bene però che questo succede in ogni paese. La scena grunge degli anni Novanta
ha trovato un suo regista con Gus Van Sant, e
allora adesso Temple – eccezionalmente in trasferta
– sta preparando un film su Detroit, altra scena
calda degli anni Sessanta-Settanta, città “difficile” e
dalla grande tradizione musicale. Saranno coinvolti
MC5 e Stooges, e forse anche Eminem, pare.
la sera della prima
145
Kobe Doin’ Work
di S pike L ee (USA, 2009)
A Spike Lee piace il basket. E parecchio. Si potrebbe
analizzare la sua intera filmografia utilizzando come
chiave di lettura la metafora offerta dallo sport del
cinque contro cinque, delle ali e delle guardie tiratrici. Se Mars Blackmon/Spike Lee parla di Michael
Jordan e si vanta di possedere le sue scarpe in She’s
Gotta Have It, 1986, Monty Brogan/Edward Norton è detentore di un record meritato sul campo in
25th Hour, 2002. In He Got Game, 1998, tutto il film
è costruito sulla denuncia del sistema puramente
economico di gestione delle rookies nel campionato universitario americano.
Con tali precedenti, la ESPN, emittente televisiva
americana specializzata nelle trasmissioni sportive,
accetta immediatamente la sua proposta, 2008, di
fare ciò che Gordon e Parreno hanno fatto con Zinedine Zidane in Zidane, un portrait du 21e siecle,
2005. Nel documentario franco-islandese, infatti, la
partita di calcio Real Madrid-Villareal del 23 aprile
2005, è raccontata in modo unico: tutte le telecamere sono concentrate su Zidane, non lo perdono
un istante sia quando ha la palla, sia quando è fuori
dell’azione. Il regista americano racconta d’aver visto il documentario a Cannes, l’anno successivo e
di esserne rimasto tanto colpito dal volerne fare un
adattamento al playground del NBA. Oggetto della
sua attenzione: Kobe Bryant.
Nasce così Kobe Doin’ Work, racconto della partita Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs, della
primavera 2008. Bryant, idolo e icona del suo sport
a livello planetario è ripreso da Lee in un modo
squisitamente elegiaco che ne sottolinea il ruolo di
ciarliero leader dentro e fuori dal campo. Sin dal
suo arrivo al Staples Center per la convocazione, il
riscaldamento e la preparazione spirituale, Bryant
è mostrato fare ogni cosa al meglio. Qualora non
bastassero le immagini e il montaggio veloce di Barry Alexander Brown, montatore “ufficiale” di Spike
Lee, a ottenere l’effetto desiderato, ci pensano le
voci over del regista e del campione e la maestosa
colonna sonora a sottolineare costantemente che
Kobe doin’ the right thing.
Come accade sempre con Lee, non si è incerti
sull’opinione del regista al riguardo dell’argomento
narrato. Manicheo, simile a Radio Raheem/Bill Nunn
di Do The Right Thing, 1989, ricorda sempre che
sono odio e amore i due pilastri sui quali tutto si
basa, non lasciando mai disatteso un giudizio. Appare evidente, qui, che il suo amore per Bryant sia
146
la sera della prima
sconfinato e meritevole di una ricompensa. Proprio
così pare il film a chi, europeisticamente amante più
del calcio che del basket, più di Zizou che di Kobe,
vede in questo documentario un divertissement, un
regalo di Spike Lee a Spike Lee prima che a Bryant.
Aldo Romanelli
S.Darko
di C hris F isher (USA, 2009)
S.Darko non è un sequel, è un film tributo. Brutto.
Tutto ora è affidato a una giovane ragazza, Samantha, Daveigh Chase, sorella di Donnie, cresciuta di
ben sette anni dalla misteriosa morte del fratello
e allo sbando nelle badlands americane nelle quali
un ormai stantio viaggio on the road l’ha condotta
muovendo verso la California, in compagnia della più
stereotipica amica possibile, Briana Evigan. Il clima è
quello di un continuo onirismo che sa poco di lisergico e troppo di anacronistico. Non bastasse questo,
va ad aggiungersi all’insieme l’ennesimo impotente
clone di James Dean, posto a turbare un equilibrio
già di per sé irreperibile, con tanto di pacchetto di
sigarette nella manica arrotolata.
Giunte nel paese di Conejo Springs, nello Utah, le
due ragazze scoprono i misteri del luogo - la protagonista che cammina seminuda lungo i binari del
treno all’alba vorrebbe essere Laura Palmer? - e il
mistero che Samantha porta dentro di sé. Quasi
fosse una tara di famiglia, anche lei è narcolettica e
compie, durante il sonno, azioni inspiegabili. A tutto
questo fa da contraltare la figura di Iraq Jack, James
Lafferty, un emarginato soldato tornato dall’ Iraq,
siamo nel 1995, in stato di totale confusione ma illuminato su quanto sia diversa la realtà rispetto a ciò
che credono gli abitanti di Conejo Springs. Necessario è, per lo sceneggiatore, specificare in maniera
molto poco credibile, che si tratta del nipote di Roberta Sparrow, la “nonna morte” di Donnie Darko,
autrice de La filosofia dei viaggi nel tempo, il libro
guida di Donnie, di Samantha e di tutti quelli che,
su internet, vogliono scoprire come si fa a citare
Einstein e Hawkins al cinema. A queste basi instabili si devono aggiungere, inevitabilmente, morti che
tornano, fantasmi guida e corpi celesti che portano
la peste bubbonica.
Tutta la visione è continuamente solleticata da effetti speciali qualitativamente scadenti e narrativamente inutili che rendono questo film un brutto
horror per teenagers. La scelta di un carattere più
orrorifico che fantastico, insieme alla partecipazione di attori giovani e belli presi dalla televisione, il
James Dean è Ed Westwick, preso direttamente da
Gossip Girl, dimostra la dimensione esclusivamente
commerciale di questo prodotto. Costato quattro
milioni di dollari, uno in meno del film di Richard
Kelly, dimostra tutto il cattivo uso che di tale cifra
è fatto e rende il film del 2001 quasi un colossal. Se
Donnie Darko parlava al cuore, a giovani che, ascoltando i Joy Division nelle proprie stanze, credevano
che prima o poi tutto si sarebbe sistemato da solo,
S.Darko parla a chi crede che Facebook ci salverà e
che Britney Spears sia solo una vittima.
Se il sequel cinematografico lavora sulle direttrici
opposte dell’assonanza e della distinzione con il film
che lo precede, il film di Fisher, nelle sale italiane dal
21 agosto, lavora sulla direttrice monodirezionale
del riferimento e della citazione che si tramutano
in sterile copia di un modus operandi altrui. Basandosi esclusivamente sull’assonanza e tralasciando
l’importanza della distinzione, il film si risolve nella
pantomima di un piccolo cult. Nessun elemento rinvenibile nel film suscita il dubbio o la curiosità di voler decifrare i misteri di Donnie: niente di quanto lui
ha lasciato inesplicato è qui chiarito. Il film perde la
possibilità di avvicinare intelligentemente il mistero
ma sceglie solo di replicarlo in brutta copia e all’eccesso, senza una reale motivazione se non quella
economica. La confusione, le false piste e gli indizi
disseminati nella vicenda non riescono a suscitare
altro se non il feticismo della scoperta, il gioco vano
del “cosa si è visto o capito”. Come Donnie Darko
aveva molte spiegazioni possibili e interpretazioni
sostenibili, questo film non ha una via motivata e
forte. Tutto si risolve in un canto stonato e sbilenco
di un verso condiviso e chiaro, di un film che per
molti ha assunto, negli anni, un valore intimo e generazionale allo stesso tempo.
Aldo Romanelli
Transformers 2 – La Vendetta del
Caduto
di M ichael B ay (USA, 2009)
Autobots e Decepticons hanno fatto della Terra il
teatro di una battaglia all’ultimo bullone che ricorda
gli scontri nel fango tra auto tanto in voga in alcune
fiere americane e teutoniche. O meglio potremmo
dire che, visto il gusto quasi autolesionistico che
questi caleidoscopici robot provano nel darsele di
santa ragione, il metro di paragone più azzeccato
sarebbe quello del crashtest o dell’autoscontro da
festa rionale. I personaggi robotici, differentemente dal primo capitolo, si ritagliano un ruolo decila sera della prima
147
samente più importante. Nonostante gli incentivi
sulla rottamazione e le rigide norme in materia di
immigrazione avallate dalle ultime amministrazioni
americane, dopo il messaggio interstellare lanciato
da Optimus Prime e soci alla fine del primo capitolo,
i robot si sono moltiplicati. Anzi, lavorano per una
fantomatica organizzazione al servizio del governo.
Ecco, qui si ferma l’aspetto politico della pellicola, il
resto sarebbero forzature. Come collegare il finale
egiziano alla guerra in Iraq e Afghanistan , il Devastator – gigantesco robot formato dall’unione di più
Decepticon – alla minaccia delle cooperative sovietiche, o parlare di teoria di complotto o del fallimento dell’intelligenza artificiale che sorveglia il mondo
come lo spettro di quella fallace che non è riuscita a
prevenire gli attentati dell’undici settembre.
Michael Bay costruisce una Matrix meno filosofica
e più vicina alla mentalità del Superbowl già usata
in alcune battaglie dal Ridley Scott de Il gladiatore
e vi aggiunge quella miscela di testosterone, machismo e patriottismo che fanno di lui un esperto in
materia di blockbuster estivi. Insomma quelli che
la famiglia tipo del South Dakota può rivedere il 4
luglio davanti ad una grigliata di carne, birra e sala148
la sera della prima
melle pomeridiane. L’impronta del primo episodio
è amplificata: per prima cosa la durata (quasi tre
ore), il montaggio serrato, ralenti che non aspettano
altro che divenire oggetto di culto, per pochi, e di
parodia per i rimanenti, punti di vista così improbabili che se utilizzati nel porno potrebbero aprire nuove frontiere del voyeurismo. Indubbiamente
il livello qualitativo raggiunto dalla ILM (Industrial
Light & Magic) di Lucas e dalla Digital Domain è
altissimo, i movimenti sono di una fluidità mai vista
al cinema, le trasformazioni tanto credibili quanto
compiaciute e fini a se stesse, ma questo non riesce
a supplire una carenza disarmante sul fronte della
sceneggiatura. Non me ne vogliano Ehren Kruger,
Roberto Orci e Alex Kurtzman. Ho sempre immaginato le riunioni di ideazione di Bay e collaboratori
come: «Allora ragazzi ho una storia pazzesca tra le
mani. Immaginatevi questa figa galattica…», «Wow,
e poi?» «Delle esplosioni da tutte le parti, gente in
panico, i nostri ragazzi dei marines, missili, dei meteoriti, bum, fine!»
Le scene di battaglia occupano circa l’80% della pellicola, la sola scena finale un’esasperante ultima ora,
e gli scontri sono all’ordine del giorno in un’azione che immaginariamente dovrebbe compiersi in
48 ore ma che ha più tramonti di un film mélo.
Dall’apertura sorprendente a Shangai al duello nella
foresta tra Optimus Prime e tre Decepticons, citazione ovvia dello scontro tra King Kong e il tirannosauro, il film procede con il classico stile sincopato
ricco di inquadrature in movimento degne del miglior videoclip – fosco quanto patinato passato del
regista - fino ad un finale misticheggiante. È lì che si
capisce che questa volta Bay si prende sul serio. E
sbaglia. Certo non siamo ai livelli quasi imbarazzanti
di Terminator Salvation di McG, ma poco ci manca.
Non bastano le gag comiche dei Gemelli, déjà vu
Reloaded (Andy e Larry Wachowski, 2003), e di alcuni personaggi macchietta come Leo (Ramon Rodriguez), compagno di stanza del college di un Sam
Witwicky (Shia LaBouf) ormai abituatosi all’idea di
salvare il mondo e di avere una ragazza (Megan Fox)
con la piega perfetta anche nel bel mezzo di un apocalisse da officina meccanica. La routine è una brutta cosa. LaBouf sembra essere il primo a non essere
convinto del suo personaggio. Se Peter Parker dopo
il morso di un ragno radioattivo diventa Spiderman,
lui dopo il contatto con la versione 2.0 del cubo di
Rubik si trasforma in un improbabile John McClain.
Megan Fox, oltre a inumidire le labbra e a correre
come una nevrastenica in menopausa, si candida a
pieni voti per la nomination di personaggio più inutile all’interno della storia del cinema, confermando la teoria che vede Bay bravissimo a patinare le
sue attrici – vedi Liv Tyler in Armageddon (1998) o
Kate Beckinsale in Pearl Harbor (2001) - ma meno
nel dar loro spessore. Nemmeno l’istrionico John
Turturro può cambiare le sorti del film, abbassando
alcune pretese. L’unica cosa ad abbassarsi – oltre
alle palpebre e ad altro in alcune sequenze – è il
target cui il film fa riferimento. Eliminate le velleità
filosofiche sul rapporto uomo e tecnologia, restano
le lamiere, restano i Transformers. Se torture e violenze fossero perpetrate ad un corpo umano immaginatevi il putiferio che potrebbe nascere. Ma se ad
essere dilaniati, squartati fino a sanguinare (incredibile ma vero) sono delle lamiere, il problema non
persiste. Dopo Tokio Gore, ecco la versione made
in Detroit e mamma Hasbro ringrazia. Non a caso
poi tra i partner promozionali doveva esserci la General Motors, alla fine impossibilitata dalla crisi. Ma
dal film avrebbe ricevuto un bello spottone, roba di
macchine che cadono dal cielo, sfondano palazzi, ma
i cui passeggeri si salvano grazie agli airbag. E non
stiamo parlando di Hammer.
L’idea finale è che il regista si sia lasciato un po’ prendere la mano dalla citazioni, dalle autocitazioni (da
Bad Boys II ad Armageddon), dalla ridondanza quasi
barocca del suo stile eccessivo. Ma finché a farlo è
Bay poco importa. La cosa sorprendete è che uno
come Steven Spielberg, produttore della pellicola e
da sempre intelligente dosatore di alcuni elementi,
non sia riuscito a sottrargli le casse di Red Bull. Ne
esce un film compiaciuto in cui la vera sconfitta è
una trama ricca di spunti potenziali nemmeno sfruttati come il personaggio di Jetfire o come quella del
Caduto, la cui mitologia si ferma al titolo per poi
esser liquidata in meno di cinque minuti. Per il resto
sarà sicuramente candidato a qualche Oscar. God
bless America.
Luca Colnaghi
la sera della prima
149
i cosiddetti
contemporanei
Merce Cunningham
L’ultima danza di Merce
Lo scorso giugno è scomparso il più grande coreografo del Novecento. Insieme al compagno di una vita John Cage aveva rivoluzionato l’arte della danza nel suo rapporto con
la musica.
Ciò che mi interessa è il movimento.
Non il movimento che si riferisce necessariamente
a qualcos’altro, ma ciò che esso semplicemente è
(Merce Cunningham)
Ha ballato la sua ultima danza con il pensiero. “Nearly Ninety”, quasi novantenne, il padre della danza,
non ancora pago della sua esperienza di artista, anche se costretto su una sedia a rotelle da quando
di anni ne aveva una sessantina, ha voluto dedicare
alla sua veneranda età l’ultima coreografia. Deve
essere difficile, per chi ha consacrato tutta la vita
all’arte del corpo e del suo movimento, non potersi più esprimere come ha sempre fatto. Ma Merce
Cunningham non si è mai arreso al suo destino, provando a trasmettere la sua eredità per mezzo delle
nuove tecnologie informatiche, ideando un software
attraverso il quale poter simulare i movimenti di un
ballerino. Non si era neanche rassegnato alla morte
di John Cage, suo compagno di una vita, la cui
scomparsa, nel 1992, lo aveva lasciato privo di una
150
contemporanei
parte importante di sé, dopo cinquant’anni passati
insieme a stravolgere il senso stesso dell’arte.
Se n’è andato così, in silenzio, come fanno i grandi,
nella notte del 26 luglio. Da due mesi aveva compiuto novant’anni e sapeva che con la sua scomparsa
non sarebbe andata via la sua filosofia sulla danza,
custodita dagli allievi della Merce Cunningham
Dance Company, compagnia da lui stesso fondata nel 1953 e che gli è rimasta fedele fino all’ultimo.
Prima di morire era stato lui stesso ad annunciare
un piano per garantire la sopravvivenza della sua
arte, il Living Legacy Plan, con l’intenzione di lasciare
un progetto concreto per i suoi allievi, affinché il
messaggio che si era da sempre ostinato a portare
avanti, non si perdesse con il ricambio generazionale.
I suoi riconoscimenti (tra i quali spiccano le cariche
di Chevalier e Officeur della Legion d’Honore francais e il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia) non
si contano, segno che anche il mondo accademico,
cosa più unica che rara per un artista radicale come
lui, ha riconosciuto la grandezza delle sue innovazioni.
La danza Mercier ce l’aveva nel sangue. Nato nel
1919 a Centralia, nello Stato di Washington, muove i primi passi come ballerino di tip-tap nella sua
cittadina natale, per poi trasferirsi a Seattle, alla
Cornish School of Arts, dove già dimostra doti di
grande ballerino. La passione per la danza lo spinge
a trasferirsi a New York, nel 1939, al capezzale di
Martha Graham, la più grande danzatrice americana del XX secolo, madre della danza moderna e
sostenitrice del movimento come massima forma
d’espressione. È con lei che Merce compie i primi
passi verso un’autonoma concezione dell’arte della
danza: per cinque anni è solista nella sua compagnia,
la Martha Graham School of Contemporary Dance, con il privilegio di essere tra i primi
uomini, insieme ad Erik Hawkins, ad essere accettati nel gruppo di danzatrici.
Sono gli anni ‘40, un periodo tanto difficile per gli
artisti europei, quanto prolifico per quelli americani.
È proprio negli anni trascorsi a New York presso
la scuola della Graham che Cunningham conosce
quello che sarà il suo compagno di una vita e l’artista più vicino alle sue idee rivoluzionarie: John Cage.
Un sodalizio, quello con il compositore americano,
contemporanei
151
che durerà tutta la vita e sarà interrotto solo dalla
morte di quest’ultimo. È con la sua collaborazione
che prendono forma le coreografie più intraprendenti, soprattutto dopo la fondazione della sua propria compagnia, la Merce Cunningham Dance Company, passo decisivo verso la svolta.
La danza “pura”
Di Cage, Merce Cunningham, oltre allo sguardo pacifico e beato e all’inconfondibile sorriso sincero,
acquisisce l’idea di un’arte slegata da tutti i vincoli
narrativi e imitativi che la avevano condizionata per
secoli, soprattutto in Occidente, esplorando una
nuova dimensione dell’espressività, quanto più possibile legata alla natura. Se in Cage il compositore
scompare, lasciando alla casualità e al suono in sé
la possibilità di esprimersi senza alcun tipo di limitazione, così in Cunningham il soggetto della danza
diviene la danza stessa. Un soggetto che possiede sì
una struttura, ma che non è imposta dal materiale,
bensì legata alla natura e quindi “organica”. Il primo
tentativo di mettere in pratica questa comunanza di
intenti si concretizza nella coreografia The Seasons
(1947). Per far sì che musica e danza esistano indipendentemente l’una dall’altra, Cunningham realizza
le sue coreografie nel silenzio, mentre Cage compone la musica a parte. Ne viene fuori un’opera in cui
le due arti, entrambe legate al tempo, si sviluppano
parallelamente senza mai creare situazioni di dipendenza reciproca, come normalmente succede nel
balletto “classico”, che sottomette i gesti al ritmo
musicale.
A questa concezione di estrema libertà compositiva
si aggiunge preso il fascino per la cultura orientale: l’essenza della filosofia Zen e, in particolare, la
fascinazione per l’I-Ching, il Libro dei Mutamenti,
rappresentano un passo ulteriore verso lo sviluppo delle teorie di Cunningham. L’applicazione, come
in Cage, delle 64 combinazioni degli esagrammi a
movimenti e forme, diviene una tecnica compositiva
fondamentale per le idee aleatorie dei due artisti.
Attraverso un’estrazione, si stabilisce l’ordine delle
sequenze decise in precedenza, allo stesso modo in
cui Cage combina le sue partiture.
“La mia idea è sempre stata quella di esplorare il movimento del corpo umano.”, come ha affermato egli
stesso. “Ho cercato di insegnare a studenti e ballerini la
mia tecnica, ma in un modo che lasciasse spazio all’individualità”. Tutta la sua ricerca si muove attorno ai
concetti di spazio, tempo e immobilità con l’intento
di ripensare la danza, il corpo e la sua relazione con
152
contemporanei
la scena in una prospettiva non comunicativa, priva
di messaggi e di visioni precise della realtà. Nel movimento, considerato in sé stesso, mezzo e messaggio
si sovrappongono. Una separazione tra significante
e significato che si avvicina molto agli esperimenti
aleatori di Cage, così come alla riscoperta dell’essenza materica degli oggetti promossa negli stessi
anni da Robert Rauschenberg, conosciuto nel
‘52 al Black Mountain College in North Carolina,
di cui diverrà presto amico e collaboratore, dando
vita, insieme a lui, al primo happening della storia.
Allo stesso modo, per simili convergenze artistiche,
sia lui che Cage si avvicineranno ad un altro grande artista del Novecento, Marcel Duchamp, in
memoria del quale utilizzeranno una sua opera, Il
Grande Vetro, come scenario per la coreografia di
Walkaround Time (1968).
Dal video al computer: la danza
multimediale
Gli anni Sessanta e Settanta sono decenni di grande
affermazione, riconoscimenti e nuovi orizzonti:un
tour mondiale porta la compagnia in Europa (Occidentale e Orientale), India, Thailandia e Giappone,
mentre sul versante creativo, il coreografo si avvicina al video, realizzando alcuni film sulla danza in collaborazione con registi e video artisti del calibro di
Frank Stella, Andy Warhol, Robert Morris,
Charles Atlas ed Eliot Caplan. Il video stimola
in Cunningham una nuova prospettiva artistica, legata al punto di vista. Traducendo in immagini le sue
teorie sulla molteplicità di centri, permutate dalla
filosofia Zen, i suoi film annullano la centralità della
figura, così come era stato per i danzatori sul palcoscenico, quando, decidendo di illuminare il proscenio a giorno e, dunque, eliminando i riflettori, aveva
escluso qualsiasi elemento di “sottolineatura”.
Quando il suo corpo non può più supportare l’
inesauribile voglia di danzare, Merce è costretto
a smettere di esibirsi, ma non di lavorare. Le sue
idee continuano a vivere nella sua testa e, per altri
trent’anni, fino alla sua scomparsa, il mondo della
danza beneficerà delle sue creazioni. La scoperta
dell’informatica negli anni ‘80, ancora una volta condivisa con il compagno di vita John Cage, diventa un
nuovo orizzonte di scoperta e presto si trasforma in
uno strumento utilissimo a compensare i suoi limiti
fisici. Nel 1986 crea il primo software di notazione
coreografica, Life Forms (ora disponibile sul mercato con il nome Dance Forms), un programma
che gli permette di creare movimenti e coreografie
direttamente al computer e quindi di continuare la
sua attività di maestro, direttore e insegnante, anche
senza l’uso delle gambe.
A lifetime In Dance, una vita nella danza. La
video-biografia prodotta nel 1999 in collaborazione
con il film-maker Charles Atlas non potrebbe avere titolo più significativo e ha quasi il sapore di un
epitaffio. Ma il canto del cigno del padre della danza
d’avanguardia sarà rimandato ancora di dieci anni.
Nearly Ninety è l’ultima delle circa duecento
coreografie che il grande artista ha regalato alla storia. Ai novanta anni Merce è riuscito ad arrivarci. Poi
si è fermato, la sua vita ha deciso che non era il caso
di andare oltre. La sua arte, no.
Daniele Follero
contemporanei
153
www.sentireascoltare.com