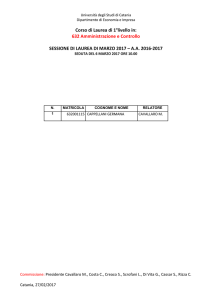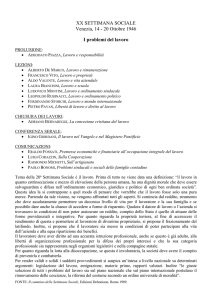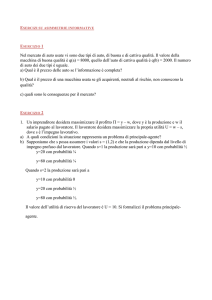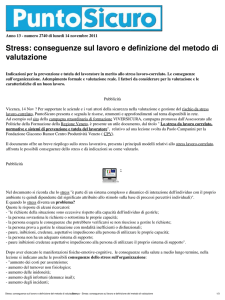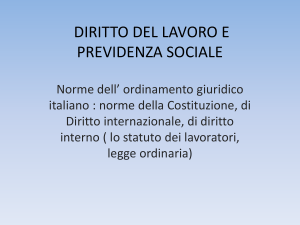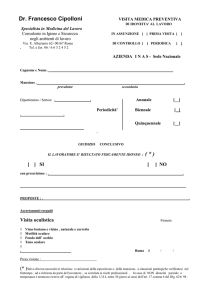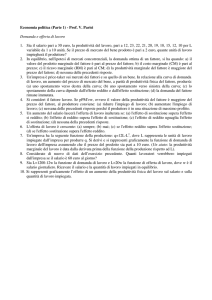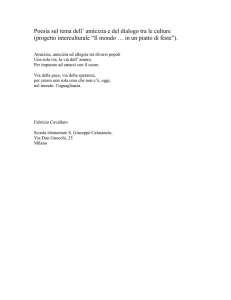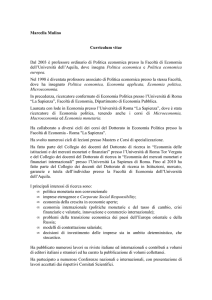Salari e merito
Su Liberazione del 29 novembre Luigi Cavallaro spiega in modo limpido e rigoroso quali siano le
ragioni della sinistra tradizionale per rifiutare l’idea della sinistra liberista secondo cui la retribuzione
debba in qualche misura dipendere dal merito. È un tema focale del dibattito politico da cui
dipendono, tra l’altro, le strategie del Partito Democratico.
Cavallaro è categorico: “Merito e salario non possono essere legati in alcun modo salvo che
accollando al lavoratore il rischio di impresa” a cui egli “è per definizione estraneo”. E questo, oltre
ad essere concretamente impossibile per la non misurabilità del merito, è incompatibile con l’art. 36
della Costituzione secondo cui la retribuzione deve essere “in ogni caso sufficiente” ad assicurare
“un’esistenza libera e dignitosa” al lavoratore e alla sua famiglia. Richiamando Marx, il salario non è
il prezzo del “lavoro” effettivamente erogato, ma della “forza lavoro” intesa come “astratta capacità
umana di erogare energie fisiche e mentali”, assunta uguale per tutti. Quindi il contratto collettivo
nazionale deve esistere per assicurare a ogni lavoratore quella stabilità e quella retribuzione che
soddisfino la seconda parte dell’Art. 36. Anzi, aggiunge Cavallaro, un trattamento contrattuale
uniforme per tutti migliora l’efficienza delle imprese costringendo quelle meno produttive a
ristrutturarsi: Se il salario contrattato non è compatibile con profitti positivi è colpa del “padronato
nullafacente” che non sa gestire e sviluppare tecnologicamente le imprese.
Il ragionamento di Cavallaro, pur nella sua chiarezza, ha due difetti. In primo luogo, confonde il
“dover essere” con l’“essere”. In secondo luogo, dimentica quello che la “teoria economica
dominante”, come lui la chiama, ha prodotto da quando negli anni ’920 ha iniziato a incorporare nei
suoi ragionamenti proprio quelle imperfezioni del mercato e quelle asimmetrie informative che a suo
avviso impediscono nei fatti di commisurare il salario al merito.
Se la produttività di un lavoratore (anche nel senso dell’“astratta capacità” di Cavallaro) fosse una
caratteristica innata che un lavoratore non può modificare con un minore o maggiore impegno, il
ragionamento di Cavallaro sarebbe perfettamente compatibile con “la teoria economica dominante”
perfino nel caso (realistico) in cui questa caratteristica fosse diversa da persona a persona. La
produttività di ciascuno sarebbe, infatti, un dono ricevuto dalla natura “senza merito” per il ricevente.
Dietro il “velo dell’ignoranza” Rawlsiano, una collettività potrebbe benissimo accordarsi per pagare
tutti nello stesso modo, dal momento che nessuno può sapere ex-ante chi sarà bravo e chi no. Ex post,
i più dotati cercherebbero e troverebbero imprese disposte a pagarli di più, ma la Costituzione avrebbe
proprio lo scopo di costringere tutti a non abbandonare ex post il “patto assicurativo” contrattato ex
ante (ossia, di fare in modo che l’“essere” si pieghi al “dover essere”).
Ma è ragionevole assumere che la produttività individuale non possa essere modificata da un
maggiore o minore impegno del lavoratore? Questo è il nocciolo del problema che divide sinistra
tradizionale e sinistra liberista. I tradizionalisti ritengono che le dotazioni innate (immeritate) e il
contesto (ad esempio, l’imprenditore fannullone) siano gli unici fattori che determinano la produttività
individuale effettiva, e che quindi sia non solo eticamente ingiusto, ma anche inutile pagare i
lavoratori in modo diverso perché questo non influirebbe sulla loro produttività. E se così fosse il
mondo concorderei con loro senza esitazioni.
Tuttavia se Cavallaro rifiuta l’equazione “salario = produttività marginale” perché esistono
imperfezioni del mercato, allora le imperfezioni le deve considerare tutte, non solo quelle che fanno
comodo al suo ragionamento! In particolare, deve accettare la possibilità che ciascuno di noi lavori
con maggiore o minore impegno a seconda del vantaggio, comunque definito, che dal nostro lavoro
deriviamo (quello che gli economisti chiamano rischio etico). In questo contesto il modello
economico su cui dovremmo ragionare è quello in cui la produttività del lavoratore dipende non solo
dalle sue caratteristiche innate e da eventi di contesto a lui estranei (tra cui la “nullafacenza” del
padrone), ma anche dall’impegno che il lavoratore decide di esercitare.
La soluzione di questo modello proposta dalla teoria economica prevede un contratto in cui la
retribuzione sia composta da una parte fissa, per assicurare il lavoratore dagli eventi a lui estranei, e
una parte variabile in funzione del prodotto, per incentivare il lavoratore ad esercitare l’impegno
socialmente ottimale. Notate: sembra proprio quanto prescrive l’Art. 36 della Costituzione nelle sue
due parti. Discutiamo pure di quanto sia giusto privilegiare la componente assicurativa e quanto quella
incentivante, ma, come la stessa Costituzione suggerisce, entrambe sono necessarie. Anche perché il
“dover essere” non può prescindere dall’“essere”. Ossia il contratto non solo deve dare gli incentivi
ottimali alle parti, ma deve anche assicurare che le parti abbiamo voglia di partecipare al contratto.
Ma il merito non è misurabile, dice Cavallaro, e anzi secondo la sua intepretazione delle sentenze
della Cassazione, non dobbiamo nemmeno cercare di misurarlo mediante paragoni tra lavoratori. Qui
non seguo più il suo ragionamento, così lucido altrove. Le promozioni o i concorsi pubblici (che gli
economisti analizzano con la teoria dei tornei di Lazear and Rosen, che certo Cavallaro conosce) non
sono forse paragoni tra lavoratori di cui è palesemente lecita, prima ancora che desiderabile,
l’esistenza?
Nulla da eccepire, invece sull’idea che salari più alti costringano i “padroni nullafacenti” a darsi una
mossa o a soccombere. Ma è disposto il sindacato a lasciare che gli imprenditori facciano le loro
libere scelte su come ristrutturare e potenziare le loro imprese, decidendo quindi anche su come e
quanta forza lavoro utilizzare? Ed è disposto a lasciar soccombere le imprese mal gestite? Così deve
essere allora, perché non si possono avere la “botte piena e la moglie ubriaca”.
Andrea Ichino [email protected]
29 novembre 2007