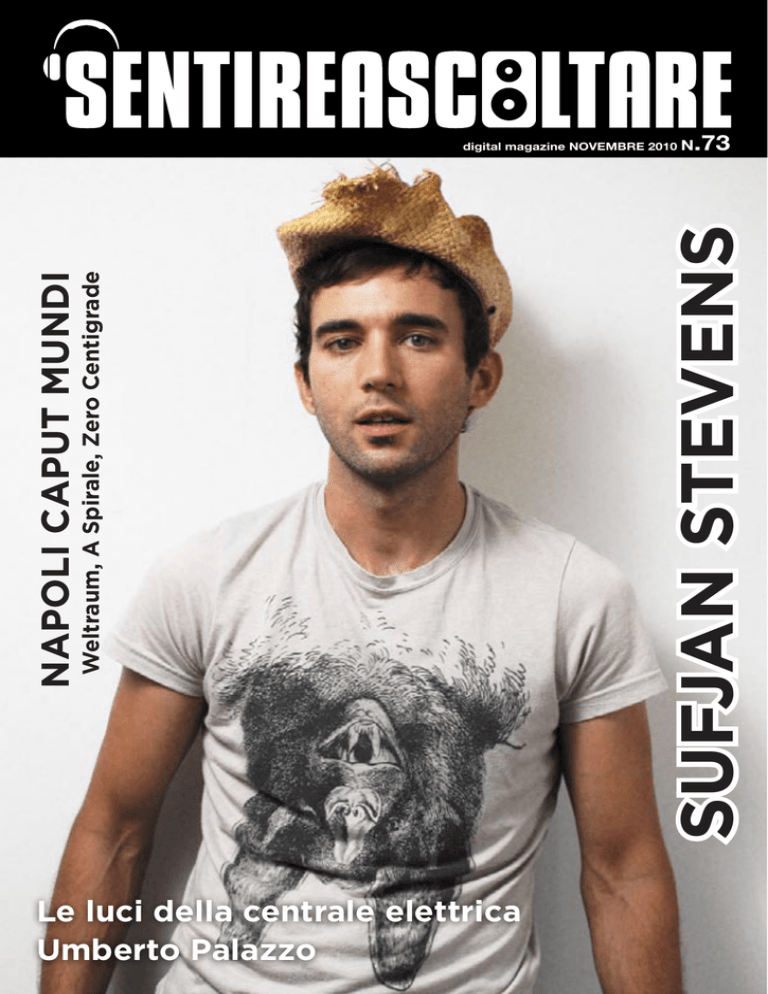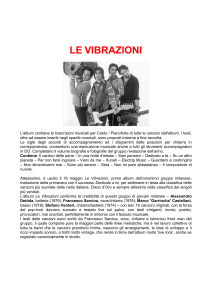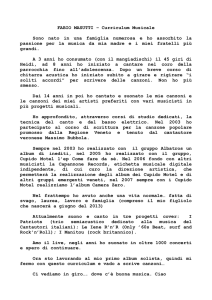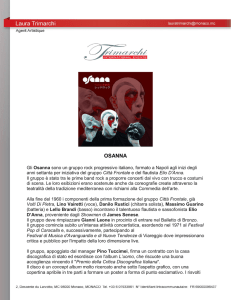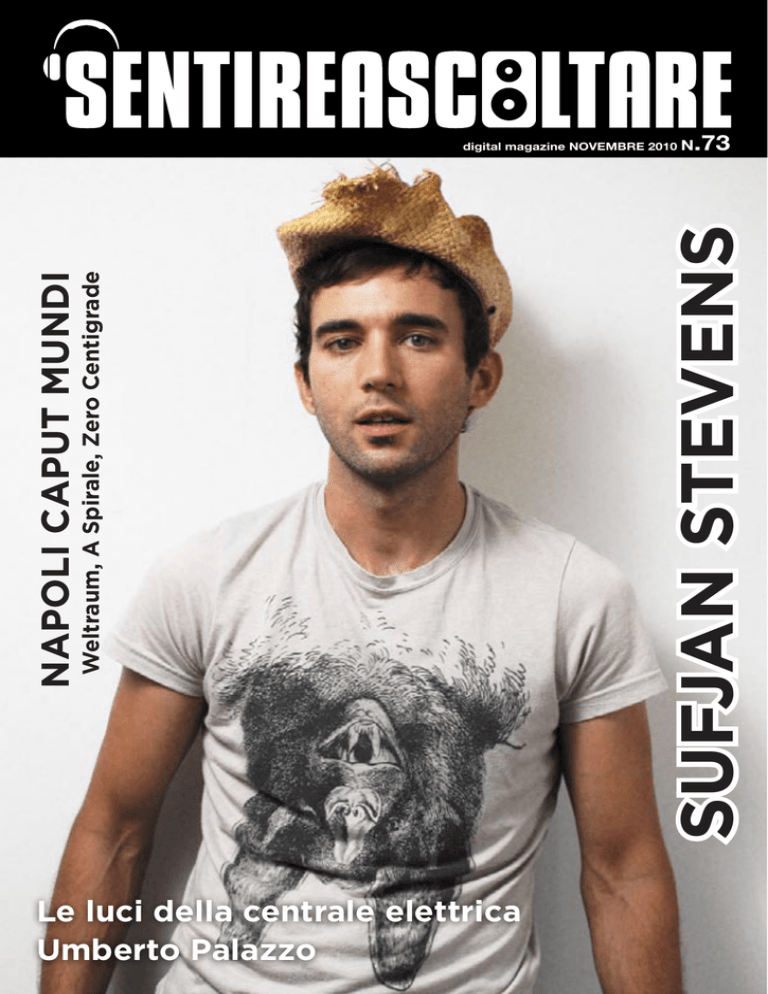
Le luci della centrale elettrica
Umberto Palazzo
N.73
Sufjan Stevens
Weltraum, A Spirale, Zero Centigrade
Napoli Caput Mundi
digital magazine novembre 2010
Turn On
p. 4
Small Black
5
Andreya Triana
6
Kelley Stoltz
8
Phantom Band
Tune IN
p. 10
Le Luci della Centrale Elettrica
14
Umberto Palazzo
18
Deerhunter
Drop Out
22
Sufjan Stevens
32
Napoli Caput Mundi
Recensioni
40
Blind Jesus, Antolini, Dark Star, Onorato, Traoré....
Rearview Mirror
92
The Manhattan Transfer
Rubriche
84
Gimme Some Inches
86
Re-boot
88
China Underground
98
Giant Steps
99
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,
Stefano Solventi, Teresa Greco.
Staff: Stefano Solventi, , Salvatore Borrelli, Diego Ballani, Marco Boscolo, Stefano Pifferi, Filippo Bordignon,
Giancarlo Turra, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca Barachetti, Andrea Napoli, Fabrizio Zampighi,
Marco Braggion
Guida
In
2
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
sufjan stevens
Turn On
Andreya
Triana
Small Black
Turn On
—Nu-Soul Queen—
Esordio promettente su Ninja
Tune per la nuova sensation del
soul UK
—Glo-fi newbies—
L
Arrivano all'album di debutto gli
ultimi affiliati dell'hypna-pop
G
iusto un anno fa pubblicavamo un articolo (Candeggina Pop) che passava in rassegna i nomi
più interessanti della sensazione del momento: il glofi. Dietro l’ etichetta - sempre opinabile – personaggi
come Toro Y Moi, Neon Indian e Washed Out recuperavano gli umori più esotici della wave di fine Ottanta, dai beat delle prima acid house alle suggestioni di
un’Ibiza più immaginata che vissuta.
Della partita (hypnagogica) erano anche gli Small
Black, lasciati in panchina in attesa dei primi risultati.
Di lì a poco quartetto di Brooklyn avrebbe rilasciato un
7 pollici split con il sodale Washed Out - in cui ciascun
act remixava un brano dell’altro – e un singolo di debutto raramente così azzeccato. Nei brevi solchi di Despicable Dogs (trecento copie per l’inglese Trasparent)
due inni glo-pop che, per chi ebbe la fortuna di far propri, non si toglievano più dalla testa. Inutile dire che la
tiratura andò bruciata in pochi mesi, portando i nostri
a includere i brani del 7 pollici anche sull’EP omonimo
4
che a breve avrebbe visto la luce su Cass Club prima (e
Jagjaguwar subito dopo). Peccato che i pezzi del nuovo vinile non vantassero il piglio irresistibile del primo
singolo, lasciando i fan in attesa di un’uscita che gli restituisse le melodie da poco assaporate e già irrinunciabili.
Per questo si è dovuto aspettare New Chain, album
con cui i newyorkesi tornano a sfornare le piccole hit di
pop fuori fuoco che gli sono proprie. Camouflage, Photojurnalist e la title-track dicono di come il sound femmineo ed etereo, spostato sull’asse più smaccatamente indie-rock da Wild Nothing e Beach Fossils, possa
essere ancora appannaggio di gente che alle chitarre
preferisce i synth e i campionamenti. Anche se di tempo ne è passato da Causers Of This e Psychic Chasms
e, si sa, le mode musicali fanno presto ad accusare i segni dell’invecchiamento.
Andrea Napoli
e nuove reginette del blues inglese si fanno introdurre nel gotha da nomi alternativi, che producono con il cuore sapiente dei bluesman più scafati. Cresciuta nell'ambiente artistico di Leeds con la band funk
Bootis, Andreya Triana si fa notare da Flying Lotus alla
Red Bull Music Academy australiana del 2006: da lì nascerà un featuring (Tea Leaf Dancers) pubblicato nell'EP
Reset dello stesso FlyLo. Oggi esce su Ninja Tune con
Lost Where I Belong, album prodotto dall'amico Bonobo, con cui aveva già collaborato nelle parti vocali
di Black Sands. L'incontro “è avvenuto in maniera naturale”, ci dice la giovane e bella cantante di South London “ci siamo conosciuti nel 2006. Lui stava cercando una
cantante. Mi piaceva molto la sua musica e sapevo che
avrebbe voluto collaborare con una persona sola nell'album, non con troppi produttori. Così gli ho chiesto se c'era
spazio per me e lui ha detto di sì. Il resto è venuto da sè”.
Un appoggio totale anche da parte della grande
famiglia Ninja, che quest'anno compie vent'anni, ma
che già nella supercompila riassuntiva dell'anniversario considera Andreya come un piccolo classico: “penso che lavorare con una label indipendente sia eccitante, dato che loro vogliono poprio far emergere il meglio
di me. Mi sento libera a lavorare con loro”. L'etichetta
inglese è la patria delle contaminazioni hop: il mesh
non può che essere anche per Andreya un passaggio
obbligato: è stata infatti recentemente remixata dalla
next big thing del dubstep Mount Kimbie, anche se
non prevede collaborazioni ulteriori su questo versante. Fra le sue coordinate cita ovviamente la soul music, ma ci dice di essere attratta dalla musica che “non
definisce bene i confini. Tipo Jamie Lidell, che è soul, ma
sperimentale ed elettronico. E anche Björk, che mi ha influenzato molto. Questi artisti non si incasellano in una
scatola. Creano, tentano di esprimersi e basta. Dovrebbe
essere così”.
E' bello poi vedere che la ragazza non ha un'educazione formale: “non ho avuto un training musicale e mi
considero un po' dislessica per quanto riguarda la teoria
musicale. Sono sempre stata un po' maniaca della musica, ho passato giorni e giorni a sezionare voci, melodie,
armonie e a sviluppare il mio stile personale”. Una tipa tosta, che ha già in mente numerosi progetti per il futuro:
“Uno è The Dreamscape Soul Session, una collaborazione
live con la mia amica illustratrice Sri McKinnon. Riprenderò le mie sperimentazioni con la voce e Sri disegnerà sul
palco dei grandi dipinti quando canto. L'altro progetto è
una band di rock psichedelico che si chiamerà Annie &
the Duke. Il nostro EP dovrebbe uscire fra qualche mese”.
Buon lavoro Andreya!
Marco Braggion
5
Turn On
Kelley Stoltz
—L'arte del sogno—
Brian Wilson fai-da-te o bricolage
retrofurista? Andata e ritorno nello
scombintato mondo dell’ultimo
folletto pop "made in USA".
C
i sono artisti che piombano sulla scena musicale come fulmini a ciel sereno e la rivoluzionano da capo a fondo, forti di un'ineguagliabile carica innovativa. Ecco, Kelley Stoltz non è uno di questi.
Il trentanovenne del Michigan, trapiantato a New York, è uno di quei songwriters innamorati della bella calligrafia applicata alla pop song, obbiettivo che negli anni ha perseguito con dovizia certosina, in barba alla povertà
dei mezzi a disposizione. Kelley, che abbiamo contattato in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro To Dreamers, è il classico genietto che adora trastullarsi con giocattoli lo-fi e chincaglieria vintage, cosa che gli ha fatto
perfezionare uno stile immediatamente riconoscibile ed estremente personale, dal mood intimamente psichedelico, fatto di suggestioni 60s e rumori della modernità.
"Effettivamente penso che nei miei brani ci sia una particolare sensibilità costruita su riverberi, twang chitarristici,
beat pesanti, suoni di synth… mi piace creare un collage sonoro integrato con il pop dei 60s. Passo molto tempo a lavorare sul feeling di ciascun brano, molto più che sulle liriche delle canzoni. Generalmente la melodia è la prima cosa
6
che prende forma e quando questa è pronta ci do dentro
a manipolare i suoni di ogni strumento".
Stoltz, è uno dei segreti meglio custoditi del panorama indipendente americano: appartiene al roster
della Sub Pop già da qualche anno, anche se pochi
fino ad ora se ne sono accorti. To Dreamers potrebbe essere il "turning point" di una carriera poliedrica,
iniziata come curatore della “fan mail” di Jeff Buckley
e proseguita con la realizzazione di ben otto album,
per lo più suonati, registrati e prodotti in maniera autonoma, e fra i quali spicca una rivisitazione integrale
di Crocodiles degli Echo & The Bunnymen.
"E’ vero. Gli Echo & The Bunnymen sono sempre stata la mia band preferita, sin da quand’ero appena un
ragazzino, ancora prima che iniziassi ad ascoltare David Bowie e Leonard Cohen e che decidessi di mettere in
piedi la mia band. Sono i miei eroi, ho registrato tre dei
loro primi quattro album. Spesso cerco di cantare come
Ian McCulloch o di copiare le linee di chitarra di Will Sergeant, ma ogni volta mi accorgo che il risultato suona
differente da come vorrei. A volte, musicalmente, credo
di esser loro debitore, salvo poi accorgermi che sono altri
interessi che indirizzano il mio stile".
Nella sua bizzarra storia, tuttavia, ci sono elementi
che ne fanno qualcosa di diverso del loser romantico e
spiantato. Questo grazie ad alcuni brani utilizzati per
spot televisivi e come colonne sonore di serie televisive. A tal proposito Kelley chiosa ironico:
"Non ho nessun problema a tal proposito, anzi penso che sia una grande cosa! Mia madre poi si emoziona
quando sente le mie canzoni in TV. A parte gli scherzi,
questa cosa mi ha permesso di guadagnare abbastanza
denaro per dedicarmi a tempo pieno alle mie canzoni.
Ora lavoro per un paio di giorni alla settimana in un negozio di dischi, per il resto posso permettermi di mangiare e dormire grazie ai soldi di quelle pubblicità. Il bello è
che negli spot le mie canzoni si riescono appena a sentire. Trovo incredibile che paghino così tanto per qualcosa
che rimane così nascosto in sottofondo.
Sub Pop, oggi nuova Mecca per ferventi spiriti DIY,
sembra aver riposto in lui illimitata fiducia, dotandolo
dei mezzi necessari per esprimere al meglio quell’aspirazione ad una grandiosità compositiva dal tiro wilsoniano, che si nutre di vecchi espedienti e di nuove
tecnologie. Il risultato è che To Dreamers suona assai
denso e stratificato, a dispetto della leggerezza delle
melodie e dell'emotività frizzante che lo pervade.
"Ci è voluto circa un anno e mezzo dal suo concepimento al risultato finale. Io per lo più registro a casa
mia e suono personalmente tutti gli strumenti, per cui
è naturale che a terminarlo ci abbia impiegato un pò di
tempo. In questo senso non è cambiato molto rispetto
alle mie prime produzioni, a parte il fatto che ora ho a
disposizione microfoni migliori e, in generale, penso che
tutto suoni meglio che in passato. In occasione del nuovo
disco ho anche comprato un Mellotron".
Il vizio del DIY dunque è duro a morire: "Sul disco la
mia band suona solo in due occasioni - "Baby I got news
for you" e "I Like, i like" - le abbiamo suonate dal vivo per
un pò di mesi e ho pensato di far partecipare anche gli
altri alle registrazioni. Mi sembra giusto che anche loro
sentano di avere avuto un ruolo sull’album, in modo che
possano andare in tour e suonare quei brani col cuore,
come se fossero un pò anche loro".
Tuttavia è inevitabile che la resa live dei brani dell’album sia differente rispetto alla loro genesi in studio:
"Certo, è difficile replicare tutti i più piccoli rumori e gli
effetti che si sentono sul disco, mi occorrerebbe un gruppo di 7 o 8 elementi per riprodurre tutte le percussioni e
le armonie vocali. In effetti per me è fonte di frustrazione,
ma non posso certo permettermi di portare tutte quelle
persone con me, così lascio che le canzoni dal vivo prendano la loro strada. Mi sembra che generalmente i brani
suonino più rock e meno sinfonici. Più Highway 61 Revisited che Pet Sounds".
Recentemente Stoltz e la sua band sono stati visti
di supporto ai Raconteurs, cosa che gli ha permesso
di esibirsi di fronte a grandi platee e maturare quel
genere di ambizione che porta songwriter come lui a
confrontarsi con i più grandi.
"È divertente suonare per un gran numero di persone. Cosa ho imparato andando in tour con i Raconteurs?
Credo che mi abbia fatto venir voglia di scrivere canzoni
più ambiziose che possano arrivare a più persone. Penso
che il nuovo album risponda a questa esigenza. Inoltre i
miei set precedenti avevano un po’ troppi mid tempo, ora
ci sono rock song dal ritmo decisamente più sostenuto".
Intanto il tour promozionale è già partito e il calendario dei concerti promette di portarlo in giro per il
mondo.
"Sarò in tour in Europa a novembre. Mi piacerebbe
molto venire a suonare anche in Italia. In passato ci sono
stato con i Dirtbombs, nel 2008, con cui abbiamo realizzato alcuni ottimi show. Ho suonato anche con i Father
Murphy da qualche parte nelle vicinanze di Venezia. E’ lì
che ho conosciuto Marco dei Jennifer Gentle, ottimo ingegnere del suono e incredibile songwriter. Spero proprio
di tornare ad esibirmi nel vostro Paese".
Un auspicio, questo, di cui ci facciamo convinti portavoce.
Diego Ballani
7
Turn On
The
Phantom
Band
—Sono pazzi questi
scozzesi!—
Da quanto aspettavamo un gruppo
che osasse sbatacchiare il passato
dentro a un frullatore di memoria
pop e cavandone qualcosa di fresco
e spontaneo? The Phantom Band, da
Glasgow, per servirvi.
"L
’amicizia in questo gruppo risale all’epoca della scuola. Siamo grandi fan di musica e, in quanto tali, non avevamo interesse alcuno a pubblicare un disco che non ci trovasse soddisfatti.." Così affermava con unanime
e benvenuta modestia la Phantom Band un annetto fa, allorché l’esordio Checkmate Savage vedeva la luce per
Chemikal Underground. Era stata nondimeno lunga per quest’era distratta e frettolosa la loro gavetta, intrapresa
grossomodo un lustro prima in quel di Glasgow da Duncan Marquiss e Greg Sinclair (chitarra), la sezione ritmica
di Gerry Hart (basso) più Damien Tonner (batteria), il tastierista Andy Wake (tastiere, ultimo ad aggregarsi in
ordine di tempo) e il cantante Rick Anthony. Ognuno “trenta-e-qualcosa” con lavori cui badare alla faccia degli
sbarbatelli da cameretta con velleità arty, forti del disincanto cinico ma umoristico che si ha a quell’età. Quando
puoi ancora giocarti delle carte ma un po’ di vita e di musica le hai masticate; quando ragioni prima di aprire bocca
e, nello specifico, di scrivere canzoni. Si potrebbe partire anche da qui per provare a spiegare i motivi che stanno
alla base di The Wants, replica datata 2010 che ci ha stregato; da come un disco buttato lì dentro una copertina
banalmente low-fi (l’unico suo difetto…) ci abbia scombussolato nei primi ascolti e sia cresciuto man mano alla
8
luce dei suoi pregi. Che sono un raro senso sincretico,
una tela sonora dettagliata, il mostrare i propri modelli
smontati e ricomposti in qualcosa d’altro.
Sarebbero però i diretti interessati per primi a buttarla non troppo sul serio, seppur astenendosi dalla
caciara e prendendo seriamente quel che merita. Un
atteggiamento evidente sin dai primi anni di esistenza spesi a cambiare nome senza sosta (NRA, Les Crazy
Boyz, Tower Of Girls, Wooden Trees, Robert Redford,
Robert Louis Stevenson: “Se non riuscivamo a tirare fuori un nome decente, dicevamo a quelli del locale di scrivere quel che gli pareva sul cartellone”.) e lasciarsi dietro
un CD-R andato a ruba e una Crocodile ripescata nel
debutto. Nel frattempo ecco la scelta di affidarsi all’attuale ragione sociale, a sottolineare l’assenza di protagonismo in un Regno Unito costantemente pronto a
inventarsi sensazioni presto dimenticate e prono sotto vacuità sensazionaliste. Piace pensare che chiamarsi “il gruppo fantasma” indichi un volersi liberare del
contorno per focalizzare l’attenzione sulla musica. E,
magari, sul gusto per il tagliente nonsense dadaista comune nella cultura d’oltremanica (Monty Phython e
Bonzo Dog Band, Television Personalities e gli stessi Beatles), che emerge da concerti in maschera (assecondando l’atavico senso di ritualità pagana che in
Albione è retaggi e che ripropongono nell’approccio
percussivo al ritmo) o dove si issa sul paco un’attrezzatura da body building invitando il pubblico a usarla.
Colore e basta, se non vi fosse una sostanza sgusciante e spremuta da tanti differenti frutti: “Esiste un
terreno comune composto da Led Zeppelin, Stooges, Bo
Diddley, Capitan Beefheart, Beta Band e una bella dose
di soul e blues, tuttavia i nostri gusti personali sono più
influenti di quanto ci unisce, così tanti nomi che la lista
diventerebbe una faccenda noiosa. Siamo testardi e
questo si riflette nel modo in cui scriviamo e suoniamo
assieme. Inoltre siamo appassionati di cinema, così che il
tentativo di creare un’atmosfera caratterizza da sempre
quel che facciamo. Abbiamo anche interessi più ampi nel
campo dell’arte, dei videogiochi, della letteratura e della pornografia. Le solite cose, insomma. E a tutti piace il
caffé."
La quotidianità e lo sforzo di riderci sopra, di trascenderla inventandosi un linguaggio che esca dalle
pastoie di una Scozia - ma vale per qualsiasi altra nazione - adagiata su fotocopie trash-pop e post-punk
(“Prima tutti andavano in giro conciati come gli Strokes
e poi come i Franz Ferdinand. Questa città ha un ‘giro’
chiuso e non piacevamo a nessuno, così ci siamo ritrovati assieme. Essendo soprattutto amici, la faccenda s’è
evoluta organicamente e alcolicamente. Tutti i venerdì
sera lasciavamo gli amici al pub e suonavamo fino a tarda ora: dalla jam settimanale siamo giunti a un singolo
e agli album.”
A un certo punto toccava decidersi per un nome:
da lì, nel 2007 si stampa il 7" Throwing Bones per la londinese Trial & Error che attrae l’attenzione della concittadina Chemikal Underground. Ne risultava un primo
lp acerbo, dove l’ex Delgados Paul Savage cercava di
ordinare produttivamente l’eccesso di carne sulla brace. Non sfuggiva però il talento dei ragazzi ad allestire
una fitta rete di rimandi che prometteva bene; i più
attenti, anche alla luce della presenza dei Fantasmi ad
alcuni prestigiosi festival, un asso se lo sarebbero attesi.
Non della portata di The Wants, però, dove la scrittura gode di una naturalezza di sviluppo evidente solo
dopo ripetuti ascolti, quando cioè si varca una complessità che attrae e anzi avvince in luogo di respingere. Danno dipendenza, queste canzoni che respirano:
è folk che cavalca krauto (The None Of One) o sorge da
un alveo limpido (Come Away In The Dark); è new wave
che si rivolta in varchi spazio-temporali (Into The Corn,
Everybody Knows It’s True); sono pugnalate all’ultimo
grido da New York e da Londra (Mr. Natural, Walls). Il
resto ce lo mettono una voce che, indecisa tra David
Sylvian e Ian McCulloch, tra Ian Curtis e Bill Callahan, li lascia confluire nel fiume in piena di arrangiamenti calorosi e policromi. Si osa con trasporto emotivo, ripudiando la frigidità sin troppo smaliziata oggi
di moda.
Sperimentazione pop col sorriso e lo scudiscio: da
quanto ne attendevamo la ricomparsa? “Siamo pieni
di passione: il gruppo è una famiglia disfunzionale in cui
discutiamo molto ma che tende a lavorare in maniera
fluida. Le canzoni sono tirate in direzioni diverse finché
non si tramutano in qualcosa che possiamo utilizzare,
l’ispirazione arriva dagli ascolti passati e dalla voglia di
migliorarsi. Cambiare nome ci permetteva di metterci ed
era divertente. A lungo andare, però, ci siamo resi conto
di come fosse un po’ perfido e potesse infastidire la gente,
così ci siamo fermati a ‘The Phantom Band’. Avendo raggiunto un qualche obiettivo artistico, era tempo che ci
legassimo a qualcosa. Per ora non abbiamo in mente di
cambiare di nuovo nome: nel caso, ve lo faremo sapere.“
Quel che conta è che costoro rimangano tra chi
conta, ora che un nuovo decennio è alle porte e qualche certezza servirà. Tra genio e sregolatezza, sanno
cosa scegliere.
Giancarlo Turra
9
Tune-In
Le luci della
centrale elettrica
—Gli anni zero sono finiti?—
Testo: Marco Boscolo
Foto: Ilaria Magliocchetti Lombi
Due anni che lo hanno trasformato in un'icona
generazionale, ma a Ferrara "non mi caga nessuno"
I
l successo trasversale di Canzoni da spiaggia deturpata ha spinto Vasco Brondi nella casella delle
icone, almeno sociologicamente parlando. Nell'era della comunicazione per memi sempre più brevi e di stampo sloganistico, i flussi di coscienza infarciti di immagini
da sinistra storica che si reincarnano nella “gigantesca
scritta COOP” hanno una forza tale da diventare punti
di riferimento per una generazione indie cresciuta a Facebook. Una generazione che per certa parte ha visto
in lui il menestrello di "questi cazzo di anni zero".
Del fenomeno si è accorto il mainstream, che ha voluto il libro di Brondi, che lo ha fatto entrare nel mondo
paludato del Premio Tenco, che in qualche modo si è
interessato ai potenziali aspetti di marketing che ne
scaturivano. Si potrebbe addirittura vedere in Brondi
lo spettro di un altro Vasco, quello da Zocca che cantava la vita spericolata. O una vicinanza all'esaltazione
di certa provincia che ha aperto le porte degli stadi a
Ligabue. Come se i ventenni di oggi avessero trovato
il proprio faro, come ai loro coetanei di trenta, venti o
dieci anni fa era successo con Vasco Rossi e Luciano
Ligabue
Il secondo disco, Per ora noi la chiameremo felicità,
non sposta la barra del timone e ripropone lo stesso
immaginario raccontato “viscere sul tavolo” fornendo
nuova linfa al fenomeno. Dietro all'icona, però, c'è un
ragazzo schietto che questi ragionamenti sul marketing, sulla sociologia e sulla fenomenologia – forse –
non li ha fatti mai. Dalle sue stesse parole, la sua sembra
più una navigazione a vista, in un perfetto stile punk, in
cui il dire e il fare coincidono. Se al momento il fenomeno susciterà ancora innamoramento e identificazione
in una fetta importante del pubblico, e non mancherà
di far uscire gli inevitabili “te l'avevo detto”, dove stia
andando il progetto Luci della centrale elettrica lo
può sapere solo Vasco Brondi. E per cercare di capirlo,
non vi è altra via che leggere le sue stesse parole
Com'è stato fare questo secondo disco dopo un
esordio così visibile e accolto così positivamente da
pubblico e critica?
10
In realtà ho cominciato a farlo mentre stavo ancora finendo di mixare il disco precedente. Le canzoni sono
venute fuori in giro per i concerti in questi due anni. In
generale quando è stato il momento mi sono rimesso
nella situazione di non avere niente da perdere perché
effettivamente è così. Fortunatamente ho anche altre
cose e altre pensieri, dovere portare avanti una carriera
è una cosa che non mi pongo e che mi ripugna anche
un po'.
In cabina di regia non c'è più Giorgio Canali. Chi ha
prodotto il disco? Come sono nate queste scelte?
Il disco se parliamo di produzione artistica direi che ho
fatto molta roba io da solo. Con Giorgio c'è un rapporto
di confronto continuo, ha sentito tra i primi i provini
delle canzoni chitarra e voce, mi ha dato una mano a
registrare le voci qui a casa e molti consigli. Le Luci della centrale elettrica è una sorta di collettivo e cambia
sempre, cambia con me. È venuto da solo fare cose diverse. In generale cambio tutto quello che posso: ho
traslocato quattro volte in un anno. Mi sentivo anche
tranquillo da solo, ho ricostruito il momento di solitudine che ho quando faccio le canzoni, ma in studio,
ho fatto io i premix che sono stati sostanzialmente un
momento di arrangiamento. Poi Paolo Mauri, sempre
a casa, ha mixato il disco dando un grande apporto.
Le scelte di produzione sono state le uniche possibili,
le più immediate e le più sincere. Non mi sono voluto
inventare un suono in una settimana di studio, le canzoni anche questa volta nascevano chitarra e voce e ci
sono rimaste. Le abbiamo suonate tutte in un giorno in
presa diretta e quello che doveva essere un provino è
diventata la base del disco perché andava bene così.
I testi nuovi arrivano sull'onda del successo del primo disco e della pubblicazione del libro: questi fattori hanno cambiato il tuo processo creativo?
Non credo. Quando scrivo, scrivo. E si crea una dimensione diversa. Poi devo dire che tutto questo supposto
successo è per gran parte autosuggestione degli addetti ai lavori del micromondo indipendente musicale.
11
Mi sono ritrasferito a Ferrara e posso assicurarvi che
nella realtà non mi caga nessuno.
Dopo essere riuscito a costruire un immaginario coerente e riconoscibile, avevi paura di cadere nella
tentazione di rifare lo stesso disco? Hai preso delle
precauzioni in questo senso?
Non mi sono posto il problema. Non avevo nessuna
tentazione di rifare lo stesso disco, anzi, allo stesso tempo non avevo nessuna intenzione neanche di fare una
cosa completamente diversa da quello che sono adesso solo per stupire o per sorprendere qualcuno. Non ho
preso precauzioni di nessun tipo, se non di rispondere
all'unica regola che vale in queste cose: viscere sul tavolo. Come diceva Pazienza.
Nei testi nuovi ci sono molte citazioni più o meno
esplicite. Ma quali sono le tue fonti di ispirazione?
Sono maggiormente cantautori o scrittori?
Sono sempre in difficoltà davanti a questa domanda
rituale. Non è che mi ispiro a uno o ad un altro, non capisco neanche come si possa fare. Sicuramente ci sono
cose fatte da altri che mi colpiscono a morte ma che
magari non entrano in nessun modo in quello che faccio. Forse mi viene da mischiare tutto, i palazzi che ho
di fronte ad una canzone di Fausto Rossi, una frase di
Gianni Celati e la faccia di una passante, allo schermo
del computer, una conversazione con mia madre e un
film di Wim Venders. Tutte queste cose probabilmente.
Non ti viene mai voglia di lasciare da parte la musica e dedicarti completamente alla scrittura?
A volte penso che sarebbe più comodo che sarei più
tranquillo. La parte pubblica della questione devo dire
che un po' di rotture di cazzo me le ha procurate e per
quasi un anno non ho fatto concerti perché non ne
avevo più voglia. Però credo che non riuscirei, che mi
mancherebbe la parte della condivisione, dell'immediatezza delle canzoni.
Scrivo molto ma forse è solo un laboratorio per le canzoni, anche per questi testi a volte partivo da storie di
quaranta pagine che diventavano una canzone, come
per Una guerra fredda. Anche Cosa racconteremo di
questi cazzo di anni zero è stato in questo senso un
laboratorio, l'ultima parte di quel libro l'ho scritta mentre venivano fuori anche le canzoni di questo disco e si
sono parlati a vicenda.
Che effetto ti fa essere considerato il cantore di una
certa fetta del mondo indie, non dico generaziona12
le, ma che effetto ti fa sentire la gente che canta a
squarciagola le tue canzoni?
La frase dei C.S.I. "trasformami in un megafono e mi
incepperò" mi sembra perfetta. Facendo questa cosa
a volte sono finito in questa dimensione dell'irrealtà
dove ogni cosa diventa possibile e da questa dimensione dell'irrealtà però non è che provi grandi soddisfazioni: è come se non succedesse a te, banalmente. Gli
unici momenti di gioia sconfinata è quando ti accorgi
che dopo un bel po' di settimane che stai sopra una
canzone, all'improvviso capisci che è finita.
Come pensi che verranno accolte le nuove composizioni, o come vorresti che venissero accolte?
Vorrei che fossero ascoltate, è un disco fuori tempo e
fuori moda perché credo che per entrarci devi ascoltarlo un po' di volte. Sono tranquillo perché è proprio
come lo volevo e può andare in qualsiasi modo: non
ci sono recriminazioni. Credo che molti non le ascolteranno neanche e diranno la solita cosa che si dicono per i secondi dischi di chiunque o per i dischi di
chiunque prima non aveva seguito e adesso ne ha un
minimo. Dai CCCP ai Marlene Kuntz, agli Afterhours,
ai Baustelle adesso. Il solito gioco di ruolo. Credo che
ci siano anche tante persone con cui mi capisco e che
capiranno le canzoni e che ci troveremo ai concerti e
dopo i concerti e che ci accompagneremo a vicenda
ancora per un po'.
Com'è cambiata la tua vita privata? Com'è andare al
bar a Ferrara oggi?
Come ti dicevo, a Ferrara non mi caga nessuno, solo
ogni tanto se viene qualcuno da fuori c'è questo cortocircuito che qualcuno mi ferma per strada e addirittura si stupisce che cammino così tranquillamente per
la città, e poi mi chiede di fare una foto assieme e io mi
vergogno gli dico di no per favore, che se vuole parliamo finché vuole ci abbracciamo o quello che vuole
ma la foto mi vergogno, ci ho provato ma mi vergogno
e allora questa persona se ne va presa male e probabilmente va poi su Facebook a scrivere che me la tiro.
In generale la mia vita privata non è cambiata, ho gli
stessi quattro amici di prima, gli unici che sono rimasti
a Ferrara, frequento strettamente le stesse persone e
gli stessi posti, solo che ogni tanto parto e vado a fare
dei concerti e alcuni giornali e siti mettono delle mie
foto brutte con la bocca aperta mentre urlo e alcuni
che non conosco parlano di me quando non hanno di
meglio da fare.
Come hai vissuto il Premio Tenco?
Questa è un'altra domanda ricorrente che mi mette in
difficoltà. Il Premio Tenco sono stati due giorni in cui
io, Giorgio, Enrico Molteni e Daniela che suonava il violoncello siamo andati a Sanremo a suonare e a bere la
sera e ha sempre piovuto, ma ci siamo divertiti molto.
Eravamo così disorganizzati e fuori dal mondo che nessuno di noi sapeva neanche che il disco era in finale
al premio Tenco. Così una mattina che de Angelis mi
ha chiamato per dirmi che Canzoni da spiaggia deturpata aveva vinto io stavo dormendo e quando mi ha
richiamato che ero sveglio sono caduto dalle nuvole e
lui c'è rimasto un po' male. È stata poi una cosa importante, un mondo diverso che si accorge di una cosa che
viene da un'altra parte, una produzione da zero euro
che vince davanti a produzioni da centomila.
re, dopo tutto questo tempo in casa e in studio, di fare
uscire le canzoni e incrociare gli occhi di un po' di persone mentre suoniamo e pensare cosa faranno delle
loro serate e delle loro vite. Appena finito di registrare
il disco ho ricominciato a scrivere e suonare in modo
compulsivo direi, non so cosa succederà. Credo che andrò in qualche altra direzione e con qualcun altro. Poi
ci sono alcune canzoni di altri che mi stanno accompagnando da tantissimo e mi piacerebbe registrarle ma
forse le faremo solo dal vivo. Poi ho preso una batteria
elettronica che fa un po' cagare, ma che passata negli
effetti della chitarra e poi dentro l'ampli diventa una
figata!
Programmi per il futuro?
Stiamo preparando i concerti e non vedo l'ora di inizia13
Tune-In
Umberto
Palazzo
—Ciò che è più vicino—
Passato e presente, psichedelia e sesso, globale e locale,
social network e testate surriscaldate. Lo stato delle cose
rock di Umberto Palazzo.
Testo: Stefano Solventi
U
mberto Palazzo si aggira dove in
Italia c'è rock da un bel pezzo. Narra la cronaca, almeno dagli anni ottanta,
quando circa ventenne suonò garage negli Ugly Things, prima di condividere un
pezzo di strada assieme ad Amerigo Verardi nei molto psichedelici Allison Run. Il
colpo grosso lo stava per fare coi Massimo
Volume, però li mollò un attimo prima che
esordissero. A quel punto erano già gli anni
novanta, e Umberto Palazzo aveva maturato un'idea rock precisa, piuttosto sintonizzata sulle frequenze di Seattle. Raccolse
all'uopo una band attorno a sé, la chiamò Il
Santo Niente ed esordì - 1995 - con La vita
è facile per il Consorzio Suonatori Indipendenti. Una formula adulta come nel nostro
paese non capita spesso di udire guadagnò
al gruppo gli apprezzamenti del caso. Il re14
sto è storia: un altro album per il CSI, la soundtrack di
Jack Frusciante è uscito dal gruppo, la crisi psicofisica
del leader che preferisce investire energie nell'attività
di DJ, quindi il ritorno - a dieci anni dal debutto - con lo
stupendo Il fiore dell'agave su etichetta Black Candy. Il
Santo Niente è cambiato nei suoi membri e nell'anima,
ma continua a far perno sull'abruzzese - di Pescara - Palazzo, dalla calligrafia sempre più densa e incendiaria.
E' passato un lustro da allora, e il destino non ha smesso un istante di scozzare le carte. Umberto è, tra le altre
cose, uno dei rocker-dj più attivi sul grande social network blu, nel quale sembra trovarsi straordinariamente
a proprio agio. Ma non ha smesso il vizio del fare musica. Ho avuto il piacere – stavo per scrivere il privilegio – di ascoltare una pre-release del debutto solista di
Palazzo, Canzoni della controra. Un disco molto bello,
nato quasi per caso durante la lavorazione di un altro
album, Tuco (vedi in spazio recensioni), anch’esso un
debutto per El Santo Nada, sorta di incarnazione texmex del Santo Niente. Canzoni della controra avrebbe
dovuto uscire questo settembre, ma c’è stato un contrattempo piuttosto… prosaico.
Canzoni della notte e della controra uscirà tra
qualche mese, uno slittamento dovuto a strategie
commerciali/promozionali o che altro?
Lo slittamento è dovuto principalmente al diodo che
comandava la ventola del radiatore della mia vecchia
macchina e che la faceva entrare in funzione quando il
motore raggiungeva una certa temperatura. Si è rotto,
la ventola non è più partita e così la testata si è surriscaldata e deformata. Ho dovuto farla rettificare e nel
frattempo ho anche comprato una Toyota Corolla un
po' più giovane, ma di poco e il budget promozionale
che avevo accantonato andrà via in gomme, cinghie,
olio, filtri e passaggio di proprietà. Quindi per coprire il
buco che si è creato devo vendere le edizioni, cosa che
non volevo fare e che richiede una trattativa paziente.
Nel frattempo abbiamo finito Tuco, il disco del Santo
Nada e la band, che è in forma smagliante, scalpita per
suonare.
E allora avanti con El Santo Nada, roba da mariachi muti, da cugini malinconici dei Calexico. Ma anche qualcosa di più, un quid periferico irriducibile
che torna ad ammiccare dalle parti dei balcani...
Per la gente dell'adriatico le frontiere sono due: il
sud e l'est. Il messico fantastico del Santo Nada è un
allegoria del nostro sud. L'est è solo un altro tipo di sud
ed El Santo Nada è gente di frontiera che non appartiene né a un mondo, né all'altro. San Severo, patria di
Andrea Pazienza, è la nostra Ciudad Juarez. Da lì in poi
inizia una terra incognita senza regole o con regole dif-
ficilmente comprensibili ai non indigeni o iniziati. Un
universo magico e selvaggio, ma soprattutto una terra
di feroce sfruttamento e prepotenza. Tuco è un'allegoria dei problematici rapporti tra i nord e i sud del mondo sempre a vantaggio ovviamente dei più ricchi. Tuco
non è solo l'erede bastardo del personaggio reso immortale da Eli Wallach e Sergio Leone. Tuco è qualsiasi
persona che cerchi di sottrarsi ad una situazione svantaggiata tramite la forza di volontà. Tuco è un messicano che guada il Rio Bravo. E' un africano che attraversa
il Ténéré su camion stracarico. E' un meridionale che si
sottrae alla mafia. Tuco è un viaggio di emancipazione
ed un romanzo di formazione.
Quando e in quanti avete suonato su Tuco?
Siamo partiti col progetto a maggio del 2007. All'inizio era semplice musica di circostanza per essere ugualmente presenti in una situazione in cui non ci saremmo potuti esibire come Santo Niente. Buona parte del
repertorio, non tutto presente sul disco, è stato scritto
nel primo mese di attività. La cosa ha preso a vivere di
vita propria e ci ha fatto completamente trascurare il
Santo Niente. Ci ha entusiasmato da subito. Poi abbiamo fatto due distinte sedute di registrazione, a distanza di un anno ed una terza sessione per il missaggio.
Siamo stati rallentati dai molti impegni dei componenti la band che alla fine si è scissa in due e a quel punto la
situazione si è sbloccata. La sezione ritmica ha fondato
una nuova band che si chiama Caja Sonora ed è più
operativa in Spagna che in Italia. Io, Alessio D'Onofrio
e Christian Carano abbiamo continuato a suonare sia
nel Santo Niente che nel Santo Nada, ma ora ci sono
due sezioni ritmiche diverse. Nel Santo Nada ci sono
Fabrizio Crecchio e Alberto La Torre, musicisti completi
e veramente ottimi. Nel Santo Niente ci sono i giovani e
agguerritissimi Tonino Bosco e Federico Sergente, che
suonano anche negli Zippo e nei Death Mantra For Lazarus, due grandissime band. Sono perfetti per il Santo Niente e gli hanno restituito una grinta che solo dei
ventenni possono avere.
Con quali modalità uscirà Tuco? Ci sono state difficoltà per la distribuzione?
Per Tuco sogno la pubblicazione all'estero. Dopotutto è la sua natura di emigrante che lo esige. E se non
si dovesse trovare una distribuzione lo venderemo ai
concerti e on line.
Tornando a Canzoni della controra, hai definito
una specie di "popolare profondo", un narrare ad altezza d'uomo, simbolico e carnale, che svela le ombre, le magie, i mostri del quotidiano. E' un modo - il
tuo modo - di fare musica "impegnata"?
Sì, il mio impegno è sempre stato quello di guarda15
re ciò che più mi è vicino. Da molti anni ho adottato
il motto The reality of my surroundings, dal titolo di
un album dei Fishbone. Penso che il modo migliore
di parlare delle questioni generali, che sono sempre
enormi e lontanissime, sia descrivere fatti minuscoli e
vicinissimi. In questo particolare album si parla di sesso
e quindi può sembrare che ci sia meno impegno, ma la
politica dei sessi è importante. Fondamentale.
Come è nata l'idea, come si è realizzata?
Essendo Tuco un disco strumentale ed un lavoro
collettivo, mi sono trovato con meno impegni a livello
compositivo e soprattutto con il mio studio casalingo
finalmente pronto. Quindi mentre lavoravamo a Tuco,
io scrivevo e registravo altri pezzi. Nel frattempo insegnavo anche Storia della Popular Music al conservatorio e avevo voglia di mescolare linguaggi musicali antichi ed esotici che non avevo mai usato, ma di cui ho
una conoscenza profonda, a quelli che uso da sempre.
Suonare tutto da solo mi ha facilitato il lavoro perché in
questo caso avevo bisogno di avere il controllo totale
dell'arrangiamento e della produzione perché era tutta una questione di giustezza della miscela. E poi non
sapevo dove stavo andando e lo scoprivo minuto per
minuto. E' stata una bellissima avventura intellettuale.
Mi hanno dato una mano Sandra Ippoliti che canta in
tre pezzi, Tying Tiffany che canta in uno, Luca D'Alberto
che suona la violectra in un pezzo e poi ho sfruttato
un'antica drum track di Gianluca Schiavon, che non sa
ancora di aver suonato in questo disco. Contiene nove
pezzi per trentotto minuti di durata. Ne sono molto, ma
molto fiero. E' un gran disco d'esordio secondo me. Se
potessi scrivere degli emoticon qui andrebbe la faccina
sorridente.
Il rebetico come una bussola formale ed emotiva. Musica per anime in conflitto, voce di outsider
senza possibilità di remissione. In effetti il rebetico
potrebbe essere per l'Europa quello che il blues è
(stato) per gli USA... No?
Per la Grecia lo è certamente. Il rebetico nasce
dall'esilio delle popolazioni greche che abitavano la
costa turca. I greci di Smirne persero tutto e si ritrovarono a vivere in una terra che non li desiderava e l'unica
cosa che riuscirono a portare con loro fu la musica di
un altro continente. Nel rebetico c'è nostalgia, disperazione, senso di perdita, persecuzione, sensualità, droga
e carcerazione, come nel blues e come nel blues c'è un
contenuto musicale alieno che ha finito per colonizzare la musica del paese ospite. La discendente attuale
del rebetico, la neo kyma, è una forma musicale molto
interessante nel suo integrare presente e tradizione e
andrebbe seguita con più attenzione di quanto non
16
succeda. In effetti è una delle poche forme di popular
music moderne completamente autonome esistenti in
Europa.
C'è un elemento psichedelico che non demorde,
anch'esso però terrigno, verrebbe da dire mediterraneo. Che pure innesca legami intensi col fare
musica angloamericano. Il risultato è a mio parere
apprezzabilissimo, è come trovare una base comune da premesse diverse, dribblando la tipica sudditanza del nostro rock. Sei d'accordo?
Assolutamente sì. La sudditanza del nostro rock mi
sembra un problema sottovalutato, quando non affrontato nella maniera più sbagliata. Mi lasciano perplesso
le recensioni che dicono "questo è un disco italiano, ma
sembra americano o inglese al 100%". In genere, lingua
a parte, vuol dire che si tratta di musica totalmente assimilabile e assolutamente indistinguibile dall'ultima
moda arrivata da oltremanica o oltreoceano. Mi viene
da pensare: e allora? Come può essere questa una cosa
buona? Come può essere buono che non trapeli nulla della vera personalità delle persone che hanno fatto questo disco? Che questa musica non appartenga
a nessun luogo e a nessuna cultura se non ai cascami
della globalizzazione e del consumismo? Che questi
musicisti si siano talmente immedesimati nei panni di
qualcun altro da risultare personalmente invisibili? Mi
sembra che tutto ciò superi i confini del rock per entrare in quelli della pantomima, genere rispettabile e pure
impegnativo, ma che non m'interessa.
Sei molto presente su Facebook, hai un considerevole numero di amici (quanti?). Al di là delle ovvie
e per certi versi inevitabili ragioni di carattere promozionale, pensi che ci sia un rapporto più profondo
tra le tue attività artistiche e quelle di "social networking"? Ovvero: non hai la sensazione che i codici del
web stiano rendendo il "momento" promozionale in
qualche modo complementare a quello artistico?
Ho 4477 amici su Facebook in questo momento e
300 richieste in attesa. Ho il terrore di arrivare a 5000
che è il limite. A me piace il fatto che possa prendere un
pezzo inedito che ho sull'hard disc e in un click metterlo a disposizione di migliaia di persone. Ho reso disponibili i miei vecchi album e ho invitato i miei contatti a
scaricarli e i blog a condividere i link e ho avuto 2000
download finora. Questa cosa non rende nulla (costa
pure qualche euro in realtà), ma mi piace tantissimo,
del resto faccio musica perché venga ascoltata il più
possibile e quindi penso che il momento della condivisione sia importante quanto se non di più di quello
della creazione. E poi ho conosciuto la mia innamorata
grazie a Facebook.
17
Tune-In
Deerhunter
—Prove da rock star—
Testo: Marco Boscolo
18
Bradford Cox dentro e fuori i Deerhunter,
una figura essenziale per il pop anni zero
N
el mondo del rock esistono topoi che a volte si
avvicinano pericolosamente ai luoghi comuni,
perdendo qualsiasi sfumatura leggendaria, mitologica o – semplicemente – di coolness per trasformarsi in
parodie, spesso involontarie (e quindi più gravi) della
figura dell'indie-rocker. Per fare un esempio, un conto
è l'estetica da slacker o da nerd che ha fatto la fortuna
di molti gruppi e musicisti, capaci di prendersi in giro
e prendere in giro con l'arma dell'ironia, spesso accompagnata da canzoni di ottima fattura come nel caso
dei redivivi Pavement. Altra cosa è, invece, continuare
a prendersi sul serio quando si è persa qualsiasi credibilità, quando il proprio mondo di riferimenti culturali
è diventato un teatrino di plastica nemmeno più così
luccicante. Guardando solo in casa, basti ricordare due
nomi e si capisce a cosa ci si riferisce: Vasco Rossi e
Luciano Ligabue.
Anche per Bradford Cox c'era questo rischio, per lui
nato nell'America che potremmo definire di provincia
(Atlanta, Georgia) e cresciuto in una famiglia non propriamente coesa. Affetto dalla sindrome di Marfan, una
rara condizione genetica ereditaria che oltre a presentare rischi gravi per la salute, fa allungare a dismisura
arti e dita di mani e piedi (e sembra aver affetto, tra gli
altri, personaggi storici come Charles de Gaulle e Abraham Lincoln, Niccolò Paganini e Sergei Rachmaninov,
oltre a Joey Ramone), Bradford Cox non deve avere
avuto un'infanzia e un'adolescenza particolarmente
semplici, soprattutto perché conditi da un dubbio gusto per l'abbigliamento di Cobainiana memoria. La sua
eccessiva magrezza è spesso stata confusa per anoressia (o forse c'è stato davvero anche qualche disturbo
alimentare?) e la sua vita è stata segnata da un karaoke
scovato in un sottoscala di casa. Insomma, c'erano tutti
gli ingredienti per una classica mitologia americana da
underground indie, invece Bradford se ne frega un po'
di tutto e si concentra sui suoi esperimenti sull'Atlas
Sound (il nome della marca che aveva prodotto il karaoke) che saranno la base della sua inclinazione musicale.
Comincia così l'avventura sonora di Cox, con i Deerhunter ancora lì da venire e un progetto solista già
pensato e immaginato nella propria cameretta. Ma è
con altri quattro amici, anche loro figli della stessa marginale Atlanta che si ficca in garage, calcando l'eterna
storia di sogni del rock: suonare, incidere un disco,
andare in tour per il mondo. Una storia che potrebbe
essere stata scritta nel 1965 o nel 1980, e invece è del
2001. La formula di quel consesso di “cacciatori di cervi” è una mutevole variazione di garage-indie-pop con
forti inserti shoegaze e qualche accenno d'ambient, un
tocco che diverrà via via più importante nel corso della
vicenda Deerhunter.
Il disco di debutto, omonimo o noto anche con il
titolo di Turn It Up, Faggot, arriva quattro anni più tardi per la piccola Stickfigure. Le chitarre possenti fanno
pensare a un misto di Dinosaur Jr. e Jesus & Mary
Chain adagiato su una ritmica robotica, forse figlia di
quel giocare di Cox con le macchine fin dalla più tenera età. Due sono i santini che si sentono pervadere
molti anfratti di questi primi Deerhunter: uno è Mark
E. Smith, l'altro il sound abrasivo anni '80 dei Gang of
Four. Dopo la pubblicazione dell'esordio la leggenda
entra davvero nel suo vivo. Pare che sia stata Karen
O degli Yeah Yeah Yeahs a vedere dal vivo la band
all'epoca e a descrivere il live set come “un'esperienza
religiosa”. Scintilla d'amore musicale scaturita al primo
impatto e il nome dei Deerhunter arriva alle orecchie
giuste, facendoli andare in tour con i Liars e vedendosi
spalancate le porte della Kranky.
Ma il periodo che separa l'episodio dall'uscita di
Cryptograms nel 2007 non è facile per la band, che
registra una parte del disco già nel 2005, con le session rovinate da problemi tecnici e psicologici (attacchi di panico compresi). La prima parte del disco viene
quindi registrata nuovamente nello studio che li aveva
ospitati per il primo disco e le cose sembrano andare
meglio. Per la seconda metà entrano in studio qualche
mese dopo e finalmente il disco viene alla luce all'inizio
del 2007 e fa mostra di sé nei negozi di tutto il mondo. L'impatto sugli addetti ai lavori, soprattutto dall'altra parte dell'Atlantico, è molto positivo, nonostante
la doppia registrazione abbia fatto dare alle stampe
un disco non del tutto omogeneo e sostanzialmente
diviso praticamente in due parti (essendo lo spartiacque Red Ink). Più garage e spigolosa la prima, sebbene
19
aperta da una traccia intrisa di ambient, più melodica la
seconda, che sembra raccontare un equilibrio cercato
e finalmente trovato. Cryptograms non è in realtà quel
gran capolavoro che ci voleva far credere Pitchfork, ma
due cose sono innegabili. La prima è che Bradford Cox
e soci sono una delle realtà più interessanti a emergere a metà del decennio, in quel periodo di post-tutto
che sembra non trovare più quadrature del cerchio. I
Deerhunter si sollevano sopra la media grazie a una
capacità di creare atmosfere fuori dal comune, mandando a memoria la lezione di Ride e Slowdive, inbastardendola con il garage e la psichedelia, sporcandola
di krautrock e aggiornando lo iato wave. La seconda
è che nonostante tutte le ingenuità e qualche caduta,
il disco fa pensare che quella dei Deerhunter sia una
storia solo appena accennata.
E così è, a partire da un 2008 denso di buona musica firmata Bradford Cox. La prima tappa è l'esordio
ufficiale del progetto Atlas Sound, quello iniziato sul
piccolo apparecchio domestico per il karaoke. Let The
Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel, definito ambient punk dal suo ideatore, è una summa pop
fortemente sì screziata di ambient, ma dal sapore decisamente shoegaze. Rispetto alla band maggiore, qui
Cox preferisce rallentare i ritmi e lasciare che la musica
stessa trasogni in liquidi feedback, prendendo a prestito atmosfere da Sigur Rós e Postal Service, ma sempre riuscendo a conferire al tutto una connotazione
poppeggiante. Ecco allora che i drone non allontanano
i meno abituati a certe sonorità più underground, ma
servono a introdurli a paesaggi sonori atmosferici capaci di far viaggiare lontano. O forse vicinissimo, dentro di sé.
Qualche mese più tardi arriva il secondo episodio
adulto a sigla Deerhunter. In Microcastle le alchimie
sonore della band sono messe a fuoco come mai prima
di allora, in equilibrio delicato che sembra costantemente sull'orlo di scivolare verso la wave o l'ambient di
krankyana fattura, ma riuscendo quasi sempre a mantenere la barra dritta per una dozzina di tracce che entrano in molte classifiche di fine anno. Rispetto al passato,
l'attitudine pop ha vinto, regalando canzoni facilmente fruibili, infarciti di pastelli acidi e qualche tocco 4AD
che letto in prospettiva sembra una premonizione. Il
definitivo approdo a un pop più ampio è sancito dal
singolo Never Stops, una sorta di aggiornamento 2.0
del Darklands dei fratelli William e Jim Reid, mentre nella titletrack fanno capolino echi surf da revival
Sixties di fine duemila e non mancano gli irremovibili
riferimenti a Ride e Slowdive. In Microcastle le citazioni ambient, psichedeliche, garage, wave, punk, post,
20
kraut e quant'altro sono sostenute dalla felicità della
vena compositiva di Cox e compagni che sembrano
riuscire a interpretare un decennio di totale assenza di
riferimenti definiti frullando tutto in una pietra filosofale dell'indie attuale che sa di miracoloso e ha il pregio
di suonare personale in ogni sua incarnazione.
Quando nel 2009 dà alle stampe la seconda opera
a nome Atlas Sound, oramai Bradford Cox è una stella
del firmamento indie e i suoi Deerhunter sono pronti
per un salto definitivo nell'empireo. La loro storia assomiglia a quella dei canadesi Arcade Fire, band di
provincia che dall'indie sembrano in grado di approdare a palchi mainstream senza perdere in coerenza e
personalità. Nel frattempo l'allampanato cross-dresser
di Atlanta mette insieme un pungo di canzoni da nuggets-delia che vanno a comporre Logos: un lavoro retrò, raffinato e impalpabile come organza nera.
In un'intervista rilasciata a Pitchfork in quel periodo, Cox dichiara che laddove le canzoni del primo Atlas Sound erano essenzialmente una cosa da laptop e
cameretta e “davvero introverse”, quelle finite su Logos
sono invece frutto di collaborazioni e di una maggior
apertura verso l'altro. L'atmosfera di condivisione si
percepisce dalle ospitate, dal mezzo furto Panda Bear
/ Animal Collective di Walkabout a Laetitia Sadier
che tinge di Stereolab una Quick Canal altrimenti interamente shoegaze, fino al violino di Sasha Vine dei
Sian Alice Group in Attic Lights: Cox sembra quasi un
vampiro, capace di succhiare ogni buona idea dall'ambiente che lo circonda, ma sempre restituendola in
qualcosa che suona al cento per cento come suo. Il
secondo disco solista di Cox segna anche il passaggio
dalla Kranky alla 4AD, a completamento di un'evoluzione già parzialmente segnalatasi con Microcastle.
Come scrivevamo all'epoca dell'uscita del disco, Cox
preferisce addentrarsi in una forma impalpabile di pop,
quasi una sublimazione di una memoria sonora collettiva che lo rende potenzialmente il demiurgo di una
generazione di musicisti indie pop.
Il passo successivo, anch'esso uscito per 4AD è il
recente Halcyon Digest, probabilmente l'album più
matura a sigla Deerhunter, ma anche il disco più solido sotto il profilo delle canzoni tra quelli su cui Bradford Cox ha messo la firma. Più ancora che nel passato,
però, è fondamentale l'apporto del sodale si sempre,
quel Lockett Pundt che divide con Cox la stanza in
tour, l'affitto, le scelte musicali e che con la sua chitarra
elettrica ha determinato sin qui molte delle atmosfere
dark e ambient di tutta vicenda musicale dell'amico.
Si vedano le citazioni byrdsiane di Memory Boy o le reminiscenze di altri georgiani come i R.E.M. in Revival,
ma anche la capacità di prendere un attacco tipicamente Arcade Fire e springsteeniano (Desire Lines) e
trasformarlo progressivamente in qualcosa di diverso,
personale e retro-modernista. Anche qui è innegabile
l'amore di Cox per The Jesus & Mary Chain e per le
loro terre oscure che pervadono tutte le composizioni come fossero uno spirito che dal passato continua a
bussare alle porte dell'immaginario musicale dell'indie
contemporaneo. Quando gli spazi si dilatano e si amplificano l'inclinazione 4AD del disco, esce anche tutto
il potenziale dream pop della band.
La grande capacità di Cox e soci è far apparire tutto questo come semplice, naturale, quando in realtà si
tratta del frutto di un percorso lungo, che ha le sue radici nella cameretta di Atlanta, ma che adesso ha i muscoli e lo spessore per essere lanciato non solo all'interno del ristretto mondo dell'indie, ma per conquistare
anche palchi più visibili, come se il processo di maturazione della band sia stato quello della psicanalisi di un
mondo per poi poterlo piegare alle proprie atmosfere
e visioni.
21
Sufjan stevens
—All Along The Watchtower—
Drop Out
Uno sguardo alla carriera di Sufjan
Stevens, ovvero un tentativo di
decifrare e ridefinire il ruolo del
cantautore. Scampato, forse, al giro
di ruota degli anni zero.
Testo: Stefano Solventi
22
23
"La disgregazione, e quindi l'incertezza, è propria di quest'epoca. Nulla poggia su
una solida base e su una fede dura. Si vive per il domani, perché il posdomani è dubbio. Tuttto è sdrucciolevole e pericoloso sul nostro cammino. Il ghiaccio che ancora
ci sostiene è diventato così sottile e noi tutti sentiamo il caldo soffio del vento del
disgelo: qui dove noi camminiamo, fra poco più nessuno potrà camminare." (F. W.
Nietzsche)
Fare il cantautore all'alba degli anni zero non è una prospettiva semplice. Anzi. Nasconde svolte e insidie tutte da esplorare. Se sei un debuttante,
è un po' come pescare la paperella fortunata: ti affidi alla buona mira, provi a sbirciare, ma è la fortuna che rimette i conti. Ecco: ci chiediamo oggi,
dopo un primo scorcio di carriera che convenzionalmente abbraccia una
decade - ovvero questo decennio critico e formidabile che ancora dobbiamo finire di decifrare - com'è andata la pesca per Sufjan Stevens. Non lo
avremmo fatto, forse, se le ultime recenti prove discografiche (l'ep All Delighted People e l'album The Age Of Adz, usciti a stretto giro di posta nel
ventre caldo del 2010) non avessero suggerito una sorta di resa dei conti,
un raccolto, una disamina. La chiusura di un ciclo che, a partire dall'attitudine già espansa di Sufjan, mira ad un orizzonte sempre più affollato, caotico,
imprevedibile.
C'è insomma la sensazione che Mr. Stevens con questi ultimi lavori abbia
voluto marcare un segno forte rispetto al senso del suo percorso espressivo, maturato infine come sguardo sulla contemporaneità, oltre gli argini di
un repertorio che da sempre, ad onor del vero, ha coltivato aperture che ne
scompaginavano qualsivoglia solco personalistico. Con risultati non sempre straordinari, talvolta neanche convincenti, come è del resto normale da
parte di chi si prende il rischio di esplorare, di esplorarsi. Inseguendo nel
farlo frequenze anche improbabili, augurandosi di azzeccare la rivelazione
come una sintonia improvvisa, come un segreto geografico e sentimentale.
Canzoni quindi come uno scherzo del destino, lo struggente collasso della
cultura nella memoria, della società nella cronaca, del sogno nel racconto.
Un
destino nel nome
Sufjan Stevens: cognome standard che più standard non si può, nome esotico causato dall'infatuazione (passeggera) dei genitori per la comunità
sincretistica islamico-cristiana dei Subud, il cui capo spirituale suggerì loro
di ispirarsi alla figura di Abu Sufyan - figura cardine dell'Islam primigenio per battezzare il nascituro (per la cronaca, Sufjan significa: "viene con una
spada"). Oggi che possiamo individuare nella polarizzazione e globalizzazione dello scontro tra modello liberista (o occidentale tout court) e neointegralismi islamici uno degli argomenti portanti di questo primo scorcio
di millennio, determinando uno stato di tensione permanente tra posizioni ideologiche sempre più distorte, è lecito vedere in quell'accostamento
anagrafico il marchio di una predestinazione: allo sguardo mai meno che
duplice, alla inevitabile ricomposizione di ogni conflitto in una "crisi" che ti
porti addosso come un altro strato di pelle. Nella sua musica, fin dai primi
lavori, accade una specie di lotta subliminale tra domini formali estranei
ma sovrapponibili, tra la dimensione tradizionale sedimentata in manufatto pop e l'elemento esotico/alieno, tra le istanze indie-folk e le trame sintetiche, tra la definizione di un solco espressivo ed il suo scompaginarsi in
dieci, cento, mille rivoli.
24
25
Nato a Detroit il 1 luglio del 1975, Sufjan si spostò ancora bambino a
Petoskey, 6000 anime adagiate sulla sponda nord est del Lago Michigan,
dove frequenta prima la Harbor Light Christian School e quindi la rinomata
Interlochen Arts Academy, abbozzando un percorso formativo senza indugi che lo vedrà poi studente del prestigioso Hope College di Holland, istituto privato di belle arti. E' in questo scenario che compose e incise A Sun
Came. Già in possesso di una buona pratica con una pletora di strumenti
quali banjo, pianoforte, chitarra, oboe e batteria, da qualche tempo - metà
anni novanta - aveva allestito un'etichetta - la Ashtmatic Kitty Records - e
messo in piedi una folk band, i Marzuki (dal nome di suo fratello, maratoneta professionista), che vedeva nel ruolo di chitarrista e cantante la brava
Shannon Stephens. Nello stesso periodo Sufjan iniziò a collaborare con
la Danielson Famile, band del New Jersey capitanata da Daniel Smith e
dedita ad una interessante contaminazione tra pop alternativo e gospel,
tra arguzie freak e misticismo bucolico. Entrambe le situazioni vedevano
già il Nostro alle prese con un'idea di spiritualità composita e informale,
annidata nelle manifestazioni pop del quotidiano, il cui portato di meraviglia è solo dissimulato - e non estinto - dalla sua banalizzazione. In altre
parole, è il caso di sottolineare, sembra che l'avventura sonora di Stevens
inizi come un tentativo di recuperare la meraviglia pop malgrado la sua
banalizzazione.
Esaurita l'esperienza Marzuki, era dunque tempo di avventura solista: al
già citato A Sun Came (Asthmatic Kitty Records, 6.5/10), segue pochi mesi
dopo Enjoy Your Rabbit (Asthmatic Kitty Records, 6.8/10). Il primo venne
inciso ad Holland, il secondo a New York, dove Sufjan si recò per seguire
un master di scrittura creativa alla New School for Social Research. Tra i
due lavori passa un intero universo espressivo. A Sun Came è un autentico
zibaldone lo-fi con escursioni esotiche, è il benedetto eccesso di vita di uno
studente con fregole etniche ma pur sempre cresciuto ascoltando Beck,
Sebadoh e Pavement con qualche deviazione più marcatamente psych
dalla fibra anche sixties. Un album in cui le intenzioni eccedono i risultati, a
partire dal numero dei pezzi (ventuno), però non privo di ottime intuizioni
e già una certa personalità.
La scaletta di Enjoy Your Rabbit mette invece in fila quattrodici pezzi
sintetici dedicati ai dodici segni zodiacali cinesi, al cui bestiario si aggiungono un gatto asmatico e un non meglio precisato "Nostro Signore". Un
po' Matmos e un po' Oval, con un estro post che ricorda dei Gastr Del
Sol giocosi o una preveggenza degli imminenti The Books, la calligrafia
digitale di Sufjan dimostra una disinvoltura stupefacente, si disimpegna in
un immaginario da ludoteca di marzapane, carte da parati manga e squarci
di vaporoso misticismo. Se pure è plausibile interpretarlo come esercizio
di stile o divertissement, è a suo modo un punto di non ritorno. Assieme al
predecessore segna gli estremi di un ventaglio stilistico che aveva appena
iniziato a svolgersi. Ad indagarsi.
Car toline
dal centro del mondo
Quelle due prime prove non bastarono a proiettare il nome di Sufjan
Stevens nel giro importante del pop-rock alternativo, ma era solo questione di tempo. Il terzo lavoro Greetings From Michigan, The Great Lake State (Asthmatic Kitty Records, 7.7/10) piovve nel bel mezzo del 2003 con le
stimmate del disco-fenomeno, quello di cui non puoi non parlare. Le note
26
di presentazione lo indicavano come il primo capitolo di un progetto che
avrebbe dovuto prevedere un album per ogni stato dell'Unione, uno per
ogni stellina della bandiera. A partire, ovviamente, dal suolo natio. Molti,
come il sottoscritto, la considerarono una sparata un po' furba e un po'
spaccona, o in alternativa il proclama velleitario di un autore più ruspante
che realista. In pochi, forse nessuno, gli concessero pieno credito. In realtà
non era stato messo a fuoco il vero punto della questione: perché un autore tanto capace e profilico sentiva il bisogno di fornire un pretesto ed un
contesto così forti, per non dire debordanti, alla propria musica? Solo gli
sviluppi futuri avrebbero abbozzato una spiegazione, una specie di risposta.
All'epoca potevamo al più prendere atto di un album straordinariamente ispirato, eclettico, fluviale. E appassionato. Sufjan fa vagare il suo sguardo
27
sulla quotidianità ad altezza d'uomo, spedisce cartoline affettuose che si
rivelano il lato scintillante di una commossa e a tratti cupa elegia del quieto
vivere. La tavolozza dei colori è una sarabanda ammaliante di easy listening
e jazz, intrecci vaudeville e Tin Pan Alley sfumati post-rock, memorie prog
e fregole latine, il folk come una trama che sostiene e avvolge, il gospel la
dissolvenza che stempera i margini. Chitarre e pianoforti, xilofoni e banjo,
fiati e percussioni, il controcanto etereo e dolciastro di Megan Smith della
Danielson Famile: ingredienti dosati con garbo inquieto (Holland, Say Yes!
to M!ch!gan!), con frugale trasporto (Sleeping Bear, Sault Saint Marie, la magnifica Vito's Ordination Song), con incontenibile frenesia (Detroit, Lift Up
Your Weary Head!), come a definire una classicità scossa, la cifra vibrante
di un autore sospeso in una molteplicità di memorie, prospettive e aggetti
poetici.
E' un disco gradevole e toccante, un po' bizzarro e vagamente eccessivo,
che proprio in questo eccedersi nutre una garanzia di autenticità: è la testimonianza del coinvolgimento di Sufjan, interprete dolcemente flemmatico, per la terra che ha rappresentato lo sfondo reale della sua esistenza,
divenuta ormai location sentimentale - virtuale - di un'espressività poliedrica. Il quadro della situazione a quel punto era già chiaro: avevamo a che
fare con un giovane talentuoso dalle attitudini balzane, un genio dispersivo con tante idee ma bizzarre e a tratti imbizzarrite.
Stante questa anomalia, l'uscita a distanza di un anno del quarto album
Seven Swans (Asthmatic Kitty Records, 7.2/10) lasciò oltremodo interdetti,
visto che si trattava di un album "normale". Una raccolta di canzoni folk
asperse psych e condite con un pizzico di elettronica (colta nel solco tra
valvolare e sintetico): nient'altro. L'unica bizzarria, se così la si vuol vedere,
stava nel sogno che avrebbe ispirato lo Stevens, sette cigni indimenticabili
e sconcertanti ai quali l'album - al di là del titolo - era in un certo senso dedicato, anche se non per questo sembra il caso di definirlo un concept. Prodotto da Daniel Smith, è disco dal suono assieme frugale ed etereo, il banjo
ingrediente principale assieme alla voce, sempre più levigata e inquieta, in
cerca di un intimismo tra il mistico ed il malinconico.
Non per questo smetti di avvertire cortocircuiti di passato nel presente,
da una parte le palpitazioni crosbyane di Abraham e dall'altra il collage ciberacustico vagamente Califone di The Devil's Territory, e ancora i languori
seventies nella strumentale Sister o una The Transfiguration che fa rimbalzare particelle melodiche Xtc in un teatrino mutante M.Ward. La tempra
crepuscolare già apprezzata in Michigan trova nuovi notevoli esemplari in
tracce come Size Too Small e We Won't Need Legs To Stand, la voce un tappeto d'ombre su cui germogliano arpeggi che sembrano possedere una felicità segreta. E' disco insomma di quelli che sanciscono statura e maturità.
Paradossalmente anomalo, nella sua sostanziale convenzionalità, rispetto
ad un repertorio precedente (e futuro) ben poco convenzionale. Un futuro
che non ne voleva sapere di attendere.
Lo
tsunami iperpop del ragazzo invisibile
Tempo pochi mesi, anno 2005 ormai, ed ecco arrivare sugli scaffali
Sufjan Stevens Invites You To: Come On Feel The Illinoise (Asthmatic Kitty Records, 8.0/10), seconda tappa del viaggio musicale attraverso gli stati dell'Unione. Il canovaccio ricalca quello del Michigan, un'escursione tra
immaginario e Storia, sogno e miseria, tragedia e memoria, ora frenetico
zibaldone e ora ritratto affettuoso, ironia e lirismo come due frequenze armoniche che s'intrecciano in un accordo talvolta incantevole, talaltra sconcertante (a partire dai titoli, spesso vere e proprie dichiarazioni d'intenti).
Le ventidue tracce, compresi gli intermezzi strumentali, lasciano intendere
una prolificità notevole che diventa sbalorditiva sommando le altre ventu28
29
no di The Avalanche: Outtakes and Extras from the Illinois Album (Asthmatic Kitty Records, 6.8/10), raccolta quest'ultima che a dire il vero probabilmente non avrebbe neanche visto la luce senza i favorevoli riscontri di
critica e vendite di Illinois.
Riscontri meritatissimi per quello che apparve subito come un istant
classic, con la sua capacità di proporre una trama complessa ma avvincente,
il punto di vista che galleggia tra intimità dolorosa e febbrile appartenenza,
toponimi e personaggi (poeti e serial killer, presidenti e jazzisti...) nominati
come un mantra gelatinoso con l'obiettivo preciso di far vibrare il cuore
infranto dell'American Dream. A partire da una sensibilità giovane, dall'arguzia fragile di uno studente (o ex studente) che vive il proprio territorio
come una promessa sul punto di tradire, un carosello di segni didascalici ed
esistenze smarrite, un groviglio formidabile di radici sfilacciate nelle quali
malgrado tutto pulsa ancora vita.
La "location" musicale è una forma pop carpita al cantautorato country
e ad una certa coolness cameristica, passando dal folk più pacato alla psych
contagiata vaudeville, dalla rumba al minimalismo con persino qualche innesco power pop, in modo da abbozzare una formula assieme tradizionale
ed eversiva, integrata ed apocalittica. Canzoni come Chicago possiedono
enfasi Paul Simon stemperata in un'epica che diverrà tipica Arcade Fire,
Jacksonville è un distillato leggero Neil Young, The Man Of Metropolis Steals
Our Hearts è una mini suite che centrifuga il neo power dei New Pornographers e il bucolico deliquio Polyphonic Spree, The Black Hawk War un
orchestrale discendente da visioni Brian Wilson e Beatles, Out Of Egypt
una fatamorgana seriale tra Stereolab e Gastr Del Sol, mentre John Wayne
Gacy, Jr. sembra proprio la madre di tutte le ballad tenere e crudeli. Sufjan
è dentro e fuori l'alveo conformista, è l'istrione magniloquente e il ragazzo
invisibile della porta accanto, è lo sperimentatore un po' folle, il credente
allibito ed il busker che ti accarezza la malinconia.
Nel caso di Illinois parliamo di capolavoro anche perché definisce, probabilmente in termini assoluti, il ruolo e la funzione di Stevens cantautore:
un'intelligenza polimorfa e disallineata come testimone dello tsunami semantico e culturale contemporaneo, dell'implosione sincretistica (e relativistica) della spiritualità, della contraddizione permanente tra identità territoriale e accessibilità del mondo. Infine - ma importantissimo - della crisi
dell'idea di Stati Uniti come faro egemonico, una crisi profonda che investe
i macro sistemi economico/militari ed il microcosmo morale del cittadino,
scuotendo fino nell'intimo le basi stesse dell'esistenza civile e individuale.
Ecco spiegata quella specie di rassegna del DNA storico/culturale statunitense, la rievocazione di un Frank Lloyd Wright e del killer John Wayne Gacy
Jr, dell'icona pop Superman (che la DC Comics gli contesterà per la copertina dell'album) e di Abraham Lincoln, senza scordare anonimi protagonisti
del quotidiano come i lavoratori della Rock River Valley.
C risi
mistiche ,
A pocalissi
spettacolari
Come intimorito da tanta impresa e dal conseguente successo di pubblico e critica, Sufjan vivrà negli anni successivi una fase di crisi creativa.
L'uscita di Song For Christmas (Asthmatic Kitty Records, 7.2/10) nel 2006
non deve ingannare: trattasi della raccolta di ben cinque album dedicati al
tema del Natale a partire dal 2001, in sostanza una collezione di cover (da
Silent Night a O Come O Come Emmanuel) e inediti a tema per un totale di
30
42 pezzi in una confezione deliziosamente ipertrofica (stickers, illustrazioni,
piccoli racconti scritti dallo stesso Sufjan, video e persino un saggio natalizio ad opera dello scrittore Rick Moody. Un'operazione un po' alla Phil
Spector in nuce, una chicca per fan ma anche il necessario complemento
dell'aspetto traditional-kitch - con aspersioni mistiche - del Nostro, la cui
meditazione sul lato spirituale del pop è più sostanza che forma, vera e
propria bussola poetica.
Tuttavia, per i successivi tre anni non si sentirà parlare di Sufjan Stevens
se non in occasione di qualche collaborazione di sponda (con la Danielson
Familie, Rosie Thomas, The National e DM Stith tra gli altri) e per certe
dichiarazioni concernenti la crisi d'ispirazione che lo avrebbe colto. Occorre
attendere il 2009 per un nuovo album a suo nome, e si tratterà di un lavoro
svolto su commissione per la Brooklyn Academy of Music. The BQE (Asthmatic Kitty Records, 6.0/10) è una faccenda di pop orchestrale che travalica
se stessa, un esercizio di stile che cade nel pacchiano giusto un attimo prima di affascinare, un po' il nipotino ironico e arty di Atom Heart Mother.
Possibile vederlo come un pretesto per tornare a fare musica, perché forse
senza un pretesto così pervadente sarebbe stato impossibile, e comunque
pur sempre tentando di battere nuove strade, qualcosa di molto diverso,
che segnasse uno strappo da Illinois. Ma Sufjan è chiaramente fuori contesto, gioca con gli elementi di un gioco più grande di lui, azzeccando tuttavia una chiave creativa quasi goliardica che non spiace. Da qui al presente
è quasi un attimo.
L'ispirazione lo coglie di nuovo di lì a poco, tanto che il 2010 vedrà due
uscite del Nostro: quel All Delighted People EP (Asthmatic Kitty Records,
7.4/10) che in realtà copre un'ora di musica per otto tracce a rotta di collo in
un immaginario seventies condito di sostanze psicotrope, tremori esistenzial/sentimentali, incenso e timor d'apocalisse; infine l'ipertrofico The Age
Of Adz (Asthmatic Kitty Records, 7.4/10), praticamente un frullato generoso del Sufjan Stevens passato e presente con qualche soncertante prospettiva di futuro. Entrambi i lavori sembrano suggellare quel senso di missione
cantautorale che già abbiamo delineato, ovvero adeguata alle istanze del
decennio che va a concudersi. Anni (zero) che hanno messo il musicista
con le spalle al muro, hanno squadernato tutti i trucchi, determinando un
disincanto totale ma anche un ventaglio formidabile di possibilità.
Sufjan Stevens fa di se stesso un cantautore onnicomprensivo, pratica
una versatilità incontenibile (stilistica e poetica) perché - suggerisce - non
gli è possibile fare altrimenti. E' il testimone di un'epoca, della sua abbondanza tragica e sterile, dell'accalcarsi di segni come scorie di una comunicazione in cortocircuito, dell'intersecarsi slevaggio di testimonianze e
progetti. Un'epoca incapace di un discorso lineare, condannata alla logica
della rete in ogni aspetto del suo procedere. E' questa insomma l'epoca
della grande alluvione, ed il cantautore è una torre di guardia tra i flutti.
Si aggrappa al suolo (alla propria terra) con la foza disperata della sensibilità, a quel che resta della fede e dell'amore per il passato (la Storia),
all'ironia perché la battaglia si gioca pur sempre in una dimensione che
non fa morti né feriti (non tangibili, almeno). Ma non può fare a meno di
venire scosso e spazzato dalla corrente. In un certo senso lo desidera, perché vi riconosce il proprio destino. Ed è uno spettacolo (nuovamente) meraviglioso.
31
Napoli
caput
mundi
—Weltraum,
A Spirale,
Zero Centigrade—
Drop Out
C
Tre rizomatiche figure dell'avant tra
interconnessioni, pars destruens e
Napoli, tangente invisibile.
Testo: Salvatore Borrelli
32
ittà scissionista, Napoli. Caotica, affamata, zeppa di contraddizioni
al punto da essere essa stessa sinfonia noise, psicotropi geografica.
Napoli non è metropoli, quanto grumo di vicoli, stradine, cunicoli differenziati con ognuno una sua musica interna: quella delle sovvenzioni
spropositate per Piedigrotta, le suburbane Piazza Mercato, Forcella, Sanità, con le feste di piazza per banditi locali su banchetti neo-neomelodici,
fino alle inaccessibili sfilate di posillipini del Teatro Sancarlo, avamposto
e ultima rappresentazione del baronato monarchico.
Napoli è tutta riversa nelle sue antichissime distinzioni vassallatiche
tra zona alta e zona bassa. Città parassitaria divisa tra San Gennaro, Pulcinella e pizzerie che spuntano come funghi. Luciano Cilio, ed erano gli
33
anni Ottanta, già sentiva la morte in atto: il suo suicidio fu la resa del dialogo. Tuttavia l’anarchia è portatrice di libertà, di caos. Di desiderio rizomatico, trasfigurativo, performativo, che sono i tre elementi principali di questa
microfetta avant, che, passando a Napoli, potrebbe capitarvi di vedere.
Sia chiaro: Napoli e il suo immaginario sociale hanno poco da spartire
con questa particolare fenomenologia della disconnessione avant, tuttavia
non è un caso che si sia formato un groviglio di collaborazioni, partecipazioni, microfestival, tutti all’interno di questa città-inferno. L’esiguo numero
di locali adatti e la pressapochezza gestionale hanno fatto in modo che il
discorso avant si focalizzasse in due piccoli ma importanti luoghi-crocevia:
Oblomova, ovvero ex-Demos, storico nei dischi, e Perditempo, libreriabar. Non si tratta di posti pensati per concertare quanto i soli due luoghi ad
avere accolto scelte di musica altra. Con un’ospitalità che non raggiunge le
60 unità, hanno fornito uno spazio affinchè artisti di diversa estrazione potessero organizzarsi pubblicamente. Perditempo ed Oblomova non hanno
condiviso il formato dell’associazione culturale, né quello più sinistro delle sovvenzioni pubbliche. I concerti, da queste parti, si organizzano gratis
con piccoli rimborsi per i musicisti coinvolti. Da questa de-localizzazione
canonica degli spazi sonori agibili, è nata, prima sotterraneamente, poi in
maniera sempre più collaborativa, una piccola scena musicale, che ruota
intorno agli A Spirale. Tutto si muove sotto il segno di poche persone, che
nemmeno si considerano addette ai lavori, che se organizzano qualcosa
lo fanno per pura filantropia: lo staff di Perditempo (Luca Marini, particolarmente), Fabio e Claire di Oblomova, Francesco “Limone”Tignola che
tiene in vita edizioni Ammagar e il suo gruppo Ne Travaillez Jamais. E poi i
gruppi stessi, ovvero gli A Spirale, i Weltraum, e, in maniera differente, ma
altrettanto incisiva, Zero Centigrade.
a spirale
34
A Spirale nascono dalle ceneri di Missselfdestrrruction, nel 2002,
ma è di due anni più tardi la formazione a tre, composta da Argenziano,
Gabola, Spazzaferro, chitarra, fiati, spazzole. Da quel momento, sia le
collaborazioni (Bellatalla, Chadbourne, Taxonomy, Psychofagist, Cris
X,Anatrofobia, Jealousy Party, etc..), sia i tentativi di collettivi live, da
Tempia ed @ltera, sono state innumerevoli. E’ il gruppo stesso a spiegarci in
concatenamenti successivi i propri obiettivi: “A Spirale non è una pluralità, è
un morbo, un’ansia, una psicosi, qualcosa che si getta continuamente nell’indifferenziato, fa musica a partire dal non suonare, dal blocco, dall’incapacità.
Allo stesso tempo nella sua musica non c’è niente che rappresenti tutto questo,
una pratica che è un continuo eccedersi, un evitarsi, evita lo strumento, evita
la musicalità, evita l’arte, evita di pensare a come rappresentarsi. E' una goffa
e pesante relazione, un’intesa mancata, un disturbo autistico ben nascosto,
un discorso muto ma allo stesso tempo un rimorso, una rabbia, una strategia
che uccide, un piano d’attacco, una bomba che lentamente diffonde il suo gas
mortale; un’incapacità agli affetti ma una morbosità al contatto fisico, un raziocinio snervante, un radere al suolo un territorio, un blocco massivo ad un
piano di sviluppo…”.
Né loro, né le diverse trasfigurazioni interne che hanno dato vita a formazioni onomatopeiche con intrecci sempre variegati - Asp, ASp/SEC_,
Aspec(t), Tuner+ (tra i due chitarristi Argenziano e Taiuti dei Zero Centigrade), Strongly Imploded, Agaspastik, Razoj - amano sentir parlare di
napoletanità o scene: “Non so cosa intendi per scena; l’unica cosa che vedo è
un campo di battaglia e quando penso alla gente che si muove in queste fila mi
viene da associarla al MEND in Nigeria, gruppi di guerriglia diffusi, una “leadership sfuggente”quasi assente. Si agisce nell’ombra, non solo per sottrarsi a una
repressione. Un continuo smarcarsi, un qualcosa di fluido, inclusivo, non proprio una clandestinità/underground, passa ovunque: città, provincia, centri,
periferia… Si costruiscono pratiche e le si smantellano, si fabbricano armi, le si
fanno esplodere, la cosa più bella è che faccio difficoltà a pensare che questo
cosa possa avere un centro in Napoli; le relazioni, da qui, sono intessute tutte
al fuori. Non ci sono più mappature ma linee di fuga, campi vettoriali, direzioni, intensità, geografie dinamiche, aggregati di forze, distribuzioni di potenziali. Oblomova e Perditempo, ma anche il BlackHouseBlues di Avellino, sono
i luoghi in cui si pianificano e avvengono le più efferate battaglie: le bombe si
costruiscono lì. Non è Napoli. Sono i luoghi che hanno assicurato, nel deserto
del reale, nella difficoltà di stringere relazioni al di fuori dalla loro stessa mercificazione, un modo per far emergere le affinità non solo di tipo musicale”.
Dei dischi pubblicati finora, tra collaborazioni, cd-r ed ufficiali, si supera
la dozzina. Fino all’ultimo importante cofanetto Viande su Die Schachtel,
che racchiude 10 dischi, uno per improvvisatore, e che dovrebbe rappresentare ciò che di più valido c’è nella musica impro italiana. “A parte il primo
disco, un vagito neonatale, il percorso che unisce Gariga, Agaspastik e porta fino all’imminente Viande non ha la linearità che sembra emergere dallo
scandire delle uscite; alcuni pezzi di Agaspastik sono nati prima di Gariga, ma
per la loro natura meno improvvisativa hanno avuto bisogno di ripetute “scremature”. Di de-arrangiamenti, potremmo dire. I due lavori si sono sviluppati
contemporaneamente, per poi condensarsi poi in due uscite molto diverse tra
di loro, una più spinosa, urticante, lirica a modo nostro, l’altra più scura e di
impatto”.
Gli A Spirale sono noti ai più, e con banale analogia, come la pars de35
struens degli Zu. Eppure siamo su altre coordinate: flussi amniotico-cerebrali che slittano tra momenti di raccoglimento energetico come nella
AMM, e talvolta in vere e proprie sfuriate ossessive. Si è spesso parlato di
avanguardie storiche per desrivere le loro piste ferrate, ma dell’avanguardia
hanno solo il pensiero di un limite. Altrettanto poco spartiscono col freejazz, almeno con quello canonico/accademico tutto centrato sul prestigio
tecnico e la velocità. Piuttosto gli A Spirale potrebbero somigliare ad un
trait d’union tra due teorie opposte ma affini: minimalismo (inteso come
ricerca del vuoto) e decostruzionismo (inteso come de-programmazione).
“Ascoltiamo veramente tanta musica, crediamo ci abbia influenzata tutta,
dall’impro radicale inglese - Evan Parker, Derek Bailey, AMM, Jack Wrigh - a
certe cose dell’impro australiana - Anthony Pateras, Jim Denley -, da certa
scena free form neozelandese - Bruce Russel e gli A Handfull of Dust - al noise “aktionista” svizzero - Rudolf Eb.er, Dave Phillips, Joke Lanz -, ai Voice
Crack, Gunter Muller, NMPERIGN, Borbetomagus, Karkowsky. Gente che
ci ha fatto pensare che con la musica si può fare tutto, una rivoluzione, un massacro, un’operazione chirurgica, cambiare le geografie…”.
Una musica fatta di micro-interventi senza anestesia, tessuto per tessuto, quasi si trattasse di origami o di chimiche allo stato grezzo che s’infrangono su specchi galoppanti. Materiali stellari di termo durata, di collassi
interpaziali e rigurgiti e rimbrottamenti. Vederli dal vivo è uno spettacolo:
ognuno dietro lo strumento dell’altro scompare per riapparire, quasi si trattasse di un nascondino, in cui batteria, chitarra e sax preannunciano delle
metafore di vuoto, ed imitano fraseggi incomparabili col flusso amniotico a
cui siamo abituati dal jazz-avanguardia masticato fino ai nostri giorni.
Dei Weltraum, come degli Endorgan, segnalammo i corrispettivi esordi (per quanto i primi avessero inciso un 3” che però andava in tutt’altra direzione). Nel frattempo, le attività collaterali di _Sec con Aspec(t) (insieme
agli A Spirale) e Strongly Imploded, con una fitta attività live per tutta la
penisola, hanno dilatato ulteriormente il logo della loro causa: il Rizoma. Se
c’è un termine programmatico per i materiali qui presi in considerazione è
proprio quello di Deleuze & Guattari: una sorta di rizomatica sonora. Rizoma distillato nella Napoli della resistenza invisibile, quella che non ha dialetti quanto una lingua minoritaria che sbuca come un vulcano e le sue lave
mobili, i suoi lapilli scompaginati. La musica dei Weltraum, appaiata attorno
ad un plasma germinativo, vibra e crea macchine illogiche, come i suoi tre
strumentisti, tutti discombaciati nella forza triangolare di distruggere i loro
strumenti per decodificarli con istanze decomponibili, labili. “Weltraum è
una parola tedesca che significa spazio siderale, cosmo. Come puoi facilmente
immaginare non è il suo significato a rappresentarci in alcun modo. Un nome
si sceglie per molti motivi, spesso per caso o perché ha un suono interessante,
ma dopo poco ciò che rimane è soltanto la sua referenzialità, l’indicazione di
qualcosa che accade”.
La chitarra di P’ex è un oggetto plastico, tra delays, oscillazioni occulte e
corde residuate, così come la para-elettronica cerebrale di _Sec. Se non è un
Rizoma è William Burroughs, se non sono macchine sono miniature dentro
macrocosmi per uno spassionato Abracadabra. Il sound di Weltraum, che in
linea genealogica potrebbe essere l’ereditiere dei This Heat, o forse una versione rock di Hotel Parallel di Fennesz, è studiato con sconvolgente beltà
per fare buchi nel terreno, e fuoriuscire dall’altra parte dei subwoofer. Più che
gesticolare attorno alla materia improvvisativa radicale, erompe verso la di36
weltraum
mensione elettroacustica. “Ascoltando il disco si direbbe che non c’è quasi per
niente. In realtà l’avvicinamento all’elettroacustica e a tutto il vastissimo mondo
di sperimentatori e improvvisatori in quel campo ha avuto un’importanza decisiva per il disco. E’ attraverso queste esperienze che si è consolidato in noi l’interesse
per il suono e il timbro, piuttosto che per l’armonia; per il ritmo e il taglio, piuttosto che per la melodia. In una parola, per la materia piuttosto che per il concetto.
La materia non ha rimandi, non ha significati reconditi, non ha interpretazione.
Non è nient’altro che quello che è, quello che ti tocca o ti ferisce. Sensazione e
nient’altro. L’improvvisazione, comunque, per noi è un punto fermo. L’interesse
nasce dall’ascolto e dall’amore per alcuni musicisti del free jazz come Albert Ayler, Sun Ra, Giuseppi Logan, ecc. L’improvvisazione non è, non esiste, in quanto cambia in continuazione e questa è la sua condizione assoluta. I Weltraum
sono il miscuglio di una sensibilità industriale (Swans, Godflesh, Techno Animal,
This Heat), di un fascino rock o math-rock (Don Caballero, Laddio Bolocko)
e di una pratica noise e improvvisativa (Sightings, Moha, Starfuckers, Lasse
Mahraug, Otomo Yoshide)”. Una versione poco italiana e molto giapponese
(gli Endorgan sono assai similari a Merzbow) di una elettroacustica-postrock dove pedali, computer e batteria trovano un accordo come in pochi e
rari casi. “In "Sy" c'è molto ferro: barre metalliche con piezoelettrico, lattine, campane, ferraglia in genere. La chitarra è spesso preparata con inserimenti di molle
e altri oggetti tra le corde. La batteria ha due timpani. L'elettronica è un ibrido di
analogico e digitale: il sintetizzatore analogico è spesso processato attraverso il
computer, e l'uso "suonato" di campioni e manipolazioni dà al tutto un'impronta
molto noise e materica”.
Due esordi profondamente alienanti, dall’impianto ferroso e vulcanico,
che si smaterializzano su cristalli e orientamenti incerti, ribadendo quell’in37
quieto equilibrio tra materia ed antimateria. Non rock quanto microorganismi autoriproduttivi, particelle di DNA, direzioni che si sbranano lungo il
tragitto che sembra un concorde impazzito per una guerra futura, un’irruzione elettrostatica, giocata tutta sul modo in cui gli strumenti smettono
di suonare come li conosciamo e diventano qualcosa di flessibile, amorfo.
“Similitudini molte: siamo io e P’ex, ossia due terzi dei Weltraum, abbiamo una
consapevolezza abbastanza forte del nostro percorso musicale e la riportiamo
in entrambi i progetti. Differenze evidenti: manca la batteria, c’è molta percussione elettronica rigorosamente suonata live e molto noise di quello sporco, i
pezzi sono molto più basati sull’improvvisazione. Sy è il frutto di più di due anni
di lavoro. La sua realizzazione è il prodotto di un lungo processo di maturazione e di sperimentazione, dove hanno influito molto sia le precedente esperienze, sia i nuovi incontri musicali e personali. La decisione di aprire un’etichetta
nasce dall’esigenza di pubblicare Sy e di farlo esattamente come volevamo noi,
curando ogni singolo passaggio della produzione, dalla registrazione, al mixaggio, al packaging, alla distribuzione. Noi non facciamo dischi per vendere o
per fare soldi, ma il disco è tutt’uno con la nostra attività di musicisti, ci aiuta a
entrare in contatto con altre persone, a instaurare relazioni, a trovare dei concerti. Non avrebbe senso che qualcuno si occupasse di questo al posto nostro”.
Tonino Taiuti e Vincenzo De Luce, in arte Zero Centigrade, sono una di
quelle constellazioni di difficile collocazione. Prima che musicisti, si presentano come accaniti ascoltatori e collezionisti di musiche altre, e l’approdo
al tardivo esordio è avvenuto in un’età in cui si è soliti considerare la musica
un'esperienza lontana e superata. “Zero Centigrade è un duo acustico nato
per sperimentare con chitarra e tromba, suoni e rumori che a tratti avessero dei
passaggi armonici quasi a sfiorare la forma canzone. Una musica impossibile
nella sua semplicità: corde sfiorate, stridori atonali, contrappunti frastagliati
e timbri di una tromba acida, uno sbuffo tanto umano quanto animale. Zero
Centigrade nasce da una proposta di Vincenzo, ma anni prima avevo portato in
teatro uno spettacolo che si chiamava Zero e che completai, successivamente,
con altri due lavori che s’intitolavano “Tò con Zero” e “Zerovatt”, tutti scritti per
me da Antonio Fiore. Dietro il nostro moniker non c’è nessun riferimento particolare. A zero gradi centigradi, l’acqua ghiaccia, diventa immobile generando
forme affascinanti e mutevoli. Generalmente all’immobilità non si associa mai
un atto creativo e questa idea mi intrigava” Anche la natura Napoli-centrica è
più interiore, basata com'è sulla musicalità dei rari interventi vocali di Taiuti:
“Innanzitutto da un’esigenza personale e poi dalla necessità di avere del materiale da poter far ascoltare agli amici, in quanto siamo due persone fuori da giri
organizzativi e suoniamo raramente dal vivo. Hanno entrambi un’atmosfera
molto “live”, un suono ruvido e saturo e la cosa ci piace”.
Il Taiuti è un attore teatrale e cinematografico (Morte di un matematico
napoletano, Rasoi, I Vesuviani), sceneggiatore (suo lo script di Polvere di
Napoli di Antonio Capuano) e rappresenta quella Napoletanità che non
ritroverete mai e poi mai in nessuna volgarizzazione propagandistica o
pubblicitaria di Napoli. Il De Duce è architetto, e ha imbracciato la tromba,
nella stessa maniera con cui di solito un ateo, improvvisamente, decide di
diventare fervente cattolico. “Napoli è una maledetta città ma è anche una
maledetta fonte d’ispirazione. D’altronde, quale artista non vorrebbe vivere a
Napoli? C’è un rapporto di odio amore tra noi e lei. Vorresti scappare ed invece
resti, trattenuto da una mortificata bellezza. Se si pensa solo alla sua ricchezza
38
letteraria, quella favolistica del Basile, il lirismo dell’antica canzone, la drammaturgia di Viviani, Eduardo ecc…E non è un caso se, attualmente, a Napoli
c’è una delle scene “impro” più vive ed interessanti d’Italia”. Ciò che separa Mississipi John Hurt o Robert Johnson dai Zero Centigrade, più che un secolo passato, è forse Napoli. Se certe musiche dell’anima fossero partite qui, in una città in bilico tra frammentazione e pienezza,
brutalità e poesia, non si sarebbero distanziate troppo dall’essere delle forme sonore così complesse, contraddittorie eppure così nudamente semplici. Non a caso, quella che chiamiamo Pre-War Folk Music è l’epicentro strutturale di un casuale e stranissimo modo d’inventare il blues, di far parlare
l’animo, senza che tecnicismi o teorie subentrassero nel suono.
I Zero Centigrade partono quasi da zero in un limbo assai dilatato, ma
profondamente similare, che collega l’avant al blues. Non si considerano
musicisti, non si presentano come intenzionati a costruire discografie perfette, ma semplicemente estendono i vuoti del loro lavoro, gli spazi architettonici vuoti e quelli teatrali, ancora più tombali, in un suono dall'ostica
praticabilità. “Abbiamo un’idea di improvvisazione abbastanza personale,
non legata né alla classica jam, né all’improvvisazione radicale alla AMM. L’improvvisazione per noi è un punto fermo. L’interesse per l’improvvisazione nasce
dall’ascolto e dall’amore per alcuni musicisti del free jazz come Albert Ayler,
Sun Ra, Giuseppi Logan, ecc. L’improvvisazione non è, non esiste, in quanto
cambia in continuazione e questa è la sua condizione assoluto. Il vuoto in teatro è l’oscuro oggetto del desidero. Ci vuole un vuoto per riempirlo in un pieno,
bisogna sospendere il tragico e far nascere la causa sul nulla, sul vuoto. Il vuoto
è la rappresentazione del cosmo. Noi ci nutriamo di luce e di buio, come di suono e di silenzio, il vuoto serve nel teatro come nella musica per parlare di un al
di là, o un al di qua. Il vuoto è qualcosa di molto soggettivo, acquista senso solo
in relazione a colui che lo percepisce. Il vuoto, tra le sue tante accezioni, può
essere inteso anche come risultato di un lavoro di sottrazione, di scavo. Uno
scavo che in musica si traduce nella ricerca di semplicità che richiede grande
attenzione e fatica”
A differenza di tutta la scena avantgarde, amano solcare la differenza
prediligendo effetti poco speciali, ovvero gli strumenti (tromba e chitarra)
nudi e crudi, come madre natura li ha inventati. Del blues c’è il pathos, e
del minimalismo c’è il mare magma della ricerca sonora più estrema. E poi
troverete l’harsh-noise (fatto senza pedali), la microtimbrica di fiati di Nmperign, i fraseggi nostalgici di Loren Connors, il no-input–signal di Sachiko M, l’aleatoria di Tetuzi Akiyama. Su tutto aleggia il teatro dell’assurdo,
dove non sai mai quel che accadrà. Tra l'altro è appena fresco di stampa
il loro terzo lavoro, licenziato dall'italiana Ripples, insieme al giapponese
Former_Airline, disco di sbalzi dinamici, ossessivo, che ricorda i primi timidi tentativi di associare la freddezza sferica dell’elettronica modulare del
Giapponese, con le criptiche conversazioni duettate dei Zero Centigrade.
Napoli è un crocevia, il crocevia. Dentro ogni crocevia c'è la fretta del
movimento, l'oscillazione del viaggio. L'Avant ai nostri giorni è un porto
franco, ha più bisogno di velocità e forze centrifughe che di luoghi solidi.
La ricerca in Italia trova qui un luogo baricentrico, ma anche una via di fuga
da cui diramarsi come un rizoma, senza creare alberi, ma solo connessione,
luce e vita?
39
Recensioni
— cd&lp
highlight
AA. VV. - Fünf (Ostgut Ton, Ottobre 2010)
Genere: House, Techno
La Ostgut Ton, è la label personale del giro Berghain/
Panorama Bar, un club berlinese che sta facendo sempre di più sentire la sua presenza (e potenza) nel panorama techno e house europeo. La riprova è in queste
fascinose tracce contenute in un doppio cd celebrativo
compilato per i primi cinque anni di attività del locale.
Protagonisti i dj resident e altri personaggi UK di tutto rispetto quali Luke Slater, Emika e il noto SCB aka
Scuba (trasferitosi nella capitale da circa un anno) tutti impegnati a comporre tracce ad hoc per la compila.
L'interessante espediente era che ogni brano doveva
partire da - e magari costruirsi solamente attorno a field recording catturati nel locale (una vecchia centrale elettrica).
Il risultato è affascinante. Un affresco post-Berlino con
richiami all’industrial e al post-punk storici che ogni
DJ ha declinato in uno spettro che va dai clangori Einsturzende ai grigiori Cabaret Voltaire, passando naturalmente per l’epopea dei Throbbing Gristle, Chris e
Cosey.
Beninteso, l’approccio ha comunque in sè il nerbo
technoide Ostgut, e giusto un pizzico di house, magari caratterizzato dalla minimal+groove al ralenti che
ricorda il recente esordio di Magda (From The Fallen
Page), come accade nella splendida Down Moment del
citato progetto techno di Scuba (senz’altro uno dei killer beat di Fünf ), oppure nel thriller da sottomarino del
fresco di firma Ryan Elliott, Abatis. In più innumerevoli
flavours: prezioso il contributo Marcel Fengler che al
Berghain è uno dei dj di punta: Shiraz è un incubo deep
su cassa morse, lontane visioni ardkore e un frastaglio
ritmico decisamente tech (quasi una versione auf Berlin degli Autechre); egregio Daybreak con il groove
house d’antan à la Omniverse calato attorno alla cassa
4 e claps old skool.
Buoni anche coloro che si sono maggiormente attenuti
ai field recording per creare le loro tracce, come Marcel
Dettmann la cui Shelter è un incubo Gristle in piena
regola. Sul lato house c’è, invece, Murat Tepeli con Elif
Biçer, tra Roland e groove ’90 stretchati; e la Chicago al
distorsore di Soundstream con Wenn Meine Mutti Wüs40
ste; mentre sulla techno più vicina alla Minus troviamo
Boris con Rem, degna del miglior Plastikman (ma senza sbotto), e l’attacco di Cassy in Never Give Up A Mood
Swing (che poi virerà house).
La conferma dell’altissima qualità della Ostgut Ton.
Una compila indispensabile anche per tutti gli amanti
del cielo sopra Berlino.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
AA. VV./Apparat - Dj Kicks (!K7, Ottobre
2010)
Genere: Elettronica, dance
Torna pesissimo Sasha Ring sul nuovo corso del DJ
Kicks. E sforna un mix di tutto rispetto dal flavor multidisciplinare, come già le sue collaborazioni con Ellen
Allien e Moderat ci avevano testimoniato. Che il ragazzo scapigliato possa fare di tutto con tutto l’avevamo già capito da mo’: il suono da club nel suo show
sull’etichetta berlinese la fa da padrone, ma viene modulato con crescendi di intensità che addolciscono la
pillola anche per i non addetti.
Maestoso nell’incipit (stupendo il pezzo di 69), diretto nel proseguio con le malinconie Telefon Tel Aviv,
squadrato e ossessivo al punto giusto (Luke Abbot in
visibilio Basic Channel), ossessivo in salsa now (Martyn
e il remix di Four Tet per i Born Ruffians), tribalista con
l’ausilio di Ramadanman, ambientale su Thom Yorke e
clubbissimo nel suo inedito Sayulita in esclusiva per la
compila.
L’esito conferma la dichiarazione rilasciata alla stampa:
"Ho bisogno di mixare cose differenti per mantenermi
motivato". Senza stile e per questo con più stile degli
altri. Passaggi morbidi e indolori per uno dei migliori
personaggi che distillano dolcezza dal tunel oscuro
della techno (vedi la stupenda chiusa finale con Tim
Hecker) che rimanda comunque ad una matrice sottostante dreamy, da sempre caratteristica del ragazzo
apparato. Il comeback della melodia: lacrime e pelle
d’oca per noi.
(7.2/10)
Marco Braggion
Afrirampo - We Are Uchu On Ko (Rock Action, Settembre 2010)
Genere: japapsychnoise
Se la madre terra vorrà, o il cielo, o chi per essi, suoneranno ancora insieme. Così dicono le Afrirampo,
dopo aver annunciato lo scioglimento, e pubblicato il testamento, oggi a disposizione, dopo sei mesi,
anche alle nostre coordinate sul geoide. A noi non rimane che ascoltare il sapore energico/nostalgico
di We Are Uchu On Ko, capitolo finale del duo japanoisepunk, meteora o sottobosco costante dal 2002
a oggi.
Il pensiero va ovviamente a OOIOO, ma da Occidente si rischia spesso di non godersi le sottigliezze.
E We Are Uchu On Ko è un doppio album pieno di omaggi al cultore rock, di quello che ama tanto i Grateful Dead quanto i Boredoms. Strepitoso il secondo CD, cavalcata dietro cavalcata, calumè
sopra calumè, freccia dietro freccia di un arco indiano che semplicemente diremmo acid psych (Sunwave Dance). Hoshi No Uta, divisa in cinque
tracce, è una composizione psichedelica che articola pause e ripartenze,
la tradizione dei Red Crayola e quella dei rumoristi giapponesi. E, ancora,
rarefazioni acide e acidissime galoppate, che vanno a lambire i Lightning
Bolt, pur mantenendo come universo di riferimento il rock americano degli anni Sessanta, il dolce calore pastorale che si apre all’alba di una notte
piena di funghi.
Sore Ga Afrirampo, tornando al primo CD, ha una chitarra garage esplicita,
ma di fatto la stessa linea d’onda. Più catchy dell’altra metà del cielo di We Are Uchu Ok No (ma sempre
meno degli altri album), le sette tracce del disco uno mantengono un respiro che cortocircuita un tutto
tondo Sixties USA - MC5 compresi (Tou Zai Nan Boku) - con i caratteri del Sol Levante. Paradigmatica
Umi, capolavoro a parer di chi scrive, fatto di trance, porte della percezione, ma anche africanismo
fake - certo, le Nostre sono perdonate, memori dell’esperienza camerunense, a stretto contatto con
tribù pigmee - e chiusura sardo-zen. Altrettanto esemplare Egolo Island, zappiana ed eccessivamente
nipponica, ma garagissima nei riff e nelle strutture che si susseguono; praticamente l’equivalente di
un disco della In The Red. Ecco una buona descrizione di We Are Uchu On Ko: un doppio concentrato
qualiquantitativo di brani che potrebbero fare ognuno da esempio per altrettanti dischi. Speriamo
nella madre terra.
(7.4/10)
Gaspare Caliri
AA. VV./Friendly Fires - Bugged Out!
presents Suck My Deck Mixed By Friendly
Fires (!K7, Settembre 2010)
Genere: p-funk house
I principini del crossover indie/dancefloor si misurano
con un mix eclettico su Bugged Out! che sorprende per
lo stile sopraffino dell’innesto. Non si sfora nel baraccone truzzo, signori: qui house è sinonimo di chicness
che titilla i timpani dei clubbers più esigenti, ma anche
di chi non ha più l’età per sopportare gli afterhours del
cornetto e cappuccio all’alba e si consola con del sano
savoir faire speziato rock.
Il bilanciatissimo trattato dell’arte di mixare dei tre ragazzi di St Albans - nell’Hertfordshire inglese - va di
lusso su coordinate prog (la stupenda rivisitazione di
Aeroplane per Linsdtrøm & Christabelle), ossessioni
41
deep (Rebotini), inni disco (la bella collaborazione giocattolosa con gli Azari & III da Toronto), il soul di The 2
Bears, esplosioni al laser Novanta (BDI), tocchi che accennano al fidget (Boo Williams) e cantabilità dei sempre validi Phenomenal Handclap Band. Come a dire
che si possono ancora coniugare i sapori del ritmo con
un certo sentimento live, che smuove il sangue nelle
vene e fa ballare anche senza l’ausilio di droghe più o
meno pesanti.
Una presa di posizione in sordina che piace per il dosaggio di elementi altri rispetto al mondo da club (la
stupenda visione/sogno post-balearico di Tom Trago
per dirne una). Regalate un’oretta del vostro prezioso
tempo ai Friendly Fires. Non sia mai che poi anche a voi
scatti il repeat in automatico. Contagioso e seducente.
(7.2/10)
Marco Braggion
AA. VV./Gui Boratto/Kreidler - Different
(Boxer, Novembre 2010)
Genere: Ambient, dub, techno
La boxer recordings è un'etichetta di Colonia attiva dal
2002 che si occupa, anche attraverso sotto marchi quali Kickboxer e Boxer Sports, di produzioni techno e minimal. Different è una compilation inedita che, già dal
titolo, preannuncia una tracklist alternativa alla dance:
tra le produzioni di molti giovani artisti che la label recluta costantemente (e alcuni nomi noti) troviamo produzioni ambient, world, down tempo e una manciata
di pop song. In pratica, è una compila chill out ma con
rigore e taglio krauto dove alla psichedelia si preferisce
il taglio tech con ritmi esotico-etnici conditi da smalti e
echi dub in gran spolvero.
Ne viene un caleidoscopio elegante e risaputo per gli
aficionados IDM: Patrick Chardronnet mescola Orb, predicatori Eno Byrne e Miles Davies (Seeing In The Dark), Extrawelt rimette in pista i primi Autechre (Yummi), Airbus
Modular rallenta la deep e condisce con ricordi pop (Assembly Notegram), Stephan Hinz ripesca alcune atmosfere dei Tarwater (Dry Toast And Half A Grapefruit), mentre
Matzak, con &lz, punta dritto al cantato r’n’b sempre su
basi post-IDM (e questa volta umori Thom Yorke).
Tra i guest famosi: Gui Boratto (deep techno girata
Kraftwerk e eighties per Half Life) e Kreidler (l’etno seventies e gli attacchi chamber di Venusia) non a caso
messi a inizio scaletta.
Mettiamola così: potrebbe essere vista come l’equivalente di Nuggets per l’ambient tronica tedesca dei duemila. Nel bene e nel male. Eleganza soprattutto.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
42
Adam Franklin - I Could Sleep For A
Thousand Years (Second Motion Records,
Settembre 2010)
Genere: post shoegaze
Album numero tre come solista per Adam Franklin,
coadiuvato stavolta - anche nella ragione sociale dalla propria live band Bolts Of Melody. Il chitarrista e
cantante dei Swervedriver ed ex-Toshack Highway,
insiste con la formula del non troppo convincente
predecessore Spent Bullets ma coglie un punto di fusione più intenso e definito. Il languore onirico figlio
dello shoegaze di ritorno e già debitore del mai troppo
rimpianto Elliott Smith, si arricchisce oggi di torpori
obliqui Big Star (conclamati in Carousel City, striscianti
in She's Closer Than I've Ever Been) e più solenni inquietudini Tom Petty, mentre una rinnovata verve elettrica
scomoda foschi scenari Jesus & Mary Chain e fregole
Folk Implosion, spingendosi persino ad ammiccare
l'impeto dei Sonic Youth più friendly (I'll Be Yr Mechanic).
Manca un centro di gravità cui saldamente aggrapparsi, quindi non resta che cogliere al volo le canzoni che
scorrono piuttosto gradevoli, cogliendo il climax con
la trepida I Want You Right Now e riscattando una fin
troppo brumosa Lord Help Me Jesus, I've Wasted A Soul
(misticanza spacey, gospel e desertica) con lo spurgo
power pop conclusivo di Take Me To My Leader.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Admiral Radley - I Heart California (The
Ship, Ottobre 2010)
Genere: low-fi pop
Non che avessimo dubbi su chi, tra i "nonnetti" californiani, fosse il più dotato. A Jason Lytle lo scorso anno
bastò la bellezza di Yours Truly, The Commuter per convincerci che, dopo lo scioglimento dei Grandaddy, ci
fosse una vita oltre la semplice dignità. Frattanto, l’iperattivo ragazzo metteva in cantiere gli Admiral Radley
con l’ex compagno di squadra Aaron Burtch e gli amici Aaron Espinoza e Ariana Murray degliEarlimart.
Oggi, accantonato il rischio di recensire un lavoro intestato a Grandimart o Earlidaddy (quella l’idea originale...), l’ascolto invoglia dapprima al sorriso e poi induce
a collocare il dischetto sotto la lettera "G".
Poiché dove Lytle ricorda il passato prossimo - su tutto
I Heart California, Lonesome Co. e il valzer cantato dalla
Murray The Thread - riemerge la sognante melanconia
che non abbiamo mai dimenticato negli anni. Miscela
di Pavement ed E.L.O. con ombre di Guided By Voices ancora intatta, benché - com’è logico che sia - quel
tot meno fresca; tuttavia, l’integrità artistica produce
azzeccate variazioni di rotta come chitarre più del solito aspre in Red Curbs, una stratificata GNDN, l’articolato omaggio lennoniano Ending Of Me. Il problema è
l’uscita dal seminato di un elettro-rock abborracciato
(orrida I'm All Fucked On Beer; inutile Sunburn Kids) di
cui avremmo fatto a meno. I fan avranno comunque di
che dilettarsi: gli altri assaggino e chissà che il cuore
non gli si sciolga nell’amarezza scintillante di Chingas
In The West e I Left U Cuz I Luft U.
(6.9/10)
Giancarlo Turra
Alcool Etilico - Alcool Etilico (Enzone
Records, Novembre 2010)
Genere: rock d'autore
Ci si lamenta spesso di quanto poco passi fra la nascita
di un gruppo e la pubblicazione di un demo o di una
prima uscita ufficiale. Però prendete l'esempio degli
Alcool Etilico da Lipari: inizio nel 1996, diversi cambi
di formazione, ora l'esordio. Dieci tracce di rock d'autore, arrangiate anonimamente quando non proprio
male (certe scelte di suoni...), cantate con una pronuncia da strapaese e parecchie incertezze d'intonazione,
dotate di liriche come spesso accade troppo ermetiche
o autoreferenziali. Lì in mezzo da qualche parte nella
landa sconfinata che separa i Marlene Kuntz dai Negramaro, con l'aggravante delle zavorre appena elencate. A metà tracklist Nala prova addirittura un mezzo
tango e, a parte che sembra di sentire Le Vibrazioni, è
la conferma di una specie di circolo vizioso tra inutilità
e bruttezza. (4.8/10)
Luca Barachetti
sione dell’elettronica e dei concretismi astratti di Alva
e il borborigmo vocale di Blixa. Once Again riprende un
processo ritmico traslato da Zeichnungen Des Patienten
OT, su un refrain inedito per entrambi. Il suono è più
sanguigno degli ultimi Einsturzende, e l’elettronica di
Alva Noto si dimostra vivida, meno algida del previsto.
Il più delle volte l’ascolto si teatralizza - e qui BB è decisivo - senza che questo sia sempre un bene. Ci si immagina la performatività della coppia, la presenza scenica
di Bargeld, l’affilatissima elettronica di Carsten. Blixa si
mette in gioco, tenta tutto lo spettro espressivo dei registri che la sua voce può produrre, e ce ne dà prova in
I Wish I Was A Mole In The Ground (in versione estesa rispetto all’EP), peraltro infiorettata di mestiere da Noto,
così come nei miagolii di Katze. Red Marut Handshake
- mutuata anch’essa dall’EP che ha dato il via alle pubblicazioni congiunte del duo - se ne va con un down
tempo accelerato e perturbato da elettroniche in chiaro e l’onnipresente para-declamazione del Bargeld.
Bersteinzimmer (long version) colpisce con struggenti
ambientazioni e atmosfere da canzone teutonico-mitteleuropea.
Mimikry è un calendario di colpi da maestro, da parte
di due posizioni tangenti ma non ancora sovrapposte.
AN e BB sono due penne e due teste distinte, e questo rimane, così come il giudizio che avevamo dato al
precedente EP, di cui questo album non è di fatto che
un’estensione. Le aspettative create nei primi due minuti dell’album sono, se non ridimensionate, virate in
attenzione alla statura, al mestiere, alla bravura dei
comprimari. Bene così, ma a questo punto ci aspettiamo un passo in più
(6.9/10)
Gaspare Caliri
Alva Noto/Blixa Bargeld - Mimikry
(Raster Noton DE, Ottobre 2010)
Genere: elettronica
Il grido strozzato di Blixa Bargeld, tratto distintivo e
tic linguistico del suo codice, usato come campione,
materia su cui sviluppare layer elettronici e glitch. Così
inizia Mimikry, attesissimo debutto sulla lunga durata
della sigla ANBB: alzando la posta, con un quasi-manifesto programmatico, una dichiarazione di potenziale
tra mr. Bargeld e mr. Nicolai.
La iniziale Fall è in realtà una suite, così come la maggior
parte dei brani. Nascono su alcuni temi e terminano su
altri, lavorano di cesellature raffinate e trovano spesso
un collante molto forte - e tensivo - nella percussività
(Mimikry, o l’ipertensione e le extrasistole di Berghain),
grande matrice ancestrale che bilancia l’algida preci-
Amiina - Puzzle (Amiinamusik, Settembre
2010)
Genere: Chamber folk-rock
A tre anni dal precedente long playing, Kurr, le quattro
Amiina non sono più quattro ma una piccola comunità. Già un eppì in tiratura limitata aveva indicato il
nuovo corso: un emancipato ensemble allargato a sei
elementi dal sound più corposo, organico, variegato, e,
se vogliamo, anche maggiormente rock.
Con Birgir Jón Birgisson al desk, le islandesi hanno riavvolto il nastro post-rock tanto caro all’Islanda e sono
ripartite daccapo, ridisegnando cioè il chamber folk
degli esordi in una faccenda concreta di ragazzi (i due
nuovi membri Vignir e Maggi) e ragazze raccolti attorno al focolare. Puzzle ci racconta così di viaggi con la
43
mente, epopee (In The Sun), sapori giapponesi (Púsl),
ovvie passeggiate con Mùm e Sigur Rós (Mambo), film
in bianco e nero (Thoka) e a colori (Sicsak).
Coordinate già note a chi aveva acquistato il citato EP
del 2009 (Re Minore), caratterizzato però da tagli più
elettronici e dark rispetto a Ásinn, Púsl e Sicsak. In Puzzle
domina l'approccio suonato, la casa è più grande e le ragazze intime e sincere come ce le ricordavamo. Le voglie
Mogwai di un brano come Sicsak aprono poi altre prospettive. E chissà quale sarà la prossima mossa...
(7/10)
Edoardo Bridda
Apples (The) - Kings (Freestyle Records,
Ottobre 2010)
Genere: crossovered funk
Piacciono sia la musica che l’attitudine, negli Apples.
Nel senso che ti affezioni subito al loro funk fumigante
e appropriatamente groovy eseguito insieme al leggendario Fred Wesley (su tutto James Brown e l’asse
Parliament/Funkadelic: meglio specificare, che non si
può mai sapere
); addirittura applaudi allorché - nel poker di brani che ospitano Shlomo Bar, eminente figura
della musica popolare d’Israele - ci si affaccia su scenari
mediorientali. Stanno in un desiderio di con-fusione
totale e in una voglia di costruttiva ambivalenza, segreto e magia del risultato, ottenuti da questo nutrito ensemble di nove elementi varcando la porta dello
studio di registrazione con due mostri sacri e interagire
con loro senza timori reverenziali.
Catturando in tal modo una visione sonora e culturale
genuinamente a 360°, che - in una scaletta salomonicamente spartita - racchiude i due poli del loro mondo
sonoro solo per mostrare quanto sia possibile mescolarli e cavarne freschezza. Accade con costanza in trentotto minuti di esuberante funk urbano rigoglioso di
fiati e scratching (Howlin’ With Fred, In The Air), di favoloso dub un momento sinuoso e quello successivo dolente (Walking To The Palace), di oscillazioni tra oriente
e occidente che respirano l’attualità (una title-track
riassuntiva e divertita; il suono "totale" di Batash e Banana Jam). Meticciato consapevole, energico e stiloso,
alla faccia di chi ancora vuole erigere muri e steccati in
un pianeta sempre più globale.
(7.2/10)
esclusivamente ai concerti americani dell'ultimo tour
degli Ariel Pink's Haunted Graffiti, eccentrico souvenir
dalla grafica rivelatrice. Sono cinque pezzettini in collaborazione con gli Added Pizzaz, fantomatico combo
avant-jazz di Dallas (ma sul disco troviamo in realtà la
stessa formazione b/vintage che suona su Before Today, guidata dai fiati dei fratelli Gonzalez).
Lounge disturbata, drogata e onirica, un po' Madlib
in vena psych un po' Mothers of Invention di America
Drinks and Goes Home, il tutto, ovviamente, abbastanza
cazzeggio pseudo-avant, compreso il cut lungo della
già nota Hot Body Rub. Spicca soltanto il bel gioco di
estremo zapping pop-deformato - zappiano rundgreniano fowleyano residentsiano - di 4 I M NN7. Cool fuffa.
(6/10)
Gabriele Marino
Arturo Fiesta Circo - E lo chiamerai
Giovanni (Via Audio, Ottobre 2010)
Genere: cantautorato-folk
"I sarti che vestono le mie storie sono musicisti attivi in
diversi contesti musicali. Questo è un sistema che mi piace perché è una finestra aperta sul mondo e mi obbliga
a stare sveglio. Il Circo non è una band. Assomiglia di più
ad un "cantiere" o a una "palestra" per i giovani musicisti
che lo compongono." A parlare è Sergio Arturo Calonego, titolare della ragione sociale e deus ex machina
del progetto. Tanto per chiarire che tutto quello che
ruota attorno a questo secondo disco della formazione
è materiale vario ed eventuale nel genere, nella forma
e nelle atmosfere. Un folk-jazz-chanson-cantautoratorock nomade e difficilmente etichettabile, un po' figlio
dei tempi in cui viviamo e un po' consapevole esercizio
di stile per una band di strumentisti virtuosi.
Ce n'è per tutti i gusti, dal valzer spazzolato de La Ballerina alle chitarre elettriche de L'idiota, dal Tenco de
L'acrobata al jazz confidenziale de Il domatore, dal ragtime-folk di Le Royal al blues virato Sud America de La
regina del circo. Brani suonati da dei Raymond Queneau in note che vanno a comporre un'opera esemplare, inaspettatamente coerente e malinconica al punto
giusto.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Giancarlo Turra
Ariel Pink - With Added Pizzazz (Free Dope
And Fucking In The Streets, Luglio 2010)
Genere: psych lounge
Questo ep in edizione limitata si poteva acquistare
44
Avey Tare - Down There (Paw tracks,
Ottobre 2010)
Genere: avantpop
Mentre Panda Bear in solitaria si è preso soddisfazioni anche pari a quelle del gruppo madre, David Port-
highlight
Bachi Da Pietra - Quarzo (Wallace Records, Ottobre 2010)
Genere: minimal-rock
Il ritorno dei Bachi Da Pietra dopo l’ottimo live Insect Tracks ha di nuovo un titolo materico, in cui l’allusione alla pietra, al tempo, ad una forma primigenia di elettronica, prelude allo spostamento dei paletti
del sentire lirico-musicale della coppia Dorella-Succi. A far da humus, al
solito, un minimalismo sofferto e angoscioso, vibrante e reiterato, fatto di
corde percosse e percussioni risicate all’osso che stazionano sempre sul
crinale di una personale forma di blues desertificato e un sentire rock irregolare e unico. Gli intarsi di chitarra di Dragamine o l’incedere claudicante e trance-inducing di Niente Come La Pelle ne sono perfetta esecuzione.
Accanto o sottotraccia, però, c’è ben vivo il gusto per la sperimentazione,
per il superamento dei confini di una musica troppo riconoscibilmente
"classica". Ecco allora la rarefazione elettroniconcreta di Zuppa Di Pietre, il
rumorismo di matrice technoide di Pietra Per Pane, i carsici disturbi elettrostatici di Non È Vero Quel Che
Dicono o il frammento hayesiano reso famoso da Tricky e Portishead che traina l’intera Orologeria:
tutto sempre rigorosamente suonato col solo ausilio degli strumenti d’ordinanza. Dimostrazione del
saper magistralmente giocare con dinamiche "altre" e prestiti (rielaborati, rivisitati, ripensati) da generi
"distanti".
Un procedere quasi di svelamento di fonti, di apertura al mondo che tocca anche le liriche succiane,
altro punto fermo dei Bachi. Mai come ora intelligibili, dotate di un taglio tra l’ironico e il sarcastico, beffarde nella esplicita Bignami (noi vi amiamo vi adoriamo vi benediciamo / noi cantiamo (zitti cantiamo) / il
vasto mondo aperto / nel nostro trovar chiuso / al vostro orecchio duro ottuso illuso / che non sente giustamente (e me ne scuso) / il nostro tessere) o nell’amarezza senza respiro di Fine Pena, sembrano smorzare
i toni dello sguardo lucido e tragico sull’esistente dei Bachi. Una indagine nel sottosuolo letterario che
riabilita il senso del termine songwriting, scegliendo vie metriche e melodiche personali e mai banali.
Un ottimo ritorno, dimostrazione di personalità e capacità oltre che di volontà di superare se stessi
giocando sul terreno di casa.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
ner, che ne è paradossalmente la penna più prolifica,
come solista doveva ancora fare la sua comparsa. Prima
di quest'esordio, è vero, c'era stato Pullhair Rubeye, ma
era un album registrato in estemporanea con la moglie
Kria Brekkan (ex Mùm) e non un canzoniere privato da
opporre al compagno di cordata.
Prima regola è trovare un percorso, un tratto distintivo.
E così, se Panda si è più volte dimostrato a proprio agio
nel confrontarsi con la psichedelia, Avey ha scelto il decennio del post-punk e - soprattutto - del synth pop per
trovare una valvola di sfogo. Il risultato è forse meno
disinvolto e quando la ricerca individuale s’interrompe,
il tutto confluisce amabilmente nei codici e nelle modalità della band madre di cui Porter è il co-motore creativo.
Proprio sulle mode si gioca l’ambiguità di Down There.
Da una parte, regna l’immaginario doppio zero, che gli
Animal Collective hanno contribuito in maniera determinante a creare, e che qui si riconfigura con assonanze Indian Jewelry (per oscurità di esercizio), Ruby Suns
(Heads Hammock) e persino Xiu Xiu (Lucky 1 è a metà
tra gli Animal e il progetto di Jamie Stewart); dall’altra
questo si va a sposare con quegli Ottanta che fanno
un occhiolino ipnagogico (Oliver Twist) certamente furbesco, anche se qualitativamente una spanna sopra la
media delle produzioni in questo senso (Heather In The
Hospital).
Dimenticandoci della sbornia glo, è lecito guardare a
dischi come Down There come una nuova possibilità
di cantautorato post-’00 (e post-revival ’80), con tutti i
crismi e strati compositivi a cui ci dobbiamo abituare al
voltar del decennio.
(7/10)
Gaspare Caliri
45
Bad Religion - The Dissent Of A Man
(Epitaph, Settembre 2010)
Genere: punk legends
Dei Bad Religion impressiona non tanto il fatto che siano in piedi da trent’anni. E’ la forma in cui sono giunti
al fatidico appuntamento a guadagnarsi la nostra ammirazione; l’evidenza che, al quindicesimo lp in studio,
Greg Graffin e Brett Gurewitz impugnino ancora saldamente il timone e che rimangano essenzialmente
immutati i motivi che li hanno resi esemplari. Fuor di
retorica: la loro è una ricetta semplice ma che come
tale vanta infiniti tentativi di imitazione e ognuno inferiore. Che, se combinata con mano sapiente, può
offrire canzoni di rango tipo la cavalcata The Day The
Earth Stalled e l’amara innodia di Only Rain che aprono
questo disco.
Degne di Maestri che le loro rivoluzioni sonore già le
hanno inscenate epperò non mollano, consci di come
sarebbe impossibile proporne nel canone hardcore
punk da loro stessi forgiato a meno di assurde o ridicole modernizzazioni. Si tratta di tradizione, per cui se
assaggi la torta della nonna da un forno industriale il
gusto non è uguale e idem se il cuoco non ci mette
cuore e testa. Così che, anche nel lavoro meno azzeccato da che a inizio decennio i californiani risorsero con
The Process Of Belief, i brani eccessivamente formulaici
vengono spazzati via dal pugno di nuovi classici che
fondono aggressività, melodia e testi intelligenti: una
scintillante Cyanide e una fenomenale The Resist Stance, l’epidermica Won’t Somebody e le eleganti però possenti Avalon e Meeting Of The Minds. Punk di mezza età
senza patetismi: si può.
(6.9/10)
Giancarlo Turra
Barn Owl - Ancestral Star (Thrill Jockey,
Ottobre 2010)
Genere: doom
Austerità, ampiezza, doom, passo mantrico, chitarre,
rarefazione del blues, droni. Le parole chiave di Ancestral Star sono le stesse di The Conjurer. La concentrazione e l’ossessione della ricerca dei Barn Owl non
può che rimanere autentica. Perché, al di là delle parole
chiave, il nocciolo della musica di Caminiti e Porras è
proprio l’autenticità, la purezza della formula, della materia musicale e del messaggio che ne consegue. Ogni
brano (la title-track, che monta dronicamente, ridiscende, lascia spazio a un lamento al ralenti di chitarra,
in secondo piano, si rarefa) è un esemplare raro, eppure estremamente familiare. È un tutt’uno che vive del
proprio respiro, a cui non si può aggiungere nulla né
46
togliere alcunché. E ciò valga per tutta la psichedelia
siderale che il duo è capace di esprimere (un deserto di
stelle in Vision In Dust, con accompagnamento vocale
alla Ummagumma Live), per tutte le ascensioni e gli
atterraggi nel deserto.
Ripetizione è un altro nome per quella purezza che
quando si svolge in strutture ha bisogno di riprodurle
in continuazione. Night’s Shroud sembra essere l’unico
tema possibile per il loro universo desolato, un tema
reiterato senza fretta, anzi con la calma di chi ha la consapevolezza che la fine dei tempi è una realtà, e chiuso in un paio di minuti. L’eccezione - neanche troppo
distante dalla regola, però - è il pianoforte di Twilight,
crepuscolare ma anche vitale, nella sua progressione
infinitesima e impercettibile. Il culmine è probabilmente la finale Light From The Mesa, ma solo perché deve
procrastinare l’atmosfera apocalittica fino alla prossima prova dei Barn Owl. Ci sembra, nell’attesa, di essere
tenuti a rimanere immobili, ma nel frattempo sposteremo i nostri giudizi e le nostre facoltà. Come questa musica, che sembra immobile e identica a se stessa, eppur
si muove, procede, vedendo l’orizzonte - e l’agognata
fine - che a ogni passo di sposta sempre più in là.
(7.3/10)
Gaspare Caliri
Benoit Pioulard - Lasted (Kranky, Ottobre
2010)
Genere: Folk, drone
A quattro anni dall'esordio Précis e due dal sophomore
Temper, il femmineo Thomas Meluch non ha cambiato metodo e intenzioni. Lasted è stato inciso e missato
in completo isolamento domestico, intinto nel folk/pop
di Drake-iana memoria e inframezzato di droni e brevi
strumentali avant-folk. L'ispirazione è sempre lì, tiepida
e delicata, pastorale e astratta. Il terzo album di Meluch
è un canzoniere della memoria pronto a indirizzarsi
verso un songwriting immerso nei field recording, che
in alcuni casi pare maturato (le inflessioni folk-rock e i
tocchi eighties di Lasted) e in altri ripetuto all'infinito
(Tie, A Coin On The Tongue).
Camminare, ogni due anni, in questo piovoso giardino
è un po' come tornare a casa in autunno. Ci ritrovi un
ragazzo chiuso in sé stesso ripetere la stessa, suggestiva, incantevole canzone. E' un tutt'uno con il fascino
della decadenza.
(6.7/10)
Edoardo Bridda
highlight
Beatrice Antolini - Bioy (Urtovox, Novembre 2010)
Genere: funk-psichedelia
L'arte di Beatrice Antolini risiede nel saper decontestualizzare e riconvertire particolari musicali diversissimi tra loro. Un dipingere immaginari weird con accostamenti che vanno oltre la coerenza ortodossa
di un genere, sfociando in una musica centrifuga che è prima di tutto attenzione per la ricchezza del
suono. Un Sud America piroettato sui tasti del pianoforte, certa psichedelia vaporosa, una classica da
fondale dipinto, qualche drappeggio pop: di questo è fatta la sostanza del
verbo antoliniano. Di volta in volta rielaborata, ricombinata, contaminata,
alla luce di una maturità stilistica che parrebbe dietro l'angolo ma che in
realtà sposta coscientemente il proprio punto di arrivo sempre un po' più
in alto.
Bioy recupera le tematiche che avevano reso il precedente A Due un deciso passo in avanti rispetto all'irruento Big Saloon (complesse aperture
strumentali, cambi di registro inaspettati, progettualità unitaria) arrivando
a una sintesi ormai lontana anni luce dagli esordi. Con un funk-wave coeso
e pseudo-futuristico - "I riferimenti agli anni '70 sono più che altro cromatici e credo che un certo funk di
quel periodo sia stato molto importante per me. Ma la mia musica è la mia musica e assomiglia a me, nel
bene e nel male" - che è soprattutto arte dell'incastro in una spessa coltre ritmica focalizzata sul groove,
sulla stratificazione. Come dimostrano gli Ottanta di una Madonna distesa sul tappeto di fiati di We're
Gonna Live o il tribale sottomesso e spacey di Eastern Sun, i droni di synth di Night SHD o una Bioy in
bilico tra percussioni in stile Joy Division e certe tastiere in levare filo-reggae.
E' l'organizzazione a far la differenza. Il saper trovare il giusto equilibrio per ogni dettaglio nell'ottica
di un progetto che per la prima volta nella storia discografica di Beatrice sembra possedere radici profonde (gli Eightes). Grazie a un'inedita quadratura e a un rigore da session man capaci di conciliare la
strumentazione di cui è diretta responsabile la padrona di casa (batteria, percussioni, sax, moog, piano,
basso, chitarra, clavinet) con i contributi alla tromba/violoncello/sax (anch'essi trattati, decontestualizzati, alieni) degli ospiti Mattia Boschi / Enrico Pasini / Andy (Bluvertigo). Per un disco che ha tutto
l'aspetto di un punto di arrivo. O per meglio dire, di uno dei tanti possibili.
(7.5/10)
Fabrizio Zampighi
Blank Dogs - Land And Fixed (Captured
Tracks, Ottobre 2010)
Genere: synth-pop
Perde molto dell’abrasività lo-fi che ne caratterizzava
gli esodi, mr. Mike Sniper, qui alle prese col terzo fulllength sotto la sigla Blank Dogs. Nella naturale evoluzione delle cose, penseranno i bendisposti, mentre i
critici vedranno nella pulizia del suono la prima avvisaglia dell’abbandono di un underground che ormai non
ha più quasi senso di esistere come categoria.
Limitandosi alla musica, questi 12 pezzi nuovi di pacca restano legati all’ormai classico suono Blank Dogs:
musica post-punk spettrale e al limite del catatonico in
grado di frullare e riproporre i primi vagiti wavish dei
Cure (Insides, Longlights), l’angoscia claustrofobica dei
Joy Division (Out The Door), la straniante accessibilità
pop targata C86, il synth-pop più trasversale di matrice
New Order (Collides, Elevens) e quant’altro d’ordinanza. Però sulla falsariga dell’ultima manifestazione del
progetto, l’ep Phrases della primavera scorsa, l’accento
sembra posto su soluzioni non solo segnate da un appeal più marcatamente e melodicamente pop (Blurred
Tonight, Northern Islands, Another Language), ma anche
da un sound più pulito e cristallino. Un procedimento
simile a quello messo in atto da Zola Jesus e da altri
frequentatori del sottobosco lo-fi: mano a mano intenti, cioè, a sgrossare quel manto di grezzo lo-fi che
ne aveva segnato le proposte agli esordi e che a questo punto si può definitivamente considerare più una
necessità legata agli scarsi mezzi che una intenzione
47
stilistica ben definita. Insomma, svanito già da un pezzo l’effetto sorpresa, rimosso praticamente del tutto il
pulviscolo a bassa fedeltà, non restano che le canzoni.
Troppo omogenee e monocordi per attestarsi sui livelli
dei precedenti passi di Blank Dogs, seppur sempre di
ottima fattura.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Boduf Songs - This Alone Above All Else In
Spite Of Everything (Kranky, Settembre
2010)
Genere: songwriting, folk
Mathew Sweet, l’enigmatico cantautore che si cela
sotto lo pseudonimo di Boduf Songs, torna con un
quarto album. Humming sofferto, testi cupi, atmosfere minimali: gli ingredienti di base non cambiano, ma
l’inglese evita la ricetta della ripetitività aggiungendo
qualcosa in più, ossia degli arrangiamenti più complessi e articolati, che fanno di This Alone Above All Else
In Spite Of Everything un vero passo avanti nella crescita artistica di Sweet.
Una parte delle novità è immediatamente percepibile
nell’introduzione, Bought myself a cat o nine tails, sofferta composizione per voce e pianoforte: se prima
Boduf Songs affidava l’espressione della sua intimità
a una scarna chitarra e a qualche casalingo intervento elettronico, adesso, ferma restando la base di poche note e colpi di martelletto sulle corde del piano,
il range è decisamente più ampio; e così Decapitation
Blues: da un loop di vibrafono si sviluppa un'avvolgente ambient song tanto rock quanto folk, tanto goth
quanto post. In I Have Decided To Pass Through Things i
sussurri si evolvono in una splendida melodia cantata a
piena voce, confermando ai maligni che Sweet sa cantare in altri registri e che l’humming è una scelta. Altri
arrangiamenti degni di nota sono la batteria, basso e
tastiere à la 4AD di They Get On Slowly e la splendida
The Giant Umbilical Cord That Connects The Brain che ci
porta indietro ai sussurri e ai pizzichi di chitarra degli
Slint (versante David Pajo).
E' il migliore album Boduf Songs fin'ora. Il primo a tirare
le fila di una personale vena "heavy metal acustica".
(7/10)
Gemma Ghelardi
Boris/Ian Astbury - BXI (Southern Lord,
Ottobre 2010)
Genere: hard-rock
In un mercato affollato come quello attuale ci sono
dischi di cui si sarebbe fatto volentieri a meno. Già di
48
per sé, i nippos non sono proprio parchi di uscite ma
spesso e volentieri abusano di collaborazioni e release.
Questo mini-album con alla voce l’ex leader dei Cult
appartiene alla seconda categoria, ovvero a quei dischi di cui proprio non si sentiva la mancanza. Soprattutto perché la voce di quest’ultimo catalizza il tutto,
prendendo il sopravvento e riducendo i sodali heavydroners giapponesi ad abbassare la guardia accontentandosi di un rock hard dai sapori old-fashioned, iperimpostato (Teeth And Claws) e a volte anche pacchiano
(We Are Witches).
Una cover di Rain cantata dalla voce eterea di Wata - apprezzabile più sull’onda della nostalgia che altro - non
può da sola risollevare le sorti di questo mini, sorprendentemente targato Southern Lord.
(5/10)
Stefano Pifferi
Brainkiller - The Infiltration (RareNoise,
Ottobre 2010)
Genere: jazz-fusion
Impro su basi sudamericane (Spider), marcette in bilico tra Mingus e Coltrane (U Can't Stop Z Train), fusion
in chiave funk all'ombra di Cannonball Adderley (Casketch), pianoforti crepuscolari orfani di un Chet Baker
qualunque (Ice Fishing), free analgesico (Michaelsketch),
balbettii in stile Monk (Unfiltered).
Sembra il menù di un disco di Improvvisatore Involontario e invece stiamo parlando di una produzione Rare
Noise. Ad agitare le acque di una tracklist veloce e easy
- anche per chi non mastica abitualmente certe cadenze -, Brian Allen, Jacob Koller e Hernan Hecht, rispettivamente al trombone, alle tastiere e alla batteria. Colti
in un non-luogo musicale misurato e pulitissimo, capace di sperimentare nuovi colori e forme - come dimostrano anche le svisate orientaleggianti di Eepy - senza
stravolgere i canoni di un jazz riflessivo, riconoscibile e
tutto sommato familiare.
(7/10)
Fabrizio Zampighi
Brian Eno - Small Craft On A Milk Sea
(Warp Records, Novembre 2010)
Genere: ambient, idm
Il debutto su Warp di Brian Eno, tardiva chiusura di un
cerchio, è una bolla di sapone, elegante, fragile, vuota. Fuori, cofanetto, vinili e stampe in edizione limitata;
dentro, retroguardia elettronica da salotto, apparentemente varia nelle declinazioni, in realtà monocroma
come la satinatissima immagine di copertina.
Titoli evocativi-descrittivi per una parata di esercizi di
stile irrisolti registrati tra 2009 e 2010 nei ritagli di tempo
da altri progetti (sono incluse alcune selezioni scartate
dalla colonna sonora di Amabili Resti), in collaborazione con i giovani discepoli Jon Hopkins ("programming")
e Leo Abrahams (chitarre trattate). Se il tocco del primo
è a tratti anche troppo caratterizzante e invadente (Flint
March), gli interventi del secondo sono omeopatici e tutto sommato trascurabili. Small Craft Over A Milk Sea è
una lussuosa vetrina di spunti incolori - non audaci, non
classici, non così manieristici da giustificarsi come ricerche o giochi da scienziati del suono (Autechre) - che
pescano nel solito bacino eniano ma senza guizzi, tra
romantica ambient pianistica, intermezzi cinematici ora
sinistri ora severamente contemplativi, morbida elettronica condita di concreta e tentativi di aggiornamento
electro (e addirittura big beat, Dust Shuffle). Salviamo il
grip del motorik 2 Forms Of Anger e il giocoso disimpegno per tastiere-basso, molto naïveté Ottanta, di Bone
Jump. Per il resto, vuoto.
(5/10)
Gabriele Marino
Brian Wilson - Reimagines Gershwin (EM
Records, Settembre 2010)
Genere: pop
Custodi di sogni, codici d'immaginario riassunti in un
nome. In due nomi: George Gershwin e Brian Wilson.
Lontanissimi e uguali. Assimilabili, in qualche modo,
quali ridanciani sacerdoti di meraviglie in forma di canzone e oltre. Ecco, qui si entra nel mondo del sacro. Per
questo forse la notizia che Wilson avrebbe dedicato un
disco al canzoniere di Gershwin - inventandosi peraltro due pezzi inediti a partire da altrettanti canovacci
incompiuti - mi lasciò una piuttosto indefinibile sensazione di blasfemia. Come un sincretismo possibile - non
ne esistono di impossibili, credo - ma inopportuno. Un
facile sillogismo chiamato a gettare luce su due misteri
tanto scoperti quanto insondabili.
A disco uscito, m'accorgo che l'esito è forse l'unico possibile (e auspicabile): entrambi i misteri rimangono al
loro posto. Le dimensioni non s'incontrano mai davvero. Gershwin sembra un tema accidentale (avrebbe
potuto essere Bacharach o i Beatles, e non è detto che
non accadrà), l'acchito che incita Wilson a dar fondo a
trucchi e vezzi del mestiere. L'ex-Beach Boys ci mette
la tipica calligrafia posterizzata, è crooner impalpabile e giocoso, rinuncia volentieri all'effettistica 3D per il
fascino vintage d'un cartoon tutto colori e dinamismo,
infarcito di boogie e bossa, doo wop e - naturalmente - fregole surf. Sospeso tra un palco di Broadway, la
spiaggia di Santa Monica e una sequenza del disneya-
no I tre caballeros, si rivela per così dire un buon additivo per brani già resisi abbondantemente immortali
negli ultimi ottanta anni o giù di lì. Ma non ne coglie
il cuore. Più che reimmaginarli, li contabilizza. Col mestiere patinato, un po' bolso ma inesorabile d'una star
a Las Vegas.
E poi non tutto va per il verso giusto: c'è nel suo approccio una leggerezza quasi soprannaturale che se
esalta il setoso languore di I Love You Porgy o la verve di
They Can’t Take That Away From Me, si rivela incompatibile con l'inquietudine infinita di Summertime e rende
banalotta l'euforia di I Got Rhythm. Quanto ai due inediti - The Like In I love You e Nothing But Love - si lasciano
gradevolmente ascoltare e dimenticare. Come tutto il
disco.
(5.5/10)
Stefano Solventi
Carrick - Nasty Affair (Enzone Records,
Ottobre 2010)
Genere: indie-garage
Un tre più uno - almeno così pare di capire dai crediti
del disco - dedito a un indie-rock testosteronico (nonostante la batterista donna) in bilico tra garage e punk. Il
cantato è rubacchiato al duo Libertines / Clash, sdrucito e sboccato come prevede la scuola inglese, con la
strumentazione ridotta a un incrocio di chitarra elettrica, batteria e basso che non va per il sottile.
Anche se la formazione milanese è tutt'altro che una
congrega di sprovveduti con la mano pesante, almeno a giudicare da una tracklist che sa come trattare
la melodia (Back One Step, la title track) e da richiami
strumentali sparsi un po' ovunque - qualche assolo ricorda addirittura certi Oasis d'antàn - utili a garantire
al suono un' apertura insolita per prodotti sul genere.
Pur nell'ottica di un disco d'esordio con qualche difetto, nello specifico troppe idee a cui dar forma e poca
esperienza per focalizzarle nella giusta maniera. (6.2/10)
Fabrizio Zampighi
Cindytalk - Up Here In The Clouds (Mego,
Settembre 2010)
Genere: industrial
Gordon Sharp sembra vivere una seconda giovinezza,
ammesso che abbia mai vissuto la prima. Una nuova
incarnazione sonora segna infatti il ritorno del progetto dello scozzese dopo un’assenza ultradecennale che
sapeva tanto di ritiro dalle scene: prima con The Crackle
Of My Soul dello scorso anno e ora con Up Here In The
Clouds (prossimi alla ristampa in box vinilico con ag49
giunta di un 7"). Più dilatato e visionario, il suono del
nuovo corso di Cindytalk sfrutta tutto l’armamentario
post-industrial per disegnare trame di largo respiro tra
elettronica sporca, grumi di sinfonie microrumoriste e
ambient textures mefitiche. Ne esce un disco sulla scia
di The Crackle
, pervaso da una densa caligine, brumosa
e ottundente, rotta da qualche sparuta vocals loopata
di matrice haunted, da sibili disturbanti che si sciolgono in folate al limite dell’harsh o da deturpati field recordings.
Da quella coltre spessa e a tratti apparentemente invalicabile, emerge però un taglio visionario ed evocativo,
astratto e destrutturato. The Eighth Sea (liquido fluire
magmatico in modalità field-recordings), Guts Of London (sbuffi da rumorismo cubista), Hollow Stare (microrumorismo e white noise senza soluzione di continuità), We Are Without Words (droning evanescente e
chiesastico) sono solo alcune delle frecce nell’arco di
Sharp, ormai maturo sound-artist in grado di manipolare uno spettro sonoro ampio e screziato. Up Here In
The Clouds è un album sfiancante, monolitico, densissimo di suggestioni, variazioni e rimandi e che non si
smette di ascoltare.
(7/10)
Stefano Pifferi
Commix - Re:Call To Mind (Metalheadz,
Ottobre 2010)
Genere: House, ambient
La premessa è quasi d’obbligo. Parliamo di un remix album di uno degli album d’n’b più esaltati degli ultimi
anni assieme all’esordio di Utah Jazz ed è inutile ribadire ancora una volta la quantità di riflettori e inserti
nei mix che il genere più dimenticato dalla critica ha
avuto negli ultimi tre anni. Il 2010 doveva essere l’anno
del ritorno vero e proprio ed eccoci qui attorno ai Commix pronti a scattare la foto della nuova scena cassarullante in una decina di remix tra cui troviamo nuovi
rampolli e superstar diversissime per estrazione quali
Burial e gli Underground Resistance. Ebbene?
RE:Call To Mind non è un album che rimescola le carte: prende un nuovo mazzo e ce lo mette accanto. Il
già piuttosto contaminato lavoro originale è ora una
bestia completamente nuova che si muove attraverso
ritmi e scenari anche molto distanti. Troviamo il duo
Instra:mental rimette le mani su Japanise Electronics
ripensando alla chill out ibizenca, aggiungendo effetti
glitch e tocchi jap à la Sakamoto; Panagea piroettare
dub e interventi tech decisamente quadrati trasformando l’estate’92 di Steve Spacek in un tunnel di speed
e keta da pieni anni zero (How You Gonna Feel); A Made
50
Up Sound (ovvero Dave Huismans, noto ai più come
2562) purgare la blackness di Change (con Nextmen)
cavandone asettici ritmi tech-house, folate dubstep e
visioni a raggi infrarossi.
In pratica, in tanta avventurosità e ricerca, e un'unica
traccia a conservare i fondamenti d’n’b (il remix di Belleview da parte di DBridge) è quasi un peccato che le
due citate star rivestano semplicemente di se stessi le
rispettive tracce (Be True di Burial ne esce haunted 2
step, Satellite Song si trasforma in una traccia techno
detroit); molto più interessante il trittico house della
raccolta a base di stilemi deep (grandioso Kassem Mosse in Stricktly), classic (Two Armadillos in Spectacle) e
glitch house (Sigha She in Emilys Smile), nonché l'intervento techno di Marcel Dettmann (Satellite Type 2).
Pensando alla chiusura del mondo d'n'b fino al 2007,
Re:CAll To Mind è un remix album doppiamente importante: si arrende alla contaminazione a 360° come
unica base per una rinascita ed è basato su uno streaming coeso, ovvero con una logica da album. Morale:
il d’n’b, nel 2010, anche grazie al successo dell'ultimo
Prodigy e a commecialoni quali i Pendulum, sarà anche tornato. Eppure, over-come-under-ground, è soltanto facendosi ibridare di nuovo che possiamo auspicarne una rinascita vera.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Curv - Between Here And Nowhere (Vinyl
Vibes, Settembre 2010)
Genere: Space disco
Rainer Düring è un veterano del suono electro berlinese. Partito alla fine degli anni Novanta come metà
di Thrust & !Pez, ha pubblicato numerosi singoli su etichette culto del calibro di Vienna Scientists, Stereo Deluxe e Ministry of Sound. Come Curv è attivo dal 2001 e
questo disco è il primo full length col nuovo moniker.
Infatuato del suono spacey di Daniele Baldelli e di
Prins Thomas, il ragazzo ci fa volare su pianeti e cosmi
seducenti, facendoci passare per spiagge tribali, ricordi
in odore del baffo di Moroder e tanta tanta progressività, che il più delle volte non si accosta tanto al verbo
house, bensì lascia nell’aria un sapore chill, che ricorda
vagamente le proposte dei primi Orb.
Ascoltabilissimo da chiunque viaggi sulle onde cosmiche di Lindstrøm e compagnia cantante. Da viaggio.
(7/10)
Marco Braggion
highlight
Bjørn Torske - Kokning (Smalltown, Novembre 2010)
Genere: downtempo, kraut
Bjørn Torske non è solo uno degli artefici della scena di Bergen, ma probabilmente l’animatore principale che ne ha fatto il place to be lungo tutti gli anni Zero. Da sonnacchioso dormitorio universitario
a Nord della Norvegia, la cittadina è diventata, grazie a gente come lui, Erol, Annie, Mikal Telle e i Röyksopp, il posto dove fare girare elettronica e folk (vedi alla voce Kings Of
Convenience), dove ballare e sballare, divertirsi e ogni tanto aprire qualche libro. Torske, da vero capobanda, s’è pure inventato uno stile di house,
la skrangle-house, per alzare la temperatura dei club. I singoli di allora erano Disco Members (2000, Tellé) e Aerosoles (2000, SVEK), mentre oggi sentiamo quel sound in brani come Furu o Bergensere, cassa in quattro, dub/
deep, remember disco, percussioni magrebine. C'è pure qualche segnale
dallo spazio che rimanda diritto a Baldelli e alla space disco, materia di cui
quest’uomo, classe '71, è maestro, ancor prima di Lindstrøm e Prins Thomas (che sono chiaramente figli suoi).
Kokning è un disco che sembra chiudere un cerchio e aprirne un altro. Kokning è il gesto che i norvegesi
fanno quando mettono le patate a cuocere e vanno a pescare, per poi ritornare e cucinare il pasto. Vuol
dire farlo alla loro maniera, in modo leggero. Torske ha un modo unico d’inserire i kraut tedeschi o l’ambient di Brian Eno-iana memoria nella disco music o in qualche landscape che non bisogna temere
di chiamare folk (Kokning, Slitte Sko). L’album è stato concepito tra Feil Knapp (2007) e l’inizio del 2010
e, rispetto alla prova precedente, suona decisamente più acustico e concreto. Troske sa esattamente a
che punto dello stream inserire certi dettagli del reale e del quotidiano, che siano sopra gli smalti dei
synth, i jingle jangle della chitarra o i theremin (Kokning, Bryggesjau). Non solo, la bravura si riconferma anche nei groove dove, partendo da un battito e un clapping disco, il Nostro imbastisce un brano
space-deep-cosmico della madonna come Bergensere. Oppure ancora, quando narra senza parole una
di quelle storie ambientate a Düsseldorf (i Kraftwerk all’ananas di Slitte Sko) che i compagni Röyksopp
non raccontano più (notare ancora l’innesto concreto che fa la qualità della produzione).
Troske chiude il decennio (e l’epopea Bergen) iniziandone una propria, a Tromsø, in mezzo al niente, nel
luogo da dove è partito. Registrando in un semiterrato di cemento, senza finestre, sfruttando il riverbero creato dal lungo corridoio adiacente. La sua musica non è ambient né folk, space disco, dub, psych o
balearica. E’ tutta roba sua. Disco down-tempo dell’anno.
(7.4/10)
Edoardo Bridda
Cut In The Hill Gang - Mean Black Cat
(Stag-O-Lee, Ottobre 2010)
Genere: punk roots
Johnny Walker, già nei modesti Soledad Brothers,
giunge al secondo lp con gli amichetti Lance Kaufman
e Reuben Glaser convocando John Wesley, organista e
cantante dei Black Diamond Heavies. Aggiunta che
trova motivo nella natura del lavoro, interamente dedicato a brani altrui e preceduto la scorsa primavera da
un 7" che omaggiava i bluesmen preferiti dalla cricca.
Da lì è stato un gioco confezionare un 33 pescando
oculatamente dentro a un pozzo infinito. Diversamente dall’operazione condotta dai Morlocks, però, le do-
dici battute lasciando spazio a una più ampia indagine
punk-roots e pure la trascendono, consentendo a una
livida Serves Me The Right To Suffer (John Lee Hooker)
di affiancarsi all’energica resa del "traditional" Help Me;
al disinvolto medley tra Kills/Spacemen 3 di fare bel
paio col gemello che unifica Hound Dog Taylor ed
MC5.
Ne desumi un’apertura mentale superiore alla media,
una concezione delle "radici" che adatta l’esempio prezioso offerto tre decenni fa da quei Gun Club dei quali
è presente la struggente Promise Me. Assai più vigoroso il resto della scaletta (Please Give Somethin' di Bill
Allen suona come i Jesus & Mary Chain che incidono
51
Automatic ai Sun Studios; la ripresa di Gary US Bonds
I Wanna Holder tambureggia crudo errebì; The Right To
Love You di Mighty Hannibal è soul con nerbo) quando non semplicemente deragliante, come può solo chi
conosce a menadito la materia per esserci cresciuto
dentro. Abilità che non è sfuggita a Jack White, pronto a pubblicare la prossima fatica dei ragazzi su Third
Man. Nell’attesa tiratevi questo calcio in fronte più volte, visto come rinvigorisce senza lasciare ematomi.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Danuel Tate - Mexican Hotbox (Wagon
Repair, Novembre 2010)
Genere: electro, nu-jazz
Il tastierista dei Cobblestone Jazz parte in solitaria e
si cimenta con l’esordio sulla lunga distanza su Wagon
Repair. L’etichetta canadese - che ha già pubblicato singoli del trio da cui Danuel proviene - ha nel suo roaster
gente eterogenea nel panorama elettronico mondiale,
nomi che vanno dalla pesanteza del quattro sghembo
di Seth Troxler, al minimalismo di Dinky, al dub di Deadbeat e alle uscite in singolo dell’altro Cobblestone
Mathew Jonson.
L’ampiezza di visioni e di esperienze dell’etichetta sembra fittare a fagiolo con la proposta del buon Tate. La
scatola messicana è un prodottino da consigliare chiavi in mano a chi ama l’elettronica non troppo intrusiva, i party che vanno su e giù di bpm senza sconvolgere troppo gli ospiti. In una parola coolness distillata
sapientemente, attraversando ere e stili disparati (lo
swing, il latin, il funk e l’electro per dirne quattro) che si
riconducono sì al lavoro di composizione con il trio, ma
che allo stesso tempo se ne discostano con un guizzo
più chic.
Qui verrebbe da fare un paragone con un’altro mago
del ritmo e della riscoperta delle tastierine analogiche
di cui ci siamo infatuati molte volte: Danuel è uno Luke
Vibert che guarda alla lounge da una prospettiva nuova, filtrata di esperienze live e di set in acidità behind
the console. Senti il riffetto a 8 bit di Populatio e non
potrai che memorizzarlo istantaneamente, sorseggiando un Martini; prova la coolness di Big Spender, la strizzatina ai privé Ottanta di California Can Can e ti accorgerai che Danuel ci sa fare di brutto. Anche da solo.
(7.3/10)
Marco Braggion
52
Darren Hayman - Darren Hayman & The
Secondary Modern - Essex Arms (Fortuna
Pop!, Ottobre 2010)
Genere: songwriting
Seconda parte di una trilogia, di cui il penultimo Pram
Town (2009) costituisce la parte iniziale, Essex Arms
riporta il songwriter Darren Hayman su atmosfere
prettamente acustiche ed essenziali rispetto all’abituale pienezza di suono. Ricordiamo che Hayman è autore
assai prolifico e con una carriera ormai piuttosto lunga,
essendo stato coinvolto negli ultimi dieci anni in una
serie di formazioni (tra cui gli Hefner poi diventati il
suo progetto in solitaria).
La vita in campagna e i suoi lati più nascosti, amore
compreso, fanno da tema a quest’ultimo album ambientato nel natale Essex, dopo la celebrazione della
vita nelle piccole città del precedente Pram Town e i
racconti cittadini dei primi due dischi. Atmosfere acustiche si diceva, piuttosto spoglie, per canzoni ridotte
all’essenziale, che lo riconducono al consueto revival
byrdsiano alla Robyn Hitchcock e R.E.M, misto al songwriting di marca UK (Elvis Costello e affini), e una
buona fluidità nei testi; il Nostro è infatti un ottimo
scrittore e un accorto songwriter e si sente.
Una conferma quindi.
(7/10)
Teresa Greco
DJ Nate - Da Trak Genious (Planet Mu
Records, Settembre 2010)
Genere: urbanbreak/footwork
Pare che Mike Paradinas abbia scoperto questo microcosmo urban su Youtube. E giustamente non se lo
lascia scappare. Ecco allora il bollo Planet Mu su due
dischi usciti praticamente in contemporanea con i quali intende sdoganare il (sotto)genere fuori dal ghetto. I
dischi del giovanissimo Dj Nate (vent'anni) e di Dj Roc,
entrambi di Chicago, sono due gemelli diversi, figli dello stesso mo(n)do dance a tinte forti chiamato footwork
distinguibili grazie ad alcune piccole significative differenze. Se in sintesi il footwork - il nome dice già tutto - è
un tappeto di breakbeat (non di matrice d'n'b, ma costruiti su bolle techno-rave) doppiato da un taglia&cuci
ossessivo di voci trip hop (o di voci da trick/trip djistici
usate con funzione strutturale e non semplicemente
effettistica) che agisce decostruendo sfondi di house
superaccelerata e di tastiere grime, ecco che Roc risulta
più barocco, colorato e legato al suo retroterra house e
Nate più stilizzato, minimalista, videogameistico. I due
album comunque dialogano, lo dimostra il fatto che
Roc cita Nate a inizio tracklist campionando alcuni mi-
croframmenti da un suo pezzo. Insomma, avete capito,
ascoltateli insieme questi due dischi.
Per Nate, parafrasando Aphex Twin, Da Trak Genious
è una specie di "Selected Footworks 2005-2010" che
raccoglie trax uscite su cd-r e messe in giro per il web
prodotte quando il ragazzo aveva anche 15 anni. Come
Roc, anche Nate mette in evidenza il sapore artigianale
della produzione (si sentono tutti i tagli), la componente - spesso anche spintamente - giocosa e deformante (vocine pitchatissime, tra il divertente e l'irritante, a
due passi dai Chipmunk) di questa che in fondo è una
musica da ballo street, e puntate che ne scoprono le
radici assolutamente nere attraverso numeri più marcatamente rappusi e loop vintage di matrice funksoul
(quindi, ancora e sempre rappusi). Senza dimenticare
la melodia: note di piano (trip hop enfatico), ricordi di
colonne sonore Ottanta (Halloween), citazionismo pop
(Lady Ga Ga).
Nate e Roc ci introducono a un'estetica molto interessante e dalle grandi potenzialità, veicolata da ottimi
episodi singoli e forte dell'impatto massiccio di un suono - paradossalmente - monolitico. Estetica però che
non sembra ancora reggere benissimo il formato lungo: non tutti i pezzi hanno lo stesso appeal; non tutte
le trovate hanno la stessa efficacia; accanto a pezzi che
suonano inequivocabilmente come nuovi, ce ne sono
molti che non si discostano troppo dalla koiné grime/ghettohouse. Insomma, ancora da affinare, come
si dice. Esperimento: prendete Wind It Up di Mark
Pritchard/Om'Mas Keith, acceleratela e infarcitela di
breaks, e vedete un po' se non è footwork quello lì.
(7/10)
Gabriele Marino
DJ Roc - The Crack Capone (Planet Mu
Records, Ottobre 2010)
Genere: Chicago Juke
Il ghettotech evoluto di DJ Roc si chiama Juke. E viene
da Chicago. Insieme al Jit di Detroit è la nuova sensation del ballo nero americano, denominato da molti
con l’appellativo omncomprensivo di footwork. Una
cosa da strada e profondamente urban che investe
da anni la cultura post-breakdance e di cui solo oggi
ci accorgiamo grazie all’interessamento di Paradinas
della Planet Mu. In questo disco appaiono tracce che
viaggiano sui 150-160 bpm, battiti utili per far saltare le
gambe e i piedi in modo spastico. E come spastica era la
musica dei rave del 92, anche in questo caso ci sono le
ripetizioni ossessive (Fuck Dat), le vocine (Let’s Get This
Started) e gli altri tools, ma il tutto viene integrato con
delle atmosfere gloomy ereditate dal miglior Terror
Danjah (il coro post-operistico e rituale nell’ostinato di
Phantom Call), quelle cose oscure che mai si sarebbe
pensato potessero arrivare ad essere applicate al ballo o con una sensibilità soul blackissima (splendido il
meshing di voce ispirata e di ritmi à la Four Tet in Lost
Without U).
Questo disco è un segnale americano che gioca a ping
pong con le più recenti evoluzioni del suono UK bass
(vedi le ottime compilation Elevator Music e Future
Bass). Lo stile dei cugini inglesi Ramadanman e Toddla T viene trapassato in due con passi velocissimi e
figurazioni nuove, la voglia di segnalare un mondo che
prende il rave, lo attualizza e lo sdogana alle generazioni post-00 apparentemente senza l’ausilio di droghe
(provate a guardare su youtube qualche video di footwork e capirete perché).
Ballate su questi ritmi spezzati, dedicatevi a perfezionare il vostro passo su questi singoli da tre minuti. La
proposta di Clarence Johnson definisce un’ortodossia
pesante, sia sulle scelte ritmiche che su quelle melodiche: ma è così che di solito si costruisce qualcosa
di duraturo (vedi l’eredità Underground Resistance).
Il wonky per definizione aveva un range amplissimo;
qui si restringe la variabilità a pochi mattoni squadrati
ma più che mai distinguibili, già testati sulle streets di
Chicago. DJ Roc è il padrino dello spezzettamento del
ritmo. Baciamo le mani.
(7.3/10)
Marco Braggion
Drum Eyes - Gira Gira (Upset The Rhythm,
Settembre 2010)
Genere: neo-kraut
Un nome che racchiude due dei termini più in voga nel
sottobosco mondiale non può che portare buone cose.
La drum thunder worship gang di DJ Scotch Egg aka
Shigeru Ishihara (uno con uscite su Load, tanto per capirsi) raccoglie gentaglia del giro Boredoms e Trencher,
condivide stage con Omar Souleyman e Damo Suzuki e
si mostra eclettica e disturbata in questo suo esordio.
Evidente matrice neo-krauta e attitudine free-noise
percussiva, Gira Gira è uno di quei dischi bastardi che
entrano in circolo al primo ascolto e non fanno prigionieri: space-rock alla Can/Neu! rotto da schizofreniche
aperture casio-oriented e tribalismo acceso (50-50),
passaggi limitrofi ai Laibach più pacchianamente marziali che suonano Moroder sotto acido (Future Police), i
Neurosis di Enemy Of The Sun catapultati in una quarta
dimensione in cui a farla da padrone è l’elettronica per
come possono intenderla i Fuck Buttons (Future Yakuza). Di carne al fuoco ce n’è tantissima e ce ne sarebbe53
highlight
Blind Jesus - Blind Jesus (Von, Aprile 2010)
Genere: avant rock
C’è tutto un gotha, in Blind Jesus, a partire dal packaging del vinile. Immagine coordinata di Carlos
Casas (imparentata con quella dell’ultimo Netmage), label Von - recente creatura discografica di Nico
Vascellari - e poi quei nomi presenti in calce. C’è Stefano Pilia, la mente principale del progetto, che
ormai potremmo chiamare l’artigiano della musica sperimentale nostrana di più alto livello, una figura
costante, laboriosa, fortemente duttile, un artigiano, appunto. C’è Giuseppe Ielasi al mastering. Ci sono i nastri e i delay di Andrew L. Hooker, artista
multimediale che con Pilia ha condiviso live e performance, producendo il
sostrato per l’esordio a nome Blind Jesus.
Ci sarebbero anche le avvisaglie per un progetto di raffinata caducità. La
musica di Blind Jesus deriva dall’arrangiamento produttivo di Stefano di
quel materiale per lo più improvvisativo derivante dalle sessioni live con
Andrew. Ma Pilia è maestro nell’usare studio, voci, strumenti, materia prima
e livelli di fuoco. Usa spostamenti cognitivi e armonici alla Jandek, lamenti
alla Genesis P-Orridge, chiude il lato A con urla strozzate di Kubrick. Riprende con tensioni ambientali
non distanti dagli Excepter, solitudini chitarristiche, e mantiene sempre una capacità espressiva e una
lucidità compositiva, pur nello sfilacciamento dei brani, impeccabili. Il gotha non strombazza i propri
nomi senza aggiungere peculiarità e spendere personalità. Pilia e Hooker alzano la posta dell’ambiente, confezionano timbriche e architettano sviluppi con un’impressionante facilità di comunicare sensazioni, stati d’animo, e di tenere incollato l’ascoltatore.
Blind Jesus è uno dei parti migliori della Von (è il numero 6 del catalogo), e si adegua peraltro perfettamente al concept dell’etichetta: sposare musica (di improvvisazione, spesso) e media art (nelle vesti di
Andrew). Ma ciò che preme dire è che qui accade una cosa molto rara: questa musica è spendibile, leggibile, abile a circolare anche fuori dal circuito avant. Sarebbe perfetta ambasciatrice, pur essendo per
nulla commerciale o popolare. Il gotha ha lavorato con una sensibilità rara, e ha dato gambe proprie a
un progetto che speriamo davvero di veder camminare a lungo.
(7.5/10)
Gaspare Caliri
ro ancora tante di band e suggestioni da tirare in ballo
- Black Dice, Wolf Eyes, Test Department, avant-rock,
sludge-metal, tribalismo industrial - a dimostrazione di
eclettismo e coraggio nel percorrere strade nuove. Gira
Gira è una gran bella sorpresa suggerita ad ascoltatori
open-minded e a curiosi indagatori delle estremità più
free delle musiche contemporanee.
(7.1/10)
Stefano Pifferi
Dusting Wong - Infinite Love (Thrill
Jockey, Ottobre 2010)
Genere: guitar-minimalism
"Tutto nacque quando il mio amico Andrew mi chiese di
fare un concerto solista la scorsa estate": così, Dustin
Wong, chitarrista e bassista dei Ponytail, descrive i primi passi di Infinite Love, primo atto solista, dopo che
54
per anni suonare in solitaria era stato per lui un training
autogeno senza pubblico.
La scuola, a compiti fatti, è chiara, le discendenze anche: entrambe portano i segni di un minimalismo progressivo per sola chitarra (e batteria, per i minuti finali)
che risale la genealogia - o ridiscende l’albero genealogico - da Don Caballero e Dave Pajo a Robert Fripp.
Quest’ultimo è presentissimo con le sue tecniche chitarristiche e compositive, che alternano momenti di intensità a momenti di distensione ambientale. Niente di
originale, eppure, nonostante la gran quantità di questa musica che è passata dalle nostre orecchie, Infinite
Love non va a noia. Si sente la leggerezza, aldilà dell’ingombro dei riferimenti.
Il segreto è anche nascosto anche nella trovata che
sta alla base della pubblicazione. Infinite Love è fatto
di due composizioni (una per CD) che iniziano ugua-
li, procedono allo stesso modo per venti minuti e poi
prendono direzioni diverse, per poi convergere di nuovo alla fine, intorno al cinquantesimo minuto. Ogni
tanto l’ascolto sale in primo piano, poi ritorna come
accompagnamento dei nostri pensieri. E si legano le
somiglianze, i punti che di un disco ci ricordano l’altro,
in un circolo in cui è difficile risalire all’origine. Chi assomiglia a chi, in una coppia di gemelli?
Due versioni lasciate a disposizione persino di chi al CD
preferisce il video (in DVD) realizzato in collaborazione
con Andrew Schenker e Angel Oloshove. Finalmente
un album con un concept dietro, un’idea forte che non
ci fa parlare di carriera solista, ma di sviluppo delle possibilità di un’idea in musica. Che cosa scegliere? Preferisco il primo o il secondo? E ogni volta siamo costretti
ad ascoltarlo tutto
Premiamo la stranezza, e la compiutezza con la quale è stata perseguita.
(7/10)
Gaspare Caliri
Edwood - Godspeed (A Cup In The Garden,
Ottobre 2010)
Genere: indie wave
Tornano gli Edwood dopo l'excursus in italiano sotto
l'egida Intercity, solito il senso di apprensione futuristica, la dietrologia onirica che rende palpabile il timore di
vivere in un oggi sbalzato dallo ieri. La cifra melodica e
sonora dei cinque bresciani è un impasto assieme denso e aereo di trepidazioni hardcore-pop à la Grandaddy, sussulti post/wave Notwist, indie mutante Broken
Social Scene e una spruzzatina di nostalgia shoegaze.
Non ti regala scossoni inauditi, ma funziona.
Tanto le ballate più soft (i languori spacey della title
track, la sognante Millions arricchita dalla presenza di
Sara Mazo, indimenticata vocalist degli Scisma) che gli
episodi più mossi (The Pianist, Happy Togheter) sembrano immerse in una stessa glassa, in quella scenografia
pervadente e permanente che è assieme punto di forza e di debolezza. Però, giusto un attimo prima di sembrarti monotono, Godspeed mette in gioco arguzia,
eleganza e la più concisa delle trepidazioni. E sa farsi
voler bene.
(6.7/10)
Stefano Solventi
El Santo Nada - Tuco (Autoprodotto,
Novembre 2010)
Genere: desert folk rock
Impressioni di un album di debutto che - al momento
in cui scriviamo - ancora non c'è. Di Tuco, esordio per
El Santo Nada ovvero il Santo Niente in tenuta tex-
mex, abbiamo ascoltato una pre-release. Non è chiaro
il quando e il come verrà distribuito. Forse, nella peggiore (?) delle ipotesi, anche solo ai concerti della band.
In ogni caso, ci sembra giusto mettervene a conoscenza adesso: si tratta di nove pezzi inediti, strumentali,
frammenti di deserto trapiantati in un immaginario di
frontiera sempre più apolide, globale, collettivo. Magari qualcuno si ricorderà di Tuco, il "brutto" del celebre
film di Sergio Leone interpretato da un indimenticabile
Eli Wallach: personaggio emblematico ieri e ancor più
oggi, incarnazione della rivalsa individuale che nessun
muro, check point o foglio di via potrà mai realmente
sopprimere.
Un clandestino della Storia nella Storia, un uomo e la
semplice feroce brama di vivere, un evento naturale interpretato dal sistema come un'anomalia, il granello di
polvere che può inceppare il meccanismo. Questa - al
di là delle splendide suggestioni mariachi, dei miraggi
desert rock, delle fregole surf e delle brume balcaniche
- è l'anima del disco. La soundtrack di un film invisibile
che sta accadendo davvero.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Electric Sixty Nine - Cornelius The
Colonel & The Hot Air Baloon Club (Face
Like a Frog Records, Ottobre 2010)
Genere: Rock
Una piacevole sorpresa quella che arriva dal novarese,
anche se non stiamo certo parlando di una band di novizi. Gli Eletric Sixty Nine sono una compagine formata da ex militanti della scena hardcore-punk di Novara.
Da anni sono dediti ad un rock senza additivi, prefissi
e suffissi, con Who, Mc5, Hendrix come numi tutelari
anche se riletti con la freschezza della band scandinave
post Hellacopters.
Cornelius The Colonel & The Hot Air Baloon Club
è il loro terzo album, è stato registrato agli Electrical
Studios di Steve Albini ed è uno di quei dischi che ti
riavvicina alla muscolarità del rock, alla sua passione e
al sudore che ne traspira, tenendo fuori gli aspetti più
retorici e deteriori. Il tutto grazie al fluire di energia positiva che dall'opener Magnolia (wah wah a piede libero e chorus liberatorio) irrora l'album da cima a fondo,
donandogli momenti di intenso lirismo.
Brani come Bone Ambitious Times e Whoohee si ricollegano a quel neo tradizionalismo rilanciato dai Pearl
Jam e da quelle band che nei primi 90s inserivano nelle loro partiture southern buone dosi di psichedelia,
il che ne fa qualcosa di lontano da tanto pessimo neo
grunge che intasa l'etere delle stazioni americane. Nel
55
highlight
Darkstar - North (Hyperdub Records, Ottobre 2010)
Genere: pop wave
Leggi Hyperdub e ti aspetti il solito clone di Kode9 o Burial. Invece questo nuovo Darkstar spinge su
una pista non ancora battuta (per lo meno dai music makers del suono now UK) e per questo degna
di essere praticata a ripetizione. La proposta del trio britannico viaggia su un territorio che mescola la
wave al glo, le ritmiche squadrate del pop alla melodia che dall'estate scorsa ci travolge con fiumi di lacrime ipnagogiche che mai avremmo pensato
di poter versare ancora, noi post-adolescenti invecchiati a pane e melanconia My Bloody Valentine.
Sarà merito delle vocals del nuovo arrivato James Buttery (il gruppo era
fino a qualche tempo fa un duo dubstep formato da James Young ed Aiden Whalley), saranno i riferimenti agli onnipresenti Four Tet, Apparat
e Morr Music, sarà che la techno da dancefloor l'avevano già esplorata a
fondo altri maestri. Possibilità di riferimenti incrociati che si aggiungono
al pianismo Ottanta semplice ma intriso di midi e 8-bit in Gold, alle chitarre dei Cure e allo spleen del
dark in Deadness, al minimalismo nel singolo (già noto ai fan di Harmonic 313 e osannato nel 2009 da
Pitchfork) Aidy's Girl Is a Computer e agli stupendi rimandi kraut nei synth di Two Chords e Ostkreuz.
Che Londra e l'oscurità siano definitivamente da riporre nel diario dei ricordi? Passeggiando per i vicoli
bui dello sprawl britannico restiamo abbagliati da un retrogusto di malinconia che si apre al pop tout
court e che preannuncia rivoluzioni. Quando un piccolo disco promette universi e deviazioni, quando
una manciata di tracce accadono alla fine di un decennio, qualcosa di profetico ci sarà. Segnatevelo. Già
in top ten di fine anno per chi scrive.
(7.8/10)
Marco Braggion
sound degli Electric Sixty Nine la vena radiofonica c'è,
ma viene direttamente dai 70s e suona come una ventata d'aria fresca.
(6.5/10)
Diego Ballani
Elio P(e)tri - Non è morto nessuno
(Matteite, Novembre 2010)
Genere: cantautorato indie
Emiliano Angelelli è giornalista e cantautore di origini
umbre ma stanziato a Roma, la fama di bizzarro confermata dalla scelta d'imporre al suo progetto solista
il nome di un grande regista morto troppo presto, fatto salvo un uso non convenzionale delle parentesi. Ma
Elio P(e)tri non esisterebbe senza il decisivo contributo di Matteo Dainese, batterista in primis (già Ulan Bator e Jitterbugs) e in questo caso anche produttore. I
due si sono conosciuti nel 2009, intesa fruttuosa che,
a partire da demo casalinghi risalenti all'ultimo lustro,
confeziona oggi un album di debutto degno di considerazione.
Dieci tracce in italiano, testi come haiku in loop a cele56
brare una travagliata ricerca (e riscoperta, e smarrimento) di sé, trame sonore elettroacustiche che rammentano dei Blur in fregola zen, certo camerismo corrucciato
dEUS, angolosità poetiche Marco Parente, lirismo
rappreso La Crus oppure un Paolo Benvegnù robottizzato Warp. Non spiace l'aria grave continuamente
stemperata tra disillusione e autoironia, come un'intensità spacciata per scherzo. Infine, giusto mettere in
rilievo due pezzi come Rachmaninov e Bradipo, che nel
fantomatico mondo dei giusti avrebbero i numeri per
farsi largo nelle migliori playlist.
(7/10)
Stefano Solventi
Fabulous Diamonds - Fabulous Diamonds
II (Siltbreeze Records, Giugno 2010)
Genere: free-rock
Cinque tracce untitled per una mezzora abbondante
di reiterato, ossessivo e circolare free-rock. Così si presenta il ritorno dell’accoppiata australiana Nisa Venerosa (batteria/voce) e Jarrod Zlatic (voce/tastiere) dopo
l’eponimo esordio di un paio di anni fa: mettendo sul
piatto il portato lisergico del kraut-rock più intenso
(Can e Neu! su tutti) così come la devastante prova di
forza che fu Sheets Of Easter degli Oneida.
Un solo giro di organo su base percussiva si protrae
per gli oltre 12 minuti dell’opener creando sfilacciamenti nella percezione dell’ascoltatore. Quando ormai
la trance sembra prendere il sopravvento, ecco la voce
di Nisa: mantrica e perversa come una Nico sciamanica, non spezza l’incanto, ma stende definitivamente al
tappeto. Nello stesso modo, la traccia conclusiva - altri
abbondanti undici minuti - si snoda come un raga ossianico, maligno, parossistico proprio alla maniera dei
citati Oneida, intenti però a rielaborare il drone-rock
della Vibracathedral Orchestra.
Robotici come i Suicide e minimali come discepoli antiaccademici e sfrontati di Terry Riley, i due dimostrano
di saper giostrare col free-rock anche nei restanti 3 pezzi, dal minutaggio più umano: paranoici sing-a-long e
ipnotiche influenze velvetiane, esoterici richiami orientali e trance strumentale si alternano senza soluzione
di continuità, dando la misura di un disco-bomba. Spiritualmente pagano, musicalmente trascendentale.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Farabrutto - Estremoriente Mediocre
Occidente (Freecom, Ottobre 2010)
Genere: cantautorato rock
Un trio da verona sbocciato allo scoccare degli anni
zero, al debutto nel 2004 con Alzare la voce che si
guadagnò attenzioni al Tenco (terza piazza categoria
opere prime). Quanto al successore, dovevamo riparlarne solo sei anni più tardi, ovvero oggi. Estremoriente Mediocre Occidente mette in fila undici tracce di
cantautorato (folk) rock, il piglio intenso e disturbante,
lo strano contrasto tra la flemma quasi garbata, gli spasmi acidi e le sferzate post-punk, tra il sostrato acustico
e i watt in derapage.
Potremmo collocarli da qualche parte tra la passionalità obliqua di Paolo Benvegnù e i Perturbazione più
pensosi, con memorie Eugenio Finardi, particelle Andrea Chimenti e un più che palpabile retroterra artwave. La triangolazione sonora è comunque inedita,
che io ricordi: chitarra acustica, mandolino elettrico
e "ground drums". Ed efficace. Molto buono il singolo
Vivere, ottime intuizioni in Retorica, climax degno del
miglior Ivano Fossati in Contenimento. Unica pecca il
canto un po' monocorde, ma sospetto si tratti di una
scelta precisa.
(7/10)
Stefano Solventi
Former Ghosts - New Love (Upset The
Rhythm, Ottobre 2010)
Genere: synth-pop
Il nuovo amore dei Former Ghosts non si discosta da
quello vecchio. A brillare nel firmamento della band di
Freddy Ruppert - al solito coadiuvato da mr. Xiu Xiu
Jamie Stewart e Nika Zola Jesus Roza e dalla new entry
Yasmine Kittles dei Tearist - brillano synth-pop Ottanta
(quello più dark e alienato) e soprattutto la stella nera
dei Joy Division.
Quelle create dalla formazione losangelina sono infatti claustrofobiche atmosfere synth-oriented messe al servizio di una poetica struggente, pregne di un
romanticismo decadente e spaccacuori che trasuda
disperazione e smarrimento nel narrare storie di cuori
infranti, gelosie e ossessioni personali proprio nella migliore tradizione JD.
È un continuo vortice spazio-temporale tra l’here&now
e un passato introiettato alla grande, New Love. Un
omaggio, un plagio, una rielaborazione e riedizione
continua degli stilemi più evidentemente e marcatamente propri della storica formazione di Manchester (And When You Kiss Me e Bare Bones sono puro JD
sound, con un baritonale e melodrammatico Ruppert
in pieno mega-trip Curtisiano). Ma anche una maniera,
troppo evidente per sembrare artefatta, per smarcarsi
dall’emul-rock che in questi anni ’00 ha usato e abusato
di quel sound, di quell’immaginario, di quelle cicatrici
dal lato più commercialmente spendibile (vedi Interpol et similia).
New Love è indubbiamente più "pop" rispetto al predecessore Fleurs, ma resta sempre in filigrana una sensazione di imminente tragedia, di tocco al cuore, di ferita
non rimarginata. Sempre in tensione, sempre emotivamente instabile. Che a ben vedere è proprio ciò che si
chiede ad un certo tipo di musica.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Frisvold & Lindbæk - Diskosm (Beatservice
Records, Ottobre 2010)
Genere: Etno, ambient, dance
Rune Lindbaek e Kare Frisvold, sono due dei numerosi personaggi di culto della cricca space disco di Oslo,
gravitante attorno a Prins Thomas, Lindstrøm e Bjørn
Torske. La loro specialità consiste nel mescolare dub,
ambient balearico e sample bleepy in una serie di traiettorie etno - come piacerebbero a Bill Laswell ma
soprattutto ai Future Sound Of London - aggiornando il tutto al clubbing odierno. Niente di nuovo per i
movimenti di un personaggio come Torske: la coppia
57
punta infatti a un'analoga zona di confine tra house e
decompressione in Diskosm, una compila di remix che
è sin’ora il loro unico disco lungo.
Nella proposta di accostamento troviamo i newyorchesi Phenomenal Handclap Band opportunamente cocktalizzati e sparati su una spaggia su marte (All
Of The Above), oscuri norvegesi che si abbeverano alla
techno pop Kraftwerk-iana (The New Wine The Bridge),
sanfranciscoani IDM fine ’80 (Lemonade, Bliss Out) e fischiettate cinematiche (Kohib, Tales from a Nomad). Ma
soprattutto una manciata di track 4/4 belle bombate e
tagliate funk house (Holy Heckler, I Wish for You), deep
(Kurt Maloo, Afterglow) e jazz (Skatebård, Vuelo).
Quando calcano sui bpm, Frisvold & Lindbæk hanno
i numeri per spaccare, eppure a tradirli spesso è una
voglia di mesh di scuola francese che andrebbe tenuta
a bada (Mungolian Jetset, Moon Jocks). Calibrando la
generosità dell'offerta scopriamo un gusto già solido
su ritmi caldi, senza distinguo tra Est e Ovest del mondo. Godibile.
(6.5/10)
Edoardo Bridda
Giant Sand - Blurry Blue Mountain (Fire
Records, Ottobre 2010)
Genere: americana
Parafrasando Forrest Gump, ascoltare un album di
Howe Gelb equivale ad aprire una scatola di cioccolatini. Non sai mai bene cosa farà costui e come lo farà: un
pregio proprio dell'indole arruffata e spontanea di chi
sa sfruttare il momento e porge gemme che scavano
come formiche nella terra: calme, tenaci e figlie del genio. E anche di un caso piegato splendidamente dentro rock turgidi (Thin Line Man) oppure aciduli (Monk’s
Mountain), dentro serafiche istantanee (Better Man
Than Me) e ballate da deliquio (Fields Of Green), dentro
un jazz come lo suonerebbero Thelonious Monk da
un lounge-bar di provincia (Chunk Of Coal) o un giovane Waits già "out" (Time Flies). Se non che talvolta l’approssimazione butta lì robetta che confonde e addirittura irrita: se Howe rifinisse e scartasse, rischieremmo
però di perdere personalità e magia.
Così è trascorso un quarto di secolo, oggi festeggiato
con l’accasarsi alla Fire avviando un interessante piano
di ristampe e questo album nuovo di zecca. Che manco
a dirlo è amorevolmente sconclusionato, svolto tra canzoni odorose di nottate spese a guardare le stelle e levare sabbia dai cardini con qualche amico - la band danese
che lo ha accompagnato dal vivo di recente - e poco che
soccombe alla svagatezza (il girare a vuoto di Brand New
Swamp Thing, una Spell Bound col pilota automatico). Per
58
il resto, solo assi di cremosa narcolessia che diresti scritti
ed eseguiti da visionari assonnati (The Last One, No Tellin’) e che mai scambieresti con belle forme senz’anima.
Sommate a quanto sopra, a una sublime Ride The Rail più
realista di Re Johnny Cash e allo struggente commiato
Love A Loser, danno una sostanza che non gusti spesso.
Altri venticinque anni come questi, Mr. Gelb.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Goose - Synrise (!K7, Ottobre 2010)
Genere: nu-rave
Anche se la copertina è di Storm Thorgerson, il designer che ha creato il monolite dei Pink Floyd Dark Side
of the Moon, il disco dei belgi Goose non può essere
propriamente definito un classico. Impantanato su vaghe coordinate nu-rave e qualche progressività Ottanta, il sophomore (dopo l’esordio del 2006 Bring It On)
replica un sentire ormai fatiscente, impolverato e autoreferenziale, che ha già dato e/o detto tutto.
Non serve chiamare Peaches a cantare i cori della traccia che da il nome all’album, scimmiottare i Depeche
Mode di Speak & Spell (After, Like You, Words) o i Duran
Duran (Can’t Stop Me Now). Questi Goose, come molte
band che cavalcano l’onda del retrofuturismo spicciolo
durano il tempo di un veloce skip. Meglio riprendere
in mano quei vecchi dischi con il baffo di Moroder che
traguardava utopie eurodisco. Un’inutile tamarrata.
(3.5/10)
Marco Braggion
Harmonious Thelonious - Talking (Italic,
Ottobre 2010)
Genere: poli-minimalism
Si descrive facilmente, la musica di Harmonious Thelonoius. È sufficiente leggere la mission del combo,
dichiarata su sito ufficiale: american minimalists VS
african drumming VS european sequencing. Talking
è costruito come un flusso indefesso di percussioni
africane sposate a tecniche di ripetizione minimalista,
con innesti di beat elettronici e sequenze percussive di
macchine. Un para-live infinito, che assume a principesco riferimento la cricca Konono N°1 (Makeshift, Primitive, Persuasive, Provocative Percussion), soprattutto per
le armonie minime scaturite dalla jam e dai tamburi
(senza pelli, nel caso degli africani, come sappiamo).
Dietro al progetto c’è Stefan Schwander, maggiormente noto come Antonelli o Antonelli Electr. La provenienza del Nostro è flebile giustificazione dei sentori
di motorizzazioni kraute dietro al sound di HT, ma non
dice nulla sulla evidente intenzione (dentro alla musi-
ca, non all’autore) di nascondere la propria penna, di
sottrarsi dal ruolo di scrivere musica, per godere del
risultato di un tipo musicale, anzi di un intreccio di tipi
oggi molto in voga. Per adagiarsi su quella che in effetti, sulla carta, sembra a formula perfetta.
È molto furbo, Stefan, ma lo sarebbe stato di più un
paio di anni fa, quando l’ondata dei tribalisti metropolitani surfava ancora sulla maggior vivacità della propria
cresta. L’effetto di Talking è un appagamento completo
dell’orecchio ma un annebbiamento dell’attenzione
cognitiva. Nonostante i beat, i poliritmi e le ripetizioni minimaliste, resta in mente un vuoto ipnotico, una
sospensione immobile, pur martellata di percussioni.
Non siamo lontanissimi dal trip indotto dai Konono,
ma onestamente neanche vicini.
(6/10)
Gaspare Caliri
Heliogabale - Blood (Les Disques Du
Hangar 221, Settembre 2010)
Genere: indie-noise-rock
Con un nome di artaudiana memoria e un suono spigoloso e distorto, i francesi Heliogabale rappresentavano nella seconda metà dei ’90 uno dei vertici della
ventata rumorosa proveniente d’oltralpe. Ora, dopo
uno iato più che quinquennale (Diving Rooms del 2004
l’ultimo passo conosciuto) tornano con un album che
lima le asperità e le peripezie da funamboli del mathrock noise che ne segnavano la proposta per adagiarsi
su un rock corposo, rotondo e accessibile.
Molto nel suono del quintetto parigino ruota intorno
alla personalità della vocalist Sasha Andrés, debordante e fin troppo catalizzatrice degli umori di un disco
che invece ha nelle soluzioni strumentali varie e non
noiose una buona lezione di indie-rock "della maturità". I Come di Thalia Zedek, alcuni passaggi shellacchiani nelle parti di chitarra, un andamento noise-blues
sottotraccia, una spruzzata di Sonic Youth del medio
periodo, una buona tenuta indie sono messe al servizio
della chanteuse francese e dei suoi toni chiaroscurali e
ondivaghi, ora da Joplin indemoniata, ora sensuale e
roca come una Kim Gordon ventenne. Trovare il giusto
equilibrio è possibile e potrebbe essere la mossa giusta
per rilanciare un'onesta carriera.
(6.2/10)
Stefano Pifferi
Hjaltalín - Terminal (Borgin, Settembre
2010)
Genere: chamber pop
Facilità melodica e leggerezza, si diceva l’anno scorso
a proposito del bel debutto (Sleepdrunk Seasons)
del collettivo islandese Hjaltalín - guidato da Hogni
Egilsson - che si ripropone ora a distanza di un anno e
mezzo circa con Terminal (già uscito nel 2009 in patria
e ora distribuito).
Chamber pop cantato spesso a due voci, maschile e
femminile, con massime variazioni in tempi e mood: le
caratteristiche fondamentali del gruppo sono rimaste
inalterate per questo sophomore album, in cui la cifra
lirica è sempre presente, così come il talento compositivo e l’alchimia di gruppo, che avevamo già rilevato.
Degli Arcade Fire meno impetuosi, o meglio dei Broken Social Scene, con un amore per Burt Bacharach,
Lee Hazlewood, Beach Boys, così come per la musica
colta.
Di nuovo in Terminal c’è un maggiore senso della
coralità e un avvicinamento ad atmosfere da musical
(Antony sembra essere dietro l’angolo) e in generale
al pop sixties che prima era meno evidente - si prenda per esempio un pezzo come la mini suite Feels Like
Sugar, che ricorda i duetti di Bacharach e certe cose
di Dusty Springfield - per evidenziare questa piccola
svolta. Non mancano anche piccoli richiami soul funk
e disco assenti finora (la mutevole Seven Years con tentazioni Abba e Water Poured In Rain) e omaggi neanche troppo celati al maestro Robert Wyatt (la variabile
Song From Incidental Music).
Talento confermato.
(7.2/10)
Teresa Greco
Hugo Race - Fatalists (Interbang Records,
Ottobre 2010)
Genere: indie-folk-rock
A livello superficiale, il mondo sonoro di Hugo Race
appare come certi film di fantascienza sociale degli
anni Settanta: una situazione normale, ordinaria che
nasconde piccoli scarti verso il nero, il disperato, l'indicibile, ma senza che tutto ciò sembri turbare gli abitanti di quel mondo. Una musica, quindi, che se ascoltata
distrattamente potrebbe scorrere nelle nostre cuffie
come l'ennesimo disco di rock che affonda nelle radici
più sanguigne della tradizione, similmente al Mark Lanegan onnipresente di oggi, con o senza Greg Dulli,
con o senza la biondina scozzese.
Ma se gli intarsi vocali di Will You Wake Up possono ricordare le fatiche dell'ex Screaming Trees in compagnia di Isobel Campbell, l'iniziale Call Her Name mette
su altri binari queste otto tracce di Hugo Race: i pochi
squarci di luce nel cielo nuvoloso vengono ricacciati indietro a suon di disperate mutazioni di slideguitar, at59
mosfere esiziali e una tendenza all'assoluto che lascia
senza fiato. Lo stesso si deve dire di Coming Over, che
sa di marcia funebre, contornata di corvi in volo sopra
la bara, o della corsa a fari spenti nella notte di Nightvision.
D'altra parte, questo disco incentrato sul concetto di
morte, è stato registrato mentre lo stesso Hugo superava la polmonite in una villa nella campagna italiana
(Italia che deve proprio piacere a Race, tanto che per
qualche tempo ha vissuto a Catania) durante lo scorso
autunno: "faceva freddo e per tutto il tempo della produzione me ne sono dovuto stare a guardare e ascoltare a causa della febbre". Più fatalista di così...
Non tutto è allo stesso livello, a partire da una poco
convinta In The Pines già resa nota dall'Unplugged dei
Nirvana, e una Serpent Egg che sembra proprio un outtake di Here Comes That Weird Chill proprio di Lanegan.
Detto questo, il resto fa scendere più di qualche brivido
lungo la schiena. Di disturbante piacere.
(6.8/10)
Marco Boscolo
Islaja - Keraaminen Pää (Fonal, Novembre
2010)
Genere: folk, elettronica
Se n'è parlato tanto della freakerie finlandese: terra di
folletti lo-fi, registratori magici, strumenti scordati che
somigliano ad incantesimi pagani. Islaja ne è stata
l'indiscussa regina e ora con Keraaminen Pää, abbandonati balalaika, orpelli e plaid boschivi, tenta la svolta
vestendosi di un suono di disincantata inattualità poggiato su elettroniche e calore vocale inedito.
E' infatti l'Occidente di Soap & Skin (così come
quest'ultima riscrive la mitteleuropa di Nico) l'ambito
che la folkster guarda con interesse rinunciando alle
corde per liberarsi in sarabande corali (Joku Tai Roden),
reggae per organetto (Dadahuulet), monologhi solitari da sirena oceanica (Pimeyttä kohti), loop etno-tribali
(Rakkauden palvelija 14), trasfigurazioni eighties similbjorchiane (Ajanlaskun Aatto).
Testimoni del salto avvenuto, i saliscendi di pianoforte
nell'avveniristica cornice barocca, la preziosità di certi
arrangiamenti che hanno un sapore lirico e certi accostamenti elettronico-orchestrali dall'impatto luminescente e disinvolto. Proprio sul versante laptop - come
anche con Es, ed i conterranei Paavoharju - il passaggio al suono algoritmico ha fornito ulteriori elementi di
arricchimento e trasversalità. (7/10)
Salvatore Borrelli
60
Jocelyn Pulsar - Il gruppo spalla non fa
il soundcheck (I dischi della lavatrice,
Aprile 2010)
Genere: indie-pop
Ormai è un fatto assodato: nell'indie nostrano esiste
una scuola "romagnola". Una via leggera e scazzata al
pop capace di riassumere in sé tutti quelli che sono i
caratteri fondanti di chi nella terra del cappelletto è
nato: indifferenza nei confronti del mercato, ironia che
ammicca al demenziale, flagello di "c" e di "z" in una
pronuncia che è carta di identità in tutto e per tutto (e
credetemi, so di cosa parlo). Agli ultimi Granturismo
e Nobraino si aggiungono ora i Jocelyn Pulsar - anzi
si sono aggiunti già da un po', visto che parliamo del
quinto disco della formazione -, al secolo Francesco
Pizzinelli da Forlì. Con un tripudio di chitarre acustiche e melodie appiccicose orgogliosamente provinciali, autobiografiche, irrimediabilmente nerd ma anche
"modaiole", almeno nell'accezione del termine tipica di
una Romagna estiva e fin troppo easy.
I proverbiali Mr. Brace stavano su un altro livello, è
vero, sia dal punto di vista del suono - qui è un po' tutto uniforme, senza picchi né particolari cadute di tono
- che dei testi. Tuttavia il pop disimpegnato da sabato
pomeriggio in centro dei Jocelyn Pulsar lo si ascolta
volentieri, una volta spenti gli interruttori del pensiero
critico più impegnato.
(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
John Roberts - Glass Eights (Dial, Ottobre
2010)
Genere: Deep
Se da una parte la deep spopola ancora sul dancefloor,
a Berlino la voglia di IDM non è passata, anzi c'è pure
molta spinta a portarla nei teatri, questa house oramai
istituzionalizzata. Dopo la dream di Apparat, i ghiacci
di Pantha Du Prince, le atmosfere di Efdemin e Lawrence e il pianoforte in cassa di Francesco Tristano
arriva John Roberts. Lui è un giovane produttore proveniente da Cleveland attualmente residente a Berlino
già fattosi apprezzare da Resident Advisor per un paio
di uscite su Dial Records (dove tutt'ora è l'unico artista
non krauto del roaster).
A parte Pruned apparsa su Mirror EP della scorsa estate,
quest'esordio sulla lunga distanza è interamente formato da materiale inedito e parla la lingua della deep
house classica e della Warp primi Novanta. Di suo Roberts, oltre a claps e drum machine Roland, un basso
avvolgente e synth analogici, ci mette il pianoforte
classico proprio come Tristano, ma con finalità in tutto
e per tutto ambient, attingendo per costruire la sua tavola da tipici paesaggi germanici tra pioggia e finestrini appannati, cementi diroccati e cieli color piombo.
C'è tanto cuore nell'house dell'americano ma anche
capacità di sceneggiatura come si nota in August (note
uggiose, tocchi ironici delle vocals, i synth e la linea melodica appena accennata) e Went (solo piano e gracchi
del giradischi in remember glitch). Da avere.
(7/10)
Edoardo Bridda
Josephine Foster - & The Victor Herrero
Band - Anda Jaleo (Fire Records,
Novembre 2010)
Genere: musical poetry
Ancora una scelta sui generis, in questo caso di natura politica e autoriale, è alla base del nuovo album di
Josephine Foster realizzato con The Victor Herrero
Band: si tratta di una serie di canzoni popolari scritte
da Federico Garcia Lorca e contenute nel libro Las
Canciones Populares Espanolas, le quali hanno rappresentato la dissidenza contro il regime spagnolo franchista.
Bandite all’epoca in Spagna durante gli anni della dittatura, sono state un importante veicolo culturale e
vengono oggi riscoperte grazie all’autrice americana e
al suo compagno Victor Herrero. Già testimone coraggiosa di scelte altre, si veda il recentissimo Graphic As
A Star (Emily Dickinson in musica), nonché la rivisitazione di una serie di lieder tedeschi di Shubert, Brahms
e Schumann (A Wolf In Sheep's Clothing, 2006), la Foster qui riduce all’osso la sua musica, che diventa performance a due prettamente acustica, accompagnata
un ristretto numero di musicisti; registrato dal vivo
Anda Jaleo ripercorre con vigore le canzoni del poeta
spagnolo, rispettandone tempi e modi in una riproposizione appassionata e filologicamente impeccabile. Al
solito la voce della Nostra si snoda tra tentazioni folk e
personalità da vendere, e fa perciò la differenza in queste cover sghembe e fascinosissime. Grande musica
d’autore.
(7.3/10)
Teresa Greco
Jules Not Jude - All Apples Are Red, Except
For Those Which Are Not Red (Produzioni
Dada, Novembre 2010)
Genere: psych pop
L'ep Clouds Of Fish col quale li ho conosciuti, vi dirò,
mi è rimasto incastrato da qualche parte tra l'anima e
il cuore. Una di quelle cose che ti capitano e dici che
bello, il refolo d'aria fragrante in mezzo a troppi respiri
affannosi. Ai tempi - pochi mesi fa - i Jules Not Jude
erano un duo. Oggi, in occasione dell'album d'esordio,
diventano quartetto: ai fondatori Simone Ferrari e Mirza Shaman si sono aggiunti il bassista Mauro Parolini e
la drummer Marzia Savoldi. Il suono ne esce più sbrigliato e definito, perdendo un po' di quell'alone caliginoso sui cui - a mò di cortina fumogena - si proiettavano aspettative e dolci misteri psych-pop.Peccato? Ok,
peccato. Ma è un prezzo congruo se sul piatto della bilancia ci metti una disinvoltura che somiglia parecchio
alla piena consapevolezza di mezzi e obiettivi.
Gli undici pezzi caracollano tra gli Samshing Pumpkins più soft (il canto di Ferrari strizza spesso l'occhio
a quello di Corgan), i Belle And Sebastian e tutto un
poppeggiar bucolico che pesca suggestioni sixties
(Zombies, i primi Small Faces) e contemporanee (Delgados, Super Furry Animals), per non dire nostrane
come Annie Hall e Le Man Avec Les Lunettes (entrambi a vario titolo presenti nei credits). Buon disco,
col valore aggiunto di un potenziale hit come Caramel
Lovelypop. (7/10)
Stefano Solventi
Keith Fullerton Whitman - Disingenuity
b/w Disingenuousness (Pasta Base,
Ottobre 2010)
Genere: classic tronica
Keith Fullerton Whitman aka Hrvatski torna al full
lenght vinilico dopo quattro lunghi anni passati a diffondere il verbo dell’avanguardia elettronica classica in
serate live, split, mini 12’’, edizioni limitate, nastri e attivismo culturale. Due facce del disco per due pezzi che
riprendono registrazioni dal vivo degli ultimi anni, passati tra Cambridge (il ragazzo ha studiato alla Berklee),
New York e Toronto e li rielaborano seguendo un approccio anticommerciale senza nessun compromesso
o pelo sulla lingua.
La mezz’ora complessiva delle tracce è una selezione da una più lunga improvvisazione, basata su field
sounds di elicotteri (e qui ritorna il fantasma del quartetto di Karlheinz Stockhausen), passeggiate nella
neve e voci di bambini riversati su una macchina Nagra
a nastro, che non registra solo il suono degli speakers,
ma anche i rumori dei chip interni. Il risultato è distante dalle prove di musica informatica (costruita cioé solo
con l’elaboratore o con le macchine), cui ci ha abituati il
ragazzo Whitman: oggi ci si confronta con le sperimentazioni live dei francesi, passando per lo Studio di Fonologia milanese di Nono, Berio, Maderna e Zuccheri.
61
highlight
Francesco Tristano Schlimé - Idiosynkrasia (InFiné, Novembre 2010)
Genere: Detroit piano
Prima la collaborazione con Murcof (sua la produzione di Not For Piano), poi con Moritz Von Oswald
in Auricle Bio On e infine oggi con Carl Craig su questo nuovo full length. La parabola di Tristano si
aggancia alle visioni di un ambient/classica ormai sempre più a portata di club, tanto che la prova generale di queste nove tracce si è tenuta proprio in una delle mecche del clubbismo europeo. Lo scorso
luglio allo Space ibizenco, gli increduli spettatori hanno infatti assistito alla prova generale preludio di
questo bel disco: un pianoforte gran coda immerso nel buio nel tempio della house e un Cark Craig che
comanda l’iPad per modificare dal vivo il suono del ragazzo, aggiungendo
i suoi tocchi magico-estatici. Da quella serata il duo ha tratto la forza e la
consapevolezza di essere sulla giusta strada per un progetto definitivo.
Ai confini con una visione che distilla il sentire soul di Detroit (le registrazioni sono state effettuate negli studi Planet E di Craig, impiantati nel suburbio della Motor City della techno), le nove tracce che abbiamo l’onore
di ascoltare oggi si adattano all’ascolto per palati sopraffini, delineano tocchi ritmici che vanno ad ampliare il suono del gran coda senza sovrastarlo,
quasi dei piccoli incantesimi che elevano l’antesignano acustico di tutte le
consolle a culto. Idiosincrasia appunto, che si adagia sui territori ambient: un viaggio, dice Francesco,
"in qualche modo tra l’acustico e l’elettronico. La mia ambizione è quella di conferire al pianoforte una nuova identità, poiché è spesso associato con la musica classica ed è visto come uno strumento del passato. Io
lo vedo invece come uno strumento proiettato nel futuro".
Ben vengano quindi gli intagli con la tradizione techno, purché dosati con parsimonia e savoir faire da
rodati arrangiatori: il sapore sudamericano di Fragrance De Fraga, i sogni che ricordano l’ultimo David
Sylvian in Lastdays, le visioni post-jazz cubiste con gli echi dei migliori Underworld (Mambo), i silenzi
di Vladislav Delay mescolati al minimalismo classico di Philip Glass in Nach Wasser Nor Erde, la progressione à la Steve Reich contaminata con l’anima black in Idiosynkrasia, il ricordo easy listening con
i clap uptempo di Eastern Market, Single And Doppio che potrebbe essere l’unica traccia destinata a un
DJ set dei più ispirati e per finire la lunghissima chiusa psych con i synth di Craig nei dieci minuti e più
di Hello-Inner Space Dub. Tristano e Craig: grandissima abbinata. Puntate tutto su di loro.
(7.6/10)
Marco Braggion
Il viaggio attraverso le tecniche classiche di elaborazione del suono in Disingenuity sembra non avere un
punto di riferimento, è un collage di sperimentazioni
adatte per un trip acido che ricorda le infatuazioni per
il concretismo di Parmegiani o del primo Xenakis. Se
il lato A si confina ad un eremitaggio per pochi eletti,
la seconda faccia (Disingenuousness) parte invece con
una progressività minimal glitch che richiama la mitica
serie Octagon della Hard Wax, il sogno Basic Channel
che entra nelle classi di musica elettronica e ne esce
ancora più spaced out di quanto già non fosse di suo
all’origine.
Keith ci porta con ostinata e certosina pazienza a toccare ancora una volta con mano la potenza del suono
sperimentale, che se sapientemente costruito, può farci
62
vedere nuovi mondi di cui non conoscevamo l’esistenza. Non è di immediato appealing come Lisbon, ma in
qualche modo scovatelo questo vinile, anche se è già
esaurito su tutti i siti. Non ne uscirete vivi.
(7.2/10)
Marco Braggion
King Me - Them Brawlers (A Cup In The
Garden, Ottobre 2010)
Genere: lo-fi psych
I King Me sono un sestetto olandese con undici anni
di carriera alle spalle e, col qui presente Them Brawlers, ormai sei album all'attivo. Non so voi, io non ne
avevo mai sentito parlare. Ma, ad occhio e croce, sono
una grande band. Con un'idea non precisa ma forte di
lo-fi psichedelico, piuttosto romantico, l'aria matura e
indolenzita di chi ormai ha masticato parecchia disillusione ma non rinuncia alle fatamorgane rock. Li senti
muoversi tra dissonanze My Bloody Valentine ed incubi psicoattivi Flaming Lips (Gimme Lies), tra melodie
deragliate Daniel Johnston e post-glam sfrigolante
Brian Eno (Red Eyes), spiegazzando dolcezze malmostose Magnetic Fields in salsa Sparklehorse (You
Should Wear A Dress) o Radiohead (Raged Nights), permettendosi di sdolcinare Beck in un brodo Polyphonic Spree (Motor Fear) oppure d'incendiare languori da
camera Nick Cave con un tripudio di svalvolate spacey
(Away And Still Cold).
Ogni pezzo azzecca un equilibrio prodigioso sulla propria obliqua congiuntura sonica: come una trottola che
traballa ma non smette di girare, come una generosa
problematica ostinazione, come un rammarico che
non rassegna a spegnersi. Disco che vibra vivo dalla
prima all'ultima nota.
(7.5/10)
pari del tipico chitarrismo effettato "alla The Edge" o di
certe soluzioni ritmiche introdotte da band new wave,
sono diventate patrimonio comune di qualunque pop
band voglia apparire anche solo minimamente up to
date. Il languore psichedelico di canzoni come The Face
è qualcosa che si inserisce agevolmente in questo solco; eppure, con la voce impastata di Caleb Followill a
fare da contrappunto, l'effetto è estremamente affascinante.
Ecco dunque la chiave di lettura dell'album e la peculiarità che rende questi Kings Of Leon ancora degni di
considerazione. I Followill sono come quei redneck che
si vestono da damerini per una notte brava da spendersi fra le luci della città: hanno abiti firmati ma quando
parlano d'amore, come nella ballata Mary, si portano
dietro lo spleen della campagna. Quando poi accelerano e irrobustiscono le trame (come nel moderno boogie di No Money) la sporcizia è ancora lì, sotto le unghie,
e non importa quanto si cerchi di nasconderla.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Diego Ballani
Kings Of Leon - Come Around Sundown
(RCA, Ottobre 2010)
Genere: Indie rock
Kit Downes - Kit Downes Trio - Golden
(Basho Records, Novembre 2009)
Genere: jazz
Il precedente Only By The Night è stato un vero e proprio nuovo inizio per i Followill. Dopo il classico esordio
da next big thing e l'inevitabile parabola discendente
tipica di chi ha invaso per mesi le pagine dell'NME, i
quattro del Tennessee hanno saputo ricalibrare il proprio sound su un alt rock decisamente più edulcorato
rispetto al garage degli esordi, tuttavia non privo di
spunti.
I maligni li hanno già ribattezzati i "Southern U2", per
l'attitudine da "stadium song" di brani come Sex On
Fire. Ecco allora che questo Come Around Sundown
funge cartina di tornasole per testarne la reale consistenza, anche alla luce dell'imponente dispiegamento
di mezzi che presumibilmente l'etichetta avrà concesso loro.
La cosa che colpisce, infatti, non appena partono le
prime note dell'opener The End (!), è l'imponenza della
produzione. Col precedente lavoro, hanno assaporato i
grandi spazi, ma i nuovi brani gettano lo sguardo ancora più lontano, rallentando il ritmo, facendo respirare le
armonie e aprendosi a suggestive soluzioni shoegaze,
affermazione quest'ultima su cui è necessario aprire un
inciso.
Quello che siamo soliti descrivere come "shoegaze", infatti, è un mix di chitarre psichedeliche nebulizzate che
baluginano all'orizzonte; un espediente sonoro che, al
Arriva solo ora in Italia questo esordio del Kit Downes
Trio. In realtà il disco risale a fine 2009 e dal momento
della sua uscita non ha raccolto che elogi da stampa
specializzata e non. Comprensibile, dal momento che il
jazz del diretto interessato - pianista britannico con un
curriculum di tutto rispetto alle spalle - sa gravitare con
stile tra modernità e classicismo. Nello specifico, tra un
approccio piuttosto elastico e per nulla intimidito nel
mescolare cambi di registro repentini (l'ottima Jump
Minzi Jump in cui si passa da un suono crepuscolare a
un Sud America appena abbozzato a un'esplosione di
note quasi in sbornia free) e una formazione "tipo" (col
contrabbasso di Calum Gourlay e la batteria di James
Maddren) legata a filo doppio alla golden age del jazz.
Keith Jarrett benedice i fraseggi elaborati ai limiti della classica, Bill Evans è chiamato in causa dalla raffinatezza di certe atmosfere (Homely), Thelonious Monk
è il nume tutelare di alcune soluzioni armoniche non
troppo rotonde. Racchiusi in un'opera forse poco rivoluzionaria ma assai godibile, in cui spiccano oltre all'ottimo interplay tra gli strumenti anche le buone doti di
compositore del titolare del progetto.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
63
Kongrosian Trio - Bootstrap Paradox (Aut
Records, Settembre 2010)
Genere: impro jazz
I Kongrosian sono un trio, diciamo così, trevigiano, che
come il (giustamente) celeberrimo radicchio si esalta
espandendosi, apparentando sapore e consistenze con
altri sapori altre consistenze. Tendono naturalmente al
quartetto, e infatti vantano collaborazioni col notevole sassofonista Beppe Scardino e col drummer Stefano
Giust tra gli altri. Di base, i tre combinano una misticanza insolita: clarinetto (alto e basso), sax (contralto e
soprano) e un altro sax (baritono), quest'ultimo spesso
e volentieri barattato con un mellofono.
Coadiuvati in questo album d'esordio dal clarinettista
Oreste Sabadin, sfornano impro con piglio dadaista e
patafisico ma sanno metterci sotto (e sopra, e di lato)
qualche batuffolo di mistero e un pizzico di serietà, così
da sembrare una brass band ebbra sul ponte sospeso
tra l'Apocalisse e il Paese dei Balocchi. Sedici tracce
folgoranti (durata media sui due minuti) come micro
massaggi neuronali o sketch ora garruli ora enigmatici,
col jazz (passato, presente, futuro?) ridotto in coaguli
scarmigliati e fragorosi, insospettabilmente lucidi. (7.1/10)
Stefano Solventi
Le luci della centrale elettrica - Per ora
noi la chiameremo felicità (La Tempesta
Dischi, Novembre 2010)
Genere: canzone d'autore
Recensire il secondo disco di Vasco Brondi è un po'
come giocare alla roulette russa. Con il revolver puntato alla tempia e il colpo in canna. E non tanto per
un discorso legato al giudizio sulla qualità effettiva
dell'opera, quanto per quello che il Brondi-pensiero
rappresenta per una buona fetta di ascoltatori. Specchio di una generazione, oltre che modello musicale di
riferimento, abbastanza diretto e disperato da assurgere al ruolo di vera e propria icona con tutti i pro e i
contro del caso. Tra questi ultimi, un'aura da intoccabile cucitagli addosso da un seguito fin troppo acritico
con il proprio paladino in virtù di un'onestà artistica
evidente ma, a nostro avviso, ancora tutta da formare.
E' un intercettare involontario il momento storico, l'arte
del Brondi, unito alla capacità di scrivere testi "universali", frammentari, comunque profondi, in linea con la
velocità di assimilazione che richiede il nuovo millennio. Con la chitarra acustica al centro e brani da un paio
di accordi a fare da cavallo di Troia. Come se si unisse
l'immediatezza DIY del punk - con tutto il meccanismo
di identificazione che ne deriva - alla profondità della
64
canzone d'autore, in una convergenza tra il pubblico
giovanile e quella critica "adulta" che non ha esitato
un attimo a gratificarlo, la scorsa stagione, col Premio
Tenco.
In Per ora noi la chiameremo felicità Brondi scrive per
loro. Non per chi non lo conosce ancora, non per far
cambiare opinione a chi lo ha già catalogato come un
"difetto" del sistema indie e nemmeno per dimostrare
di aver compiuto un percorso. Soltanto per ritrovare
quell'unità di intenti che ha reso il suo esordio un caso
discografico e i suoi concerti degli happening in pieno
stile. Tanto che non ci si muove di un millimetro dall'approccio che aveva reso Canzoni da spiaggia deturpata
quello che era, replicando estetica, forma e immaginario. Stesso stile, stessa poetica e soprattutto nessun accenno a tematiche inedite o a cambi di direzione. Nella
pratica, tutto si riduce al solito cut up che trita paesaggi urbani e storie lungo i bordi, legate a filo doppio ad
una sfera individuale claustrofobica, omnicomprensiva
ma, in qualche caso, anche fin troppo vaga. Dal fiume
in piena si salvano due o tre brani particolarmente riusciti (Quando tornerai dall'estero, Una guerra fredda,
L'amore ai tempi dei licenziamenti dei metalmeccanici) e
gli arrangiamenti, questi ultimi giocati su una musica
"atmosferica", stratificata e più varia rispetto al passato,
frutto del buon lavoro di Giorgio Canali, Stefano Pilia, Rodrigo D'Erasmo e Enrico Gabrielli.
Per una continuità che rasenta il vicolo cieco. Anche
perchè le scritte sui muri, le case inagibili o le polveri sottili che rendevano riconoscibile il Brondi degli esordi
guadagnano qui un'immobilità quasi dannosa, come
se consolidare significasse ripetersi ad libitum e non rielaborare un esordio a cui si perdonava molto in virtù
di una vis comunicativa enorme. E che almeno possedeva "inni generazionali" come Per combattere l'acne.
(6.2/10)
highlight
Giancarlo Onorato - Sangue bianco (Lilium Produzioni, Ottobre 2010)
Genere: canzone d'autore
Per parlare di Giancarlo Onorato occorre parlare di un cantautore come ce ne sono ormai pochi. Non
tanto e non solo per la qualità di una produzione diradata nel tempo ma
fondamentale negli esiti (quattro dischi dal 1996 ad oggi, dopo la fine
dell'esperienza con gli Underground Life), quanto per la peculiarità di
una scrittura da sempre differente rispetto alle tendenze in circolo. Come
altri inestimabili outsider prima di lui (Flavio Giurato, Juri Camisasca, il Fausto Rossi degli anni novanta) Onorato ha sempre cercato la massima potenza espressiva delle sue canzoni attraverso un lavoro sulla densità della
parola, proprio intesa letterariamente, e nel suo caso poeticamente. E di
poeticità per una volta è bene parlare quando siamo dinanzi ad un autore
che non teme la nudità estrema (eccolo probabilmente il maggior punto di contatto con gli outsider di
cui sopra), l'imprevedibile e inconsueto utilizzo lessicale, in ultimo lo zenit comunicativo intercostale e
sovrumano.
Sangue bianco, a sei anni di distanza dal precedente Falene, schiera le sue canzoni al bivio tra nascita
e nulla, lungo un orizzonte lirico che mischia dolcezza essenziale ed erotismo radicato, laddove la carne
si confonde con la purezza in un lascito di fecondità e misticismo. Sono per lo più ballad, arrangiate
classicamente ma con lievi dettagli a determinare ogni singolo brano, in cui la grande gamma strumentale e i venticinque musicisti coinvolti (fra di essi un nugolo di nomi nuovi da tenere d'occhio ognuno
nei propri campi: Christian Alati, Mario Congiu, Attila Faravelli, Christian Rainer, Davide Tosches)
non mettono a repentaglio la compattezza di un lavoro che pulsa grazie alla forza dei propri spunti
originari.

Ascoltate tracce come Else lied (dove i versi della poetessa tedesca Else Lasker-Schüler vengono
immersi di una soffusa luce d'alba), Il tuo venire, Io ti battezzo (intrinsecamente religiosa, seppur in un
senso del tutto anti-dottrinale) e la conclusiva Reginebambine, un'autentica preghiera d'amore generativo distante anni luce dalle lagne camerettarde di questi anni, e diteci se non è vero che di canzoni
così ce ne sono sempre meno, se chi scrive non dovrebbe tornare con più frequenza - e soprattutto
urgenza - al sangue, alle lacrime, alle ossa. In una parola alla vita: "passo e ripasso la lingua gentile sulla
ferita / immaginandola colma di bellezza traboccata / fonte segreta, bocca di un nulla dimenticato".
(7.5/10)
Luca Barachetti
Fabrizio Zampighi
Leo Zero - Disconnect (Strut Records,
Ottobre 2010)
Genere: DJ favourites
Bella partenza per la nuova serie di mix della Strut Disconnect, che affida ad alcuni tra i migliori DJ del globo un CD da stipare con stranezze, rarità e gioielli dimenticati delle proprie collezioni di dischi. Si parte col
britannico Leo Zero, nella vita di tutti i giorni (?) Leo
Elstob, noto da tre lustri e impegnato in diverse situazioni, dal figurare come "resident" allo Shrink2Fit durante il boom della techno detroitiana dei ’90 all’aver
inventato serate deep house con Stuart Patterson e
aver partecipato al collettivo Faith. Non contento, a un
certo punto ha preso a produrre e remixare senza posa
(benché non sempre a ragion veduta: sua la porcata
su Satellite Of Love di qualche anno fa) e ricoperto un
ruolo fondamentale nel progetto A Mountain Of One.
Come remixer lo hanno preteso Paul Weller, Florence
& The Machine, Bryan Ferry.
Quanto c’è di tale molteplicità di gusti e interessi in
questo mix? Tantissimo, giacché si passa con "cut" eleganti e raffinati da afro-pop a disco e reggae tramite
le contaminazioni new-wave di Basement 5 (un possente "extended" di Silicon Chip) ed Essential Logic;
successivamente planando sugli Ottanta di Chris &
Cosey (Exotica) e Propaganda per rapirsi il cervello in
un frammento di Halleluwah dei Can senza perdere di
vista l’Africa e le morbidezze da dancefloor, chiudendo
con la dolcezza di Spinning Away (Eno/Cale) e la marpiona My Oasis di The Countach. Saliscendi brillante a
medio livello di BPM e bello sfoggio di apertura mentale.
(7/10)
Giancarlo Turra
Les Savy Fav - Root For Ruin (Frenchkiss
Records, Ottobre 2010)
Genere: Indie Rock
Appena tre anni fa Let's Stay Friend mieteva consensi
unanimi da parte di critica e pubblico, mentre oggi il
quinto lavoro dei newyorchesi esce quasi in sordina.
65
highlight
Loners - I Remember A Dream (Boom Devil
Records, Settembre 2010)
Genere: folk rock
Lobi Traorè - Rainy Season Blues (Glitterhouse, Ottobre 2010)
Genere: Bambara blues
Chissà che costa stavate facendo il 9 agosto del 2008. Lobi Traorè era ai Bogolan Studio di Bamako,
Mali. Stava registrando l'ultimo disco della sua vita. Poco meno di due anni dopo, lo scorso giugno,
sarebbe morto, improvvisamente e senza tante spiegazioni di contorno. In studio con lui c'era l'ex
Walkabouts Chris Eckman e se ci avete seguito negli scorsi mesi durante
le nostre peregrinazioni sulle ultime novità in fatto di musica dalle parti
del delta del Niger sapete già che ci stiamo nuovamente inoltrando in un
qualcosa che va ben oltre la semplice uscita discografica ma riguarda gli
incontri intesi come le vite che s'incrociano e rifioriscono.
In pratica Traorè conosce Eckman durante le registrazioni del secondo disco dei Dirtmusic, sul quale il chitarrista maliano mette il proprio strumento in un paio di pezzi. Eckman aveva ascoltato di Traorè, innamorandosene perdutamente, The Lobi Traorè Group, ovvero il lato elettrico del
musicista, ovviamente figlio di Ali Farka Tourè ma anche grande ascoltatore del blues di questa parte
di mondo, John Lee Hooker su tutti. Da lì nasce una vicenda di demo registrati alla buona per una
nuova pubblicazione di Lobi che fatica a trovare un'etichetta in grado di sostenerlo - nonostante una
carriera più che ventennale - e poi scambi di mail, fraintendimenti dovuti alle differenze linguistiche
(Traorè parla soprattutto il Bambara, lingua a cui corrisponde una tradizione musicale di cui il suono
della sua chitarra è profondamente intriso) e infine questo disco benedetto.
Registrato tutto dal vivo, senza una setlist prestabilita, durante una session di quattro ore, Rainy Season Blues illustra il Traorè acustico, solo chitarra, voce e storytelling. Le canzoni sono legnose di un
legno brulicante di vita, la chitarra brucia di un'inquietudine ritmica figlia dei primi passi da percussionista del titolare (suonava le maracas in una banda di quartiere e le timbalas in un gruppo per matrimoni). La voce è vigorosa, muscolare, eppure straordinariamente lirica. Oltre ai nomi citati nell'aria c'è
anche Howlin' Wolf e insomma Traorè è un altro di quegli alvei provenienti dal Mali e non solo al quale
è impossibile per noi occidentali non andare a dissetarsi come ci si disseterebbe ad una fonte capace di
farci conoscere l'unica vera nostra origine, il grande Ritorno.
La storia completa di come sia nata un'opera come questa la trovate raccontata dallo stesso Eckman
nel booklet del disco. Vi anticipiamo solo che ha tutta l'epica, la purezza e la tragicità della musica di
quelle parti. Lobi Traorè è morto a quarantanove anni, non sappiamo cosa avrebbe potuto suonare ancora ma, credeteci, questa decina di canzoni scompaginano quella sublime indifferenza in cui la morte
farà cadere tutti noi e la memoria del nostro transito qui: per Lobi non sarà esattamente la stessa cosa.
(7.4/10)
Luca Barachetti
La smania di novità rischia di farci perdere uno degli
album più focalizzati e maturi di Tim Harrington e soci,
un inarrestabile fluire di elettricità policroma, che si
apre con il riff dissonante di Appetite e prosegue con
una serie di brani carichi di adrenalina: geometrie post
punk per chi, artisticamente, è cresciuto col melodismo
schizofrenico di Pixies e Superchunk.
I LSF non hanno intenzione di cedere di un millimetro
di fronte all’età che avanza anche se oggi a colpire, più
che la follia del barbuto singer, è un chitarrismo sugge66
stivo e coloratissimo, ricco di riverberi ed effetti assortiti che avvicinano Dirty Knails e Lips’n Stuff al surf spaziale dei Man Or Astroman? e che illuminano di bagliori
psichedelici la filastrocca di Sleepless In Silverlake.
Root For Ruin è la somma algebrica delle esperienze
di una band nata 90s, ma che continua ad elaborare
con gusto ed originalità le sonorità contemporanee.
(6.7/10)
Diego Ballani
Che c'azzeccano due siracusani con un blues rock
asperso di umori southern, dalle venature contry-psych luccicose come ne intarsiavano i Grateful Dead del
periodo Arista, il cuore ora in piena e ora in ambasce
- conteso tra palpitazioni ruspanti e spasmi angolosi
- come una disputa tra Wilco e Black Crowes? Abbastanza, perché Sante Barbagallo e Salvo Rizzuto iniziarono a staccare il biglietto per il loro sogno di rock'n'roll
trent'anni orsono, abbozzando un sodalizio mai approdato ad alcunché di concreto. Un cerchio che si aprì
quando Salvo abbandonò la terra natìa per l'ambita
Londra, dove ebbe modo di farsi apprezzare come cantante lavorando con Trevor Horn e Stephen Duffy tra
gli altri.
Sante invece è rimasto a Siracusa dove ha aperto un
negozio (di dischi, of course) senza però smettere il vizio di fare musica, suonando in diverse band della scena cittadina e organizzando eventi. Tre decadi dopo,
cioè oggi, quel cerchio si è chiuso, ovvero l'intesa tra
i due ha potuto finalmente compiersi, col non piccolo
aiuto di Carlo Barbagallo (già Albanopower) in fase
di arrangiamento e produzione. Al netto di qualche eccesso melodico, è un disco di ballate calde, intense, generose, capace di languori power pop (la notevole So
Wrong) così come di abbozzare ombre Mark Lanegan
in Brand New Day. Mai dimenticarsi di ricordare i sogni
migliori. Vero?
(7/10)
Stefano Solventi
Love In Elevator - Il Giorno Dell'Assenza
(Go Down Records, Ottobre 2010)
Genere: Noise rock
Siamo un popolo di navigatori, di santi e, forse, di eroi,
ma di sicuro non di shoegazers. Poi arriva un gruppo
come i Love In Elevator, che non solo sfoggia la liquidità psichedelica del dream pop, ma dimostra di saperla coniugare con i costrutti più fisici del noise a stelle e
strisce e del post punk.
Il gruppo, fra vari cambi di formazione, esiste dal 2001
e giunge al terzo album con uno stile personale che fagocita trent'anni di rumorismo per creare il proprio magniloquente affresco psichedelico. Magari non sempre
equilibrato: gli otto minuti della monolitica Dune, maelstrom sonico con contrappunto di violini, richiedono
più di qualche ascolto per essere metabolizzati. Di certo non fa difetto una sana ambizione che li porta a trattare con maestria una materia estremamente urticante
e variegata, a base di sfuriate punk e deliqui noise, e a
cui la voce eterea della brava Anna Carazzai concede
sempre una raffinata gentilezza pop.
A fine ascolto resta ancora il fiatone per il tour de force de I Cieli Di Munch e il piacevole perdersi nelle suggestioni de Il Sesso Delle Ciliegie e Mata Hari, fra le cui
complesse trame risuonano gli echi dei mai dimenticati Scisma.
(6.8/10)
Diego Ballani
Low Frequency Club - West Coast (Foolica,
Novembre 2010)
Genere: electro funk
Una chitarra che graffia nervosetta l'estro funk, tastiere (tastierine, tastierone, tastieracce) a pennellare frizzi
e lazzi disco anni ottanta più o meno italo, traslati poi
nelle aciderie club dei nineties con tutto il sovraccarico
di tensione febbricitante e liberatoria, il tutto attualizzato per gli anni zero con piglio DFA. Due anni (quasi
tre) dopo l'omonimo debutto, a pochi mesi dalla cover
di Johnny Come Home (pezzone targato Fine Young
Cannibals) che annunciava il nuovo corso su Foolica
Records, i tre Low Frequency Club tornano con questo West Coast per ragguagliarci sulla loro frizzante
ossessione.
Traccia via traccia, cogli entusiasmo, impudenza, energia, la cura ludica dei dettagli, la saldezza affilata degli
intenti. Una scrittura capace di sfornare potenziali craque come Disturbed Dancer o la feroce We Are Wolves.
Roba felice e facile col ghigno nel taschino, attenta
(giustamente) solo al qui e ora, tuffandosi dal trampolino di un passato ancora turgido. Capiterà ai bradipi
come il sottoscritto di chiedersi: ma perché? Solo per
sentirsi rispondere: perché no?
(6.6/10)
Stefano Solventi
M.O.F. 5tet - Embarrassing Days (Marco
Forieri Edizioni Musicali, Ottobre 2010)
Genere: avant jazz
Cinque ragazzi freschi di conservatorio (il Frescobaldi di
Ferrara) portatori sani di disparità geografica (Veneto,
Abruzzo e Sicilia) diventano un combo jazz con licenza
di evadere. Condiscono la misticanza di trombone, sax,
chitarra, basso e batteria con effetti sintetici e un diffuso estro avant-rock. E' tutto un giocare col fuoco, lo spirito lieve e serioso di chi sa le regole ma non può fare a
meno di pasticciarle. Un processo irreversibile che produce imbastardimenti arguti, frutto d'istinto ma anche
di evidente premeditazione.
67
Tengono le porte aperte anzi non ce ne sono proprio, e
non a caso nella ragione sociale hanno messo l'acronimo del Mercato Orto Frutticolo, un parcheggio gratuito
del centro, luogo di passaggi e incroci e guarda un po'
chi si rivede. L'esordio Embarassing Days mette in fila
otto pezzi originali che spaziano tra post-bop allucinato e disinvolta pensosità (la fascinosa Giù lì a Portobello), tra Blue Note ed E.S.T. (la title track), tra eleganza e
sconcerto (Via delle Belle Arti). Più una cover genialoide,
No One Knows dei Queens Of The Stone Age, virata in
uno swing tra il maligno e lo sbarazzino. Disco che diverte e sbalordisce. Bravi ma bravi davvero.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Maciste - Maciste (Devil's Ruin Records,
Ottobre 2010)
Genere: etno blues folk
Neanche il tempo di segnalarli sul Re-boot che i Maciste esordiscono con un album tutto intero e "ufficiale". Ribadiamo la bella impressione ricavata dal demo:
il loro teatrino da folk-rock tarantolato, balcanico, circense, portatore insano di febbre garage e vintagismi
psych, riesce a stare in piedi anzi a zompare come un
bucaniere elettrificato. Ogni canzone una baracconata
di trombe, tromboni, theremin, hammond, farfisa, chitarre, pelli sbatacchiate con soverchiante foga.
La bombetta ben calata sul cranio, i cinque non fanno
sconti alla loro voglia di ghigni, visioni alcoliche e sudori polverosi. Scomodano Tom Waits e Cramps, Jon
Spencer ed Emir Kusturica, Sonics e Gogol Bordello,
per un bailamme che diverte travolgendo (e viceversa). La multicefala God Is My Klaxon, la truce Callaghan
Is Dead ed il folle barnum di B.B.B. sono forse i momenti
migliori di una scaletta che non conosce tregua.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Madame Lingerie - D'amore, soldi e
vendetta (, Novembre 2010)
Genere: Rock
Una sorta di riuscita versione italiana degli Interpol, così
si definiscono i Madame Lingerie, band romana che
con l'esordio D'amore, soldi e vendetta sforna dodici valide tracce di noise rock filo americano in bilico tra un
crooning à la Interpol e un declamato letterario firmato
Pierpaolo Capovilla.
La prima traccia, Piu' niente, ha le carte in regola per
una degna apertura: ritornello martellante su disilluse
parole d'amore; ma nell'album quel che colpisce sono i
cambi calcolati, i netti tagli ritmici, lo stile oscuro delle
68
liriche che declinano sentimenti persi in meandri dark.
Ponciarello immerge le proprie radici nell'hardcore
evoluto dei '90, quello del milieu Touch'n'Go per intenderci, Titanioc e E R R E macinano un grumoso basso Big
Black, quando altrove un'altra strategia vincente sta nel
dosare l'urgenza col taglio wave e il respiro maestoso
dei cugini di Banks e co, ovvero gli Editors.
Il quartetto, disincanto da false promesse e coscienza
di ogni sfumatura dei propri riferimenti musicali, ha
un impatto sonico egregiamente autoprodotto. Anzi,
per dirla tutta, questo è uno dei casi in cui autoproduzione fa rima con qualità in missaggio e produzione,
con l'unico difetto - che non andrebbe troppo stigmatizzato - dei testi di Alessandro, certamente ancora
troppo succubi del frontman del Teatro degli Orrori
sia quando s'affrontano temi di lucida rassegnazione (L'abbiamo pagata cara noi la nostra ingenuità / ma
quanto ancora? Così seducente ed affascinante / ma l'oro
che hai non brillerà mai da Titanioc), sia quando conducono l'amore al limite (Voglio una vita di stenti e che tu
ti accontenti soltanto di me sempre da Titanioc), oppure
ancora quando, pensando a Manuel Agnelli, cacciano i
sentimenti in faccia (Ti regalo un po' della mia giovinezza per avere l'incubo nel cuore di non farcela / non ce la
fai più ad amare / non ce la fai più a sentire quella voce
che diceva 'tutto cambierà da La cartomante).
Lavorando in personalità, sulla padronanza dell'articolazione lirica e limando certe cadenze à la Banks, dai
Madame Lingerie possiamo aspettarci grandi cose. Per
il momento abbiamo un esordio potente e coeso, dalle
dinamiche chitarristiche e ritmiche notevoli.
(6.9/10)
Giulio Bartolomei
Magda - From the Fallen Page (Minus
Records, Ottobre 2010)
Genere: Minimal
Nonostante sia accanto a Richie Hawtin sin dai tempi
di Detroit, ovvero dai primordi di Plastikman, Magda,
che nella scuderia ora berlinese del maestro è probabilmente la migliore scoperta, arriva soltanto oggi a
pubblicare l'esordio sulla lunga distanza.
From The Fallen Page è una bestia scura che ti cattura
lentamente: ritmi minimal a basso contenuto di bpm,
groove bituminosi che grondano dalle pareti dei club
techno di mezza Europa di cui la ragazza conosce ogni
segreto e tocchi di fantomatiche soundtrack operistiche o sci-fi (Lost In Time) che se, da una parte, sciorinano l'industrial danzereccia, dall'altra mandano a memoria i Kraftwerk amati dalla città dei Motori (Music
Box) e persino il post-punk newyorchese accarezzato
dalla cricca Gigolo (Little Bad Habits). A Detroit, Magda
c'ha abitato dai nove ai trent'anni. Ora che sta a Berlino,
quest'album sembra un dedica alla culla della mitteltechno delineata attraverso originali e preziosi toni di
grigio, chiaroscuri '80/'90 e quell'amore viscerale per le
Roland più scrause e nerdy. La polacca poi, ci aggiunge
l'inquietudine fast inguaiata con la keta, che è un po' il
sign o' the times 00, dosandola egregiamente dall'inizio alla fine; proprio nel finale Japan rilascia l'adrenalina sotto forma di cocktail Ottanta, sempre e comunque
guidato dall'implacabile beat che borbotta, gorgoglia,
gracchia. Ti prende.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Magnetic Man - Magnetic Man (Columbia
Records, Ottobre 2010)
Genere: Dub all star step
Sembrava dovesse venir giù il mondo con lo sbarco degli uomini magnetici, tre ragazzi stanziati a Croydon,
South London, che un lustro abbondante fa contribuirono a creare la miscela esplosiva che dette origine al suono elettronico più famoso degli anni Zero, il dubstep.
Abbiamo invece un debutto diviso tra una noiosa parte
strumentale e un’altalena di potenziali singoli dal taglio
pop (e un tocco di grime) che flirtano con l’immaginario
rave e cercano spasmodicamente di incunearsi nei gusti
allargati di due generazioni ravetroniche. Per i catastrofisti e i puristi, il 2010 sarà l’Altamont del dubstep, più concretamente il debutto di Magnetic Man lo banalizza togliendogli quasi ovunque la carica anthemica e offrendo
in cambio al massimo due canzoni di futile appeal.
Provenienti da un genere pop per eccellenza come il
2step e da pionieri quali gli Horsepower Production
(primi destinatari dell’etichetta nel 2002 che le canzoni
le sapevano fare), i tre supereroi del dubstep, Benga,
Skream e Artwork, più vicini al grime (hip hop e ragga) che allo stepping e all'immaginario di un Burial,
faticano a trovare le soluzioni melodico-ritmiche per
reinventarsi mainstream (Boiling Water con Sam Frank
è imbarazzante), mentre trovano alcune suggestive
soluzioni sul lato black della scaletta dove il tocco di
Benga è evidente e la consolle libera dai compromessi
(Fire, The Bug).
Di fatto più che su un discorso di strofe, il grande successo del singolo apripista I Need Air è un gioco sul bliss
da rave ed è un peccato che l’album punti proprio su
quelle, fallendo inesorabilmente la sua riuscita (Crossover). La parte strumentale, dicevamo, è spesso inutile:
Anthemic e Mad mescolano edulcorati gracchi Terror
Danjah con noiosi interventi di synth cinematici e me-
morabilia IDM, Ping Pong si butta soltanto su questi ultimi con risultati ancora più inconsistenti.
Verso il finale, Skream si cimenta in territori Aphex
Twin con la discreta ambient psych di Box Of Ghosts
e un attacco d’ouverture (Karma Crazy) che convertirà
nelle vecchie maniere. E’ troppo tardi però. Il pasticcio
è già fatto. "Getting Nowhere" canta in toni soul John
Legend nell’omonima track, ed è l'unico episodio veramente degno di nota.
(5/10)
Edoardo Bridda
Mambassa - LP (EMI, Ottobre 2010)
Genere: pop d'autore
Compito non facile quello di tornare dopo sei anni
- che alla voce pop italiano hanno significato molto:
fatela voi una lista dei dischi importanti usciti nel mentre. Eppure i Mambassa ci riprovano, con l'orgoglio di
aver rappresentato un bel capitolo della nuova musica
italiana a cavallo tra la fine del secolo scorso e l'inizio
del nuovo e con la forza di tante esperienze musicali e
non solo (vedasi il libro e il film realizzati nel frattempo
dal leader Stefano Sardo). A ciò aggiungete anche due
cambi di formazione (dentro il tastierista Fu, fuori durante la lavorazione il chitarrista Ninotosh) e i predicati
ci sono tutti: LP, ovvero Lonely Planet, è il racconto di
una contemporaneità affollata ma carica di solitudine
da parte di chi, superati i trenta, traccia bilanci, riparte,
si disillude. Il tutto vergato in una serie di pop-ballad
che definiamo manualistiche per parlarne bene, tra i
canonici climax a gradoni d'intensità de La costruzione
della notte, le voci di cuori digitali in zona Subsonica
via Air di Immolando e la presa rapida di un singolo
tutt'altro che ruffiano ma gravido di buone idee (in primis la chiusura tranchant) come Casting.
Tuttavia viene difficile non pensare ai Mambassa come
ad un gruppo che da qui in poi dovrà inseguire. Vuoi
perché gli anni intanto sono passati e i novanta non
hanno più quella fortuna, vuoi per qualche lirica un po'
semplicistica, vuoi per i rimandi continui che rallentano
qualche traccia (a realtà anche contigue: i Perturbazione qua e là, oltre ai già citati torinesi), alla fine succede
che Lonely Planet decolla, sì, ma rimane a mezz'aria o
poco più su. E dire che ci piacerebbe trovarli in radio
al posto dei Negramaro è un complimento che non
basta. Meglio concentrarsi sul fiore all'occhiello delle
coloriture de La pioggia di settembre o sull'ossatura vintage da Pregherò di Ora che non ci sei più tu. Segnali non
tanto piccoli di un gruppo comunque ancora in gara.
(6.5/10)
Luca Barachetti
69
Mark Chadwick - All The Pieces (Stay By,
Settembre 2010)
Genere: Folk biopic
Chi seguiva le vicende della terra d'Albione a cavallo tra
Ottanta e Novanta, ricorderà come Mark Chadwick e i
suoi Levellers fossero qualcosa di molto vicino a rock
star. Il loro folk-punk era riuscito ad infilarsi nelle posiozioni alte delle classifiche e il loro culto era cresciuto un
po' ovunque nel biennio successivo al debutto A Weapon Called the Word nel 1990. In seguito le cose non
sono andate tanto bene, decretando un primo stop
all'attività già nel 1998. Gli anni zero li hanno rivisti in
azione, con due album che non hanno spostato di una
virgola la loro storia e che hanno solo soddisfatto i nostalgici.
Oggi il loro leader e frontman esordisce in solitaria, con
dodici brani che rappresentano una sorta di piccola autobiografia in musica e che ce lo restituiscono in una
forma notevole. Non che All The Pieces faccia gridare
al miracolo, ma è sicuramente il miglior lotto di canzoni
che il cantautore di Brighton scrive da almeno un decennio. Rispetto al gruppo-madre, qui si spinge il tutto
in territori più pop, senza rinunciare a qualche messaggio tra l'ironico e l'impegnato ("stop the war/and all of
that/just keep drinking/perhaps we're better at that"
canta in Indians). Gli episodi migliori sono quelli più solari e corali, oltre alla già citata Indians, la titletrack (tra
le cose più appiccicose dell'anno), Havens, Empty Now.
Non sarà l'evento dell'anno, ma la freschezza delle melodie, la semplicità degli hook e una maturità serena
dicono di un musicista con il quale fare ancora i conti.
(6.7/10)
Marco Boscolo
Marnie Stern - Marnie Stern (Kill Rock
Stars, Ottobre 2010)
Genere: Math rock
Non è eccessivo affermare che i due precendenti lavori di Marnie Stern avevano lasciato sbigottiti anche
i recensori più smaliziati. Quel brutale cozzare di stili
(rock, metal, prog, noise, psichedelia e chissà quant'altro) lasciava sul campo un'installazione surreale che
proprio non si sapeva da che parte iniziarla ad ascoltare: affascinante, come tutte le cose di cui ancora non
si comprende bene la portata, ma solo per i primi minuti. Superato lo stupore iniziale iniziava a subentrare
un certo senso di irritazione destinato a protrarsi per il
resto dell'ascolto.
L'effetto viene in parte lenito in questo terzo e omonimo album, infarcito di un math rock metallifero senza
posa, con batteria in assolo perenne, chitarra tormen70
tata e una vocalità portata a raggiungere note impossibili. Il problema di fronte ad un tour de force sonoro
così deliberato è capire fino a che punto arriva la spontaneità, non tanto perché sia interessante sapere se la
Stern soffra realmente di qualche sindrome isterica,
quanto perché, a tratti, tutto ha il sapore un pò artefatto dell'esercizio di stile.
L'euforia declinata nel febbrile finger picking è un'idea
interessante, ma quando se ne fa un uso così sistematico, finisce per inficiare sul risultato finale. Basterebbe
poco, magari solo un piccolo aggiustamento, tipo ripiegare su formule più contenute, come accade nella
più rilassata e focalizzata Tranparency Is The New Mistery, in cui l'irruenza della bionda chitarrista viene disciplinata in geometrie più intellegibili, consentendole di
trasmetterci un pò di quel fuoco sacro che da tempo
sembra essersi impossessato di lei.
(6.3/10)
Diego Ballani
Matthew Herbert - One Club (Accidental,
Ottobre 2010)
Genere: minimal, concrete
"Dai free party siamo finiti nei Club e da lì il discorso non
si è spostato, anzi, nei Club c’è la vita reale, ci sono le compagnie di tabacco, telefonia, alcol. Insomma c’è la pubblicità, gli sponsor e cose così. Invece di aprire la mente alla
gente, il Club gli ha fatto accettare una realtà corporativa. Con la mia musica sto cercando rendere chiari questi
link".
Lo scorso giugno Matthew Herbert, in un misto di
nostalgia e rabbia, ce la dipingeva così la vita nei Club
odierni, dal punto di vista di un uomo che dopo essersi vissuto il meglio dell'epopea free party, si ritrova
di fronte a una realtà di contenitori sociali totalmente
controllati da multinazionali lecite e illecite. Da lì One
Club, il disco di musica da ballo imballabile, la telecronaca del weekend sballone dove tutto è meccanizzato
fin nei più minimi bit, dal ritmo all’accensione di una
sigaretta, dal blin blin della cassa, al succhio della cannuccia del cocktail.
L’ex Dr. Rockit che in passato pionierizzò la microhouse
ritorna sulla dance per parlarci dei legami subdoli che
ora la alimentano. Le sorgenti dell’album sono state
prese in un’unica serata al Robert Johnson, un nightclub
di Francoforte. Herbert li ha successivamente tagliati,
cuciti e messi in battute industrialeggianti (Jalal Malekidoost), rotonde o robotiche con il preciso scopo di
generare nell’ascoltatore un rise da pasticca marcio e
distante, inebriantemente guastato o disumano tout
court (Robert Johnson). L'unico tocco uber alienazione
che apre alla cosiddetta creatività - completamente assente nella minimal di molti set - è un coro che è poi
il leitmotiv del disco: ballerini di musical (?) che sporadicamente rompono la monotonia, come se dal cubo
club si passasse al teatro, dove tutto è più gruppale e
umano.
One Club è un lavoro tanto sociologicamente riuscito
quanto sonicamente controverso. Da un lato ricorda
alcuni lavori giovanili dei Matmos o i Residents di Diskomo (Marlies Hoeniges); dall’altro, resistendo alle ipotesi gigione o sarcastiche, costringe l’ascoltatore a una
seduta musicalmente anomica e monodimensionale.
Forse al Sonar chi ha fischiato Herbert non aveva tutti i
torti questa volta. Aspettiamo One Pig. Finale della trilogia nonché l'episodio più atteso.
(6/10)
Edoardo Bridda
Maximum Balloon - Maximum Balloon
(Interscope Records, Settembre 2010)
Genere: funk pop
David Andrew Sitek risponde al coming out solista di
Tunde Adebimpe - sotto le spoglie dei Rain Machine
- gettando ulteriore luce sulla ricetta Tv On The Radio.
Come dire: se Adebimpe costituisce il portato black con
tutte le rifrazioni psych, soul, hip-hop e gospel, Sitek è
l'emisfero sinistro synth-pop impegnato a razionalizzare il virus funk. C'ha la stoffa, il passo, la vena del produttore, quello che tiene il suono nei ranghi, come ha
già dimostrato lavorando per Yeah Yeah Yeah's, Foals
e Scarlett Johansson. Per questo debutto del se stesso
cammuffato da Maximum Balloon, intendeva confezionare tracce da ascoltarsi "in auto, in banca, uscendo con
la ragazza, in qualsiasi circostanza". Elogio del medium
freddo, coinvolgimento epidermico, understatement
emotivo: in effetti, c'è riuscito.
La scaletta celebra un intrattenimento agile e arguto,
ingredienti e dosaggi azzeccati, interpreti compresi.
C'è soprattutto un'anima talkingheadsiana che pompa
funky in Tiger (affidata all'ottimo Aku, singer dei Dragons of Zynth), s'imbizzarrisce d'umori Prince in Groove Me (per la voce del rapper newyorkese Theophilus
London) e ciondola etniche ironie in Apartment Wrestling (a cura del maestro David Byrne). C'è poi la verve
Gorillaz diluita Bob Sinclair di If You Return (ospiti gli
svedesi Little Dragon) e tanta voglia di eighties in guisa
Human League e David Bowie che zampilla in Young
Love (per la voce equivoca di Katrina Ford). Sono episodi gradevoli e intensi come caramelline di zucchero ed
altrettanto effimeri, alla pari di Communion (feauturing
Karen O) e delle pur vagamente eniane Pink Bricks (can-
ta Ambrosia Parsley) e The Lesson (per una interessante
Holly Miranda).
Lo pseudo ricongiungimento della band madre in Absence Of Light non esalta, però serve a ricordarci che
spesso il totale supera la somma delle parti. E neanche
di poco.
(6/10)
Stefano Solventi
Method Of Defiance - Nihon (RareNoise,
Settembre 2010)
Genere: fusion impro
I Method Of Defiance sono il considerevole sfizio allestito da Bill Laswell per esplorare ed escogitare una sua
certa idea di fusion contemporanea. Che prevede inneschi e incroci dub, electro-hardcore, improv jazz, drum
& bass e spurghi noise. Una formula a tratti incendiaria,
soprattutto quando in Method Plan One e Black Rain
preme sull'acceleratore e scioglie le briglie alla tromba
di Toshinori Kondo, col suo lirismo vetrificato e luciferino che si sposa assai bene coi vocalizzi mutanti di Dr.
Israel.
Bei momenti, una strana dimensione da rave espanso,
brodo di cagna nel drink energetico, hammond (a cura
del leggendario Bernie Worrell) che gronda sudori antichi per estasi nuove. La fase dub è invece più scontata e
dispersiva, insegue suggestioni che - soprattutto negli
assolo del bassista - non vanno oltre una maniera cortocircuitata, e la band finisce per sembrare un manipolo di virtuosi al guinzaglio di un'idea bolsa e un po' dispotica. Disco comunque zeppo di spunti interessanti,
esaltati dall'incisione live (due set giapponesi del 2007)
giustamente testimoniata dal DVD allegato.
(6.3/10)
Stefano Solventi
Midnight Juggernauts - The Crystal Axis
(Siberia Records, Settembre 2010)
Genere: synthpop
The Crystal Axis lavora su un contesto estremamente
definito: synth pop alla Ultravox con ambientazioni
Kraftwerk-iane. Pop e "canzoni" per androidi d’antan.
Nonostante la formula assodata, però - e forse proprio
con un peso così grande sulle spalle - è proprio ciò che
porta tale retroterra nel "popolare" a evidenziare delle
pecche. Ossia, detto semplicemente, l’avvicendamento
strofe / refrain.
Sono proprio i ritornelli, quei momenti che dovrebbero
imperniare attorno a sé l’efficacia di una canzone, nello
schema scimmiottato del rondò, che finiscono per rovinare i brani (Lifebllod Flow), laddove nella costruzione
71
delle parti restanti dei brani si nota una certa abilità a
gestire gli strumenti pop-androidi dei già citati Kraftwerk, Ultravox, oppure Jean Michel Jarre, delle volte Roxy Music (This New Technology) Anche quando
l’architettura della canzone sta in piedi e mostra delle
buone "solette" (il riff di Lara Versus The Savage Pack), le
melodie - e la voce che canta - non si distinguono per
personalità, eppure risultano evidentissime, perché in
primo piano (eclatanti in Dynasty).
I Midnight Juggernauts hanno sicuramente ascoltato e interiorizzato le cose migliori del genere. Epperò
gli australiani, pur essendo attivi da cinque anni, non
sembrano aver trovato una buona penna con la quale scrivere, solo un set per fare miniature e disegnare
paesaggi siderali. Rispettabile compito. E lo faremmo
volentieri un viaggio, nella galassia stereotipata degli
uomini macchina. E invece dobbiamo starcene a guardare l’astronauta partire, dal pianeta Terra.
(5/10)
Gaspare Caliri
Milva - Non conosco nessun Patrizio!
(Universal, Settembre 2010)
Genere: pop d'autore
Questi due insieme hanno fatto faville. Milva e Franco
Battiato, negli anni Ottanta, lei già consacrata qualche
interprete brechtiana, lui eccentrico re mida del pop di
casa nostra, due dischi insieme (Milva e dintorni, 1982,
Svegliando l'amante che dorme, 1989) da avere assolutamente quali gioielli laterali di un decennio che
cambiava le regole dello scrivere canzoni in italiano - e
a cambiarle c'era proprio lui, che per la Rossa scriveva
la celebre Alexander Platz, ma anche Poggibonsi, Atmosfera: cercateli in rete (visto che la discografia langue) e
fateli vostri.
Proprio da due canzoni di quel periodo (Una storia inventata e I processi del pensiero, entrambe dal secondo
disco) riparte oggi la collaborazione. E fa strano ritrovarli insieme in quella che fu una partnership mitologica, se non altro perché se là di oro si trattava qui è
di bigiotteria che parliamo, di quella d'artigianato vero
però, certo non così inarrivabile eppure di tutto rispetto visti anche gli anni passati (Milva ha annunciato la
fine della propria carriera dal vivo) e le situazioni differenti.
Il repertorio scelto è di quello che non t'immagini del
tutto, ed è forse questa imprevedibilità senza troppo clamore il quid di Non conosco nessun Patrizio!.
Come a dire che la coppia si voleva divertire, trovarsi
insieme ancora una volta a fare musica e niente di più.
Oltre ai ripescaggi dai dischi precedenti, debitamente
72
riarrangiati (splendida I processi del pensiero), troviamo
due canzoni da Il vuoto (non fra i momenti memorabili della produzione di Battiato) rinvigorite da lei con
la giusta dose di ieraticità per I giorni della monotonia
e uno slancio vitale per Io chi sono, l'episodio migliore
dell'intero lotto, trasformata da meditazione sintetica
alla Eno in illuminazione pop su un lago calmo di synth.
Poi l'inedito, una title-track immalinconita, lì a metà tra
le ultime cose del siciliano e L'ombrello e la macchina
da cucire. Infine una serie di recuperi anche coraggiosi
(Il ballo del potere, un vestito insolito addosso a Milva
ma portato con dignità), a volte condotti tramite eccessiva verbosità (Le aquile, Bis Du Bei Mir) altre volte
con la giusta dose di dramma vista l'apoteosi d'archi di
contorno (Segnali di vita).
Certo, lo dicevamo, negli anni ottanta era tutt'altra storia. Oggi Battiato pare in preda ad un'ansia da lavoro su
materiale già esistente (suo e di altri) che non ha però
portato a chissà quale exploit. Milva invece saluta lasciando un filo di rimpianto: potrà piacere o meno, ma
scorrete la sua discografia e diteci il nome di un'altra
interprete, anche oltreconfine, che ha cantato così tanti autori e così diversi.
(6.8/10)
Luca Barachetti
Ministri - Fuori (Universal, Ottobre 2010)
Genere: rock italiano
Giunti alla quarta uscita in quattro anni (tre dischi sulla
lunga distanza e un ep) i Ministri deviano sensibilmente verso un songwriting meno furente, più concentrato
nei dettagli e nella rotondità di forme. Non è tanto il
marchio Universal a guidarli - siamo pur sempre distanti da una qualsivoglia possibilità radiofonica - ma l'esigenza di un cambiamento che li salvaguardi da ogni
manierismo in agguato.
Se Fuori lascerà piuttosto tiepidi i fan della prima (e
della seconda) ora non sarà solo per l'introduzione di
un pianoforte qua o di un banjo là, per qualche cascame new-wave che si profila non così inaspettato
all'orizzonte o per una manciata di interventi elettronici tutt'altro che invasivi. A mancare semmai è l'impeto
delle prove precedenti, volutamente calmierato in favore di un mood più interiore, personale.
Nessuno slogan, nessuna citazione di nomi e cognomi;
piuttosto un'indole cantautorale che racconta storie
attraverso frame fotografici o visioni vagamente surreali su linee melodiche anche seduttive. Funziona? Non
troppo. I testi di Federico Dragogna non reggono per
dodici tracce e a volte faticano a scorrere lungo l'incedere più sciolto di un tempo dei brani; la voce di Davi-
de Autelitano compensa con le solite eccellenti parti
urlate (al limite dello screaming più puro) un'interpretazione che nei momenti meno concitati fatica a trovare una sua espressività.
Innegabile dunque il gap tra intenzione e attuali capacità: nonostante ciò Fuori strappa una sufficienza risicata grazie un'urgenza che, seppur oggi più sottocutanea, a differenza di altri nomi-simbolo degli anni zero
italici non è venuta a mancare.
(6.2/10)
Luca Barachetti
Mt. Desolation - Mt. Desolation
(Cooperative Music, Ottobre 2010)
Genere: pop supergroup
Raccontata così sembra una barzelletta: ci sono due
Keane (Tim Rice-Oxley, Jesse Quin), uno dei Killers
(Ronnie Vannucci) e un tizio di Noah And The Whale (Tom Hobden) che hanno deciso di formare un supergruppo con Winston Marshall dei Mumford And
Sons. Uno dal discreto talento, quest’ultimo, che messo a confronto con gli altri nomi coinvolti passa per
genio e comunque non impedisce il naufragio di uno
scontato country-folk che degenera in irritante banalità da FM. Salviamo giusto il brio dell’iniziale Departure,
la morbida efficacia di Bridal Gown e la malinconica My
My My da cinquanta minuti che svelano subito la natura di passatempo allestito da mezze tacche più un onesto musicista, giocati tra pulite esecuzioni buone per la
radio di un centro commerciale, belle forme senza un
filo d’ironia e qualche pallido esercizio di stile.
Roba priva di un perché, quando di dischi ne escono
cento e anzi mille in un mese e un pubblico che li acquisti non esiste praticamente più, ma figurarsi se costoro si sono posti il problema. Siccome la pubblicità è
l’anima del commercio (e in questo caso de li mortacci
loro), il comunicato stampa informa che il progetto è
nato dopo una colossale sbronza al pub. Ripensarci
la mattina seguente dopo un bel caffé forte e un paio
d’aspirine pareva brutto, eh?
(4.5/10)
Giancarlo Turra
Orb (The)/David Gilmour - Metallic
Spheres (Columbia Records, Ottobre 2010)
Genere: Ambient, psych
L’egregio David Gilmour è uno vecchio stile. Alla politica ci guarda e ai charity event - come li chiamano in Inghilterra - è sempre in prima linea. Lo scorso 11 luglio ha
nuovamente condiviso il palco con il non troppo amico
Roger Waters per dare speranza alla prossima genera-
zione di palestinesi che cresceranno nella famigerata
striscia di Gaza, mentre lo scorso anno aveva registrato
un contributo così così (Chicago) per una canzone pro
Gary Kinnon, il famoso hacker reo di aver operato la più
grande intrusione informatica di tutti i tempi. Il ritornello lo potete ancora ascoltare: si trova nella seconda
delle due suite di questa improbabile collaborazione.
Ci sentite Gilmour, nel classico registro alto e roco, intonare "do you believe in justice / do you believe in freedom"
e in sottofondo - pare ancora di sentirceli - i due vecchi
amici Alex Paterson e Martin "Youth" Glover farsela sotto dal ridere.
Mille anni fa il primo iniziò la carriera musicale come
roadie dei Killing Joke - e per lui galeotto fu l’ascolto
del Brian Eno di Music For Films sotto LSD - mentre
il secondo, bassista di quella stessa band, fu l’artefice,
assieme ai compagni, di quella fusione tra post-punk e
metal che sarà poi la base per dozzine di gruppi vampironi d’oggi e nu metal di ieri.
Quei due oggi sono persone diverse. Youth, ad esempio, è un produttore di grido nonché cofirmatario di un
progetto con Paul McCartney. Eppure il credo punk e il
disprezzo hippy non sono cose che si cambiano facilmente, specie se cresci a pane e sound system e ti trovi
dietro al vetro non più un Steve Hillage qualsiasi, ma il
chitarrista più odiato dalla tua generazione. Negli anni
d’oro gli Orb confezionavano alcuni singoli dal minutaggio impegnativo (Blue Room), prendevano in giro i
Pink Floyd di Animals nella copertina di un loro album
live (Live 93) e soprattutto davano alle stampe un monolite come The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld
che altro non era se non una grande truffa di visioni
pastorali, campioni rubati a gente famosa tipo Steve
Reich, robusti reggae dub e spruzzate psichedeliche
tutt’altro che serie ma funzionali alle amplificazioni
emotive della generazione E.
Oggi ritroviamo quelle suggestioni, un po' rabbonite
ma non senza la proverbiale ironia, in un viaggio psych
che è come ce lo si aspetta: due lunghe suite (divise al
loro interno in cinque parti) d’ambient house primissimi Novanta, tra accordi blues, folk e new age (à la Wish
You Were Here, per intenderci) con il chitarrista inglese
più presente nella prima e qualche cedimento narrativo sulla seconda. Ad ogni modo, un tassello indispensabile nella discografia orbiana.
(7/10)
Edoardo Bridda
73
Owen Pallett - A Swedish Love Story EP
(Domino, Novembre 2010)
Genere: chamber pop
EP di inediti che segue di alcuni mesi Heartland uscito
a inizio 2010, A Swedish Love Story EP ripercorre da
abbastanza vicino per mood l’album concept che lo ha
preceduto: chamber e synth pop, indie e songwriting
classico, analogico e digitale, con il consueto rimescolamento che il Nostro fa ormai con padronanza e maturità.
Van Dyke Parks, Brian Wilson e chamber pop: insomma ritroviamo qui gli elementi basici della sua musica. Ma a differenza di Heartland, Pallett ha registrato
i quattro pezzi dell’EP molto velocemente a New York,
usando il violino, il Moog, il basso e una batteria elettronica. Una semplificazione forse necessaria dopo
l’elaborato parto precedente. Essenziale.
(6.8/10)
Teresa Greco
velocità nel precedente Psiche), Storia minima è il primo
dei tre apici del disco, un piano-voce teatrale sull'onda di
Dal loggione seppur più moderato nei toni.
Da lì in poi Nelson riprende quell'invaghimento per i
suoni sintetici già comune in alcuni dischi degli anni
ottanta e che era anche la maggior novità di Psiche.
C'est beau, ancora in francese, gioca su un quadratissimo pop modernista; Massaggiatrice è puro e pudico
relax in forma canzonettara con sonnacchiosa batteria
elettronica sullo sfondo; Sarah, secondo apice, è quasi downtempo con synth aeriformi luminosi e testo in
inglese lamentativo. Le cineserie di Sotto la luna bruna
anticipano poi il terzo apice, una Suonno è tutt'o suonno intrisa in synth subcoscienziali con violino solitario
e versi onirici, mentre il trittico finale (Los amantes del
mambo in spagnolo, il gustoso singolo L'orchestrina e
Bodyguard for myself) chiude un disco la cui dedica a
Renzo Fantini è un sigillo di memoria e commozione.
(6.8/10)
Luca Barachetti
Paolo Conte - Nelson (Universal, Ottobre
2010)
Genere: canzone d'autore
Paolo Conte è di quella genia di songwriters la cui imitazione non è solo impossibile, ma vana. Troppo personale e rigorosa una poetica che dal 1974 (anno d'esordio come titolare, dopo un decennio come autore per
altri) lo ha visto costruirsi un mondo suo proprio, d'immaginazione unica eppure così solidamente legata ad
alcune immancabili influenze (il jazz fino ai cinquanta,
la canzone francese, il tango e poco altro). Negli anni
è diventato un classico vivente ed è dunque normale
che gli ultimi dischi della sua produzione ripassino un
repertorio di soluzioni prestabilite, giocando sul filo
sottile di variazioni minime e ritorni.
Per chi scrive l'ultimo grande capolavoro contiano è
Una faccia in prestito (1995), da lì in poi una produzione
sempre sopra la media, con qualche grande momento
e tanto (buon) mestiere. Così è per Nelson, titolo-dedica ad un suo cane, un pastore francese «dal carattere
difficile ma con orecchie musicali», e quindici tracce
che smentiscono l'annunciata crisi creativa di qualche
anno fa.
L'iniziale Tra le tue braccia ripropone una classica ballad tra il malinconico e il dolorante-dondolante; Jeeves
omaggia Woodhouse con uno swing brioso e elegante;
Enfant prodige è languideria in francese; Clown una Max
ripassata Nino Rota; Nina vorrebbe osare di più sul versante carioca ma si sa che l'Avvocato il fiume di gennaio
l'ha visto solo dall'aereo. Dopo Galosce selvagge (sequel
podistico di quell'inno alla due ruote che fu Silenziosa
74
Paul Smith - Margins (V2 Music, Ottobre
2010)
Genere: Songwriting
Mentre i Maxïmo Park si leccano ancora le ferite per
non essere stati in grado di dare un degno erede a
Our Earthly Pleasures, Paul Smith, che ne è il fulgido
frontman e songwriter, si prende due dei migliori pop
maker in circolazione, i Field Music, e sforna un side
project a proprio nome, Margins.
Messa così sembra promettente, ma già dopo la prima
passata, il risultato è la solita minestra: come accadeva in Quicken The Heart, dove a latitare erano proprio
le canzoni, anche qui mancano i numeri per catturare davvero l’attenzione dell’ascoltatore. Smith para
sul confidenziale nel classico registro cristallino che lo
contraddistingue sin dagli esordi, piega le strofe del
suo gruppo in una faccenda folk (This Heat) o in qualcosa di Morrissey-iano (I Drew You Sleeping), magari con
l’aiuto degli ospiti (Strange Fiction è un brano dei Field
Music?), eppure non riesce mai a darci l’impressione
di crederci davvero. Brani dal crooning accorato come
Alone, I Would’ve Dropped, oppure episodi sul lato più
emozionale/rockista del disco (il remember anni ’90 di
Dare Not Dive) sono la dimostrazione di quanto piacevolmente inutile sia un’operazione del genere. O quanto sia inadeguato Smith quando pretende d'arrangiare
un brano à la Micah P. Hinson, con chitarrini e archi
(Pinball). Si può salvare The Tingles, il resto alle ortiche.
(5.5/10)
Edoardo Bridda
Peppe Voltarelli - Ultima notte a Malá
Strana (On The Road, Aprile 2010)
Genere: etno-folk
Non è world la musica di Peppe Voltarelli, ma di scorribande in giro per il mondo certamente si nutre. Quelle dell'ex frontman de Il Parto delle Nuvole Pesanti,
come anomalo ambasciatore italiano in terra straniera
con le sue canzoni, e quelle di un'indole che raccorda
radici diverse, proprie ed altrui. Così in questo secondo
disco in solitaria, complice la buona produzione di Finaz della Bandabardò, gli arrangiamenti smagriscono
e a giovarne è l'interpretazione - da parte di un cantante dalla voce salina e potente, che è anche attore e performer imprevedibile - fermo restando che le canzoni
raggiungono una qualità media inedita prima d'ora.
Facile allora, fatte queste premesse, immaginarsi cosa
contenga Ultima notte a Malá Strana: strizzate d'occhio al folk globalista di Manu Chao, fragranze manouche e profluvi di mandolini, lo spirito sarcastico
e rabbioso di Matteo Salvatore come quello volto
a nobilitare la tradizione di Domenico Modugno. In
mezzo anche una cover PartoBanda de Gli anarchici
di Leo Ferré cantata con Enrico "Enriquez" Greppi.
Meritata la vittoria al Tenco nella categoria dialetto dei cinque finalisti era il migliore - certo è che su disco
Voltarelli non riesce ancora a convogliare tutta l'energia dei live.
(6.6/10)
Luca Barachetti
Pete Swanson - Feelings In America (Root
Strata, Settembre 2010)
Genere: psych-noise
Lo aveva già annunciato lo scorso anno in occasione
di un'intervista, che la sua attività di musicista non si
sarebbe interrotta con i Yellow Swans, ed ecco ora per
Root Strata l'esordio da solista di Pete Swanson. Con
300 copie in vinile non si tratta di certo di un'operazione in grande stile, ma considerata la rapidità con cui il
disco è andato sold-out si può immaginare che c'era
una certa attesa per il lavoro del musicista di Portland.
E sicuramente i vecchi fans di Yellow Swans non saranno delusi: Feelings in America non si allontana molto dai
tragitti percorsi dalla vecchia band, se non per dei toni
meno aggressivi ed una maggiore predilezione per scivolate droniche, mentre la totale assenza di parti percussive e scarti improvvisi lascia intuire che dei due era
Gabriel Saloman a costituire il versante tecnoide. Delle
due lunghe tracce, migliore sicuramente The Fermata,
dove sparse note di chitarra tracimano inesorabilmente verso un wall of sound da annebbiare l'udito, mentre
senza che ci si renda conto di niente, accade di tutto.
Da manuale delle musiche immobili.
(6.9/10)
Leonardo Amico
Philip Jeck - An ark for the lister (Touch
Music UK, Novembre 2010)
Genere: Spiral-Acusmatica
An Ark of the listener prende spunto dagli oscuri sonetti di "The Wreck of the Deutschland" del gesuita
Gerard Manley Hopkins, ordigno di mistica negativa la
cui visioni apocalittiche pare abbiano stregato l'inconsolabile Philip Jeck, sempre alla ricerca di un equilibrio
spirituale.
All'appuntamento l'artista inglese si presenta armato
dei soliti attrezzi e fini: una casio da mercatino, vecchi
fonografi modificati, un delay della boss e un DAT mandati più o meno in random con l'aggiunta di riverberi
parasinfonici. Che tradotto significa: i loop disintegrati di William Basinski e i rigurgiti memoriali di Janek
Shaefer, con l'unica differenza che qui i suoni non collimano più, non s'infrangono più come onde.
A parte The all of water e The pilot, dove affiora un
po' della stralunata ricchezza dei debordanti esordi,
il resto pare ripiegato su se stesso, privo di ricami.
La mistica del gesuita si traduce così in un b-horror
monotimbrico e avviluppato nel disagio isolazionista
dell'artista inglese che pare essersi lasciato alle spalle
la vena maledetta ed essenziale dei suoi importanti
inizi.
(6/10)
Salvatore Borrelli
PQ - You'll Never Find Us Here (Expanding
Records, Novembre 2010)
Genere: ambient
Furbi sono furbi, i Pq. Interessati a dare un immagine
dell'ambient quanto più friendly e malinconica possibile, tra accenni post-rock su arpeggi di chitarre acustiche (Somebody Should Repeat My Summer) e archi in
deriva cinematica (The Cairo Truth), elettronica minimal
e crepitante (Jocelyn) e intimità soffuse in stile Yann
Tiersen condite da un retrogusto psichedelico (A Taste
Of Diminished Expectation).
Il duo belga (Samir Bekaert e Maarten Vanderwalle dietro alle macchine) dimostra comunque un gusto
sopraffino nell'assemblare i suoni di You'll Never Find
Us Here, un misurare maniacale influenze, sfumature e
ceselli strumentali da cui traspare evidente la matrice
nord-europea/francofona del progetto.
Per un disco sospeso tra melodia e costumer care, in un
75
gioco di atmosfere che va per sottrazione riuscendo
nel contempo a suonare cool.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Quest For Fire - Lights From Paradise (Tee
Pee, Ottobre 2010)
Genere: psych-stoner
La Tee Pee, label americana che si muove in ambito
psichedelico con piacevoli invasioni di campo sul versante hard & heavy, ultimamente non perde un colpo.
L’ultimo colpaccio è il sophomore dei Quest For Fire,
quartetto canadese formato dagli ex Deadly Snakes
Chad Ross e Andrew Moszynski con Josh Barman e
Mike Maxymuik che aveva già sorpreso due anni fa con
l'omonimo esordio Quest For Fire. Costretti a bissare
una prova ben accolta ovunque, i quattro allargano la
prospettiva introducendo di elementi apparentemente estranei al contesto stoner/sludge monolitico che li
contraddistingueva.
Light From Paradise è infatti legato a doppia mandata
con una psichedelia dilatata, visionaria, pinkfloydiana che predilige emotivi slanci semi-orchestrali, scarti
desert-rock o grunge alla maniera di Skin Yard o Meat
Puppets e una vocalità che abbraccia l’ampio spettro
circoscritto tra gli Om meno salmodianti e gli Alice In
Chains più corposi e afflitti. Non solo hard-rock in overdrive alla Hawkwind come in Set Out Alone o In The Place
Of A Storm ma lande drogatissime e più contemplative con soluzioni personali e varie (il mantra acustico di
Psychic Seasons, gli archi di The Greatest Hits By God, le
afasie umorali della esemplare Sessions Of Light). Pura
gioia per chi ama il versante più diluito e liquido della
psichedelia dura del terzo millennio.
(7/10)
Stefano Pifferi
Robert Wyatt - For the Ghosts Within
(Domino, Ottobre 2010)
Genere: jazz
Sin dall’inizio l’uomo di Canterbury ci ha abituato
all’anticonvenzionalità. Benissimo, giacché un mondo
senza Rock Bottom o i Soft Machine è duro da immaginare e sarebbe in ogni caso più banale. Mente pronta
allo scambio e ad adattarsi, lo trovi a fianco di Cristina
Donà e di musicisti africani, intendo a sfumare surrealismi e indignarsi con un’invettiva. Oggi eccolo a ricordarci la sua passione per gli standard jazz in compagnia
di Gilad Atzmon (sassofonista abile e misurato già in
Cuckooland e Comicopera) e Ros Stephen agi archi.
Sfrondate da ogni calligrafismo e ridotte all’osso di gra76
na vocale, fiati e quartetto d’archi (con gli occasionali
piano e ritmica in punta di dita), le celeberrime Lush
Life e In A Sentimental Mood, una fischiettata Round
Midnight e lo struggimento di What A Wonderful World
perdono la banalità accumulata negli anni aprendosi a
quella inconfondibile voce.
Che potrebbe cavar poesia anche dal menu di un ristorante, dunque figuratevi se alle prese con brani dal
cuore melanconico e mai nostalgico per gli inusuali arrangiamenti cui sono sottoposte. Trattasi di autentiche
interpretazioni, insomma, come allorquando Robert
torna sulla sua meraviglia Maryan o ripesca At Last I
Am Free - degli Chic, già riletta negli ’80 - con esito coerente all’atmosfera. Organica e piacevolissima, spezzata soltanto dall’inutile etno-rap Where Are They Now,
comunque redento da quanto sopra, dall’accorata Lullaby For Irena e dall’autografa title-track. Divertissement
d’autore esteso a chi ascolta: rarità che con Wyatt diviene norma.
(7/10)
Giancarlo Turra
Roberta Di Lorenzo - L'occhio della luna
(Raiser, Febbraio 2010)
Genere: canzone d'autore
Royal Baths - Litanies (Woodsist, Ottobre
2010)
Genere: art-pop sixties
Siete in astinenza da Crystal Stilts et similia? Non riuscite a uscire dalle sabbie mobili del revival sixties più
arty? Fiondatevi su questi californiani Royal Baths, freschi di cambio di ragione sociale e all’esordio lungo,
dopo non più di un paio di 7".
Stessa forza affabulatoria del citato quartetto newyorchese e del sound più artistoide di Williamsburg,
in generale, nel rivedere le spinte sixties-pop alla
luce dell’avanguardia velvetiana, Litanies lascia da
subito a bocca aperta per maestria e equilibrio nel
gestire una materia iper-abusata. Mezzi pochi - doppia voce maschile per un terzetto dalla strumentazione classica - ma soluzioni non banali che conquistano dai primi secondi dell’opener After Death.
Obliquo e groovey, ossessivo senza essere claustrofobico Litanies è pieno zeppo di piccoli tesori tanto
minimali quanto perfettamente dosati, capace di tirare in ballo l’ovvio pop dei sessanta, il rock inacidito
dei Velvet, la psichedelia più corposa e visionaria e
un tocco di weirdismo arty che li cala non a caso nel
catalogo Woodsist.
Psych-pop oscuro e gloomy, ritmica scheletrica e chi-
tarrismo in modalità garage/lo-fi per tanti pezzi al di
sopra della già alta media di casa, e con almeno un
capolavoro: Sitting In My Room, 5 minuti di dolce, fluttuante e ossessiva paranoia, che culla verso la California della Summer Of Love e, contemporaneamente,
verso lontani mondi orientali. Consigliatissimo.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
Sacri Cuori - Douglas & Dawn (Interbang
Records, Ottobre 2010)
Genere: desert-rock
Partiamo dai nomi coinvolti per dare la misura di questo progetto estemporaneo dal nome evocativo. Su
Douglas & Dawn appaiono a vario titolo John Convertino, Jacob Valenzuela e Nick Luca dei Calexico, Howe
Gelb, Anders Pedersen e Thøger Lund dei Giant Sand,
Bill Elm (Friend of Dean Martinez), Marc Ribot, James
Chance, John Parish (responsabile dietro al mixer) quale rappresentanza internazionale cui si unisce quella
nostrana formata dai vari Massimo Sbaragli, Christian
Ravaglioli, Rico Farnedi, Denis Valentini, Mirko Monduzzi e Andrea Costa.
Un firmamento di brillanti stelle che ruota indubbiamente intorno al "cuore" di Sacri Cuori: Antonio Gra-
Se quella del songwriting (in) italiano è una piazza affollatissima, qualche anfratto libero (forse) c'è ancora
nel settore cantautorato al femminile. Cade a puntino
dunque questo esordio di Roberta Di Lorenzo prodotto da una vecchia conoscenza in ottimo stato di salute come Eugenio Finardi. Di Lorenzo è cantautrice
ancora in via di formazione, lo testimoniamo una serie
di tracce gradevoli ma senza l'effettivo mordente per
rimanere - ad eccezione di Circe, piccolo gioiello di pop
nobile con liriche efficaci ad intrufolare nel mito un po'
di biografismo. Nonostante ciò L'occhio della luna si
lascia riascoltare per il lavoro d'artigianato degli arrangiamenti, rimescolati senza stravolgimenti brano dopo
brano e calibrati sulla direzione di ogni singolo episodio.
Intrecci di acustiche e mandolini per Anima dolce liquida, con bouzouki in Antigone (cofirmata dallo stesso
Finardi). Rhodes lunare per Corollario, folate d'archi per
Vento di costiera. Retrogusto country-folk su Faccia e
speziatura di sitar ne L'attesa. Visti i tre episodi con la
titolare solitaria alla chitarra (Luna) e al pianoforte (La
ballerina e il clown, Doloroso istinto), occorre una scrittura con la schiena più dritta, che cerchi l'epidermide di
chi ascolta più che la corteccia cerebrale.
(6.2/10)
Luca Barachetti
77
mentieri, deus-ex-machina del festival ferrarese Strade
Blu e apprezzato chitarrista di base bluesy, e Diego Sapignoli, sono infatti un apprezzato duo protagonista di
molti progetti nazionali e internazionali (da Hugo Race
al recente Saluti da Saturno di Mirco Mariani).
L’amore per una musica soundtrack-oriented, evocativa e visionaria in quanto pensata come sostrato sonoro
per performances varie, si manifesta in questo esordio
vinilico sempre sul crinale tra forme avant-folk minimale, psichedelica desertica e polverosa, blues atavico e
passionale, slow-core romantico. Musica prevalentemente strumentale, se si eccettua la Dylaniana Shelter
From The Storm cantata da Howe Gelb, che trascina
l’ascoltatore verso paesaggi jorodowskiani, polverosi
e mistici, ora delicatamente traditional, ora ossessivamente reiterati.
Disco particolare che stuzzicherà l’appetito di chi apprezza i nomi coinvolti, ma non solo.
(7/10)
Stefano Pifferi
Shannon Wright - Secret Blood (Vicious
Circle, Novembre 2010)
Genere: post cantautorato
Basta poco a Shannon Wright per ammaliare: una voce
intensa nel porgersi, una ritmica secca e precisa, qualche tastiera e corda elettrica ma d’acustico sentire (e
viceversa
). Grossomodo come se PJ Harvey si domiciliasse nella Chicago del decennio scorso, per quanto il
paragone sia in ogni caso riduttivo verso chi possiede
una cifra autoriale propria. Che sa alternare rabbia (Violent Colors) e sperimentazione (Palomino) tanto quanto rinvigorire in modo esperto le strutture della forma
canzone (Dim Reader) oppure concedersi suggestioni
cameristiche (Chair To Room).
Messo da parte quel poco d'elettronica casalinga che
faceva capolino nel precedente Honeybee Girls, Shannon torna a cacciare la testa fuori della camera e guardare giù in strada, declinando post il verbo folk-rock
con furore più (Commoners Saint) o meno (Fractured)
meditativo.
Trovando - lei e noi - requie in un pugno di ballate dalla
pienezza autoriale non comune come il capolavoro On
The Riverside, oppure come le Satellites, Merciful Secret
Blood Of A Noble Man e Under The Luminaries capaci di
dipanare con mano ferma incantesimi di semioscurità
e deboli chiarori. Ci si addentra nel disco per nulla respinti dalle sue forme, osservando anzi l’intimismo farsi
pian piano largo tra le maglie della tensione, come se
Shannon volesse riassumere in trentatré minuti un intero percorso decennale. Fino ad oggi sempre persua78
sivo e appassionato, come le gocce di questo "sangue
segreto".
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Sharon Van Etten - Epic (Ba-Da-Bing,
Ottobre 2010)
Genere: folk
sta. Diciamo che si sente: non c'è nulla che non vada in
queste canzoni che lasciano intravvedere una spiccata
facilità alla coralità che tanto va di moda in ambienti
indie, ma che sembrano non essere state digerite a dovere. L'impressione è di un notebook di appunti, con
canzoni che superano raramente i due minuti e mezzo,
come di quei taccuini di viaggio di prima della fotografia. la domanda è se abbiano ancora spazio, oggi che
siamo abituati alle foto, ai video, a Internet.
(6/10)
Sharon Van Etten è una vagabonda che nel tragitto
New Jersey/Tennessee/Brooklyn s’è fatta espellere da
scuola, ha lavorato da sommelier, poi in un non meglio
specificato "locale per tutte le età" e per un’etichetta
discografica. Già che c’era, si è incasinata la vita con
qualche ragazzaccio che le ha spezzato il cuore. Questo se presti fede a quei moderni racconti mitologici
che sono i comunicati stampa. Che si premurano di
informarci inoltre che Sharon non è "una cantante che
predilige prospettive femminili e non è una provocatrice"
e che risulterà gradita a chi "è stufo del provincialismo di
altre artiste" per le sue "osservazioni incisive e universali
su perdita e amore".
Al netto di tutto ciò, chi scrive ha incontrato una versione - logico, data la residenza - più urbana ma pure scolorita di Alela Diane (buone Save Yourself e la minimale
Love More; Don’t Do It si agghinda e si piace troppo),
che accelera il passo con discreto esito (A Crime, Peace
Signs) e inciampa nel deplorevole FM anni ’70 One Day
(a giustificazione della dedica ai Fleetwood Mac nel
booklet). Chi scrive ha incontrato una volenterosa che,
nello stanzone strapieno di colleghe, siede in fondo e
raramente parla con autorità. Quando succede, le esce
il sensazionale traslucido bordone da Kendra Smith
terrena Dsharpg. Sulla base del quale chi scrive spera
di incontrarla, infine matura, per il terzo album.
(6.7/10)
Gli ultimi della nidiata hypnagogica che un anno fa
riempiva colonne e copertine dei magazine musicali
di mezzo mondo sono un quartetto proveniente da
Brooklyn. Dopo un singolo passato immeritatamente sottotraccia (Despicable Dogs su Trasparent) e un
omonimo EP non altrettanto riuscito, i nostri arrivano
al primo full-lenght proprio mentre la versione nera del
glo-fi (leggi witch-house) comincia a scalzare dalle prime pagine i padrini Neon Indian e Washed Out.
Fa uno strano effetto risentire i toni solari e sfuocati
propri di questa progenie mentre le nenie doloranti dei
Salem rubano l’attenzione dei media di genere. New
Chain non è un cattivo lavoro, raccoglie dieci tracce di
beat riverberati d’ordinanza, aperture synth e cantato
dilatato che ci riporta a un paio d'estati fa come se nulla fosse; le melodie annacquate di Camouflage e quelle
più "elastiche" di Photojurnalist, assieme alle sincopi
electro della title-track, reggono una tensostruttura
che se pur non brilla risulta decisamente godibile.
(7/10)
Giancarlo Turra
Andrea Napoli
Marco Boscolo
Small Black - New Chain (Jagjaguwar,
Ottobre 2010)
Genere: Glo-Fi
Siskiyou - Siskiyou (Constellation
Records, Ottobre 2010)
Genere: indie folk
Sonnets (The) - Western Harbour Blue
(Despotz, Settembre 2010)
Genere: smooth pop, soul
L'ennesima band di area Constallation arriva al debutto. Si tratta di un duo canadese formato dall'ex Great
Lake Swimmers Colin Huebert e di Erik Arnesen, che
nella band madre, invece, c'è rimasto. Rispetto alle altre
incarnazioni di Huebert, qui il sound è più lo-fi, caratterizzato quasi esclusivamente dalla sua vena di songwriter malinconico e crepuscolare. Pare che le dodici tracce che compongono il disco siano state registrate un
po' qua e un po' là, "sulle scale, in stanze d'albergo" e
altrove, semplicemente per mettere su cd un eccesso di
brani che Huebert aveva scritto per il suo progetto soli-
Perché ci vuole stile. Avete presente quando Paul Weller ha dato un calcio ai Jam, ha afferrato per un braccio
Mick Talbot, si è messo un maglioncino sulle spalle ed
è andato a farsi fotografare sotto la Tour Eiffel? Quello
stile. Niente può batterlo, sarai sempre più cool degli
altri. Questo, i Sonnets, lo hanno capito benissimo - e,
soprattutto, prima degli altri. Magari il loro nu blueeyed soul non arriverà a diventare una tendenza del
pop mondiale, ma nel "nostro" panorama costituisce la
proverbiale boccata d'aria fresca, e non importa quanto sappia di già sentito. Non importa certo quando
scegli consapevolmente di aprire un disco con la più
smaccata delle citazioni, il rapidissimo crescendo di archi del Love Theme della Love Unlimited Orchestra: la
dichiarazione d'intenti è infatti palese sin dall'incipit
di No Hollywood Ending, romanticissimo giro in barca
accompagnato dal crooning soffice, fragile ed emotivo di un Roddy Frame o un Edwyn Collins, o ancor di
più nelle affettuose riprese di Shout To The Top, My Ever
Changing Moods e Long Hot Summer chiamate rispettivamente Sebastian Said, The Blue Train e Everybody's
On a High. C'è però una freschezza innegabile lungo
gli appena trenta minuti di Western Harbour Blue - durassero tutti così, i dischi pop! - che fa perdonare ogni
indulgenza di questo tipo: non c'è niente di male nel
rievocare precisamente gli '80 di Style Council, Prefab
Sprout e (perché no?) Wham! quando si possiede un
gusto tanto raffinato, e pazienza se probabilmente si
tratterà di un dischetto in fondo splendidamente effimero, di quelli di cui fra tre o cinque anni ci ricorderemo in pochi. Eccome se ce ne ricorderemo, però (a
proposito, chissà dov'è finita quella vecchia copia masterizzata di Lesser Matters...).
Ultima considerazione: che un disco così venga da Malmoe e non da Londra, la dice lunga sull'aria non propriamente salubre che da un po' tira ad Albione, ahilei
non più culla di fenomeni pop realmente genuini (sarà
mica un caso se i Belle And Sebastian sono ormai di
casa a L.A.?). Ma tutto questo finisce per interessarci
davvero poco, non appena rimettiamo su il disco per
l'ennesimo, piacevole ascolto. E l'inverno sembrerà
sempre lontano, anche con la pioggia che batte sui vetri.
(7.1/10)
Antonio Puglia
Spiritual Front - Rotten Roma Casino
(Trisol, Ottobre 2010)
Genere: nihilist suicide-pop
Eccolo il disco della maturità "pop" per la formazione
romana. Lo auspicavamo al tempo di Armageddon Gigolo, quando utilizzavamo la formula - suggerita dalla
band stessa - di "suicide-pop" per riassumere un suono
decadente, viscerale, drammatico eppure accessibile
ed aperto. Ora Rotten Roma Casino conferma e amplifica quella sensazione, anche grazie al supporto visivo (e
visionario) affidato al dvd accluso che, tra video, corti e
interviste, rievoca le stelle più oscure del firmamento
maudit della band: dal lato filmico, Fassbinder e Lynch,
da quello letterario Pavese, Majakovskji e Pasolini.
Sul versante musicale, il retroterra da folk noir e apocalittico da cui il progetto prendeva le mosse agli esor79
di è sempre presente, seppur relegato a semplice eco
sottotraccia. A farla da padrone è una forma noir-cabarettistica di moderna canzone pop, finalmente compiuta e matura, raffinata ed elegante e che stupisce per
sfumature, soluzioni e accessibilità. Musica struggente
e passionale che alterna ballads dal sapore mitteleuropeo a orchestrazioni da western morriconiano, torchsongs oscure alla Black Heart Procession a passaggi
alla Nick Cave più lirico ed intimista. Solo vaghi punti
di riferimento, perché si potrebbero tranquillamente tirare in ballo gli Ostara di Secret Homeland, i claudicanti
bozzetti di Kurt Weill, desertici echi di solitudine e disperazione, l’esistenzialismo più marcatamente nichilista e mitteleuropeo e altro ancora.
Ad accompagnare Simone Hellvis Salvatori, c'è una rodata e affidabile band (il basso di Federico Amorosi, la
batteria di Andrea Freda e la chitarra elettrica di Giorgio Maria Condemi) più una infinità di ospiti. Tra corde,
piano e trombe, le trame sonore di Rotten Roma Casino
si ispessiscono senza però perdere in espressività e accessibilità. Una soluzione che ne aumenta l’appeal, fornendo una buona (unica?) via per uscire dal pantano
spesso autoreferenziale del milieu neo-folk.
(7.1/10)
Stefano Pifferi
Squarepusher - Shobaleader One:
d'Demonstrator (Warp Records, Novembre
2010)
Genere: Vocoder pop
Cosa sarà mai preso a Squarepusher? Un disco di canzoni easy listening a base di pop, nu soul, r'n'b, eighties cantate rigorosamente al vocoder e arrangiate con
chitarra, drum machine, basso e synth? Shobaleader
One: d'Demonstrator è senz'altro l'album più smaccatamente ruffiano dell'anno. Ci puoi sentire gli arrangiamenti sfarzosi da fantasilandia kitsch (Frisco Wave),
una tonnellata di Moroder passato al colino del french
touch di chi sapete bene (Megazine), fino a una sorta di
risposta al culto glo-pop di Neon Indian e soci. In più,
oltre a proverbiali arrangiamenti slap e funk, ci si respira
pure quel gusto (che una volta chiamavamo) fusion che
tanto piace a mister Jenkins, decorato con gli scacchi
colorati al neon delle vecchie disco coi pattini.
Bello? Dipende da quanto a fondo andiamo nella faccenda. Mr spaccino non si è purgato d'anni d'accelerazioni abbandonandosi semplicemente a un'innocua
e spiazzante easy listening. A primo acchito l'album
sembra un'enorme truffa, poi capisci che il Leonardo
della situazione gioca nell'inserirti trame e riferimenti
praticamente in ogni canzone. A fine scaletta la scatola
80
si apre e tiri le fila, trovi un'overture prog-metal di dieci
minuti che parte con dei King Crimson borchiati, passa
al grind e conclude con un giro d'arpeggi e pomp-metal rallentati. La verità, dissimulata sotto a un chirurgico
clashing di epoche, culture e continenti, è che l'electrohead britannico ammette la superiorità francese in fatto di pop al silicio.
Questa confessione porta alla catarsi intrisa di Daft
Punk, Sébastien Tellier, Air (e prima il sempreverde
Giorgio Moroder): Squarepusher non potrà mettere
piede al pub per un po', ma la sua versione d'elettro pop
nerd modificata (micro inserti metal e sensibilità prog
seventies a tutto tondo) è pienamente riuscita.
(7/10)
Edoardo Bridda
Stan Ridgway - Neon Mirage (A440, Ottobre
2010)
Genere: wave folk singer
Sin dai Wall Of Voodoo questa voce inconfondibile
intrattiene con le radici un rapporto ambivalente. Nel
senso che, nell’attraversare la new wave per approdare
a una forma splendidamente attuale di cantautorato,
le ha trasfigurate e omaggiate. Se dunque l’epoca delle rivoluzioni arriva una volta sola e accadde trent’anni
fa con Ring Of Fire, di Johnny Cash Stan oggi può dirsi
erede spirituale. Canzoni come storie, le sue, che danno
corpo a hard bolied da bassifondi, a mini-sceneggiature,
a inquietudini future da uomo metropolitano del duemila, e la differenza sta lì.
Che, a questo giro, veste di abiti talvolta tradizionalisti
riflessioni frutto di recenti disgrazie (la dipartita del padre e di uno zio; il suicidio della strumentista e amica
Amy Farris, qui presente) e si riallaccia - com’è stato
giustamente notato da altri - al suo Black Diamond del
’95. Lo fa tramite la bella ripresa di una ballata colà inclusa (Underneath The Big Green Tree), un’altra cover di
Bob Dylan (la vibrante Lenny Bruce) e il tono malinconico che la versatilità degli arrangiamenti rende avvolgente e non cupo. Un disco di mezza età, se vi pare, sia
in termini di classe che di occasionale fiatone, sicché
al maldestro rock latineggiante Scavenger Hunt e alla
piatta Wandering Star rispondono una Halfway There
tra tex-mex e Irlanda e lo struggente crepuscolo Behind
The Mask.
Tra le due estremità un poco di mestiere e parecchia
bontà a piene mani: dal reggae della prateria (Flag Up On
A Pole) alle tipiche atmosfere morriconiane (This Town
They Call Fate), da una sarcastica bossanova (Desert Of
Dreams) a ipotesi di Blonde On Blonde se fosse appartenuto a Van Morrison (Day Up In The Sun). Gemme che
al sottoscritto bastano per garantire a Neon Mirage un
posto nel cuore e negli scaffali. Avanzano, perfino.
(7.1/10)
Giancarlo Turra
Styrofoam - Disco Synthesizers & Daily
Tranquilizers (Nettwerk Music Group,
Ottobre 2010)
Genere: Synth pop
Styrofoam alle mode c'è sempre stato attento. Molto attento. All'inizio, a tiro Duemila, cavalcava perfettamente
l'ondata Morr con glitch e melanconie mittel, poi lestissimo è salito sul cavallone Anticon mettendo un po' di
hop bianco dentro l’impasto indietronico, poi è arrivato
il boom degli '80 e s’è dato una bella spalmata di ottimismo e synth pop mascherandosi sempre meno europeo e sempre più filo britannico, tra uggia e tanti raggi
di sole pop. In tutto ciò, featuring rap a parte, il senso
melodico lo ha sempre salvato. A Arne Van Petegem
non è mai mancato e i suoi testi piacevoli, automatici
il più delle volte, hanno sempre conservato quell'intoccabile aura indie pop, hanno cioé sempre avuto il taglio
melodico al momento giusto.
Oggi, a due anni da A Thousand Words con Disco Synthesizers & Daily Tranquilizers il Belga s'è rotto anche
di quest'abito: basta indie-genza, basta quel suono per
pochi. Il nuovo Styrofoam non si vergogna di cantare con il
vocoder, di prendersi al missaggio uno come grosso
come Wally Gagel (Eels, Folk Implosion, Muse), d’incidere in uno studio ancor più famoso come il TTG/WAX e di
puntare diritto al pop da classifica con il suono che va
oggi, un misto di luccicanti synth un po’ techy, aperture
chitarristiche à la New Order, folate da soundtrack scura
à la Depeche Mode e in generale quell’approccio tra
suonato live e synth in remember Ottanta.
Ma i numeri killer ci sono? Get Smarter e Extra Careful ci
provano e funzionano senza uscire dai soliti seminati.
Il resto è prodotto molto bene senza che la sensazione
di già sentito abbandoni mail l'ascoltatore. In pratica
Styrofoam è neither Fish Nor Fles, il pubblico di massa non lo raggiungerà, e gli indie kid gli volteranno le
spalle.
(6/10)
Edoardo Bridda
Sun Airway - Nocturne of Exploded
Crystal Chandelier (Dead Oceans, Ottobre
2010)
Genere: Pop
L'album di debutto del duo di Philadelphia è un omag-
gio al synth pop, ma con le dovute differenze che l'era di
Ableton ha portato all'elettronica. I Sun Airway cercano di creare un punto d'incontro fra tentativi sperimentali più ricercati e l'influenza del mainstream pop degli
inglesi Coldplay: a volte ci riescono, a volte meno come
nel caso dell'intro Infinity (dove l'interpretazione vocale
di John Barthmus è fin troppo simile a Chris Martin) o
Shared Piano (la cui spumeggiante esplosione electropop è incredibilmente somigliante a Viva La Vida). Più
personali tracce come American West, con le festive tastiere svolazzanti bliss-pop, e Put The Days Away, il cui
crescendo ci conduce fino a una rilettura indie-pop priva delle chitarre sporche degli Strokes. Come in ogni
disco pop che si rispetti arrivano anche la ballata malinconica e lenta, Swallowed By The Night, e il dance-pop
oriented di Waiting on you: entrambe rimangono tentativi non proprio brillanti dalle melodie vocali insipide e
dagli arrangiamenti scontati. Un esordio piacevole ma
non del tutto convincente.
(6.3/10)
Gemma Ghelardi
Third Eye Foundation - The dark (Fire
Records, Ottobre 2010)
Genere: americana
Da un decennio Matt Elliott non comunicava col mondo tramite la Fondazione. Soltanto remix da un Little
Lost Soul che usciva per l’appunto nel 2000 ed era delle
sue la missiva a più alto tasso melodico, che così preparava il terreno allo splendido cantautorato "modernista" della trilogia Songs. Proveniente da una Bristol
lontana dai riflettori, il ragazzo aveva sin lì assemblato
col giusto distacco il dub e le stratificazioni sonore, le
chitarre trasfigurate e il ritmo dilatato senza troppo riguardo per la forma canzone. Degli abiti appena smessi
- non si sa per quanto tempo - da chansonnier notturno,
The Dark non può però esimersi dal tenere conto, visto
il loro peso emotivo e artistico che cogli anche qui, al di
là della copertina, delle prese di posizione politiche o
della visione del mondo.
In un’attenzione allo svolgimento del suono, semmai;
al mescolarlo affinché gli elementi compositivi risultino
indistinguibili e divengano il messaggio sostituendosi
alle parole. Avrete così in mano un gomitolo spinoso
composto da cinque movimenti, risolti in grigiori ambientali che raccontano un approccio sulfureo a triphop e drum n’ bass, suggestioni etniche e orchestrazioni sottratte al minimalismo colto, stordimento e rabbia
sotto pelle. Non fatevi però depistare da ipotesi di revival post-rock, ché qui - con Chapelier Fou e Chris Cole
a gestire diversi strumenti e leggere la mente di Matt - si
81
respira un’aria contemporanea e, com'è giusto, spinta al
di là delle definizioni. Malsana e ad alto tasso di personalità, anche, e dunque bentornato, Terzo Occhio.
(7.2/10)
Working For A Nuclear Free City - Jojo
Burger Tempest (Melodic UK, Settembre
2010)
Genere: Prog/Electro
Giocano sulle atmosfere i Triste Colore Rosa con il disco di esordio Scomparire in 11 semplici mosse, frutto
della collaborazione e la partecipazione di diversi musicisti su cui il progetto musicale della band si basa nella
sua ultima incarnazione.
Atmosfere si diceva, sin dal nome in attenuazione di colore scelto, per musica cantata in italiano, che passa con
disinvoltura dall’elettronica al pop rock all’indie, sospesa
tra momenti più acustici e momenti più tirati. Essendo
essenzialmente creatori di effetti soffusi, i Triste Colore
Rosa riescono meglio in pezzi tenui dove mostrano una
buona padronanza dei mezzi, anche in una formazione
variabile. Nel resto ci sembrano meno a fuoco. La personalità di gruppo è comunque ben strutturata e questo
esordio fa ben sperare per le mosse successive.
(6.8/10)
Bastano tre parole per descrivere tutto quello che
manca a Jojo Burger Tempest: selezione, coerenza,
moderazione. Il resto del vocabolario è tutto nel disco
a partire da Do A Stunt: esemplare introduzione delle
schizofreniche trame prog-folk imbastite dal quintetto di Manchester, una perfetta premessa per chiarire
cosa accadrà nell'oretta e mezzo a seguire, ovvero un
potpourri d'elettronica e psichedelia su basi prog che
lasciano il tempo che trovano. Non è tutto da buttare, qualcosa riesce a salvarsi dalla
furia compositiva in Alphaville dove il canto del bassista Ed Hulme riesce a trovare una giusta collocazione, e
Low con i suoi volumi maggiormente equilibrati. Del resto, i ragazzi amano la briglia sciolta e in un secondo cd
monotraccia (i trenta minuti di Jojo Burger Tempest) sfogheranno ogni velleità indie, psichedelica, elettro, funk,
dai Genesis ai Gong passando per gli Yes e mezzo prog
degli anni '70 (notare la lunghissima lista di influenze
dichiarate sul myspace).
Il male di Jojo Burger Tempest è proprio questo: l'aver
voluto il disco monstre. Ed aver fallito.
(5/10)
Teresa Greco
Gemma Ghelardi
Giancarlo Turra
Triste Colore Rosa - Scomparire in 11
semplici mosse (Autoprodotto, Settembre
2010)
Genere: songwriting
Trivision - Muoversi nel liquido (Indeed!
Records, Novembre 2010)
Genere: nu-metal/rock
I Trivision sono una band di Casalpusterlengo (provincia di Lodi) che approcciano il rock pesante con metodo
molto connotato (e poche e piccole variazioni sul tema).
Fanno nu-metal senza ibridazioni, una versione normalizzata dei System Of A Dawn in pratica, faro principale
ma non esclusivo dei lombardi che si nota soprattutto
nei primi brani (Involucro, Negativa, Dentro la crisi).
Muoversi nel liquido, prima fatica del combo, prova
anche ballate (Cronotopo I) ma soprattutto rock mainstream (Ore riflesse) o metal tout-court (Zanapra, con
evidenti difficoltà nell’incastro tra liriche - dionisiache
- e musica).
La formula è sostanzialmente sempre la stessa: uso di
testi (e vocalità) struggenti e romantici sopra a riff pesanti. Un disco di genere. Forse troppo di genere.
(5/10)
Gaspare Caliri
82
la conclusiva Golden Metal Shower, manifesto via rifferama cosmico del duo, sono dimostrazioni di una band
dinamica e non fossilizzata sul canone di genere.
Non è prog, non è metal, non è grind né tanto meno
noise o math: Zeus! è tutto questo frullato insieme. Deliranti e ironici il giusto (titoli come Grindmaster Flesh,
Cowboia o Suckertorte sono a dir poco geniali), violenti
e spregiudicati, Zeus! portano sulla terra la via degli dei
al culto del rumore. Noi, sinceramente, non possiamo
che sottometterci.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
.com
Zeus! - Zeus! (Bar La Muerte/Off-set/
Smartz/Escape From Today/Shove/
SangueDischi, Ottobre 2010)
Genere: free-noise
Scende dall’Olimpo del rumore per punire noi poveri
mortali, Zeus!, progetto a due di nomi noti della musica
italiana. Luca Cavina (bassista per Calibro 35) e Paolo
Mongardi (ex Jennifer Gentle e ora Il Genio) si smarcano però dalle coordinate dei gruppi madre per innalzare un muro di noise strumentale basso-batteria che
nulla invidia ai più famosi ed efferati progetti dall’approccio simile.
Ora sul versante più tribale alla Lightning Bolt, ora più
su quello prog-noise alla Ruins, ma di norma su velocità made in Locust e scelleratezza zorniana altezza Naked City, il sound del duo è sempre sfrenato e sfrontato,
irrequieto e sporco, sempre al limitare tra sconquasso
strumentale e follia ritmica. Gli occasionali e prestigiosi
ospiti (Giulio Ragno Favero, Enrico Der Maurer Gabrielli,
Valerio Canè di Mariposa e Andrea Mosconi) forniscono
poi digressioni a margine del compatto suono originario arricchendone lo spettro: Koprofiev con le sue volute
sci-fi da theremin rimanda ad ipotesi di grind alieno e
83
Gimme Some
Inches #10
Vinili e cassette inondano il nostro
spazio dedicato questo mese. Ritorni
ed esordi come al solito, in uno spettro sonoro sempre più ampio: Zola
Jesus, Holidays, Movie Star Junkies
and many more.
Anche realtà apparentemente
distanti dalla filiera produttiva del
disco come promoter e organizzatori sembrano non poter rinunciare
al supporto vinilico, vero e proprio
must di questo terzo millennio. Alla
faccia di chi lo voleva morto già da
qualche decennio.
Ci riferiamo a Keep It Yours, collettivo romano responsabile del
“worst club nite in Rome” e traghettatore di suoni hype come quelli di
The XX, Crystal Castles, Telepathe,
These New Puritans, Toro Y Moi.
Ora in attesa della celebrazione
di Unknown Pleasures per mano
di Peter Hook e di sdoganare sul
territorio italiano i precursori della
scena witchy, quei Salem da noi indagati il mese scorso, KIY aggiunge
il suffisso Records alla propria ragione sociale e produce i primi due
vinili piccoli.
84
Too Young To Love e Holidays,
volti diafani e sintomatici del nuovo
trend degli indie-kids, tra colorito
emaciato e vestiario skinny, tracciano le linee su cui si muove l’orizzonte musicale della neo-label. I primi,
terzetto da Torino, vanno di electropop capace di tirare in ballo il synthpop alla maniera dei Pet Shop Boys
cristallizzandolo in uno scenario al
limite dello shoegaze più etereo e
poppy (Frozen Fields) o come dei
MGMT meets These New Puritans
dopo una sbornia notturna a base
di electro-rock inglese: Mytria è
pura wave fredda-ma-non-troppo.
I secondi pur provenendo da zone
musicalmente depresse (Viterbo)
mostrano ottima capacità di introiezione dei trend del momento,
muovendosi con scioltezza nella
nuova onda british affrontata senza timori reverenziali. Believe è un
bel sing-a-long che strizza l’occhio
al versante più orecchiabile e accessibile della nuova wave inglese
senza suonare troppo ossequioso
dei modelli di riferimento, ma spingendo sul versante dancey. Non un
caso che sul lato b si trovi un remix
a firma Andrea Esu che apre totalmente al dancefloor più poliritmico
e eterogeneo.
Su tutt’altri orizzonti si muove una vecchia conoscenza di SA.
Matteo Bernacchia aka Above The
Tree, dopo la release su Boring Machines e lo split 12” con Musica Da
Cucina, arriva ad un altro live su
cassetta. Live A Ca’ Blasè, edito in
cassetta dalla benemerita Bloody
Sound Fucktory, è un vero e proprio album per durata e omogeneità di fondo che mette in evidenza
lo spessore del progetto mascherato. Una forma di blues intimo e disidratato, ossessivo e reiterato che
parte da suggestioni à la Fahey per
arrivare a lambire territori da musica concreta, in cui la chitarra è strumento anche non convenzionale.
Giri ipnotici di chitarra che attualizzano il blues del delta alle weirdità
più astruse degli anni ’00. Sempre
con gran classe.
Un’altra cassetta proviene invece
dalla Winged Sun, etichetta di Max
aka High Wolf. Di L’Amazon RAM
Arkestra poco si sa, nella miglior
tradizione del francese, se non che
nelle due lunghe tracce untitled riesce ad unire le istanze più free del
raga-rock (altezza Vibracathedral
Orchestra, per intendersi) con il tropicalismo più droning e ritualistico.
Biotope psychedelic music la definisce l’etichetta e il concetto non è
poi così astruso.
Scivolando su territori più aspri,
ecco tornare i temibili Robedoor
con un nuovo 7 pollici sulla label
di casa, la Not Not Fun. Pacific Drift
offre tre brani in cui il combo californiano continua la strada già battuta con gli ultimi due album (Raiders e soprattutto Burners). Quindi
ancora oscuri terremoti drone incalzati da giri di basso apocalittici
e grevi litanie a recitare l’ultimo
sabba. Nota di merito per l’artwork
stile sci-fi anni Cinquanta finto vintage. Sempre negli USA, a breve distanza da Stridulum II torna anche
Zola Jesus con quattro brani raccolti sotto l’oscura marca di Valusia, regno fantastico nato da penna
di Robert E. Howard (inventore, tra
gli altri, di Conan il barbaro). Sull’EP
Nika recupera i tre brani precedentemente inclusi come bonus tracks
nella ristampa europea di Stridulum (Tower, Sea Talk e Lightsick),
rilasciando un solo inedito (Poor
Animal) con cui conferma la svolta new wave/new age delle ultime
uscite. Niente di nuovo sotto il sole,
ma sempre il grande pathos della
beniamina degli odierni romantici.
Prima di concludere torniamo in
patria con la seconda tape di Heinz
Hopf, dopo una prima autoprodotta, per la Joy De Vivre di Napoli. Il
duo di ultra noise spacca timpani
formato da Dan Johansson (Sewer
Election) e Matthias Andersson
(tenutario della RTB e membro dei
Källarbarnen) rilascia due pezzi che
dire harsh è un eufemismo: titoli geniali quali We vote Incapacitants! e F
is for Femi Benussi per venti minuti
di puro rumore assordante. Presto
anche un 12 pollici per la rinomata A Dear Girl Called Wendy. Infine
nuovo EP per i garage-rockers più
infuocati d’Italia. In A Night Like
This viene rilasciato in solo vinile
10” in joint-venture tra la nostrana Ghost (per il mercato europeo)
e la californiana Kill Shaman (per
quello d’oltre oceano) e suona un
po’ come la metà nascosta di A Poison Tree. Due pezzi di scuola ormai
classicamente Movie Star Junkies
cui fanno da contraltare le vertigini
di Odyseey Of Jason, che ci riportano agli esordi documentati dal
mini-LP Junkyears, e il voodoobilly
di Death Sleep and Silence che pare
rubato ai Cramps degli anni d’oro.
Stefano Pifferi
andrea napoli
85
Re-Boot
#9
Sempre più schizoide è la scena, discontinua per intensità e direzioni,
ma generosa. Sempre.
Che strane sensazioni regala
l'ascolto di Marie Antoinette, al
secolo Letizia Cesarini da Pesaro:
una rabbia "riot" tenuta al guinzaglio di una vena cantautorale tesa,
voce che s'incapriccia d'inquietudini Beth Gibbons e guizzi Billie
Holiday un attimo prima di pagare pegno a Nina Nastasia o PJ
Harvey, la chitarra come mitraglia
ritmicoarmonica, il glockenspiel a
sgocciolare incantesimi, canzoni
come battaglie ormai spente che
non smettono di gridare dolore.
L'album Marie Antoinette Wants
To Suck Your Young Blood (Picicca Studio, 7.4/10) sembra la tipica
istantanea d'artista nella sua fase
iniziale, con quella grazia ruvida e
grezza, l'entusiasmo sanguigno e
un po' disperato. Teniamola d'occhio.
I Luther Blisset da Bologna
iniziarono nel 2007 come un duo
basso + batteria, poi l'espansione a
quintetto con l'innesto di contrabbasso, chitarra elettrica e sax. For86
Un mese di ascolti
emergenti italiani
mula inconsueta sì, però è naturale
quando l'improv chiama a raccolta istinti e volontà. Eccoci quindi
al disco omonimo (Eclectic Polpo
Record, 7.2/10) che sgrana groove
tosti e spasmodici incrociando le
due linee di basso come binari del
rollercoaster. Tensione e vitalismo,
urlo primordiale e discesa in folle,
ciak si gira un noir spietato e ridanciano. Sono appena al secondo
lavoro, sembra che di strada ne abbiano fatta già tanta, e tanta ancora
ne faranno.
Tolta la retorica obsoleta di alcuni testi (citiamo un “leccare il mondo con l'anima / sentirlo sulla pelle”
che sa tanto di Manuel Agnelli fuori
tempo massimo) e il solito dubbio
del “ci è o ci fa?” legato a un'onestà
artistica un po' facciata (e che facciata!) e un po' reale esigenza comunicativa, A volte capita (6.1/10,
Dcave) della torinese Monica P
rimane un esordio musicalmente
non disprezzabile. Anzi, con qualche ottima idea, visto che si viaggia tra il blues contaminato della
P.J.Harvey di Rid Of Me e una
concezione di pop all'italiana trasversale e piena di spigoli. Piace
soprattutto, oltre a una voce ruvida
quanto basta, il sapersi muovere
con agilità tra arrangiamenti affatto banali (chitarre acustiche, accenni noise, registrazioni in reverse,
synth). Merito, crediamo, dell'ottimo lavoro in fase di produzione
di un Daniele Grasso già collaboratore di Cesare Basile, Afterhours,
Hugo Race e John Parish.
Una solida preparazione accademica alle spalle (diploma al
Conservatorio in musica jazz), un
background da polistrumentista
(tromba, basso, synth, ukulele,
banjolele, batteria e chissà cos'altro) e una versatilità musicale che
non fa sconti (turnista per il liscio di
Castellina Pasi e lo swing dei Good
Fellas, oltre che co-fondatore con i
Quintorigo Andrea e Gionata Costa
del progetto Big!Bam!Boo!). Lui è il
romagnolo Enrico Farnedi e il suo
esordio solista Ho lasciato tutto
acceso (6.9/10, Sidecar) è l'ennesimo esempio di un cantautorato
ironico e di basso profilo. A far da
mattatore, l'ukulele, riciclato un po'
in tutte le salse, siano esse il valzer in odore di Messico di Quanto
piangere o il Ben Harper allo strut-
to di Lonely Planet, il blues-country
della title track o i caraibi del trip
demenzial-gastronomico Salsa di
lumaca. Spicca l'ottima scrittura,
capace con pochi suoni essenziali
di tratteggiare un universo affezionato a un localismo sentimentale e
accogliente.
I Kozminski sono un quartetto
milanese dedito ad un folk-rock
psichedelico in italiano assieme
ruspante e sghembo, squarci su
atmosfere acidule e tentazioni di
cantautorato più o meno indiepop (Lettera dall'Etna), su cui talora
tepori di tastiere e fiati (sax, diamonica) arrivano a pennellare trepidazione. L'omonimo album d'esordio
(autoprodotto, 7.0/10) riallaccia legami che credevo perduti tra il presente ed il miglior pop rock italiano a cavallo tra settanta e ottanta
(Dalla, Fortis...), più per attitudine
che altro, ovvero per quella volontà
generosa e cocciuta di raccontare
visioni ora pungenti e ora accorate. Ben venga poi che essi stessi
dichiarino d'ispirarsi a Wilco o Arcade Fire tra gli altri.
Stessa citta ma diverso il fronte
sonoro. Un trio con la ragione so-
ciale tra il goliardico e il blasfemo:
Black Wojtyla. Batteria, tromba,
basso. Effetti elettronici e distorsioni. Funk, rock e dance in una più
vasta fregola jazz. Una visione post
senza l'angoscia del post, neanche
una briciola. Sei tracce che fanno
un ep omonimo (autoprodotto,
7.0/10) dove l'estro scorre, guizza, zompa come più il momento
gli aggrada. Semplicità metodica,
trame acattivanti e fragore impro.
Visioni di celluloide e brume noir.
Frenesia e fragore. E la sensazione
di un linguaggio che ancora deve
sperimentare il proprio estremo. I
nostri più cari auguri.
Dal post-rock degli A New Silent
Corporation provengono i quattro
quinti de Il Buio, ma le coordinate ora sono del tutto diverse. L'hcpunk d'autore con testi in italiano
del loro primo ep disponibile solo
in vinile (autoprodotto, 7.2) ha tutta l'intensità d'asfalto e la densità
elettrica di pelli e corde degli ultimi
Fine Before You Came, seppur più
compatti. Vengono da Thiene, ed è
da qui che si origina quella mescola
di esistenzialismo e sguardo critico
sulla provincia potenziati da un'ur-
genza rara, essenziale, ossea. La
dedica a Georg Elser (vano attentatore di Hitler) e versi basilari come
“un nulla eravamo e siamo ancora e
resteremo fiorendo nessuno ci impasta dalla terra e dal fango nessuno
dà parola alla nostra polvere” ce li
rendono cari per il futuro, li seguiremo.
Infine, perderebbe d'interesse e
presa il rock variegato (pop, stoner,
canzone d'autore, disco) dei messinesi SansPapier senza il ripieno
di liriche sfacciate e sardoniche del
loro esordio Manuale d'uso per
giovani inesperti (Imago Sound,
6.4). Un bignami per sopravvivere
a “paure atmosferiche, ubiquitarie,
fumose, anticipatorie”, come recita
la prefazione nel booklet, ad anticipare le voci di Valeria e Già, eccentriche quanto basta (in Vodka con
ghiaccio c'è un po' di Battiato) per
emergere dal suono robusto del resto della banda. Al mese prossimo.
Stefano Solventi, Teresa Greco,
Fabrizio Zampighi, Luca Barachetti
87
China underground#2
Intervista-ritratto del cantautore cinese Zhou Yunpeng, una voce divisa
tra sensibilità artistica e responsabilità sociale
Zhou Yunpeng non ha un pubblico di massa, si può assistere alle
sue esibizioni in piccoli pub e teatri
senza dovere affrontare grandi affollamenti. Ma il suo nome ritorna
spesso nei forum sulla rete cinese
e in qualche occasione è arrivato
anche alla stampa nazionale. Ai
concerti le persone cantano i suoi
pezzi, i versi di un quarantenne poeta e cantautore cieco, evocatore
di romantici racconti all’insegna di
un girovagare e di un’ebbrezza per
anni toccati con mano. Osservatore
tanto più ironico quanto pungente
della società cinese.
La gente applaude e ride. Richiede persino canzoni, cosa che non
accade spesso in un ambiente che a
momenti può apparire freddamente distaccato dall’artista che si esibisce sul palco. Lo fa perché Zhou
Yunpeng non è di quegli intellettuali impegnati lontani anni luce
dalla gente comune: lui ne è parte
88
e canta in mezzo alle persone; ne
racconta i problemi con quell’ironica leggerezza che evidenzia drammaticità. Aggiunge una capacità
artistica a completare le sue liriche.
Canta la società con una voce piena e calda, che a volte sa farsi dissonante e altre insegue le note della
sua chitarra fondendosi con esse in
un’unica melodia.
È questo il mínyáo (民摇), il folk
cinese, una scena musicale cresciuta
incredibilmente nell’ultimo decennio, tanto qualitativamente quanto
numericamente. La base è quella di
una strumentazione e di un cantato
tradizionali; o una semplice chitarra
acustica che divene condizione per
raccontare storie di persone come
tante:
“Il senso del mínyáo è nell’essere della gente, l’essere musica delle
persone comuni e della loro vita,” ha
sintetizzato Zhou Yunpeng dopo
una delle sue esibizioni all’interno
del festival dove lo abbiamo incontrato. Un’attitudine che prescinde
da importanti considerazioni di
mercato, una musica che prende
Un cantautore
dei giorni nostri
forma fuori dagli studi delle case
discografiche, spesso registrata in
proprio e suonata in locali davanti a poche decine di persone: “Non
abbiamo bisogno dell’attenzione di
molti media, ma solo di esibirci dal
vivo e appoggiarci alla rete per trasmettere e diffondere la nostra musica. Penso che il risultato rispetto al
lavoro di un’etichetta specializzata
possa essere anche superiore.”
Il mínyáo è un respiro che proviene dal passato, uno spirito millenario da dissotterrare. Perché
riprendendo l’anima di un popolo
attraverso immagini letterarie e
leggende antiche è più facile essere recepiti dalla gente, è come parlare un linguaggio comune. Contro
l’omologazione della modernità: “Se
in tutto il mondo esistesse una sola
lingua, gli stessi versi da cantare, la
stessa estetica... sarebbe veramente
spaventoso. C’è bisogno per questo
che ogni persona inizi a fare dell’arte partendo dal proprio ambiente,
dalle persone che si ha accanto, cominciare a fare arte dal suolo che ti
circonda.”
Una delle sue canzoni più famose, Il cinema dei ciechi, è la storia di
Zhou Yunpeng stesso, quella di un
bambino di nove anni che perde
la vista e si rifugia nel cinema per
ciechi, dove la conoscenza non è
visione delle immagini, ma l’ascolto
di voci e suoni. Come nella vita di
Zhou Yunpeng il protagonista de
“Il cinema dei ciechi“, parte solitario
per dei viaggi attraverso la Cina, insegue ricerche senza risposte, ascolta e respira l’amore e l’odio senza
poter vedere. Mínyáo è anche e
questo: raccontare una storia, poco
importa se vissuta o immaginata,
che quando viene cantata diviene
creazione artistica e sa staccarsi dal
personale:
“Il cinema dei ciechi è stata ispirata dallo scrittore argentino Borges, anch’egli divenuto cieco. Lui ha
raccontato storie di fantasia. Anche
questa canzone, Il cinema dei ciechi,
in realtà solo da un lato è la mia storia e quella della mia vita; dall’altro
lato vuole evidenziare un tipo di
89
incapacità, da parte degli uomini, a
comprendere; l’impossibilità di conoscere... di capire veramente la vita.
La possibilità di coglierne solo un
aspetto come nel cinema per ciechi
dove non puoi vedere le immagini
ma puoi ascoltare le voci per capire
un film. Ma questa comprensione in
realtà non potrà mai essere corretta, o meglio, completa. D’altronde
anche i fraintendimenti della realtà
sono una cosa positiva. Voglio dire
che tutte le forme di comprensione
sono estremamente interessanti.
Quello che voglio esprimere è un
qualcosa di simbolico: ogni persona
può anche capire la vita nella maniera piu sbagliata, ma può far leva
su se stesso, sulla sua visualizzazione per dare un senso alle cose.”
Ad ogni concerto Comprare casa
e Bambino cinese sono i due titoli
più invocati dal pubblico. Il primo
pezzo rievoca ironicamente il suicidio economico di molte famiglie
cinesi, disposte a rinunciare a tutto
pur di avere una casa, il che oggi in
Cina corrisponde ad una affermazione sociale senza eguali per la gente
comune, una questione di reputazione. La seconda canzone è ancora
più coraggiosa; si tratta di un pezzo
di pura denuncia, che rievoca una
ad una le sfortune di bambini nati in
diversi punti della Cina e colpiti da
disgrazie per incuria politica e del
potere. Fino all’esplosione finale in
cui l’autore canta:
“Non voglio essere un bambino
cinese, madri e padri sono entrambi dei codardi
che per dimostrare la loro risolutezza, di fronte alla morte danno
priorità ai loro leader.”
Il riferimento è ad un fatto di cronaca avvenuto in Xinjiang nel 1994,
quando scoppiò un incendio in un
teatro dove alcuni leader politici sta90
vano assistendo ad uno spettacolo
con i giovani del posto. In quell’occasione ai dirigenti fu data la precedenza per uscire in salvo mentre
nella sala bruciarono quasi trecento
ragazzi.
Zhou Yunpeng non ama essere
ricordato per queste canzoni, che
sono racconti di denuncia, problemi
reali. Preferirebbe non dovere scrivere né cantare certi pezzi. Durante
una sua esibizione ha ripreso una
celebre melodia di Micheal Jackson sostituendo le parole con un testo molto toccante, ancora una volta
di denuncia, La cenere di Wenchuan
in memoria delle vittime colpite da
uno dei più grandi disastri della storia recente della Cina (Wenchuan è
l’epicentro del devastante teremoto
che ha colpito la provincia cinese
del Sichuan nel 2008, n.d.r.). Quando gli chiedo se ritiene possibile che
un disastro naturale di quella portata possa aver contribuito allo sviluppo di una coscienza sociale tra
la gente comune, replica con una
risposta stizzita e sostiene di non
potere accettare che l’avanzamento
sociale debba nutrirsi della morte e
della sofferenza delle persone. Dice
di amare l’atmosfera che si respira
nei festival musicali, come quello in
cui ci troviamo a parlare:
“La Cina oggi ha bisogno di festival come quello di oggi perché i giovani possano ritrovarsi in un luogo
di festa, tutti insieme ad ascoltare
la musica felici. I cinesi hanno bisogno di essere felici, hanno bisogno
di una qualsiasi felicità, hanno bisogno di esprimere felicità. Il terremoto... È stata detta una frase, non so
se la conosci: «Dopo Auschwitz gli
uomini non potranno più scrivere
liriche». Poiché ad Auschwitz furono
uccise così tante persone, morirono
tante persone, in seguito non sarebbe stato possibile scrivere altre
poesie e canzoni... ma in realtà l’uo-
mo deve continuare a vivere. Anche
per le canzoni è così. Da un lato non
puoi dimenticarti di questi disastri,
da un altro devi continuare a cantare la felicità della vita o almeno
a continuare a vivere. Ma non puoi
dimenticare, voglio solo dire di non
dimenticare.”
Problemi sociali, denuncia delle ingiustizie dei potenti e cantore
della gente comune. Eppure Zhou
Yunpeng sembra non aspirare a
quello che in altri tempi sarebbe
stato definito il ruolo del cantante
di protesta, o almeno non solo. Apprezza Calvino perché pur suggerendo percorsi sognanti, alternativi
ai problemi della società, non può
per questo essere considerato un
attivista. In Zhou Yunpeng a prevalere è la coscienza della componente artistica all’interno delle opere.
Ammira Dante perché pur avendo
compilato un’opera, la Divina Commedia, “socialmente all’avanguardia,” essa non sarebbe pervenuta a
noi se non avesse posseduto uno
spessore artistico letterario:
“Quella degli artisti è la stessa
la responsabilità sociale che hanno
tutte le persone: quando c’è qualcosa di ingiusto devi parlare. La
differenza è solo che l’artista probabilmente attraverso una propria
forma, attraverso delle parole molto
belle riesce a creare un’opera.”
Sia nella sua produzione musicale che in quella poetica i riferimenti alla Cina e ai suoi problemi
sono tanti: poesie volte alla demistificazione della retorica socialista
a servizio del popolo, provocazioni
accennate (“pensava all’inerzia di Lu
Xun e dei cinesi”) o interi pezzi. Ma
Zhou Yunpeng non è un dissidente,
almeno non nella forma in cui ce lo
immagineremmo in Italia. Lontano
da impeti rivoluzionari, e da aperta
ostilità verso il partito, preferisce
muovere le sue riflessioni dalla gente, ne fa una questione sociale ancor
prima che politica. Le sue canzoni
nascono dall’interpretazione, dalla
rielaborazione con parole e musica
di bisogni primari degli individui
all’interno della società:
“La cosa piu importante è la voce
degli individui. In Cina abbiamo a
lungo dato importanza alla voce
collettiva, a partire da una forma di
coscienza fino alla considerazione
dello stato. Io penso che la dimensione piu importante sia quella del
pensiero individuale, della coscienza individuale e della possibilità per
ognuno di esprimere il proprio pensiero, o il proprio percorso. Quando
si parla di società cinese in termini
generali, credo che essa sia in condizioni simili a quella occidentale.
C’è bisogno di una trasformazione
graduale e lenta, non quel tipo di
sconvolgimento improvviso come
le rivoluzioni violente. Di persone
in grado di ricevere un’educazione e
avere diritto di parola e non improvvisamente diventare un qualcos’altro, in prima analisi perché sarebbe
irrealistico e poi perché avrebbe
effetti disastrosi. Le mie riflessioni
muovono verso lo sviluppo di una
società civile, intendo il potere decisionale dei cittadini, la libertà individuale per esprimere una propria
scelta, la possibilità per ogni persona di esprimere se stessa. Questo
per me è un buon obiettivo, se ogni
persona si impegnasse sempre di
più in questo senso allora le cose
andrebbero sempre un po’ meglio.
Non serve quel tipo di eroe o un
agitatore di folle, non serve passare
per la violenza, ma un cambiamento lento, naturale. Una società che
possa procedere naturalmente verso un miglioramento, non si tratta
di un balzo ma di un miglioramento
progressivo.”
Una società che sa crescere con
pazienza attraverso la coscienza di
se stessa, barlumi di società civile,
contro la facile condanna e speculazioni spicciole sui diritti umani.
Con la musica come parte di questo
movimento; una delle tante storie
ancora da cantare, sospesa tra coscienza sociale ed arte, in un ideale
di poesia che può arrivare dritto alla
vita della gente comune pur mantenendo sensibilità e perfezione
estetica. Come fosse un frammento
dell’ispirazione di un cammino verso un mondo migliore:
“La forza della musica in realtà è
infinitamente sottile, microscopica
e lenta. Si manifesta poco per volta. Proprio come la pioggia. Non sai
che forza ha la pioggia che cade. Ma
la pioggia può intervenire sui semi,
può far sì che la terra diventi umida
e permettere al frumento di crescere e dare i suoi frutti. Ma forse non
puoi assistere a quel giorno, perché
il frumento ha bisogno di un anno
o di quanto per crescere. La musica ha una forza del tutto simile: sa
penetrare poco a poco nell’animo
degli uomini, sa renderli più morbidi, buoni, li cambia aggiungendo
calore, proccupazione per gli altri,
facendo capire cosa sia giusto. Ma
tutto questo avviene in un processo
lento, non è quel tipo di piacere di
cui puoi godere sul posto, è un qualcosa che penetra lentamente.”
Ascolti:
Myspace: http://www.myspace.cn/yunyunyunyunyun
Douban: http://www.douban.com/artist/zhouyunpeng/
Xiami: http://www.xiami.com/artist/1270
Opere:
Il respiro silente del mistero (CD, 2004)
Critiche di primavera (raccolta poetica, 2004)
Bambino cinese (CD, 2007)
Melone amaro saltato in padella (CD, raccolta di demo 2008)
Mucche e capre scendono dalla montagna (CD, 2010)
Il blog di Zhou Yunpeng (in lingua cinese) è all’indirizzo: http://zhouyunpengblog.blog.163.com/
91
Rearview Mirror
—speciale
Manhattan Transfer
Nati per armonizzare
Attraverso la testimonianza del suo fondatore, Tim Hauser, viaggio nel mondo dei Manhattan Transfer, il più
famoso gruppo vocale nella storia del jazz.
92
Testo: Filippo Bordignon
Vocalese: stile di jazz canoro nel quale le lyrics vengono composte in base alle melodie eseguite nella
composizione o nell’improvvisazione originale di riferimento; a differenza della tecnica scat perciò questo
fraseggio adopera, per il proprio assolo, una versificazione scritta e di senso compiuto.
In ambito solista la voce più nominata nell’ambiente è senza dubbio quella polverosa di Eddie Jefferson,
pioniere del genere con la sua versione della celebre So
What di Miles Davis. Tra i gruppi invece, è doveroso citare il trio Lambert, Hendricks e Ross, il quale contribuì a complicare la faccenda grazie alle armonizzazioni
delle tre voci e a uno stile che, sfruttando a piene mani
versi sillabici pesantemente influenzati dal bebop, riversa sull’ascoltatore una cascata di parole dalla stordente
bellezza (si ascolti il loro album omonimo del 1960).
I Manhattan Transfer, attraverso una carriera di
oltre trentacinque anni, si confermano il gruppo di vocalese più famoso e premiato nella storia, avendo contribuito all'elevazione di uno stile altrimenti ristretto
alla cerchia dei suoi fedelissimi. Ciò che va riconosciuto
all’opera della band, letta nella sua totalità, è una predisposizione al conio della canzone popolare perfetta,
summa di generi e influenze la cui base di riferimento
resta il jazz degli anni d’oro, ma solo per convenzione. Lavorando a partire dal proprio innegabile talento, i Manhattan hanno sperimentato, nel disinteresse
dell’intellighenzia musicale, contaminazioni e soluzioni
che ne hanno arricchito la discografia al punto da trasformarla in un iperbolico affresco studiato (ahinoi) sistematicamente per sommi capi.
Rapace collezionista di 78 giri oggi introvabili, il
cantante Tim Hauser (New York, classe 1941) sognava un proprio gruppo vocale che attraversasse le tante
diramazioni del jazz per portarle al grande pubblico,
reinventando brani più o meno noti ma pure omaggiando episodi 'minori' di compositori noti solo ai
propri aficionados. Il nome scelto omaggia un celebre
romanzo di John Dos Passos ambientato nella New
York Anni '20, metropoli di febbricitante modernismo
e inesauribili contraddizioni. Un'embrionale formazione Manhattan Transfer muove i primi passi a partire dal
’69 e comprende, oltre a Tim, Erin Dickens, Marty Nelson, Gene Pistilli, e Pat Rosalia. L’esordio è dunque in
quintetto con Jukin’ (1971, Capital), episodio di ardua
reperibilità per fan della primissima ora, liquidato dallo
stesso Hauser come una prova generale quasi subito
interrotta dalla defezione di Pistilli, il quale lascia per
divergenze sulla direzione artistica, appassionato più
di country & western che di sonorità affini all’universo
jazzistico.
L’anno successivo Tim ci riprova tentando un nuovo
organico in quartetto: vi prendono parte Laurel Massé, Janis Siegel e Alan Paul (distintosi a Broadway nel
primo allestimento del musical Grease).
La soluzione con due voci femminili e due maschili
si rivelerà nel tempo asciutta ma capace di coprire una
gamma cromatica praticamente illimitata; dopo tre
anni di gavetta giunge finalmente una ghiotta proposta dalla storica etichetta Atlantic Records (bastino i
nomi di Ray Charles, John Coltrane e Aretha Franklin)
che lancia sul mercato l’esordio ufficialmente riconosciuto The Manhattan Transfer (’75). Pur non essendo
una pietra miliare per il genere l’album getta il seme
di una carriera eclettica e godibilissima, bilanciata con
sapienza e mestiere tra easy jazz pronto a conquistare
i mercati esteri (il 24simo posto nelle classifiche inglesi
di Tuxedo Junction, il successo di critica Operator), prelibatezze pop (la Sweet Talking Guy che fu delle Chiffons) e tentazioni contemporanee (il funky bianco di
Occapella).
Rispedite al mittente le accuse di certa critica che
attribuiscono al gruppo un atteggiamento eccessivamente nostalgico (accentuato spesso da costumi di
scena che ripropongono con ironia le mode di tempi
evidentemente trascorsi), il successivo Coming Out
(’76, Atlantic) sembra investigare scelte relativamente
più attuali con l’aiuto di qualche cameo (la batteria di
Ringo Starr e il piano di Dr. John in Zindy Lou, il sax
dell’oggi glorificato Michael Brecker nella delicata
Poinciana). L’inaspettato successo del singolo Chanson
d’Amour – un motivetto di fine Anni ’50 – consacra definitivamente i Manhattan in Europa (primo posto in
Francia e Inghilterra) grazie all’intuizione dell’istrionica
Massè la quale, al primo take, registra la propria linea
vocale utilizzando un’inflessione ‘francese’ omaggiante
Edith Piaf. Con Pastiche (’78, Atlantic) Hauser produce una delle opere preferite della band, spaziando tra
arrangiamenti per big band (Four Brothers, cavallo di
battaglia in ambito concertistico), atmosfere country &
western (Love For Sale) e ritagliando occasioni soliste
cucite apposta per la predisposizione melodica di Paul
e l’abilità ‘scat’ della Siegel.
Intenzionato a evocare le atmosfere della Berlino
nel primo dopoguerra mondiale, il regista inglese David Hemmings contatta i nostri affinché registrino una
manciata di brani da inserire nel suo Gigolò, pellicola senza infamia e senza lode, nota per tenere David
Bowie come protagonista oltre a una fugace (l’ultima)
apparizione di Marlene Dietrich sul grande schermo.
Tratto da alcune date londinesi, The Manhattan
Transfer Live (’78, Atlantic) è il primo live ufficiale del
93
gruppo e l’ultima uscita discografica con la Massè, di lì
a poco vittima di un incidente automobilistico che la
costrinse lontana dalle scene per quasi due anni. Decisa ad abbandonare il mondo della musica la cantante
optò poi per un ripensamento, inaugurando una discreta attività solista con Alone Together nell’84. Al suo
posto venne ingaggiata Cheryl Bentyne, pervenendo
così alla formazione definitiva nota al grande pubblico.
La Bentyne arriva in tempo per prendere parte al
primo indiscusso capolavoro, quell’Extentions (’79,
Atlantic) con in copertina i disegni degli abiti di scena
creati da Jean Paul Gautier per il quartetto. L’opera è
raccolta esemplare di fusion(e) tra generi: c’è spazio per
la new wave disumanizzata in Coo Coo U (senza mai rinunciare a un pizzico di ironia), il pop magnificamente
arrangianto degli Airplay di Nothin' You Can Do About It
(merito della produzione di Jay Graydon) e il sentimentalismo a cappella in Foreign Affair (Tom Waits). Una
menzione a parte merita l’arcinota Birdland, tratta dal
repertorio degli Weather Reaport o, più precisamente,
dall’unione artistica dei fuoriclasse Joe Zawinul + Jaco
Pastorius. Il brano sarà il più ascoltato in ambito jazz
di tutto il 1980 in virtù di tre elementi imprescindibili:
validità della linea melodica (accattivante e originale
al contempo), prestazione vocale (la Siegel si aggiudicò un Grammy per la propria interpretazione) e intelligenza del testo. Quest’ultimo fu originalmente affidato
nientemeno che a Eddie Jefferson, il quale però verrà
ucciso prima di portarlo a termine (l’album è dedicato
alla sua memoria). L'ingrato compito di sostituirlo fu affidato a Jon Hendricks. Il risultato è una spassosa declamazione dei principali frequentatori del leggendario
jazz club newyorkese: sfruttando nomi e nomignoli dei
celebri jazzisti (“Bird would cook/ Max would look/ Miles came through/ ‘Trane came too”) il paroliere fornisce
all’interprete versi ritmici ideali per un’interpretazione
swingante e ‘catchy’, soluzione questa qui abbracciata
magnificamente negli ambiti solisti e coristi.
Il successivo Mecca For Moderns (’81, Atlantic) strizza l’occhio alla classifica una volta di troppo, col risultato di incoronare i Manhattan il primo gruppo a vincere
un Grammy lo stesso anno sia nella categoria pop che
jazz. La piacioneria alla base della hit Boy From New York
City sbilancia la credibilità di una band che, per capacità
tecniche e stile, avrebbe potuto azzardare un ulteriore
passo in avanti nella propria crescita artistica. Ma premi
e riconoscimenti piovono in abbondanza e i nostri non
sembrano crucciarsene. La sola eccezione di rilievo è
Kafka del polacco Bernard Kafka, efficace esempio di
frizzantura fusion contemporanea e ricca di mordente.
Il processo di commercializzazione avanza su Bo94
dies And Souls (’83, Atlantic), producendo un pop
sintetico amplificato dalla partecipazione di Stevie
Wonder all’armonica (Spice Of Life), sdoganando così
i Manhattan nelle classifiche r’n’b e concedendo l’ennesimo Grammy per l’interpretazione di Why Not!. Al
di là dai clamori della stampa l’album suona come una
raccolta oggi datata di canzoni ben arrangiate, adatte
per un film sentimentale da cassetta e poco di più. Leggerino e svagato, Bop Doo-Wop (’85, Atlantic) mischia
sei canzoni dal tour giapponese a materiale di studio,
sfornando comunque quella Route 66 di Nat King Cole
per il filmetto di Burt Reynolds Pelle di sbirro che, guarda un po’, frutta l’ennesimo Grammy come ‘Miglior prestazione vocale in ambito jazz’. Il materiale live verrà
ripreso e ampliato dieci anni più tardi con la pubblicazione del discreto Man-Tora! ('96, Rhino).
Sfumata la possibilità di una collaborazione con
Count Basie a causa della morte di quest’ultimo, il bandolo della matassa viene ripigliato col monumentale
Vocalese (’85, Atlantic), summa delle tante influenze
dei suoi protagonisti e quindi vaudeville, swing, r’n’b,
soul, doo-wop, r'n'r e jazz nelle sue tante sfaccettature.
Il prevedibilie omaggio a Basie riguarda le trascurabili
Rambo e Blee Blop Blues, per le quali ci si avvalse della
sua orchestra ufficiale. Ben più meritoria Another Night
In Tunisia, sorniona versione della A Night In Tunisia di
Dizzy Gillespie, la quale si aggiudica altri due Grammy (gli ultimi che, per ragioni di spazio, segnaleremo). Il
registro melodrammatico viene rispolverato invece con
Oh Yes, I remember Clifford e con la struggente To You.
Il successo è ormai planetario: le dodici nomination ai
Grammy di Vocalese per poco non battono Thriller
di Michael Jackson. La motivazione, oltre alle assodate capacità del quartetto e a impeccabili esecuzioni
strumentali, sta nella scelta di un repertorio particolarmente azzeccato che concede episodi appassionanti e
mozzafiato (basterebbe l’ascolto di Airegin o That’s Killer Joe), nuovamente impreziositi dai testi di Hendricks.
Live (Atlantic, ’87) contiene la selezione da un concerto
a Tokyo del 1986: secondo album live e primo con la
Bentyne a sostituzione della Massé è il ritratto perfetto del gruppo al suo apice; si consiglia la versione dvd
Vocalese Live, con una tracklist estesa a 80 minuti e la
possibilità di gustare i nostri in gigionesche coreografie
e stravaganti costumi.
Le influenze sudamericane derivate dalla preziosa
collaborazione col cantante e compositore brasiliano
Djavan in Brasil (’87, Atlantic) danno vita a uno degli
album più riusciti nel sottogenere Aor, al pari di masterpiece quali The Nightfly di Donald Fagen o dell’esordio omonimo di Christopher Cross. Dall’arcinota Soul
Food To Go passando per l’easy-rock Metropolis fino a
certe complicazioni melodico/armoniche evidenti nel
finale Notes From the Underground, l'opera è gioiello
per un pubblico adulto, capace di riconoscerne le tante finezze ma pure l'indubbia fruibilità. Unica puntualizzazione, per onor di franchezza: la versione di Agua
suona decisamente inferiore a quella di Loredana Berté (Acqua), la quale aveva già collaborato con Djavan in
Carioca, nel 1985.
L’ingresso nel nuovo decennio stimola i Manhattan
a testarsi in veste di compositori: ne risulta il transitorio
The Offbeat Of Avenues (’92) che, col successivo The
Christmas Album, esaurisce la breve esperienza per la
Columbia Records. Si segnalano alcune bizzarre tentazioni di hip-hop sui generis nel primo e la beatlesiana Goodnight nel secondo. Sorvolando il trascurabile
The Manhattan Transfer Meets Tubby The Tuba (’94,
Summit) – sorta di Pierino E Il Lupo americano – Tonin’
(’95) rappresenta il felice ritorno in casa Atlantic, con
una mirabile raccolta di classics Anni '50-'60 in duetto
con artisti del calibro di James Taylor (nella sognante
Dream Lover) e con la leggenda della Motown Smokey
Robinson (I Second That Emotion).
Le fatiche discografiche dei quattro proseguono
con una reimmersione nel passato in Swing (’97, Atlantic) e con l’omaggio al repertorio di Louis Armstrong
The Spirit Of St. Louis (2000, Atlantic), da sempre influenza imprescindibile per Tim.
A riprova di una primavera artistica che sembra non
aver mai fine Couldn't Be Hotter (’03, Telarc) è forse il
live migliore pubblicato a oggi, forte di esecuzioni effervescenti e di una carica emotiva sapientemente miscelata a un controllo vocale in grado di far scuola e
intrattenimento al prezzo di un solo biglietto. Vibrate
(’04, Telarc) intende aggiornare il repertorio, iniettando le composizioni melò del giovane cantautore Rufus
Wainwright e tentando il Miles Davis di Tutu (ma se
ne esce con un occhio pesto). Dopo un secondo album
natalizio (An Acapella Christmas Album, ’04, King Rec)
la nuova sfida è con una vera e propria orchestra sinfonica in The Symphony Sessions (’06, King Rec). Ne
deriva un album di straordinario impatto emotivo, certamente uno dei più sottovalutati nell’intero repertorio
(si ascoltino To You, Clouds o The Offbeat Of Avenues).
L’ultimo sorprendente guizzo di vitalità, alla faccia
di chi da sempre taccia i Manhattan come un barbershop group spintosi troppo in là, è titolato The Chick
Corea Songbook (’09, Four Quarters Entertainment).
Cimentandosi col repertorio del famoso jazzista americano, l’occasione è buona per approfondire lo studio
sulle sonorità latine, come pure per interpretare un
approccio compositivo contemporaneo e certamente
meno fruibile rispetto agli episodi più acclamati.
Il futuro dei Manhattan Transfer a quanto sembra,
oltre all’instancabile attività live, riserverà per l’ascoltatore disponibile sorprese pronte a deliziarne le orecchie e, al contempo, a educarle.
L' intervista
Tim, iniziamo dal presente: in che stato versa il vocalese oggidì?
Devo ammettere, non senza una certa sorpresa, che
attualmente sto scoprendo un nuovo pubblico nei giovani, specialmente quelli che magari cantano nel coro
jazz della propria università.
A dispetto di chi vi etichetta come ‘easy listening’
l’anno scorso siete tornati con un progetto assolutamente ambizioso, reinterpretando Corea…
Già, un progetto davvero interessante. Letto nella sua
interezza, l’album si distingue dal resto della nostra discografia per la sua spiccata complessità; era la prima
volta che interpretavamo il repertorio di Chick e credimi se ti dico che si è trattato forse del lavoro più impegnativo della nostra carriera, sia in termini di comprensione che di riproduzione armonica del cantato.
Non solo: in Another Roadside Attraction, a esempio,
emerge una componente sperimentale che aggiunge un importante tassello alla vostra biografia.
Mi fa molto piacere che tu abbia notato proprio quella canzone. La penso come te e ti devo confessare che
Another Roadside Attraction può vantare l’arrangiamento di mio figlio, Basie. Il risultato è ancor più sorprendente se consideri che ha ventun'anni.
Lo show biz è orribile come lo si dipinge?
Sai com'è, ci sono sempre stati e sempre ci saranno
gruppi di persone, all’interno di questo settore, animati da uno spirito 'predatorio'. Purtroppo è così che va il
mondo: alcuni individui si arricchiscono sulle spalle di
talenti giovani e inesperti.
Svariati i lavori che hai abbracciato per sostentarti durante la gavetta musicale; ne ricordi qualcuno
con particolare affetto? Ho fatto veramente di tutto e ti assicuro che ogni impiego mi ha insegnato cose importanti a livello umano e non solo. Non mi vergogno di nessuna mansione svolta: tra quelle che mi tornano alla mente ora…
vediamo… sono stato analista marketing, caddie per
un golf club, cuoco in un diner (una specie di tavola
calda molto diffusa qui negli States) e tassista. Una notte stavo guidando il mio taxi quando ho caricato questa ragazza dai capelli rossi. Al tempo lavorava come
95
cameriera ma la sua passione era il canto. Fu così che
incontrai Laurel Massé!
Elemento spesso trascurato dalla critica riguardo
ai vostri album: la straordinaria qualità degli arrangiamenti strumentali…
Avrai notato che, fin dagli esordi, abbiamo sempre tentato di procurarci la crema tra i session men sul mercato anche se, ovviamente, questo comportava per
noi un maggiore investimento economico. Una volta
in studio non seguiamo un modus particolare: ci diamo dentro mettendo sul tavolo intuizioni, mestiere ed
esperienze, cercando di pianificare gli arrangiamenti
e il ruolo da conferire a ogni strumento all’interno dei
brani selezionati.
Quali sono le qualità imprescindibili per un cantante?
A costo di sembrarti banale, tutti questi anni nel mondo della musica mi hanno insegnato che, in ultima analisi, l’unico requisito fondamentale è l’abilità di arrivare
dritti al cuore dell’ascoltatore e lasciarci dentro un po’
di se stessi.
Un gruppo vocale ingiustamente sottostimato?
Tra i tanti nomi che mi vengono in mente scelgo
senz’ombra di dubbio il quartetto degli Hi-Lo’s. Loro
non sono mai riusciti a sfondare veramente e avrebbero
meritato molto; la ragione sta forse nel fatto che, sotto
un profilo musicale, avevano un non so che di 'esoterico'. Ma credimi se ti dico che erano grandissimi.
Magari mi riesce di estorcerti il nome del musicista
più sopravvalutato nella storia del jazz?
Anche se ti dicessi chi ho in mente non vorrei che venisse pubblicato, perciò…
Il tuo stile lascia pensare che non ti sia andata a genio la ‘new thing’ esplosa negli Anni ’60…
Beh, oltre al free quel periodo ha elargito be-bopper del
calibro del tenorsassofonista Benny Golson, del quale
reinterpretammo Killer Joe su Vocalese. In questi giorni
invece stiamo lavorando su Sidewinder, altro pezzo interessante di un trombettista dei ’60, Lee Morgan.
Qualcuno ti avrà certamente accusato di essere
nient’altro che un nostalgico…
Quelli che sollevano questa critica mancano spesso di
una conoscenza musicale approfondita.
Igor Stravinsky: "La mia musica la capiscono sopratutto bimbi e animali". Riesci a tratteggiare il profilo del tuo ascoltatore tipo?
Non saprei; non sono mai riuscito a delineare un filo
conduttore tra i nostri fan. Credo si tratti di un’inspiegabile qualità percettiva, che porta una persona a scegliere un filone musicale piuttosto che un altro.
Contrariamente a quel che si potrebbe pensare la
96
dimensione live è un aspetto molto importante nei
Manhattan. Le tournée non ti snervano?
Alla gente dico sempre: “Canto a gratis, vengo pagato
per dover viaggiare”.
Tutti furono d’accordo nel decretare un enorme
successo a Extentions; da cosa credi sia dipeso?
Extentions ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta, sia per la qualità del materiale che per le
scelte di Jay Graydon in veste di produttore (da allora
in avanti è stato richiesto da artisti del calibro di Al Jarreau, Art Garfunkel e Dionne Warwick). Jay è stato
determinante per la formulazione di un sound ibrido
che in definitiva attualizzò il nostro stile, avvicinandoci
così a un pubblico ancor più vasto. Va poi evidenziato il
contributo creativo delle voci di Alan (ascoltalo in Twilight Tone) e di Janis, la cui interpretazione di Birdland
le valse un Grammy.
Spesso i vostri album ricevono un'accoglienza più
calda in Europa rispetto agli States...
Sono convinto che gli europei in genere riescono ad
apprezzare il jazz americano molto più degli americani
stessi. Triste a dirsi, ma è la pura verità.
Riascoltando Tonin’ riflettevo sul fatto che quell’album contiene con tutta probabilità l’ultima registrazione da studio di Laura Nyro, prima della sua
morte a soli cinquant’anni.
Ecco appunto, a proposito di gusti musicali: la Nyro, fin
dal suo esordio, è stata una delle mie cantanti preferite,
in assoluto. Ricordo ancora l’impressione che mi fece il
suo primo album per la Verve Forecast More Than A
New Discovery. Ho ascoltato quel vinile tante di quelle
volte che ora è completamente consumato. Ho anche
avuto il privilegio di lavorarle a fianco una volta, ai tempi dei primi Manhattan, nel 1970, se ben ricordo. Pensa
che siamo l’unico gruppo con cui ha accettato di registrare un duetto, fatta eccezione per il brano Promenade in coppia col compositore Kenny Rankin, anche se
non mi risulta che il pezzo sia mai stato pubblicato.
Comparando il jazz nella sua età dell’oro (Anni '30
e '40) con la scena attuale, quali sono le tue conclusioni?
Bisogna tener presente che in quegli anni il jazz veniva
considerato la musica popolare del momento. Trascorso quel periodo è innegabile che, generalizzando, la
sua diffusione rispetto alle grandi masse si sia abbassata significativamente in favore di altri generi ben più
immediati. Bando agli intellettualismi: non trovi che arrangiare una canzone sia molto simile a cucinare una pietanza?
Hai assolutamente ragione. Tra l’altro devo confessar-
ti che adoro far da mangiare e mi capita spesso di cimentarmi con qualche ricetta italiana. Cucinare è veramente simile a quando ti stai approcciando a un brano
ancora grezzo e decidi come sagomarlo, cosa aggiungere, quali sono le modifiche che ne determineranno
un feeling specifico.
Nell’ambiente è nota la tua passione per il collezionismo di vinili rari: qual è il titolo della tua discoteca a cui ti senti più attaccato?
Questa è dura… spero di poter scegliere, in blocco, tutta la parte dedicate ai gruppi vocali di r’n’b, dagli Anni
'30 e fino ai ’50 compresi.
A proposito di collezionismi: pare che anche le auto
d’epoca facciano parte delle tue debolezze…
Oh sì! Attualmente mi sto godendo una Mercedes Benz
190 Sl del 1961, che restauro pazientemente da una
vita. E tra un paio di settimane sarà finalmente pronta la mia Coupé-Cabriolet Mercury del ‘41. Sto anche
modificando una Ford Coupé del ’50: ho recentemente
sostituito il tettuccio con uno del ’51 e mi sono procurato una calandra proveniente da una Pontiac datata
1954. Voglio anche cambiarle il colore con un bel blu
metallo.
Com’è la tua giornata ideale?
Ti sembrerò scontato ma direi la giornata in cui riesco
a sbrigare tutto quello che mi sono prefissato senza alcun tipo di intoppo esterno.
Louis Armstrong dichiarò: "Un musicista non si ritira mai: smette solo quando non c’è più musica
dentro di lui". Mai avuto la tentazione di mollare la
carriera per un'esistenza meno movimentata?
Naaa, non sono il tipo che molla. Anche perché, riflettendoci, non saprei che altro fare della mia vita.
Nonostante trentacinque anni nel mondo della musica sei l’ultimo dei Manhattan ad aver registrato
un album solista, nel 2007. Quale necessità hai soddisfatto con Love Stories?
Avevo bisogno di esprimere un particolare aspetto della mia personalità, un lato 'intimista', diciamo, che coi
Manhattan non era mai veramente emerso. Mi sono
limitato a scegliere quelle canzoni del passato che mi
affascinavano profondamente, quei pezzi in grado di
emozionarmi ancor oggi.
Un consiglio che t'ha illuminato?
Agli inizi lavorammo con Baby Lawrence e sua moglie
Dorothy Bradley. Baby era noto nell'ambiente come
il 'Charlie Parker del tip-tap' e Dorothy era la vedova
di Buddy Bradley, coreografo attivo nel cinema per
star come Fred Astaire. In sostanza dovevano insegnarci le basi per muoverci sul palco, oltre a certi passi
tipici del jazz ballato (tipo il 'camel walk', lo 'shorty george' ecc.). Mi resterà sempre impressa la volta in cui
Baby mi disse: "Tienilo bene a mente Tim; solo due cose
sono fondamentali nello show business: atteggiamento e portamento, sta tutto lì". Non me lo sono più scordato, anche perché con gli anni ho scoperto quanto
avesse ragione.
Dopo una carriera costellata di premi e riconoscimenti resta da chiedersi quali siano i tuoi prossimi
traguardi…
In realtà ci sono ancora una serie di progetti di cui da
anni discutiamo la fattibilità, in ambito Manhattan. Il
mio intento è perciò quello di adoperarmi affinché presto o tardi si riesca a concretizzarli, come nel caso di
The Chick Corea Songbook, album che gravitava nella
mia mente dagli Anni ‘70.
Qual è l’aspetto più straordinario dell’essere un artista?
Essere in grado di sostenere me e la mia famiglia: questo è un vero e proprio dono, un privilegio che non
darò mai per scontato. E poi ho sempre pensato che
questa mia professione, per quanto complessa, sia pur
sempre preferibile a una vita in ufficio.
97
(GI)Ant Steps #43
classic album rev
Louis Armstrong
The Charlatans
The Ultimate Collection (Verve Music Group, Luglio 2000)
Some Friendly (Beggars Banquet, Settembre 1990)
Le antologie di solito le evitiamo. Eppure il fine che si
pone questo formato quando si parla di jazz, blues,
folk e in generale di una musica lontana nel tempo e
registrata su supporti dispersivi come il settantotto
o il quarantacinque giri, è assai nobile. Testimoniare,
in primis, e poi creare ponti ideali che permettano di
apprezzare il concetto di evoluzione. Discorso banale,
ma che vale soprattutto per Louis Armstrong. Uno
che la sua storia l'ha scritta attraversando tutto il jazz
che conta. Tre CD per cinquantanove brani incisi tra il
1924 e il 1968. Quarant'anni di musica suonata da un
tromba a suo modo rivoluzionaria, in un periodo in cui
esserlo non significava destrutturare all'estremo come
farà il free-jazz ma personalizzare nei limiti imposti
dalla metrica dei tempi. Con un vibrato allusivo,
un'impro inscatolata nella melodia, lo swing".
Tre i Louis Armstrong che emrgono da The Ultimate Collection. Il primo è il giovane musicista di inizio
anni Venti con alle spalle il riformatorio (dove impara
a suonar la cornetta), le orchestrine da strada, un matrimonio fallito e una serie di impieghi temporanei tra
Storyville (il quartiere dei bordelli di New Orleans),
i battelli del Mississipi e la Creole Jazz Band di King
Oliver. Lo stile ricalca a grandi linee quello dell'Oliver
padre putativo, virtuoso e rotondo, in un misto di ragtime e blues (Copenhagen) disciplinato e rafforzato dal
lavoro di big band tradizionali (tromba, trombone, clarinetto, sax, banjo, tuba, batteria). Un Armstrong rigoroso ma anche versatile, capace di passare senza batter
ciglio dalla Fletcher Henderson Orchestra alla Erskine
Tate's Vendome Orchestra della sua seconda moglie,
dai Johnny Dodds's Black Bottom Stompers ai Jimmy
Bertrand's Washboard Wizards. In una girandola di
98
esperienze che a fine anni Trenta lo ha già consacrato
al pubblico dei grandi numeri.
Del resto siamo nel periodo di When The Saints Go
Marching In e di un Louis dal suono pulito, nitido, squillante e assai meno incartato rispetto agli esordi, fuori
dal purismo nero e sempre più vicino ai palcoscenici
bianchi ed europei. Quelli che il Nostro calca portando in dote classici come Rockin' Chair, West End Blues,
Savoy Blues (raccolti sul secondo disco), in una inseguimento dei gusti degli ascoltatori che sarà una costante
della vita artistica del trombettista americano. Lo standard, allo scoccare degli anni Quaranta, sono i tempi
lenti, un cantato ruffiano e una tromba piaciona che
sostiene le note, improvvisando in maniera più strutturata rispetto al passato tra blues (la Blueberry Hill che
Fats Domino farà sua negli anni Cinquanta) e classici. Inesorabilmente alla ricerca di un jazz elegante e al
tempo stesso estremamente popolare.
Come testimonia anche la terna Dream A Little Dream Of Me / Hello Dolly / What A Wonderful World di un
terzo supporto che non si scandalizza per gli archi di
It's All In The Day, puo' contare sui duetti con Ella Fitzgerald (Stompin' At The Savoy) e Oscar Peterson (Sweet Lorraine), scopre il gusto dello scat. Nel momento
di massima notorietà Armstrong non è più un jazzista
classico ma un intrattenitore a tutto tondo, con tanto
di mimica ad effetto e trucchetti da avanspettacolo
da usare sul palcoscenico. Gli stessi che con la musica
suonata e una carriera decennale alle spalle gli garantiranno lo status di ambasciatore del jazz in giro per il
mondo e un'onestà artistica tutta sua. Fino alla morte,
avvenuta nel 1971.
Fateli i conti, che male non è e - specialmente in retrospettiva - senza dubbio aiuta. Meraviglie del distacco
che permette di rileggere serenamente e (ri)contestualizzare fenomeni e tendenze. Chissà che diremo
tra vent’anni del glo-fi, tanto per dirne una: seccature
delle generazioni che saranno, se un giornalismo musicale esisterà ancora e soprattutto un mondo a contenerlo. Prendete ad esempio la fulminea stagione di
Madchester: scaduta l’Ecstasy, cosa resta? Un Capolavoro assoluto nell’ultimo anno dei Capolavori assoluti
(Screamadelica); un disco splendido ma che c’entrava
nulla, semmai era tra gli ultimi esempi di chitarrismo
anni ’80 britannico (The Stone Roses); i borgatari Happy Mondays, che condussero accidia e cinismo in classifica; qualche singolo di Inspiral Carpets a rendere
meno tristi le spente ceneri. Gli elettronici 808 State,
ma anche lì era un’altra storia.
Aggiungete pure un altro lp, che al tempo fece tremare la stampa nazionale in virtù del physique du role
di Tim Burgess, cantante della band che ne era autrice.
Dei Charlatans di Some Friendly, oggi, colpisce il porsi
in una nicchia dalla quale osserva i coetanei e quanto
seguì - sfortune e tragedie incluse - il suo fiorire appassionato e caldo. Se nessuno dei tanti lavori successivi
dei Ciarlatani lo vale, rimane faccenda notevole che
ricorda come, da sempre, il miglior pop d’oltremanica paghi pegno alla musica nera. Dal suono sensuale
tuttavia sostenuto dei mancuniani (Northwich, per la
precisione) risali a Brian Auger, alla Graham Bond
Organization, allo Spencer Davis Group (il tastieri-
sta Rob Collins esemplare e idem lo scintillante traino
nelle charts The Only One I Know). E anche, in versione
light, a quei Prisoners da dove sbucava il traghettatore
dell’organo Hammond, James Taylor. Non fosse che
quanto era ruvido errebì in buccia d’orecchiabilità si
era col senno di poi venato di jingle-jangle (l’innodica
Sproston Green vicina ai R.E.M. di Green) pur seguitando a voler la pelle nera con Believe You Me e Polar Bear (i
ragazzi collezionavano anche 12" di house chicagoana;
anni dopo, Burgess avrebbe cantato con i Chemical
Brothers, pronti a ricambiare tramite un remix) e ricordare i ’60 (White Shirt).
Erano baggy come Elvis Costello era punk - cioè
poco o nulla: l’errore era prospettico - e semmai preferivano sapevano incupirsi (Then) e lanciarsi in una
neo-psichedelia morbida tipicamente albionica (You're
Not Very Well, Sonic). Cercavano il groove cautamente
danzabile mentre erano in "viaggio" e viceversa: ecco
l’alchimia che qui funziona con costanza e sarà per
loro l’unica volta. Prova ne sia che, a fine estate 2010,
ne è stata pubblicata una doppia versione "deluxe" su
cd con session radiofoniche e varie chicche aggiunte;
e che, più di ogni altra cosa, riascoltarlo non abbia offerto semplice nostalgia. Melting Pot si intitolava una
ben compilata raccolta del '98 che consigliamo a integrazione, ed era vero: confuso e forse involontario, ma
lo era.
Giancarlo Turra
Fabrizio Zampighi
99
www.sentireascoltare.com