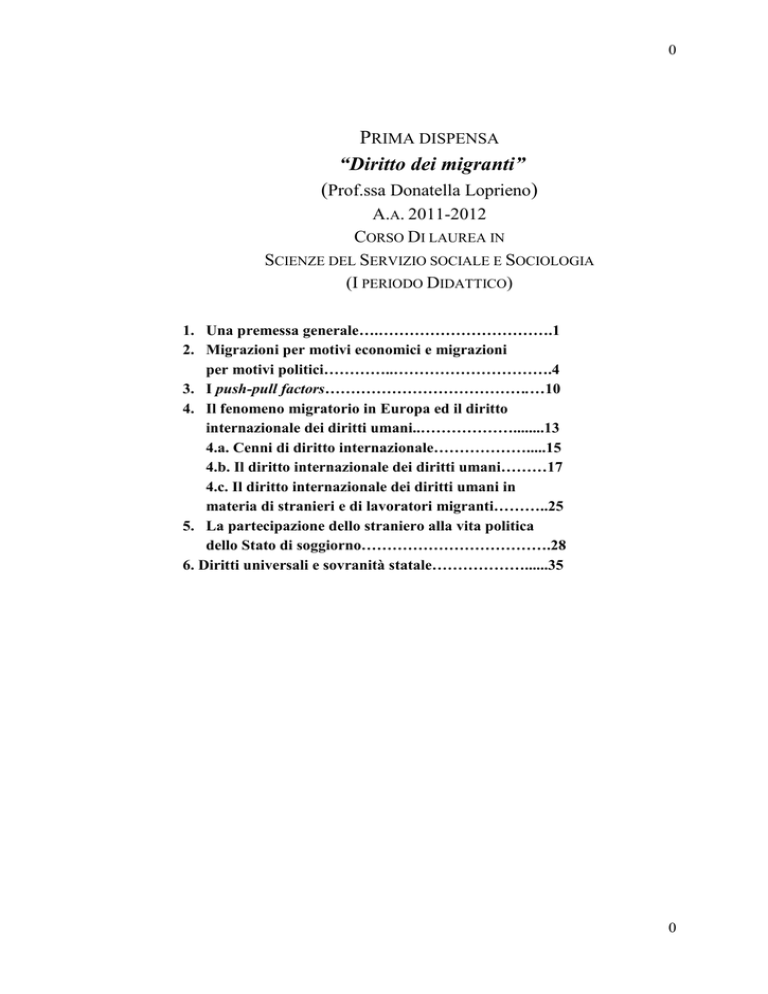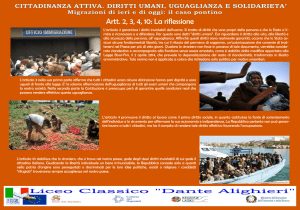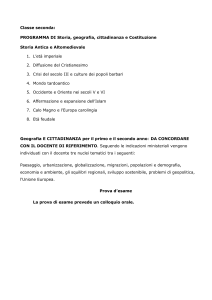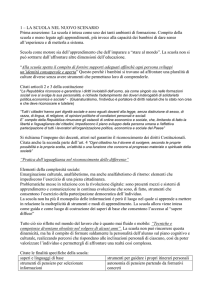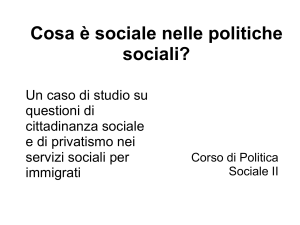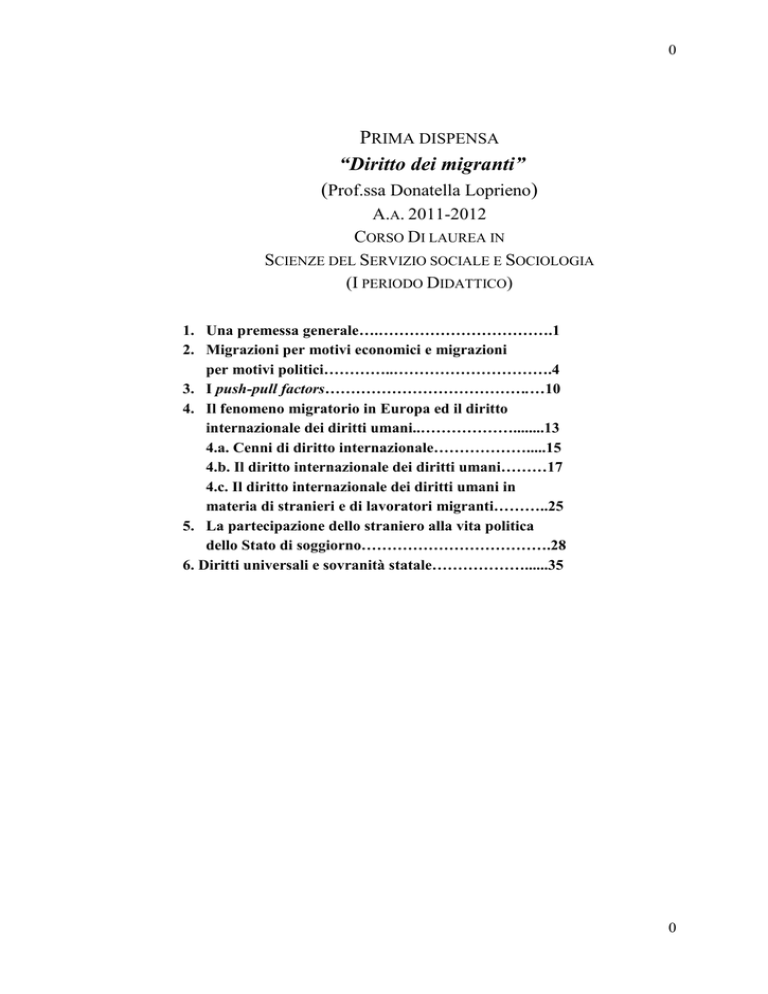
0
PRIMA DISPENSA
“Diritto dei migranti”
(Prof.ssa Donatella Loprieno)
A.A. 2011-2012
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA
(I PERIODO DIDATTICO)
1. Una premessa generale….…………………………….1
2. Migrazioni per motivi economici e migrazioni
per motivi politici…………..………………………….4
3. I push-pull factors………………………………….…10
4. Il fenomeno migratorio in Europa ed il diritto
internazionale dei diritti umani..………………........13
4.a. Cenni di diritto internazionale……………….....15
4.b. Il diritto internazionale dei diritti umani………17
4.c. Il diritto internazionale dei diritti umani in
materia di stranieri e di lavoratori migranti………..25
5. La partecipazione dello straniero alla vita politica
dello Stato di soggiorno……………………………….28
6. Diritti universali e sovranità statale………………......35
0
1
1. Una premessa generale
Le tematiche legate allo statuto giuridico dello straniero costituiscono un
osservatorio privilegiato per comprendere – non solo in Italia ed in Europa ma nelle
società occidentali - i processi di integrazione ovvero di rifiuto degli immigrati
stranieri. che coinvolgono la condizione degli stranieri. Si tratta, senza dubbio, di una
vera e propria cartina di tornasole per misurare i progressi, gli arresti o anche i passi
indietro lungo la strada della effettiva equiparazione tra immigrati e cittadini quanto
al godimento dei diritti fondamentali della persona umana ma anche per misurare il
livello di maturità delle società investite da tali problemi.
Che i processi migratori siano, almeno nel medio periodo, inarrestabili è un
qualcosa che tutti i governi europei danno oramai per scontato da almeno un
ventennio. Tali processi vengono governati con esiti alterni che dipendono da
variabili molto diverse: gli atteggiamenti delle opinioni pubbliche e le opinioni delle
organizzazioni sociali (si pensi ai partiti politici, ai sindacati, alle associazioni di
categoria, alle strutture di volontariato, alle ONG, alle chiese); la crescita o la
decrescita economica, gli indirizzi politici predominanti contingenti o di lungo
periodo “sempre oscillanti tra pulsioni umanitarie e aperture all’accoglienza
universalistica di singoli o di interi gruppi umani, da un lato e chiusure etnicoideologiche, talora venate di atteggiamenti razzisti, dall’altro” (Prisco, Abbondante).
Peraltro, è da notare che le difficoltà dell’incontro e della convivenza tra culture
diverse, mentalità diverse, modi di essere e di pensare diversi, che originano
dall’incontro e generano tensioni, sono generalmente tese ad amplificarsi nei
momenti di crisi economica. Le chiusure identitarie, la paura del doversi misurare
con il “diverso”, con l’”altro” tendono a palesarsi specie quando le persone, i
cittadini, sono impauriti dalla prospettiva di perdere, per se stessi e per i propri figli,
quel livello di benessere raggiunto in precedenza.
Le migrazioni costituiscono un fenomeno che da sempre ha caratterizzato
l’umanità, tanto che si è affermato che gli «umani sono una specie migratoria»
(Massey). Prima di divenire (relativamente) sedentaria, l’umanità è stata nomade,
impegnata in continui spostamenti per seguire le prede di cui si cibava, scoprire
nuovi territori di caccia, sottrarsi alle calamità naturali. E, sin dalle origini, della
storia umana chiunque non appartenesse al proprio nucleo familiare o tribale veniva
considerato come un elemento di disturbo in quanto portatore di interessi
contrapposti rispetto a quelli del gruppo.
Tra i popoli dell’antichità, solo gli ebrei risultavano essere ben disposti nei
confronti degli stranieri; infatti, nel diritto ebraico si rinvengono passi assai
emblematici: «… ascoltateli e ciò che è giusto giudicate, sia che egli sia cittadino o
straniero; il giudizio tra di voi sia equo, sia che a peccare sia il cittadino o lo straniero
1
2
…». Nella civiltà egiziana gli stranieri erano profondamente disprezzati al punto che
venivano allontanati dalle mense ed il coltello toccato da un non egizio veniva
considerato immondo.
I greci consideravano straniero colui che si trovava al di fuori della città-stato
non potendo, per questo motivo, godere dei diritti civili e politici. Solo più tardi
questo rigore venne leggermente mitigato e si consentì agli stranieri di divenire
titolari di alcuni diritti e di partecipare ad alcune attività all’interno della polis. Ciò
avvenne per effetto, principalmente, della stipula di trattati tra le diverse realtà locali
cui fece seguito l’emanazione di appositi decreti per disciplinare l’esercizio di tali
prerogative. Fu grazie a tali strumenti che si formarono numerose figure intermedie
tra il cittadino e lo straniero. Tra i cittadini a pieno titolo e gli schiavi (i non liberi),
un ruolo di assoluto rilievo economico era svolto dai metéci, stranieri residenti nelle
città-stato per un periodo di tempo determinato, obbligati ad iscriversi in appositi
registri, trovare un protettore e pagare una tassa diretta sulla persona. I metéci non
potevano essere proprietari di beni immobili e non potevano esercitare i diritti
politici e, dunque, la possibilità di partecipare alla formazione delle decisioni
pubbliche. Certamente, però, la loro posizione era sensibilmente migliore rispetto a
quella degli schiavi (gli oggetti animati di cui parlava Aristotele) che godevano
dell’unico diritto di non essere uccisi impunemente. Per quegli apparenti paradossi
della storia, l’asimmetria di posizione tra cittadini e meteci si ripeterà, come una
costante, ed ancor oggi essa caratterizza la condizione del lavoratore straniero
immigrato.
La civiltà romana, pur se con molta gradualità, riconobbe taluni diritti agli
stranieri. Il popolo romano, definendo lo straniero con il termine hostis (che
designava indistintamente lo straniero ed il nemico) palesava la sua particolare
ostilità verso questo soggetto riconducibile, per lo più, alla nozione di popolo vinto,
ridotto in schiavitù e privato di ogni diritto civile e politico. Alcuni esempi, a tale
ultimo proposito, possono ritornare utili. I beni degli stranieri venivano considerati
res nullius ed i rapporti che, eventualmente, essi stipulavano con i romani non
avevano alcuna valenza giuridica. Soprattutto a seguito della straordinaria espansione
territoriale dell’impero romano, si dovette modificare l’originaria impostazione e
rivedere, almeno in parte, la condizione giuridica dello straniero. In esecuzione dei
diversi accordi stipulati tra Roma ed i popoli vinti, annessi all’Impero e con l’unica
finalità di stabilire nuove relazioni commerciali, si stabilirono una serie di rapporti
fondati sulle nozioni di hospitium e amicitia e, di conseguenza, si formarono diverse
categorie di stranieri. In tal modo si fece il primo passo in favore dell’hostis che si
incorporava nelle attività dell’Impero anche se solo per motivi economici. Questo
insieme di figure differenziate, ma tutte legate in qualche modo all’Impero romano,
venne del tutto equiparato ai cittadini romani a partire dal 212 d.c. con la Constitutio
Antoniniana de civitate che rappresentò il culmine della romanizzazione e che estese
2
3
il diritto di cittadinanza a tutti i sudditi libero dell’Impero. Rimasero esclusi da tale
allargamento quelle popolazioni che i romani qualificavano come “barbare” (che, di
lì a poco e paradossalmente, avrebbero conquistato la stessa Roma).
Nel periodo feudale, il principio territoriale ebbe il sopravvento sul principio
personale e di ciò ne è sicura testimonianza l’operatività di taluni istituti quale, ad
esempio, l’albinaggio ossia il diritto dello Stato di incamerare i beni lasciati nel suo
territorio da uno straniero defunto non naturalizzato e privo di eredi legittimi o
testamentari.
La rivoluzione francese del 1789, autentico momento di rottura tra l’ancien
régime e la modernità, fece registrare notevoli aperture a favore degli stranieri e ciò
in ragione soprattutto dei princìpi della Rivoluzione stessa (eguaglianza, libertà,
fraternità) orientati verso un’umanizzazione dei diritti fondamentali (ad esempio, il
decreto francese del 6 agosto 1790 abrogò espressamente il diritto di albinaggio). È
in questa fase storica che la nozione di cittadinanza acquistò rilievo grazie soprattutto
alla trasformazione dell’individuo da mero suddito a cittadino. Nella fase giacobina
della Rivoluzione francese, l’idea della cittadinanza come virtù collettiva godette
della massima espansione ed essa veniva contrapposta alle identità alternative che
fondavano l’assetto del precedente regime (ceti, corporazioni, appartenenza
religiosa) e che venivano considerate in maniera del tutto negativa. L’idea della
cittadinanza era così esaltata da essere considerata potenzialmente estensibile a tutta
l’umanità in quanto comunità di individui liberi ed eguali.
Il superamento della fase rivoluzionaria e l’approdo al modello statuale liberale
ottocentesco, caricò la nozione di cittadinanza di sfumature molto diverse, legate
all’etnia, alla cultura, alla lingua, alla storia: in una parola alla nazione. Venne
gradualmente meno l’aspirazione alla costruzione della figura del cittadino del
mondo per fare tristemente spazio alla divisione fondata sulla etnia: la cittadinanza
divenne prevalentemente quel legame che unisce al suo interno una moltitudine di
individui diversi accomunandoli in un sistema di diritti e di doveri reciproci. Essere
cittadini significava riconoscersi (ed essere riconosciuti dal proprio Stato) come
idealmente appartenenti ad una comunità politica fondata su precisi valori storicoculturali. Ed in virtù di tale appartenenza, il cittadino era ammesso a godere di una
serie di diritti a fronte del rispetto di una serie di doveri.
Da quanto detto si evince chiaramente come nella nozione di cittadinanza si
siano sedimentati, in maniera quasi schizofrenica, due opposti significati: da un lato,
la cittadinanza nella sua dimensione verticale (o statica) come qualità personale del
soggetto che designa un rapporto tra questi e lo Stato e che viene assunta
dall’ordinamento per individuare i destinatari di determinate prescrizioni (diritti e
doveri); dall’altro, la cittadinanza nella sua dimensione orizzontale (o dinamica) per
cui essa coincide con l’esercizio pieno ed effettivo dei diritti e delle libertà
democratiche consacrate nei documenti costituzionali ed esercitabili nell’ambito
3
4
della comunità politica di appartenenza. In altri termini, nella visione tradizionale
dello Stato-nazione si finisce per identificare l’identità nazionale (ovvero il
sentimento di appartenenza etnico/culturale e l’omogeneità della discendenza) con la
cittadinanza politica (ovvero il riferimento allo Stato come associazione di individui
liberi ed eguali che ad esso aderiscono liberamente, per scelta ed indipendentemente
da ogni criterio di ascrizione come la mera nascita o la residenza).
Questo legame tra nazionalità e cittadinanza se ha contribuito a “costruire”
l’idea stessa di popolo e di sovranità ad esso spettante, ha però portato ad una
neutralizzazione della cittadinanza stessa divenuta oramai strumento giuridico atto a
differenziare i membri delle diverse nazioni ed a segnare il discrimine tra chi è
cittadino e chi non lo è, tra cittadino e straniero consolidando l’idea di un “noi”
omogeneo, legato da vincoli di solidarietà contrapposto agli “altri”, sempre
potenzialmente nemici.
La cittadinanza si configura, cioè, come un concetto di chiusura e l’universo
sociale, giuridico e politico rimane quasi perfettamente scisso a seconda che compaia
o meno la condizione della cittadinanza di talchè la definizione dello straniero sarà
una nozione fondamentalmente negativa: è straniero chi non è cittadino.
Ancora oggi non è facile dare una definizione univoca di straniero.
Sicuramente per lo Stato italiano è straniero chi non è cittadino italiano. Ma alla noncittadinanza corrispondono, come vedremo, status giuridici molto differenziati l’uno
dall’altro. Volendo schematizzare, si può dire che non sono cittadini italiani: i
cittadini europei; i cittadini dei paesi terzi (c.d. extracomunitari, regolari e non); gli
apolidi.
2.
Migrazioni per motivi economici e migrazioni per motivi politici
Da questi pochi cenni, emerge con chiarezza, da un lato, la complessità della
nozione stessa di cittadinanza ma dall’altro quanto il fenomeno delle migrazioni sia
assai antico pur se esso ha raggiunto dimensioni consistenti con il formarsi della
moderna società industriale.
Le ragioni che spingono gli individui a lasciare il proprio paese di appartenenza
e ad emigrare in Stati diversi rispetto a quello di cui si è cittadini sono assai varie ed,
in molti casi, difficili da indagare ed accertare. Tralasciando i fattori contingenti
come guerre, calamità naturali, persecuzioni individuali, rimane che una cospicua
parte di individui si sposta alla ricerca di nuove e migliori condizioni di vita.
Il ‘migrante’ può essere, così, definito come il soggetto (persona umana) che,
per motivi ritenuti essenziali, lascia la propria terra di origine o di abituale residenza
per stabilirsi altrove, per sempre o solo temporaneamente, al fine di realizzare le
4
5
proprie aspirazioni che possono spaziare dalla preservazione della propria vita fino
alla ricerca delle condizioni per una migliore realizzazione di se stessi.
Le migrazioni sono processi eterogenei e fluidi e la definizione di immigrato
cambia a seconda dei contesti giuridici, delle vicende storiche, delle contingenze
politiche ma anche dai progetti migratori e dai contesti di inserimento.
L’attenzione per i temi dell’immigrazione, dell’asilo politico, del
riconoscimento dello status di rifugiato e più in generale della condizione giuridica
dello straniero è andata sempre più crescendo, nell’ultimo trentennio, non solo in
Italia ma in moltissimi altri Stati europei. Similmente agli altri paesi del
Mediterraneo, infatti, nell’arco di venti anni l’Italia si è trasformata da paese da cui si
prevalentemente si emigrava a meta di ingenti flussi migratori e tale trasformazione è
avvenuta in maniera quasi inconsapevole ed ha colto di sorpresa le istituzioni
pubbliche, gli attori politici e la società nel suo complesso. Tale impreparazione,
come vedremo, ha pesato moltissimo sull’esatta ricezione del fenomeno migratorio
percepito dai più (e soprattutto da alcune forze politiche) non tanto come una risorsa
ma come un “pericolo” e una “minaccia” per l’ordine pubblico.
Classificare i fenomeni migratori è impresa molto difficile perché assai spesso i
fattori che spingono alla emigrazione non sono agilmente e facilmente separabili.
Accade così che molto spesso le diverse categorie di migranti elaborate dagli
studiosi finiscono per sovrapporsi le une alle altre.
La prima e probabilmente la più importante distinzione da farsi è fra le
migrazioni per motivi “politici” e le migrazioni per motivi “economici”.
Alla prima categoria appartengono i richiedenti asilo, i rifugiati e quanti
necessitano di una qualche forma di protezione sussidiaria o umanitaria (c.d.
“protezione internazionale). Ora mentre il migrante per motivi economici è colui che
decide volontariamente di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o
permanentemente, in un altro Stato alla ricerca di migliori condizioni di vita, il
migrante per motivi politici non si sposta per libera scelta, ma è costretto ad
abbandonare il proprio Paese per sfuggire a gravi persecuzioni e a violenze.
Altrimenti detto i migranti politici sono figure giuridicamente diverse dagli
immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e/o
ricongiungimento familiare. Ciò che spinge a spostarsi in un altro Paese non è una
libera scelta, ma, piuttosto, la mancanza di ogni scelta e la necessità di salvare la
propria vita.
Il quadro normativo che regola la materia delle migrazioni per motivi politici è
diverso da quello che regola la materia dell’immigrazione “economica”. Si tratta di
un insieme complesso ed articolato su cui insistono fonti normative di livello
internazionale, comunitario e nazionale. Ciò significa che nel sistema del diritto degli
stranieri, l’intera disciplina riguardante la protezione internazionale (asilo, rifugio,
5
6
protezione umanitaria e protezione sussidiaria1) presenta caratteri distinti e peculiari
e soltanto in parte si inserisce nel sistema della disciplina generale della
immigrazione.
La materia dell’asilo (e degli istituti ad esso simili), infatti, presenta
caratteristiche particolari per almeno due ragioni. Anzitutto, in ogni forma di Stato
democratico, la disciplina del diritto di asilo è ispirata a criteri e princìpi che
derogano in parte al resto della disciplina sugli stranieri prevedendo una disciplina
più favorevole allo straniero titolare del diritto di asilo e questo poiché, in tali forme
di Stato, si cerca di assicurare il più ampio ed effettivo rispetto dei diritti
fondamentali della persona. Non stupisce, perciò, che tali Stati prevedano una più
ampia tutela per l’ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio di stranieri la cui
vita, sicurezza e libertà siano in pericolo concreto a causa di particolari situazioni in
cui i medesimi princìpi e diritti fondamentali non sono effettivamente garantiti o
sono apertamente rigettati. Il secondo luogo, la disciplina del diritto di asilo è sempre
stata soggetta ai principali eventi storico-politici delle relazioni internazionali. Nella
storia dell’umanità, infatti, la migrazione delle persone è spesso stata determinata da
eventi bellici o da motivi politici o da qualche altra forma di persecuzione a cui, negli
ordinamenti giuridici di ogni tempo, ha corrisposto l’istituto dell’asilo in altri Stati.
Nel diritto internazionale, l’asilo consiste nella protezione accordata da uno
Stato, all’interno della propria sfera territoriale (asilo territoriale o diplomatico) o
in altro luogo (asilo extraterritoriale2), ad uno straniero che ne faccia richiesta.
Perché vi sia asilo, dunque, non è sufficiente che lo Stato di emigrazione offra allo
straniero una qualche forma di protezione, con la conseguente ammissione nel
proprio territorio, ma occorre che ne assuma la protezione contro ogni forma di
ritorsione eventualmente attuata ai danni dello straniero stesso da altri Stati.
È opinione largamente condivisa che tra il “diritto di asilo” e “lo status di
rifugiato” esista ancora oggi una profonda confusione a livello sia legislativo che
giurisprudenziale ed amministrativo dovuta principalmente al fatto che lo stesso
diritto è oggetto di una tutela multilivello (internazionale, comunitaria e nazionale).
1
Qualche dato potrà essere utile. Secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo, nel 2008, a fronte di 22136 domande di protezione internazionale esaminate dalle commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 25/2008),
in 1695 casi (7,66%) è stato riconosciuto lo status di rifugiato, in 7054 casi (31,87%) è stata
riconosciuta la protezione sussidiaria (di cui agli artt. 14 ss. Del d.lgs. 251/2007) e in 2100 casi
(9,49%) le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale hanno
ritenuto di trasmettere gli atti al questore per l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per la
c.d. protezione umanitaria. Ciò significa che in 10849 casi su 22136 (49,01%) è stato ritenuto dalle
competenti autorità italiane che gli individui in questione fossero in qualche modo bisognosi dei una
qualche forma di protezione politico/umanitaria e si dovesse, pertanto, provvedere nei loro confronti,
al rilascio del permesso di soggiorno.
2
Eventualmente riconosciuto nelle sedi di missioni diplomatiche o consolari, di organismi
internazionali, in navi militari, etc.
6
7
La confusione terminologica, però, costituisce certamente un sintomo dello
svuotamento e della disattenzione nei riguardi del diritto di asilo. Quest’ultimo,
infatti, è espressamente previsto e disciplinato dalla nostra Costituzione che, invece,
nulla dice in ordine allo status di rifugiato la cui origine è di natura prettamente
internazionalistica. Ebbene, l’art. 10, comma 3 della nostra Costituzione dispone
espressamente che “Lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Rivendicato
con forza e con orgoglio dai Costituenti, in quanto norma-manifesto rivolta al mondo
da parte della nuova Italia democratica, il diritto di asilo è stato unanimemente
riconosciuto quale diritto costituzionale soggettivo perfetto fruibile anche in assenza
della legge ordinaria indicata nella stessa disposizione. A tutt’oggi, infatti, non esiste
ancora in Italia una legge puntuale ed organica che dia attuazione a tale importante
principio costituzionale. Ciononostante diverse sentenze della Corte di Cassazione
hanno stabilito che il diritto di asilo sancito dalla Costituzione si configura come un
diritto soggettivo (e non come mero interesse legittimo) da riconoscere al cittadino
straniero ove ricorrano le condizioni previste dalla norma costituzionale:
impedimento, nel paese di origine all’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione stessa. Tuttavia, per poter fruire di tale diritto ed in
assenza di una organica disciplina legislativa, lo straniero deve chiedere al giudice
ordinario di adottare una pronuncia dichiarativa del diritto di asilo costituzionale.
Lo status di rifugiato, invece, come anticipato, è stato disciplinato per la prima
volta dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 19513, primo
documento in cui viene regolato il sistema legale internazionale per quanto concerne
l’assistenza a coloro i quali sono costretti ad abbandonare la propria terra. A norma
dell’art. 1 di tale Convenzione rifugiato è “colui che, temendo a ragione di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello
Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia
avvalersi della protezione di detto Stato” 4.
3 La Convenzione di Ginevra del 1951 (ratificata dall’Italia nel 1954) e il Protocollo di New York del 1967
sono ritenuti i due pilastri normativi, a livello internazionale, sui diritti dei rifugiati.
Sono gli strumenti fondamentali in base ai quali gli Stati firmatari garantiscono la loro protezione alle persone
che chiedono lo status di rifugiato. Rappresentano gli strumenti essenziali da cui prende le mosse l’attività
dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con sede a Ginevra, istituita nel 1951 e
finalizzata alla protezione dei rifugiati sul piano internazionale). Il Protocollo di New York del 1967 ha
provveduto a superare le due riserve originarie della Convenzione di Ginevra: la riserva temporale (esclusione
della protezione per i fatti accaduti dopo il 1951) e quella geografica (protezione accordata ai soli rifugiati
europei).
4
In base a quando disposto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il rifugiato gode dello stesso trattamento
accordato ai cittadini italiani in materia di: libertà religiosa e istruzione religiosa; istruzione elementare; accesso
ai tribunali e assistenza giuridica; protezione della proprietà industriale, letteraria, artistica e scientifica; assistenza
7
8
In base alla definizione di rifugiato fornita dall’art. 1, ai fini della richiesta
dello status di rifugiato occorrono 4 requisiti essenziali:
1) la fuga dal proprio paese il rifugiato per essere riconosciuto tale deve
trovarsi fuori dal suo Paese di origine;
2) il fondato timore di persecuzione Il timore di persecuzione deve essere
reale, ma soprattutto deve trattarsi di persecuzione rivolta in modo diretto alla
persona che richiede rifugio;
3) Deve trattarsi di persecuzione a titolo individuale e non generalizzata la
persecuzione, temuta o subita, deve essere perseguita in ragione di uno dei motivi
indicati dallo stesso art. 1 della Convenzione;
4) L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine il
richiedente rifugio deve trovarsi nella condizione di non potere, né volere rivolgersi
alle autorità del suo paese. Questo perché il cosiddetto agente di persecuzione (chi
perseguita), può essere direttamente il governo del paese oppure altro soggetto da
questi tollerato o non contrastato.
Tra i principi basilari della Convenzione di Ginevra vi sono il divieto di
sanzionare l’ingresso ed il soggiorno irregolare dei rifugiati (art. 31) ed il c.d.
principio di non respingimento (non refoulement) secondo il quale “Nessuno Stato
espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso le frontiere di territori in
cui la sua vita o le sue libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della
sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un gruppo sociale o
delle sue opinioni politiche” (art. 33). Il divieto di non refoulement non è assoluto
pubblica (prestazioni del sistema socio-sanitario, con iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale;
pensioni di invalidità e vecchiaia; sussidi agli indigenti); legislazione del lavoro (compreso l’accesso al lavoro
dipendente) e assicurazioni sociali; carichi fiscali.
Il rifugiato riconosciuto gode di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli stranieri
regolarmente residenti in tutte le altre materie (in particolare in materia di acquisto di beni mobili e immobili, di
lavoro autonomo, di libere professioni, di istruzione di grado diverso da quella elementare, di libertà di
circolazione).
Particolari disposizioni sono inoltre previste per i rifugiati in materia di ricongiungimento familiare e di
acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonché per quanto attiene la possibilità di accedere a
speciali contributi.
Al richiedente asilo e al rifugiato, poi, non si applicano le disposizioni generali in materia di ingresso,
respingimento e espulsione.
Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato perde automaticamente tale status se chiede la
restituzione del passaporto nazionale (qualora questo sia stato trattenuto in Questura al momento della
presentazione della domanda di riconoscimento) e contestualmente dichiara di rinunciare allo status di
rifugiato.
Perde inoltre lo status lo straniero che:
chiede la restituzione del passaporto nazionale, senza contestualmente dichiarare di rinunciare allo
status di rifugiato;
ottiene dal paese di origine (e di persecuzione), in data successiva a quella del riconoscimento dello
status di rifugiato, il rilascio del passaporto nazionale;
rientra, anche per un breve periodo, nel paese di origine (e di persecuzione) con il passaporto nazionale
o con il documento di viaggio per i rifugiati, o torna a stabilirsi in tale paese.
In tali casi la perdita dello status di rifugiato non è comunque automatica, ma viene pronunciata dalla
Commissione centrale in seguito ad un procedimento analogo a quello seguito per il riconoscimento dello status.
8
9
essendo riferito ai soli soggetti che abbiano i requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
Da quanto detto, si evince abbastanza chiaramente che diversi sono i
presupposti per il riconoscimento dell’asilo allo straniero: in base alla nostra
Costituzione è la sussistenza di un impedimento nel Paese di origine all’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione stessa; in base alla
Convenzione di Ginevra, il presupposto, invece, è il fondato timore di persecuzione
(la persecuzione, in atto o temuta, deve essere riscontrata – e dimostrata – nonché
risultare diretta e personale). In altre parole, per ottenere il riconoscimento dello
status di rifugiato è necessario un requisito che non viene richiesto per
l’accertamento del diritto di asilo ossia la sussistenza di fondati motivi per ritenere
che il cittadino straniero subirebbe nel proprio paese una persecuzione. In tal senso,
per il riconoscimento del diritto di asilo è (almeno astrattamente) sufficiente
l’oggettiva mancanza delle libertà democratiche nel paese di origine. Il
riconoscimento del diritto di asilo ha importanti conseguenze in quanto chi lo
consegue, tra le altre cose, non può essere più sottoposto ad estradizione5 o ad
espulsione6.
Per quel che concerne le migrazioni a motivo “economico”, si possono
distinguere la figura dell’immigrato “regolare” (titolare di un permesso di soggiorno
rilasciato, per varie ipotesi, da parte delle autorità del paese ospitante),
dell’immigrato “irregolare” (ossia il cittadino straniero che si trova nel territorio di
uno Stato terzo contravvenendo alle normative ivi vigenti in materia di ingresso e
soggiorno ed il cui soggiorno, in definitiva, è illecito) ed il “clandestino” (chi entra
illecitamente nel paese ricevente eludendo i controlli di frontiera).
Ulteriori classificazioni possono operarsi tra migrazioni “volontarie”
(migranti) e “forzate” (asilanti o rifugiati), migrazioni come fatto eccezionale nella
vita di un individuo e migrazioni “esistenziali” che si verificano per quei gruppi di
individui che hanno con il territorio un rapporto di continuo cambiamento
(popolazioni nomadi o anche gli apolidi).
Secondo un criterio meramente temporale si può, poi, distinguere tra
migrazioni a “breve”, “medio”, “lungo termine” e “definitive”, cui possono
aggiungersi quelle periodiche di tipo stagionale. L’immigrazione temporanea è
L’estradizione è la consegna di una persona ad uno Stato straniero perché essa venga sottoposta a
giudizio (o all’esecuzione della sentenza) per comportamenti che anche in Italia vengono considerati
reati; l’art. 10.4 Cost. vieta l’estradizione dello straniero per motivi politici (tra i quali non sono però
ricompresi i reati di genocidio o contro l’umanità), mentre la Corte costituzionale ha negato che si
possa estradare per reati punti con la pena di morte nel paese richiedente.
5
L’espulsione è, invece, l’atto con cui lo Stato allontana dal proprio territorio lo straniero, inviandolo verso lo
Stato di appartenenza o verso quello di provenienza.
6
9
10
propria di coloro che, pur riconoscendo il paese di arrivo economicamente più
vantaggioso, scelgono di viverci per un periodo di tempo limitato, al solo scopo di
integrare il proprio reddito; quella definitiva è caratterizzata dal fatto che la scelta del
modello di vita, non soltanto economico, è maggiormente coinvolgente e si basa su
un progetto migratorio definito e consolidato che riesce a muovere persone
provenienti da posti anche molto lontani. Ovviamente, la distinzione tra migrazioni
temporanee e definitive è imprecisa e fluida: le prime si possono trasformare, specie
con il succedesi delle generazioni, nelle seconde; le migrazioni permanenti possono
non essere vissute come tali ed essere considerate, almeno nelle ispirazioni, solo
come temporanee.
Rispetto al parametro “spaziale”, si hanno migrazioni “interne”, quando gli
spostamenti avvengono entro i confini nazionali e migrazioni “internazionali” se i
confini vengono valicati.
In realtà, assumendo il parametro spaziale si può operare un’ulteriore
classificazione in ragione della provenienza degli immigrati; a tal proposito, si
distingue fra immigrati comunitari (se provenienti da uno degli Stati membri
dell’Unione europea) ed immigrati extracomunitari, se provenienti da uno Stato
terzo. Mentre però la prima categoria si riferisce ai cittadini di uno Stato membro
dell’Unione che, in virtù delle disposizioni dei Trattati comunitari relative alla libera
circolazione delle persone, si spostano da uno Stato all’altro per lo svolgimento di
un’attività lavorativa (godendo, peraltro, dello status della cittadinanza europea), con
l’espressione “immigrati extracomunitari” si intende fare riferimento agli individui,
cittadini di Stati non membri dell’Unione, i quali si trovano nell’area comunitaria per
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Ed è proprio su questi ultimi,
oltre che su quelli che si spostano per altri motivi (per studio, per ricongiungimento
familiare, etc), che verrà incentrato corso di “Diritto dei migranti”, in ragione della
posizione di debolezza in cui versano e per effetto della loro diversità (linguistica,
culturale e religiosa) rispetto alla società ospitante. Non bisogna, inoltre, dimenticare
che i maggiori flussi migratori provengono proprio dai c.d. paesi “terzomondisti” e,
quindi, da coloro i quali lasciano il proprio paese di origine nel perseguimento di un
obiettivo fondamentale: migliorare le proprie condizioni di vita.
3.
I push-pull factors
Prima di affrontare l’analisi più propriamente giuridica del fenomeno
migratorio e dello status complessivo degli immigrati extracomunitari, occorre
qualche ulteriore considerazione in ordine alle cause ed agli effetti delle migrazioni
ossia cioè che la letteratura specializzata individua come i “push-pull factors”.
10
11
Le cause delle migrazioni sono costituite dall’insieme dei fattori di espulsione
(push factors: complesso insieme di situazioni demografiche, economiche, sociali,
politiche e culturali strettamente legate tra di loro) da un territorio e da quelli di
attrazione (pull factors: es. migliori condizioni di vita, opportunità di lavoro e
domanda di manodopera, possibilità di esercizio dei diritti di libertà) verso un altro.
Ai fattori di espulsione, in un dato territorio, non sempre possono ricollegarsi fattori
speculari nel territorio di approdo (alla disoccupazione caratterizzante il paese di
origine non sempre corrisponde una domanda di lavoro nel paese di approdo) . Vi
sono dei casi in cui esistono soltanto “push factors” o solo “pull factors”, come
nell’ipotesi di un perseguitato che, pur di sopravvivere, fugge dal proprio Paese
senza considerare minimamente i fattori di attrazione della sua destinazione finale
(ammesso che possa decidere a priori quale sia la propria destinazione finale).
Da un punto di vista demografico, l’immigrazione produce un effetto di
invecchiamento della popolazione di partenza e di ringiovanimento in quella di
arrivo, poiché chi si sposta è solitamente gente molto giovane (si pensi, da questo
punto, di vista quale enorme fattore di ricchezza sia la presenza di immigrati in un
paese a natalità zero come l’Italia).
Per meglio inquadrare e comprendere le caratteristiche dell’immigrazione
straniera in Italia e del ritardo con cui il legislatore italiano ha tentato di regolare tale
fenomeno, è necessario ricostruire sinteticamente la storia delle migrazioni
internazionali nell’Europa post bellica. In tale contesto possono distinguersi quattro
fasi:
1)
la prima, iniziata nell’immediato dopo guerra e conclusasi
nella seconda metà degli anni Sessanta, è quella della ricostruzione e della
espansione strutturale. Le migrazioni internazionali rispondono ad una reale
domanda di lavoro dei paesi dell’Europa centro-settentrionale (Francia,
Svizzera, Belgio e Germania) e provengono soprattutto dalle aree meno
sviluppate. L’Italia partecipa a questi processi quasi esclusivamente come
paese di emigrazione anche se al suo interno si hanno forti migrazioni dalle
regioni del Sud verso le grandi città industriali del Nord;
2)
la seconda fase – iniziata dopo la metà degli anni Sessanta e
conclusasi agli inizi degli anni Ottanta – può essere definita della crisi
strutturale e della nuova divisione internazionale del lavoro. In questo
periodo, nei paesi tradizionalmente importatori di manodopera, le migrazioni
internazionali subiscono gli effetti della crisi economica che inizia a
manifestarsi nel 1967 e, a partire dal 1973-74, sono anche apertamente
contrastate dalle c.d. «politiche degli stop», tese a bloccare l’immigrazione
per motivi di lavoro. In realtà, le migrazioni non si fermano, ma si limitano a
diventare prevalentemente illegali e ad interessare Paesi in precedenza poco
toccati dal fenomeno, come l’Italia, la Spagna ed il Portogallo che diventano
11
12
dapprima paesi di transito, attraverso i quali si cerca di raggiungere il Nord ed
il Centro Europa e poi mete dirette di immigrazione. In questa fase, inoltre, si
assiste ad una progressiva sostituzione dei flussi provenienti dall’Europa
meridionale con quelli provenienti dai paesi extra-europei. L’Italia, in
particolare, diviene terra di approdo di numerosi esuli, profughi e rifugiati
politici: agli inizi degli anni ’70 cileni, argentini e uruguayani si uniscono ai
brasiliani già presenti dal precedente decennio. A questi, nella seconda metà
degli anni settanta, si aggiungono eritrei, vietnamiti, iraniani, curdi e somali;
3)
la terza fase, che può essere definita della crisi globale dei
paesi sottosviluppati e della ripresa delle economie capitalistiche, è iniziata
dai primi anni ottanta. In questo periodo, le migrazioni internazionali, già
cospicue, si espandono ulteriormente ma sono sempre meno motivate
dall’offerta di lavoro nei paesi di arrivo e dipendono sempre più dalle forze
espulsive presenti nei paesi di esodo. Iniziano a manifestarsi gli effetti
dell’esplosione demografica, del disastro politico, sociale ed economico che
investe i paesi più poveri e quelli dell’Europa orientale. Le migrazioni
cessano di essere un fenomeno esclusivamente economico per diventare un
problema sociale e, dunque, anche politico. La contestualità tra fenomeni ed
il progressivo processo di unificazione europea, pone in primissimo piano
all’inizio degli anni ’90, il problema della omogeneità delle politiche
migratorie dei diversi paesi della Comunità europea e l’esigenza di trasferire i
controlli sugli ingressi dalle frontiere nazionali alle frontiere esterne
dell’Europa.
4)
La fase attuale pare, invece, essere caratterizzata dalla
contestualità di una profonda crisi economica a livello quasi planetario. Il che
ha comportato inevitabilmente una flessione sensibilissima della domanda di
lavoro ed un aumento notevole dei tassi di disoccupazione. D’altra parte,
però, permangono forti le cause che spingono centinaia e centinaia di persone
(uomini, donne ma anche moltissimi minori non accompagnati) a tentare di
approdare (legalmente ed illegalmente) nei Paesi europei e per quel che ci
riguarda in Italia.
L’Italia non è diventata terra di immigrazione solo a causa di spinte esogene.
Altrimenti detto, l’immigrazione verso l’Italia non è stato un ripiego o una
conseguenze delle politiche migratorie degli altri Stati europei. Essa, infatti, era
cominciata come conseguenza della crescita economica, del boom degli anni
Cinquanta e Sessanta e delle importanti trasformazioni sociali e lavorative italiane.
L’aumento del reddito procapite (così come dell’istruzione e delle aspettative di vita)
ha fatto emergere i c.d. “lavori rifiutati” dagli italiani. È stato notato (Melotti), infatti,
come le trasformazioni socio-economiche in Italia abbiano determinato (e
12
13
determinano tutt’oggi) una richiesta di manodopera a basso costo, ad alto livello di
ricattabilità e ad elevata flessibilità, non sempre disponibili sul mercato interno.
Da alcune ricerche condotte nel 2001, emerge come gli immigrati nel nostro
paese trovano lavoro in imprese molto più piccole di quelle che impiegano italiani e,
soprattutto, svolgono nell’85% dei casi mansioni operaie o assimilabili. I lavori svolti
dagli immigrati extracomunitari sono stati, infatti, definiti come i lavori delle cinque
“P”: pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzati socialmente (Ambrosini)
Vi sono tutta una serie di fattori che sono all’origine della domanda di
lavoratori immigrati. Tale domanda è rimasta a lungo implicita, non istituzionalizzata
e non riconosciuta, ma non per questo essa può dirsi non essere stata incisiva nel
ridisegnare il panorama del mercato occupazionale italiano in maniera tale che
l’immigrazione è divenuta, negli ultimi venti anni, una componente imprescindibile
per il funzionamento di tutta una serie di settori e di attività economiche. Si pensi, ad
esempio, alla generalizzata presenza della piccola e media impresa operante in settori
dell’industria leggera (tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria), all’edilizia, ai
settori turistico alberghieri, alla raccolta di prodotti agricoli, al terziario urbano
(pulizia, servizi di ristorazione, manutenzione), ai lavori di cura che svolgono
soprattutto le donne immigrate e che vanno ad integrare le risorse calanti di quel
“welfare invisibile” rappresentato dal lavoro non riconosciuto e non retribuito da
sempre svolto dalle donne. A completare il quadro, il profondo squilibrio territoriale
che affianca, nel nostro paese, regioni con tassi di disoccupazione fra i più alti
dell’Unione europea e regioni o aree territoriali con situazioni di quasi piena
occupazione e con l’opposto problema di carenza di manodopera per tutta una serie
di mansioni. Mentre nel passato i deficit di forza lavoro registrate nelle regioni
sviluppate del Nord venivano compensati soprattutto attraverso le migrazioni interne,
provenienti specialmente dalle regioni del Mezzogiorno, oggi vari fattori (aumento
del livello di istruzione, vischiosità del mercato abitativo, redistribuzione interna dei
redditi), insieme ad altri più specifici fattori (opportunità di lavoro nel mondo
sommerso, accesso a frammenti di assistenza pubblica) hanno fatto diminuire gli
spostamenti interni di manodopera, specie quando si tratta di occupare posti di lavoro
operaio o simili: i salari raffrontati ai costi della vita, la scarsità delle prospettive di
carriera, le perdite in termini di relazioni sociali e qualità della vita, rendono molto
spesso poco attraente una scelta del genere.
4.
Il fenomeno migratorio in Europa ed il diritto internazionale dei diritti
umani.
Anche a seguito degli sconvolgimenti politici prodottisi a causa della caduta
del regime sovietico, l’Europa occidentale in un arco di tempo abbastanza ristretto ha
13
14
visto modificare per qualità e quantità il fenomeno migratorio 7. Al già consistente
flusso migratorio proveniente dai paesi meno sviluppati del mediterraneo e
dell’Africa, si sono aggiunti nuovi flussi provenienti dall’Est, aggravati dalle tensioni
etniche e dall’instabilità politica dei nuovi sistemi statuali, impegnati nella difficile
costruzione dei nuovi assetti democratici. Per tutti, si pensi al terribile conflitto
jugoslavo che si è consumato proprio alle porte della vecchia Europa.
Più di recente, la progressiva chiusura delle frontiere esterne da parte degli
Stati tradizionalmente definiti di immigrazione (Francia, Germania, Inghilterra,
Olanda), a causa soprattutto di una crisi economica che ha investito la grande
industria, ha portato i flussi migratori ad indirizzarsi verso paesi, come l’Italia (ma
anche la Spagna, la Grecia e il Portogallo), che a causa della scarsa dimestichezza
nell’affrontare problemi di questo tipo, non hanno sviluppato sin da subito una
coerente politica legislativa nella materia dell’immigrazione.
Gli Stati europei, malgrado le differenti condizioni economiche, sociali e
culturali si sono trovati a dover affrontare problematiche abbastanza simili. In tale
prospettiva, essi hanno anzitutto promosso un intervento comune per regolare gli
ingressi dei cittadini extracomunitari entro i rispettivi territori ed, in secondo luogo,
hanno progressivamente liberalizzato la circolazione in ogni Stato dell’Unione
europea di coloro i quali fossero residenti in modo regolare in uno degli Stati membri
dell’Unione. A tale scopo è stato sottoscritto il Trattato di Schengen, ratificato
dall’Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 il quale prevedeva l’entrata in vigore
di un visto “uniforme” di durata non superiore a tre mesi e valido per la circolazione
su tutto il territorio delle parti contraenti.
Le tematiche dell’immigrazione sono state, dunque, in parte snazionalizzate
nel senso che gli Stati membri dell’Unione europea hanno progressivamente ritenuto
opportuno armonizzare le diverse legislazioni nazionali in materia. Armonizzazione
ormai imposta a seguito della “comunitarizzazione” operata dal Trattato di
Amsterdam che ha introdotto nel Trattato CE (nel nuovo Titolo IV), una disciplina
fino a quel momento demandata esclusivamente alla competenza degli Stati ed alla
cooperazione intergovernativa: visti, asilo, immigrazione e le altre politiche
connesse con la libera circolazione delle persone, che come vedremo più
approfonditamente in seguito, sono divenute materia di competenza comunitaria.
L’art. 2 del Trattato dell’Unione europea enuclea gli obiettivi dell’Unione tra cui
quello di «conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e
giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
7
La Germania, sul finire degli anni ottanta, si è dovuta, ad esempio, misurare con l’enorme
flusso di persone provenienti dalla Germania dell’Est che, potendo beneficiare delle regole sulla
naturalizzazione (essendo di origine tedesca), hanno potuto ottenere il riconoscimento dei diritti di
cittadinanza.
14
15
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo,
l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima». Da
questi pochissimi cenni si può evincere come la normativa comunitaria e quella dei
singoli Stati europei, allorquando regolamenta la condizione dello straniero, preveda
ampie deroghe a princìpi invece ritenuti inderogabili e fondamentali per il cittadino
comunitario, delineando un sistema che taluno ha qualificato significativamente
come “Fortezza Europa” per indicare un’Europa sempre più arroccata e
impermeabile all’ingresso di cittadini provenienti da paesi poveri.
L’aspetto su cui ora dovremo soffermarci concerne la complessa problematica
del riconoscimento e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali (anche)
all’immigrato extracomunitario. Tale riconoscimento deve tenere in debito conto il
presupposto secondo cui, accanto alla cultura nazionale di cui è portatore ciascun
Stato europeo, esistono culture diverse, non necessariamente corrispondenti a quelle
prevalenti nella società di accoglienza. Da quest’ultimo punto di vista i problemi
maggiori si pongono con riferimento agli immigrati di religione islamica, ma non
solo.
La salvaguardia di queste culture, ma soprattutto dei diritti inalienabili della
persona umana, sia esso cittadino sia esso straniero, non deriva solo dal livello di
“tolleranza” rinvenibile in seno agli Stati ospitanti ma, soprattutto, da precisi
obblighi che essi hanno assunto a livello internazionale e sovranazionale.
Tra i fenomeni giuridici a livello internazionale sviluppatisi successivamente al
secondo conflitto mondiale, quello di maggior rilievo, almeno ai nostri fini, attiene
allo sviluppo ed al consolidamento del c.d. “diritto internazionale dei diritti
umani”.
Prima, però, di chiarire cosa debba intendersi per “diritto internazionale dei
diritti umani” e in che misura esso influenzi la condizione giuridica dello straniero,
pare opportuna una breve digressione sul diritto internazionale, sulle sue fonti e sulle
modalità con cui esso viene recepito dall’ordinamento costituzionale italiano. Ciò è
assolutamente necessario in quanto a norma dell’art. 10, comma 2 della nostra
Costituzione «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali».
4.a. Cenni di diritto internazionale
Al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale si situano le c.d.
consuetudini internazionali, ossia norme generali (non scritte) che vincolano tutti
gli Stati della Comunità internazionale (anche quelli che non hanno partecipato
direttamente alla loro formazione).
15
16
Una definizione di consuetudine la ritroviamo nell'art. 38.1 lett. b dello Statuto
della Corte Internazionale di Giustizia (organo giurisdizionale delle Nazioni Unite),
che riconosce tra le fonti di diritto, «la consuetudine internazionale come prova di
una pratica generale accettata come diritto».
Tale definizione ci consente di rilevare i due elementi costitutivi della
consuetudine: da un lato, l'elemento oggettivo o materiale, che consiste nel
comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati (diuturnitas o prassi),
dall'altro l'elemento soggettivo o psicologico, ossia la convinzione dell'obbligatorietà
giuridica del comportamento stesso o, in altri termini, che quella prassi corrisponda a
diritto o sia dettata da necessità sociali (opinio iuris sive necessitatis).
Si distingue dalle consuetudini, l'accordo, ossia quella fonte di diritto
internazionale di natura pattizia o particolare che può assumere indistintamente la
forma di un trattato, di una convenzione, di un patto, ecc.. Si tratta di un documento
scritto (o di più documenti tra loro connessi) che rappresenta l’incontro delle volontà
di due o più soggetti di diritto internazionale (nel primo caso si parlerà di trattati
bilaterali, nel secondo di trattati multilaterali), ciascuno dei quali si impegna a
rispettare, nei confronti di tutti gli altri, le norme che disciplinano quella particolare
materia oggetto del trattato. A differenza delle consuetudini internazionali, i trattati
vincolano i soli Stati contraenti, ossia quegli Stati che hanno deciso di sottoscrivere il
testo dell'accordo8.
Al momento della ratifica, ciascuno Stato contraente può decidere di formulare
delle riserve, ossia può dichiarare, con atto unilaterale, di escludere l'applicazione
nei propri confronti di talune clausole del trattato (c.d. riserve eccettuative) o
modificare l'effetto giuridico di alcune norme del trattato (c.d. riserve
interpretative). Attualmente, la disciplina delle riserve è prevista dall'art. 19 della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 19699, il quale dispone che “uno
Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o di
aderirvi, può formulare una riserva, a meno che:
a) la riserva non sia proibita dal trattato;
b) il trattato non disponga che possono essere formulate solo determinate
riserve, fra le quali non figura quella in questione;
c) la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato".
8
I trattati si pongono al secondo posto nella gerarchia delle fonti poiché trovano in una norma
consuetudinaria, pacta sunt servanda, il fondamento della loro obbligatorietà. Tuttavia, ciò non
significa che un accordo non possa derogare ad una consuetudine. Queste ultime, infatti, sono
caratterizzate da una certa flessibilità che ne consente la derogabilità mediante accordo. E', però,
opinione comune che esista un gruppo di norme di diritto internazionale generale inderogabili
(c.d. jus cogens). Si tratta di norme imperative accettate e riconosciute dalla Comunità internazionale
degli Stati nel loro insieme, alle quali non può essere apportata nessuna deroga e a cui non possono
apportarsi modifiche se non da una norma di diritto internazionale avente il medesimo carattere.
9
Si tratta di un “accordo di codificazione”, a cui si deve il merito di aver codificato (trascritto) norme
internazionali consuetudinarie che disciplinano il procedimento di formazione, nonché i requisiti di
validità ed efficacia dei trattati.
16
17
Dopo aver brevemente illustrato i caratteri essenziali delle principali fonti di
diritto internazionale, occorre chiedersi in che modo gli Stati danno attuazione alle
norme internazionali (siano esse consuetudinarie o pattizie).
In altri termini, quali sono i mezzi e le procedure attraverso le quali il diritto
internazionale viene introdotto nell’ordinamento statale?
In questa sede, ci limiteremo ad analizzare il procedimento di adattamento
automatico, poiché esso rappresenta la modalità attraverso cui l’ordinamento
giuridico italiano si adatta al diritto internazionale consuetudinario. L’art. 10.1 della
Costituzione italiana, infatti, dispone che “l’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ne
discende che, le norme internazionali generali avranno validità giuridica all’interno
dello Stato italiano se e finché vigono nell’ambito dell'ordinamento giuridico
internazionale.
A questo proposito, si pone la questione relativa al rango che tali norme
internazionali assumeranno nel sistema delle fonti di diritto interno. Si può ritenere
che, essendo l'adattamento previsto dalla Costituzione, esse abbiano rango di norma
costituzionale e, dunque, si pongano ad un livello superiore rispetto alla legge
ordinaria. Ne deriva che, una legge ordinaria contraria al diritto internazionale
consuetudinario sarà ritenuta costituzionalmente illegittima, in quanto in contrasto
con l’art. 10 della Costituzione.
Cosa accade nel caso di un eventuale conflitto tra norme costituzionali e norme
internazionali generali? Trattandosi di norme di pari rango, quale delle due prevarrà?
Normalmente, si ritiene che il diritto consuetudinario prevalga sulle disposizioni
costituzionali in virtù del principio di specialità. Tuttavia, tale prevalenza incontra un
limite ossia il rispetto dei valori fondamentali che ispirano la nostra Costituzione. In
altre parole, la norma internazionale generale prevale sulla norma costituzionale
purché non violi quei principi dell’ordinamento giuridico italiano che il Costituente
ha voluto considerare assolutamente imprescindibili e immodificabili (tra questi, il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana).
4.b. Il diritto internazionale dei diritti umani
La tutela dei diritti umani, tradizionalmente garantita dai singoli ordinamenti
nazionali in quanto appartenente alle materie di esclusiva competenza statale
(sottratte evidentemente ad obblighi internazionali), ha assunto, nel corso degli anni,
un ruolo sempre più rilevante all’interno delle relazioni tra Stati appartenenti alla
Comunità internazionale.
Il diritto internazionale si è configurato per lunghissimo tempo essenzialmente
come diritto interstatale, cioè costituito da norme tese a regolare prevalentemente, se
17
18
non esclusivamente, rapporti di convivenza tra Stati, all’interno del quale nessun
peso (o quasi) aveva la persona umana in quanto tale. L’individuo, infatti, era
considerato una “pertinenza” dello Stato ed i popoli erano oggetti del dominio dei
vari sovrani. Il solo modo che gli individui avevano per far cessare una violazione
dei propri diritti e libertà, in uno Stato straniero, era quello di confidare nella c.d.
“protezione diplomatica”. Si trattava di un istituto fondato sull’assoluta ed
autonoma volontà degli Stati di decidere se assicurare o meno la difesa, sul piano
internazionale, del proprio cittadino, vittima di un pregiudizio in territorio straniero.
Nella tradizionale impostazione del diritto internazionale, l’individuo godeva,
dunque, di una posizione solo riflessa e la tutela dei suoi diritti era, pur sempre,
frutto delle singole volontà statali.
Come nota uno degli studiosi più importanti di tali fenomeni, Antonio Cassese,
“il cammino che ha portato alla comparsa degli individui e dei popoli sulla scena
internazionale è stato lungo e complesso. Non si è trattato, infatti, di un avanzare
progressivo e costante nel corso del tempo, bensì di un percorso discontinuo , che ha
conosciuto fasi di stallo, inciampi e momenti di accelerazione”.
Il 6 gennaio 1941, dunque nel mezzo della più sanguinosa guerra nella storia
dell’umanità, il Presidente americano Roosevelt, in un messaggio al Congresso in cui
disegnava la nuova società mondiale che avrebbe dovuto sorgere alla fine della
guerra, sottolineava come punto fermo il rispetto “da parte di tutti nel mondo” di
quattro libertà: quella di parola e di pensiero, quella religiosa; la libertà dal bisogno,
la libertà della paura. Questo messaggio è, in qualche modo, una sintesi del concetto
che andava facendosi strada in quel periodo: per evitare il ripetersi della tragedia
provocata dal nazismo, bisognava prendere coscienza piena ed assoluta
dell’importanza del binomio pace-diritti umani ed operare, a guerra finita, perché
questo binomio divenisse il fine di tutti gli Stati e della Comunità internazionale nel
suo complesso.
È, quindi, soprattutto nel periodo successivo alla Seconda Guerra mondiale che
gli sforzi per la protezione della dignità umana hanno visto una moltiplicazione
importante. La svolta “rivoluzionaria” consiste nel fatto che gli individui, sul piano
internazionale, non vengono più considerati solo come membri di un gruppo, di una
minoranza oppure di altre categorie ma diventano oggetto di protezione in quanto
individui. La nuova veste delle norme internazionali a tutela dei diritti umani è, così,
caratterizzata dalla possibilità di regolare anche rapporti interindividuali cioè interni
alle singole realtà statali. Le materie ritenute tradizionalmente di esclusiva
competenza degli Stati diventano, ora, oggetto di diritto internazionale anche in
risposta al crescente internazionalismo che investe i rapporti economici, sociali e
culturali. In particolare, si è avvertita l’esigenza di apportare limiti e a incidere sulla
libertà dello Stato nell’ambito del proprio dominio riservato, soprattutto, con
riferimento al rispetto dei diritti umani.
18
19
È in questa prospettiva che nasce quel complesso meccanismo di protezione
internazionale dei diritti umani volto a superare il tradizionale rapporto Statosuddito, fondato sul vincolo essenziale della cittadinanza, nell’intento di garantire
una protezione diffusa nei confronti di tutti gli individui presenti sul territorio
nazionale (concetto dell’universalità dei diritti).
Una data – il 1945 – può ritenersi fondamentale nell’avvio di tale processo.
All’indomani del secondo grande conflitto mondiale, infatti, gli Stati coinvolti
cominciarono a credere che la stabilità del nuovo ordine mondiale dovesse basarsi su
un impegno per la protezione della persona umana e delle sue libertà fondamentali.
Le aberrazioni del nazismo avevano condotto ad una presa di coscienza da parte
degli Stati della necessità di rispettare e tutelare principi quali la dignità umana e la
libertà-autonomia dell’individuo. Il 1945 rappresenta, dunque, il punto di partenza
delle attività internazionali per la protezione dei diritti umani che hanno condotto alla
creazione di un sistema di norme in grado di vincolare gli Stati al rispetto di tali
diritti.
L’atto che segna una svolta epocale nella materia dei diritti dell’uomo, è lo
Statuto delle Nazione unite10 con la solenne affermazione di quei diritti che il
nazismo e la Seconda guerra mondiale avevano tragicamente violato. L’art. 1 della
Carta indica, quali fini delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, la decolonizzazione in campo economico e politico nonché
la tutela dei diritti dell’uomo («promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, di
lingua e di religione»).
Le Nazioni Unite adottarono, in particolare, nel 1948, la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (Dudu). Si tratta di una Dichiarazione di principi
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che formalmente non ha valore
vincolante ma che è assurta a principale fonte di riferimento (per ciò che riguarda il
catalogo dei diritti umani e delle libertà fondamentali) per i successivi atti
internazionali (di natura vincolante), tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e
politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, entrambi firmati a New
York il 16 dicembre 196611.
L’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) è la principale tra le organizzazioni internazionali.
Creata e retta dalla Carta di San Francisco del 26 giugno 1945, sottoscritta da 50 paesi, costituisce il
tentativo di rilanciare il progetto, fallito, della Società delle nazioni, a sua volta creta dopo la prima
guerra mondiale. I principali organi dell’Onu sono: l’Assemblea generale (composta da tutti gli Stati
membri), il Consiglio di Sicurezza (composto da 15 membri di cui 5 permanenti – Cina, Francia,
Regno Unito, Russia e Stati Uniti – e gli altri eletti per un periodo di due anni); il Consiglio
economico e sociale, la Corte Internazionale di Giustizia, il Segretariato generale, il cui titolare è
eletto dall’Assemblea su raccomandazione-proposta del Consiglio di Sicurezza per un periodo di
cinque anni.
11 Entrambi costituiscono i primi strumenti internazionali onnicomprensivi e giuridicamente vincolanti
nel campo dei diritti umani, e, insieme alla Dichiarazione universale dei diritti umani, rappresentano il
nucleo del Codice internazionale dei diritti umani.
10
19
20
La Dudu, in particolare, poggia su quattro pilastri:
- i diritti della persona (diritto all’uguaglianza, alla vita, alla libertà);
- i diritti che spettano all’individuo nei rapporti con i gruppi sociali ai quali
partecipa (diritto alla riservatezza, di sposarsi, di proprietà);
- i diritti politici (compresa la libertà di pensiero e di riunione);
- i diritti che si esercitano nel campo economico e sociale (diritto al lavoro, ad
un’equa retribuzione).
Non bisogna dimenticare, inoltre, le iniziative in ambito regionale: la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà
fondamentali (1950)12, la Convenzione americana dei diritti dell’uomo (1969), la
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981) e la Carta araba dei diritti
dell’uomo (1994).
Le disposizioni contenute nei richiamati strumenti internazionali e regionali
tesi a garantire la protezione dei diritti umani, presentano delle caratteristiche
particolari rispetto agli altri trattati internazionali.
Innanzitutto, sono connotate da un carattere obiettivo, in quanto il
riconoscimento dei diritti umani previsto da tali strumenti, in linea di massima, non è
condizionato dal c.d. principio di reciprocità. In base a tale principio, uno Stato si
impegna a mantenere un determinato comportamento obbligatorio (nei confronti di
organi o cittadini stranieri) a condizione che gli altri Stati, legati allo stesso trattato
internazionale, facciano lo stesso nei suoi confronti (ossia dei suoi organi o dei suoi
cittadini). Nel caso dei trattati che tutelano i diritti dell’uomo, il principio di
reciprocità perde importanza perché il valore da tutelare non è tanto l’interesse dello
Stato ad accertare che gli altri Stati rispettino le disposizioni del trattato, quanto la
protezione dell’individuo e dei suoi diritti fondamentali. Se l’obiettivo perseguito è
quello di garantire la realizzazione dei diritti umani, nessuno Stato può addurre a
propria giustificazione, in caso di violazione di un diritto fondamentale, il fatto che
un altro Stato si comporti nella stessa maniera, ossia in modo da non tutelare i diritti
del proprio cittadino. Strettamente connesso a quest’ultimo aspetto è il carattere di
universalità che viene attribuito alle norme in materia di diritti umani. Queste ultime
riconoscono agli individui, a prescindere dalla loro nazionalità, una serie di diritti
fondamentali. In altri termini, ciascuno Stato che diviene parte ad un trattato sui
diritti umani si autolimita rispetto al trattamento che fornisce al proprio cittadino (ed
ai residenti sul proprio territorio), dovendo garantire tali diritti a livello universale.
Per “sistema internazionale di tutela dei diritti umani” possiamo intendere,
dunque, l’insieme di convenzioni, procedure, meccanismi ed organismi di controllo
La tutela dei diritti umani in Europa si inserisce nel quadro istituzionale del Consiglio d’Europa e si
fonda sulla Convenzione europea del 1950 e sulla Carta sociale Europea (1961), strumento che
prevede la tutela dei diritti economici e sociali, di recente modificata da una Carta Riveduta entrata in
vigore nel 1999.
12
20
21
creati dalla Comunità internazionale per promuovere e proteggere i diritti umani
fondamentali.
Prendendo in esame gli strumenti suindicati, è possibile rilevare un nucleo
comune di diritti fondamentali che vengono riconosciuti a tutti gli esseri umani
indipendentemente dalla nazionalità o dallo status giuridico di cittadino, straniero o
apolide: il diritto alla vita; il diritto alla libertà e alla sicurezza personale (divieto di
arresto o detenzione arbitraria), la proibizione del genocidio, della schiavitù, del
lavoro forzato, della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti13; il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, della casa e della corrispondenza; il diritto di
non essere privato arbitrariamente dei propri beni (posseduti a titolo individuale o in
associazione con altri); il diritto di lasciare un Paese e di ritornare in quello di
origine, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione, il
diritto al riconoscimento della personalità giuridica.
Accanto a questi diritti sostanziali, ad ogni essere umano vengono
riconosciuti diritti e garanzie processuali parimenti fondamentali, quali
l’uguaglianza di fronte alla legge, il diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso ad un
equo, sollecito e pubblico processo innanzi ad un’autorità giurisdizionale
indipendente e imparziale, il diritto di difesa, il diritto al rispetto dei noti principi
nullum crimen e nulla poena sine lege.
Si tratta di diritti civili sicuramente riconosciuti anche allo straniero in quanto
diritti essenziali o fondamentali della persona umana, derogabili solo in virtù di
particolari interessi, quali la sicurezza interna e il benessere economico della
nazione, l’ordine, la sanità e la moralità pubbliche, la salvaguardia e il rispetto dei
diritti altrui.
Per quanto riguarda i diritti politici stricto sensu, il loro godimento – come
vedremo - rappresenta il nucleo centrale della qualità di cittadino. Ad ogni individuo
viene, infatti, riconosciuto il diritto di partecipare al governo del proprio Paese, di
accedere, in condizioni di eguaglianza, ai pubblici impieghi, di essere eletto o di
votare nel corso di libere elezioni (art. 21 della DU; art. 25 del PIDCP). Tuttavia, lo
Stato è sicuramente libero, sulla base del diritto internazionale generale e
convenzionale, di escludere gli stranieri dal godimento dei diritti politici o dei diritti
pubblici funzionali in quanto essi comportano una partecipazione all’organizzazione
politica ed amministrativa.
13
Il divieto di allontanare dal territorio individui che corrono il rischio di subire atti di tortura o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti nello Stato di destinazione è un divieto assoluto che non
ammette eccezioni in alcuna circostanza. Né situazioni di emergenza nazionale che minacciano lo
Stato, né particolari caratteristiche personali, possono giustificare l’allontanamento dell’individuo in
siffatte ipotesi. Per quegli Stati europei che hanno aderito alla Cedu (il cui art. 3 espressamente
prevede il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), è fatto assoluto divieto di espellere,
estradare o allontanare a qualsiasi titolo dal proprio territorio un individuo qualora esistano fondati
motivi per ritenere che l’interessato corra un pericolo reale di subire violazione dei propri diritti
fondamentali nello Stato di destinazione.
21
22
Infine, quanto ai diritti economici, sociali e culturali, occorre precisare che,
pur in presenza di un incisivo movimento convenzionale a favore della loro
affermazione, non si può sostenere che essi siano generalmente riconosciuti. Lo Stato
può, infatti, provvedere nel modo che ritiene più opportuno alle esigenze del
commercio e della cooperazione internazionale.
Può dirsi, sinteticamente, che diverse sono le categorie di diritti contemplati
dagli strumenti internazionali.
Si distinguono, ad esempio, diritti di prima (diritti civili e politici), seconda
(economici e sociali) e terza generazione (diritto alla pace ed allo sviluppo). A
seconda dell’obbligo di facere o non facere dello Stato si distingue tra: diritti civili
(come il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di coscienza e di
religione) che postulano una astensione dello Stato nei confronti dell’individuo;
diritti politici – che consentono all’individuo di partecipare alla “gestione” dello
Stato, all’amministrazione dello stesso, all’esercizio delle funzioni pubbliche che gli
sono proprie – e che per essere garantiti necessitano di una struttura istituzionale e,
quindi, un intervento dello Stato che è, però, diverso da quello richiesto per i diritti
economici, sociali e culturali (come il diritto all’istruzione, al lavoro, all’ambiente
salubre, all’assistenza sanitaria) ove la struttura economico-sociale dello Stato deve
essere particolarmente sviluppata.
I due Patti del 1966 (in vigore dal 1976), rispettivamente sui “diritti civili e
politici” e sui “diritti sociali, economici e culturali” hanno lo scopo di individuare
una soglia minima di tutela di questi diritti, ferma restando la prevalenza di norme
interne o internazionali più favorevoli alla tutela dei diritti delle persone. La scelta di
predisporre i due testi è stata essenzialmente di carattere politico. In fase di
elaborazione, invero, emerse una maggiore difficoltà per gli Stati di ammettere
vincoli di immediata osservanza in materia economica, sociale e culturale rispetto ai
diritti civili e politici; i primi, infatti, non possono essere immediatamente applicabili
ed esigibili perché richiedono un intervento attivo dello Stato (che si sostanzia nei
diritti c.d. sociali o libertà positive), mentre per i secondi l’intervento dello Stato si
limita ad assicurare uno spazio di libertà e di autonomia dei singoli (obbligo di non
ingerenza dello Stato, libertà negative).
Tra gli 80 (e più) diritti riconosciuti nella Dudu (e, poi, reiterati nei Patti), allo
straniero non viene riconosciuto l’esercizio dei diritti politici di partecipazione negli
affari pubblici, nell’accesso alle funzioni pubbliche o all’esercizio di particolari
professioni.
Se indubbiamente ad oggi moltissimo è stato fatto per costruire una rete di
protezione internazionale dei diritti dell’uomo, non altrettanto può dirsi dei
meccanismi di garanzia istituiti a livello universale. Quanti operano nel campo dei
22
23
diritti umani14 si imbattono quotidianamente in una antinomia fondamentale: sono
proprio gli Stati – ossia i principali violatori di quei diritti – gli enti cui ci si deve
rivolgere per ottenerne il rispetto (Cassese). Il modo migliore per assicurare il
rispetto dei diritti umani sarebbe quello di prevedere garanzie giudiziarie
internazionali ma in questo settore fortissime sono le resistenze degli Stati ad una
vera e propria giurisdizione internazionale. I blandi meccanismi internazionali di
controllo, così, si presentano come una soluzione di compromesso tra le opposte
esigenze di rispettare la sovranità degli Stati e di garantire, in qualche modo,
l’osservanza delle norme internazionali sulla dignità della persona umane.
L’osservanza delle disposizioni contenute nei vari testi è generalmente affidata
a “comitati”, composti da esperti che vi siedono a titolo individuale (non
rappresentano cioè nessun Stato) e che portano il nome della Convenzione che lo
istituisce. Generalmente il comitato veglia sul rispetto dei diritti convenzionalmente
garantiti attraverso tre procedure: l’esame dei rapporti periodici trasmessi dagli Stati
contraenti; l’esame di presunte violazioni di diritti da parte di uno Stato contraente su
iniziativa di un altro Stato contraente; esame di presunte violazioni di diritti da parte
di uno Stato contraente su istanza di individui o gruppi di individui. Nel complesso, i
meccanismi di controllo istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani non sono
molto efficaci ed il ciò consiste il principale difetto del sistema internazionale dei
diritti dell’uomo, ed al suo interno dei diritti dei migranti: vi è una
incapacità/impossibilità di rendere effettivi, attraverso rimedi giurisdizionali,
l’effettività dei diritti proclamati. Come già affermava N. Bobbio, infatti, «rispetto
alla tutela internazionale dei diritti dell’uomo ci troviamo oggi in una fase in cui là
dove essa sarebbe possibile non è forse del tutto necessaria e dove sarebbe necessaria
è meno possibile»; non si può porre il problema «dei diritti dell’uomo astraendolo dai
due grandi problemi del nostro tempo, che sono i problemi della guerra e della
miseria, dell’assurdo contrasto tra l’eccesso di potenza che ha creato le condizioni
per una guerra sterminatrice e l’eccesso di potenza che condanna grandi masse alla
fame. A chiunque si proponga di fare un esame spregiudicato dello sviluppo dei
diritti dell’Uomo dopo la Seconda Guerra mondiale consiglierei questo salutare
esercizio: leggere la Dichiarazione universale e poi guardarsi intorno. Sarà costretto a
riconoscere che, nonostante le anticipazioni illuminate dei filosofi, le ardite
formulazioni dei giuristi, gli sforzi dei politici di buona volontà, il cammino da
percorrere è ancora lungo. E gli parrà che la storia umana, per quanto vecchia di un
millennio, paragonata agli enormi compiti che ci spettano, sia forse appena
cominciata».
14
Soprattutto le ONG come Emergency, Medici senza Frontiere, Amnesty International, Human
Rights Wacth, la Comunità di Sant’Egidio che peraltro si adoperano anche perché i governi si
conformino alle norme internazionali poste a tutela di quei diritti.
23
24
Un discorso a parte merita invece la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu, firmata il 4
novembre 1950 ed entrata in vigore il 1954) in quanto essa costituisce,
probabilmente, la forma più evoluta del sistema internazionale dei diritti dell’uomo.
La Cedu, promossa dal Consiglio d’Europa15, diversamente dalla Dudu, è un atto che
comporta obblighi tra gli Stati che l’hanno firmata a ratificata. Aderendovi lo Stato si
obbliga al rispetto dei diritti umani elencati nella prima parte della Convenzione nei
riguardi di chiunque sia sottoposto alla propria giurisdizione. Da qui, la presenza
nella Cedu di due novità assolute che ne hanno fatto “uno strumento costituzionale
dell’ordine pubblico europeo”. La prima è l’obbligo internazionale dello Stato di
tenere una condotta conforme all’obbligo assunto: benché il riconoscimento
convenzionale dei diritti umani dipenda pur sempre dalla volontà dei singoli Stati,
liberi di ratificare o meno la Convenzione (o di recedervi), lo Stato che l’abbia
accettata ha l’obbligo di conformarsi alle regole che vi sono dettate, senza avere la
possibilità di apporvi riserve in itinere. La seconda novità assoluta consiste nella
previsione di un meccanismo di controllo della condotta dello Stato nel caso di
denuncia di eventuali violazioni della Convenzione. Altrimenti detto, il profilo più
rilevante della Convenzione è che essa assicura la garanzia dei diritti attribuendo
agli individui, una volta esaurite le vie di ricorso interne, la legittimazione
processuale a far valere la violazione di un diritto di fronte alla Corte europea dei
diritti dell’Uomo. Al diritto sostanziale corrisponde, dunque, il diritto processuale o
di azione, idoneo a farlo valere autonomamente, e direttamente, così assicurando
quella piena giustiziabilità del diritto stesso, assente in altri strumenti internazionali.
La Corte europea dei diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, è quindi un organo
giurisdizionale, con ampi poteri di accertamento dei fatti e di interpretazione del
diritto applicabile nonché con il potere di emettere pronunce giudiziarie
(giuridicamente vincolanti). Certamente la novità più importante del sistema Cedu è
che l’accertamento della Corte può essere attivato dalle vittime di presunte violazioni
della Convenzione cioè dai diretti interessati contro uno Stato o addirittura contro il
proprio Stato. Ancora più importante, almeno ai nostri fini, è che la protezione
prevista dalla Cedu non è accordata ai soli cittadini dei vari Stati che hanno ratificato
la Convenzione ma a tutti gli individui i cui diritti siano calpestati da uno di quegli
Stati.
Il Consiglio d’Europa (da non confondere con il Consiglio europeo che è una istituzione
comunitaria) è una organizzazione internazionale creata all’indomani della Seconda guerra mondiale
per favorire lo sviluppo degli ideali di democrazia e del rispetto dei diritti umani. Lo Statuto del
Consiglio d’Europa individua quale suo fine quello di «conseguire un’unione più stretta fra i suoi
membri per tutelare e realizzare gli ideali ed i princìpi che sono loro comune patrimonio e per favorire
il loro progresso economico e sociale» (art. 1, lett. a), impegnando gli stati membri ad «accettare i
princìpi dello Stato di diritto e del godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di
ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione» (art. 3).
15
24
25
4.c. Il diritto internazionale dei diritti umani in materia di stranieri e di
lavoratori migranti
Nell’ambito della normativa internazionale a tutela dei diritti umani, meritano
particolare attenzione alcuni strumenti espressamente rivolti ad una particolare
categoria di stranieri, i lavoratori migranti.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)16 ha cercato, negli anni, di
adottare strumenti a tutela dei lavoratori migranti muovendo da due finalità: tentare
una regolazione degli aspetti più delicati del flusso migratorio e introdurre strumenti
per proteggere i lavoratori migranti. Per raggiungere tali importanti obiettivi, gli
strumenti adottati dall’OIL si sono basati sulle seguenti “idee”:
possibilità di organizzare, tramite accordi con i paesi di
origine, i flussi migratori per facilitare l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro;
consapevolezza che le scelte migratorie (come quelle di
consentire o meno l’entrata) devono basarsi su una decisione
“razionale” in cui entrano sia le condizioni di vita e di lavoro dei
paesi di origine che la conoscenza del mercato del lavoro nei paesi
di approdo;
l’idea che la protezione del lavoratore migrante è legata
strettamente alla protezione della forza lavoro nazionale.
Tra i primi strumenti adottati ricordiamo la Convenzione sulla migrazione
per motivi di lavoro n. 97 del 1949 (e la Raccomandazione n. 86 del 1949) e la
Convenzione sui lavoratori migranti n. 143 del 1975 (e la Raccomandazione n.
151 del 1975).
Entrambi questi strumenti perseguono obiettivi comuni, ossia promuovere per i
migranti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai lavoratori
nazionali rispetto all’occupazione, alla professione, alla sicurezza sociale e ai diritti
L’OIL è un Istituto Specializzato delle Nazioni Unite, che opera sulla base di un “accordo di
collegamento” stipulato tra le due organizzazioni ai sensi dell’art. 57 della Carta delle Nazioni Unite.
Pur trattandosi di un istituzione autonoma rispetto all’ONU, si può dire che, entro certi limiti, ne
subisce comunque il controllo e il coordinamento. L’OIL fu istituita con i Trattati di Pace che
conclusero la prima guerra mondiale, e le sue funzioni più importanti consistono nell’emanazione di
raccomandazioni con le quali si propone di orientare l’azione e la politica degli Stati, e nella
predisposizione di progetti di convenzioni in materia di lavoro. Riguardo alla sua composizione, l’OIL
presenta una struttura distinta da quella delle altre organizzazioni internazionali, o per meglio dire sui
generis, in quanto ispirata al principio del “tripartitismo”. I suoi organi collegiali sono costituiti non
solo dai rappresentanti dei governi ma anche dai rappresentanti dei datori di lavoro e dai lavoratori di
ciascuno Stato membro. Gli organi principali dell’OIL sono la Conferenza Internazionale del Lavoro
che costituisce l’organo assembleare; il Consiglio d’Amministrazione che presenta una composizione
più ridotta, anch’essa basata sul tripartitismo; e l’Ufficio Internazionale del Lavoro, composto da
funzionari facenti capo ad un Direttore Generale, con funzioni di Segretariato.
16
25
26
sindacali; sopprimere le migrazioni clandestine e l’occupazione irregolare dei
lavoratori migranti.
In particolare, in virtù della Convenzione n. 97 (adottata nel 1949 ed entrata in
vigore il 22 gennaio 1952) ciascuno Stato si impegna ad adottare misure tese ad
assicurare al migrante in cerca di lavoro un’adeguata informazione (art. 2), ad
impedire la propaganda ingannevole relativa al fenomeno migratorio (art. 3), a
facilitargli l’ingresso e il soggiorno nel territorio del Paese di accoglienza (art. 4), a
garantire un‘adeguata assistenza medica anche ai membri della sua famiglia (art. 5),
nonché la possibilità di trasferire i propri guadagni ovunque desideri (art. 9). Inoltre,
essi si impegnano a garantire, senza discriminazione basata sulla nazionalità, la
razza, la religione o il sesso, ai migranti legalmente presenti sul territorio nazionale,
un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai lavoratori nazionali per
quanto attiene la remunerazione, la durata del lavoro, le ore straordinarie, le ferie
pagate, l’età di ammissione all’impiego, la formazione professionale, il lavoro
femminile e minorile, la partecipazione alle organizzazioni sindacali e alle
contrattazioni collettive, l’alloggio (art. 6.1 lett. a); la sicurezza sociale (contro gli
infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la maternità, la malattia, la vecchiaia e
la morte, la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro
rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di
sicurezza sociale), le tasse e i contributi lavorativi e l’accesso alla giustizia.
La Convenzione n. 143 (adottata nel 1975 ed entrata in vigore il 9 dicembre
1978) viene considerata una sorta di integrazione della precedente e della
Convenzione OIL sulla discriminazione (occupazione e professione) del 1958 (n.
111).
Particolare attenzione merita l’art. 1 della medesima il quale prevede un
obbligo generale di protezione, da parte degli Stati contraenti, dei diritti fondamentali
dell’uomo di “tutti” i lavoratori migranti. Ciò ad indicare che gli Stati devono
rispettare i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori migranti, evitando di
condizionare il loro godimento al particolare status giuridico dello straniero, ossia
all’esistenza di un vincolo di cittadinanza o di un regolare permesso di soggiorno. La
Convenzione intende assicurare quel nucleo di diritti umani fondamentali contenuti
negli strumenti internazionali a tutela della persona umana adottati in seno alle NU.
In altre parole, si vuole assicurare al lavoratore migrante, occupato illegalmente, uno
standard minimo di protezione almeno per quanto riguarda i suoi diritti
fondamentali. Inoltre, ogni Stato deve sistematicamente appurare se esistano, sul
proprio territorio, lavoratori migranti illegalmente impiegati o in condizioni
contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali
relativi, ovvero con la legislazione nazionale (art. 2), e, in tal caso, adottare tutte le
26
27
misure necessarie ed opportune al fine di sopprimere le migrazioni clandestine e
l'occupazione illegale di lavoratori migranti (art. 3).17
Le Convenzioni suddette sono largamente complementari alla Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri
delle loro famiglie (di seguito “Convenzione”), adottata nel 1990 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, pur assumendo, rispetto ad essa, una forma
sicuramente meno estesa, dettagliata e specifica18.
Si tratta dello strumento più completo finora elaborato a livello internazionale
sui diritti delle persone migranti.
La principale caratteristica della Convenzione consiste nel fatto che i diritti
umani fondamentali sono estesi a tutti i lavoratori migranti senza distinzione
alcuna19, indipendentemente dal loro status giuridico (siano essi regolari o irregolari)
(Parte terza, artt. 8-35)20, mentre diritti supplementari sono riconosciuti ai soli
lavoratori migranti regolari e ai membri delle loro famiglie (Parte quarta, artt. 3656)21.
Essa si propone di stabilire standards minimi di protezione per i lavoratori
migranti e i membri delle loro famiglie che siano universalmente riconosciuti, ai
quali gli Stati privi di standard nazionali possono uniformare la loro legislazione.
In un ambito assai più ristretto (non già “universale” quale quello della predetta
Convenzione), si colloca la Convenzione europea sullo status del lavoratore
Il Comitato di esperti dell’Oil, a giugno 2008, ha posto al Governo italiano sette quesiti a cui
rispondere entro settembre 2008: 1) Fornire informazioni dettagliate sulle strategie sviluppate dalla
Direzione nazionale dell'immigrazione e dalla polizia di frontiera per combattere l'immigrazione
irregolare; 2). Fornire informazione sulle misure prese o previste dall'accordo di Tripoli per eliminare
i flussi di irregolari di immigrati e di indicare ogni altra misura presa con altri paesi a questo fine; 3).
Fornire informazione sugli sviluppi legislativi riguardanti la protezione degli immigrati che sono stati
vittime di abusi e sfruttamento e l'istituzione di una commissione che individui le azioni di contrasto
alla violenza e allo sfruttamento verso gli immigrati; 4). Fornire informazioni sugli obiettivi e sulla
definizione del reato di immigrazione clandestina e di tenere il comitato informato degli sviluppi
legislativi su questa materia; 5). Indicare come viene garantito ai lavoratori migranti stagionali che
hanno perso il lavoro prematuramente di non essere considerati irregolari; 6). Tenere in
considerazione la possibilità di emendare il Testo unico nel prossimo futuro per introdurre misure che
permettano ai migranti che si oppongono a un decreto di espulsione di poter restare nel paese per la
durata del caso; 7). Fornire informazione sui miglioramenti delle iniziative e del loro impatto per
promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra lavoratori nazionali e immigrati, specialmente
rispetto alle donne immigrate. SI chiede, infine, all’Italia la piena applicazione della Convenzione 143
“nella legislazione e nella pratica”.
18
Ancora l’Italia non ha aderito a questa importante Convenzione (costituita da ben 93 articoli) che
ripropone tutti i diritti del codice internazione dei diritti umani con riferimento alla situazione del
lavoratore migrante e della sua famiglia.
19
Per “lavoratore migrante” si intende, ai sensi dell’art. 2.1 della Convenzione, chiunque “eserciterà,
esercita o abbia esercitato un’attività remunerata in uno Stato cui non appartiene”.
20
Si ricordi l’art. 8 sulla libertà di movimento, l’art. 22 sul divieto di espulsione collettiva, nonché
gli artt. 25-31 rispettivamente sull’obbligo di garantire al lavoratore migrante un trattamento non
meno favorevole di quello riservato al lavoratore nazionale in termini di condizioni di lavoro, sul
diritto di partecipazione sindacale, sul diritto alla sicurezza sociale, all’assistenza medica,
all’istruzione, al rispetto dell’identità culturale.
21
Tra questi, il diritto al ricongiungimento familiare (art. 44) e il divieto di espulsione (art. 56).
17
27
28
migrante (adottata dal Consiglio d’Europa il 24 novembre 1977)22, la quale però
riguarda solo quei lavoratori migranti regolari e cittadini degli Stati membri del
Consiglio d’Europa che hanno ratificato la Convenzione stessa.
5. La partecipazione dello straniero alla vita politica dello Stato di soggiorno.
Le problematiche legate ai rapporti tra lo “straniero” soggiornante sul territorio
e lo Stato ospitante hanno, come abbiamo accennato nelle premesse, origini molto
antiche.
Pur se il costituzionalismo contemporaneo e il richiamato diritto internazionale
dei diritti umani si sono incamminati lungo il riconoscimento della necessità di far
coincidere quanto più possibile i diritti del cittadino con i diritti della persona umana
(e viceversa), continua a sopravvivere (pur se in maniera differenziata a seconda dei
diversi contesti nazionali) un importante ambito di esclusione: i diritti politici.
Altrimenti detto, alcuni diritti fondamentali dell’uomo sono riconosciuti sia al
cittadino che allo straniero ma non tutti i diritti del cittadino corrispondono, pari
passo, a quelli dello straniero. Come è stato notato «tra uomo e cittadino esiste una
cicatrice: lo straniero» (Massò Garrote).
Tutte le costituzioni democratiche riconoscono i diritti umani fondamentali,
che sono i diritti universali, ma si incontrano anche diritti fondamentali che non
sono universali in quanto sono riservati dalle Costituzioni esclusivamente a quanti
rivestono lo status di cittadino. I diritti politici (ed in specie il diritto di elettorato e
passivo) costituiscono l’esempio più lampante di attribuzione esclusiva al cittadino
ma non sono certamente gli unici. Abbiamo già detto che la nozione di cittadinanza
pur essendo molto complessa può suddividersi lungo due direttrici: la cittadinanza
orizzontale che indica l’appartenenza degli individui alla medesima comunità politica
(cittadinanza-partecipazione) e la cittadinanza verticale che indica il rapporto tra
l’individuo, quale titolare di diritti e di doveri e l’autorità sovrana sul territorio
(cittadinanza-appartenenza).
Se volessimo individuare l’ossatura della cittadinanza, quali diritti e quali
doveri dovremmo sicuramente includere?
Innanzitutto, i cittadini godono del diritto di incolato ossia del diritto di
risiedere in qualunque parte del territorio dello Stato che include il diritto di
circolazione e soggiorno (art. 16, Cost.). Poi, come si anticipava, alla cittadinanza
sono legati a filo doppio i diritti politico/elettorali, espressione del più ampio diritto
alla partecipazione politica, i diritti sociali, il dovere di fedeltà (dovere anche in
Sempre nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Carta sociale europea riveduta, adottata nel 1996,
stabilisce che i “lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla
protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte” (art. 19).
22
28
29
senso giuridico di adesione ai valori della Costituzione) ed il dovere tributario
(espressione del più ampio dovere di solidarietà economica, politica e sociale cui
allude il secondo comma dell’art. 3, Cost.).
Vincolando alcuni diritti fondamentali ai soli cittadini anziché agli individui in
quanto persone, inevitabilmente la cittadinanza assume il ruolo di grande limitazione
normativa del principio di uguaglianza giuridica. L’integrazione politica, da
intendere come esercizio dei diritti politici nella sfera pubblica, costituisce senza
dubbio l'espressione piena, anche in senso simbolico e promozionale, della
cittadinanza. Certo non sono esclusivamente i diritti politici a riempire la condizione
di cittadinanza ma resta vero che la legittimazione ad esercitare tale diritti conferisce
a chi ne è titolare il diritto/potere di partecipare, in forma diretta o indiretta, ai
processi che conducono a prendere decisioni vincolanti “per sé”, “su” e “per” gli altri
nell’ambito politico di appartenenza.
Quali sono le principali ragioni di una tale esclusione?
In realtà, già a partire dal Seicento, emerse l’idea secondo cui lo straniero dovesse
essere bandito totalmente dal ricoprire incarichi pubblici in quanto si riteneva che
l’esercizio di tali funzioni presupponesse una incondizionata fedeltà verso le
istituzioni, le leggi ed i principi dello Stato (caratteristiche ritenute non
immediatamente proprie dal non cittadino).
L’idea secondo cui allo straniero dovesse essere precluso l’esercizio della
partecipazione politica rimane abbastanza ferma nel corso degli ultimi tre secoli. Alla
base di tale principio si rinviene, anzitutto, la considerazione dello straniero come
una potenziale minaccia per la sicurezza dello Stato e che impediva che questi
potesse svolgere un qualsiasi ruolo pubblico o una qualsiasi funzione pubblica. Si
temeva, inoltre, che gli Stati di provenienza potessero influenzare l’operato dei propri
cittadini a tutto scapito dello Stato ospitante.
Prima di affrontare ed analizzare, pur se brevemente, il contenuto della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione dello straniero alla vita
pubblica locale (meglio nota come Convenzione di Strasburgo) che rimane l’atto
internazionale più importante in questa materia, occorre svolgere qualche ulteriore
considerazione.
Accanto alle libertà strettamente politiche, generalmente, nei testi costituzionali
si rinvengono una serie di diritti che possono essere considerati come strumentali
rispetto alla partecipazione politica. Ne costituiscono esempi la libertà di opinione e
di manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione. Tali posizioni giuridiche
soggettive sono così intimamente legate all’esercizio della partecipazione politica
che laddove il loro esercizio fosse ostacolato, risulterebbe minata sensibilmente
minata la possibilità stessa di esercizio dei diritti politici. Sebbene in molti testi
costituzionali le summenzionate libertà vengono riferite alla persona umana in
generale, esistono costituzioni in cui esse sono direttamente imputate ai soli cittadini.
29
30
Inoltre, si è visto che gli atti internazionali di natura convenzionale, pur avendo
esteso a tutti gli individui le garanzie di tali diritti, hanno previsto anche clausole di
salvaguardia con particolare riferimento alla partecipazione politica dello straniero.
Con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 ed
al Patto sui diritti civili e politici del 1966, occorre tenere presente che tali atti, pur
riservando ai soli “nazionali” il diritto di prendere parte alla vita politica del proprio
paese, riconoscono espressamente a favore degli individui in quanto tali le libertà di
riunione (art. 19), di associazione (art. 22), di espressione e di manifestazione del
pensiero (artt. 19 e 20). Tuttavia, tali situazioni di vantaggio possono essere limitate
a causa delle clausole limitative generali previste negli atti stessi (ordine pubblico,
sicurezza nazionale). Ne consegue che, malgrado la precisazione dell’art. 2, co. 1 del
Patto (che prevede il divieto di discriminazione nel riconoscimento dei predetti diritti
in ragione, tra l’altro, della razza e dell’origine nazionale), vi è stato chi ha intravisto
in queste clausole di salvaguardia uno strumento per limitare l’esercizio di tali libertà
con riferimento agli stranieri, perlomeno laddove esse fossero esercitate in ambito
politico.
Anche la Cedu, dopo aver riconosciuto all’individuo la libertà di espressione,
riunione ed associazione ed aver inibito agli Stati di operare discriminazioni in
ragione della razza o dell’origine nazionale, stabilisce che le disposizioni contenenti
tali diritti non possono tuttavia essere interpretate nel senso di vietare alle Alte Parti
Contraenti l’imposizione di restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Dall’insieme degli strumenti richiamati emerge la volontà degli Stati contraenti
di riservare ai soli cittadini l’esercizio delle funzioni pubbliche e dei diritti politici e
ciò in ragione del fattore “nazionale” che starebbe alla base di essi. La funzione di
partecipazione all’amministrazione della cosa pubblica (diritto di petizione, di
iniziativa legislativa, referendum, diritto elettorale attivo e passivo), secondo questa
lettura, non può che essere riservata ai soli cittadini in quanto essa costituisce la
quintessenza della sovranità dello Stato.
Quest’ultima, come recita l’art. 1 della nostra Costituzione, appartiene al
popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione stessa. Il
concetto di popolo, che sta a designare la comunità di tutti coloro ai quali
l’ordinamento giuridico assegna lo status di cittadino, assume in tal modo una
precisa valenza giuridica. La tradizionale preferenza accordata al criterio della
discendenza per determinare la cittadinanza di un individuo (c.d. ius sanguinis)
dipende proprio dalla volontà di tutelare la coesione etnico-culturale di una nazione;
mentre riconoscere la titolarità della cittadinanza, tendenzialmente, a coloro i quali
nascono sul territorio dello Stato o vi risiedono per un periodo di tempo
ragionevolmente lungo (c.d. ius soli), risponde ad una vocazione a fondare la
coesione di una comunità su valori condivisi e ad accogliere e includere nel corpo
30
31
sociale anche coloro che immigrano dall’estero23 e scelgono “elettivamente” l’Italia
come ‘luogo’ in cui vivere.
Dallo status di cittadino/a deriva, dunque, una serie di situazioni giuridiche
attive e passive che valgono a porre, in maniera esclusiva, i cittadini in relazione con
l’apparato dello Stato laddove, invece, i non cittadini sono, di regola, esclusi dal
godimento di alcuni diritti (tipicamente quelli aventi natura politica) e non sottoposti
all’osservanza di alcuni doveri (aventi anch’essi natura latamente politica). È proprio
da questo legame tra il godimento dei diritti e l’assunzione di doveri – primo fra tutti
il dovere, ex art. 54 Cost., di fedeltà alla Repubblica, insuscettibile per sua natura di
gravare sugli stranieri, ma più in generale gli obblighi di solidarietà politica di cui
all’art. 2 Cost. – che, tradizionalmente, si fa discendere l’esclusione degli stranieri
dal godimento dei diritti politici, in quanto diritti di partecipazione alla
formazione della volontà pubblica24.
Se si assumono come date queste premesse, ne discende che, poiché
l’assolvimento dei doveri inderogabili costituisce il logico corollario della
23
In Italia, è la legge 5 febbraio 1992, n. 91 a stabilire le norme che disciplinano il modo come si
acquista, si perde e si riacquista la cittadinanza. La legge sulla cittadinanza del 1992 ha modificato la
vecchia legge sulla cittadinanza che risaliva addirittura al 1912 e che conteneva tutta una serie di
disposizioni fortemente discriminatorie specie nei riguardi della donna. La riforma del 1992 avrebbe
potuto rappresentare una occasione importante per mandare un messaggio di inclusione ed, invece,
così non è stato. Anzi, per taluni aspetti, ha contribuito a rendere maggiormente difficile l’integrazione
delle persone immigrate aumentando da cinque a dieci anni il periodo necessario per ottenere la
cittadinanza. In termini generali, può dirsi che la legge del ’92 ha introdotto norme più severe e
restrittive rispetto a quelle del 1912 per quanto riguarda l’applicazione dello ius soli consentendo
l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri solo in presenza del requisito della
residenza continuativa nel paese dal momento della nascita fino alla maggiore età. Ciò premesso,
secondo la legge in esame è cittadino italiano:
a) per nascita, il figlio di un cittadino italiano, madre o padre (ius sanguinis), ed anche chi nasce nel
territorio della Repubblica da genitori ignoti, apolidi o che, comunque, non possano trasmettere la
cittadinanza di un altro paese (applicazione residuale dello ius soli);
b) per estensione o trasmissione da un coniuge che è cittadino ad uno che non lo è (residenza legale
in Italia per un periodo di almeno due anni ma il termine viene ridotto a metà in presenza di figli
anche adottivi; dopo tre anni se residente all’estero; matrimonio valido, mancanza di condanne penali,
assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale), ovvero da genitori italiani a figli adottivi o
riconosciuti dopo la nascita (c.d. iuris communicatio), in ragione del valore costituzione dell’unità
familiare;
c) per concessione in presenza di una serie di requisiti (straniero legalmente residente da almeno 10
anni; cittadino dell’Unione europea da almeno 4 anni; discendente straniero di chi è stato cittadino
italiano residente in Italia da 3 anni; stranieri nati sul territorio italiano dopo tre anni di residenza;
cinque anni per gli apolidi ed i rifugiati così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini
italiani). In tali casi, la cittadinanza è attribuita su domanda, tramite Decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previo giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi. Ricordiamo che a norma dell’art. 22 Cost., nessun cittadino può essere privato
della cittadinanza per motivi politici. L’assimilazione della cittadinanza, alla capacità giuridica ed al
nome ne tratteggia la natura di garanzia minima indispensabile della libertà/dignità del singolo nei
confronti dei pubblici poteri.
24
L’art. 48, co. 1 Cost., dispone che il diritto di elettorato attivo e passivo appartiene a tutti «i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età»; l’art. 52, co. 1 dispone che «la difesa
della Patria è sacro dovere dei cittadini» e l’art. 54, co. 1 aggiunge che «tutti i cittadini hanno il dovere
di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi».
31
32
rivendicazione dei diritti, la naturale esenzione dei non cittadini dall’assolvimento
delle prestazioni di solidarietà politica e sociale indurrebbe ad escludere costoro
anche dal godimento dei correlativi diritti.
Questa concezione tradizionale (per non dire obsoleta) della cittadinanza e del
legame inscindibile tra status di cittadino, come appartenente allo Stato, e piena
partecipazione alla gestione della “cosa pubblica”, è stata fatta propria dai diversi
strumenti ed atti internazionali prima richiamati. Dal loro (pur se sommario) esame, è
emerso come gli stranieri, risultano titolari, piuttosto, dei soli diritti alla
manifestazione del pensiero, informazione, riunione ed associazione (e talora
neanche in modo pieno godendo gli Stati di ampi margini di discrezionalità
nell’apporre limitazioni a tali fondamentali declinazioni del principio che vorrebbe la
dignità umana come principio fondante degli assetti statuali democratici).
L’unica possibilità che si è riscontrata ai fini di un riconoscimento della
partecipazione alla vita pubblica a favore degli stranieri, ha avuto come esclusivo
riferimento l’ambito delle autonomie territoriali e, forse, questo è da considerare il
sintomo di maturata consapevolezza che l’esercizio delle libertà pubbliche, almeno
sul versante più propriamente locale, non intacca quel principio della preminenza
della sovranità statale che vorrebbe estesi ai soli cittadini l’esercizio di certi diritti.
A questo proposito è decisamente da richiamare la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,
aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa il 5 febbraio 1992 (Nota
come “Convenzione di Strasburgo”), in quanto costituisce il riconoscimento più
concreto della presenza di cittadini extra comunitari ed una importante apertura verso
il possibile riconoscimento di una nuova accezione di cittadinanza che, almeno,
consenta agli “stranieri” di partecipare alla vita della comunità politica locale. La
Convenzione è entrata in vigore, per gli Stati che l’hanno ratificata (ad oggi solo otto
Stati mentre altri 5 l’hanno firmata ma non ratificata) il 1° maggio 1997.
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, con tale Convenzione, hanno creduto
ragionevole affiancare agli accordi internazionali finalizzati al controllo delle
frontiere europee da immigrazioni clandestine disposizioni dirette a facilitare
l’integrazione degli stranieri regolarmente presenti nel territorio. Le disposizioni
della Convenzione riconoscono a favore dello straniero extracomunitario il diritto di
partecipare alla vita pubblica locale, ossia a quella dimensione entro cui gli stranieri
che soggiornano regolarmente entrano in più diretto contatto. Ciò nella
considerazione che – come è dato leggere nel Preambolo della Convenzione stessa –
«i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri
dei cittadini», così come nella consapevolezza «della partecipazione attiva dei
residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della collettività locale», nonché nella
convinzione «della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale,
in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali».
32
33
La Convenzione di Strasburgo è suddivisa in tre Capitoli, dedicati,
rispettivamente:
1) alla libertà di espressione, di riunione e di associazione (capitolo a): tale
diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza l’interferenza delle Autorità
pubbliche; il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di
associazione, compreso il diritto di fondare sindacati insieme ad altri, e di
affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il
diritto alla libertà di associazione implica il diritto, per i residenti stranieri,
di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di
conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei
loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale,
nonché il diritto di aderire ad ogni associazione;
2) alla creazione di organi consultivi volti a rappresentare i residenti a
livello locale (Capitolo b): le parti contraenti si impegnano a vigilare
affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività
locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di
residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni
appropriate a livello istituzionale per provvedere ai collegamenti tra esse ed
i predetti residenti, fornire una istanza per il dibattito e la formulazione
delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri
sui temi della vita pubblica locale che li concernono da vicino, comprese le
attività e le responsabilità della collettività locale interessata, promuovere la
loro integrazione generale nella vita della collettività; incoraggiare ed
agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l’attuazione di
altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata
rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel
proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri (inchieste
pubbliche, procedure di pianificazione, partecipazioni ad organi, comitati
formati da stranieri);
3) al diritto di voto alle elezioni locali (Capitolo C): ciascuna Parte si
impegna a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad
ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse
condizioni di quelle prescritte per i cittadini e inoltre abbia da almeno
cinque anni la residenza «legale ed abituale» nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo strutturale, la Convenzione, nel ribadire all’art. 9, co. 5 che le
disposizioni che disciplinano tale materia non possono in ogni caso essere
interpretate nel senso di «limitare o pregiudicare i diritti che potrebbero essere
riconosciuti in conformità di altre disposizioni o trattati di cui uno Stato è parte»,
conferma la tecnica già adottata da numerosi trattati internazionali in materia di
33
34
diritti fondamentali (clausola della posizione più favorevole). Gli Stati sono
pienamente liberi di allargare lo spettro della disciplina dei diritti oggetto della
Convenzione ad altre situazioni giuridiche soggettive in quanto la stessa si limita a
predisporre una base minima.
Riguardo ai destinatari previsti dalla Convenzione, risulta chiaro che la figura è
quella dello straniero regolarmente soggiornante residente nel territorio, ossia titolare
di tutti i documenti di soggiorno in corso di validità e che sia iscritto nei registri
anagrafici del comune di residenza.
Una prima conclusione che può trarsi dal contenuto della Convenzione è che
essa rappresenta sicuramente una novità in quanto mira ad assicurare allo straniero
regolarmente presente l’esercizio effettivo di alcune libertà funzionalmente collegate
alla partecipazione politica. Con riferimento poi alla partecipazione politica, la
Convenzione contiene delle affermazioni di massima che lasciano agli Stati firmatari
la più ampia libertà nella regolamentazione dei singoli istituti, senza precludere la
successiva disciplina di materie non inizialmente ricomprese nello strumento di
ratifica. Il riconoscimento agli Stati di tale ampia discrezionalità di scelta in ordine
agli strumenti da scegliere per favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
politica, è stato concesso anche in ragione della varietà di situazioni che possono
crearsi non solo tra Stato e Stato, ma anche all’interno degli enti territoriali di uno
stesso Stato. Altrimenti detto, gli Stati si sono resi conto che sarebbe stato complicato
concepire un modello uniforme di partecipazione dello straniero alla vita pubblica
locale, valido per tutti gli ordinamenti. Ciò principalmente in ragione del fatto che
molto diversi sono gli strumenti di partecipazione esistenti nelle realtà locali (non
dappertutto sono previsti i referendum locali, le competenze dei minori enti
territoriali non sono uguali, le petizioni ed il diritto di iniziativa si differenziano
notevolmente da ordinamento a ordinamento).
L’Italia è stata tra i primi paesi a firmare ed a ratificare la Convenzione di
Strasburgo con la legge n. 203/1994, ma avvalendosi della facoltà concessa dall’art.
1, comma 2 della Convenzione, ha limitato la ratifica soltanto ai primi due capitoli
(A e B), giustificando la scelta di non ratificare il Capitolo C (apponendovi una
riserva eccettuativa) sulla base della circostanza che la Costituzione assegna la
titolarità del diritto di voto ai soli cittadini. A tale ultimo proposito e sulla necessità
di una riforma costituzionale onde consentire anche agli stranieri regolarmente
soggiornanti di esercitare il diritto di voto alle elezioni amministrative, si registra una
diversità di posizioni in dottrina. Valerio Onida, ad esempio, ritiene che la
Costituzione garantisce sì il diritto di voto ai cittadini ma non esclude la sua
estensione ai residenti non cittadini.
Con modalità diverse, inoltre, il diritto di voto ai non cittadini è stato
riconosciuto in Danimarca, Belgio, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia, Estonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Conservano un
34
35
impianto assai più tradizionale, insieme all’Italia, anche la Francia, la Germania e la
Grecia.
5. Diritti universali e sovranità statale
La disciplina della condizione giuridica dello straniero rivela le difficoltà
intrinseche della convivenza tra diritti universali della persona umana e prerogative
di una sovranità statuale che vuole difendere il proprio territorio nonché la sicurezza
ed il benessere dei suoi cittadini.
Diritti universali della persona umana e sovranità rappresentano in tal senso
due orizzonti che se assolutizzati finiscono con l’essere inconciliabili. Se si prendono
“sul serio” i diritti della persona umana, garantendoli a chiunque, ovunque si trovi,
presupponendo una libertà di circolazione e soggiorno transnazionali, si entra in una
ottica di un mondo senza confini in cui lo Stato nazione (i cui indefettibili elementi
sono appunto la sovranità, il popolo ed il territorio) se proprio non muore, vivrebbe
in una sorta di coma vegetativo avendo perso i suoi elementi essenziali: i suoi
cittadini ed il controllo del proprio territorio. Se, viceversa, a prevalere ed anzi a
vincere sono le esigenze di uno Stato fortezza, inevitabilmente i diritti della persona
umana risultano essere coincidenti con i diritti dei cittadini o al più di coloro i quali
divengono sempre più simili ai propri cittadini.
Rimane evidente che teoricamente le due prospettive ove assolutizzate, si
escludono reciprocamente. Ma molto spesso ciò che è teoricamente inconciliabile,
nella pratica deve essere conciliato tanto che a prevalere sono soluzioni di
compromesso.
Ma cosa implica una soluzione di compromesso?
Che i diritti universali, a scapito dell’aggettivo, in tanto valgono in quanto vi
sia un determinato luogo (territorio) in cui possano essere esercitati (con la sola
accezione di asilanti e rifugiati). In altre parole, con la positivizzazione, dei diritti
fondamentali (si veda l’art. 13 della Costituzione italiana o l’art. 9 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici), quando cioè i vecchi diritti naturali vengono
consacrati dalle Costituzioni come universali, acquistano in concretezza ma perdono
in universalità, non solo più diritti dell’uomo, ma diritti del cittadino di questo o
quello Stato particolare (Bobbio); questo perché il loro universo giuridico positivo
coincide con quello dell’ordinamento interno dello Stato, in maniera tale che i diritti
dell’uomo finiscono per appiattirsi sui diritti del cittadino e l’universalità dei diritti
umani si stempera in una universalità parziale, viziata dal suo stampo statalistico, e
quindi dai meccanismi di esclusione da esso innestati nei riguardi dei non cittadini
(Ferrajoli).
In secondo luogo, il bilanciamento tra universalità dei diritti e prerogative della
sovranità implica che non per tutti i diritti universali la presenza sul territorio è
35
36
condizione necessaria e sufficiente per poterne godere. Alcuni diritti sono fruibili dai
soli cittadini, quali i diritti politici ma anche la libertà di circolazione e di soggiorno
all’interno del territorio dello Stato che per gli “stranieri” è assoggettata ad una
autorizzazione all’ingresso nel territorio stesso. Proprio con riferimento a
quest’ultima ipotesi può parlarsi di diritti temporanei e sub condicione proprio in
quanto subordinati a scelte discrezionali.
Queste premesse inducono ad affrontare la questione della condizione giuridica
dello straniero, da un lato, distinguendo tra straniero-persona umana, individuo
richiedente asilo, soggetto individuale presente regolarmente o irregolarmente e,
dall’altro, sottolineando la centralità delle norme che regolano l’ingresso e
l’espulsione dal territorio come termometro del tipo di bilanciamento compiuto e
chiave di lettura nel processo di inclusione/esclusione dal godimento dei diritti.
Come ha giustamente sottolineato Rescigno «il problema principale e più
drammatico non è quello del godimento dei diritti delle persone una volta entrate, ma
proprio quello di entrare e rimanere nel territorio di uno Stato». Ovvio che una
politica dell’immigrazione che preveda ampie possibilità di ingresso per
ricongiungimento familiare o ricerca di lavoro o di studio, sarà sintomatica di un
certo modo di considerare il principio della effettività dei diritti umani; viceversa,
una politica orientata piattamente alla volontà di subordinare l’ingresso a presunte
curve di offerta di lavoro, corrisponde agli interessi dello Stato fortezza.
Come vedremo, se il legislatore italiano del 1998 (anche in ottemperanza dei
vincoli derivanti dall’Accordo di Schengen) ha tentato un bilanciamento tra “diritti
per chi entra, ma rigidi controlli sull’ingresso”, la legislazione del 2002 (la legge
Bossi-Fini) e quella del 2009 (il c.d. “pacchetto sicurezza”, legge 15 luglio 2009, n.
94 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) hanno progressivamente e
vigorosamente sterzato nella direzione di un utilizzo strumentale dello straniero
come mera forza lavoro, come soggetto la cui unica “merce di scambio” rimane la
prestazione del proprio lavoro, divenendo sempre più recessiva la qualità di persona
umana del non cittadino. Certamente vi sono alcuni diritti che, proprio in quanto
riconosciuti dalla Costituzione come dotazione giuridica inalienabile di ogni singola
persona umana25, neanche il legislatore più restrittivo potrebbe negare senza
“allertare” tutti gli organismi internazionali (Onu, Acnur, Oil, Ue, per citarne alcuni).
E questo anche perché, come si è detto prima, tali diritti sono previsti dal c.d. “diritto
internazionale dei diritti umani” ai quali la legge che disciplina la condizione
giuridica degli stranieri deve conformarsi.
Un ultimo aspetto merita di essere sottolineato, prima di addentrarci nello
studio della disciplina dello straniero nell’ordinamento italiano.
25
E sottratti anche al potere di revisione costituzionale in quanto principi supremi su cui si regge
l’intero ordinamento.
36
37
La “punizione” tipica riservata allo straniero per aver violato le norme
dell’ordinamento giuridico è l’espulsione (una riedizione dell’antico istituto
dell’esilio). Nella attuale fase di globalizzazione, le legislazioni nazionali si
uniformano verso l’esclusione dei non cittadini, predisponendo meccanismi di
controllo transnazionali, stipulando accordi con i governi dei paesi di provenienza
per impedire la partenza dei migranti o facilitarne la riammissione, stabilendo regole
di competenza per le domande di asilo al fine di impedirne la reiterazione in altri
paesi e così via. Gli immigrati espulsi da uno dei paesi dell’Unione europea, o
«segnalati» dalla polizia di uno degli Stati membri, vengono inseriti in una banca dati
comune per assicurare l’effettività del divieto di reingresso in tutti gli altri stati
dell’Unione. Cosicché l’espulsione si trasforma in un meccanismo transnazionale che
può arrivare a precludere l’accesso legale a una parte considerevole del mondo
occidentale e sviluppato. Le conseguenze “umane” di tale meccanismo, si crede, non
necessitino di essere commentate ma rimangono nella disponibilità della coscienza di
ognuno dei “cittadini” e delle “cittadine” degli Stati “democratici”.
37