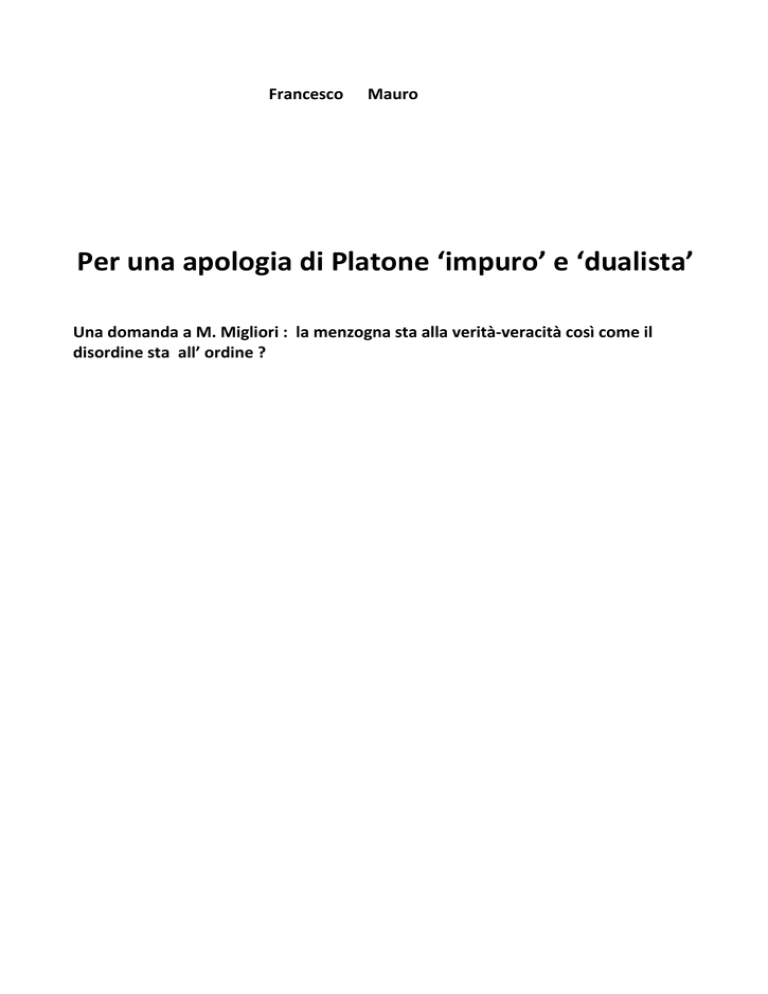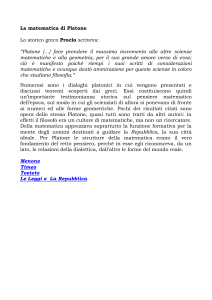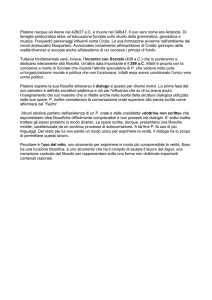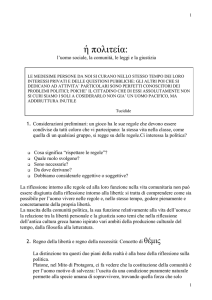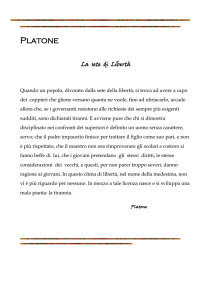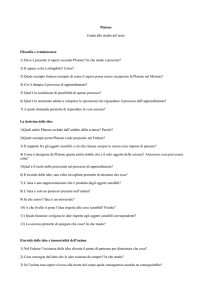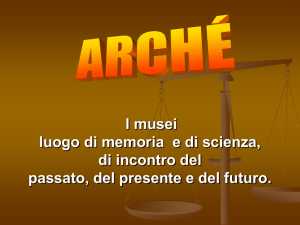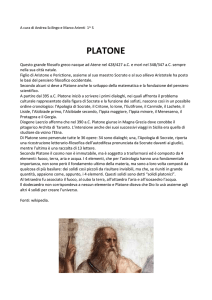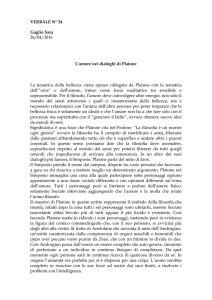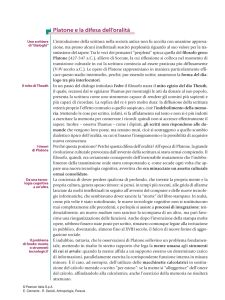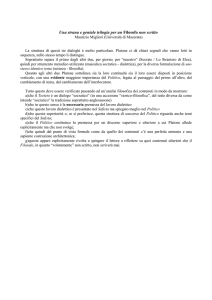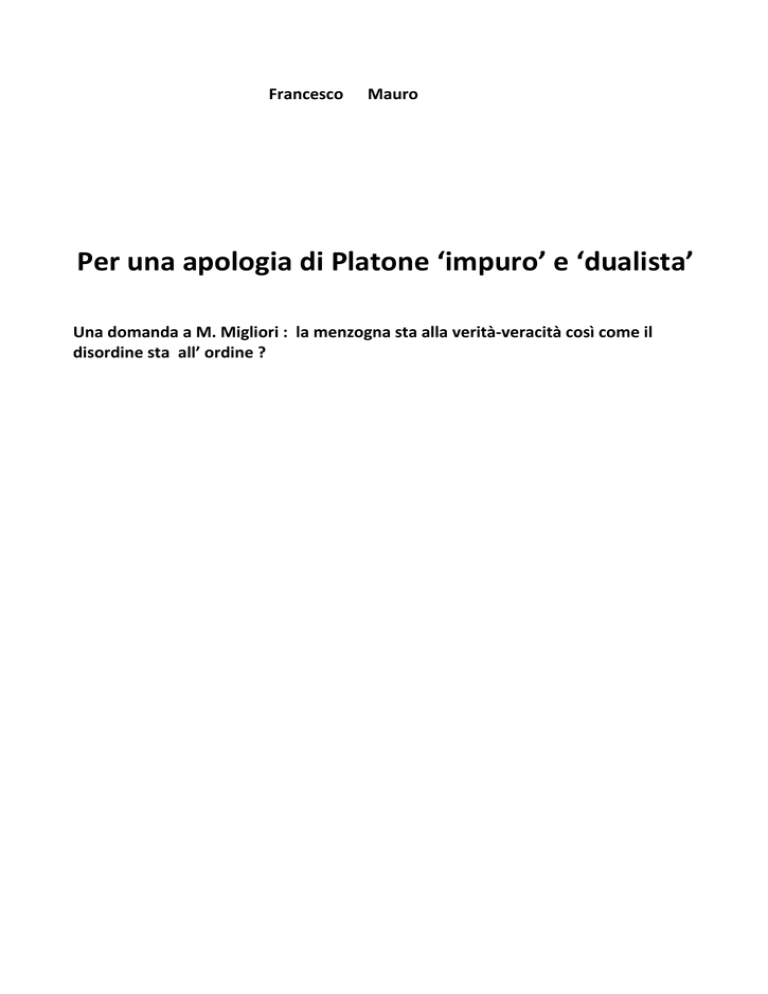
Francesco
Mauro
Per una apologia di Platone ‘impuro’ e ‘dualista’
Una domanda a M. Migliori : la menzogna sta alla verità-veracità così come il
disordine sta all’ ordine ?
1.Introduzione : un matto mondo testuale per lettori-folli.
Un libro mastodontico si aggira nelle Accademie. Inquieta non solo per la sua mole
di 1484 pagine;1 dichiaratamente , infatti, esso si presenta come il prodotto di un
pluriennale lavoro culturale ,mosso da “folle ambizione”2, di “forma e dimensione
folle e per un impresa folle” 3 – scommettendo, -io proseguo ed aggiungo- su
possibili folli-lettori interessati ad una “follia compiuta”4 .
Naturalmente esso rivendica per sé una intenzione, una proprietà, una qualità : il
suo voler pretendere, non tanto di convincere, ma di voler giustamente essere
riconosciuto quale risultato – come in ogni vera follia- di una lucida logica.
Migliori, nelle sue applicazioni interpretative, assume come basilare punto di
partenza il fermo ancoraggio a ‘fatti’ e, come regola massima di condotta della sua
lettura, la decisione di fedeltà estrema a questi fatti; e qui essi sono i testi e tutti i
testi che la tradizione e la scienza filologica attribuiscono a Platone.
Un libro, dunque, che non può lasciare indifferenti esperti e lettori comuni, e che
dovrebbe poter essere letto da tutti.
E, tuttavia, mi domando :
perché un cittadino del nostro mondo, giornalmente già pieno di pazzie, dovrebbe
ancora interessarsi a Platone, morto e sepolto da duemilecinquecento anni, e
perchè con lui, attraverso i suoi scritti, dovrebbbe prendersi ancora cura della
filosofia, per la cui definitiva liquidazione si sta da tempo lavorando anche con la
collaborazione di tutti quei moderni professori che hanno programmaticamente
deciso e creduto di poter fare a meno di lui ?
La domanda è più che legittima ed essa ha dalla parte sua la forza dell’urgenza dei
gravi ed irrisolti problemi del quotidiano che affliggono tanta gente- vecchi e
giovani, uomini e donne-, alle prese con bisogni elementari di vita , di lavoro, di
cultura, di educazione ai valori di una comunità in pace con se stessa e con la natura.
E’ mia convinzione che rispetto a questa nostra condizione storica, socio-culturale e
socio-economica, Platone , la sua eredità documentale con la sua millenaria
influenza sulla civiltà dell’ Occidente, abbiano ancora qualcosa di fondamentale da
dire a noi pur preoccupati di quel ‘primum’ che è il vivere.
M. Migliori, Disordine Ordinato. La filosofia della dialettica di Platone, Morcelliana Brescia 2013
Ib. p. 7
3
Ib, p. 8
4
Ib.. 1251
1
2
Alla dignità di questo vivere è, infatti, coessenziale il saper prendere coscienza
delle ragioni della “cattiveria dell’oggi”5 . Questo decidersi ad aprire gli occhi per
vedere dove siamo finiti come moderni e post-moderni è l’indispensabile esperienza
dell’inizio di una lunga marcia per combatterla e liberarci da questi tristi giorni.
Con questo spirito ho voluto intraprendere la fatica di una ripetuta peregrinazione
nei sentieri di quella ‘ingens silva’ che è l’opera recente di M. Migliori; e con lo
stesso spirito metto a disposizione dei miei lettori quanto ho trovato di nuovo, di
utile, ma anche di aggravamento problematico, disorientante ed in non piccola
misura sconcertante in questi percorsi ermeneutici.
Rispetto a questo libro preciso subito la mia posizione in questi termini:
A) esso rappresenta una delle più documentate, più aperte, più aggiornate ed
avanzate ricerche su tutto il Platone scritto; e,pertanto, si pone come
ineludibile , stimolante ed estremamente istruttivo terreno di studio e di
confronto sia in vista di una ricomprensione, rimeditazione, riscoperta dei
pensieri di Platone,e sia per una riflessione sulla natura cognitivo-linguistica di
quella attività che ancora oggi chiamiamo |filosofia| - o se piace- |filosofie|;
B) M. Migliori dichiara di condividere il nucleo metodologico di quel modello
ermeneutico che va sotto l’etichetta |Scuola di Tubinga e di Milano|6; la sua tesi
fondamentale e finale su un Platone che non avrebbe definito sue proprie dottrine
filosofiche e che avrebbe solo allestito ripetuti, complessi e raffinati esercizi
introduttivi al saper filosofare, è una assunzione storico-ermeneutica-teoretica che –
di fatto ed al di là della stessa intenzione dell’autore- sotto un certo aspetto mette
in crisi il modello ermeneutico, al quale l’autore pur dichiara di conformarsi.
Migliori,infatti, nelle sue applicazioni non si limita a procedere secondo la
impostazione del caposcuola italiano, Giovanni Reale ; impostazione che consiste
nel far valere tutto il contenuto delle dottrina orale dei Principi soprattutto come
codice di decodifica dei valori di teoria presenti nel testo scritto e velati dalla forma
narrativo-drammatizzante degli stessi.
Migliori, pur ammettendo come fatto storico e culturale ciò che viene denominato
|Platone Orale| e pur riconoscendo l’influsso attraene e finalizzante della dottrina
dei Principi7 dentro il |Platone Scritto|, non ritiene che il fulcro di quella dottrina,
cioè il principio Uno-Bene, sia quello che funzioni come filo conduttore ed
ordinatore della pluralità dei discorsi platonici, che si svolgerebbero,invece,
dall’inzio alla fine,invece, all’insegna di una relazione fondamentale di opposizione
polare e non mediabile tra i fattori in gioco, riassunti in generale nella coppia
Disordine-Ordine.
5
6
7
Florenskji , La colonna ed il fondamento., Mimesis, p. 32.
G. Reale
Kramer
P.
Ma comunque con Reale Migliori condivide il risultato per essi centrale della ricerca
di Szlezàk8- altro esponente di spicco della Scuola di Tubinga- : sarebbe dimostrabile
che esiste una dinamica concettuale ascensiva costruttivamente intrinseca alla
scrittura platonica, -dentro ciascun dialogo e nei rapporti tra dialoghi, e che
sfocierebbe costantemente in ciascuno di essi in un ascensivo effetto finale di
inconcluso, di mancata definitiva soluzione della catena dei problemi dichiarati.
In virtù di questo fondamentale guadagno storico-ermeneutico ogni opera
manterrebbe in ogni caso una natura sistematica, insieme “chiusa” ed “aperta”.
Ancora con Reale Migliori ribadisce che l’insieme della ricerca platonica scritta apre
ed introduce non ad una esperienza iniziatica , esoterica, segreta , ma a ciò che
Reale denomina “oralità dialettica”, dove l’esperienza di un rapporto diretto,
assiduo e comunitario con il maestro è essenziale nella ricerca della verità dei
Principi propri della protologia ; Uno-Bene, Diade Indefinitia, Idee-Forme, IdeeNumero.
Oltre Reale egli, però, sostiene che apparterrebbe alla sfera della non scrittura
soprattutto quella “Attivita”9 alla quale il ‘Platone Inconcluso ed Interrotto, proprio
con queste omissioni e vuoti, sistematicamente invita .
Questa Attività necessaria è il filosofare in generale con o senza Platone; a questo
Fare libero ed autonomo l’autore dei dialoghi inviterebbe e stimolerebbe il suo
lettore con la messa in opera di una pluralità di giochi-esercizi in forma appunto di
‘sentieri interrotti’.
Con questo modello ermeneutico Migliori valorizza tra le altre le ricerche anche di
Erler10, di Kahn11 e di Rowe12 ; di un Rowe che a sua volta riscopre - e questo non fa
Reale- la attualità e la importanza del Platone di Stefanini13 , teorico della centralità
delal “Scepsi”come progetto di una filosofia in costante cammino ed in sempre più
avanzata e mai conclusa ricerca.
Su questa base egli ritiene, poi e soprattutto, di poter spiegare con il suo modello
una circostanza culturale che caratterizza le indagini degli ultimi due secoli su
Platone ; il fatto sconcertante , cioè, che dopo tanti sforzi e tanti libri, gli interpreti
non si sarebbero accordati su nulla di essenziale capace di restituire una completa e
coerente dottrina filosofica assegnabile all’autore dei dialoghi come suo
fondamentale ed unitario pensiero nelle sue diverse e molteplici direzioni tematiche
e mutanti punti di vista.
Per tutto ciò, quanto dopo-Platone registriamo come imbarazzante e disorientante
fatto culturale, cioè appunto il mancato accordo degli interpreti circa l’effettivo ed
Szlezàk
M. Migliori op. cit, p.
10
Erler
11
Kahn
12
Rowe
13
Stefanini
8
9
autentico volto del Platone teorico, sarebbe stato volutamente e progettualmente
previsto da lui sulla base di una trasformazione stessa della visione tradizionale di
una filosofia come techne tra le technai
Secondo Migliori, dunque, non ci sarebbe accordo tra gli interpreti sul pensiero
essenziale di Platone, perché essi partirebbero da un presupposto che non sarebbe
quello dell’autore-Platone, il quale non si sarebbe proposto di elaborare dottrine
sistematiche definitive ed esaurienti, ma come si è detto- solo di offrire una pratica
esemplare di come e su quali temi notevoli si fa filosofia.
C) Detto tutto questo anche in riferimento al complesso contesto generale del
dibattito italiano ed internazionale- in cui Migliori si inserisce-, ritengo che la sua
proposta per un nuovo approccio adeguato al Platone teorico, finisca ancora una
volta per perderlo di vista (i) nella sostanza della sua strategia funzionalecostruttiva, (ii) nell’essenziale della forma espositiva-espressiva dei contenuti dei
dialoghi, (iii) nelle caratteristiche storico-problematiche della società in cui Platone
visse e scrisse, (iv) nel valore degli esiti speculativi da lui raggiunti, (v) e poi negli
stessi rapporti tra Platone scritto e Platone Orale, quello delle lezioni-conferenze
della sua Accademia; e,infine, (vi) nel rapporto tra tutto Platone e la tradizione dei
platonismi, l’un contro l’altro armato dentro un dissidio ingovernabile nel metodo
di lettura ed in alcuni fondamentai temi : anima-corpo, ideale-reale, umanodivino,essere-divenire, uno-molti,passione e ragione, violenza sociale e leggi.
Per meglio chiarire la mia posizione a questo proposito, inizio con il rifiutare
l’opinione centrale di Migliori, vale a dire quella secondo la quale in nessun dialogo il
problema posto avrebbe la sua corrispettiva soluzione, e che ogni opera
confermerebbe “ la voluta e strutturale incompletezza di quanto l’Autore
comunica attraverso i dialoghi e quindi la necessità di proseguire il lavoro alla luce
di quello che le testimonianze indirette dicono soprattutto delle Dottrine non
scritte.,14
Rifiuto questa opinione e la capovolgo così : in ogni sua opera da Apologia a Leggi,
passando per dialoghi che Migliori aveva già profondamente sondato- come il
Parmenide, il Filebo, il Sofista, il Politico,15 - il problema effettivo, attorno al quale è
effettivamente riconducibile il gioco testuale, in tutte le sue figure, mosse e
sequenze, ha la sua determinata soluzione, se facciamo valere fino in fondo, cioè
fino al procedimento di identificazione dello stesso problema, il principio del gioco.
Pertanto ed in breve : per me nessun dialogo platonico è aporetico; l’effetto
aporetico, infatti, è solo l’esito obbligato del modo in cui un lettore non adatto
procede ad osservare., riconoscere ed estrarre il senso del testo letto.
14
15
M. Migliori op. cit. p. 1252
M. Migliori
Per |lettore non adatto| intendo il lettore che come il lettore dei cieli, Tolomeo, pur
disponendo di capacità di astrazione, di elaborazione di una vasta massa di dati –
osservativi, di strumenti di modellizzazione per la istituzione di invarianti e di
controllo delle loro applicazioni , si trova, però, a costruire ed ad usare una
macchina logica-discorsiva senza problematizzare la idoneità del suo punto e modo
di osservazione della ammasso dei ‘fenomeni’ che gli stanno di fronte e sopra.
Per noi lettori dei testi platonici questi fenomeni sono elementi e complessi segnici
di una lingua alfabetica indoeuropea, quella greca del V e IV secolo a. C., disposti in
pluralità di corpi testuali, di cui l’autore non ci ha rivelato né l’ordine cronologico di
composizione, di cui non ci ha messo a disposizione preliminarmente ed
esplicitamente il piano problematico, né ci ha indicato il metodo di formazione ed
elaborazione ed articolazione dei percorsi argomentativi, né ,infine, illustrato la
natura del pubblico dei destinatari ai quali questi testi erano diretti.
Nel volerli immediatamente prendere visivamente nel loro insieme essi si danno a
noi moderni lettori come un ‘ammasso’, un blocco di insiemi segnici, che esigono di
essere esaminati uno alla volta e senza poter disporre per ciascuno di un indice , di
una prefazione , di una introduzione, di sottotitoli esplicativi, della titolazione
ordinata in paragrafi, di una conclusione, vale a dire di tutto ciò che orienta alla
stregua di un filo conduttore un lettore di trattati e di saggi ; e senza che l’autore ci
venga incontro delineando la sua complessiva strategia espositiva e teorica e senza
dirci quale sia l’effettivo problema centrale con il quale intende misurarsi.
Possiamo così affermare che l’intera testualizzazione platonica, a partire dai titoli,
avviene sotto il segno e la cifra dell’implicito e della implicitazione e poggia su un
vasto , ricco e complesso territorio di non-detto, di una gigantesca Presupposizione,
che è nello stesso tempo socio-culturale e teorica.
Quelli platonici, perciò, - e lo evidenzia anche Migliori dal suo diverso punto di vistasono testi difficili; e ad accentuare questa loro essenziale proprietà strutturale è la
loro forma di esposizione-espressione, che si fa cogliere nel modo ordinario e nello
stile del linguaggio quotidiano ed apparentemente semplice del Racconto.
Questo racconto in quanto condivide la modalità di mythos. infatti, è, invece, un
mascheramento di una operazione di alta teorizzazione-; anche quando sii fa
percepire -in opere come Apologia, Critone ed in passaggi come l’epilogo del Fedone
, in forte rilievo veristico, quasi a voler far credere al lettore che egli stia assistendo
al resoconto di una ‘cronaca vera’.
Ma questo effetto a livello di ricezione e fruizione del testo è solo il brutto scherzo
che Platone tira al suo lettore non adatto.
Questa mia osservazione vale in generale a sottolineare come la difficoltà
persistente a cogliere ed ad orientarsi nell’immenso iceberg del non detto platonico
sia aggravata e complicata da questa falsa impressione realistica, che è anche
all’origine di non pertinenti problemi ermeneutici; come quello, ad esempio, che
spinge G. Reale 16a non considerare anche nella Apologia il nome |Socrate| come
nomen dramatis, nome-maschera; ed a sottrarre l’opera alla prospettiva di una
lettura scenica, che varrebbe,invece, secondo il medesimo autore, per tutti gli altri
testi.
Mi riservo di riprendere questo importante punto, che G. Reale illustra nella sua
interpretazione del Simposio, più avanti, perché ora devo rendere conto del nesso
che questa premessa ha con la tesi generale di Migliori sopra richiamata; tesi che
troverebbe la sua fondamentale conferma in sue vaste analisi che proverebbero per
ogni dialogo l’operare di una indagine sistematica aperta ed aporetica, nel senso che
per ognuno di essi la relativa conclusione non rappresenterebbe la soluzione
soddisfacente ed adeguata del problema in campo.
Rilevo in secondo luogo che Migliori, che pure dichiara di assumere il paradigma del
gioco-esercizio come modello-guida di interpretazione del movimento semantico e
concettuale che attraversa l’intera testualizzazione platonica, non è poi fino in
fondo conseguente nella applicazione di questo paradigma, che inteso come quello
di un gioco giocato, è il paradigma- princeps di una logica dell’implicito e della
implicitazione.
Chiarisco : Migliori è inconseguente nel momento e nella misura in cui non si lascia
guidare da questo paradigma anche allorchè procede alla identificazione e
qualificazione dei termini e della struttura del problema che è effettivamente in
gioco in ciascuno dei giochi-esercizi che ricostruisce.
Egli così non si rende conto che il primato della logica del gioco giocato in Platone
sulla logica del dichiarato-esplicito fa sì che quanto da Platone è provvisoriamente
dato in forma esplicita e secondo la formula del |Che cos’è X in un complessoambito di attività determinata|, viene poi via via modificato nel corso dello
svolgimento del gioco, “in opere operato.”17,.
Il problema modificato in corso d’opera è un problema riconvertito-ristrutturato e,
perciò, trasformato in un altro, la cui formula generale implicita è la seguente :
|Perché un individuo-Tipo /E….N portatore di una determinata corrispondente
Typo-logia, pur volendolo e pretendendolo, non riesce ad accedere alla esperienza
del senso autentico e della legge interna ad una attività omologata e riconosciuta
dalla comunità come produttiva di comune valore sociale e culturale ?|.
Nella mia formula – estendibile con le dovute variazioni anche a tutti gli altri
dialoghi- la lettera maiuscola sta per la iniziale del nome del Caso-Evento che è di
scena nel dialogo e ne costituisce il titolo; e, perciò, la lettera |E| sta per
|EUTIFRONE|, la prima opera nella classificazione del grammatico Trasillo e la
lettera |N| sta per |NOMOI|, l’ultima opera come generalmente ammesso dai
filologi.
16
17
G. Reale
M. Migliori op. cit. pp. 101,103
Per precisare questa mia posizione dovrei poi aggiungere che il Nome/Maschera
,che appare ed agisce in funzione di personaggio sulla scena della scrittura, deve
essere distinto dal Nome/Titolo, che appunto come titolo rappresenta l’intero gioco
e non solo le azioni discorsive di un solo dei personaggi.
E basti qui questa osservazione, perché riprenderò più volte questo mio discorso
sulla natura e funzione dei nomi propri di persona ricorrenti nei testi platonici;
aggiungo solo per ora che le sue implicazioni chiamano in causa la questione della
forma propria che genera e struttura -la inventio (euresis)-dispositio (diathesis)locutio (lexis)-, che plasmano la intera testualizzazione platonica.
Come mostrerò, il paradigma del serio gioco comunicativo, cognitivo-immaginativolinguistico, è la via obbligata anche per dirimere la questione della natura della
cosiddetta |forma letteraria| dei dialoghi, e per trovare il suo nesso funzionale
profondo con la forma del piano di concettualizzazione e di teorizzazione.
Ora perché è importante, decisivo, saper applicare il paradigma del gioco giocato
anche alla fase della identificazione e qualificazione del problema ?
Perché questa precisa messa a punto ci permette di vedere, riconoscere e stabilire
al termine del gioco, se il problema è stato risolto oppure no ,rimanendo sospeso.
Ora se il lettore segue Migliori e si lascia condizionare dalla sua prevalente ottica del
dichiarato-esplicito, quando poi procede a focalizzare il problema attorno al quale
ruota il gioco, con lui sarà costretto a concludere che alla domanda portante non
corrisponde una chiara, univoca, e valida risposta; e che il problema ‘lungamente
agitato e variamente trattato’ giacerebbe alla fine ancora irrisolto. E questo esito
sarebbe verificabile per tutti i dialoghi sulle virtù del cosiddetto ‘periodo socratico’ e
per i dialoghi dialettici della maturità come il Parmenide, il Sofista, ecc.
Ma questo esito è obbligato solo se diamo per buona a Migliori la sua prima mossa,
vale a dire appunto che il problema esatto sia quello dato da Platone nel modo
dichiarato :
|Che cos’è il santo ?|, |Che cos’è la giustizia ?|, |Che cos’è l’idea ?|, |Quali sono i
massimi generi razionali-reali ?|, |Che cos’è la conoscenza ?| |Che cos’è il
linguaggio ?|, |Che cos’è eros ?|, |Che cos’è la morte ?| , |Che cos’è l’anima ?| e
così via.
Se, invece, facciamo valere, fin dalla messa a punto della forma del problema, la
energia funzionale, ancor prima che tematica e strutturale, del filo conduttore del
paradigma generativo-formativo-interpretativo del gioco giocato, allora l’esito sarà
opposto a quello che Migliori crede di aver dimostrato.
Questa via alternativa è stata da me ampiamente percorsa nel mio lavoro sul
Teeteto, che pubblico sul mio sito informatico; e che ho esteso anche a tutte le altre
opere platoniche; mi riservo di pubblicare anche questi risultati gradualmente.
Il modello ermeneutico alternativo che propongo riesce a rendere conto anche del
‘vizio originario’, e della stortura genetica che stanno alla base di molti modelli
ermeneutici che rivaleggiano tra loro nel progetto di rivelare ‘ciò che ha
effettivamente pensato e scritto Platone’, e dei vari insuccessi e fallimenti di queste
imprese; almeno rispetto all’obiettivo di scoprire la strategia teorica capace di far
rivedere come un tutto coerente l’opera scritta di Platone da Apologia di Socrate a
Leggi.
Questo ‘vizio originario’ per me è dato appunto dalla pretesa di comprendere
Platone a partire da un modello di teoria e di teoria filosofica basato sulla prevalenza
di una logica dell’esplicito–dichiarato , per lo più rinforzata ed aggravata da una
concezione dottrinaria dei valori di teoria, e da un ingabbiamento di questi valori
nelle ripartizioni per ambiti disciplinari caratteristici dell’ordinamento
dell’insegnamento accademico.
Guardando verso i testi platonici in questa ottica di riconoscimento, che non è
conforme alla matrice di concettualizzazione platonica, quando non si è finiti
completamente e clamorosamente fuori strada, si è presa comunque una cosa per
un’altra, come accade nelle questioni : Platone e la Poesia, Platone e la Retorica,
Platone ed il Linguaggio, Platone e la Dottrina delle Idee, Platone e la Politica,
Platone e la Scrittura…. Mi soffermerò su di esse con stretto riferimento al libro di
Migliori.
Ora prendo ad esaminare il senso di una forte presa di posizione della Scuola di
Tubinga e di Milano e che alla base dell’approccio anche del nostro autore. E’
essenziale a questo modo di accesso ai testi il rispetto di un canone fondamentale di
lettura.
La parola d’ordine di questo canone è : |Fedeltà ai testi ed a tutti i testi di Platone|,
nella consapevolezza, però, che il loro autore avrebbe sottovalutato, se non proprio
escluso, il potere cognitivo della esperienza di scrittura e dei suoi prodotti; e che
conseguentemente avrebbe deciso di produrre opere inconcluse in alcuni casi
addirittura al limite del logicamente inconcludente e, dunque, prossimi al fallimento
della ricerca.
Sulla base di quanto appena messo in rilievo è evidente che la prima domanda che
dobbiamo farci è in generale questa: che significa essere fedeli al testo che si legge e
si interpreta ?
Provo ad illustrare brevemente il mio punto di vista nelle riflessioni dei prossimi
paragrafi, tenendo conto soprattutto che Migliori ritiene che la quantità di
riferimenti al testo sarebbe prova decisiva per stabilire la correttezza e la
adeguatezza di una ipotesi interpretativa.
A questo proposito anticipo solo questo : il presupposto dal quale Migliori
dichiaratamente muove, cioè l’impiego del paradigma di ‘decodifica’, di
riconoscimento formato e funzionante sul principio del gioco giocato, introduce un
parametro qualitativo ancor prima che quantitativo nel reperimento e rilevamento
delle prove testuali.
Come proverò, il ricorso a questo principio destabilizza profondamente il prevalente
e dominante modo istituzionale-professionalizzato di leggere gli scritti platonici e va
a determinare un potenziale conflitto e comunque ad introdurre un problema non
eludibile di compatibilità tra due prospettive funzionali concorrenti : come la logica
dell’implicito e della implicitazione- che è caratteristica del modo del gioco giocatopuò in Platone convivere con quella del dichiarato –dottrinario, cioè dell’esplicito,
che è tipico del trattamento ‘scolastico’ e specialistico della sua opera ?
Dalla soluzione di questo problema dipende anche l’altro sopra accennato ; vale a
dire: se abbiamo il dovere di rendere conto della maggior quantità possibile di
superficie testuale osservata , come allora si determina questo quanto ? Con quale
criterio si decide di non considerare importante e codeterminanti parti di un testo
platonico ai fini della scoperta dei pensieri dell’autore ?
Ad esempio : perché i titoli dei dialoghi dovrebbero essere esclusi o emarginati nella
ricerca della ‘logica immanente’ che ispira, genera e plasma l’opera ?
I titoli platonici costituiscono una sfida per il lettore accademico che si propone la
massima approssimazione possibile e costante vicinanza al testo . Egli non potrà mai
‘spiegarli’ ,perché un’ottica dichiarata-dottrinaria, per sua natura astratta e
generalizzante, non potrà mai rendere conto della ragione profonda per cui Platone
usa, come titolo di molte sue opere , nomi propri di persona che il lettore
dottrinario riferisce ad un individuale-particolare-concreto.
Questo tipo di lettore legge questa occorrenza testuale come una anomalia, come
una eccezione, come ciò che inevitabilmente fuoriesce dalla sua rete- di ‘cattura’
del senso veicolato dalla scrittura. E così questo lettore è portato ad emarginare e
non considerare rilevante e probante quella porzione testuale, rappresentata dai
titoli dei dialoghi , ed a considerarli per lo più delle etichette con valore di deidica.
Ed in questo modo si comporta anche Migliori che li esclude dalla “massa” notevole
dei suoi dati-testuali., pur avendo deciso di legggere “giocando ai giochi che Platone
propone “18 .
Questa sua scelta è sintomatica di quanto ‘ non funziona’ nella impostazione della
sua interpretazione e nella sua decisione di massima fedeltà al testo.
18
M. Migliori cit. p. 26.
2. La nozione di fedeltà al testo.
“Anche in una società narcisista come la nostra la deontologia di uno studioso di
storia della filosofia dovrebbe imporgli di essere servo del testo ed aiuto a tutti
coloro che a quello si rivolgono, rinunciando alla invenzione di sue idee brillanti ed
originali,. Se ci sono idee originali in questo lavoro, ci sono malgrè moi e quasi me
ne dolgo”19
La nozione di fedeltà rimanda in generale alla idea di osservanza-rispetto di
impegni contratti e, quindi, presuppone la capacità e la dignità di un poter contrarre
tra parti che condividono una proprietà minima: quella di appartenere ai vivi, anche
quando si tratta di svolgere un compito da “servo del testo”
Ma il testo in sé come oggetto fisico, supportante tracce segniche, non è assimilabile
al suo corrispondente vivo lettore, che dispone di facoltà percettive, mnemoniche,
linguistiche e logiche, che il testo-oggetto fisico naturalmente non ha.
Perciò- ed ha ragione G. Cambiano20 nel sostenere- nella sua polemica con
Gadamer- che solo metaforicamente ed in maniera equivoca possiamo parlare di
un “dialogo vivo” con il testo; quel “dialogo vivo” che tanto piaceva anche allo
Heidegger21 interprete di Aristotele e di Kant., dei quali –come anche in riferimento
al suo Platone, non si affannava certo a tenere in considerazione il complesso
dell’opera.
Perciò, da questo punto di vista è difficile intendere che significhi rispettare gli
impegni contratti con quella cosa che è un testo, che resta indifeso e debole si
fronte all’operatore-lettore che lo usa.
E questa fragilità del libro già era stata colta dal Platone del Fedro e della Lettera VII:
Migliori seguendo G. Reale ce lo ricorda costantemente, ma non facendo valere in
questo caso , però, ‘fino in fondo’ il contesto del gioco serio.
Per me esso è avviato in entrambe le opere da una sottile ed implicita polemica
platonica non contro la scrittura ed il libro in se stessi , ma contro la Pretesa di fare
meccanicamente ed automaticamente della produzione e possesso di un libro la
condizione necessaria e sufficiente per una esperienza autentica di pensiero e di
comunicazione filosofica.
Scrivo |Pretesa| con la iniziale maiuscola, perché la Figura della Pretesa illegittima
(che fuori da un contesto strettamente platonico non sfuggiva certo né al Bacone
19
20
21
M. Migliori cit. p. 10.
G. Cambiano
M. Heidegger, Kant ed il problema della metafisica
degli “idola”22, né allo Hegel della “false meinung”23 ed al Kant denunciante le
“sofisticherie”24 di una pseudo-dialettica) - con le sue trentasei Figurazioni- in
corrispondenza di ciascuna delle opere raccolte in tetralogie da Trasillo-25
costituisce il costante bersaglio che è decisivo per identificare il piano funzionale
dove si svolge l’operare dialettico platonico.
Questo bersaglio è appunto il fine/telos che orienta l’inizio ed innanzitutto in
riferimento al livello cognitivo-linguistico al quale questo avvio-inizio appartiene.
Il ruolo fondamentale, costruttivo-funzionale, di questo Grande Innominato che è la
fenomenologia della Pretesa/Pseudos-Pseudè Doxa, è programmaticamente
emarginato, in questa sua funzione decisiva, dalla Scuola di Tubinga e di Milano.
Perché ?
Bisogna in primo luogo precisare che in questa sottovalutazione Migliori e Reale
stanno in buona compagnia .
Infatti, al partito della teoria intesa come prevalente , dominante e decisiva logica
del dichiarato-esplicito appartengono :
-Natorp26, esponente insigne delle ripresa dell’approccio dottrinario puntato sul
tema gigantesco delle Idee ;
- l’antidottrinario interprete estetico-pedagogico Friedlander 27;
- il non dottrinario Gadamer28, teorico del vivo colloquio filosofico con il testo e di
un Platone protagonista in Accademia di vivi colloqui-didattici,
-e.quindi, per finire – senza la pretesa di completare l’elenco- gli unitaristi alla
Kahn.alle Rowe e alla Sedley 29ed gli antiunitaristi alla Vlastos 30ed tutti gli anti‘oralisti’ della recente tradizione di ricerca italiana : Viano,31 Adorno,32
Casertano33,Trabattoni,34 Centrone35, Vegetti36, Ferrari,37 Fronterotta,38 Cambiano39,
Napolitano Valditara, 40Isnardi Parente, W, Lezsl,41Tulli42, Giardini;43 e con una
posizione tutta sua E. Berti 44e così ,nella area culturale tedesca , Erler45.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Bacone
W: Hegel, Fenomenologia dello Spirito
I. Kanti, Critica del Giudizio
Su Trasillo cf. G. Reale
La precisazione ora fatta è anche la risposta alla mia domanda di partenza : il
bersaglio polemico camaleontico, poli-paramorfico, policefalo, costituito dalla
variopinta fenomenologia della Pretesa/Pseudos è per lo più un modo di produzione
semiosico Assente, cioè non identificabile e riconoscibile dentro una testualizzazione
vista, letta ed interpretata secondo appunto una logica fondata sul modo dichiaratoesplicito, al quale il modo implicito, ellittico, si aggiungerebbe come proprietà
essenziale ,ma subordinata ad esso.
Reale e Migliori non colgono insieme a tutti gli altri il ruolo fondamentale della
Pretesa/Pseudos, perché stanno nell’atteggiamento di aspettativa di un lettore che
crede che ci sia indicazione problematica e teorica solo lì dove nel testo l’autore
espressamente ed adeguatamente la dichiari nella sua importanza e la dichiari
necessariamente secondo lo stile, secondo il modo che da qui in poi indicherò con
la sigla |DDP|, cioè |Dichiarato-Dottrinario-Puro|.
Le omissioni, interruzioni, le riserve di rimandi (– che sono generalmente registrate a
quel livello di prima lettura che porta ad un buon riassunto e che almeno a questo
primo livello sono di solito condivise dalla generalità dei comuni lettori e dagli
interpreti, perché anche essi passano per l’esperienza di una prima ricapitolazione),
questi vuoti appunto si sperimentano come tali, mantenendosi e facendo valere
questa aspettativa, questo prae-giudizio, questo presupposto criterio su ciò che è
sarebbe intenzione teorica e su ciò che non lo sarebbe.
Kramer – il capostipite della Scuola di Tubinga- che rileva la mancanza di una teoria
adeguata del Bene in Repubblica, è appunto un lettore di questo tipo. Egli si aspetta
di vedere la teoria platonica del Bene in forma |DDP|, guardando in questo modo
verso il testo e naturalmente non vedendola, conclude argomentando che
nell’opera non ci sarebbe una teoria del Bene e, che pertanto, data la sua
importanza nella economia della ricerca platonica, bisognerebbe cercarla fuori dalla
scrittura e senza perdere il contatto nello stesso tempo con Platone.
E dove pensa di trovarla ? Lì dove essa si manifesta in veste di Dottrina Pura di
Platone.
Che cos’è questo |Dove| ? Come vi accediamo ? Questo |Dove| sono le Dottrine
Orali su i Principi e vi accediamo attraverso i documenti della Tradizione indiretta.
Il cerchio ipotizzato da Kramer sembrerebbe fecondamente chiuso, ma a partire da
un presupposto inadeguato e fuorviante, che investe non il fatto della esistenza o
meno di questo Platone cosiddetto |Orale|, |Sconosciuto|, perché per quanto mi
riguarda anch’io lo ritengo scontato – e ne spiegherò più avanti le ragioni che vanno
ben al di là dell’ambito di queste dottrine.
Il cerchio chiuso ,però, è un ‘cerchio vizioso’ perché Kramer – e con lui tutti gli autori
che condividono di fatto , in una convergenza oggettiva, un unilaterale modello di
42
43
44
45
teoria, oralisti o antioralisti o aoralisti che siano, trovano nel testo solo quei
contenuti teoria che quella loro visione riduttiva di essa permette loro di trovare;
o sempre in virtù di questa ottica li induce a ritenerla assente, non contenuta nel
testo, che appare così ad essi relativamente omissivo, vuoto, allusivo.
Chi guarda principalmente in questa maniera, mi obietterà, pertanto, che non ci
sarebbe alcun luogo o insieme di luoghi rilevanti nei dialoghi dove sia rintracciabile
una teoria della Pretesa/Pseudos nella funzione codeterminante che io gli
attribuisco.
E, pertanto, se questa fosse una obiezione irresistibile ed insuperabile, dovrei
accettare la accusa di forzare il testo , di fargli violenza ; dovrei, dunque, rinunciare
al mio punto di vista, che sarebbe non confortato dai loci documentali.
Ma io dico a me stesso ed agli altri : il Platone di tutti i dialoghi ed il Platone di ogni
dialogo. ripreso nell’intero delle sue parti, alle quali appartiene anche il titolo
dell’opera, il Platone Teorico, è ‘catturabile’ mediante la ‘rete’ di Kramer e Gaiser?
Questa rete è anche quella fondamentale per lui ed in lui autore dei suoi testi ?
Io dico di no; e le prove sono proprie quelle che ai lettori dottrinari, quali anche
sono,i appaiono come anomalie, eccezioni, scostamenti ripetuti, atipicità, che
costituiscono la dinamica costante di ciò che essi co Szlezàk chiamano | passi di
omissione| .
Ora è’ testualmente certa questa caratteristica ricorrenza, ma questa certezza- che
sarebbe fuori discussione per questi interpreti e, quindi, anche per Reale, Migliori,
Movia- è, però, relativa –come ho detto - ad un punto di vista, cioè a quel punto di
osservazione che investe la natura della teoria, la teoria della teoria.
Come illustrerò, l’unicità ed eccezionalità di Platone rispetto a ciò che per comodità
chiamerò |Abitudini ed Abiti mentali delle Accademie, delle Scuole,
delleUniversità|, consiste in questo : egli non innova solo i contenuti della riflessione
filosofica, dando luogo “ alle classiche teorie platoniche, come quella delle Idee e
del Bello”46, ma opera una svolta funzionale-costruttiva del livello di
semantizzazione e di quello connesso della concettualizzazione; una svolta che
investe l’idea stessa di teoria e di fondazione teorica.
Per dirla con P. Chiodi 47, interprete della deduzione trascendentale in Kant, ed
analogamente a quest’ultimo, osservo : in Platone prima ancora della questione “del
fondamento”, di un das-that, c’è ne una “di fondamento”. di un wie-how, che si
estende in profondità fino alla dimensione funzionale cognitivo-linguistica.
Platone così mette in campo lo ‘sfondamento’ di un pregiudizio sul fondamento
funzionale della teoria : quello appunto che impone la esclusività di un teorizzare
per modo ( DDP) ed in forma pura, cioè senza ciò che è proprio del Racconto.
46
47
M. Migliori , cit. p. 28.
P. Chiodi, La deduzione trascendentale nell’opera di Kant
E Platone fa questo dunque, non perché non avrebbe maturato a sufficienza la
capacità di elaborazione riflessiva-astratta, come crede incredibilmente Havelock48
quando indaga sul rapporto tra Platone e Scrittura/ Oralità; né perché egli avrebbe
concepito “una irrepetibile fusione di arcaismo e profezia di un nuovo mondo”
come conclude M. Vegetti nel suo saggio “All’ombra di Toth”49 .
La svolta sull’asse della forma del piano della generazione di significati e concetti e
su quello della composizione-esposizione di essi è, al contrario. la indiretta prova
che Platone, come nessun altro nella sua Accademia, maneggia gli statuti e le
metodiche dei diversi ambiti tecnico-disciplinari – a cominciare dalla regina delle
Techne, cioè la geometria-matematica, per finire con la retorica e la poetologia.
E li padroneggia in tale grado di consapevolezza teorica al punto da farne un
costante punto di appoggio e garanzia/omeros 50per metaparadigmi analogici della
sua dialettica.
Platone è obbligato a questa svolta – come meglio via via cercherò di chiarireperché a ciò è trascinato dalla natura funzionale e circostanziale del suo costante
bersaglio, la fenomenologia dello Pseudos appunto.
Per ora mi fermo su questo punto e preciso ulteriormente così : Platone in via
principale e fondamentale non concettualizza per modo |DDP| non perché non
saprebbe farlo a regola d’arte o perché la scrittura come attività di testualizzazione
non permetterebbe di farlo in maniera adeguata ed efficace soprattutto in
riferimento alle “Cose Massime”/ta megista51, come sostengono, a proposito della
scrittura, tutti gli esponenti della Scuola di Tubinga e di Milano e, naturalmente
,anche Migliori.
Un altro importante aspetto bisogna tenere preliminarmente presente a questo
proposito : Platone deve operare il passaggio/metabasis di piano funzionale
rispetto a quello proprio delle Technai e deve operare una trasformazione
costruttivo-funzionale della teorizzazione già a partire dalla problematizzazione ;
infatt, la prospettiva tecnica, in generale e per suoi naturali limiti, non è in grado di
per sé di affrontare, di diagnosticare e di mettere fuori gioco le Pretese dello
Pseudos della fenomenologia sofistico-eristica, che arma i suoi pseudo-modelli con
i meccanismi della comunicazione spettacolare e teatralizzante; e, quindi,
soprattutto con caratteristiche del modo performativo52 , in cui il ruolo
dell’implicito, del gioco giocato, è determinante.
Havelock
M. Vegetti in Etienne | a cura di)
50
Per uesto termine e d il suo contesto cf.
51
Apologia di Socrate
52
Per la collocazione storico-culturale del modo della performance nella vita di comunicazione
della polis . ad es. B. Gentili in M. Vegetti ( a cura di ), Introduzione allE culture antiche I ORALITA’
SCRITTURA SPETTACOLO, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 53-76.
48
49
In conclusione e così anticipo il punto centrale della mia ipotesi : ciò che in un ottica
di lettura, guidata dal paradigma |DDP|, appare come omissione- interruzioneallusione, è in realtà non una indicazione per andare oltre il testo che circoscrive
ciascun dialogo ed oltre il corpus testuale includente tutte le opere scritte.
Al contrario questi vuoti sono istruzioni ‘in opere operato’ orientate e puntate verso
il lettore perché egli sia provocato e stimolato a passare dal primo ‘naturale’ livello
di lettura e di quello proprio di una logica dell’esplicito, ad un livello più profondo,
che è appunto quello della ‘grammatica’ dell’implicito intrinseca al modo |GG=
Gioco Giocato| di produzione di una significazione intrecciata intimamente con una
concettualizzazione di tipo costruttivo-operativo. ed il cui valore di teorizzazione
sulla base della sua capacità di saper falsificare quella Pretesa Illegittima in ciascuna
delle sue varianti, messe in atto in pseudo-giochi del modo di produzione
paradiscorsivo di tipo erisitico-sofistico.
2.1 Il libro come eredità preziosa da amministrare con fedeltà.
Quando un libro ha il valore di una eredità preziosa da custodire e conservare, si
pone la esigenza di una ‘amministrazione’ fedele del lascito spirituale che esso
registra per mezzo di segni significanti, soprattutto quando si è consapevoli della
circostanza che esso ha perso il padre che lo ha generato e che ,pertanto, non può
difenderlo nella intenzionalità ed integrità di senso di cui esso è veicolo.
Se ,poi, le singole parole, le frasi, il contesto, che circoscrivono una opera scritta
hanno prima di sé un vasto territorio di presupposizioni storiche, socio-culturali, e
teoriche , allora il compito di riempire gli spazi vuoti nel piano del dichiaratoesplicito della superficie significante diventa ineludibile, ma anche pieno di rischi.
Siamo ,infatti, tentati come lettori di riempire gli spazi allusivi al non-detto con
quanto più ci aggrada ed è affine alle nostre concezioni e punti di vista di fruitori
post-platonici, moderni e post-moderni. Il rischio, dunque, è di finire nell’arbitrario,
dove il testo è solo un pretesto per operazioni puramente letterarie o teoreticistiche
e comunque svincolate dall’obbligo del rispetto di quei canoni che con Betti,53
teorico della interpretazione- potremmo chiamare i canoni della totalità
determinata e della immanenza.
Il problema del |se e come essere fedeli al testo platonico| chiama, dunque, in
causa la possibilità e la necessità di mantenere in equilibrio da un lato questo
obbligo di fedeltà e le esigenze - dall’altro- , le caratteristiche ricettive di un lettore
che vive in un tempo diverso da quello del suo autore e che, quindi, per forza di cose
è portato a far valere quelle sue esigenze ed a far pesare gli effetti del suo abito
culturale nella riproduzione, nella ricostruzione interpretativa, come appena ora ho
osservato.
Alla realizzazione di questo equilibrio ci spinge una qualità strutturale del testo;
tale è la sua capacità di resistenza alla deformazione ed agli abusi di un lettore che
lo piega sistematicamente ad un campo di intenzioni e significati ad esso estranei.
Come meglio chiarirò questo proprietà che ha il testo di resistere ad usi impropri
non è, però, una qualità del testo-oggetto, ma ancora una volta essa appartiene
alla dinamica che accade dentro la attività del leggere, di quel leggere che assume il
corpus segnico come necessario e costante contrappeso di ogni libera e creativa
interpretazione , e che in concorrenza o rivalità con altri modi di leggere, riesce a
rendere conto di una maggior quantità di superficie segnica-significante.
Anche un esperto di indagini storiografiche e di storia della filosofia greca – come
Migliori- dovrebbe in generale ammettere che non esiste un testo assoluto, cioè
pensabile fuori dalla sua relazione necessaria con un leggere in potenza o in atto.
Appartiene dunque, al codice generativo di un testo ed allo struttura della sua
costituzione, il suo dover essere pensato come ciò che è effettivamente solo in
relazione con quell’altro-diverso che è la attività , storicamente e culturalmente
determinata e condizionata, che è il leggere.
Chi ritiene il contrario e reifica un testo, immaginandolo separato da un rapporto
dinamico con il vivo atto del leggere e del comprendere, deve considerarsi vittima –
53
Betti, Teoria generale dell’interpretazione
per dirla con Gadamer54- dell’alienazione oggettualistica, contro la quale –ed
almeno in questo a ragione- si muove l’intera tradizione idealistica da Hegel a
Gentile e Croce55.
Ho introdotto questa osservazione circa la relazione elementare tra testo e lettore,
perché proprio nell’ambito degli studi platonici si è ripresentata la questione della
differenza tra approccio teoretico ed approccio storiografico, come si può rilevare
,ad esempio, nell’opera di Vlastos56 su il “Socrate moralista” ed in quanto scrive G. -Reale57 a proposito della necessaria distinzione da fare tra interpretazione “storico
ermeneutica”, e quelle ‘puramente storica’ o ‘puramente teoretica’.
E Migliori sta con Reale , nel guardare verso i testi per trovare i luoghi dove si
troverebbero i pensieri di Platone; e ,perciò, assume il modo “storico ermeneutico”
come via maestra di interpretazione:
“Vorrei però evitare un equivoco : questo testo non sarebbe mai stato scritto se lo
scrivente non avesse conosciuto le testimonianze indirette su Platone … La mia
scelta, certo non in contrasto con quella degli altri studiosi corre un rischio che va
esplicitato, cioè che qualcuno possa sostenere sulla base del mio lavoro , che le
Testimonianze indirette non sono necessarie o non sono decisive o non sono utili,
tutte affermazioni che in vario modo ho cercato di falsificare in anticipo. Tuttavia
accetto il rischio : credo che in questa fase di studi sia più importante mostrare
come il nuovo paradigma offre la possibilità di meglio comprendere i testi ( e
questo spero di dimostrarlo in modo più efficace in libri successivi 58
Rinunciando ora a far scendere in campo quella posizione estremistica di
ermeneutica filosofica, per la quale non esisterebbero fatti-testi ma sempre e solo
interpretazioni59, mi limito in questo momento alle seguenti considerazioni :
1) Faccio mio il canone del Migliori, nel senso che il valore critico di un
paradigma interpretativo si misura nella sua capacità di far meglio
comprendere i testi rispetto ad altri modelli concorrenti e/o rivali; e che in
riferimento a Platone
il paradigma assunto deve spingersi – in
approssimazione massima- a rendere conto del tutto determinato di ogni
dialogo e di quel tutto che è l’insieme dell’opera scritta platonica. Deve
,quindi, spingersi il più possibile nell’analisi di tutto testo, e non limitarsi a
porzioni più o meno ampie di esso.
Gadamer
B. Croce, La storia come pensiero e come azione; e u tale quesionte in ambito crociano R.
Franchini, Croce interprete di Hegel, Espeirenza dello storicismo
56
Vlastos
57
G. Reale
58
M. Migliori, cit. p. 1252: p. 7, nota 1.
59
Per una introduzione aggiornata alla ermeneuaci rinmndo a M. Ferraris
54
55
2) al piano ed ai livelli di ciò che si è chiamato Presupposizione, (altrimenti
indicata anche come Conoscenza Previa,Precomprensione ed nell’ambito
della semiotica, “enciclopedia” o “thesaurus”60)- appartiene non solo un certo
numero di contenuti concettuali ed un determinato ordinamento degli stessi,
ma anche una particolare visione di ciò che in generale debba intendersi per
teorizzazione e teorizzazione filosofica, e per Racconto-Narrazione.61
La seconda mia osservazione tiene conto di quella circostanza di fatto già
evidenziata e che ora richiamo correndo il rischio di apparire pedante e ridondante
e forse stucchevole; ma lo esige la acutezza e la complessità della questione.
Il modello standard di teoria e di teoria filosofica, che si è imposto di fatto e che è
stato omologato nelle Scuole e nelle Accademie come quello proprio di un approccio
e di una impostazione scientifici, prevede tra l’altro questa condizione necessaria :
si darebbe consapevolezza teorica solo quando essa sia data dall’ autore in forma
|DDP|,e ,dunque, anche astratta-generalizzante, astratta-determinata. Così pure
non vi sarebbero,perciò, speculazione e prodotti speculativi nei discorsi che
pretendono essere riconosciuti come filosofici, fuori da questa modalità
fondamentale di produzione e di espressione.
Ed ad essa si deve poi aggiungere quest’altra proprietà : ciò che è teorico dovrebbe
essere anche necessariamente dottrina, cioè argomentazione sistematica, per
postulati e definizioni dichiarate, e non mescolata con l’elemento retorico, che
determinerebbe genericità, oscurità ed ambiguità di significato, violando così la
regola del rigore, della chiarezza, della distinzione, della nettezza , coerenza e
completezza dei nessi, della necessaria mediazione concettuale.
Tutti i modelli ermeneutici applicati ai testi platonici – e per quello di Gadamer
bisognerebbe fare una considerazione a parte per quanto egli scrive nei suoi “Studi
Platonici” su Aristotele e la nozione di “riflessività”62- condividono questa
presupposizione sulla natura della teoria; e sulla base di questa comune previa
ottica, prae-giudizio, essi poi calano su i testi le loro mappe e procedimenti di
decodifica per scoprire ‘che cosa ha detto e pensato veramente Platone’.
Qui osservo di passaggio soltanto che l’idea gadameriana di “circolo ermeneutico” –
che M. Migliori con G. Reale crede di valorizzare con la sua applicazione al rapporto
tra il Platone Orale ed il Platone scritto- è dichiaratamente elaborata da Gadamer in
un piano funzionale che è fenomenologico e non dottrinario e non sistematico;
e,pertanto, l’uso che essi ne fanno è ,rispetto a Gadamer ,improprio.
Vlastos 63che si propone di essere un puro storico e non un teoreta, è vuol far valere
fino alle estreme conseguenze dello smembramento di due ‘Platoni’ la forza e la
U. Eco, Trattato di semiotica, Lector in fabula, I limiti della interpretazione.
La questione di idea.racconto è prospettata nel contesto del dibattito sulla natura della teoria
filosofica per es. da S. Givone.
62
Gadamer, Studi Platonici.
63
Vlastos
60
61
quantità dei dati testuali che raccoglie, è condizionato nella sua ricostruzione dei
pensieri di Platone da questo prae-giudizio di fondo, che è quanto di più
teoreticistico si possa immaginare, proprio perché investe indirettamente ed
implicitamente l’idea stessa di teoria in generale e di teoria filosofica in particolare.
G. Reale con Kramer, Gaiser, Szlezàk, - autori della “nuova interpretazione”,
“storico-ermeneutica”-, muovono da questo stesso presupposto squisitamente
teoretico, che fa anche capire perché essi ritengono così importante il ‘Platone
Orale’ della tradizione indiretta .
E la ragione sta nel fatto che questo Platone ci si offre appunto come autore
dottrinario puro della più importante delle sue speculazioni : quella della dottrina
pura dei Primi Principi e – su questi fondamenti- della Deduzione Sistematica per
livelli logico-ontologici ed analogici di tutto ciò che è razionale e reale.
Questo Platone delle “Idee-Chiave” – secondo la formula di G. Reale64- diventa così
la dottrinaria cartina di tornasole per andare alla ricerca e trovare, isolandoli e
separandoli dall’ elemento narrativo-retorico, i contenuti speculativi , filosofici,
presenti nei testi dei dialoghi sotto il velo di una forma letteraria atipica
,insolita,unica.
Che poi questi stessi interpreti precisino che il sistema così scoperto debba essere
considerato un “sistema aperto”, non fa venire meno ed anzi ribadisce che il
modello di riconoscimento adottato da essi è conforme al paradigma funzionale
|DDP|. Essi, perciò, stanno ancora con questa precisazione sotto l’influsso
condizionante e determinate di quella presupposizione su ciò che debba intendersi
per teoria e su ciò che non lo sarebbe.
La capacità di resistenza e la forza di affermazione della Scuola di Tubinga e di
Milano rispetto alle altre Scuole, che non ritengono né necessario e né decisivo il
riferimento alle platoniche Dottrine non scritte, è dovuto anche ed in grado
rilevante al fatto che queste Scuole concorrenti e rivali – come ad esempio quella di
Vegetti e di Cambiano si situano e si muovono dentro la stessa presupposizione, cioè
appunto dentro una concezione della riduzione del fare teoria al modo |DDP|.
Pertanto, la notevole quantità di dati e loci testuali che M. Migliori trova 65 a
conferma e per corroborare la correttezza ed adeguatezza di questa interpretazione
“storico-ermeneutica”, subisce una distorsione di fondo, perché quei dati vengono
usati dopo che Migliori operativamente ed implicitamente li ha separatii dal loro
effettivo ‘codice di produzione’ e dal loro contesto costruttivo-funzionale; ed esso
in Platone Scritto – mi ripeto- non è affatto di tipo originariamente |DDP|, ma
è.dipendente dalla matrice caratteristica di paradigma funzionaler |GG|.
Fuori da questa matrice i relativi loci testuali assumono un significato diverso e in
più casi opposto. E ciò, ad esempio, si verifica in rapporto alla posizione platonica
64
65
G. Reale
M Migliori, cit. pp 1407-1448.
sulla poesia, sulla scrittura, sulla retorica, come cercherò di illustrare, utilizzando il
principio del gioco fino in fondo, cioè fino a conferirgli un primato funzionale
sull’altro.
In Migliori, che pure ci invita – come ho ricordato- - a giocare con Platone che gioca
, al contrario e di fatto , è proprio quest’ultimo modo a prevalere fin dalla messa a
fuoco del problema specifico di ogni dialogo.
Nel Parmenide,per esempio e per me, , il problema non è quello della possibilità di
poter pensare rigorosamente l’Uno in sé, come sostiene il Migliori nella sua vasta e
ricca indagine; bensì quest’altro così articolato : perché una concezione dell’ Uno
come Ente-Oggetto Ideale (quella del giovane Socrate) non può costituire lo
strumento teorico che ci permette di falsificare la opinione sofistico-eristica di
quanti sostengono la non verità necessaria ed universale del principio di identità e di
non contraddizione, che costituisce la manifestazione primigenia della attività di
concettualizzazione ? E poi : come si dimostra in una mediazione discorsivoargomentativa, in forma di esercizio-prova cruciale, la validità di questo principio,
che in quanto principio si porrebbe in maniera assoluta e che in quanto tale non
sarebbe dimostrabile ?
Platone lo fa portando in primo piano il nucleo funzionale-costruttivo di quella
logico geometrica-matematica, che conoscerà la sua compiuta formalizzazione negli
Elementi di Euclide e che Platone in Accademia maneggiava nel suo nucleo
statutario a livello magistrale .
Dobbiamo,dunque, saper ripensare – magari con l’aiuto del lavoro di Acerbi 66(2007)
ed in parte della ricerca di Toth 67sull’Aristotele matematico- che significa per un
matematico greco |ipotesi|, |problema|, |teorema|, |dimostrazione|,
|dimostrazione per assurdo|, |prova|,|sistema|, |operazione-costruzione|,
|equazione|; e soprattutto in quale contesto operativo implicito, non dichiarato
preliminarmente da Euclide, nascono le |definizioni| ed i |postulati|.
Nel Parmenide Platone , sul piano di una metalogica analogica ed avendo come
bersaglio non un problema di logica matematica ma una innominata ,implicita,
raffinata variante di una falsa opinione eristico-sofistica, guarda verso questo
modello d’origine geometrico-matematica per valorizzare analogicamente la sua più
preziosa qualità generale : il saper trovare una Invarianza in Processi di Variazioni
del Punto che si muove in uno spazio delimitato da tre matrici dinamiche
fondamentali : l’Angolazione, la Circolarizzazione, la Triangolazione.
Queste invarianze determinate sono appunto i Teoremi. Il concetto platonico di
Idea-Paradigma-Modello guarda analogicamente verso questo ambito –campo
d’origine e ne costituisce una ‘metaforizzazione logica’, un metamodello analogico.
66
Acerbi
67
Toth
Per farla breve – e rinviando alla mia interpretazione del Teeteto- il mio punto di
vista è il seguente : nel Parmenide Platone adotta il metodo operativo e di una
dimostrazione per assurdo e nella messa in opera di un esperimento teoricolinguistico; questo consiste in un ‘bombardamento’ mirato e sistematico della
tavola articolata in più livelli della Matrice-Sistemica, logico-linguistica-ontologica,
che è la relazione fondamentale |uno-molti| e perviene al risultato mirabile della
esibizione performativa, del mostrarsi da sé, della cosa : questo cosa è l’unomedesimo, l’ “uno in sé”, cioè inteso come Invarianza-Costanza di una Relazione di
Negazione.
Attraverso questa strada Platone perviene alla soluzione del problema che è
effettivamente in gioco nel Parmenide; vale a dire come si dimostra la necessità ed
universalità di quel principio di uno-medesimo, di fondamentale InvarianzaCostanza, che è appunto il principio di Identità e di non-contraddizione, che per
Platone ha una valenza logico-ontologica e nello stesso tempo assiologica cosmologica-teologica.
Potrei dire il senso complessivo di questa opera anche in questo modo : guai a noi se
non riuscissimo a dimostrare la verità di questo sommo principio che la falsa
opinione/pseudè doxa del modo di produzione sofistico-eristico dei logoi mette in
discussione; e se,infatti, non fossimo capaci di farlo allora avrebbero ragione quelli
che chiamano giusto l’ingiusto, bello il brutto. vero il falso, utile il dannoso, dare vita
il dare morte all’altro.
La negazione di questo principio è la massima ‘arma’ culturale – o meglio
pseudoculturale- che ha a disposizione ogni potere tirannico ,violento ed
arbitrario/Pleonessia, per legittimare ‘ideologicamente’ i suoi interessi. Questo
assoluto relativismo non giova forse alle logiche di dominio, come in un contesto
non platonico, segnala anche l’analitico Bogossian68 ?
Ci sono ,dunque, importantissime motivazioni etiche , politiche, educative,
teologiche che non ci consentono di abbandonare il terreno dove la più sofisticata
versione del sofisma/menzogna ci sfida, negando appunto il valore di verità di quel
principio e ,quindi, la sua natura e valenza di principio, la sua principialità.
E Platone accetta la sfida : fa finta di dare per buona quella pretesa sofistica e
poiché essa pretende di essere vera e giustificata, decide di applicarla
coerentemente, sistematicamente e compiutamente alla Tavola Massima/UnoMolti.
Ora proprio la Coerenza e la Sistematicità di questa Applicazione fanno emergere
necessariamente un Ordine/Kosmos di Negazioni, determinando con ciò stesso
autoconfutazione performativa della legittimità di quella Pretesa; appunto per la
ragione che quella massa di negazioni si danno ed appaiono comunque in un
principio d’ ordine : la Costante di una Relazione di Negazione , come si è detto.
A proposito della questione del relativismo. E del suo contesto etico-politico Tornata di attualità
si veda ad ese,
68
E così che da lettori adatti possiamo assististere alla ‘rappresentazione’ della
soluzione del problema intrinseco e tutt’uno con il gioco giocato che viene alla luce
nella scrittura del Parmenide; scrittura che, pertanto, si mostra nella sua
attualizzazione nella attività del leggerla, sufficiente ed adeguata a veicolare la
soluzione determinata di un problema determinato in essa ‘depositato’.
E sul Parmenide, dialogo fondamentale per la tesi generale di M. Migliori, ritornerò
più avanti, avendo qui abbozzato un tratto di linea generale di interpretazione
diversa da quella del nostro autore.
2.2 La scrittura, che dice sempre debolmente la verità, necessariamente la dice
debolmente anche quando parla di se stessa in ordine al proprio valore cognitivo,
cioè nell’atto- enunciativo pur scritto |la scrittura dice sempre debolmente la
verità|.
Con questo paradosso autoreferenziale introduco le mie osservazioni sul primo
capitolo del primo volume del libro di Migliori, dal titolo Come Scrive Platone 69.
Seguendo soprattutto in questo G. Reale e Szlezàk, Migliori conserva la presunta
svalutazione platonica della scrittura come un architrave del suo modello
ermeneutico.
Egli continua a credere che il Fedro e la Lettera VII soprattutto, conterrebbero la
prova, la “autotestimonianza” – come precisa Reale- se non di una condanna e di un
totale misconoscimento, certamente di una svalutazione della valenza cognitiva
della scrittura e del libro intorno ai valori di verità ed in particolare modo riguardo
alle verità ultimative : quelle dei primi Principi, oggetto della platonica dottrina non
scritta e data dal suo autore per “oralità dialettica” a discepoli adatti a
comprenderla.
L’ evidenza che avrebbero le relative porzioni testuali e sulle quali anche Migliori fa
leva, è – come già in parte ho anticipato- un dato carico di teoria e di teoria della
teoria; e –almeno il Fedro- sta anche , relativamente a questi passaggi sulla
scrittura, certamente sotto il segno ed il modo funzionale |GG|.
Ma il testo della Lettera VII è ancora un gioco o ha valore di documento di una pura
e veristica autobiografia politica ed intellettuale del Platone storico ?
Per questo stesso testo si deve applicare la visione di una ‘scrittura debole’ ? Oppure
si può dire che il genere letterario |Lettere Platoniche|- e soprattutto la Lettera VIInon è affatto del tutto fuori da una modalità inventiva-espressiva di tipo oratorioepidittico, con effetto spettacolare e teatralizzante, come si ammette
implicitamente, quando si parla analogicamente – e lo anche Migliori- di “teatro
filosofico 70” (, , di “scena della scrittura”, di ‘nomina dramatis’ ?
Nel tentare di rispondere a queste domande procederò in ordine, iniziando dalla
ricostruzione essenziale del Fedro offerta da Migliori nel suo capitolo.
Metto in rilievo in primo luogo tre indicazioni che ci vengono dal testo ripreso in
fase di prima lettura, di lettura di primo livello :
1) le dichiarazioni platoniche che riguardano la natura ed il valore della scrittura
appartengono ad una sotto-struttura testuale generata secondo la forma del
“mito”: il racconto-fabula di Teuth.
2) La scrittura è considerata come una invenzione che viene presentata in un
gruppo di invenzioni che sono tutte, a diverso titolo e rispetto a diversi ambiti,
nomi di situazioni che sono attività di giochi cogntiivo-figurativi-linguistici : la
69
70
M. Migliori, cit. pp. 25-190.
M. Migliori, cit. p. 26.
geometria, la aritmetica, la astronomia, il gioco della schcchiera e il gioco dei
dadi;
3) I loci testuali ‘ che parlano’ della scrittura sono compresi in un tutto testuale
determinato, al quale appartiene anche la parte dell’Esordio-Prologo; ed io
aggiungo : essa vi appartiene in maniera integrante e sostanziale ai fini
dell’orientamento della semantizzazione e della teorizzazione messe in opera
da Platone in questa tappa della sua navigazione nel mare dei logoi..
Ora proseguo così : di queste indicazioni da me evidenziate, le prime due sono
certamente e naturalmente punti di partenza di Migliori, in quanto “dati innegabili”;
per la terza osservo che egli nel suo richiamo al Fedro , pur non tralasciando la
figura-ruolo di Lisia che appare nell’ Esordio-Prologo, poi,però, non ne coglie la sua
forza segnica di decisivo orientamento del senso complessivo che la sua figura-ruolo
ha su ciò che Migliori continua a pensare – e per me in maniera impropria e non
pertinente alla matrice del gioco- come dichiarata dottrina ultimativa di Platone
sulla scrittura.
Che cosa non vede Migliori in questo Lisia dell ‘Esordio-Prologo e perché non riesce
a scorgerlo ?
Per il nostro autore Lisia nel testo figurerebbe, sostanzialmente e prevalentemente,
come eccellente portatore di una Techne, quella del saper scrivere per un pubblico e
saper leggere al pubblico e, quindi, rimanderebbe alle caratteristiche proprie del
Lisia , individuo storico. Platone ‘per Socratem’ polemizzerebbe in tal modo contro
lo statuto intrinseco a una Techne e contro quel suo illustre esperto che sarebbe il
Lisia che appare sulla scena della sua scrittura.
A questo punto osservo :
a) Per sapere chi è il Lisia del Fedro, bisogna stare attenti a cogliere ciò che
Platone gli fa fare sulla scena : sono le sue Azion ‘raccontate dall’uditoreFedro’ ad identificare e qualificare la portata semantica del suo nomeMaschera e del suo effettivo ruolo nel complesso di quel determinato gioco
giocato che anche il Fedro è.
E noto di passaggio che così rimando ad un canone teorizzato dall’ Aristotele
della Poetica;71 e sono consapevole che con questa notazione apro un
problema dei rapporti tra Platone e l’ Aristotele dell’opus aristotelicum che va
ben oltre la questione, pur importante, della posizione di Platone sulla poesia
ed dell’altra connessa: vale dire : in che misura l’Aristotele di quel trattato è
un platonico72 ?
L’interrogazione deve estendersi a ben oltre e fino a questo punto : in che
misura è platonico l’Aristotele d tutto quell’opus , cioè in che misura ed in
71
72
Aristotele, Poetica
Berti
quale piano di lavoro culturale egli conserva e sviluppa le ricerche e le lezioni
del Platone Orale ? Chi è effettivamente il ‘Platone’ che Aristotele critica ?
Mi riservo di tornare su questo punto strategico, quando cercherò di offrire
qualche utile spunto per capire (i)‘ chi è il Platone Orale’ , quello
‘Sconosciuto’; (ii) perché non è riducibile al Platone autore della dottrina
orale dei Principi, (iii) perché la portata in primo piano di quest’altro volto di
Platone è fondamentale per comprendere che cosa accade nella ‘grammatica
costruttiva-funzionale’ generatrice della sua eccezionale testualizzazione, (
ben prima ed oltre ,dunque, dell’ influsso del Platone Orale sulla struttura e
dinamica semantica realizzate nell’opera scritta ed alludenti a quella dottrina
orale sulle cose “più importanti” e “massime”) ;
b) Dobbiamo applicare al nome-maschera |Lisia| questo codice – o se si vuole,
sotto-codice- di decodifica, di riconoscimento del suo ‘senso e funzione
scenici’, se intendiamo dare una precisa connotazione alla “metafora viva” 73
che è l’ immagine di un “teatro filosofico”, che è fatta propria anche da
Migliori nel relativo paragrafo | La fiction svela le intenzioni dell’ Autore|. Ne
riporto il significativo passaggio : “Data la genialità artistica di Platone
sarebbe meglio cercare di non ricondurre in unico schema la sua capacità di
comunicare. Ciò ha molte conseguenze : ad esempio bisogna smetterla di
pensare che sia sempre Socrate a proporre la filosofia di Platone. Questo
non può costituire un principio ermeneutico assoluto : è il teatro filosofico
che si svolge sotto i nostri occhi a parlare al lettore attento”.74
Tra le conseguenze di cui parla Migliori, aggiungo da parte mia anche questa :
se il lettore-spettatore dei logoi scritti platonici vuole essere coerente e
rigorosamente conseguentemente, conformandosi nelle sue applicazioni
interpretative alla natura funzionale propria di questo codice di fruizionericonoscimento, allora non può non contestualizzarlo storicamente e
culturalmente.
E, perciò, non si può parlare in maniera generica di “teatro filosofico”, ma
dobbiamo guardare al teatro dei Greci del V e IV secolo a. C., ed a quella
‘grammatica’della drammaturgia classica che è appunto data, relativamente
alla tragedia dalla ricordata Poetica aristotelica.
E dobbiamo guardare verso questo campo di origine della matrice propria
della forma del piano di invenzione-composizione-espressione che viene alla
luce con i dialoghi, sapendo che Platone intende fare teoria filosofica e non
teatro in senso proprio e stretto.75 Dobbiamo, quindi, prepararci a capire che
cos’è e come funziona dal punto di vista cognitivo-immaginativo-linguistico
73
74
75
P: Ricoeur
M. Migliori, cit. p. 93.
Badiou
quella operazione analogica di metaforizzazione, funzionale e strutturale, di
elementi essenziali della grammatica drammaturgica attica, e che approda a
ciò che possiamo chiamare |scrittura spettacolare e teatralizzante di una
teorizzazione rigorosa eseguita in forma di gioco giocato|, che prevede un
lettore-destinatatori come “spettatore di logoi”76 , ma di logoi di una nuova
modalità di teorizzazione.
Per tutto ciò un’altra conseguenza importante è questa : quando parliamo di
|dialoghi| in relazione alle opere di Platone dobbiamo sapere che questi
discorsi, in prima istanza ed in via diretta, non imitano a mezzo di scrittura
alfabetica l’esperienza del colloquio filosofico vivo di individui della storia, ma
la dinamica del racconto e del dialogica propria della comunicazione
drammaturgica attica.
E,perciò, i cosiddetti |dialoghi platonici| non sono una Mimesis diretta del
dialogare naturale della comunicazione quotidiana, né di quello di esperti
impegnati in una discussione puramente epistemico-tecnica dentro i loro
circoli di addetti ai lavori.
In questo senso possiamo dire che quelli platonici non sono dialoghi ; ciò che
al livello di superficie testuale leggiamo immediatamente come articolazione
discorsiva per domande-risposte sta dentro una grammatica funzionale e
costruttiva di fondo che ne fa passi-mosse-battute di un calcolo logico ed
argomentativo puntato su un preciso bersaglio. Questo è sempre
riconducibile ad una Pretesa ; il riferimento ad essa è Indispensabile anche
per identificare e qualificare la figura ‘ logica’ di Lisia .
La disposizione del discorso per domande-risposte in Platone,pertanto, non
ha nulla dello spontaneo e dell’imprevisto proprio di una conversazione
quotidiana; il movimento dialogico affonda costantemente le sue radici in
movimento dialettico, cioè appunto in un gioco-calcolo di significazione, che
risponde ad una strategia che si realizza in mosse-battute, in sequenze
montate secondo un preciso e cosciente disegno dell’autore.
L’effetto espressivo e pittorico-scultoreo di freschezza, vivacità, colore, che
caratterizza alcune opere come l’Eutifrone, lo Ione, il Carmide, il Simposio e
si attenua di molto in altre come ,ad es.,Leggi, costituisce la superficie
luminosa o la cornice preziosa di un quadro che è,però, sostanzialmente una
‘opera di teoria filosofica. E questo vale anche per l’Apologia di Socrate ed il
Critone.,il Menesseno.
c) Il colpo di scalpello, il tratto di pennello che la scena dell’esordio rappresenta
suggerisce e rimanda ad uno sfondo che è essenziale per situare il
personaggio Lisia nel suo contesto socio-culturale e, quindi nella scena del
testo. Il suo volto presuppone che il lettore sappia inanzitutto tenere
76
D. Loscalzo
presente uno scenario che fa da sfondo. Questo fuori-scena è il tempo-spazio
dove brillanti retori cioè esperti di comunicazione pubblica alle cui
conferenze da parata –per usare una espressione di G.Reale- accorrono
ambiziosi giovani intellettuali di ricche famiglie greche; queste vivono in una
Polis segnata ed impregnata da una comunicazione pubblica a spettacolarità
diffusa e spinta, dove “l’elemento-teatro”77 pervade anche quelle esperienze
sociali diverse da quella teatrale in senso proprio; tali sono le riunioni
simposiali, le assemblee politiche e giudiziarie, le feste popolari, gli eventi
culturali come le conferenze in case di famiglie in vista in città e di personalità
illustri, come viene rappresentato ,ad esempio, nel Gorgia.
In questa Polis molti intellettuali sono alla ricerca ossessiva della massima
visibilità, di un alto indice di gradimento del pubblico, e sono spinti, pertanto,
dallo smanioso desiderio di occupare il centro della scena sociale anche con
colpi di teatro, con trovate sensazionali escogitate apposta per fare scalpore
in città.
E questo è il caso non solo del Lisia di Platone, ma anche di altri suoi
personaggi come Eutifrone, Ione .
Su questo sfondo storico Platone crea la figura di un Lisia che per fare
audience e denaro, annuncia di aver scritto un libro su eros che
rappresenterebbe una rivoluzione culturale e dei costumi e sarebbe capace da
sè di convincere, con la bellezza del suo stile e la brillantezza della sua
argomentazione, giovani intellettuali sulla verità del suo rivoluzionario
messaggio : l’amato dovrebbe corrispondere con amorosi sensi non chi lo
ama, ma chi non lo ama.
Il volto di Lisia ha come tratto caratteristico proprio questa Pretesa, quella di
credere e di voler far credere che con un libro ‘ben fatto’ si potrebbe
dimostrare tutto ed il contrario di tutto, anche in riferimento a ciò che
appartiene alle “Cose Massime”, come l’esperienza di eros.
L’avvio accennato dall’ Esordio-Prologo mette di colpo in campo, dunque, il
Caso di una comunicazione pubblica deformata, distorta, che pubblicizza
come vero un falso messaggio, e che a questo scopo usa ed abusa di quel
mass-medium che è la scrittura, il libro.
Contro questo stravolgimento e corruzione dei valori di interesse generale, e
contro l’abuso di una techne , contro questi fenomeni che contaminano ed
ammalano l’anima dei giovani intellettuali – come il Fedro di Platone- si
muove il Socrate platonico , che ben conosce l’autentica arte della scrittura ed
i ‘segreti’ della vita amorosa, i ‘misteri’ dell’anima dell’amante e di quella
dell’amato.
E quando Platone in questo stesso esordio ci figura un Fedro stressato dalla
travolgente performance di Lisia e che, perciò , ha bisogno di passeggiare e di
77
Friedlander
aria di campagna e della pace dei boschi, ci dice indirettamente che il suo
giovane amico patisce un disagio che esistenziale e mentale e che egli ha
bisogno di essere curato e possibilmente avviato sulla via della guarigione;
guarigione che investe la stessa sua immagine della essenza della scrittura.
In “opere operato” il gioco giocato , istituente e movente la struttura e le
sottostrutture della testualizzazione del Fedro, si afferma così via facendo
anche come terapia-purificazione della cognizione , della immaginazione e del
linguaggio , colti nei loro ‘movimenti’ intorno all’essenza del libro e dell’eros.
Ed ancora una volta questo Fedro, soggiogato e plagiato da un distorto uso di
una techne e del suo prodotto, ci dice qualcosa di essenziale ed implicito nella
figura di Lisia : questi è mosso e guidato non da un autentico paradigma dello
statuto funzionale della scrittura, ma da un falso modello, da una falsa
immagine logica della sua essenza tecnica.
Il suo gioco ingannatore, che mira a catturare l’adesione entusiastica del suo
pubblico, amante delle cose alla moda e di successo, si avvale implicitamente
appunto di quella pseudo-immagine che Platone denomina nel Sofista
|phantasma|78, cioè un simulacro prodotto da una falsa-modellizzazione :
quella della Dossomimetica. 79In questo Lisia opera appunto implicitamente
una variante di questa Dossomimetica, quella appunto che prende di mira le ‘
virtù magiche’ dell’alfabeto e dei suo segni grafici, che fissano e danno
stabilità alle nostre parole ed ai loro significati.
Tutto ciò non solo è importante tenere presente, ma è decisivo per
individuare con precisione di che cosa parla Platone quando polemizza con la
scrittura; quale è il suo effettivo ed operativo bersaglio; a quale piano esso
appartiene.
Valorizzando uno spunto illuminante di Derrida,80 autore della “Breve storia
della menzogna” che si interessa anche all Ippia minore, dico che il simulacro
non ricade nell’ambito delle Technai, ma Attorno ad esse, Dopo di esse, Sopra
di esse. La falsa immagine logica, cioè è il prodotto di una cattiva metalogica,
di una distorta visione metatecnica, quella propria ed intrinseca al modo di
produzione sofistico-eristico dei discorsi pubblici.
Questo significa che la scrittura, di cui Platone parla nel Fedro, è da lui vista
,ripresa ed attaccata, dentro un contesto di gioco, nel quale essa viene fatta
apparire travestita e tradita nelle sembianze di quel simulacro lisiano.
L’introduzione del nome-maschera |Lisia| è, pertanto, una mossa iniziale
determinante e da mettere in forte rilievo per cogliere l’effettiva intenzione
del Platone critico della scrittura.
78
79
80
Sofista
Sofista
J. Derri,da, Breve storia della menzogna.
Ma questo non fa Migliori, pur muovendo dalla idea di “teatro filosofico” ,
dalla posizione della centralità del paradigma del gioco giocato e del canone
della fedeltà all’intero testuale, alla sua totalità determinata di singola opera.
d)Perché Migliori non si spinge a tanto, perché continua a credere e sostenere
che Platone sarebbe autore di una dichiarata dottrina di relativa svalutazione
del valore cognitivo della scrittura ?
Tento questa risposta : il suo modello ermeneutico è un modello misto, nel
senso che esso mette insieme lo sguardo sul testo secondo il paradigma
funzionale |GG| e quello di un riconoscimento dei valori di teoria secondo il
paradigma |DDP|.
E, pertanto, Migliori combina ciò che è proprio di una logica-ottica
dell’implicito con ciò che essenziale ad una logica-ottica dell’esplicito, dato
quel modo appunto che è caratteristico appunto dello stile accademico ,
disciplinare-, pe ripartizioni tematiche.
Ma nelle sue applicazioni interpretative ed in questa combinazione le due
ottiche non stanno alla pari, soprattutto lì dove Migliori – come si è già
notato- procede a identificare e qualificare la forma, la formula ed i termini
del problema che costituiscono il centro gravitazionale dell’opera di volta in
volta presa in esame; ed io l ‘ ho messo in evidenza a proposito dell’esordioprologo del Fedro e vi tornerò sopra quando esaminerò l’interpretazione dello
Eutifrone data da Migliori.
Questa subordinazione da parte sua del modo implicito a quello esplicito
costituisce di fatto una significativa limitazione del grado e del campo di
applicazione del principio |GG|, che non costituisce più così in Migliori, la
matrice funzionale fondamentale e preminente per la ricostruzione
interpretativa del testo platonico.
Ora io, invece, sostengo che in tutto il Platone Scritto dei dialoghi è
costruttivamente e funzionalmente centrale e dominante proprio il principio
|GG|, la matrice dell’implicito rispetto all’esplicito dato nel modo e nello stile
|DDP|.
E’ ,dunque, il tutto delle mosse del gioco , il suo moto dall’ esordio all’epilogo
e dall ‘epilogo all’ esordio, a dare il proprio preciso senso a termini, frasi,
sequenze del discorso testualizzato : e questo vale anche per quanto Platone
fa dire al suo persoanggio Thamus a commento ed a condanna della
invenzione della scrittura da parte del dio egizianoTheuth.
“ Non solo bisogna evitare di assolutizzare e di isolare singole affermazioni”81
– come raccomanda Migliori in una sua osservazione su una interpretazione di
Gonzalez sul rapporto tra percezione sensibile e l’idea di opposti: ma è
necessario, in riferimento a Platone , soprattutto evitare di estrarre e valutare
81
M. Migliori, cit. p. 712.
una singola affermazione fuori dal gioco giocato. E purtroppo Migliori fa
metodicamente a proposito della scrittura quello che egli rimprovera su un
altro tema a quel suo interlocutore.
E per chiarire che significa e cosa comporti l’attenersi o meno al contesto di
gioco faccio questo esempio e prospetto questa situazione : un pallone con
un calcio viene gettato fuori dal campo da un giardiniere che ne sta curando il
prato; supponiamo ora chequesto pallone sia visto da un osservatore
esperto di calcio che sta passando per quel luogo.
Domanda : questo palllone in quel suo posto fuori campo ha per questo
osservatore lo stesso significato del pallone che si troverebbe nello stesso
posto perché vi è stato spinto con i piedi da un giocatore a partita iniziata e in
corso ?
Evidentemente no; Infatti, in questo suo ultimo stato il pallone veicola una
sua proprrietà circostanziale che nella prima situazione non ha: e questa suo
proprietà-connotazione recita: “ il pallone finito fuori campo per l’azione di un
giocatore deve essere preso con le mani di un giocatore appartenente alla
squadra avversaria e con le mani deve essere da lui rilanciato in campo’.
E’ l’uso di esso, dunque che gli conferisce il preciso significato nel posto che
esso occupa e nella relazione che ha con il contesto; ma questo uso dipende
dal farsi stesso del gioco e dalla attualizzazione e dalla riproduzione delle sue
regole.
Le frasi di Platone sulla scrittura, isolate da Reale e Migliori dal loro contesto
funzionale del gioco giocato e trattate in via principale secondo una logica
|DDP|, vengano in tal modo riprese e riusate non in conformità al loro
principio di produzione che è quello del primato di |GG|.
Essi per questa via finiscono per attribuire a Platone- autore della ‘giocata
con lil pallone/scrittura- una intenzione di senso che non è sua, appunto
perché Platone- “autore implicito”82 esige che quella sua presa di posizione e
figurazione di gioco vengano comprese rimanendo dentro il piano costruttivofunzionale che la genera e gli dà forma proposizionale-testuale.
Rispettare il contesto e riportare le singole frasi ad esso significa, pertanto, in
primo luogo ricondurle e tenerle ancorate alla loro matrice funzionale, che
decide anche dellla loro intenzione di senso.
La dimostrazione sistematica indiretta di questa presunta dottrina platonica
sulla ‘insufficienza cognitiva della scrittura’ è stata elaborata da Szlezàk con la
sua ipotesi-chiave della “struttura di soccorso”83 applicata a tutti i dialoghi
platonici, a partire della stessa Apologia. Ed ai risultati di questa vasta ricerca
si rifanno anche Reale e Migliori, considerandola come acquisizione scientifica
irreversibile e fondamentale punto fermo del loro modello ermeneutico.
82
83
U. Eco, Lector in fabula
Szlezàk
La questione di che cosa effettivamente Szlezàk pesca con questo suo modulo
teorico ermeneutico e quell’ l’altra relativa al rapporto tra questo punto di
vista generale ed il principio del gioco serio- che è il cavallo di battaglia
specifico soprattutto di Migliori-, sono troppo importanti per essere
affrontate ora; e,perciò, mi riservo di dedicare a questo aspetto della
discussione il successivo mio paragrafo n. 3.
Voglio, invece, a questo punto evidenziare un’altra proprietà essenziale del
testo platonico : appartiene in maniera sostanziale al tutto determinato del
gioco la forma spettacolare e teatralizzante che –come in tutti i dialoghi
platonici- anche nel Fedro agisce e concorre ad orientare la significazione.
Che le dichiarazioni messe in bocca da Platone a Thamus siano date dentro il
modo del “mito”84 non è un caso , né solo una fascinosa preziosità di
arricchimento stilistico.
Ci troviamo in presenza, infatti, di un Racconto di Racconto, di un
Mitologizzare generale implicito nel quale ad un certo punto emerge , come
sua sotto-struttura e sotto-codice, un discorso esplicitamente qualificato da
Platone ,per mezzo dell’ Attore-Socrate, in quel modo.
Ed anche qui per questo ultimo termine bisogna uscire da una nozione
generica di esso, e ricordarsi che con |mythos|, nella Poetica85 di Aristotele,
viene chiamata una delle sei parti della tragedia.
Verso questa parte guarda analogicamente anche Platone-autore/regista e vi
guarda da greco e grande esperto di drammaturgia e come chi sa che il modo
di narrazione per mythos sta sotto il generale segno di una logica del
Tipologico86 e del Simbolico.87
A Platone , poi, non sfugge che la sua trasposizione analogica del nucleo
costruttivo del testo e della comunicazione drammaturgici, si estende anche
,tra l’altro, a quell’altra parte della tragedia che è la |lexis88|, cioè l’insieme
dei suoi registri e tonalità espressive.
A questo insieme appartiene anche il modo centrale della polemica dell’invettiva,
quello della ironia, quello della presa in giro, della canzonatura,
della
minimizzazione in contrapposizione ad una esasperata magnificazion enfatizzazione
di un evento, di un’opera, di un personaggio, di una opinione, di una techne.
Questi registri tipici sono all’opera anche ed in maniera rilevante nel Fedro ed il
racconto dell’incontro tra Thamus e Theuth è appunto escogitato ed espresso da
Platone con un registro in cui mescola invettiva e minimizzazione, in presenza di
Fedro
Aristotele, Poetica
86
Il termine |typos| fa segno
87
Qui per |simbolico|
88
Aristotele, Poetica
84
85
una esaltazione smisurata e deformante di quella natura della scrittura e del libro,
che è racchiusa nel nome-maschera/Lisia e nella descrizione indiretta della sua
Azione Caratteristica.
La forma-Mito ,pertanto, non va intesa e ridotta a semplice velo di una idea e tanto
meno di una posizione dottrinaria; essa non è un suo bel surrogato come ad
esempio, crede G. Reale,interprete del Simposio89, a proposito del mito fatto
raccontare da Platone al suo Aristofane.
Essa in sé ha, invece, una sua autonomia di statuto e da Platone viene potenziata
fino a valorizzarne al massimo la sua valenza di semantizzazione connessa
intimamente ad una problematizzazione-teorizzazione.
La polemica minimizzante , dunque, concorre ad individuare l’effettivo senso del
discorso platonico sulla scrittura, ma questa polemica deve essere contestualizzata
dentro la preminenza del gioco giocato e di tutto il gioco, sapendo cogliere la
traformazione funzionale che essa implica in sede di attività cognitiva di
riconoscimento.
Ugualmente devo ribadire questo punto: la dominanza del principio del gioco che
identifica con precisione la regola per individuare il ‘sottointeso’ ed il relativo ‘sottotesto’90 , si fa valere e riconoscere proprio nel momento in cui si tratta di individuare
ed isolare il problema portante in gioco, come sopra ho già messo in rilevo.
Mi pare, poi, che ci sia anche un’altra ragione per spiegare la decisione di Migliori
di privilegiare di fatto il modo della significazione e concettualizzazione per via
esplicita..
Non soffermandomi su ciò che potremmo chiamare gli effetti della deformazione
professionale tipica di un esperto e specialista di una disciplina accademica- la storia
della filosofia antica e platonica-,e che per forza di cose maneggia soprattutto
prodotti dottrinari in vincoli disciplinari di pertinenza-, qui avanzo questa ipotesi : la
opzione preliminare e programmatica di Migliori di considerare utile, necessaria,
decisiva la Dottrina Orale dei Principi, per decodificare i valori teorici del Platone
Scritto, gli impone oggettivamente, funzionalmente, – ben al di là, dunque, di un
dovere di solidarietà con gli altri esponenti della Scuola di Tubinga e di Milano- di
conformarsi ad un paradigma a dominanza funzionale dottrinaria nelle operazioni
interpretative. Di questo passo, con questa decisiva mossa iniziale, Migliori dovrà
approdare necessariamente ed inevitabilmente alla immagine di un Platone Scritto
che non avrebbe risolto ,in grado adeguato, con i suoi molti e vari giochi i suoi
problemi registrati nei suoi dialoghi.
Di questo passo e con questa decisiva iniziale mossa
Migliori deve
obbligatoriamente tenere ancora in piedi anche la immagine di un Platone, autore di
un pensiero forte affermante una scrittura costituzionalmente, cognitivamente,
debole.
89
90
G. Reale
Per questo termine e nozione cf. Sedley
3. I capisaldi della strategia ermeneutica di Migliori .
Ai fini del mio studio e di questo confronto con l’autore, riassumo i suoi capisaldi in
questo modo:
a) L’idea di “struttura di soccorso”, mutuata da Szlezàk;
b) Il paradigma del “gioco serio”;
c) Il canone del rispetto della totalità determinata di ogni singolo dialogo;
e,pertanto, il rispetto dell’obbligo di saper rendere conto di tutte le parti che
compongono ognuno di essi.
d) Il confronto con tutti i modelli ermeneutici ;
e) l’assunzione del Platone Orale come autore di dottrine i cui riflessi si fanno
leggere anche nel Platone Scritto, ma che non possono essere assunte come
esclusivo codice di decodifica del movimento concettuale e del senso
complessivo che caratterizza ogni dialogo; infatti, tutte le parti concorrono ad
una finalità unica e dominante : sapersi esercitare a filosofare;
f) e,pertanto, l’ idea secondo la quale ciò che sta oltre il Platone Scritto non è
una esperienza iniziatico-esoterica, riservata ad un circolo di una minoranza
privilegiata a contatto con l’insegnamento orale del maestro che illumina sulle
cose più notevoli, di maggior valore;
g) la tesi che in nessun dialogo al problema posto viene data una adeguata
soluzione;
h) la posizione del tema uno-molti come motivo fondamentale dei giochi-esercizi
messi in opera con una pluralità di testi.
i) la necessità di spiegare un ‘inquietante’ fatto culturale, “ un mistero che non
ci dovrebbe essere” : il generale e costante disaccordo tra gli interpreti nella
individuazione di quel principio che permette di rendere conto dell’unità
teorico e tematica capace di ‘abbracciare’ l’intero Platone Scritto, e . poi, di
chiarire il suo rapporto con il Platone delle lezioni orali.
j) La affermazione di un Platone autore di un sistema e di un opera aperti e dove
come |apertura| deve intendersi in via principale un saper andare con
Platone Scritto oltre Platone,cioè verso il sapere fare filosofia sulle “Cose
massime” , cioè su quanto oggi chiamiamo valori fondamentali della realtà
umana e naturale.
k) La qualificazione di questo sistema aperto come polivalente, ambivalente,
ambiguo e minato dall’interno da quella contraddizione mortale che sarebbe
data dalla posizione non di un originario prinicpio unico ma da una relazione
di contrari in tensione costante e non mediabile in un superiore Uno, che nel
Parmenide sarebbe dimostrato come “ineffabile ed impotente”.
Delineata in tal modo la rete che Migliori getta su i dialoghi per ‘pescare’ i pensieri di
Platone, ora intendo mettere in evidenza ciò che considero tre assi costitutivi
essenziali del nucleo del suo modello : il codice della “struttura di soccorso”, il
principio del gioco e l’individuazione del problema-guida; ll canone della totalità
testuale determinata in riferimento alla Lettera VII.
3.1 Richiamo la nozione di “struttura di soccorso” per ‘ i non addetti ai lavori.’
Leggendo Platone ci si accorge che ripetutamente egli omette di rispondere
compiutamente ad una domanda-guida e lascia aperto il relativo tema-problema,
producendo l’effetto di un ‘inconcluso’; e nello stesso tempo avvertiamo da lettori
che egli opera una riserva, rinviando operativamente al un altro momento
successivo per l’approfondimento della indagine.
Questo , ad esempio, accade emblematicamente – come ha messo in rilievo
Kramer91- con l’idea di Bene; e con tutti i dialoghi sulle virtù come ha dimostrato
Erler92, pur fuori dalla prospettiva della Scuola di Tubinga e di Milano; e come ha
provato per molti dialoghi – a partire dalla stessa Apologia- Szlezàk.
Il meccanismo della omissione-interruzione-riserva ed il rinvio ad uno stadio
successivo più ricco del precedente e con la funzione di illuminare a ritroso i luoghi
testuali della omissione-interruzione, essendo una costante costruttiva, viene perciò
ad assumente la valenza di una “struttura”. In virtù di essa l’intera testualizzazione
platonica si esibisce in un moto di ‘auto-oltrepassamento’, ‘auto-trascendimento’ di
se stessa vero il ‘mondo’ di una non-scrittura.
Questo movimento semantico ed argomentativo di un ‘autocongedo’ della scrittura
da se stessa-( fuori dalla visione sistematica-dottrinaria che sarà poi quella della
Scuola di Tubinga e di Milano) - era stato già messo programmaticamente in
evidenza in rifrimento a ciascun dilaogo da Friedlander, per il quale il mondo ,però,
della non-scrittura è la vita dell’uomo e cittadino Socrate, la sua esistenza ineffabile
fatta di scelte eroiche non ‘dottrinizzabili’ ed addirittura ineffabili: Il “mistero”Socrate, perosna storica.
Ricordo qui l’opera di Friedlander su Platone per chiarire questo punto : il
riconoscimento di questa dinamica “ingressiva” – come la chiama Migliori nella sua
introduzione al lavoro di Kahn-93 non costituisce la prova regina per dimostrare che
la sfera della non-scrittura si identificherebbe e si esaurirebbe nella dottrina orale
dei Principi, perché l’’Oltre-Scrittura’ può appunto essere configurata diversamente;
ed in questa direzione si muove anche Migliori, allorchè pensa l’OltreScrittura come
il saper fare filosofia dopo esserci esercitati con Platone nei suoi giochi.
Ma Migliori opera questa estensione del mondo della non-scrittura, tenendo ferma
e non rinunciando alla visione di una scrittura debole rispetto alla esperienza orale
di comunicazione filosofica, e lo fa nei termin e con gli argomentii della Scuola di
Tubinga e di Milano.
Assistiamo,però, comunque e di fatto – e sopra vi ho fatto cenno- ad una
variazione importante della dottrina orale dei Principi in quel ruolo direttivo
dominante che le attribuisce G. Reale con la sua formula delle “Idee –Chiave” e con
le sue applicazioni ad una serie di dialoghi. Questa variazione comunque – ed è
Migliori stesso a precisarlo- non costituisce una messa in discussione dei fondamenti
di quell ‘indirizzo e programma di ricerca della Scuola al quale l’autore non rinuncia
ad appartenere.
91
92
93
Kramer
Erler
M- Migliori
Dopo aver chiarito per il lettore non specialista il senso del codice di decodificazione
denominato “struttura di soccorso”, ora cercherò di stabilire quale sia il suo
rapporto con il paradigma del “gioco serio”.
Avanzo in questa prospettiva la seguente provocazione : non c’è nessun luogo
testuale dove Platone apertamente dichiari o dottrinizzi un tale principio costruttivo
e nomini espressamente |struttura di soccorso! e |passi di omissione|.
Voglio intendere con questa mia relativa provocazione quanto segue: Szlezàk,
l’autore –inventore di questa formula, può escogitarla perché guarda verso il testo
cercando di cogliere non solo ciò che Platone espressamente dice e concettualizza,
ma anche ciò che Platone fa e non dice con la sua testualizzazione. Egli ,cioè, legge
Platone “in opere operato” – secondo la formula dello stesso Migliori-; più
chiaramente egli fa emergere un “sottotesto” – per dirla con Sedley- lungo l’asse
autore- lettore adatto.
Il “sottotesto”, al quale appartiene la ricorrente dinamica della “struttura di
soccorso”, è funzione, dunque, della attivazione di una lettura che è oggettivamente
– limitatamente a questa visione sul testo- quella di un riconoscimento secondo il
principio performativo del paradigma |G G|,cioè per un gioco giocato riprodotto
dall’interprete e,quindi, ‘trans-dotto’, trascritto,poi, dal medesimo secondo una
grammatica del dichiarato, dell’illustrato e del dottrinario.
Il termine-dato che Szlezàk isola come dato emblematico della sua scoperta, cioè la
parola greca |Boethein94|-Andare in soccorso, è pregno, dunque, di teoria e della
sua teoria della teoria; e questo è una ulteriore prova che il dato testuale assoluto
non esiste e che,pertanto, non esiste una fedeltà testuale intesa come aderenza ad
un dato concepito in questa forma reificata,oggettualizzata.
Qualsiasi storico e qualsiasi esperto di storiografia filosofica e di filosofia antica deve
mettere la sua anima in pace e decidersi a fare i conti con le sue presupposizioni di
lettore vivo e che vive nel presente di una viva comunità umana, che ha tra l’altro
anche una particolare visione della natura del teorico e del non teorico.
Questo è anche il meglio della lezione di Gadamer autore di “Verità e metodo”
dentro il meglio della tradizione idealistica tedesca. Una eredità questa valorizzata
ed approfondita da Gentile e Croce, come ho sopra ricordato ; una eredità che
rimane preziosa e si conserva tale ben oltre gli usi e gli abusi95 dei testi perpetrati da
essi in nome e per conto di un inesistente “Spirito” e delle sue pretesi leggi del
superamento, dell’unità di finito ed infinito, della “eternità dello Spirito”96, della sua
Szlezàk vede agire questo termine con questa valenza strutturale e strategica già nella Apologia
di Socrate
95
Su questi usi-abusi cf. ad es. P. Rossi
96 Questa somma idea è la colonna portante delle filosofia idealistica; essa va intesa come la
posizione assoluta di quella Cosa, che è il genere umano che come genere sarebbe destinato alla
immortalità grazie e solo per la sua endogena ed inesauribile potenza di produzione di vita e di
valori. Questa idea delle idee e questo inizio reale di tutti gli inizi dai suoi autori non vengono mai
dimostrati o problematizzati, ma sempre posti in un ‘atto di fede’ immanentistico e nella
94
irresistibile ed eroica ‘cavalcata enciclopedica’, della sua risibile abilità chirurgica di
separare il vivo dal morto , della sue scorpacciate di ‘cannibalismo testuale e
culturale’.
In conclusione : la nozione-guida di |struttura di soccorso| è il prodotto di una
applicazione ai testi non, in prima istanza, di una logica del dichiarato, esplicito e del
dottrinario, ma appunto quella implicita di una riproduzione-ripetizione da parte di
un lettore-Cooperatore del movimento di ciò che è funzionalmente proprio di un
“gioco serio”.
Se così stanno le cose, allora anche in forza del modo in cui viene generato quel
codice di riconoscimento detto |struttura di soccorso| dovremmo mettere al centro
del funzionamento del modello ermeneutico di Migliori questo saper fare, questo
saper ripetere in tutte le sue mosse, figure e figurazioni, il gioco giocato da Platone e
fissato e registrato nella sua testualizzazione..
Dovremmo ,pertanto, sempre subordinare ad esso quanto nel testo platonico stesso
ad una prima lettura ci appare come significato dichiarato ed elaborazione
dottrinizzante. Ma di fatto in Migliori ed in Szlezàk non è così. Perché ?
Do subito la risposta : entrambi quando leggono i testi platonici e vanno alla ricerca
del problema proprio di ogni dialogo, si lasciano guidare da un modo di osservazione
e di riconoscimento che non è quello conforme al paradigma |GG|, ma a quello
|DDP|.
esperienza di una presunta autorivelazione della storia a se stessa come storia eterna. Sulla base
di questa fondamentale e suprema lex continui, viene trattato il problema del male, della morte
individuale, ed in generale del negativo. Per Hegel pensare filosoficamente è saper pensare le
molte e diverse manifestazioni della cultura e delle civiltà alla luce di questa legge di tutte le leggi,
principio di tutti i principi. Quando, perciò. B. Croce conierà la espressione “religione della libertà”
porterà in evidenza che l’idealismo di ispirazione hegeliana poggia nel suo inizio e cosa ultima in
un Atto di Fede, che se pur è proclamato tutto e solo mondano nondimeno rimane appunto
qualcosa di non razionale, qualcosa di non dimostrato e di non dimostrabile; esso come
fondamento sarebbe accessibilie solo per una illuministica e ‘romantica’ autoilluminazione della
storia a se stessa. Da qui discende anche la visione di un pensare filosofico come il saper dire e
concettualizzare in maniera rigorosa e determinata l’unità degli opposti e di reale e razionale; ed
in questa prospettiva teorica ,pertanto, l’idealismo rinforzato dall’ attualismo gentiliano e
riformato dallo “storicismo assoluto” crociano sente e denuncia ogni dualismo o giustapposizione
come ‘pensiero imperfetto’, immaturo, che deve essere perfezionato, e che si autoperfeziona in
uno con il movimento stesso della storia e delle sue culture.
Ho richiamato questo nucleo concettuale essenziale dell’idealismo tedesco e del neo-hegelismo
italiano, perché esso fa sentire la sua influenza anche su come Migliori interpreta e valuta il
rapporto uni-molti e quello di uni-molti e contrari in Platone, visto anche alla luce della filosofia a
questi successiva ( la tradizione di ricerca aristotelica e quella neo-platonica).
Ciò che Migliori chiama la |contraddizione mortale| di Platone è il risultao di un suo punto di vista
teoretico che oggettivamente – e quindi al di là della sua stessa espressa intenzione di voler essere
un puro storico “servo del testo”- è pregno del perdurante e profondo odierno influsso della
eredità hegeliana nella concezione dell’opposto e del negativo, del male e dell’errore.
Essi cadono in quel tranello che Platone stesso tende al suo lettore di primo livello
ed anche a quello accademico; e lo fa a fin di bene, cioè con l’intenzione di stimolare
il suo lettore a ritornare ed a stare sempre vicino alla sua scrittura, alle sue tracce.
Questo tranello è la rappresentazione del problema nel modo dichiarato secondo la
formula |Che cos’è X nel suo relativo ambito di esperienza al quale appartiene ?|.
Ho già richiamato sopra questo punto ed ora vi insisto, perché lo ritengo un
obbligato e fondamentale passaggio per capire il limite originario della nozione di
“struttura di soccorso” così come ripresa e rilanciata dal Migliori dei “giochi”Già indirettamente ho affrontato questo aspetto della questione, quando sopra
richiamando la funzione del personaggio Lisia nel Fedro; lì ho cercato di chiarire
perché è fuori dal gioco platonico il lettore che crede che Platone in quella opera
stia rispondendo ,in via principale e finale, alla domanda |Che cos’è la scrittura, che
cos’è il libro ?|.
E ho segnalato che il bersaglio vero, cioè quello determinato dall’insieme di tutte le
mosse del gioco, è uno Pseudos, una Pretesa Illegittima, incarnata in Lisia e che ha
contaminato il giovane intellettuale Fedro.
Questo Pseudos è implicitamente ed operativamente armato di una falsa immagine
logica della essenza della arte della scrittura e dei suoi prodotti. Come sopra ho
detto , Platone la smaschera con il suo Socrate e la ridicolizza, minimizzando
esasperatamente la natura e la funzione del libro in un contesto argomentativo di
una polemica drammatizzante.
Ora per meglio capire perche il momento dell’esatta individuazione del problema in
gioco è strategico e decisivo nella economia del modulo ermeneutico |Struttura di
Soccorso| e per la sua valutazione critica , passerò ad esaminare brevemente sotto
questo aspetto un dialogo che Migliori – e con lui la maggior parte degli interpreti
anche di altre tradizioni di ricerca -, considera aporetico, cioè caratterizzato da un
problema-tema posto e svolto con l’omissione ,però, della sua corrispondente
soluzione; sì che esso – ‘sul più bello’- sembra interrompersi nella promessa-riserva
di un ulteriore ricerca ed approfondimento in vista della adeguata soluzione di esso.
4. L’ esatto problema dell’ Eutifrone e la comunicazione filosofica del Platone
Scritto.
Come si cerca e qual è il dato-prova testuale di conferma del suo problema-guida ?
Chi legge il testo come Migliori – e sono ,sotto questo aspetto dell’aporeticità, i piùe crede che esso vada cercato in quella porzione testuale dove esso appare nella
formula |Che cos’è il santo ?| ed in quel contesto che può essere indicato come
|ambito delle virtù|, chi legge così si dispone ad uscire fuori strada, se non si
accorge che lo svolgimento del gioco argomentativo ha un progressivo effetto di
feed-back, cioè di retro-effetto, che investe e modifica l’assetto e l’orientamento
iniziale dello stesso problema.
Quando, dunque, pensiamo al paradigma |GG| e lo pensiamo in un suo primato
funzionale rispetto al paradigma |DDP| , dobbiamo anche necessariamente tener
presente questa sua importante caratteristica di ‘rinculo’ di ‘epìstrophè’.
Il gioco nella opera in esame si fa vedere in un processo definitorio sull’essenza del
santo/hosìon, articolato in queste fasi : 1) santo = ‘ ciò che fa Eutifrone’;2) santo= ciò
che piace agli dei;3) santo= ciò che piace a tutti gli dei; 4) santo = parte di quel giusto
che piace agli dei e quel giusto che è anche il timore-paura del divino; 5) santo=
scienza dei sacrifici e delle preghiere che piacciono agli dei.97
Platone, quindi, procede facendo smontare al suo Socrate la pretesa valenza
paradigmatica di ognuna di queste presunte definizioni in cui Platone coinvolge il
suo Eutifrone . E, dunque, sulla scena della scrittura questo Socrate dall’inizio alla
fine del dialogo sembra essere solo autore di un puro elenchos, cioè di un’attività di
confutazione del punto di vista sul santo del suo giovane amico teologo-indovino.
Ora se poniamo che questo Socrate è un nomen-dramatis, un Attore in una
rappresentazione drammatizzante con due Attori sulla scena – Socrate ed Eutifrone
appunto- ed il cui il reale e ‘nascosto’ ed unico protagonista è Platone che fa più
parti e conduce da ‘dietro le quinte’ il gioco, allora la domanda che sorge è questa :
è mai possibile che il grande logico ed ‘uomo divino’ Platone non disponga di una
idea vera della esperienza religiosa autentica ? E poi : come una attività di
confutazione può pretendere di essere non solo efficace ma anche soprattutto
veritativa, se non dispone come conoscenza previa di un paradigma del santo da
usare come parametro e criterio di corretta e valida falsificazione di una visione del
santo concorrente e rivale rispetto ad essa ?
A questa domanda rispondono dal loro punto di vista e per i loro scopi anche gli
esponenti della Scuola di Tubinga e di Milano.
Il bisogno di quel “soccorso” – di cui parlano Szlezàk e Migliori- trova il suo
fondamento ed alimento in questo situazione discorsiva, sostanzialmente,
strutturalmente, ricorrente e ricorsiva in tutto il Platone scritto- ; ed a questo
originario bisogno viene via via in soccorso lo stesso Platone, elevando la qualità ed
il contenuto di questo bisogno, attraverso operazioni di relativa soddisfazione
‘teorica’; al culmine di questa dialettica ascendente di bisogno-soddisfazione, vi
sarebbe il bisogno superiore e massimo : quello appunto della cose più notevoli e
massime, Esse rinvierebbero tutte al Platone della ricerca per “oralità dialettica”
della “dottrina dei Principi”.
97
Eutifrone
Nella sua interpretazione dell’ Eutifrone G. Reale98 dice che qui il non detto,
l’implicito, l’alluso , che orienterebbe in senso positivo ciò che nella scrittura appare
in forma inconclusa, è l’idea ‘orale’ del divino , cioè l’ Uno-Bene in quanto fonte di
ogni bene.
A questo proposito osservo che : la visione platonica del divino= Bene fonte di ogni
bene,appunto perché Uno-Bene – leggibile in forma piana e dichiarata-dottrinaria
nei documenti della tradizione indiretta sul Platone-Orale- può ben essere
considerata come idea illuminante e presente in maniera implicita-allusa-velata nel
testo ; ma questa pur importante concezione, non costituisce ,però, quel filo
conduttore adeguato che ci permette di ricostruire tutte le mosse del gioco così
come accade nello svolgimento passo passo nel testo; e soprattutto non ci consente
di spiegare, rimanendo fedeli al testo così determinato, quella forma che dà ad esso
una impostazione ed un andamento marcatamente paradossali e disorientanti,
rispetto ad un lettore che si aspetta di vedere seguire alla domanda inizialmente
posta un risposta coerente, congrua e convincente. Reale crede che tale circostanza
nel finale di lettura possa essere spiegata con la “dottrina” e la “autotestimonianza”
circa insufficienza, la non “autoarchia” della scrittura.
Questo effetto di spiazzamento di una precisa aspettativa del lettore . è proprio –
come sopra ho già rilevato- sia del lettore comune e sia del lettore esperto.
La differenza tra l’uno e l’altro consiste innanzitutto in questo : il primo al termine
della fruizione del testo rimane in questa situazione di imbarazzo e sotto l’effetto di
questa stranezza discorsiva ed argomentativa; il secondo , ritenendo confermato da
‘dati testuali innegabili’
l’effetto di paradossalità-aporeticità e vedendolo
ripresentarsi in molti dialoghi, si chiede perché il discorso platonico si svolge così e
cerca una risposta ragionata a questo insolito modo di procedere in un esame di una
questione di teoria, qui – etico-teologica.
Questo tentativo di spiegazione storicamente assume diverse direzioni: esse sono
tante quanti sono le Scuole, le tradizioni e programmi di ricerca. I modelli
ermeneutici degli studi su Platone (accademici, medio platonici, neoplatonici
anticihi, neoplatonici moderni, scettici-problematicisti, zetetici puri, dottrinaristi,
retorici-dialogico-educativo, fenomenologici, unitaristi , revisionisti, analitici, oralisti
ed antioralisti, sistematici ed antisistematici ).
Ma la storia di questi esami e studi – e su questo ha pienamente ragione Migliori- è
la storia di un grandioso fallimento,perché esso appunto lascia ancora
sostanzialmente irrisolto un “mistero che non dovrebbe esserci” 99 e tiene aperto lo
scenario intepretativo di un ‘bellum omnium contra omnes’ , cioè di una situazione
per cui “ un confronto plurisecolare non ha prodotto nemmeno un plafond
comune a partire dal quale intrecciare un dibattito, magari anche accesso, Ciò
permetterebbe di bloccare posizioni arbitrarie, presenti in questo ambito di studi
98
99
G. Reale
M. Migliori, cit. pp. 31-32, 7, 32-34;
in una quantità che non ha uguali nella storia della filosofia “; e favorisce così
“tentazione ricorrente”, che è una finta e comoda via di uscita , cioè la tentazione di
pensare Platone come autore di un “problematicismo rigoroso”.
Naturalmente come accade in tutti i naufragi di gigantesche navi non è escluso che
in esse possa essere contenuta una grande quantità di ‘pietre preziose’ e di ‘tesori’.
Ma un Platone resuscitato potrebbe anche reagire diverito così: |‘Dagli amici
professori di filosofia platonica mi guardi Iddio, perché dai miei avversari
antiplatonci mi guardo io ). E ciò vale anche per le interpretazioni dell’ Eutifrone e
vale soprattutto a partire dal momento e dal modo in cui si individua il suo
problema.
Ed il punto cruciale è proprio questo, che ora cerco di ulteriormente chiarire,
introducendo la riflessione che segue : la cosiddetto forma letteraria in Platone,
quella che io denomino |la forma del piano di esposizione-espressione| è una
‘forma ad substantiam” non solo dell’assetto semantico, ma anche rispetto alla
generazione dei contenuti di teorizzazione. Ed appartiene al loro campo la stessa
fase di problematizzazione.
Nell’ Eutifrone ci sono due momenti, apparentemente complementari e dati in
modo narrativo/mythos, che emarginati o sottovalutati in sede di lettura,
compromettono in grado decisivo la possibilità di capire che cos’è e perché il suo
effetto aporetico .
Il primo di questi momenti è il veloce accenno all’antefatto100 : il padre di Eutifrone
a Nasso viene coinvolto in un duplice omicidio. Un suo bracciante ubriaco uccide un
suo schiavo. Non sapendo come comportarsi nei confronti del suo dipendentebracciante, egli manda un altro suo domestico a chiedere consiglio al giudice
competente, l’arconte-re. Per assicurarsi che questo suo bracciante non prenda la
fuga e non si sottragga così alla giustizia, il padre di Eutifrone lo lega e lo cala in un
pozzo. Ma in questo frattempo il bracciante muore. Eutifrone, suo figlio. ‘teologomoralista’ saputo il fatto decide di denunciare di omicidio il proprio padre, perché
secondo lui avrebbe commesso un reato-peccato, essendosi assunta la
responsabilità di bloccare il suo bracciante e in un modo che sembrerebbe avere
una connessione causale con il suo decesso.
Questo passaggio narrativo risponde nel suo nucleio semantico allo schema tragico :
ci si rende autori di fatto di un reato-peccato, pur avendo voluto fare una cosa
diversa e – nel caso del padre di Eutifrone- addirittura opposta, cioè l’ aver voluto
collaborare attivamente a fare giustizia secondo le leggi della città.
Il secondo momento, anche esso accadente testualmente narrativamente, è
costituito dalle frasi che circoscrivono una Pretesa : l’ Eutifrone di Platone viene
esibito come portatore di una grande idea di sé come massimo esperto di cose sacre
e divine. Egli si ritiene uno scienziato del santo sulla convinzione di disporre inoltre
100
Eutifrone
di una “Grande Prova(“mega tekmerion)101 a fondamento di questa sua presunta
alta competenza teologica e morale.
A caratterizzare, poi, il volto drammatico di questo personaggio platonico, concorre
un ulteriore tratto : Eutifrone è un giovane frustrato, perché la sua presunta alta
competenza in techne divinatoria/mantikè non solo non è richiesta da quelli che in
città decidono sulla vita e sulla morte, sulla pace e sulla guerra, su i delitti e sulle
pene, ma è addirittura da essi ridicolizzata.102
Eutifrone ,dunque, scenicamente appare come chi per aver successo ,fama e
denaro, vuol dimostrare a quelli che nella città contano di cosa egli sia capace in
forza della sua scienza in cose sacre. Egli vuol provare ai potenti così che la sua
capacità si spinge fino a citare in tribunale il proprio padre per chiedere la sua
condanna a morte, per un fatto di cui questi non è affatto coscientemente e
volutamente responsabile; il suo, infatti, è - diremmo con il nostro linguaggio
giuridico- un omicidio colposo e preterintenzionale.
Dunque, l’Eutifrone di Platone non solo è un generico nomen-dramatis, ma
appartiene al sotto-codice dell’ Ethe,103 cioè è un Carattere/Personaggio; vale a dire :
in questa funzione è portatore e riassume in sé un storia Tipica ed un preciso Tipico
comportamento ed abito mentale , apparentemente di natura cognitivo-linguistica ,
assiologico-teologica. Ed ad esso fa capo una relativa phainomeno-loghia, cioè certi
logoi e un certo modo di pensarli e dirli; ed egli non limita in un ‘dialogo’ tra sé e sé
o nella conversazione in una ristretta cerchia privata di conoscenti. Eutifrone punta
a far clamore, ad esibirsi in ciò che è simile ad un colpo di teatro, in qualcosa che
non deve essere più dimenticato in città, e deve rimanere nella sua storia e
costituire un evento memorabile di glorificazione di un ingiustamente bistrattato
indovino.
L’ossessionato decisionista-attivista Eutifrone, che si spinge -in nome ‘ del rigore
,della sua coerenza e purezza di scienziato del sacro-santo e del saper fare bene i
sacrifici’, a sacrificare il suo stesso padre,vittima innocente, e colui che nel suo volto
tragi-comico- viene mostrato dal suo autore-regista come partecipe , coautore e
sotto altro aspetto anche giovane intellettuale-vittima., di una comunicazione
pubblica spettacolare- teatralizzante intorno a quella cosa massima, appartenente
alle “Cose Massime”, di “Maggior Importanza”, che è appunto il sacro-santo.
Perciò non mi sembra una ipotesi cervellotica vedere in questo nome | Eu- THYPHRON| un ripresa etimologica di conio platonico |Eu= Ben|, |Thyein= Sacrificare|,
|PHRON= Pensante|. Da qui : |Eutifrone| = |Colui che pensa il Ben-Sacrificare|. E
così nel nome c’è tutto il programma di questa rappresentazione tragico-comica al
limite di un terribile farsesco.
101
102
103
Eutifrone
Eutifrone
Aristotele, Poetica
Abbozzata questa analisi del Tipo/Eutifrone ‘incapsulato’ nel suo Nome-Maschera
da far valere come il pro-memoria di |Che cosa disse, fece e patì|, ora metto in
rilievo questo punto : il passo testuale dove appare la domanda |Che cos’è il santo|
accade in un testo in cui gli altri passi testuali che si riferiscono all’Antefatto non
possono essere separati o marginalizzati come puro riempimento narrativo o
addirittura con valenza biografica tutta storica o prevalentemente tale.104
La domanda socratica in questione,infatti, è rivolta a Questo Eutifrone, inserito in
Questo Fatto e ripreso in Questa Decisione Orrenda. E ciò non va inteso come se la
domanda fosse fatta ‘ad hominem’ e ,perciò, fuori e senza una intenzione di
universalizzazione determinata. Eutifrone, infatti, della scena del testo non è un
individuo empirico, un individuo della storia; ma – lo ribadisco- è un Tipo, portatore
di una Typo-loghia che circoscrive un Caso; sta, dunque, nella ‘logica’del RipetibileRicorrente.
Essere ‘servi’ del testo qui esige saper rispettare il contesto e la sua matrice
funzionale-costruttiva. La domanda ,dunque, va intesa sulla base di quella
circostanza che Platone segnala al suo lettore come determinante per capire a quale
scopo egli la mette in bocca al suo Socrate. Ed il suo lettore ‘medio’, di buon senso
ed in possesso anche solo del minimo di codice etico, ‘Già Sa ‘che la condotta
incarnata in Eutifrone ha ben poco di santo e di giusto. E con lui lo sa Platone ed il
suo Socrate sulla scena.
Qual è, dunque, lo scopo per cui quella domanda che viene data in quella forma ?
Qui entra in gioco la Figura della Pretesa Illegittima, di una Pseudè Doxa : Eutifrone
non solo sta in una situazione-decisione di fatto, ma crede che rispetto a questo
Fatto egli sia quello Scienziato che di questo Fatto dispone di una opinione vera
giustificata e con valenza di un autentico valore etico-religioso. Eutifrone in questa
pretesa epistemico-tecnica intorno alla natura del sacro-santo è colui che già in
partenza,dunque, ha in testa la convinzione di saper rispondere alla domanda |Che
cos’è il santo ?|.
Il Socrate di Platone allora è quello che nel fare questa domanda la fa a partire dalla
Pretesa di Eutifrone, che Platone fa assumere al suo Socrate metodicamente come
Premessa della catena della argomentazioni che seguono. Perciò ci troviamo di
fronte ad un problema dato in quella forma ‘dottrinaria’, perché essa deve valere
come Premessa Condivisa-Omologata tra un Socrate che si mette dal punto di vista
dell’Interlocutore – che come detto è anche un Malato e ,dunque, un Paziente- , ed
un Eutifrone che crede di essere in possesso della Dottrina Vera-Giustificata del
Sacro-Santo.
Insomma Platone presenta, in coerenza con l’Antefatto, il suo Socrate come chi
concede per buona al suo interlocutore la prima mossa, cioè la posizione del
problema nella formula: |Che cos’è il santo nell’ambito delle virtù ?|.
Così sembra credere G. Reale quando cerca di stabilire la ‘data’ di un presunto fatto storico
che sarebbe la vicenda di Eutifrone.
104
Ora lo svolgimento del gioco delle risposte-definizioni è tutto condizionato da
questo preciso avvio, dove l’Operativo Antagonista del Socrate-Operativo
Protagonista è uno Pseudos, una Pretesa Illegittima di coscienza,conoscenza e
scienza intorno ad una ‘cosa massima’, appartenente alle ‘cose più
importanti’/timiotera.
Questo Pseudos, questa Fantasmalogia eristico-sofistica condensata nel
Caso|Eutifrone, diventa allora il principale bersaglio e, dunque, il fondamentale
senso del gioco giocato del testo : il Socrate vincerà la partita testuale, avrà
successo nella sua ‘caccia’, quando riuscirà a provare che Eutifrone Crede di
possedere e saper applicare il Paradigma del Santo, ma in realtà egli dispone solo di
una Falsa Immagine della essenza del rapporto dell’uomo-cittadino con il divino e
sta sotto la cattiva influenza di questo Simulacro, che è suo perché ormai è quello
dominante nella comunicazione pubblica della città, nelle sue stesse feste religiose.
Il gioco giocato è un gioco riuscito, perché Socrate riesce a smontare con diverse
operazioni di tecnica logico-paradigmatica a partire da una premessa omologata105 il
presunto modello-paradigma ‘scientifico’ del santo di cui è portatore
implicitamente Eutifrone il decisionista estremo e puro, ossessionato dal bisogno di
purificare la famiglia per il sangue versato nel suo ambito e da essa per presunta
responsabilità del capo-famiglia.
Il gioco giocato ,dunque, coerentemente prenderà la forma di un procedimento di
Falsificazione-Smascheramento di una presunta Opinione Epistemico-Tecnica sul
Santo, costruita sulla base di una Falsa Immagine Logica di questa Virtù/aretè.
Il problema attorno al quale ogni passo, ogni mossa, ogni figura ( ad es. Dedalo,
Proteo,l’isola di Nasso. Hestìa,Crono) , ogni figurazione argomentativa ruotano è
quello del saper fare una falsificazione, una negazione-‘decostruzione’smantellamento di ciò che alla fine non si mostrerà come un Modello RivaleOpposto perdente , ma come ciò che ha assoluta inconsistenza cognitivoimmaginativo-linguistica e che funziona solo come copertura di un fatto che la
decisione ispirata solo a violenza distruttiva dell’altro,e –qui- addirittura di un padre
sfortunato ( subisce un danno economico per la morte del suo schiavo e si ritrova in
un guaio giudiziario per il suo omicidio colposo); è un padre,dunque,sostanzialmente
innocente,perché non solo non voleva ed era cosciente di uccidere il suo bracciante,
ma lo aveva calato nel pozzo per assicurarlo alla giustizia; egli agisce a fin di
bene,dunque.
F. Adorno richiama in sede i qualificazione della premessa generale del procedimento
argomentativo la differenza tra synchoresis ed omologhia, che trova corrispondenza tra la nosione
scolastica di suppositivo e petitio. Quantunque Platone non sia costante nell’attribuire ai due
termini una differenza sostanziale tra enunciato ipotetico ed apodittico, tuttavia la distinzione è
utile per mettere in evidenza una costante implciita nella impostazione dell’argomentazione che il
Socrate di Platone svolge sulla scena della scrittura: senza avvertirci Platone fa ragionare Socrate a
partire dal punto di vista dell’interlocutore-avversario, per portare dall’interno alla imposizione
della opinione di quest’ultimo che pretende esibilrla come vera e giustificata.
105
Se le cose stanno così, se il gioco messo in opera nell’ Eutifrone ha questa logica e
questo scopo e si svolge conformemente ad essi, allora non ha alcun senso
continuare ad affermare che esso sarebbe tra i più testualmente innegabili ed
indiscutibili dialoghi aporetici , come tra tanti altri anche Migliori pensa, pur dando
una diversa spiegazione della aporeticità : quella che punta tutto sulla presunta
insufficienza della scrittura , sulla “struttura di soccorso”, sulla natura ingressivaascensiva della ricerca platonica.
Ma io non dirò che la ‘sola scriptura’ ci consente di spiegare l’enigma /Eutifrone;
perché questa formula è equivoca. Essa fa ,infatti, immaginare anche che si darebbe
un ‘testo assoluto’ che ‘sarebbe un padrone assoluto’ di cui noi lettori dovremmo
essere ‘servi’. Ripetendomi, insisterò a richiamare l’attenzione che la visione di un
‘testo assoluto’ è una cattiva astrazione, effetto di una falsa immagine mentale della
attività dello scrivere e dei prodotti di scrittura. L’una e gli altri sono ,infatti, funzioni
di un leggere in atto ed in relazione di contrappeso-hardware con esso; e dove la
sua relativa autonomia di contrappeso di superficie significante è sempre decisa
dentro l’agire di lettori vivi concorrenti ed eventualmente rivali, ma che condividono
il canone della massima approssimazione possibile al campo segnico-significante.
Pertanto, il testo|Eutifrone e il relativo problema |”Come scrive Platone” devono
essere inquadrati piuttosto nella prospettiva di un |Come leggere Platone|.
E’,dunque, per mutuare analogicamente da Eco, ci troviamo di fronte ad un
questione di “pragmatica testuale”106, di una teoria di codice e sotto-codici di
produzione e di fruizione, in una strategia di “Cooperazione interpretativa” a partire
da un campo di Presupposizioni Socio-Culturali, che investono sia l’ “autore
implicito” che il “Lettore-Modello”, situati in spazi letterari con precise
caratteristiche.
Che ci siamo,pertanto, dei limiti alla interpretazione dentro la decisione di una
“cooperazione “, cioè di rifacimento asintotico del gioco giocato nel testo, è cosa
provabile; ma che si possa pensare il concetto di testo , della sua ‘struttura’ e del
suo modo di funzionamento, fuori da una relazione con l’attività del leggere è
impossibile. E se leggo, interpreto; se interpreto penso, se penso devono anche
saper pensare che significa teoria e che cosa comporta l’assumere il paradigma del
gioco giocato come ottica fondamentale e prevalente di sguardo sul testo.
A questo saper ripensare fino in fondo ciò che è proprio di una strategia di gioco ci
sfida Platone, ed implicitamente ci invita a ripensare con lui la sua pratica testuale di
comunicazione filosofica.
Per restare all’opera che ho esaminato sotto il profilo della identificazione e
qualificazione del suo problema centrale, aggiungerò solo un’altra osservazione.
Tra le conoscenze previe che Platone autore-implicito, quello della “intentio operis”,
chiede di attivare al suo Lettore-Modello- nell’ avvio e nel corso della lettura dell’
106
U. Eco, Lector in fabula,
Eutifrone- c’è anche – anzi soprattutto- quella che testualmente appare nel
“Gorgia”, nel I Libro di “Repubblica” ed anche in “Leggi” come lo spotprogrammatico |Il giusto è l’utile dei più forti|107.
Per capire ,poi, la ragione che induce Platone a ‘ ricordare’ scenicamente al suo
lettore-spettatore l’Antefatto – quel ‘brutto pasticciaccio nell’isola di Nasso’- ,
dobbiamo far valere tutti quei segnali che egli sparge via facendo e spesso
velocemente, con brevi accenni.
E mi riferisco soprattutto a quei segnali che egli dà in forma narrativo-descrittivainformativa : uno di questi è il riferimento alle sacro-sante processioni dove tra
l’altro vengono esibiti stendardi allestiti da artigiani e pittori per rappresentare “dèi
in guerra tra loro”.
Per capire perché Eutifrone viene figurato nella testarda-ossessiva-frettolosa
decisione di accusare il padre di omicidio , con Platone, con la sua scrittura, è
necessario tenere conto di questo scenario di fondo della vita della sua Polis e dei
fenomeni di comunicazione pubblica che la caratterizzano.
Essi sono ormai invasi, pervasi, permeati, dagli effetti lusinganti-illudenti/kolakeia
della propaganda di una visione della vita cittadina, considerata in tutte le sue
diverse manifestazioni, drogata ,dopata, avvelenata da quel falso ideale di giustizia,
per la cui giustificazione e legittimazione paraculturale si è scatenata una corsa per il
primato in città tra i vari gruppi di intellettuali: retori, indovini, poeti,rapsodi, esperti
di diritto, strateghi, logici, esperti nella ‘tecnologia’ del piacere, educatori , psicologi,
naturalisti, fisiologi.
E,perciò, quello spot-programmatico è diventato l’insegna di una pretesa nuova e
superiore sapienza di vita /sophia quella contro cui – fin dalla Apologia- il Socrate di
Platone si oppone, resiste, e combatte, per denunciarne la inconsistenza noetica .
l’indegnità linguistica, l’immoralità di discorso.
Eutifrone, è un giovane teologo che si è fatto ammaliare e contaminare da questo
pseudo-cultura della Pleonessia/Soperchieria-Tracotanza-Sopraffazione; egli
appartiene idealmente alla ‘arciconfraternita’ che ha ideato quello stendardo
osceno e blasfemo. Ma non lo sa, perché egli crede che il divino , gli dèì, vanno
pensati, immaginati e detti secondo quel falso sommo principio di un “giusto” come
“l’utile dei più forti” : Eutifrone smania di essere riconosciuto dai capi di questo
‘partito’ come loro speciale e prestigioso consulente nell’arte di fare vaticini
soprattutto in riferimento alle guerre di conquista. Ma sa anche che è tenuto in poco
Gorgia, Repubblica, Leggi . Questa opinione vinncente nei processi di condizionamento della
opinione dei cittadini è per Platone la madre di tutte le false opinioni sul senso ed il valore della
vita della Città. Perciò, la preoccupazione fondamentale di Platone è quella di mapparla e
diagnosticarca nella sua dimensione paracognitivo e paralinguistica. Tutta la pratica dialettica
platonica è finalizzata architettonicamente e strategicamente a mettere a nudo ed a denunciare la
fatuità ‘brillante’ di questa pretesa somma verità umana, cosmica e divina.
107
conto da quelli che comandano in città che ridono delle sue performances
divinatorie.
Egli ,perciò, è alla ricerca di una grande occasione per poter dimostrare a loro la sua
insuperabile competenza in cose divine. Ora poiché per lui e per i suoi potenti amici
gli dèi sono quelli più forti tra i potenti e , poiché, dunque, sarebbe la volontà di
potenza e di dominio a costituire la somma virtù anche sotto il profilo del sacrosanto, ecco che accusare ingiustamente la persona più cara, cioè il proprio padre,
diventa ai suoi occhi la “grande prova” non solo del suo coraggio, ma anche della
validità della sua pretesa scienza del saper far bene sacrifici.
Eutifrone li sa far così bene che nulla lo ferma, neppure il rispetto che deve da figlio
a suo padre. Con questa azione clamorosa e spietata Eutifrone crede che sarà
finalmente accolto sul carro dei vincitori.
Quando Platone mette in bocca al suo Eutifrone il termine |philès|- caro, metterà
anche in gioco lungo l’asse semantico e delle forme del verbo attivo|philein|,e di
quello medio |philoumenon| intricati sentieri di giochi metaparadigmatici ( logicosemantici-assiologici-teologici), che rendono non affatto facile il dipanamento dei fili
che Platone intreccia in questo complesso ed epocale dialogo, che investe il
rapporto tra violenza-sacro-108 propaganda di una ideologia parateologica, quella
che sta a servizio di una politica di dominio.
E Platone ci dirà anche che l’esaltazione di un puro- assoluto fare-agire109 anche
nella attività di amare non è condizione sufficiente perché il nostro fare sia buono ,
vero e giusto. Senza la dignità in sè di ciò che è amato , il nostro agire da amanti è
senza un intrinseco principio d’ordine/kosmos ed è volontà di possesso egoistico e
distruttivo.
A questo punto credo di aver fornito sufficiente elementi per intendere perché
l’Eutifrone di Platone appare sulla scena della sua scrittura inquadrato in quel
problema ed in quella forma del problema; e perché quando parliamo di soluzione
del problema nel Platone scritto, dobbiamo sapere che questa soluzione avviene nel
modo di una dimostrazione indiretta, per la via negativa-decostruttiva della
falsificazione di una illegittima pretesa parascientifica, paraculturale, paralogica,
paralinguistica, paraetica, e - nell’ Eutifrone- parateologica. Dobbiamo sapere che
questa progressiva falsificazione di uno pseudo-paradigma implica una progressiva
trasformazione del problema dato in maniera esplicito-dichiarata in un altro
problema implicito da ricostruire, da ‘tradurre’ ed illustrare tenendo conto
dell’intero ed effettivo movimento concettuale-semantico-argomentativo che
costituisce il gioco giocato.110
Su questo tema in generale cf. Girard.
Eutifrone
110
Risolvere un problema sussmendolo e trasformandoli in un altro è un procedimento
caratteristico della logica geometrico-matematica platonico-euclidea. Il cosidetto teorema di
108
109
La questione della precisa identificazione e qualificazione del problema proprio di
ogni dialogo – e Leggi non sfugge a questa ‘legge’- chiama in causa dunque, una
questione “architettonica” di primo ordine, perché appunto esige il saper far agire
tutte le parti di quella totalità determinata che il discorso testualmente circoscritto e
delimitato.
Ma questo non basta, perché ,poi, bisogna saper operare ,come lettori-spettatori di
logoi ‘dipinti’ in scrittura alfabetica, un passaggio/metabasis di piano Funzionale
da una logizzazione-semantizzazione esplicita ad una implicita che la condiziona in
maniera determinante; questo implicito e questo movimento di implicitazione non
coincidono con quel comune modo ironico, non convenzionabile e governabile
intersoggettivamente, perché la sua identificazione sarebbe sempre imprecisa e
discutibile, in quanto sarebbe affidata solo alla sensibilità soggettiva di ogni singolo
interprete o alla cosiddetta ‘evidenza’ del testo.
Per Friedlander,per esempio, è evidente che quanto scrive Platone sulla natura della
scrittura nel Fedro ha una valenza espressivo-semantica di tipo ironico:111 Platone
direbbe una cosa ma per come la dice intende dire un’altra cosa, diversa o
addirittura opposta alla prima.
Ma non condivido questo escamotage di Friedlander; e non perché su questo
abbiano ragione gli esponenti della Scuola di Tubinga e di Milano. In Platone,infatti,
la relazione tra piano dell’esplicito-dichiarato e quello dell’implicito-non dichiarato
non si esaurisce in un territorio di natura semantico-espressiva e circostanziale., e
comunque non ‘oggettivamente’ decidibile.
Anche in questo caso – anzi soprattutto sulla comunicazione ironica- Platone opera
una svolta noetica, una rivoluzione paradigmatica radicale, perché la trasformazione
della dimensione architettonica-strutturale è preceduta ed fondata su quella
funzionale, attraverso la piena valorizzazione del principio della Performance, della
“formatività” ( per usare una idea e un termine di Pareyson112) ; la matrice di
questo modo performativo è appunto è quella generale di |GG|; che in Platone va
ben oltre al suo uso come “filo conduttore dell’opera d’arte”, come è leggibile,per
esempio, in G. Gadamer113.
Questa matrice generale può essere intesa solo se ci esercitiamo a ripensare con
Wittengenstein – che pure sta sotto una immagine inadeguata del Platone teorico
delle idee e del numero- il suo paradigma di un linguaggio come una attività di una
“pluralità di giochi linguistici in forma di vita”114.
Pitagora non si comprende nella sua ‘ratio genetica’ senza connetterlo a quello diverso della
incommensurabilità per interi tra la misura della diagonale di un quadrato e quella di un suo lato.
111
P. Friedlander, cit. p.
112
Pareyson
113
Gadamer, Verità e metodo,
114
Wittengenstein
Platone si decide per questa rivoluzione nella concezione della problematizzazionetematizzazone perché spinto dal problema della natura funzionale atipica di quel
suo fondamentale bersaglio. che è la phainomenologia eristico-sofistica che egli
esplora in tutte le sue più importanti varianti; e che egli mette sotto gli occhi del suo
lettore-spettatore già nell’esordio proprio della Apologia. con la figura di Socrate
che si fa credere abbagliato e stregato dai logoi sofisticati del suo accusatore
Meleto. 115
Phainomenologia , la cui natura sfuggente e capacità di influenza, sono inscindibili
per Platone dalla loro connessione funzionale profonda con il modo-performance
della comunicazione spettacolare e teatralizzante di una Polis a spettacolarità
spinta; Polis che in un certo senso è ‘tutta un teatro’.
La comunicazione filosofica che diventa “Teatro Filosofico”lo diventa appunto in
questo contesto di vita socio-culturale.
E se vogliamo dare un nome a questa svolta funzionale potremmo dire che Platone
Inventa il Modo di una Ironizzazione Logica dentro il territorio di una
Metaimmaginazione Metalogica-Metalinguistica, dove si incontrano-scontrano veri
MetaParadigmi Analogici con Pseudo-Metaparadigmi di una finta analogia.
Ironizzazione Logica significa : Platone ci appare a prima vista come colui che
problematizza-tematizza-concettualizza per modo esplicito-dichiarato; ma questo
modo. per come effettivamente in corso d’opera si realizza, fa emergere una ‘Cosa
Diversa’, cioè l’0perare del Gioco Giocato, che determina l’effettivo e finale
intenzione di senso di quanto è dato in quel modo esplicito-apertamente detto.
Il riferimento al mondo del non-detto,. il meccanismo della allusioni-riserva e le
connesse omissioni-interruzioni in Platone non sono altro, pertanto, che un
complesso di istruzioni-segnali ‘in opere operato’; esse indicano a noi lettoristandard la necessità del nostro dover passare da un codice di lettura per relativo
modo esplicito a quel codice di riconoscimento cooperativo di un modo implicito
non generico, (cioè come quello caratteristico del registro ironico limitato al livello
espressivo-semantico) , ma specifico e speciale : quello appunto della ripetizioneriproduzione asintotica di un gioco testualizzato come base costante per la
trasposizione , poi, di quanto trovato, in questa ripetizione-riproduzione
cooperativa, nella forma piana del commento, della illustrazione dei risultati
interpretativi, del confronto esegetico, analitico e critico.
Moltissime altre ‘gemme’ ci sono in questa opera ‘apparentemente prima’ – e su
questo Trasillo, con la sua classificazione per nove tetralogie ed il suo inserimento
del dialogo come il primo della prima tetralogia, non ci aiuta certo a trovarle-; così
come non ci aiutano e ci portano fuori strada i commentatori accademici che hanno
sottotitolato l’opera con la etichetta |Sulla Pietà|, quasi che Platone avesse voluto
darci un breve saggio dottrinario di dottrina etico-religiosa.
115
Apologia di Socrate,
‘De ceteris modernis nunc silemus !’, soprattutto di quelli che hanno la pretesa fare
esami di logica elementare al più grande logico della Antichità, tanto grande da
permettersi una ‘metaforizzazione di grammatica’ dello statuto di quella geometriamatematica che ben possiamo richiamare platonico-euclidea.
Chiudo questo paragrafo, riservandomi di ritornare sull’ enigma-Eutifrone, e,quindi,
seguendo il percorso di Migliori – alla stregua di un minuscolo pesciolino che si lascia
trasportare da un gigantesca balena nel mare dei logoi platonici-, mi fermerò ad
esaminare ,in un confronto con lui, (i) il rapporto tra dialettica e Technai,(ii) tra
dialettica-Technai-Sofisma; e in questo contesto ,(iii) quello tra filosofia e geometriamatematica, e,quindi, (iv)quello del rapporto del Platone Scritto ed il Platone
fondatore, ispiratore, promotore ed alta guida delle ricerche epistemico-tecniche
della comunità della sua Accademia.
Per chi sia interessato ad una ricostruzione di tutto il dialogo dal mio punto di vistaqui delineato nel suo nucleo - rimando al mio lavoro sull’ Eutifrone che verrà
pubblicato sul mio sito.
Ed a questo proposito ne approfitto per confessare che su una cosa non stancherò
mai di prendere lezioni da Migliori : sul dovere etico e scientifico di leggere e
studiare incessantemente tutte le opere di Platone – parola per parola, frase per
frase, sequenza per sequenza, dialogo per dialogo- se si pretende di contribuire non
a depistare ,ma ad aprire varchi per entrare nella Odissea Dià/logica del Platone
scritto.
Illustrerò più avanti perché ho evidenziato in neretto la preposizione greca |Dià|
ed, infine, in che senso, senza penetrare il senso di fondo della matrice funzionalestrutturante della logica che sta sotto gli Elementi di Euclide, ben poco si intende
della visione platonica della teoria , della Idea, della Idea Uno-Molti, della nozione di
Errore e di Male, di Disordine. Snodo quest’ultimo di primo ordine di tutte le
filosofie; la loro croce; lo stretto di mare in cui è naufragata una magna pars della
filosofia moderna, idealistica e non; e nelle cui acque ‘rari nantes’ ed in deriva
giacciono e si muovono senza bussola le visioni del post-modernismo e del postumanismo.
L’intera navigazione testuale platonica può essere ricondotta al tentativo realizzato
per tappe di rispondere a questa domanda che enucleo come segue.
Come può essere pensato,immaginato ,espresso,comunicato il Male che per sua
natura di energia puramente e volutamente distruttiva del reale e del razionale, è
per ciò stesso Anti-Pensiero, Anti-Immaginazone, Anti-Linguaggio, AntiComunicazione ? Come si dice quell –Non Essere che è un AntiEssere, che non è il
contrario-opposto che sta in tensione con l’ Essere, ma mera forza distruttiva del
Bene, del Vero, del Bello, del Giusto, della Vita ?
La gigantesca e ciclopica impresa di Pensare l’Antipensiero, di catturare e
smascherare l’Antilinguaggio attraverso il Linguaggio, e l’Antimmaginazione
attraverso l’Immaginazione ben temperata, è il Tremendum-Fascinans con cui si
misura il fondatore della filosofia come filosofare nella vita comunicante della città.
In una meditazione intensa e sofferta sulla sua Ellade in agonia 116e che va morendo
nelle voglie di conflitti senza fine e nel tradimento degli intellettuali che hanno
‘commercializzato e negoziato, per conservare e consolidare i loro privilegi di casta,’
il principio della giustizia, Platone, il più grande figlio della Ellade, va alla caccia di
questo Anti-Essere che non è il Nulla dell’Essere, ma la sua NullificazioneDistruzione; e lo fa, fiutando ed inseguendo la paralogica, la paraimmaginazione, il
paralinguaggio del modo di produzione sofistico-menzognero di paralogoi
spettacolari intorno alle “Cose Massime”.
5. La Lettera VII come prova testuale di conferma presunta di una dottrina di
condanna presunta della scrittura.
116
L. Canfora
Migliori scrive : “ … Questo contrasto tra scrittura e serietà è confermato anche
dalla Lettera VII, là dove Platone, prima di garantire che su quelle cose non ci sarà
mai un suo testo, condanna coloro che hanno scritto su queste realtà dicendo di
conoscere ciò di cui lui si occupa seriamente,(perì on egò spudazo , 341C 1-2,),
perché non l’hanno capito affatto. Segue poco dopo una condanna dello scritto
perentoria quanto nel Fedro… 117.
Ed io mi domando di nuovo : che tipo di lettera è la Lettera VII ?
Guardando sopra di essa a volo d’uccello e per tratti generali, questi possono essere
così isolati:
a) La lettera ha una valenza Informativa : veicola alcune notizie su individui ed
fatti della storia reale;
b) Essa ha una manifesta intenzione Apologetica di ciò che avrebbero fatto gli
amici di Platone a Siracusa nello scontro politico con il tiranno Dionigi;
c) Introduce una Polemica con la Pretesa di Questo Dionigi di aver dato,
scrivendo un libro, una summa del meglio del pensiero platonico:
d) Si fa avvertire come una sorta di ‘omiletica-catechetica’ di come e perché si fa
filosofia;
e) Tratteggia il nucleo strutturale di una filosofia dei livelli di conoscenza.
Per tutti questi caratteri la Lettera VII non può essere inquadrata nel suo tutto
determinato testuale come un prodotto di pura dottrina o come prevalente
documento di un resoconto cronachistico-autobiografico.
E’ difficile ,infatti, negare la sua qualità di ‘opus oratorium’, di prodotto di una
epidittica memoriale a conforto e sostegno educativo- morale di una comunità,
rappresentata in questo caso dal circolo degli amici di Dione, caduto nella battaglia
per la Libertà di Siracusa.
Apertamente è detto che la lettera è scritta allo scopo di Consigliare-Esortare i suoi
diretti destinatari intorno alla giusta Costituzione 118
Per tutto ciò non la si può leggere - come ancora fa Migliori- ritagliandovi e
estraendovi frasi sul valore e funzione della scrittura da usare come dichiarazioni
testuali evidenti ed incontrovertibili di una Dottrina di condanna o svalutazione della
Techne della scrittura e dei suoi syngrammata.
Se anche qui ci troviamo di fronte ad un testo da rispettare – come anche esige in
generale Migliori- nella sua integrità di superficie significante e nel suo genere
letterario, allora non lo possiamo utilizzare secondo una ottica di fruizioneinterpretazione che non è conforme al suo immanente codice di produzione. Anche
in questa circostanza il ricorso ad un po’ di buona semiotica testuale non fa male ed
117
118
M. Miglior, cit. p. 76.
Lettera VII 334 c-d ].
anzi ci aiuta a liberarci dagli effetti di lenti deformanti di fuorvianti presupposizioni
che investono in generale il rapporto tra testo ed attività di lettura.
Ciò che Reale chiama |autotestimonianza| testuale ,pertanto, non sfugge alla legge
per la quale ogni testo è funzione della atto mentale di un vivo lettore che sta
sempre in una tradizione culturale e linguistica attiva, cioè che esiste perche esiste
una Comunità Vivente di lettori che interagiscono tra loro e si riconoscono nella
‘autorità’ ,liberamente e criticamente accettata, di questa Tradizione.
Ciò che ci direbbe apertamente lo stesso Platone in persona di scrittore, cioè la sua
cosiddetta |autestimonianza|, è, dunque, relativa ad un determinato punto di vista
sul testo; punto di vista che anche in questo caso non chiama solo in gioco contenuti
di senso, ma preliminarmente una certa visione del rapporto tra significazionecomunicazione filosofica e modo funzionale del far dottrina e del leggere da
dottrinari.
E d’altra parte, la |autotestimonianza| di Platone sulla scrittura è ancora scrittura;
se la scrittura di per se stessa non è in generale affidabile nel dirci la verità, allora
tale rimane anche quando si esibisce come scrittura in valenza di pretesa di vera
autotestimonianza.
Come si può capire, agisce di nascosto sotto la nozione di |autotestimonianza
testuale| una non problematizzata visione sulla natura in generale di un testo;
visione tacita in cui si insinua ‘furtivamente’ il cattivo generale pregiudizio di un
‘testo assoluto’, di una ‘sola scriptura’.
Così che, quando G. Reale polemizza contro la “sola scriptura’, di fatto polemizza
non contro la scrittura in sé, ma contro ciò che è ancora un modo di lettura : quello
degli interpreti aoralisti ( come ad esempio Schleiermacher) o antioralisti.
Per via indiretta G. Reale viene così a confermare – ed al di là della sua stessa
intenzione- che la nozione di testo assoluto – anche quando questo assoluto è
l’assoluto testuale di una autotestimonianza data per scrittura- è un non-sense,
perché poggia su una deformazione implicita del ‘sinolo’originario testo-attività
mentale di lettura; deformazione che porta a separare ed a considerate in sé ciò che
per sua natura genetico-funzionale non è separabile, come è appunto un testo.
Nella stessa nozione di “oralità dialettica”- elaborata da G. Reale e condivisa nella
sostanza da M. Migliori- convergono e, poi, si confondono tre cose diverse : (i) se
per |oralità| intendiamo quella non –scrittura che è la ‘Vox’, cioè per me l’attività
mentale,- percettiva-cognitivo-linguistica-, del saper fare una comunicazione diretta
– senza la mediazione di un testo-, allora è chiaro che esiste un primato funzionale
della ‘oralità’ sul testo-oggetto119; (ii) se per |oralità| intendiamo l’attività di
interpretazione di un testo, è chiaro –per quanto fin qui ho illustrato- che questa
attività proprio in quanto attività di un vivo lettore di una comunità culturalelinguistica, costituisce la prioritaria conditio sine qua non perché sia un testo
Quando Gadamer scrive che la scrittura è naturalmente protrettica intende riferirsi appunto a
questa condizione originaria effettuale della esperienza di lettura.
119
riconoscibile come testo; (iii) se per |oralità| intendiamo la |oralità dialettica| come
esposizione della Dottrina dei Principi ‘per bocca’ del maestro a vantaggio della
comunità dei suoi discepoli, allora di fatto assistiamo ad una equiparazione tra
pensiero dialettico e dottrina dialettica, ed ancora implicitamente, ad una riduzione
funzionale della attività di teorizzazione a quella della elaborazione per |DDP|.
Debbo a questo punto introdurre una quarta accezione di |Oralità|, quella
riconducibile alla posizione specifica ed originale di Migliori nell’ambito della Scuola
di Tubinga e di Milano : (iv) se per oralità intendiamo |saper fare l’attività del
filosofare| assumendo il Platone Scritto come autore-guida di giochi seri, protretticieducativi e non conclusivi sulla verità delle “Cose Massime” contenuta nella
“Dottrina Orale dei Principi”, allora di nuovo affermiamo che la filosofia è una
attività , ma anche che questa attività è fondamentalmente far dottrina, nonostante
il richiamo di Migliori a Wittengenstein120, che purtroppo a sua volta legge Platone
da dottrinario121, dimenticandosi di far valere quella idea di filosofia come “attività”;
idea rinvenibile nel Kant che ribadisce nella Terza Critica nella suo concetto di
“esame “122
Dopo questo giro ci accorgiamo che il recupero e la valorizzazione ‘spinta’ che fa
Migliori del codice del gioco serio rispetto alla nozione di gioco come divertimento,
come ciò che non è veritativamente serio, sta alla fine ancora sotto la legge del
primato di una teoria filosofica da intendere come pura e chiara dottrina filosofica.
Ma Platone procede mettendo fin dall’inizio in discussione questo primato e questa
assoluta equivalenza : a dimostrarlo sta una costante testuale trasversale a tutte la
sua opera; quella data dalla presenza dell’ Elemento Narrativo in una attività di
comunicazione filosofica per mezzo di una scrittura spettacolare e teatralizzante; e
quindi, sta questo gigantesco ‘macigno’ contro il quale finiscono per battere la testa
tutte le pretese dell’ottiche di lettura proprie delle Accademie, delle Scuole, delle
medievali e moderne Università. Quelle ottiche che calate anche sulla Lettera VII
finiscono per deformarla nell’impiego dottrinario che ne viene fatto in sede di
esame della posizione platonica sulla scrittura.
Ed al suo esame adesso ritorno.
M Migliori, cit.
E ciò accade nella sua attribuzione a Platone di un nuomero come oggetto ideale, sganciato da
quella logica costruttivo-operativa che in generale tanto piace al Wittengensteni del “Calculemus”
e del linguaggio come pluralità di giochi.
122
I. Kanti
120
121
5.1 La Lettera VII è assolutamente fuori dalla prospettiva generale di un “teatro
filosofico”, di unica comunicazione filosofica a mezzo di una scrittura spettacolare
e teatralizzante ? E’ serio dire attraverso una scrittura che sarebbe ‘non seria’
quella cosa tanto seria che è la teoria cognitiva dei “cinque’ ?
Rispondo a questa domanda ancora provocatoria e subito dico : se dobbiamo stare
all’altezza della totalità determinata anche di questo testo, allora dobbiamo saperlo
leggere in modo da poter dar conto di tutte le sue parti e valorizzando i diversi
segnali che indicano la natura della sua matrice generativa ed il tipo di lettore che
questa esige dal suo stesso interno.
Infatti, come ogni scrittura essa nasce come tale in vista di un pubblico-destinatario :
e qui, in questa ‘Lettera’ questo pubblico è costituito dai “familiari” (oikeiosis) e gli
“amici” (etairois) di “Dione”. Dunque, i destinatari non sono accademici o comunque
individui considerati nei loro interessi-problemi tecnico-epistemici.
L’esordio [ 324 a-b) nasce per il bisogno di ricordare un amico morto, Dione, e fare
onore a ‘ciò che egli disse, fece e patì’per amore della libertà dei Siracusani (dein
eleutherus einai) e per additarlo come esempio di uomo giusto da imitare [336 c]; e,
dunque, il lettore si trova di fronte a ciò che è proprio di un elogio funebre.
La parte del testo che segue all’esordio dà avvio ad un discorso per potrebbe essere
intitolato |Apologia di Platone|. E per ciò stesso esso risponde alla logica di una
Difesa in presenza del prolungarsi, nell’ambito di un pubblico sicuramente più vasto
di quello della cerchia degli amici e familiari di Dione, degli effetti di una Accusa che
non può trattata con un ‘ Guarda e Passa e non ti curar di loro’.
Come è scritto nell’epilogo, Platone dichiara di essersi deciso a dare pubblici
chiarimenti ed un necessario “consiglio”/synbuleuo, per via della “stranezza”/atopia
e della “illogicità”/alogia di quanto avvenuto”.[352a]
L’atteggiamento polemico, pertanto, è una dimensione essenziale della
discorvizzazione che prende corpo nel testo; questa nasce ,dunque, nella
impostazione di un ‘contra quem’, che dovremo con precisione identificare
soprattutto nel suo ruolo costruttivo e di principio di orientamento del discorso in
questione.
Platone si autopresenta, dunque, in un modo che richiama un Monologo di un
personaggio sulla scena e che ad un certo punto svolta in un effetto di flasch-bak
realizzato con una fictio retorica di dialogo che simula un Dione risuscitato che parla
a Platone [ 328 d- 329 a] e lo accusa amichevolmente di “tradire” la filosofia, perché
egli farebbe solo chiacchiere, non andrebbe in aiuto dei suoi amici e non si
impegnerebbe ad educare e consigliare i Siracusani di buona volontà a rifondare la
costituzione, riformando la vita politica; una vita politica – come è scritto in passi
precedenti- degli Italioti e Sicelioti, fannulloni e festaioli, degenerata in una voglia
esasperata di conflitto “stragi ed uccisioni” ed in persistente grave instabilità politica
con continui passaggi di regime.123
Ma c’è una seconda Figurazione della Figura della Accusa e del Tradimento; essa
viene ad occupare un posto orientante come centro gravitazionale dell’opera : essa
è introdotta dal Ricordo dell’ Attacco di gelosia e di invidia che colpisce Dionigi che si
sente trascurato ‘affettivamente’ da Platone che privilegerebbe Dione nell’ ‘analisi’
della situazione politica e nella definizione del progetto di un nuova e migliore
costituzione; di più adeguate e giuste leggi. [330 a-b ].
Dionigi vuole Platone tutto per sé, perché vuole impossessarsi dei segreti della sua
‘sapienza politica’, del suo Desiderio per discorsi di filosofia ( ton perì philosophian
logon), di quella filosofia che alimenta ed è alimentata dalla vita ( zoè) , di quella vita
che è per Platone la vita giusta.
Questo tratto del volto di Dionigi, insieme frustrato e possessivo ed avido di ‘carpire’
a Platone i segreti della sapienza, è determinante per capire poi quale senso
dobbiamo dare alla sua Pretesa di essere impossessato di questa ‘sapienza nascosta’
attraverso la compilazione di un libro.
C’è un altro tema che concorre a qualificare in modo funzionalmente sostanziale il
racconto ‘epistolare’: esso è la insistita messa in evidenza del nesso tra
comunicazione filosofico-politica ed il Consigliare/symbuleuein : in un breve spazio
testuale [330 b- 331 c] il termine nelle sue varianti grammaticali è ripetuto ben
quattordici volte.
E questa attività del Consigliare viene detta , nello stesso luogo,in un nesso
essenziale con il Curare una Malattia. Dionigi, come tanti altri che comandano a
Siracusa e come tanti cittadini che si sono consegnati mani e piedi al ‘consumismo’
sessuale e mangiatorio e a quello dello spreco di risorse, è uno che deve essere
messo a dieta fisica e morale, e,pertanto, egli ha bisogno e deve chiedere di essere
curato; e , pertanto, per diventare cosciente di questa sua condizione morbosa deve
chiedere consigli a Platone, che solo sulla base di questa presa di coscienza anche
da parte di Dionigi è disposto poi a darli a lui , allo stesso Dione ed a tutti gli altri.
[331 a – 331 d].
La figura di un Dionigi Ammalato nell’anima , nei costumi , e negli stessi logoi perì
politeian, cioè i discorsi riguardanti quel grande bene che sono le città ben
governate e quella grande virtù che è il saperle governare nella pace e nella
concordia tra i gruppi dirigenti e tra i gruppi sociali –come seppero fare Dario e gli
stessi Ateniesi [331 e- 332 b], questo Dionigi Ammalato, anche perché male educato
da un padre despota [332 d] , si farà vedere in questa sua condizione morbosa anche
quando Platone alluderà al ‘trattato di filosofia platonica’ che egli avrebbe spacciato
come contenente i veri e grandi pensieri di Platone.
Mi domando : di questa contestualizzazione costruttiva può mai non tener conto il
lettore che cerca di capire quale è il senso di ciò che –fuori e contro questo contesto
123
– viene interpretata,invece, da un lettore non adatto come dottrina di “perentoria
condanna” della scrittura ?
Certamente no, se questo lettore vuole applicare la raccomandazione generale di
Migliori di non strumentalizzare il testo e farne un pretesto per ‘operazioni’
teoreticistiche’ estranee all’intenzione dell’autore Platone.
Ma se c’è un teoreticismo sicuro – e lo sto via via provando con un’analisi sia pure
sommaria della Lettera VII – questo è appunto il modo in cui Reale e Migliori
interpretano quel passaggio testuale dell’opera, condizionati e fuorviati da un punto
di osservazione che non è conforme alla forma generativa e strutturante immanente
ad essa.
Se ritorniamo sul testo e precisamente in quella sua parte in cui sarebbe registrata la
“condanna perentoria” della scrittura, perché sarebbe inadatta a comunicare le
cose serie [ 341 b- 342 a], leggiamo e prendiamo atto che questo discorso è
introdotto perché “Dionigi. si atteggiava a chi conosce già molte ed
importantissime/ta megista e di averne sufficiente padronanza per aver imparato
nozioni apprese da altri. In seguito , a quanto sento dire, egli stesso scrisse di quelle
cose che allora ascoltò e compose in modo tecnico/technen prendendosene il
merito /os autu, e non come trascrizione di quanto aveva ascoltato”[341b].
Il pronunciamento di Platone sulla scrittura viene ,dunque, provocato da Questa
Pretesa di Questo Dionigi, di cui nel corso della lettera sono state ricordati alcuni
tratti essenziali del suo Carattere: Dionigi è Ammalato di voglia sfrenata di dominio e
vede nemici ovunque, a partire da quelli che gli sono più prossimi e che lo
frequentano; Dionigi è ,perciò, Geloso ed Invidioso perché vede la stretta intesa ed
intimità tra Platone , il massimo esperto di cose politiche che per lui sono le più
importanti, e Dione.
Perciò il Dionigi qui in gioco non è l’esperto portatore di una Techne, della tecnica
della composizione scritta, ma chi usa ed abusa di un modo ‘tecnico’ per
propagandare un presunto valore scientifico delle sue opinioni, per di più
vantandosi della sua –volutamente ostentata- amicizia con Platone, il Platone
insuperabile esperto di costituzioni, di legislazione.
Di nuovo : Questa Pretesa di Questo Dionigi, proprio in forza di quanto di generale
Platone si appresta a dire sul rapporto tra scrittura e “cose serie” , non è una
situazione particolare di un individuo particolare, tutto e solo della storia.
Platone scorge implicitamente in lui qualcosa che è Tipico del tiranno e di tutte le
tirannie, di tutti i dispotismi ed autoritarismi. Vale dire intravede in lui il fenomeno
di logiche di dominio sfrenato e violento che non solo si attrezzano per imporsi di
fatto dentro e contro una società. ma che hanno anche estremo bisogno di
legittimarsi culturalmente. Di qui l’immagine di un Dionigi che ad intermittenza e
secondo la convenienza fa passare la voce che si sarebbe infiammato di ‘eros
filosofico’; di qui l’immagine di un Dionigi che vuol convincere il pubblico che la sua
politica sarebbe la migliore possibile perché la più ‘scientifica’ e la più scientifica
perché fondata su un libro, concepito mettendo a frutto presunti insegnamenti di
Platone , equivocando volutamente sulla circostanza, adeguatamente pubblicizzata,
del fatto di un Platone illustre ospite e massimo consulente del tiranno.
Di fronte a questo spettacolo di comunicazione pubblica sofistico-menzognera, che
si sorregge su una implicita falsa immagine della essenza di quel mass-medium che è
il libro e ne esaspera e deforma la funzione, Platone reagisce con una provocazione
di uguale grado e contraria : a quella esaltazione di un presunto potere della
scrittura egli contrappone un depotenziamento ed minimizzazione di essa al limite
della denigrazione.
Ancora una volta così assistiamo alla ricorrenza nel testo, che appartiene al genere
dell’epistolè-synbuleuein, di moduli espressivi propri della comunicazione
drammaturgica, rinvenibili - ne ho parlato sopra- anche nelle performances
oratorie dei simposi, delle assemblee giudiziarie e legislative, delle conversazioni
erudite ( di piazza o presso un tempio o lungo una via sacra), delle conferenze ‘in
parata’ nelle case lussuose di ricchi cittadini.
E,pertanto, chi legge in ottica accademica questo passaggio testuale, vedendovi un
pronunciamento di tipo dottrinario e la posizione di un paradigma sulla natura della
scrittura, lo decontestualizza, lo estrae e , quindi, lo riporta in un modo funzionale
di riconoscimento e di decodifica che va contro la forma immanente generatrice e
strutturante cognitivamente-linguisticamente il testo in esame ed in questione.
Platone,quindi, anche in questa circostanza sta in una dimostrazione realizzata nel
modo di una falsificazione-smascheramento di una illegittima pretesa di una Pseudè
Doxa supportata implicitamente da un falso modello del rapporto tra mente
,scrittura libro e vita comunicante in città intorno alla costituzione ed alle leggi.
Ed è in vista del rafforzamento del parametro di falsificazione che viene introdotta la
famosa riflessione su i “cinque”, esposta in forma narrativa /mythos e a mò di
digressione/plano [344d].
Platone,infatti, scrive : “… C’è in effetti un discorso veritiero/logos alethes che si
oppone /enantios a colui che Pretende/tolmesanti scrivere di tali cose ed in
qualsivoglia modo, e che è stato già sviluppato da me molte volte in precedenza e
che è necessario ridirlo anche ora “. [342 a].
Questo “discorso veritiero” è la descrizione di un modello cognitivo-immaginativolinguistico che è un Metamodello Analogico, che è stato formato e che ora viene da
Platone ripreso per colpire un bersaglio ben preciso e che si situa in un territorio
funzionale che non è quello proprio né dell’technai-epistemai, né quello di
produzione regolata di una immagine/eidolon, né quello di una definizione
nominale/logos, né quello di nomi-termini/onoma. Il contesto di tutta la
lettera/epistolè e questo sub-contesto sono orientati e finalizzati, dunque, a
smantellare una ‘ideologia del libro’ ; essa si inserisce nella più vasta, variopinta e
ben mascherata phainomeno-logia dei logoi eristici-sofistici intorno alle “Cose
Massime”, alle ‘Cose Serie’, alle ‘Cose più importanti e di maggior valore’.
Questo abbozzo di teoria di conoscenza, dunque, non è un fine in sé ma è uno
strumento, un ‘criterium operandi’, là dove appunto l’operari è un saper falsificare
una opinione che pretende essere vera e dimostrata, mentre è solo prodotto di
illusioni-lusinghe paralogiche.
Per meglio spiegarmi mi avvicino al dettaglio di questo sub-contesto ed osservo
quanto segue e che si aggiunge a quanto già ho messo fin qui in evidenza :
La domanda implicita è :
come sorge necessariamente il conoscere/epistemen ananche paragignesthai
rispetto ad“ognuna delle cose esistenti”/ton onton ekasto ?
Già da questo momento dobbiamo tenere presente che agli “enti” appartiene anche
quell’artefatto che è il libro.
Ed è indispensabile non farsi sfuggire l’importanza costruttiva di prim’ordine di una
mossa che è caratteristica del fare-operare dialettico platonico : questa mossa è il
Guardare verso la Geometria-matematica come Modello; e di solito i traduttori, in
passaggi analoghi rinvenibili in molti dialoghi, rendono |paradigmata| come ‘fare
esempi’. Ma questa traduzione è generica e nasconde la portata cognitivo-linguistica
implicita in questa ‘operazione costruttiva’ che è di fondamentale importanza per
cogliere il piano funzionale dove si situa la dialettica platonica rispetto alla
epistemai-technai e alla sfera del cognizione-linguaggio propri del parlare
quotidiano/Doxa-Pistis.
Ed, infatti, questo Guardare Verso/Apoblepein è anche qui, ed ‘in opere operato’, un
Guardare da Sopra e da un Dopo, ciò che sta Sotto e Viene Prima rispetto ad esso.
L’Apoblepein è così una Over-View, cioè una Sopravisione ed una DOPO-Visione; e
così è originariamente un Meta-Blepein.
Che cosa è qui, in questo passaggio testuale, ciò che sta sotto ? E’ lo statuto della
geometria-matematica,ripreso prospetticamente e selettivamente, analiticamentediareticamente/diairesis, in un suo ‘elemento’, cioè il “cerchio”/kyklon; ripreso in
una operazione analogica di nuovo, avanzando nell’ analisi, nella sua struttura
linguistico-figurativa-logica :
A)
- “Il cerchio è una certa cosa che viene espressa, che ha appunto il nome che
abbiamo appena pronunziato .
- Viene poi la sua definizione composta di nomi e verbi : ciò che infatti al centro
è equidistante in ogni punto delle estremità…
- Terzo è cò che viene disegnato e cancellato che si fa col compasso e svanisce :
nessuna di queste cose è il cerchio in sé, cui pure tutte si riferiscono in
quanto è qualcosa di distinto.
- Quarto elemento è la conoscenza(episteme) e l’autocoscienza /nous) che ci
danno la opinione ver alethè doxa di queste cose;
B)
Questo quarto elemento va considerato come un tutt’uno (pan) dato, che non
risiede né nelle parole pronunziate (phonais) né in figura (schematon) di cose
corporee ma nell’anima; donde è evidente che si tratta di una cosa diversa sia dalla
natura del cerchio in sé sia da tre elementi citati sopra.
Tra questi l’autocoscienza si avvicina più di tutti per comune genesi(syngeneia) e
somiglianza ( omoiteti), mentre gli altri si distanziano maggiormente;
C)
Lo stesso vale per la figura tanto dritta quanto circolare, e per il colore, e per il
buono, cattivo e giusto,e per ogni corpo, sia esso artificiale o naturale, e per il fuoco
e per l’acqua e ogni cosa del genere, e riguardo a tutti gli esseri viventi e a ogni
azione e passione:
D)
Se uno in un modo o in un altro non coglie i primi quattro di questi elementi, non
sarà mai completamente partecipe della conoscenza del quinto”.
Ho raggruppato gli enunciati testuali in quattro complessi (A-B-C-D), perché
rappresentano sequenze diverse della formazione progressiva-ascensiva di un
Metamodello dentro un procedimento che è :
in A)- di Scomposizione del tutto dato di un ‘elemento nucleare’ dello statuto della
geometria -matematica ; in B) di ripresa del risultato di questa Analisi e della sua
inclusione in una operazione di ‘psicologia cognitiva’, per così dire ;
in C) di una Generalizzazione-Universalizzazione di quanto stabilito in A) e B);
ed in D) in una operazione di una comparazione con un ultimo livello di esperienza
mentale chiamata |Quinto Elemento| di un Tutto Funzionale-Strutturale che
intenzionalmente è il Metaparadigma della Attività di Conoscenza degli “Enti”.
Il testo,dunque, ci mette sotto gli occhi un insieme articolato di enunciati che sono
tutti riconducibili ad una Attività Mentale che è una attività metaepistemica,
metalogica e metalinguistica.
Ed osservo subito, (pensando alla polemica wittengesteiniana contro la “metalogica”
ed a quanti confondono la funzione metalinguistica con gli abusi e le prevaricazioni
delle pretese organicamente normative di una metalogica e di un metalinguaggio
‘non temperati’)- che la filosofia platonica della geometria-matematica, ‘in re’ , cioè
costruttivamente-operativamente, non ha alcuna intenzione di affermare la sua
supremazia su di essa, e così di valere come perfezionamento organico dello statuto
dei suoi principi. Platone non è un hegeliano.
Una conferma ci viene ancora da questi passaggi della Lettera VII : lo Sguardo
Prospettico ,infatti, Sopra elementi dello statuto della geometria-matematica non
avviene per rispondere ad un problema che nascerebbe dentro il campo
problematico-tematico-metodico della techne-episteme geometrico-matematica. La
spinta a guardare verso il campo matematico nasce da un bisogno extra-matematico
e per un scopo che sta Dopo-Oltre questo campo.
Non dobbiamo perdere di vista ancora una volta il contesto ed il sub-contesto :
Platone si sta misurando con una Pretesa armata di una falsa immagine logica
dell’essenza dell’attività dello scrivere e della specifica natura cognitiva dei suoi
prodotti. E,perciò, il movente prossimo della sua ‘teoria dei cinque’ è il bisogno di
confutare-falsificare una visione magica, della scrittura e del libro. Ha di fronte a sé
una falsa implicita modellizzazione della essenza della Techne del Graphein, - o
meglio- assume come bersaglio una falsa metamodelizzazione e, dunque. una
scorretta attività metatecnica, metalogica e metalinguistica.
Dionigi si avvale anche lui di una applicazione di quella Dossomimetica che fa la sua
comparsa nell’epilogo del Sofista.
Per tutto questo la metalogica platonica è originariamente e funzionalmente
Analogica o meglio ‘Digitale’ : essa guarda –nel nostro caso- verso la geometriamatematica nel Permanere di una Distanza, di una Discontinuità funzionalestrutturale, da essa colta nel suo tutto determinato di episteme. Quando ,pertanto.
il dialettico platonico ‘scende giù’ , lì dove sta la geometria-matematica, opera una
Induzione Speciale.
E’ un procedimento speciale, perché la scomposizione di un tutto validamente dato
nei suoi costitutivi elementi- a partire da un preciso e limitato punto di vista- e la
connessa ricomposizione /sintetizzazione di essi, non avviene direttamente ed in via
principale nell’interesse e per bisogni della scienza geometrico-matematica. Questa
,infatti, è presupposta come ciò che è stata omologata come valida e vera. E’ un
Fatto-Garanzia/omeros.
Il procedimento in questione, dunque, nasce e sta costantemente in un piano
cognitivo-linguistico che viene Dopo e che sta Oltre quel ‘Fatto’- Paradigmatico che è
la geometria-matematica come scienza.
E così sotto gli occhi di noi lettori si mostra da sé un processo di
Metaparadigmatizzazione Analogica, cioè di formazione di un Paradigma di un
Paradigma, assunto come fatto-oggetto di osservazione metalogica e
metalinguistica, come ho sopra già rilevato.
Questo andamento effettivo-operativo del dialettizzare platonico – sul quale
tornerò ,quando mi tratterò sul rapporto tra filosofia e Technai , è un tema
fondamentale del quale G. Cambiano124 da tempo ha segnalato l’importanza; esso lo
richiamo qui, perché è decisivo per individuare su quale effettivo piano si collochi il
riferimento a quella scrittura che è presa di mira da Platone. Ed io l’ho già
G. Cambiano,però. con ci aiutra ad indviduare i’effettivo piano cofntitivo-linguistico dove
funzionalmente opera la filosofia platonica come ‘analitiica’ delle possibilità e limti delle technai; il
suo ruolo critico rimane sopseso a mezz’aria tra le tentazione di una superscienza filosofica e il
rischio di sciogliere lo sguardo filosofico in una coscienza< ed auto scienza epistemologica tutta
internea alle esigense ed ai problemi del campo dei saper fare tencici.
124
individuato, indicandolo come quello di prodotti di una cattiva metalogica
falsamente analogica, perché ‘dossomimetica’, operante con simulacri
parametalogici.
Di questo piano bisogna tenere conto quando si leggono le frasi platoniche in cui
Migliori crede di avvertire il tono “perentorio “ di una “condanna della scrittura” :
“…..quando si vedono le opere scritte di qualcuno, sia di un legislatore sulle leggi e
sia di chicchessia su una qualsivoglia altra materia, queste cose per questi non erano
le più serie se egli stesso è serio, ma queste sono riposte nella zona più bella di
quelle che possiede; se invece realmente ha messo per iscritto le sue riflessioni
serie, ‘allora senza dubbio’ non gli dèi, ma i mortali ‘gli hanno fatto perdere il senno
“.[
Nel titolo di questo paragrafo in forma di domanda ho posto un questione logica
implicita in questo discorso sul serio e non serio, se esso viene considerato come
dottrina seria della scrittura in connessione di una teoria cognitiva seria; vale a dire
se tutte queste parole vengono separate dal loro contesto polemico, isolate ,quindi,
estratte e riportate sul piano di una pura teorizzazione della natura della scrittura.
Ostinarsi a prendere sul serio queste dichiarazioni come fa anche C. Sini125- significa
dare spazio ad una autoconfutazione performativa, di cui non potrebbe non
accorgersi il Platone di una finissima sensibilità linguistica ed alta capacità logica .
Infatti, pur volendo concedere che questo abbozzo di teoria della conoscenza –con
annessi elementi di psicologia cognitiva- non debba essere incluso come contenuto
stretto della Dottrina Orale dei Principi- che costituirebbe quell’apice della filosofia
platonica che non si deve e non si può mettere per iscritto- è molto difficile poi
sostenere anche che queste riflessioni gnoseologiche scritte non starebbero in uno
spirito di serietà. Tali riflessioni , che tra l’altro fanno riferimento alla “cose giuste
ed ad ogni altra cosa bella”alla “virtù” ed al “vizio”[344a] possono mai essere
considerate da Platone scrittore come non serie e dette per gioco, per un gioco
senza vera valenza cognitiva ?
Dobbiamo concludere che Platone così si autoconfuta o che,invece, leggendo ancora
prevalentemente da dottrinari, da lettori non adatti questi passi, siamo noi a finire
in una autocontraddizione ?
Chiudo questo paragrafo cercando di rispondere a questa domanda : perché Platone
per smantellare la Pretesa Illegittima di far coincidere la scrittura di un libro e di un
libro di presunta filosofia platonica chiama in soccorso ed introduce quel nucleo di
teoria della conoscenza e – per accenni- di una teoria dell’errore ?
Perché Platone -in questo contesto di critica di un abuso della scrittura- mette
l’accento sul livello quinto, cioè chiama in causa l’idea che non c’è vera conoscenza
senza l’affinità con il ‘Fatto’ (syngennè tu pragmatos) e senza predisposizione verso
le cose giuste ed ogni altra cosa bella e ci lascia quella immagine- splendida gemma
di che significa fare una esperienza di verità | decidersi per una comunione
125
Sini
spirituale, morale ed intellettuale nella sincerità ,nella pacifica e prolungata
ricerca| ?
In una parola, perché Platone mobilita un così pregnante apparato concettuale per
smantellare un cattivo pregiudizio sulla natura della scrittura, facile in sè da
smantellare ?
Non mi sembra azzardato vedere sullo sfondo di questa polemica platonica un
ambiente sociale e culturale che registra un grande successo della comunicazione
scritta126 : dove il possesso di libri è uno ‘status symbol’, e dove la composizione e la
messa a disposizione del pubblico di un libro è vista dalla massa come prova di
autorità e prestigio intellettuale del suo autore. Dionigi sta in questo clima e respira
quest’aria, perciò, fa leva su questa ‘sensibilità e mentalità collettiva’ per imporsi
come ‘tiranno illuminato’, profondo cultore della filosofia e grande esperto di
scrittura.
Mi sembra che qui venga allo scoperto anche e per la prima volta la falsa immagine
di un conoscere per ‘sola scriptura’, dove scriptura sta per ciò che implica il
simulacro del ‘testo assoluto’, fuorviante astrazione che ancora oggi condiziona
molti lettori comuni e tanti esperti e tra questi da una parte ed indirettamente gli
‘ermeneutici assoluti’ che marciano sotto la bandiera del ‘Non ci sono fatti ,ma solo
interpretazioni’ ; e dall’altra direttamente ‘filologi-storici fondamentalisti dei testi’,
per il quali teoresi in sede di interpretazione è sinonimo di uso ed abuso del testoFatto, per scopi ed esigenze che non sarebbero dell’autore che l’ha prodotto.
Ribadisco un punto : i cultori ed i ‘tecnici’ di storiografia filosofica quando decidono
di ricostruire i pensieri dei filosofi non possono fare a meno di guardare attraverso
di essi per ri-conoscerli sulla base di una determinata visione di ciò che è teoria e di
ciò che non lo sarebbe.
Dunque, pur volendo ammettere che questi storici non abbiano una propria filosofia
o che pur possedendola non la facciano poi valere in sede di interpretazione,
certamente dobbiamo necessariamente anche presupporre che essi fanno valere
una loro precomprensione circa il parametro che permette di discriminare il teorico
da non-teorico nei testi esaminati.
Ora è un fatto che in sede di ermeneutica platonica questi storici di diverse e
concorrenti scuole condividono tutti la presupposizione, mai problematizzata, che
dire | pensiero filosofico| sia funzionalmente del tutto equivalente al modo
dichiarato, dottrinario e puro di elaborazione dei contenuti concettuali.
E’ appunto questo pregiudizio ‘accademico’ la causa principale di tutti i problemi
che nascono quando si legge Platone e quando lo si legge sulla base della giusta
decisione preliminare di cercare di rendere conto di ‘tutto il Platone scritto’ ,
rispettando e pensando tra l’altro l’ integrità di quella proprietà fondamentale della
Questo è l’aspetto fondamentale che porta alla luce Havelock, ma suoa intepretazione della
poszione platonica sulla scrittura è completamente fuori bersaglio,perché appunto il discorso di
Platone non è da lui – come da tanti altri – non contestualizzato funzionalmente
126
sua esposizione che il ‘sinolo’ tra Modo Narrativo Drammatizzante e Modo di
Teorizzazione.
Per restare al tema di questo mio paragrafo richiamo l’attenzione sul fatto che nella
stessa interpretazione della Lettera VII ad opera degli esponenti della Scuola di
Tubinga e di Milano si fa avvertire l’influsso di questa presupposizione culturale, che
fa passare in secondo piano o addirittura taglia fuori l’elemento retorico-polemico
che è,invece, parte integrante e sostanziale di questo discorso platonico sulla
scrittura. E come sopra ho accennato di nuovo sottolneo che ci troviamo di fronte ad
un atteggiamento polemico, di contrasto che punta su un preciso bersaglio : la
Pretesa Illegittima incarnata da un tiranno che cerca giustificazione culturale alle sue
pratiche dispotiche e di dominio.
Dentro questa Pretesa opera il simulacro di un ‘testo assoluto’ – già
all’operanell’esordio del Fedro nella figura di Lisia- e contro questa Pretesa viene
chiamata in soccorso la ‘dottrina’ dei ‘Cinque’.
E ora la puntualizzo come segue :
a) Non c’è conoscenza vera senza che il passaggio attraverso i ‘Quattro’ non sia
sorretto costantemente dall’agire del “Quinto” ,cioè ‘Affinità-Congenialità
intima al Fatto;
b) Questa Affinità vive nella esperienza di una Comunità di ricerca;
c) Comunità di Ricerca che rifiuta ‘logiche’ di Rivalità, di Supremazia mosse da
“Invidia”;
d) Ricerca di verità dove questa si fa scoprire nella esperienza di Illuminazione;
e) Una Illuminazione che è simile ad una “Scintilla” dalla quale prende avvio un
processo di autoaccrescimento della vita mentale.
Questo modello ‘in nuce’, applicato alla esperienza di scrittura e di lettura di un
libro, ci offre questa prospettiva teorica:
a) Il libro appartiene al mondo del ‘Fatto’ come Arte/Techne- Fatto, cioè come
ciò che è prodotto secondo un determinato metodo , che prevede dal suo
stesso interno un preciso uso-fruizione del prodotto;
b) Non c’è vita cognitiva effettiva sia nella produzione che nella fruizione di un
libro che vuol rappresentare una esperienza di verità ,soprattutto su ciò che
possiamo chiamare come i Valori di una Società, senza un effettivo Accesso
alla ‘natura’ del Fatto, cioè alla sua Matrice Funzionale che prevede dal suo
stesso interno il suo proprio Uso; Uso che è l’attività del leggerecomprendere.
c) Il libro nasce per la decisione di un autore che sta dentro una esperienza di
comunicazione pubblica e che,dunque, si rivolge ad un Pubblico : il Pubblico di
Vivi Lettori.
d) Scrivere intorno ai Valori e Legger un libro che di essi parla esige che ci sia una
Affinità ad essi, sia da parte dell’autore che del fruitore.
e) Da questa Afffinità è alimentata l’attività di incremento cognitivo di cui
beneficiamo leggendo i libri.
Strappato da questo ‘naturale’ contesto, socio-culturale e funzionale-tecnico , un
libro fatto valere di per se stesso , solo in forza cioè del suo essere un ente-oggetto,
è una ‘cosa da pazzi’, tanto più se promette di dirci e darci la verità sull’ Ottimo
Stato, sulla Migliore Res- Publica, su una Superiore Politeia e su perfetti Nomoi,
come pretende essere il trattato di Dionigi.
Se Dionigi fa intrighi per essere preso sul serio come scrittore di ‘importanti cose di
filosofia politica’ pubblicizzando la sua cosa come depositaria di vera e seria vita e di
seria verità vitale per la comunità dei cittadini, allora né è lui è serio , né è serio il
suo libro.
Dionigi in questa Pretesa è un Tipo, anzi il ‘Prototipo’ del tiranno pseudo-illuminato ,
che ama circondarsi di intellettuali illustri e che non vede l’ora di asservire a sé
come ‘ sofisti’, cioè come autori, anche attraverso libri e libelli, e organizzatori di
quella propaganda tutta tesa a presentare il fatto del dominio e dell’arbitrio come
valore necessario ed universale dentro una visione della giustizia come l’utile del più
forte.
Di nuovo ribadisco : la polemica platonica contro Dionigi non è una polemica
esclusivamente o prevalentemente ‘ad hominem’; essa ha ,invece, una precisa
ricaduta sulla visione generale che ha Platone della scrittura; essa viene purificata e
‘redenta’ non svalutando nella sua valenza cognitivo-linguistica la techne del
graphein, ma sottraendola al gioco fantasmagorico di un suo uso distorto nell’
ambito della comunicazione mass-mediatica di una Polis a spettacolarità e teatralità
spinta, come anche Siracusa è con il suo magnifico teatro.
Non dobbiamo sorprenderci allora se il cosiddetto Platone ‘nemico della scrittura’
ha poi scritto tanto.127
Cadiamo nell’imbarazzo solo quando non cerchiamo di essere ‘affini-congeniali’ a
questo Platone, per il quale la forma del piano di esposizione dei suoi pensieri – ai
quali appartengono anche le sue considerazioni polemiche sulla scrittura ‘alla
Dionigi’- concorre in maniera sostanziale all’orientamento del senso effettivo di
questi suoi pensieri: ‘Hic Rhodus, hic salta !’.
Questo significa anche che ancora nella Lettera VII la logica performativa di un gioco
giocato deve essere fatta prevalere sulla logica dell’esplicito e puro come è propria
dell’approccio dottrinario al testo.
Il Migliori della importanza dei giochi non gioca, però, fino a questo punto; egli
rimane condizionato da un modo di accesso al testo della Lettera VII che risente in
maniera decisiva della sua implicita decisione : ‘ bisogna far valere il principio del
gioco, ma quello della dottrina pura deve comunque mantenere il suo primato
dentro il contesto platonico’. E sulla base di questo presupposto e da esso guidato
127
E. Maltese
nella attività di riconoscimento del senso, Migliori crede di vedere nella scrittura
platonica una “condanna perentoria” di essa, finendo nel paradosso sconcertante in
cui Platone trascina un lettore non adatto e non ‘affine’ nella sua ottica di lettura
alla natura propria della matrice del suo testo. Per questa matrice, ad esso
endogena,in Platone la logica dell’implicito e della implicitazione,- così come
realizzata applicando il principio di una problematizzazione, semantizzazione e
teorizzazione per |GG| ha una funzione orientante e determinante su quanto dal lui
stesso è dato nel modo |DDP|, per affermazioni di tipo generale-astratto-puro, cioè
senza il miscuglio con modalità retoriche come quelle della ironia,polemica,
invettiva, denigrazione esasperata. Queste modalità non solo devono essere difese
come essenziali 128, ma con il Platone operativo devono essere pensate nella loro
con-possibilità ed omogeneità funzionale con una attività discorsiva che è molto di
più di una “buona forma di retorica”; essa , infatti, è il risultato di una originalissima
e mirabile innovazione-rivoluzione nella visione della teorizzazione filosofica.
Conclusione.
L’ incoerenza di partenza e la finale inconseguenza di Migliori che sposa l’importanza
fondamentale della idea di gioco e poi ad un certo punto si separa da essa,
privilegiando il modo |DDP| è secondo me dovuta anche ad una insufficiente
messa a punto teorica dello statuto funzionale proprio di una significazionecomunicazione e concettualizzazione realizzata secondo la ‘grammatica di un gioco
giocato’.
Un bagno di semiotica testuale – come quello impostato, per esempio, da U. Eco
nel suo Lector in fabula- e la chiamata in soccorso di quella psicologia cognitiva che
si occupa di giochi analogici come quelli su cul alza un velo Hoffstardt 129nella sua
indagine sulle ‘affinità’ formali-funzionali tra Bach,-Godel-Erscher “, -potrebbero
costituire un fondamentale, utile esercizio preliminare, per poi passare a valorizzarlo
analogicamente – e nei limiti del possibile- nella interpretazione di testi teoricinarrativo/drammatizzanti come quelli platonici.
A questo scopo ed in particolare per avere un punto di riferimento del
funzionamento generale dei quei processi cognitivi che con Lakoff-Nunez
130
chiamerò |metaforizzazioni concettuali| e |miscelamenti|, fruttuosa potrebbe
essere la meditazione della loro opera “Da dove viene la matematica ?|.
E molto avrebbero ancora da insegnarci il Pareyson della teoria della “Formatività”
ed il Wiittengestein ‘ciritico’ di una metalogica ‘maltemperata’ e della connessa
teoria della pluralità di giochi linguistici. Molto stimolante sarebbe anche la ripresa
del Gadamer del ‘gioco come filo conduttore dell’opera d’arte” soprattutto se
questa idea fosse estesa alla modalità di teorizzazione di Platone e se Gadamer non
128
129
130
F. Trabattoni
Hoffstardt
Lakoff- Nunez
mostrasse da una parte una invincibile ritrosia nel vedere nelle domande platoniche
quella modalità problematica che si sposa alla idea di Esercizi come ‘Calcoli’
argomentativo-linguistici; e dall’altra se egli non ribadisse la sua convinta adesione
ad una paradigma di teoria e di speculazione, per la quale essa è equivalente
funzionalmente al modo riflessivo-dichiarato il cui classico esempio ci è dato dalla
pratica di concettualizzazione dell’ Aristotele dei trattati.131
In particolare l’ apertura alla semiotica dei testi narrativi è anche- tra l’altronecessariamente richiesta dalla impostazione che il maestro di M, Migliori , G. Reale,
applica alla lettura del Simposio svolta in chiave di “lettura scenica” , di “personaggi
in maschera”, di meccanismi teatrali come quello di cambio di maschera in corso
d’opera. 132
Questa importante innovazione del modo di interpretazione rimane ancora, però, in
Reale, mischiata e subordinata al punto di vista dottrinario in dipendenza della
proiezione sul testo della dottrina orale dei Principi in funzione di paradigma-chiave
per individuare il contenuto speculativo preminente del Simposio; contenuto fissato
e velato da Platone, secondo Reale, nella favola di Aristofane sotto la cui maschera
Platone ci trasmetterebbe l’idea-guida di questo gioco : quella di eros come
esperienza demonica e nostalgica dell’ Uno.
La suggestiva operazione ermeneutica di Reale si giustappone,però, al complesso
del gioco in questa opera rappresentato e finisce per non riuscire a dar conto di quel
suo senso finale capace di spiegare tutte le mosse e le figurazioni di quanto appare
sulla scena della scrittura.
Essa , ad esempio, tra l’altro non riesce a cogliere che la parte finale dell’opera ,
quella dove si rappresenta l’entrata improvvisa di Alcibiade nella sala del banchetto,
non costituisce solo un emozionante’ e coloratissimo epilogo;ed esso, veicola ben
più di un importante contenuto filosofico sul tema Eros-Socrate.
La sua forma narrativo-descrittiva ,infatti, rompe costruttivamente tutto il
precedente movimento dei complessi argomentativi ed in questa interruzione
introduce una riconversione, un riorientamento ed una ristrutturazione dellla
impostazione problematica iniziale del gioco, ispirata appunto alla formula |Che
cos’è X…?| ed in questa circostanza : |Che cos’è Eros ?|.
Per effetto di questo feed-back e per la conseguente conversione performativa del
problema dichiarato nell’avvio della narrazione, la domanda che costituisce il centro
gravitazionale dell’opera diventa questa : perché i ‘tecnici’ (un filologo, un retore, un
medico, due esperti di drammaturgia, una profetessa), che credono e pretendono di
poter conoscere la essenza di eros e lo stesso Socrate, nella misura in cui si identifica
con Diotima e fa per un momento sua la techne mantikè , rimangono sorpresi e
spiazzati da quella visione di eros che si incarna in un Alcibiade dissoluto e violento
picconatore di costituzioni, scostumato sovvertitore della misura e dell’ordine delle
131
132
Gadamer
G. Reale
bevute di vino e degli interventi di elogio ad eros ? Perché reagiscono
addormentandosi o lasciando la sala del banchetto ? Perché solo Socrate, ormai
senza più la maschera della profetessa Diotima, rimane sveglio e quando va via non
va a dormire, ma ad allenarsi fino all’alba nella palestra ?
Questa trasformazione della domanda a seguito del passaggio da una logica del
dichiarato ad una logica dell’implicito (che non è altro che la logica dell’ “in opere
operato” che – come si è evidenziato – è proprio della applicazione del principio del
gioco giocato), sta non sul piano dei rapporti dei personaggi narranti sulla scena
della scrittura, ma su quello della relazione dell’autore-regista- unico attore con più
maschere, cioè Platone, con il lettore-spettatore dei logoi della sua scrittura.
Anche in questo caso, dunque si vede come una fedeltà testuale, che -come quella
di G. Reale- si fa forte di ampi riassunti dell’opera, di vasti e ricchi commenti, di una
quantità significativa di citazione di loci, quando poi non è fatta valere dentro
l’applicazione del principio del gioco nel suo primato funzionale, non si rivela
all’altezza e rimane al di sotto della effettiva e complessiva consistenza e portata d
segnico-semantica e , quindi, al di sotto dell’ essenziale valenza teorica del testo
platonico.
Pertanto , quando Migliori raccomanda di non forzare i testi e di considerarli in tutta
la loro estensione introduce una questione che non può essere trattata senza un
preliminare esame della natura di un testo in generale e del suo originario relazione
con l’attività del leggere e del senso del testo come prova della dimostrazione della
correttezza ed adeguatezza di una interpretazione. E Migliori ne è consapevole ed
affronta questo problema nella “Terza Appendice”, focalizzando tre modalità di
lettura: quella guidata dal metodo storiografico, l’altra mossa prevalentemente da
interessi teoretici esterni e da intenzioni di verifica della validità e della verità delle
posizioni platoniche; e quella propria .
Questa prevede la esplicitazione del paradigma interpretativo e la sua verifica con il
tutto testuale di ogni dialogo e con tutti i dialoghi in un confronto costante e
sistematico con la letteratura secondaria, provando che il paradigma assunto spiega
più testo e mette meglio in chiaro la sua coerenza problematico-tematico-teorica
rispetto a tradizioni di ricerca rivali e concorrenti, a partire dalla analisi dei più
importanti ‘rompicapo’ platonici.
Questa scelta appartiene certamente al rispetto degli impegni che si contraggono
con la integrità e totalità determinata di un testo, dove stanno in gioco da una parte
la relativa autonomia del documento con la sua funzione di costante contrappesoinerziale e dall’altra l’iniziativa di creativa e libera cooperazione del lettoreinterprete con un suo continuo ritorno sulla superficie segnica-significante ed
avendo un occhio diretto al cotesto ed all’inter-testo, come per quest’ultimo aspetto
sa fare. con acume e finezza unici, Friedlander.
Che cosa manca di importante in questo impostazione condivisibile del Migliori ? La
presa di coscienza che l’assunzione del principio funzionale-costruttivo |GG| deve
valere come istanza fondamentale di riconoscimento che deve subordinare sempre
a sé , alla sua ‘logica operativa’, il principio della concettualizzazione data per |DDP|.
|Sempre a sé| significa – come ho detto- che l’applicazione di quel principio deve
essere assicurata fin dalla individuazione del problema-guida di ogni dialogo; cosa
che esige un chiarimento di fondo sul rapporto organico tra l’elemento /Racconto e
l’elemento/Teoria.
Ora è evidente che se si pone l’equivalenza sostanziale e funzionale tra teoria e
modo |DDP|, in nessun modo e per nessuna strada la dimensione del Racconto – la
forma cosiddetta ‘lettararia’- può essere considerato cooderminante dell’assetto e
portata teorica dell’opera.
Nessun paradigma di storiografia filosofica, di lettura teoretica, di lettura letterariaretorica , di nuova interpretazione , può risolvere il ‘puzzle’ intricato e rompicapo di
un Raccontare platonico che rivendica per sé la sua indissolubile simbiosi con un
Teorizzare Rigoroso, istitutivo di un filosofare come ricerca risolutiva di problemi
precisi in un ambito cogniitvo-linguistico ben determinato da originali procedimenti.
Ben oltre, dunque, la prospettiva di una filosofia platonica come una nuova ed
buona forma di retorica guidata da una ‘logica del probabile’.
Che la giustizia come utile del più forte sia un sofisma solo probabile e che solo
probabili siano i risultati di una logica della filosofia che lo smaschera e lo falsifica , è
quanto di più antiplatonico si possa mai concepire. Ma non meno grave dal punto di
vista di questa conseguenza oggettiva, è la conclusione del Migliori ,per il quale
Platone avrebbe deciso di non risolvere in maniera congrua i suoi problemi e che
offrirebbe solo complessi esercizi introduttivi perché i lettori possano risolvere i
propri, con lui -puro protrettico- e magari contro di lui.
Migliori avrebbe ragione solo se la regola fondamentale per isolare questi problemi
fosse quella insita nell’abito culturale della ‘scienza normale’ che si impone con la
marea ingovernabile degli studi specialistici su Platone e dove non affiora il sospetto
che forse questa quantità sterminata di libri nascono da un iniziale inavvertito passo
falso : pretendere di catturare ’tutto Platone’ con una rete che non fa fino in fondo i
conti con la stranezza di una teoria che non rinuncia ma ad essere solidale con un
Raccontare; e ,quindi, in tal modo mettersi nella condizione di farsi sfuggire la
principale sfida che Platone lancia al sul lettore/pescatore:.
Tale è quella che l chiama questo lettore ,che getta reti sul testo,
a saper
trasformare con Platone la stessa idea corrente, epistemicamente accreditata ed
omologata, di Teoria e di Racconto.
Non vi è ,dunque, corretto accesso al mare dei segni-campi di tracce platonici senza
la conversione funzionale-strutturale di questi modi cognitivo-immaginativolinguistici di concepire questo nesso cruciale: e.pertanto. il paradigma-disegno da
calare sul testo deve essere puntato e proiettato , su un Platone Scritto, ripreso,
mappato, diagnosticato nel suo ‘totum ‘ ‘genealogico’, cioè nella sua originaria e
originale matrice funzionale e costruttiva.
6 Dialettizzare/dialeghesthai, Opinione/Doxa, Opinione Vera/alethè Doxa e
“Falsa Opinione”/Pseudè Doxa ed il problema |Dove sta la Teoria in Platone ?|.
Dove sta la dialettica nel Platone Scritto ?
Sono spinto a porre questa domanda da quell’altra più generale di M. Vegetti :”Dove
sta la teoria in Platone ?”133. E, quindi, io proseguo : ‘ E’ la stessa cosa in riferimento
a Platone dire |Teoria| e dire | Dottrina Dialettica| ?
Se poniamo una equivalenza piena ed esclusiva tra |Teoria Filosofica| e | Dottrina
Dialettica|, allora subito e fin dall’inizio dobbiamo affermare che la dimensione
Narrativo-Drammatizzante, cioè una costante funzionale e strutturale dei testi
platonici, sarebbe irrilevante ai fini delle ricerca dei ‘loci’ dove starebbero i
contenuti teorici, speculativo-filosofici, del pensiero platonico.
Se decidiamo, invece, di rispettare questa proprietà fondamentale del testo,
dovremmo allora tentare di capire perché Platone ha voluto essere fedele dall’inizio
alla fine a quella sua scelta di ‘mescolare’ ciò che è speculazione e ciò che è
“rappresentazione”.134
Attorno a questa domanda si muovono le diverse scuole ermeneutiche e
naturalmente anche gli esponenti di quella tradizione e programma di ricerca nella
quale anche Migliori si riconosce.
Nel decidermi a seguire Migliori nelle sue circa duecentocinquanta pagine di quella
parte del suo primo volume intitolata “La filosofia come dialettica”135, terrò conto
della sua insistente raccomandazione: tornare continuamente a tutti i testi dei
dialoghi e tenersi strettamente ancorati e prossimi ad essi.
Ed allora la coerenza a questo canone mi imporrà anche di domandarmi : dove sta la
teoria platonica nella Apologia di Socrate e nel Critone ? E, dunque, anche : dove sta
la dialettica in questi due dialoghi quasi del tutto apparentemente solo narrativi ?
Ho già osservato come G. Reale di fronte alla Apologia non accetta che anche qui
Socrate sia innanzitutto un nomen dramatis, un nome-maschera come a me piace
dire. Conseguentemente con Reale -che parla della dimensione narrativodrammatizzante come velo coprente ed alludente a contenuti dottrinari, i quali
nella loro massima elaborazione starebbero fuori ed oltre la scrittura –(nella
dialettica orale della dottrina dei Principi), con Reale appunto dovremmo
concludere che in quella opera non si può parlare di velo drammatizzante di pensieri
platonici, perche essa sarebbe per lo più un racconto storico del Socrate della
storia136.
133
M Vegetti, Quindici Lezioni
Su questo Hegel della teoria della rappresentazione in generale cf. ad es. N. Abbagnano,
Dizionario di Filosofia”; su Hegel interpreti di Platone
135
M. Migliori, cit. pp. 191-442.
136
G. Reale, Socrate
134
Dovremmo perciò registrare un’ eccezione rispetto al compito di trovare – come in
generale invita a fare la Scuola di Tubinga e di Milano--, la teoria platonica e la sua
teoria dialettica in ogni suo testo ed in tutti i suoi testi.
Come, però, ogni eccezione e scostamento rispetto ad una paradigma di previsione,
assunto come modo di osservazione, mappatura e spiegazione, anche in questa
circostanza vedremo che questa anomalia è sintomatica di uno stato diverso delle
cose; esso prova la incapacità di risolvere un problema determinato sulla base
esclusiva o prevalente di quel paradigma, con il quale anche Migliori cerca di
‘pescare’ la teoria nel testo platonico.
Ora io sostengo che un paradigma ermeneutico che vuole abbracciare tutti i testi dei
dialoghi e renderli omogenei rispetto al raggiungimento per vie diverse di un
comune e trasversale articolato obiettivo, non può ammettere questa eccezione,
perché appunto essa costituisce una parziale smentita della validità di quell modello
ermeneutico.
Di questo è consapevole Slezak, il quale include la stessa Apologia nella strategia
platonica della “struttura di soccorso”; e, perciò, vede come tratto prevalente del
volto del Socrate platonico non quello di uno che si difende da una accusa ingiusta,
bensì quello di chi è preoccupato di andare in aiuto e prestare soccorso a quanti
credono di aver trovato o di essere già in possesso della sapienza, e che ,invece, ne
sono lontani.
E senza dubbio questo è un importante movimento concettuale di quanto accade
testualmente, ma non credo che ne costituisce quel centro gravitazionale che
permette di rendere conto di tutti i passi che costituiscono la rappresentazione ,
dove la dinamica di accusa-difesa ed il suo peso nella determinazione del senso
dell’opera non possono certo essere emarginati.
E, poi, per tenerci fedeli a quel canone, dovremmo in ogni caso chiederci : dove sta
la teoria e dove sta la dottrina dialettica nella Apologia ?
Ancor prima, tuttavia, dovremmo liberarci da quell’effetto-illusione-autoillusione
mentale che si nasconde nel |Dove|, quando lo lasciamo nella sua genericità ed
ambiguità. E’ chiaro, infatti, che il testo-ente non è ‘il luogo-ricettacolo dove stanno i
pensieri di Platone sulla teoria e sulla dialettica ‘.
Intendo ribadire questo : (i) il |dove testuale| è funzione della attività del leggere e
del come si legge, cioè a partire dalle presupposizioni. (ii)
in queste
precomprensioni non stanno in gioco solo contenuti filosofici determinati che
concorrono ad orientarci nella interpretazione; infatti, nei presupposti, che
influenzano il lettore-interprete che si accinge come Migliori a ‘tuffarsi’ nei
contenuti filosofici dei testi platonici, c’è soprattutto un certo modo di intendere la
attività di teoria , di teoria filosofica.
Questo aspetto per me è un punto fondamentale di discussione; sostengo ,infatti, e vi ho sopra già accennato- che Platone non introduce ed elabora solo nuovi
contenuti filosofici in un determinato ordine di esercizi-giochi, ma pone ‘in re’, ‘in
opere operato’ una questione che investe la natura stessa funzionale del teorizzare e
della teorizzAzione filosofica.
Per questo il problema dell’ Accesso 137‘ a ciò che ha effettivamente pensato e detto
Platone nei suoi scritti’ deve essere espressamente e preliminarmente posto a
questo livello di problematizzazione; e proprio perché il solo subito ‘tuffarsi per
ripartizioni tematiche nei testi’ per cercare i luoghi della teoria e della dialettica
platonici non è sufficiente a garantire un giusto accesso all’opera.
Mi spiego subito con un esempio e riporto innanzitutto l’esordio del secondo
capitolo di Migliori : “ il capitolo è strutturato in due parti. La prima, che concerne il
problema della conoscenza delineato nel Fedone 96A 102°, che anticipiamo per
evidenziare alcuni dati di fondo…. ” ; e richiamo il seguente: “ …nella Parte II si
affronta il problema della filosofia di Platone, che si manifesta come dialettica in
senso proprio, distinta dalla tecnica del dialogo, dialogica, e dalla antilogia eristica.
Questa visione filosofica trova la sua ragion d’essere nel reale che per Platone è
uni-molteplice: ogni ente è tanto uno quanto molti. L’affermazione della identità
di uno e molti esplicitata nel Filebo comporta, per non offendere il principio di
non-contraddizione, la costruzione di un complesso “sistema” (Cfr. C 4) , a partire
dalla “invenzione” del postulato delle Idee, evidenziato nel Fedone e nel
Parmenide, dialoghi fra loro strettamente connessi. L’analisi dimostra che Platone
non ha mai avuto dubbi sulle Idee, strumenti necessari per superare le aporie delle
spiegazioni fisiche, ma ha solo mostrato che esse sono a loro volta aggredibili con
forti obiezioni esplicitate nel Parmenide. Per superare queste aporie e quindi per
procedere oltre le Idee Platone propone un difficile lavoro dialettico per scoprire i
superiori Principi in grado di superare quel livello di difficoltà)138.
Qui è dato per scontato che quella porzione testuale del Fedone possa essere
ritagliata ed estratta come prova per fondarvi sopra una Dottrina platonica
all’interno della prospettiva canonica-disciplinare del Problema della Conoscenza.
Si vedono così immediatamente gli effetti di una presupposizione non
problematizzata, vale a dire appunto che il Platone del Fedone sarebbe in via
principale un autore di dottrine filosofiche per rispondere ad un problema
dottrinario . Ugualmente assisteremmo nel Filebo alla esposizione di una
teorizzazione dichiarata e dottrinaria della dialettica uno-molti lungo il tema del
vero e falso piacere; in questa veste essa costituirebbe lo scopo dell’intero dialogo.
Posso solo qui accennare al fatto che all’insegna della messa al cento della questione dell’
Accesso ai valori di teoria c si muove la concettualizzazione fenomenologico promosso da Husserl
e ripreso a modo suo da Heidegger; si vede ad es. di questo ultimo la “Fenomenologia della vita
religiosa”. In generale osservo che ogni svolta che fa epoca nella storia della esperienza filosofica
(Platone-Aristotele, Kant, Hegel, Husserl-Heidegger, Wittengenstein) è tale soprattutto perché il
nuovo inizio di fatto si pone la questione della natura ‘funzionale’ della attività di teorizzazione in
generale e , quindi, in questa impostazione, si riproblematizza la idea stessa di teoria filosofica.
138
M. Migliori, cit., p. 191, 193;
137
A questo proposito rilevo che l’impostazione di questo approccio ai testi,
tipicamente accademico e caratteristico anche di altri modelli ermeneutici
concorrenti e rivali rispetto a quello di Migliori, è il primo gigantesco passo falso per
entrare nel territorio dell’ ‘Arcipelago’ costituito dalla pluralità di logoi-kosmoi
realizzati in forma di giochi testualizzati da Platone.
E non dico che queste trascrizioni ‘miglioriste’ in forma di dottrina dichiarata di
quanto in Platone accade, per la stessa ammissione dell’autore, per gioco giocato,
siano il risultato di frettolose generalizzazioni di comodo e prodotte sotto il
condizionamento degli obblighi di fedeltà ad una corrente ed ad una scuola. A
contraddirmi starebbero , oltre che questa sua ‘folle opera’, anche i suoi già ricordati
analitici studi sul Parmenide, Filebo, Sofista, Politico.
Intendo, invece, richiamare l’attenzione del lettore su uno snodo funzionale
decisivo, che per un certo aspetto è rinvenibile anche in Gadamer, quando indaga
sul rapporto tra modalità riflessiva di elaborazione del concettuale propria di
Aristotele etico in particolare e il movimento dialogico e costantemente
interrogante del Socrate di Platone.
Questo snodo viene allo scoperto (i) quando si mette in atto una operazione
interpretativa da parte di un lettore,, che come Migliori si propone di valorizzare
costantemente una visione della filosofia come filosofare, cioè come Attività e
secondo il principio del gioco serio-; e (ii) nel momento in cui questa operazione
interpretativa punta dritta verso l’identificazione e la qualificazione del problema
effettivamente in gioco nell’opera determinata, per procedere poi a restituirlo in
forma illustrativa-esplicita e nello stile dottrinario.
Questa fase iniziale di accertamento e riconoscimento – come già ho avvertito
quando ho ripreso schematicamente l’ Eutifrone, il Fedro, il Simposio, il Parmenide,
Lettera VII,- anche per il Fedone è della massima importanza; perciò ora mi
applicherò a questa opera con questa specifica intenzione di messa in rilievo di un
momento costruttivo cruciale.
6.1 Di che cosa va a caccia Platone nel Fedone e come qui egli punta il suo
bersaglio.
Se dobbiamo seguire Migliori e con lui ritenere che l’opera risponderebbe in via
principale alla domanda |Che cosa sono le Idee ?| avendo come specifico piano di
indagine quello sulla natura della conoscenza, allora mi chiedo : perché il dialogo si
chiude con il racconto di un “ evento epocale”139 , cioè la morte di Socrate.
Ed in generale mi domando : tutto ciò che è in esso riconducibile alla dimensione
della Narrazione Drammatizzante risponde solo o prevalentemente alla esigenza di
offrire al lettore una “bella scrittura’ pregna di “fascino emotivo”140 come in nessun
altra opera di Platone accade, se si esclude la Apologia ? Con questo Platone artista
della parola scritta ci troviamo solo di fronte ad una grande e “buona forma di
retorica”141 ed ad un capolavoro di un Esercizio di Persuasione intorno alle “grande
questioni della vita umana,privata e pubblica”142 ?
Io che cerco i termini e la forma del problema che sianp capaci di rendere conto di
tutta l’opera e dello stesso titolo, per farlo dovrò ‘inforcare gli occhiali’ della
retorica o della logica, della epistemologia o dell’etica, della fisica, della metafisica ?
Porre,però, in questo modo il problema è già, rispetto alla intenzione problematica
di Platone, cioè quella immanente all’intero della sua opera, la prima mossa di un
lettore non adatto, che guarda verso il testo e lo legge condizionato da una
formazione culturale- come è quella accademica- che prevede una visione di un
sapere distribuito e ripartito in ambiti disciplinari distinti e non confondibili l’uno
con l’altro.
E,perciò, questo lettore sarebbe obbligato a scegliere : o retorica o logica; o
epistemologia o etica, o fisica o teologia; o linguaggio o ontologia. L’alternativa a
questo aut… aut. sarebbe quella di tenere ecletticamente insieme queste
prospettive teorico-tematiche senza riuscire a rendere conto di come Platone
garantisce la loro omogeneità funzionale, cognitivo-linguistica; per farlo ,infatti,
l’interprete dottrinario dovrebbe trattaròe con il paradigma |DDP|, che per sua
natura esige la ripartizione e distinzione di tipo disciplinare che non ammette quel
‘miscuglio’ di statuti e di campi problematico-tematici; e che tutt’al più quando si
decide per la unificazione degli ambiti di ricerca lo fa secondo un principio di
gerarchizzazione organica o per via interdisciplinare , e comunque sempre
139
140
141
142
F. Trabattoni ( a cura di), Fedone, 2011, p. VII.
Ib.
F. Trabattoni, cit. p. XI.
Ib.
conforme funzionalmente a questo modo standard di concepire la elaborazione
teorica.143
Per raggiungere questo scopo l’interprete accademico devo spezzettare e
smembrare Platone e, quindi, ricostruirlo secondo il paradigma |DDP|; il risultato di
queste operazione è appunto una deformazione sostanziale dei pensieri di Platone.
Ed è in forza di questo condizionamento previo e fuorviante che poi sorge uno
scenario generale di lettura che in riferimento al Fedone descrivo con le parole di F.
Trabattoni :
“…. è uso frequente assumere il Fedone come un repertorio di tematiche filosofiche
interessanti in quanto tali, indipendentemente dal contesto, e in particolare la tema
centrale che regge tutto il dialogo ( ossia la seconda difesa di Socrate, nei termini
esatti che abbiamo prospettato).
Si potrebbe essere tentati, per esempio, di rintracciare nel Fedone dei <pezzi>, più
o meno coerenti, della filosofia platonica, meritevoli di essere analizzati di per sé.
Ma il punto è che tali <pezzi> non sono affatto indipendenti dal contesto,
ediventano questa o quest’altra cosa a seconda del fine per cui sono impiegati.
Così, se si tenta di leggere il Fedone a prescindere dall’ eudemonismo etico che lo
comanda e dalla immortalità dell’anima che lo sostiene - tentativi generati dalla
scarsa attrazione di questi temi nella filosofia di oggi- la pretesa che il resto (ossia le
supposte tematiche di attualità) rimanga inalterato è del tutto illusoria.
Nel Fedone non ci sono una metafisica, un’etica, una epistemologia, una fisica in
generale. Ma ci sono quella metafisica, quell’etica, quell’epistemologia e quella
fisica che sono funzionali all’assunto che il dialogo vuole dimostrare.
Se tale assunto viene messo da parte , probabilmente non è escluso che si possono
sviluppare dall’analisi del testo discussioni filosofiche interessanti; è
escluso,invece, che si riesca a capire il pensiero di Platone”144
Ho evidenziato passaggi della posizione di Trabattoni che in generale anche Migliori,
massimamente interessato al rispetto del testo e del contesto dell’opera, non
potrebbe non condividere. E, tuttavia, proprio in quell’approccio –riportato all’inizio
di questo mio paragrafo- sembra che Migliori faccia ciò che secondo Trabattoni ed
anche secondo me non si dovrebbe fare se si vuole essere lettori adatti; vale a dire
rintracciare un pezzo,pur importante, dell’opera – cioè la cosiddetta dottrina delle
Idee- e non rendere conto di quale sia il suo rapporto con il resto del contesto.
Lo stesso Friedlander, cioè uno dei grandi intepreti più refrattario al trattamento dottrinario
dei dialoghi, soggiace a questa visione organicistica dei rapporto tra filosofia e technai; a questo
proposito cf., ad es., la sua interpretazione del Fedro ed in particolare sul tema filosofia/dialettica
e retorica; pp. 971-974.
144
F. Trabattoni, cit. p. XXIII.
143
E questo resto per me è costituito in primo luogo dalla parte finale del Fedone, cioè
la Narrazione del Socrate uomo e cittadino giusto ingiustamente condannato a
morte dalla sua stessa città, che lo accusa di violare proprio quei valori – la pietà, la
veracità, la buona educazione etico e politica dei giovani- che egli ha deciso di
testimoniare in tutta la sua vita e fino alla morte.
Ma a differenza di F. Trabattoni, che promuove e difende il modello ermeneutico
della ‘Buona Forma Retorica’, ritengo che la presenza forte dell’elemento narrativodrammatizzante abbia innanzitutto un ruolo logico-teorico di primo piano, perché
contribuisce in maniera sostanziale alla generazione del problema-tema
fondamentale che orienta e guida tutte le mosse costitutive di quel tutto
determinato che è il gioco serio del Fedone. Un gioco – lo dico subito- che è una
attività cognitivo-linguistica di una Dimostrazione realizzata in forma indiretta, cioè
come Falsificazione di una variante importante della phainomeno –logia di una
Illegittima Pretesa relativa alla conoscenza delle “Cose Massime”, che qui è il destino
dell’anima ed il suo rapporto con il corpo che muore e si dissolve.
Delineo ora una prima conclusione che apre anche ad altro : il Fedone costituisce la
messa in opera di una Attività di Teorizzazione in forma di scrittura spettacolare e
teatralizzante in un contesto di Performances di comunicazione pubblica – a sua
volta spettacolare e teatrale- dove si danno battaglia da una parte la ricerca di
sophia e dall’altra una tracotante, spudorata, lusingante-illudente e menzognera
anti-sophia, nella vita della città che cerca felicità e giustizia, e che quindi si
interroga sul senso della morte e sul nostro amore alla vita.
Fedone non è naturalmente né l’autore, né l’intellettuale che si è coscientemente
asservito a giustificare e propagandare questa Falsa Opinione intorno alla essenza
della vita felice ed alla giustizia; Fedone,invece, è la Figura Tipica del giovane e
brillante intellettuale appassionato di filosofia, sincero ed in buona fede, ma
culturalmente e dialetticamente non attrezzato per mascherare la presunta validità
di una visione della giustizia e della felicità come “l’utile ed il massimo utile ( la
felicità appunto) del più forte’. Egli, infatti, crede che la visione pitagorica ed il
connesso modo di vita sarebbero in grado di costituire il supremo paradigma
culturale e filosofico, la fondamentale Misura, per spiegare il Piacere ed il Dolore, il
Bene ed il Male, la Verità e la Menzogna, la Vita e la Morte.
Platone mostrerà al suo Fedone la inadeguatezza del suo modello pitagorico rispetto
al compito di catturare e smascherare quella falsa opinione che è alla base della
condanna a morte di Socrate; e soprattutto la radicale insufficienza di esso nello
spiegare quel Non-Essere, che non è il morire naturale dell’individuo umano, ma
quell’ Anti-Essere che è l’Energia cattiva-distruttiva/kakurghein che travolge l’uomocittadino giusto ed innocente Socrate, amante più di ogni altro della sua Città; una
catastrofe morale ed intellettuale che sta per annientare anche l’Ellade, civiltà delle
Poleis, della ‘Città al plurale’.
Ed è ancora l’ elemento Narrativo- Drammatizzare a fondare il legame tra la
Figura/Nome-Maschera |Fedone| ed il Paradigma Pitagorico; il Prologo [51 a-61 c],
dunque, e l’ Epilogo sono gli estremi testuali di tipo narrativo che funzionano come
due capi di quel filo che è parte essenziale di quell’intreccio , al quale appartiene la
stessa Teoria leggibile e riconoscibile nell’opera.
E sia chiaro : non è il pitagorismo a circoscrivere la Falsa Opinione , assunta qui come
bersaglio. Platone non è programmaticamente anti-pitagorico. E su questo ha piena
ragione Trabattoni. 145 Il preciso bersaglio, che solo rifacendo l’intero gioco giocato
da Platone può emergere di fronte ad un Lettore/Spettatore-Cooperatore-, è
,invece, appunto quella implicita Pretesa Illegittima, che Platone incapsula nel
nome-maschera |Fedone|.
Per cogliere lo schematismo funzionale-costruttivo latente che sorregge la FiguraFigurazioni della Pretesa nel testo-contesto circoscritto dal Fedone, dobbiamo
pensare direttamente a quanto accade soprattutto anche nel Teeteto, nel Sofista,
nel Politico, nel Filebo, nel Cratilo, nel Simposio, nel Timeo; ed con un puntamento
del bersaglio ancor più mirato, con una precisa messa a fuoco sulla Techne
Rhetorikè, dobbiamo guardare al Protagora, Gorgia, Ippia maggiore, Ippia minore.
Nel mio lavoro sul Teeteto ho scritto che Sofista è il ‘Teeteto della Grande Logica’, e
Filebo è il ‘Teeteto della Tecnologia-Psicologia dei veri e falsi piaceri’, che Cratilo è il
“Teeteto della Tecnica-episteme del linguaggio’; che nel Politico la figura-operativa
centrale è un ‘ Teeteto del metodo analitico-semantico’ ed , Timeo è il Teeteto della
scienza cosmologico-biologica’; nel Simposio, infine, i vari intellettuali , che
gareggiano a chi meglio tra loro – Socrate-teologo compreso- ed in grado più
convincente sappia dire che cos’è eros, sono tutti esponenti di una varietà di
Technai di cui Platone intende mostrare – come nel Teeteto con la techne-episteme
geometrico/matematica- il loro naturale ed intrinseco limite . Un limite che diventa
grave causa di responsabilità oggettiva nel traviamento di massa, quando ignorato
spinge i portatori di queste diverse Technai, a misurarsi con il fenomeno e la
phainome-logia del modo di produzione eristico-sofistico dei discorsi pubblici sulle “
Cose Massime”. Quella Fenomeno-logia alla quale appartengono soprattutto i
discorsi di Accusa e di Condanna a morte di Socrate.
Dentro questo quadro gli illustri sofisti, ai quali Platone dedica gli omonimi dialoghi,
non sono anche essi autori consapevoli del sofisma-menzogna, ma intellettuali di
successo e ricercati maestri che, però, non si rendono conto che la loro tecnica
raffinata nell’arte della comunicazione pubblica efficace non è in grado di
fronteggiare e smantellare quell’abuso della retorica che è l’eristica, come
complesso di espedienti di manipolazione della sensibilità e mentalità privata e
collettiva interessata ai valori massimi della vita cittadina.
145
F. Trabattoni, cit., pp. XII-XV.
Tutti questi interlocutori di Socrate, ai quali non a caso ‘ sull’altare del memoriale di
Socrate’ Platone riconosce l’onore di figurare come titoli dei rispettivi dialoghi
omonimi, devono , dunque, essere considerati come intellettuali-cittadini
‘mentalmente’ indeboliti e malati. Essi cioè sono stati contaminati dal morbo sociale
di una comunicazione pubblica distorta e menzognera, dai cui effetti non riescono a
liberarsi da soli, cioè senza l’intervento di colui che è anche un medico della
cognizione, della immaginazione e del linguaggio ; senza il soccorso di quel
terapeuta cioè che è il Socrate di Platone.
Perciò per ogni titolo ,là dove figura soprattutto un nome proprio di persona,
dobbiamo includere come implicita l’idea di Liberazione-Cura-Purificazione.
|FEDONE| come nome-maschera del personaggio - che sulla scena della scrittura
racconta e dialoga con altri portatori di nome-maschera, |ECHECRATE| ad esempio, non equivale ad !Fedone| come nome-titolo, cioè come indicatore che sta appunto
non solo in riferimento a ciò che al determinato personaggio |FEDONE| Platone fa
dire e fare, ma a tutto quello che accade nell’opera, cioè all’intero gioco delle parti .
delle Figure e delle FigurarAzioni sceniche.
Il titolo |FEDONE| sta allora per |Fedone Liberato , Curato e Purificato|. E
naturalmente qui Fedone è non l’individuo della storia, ma una sua trans-figurazione
Tipologica portatrice di una Typo-logia rappresentata e messa in scena nella
scrittura come Esibizione di un Caso.
Questo significa per lo scopo di questo mio paragrafo almeno due cose: (i) per
venire a capo del problema-tema che orienta l’intera opera non basta valorizzare
una forma di esposizione caratterizzata da generici “elementi dialogici, letterari e
retorici”146; ma bisogna aver il coraggio di spingersi ancora più in là ed identificarequalificare la ‘forma letteraria’ come |Forma di una scrittura spettacolare e
teatralizzante|, avendo costantemente un occhio diretto analogicamente verso
quella grammatica della drammaturgia attica rinvenibile in maniera significativa
nella Poetica di Aristotele; |ii) quando parliamo di Dimostrazione in riferimento alle
argomentazioni che Platone mette in bocca al suo Socrate anche nel Fedone,
dobbiamo saper pensare il dimostrare platonico in una relazione essenziale anche
ad una Attività di Logoi-Terapia nella partecipazione ad un Processo di
Comunicazione Pubblica in una Polis a spettacolarità diffusa e spinta, dove
imperversa ed impera lo spot “ La giustizia è l’utile del più forte” .
Ora se Dimostrazione dovrà essere intesa anche ed in modo essenziale come
|Liberazione-Cura- Purificazione|, allora già da adesso sappiamo che lo scopo finale,
il telos che orienta anche quell’inizio logico che il problema-tema/guida, non è una
Opinione più o meno ben argomentata e giustificata appartenente ad un ambito
epistemico-tecnico o anche ad una generale visione culturale.
L’Opinione di cui dovremo con Platone andare a caccia, per stanarla e catturarla, è
quella motivata e retta da una Pretesa Illegittima che è fattore che rende l’Opinione
146
F. Trabattoni, cit. p. X.
geneticamente e strutturalmente corrotta, e dunque da tenere rigorosamente
distinta da quell ‘Opinare che può essere unilaterale, parziale, non giustificato, ma
non per ciò volutamente ed in maniera calcolata, falso.
L’Opinione bersaglio dovrà essere pensata dal lettore adatto con l’autore Platone
come Pseudo-Opinione, come Pseudè Doxa, dove Pseudos non indica l’errore
tecnico-epistemico o un opinare difettoso appunto, ma una Fenomenologia
Paralogica, scientificamente e culturalmente inconsistente, anche se munita di
dispositivi paracomunicativi che le conferiscono un formidabile potere di attrazione
su i privati e la massa dei cittadini.
Stabiliamo ,perciò, un punto fermo : Pseudè Doxa – nel senso preciso ora indicatonon è la visione pitagorica della vita terrestre cosmica, ma una credenza che ha che
fare con la presunta verità e validità di un progetto di vita umana, socio-economica,
socio-culturale e politica-, pubblicizzato e realizzato in conformità a quel tremendo e
lusingante assunto, che Platone mette in capo al personaggio Callicle.
Questa credenza è coniugata ellitticamente nel Fedone con il tema della morte.
Perché ?
La volontà di potenza e l’hybris della Pleonessia che caratterizzano chi ha scelto la
forza-violenza come modo di vivere i rapporti sociali e politici, fanno della minaccia
di morte e del potere di mandare a morte l’altro la manifestazione più propria ed
‘eloquente’ della volontà e delle pratiche di dominio.
‘ Sono più forte di te e tanto più forte di te che posso ucciderti o farti uccidere’ : così
ragiona il dominatore di tutti i tempi. L’Innominato del Fedone è appunto questa
Figura Generale che qui si aggrava di una ulteriore essenziale connotazione : la
‘legge’ del più forte è fatta valere contro “il più giusto” e come nientificazione,
attraverso la sua messa a morte, del massimo-bene della vera giustizia.
La scelta della vita giusta sarebbe così radicalmente fragile, perché il suo demonico
testimone e custode – Socrate- può essere annientato.
E’ questo modo di pensare e di manifestarsi al pubblico proprio del potente147 la
phainomeno-logia nascosta contro cui il Socrate di Platone prende operativamente
posizione, resiste ed ne opera la falsificazione.
L’introduzione del discorso sull’anima e sulla sua immortalità, sulla Svolta culturale
verso la quale si decide Socrate ad un certo punto della sua vita, sulle Idee, e
naturalmente lo stesso confronto con il pitagorismo, appartengono a questo
contesto implicito. L’amico dei pitagorici di Fliunte, cioè Fedone, non si rende conto
che la morte ingiusta di Socrate, il più giusto che diventa Vittima Innocente e che
‘muore per tutti’, per tutta l’Ellade, è un Evento Epocale perché il Male e la
Menzogna si ostentano non come semplici contrari del bene e della verità e, quindi,
Questa figurazione del potente che si auto esalta nel suo usare come ‘argomento’ contro il
giusto il suo potere di mandarlo a morte, riappare nelle meditazioni in carcere del platonico T.
More; cf. Dialogo del conforto nelle tribolazion’; De tristiitia Domini.
147
necessari per lo sviluppo della vita e della mente, ma come Anti-Bene, Anti-Verità,
cioè dove il prefisso |Anti| è indicatore di una energia cattiva ed assolutamente e
volontariamente distruttiva.
Il pitagorico,- con la sua visione culturale di un’anima come armonia di diversiopposti, con il suo apparato categoriale binario ed il suo ascetico stile di vita- rimane
spiazzato di fronte alla novità tremenda di questo Evento e se pretende sulla base
dei suoi soli presupposti misurarsi con esso è condannato ad non vederlo nella sua
effettività, e così
ad essere inevitabilmente ‘contaminato-infettato’ dalla
incoscienza generale e dalla irresponsabilità di massa : essi non sanno veramente
quello di cui pure sono testimoni e spettatori. Non sanno che l’Agonia di Socrate
annuncia l’Agonia dell’Ellade come civiltà politica.
Ecco perché filosofare è saper pensare ‘rigorosamente’ non solo e tanto la morte
come evento naturale dell’individuo , ma in primo luogo la morte ingiusta del giusto,
vittima innocente condannato a morte dal suo stesso popolo e dai suoi capi.
L’esercizio filosofico preparatorio intorno alla ‘buona morte’ è, pertanto,
indissolubile dal pensiero intorno alla ‘buona vita’ in città’ ed alla ‘buona vita del
cosmo’, al quale la Terra appartiene. Pitagora ed i Pitagorici non devono essere
dimenticati e messi da parte, ma ricordati, ripensati radicalmente a partire dall’
Evento-Socrate che impegna soprattutto ad un nuovo impegno di vita nella città che
va risanata e salvata, attraverso soprattutto una riforma morale ed intellettuale dei
suoi gruppi dirigenti ed in generale dello spirito pubblico. E’ l’ora, dunque dela
necssità di una Imitatio dell Bios Sokratilkòs, di una nuova socratico-platonica
Paideia148, soprattutto ora che Socrate è morto e possiamo solo tenerlo con noi in
un vivo ed appassionato memoriale, dove la scrittura è a sua volta memoria di
memorie di ciò che disse, fece, e patì il più giusto degli Elleni.
Jaeger , Paideia; testo fondamentale per la messa in luce di una filosofia platonica come
Attività di Formazione culturale e spirituale dell’uomo-cittadino che sa far propro il meglio della
tradizione , nei suoi valori ideali . etici, civili. In questa prospettiva per Iaeger lo spirito della
filosofia platonica sta prima ed oltre la sua dimenzione dottrinaria.
148
6. 2 La teoria nel Fedone ed “il postulato delle Idee”.
La domanda generale |dove sta la teoria nel Platone scritto ?| deve essere
preceduta da una operazione preliminare che trasformi la domanda nel modo
seguente : | Come Platone Fa Teoria con la sua speciale testualizzazione ?|.
Questa trasformazione produce i suoi effetti anche su ciò che Migliori chiama
|postulato delle Idee| e tra l’altro su i rapporti, tra il Fedone ed il Parmenide, da lui
istituiti.
Per intendere il significato della trasformazione problematica che propongo, parto
da questo punto comune a tutti i diversi modelli ermeneutici : costituisce un
consolidato condiviso dato il fatto che i discorsi testualizzati platonici non sono
inquadrabili come trattati, essendo caratterizzati come osserva Trabattoni da “
elementi dialogici, letterari e retorici” vhr funzionano come fattori essenziali di
costituzione del contesto di concettualizzazione.
Ma che significa comporre un discorso in forma di trattato ?
Fare un trattato è in generale fare il punto sullo stato dei risultati validi fino ad un
certo punto raggiunti da una determinata disciplina; in questa definizione di
massima sono implicate anche queste assunzioni :
(i)
il contenuto concettuale è messo a disposizione nel modo esplicito,
dichiarato e puro, cioè senza miscugli con elementi retorici ( tali sono il
modo metaforico,quello ironico, quello parenetico,informativo-descrittivodecorativo);
(ii) esso a partire della enunciazioni problematiche è dato in forma generaleastratta;
(ii)
l’argomentazione è di tipo sistematico, cioè :
a) un certo numero di contenuti concettuali è articolato secondo una idea di totalità,
che permette una connessione secondo un principio ordinatore comune che
assegna a ciascuna parte il suo posto e la sua funzione insostituibile nel tutto;
b) il principio ordinatore o è quello che si trova a fondamento degli oggetti stessi e/
o risulta dal modo in cui essi sono conosciuti o ha solo valenza euristica, cioè
permette di orientarsi in un territorio molto vasto di conoscenze;
c) le conoscenze sono ottenute per deduzione, per cui le relative proposizioni o sono
primitive o sono derivate; le proposizioni non derivate evidenti per sé o presupposte
si chiamano |Principi| e le preposizioni derivate |teoremi| o |tesi|;
d) da ogni teorema, attraverso un numero finito di passaggi si deve poter risalire ad
un principio, altrimenti il teorema rimane indimostrato; è vietato, dunque, il
regressus ad infinitum.
e) un sistema può essere chiuso o aperto, cioè può essere rispettivamente
considerato definitivamente esaustivo ed immodificabile o suscettibile d integrazioni
e sviluppi.
Questo abbozzo di modello generale standard della idea di teoria e di sistema può
essere considerato come quello proprio dei saperi disciplinari istituzionalizzati ,
praticati ed insegnati nelle Accademie, nelle Scholae, nelle moderne Università.
Ora è evidente anche al comune lettore dei dialoghi che se questi vengono
approcciati secondo un’ottica conforme alla forma-trattato siamo costretti ad una
scelta : o neutralizziamo , emarginandoli, gli elementi dialogici, letterari e retorici, e
procediamo a considerare solo i cosiddetti contenuti di teoria filosofica; oppure
rimaniamo fedeli al miscuglio, al modo misto di esposizione caratteristico di Platone
autore che mescola quegli elementi, che per comodità riassumo nella formula
|Dimensione narrativo-dialogica drammatizzante|, con l’elemento della TeoriaDialettica.
E questa ultima scelta presuppone che dobbiamo avere una precisa idea di
|dialogo|, di |letteratura|, di |retorica|; e ,pertanto, di nuovo siamo tenuti riferirci
a generi distinti di discorso ed a classificazioni-ripartizioni per ambiti disciplinari, il
cui minimo comun denominatore è la prevalenza in ciascuno di essi di una logica del
Dichiarato-Esplicito.
E, poi, dobbiamo dire come evitiamo di attribuire a Platone un modo di mettere
insieme quelle due fondamentali dimensioni , riconoscibili nella sua esposizione, tale
da farcelo considerare come mera giustapposizione, sommatoria, ibridazione; cioè
come ciò che in quanto causa di confusione, ambiguità e di mancanza di chiarezza e
di distinzione è incompatibile con la natura del teorico e del sistematico. Per cui ci
troveremmo da capo nell’alternativa : o logica o retorica; o dimostrazione rigorosa o
argomentazione procedente per verosimiglianza con l’obiettivo prevalente di saper
persuadere.
Lo scenario che ho delineato è tanto noto agli studiosi specialisti di Platone, quanto
poco da essi pensato dal punto di vista del Platone Teorico, perché erroneamente si
ritiene che Platone non si sarebbe posto il ‘problema del miscuglio’ dei due ‘grandi
elementi’, cioè quello della Teoria e della |Dimensione narrativo-dialogicadrammatizzante|o che addirittura non sarebbe stato intellettualmente capace di
affrontare una simile questione; egli, ad esempio, secondo alcuni- come giù
richiamato- non avrebbe maturato un livello adeguato la capacità di astrazione,
perché sarebbe stato arcaicamente legato ai modi della oralità propria della
conversazione quotidiana.
A questo proposito sostengo :
(i)Platone dispone di una capacità ‘politecnica-epistemica’ che non ha eguali fuori e
dentro la sua Accademia, e soprattutto in riferimento alla logico-geometrica
matematica, alla drammaturgia, alla retorica, alla linguistica, al campo giuridicopolitico, alla psicologia, alla medicina di ciò che potremmo chiamare |disagi
esistenziali con annessi disturbi cognitivo-linguistici|;
(ii) Platone da fondatore , promotore e guida del programma di ricerche e studi
della sua Accademia, non solo non poteva non porsi il problema dell’impatto che il
suo modo di teorizzazione avrebbe avuto su gli esperti di trattati e di sistemi, ma
riesce guadagnare un livello di attività cognitivo-immaginativo-linguistica che gli
permette di trasformare quanto dal punto di vista limitato epistemico-tecnico come
miscuglio di “rappresentazioni “ e “concetti speculativi”- per dirla ancora con Hegel
,interprete di Platone,- in un modo funzionale-strutturale sistemico, dove l’elemento
|Narrativo-dialogico-drammatizzante| sta a servizio di una originale attività che
eminentemente di Teorizzazione;
(iii) questo piano -che Platone istituisce e mostra operandovi e via facendo, nelle
performances di una pluralità –costellazione di giochi giocati in forma di
partecipazione ad una vita pubblica, comunicante e mass-mediatica (teatro, libri,
conferenze spettacolarizzate, talk-schow in ambienti aristocratici)- questo piano
appunto è una Attività Metaepistemica, Metalogica, Metaimmaginativa,
Metalinguistica non organicamente e gerarchicamente impostata e realizzata , nella
sua scrittura, come perfezionamento necessario né degli statuti delle technai e né
degli suoi quotidiani del linguaggio; essa,infatti, viene avviata e messa in opera in
vista di uno scopo che è extra/epistemico-tecnico e che è extra/doxa-pistis, cioè
fuori ed oltre la sfera delle pratiche linguistiche ‘ingenue’ e circostanziate della
comunicazione comune. Questo scopo metodico è la Falsificazione della
Phainomelogia sofistico-menzognera, spettacolarizzata, intorno alle “Cose
Massime”.
(iv) Questa Attività di falsificazione-purificazione puntata a ‘denudare’ i variopinti
mascheramenti di questi Pseudoi Logoi|Discorsi Falsi ( nel senso che sono
Paradiscorsi, e non semplicemente Discorsi Erronei), si serve come ‘ Criteria
Operandi’ di Metaparadigmatizzazioni e di Metatipologizzazioni; e la dimensione
paradigmatica verso cui Platone Analogicamente guarda è innanzitutto quello della
logico-geometrico matematica (pitagorico-accademica) che poi sarebbe rifluita ed
ordinata negli Elementi di Euclide; mentre per quella tipologica è la poetologia che
sarebbe stata formalizzata-dottrinizzata dal platonico Aristotele nella sua Poetica, il
campo d’origine verso cui Platone guarda in un costante rapporto di discontinuità
con esso mentre appunto ne riprende in sede metapoetica e per via analogica alcuni
moduli costruttivi-espressivi dello statuto della drammaturgia attica del V secolo.
(v) quello che appare ad un lettore mosso da ottiche disciplinari e dottrinarie come il
‘genere misto’ del discorso filosofico platonico e come sostanzialmente eclettico, in
quanto assemblaggio di elementi eterogenei. che obbligano questo tipo di lettore ad
approcci ermeneutici alternativi l’uno all’altro , è appunto un effetto inevitabile se si
rimane fermi a questo modo di accesso ai testi, proprio di un lettore non adatto.
Tale è sia il lettore che si decide ad attraversare i testi platonici guidato dal modello
della ‘buona forma di retorica’ , sia l’altro che procede al riconoscimento attraverso
il modello del ‘dottrinario-sistematico’ , puntando sulla dottrina delle Idee e sulla
dottrina della dialettica.
Come ho già osservato, Platone nel suo ‘totum ‘, determinato in maniera originale
sia dal punto di vista funzionale che strutturale, non si lascia catturare da nessuna
rete costruita secondo antichi, medievali o moderni parametri disciplinari (logica,
ontologia, cosmologia,fisica, retorica, psicologia, dottrina del linguaggio, dottrina
etica, dottrina politica. dottrina teologica).
Questo non solo è un risultato di fatto ed un dato culturale della storia delle
interpretazioni delle sue opere; essa è anche alla base della rivalità e incomponibilità
della pluralità di modelli ermeneutici che fanno dire a Migliori che ci troviamo di
fronte ad un colossale fallimento nella ricostruzione condivisa del pensiero
platonico; ma questa situazione può non essere necessariamente un’ mistero’ .
E’ mia opinione,infatti, che si possa uscire da questa condizione paradossale degli
studi su Platone, se con lui e rimanendo ancorati ai suoi testi cerchiamo di operare
una svolta nel modo di intendere sia la Teoria che la Narrazione.
(v) Come in parte ho già chiarito, questa svolta è possibile in virtù di una Metabasis,
di una Mexis, di una Metabolè . Queste sono operazioni – rispettivamente- a) di
Passaggio ad altro piano funzionale,b) di Miscelamento di modelli ,ripresi
analogicamente e prospetticamente da campi già validamente dati, ed, infine. c)
della loro Trasformazione ed impiego in vista di uno scopo ben determinato che
appartiene a questo piano, originano l’ Operari che testualmente accade ed accade
innanzitutto come un Fare-Poiein specifico del Giocare un Gioco dall’inizio alla fine,
dalla fine all’inizio,
E Platone guarda alla geometria-matematica perché proprio in essa e con essa il
Principio del pensare, immaginare e dire per gioco giocato ha la sua più rigorosa
attuazione.
Così pure egli guarda verso la comunicazione drammaturgica, perché come già
indica la radice dran149 in questa esperienza il ‘pensiero-linguaggio’ è ‘in azione’, è
Performance; è attività di gioco semiosico.
Dal campo d’origine della geometria-matematica greca Platone mediante una
‘induzione speciale’ prenderà ‘in prestito’, trasponendole funzionalmente, le nozioni
di Paradigma e di Dimostrazione per assurdo; dal campo d’origine della pratica
drammaturgica Platone mediante una ‘induzione speciale’ prenderà in prestito
‘metaforizzandole’ le nozioni di Tipologico, di Caso, di Carattere, di Mythos, di Lexis ,
di Opsis.
149
Aristotele, Poetica III, 1448 b.
Il trasferimento del principio paradigmatico nel territorio metalogico metterà capo
ad una attività di metaparadigmatizzazione che costituisce una parte essenziale
della forma del piano di concettualizzazione platonico; mentre la ‘metaforizzazione
di elementi portanti della ‘grammatica’ del drammaturgico attico è alla base del
forma del piano di esposizione testualizzata in quella maniera originale che è propria
ed esclusiva di Platone.
L’una e l’altra forma, l’unao e l’altro piano, non solo stanno nel territorio funzionale
metalogico , metatecnico e metadisciplinare in corrispondenza reciproca, ma in
esso si interpenetrano e si fondono dando luogo al Sinolo di TeorizzazioneNarrazione, cioè ad un Tutto Funzionalmente Omogeneo ed Orientato al medesimo
Scopo; scopo che è Attività di Falsificazione di una Finta Metalogica e di una Distorta
Metanarrazione.
La sfera delle Technai e delle stesse condotte linguistiche naturali e spontanee
stanno, dunque, in un al di qua Discontinuo rispetto a quella Metalogica Dià/ Logica
che origina e tesse la testualizzazione speciale platonica; ed è per questo allora che
nessuno sguardo basato su una ripresa dell’ ottica delle ripartizione per ambiti
disciplinari o sorretta dal privilegiamento della cognizione-linguaggio quotidiano
possono permettere il corretto e giusto accesso a quel Sinolo Platonico in quanto
Sinolo che sta costantemente e discontinuamente in un Dopo/Oltre, e senza quindi
unilateralizzare una o più sue parti o dimensioni.
Gli antichi ,moderni e contemporanei modelli ermeneutici – che si affrontano in
‘battaglia’ per la conquista della chiave che consentirebbe l’apertura della porta di
entrata in quel forziere dove starebbe il tesoro della teoria platonica ed lo
svelamento del mistero della sua coniunctio con una forma letteraria sui generis – si
contrappongono reciprocamente proprio perché condividono funzionalmente lo
stesso piano; quello appunto di una visione della cultura in generale e della cultura
filosofica distribuita in ambiti disciplinari, che rivendicano l’uno rispetto all’altro una
autonomia di campo e statutaria.
Questa impostazione è evidente già, ad esempio, nella Poetica e nella Retorica, nella
stessa Etica di Aristotele; essa si consoliderà e si imporrà in tutto il periodo
ellenistico, influenzerà la tradizione medievale e mutatisi mutandis detterà legge
nella concezione disciplinare , interdisciplinare e transdisciplinare moderna; e negli
ambiti degli studi platonici influenzerà in maniera rilevante – come ci ricorda
Gadamer- lo stesso Schleiermacher dialogico, quando si cimenta a dare una sinossi
del pensiero platonico150.
(vi) Nel Platone scritto troviamo ,invece, uno sguardo metalogico e metalinguistico
poliprospettico in direzione del territorio di una techne-episteme ‘al plurale’ e del
vasto campo degli usi normali e quotidiani della comunicazione; entrambi queste
territori complessi –come ho appena indicato- stanno ‘giù e sotto’ l’operare
metalogico platonico e vi stanno con i loro propri bisogni, problemi, principi, statuti;
150
Gdamer, Studi platonici
con i propri specifici legomena-prattomena/detti-operati, con le proprie ophelia ed i
propri pragma. E finchè sono tali e tali si conservano, per Platone essi non hanno
necessità di essere perfezionati da una metalogica-metaepistemica organicisticagerarchizzante. E questo vale anche naturalmente per la geometria-matematica,
come in dettaglio più avanti illustrerò con riferimento alla nozione di Ipotesi e di
Figura geometrica.
Per incontrare la ‘logica’ del Platone scritto dobbiamo allora co-operare con lui ‘per
mezzo della sua scrittura’ e con lui dobbiamo saper rifare la sua MetabasisMetabolè-Mexis , e con questo Platone saper risolvere un problema trasformandolo
in un altro.
Gadamer si rende perfettamente conto che Platone non è accessibile nella sua
autentica attività cognitivo e linguistica se viene approcciato privilegiando il
principio di ciò che egli chiama |Metodo|, tenendo conto sia dell’antica che della
moderna visione del tecnico-epistemico e delle ripartizioni disciplinari. Ma la via da
lui scelta, la comprensione dialogico-fenomenologica, non riesce a stare all’altezza di
quella ‘logica dell’implicito e per gioco giocato’ che attraversa da sopra e sotto, in
lungo ed in largo, dall’inizio alla fine, ogni opera platonica ed il loro stare insieme in
forma di cum-stellazione.
Non solo egli ,infatti, sta sotto il cattivo influsso heideggeriano nel pensare il
metodico-tecnico come non-conoscenza nella esperienza della |Verità|, ma in primo
luogo egli non riesce a far valere fino in fondo, cioè fino alla identificazione e
qualificazione del movimento teorico-narrativo platonico, quella che è pure una sua
importante già da me richiamataidea : “il filo conduttore del gioco” in riferimento
all’opera d’arte.
A fare di ostacolo a Gadamer è ancor prima di quel cattivo pregiudizio contro la
‘Techne’, la posizione di una piena ed assoluta equivalenza tra teorizzazione e
l’elaborazione per “riflessività” e per modo prevalentemente dichiarato, così come
leggibile in tutto Aristotele ed in particolare nell’ Aristotele etico, se pur letto
fenomeno logicamente.
Incredibilmente anche Gadamer crede che il Platone scritto operi per via dialogica.
perchè avrebbe scelto di non credere in maniera assoluta ad una teorizzazione
filosofica che si avvalesse dei modi e dei risultati del saper fare tecnico.
Gadamer così si impedisce di cogliere il fondamentale ruolo costruttivo-funzionale
che ha nella teorizzazione e nella dialettica platoniche il riferimento costante al
mondo delle Technai; ed addirittura ne fraintende la natura, quando ,ad esempio,
attribuisce al modo tecnico la responsabilità del mancato accesso al senso autentico
della esperienza morale .cosi come rappresentata nei dialoghi sulle virtù151; o allor
quando nel Teeteto crede di vedere una presunta affermazione platonica della
151
Gadamer, Studi platonici
superiorità gerarchico-funzionale della dialettica sulla logica geometricomatematica. 152
Ma in tutte le opere di Platone il bersaglio costante è una falsa immagine/Pseudos
extra-tecnica e paratecnica degli ambiti e dei valori realizzati dalle Technai; Pseudos
,dunque, che si avvale di una falsa immagine della loro essenza.
Ma il più grande infortunio – se così posso dire di un acuto interprete,tanto
appassionato di Platone da preferirlo al suo maestro Heidegger.. è quello di non aver
colto la centralità della fantasmagoria di questo Pseudos in tutto Platone, ivi
compreso il Platone del Timeo –dove per Gadamer lo Pseudos153 sarebbe
sorprendentemente assente e senza un posto ontologico.
Per spiegare questo Gadamer, che non vede quanto spazio ha ciò che sopra ho
chiamato |il Grande Innominato|, bisognerebbe portare in primo piano il Gadamer
interprete di Hegel e della teoria di quest’ultimo sulla ‘false Meinung”154.
E mi basta qui questo accenno, che apre il discorso su un aspetto decisivo di tutta la
filosofia moderna e sullo stesso tema del Disordine-Ordine rinvenibile nel i titolo
all’opera di Migliori; e che considero uno spartiacque, una discriminate
fondamentale tra Platone da una parte ed Hegel e l’hegelismo dichiarato
/consapevole o nascosto/inconsapevole dall’altra.
B. Croce ebbe ben chiaro e più di tutti che il confronto-scontro con Hegel si sarebbe
deciso sul terreno di una Teoria dell’ Errore,155 estetico, logico, economico-politico,
etico. Uno scontro che avrebbe portato Croce . sia pure in un ‘odi et amo’- ad una
riconversione tragica alla fede nello “Spirito Eterno”156, cioè in quella che io
considero la ideologia fantasmalogica del moderno.
Ho richiamato in questo sottoparagrafo . dedicato al Migliori del “postulato delle
Idee”, la questione di |Gadamer e le Technai in Platone|, perché nella ricerca della
teoria e del significato della dialettica nel Platone scritto questa indagine preliminare
è ineludibile; essa,infatti, deve investire il modo in cui egli Fa Teoria, Opera
Idealizzazione, Opera Postulazioni; riguarda, dunque, il modo in cui Platone ‘agisce
filosoficamente’, mette in opera una Attività – come piace dire anche a Migliori, che
però ,poi, non fa valere radicalmente ed ‘in principio’, cioè a partire dalla
focalizzazione del problema, il primato della Attività.
(VIII) Se G. Cambiano, -impegnato per primo nella messa in luce del Platone
costantemente attento al fiorire dei metodi tecnici e a descrivere lo “spazio
Gadamer, cit. p.
Gadamer. cit. p.
154
Sulla scia del primato della intesa sulla cosa Gadamer pensa che si posssa dire il negativo,
considerato nella sua più vasta accezione e nelle sue più radicali implicazioni, solo a partire dalla
esperienza del postitivo, che è per lui la esperienza comunitaria della comprensione dialogica.
155
B. Croce, Saggio sullo Hegel.
156
Questo Croce ‘fervente devoto dello Spirito’ ò leggibile ad es. nell’ epilogo della sua “Filosofia
della pratica”. Come questa fua fede entra ‘ in crisi’ e porta ad un sistema filosofico che o unisce
troppo e distingue poco e che distingue troppo ed unusce poco, cf. G. Sasso
152
153
letterario”157 , storico e socio-culturale nel quale va situato il Platone scritto, non ci
dice,poi, come in Platone stanno in equilibrio funzionale-strutturale, cognitivoimmaginativo-linguistico, lo sguardo sulle Technai e la Dimensione Narrativa- è
perché anche il suo modello ermeneutico è schiacciato sulla logica del dichiarato e
del dottrinario.
E non ce lo dice neppure F. Adorno, che non condivide la soluzione sociologica data
da G. Cambiano, che attribuisce al filosofo portatore della dottrina filosofica una
funzione di mediazione socio-culturale-politica dei portatori delle Technai.
Come ho in parte illustrato fin qui, la visione di Adorno di una conoscenza filosofica
e di una dialettica platoniche che avrebbero come compito metodico e destinazione
finale quello di un’Analisi delle possibilità e dei limiti dei vari saper-fare, teorici e
pratici158, per la costruzione di un sapere a vantaggio dell’uomo – secondo la
generale concezione filosofica propria di N. Abbagnano-159, questa visione ancora
una volta sacrifica l’elemento Narrativo e non coglie quel rapporto di discontinuità
organico-strutturale-funzionale tra l’Operare Teorico e Dialettico platonico e
l’arcipelago tecnico- . Discontinuità determinata dalla natura extra-tecnica e
paratecnica del Bersaglio che Platone ‘fiuta’, insegue, prende di mira, e colpisce: lo
Pseudos in una Comunicazione Pubblica Spettacolarizzata intorno alle Immagini
‘Logiche’ della felicità e della giustizia.
In Platone l’ Analitica si attua in Operazioni Analitiche che accadono in un territorio
e sono destinate a soddisfare bisogni di natura Metalogico-Metaanalitica; dunque,
ancora una volta fuori e sopra una analisi epistemologica o logica, nel senso
moderno di questi termini. Se si tiene presente che il modo sofistico.-menzognero di
produzione dei discorsi pubbilci si avvale di una implicita pseudo-metaanalitica e di
una pseudo-metalogica, si può meglio intendere perché lo sguardo ‘analitico’ – così
di moda nella tradizione di ricerca anglo-sassone ed americana- sia inadeguato a
riprendere per approssimazione testuale massima ,- e sia pure nel permanere di
una distanza tra noi e lui- il Platone scritto nel suo ‘totum’ nel suo Sinolo : l’intreccio
profondo tra la formatività del piano di esposizione e la formatività del piano di
concettualizzazione.
Migliori tra l’altro ci richiama a stare attenti alla Diaresis, anche quando essa non è
da Platone apertamente tematizzata-dichiarata-dottrinizzata, ma appunto data in
‘opere operato’. Questa sua indicazione è preziosa, a patto che teniamo come lettori
costantemente in vista la natura del piano cognitivo-linguistico in cui Platone
effettivamente si muove ed il suo stile ellittico e brachilogico , che rende molto
difficile cogliere il modo in cui Platone procede nella sue operazioni analitiche di
‘Induzione speciale’ – oserei dire |trascendentale| ; e penso a ciò che
operativamente fa Kant con le sue “analitiche trascendentali” che vengono
157
G. Cambiano (a cura di ) , Lo spazio letterario dell’Antica Grecia.
158
F. Adorno
159
N. Abbagnano
completamente fraintese quando vengano separate dal loro scopo metodico che è
dato testualmente dalle “dialettiche trascendentali”, che prendono di mira una
varietà di ‘sofisticherie’ come lo stesso Kant dichiara espressamente nella “Critica
del Giudizio”.160
Cosciente della mia caduta in forse fastidiose ripetizioni, ho voluto enucleare questi sei punti di focalizzazione dell’ operari/poien teorico di Platone , perché li
considero importanti prima di esaminare da vicino quel che scrive M. Migliori nelle
pagine 191-713 del primo volume della sua opera.
Questi sei punti potrebbero essere riassunti in questa osservazione generale : sono
esistiti Due Platoni ; un Platone, scienziato lui stesso, e maestro ed interlocutore di
altissimo livello di scienziati; e un Platone Scritto, quello dei suoi cosiddetti
|Dialoghi|.
Questi Due Platoni, però, stanno a capo ed in corrispondenza di due ProgrammiProgetti Culturali diversi, sia sotto il profilo dell’orientamento della esperienza
problematico-tematica e sia dal punto di vista della loro matrice funzionalecostruttiva , nonche del pubblico ai quali sono destinati..
E questa diversità di fondo e di finalità progettuale non significa né assoluta
separazione dell’uno e dall’altro, né subordinazione organica del secondo
programma-progetto rispetto al primo; ed, invece, è propria questa subordinazione
l’implicita presupposizione di quelli –come gli esponenti della Scuola di Tubinga e di
Milano- usano la Dottrina Orale dei Principi come un nucleo di Idee-Chiave per
scoprire i valori teorici del Platone scritto e la portata della sua dottrina delle Idee.
Per essere più chiaro : il Platone maestro dei maestri nella vita di ricerca della sua
Accademia non è colui che si riduce a colloqui didattici con i suoi amici ed allievi
commetando, spiegando e discutendo i testi dei suoi dialoghi, come sembra
credere, ad esempio, Gadamer161; non è un Platone che non saprebbe distinguere
tra dottrina pura e discorsi semi-dottrinari mescolati di miti e metafore. come
credono quelli che leggono in maniera sbagliata Aristotele , critico dei ‘platonici’ in
Accademia. E non prendo neppure in considerazione perché veramente ridicola,
l’opinione di quegli altri che si immaginano un Platone che non avrebbe maturato un
livello di attività di astrazione, che gli permettesse di operare senza racconto e senza
metafore ed allegorie .
Con il decisivo aiuto di Acerbi162, infatti, sono convinto che Platone abbia avuto un
ruolo di primo piano nella impostazione, purificazione e sviluppo della logica
geometrico-matematica, che è alla base degli Elementi di Euclide.
160
161
162
I. Kant
Gadamer, Studi platonici
Acerbi
E lo provo nel mio studio sul Teeteto, dove metto in rilievo che Platone maneggiava
così bene i principi di quella logica da permettersi una loro ‘acuttissima e strabiliante
‘metaforizzazione’ in sede di metalogica-metamatematica.
Rritengo,poi, che non si capisce l’ Aristotele matematico – che ha sondato I. Toth163senza il Platone –matematico; e così pure platonico è ancora l’ Aristotele della teoria
della imitazione nella Poetica164, perché l’idea di Imitazione in Platone non va
confusa con quella falsa opinione sulla imitazione che egli denuda e smaschera nella
sua polemica con i pararapsodi alla Ione e la parapoesia che egli propaganda come
presunto ideale cognitivo ed educativo; quella parapoesia che Platone sbeffeggia
nella sua Repubblica.
La idea di Imitazione,infatti, è quel primo livello della attività di immaginazione
logica che porta per trasformazioni concettuali-astratte alla nozione di ModelloParadigma- MegaParadigma –Metaparadigma e ,quindi, anche di Dossomimetica,
come si assiste nel Sofista.
Platone sa , dunque, molto bene quanto sia importante la funzione imitativa in
generale; essa tra l’altro, attiva i procedimenti di confronto-comparazione che
stanno alla base della esperienza della relazione di Simile-Dissimile, di Immagine
Originale ed Immagine- Copia, di Partecipazione, di DifferenziazioneOmogeneizzaione; cioè di modi di strutturazione logico-linguistica di prim’ordine.
In questa prospettiva vanno anche ripresi e valorizzati i risultati della ricerca di
Kramer sulla intima persistenza della idea platonica di aretè nell’ Aristotele etico.
Dove nasce allora il problema per me e per quanti accettano questo doppio volto
del Platone della storia ?
Nasce dalla estrema e scoraggiante difficoltà di portare alla luce e di scoprire come,
nella scrittura, che Platone ci ha lasciato in eredità e che l’Occidente ha fino ad oggi
conservato, viene realizzato cognitivamente-immaginativamente- linguisticamente ,
ciò che ho segnalato con i temini Metabasis, Metabolè. Mexis – a cui possiamo
aggiungere – quello di Telos/Scopo ‘Metodico’ e di Eneka Ou/In Vista di=
Destinazione finale.
Questi diversi movimenti, queste modalità di Kinesis/Processo-Attività, Platone li
‘Dice’ ‘ Mostrandoli’ in Operazioni, di cui dà spesso solo il risultato senza spiegarci la
regola secondo cui li forma e produce: dunque, egli non solo procede secondo una
logica dell’implicito, ma dentro questo implicito opera ulteriori ellissi; e quindi
finisce per complicare in grado estremo il riconoscimento della sua logica di fondo e
della sua intenzione di significazione complessiva e finale; e soprattutto poi se
questo riconoscimento deve essere fatto da parte di un lettore non adatto .
Tale è quello che sta nell’atteggiamento e nella aspettativa di un individuo educato
ed istruito a decodificare un messaggio e a comprendere un concetto, avendo
preventivamente a disposizione ed in forma dichiarata il preciso ed univoco
163
164
I. Toth
Questo pregiudizio è ancora molto influente.
significato di un termine, dei termini di un problema, della formula chiara di esso e
delle regole applicando le quali si può decidere se il tema-problema sia stato bene
illustrato ed ,infine, eventualmente risolto.
Perciò Platone dovendo, ad esempio nell’ Eutifrone, spiegare che la virtù della pietà
è parte specifica della virtù della giustizia, non ci avverte sul fatto che per poterlo
seguire nella sua argomentazione, noi suoi lettori dobbiamo disporre della
competenza che ci permette di saper distinguere ed unire per ‘genere e differenza
specifica’; né ,chiamando in causa ed in aiuto quel tutto determinato di pari e dispari
che è il numero , Platone-autore ci dà la regola generale del procedimento
analogico; né tanto meno egli affronta la questione della legittimità di questa
analogia tra l’ambito etico-religioso e l’ambito matematico. Gli si potrebbe,infatti,
obiettare da un punto di vista di pura dottrina che con quella analogia egli sta
cadendo nell’ errore della non ammessa Metabasis eis allo ghenos/Passaggio ad
altro genere; tanto più che il genere è un ambito scientifico, tecnico-epistemico.
Platone forse vuole matematizzare l’etica e la teologia ? Naturalmente per me non
è così, perché quella obiezione e questa domanda sarebbero ammissibili se e solo se
Platone scritto si muovesse sul piano del dottrinario –disciplinare puntando ad una
super-dottrina ed ad una massima disciplina di tipo enciclopedico o sistematicodeduttivo.
Ovviamente chi sta in questa ultima aspettativa di fondo – come implicitamente il
Migliori del “postulato delle Idee” - finisce per non trovarla e si fa catturare
inevitabilmente dal relativo falso problema del perché il preteso Platone,
dottrinario sistematico-deduttivo, non mantiene nella sua scrittura ciò che pure
prometterebbe continuamente ed in più stadi del suo viaggio testuale.
Ma si fa torto a Migliori ed a tutta la Scuola di Tubinga e di Milano se non si
riconosce ad essi un grande merito : l’aver obbligato tutti quelli che credono di aver
capito Platone, e magari di averlo ‘superato’, a ritornare sulla complessità del suo
‘opus scriptum’, non usandolo a pezzettini e per ammasso di pezzettini, ma
riconoscendolo come prodotto di una rigorosa e coerente strategia di
concettualizzazione e di semantizzazione ; e portando i lettori ben disposti a
sobbarcarsi la dura fatica di leggere e rileggere i suoi testi ed a farsi sfidare da un
dubbio : quello che ci prospetta la possibilità che dopo duemilacinquecento anni
non abbiamo capito che cosa effettivamente ha fatto Platone con la sua mirabile
impresa , che apre alla scoperta di un nuovo mondo della mente umana , con lo
scenario di un universo di logoi. dove è in opera l’incontro-scontro non tra
Disordine ed Ordine , ma tra Ordine-Relativo Disordine ed Anti-Ordine.
E c’è un altro aspetto meritorio della attività di quella Scuola e sul quale intendo
soffermarmi, completando la conclusione di questa mia osservazione riassuntiva di
un punto cruciale della complessità platonica, dei due Platoni, che qui vengono
introdotti in un senso diverso ed anzi opposto anche a quello proposto dal Vlastos
del Socrate platonico della “ironia complessa”.
Kramer,Gaiser, Szlezàk, Reale, Migliori, Movia con le applicazioni del loro modello
ermeneutico hanno portato di fatto ed indirettamente in primo piano ed a massima
tensione la questione della teoria della teoria in generale e quella della teoria della
teoria filosofica in particolare in connessione con la questione della presenza
costante nel Platone scritto di “elementi dialogici, letterari e retorici”.
Benchè tutti questi studiosi concordemente premettono di essere ‘storiciermeneutici’ e non ‘puri storici’ e né teoreti, il loro programma di ripensare l’unità e
la distinzione tra Platone Scritto ed il Platone Orale ed il rapporto tra Platone ed l’
Aristotele dello opus aristotelicum, al di là della loro stessa volontà ed intenzioni
dichiarate, rimette al centro la madre di tutte le questioni : che cos’è dal punto di
vista cognitivo,immaginativo e linguistico quella attività mentale che denominiamo
Saper Fare Filosofia ? Quale livello cognitivo-linguistico istituisce questa Attività che
ebbe in Platone Scritto il suo fondatore o comunque rifondatore ? A che cosa essa
serve ? Quale è il suo posto ed il suo compito nel mondo della cultura umana e della
vita sociale ?
Dunque, l’odierno dibattito internazionale sulla Questione Platonica riapre
oggettivamente e fuori degli stessi steccati dei dipartimenti universitari di storia
della filosofia antica una Questone Moderna, che è tutta radiciter teorica e che è
riaperta dal Kant che non sa venire a capo della natura cognitiva di ciò che pure fa
con le sue tre Critiche, allorchè distingue tra “esame” (Untersuchung) e “dottrina
filosofica” in rapporto alle “pericolose pretese dell’ Intelletto (die bersorglichem
AnmaBungen der Verstandes) 165 , per di più nella infondata credenza di essersi
lasciato per sempre dietro le spalle Platone, non sapendo,invece, (perché anche lui
vittima di una deformante immagine del Platone scritto),
quanto gli è
‘funzionalmente’ prossimo ,sia pure in un diverso contesto storico-culturale. E non
mi riferisco né al Kant ed al Platone di Natorp 166, né a quello di Cassirer,167 che
proprio la centralità costruttiva e funzionale di quelle “pericolose pretese” non
vedono nella loro speciale natura e che in ogni caso emarginano.
Ma in Kant tutto è dato nel modo dichiarato-esplicito e senza ‘Mitologizzare’ , anche
se Kant non sa spiegare, e quindi rimane per lui misteriosamente’ implicita, la radice
funzionale, cognitivo-immaginativo-linguistica, si quella Attività che egli denomina
|Esame|: il Dovere Necessariamente e Preliminarmente Esaminare la sussistenza
della legittimità di “pericolose pretese”, che egli alla fine denuderà come
inconsistenti sul piano teorico.
La grave ‘complicazione’ platonica, al contrario, è determinata proprio dalla
presenza e dalla strenua e costante difesa platonica di questa dimensione
‘mitologizzante’ dentro la rifondazione della teoria come teoria; e questo accade
nello stesso tempo in cui Platone mostra operativamente che la filosofia non è
165
166
167
I. Kant, cit.
Natorp
Cassirer
pensabile fuori e senza un rapporto necessario e necessariamente discontinuo con il
mondo delle Technai; e, quindi, con lo stesso Platone scienziato.
Come si fa vedere nel testo questo Platone esperto ‘politecnico’ ? Egli si mostra
nell’atto di fare Esempi/Paradigmata che rimandano appunto a quel loro territoriocampo d’origine, che stando al di qua e prima del suo fare esempi , si configura
come conoscenza previa di cui devono preventivamente disporre sia i personaggi
della scena della scrittura, sia il lettore adatto che è chiamato a ripercorrere quelle
che sappiamo essere mosse-figure di uno stesso gioco.
Pertanto, questo Operare per Paradigmata poiché avviene nell’interesse prevalente
di una attività che viene Dopo e sta Oltre il territorio tecnico è ‘ipso facto’ un
Operare Metaparadigmatico in funzione analogica. Il Platone ‘scienziato’, quello
delle ricerche, delle discussioni, delle lezioni e della formalizzazione tecnicoepistemiche della vita accademica, sta in questi Richiami e Rimandi per salti di piani
ai ‘Fatti Tecnici’ assunti come Fatti-Garanzia ; Salti e Fatti che il lettore adatto deve
sapere ripetere nei loro nuclei costitutivi.
Il Platone scritto e quel Platone scienziato,- le cui tracce si trovano in gran numero
nell’opus aristotelicum - devono essere ricomposti non secondo la lex di un
continuo sistematico-deduttivo fondato sulle Idee-Chiave della dottrina dei Principi ,
ma dentro l’equilibrio complesso di piani discontinui strutturanti la sua MetalogicaMetatecnica, Metaparadigmatica e Metatipologica, così come messa in opera nei
suoi scritti.
Per questa eccezionale collocazione dei suoi logoi. Platone spiazza tutti i dottrinar,
‘analiticì e “continentali” che siano ; e si sottrae alle reti dei puri logici e dei
sostenitori della prevalente e buona retorica; e dielle reti degli ontologi,
epistemologi, cosmologi, teologi, linguisti, giuristi e moralisti, storici delle idee.
Egli sta,infatti, sopra di essi, ma non per dominarli e neppure per governarli
direttamente in una mediazione culturale. Platone sta lì dove dopo ed oltre di essi si
annida la paracultura della paracomunicazione sofistico-eristica; paracultura che essi
tutti non possono vedere finchè rimangono nei loro specifici ambiti; paracultura che
ha avvelenato la visione di vita in città ed ha ammorbato quella aria che essi stessi
finiscono inconsapevolimente per respirare.
Platone,poi, non scrive per trattati le sue ricerche di scienziato, nelle quali si può
anche bene includere la sua dottrina dei Principi, perché questo compito egli lo ha
lasciato ai lavori di sistemazione, di rielaborazione , di correzione e sviluppo, del più
grande dei suoi discepoli, Aristotele.
Platone ha deciso di dedicare, infatti, tutto il suo tempo di scrittore alla creazione di
una scrittura alla altezza del suo tempo; il tempo della comunicazione pubblica
spettacolare e teatralizzante, dove si incrociano una pararetorica, una
paraletteratura, un paradialogica.
Questa nuova scrittura di un nuovo e rivoluzionario pensiero deve valere come
Memoriale di ciò che disse, fece e patì Socrate per amore della giustizia ed in una
testimonianza epocale ; essa è vista da Platone come grande Annuncio della
possibilità di una rifondazione-purificazione etico-educativa e politica dell’ Ellade e
dei suoi intellettuali e dirigenti.
Socrate ,perciò, ‘risorge nell’ |Ateniese| di Leggi e qui in queste vesti non si esibisce
come autore di un manuale di diritto pubblico e costituzionale da usare per la
rifondazione della ‘città reale’; ma ancora una volta come chi è in navigazione in un
mare di logoi, pericoloso e tempestoso, dove i cattivi discorsi hanno contaminato
anche il principio di costituzione e le norme che ad esso si ispirano e da esso
derivano. L’ “Ateniese” è, infatt.i rappresentato nel prologo come chi si trova a
dover convincere due illustri padri costituenti- Megillo e Clinia- che una città ed uno
Stato non possano avere una lex fundamentalis che poggia sul ‘postulato’ della
guerra assoluta.
In questo spirito la scrittura risponde ad una Opzione di moralità del metadiscorso
dentro la vita comunicante della Polis e viene intrisa di quella stessa energia
demonica-magnetica-mediatrice che caratterizza il suo Socrate amante di libri e
cacciatore dello Pseudos: essa,perciò, non può essere profanata dagli abusi della
paracomunicazione pubblica sofistico e menzognera.
Ed è questa ultima la scrittura o meglio la parascrittura che Platone attacca e
condanna: la scrittura/veleno-propaganda a servizio dei poteri tirannici e violenti
per la manipolazione della sensibilità e mentalità privata e collettiva dei cittadini.
6.3 Logoi che parlano di logoi : l’attraversamento di uno stretto di mare pieno di
insidie. Il problema della intepretazione ‘oggettiva’ della metafora della “seconda
navigazione” nel Fedone e la scoperta delle Idee-Forme.
Di “interpretazione” (il più possibile) oggettiva” parla lo stesso Migliori nella sua
“Appendice Terza”.168 Lo fa in un confronto con Brandt 169, avversario di ogni
relativismo interpretativo ed autore del libro “La lettura del testo filosofico”; quindi
Migliori richiama:
il Gadamer del circolo “precomprensione-testo” ,
il Garin del fare storia della filosofia in un atteggiamento di “fedeltà e rispetto
costante di ogni individuazione concreta, d ogni situazione reale entro il complesso
dell’atto storiografico”;
lo Szlezàk che denuncia i limiti del senso della differenza storica nel Popper
‘influenzato dal clima del suo tempo, e che polemizza con il presunto ‘totalitarismo’
platonico e di quanti non sanno distinguere tra il segreto pitagorico ed l’esoterismo
platonico;
il Piaia che rivendica la pari dignità cognitiva tra ermeneutica filosofica (in quanto
momento costitutivo della indagine teoretica( e storia della filosofia;
il Fronterotta critico del “principio di carità” che propone di uscire dalle difficoltà
interpretative valorizzando al massimo “ il contesto testuale immediato,”, “ le altre
opere dello stesso autore e possibilmente anche con il confronto dei suoi
contemporanei, con la cultura ed il pensiero del suo tempo ed, in ultimo, sul piano
generale di una storia delle idee”.
Ed, infine, Migliori fa sua la posizione generale di E. Berti che si oppone alle
“strategie di appropriazione”, cioè “il tentativo di usare alcuni aspetti delle filosofie
antiche al fine di corroborare posizioni filosofiche odierne”.
Respingendo anch’io – come ho già fatto sopra- la visione di un testo-assoluto e di
una lettura assoluta, cioè sciolta dal vincolo della fedeltà e del rispetto del testo,
ora cercherò di lumeggiare in questa prospettiva un particolare problema
interpretativo : come va inteso il nesso tra la metafora della “seconda navigazione”
ed i logoi nei quali Socrate dichiara di essere fuggito; e, quindi, la domanda specifica
è la seguente: qual è la natura propria di questi logoi ? Qual è il loro rapporto con le
Idee ?
168
169
M. Migliori, cit. pp. 1220-1250.
Brandt
Dobbiamo seguire il “contesto immediato” : d’accordo ! Dobbiamo tenere conto
contesto di mezzo e quello remoto : d’ accordo ! Dobbiamo tenere presenti le altre
opere di Platone : d’accordo !
Mi fermo qui e mi chiedo : come deve essere allora percorsa questa via verso il
testo |Fedone| e verso gli altri, verso il Parmenide, ad esempio, come propone il
Migliori ? Intendo dire : quale modo funzionale di riconoscimento del senso
testualizzato deve essere adottato nell’ Atto della interpretazione ?
Infatti, rispettare quei canoni, che in particolare sopra Fronterotta170 ben riassume,
costituisce una condizione necessaria , ma non sufficiente per effettuare un corretto
ed adeguato accesso alle opere di Platone.
Se, infatti, poniamo con Migliori il paradigma del “gioco serio” come necessario
funzionale filo conduttore per poter effettivamente ‘entrare’ nel testo e per
muoversi ben orientati in esso, allora l’applicazione di quei canoni deve essere
preceduta da una messa a punto preliminare di come il paradigma del “gioco serio”
condizioni in maniera significativa il loro impiego.
In forza dello statuto operativo proprio di un gioco cognitivo-immaginativolinguistico, termini, proposizioni., gruppi di proposizioni, e l’insieme determinato
dell’intero testo, subiscono una conversione funzionale .
La logica di decodifica dei termini e di quelle relazioni che sono le proposizioni e
della catena delle strutture171 e sub-strutture argomentative non solo sta sotto la
legge dell’unità-molteplicità, del tutto determinato-parti; ma deve rispondere in
primo luogo alle esigenze del modo di implicito dinamico, che costituisce la
formatività propria di un gioco cognitivo-immaginativo-linguistico giocato.
Il canone,dunque, della interdipendenza tutto –parti, parti-tutto, è qui subordinato
al canone della ‘immanenza’, cioè del rispetto della matrice funzionale che sta alla
base del modo di produzione della concettualizzazione e della sua messa in una
particolare forma espositiva.
Quindi nel momento in cui leggo e vado in cerca del significato del termine |logoi|
non mi basterà che io prendi un Lexicon platonico – come ad esempio quello di
Radice172- o vocabolario della lingua greca -come ad esempio il Little-Scott173 o il
Montanari174- per schierare in successione secondo lo schema lineare per classi di
significati e di usi proprio di un dizionario le connotazioni-denotazioni corrispettive
del termine in questione.. dandone così uno spettro semantico.
Né mi è sufficiente che in conformità ad un principio ‘sistemico-enciclopedico’ io
cerchi di selezionare dentro quello spettro il contenuto semantico più compatibile
170
171
172
173
174
Fronterotta
Sul rilievo della funzione-struttura cf. G. Casertanto
Radice
Little- Scott
Montanari
con l’immediata porzione contestuale, vale a dire l’espressione |rifugiarsi nei
logoi|[99e] e la metafora della “seconda navigazione” [99 c-d].
infatti, se con Migliori voglio far valere in maniera forte il principio del gioco, allora
prima di tutto, cioè prima di attivare una interpretazione per dizionarioenciclopedia. devo posizionarmi ed atteggiarmi verso il testo per cogliere il checome-perché di un termine , di una relazione, di una struttura dentro l’aspettativa di
un atteggiamento di lettura peculiare; cioè quello di un lettore il quale è
consapevole che a decidere della intenzione teorica dell’autore Platone sarà quel
modo di comprendere che sta attento a quel che egli ‘dice’ e mostra con il gioco
nel suo stesso effettuarsi e nel tutto determinato di questo suo accadere.
E’, dunque, il suo darsi dall’inizio alla fine dentro un primato dell’implicito e della
implicitazione ed il suo dover essere riconosciuto in questa modalità funzionale
fondamentale, è questa propspettiva di lettura specilae a costituire il canone
princeps al quale deve conformarsi un lettore che come Migliori vuole essere il
Lettore-Spettatore/Cooperatore di un gioco giocato.
Mi chiedo ora : quando Migliori e con lui G. Reale interpretano il termine |logoi|
come significato del concetto di |Idee| e la metafora della “seconda navigazione”
come passaggio dalla esperienza sensibile al piano soprasensibile delle Idee, stanno
veramente rispettando quella regola del gioco che esige che il modo del gioco
debba valere come principale codice di decodifica dei significati e messaggi del
testo ?
Non la rispettano e per una precisa scelta : essi preliminarmente si sono decisi di
assumere come paradigma di riconoscimento dei pensieri del Platone Scritto un
pensiero apicale e fondamentale del Platone Orale, cioè quello della “Dottrina dei
Principi”.
Ma il modo dottrinario è il modo del Dichiarato, dell’Esplicito, della Pura
Concettualizzazione, una volta assunto come Paradigma-Funzionale/Guida, come
nucleo dottrinario di “Idee-Chiave”-, di fatto relega ad un ruolo secondario e
comunque subordinato la lettura del testo secondo il principio del gioco e della
pluralità di giochi , che è tanto caro a Migliori e che ha pure tanta parte nella
impostazione e nella applicazione della sua prospettiva storico-ermeneutica.
Ed ora prima di procedere ad un riesame del significato di logoi in questa
connessione con la metafora acquatica e marina della “seconda navigazione” e
partendo dal Migliori che a suo modo pure gioca, intendo mettere in rilievo un
nucleo importante della apparato categoriale-ermeneutico che Migliori illustra nel
capitolo terzo del primo volume , intitolato “Il LEGAME TRA FILEBO e TIMEO”175.
Infatti, il modo in cui si cercano i legami tra un dialogo ed un altro fa vedere se e
fino a che punto un inteprete come il Migiori dei “giochi” sia fedele e coerente nel
leggere i testi a questo suo principio di riconoscimento del senso e dello scopo delle
argomentazioni platoniche.
175
M. Migliori, xit. pp. 443-491.
Il suo modo di stabilire questo collegamento è poi decisivo per capire come egli
collega il Fedone ed il Parmenide a partire dalla equivalenza diretta che egli
stabilisce tra logoi ed Idee-Forme; e per la quale la fuga nei logoi dovrebbe
intendersi come rifugio nella sfera metafisica, del soprasensibile.
Ma ciò che su cui bisogna tenere ferma l’attenzione è l’immagine logica della natura
Idee-Forme che emerge da questi collegamenti istituiti da Migliori; di come egli le
connette alla visione platonica del linguaggio e della sfera ontologica ed ontogonica.
6.3.1 Un esempio di come si cercano i legami – secondo Migliori- tra un dialogo
ed un altro.
“L’intento di questo capitolo non è quello di mettere a confronto, e quindi di
assemblare, questi due importanti dialoghi, ma di sostenere che Platone li ha
scritti in un quadro di allusioni unitarie, fornendoci con una serie di paralleli una
indicazione sulla utilità, se non necessità, di leggerli in stretta connessione.
In quanto l’uno getta luce sull’altro, e ne integra, sia pure parzialmente, le
manchevolezze”.176
Ho evidenziato un insieme di termini e di espressioni che sono sintomatici della
natura ibrida del modello ermeneutico di Migliori, che mentre dichiara di vuol
essere fedele al Platone scritto che si muoverebbe in via principale secondo la logica
del gioco serio, nello stesso tempo ed operativamente si fa guidare in maniera
determinante da un’altra ottica, quella del non gioco costituita dalla Dottrina Orale
dei Principi, Ottica che – e lo già segnalato- prima di trascinarsi con sé dei contenuti
filosofici determinati, si porta in sé un matrice funzionale di riconoscimento della
teoria nel Platone scritto che, nella misura in cui è considerata fondamentale, entra
in conflitto con quell’altra che Migliori pure assume come paradigma funzionaleguida, cioè appunto quella del principio |GG|. .177
Osservo subito una incoerenza ed a questo scopo faccio questa premessa : se
poniamo una pluralità di giochi rispondenti ad una comune strategia, si spiega anche
perché siamo coerennti quando individuiamo una “serie di paralleli” tra giochi
diversi secondo le regole dell’isomorfismo, dello isodinamismo e, quindi, della
simmetria, della proporzione, del gioco dei piani e livelli, dell’olismo, della
ricorsività.
Ma parlare delle manchevolezze di un gioco nel senso della sua incompiutezza –
come appunto fa Migliori- , equivale a dire che il gioco non è veramente e
relativamente riuscito in quanto tale; che la ‘partita’ – magari non entusiasmante e
forse brutta e noiosa- non abbia avuto la sua relativa compiutezza, la sua ‘storia’
singolare; e che ci sarebbe,pertanto, un’altra partita che la completerebbe e la
perfezionerebbe .
Nel gioco del calcio ed in tutti gli altri in cui si vince , si perde o anche si pareggia- e
l’analogia qui è utile- ogni partita per regolamento ha ‘storia a sé’ . Ciò naturalmente
non significa che esse si equivalgono per quantità e qualità di ‘azioni dei giocatori,
ma appunto che non c’è una partita che può ‘integrare’, completare organicamente
un’altra. E, tuttavia, questa proprietà di singolarità e di finitezza determinata che è
176
177
M. Migliori, cit. p. 443.
M. Migliori, cit. pp. 23-141.
essenziale alla natura del gioco e del ‘ gioco al plurale’ neppure istituisce una
separazione ed irrrelazione tra di essi,
Per restare alla analogia introdotta, richiamo il fatto che per tutti i giochi le regole
generali sono le stesse; e persistono tra l’altro identici schemi di gioco rispetto ad
una stessa squadra che fa più partite; perciò, possiamo anche parlare di parallelismi.
Per non fermarci al moderno gioco del calcio ed anche per contestualizzare quanto
fa Platone con il suo Paizein, e per avere un punto di riferimento preciso e in sé
stabilizzato, dobbiamo con Platone tener presente quei giochi peculiari che sono i
teoremi nella geometria-matematica greca.
Dire a questo proposito che un teorema ha delle manchevolezze e che dovrebbe
essere integrato da un altro, è come riconoscere che il teorema non risolve il suo
problema in tema, cioè appunto che esso non è riuscito; e che,pertanto, non è un
teorema. Or questo è incompatibile con la logica generativo-costruttiva-statutaria
della geometria-matematica greca, che prevede appunto una pluralità di giochi
ognuno dei quali fa storia a sé. E tutto ciò vale anche analogicamente anche per una
piece drammaturgica.
Il gioco come Game e quello come Play condividono su distinti piani questa
caratteristica strutturale-funzionale.
Ma come dovremmo spiegare allora ciò che Migliori chiama “manchevolezze” ?
Questo suo punto di vista è quello che sta anche alla base della idea di Szlezàk della
“struttura di soccorso” e delle connesse nozioni di “passi di omissione” e tali sono
anche quelle improvvise interruzioni finali dei dialoghi, rinvenibili con particolare
evidenza nel Crizia, nel Teeteto, come rileva lo stesso Migliori.
Come ho sopra ripetutamente precisato, l’apparente estrema evidenza delle
“manchevolezze” è in realtà un dato osservativo ‘carico di teoria’ ed, in questo caso,
pregno di una determinata visione della natura generale del teorizzare e della teoria
filosofica.
Se considero come tratto essenziale e fondamentale di essa il Modo DichiaratoEsplicito di un Astrarre Determinato – e così fa costantemente ed operativamente
anche Migliori- , allora ogni qualvolta vedo un mancato dichiarato in un movimento
di concettualizzazione importante – come ad esempio il discorso sul Bene (Kramer) ,
sull’Uno (-Migliori), sulla massima relazione uni-molteplice e sulla sua interazione
con le nozioni di quel opposto rispetto all’ordine del bene e della verità che è il
disordine del male/falso-, sono portato necessariamente a concludere che mi trovo
di fronte ad un ‘vuoto’, ad una ‘assenza’; e,quindi, sono spinto a cercare fuori dal
testo ed in un altro testo ed, infine, oltre tutti i testi platonici quanto mi può
permettere di riempirlo - con Platone in ogni caso-.
E così ci si dimentica che un tale atteggiamento osservativo sulla scrittura platonica
se è coerente per il lettore dichiaratamente e programmaticamente tutto o
prevalentemente dottrinario, non lo è per un lettore come Migliori che ha deciso di
guardare verso il documento nell’ottica di chi vuol ripetere con la massima fedeltà
possibile il gioco testualizzato da Platone , in base al presupposto che Platone
consapevolmente abbia deciso di far sua la logica del “gioco serio”.
Ribadisco : appartiene alla essenza della matrice, cioè al modo di produzione, dei
discorsi ‘per gioco serio’ il principio di una concettualizzaione secondo il Modo
Implicito-Costruttivo- Operativo; il modo dell ‘in opere operato’ .
Ed in Platone questo ‘Codice Produttivo’ è prevalente e determinante rispetto al
Codice del |DDP|., e dà luogo a quel complesso meccanismo dinamico che sopra ho
chiamato |Ironizzazione Logico-Costruttiva|, di cui do la regola generale in questi
termini : concettualizzo una cosa ma nel modo in cui lo faccio e lo espongo lascio
delle indicazioni-tracce per rimandare ad un diverso modo di concettualizzazione.
E così Platone in ogni dialogo passa da una elaborazione per modo dichiarato e per
problematizzazioni-tematizzazioni in stile dottrinario, ad una concettualizzazione per
Modo Implicito, per |GG|..
Questi passaggi progressiv,i dal piano in superficie del dichiarato-esplicito al piano
profondo ‘sottomarino’ del non dichiarato-implicito, sono segnalati da Platone al
suo lettore proprio attraverso quei segnali-indicazioni che rimanendo nell’ottica del
dichiarato appaiono come “manchevolezze”, “passi di omissione”, riserve e rimandi.
Insomma le varie interruzioni platoniche devono essere considerate come
destabilizzazioni della aspettativa di un lettore standard , sia comune che esperto,
abituato a vedere i contenuti problematici e tematici sono lì dove essi vengono
elaborati ed esposti in maniera esplicita e piana e dove gli elementi dialogici,
letterari e retorici siano intesi come ciò che è subordinato e sta originariamente a
servizio di questa maniera di speculare.
Queste destabilizzazioni sono, dunque, delle provocazioni-stimoli al lettore, affinchè
appunto si renda conto che egli deve saper passare da un modo ad un altro della
attività di riconoscimento-decodifica , cioè da quello |DDP| a quello |GG|,
diventando così lettore adatto, Lettore/Modello.
Migliori,invece, pur avendo deciso di far valere in grado rilevante il principio del
gioco e di una pluralità di giochi, non lo valorizza più proprio in riferimento a due
passaggi decisivi in sede di lettura : il primo è quello dell’individuazione del
problema preciso che è in gioco in ogni dialogo ed il secondo è dato
dall’interpretazioni che bisogna dare dei “passi di omissione” , delle “interruzioni”,
delle “manchevolezze”.
Migliori si tira indietro e non applica fino a questo punto quel suo canone
ermeneutico, perché è condizionato dalla sua preliminare opzione di guardare verso
il testo platonico da quel dopo-testo ed oltre-testo che è la Dottrina Orale dei
Principi, che è appunto anche -e per me soprattutto- implicitamente la posizione
del Modo Dichiarato, Puro, Dottrinario come modo fondamentale di interpretazione
dei contenuti e valori di teoria del Platone Scritto.
Perciò sopra ho chiamato |ibrida|ed a prevalenza dottrinaria la sua ottica e come
tale non conforme alla matrice formativa e dinamizzazione della concettualizzazione
testualizzata platonica, che è Operativo-Costruttiva-Implicita ed ‘Impura’, cioè
pregna fin nelle ‘ossa’ dell’elemento narrativo- spettacolare-teatralizzante.
Mi preme ,inoltre, rilevare che ciò che Migliori considera un dato testuale evidente e
non discutibile in questa sua pretesa evidenza – vale a dire le “manchevolezze”- è in
realtà – come già ho puntualizzato- un dato relativo ad un certo modo di
approcciare e di guardare questi passi testuali. Quella evidenza deve essere
conseguentemente messa in discussione ed io l’ho fatto ed ho anche spiegato come
e perché l’ho fatto.
E bisognava, poi, farlo, perché alla questione delle “manchevolezze” è connessa
quell dei collegamenti di un dialogo ad un altro e di un gruppo di essi ad un altro.
I lettori che si sono decisi per una lettura trasversale,unitaria , “ingressiva” ed
ascensiva dei dialoghi – Migliori è tra questi e lo ribadisce nella sua introduzione alla
opera di Kahn178 sulla forma letteraria – questi lettori non sempre sanno che si
trovano di fronte ad un compito tutt’altro che facile e senza rischi di vistosi
fraintendimenti ; ed ad esempio, finisce in un fuori pista G. Reale179 quando collega
lo Ione a Repubblica sull’asse di una presunta svalutazione-condanna platonica della
poesia teatralizzata. Nello Ione,infatti, nella persona del nome-maschera |IONE| è
di scena una pararapsodia di una parapoesia, tali perché degenerate in pura
propaganda guerresca a servizio dei ‘signori delle guerre’, che finanziano appositi
festival per eccitare le masse dei cittadini e predisporli così a facili ed attraenti
arruolamenti. Non sono,dunque, né la vera poesia, né la vera rapsodia i bersagli
della polemica platonica. A Reale tutto questo sfugge e interpreta Ione come
portatore di una autentica arte rapsodica e di una corretta visione della poesia
teatralizzata.180
Ritorno al punto in esame e mi chiedo: quando il lettore-interprete opera
collegamenti che cosa collega ? Termini, enunciati, strutture di enunciati, complessi
di strutture, fissati e veicolati da precise porzioni, ‘segmentazioni’ testuali .
E’ ,dunque, decisivo il modo in cui si procede all’accertamento , alla identificazione e
qualificazione concettuale dei ‘dati’ da collegare ; questo procedimento
naturalmente non può ignorare il tutto determinato al quale quei dati
appartengono. Se,poi, questo tutto è quello di una forma e formatività di “gioco
serio” – come in Migliori, sia pure con quel limite di fondo sopra rilevato-, allora
dobbiamo rispettare i contesti propri di ogni dialogo. Dobbiamo cioè pensare i
collegamenti a partire da collegamenti di contesti , non essendo ammesso che si
prende una quantità di dati da un dialogo , senza e fuori il loro contesto, e li si
trasferisca in un altro.
178
179
180
Kahn : quale passo di svolta l’autore prospetta e non fa.
G. Reale ( a cura di), Platone, IONE.
Su Platone e la Poesia cf, il recente
smantellamento di una ‘idola accademiae’.
,; ottimo punto per una ripartenza in vista di un definitivo
Ogni dialogo, come ogni gioco in una pluralità di giochi, ha una singolarità di storia,
una storia a sé, una sua autonomia come ho sopra illustrato. Quindi , se vogliamo
essere coerenti con questi presupposti dobbiamo pensare i collegamenti secondo la
logica del Morfologico e di Processi di Discorvizzazioni autoregolantisi, cioè secondo
la visione di messa a confronto e di comparazione di una pluralità di ‘tutti
determinati’; e,perciò, dobbiamo riferirci a ‘somiglianze di famiglia’, ad
isomorfismi,a parallelismi, ad analogie architettoniche ,strutturali e funzionali; e solo
su questa base anche a collegamenti di dati tematici.
Ne consegue che se non si mettono a fuoco le caratteristiche della Architettonica
platonica e della sua Strategia Generale, attualizzata ed intrinseca ad una ‘pluralità
di giochi giocati’, manchiamo di una bussola e di un criterio euristico per stabilire
con correttezza i collegamenti.
Ora se dico|architettonica| mi riferisco alla idea di un Disegno di Struttura intrinseca
ad un intero di parti di diversa forma e con distinta funzione che realizzano una
‘statica’ in equilibrio; e se parlo di |strategia| presuppongo che si parli di un Piano
che prevede un complesso di Azioni Convergenti per vie diverse a raggiungere uno
stesso obiettivo.
Naturalmente non c’è uno specifico dialogo in cui Platone dichiari e metta a
disposizione del suo lettore in maniera chiara e distinta le Regole Generali del suo
Gioco realizzantesi in una Pluralità di Giochi nel contesto della sua decisione di
partecipare con i suoi testi alla Vita Comunicante della Città intorno alle “Cose
Massime” e tra esse in particolare intorno alla Giustizia ed alla Felicità.
Chi come Leibniz - e ce lo ricorda Reale181- prospetta la necessità per la cultura
mondiale di mettersi alla ricerca del sistema nascosto nell’opera platonica e chi
come Goethe si augura che prima poi qualcuno riesca a scoprire un parametro
condiviso da tutti per stabilire con certezza quando Platone scherza e quando fa sul
serio, tutti costoro sono accomunati da questa estrema difficoltà di partenza.
E così costoro si trovano nella condizione di uno spettatore di una partita di calcio
che non sa nulla sulle regole del gioco che si sta svolgendo sotto i suoi occhi e che
non ha nessuno che lo aiuti a decifrarle, e che nello stesso tempo sa che sarà
chiamato alla fine della partita a spiegare quali siano i risultati del suo lavoro di
‘decodifica’ e come essi siano capaci di illustrare tutte e le effettive regole del gioco
al cui svolgimento ha assistito magari più volte.
Come spettatori dei logoi, giocati da Platone, siamo in tale condizione anche noi,
suoi lettori, chiamati e sfidati a saper operare per via induttiva, ripetutamente e con
aggiustamenti continui, affinchè il modello di lettura, , sia capace di essere
conforme all’oggetto sul quale viene puntato e calato e che,quindi, sia tale da
permettere a noi interpreti, che lo abbiamo allestito e lo usiamo, di rendere conto,
in maniera il più possibile coerente e completa, dello spettacolo di logoi in gioco, al
quale abbiamo deciso di assistere attivamente.
181
G. Reale
Questo vuoto e questa manchevolezza intorno alla messa in chiaro da parte
dell’autore Platone delle regole che presiedono la ideazione, la generazione, la
strutturazione e la finalizzazione del suoi giochi, vengono richiamati da Migliori
anche con la ripetizione di un argomento tipico della Scuola di Tubinga e di Milano :
Platone non ci avrebbe dato un dialogo in risposta alla domanda che pure pone ,
cioè quella di |Chi è ll filosofo ?|, e ci avrebbe fornito una spiegazione solo sulle
altre due : |chi è il sofista ?|, |chi è il politico ?|.
Questa risposta – secondo il nostro autore- bisognerebbe trovarla sì con Platone ,
ma fuori ed oltre la sua scrittura, nella Dottrina Orale dei Principi, nella “oralità
dialettica” ed in generale nel saper Fare Filosofia .
La mia opinione a questo proposito è : Platone non scrive un’ opera in risposta alla
domanda |chi è il filosofo ?|, perché ogni suoi dialogo costituisce questa risposta in
corrispondenza ad una varietà di punti di vista problematico-tematici.
Naturalmente per vederla dobbiamo saper procedere ad una ‘commutazione’
funzionale del modo di guardare , di leggere e di interpretare il testo,
riconoscendolo appunto innanzitutto come un Campo di Gioco – o meglio- Pluralità
di Campi dove accadono giochi rispondenti ad una stessa Architettonica ed ad una
stessa Strategia, tutte implicite, tutte implicitate nelle operazioni cognitivoimmaginative-linguistiche che costituiscono il ‘concreto’ e la singolarità originale
dell’opera.
Ed insisto ancora su un punto che ritengo decisivo per cogliere ciò che si iinceppa
nel meccanismo interpretativo del Migliori .
La peculiarità e l’importanza sintomatica del suo lavoro sta nel fatto che egli legge
sì, dando credito e validità alla logica del gioco serio, del Game, ma solo per un
tratto funzionale di attraversamento dei testi, perché poi egli si ferma , rimane in
mezzo al guado e, quindi torna indietro verso il tradizionale modo di leggerli-.
Migliori cioè dà luogo a ciò che ho chiamato | ottica mista|, che è caratteristica di
un approccio il quale mescola il riconoscimento per modo |DDP| con quello per
Modo Implicito della ripetizione cooperativa del |GG| .
E per di più in questa mescolanza finisce per far prevalere in ultima istanza il primo
modo, quello del modello dell’esplicito e dell’illustrato dottrinariamente.
Sintomo e prova di questo suo eclettismo è proprio appunto, nello stabilire
collegamenti tra isingoli dialoghi, l’associazione e la subordinazione della relazione
di corrispondenza per parallelismi a quella organica per ‘integrazione relativa di
manchevolezze’.
Prima di fornire ulteriori indicazioni su ciò che sono per me le proprietà e le
articolazioni essenziali dell’ Architettonica e della Strategia del Platone scritto e
prima di configurale mella immagine- metafora viva di “costellazione”, che in parte
desumo da Friedlander182 – il più fine scopritore di parallelismi e rimandi riflessivi tra
i dialoghi fuori, però, da una ottica a prevalenza dottrinaria e fuori dal riferimento al
182
Friedlander, cit. p.
Platone Orale - , intendo a questo punto dire la mia su i “15 argomenti proposti” da
Migliori183 per stabilire dei “nessi” tra il Filebo ed il Timeo. Essi autorizzerebbero
secondo il nostro autore a ritenere che Platone esiga dal suo lettore adatto che
questi li debba necessariamente leggere e pensare filosoficamente insieme , “tanto
più per la presenza di evidenti incastri”184.
Faccio valre questa riflessione come necessaria digressione, per poi tornare al
punto di partenza di questa parte del mio discorso, che ha preso avvio dall’esame
della questione della interpretazione da dare alla metafora della “seconda
navigazione” nel Fedone ed alla connessa questione del “postulato delle Idee”, che
troverebbe per Migliori la sua più fondamentale trattazione nel Parmenide.
183
184
M. Migliori, cit. pp.
M. Migliori, cit. p. 491.
6.3.2 Collegare i dialoghi : o per Parallelismi o per Incastri ?
Per quanto fin qui ho posto in rilievo del capitolo in questione dell’opera di Migliori,
dovrebbe essere chiaro perché l’aut ..aut che introduco nel titolo di questo
sottoparagrafo è coerente con la mia prospettiva e non con quella dell’autore, per il
quale è normale mettere insieme – e lo conferma il passo appena citato- i due modi
di istituire il legame tra un dialogo ed un altro.
Nel merito di quei quindici argomenti rilevo che :
1 Scrive Migliori :“Abbiamo due dialoghi sostanzialmente contemporanei” .
Osservo: la relazione cronologica di composizione.redazione in Platone secondo lo
schema | prima-contemporaneo-poi, se mai fosse decidibile con certezza assoluta,
non deciderebbe dei rapporti morfologici tra le opere; essi,infatti, seguono un’altra
logica e rispondono ad una originale idea platonica di ordine, complessità e di
sviluppo. E,pertanto, ammesso che un dialogo sia stato composto prima di un altro.
non solo e soprattutto per questa circostanza temporale esso costituirebbe uno
sviluppo di un dialogo che si pone come redatto prima.
Su questo – e credo di interpretare correttamente – è d ‘accordo anche Migliori, che
richiama l’utilità delle ricerche stilometriche solo quando il problema è quello di un
raggruppamento delle opere platoniche per gruppi e fasi. E, quindi, dovremmo con
Migliori considerare il Filebo ed il Timeo come appartenenti allo stesso gruppo. Ed
allora perché non dovremmo collegarli anche ad opere come, ad esempio, Il Sofista
il Teeteto, il Cratilo, il Simposio, il Fedone , il Gorgia, il Protagora, l’Ippia Maggiore,
l’Ippia minore ? Su perché dovremmo farlo già in un certo senso mi sono
pronunciato e riprenderò qui di seguito il mio punto di vista a questo proposito.
Provo a seguire Migliori lungo la sua strada di indicazioni-segnali.
2. I titoli : tutti i nomi dei titoli dei dialoghi, sia quelli che si riferiscono a nomi propri
di persona o a nomi comuni di persona ( Sofista, Politico) o nomi astratti di azioni
sociali umane (Simposio, Repubblica, Leggi) rispondono ad una logica Tipologica – o
meglio- Metatipologica che è il risultato di una trasposizione funzionale-analogica
della grammatica del drammaturgico attico. Lo stesso titolo |Apologia di Socrate|
non sfugge a questa matrice ed anzi né è intimamente impregnata.
Pertanto, dire come scrive Migliori che il Filebo ed il Timeo sono contemporanei
anche perché “hanno come titolo il riferimento ad una dramatis persona” non
costituisce un distintivo discriminante rispetto alle altre opere che sopra ho
richiamato.
3. Finisce con un troncamento sconcertante anche il Simposio, il Teeteto, il Sofista e
che dire dell’ Eutifrone o del troncamento narrativo del Fedone ? Il
troncamento,dunque, - che Migliori considera come segno distintivo comune alla
due opere- non è caratteristica solo del Filebo e del Timeo.
4. Ancor prima di domandarci con il nostro autore che cosa sia la esasperazione
enciclopedica propria di questi due dialoghi, dovremmo mettere in chiaro che cosa
sia, funzionalmente-costruttivamente, cognitivamente e linguisticamente,la
prospettiva per “enciclopedia” “che caratterizza tutte le opere platoniche”.
E’ di tipo disciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare ? Nulla di tutto ciò, come
più avanti ancor meglio proverò.
5. La qualificazione precisa di quella ricchezza e complessità dello sguardo platonico,
che noi accostiamo alla moderna nozione di sapere enciclopedico, è importante
anche per stabilire di che parliamo quando ci riferiamo alla metafisica, alla
antropologia. alla cosmologia, in sede di comparazione dei due dialoghi in
questione.
Infatti, qui il Platone metafisico, antropologo e cosmologo, non agisce direttamente
ed in prima istanza nella figura di esperto epistemico-tecnico che si muoverebbe in
un ambito disciplinare. Questo Patone Operativol’ si muove,invece, costantemente
in un piano di esame metalogico e metadisciplinare, che con questa fua qualità
funzionale omogeneizza il suo sguardo complesso, pluridirezionale e
pluriprospettico verso il territorio delle diverse manifestazione della cultura
epistemico-tecnica; e tutto ciò accade in Platone per uno scopo metodico ed una
destinazione finale che sta Sopra-Oltre lo spazio della pluralità dei vari saper fare
tecnici.
6. Conseguentemente se nel Filebo riscontriamo molta ‘antropologia’ nella
dimensione etica e l’assenza –vuoto di metafisica .cosmologia , che vediamo,invece,
prevalente nel Timeo, dove l’elemento antropologico si fa cogliere nella sua
dimensione politica-, per tutto ciò non siamo autorizzati a porre la necessità di un
“incastro” come,invece, crede Migliori. E per spiegarmi chiamo in soccorso di nuovo
la analogia con il gioco del calcio.
Se in un partita l’allenatore della squadra ha deciso di giocare prevalentemente in
difesa e riducendo al minimo il ricorso all’utilizzo di schemi di attacco, e se
,pertanto, non vediamo nel corso dello svolgimento del gioco alcuni suoi temi, noi
certamente non concludiamo che si è determinato in esso un vuoto che
bisognerebbe colmare con l’incastro di ‘azioni e temi di attacco’ di un’altra e diversa
partita.
Fuori analogia : se Platone opera variazioni nel grado di utilizzo di contenuti del suo
‘sapere enciclopedico’ ciò accade perché il contesto e l’obiettivo del gioco che
mette nel campo della sua scrittura non hanno bisogno della svolgimento di
ulteriori temi per la buona e felice riuscita di esso.
Quando, perciò, Migliori scrive | “I due dialoghi costituiscono un gioco a perfetto
incastro”|185, egli non tiene conto e va contro un dato testuale macroscopico : il
gioco platonico si dà in una Pluralità di Opere-Giochi. Non è ammesso dire,pertanto,
che i due ‘giochi’ dei due dialoghi costituiscono” un gioco”.
185
M. Migliori, cit. p. 490.
Il rispetto di questa proprietà essenziale del ‘corpus scriptum’ platonico non
significa,però, d’altra parte che vi sarebbe un implicito divieto ad una lettura
trasversale di questi ‘gioco al plurale’, ma solo che il passaggio dall’uno all’altro deve
essere operato da un lettore che nel saper cogliere i rimandi riflessivi morfologici e
dinamici, tematic,i dall’uno all’altro, non si deve poi far condizionare e fuorviare da
un’ottica di tipo dottrinario. A questa ,infatti, è anche essenziale una certa visione
dello svolgimento e del progresso cognitivi ; per essa lo sviluppo dei pensieri accade
per progressiva accumulazione, da uno stadio di incompletezza ad un altro in sé più
compiuto o che rende anche il primo più compiuto, appunto attraverso un reciproco
incastro organico.
Che sia possibile una lettura trasversale dei dialoghi senza dover ricorrere alla ‘logica
degli incastri necessari ’che implica l’effettività di un vuoto-omissione relativi . l’ha
dimostrato ampiamente,ad esempio, quel Friedlander che ho già ricordato.
Anche se poi questo grande interprete non ci ha aiutato a penetrare, anche nella
permanenza di uno sguardo trasversale, nel fondo del Platone Teorico, che non è
riducibile all’immagine tradizionale ed accademica del Platone autore di una
dottrina delle Idee; e così Friedlander ha lasciato cadere e lasciata non valorizzata
quella sua bella intuizione sull’ “elemento teatro”, sull’ ‘elemento epiditticospettacolare’ come caratteristiche della comunicazione socio-culturale del tempo di
Platone.
Ma questa strada non ha imboccato neppure il suo giovane discepolo Gadamer,
che si è fissato ad identificare la forma dialogo della scrittura platonica come. in via
principale. forma imitativa del colloquio filosofico viva, mentre essa guarda
direttamente e ‘metaforicamente’ – mi ripeto- alle proprietà della comunicazione
pubblica teatralizzata e teatralizzante.
Migliori,poi, a proposito del suo modo di leggere ‘per incastri’, che troverebbero
giustificazione nel dato testuale , il quale proverebbe una incompletezza di pensieri,
scrive : “L’incastro procede anche sul piano del metodo: il Filebo è generalizzante e
procede essenzialmente in modo riduttivo; il Timeo è elementarizzante e procede
essenzialmente in modo deduttivo “ 186
In generale ancora osservo : in Platone queste due modi costruttivi-dinamici, che
danno luogo al circolo deduzione-induzione, avvengono per bisogni e scopi di una
attività metalogica ,metaimmaginativa, metalinguistica, ben temperata e finalizzata
allo smascheramento delle ‘strabilianti giravolte’ del modo di produzione sofisticomenzognero dei discorsi pubblici. Essi sono esercizi-applicazioni che direttamente
mirano alla formazione di metaparadigmi da usare come criteria operandi in quella
attività di falsificazione ben mirata.
Perciò, dovremmo sempre precisare che nel Platone scritto le operazioni deduttiveinduttive hanno una natura speciale proprio perché stanno in uno speciale contesto
funzionale, che non è quello della disciplina logica, intesa in senso stretto e tecnico.
186
M Migliori, Ib.
In particolare rimando ,per quanto riguarda la presunta necessità dell’incastro, a
quanto ho sopra già rilevato; e,perciò, anche in questo caso il bisogno di questo
incastro è in Migliori indotto da una indebita o non adattata prospettiva di
riconoscimento di ciò che Platone teoricamente fa con la sua scrittura.
7. E’ difficile,infine , negare la presenza di uno importante sfondo pitagorico anche
nel Fedone, nel Teeteto : dobbiamo allora ‘incastrarli’ con il Filebo ed il Timeo ? A
questo domanda rispondo così : non dobbiamo ‘incastrarli’, ma dobbiamo guardarli
sì, in quanto entrambi riproducono uno stesso impianto e strategia teorici, variati in
corrispondenza di una varietà di Pretese Illegittime accomunate dallo stesso tipo di
Errore.
Fedone, Teeteto, Filebo e Timeo sono tutti Tipi portatori di una determinata Typologhia Ricorrente nella vita comunicante della città intorno alle “Cose Massime”.
Il Fedone che pitagoricamene Crede nella potenza teorica e purificante della
dottrina dei contrari e dell’armonia; il Teeteto che per un tratto della sua vita,
influenzato dal suo maestro Teodoro, si è fatto plagiare, pur essendo un ideale
discepolo di Pitagor e grande matematico, da un Abuso spettacolare, eristicosofisitico, cioè quello della immagine protagorea dell’ “Uomo Misura” dell’ Essere e
del Non Essere; il Filebo che Crede che la ‘dialettica etica’sia in grado di spiegare
l’essere ed il non essere del piacere lungo l’asse dell’ uno-molti e di ‘catturare’misurare così anche il tutto del ‘falso piacere”; il Timeo che Crede nella virtù
‘taumaturgiche ‘ della scienza geometrico-cosmologica e che Crede di poter spiegare
causalmente il Disordine del Male come Anti-Bene attraverso l’idea del Caos e del
Demiurgo; ebbene tutti questi intellettuali-Tipo- ai quali si potrebbero aggiungere
anche altri- sono accomunati dalla Pretesa che l’ideale culturale e scientifico, di cui
in diversi aspetti sono eccellenti cultori ed entusiastici promotori, sia di per sé
sufficiente e capace di fronteggiare e di misurarsi con quella Phainomeno-logia di
quello Pseudos emblematizzato dallo spot dell’impudente Callicle del Gorgia e nel
primo libro di Repubblica posto ‘brutalmente’ davanti agli occhi dei convenuti da
Trasimaco .
La visione del giusto implicito in questo ‘Annuncio-Programma’ non coincide affatto
con quel non giusto di fatto che è l’utile soltanto di pochi o comunque di una
minoranza rispetto a quel giusto che è l’utile di tutto il popolo.
Stiamo con Callicle e Trasimaco oltre una logica di opposti, di cui comunque si cerca
in qualche modo e progressivamente una unità , sia pure nella diversità degli ‘utili’ e
nella loro costante e benefica tensione.
Quello loro spot dice terribilmente e ‘fascinosamente’ del’altro : esso vuole elevare
la volontà e le pratiche di dominio e di ‘accumulazione degli utili’ dei più
socialmente e militarmente forti a legge universale e necessaria della vita in Città.
Questo è il nocciolo di quella ‘nuova sapienza alla moda’ contro cui il Socrate di
Platone prende posizione in maniera tanto sublime quanto per lo più ellittica nella
Apologia.
E contro le parascientifiche pretese orrende ed attraenti di questa presunta
modernità culturale i portatori delle Technai e la coscienza tecnica – figurati da
Platone in diversi Casi , Tipi e Tipologie- si trovano disarmati ed impotentì e,
dunque, costretti anche a subirla, fino ad essere oggettivamente essi stessi
corresponsabili del suo propagare in tutte le pieghe della sensibilità e mentalità
privata e collettiva.
Il Grande Innominato , soprattutto in questi dialoghi, è proprio, dunque, quell ‘
Opposto- Non Essere, quella Non-Conoscenza, quel Non –Piacere, quel Non-Kosmos,
che è un ‘Anti’, cioè una cattiva energia che punta ad annientare, a nullificare, a
distruggere radicalmente la possibilità stessa (i) di un gioco logico-fisiologicocosmico dei contrari,(ii) della dinamica data dalla verità come armonia-omologhia da
una parte ed opinione unilateralizzata dall’altra; (iii) di una attività di temperanzamediazione-equlibrio tra gli estremi di una esperienza di piacere; (iv) di azionereazione tra Kaos-Kosmos.
La coscienza ‘scientifica’ – che splende nella fioritura di tanti e vari saper fare
tecnici-epistemici- si ritrova spiazzata di fronte a questo mare ed ondate di logoi
spettacolari, convergenti nel fornire una giustificazione paraculturale a quel falso
ideale di vita in città, della Città. dell’ EssereCittà/Politeia187.
E lo spiazzamento è dovuto alla Stranezza di questi Logoi Speciali, che lusingano ed
illudono/kolakeia188, colpiscono con efficacia e poi fuggono e si nascondono nella
loro ‘tana’, sono diffusi e ‘sottili’ e non facilmente prendibili, travolgenti ed ambigui,
apparentemente argomentati ed insieme fantasmagorici; si offrono come cibi
mentali gustosi e nutrienti, mentre in realtà intossicano e fanno star male l’anima ed
il corpo : il prologo del Fedro docet !
Di fronte a queste correnti e flussi suadenti e tempestosi di comunicAzione pubblica
distorta solo la filosofia, il filosofare può competere ; perché solo il filosofare può
accettare la sfida di catturare attraverso il pensiero l’anti-pensiero, attraverso la
immaginazione logica la anti-immaginazione , attraverso il suo linguaggio
l’Antillinguaggio. Ed il Sofisma-Menzogna, quel Sofisma, quella Menzogna –
solennizzati da Callicle- per loro natura stanno Dopo ed Oltre il territorio delle
Scienze-Tecniche ; e stanno Attorno ad esse, abbarbicate come mala pianta e come
parassiti che fingono di essere tutt’uno con ciò con cui si mimetizzano, spacciando
come vere immagini dei principi e dei risultati delle scienze-tecniche ciò che la
filosofia denuncia,invece, come volute false immagini, come simulacri di essi.
Lo scenario nascosto nel Timeo e nel Filebo si regge,dunque, su questo Parallelismo
di impostazione funzionale-strutturale, su cui getta una luce fulminea il Sofista con
Traduco così il termime |Polieia| come sostantivizzazione di Politeuein”= vivere da cittadini in
uno spirito fede costituzionali madre di buone leggi, eunomia.
188
Impiego il termine graco |Kolakeia| in questa sua pregnaza strategica .
187
il suo strano epilogo, più volte da me richiamato nella sua qualità di indicazione
essenziale e strategica per la messa a punto platonica dello statuto dello Pseudos
come ciò che utilizza anti-immagini paradiscorsive degli ordini del razionale e del
reale.189
Ed esso, insieme agli altri dialoghi sopra menzionati, introduce al problema
fondamentale che occupa la lunga riflessione di Migliori e che va oggettivamente
ben oltre i suoi interessi di autorevole storico della filosofia antica e platonica : la
questione appunto di quel Non-Essere, Non-Bello, Non-Vero, Non-Piacere, NonBene, Non-Ordine che nessuna dialettica dell’uni-molti da sola e da sola se stessa
può mai pensare,immaginare e dire: l’agire distruttivo/kakurghein190 della
Pleonessia191, del ‘Terribile ed Attraente’ Piacere dell’uomo di Uccidere, di
Annientare l’altro, alimentata dalla voglia sfrenata di dominare/libido dominandi192,
di asservire,strumentalizzare, sfruttare,mercificare.
La modernità filosofica, il Novecento filosofico,- a partire soprattutto da Hegel e poi
soprattutto in Italia con Gentile e Croce - si è misurato con questa esperienza e con
la domanda tragica che la sorregge; ha creduto di risolvere questo gigantesco
problema ed,invece, ha clamorosamente fallito ,naufragando nelle deriva del postumanismo, finendo per mettere in discussione la utilità e la validità stessa della
filosofia come sapere.
E si perde di nuovo di vista la incommensurabile grandezza della intelligenza
filosofica di Platone, se si crede di risucchiarlo e di inquadrarlo secondo il paradigma
hegeliano, che prevede l’assorbimento della energie distruttive come male
necessario, presunta ‘via crucis,193’ del progresso della umanità.
L’Anti-Bene in Platone ,pertanto, non è quell’estremo negativo , che in più fasi ed a
più livelli sarebbe metabolizzato dal positivo o anche tenuto in viva tensione –mai
definitivamente conciliata ed in riposo.
Con questo accenno alla mia interpretazione del Sofista mi differenzio sia da Migliori che da
Movia e faccio valere alla luce del principio del gioco i ‘giochi’ platonici di montaggio dei blocchi di
sequenze; essi prevodono anche la mostrazione-esibizione del loro contrasto che mostra da sé
l’intezione teorica ed il senso finale del messaggio trasmesso al lettore-spettatore, che qui viene
fatto assistere a come la Grande Logica che si misura con il Non Esssre come Molteplice-Diverso,
non può per sua natura mappare l’Anti-Essere dello Pseudos.
Questo Pseudos non va confuso con l’Errore, che stimola la fecondazione della verità e ka
maturazione dell’apprendimento; e che, quindi in quanto tale, sta in costante e progressiva
tenzione ‘organica’ con la Verità, appartiene al suo “totum” come ricorda anche M. Cacciari (2014)
189
Per questo termine cf. Eutiforne.
Per questo termine e noszione cf. anche M. Vegetti.
192
Agostino, Città di Dio.
193
Per la ripresa – gravemente da lui distorta- di questa idea cf. Hegel, Fenomenologia dello
Spirito.
190
191
Perciò in Platone, nel suo MegaParadigma Uno-Molti. non c’è una originaria aporia
come crede Migliori; l’Anti-Bene non è l’estremo grado inferiore del movimento
verso il massimo dei molti o – se si vuole, verso il massimo molto dei molti.
Il Disordine inteso come Anti-Bene è fuori dalla dialettica Ordine-Disordine; esso
appunto è la distruzione di questa stessa dialettica. E questo è inammissibile per
Hegel ed è imputabile a Platone come fondamentale aporia solo se leggiamo questo
Platone con una cartina di tornasole oggettivamente – al di là della stessa espressa
intenzione di Migliori- di ispirazione e matrice hegeliana.
Conseguentemente trasformare un fatto culturale- come l’interpretazione neoplatonica del primato dell’Uno-, come una risposta e superamento di un problema
che sarebbe costitutivo ed interno alla dialettica platonica dell’uno –molti , è ancora
una volta trasformare un ‘dopo fattuale’ in un ‘pertanto, in una necessaria
conseguente alternativa logica’ : Platone – in verità- si regge bene sulle sue sole
gambe e non ha messo un suo piede in fallo; siamo noi post-platonici e sono gli
interpreti soprattutto accademici a non voler pensare ed accettare con Platone la
presenza e l’agire di un male e di una menzogna radicali dentro la condizione e la
esperienze umane, e tali da non poter essere metabolizzabili dentro una ‘logica’ del
bene e della verità.
Ciò che ha scritto l’ Aristotele del cosiddetto primato della immanetizzazione della
relazione uno-molti’ non è contro Platone e né costituisce un suo superamento su
quel punto strategico; anche perché molte di queste cose sono opera di un
Aristotele che ha meditato a lungo ed assimilato le lezioni ed i colloqui del Platone
Orale, del Platone Scienziato.
Per esempio, se Aristotele non riprende l’idea di Demiurgo è perché già sa che il suo
maestro ha introdotto questo divino Artigiano dentro il contesto di una
ricostruzione e rifacimento di un paradigma ontologico,ontogonico, cosmologico che
sta a servizio direttamente non di una dottrina scientifica, ma di un confronto tra il
Socrate di Platone e la condizione di un intellettuale-tipo-personaggio. Tale è
appunto Timeo appunto, in quanto non si è reso conto che la gara tra tecnici per
meglio intendere le ‘leggi’ dello spazio cosmico rischia di far dimenticare e perdere
di vista quanto accade nelle città della Terra, dove voglie di guerra e di inganni
sistematici smentiscono la pretesa di quell’approccio alla cultura di essere misura
del tutto. Ed è come se Platone dicesse : ‘ adesso a voi scienziati del kosmoi-logoi do
una mano a perfezionare il vostro modello ed a questo scopo per renderlo coerente
e completo vi suggerisco l’idea di una causa efficiente che denomino|Demiurgo|;
perfezionato in tal modo il modello e condividendo il vostro punto di vista, ora
faccio toccare con mano al mio lettore come questo modello non è in grado di
catturare lo Pseudos.’.
DI questa mancanza di un posto ontologico per lo Pseudos nel Timeo- si accorge –
come ho ricordato sopra- con sorpresa Gadamer nel suo studio su questa opera; ma
stranamente egli sottovaluta su questo punto cruciale Platone e ritiene che questi
non abbia maturato teoreticamente il problema che la rappresentazione dialogica si
trascina con sé fino alla sua conclusione; e crede che sia stato Heidegger per primo a
porre consapevolmente la domanda, madre di tutte le domande : se l’Essere, se la
Vita e se la Verità, ‘unde pseudos’ di un Anti-Essere e di un’Anti-Verità , di un ‘AntiVita?
Ed è incredibile –anche se è spiegablle sulla base dei pregiudizio gadameriano sul
primato della comprensione dialogico-fenomenoligca centrata sulla forza motrice
del domandare e della intesa sulla cosa – che l’allievo di Friedlander e di Heidegger
non si sia reso conto che se c’è una costante nella ricerca platonica essa consiste
nella permanenza di un polemos contro la Pseudè Doxa , che in Platone non è una
generica falsa opinione, ma il prodotto tipico del modo sofistico-menzognero di
parlare intorno ai valori.
Mi sono di nuovo soffermato su questa interpretazione di Gadamer, perché essa mi
introduce in questo problema : come testualmente posso trovare nel Timeo un
punto di appoggio su cui basare il rilievo di questa assenza, che diventa per il lettore
un fondamentale punto di vista a partire dal quale deve leggere quel testo , dove a
guardare nell’ottica dell’esplicito e dichiarato non ‘ si vede mai’ il riferimento allo
Pseudos, come antagonista innominato fuori scena , ma non fuori la comunicazione
spettacolare tra l’autore ed il suo pubblico adatto ? Nel Timeo, infatti, c’è molto di
più e di diverso di una incompletezza-manchevolezza; c’è appunto un assordante e
provocatorio silenzio sul ruolo ontologico dello Pseudos come si è detto.
Per trovare il punto di appoggio testuale che ci catapulta ,sull’asse del rapporto
autore-lettore adatto, lì dove il messaggio centrale e finale di quest’opera si svela,
dobbiamo capire che in Platone il nome/maschera , il nome di ogni personaggio che
appare sulla scena della sua scrittura, ha una portata Tipologico-Paradigmatica, Esso
è indicatore ed riassume una storia caratteristica : ciò che egli disse, fece e patì. E di
questa storia inscritta nel nome/maschera deve tener conto il lettore quando legge
ciò che Platone fa dire e fa fare sulla scena al personaggio. I significati da riconoscere
sono appunto il risultato di questa interazione dell’implicito di cui è portatore il
nome/maschera e l’esplicito delle sue ‘azioni’ e ‘detti’ nel corso dello svolgimento
della rappresentazione.
Nel caso del Timeo la Figurazione del Socrate Rammemorante un discorso
precedente sullo Stato e la Figura del Socrate che Ascolta per lungo tratto
istituiscono una Differenza rispetto alla lunga estensione del discorso
apparentemente principale, che ha tanto interessato storicamente anche fisici,
fisiologi e medici.
Questa differenza che visibilmente sembra stare a margine e indicarci un Socrate ‘in
lunga pausa’ è il principio di quel contrasto di montaggio, cioè costruttivo-operativo
interno all’opera; esso va pensato dal lettore : che cosa ha da dire il puro
‘cosmologo’ sulla vita e morte di Socrate ? Nulla, perché nella unilateralizzazione di
questo punto di vista la domanda non sorge proprio. Eppure è un fatto che Socrate ,
il cittadino più giusto, è stato ingiustamente messo a morte, sulla base di Accuse
fatte di logoi menzogneri, di Pseudos. Ma tutto ciò non può essere evidenziato dal
Socrate in scena, lo dice per lui al lettore il suo autore.
Dunque, lo Pseudos non ha un posto ed un ruolo ontologico nell’opera non perché
Platone l’avrebbe escluso, ma perché il Platone che ha indossato la maschera del
cosmologo ha fatto proprio questa prospettiva assolutizzata fino alla sua estrema
conseguenza : l’oblio dello Pseudos appunto.
Qui c’è ,dunque, un movimento di semantizzazione e logizzazione che richiama
implicitamente e sotto un certo aspetto il procedimento di ‘reductio ad absurdum’, il
cui uso è costante in Platone e che è presente in maniera estremamente ellittica
anche nel Filebo e nel Timeo.
Concludo. Ho fatto valere il canone ermeneutico del parallelismo applicandolo
anche e- direi soprattutto- alla logica costruttivo-operativa platonica; e ritengo
incompatibile con esso il ricorso alla incastro organico tra i dialoghi, sul presupposto
che ciascuno di essi sarebbe manchevole in qualcosa di importante e che sarebbe
integrabile da quanto si darebbe in un altro dialogo.
E penso,invece, che se il modo dell’incastro deve essere utilizzato esso va applicato
a due distinti fasi del modo di leggere ; tali sono quella del piano dei rapporti tra i
personaggi sulla scena della scrittura e l’altra che investe il rapporto tra l’autore ed il
suo lettore adatto.
.
6.5 “Il postulato delle Idee” nel Fedone ed il significato di |postulato| nella
logica geometrico-matematica greca.
M. Migliori nella “Appendice Terza”, nel riferirsi alla esigenza di un interpretazione (
il più possibile) oggettiva”,194 cita, per condividerlo, un canone ermeneutico di E.
Berti; lo riporto anch’io a giustifica dello spirito e della intenzione che guidano
quanto mi accingo ad illustrare in questo ulteriore sottoparagrafo.
Premetto solo e ribadisco che la posizione di Brandt sul come leggere un testo
filosofico dovrebbe essere preceduta da un recupero in aspetti importanti della
teoria generale della interpretazione di Betti ed di quanto U. Eco ha elaborato in
relazione alla idea di Cooperazione del Lettore/Modello in sede di esame delle
possibilità ed i limiti di una attività interpretativa:
“… Non mi sembra corretto leggere gli antichi a partire da una problematica
attuale, applicando al loro pensiero degli schemi concettuali a noi contemporanei
e distruggendone l’unità , allo scopo di utilizzare dei frammenti all’interno di una
prospettiva ad essi estranea….”; e,quindi Berti raccomanda di “ partire dalla
prospettiva propria del filosofo studiato, cercando di cogliere l’unità del suo
pensiero ed, eventualmente, individuando che cosa sia legato alla cultura del suo
tempo, e che cosa è ,invece, originale, ma sempre tenendo presente il senso di
ciascuna sua parte , cioè la sua funzione nella economia generale di una
determinata filosofia. Per fare questo è necessaria anzitutto una lettura di tipo
storico, cioè capace di collocare un filosofo nel suo tempo, liberandolo dalle
interpretazioni che ne sono state date in epoche successive e restituendo al suo
pensiero il suo significato originaro.”195
Dunque, come interpreti che puntano alla massima oggettività possibile, dobbiamo
sapere contestualizzare e valorizzare ambiti importanti dello ‘spazio letterario’ della
Grecia Antica. Ad esso appartiene in grado eminente aanche l’opera di Euclide.
Se non entriamo almeno nel nucleo essenziale del suo ‘spirito’, rischiamo di usare
parole come |postulato| senza afferrarne la specificità e la differenza logico- storica
culturale rispetto alla nozione corrente di essa negli usi odierni.
In generale ed in prima approssimazione bisogna mettere in discussione la nozione
di postulato come posizione assoluta di un enunciato assoluto, sia che esso lo si
194
195
M. Migliori, cit. pp. 1220-1250)
M. Migiori, p. 1229.
assuma come generale ipotesi di partenza sia che lo si consideri come una verità
fondamentale evidente.
In Euclide il termine è |Aithemata|196, che Acerbi traduce |Richieste|.
Queste ‘Richeste’ da ‘dove’ e da ‘chi’ provengono e perché sono necessarie e per
‘chi’ e per quale scopo sono tali ?
Nel rispondere a queste domande che investono la caratteristica di ‘assoluto’-non
derivabile che di solito si associa al concetto di postulato, . mi limito solo ad accenni,
perché il discorso meriterebbe un ben più ampio sviluppo, di cui peraltro sarei
capace in misura molto limitata , poiché non sono né un matematico di professione,
né un esperto di storia della matematica antica e greca.
Faccio questa osservazione in sede prima lettura del testo euclideo, rilevando
l’impressione di una ‘partenza in quarta’, di ‘enunciati sparati’ che colpiscono il
lettore trascinandolo in medias res, obbligandolo subito a gettarsi in acqua, a farsi
prendere dal gioco ed a seguirne le mosse.
Non c’è un autore- regista che in via preliminare e dichiarata ci dia le istruzioni per
meglio orientarci nella strategia generale che presiede lo svolgimento e
l’articolazione degli enunciati e ci spieghi anche l’ordine in cui vengono esposti. E ci
imbattiamo subito nella prima difficoltà : perchè il primo passo non è costituito dalla
enumerazione-successione delle cinque “Richieste”, ma dalla definizione di punto ?
L’enunciato di avvio |Punto è ciò di cui non <è> alcuna parte|197 non è forse a suo
modo un ‘postulato’, ma perché deve precedere ed in quale relazione sta con i
successivi che costituenti le “Richieste” ? Il lettore deve constatare solo il procedere
per ‘blocchi’ : “Termini”/Oroi- Aithemata/Richieste- Nozioni Comuni/Koinai
Ennoniai. Nono sono quest’ultime regole degli Eguali /Tà isa198 a loro volta dei
‘postulati’ ?
L’unica cosa evidente ad un lettore attento è il ‘vedere’ subito che il primo teorema
|Costruire sulla retta delimitata data un triangolo equilatero|199 implica
necessariamente la posizione di quei ‘blocchi di enunciati’.
Ma se questo stesso lettore tenta di cogliere la loro regola generatrice ed
intrinsecamente ordinatrice, allora ciò che sicuramente riesce a percepire è che che
c’è una vasto non-detto che sta dietro l’impostazione del gioco.
Mi domando : come è possibile fare un ipotesi ragionevole e verisimile sulla natura e
caratteristiche di questo ‘mondo nascosto’, ‘sottomarino’’, implicito, utilizzando le
stesse tracce del detto, dell’esplicito, del dichiarato ?
Esiste una ‘ratio essendi et cognoscendi di fondazione di tutto questo campo
strutturato in una generale connotazione dell’essere richiesto ?
196
197
198
199
Euclide. Elementi
Euclice, cit.
Euclide, cit.
Euclide, cit.
Come, quindi, questo abbozzo di indagine sul concetto geometrico di postulato ci
aiuta a capire meglio il Platone matematico, amico di Teodoro e di Teeteto, e quello
metamatematico della sua opera scritta , atteso che lo spirito geometrico euclideo è
certamente anche ‘spirito’ platonico ?
Di solito si cerca di aggirare questo problema dicendo che il complesso |Termini.
Richieste-Conoscenze Comuni| sono ‘verità puramente intuitive’ di ‘dati primitivi
evidenti in sé e per sé’’, che in quanto tali devono essere accettati e basta, e non
sono dimostrabili. Sembrerebbe così impossibile ricondurli ad un originario principio
capace di farne vedere l’effettiva origine ed la loro endogena, intrinseca ed
articolata qualità sistemica.
Ora la mia ipotesi su questa pregnante proprietà ellittica della sistemazione euclidea
è la seguente : l’intero apparato concettuale ,che possiamo chiamare ‘introduttivo’
e che è costituito da quei blocchi di enunciati, presuppone questo scenario ‘nascosto
‘ ed ‘hypo-tetico’, ciò che sta sotto nel senso che è implicito:
a) Il punto come ‘punto mobile’ che impatta uno spazio indeterminato e che via
via acquista un ordine come un pluralità di Figure-Forme generate secondo la
legge del gioco e venendo a formare un pluralità di giochi costruttivi-mirati
alla soluzione di un problema/incognita interno a ciascuno di essi
b) Il punto mobile che impatta dà luogo a tre configurazioni fondamentali,
distinte e reciprocamente correlate, di questo spazio . Queste ‘azioni del
punto sono l’angolazione, la circolarizzazione, la triangolazione per angolo
retto.
c) Il percorso del punto è assunto dentro il paradigma dell’Equazione, che
prevede l’articolazione di una relazione di identico-diverso in direzione della
conoscenza di un ignoto correlato ; e ciò a partire da quel noto che è dato
dall’ ‘apparato introduttivo’ e dal suo rinvio a quelle tre matrici originarie
fatte agire in se stesse e/o in combinazione reciproca.
d) Teorema è il percorso costruttivo di una Invarianza in un attività di variazione
determinata della combinazione di ciascuna delle tre matrici con le altre.
Il Teorema è un gioco felicemente riuscito, con valenza universale e
necessaria, dentro quei presupposti dichiarati (Termini-Richieste- Conoscenze
Comuni) ed impliciti ( il punto mobile e le tre matrici fondamentali regolanti il
suo ‘moto’/kinesis nello spazio indeterminato.
e) Lo spazio ‘energizzato’ ed ordinato dal moto di un punto regolato viene a
configurarsi con un pluralità di giochi costruttivi distribuiti in diverse areeterritori problematici.
f) Il quinto postulato – che da tante discussioni è stato successivamente
caratterizzato(è un teorema dimostrato o dove sta la sua necessità di
postulato distinto dagli altri ?)- deve essere inteso dentro il generale contesto
delimitato dal paradigma di spazio euclideo che sto delineando. A questo
proposito segnalo il fatto che la versione scolastica del quinto postulato (
‘data una retta e un punto fuori di essa, per questo punto passa una ed una
sola retta parallela a quella data’) è già un interpretazione che si allontana dal
contesto proprio euclideo ed che ha in questa sua differenza dalla
enuniciazione testuale la causa dei problemi indotti che porteranno alla
invenzione di una geomatria non-euclidea.
Nel primo teorema 200questo modello inventivo-costruttivo è agevolmente visibile:
- Si parte da una retta data determinata, cioè dal risultato di un moto del punto
tra due estremi fissati e fissabili in virtù della prima delle “Richieste”;
- Si pone l’incognita : un triangolo equilatero da costruire sulla base di questa
retta data determinata e quindi si chiede la costruzione di angolazioni
secondo lo schema-figura –concetto |Triangolo Equilatero|; il che presuppone
appunto il ricorso alle matrici funzionali |Angolazione| e |Triangolazione|;
- Il punto mobile a partire da un estremo e nel limite dell’altro estremo si
muove secondo la regola della matrice|Circolarizzazione| , una volta facendo
centro su un estremo ed un’altra volta sull’altro; applicazione della terza delle
“Richieste”:
- Si ha,dunque, un combinazione funzionale-sistemica tra rettilineazzazione,
che è riconducibile ad una operazione di definizione/limitazione dello spazio
ed in questo senso in una funzione generale di angolazione;, ed una attività di
circolarizzazione;
- Questa combinazione genera un punto- intersezione tra due circonferenze
che inglobano in sé la retta determinata di partenza in una operazione di
omogeneizzazione di diversi, cioè di prodotti di due differenti matrici che
interagiscono reciprocamente;
- Da questo fase/momento del punto, che si dà in una attività di intersezione, lo
stesso punto si muove in direzione dei punti-estremi della retta
data/inglobata; (secondo la regola della Prima Richiesta), generando un
triangolo; dunque, assistiamo alla combinazione determinata ed orientata
ancora delle due matrici (Angolazione-Trangolazione);
- queste operazioni costruttive-compositive /synestesasthai di trasformazione
di figure schematizzate devono essere verificate e validate come quelle
effettivamente adatte per raggiungere l’ignoto/incognita; dobbiamo cioè
Equalizzare questa figura prodotta, cioè provare e dimostare che essa è
conforme nella sua determinatezza alla idea-modello/paradigma |Tirangolo
Equilatero| e, perciò, dobbiamo dimostrare che i due lati trovati, e all’inizio
non noti, siano effettivamente uguali alla retta determinata data e siano
uguali tra loro;
- Bisogna allora far ricorso di nuovo alla matrice/Circolarizzazione e
precisamente a quella sua proprietà per la quale i raggi all’interno di una
200
Euclide, cit. pp.
circonferenza data sono tutti uguali tra loro; e, quindi, dobbiamo riconoscere/ e ri-nominare i lati del triangolo formato come raggi distinti di due
intersecantesi circonferenze; e che uno di questi raggi- quello che coincide
con la retta data di partenza è comune alle due circonferenze ( ancora una
volta
combinazione
di
tre
matrici
Angolazione-TriangolazioneCircolarizzazione);
- In forza di questa sola regola dell’ Eguaglianza dei raggi non possiamo ancora
concludere che i tre lati ‘sono reciprocamente uguali; infatti, uno di questi lati
è immediatamente‘visibile’ come corda e non come raggio ; non sappiamo
ancora se ciò che appare come corda ha la stessa lunghezza di quei distinti
raggi; e neppure il solo gioco della combinazione delle tre matrici ci aiuta a
decidere di questo momento essenziale del problema ;
- Di qui la necessità di fare entrare in campo la prima delle “Conoscenze
Comuni”: “Gli uguali allo stesso sono anche uguali tra loro “. Applicandola al
caso, vediamo che i due lati –costruiti sono entrambi uguali – sia pure da due
distinti punti di vista geometrica – alla retta data di partenza; e,perciò, sono
anche uguali tra loro.
Non si tratta di una regola di pura logica, cioè astratta dal gioco costruttivo
geometrico; infatti tra le conoscenze comuni una
recita : “Ed i
sovrapponentisi/epharmozonta tra loro sono uguali tra loro”; dunque, la
regola della sovrapposizione è ancora operazione geometrico-costruttiva.
Mi sembra che da questa mia veloce e breve ricostruzione del primo teorema sia
possibile fissare alcuni punti importanti per il discorso sul concetto greco e
platonico-euclideo di postulato , di dimostrazione e di prova, di Idea-forma; e forse
abbiamo anche qualche utile indicazione di quella idea di “generazione dei numeri”
che Aristotele attribuisce a Platone :
A) Postulato-dimostrazione-prova stanno in una logica operativa-costruttiva,
dove l’ universale-necessario vive nell’ effettuarsi di una pluralità di giochi
determinati puntati ciascuno su un preciso obiettivo/problema da
colpire/risolvere, secondo una procedura ripetibile ed intersoggettivamente
controllabile e,percio., omologabiile in maniera valida-oggettiva
La ‘dottrina geometrica’ è tutt’uno con le sue effettive Applicazioni; non è
isolabile in un complesso di enunciati generali-astratti di natura meramente
proposizional.
In questo senso possiamo dire che il |postulato| non coincide con il suo
enunciato-proposizione, poiché esso vale in quanto Istruzione –guida per un
fare /poiein conforme ad una Attività di Concettualizzione che prova il suo
ordine e la sua fecondità ‘ nei campi di gioco’ e in ‘precise partite’; e,dunque,
in processi-percorsi di passi-figure-figurazioni orientati e finalizzati a‘ fare
goal’.
Analogamente il dimostrare non è riducibile ad un procedimento ipotetico
e/o apodittico deduttivo sganciato da un contesto specifico ; che non è di
natura contenutistica/tematica soltanto o soprattutto. Questo concetto di
contesto, infatti, ancor prima di quello contenutistico chiama in causa il livello
funzionale, cioè il modo di generazione e di connessa strutturazione di un
complesso semantico e teorico; modo che condiziona anche l’attività
mediante la quale lo si fruisce e riconosce.
Per vedere e valutare allora il Platone che dimostra noi dobbiamo sapere
bene che gioco egli stia facendo e quale vero problema il gioco nel suo stesso
svolgersi faccia emergere; e solo dopo valutare il senso e la portata di ciò egli
dichiara come dimostrazione/apodeixis.
I lettori di Euclide almeno in questo sono più fortunati ; infatti, come ho
illustrato riesponendo il primo teorema nel suo movimento logicoconcettuale, egli sulla linea di partenza del suo gioco, dichiara
preventivamente ciò che ha intenzione di fare. Purtroppo in Platone questo
non avviene mai e quando sembra avvenire con l’ostentazione della formula
|Che cos’è x nel dominio A) , allora bisogna stare molto attenti, perché a
seguire questo Platone, assumendo come principale filo-conduttore questa
indicazione iniziale, inevitabilmente si finisce fuori strada ed in vicoli ciechi.
Per fermarmi al Fedone dico,pertanto, che il problema che conduce tutto il gioco
non è |che cos’è l’anima|, né |che cos’è la morte|, né |che cosa sono le Idee ?| e,
dunque, la prospettiva platonica non è né quella di una dottrina della anima e della
sua immortalità, né quella di una dottrina della morte, né quella di una dottrina
delle Idee-, né connessa ad esse, questa prospettiva includerebbe una dottrina
critica del pitagorismo, una dottrina critica della indagine naturale.
Tuttti questi riferimenti tematici-problematici sono naturalmente presenti ma non
sono generati e struttura secondo una logica del modo dichiarato-dottrinario, ma
dentro l’attività di un gioco di testualizzazione che deve esser ripreso per intero,
cioè nel suo intreccio funzionale di Racconto-Argomentazione; ed è solo dal rispetto
di questo intreccio può emergere l’effettiva domanda di fondo che orienta il senso e
lo scopo dei cosiddetti “contenuti filosofici”.
Si avvicina alla scoperta di questo problema implicito – e fuori dall’applicazione
consapevole del paradigma del gioco come modo fondamentale di teorizzazione di
Platone- il Friedlander201 che rileva che tutto quello che è detto nell’opera è
caratterizzato da una costante : esso non spiega il “mistero Socrate”,l’ineffabile della
sua esistenza e del suo destino. Ciò che Friedlander,però, anche qui non ci fa capire
è la natura originale della teorizzazione messa in opera da Platone e del suo nesso
funzionale-costruttivo con l’elemento/Racconto; né egli egli riesce a cogliere il ruolo
della Pseudè Doxa dentro l’attività platonica di teorizzazione.
201
Friedlander, cit. p.
Infatti, Friedlander è preso da
una immagine artistico-retorico-educativapsicacogica della natura del discorso platonico. Anche egli indirettamente sta sotto il
pregiudizio che teoria equivalga a dichiarazione dottrinaria e, perciò, è portato ad
emarginare il discorso sulle Idee che è un punto rilevante nel gioco del Fedone, e si
fa prendere,poi, da una visione mistica e vitalistica del mondo della vita, al quale la
scrittura platonica pur fa segno e rimanda come sua destinazione finale, come suo al
di qua, quello cioè della buona prassi etico-politica per “vivere neglio”, come
Platone fa dire al suo Socrate nell’epilogo dell’ Eutifrone.{ ]
B) Il rinvio analogico al campo della geometria-matematica. così come da me
schizzato nel suo nucleo funzionale-costruttivo, ci permette,poi, di capire
meglio da dove viene la visione platonica della Idea come Metaparadigma e
come funziona un paradigma.
Lo spazio geometrizzato non è un contenitore –come ho già sottolineato- di
enti ideali oggettualizzati-reificati; ed ugualmente dicasi per il concetto
platonico di numero-misura e di figura geometrica.. Essi non sono degli
assoluti posti, ma sono dei Generati secondo precise202 matrici costruttive ed
operazionali che presuppongono sempre l’originarsi ed il farsi di un
Processo/Kinesis.
Il Paradigma allora è il Costante-Invariante in un gioco di Variazioni. Teorema
è la ‘visione di generazione e formazione di una Invarianza Determinata, cioè
contestualizzata in un preciso gioco giocato.
Quando ad esempio nell’ Eutifrone Platone introduce il riferimento alla mia
idea,[ ] cioè al medesimo che si mantiene costante e così unifica una
molteplicità varia di connotazioni, egli sta guardando verso quella nozione di
paradigma che ho sinteticamente delineato con riferimento al procedimento
geometrico-matematico, Ed il concetto di Invarianza in un ambito processuale
di variazioni polarizzate è indispensabile per capire che cosa accade nella
gioco giocato del Parmenid , dove la Gymnasia della seconda parte è solo una
fase di un gioco più ampio cricoscritto anche dal Prologo e dalla prima parte,
figurante un giovane Socrate coraggioso,ma in difficoltà nel pensamento della
idea come Paradigma-Modello, proprio perché lo pensa come ente-oggetto
ideale e per di più in una prospettiva unicamente etica.
Questa natura del paradigmatizzare, cioè il suo essere indissolubilmente
legato ad una modalità e livello di Kinesis ed alle variazioni relative di cui
costituisce la dinamica relazione di Invarianza-Costanza-Medesimezza, ci fa
capire che il platonico “in sé” proprio dell’essere della Idea-Forma deve essere
pensato come principio d’ordine/kosmos immanente di ogni ente fisico o
meta-fisico che sia.
Suk passagio nelle ricerca matematica greca da una logica del “pressappoco” ad una
matematica di precisione cf. Szabò, Fraiese.
202
Quali siano le conseguenze di questa visione – che esce ampiamente allo scoperto
nel X libro di Leggi- sul problema in Platone tra sensibile-soprasensibile, tra
phronesis ed hedonè, tra metexis/partecipazione e mexis/combinazione, tra
causalità ed Idea-Forma ?
Naturalmente enormi, almeno rispetto alla concezione tradizionale di un Platone
che si sarebbe ‘impantanato’ in questi terreni aporetici e che avrebbe preteso di
cavarsela con metafore senza il rigore del concetto.
Quanto alla concezione della Prova/tekmerion e della dimostrazione/apodeixis rilevo
ciò che in parte ho già evidenziato : per riconoscere la natura logico-cognitiva del
procedimento dimostrativo platonico e per valutarne la consistenza critica non
bisogna mai separarlo dal contesto in cui accade; contesto,però, che è accessibile
nel suo piano solo se pensiamo questo in prima istanza non come quello del
presentarsi di ‘contenuti filosofici’ organizzati in strutture e sottostrutture
argomentative con esiti più o meno convincenti e/o più o meno validi dal punto di
vista della scienza logica.
Si accede,pertanto, al contesto specifico platonico solo guadagnando il suo punto di
vista funzionale-costruttivo e chiedendoci appunto che cos’è cognitivamente e
linguisticamente il movimento dell’implicito e della implicitazione in Platone sotto il
profilo della teorizzazione.
Chi,ad esempio, come F. Trabattoni si oppone alle deformazioni dell’ unilaterale
immagine di un ‘Platone sistematico’ e, quindi, sponsorizza quella di un Platone di
una ‘buona forma di retorica”, tacitamente presuppone ,ammette e concede che il
pensiero sistematico sia tutt’uno con una Dottrina sistematica e con un concezione
dottrinaria di sistema. Ma Platone la prima cosa che ‘dice’ con le sue performances
testuali è che non è vero che si può produrre un pensare rigoroso solo per via
dichiarata, pura, dottrinaria; infatti, c’è una area problematica – quella della
produzione eristica-sofistica di logoi spettacolarizzati- che non è inquadrabile solo e
prevalentemente in quell’ottica ‘scientifica’, tecnico-epistemica.
Analogamente succede in M. Migliori: egli dopo una lunga e dettagliata esplorazione
dei testi platonici prende atto che non c’è una dottrina sistematica di Platone su
nessuno dei fondamentali problemi-temi che egli affronta-,
Migliori,perciò, deve necessariamente concludere –per rispetto del genio di Platoneche questi avrebbe consapevolmente voluto e realizzato un filosofare senza una
‘sua precisa filosofia’ e che lo avrebbe fatto a scopo educativo-didattico-introduttivo
per spingere il suo lettore a ‘fare filosofia da sé’ dopo aver preso ripetute ‘lezioni’ da
lui.
Questo Migliori così soggiace nella sostanza ed in ultimo anche lui a quel pregiudizio
culturale senza problematizzarlo ‘radiciter’, pur avendo suggerito ed percorso più
volte ed in profondità una strada ‘alternativa’ per la scoperta dei pensieri di
Platone. Questa strada è quella che si svolge secondo il principio del “gioco serio” e
di una pluralità di giochi-esercizi. Perché il nostro autore e dove e quando ‘torna
indietro’ e di fatto rinuncia a far valere fino in fondo questo principio funzionale di
accesso ai testi platonici per un adeguato e ‘con-formato’ riconoscimento
dell’insieme dei loro valori espressivi, semantici, filosofici, teorici come un grandioso
ed eccezionale ‘sinolo’ di un vasto ed affascinante ‘grande gioco’ che vive in un
pluralità di giochi cognitivo-immaginativi-linguistici ?
Questo punto di crisi – lo ripeto- è il momento della individuazione del problema
che sta in gioco in ogni opera platonica; a questo riconoscimento Migliori procede
non secondo quella logica dell’implicito e della implicitazione che è intrinseca e
fondamentale ad una attività come gioco giocato, bensì per via dell’esplicito, del
dichiarato e-per di più- dello stile dottrinario; e,perciò. ritiene come direzione
principale della ricerca quella indicata e prospettata dal quella dichiarata-dottrinaria
forma-formula del problema |Che cos’è x in una classe-dominio /A ?|. Chiarisco:
dico |classe-dominio/A| pensando ad |A| come iniziale di Arethai/Virtù, tenendo
conto, quindi, che questa formula è costantemente presente in molti dialoghi a
partire da quelli cosiddetti |giovanili| e della fase |socratico-platonica| o
|platonico-socratica!.
Ora l-’interprete che come Migliori si decide per farsi guidarle in via principale da
questa formula, nella ricostruzione del senso finale e dell’ordine argomentativo dei
discorsi platonici, di fatto e,quindi, senza averne piena consapevolezza, considera
secondaria e supplementare l’ottica di osservazione-esplorazione/scopeindiascopein secondo quel principio del gioco ‘al plurale’ che pur si dichiara
espressamente di voler seguire nel lavoro di interpretazione della direzione
fondamentale dei pensieri di Platone.
Ed è questa incoerenza ed inconseguenza, ricorrenti all’interno del modello
eremeneutico elaborato, a condizionare il giudizio finale di Migliori sul senso e la
portata della Teoria in Platone.
Se,invece, in conformità ad una parte essenziale del proprio paradigma. Migliori
provasse ad applicare all’operazione fondamentale di messa a fuoco dell’effettivo
problema in gioco il principio appunto di un dire-concettualizzare per gioco giocato,
allora lo scenario muterebbe sostanzialmente ed egli si metterebbe sulla strada per
riconoscere che Platone ha –eccome- una sua filosofia, rigorosa-coerentepoliprospettica e che risolve i problemi che via via ed in diversi fasi si pone dentro
un'unica strategia espositiva e teorica.
Ma questo sviluppo-riconversione è possibile solo facendo valere la forma della
esposizione- spettacorizzante-drammatizzante- come forma ‘ad substantiam’ anche
ai fini dello isolamento dei meccanismi delle impostazioni argomentative.
A questo proposito quanto scopre G. Reale nel gioco di ‘maschere che passano’, per
il quale assistiamo nel Simposio ad uno scambio e sovrapposizione di maschere
nell’azione scenica di Socrate elogiatore di eros, è una indicazione strategica
fondamentale anche ai fini della scoperta del problema-guida in campo in opere ,
come ad esempio, il Teeteto ed il Fedone, sulla quale mi sto ora soffermando.
Questa scoperta è possibile a Reale, perché in questo rilevamento del gioco delle
parti sulla scena della scrittura platonica anche egli si lasca guidare da una
prospettiva di lettura conformata al principio del gioco drammatico e guarda verso il
movimento concettuale sotto questa luce; salvo poi,però a non farla valere sia nel
Simposio come in altri suoi lavori – ad esempio quelli sull’ Eutifrone, sullo Ione,sul
Fedro- nel momento cruciale in cui si tratta di stabilire e precisare con chiarezza in
quali termini deve essere messo in evidenza il problema-guida, tenendo conto dello
svolgimento complessivo e dell’esito finale della rappresentazione discorsiva
platonica.
In conclusione : nozioni come quelle di postulato, ipotesi, dimostrazione ,prova,
problema devono essere usate in riferimento al Platone Scritto dentro una costante
rispetto e valorizzazione di un contesto complesso ed in larga parte ellittico,
‘nascosto’, non espresso da Platone; da una parte esso rimanda ad un acutissima
meditazione platonica sulla natura di quella problematizzazione-teorizzazione che
accade nel fare geometrico-matematico e dall’altra su quella problematizzazionesemantizzazione che accade nel fare drammaturgico. Platone combina l’essenziale
dello statuto funzionale di queste due ‘grammatiche’ in un attività di
‘metaforizzazione di grammatica’ e di ‘miscelamento’ che istituisce la sua originale
‘logica’ metalogica analogica; una logica del ‘quarto ordine’, posto che il primo sia
quello del linguaggio quotidiano, il secondo quello intrinseco all’operare metodico, il
terzo quello epistemologico , cioè relativo ad una consapevole teoria della logica
tecnico-epistemica.
Platone vede in queste due differenti grammatiche un tratto essenziale-funzionale
comune: il prevalere del principio della Performance, di un dire-significare
agendo/operando, costruttivo/implicito che si differenzia da quello spiegatoesplicito che è proprio del forma piana della comunicazione e dello stile |DDP|.
Il lettore adatto del testo platonico deve perciò tentare di guadagnare questo modo
di osservazione della sua scrittura, se non vuole finire fuori strada ed aggiungersi ai
tanti lettori e studiosi che non si decidono a convincersi che Platone ne sa molto di
più di quelli che pretendono fargli esami e magari ‘bocciarlo’, perché giudicato
confuso,contradditorio ed inconcludente; autore di un fallimento; cosa che
confermerebbe oggettivamente tanti dei moderni e post-moderni nella loro
convinzione che di questo grandissimo genio bisogna assicurare solo una solenne
sepoltura, anche a seguito delle prove stesse addotte dalla miriade di interpreti di
Platone e della sterminata quantità di letteratura secondaria che si è accordo sulla
‘vera filosofia’ del più strano dei filosofi.
6.6– Gli incastri del Migliori e la selezione dei passi testuali per la enucleazione
della platonica dottrina della anima a partire dal Fedone. Non vi sarebbe una
unitaria e stabilmente definita dottrina dell’anima ma solo un pluralità di punti di
vista, che per sottrarli alla accusa di costituire le prove della incoerenza e
dell’autocontradditorietà di Platone, dobbiamo pensarli come temi di un gioco
protrettico,. polivalente, sistematico ed “intrinsecamente aporetico” (p 1254).
Migliori deve essere letto tutto ed inseguito non solo in quel che dice e scrive, ma
soprattutto in quel che non dice sul modo suo di andare alla ricerca della teoria in
Platone.
In questo Migliori è esemplare, perché ripetutamente e sistematicamente fa vedere
‘in opere operato’ – ed è lui che rimette in circolazione questa formula- che cosa non
funziona nel suo approccio ai testi e perché non funziona rispetto alle sue stesse
premesse di teoria ermeneutica, riassunte con particolare chiarezza nella
“Appendice Terza”, nella “Introduzione” e nel “Capitolo primo”203.
Osserviamolo da vicino partendo dal titolo stesso di questa parte del suo libro “Il
problema dell’anima”.
Innanzitutto mi domando : perché Platone non ricorre alla formula |Il problema
di…| nel dare un titolo ad un opera come il Fedone, dove è certamente ricorrente,
“centrale” 204 il discorso sull’anima ?
Questa trasposizione di un nome proprio di persona |Fedone|fungente da titolo in
quel tipo dottrinario e disciplinare-tematico di titolazione è rivelatrice di un modo di
leggere e riassumere ciò che si ritiene l’essenziale dell’opera.
Che cosa implica l’attività di riassumente in questo modo e sotto questi termini ?
Una ‘proiezione ottica’ su il dato testuale che ha in sé una modalità peculiare del
lavoro di ri-conoscimento del senso veicolato da esso. Questa attività di riconoscimento punta dritta verso i contenuti filosofici e alla loro esposizione
argomentativa secondo un individuazione e ripresa degli stessi mediante una ‘rete’
costruita per pescare ciò che si presenta come Generale-Astratto in articolazione
problematiche-tematiche della stessa qualità : il problema della immortalità o
mortalità dell’anima; il problema della sua unità e molteplicità si sotto il profilo
anima-corpo sia sotto quello della molteplicità delle sue funzioni e così via.
Ora proprio questo tipo di ‘trascrizione’-trasposizione del discorso platonico è a sua
volta il risultato di una ‘astrazione-separazione-riassunzione’ che fin dal titolo per
203
204
M. Migliori, cit. pp. 7-190.
M. Migliori, cit. p. 847.
forze di cose de-forma e de-contestualizza Funzionalmente-Costruttivamente il testo
platonico : Migliori spiega e dà in forma piana quel movimento discorsivo che
Platone dà ,invece, originariamente e principalmente in modo implicito; quel modo
implicito che è appunto il dire-concettualizzare secondo il principio di formatività
proprio del giocare con parole, immagini ed argomentazioni.
In questo modo Migliori ‘traduce’ quel percorso implicito che con Platone da lettore
spettatore-cooperatore egli ha dovuto ‘silenziosamente’ rifare . Ora ogni lettore, chi
più e chi meno, con maggior o minore consapevolezza e con risultati di diverso
valore, cerca di fare quel che Migliori fa, nella misura in cui è un lettore capace di
elaborare un buon riassunto.
Anche io che sto scrivendo questo testo mi comporto in maniera analoga.
Dico questo per precisare che la questione non è data da questa operazione di
traduzione dal gioco al riassunto/parafrasi- e, quindi, da qui alla interpretazione di
ciò che è non chiaro e distinto o che appare contraddittorio ed incongruente.
Di fatto facciamo sempre questa operazione e siamo in qualche modo obbligati a
farla nel momento in cui inizia una discussione sul testo.
Ed allora dove nascono la distorsione e la deviazione all’interno di questa fruizione
riproduttiva e necessariamente traspositiva da un modo implicito ad uno esplicito ?
Sopra ho già segnalato che questo allontanamento dalla matrice funzionale del testo
platonico accade nel momento in cui si procede alla individuazione, all’ isolamento e
rilevamento del problema-guida del dialogo; operazione questa tacitamente
effettuata da Migliori non facendo valere anche rispetto ad esso quel principio
funzionale di decodifica che pure egli fa programmaticamente suo;
un’operazione,invece, da lui eseguita secondo la modalità prevalentemente esplicita
e, quindi, secondo la formula generale |Che cos’è X ?|.
E da qui le domande : |che cos’è la morte|, |Che cos’è l’anima ?|. |Che cos’è il
corpo ?|, |Quali sono i loro rapporti ?|. |Morto il corpo è morta anche l’anima ?| e
via di questo passo nella interpretazione e messa in luce del problema e delle sue
articolazioni.
Ma la forma della domanda-problema anche essa soggiace al principio di
‘formatività’, ad un farsi progressivo dentro lo svolgersi del gioco il cui effettivo ed
intero movimento è il principale parametro da usare per l’accertamento ricognitivo
del suo autentico profilo e precisi termini.
E questo appunto anche in questa circostanza non fa Migliori, che ritiene per buona
e fondamentale quella formula problematica esplicita con la quale Platone ‘tenta’
‘sistematicamente’ il suo lettore .
Ed anche questa mia osservazione è una ripetizione di una riflessione già svolta
sopra; la sto riprendendo a questo punto, per cercare di capire ancora meglio il
meccanismo di questo inavvertito ‘scambio erroneo di binario’ , causa di un
conseguente ‘deragliamento’ nella ricostruzione della intenzione teorica che
presiede e regola il discorso platonico del Fedone.
Tento di spiegarmi così : la domanda |Che cos’è la morte ?| è sola la punta di un
iceberg, dove quanto emerge dall’acqua ed è visibile direttamente è da considerarsi
sola la parte di un blocco più grande sommerso e,dunque, non immediatamente
rilevabile. Ora il senso di questa domanda così posta sta in connessione costante
con il percorso costituito dalle varie tappe della risposta; il fatto che questa risposta
si fa dentro la modalità funzionale-costruttiva di un gioco serio esige che la stessa
domanda partecipi di questa modalità fondamentale e che, quindi, rifluisca in essa e
sia in essa mediabile.
Questo significa – tenendo conto della metafora dell’iceberg- che l’esplicitodichiarato visibile, immediatamente leggibile, che caratterizza la formulazione del
problema, deve essere collegato al sommerso, all’implicito, a quell’ fare implicito
che il venirsi a formare di quell’intero testuale veicolante l’intero semanticoespressivo e l’intero della concettualizzazione .
E, perciò , possiamo dire che la vasta area del sottointeso platonico implica la
produzione di un ‘sotto-testo’, che è appunto lo spazio di quel non dichiarato
espressamente costituito da un dire-pensare’/agendo-operando secondo quel
principio appunto di Performance. E dobbiamo anche aggiungere che sottointeso/sotto-testo stanno sull’asse del rapporto tra autore e suo lettore adatto.
Solo dopo aver sottoposto a questo ‘trattamento’ il problema-guida possiamo
procedere al riassunto ed alla trasposizione per via spiegata come accade in un
commento all’opera, in un saggio.
Se applichiamo questa regola di interpretazione potremo anche capire perché lo
svolgimento del discorso platonico è una progressiva conversione, modifica e
rettifica di quella iniziale domanda e di quella sua corrispondente risposta |La morte
è la separazione dell’anima dal corpo|.
Questa conversione avviene secondo il canone di una alleanza terapeutica tra il
Socrate di Platone ed il Fedone di Platone; sì, perché Fedone – come ho sopra già
accennato- è il prototipo del convinto pitagorico che,però, non è consapevole dei
limiti teorici intrinseci a quella visione del rapporto anima-corpo, vita-morte, che la
pitagorica illustre tradizione culturale , politica ed etica ha coltivato e promosso.
Fedone, quindi, ha bisogno di purificarsi-liberarsi dalla pretesa illegitima di far valere
quella concezione come ‘misura di tutto ciò che è e di tutto ciò che non è’ , fino a
quel non-essere a cui è prossimo il Socrate Moriturus.
Ed il metodo della alleanza terapeutica prevede
che il medico sappia
immedesimarsi il più possibile con lo stato mentale ed emotivo del paziente, per
aiutarlo dal di dentro a curarsi ed a superare gli effetti del suo stato morboso, che
può essere anche una disagio esistenziale e mentale. E di fatto così accade in molti
personaggi platonici interlocutori di Socrate (da Eutifrone-Ione-Carmide a Fedro e
Teeteto).
In virtù di questa funzione di un Socrate-medico dell’anima che vive in
comunicAzioni, tutto ciò che Platone gli farà dire sull’anima e sulla immortalità
dovrà essere letto in questa ottica .
La conseguenza importante di questa impostazione per il lettore è questa : nella
discorvizzAzione rappresentata sulla scena della scrittura del Fedone il piano non è
quello né di una dottrina sull’anima del Socrate storico, né quello di un problema
dottrinario del Platone della storia, di un Platone che per di più non ci darebbe una
sua precisa ed univoca dottrina , ma solo prospettive di una ricerca/skepsis da
proseguire da parte del lettore desideroso ed educato a fare dottrina filosofica
sull’anima.
Perciò la titolazione |Platone ed il problema dell’anima| non è conforme , già come
trasposizione spiegata dell’assetto problematico, alla matrice costruttivo-funzionale
dell’opera.
E, invece, anche essa un uso del testo tipico della tradizione accademica; una lettura
che rimane un uso anche se confortata da un gran numero di citazioni di luoghi
testuali.
Chiarisco e ribadisco : la quantità delle citazioni da sola non ci dà automaticamente
la qualità funzionale-costruttiva che costituisce quel contesto dentro il quale esse
devono essere riconosciute nella loro intenzionalità finale di senso.
Aggiungo e preciso ulteriormente : il criterio della quantità fatto valere dentro un
prevalente ottica dottrinaria viene per forza di cose smentito da un serie di luoghi
testuali che essa non può catturare; uno di questo luoghi sintomatici è appunto lo
stesso titolo dell’opera , che non è dato in una formula dottrinaria |De anima|, |Il
problema dell’anima|, ma con |Fedone|, cioè con un termine che apparentemente
si fa leggere come nome proprio di persona, di un singolo, di ciò che per definizione
non è né generale, né astratto.
Ma naturalmente la parte del testo che si sottrae a questo paradigma dominante si
estende a tutto ciò che erroneamente viene, dal punto di vista teorico, emarginato
come |cornice|, |veste mitica|, |descrizione storica o semistorica|,|divertimento
drammatico|, in una parola come l’ |Elemento-Racconto|.
Dove allora è finita la raccomandazione di Migliori di essere fedeli al testo , di non
forzarlo, di essere il pù possibile prossimi ad esso ? Da questo punto di vista l’ottica
dottrinaria si autoconfuta necessariamente, per effetto inevitabile della sua opzione
iniziale sulla modalità di accesso alla scrittura platonica. Possiamo dire che Migliori
viene meno alla sua promessa di farci vedere fino in fondo il gioco ed i giochi
platonici; questo ‘fondo’ viene eluso perché il fondo, il profondo della struttura e
dinamica problematica non può essere esplorato con quella mappa che egli cala sul
testo.
Di nuovo mi avvalgo di un esempio tratto dal gioco del football : la domanda
pertinente e congrua per ricapitolare bene e per così indicare correttamente la
natura del gioco del pallone non è |Che cos’è il pallone ?| e neppure: |Che cos’è
una pallone mosso dai piedi ?|, o |Che cos’è il pallone finito in porta ?|. Ma : |come
si svolge quella attività nella quale ventidue individui ,riuniti in due gruppi in
competizione, gestiscono e colpiscono con i piedi e con la testa un pallone con lo
scopo di farlo entrare nella porta della squadra avversaria ?|. Vale a dire : si può
rispondere alla domanda |Che cos’è il pallone ?| solo rinviando al contesto dei suoi
usi all’interno di una attività di gioco regolato da precise istruzioni e puntato su un
obiettivo da raggiungere. E’ il farsi del gioco che ci fa vedere in action il suo
autentico problema.
Mi domando a questo punto : ci sono dei segnali testuali con i quali l’autore Platone
avverte il suo lettore che egli con il Fedone non intende offrine una dottrina
riconducibile a lui o al suo maestro e che nello stesso tempo egli vuol fare teoria e
risolvere in maniera soddisfacente e valida un problema preciso ?
Uno di questi segnali è il tono della esasperazione polemica che il lettore può
avvertire ; questa tonalità espressiva tratta dai registri della comunicazione
drammaturgica – sulla quale richiama l’attenzione tra gli altri G. Reale, come ricorda
lo stesso Migliori- deve, però, essere pensata nel suo risvolto e nel suo effetto di
ricaduta sul piano della intenzionalità teorica platonica.
Polemica-Polemos richiama una attività che si caratterizza come Presa di Posizione e
Presa di Mira per colpire un bersaglio. Platone addirittura in riferimento all’indagine
sulla realtà parla di una “caccia all’essere” e nel Fedro allude alla skepsis come una
‘saper fiutare e stanare una preda’.
Questo ‘spirito polemico’ vive nello schematismo argomentativo come Elenchos, che
non significa solo |Confutazione|, ma in primo luogo |FalsificazioneSmascheramento-Smantellamento-Purificazione-Liberazione|.
Infatti, un interlocutore può essere di fatto confutato, ma non per questo soltanto
la confutazione che ha colpito i suoi discorsi può essere considerata produttrice di
valori di verità.
Platone,dunque, intende ‘polemizzare’ per fare verità e farlo attraverso un
procedimento di giustificazione rigorosa.
Ma contro che cosa effettivamente combatte il Socrate di Platone nel Fedone ?
Riuscire a stabilire con lui questo ‘terminus contra quem’ significa innanzitutto
acquisire ulteriori elementi importanti per mettere a fuoco il suo effettivo problema
e per convincersi ulteriormente che la sua domanda non appartiene al piano
dottrinario, perché ,come di nuovo e meglio vedremo, il bersaglio platonico non è
una dottrina concorrente e rivale sull’anima e sul suo rapporto con il corpo, ma una
pseudo-dottrina che vive di una pseudo-immagine dell’essenza del fisico , del
sensibile, del corporeo.
Dunque, dal tono veniamo a sapere che Platone ‘sta contro qualcuno o qualcosa’;
poi leggiamo il riferimento ad un intellettuale-poeta, Eveno, che si è venduto l’anima
alla Pleonessia e che ha messo al servizio di esso la sua parapoesia. Quindi si fa
accenno a quelli che tra la gente sfottono e prendono in giro i filosofi chiamandoli
‘amanti della morte’ e come moribondi incapaci di apprezzare e di godere delle
gioie ed i piaceri della vita , dei sensi e del corpo.
Ora è proprio questo scenario di fondo per lo più alluso ed i peculiari logoi in cui
quelle Opinioni Dominanti si concretano in diversi momenti della comunicazione
pubblica , a funzionare da contesto scenico ed extra –scenico dentro il quale
collocare lo spazio di quel bersaglio per lo più nascosto, implicito, contro cui il
Socrate di Platone muove in questa sua ‘seconda apologia’, come è detto nel testo,se pure nella forma indiretta di una difesa dei postulati pitagorici , secondo la parte
di quel Socrate-Medico e Terapeuta che Platone assegna al suo personaggio
principale.
Ed allora il bersaglio sul piano intra-scenico , e per lo più implicito, non è costituito
dalla dottrina di una filosofia della natura, del corpo, dei sensi interni ed esterni; non
dai logoi della ricerca fisiologica, biologica, psicologica e dai discorsi su i costumi ed
i valori educativi.
Il ‘terminus contra quem’ sono gli pseudoi-logoi di un falsa opinione di moda, diffusa
in città e propagandata da pseudo-intellettuali ‘alla Eveno’, sulla funzione del corpo
e del suo rapporto con l’anima.
Essi non solo pubblicizzano la distorta opinione secondo la quale con la morte del
corpo finisce tutto di un individuo umano, ma pretendono imporre tale opinione
come credenza vera giustificata. E, perciò, programmaticamente stanno in lotta con
gli esponenti di quella tradizione culturale-educativa come quella pitagorica che al
contrario punta tutto sull’anima fino a disprezzare il corpo.
Il Socrate, dunque, del problema dell’anima è inserito in questo contesto che ha
appunto come sfondo essenziale le pretese di una paracultura sul corpo di valere
come moderna e superiore concezione dell’uomo e del cittadino. In questa scontro
culturale egli prende posizione e si schiera a favore della concezione pitagorica; e
non perché la condivide in tutto e per tutto o perché la ritiene adeguata per stare
all’altezza di quel tempo segnato dall’ Evento della Passione e Messa Morte del Più
Giusto.
Platone fa schierare il suo Socrate a fianco dei pitagorici, perché essi sono in buona
fede, stanno in una ricerca sincera della verità sull’anima e sul corpo, anche se la
loro visione è segnata da importanti aporie e non sanno venire a capo del giusto
rapporto tra anima e corpo, tra soprasensibile e sensibile, tra vita e e morte; perciò
Platone viene in loro soccorso per perfezionare dall’interno della concezione
pitagorica stessa il nucleo dei loro postulati, per renderli comprensibili e coerenti.
Gli antipitagorici bersagliati implicitamente da questo Socrate platonico non sono –
lo ribadisco- gli esponenti di una scuola concorrente e rivale di ricercatori in buona
fede e con volontà di verità e di veracità; ma gli autori smaliziati ed efficienti della
costruzione di una Menzogna e della sua diffusione spettacolarizzata.
La menzogna secondo la quale con la morte del corpo viene distrutta anche l’anima
e l’anima dei giusti; e,perciò, tiranni, dominatori,carnefici, sterminatori, con il
potere di distruggere il corpo disporrebbero di un potere di una assoluta
nientificazione dell’altro : avrebbero il potere di ridurre l’essere ad un assoluto non
essere.
Il lettore che non percepisce che il problema fondamentale che sta in gioco in
questo Socrate, Figurato come il più convinto e rigoroso dei pitagorici , è appunto
il problema dei logoi eristico-sofistici intorno all’anima ed il corpo, si predispone a
prendere una cosa per un’altra, ed a considerare una questione dottrinaria quella
che è, invece,
una ‘critica militante’ di qualcosa che è extra-dottrinario,
paradottrinario.
Le argomentazioni che Platone mette in bocca al suo Socrate sono, quindi, una
ripresa in sede di metalogica analogica dei principi della ‘logica’ pitagorica. (anche
,in questo caso, per correggerla-integrarla –finchè è possibile)-; lo scopo è quello di
‘armare’ meglio la visione pitagorica impersonata da Socrate nella lotta contro quel
sofisma che ha tanto successo in città e che ha dato la grande prova della sua
terribile potenza attaccando e portando alla sua morte; e naturalmente questo lo
dice Platone al suo lettore.
I logoi della Accusa a lui sono il massimo concentrato di Menzogna spacciata come
Verità della vita dell’uomo e del cittadino.
Il valore dimostrativo di queste argomentazioni va, dunque, cercato nella loro
capacità di falsificare l’assunto |con la morte del corpo finisce tutto| come pretesa
opinione vera e giustificata.
Questa capacità non è la capacità platonica di darci una compiuta e coerente
dottrina intorno al problema dell’anima; bensì è la capacità della visione pitagorica,
pur ‘purificata logicamente’, di operare con efficacia metodica questa falsificazione .
La risposta Platonica a questa domanda è affidata al suo nascosto lavoro ‘critico’ nel
fare emergere la debolezza e le incongruenze teoriche intrinseche al pitagorismo.
Debolezza-incongruenze costruite, dunque, da Platone stesso in vista di una
strategia che ha il suo apice non in una vetta argomentativa, ma nell’esibizione per
Racconto Spettacolare, emozionante ed affascinante , del Socrate, il più giusto, che
Muore.
Il Messaggio finale è,dunque, : l’Evento del Più Giusto accusato e condannato a
morte ingiustamente dal suo popolo e dai suoi capi, non è pensabile e dicibile
dentro una visione della vita e della morte di ispirazione pitagorica- sia pure di un
‘pitagorismo’ sviluppato-avanzato-.
Esso è una svolta epocale che impone una ‘rivoluzione’ del pensiero sfidato dallo
scontro tra essere e non essere, dove il non-essere non è un contrario che stimola e
coopera allo sviluppo dell’essere, ma è un’ AntiEssere da intendere come “energia
distruttiva radicale dell’essere’.
Pensare questo Anti-Essere che si fa vedere nei logoi come Menzogna è la sfida alla
quale è chiamato il filosofare se vuole essere un sapere a vantaggio della vita
dell’uomo.
E’ questo epilogo tutto narra del tivo , dunque, a dover essere fatto rimbalzare a
ritroso, nuotando sul dorso – come è scritto nel Fedro,{
], attraverso le parti
argomentative e fino al problema ! Che cos’è la morte di un uomo ?|.
Non c’è dottrina per Platone che può rispondere a questa domanda, perché essa sta
prima ed oltre le possibilità dell’umana comprensione, soprattutto quando essa si
spinge a pensare la ingiusta morte del più giusto. Ma il pensare non è prigioniero
delle pretese dottrinarie; esso vive in quella attività noetico-progettante che si fa
sentire immediatamente come fede e speranza nella vita eterna del cosmo alla
quale la vita terrestre appartiene.
La buona speranza e ‘l’entusiasmo’ della fede nel divino che si prende cura di noi e
la stessa ‘ispirazione’ e “mania filosofica” 205non sono stati d’animo ma decisioni del
Il mondo di una ’emozione illuminante e svelante – e ,perciò. non riducibile al cosiddetto
irrazionale cieco e disordinante- e, quindi, la sfera di un agire emozionato ed emozionante come
esperienza di intelleggenza della realtà umana e cosmica, costituiscono una dele più alte conquiste
culturali e teoriche di Platone, che riprende il meglio della ‘ccultura del sentimento’ della
tradizione ellenica nutrita di oriente e lo proeitta dentro la stessa modalità della Praxis-Pragma.
E ciò non hanno compreso quanti parlano di intellettualismo etico platonico-socratico e di
disincarnato idealismo- e di mitologico sentimentalismo platonici.
Su questo tema in generale cfr. il classico Dodds, I Greci e l’irrazionale, Natorp, Kruger, Passione e
Ragione, e recentemente M- Cacciari, Labirinto filosofico, Adelhhi, Milano, 2014. pp. .
Ed in Platone questa Praxis-Pragma non è un azione-fare generico e senza aggettivi, ma al
contratio è il Saper fare e farsi in una vita vissuta secondo giustizia./Nous-- Sopprosyne, ascoltando
il Divino, principio e fonte di ogni azione buona, bella e giusta. Questa vita intelligente ‘activa’ è.
però. per Platone sempre esposta alla lusinga-illusisone dei ‘falsi entusiasmi’ che si nutrono della
pseudo-luce della allucinazioni ed accecanti ‘manie’ proprie del male e della menzogna.
La metafisica platonica,perciò, viene radicalmente deformata quando la si separa da questa sua
intima Decisione Teorica : in una opsione di vita in città prendere posizione cogntivamente.
Immaginativamente, linguisticamente, contro i paradiscorsi di una comunicazione pubblica che o
sponsorizza la ‘necessitàì della ingiustizia o vi soggiace decidendo di non parlarne, lasciandol così
di fatto libera di imperversare e di manipolare le anime dei cittadini. Che del negativo non si possa
parlare che dentro la ‘logica del primato del positivo’, non è un principio che possa essere usato
per concludere che il male sarebbe organico al bene, e la menzogna al fare verità. Questo è il
messaggio costante e centrale dell’operare dialettico platonico, che ,perciò, sfugge alla presa ed
alla pretesa di superamento di ogni variante di idealismo assoulutamente immanentistico o di
nuovo ‘realismo’post-moderno , che rifiutino di misurarsi con la terribile radicalità del male come
energia cattiva distruttiva del bene della vita e della vita del bene, di quella vita della parola che è
la sua veracità. Se,pertanto, vogliamo estendere anche a Platone la metafora del “labirinto”,
quella cioè di rete complessa che rimanda alla difficile e rischiosa esperienza di percorsi
concettuali e linguistici intorno al Bene/Agathòn, con Platone ed anche con l’aiuto di Derrida,
autore di quell’ aureo libretto, dobbiamo sapere che nell’ Intorno delll’ unoverso del Bene che
tentiamo di esplorare con la nostra ‘immaginazione logica’ si aggirano ed operano anche
‘fantasmi- Sirene, prodotti da una ingannevole e seduttrica cativa immaginazione : quella che sta
205
pensare; e come scelta hanno come loro essenziale connotazione quella dell’ OsareRischiare-Scommettere ; un Proiettarsi Oltre ed una sapere stare in questo Progetto,
come ci viene detto nel finale di Leggi
Questa elevazione, tensione e slancio oltre quel termine che il fatto della morte
dell’individuo delimita, costituiscono la forza propulsiva del Mitologizzare platonico,
della sua Immaginazione noetico-simbolica.
Questo modo del dire-comunicare non è una non filosofia, una filosofia per le
moltitudini non istruite, una filosofia ‘indebolita’. Essa è intessuta di ‘metafore vive’,
quelle che sono più che dottrina, perché non sono prodotti di una fantasia senza
freni ed alienante; esse,infatti, appartengono alla luce della vita, alla luce che viene
dal saper vivere secondo giustizia; quella giustizia che sta anche dentro il cosmo. Da
qui viene la sapienza.
Questo ‘Mito’, dunque, è parola che è tutt’uno con la dimensione ‘espressiva’ della
prassi etica e politica, mossa ed attratta dal Bene, da quel Divino che è fonte di ogni
bene.
Perciò, non dobbiamo scandalizzarci se essa diventa anche ‘parola liturgica’ in un
Socrate che chiede che venga offerto un gallo ad Asclepio, dio che ci fa ‘risorgere’
dalla malattia, di quella malattia che non è la vita, ma la azione ammorbante e
distruttiva della ingiustizia.
La filosofia come sapersi preparare a morire è, dunque, un progetto di amore alla
vita terrestre e cosmica. Per questa opzione compito della filosofia non è risolvere il
problema del che cos’è la morte di un individuo umano, ma vigilare ,da Custode ,
Sentinella della città dei logoi sulle “Cose Massime”, affinchè pseudo-logoi sul senso
della morte non si introducano nella comunicazione pubblica con la pretesa di
costituire una superiore cultura e di imporsi come vera sapienza.
Il più attraente ed illudente di questi falsi discorsi, apparentemente di buon senso,
che ci terrebbero con i piedi per terra e che sarebbero scientificamente dimostrati, è
appunto quello che ci chiede di rassegnarci alla presunta certezza che con la morte
del corpo di un uomo l’uomo finisce nel nulla.
In questo senso la filosofia è, per costituzione e missione, ‘apologia della vita
eterna’; ma essa non è eterna senza il Divino, che si prende cura di noi, che dèi non
siamo , e ci rende partecipi di quella intelligente ed inesauribile energia che il
Divino è come vita buona , bella , vera. giusta.
La filosofia Platonica, in questa sua interna impostazione funzionale , dunque, sa
risolvere, dentro i discorsi sulla anima , sulla vita e morte dell’umano, il Suo
problema e lo risolve in maniera dimostrativamente rigorosa; perciò, essa non è
affatto “intrinsecamente aporetica”, come ribadisce
il Migliori nelle sue
a servizio della Pleonessia (Platone), della libido dominandi(Agostino), del “deomonio
meridiano”(T. More) del “male radicale”(Kant), di quella Superbia-Invidiosa di volere essere dèi
senza e contro Dio.
“Conclusioni” 206. Tutto sta naturalmente nel decidersi a ripensare con Platone“autore implicito” il concetto di dimostrazione e di prova cosi come da lui realizzato
nella sua testualizzazione.
Dimostrare in sede metalogico-metalinguistica analogica è Saper Falsificare,
utilizzando Metaparadigmi analogicamente ben formati e ben orientati sugli statuti
delle Technai e sugli usi omologati delle pratiche linguistiche della comunicazione
quotidiana.
Saper falsificare che cosa ?
Non dottrine rivali, ma finte dottrine, che sono in realtà pure e ben congegnate e
seduttrici sofisticherie’ pseudo-metalogiche intorno alle “Cose Massime”; e in
questo sono incluse l’immortaità dell’anima e la bellezza corporea.
Queste sofisticherie hanno invaso e corrotto lo ‘spirito pubblico’ attraverso
l’impiego sistematico degli stili ed apparati della comunicazione sociale
spettacolarizzata.
La filosofia non può chiudere gli occhi su questa devastazione della sensibilità, della
immaginazione e mentalità di individui, famiglie, ceti e folle.
Essa deve uscire dai recinti delle ‘accademie’, ed appoggiandosi sui migliori risultati
del lavoro culturale, in cui gli accademici sono impegnati, essa deve dare aperta ed
incessante battaglia- polemos/elenchos- al sofisma trionfante ed applaudito, che
vuol convincersi che ciò che è pure un esteso e mondiale fatto sia per ciò stesso e
solo per questo anche la più grande presunta verità della vita nelle città. Vale a dire
che la giustizia sarebbe sempre e dovunque, in terra ed in cielo, l’utile del più forte,
che si pretenderebbe essere così forte da poter ridurre a niente con la messa a
morte del suo corpo, anche l’anima del più giusto.
206
M. Migliori, cit. pp.1231-1347..
.
6.7 La dottrina dell’unità dei contrari nella dottrina dell’anima nel Fedone ed la
prospettiva del Parmenide.
Riprendo questo tema, perché esso appartiene ai fondamenti ed alla conclusione
generale della interpretazione di M. Migliori sul valore teorico della filosofia di
Platone.
Cito ancora dalle “Conclusioni”207(pp. 1342-1343) :
-“…L’ambiguità costitutiva del platonismo ha il suo fondamento nel Principio
primo stesso ,che per Platone non può essere un Uno : questo non solo gli appare
ineffabile ed impotente, ma anche e soprattutto incapace di spiegare il parziale
ordine, “appena sufficiente”, di un mondo in gran parte disordinato….. In sintesi il
principio deve essere una polarità e la realtà ordinata manifesta una costante
tensione, esasperata nella visione pendolare : il mondo è una costante
trasformazione dal massimo di ordine al massimo di disordine per la resistenza
“potente” del principio Grande-Piccolo, per l’azione costante della Misura, per le
travagliate relazioni che si stabiliscono tra le cose stesse, per l’azione mai del tutto
costante del Nous divino e sempre incostante del nous umano…..
-..Platone..costruisce all’opposto , a partire da “due principi”, due colonne di
realtà contrapposte, segnata l’una da caratteristiche positive e l’altra da negative,
sul modello delle coppie pitagoriche ,dalle quali certamente ha preso le mosse e
dalle quali risulta condizionato- Per sua sventura, perché questo determina una
contraddizione mortale nel suo sistema che non a caso non ha avuto diretti
continuatori..
-“…qui emerge la peculiarità di Platone che nell’argomento dei contrari del
Fedone 70 C-72D afferma che il vivo nasce dal morto, che un contrario è connesso
e “deriva” dal suo contrario…..La dialettica è proprio la capacità di pensare la
tensione come primaria e costitutiva, rifiutando la pace soffocante di un uno che
assorba tutto nella sua perfezione…”.
L’immagine di questo Platone che “rifiuta”, la “pace” dell’ “uno” è veramente
conforme al Platone che si mostra nella forma, nella struttura e dinamica dell’intero
sua scrittura ?
207
M. Migliori, pp. 1342-1343.
E’ sufficientemente certo, perchè estesamente ed immediatamente leggibile,
nell’attraversamento dei suoi dialoghi, che c’è un Platone che prende posizione e va
all’attacco; ma di che cosa e di chi ed in che modo ?
Se assumiamo il Parmenide come opera centrale per la giustificazione di questo
Platone, amante appassionato del polemos come polemos, facciamo un passo
obbligato, ma riproponiamo anche la questione preliminare del modo di accesso al
‘come Platone fa teoria’ e al ‘come Platone problematizza’ in generale e ,quindi, in
questa opera. Mi ripeto ; nel Parmenide il problema non è in via principale |Che
cos’è l’Idea ?| e neppure !Che cos’è l’uno/Idea ?|, bens’ questo : Come si falsifica
quella opinione che pretenderebbe negare con portata necessario ed universale la
realtà della Idea, la cui essenziale proprietà di medesimo ha la sua ‘aurora’ nel
principio di identità e di non contraddizione ?|.
Alla identificazione e qualificazione del problema in questi termini si può pervenire
solo applicando quel canone che sopra ho ripetutamente illustrato : se si deve
leggere il testo giocato riproducendolo secondo il principio funzionale |G G| allora
anche l’isolamento del problema-guida del Parmenide deve essere operato
nell’azione-retroazione del movimento complessivo, nell’intero del suo svolgimento
w tenendo ferma la sua relazione di affinità-omogeneità funzionali in coerenza con
esso .
Nel Parmenide la costanza della negazione polarizzata , distribuita su più piani
semantico-categoriall lungo l’asse uni-molti,i è una caratteristica pienamente
evidente e testualmente confermabile in grado forte.
Ma questa caratteristica costanza strutturale della dinamica argomentiva non prova
affatto che l’uno-medesimo della ideAzione sia impossibile, ma proprio il contrario.
Infatti, ciò che l’esercizio in un procedimento per assurdo mostra è proprio il farsi
progressi della Costante-Medesimo della relazione negativa.
Questa Costante è la prova indiretta della realtà e della razionalità dell’Idea-uno, che
perciò è dicibile e pensabile; non ineffabile , né impensabile, se leggiamo ed
interpretiamo nell’ottica di lettori-spettatori di un gioco di relazioni
sistematicamente oppositive. Platone dice l’uno Mostrandolo appunto nel farsi di un
discorso che accade in coerenza all’unità propria ,oggettiva, de procedimentol
sistematico-operativo.
Questa è la mia ipotesi sull’opera, che perciò anche essa non è aporetica, perché
risolve il problema incorporato nel suo gioco. E potrei ampiamente dimostrarla
tenendo conto di tutto il testo; naturalmente non posso farlo qui . Posso solo fissare
la condizioni per poterlo fare, richiamando ciò ho sopra ho posto e puntualizzandolo
ulteriormente:
a) Le tre parti dell’opera (prologo, rappresentazione di un giovane Socrate in
discussione con Zenone gymnasia di Parmende assistito da Aristotele) devono
essere tenute strettamente insieme ( e così esige anche Migliori); l’elemento
narrativo del prologo concorre alla generazione della problematizzazione;
b) Tutte queste tre parti sono parti integranti e sostanziali di una
discorsivizzazione che si svolge sotto il principio di Performatività, secondo la
grammatica del gioco giocato e ,quindi, sotto la insegna della dominanza
dell’implicito e di procedure di implicitazione;
c) La forma di esposizione è quella di una scrittura spettacolare e teatralizzante;
d) Il discorso messo in testa al giovane Socrate è una fictio logico-argomentativa,
che prevede la rappresentazione di un Socrate che prende arditamente
posizione a difesa di una Idea concepita come Ente Ideale con forte
connotazione etica, e contro un Innominato Implicito: Questa concezione non
pecca tanto di naturalismo o di moralismo, ma soprattutto di una immagine
entificata-reificata dell’Idea, e,dunque, il suo limite principale è
l’oggettualismo. Essa è costruita da Platone come poiszione lodevole da punto
d vista dell’affermazione di una moralità del discorso, ma teoricamente
debole; e ,dunque, necessaria di un radicale ripensamento e rafforzamento
speculativo. La terza parte, cioè l’Esercizio-Calcolo argomentativo svolto da un
vecchio Parmenide, che in realtà è Platone, ha appunto il compito di
perfezionale formalmente le proprietà di universalità determinata, di
necessità intrinseca, che caratterizzano il nucleo statutario di ciò che
possiamo chiamare Ide-Azione; termine che mi accingo di seguito subito a
spiegare:
e) Dico !Ide-Azione| per sottolineare il fatto che il ruolo del dire-pensare come
Attività. che venendo alla luce e nello stesso suo svolgersi esibisce- ‘mette in
mostra’ l’ordine immanente che la muove e la struttura. è fondamentale per
capire cosa intenda Platone per Idea-Paradigma-Modello.
f) Per individuare il campo d’origine di questa visione, bisogna calarsi nello
spirito di quella logica matematica-greca che sopra ho tratteggiato ed
abbozzato E,pertanto, bisogna evitare di fermarsi ad un concetto generico e
non storicamentet e culturalmente contestualizzato-specificato, di NumeroMisura.
g) Il Calcolo Argomentativo del personaggio-Parmende è un procedimento per
assurdo, cioè fatto ammettendo e solo perciò metodicamente concedendo
che sarebbe impossibile e, quindi, indicibile e non pensabile quello IdenticoMedesimo che è proprio dell’ideare come attività di unificazione determinata
di un molteplice.
h) L’uni-molteplice messo in discussione è quello paradigmatizzato nella ‘Tavola
delle categorie per lo più pitagoriche’ ripresa nel suo nucleo essenziale e
arrichita di ulteriori relazioni; e si tratta di categorie logico-ontologichepsico/logiche -assiologiche- cosmologiche-teologiche.
i) Il procedimento per assurdo può esser concepito come ‘bombardamento
sistematico ‘ delle relazioni istituenti quella Tavola dell’uni-molteplice , per
osservare e riconoscer che cosa accade” in questa metodica de-costruzione
che mette in tensione ed in contrapposizione ‘come per romperli nella loro
necessario ed originario legame, i termimi-categorie assunti in coppie
polarizzate;
j) L’indicazione testuale ‘vediamo che cosa accade’ è una fondamentale
istruzione al lettore-cooperatore, affinchè si predisponga ad un
riconoscimento che dovrà muoversi in via principale non per via dicharataesplicita, ma stando orientato appunto su ciò che effettivamente accade in un
puro Operari, ‘in opere operato’; e,dunque, per via implicita; e, dunque, il
Modo immanente alle applicazioni ripetute e ricorsive è determinante per
cogliere il senso finale del gioco argomentativo
k) La dimostrazione platonica così è una ‘Mostrazione’, che svolgendosi secondo
una regola data |Si-No, No-SI; Né…Né ) applicata ad un complesso strutturato
e dato in più livelli, può essere pensata come un ‘Calculemus ‘ che parla da sè
con il suo stesso rigoroso, coerente, completo e felice svolgimento.
l) Ciò che emerge da questo complesso ‘calcolo’ è proprio il mirabile di un
Costante-Medesimo del Persistere di una Relazione di Negazione; vale a dire :
l’uno si afferma in una maniera rovesciata, ma vera, giustificata-mediata e
reale; se manca solo ‘il nome della Cosa’ – come osserva Hegel-, questo
significa che la ‘Cosa non è detta’; cioè appunto che non è DichiarataEsplcitata; ma in Platone il non detto è detto altrimenti, cioè attraverso il
principio funzionale di Performance, che vive analogicamente di ‘spirito’
geometrico-matematico e del drun (Aristotele, Poetica ) animante e formante
il drammaturgico.
m) Sopra ho precisato che ciò che è in gioco in questa opera è la validità del
principio di identità e non contraddizione; con questo non ho voluto dire
naturalmente che Platone riconoscerebbe il primato della contra-dictio e che
programmaticamente cadrebbe in autocontraddizione: Eì, infatti, evidente
che i contrari fatti muovere l’uno contro l’altro in una dinamica di
polarizzazione per coppie, non sono quei contradittori risultanti dalla
violazione di quel principio fondamentale del pensiero e del linguaggio.
A mettere in discussione la validità di questo principio è la Innominata Falsa
Opinione eristico-sofistica che il vero e principale e, tuttavia, costantemente
implicito bersaglio che Platone con la sua più ellittica delle opere intende
colpire e smascherare nella sua pretesa di essere una opinione vera
giustificata.
In breve : Platone mette in campo un esercizio metalogico e
metaparadigmatico che permette di inquadrare quella falsa opinione in una
operazione che la porta all’implosione, ad una autocontraddizione
performativa, partendo proprio dalla sua pretesa di essere valida, cioè
universale e necessaria. Esemplifico : posto l’enunciato | dico che il principio
di identità e di non contraddizione non è valido e lo dico con la pretesa che
questo enunciato sia necessario ed universale!, allora ammetto che c’è
almeno un caso in cui tale principio è valido; questa caso è appunto dato
dall’enunciato posto, che ,perciò, si autoconfuta e viene smascherato come
non sense, un mero flatus vocis, phetenngesthai
Ma Platone fa di più : decide di dimostrare questa falsità, che non è un
semplice errore di tecnica logica; egli, cioè, si propone di dirla e pensarla in
una mediazione logico-linguistica, e,quindi, in uno svolgimento per
passi/mosse, organizzati in percorsi-sequenze, facendosi cos’ sfidare dal
problema della possibilità di dimostrare un Principio, che per definizione e per
sua natura non è dimostrabile, non è pensabile come un risultato-derivato.
Platone si cimenta con la impresa di dire rigorosamente la Principialità del
Principio. Questo ,perciò, non è dato nella forma di una proposizione
fondamentale, ma dentro un multiforme movimento concettuale dentro un
‘Fatto-Garanzia’, metodicamente scomposto come per ‘distruggerlo’ nella sua
realtà di totalita validamente determinata. Questo paradigma complesso e
multiforme è appunto ciò che ho chiamato la ‘Tavola massima delle categorie
pitagoricamente ispirate’.
L’idea che è in discussione ,dunque, è quella alla IdeAzione che è l’epifania
della idea di Principio – ed in questo senso di Uno. E qui si fa vedere che non si
dice e si pensa l’Uno come supremo ente-oggetto e nella forma di un
enunciato assolutamente e separatamente posto; la sua semplciità ed il suo in
sé, la sua immutabilità e permanenza. è quella Invarianza indicibile ed
impensabile fuori da una Koinonia originaria ,strutturale-funzionale e finale,
con una Energheia-Kinesis, che è di vita e di vita intelligente ,come dichiarato
apertamente nel X libro di Leggi. Ed anche in questa circostanza se non ci
alleniamo a far nostro la nozione di Invarianza-Costanza ‘vivente’ nella logica
geometrico-matematica platonico-euclidea è molto difficile sottrarsi alla
conclusione alla quale perviene M.Migliori nella sua analisi dell’opera : il
prevalere di una assoluta relazione, polarizzata ed ‘internamente minata’,
dell’ uni-molti, destinata ad essere abbandonata dalla tradizione filosofica
post-platonica ed essere divaricata in un aut… aut.. : o in direzione del
primato dell’ Uno/neoplatonico da cui tutto ‘degradando’ deriva od in quella
del primato del principio aristotelico della immanenza uno-i molti sotto
l’azione attraente dell’ uno motore immobile 208.
Per quanto fin qui ho delineato, non ho paura di sostenere che questa
alternativa, che pure di fatto si è imposta, è il risultato di una mancata
comprensione della eccezionale originalità ed incomparabile acutezza
speculativa del Platone teorico della teorizzazione e della problematizzazione;
nonché della perdita di vista del contesto storico-culturale con cui Platone si
confronta e che è caratterizzato da un nuovo , impetuoso ed emergente
208
M. Migliori, cit. pp. 1345-1346.
fenomeno; tale è l’imporsi e il diffondersi in larga scala di una comunicazione
pubblica spettacolarizzata ed intrecciata con le esigenze ed i calcoli della
propaganda di un ideale paraculturale e paraeducativo di una vita sociale
influenzata e corrotta dalla voglia diffusa di supremazia e di conflitto per il
conflitto.
n) di questo contesto c’è un breve accenno nel Parmenide nella figura di un
Aristotele, a cui piace a farsi vedere in compagnia di intellettuali illustri e che
è vocato ed attratto dalla sirena della tirannide; queste informazioni che
Platone ci dà in stile incidentale sono segnali precisi per farci intendere perché
è questo Aristotele ad essere scelto per accompagnare da interlocutore il
Parmenide impegnato in una ‘cavalcata’ argomentativa; e qual è il senso della
battuta finale |Verissimo | che Platone gli mette in bocca. Se facciamo valere
ancora il criterio per le quali sono le Azioni che fanno il Carattere, allora le
azioni a lui attribuite scenicamente, nel suo presente e nel suo futuro, ci
dicono –mi sembra- questo : egli è uno che finisce per non capire e ,quindi,
per fraintendere il senso della impostazione di un discorso dove –per così
dire. vengano figurati degli ‘omnes’ ‘contra omnes’ e così rappresentata una
radicalizzazione della contrapposizione; la sua finale esultanza è il sigillo della
sua implicita convinzione che Parmenide avrebbe dato con la sua performance
la dimostrazione che il conflitto sarebbe la vera legge della realtà terrestre e
cosmica.
Questo Aristotele è, perciò, un giovane intellettuale contaminato dagli effetti
di quel sofisma, di cui ho più volte richiamato l’essenziale ruolo in ogni dialogo
platonico.
Questo |Verissimo| dell’epilogo retroagisce sul prologo e ci aiuta ad
intendere la grave preoccupazione che è alla base di quella delegazione di
“veri filosofi” venuti da Clazomene, la patria di Anassagora, scopritore
dell’uno-nous. Se la questione non fosse di fondamentale e decisiva
importanza, se essa non coinvolgesse la prospettiva stessa della ricerca sulla
necessità di un principio. non si giustificherebbe la loro peregrinatio di fonte
in fonte, per accertare con sicurezza che cosa effettivamente si dissero
Socrate, Parmenide e Zenone intorno ad una questione così cruciale .
Il Platone del Parmenide, dunque, rilancia -in forma spettacolare ed in una
trasformazione mirabile, che investe sia la problematizzazione sia la
dimostrazione-, da una parte la dalettica di ispirazione zenoniana procedente
per riduzioni all’assurdo e dall’altra l’affermazione parmenidea del primato
della persistenza necessaria ed universale dell’ Essere contro la falsa opinione
di un assoluto divenire. Platone,poi, dimostrerà nel Teeteto che l’enunciato
|tutto è solo uno scorrere-un flusso/ si autoconfuta; infatti, c’è qualcosa che
non scorre e rimane fermo ed è la pretesa verità ,che si intende affermare, di
questo enunciato. La dottrina dell’assoluto divenire non ha dgnità di dottrina,
ma è solo un sofisma e,perciò, impiega una falsa immagine logica del divenire
stesso.
Platone opera una sintesi tra principio del Medesimo e la dialettica dei
contrari, trasformando il problema, riutilizzando su un altro livello il
procedimento per assurdo,innovando la modalità funzionale della
dimostrazione, valorizzando al massimo la via del gioco giocato.
Su questa base credo di potere rischiare di dichiarare, in maniera non arbitraria, che
la posizione del Migliori, che intitola il suo penultimo paragrafo “ la contraddizione
mortale del platonismo”209, è fondata sì su una vasta massa di dati testuali e di
confronti critici con i risultati della letteratura secondaria, ma la moltitudine di
questi dati condizionati tutti da una visione della teoria che non è funzionalmente
congrua al modo proprio originario in cui Platone fa teoria con la sua peculiare
testualizzazione.
Mi rendo conto che ‘‘l’ho fatto grossa’, assumendo questa posizione; ma la
provocazione viene dalla stessa opera platonica se letta ‘iuxta propria signa et
principia’ e se questi signa-principia vengono riconosciuti nella consapevolezza che il
confronto con Platone obbliga ad un intenso e continuo reset del modo in cui siamo
abituati, per tradizione consolidata ed educazione permanente, a considerare e
valutare un testo filosofico e la natura della teoria e del linguaggio filosofici.
Platone non “ha avuto diretti continuatori”, proprio perché egli realizza una
discontinuità funzionale-paradigmatica sul concetto di comunicazione filosofica e di
elaborazione speculativa. Questa discontinuità affonda le sue radici nella particolare
natura storico-culturale e funzionale del problema che Platone deve affrontare e
viene affermata sia per differenziarsi dai una attività riflessiva prodotta secondo il
paradigma della trattazione dottrinaria . e sia ,ed ancora più radicalmente, per
stabilire una distanza dal paradigma di una logica-dialogica con un primato
dell’esplicito.
Perciò, Platone non è un capitolo pur fondamentale della storia della filosofia; egli è
appunto un’Altra storia, che non ha avuto continuatori sia per le mutate condizioni
del contesto socio-culturale post-platonico e poist-aristotelico, e sia perché Platone
è stato gravemente ‘sottovalutato’ nella sua potente,immens,complessa e feconda
originalità teorica e sensibilità problematica.; nonché fraintesto nel suo lungo e
profondo rapporto con iil massimo dei suoi discepoli, cioè Aristotele.
Questa sottovalutazione è riconducibile anche al fatto che il lettore adatto di
Platone è chiamato ad attrezzarsi di conoscenze previe tutt’altro che semplici e facili
Questo lettore,infatti, non può entrare nello spazio segnico dei suoi scritti, se non
dispone di una conoscenza essenziale dello spirito della logica-matematica
209
M. Migliori, cit., p. 1343.
platonico-euclidea e dell nucleo costruttivo-funzionale della grammatica della
drammaturgia attica del V-IV secolo. Senza una maturazione sufficiente di questi
prerequisiti è inveviitabile che si imponga il fuorviante modo accademicodottrinario di leggere i testi platonici.
Queste competenze ebbe certamente l’ Aristotele210 matematico-portato alla luce
da Toth- e l’Aristotele autore di trattati come ,ad esempio, quelli della Poetica e
della Retorica. Ma questo Aristotele non è direttamente e funzionalmente
riconducibile al Platone Scritto,proprio perché questo non è riconoscibile secondo
l’applicazione prevalente del modo dottrinario tipica di Aristotele, codificato nella
forma-trattato. Ma non per questo Aristotele soprattutto in questi terreni sarebbe
anti-platonico o non platonico. Anzi ritengo che proprio in queste indagini Aristotele
sia il più fedele prosecutore del Platone ispiratore e guida delle ricerche tecnicoepistemiche del lavoro accademico. Il problema enorme allora è quello di stabilire il
rapporto tra Platone scienziato e dottrinario ed il Platone autore di dialoghi, in cui
l’elemento-dottrina non solo è mescolato con l’elemento –Racconto, ma è
subordinato ad una teorizzazione come gioco giocato.
Accenno qui ad un problema che non oserei neppure nominare a ragione della sua
complessità e della mia attuale impreparazione ad affrontarlo, se non fosse
collegato a quella osservazione del Migliori sul Platone che “ non ebbe diretti
continuatori”. Se è impensabile ed incredibile un Platone non scienziato, per tutto
quanto è stato detto a cominciare da Friedlander211 sul Platone ‘politencnico’
(giurista, urbanista, linguista, logico,matematico, esperto di drammaturgia e di
medicina, di geografia..psicologo, moralista e teologo), allora dobbiamo poter
pensare il rapporto di discontinuità che esiste tra questo Platone con competenze
‘enciclopediche’ ed il Platone Scritto. Aristotele dell’opus aristotelicum purtroppo
non ci aiuta a venira a capo di questo fondamentale problema, che ,dunque, prima
di riguardare il rapporto tra Platone e la filosofia post-platonica, è interno alla
attività culturale stessa di Platone, che sembra sdoppiarsi in due progetti distinti e
reciprocamente discontinui, ma certamente non assolutamente separati l’uno
dall’altro. : la promozione e lo sviluppo e la sistemazione di programmi tecnicoepistemici da una parte, e dall’altra l’instaurazione del Memoriale di Socrate come
programma di una riforma intellettuale, educativo e morale dei gruppi dirigenti
dell’Ellade prossima alla catastrofe politica.
La Scuola di Tubinga e di Milano non ha risolto questo problema, che è funzionale e
strutturale e non unicamente tematico; essa ha, però, avuto il merito di averlo
portato alla ribalta, sia pure in un forma- quella del rapporto necessario ed
indispensabile con Dottrine non scritte’-, che ha finito per ulteriormente
complicarlo.
210
211
La causa di questa complicazione consiste nel non rendersi conto che il rapporto tra
i due Platoni non può essere impostato proiettando ed inserendo organicamente i
temi delle dottrine non scritte su i testi platonic, facendole valere come
“Idee.Chiave” di decodificai; ciò è scorretto per la ragione che a conservare la
differenza funzionale-strutturale è proprio il fatto che quelle ‘orali’ sono date
secondo il modo |DDP|, mentre i contenuti filosofici del Platone scritto sono
generati da una matrice mista e secondo una logica prevalente dell’implicito;
implicito che non è un generico ‘dialogico-ironico’, ma la problematizzazionesemantizzazione-concettualizzazione per |GG|.
Non è, perciò, un caso che gli esponenti di quella Scuola non riescono a riconoscere
la portata teorica dell’elemento /Racconto, che viene derubricato a bella scrittura,
ad espediente comunicativo-didattico in funzione psicagogica-protrettica e di
esemplificazione di messaggi complessi.
Ed allora come deve essere pensato questo rapporto di discontinuità, che non
significa né separazione, né omogeneità organico-funzionale in termini di attività
cognitivo-linguistica ?
Questo snodo strategico interno alla discorsivizzazione platonica non è stato visto né
da Aristotele e né dai neoplatonici, né tanto meno dalle scuole che nel nome di
Platone e di Aristotele si sono talora contrapposte ,anche se poi soprattutto nel
medioevo il platonismo è stato aristotelizzante e l’aristotelimso platonizzante
212
(Vansterbergen)l, Perciò, proprio per questa mancata esplorazione e sistematico
sondaggio della natura cognitiva di questa discontinuità, Platone non ha avuto
“diretti continuatori”.
Tale nodo costruttivo rimanda alla questione di |‘Platone e le Technai’|; l’ho
affrontato per quanto mi riguarda nella mia interpretazione del Teeteto in
riferimento alla techne-episteme213 geometrico-matematica; ad essa rimando.
Ed ora faccio solo questa osservazione : la costante attenzione prospettica di
Platone verso i campi dei vari e molteplici saper fare non è mappabile né con il
paradigma degli “analitici”, né con quello dei “continentali”214; e tanto meno con
l’altro proprio degli ermeneutici che si ispirano a Gadamer215., che nei suoi “Studi”
non scorge la funzione positiva ed costruttivamente indispensabile dello sguardo
platonico sugli ambiti metodici.
Né l’approccio socio-culturale- politico216 nè quello critico 217 storico-gnoseologico218
(Hosle), né quello proprio di una storia delle idee 219(P. Pritchard) sono sufficienti per
212
Van Stenberghen
213
Per questa espressione cf. Ione.
D’Agostini
G. Vattimo
G. Cambiano
214
215
216
217
218
219
Adorno
Hosle
Pritchard
capire dal punto di vista cognitivo-linguistico che cos’è la platonica filosofia della
matematica.
Certo essa non è una epistemologia e, tuttavia, la presuppone come necessaria
conoscenza previa, perchè si possano capire i i cosiddetti ‘esempi’ tratti dal campo
dei risultati della ricerca matematica greca.
Perciò, sia che parliamo di ‘analitica’ platonica dello statuto delle Technai e sia che
cerchiamo in questa direzione la sua dialettica, dobbiamo essere consapevoli di
questa grande difficoltà di trovare in tutta la tradizione filosofica post-platonica un
aiuto decisivo per venire a capo della natura di ciò che Platone effettivamente ed
teoricamentefa con il suo rinvio al numero-misura/metron ed alle
figure/diagrammata.
Naturalmente, questa difficoltà scoraggiante non è dovuta agli effetti anche sul
Platone-matematico di quella presunta “contraddizione mortale”, ma alla
sistematica sottovalutazione di fatto220 del Platone dei giochi logico-matematici in
forma di rebus metaforici- cartterisitici soprattutto del Teeteto- e alla perdita di vista
del ruolo fondamentale che ha nella sua opera la polemica non contro il movimento
sofistico della storia221, ma contro quel sofisma che si eleva a menzogna ed
influenza fortemente la comunicazione pubblica intorno alle “Cose Massime”: il
sofisma di Callicle nel Gorgia richiamato da Trasimaco nel I libro di Repubblica. e che
riemerge in Leggi sotto forma della falsa legge fondamentale della guerra assoluta.
Quel sofism di cui Platone offre – lo sottolineo di nuovo- un potente abbozzo
funzionale generale nell’epilogo del Sofista con il termine |Dossomimetica| e che è
il protagonista negativo ben in rilievo in dialoghi come ,ad esempio,l’Eutifrone, lo
Ione, il Carmide. Quel sofisma che non è riducibile ad errore tecnico e che gli stessi
illustri ed in buona fede Protagora, Gorgia. Ippia non sanno mappare’ e riconoscere
nella sua causa funzionale e nel posto che occupa nel territorio dei logoi, e nell’Ippia
minore questa impotenza e smacco viene allo scoperto in una forma che più ellittica
non si può. Quel sofisma,infine, che sta sulla scena dell’ Apologia e che arma i logoi
della accusa a Socrate e che sta sul fondo in opere apparentemente senza polemica
con lo Pseudos, come il Timeo, il Politico, il Simposio, il Cratilo, il Filebo.
Ed allora come si può uscire da questo imbarazzo e paralisi ?
La filosofia platonica della matematica appartiene ad una attività metamatematica,
che è una metalogica analogica, per la quale la techne-episteme geometricomatematica è considerata un ‘Fatto-Garanzia(omeros; cioè una campo di valori
cognitivi validamente dati e come tali omologati dalla comunità dei matematici.
Dunque, in Platone la filosofia della matematica non costituisce un perfezionamento
sistematico dei principi della matematica come,invece, ad esempio, naturalmente in
un altro contesto storico-culturale, crede Kant222 quando pensa al rapporto tra la
220
221
222
Sedley, Ferrari
Untersteiner, Casertano
I. Kant
sua analitica trascendentale della prima Critica e lo statuto della fisica-matematica
galileiana-newtoniana.223 .
L’attenzione platonica alla matematica accade,infatti, non per esigenze e problemi
interni e propri di essa ; perciò, essa non mira a correggere – come,invece, crede F.
Adorno- prodotto o metodi di essa; e neppure pretende essere determinante nel
raggiungimento di una adeguata autoconsapevolezza teorica della natura della
matematica – come, invece, pensa Gadamer interprete del Teeteto e della nozione
di Aisthesis, che egli intende come |evidenza|.
Al contrario questa regina delle Technai ci offre un campo ricco di paradigmi e di
operazioni paradigmatiche, rispetto ai quali dobbiamo azionare un procedimento di
metaforizzazione concettuale, di ripresa analogica, per abduzione-sussunzione di
elementi essenziali dei loro nuclei statutari- funzionali . e di trasferimento di questi
in un territorio non di super- logica matematica, perché il suo problema.guida è
extra-matematico; tale è la necessità platonica di smascherare la phainomeno-logia
eristico-sofistica che dal punto di vista funzionale è una cattiva metalogica operante
per pseudo-immagini logiche anche dell’essenza della matematica. Il matematismo
è un caso di ‘dossomimetica’, cioè di scorretta metamodellizzione della essenza
della matemtatica connessa ad una sua indebita assoluta generalizzazione nella
sfera della cultura.
Quando,perciò, Platone fa esempi tratti dalla matematica e guarda a questa come
campo d’origine di valori cognitivi egli lo fa per questo scopo metodico e per istituire
quella generale premessa omologa che sostiene la catena inferenziale che sta a
servizio di questa falsificazione. Falsificazione che si fa vedere spesso come
incoerenza dell’interlocutore di Socrate rispetto a quella che pure inizialmente ha
ammesso; così accade con Eutifrone che accetta di riferirsi all’ambito del numero
nella indagine sul rapporto parte-tutto.
E quando sembra che sia lo stesso Socrate incoerente, allora qui Socrate sta in una
alleanza terapeutica, cioè ragiona dal punto di vista dell’avversario per portare per
linee interne alla implosione ed all’autocontraddizione le posizioni di quest’ultimo,
Nel Teeteto, ad esempio, Socrate ostetrico nella indagine sulla natura della
conoscenza e su quella dell’errore, ragiona fino alla fine dal punto di vista di un
Teeteto vittima del matematismo e che, perciò , non è in grado di inquadraresquadrare-tassellare quell’ errore speciale che è il sofisma. Naturalmente questo
messaggio è identificabile solo se ci poniamo sull’ asse autore-lettore adatto e se
non emarginiamo l’elemento narrativo del prologo e dell’epilogo e sappiamo
cogliere la pregnanza di spirito matematico soprattutto nella metafora della voliera.
In conclusione : la platonica filosofia della matematica è una analitica metalogica
analogica il cui scopo è formare metaparadigmi analogici da usare come criteria
operandi per la falsificazione dei logoi direttamente di matrice eristico-sofistica e
223
Mathieu
indirettamente influenzanti visioni paraculturali e paramatematiche. Una
emblematica di queste è l’abuso -nel contesto di una comunicazione pubblica sulle
“Cose Massime”, della formula protagorea “L’uomo è misura/metron di tutte le
cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non
sono”. E,perciò, quella attività analitica ‘sui generis’, che non si scioglie nella
epistemologia matematica e che non costituisce una superepistemologia,
gerarchicamente ed organicamente sovroordinata a quella, è strumentale e
funzionale allo smantellamento di una pseudo-dialettica, di una pseudo-metalogica
analogica che si avvale di pseudo-metamodelli, di false immagini metalogiche.
Per tutto ciò, le moderne ottiche interdisciplinari e transdisciplinari non possono
catturare il Platone di una metalogica analogica poliprospettica , ‘politecnica ed
‘enciclopedica’: ed in Platone lo stesso suo sguardo profondamente analogico e
costantemente rispettoso della pluralità dei diversi saper fare e della autonomia dei
loro domini, ci addita e proietta in un territorio dell’operare analogico, unico ed
eccezionale, originalissimo ed inimitabile; perciò Platone non poteva avere ‘diretti
continuatori’. E mi spingo ad aggiungere che tra i post-platonici e tra i moderni un
solo filosofo si è avvicinato a lui senza,però, avere la sua acutissima sensibilità
linguistica e metalinguistica e la sua preparazione matematica, senza in fondo
saperlo ed anzi- almeno nella “Critica della Ragion Pura”- contro di lui : I. Kant.
Ma non il Kant del neo-kantismo , che emargina la valenza di principio di
orientamento fondamentale delle “dialettiche trascendentali” o il Kant elevato a
capostite dei moderni filosofi della scienza 224, dove la filosofia è ridotta nel migliore
dei casi a precorritrice e stadio aurorale della moderna e contemporanea fisicamatematica: o –tanto meno- il Kant di Hegel autore di una superfilosofia di una
supermatemtatica, che non fa bene alla filosofia e che non serve alla coscienza
teorica del lavoro matematico.
Il Kant prossimo a Platone è quello che dichiara che la “critica” non è una “dottrina”,
ma un “esame”, e che il suo fondamentale bersaglio sono le “sofisticherie”, la paraepistemologia a servizio di una cattiva teologia ‘scientificata’, la para-etica a servizio
dell’utilitarismo , la parafiosofia relativistica e scettica della poesia e del bello a
servizio dell’arbitrio soggettivistico.
Questo è il Kant che non rinuncia alla metafisica, alla metacognizione ed alla
metalogica,- proprio perché di fatto egli le fa con le sue tre “Critiche”-; questo è il
Kant,invece, che vuole purificarla e liberarla da pretese illegittime e da
inammissibili unilaterali riduzioni ed indebite generalizzazioni.
“Sofistecherie strumentali a giustificare politiche culturali paternalistiche
,autoritaristiche,dispotiche, illiberali, tiranniche: tutte convergenti a trattare
l’umano come mezzo e non come fine; “sofisticherie” che non tengono conto della
finitudine dell’uomo che non è un dio e non lh energia noetica divina ed il cui
“Intelletto”/Verstand è ‘naturalmente’ tentato di degenerare in una “ragione”/Vern
224
Popper, Giorello,
unft che non riconosce limiti dentro se stessa e che finisce per considerarsi
onnipotente, misura di tutte le cose, dell’ Essere e del Nulla. Diversamente da come
interpreta Heidegger il pensare che Kant opera non è prigioniero di un ‘intelletto
scientista’, cieco di fronte a quanto di importante ha da dire ad esso la ‘sensibilità
immersa nella vita’;225 tant’è che esso è capace di andare oltre di esso proprio con
un’attività di “ esame” che chiama in causa, ‘in tribunale’. le “sofistecherie” che
fanno parte essenziale dell’armamentario degli arcana regni strumentali alla libido
dominandi che imperversano nel ‘mondo della vita umana’ di ogni tempo e
scendono in campo soprattutto quando di tratta di giustificare la necessità delle
guerre di conquista; Platone direbbe : ogni volta che il tiranno ed il demagogo ha
bisogno di dare apparente dignità culturale e morale al sofisma di una giustizia come
l’utile del più forte.
Tutto questo excursus, appena svolto, mi aiuta adr affrontare due particolari ma
rilevanti questioni, che sono importanti per il discorso sulla legge dei contrari , sul
rifermento al numero ed all’eguale in sé, nel Fedone: la prima attiene all’impiego del
megaparadigma “Grande e Piccolo” – di cui si parla nelle Dottrine non scritte- nella
indagine sul tema del bene-male ; la seconda ad essa connessa è quella del relazione
Ordine-Disordine e di uni-molti.
Mi occupo ora della prima .
Se contenstualizziamo l’impiego in Platone di quel megaparadigma – e non
possiamo non farlo per tutte le ragioni fin qui da me addotte e relative alla
platonica filosofia della geometria-matematica- è inammissibile sulla base dei suoi
fondamentali presupposti teorici parametrare il male come “energia
distruttiva”/kakourghein secondo il criterio del massimo | Piccolo| di quel estremo
superiore della scala del |Grande!.
Spero di spiegarmi meglio . Che cos’è il male ? Unde malum ? Il male si dice in molti
modi : si può dire come privazione relativa di un bene e da attribuire ad una varietà
di cause: naturali-biologiche, socio-culturali, di insufficienza morale-educativa,
quelle di una cattiva sorte; ognuna di queste considerata da sola, o nella interazione
con alcune delle altre, o anche tutte insieme.
Ma c’è un altro modo in cui si può dire il male; ed è quello dato da quel termine che
appare nell ‘ Eutifrone226 , dove l’omonimo giovante teologo esperto nell’arte dei
vaticinii rimane impressionato dal venire a sapere che Socrate è stato accusato e
trascinato nel tribunale dell’arconte re, competente nel giudizio su reati-peccati.
Platone rimarca questo effetto di disorientamento grave che colpisce questo
giovane amico di Socrate facendogli esclamare ciò che così esplicito : ‘Come si
permettono di accusarti di un reato di empietà ? Non sanno che così facendo è
come se si accingessero a distruggere il tempio del ‘Fuoco Sacro”, di Hestìa ?’.
225
226
Sull’umanità , sul il senso del concreto e della storia di Kant avevano insistito interpreti come…
Eutifrone
Questa metafora di una Socrate/Hestia,di un Socrate/Luce-Fiamma sacro-santa della
Città, mentre costituisce un potente colpo di scalpello svelante e che fa uscire fuori
un tratto del Volto di Socrate pregno di senso liturgico-etico-teologico, apre anche
indirettamente ad una visione platonica del male non come Privazione-DifettoDebolezza-Incompletezza; ma come altro.
Che cos’è questo |altro| ? Seguendo l’asse semantico di quel termine veniamo a
sapere che esso è kakia/cattiveria ed energia/energheia, non, dunque, una
‘cosa’/ente.
In quale altra opera potremmo vedere trattato e sviluppato questo tema ? A quale
dialogo si potrebbe assegnare come sottotitolo quello di |De malo | ?
Rispondo : a nessun dialogo in particolare, perché esso è trasversale ed in maniera
fondamentale a tutta l’opera scritta platonica. Naturalmente non nella forma di una
dottrina, ma dentro l’impostazione di quella fuga nei logoi che è al centro del
Fedone e che riapparirà come l’ oceanico spazio del “mare di logoi” nel Parmenide. ,
e come lo scorrere di un fiume nel Teeteto .
L’esame /skepsis e la osservazione/skopein e la esplorazione/diascopein del male
hanno, dunque, una via obbligata : quella del linguaggio; meglio : quella della
comunicazione pubblica spettacolarizzata intorno alle “Cose Massime”.
Ed in questo spazio-tempo , in questo così essere-situati, che il male fa la sua
apparizione, si concentra e si condensa in un colpo ad effetto, che ha una capacità di
attrarre e di illudere quasi smisurata e travolgente .
Esso si fa vedere in logoi , in paralogoi ben truccati che simulano l’Ordine attraverso
gli espedienti e gli ingredienti di una ‘cosmetica’ ed gli effetti speciali propri del
piacere-gioia della partecipazione ad un banchetto ricco di cibi raffinati e rari; essi
simulano l’emozione dell’essere invitati ad una festa e fanno il verso allla sua dolce
ed entusiasmante atmosfera. Questo è rispettivamente lo scenario introduttivo
della “Apologia” e del Fedro e del Gorgia.
Per questa via e con questi mezzi il male si mostra come male del discorso, del
metadiscorso; e si mostra come ‘malattia’ della mente contaminata e stregata da
quell’ potere di lusinga e di illusione iniettato nel sangue del dire e pensare da una
formula magica che aggredisce e blandisce con la sua satanica ambiguità : “il giusto
è l’utile del più forte”. La bestia a più teste e che costituisce una caricatura di Proteo
dalle mille facce, che atterrisce ed affascina. è questo Sofisma-Menzogna.
IL male,dunque, come ‘energia cattiva distruttiva” può essere detto, può essere
identificato, qualificato, cacciato, stanato ,smascherato e denunciato come
distruzione del senso, come anti-comunicazione, come anti-linguaggio, come antipensiero; come distruzione del bello, della verità, dell’utile sociale, del bene.
Ed allora questo male è programmaticamente e sistematicamente anche AntiOrdine, cioè non Disordine stimolante e coogenerante l’Ordine. ma lo scatenarsi di
‘forze distruttive della possibilità stessa che un Ordine ‘giochi dialetticamente’ con
l’inimicizia-amicizia del Disordine.
Per Platone giammai quell’Anti-Ordine che è il sofisma-menzogna può appartenere
all Cosmo-Loghia generato dalla cooperazione competitiva di
quelle due
fondamentali modalità della realtà e della razionalità.
Tutti gli esercizi-giochi platonici sono finalizzati a provare e far vedere perché e
come il sofisma è molto di più che disordine logico e linguistico; esso è l’iimmoraliità
di un metadiscorso che si rafforza con gli espedienti della paracomunicazione
spettacolarizzata dove non c’è nulla di verace, poiché tutto è strumentale a
catturare a qualsiasi prezzo l’adesione dell’uditorio, il consenso della moltitudine; a
plagiare l’anima dei giovani, ad adescare gli stessi intellettuali anziani.
Perciò non è applicabile a questo polemos la legge dell’unità dei contrari, perché la
menzogna non sta nella ‘colonna’ dei negativi sussistenti e coesistenti in una
relazione essenziale.organica e in tensione con i positivi corrispondenti ed a loro
volta ‘incolonnati’. Le sue immagini logiche non sono immagini contrarie a quelle
della esperienza della verità del bene e del giusto; esse sono Anti-immagini , quelle
proprie di una phantasmalogia.
Per queste fondamentali ragioni il megaparadigma Grande-Piccolo non può essere
impiegato per pensare il male, soprattutto una volta che abbiamo riconosciuto che
quello trova la sua più valida ratio essendi et congnoscendi nel saper fare
caratteristico della techne-episteme geometrico-matematica.
L’irrazionale- il cosiddetto incommensurabile del’estremamente piccolo-- in cui essa
si imbatte non è la prova che essa sperimenterebbe lo scontro con una antimatematica, con un Anti-Numero. un’Anti-Figura; il disordine matematico è ancora
ad un diverso livello ordine matematico, una diversa qualità e modalità di calcolo e
di misura, di teorematizzazione, con l’apparire di un nuovo campo di problemi.
Alla formazione del messaggio finale del Teeteto è essenziale la dimostrazione
platonica che l’ anti-razionale del sofisma non è l’irrazionale227 proprio della ricerca
matematica; e su questa base, perciò Platone potrà dire al suo lettore che questa
non dispone in sé delle armi culturali, logico e teoriche, per catturarlo e smontarlo
nella sua illegittima pretesa di valere come momento necessario endogeno al fare
verità.
La geometria –matematica non può per un ‘naturale’ ed intrinseco limite, misurare e
figurare il non essere del sofisma, perchè iquesto è un anti-essere, l’energia cattiva
di forze distruttive dello stesso concepimento e nascita dell’essere. Il male sta in un
scontro radicale con il bene; cioè esso è assoluta distruzione che punta ad
annientare le radici stesse dell’ agire buono e giusto, del pensare la verità di questo
agire
Sul rapporto in generale tra sofisma ed irrazionalità vitalistica in un prospettiva crociana cf. R.
Franchini, Sofisma e Libertà, Giannini, Napoli, 1971227
Ora che Platone non abbia avuto “diretti continuatori’ in questa concezione del
male non è dovuto alla presunta interna “contraddizione mortale” che la
caratterizzerebbe, ma al fatto che questo Platone è di una grandezza, profondità ed
acutezza tali che né la tradizione aristotelizzante, né quella neo-platonica hanno
avuto il coraggio e la capacità di vedere, di intendere, continuando la ricerca in
questa direzione.
La fissazione del sistematicismo, quello che non tollera i dualismi di nessun genere e
che ha la mania della imposizione di una assoluta ‘lex continui’ ed il terrore di scontri
che non prevedono mediazioni e compromessi, non può accettare questo Platone
inquietante ed irriducibile.
Il più tenace ed il più armato. tra i moderni. in questa aggressione alla prospettiva di
un dualismo radicale tra bene ed una male come pura potenza distruttiva è W.
Hegel.
Non a caso egli preferirà il neoplatonismo e Proclo a Platone; e si schiererà con un
Aristotele che avrebbe ‘superato’ Platone proprio sul terreno della messa a bando
di ogni assoluta separazione nell’ ordine del reale e del razionale, valorizzando il
positivo, le singolarità sostanziali, la continuità e la energia eterna della sola vita, che
ingloberebbe in sé il male come necessaria ‘ via crucis’ed antitesi organica
indispensabile per il trionfo del bene.
Questa legittimazione culturale e filosofica di ciò che Platone chiama Pleonessia,
Agostino |libido dominandi|, il platonico T- More228 nei suoi scritti del carcere |leo
rugens quaerens quem devoret| e Kant |male radicale| , l’ultimo Croce |AntiCristo|229, Florenskyi |la cattiveria del giorno|, costituisce la madre di tutte le
questioni; quella che naturalmente non può vedere né una filosofia ridotta a
moderna epistemologia e ricerca interdisciplinare, nè una filosofia che si
riappassiona – è sta accadendo anche ai nostri giorni 230- ad una ontologia ed ad
una metafisica , dove, però, l’oblio del problema della menzogna e del ‘male
radicale’ sembra programmatico e sistematico.
Che Platone non abbia avuto e non abbia dei continuatori è, perciò, un gigantesco
fatto storico e culturale; ma come ogni giudizio di rilevamento di fatti esso è carico
di teoria e,quindi, anche di cattiva teoria; almeno nella misura in cui questa
discontinuità di fatto viene considerata coincidente con un giudizio di valore su un
aspetto centrale della filosofia di Platone.
Al più grande dei logici della antichità – quello che maneggia e padroneggia la logica
geometrico-matematica al punto di permettersi metaforizzazioni concettuali ardite
e vertiginose di alcuni suoi essenziali moduli operativi-,a questo Platone non
sarebbe mai potuto sfuggire la presenza di una “contraddizione mortale” dentro le
228
229
230
T. More, Dialogo del conforto nelle tribolai azioni, e De Tristitia Domini.
B. Croce
M. Cacciari
Ferraris
fondamenta del suo impianto di teorizzazione. C’è, invece, in Platone un operare per
contra-dictio che implica un terminus contra quem tuto speciale ed ccezionale.
Questo operare è un Pensare l’Anti-pensiero. Dire l’anti-verbum, Immaginare l’Antiimmagine, teorizzare l’Anti-teoria – per mascherarli e denunciarli come
inconsistenza ammaliatrice e terrificante; questa è la sfida, segnante un
oltrepassamento epocale- che Platone decide di affrontare e mettere in opera nella
sua ‘Odissea di Attraversamento dei logoi pubblici spettacolarizzati’. Ed in questo
attraversamento e in un tutt’uno con il suo movimento emergerà anche una nuova
visione della stessa contra-dictio, della anti-logica, dell’elenchos, della negazione,
della negatività. della mortificAzione, del mortifero.
Platone in questa prospettiva cercherà di pensare il ‘luci-ferino’, cioè quella
allucinazione, che nella menzogna si ostenta come più potente luce e promessa di
una più intensa e ricca vita, e di una primigenia verità.
Si può allora confinarlo nell’inattuale ed in ciò che è morto definitivamente in una
‘contraddizione mortale’ ? Non c’è il rischio che per questa strada, senza volerlo ed
in buona fede, si dia un contributo decisivo – proprio per la vasta e documentata
ricerca del Migliori- per un nuovo seppellimento, dopo un ennesimo involontario
parricidio. del padre della filosofia ?
Contrari,opposti, contraddittori : questi fattori-attori, essenziali nel gioco che
Migliori storico della filosofia platonica ricostruisce, inevitabilmente spostano il
confronto con la sua ricerca su un livello logico e teoretico . Sottovalutare questo
aspetto equivale a mettersi nelle condizioni anche per fraintendere il testo
platonico. Naturalmente l’esame di queste stesse nozioni deve partire dalla
consapevolezza che esse sono state indagate da Platone non solo in sede di scienza
logica – di quella scienza che il suo discepolo Aristotele ,tenendo conto delle lezioni
del maestro, porta a perfezione sistematica in una formalizzazione disciplinare., ma
su quel terreno metalogico analogico che egli istituisce performativamente, cioè in
uno con la sua lunga e variegata esecuzione.
Per non allontanarmi troppo dal merito specifico, dirò subito che il problema del
sofisma è in Platone non trattabile rimanendo nel campo di una tecnica logica e
linguistica, e in questa senso nell’ottica dell’ Aristotele ‘scienziato logico’, autore di
una logica formale tanto apprezzata dallo stesso moderno Kant.
La fondamentale lezione platonica è appunto quella che prospetta e stabilisce ‘ in
opere operato’ il problema-tema del modo di produzione sofistico dei discorsi come
fenomeno metalogico e metalinguistico intimamente connesso ai processi di
comunicazione sociale; di quel sociale che sta in rapporto diretto con i bisogni dei
ceti dirigenti e degli apparati istuzionali-statali di influenzare la sensibilità e
mentalità degli individui associati in gruppi familiari , in classi e corporazioni, in
comunità culturali.
Per avere un termine di confronto moderno, indico per linee molto generali il campo
della ideologia231 come quello più adatto per un primo orientamento in ciò che ho
sopra chiamato Phantasmalogia Dossomimetica.
Dello spetto semantico di ideologia nell’accezione moderna , il concetto di falsa
coscienza e di auto illusione, con le caratteristiche ammalianti ed decettive proprie
dell’onirico e del magico, è quello rinvenibile in più luoghi ed in più momenti nello
stesso Platone. Ma è anche platonica la scoperta della relazione originaria tra questa
falsa coscienza-distorsione linguistica ed una volontà di una più potente e piacevole
vita in città, dove desiderio erotico e piacere del mangiare insieme e del fare festa
insieme svolgono una funzione di prim’ordine. La brama della massima visibilità ,
della fama. della gloria costituiscono il grado più alto di questa ‘volontà di vita
potente’. fino a quello della tentazione di voler essere considerati come dèi.
La forza e la complessità del modo di produzione eristico-sofistico dei discorsi su i
valori e su i costumi dipende dalla sua capacità di strumentalizzare per i suoi calcoli
persuasori questi modi di vita, questi mondi emozionali ricchi di immaginazione.
Platone né e pienamente consapevole e,perciò, egli pensa e realizza la sua scrittura
come testualizzazione spettacolare e teatralizzante; e dà tanto rilievo al metaforico
ed al simbolico.
Ma la sua preoccupazione è soprattutto quella di dar luogo ad una ‘magna
instauratio’ di una nuova logica capace di fare quello che la logica accademica non
sa fare perché non può , per statuto funzionale,. fare.
Le relazioni di contrario, opposto, contraddittorio vengono, pertanto, da lui riprese
ed immerse nel contesto di questo nuovo livello funzionale, che è condizionato da
Bechè oggi sia di moda parlare del nostro tempo come quello della ‘ fine di tutte le ideologie’,
in realtà questo presunto tramonto rimane l’orizzonte fondamentale proprio di un filosofara che
si afferma nella sua autonomia di sapere proprio come critica della comunicazione ideologizzata e
proprio a partire da quella variante sofisticata di essa che è la ripetuta falsa opinione della |fine di
tutte le ideologie|, Questo perdurante equivoco tutt’altro che innocente è stato reso possibile
anche a causa di una mancata adeguata chiarificazione formale, cognitivo e linguistica, dello
‘statuto’ funzionale del modo di produzione ideologico del discorso pubblico. Essa va realizzata
riconoscendo che Platone per primo ed in grado eccelso si è misurato con questo fenomeno della
condizione comunicativa della vita sociale e politica e lo ha fatto in relazione a partire dalla nessa
in primo piano di due aspetti fondamentali che sembrerebbero propri solo della epoca moderna e
del tempo del post-moderno : quello della città della comunicazione pubblica spettacolare e della
manipolazione ‘tecnicizzata’ della opinione pubblica, su cui ha scritto pagien importanti Chomsky.
di cui ad es. cf. Capire il potere.
E, perciò, quanto la “Scuola di Fraancoforte” con Horkeimer, Adorno, Apel, Habermas, Marcuse ha
inauguarato con i suoi programmi di ricerca va ripreso e rimeditato alla luce di questo Platone
critico della phantasmalogia dosso mimetica eristico-sofistica, alla quale può essere ricondotta
anche quella ‘ideologia del moderno’ partorita dal positivismo e dall’idealismo tedesco ed italiano,
e dalla riduzione della filsofia ad epistemologia ed a ricerca interdisciplinare.
Da questo breve accenno si può capire anche perché Platone è un punto di riferimento
ineliminabile nel dibattito sul cosiddetto “pensiero debole” e della rinascita della ricerca metafisica
e dello spirito di un nuovo realismo in polemica con la esaltazione del relativismo dei valori.
231
una esigenza metodica fondamentale : falsificare sistematicamente il sofisma,
considerato nel maggior numero di varianti possibili. E queste saranno tante, quanti
sono i suoi dialoghi.
Ognuno di essi, pertanto, ruoterà attorno ad una specifico ‘ruotare appariscente’
della fantasmagoria eristico-sofistica. Sarà, perciò, una “caccia” per una cattura di
una preda che colpisce e fugge, cioè si rende imprendibile a reti proprie del solo
livello della disciplina logica e di quella epistemologica.
Essa,infatti, è ambigua; si veste di panni paralogici e paraepistemologici; agisce da
parassita subdolo, da dolcificante velenoso , dopante, allucinogeno.
Perciò dovremmo tradurre platonicamente il termine moderno | Ideo- logia |. come
|phantasma- paralogia|.
Nel Fedone, il Socrate che va in soccorso ed in difesa del modello pitagorico di
pensiero e di vita e che in questa intenzione riprende fin dall’ inizio del suo
intervento la legge dei contrari, questo Socrate è appunto un Platone che guarda
analogicamente verso un contenuto importante di quell’inizio di scienza logica
rappresentato dalla dottrina pitagorica dei contrari.
Contrariamente a quanto interpreta Migliori, questo Platone,bperò, non si adagia
sulla presunta universalità e necessità di questa legge.
Per lui,infatti, essa va usata in ambiti precisi sia dell’indagine naturale-biologica che
di quella psicologica; ma Platone operativamente ci avverte che bisogna stare
attenti nel generalizzarla, perché la legge dell’unità dei contrari può portare a
risultati erronei ed inammissibili; e comunque ad aporie insormontabili e
logicamente a circoli viziosi.
Platone così argomenta facendo sua come “suppositio” la premessa generale di una
presunta validità illimitata di quella legge ; e così include nell’ambito del suo campo
di applicazione anche la relazione giusto-ingiusto, bello e brutto.
E’ appunto questo passo che costituisce l’innesto del punto di appoggio di una
catapulta che Platone far funzionare per ribaltare e riconvertire la impostazione
iniziale, prospettando il deragliamento in una contraddizione se l’applicazione di
quella legge anche al giusto-ingiusto venisse difesa e conservata.
Bisogna evitare questo deragliamento : se il giusto è giusto, cioè se si costituisce, si
afferma e permane nella qualità di questo essere-agire determinato, non può avere
dentro di sé quel contrario che si muove per annientare il suo costituirsi, il suo
svolgersi, il suo permanere in questo venire alla luce e crescere.
Il giusto non può autocontraddirsi ed ammettere in sé l’antigiusto. Dunque, la legge
dei contrari non è assoluta; e se applicata lì dove non deve esserlo, genera il non
sense proprio di una contraddizione logica, la violazione del principio di identità, di
non contraddizione.
Ma questo identico in Platone non un ente compatto ed immobile. ma è il
Medesimo che vive in una multiforme buona/bella energia di vita intelligente e di
una intelligenza fonte di tutta la vita, terrestre e cosmica, ed in una pluralità di
‘ordini cosmici’ distribuiti su più livelli distinti.
C’è, dunque, nell’ Inizio logico- ontologico di Platone la Posizione Assoluta di una
Cosa. Questa non è L’Uno astratto e separato; infatti, un tale uno è per Platone solo
il risultato di una erronea ed inadeguata immagine del rapporto tra principio
formativo-cosmicizzante ed i modi della Kinesis/processo. E la geometriamatematica – quella che sopra ho tratteggiato nel suo ‘esprit’- costituisce la grande
prova/mega tekmerion del perché e del come non si dà paradigmatizzazione/ l’in sé
di una idea-forma, la mia idea , se non come legge immanente unificante un
determinato processo di determinate variazioni.
Parlando di Posizione Assoluta ci viene in mente il concetto di Opzione-Scelta e,
quindi, ci si apre una prospettiva assiologica-etica . Non bisogna allora sorprendersi
e rimanere scandalizzati se Platone inscrive nel cuore dell’ Inizio logico-ontologico
dentro la sua metalogica analogica una Decisione Etica e che nello stesso tempo
Teologica. Questo a suo modo ed in direzione radicalmente contraria fa lo Hegel che
pone nel suo vero inizio non-detto l Atto di ’autoilluminazione dell’umano a se
stesso, rivelatore della sua eternità come specie tutta e solo storica, nell’ eventoannuncio del “tempo nuovo” del moderno con la sua straordinaria ricchezza e
complessità di vita culturale ed economico-sociale-istituzionale.
In Platone l’in sé del giusto, la sua viva assolutezza non si dimostra ma si sceglie;
questa scelta non è una azione arazionale o irrazionale, ma è una superiore azione
noetica, di un nous che si fa nell’operare buono che guarda ed ascolta il Bene Divino.
La verità che illumina e la illuminazione vera è tutt’uno con questo agire noetico e
comunitario. Fuori da questa Koinonia dobbiamo sospettare di tutte le illuminazioni,
perché non di rado sotto di esse si nascondono allucinazioni dagli effetti terribili ed
orribili.
A tali effetti appartiene la falsa opinione di un giusto al quale sarebbe congeniale ed
omogeneo l’ingiusto di una violenza distruttiva della vita; e di una verità che
avrebbe bisogno di alimentarsi di sofisma e di menzogna.
Tra i moderni non hanno avuto successo quelli che hanno cercato di non far
spegnere questa fiammella del pensiero platonico; la modernità ha preferito
un’altra strada ed ha interpretato il suo passato secondo ciò che di esso vede
rimanendo chiusi in questa.
Tale via ha anche esso nel suo nascosto inizio una opzione ed una esperienza di
‘illuministica illuminazione’ : l’opzione, la posizione assoluta della “Spirito” e della
sua “Eternità” : cioè la fede e la speranza umane, solo umane, troppo umane, nella
eternità della storia, della vita eterna del genere umano.
Per questo atto di fede l’immanentismo assoluto ha necessariamente bisogno di
estendere la legge dei contrari – raffinata e potenziata – anche al bello, al vero, al
bene; e, perciò, per la ferrea legge del suo postulato ha dovuto pensare il brutto
come coogeneratore del bello, il sofisma-menzogna come amica della verità, la
messa a morte degli innocenti, degli inermi e dei giusti, come via dolorosa obbligata
per la affermazione di una pretesa superiore civiltà, quella dei totalitarismi del
Novecento e delle due guerre mondiali nell’arco di meno di cinquantanni.
Il dio immanentistico è morto; ma il suo fantasma si aggira ancora in molti santuari
della vita culturale odierna, dove sembra che ci sia una gara a chi porta più
argomenti per la santificazione e la razionalizzazione definitiva dell’antirazionale,
della necessità della falsa opinione secondo la quale perché si affermi la giustizia
sarebbe legge storica quella del dover passare per l’antigiustizia dei più forti.
Concludo su questo punto richiamando l’attenzione su una distinzione dentro la
nozione di opposizione: nella logica scolastica e neoscolastica a questo proposito si
opera una differenza tra opposizione contraddittoria e quelle privativa, relativa,
polare, dinamica. Benchè Platone non fornisce un suo nome a queste relazioni
logiche che sono presenti implicitamente anche nell’ articolazione argomentativa
del Fedone, questo non significa che lui non sia stato capace di concepirle e di
averne consapevolezza logica.
Egli, infatti, in coerenza con la sua impostazione ed andamento in stile operativo, le
teorizza nel momento stesso in cui le impiega.
Quando parla della non ammissibilità di una applicazione della legge dei contrari ai
valori sommi Platone ci dice che il rapporto tra giusto ed ingiusto, tra bello e brutto,
istituisce una opposizione contraddittoria, cioè una esclusione reciproca
“illimitata”232 e,quindi, senza possibilità di mediazione tra i due termini;
diversamente accade nella opposizione relativa polare dei contrari. Qui i termini “si
richiedono reciprocamente , e ammettono un medio, ma non nella direzione in cui
c’è opposizione relativa” .
A Platone non sfugge che il dolore fisico alle gambe del suo Socrate incatenato in
carcere, quel dolore che sta in relazione polare con il piacere di farlo passare con un
massaggio , è altro cosa del dolore che gli viene inferto con quella ingiusta condanna
alla pena di morte. Queste due dolori appartengono ad ambiti molto diversi; non
solo nel senso che l’uno è proprio della sfera naturale e corporea, è l’altro di quella
etica e politica. Se c’è,infatti, il medio sussistente e reggente che permette il
movimento pendolare tra il venir meno dello stato normale delle gambe quando
sono libere dalla pressione e dal peso delle catene ed il ristabilimento della loro
normalità a catene tolte, non c’è, invece, il medio tra il dar dolore all’altro fino alla
sua soppressione fisica ed il dolore subito e sofferto dalla vittima innocente.
Che non ci sia vittima senza carnefice e viceversa, non significa che essi si
omogeneizzano dentro uno stesso processo che li renderebbe opposti contrari
necessari. Su questa strada si trova solo la giustificazione pesudo-culturale della
necessità di ogni violenza e delle forze distruttive della vita.
232
Brugger
Vengo ora alla seconda questione di questo paragrafo : quella che riguarda le
nozioni di Ordine e Disordine e la natura della loro relazione reciproca. Essa è così
importante in Migliori da essere elevata a a titolo della sua opera : “Il Disordine
ordinato,. La filosofia dialettica di Platone,”
E’ evidente che qui ci troviamo ancora sul terreno dove stanno in gioco ’identicodiverso-opposto, il positivo ed il negativo, l’essere ed il non essere.
Che questo territorio sia quello che ha visto protagonista nel primo ottocento
l’idealismo tedesco (Hegel, Fichte. Scelling) e, poi, nella prima metà del Novecento il
neo-hegelismo attualistico di G. Gentile e lo “storicismo assoluto” di B. Croce, non
c’è bisogno di ricordarlo, se non fosse per la circostanza che molti ritengono ormai
superato ed- obsoleto -come si dice con leggerezza e superficialità- lo spirito di
fondo di quelle filosofie e la montagna di problemi che esse trascinano ancora con
sé.
A questa massa problematica appartiene una questione di fondo che travagliò
l’esperienza idealistica e che la maggior parte delle tradizioni di ricerca antiidealistiche credettero di risolverla emarginandola e non ponendola nella sua
radicalità. Tale è appunto quella connessa alle domande : che cos’è il male ? Da dove
il male ? Che cos’è la morte dell’individuo umano ? Perché le guerre di conquista con
le loro violenze e distruzione di uomini e cose? Perché le catastrofi storiche e la
scomparsa di civiltà ad opera dell’azione soprafattrice di altre civiltà e per in
componibili acuti e prolungati lunghi conflitti interni ?
Gli idealisti come ebbero il coraggio di guardar in faccia la morte degli individui e
quella dei popoli e della nazioni, con altrettanto temerarietà osarono pensare ciò
che Platone non avrebbe mai potuto ammettere ; vale a dire che il naturale morire
di uomini e quello per esaurimento di una civiltà appartengono ad stessa economia
di conservazione, sviluppo e salvezza del genere umano alla quale contribuirebbe in
maniera coessenziale quella che egli chiama Cattiva-urgia del Kakourghein.
C’è, dunque, in Platone la visione di un Disordine che sta in una relazione di
“opposizione contraddittoria” con l’Ordine; e, perciò, per distinguerlo dall’altro che
sta in relazione polare e pendolare con quest’ultimo, io chiamerò Anti-Ordine.
Nella filosofia dialettica platonica- come ho detto-, c’è una opzione di resistenza, di
contrasto senza prospettiva di alcuna possibile mediazione-conciliazione o di
coesistenza polarizzata dinamica tra Ordine-Disordine ed Anti-Ordine.
Perciò, come osserva anche M. Migliori –però sotto diverso punto di vista- la
filosofia dialettica ci Platone è tutta etica, nel suo inizio e nella sua destinazione
finale.
Il Platone ‘totus ethicus’ e ‘totus politicus’ è comprensibile nella coerenza di questo
suo carattere con il Platone dialettico, se no ci facciamo condizionare dalla
presupposizione che etica. Politica .dialettica coincidono con il modo dottrinario
della loro trattazione. Questa complessità platonica, quindi, non è riconoscibile nel
suo contesto originario e nella sua valenza metodica, se cerchiamo di avvicinarci a
lui con le mappe e le reti della disciplina morale, di quella etica e dialettica , magari
collegandole, poi, insieme in prospettive interdisciplinari.
Richiamo questo aspetto – peraltro rilevato da più interpreti- non solo per
assumerlo come dato condiviso, ma per cercare soprattutto di pensarlo dentro
l’unìtà funzionionale-costruttiva che regge e governa la strategia problematicotematica generale di Platone.
Qual è questo piano che ci consente,dunque, di riconoscere la coerente complessità
platonica, visto che le accademiche ottiche dottrinario –disciplinari ci fanno da
ostacolo nel nostro tentativo di venirne a capo ?
Rispondere a questa domanda significa anche fissare il livello dove Platone
operativamente situa la relazione tra la prospettica etica-politica e quella della
dialettica, ed il discorso sull’ Disordine e sull’Ordine, e che cosa istituisce la
differenza tra lui e la tradizione pitagorica.
Mi devo allora necessariamente ripetere : la sensibilità e lo sguardo di Platone su
etica-politica-dialettica sono attivati ed alimentati da quella sua fondamentale
decisione che è alla base anche del suo interesse per il problema-tema dell’anima.
Tale è quella di inseguire i logoi, di seguirli nel loro flusso, di fuggire con essi che
fuggono come onde, di rifugiarsi in loro affinchè dal loro interno possa orientarsi
nella esplorazione di etica,politica,dialettica., della psychè.
Con questa decisione Platone non rivendica solo la centralità dell’essere nel
linguaggio, ma si immerge in una sua peculiare modalità.
Questa in via principale non è quella della esperienza della comprensione dialogica –
come crede e teorizza da un punto di vista fenomenologico Gadamer, sulla sica di
un Schleiermacher da lui riformato ripartendo dalla via aperta da Husserl233-; i logoi,
i fenomeni del linguaggio che attraggono l’intereresse e stimolano l’attenzione di
Platone sono quelli che sono veicolati dalle attività di quella comunicazione sociale
in cui la influenza dell’ elemento spettacolo ha penetrato tutte le sue direzioni.
La stessa vita sociale religiosa ne è pregna : per esempio, le offerte votive ad Apollo
Delfi, i tripodi ed i ‘tesori’, non nascono solo da esigenze di onorare la potenza del
dio, di manifestargli riconoscenza per le ‘grazie’ ricevute, e per chiedere ancora la
sua protezione. In quella gara a chi offre i doni più preziosi c’è anche la ricerca della
massima visibilità di città e delle loro elites in un contesto di concorrenza e
conflittualità spettacolarizzata, ampliata anche dal fatto che quel luogo è anche lo
spazio dove si svolgono giochi sportivi che vedono una grande affluenza di pubblico
da tutta la Grecia.
Se Platone non ha avuto “ diretti continuatori” è perché chi è venuto dopo di lui
non ha colto e capito l’importanza di questa straordinaria innovazione introdotta da
lui nello ‘sguardo filosofico’; una novità che è un passaggio di piano funzionale
dentro la attività della cognizione e del linguaggio: e che, quindi va oltre la
233
G. Gadamer, Studi platonici, p.
introduzione di altri contenuti filosofici e di altre regole della loro organizzazione
logico-argomentativa.
Pertanto, Platone scritto non è confrontabile con i suoi predecessori pitagorici e con
i suoi successori aristotelizzanti e neoplatonici, assumendo come terreno di questo
confronto quello tutto o prevalentemente dottrinario e disciplinare.
Gli studiosi che continuano a farlo senza mettere in discussione questo prevalente
modo di accesso ai suoi testi, devono fin dall’inizio sapere che possono anche
percorrerlo in lungo ed in largo la sua scrittura, ma alla fine Platone si sottrarrà a
loro e li lascerà nella convinzione di averlo ‘sistemato’ e tagliato fuori da una
filosofia che gli ha voltato le spalle proprio mentre diceva di riconoscere la
grandezza del genio del suo fondatore..
C’è qualcosa in questo atteggiamento –peraltro in questo caso ispirato da buona
fede ed onestà intellettuale- che richiama la favola della volpe e dell’uva; di fatto ci
viene proposto un giudizio di valore per il quale ‘Plato nondum maturus est ! ‘; e
che, dunque, costituirebbe un avanzamento della cultura filosofica il suo abbandono
e che ci si dovrebbe occupare di lui solo per riseppellirlo con tutti gli onori e
salutarlo per sempre.
Ma Platone risuscita non perché sia un dio. ma perché ciò che egli vide nella
condizione umana, cioè il male radicale della voglia di sopraffazione e di distruzione
della vita degli altri inermi ed inoffensivi, il male giustificato con ‘bei discorsi’ ed
entusiasmanti spettacoli di propaganda e di ‘fiera di logoi’, è ancora il nostro grave
problema di moderni e post-moderni, post-umanisti, cittadini delle città della
globalizzazione mondiale, piena di conflitti e di saccheggi,organizzati su scala
planetaria attraverso le macchine della speculazione finanziariaPlatone sta così con noi e anche davanti a noi, almeno nella misura in cui
continuiamo a confondere la dialettica di Ordine-Disordine con l’incontro-scontro
tra Ordine-Disordine ed Anti-Ordine,
Con Platone non dobbiamo aver paura di prendere posizione a favore di questa
“opposizione contraddittoria” , di difesa e promozione di questo dualismo, che non
offende il principio di sistema, ma le pretese illegittime di una presunta lex continui
che dovrebbe essere applicata anche al rapporto tra giustizia e antigiustizia, tra
felicità e sterminii di massa.
E Platone pensa e dice, pertanto, l’Antiordine come Menzogna, ciò provando con il
suo attraversamento dei logoi intorno alle “Cose Massime”, cioè con la sua
dialettica, che i suoi ‘messaggi’ sono finto pensiero, ingannevole paralinguaggio,
pseudo-cultura.
La Dialettica come falsificazione del sofisma è in tal modo dal suo stesso interno è
connessa alla etica ed alla politica, perché la madre di tutte le sofisticherie intorno
ai valori è appunto la falsa opinione che la giustizia, il bene etico e politico per
antonomasia, sia l’antigiustizia dei più forti.
La “prassi etica e politica” è, pertanto, risucchiata dentro lo scenario platonico di
fondo dello ‘spettacolo e teatro dei logoi ‘, cioè nel contesto dei processi della
comunicazione pubblica, dove cerca di passare ed imporsi una falsa opinione sull’
etica e la politica, e sull’anima.
Il Platone di Leggi che ci segnala velocemente che egli non ci sta dando un manuale
di diritto costituzionale, pronto per essere messo in pratica, ma una progetto di
fondazione con e dentro il discorso, è ancora questo Platone che ha scoperto il
mondo dei logoi in quella loro eccezionale ed inquietante novità.
L’ Aristotele etico, politico, psicologo non è un anti-platonico, perché egli si muove
su quel piano dottrinario e di esposizione per trattati e trattazioni che anche Platone
ben conosceva e padroneggiava, da maestro dei maestri nella sua Accademia.
Aristotele anti-platonico è quello che si oppone agli usi dottrinari da parte dei
‘platonici’ di testi che nascono da bisogni culturali differenti da quelli specifici che
motivano e guidano una chiarificazione e sistemazione linguistico e concettuale di
impianto tecnico-epistemico di quei problemi-temi.
Il che implica che in questo Aristotele anti-platonico e dottrinario puro ci sia non
poco dello stesso Platone scienziato, Mi rendo conto che questa mia ipotesi
sconvolge quanti sono abituati all’immagine di un Aristotele programmaticamente
anti-platonico o che pensano che l’incontro tra l’uno e l’altro possa essere pensato
solo secondo il paradigma neo-platonico o dell’aristotelismo platonizzante, o della
intepretazione gadameriana dell’ Aristotele etico o ancora secondo il modello
ermeneutico della Scuola di Tubinga e di Milano.
Questo, però, significa che interpretare Platone scritto condividendo il piano
funzionale proprio di Aristotele è fare ciò che quest’ultimo stesso proibisce di
compiere.
Resta naturalmente da spiegare perché nel testo dell’opus aristotelicum e nei loci
della polemica espressamente anti-platonica si parla anche di |Platone| e non solo
dei |platonici|; e, quindi, non ci possiamo sottrarre all’obbligo di provare
filologicamente quanta influenza abbiano avuto i conflitti tra scuole aristoteliche e
scuole platoniche nella fedele trasmissione di quell’opus con particolare riguardo a
quei loci in cui Aristotele si riferisce esplicitamente al suo maestro.
Oso sottolineare a questo proposito che la interpretazione che sposo permette di
tenere insieme sia il Platone scienziato che il Platone autore dei dialoghi e garantisce
la sostanziale continuità e omogeneità di ricerca tra il primo ed il suo massimo
discepolo Aristotele.
Certamente l’Aristotele matematico-per esempio- non è pensabile fuori da un
rapporto intenso di ricerca condivisa tra lui ed il suo maestro. E,perciò, ritengo
inammissibile che egli non si sia reso conto che il concetto platonico di
partecipazione/metexis nel Parmenide non è un surrogato metaforico, ma una
trascrizione metalogico- analogica del concetto geometrico-matematico di
Invarianza in un processo determinato di variazioni-trasformazioni.
Ma per intendere dentro il Platone scritto il rapporto con il Platone scienziato,
dobbiamo rimandare a quanto sopra ho accennato alla questione del rapporto tra
Platone dialettico ed il suo riferimento ai principi,ai metodi ed ai risultati delle
Technai ,verso le quali egli costantemente e sistematicamente guarda per trarvi
‘esempi’, intrecciando un procedimento metadiaretico e metaparadigmatico
analogico.
7.. “ L’unità del pensiero etico e politico” ed il suo effettivo piano cognitivolinguistico. La tensione polare tra Ideale e Reale, tra Virtù e Piacere, tra Divino ed
Umano.
Nell’accingermi a riflettere sulle pagine 859-1142 dell’opera di Migliori, procederò
in questo modo : prima riprendo, riassumendoleo e rifoclaizzandoli, il cruciale
punto critico caratteristico dell’ottica in conformità alla quale Migliori guarda verso i
testi platonici.
Tale punto è costituito dalla natura ibrida del paradigma di osservazione del testo e
di interpretazione dei suoi dati di senso. In esso ,infatti, confluiscono due modi di
riproduzione e di riconoscimento dei complessi significativi; l’uno è quello proprio
della tradizione accademica che ho indicato con la sigla |DDP|, l’altro è quello che
Migliori introduce ,valorizzando alcune tracce dello stesso Platone, e che io
connotato con la sigla |GG|. Queste due prospettive funzionali di lettura in Migliori
operativamente non hanno la stessa valenza, poiché la seconda è subordinata alla
prima.
Questa subordinazione risulta evidente non solo in sede di individuazione della
forma del problema che costituisce il centro gravitazionale di ogni dialogo, ma anche
nel modo in cui Migliori pensa ed istituisce i collegamenti tra i dialoghi o gruppi di
essi. Sopra ho esaminato questo procedimento in riferimento ai rapporti tra Fedone
e Parmenide, tra Filebo e Timeo .
Ora rivolgerò l’attenzione soprattutto e seguendo Migliori al modo in cui questi
evidenzia i collegamenti tra le opere che nel loro titolo appaiono ‘dichiaratamente’
politiche: Repubblica, Politico, Leggi.234
Sulla base di questo esame ,poi, cerco di dimostrare come la cosiddetta
“contradizzione mortale del platonismo”, che l’autore attribuisce a Platone scritto,
Per me tutte le opere platoniche sono intrinse di ‘politicità’, per cui considero una deformante
trascrizione dottrinaria la ripartizione di esse in morali, dialettiche, politiche,cosmologiche,
psicologiche, retoico-linguistiche. Il difetto principale di questo modo di classificazione degli scritti
consiste nel fatto che esso rompe l’omogeneità funzionale delle diverse prospettive attivate da
Platone in direzione dell’ambito dei saperi particolari, e lo adotta sbaglia quando crede che non vi
sarebbe una via alternativa a quella accademico-disciplinare per la identificazione cognitivo e
linguistica del piano a partire dal quale Platone guarda verso le diverse manifestazioni della
cultura del suo tempo. A garantire l’unità e omogeneità funzionale del complesso sguardo
politecnico platonico è proprio ,invece, la costituzione meta tecnica e metalogica analogica del
suo operare dia-logico/dialettico - smascherante dello Pseudos, esplorato nella maggior numero
possibile di varianti, Ed è proprio la nautra funzionale e contenutica dello Pseudos a rendere il
filosofare platonico sempre e tutto politico, cioè come attività di comunicAzione pubblica su i
principi ,valori e beni della vita di una città , dove ormai tutto è spettacolo. Non a caso nel Fedro
,ad esempio, Platone associa il nome dell’esperto di comunicazione pubblica a mezzo di scrittura,
Lisia, con quello di Trasimaco, che apre provocatoriamente il discorso sulla Politeia., sull’ottimo
Stato. E ciò che li unisce fun<ionalmete-costruttivamente è proprio la loro paralogica spettacolare.
234
sia il risultato obbligato di questa combinazione gerarchizzata di ottiche
interpretative e della loro applicazione nel momento della lettura trasversale dei
diversi dialoghi.
In questo contesto ribadirò che questo paradigma complesso di Migliori finisce per
essere inconseguente rispetto ai suoi stessi presupposti canonici, tra i quali per il
nostro inteprete ha estrema rilevanza quelli del massimo rispetto possibile di
quanto registrato nella superficie testuale e della messa tra parentesi di ogni
sguardo teoretico più o meno originale.
Ora prendo spunto dal titolo stesso con il quale l’autore ordina i suoi pensieri sul
Platone ‘politico’; titolo che riporto negli stessi termini e nella stessa funzione in
questo mio paragrafo.
Perciò leggendo la parola |unità| dobbiamo attenderci una intepretazione
migliorista che alla fine approdi ad una unità che sia tale, fermo restando, però,
che ad essa appartenga intrinsecamente anche in maniera essenziale appunto una
“contraddizione mortale”, dunque, una non unità. La domanda mia principale allora
è questa: sulla base di quale parametro teorico ci decidiamo per questa valutazione
dell’ordine interno del Platone scritto ?
Migliori ci raccomanda di leggere sforzandoci di cogliere le “connessioni logiche “ tra
questi dialoghi, che sotto distinte prospettive e diversi gradi di sviluppo parlano di
comportamenti in privato ed in società ispirati ai valori del coraggio, della
temperanza, della pietà, della amicizia, della giustizia; e che rimandano alla sfera
delle costituzioni, delle istituzioni e delle leggi, ed a quella delle azioni dei politici;
che chiamano in causa la ricerca della felicità e l’esperienza del piacere sia del
privato cittadino che della intera comunità.
|Rendere migliore la vita in città, facendo sempre più unità| è il significato di quella
parola d’ordine con la quale Platone conclude l’ultima delle sue opere : |RischiareScommettere sulla Politeia|.
Questi temi possono essere rilevati anche da un paziente ed attento comune
lettore; da dove nascono allora i problemi ed in che termini essi si pongono ?
E,quindi, perché in questo esame Platone finirebbe in quella ‘contraddizione
mortale” ?
Ritorna a questo punto la questione : come dobbiamo leggere i testi platonici ?
Sulla base ed in virtù di qualle attività logica dobbiamo istituire le “connessioni” e
che significa |connettere|?
Se partiamo dal presupposto del Migliori , allora tutti i dialoghi sopra richiamati
sono “giochi seri “ che vanno considerati ciascuno nel loro intero di giochi
determinati e nei loro rapporti come interazione reciproca di una pluralità di giochi ,
di interi cognitivo-immaginativo-linguistici .
Come sopra ho ripetutamente evidenziato, da lettori non possiamo porci nell’ottica
della ricera di connessioni tra i dialoghi se non a partire dal tenere fermo l’intero di
ogni dialogo; e ciò significa anche che ogni parte di esso non può essere separato dal
problema attorno al quale esso si svolge.
E facendo ancora un passo indietro, ci ritroviamo di fronte al problema di come si
identifica un problema in un campo dove domina la logica dell’implicito propria di
un dire e concettualizzare che sono impiantati sul principio costruttivo-funzionale
della ‘grammatica’ performativa del modo | GG |.
Esemplifico : il dialogo Eutifrone è classificato dalla letteratura secondaria come
dialogo morale che tematizza la virtù della pietà, della esperienza del santo, e di
come dobbiamo atteggiarci di fronte al divino.
Quasi all’unanimità gli interpreti concordano nella individuazione dei termini del
problema-guida nella formula che lo stesso Platone nell’avvio mette sotto gli occhi
del suo lettore |Che cos’è il santo ?|. E gli stessi convengono sul fatto che Platone
non risolverebbe al termine della sua rappresentazione il problema che dichiara. Per
questa caratteristica il dialogo viene incluso nelle ’opere aporetiche.
Ma quale tipo di lettore si comporta in questo modo ? Quello che parte dalla
presupposizione secondo la quale Platone esporebbe i suoi pensieri e,dunque,
anche il suoi problemi secondo la prevalente logica |DDP|.
Ora se con Migliori vogliamo essere coerenti con la sua assunzione di fondo, vale a
dire che tutti i dialoghi platonici sono “giochi seri”, allora fin dall’inizio dobbiamo
leggerli come lettori che sanno ripetere e riprodurre i sensi e le loro reciproche
relazioni e connession in conformità al principio del gioco e di una “pluralità di
giochi.
Dobbiamo, pertanto, essere conseguenti dall’inizio alla fine della ripetizione dei
games platonici e, perciò, siamo obbligati a tenere conto che quella parte del gioco
serio che la posizione del problema deve essere riprodotta e riconosciuta in sede di
interpretazione secondo i canoni della perfomance e della totalità determinata. In
virtù di essi ci tocca assicurarci e garantirci che il problema –guida isolato sia quello
che è coerente e conforme con l’articolazione del suo intero svolgimento.
Nel fare questo dobbiamo , poi, ricordarci di altri due aspetti importanti – già sopra
illustrati- che caratterizzano la pratica della gymnasia/ginnastica cognitivoimmaginativo-linguistica che Platone dice facendola.
E ribadisco questo punto, per rispondere anche alla obiezione che mi potrebbe
essere fatta di attualizzare e ‘modernizzare’ Platone, proiettando in maniera
anacronistica ed antistorica problemi , metodi e risultati scientifici, sensibilità e
mentalità specificamente e solo della nostra epoca.
|Contestualizzare storicamente e culturalmente i pensieri di Platone| è, perciò,
anche la mia parola d’ordine ; e , pertanto, applicando ai suoi testi il modello
ermeneuticio che assume come suo principio e filo conduttore quello del gioco
giocato, dico che esso va pensato sapendo ripensare lo spirito , lo stile, la
‘grammatica’ e, dunque, anche la sintassi della logica geometrico-matematica
platonico-euclidea; nonché sapendo guardare alla esposizione drammatizzante a
partite ed orientati dalla poetologia platonico-aristotelica.
E sono ben cosciente che non pochi si stracceranno le vesti a sentirmi affermare
che la “Poetica” di Aristotele è la messa in opera secondo la forma-trattato di
principi ed impostazioni del Platone massimo competente di drammaturgia attica.
Il Platone di cui qui parlo è in un certo senso e sotto un diverso profilo quello che
Kramer - cofondatore con Gaiser della Scuola di Tubinga-. scopre nella sua indagine
sul concetto di virtù in Platone ed Aristotele; a cui accenna anche il Migliori , citando
a questo proposito la presa di posizione favorevole di di E. Berti.
Anch’io condivido la conclusione di Kramer che vede nel nucleo concettuale
platonico di Idee-forme e di Idea-Misura il fondamento del concetto aristotelico di
virtù e di phronesis come medietà-mediazione di estremi.
Ma ciò se da una parte è una prova a favore del fatto storico che è esistito e che ha
operato un Platone dottrinario e scienziato parallelamente al Platone autore dei
dialoghi, dall’altra parte, però, questa circostanza storica non autorizza affatto a
leggere i pensieri di quest’ultimo sulla base funzionale di quelle che Reale chiama
“Idee-Chiave”. E ne ho ampiamente fin qui illustrate le ragioni e ne richiamo la
principale che vale anche per Migliori che ricostruisce “ per sommi capi”- 283
pagine !- il pensiero etico e politico di Platone.
La proiezione su i dialoghi di quella mappa di riconoscimento, di quel codice di
decodifica, se fatti valere in tale funzione ed in via principale, allora essi entrano in
conflitto con quella caratterisitica del suo codice di produzione, che prevede
l’elemento/Racconto come dimensione integrante e sostanziale della
problematizzazione e della semantizzazione connesse alla teorizzazione.
Il Migliori - ma questo vale anche per Reale- che legge i contenuti etici e politici
dell’ Eutifrone, emarginando e mettendo tra parentesi la dimensione narrativa in
quel ruolo coessenziale alla generazione del concettuale-speculativo, sta in una
impostazione delle operazioni di “connessioni logiche” tra i dialoghi che prima di
non essere conforme alla matrice costruttivo-funzionale platonica, sta in contrasto
con i suoi stessi dichiarati presupposti ermeneutici : rendere conto di tutto Platone e
dell’intero di ogni dialogo, valorizzando il principio di una fedele riproduzione del
gioco testualizzato.
Quali sono le conseguenze di questa impostazione sulla interpretazione del Platone
etico e politico ?
Molte e molto serie. Provo ad elencarle:
1-- Qale sia l’effettivo problema dell’ Eutifrone e perché esso non ha natura
aporetica ed in quale rapporto stia con gli altri cosiddetti “dialoghi socratici” sulle
virtù ho cercato di chiarirlo nel paragrafo che sopra è stato appositamente
dedicato a questa opera.
Ora mi soffermo all’interno della prospettiva di ciò che Migliori dal suo punto di
vista chiama |connessioni logiche| e mi chiedo quale sia il suo rapporto con quel
discorso teologico che troviamo nel X Libro di Leggi, dove assistiamo ad una
polemica contro l’ateismo materialista-scientista, che viene spacciato come nuova e
moderna scienza e sapienza.
Quale domanda può guidarci a stabilire il collegamento logico tra i due discorsi
teologici ed a trovare la loro unità ?
Proviamo con questa : Che cos’è il divino e quale deve essere il rapporto dell’uomo
con esso ?
Utilizzando questo filo conduttore problematico certamente ci assicuriamo la
scoperta di contenuti filosofici comuni ad entrambi. Ne evidenzio due importanti :
a) la religiosità, la esperienza del santo, non è un fatto privato, ma appartiene
alla sfera pubblica, quello dello Stato e delle sue leggi. L’indovino-sacerdote
Eutifrone è rappresentato come chi denuncia il padre per una violazione di
una legge penale che è anche una legge sacra; e,perciò il magistrato
competente è l’arconte-re. Nel X Libro di Leggi la questione della esistenza
degli dèi, del se essi si prendano cura degli uomini e si facciano corrompere da
doni e sacrifici è dichiaratamente contestualizzata nel progetto di dire in
maniera corretta quale siano le migliori leggi che devono regolare la vita di
uno StatoE qui confermiamo un concetto che pure Migliori evidenzia nel sottolineare
la differenza tra concezione moderna del rapporto tra religione etica e
politica e quella greca. Nella prima - e lo si può vedere in Hobbes- viene
operata una separazione di ambiti, nella seconda il religioso-etico è
organicamente anche politico.
b) il Rispetto ed ‘il timor di Dio’ è la forma caratteristica del rapporto
dell’uomo con il divino; perciò, questo deve essere onorato e non offeso con
parole ed azioni. Osservare il comando e i comandamenti divini è compito
fondamentale dell’ uomo-cittadino. Eutifrone viene scolpito come chi crede
e pretende di essere il più rigoroso osservante della legge divina e di ciò che
essa ordina. Il discorso del X libro Leggi inizia proprio con la costatazione
che giovani in particolar modo sono intolleranti ed insolenti verso i credenti ;
essi li prendono in giro e li disprezzano.
Interpretando in questo modo i due testi e la loro connessione logica certamente
non pervengo ad un risultato erroneo ed in contrasto con i dati della scrittura
platonica- Questa modalità di riconoscimento del senso è naturalmente per un
certo aspetto legittima; ma essa è anche una estrazione-astrazione di contenuti,
che originariamente non appartengono ad un contestto funzionale dichiarato di
dottrina etica, teologica e politica.
L ‘ Eutifrone e il X Libro di Leggi sono testi generati secono il principio di un gioco
cogntivo-immaginativo-linguistico e sono svolti in coerenza ad esso ed alla sua
‘grammatica’; e, perciò, prevedono anche un determinato tipo di lettore; quello che
fruisce dell’ opera conformandosi nella sua attività di riproduzione dei significati a
quel principio ed alla sua relativa ‘grammatica’.
Perciò, dobbiamo subordinare quel rilevamento per dottrina ad una attività di
riconoscimento capace di far valere fino in fondo quella matrice, quel codice
produttivo.
Se così facciamo non solo guadagniamo alla nostra comprensione logico e teorica
più testo, ma riconvertiamo e ristrutturiamo i dati a tal punto da trovarci di fronte
ad un altro scenario della impostazione platonica della teorizzazione; dalla scoperta
di questo impianto costruttivo-funzionale noi abbiamo a disposizione il punto di
vista ‘interno a tutto il testo’ che ci permette di capire il piano cognitivo-linguistico
in cui Platone effettivamente si muove e, dentro di questo, di cogliere la forma ed i
termini dell’ effettivo problema-bersaglio che è il ‘principio del fine’.
Nell’ Eutifrone, come pure in Leggi, ciò che Platone prende di mira in via
principale non è una posizione teorica e dottrinaria rivale e concorrente sul divino e
sul santo, ma una ‘fenomeno-paralogia’ sofistica, adulatrice e menzognera; essa
investe la esperienza stessa del sacro-santo, in connessione essenziale ad una
deformata visione dei rapporti sociali ed ai costumi, ai comportamenti virtuosi.
L’unità di teologia, etica e politica che accade sulla scena del testo si
colloca,dunque, in questo piano ; cioè – e mai come in questo caso ‘repetita
iuvant’- in uno spazio costruttivo condizionato dalla natura peculiare-funzionale
proprio delle ‘sofisticherie’, del modo di produzione e trasmissione degli pseudologoi sofistico-eristici, paradottrinari.
Dunque, è la natura del bersaglio a provarci che il Platone teologico, etico e politico,
non è il Platone del dottrinario e, perciò, non può essere letto come ,invece, fa
Migliori dentro il piano di una storiografia delle dottrine teologiche, etiche e
politiche; dentro quella modalità funzionale di riconoscimento con la quale
leggiamo da moderni il moderno Hobbes.
Conseguentemente non può essere deciso su questa base se il problema in campo
nell’opera in questione venga risolto e se esso sia minato da una interna
contraddizione mortale.
Come già si può intravedere a questo punto della mia riflessione, dire che bisogna
trovare le “connessioni logiche” tra i dialoghi per trovare l’unità etica e politica nella
visione platonica, non equivale a cercarla secondo l’ ottica |DDP|; anzi così facendo
non solo perdiamo di vista parti testuali rilevanti ai fini teorici, ma ci allontaniamo
dalla ‘logica fondamentale del gioco e, quindi, dal suo senso complessivo.
Stando nel merito delle due opere, rilevo che a seguire questa ottica funzionale
,che Migliori di fatto viene a condividere con tutti gli studiosi con i quali
interloquisce , discute, devo rilevare che il tema violenza-sacro e quello di violenzaleggi che stanno rispettivamente nel cuore del gioco dellì Eutifrone e Leggi, vengono
gravemente sottovalutati, se non proprio emarginati.
Ora,invece, è proprio su questo asse semantico che si stabilisce il collegamento
portante tra le due opere ; un collegamento che è fatto di rimandi riflessivi ,
costruttivi e tematici tra due giochi che rimangono fino alla fine distinti e ciascuno
felicemente riuscito , perché ognuno di essi risolve il suo specifico problema .
Perciò, l’ultima opera non completa ed integra la prima. , secondo una idea di
sviluppo logico che è proprio del principio sistematico di tipo dottrinario.
Nella configurazione dei dialoghi secondo la figura della cum-stellazione certamente
non manca uno spirito ed una strategia sistemica; ma questa deve essere cercata in
tutto Platone ed in particolare tra queste due opere secondo criteri dell
morfologico , dell’iso/morfismo-funzionalismo, della proporzione; e, quindi,
secondo il parametro di quell’analogico che prevede la permanenza di una
differenza tra i diversi giochi. Questo non fa Migliori; e così finisce per istituire
parziali e deformanti collegamenti. soprattutto tra Repubblica, Politico e Leggi, -come più avanti evidenzierò.
Parlo di | de-formazione| in questo senso : Migliori pesca una grande massa di
dati testuali , valorizza molti risultati della letteratura secondaria, ma lo fa sulla base
di una implicita commutazione dell’originario codice di produzione platonico.
Questa commutazione che è di tipo funzionale e non solo contenutistica e di
ristrutturazione argomentativa, è quella che fonda tutte le sue operazioni di
“collegamenti logici” tra un dialogo ed un altro; operazioni a loro volta strumentali al
raggiungimento del suo scopo ermeneutico-metodico : provare che anche dentro il
Platone etico e politico ci sarebbe un radicale ed inammissibile dualismo, che
giustificherebbe quanti dopo di lui lo hanno salutato come genio senza futuro, ed
esso riguarderebbe il rapporto tra sfera dell’ ideale e quella del reale, tra quella del
divino e dell’umano, di virtù e piacere, e tra ethos e kratos.
Martello ancora su questo aspetto, perché Migliori giunge a questa conclusione in
maniera paradossale : egli ci promette solennemente che leggerà i testi come
lettore/spettatore di giochi seri fatti di logoi , e poi viene meno al suo impegno e si
fa prendere da quella abitudine culturale e deformazione professionale che spinge a
pensare la teoria unicamente e prevalentemente come dottrina ed in opposizione
all’elemento/Racconto, causa di impurità, di confusione, di equivoci, di oscurità.
E purtroppo non posso neppure dire che Migliori rimane in mezzo al guado tra il
principio della forma /dottrina e quello della formatività/gioco; esso,infatti,
operativamente subordina sempre la seconda alla prima.
Perciò non colpisce nel segno chi rimprovera a Migliori di aver introdotto nel suo
modello ermeneutico il paradigma del gioco serio come bussola di orientamento
interpretativo; Migliori qui ,infatti, è ‘ironico’: dice una cosa,ma poi come la dice
fa una cosa diversa ed alla fine contraria.
Violenza-Sacro, Violenza- Leggi. Eutifrone crede che per essere cari agli dèi,
bisognerebbe imitarli in quel che secondo lui li caratterizzerebbe : la volontà di
potenza e il piacere del conflitto. I ‘senatori-padri i costituenti- il cretese Clinia e
lo spartano Megillo- all’inzio del loro pellegrinaggio verso la motagna sacra e la
grotta divina, dove c’è l’orcalo di Zeus Nomoteta- credono ancora che il principio sul
quale fondare uno Stato ed un ordinamento legislativo sia quello della guerra
assoluta; e che ,quindi, legge fondamentale e tutte le leggi siano solo legittimazione
dei reali rapporti di forza dentro una città e nei rapporti tra città; e, che, dunque,
in fondo quell giusto che fonda la costituzione e le norme sia solo l’interesse del più
forte”.
Eutifrone, Clinia e Megillo sono Tipi portatori di varianti di una medesima Typologia : nel Caso/Eutifrone si accentua e si porta in primo piano lo sguardo in
direzione della esperienza teologica-liturgica- etica , e quella politica rimane sullo
sfondo , pur facendosi indirettamente sentire nella sua determinante funzione.
Nel Caso/ Clinia –Megillo, Tipi inquadrati nel MegaParadigma /Leggi, la ‘cinepresa’
è puntata in direzione della attività politica come attività di produzione e
formazione di leggi, regolanti i vari aspetti della vita economico-socioculturale e
dell’ordinamento militare e giuridico. Ma non manca lo sguardo sul teologicoliturgico come prova il prologo ed il X libro.
La direzione del puntamento e la natura dell’obiettivo preso di mira sono costantti
sia nell’Eutifrone che in questo libro dell’ultima opera : l’attività dialettica è diretta a
smascherare una finta dottrina; la natura funzionale di questo obiettivo polemico è
quella del modo di produzione sofistico dei logoi.
Questo tipo di collegamento strutturale-dinamico che istituisco tra le due opere in
esame ha il vantaggio rispetto a quello proposto in generale da Migliori di salvare la
differenza e la autonomia dei due giochi, senza considerare il primo come un
discorso teologico incompleto che sarebbe completato organicamente dal secondo;
e poi nel rispetto di questa autonomia valorizza in entrambi l’elemento/Racconto.
Così inquadrati in virtù di una prospettiva isomorfica-isofunzionale l’Eutifrone è la
falsificazione-purificazione di un modo di pensare e di comunicare che pretende di
dare giustificazione paraculturalre a all’uso violento della religione; in Leggi
,invece, a venire falsificato è lo scientismo materialista impiegato come strumento
per sostenere che gli dèi non esistono e sono pura invenzione umana; e per educare
i giovani all’ateismo. Il tutto di questo sofisma è funzionale a rafforzare una visione
di leggi come strumenti di legittimazione dell’utile dei più forti.
In entrambe le rapparesentazioni Platone fa vedere l’intimo rapporto tra religiositàpoliticità-eticità da una parte e dall’altra una certa maniera di usare i logoi nella
vita comunicante della città. E tutto ciò accade operativamente in una
testualizzazione spettacolare e teatralizzante e su un piano che è metacognitivo
,metaimmaginativo e metalinguistico. E questo vale anche per i tre dialoghi
dichiaratemente ‘politici’: Repubblica- Politico e Leggi, su i quali ora mi soffermo.
2. Migliori insiste su tre caratteri fondamentali del pensiero etico e politico di
Platone : l’ “unità” . la “ polivalenza”, l’ “ambivalenza”, nel senso che la prospettiva
ultraterrena segna costantemente la sua navigazione testuale. A proposito di
questa metafora marina ritroveremo in Repubblica il richiamo alle ondate e nel X
libro di Leggi alle difficoltà di attraversamento di un fiume impetuoso.
Per quanto riguarda le tre caratteristiche in discorso, non solo dobbiamo con
Migliori prenderne atto e tenerle presenti e così non dimenticare che tra
anima,mondo e divino e visione etica e politica in Platone c’è un nesso orginario ed
ineliminabile; e che, pertantp, non c’è legge morale che non rimandi ad una norma
morale, e non c’è ‘psicologia razionale’ senza ‘cosmologia e teologia e ‘ragion
pratica’.
Dobbiamo anche, però, domandarci come questa unità e polivalenza dentro
Platone, autore implicito, siano cognitivamente e linguisticamente possibili, senza,
perciò, ridurle ad un assemblggio di eterogenei, a giustapposzione non mediata di
differenti ambiti di realtà e di razionalità.
Alla scoperta della omogeneità funzionale di questa ‘dialettica complessa,
politematica e proiettata polimetodicamente, non aiutano certo né l’ottica
disciplinare e nè quella interdisciplinare proprie dell’elaborazione dottrinaria e
tecnico-epistemica.
E se con Migliori facciamo valere il principio del gioco e rimaniamo ad esso fedeli fin
dall’inizio dell’ avvio problematico e fino al fondo dell’intreccio indissolubile tra
Racconto-Teorizzazione, allora l’accesso alle ragioni costruttive-funzionali di quella
unità-polivalenza diventa improcedibile per la via delle ripartizioni e specializzazioni
disciplinari.
Perciò mi domando : possiamo stabilire i collegamenti tra quei tre dialoghi non
affrontado questo problema fondamentale ?
Per esempio, in riferimento a Repubblica è ancora sostenibile il punto di vista –
dibattuto in particolar modo da M. Vegetti 235– per il quale il primo libro e l’epilogo
mitico mal si accordano con la dottrina socio-politica che costituirebbe il cuore ed il
nerbo dell’opera ?
Ritengo che quando un lettore dottrinario come M. Vegetti rileva questa anomalia e
questo scostamento del testo dal paradigma di riconoscimento che ci cala sopra, il
problema non è di Platone,’autore del testo – , ma deve essere messo a carico in
primo luogo di questo tipo di lettore.
Questa messa in discussione della adeguatezza del punto di osservazione sull’opera
platonica, non viene attivata, perché si è condizionati da quella presupposizione
culturale, istituzionalmente consolidata, per la quale si fa valere la equivalenza
assoluta tra il modo dichiarato-dottrinario della elaborazione dei contenuti filosofici
con l’attività di teorizzazione filosofica.
235
M. Vegetti.
Per forza di cose e per effetto di inerzia, quando così si legge Platone, si è poi
costretti a mutilarlo o a tenerlo insieme, rilevando che egli rimarrebbe ‘impuro’
,contaminato dall’assemblaggio di eterogenei.
Da questa impostazione ci si aspetterebbe che il Migliori dei “giochi seri” prendesse
le distanze, ma così non accade; e cosi assistiamo anche in lui alla emerginazione
costruttiva-funzionale del primo libro di Repubblica, il “Trasimaco”.
Lo scopo metodico del “Trasimaco” è per me quello di delinerare qual è l’obiettivo
polemico-guida che Platone prende di mira come bersaglio e contro cui orienta
tutto il suo succesivo discorso di formazione del modello della società e dello Stato
ideali.
Ancora una volta,infatti, – come d’altra parte in tutti i dialoghi- il ruolo della
phainomeno-logia paralogica del modo sofisitico di comunicare intorno allle “Cose
Massime” è codeterminante non solo per individuare l’asse di orientamento che
spiega il senso effettivo e complessivo di questo lungo discoso politico platonico.
L’obiettivo polemico-guida – come ho ripetutamente messo in luce- ci dice
soprattutto qual è il piano funzionale-costruttivo., cognitivo e linguistico. dentro cui
bisogna collocare la cosiddetta dottrina socio-poitica ed etica del Platone di questi
tre importanti dialoghi.
Ora è proprio la natura funzionale metalogica del modo di generazione e di
organizzazione dei logoi sofistico-eristici ad indicarci indirettamente , ma
fondamentalmente, a quale piano appartenga anche quella attività cognitivo,
immaginativa, linguistica che istituisce la “dialettica” platonica, la sua ‘analitica’ e la
sua ‘critica’ della pseudo-dialettica sofistico-eristica.
E tale piano non è dottrinario; da ciò consegue che la unità, la polivalenza e la
cosiddetta ‘ambivalenza’ e presunta “contraddizione mortale del platonismo”
devono essere esaminate guadagnando con tutto Platone , autore implicito,
l’accesso a quel piano dove egli operativamente si muove, ed esso non è quello che
tutti gli interpreti dottrinari - gli uni contro gli altri armati- gli attribuiscono.
Devo a questo punto ribadire - e lo faccio condividendo le critiche di Cambiano a
Gadamer sul ricorso alla idea di dialogo vivo con il testo e senza nello stesso tempo
dimenticare che il primo non esce fuori dalla ottica prevalentemente dottrinaria –
quanto segue : Gadamer, sulla scia d Friedlander e valorizzando al meglio lo spirito
fenomenologico , non è stato seguito nella sua fondamentale intuizione sulla
natura non dottrinaria della elaborazione concettuale platonica.
Questo è accaduto soprattutto perchè Gadamer ha cercato di ‘catturare’ Platone
con il paradigma dialogico236, cioè attraverso l’identificazione della forma letteraria
per domande-risposte come direttamente e principimente imitazione del vivo
colloquio filosofico svolgentesi tra vivi ricercatori; e su questa intepretazine del
modo di esposizione platonico ha applicato ad esso un modello di teoria filosofca
fondato sul principio della comprensione e comunicazione del dialogo sincero,
236
Sul rapporto Schliermacher- Gadamer cf.
‘senza invidia’, sensza l’obiettivo di voler ad ogni costo prevalere nella discussione,
in una ricerca ed interrogazione incessanti e continua della “verità” del senso della
vita umana..
Ritorno su Migliori e sulla sua messa evidenza in Platone di una pluralità di modelli
politici tra loro collegati logicamente, partendo dalla città per dèi o semidei di
Repubblica, alla città umana del politico e delle leggi per finire a quella di un
ordinamento complesso che tiene conto della concreta varietà degli interessi privati
e pubblici in una società in cui la forza e la autorità delle leggi non deve significare
la lo strumentalizzaione dei gruppi più forti.
Ma questi modelli non sono il fiine di quei tre importanti “giochie seri” intono a alla
“ prassi etice e politica”; essi,invece, costituiscono i mezzi m i criteria operandi, di
una attività di falsificazione di una illegittima pretesa. In Reppubblica questa vinee
figurata proprio nel primo libro nella sua espressione piò forte e concentrata di un
“giusto come l’utile del più forte”. E,pertanto, essa si svolge per tutto il suo percorso
mossa e guidata da questa fondamentale ntenzione polemica contro la pretesa che
il atto diffuso delle violenza e dei confliti endici nell’ Elladade e tra e dentro le sue
città solo per i l suo immane peso di fatto debba essere anche necessariamente un
valore, un presu modello politico della città reale.
Migliori fa bene a richiamare l’attenzione sulla nautra non meramente di ssogno
utopico della conezione polica di Platone in Repubblica, ed ad evidenziare ch
l’accento deve essere posto soprattutto in prospettiva di una “città possibiie” di un
possibile miglior vita per tutti.
E,tuttavia, il piano di questa prospettiva non è quello di una dottrina socio-politica a
forte rilevo etico ed educativo ; se fosse così avrebbe ragione Vegetti a considerare
giustapposto il discorso del primo libro e ‘spuria’ l’epilogo mitologico della intera
opera; e tra l’altro da questo punto di vista sarebbe anche strana la polemica
esasperata contro la poesia teatralizzata, contro la pittura.
Nella stessa interpretazione di Friedlander, che pura sottolinea che senza la disputa
del primo libro non avrebbe senso tutto ciò che segue, rimane indeciso il problema
fondamentale dell’effettivo livello cognitivo-immaginativo-linguistico in cui accade
questa rappresentazione discorsiva, che inizia drammaticamente con posizioni in
conflitto per poi entrare in una atmosfera di “calma”
Ed è questo uno nodo funzionale e costruttivo che riguarda anche il Politico e Leggi.
Che ne sarebbee,poi, dell’ unità e polivalenza tematica del pensiero etico e politico
platonico, se questa non fosse retta da una unità-omogeeeità generata da una
peculiare attività cognitivo-linguistica. Non affrontare questo problema di fondo
significa lasciar agire quella presupposizioni culturali che stanno alla base e
condizionano le letture dottrinarie – come è quella di Migliori- del testo di
Repubblica.
A suo modo questo problema preliminare è centrale in Friedlander. A proposito del
Trasimaco egli scrive : “ Soprattutto il fatto che questa disputa preliminare non solo
precede le parti costruttive seguenti ma rimane in costante tensione coon esso
rende più di ogni altro la Repubblica un autetico <dialogo> e non uno scritto
dottrinario arbitrariamente costretto in una forma dialogica “ ( P. Friedlander, cit.,p.
784). Ed nella nota relativa (p. 1352) a ragione si contrappone a F. Dornseiff (1941)
Per il quale “ < discussione di Repubblica inizia con il libro II> “; ed a ragione si
differenzia anche da Schorey, per il quale non sarebbe possibile alcune decisione in
merito.
Dunque, a distanza dio più di settanta anni, il problema sta ancora davanti a noi
irrisolto o ingiustamente emarginato, almeno dal punto di vista di chi come Migliori
pur si propone di rendere conto di tutto Platone e del tutto di ogni opera.
Ad indebolire la importante presa di posizione di Friedlander sul ruolo non
marginale e non meramente scenico-decorativo del I Libro è,però, la sua
identificazione del modo cognitivo-linguistico secondo il paradigma dell’ |autentico
dialogo|.
Se è vero che il paradigma dottrinario non è in grado di ‘pescare’ tutto il Platone di
tutta la Repubblica, perché non sa spiegare il suo intreccio costante ed intimo con
l’elemento/Racconto e con la funzione costruttiva decisiva della disputa
raprresentata nel I libro, non di meno si rivela inadeguata l’applicazione del
paradigma dialogico, se lo intendiamo come ripresa imitativa del dialogo vivo.
Come vado sostenendo fin dall’inzio di questo mio saggio di confronto con l’opera
del Migliori, la forma del piano di composizione –esposizione platonica per me non
sta in diretta corrispondenza imitativa con la esperienza di una sincera
comunicazione di dotti ,intellettuali e filosofi riopresi nel vivo di una ricerca e di una
discussione. Quella formai,invece, è il risultato di una trasposizione analogica di
elementi, strutture, meccanismi, proprri della poetologia drammaturgica attica del V
e IV seciki. Essi così metafaforizati e rifusi, rimescolati, sta al servizione ed in
comunione problematica—semantica profondo con il lavoro di teorizzazione.
Una atttività di teorizzazione di natura performativa- come è quella che si svolge
secondo ia logica dell’implicito propria del gioco giocato- e xhw ai realizza per vi
anegativa come falsificazione di quel sofisma che proprio nel primo libro di
Repubblica roccupa prpepotentemente le provocatoriamente la scena.
Ed è queaa l’alternativa al modo dottrinario di elaborazione dei contenuti
concettuali xhw afugge a Friedlander ed anche al suo allievo Gadamer, che pure –
prendendo le distanze da un Friedlandere rinito nella centralità dell’indicibile e nel
non concettualizza- ripensa la forma-dialogo nella radice di pensiero rigoroso della
vita uamna comunitaria impregnata di ethos, di una “etica dialettica”.
IRassumo : il primo libro di Repubblica, il cosiddetto Trasimaco, al di là del problema
filologico della sua effettiva redaxione risptto agli altri libri- è funzionalmente e
strutturalmente parte integrante e sostanziale dell’opera; ed anzi rappresenta la
focalizzazione del pimtp do proemtamento di tutto il suo svolgimento; essa,infatti, si
pone cone indicatrice del terminus contra quem, dell’obiettivo fondamentale da
colpire utilizzando come strumento-rete un modello della città ideale possibile.
E tutto questo dentro una filosofia dialettica che è immersa in una comunicazione
pubblica di tipo spettacolare , dove quella teatrale ha un ruolo di primo piano.
Perciò ytoviamo in una opera che dovrebbe essere di dottrina socio –politica o
l’autentico dialogo sullo Stato Educativo una polemica inisstita contro la poesia che
ha nel teatro il suo mass-medium..
Solo su questa commutazione funzionale di paradigma è poossibile uscire dalla
falsa alternativa o intepretazione secondo il principio dialogico-artistico-retorico o
secondo il modo dottrinario sistematico.
L’unità e la polivalenza di paradigmi in Platone – di cui in una polemica contro il
sistematicismo parla anche G. Casertano- deve essere ,dunque, ricondondotta e
ripensata dentro questo impianto di base, a meno che non si vuol ridurre Platone
ad uno scettico-propabilista o – come sostiene Miglioti- ad un aturoe di tanti giochi
seri, dove pur essendoi molte idee forti- non vi sarebbe una ben delienate,
coerente, positiva filosofia platonica; e che addirittura essa sarebbe inficiata del suo
stesso interno da una “contraddizione mortale. E così Migliori dopo un lungo
impegno per riportare in vita ed al centro della disucussione culturale Platone, alla
fine lo seppellisce di nuovo .
7.1. Il collegamento logico tra Repubblica e Politico.
Da quanto fini qui ho rilevato mi sembra chiaro che la questione del collegamento
tra un’opera ed un’altra di Platone è condizionata dal modo in cui intepretiamo ogni
dialogo e dalla decisione di ritenere importante o meno il dover dare conto
dell’unità e polivalenza di tutto il Platone scritto, ripreso e rispettato in
quell’intreccio indissolubile e decisivo tra Racconto e Teoria.
Per quanto mi riguarda ritengo che un confronto ed una discussione su Platone
che non rispettino questi canoni costituiscono solo un ulteriore contributo per
fraintenderlo e per perderlo di vista nellla sua perdurante attualità e superiorità
rispetto a tutti quelli che a loro volta credono di averlo ‘superato’,mentre lo hanno
soltanto ‘chiosato’ e costantemente sottovalutato nel suo essere il più grande
logico della logica filosofica.
Il Politico – sul quale ora brevemente mi tratengo- rappresenta uno dei passaggi
più complicati che sfidano il lettore ; dico subito che esso non è la messa in opera
di un discorso di dottrina o di filosofia politica in senso tecnico e disciplinare.
Platone stesso espressamente ci dice che esso appartiene ad un contesto
problematico strutturato in tre domande riconducibili ad ambiti diversi ed in cu una
di essa- |Chi è il sofista ?- rimanda ad un territorioi che è paratecnico , nella misura
in cui si tiene conto della fenomenologia eristica-menzognera.
Quando Migliori scrive che questa opera costituisce un necessario passaggio tra
Repubblica e Leggi, poiché funzionerebbe come il primo momento di una messa
con i piedi per terra del modello politico per dèi o semidei - e realizzerebbe questo
suo ruolo con la focalizzazione della natura del politico come colui che mediante le
leggi si prende cura del suo popolo e lo custodisce come il pastore fa con il suo
gregge- , egli continua a leggere da lettore che fa prevalere il modo |DDP| rispetto
a quello implicito proprio del paradigma |GG|.
Migliori ancora una volta e come tanti altri interpreti crede che le domande-guida
sia quelle fissate definitivamente in quella forma, che qui costituisce una variazione
‘personalizzata’ di quella generale |Che così è x in un contesto dato ?|.
Ma i rispettivi giochi testualizzati platonici sono nel loro intero riconducibili
effettivamente a quella forma di domande ?
Lo sono solo se mettiamo tra parentesi il nome |Socrate| nella sua funzione prototipica-paradigmatica e nella relazione che essa ha così e, dunque, implicitamente
nell’orientamento complessivo del dialogo.
Ed anche questo proposito in sede di lettura del Politico devo ripetermi e ricordare
che quello di |Socrate| non meno dei nomi degli altri personaggi, è un NomeMaschera e, perciò, esso è riassuntivo di una storia; vale a dire di ciò che egli ‘disse
,fece e pat’ì, secondo una formula analogicamente mutuata dalla ‘grammatica’ della
drammaturgia attica.
Che cosa consegue da questa identificazione e quali conseguenze ha sul lettore
questa caratteristica del ‘fare il nome’ ?
Nel Politico il discorso è introdotto da Socrate che interloquisce e parla di “calcolo”
con il matematico Teodoro, ed è chiuso da Socrate Giovane, che condivide con il
primo solo il nome e che scenicamente prende il posto del giovane matematico
Teeteto, che assomiglia a Socrate anche nel volto.
Dunque, chi legge il testo non deve mai dimenticare che la ‘storia di Socrate’,- cioè
quella che lo ritrae come il cittadino più giusto ingiustamente accusato e
condannato a morte dai cattivi giudici e dalla cattiva politica della città ormai
‘mentalmentee’ corrotta- , non è qualcosa di esterno al discorso che immediamente
si farà riconoscere come una attività Analitica della parola e del concetto di
|Politico|. Ed,invece, proprio così di fatto pensa il lettore accademico, cioè quello
educato ed abituato alla logica |DDP|.
Per questo tipo di interprete – tale è anche nella sostanza anche il Migliori,
nonostante ll suo richiamo alla logica dei “giochi seri”- - quell’ elemento della
grammatica del Racconto che è costituito dall’uso del nome in funzione tipologica, è
irrilevante nella determinazione della intenzione teorica della intera
rappresentazione.
Ma così facendo , questo lettore viola il canone che impone di rispettare il tutto
della forma del piano di espressione che è tutt’uno con il modo in cui Platone
manifesta i suoi pensieri.
Questa forma per me – lo ribadisco- non è quella dialogica in senso stretto,, come è
in Schleierrmacher-; ma è appunto quella di una dialogica così come realizzata da
una scrittura di tipo spettacolare e teatralizzante ; tale è anche quella del Politico.
Pertanto, anche rispetto a questo testo il lettore adatto è quello che sa procedere
dal lettore/spettatore-cooperatore nella riproduzione asintotica di un gioco di logoi,
tenendo appunto conto che appartiene alle regole di questo gioco l’impiego
tipologico-paradigmatico del nome-maschera |Socrate|.
Ed allora se così ci comportiamo nello sforzo di riconoscimento del senso
complessivo di quest’opera, ci accorgeremo che la sua logica è quella operativa
implicita anche in altri dialoghi, come ad esempio inel Protagora, Fedone, nel
Simposio, Cratilo, Filebo e naturalmente nel Teeteto e nel Sofista.
Vale a dire : Platone parlando al suo lettore, e, quindi, muovendosi su ciò che Sedley
dal suo diverso punto di vista chiama “sottotesto”- sottoscena , io aggiungo- gli
trasmette un messaggio che riassumo nei termini che seguono.
La questione-Socrate, cioè quanto di serio e terribile viene alla luce nell’evento di
una città che organizza un processo menzognero contro il suo cittadino più giusto e
sulla base di questa menzogna collettiva lo condanna a morte, questa catastrofe
morale della sensibilità e mentalità privata e collettiva non è indagabile secondo
una pura logica tecnico-epistemica. E non perchè – come interpreta Friedlander-
l’esistenza ed il destino del Socrate della storia costituirebbero un mistero ineffabile
e non pensabile.
Platone ricorda il suo Socrate in sede di scena della scrittura come un Prototipo
portatore di una Proto-tipo.logia intorno al logoi realtivi alle “Cose Massime”.
Dunque, lo scenario è quello di logoi contro pseudo-logoi; lo spettacolo è quello di
una ricerca della veracità nella vita comunicante della città in presenza di un attacco
in grande stile e di uno sostanziale vittoria di fatto in città di una comunicazione
pubblica distorta; essa si avvale dei meccnismi della elaborazione e della
trasmissione spettacolare e teatralizzante dei discorsi su i valori, sulle virtù, sulla
prima di esse, cioè sulla giustizia. sulla felicità e sul loro rapporto con la natura
dell’uomo politico, con le forme di governo e con le leggi.
Questo Platone, inoltre, non fa mai incontrare il suo Socrate direttamente con i
confezionatori-calcolatori, pianificatori, della phantasmologia menzognera a diretto
servizio dei dominatori di turno; infatti, la rappresentazione degli incontri sulla
scena della sua scrittura chiama in gioco drammatizzamte figure di intellettuali
giovani e non giovani che in un modo o in un altro e con diverso grado di
soggezione all’ effetto discorsivo distorcente , non riescono ad avere coscienza ed
adeguata consapevolezza della natura mistificatoria ed immorale di quella
paracultura di cui ha bisogno di ammantarsi il falso messaggio di una “giustizia
come l’utile del più forte”.
Perciò, questi interlocutori di Socrate vengono a comporre una ‘galleria’ di ‘malati
mentali’ (Eutifrone, Ione, Carmide), Callicle, Menone) o una ‘teoria’ di intellettuali
chiusi nei loro saperi specialistici, che li unilateralizzano ed assolutizzano, nella
infondata pretesa che essi da sé possono far capire che cosa di tremendo e di
epocale sta accadendo nell’Ellade con la passione e morte del più giusto e più pio
degli Elleni : il maestro educatore, cittadino esemplare, Socrate.
Analogamente nel Politico, lo “Straniero”, al quale il Socrate di Platone in accordo
con il matematico Teodoro lascia il compito di prodursi in una analisi sistematica ed
essenziale della natura del politico,
rientra appunto in quella categoria di
intellettuali, che forti dei loro metodi e dei risultati teorici attraverso di essi acquisti
ed omologati, non si accorgono e non sanno ‘spiegare’ che cosa sono e da dove
provengono i logoi della accusa a Socrate.
La sua raffinata ‘logica analitica’ – che Platone in alcuni passaggi mette anche in
ridicolo- perviene alla conclusione che l’attività politica sia una “retta tessitura” e
che il politico è colui che si prende cura del bene del suo popolo.
Ma se questa è l’essenza del politico, se questo è il suo modello, come questo poi
può mappare-misurare quella antipolitica dei cattivi politici che ispirano ed
organizzano la congiura contro Socrate con la complciità di intellettuali venduti e
con l’appoggio della massa corrotta che appae in quei logoi, che nella Apologia
Socrate porta alla ribalta e denuncia com subdolamente ‘scientifici’ ed allettanti con
la loro sofisticata brillantezza ed apparente logicità ?
Ed è proprio questa la domanda implcita-guida che Platone rivolge al suo lettore
adatto con la figurazione del Socrate in Silenzio subito dopo l’avvio della
rappresentazione e fino al termine della messa in opera del Politico; non caso
,perciò, essa si chiude con un battuta di adesione del Giovane Socrate alle
conclusione dello “Straniero”; ma non con un intervento del Socrate che ha dato
avvio al dialogo ed insieme ai convenuti ha posto il problema della natura del
politico in quei termini.
Ma via facendo a questi termini ed alla forma dichiara del problema che essi
compongono, segue un gioco argomentativo che è caratterizzato da un costante
sottointeso che funge da implicito contrappeso di interna limitazione della portata
di quel finale approdo.
Questo sottointeso non è una sfuggente e generica dimensione ironica che
caratterizzerebbe il ruolo di Socrate sulla scena e che sarebbe riconoscibile solo per
la soggettiva sensibilità e gusto del lettore.
Esso al contrario è una proprietà testuale e precisamente quella del segno-guida che
il Nome-Maschera |SOCRATE| e di quella figurazione del Socrate in Silenzio, sul
quale Friedllander richiama – purtroppo per lo più non ascoltato- l’attenzione.
E per valorizzare questo Friedlander, però, bisogna non seguirlo nella sua
sottovalutazione della dimensione di teorizzazione che è fondamentale nel Platone
dei dialoghi, e contemporaneamente bisogna spingersi fino in fondo a pensare la
natura funzionale propria dell loro costante profilo drammatico; senza aver timore
di offendere Platone, svelando come lui che si presenta apparentemente come
‘nemico della poesia teatralizzata’, in realtà valorizza al massimo analogicamente
canoni costruttivi stabilizzati ed omologati dalla poetologia del suo tempo.
Chi, dunque, legge quel nome deve in via previa sapere che esso fa segno ad una
‘storia’, quella della vita di un Socrate amante della giustizia e che per la giustiza ha
patito da vittima innocente la sua messa a morte .
La scelta di Socrate è un decidersi per un martirio, per la estrema testimonianza
della sacralità che è il bene irrinunciabile di una comunità umana regolata da giuste
leggi,; leggi che bisogna rispettare nel loro valenza di principio, senza sfuggire loro
anche quando esse vengono strumentalizzate e negate con le azioni ingiuste. Ed è
questo appunto il messaggio del Critone, che con l’ Apologia ed il finale del Gorgia e
del Fedone concorre a d offrire al lettore –spettatore gli elementi essenziali del
Nome-Maschera |SOCRATE|.
In conclusione : la formazione del modello di politico che prende corpo testuale
nell’omonimo dialogo non costituisce lo scopo metodico dell’opera, ma solo la
progressiva messa a punto e definizione per via analitico-.semantica di un modello
epistemico-tecnico della natura dell’uomo politico, con la intenzione di mostrarne
gli interni limiti allorchè lo si proietta sulla ‘storia di Socrate’, il più gtande deli
politici. Esso,infatti, non riesce a rende conto di quella Antipolitica che si abbatte su
questo Socrate fino a distruggerlo. Questo significa che bisogna andare oltre la
‘dottrinaa poilitica’ che può indagare sugli errori ‘tecnici’ del fare politico, ma non
spiegare quell’attacco allo spirito costituzionale che si realizza strumentalizzando
ordinamenti, leggi e pratiche di governo agli interessi esclusivi dei più forti, dei più
ricchi; ed allestendo e ‘mandando in onda’ , ‘ - le onde della navigazione nel mare di
logoi’-. spettacoli di comunicazione pubblica, che manipolano la opinione della
moltitudine dei cittadini.spettatori con phantasmalogie paraculturali e
paraeducative, propagandate come ‘superiore religione’, come ‘vera educazione’,
come ‘scienza alla moda’, come verità della realtà.
Repubblica e Politico,pertanto, sono dialoghi che ‘marciano divisi e colpiscono uniti’
: l’uno prende di mira una falsa opinione ‘spettacolarizzata’ sulla natura della
giustizia e a questo scopo apppronta una complessa modellizzazione di una città
possibile anche se molto difficile, al limite dell’impossibile per le capacità umane;
l’altro denuncia i limiti di una visione puramente tecnicco-epistemica in una ricerca
attorno alle “Cose Massime” e soprattutto nella lotta contro il sofisma-menzogna,
che per sua natura sfuggge alle retti dei vari saper fare tecnici, al quale anche la
modellizzazione- del politico – simulata da Platone nelle vesti di un ‘ analitico’appartiene.
La domanda che Platone lascia al suo lettore è, perciò. questa :
Se il politico è colui che si prende cura in maniera disinteressata del bene del suo
popolo e lo custodisce e lo guida per questo scopo, e se l’attività politica e legislativa
è una corretta arte della tessitura nell ‘ interesse ed esigenze di tutti gruppi di
cittadini, allora perché si impone di fatto nelle città una mala politica che non è un
semplice ‘errore’ nella applicazione di quella techne di mediazione e di unione del
molteplice e del diverso – come sono i fili di una tessuto-, ma è la distruzione del
cittadino che meglio e più di tutti costituisce un esempio mirabile di questa ricerca
incessante di unità nel bene e per il bene comune ?
Questa mala politica non è, dunque, risultato di una incapacità tecnica , di
inadeguati ed immature dottrine e prassi politiche; c’è in essa qualcosa di terribile ;
c’è la volontà cattiva di annientare la stessa possibilità di una mediazione, c’è l’
Anti-Politico, una pura volontà di violenza anticostituzionale, spacciata come
superiore e più aggiornata ed avanzata ‘scienza politica’.
Questo è il tragi-comico nascosto nella drammatizzante messa in opera del Politico.
Mi fermo qui; credo che ho prospettato un collegamento tra le due opere non solo
diverso da quello proposto da Migliori, ma con il vantaggio di rispettare la relativa
compiutezza del gioco giocato sia in Repubblica e sia di quello eseguito nel Politico.
Posso anche dire che ho imitato Migliori, l’ho preso sul serio, ho accettato la sua
fondamentale indicazione suilla importanza in Platone dei “giochi seri” e sulla
necessità di rispettare l’intero Platone; la mia aggiunta è il risultato di una
applicazione conseguente e sistemica fino in fondo della sua prospettiva che
vorrebbe essere diversa da quella degli interpreti dottrinari che vedono come fumo
negli occhi il paradigma del gioco.
Ma Migliori via facendo di fatto si pente, o almeno non si accorge di pentirsi;
l’effetto inerziale dei modelli ermeneutici istituzionallizati nella pratiche degli studi
dell’Accademia lo trascinano,infatti, verso il piano di una lettura in cui l prevale
l’ottica propria del paradigma dell’esplicito e del dottrinario-disciplinare, con
l’emarginazione continua della funzione di coteorizzazione dell’ elemento/Racconto,
inelimanbile,però, se Migliori si propone – come dichiara programmaticamente- di
rendere conto di tutto Platone, almeno nei fondamenti della sua strategia teorica e
dell’ impianto funzionale- strutturale della sua testualizzazione.
7.2 Il collegamento tra Repubblica e Leggi.
A questo proposito la mia ipotesi è la seguente : le due opere, che anche
quantitativamente hanno un posto fondamentale nel Platone scritto, possono
essere figurate come due soli di un sistema planetario, dove appunto i pianeti
orbitanti attorno ad esso sono rappresentati dagli altri dialoghi.
In tal modo riprendo la metafora della “costellazione” rintracciabile nel Friedlander,
che propone una configurazione dell’insieme della produzione dialogica platonica;
questa si dà appunto di fatto come una pluralità di totalità testuali determinate,
quali sono analogamente una pluralità di opere d’arte, , drammatiche, scultoree,
pittoriche che siano; di composizioni musicali.
Questa metafora astronomica , cosmologica, ben si addice alla spirito platonico;
svolgendola , perciò, si può dire che l’insieme dei dialoghi è una pluralità di logoikosmoi, cioè di ‘discorsi cosmicizzati’, vale a dire caratterizzati ciascuno da un
intrinseco principio d’ordine e che , sulla base di questa loro costituzione ‘al
plurale,’ essi interagiscono ‘riflessivamente ‘ tra loro e con quei ‘due soli’.
Affinchè questa metafora possa funzionare veramente e guidarci in questi viaggi
logico-cosmici ed in questa navigazione linguistica e metalinguistica, dobbiamo
fissare questo punto : in ogni dialogo la polemica contro il sofisma ed i suoi falsi
‘mondi logici’ è funzionalmente e strutturalmente costante; come tale essa ci indica
la direzione nella quale dobbiamo cercare l’isomorfismo tra i diversi dialoghi
e,dunque, il loro originale principio sistemico; questa caratteristica , insieme ad
altre, è una proprietà costruttiva applicabile a tutti i dialoghi, compresa l’Apologia.
Pertanto, è sulla base di una concezione morfologica ed isomorfica che si può
parlare di sistematico o di sistemico in Platone, visto e letto nella sua costante
pratica dei rimandi all’interno di ogni dialogo ed tra tutti i dialoghi.
Migliori , seguendo lo Szlezak della “struttura di soccorso” ed introducendo il lavoro
d Kahn sulla forma letteraria dei dialoghi platonici , evidenzia la dinamica ascensiva
ed ingressiva in senso verticale in ogni opera e in senso trasversale al loro insieme.
Ma se egli assume il paradigma del giochi seri come via determinante per la
scoperta dei pensieri di Platone e se vuole essere coerente con questa scelta
ermeneutica , egli non può, poi, concepire la dinamica ascensiva ed ingressiva in
senza rispettare il principio dell’autonomia di ogni partita del gioco in una pluralità
di giochi diversi. Ed così Migliori non dovrebbe parlare di manchevolezze e di
necessità di integrazioni in diversi fasi e livelli argomentativi.
Come ho sopra illustrato, infatti, dire che si dia un gioco incompiuto significa
ammettere che si è fuori dalla logica dei giochi ; per essa in ogni gioco effettuato la
partita deve finire con un risultato suo e solo suo.
La coerenza con questo canone ben si sposa con il modello morfologico-isomorfico;
mentre entra in lotta di collisione ‘mortale’ con la logica |DDP| assunta come
prevalente e dominante paradigma in sede ermeneutica.
Purtroppo Migliori non sospetta minimamente di questa incompatibilità funzionale
tra ciò che egli dice e fino ad un certo punto fa – soprattutto nei suoi lavori
precedenti su i dialoghi dialettici – e ciò che in realtà ed in massima parte fa in
questa sua imponente ricerca.
La sua conclusione sulla “contraddizione mortale del platonismo” è figlia di questa
contraddizione operativa di fondo che lo accompagna dall’inizio alla fine della sua
indagine.
Per uscire da essa, dobbiamo allora saper coniugare il modello morfologicoisomorfico con il principio di perfomance proprio del modello di gioco serio; e
soprattutto non dobbiamo dimenticare che questa coniugazione sta dentro la
prospettiva platonica della centralità della vita comunicante di una Polis a
spettacolarità spinta, dove si confrontano ed entrano in conflitto due visioni di ciò
che è bene e ciò che è male per la città ed i cittadini.
Non ci deve,poi, sfuggire che in questo contesto l’evento nuovo è l’imperversare
della phantasmalogia sofisito-eristica che punta ad una legittimazione paraculturale
delle politiche di violenza e dei rapporti sociali improntati al dominio ed alla
conquista ad ogni costo della ricchezza, del successo, della massima visibilità, della
fama , della gloria, della immortalità storica.
Se teniamo fermo questo scenario di fondo possiamo capire perchè i nostri ‘ due
soli’ devono anche essi essere inquadrati in una attività dialettica come opera
incessante di liberazione e purificazione del discorso, del metadiscorso, dalle false
ed allettanti promesse di superscienza e di felicità pubblicizzate con quella
girandola fantasmagorica di logoi, confezionati e cucinati dagli intellettuali che si
sono venduti l’anima a chi detiene il potere, per acquisire e consumare privilegi di
casta, e per esclusivo proprio tornaconto personale e familiare.
Quando , perciò, in Leggi Platone insiste a precisare che la sua fondazione della
nuova colonia accade nel e con il discorso/Logo, non dobbiamo dimenticare che
questo logos non è quello puramente dottrinario, quello degli ‘scienziati della
politica’ e dei tecnici delle leggi, degli esperti di coesistenza sociale.
E Migliori di fatt lo dimentica e segue anche lui questa ultima strada , quando
inbocca la direzione che lo porta a vedere questa opera come momento di una
dottrina politica realistica, più vicina alle effettive possibilità umane; essa
prenderebbe così la distanza da quella città per soli dèi o semidei che secondo lui
verrebbe rappresentata in Repubblica e che ne costituirebbe lo scopo metodico e
varrebbe solo come modello ideale da imitare per quanto è possibile alla condizione
umana.
Lo schema | dalla città ideale alla città reale| è , però, il risultato di una prospettiva
interpretativa che non tiene conto dell’effettivo territorio dove accadono anche in
quest’ultima opera i logoi politici platonici.
Per forza di cose Migliori deve ancora una volta tagliar fuori la dimensione narrativa
e pur segnalandola , egli è portato a non riconoscere come centrale la polemica con
quel sofisma che fa qui capolino in una sua variante ; tale è il pregiudizio del
presunto valore costituzionale del principio della guerra assoluta, sotto la cui
ingannevole attrattiva sembrano soggiacere, almeno per un breve tratto iniziale, i
due padri costituenti , simboli di due grandi civiltà : lo spartano Megillo ed il cretese
Clinia.
Questa variante del sofisma, che nel corso dell’opera è rafforzata anche con il
richiamo del sofisma-madre, quello del
Trasimaco che provoca l’avvio
argomentativo di Repubblica, decide , dunque, anche della natura funzionale del
piano dove accadono i discorsi sulle legg.Questo piano è operativamente di natura linguistica e metalinguistica, perché
paralinguaggio e parametalinguaggio è la falsa opinione che costituirebbe una
fondamentale legge della vita della città , della sua conservazione, della sua salvezza,
del suo svilupp, la presunta ‘legge dei più forti’, siano essi tiranni con le loro
famiglie, partiti, con le loro consorterie affamate di denari e privilegi, sia che quella
pretesa legge fondamentale sia quella della dittatura della maggioranza, della
moltitudine aizzata , illusa,strumentalizzata dai demagoghi.
Il terreno dello scontro è allora quello dell’etica del discorso, dei discorsi scritti e
non scritti, in cui prendono corpo le parole e le argomentazioni sulle pratiche
legislative e su quelle della instaurazione di forme di governo.
Ma discorso su i discorsi è appunto metadiscorso; questo ha di fronte a sé non una
posizione dottrinaria concorrente e rivale, ma una pseudo-dottrina legislativa che è
strumentale solo ad una legittimazione formalistica e , perciò, pseudo-giuridica dei
risultati ottenuti con la forza delle armi e con i meccanismi e gli strumenti di
controllo e di repressione del dissenso.
Anche in Leggi è, dunque, in gioco una attività di etica del discorso pubblico e del
metadiscorso filosofico; pertanto,- ci dice a modo suo Platone- ragionamenti e
dimostrazioni che qui vengono impiegati in tanto hanno senso e valenza in quanto
ci predisponiamo e ci situiamo in una Opzione-Scelta intelligente dei Valori.
Questa Decisione costituisce il cuore del Nous, dello spirito costituzionale, senza il
quale la formazione delle leggi non potrà mai assicurare una autentica , stabile e
solida coesistenza pacifica in quella armonia sociale. che è propria di una vita
migliore del singolo cittadino in Città e di tutta la Città.
In questa prospettiva io valorizzo anche il nesso semantico evidenziato da Migliori
sulla scia di una esplicita indicazione di Platone, tra nomos-voos237 .
Dunque, l’intelligenza di cui Platone scrive [ 957 C4-7] è tutt’uno con una prassi,
sta dentro di essa, non solo prima o solo dopo di essa.
C’è, infatti, in Platone un pensare peculiare che è molto di più di una preparazione
all’azione etica o di una riflessione su questa ’azione compiuta.
237
Migliori, cit, p. 869.
La scelta del bene e di quel bene che è la giustizia è , in Platone e per Platone, Agire
Rivelante-illuminante l’essenza della vita umana nel momento stesso del suo
avvenire e farsi; perciò, è svelamento ‘in action,’ è perciò pensare autentico.
In forza di questa sua preziosissima gemma speculativa , Platone -non compreso e
per lo più frainteso come teorico sostenitore di ciò che i dottrinari interpreti
denominano |ntellettualismo etico|-, farà dire al suo Socrate che si guadagna
l’accesso alla virtù conoscendola.
Si tratta qui appunto di quel peculiare conoscere che non si identifica con la ragione
discorsiva e riflessiva, ma di quella consustanziazione/synousia comunitaria che si
realizza facendo il bene e che in questo fare si mostra nel suo interno ordine e fa
vedere, fa conoscere l’ordine umano e cosmico al quale appartiene.
Non dobbiamo aspettare Hegel per scoprire l’importanza della coscienza dello
“Spirito Oggettivo” e della luce delle sue Figure-Figurazioni.238.
Che l’individuo e la sua coscienza ‘soggettiva’ stiano in un gioco di ordine terreno
ed ultraterreno molto più grande di lui, è un idea che appartiene ai fondamenti del
pensiero platonico, che per altro aspetto è certamente radicalmente e
fortunatamente dualista ed in questo senso anche, anti-litteram, anti-hegeliano.
Esso,infatti, non ammette in alcun modo una mediaizione agli estremi di verità e
sofisma, tra giustizia e violenza distruttiva dell’umano.
Questo Platone irriducibile non dobbiamo compatirlo per la sua “contraddizione
mortale”, ma dovremmo ringraziarlo per aver capito prima dei moderni e postumanisti ciò che questi non hanno capito; o per innocente confusione o perchè non
hanno voluto capirlo per un preciso calcolo, come è quello pianificato
hegelianamente per un ‘superamento’ dello spirito del Cristianesimo nel programma
di una dolorosa ma necessaria organica conciliazione tra giustizia ed ingiustizia, tra
verità e menzogna, tra bene e male.
Non c’è, dunque, bisogna di cristianizzare Platone, perché al dialogo con il
Cristianesimo , pur fuori dalla concezione di un Dio Personale, Incarnato e
Salvatore, egli oggettivamente offre un punto fondamentale di convergenza ,pur
nella distanza storica ineliminabile.
Questa eredità non è quella di un generico platonismo in un indistinto ellenismo,
ma lo ‘scandaloso’ dualismo radicale tra bene e l’anti-bene delle energia cattiva
distruttiva della comunitrà umane, dei suoi membri, dei suoi giusti.
Questo Platone, perciò fortunatamente per noi ‘dualista’, è anche quello delle
Leggi, proprio lì dove egli dall’inizio alla fine si oppone al preteso insuperabile
Perciò in Hegel è fondamentale la esperienza della verità come ìApparizione Illuminante LogicoLinguistica’ di quella Cosa che l’autorivelarsi della vita storica nella sua Eternità, tutta e sola qualità
dell’agire del genere umano, rispetto al quale i singoli e la loro singolarità sono soltanto mezzi
biologici-culturali. Questo aspetto fondamentale della ‘logica hegeliana’ viene per lo più non
messo in risalto nella sua natura ‘mitologica’, pseudo-scientifica.
238
dualismo di comodo tra Kephalè e Nous, cioè tra principio di Autorità-Sanzione/
Kratos e quello di Bene Comune/Ethos.
In gioco, infatti, in tutta l’opera , dalla prima battuta all’ultima, c’è proprio il
Platone che accetta la sfida di Dire rigoramente la possibile e reale Koinonia tra
questi due principi, partendo della situazioni tipiche relative alla disciplina degli
interessi economico-sociali e delle pratiche giuridiche-istuzionail, regolanti questa
pluralità di concrete situazioni ricorrenti nella vita della Polis.
Platone, dunque, scrive quest’ultima opera non per farsi perdonare l’utopicaastrattezza e la strana commistione di polemica-argomentazione-mito, di cui si
sarebbe ‘macchiato’ con il sogno di Repubblica.
Platone aveva vivo, per l’influenza esperienza e lunga tradizione familiare e per la
sua personale formazione culturale, il senso del concreto , del ‘particulare’,
dell’effettuale, ed era certamente il più esperto in costituzioni e legislazione del suo
tempo, nonché il più acuto analista del ruolo degli interessi economici e di classe
nelle vicende politiche della sua Ellade.
E cone nessun altro egli sa esplorare la psicologia delle folle e gli ‘impazzimenti’ di
intellettuali turbati , stressati, contagiati dalla follia del successo sociale e
professionale. Questo Platone è particolarmente visibile in opere come i già citati
Eutifrone, Ione, Carmide e fa capolino nel prologo del Fedro.
In Leggi- come ho detto- non assistiamo ad un Platone idealista ‘pentito’ e
ravveduto che si fa perdonare per averla fatta grossa con i vaneggiamenti
iperuranici sull’Ottimo Stato di Repubblica.
Questa intepretazione, prevalente negli ambiti degli studi platonici e che è
presente anche in Migliori, risponde ad uno schema di ideale-reale che mal si
adatta alla relazione funzionale-strutturale tra le due opere.
Per capire quale sia la loro differenza e , dunque, per intendere quale sia la ragion
d’essere di ciascuna di esse, dobbiamo richiamare quelle proprietà di quei kosmoilogoi che sono gli scritti tradizionalmente denominati dialoghi.
Il loro principio sistemico deve essere pensato alla luce del paradigma non solo del
morfologico e dell’isomorfico-/isofunzionale ; ma dobbiamo anche ,infatti,
richiamare un aspetto essenziale del principio architettonico. Tale è quello della
proporzione e della simmetria.
Cerco di spiegarmi così con questa ulteriore digressione, dove richiamo la questione
del rapporto tra forma letteraria e la forma della concettualizzazione .
E’ caratteristico dello scrittore Platone ed è proprio del principio del gioco
cognitivo-immaginativo-linguistico - così come da lui operativamente applicatol’intrecciarsi del gioco, più direttamente osservabile da un lettore/spettatoreCooperatore, con altri giochi espressivi-semantici- significativi apparentemente
secondari; ma comunque convergenti con il primo per la formazione e trasmissione
di un comune messaggio e di un identica intenzione teorica fondamentale.
Potrei dire che Platone scrive in ‘contrappunto armonico’, che prevede una pluralità
di voci e di temi che si rimandano l’uno all’altro all’interno della stessa opera e poi
tra dialoghi che hanno un’ evidente ‘somiglianza di famiglia’. Ed è questo il caso di
Repubblica e Leggi.
Osservazione questa che mi riporta a Friedlander ed al problema che con la sua
intepretazione di Platone viene allo scoperto e rimane irrisolto cioè quello relativo
al rapporto tra forma letteraria e movimento di concettualizzazione.
Firedlander a questo proposito parla in generale di “spostamenti ironici” e di
slittamento del “centro gravitazionale dell’opera”, allorchè cerca di individuare
l’intenzione finale e complessiva di significazione del dialogo studiato.
Queste sue indicazioni sono fondamentali solo se le sottraiamo alla critica di quegli
interpreti che rimproverano a Friedlander di rimandare l’accertamento di questi
‘fenomeni linguistici’, caratterizzanti l’esposizione platonica, solo ai gusti non
concettualmente governabili del lettore-artista ; tale è quello che vede con il fumo
negli occhi tutto ciò che è teoria e, quindi, ogni operazione di regolamentazione, di
convenzionalizzazione di questi meccanismi semiosici, in sede di fruizione del testo.
E questa mia osservazione deve estendersi soprattutto al problema di identificare e
qualificare cognitivamente e linguisticamente con il ‘Platone Operativo’ il bersaglio
costante, sincronicamnete e diacronicamente disposto, della sua diaettica negativa,
cioè di falsificazione rigorosa, dei logoi spettacolari eristico-sofitisci intorno alle
“Cose Massime” : qui tali somo l’ Ethos ed il Kratos/Principio di Autorità-Sanzione;
ed in connessione con essi tali sono l’idea di felicità sociale e della necessità delle
leggi da istituire secondo il concetto della isonomia, di una legge uguale per tutti; e
della richiamata legge della Koinonia di Kephalè e Nous.
Anche in Friedlander è vivo il senso del ruolo della ‘teatralità’ della fenomenologia
eristico-sofistica e della costanza della sua presenza nella “costellazione” dei
dialoghi.
Ma la sua acuta e raffinata sensibilità per la dimensione poetico- drammaticaespressiva del discorso platonico non fa i due passi di svolta che bisogna saper
rischiare e che io ho cecato di eseguire.
Il primo l’ho sopra indicato come quello di saper trasformare la forma dialogica –
drammatizzante in quella di una scrittura spettacolare e teatralizzante , che guarda
analogicamente e da vicino verso alcuni elementi strutturail ed ai moduli
compositivi-espressivi di quella drammaturgia attica di cui Aristotele, da fedele e
coerente platonico, ci ha dato la ‘grammatica’ con la sua Poetica
Il secondo passo consiste nell’ istituire una relazione costitutiva e genealogicafunzionale tra il Platone matematizzante e quello drammatizzante in modo da
portare allo scoperto la logica immanente che permette a Platone di tenere insieme
e di stringere in simbiosi funzionale la formatività che plasma ed ordina il piano della
composizione-esposizione con la formatività propria del piano di teorizzazione.
Questa combinazione e fusione vengono realizzate da lui secondo una matrice
cognitivo-linguistica comune ad entrambi i piani ed alla quale essi sono
funzionalmente riconducibili . Tale matrice è appunto è quella del Gioco Giocato ,
che ha un ruolo preminente e decisivo come logica dell’implicitazione dell’ impianto
e della procedura e della finalizzazione delle fasi argomentative e dei connessi
cosiddetti |contenuti filosofici|.
Migliori che ha il coraggio ed il merito della sistematica riabilitazione ermeneutica
del principio del gioco serio, non ci aiuta poi a penetrare nel fondo di questa ‘ottica
logica’ ed a portare in chiaro che cosa essa esige da non lettori-interpreti dei testi
platonici, una volta che l’abbiamo assunta come principale filo-coduttore nella
attività di riproduzione dei significati veicolati dal testo .
Questa mancata chiarificazione dipende dalla circostanza che Migliori sembra non
rendersi conto che la convivenza tra questo sguardo e quello formalizzato ed
istituzionalizzato dallo stile accademico- cioè quello operante secondo il modo
|DDP|- è tutt’altro che scontata e pacifica. Anzi essa dà luogo ad un attrito ed ad un
conflitto, quando i due modi di leggere entrano in reciproco contatto.
Da questo potenziale conflitto Migliori non esce fuori ed anzi lo acuisce con una
una costante giustappozisione di queste vie
diverse di riconoscimento
interpretativo e privilegiando l’ottica accademica; ed, infatti, non a caso egli imposta
il suo lavoro secondo il parametro delle ripartizioni tematiche, che per forza di cose
rimandano ad ambiti che sono disciplinari : la “dialettica”, la “metafisica”, la
“cosmologia”, la dottrina dell’ “anima” e della “prassi etica e politica”, come
,infatti, viene annunciato nei sottotitoli dei due volumi della sua opera.
Ma con questa tacita decisione metodica egli dà luogo ad un accomodamento di
approcci che in primo luogo non è conforme al modo di produzione e di
composizione platonico, per il quale l’elemento/Racconto, la ‘Rappresentazione’, è
consustanziale al ‘Concetto’ considerato nella sua stessa struttura e dinamica
interne.
Il Concetto’,pertanto, non perfeziona quanto dato per via rappresentativa, come
se questo varebbe come concetto imperfetto o semi-concetto, un grado inferiore
della ideazione speculativa.
Come questa dimensione narrativa abbia pari dignità di quella di teorizzazione,
Platone lo fa vedere quando e nel modo in cui Opera la problematizzazione e la
semantizzazione specifica che è a questa connessa.
Coerentemente al principio del gioco , Platone non dice dichiaratamente il
problema-guida in gioco, ma lo ‘dice’ Facendolo come Orizzonte attraente che
unifica tutte le Mosse e le Figure del gioco giocato i ciascuna opera.
La Problematizzaziopne in Platone è così il massimo punto di condensazione e di
concentrazione della sua logica dell’implicito, della implicitazione costruttivooperativa; perciò, essa sfugge al lettore che cerca il problema-guida per via
prevalentemente esplicita-dichiarata. A questo genere di lettore appartiene anche
Migliori, nonostante la sua professione di ‘cultore’ della logica per giochi.239
Come gli sfugge e con quali conseguenze sul piano del riconoscimento della
portata della ‘teorematizzaione’ l’ho accennato sopra nel corso della mia
interpretazione della figura di Lisia nel Fedro, di Dionigi nella Lettera VII, di
Eutifrone nell’omonimo dialogo, del Socrate ‘ in silenzio’ nel Politico .
Qui aggiungo soltanto ancora che la problematizzazione in Platone è il punto
decisivo di contatto e ,quindi, di confluenza della struttura e dinamiche narrative e
di quelle argomentative ; in virtù di questo contatto accade il passaggio dal modo
esplicito a quello implicito ; e ciò è possibile perché il narrativo in Platone non è un
generico prodotto retorico-letterario, ma è una dinamica di strutture e funzioni
Tipologiche, cioè di un peculiare modo di universalizzazione; e perciò esso affine è
coniugabile con l’universalizzaione propria del procedimento paradigmatico.
Questa mediazione funzionale tra Tipologico e Paradigmatico accade in un terreno
metacognitivo-metaimmaginativo-metalinguistico e secondo il comune principio
performativo del gioco giocato, ed a partire dall’insediamento dell operare
filosofico dentro i processi e la battaglia della comunicazione pubblica in una Polis a
spettacolarità diffusa dove la comunicazione politica va a cercare le sue armi per
costruire il consenso ed imporre i suoi interessi dominanti come valori nella
coscienze dei cittadini.
Se con Platone facciamo questa svolta nel modo di osservare e di leggere i suoi testi,
allora potremo anche capire perché la sua filosofia sta oltre quella propria
dell’Academia antica ,medievale e moderna, senza,però, essere anti-accademica.
L’ ‘università’ delle Technai, dei multiformi e vari Saper Fare , le ricerche disciplinari
con l’ elaborazioni in forma di trattato, in una parola , il ‘mondo del Metodo’- infatti,
costiuiscono quella sfera del “Fatto”—Garanzia verso cui deve necessariamente
guardare per trarvi Paradigmi-Modelli un filosofia che sappia bene attrezzarsi nella
lotta contro il Sofisma-Menzogna.
Questo sguardo è costituzionale per il ‘saper fare’ pensiero e comunicazione
filosofici, proprio perchè il nemico del filosofare - il sofisticare appunrto—agisce e
colpisce sempre con abiti paraculturali, ‘paratecnici, paraepistemici, paramitologici.
com paramodelli finti e truccati paradigmi.
Ed è proprio questa malizia cosmetica di una volontà di ingannare, pianificata ed
organizzata, ad ‘elevare’ e qualificare le sofisticherie e le sue bugie come
Menzogna.
Questa mia digressione, che richiama alcuni punti essenziali del mio generale punto
di vista sul Platone Scritto e su i suoi rapporti con il Platone ‘Orale’- scienziato
enciclopedico- è stata necessaria per far intendere quale sia l’effettivo rapporto
239
M. Migliori, cit. ed in particolare tutto il Capitolo Primo del Primo Volume.
funzionale e sistemico tra Repubblica e Leggi, e di come si combina in essi ,in una
varietà di rapporti i, la dimensione etica e quella giuridico-politica.
Nell’ultima opera il sofisma implicito da falsificare è la ‘sistematica’ opinione
secondo la quale la varietà delle situazioni sociali, la differenza e la divaricazione
degli interessi socio-economici, il predominare dei puri rapporti di forza economico
e militari, l’egoismo irrefrenabile di individui ,famiglie e ‘corporazioni’, le differenze
di classe, renderebbero improcedibile la formazione di istituzioni e di una
legislazione capaci di garantire una stabile coesione sociale e l’uguaglianza dei
cittadini di fronte alle leggi; e che,pertanto, queste sarebbero solo ‘apparati e
meccanisi’ funzionali alla legittimazione ex-post del’utile dei più forti.
Per smontare l’apparente verità dimostrata di questa ricorrente opinione Platone
appronta la formazione progressiva di un modello – o meglio di un Metamodellocon il quale Operativamente mostra la possibilità di un ordinamento coerente di
una pluralità di leggi, ispirato e plasmato secondo quel principio di Koinonia tra
Kephalè e Nous, e non secondo quello della Pleonessia.
La dimostrazione della validità di questo Metamodello sta proprio nella sua capacità
di scendere nel concreto, nell’effettuale, nel particolare delle situazioni sociali che
caratterizzano la vita della Polis, e di tessere coerentemente questo insiemecomplesso Dicendolo in maniera Coerente a quel Pirncipio di Comunione
Costituzionale.
Perciò, rispetto a Repubblica qui ha tanto spazio la trattazione ‘analitica’ dell’
ordinamento giuridico, considerato nei suoi diversi aspetti fondamentali di attività
legislativa, di governo, giudiziaria.
Ma non manca in Leggi l’ Ethos, né il Teologico ed il Liturgico; assistiamo solo ad un
diverso proporzionamneto delle dimensioni della architettura del discorso, ad una
diversa simmetria e combinazione dello spirito giuridico e di quello etico-teologico.
In Repubblica, la cosiddetta dimensione |utopica| è per così dire una ‘provocazione
idealistica’ a fronte di quella provocazione falsamente iperrealistica rappresentata
dal sofisma-menzogna a cui da ‘voce spettacolare’ Trasimaco.
A quell’inquietante ed ammorbante spettacolo di propaganda del dominio e della
violenza sociale come massimo valore e via regia verso la felicità privata e
pubblica, Platone si contrappone con uno slancio di immaginazione creatrice e
simbolica per falsificare la opinione prevalente ormai, secondo la quale solo perché
la violenza ed il conflitto sociale radicalizzato è diffuso in tutta l’Ellade, solo per
questo esso sarebbe anche un valore etico ,giuridico, sacro-santo.
Si tratta ,dunque, per Platone ,di fronte a questa sfida immane della prepotenza dei
fatti di dominio e di lotte civili radicalizzate, di scendere nelle fondamenta dello
stare insieme in città e di scoprire le ragioni ultime ed i fini supremi che spingono
una moltitudine di individui ed un complesso di gruppi a decidersi per fondare una
Città-Stato ed a vivere in pace.
Perciò rispetto ad entrambe le opere la direzione principale dello sguardo non è
questa indicata dallo schema Ideale-‘Semi-ideale- Semireale- Reale – come
interpreta Migliori- -, bensì quella che sta in corrispondenza con quelle due
importanti varianti del sofisma, che è un mostro policefalo ed un falso Proteo. un
falso Dedalo, un finto Labirinto-, una illudente e fantasmagorica girandola
paraenciclopedica.
Il Platone etico e politico chiede, dunque, di essere ‘misurato’ e giudicato dentro
questo suo impianto architettonico, non visibile se con lui non sappiamo andare
Oltre e Dopo l’ambito dottrinario, tecnico-epistemicquell’ Oltre-Dopo in cui vive la
sua Metalogica-Metatecnica; e qui essa dimora ed opera non per instaurare un
dominio sulle Technai , ma per ‘guardare loro le spalle dalle intrusioni e
prevaricazioni nei confini del loro territorio dagli scimmiottamenti paratecnici del
modo di produzione eristico-sofisito dei logoi intorno alla natura della giustizia e
della felicità.
In questo senso la filosofia non è la ‘regina delle scienze’, ma il loro Custode; essa è
un Sentinella Metalogica, una attività di liberazione-purificazione dalle false
promesse della pretesa ‘super-metalogica’ sofistica. E, dunque, filosofia è anche
Educazione ed Autoeducazione del Metadiscorso intorno alle “Cose Massime” :
l’anima, la politeia, il cosmo, l’intelligenza vivificante e splendente del divino.
Tutto questo permette anche di capire meglio che cosa significhi in Platone
Dimostrazione Giuridica come dimostrazione della Vera Natura delle leggi e dello
|Stato| .; e,dunque, che significhi filosofia del diritto.
Ma soprattutto consente di tenere insieme tutto il testo – cosa che raccomanda
continuamente MIigliori. Dal suo punto di vista sostanzialmente dottrinario il nostro
autore, però, non potrebbe mai spiegare che la platonica immaginazione creatrice e
simbolica è una funzionaecognitiva e non unicamente retorico-educativa e di bella
ed emozionate scrittura. Così come non potrebbe mai farci capire perché in Platone
la funzione di Esortazione/Saggi Consigli appartenga in maniera integrante e
sostanziale alla Dimostrazione della Verità e
del Valore della legge
costituzionalmente fondata.
Eppure le parti Proemiali sono parti importanti del testo; non possiamo non essere
fedeli anche ad esse; il che è possibile se tentiamo di pensare come Platone opera
la loro relazione di unità con quella che si mostretà come legislativa Performance ,
come Legisl-Azione orientata e mossa da una Decisione, dai suoi Imperativi.
E’ proprio del saper educare il saper esortare: e non c’è attività educativa fuori di
una esperienza di amicizia e di solidarietà tra educatore ed educato. Perciò la
dimostrazione di un qualcosa qui non è mai imposizione, neppure nel senso
dell’imporsi da sé del dimostrato con la sua ‘ferrea forza’ logica.
Il rapporto attivo-passivo – coppia concettuale che Migliori pone in risalto come
parte importante della ‘tavola’ paradigmatica platonica—si lascia cogliere in una sua
occorrenza non facile da comprendere da chi è abituato a separare in maniera
assoluta l’idea di attivo da quella di passivo e l’idea di azione da quella di
esperienza cognitiva.
Nell’ Eutifrone c’è una polemica amichevole tra Socrate ed un giovane teologo
‘decisionista-azionista’ e che ,perciò, crede che l’azione renderebbe per sé - solo
per essere azione- una cosa buona e giusta.
In un passaggio veloce e complicato Platone farà dire al suo Socrate che non solo
non ci sarebbe un agire senza una relazione costitutiva ad un patire, ma c’è
addirittura un patire che è superiore all’agire. Tale è la dignità in sé del bene e del
giusto che attraggono verso di sé il cittadino che li vuole e li cerca.
Su questa visione mirabile Aristotele poi dirà che il Divino agisce come “ciò che è
amato”.
Alla luce di questa gemma teorica platonica l’educando, l’esortato, è chiamato a
prendere l’iniziativa ed a corrispondre all’azione del suo educatore con un suo
proprio agire. Così come anche in altri dialoghi, Platone prospetta una impostazione
di ‘alleanza terapeutica’ tra medico e paziente, analogamente qui potremmo
parlare di ‘ alleanza educativa’.
Ma l’eccezionale nella prospettiva platonica è che il principio della Performance,
che tanta parte ha nell’azione drammatica e nell’operare geometrico-matematico, si
estende anche alla prassi etica e politica, soprattutto quando ‘politicità’ è saper
vivere lo spirito costituente e costituzionale.
Platone non si lascia, perciò, imbrigliare nello schema pensiero-vita, perché per lui
la vita buona e giusta è in sé esperienza noetica, di ‘illuminazione’ e ‘rivellazione’
dell’ ordine umano e cosmico. Perciò egli istituisce un nesso originario tra la virtù di
Sophrosyne e Nous, tra vita dell’anima e vita dell’universo al quale l’umano e la
Terra appartengono.
Quella di Esortare.Consigliare è, dunque, una Decisione-Scelta, pregna di noesis in
azione; e,perciò, il disporsi ad Ascoltare chi ci esorta e l’adesione convinta al suo
appello ed invito a fare –Costituzione è un pensare vivente di una vita pensante.
Solo se guadagniamo con Platone -e seguendo le indicazioni delle sue tracce di
scrittura- questo orizzonte, inaccessibile ad un approccio tutto dottrinario,
possiamo metterci nella condizione di apprezzare teoreticamente quel suo
passaggio più volte richiamato, cioè ’epilogo di Leggi; precisamente lì, dove il Saper
Rischiare-Osare-Scommeytere sulla Politeia si dà come Inizio di FondAzione della
Communitas etica-politica aperta al Divino che si prende cura degli uomini e che
non si lascia corrompere dai doni e dai sacrifici offerti dai potenti.
Iniziare, l’IniziAzione è, dunque, un ‘Opzione : quella propria della Scelta di
FondAzione Rivelativa dell’Operare Buono e Giusto; la scelta che non accetta
nessun compromesso, nobile o meno nobile, con l’energia cattiva della Pleonessia,
della Violenza Distruttiva del bello, del vero, dell’utile sociale, del bene comune,
della vita e comunione costituzionali.
Questo dualismo radicale- che Platone professa ed isttiuisce in ogni tappa della sua
navigazione testuale e di attraversamento del mare dei logoi della comunicazione
pubblica- non è la contraddizione mortale interna al platonismo, ma la più grande
conquista spirituale e culturale del pensiero occidentale e mondiale.
Questa è l’’eredità più preziosa che sfida la modernità ed il presente filosofico
come ciò che bisogna saper ripensare nell’epoca dell’imperialismo globale delle
oligarchie finanziarie. dove le moltitudini deii nuovi dominati costituiscono
l’immensa massa dei ‘debitori’, individui, famiglie, popoli , e Stati; dove la
radicalizzazione del conflitto sociale e la voglia del rilancio delle guerre di conquista
ha preso il sopravvento sulla ricerca della pace e del ben-essere per tutta l’umanità.
8. Conclusione : Dialettica di Disordine ed Ordine.
Riassumo in questi ultimi due paragrafi quanto fin qui illustrato per il lettore che non
ha la pazienza ed il tempo per leggere il mio intero testo; e lo faccio, puntando a
focalizzare il problema-tema che Migliori richiama con il suo ossimoro |Disordine
Ordinato|, accennando a come esso applicato a Platone nello stesso tempo chiami
in causa un problema-tema centrale dello stesso odierna discussione sulla natura,
funzione e scopo della filosofia nella vita culturale delle moderne città.
Migliori, infatti, da storico della filosofia antica e da autorevole studioso di lungo
corso della filosofia platonica riporta alla ribalta indirettamente una fondamentale
questione teoretica ; quella del rapporto tra reale-razionale ed irrazionale.
A Vlastos non sarebbe piaciuto che un puro storico della filosofia si fosse lasciato
prendere dal fascino e dai rischi dell’ ottica speculativa ineliminabile soprattutto in
riferimento a questo tema.
Ma non c’è più teoreticista di uno storico della filosofia platonica che
pregiudizialmente prende le distanze da ogni modello teoretico.
E Vlastos non sa quanta teoria della teoria è insita nella sua riduzione implicita della
elaborazione concettuale al trattamento dichiarato-dottrinario.
Friedlander provò fastidio nei confronti di tutti quelli che pretesero riportare
forzatamente Platone nei ranghi degli autori di dottrine e soprattutto delle dottrina
delle Idee. Ma in questa resistenza ed opposzione egli lasciò aperto ed irrisolto il
problema della natura della teoria in Platone. E tra l’altro egli non ci ha spiegato
come il suo Platone Politecnico240 si accordi con il suo Platone Educatore-Autore di
una prosa d’arte.
240
Gli venne in parte in soccorso, il suo allievo Gadamer, con la sua concezione
fenomenologica della teoria come esperienza viva di comprensione dialogica.
Ma poi il suo allievo non ci aiutò nel rendere conto del ruolo positivo che hanno nei
dialoghi i tanti riferimenti ai metodi delle Technai, aspetto che,.nvece, non è
sfuggito a G. Cambiano.
Kramer da parte sua progettò di recuperare il Platone teorico, partendo
dall’imbarazzo di Hegel di fronte ad un Platone riconosciuto da lui stesso come il
più grande dialettico del periodo classico e nello stesso tempo come un arcaico che
si attardava a mescolare “Rappresentazioni” e “Concetti speculativi”.
E così Kramer pensò di sciogliere il nodo valorizzando il Platone sistematico delle
dottrine non scritte e partendo da una valutazione della forma letteraria come
inessenziale alla teorizzazione platonica, e, dunque, tale da dover essere
emarginata riducendola ad un funzione didattico-protrettica in vista di ciò che G.
Reale qualificherà come “oralità dialettica”.
E Szlezak gli darà una grande mano nel provare la natura ‘omissiva’ ed impostata per
“struttura di soccorso” ed in una dinamica e ascensiva, della elaborazione
concettuale del Platone Scritto.
G. Reale a sua volta, insistendo sulla natura di gioco non serio e su una presunta
svalutazione cognitiva della scrittura da parte di Platone, utilizzerà i concetti delle
Dottrine non scritte come “Idee-chiave” per decodificare i contenuti filosofici velati
e nascosti sotto la forma letteraria, e per restituire finalmente all’ umanità il sistema
di Platone, come aveva auspicato Leibniz.
Il modello ermeneutico di tipo sistematico provocò la reazione degli anti-sistematici
e degli asistematici, che da una parte puntarono a recuperare il Platone ‘analitico
delle technai241’ e dall’altra a mettere l’accento sul Platone della “buona forma di
retorica”242 o sul Platone autore di una “pluralità di paradigmi” dentro una prassi
dialogica 243.
Mentre altri intepreti cercavano di valorizzare il Platone della ‘logica argomentativa’
ed a fargli esami di riparazione partendo dalla moderna logica, altr244i come
cominciarono a scoprire che il Platone di Stefanini245- forse aveva ancora qualcosa di
buono e di importante da dire sul significato di una filosofia come Scepsi, di ricerca
incessante e mai compiuta, pur nel guadagno di idee forti e prospettive ideali
fondamentali per la cultura. e per la vita dell’uomo.
Per altra strada, con differenti diramazioni e per lo stesso obiettivo, cioè quello di
portare alla luce il Platone Teorico, si sono mossi gli interpreti che hanno messo al
241
Cf. i citati F. Adorno, Viano, Cambiano;
242
Cf. citato F. Trabattoni
Cf. citato G. Casertano.
Cf. ad es. Rowe
245
Ricordo che a questo Platone G. Reale aveva dato pietosa sepoltura e Napolitano Valditare ha
difeso nella sua feconda attualità
243
244
centro il Platone autore di una dottrina delle Idee246 e di una dottrina socio-politica
‘sui generis’ dentro una polivalente prospettiva filosofica , dove non è facile trovare
la ‘teoria pura’’, stante anche la forza di una forma letteraria impregnata dell’
elemento/teatro.247
Questo abbozzo di scenario ,peraltro molto incompleto248, della pluralità dei
modelli ermeneutici, mi serve principalmente per mostrare che la vera
discriminante tra di essi non è il parametro della valorizzazione o meno del
cosiddetto Platone Orale, bensì quello della assunzione o non assunzione del
paradigma dottrinario come ottica-guida della interpretazione.
Da questo punto di vista gli unici ad uscire fuori dal coro della maggioranza degli
interpreti, puri storici che si dichiarano o semi storici e che io chiamo tutti
|Dottrinari|- sono Friedlander e Gadamer, il quale anche in riferimento al Platone
delle lezioni orali terrà ferma l’immagine di un Platone di puri e vivi colloqui
filosofici -didattici.
In Migliori, che inserisce il suo modello dentro un vasto e dettagliato dibattito
internazionale, non appare mai un minimo sospetto circa la adeguatezza del
modello dichiarato-dottrinario per scoprire i luoghi dove ‘sta’ la teoria di Platone.
Egli parte in quarta e fa suo questo modo funzionale di riconoscimento dei
contenuti filosofici nella scrittura platonica e su questa base giunge alla sua
paradossale conclusione di una “contraddizione mortale nel platonismo” ed alla
immagine del fondatore della filosofia come il pensatore che non avrebbe una sua
ben definita e relativamente compiuta filosofia.
Ho sopra ripetutamente evidenziato a questo proposito come Migliori con la idea di
di una teorizzazione per giochi seri prospetti la possibilità di un altra modalità di
sguardo e di ‘mappatura’ della dimensione concettuale dei dialoghi; ma parimenti
ho cercato di mostrare come Migliori dopo aver proposto questa alternativa strada
di accesso al Platone Teorico, torni di fatto indietro in questa sua ripetuta
indicazione, facendosi prendere la mano da quel modello professionalizzato ed
istituzionalizzato di lettura prevalentemente dottrinaria.
Così facendo, egli applica ai testi platonici un ‘codice di decodifica’ che non è
funzionalemente conforme al ‘codice di produzione’ platonico dei valori teorici, e
finisce per vedere solo quella parte del testo- pur vasta- che è strumentale alla sua
ottica di lettura.
E qui devo ripetermi ed inistere sul fatto che il testo è funzione dell’ Attività del
Leggere di vivi lettori, che appartengono ad una viva e determinata comunità
culturale; e che, pertanto, non esiste il testo-assoluto, un testo/oggetto-deposito di
significati.
246
247
248
Cf. supra Berti, Centrone, Fronterotta, Leszl, Ferrari, Tulli.
M. Vegetti
Mi riferisco qui soprattutto ai lavori di Brisson, Loriaux, Badiou, Kahn, L. Rossetti.
Questo dovrebbe essere noto , anche se esposto alla falsa opinione che non
esisterebbero fatti testuali che funzionano da oggettivo contrappeso-resistenza agli
abusi,: e che si darebbero , pertanto, solo pure e varie interpretazioni , ingovernabil
e naturalmente tra loro in concorrenza ed in conflitto.
Anche la semiotica dei testi narrativi249 ha provato che c’è un limite per l’attività
interpretativa e che, pertanto, risulta possibile distinguere tra un lettore che sa
cooperare con l’autore implicito e quel tipo di lettore aderente al partito dei ‘liberi’
usi dei testi , de i fantasiosi ed arbitrari abus di esso.
E la semitotica lo fa proprio valorizzando fino in fondo i il paradigma del gioco sia
come play e sia come game.
Non è, invece, sufficientemente noto a molti interpreti che anche l’idea platonica di
gioco deve esserre storicamente e culturalmente contestualizzata; e che ciò in
riferimento a Platone significa saperla ricollegare con il gioco drammaturgico attico
e con il gioco geometrico-matematico. E in Migliori questo aspetto ,nella sua
importanza costruttiva, è largamente sottovalutato.
Ben prima di Wiittengestein – e purtroppo non riconosciuto da lui- Platone ha
scoperto il vasto continente degli usi del linguaggio comune e ‘tecnico, come gioco
giocato dentro i processi di quella vita che è vita di comunicAzione su i Valori della
vita umana.
E si potrebbe continuare in questa osservazione, immaginando un Platone che
ricorda a Wittengenstein che il nemico del linguaggio non è un generico
metalinguaggio ed una indistinta metalogica; ma la parametalogica menzognera
genitrice di tutte le sofisticherie messe a servizio dei progetti di dominio delle
coscienze e di manipolazione dell’opinione pubblica desiderosa di felicità e di
giustizia.
Il nemico insidioso e subdolo è quella falsa metalogica che vive di false immagini
culturali, come Derrida ben intuisce nella sua operetta “Breve storia della
Menzogna” con un espresso riferimento anche all’ Ippia minore di Platone.
Mi fermo qui, perché con queste mie finali riflessioni intendo solo segnalare che
Migliori storico è finito su una questione – quella tra razionale-irrazionale, benemale, verità-menzogna- che è originariamente e sostanzialmente teoretica; essa è
ritornata attuale anche fuori dall’ ambito stretto degli studi platonici; a questo
proposito si può vedere il recente libro di un matematico italiano250 P. Zellini “
Numero e Logos” e quello diel citato Toth sull’ Aristotele matematico.
Ma questo, non voluto eppure rilevante, esito teoretico rimette al centro il
confronto con Hegel, con G. Gentile e soprattutto con l’ultimo B. Croce : ma non
erano tutti questi filosofi superati ? L’idealismo non era tramontato ? Non stiamo
noi nell’epoca del post-umanismo e del post-moderno ? Nell’eclissi della filosofia
249
250
U. Eco, Limti della interpretazione.
P. Zellini,
nelle filosofie e delle filosofie in una pluralità di Racconti o nelle ricerche
interdisciplinari ?
Mi chiedo : si può giungere alla conclusione di Migliori su Platone senza iniziare a
mettere in discussione la tradizionale ed accademica visione di Teoria filosofica e di
Racconto e la normale distinzione tra Pensiero- Discorso e Prassi251 ?
Platone, infatti, prima ancora di coinvolgerci a riflettere con lui su i ‘contenuti
filosofici’ --come la natura delle virtù, la idea della idea, la realtà dell’anima e del
cosmo, sulla possibilità di uno ottimo Stato, sull’esistenza del divino -, ci obbliga a
fare con lui un passo indietro ed a domandarci con lui che significa Pensare
Filosoficamente e quali sono i problemi propri di questa scelta di vita e di questa
opzione mentale di fondo, che è insieme vocazione e ‘professione’, cioè
testimonianza e militanza di un agire comunicativo che prende posizione intorno ai
Ptincipi ed ai Valori di una vita comunitaria impegnata nell’ agire in vista della
giustizia così come all’uomo è possibile.
Ma chi cerca questo Platone sul presupposto e sull’attesa che egli Dichiari
apertamente la necessità di questo nuovo Inizio della interrogazione filosofica nella
forma delle domande |Che cos’ è la filosofia ?|, |Chi è il filosofo ?| e |Qual è il suo
problema ‘|, costui rimarrà deluso e frustrato. E,perciò, nella sua scrittura non
troverà neppure la questione della dialettica e del Disordine Ordinato poste in
quello stile che è proprio di Migliori ed in generale dell modo esplicito di
elaborazione dei contenuti concettuali e della trattazione dottrinaria.
A questo stile appartiene – come è noto- la forma pura, chiara,piana, senza
metafore e tacconti ‘inquinanti’ l’univocità dei termini la continuità e la completezza
dei passaggi logici, la distinzione precisa dei concetti, l’ordine argomentativo del
discorso.
Ora è generalmente riconosciuto da tutti gli interpreti che quella platonica è una
‘forma impura’ di esposizione, perché c’è un intreccio indissolubile tra l’
elemento/Racconto e l’elemento/Teoria.
Ma chi sa questo poi non si decide a pensare questa ‘modo impuro’ come forma ad
substantiam, cioè come parte integrante e sostanziale del piano della
problematizzazione e della teorizzazione; e, dunque, non come ciò che, invece,
dovrebbe essere messo tra parentesi e derubricato a retorica ‘filosofica’ con scopo
protettico-educativo, senza alcuna influente ricaduta sull’ assetto e la valenza
teorica del discorso platonico.
In questo mio saggio-recensione ho cercato di provare come la cosiddetta
dimensione narattiva connessa alla forma letteraria dei dialoghi non è classificabile
La ripresa ed il rilancio di una visione del problema-tema |Pensiero-Linguaggio- Prassi| ,
rompendo il tradizionale schema di un pensiero senza volontà e di una volontà senza intima
noeticità , mi sembra la prospettiva più interessante ed innovativa dell’ultimo citato lavoro di M.
Cacciari. teorico della centralità della singolarità-ente e della originari età della praxis-pragma.
251
come narrazione dialogica in senso proprio, stretto, corrente.; né come vivo
colloquio filosofico tra vivi filosofi in comune ricerca.
Il Racconto platonico non è neppure racconto, cronaca vera o romanzata in tutto od
in parte; nè è un resoconto più o meno storico di dibattiti culturali del suo tempo e
delle dottrine filosofiche del Socrate della storia.
Questa forma per me è quella di una scrittura spettacolare e teatralizzante dentro la
scelta di un Fare Filosofia partecipando alla battaglia per una comunicazione
pubblica non distorta intorno ai Principi ed ai Valori della vita umana; e ciò dentro
un contesto socio-culturale caratterizzato dalla forte presenza ed influenza di quella
comunicazione mass-mediatica realizzata soprattuto attraverso la ‘macchina’ del
teatro di Stato.
La forma lettaria dei dialoghi è – come ho più volte sottolineato- il risultato di una
trasposizione analogica-funzionale di alcuni elementi strutturali e moduli espressivi
della drammaturgia attica del V e IV secolo.
E, perciò, tutto il narrato platonico sta sotto il segno del Tipologico; ed in questa
natura di peculiare generalizzazione esso può combinarsi ed omogeneizzarsi con la
funzione di universalizzazione propria della concettualizzazione filosofica.
Perciò esso non è separabile e non può essere separato, in sede di lettura ed
interpretazione, dall’elemento/Teoria.
Tutto questo ci impone che, per essere lettori adatti dei testi platonici, dobbiamo
guadagnare il piano ottico di Lettori/Spettatori-Cooperatori di una
Rappresentazione Teorica o di una Teoria Rappresentata, che si svolge secondo il
principio funzionale di un gioco cognitivo-immaginativo-linguistico giocato.
E non ci deve sfuggire che questo per sua natura risponde ad una logica
dell’implicito e della implicitazione costruttiva, fin dalla generazione e formazione
‘plastica’ del problema-guida.
Il passaggio da questo piano ottico, che guarda verso l’implicito. a quello di una
illustrazione piana, costituisce una trasposizione che va regolata in conformità al
canone fondamentale del dover rendere conto di ogni passo e mossa del gioco, fin
dal titolo dell’opera.
Ed è questo il parametro principale per verificare la correttezza e la adeguatezza di
una intepretazione che ha deciso di misurarsi con ogni dialogo platonico nella sua
interezza e con l’insieme complesso di essi.
A chi cerca, poi, le dimostrazioni e le argomentazioni di Platone bisogna ricordare
che per questo Platone Dimostrare è Saper Falsificare; che a questo scopo è
necessario Saper Formare corretti Paradigmi in corrispondenza analogica con
l’universo delle Technai; paradigmi che vengono poi impiegati operativamente
appunto come criteri di falsificazione. di smascheramento, di smantellamento della
phantasmalogia paraculturale di quella bestia policefala , fascinosa e terribile, del
falso messaggio, spacciato come suprema legge umana e divina, di una giustizia
come l’utile del più forte.
Tutta la Dialettica platonica- da Apologia di Socrate a Leggi- non ha altro scopo che
questo : liberare e purificare la cultura dalle illusioni-lusinghe di questa presunta
super-sapienza. Il senso ed i valore di quella dialettica vanno, dunque, identificati e
misurati rispetto a questo preciso obiettivo. In questa prospettiva in Platone
possiamo dire che non c’è teorizzare filosofico che non sia un saper dare la caccia
alla Menzogna, a quella precisa Menzogna.
C’è in Platone un Ordine del Discorso e del Metadiscorso che in nessun modo ed in
nessun momento può coniugarsi e mediarsi con quel Disordine che è costituito da
essa.
Quest’ Ordine, questo ‘cosmo di logoi’ è appunto quell’operare incessante di
falsificazione che è nello stesso un fare moralità nel metatdiscorso impregnato di
comunicazione pubblica ed impegnato in essa, che esposta al rischio ed agli attacchi
subdoli di quella falsa visione della vita umana, della ragione, della immaginazione,
del linguaggio. E con Platone bisogna fare questo ‘in memoria di Socrate’.
E non è questa la più bella ,la più preziosa, la più ‘classica’ , la più inimitabile delle
filosofie ? Non ha essa diritto di vivere ancora, tra noi , ben oltre la sua presunta “
interna “contraddizione mortale” ?
Saluto ora Migliori, ribaltando sul suo modello eremeneutico - ma sotto un diverso
aspetto che mi accingo a chiarire-, quelle proprietà essenziali che egli rileva nel
Platone scritto : la polivalenza, l’ambivalenza, l’ambiguità , culminando in quel
voluto presunto fallimento teorico.
Parto da quest’ultima conclusione ed introduco in questo modo la mia osservazione
con la quale ribadisco quanto sotto diversi profili e contesti tematici ho già
evidenziato : con il ricorso e con l’impiego sistemico del paradigma di
riconoscimento, costruito su una visione della attività cognitiva e linguistica come
“Attività” e come attività di gioco, Migliori non si rende conto che ha introdotto
nella sua colossale fortezza un ‘cavallo ‘ che nasconde e contiene nella sua pancia il
più terribile avversario di quel suo modo di lettura dei testi platonici che egli arma
con una “sufficiente “massa critica” di argomenti e di dati “ (p. 1347).
Infatti, questa consistente ‘quantità’ di prove è prodotta da Migliori utilizzando una
chiave funzionale di riconoscimento interpretativo che entra in conflitto con ciò che
è proprio del principio del gioco, una volta assunto come ottica essenziale ed
indispensabile per scoprire i veri pensieri e le reali intenzioni teoriche di Platone.
Pertanto, proprio mentre cita Wittengenstein del “Tractatus 4.112 <la filosofia non è
una dottrina, ma una attività> “ (p. 1347), Migliori ci sorprende e ci disorienta,
atteso che per tutto il suo tragitto ed il suo vasto e profondo scavo dei testi, egli si
è fatto guidare da una logica prevalentemente dottrinara, subordinando ad essa il
meccanismo dei ‘giochi’.
In questo senso Migliori è ambivalente fino ad essere ambiguo : proprio la sua
interpretazione del Parmenide è la prova fondamentale di questo suo tendenziale
strabismo, dove prevale comunque l’occhio professionalizzato dell’accademico che
vede la teoria solo o soprattutto lì dove essa è data in modo esplicito, illustrato,
dichiarato, puro, e rispetto al quale il modo del Racconto e del Metaforico ha un
ruolo ancillare di abbellimento espressivo e di esemplificazione retorico-educativa;
e dove il principio dell’ Attività ( che io ho rinominato impiegando il termine
Perfomance per indicare il primato dell’ Operativo-Costruttivo), non è fatto valere
fino in fondo; quel fondo-inizio che per me è la identificazione, valorizzando tutto il
gioco giocato con una testualizzazione determinata, dell’ effettivo problema al
quale tutte le figure, i passi e le figurazioni che compaiono sulla ‘scena della
scrittura’ sono coerentemente riconducibili.
Scrive Migliori : “L’ambiguità costitutiva del platonismo ha il suo fondamento nel
Principio primo stesso, che per Platone non può essere un Uno : questo non solo
gli appare ineffabile ed impotente, ma anche e soprattutto incapace di spiegare il
parziale ordine, “ appena sufficiente”, di un mondo in gran parte disordinato (…)
In sintesi il principio deve essere una polarità e la realtà ordinata manifesta una
costante tensione, esasperata nella visione pendolare : il mondo è un continuo
trasformarsi al massimo di ordine al massimo di disordine per la resitenza
“potente” delle manifestazioni del Principio del Grande e Piccolo, per l’azione
costante della Misura, per le travagliate relazioni che si costituiscono tra le cose
stesse, per l’azione mai del tutto costante del Nous divino e sempre incostante del
nous umano” ( pp. 1342-1343)
Migliori può trarre questa conclusione di enorme valenza teorica, facendo leva
soprattutto sul suo lavoro di storico-ermeneutico convinto di aver dimostrato che
il luogo-princeps che conterrebbe questa teoria platonica sia il testo del Parmenide;
e di averlo dimostrato non leggendo l’opera da teoretico.
Ma proprio questa sua conclusione da puro storico, che prende le distanze dalla
teoretica, è carica a sua volta di teoresi, cioè di una determinata concezione della
teoria in generale e della teoria filosofica.
Questo pregiudizio, non problematizzato da Migliori, è quello che gli impedisce di
vedere che proprio in questa opera strategica, Platone mostra la pensabilità , la
dicibilità e la potenza di un Uno. Ed egli realizza questa mirabile impresa metalogica
con tutte le figure e con tutte le mosse che circoscrivono il tutto testuale
determinato della sua messa in opera.
Per vedere questo Platone - mi ripeto- bisogna decidersi ad attribuire al principio
del riconoscimento per gioco giocato il primato funzionale-costruttivo rispetto al
modo di interpretazione accademico ,dominante nella storia delle ricezione e
fruizione della eredità platonica e che ha dato origine a ‘tanti Platoni’.
Un fatto questo storicamente evidente in quanto tale; ma che per questa sua
dimensione di immane fatto culturale non autorizza a concludere che Platone
avrebbe rinunciato ad essere Platone, cioè ad avere una sua originale, fondata ,
coerente ed adeguata filosofia.
Se Migliori valorizzasse al meglio quella indicazione che è pure implicita nella sua
formula dell’ “ in opere operato,scoprirebbe che Platone significa l’Uno
‘agendolo’ cognitivamente e linguisticamente alla rovescia252, , cioè realizzando
con una scrittura spettacolare e teatralizzante, un esperimento teorico253 che è un
‘calcolo metalogico’ per assurdo, dalla cui coerente e completa esecuzione, l’essere
dinamico delll ‘ Uno ‘sorge e si innalza nel suo splendore’ vincendo su un attacco di
catassfrofe distruttiva radicale.
Qiesto Uno, infatti, mostra la sua identità e potenza di uno, nel processo stesso
della sua sistematica negazione; di una negazione pretendente ad essere opinionie
vera giustificata.; e si mostra, nella formazione progressiva della problematizzazione
e del calcolo argomentativo, come Coerente Invarianza-Costanza Negativa; e così
mostrandosi esso nello stesso tempo falsifica in tal modo ed operativamente la
innominata opinione sofisitco-eristica della inesistenza, impensabilità ed indicibilità
del Principio-Uno. Opinione falsa che è il fondamentale bersaglio ellittico dell’opera.
Per Platone l’uno ineffabile ,impotente, incapace di spiegare l’ordine relativo
accessibile alla esperienza umana è quello erroneamente pensato-immaginato come
separato-astratto dalla viva realtà dei processi divini, cosmici ed umani.
Per leggere il Parmendie in questa sua fondamentale intenzione teorica con Platone
bisogna saper operare una svolta paradigmatica, che è innazitutto di tipo funzionale,
nel modo di concepire la problematizzazione e la teorizzazione ; ma per poterlo
ripetere per quanto è possibile, dobbiamo con Platone entrare in ciò che ho
chiamato sopra lo |spirito della geometria-matematica platonico-euclidea|, e per
quanto riguarda la forma del piano di composizione-esposizione dobbiamo saper
riconoscere in che modo Platone ha operato una trasposizone funzionale-analogica
di moduli costruttivi-espositivi della drammaturgia attica.
Si deve prestare attenzione a come essi vengono impiegati in modo da costituire
parte integrante e sostanziale della impostazione e dello svolgimento delle
argomentazioni e, quindi, del senso complessivo e della intenzione teorica di quella
strategia che viene realizzata per tappe, ciascuna delle quali è, però, un gioco
determinato felicemente riuscito , se pure con diversa complessità costruttiva e non
uguale ricchezza tematica; e non un gioco,invece, ogni volta incompiuto ed che
dovrebbe essere organicamente integrato ed incastato con altri giochi, che
comunque lascerebbero alla fine il tutto dell’opera come l’accumulazione ascensiva
di inconclusi, come crede Migliori.
Migliori parla spesso di |Misura! e di |Giochi drammatici|, |Gioco protrettico|254 e ,
citando Isnardi Parente, ricorda il “.. il crescente amore del vecchio Platone per i
giochi logico-matematici-255; quindi evidenzia il problema della comunicazione
252
253
254
255
Su questa logica alla rovescia, paradossale cf. in gnerale Odifreddi e Borzacchiini.
Sul tema dell’esperimento teorico in generale Conoscenza ed Erroe di Mach.
M. Migliori, cit. p.919,nota 83
M. Miglori, cit. p. 1193, nota n. 99.
filosofica , dei “limti della comunicazione scritta”, nonché la dimensione della
fiction. 256
Tutte queste indicazioni sono utili orientamenti verso la messa a fuoco di aspetti
fondamentali del discorso platonico, solo se non si rinuncia a sottrarli alla genericità
ed a comprenderli cercando di far nostro quello spirito; cosa che per quanto mi
riguarda ho abbozzato nel paragrafo dedicato alla dilucidazione dell’impiego della
nozione di postulato nella logica geometrico- matematica greca.
A questo sforzo di contestualizzazione storico-culturale non ci si può sottrarre
neppure quando si parla, con riferimento a Platone, di fiction, di nomen dramatis, di
giochi di maschere e scambi di ruoli tra i personaggi, di moduli compositiviespressivi ( la funzione importante del prologo e dell’epilogo, il montaggio delle
sequenze ed i giochi semiosici attuati attraverso ben congegnate combinazioni di
episodi, l’impiego dei registri della ironia, dell’iperbolico, della invettiva, della
canzonatura, del lirico, dell’esortativo, dell’augurale ).
Queste proprietà drammatizzanti della scrittura platonica devono essere comprese
nella loro specificità e tenute sempre presenti allorchè ci si propone di ricostruire il
senso delle argomentazioni che Platone fa recitare al suo Socrate .
A questo proposito richiamo quanto sopra ho già rilevato, vale a dire – ad esempio-: nel Teeteto se il lettore da spettatore-cooperatore non coglie che il Socrate che
argomenta sulla nautra della conoscenza è un Socrate al quale –senza dirlo
espressamente al suo lettore- Platone ha fatto indossare la maschera di un Teeteto
che pretende sapere, grazie alla sua esperienza e competenza di logico-matematico,
tutta la natura di tutta la conoscenza, questo lettore non riuscirà ad accorgersi del
senso finale di tutto il gioco e non capirà che esso risolve il suo problema.
Problema che non è dato dalla formula |che cos’è la conoscenza ?|, bensì da
quest’altra implicita : Perché è illegittima la pretesa di Teeteto di dare una
definizione della conoscenza, unilateralizzando ed assolutizzando il metodo della
logica geometrico-matematica, colta nel suo sforzo di rendere conto della natura
dell’errore e del suo rapporto con l’irrazionale in generale ?
Con questa trasformazione del problema e rileggendo l’opera così orientati, ci
accorgiamo che essa alla fine lo risolve, dimostrandosi nella esecuzione del gioco
ccome
non aporetica, come per lo più,invece,
accademicamente viene
interpretata.
Infatti, il rilevamento dell’esito aporetico è relativo al modo dichiarato-dottrinario
di leggere questo dialogo e,quindi, di individuare il suo problema-guida .
Ma questo tipo di sguardo sul testo non è quello che deve avere il Lettore-Modelio
previsto da Platone-autore, il quale producendo un gioco cognitivo-linguistico in una
testualizzazione spettacolare e teatralizzante, esige dal suo lettore adatto che egli
proceda riproducendo questo gioco e cercando nel svolgimento complessivo di
questo i termini del problema effettivamente-operativamente in campo.
256
M. Migliori, cit. p. 475, note nn- 82-83.
A questo scopo questo lettore deve possedere in via previa la competenza del
lettore-spettatore, che sa riconoscere la valenza paradigmatica del nome-maschera
ed il meccanismo dello scambio e della sovrapposizione di maschere, nonchè sulla
valenza essenziale ai fini della problematizzazione, delll’elemento Racconto.
Senza questa competenza si finisce per prendere una cosa per un’altra e si carica il
testo di una serie di problemi non pertinenti, come ,ad esempio, quello relativo alla
mancancaza -nell’opera del periodo dialettico e della maturità speculativa platonica
di un adeguato riferimento alla dottrina delle Idee-Forme; e,pertanto, ci si sente
obbligati ad ipotizzare su questo presunto ovvio testuale, ( come fa ultimamente
Sedley) che qui Socrate –semistorico in polemica con il sensismo relativistico ,
funzionerebbe come midewife, come ostetrica del platonismo.
Questa via di uscita,però, è obbligata solo se – come Sedley ( e tra gli altri anche
Ferrari che condivide la sua proposta) crediamo che Platone con il suo Socrate
dottrinizzi sulla natura della conoscenza; ma come ho sopra accennato e
dimostrato ampiamente in altra sede., ben poco si capisce della intenzione teorica
platonica operta con il Teeteto, se non si porta allo scoperto ed in evidenza
l’implicito di una variante importante della Falasa Opinione e di una connessa
Illegittima Pretesa, quella propria del matematismo,
Mi congedo da Migliori segnalando che il suo innamoramento per la logica dei
giochi cognitivi e linguistici, a servizio della significazione e della comunicazione
filosofica, - seguendo e ripetendo Platone per quanto è possibile ai noi suoi
commentatori, è un magnifico rischio, che deve essere con lui condiviso senza ,però,
di fatto e via facendo , pentirsi.
Infatti se esso è con tenacia affrontato e sistemicamente svolto, apre la strada, a
tutti gli attenti e rispettosi lettori di Platone, per la scoperta che il fondatore della
filosofia rimane il filosofo che viene dal futuro a riorientare la presente coscienza
filosofica mondiale, ancora influenzata e depistata da un passato prossimo e
remoto che – nonostante i sinceri riconoscimenti della sua grandezza di scrittore e di
educatore - lo ha gravemente sottovalutato nella potenza innovativa del suo genio
teorico –linguistico.
Platone, questo extra-terreste., questo ‘marziano’, sfidato dall’evento
dell’affermarsi della Menzogna, potenziata da comunicazione pubblica spettacolare
e provocato in essa dal suo successo nella capacità di adescamento di individui e
folle, questo Platone comprese prima e meglio di tutti gli altri ed a tutt’oggi
rimanendo incompreso, che quella attività mentale che per comodità ed
accademicamente chiamiamo dialettica e dialettizzare, se voleva essere utile alla
città ed all’umanità, doveva decidere di uscire dalla ‘Accademia’ e di scendere in
campo e di misurarsi-scontrarsi con quella falsa immagine della essenza della
giustizia e della felicità umane. che egli vide trionfante nel suo tempo e colse come
costante dramma tragicomico della condizione umana.
Platone osò e rischiò di pensare e di dire una potenza cattiva che è molto di più di
quel Disordine che sta in relazione polare e pendolare con l’Ordine; egli si cimentò
con una fatica che nessun Ercole aveva neppure mai immaginato e con una ‘Odissea’
nessun Ulisse avrebbe mai osato : attraversare il vasto e pericoloso mare dei logoi e
dei metalogoi per pensare e dire l’Anti-Ordine di un ‘male radicale’, di una cattiva
energia distruttiva che seduce ed ammorba lo spirito pubblico, quello degli individui
che vivono in società e Stati.
Un male che egli immaginò cone anti-essere e,dunque, fuori dalla stessa relazione
polare di essere-non essere, di vita e morte, di quella morte che è l’esaurisrsi ed il
dileguare di una vita.
L’indicibile per Platone non è il principio di unificazione e di distinzione di disordieordine, ma qualcosa che come anti-lignuaggio ed anti-comunicazione è, tutavia,
mascherato di messaggi fuorvianti e nello stesso tempo terribilmente seducenti e
sfuggenti : dominare, sfruttare , far morire l’altro nel desiderio di potenziare la
propria vita. Qui ‘mors tua, vita mea’ sta oltre il piano di una difessa necessitata
dalle circostanze dell’attacco di un nemico violento .
E’,invece, lo spot che fa segno all’assunzione di fatto a valore di vita di ciò che è
contro la vita , cioè la voglia ed il falso piacere di far del male e di uccidere e
soprattutto di sopprimere i giusti, il più giusto dei giusti; uno spot che si arma,
dunque, di false imitazioni e di pseudo-modelli dei beni che gli uomini situati in
‘Città’’cercano lottando contro le leggi ingiuste ed i politici despoti e corrotti che
ammantano il loro dire ed agire ‘spettacolari’ con eleganti abiti paraculturali ,
pseudotecnici-scientifici.ed addirittura con una presunta super-filosofia politica,
come quella pubblicizzata da Dionigi a Siracusa con il suo super-libro.
La “filosofia dialettica di Platone”, la sua logica, la sua “metafisica e cosmologia”, la
sua ‘dottrina’ dell’ “anima e della prassi etica e politica” , la sua cosiddetta dottrina
di condanna della scrittura e della poesia teatralizzata, accadono testualmente in un
piano cognitivo-immaginativo-linguistico che si fa ed appare progressivamente e
ricorsivamente come Attività di Falsificazione delle Pretese del Sofisma-Menzogna
di valere come Verità della essenza della vita divina, dell’ordine cosmico, dell’anima
del singolo e della sua mente, come legge fondamentale delle città degli uomini.
Platone non ha scritto un solo libro ma una pluralità di libri, perché tante e diverse
sono le varianti della fantasmalogia a servizio della Pleonessia, della soperchieria
socio-economico e politica, per legittimarla culturalmente come presunto superiore
modello educativo dello spitito privato e pubblico; scrisse tanto, perché tanti sono i
modi per dire che la filosofia come sapere a vantaggio dell’uomo è inutile ed ormai
superata dal successo di tante Technai, di saper fare specialistici.
In questa ultima prospettiva osiamo dire che i Protagora, i Gorgia, gli Ippia, i Cratilo,
i Teeteto,i Timeo, i Filebo, i Fedone, riappaiono costantemente ed anche oggi
stanno tra noi: essi fanno parte di quella schiera di intellettuali che non hanno
compreso il potere moralmente ed educativamente distorcente e devastante della
comunicazione pubblica menzognera volta a giustificare con performances
spettacolari -subdolamente ed in maniera ‘sofisticata’ e sub-liminalele
prevaricazioni, le sopraffazioni, le ingiustizie , le violenze.
Pertanto, chi vuol tentare di comprendere che cos’è la dialettica in Platone e
perché in lui la filosofia o è dialettica o non ha ragione di essere come sapere
rigoroso nella ‘città’ dei molti e vari saper fare, deve seguirlo ed inseguirlo in ciò che
egli effettivamente fa con la sua eccezionale testualizzazione; cioè deve sforzarsi di
cogliere in una attività di riproduzione cooperativa di una pluralità di giochi giocati
la caratteristica del piano cognitivo-linguistico che egli attraversandolo istituisce e
mostra-esibisce nella sua peculiarità e diversità rispetto a quello generale di tipo
dichiarato-dottrinario.
Se, come giustamente ricorda Migliori, la filosofia non è una “dottrina” ma una
“attività” - idea che a suo modo sta già nel Kant che distingue tra “esame” e
“dottrina”- , allora rimane il compito di indagare su questa originale attività mentale,
per stabilire che cos’è funzionalmente questa attività di cognizione e di linguaggio,
e,dunque, quali siano le sue effettive possibilità ed i suo intrinseci limiti dentro la
finitudine della condizione umana.
Questo compito per primo e –per me in maniera a tutt’oggi insuperata- affrontò
Platone e con questa straordinaria e gigantesa impresa fondò la filosofia e rifondò
la dialettica come attraversamento del mondo mobile, affascinante e pericoloso,
della comunicazione pubblica in quella città dove tutto fa spettacolo’, ivi compresa
la paralogica della Menzogna di una “ giustizia come l’utile del più forte”.
A questa fantasmagoria paradialettica Platone diede la caccia in tante battute di
caccia quante sono le sue opere scritte – comprendendo in questa prospettiva
anche la Lettera VII e naturalmente l’ Apologia di Socrate-. E la preda da fiutare,
inseguire nelle sue varie ed intricate piste è appunto quella falsa dialettica, che è
una depistante ed ingannatrice navigazione nei discorsi intorno ai Principi , alle
“virtù’, ai ‘ Beni’, ai Piaceri della vita, alle Leggi, ai Politici, alla Poesia, alla Sapienza.
Di questa falsa colomba – che per Platone non è mappabile e diagnosticabile se
rimaniamo a livello del paradigma -metro dell’ errore tecnico-epistemico. – egli
indica e mostra ‘in opere operato’ – via facendo, in una navigAzione, la natura
funzionale specifica : Platone così la mette sotto gli occhi del suo attivo e
cooperante lettore-septtatore come Abuso di una cattiva Metalogica e di un
furviante
Metalinguaggio, rinforzati con calcolate strumentalizzazioni della
immaginazione simbolica , che tanta parte ha nella comunicazione spettacolare e
teatrale.
Questa ‘ corrotta metalogica , questo lusingante-illudente metalinguaggio’, agiscono
con surrettizi procedimenti argomentativi-dimostrativi; essi si appoggiano su ‘false
imitazioni’, ‘false modellizzazioni’ sia di elementi essenziali allo statuto delle Technai
e sia agli stessi usi del linguaggio quotidiano e della innocente opinione
comune/doxa-eikasia-pistis.
Nel Sofista questa procedura capziosa è segnalata come Dossomimetica, cioè quale
attività mentale utilizzante fantasmi paralogici-paralinguistici come strumenti di una
pratica ingannatrice, nel contesto di una paracomunicazione sociale; quella che nel
Gorgia viene denunciata e bollata come mera empriria persuasoria, finalizzata alla
manipolazione della opinione pubblica ed al plagio delle coscienze di intellettuali
giovani e meno giovani.
Per tutto ciò la filosofia come dialettica- la dialettica come filosofia nasce ed agisce
come Metatecnica Analogica Ben-Temperata formante e utilizzante corretti
metamodelli , per liberare e purificare il mondo del Metadiscorso, dei Metalogoi,.
dalle ‘sofisticherie’ di quella pseudo- Metatecnica, imbellettata di pseudo-ometamodelli e di un decettivo Metalinguaggio; di essi hanno bisogno le ‘logiche di
dominio’ di tutti i tempi, per spacciarsi come superiore cultura e ‘moderno’, nuovo
e più avanzato modello educativo degli individui che vivono ‘in città’.
Il Platone Polivalente, quello che cioè dispone di una vasta cultura e di una varietà
di alte competenze in rapporto ai saperi del suo tempo,- come mette in risalto
Migliori in sede di analisi e di comparazione del Filebo e del Timeo- -, si colloca
prospetticamente su questo piano funzionale, che è appunto metalogico analogico;
non, dunque, disciplinare ed interdisciplinare o genericamente trans-disciplinare.
E, pertanto, la sfera dei metodi e delle discipline nel Platone dei dialoghi sta al di
qua – come fatto/Garanzia- di questa speciale metatecnica che è appunto la
dialettica platonica.
Per questa ragione essa non è configurabile come enciclopedia organicamente e
gerarchicamente perfezionante i vari saper fare . Essa non si dà come una scienza
delle scienze, né è il complesso dei suoi rapporti con le Technai è disegnabile
secondo la figura di un albero, caratterizzato da radici e rizomi.
La superiorità della dialettica, rivendicata da Platone, infatti, rispetto alla logica
della stessa geometria-matematica257 deve essere contestualizzata dentro la
polemica con lo Pseudos e contro le pretese unilateralizzanti e, quindi, deformanti
aspetti essenziali dello statuto proprio della logica geometrica-matematica258, cioè
della massima manifestazione del procedere per techne ed episteme, secondo una
espressione platonica rintracciabile nello Ione. 259
Il Platone Ambivalente – quello ,ad esempio, erroneamente rappresentato come
colui che contrappone corpo-anima, piacere e virtù, retorica e logica, filosofia e
poesia, oralità e scrittura, idea-forma e realtà fisica, essere e processi-, questo
Platone disorientante il lettore-standard non adatto, deve anche esso essere
contestualizzato dentro un agire argomentativo al quale è essenziale, anche stto
257
258
259
Platone, Repubblica
Platone, Teeteto.
Platone, Ione
questo profilo, l’atteggiamento proposizionale ed espressivo caratteristico della
polemica; un polemos discorsivo – quello platonico- che non si oppone ad una
opinione semplicemente sbagliata per imperizia del suo portatore e sostenitore.
La falsa opinione/pseudè doxa contro cui la dialettica platonica prende posizione e
contro cui si muove incessantemente, ha quella natura parametalogica di cui ho
appena riparlato.
Essa, dunque, è un finto prodotto culturale e dottrinario; essa,infatti, è solo un
simulacro di un agire comunicativo che non ha alcun interesse alla esperienza di un
verace scambio di opinioni e di una sincera e serena discussione.
E, perciò, non è esatto dire – ad esempio- che Platone si opporrebbe al sensismo,
all’edonismo, all’ateismo, all’irrazionalismo poetico, all’utilitarismo, al relativismo,
come se egli si stesse confrontando con dottrine concorrenti e rivali.
Per il fondatore della filosofia, invece, questa galleria delle fonti di una varietà di
falsi opinioni non ha alcuna dignità cognitivo-linguistica ; il somatismo,per esempio.
è una falsa opinione non solo perché si oppone alla realtà dell’anima, ma in primo
lugo perché non riesce a rendere conto della natura stessa del corpo umano; così
come il materialismo dei ‘nuovi fisici’ – di cui Platone scrive nel X libro di Leggi – è
inaccettabile perché innanzitutto non riesce a spiegare la natura stessa dell materia
terreste e cosmica.
L’atteggiamento polemico, dunque, in Platone, non è solo una modalità espressiva
ed argomentativa; esso, infatti, fa segno e rimanda alla natura costruttivo-funzionale
del piano della attività mentale in cui egli decide di navigare e di esplorare con il
farsi stesso della navigazione e della sua ‘odissea’ testuale.
Conseguentemente questa platonica ambivalenza non deve essere confusa come ciò
che porterebbe alla ambiguità e da qui, poi, alla ‘contraddizione interna mortale’.
Cadere in questa confusione è, tuttavia, facile, perché Platone in molti casi – senza
avverite espressamente ed adeguatamente il lettore- fa ragionare il suo Socrate dal
punto di vista dell’avversario-interlocutore, per portare all’implosione ed alla
inconsistenza di senso e di forza critica, la falsa opinione presa di mira in una sua
precisa variante, e di cui quello è più o meno consapevole portatore.
La complicazione si aggrava, quando Platone adopera una tecnica drammaturgica
propria della comunicazione teatrale greca, cioè lo scambio di ruoli tra i personaggi
mediante la sovrapposizione di maschere.
Questo meccanismo è chiaramente indicato da Platone nel Fedro, allorchè egli fa
ragionare il suo Socrate intorno all’eros facendogli assumere nel suo primo discorso
il punto di vista di Lisia che sostiene la nocività dell’amore sia per l’amato che per
l’amante.260
Esso è ,invece, implicito nel Simposio,261 quando Platone autore-regista fa
indossare per un tratto a Socrate, già in maschera, la maschera della sacerdotessa260
261
Platone, Fedro
Platone, Simposio
profetessa Diotima; salvo ,poi, senza avvertire espressamente il suo lettore, a
toglierla nella scena finale costituita dall’entrata rumorosa,scostumata,impudente e
sfacciata di un Alcibiade, che da menzognero accusa di menzogna amorosa il suo
amato maestro, Socrate, difensore e testimone di un eros mediatore tra l’umano ed
il divino, come pure da un diverso punto di vista sul senso complessivo del dialogo,
mette in luce G. Reale, nella sua interpretazione di questa opera, la più
scopertamente ‘teatralizzante’ di tutte.
Il Platone Ambiguo sottende una ambiguità feconda che è in realtà una complessità
funzionale –costruttiva che dipende dall’intreccio operativo tra il modo esplicito e
quello implicito ed ellittico di problematizzazione, di semantizzazione e di
concettualizzazione.Quando il lettore accademico, cioè quello condizionato da una ottica di
riconoscimento prevalentemente dichiarativa e dottrinaria, rileva nel corso dello
svolgimento delle argomentazioni, omissioni-riserve- allusioni- rinviii-, questo tipo
di lettore sta sotto l’influenza del modo esplicito; esso può essere considerato come
la maniera normale/standard di interpretazione.
Essa è un passaggio obbligato sul testo, ma anche insidioso e pericoloso, nella
misura in cui l’interprete non si rende conto che deve andare oltre i risultati e le
discussioni connessi a questo piano di lettura.
Ma che cos’è questo |Oltre| ?
Questa è la domanda cruciale che introduce allla madre di tutte le questioni e
rispetto alla quale prendono posizione concorrente e rivaleggiante i diversi modelli
ermeneutici ed i conseguenti conflitti interpretativi, riconducibili ad una varietà di
scuole , di tradizioni e programmi di ricerca nell’ambito degli studi platonici.
Migliori crede che questo |Oltre| sia l’attività del Platone cosiddetto |Orale|, quello
della tradizione indiretta e quello di un complesso di ricerche metafisiche che
culminano nella dottrina dei Principi, la cui trattazione non troverebbe accoglienza
adeguata nei dialoghi scritti, perchè Platone non riconoscerebbe alla esperienza
della scrittura e quindi della lettura la capacità di farci accedere a questa speciale e
fondamentale cognizione.
Secondo Migliori in forza di questo limite intrinseco alla scrittura-lettura, il Platone
scritto si autocondannerebbe alla ambiguità strutturale e dinamicamente polarizzata
tra differenze di piani non reciprocamente mediabili, ed all’interno di ogni piano tra
il principio d’ordine ed i moti del disordine ;.
Platone così si farebbe leggere come chi avrebbe rinunciato alla messa in opera di
una filosofia come unità dei vari e molti saperi, perché per realizzarla vi sarebbe
stato bisogno di potere fissare nella scrittura la conoscenza dell ‘Uno-Principio,
insieme Inizio e Cosa Ultima. Ma questa capacità di accesso non l’ha alcun libro.
Sopra credo di avere adeguatamente provato, perché non esiste una condanna
platonica della scrittura e del libro ; a vederla come testualmente evidente sono
tutti quegli interpreti – anche estranei alla Scuola di Tubinga e di Milano- che
emarginano e sottovalutano, nel discorso platonico sulla scrittura, l’atteggiamento
discorsivo della polemica, contro quella che è una variante della Pseudè Doxa.
Quel puntamento su un obiettvo contro il quale ci si contrappone e che
costruttivamente e funzionalmente caratteristico del modo polemico è il segnale al
lettore di una svolta che deve operare e che è imposta dalla natura peculiare di
quell’obiettivo che in Platone è lo Pseudos.
Poichè questo non è un prdotto dottrinario – come ho più volte rilevato- esso non
può essere preso di mira ed attacato con puri mezzi dottrinari; e, perciò, quella
platonica non è una dottrina di condanna della scrittura o di svalutazione cognitiva
rispetto alla comunicazione filosofica orale e di quella dell’anima con se stessa.
E,perciò, Platone non è ambiguo, in quanto condannerebbe la scrittura e nello
stesso tempo scriverebbe tanto.
Chi così lo giudica – e Migliori e tra questi- è il lettore che è porato a vederlo alla
luce di un modo di vedere l’intenzione di significazione e di concettualizzazione che
è dipendente dal modo comune di riconoscimento, rinforzato e complicato da
quello proprio del lettore specialistico isstruito e educato ed abituato a scorgere i
‘contenuti teorici e filosofici’ secondo l’ottica dello esplicito, dello spiegato, della
messa chiaramente ed espressamente a disposizione del fruitore-lettore.
Ma Platone significa e concettualizza secondo il principio del gioco giocato; Migliori
che si schiera apertamente a favore di questa ottica, in realtà ,poi, rimane
ambiguo. Egli,infatti, non applica questo principio quando si tratta di rendere
ragione della portata della impostazione polemica in Platone, che appartiene al
movimento appunto di un giocare che ha,però, di fronte a sé uno pseudo-gioco, che
è decisivo per stabilire quale sia la effettiva natura logico e linguistica dell’ obiettivo
contro cui polemicamente la dialettica platonica muove.
Migliori ha ragione allorchè denuncia l’abuso del parametro della ironia, quando si
tratta di decidere della ambiguità platonica; ma non attraverso il ricorso al modo
ironico –per di più inteso come regisdtro puramente semantico-espessivo – si può
identificare e qualificare funzionalmente il piano cognivo-linguistico che attiva
l’atteggiamento discorsivo della polemica.
Per risolvere questo problema bisogna combinare due operazioni : tenere ferma
l’ottica di lettura gudata da quel principio per tutta la superficie testuale del
significante e mantenere bene in vista il piano effettivo ed operativo dove agisce lo
Pseudos con la sua Dossomimetica, E questo piano è di natura paralogico, extratecnico-epistemico e scorrettamente/abusivamente meta-tecnico; e ,perciò, fuori
dagli ambiti di discorsi dottrinari.
Questa è la svolta e questa è la conversione funzionale-paradigmatica che Platone
esige dal suo lettore che guarda verso i suoi testi.
Sulla base di questa trasformazione ottica possiamo parlare anche di un ‘sottotesto’,
quelllo appunto veicolante un sottointeso , riconoscibile attivando e conformandosi
a quella matrice, in forza della quale noi siamo chiamati ad agire come lettori
spettatori-cooperatori di un gioco di logoi, di una pluralità di giochi disposti in cumstellazione.. od anche nella configurazione propria di una vasto e complesso
arcipelago.
L’ambiguità platonica è, dunque, l’effetto che produce l’intreccio indissolubile di
esplciito-implcito sul lettore che rimanga schiacciato dall’ottica propria della
accademia e delle scuole e che non sa attivare il codice di riproduzione richesto dal
codice produttivo platonico.
A complicare le cose si aggiungono, poi, altre due caratteristiche essenziali alla
costruzione discorsiva platonica : la prima è data dall ’impiego costante di moduli
compostivi-espressivi mutuati analogicamente dalla drammaturgia attica e
trasformati in operatori della prolematizzaiozne e semantizzazione connesse alla
argomentazione e teorizzazione; la seconda è la sua assunzione del modo implicito
proprio di un pensare ,immaginare e dire secondo il principio funzionale .
performativo-applicativo del gioco serio, come il modo che decide della ragione e
del senso di quanto è dato per modo esplicito .
Platone, ad esempio. dice dichiaratamente il problema secondo una formula tipica
dello stile accademico |Che cos’è X in un complesso determinato dato ?|; ma poi
svolge i passi della articolazione della risposta in modo tale che finisce via facendo
per trasformare il problema di partenza in un altro da esso diverso, e cioè | Perché
un Tipo( A portatore di una Tipo-logia/ A1 non riesce ad accedere all’autentico senso
di X in un complesso dato (x, y, z.. ). ?|. Per verficare questa soluzione del problema
,mediante la trasformazione dei suoi termini che implicano una passaggio di piano
non solo tematico , ma soprattutto funzionale, rimando a quanto ho illustrato nel
paragrafo dedicato alla esame del dialogo Eutifrone.
A questo punto posso anche indicare –sperando di non essere frainteso- questa
costante costruttiva-operativa platonica come procedimento di Ironizzazione Logica:
:problematizzo ed argomento in modo dichiarato-esplicito, .dottrinario , ma poi per
come lo dico e per come procedo argomentativamente finisco per dire un
problema diverso ,che decide del senso e della intenzione teorica che muove ed
orienta il primo modo.
Questo signfica anche che l’ironia platonica, fonte della sua cosiddetta ambiguità,
non è riducibile ad una tonalità puramente espressiva e come tale accertabile solo
sulla base della sensibilità e del gusto soggettivo dell’interprete. Essa, invece, è
metodizzata e proceduralizzata come regola fondamentale dei giochi giocati e
,quindi, è intersoggettivamente e testualmente controllabile e verificabile da lettori
che accettano di guardare verso il testo conformandosi al Lettore Modello che
Platone prevede per la sua opera; quel lettore che sa combinare il modo esplicito di
problematizzazione-tematizzazione con quello implicito, riconoscendo a
quest’ultimo un primato funzionale-costruttivo.
Proprio questo ultimo ed determinante passo di impostazione interpretativa non fa
Migliori, che pure dichiaratamente e programmaticamente fa ricorso alla idea di
gioco.
Egli,infatti, - come sopra ho ripetutamente notato- rimane ancorato al modo
dottrinario –tematico di rilevamento delle prove testuali e di riconoscimento della
intenzione teorica platonica.
Ed con questa sua scelta egli lascia irrisolto il problema del rapporto ‘ ad
sustantiam’ della cosiddetta forma letteraria dei dialoghi con i processi platonici di
teorizzazione.
Questa forma, infatti, non è identificabile nella sua effettiva natura senza ripensare
il suo costante e fondamentale rapporto analogico con la grammatica della
drammaturgia attica; e,quindi, bisogna uscire dal generico
e tradizionale
rilevamento di proprietà drammatizzanti della testualizzazione platonica, senza,poi,
portare im primo piano gli essenziali meccanismi funzionali-costruttivi-espressivi che
Platone mutua da quel campo d’origine, ma per la messa in opera di un lavoro di
teorizzazione coerente e sistemica e felicemente riuscita.
Naturalmente questo può essere riconosciuto solo se con Platone operiamo una
trasformazione delle visione accademica di teoria in generale e se in questa
direzione ci sforziamo di guadagnare con lui una pratica di una concettualizzazione
che guarda costantemente ed analogicamente alla logica costruttiva-operativa
propria della geometria –matematica greca.
Perciò ritengo che ll concetto di Performance combinato con
quello di
“Formatività” sia fondamentale per stabilre se e come Platone pone e risolve i suoi
problemi dentro l’orizzonte del suo problema fondamentale-guida : perché L’Ellade
ha accusato, condannato a morte e,quindi, ucciso il più giusto dei suoi cittadini :
Socrate. Da dove vengono e che cosa sono i discorsi che armano la Accusa contro di
lui ? Quale scenario di vita in città presuppongono ?
Questa domanda è da Migliori costantemente e sistematicamente messa tra
parentesi nella sua lunga ricostruzione della “filosofia della dialettica di Platone”.
Ma questa filosofia e questa dialettica sono sostanzialmente snaturate se
procediamo alìa emarginazione di questa interrogazione strategica ed epocale, che
rinvia al contesto storico-culturale-spirituale in cui avviene la decisione platonica di
elevare il suo grandioso monumento alla memoria del suo venerato maestro ed
amato educatore.
Senza l’ancoraggio ai giorni della passione e morte del giusto, del più giusto, senza
tener fermo e continuamente in vista il Nome-Maschera |Socrate| che come
maschera riassume elliticamente appunto una storia, la sua emblematica storia,
perdiamo la bussola per orientarci nella ricerca per individuazione-qualificazione del
bersaglio complesso che Platone pone come obiettivo unico delle sue varie battute
di “caccia”/teras..
Dialettizzare ,infatti, è per lui formare ed lanciare reti, fatte di logoi di metalogoi,
prospetticamente ed analogicamente ‘politecnici’, per ‘catturare’ una preda dalle
molte teste, perché anche essa a suo modo, cioè con le sue false modellizzazioni,
guarda verso i campi dei molti e diversi saper fare e ,quindi, anche essa si attreggia
in maniera poliprospettica, simulando una seria attenzione ed una valorizzazione dei
risultati culturali e scientifici che concorrono a costituire il patrimonio spirituale ed
educativo della città.
Dunque, senza un programmatico e sistematico riferimento al Dovere di mettersi
alla ricerca di questa bestia policefala e,p erciò, anche sfuggente, non c’è per
Platone né autentica ricerca filosofica, né dialeghesthai.
La ricerca senza la quale la “vita non è degna di essere vissuta” è in Platone appunto
quella mossa da questa Opzione di resistenza, opposzione e lotta contro
l’ingannevole ed attraente splendore di quella falsa vsisione sulla essenza della vita
in città. E,perciò, la sapienza che si deve amare nell filo-sophia è impregnata nelle
sue radici, nelle sue fondamenta di ‘Politicità’.
Ma con l’evento della passione e morte di Socrate che cosa ha a che fare questo
progetto di ‘caccia incessante’ di un qualcosa che brillantemente appare, che
colpisce con i suoi effetti fantasmagorici ed allettettanti e, poi, si rende imprendibile
rifugiandosi in una tana ‘segreta’, per la scoperta della quale sono insufficienti ed
inadeguate le vie tecnico-epistemiche e quelle degli usi cognitivi e linguisti della
comunicazione quotidiana ?
Per trovare una indicazione dell’orizzonte in cui cercare la risposta a questa
domanda essenziale per capire quale dialettica Platone opera, dobbiamo rivolgere
attenzione ai logoi – o meglio- ai paralogoi che armano l’accusa a Socrate di voler
introdurre una nuova concezione del divino, di corrompere anche così l’’anima dei
giovani-cittadini, di essere autore e maestro di una comunicazione truccata ed
ingannatrice intorno ai valori, alle “Cose Massime”.
Questi paralogoi della paracomunicazione che si concreta nell’ Accusa a Socrate
sono importanti e decisivi per capire lo sfondo occupato dalla agonia civile e
spirituale di un Ellade caratterizzata dal culto del conflitto e della esaltazione delle
‘logiche’ di dominio e di arricchimento senza freni e spietato.
Ma il punto di aggravamento e di precipitazione di una catastrofe per Platone non è
la diffusione quantiva dei fatti di violenza nelle città e tra le città.
Per lui la crisi si prospetta irreversibile nel momento in cui gli intellettuali si
prestano attivamente, per tornaconto personale e di casta, a legittimare
culturalmente la via della violenza soclale, delle guerre civili e di quelle di conquista,
come ‘lex fundamentalis’ della vita in città e, dunque, come principio ispiratore della
educazione politica , etica e religiosa.
Questa giustificazione prende corpo e forza persuasoria in talk-schow, cioè in
pratiche di comunicazione spettacolarizzata , teatralizzata e teatralizzante,
finalizzata al condizionamento ed alla manipolazione propagandistica della
sensibilità e mentalità privata e collettiva per conquistare il consenso della folla dei
cittadini, delle loro eterie, corporazioni, circoli, clan familiari.
Gl intellettuali autori e protagonisti di questo Tradimento fanno appena capolino
nell figure di Meleto,Anito, Licone ; essi vengono ‘dipinti’ non come sinceri
interlocutori di Socrate, ma come segnavia, abbozzi di nomi-maschere che alludono
e rinviano alla realtà delle effettive e gravi condizioni di vita in una città intossicata e
malata di Pleonessia, di ‘libido dominandi’; di quella città che sta prima ed oltre il
‘teatro dei dialoghi’.
Gl intellettuali , giovani ed anziani, che vengono costruiti e fatti recitare sulla scena
della scrittura come attori-interlocutori del protagonista |Socrate|, sono,invece,
esponenti di una aristocrazia culturale , che a diverso titolo ed in diverso grado di
incosapevolezza non sono capaci di rendersi conto della ragioni e della natura del
disastro che ha investito la testa e l’animo degli Elleni.
Questo indebolimento della loro coscienza di intellettuali,( pur prestigiosi nel loro
campo come nel caso di Gorgia, Ippia, Protagora, Cratilo. Teeteto. Fedone, Fedro e
degli illustri esperti di vari saper fare del Simposio), è dovuto al fatto che essi non si
rendono conto che quella phainomeno-logia, che raggiunge il suo terribile acmè, nei
paralogoi della Accusa a Socrate, non è mappabile e ‘caturabiei’ con le reti dei saperi
disciplinari o – come nella rappresentazione di Ippia- polidisciplinari.
Questa phainomeno- logia è, infatti, di natura extra-tecnica e paatecnica; essa opera
insinuandosi nel terrriotorio mentale di una funzione metatecnica e, perciò. anche
metalogica e metalinguistica.
Questo è il terrritorio di una attivià di un Dopo-Oltre dove il principio della
imitazione raggiunge l’estremo raffinamento proprio di metamodellizzazione
analogica; quella che nel Sofista Platone denomina |Dossomimetica|è appunto uno
scimmiottamento di questa funzione mentale, che Platone ‘nomina’ . ‘indaga’ e
mostra ‘ in action’, cioò con l’operare-agire stesso della sua traversata , della sua
navigazione nel mare affascinante e tempestoso dei metalogoi; e questo accade in
tutto il percorso da Apologia a Leggi.
Il bersaglio a più facce contro cui muove il dialeghesthai platonico e che in questo
polemos trova la sua ratico essendi et cognoscendi, appartiene a questo
phainomeno-logia imperante nella città dove tutto fa spettacolo.
Questa preda la possiamo chiamare anche |Pseudos|, |Pseudè Doxa|, ma con la
rinnovata avvertenza che Pseudos non deve essere confuso con il falso logico o
l’errore tecnico ed un generico irrazionale/alogos; cosi pure |Pseude Doxa! non sta
come termine contrario nella stesso piano cognitivo-lmmaginativo-linguistico al
quale appartiene la Doxa, cioè il campo della opinione comune e degli usi linguistici
della comunicazione quotidiana.
Anche la Pseudè Doxa è una MetaDoxa – o meglio- essa è una ingannevole ripresa
ed imitazione e riproduzione di ciò che è proprio del campo del comune , naturale
ed innocente opinare nella esperienza delle conversazioni in cui ci si intrattiene per
bisogni pratici, per diletto, per piacevole passatempo, per ragioni di cortesia.
La massima Falsa Opinione, quella che concentra in sé la potente carica
allucinogena e illudente di una falso messaggio di una promess di vita piena e felice
in città, è lo spot di una “giustizia come l’utile del più forte”.
Socrate viene investito da una accusa di massa , fomentata ed utilizzata dai
dominatori di turno, che armano la ‘bocca’ della ‘banda dei tre’, proprio perché egli
mette apertamente ed insistentemente in discussione il valore di verità e di vita di
questa presunta fondamentale legge della costituzione , dell’ordinamento e
funzionalmento dello stare insieme in città e delle città.
In questa prospettiva la politicità non è in Platone in prima istanza ed in linea
strategica un oggetto di riflessione riducibile ad una trattazione tematica , di scienza
politica o di dottrina di filosofia politica.; come al contrario sembra fare Migliori,
quando , mettendo al centro il Politico, cerca di stabilire il collegamente tra il mondo
idelale dipinto con la scrittura di Repubblica ed la città più vicina a quella reale ,
rappresentata in Leggi-.
Politicità è una proprietà funzionale interna alla impostazione dell movimento
concettuale in cui si realizza la dialettica; questo dinamica metalogica, infatti, ha
come suo scopo metodico e statutario non la formazione della dottrina uni-molt
come dottrina di contrari senza la dottrina di una mediazione dei contrari per
l’agire di un Principio-Uno. Il fine che funziona da principio di orientamento
dell’operare dialettico platonico è, invece, appunto la attività di smascheramento di
una Falsa Opinione che è intrisa di passioni e di visioni di vissuta vita politica e di vita
di comunicazione sui i beni ed i valori che a questa dovrebbero appartenere.
E, perciò. la politicità è una dimensione propria di ogni dialogo platonico :
L’Eutifrone,ad esempio, non è classificabile come una opera di dottrina eticoteologica; in essa,infatti, prende corpo testuale un operazione di falsificazione di una
distorta immagine metalogica dell’essenza del divino e della relazione che deve
avere con esso l’uomo-cittadino.Il teologo-indovino che occupa la scena è portatore
non di una scienza sulla natura del santo e della pietà, ma di un fantasma discorsivo
che è una variante della Pseudè Doxa. L’andamento negativo del movimento
dialogico sta appunto a provare non che l’opera sia aporetica, ma appunto che essa
si svolge come attività di negazione-falsificazione di una illegittima pretesa, che
vorrebbe far valere uno Pseudos teologico come verità teologica.
Eutifrone, giovane e rampante sacerdote in carriera, è stato contagiato dal sofismamenzogna della immagine di un divino sentito e concepito secondo il criterio della
pura forza e potenza e che su solo questa base si rapporterebbe alla giustizia.
Gli onori ed i sacrifici dovuti al divino – il suoi utile/theophiès per così diredovrebbero ad esso venire attribuiti sotto la spinta della paura di qui più forti che
gli dèi sono.
Eutifrone è portatore infetto di una pseudo-teologia a servizio di una pseudopolitica; la sua ‘città di Dio’ è costruita da immagine e somigliana della cattiva città
degli uomini., ammaliata e stregata da volontà ed azioni di potenza e di
arricchimento violento.
Dunque, la presa di posizione e la lotta contro lo Pseudos .che è sempre tutto ed
origimariamente politico è ciò che muove, ordina e finalizza l’operare dialettico
platonico sia nei cosiddetti dialoghi sulle virtù sia in quelli denominati |dialettici| e
sia nelle opere che sembrano specificamente politiche.
L’habitat ed il terreno di coltura di questo Pseudos è la vita di comunicazione
pubblica, cioè quella che accade negli spazi e tempi della comunicazione sociale
intorno ai valori di interesse generale; e nel contesto di una città a spettacolarità
spinta.
Platone riprende la dialettica come arte dialogica, come saper operare secondo la
regula maxima dell’ uni-molti e come tecnica della confutazione; ma questa ripresa
iimplica una profonda trasformazione di questa pluralità di profili; essa comporta un
passaggio di piano costruttivo-funzionale, che coinvolge sia la forma del piano di
concettualizzazione sia quello della sua esposizione letteraria.
Pe tutto ciò con Migliori dirò che la dialettica in Platone non è una dottrina, ma
diversamente da lui preciserò che essa è sì una attivià, ma una attività di esame e di
smantellamento di fenomeni paraculturali che sono ‘ arcana et istrumenta imperii’
mezzi semiosici di corruzione dellle anime dei cittadini e soprattuto dei giovani
cittadini. Questo avviene nel momento in cui i Principi della Giustizia, della Verità,
della Veracità vengono strumentalizzati e negati come l’utile di chi occupa il potere e
si sente il più forte.
Non ci sorprendiamo così che la dialettica venga a configurarsi anche come
logoterapia, come purificazione, per la moralità del metadiscorso.
Infatti, come la politicità, la eticità è funzionalmente immanente allo statuto della
dialettica e non un oggetto-tema alla quale essa dottrinariamente si appilca.
Ed a renderla tale è innazituto appunto la battaglia contro lo Pseudos, contro quel
Sofisma-Menzogna che ha invaso ed ammorbato lo spirito della comunicazione
pubblica intorno alle “Cose Massime”.
Ed è anche in questo impianto teorico che bisogna collocare lo sguardo psicologico,
linguistico,gnoseologico, metafisico e cosmologico del Platone Scritto.
Dialoghi come il Filebo, il Cratilo, il Teeteto,il Parmenide, il Timeo si caratterizzano
per una comune costante che anche nel Politico sta in particolare rilievo : l’assenza
apparente dello Pseudos nella sua funzione di orientamento fondamentale dei
discorsi che quelle scritture veicolano.
In generale possiamo anche dire che questo Pseudos in questa suo strategico ruolo
costruttivo è il Grande Innominato di tutta la ‘Odissea dialogica’ platonica, dove il
ritorno ad ‘Itaca’ è prospettato come la promessa del mondo migliore della colonia
dei Magneti, che ancore non c’è e che resta da fondare e rifondare in una riforma
radicale che investe lo spirito costituzionale ed il rapporto tra Kratos ed Ethos, tra
Autorità e Koinonia Comunitaria, tra Kephalè e Nous; e dove la virtù del coraggio
diventa volonta noetica di saper osare,rischiare, scommeterre sulla Politeia, sull’
EssereCittà aperta alla vita intelligente del Cosmo e della sua massima fonte
energetica e plasmatrice: il Divino, fonte –principio di tutti i beni
Per cogliere lo Pseudos come bersaglio costante e sistemico dell’operare dialettico
platonico dobbiano valorizzare l’elemento/Racconto ed in esso la funzione
tipologica e paradigmatica del nome-maschera|Socrate| e le indicazioni e
descrizione del suo posizionamento e atteggiamento scenici.
Il lettore dei testi platonici,infatti, deve sapere in quanto lettore/spettatore di uno
spettacolo di logoi che egli è chiamato a riconoscere il senso ed il messaggio della
rappresentazione discorsiva , applicando quella regola di fruizione ricordata da
Ateneo nella sua curiosa, stravagante ed istruttiva opera “ Deipnosofisti”262 ( 2001)
quando parla dellla fortuna della tragedia rispetto ad altre fomre di composizione
drammaturgica:
“ La tragedi a è in tutto
poesia fortunata. Il pubblico
ne conosce bene gli argomenti
ancor prima che parli un personaggio, sicchè il poeta
deve solo ricordarli. Mi basterà di Edipo fare il nome :
ogni altra cosa conosce :che Laio gli è padre,
madre Giocasta, quali sono figli e quali figlie,
che cosa patirà , quali imprse ha compiuto..
Se poi una nomina Alcmeone, anche i bambini
Hanno già detto tutto. : che in preda a follia uccise
La madre, e che subito Adrasto adirato.
giunge e di nuvo se ne andrà “ ( p. 541).
Dunque, qui ci viene detto che lo spettatore che ascolta il nome dell’eroe Già Sa la
sua storia, ‘ciò che egli disse ,fece e patìì. E deve saperlo per capire quel che accade
sulla scena , per intendere il senso proprio e complessivo delle azioni ed i discorsi
che vi vengono raprresentati Questo significa allora che tra i significati ‘riassunti’ed
impliciti nel nome/maschera e queste situazioni-azioni. discorsi esiste una
interazione che lo spettatore deve tenere presente, ripetere e far funzionare nella
fase della sua fruizione.
Questo meccanismo della comunicazione e ricezione teatrale caratteristico della
drammaturgia ‘classica’, attica, è ripreso analogicamente da Platone autore di una
scrittura teatralizzante.
262
Ateneo, Deipnosofisti
Conseguentemente il lettore/spettatore della sua scrittura è chiamato a saper
riconoscere le intenzioni di senso del testo, . quando legge i nomi/maschera che ivi
compaiono, in maniera simile a quel tipo di spettatore di cui parla Ateneo.
In breve : ogni volta che leggiamo il nome-maschera |Socrate| da lettori adatti dei
dialoghi, dobbiano richiamare alla memoria i tratti essenziali de ritratto dell suo
Volto, che viene dinamicamente ‘scolpito-dipinto in maniera esemplare nell’
Apologia e nel Critone ,nen finale del Gorgia, e nell’epilogo del Fedone.
Da questa scultura-pittura a mezzo di scrittura Socrate emerge come la figura del
Più Giusto Accusato di ingiustizia dalla maggioranza del suo popolo, Tradito dal suo
partito, e come colui che ha Patito per l’odio e l’invidia di cui è stato fatto oggetto
dalla folla e dai suoi capi, ed, infine, Condannato a morte, Imprigionato ed Ucciso.
Lo Pseudos , la Menzogna è così diventata energia distruttiva che si è abbattuta e
che ha travolto il cittadino degno di essere rispettato ed onorato come messagero e
testimone di una ‘luce e fuoco sacri’, di Hestia come Platone fa dire ad Eutifrone
nell’omonimo dialogo.
Questa pregnanza tipologica del nome maschera |Socrate| ha un rilievo
paradigmatico, cioè concorre in maniera integrante a formare sia il messaggio che
la intenzione teorica dell’opera.
Ora ciò che si oppone alla considerazione di quei dialoghi – sopra ricordati- come
rispettivamente trattati sul piacere, sul linguaggio, sulla conoscenza, sullla metafisica
dell’ Uno e dell’uni-molti, sulla cosmologia, sulla natura del politico e delle leggi, è
proprio questa funzione decisiva che ha l’elemento/Racconto Teatralizzante nella
generazione , formazione ed orientamento del problema-guida, della connessa
semantica e valenza concettuale di quelle opere.
In esse il rinvio allo Pseudos,pertanto, deve essere cercato ‘aprendo’ quel nomemaschera e facendo rifluire ed interagire la sua portata semantica con tutto il resto
che viene discorsivamente rappresentato. E così ci si deve comportare se
intendiamo rispettare il canone che esige il rispetto della maggior quantità possibile
di superficie testuale, come ci invita a fare ripetutamente anche Miglior, che.però,
sottovaluta ed emargina in quella sua funzione speculativa ciò che immediatamente
si lascia leggere dal lettore dottrinario come Racconto.
Platone,inoltre, dichiara ed eiprime i suoi pensieri non solo costruendo nomimaschera e connettendo intimimamente ad essi le azioni discorsive ad esse
riconducibili, ma anche in riferimento a Socrate con i lunghi suoi silenzi , con i suoi
strani ritardi ad importanti e memorabilii appuntamenti, con il suo appartarsi ed
allontanarsi, con il suo stare sveglio mettre tutti gli altri si fanno prendere dal sonno,
con le sue preghiere e la sua attenzione alle feste religiose ed ai riti.
Come sopra ho già ricordato , le chiusura, ad esempio, apparentemente
puramente narrative del Fedone e del Teeteto costituiscono stacchi-sequenze che si
ribaltano in contrasto con tutto ciò che precede e che è dato sotto forma di
sequenze di azioni argomentative.
Questo contrasto è voluto da Platone, autore del loro montaggio , ed è voluto
perché questo stacco di tipo drammaturgico ‘parli da sé’ al lettore /spettatore, e
provocandolo con la sua ‘stranezza’ di racconto miscelato con le argomentazioni, lo
induca a ritornare sul testo per riorientare la sua interpretazione di lettore comune
o di lettore ‘accademico’.
|Filebo| e |Timeo|, pertanto in quanto titoli, stanto per | Filebo e Timeo LiberatiPurificati|, ma da che cosa ?
Rispettivamente essi vengono liberati dalla illeggitima Pretesa che la ‘Tecnologia del
piacere” e la ‘scienza cosmologica’ siano tutta la conoscenza, al punto che sulla loro
base sarebbe possibile esplorare l’intero mondo dell’anima-corpo alle prese con i
piaceri o l’intera realtà terrestre e celeste. Chi sta in questa pretesa si mette nella
oggettiva condizione di patire l’ oblio di quanto di eccezionale e di memorabile
accade con la passione e morte di Socrate.; e in questo oblio sta soprattutto la
perdita di coscienza e di consapevolezza del male che lo spettacolo della menzogna’
spaccia per nuova e superiore sapienza corrompendo le anime degli Elleni, dei loro
gruppi dirigenti.
Il senso di svolta culturale e spirituale della ‘storia’ esemplare e tragica del più
giusto degli Elleni,, sfugge alla Tecnologia del piacere ed alla Cosmologia
assoluttizate nel loro dimensione di Techne. E Platone deve essere colto dal suo
lettore adatto come colui che indossa i panni dello psicologo e del cosmologo ,
ampliando e raffinando le l prospettive e le concezioni di quei saperi del suo tempo
proprio per estremizzarle ed in alcuni passagi anche ridicolizzandole- nella loro
pretesa di abbracciare il tutto del piacere ed il tutto dell’ oridine cosmico. non
riescono a venire a capo e spiegare così quell evento epocale che per Platone è uno
spartiacque tra un prima e dopo Socrate.; ed in esso non sanno dare la caccia allo
Pseudsos di un Anti-Essere e di un Anti-Esserecittà che sembra trionfare; ma non è
così, perché Socrate si trasfigura e ‘risorge’ nell’ ‘Ateniese’ di Leggi, riapparendo agli
uomini annunciando una sfida : è possibile l’ideazione e la messa in un opere idel
progetto-sogno di Fondazine di una Città Futura Migliore, quella dove Autorità e
Bene Comune vivano in armonia, ‘musicalmente’; perciò, nel Fedone Platone farà
dire al suo Socrate che la “filosofia è la più grande musica”263 e nel Simposio264 la più
nobile tragedia e la più autentica commedia.
Il platonismo di Platone non ebbe storicamente fedeli continuatori, non perché nel
suo sistema di spensiero vi sarebbe una “contraddizione mortale”, due prospettive
incoliabilii e non reciprocamente fondibili; ma perché le Scuole e poi le Univrsità
non riuscirono a stare all’altezza della sua mirabile ed insuperata ideazione, alla cui
origine c’è la consapevolezza platonica che i processi di comunicazione pubblica
‘mass-mediatica’ ( scrittura, macchina del teatro di Stato) impregnate di tecniche di
condizionamento anche sub-liminale, ‘entusiastico’, delle senzibilità e menalità
263
264
collettiva e di propaganda spettacolare , imponevano una rivoluzione della visione
del filosofare e della sua pratica.
La filosofia doveva uscire dal recinto dell’ Accademia e del culto assoluto di
discipline pure senza macchia dell’elemento mitico-metaforico-, e decidersi a
fronteggiare e misurarsi con fenomeni di una comunicazione sociale dove l’impiego
spettacolare, teatrale e teatralizzante del linguaggio diventava una formidabile arma
ed un potente veicolo di trasmissione e di iniettamento di falsi messaggi di felicità,
di giustizia, di vita in Città, delle Città.
La nuova filosofia avrebbe affermare la sua originalità ed autonomia di saper fare
nel cosmo di una varietà e pluralità di scienze-tecniche, se essa avesse osato
intrraprendere una impresa culturale , educativo e purificatrice, che ciascuna di esse
e tutte esse messe insieme per una naturale intrinseco limiti non avrebbero potuto
fare : viaggiare nel mondo di quei logoi peculiari dove imperversa una
Phantasmalogia, cioè usi paralingisutici e paracomunicativi di false immagini dei
prodotti culturali per giustificare il fatto del dominio-sfurttamento e violenza come
presunta legge necessaria per la conservazione e promozione della vita delgli Elleni e
dei barbari, della umanità.
E’ questo Platone che sta ancora tra noi , che suscita meraviglia, esige rispetto e
venerazione ed infonde ed alimenta in noi la coscienza di non sottovalutarlo ed il
desiderio di continuare a leggerlo e rileggerlo, per cercare di riconoscerlo seguendo
il più possibile da vicnio tutte le sue tracce complesse ed magneticamente attraenti;
le racce di una teoria emozionante che è ancora “antiquissima sapienza, alla quale
essa apparitiene il finale e fondamentale messaggio della “Scienza Nuova” del
platonico Vico : l’uomo non è saggio se non è innanzitutto pio265.
265
G: Vico
9. Chi è il filosofo ? A che serve la filosofia nella Città dei Molti e Vari Saper Fare ?
Quale vantaggio promette e dà all’uomo-cittadino ?
Se rimane qualcuno oggi ancora sinceramente interessato a queste domande.,
costui deve sapere che non può comprenderle senza rifarle e ripensarle con
Platone.
E Platone per prima cosa gli chiederà di metterle in discussione in questa loro forma
‘scolastica’ ed esigerà da lui un diverso inizio nella esperienza di questa
interrogazione.
Gli chiederà di mutare la direzione e di operare una conversione del suo sguardo
,perché da quelle domande egli è chiamato innanzitutto a vedere ciò che accade
quotidianamente nella città in cui vive e solo dopo sarà stimolato a rivolgersi anche
a quel che sta scritto nei libri ed illustrato dai professori di filosofia o denunciato dai
suoi denigratori come scienza morta e chiacchera vuota.
Il Platone che si interroga sulla natura del filosofo è, pertanto, il Platone che da noi
esige di saper scrutare nelle profondità di quel quotidiano, dove hanno grande
spazio la voglia di litigare, il culto del conflitto, il piacere dell’ inganno e della
aggressione, la volontà di prevaricazione e di sopraffazione.
Questo spazio-tempo di ciò che il platonico Florenschyi chiama la “cattiveria del
giorno”, cioè delle forze distruttive della vita è da Platone colto, osservato, meditato
da un preciso punto di vista. Tale è quello di una prospettiva che guarda verso la
realtà della Polis/Città, come vita di comunic-Azione.
Metto in risalto con la lettera maiuscola la seconda parte di questo termine, per
segnalare che per Platone la visione della ‘parola’ ed in generale del discorso come
un agire, un fare e, quindi, come un messa in movimento – un dis-correre
266
appunto-, istituisce e guida uno sguardo sulla condizione umana che è
consustanziale alla sua idea di filosofia.
A rimarcare questa proprietà centrale del suo atteggiamento teorico di fondo sta
l’impiego del prefisso |dià| nella parola |dialeghestai|dialettizzare.
Il primo significato di questo prefisso nella lingua greca è quello di |attraverso|267.
Filosofare è, dunque, un Attraversare con il discorso i discorsi, trovandosi situati,
‘abitando’ nei processi di comunicazione sociale ed interagendo con i suoi flussi.
Non a caso Platone, quando parlerà dei discorsi/logoi, ai quali egli si interessa e dai
quali è attratto, conierà nel Parmenide la metafora del “mare dei discorsi” e la
amplierà nel Teeteto con quella che rimanda al guado di un fiume, dove nel
guadare stesso si scopre la cosa che si cerca di sapere e che,perciò, in questo
movimento di attraversamento si mostra, si rivela in ciò che è ; ed in Repubblica
parlerà del moto dell’argomentare paragonandolo a quello delle ondate.
Nel Filebo , su questo asse metaforico, accennerà a discorsi tempestosi e pericolosi;
e nel Fedone utilizzerà le sensazioni, i desideri, le paure e le immagini di quella
esperienza che nel linguaggio marinaro del suo tempo veniva chiamata |seconda
navigazione|.
Con questa ripresa metaforica Platone non allude solo alla fatica di dover procedere
solo a forza di remi, quando il vento cessa e non gonfia più le vele; ma rimanda allo
scenario di fondo, che non bisogna perdere di vista, delle avventure degli uomini in
mare con le loro navi e barche.
E’ tutto il mondo marino, con il suo fascino ed i suoi pericoli, con la costante
‘liquidità’, mobilità e natura sfuggente, instabile, del suo ‘elemento’, a catturare
Platone nella sua grande impresa di pensiero, di un pensiero che guarda alla Terra
ed al Cosmo, al Divino, mentre è sfidato dal suo tempo : l’età del Tramonto della
Civiltà Politica dell’ Ellade, della Grecia e della Grande Grecia, chè è l’Italia da loro
abitata, Il nostro Mezzogiorno .
La filosofia platonica, dunque, è anche quella di un Meridione che, insieme alla
madrepatria è prossimo alla catastrofe;; un precipitare nell’abisso che è per Platone
fondamentalmente spirituale, culturale, educativo; esso travolge i gruppi dirigenti e
le moltitudini che ne condividono il falso ideale di vita.
Quel presunto ideale che induce a credere, lusingando ed illudendo/kolakeia, che la
via della violenza sociale e della corruzione diffusa, della irresponsabilità ed egoistica
inettitudine politica, sia la via regia, la via breve per raggiungere la felicità
personale, familiare, di clan, di corporazione, di ceto , di Stato.
Sullo scenario platonico di un linguaggio come dynamis, flusso ordinato, richiama l’attenzione
anche M. Cacciari, pp.
; qui io aggiungo l’idea che queste ‘dis-correre’ è intriso
dell’elemento spettacolare e che in questo contesto funzionale bisogna riportare il nesso tra il
filosofare e la esperienza del meraviglioso-prodigioso e del tremens.
267
Little-Scott, cit. p.
266
Di fronte a questa tempestosa devastazione Platone pone la sua filosofia e la pone
nella piena coscienza che davanti a questo spettacolo di esaltazione ed adorazione
del conflitto e della prevaricazione, la filosofia può fare ben poco; ma quel suo
‘poco’ è un passaggio decisivo per svoltare verso la rinascita della Città, di una vita
migliore in essa.
Il progetto di una Città governata da filosofi è una reazione spettacolare ed
iperbolica; essa nasconde ed indirettamente dice un altro Platone : quello che, da
grande esperto di costituizione e di legislazione e da acuto osservatore dei moti
economico-sociali ,ha una viva , dolorosa, tragico-comica percezione della
prossimità della fine di un ordine sociale, rispetto al quale l’avanzare del disordine
non è un sicuro ed inevitabile passaggio alla sua ‘Colonia dei Magneti’ salvata,,
risanata, restituito alla Koinonia di Ethos e Kratos; e, dunque, ad un superiore
ordine.
Pensare-Immaginare- Consigliare questa Altra Città è tutt’uno con la decisione di
Osarla, Rischiarla in una Scommessa.
Questo ‘poco’ che è difficile a farsi e che la filosofia fa , è una ‘scintilla’ : quella che
mentre stiamo nella comunic-Azione intorno al Giusto, al Vero, al Bello, al Bene
Comune, allla serentià di un pacifico e rispettoso vivere insiele , ci permette di
provare e dimostrare che la Menzogna potrà pure disporre di una immane plagiante
potenza persuasiva, ma non potrrà mai provare di essere Parola Verace, Pensiero
Vivente e Vita Pensante, Esortante immaginazione simbolica creatrice, promotrice di
nuovi possibili mondi umani senza Pleonessia.,senza libido dominandi .
Questo ‘poco’ solo questa filosofia può farlo e nessuna altra scienza : perché esso
non è fattibile fuori e senza una imitAzione di ciò che disse, patì e fece Socrate
contro la Menzogna di una giustizia propagandata ed esaltata come l’utile del più
forte.
Alla visione platonica del filosofare è, perciò, fondamentale l’opzione di un Dovere
di Ricordare, del dover fare un continuo Memoriale del più giusto tra i giusti della
Ellade.
E, perciò, nessun modo dottrinario e nessuna concezione tutta epistemico-tecnica
può ridurre a sè il suo pensiero, perché questo vive in un Azione Noetica che è
tutt’uno con l’agire intelligente verso la ‘Politeia’, verso l’ESSERECITTA’.
Perciò, in Platone la filosofia è ‘ in principio’ e staturiamente un filosoFare, cioè
Azione; ma non un’azione generica, indistinta, vitalistica, ineffabile in sé ed in sé
senza un pensare.
E proprio di essa, invece, un’ Azione Amorosa, un Poiein-Philein; ma il suo Amato
non è una Sapienza, Sophia, riducibile a sommo modo e grande momento di una
Cultura, cioè alla sua pretesa di fungere da attività du unificazione dottrinaria deila
varietà dei molti saper fare.
Nell’ inizio del filosofare opera una Scelta Intelligente, impregnata di Nous, di spirito
sempre in lotta con un anti-spirito, con il quale non è possibile alcun pur ‘onorevole’
compromesso e né è ammissibile alcuna realistica negoziazione.
Questa cattiva energia è molto più che disordine; essa mira all’annientamento dello
stesso gioco umano e cosmico dell’ordine-disordine, dove questo relativo disordine
è uno stimolo per l’affermazione di un nuova è più ricca realtà posiitiva.
Questo anti-spirito è denunciato da Platone come anti-Parola, anti-verbum, antilogos , come un anti-Socrate.
Ma come la ‘Parola’ può dire ciò che come anti-parola è qualcosa di cognitivamente
e linguisticamete inconsistente; non solo non-sense, ma anti-senso, un agire
distruttivo della possiblità stessa dii una comunicazione verace ?
Catturare con le reti del pensiero e del linguaggio e di una immaginazione logica
ben regolata questo loro radicale negativo è l’impresa che Platone affronta in ogni
dialogo , puntando questo suo bersaglio ed esploransolo in una molteplicità di sue
mutazioni.
La Menzogna è per definizione, infatti, un ‘mutante’; essa ha bisogno di cambiare
continuamente aspetto, per sfuggire alla presa della dialettica che la smaschera .
Ma c’è una costante di questo suo agire falsamente poliedrico perché solo
fantasmagorico; questa costante è l’elemento in cui essa nuota : le trovate e gli
effetti magico-magnetici-entusiastici della agire spettacolare.
Perciò la Menzogna è un programmato ’talk-schow’ a servizio della volontà e del
falso piacere del dominare, che tenta ed attenta tutte le forme in cui gli uomini
cercano di regolare la vita sociale, tutti i modi di governo della ‘Città’.
In questa prospettiva la Menzogna è il ‘male radicale’ nel territorio della parola,
della idea, delle immagini.
Vocazione e missione del filosofo è allora un saper fare socratico, militante contro la
pretesa di questa energia cattiva di valere come vera ed ineluttabile ‘sapienza’ di
vita ed autentico comunitario entusiasmo.
Ed ora possiamo anche capire perché in Platone alla filosofia è essenziale una
polemica contro la ‘poesia’, la ‘retorica’, la ‘scrittura’, la pittura : essi vengono
appunto viste e riprese da lui nella condizione di modi e mezzi di una
comunicazione sociale distorta e corrotta, ma dipinta, abbellita e resa attraente ed
‘entusiasmante’, ‘coribantica’, dalle magie dell’agire spettacolare in quella città
dove tutto fa spettacolo, e soprattuo la Menzogna, quella Menzogna, quella che
aggredì Socrate : lo Strano/atopos, il Diverso, scomodo ed inquietante perché
annunciante la possibilità di un altro migliore mondo; quello dove la Parola sulla
giustizia si illumina nello stesso ‘Socrate in persona’; e che , perciò, come
singolarità-persona doveva essere annientato e messo a tacere per sempre.
Di questo ‘per sempre’ è convinto il tiranno, la tirannia di tutti i tempi.
Ma il Socrate morto è scenicamente ed idealmente fattto ‘risorgere’ da Platone
trans-figurato nell’ “Ateniese”268 personificante un Altro e Nuovo Logos di
Comunicazione in città sull’ESSERECTTA’.
Questa ‘Risorgere’ sta in un cammino che è un pellegrinaggio verso la Montagna
sacra dove nella grotta si può udire la voce di Dio, Principio dei Principi.
Questo apertura della scena di Leggi ci dice che alla filosofia platonica è costitutiva
una ‘liturgia’ : un azione comunitaria per una Synlusia-Koinonia di Liberazione e
Purificazione della Parola dalla aggressione mortale di un Anti-Parola, quella che
rende impossibile il comunicare perché essa è solo strumento di manipolazione
delle menti dei cittadini che dovrebbero persuadersi che il vizio è virtù, che la
spudoratezza ed impudenza sia pudore, che il brutto sia bello, che la schiavitù sia
libertà, che la menzogna sia la verità somma e definitiva.
268
Platone, Leggi.