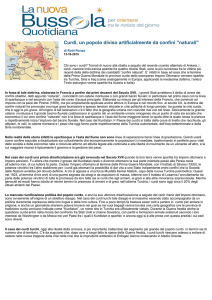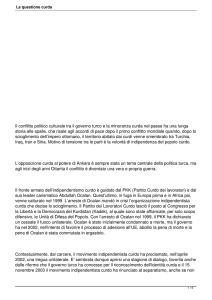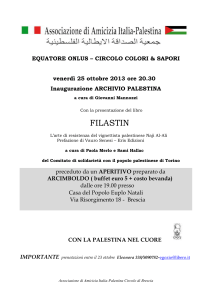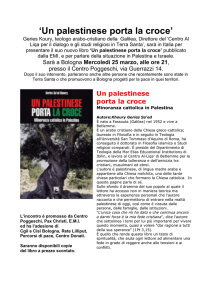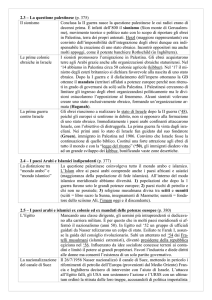www.invisible-dog.com
[email protected]
LA QUESTIONE CURDA NEL FUTURO MEDIO ORIENTE
C’è uno spettro che aleggia nei conflitti in Medio Oriente e che riaffiorerà una volta
conclusi i conflitti in Siria ed in Iraq: la questione curda. E’ già presente in Turchia, dove la
sollevazione curda continua imperterrita ed ha trovato rinnovato vigore; lo sarà in Siria,
dove le milizie filo-curde stanno giocando un ruolo fondamentale nella lotta contro l’ISIS; lo
è da una decade in Iraq, dove il Kurdistan iracheno è, nei fatti, uno Stato nello Stato.
Le origini del problema
I curdi sono una comunità etnica con cultura, tradizioni e lingua propria. Sono in
maggioranza sunniti ma anche sciiti (come in Iran e Azerbaijan). E' una popolazione
autoctona della regione mediorientale.
Nel mondo sono circa 30/35 milioni, di cui circa 15/16 milioni in Turchia (18/20% della
popolazione), 5/6 milioni in Iraq, 6/7 milioni in Iran, 2/2,5 milioni in Siria (circa 10% della
popolazione), il resto in alcune nazioni caucasiche o diaspora nel mondo.
Complessivamente non esistono statistiche precise in quanto, proprio per non alimentare
le loro rivendicazioni, il loro peso demografico non viene quantificato, anche se è talvolta
mistificato. Il vero problema risiede nel fatto che questo popolo non ha una patria. Gli è
stato negata nel tempo anche ogni forma di autonomia.
Con la dissoluzione e relativa spartizione dell'impero ottomano dopo la prima guerra
mondiale, l'accordo segreto di Sykes Picot (1916), poi formalizzato nel trattato di Sèvres
del 1920, sancì la suddivisione del Medio Oriente in aree di influenza tra Francia e
Inghilterra. Questo prefigurava l'ipotesi che i curdi potessero avere una loro patria. Nel
trattato successivo di Losanna del 1923, tale suggestione venne poi accantonata anche in
virtù della forte opposizione dei nazionalisti turchi che avevano ostacolato il progetto e
trasferito nelle aree a maggioranza curda del loro Paese popolazione non-curda. Da allora
i curdi sono diventati oggetto di discriminazioni e persecuzioni nei rispettivi Paesi
mediorientali dove vivevano, alimentando il risentimento e, al contempo, accentuando la
loro specificità etnica.
Sono stati perseguitati dal regime di Assad in Siria dove non avevano diritto al voto; da
quello di Saddam Hussein in Iraq dove la persecuzione ha assunto caratteristiche di
genocidio; sono sotto stretto controllo ed emarginazione in Iran; sono da sempre oggetto
di restrizioni e persecuzioni da parte del governo turco che dopo i falliti tentativi di dialogo,
ha dichiarato le zone curde off-limits ed arresta e perseguita i sostenitori delle istanze della
minoranza nel nome della “lotta al terrorismo”, da parlamentari, a giornalisti a semplici
attivisti.
I curdi in Turchia
La repressione del governo turco nei confronti dei curdi ha spinto la minoranza ad
abbracciare la lotta armata che, nel corso degli anni e fino ad oggi, ha assunto
connotazioni terroristiche contro le autorità di Ankara colpendo soprattutto obiettivi militari
o forze di sicurezza.
Il principale gruppo è il Partito dei Lavoratori Curdi (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK), una
formazione paramilitare di ispirazione, almeno fino al 1999, marxista-leninista e creata alla
fine degli anni '70. Fino al 1984 il PKK ha portato avanti una lotta politica, era anche
riuscito ad avere rappresentanti in Parlamento, salvo poi abbracciare le armi. Negli ultimi
30 anni la lotta armata del PKK in Turchia si è sviluppata in maniera intermittente,
passando da periodi di guerra civile a momenti di tregua. Un conflitto che finora ha
causato oltre 40.000 morti.
Il leader del PKK, Abdullah Ocalan, è stato arrestato nel 1999 a Nairobi, poi estradato in
Turchia dove è tuttora detenuto in isolamento sull’isola di Imrali. Tramite la sua
intermediazione, nel 2008 sono cominciati dei colloqui segreti con il governo di Ankara che
hanno portato alla tregua annunciata dal PKK nel 2013. L'iniziativa lasciava presagire la
possibilità di trovare una formula per una maggiore autonomia dei curdi in Turchia.
Tuttavia, i negoziati e la tregua sono stati violati unilateralmente da Recep Tayyip Erdogan
nel luglio 2015. I bombardamenti della basi militari del PKK nel nord dell’Iraq erano dovuti
a questioni di politica interna: l’AKP di Erdogan non aveva ottenuto la maggioranza
assoluta dei seggi nelle elezioni politiche del giugno 2015 che, anzi, avevano visto
l’ingresso del partito filo-curdo del HDP in Parlamento. Il riattizzare del conflitto curdo e del
nazionalismo è servito a far ottenere la maggioranza al AKP nelle elezioni anticipate del
novembre 2015. Poco importa se lo si è fatto a spese di una componente delle
popolazione turca e proiettato la Turchia verso un’involuzione democratica sfociata nel
tentato golpe del luglio 2016.
Oggi Ankara addita come terroristi ogni forma di opposizione, democratica e non, al
regime. La rimozione dell’immunità parlamentare ha dato la possibilità al sistema
giudiziario – sempre più sotto controllo governativo dal fallito colpo di Stato – di incriminare
e arrestare diversi deputati dell’HDP. Lo stesso avviene per quegli esponenti della società
civile che denunciano la deriva autoritaria o il permanente stato di emergenza nelle aree a
maggioranza curda che consente al governo di Ankara di rimuovere le amministrazioni
locali tacitate di sostenere i “terroristi”. Tuttavia, non è mai emersa una contiguità tra l'HDP
ed il PKK se non nel perseguire, con mezzi diversi, le aspirazioni della popolazione curda.
La riapertura delle ostilità ha portato il PKK ad inscenare una serie di attentati sul suolo
turco colpendo, il più delle volte, obiettivi militari o governativi. Le basi del gruppo sono in
Iraq: a Qandil, dove è dislocato il quartier generale, e nell’area yazida di Sinjar. Qandil
vede la presenza anche delle milizie del partito filo-curdo iraniano del PJAK ed è spesso
oggetto di bombardamenti da parte dell’aviazione turca e/o iraniana. La presenza del PKK
in Iraq è frutto dell’accordo con i turchi del 2013 e della disponibilità di Masoud Barzani,
presidente del Kurdistan iracheno, ad ospitarli. A Sinjar la presenza del PKK è invece il
risultato del sostegno fornito contro lo sterminio perpetrato dall'ISIS nei confronti della
comunità di fede yazida. Milizie curdo-yazide operano adesso congiuntamente. Il leader
del PKK, Murat Karayilan, ha recentemente espresso la disponibilità a ritirarsi dal Sinjar a
seguito delle pressioni americane, le minacce turche e l'ostilità dei curdi iracheni.
La recrudescenza della lotta contro la Turchia ha alimentato la crescita anche di un’altra
fazione ancora più estremista: il TAK (I falchi per un Kurdistan Libero). Già nel 2004 il
gruppo si era rifiutato di accettare l'inizio delle trattative con il governo turco. Il TAK ha
rivendicato i recenti e maggiori attentati avvenuti al di fuori delle aree a minoranza curda in
Turchia.
I curdi in Siria
La guerra civile in Siria ha nei fatti permesso ai curdi siriani di affrancarsi dalle
persecuzioni del regime e di ottenere una propria autonomia territoriale. Sono
rappresentati dalle formazioni militari dell'YPG (Unità di Protezione Popolare), braccio
armato del PYD (Partito dell'Unione Democratica). Nata nel 2003, fino al 2011 il PYD
svolgeva attività clandestina contro il regime siriano.
Con l'insorgere della guerra civile si sono distinti nella lotta contro l'ISIS mantenendosi
fuori dalla lotta contro Assad. Così facendo hanno esteso il loro controllo su una fascia di
territorio nel nord della Siria al confine con la Turchia denominata Rojava, occidente,
anche in virtù del sostegno militare degli USA. Oggi i combattenti curdi, con circa 20.000
uomini, guidano le Syrian Democratic Forces, attualmente impegnate nei combattimenti
per conquistare la "capitale" del califfato, Raqqa. Al loro fianco lottano anche formazioni
militari di donne curde siriane, le IPJ (Forze di Protezione Femminile).
Il PYD, essendo una formazione politica di sinistra, curda e implicata nella lotta armata, è
ritenuta contigua al PKK dalla Turchia. La retorica di Ankara è quella di accomunare la
formazione siriana ai ribelli turchi e vorrebbe estendere l’iscrizione nelle liste del terrorismo
internazionale anche allo PYD, tesi non condivisa dagli Stati Uniti.
I curdi in Iraq
Dalla caduta del regime di Saddam Hussein, i curdi iracheni hanno ottenuto una loro
autonomia territoriale. Hanno mantenuto anche le loro forze militari, non integrando i loro
peshmerga (circa 90.000 uomini) nell'esercito iracheno. E come i curdi siriani hanno avuto
l'appoggio americano e si sono dimostrati tra le milizie, militarmente più efficaci nella lotta
contro l'ISIS. Questo fa sì che, nel caos iracheno, il Kurdistan rappresenti l'area più stabile
del Paese.
I curdi iracheni sono politicamente divisi al loro interno tra il KDP (Kurdistan Democratic
Party) di Masoud Barzani, che guida la regione semi-autonoma, e il PUK (Patriotic Union
of Kurdistan) di Jalal Talabani, presidente iracheno dal 2005 al 2014 . E' una divisione
legata anche a delle divisioni tribali e che nel passato, sopratutto negli anni ‘94-’98, hanno
portato a degli scontri armati. Politicamente, Barzani coltiva buoni rapporti con la Turchia,
mentre Talabani con l’Iran. La vicinanza con Ankara – che postula l’ostracismo nei
confronti del PKK e, di riflesso, lo PYD – deriva dal fatto che il Kurdistan iracheno ha già
una propria autonomia, un suo governo ed un suo "esercito". Non ha quindi motivi per
alienarsi la Turchia con cui invece sviluppa stretti rapporti ed interscambi commerciali, ha
un oleodotto diretto per la vendita del petrolio e coltiva stretti contatti politici.
L'unico obiettivo dei curdi iracheni è quello di allargare i territori sotto il loro controllo e
quindi poter meglio sfruttare le risorse petrolifere dell'area. E' una strategia che li pone in
antagonismo con le autorità di Baghdad. Soprattutto a Kirkuk, città rivendicata dai curdi
essendo stata a suo tempo forzatamente arabizzata da Saddam Hussein proprio per
emarginarli. Oggi i curdi rappresentano circa il 20% della popolazione di Kirkuk da dove
provengono i circa 600.000 b/g esportati in Turchia.
Uno dei problemi del Kurdistan iracheno è l’instabilità economica ed un grosso debito
pubblico, oltre 22 miliardi di dollari, contratto in buona parte con la Turchia. A metà
dicembre 2016 il primo ministro Nechervan Barzani ha presieduto a Dahuk una
conferenza sull’indipendenza del Kurdistan che ha visto la presenza di delegazioni delle
comunità curde dei paesi limitrofi. In quell'occasione ha sollevato ben chiaro il problema
della propria indipendenza, seppur collegandola a prossime trattative con Baghdad e
Ankara. Sempre nella stessa occasione il premier curdo ha offerto la sua disponibilità a
mediare tra Turchia e PKK, come già fatto in passato durante le trattative di Oslo.
I curdi in Iran
I curdi iraniani hanno anche loro una lunga storia di rivolte volte a ottenere indipendenza o
autonomia. Anche in questo caso un'insurrezione armata è condotta in maniera
discontinua fin dal 2004 da una formazione politico-militare di ispirazione marxista come il
PJAK (Partito per la Vita di un Kurdistan Libero). Operante ai confini con l'Iraq, è
considerato affiliato al PKK e come tale messo su una lista di organizzazioni terroristiche
anche dagli USA. Il suo braccio armato è l'YRK (Unità di Difesa del Kurdistan Orientale).
Come avvenuto nei Paesi limitrofi, il regime iraniano ha anch'esso debellato ogni tentativo
insurrezionale, ma non con la stessa brutalità. Questo ha fatto sì che tra Teheran ed i curdi
vi sia una forma di convivenza. Teheran resta comunque contraria ad ogni forma di
autonomia curda. In alcune circostanze i curdi iraniani sono stati colpiti dalle rappresaglie
turche in virtù dei legami con il PKK.
Il futuro
A diverso titolo, le varie comunità curde hanno oggi maggiori opportunità affinché le loro
aspirazioni autonomistiche, se non indipendentistiche, possano avere udienza (non
necessariamente soluzione) internazionale. Il problema curdo, se non adeguatamente
risolto, potrebbe costituire ulteriore elemento di tensione in Medio Oriente.
Il maggior ostacolo verso una soluzione della questione è l'intransigenza turca, che non
solo osteggia le aspirazioni della componente curda della propria popolazione, ma anche
quelle dei curdi negli altri Paesi della regione. E' una circostanza che blocca qualsiasi
iniziativa o negoziato visto che la Turchia è la vera potenza militare nella regione. Ed ha
quindi voce in capitolo nella definizione degli assetti futuri del Medio Oriente. Ankara teme
l'effetto contagio che potrebbe ingenerarsi se un'autonomia curda venisse concessa in altri
Paesi della regione.
Un altro problema è la divisione in seno alla comunità curda. L'atteggiamento filo-turco dei
curdi iracheni è in contrasto con l'ostilità dei curdi siriani e turchi nei confronti di Ankara.
Nei fatti, la raggiunta autonomia territoriale dei primi cozza con le analoghe aspirazioni dei
secondi. Si rende così impossibile un’eventuale soluzione globale del problema curdo. Per
saperlo con certezza è necessario attendere la scomparsa del califfato e i prossimi assetti
geo-politici in Siria e Iraq. Troppi interessi si intrecciano nel futuro del Medio Oriente ed è
probabile che ancora una volta non siano i curdi a decidere del loro destino, ma altri attori
della regione.
LO STATO PALESTINESE CHE NON C'E'. NUOVA INTIFADA?
Israele è un Paese militarmente molto forte, il più forte del Medio Oriente, che non teme
rivali, e che gode del sostegno finanziario e politico di una lobby ebraica internazionale e
della cooperazione tecnico-militare degli USA, oltre ad avere in suo possesso 80 ordigni
nucleari.
Tutte queste circostanze nei fatti impediscono una soluzione negoziata del problema
palestinese perché quando si è troppo forti non si negozia, si impongono condizioni e non
si è disponibili a concessioni. Politicamente, questo approccio è oggi espressione di uno
dei governi più estremisti della storia israeliana.
Sul fronte opposto c'è una variegata comunità palestinese che vive con frustrazione
questa situazione di sudditanza, cova il rancore della rivalsa, si sente defraudata di un
diritto sancito da varie risoluzioni internazionali ( e mai applicato) e vede che la prepotenza
dell'occupante erode ogni giorno gli spazi a qualsivoglia accordo negoziato. Gli
insediamenti nei territori occupati sono lo strumento di questo spazio negoziale che si
assottiglia.
E qui , in campo palestinese , ci sono le due anime che si confrontano : tra chi nonostante tutto - vorrebbe continuare a negoziare e chi , invece vuole riprendere o
continuare la lotta armata.
Più gli spazi negoziali si restringono , più la seconda anima prende il sopravvento . Se
non si negozia si combatte.
Una situazione in peggioramento
Questo è lo stato delle cose oggi in Israele e nei territori occupati. Non c'è lungimiranza
nel pensare che con la prevaricazione si possa risolvere un contenzioso territoriale che
oramai si trascina da oltre 60 anni. Non c'è lungimiranza nel pensare che con la ripresa
del terrorismo palestinese si possa ottenere quello che i negoziati non concedono. Ma
purtroppo la convivenza tra israeliani e palestinesi è disseminata di errori da entrambe le
parti.
E' una miscela sociale e politica che adesso rischia di deflagrare con l'arrivo di Trump alla
presidenza degli Stati Uniti. Se anche i cosiddetti brokers internazionali - quei Paesi che
hanno il peso politico per costringere le parti a negoziare - non recitano più un ruolo super
partes e come il caso sembra adesso prevalere nella politica estera americana di Trump ,
allora oggettivamente la strada che porta al terrorismo non trova alternative sociali
percorribili agli occhi dei palestinesi.
Se poi si delegittima il ruolo delle Nazioni Unite definendolo un club per chiacchiere non si
capisce quale altro organismo internazionale (che oggi non esiste di eguale peso) possa
domani ospitare e garantire un negoziato che porti ad un eventuale accordo operante o
vincolante. Se poi si pensa che le Nazioni Unite sono utili solo quando mettono il veto sulle
Risoluzioni che meglio aggradano una parte o diventano irrilevanti quando invece
esercitano una decisione contraria, è un approccio che squalifica l'esatta rilevanza
dell'organismo stesso.
Le altre guerre
Sinora il problema palestinese, per tutta una serie di altre emergenza nella regione
mediorientale, non ha trovato adeguata attenzione. L'ISIS ed il suo fatiscente Stato
islamico, la guerra civile in Siria, il terrorismo curdo, le giravolte della politica estera ed
interna di Erdogan, il fallito colpo di Stato in Turchia, la guerra in Yemen, la strisciante
guerra tra sunniti e sciiti, il confronto tra Iran e le nazioni del Golfo, hanno attratto
l'attenzione della politica internazionale ma soprattutto hanno distolto l'attenzione e
l'interesse della opinione pubblica internazionale sulle vicende palestinesi.
E di questa disattenzione, obiettivamente, se ne è approfittato Israele che ha continuato la
sua politica di esproprio delle terre palestinesi e della conseguente costruzione degli
insediamenti in quelle aree che invece dovrebbero essere dedicate alla edificazione dello
Stato palestinese.
Ma il Medio Oriente insegna che niente è duraturo nella regione. Le crisi si accavallano e
talvolta si elidono, le alleanze durano il tempo di un interesse condiviso per poi dissolversi,
amici e nemici sono intercambiabili.
Se il il parametro di riferimento per i rapporti di forza fosse valutato oggi, le chances della
popolazione palestinese a potere ambire ad un proprio Stato sarebbero molto poche o
nulle.
Gaza, che è l'area dove è prevalente l'approccio a combattere Israele, è oramai un ridotto
militare circondato da Israele ma soprattutto dall'Egitto che in passato garantiva la
sopravvivenza politica e militare delle istanze di Hamas. L'Autorità Nazionale Palestinese
sotto la debole guida di Mahmoud Abbas non appare in grado di mettere insieme una
dovuta lobby internazionale sulle aspettative della popolazione palestinese né di confutare
adeguatamente ogni prevaricazione o provocazione che possa emergere contro gli
interessi della propria causa. L'ANP è attraversata da faide politiche interne e da scandali
e tutto sembra andare contro gli interessi, almeno internazionalmente riconosciuti legittimi,
dei palestinesi.
Israele e gli USA
Sui rapporti tra Israele e gli U.S.A. c'è stato sicuramente un peggioramento relazionale
durante gli otto anni della presidenza di Obama. Dal confronto sulla soluzione politica del
problema palestinese e la relativa inconsistenza nei negoziati a fronte dell'intransigenza
israeliana , nel tempo la contesa è scivolata anche sul piano personale tra Obama e
Netanyahu. Quest'ultimo ha gratificato il presidente americano di varie scorrettezza
istituzionali e politiche (sia attivandosi per opporsi ad una ratifica del trattato nucleare con
l'Iran, sia relazionandosi direttamente con il Congresso e l'opposizione repubblicana).
In questo contesto può essere quindi interpretata la recente decisione americana di
astenersi da una risoluzione ONU che condanna Israele per i continui insediamenti nei
territori occupati. (in passato era invalsa la consuetudine di porre il veto nel ruolo di
membro permanente del Consiglio di Sicurezza). Una decisione che risente anche di una
altrettanta contesa tra Trump e Obama sulla politica internazionale degli USA che va dai
rapporti con la Russia a quelli con Israele con la chiara promessa del presidente designato
(e del prossimo ambasciatore designato) di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a
Gerusalemme.
Apparentemente tutto sembra assecondare la politica nazionalista di Netanyahu: l'avvento
di Trump, il suo chiaro appoggio alle tesi israeliane, la delegittimazione dell'ONU (che ha
sempre costituito per Israele un ostacolo alle sue intenzioni espansionistiche) e forse il
fatto che tanti attori mediorientali non sembrano in grado di contrastare le decisioni di
Israele o di porsi a sostegno di quelle palestinesi.
Ma in politica estera le forzature, le scorrettezze e gli sgarbi che oggi possono essere
possibili e esercitabili dalle circostanze domani potrebbero ritorcersi contro gli interessi
israeliani sia sul piano politico che diplomatico. E questo, ovviamente, non vale solo per la
questione palestinese che comunque è subordinata alla credibilità dello Stato di Israele nel
contesto internazionale e quindi al suo peso contrattuale. Israele sa bene che l'opinione
pubblica internazionale non gli è generalmente favorevole ed è un dettaglio di cui dovrà
tenere sempre conto.
Sul piano internazionale la convergenza di posizioni tra Trump e Netanyahu ha portato ad
una collisione nelle relazioni con Francia e Inghilterra che hanno votato all'ONU per la
risoluzione di con danna degli insediamenti.
Israele e la Russia
Netanyahu poi sottovaluta il fatto che la Russia, più che gli USA, sta acquistando peso
nelle vicende mediorientali. E la Russia è stata sempre, storicamente, dalla parte
palestinese. Risolta (a suo favore) la questione della Siria, sconfitto l'ISIS, Mosca sarà in
grado di condizionare scelte ed alleanze nella regione a maggior titolo di quanto oggi
possa fare l'America.
Né può certo tranquillizzare il premier israeliano la circostanza che oggi Trump e Putin
possano mostrare di essere in sintonia su molte scelte. Arriverà anche il momento in cui le
due superpotenze entreranno in collisione perché gli interessi dell'una si incrociano con gli
interessi dell'altra in quella contesa di egemonia mondiale che li divide.
I rapporti con la Russia sono centrali nella prospettiva di un assetto della questione
palestinese. La guerra in Siria ha favorito accordi di sicurezza tra Tel Aviv e Mosca anche
per evitare incidenti tra le rispettive Forze Armate. Israele è potuta così intervenire con i
suoi aerei su obiettivi Hezbollah in Siria anche in presenza dell'esercito russo (attacco
aereo contro i campi di addestramento sciiti a Zahara eNubl in agosto e contro l'aeroporto
di Mezzeh a novembre 2016).
Oramai sono oltre 25 anni che i due paesi hanno riallacciato le relazioni diplomatiche, tra
Putin e Netanyahu si è instaurato un buon rapporto interpersonale (Israele si è
recentemente astenuta nel voto Onu per le sanzioni alla Russia) e vari ministri del governo
israeliano (compreso quello della difesa) parlano russo. Ma è una convergenza tattica del
momento, un matrimonio di interesse e non d'amore. La strategia, in prospettiva, porterà i
due Paesi nuovamente su fronti opposti.
Il futuro è incerto
Poi c'è il problema delle cosiddette guerre per procura. Una volta che la Siria sarà
pacificata ed asservita - come lo era in passato- agli interessi russi, la diaspora
palestinese, quelle fazioni più intransigenti della galassia palestinese, che hanno sempre
goduto della assistenza del regime di Assad, troveranno nuovamente il tempo per
dedicarsi alla lotta contro Israele. E se sinora il loro peso era comunque limitato, la
frustrazione della popolazione dei territori occupati potrà fornire loro maggiore
manovalanza.
Poi ci sono le milizie degli Hezbollah che adesso combattono per Assad ed hanno
acquisito nel tempo una esperienza militare che tornerà loro utile nel confrontarsi con
Israele. E dietro gli Hezbollah, come è noto, c'è la longa manus dell'Iran.
Gli Hezbollah sono oggi l'unica forza militare in grado di creare problemi agli israeliani
come dimostrato nel 2006.
Si potrebbe obiettare che la forza e capacità militare di Israele non avrebbe problemi a
combattere le fazioni palestinesi o gli sciiti libanesi, ma lo scenario di riferimento non è una
guerra convenzionale ma una guerra asimmetrica, fatta di guerriglia, attentati, atti di
terrorismo. Insomma una guerra di logoramento e strisciante che comunque non
garantirebbe allo stato ebraico di vivere in pace nella regione. L'insicurezza, quel senso di
percezione del pericolo che un accordo coi palestinesi potrebbe comunque garantire, sarà
il prezzo che verrà pagato dai cittadini israeliani se si mantiene irrisolto il problema
palestinese.
L’accordo non ci sarà
Alla luce di quello che appare adesso, non esistono margini per un accordo negoziato tra
le parti. Israele non ha voglia di negoziare se si intende con questo concetto la ricerca di
un accordo che possa dare vita ai due Stati come previsto dalle risoluzioni ONU del 1967
e che sia fatta di concessioni territoriali.
Netanyahu, nell'ultima campagna elettorale aveva affermato che mai avrebbe avuto luce
uno Stato palestinese sotto la sua gestione politica.
Allora è lecito domandarsi se esistono soluzioni alternative che non sia quel
Bantustan/apartheid che ovviamente i palestinesi non accetterebbero.
Garanzie e sicurezza in cambio di uno Stato palestinese.
Strada percorribile? Sì, se esiste la volontà politica da parte di Israele di negoziare e
concedere. Sì, se da parte palestinese si vorrà dare spazio alle istanze di sicurezza della
controparte.
L'unica speranza è solo in una parola: un compromesso accettabile ad entrambi.
Gli attentati
L'ultimo attentato a Tel Aviv dell'8 gennaio, con modalità tipiche e mutuate dall'ISIS (un
camion contro la folla come a Nizza e Berlino. Ma similitudini ricorrono anche nell'attentato
al mercato dell'8 giugno scorso e quello contro un bar del primo gennaio 2016) è solo la
premessa di quello che potrà presto accadere. Netanyahu ha subito attribuito l'episodio
all'ISIS, forse nel tentativo di porre sullo stesso piano le rivendicazioni palestinesi alle
efferatezze delle milizie di Al Baghdadi.
Sicuramente c'è una collusione di intenti, un accostamento operativo tra le due lotte,
Hamas è la fazione della galassia palestinese più vicina all'estremismo islamico, ma il
problema palestinese è antecedente alle vicende dell'ISIS e vive di una luce propria.
E purtroppo, se non ci sarà spazio per una soluzione negoziata, ai palestinesi rimane
l'unico strumento che è quello della lotta armata, del terrorismo.
C'è stata una prima intifada nel 1987, una seconda nel 2000, una terza nell'ottobre 2015 e
forse ci stiamo preparando alla quarta. Si è passati dalle pietre ai coltelli ed adesso ai
camion.
La politica di Netanyahu è anche condizionata dalla coalizione che lui presiede nel
governo. Essendo alleato a vari partiti estremisti e nazionalisti - come il Bayit Yehudi, Shas
e United Torah Judaism - (oltre ad aver spostato l'asse del suo Likud su posizioni
estreme), Netanyahu ha bisogno spesso e volentieri di cavalcare tesi e comportamenti di
un certo tipo estremizzando anche il concetto di sicurezza.
Armi di distrazione di massa
Netanyahu inoltre combatte adesso una propria battaglia di sopravvivenza politica a fronte
delle accuse di corruzione (soldi ricevuti illegalmente per la campagna elettorale) e della
relativa inchiesta giudiziaria a suo carico. Il premier sa bene che in Israele anche gli ex
presidenti dello Stato possono finire in galera come il caso di Moshe Katsav o come un
suo ex predecessore, Ehud Olmert. Lui stesso, già in un precedente mandato governativo
nel 1996-99, era stato messo sotto inchiesta per aver ricevuto regalie e per spese
personali addebitate a carico dello Stato.
L'intransigenza verso la questione palestinese è da un lato un elemento di distrazione di
massa e dall'altro un argomento per acquisire solidarietà dalle altre formazioni politiche
che lo sostengono. Lui cerca di tramutare una inchiesta giudiziaria o una campagna
stampa ostile in una persecuzione politica. Ma per sua sfortuna in Israele non esiste
l'immunità parlamentare per il primo ministro. Ed è un dettaglio che lui non può
sottovalutare.
Sono tutte circostanze interne che rendono però difficile una soluzione al problema
palestinese.
Sul fronte opposto c'è Hamas che è indebolita dall'assedio di Gaza, le condizioni di
indigenza della popolazione e la brutalità dei miliziani hanno eroso parte del sostegno al
movimento. Anche lì la proiezione di una situazione di guerra strisciante come l'intifada
avrebbe il vantaggio di distogliere l'attenzione dalle difficoltà quotidiane.
L’appello del Papa
Che la situazione israelo-palestinese stia scivolando verso una brutta direzione trova
conferma anche nelle dichiarazioni del Papa a cavallo dell'Epifania. La Chiesa, che è
fortemente interessata ai luoghi santi, ha lanciato un appello affinché si riprenda il dialogo
e si arrivi ad una soluzione, si garantisca la coesistenza. Si faccia insomma una pace
stabile e duratura.
Ma quel che è più significativo è l'accenno che un conflitto - nel caso specifico questo
conflitto - non diventi un'abitudine, qualcosa di cui non si possa fare a meno.
Una Risoluzione Onu a seguito della guerra del 1967, gli accordi di Oslo del 1994 (a cui
aggiungere una serie infinita di iniziative, mediazioni, interessamenti), l'idea di due Stati in
pacifica coesistenza sono tutti rimasti carta straccia. Colpa dei diretti interessati ma anche
di quei Paesi che non hanno saputo ma soprattutto voluto che questi accordi fossero
applicati.
L’impunità allontana la soluzione
E' una situazione che ha ingenerato nelle parti in causa l'idea che quanto viene deciso nei
consessi internazionali non ha valore vincolate, che l'Onu è ininfluente e che quindi esista
una forma di impunità internazionale a fare quel che si vuole.
Adesso si riparla di una iniziativa OLP per un accordo ad interim di tre anni prima di
addivenire ad uno status definitivo, con possibile accettazione che gli insediamenti nei
territori occupati possano rimanere in loco ma sotto la giurisdizione palestinese. La
Francia ripartirà adesso con un'altra conferenza di Pace con un'ampia partecipazione
internazionale.
Ma è inutile negoziare se non c'è la volontà di farlo e soprattutto se non esiste un sistema
che obblighi gli interessati a rispettare gli accordi.
LA METAMORFOSI DEI MUJAHEDIN-E-KHALQ
Se esiste oggi in Medio Oriente un movimento che riassume tutte le incongruenze,
volatilità e imprevedibilità delle vicende regionali questo è sicuramente quello dei
Mujahedin-E-Khalq (MEK - “Combattenti del Popolo”) in Iran. Dalla sua fondazione nel
settembre del 1965 ad oggi non c'è stata vicenda bellica nella penisola arabica che non
abbia visto un ruolo attivo di questa formazione paramilitare. Ha iniziato combattendo lo
Shah ed appoggiando Khomeini, poi ha combattuto gli ayatollah affiancando Saddam
Hussein nella guerra contro l'Iran fino alla caduta del dittatore iracheno. Con l'arrivo degli
sciiti al potere a Baghdad si sono saputi riciclare ottenendo la protezione americana, che
ha imposto il disarmo dei combattenti ma ha anche impedito che la vendetta dei vincitori li
potesse sterminare.
L'ultimo atto è stato la cancellazione, nel settembre del 2012, dei Mujahedin dalla lista
delle organizzazioni terroristiche del Dipartimento di Stato americano. Iscritti nel 1997,
sono stati rimossi grazie ad un’intensa attività di lobbying al Congresso. I loro combattenti,
confinati e/o rinchiusi nelle prigioni militari in Iraq, sono stati successivamente evacuati in
varie parti del mondo. Una parte risiede negli USA, dove vive la dirigenza del gruppo,
mentre altri sono stati accolti in altri Paesi, soprattutto in Francia. Nel marzo 2016, il
Segretario di Stato USA John Kerry, visitando Tirana, ha ringraziato le autorità locali per
aver concesso asilo ed assistenza a oltre mille Mujahedin.
E' questo l'epilogo della storia del MEK? Probabilmente no, perché potrebbero ancora
servire. Molto dipenderà dai rapporti futuri tra gli Stati Uniti e l'Iran. Anche se adesso
militarmente disattivata, la formazione iraniana è forse la più efficiente in circolazione e,
all’occorrenza, potrebbe riprendere le armi contro Teheran. Tornare, in sostanza, a
svolgere il lavoro sporco come già faceva in passato. Non è quindi casuale che dietro alla
riabilitazione politica dei Mujahedin vi siano la mano della CIA e del Mossad. Perché la
rete di contatti del MEK sul territorio iraniano è, oggi come ieri, molto utile. Alcuni scienziati
iraniani implicati nel programma nucleare sarebbero stati eliminati da cellule del MEK con
il sostegno e l'addestramento israeliano.
Una riabilitazione di comodo
Sarebbe altrimenti difficile capire come mai il MEK, che nei suoi oltre 40 anni di lotta
armata ha ammazzato anche cittadini americani – circostanza sempre negata, soprattutto
per quanto concerne gli omicidi dei primi anni ‘70, accusando una fazione estremista
interna al movimento denominata Peykar – colpito le sue società (Pan Am, Pepsi, General
Motors) quando combatteva lo Shah, abbia adesso l'appoggio di Washington. Anche
perché il MEK, almeno nella sua configurazione iniziale, era un movimento marxista, uno
dei tanti che infestavano il Medio Oriente con attentati. E per lungo tempo si è dedicato
alla propaganda contro Israele, incitava la distruzione della "entità sionista" ed ha
parteggiato per l'Iran quando fu occupata l'ambasciata americana a Teheran lanciando
slogan contro il cosiddetto "imperialismo" yankee.
Tuttavia, oggi il MEK è l'unica opposizione armata alla teocrazia iraniana e questo ha fatto
dimenticare i tanti crimini di cui si è macchiata l'organizzazione. Nel mondo dello
spionaggio prevalgono sempre gli interessi e c'è quindi poco spazio per etica,
sentimentalismo o rancore. Il merito del MEK è stato sempre quello di mettersi dalla parte
di coloro che avevano bisogno dei suoi servigi, trasformando l'ostilità del mondo
occidentale verso l'attuale dirigenza iraniana in un vantaggio.
Adesso è molto probabile che con l'arrivo di Donald Trump alla presidenza americana, e
vista la sua avversità al recente accordo sottoscritto sul programma nucleare di Teheran,
si creino nuove opportunità per quel lavoro sporco che il MEK ha saputo sinora fare: atti di
terrorismo o attentati sul territorio iraniano. Del resto il MEK aveva messo in piedi una
potente lobby per cercare di bloccare la sottoscrizione dell’accordo ed in negoziati in
Svizzera.
Una storia terroristica
Dopo l'iniziale appoggio alla rivoluzione khomeinista, dal 1981 in poi il MEK ha lasciato
una scia di morti ammazzati arrivando a colpire personaggi di alto livello della a teocrazia
iraniana. Secondo alcune stime avrebbero causato oltre 15.000 morti sul territorio
iraniano, fra cui alcuni personaggi eccellenti come il presidente Mohamed Ali Rajaei, il
primo Ministro Jawad Bahonar e 27 membri del Parlamento.
Ai tempi di Saddam Hussein il braccio armato del MEK, il cosiddetto "Esercito di
Liberazione Nazionale", era uno strumento militare particolarmente potente. Il dittatore
forniva ai dissidenti iraniani armi pesanti, soldi, guarnigioni e caserme dove vivevano e si
addestravano. Un piccolo esercito in piena regola. Una forza paramilitare che non solo
combatteva contro l'esercito iraniano e si dedicava ad attentati contro la leadership
iraniana, ma all'occorrenza combatteva, come nel 1991, contro i curdi iracheni o contro la
ribellione sciita e a sostegno del regime di Baghdad. Nel 2003 l'esercito del MEK aveva a
sua disposizione oltre duemila armamenti pesanti tra mezzi corazzati carri armati e
artiglieria varia. Sembra che il dittatore iracheno, benché notoriamente diffidente per
natura, si fidasse più del MEK che del proprio esercito.
Caduto Saddam e confinati nel campo di Ashraf al confine con l'Iran ed in altri tre campi
sul territorio iracheno, gli uomini del MEK sono riusciti a far dimenticare il lato oscuro dei
loro trascorsi facendo risaltare invece il lato positivo del loro ruolo di opposizione armata al
regime di Teheran. Questo ha permesso la loro sopravvivenza, non solo politica, ma
anche fisica, apparendo agli americani non più come terroristi prezzolati al servizio di un
dittatore sanguinario, ma come combattenti per la libertà. Un tardivo ritorno romantico alle
origini del movimento quando i Mujahedin si facevano chiamare “Santi combattenti del
popolo dell'Iran”.
Una leadership familiare
L'artefice di questa metamorfosi è stato il leader del movimento: Massoud Rajavi e, forse
più di lui, la moglie Maryam con la quale è sposato dal 1985 e con la quale guida in modo
paritario il movimento dal 1993. I Rajavi gestiscono il MEK come fosse una azienda
personale. La loro capacità manageriale si è tramutata nel tempo in culto della personalità.
Basti pensare che Massoud Rajavi è ufficialmente disperso dal 2003 e la moglie ha
mantenuto inalterato il timore dell’organizzazione nonostante, almeno apparentemente,
esista all'interno del MEK esiste una specie di parlamento in esilio, il "Consiglio nazionale
della resistenza iraniana". Maryam Rajavi adesso vive negli USA i due figli.
Quando combatteva gli ayatollah Masoud Rajavi si era rifugiato nel 1981 in Francia
sperando di poter godere della stessa ospitalità che a suo tempo era stata fornita a
Khomeini. Cacciato via perché considerato un terrorista – in quel momento Parigi era
interessata a coltivare i rapporti con la teocrazia iraniana giocando ovviamente sulle
benemerenze acquisite per aver ospitato l'opposizione allo Shah e, nel contempo, dopo
aver ricevuto l'aiuto iraniano nel liberare degli ostaggi francesi in Libano – aveva subito
trovato sponda in Saddam Hussein, allora sostenuto dagli Stati Uniti in chiave antiayatollah.
I Rajavi hanno imparato a circondarsi di un’efficace macchina propagandistica in grado di
diffondere un’immagine positiva del MEK. A questa hanno affiancato anche una puntuale
attività lobbistica aprendo uffici del MEK in diverse capitali: Londra, Ottawa, Canberra,
Parlamento Europeo e persino in Medio Oriente. Il MEK, una volta abbandonata l'iniziale
ideologia marxista, ha infatti oggi come unico obiettivo politico-militare il rovesciamento del
regime iraniano. E per enfatizzare questo obiettivo propagandistico si avvale di varie
strutture/associazioni/comitati in giro per il mondo che possano dare l'impressione che
questa finalità sia condivisa non solo dal MEK, ma anche da tanti altri.
Chi sostiene il MEK?
Il MEK è riuscito a convincere il Congresso americano a cancellare il movimento dalla
Black List del Dipartimento di Stato e, quando è stato necessario evacuare i propri
combattenti disarmati dall'Iraq, è riuscito a far prevalere la ragione umanitaria. Nel 2003, il
MEK ha sottoscritto con l’esercito americano un cessate-il-fuoco che gli ha consentito di
ritirarsi nel Campo di Ashraf senza consegnare le armi o arrendersi pur essendo all’epoca
ancora formalmente un’organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti non solo gli hanno
riconosciuto lo status di “persone protette”, ma hanno finanziato le agenzie dell’ONU con
20 milioni di dollari per le operazioni di rimpatrio o ricollocazione. L’Unione europea ha
invece cancellato il MEK dalla lista delle organizzazioni terroristiche si dal 2009.
Più di recente il MEK ha cercato di convincere il Congresso americano – per quanto fosse
una tesi alquanto ardita – che per debellare l'ISIS bisognava prima rovesciare la teocrazia
iraniana lasciando prefigurare una presumibile connivenza tra Abu Bakr al Baghdadi e
Teheran. Affermazioni, per quanto spericolate, che hanno trovato udienza tra i deputati e
senatori americani. In Europa invece il MEK sottolinea argomenti più appetibili per
l’opinione pubblica: non rispetto dei diritti umani, il ricorso sistematico alle torture e alla
pena di morte, la discriminazione ed emarginazione delle donne, la libertà religiosa, la non
violenza del movimento dal 2003 in poi.
A parte la capacità di Rajavi e del MEK di essere sempre dalla parte giusta della storia, di
far dimenticare le efferatezza del passato magnificando la sua utilità nel futuro, è da
sottolineare come tutta questa attività internazionale del movimento abbia un costo
finanziario che, almeno ufficialmente, non potrebbe essere sostenuto senza il sostegno
esterno di poteri più o meno occulti, ma anche facilmente immaginabili. A poco servono le
donazioni di facoltosi iraniani in esilio o i fondi scongelati dalla banche americane dopo la
cancellazione dalla black list. Una campagna di informazione e lobbying di questo tipo
costa svariati milioni di dollari, tanto più che l’obiettivo da raggiungere – il rovesciamento
del regime degli ayatollah – è ancora molto lontano.
Sappiamo che dei circa 10.000 combattenti che prima stazionavano in Iraq non rimane più
nulla. La struttura militare del MEK si è dissolta con lo smantellamento dei campi iracheni
ed il successivo esodo dei combattenti. Esiste però una rete informativa e delle cellule
operative all'interno del territorio iraniano. Questa è, in estrema sintesi, la forza di
convincimento del MEK presso le nazioni occidentali.
A conferma di questo c'è il fatto che le prime informazioni sulla fatto che alla centrale
nucleare di Natanz gli iraniani stessero arricchendo uranio per un ordigno militare è stata
fornita alla CIA, e probabilmente anche al Mossad, da informatori del MEK già nel 2002.
Ed in quel momento i Mujahedin erano ancora sotto la protezione di Saddam Hussein. In
altre parole, il MEK lavorava nel contempo con il dittatore iracheno, con gli imperialisti
USA e con la tanto vituperata "entità sionista". Un doppio/triplo gioco a dimostrazione che
la citata sagacia di Massoud Rajavi anticipava gli eventi e già si preparava ad un
subitaneo cambio di casacca.
Vista la guerra strisciante che incombe in Medio Oriente tra sciiti e sunniti è probabile che
il MEK possa in futuro allargare la lista dei suoi clienti. In prima fila l'Arabia Saudita e gli
altri paesi del Gulf Cooperation Council che vedono con crescente preoccupazione
l'espansione dell'influenza iraniana nella regione. Negli ultimi anni il supporto finanziario
fornito dai sauditi al MEK sarebbe addirittura decuplicato. Il possibile impiego del MEK nel
prossimo futuro nella disputa fra Arabia Saudita ed Iran è confermata dalla presenza, nel
luglio 2016, dell’ex capo dell’intelligence saudita, Turki al Faisal, ad un convegno del MEK
a Parigi che, si vocifera, sia stato finanziato da Riad. In quell’occasione, Faisal si è fatto
sfuggire per due volte che Massoud Rajavi era morto, con il disappunto della moglieleader del movimento e di quanti vogliono ancora coprire un segreto di Pulcinella.