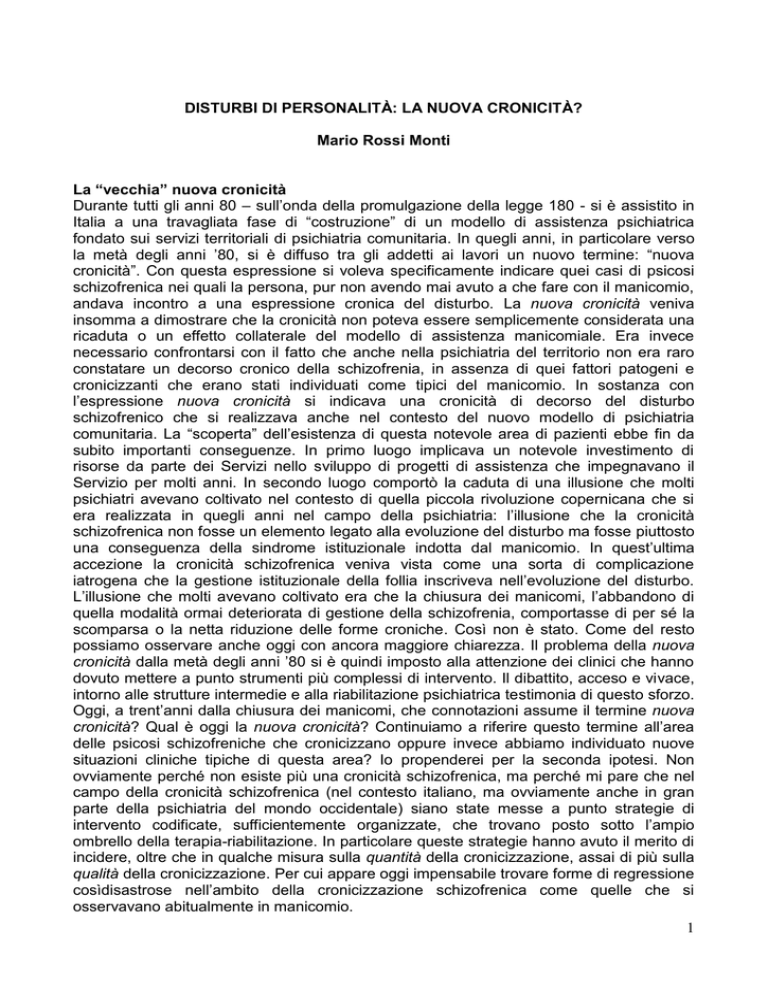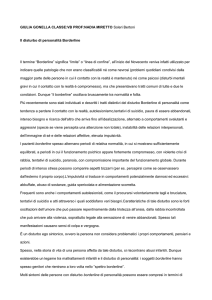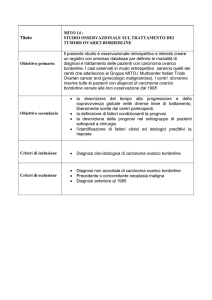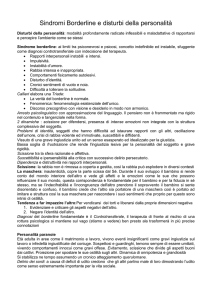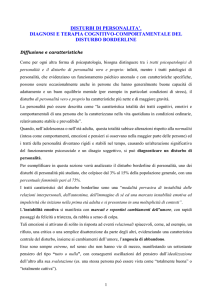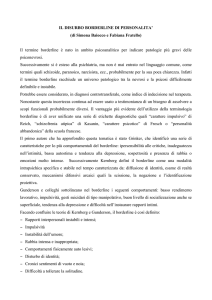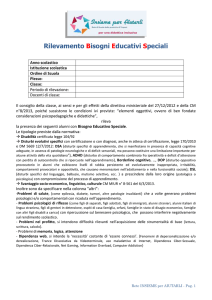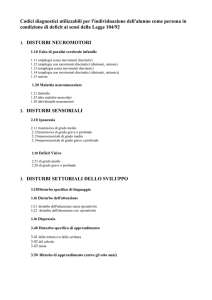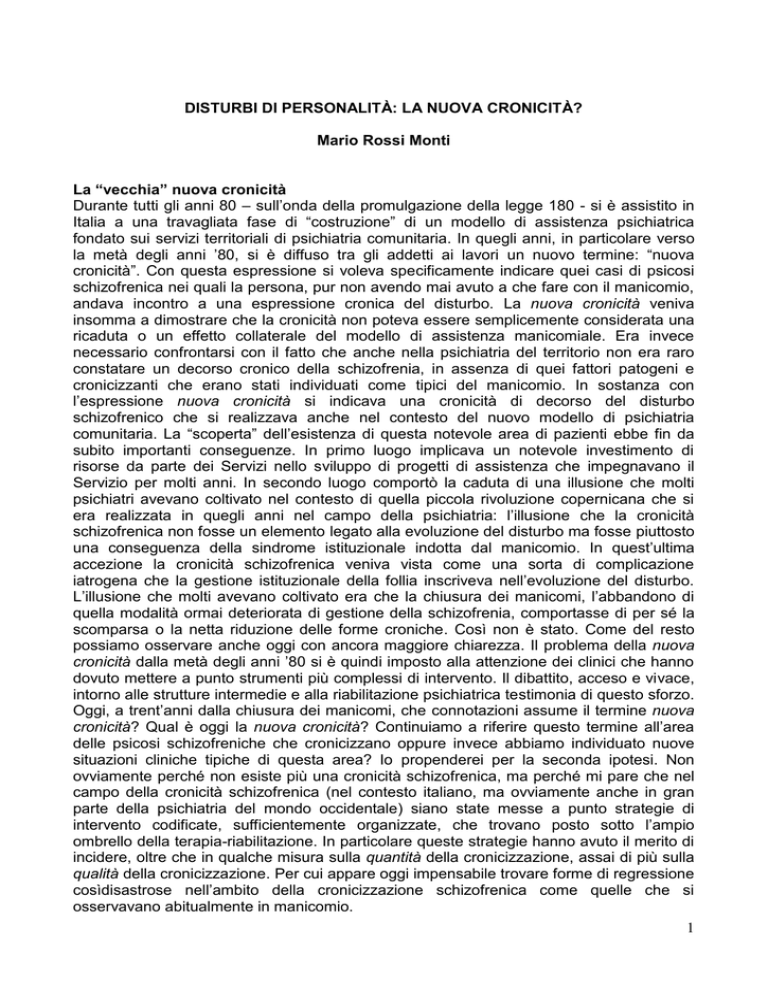
DISTURBI DI PERSONALITÀ: LA NUOVA CRONICITÀ?
Mario Rossi Monti
La “vecchia” nuova cronicità
Durante tutti gli anni 80 – sull’onda della promulgazione della legge 180 - si è assistito in
Italia a una travagliata fase di “costruzione” di un modello di assistenza psichiatrica
fondato sui servizi territoriali di psichiatria comunitaria. In quegli anni, in particolare verso
la metà degli anni ’80, si è diffuso tra gli addetti ai lavori un nuovo termine: “nuova
cronicità”. Con questa espressione si voleva specificamente indicare quei casi di psicosi
schizofrenica nei quali la persona, pur non avendo mai avuto a che fare con il manicomio,
andava incontro a una espressione cronica del disturbo. La nuova cronicità veniva
insomma a dimostrare che la cronicità non poteva essere semplicemente considerata una
ricaduta o un effetto collaterale del modello di assistenza manicomiale. Era invece
necessario confrontarsi con il fatto che anche nella psichiatria del territorio non era raro
constatare un decorso cronico della schizofrenia, in assenza di quei fattori patogeni e
cronicizzanti che erano stati individuati come tipici del manicomio. In sostanza con
l’espressione nuova cronicità si indicava una cronicità di decorso del disturbo
schizofrenico che si realizzava anche nel contesto del nuovo modello di psichiatria
comunitaria. La “scoperta” dell’esistenza di questa notevole area di pazienti ebbe fin da
subito importanti conseguenze. In primo luogo implicava un notevole investimento di
risorse da parte dei Servizi nello sviluppo di progetti di assistenza che impegnavano il
Servizio per molti anni. In secondo luogo comportò la caduta di una illusione che molti
psichiatri avevano coltivato nel contesto di quella piccola rivoluzione copernicana che si
era realizzata in quegli anni nel campo della psichiatria: l’illusione che la cronicità
schizofrenica non fosse un elemento legato alla evoluzione del disturbo ma fosse piuttosto
una conseguenza della sindrome istituzionale indotta dal manicomio. In quest’ultima
accezione la cronicità schizofrenica veniva vista come una sorta di complicazione
iatrogena che la gestione istituzionale della follia inscriveva nell’evoluzione del disturbo.
L’illusione che molti avevano coltivato era che la chiusura dei manicomi, l’abbandono di
quella modalità ormai deteriorata di gestione della schizofrenia, comportasse di per sé la
scomparsa o la netta riduzione delle forme croniche. Così non è stato. Come del resto
possiamo osservare anche oggi con ancora maggiore chiarezza. Il problema della nuova
cronicità dalla metà degli anni ’80 si è quindi imposto alla attenzione dei clinici che hanno
dovuto mettere a punto strumenti più complessi di intervento. Il dibattito, acceso e vivace,
intorno alle strutture intermedie e alla riabilitazione psichiatrica testimonia di questo sforzo.
Oggi, a trent’anni dalla chiusura dei manicomi, che connotazioni assume il termine nuova
cronicità? Qual è oggi la nuova cronicità? Continuiamo a riferire questo termine all’area
delle psicosi schizofreniche che cronicizzano oppure invece abbiamo individuato nuove
situazioni cliniche tipiche di questa area? Io propenderei per la seconda ipotesi. Non
ovviamente perché non esiste più una cronicità schizofrenica, ma perché mi pare che nel
campo della cronicità schizofrenica (nel contesto italiano, ma ovviamente anche in gran
parte della psichiatria del mondo occidentale) siano state messe a punto strategie di
intervento codificate, sufficientemente organizzate, che trovano posto sotto l’ampio
ombrello della terapia-riabilitazione. In particolare queste strategie hanno avuto il merito di
incidere, oltre che in qualche misura sulla quantità della cronicizzazione, assai di più sulla
qualità della cronicizzazione. Per cui appare oggi impensabile trovare forme di regressione
cosìdisastrose nell’ambito della cronicizzazione schizofrenica come quelle che si
osservavano abitualmente in manicomio.
1
Ma se esiste una cronicità più attuale della “vecchia” nuova cronicità, di quale cronicità si
tratta? In altri termini che cosa comprende oggi l’area della nuova cronicità?
La “nuova” nuova cronicità
Ho provato a elencare tre aree che mi pare siano diventate parte di questa nuova
cronicità: aree cliniche e problematiche con i quali i clinici si confrontano nei loro
ambulatori privati e nelle istituzioni psichiatriche comunitarie.
1. La prima area è rappresentata dalla cronicità di tipo depressivo: uno stato di
depressione protratta che si differenzia grandemente dall’Episodio Depressivo Maggiore
che il DSM pone a fondamento dei Disturbi dell’Umore. Sempre più spesso infatti
constatiamo nella nostra pratica clinica come l’“episodio depressivo” rappresenti una sorta
di entità mitica. Grappoli di episodi depressivi, ripetizioni, ricadute o addirittura una
stabilizzazione nella cronicità rappresentano una cospicua percentuale delle depressioni
che osserviamo. La letteratura dà ampia documentazione di questa trasformazione nella
clinica della depressione. Un dato banale: se cercate su PubMed, la più diffusa banca dati
medica, i lavori che hanno nel titolo le parole “depressione” e “cronicità” trovate che i lavori
pubblicati su questo tema durante gli anni che vanno dal 1980 al 1990 sono 88. Negli anni
che vanno dal 1995 al 2005 sono 312! Un indicatore assolutamente grossolano ma
certamente di forte impatto. La associazione tra depressione e cronicità è molto presente
alla mente dei clinici e dei ricercatori; in un modo assolutamente diverso da come
accadeva negli anni successivi alla pubblicazione del DSM III (1980). Dopo la sbornia
psicofarmacologica che aveva eletto i farmaci antidepressivi a unico strumento terapeutico
risolutivo nella depressione, la clinica della depressione si è fatta più variegata e
complicata soprattutto nel lungo periodo. I fattori personologici ad esempio fanno sentire la
loro influenza, modulando percorsi stabili nel tempo in quel circa 30% di depressioni che
evolvono in cronicità. Un panorama del fenomeno depressivo completamente diverso da
quello scenario che si era delineato sull’onda dell’euforia che l’intervento farmacologico
aveva suscitato in molti: sembrava che la depressione potesse essere sconfitta e fermata
per così dire sulla battigia: al primo-singolo-episodio. Un ulteriore elemento di riflessione,
nella letteratura che prende in considerazione la depressione cronica, è rappresentato dal
tipo di linguaggio utilizzato per descrivere le caratteristiche di questo nuovo fenomeno
clinico. Alcuni termini che appartengono tradizionalmente al campo della cronicità
schizofrenica vengono oggi utilizzati per descrivere alcuni fenomeni clinici che compaiono
nelle depressioni a decorso cronico. In primo luogo lo stesso termine “cronicità” appartiene
al vocabolario dell’area del deterioramento schizofrenico: a Kraepelin è stato attribuito il
grande merito di avere distinto il decorso cronico-deteriorante della dementia praecox dal
decorso fasico della psicosi maniaco-depressiva. Ma un altro termine compare spesso
nella letteratura sulla depressione cronica: deterioramento psicosociale. La parola
“deterioramento” rimanda immediatamente all’idea che Kraepelin aveva proposto della
schizofrenia come patologia che produce un progressivo deterioramento, tale che un
giovane individuo affetto da demenza precoce, appunto, può rapidamente deteriorarsi, un
po’ come un demente. Un paziente affetto da psicosi maniaco-depressiva invece avrebbe
dovuto transitare attraverso episodi di segno opposto senza compromissione del suo
funzionamento psico-sociale. Non è così nelle depressioni croniche in cui viene appunto
rilevato una deterioramento psicosociale. Tanto che viene anche riesumato – sempre a
proposito di depressione! – il vecchio termine di difetto: uno dei “marchi di fabbrica” del
concetto classico di demenza precoce. Ancora: nella letteratura sulle depressioni croniche
si parla sempre più spesso di irreversibilità. Si diffondono insomma nella letteratura sulla
depressione cronica termini carichi di significato prognostico negativo e che evocano un
senso di impotenza terapeutica.
2
2. La seconda area nella quale si affaccia una nuova cronicità è quella dei gravi disturbi di
personalità. Il tema dei disturbi di personalità è di grande attualità nei Servizi, se non altro
per il carico di lavoro che implica. In particolare questo peso grava soprattutto sui Servizi
che si occupano di tossicodipendenze: la maggior parte delle situazioni di dipendenza
infatti si intreccia con importanti distorsioni dell’assetto di personalità, soprattutto del
cluster B. In questo senso i Servizi per le dipendenze patologiche sono la frontiera sulla
quale si gioca la possibilità di mettere a punto una modalità di intervento in forme cliniche
nelle quali la perturbazione grave della relazione (e quindi anche della relazione
terapeutica) è centrale. In questa area il disturbo borderline di personalità la fa da
padrone: la maggior parte di diagnosi di Asse II infatti riguarda proprio questa entità
clinica.
3. Una terza area è data dall’intersezione delle prime due: un’area clinica nella quale la
componente di carattere depressivo si colloca nel contesto di un disturbo di personalità. Mi
riferisco alle cosiddette depressioni atipiche dell’area borderline o alle “depressioni
narcisistiche”, a proposito delle quali la letteratura psicodinamica ha fornito importanti
approfondimenti conoscitivi.
L’emergenza di queste nuove aree nella quali si declina la nuova cronicità ha sollecitato la
messa a punto di nuovi strumenti conoscitivi. Accanto ad analisi di tipo epidemiologico o
sociologico che tentano i delineare la portata e le caratteristiche, ad esempio, del
fenomeno depressivo soprattutto in relazione agli stili di vita prevalenti nelle società
occidentali avanzate, è necessario sviluppare una riflessione psicopatologica su che cosa
vuol dire essere depressi oggi. Quando Freud nel 1915 scriveva “Lutto e melanconia”
paragonava il processo fisiologico del lutto a un processo patologico depressivo,
scegliendo come rappresentante della depressione patologica la melanconia. La
melanconia era, a quell’epoca, il paradigma della depressione: la vera e più autentica
depressione. La pietra di paragone di ogni depressione. Se dovessimo oggi individuare il
paradigma della “vera” depressione lo cercheremmo ancora nella melanconia classica?
Oppure lo cercheremmo altrove? Certamente la melanconia continua ancora oggi a
rappresentare una delle forme più gravi ed estreme della depressione clinica. Ma la
melanconia costituisce una variante rara e forse non più paradigmatica di modi in cui la
depressione si declina nella patologia mentale. Il paradigma della depressione sembra
essere rappresentato da altre forme depressive: depressioni meno definite, con
caratteristiche meno nette della melanconia; forme più sfumate, in cui l’umore resta in
continua risonanza con l’ambiente. Depressioni in cui la persona è meno chiusa su se
stessa e più in contatto con l’ambiente: depressioni nella quali manca ad esempio
quell’estremo ripiegamento su se stessi che caratterizza la esperienza della colpa e si
osserva invece l’emergere di un senso di vuoto che la persona registra e lamenta come un
tormento. Una sindrome che la psichiatria colloca nel variegato ambito delle depressioni
atipiche. Il fatto è che queste depressioni atipiche oggi sembrano essere diventate tipiche.
Questa fenomenica di carattere depressivo si ingrana spesso con un assetto borderline di
personalità, nell’ambito di quella vera e propria epidemia borderline che travaglia le
società occidentali avanzate. Se da un lato la categoria borderline viene spesso
(rozzamente) utilizzata come contenitore di tutte quelle situazioni che non trovano
agevolmente spazio nei nostri ordinati schemi nosografici, dall’altro si assiste
effettivamente ad una sensibile crescita di questo tipo di problematica. Tanto che alcuni
clinici e sociologi hanno cercato di mettere in rapporto la diffusione della psicopatologia
borderline con alcune caratteristiche del funzionamento della nostra società. Basti pensare
ad esempio al ruolo che la frammentazione del vissuto temporale gioca nel nostro stile di
3
vita. La nostra epoca è stata sommariamente definita come “l’epoca dello zapping”,
l’epoca nella quale il tempo è straordinariamente accelerato, tanto da favorire una sorta di
fisiologico “sfarinamento” del Sé. Da questo punto di vista la psicopatologia borderline
potrebbe costituire l’estremo limite di questa diversa modalità di muoversi nel tempo:
frammenti di esperienza, collezionati come momenti isolati, si collocherebbero gli uni
accanto agli altri, senza che sia possibile procedere ad una loro integrazione. Realizzando
quella particolare configurazione della temporalità che un grande psicopatologo come
Kimura Bin ha descritto come “momentaneizzazione” del vissuto temporale. Per non
parlare delle depressioni narcisistiche, caratterizzate da un terribile senso di vuoto che
rischia di fare collassare una struttura di personalità che – un po’ come una mongolfiera –
ha bisogno di continue dosi di aria calda per mantenersi in volo. Allo stesso modo il
narcisista patologico può tenersi in stato di compenso solo al prezzo di usare gli altri come
rifornimenti narcisistici.
Tutto quest’ambito, che potremmo ascrivere a quella che propongo di chiamare la “nuova”
nuova cronicità, grava in misura diversa sui clinici e sui servizi con una drammatica
conseguenza: i Servizi sono in difficoltà nel gestire un ambito problematico così
impegnativo anche perché gli operatori (psichiatri e psicologi clinici) non sono
sufficientemente preparati nella loro formazione a conoscere queste evenienze cliniche e
soprattutto lo stile relazionale che queste condizioni implicano.
In un saggio molto breve, di facile lettura e molto avvincente, intitolato “L’epoca delle
passioni tristi”, due colleghi che lavorano nei servizi per adolescenti in Francia, Benasayag
e Schmit, esprimono il loro disagio in maniera chiara ed esplicita. Alle porte dei nostri
ambulatori – scrivono – si presenta una schiera di adolescenti e di genitori molto sofferenti
che vengono a chiedere aiuto. Queste persone sono portatrici di una grande sofferenza.
Ma questa sofferenza non trova posto nelle categorie cliniche che la nostra formazione di
clinici ci ha fornito. E’ una sofferenza di cui cogliamo la rilevanza ma che non riusciamo ad
inquadrare e che si aggira libera – per così dire – tra le nostre tradizionali categorie
nosografiche (schizofrenia, depressione melanconica, mania, conflittualità nevrotica, etc.).
Benasayag e Schmit lanciano quindi un vero e proprio grido di aiuto, sottolineando il
bisogno di una riflessione e di una comprensione psicopatologica di queste nuove forme
del sintomo. La impreparazione dei clinici, dei Servizi, degli operatori nella gestione di
questa grande area problematica si fonda da un lato sulla mancanza di riferimenti teoricoconcettuali più precisi e dall’altro su una grave impreparazione alla relazione: soprattutto
quando questa, come nel caso della relazione con il borderline, è fisiologicamente
turbolenta, se non rabbiosa, provocatoria e “manipolatoria”. Inoltre, la assenza di quella
incomprensibilità che Jaspers ci ha insegnato a cogliere come indicatore della alienità
psicotica (schizofrenica), mette i clinici in una posizione scomoda: una posizione nella
quale non è possibile compiere una operazione di distanziamento e oggettivazione che
almeno protegge dall’impatto con il perturbante. Si realizza così, nel caso del disturbo
borderline di personalità, una maggiore vicinanza nella relazione e un maggiore
coinvolgimento che è sempre difficile gestire nella relazione terapeutica. Ad esempio
quando si sottolinea l’elevata tendenza al drop-out dei pazienti borderline bisognerebbe
non dimenticare che una significativa parte dei drop-out è probabilmente legata ad una
difficoltà nella presa in carico da parte del clinico. Quando addirittura di fronte alla difficoltà
di gestire la relazione terapeutica con un paziente borderline non venga teorizzata la
opportunità di una “presa in scarico”: come quando si sente dire – anche da autorevoli
clinici- “questi pazienti, meglio perderli che trovarli!”.
Uno scivolamento della clinica verso l’area dei disturbi di personalità era stato
preconizzato da molti. Tra gli altri un grande psicoanalista italiano: Eugenio Gaddini. Molti
anni fa, nel 1984, aveva scritto un lavoro intitolato “Se e come sono cambiati i nostri
pazienti fino ai nostri giorni”. In questo scritto faceva riferimento al cambiamento nella
4
psicopatologia avvenuto fino al 1984. Non tralasciava tuttavia di fare anticipazioni sul
futuro. Dal suo punto di osservazione, di psicoanalista che lavora nel setting psicoanalitico
classico, Gaddini mostrava come gli psicoanalisti – la cui disciplina si fonda sul modello
freudiano nato intorno al trattamento delle nevrosi – avessero assistito ad un graduale
cambiamento del tipo di pazienti che intraprendevano una analisi. Una trasformazione dei
pazienti che si è accompagnata anche a un cambiamento dell’assetto di lavoro degli
psicoanalisti. Sono cambiati i pazienti e sono cambiati gli psicoanalisti: è cambiata la
coppia al lavoro. Si è passati da un prevalenza di forme nevrotiche classiche a una
massiccia presenza di gravi organizzazioni del carattere. Gaddini pensava che la
successiva frontiera sarebbe stata rappresentata dalle psicosi. Utilizzava una affascinante
metafora. Lo psicoanalista al lavoro con i disturbi del carattere sente sullo sfondo lo
scroscio di una cascata: la cascata delle psicosi. In realtà – con il senno di poi – possiamo
dire che le cose sono andate diversamente. Il rumore della cascata che continuiamo a
sentire non ha tanto a che vedere con le psicosi acute o croniche quando piuttosto con i
mulinelli dell’area borderline o viceversa con il silenzio della stagnazione narcisistica.
Disturbi disturbanti?
Abbiamo sostenuto la tesi che i disturbi di personalità sono uno dei paradigmi della
“nuova” nuova cronicità. Quali elementi autorizzano a considerare i disturbi di personalità
come disturbi cronici? Tre elementi. In primo luogo la definizione stessa del DSM, a partire
dal DSM-III del 1980, nella quale vengono messe in evidenza alcune caratteristiche
fondamentali dei disturbi di personalità: esordiscono alla fine dell’adolescenza o all’inizio
dell’età adulta; sono permanenti, pervasivi e inflessibili; costituiscono un aspetto basilare
del funzionamento del soggetto. Alla fine dell’adolescenza dunque, il giovane adulto
raggiungerebbe un suo pattern di funzionamento globale e complessivo che tende ad auto
mantenersi. In questo senso i disturbi di personalità sono da concepirsi come disturbi
cronici: una volta strutturati tendono a persistere indefinitamente. Una caratteristica
costitutiva dei disturbi di personalità (in particolare di quelli del cluster B) è quella di
immettere nella relazione con gli altri un carico di problematicità che si riversa sull’altro e lo
travolge. Tanto che nel mondo anglosassone è in voga la dizione patients that
psychiatrists disilike per indicare questi pazienti. Una delle caratteristiche dei disturbi di
personalità del cluster B è dunque quella configurarsi allo stesso tempo come disturbo
soggettivo ma anche come disturbo altamente disturbante la relazione: un disturbo
disturbante. Perché disturbante? Perché – si dice - sono pazienti difficili, rabbiosi,
impulsivi, che agiscono al posto di pensare, aggressivi, manipolativi, che bruciano
operatori, tempo e risorse, sempre alla ricerca estrema di attenzione, che mettono in crisi i
Servizi con condotte revolving door. Ancora – si dice – è difficile che migliorino e sono
dunque pazienti cronici che condannano il Servizio a una gestione “cronica”.
In questo tipo di considerazioni si può probabilmente riconoscere chiunque abbia lavorato
con pazienti borderline, se non altro perché questi pregiudizi riflettono alcune esperienze
controtransferali tipiche di chi si impegna in un progetto terapeutico di questa portata.
Queste considerazioni - invece di essere considerate materiale sul quale lavorare e da
gestire nella relazione - sono state tradotte da due psichiatri britannici in veri e propri
argomenti a favore della tesi che i Servizi psichiatrici non si devono fare carico di questo
tipo di pazienti. Più di dieci anni fa infatti Cawthra e Gibb (1998) sostenevano sulle pagine
dell’autorevole British Journal of Psychiatry che non aveva senso impegnare energie nella
cura dei pazienti con gravi disturbi di personalità: sia perché non si ottengono risultati, sia
perché, anche quando li si ottengono, il prezzo è troppo alto e soprattutto compromette la
funzionalità complessiva del servizio e l’equilibrio degli operatori. Tra le motivazioni per le
quali un Servizio non dovrebbe farsi carico di questi pazienti essi citano ad esempio il fatto
che questi pazienti, a causa della loro turbolenza, mettono a repentaglio il percorso
5
terapeutico di altri pazienti. Ad esempio, quando un paziente borderline viene ricoverato in
un reparto psichiatrico si determina quasi invariabilmente uno sconvolgimento
complessivo dell’ambiente terapeutico.
Adottare questa prospettiva significa – in linea con la tradizione kraepeliniana nel campo
della schizofrenia – fare coincidere una diagnosi di disturbo con un vero e proprio destino:
un po’ come la diagnosi kraepeliniana di dementia praecox configurava inesorabilmente il
deterioramento come destino. Allo stesso modo, sulla base di queste considerazioni, si
vedrebbe nella diagnosi di disturbo borderline di personalità un percorso inesorabile, a
senso unico, il cui destino è segnato una volta per tutte. In realtà, lungi dall’adottare il
suggerimento dei due colleghi, il Ministero della Sanità inglese ha affrontato seriamente il
problema: nel 2002 è stato indirizzato a tutti i Servizi un questionario volto a monitorare gli
strumenti con i quali i servizi di psichiatria gestiscono il problema dei disturbi di
personalità. Da questa indagine è emerso che il 17% dei Servizi aveva sviluppato modalità
specialistiche di intervento. Il 40% dei Servizi invece gestiva il problema in forma “non
specialistica” cioè senza una adeguata formazione del personale. Il 28% dei Serivi
teorizzava, sulla scia di Cawthra e Gibb, la impraticabilità della gestione di questi pazienti.
Infine il 15% dei Servizi non dava alcuna risposta. Nel complesso il 45% circa dei Servizi
non era in grado di mettere a punto una strategia di intervento o rinunciava tout court ad
un intervento specialistico in questo ambito. Sulla base di questi dati nel 2003 l’Istituto
Nazionale per la Salute Mentale ha varato su tutto il territorio nazionale un progetto pilota
sui disturbi di personalità, con durata limitata nel tempo e teso a verificare che cosa si può
ottenere impegnandosi attivamente in questo campo. Il progetto pilota si fonda su linee
programmatiche piuttosto generali tese a favorire la messa a punto nei Servizi di équipe
specialistiche multidisciplinari deputate al trattamento dei disturbi gravi di personalità. Il
progetto non indica quali strumenti istituzionali devono essere privilegiati: il trattamento in
regime di ricovero prolungato, l’uso di strutture intermedie o viceversa il servizio
psicoterapeutico ambulatoriale. Ogni servizio è abbastanza libero di mettere a punto un
modello di intervento. Proprio dalla valutazione comparativa di questi risultati verranno
tratti elementi orientativi per un progetto di organizzazione stabile dei Servizi. La filosofia
complessiva del progetto si fonda sulla idea che la diagnosi di disturbo di personalità non
debba più essere una diagnosi di esclusione: vale a dire una diagnosi utilizzata per non
occuparsi di un problema. Al contrario è necessario promuovere il passaggio da un
atteggiamento di rifiuto a una ipotesi di trattabilità, mettendo a confronto tra loro differenti
progetti terapeutici. Gli stessi promotori di questa importante iniziativa hanno rilevato come
la stessa diagnosi di disturbo di personalità sia di per se stessa “appiccicosa”: una volta
attribuita a un paziente essa tende a persistere immutata, innescando una serie di effetti a
catena che vanno nella direzione della stigmatizzazione. La tendenza alla
stigmatizzazione fa sì che atteggiamenti rivendicatori, di sfida, a tratti violenti di questi
pazienti non vengano visti come dati parziali da integrare in un contesto clinico più ampio
ma piuttosto come elementi sintomatologici tali da precludere ogni progetto terapeutico. In
sostanza di fronte alla impossibilità di comprendere il funzionamento della mente
borderline scatta nell’operatore la tendenza all’oggettivazione stigmatizzante e si riaffaccia
il paradigma della cronicità-intrattabilità: la conclusione porta inevitabilmente ad un
atteggiamento del tipo: “non voglio avere niente a che fare con questo tipo di pazienti!”.
Del resto Biederman e Tayler (2004) hanno mostrato come raramente i pazienti con
disturbi di personalità abbiano accesso a trattamenti adeguati nei Servizi. Per lo più sono
gestiti con scarso impegno alla periferia del sistema di cura. I Servizi raramente hanno le
competenze e capacità richieste per il trattamento dei gravi disturbi di personalità. Alcuni
Servizi arrivano a escludere il trattamento nell’erronea convinzione che questi pazienti non
abbiano un problema psichiatrico.
6
D’altra parte questa posizione di scarso interesse, o meglio di sostanziale disinteresse per
quest’area problematica, non è nuova: appartiene piuttosto alla storia anche recente della
psichiatria. Quelli che oggi chiamiamo Disturbi di Personalità sono stati per tanto tempo
considerati “i figliastri della psichiatria”: una problematica che sta a margine dello specifico
della psichiatria, della quale è lecito interessarsi poco o niente. Fa una certa impressione
andare a rivedere il capitolo dedicato ai Disturbi di Personalità in un Manuale di Psichiatria
degli anni ’70. In genere si tratta poche pagine sui disturbi del carattere. L’idea che
dominava nella formazione di base degli psichiatri dell’epoca era quella secondo la quale
si trattava di “persone fatte così”: prevaleva quindi nella clinica un atteggiamento di
fatalismo, di rassegnazione, di sostanziale nichilismo terapeutico. L’introduzione del
secondo asse nel DSM-III (1980) ha certamente avuto il merito di stimolare tutti i clinici a
indagare sistematicamente la relazione tra asse I e asse II, mettendone in evidenza gli
incontri e le eventuali sovrapposizioni, favorendo un ragionamento clinico dinamico in
senso lato.
Kurt Schneider è stato uno dei pochi clinici che – alla metà del secolo scorso - aveva
dedicato grande attenzione al problema dei disturbi di personalità parlando di personalità
abnormi e personalità psicopatiche. Recentemente l’editore Giovanni Fioriti ha ripubblicato
questo classico della psicopatologia in cui Schneider traccia una tipologia a-sistematica
dei disturbi di personalità, mediante la messa a fuoco di prototipi. Uno degli elementi
centrali nella diagnosi di personalità abnormi e psicopatiche era rappresentato dal rilievo
che questi pazienti “soffrono” e “fanno soffrire”. Con questa duplice connotazione dei
disturbi di personalità Schneider ha avuto il grande merito di inaugurare una prospettiva
particolarmente adatta a cogliere il nucleo problematico dei disturbi del cluster B. Il fatto
cioè che il nocciolo della diagnosi ha una duplice radice: da un lato in un assetto che la
persone stessa sente come problematico, dall’altro nel sentimento di sofferenza, fastidio,
disturbo o aperta ostilità che il l’altro (e anche il clinico) avverte. La diagnosi del disturbo si
fonda quindi – con una vera e propria capriola epistemologica – sul vissuto del soggetto e
sul vissuto di chi ha a che fare con lui: vale a dire sull’effetto che il disturbo induce negli
altri. Un disturbo che è tale nel senso che è anche disturbante: un “disturbo disturbante”.
In questo modo Kurt Schneider, lontano anni luce da una prospettiva psicodinamica, dà
forma ad un elemento essenziale dei disturbi di personalità: il fatto cioè che il terreno sul
quale il disturbo inevitabilmente si esprime è rappresentato dalla relazione con gli altri.
Tanto che Fonagy può dichiarare paradossalmente (parafrasando Winnicott) di non avere
mai visto un disturbo borderline di personalità: poiché tutte le volte che c’è un disturbo
borderline esiste anche un altro che interagisce con lui. Insomma non è possibile essere
borderline da soli, nel vuoto relazionale.
Se da un lato questo mette l’operatore in una posizione privilegiata - nel senso che il
paziente borderline (diversamente da un paziente autistico schizofrenico o da un grave
melanconico murato nel suo delirio di colpa) coinvolge l’altro immediatamente nella
relazione - dall’altro però complica maledettamente le cose, poiché questa relazione è di
assai difficile gestione e tende a ripetere percorsi travagliati, poco fruttuosi e
sostanzialmente distruttivi.
Discutendo di questi temi nei Servizi, con operatori che si occupano di pazienti borderline,
ho notato quanto grande sia il loro bisogno di vedere riconosciuti e discussi una serie di
sentimenti (anche molto ingombranti) che si affacciano alla mente degli operatori in ogni
percorso terapeutico di lungo periodo: ogni operatore si sente in qualche misura ipercoinvolto, trascinato, usato, svuotato, manipolato, colpevolizzato, messo al muro,
“sbatacchiato”, provocato, maltrattato, traumatizzato, esposto a instabilità –
imprevedibilità, idealizzato, perso, compartimentizzato, desolato, sconfortato, inutile,
spaventato, invaso, angosciato, sospettoso, diffidente, arrabbiato, etc.
7
Certamente anche un paziente delirante esercita un notevole effetto su ciascuno di noi e
tocca corde delicate e sensibili, ma in genere – di fronte al delirio - è possibile recuperare
una possibilità di distacco mediante la oggettivazione di una modalità di funzionamento
della mente aliena. Nel rapporto con il paziente borderline invece tutto questo è molto più
problematico: si viene assolutamente presi all’interno del suo stile relazionale che non è
così radicalmente diverso da poterlo qualificare come alieno; ma nemmeno così’ vicino da
potere essere sentito come accettabile o familiare. Spesso non si sa che cosa fare. Si
avverte il peso della propria impreparazione a queste sistematiche turbolenze relazionali.
Se non si riesce a sviluppare una serie di conoscenze e una riflessione che svolga una
funzione mitigatrice nel rapporto tra emozioni e tendenza ad agire la soluzione che viene
più frequentemente adottata è la fuga o la repulsione. Per questo l’aspetto relazionale
diventa uno dei cardini del problema e soprattutto dell’intervento.
Il dramma della disforia
A questo punto vorrei porre una prima conclusione che riguarda le due facce della
cronicità. Abbiamo cominciato parlando di cronicità schizofrenica e abbiamo visto che una
cronicità che pensavamo artefatto, la cronicità schizofrenica come esito del manicomio, in
realtà si è rivelata reale: una cronicità che persiste in una certa quota di pazienti che non
hanno vissuto l’esclusione manicomiale. In secondo luogo, una cronicità che pensavamo
reale, cioè una cronicità che pensavamo facesse parte del funzionamento tipico di ogni
disturbo di personalità, tanto da essere inclusa nella definizione stessa del disturbo, si è
rivelata un artefatto. Solo da alcuni anni cominciamo a disporre di una letteratura che si
fonda su studi di lungo periodo sul decorso dei disturbi di personalità. Questi studi hanno
mostrato che la nostra presunzione di cronicità del disturbo non è stata confermata dalla
ricerca, nel senso che queste forme psicopatologiche non si sono rivelate così
assolutamente immodificabili e stabili nel tempo come si presumeva. Quali sono le ragioni
che avevano indotto gli estensori del DSM-III a quest’assunzione teoretica?
Innanzitutto la tradizione psicopatologica. Un grande autore come Kurt Schneider vedeva
questi disturbi come assetti abnormi di personalità sostanzialmente immodificabili. Altri,
come Kretschmer, ne avevano colto il potenziale mutativo: ma solo nel senso di uno
scivolamento verso la psicosi. Nei 20 anni successivi alla messa a punto della categoria
diagnostica Disturbo Borderline di Personalità è stato possibile monitorare l’evoluzione del
disturbo nel tempo. Così da qualche tempo disponiamo di dati relativi a borderline
“anziani”, nel senso che hanno alle spalle una lunga esperienza da borderline.
Non solo non è più sostenibile la tesi di una evoluzione cronica di alcuni gravi disturbi di
personalità, ma è possibile studiare anche il modo nel quale evolvono nel tempo i disturbi
di personalità: quali aspetti sono più aperti al cambiamento e quali invece tendono a
persistere, magari al di sotto della soglia clinica. Non per nulla si è aperta, da alcuni anni,
una grande sfida, centrata sul confronto tra diversi modelli di trattamento della
psicopatologia borderline di personalità, che costituisce il nocciolo duro dei disturbi gravi
di personalità: il modello della psicoterapia dialettico-comportamentale di Marsha Linehan,
la psicoterapia centrata sul transfert di Kernberg, la psicoterapia basata sulla
mentalizzazione di Bateman e Fonagy, la terapia cognitivo-analitica o il modello del
trattamento istituzionale di John Gunderson. Questa enorme vitalità dei ricercatori e dei
clinici si è espressa sia nel tentativo di formulare modelli patogenetici della psicopatologia
borderline (il ruolo delle esperienze traumatiche in età evolutiva, la ricerca sul ruolo della
dissociazione, etc.) sia nel mettere a punto modelli efficaci di intervento. Tutto ciò
testimonia del fatto che si è aperta una speranza là dove prima si vedeva un vicolo cieco.
Una speranza che la maggior parte degli studi di follow-up sui pazienti borderline ha reso
più che ragionevole, oltre che eticamente doverosa. Passerò brevemente in rassegna solo
alcuni studi di questo tipo. Paris (2001), per esempio, ha preso in considerazione un
8
gruppo di pazienti borderline seguiti per un periodo di 2, 5, 8 e 10 anni verificando come, a
distanza di 10 anni dal trattamento, circa il 50% dei pazienti inizialmente diagnosticati
come borderline non rientravano più nei criteri diagnostici. Il fatto di non rientrare nei criteri
diagnostici del DSM significa che quei soggetti non soddisfano 5 criteri dei 9 item previsti
per la diagnosi. Magari ne soddisfano 4 e conservano una qualche problematicità di
funzionamento, ma comunque una problematicità non clinica, nel senso che non si
affaccia oltre la soglia imposta come elemento differenziale tra normalità e disturbo.
Mary Zanarini et al. (2003) hanno condotto uno studio di 6 anni su un numeroso campione
di pazienti borderline dimostrando che la prognosi è molto migliore di quanto ci si poteva
aspettare: la remissione dei sintomi nell’arco di 6 anni riguarda una percentuale di pazienti
estremamente elevata. Secondo Zanarini è possibile individuare una tendenza, in qualche
modo naturale, al miglioramento e al cambiamento. Lo studio entra poi nel dettaglio
cercando di mettere a fuoco quali aspetti del funzionamento borderline si modificano nel
corso del tempo. In particolare Zanarini ha distinto l’area clinica sintomatologica della
psicopatologia borderline in due grossi ambiti: una prima area che riguarda i sintomi più
acuti e più problematici incentrati sulla impulsività; una seconda area che comprende
sintomi legati al temperamento di base.
Il primo gruppo di sintomi, di carattere acuto, comprende tutte quelle manifestazioni
comportamentali drammatiche che inducono violente reazioni nell’ambiente: in particolare
gli agiti impulsivi e le condotte parasuicidarie.
Il secondo gruppo di sintomi è costituito da sintomi più stabili, meno acuti e anche meno
allarmanti. Comprende quell’insieme di fenomeni che hanno una dimensione più emotiva e
affettiva: sentimenti cronici di vuoto, sospettosità, difficoltà a tollerare la solitudine, paura
dell’abbandono, angoscia di separazione con la conseguente necessità di “macinare”
relazioni per tamponare la possibilità di rimanere soli con se stessi. Questi aspetti vengono
considerati più vicini all’aspetto temperamentale e costituzionale: e anche più durevoli e
radicati nel tempo.
Dallo studio di Zanarini emerge una immagine della psicopatologia borderline come area
ibrida in cui si mescolano sintomi discontinui, cioè acuti, con tratti che sono invece stabili
nel tempo. Non solo. Paradossalmente quegli aspetti sintomatologici che rendono
inizialmente molto faticosa la presa in carico, sono anche quelli che nel corso del
trattamento regrediscono per primi. Come dire: nella presa in carico della psicopatologia
borderline non bisogna lasciarsi troppo impaurire dal corteo di sintomi imputabili alla
impulsività o al difetto della mentalizzazione: questi aspetti problematici sono infatti i primi
a risentire positivamente di una presa in carico terapeutica sviluppata saldamente nel
tempo. Ad analogo risultato è arrivato Gunderson (2008) nel documentare l’evoluzione dei
pazienti borderline nel corso di un trattamento istituzionale. Nel giro di alcuni anni si può
raggiungere un notevole miglioramento del funzionamento psicosociale e quindi realizzare
un significativo miglioramento della qualità della vita.
Da studi di questo genere ricaviamo quindi una prima conclusione: se ci impegneremo,
nell’ambito di un trattamento istituzionale, a seguire nel tempo un paziente borderline
grave (in cui prevalgono gli aspetti sintomatici legati all’area della impulsività) assisteremo
probabilmente a fenomeni drammatici acuti (tipici della prima area sintomatologica
descritta da Mary Zanarini). Queste condotte (provocazioni, rabbia, atti impulsivi, condotte
autolesive, minacce o veri e propri ricatti suicidari) getteranno lo scompiglio tra gli
operatori, metteranno in crisi il Servizio e la sua organizzazione. Ma questi stessi fenomeni
andranno più facilmente incontro a remissione se noi clinici, naturalmente, saremo in
grado di reggerne l’impatto e lavorare su di essi, non considerandoli corpi da espellere ma
fenomeni drammatici da inscrivere in un continuum di senso: in un percorso mutativo
invece che di rifiuto.
9
Un secondo gruppo di fenomeni tende invece a persistere anche quando gli aspetti più
drammatici della psicopatologica borderline si saranno stemperati. Riassumerei questo
secondo aspetto sotto la voce “il dramma della disforia della esistenza borderline”. La
disforia infatti sigla l’intera esistenza borderline, paradossalmente anche quando il
soggetto non risponde più ai criteri per la diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità,
configurandosi così come un vero e proprio marker strutturale del funzionamento
borderline. Un vero e proprio marker psicopatologico del funzionamento mentale
borderline che persiste anche al di là della emergenza sintomatologica. Una sorta di
umore di fondo fatto di irritabilità, malumore sordo, tensione interna, sospettosità-ostilità
preconcetta, scontentezza senza nome che tormenta da sempre l’esistenza borderline e
che spinge all’ azione indifferenziata, nel tentativo di liberarsi (almeno momentaneamente,
nella ebbrezza della azione) di questo stato mentale. Dunque mentre il paziente bordeline
può in qualche modo venire a capo delle sue condotte impulsive, nell’ambito di un
articolato e continuativo progetto terapeutico, difficilmente riuscirà a lasciarsi alle spalle
uno stato umorale di fondo fatto di irritabilità, malumore, insofferenza. Una condizione
emozionale-umorale di fondo che ha probabilmente molto a che fare con vicende
traumatiche che – mediante il loro effetto disorganizzante – hanno reso impossibile
approdare alla possibilità di vivere con minore pericolo o addirittura con tranquillità e
piacere le relazioni con gli altri.
Trauma e traumaticità
L’area del trauma rappresenta infatti un altro degli ambiti di riflessione e di ricerca centrali
nella conoscenza del funzionamento borderline. Troppo spesso tuttavia il trauma viene
inserito in modelli esplicativi che danno per scontato un rapporto diretto di causa effetto tra
esperienze traumatiche infantili e insorgenza di una psicopatologia borderline di
personalità. In realtà il trauma occupa un posto assai più rilevante nella psicopatologia
borderline poiché non appartiene affatto alla dimensione del passato quanto invece alla
dimensione del presente e della relazione. Voglio dire che avere a che fare con un
paziente borderline e tentare di stabilire con lui una relazione terapeutica implica un alto
grado di traumaticità per il clinico, intendendo per traumaticità la portata traumatica della
relazione con una persona borderline. Il trauma nella psicopatologia borderline appartiene
forse al passato ma certamente appartiene al presente: nel senso che si esplica nella
relazione attuale. Tutti quei sentimenti evocati nel clinico dal contatto con il paziente
borderline configurano – per il clinico, così come anche per i familiari, conoscenti, partner,
etc. – una situazione traumatica.
Quindi, il trauma sul quale abbiamo bisogno di ragionare quando lavoriamo con i pazienti
borderline, non è solo il trauma che appartiene alla storia lontana, infantile del paziente ma
il trauma (o la traumaticità) che si fa concretamente sentire nella sua modalità di
funzionamento attuale, nelle sue relazioni con gli altri: il trauma del presente. Il trauma del
presente si riflette in primo luogo sul paziente: si manifesta in comportamenti
autolesionistici, in condotte rischiose, sia di sfida alla morte, condotte parasuicidarie
qualche volta simili a riti ordalici di sfida alla morte con fantasie di purificazione-rinascita.
Esperienze estreme che i pazienti borderline ricercano spesso anche attraverso l’uso di
sostanze. Ricordo un giovane paziente che si era scoperto improvvisamente omosessuale
e aveva iniziato una relazione con un partner sieropositivo. Senza prendere
deliberatamente alcuna precauzione. In secondo luogo il trauma del presente riverbera
sugli operatori. La traumaticità borderline si esprime spesso con la rabbia, l’attacco
verbale o fisico: tutte situazioni che confrontano il clinico con emozioni violente, con le
quali non abbiamo tanta familiarità all’interno del nostro ruolo terapeutico. Situazioni, per
così dire, da trincea alle quali non siamo stati certamente formati e che facilmente
inducono alla fuga o alla repulsione (magari giustificata da ragionamenti pseudo10
terapeutici). E’ importante invece sottolineare che non soltanto che avere a che fare con
un paziente borderline vuol dire avere a che fare con un paziente arrabbiato, ma anche il
fatto che ciò implica avere a che fare con un clinico arrabbiato: con la propria rabbia.
Insomma una rabbia à deux che circola nella relazione. Ma che circola tanto più
distruttivamente quanto meno noi clinici per primi siamo capaci di farvi fronte, di esprimerla
in maniera non distruttiva e di viverla invece come un passaggio di grande importanza per
la costruzione di una relazione terapeutica, nella quale la rabbia possa esprimersi sul
terreno della relazione senza che quest’ultima venga distrutta dalla rabbia stessa. Non è
facile insomma tenere nel proprio bagaglio terapeutico quell’odio per i pazienti del quale ci
ha coraggiosamente parlato per primo Donald Winnicott.
Ancora. E’ fortemente traumatico sentirsi maltrattati, “usati” per la propria funzione ma
senza alcun riguardo per la proprio persona: “manipolati” (anche se questo termine
meriterebbe una più precisa messa a fuoco). D’altronde, nella misura in cui ci
impegniamo in un progetto terapeutico, dobbiamo essere consapevoli del fatto che una
delle funzioni del clinico è proprio quella di “lasciarsi usare”, di prestarsi a rappresentare
sulla scena una parte precostituita nella psicopatologia del paziente (anche se all’interno
dei limiti garantiti da un “sistema di sicurezza” costituito dal setting istituzionale). Ma
questo sentirsi usati non deve perdere - nel nostro vissuto - il legame con la speranza in
una evoluzione, in un progetto terapeutico. L’operatore ha cioè bisogno di sentire che
questo “uso” che il paziente fa di lui non è semplicemente la ripetzione-replica di una
modalità distruttiva e inconcludente di rapportarsi agli altri, ma il primo passaggio di un
percorso potenzialmente evolutivo. Se è più facile mantenere questa consapevolezza nel
rapporto con un paziente regredito, deficitario o magari chiuso nel suo mondo autisticodelirante, non lo è affatto nel rapporto con un paziente borderline. Una persona tutt’altro
che incompetente nelle relazioni. Anzi, direi che il borderline ha il problema opposto: una
competenza relazionale selettiva, iper-specialistica che piega e forgia le relazioni tutte
nello stesso modo: mettendole a ferro e fuoco. E in questo ristretto ambito ha una
competenza relazionale assai più elevata di una persona normale: non è affatto facile
mettere a ferro e fuioco tutte le relazioni. Per converso manca la possibilità di esprimere
tutta quella gamma del repertorio relazionale che consente lo sviluppo di relazioni umane
affettuose e positive. Concludo con una vignetta che rappresenta particolarmente bene
uno dei dilemmi in cui cade l’operatore quando viene maltrattato dal paziente borderline.
Ho dato a questa vignetta il nome “Effetto Pasquale” e ne sono debitore a Giuseppe
Riefolo che per primo la proposta e utilizzata a questo scopo. Si tratta di una apparizione
di Totò a Studio Uno del 1966. Il compare di Totò è Mario Castellani. Riporto di seguito la
sequenza e lascio a voi trarre una conclusione intorno alla domanda: quanto essere
Pasquale con i nostri pazienti borderline?
Totò
Voglio raccontare un esipodio che mi è capittato
Castellani
Episodio vorrai dire
T
Mi è venuto incontro un pezzo di giovanotto che era così, con delle spalle così….
C
Grosso… aitante..
T
11
Non lo so se era aiutante … ma un pezzo di … mi è venuto incontro
C
Ho detto aitate, aitante! un pezzo di giovanottone grosso..
T.
È venuto vicino a me, mi ha guardato fisso negli occhi, con una ghiglia sulle labbra come
per dire ‘mo te fa faccio vedere io’
C
Cos’è questa ghiglia…la ghiglia sulle labbra, sarà stato un ghigno, un ghigno
T
Era un ghigno? A me m’è parsa una ghigna
C
Vabbè, t’ha guardato
T
Mi ha guardato fitto fitto per dire ‘PASQUALE’… a me!? Pasquale!
C
Ma che c’è da ridere?
T
‘Era un pezzo che ti cercavo…’
C
A te?
T
A me… ‘Figlio di un cane’, dice…
C
Ti ha detto ‘figlio di un cane’?
T.
Sì, ‘finalmente ti ho trovato’. Alza la mano e pam! E mi ha mollato uno schiaffo..
C
Ti ha mollato uno schiaffo?
T
Ma forte!!
C
Ti ha detto figlio di un cane e ti ha dato uno schiaffo!!??
E tu?
T
Io pensavo tra me e me: chissà sto stupido dove vuole arrivare?… hai capito?
12
C
Pensavi.. e poi?
T
Mi ha preso per la giacchetta e mi sbatteva vicino al muro così.. io ,lo lasciavo fare
C
Lo lasciavi fare?
T
‘Pasquale, te possino ammazzatte’.. tum, pah… due
C
Ti ha dato due schiaffi?
T
Due schiaffi
C
Due schiaffi!!
E tu??
T
A me queste cose mi scompisciano!!
Io pensavo tra me e me: chissà sto stupido dove vuole arrivare?
C
Tu pensavi… e poi, che è successo?
T
‘Pasquale! togliti il cappello!’. Non glielo ho fatto dire due volte. ‘Pasquale maledetto, ti
debbo sfondare il cranio’. Pum. Un cazzotto qui che ci ho ancora la ficozza!
C
Ti ha dato pure un pugno in testa?? Ma tu scusa che facevi?
T
Io pensavo tra me e me: chissà sto stupido dove vuole arrivare?
C
Ma che ridi? Mi fai rabbia. ride, ride, ‘io pensavo, pensavo’… Ma scusa, ma perchè non
hai reagito?
T
E che me frega a me! E che so’ Pasquale io??
13
BIBLIOGRAFIA
Gunderson J. (2008), Disturbo di personalità borderline. Cortina, Milano, 2010
Paris J., Zweig-Frank H. (2001), A 27 year follow-up of patients with borderline personality
disorder. Compr Psychiatry,42:482-487
Zanarini M., Frankenburg FR.,Hennen J., Silk KR., (2003), The Longitudinal Course of
Borderline Psychopathology: 6-Year Prospective Follow-Up of the Phenomenology of
Borderline Personality Disorder.Am J Psychiatry 160:274-283
14