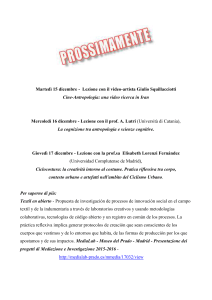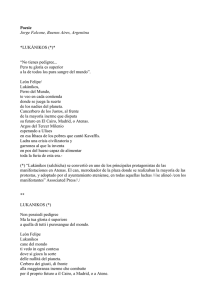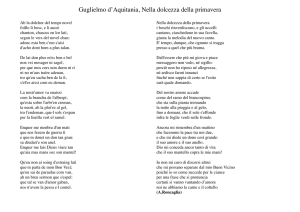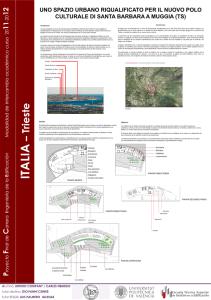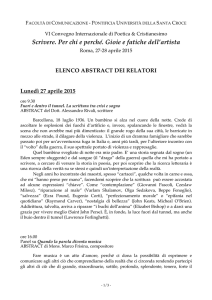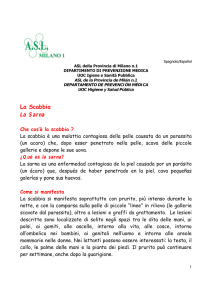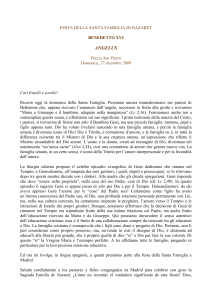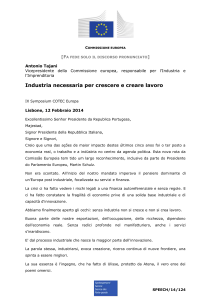Q
UADERNI
di antropologia e scienze umane
Quadrimestrale del Laboratorio Antropologico
del Dipartimento di Scienze umane, filosofiche
e della formazione dell’Università di Salerno
con la collaborazione de
La Rete
Associazione per l’integrazione
dei saperi antropologici, letterari, filosofici e psicologici
INIZIATIVE EDITORIALI
Quaderni
Direttore
Simona De Luna
Direttore responsabile
Mirella Armiero
Condirettore
Domenico Scafoglio
Comitato Scientifico
Annamaria Amitrano (Università di Palermo)
Giulio Angioni (Università di Cagliari)
Claudio Azzara (Università di Salerno)
† Rocco Brienza (Università di Trieste)
Antonino Buttitta (Università di Palermo)
Giovanni Casadio (Università di Salerno)
Alicia Castellanos Guerrero (Università Autonoma Metropolitana del Messico)
Luigi M. Lombardi Satriani (Università La Sapienza di Roma)
Gilberto Lopez y Rivas (Instituto de Antropología e Historia, Messico)
Sebastiano Martelli (Università di Salerno)
Pablo Palenzuela (Università di Siviglia)
Gianfranca Ranisio (Università Federico II di Napoli)
Luigi Reina (Università di Salerno)
Domenico Scafoglio (Università di Salerno)
Enzo Segre (Università Autonoma Metropolitana del Messico)
Laboratorio Antropologico – DISUFF Università degli Studi di Salerno
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa)
[email protected]
La Rete – Associazione per l’integrazione dei Saperi Antropologici, Letterari, Filosofici e Psicologici
Piazza Gerolomini n. 103, 80138 Napoli
[email protected]
ISSN 2282-2968
Autorizzazione richiesta al Tribunale di Nocera Inferiore (Ruolo Generale n. 2247 del 2015)
copyright 2014 Paolo Loffredo - Iniziative Editoriali Srl
Q
UADERNI
DONNE IN ARMI
anno
II •
n u m e ro
3
ANTROPOLOGIA E STORIA/1
NOVEMBRE 2014
simona piera de luna
Presentazione del Quaderno, 7
domenico scafoglio
L’altra metà della banda (Italia meridionale1861-1870), 15
simona piera de luna
Donne in guerra: il brigantaggio femminile postunitario, 49
- francisco pinéda gomez
Mujeres en armas: la revolución mexicana de 1910, 79
alicia castellanos guerrero
claudio azzara
Le amazzoni di Procopio. Variazioni di un mito nella Bisanzio
del VI secolo, 107
IN TERV ENT I E CONT R I B U T I S U L T E M A
arianna bonnini
Donne e armi nell’alto medioevo. Il caso longobardo, 113
anna maria musilli
Dove porta la storia: soldatesse crudeli, afroamericane e arabe, 116
annalisa di nuzzo
Erano innamorate di Mussolini: le ausiliarie di Salò, 120
ANT ROPOLOG I A E S TO R I A/ 1
domenico scafoglio
“Facta ficta” nella ricerca scientifica e nel romanzo storico-antropologico, 125
giulio angioni
Fare e dire la storia raccontando storie, 141
DISCUS S I ON I
stefano semplici
Su alcuni effetti della valutazione all’italiana, 145
A NT ROPOLOGIA E L E T T E R AT U R A
luigi reina
Ritorno ad Alvaro. Tra richiamo antropologico e tensione letteraria, 157
S C AF FALE ANT RO POL OG I A/ S TO R I A
G. Botti, Sulle vie della salute. Da speziale a farmacista-imprenditore nel
lungo Ottocento a Napoli (D. Verrastro), 163
RA SSEGNA DI ST UDI
Raíices de nuestra justicia (G. Gasparello), 167; F. Cardini, In Terrasanta; fra pellegrini tra medioevo e prima età moderna (O. Paesano), 168.
N OT I ZI AR I O L I B R I / E V E N T I
Un convegno e una iniziativa per la maschera di Pulcinella, 171; Congresso internazionale a Morelia su
Poéticas de la oralidad, 171; “Ethnologie française” (ottobre 2014) sull’Etnologie du litteraire, 173.
6
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Presentazione del “Quaderno” 3
Simona Piera De Luna
Uno sguardo nuovo su brigantesse e zapatiste
S
i ritiene che la storia della guerra
civile postunitaria denominata
brigantaggio sia ormai abbastanza nota, perché studi ulteriori possano riservarci sorprese di un certo
interesse. In effetti sappiamo molto di scientificamente provato sugli aspetti politici, militari, economici del brigantaggio del decennio 1860-1870 e sulla sua repressione, a parte
alcuni significativi silenzi su fatti per amor
di patria taciuti, ma poco o nulla conosciamo della vita dei briganti, di quell’insieme di
elementi che impediscono di fare dei briganti
soltanto attori, più spesso comparse, o marionette manovrate da un destino inclemente o
piuttosto da un groviglio indecifrabile di poteri e contropoteri che li usavano per un gioco
più grande di loro: una visione che toglie ai
protagonisti di una delle poche guerre contadine che abbia avuto l’Italia spessore e dignità,
vanificando il bisogno di conoscere chi erano
veramente quei contadini e pastori che per
quasi un decennio si confrontarono per con
più di metà dell’esercito italiano, di chiedersi
se credevano nei valori per i quali combattevano, di indagare il loro mondo morale, l’organizzazione della loro vita alla macchia, le forme di solidarietà che li compattavano, il loro
legame col territorio, la montagna, il bosco,
il paese, le forme della loro vita quotidiana, i
loro legami familiari e parentali, i loro comportamenti nella guerra e nelle altre forme di
violenza istituzionalizzate, il loro rapporto col
sacro, la paura, la sofferenza, la morte.
In questo affresco che gli storici hanno
lasciato dipingere in parte a pittori e scrittori
(i quali peraltro, a parte qualche eccezione,
non sarebbero andati oltre la costruzione di
pasticciate fantasticherie), la scoperta delle
brigantesse, di cui la storiografia ufficiale ha
ignorato l’esistenza per più di un secolo e mezzo, poteva occupare una centralità indiscussa,
o costituire un nuovo punto di osservazione,
da cui guardare con occhi nuovi l’intera vicenda del brigantaggio. In questo spirito sono
stati concepiti i due saggi presenti in questa
rivista, che anticipano l’uscita, ormai imminente, di un’ opera assai più vasta sul medesimo tema degli stessi autori. In essi sono
illustrate le ragioni che spinsero le brigantesse
alla macchia, è ricostruito per la prima volta
il loro rito di iniziazione, sono spiegati i ruoli
e le funzioni che ebbero nella banda, la loro
partecipazione alle operazioni di guerra, la
loro cattura e il processo che subirono, riportando condanne lievi e qualche assoluzione.
Intorno alle donne è stato ricostruito, attraverso le connessioni più significative, il contesto nel quale si colloca la loro storia, con
la necessaria attenzione – per la prima volta
esercitata negli studi sul brigantaggio – ai loro
rapporti con gli uomini con i quali condivise7
Q
uaderni
ro una quotidianità intensa e difficile, e alla
determinazione del peso che le famiglie e le
reti parentali ebbero nell’organizzazione delle
bande, nei rapporti di forza al loro interno e
nella vita dei paesi. Ne viene fuori un quadro
inedito della complessità della vita alla macchia, una visione inaspettata del brigantaggio,
che fa luce sugli angoli oscuri di una vicenda
in parte da riscrivere. La storia collettiva delle
brigantesse come gruppo (e come insieme di
gruppi) si incrocia continuamente con le singole storie, che restituiscono in maniera più
intensa e drammatica i vissuti dei protagonisti, all’interno di trame di guerra e di amori,
alcune delle quali di notevole spessore.
Sulle brigantesse non esiste bibliografia
scientifica (nemmeno se ne fa cenno nell’opera monumentale di Molfese). Si può dire che
la storiografia ufficiale ha ignorato totalmente
il fenomeno, a parte alcuni contributi parziali
di Domenico Scafoglio e di chi scrive, pubblicati a partire dal 2004, e poche raccolte di
documenti e di notizie biografiche prodotte
da qualche storico locale. Le conclusioni cui
si è giunti sono il risultato di ricerche condotte negli archivi di Stato e comunali. In modo
particolare sono state esaminate le carte processuali, con la necessaria attenzione alle strategie che hanno orientato le accuse, le difese e
le testimonianze, col risultato di conferire alla
documentazione rimasta un carattere sibillino, spesso di non facile interpretazione. Si è
però evitato di limitare la ricerca, come normalmente fino ad oggi si è fatto, ai documenti
di archivio, integrando la documentazione
archivistica con una molteplicità di altre fonti, che restituiscono altre dimensioni del fenomeno finora trascurate, quali gli scritti dei
militari che conobbero meglio di altri il brigantaggio, per averlo combattuto per anni, o
le scritture autobiografiche degli “insorgenti”
8
filoborbonici e dei capi della guerriglia: utilizzati poco e male come fonti di informazioni e
di controinformazioni, questi testi consentono di ricostruire, dando la parola ai protagonisti, le opposte visioni del conflitto, che era
anche uno scontro di culture prima che politico. Preziosa risulta soprattutto una categoria di scritti finora, a parte qualche eccezione,
poco studiati, quali le memorie dei sequestrati, che, per essere vissuti insieme ai briganti
a volte per lunghi periodi, costituiscono le
testimonianze rare di incontri/scontri ravvicinati di universi culturali diversi, a momenti altamente empatici, e sono state utilizzate
dagli autori dei due saggi come fonti preziose
per una conoscenza dall’interno della vita delle brigantesse e delle loro bande.
Esistono altre fonti, che restituiscono
una rappresentazione del brigantaggio, maschile e femminile, molto vicina a una autorappresentazione, per la loro straordinaria
vicinanza, che a volte è sintonia e immedesimazione, al mondo della guerriglia contadina. Uno dei più gravi limiti degli studi
storici del brigantaggio è l’avere pressoché
disdegnato l’uso delle fonti folkloriche. Indubbiamente la persistenza all’interno degli
studi etnografici della tendenza a leggere le
tradizioni popolari con lo sguardo rivolto
al passato può avere incoraggiato gli storici
ad assumere atteggiamenti di diffidenza e
di rifiuto, ma questo non li giustifica interamente, perché quelle fonti potevano essere utilizzate in modo nuovo, per esempio
trasformando, sulla scia di Thompson, “le
informazioni che erano soltanto antiquarie
ed inerti in un ingrediente attivo della storia
sociale”. Il problema è esattamente questo:
restituire vita a materiali inerti, mobilitando
le risorse e le opportunità delle scienze sociali. L’epos brigantesco popolare disdegnato
antropologia e storia
dagli storici, ad esempio, è una delle pochissime fonti che ci consentono di addentrarci
nell’ordine emotivo della vita brigantesca.
Circa un quarantennio separa l’esperienza delle donne coinvolte nel brigantaggio da
quella delle messicane che parteciparono
alle rivoluzioni di Emiliano Zapata e Pancho
Villa, studiati per i nostri “Quaderni”da Alicia Castellanos Guerrero e Francisco Pinéda
Gomez. Un’altra guerra civile, anch’essa decennale, che afferisce alla storia delle rivoluzioni moderne, laddove il brigantaggio, secondo le categorie dominanti, pur nelle sue
ambivalenze si colloca nella storia dei movimenti popolari di resistenza alle rivoluzioni
giacobine imposte dall’alto e dall’esterno a
popolazioni rimaste ad esse estranee. Una
delle differenze di fondo è il coinvolgimento nella rivoluzione messicana degli operai
e di fasce di ceti medi e intellettuali, mentre
il brigantaggio ebbe come unici protagonisti i contadini, i pastori e una minoranza di
artigiani, dal momento che i capi del legittimismo borbonico si limitarono a finanziare
e, al più, cercare di dirigere a distanza e segretamente le masse degli insorgenti. Questo rende ragione del fatto che le brigantesse
erano contadine, filatrici, carbonaie e inservienti, quasi sempre analfabete, mentre negli
eserciti rivoluzionari messicani solo nelle
campagne le contadine costituivano una
presenza maggioritaria, perché nelle città
il movimento rivoluzionario contava sulla
partecipazione degli operai, delle insegnanti,
delle non poche donne patriottiche dei ceti
medi colti e delle prime organizzazioni socialiste, che nelle armate rivoluzionarie portavano una diversa coscienza di classe e una
consapevolezza più moderna degli obiettivi
da perseguire e associavano alle rivendicazioni sociali il sentimento patriottico e la
/ 1 – donne in armi
difesa della patria dalle ingerenze straniere,
soprattutto statunitensi. Infine, sul brigantaggio italiano ha pesato una damnatio memoriae che ha escluso l’esperienza della guerriglia contadina dalla costruzione dei miti di
fondazione della nazione italiana, come un
incidente di percorso da rimuovere dalla
memoria collettiva; al contrario il decennio
rivoluzionario messicano ha lasciato in eredità alle generazioni successive domande di
liberazione e di giustizia, in cui si ritrovano
le istanze delle donne zapatiste, oggi giunte a
maturazione e codificate in dieci diritti della
Legge Rivoluzionaria delle Donne del movimento zapatista dei nostri giorni: “1. Le
donne, indipendentemente dalla razza, dalla
religione, dal colore e dall’affiliazione politica, hanno il diritto di partecipare alla lotta
rivoluzionaria nel luogo e grado determinati dalla loro volontà e capacità. 2. Le donne
hanno il diritto di lavorare e ricevere un salario giusto. 3. Le donne hanno il diritto di decidere il numero dei figli che possono tenere
e accudire. 4. Le donne hanno il diritto di
prender parte agli affari della comunità e gestirli, se sono elette liberamente e democraticamente. 5. Le donne e i loro figli hanno il
diritto all’attenzione primaria alla loro salute
e alimentazione. 6. Le donne hanno diritto
all’educazione. 7. Le donne hanno diritto a
scegliere il loro partner e a non essere obbligate con la forza a contrarre matrimonio. 8.
Nessuna donna potrà essere picchiata o maltrattata fisicamente né dai familiari né dagli
estranei. I delitti di tentato stupro saranno
puniti severamente. 9. La donne potranno
occupare carichi di direzione nell’organizzazione e tenere gradi militari nelle forze armate rivoluzionarie. 10. Le donne terranno
tutti i diritti e gli obblighi indicati dalle leggi
e dai regolamenti rivoluzionari”.
9
Q
uaderni
Donne in guerra oggi. Dove porta la storia?
Tra i casi di donne che collettivamente
sono presenti e militarmente attive in gruppi
armati, le zapatiste messicane e le brigantesse della guerriglia antiunitaria, evocate in
questa rivista, occupano un posto privilegiato, ma gli interventi di Musilli e Di Nuzzo
richiamano l’attenzione su altre esperienze
analoghe, quelli delle soldatesse americane
della guerra del Golfo e dell’Afganistan, delle miliziane fondamentaliste islamiche, del
fenomeno delle bambine guerriere di molti
stati africani lacerati da conflitti interni. L’elenco è cresciuto, ma risulta ancora incompleto, se si pensa, per esempio, al caso delle
soldatesse israliane. Sono, per il momento,
aperture di discorsi, che avranno l’approfondimento che meritano nei prossimi numeri
dei nostri “Quaderni”. Intanto si intravedono problematiche complesse che li attraversano e sollevano domande a volte inquietanti. Ci cominciamo a chiedere, ad esempio, se
il successo dei regimi autoritari e fondamentalisti tra le donne, e la loro trasformazione
in guerriere, a volte temerarie e spietate, sia
il prodotto di motivazioni quali la difesa della patria dall’annientamento, realisticamente
temuto soprattutto dalle donne curde peshmerga, o il rifiuto radicale della modernità,
con cui i gruppi fondamentalisti difendono
il proprio stile di vita minacciato dall’invasione di modelli esterni; o se anche, in alcuni
casi, come quello fascista, abbia giocato un
ruolo il fascino del capo, incarnazione della
virilità e della forza, plasmata da una forte
tensione erotica. Tra le motivazioni più forti,
che attraversano tutta la storia delle donne
guerriere, sembra esserci il bisogno materno
di difendere i propri figli, ma non si possono
sottovalutare l’attrazione dell’avventura e la
10
liberazione dai ruoli familiari. Ci troviamo
comunque davanti a una situazione di una
insospettata e sorprendente complessità, che
obbliga a ripensare criticamente l’idea che
l’emancipazione radicale della donna dal
potere maschile possa liberare il mondo da
tutte le forme di oppressione, dalla violenza
e dalla guerra. Ma, rovesciando in parte la
fortunata massima di Lévi-Strauss, come si
legge in altre pagine di questa rivista la storia
porta a tutto, purché vi si entri. E il fascismo
fornì l’apparato ideologico e i percorsi formativi per fare entrare le donne nella storia,
trasformando il loro bisogno di emancipazione in desiderio e passione patriottica.
Miti classici e storie medioevali
Le donne guerriere hanno anche una storia, che affonda le sue radici in miti oscuri, di
non facile decifrazione. Il saggio di Claudio
Azzara sulle Amazzoni raccontate da Procopio pone il problema con cui si raccordano
le riflessioni di Scafoglio e Angioni sul rapporto tra mito e storia. Problema già presente
nell’antichità classica, e poi lasciato in eredità
all’antichistica europea a partire dal Rinascimento e riproposto in termini nuovi in tempi
più recenti, grazie anche ai contributi teorici
maturati in sede antropologica. Azzara conclude il suo lavoro sulle notizie e le idee di
Procopio, confrontate con le narrazioni di
diverso impianto di Strabone e Jordanes,
apprezzando “lo scrupolo storiografico di
Procopio, così dichiaratamente attento a discernere il vero storico dalla tradizione mitografica e letteraria e a fornire una spiegazione
logica e verosimile dell’esistenza delle Amazzoni”, presentandole come donne rimaste
sole dopo la strage degli uomini del loro
antropologia e storia
villaggio e perciò costrette a imparare l’uso
delle armi per difendersi. In questo modo le
Amazzoni venivano sottratte alla leggenda
che le aveva da sempre avvolte. La metodologia di cercare i fatti attraverso l’interpretazione del mito, propria delle spiegazioni
razionalistiche dell’antichità, potrebbe essere
anche invertita, quando le fonti lo permettono, rispetto a quella di partire dal mito, capovolgendolo, per arrivare ai fatti: è quello che
ci consente la preziosa fonte individuata da
Adriana Bonnin, che racconta come nell’età
di mezzo le donne almeno in qualche caso
venissero utilizzate dagli uomini anche come
guerriere per assaltare e razziare i villaggi vicini: fatti come questi potrebbero essere all’origine del mito delle Amazzoni. Queste donne longobarde nei loro assalti si mostravano
più temerarie e spietate dei loro uomini, ma
il loro ruolo di guerriere non era apprezzato
da tutti, erano anzi contrastate, considerate
inferiori ai guerrieri maschi e non avevano
i loro diritti: una situazione che a volte si ritrova, mutatis mutandis, anche in altri casi di
donne guerriere presenti nelle bande o negli
eserciti di altre epoche.
Storia e romanzo
Giulio Angioni e Domenico Scafoglio
riflettono successivamente sui rapporti tra
l’antropologia e la storia partendo da una serie di riflessioni sulla finzione nella ricerca
scientifica e nel romanzo storico-antropologico, conferendo centralità a un tema su cui
si fa addensare gran parte dei nodi teorici
della questione. Sono le prime uscite, che
avranno un seguito nei numeri successivi
dei “Quaderni”, in cui si individuano affinità
e differenze, si inizia a fare un bilancio degli
/ 1 – donne in armi
incontri tra le due discipline finora avvenuti
e si prospettano possibilità di nuove convergenze, nel rispetto delle specificità disciplinari e tenendo conto delle difficoltà a trasformare queste convergenze in una nuova
disciplina, come l’antropologia storica.
Le analisi procedono con un itinerario
segnato da audacie e orientato da cautele, nella consapevolezza di muoversi in un
mare in cui vanno evitati gli scogli pericolosi di Scilla e Cariddi: da un lato la pretesa di
una storiografia scientifica, che indaga e ritrova con metodi oggettivi le leggi della storia; da un altro una concezione che risolve e
dissolve la storia nella mitologia, portatrice
di contenuti che sono valori, assimilabili a
quelli del mito, più che fatti.
Due ci sono sembrate le preoccupazioni
dominanti: la prima è la difesa dell’identità
della ricerca storica e storico-antropologica, tradizionale o “nuova” che sia, purché
privata di ogni valore assoluto, relativizzata,
col necessario riconoscimento dei condizionamenti su di essa operato dalle mitologie
individuali e collettive. La seconda è il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto dell’uomo occidentale con la storia, non
mediato dagli storici di professione e dalla
storiografia scientifica. La natura di questo
rapporto è quella che emerge da altri generi scritturali, quali, soprattutto, l’epos, il romanzo storico e, in genere i testi letterari di
ispirazione storica, in cui il mito non si limita a operare un inevitabile condizionamento,
ma diventa la loro sostanza. In queste scritture si ripropone ciò di cui gli storici non riescono del tutto a liberarsi quando scrivono
di storia, che diventa a volte la tentazione
e seduzione che li spinge a trasformarsi in
scrittori di romanzi. Il bisogno che li sollecita a scrivere testi narrativi è lo stesso che
11
Q
uaderni
induce la gente a leggerli: cogliere la vita nella sua essenza. In questa avventura, il travestimento storico aspira a dare la certezza che
ciò che si racconta è veramente accaduto.
Antropologia e letteratura
Nello “Scaffale” il saggio-recensione di
Luigi Reina ripropone una visione d’insieme
di Corrado Alvaro sospeso, per così dire, tra
letteratura e antropologia. Lo scrittore calabrese è noto agli antropologi come autore di
acuta sensibilità antropologica, soprattutto
nel suo campo d’osservazione privilegiato,
costituito dalla nativa Calabria, che gli ha
ispirato pagine di consistente spessore etnografico, come il volumetto La Calabria e Un
treno nel Sud. Queste opere, unitamente ai
romanzi di ambientazione calabrese, che per
certi versi potrebbero essere letti come una
etnoantropologia romanzata, hanno a volte
costruito l’immagine di un Alvaro nostalgicamente proiettato verso la rappresentazione
di una Calabria “arcaica”, anteriore agli sconvolgimenti prodotti dalla modernizzazione.
Che nell’opera e nella biografia dello scrittore
si ritrovino e riconoscano le sue radici etniche è del tutto legittimo, ma non è lo stesso
che riconoscere in lui l’incarnazione di un
modello ideale di “calabresità”, correndo il rischio di provincializzarlo: è quello che Reina,
da fine italianista, sostiene con valide argomentazioni. La ricognizione critica che egli
fa dell’insieme delle opere alvariane (molte
delle quali notoriamente non sono né calabresi né arcaicizzanti), insieme alla considerazione della ricchezza dell’esperienza di Alvaro
uomo, viaggiatore e giornalista, gli consente
di restituire allo scrittore calabrese varietà e
modernità, ricomponendo l’unità della sua
12
figura intellettuale e del suo immaginario, pur
nella sua a volte contraddittoria complessità:
nel mondo di Alvaro si incontrano l’ “umanità paesana fissata in assolute figurazioni antropologiche” e “il prototipo del meridionale
inurbato, costretto a vivere l’avventura come
sradicato o come pedina alienata con una
controstoria da costruire, come altra memoria, sulla storia che non può essere ormai altro
che metropolitana ed europea”.
Riforma universitaria e valutazione
Stefano Semplici nella rubrica “Discussioni” ritorna sulla riforma universitaria,
cui a fine aprile 2014 ha dedicato insieme a
G. Salmeri considerazioni importanti, con
argomentazioni approfondite, che sarebbe
riduttivo ridurre a semplici provocazioni.
Questa volta la sua riflessione è Su alcuni
effetti della valutazione all’italiana, e tiene
conto degli ultimi documenti dell’ANVUR.
Lo scopo ultimo non è lo sfogo amaro per la
sconfitta annunciata dell’Università italiana,
ma l’invito, che facciamo nostro, di “aprire e
mantenere un serio confronto pubblico” sui
temi centrali della riforma.
Ridotto all’osso, il pensiero dell’ANVUR
è quello del “valutare e punire” le università
e i centri di ricerca attraverso modalità comparative, che si esplicitano in un progetto
omologante di controllo in termini di qualità,
eccellenza, efficienza, merito, per approdare
al risultato di “tagliare, chiudere, diminuire”,
instaurando un darwinismo accademico che
legittima l’eliminazione dei più deboli per
il bene della società e il progresso dell’Università. Ad essere messi in discussione sono
i criteri di valutazione, di cui è criticata con
fondate ragioni la presunzione di neutralità,
antropologia e storia
presunzione che si vanifica appena si prendono in considerazione “gli obiettivi che si propongono, i comportamenti che incentivano
o sanzionano, i rapporti di potere che disegnano”: la presunzione di oggettività conflige con la giusta considerazione che “i criteri
di valutazione comparativa non si limitano a
fotografare una realtà”, ma “in qualche modo
la creano”. Se la comparazione comporta il
confronto di aree scientifiche differenti, senza
tenere conto della diversità della loro storia
culturale e dei loro territori, si lede gravemente il principio dell’autonomia accademica, e la
possibilità di salire nelle graduatorie determina l’adeguamento opportunistico a criteri
ministeriali che “non sempre corrispondono
a quelli che davvero promuovono lo sviluppo del sapere”; per esempio, ottenere risultati in breve termine fa a pugni con “lo sforzo
di pensare lungo, dal quale sono nate molte
delle più importanti rivoluzioni scientifiche e
culturali”. Lo scopo della valutazione è dunque premiare le università e gli studiosi che
hanno ottenuto i migliori risultati, abbandonando intere aree del paese alla “desertificazione universitaria”. Anche se, in realtà, data
la scarsità delle risorse, si tratta più di tagliare
le poche esistenti che di acquisirne di nuove:
“quella della lotta di tutti contro tutti per la
sopravvivenza non può essere una soluzione,
e l’esercizio della valutazione deve necessariamente avere un orizzonte e obiettivi più vasti”.
La più aperta delle questioni ci sembra
quella della distinzione, interna alla “terza
missione”, tra il vettore della produzione della conoscenza a fini produttivi (il cosiddetto
“sapere utile”) e il vettore della produzione di
beni che possono avere contenuto culturale,
educativo o di consapevolezza civile. Su di
essa ritorneremo nel corso del dibattito che
contiamo di avviare nelle prossime uscite.
/ 1 – donne in armi
Particolarmente attente e pertinenti risultano le considerazioni sull’emarginazione
della didattica: non conta ai fini della carriera accademica, che è determinata esclusivamente dalla qualità e originalità della
produzione scientifica, sia prima che dopo
la presa di servizio, e conta pochissimo (10
per cento della “quota premiale”) nelle classifiche della qualità della ricerca ai fini degli
interventi premiali. Opportunamente si osserva che “una università senza didattica o
comunque con una didattica senza qualità è
una contraddizione in termini”, considerato
soprattutto che la mission to educate “è stata
la prima missione delle università europee
sin dal medioevo”.
È soprattutto nella parte conclusiva del
saggio che la navigazione attenta tra le carte
prodotte dall’Agenzia e dal Ministero consente di farci toccare con mano l’ “ipertrofia
burocratica”, che costituisce forse l’aspetto più
sconcertante di un sistema di calcoli e conti
fatti passare per verità oggettive, soprattutto
nella formulazione dei requisiti che dovrebbero assicurare la qualità dei corsi di studio e
degli insegnamenti. Veramente “la fredda oggettività degli algoritmi elaborati dagli ‘esperti’ è diventata la scialuppa di salvataggio degli
zelatori della qualità”. È una sorta di terrorismo delle cifre (e perfino delle sigle), che ha
raggiunto lo scopo di fare a meno del potere
politico, troppo disattento o troppo incapace e disinformato o indifferente, di ottenere
l’assenso passivo del Ministero e ignorare il
punto di vista della docenza: tutto sulla base
della “presunzione della naturale purezza delle regole e la loro dilagante, soffocante, inutile
ipertrofia, pendant patologico della convinzione che non ci si possa fidare dei professori
universitari più che di un noto borseggiatore
su un autobus affollato”.
13
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
L’altra metà della banda
(Italia meridionale 1861-1870)
Domenico Scafoglio
Come i briganti vedevano le brigantesse
U
n particolare significativo
della storia delle brigantesse dell’Italia postunitaria
è costituito dal fatto che le
presenze femminili stabili nella banda erano
quasi sempre le donne dei capi e dei luogotenenti o dei briganti importanti, mentre le
donne dei briganti comuni, mogli, fidanzate, amanti, di solito rimanevano nel paese,
con tutti i rischi ed inconvenienti che questo
comportava. Il gruppo delle donne variava da
banda a banda, ma era sempre minoritario e a
volte assente. Perché non ci fu una partecipazione militare femminile di massa al brigantaggio, paragonabile a quella degli uomini,
pur essendo le donne delle classi popolari ad
esso generalmente favorevoli? Si trattò, in realtà, di una concomitanza di cause.
Ogni banda aveva bisogno di un legame
forte con il suo paese, che poteva essere assicurato dai propri familiari e dai parenti, in
particolare dalle donne della famiglia, madri, sorelle, mogli. Erano le manutengole,
che con la loro fedele collaborazione rendevano possibile ai loro uomini la vita alla
macchia e da essi erano gratificate con doni
consistenti, che le rendevano potenti e invidiate agli occhi del paese. Le manutengole
erano più utili delle brigantesse, perché di
queste ultime si poteva anche fare a meno,
ma delle fiancheggiatrici del paese no. D’altra parte, se un numero consistente di uomini prendeva il bosco, era inevitabile che non
tutte le donne potessero farlo, perché questo
avrebbe comportato il rischio di mandare in
rovina l’economia delle famiglie e dei villaggi. In teoria potremmo credere che le donne avrebbero voluto seguire i loro mariti o
fidanzati, ma sapevano di dover restare nel
paese per produrre.
Le brigantesse furono notevolmente minoritarie all’interno delle bande anche perché
la loro scelta richiedeva doti particolari di
temperamento (coraggio, spirito di avventura, resistenza fisica) o era determinata da situazioni per così dire eccezionali: delitti passionali, fughe dalla famiglia, esperienza del
carcere, sete di vendetta per l’uccisione di familiari, passioni intense. In altri termini, se la
loro scelta poteva essere non solo largamente
condivisa, ma anche invidiata e sognata da
molte altre donne, non tutte avevano abbastanza forza e coraggio o sufficiente spirito di
avventura per scegliere la vita alla macchia.
15
Q
uaderni
La presenza di alcune donne in bande di
maschi non abituati a forme strette e spesso intense di promiscuità avrebbe inoltre
potuto suscitare gli appetiti dei compagni,
e trasformarli in un branco sessualmente
aggressivo, o comunque innescare tensioni
pericolose e conflitti. Era forse inevitabile allora che le poche donne della banda fossero
soltanto le donne dei capi e dei briganti più
capaci, in condizione di offrire ad esse una
protezione più certa, soprattutto nei confronti dei desideri dei compagni, e che gli
altri dovessero accontentarsi dei liberi amori
nei campi, del sesso mercenario o di stupri
occasionali di donne nemiche da punire
o indifese. Per un altro verso in una situazione di guerra, in contesti per alcuni versi
arcaici, le brigantesse in quanto donne non
potevano non apparire il premio dei migliori, e questo poteva anche rendere accettabile
la loro appartenenza esclusiva ai capi della
banda, in comitive in cui lo spirito egalitario
si sposava con il riconoscimento del merito
e con l’oculata considerazione dei rapporti di
forza, anche se poteva al tempo stesso scatenare invidie e gelosie, non sempre controllate o represse.
Infine, quello che minacciava la coesione del gruppo e la stessa prosecuzione della
guerriglia era “l’acuto desiderio di tornare
a casa dalle donne, a letto”1. E nella banda,
quello che dà la sicurezza se non della vittoria, almeno della sopravvivenza è il capobanda. Soprattutto quando erano molto legati a
un capo carismatico, i briganti facevano di
tutto per non perderlo, non solo accettando
il suo privilegio di avere la donna o le donne,
3
1
2
16
Murr in Bork; 295.
Bourk: 294.
Murr in Bourk: 294.
ma spesso collaborando con i suoi desideri,
a volte arrivando a preparargli l’alcova.
Ma a fondamento della diseguaglianza
sessuale poteva anche esserci una motivazione
profonda, più o meno inconscia: i gregari accettarono che solo i capi avessero le loro donne, perché in questo modo limitavano le presenze femminili nella banda, e la paura della
castrazione psicologica che questo comportava: i briganti non pensavano diversamente dal
soldato inglese, che nel maggio del 1940 rifletteva sulla presenza delle donne negli eserciti
della seconda guerra mondiale: “Alcuni milioni di donne armate di fucili era la visione
più terrificante che un uomo potesse avere”2.
Vale perciò per le brigantesse, entro certi limiti, quanto è stato pensato per le soldatesse dei
moderni eserciti regolari dell’ultima guerra
mondiale: i militari maschi temevano soprattutto che “l’armamento delle donne avrebbe
rimesso in discussione i rapporti fra i sessi.
Accogliendole su base paritaria, sarebbe stata
minacciata l’identità maschile. Dal punto di
vista sociale, la loro presenza al fronte avrebbe
demoralizzato gli uomini, spezzando i vincoli
di coscienza creati dalla ‘virile’ etica guerriera.
La lotta era il segno supremo della virilità: le
donne avrebbero simbolicamente castrato le
forze armate. (…) Ammettere le donne nei
corpi combattenti significava minare alla base
l’accesso maschile privilegiato alla guerra, con
tutto quello che ne conseguiva”3.
Per questo complesso di ragioni, la presenza minoritaria delle brigantesse finiva per
essere accettata e perfino apprezzata; tuttavia
questo non impedì che ci fosse una certa resistenza, non solo iniziale, ad approvarla sen-
antropologia e storia
za riserve. Alcuni indizi tradiscono una certa
preoccupazione, se non diffidenza, soprattutto tra i gregari: in alcuni casi, per esempio, si
faceva passare del tempo, prima di consegnare alle donne le armi e la “divisa” maschile: il
capobrigante Pace fece vestire da brigantessa
Giocondina Marino solo venti giorni dopo il
rapimento e Santaniello, quando accettò Maddalena De Lellis nella banda, la fece attendere
quattro mesi prima di consegnarle il fucile,
che fece di lei una brigantessa. Dalle testimonianze processuali risulta che a volte i briganti
facevano sorvegliare le donne da due uomini,
quando riposavano alla macchia, ma anche nel
corso delle razzie e dei combattimenti, oppure
da altre donne, quando dormivano o erano affidate a manutengoli. Questi comportamenti
potevano anche essere misure protettive, ma
venivano astutamente addotti dalle brigantesse durante i processi per dimostrare che i
loro compagni diffidavano di esse. Le donne
inoltre erano tendenzialmente dispensate dal
cucinare, e tra le ragioni di questa scelta c’era,
non ultima, la paura, tutt’altro che infondata,
che più frequentemente attraversava la mente
dei briganti, quella di morire avvelenati. Nel
dramma che un commediografo calabrese,
Luigi Stocchi, dedicò alla brigantessa Maria
Oliverio alcuni briganti sono contrari all’accettazione della donna nella banda; ma probabilmente in questo caso il rifiuto nasceva dalla
repulsione che gli uomini della banda potevano avvertire per una donna che per gelosia
aveva massacrato in maniera efferata la sorella
incestuosa.
Questa diffidenza poteva tradursi in
qualche caso nella volontà di escludere le
4
5
/ 1 – donne in armi
donne dalle bande. Lo si voleva soltanto per
i gregari, ma in alcune comitive il divieto
poteva eccezionalmente estendersi anche ai
capi: molto però dipendeva dalla forza e dalla personalità di questi ultimi. Sappiamo, per
esempio, che la banda di Gennaro Petrucci
contestava al loro capo il diritto di tenere
nella banda la sua compagna, la brigantessa
Carolina Di Ruocco; un brigante testimoniò
al processo: “Gennaro Petrucci, Chiuppetiello, era mio nemico, perché dispiaciuto
delle insinuazioni che io gli facea di non rimanere sulla montagna la innamorata, non
dovendo la comitiva tenere donne”4.
A volte i timori dei briganti sono quelli
che gli uomini hanno nutrito da sempre nei
confronti delle donne. Per esempio, la paura
che le brigantesse convincessero i loro compagni a ritornare a una vita normale. Quando Crocco manca all’appuntamento con
Borjés, lo spagnolo annota: “Egli è andato
a dormire con una sua concubina, che tiene
in uno dei boschi vicini, con grande scandalo di alcuni”. L’impressione di scandalo è
legata al timore che Crocco possa costituirsi,
perché ha ricevuto un’offerta di amnistia, e
Borjés teme che, “vinto dalla sua concubina che egli conduce con noi, non commetta
qualche viltà”5. In effetti conosciamo casi di
briganti che decidevano di costituirsi quando si sposavano o pensavano di sposarsi.
Anche la nascita di un figlio poteva a volte
dar vita al desiderio di una vita normale.
Nell’epos popolare è sempre presente tra
i briganti comuni il timore che il loro capo
sia troppo preso dalla sua donna e che questo
costituisca un rischio per tutti. E poiché la
Baro: 127.
Borj: 71.
17
Q
uaderni
maggior parte dei gregari non aveva con sé
né la moglie né l’amante, questo era un motivo in più per non approvare del tutto il privilegio del capobanda. Come accade all’interno della mafia, “quello che appare pericoloso
è il cedimento, sul piano sentimentale, che
rischia seriamente l’organizzazione (…) La
sessualità, anche quella più mercificata e alienata, comporta una regressione, un temporaneo ritorno a se stessi, un cedimento al principio del piacere, che indebolisce il principio
di realtà. Abbassare la guardia, per un uomo
d’onore, è comunque pericoloso, sia sul piano
intimo, sia su quello materiale”6.
Per queste ragioni un capobanda noto
per il suo coraggio e la sua efferatezza, Pietro Bianco, prima di andare a trovare la sua
Generosa, tiene una sorta di consiglio, nel
quale egli chiede l’approvazione dei gregari
in nome della loro fedeltà, e questi ultimi
fanno al capo il solito avvertimento:
Duoppu mangiatu, disse: – Amici cari,
vuogliu jire a trovare Generosa,
vuie siti tutti fidili cumpari,
e criiu m’ammattiti chista cosa –.
Li cumpagni respundu tutti pari:
– Te tira amure de la tua amorosa!
Ma sappi, ca la donna è nu peccatu:
Quandu menu ti cridi, si’ ligatu –7.
6
7
8
9
18
La risposta della banda, più che un divieto, è un consiglio, che il capobanda prende
come un’approvazione. “Sei legato”, dicono i
briganti, nel duplice significato, dai lacci d’amore e dalle catene del carcere. Non avevano
torto: Pietro Bianco si reca a un paese, Castagna, dove si sente al sicuro; qui fa venire,
complice una manutengola, la sua amante,
Generosa Cardamone, una filatrice, nata nel
1845, aggregata alla banda nel 1863. Dimorava nel paese, evidentemente perché non
ancora identificata come brigantessa, ma
periodicamente, vestita da uomo e armata
di fucile, partecipava alle azioni della banda.
I due si incontrano, e Generosa convince il
brigante a stare con lei per qualche tempo;
vanno a nascondersi nella località Colla, con
l’aiuto della cognata di Pietro. La polizia viene informata, e costringe la cognata a svelare il nascondiglio. Per Pietro è finita. Anche
Generosa sarà arrestata e subirà una dura
condanna8. Il rischio maggiormente paventato era dunque quello della cattura a causa
della donna: i briganti andavano spesso a
trovare la loro moglie o amante nei paesi o
nelle masserie, e una semplice spiata poteva
esporli all’arresto. Gli stessi militari, artefici
di trappole e inganni, ci hanno lasciato non
poche notizie di questi fatti9. Maria Madda-
Sieb: 87.
“Dopo che ebbe mangiato disse: – Cari amici, / voglio andare a far visita a Generosa. / Voi siete tutti fedeli compari,
/ credo che approviate questa mia scelta. / I compari risposero tutti allo stesso modo: / – Ti attira l’amore della tua
amante! / Ma sappi, che la donna è un peccato, / quando meno te lo credi, sei legato” (Sca1: 119; Sca2: 159. I versi
appartengono al poemetto di ispirazione brigantesca di tradizione mista scritta/orale, Pietru Biancu, composto da
un poeta contadino, Michele Rizzuto, molto vicino ai briganti della Sila, subito dopo che Pietro Bianco era stato
giustiziato. Si noti come il capobrigante si appelli al comparaggio, grazie al quale si diventa parenti spirituali. Il
tema dell’evitazione delle donne nell’epos brigantesco risente anche dell’influsso di analoghi atteggiamenti presenti
nella letteratura cavalleresca, dove gli amori vengono normalmente evitati e gli eroi trascurano spesso le loro
donne per le imprese guerresche. Il ciclo carolingio con tutte le sue derivazioni medioevali e moderne esercitò una
influenza profonda sulla tradizione popolare soprattutto attraverso la letteratura di colportage e il teatro di figura.
AUSSME, b. 80, fasc. 7, c. 5. Generosa fu condannata a 20 anni.
Un brigante “era in groppa del suo cavallo, e di notte tempo si accostava al paese di San Giuliano per poter riab-
antropologia e storia
lena De Lellis fu catturata con quanto restava della banda dopo che il capo Santaniello
permise che il brigante De Cesare andasse a
vedere la moglie, seguito da tutti gli altri10.
A tutto questo si aggiunge il timore che
la donna, moglie, amante o fidanzata potesse anche essere usata come esca: quando
un brigante aveva l’“amorosa” nel paese,
militari e galantuomini filounitari potevano corromperla, inducendola a dare un appuntamento al brigante in un posto dove si
facevano trovare soldati o Guardie Nazionali
o carabinieri11. È accaduto più di una volta.
Si temeva ancora che l’amore, con le sue
complesse implicazioni psicologiche, potesse
indebolire il capo e mettere a rischio la compattezza della banda, per le gelosie che poteva suscitare tra i briganti più importanti: al
processo alla banda di Gennaro Petrucci, Carolina Di Ruocco testimoniò: “Petrucci, per
gelosia di me, si disgustò coi suoi compagni
in modo che lo percossero, e perciò egli si divise dalla banda”. In effetti Petrucci fu privato
del comando e fece parte a sé: rimasto solo,
fu catturato, processato e fucilato; ma “dopo
la sua fucilazione, i compagni lo compiansero”12. Diversamente tragica la storia di Domenica Rosa Martinelli, di Ceglie Messapica
(BR): contadina famosa per la sua bellezza, fu
l’amante del brigante Francesco Monaco, che
fu ucciso dai compagni per gelosia.
/ 1 – donne in armi
I briganti erano convinti – e i fatti davano ad essi ragione – che le donne potevano
essere fatte facilmente prigioniere, perché,
per partorire, dovevano necessariamente ritornare nel paese, ed era difficile che la loro
presenza passasse inosservata. Inoltre i militari di solito non uccidevano le brigantesse,
quando le riconoscevano come donne sotto
il travestimento maschile, e, risparmiandole,
potevano disporre di un numero consistente
di potenziali informatrici. E i briganti temevano che le donne avrebbero potuto fornire
alle autorità informazioni sulla composizione delle bande e sulla rete vastissima dei manutengoli che rendeva possibile l’esistenza
delle bande.
I maschi della banda inoltre pensavano
che le donne non fossero del tutto adatte alla
vita dura del brigante alla macchia, senza
tetto e perennemente braccato, e per questo
avrebbero creato dei problemi. Il caso della brigantessa Maddalena De Lellis, lasciata
da Santaniello in paese per qualche tempo
come manutengola, è significativo. A volte
l’accettazione delle donne nella banda era
una necessità, ma in qualche raro caso, dopo
averle accettate, furono gli stessi briganti a
rispedirle a casa: Carolina Grieco l’11 maggio 1864 nelle compagne di Castronuovo in
Lucania viene rapita da Egidio Florio e da
cinque briganti, ma dopo tre giorni la rila-
bracciare di nascosto Carmela sua, quando fu fatto segno a quel colpo di fucile che lo gettò a terra, dove fu raggiunto da più militi cittadini, e catturato” per essere successivamente fucilato (DeWi: 308). Altri episodi in DeWi: 313.
10
Boja: 52-53.
11
In questo modo fu distrutta in Terra di lavoro nel 1865 la banda Valente, fatta cadere in una trappola ordita dal
sindaco di Cervaro con la complicità della ragazza di cui il capobanda era innamorato (Croc: 23; ASSME, b. 83,
fasc. 17, cc. 145-150; b. 96, fasc. 10, c. 18; b. 97, faSC. 4, CC. 198-200, 2126, 231). Nel 1866 tre briganti sono invitati
a un festino da due ragazze in una masseria presso Corleto Perticara nel potentino: è un agguato. Mentre ballano
sono attaccati e uccisi, ma riescono a uccidere una delle ragazze prima di morire (ASSME, b. 116, fasc. 2, cc. 7087). Nel 1865 nella zona di Caserta i militari falliscono nel tentativo di catturare i briganti Santaniello e De Cesare
utilizzando donne (ASSME, b. 92, fasc. 1, c. 103).
12
Baro: 127.
19
Q
uaderni
sciano perché “incommoda” (scomoda, inadeguata) ad andare nei boschi13. I briganti
si spostavano continuamente, a volte non
restando nello stesso posto neppure un solo
giorno, per motivi di sicurezza14. Le donne,
specie se incinte, avevano qualche difficoltà
a seguirli. La maternità costituiva forse il
problema più grosso, anche perché occorreva trovare per la partoriente un rifugio sicuro presso persone fidate. Era una soluzione
costosissima ed esposta a incertezze e rischi.
Per tutte queste ragioni la sfera di azione delle brigantesse nelle operazioni militari
poteva essere limitata. Queste limitazioni riguardavano alcuni casi e potevano dipendere anche da opposte ragioni, quali il timore
che in circostanze particolari alcune delle
donne potessero fuggire, oppure la preoccupazione di non esporre al pericolo le donne
particolarmente amate: si disse, per esempio, che Michele Caruso non voleva che la
sua presunta amante, Filomena (Filomena
Pennacchio, che in realtà era la donna di
Schiavone), prendesse parte alle imprese più
arrischiate, affinché non corresse pericolo15,
ma la donna amava combattere come un demone16. Lucia Di Nella era nota anche come
combattente, anche se risulta che per volontà del suo uomo, Francescantonio Summa,
“allorché dovevasi fare un grosso colpo e
bisognava andare molto lontano, veniva nascosta in casa di questo o di quell’altro contadino”, che poi vennero arrestati e condannati17. Anche la narrativa di tradizione orale
15
16
17
18
19
13
14
20
insiste su questo argomento. Era una sorta di
privilegio della donna del capo. Anche Barone, il capobanda dei monti Lattari, quando
faceva incursioni nei paesi lasciava nel covo
la sua donna, Luisa Mollo, insieme a un brigante, per “farle compagnia”18.
Anche se i briganti potevano essere non
del tutto favorevoli, in linea di principio, alla
presenza delle donne nella banda, di fatto
finirono quasi sempre per accettarla. Dopotutto le brigantesse erano un numero esiguo
rispetto ai maschi, e il rispetto che i gregari
portavano al capo si riverberava inevitabilmente sulla sua donna, che veniva spesso
fatta oggetto di particolari attenzioni: a Luisa Mollo, compagna del capobanda Barone,
i briganti “avevano sul punto più bello della
montagna costruito un pagliaio con un soffice
giaciglio di muschio”19. Ma le presenze femminili nelle bande erano accettate anche perché queste presenze si rivelarono quasi sempre indispensabili e spesso perfino preziose.
Da qui la necessità di capire quale era il posto
e la condizione della donna tra i briganti.
I ruoli familiari
A contenere o neutralizzare le tensioni
tra le componenti maschile e femminile della banda contribuivano l’approfondimento
della conoscenza reciproca in una situazione in cui la preoccupazione dominante e
comune a tutti era la sopravvivenza, il nuo-
ASP, Atti e Processi di Valore. Storico, cartella n. 387/13; cfr. Varu: 82.
ASC, Pref. della Provincia di Terra di Lavoro, Circondario di Caserta, interrogatorio. di G. Marino.
Gell: 116.
DeWi: 320.
Bian: 151.
DeBl: 19.
DeBl: 21.
antropologia e storia
vo senso di appartenenza alla comunità dei
guerriglieri, l’autorità del capo, garante assoluto della convivenza solidale e delle regole,
a cominciare dalla regola dell’onore. Insieme
alla forza dell’organizzazione, la religione costituiva un elemento di coesione delle bande,
ma né l’una né l’altra avevano la forza coesiva delle appartenenze familiari, parentali e
territoriali. La religione ha sempre costituito
per le genti delle campagne un forte elemento di identificazione collettiva e di aggregazione, ma non è mai bastata a far superare
a contadini e pastori il loro individualismo
in nome delle credenze e dei valori comuni.
L’idea della “guerra santa” nella cultura popolare meridionale non ha acquisito, neppure nella controrivoluzione del 1799, la forza
tragica che alimenta i fondamentalismi nelle
vittorie come nelle sconfitte.
In una cultura, come quella meridionale,
in cui “i sentimenti forti dell’individuo scaturiscono in rapporto ad associazioni basate
sulla parentela e sul luogo di residenza”20, i
sistemi familiari e di parentela non potevano
non giocare un ruolo importante nella formazione e nelle vita delle bande. Famiglia e
parentela contavano soprattutto nelle comitive piccole e medie, in cui occupavano uno
spazio consistente. I rapporti familiari mediavano l’integrazione dei briganti nella banda, rafforzando sicurezza, influenza e potere,
specialmente quando si trattava di fratelli, e
questo valeva soprattutto per le donne. Le
dinamiche della banda sotto questo aspetto rispecchiavano quelle della condizione e
del lavoro femminile, in cui l’integrazione
della donna nei mestieri avveniva attraver-
/ 1 – donne in armi
so la mediazione dei mariti, fratelli, genitori.
Maggiore autonomia avevano le vedove, che
più facilmente potevano navigare sole.
Una parte della famiglia dei briganti più
importanti era alla macchia. Vincenzo Padula, il prete antropologo che fu anche uno
dei più acuti cronisti del brigantaggio in
Calabria negli anni 1864-1865, osservò che
il brigante, quando prendeva il bosco, rompeva con la moglie e che “Pietro Monaco
solo si portava la sua d’appresso, perché quel
donnone era più brigante di lui; ma gli altri
hanno sempre una o più drude, o volontarie,
o rapite”21. Queste rotture non erano generalizzate, e vanno spiegate nel modo giusto. Rompere con la moglie era necessario,
innanzitutto per evitarle di essere carcerata
e perseguitata dalle forze dell’ordine, allo
scopo di ricattare il suo uomo alla macchia.
Questa rottura poteva essere perciò strumentale e conseguentemente più formale
che sostanziale, e valeva soprattutto per i
briganti comuni; le mogli dei capibanda entravano spesso nella comitiva, in cui il loro
numero sembra essere consistente, anche se
non in grado di competere con quello delle
amanti.
Da qualche militare che aveva la passione
della scrittura apprendiamo, però, che negli anni del grande brigantaggio “ogni capo
banda aveva generalmente con sé la moglie
o una amante”22, e le informazioni fornite dai
documenti di archivio lo confermano ampiamente, consentendoci di aggiungere che non
solo il capobanda, ma anche i suoi luogotenenti avevano le compagne. Maria Oliverio,
moglie di Monaco, non costituiva dunque
Chap: 98.
ASSME, b. 55, fasc. 9, cc. 31-38.
22
Cesa: 152.
20
21
21
Q
uaderni
un’eccezione: nelle bande c’erano altre mogli,
come Angela Cotugno, che si diede alla macchia quando era già sposata col capobanda
Rocco Chirichigno (“Coppolone”); Rosa Tudisco, lucana, moglie di Giuseppe Caschetta, ufficiale di Crocco23; Angela Consiglio,
contadina, moglie del capobanda Tardugno,
aggregata anch’essa alla banda Crocco; Agnese Percuoco, venticinquenne di Campagna,
catturata con la banda Ciardullo insieme al
marito ventiquattrenne24; la moglie di “Cedrone”, alla quale il capobanda consegnava il
danaro da nascondere25.
I briganti rompevano con le mogli quando il rapporto coniugale era già compromesso o consunto e in questo caso la moglie
veniva sostituita dall’amante; altre volte essi
lasciavano le mogli a casa, perché non le ritenevano in grado di affrontare la vita dura
e pericolosa dei briganti: decisione dolorosa, perché non potevano non sapere che le
mogli e le fidanzate rimaste in paese erano
esposte al rischio della carcerazione come
complici o manutengole e venivano spesso
arrestate senza alcuna prova e perseguitate
per costringere i mariti a costituirsi o fatte oggetto di violenza. Quando il rischio
– come vedremo – diventava reale, era giocoforza che la moglie o la fidanzata seguisse
o raggiungesse il proprio uomo alla macchia. Maria Oliverio si fece brigantessa non
perché – come suggerisce Padula – era un
donnone più brigante del marito, ma perché
aveva ucciso sua sorella e sarebbe stata per
questo delitto arrestata.
Non era neppure infrequente il caso che
il brigante sposasse la donna della banda che
era la sua amante, quando voleva dare al rapporto una forma di regolarità agli occhi non
tanto della comunità, quanto delle autorità
istituzionali: non a caso questo accadeva, per
esempio, quando nasceva un figlio o quando
il brigante si preparava a costituirsi con la speranza di avere sconti di pena se non di essere
lasciato libero. La brigantessa Agnese Alanza,
amante di “Tinna”, fu sposata dal capobrigante quando a costui vennero accordati gli otto
giorni di tempo per la sua presentazione26.
È comunque certo che buona parte delle
brigantesse era costituita da amanti (nel linguaggio del tribunale spregiativamente “drude”, meno frequentemente “concubine” e più
eufemisticamente “donne di confidenza”, che
può anche alludere a rapporti non sessuali,
ma ambiguamente li suggerisce) e non pare
che esse si vergognassero eccessivamente
di essere e apparire tali. Maria Parente, per
esempio, dichiarò con disinvoltura al processo di essere stata la “donna di confidenza”,
di Federico Aliano, brigante della banda di
Giuseppe Padovano (ma era anche l’amante di Angelo Di Giacomo)27. Le brigantesse
dunque introiettano il linguaggio del tribunale col suo implicito disprezzo. Può darsi
che lo facessero inconsapevolmente, almeno
in qualche caso, per carenze linguistiche, ma
altri indizi fanno pensare a un’accorta strategia di sopravvivenza: la condizione di drude
o amanti lasciava in ombra lo statuto di brigantesse: il commercio carnale non era pu-
ACS, Roma, Tribunale Militare per la Repressione del Brigantaggio nelle Province Meridionali, cartella n. 178/46;
cfr. Varu: 45,137.
24
Cesa: 103.
25
“Po”: 14/5/1866.
26
ACS, Roma, Tribunali. Militari. per la Repressione del Brigantaggio nelle Province Meridionali., cartella n. 178/54.
27
Ibidem.
23
22
antropologia e storia
nibile dalle leggi di guerra, o non lo era nella
stessa misura in cui lo era la partecipazione
attiva a bande armate.
Anche nelle deposizioni dei briganti maschi catturati trascritte in italiano dai cancellieri dei tribunali e nelle testimonianze
della gente, anch’esse quasi sempre “tradotte”
nelle trascrizioni, viene adoperato a volte il
termine “concubine” e, più frequentemente,
“drude”, ma è difficile dire se per essi questi
termini (ammesso che li usassero) avevano
lo stesso significato che ad essi attribuivano
gli uomini del tribunale. A volte i briganti,
uomini e donne, usano altre parole: Michelina De Cesare è detta “moglie” di Francesco
Guerra, mentre era la sua amante28; Domenica Ianni chiama “sposa” la donna di Fuoco29;
Francesca Cerniello, amante di Tranchella,
nei verbali ufficiali è chiamata “concubina”
o “druda”, ma lei stessa si definisce “sposa”.
Tutto questo sta a indicare che alla macchia
i rapporti tra amanti, quando erano intensi e duraturi, erano considerati alla stregua
dei rapporti coniugali. Non a caso le unioni
considerate serie a volte venivano celebrate
solennemente, come delle “nozze rustiche”.
Tutto questo in omaggio allo stile di pensiero contadino, per il quale solo la donna
sposata “è messa all’onore del mondo”. E nel
mondo contadino non solo erano frequenti i
casi di concubinaggio vissuti come normali,
ma spesso si rimaneva concubini per evitare
le spese delle nozze, nel qual caso il concubinaggio era pressoché l’equivalente del matrimonio. I briganti conferivano molta importanza a queste unioni, e spesso celebravano
/ 1 – donne in armi
l’evento in maniera, a modo loro, ritualmente fastosa. Sembra una favola la storia del
fratello di Ninco Nanco che va a chiedere in
sposa Lucia, con un corteo di cinquanta armati, come facevano i grandi capi nell’epica
più antica delle genti europee.
La novità più significativa della famiglia
del brigante rispetto al costume contadino
va cercata altrove. Nelle campagne e nei villaggi dell’Italia postunitaria le unioni avvenivano su una base contrattualistica, gestita
dai genitori, che “combinavano” i matrimoni,
mentre i rapporti tra le brigantesse, mogli o
drude che fossero, e i loro uomini nascevano
o comunque erano governati dalla passione, e
tendevano ad essere esclusivi, soprattutto nei
desideri della la donna, e duraturi. Erano al
tempo stesso rapporti che esponevano la coppia al rischio della precarietà, minacciati dalle difficoltà della vita nel bosco e dai pericoli
della guerra; ma esistevano spinte di senso
opposto, che rafforzavano le unioni, come la
consapevolezza delle difficoltà e delle insidie
della vita alla macchia e del bisogno di affrontarle insieme, con condivisione e reciprocità.
I rapporti liberi, pure presenti nelle comitive,
potevano invece scatenare la gelosia, che diventava a volte la porta del tradimento: Giuseppe Schiavone si innamora di Filomena
Pennacchio e lascia Rosa Giuliani; quest’ultima lo tradisce, indicando il suo nascondiglio
ai soldati, e innescando una catena rovinosa
di vendette che porterà alla distruzione della
banda più forte del beneventano.
Evitando le generalizzazioni assolute,
che ci indurrebbero a trascurare casi atipi-
ACS, Roma, Tribunali Militari Straordinari, b. 170, processi 1971, fasc. 66, interrogatorio di Domenico Compagnone dell’11 maggio 1865.
29
ASI, Sottoprefettura d’Isernia, Atti di Polizia, Brigantaggio 1867, gennaio-dicembre, b. 6, fasc. Brigantaggio del
mese di Aprile 1867, Deposizione di D. Ianni.
28
23
Q
uaderni
ci di tutt’altro tenore, possiamo dire che la
“famiglia del brigante” non era solo un tema
pittorico diffusissimo nelle rappresentazioni
artistiche del secondo Ottocento, in cui la
donna è collaboratrice fedele e affettuosa del
brigante, ma costituiva una istituzione molto
presente nelle bande, ispirata da un sogno di
avventura e al tempo stesso influenzata dal
modello familiare della normale vita contadina. Come nei matrimoni regolari, valeva
anche alla macchia il principio della territorialità nella scelta del partner: le compagne
dei briganti erano di solito dello stesso paese
del compagno, in omaggio al principio popolare “donne e buoi dei paesi tuoi”: come
tutti i contadini e pastori, il brigante sceglieva una donna che conosceva bene e legava a
sé in qualche modo il suo parentato.
In assenza di un criterio tradizionale
fondamentale per la definizione della coppia, quale è la coabitazione, in situazioni
in costante movimento, non sempre stabili o durature, tra i briganti la procreazione
diventa il mezzo identitario fondamentale.
Nonostante i rischi della guerra per bande,
le coppie ebbero dei figli alla macchia, che
non sarebbero stati concepiti, se i genitori non avessero avuto qualche speranza nel
loro futuro familiare e sociale. Molte brigantesse durante la guerriglia diedero ai compagni dei figli, che spesso partorivano in
carcere. Rimasero incinte, tra le tante, Giocondina Marino, Chiara di Nardo, Generosa
Cardamone. Poiché in quasi tutti i casi che
conosciamo l’evento trovò molto attenti e
affettuosi i mariti o gli amanti, dobbiamo
pensare che la procreazione era pienamente
accettata dai genitori, rafforzava il legame di
Cesa: 103.
Bian:153.
30
31
24
coppia e assicurava alle donne un maggiore
riconoscimento in quanto “spose”.
Le donne, mogli o amanti, erano nel futuro dei loro compagni, che, pur fidando religiosamente nella guerra vittoriosa, con sano
realismo si andavano preparando anche alla
peggiore eventualità. E il pensiero dei figli occupava un posto centrale, nella buona come
nella cattiva sorte. Spesso facevano custodire
dalle compagne i piccoli tesori che riuscivano
ad accumulare, o per lo meno le tenevano informate della loro esistenza e del luogo in cui
li tenevano nascosti. Questi tesoretti dovevano servire ad assicurare al brigante una buona
difesa in caso di carcerazione, ma soprattutto
a garantire in qualche modo il futuro ai figli
e alla compagna. Alla sua amante Olimpia
Chiavone consegnò i ducati che Francesco II
gli aveva donato per le spese militari, a vantaggio del figlio quattordicenne30. Francescantonio Summa, fratello di Ninco Nanco,
affidò a un manutengolo 8.000 ducati, perché
li consegnasse alla sua compagna Lucia Di
Nella, nel caso fosse stato ucciso dalle forze
dell’ordine31. Sono solo alcuni esempi.
Le bande costituivano una microsocietà
meritocratica, in cui si diventava capi solo se
capaci di direzione e di comando, di assicurare la sopravvivenza della banda, di essere utili
ai compagni e guidarli con successo. Questo
valeva per entrambi i sessi, ma al tempo stesso la condizione di compagne dei briganti
che contavano contribuiva a conferire alla
donne importanza e potere. L’essere le compagne dei capi fu indubbiamente di grande
aiuto alle donne, non perché assicurò ad esse
dei privilegi, ma perché contribuì a renderle
sicure di sé per dare il meglio di se stesse.
antropologia e storia
Le reti parentali
Oltre ad essere mogli o amanti dei capi,
le brigantesse avevano di solito nella banda fratelli, sorelle, cognati, cognate, zii e in
qualche caso genitori. Una donna completamente sola, ossia senza legami familiari o
parentali, sarebbe stata in una condizione di
debolezza, a meno che non fosse la compagna di un brigante importante e influente. Il
fatto che proprio alcune delle poche donne
che non avevano il supporto della parentela
emergessero sulle altre conferma che l’elemento decisivo del successo femminile nella
banda era il valore personale. Filomena Pennacchio era una di queste.
Dominanti erano i rapporti parentali
nelle bande del salernitano: nel settembre
1869 Ferdinando Pica, dopo la morte del suo
ex socio Ferrigno, si alleò con Carbone, ricostituendo una banda molto affiatata, grazie
soprattutto ai legami familiari che stringevano i briganti: il capobanda Pica, oltre ad
avere le sue amanti, era accompagnato da
due fratelli, un cognato e una sorella, Carmela Pica; l’altro capobanda, Alfonso Carbone, poteva contare sul padre e sulla madre,
Angela Di Genova, oltre che su tre fratelli;
il brigante Francesco Saolino aveva con sé la
moglie, Maria Carfagna, la madre, Rosa Di
Giacomo, e la figlia, Anna Solino; ma nella
banda c’era ancora parte della famiglia Pizza,
la madre Matilde con Camilla e due parenti maschi; parenti erano ancora Camilla ed
Elisabetta Volpe, Vienna e Generoso Cianci,
34
35
36
37
32
33
/ 1 – donne in armi
cinque membri della famiglia Gambone con
Irene Gambone, e così via: tra i pochi a non
avere parenti nella banda c’era una sola donna, Agnese Capone32.
Situazioni identiche in Terra di Lavoro.
L’amante di Francesco Guerra, Michelina
Di Cesare, abruzzese, era nella banda insieme a suo fratello Domenico33. Nell’area del
Pollino Serafina Ciminelli era nella banda di Giuseppe Antonio Franco, di cui era
amante, con tutta la sua famiglia, la sorella
Mariateresa, il padre, la madre, e il fratello
più giovane, da lei stessa convinto a farsi
brigante. In Calabria Caterina Talarico era
la compagna di Serafino Bianchi, fratello del
capobanda Pietro Bianchi; Maria Oliverio
poteva contare non solo su suo marito capobanda, Pietro Monaco, ma anche su Antonio
Monaco, suo cognato fratello di Pietro, e sul
proprio fratello, Raffaele Oliverio. Le bande
del territorio di San Marco in Lamis erano in
gran parte clan di consanguinei: i Ciavarella,
i Giuliani, i Gravina, i Nardella, i Polignone,
i Rendina, i Tancredi e così via34. Nel Cilento
la madre del capobanda Tranchella, Luigia
Cannalonga, faceva parte della banda del
figlio e partecipava alle sue scorrerie35. Nel
napoletano Giuseppa Paradiso, di Carbonara di Nola, era sorella uterina del capobanda
Crescenzo Gravina36. Luisa Mollo era nella
banda Barone con suo padre Sabato e suo
fratello Antonio: valevano poco, ed erano
perciò malvisti dagli altri gregari, che non
apprezzavano il favore di cui godevano presso il capo37.
DBia: 125-26.
Tor1: 58.
Cfr. Clem: 49n.
ASS, Gabinetto. di Prefettura, Affari Speciali, b. 46, fasc. 5; cfr. Melc: 41.
ASCO, Gabinetto di Prefettura, b.4, anno 1863.
Cimm: 68.
25
Q
uaderni
I legami più forti erano quelli che formavano la famiglia in senso stretto, e tra essi era
importante il rapporto tra le sorelle e i fratelli, tradizionali difensori dell’onore delle
sorelle, che anche nella banda costituivano
un baluardo contro le eventuali aggressioni
sessuali dei maschi. Il rafforzamento dei rapporti tra gli altri consanguinei, ascendenti e
discendenti collaterali, che formano la parentela, è un fatto tipico del brigantaggio. La famiglia estesa nel mondo contadino è risultata
un mito più che una realtà. La famiglia contadina normale era nucleare, perché la limitatezza delle risorse ostacolava l’ampliamento
della rete parentale attraverso la costruzione
di rapporti di reciprocità. Il brigante però ha
bisogno di una rete di persone fidate, senza
la quale gli riesce impossibile sopravvivere
alla macchia, ed ha a disposizione consistenti somme di denaro e altre forme di potere,
che gli consentono di crearsela: il danaro dei
comitati borbonici e soprattutto il frutto dei
ricatti, delle razzie e delle estorsioni finanziano le bande contadine, e i briganti, una volta
contadini poveri, ora mettono a disposizione
dei parenti risorse economiche, oltre un riflesso di potere, di cui essi approfittano per
arricchirsi ulteriormente a spese dei paesani.
Come ebbero a scrivere già allora alcuni osservatori, “in due modi lucrano i parenti dei
briganti: lucrano coi regali, coi doni che portano loro tutti i cittadini per non avere molestie e aggraziarseli. (…) Tutti, ricchi e poveri,
liberali e borbonici, onesti e cattivi cittadini
mandano alla madre, alla moglie, alla sorella
del brigante donativi d’ogni genere, e raccomandano alla bontà di sì onorata famiglia il
Bour: 87.
Bour: 87-88.
40
Binc: 86.
38
39
26
proprio grano, la masseria, il gregge, il bestiame”. Ma non basta: il parente del brigante
“va nelle famiglie e chiede denaro ed oggetti,
e nessuno glieli nega”38.
Il potere delle famiglie cresceva all’ombra del potere dei briganti, ingrandendo e
rafforzando la parte filobrigantesca e filoborbonica del paese, che costituiva una sorta di “esercito interno”, che rendeva possibile
con la sua connivenza la vita alla macchia
dei fuorusciti. Il parente del brigante “chiama l’amico, il vicino, il primo che trova, lo
obbliga a portare al parente brigante viveri,
vestiti, notizie, e nessuno si ricusa. Se per
caso non acconsente, lo minaccia di morte,
di rovine, onde, non v’è a che dire, ubbidisce. (…) I parenti sono i primi che aiutano
i briganti, che esagerano il loro numero, le
loro azioni e anche i loro delitti, per tenere
timorosi e soggetti gli animi”39. La situazione
sopra descritta si riferisce direttamente alla
Lucania, ma identiche condizioni si ritrovano nelle altre regioni, come la frontiera pontificia, in cui – è stato scritto – “le famiglie
dei briganti sono ora le famiglie più comode
e quelle che comandano nei paesi”40.
All’interno dei paesi il gruppo dei consanguinei si ricompatta e rafforza dunque
intorno all’immagine dei parenti diventati
briganti; per un altro verso il favore e l’aiuto dei parenti si rivela risolutivo per la vita
delle bande, e proprio per questo scatena le
reazioni più violente delle forze dell’ordine
contro le loro famiglie, con persecuzioni e
deportazioni. Grazie alla rete parentale, il
brigantaggio controlla la vita dei paesi meridionali; la rete assicura ad essi il control-
antropologia e storia
lo vicario del paese e di tutto il territorio,
guadagnando il favore popolare alle bande
mediante favori e servizi, soprattutto illeciti, ma anche ricorrendo alle intimidazioni e
minacce. Parenti ed amici dei parenti fanno
crescere la banda con nuove aggregazioni di
consanguinei, che a loro volta rafforzano il
clan al suo interno; forniscono ai fuorusciti
appoggio logistico, li nascondono e gli assicurano la possibilità di disporre di un tetto
dove possono eventualmente svernare, essere accolti ed essere accuditi e curati; gli garantiscono un sistema di informazioni, concernente i movimenti della truppa, i tempi, i
luoghi e la consistenza numerica; ma anche
notizie sulle tendenze delle altre famiglie, su
amici e nemici, e, infine, sui possidenti da
sequestrare. Sono i parenti soprattutto che
provvedono al vettovagliamento, fornendo
tutto quello che ai briganti occorre in termini di vitto, biancheria, munizioni, medicine, direttamente o inducendo altri con le
minacce a farlo; oltre a tutelarli dal rischio
di venire uccisi o denunciati dai cacciatori
di taglie, per la certezza diffusa che essi non
sfuggirebbero alla vendetta dei familiari ed
amici del brigante ucciso o fatto arrestare: “il
timore di rappresaglie da parte dei parenti
e proseliti del brigante posto a taglia impedisce ai paesani di azzardarsi a togliere dal
mondo un individuo nocivo alla società”.
Quando qualcuno decide di farlo, perché
troppo temerario o perché il brigante si trova isolato, la prima cosa che chiede alle autorità è che “la faccenda non sia resa prima e
poi di pubblica ragione”41.
Tutto questo si configurava ideologicamente come effetto esclusivo del “debito
del sangue”. Ma non era soltanto efficacia
/ 1 – donne in armi
simbolica: il brigantaggio offrì ai sistemi parentali nuove opportunità e vantaggi, nuove
forme di reciprocità, che rafforzarono i tradizionali legami tra parenti: i parenti rimasti
nel paese potevano disporre di una sorta di
esercito esterno che incombeva sul villaggio
come una rassicurazione e insieme come
una minaccia41. Lo spirito meritocratico che
dominava nelle bande si conciliava con i
fondamenti familistici della società popolare
meridionale, alla quale i briganti appartenevano. I rapporti di parentela avevano importanza anche nella vita sociale e affettiva della
banda: i vincoli di sangue umanizzavano i
rapporti gerarchici, materiandoli di affetto e
fiducia e rendendoli più stabili.
Le brigantesse potevano guadagnare
posizioni preminenti grazie anche ai loro
rapporti parentali. Non fu difficile per Maria Oliverio farsi obbedire dalla banda, dopo
che suo marito, il capobanda Pietro Monaco,
fu ucciso da due traditori, anche se difficilmente la brigantessa sarebbe diventata leader della comitiva, se non le fossero state riconosciute le qualità per esserlo. Se è errato
immaginare che il potere delle donne fosse
solo il riflesso del potere dei loro uomini e,
più in generale, della forza dei legami familiari, è altrettanto erroneo fingere l’inesistenza del problema.
Il paese e il bosco
Il paese tradizionale all’epoca del brigantaggio postunitario è una costruzione sociale
ricca di ambivalenze: il fatto che esso garantiva la vita sociale e promuoveva una “esuberanza di rapporti umani” conviveva con i ran-
Bart: 141-42.
41
27
Q
uaderni
cori e le insidie del vicinato, la paura costante
dell’invidia nelle forme istituzionalizzate del
“malocchio”, la pressione del controllo sociale
capillare e quotidiano. Il paese era per il contadino o pastore il luogo in cui maggiormente
si misurava l’oppressione dei ruoli sociali, la
disuguaglianza delle risorse, la maldicenza e
la miseria del conformismo dei luoghi piccoli
e degli orizzonti chiusi. L’ equilibrio che aveva
per secoli governato le contraddizioni della
vita paesana era saltato nell’impatto con i disastri prodotti dall’unificazione e dalla guerra civile, con la lotta feroce tra le fazioni, le
persecuzioni politiche, la distruzione di interi
paesi, l’abbattimento o incendio delle case dei
fuorusciti, la carcerazione delle famiglie dei
briganti, le offese recate alle proprie donne.
Secondo uno schema classico si diventa briganti dopo che si è subito un torto, e la scena
dell’ingiustizia è soprattutto il paese. Egidione
fugge da S. Giorgio Lucano, suo paese natale,
col pensiero di tornarvi per uccidere il sindaco Giuseppe Lauria42. I grandi capi delle bande brigantesche – si pensi a Ninco Nanco e
a Crocco – vengono fuori da analoghe storie
di violenze paesane e sopraffazioni che hanno colpito le loro famiglie e hanno segnato la
loro esistenza.
Ma più che degli uomini la miseria del
paese doveva segnare le anime e i corpi delle
donne, oppressi entrambi dalla doppia servitù domestica e sociale: “Nulla posseggo – dichiarò ai giudici Teresa Ciminelli – sono stati
anche i miei malevoli paesani a farmi seguire
Antonio Franco”43: perché, come è stato efficacemente scritto, “quando la sua appartenenza al genere umano, quando la sua dignità
Ri-L: 222.
Ri-L: 354.
44
Hadd: 18.
42
43
28
gli pare minacciata, l’uomo ‘prende’ o ‘fa’ la
strada, ritrova nel cammino un ricorso, una
nuova risorsa contro questa minaccia”44. Filomena Pennacchio, quando si dà alla macchia,
vende la sua povera casa, perché sa che sarà
abbattuta o incendiata dalle forze dell’ordine.
Al di là di ogni calcolo, si fuggiva facendo
terra bruciata, perché il nemico che restava
o veniva non potesse ulteriormente infierire.
Ma non c’è solo una storia di insofferenze
e di rancori in queste fughe dal paese. Quale che ne sia stata l’origine e la causa, c’è in
esse il ritrovamento di nuove risorse contro
la minaccia della disappartenenza e della dignità offesa. In primo luogo, il richiamo del
viaggio, il riaffiorare della natura vagabonda dell’uomo. In un certo senso, l’uscita alla
macchia dei briganti è una fuga dal paese e
dalla campagna, che precede l’abbandono
contadino dei campi, che si intensificherà
nei decenni successivi e durerà fino ai nostri
giorni, e ne presenta alcune caratteristiche
importanti. D’altra parte, la vita dei paesi era
tutt’altro che dominata dalla stanzialità: la
ricerca del lavoro spingeva gli uomini a una
costante migrazione all’interno della provincia e della regione e uomini e donne avevano una relativa dimestichezza con le prove
e la fascinazione del viaggio, grazie anche ai
pellegrinaggi, ai lavori stagionali, alle fiere,
ai mercati: una mobilità di piccolo raggio,
presente come l’“ulterioris ripae amor” delle
anime morte virgiliane, la riva ulteriore del
desiderio, presenza costante nell’immaginario tradizionale. La coltivazione dei campi
era troppo dura, perché l’agricoltore non
fosse tentato di cambiare la propria esisten-
antropologia e storia
za, tutte le volte che gliene fosse stata offerta
la possibilità.
Il brigante non aveva una dimora fissa,
la sua casa-rifugio erano il bosco e la montagna, dove la vita era diversamente dura e
difficile, ma aveva tutti i vantaggi della liberazione da vincoli e pesi che rendevano l’esistenza nel paese quasi invivibile. I contadini coltivavano la terra, ma non è detto che
amassero fare questo lavoro durissimo, poco
redditizio e poco gratificante (la gente tende
infatti da sempre a lasciare la campagna per
la città). La convinzione che la ruralità faccia
parte del corredo genetico della specie umana potrebbe risultare non del tutto fondata,
dal momento che gli uomini trovano tutt’altro che piacevole coltivare la terra, anche se
riesce difficile condividere l’idea che l’agricoltura abbia costituito “il più grave errore nella
storia dell’umanità”, rispetto alle attività più
intense della caccia e raccolta. Sotto alcuni
aspetti lo stile del brigante ripropone i modi
e i ritmi (con le emozioni e i piaceri) del nomadismo e della predazione originari45.
Il bosco non è semplicemente l’habitat naturale del brigante: il brigante e il bosco sono
una cosa sola, lo sapeva la gente delle campagne, e lo aveva intuito Alessandro Dumas,
quando scriveva che “l’Italia meridionale produce naturalmente frumento nelle pianure,
olio nelle valli e briganti sui monti”. La fuga
dal paese riattiva le energie addormentate
nella interminabile e monotona reiterazione
dei gesti di una quotidianità poco gratificante. Una volta lasciata la vita grama del paese,
il fuoruscito, pur tra le ristrettezze e i pericoli
/ 1 – donne in armi
di ogni genere, percepisce, forse per la prima
volta, l’espandersi della sua personalità al cospetto di situazioni nuove, che deve affrontare
facendo un uso nuovo e creativo delle risorse
mentali e materiali che ha accumulato nella
sua giovane esistenza di contadino, pastore,
artigiano: il pericolo si muta in opportunità,
la mancanza sollecita l’invenzione, la paura
indurisce il coraggio, il diverso e libero scorrere delle ore apre le ali al gioco, alla contemplazione della bellezza e alla liberazione dei
sensi, il corpo in movimento si abbandona
alla gioia della corsa, mentre si cercano o riscoprono altre relazioni e appartenenze all’umanità e al mondo naturale. Come è stato
felicemente rilevato, “la preoccupazione estetica compare sin dai primi passi dell’uomo,
intimamente connessa con il richiamo del
viaggio”, del camminare e del correre46, e con
essa la piacevolezza, “motivata dai profumi,
dal paesaggio, dalla spaziosità dell’ambiente
primordiale”. Si consuma così “un tentativo
di tenere a distanza i dolori paesani circondandosi di piaceri rurali”, che sono piaceri del
corpo, della psiche e dell’anima, come la carezza dell’aria profumata, il senso di uno spazio immenso, l’idea di una immacolata sanità
naturale: cantava il brigante:
Ssi pini su ppe mie parienti e frati,
ssa nive ianca è lu tisouru mio;
aduru s’acquicelle ‘mbarsamate,
sse funtanielle cuomo grande Diu:
chistu vuoscu de arvuli arramati
è la casella e lu pagliaru mio;
nun ce venite ppemmu me tentati
nullu, ccà la pagati, ppellu Diu47.
Tiger: 216.
Hadd: 24.
47
“Questi pini sono per me parenti e fratelli, / questa neve bianca è il mio tesoro; / adoro queste acquicelle imbalsamate, / queste fontanelle come grande Dio: / questo bosco di alberi ramosi / è la casetta e il mio pagliaio; / non
45
46
29
Q
uaderni
Bellezza e affettività, familiarità. La natura, il bosco sono la nuova casa e famiglia
del brigante, che da essi si sente protetto e
guardato. Perché, come ha compreso Lacan,
dopo Cezanne, non siamo noi che guardiamo gli alberi. Sono gli alberi che guardano
noi48. Il brigante in fuga dai suoi familiari e
dalla sua gente dispone di molto poco, poco
gli è rimasto di tutto quello che come essere sociale ha costruito intorno a sé nell’arco
della sua giovane vita. Egli ritorna alla natura nudo, come mai non è stato. Familiarizza
con le ombre del bosco che hanno sempre
inquietato il contadino, cogli alberi diventati
la sua nuova casa e famiglia silente. Si inoltra
in un nuovo mondo sensoriale, in cui la più
elementare delle bevande, l’acqua, diventa il
suo balsamo e la neve il suo tesoro: affascinante nel suo biancore e inconsistente, come
il denaro e l’oro delle predazioni, che passa
per le sue mani, rapidamente dissolvendosi
nei giochi d’azzardo e nei doni alle sue donne. Se il paese si ricorda pensando al ritorno,
perché ciò avvenga occorre prima fuggirne,
cambiare aria, dimenticare. Si aspettava l’occasione giusta, e la grande occasione venne
col brigantaggio, che dal punto di vista dei
destini individuali produsse l’impulso liberatorio verso un altrove, in cui la “resurrezione dei poverelli” (quella cantata la prima
volta, al suono della grancassa, dai sanfedisti
nel 1799) era ancora possibile e la propria
vita poteva ancora essere riscritta. La fuga
dal paese, gli errabondaggi nella macchia
hanno generato una nuova umanità, con cui
è possibile costruire nuove appartenenze: le
autorappresentazioni del brigantaggio non
sono quelle di banditi solitari, “lupi solarini”,
ma di capi e gregari uniti nelle bande da un
comune sogno di cambiamento, quello promesso dal canto del capobanda mitico Nino
Martino:
Chi si vo’ fari surdatu riali
jisse ’ncampagna cu Ninu Martinu;
a vivari u’ li porta alle funtane,
ca’ appriessu li va l’ utru cu lu vinu.
Nu li fa jire vestuti di lana,
ma i vesti tutti di dommaschiu finu;
lu pani jancu nu lu fa mancari,
lu cumparaggiu nu li veni menu49.
Nell’epos brigantesco popolare l’addio ai
luoghi più cari costituisce un momento lirico per eccellenza. Proprio perché la leggenda
del bandito sociale rispecchia in certa misura
la realtà profonda, è assente nell’epos brigantesco il legame con la terra lavorata, che è il
luogo della natura domesticata, del duro lavoro e della vita normale. Il brigante non ha
nostalgia dei campi coltivati, perché, fuggito
di solito giovanissimo dal villaggio, ha cessato
di coltivarli o non li ha mai coltivati. Il suo
ultimo saluto, intenso e struggente, quando è
catturato o sta per essere giustiziato, è rivolto
al bosco dei pini e all’altopiano (che nell’immaginario collettivo sono i luoghi dell’“omo
selvatico”), da cui è stato accolto e protetto e
dove è vissuto libero e dominatore:
Nun ce tuornu cchiù a chillu pinitu,
chille belle chianure e chillu pratu.
venite a tentarmi / perché la pagate, per Dio”. Si tratta di un canto brigantesco, pubblicato la prima volta in Bilo e
successivamente in Sca1: 137.
48
Hadd: 48.
49
“Chi vuole farsi soldato reale / deve andare in campagna con Nino Martino; / a bere non lo porta alle fontane, /
ché dietro gli va l’otre pieno di vino. / Non li fa andare vestiti di lana, / ma li veste tutti di fine damasco; / non gli fa
mancare il pane bianco, / e non manca mai il companatico”. Il pane bianco era quello dei signori: in Sca1: 127.
30
antropologia e storia
La ruina, ch’è stata stamatina,
non minde lassa cchiù corda e catina.
(ott. XLI)50.
Il bosco dei briganti deve essere fitto di
vegetazione, in modo da risultare pressoché
impervio a chi non lo ha mai attraversato,
ricco di grotte e possibilmente collocato su
un’altura. Come le dimore delle bande pugliesi, “le impervie foreste delle Grotte, presso il Fortore, le selve degli Umbri, Dragonara, Incoronata, S. Agata e Maresca, a nord, i
boschi di Acquaviva, Gioia, Noci e S. Basile,
al centro, la cupa foresta di Pianella, i boschi di Arneo e le Macchie di S. Marzano, a
sud”51. Nel territorio di Ginosa Antonio Locaso (“Capraro”) costruì la base principale
della sua banda nel bosco Rita, fitto di piante
di alaterno, olivastri e citiso spinoso: vi si accedeva attraverso un sentiero che terminava
in uno spianato circolare e poi in altri spianati, usati come dormitorio per gli uomini e
stalle per i cavalli52.
I periodi di stagnazione delle operazioni
di guerriglia potevano essere lunghi e altrettanto, a volte, le soste. E il bosco era il luogo
per eccellenza del loro riposo e degli interminabili giochi d’azzardo che riempivano
il loro tempo libero. Ma era anche il luogo
dei loro spostamenti tattici e strategici e di
molte delle loro imprese. Quando dovevano
combattere, le bande sceglievano la pianura ai margini del bosco, in modo da potersi
rifugiare e nascondersi nella vegetazione.
/ 1 – donne in armi
Il bosco per le comitive è elemento onnipresente di sicurezza. Se i briganti devono
scegliere tra due case dove devono andare a
gozzovigliare, preferiscono quella che consente una fuga facile, per la vicinanza del
bosco e la lontananza dal centro abitato53.
Una volta che sono usciti dal paese, solo
i briganti più temerari, più capaci e sicuri di
sé vi rientravano con una certa frequenza.
Soltanto per pochi il paese era la loro dimora fissa, da dove, indisturbati, comandavano
i gregari alla macchia. Si direbbe che il brigante si fosse assuefatto all’idea che ormai il
suo universo era quello delle masserie, dei
pagliai, dei boschi, ma tutto questo è solo
in parte vero: egli vive emotivamente in due
dimensioni, e frequenta poco il paese, solo
perché le forze dell’ordine glielo impediscono. I briganti di Manzo spesso lasciavano il
gruppo impegnato nell’odissea dei sequestri
e raggiungevano il loro villaggio, dove rimanevano alcuni giorni, col permesso del
capo54: una sorta di vacanza-premio, con la
famiglia o l’amante.
Non a caso, i briganti operavano di preferenza in un’area che aveva come epicentro
proprio il loro paese. Non ne potevano fare a
meno, perché, oltre a fare nuove reclute con
maggiore facilità e trovare favoreggiatori e
manutengoli, si assicuravano il controllo del
territorio grazie alla conoscenza perfetta dei
luoghi (strade, sentieri, boschi, nascondigli,
case di campagna). Il pae­se di appartenenza era la cassa di risonanza delle imprese
“Non ci tornerò più a quella pineta, / quelle belle pianure e quel prato. / La rovina, che c’è stata questa mattina, /
non me ne lascia più di corda e catena” (= sono caduto nel pozzo, senza possibilità di risalirne: Pietru Biancu, in
Sca1: 162, ott. XLI.
51
Luc2: 45.
52
Mian: 31.
53
Fonte in Mosc: 134.
54
Fri2: 163, 166.
50
31
Q
uaderni
brigantesche, e il brigante viveva anche del
proprio mito; nel paese i briganti avevano lasciato la loro famiglia o le loro amanti, con le
quali si incontravano di nascosto tutte le volte che potevano; nel paese i feriti potevano
essere visitati facilmente dai medici ed avere
medicine dal farmacista; nel paese c’erano i
barbieri che li radevano, i sarti che cucivano
per loro. Un legame intenso, rafforzato dal
principio della reciprocità, perché i briganti
distribuivano denaro, aiutavano i bisognosi,
offrivano servigi ai potenti, operavano vendette, che a volte erano atti di riparazione e
di giustizia.
Nel fuoruscito l’immagine del paese permaneva come ancoraggio sociale, spaziale e
temporale: è proprio vivendo alla macchia
l’esperienza sofferta della perdita che il brigante scopre l’importanza del borgo natio.
Non a caso la dispersione dei fuorusciti nelle
campagne produce una forma originale di
incistamento etnico, per l’aggregazione alla
stessa banda di briganti dello stesso paese.
Anche nelle bande di più complessa formazione sono distinguibili nuclei compattati
dalla medesima appartenenza territoriale.
Questa modalità di aggregazione ha qualche
affinità con l’incistamento etnico dei migranti e dei profughi e con l’associazionismo
su base regionale delle migrazioni interne,
che salvano dai turbamenti dell’isolamento
e dello sradicamento, che fanno del fuoruscito un vagante senza scopo e senza meta,
diventato “altro” per la comunità di appartenenza: la dipartenza del brigante non è del
tutto “spartenza”, non spezza il circuito della
reciprocità, della pubblica solidarietà, del
vicendevole riconoscimento e delle intime
Brow: 28.
55
32
complicità. In un certo senso, anche la storia
di una comitiva brigantesca è la storia di un
paese fuori del paese stesso.
Sul piano simbolico e psicologico non c’è
un distacco totale dei fuorusciti dalla piccola
patria. C’è anzi un intenso rapporto di odio
e di amore per il proprio paese: nella loro
fuga c’era già il loro ritorno. Ma vorrebbero
tornarvi da vincitori, come oggi gli emigranti di successo, e al tempo stesso occuparlo
e devastarlo, ricongiungersi, vestiti di una
nuova vita, coi parenti e gli amici, ed esemplarmente punire, annientare i propri nemici e coloro che hanno causato la loro rovina.
Era il sogno incattivito di Ninco Nanco e di
Antonio Franco. In fondo, il viaggio, la fuga,
l’errabondaggio sono vita sospesa, servono
a esperire l’ampiezza dell’esistenza e superare la prova. Solo il ritorno è fondante. Tutti
i miti dei viaggi trovano nel ritorno il momento fondante. Il sequestro degli abitanti
del proprio paese a scopo di ricatto poteva
costituire un sostituto simbolico della riconquista del paese natio e della vendetta sui
propri nemici. È un altalenare a volte convulso, che dà vita a una circolarità paese/
campagna a volte ossessiva. Le piccole bande
(le bande medie e grandi ampliavano il loro
raggio d’azione) sconfinavano nei territori
adiacenti solo per l’approvvigionamento di
viveri, per operare sequestri e per vanificare
le disposizioni eccezionali anti-brigantaggio
emanate dai prefetti: poiché esse variavano
da luogo a luogo, le bande tendevano a lasciare una provincia in cui il prefetto rendeva loro difficile la vita, per riparare in altre
province in cui la repressione era meno pesante55. A volte era necessario sconfinare, per
antropologia e storia
potere più facilmente indurre in errore il nemico, quando, rimanendo nella propria regione, non si riesce a ingannare l’avversario.
In fondo – a parte la novità e le ovvie
differenze – la banda è il prolungamento del
villaggio. Insieme alla famiglia, è il villaggio,
il paese, il territorio a generare nei briganti i sentimenti più intensi e le emozioni più
forti. Il villaggio e la famiglia costituiscono
le uniche aggregazioni reali; gli altri gruppi,
associazioni, partiti, burocrazia statale, sono
“gruppi irreali”, perché non producono rapporti di intimità, solidarietà e coesione. La
bande costituiscono aggregazioni forti, proprio nella misura in cui trasferiscono nella
loro organizzazione i valori della famiglia e
del villaggio. Le relazioni parentali plasmano
le altre relazioni e contribuiscono a modellare i ruoli. Il capobanda è una figura paterna,
terribile e rassicurante, i gregari sono i suoi
figli obbedienti che però partecipano alle
sue decisioni. Si appartiene alla banda, ma la
nuova appartenenza non comporta l’assunzione di comportamenti totalmente o radicalmente diversi da quelli abituali, che produrrebbero sensi di estraneità e lontananza.
La novità costituita dalle bande (e, in
epoca successiva, dalle organizzazioni mafiose) risiede proprio nel loro essere una
associazione autoctona, non trapiantata
dall’esterno, che riscuote un notevole successo tra la gente: il contrario di quello che
succede nel Sud alle associazioni nuove e
calate dall’alto. Il modello della famiglia e
del villaggio in parte trapiantato nella banda
produce al tempo stesso fatti nuovi: per la
prima volta una organizzazione che non è la
famiglia si fonda sul principio che il bene di
tutti coincide con il proprio bene; che, al di
sopra del proprio interesse particolare, sottoporsi a regole condivise, creare un fronte
/ 1 – donne in armi
comune, è l’unica possibilità di realizzazione
del singolo, e l’unica via del successo; che si
ha il diritto di partecipare alle decisioni, e al
tempo stesso occorre sottoporsi a delle regole comuni; che il principio dell’uguaglianza
non conflige necessariamente col potere dei
capi che meritano di essere tali. L’organizzazione della banda è a metà strada tra l’autoritarismo paternalista e la democrazia, l’egalitarismo e la meritocrazia.
La territorialità è propria degli abitanti
dei paesi meridionali: essi hanno un forte
senso di appartenenza al paese nativo, dove
vivono in una rete di parentele e legami amicali, mentre sono estranei e perfino ostili agli
altri territori vicini, in cui di rado si avventurano, a parte i lavori stagionali e le migrazioni temporanee alla ricerca di lavoro. Povertà di spostamenti, dovuta alla mancanza di
vie e di mezzi di comunicazione, all’assenza
di scambi, all’insicurezza che regnava nelle
campagne e rendeva pericolosi i viaggi. Ma
c’erano anche le ragioni culturali, la paura
dell’Altro, che ha lasciato segni forti nei “balasoni popolari”, rappresentazioni deformate
che ciascun paese faceva del paese vicino,
per stigmatizzare la diversità degli altri paesi
e difendere la propria “normalità”.
Come abbiamo anticipato, i paesi erano
di fatto silenziosamente presidiati dai briganti
stessi. Oltre alle reti familiari e ai manutengoli,
in essi conducevano una vita apparentemente
normale i briganti temporanei o stagionali.
Anche se questo fenomeno è rimasto quasi
interamente sepolto nei misteri dei paesi meridionali, alcune testimonianze dell’esistenza
di queste doppie vite nelle comunità dei paesi
del sud ci sono state conservate: nello Stato
pontificio, sui monti di Roccaguglielmina gli
abitanti dei paesi “non solo erano prodighi
di aiuti, di indizi e di consigli ai briganti, ma
33
Q
uaderni
spesso di loro proprie persone sussidiavano
la banda per commettere notturne aggressioni, ritornando poi allo spuntar del giorno
nei loro abituri, o a lavorare precisamente i
campi, o a guidare al pascolo le greggi” (Binc:
150). Anche alcune brigantesse avevano questa doppia vita, trovandosi ad essere all’apparenza persone normali, di fatto manutengole
e insieme brigantesse, con tutti i vantaggi che
questo comportava per le bande.
L’amore e gli amori
In un accampamento frequentato dalle
donne dei capi in veste di brigantesse, ma
anche dalle amanti che venivano di tanto
in tanto dal paese e dalle donne di piacere mercenarie, poteva capitare che le feste
prendessero le forme di una licenza che agli
osservatori esterni poteva sembrare una
non precisata “orgia”. Potevano sembrare
più verosimilmente orge le libertà, comuni a tutti gli eserciti e a tutte le guerre che
hanno conosciuto le conquiste e i saccheggi, che esplodevano in occasioni particolari,
come la messa a sacco di un centro abitato,
i festeggiamenti per una vittoria. Erano un
modo di “misurare la vittoria, che faceva
parte della dimostrazione del successo e della virilità del soldato, una ricompensa tangibile per i servizi che questi aveva reso”55,
ed anche un modo di far pesare ai vinti l’angoscia della sconfitta. Ad esse partecipavano
indistintamente tutti i briganti. Ecco la descrizione, in parte forse immaginaria, fatta
dal giovane ufficiale De Witt, dell’assalto
della truppa guidata dal colonnello Balsani
DeWi: 280; n.72.
56
34
al villaggio Mezzane, dove si era accampata
di notte una banda per festeggiare cogli abitanti: “Quando fu a circa 2 miglia di distanza
da quel luogo, vide che il villaggio era tutto in fiamme: i briganti colà giunti avevano
acceso dei fuochi di gioia e si erano dati in
braccio a notturna orgia, divisa fra loro e le
più impudiche donne di quella campagna.
Nella via di mezzo del villaggio, intere botti
di vino offrivano gustose libazioni ai festanti
masnadieri ed intorno a quelle i più giovani
di essoloro si consacravano ad ogni atto di
lascivia, ed alle più voluttuose ridde, intantoché nel vicino proto i cavalli briganteschi
si satollavano di strame e di erbe”56.
La pubblicistica postunitaria, sia per assecondare le curiosità erotiche dei lettori,
sia per demonizzare la guerra delle bande,
insistette più del giusto sulle perversioni sessuali dei meridionali alla macchia. Nella loro
asciutta castigatezza i documenti di archivio
fanno invece scarsi riferimenti all’eros nelle
bande, a differenza delle cronache del tempo, che indulgevano sulle presunte scelleratezze sessuali e orge promiscue dei briganti.
In effetti gli elementi erotici non hanno avuto nella storia dei rapporti tra briganti e brigantesse un rilievo eccessivo, probabilmente
perché i componenti delle bande erano briganti prima di essere uomini e donne e in
quanto tali, almeno in pubblico, subordinavano sentimenti e impulsi alle esigenze della
vita ordinata della banda e alle sue regole. A
questo scopo contribuiva, come abbiamo visto, il controllo esercitato dalla rete parentale
all’interno delle bande.
Di norma ogni brigantessa era legata
a un solo uomo, anche se questo rapporto
antropologia e storia
poteva assumere forma e valore diversi da
coppia a coppia. Non sono del tutto credibili
i riconoscimenti che le brigantesse meritarono nelle pagine dei giornali e nella narrativa
del tempo come donne capaci di “dedizione
totale di sé al proprio uomo”, tenaci nella fedeltà “fino al sacrificio”, perché gli scrittori
cercavano nel presunto primitivismo delle
genti del Sud le forme incontaminate dei
loro valori, che la civilizzazione aveva corroso. Si evocavano i casi dell’amante del brigante Michele Carpentieri, che “si lasciò uccidere con lui, difendendolo fino all’ultima
agonia”57; di Maria Tulino, che per salvare il
suo uomo, Crescenzio Gravina, denunciò un
componente della banda, Curcio, che poi la
uccise58; di Serafina Ciminelli, piccola di età
e di corpo, che seguì per amore oltre che per
legittimismo politico il capobanda Antonio
Franco: quando il fotografo dell’esercito li
ritrasse, prima che l’uomo fosse fucilato e la
donna condannata, i due amanti si tenevano
teneramente per mano, come, in una circostanza analoga, i giovani briganti Agnese
Percuoco e Vincenzo Letteriello della banda
Ciardullo. Oscar De Poli, che conobbe direttamente i briganti, in una banda lucana
trovò “tre donne, spose fedeli e coraggiose,
che dividevano fino alla morte ogni rischio
con i loro mariti”59. Era però un legittimista,
portato ad enfatizzare la purezza e la normalità delle bande. L’opzione prevalente per
il rapporto di coppia era comunque dettata
dal bisogno di avere un compagno fisso, per
affrontare insieme le enormi difficoltà della
59
60
61
57
58
/ 1 – donne in armi
vita alla macchia e per sottrarsi ai desideri
destabilizzanti dei più. Questo aiuta a capire
perché nelle bande, a parte qualche eccezione, non militassero donne sole.
Le brigantesse erano, come sappiamo,
quasi sempre le donne dei capi o dei briganti più influenti; perfino quelle di più liberi
costumi, come la Bonnet, riservavano i loro
favori soltanto ai capibanda. Quanto più la
compagna del capo era tenuta in considerazione dal suo uomo, e quanto più costui era
forte e temuto dalla banda, tanto più cresceva verso la donna la considerazione e l’affetto dei gregari: come abbiamo anticipato, alla
favorita di Vincenzo Barone, che combatteva
al suo fianco, Luisa Mollo, i briganti costrui­
rono un giaciglio di muschio in un pagliaio
“sul punto più bello della montagna”60.
Quando una relazione si esauriva, sia
l’uomo che la donna costruivano facilmente
un nuovo rapporto con un altro partner. Non
pare che fosse sempre l’uomo a porre fine alla
storia, almeno a giudicare dal caso del capobanda Cerino, che, perduta la direzione della sua comitiva, perdette anche l’amore della
sua donna, “Doniella”61, che lo abbandonò.
In caso di morte, il capo-amante veniva sostituito da un altro amante. A seconda dei
casi, era la donna che sceglieva di stare con
il capobanda successivo o era quest’ultimo
che la ereditava, la sceglieva o la prendeva.
Maria Domenica Piturro, indicata nei documenti come prostituta (tali erano agli occhi
di alcuni le brigantesse, per il fatto di vivere
nella clandestinità, appartenere a un mondo
Casc: 151.
Gell: 151.
DePo in Del: 150.
DeBl: 20-21.
Moe: 212.
35
Q
uaderni
considerato deviante, avere rapporti fuori
del matrimonio), quando entrò nella banda
diventò la compagna di Paolo Serravalle e,
dopo la sua uccisione, del nuovo capobanda,
Pasquale Serravalle, nipote del precedente62.
Siamo certi che Filomena Di Poto, amante
di Gaetanio Tranchella (ma pare che abbia
avuto una storia per qualche tempo o in
qualche occasione con Schiavone), diventò
la donna di Vitantonio D’Errico (“Scarapecchia”), quando quest’ultimo ereditò dal
precedente la funzione di capobanda. Non
sempre la documentazione offre gli elementi
utili per una giusta interpretazione di queste
situazioni. Pare che la spinta all’eliminazione
del capo, considerata imperdonabile se dettata dalla sete di potere, in qualche raro caso
fosse determinata anche dalla gelosia.
Il modello familiare all’interno della
banda rimase quello contadino, con le modificazioni prodotte dalle diverse condizioni
di vita e dall’alterazione del modello culturale complessivo della vita nelle campagne.
I rapporti monogamici furono parecchi e di
notevole intensità, anche se non comportavano sempre, se non in linea di principio,
la fedeltà assoluta: accanto alla brigantessa
fedele fino alla morte c’era quella che apprezzava la corte di altri capi, con i quali
poteva civettare e ai quali in qualche caso
e occasione forse concedersi. Michelina Di
Cesare era l’amante del capobrigante Francesco Guerra, ma si chiacchierava che avesse
qualche legame segreto col pastore abruzzese Curcia, secondo una testimonianza resa al
processo del 22 maggio 186963; Mariannina
64
65
62
63
36
Corfù o Algieri era l’amante di Ninco Nanco,
ma sul retro della sua fotografia è indicata
come “Marianna Algiera o Algieri, amante
di Michele Caruso”64; Maria Giovanna Tito
fu prima l’amante di Crocco, poi, quando il
capobanda la abbandonò, di Agostino Sacchetiello. Sono solo esempi.
Le relazioni, dunque, tendevano ad essere monogamiche, ma il nuovo potere e le
relative ‘parità’ guadagnati dalle donne, il
clima di libertà e di trasgressione che si respirava nelle bande, la difficoltà di conferire
normalità a rapporti che non potevano oggettivamente avere le caratteristiche dei normali rapporti familiari, la possibilità, per la
donna, di avere una molteplicità e varietà di
contatti maschili cui non era abituata, potevano a volte conferire una certa elasticità al
tradizionale rapporto di coppia contadino.
La documentazione tuttavia non ci consente
di approfondire adeguatamente buona parte
delle diverse situazioni. È difficile, per esempio, accertare se questi rapporti multipli si
siano sempre succeduti regolarmente nel
tempo o siano stati contemporanei e compresenti. Contro quest’ultima ipotesi militerebbe la regola che le donna di un brigante
non doveva essere insidiata da altri, pena
la morte. Era una regola non scritta, che,
anche se non sempre osservata nella realtà,
funzionava come orientamento e deterrenza. A volte, soprattutto quando le bande cominciavano a disgregarsi, anche i rapporti
esclusivi di coppia si indebolivano, aprendo
la possibilità di relazioni erotiche estranee
ai codici prevalenti. Mariateresa Ciminelli,
Varu: 137.
ASC, Processi. Politici e di Brigantaggio, Camera di Consiglio. del Tribunale. Correzionale di Cassino, ……
Gell: 226.
ASP, Prefettura di Potenza, Gabinetto, Cat. VIII Brigantaggio, b, 43, f. 455; b. 55, f. 88; b. 31, f. 15; cfr. Roma: 80.
antropologia e storia
già sposata a un giovane contadino, in una
dichiarazione fatta durante il processo si
disse “druda” del capobanda Antonio Franco65, che era l’amante ufficiale di sua sorella
Serafina; Elisabetta Blasucci fu soprannominata “Pignatara”, forse per la facilità con
cui si concedeva (il “pignato” nei dialetti
meridionali è metafora dell’organo sessuale
femminile), anche se aveva un compagno
ufficiale66; Maria Parente era l’amante di Federico Aliano, ma fu posseduta dal brigante
Cappuccino67. L’idea un tempo dominante
del mondo popolare tradizionale governato da un patriarcato assoluto e intollerante
si va rivelando in parte infondata, perché
non considerava quanto nella strutturazione
dei rapporti familiari e nell’economia della
sessualità pesassero il condizionamento dei
rapporti di forza e la generale debolezza del
modello patriarcale, aprendo contraddizioni
tra l’ideologia e il vissuto quotidiano68. Ad
uno sguardo d’insieme sembra che le brigantesse oscillassero tra una relativa soggezione al potere maschile, che poteva giocare
a favore del rapporto monogamico, e la tentazione di cedere alla forza incontrollabile e
destabilizzante dell’eros, che rappresentava
la sua eterna minaccia. La diversità delle
situazioni e la povertà delle informazioni rende difficile operare generalizzazioni,
ma molto probabilmente, se, da un lato, la
precarietà delle condizioni di vita alla macchia e le difficoltà quotidiane spingevano in
favore dei rapporti di coppia stabili, per un
/ 1 – donne in armi
altro verso l’eros si poneva come una forma
possente di recupero, esaltato dalle forme di
vita tendenzialmente anarcoidi proprie del
brigantaggio. Per quanto briganti e brigantesse cercassero di dare alla loro esistenza
alla macchia la normalità del modello familiare tradizionale, la vita sessuale si svolgeva
spesso nella dimensione dello straordinario
e dell’avventura. Nella sua banda Vincenzo
Barone aveva come sua amante ufficiale, o,
comunque, stabile, Luisa Mollo, che era anche la sua collaboratrice, la quale non solo
tollerava che il capobanda amoreggiasse
con la ventunenne donna Matilde, figlia del
possidente Luigi Di Marzo, che si era invaghita del brigante, ma in una circostanza fu
proprio lei ad accompagnare la rivale a un
incontro col suo uomo69. Il capobanda fu
amato anche da una monaca più avanti negli
anni, De L., che gli mandava rosolio e tabacco70. Questi comportamenti rimangono in
parte un mistero, che le scarse informazioni
fornite dalla fonti non aiutano a dipanare del
tutto. Amori promiscui, non segnati dall’appartenenza ad un unico maschio, poterono esserci in qualche caso, che comunque
riesce difficile individuare con precisione,
perché nell’ottica di molti informatori tutte
le brigantesse potevano apparire le prostitute dei briganti più importanti o del gruppo:
Antonia Abate è detta nelle cronache “druda” di Domenico Calabrese e Giuseppe Di
Marzio71. Nelle cronache Rinalda Chianti
(o Chianni) è detta “druda” di Pasquale Io-
ACS, Roma, Tribunali Militari di Guerra per la Repressione. del Brigantaggio nelle Province Meridionali, b. 179
(Potenza), fasc. 2117/72; cfr. Varu: 71.
67
ASP, Prefettura di Potenza, Gabinetto, Cat. X Brigantaggio, cartella n. 28; cfr. Varu: 94-95.
68
Sca4: 31-37.
69
Gimm: 82.
70
DeBl: 20-21; DeBi: 21.
71
“Pu”: 24/12/1863.
66
37
Q
uaderni
rio e di Francesco Salerno72. Maria Giovanna Bonnet era legata a Michele Larotonda,
ma si diceva avesse rapporti con i capi della
banda.
I canti popolari ci hanno lasciato testimonianze preziose degli amori dei maschi
delle bande. I briganti comuni lasciavano la
loro donna al paese, e questa situazione era
oggetto di canti struggenti:
Catàba mi nde jia ppe ssi piniti
e jia guiardandu li luntani prati;
càpitu nu truppuni de rusiti,
unu se distinguìa d’amminezu l’atri;
haldelluti venianu ‘mbardansiti,
e lu rusitu lassai stare ‘n pace.
Lu rusitu si tu del la mia vita,
gioiuzza mia, chi me si custata;
ma dassu ncunu juornu sti piniti,
e viegnu a ttie mu restamu mbiati73.
La tentazione di tornare dalla donna
amata era, come sappiamo, a rischio della
vita. I maschi erano generalmente legati alle
loro donne, alle quali non negavano attenzioni, che si traducevano vistosamente in
regali di gioielli, acquistati o frutto di rapine
e di razzie, o in attestati di fiducia, con l’affidamento del proprio gruzzolo o tesoretto, o
in altri segni di interesse e di affetto: Nunziante D’Agostino, visto che le calzature della
sua compagna Chiara Di Nardo erano rotte,
fece togliere le scarpe a un prigioniero e gliele fece calzare74. La prova d’amore più gran-
de che l’uomo potesse dare era l’accettazione
della gravidanza e poi la nascita del figlio,
che apriva le porte della speranza nel futuro.
Gli amori dei maschi erano decisamente
più liberi di quelli delle donne e non mancavano altri modi e progetti di vita. Carmine
Crocco, carcerato da molti anni e ormai vecchio, rilasciò un’intervista in cui, tra l’altro,
spiegò il suo rapporto con le donne: “– Facevate vita libertina, vi piacevano le donne?
– Sì, quando le trovavo non le lasciavo, ma
non amavo molto né le donne né il vino. –
Avevate con voi nella vostra banda qualche
donna? – No, quando si trovavano si faceva
come il beccafico: si beccava e via”75. Sono
mezze verità, mescolate a menzogne tattiche, che non rispecchiano la media dei comportamenti, ma in cui si riverbera comunque la componente leggermente misogina
dei briganti maschi, di cui all’inizio di questo
saggio abbiamo cercato di comprendere le
ragioni. In particolare, l’intervista rispecchia
la storia erotica di Crocco, che ebbe molte
amanti che gli furono accanto anche nelle
battaglie e di cui subì il fascino e forse l’influenza, suscitando, come sappiamo, le preoccupazioni del generale Borjés. Certo è che
anche i maschi che avevano una compagna
la tradivano a volte e spesso mantenevano in
piedi più rapporti collaterali. Andrea Ferrigno aveva come amante Concetta Solimene,
ma questo legame non gli impedì di duellare
a colpi di pistola per la brigantessa Antonia
“Gio”: 24/4/1867; “Om”: 24/4/1867.
“Pian piano me ne andavo per queste pinete / e andavo guardando i lontani prati; / mi imbatto in un cespuglio di
roseti, / uno si distingueva in mezzo agli altri. / Carabinieri venivano inbaldanziti, / e lasciai stare in pace il roseto,
/ Tu sei il roseto della mia vita, / gioia cara, che mi sei costata (= che mi è costato lasciare); / ma qualche giorno
lascio queste pinete, / e vengo da te, per restare beati” (canto brigantesco, in Bilo e in Sca1: 138). I carabineri sono
detti “haldelluti” per la lunga falda della divisa.
74
ASS, Reati politici e brigantaggio, b. 67, fesc. 963.
75
Crocco in DeBl: pp. 90-91.
72
73
38
antropologia e storia
Scarano, ponendo fine all’alleanza tra le loro
bande76. Quello che collezionò più amori,
avendo, a quanto pare, i titoli per farlo, fu
forse Antonio Franco, il capobanda del Pollino. Vestiva, come la maggior parte dei capi,
in maniera più raffinata dei suoi gregari, con
una lunga e densa barba che ingrandiva la
sua figura; aitante e coraggioso, era anche
tra i pochi briganti che sapessero scrivere,
componeva canzoni che egli stesso eseguiva:
non c’è da stupirsi se anche per tutto questo
aveva un grande ascendente sulle donne, a
molte delle quali non rimase insensibile. Era
però il compagno ufficiale di Serafina Ciminelli, che peraltro amava teneramente, senza
che questo gli impedisse di avere commercio
sessuale con sua cognata, Mariateresa, alla
quale questa sorta d’incesto dovette sembrare pressoché normale77. Per voce popolare furono “drude” di Franco, oltre che sue
manutengole (per averlo ospitato nelle loro
masseria, avergli lavato la biancheria e fornito informazioni), altre donne sposate, una
delle quali si faceva ammirare e invidiare in
paese per le vesti lussuose, che comprava
con i soldi di Franco78.
Due furono le donne che contarono nella
vita breve di Schiavone, ma poco sappiamo
di Rosa Giuliani, donna giovane e bella, abbandonata dopo qualche tempo per Filomena Pennacchio, certamente il suo amore più
grande, che però non gli impedì, secondo
78
79
80
81
82
83
84
76
77
/ 1 – donne in armi
il gossip costruito o avallato dai militari, di
avere altre due donne, Filomena Di Poto,
nota come la sua “amante titolare” e Rosa
Tardugno, presunta “amante supplementare”79. Antonio Cozzolino detto Pilone, capobanda del napoletano, ebbe rapporti amorosi con Carolina Esposito, amante di Luigi
Carillo, con Chiara, moglie di uno sconosciuto Paolo, e con una donna di Ottaviano,
che pare gli abbia dato un figlio80.
Molte donne ebbe Ninco-Nanco come
amanti, tra cui Filomena De Vito di Grassano e Filomena Di Pecora81, ma sarebbe
stato l’amante anche di Marianna Corfù o
Algieri, di cui è incerta la fisionomia e perfino l’esistenza82. L’8 dicembre 1863 convinse
a seguirlo nei boschi e ne fece la sua amante
Filomena Nardozza, nata ad Avigliano nel
1843. Francescantonio Summa, fratello di
Ninco Nanco, aveva un legame forte con Lucia Di Nella, ma forse attentò, nella disperazione di trovarsi, alla fine, sconfitto e ferito,
all’onore della moglie del contadino che lo
curava83. Alessandro Pace era il compagno
di Giocondina Marino, ma mise incinta una
donna della stessa banda, Maddalena Cioffi,
per esplicita confessione della donna. Nella
confessione della stessa Maddalena Cioffi, Brigida Marino era l’amante di Giacomo
Ciccone, ma è detto anche che “è stata e si sta
possedendo da un altro capobanda”, che era
Domenico Fuoco84. Del gioco dei tradimenti
ASA, Br., b. 8, fasc. 421.
ASP, b. 368, Deposizioni di Teresa Ciminelli, 1865; cfr. Ri-l: 235.
Ri-L: 235-36.
Gell: 246. Nella fotografia la Di Pote è in piedi, la Tardugno è seduta. Rosa Tardagno potrebbe essere Rosa Giuliani.
DeBl: 64.
Bi.Q: 150.
Gell: 226.
Bi.Q: 150.
ACS, Roma, Tribunali Militari Straordinari, b. 160, fasc. 1807, interrogatorio del 1 luglio 1864.
39
Q
uaderni
è rimasta notizia, molto nota per il suo tragico ed efferato epilogo, di Cappuccino, che,
tradito da sua moglie, possedette Maria Parente, compagna di Angelo Di Giacomo, ma
amante anche di Federico Aliano85.
Come in tutti gli eserciti, intorno alle bande giravano donne di piacere a vario titolo,
ma erano, sostanzialmente, mercenarie del
sesso. I rapporti non erano sempre pacifici,
dal momento che i briganti, sempre generosi con le brigantesse, litigavano spesso con le
meretrici per problemi di retribuzione. C’erano anche procacciatori di donne, che pare abbiano realizzato guadagni notevoli con questa
attività86. I militari dell’esercito italiano tendevano a considerare prostitute anche le brigantesse87. Sulle donne combattenti semmai
pendeva il rischio di finire nel lupanare o nel
carcere, solo se la guerra delle bande si fosse
conclusa tragicamente, ma i casi di brigantesse risucchiate dalla prostituzione risultano
molto rari, transitori e dovuti a esigenze di
sopravvivenza. Domenica Ianni, una delle ultime compagne di Domenico Valerio (“Cannone”), quando lascia la banda, ormai in fase
di disfacimento, accetta prima un menage
à trois con un giovane che l’accoglie in casa
sua con sua moglie, poi se ne allontana, e va
a esercitare la prostituzione con i militari. Per
una brigantessa allo sbando dichiararsi meretrice aveva almeno il vantaggio dell’impunità,
rispetto alle donne associate alle bande armate che venivano combattute e condannate.
Certamente la relativa libertà che governava le relazioni amorose era generalmente
87
88
89
85
86
40
tollerata, forse in qualche caso intimamente
subita, perché la guerriglia creava tra gli uomini un compattamento che compensava o
faceva passare in secondo ordine i contrasti
personali. Ma questo non valeva in assoluto.
Anche se non erano generalizzati, al punto
da influire pesantemente, a parte qualche
eccezione, sull’andamento delle operazioni militari, gelosie e conflitti erano presenti
nelle relazioni amorose dei briganti e furono, in qualche caso, rovinosi. Storie più o
meno leggendarie circolavano sulla gelosia
che Filomena (verosimilmente Pennacchio),
suscitava in Giuseppe Caruso: Crocco e Caruso si sarebbero per lei sfidati a duello, ma
la sapienza della donna avrebbe evitato la
catastrofe88. L’episodio si ritrovava nei repertori dei cantastorie popolari, perché gli amori dei briganti erano già diventati leggenda,
mentre la realtà andava forse da un’altra
parte. Pare che anche tra i briganti il duello
per amore tra capi tendesse ad evitare che si
arrivasse all’uccisione del rivale. Ancora la
gelosia determinò la fine dell’alleanza di altri
due capibanda, Pica e Ferrigno. Pica aveva
litigato con il socio per amore di Antonietta Scarano e i due si erano sfidati a colpi di
pistola; successivamente le due bande si disaggregarono pacificamente, impegnandosi
a limitare il proprio controllo del territorio,
quella di Ferrigno nell’avellinese, l’altra di
Pica nel salernitano, e la donna seguì Pica89.
Come sappiamo, Carolina Di Ruocco fu l’amante di “Chiuppetiello”, il capobanda dagli
“occhi cerulei e colorito rubicondo”, che per
ASP, Prefettura. di Potenza, Gabinetto, Cat. XXVI, cart, n. 502; cfr. Varu: 94, 97.
Varu: 133.
Mele: 69.
Si tratta di narrazioni raccolte e manipolate da DeWi: 294-300.
ASA, Brigantaggio, b. 8, fasc. 421; DeBi: 123.
antropologia e storia
lei litigò con i compagni per motivi di gelosia90, senza tragiche conseguenze.
Le donne invece si vendicavano a volte
degli uomini con la denuncia e la delazione,
e in qualche raro caso determinarono la rovina delle coppie e perfino delle bande. Rosa
Giuliani non perdonò a Schiavone di averle
preferito Filomena Pennacchio, e denunciò
il suo nascondiglio alle forze dell’ordine, che
lo arrestarono e fucilarono insieme ad altri
capi, gregari e brigantesse91. Maria De Martino, amante del capobanda Ferrigno, sin
da quando costui era aggregato alla bande
associate di Cerino e Cicco Cianci, diventò
l’amante di Ferdinando Pica, quando entrò
nella banda di quest’ultimo, ma fu dopo non
molto tempo ripudiata e sostituita con Antonietta da un anno madre di un bambino,
ventunenne: la donna per vendicarsi il 19
settembre 1868 andò a presentasi al Delegato di Montella, raccontando i fatti e le connivenze occulte della banda92.
Per quanto il demone della gelosia fosse
tenuto a bada dalla regole di comportamento della banda e dal buon senso, il tradimento e il delitto rimanevano sempre dietro
l’angolo e qualche volta colpivano tragicamente. Non sappiamo con certezza quanto
la gelosia fosse determinante nella storia di
Maria Giuseppa Gizzi: fidanzata di Parra
già quando ancora non era brigante, pare
fosse desiderata anche dal capobanda Matteo Stiusi, che ironizzava, a volte, interessa-
/ 1 – donne in armi
to, sulla sua corpulenza: (“Sceppa, Sceppa,
come sei fatta grassa!”)93. Il Parra diventò
suo gregario, ma poi lo uccise, diventando
il nuovo capobanda; Maria Giuseppa continuò ad essere la sua amante, ma secondo
alcuni amoreggiava anche col brigante Meola, determinando tra i due tensioni mal
sopite, che alla fine indussero Meola a lasciare la banda94. Rosa Martinelli, amante di
Francesco Monaco, scatenò gelosie furiose
negli altri briganti, e il suo uomo il primo
febbraio 1863 trovò la morte in un’imboscata ad opera dei briganti Elia e De Martini95.
Il brigante lucano Genuario Lagrosa uccise
il compagno Genuario Lapolla che gli aveva
insidiato la moglie96, in ossequio alla legge
della banda, che ordinava di rispettare le
donne dei compagni.
Assurdamente tragica la vicenda di Teresa Raimondi. Nata a Centola, nel Cilento,
nel novembre del 1868, a diciotto anni, si
allontana dalla casa paterna per raggiungere
Pietro Ierardi (o Ierardo) nella banda Greco.
Ha col brigante una relazione, ma è anche
corteggiata vanamente dai fratelli Nicola e
Apollonio Marino, anch’essi di Centola. Secondo alcuni testimoni il 20 ottobre la Raimondi si reca al mulino di Pisciotta con un
sacco di grano, i due la fermano, impongono
al fratellino che l’accompagna di ritornare
a Palinuro, e, dopo averla condotta in un
burrone, le rinfacciano di essere la “druda”
di Ierardi e la uccidono a pugnalate per poi
“Gio”: 25/11/1964; Baro: 109.
Bour: 262; DeZi: 74.
92
DeBi: 111; ASA, Brigantaggio, b. 6, fasc, 358, Salerno, 20 ottobre 1868 e fasc. 370, Campagna, 26 ottobre 1868 e
Montella, 12 novembre 1868.
93
ASSa, Tribunale Civile e Correzionale e Corte d’Assise, b. 55, fasc. 783-83.
94
DiG3: 122-23.
95
Arch. Prov. Bari; Torr: 96.
96
Varu: 68.
90
91
41
Q
uaderni
seppellirla nello stesso posto97. Il più efferato dei delitti passionali fu compiuto da Pietro Bianco. Avvenne perché il capobanda
sospettava che Angelantonio Aiello avesse
tentato di sedurre la sua compagna. La reazione fu di una crudeltà indescrivibile, che
fece emettere un grido di orrore al pubblico
che assisteva al suo processo: il rivale, dopo
essere stato ucciso, fu straziato e ridotto a
brandelli98. Era il più alto grado di pena che
ritualmente si infliggeva ai traditori. Non fu
il solo delitto di gelosia di Pietro Bianchi:
quando si convinse che la madre di un tale
Francesco Scalise “avesse condotta Generosa
Cardamone, sua druda, a far le voglie del signor Bernardo Moraca”, freddò con due colpi di fucile il figlio della presunta mezzana99.
Guerriere in maternità
Le brigantesse avevano intensi rapporti sessuali con i loro uomini e rimanevano
molto spesso incinte. Nella maggior parte
dei casi dovette trattarsi di maternità involontarie, da addebitare alla mancanza di
contraccettivi, perché le donne sapevano benissimo che lo stato di incinte crea problemi
a donne che fanno la guerra e anche ai loro
compagni e all’intera banda. Tuttavia i compagni delle brigantesse accettavano l’evento
ed erano emotivamente coinvolti sia nella
fase della gravidanza che alla nascita del figlio. Le brigantesse più forti e più coraggiose
partorivano frequentemente nei rifugi dei
briganti e i bambini nascevano nelle grotte,
come Gesù. Nella seconda metà di febbraio
1865 Michelina De Cesare, compagna del
capobanda Guerra, portò a termine la gravidanza nella grotta di una montagna presso
Collepardo. Lo racconta un contadino, che
stette due mesi sequestrato tra i briganti100.
A fine maggio 1867 fu la volta di Giocondina Marino, amante del capobanda Pace, che
ebbe un maschietto su una montagna del
Matese, dove si era rifugiata per partorire101.
Di solito però i compagni in attesa del parto
affidavano le brigantesse a manutengoli, levatrici e sorveglianti, che, lautamente compensati, garantivano alle donne sicurezza e
assistenza. Filomena Cianciarulo, incinta di
Nicola Masini, al suo primo parto, dopo un
anno di brigantaggio, si rifugiò con Maria
Rosa Marinelli, compagna del capobanda
Angelantonio Masini, presso la famiglia del
proprietario amico a Sala Consilina, dove
partorì una bambina che un prete battezzò.
Il possidente e il prete furono poi arestati,
perché manutengoli, e condannati a pene
detentive102. Il capobanda Franco mandava
spesso Serafina Ciminelli presso amici, non
badando a spese. Quando la fece ospitare
in Latronico dal prete Pelagano gli costò,
per pochi giorni, 3.000 lire di allora: un patrimonio. Serafina doveva partorire, ma il
bambino morì, lasciando una grande pena
nei genitori103. Situazioni come queste non
erano soltanto prova dell’affetto per le bri-
ASS, Tribunale Civile e Correzionale, b. 20, fasc. 164; ASS, Prefettura, Gab., b. 56, fasc. 462.
An: 978.
99
Sca2: 108.
100
Nico: 111-112.
101
ASC, Deposizione di G. Marino alla Delegazione di P.S. in Mugnano, 1865.
102
AUSSME, b. 81, fasc. 6, cc. 55, 62.
103
Pa-R: 619; Rizz: 36.
97
98
42
antropologia e storia
gantesse dei loro uomini, ma attestano come
anche i briganti maschi fossero interessati ad avere figli. A volte questi affidamenti
duravano tutta la stagione fredda, in cui le
azioni brigantesche si fermavano o quasi.
Anche Maria Giovanna Tito, incinta, fu affidata al manutengolo di Bisaccia. Nel giugno del 1864 – racconta lei stessa in tribunale – “Crocco pensò di ricoverarmi presso
don Michele Rago in Bisaccia. Difatti verso
un’ora di notte venne un uomo a cavallo a
prendermi, e fui dallo stesso condotta in
detta casa, ove stetti in permanenza fino al
giorno in cui venni arrestata”104. Giuseppina Vitale fu portata nel gennaio 1863 nella
massaria di un manutengolo, dove dopo due
mesi partorì una bambina105.
La condizione di ricoverate in città o
nelle masserie in case amiche era comunque
pericolosa non solo per la banda, ma per le
stesse brigantesse, perché potevano essere
individuate e arrestate in seguito a delazioni. Filomena Pennacchio, amante riamata di
Schiavone, fu fatta accogliere per oltre due
mesi da un manutengolo e poi, in previsione
del parto, fu affidata a una levatrice di Melfi, che la tenne nascosta in casa sua106. Sarà
arrestata in seguito alle incaute rivelazioni
di Schiavone. Rosaria Rotunno, amante del
capobanda Ciardullo, che operava nella piana di Battipaglia e sulle montagne contigue,
rimasta incinta, al settimo mese fu affidata a
un manutengolo, ma una spiata la consegnò
alla squadriglia di Campagna.
Non tutte accettavano però che, quando
/ 1 – donne in armi
non erano più in grado di seguire la banda, il loro compagno le affidasse a persone estranee, comunque prezzolate: alcune,
come Maria Giuseppa De Meo, compagna
di Fuoco, si rifiutavano, preferendo tornare
alla casa paterna: un ritorno che quasi inevitabilmente diventava oggetto di delazioni
e implicava l’arresto, il processo e il carcere.
In questo caso non restava che sperare nella
clemenza dei giudici. Si poteva, in alternativa, precedere le mosse della giustizia, consegnandosi spontaneamente alle autorità. È
il caso, non unico, di Maddalena Cioffi, che
si consegnò, fingendo di essere fuggita dalla
banda107. Un’altra soluzione era quella di tenere nascosta la donna e poi anche il bambino in casolari sperduti. Francesca Cerniello,
compagna di Tranchella, per partorire fu nascosta in una casa isolata di montagna, che
il brigante fece sapere a una persona amica
prima di morire. Solo in qualche caso estremo i briganti, quando non erano più in grado di occuparsi delle donne in gravidanza,
potevano essere costretti anche ad abbandonarle. Perché nel loro mondo non serve
sfidare le decisioni del destino avverso: “Necessità nun abita (= habet) lege”.
Non abbiamo notizie di aborti, che nella
società tradizionale erano molto frequenti,
mentre ci risulta attestata la volontà delle
donne di condurre fino in fondo la maternità, anche per più di una volta nel giro di
pochi anni, il che implica che esse avessero
una qualche fiducia nel futuro. Un comportamento analogo dovettero avere gli uomini.
ACS, Roma, TMS, b. 19, fasc. 320.
ACS, Roma, Trib. Mil. di Guerra per la Repr. del Brig. nelle Prov. Merid., b. 14 (Avellino), fasc. 168….
106
ACS, Roma, Trib. Mil. di Guerra per la Repr. del Brig. nelle Prov. Merid., b. 19, interrogatorio di F. Pennacchio, 28
novembre 1864.
107
ACS, Roma, Tribunali Militari Straordinari, b. 160, fasc. 1807, 232.
104
105
43
Q
uaderni
Ma il parto faceva crescere il prestigio della
donna nella banda, in quanto madre del figlio o dei figli del capo.
Per molte brigantesse la maternità rappresentava solo una sospensione momentanea delle loro attività brigantesche. Dopo
il parto, quelle che non erano state scoperte e arrestate quasi sempre ritornavano alla
macchia. Chiara Di Nardo, rimasta incinta,
continuò a partecipare alle operazioni della
banda Scarapecchia108; Giocondina Marino
dopo il parto affidò il bambino a persone
amiche; quindi riprese la sua attività brigantesca, durante la quale rimase nuovamente
incinta: era al quarto mese quando fu catturata109. Filomena Cianciarulo non poté
partecipare allo scontro a fuoco, sul finire
del 1864, in cui il suo compagno fu ucciso,
perché nuovamente incinta110. Filomena
Luongo, della banda Boffa, sparisce improvvisamente dalla comitiva perché incinta, ma
vi fa ritorno subito dopo.
La condizione di incinta era una carta a
favore delle donne, perché diventava più facile per loro salvare la vita al momento della cattura e ottenere poi un alleggerimento
della pena durante il processo; ma è difficile
pensare nella maggior parte dei casi a una
programmazione mirata a questo scopo.
Maddalena Cioffi, quando si consegnò, dichiarò di essere incinta del capobanda Pace.
Secondo il commediografo calabrese Stocchi, che attingeva a fonti orali, Maria Oliverio avrebbe simulato maternità per evitare la
condanna a morte.
Il bambino che nasceva veniva battezzato col nome di un capobrigante amico o
con quello del padre, se questi era morto:
Francesca Cerniello chiamò Gaetana la figlia
nata dopo la morte del capobanda Gaetano
Tranchella, suo “sposo”. Per l’occasione si faceva una grande festa, cui partecipava tutta
la banda. Il figlio della brigantessa veniva
poi affidato a persone amiche o mandato
in luoghi protetti. Il bambino di Francesco
Guerra e di Michelina Di Casare fu battezzato in pompa magna nella chiesa locale,
essendo padrino l’altro capobanda, Domenico Fuoco, ed ebbe il nome Michelangelo
Guerra. L’evento fu festeggiato fino a sera da
tutta la banda. Guerra poi dispose la partenza di Michelina Di Cesare per il suo paese,
travestita da uomo, e accompagnata da un
pescivendolo, dopo che il prete le aveva restituito il denaro che conservava presso di
sé. Poi Guerra si ammalò e la partenza fu sospesa. Il bambino fu mandato in S. Spirito di
Roma111. ll figlio di Giocondina Marino per
volontà dei genitori fu portato a Piedimonte
d’Alife da due carbonari, che poi furono arrestati112.
Delle brigantesse più note erano incinte al momento della cattura anche altre due
amanti di Schiavone, Filomena Pote e Rosa
Tardugno, oltre Chiara Di Nardo, amante
di Nunziante D’Agostino, e Carolina Casale, compagna del brigante Lippiello. Poiché
molte donne furono condannate al carcere,
i bambini nascevano in cattività, venivano
battezzati e affidati alla “cura della carità
ASSa, Tribunale Civile Correz. e Corte d’Assise, b. 67, fasc. 964.
ACS, Roma, Provincia. di Molise, Sottoprefettura. del Cincondario. d’Isernia, relazione sul fatto brigantesco di
Presenzano, 14 marzo 1868, f. 93.
110
Cfr.: Rest: 72.
111
“Po”: 15 marzo 1866; Duba: 276.
112
ASC, Deposizione di G. Marino alla Delegazione di P.S. in Mignano, 1865.
108
109
44
antropologia e storia
pubblica”113. I padri erano morti in combattimento o erano stati fucilati, ma la loro
ombra aleggiava in mezzo a loro: Filomena Cianciarulo partorì in carcere il suo secondo bambino, che battezzò chiamandolo
Angelantonio, come il capobanda Masini114.
Il primo bambino, partorito nel grottone
di Val d’Inferno, era stato messo al sicuro,
mandandolo in S. Spirito di Roma115.
La letteratura popolare, di norma vicina
al modo di sentire delle bande, ha interpretato secondo il proprio sistema di valori l’investimento che le donne meridionali facevano sui loro figli. Esemplare questa Ninna
nonna calabrese:
Lu sangu chi t’abbivara lu cori
è di cui si criscìu dintra la Sila;
tu fatti guappu, nsonduvè si mori,
115
116
113
114
/ 1 – donne in armi
spezza a cui avanti a tia stendi la fila.
Oh! oh! oh!
Briganteiu, ninna no’.
Si a patrita mu agguali no nsi griju,
si timisci di voscura o sordatu,
jieu di mo ti jestimu, o picciriju:
– Vipara mu ti ntossica lu hijatu.
Oh! oh! oh!
Briganteiu, ninna no’116.
Le madri del Sud erano depositarie dei
valori e dei miti collettivi alla luce dei quali
conferivano alla discendenza una plasmazione forte e violenta. Condividevano la
violenza dei maschi e dell’intera società, ma,
poiché alla maggior parte di loro era negata
l’esperienza del combattimento, “esse reagirono offrendo e sacrificando i corpi dei loro
figli, fidanzati e mariti, sui campi di batta-
Gell: 234.
Pa-R: 619; Rizz: 36; Comune di Potenza, Indici dello Stato Civile, Atto di nascita n. 125 del 6 marzo 1865; ved. Rest: 72.
“Po”: 15/3(1866.
“Il sangue che ti abbevera il cuore / è di chi è cresciuto nella Sila; / tu fatti guappo, dovunque si muore, / spezza (la
vita) a chi ti contrasta. / Oh! oh! oh! / Brigantello, ninna nonna. // Se non sei in grado di uguagliare tuo padre, /
se hai paura dei boschi o dei soldati, / sin da adesso io ti bestemmio, piccolino: / Una vipera ti possa attossicare il
fiato (l’anima)”. Il testo fu donato da Vincenzo Ammirà, poeta dialettale calabrese, a T. Papandrea, che lo pubblicò
come canto del circondario di Nicastro (Papa), insieme alla seguente ninna nonna: “Veni addurmentati / subbra
a stu sinu / la hiocca è mammata / tu puricinu / chi sutt’a l’ala / si ngrugna e sta. / O brigantuzzu / la ninna fa. //
S’occhiuzzi chiudili, / quantu sì caru! / Tutti guardatilu / già ci mbilaru, / pari lu suli / chi si ndi va. / O brigantuzzu
/ la ninna fa. // Dormi: si orfanu, / lu patri amatu / a tradimentu / t’hannu ammazzatu, / di ccà squatrigghi / sbirri
di jià. / O brigantuzzu / la ninna fà. // Vint’anni, cridimi, / no ntoccau tila; / dormia nta l’erbi / ch’avi la Sila, / pe di
chiù stessu / senza pietà. / O brigantuzzu / la ninna fà. // Crisci, vindìcalu / cà nci si figghiu / nommu si timitu /
comu conigghiu, / sperditi, dassa, / casa e città. / O brigantuzzu, la ninna fà. // Crisci: t’aspettanu / brava scupetta,
/ cervuni e zainu, / nova giacchetta, / cu lazzi d’oru, / comu si sa. / O brigantuzzu / la ninna fà. // Jiieu vorria vìvari,
/ palumbu meu, / e mu fai quantu / ti cantu jieu, / e poi mu moru, / filicità! / O brigantuzzu / la ninna fà”: ossia:
Vieni, addormentati/ su questo seno, / tua mamma è la chioccia, / tu (sei) pulcino / che sotto l’ala / si ingrugna
e sta. / O brigantuzzo / fà la nonna. // Chiudi questi occhiuzzi / – quanto sei caro! – / guardatelo tutti, / già gli si
sono velati, / pare il sole / che se ne va (tramonta. // Dormi: sei orfano, / l’amato padre / a tradimento ti hanno
ammazzato / di qua squadriglie, / sbirri di là. // Per venti anni, credimi, / non toccò lenzuola, / dormiva nell’erba
/ che ha la Sila, / per di più, / senza pietà. // Cresci, vendicalo, / perché sei suo figlio, / non esser timido / come un
coniglio, / datti alla macchia, lascia / casa e città. // Cresci: ti apettano / un valente schioppo, / il cervone e lo zaino,
/ una giacca nuova / con lacci d’oro, / come si sa. // Io vorrei vivere, / o mio colombo, / finché farai quello / che io ti
canto, / e poi (vorrei) morire, felicità!”. I due testi sono stati riproposti in Sca1: 134-36). Soprattutto il secondo testo
deve essere stato fortemente rimaggiato da Ammirà, se non è proprio una sua creazione. Entrambi i testi tuttavia,
come quasi tutta la produzione poetica di Ammirà, rispecchiano un modo di sentire diffuso, se non propriamente
brigantesco (su Ammirà e il mondo popolare cfr. Sca6). Entrambi i testi sono stati ripubblicati in Sca1: 134-36.
45
Q
uaderni
glia. Grazie a tale violenza, esse si sono guadagnate il diritto al dolore”117. Le brigantesse
appartenevano a quella minoranza alla quale
non era interdetta la partecipazione diretta
alla guerra e la condivisione operativa della
violenza, ma con esse era in larga sintonia
il mondo morale femminile delle campagne.
Anche le contadine, le braccianti, le carbonaie, le serve di casa sognavano di fare dei
figli rampolli forti e temerari, capaci di abbattere i nemici, resistere alle intemperie,
reggere la dura vita del bosco e affrontare i
soldati: sostituti dei genitori estinti o caduti,
essi dovevano garantire la continuità di uno
stile di vita, contiguo a quello del brigantaggio, di cui esse erano intensamente partecipi
e testimoni. Come è stato detto delle donne della mafia, “la nascita del figlio maschio
concede alla donna, seppur come riverbero,
una partecipazione allo splendore del principio maschile – principio dominante nella
sfera pubblica – e, contemporaneamente, le
dà la possibilità di modellarlo, di legarlo, di
renderlo dipendente e di farlo suo per interposta persona – nel privato”118.
Dei figli dei briganti nati nel carcere o
alla macchia, generati da brigantesse o da altre donne, si sono perse quasi interamente le
tracce, fin nei documenti scritti, che sono andati perduti o sono stati distrutti. Il capobanda Pietro Monaco aveva un rifugio nel territorio di Cotronei, alle pendici della Sila, nelle
grotte di Rivioti, scavate in un dirupo roccioso, pressoché inaccessibile. Qui si in contrava
con una amante, Rosa Fabiano, proprietaria
dello stesso bosco. Ancora oggi i proprietari,
discendenti di Rosa, portano come sopran Bouj: 299.
Sieb: 96.
119
Cal2: 384, 387.
117
118
46
nome “i Petramonaca”, a ricordo di Pietro
Monaco. In Cotronei risulta bruciato il registro dei nati del 1860, e la gente narra che il
libro di tale data fu bruciato perché vi erano
annotati due gemelli dichiarati nati da Rosa
Fabiano, invece i bambini erano uno, Michele, di Maria Oliverio, moglie del capobanda,
e l’altro, Pietro, di Rosa Fabiano119.
Il paragrafo I ruoli familiari è stato scritto in collaborazione con Simona Piera De Luna.
Archivi storici
ACS Archivio Centrale dello Stato, Roma.
ASA Archivio di Stato di Avellino.
ASC Archivio di Stato di Caserta.
ASCo Archivio di Stato di Cosenza.
ASI Archivio di Stato di Isernia.
ASP Archivio di Stato di Potenza.
ASS Archivio di Stato di Salerno.
AUSSME Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito, Roma. Carte descritte
in P. Crociani, Guida al Fondo Brigantaggio,
Roma, 2004.
Abbreviazioni
An = Anonimo (v. C. Melegari).
Baro = A. Barone, I briganti dei Monti Lattari,
Castellammare di Stabia, Archivio Storico
Comunale, 1986.
Bart = C. Bartolini, Il brigantaggio nello Stato
Pontificio 1860-1870, Roma, Felziani, 1897.
Bian = Q. Bianchi, Vita di Ninco Nanco, Manduria, Lacaita, 2001 (ed. or. 1903).
Bilo = V. Bilotti, Canti briganteschi di Carlopoli, in
“Calabria”, Monteleone, a. IV, n. 9, 15 maggio
1892.
antropologia e storia
Binc = A. Bianco di Saint Joroz, Il brigantaggio
alla frontiera pontificia, Cerchio, Adelmo Polla Editore, 2001.
Bi.Q = Q. Bianchi, Vita di Ninco Nanco, Manduria, Lacaita, 2001 (or. 1903).
Boja = A. Bojano, La brigantessa del Matese nel
verbale di interrogatorio del 1865, estratto
s.n.t.
Borj = J. Borjés, La mia vita tra I briganti, a cura
di T. Pedio, Manduria, Lacaita, 1964.
Bour = G. Bourelly, Il brigantaggio dal 186o al
1864, Venosa, Edizioni Osanna Venosa, 2004
(ed. or. 1865).
Bourk = J. Bourke, Le seduzioni della Guerra, tr.
it., Roma, Carrocci, 2001 (ed. or. 1999).
Brown = S. Brownmiller, Against Our Will: Men
Women and Rape, New York, Bantan, 1975.
Cal2 = S. Caligiuri, Cotronei, Reggio Calabria,
Laruffa, s.a.
Casc = F. Cascella, Il brigantaggio. Ricerche sociologiche ed antropologiche, Aversa, Noviello, 1907.
Cesa = C. Cesari, Il brigantaggio e l’opera dell’esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma, Ausonia,
1828.
Chap = G. Chapman, Milocca. Un villaggio siciliano, tr. it., Milano, Franco Angeli, 1985.
Clem = G. Clemente, Introduzione a T. La Cecilia, Brano dell’istoria del brigantaggio di Capitonata e Basilicata dal 1861 al 1864, Foggia,
Edizioni del Rosone, 2008.
DBia = G. De Biase, Brigantaggio ai piedi del Terminio, Comune di Serino, 2006.
DePo = G. De Poli, Voyage au Royaume de Naples
en 1862, Paris, Duparay, 1863.
DeB1 = A. De Blasio, Altre storie di briganti. Prove di antropologia criminale, Lecce, Capone e
Del Grifo, 2005 (ed. or. 1908).
Delu = S. De Luna, Ultima tellus. Temperamento
crimine follia nelle pagine calabresi di Lombroso e Levi Bianchini, Cava de’ Tirreni, Marlin,
2008.
DeWi = A. De Witt, Storia politico-militare del
brigantaggio nelle provincie meridionali d’Italia, Firenze, Coppini, 1884.
/ 1 – donne in armi
DiG3 = M. Di Gè, L’autobiografia di un brigante, a
cura di Gaetano Salvemini, Roma, Loescher,
1914.
Fri2 = I. Friedli, Quattro mesi fra i briganti del
Sud Italia, tr. it. in A. Caiazza, La banda
Manzo tra i briganti campani e lucani nel periodo postunitario, Napoli, Tempi Moderni,
1984.
Gell = J. Gelli, Banditi, briganti e brigantesse nel­
l’Ottocento, Firenze, Bemporad, 1931.
“Gio” = “Giornale Officiale di Napoli”, 1861-1867.
Hadd = A. e G. Haddad. Freud in Italia, tr. it., Milano, Xenia, 1996 (ed. or. 1995).
Luc2 = A. Lucarelli, Il brigantaggio politico delle
Puglie dopo il 1860, Bari, Laterza, 1946.
Mele = B. Melegari, “Briganti, arrendetevi!.” Ricordi di un vecchio bersagliere, Venosa, Osanna
Venosa, 1996 (ed. or. 1897).
Moe = W.J.C., Briganti italiani e viaggiatori inglesi, a cura di M. Merlini, tr. it., Milano, TEA,
1997 (ed. or. 1866).
Mosc = P. Moschiano, Il brigantaggio postunitario nel Vallo di Lauro, Marigliano, Pro Lauro,
1989.
Murr = E.R. Murrow, This is London, New York,
1841.
Pa-R = E. Pani-Rossi, La Basilicata, Salerno, Libri
Antichi Cassari, 1972 (ed. or. 1868).
“Po” = “Il popolo d’Italia”, 1862-1866.
“Pu” = “Il Pungolo”, 1862-1865.
Ri-L = G. Rizzo, A. La Rocca, La banda di Antonio Franco, Castrovillari, Il Coscile, 2002.
ScaDel = D. Scafoglio-S. De Luna, Le donne col
fucile. Brigantesse dell’Italia postunitaria, Università di Salerno, 2008.
Sca1 = D. Scafoglio, Terre e briganti. Il brigantaggio cantato dalle classi subalterne, Messina-Firenze, D’Anna, 1977.
Sca2 = D. Scafoglio, L’epos brigantesco popolare
nell’Italia meridionale, Salerno, Gentile, 1994.
Sca3 = D. Scafoglio, Le Cronache tra storia e romanzo, introduzione a V. Padula, Cronache
del brigantaggio in Calabria, Napoli, Athena,
1974, pp. XXIII-XXXII.
47
Q
uaderni
Sca4 = D. Scafoglio (a cura di), Racconti erotici
italiani, Roma, Meltemi, 1996.
Sieb = R. Siebert, Le donne, la mafia, Milano, Il
Saggiatore, 1997.
Tiger = L. Tiger, La ricerca del piacere, tr. it.,
Como, Lyra, 1993 (ed. or. 1992).
48
Tor1 = L. Torres, tra carabinieri a caccia di briganti nell’Abruzzo postunitario, Cerchio, Polla
Editore, 2001.
Varu = P. Varuolu, Il volto del brigante. Avvenimenti briganteschi in Basilicata, Galatina,
Congedo, 1985.
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Donne in guerra:
il brigantaggio femminile
postunitario
Simona Piera De Luna
Combattenti e fiancheggiatrici
I
l fenomeno del brigantaggio femminile postunitario rimane ancora
poco indagato, riassorbito nell’epopea del Grande brigantaggio. Di frequente le brigantesse vengono confuse con
le manutengole, che erano legate ai briganti
da rapporti di complicità: li rifornivano di
vettovaglie, armi e munizioni, li ospitavano
e nascondevano in casa propria, li tenevano
informati dei movimenti delle forze dell’ordine e di tutto ciò che poteva risultare utile
nella preparazione dei sequestri. Pur nella
coincidenza di alcune funzioni che spesso
ne confondevano i ruoli, le differenze sono,
sotto molti aspetti, radicali: le brigante vivevano nella clandestinità, (tra)vestite da uomini, nel tentativo di mimetizzarsi per non
essere identificate, mentre le manutengole
dimoravano nei paesi, di norma rispettate,
perché in grado di intercedere presso i briganti, ma anche temute, perché capaci di
compiere vendette e rappresaglie con il loro
aiuto. Nel mosaico delle motivazioni che
indussero giovani contadine indigenti ad
abbandonare il paese e la vita normale per
darsi alla macchia, non sempre è possibile
trovare una spiegazione univoca e che dia
conto, esaustivamente, del come e del perché
si diventasse guerrigliere. Pur nella cautela
metodologica che una corretta analisi del
fenomeno suggerisce, è necessario restituire
alla riflessione antropologica lo spessore culturale della scelta delle donne del Sud che,
con livelli diversi di consapevolezza, produssero una profonda lacerazione nel tessuto apparentemente compatto di un mondo semplicisticamente definito arcaico che,
invece, magmaticamente, conteneva al suo
interno i segnali del cambiamento. Le brigantesse se ne rendono interpreti: dopo aver
“saltato il fosso” della normalità, nell’altrove
interdetto dei boschi – luogo per eccellenza
di insidie, ma anche di trasformazioni prodigiose, come la narrativa popolare di tradizione orale aveva codificato – tentano la
riscrittura del proprio destino, operando un
passaggio di status, simbolicamente sancito
da un rito di iniziazione e dalla consegna
delle armi, che segna una differenza decisiva
rispetto alle manutengole. Significativamente diverso anche l’esito processuale della loro
avventura: una volta scoperte e inquisite, le
manutengole subivano condanne durissime,
come la fucilazione, perché l’aiuto prestato
49
Q
uaderni
ai briganti era interpretato come frutto di
scelte consapevoli, mentre le brigantesse,
come vedremo, pur essendosi macchiate di
azioni ritenute delittuose, che prevedevano
la morte o il carcere a vita, ebbero pene molto più lievi, perché agli occhi dei giudici esse
avevano agito in regime di costrizione. Non
sempre tuttavia le manutengole si limitavano a rifornire, informare, ospitare i briganti;
a volte, quelle dotate di più forte personalità
e intraprendenza raggiungevano segretamente le truppe brigantesche e prendevano
parte alle loro azioni di guerra e di rappresaglia, vestite da maschi. Vivevano così un
doppio ruolo: informatrici mansuete in paese ed erinni furiose alla macchia. Una volta
accolte nella banda, le brigantesse, invece,
non rientravano più nel paese, a parte qualche eccezione, dovuta al fatto di non essere
ancora state individuate come fuorilegge, o,
più raramente, in seguito a un temporaneo
ripensamento, se non a un definitivo pentimento. Era, comunque, una scelta rischiosa:
Rosa De Reo di Corano si era aggregata alla
banda Marco per seguire il proprio amante;
il 3 agosto 1865 fece ritorno in paese, ma la
Guardia Nazionale ne fu informata e la arrestò1. Il tentativo di negare la specificità della
partecipazione delle donne al brigantaggio
meridionale, all’indomani dell’unità, ha determinato, di fatto, l’assimilazione delle brigantesse alle “donne di piacere mercenarie”.
Anche se i confini in qualche caso sembrano
labili, la differenza è sostanziale: le brigantesse erano membri effettivi e stabili della
banda, pressoché cogli stessi diritti e doveri
dei maschi, mentre le donne di piacere erano
1
3
2
50
“Gio”: 1/9/1865.
Lich: 41.
Moe3: 83, 94-95, 103, 107, 214.
per lo più avventizie; la briganta, di norma,
apparteneva soltanto al proprio uomo, mentre le altre erano “a disposizione” di tutti i
maschi della banda; queste ultime erano
remunerate per le loro prestazioni sessuali,
mentre le brigantesse non percepivano denaro, se non quello derivante dalla spartizione del bottino. L’equiparazione delle brigantesse alle meretrici, che troviamo in qualche
documento, era il frutto di una confusione,
che nasceva dalla incapacità di inquadrare
un fenomeno del tutto nuovo e per molti versi destabilizzante. Per il sequestrato svizzero
Lichtensteiger le brigantesse “per lo più sono
rozze prostitute di campagna, che per libera
scelta danno via il loro onore per amore del
denaro che sperano di guadagnare, e perciò
molte di esse sfuggono anche alla giustizia.
Solo poche sono spinte nei boschi dall’amore per un brigante”2. Quelle conosciute dallo
svizzero nel maggio 1865 sono le stesse incontrate dall’inglese William Moens, sequestrato qualche mese dopo dalla stessa banda:
nelle pagine di quest’ultimo ogni brigantessa
ha il suo uomo e tutte, anche se con diverse
modalità, esprimono valori e sentimenti di
una serena normalità3.
Come si diventa brigantesse
Anche se in molti casi le donne diventarono brigantesse per stare accanto al loro
uomo, spesso esse aggiunsero alla motivazione affettiva l’attrazione per la vita brigantesca, trasformando l’avventura dell’amore
nell’amore dell’avventura. Intensi rapporti
antropologia e storia
sentimentali segnarono la vita di Giuseppina Vitale, Maria Domenica Piturro, Maria Capitanio, Filomena Pennacchio, Maddalena De Lellis, Rosa Todisco, Filomena
Di Pecora, per citarne solo alcune. Maria
Maddalena De Lellis nacque l’8 agosto 1835
a San Gregorio Matese, in Terra di Lavoro,
in una famiglia di estrema indigenza; sposò
un contadino di un paese vicino, Montorfano, dove si trasferì. Fu un matrimonio infelice. Suo marito fu arrestato con l’accusa
di brigantaggio; la donna, rimasta sola con
un figlio di sette anni e la madre semicieca, dovette provvedere alle necessità della
famiglia, con i magri guadagni provenienti
da qualche piccolo lavoro agricolo e dalla
raccolta della legna nei boschi vicini4. Nell’opinione comune era una bella giovane dal
temperamento ribelle, e i fatti dimostrarono quanto fosse vero. Nell’autunno del 1864,
incontrò nei campi il capobrigante Andrea
Santaniello, in divisa di ufficiale borbonico,
e ne rimase affascinata: “Di fisico alto, ma
con naso molto schiacciato, tanto da renderlo non proprio bello, era un uomo di 33
anni che portava i distintivi alla borbonica
(…). Indossava la divisa, ed al gilet portava
attaccata una piastra di 12 carlini d’argento
come medaglia”5. Santaniello era nato a Bracigliano, un piccolo paese del salernitano, il
28 maggio 1832. Fu soldato borbonico e con
il grado di caporale combatté al Volturno;
dopo la caduta di Gaeta seguì il re in esilio
a Roma, rimanendo legato alle organizzazioni di resistenza legittimiste. Nel marzo
1863 partì da Civitavecchia con 25 uomini
e guadagnò le montagne del Matese, per
aggregarsi al gruppo di Cosimo Giordano,
4
5
/ 1 – donne in armi
diventandone il luogotenente. Non condivideva i metodi del capo, per cui si allontanò,
per aggregarsi alla banda di Libero Albanese, ma nell’estate del 1864 ne formò una propria, cui diede una organizzazione militare
che, accanto all’abilità mostrata nel condurla
felicemente negli scontri, contribuì a fare di
lui un personaggio mitico, invulnerabile – si
affabulava – ai colpi di fucile. Maria Maddalena si mise prima al servizio del brigante
come manutengola, rifornendo la banda di
viveri e biancheria. Ma era diventata anche
la sua amante, lo raggiungeva di giorno, sui
monti, mentre la sera rientrava al villaggio.
Nel novembre del 1864, tornando da un incontro con Santaniello, fu avvisata dai vicini
di casa che i soldati la cercavano per arrestarla; Maddalena tornò indietro e si unì
alla banda. Aveva ventinove anni. Quattro
mesi dopo, nel marzo 1865, la comitiva tese
una imboscata a cinque guardie nazionali,
sequestrò ad esse i fucili e Santaniello ne
consegnò uno a Maria Maddalena, che da
allora partecipò attivamente alle azioni della
banda. L’amore per il brigante aveva fatto di
lei una manutengola, la paura della carcerazione fece della manutengola una brigantessa. Nel febbraio del 1865 il duro regime
di detenzione aveva stroncato la vita di suo
marito, e Maria Maddalena si votò completamente alla lotta armata. Il 16 aprile dello
stesso anno l’esercito circondò San Gregorio
e arrestò tutti i parenti della brigantessa, con
l’obiettivo di costringerla a costituirsi, ciò
che tuttavia non fece, ben consapevole che,
costituendosi, avrebbe potuto rischiare persino la fucilazione, senza risolvere peraltro
il problema del figlio che sarebbe rimasto,
Ferr: nov. 208, 25.
Palu: 229.
51
Q
uaderni
ancora piccolo, senza famiglia, abbandonato
a se stesso6. Rimarrà alla macchia fino a che
Santaniello non sarà ucciso a tradimento.
L’idea che le brigantesse evadessero da
situazioni familiari insostenibili era molto
diffusa tra la gente. Lo dimostra in maniera
esemplare la storia, in larga misura inventata, ma popolarmente nota, anche per merito
dei cantastorie, del passaggio alla macchia di
Filomena Pennacchio, che sarebbe diventata
brigantessa dopo aver assassinato il marito
ossessivamente geloso. In effetti non furono
pochi i casi di donne che scelsero la fuga sui
monti per spezzare rapporti coniugali assopiti nell’indifferenza o irreversibilmente
segnati dall’odio. Nel 1862 la Guardia Nazionale di Rapolla fucilò una donna che aveva
fatto uccidere suo marito da un brigante per
seguire quest’ultimo7. Come vedremo, solo
raramente le forze dell’ordine passavano per
le armi le brigantesse; evidentemente, alla
luce dei casi qui brevemente esaminati, il
tradimento coniugale che disonorava il marito, specie se associato al delitto, era considerato un’aggravante che giustificava un
intervento di giustizia sommaria, sulla base
dell’indignazione del momento: nel 1869,
nell’area di Vasto e Lanciano, viene colpita
una brigantessa, Vittoria Di Giovanni, sposata Polidori, che era diventata amante di
un brigante, fucilato accanto a lei. La donna,
“abbenché ferita mortalmente nel viso e nel
corpo, non volle svincolarsi dal suo amato in
quella mezz’ora che ancora gli restò di vita”8.
8
9
Analoga dovette essere la storia di Maria
Carmina Valente, di Cusano, brigantessa del
Matese, che, sposata a Pasquale Pecoraro, fu
l’amante del brigante Gerardo Autunnale,
disertore dell’esercito italiano9. Nell’ottobre
1861, a Pagani, Lucia Pepe lasciò il marito
Salvatore D’Avino per fuggire col brigante
Agostino Visconti10. Non è del tutto fondata
l’idea secondo cui le motivazioni di ordine
sociale e politico furono estranee alla scelta di diventare brigantesse. Angela Maria
Consiglio, giovane donna, nata a Rionero
in Vulture nel 1834, aveva sposato un bracciante, Francesco Tardugno, detto Bomba,
ed entrambi, dopo avere vanamente sperato
dalla rivoluzione liberale il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini, si
aggregarono alla banda Crocco nell’aprile
1861 e poi ad altre bande a lui collegate11.
Da Ruvo del Monte proveniva Elisabetta
Blasucci, nata nel 1834, madre di quattro
figli, bracciante, con piccoli reati alle spalle. Suo marito, dopo la delusione dei primi
anni sessanta, si diede alla macchia, ma fu
presto preso e fucilato. Fu allora che Elisabetta, per vendicarlo, ne sposò la causa e si
aggregò alla banda di Pio Masiello. La più
politicizzata delle brigantesse fu forse Cherubina Di Pierro (o Pierro): nata a Ferrandina nel 1826, dopo l’unificazione organizzò
la banda dei Ferrandinesi, aggregandosi alle
bande di Stancone, Egidione, Cappuccino,
ma conservando una sua autonomia. La si
vedeva cavalcare sola, per le campagne, a
Ferr: genn. 209, p. 21.
Ved. Sca-Del: 10.
AUSSME, b. 134, fasc. 5, c. 80.
ACS, Roma, c. 37, processo n. 27 contro Maria Valente e altri, deposizione del Settembrini del 10 maggio 1864 al
Trib. Mil. di Guerra di Caserta.
10
Tra: 111-12.
11
Sca-Del: 12-13; Varu: 206-07.
6
7
52
antropologia e storia
fare proseliti, inneggiando a Francesco II12.
Non sappiamo quanto pesasse la fede legittimista nella scelta di non poche donne di
prendere parte alla guerriglia brigantesca,
dopo aver partecipato alle rivolte contadine
degli anni 1860-1861. Questi casi sottolineano la continuità, che spesso ci fu, tra le insurrezioni popolari e il brigantaggio. Beatrice
Martinelli fu tra gli “insorgenti” dei fatti di
Melfi nell’aprile del 1860, prima di aggregarsi
alla banda Coppa. Carmela Di Genova, nata
a Ripacandida nel 1833, partecipò ai moti
legittimisti del 1861, poi raggiunse alla macchia il marito Michele Di Biase. Era madre di
due figli. In uno scontro a fuoco del 9 gennaio 1862 i soldati, dopo aver ucciso il marito,
fucilarono anche lei, mentre la conducevano
prigioniera in paese13.
Il carcere, pozzo senza fondo
Non mancarono, dunque, le motivazioni
politiche, sia pure mescolate ad altre ragioni.
In Francavilla Sinnica viveva la famiglia Ciminelli, piccoli massari che godevano di un
minimo di benessere, filoborbonici, rimasti
tali anche dopo il 1860 e per questo invisi in
paese. Ma fu l’unificazione nazionale a sconvolgere la loro vita: il cugino Antonio Franco
si dà alla macchia, diventando in breve il più
celebre capobanda del territorio, e i Ciminelli diventano i suoi manutengoli; il capofamiglia è arrestato il 9 giugno 1862, perché
trovato nel luogo in cui era stato sequestrato
e ucciso un possidente; il 15 settembre 1863
è arrestata e condannata a 10 anni anche la
/ 1 – donne in armi
moglie dopo che, su indicazione di un delatore, in un’aia vicina alla sua masseria viene
dissotterrata una cassa contenente gioielli,
stoffe e una carabina, un “tesoretto” consegnatole da Franco; la donna dopo l’arresto
fu processata ed assolta, perché, secondo i
giudici, “miserabile sventurata”, aveva subito
la “pressione morale” della famiglia, ma in
seconda istanza viene condannata ai lavori
forzati a vita, successivamente ridotti a 10
anni. Dopo questi fatti era diventato difficile per la famiglia Ciminelli vivere in paese. Ne soffre la figlia Mariateresa, nata il 14
agosto 1841, sposata al contadino Vincenzo
Mainieri: una giovane donna “di statura giusta, fronte alta, occhi cervini, bocca giusta,
capelli neri, sopracciglia nere, viso tondo,
colorito naturale”, che lavorava nei campi
e d’inverno faceva la filatrice. Più piccola e
delicata, quasi una bambina, Serafina, nata
il 5 febbraio 1844, è innamorata, riamata, di
Franco. Le due sorelle diventano latitanti,
abbandonando il paese dove la già precaria esistenza era diventata insopportabile,
avvelenata da pettegolezzi ingiuriosi per lo
più alimentati da gelosie e rancori pregressi.
Nella banda le due donne indossano i pantaloni, come tutte le brigantesse, e “persino”
(così si disse) gli stivali che, nell’immaginario collettivo, rappresentavano un tipo di
calzatura prettamente maschile, al punto che
il particolare che a farne uso fossero anche
le donne venne ritenuto dai cronisti degno
di menzione14. Le segue il fratello diciassettenne Fiore, mentre l’altro fratello, Lattanzio,
è arrestato perché sospettato di connivenza
con i briganti. È dato per certo che Serafi-
Roma: 108.
DiCu: 68, 187.
14
In Ri-L: 373, 409.
12
13
53
Q
uaderni
na abbia aderito al brigantaggio soprattutto
per amore, ma la gente è convinta che anche Mariateresa sia la druda del brigante15.
Dirà in tribunale che è stata colpa dei paesani a farla associare a Franco”16. Giuseppe
Antonio Franco era nato l’8 ottobre 1832 a
Francavilla in Sinni (PZ), un paesino di scarse risorse, popolato di braccianti disperati e
di contadini poveri. Ancora piccolo, va a lavorare nei paesi vicini come forese e come
pastore, al servizio di possidenti locali. Tra
il 1855 e il 1857 va sotto le armi e diventa
caporale. Sciolto l’esercito borbonico a metà
del 1860, torna al suo paese, in una “casa povera e vuota di tutto”: è un ex soldato sbandato di un esercito sconfitto e non amato dai
vincitori; chiede di essere arruolato nelle file
sabaude, ma, per motivi non chiari, non ci
riesce. Lo troviamo, subito dopo, “forbandito”, insieme ai primi briganti, anch’essi, per lo
più, soldati sbandati, che lo designano capo.
In parecchi casi, anche in presenza di una
concomitanza di motivazioni, per le donne
era la paura di essere arrestate come complici la spinta decisiva a fuggire dal paese. In
virtù della legge Pica, quelle che avevano o
erano sospettate di avere qualche legame con
le bande potevano essere imprigionate senza un’accusa specifica, allo scopo di isolare i
briganti, costringendoli a costituirsi. Ma nel
Meridione postunitario era opinione comune che “uno, una volta in carcere, è perduto”17. I manutengoli, individuati come tali,
temevano “come tutti i rozzi napoletani, di
17
18
19
20
15
16
54
finire in carcere, dal quale pensava[no] che
una volta entrat[i] non sarebbe[ro] più uscit[i]”18. A Napoli, durante un’irruzione della
polizia nella casa di un prete, in cui si arruolavano legittimisti, si scoprì una ragazza
nascosta sotto il letto, la quale fu costretta a
raccontare tutto, “per non essere gettata nelle carceri delle prostitute”19. In molti casi fu
questa la ragione, finora rimasta incomprensibile, per cui le donne, “se dapprima parteciparono alla lotta come favoreggiatrici, diventarono esse stesse in seguito – tra il 1863 ed
il 1864 – brigantesse accanto ai loro mariti,
amanti, fratelli, figli”20. Ed è questa la storia,
per esempio, di Angela Cotugno, Michelina
Di Cesare, Carolina Casale, Giuseppina Vitale, Filomena Miraglia, Maria Folino.
L’orrore e la vergogna della detenzione
motivarono l’adesione alla lotta armata di
altre giovani donne che, macchiatesi di colpe anche non gravi, credettero di scegliere il
male minore, per evitarne uno devastante.
La prospettiva della carcerazione le terrorizzava non tanto per la misura restrittiva
cui sarebbero state sottoposte, quanto per
le molestie sessuali – fino al limite estremo
dello stupro – che, impunemente, durante
la reclusione venivano esercitate su di esse.
Non di rado le donne delinquevano per motivi passionali o di onore: Filomena Soprano
uccise per amore Giuseppe Desiderio; pur
di non essere arrestata, abbandonò il paese
per rifugiarsi nei boschi del chietino dove,
ormai briganta, divenne la compagna del
ASP, Proc. di Val. Stor., cart. 328, 2; ACS, Roma, Trib. Mil. Str., b. 178, fasc. 2083-84.
In Ri-L: 354.
Frie: 133.
Frie: 172.
Monn: 54.
DiTe: 209.
antropologia e storia
capobanda D’Alena21. Il carcere non era solo
prospettiva terrorizzante di diritti negati, ma
anche ricordo lacerante della prevaricazione
innalzata a sistema, la ferita non rimarginata
di abusi reiterati, che segnavano irreversibilmente tanto gli uomini quanto le donne22,
al punto che, usciti di prigione, essi prendevano la via del brigantaggio. Se non poche
brigantesse diventarono tali per l’effetto devastante della carcerazione subita, lo stesso
accadeva normalmente per gli uomini:
Hue carceratu ch’ammazzai nu cane;
giustizia de lu celu, quandu vene?
Sett’anni mi ci stetti senza pane,
vattutu e rruinatu ntra le pene.
Ma nun cce caiu cchiù, no, ppe demane,
ccà duve signu mi truovu bene;
vuogliu morire ccà cuomu nu cane,
handu giustizia ad autru ed a mie bene23.
Lo stupro, è inoltre oscuramente percepito dalle donne come la colpa infamante di
chi lo subisce, al punto che esse da sempre,
vergognandosene, non lo denunciano, rendendosi complici dei loro violentatori. Lo
stigma sociale ostracizzante le marchiava
come disonorate, facendone “donne perdute”
si delinea così l’itinerario obbligato che portava alla scelta riparatrice della fuga nei boschi e l’assunzione dell’identità di briganta tra
i briganti. Meglio briganta che donna violata:
trova così spiegazione la storia di Teresa, una
giovane della Valle del Liri: il suo fidanzato
/ 1 – donne in armi
si era fatto brigante sulle montagne di Sora;
una sera fu sorpresa da una pattuglia mentre
si recava a portargli cibo e biancheria; il comandante le promise di ignorare il fatto, in
cambio di favori sessuali, lei lo colpì a morte
con una falce e scappò; i soldati spararono,
spezzandole il braccio sinistro, ma Teresa
raggiunse il suo uomo e rimase con lui24.
Un dato interessante, emerso dai documenti di archivio, consente di aggiungere
l’ultima tessera al mosaico delle motivazioni
che spinsero le donne ad aggregarsi alle comitive. Non mancano i casi in cui l’ingiusta
restrizione della libertà favorisce un processo
di maturazione, che al sentimento della vergogna sostituisce un più consapevole rifiuto
del sistema del ricatto istituzionalizzato. È
una generosa testimonianza di disobbedienza la scelta di quante, nel rifiuto di protezioni
e favori che sarebbero stati loro accordati in
cambio di delazioni, seppero non prestarsi
all’iniquo patteggiamento: una spia, assoldata dalle forze dell’ordine per ottenere le confidenze delle detenute, riferì che tale Maria,
amante del brigante Ricco, detenuta “senza
colpa alcuna”, a onta dell’ingiustizia subita,
aveva manifestato la ferma intenzione di farsi
brigantessa appena tornata libera25.
Il rito di iniziazione. Rivestirsi e travestirsi
Al loro ingresso nella banda le donne abbandonano i vestiti di contadine, vestono gli
Tor: 150.
Vedine alcune impressionanti testimonianze in Padu: 146.
23
“Sono stato carcerato perché ho ammazzato un cane, / quando verrà la giustizia del cielo? / Sette anni sono stato
in carcere senza pane, / battuto e rovinato in mezzo alle pene. / Ma non ci cascherò più in futuro, / ché dove sono
mi trovo bene; / voglio morire qui come un cane, / facendo giustizia ad altri e a me bene” (canto brigantesco, pubblicato in Sca: 137).
24
Zimm: 70-71.
25
ASS, Prefettura, Gab., b. 54, f. 405, telegramma, 1868.
21
22
55
Q
uaderni
abiti dei maschi e si tagliano i capelli, prima
di ricevere le armi e il cavallo, come i briganti maschi. Abbiamo anche qualche traccia
di rituali di giuramento. Questi comportamenti si registrano, a parte qualche variabile
individuale o locale, in quasi tutte le aggregazioni femminili alle bande, il che induce a
pensare che essi fossero previsti e prescritti.
Il rito segna il passaggio da donna comune
a brigantessa, consegna all’iniziata un bagaglio di conoscenze, regole e certezze attraverso un linguaggio di gesti ed azioni dotati
di grande valore emozionale. La donna viene
integrata nel gruppo con un conseguente acquisto di rispetto, protezione e sicurezza, ma
al tempo stesso il rito definisce l’appartenenza alla banda in maniera definiva e irreversibile. Soprattutto nelle bande meno piccole,
in cui non basta la parentela, l’amicizia e la
conoscenza reciproca a cementare il gruppo,
l’efficacia simbolica del rito si rivela decisiva
per il compattamento delle comitive, assicurando l’assimilazione dell’elemento maschile
e di quello femminile.
Il rito è segreto, nel senso che si svolge
all’interno della comitiva brigantesca e non
è reso noto agli estranei. È, come vedremo,
un travestimento, che assicura la “scomparsa”
della donna all’esterno della banda e, all’interno, la sua identificazione (che è in parte confusione) con il gruppo dei briganti maschi.
La documentazione esistente non ci consente di generalizzare l’uso, presente in molte
bande, di cambiare o modificare i nomi delle
brigantesse al momento dell’iniziazione: a
Mariuccia Andreoli i compagni, dopo averla
vestita da ragazzo, imposero il nome Coluccio; Maria Oliverio ebbe come soprannome
Ciccilla e Maria Domenica Piturro era nota
come Cicillo, maschile. Questa rinominazione conferma che le intenzioni dei briganti
non erano quelle di semplicemente vestire,
ma travestire le donne da maschi. I nomi
però venivano cambiati o modificati anche
per motivi di sicurezza e per confondere le
forze dell’ordine. Non a caso il più delle volte
è il cognome ad essere alterato: Piturro veniva trascritta nei documenti ufficiali come
“Veturra”, “Vitorre”, “Petulli”, e non si trattava semplicemente di errori di trascrizione,
come talvolta accadeva26.
Non abbiamo prove dirette che le brigantesse facessero il giuramento durante il
rito di iniziazione, ma è legittimo ipotizzare
che, come membri della banda a pieno diritto, anch’esse dovessero farlo, come i maschi,
almeno nelle bande in cui il giuramento era
previsto: a chi si associava alla sua piccola
banda, Giacomo Parra ordinava: “Prima di
avere la nomina effettiva di brigante, dovete
profferire il giuramento di fedeltà ai vostri
soci, sottoporvi a tutti i servizi necessari a
dimostrare l’attitudine e il coraggio che si
richiedono ad un bandito”. Chi aderiva alla
banda del Sergente Romano, che contava oltre 200 uomini, doveva giurare fedeltà alla
monarchia borbonica e alla religione cattolica. È difficile pensare che le donne fossero
esentate da questo rito, che sacralizzava la
loro appartenenza alla banda27.
Il vestito delle brigantesse del periodo
postunitario è pressoché identico a quello
degli uomini. Portano l’abito maschile: camicia, giacca, cappello per lo più “alla calabrese” o foulard (più raramente, berretto),
scialle, stivali o scarpe. Tutto solitamente di
Per queste notizie ved. spec. ASP, Tribunale di Guerra di Bari, Atto d’Accusa, fasc. 4; Rest: 161, n. 6.
Per il rito del giuramento ved. DiBi in Chie: 192; per il Sergente Romano ved. Luc1: 118 e passim.
26
27
56
antropologia e storia
buona fattura e di qualità, ad imitazione dei
vestiti dei signori. Una fonte preziosa per la
ricostruzione dell’abbigliamento delle brigantesse potevano essere i ritratti eseguiti
dai fotografi dopo il loro arresto. Risultano,
invece, largamente inaffidabili. Per ragioni
diverse i militari e/o i fotografi assicurarono
alle brigantesse catturate, in attesa di essere
fotografate, un abbigliamento convenzionale e sfarzoso: le donne portano “una veste
lunga fino ai piedi (di tela o di pannetto),
col sovrastante sinàle o vantesìno fin sopra
le ginocchia, la giacca corta detta juppone, la
camicia bianca col giracollo merlettato che
cade sul petto, le calze bianche e le scarpette di cuoio. Sul capo portano un fazzoletto,
una specie di sciarpa rovesciata sul collo,
nella Calabria cosentina detta u mende. Sarà
necessario, pertanto, servirsi di altre fonti,
documentali, artistiche e letterarie, tenendo
conto della specificità dei loro linguaggi.
L’elemento assolutamente nuovo per una
donna contadina sono i pantaloni, gli stessi dei compagni maschi. L’uso rispondeva a
una esigenza di ordine pratico, dal momento che per andare a cavallo era più comodo
se non necessario per una donna portare i
calzoni, in modo da cavalcare meglio e coperta. Dei pochi particolari che differenziano il vestito femminile da quello maschile
i più notevoli sono il corsetto e uno strano
/ 1 – donne in armi
gonnellino, per di più di seta, o una semplice
gonna per lo più corta, che si portano sopra
i pantaloni: un elemento minimo per distinguere agli occhi dei briganti stessi le donne
dagli uomini. Filomena Pennacchio cavalcava portando sopra i pantaloni una gonna
bianca. La documentazione fotografica conferma questo significativo dettaglio, che si
ritrova in altre donne delle bande28.
Le brigantesse, lasciate le calzature contadine, si abituavano presto a portare quelle
dei signori. La loro aspirazione più grande
era calzare buoni stivali. Con eleganti stivaletti che chiudono i pantaloni è rappresentata Maria Oliverio nelle fotografie pubblicate
sui giornali dell’epoca, e per gli stivali alti
era notata un’altra importante brigantessa,
Maria Domenica Piturro29. Portare in ogni
circostanza gli stivali non si addiceva alla
condizione della donna, né tanto meno al
suo stato di contadina, ed era perciò una
scelta doppiamente trasgressiva, che rappresentava un segno distintivo di appartenenza alle bande, utilizzato dalla gente come
un elemento per identificare le brigantesse:
Mariateresa Ciminelli in occasione di un
sequestro fu riconosciuta come brigantessa
da un testimone perché “era stata vista con
gli stivali, quindi faceva parte della banda”30.
Per i briganti e le brigantesse gli stivali erano
uno dei massimi titoli di nobiltà che si potes-
L’inglese Moens, che fu prigioniero del capobrigante Manzo per 102 giorni, ha lasciato informazioni preziose sulla
vita quotidiana della banda: le brigantesse vestivano come i briganti, “l’unica differenza nel loro abbigliamento era
costituita da certi piccoli indumenti senza stecche d’osso, che, credo, le signore chiamino corsetti” (Moe: 76). Per il
gonnellino di seta, ved. Bour: 258, che ricorda Antonietta Laratro, quindicenne che Tortora rapì, fece vestire di un
gonnellino di seta nera sui pantaloni e ornò di gioielli. Filomena Pennacchio incitava i suoi briganti alla battaglia,
“in gonnella bianca e sopra un cavallo” (DiTe: 192). Delle donne fotografate Maria Lucia Di Nella porta una gonna
sopra i pantaloni.
29
“Pou”: 5/3/1886. Una briganta lucana, forse la Piturro, fu vista nella banda di Egidione con stivali lunghi, vestita da
uomo, cappello alla calabrese; gli uomini portano vestiti di velluto” (ASP, Atti e Proc. di Val. Stor., cartella n. 363/3;
cfr. Varu: 64).
30
Ri-L: 231, 337.
28
57
Q
uaderni
se conquistare, in quanto segni di appartenenza oltre che di sfida ai ceti superiori: “Io
dovevo la mia ‘nobiltà’ ai miei stivali”, racconta il sequestrato Lichtensteiger31, sapendo quanto fossero apprezzati e concupiti dai
briganti suoi carcerieri.
Il vestito dei briganti maschi e femmine
nella sua concezione di base è il vestito contadino locale, impreziosito, quando i mezzi
finanziari delle bande lo consentivano, da elementi del costume borghese e signorile, con
l’aggiunta stravaganze folkloriche e di elementi delle divise militari. La relativa uniformità,
insieme a questi ultimi elementi, facevano
dell’abbigliamento brigantesco qualcosa che
somigliava a una divisa. Ma l’abbigliamento
delle brigantesse presentava una maggiore
complessità di quello dei maschi, essendo divisa e mascheramento al tempo stesso.
Le brigantesse dovevano recidersi i capelli e in qualche caso li legavano e nascondevano dentro il cappello. I capelli lunghi
costituivano un problema per chi doveva
muoversi tra alberi e sterpi, attraversare
siepi, cavalcare, fuggire per i boschi, usare
le armi, ed andavano necessariamente accorciati. Ma il taglio dei capelli delle donne
all’interno del rito dell’iniziazione acquistava una efficacia simbolica che andava probabilmente anche al di là delle intenzioni
dei briganti: nella società tradizionale esso
è vissuto come una limitazione delle forze
istintive che nella testa hanno la loro sede
privilegiata: si tagliavano i capelli nelle prigioni, nei monasteri, negli eserciti, come segno di sottomissione volontaria o coatta; nel
nostro caso può avere avuto il significato più
o meno consapevole di accettazione delle regole comuni, nel momento in cui si entrava
nell’esercito dei briganti.
Ma la pratica era quasi certamente legata
al bisogno di esorcizzare l’idea (o il rischio)
della provocazione sessuale, quella che emana dalla suggestione della capigliatura abbondante, scomposta e fluente, la stessa idea
che si ritrova nell’obbligo per le donne di coprire la testa all’ingresso nella chiesa o nei
luoghi sacri. Il taglio dei capelli è il primo
degli atti miranti alla deminutio della femminilità (nel caso specifico, nella sfera sessuale) a vantaggio della mascolinizzazione
della donna. Nelle società che non si reggevano su regolamenti scritti, questi gesti simbolici acquistavano una rilevanza notevole e
conferivano all’iniziazione gli elementi fondamentali dei riti di passaggio32.
In aggiunta brigantesse e briganti portavano un “abitino” apotropaico, di solito
regalato ad essi dai preti filoborbonici o preparato in famiglia33. Sul bavero o sui polsi
Lich: 59.
Sul taglio dei capelli tutte le fonti concordano, non solo quelle archivistiche (per esempio, Luc1: 92). Rosa Martinelli si tagliò i capelli, vestì indumenti maschili e si pose in testa un berretto (Luc1: 96; Bour: 88). Moens tra i
suoi sequestratori riconobbe cinque brigantesse “con i capelli molto corti” (Moe3: 76). Maria Lucia Di Nella (o
Dinella), quando entrò nella banda si tagliò le trecce e vestì da brigantessa; Maria Giantommaso, rapita dalla banda
di Nunzio Di Paolo, fu costretta a tagliarsi i capelli e a vestire un abito maschile (DeBl 28).
33
Padu: 26. Sull’“abitino” o “sacchetto” ved. Sc-De: 87: era “di stoffa rosa (per il sesso femminile) o rossa, spesso a
forma di cuore. Quando la stoffa è nera, simboleggia l’abito della Madonna. Questi contenitori vengono riempiti
da alcune anziane o dai preti o dai monaci del paese di ingredienti antifascino, che possono essere: sale (spesso solo
tre acini o tre pizzichi); sabbia del mare; spilli; incenso; santini a cui si è devoti; triangoli di velluto nero o rosso;
foglie di palma benedetta; tre pezzettini di foglie di ulivo benedette il venerdì santo; paglia delle sedie intrecciata
in forma di croce; foglie o semi di piante anti-fascino; l’erba di muro; pietruzze di crocevia; tre pietre, una per ogni
31
32
58
antropologia e storia
della giacca venivano invece cucite le figurine dei santi, che di solito erano quelli del
proprio paese. Si portavano addosso anche
amuleti benedetti dal papa o dal re. Talismani, immagini e oggetti sacri proteggevano
dai proiettili e dalle sciabolate, e davano la
speranza se non la certezza dell’invulnerabilità o almeno della protezione divina. Tutte
le bande dell’Italia meridionale si consideravano sotto la protezione della Madonna.
Anche se questo elemento magico-religioso
nel brigantaggio meridionale non fu importante e incisivo come in quello dei banditi
del Nordeste brasiliano o dell’Indonesia34,
esso era costantemente presente, e conferiva
forza alle bande, convincendole di stare dalla parte di Dio.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalle brigantesse dopo la cattura e da altri loro racconti risulta che sia il vestito maschile che
il taglio dei capelli era imposto dai maschi,
o per lo meno era nelle regole non scritte
delle bande: “fui vestita da uomo – racconta
Sceppella, come tante altre – e mi si tagliarono i capelli”35. Generalmente le brigantesse
prigioniere tendevano ad alleggerire le loro
responsabilità, il che non implica che fossero
sempre del tutto menzognere.
La donne che sceglievano o erano costrette a scegliere la vita brigantesca non
erano donne qualsiasi, oggetto di semplice
predazione: erano donne amate o molto desiderate, ed i briganti curavano molto il loro
36
37
38
34
35
/ 1 – donne in armi
abbigliamento, sia quando esse dismettevano il vestito brigantesco, nelle più tranquille
dimore dei manutengoli, lontane dalle bande e dai combattimenti, sia nei rifugi dei boschi e delle grotte, a cominciare dal momento in cui esse si spogliavano per indossare
l’abito maschile. Perché “la vera sensibilità
erotica, evocando l’immagine della donna, non manca mai di abbigliarla: vestirsi e
spogliarsi, ecco il vero fulcro dell’amore”36.
Tuttavia un singolare senso del pudore, radicato nelle consuetudini familiari dello stile
di vita contadino, impone ai briganti maschi
il rispetto della privacy femminile: essi di solito non assistono alla svestizione/vestizione
delle donne, e, quando è possibile, affidano
alle altre donne della banda il compito di accudire nell’operazione la nuova venuta o si
fanno aiutare da esse nel vestirla: come nei
rituali di nozze. Isabella Caramuta, dopo
che viene posseduta da Francesco Franzese,
è fatta spogliare dei suoi abiti dalla brigantessa Porzia Montanaro, che le dà un vestito da uomo37. Analoga, ma non identica, la
vestizione Maria Giuseppa De Meo: dopo
averla portata via, consenziente, da casa,
durante una sosta, “Fuoco mi fece spogliare
– racconta – dell’abito donnesco, facendomi
vestire da uomo, che egli stesso mi somministrò, aiutandomi all’uopo e facendomi coraggio la druda di Cannone”38.
Il nuovo abbigliamento attestava visivamente la promozione sociale garantita dal
strada, se si tratta di un trivio; pietruzze di mulino, di solito tre; pezzi di corda di campana, di norma tre; cuoricini
rossi che si vendono a Natale; i capelli di qualcuno nato a gennaio, contro cui, notoriamente, nulla può il fascino;
soldini, ec. Tutto in varie combinazioni, e secondo gli usi e le risorse locali e personali”.
Hob2: 46.
DiBi in Chie: 188.
Mach: 81.
ASP, Atti e Processi di Valore Storico, cartella n. 282/18.
ASI, Atti di Polizia, Brigantaffio 1867, gennaio-dicembre, b. 6, fasc. Brigantaggio del mese di aprile.
59
Q
uaderni
brigantaggio, e non poteva non produrre un
notevole effetto sulla mentalità e l’immaginario delle genti delle campagne, a giudicare
dall’attenzione che ad esso tutti gli osservatori del tempo dedicavano. I vestiti delle brigantesse dovevano risultare fastosi al
confronto con i miseri panni di cui si erano
liberate. Mariuccia Andreoli, contadina ventenne poverissima, prima di diventare brigantessa portava “una veste di lanetta bianca
con fiori, due sottanini, un fazzoletto bianco
per la testa, ed un grembiale”39. Nella foto di
gruppo della banda Ciardullo in cui compare
Agnese Percuoco col marito Vincenzo Letteriello, la donna non è vestita da brigantessa
(la sua è una delle pochissime foto delle brigantesse senza il mascheramento e la messa
in posa teatrale voluta dai fotografi e dai militari) e porta il vestito povero e il copricapo
delle contadine dell’area di Campagna.
Le brigantesse erano le compagne dei
capi, i quali portavano abiti con maggiori
pretese rispetto a quelli dei gregari, ed erano perciò vestite in maniera più accurata dei
briganti comuni, amavano le stoffe pregiate
e portavano gioielli. Il nuovo vestito diceva
non solo l’affrancamento dalla povertà e dal
bisogno, ma anche il nuovo ruolo sociale, la
condizione privilegiata all’interno della banda. Per i briganti i vestiti di lusso, insieme
ai non infrequenti pranzi da signori, erano i
fondamentali beni ostentatori, che segnalavano il cambiamento delle condizioni di vita
e del ruolo sociale, e non urtavano la sensibilità della gente comune, che leggeva in essi
41
42
39
40
60
i segni del potere e della forza della banda.
D’altra parte la banda è una piccola società
meritocratica, portata a premiare i capi, di
cui si riconoscono capacità e valore, e da cui
dipende la vita di tutti.
Alcune descrizioni conservate nelle carte
processuali attestano ampiamente la qualità
del vestiario e della biancheria delle brigantesse: Maria Giovanna Tito consegnò alla
famiglia del manutengolo Raho “una vesta
(sic) di seta di colore d’arancio, e un paio di
scarpe di seta, ed un altro paio di vitello inverniciate, una gonnella di castoro e lo specero (?) pure di castoro nero, quattro camicie di muscolina da donna, tre paia calzate,
due di lana, e l’altro di filo, e un grembiale di
cotone, quattro fazzoletti, e due salviette”40.
Nel vestito delle brigantesse si possono
anche registrare differenze locali, che rappresentano una sottolineatura del carattere
territoriale delle bande: Rosa Cedrone, che
operava nell’area di Sonnino (LT), quando fu uccisa in combattimento il 7 febbraio 1866 era “vestita da uomo, con ciocie e
stringhe alla regnicola, calzoni di mezza lana
color tabacco, fascia rossa alla cinta, gilé con
ventriera per cariche, giacchetto di mezza lana, camicia da donna, maglia di lana,
cappello alla come ci pare, due anelli d’oro”41. Meno etnicamente connotato il vestito
della brigantessa della Sila, Maria Oliverio,
che portava “gilé di panno a colore, giacca
e pantaloni lunghi di panno nero e il capo
avvolto in un fazzoletto”42. Cherubina Di
Pierro indossava pantaloni bianchi, cappello
DeLu: 31.
Sang: 179-80.
ASFr, Direzione di Polizia, Malviventi e briganti, miscellanea b. 301, f. 713.
Roma: 142. Maria Oliverio nelle fotografie porta il cappello conico dei briganti, ma le brigantesse prigioniere di
solito venivano fatte rivestire e mettere in posa dai militari e dai fotografi.
antropologia e storia
con fettucce di velluto nero e braccialetti di
ferro43. Maria Domenica Piturro portava il
solito cappello “calabrese”44. Una misteriosa
e avvenente Caterina, che combattè l’8 aprile
1862 a Lucera (FG), “vestiva una giubba di
velluto nero, calzoni bleu con fascia bianca,
e un turbante in testa”45.
La vestizione/travestimento delle donne era una regola normalmente seguita, ma
non drasticamente applicata. Maria Rosa
Marinelli pare abbia ottenuto di non indossare abiti maschili, metteva sempre un fazzoletto sul capo e portava armi solo quando
non poteva farne a meno46: lo faceva per non
sacrificare la sua avvenente femminilità, che
affascinava i briganti, i quali in non pochi
casi mostrarono di assecondare i capricci e
la vanità delle loro donne. Per questo motivo
alcune brigantesse non si tagliarono i capelli,
e curarono la loro capigliatura abbondante e
folta, che però potevano nascondere sotto il
cappello brigantesco. Non è provata l’ipotesi
che questo servisse a “far passare attraverso
le perquisizioni messaggi compromettenti
chiusi in rotolini di carta nascosti fra i riccioli”. C’era poi chi, come Maria Domenica
Piturro, alternava vestiti femminili a maschili, o come Carolina Casale, che – dichiarò in tribunale – quando era vestita da
uomo, non portava armi, anche se riesce difficile crederle. Mariuccia Andreoli, appena
/ 1 – donne in armi
ventenne, considerata non troppo affidabile,
fu fatta vestire da uomo giovane con “maglia
di flanella a guisa di casacca, calzoni di cotone grigio, scarpe piuttosto sottili e cappello
basso alla contadina”47.
La consegna delle armi e del cavallo
Come si dimostra in un altro studio di
questa rivista, la presenza nelle bande di
donne combattenti era in parte vissuta come
una minaccia per l’identità maschile e per
l’idea che la sorreggeva, del combattimento
come prerogativa del maschio e dimostrazione radicale della sua virilità. “Lo spettro
delle donne combattenti ossessionava molti
uomini e minacciava dal punto di vista fisico
e militare la loro idea di virilità. Se vederle in
uniforme era teoricamente castrante, si può
immaginare che effetto provocassero le donne con le armi”48.
Le donne che entravano a far parte della
banda venivano armate di fucile con bandoliera, pistola e pugnale, come i maschi.
Anche a proposito delle armi le descrizioni
degli scrittori militari sono le più attendibili,
insieme ai verbali degli arresti o del bottino:
l’arma principale dei briganti è costituita dal
fucile, che di solito è una schioppetta a due
canne o una carabina a percussione, spesso
45
46
Roma: 108.
ASP, Atti e Processi di Valore Storico, cartella n. 363/3.
“Pu”: 12/4/1862
Poli: 15-16; ASP, Corte di Ass. di Potenza, Proc. 1861- 1902, cartella n. 432/72, interrog. di M.R. Marinelli. Le
notizie concernenti la Marinelli fornite durante il processo dall’avvocato difensore e da testimoni compiacenti non
sono del tutto affidabili; che la Marinelli portasse armi è attestato inequivocabilmente da altri testimoni.
47
Per queste notizie ved. ACS, Roma, Trib. Mil. di Guerra per la Repr. del Brig., b. 17 (Chieti), fasc. 1326 (1864);
ASP, Tribunale di Guerra di Bari, Atto d’accusa, fasc. 1; ASC, Tribunale civile e correzionale di Napoli, Verbale di
querela o denuncia orale, Mignano, 12, marzo 1868, fasc. 14.
48
Bourk: 295.
43
44
61
Q
uaderni
egregiamente intarsiate, che portano a tracolla o tengono appesa al fianco destro del
cavallo; la cartucciera, contenente da 32 a 64
colpi, stretta alla cintola “ad uso di giberna”,
assicura un pugnale lungo, somigliante a un
coltellaccio, e una pistola. Tuttavia, se alcuni
hanno fucili eccellenti, un numero inferiore dispone soltanto di “pessimi fucili ad una
canna di corta portata”49.
Michelina Di Cesare seguiva il capobanda Guerra “armata di un due colpi mozzato”,
oltre che di pistola. Alcune brigantesse compaiono in alcune occasioni armate di armi
improprie o bianche: Chiara Di Nardo fu
vista una volta armata di una “grossa scure”,
ma non sappiamo perché; Giuseppina Gizzi
teneva stretta un’ascia accanto a sé quando
dormiva. Abbiamo notizie di brigantesse che
stavano nella banda disarmate, ma queste
informazioni vengono dagli stessi briganti
o dalle loro compagne e sono largamente
inattendibili, perché mirano a discolpare le
donne: Maria Giuseppa Di Meo, compagna
di Fuoco, dichiarò alla polizia durante l’interrogatorio che le due donne della banda,
Gioconda Marino e la non ben nota Peppina
l’Abbruzzese, erano “vestite da uomo, però
disarmate”. I briganti non dovevano avere
molta fiducia nelle qualità di Mariuccia Andreoli, forse anche per la giovane età, se non
le furono mai date armi da fuoco, ma solo,
qualche volta, una scure. La consegna delle
armi da fuoco alle donne significava conferimento di potere, e rappresentava un fatto
sconvolgente nel sistema ideologico della
società tradizionale. Per di più, le armi erano
(anche se non sempre) le stesse che portavano i capibanda, e conseguentemente armando le donne alla loro maniera, le si innalzava
al rango dei capi: delle due donne che militavano nella banda di Francesco Guerra e di
Domenico Fuoco, “quella di Guerra” (ossia
Michelina Di Cesare) “è anch’essa armata di
fucili a due colpi e di pistola. I capi della banda sono armati di fucili a due colpi e di pistole”; Luisa Mollo, amante di Barone, portava
due pistole alla cintola50.
L’amore delle armi è forte e intenso tra i
briganti. “Ognuno sa che qualsiasi cacciatore
considera e definisce il proprio fucile come
il migliore nel raggio di cento miglia. Questo rapporto fra l’arma e il suo portatore lo si
trova anche tra i briganti”. Il brigante non ha
una cura eccessiva del proprio corpo, per ragioni che si possono capire, ma “la sua arma
la mantiene immacolata” e le dedica un notevole lavoro per pulirla e metterla a punto
durante i periodi di inattività51.
Le brigantesse vengono dotate di cavalli,
come tutti i membri delle bande non appie-
Lich: 48, 60;ASP, Atti e Proc. di Val. Stor., cartella n. 282/18; cfr. Varu: 60. Tra i briganti “alla cintura ogni uomo, ed
anche ogni donna, portava il pugnale e una bandoliera ben fornita di cartucce” (Cesa: 132; confermato dalla quasi
totalità delle fonti). Delle brigantesse conosciute da Moe3 due portavano fucili, le altre tre i revolvers (Moe3: 76).
Michelina Di Cesare entrando nella banda si tolse il corpetto ed il grembiule, indossò i pantaloni e il farzetto e si
armò del fucile. ACS, Tribunale Militare Straordinario, interrog. di F. Pennacchio, 28 novembre 1864; ACS, Roma,
Trib. Mil. di Guerra per la Repr. del Brig. nelle Prov. Merid., b. 117, fasc. 1326.
50
Notizie sulle armi delle brigantesse si trovano ancora in Bour: 92; DeWi: 293; ASFr, Direzione di polizia, b. 412,
Registro briganti e squadriglieri della provincia di Frosinone; ACS, Tribunale Militare Straordinario, Processi
1871, interrogatorio di D. Compagnone, 11 maggio 1865; ASS, Tribunale Civile e Correzionale, Corte d’Assise, b.
67, fasc. 964; DiBi in Chie: 195; ASI, Prefettura d’Isernia, Atti di polizia, Brigantaggio 1967, gennaio-dicembre, b.
6, fasc. Brigantaggio del mese di aprile 1867; Dip2: 268; Lich: 60.
51
Lich: 60.
49
62
antropologia e storia
date; li bardano, come gli uomini, “con una
coperta di lana doppiata e una sella con lo
scheletro di legno, ma leggero; sopra questo
dispongono una pelle di capretto o altro;
li tengono sempre insellati e li nutrono di
ottima avena. Quando devono partire, empiono una bisaccia di avena ed una di viveri
per loro”. Per non appesantire la cavalcatura
portano il minimo indispensabile, che varia
a seconda dei bisogni individuali, che a volte
differiscono da quelli degli uomini: dal cavallo di Filomena Pennacchio durante una
fuga caddero “un ombrellino bianco, una
morbida pelle per sella, una coperta e un
cappotto”. Il cavallo era utile ai briganti per
l’attacco come per la fuga, e le brigantesse diventarono ottime cavallerizze. Ma svolgeva
anche una importante funzione simbolica.
Il possesso e l’uso di una cavalcatura “nobile”, di norma estranea alla condizione della
donna contadina, “innalzava al piedistallo
della grandezza e della maestà”, enfatizzava
vistosamente il cambiamento di status, da
contadina a soldatessa52. Di queste cavallerizze è rimasta famosa la misteriosa Caterina
della banda Coppa, sopra ricordata: guidava
insieme al capobanda una comitiva di circa 200 uomini che, nei pressi di Lucera, l’8
aprile 1862, ebbero un epico scontro con un
centinaio di cavalleggeri: l’avvenente amazzone stava per soccombere, quando fu salvata dal suo cavallo, che “saltò una fossata di
12 palmi di larghezza”. “Vuolsi sia una nobile
dell’alta Italia”, riportarono i giornali53.
/ 1 – donne in armi
Strategia e trasgressione
L’abbigliamento delle brigantesse presentava connotazioni fortemente trasgressive: armate fino ai denti, queste amazzoni contadine
oltre che per la naturale avvenenza e l’eleganza
del vestire, meravigliavano e inquietavano la
gente per i segni di promiscuità, che vedevano inscritti nel loro stesso abbigliamento,
per l’uso dei pantaloni e il taglio dei capelli,
l’uno e l’altro interdetti alle donne nella vita
normale dei paesi meridionali. Il loro vestito collaborava col loro comportamento nel
farle individuare come figure diaboliche e
streghe – quello che era toccato a Giovanna
d’Arco, la contadina che s’era tagliata i capelli e aveva indossato l’abito maschile per fare
la guerra –, tanto più che nelle tradizioni religiose popolari di tutta l’Europa il taglio dei
capelli era riservato alle possedute dagli spiriti
o dal demonio. Ma il rito aveva una sua interna ambivalenza: si tagliano i capelli anche alle
monache, in segno di umiltà e sottomissione;
la Pulcella d’Orleans, vestita da uomo con i capelli a scodella, se per alcuni è strega, per altri
è la “guerriera di Dio”. Come le brigantesse. Il
loro abbigliamento, assolutamente non convenzionale, né “civile” né contadino, maschile
con segni femminili, era motivo di meraviglia
e di scandalo anche per i soldati che combattevano i briganti. A loro giudizio quelle donne
si vestivano “deturpando con abiti strani l’indole e la grazia femminile, e lasciando tristi
ricordi di sfacciata libidine e di atti eroici”54.
Bour: 92, 90; “Pu”: 1/12/1862; I briganti avevano la passione dei cavalli. Il caso estremo è rappresentato da Nicola
Morra di Cerignola: “avere una buona cavalcatura era per lui non solo una necessità, ma quasi un segno di riconoscimento, un segno di nobiltà” (Ma-Fa: 215).
53
“Pu”: 1/12/1862.
54
ASP, Requisitoria dell’Avv, fiscale mIitare Mel, Tribunale Militare di Guerra, Potenza, 8 Aprile 1863; Cro-Delz; 34;
cfr. Casc: 151.
52
63
Q
uaderni
In realtà il cambio dell’abbigliamento, al
di là delle sue valenze simboliche e ai suoi
scopi militari, era anche un travestimento
maschile, che serviva alle donne a non farsi riconoscere dal nemico, e poter spiare, in
veste di contadini maschi, i movimenti dei
soldati senza essere individuate, svolgere
funzioni di staffetta, vedetta e sentinella. Negli atti del processo a Mariuccia Andreoli è
detto che alla brigantessa furono dati “abiti da uomo per non essere riconosciuta”, in
modo da servire ai briganti “da sentinella”.
Quando una contadina la riconobbe “alla
taglia, agli atteggiamenti, alla voce, al volto, a tutto insomma” e glielo fece sapere, la
brigantessa “si fece rossa, e piena di rabbia
rispose: – Come sai tu che io son donna? e
col dir ciò hai forse guadagnato qualcosa?” e
la minacciò duramente. Analoga la testimonianza di un contadino: “Io osservai ch’egli
mi sembrava di esser donna, ed egli quasi
corrucciato mi diede un pugno nel petto, sostenendo esser uomo, ed entrandosene dentro il mio pagliaio”. I giudici concluderanno
che la donna “coll’aggirarsi in abito maschile
non aveva altro scopo di eludere la sorveglianza della forza e poterne più facilmente
spiare i movimenti, onde tenere informati
i briganti”55. Per i briganti e le brigantesse
ingannare le forze dell’ordine riuscendo a
passare inosservate sotto i loro occhi era una
prova meritoria, Crocco era fiero di questa
sua capacità, e raccontava con soddisfazione
di poter passare davanti a un distaccamento di soldati per poi poter dire ai compagni:
“Vedi, per la Madonna, come si passa innanzi ai soldati senza farsi conoscere?”56. Per
questo, comunemente i giudici consideravano il travestimento indizio di colpa se non
colpa tout court.
Vestirsi da contadine era invece più rischioso per le brigantesse, perché le donne
del popolo, specie se trovate in contesti inconsueti, destavano sempre sospetti nelle
forze dell’ordine: Filomena Pennacchio fu
rivestita dei panni di contadina, quando fu
portata in una casa di manutengoli, per evitare di essere individuata come brigantessa;
ma la padrona di casa non fu dello stesso avviso, perché temeva che proprio in quei panni avrebbe destato sospetti; perciò, “appena
giunta in casa – racconta al tribunale – fui
dalla medesima immantinente spogliata dei
miei abiti alla contadinesca, e vestita coi suoi
propri, dicendomi che così non sarei stata da
alcuno conosciuta”57.
In parecchi casi il nascondimento della
propria identità consentiva alle donne di rientrare indisturbate nei paesi sotto le spoglie
abituali, come gli eroi mascherati popolari,
sia temporaneamente, per poi ritornare alla
macchia al momento giusto, portando nuove informazioni e vettovaglie, sia permanentemente, nel caso che il brigantaggio fosse
finito e la banda distrutta.
Per i briganti abituati a concepire la vita
militare, la guerra e i combattimenti come
prerogativa maschile, vedere delle donne
con la loro stessa “divisa” poteva essere castrante, perché metteva in crisi la propria
identità. Per attenuare questo effetto, senza
aspirare a cancellare interamente l’identità
femminile dell’iniziata, occorreva “diminui­
re” nel nuovo look delle contadine transfu-
ACS, Roma, Tribunale Militare di Guerra, b. 17 (Chieti), fase 1326 (1864)
Crocco in DeJa: 91.
57
ACS, Tribunale Militare Straordinario, interrogatorio di Filomena Pennacchio, 28/11/1864.
55
56
64
antropologia e storia
ghe dai campi i segni e i simboli della femminilità, dal taglio dei capelli all’armamento:
grazie ai processi di trasposizione emotiva,
anche il vestito maschile assimilava le poche
donne al gruppo dei maschi ed era segno di
una mascolinizzazione percepibile da altri
particolari del rito di iniziazione, come la
rinominazione maschile delle donne, sopra
ricordata. Anche se inconfessata, l’immagine virile della donna non dispiaceva alle brigantesse, perché esaltava la loro capacità di
essere al livello degli uomini e di saper fare
quello che essi facevano, a cominciare dal
combattimento.
Il travestimento delle donne era di comprovata efficacia. I soldati che le catturarono
e i sequestrati che vissero per diverse settimane insieme ad esse si accorgevano sempre
con ritardo di avere a che fare con delle donne. Questo dipese anche dalla capacità delle
donne di sintonizzarsi sui comportamenti e
sul linguaggio espressivo, corporeo e verbale, dei briganti maschi. Per questo qualche
contemporaneo riconobbe ad esse “una forte
capacità mimetica”. Moens, che visse per un
certo tempo, sequestrato, nella banda Manzo, non riconobbe subito tra i suoi rapitori
le donne: “Giunti che fummo (alla forra),
mi accorsi che cinque membri della banda
in realtà erano delle brigantesse”. Un altro
sequestrato, Michele Falcone, per parecchio
tempo scambiò la brigantessa Maria Oliverio per un giovanotto. Chiara Nardi, amante del capobanda Nunziante D’Agostino, al
momento della cattura fu scambiata per un
maschio, prima che lei stessa si facesse rico-
/ 1 – donne in armi
noscere come una donna incinta. Giocondina Marino, fatta prigioniera, fu schernita dai
soldati che la scambiarono per un piccolo
maschio goffamente panciuto, e solo con il
suo aiuto i soldati capirono che si trattava del
ventre prominente di una donna incinta. La
moglie del capobanda Cedrone fu scambiata
per un uomo dal granatiere che poi lei cercò
di uccidere, ma fu uccisa da un altro soldato.
Furono scambiate per briganti maschi anche
Carminella Telese, Giuseppina Gizzi58 ed altre. Di certo le brigantesse vivevano un processo di mascolinizzazione, che cominciava
proprio col rito di iniziazione. Farsi simili
agli uomini significava integrarsi più facilmente nella banda e partecipare del potere,
nelle forme che ad esso avevano dato i maschi. Le valenze maschili del travestimento
erano tanto più accentuate, quanto più forte
era l’ambizione delle donne e più nativamente pronunciata la loro “parte maschile”. Tale
caratteristica nella terribile Maria Oliverio
assume una dimensione paradossale: quando per il riscatto del sequestrato acrese Angelo Feraudo furono inviati denaro e gioielli
alla banda Monaco, la brigantessa irritata
ammaccò con una pietra gli orecchini, perché non erano rotondi, come li portavano gli
uomini59.
Non sappiamo con precisione tutti i significati che le forze dell’ordine attribuivano a questo abbigliamento, che esse stesse
indicavano come “travestimento”, oltre la
funzione, ampiamente certificata, di spiare il
nemico. Certo è che ogni volta che nei documenti ufficiali fa la sua apparizione una
Che le brigantesse venissero scambiate spessissimo per briganti è provato da numerose attestazioni. Le citazioni
sopra riportate si trovano, ad esempio, in Dip2: 268; Moe3: 76; Falc: 8; Gell: 240; Gell: 218-19; Bart: 39; Lich: 40-41;
DiBi in Chie: 185.
59
Fera: 51.
58
65
Q
uaderni
brigantessa, il riferimento primo è al fatto
che è vestita da uomo. A parte le suggestioni
inconsce l’abbigliamento maschile era per
le forze dell’ordine un segno inequivocabile
di appartenenza alle bande e un indizio di
colpa. Quando il sottotenente Polistina sosterrà in tribunale l’innocenza di Maria Rosa
Marinelli, la sua preoccupazione prima sarà
quella di dimostrare che la sua assistita non
indossava l’abito maschile e non portava
armi: “Armi non cinse mai; non dismise le
vesti muliebri”60.
Ruoli e funzioni delle donne alla macchia
Se alla storia negata si vuole opporre la
storia ritrovata delle donne briganti, è necessario integrare il senso e lo spessore di
quell’esperienza nel contesto più generale
in cui essa si inscrive. Al di là della registrazione del semplice dato di fatto, d’altra parte
innegabile, della cospicua presenza femminile nelle bande, si è deliberatamente creato
un vuoto storiografico in cui sono precipitate le protagoniste di una vicenda storica
ed esistenziale che, dopo il suo epilogo tragico, è stata ignorata o rimossa. Le brigantesse, confusamente ammassate nel buco
nero dell’oblio, hanno trascinato e seppellito
con sé i propri percorsi biografici, i vissuti
quotidiani, i tracciati culturali, gli affetti, i
desideri, i progetti, le scelte coraggiose; benevolmente assolte in giudizio, senza alcuna indulgenza esse furono poi condannate
ad una sopravvivenza puramente cartacea,
affidata alla ritrattistica manipolata61, cui va
riconosciuto il merito di una testimonianza
Poli: 60.
Cfr. DeLu1: 18-19, 39-51.
60
61
66
indiretta e vicaria, e alla prosa gelidamente
impersonale dei documenti di archivio e delle carte processuali. Nei rari casi di verdetti
non favorevoli, il rilievo politico della ribellione andava appiattito e riportato nell’alveo
più rassicurante della devianza femminile
comune (“delinquenti nate”, sentenzieranno
gli storici lombrosiani nella necessità di ridimensionare la rilevanza del fenomeno). Solo
ora le donne, espulse dalla scena del brigantaggio postunitario di cui i maschi, anche se
in negativo, furono ritenuti i protagonisti assoluti, sono da noi riammesse alla riflessione
storico-antropologica che ritrova le ragioni
della loro avventura e ridisegna i percorsi
della loro storia. Per legittimare uno studio
scientifico sulle brigantesse è indispensabile
non cedere alla tentazione di un lavoro compensativamente agiografico, che finirebbe
col nascondere, più che rivelare, il carattere
estremamente composito di questa storia.
Rimane, invece, l’impegno intellettuale ed
etico di disseppellire il sepolto e ritrovare le
tracce di un’esperienza che si rivelò una più
o meno consapevole migrazione da sé, che le
donne seppero vivere in una prospettiva, sia
pure confusa, di rinnovamento. La vita alla
macchia (di cui abbiamo cercato di indagare e ricostruire rigorosamente lo spaccato
etnografico) favorì l’affiorare di potenzialità
sommerse, la dilatazione dei ruoli tradizionali, una repentina acquisizione, guadagnata
sul campo, di insospettate capacità e competenze. Un dato che emerge è che la condizione delle donne all’interno di ciascuna
banda poteva mutare a seconda dei legami
familiari, dell’appartenenza territoriale e del
loro rapporto col capobanda e con i suoi luo-
antropologia e storia
gotenenti, con una forte variabile rappresentata dal diverso spessore individuale. Questa complessità di situazioni rende in parte
ragione di alcune contraddizioni presenti
nelle fonti su ruoli e funzioni delle donne;
a volte esse risultano essere membri autonomi della comitiva, in condizione di assoluta parità cogli uomini: di questo parere era
lo svizzero Lichtensteiger, sopra ricordato;
altre volte “venivano considerate da tutti
come le ultime compagne della banda, non
prendevano parte alla divisione dei riscatti e
spesso venivano picchiate e trattate male dai
loro uomini”, come ebbe a scrivere un altro
illustre testimone oculare, sequestrato dagli
uomini di Cerino, aggregatisi in parte alla
banda Manzo, responsabile del rapimento
di Lichtensteiger62. I due sequestrati descrivono dunque in maniera diversa, in certo
senso opposta, la condizione delle donne
alla macchia. Perché? Secondo le regole non
scritte del codice brigantesco, prendevano
parte alla spartizione del denaro dei riscatti solo i briganti che avevano partecipato al
sequestro, e quasi certamente le brigantesse,
citate e compatite da Moens, vennero escluse
non in quanto donne, ma in quanto assenti
al momento della cattura degli ostaggi. Ma se
anche l’esclusione dal bottino fosse avvenuta
sulla base di un criterio di discriminazione,
si tratterebbe di un caso particolare, non generalizzabile, dal momento che sono prevalenti le testimonianze di segno contrario. Per
esempio, in tribunale risultò che una protagonista indiscussa del brigantaggio femminile postunitario come Giocondina Marino
“prendeva parte alle spoglie dei depredati”
e un’altra, come Maria Oliverio, protestava
/ 1 – donne in armi
perché nel bottino non trovava gioielli di
suo gradimento63. Non pare, inoltre, che le
brigantesse della banda Manzo-Cerino brillassero per doti particolari, a differenza, per
esempio, delle donne della banda Caruso o
Schiavone, ed era proprio questo, più che la
condizione femminile, a collocarle in fondo
alla scala gerarchica del gruppo.
Più attendibile risulta il dato, su cui le
fonti concordano, del maltrattamento delle
donne che non erano capaci di adeguarsi ai
ritmi serrati delle marce. Il problema riguardava, in verità, sia le donne che gli uomini e
anche gli stessi sequestrati quando non reggevano al passo dei briganti. Negli spostamenti e soprattutto nelle fughe, non si aveva
il diritto di essere stanchi o di rallentare. Era
una regola ineludibile, da cui dipendeva l’esistenza e la sicurezza della banda.
Anche qualche fonte processuale sembra
dar ragione alla tesi della marginalità delle donne all’interno delle bande. Dagli atti
del processo contro Maria Rosa Marinelli
emerge che le brigantesse erano insultate
e picchiate quando non si adeguavano alle
regole imposte dai maschi ed erano escluse
dalla spartizione del bottino e dei proventi
delle grassazioni; non prendevano parte alle
imprese più arrischiate ed erano sottoposte a
stretta sorveglianza anche quando venivano
affidate ai manutengoli64. Queste testimonianze vanno lette nel modo giusto, perché
la difesa, per ottenere sconti di pena, grazie a
testimoni compiacenti, tendeva a presentare
le donne come vittime impotenti dei briganti e strumento passivo della loro violenza.
In gruppi armati formati nella stragrande
maggioranza da uomini, provenienti da ceti
Moe: 94.
Ferau: 151.
64
Sca-Del: 56.
62
63
67
Q
uaderni
sociali in cui, almeno sul piano formale, prevaleva il principio della subalternità delle
donne, è probabile che i briganti avessero
dei vantaggi sulle loro compagne, del tutto
compatibili, però, con altre opportunità e
risorse che il brigantaggio, come vedremo,
ad esse offriva. Dopotutto i briganti maschi
prevalevano,ma non sempre, nelle decisioni
per il semplice fatto che erano più numerosi
delle donne e facevano valere il peso della
maggiore consistenza numerica.
Ma la storia di ogni brigantessa ha qualcosa di sorprendente nella sua irripetibilità:
sappiamo della lucana Luisa Ruscitti (o Roscitti) che, rapita poco più che adolescente
dal capobanda Caruso, diventò, secondo un
percorso che possiamo soltanto immaginare, allieva attenta e fedele del suo rapitore,
dal quale imparò l’arte della guerra, ma andò
al di là delle sue aspettative, diventando una
sorta di eroina-bambina, interamente votata
alla causa che credeva giusta. Questa vergine guerriera “dagli illibati costumi”, per la
fierezza e la determinazione dimostrate, fu
capace di far sentire in soggezione lo stesso
feroce colonnello, che ebbe per lei un affettuoso e tenero rispetto65.
Alla luce dei fatti accertati, senza timore
di sfiorare l’azzardo, si può sostenere che la
scelta del brigantaggio cambiò la vita delle
donne: diventate briganti, esse guadagnarono un’insperata parità cogli uomini, soprattutto quando alle attitudini militari associavano predisposizione al comando e durezza
di temperamento, ai limiti della crudeltà,
doti particolarmente apprezzate che, in alcuni casi, faranno di loro i capi acclamati e
temuti dalle bande. Lo statuto di guerrigliere
Su Roscitti ved. Sang: 213, 179-81; DeBl: 50.
65
68
dilatava i confini delle rigide distinzioni di
genere, consentendo attraversamenti culturali e riconfigurazioni identitarie di soglia, di
cui, più dei maschi, le donne dimostrarono
di essere capaci. Spavaldamente anfibie, si
adattarono, non senza insofferenze, all’inospitalità dei boschi: l’approvvigionamento e
la preparazione, condivisa con i maschi, del
cibo, la predisposizione dei piani di attacco
e la spartizione del bottino, la cura dei malati e l’accudimento dei sequestrati, le marce
estenuanti e le fughe improvvise scandivano
la loro dura esistenza sui monti e nei boschi,
instabili dimore solo in parte domesticizzate. Quelle che non erano identificate come
brigantesse dalle forze dell’ordine, indossati
i vestiti consueti o mimetizzate in abiti maschili, studiavano i movimenti delle truppe
e riferivano ai compagni, trasmettevano informazioni sbagliate ai soldati, depistandoli
o attirandoli nelle imboscate; rifornivano la
banda di munizioni che nascondevano sotto
le gonne che tornavano a indossare quando,
in alcune situazioni, poteva risultare utile
“travestirsi” da semplici contadine; quelle,
pochissime, che sapevano scrivere svolgevano compiti di segretarie e non di rado
assumevano funzioni “diplomatiche”, prestandosi come intermediarie tra i briganti e
le famiglie dei rapiti. Anche la bellezza e il
fascino che esercitavano sugli uomini della
banda contribuirono al mito delle amazzoni
bellicose, esperte nell’arte della guerra come
in quella dell’amore. Pre-condizioni soggettive favorevoli, che si saldavano a situazioni
oggettive di vantaggio, quali, come già detto,
lo status di compagne dei leader e il peso dei
rapporti parentali, consentirono la meta-
antropologia e storia
morfosi delle contadine in brigantesse e delle
brigantesse in protagoniste: è questa soprattutto la storia di Maria Oliverio, Michelina
De Cesare, Filomena Pennacchio, Filomena
Piccaglione, Maria Capitanio, Giocondina
Marino66. Non sappiamo chi fosse a capo
della banda di circa 50 briganti che il 30
settembre 1863 nelle campagne di Gioia del
Colle misero in fuga guardie nazionali e carabinieri, dileguandosi subito dopo all’arrivo
dei rinforzi, ma sedicenti testimoni oculari
affermarono che inequivocabilmente fosse
una donna.
Processi e strategie di difesa
Durante i dibattimenti i briganti rimanevano silenziosi di solito perché reticente:
ignoravano o non ricordavano i luoghi e i
nomi dei manutengoli, non riconoscevano
gli altri imputati e davano la colpa di questa smemoratezza più simulata che reale alle
violenze che li avevano sconvolti. Quando
decidevano di parlare, sorvolavano sui particolari che potevano aggravare la loro posizione processuale. Essi contavano sul fatto
che la corte giudicante non poteva avvalersi
di molte testimonianze avverse: i convenuti non rilasciavano dichiarazioni esaurienti
perché temevano le rappresaglie dei briganti
ancora alla macchia o quelle dei parenti nel
paese, e inoltre era convinzione diffusa l’estraneità delle leggi e dello Stato al proprio
mondo, per cui le stesse vittime del brigantaggio ritenevano che le questioni andassero
regolate all’interno della comunità. Le donne sotto processo ricalcano i comportamenti
/ 1 – donne in armi
maschili. Tacciono o mettono in atto strategie, ora più o meno istintive ora subdole,
che miravano ad ottenere attenuanti in vista
di una riduzione della pena, se non addirittura dell’assoluzione. Intuito l’orientamento
dei giudici, le brigantesse riscrissero la loro
storia, assecondando le aspettative degli inquirenti che conducevano gli interrogatori
in modo che prevalesse la tesi innocentista,
col proscioglimento delle imputate. Nelle
domande era spesso implicitamente contenuta anche la risposta e le inquisite seppero
cogliere quella opportunità: esse sostennero,
in una stereotipia che non poteva non essere
preordinata, che i capi non le tenevano informate delle loro decisioni e intenzioni, al
punto che qualcuna, come Francesca Cerniello, dichiarò di non essere a conoscenza
di nulla, se non di qualche indiscrezione
orecchiata dai compagni. Quanto allo spinoso problema di rivelare il nome dei complici, esse rivendicavano l’assoluta estraneità ai
fatti ascritti, affermando, contro ogni smentita, che quando tra i briganti arrivavano i
manutengoli o i loro emissari, i capi facevano in modo che essi non fossero visti e riconosciuti da nessuno, nemmeno dagli altri
membri maschi della banda.
Pur essendo mediamente molto giovani,
non di rado le imputate, nel declinare le proprie generalità, mentirono ai giudici. Molte
dichiararono di essere ancora minorenni e di
non avere, all’epoca dei fatti, più di quindici
o sedici anni. Così fecero Domenica Piturro,
Filomena Pennacchio, Mariuccia Andreoli,
Rosa D’Ascoli, Generosa Cardamone, Luisa
Mollo, ottenendo una diminuzione di pena,
che fu concessa anche alle brigantesse e alle
Ved. Sca-Del: 57-60.
66
69
Q
uaderni
manutengole incinte. Lo stato di gravidanza era di solito facilmente verificabile, ma in
qualche caso si trattò di gravidanza simulata.
Erano incinte al momento dell’arresto Generosa Cardamone, Pietra Le Porte, Chiara Di
Nardo.
Per guadagnarsi il favore del tribunale,
molte riferirono episodi in cui la loro intercessione presso i capi delle bande aveva salvato la
vita di sequestrati o prigionieri o aveva evitato ad essi torture e maltrattamenti. Vantarono
meriti di questo tipo soprattutto Giocondina
Marino, Filomena Pennacchio, Giuseppina
Vitale, Filomena Piccaglione e Maria Oliverio.
Quando era difficile sostenere che erano state rapite, le brigantesse raccontavano
ai giudici di essere state spinte alla macchia
dalla paura di un’ingiusta carcerazione, in
quanto parenti o amanti dei briganti. Il più
delle volte il racconto era veritiero, ma alcune come Giuseppina Vitale e Angela Cotugno conferirono ad esso una notevole enfasi,
sapendo che i giudici ne sarebbero stati favorevolmente colpiti, aggravando le accuse nei
confronti dei briganti, imputabili così anche
di plagio. L’argomentazione più forte da esse
addotta fu la storia, quasi sempre inventata,
del ratto, che solitamente testimoni compiacenti confermavano. Tuttavia i giudici non
sempre potevano negare l’evidenza dei fatti.
Dalle deposizioni delle imputate che cadevano in contraddizione e dalle palesi incongruenze di molte testimonianze, dovettero
a volte riconoscere il carattere menzognero
dei racconti di rapimenti e violenze: in questi
casi diventava impossibile pronunciare verdetti di completa assoluzione. Andò bene,
invece, a Luisa Mollo: nel processo contro
“GiOf ”: 17/6/1863.
67
70
i superstiti della banda Barone, istruito nel
giugno 1863, la brigantessa amante del capobanda uscì assolta, perché, anche grazie
all’impressione che esercitò sulla corte, che
dovette tenere conto del fatto che aveva solo
diciannove anni, le fu riconosciuta la coazione su più piani, a cominciare dal ratto.
Il carnefice diventava vittima, e un giornale
riassunse in questi termini la “dolorosa storia” della “giovane ed avvenente popolana,
“amante o vittima del Barone”: “Il Brigante la
strappò alla sua famiglia, la trasse seco nelle
montagne, la tenne il più delle volte chiusa
in una pagliaia per soddisfare le sue voglie
brutali. È una sciagurata ben più degna di
commiserazione che di spregio”67. Luisa era
stata invece amante consenziente e collaboratrice del capobanda, che seguiva anche nei
combattimenti e nelle rappresaglie.
Un giudice avrebbe potuto obbiettare che, quale che fosse stata l’origine della
loro iniziazione al brigantaggio, le donne
avevano comunque partecipato ad azioni
illegali o criminali. Anche a questo esse si
erano preparate, dal momento che di solito sostennero: a) di non aver preso parte
alle operazioni della banda, quali sequestri,
grassazioni, razzie, scontri a fuoco e, quando riusciva difficile dimostrarlo, b) di essere
state costrette a farlo. Per quanto concerne il
primo punto (a), non era facile dimostrare la
partecipazione delle donne alle azioni militari della banda; si richiedeva infatti che esse
dovessero essere state viste in azione insieme
ai briganti, per essere dichiarate colpevoli di
brigantaggio (il reato per il quale erano previste le pene più dure), ma questo riusciva
molto difficile, sia perché il travestimento
antropologia e storia
maschile le rendeva irriconoscibili, sia perché potevano contare su testimoni favorevoli o omertosi. Le testimonianze risultavano
in effetti incerte e lacunose e non c’erano
elementi sufficienti per considerare veritiera una testimonianza invece di un’altra, ma
i giudici si mostrarono straordinariamente
disposti a prestar fede a quelle più favorevoli alle donne. Scelsero la strategia difensiva
dell’assoluta estraneità ai fatti, tra le altre,
Giuseppina Vitale, Maria Parente, Maria
Suriani, Generosa Cardamone, Mariuccia
Andreoli, Maria Giovanna Bonnet. Circa il
secondo punto (b), anche quando era attestata e provata la partecipazione delle donne
alle azioni di guerriglia, bisognava accertare
se esse avessero agito liberamente o in regime di costrizione. Ovviamente le decisioni
ultime erano a discrezione dei magistrati, i
quali, per confermarne la subalternità che
storicamente le pretendeva docili e indifese,
vollero credere alle donne. Maria Capitanio,
inaspettatamente assolta con formula piena,
non fu la sola a sostenere che durante i frequenti spostamenti della banda era obbligata a seguire i briganti, costretta, con la forza,
a prendere parte alle operazioni militari. Pur
non completamente prosciolte, in virtù delle attenuanti concesse ottennero consistenti
riduzioni di pena le Filomena Di Poto, Carolina Casale, Carolina Di Ruocco68.
La clemenza dei giudici
Un procedimento dall’esito clamoroso
fu quello a carico di Maria Rosa Marinelli,
/ 1 – donne in armi
processata insieme a Filomena Cianciarulo
e Reginalda Rosa Cariello, la cui difesa fu
assunta da due ufficiali dell’esercito, Antonio Polistina e Gustavo Pollone. In giudizio
essi addussero, a totale discolpa, queste argomentazioni: (a) le donne furono rapite;
(b) sapevano di non poter tornare indietro,
per aver perduto l’onore; (c) avevano “stolta
paura del rigore delle leggi”; (d) erano “tenute guardate” dai briganti; (e) non presero
parte ai crimini della banda e (f) quando
non poterono evitare di parteciparvi, lo fecero perché costrette69. Già nelle pagine di
un precedente studio monografico, scritto
in collaborazione con Domenico Scafoglio,
Le donne col fucile, si era sottolineata l’inverosimiglianza di molte delle eccezioni sollevate dal sottotenente Polistina, in una pur
splendida ed appassionata arringa difensiva. Maria Rosa Marinelli fu presentata da
alcuni testimoni come una “malafemmina
ladra”, altri però negarono che avesse avuto
rapporti con i briganti. Il difensore smontò
le testimonianze avverse con grande abilità,
ma “non sempre oggi le sue argomentazioni
risultano convincenti, né a lume di logica, né
alla luce del diritto, anche se i giudici vollero
credere alle sue conclusioni”70. La brigantessa, infatti, fu assolta in prima istanza, insieme alla Cianciarulo, e solo successivamente quest’ultima fu condannata a tre anni di
reclusione. Furono prosciolte, per aver agito
in regime di costrizione, Reginalda Cariello,
Maria Domenica Piturro, Luisa Mollo, Maria Lorenza Ricciardi, Filomena Ciccaglione,
Rosa Todisco, Maria Rita, Caterina Di Lucchio, Maria Di Vincenzo.
Sca-Del: 139.
Sca-Del: 140; Poli.
70
Sca-Del: 141.
68
69
71
Q
uaderni
Altre furono condannate a pene lievi, nonostante la gravità dei capi di imputazione.
Carolina Casale, catturata nel 1868 dopo che
le bande di Terra di Lavoro furono disfatte a
Monte Cavallo, il 13 novembre 1872 venne
assolta dal reato più grave, quello di brigantaggio. Successivamente la Corte d’appello di
Napoli la rinviò in giudizio con l’accusa di associazione di malfattori, sequestro di persona e atti criminosi, omicidio volontario premeditato. Sorprendentemente, a conclusione
del processo, Carolina, ritenuta responsabile
solo di associazione di malfattori, fu condannata il 5 maggio 1875 ad un anno di carcere
e a due anni di sorveglianza speciale, ma fu
subito rilasciata, perché, detenuta dal 1868,
aveva scontato una pena maggiore di quella
che le venne inflitta71. La stessa clemenza fu
esercitata dai magistrati nei confronti di Teresa Russomanno, Caronia Di Ruocco, Isabella Caramuta, Chiara Di Nardo.
Solo in pochi casi, per l’impossibilità di
negare l’evidenza dei fatti o per la insussistenza o l’estrema debolezza delle argomentazioni degli avvocati difensori, le brigantesse ebbero pene più severe. Fu condannata a
10 anni di lavori forzati Maria Lucia Di Nella,
compagna di Francescantonio Summa, processata il 25 aprile 1864. Il Tribunale Militare di Guerra in Potenza, prendendo atto del
fatto che “al momento dell’arresto la Dinella
(sic) trovavasi senz’armi”, ma che “avrebbe
seguito per lo spazio di quindici mesi la banda di Ninco Nanco, quale amante del fratello
di quel capobrigante”, sentenziò che “quan-
71
72
72
tunque militino a di lei favore delle circostanze attenuanti, specialmente quella dalla
medesima dedotta, di essere stata rapita e
condotta a forza dai briganti dal suo amante,
non può tuttavia escludersi a suo carico l’imputabilità del fatto di sua criminosa permanenza, per ben quindici mesi, nella banda di
Ninco Nanco, non essendo presumibile che,
durante quel tempo, essa non abbia potuto
trovare occasione, o modo di abbandonare
quell’orda, né che vi sia stata costretta a rimanere colla violenza, dovendosi ritenere il
contrario, per la circostanza appunto, che la
medesima era amante del fratello di Ninco
Nanco, il quale le avrebbe promesso di farla
sua sposa (…); che però non essendo risultato che la medesima, durante quel tempo,
abbia commesso alcun reato, o preso parte
attiva nei misfatti perpetrati dalla banda alla
quale trovavasi unita, né che sia stata mai armata, non potrebbe quindi ritenersi imputabile del reato di brigantaggio, ma soltanto di
complicità di detto reato (…). Ritenuto infine che la Dinella non avrebbe compiuto l’età
del 21° anno, sebbene sia maggiore di quella
di 18, condanna la donna a 10 anni di reclusione”72. Altre condanne a 10 anni ebbero
Filomena Nardozza, Maria Teresa Ciminelli,
Maria Giovanna Longiello, Maria De Piana,
Elisabetta Blasucci, Maria Nicola Suozzi, Caterina Boccia, Anna Pafundi, Maria Giuseppa De Meo, Cristina Cocozza.
Poche furono le brigantesse condannate per brigantaggio, ma le pene furono più
miti di quelle comminate agli uomini, che
ASCa, Corte d’Assise di S. Maria Capua Vetere, Sentenza d’accusa, b. 158, c. 1089, fasc. 13, f. 12, 13; Sentenza finale,
5 maggio 1875, f. 137, 138.
ASP, Corte di Assise di Potenza, Processo n. 1688, cart. 1880, p. 31, estratto della sentenza del Tribunale di Guerra).
La pena fu poi ridotta con Regio Decreto del 22 aprile 1868 a 5 anni; ASP, Corte d’Ass. di Potenza, Processo n. 1688,
cartella 1880, p. 31, estratto della sentenza del Trib. di Guerra, 15 aprile 1864.
antropologia e storia
venivano fucilati o, in subordine, costretti ai
lavori forzati a vita. I giudici, anche inconsapevolmente, si resero esecutori di un progetto normalizzatore che, nella retorica della
fratellanza, pretendeva di edificare un’identità nazionale in cui i contadini meridionali
non volevano riconoscersi. Le cifre culturali
dell’assimilazione spingevano alla eliminazione delle diversità, che la miopia politica
dei generali dell’esercito regolare trasformò
drammaticamente in ribellione e violenza.
In un processo di unificazione sincopato e
convulso, le due Italie – quella “progredita”
del Nord e quella “arretrata” del Sud – si toccavano senza incontrarsi. Nell’ambiguità del
teorema civilizzatore, la posta in gioco era
il ristabilimento dell’ordine minacciato che
mal si conciliava con la punizione esemplare
delle brigantesse, che vennero viste o fatte
passare per soggetti marginali, plagiati da
pericolosi “delinquenti congeniti”, nella cui
fisiognomica – come gli studi antropometrici introdotti da Cesare Lombroso cominciavano ad ipotizzare – era già inscritto il destino di banditi. Occorreva che la “giustizia”
operasse una distinzione di responsabilità
tra chi aveva progettato e organizzato la lotta
armata e chi vi aveva invece preso parte senza alcuna condivisione. L’accusa di brigantaggio estesa alle donne ne avrebbe avallato
un protagonismo che doveva essere istituzionalmente negato; di conseguenza, derubricato il reato in associazione a delinquere,
le condanne inflitte dai tribunali oscillarono,
al massimo, tra i 10 e i 20 anni di lavori forzati. Solo in alcuni casi, più per valutazioni
di ordine pratico che per motivazioni giuridiche, a scopo di deterrenza, vennero appli-
/ 1 – donne in armi
cati criteri più severi di giudizio. A Maria Teresa Ciminelli non fu perdonata la sua fede
legittimista e forse non giocò a suo favore
l’appartenenza filoborbonica dell’intera famiglia. Sul finire del 1865, nonostante avesse
collaborato con i militari dopo la cattura, fu
accusata di brigantaggio e condannata ai lavori forzati a vita, nel 1867 ridotti a 10 anni
di reclusione ordinaria. Maria Luisa Ruscitti,
pur essendo nelle carte processuali descritta
unanimemente come donna “di sanissima
morale ed illibatissimi costumi”, fu condannata a 25 anni di lavori forzati dalla Corte
di Assise di Trani e alla sorveglianza speciale
a vita, soprattutto in considerazione del fatto di aver ucciso in uno scontro a fuoco un
ufficiale con un colpo di pistola, obbedendo
agli ordini di Caruso73. Ebbero condanne
analoghe Elisa Garofalo, Filomena Soprano,
Angela Maria Consiglio, Rosa Pezzigni, Generosa Cardamone, Maria Carmina Valente,
Maria Maddalena De Lellis, Maria Giovanna
Tito, Francesca Cerniello, Serafina Ciminelli, Giuseppina Vitale, Giocondina Marino.
La conclusione è che, tranne qualche eccezione in cui l’eccesso di rigore sembra apparentarsi con l’accanimento, i magistrati
accoglievano senza troppe difficoltà le tesi
difensive delle donne e, col riconoscimento
della coazione e della impossibilità di dimostrare la loro presenza nelle operazioni
delle bande, le assolvevano con formula piena o le discolpavano delle imputazioni più
gravi. Come interpretare l’atteggiamento di
clemenza durante i processi tradotto poi in
sentenze che, nella palese disparità di trattamento, finivano coll’inficiare il principio
dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte
Sang: 215.
73
73
Q
uaderni
alla legge? Il proscioglimento delle imputate
tendeva ad esorcizzare l’idea che l’esperienza del brigantaggio avesse consentito alle
donne forme di emancipazione che ne legittimassero aspettative di affrancamento dal
regime di tutela che le assimilava ai minori.
I giudici preferirono perciò immaginare che
esse avessero per forza o per amore aderito
alle bande e quando combattevano con accanimento accanto ai briganti lo facessero
nella più totale irresponsabilità. Se la scienza, nel quadro teorico dell’arresto biologico
dello sviluppo femminile74, cercava di dimostrare che le brigantesse erano solo delle degenerate e che nelle tare congenite ed
ereditarie andasse ricercata la ragione della
non imputabilità, i giudici le vollero vittime
irresponsabili e stolide. Sono due facce della
stessa medaglia, quella che sanciva l’inferiorità della donna, rallentandone il lungo e accidentato viaggio verso la parità75.
La condanna a morte di Maria Oliverio
Come abbiamo anticipato, per il reato
di brigantaggio politico con resistenza alle
forze dell’ordine le leggi prevedevano la fucilazione; in assenza di resistenza, lo stesso
reato era invece punito con i lavori forzati a
vita, che solo le attenuanti potevano ridurre
di alcuni anni. È in rapporto a questa normativa penale che Maria Oliverio organizza
insieme al suo avvocato, Giacinto Oliverio,
la sua difesa. Per quanto fosse raro che una
donna venisse condannata a morte, il rischio
che ciò accadesse diventava reale quando
l’imputazione di brigantaggio risultava provata senza residui di dubbio. In questo caso,
specialmente se l’alto numero delle vittime
o le efferatezze dei crimini perpetrati aveva suscitato l’esecrazione collettiva, poteva
prendere forma nell’opinione pubblica il
desiderio di una giustizia vendicatrice che
non doveva risparmiare neanche le donne.
Durante il processo, senza timore di influenzare la libertà dei giudici, anticipandone la
decisione, il Comandante della Guardia Nazionale di Spezzano Grande scrisse al Comandante Sirtori una lettera in cui chiedeva
che l’esecuzione di Maria Oliverio avvenisse
“nel proprio rione, per essere di esempio a
questi comuni del mandamento, fieri e tristi
per propria indole, e per creare lo spavento
e lo abbattimento ai moltissimi tristi, onde
non difettare pel prosieguo”76. In effetti sulla
brigantessa gravavano pesanti imputazioni,
quali l’uccisione della sorella Teresa, amante di suo marito, la partecipazione a omicidi
consumati dalla banda, sequestri, razzie e
resistenza finale all’attacco sanguinoso delle
forze dell’ordine.
La difesa che la Oliverio costruì al processo si avvaleva di silenzi e invenzioni, per
avallare la tesi delle coazioni continuate. Il
suo comportamento non fu perciò diverso
da quello delle altre brigantesse, con la sola
differenza che a lei i giudici non vollero credere. Dal principio alla fine la sua difesa è
coerente e ben articolata. “Interrogata se
conosca il motivo del suo arresto, risponde:
– Perché mi trovavo tra i briganti –. Interrogata analogamente, risponde: – Mentre mio
marito Pietro Monaco latitava (…) mia so-
Cfr. Serg1: 167-182; le stesse riflessioni sul tema dell’inferiorità femminile si trovano in Serg2.
Sca-Del: 142-143.
76
AUSSME, Roma, Fondo Brigantaggio, b. 53, c. 1-54.
74
75
74
antropologia e storia
rella Teresa, maggiore di età di me, maritata
con Salvatore De Cicco, istigava mio marito
ad uccidermi non so per quale ragione, e mio
marito veniva ogni volta alla mia abitazione
tentando di uccidermi, ma ne venni sempre
sottratta ad opera dei vicini dell’abitato che
accorrevano tosto in mio aiuto. Un giorno,
dopo che io sono uscita dal carcere di Celico
(…) detta sorella disse a mio marito che tutti quelli che custodivano le carceri suddette
avevano avuto illecito commercio con me
durante quel tempo, ad eccitare lo stesso alla
vendetta a mio danno. Ed infatti una sera capitò alla mia abitazione, cioè a Macchia, frazione del comune di Spezzano Piccolo, domicilio pure di mio marito, mi condusse in
un vicino vallone, dove giunti fece col fucile
che portava ad un tratto una scarica contro
di me, che miracolosamente ne rimasi illesa, e tentando egli poi di uccidermi, traendo di tasca un coltellaccio, io riuscii con la
fuga a salvarmi in casa della suddetta mia
sorella nello stesso villaggio, ove non venne esso mio marito. Colà lagnandomi colla
Teresa che essa era causa di quei tentativi di
detto mio marito e dell’infelice mia situazione, essa ostinatasi a dire di nulla saperne e
questionando fra noi due con molto calore,
siamo venute alle prese; la sorella diede di
mano ad un coltello tentando di scannarmi,
ed io difendendomi, trovata a caso ivi una
scure, diedi di piglio a questa e furiosamente
scagliando colpi a mia difesa, vidi la sorella
cadere al suolo, ed io fuggii e mi tenni nascosta per otto giorni in capo ai quali comparve
mio marito insieme ad un certo Salvatore De
Marco di Serra Pedace e mi condussero alla
/ 1 – donne in armi
Sila. Mio marito mi voleva ammazzare, ma
il suo compagno suddetto De Marco s’intromise calorosamente e lo fece desistere. Seppi
in seguito che mia sorella soccombette alle
ferite ricevute dopo alcune ore dal ferimento. Ma io ero ben lontana dal venire a quei
fatali estremi causati dall’inevitabile mia difesa, oltreché la medesima era la ragione per
cui io ero perseguitata a morte dal marito
stesso. Tale irreparabile sventura mi trasse
nell’altra non minore di dovermi ricoverare
fra i briganti e ridurmi allo stato infelice in
cui mi trovo”77.
La brigantessa si presenta come una vittima della sorella, del marito, del cognato e
del resto della banda. Ma non era facile contestare le imputazioni, ampiamente provate,
concernenti la sua attività brigantesca, né,
d’altra parte, Maria poteva dimostrare in
maniera convincente di non aver opposto
resistenza all’arresto finale, sfruttando fino
in fondo l’argomento della coazione: “poche
settimane prima dell’uccisione del capobanda Pietro Monaco l’accusata – sostenne l’avvocato difensore – volendo presentarsi alla
giustizia, scappò dalla pressura dei masnadieri; ma fattosene accorto il Monaco la raggiunse, e l’intercessione dei compagni di lui
la campò (sic) dalla morte che quegli voleva
darle”. Su questo tema si sintonizza anche la
brigantessa: “Nell’occasione in cui rimase
ucciso mio marito, io riportai al braccio sinistro (…) tale ferita che tutt’ora porto e che
qui vedete, onde ero risoluta a consegnarmi
all’autorità, ma Antonio Monaco mi minacciava di uccidermi, ogni volta che così mi
esternava”78. L’imputata aveva preparato da
ACS, Roma, Tribunali Militari di Guerra per la Repr. del Brig. nelle Prov. Merid., b. 80 (Catanzaro), fasc. 984.
ACS, Roma, Tribunali Militari Straordinari, b. 80; ACS, Roma, Tribunali Militari di Guerra per la Repr. del Brig.
nelle Prov. Merid., b. 80 (Catanzaro), fasc. 984.
77
78
75
Q
uaderni
tempo questo elemento difensivo: nel verbale che il capitano Baglioni stese al momento
della cattura si legge: “la Maria Oliverio, tosto che fu nelle mie mani col brigante Gagliardi disse che, sentite le prime fucilate,
voleva arrendersi, ma che il Gagliardi l’aveva
minacciata d’ucciderla con un colpo di revolver e ciò non fu smentito da Gagliardi”79.
In realtà il Gagliardi, gravemente ferito e
prossimo alla fucilazione, non aveva né confermato né smentito.
Maria Oliverio il 30 aprile 1864 è condannata alla pena capitale mediante fucilazione alla schiena. Fu l’unica condanna a
morte di una donna brigante, decisa da un
tribunale regolare. La richiesta di grazia fu
tempestivamente avanzata con telegramma
dal più democratico e civile dei generali
italiani, Giuseppe Sirtori. Quali che fossero
le sue convinzioni personali e i suoi segreti sentimenti, il generale argomentava che
la donna “era stata trascinata al male dalla malvagità del marito”, aggiungendo una
considerazione di opportunità, dal momento che quindici giorni prima nella stessa
Catanzaro era stato giustiziato il brigante
Coppola, ed un esempio di reale clemenza
dopo un esempio di rigore avrebbe sortito sicuramente un effetto positivo80. Altro
colpo di scena: inaspettatamente giunge
una lettera al generale Sirtori, in cui Nicola
Parisio, Consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, attesta “alcune circostanze in
favore della condannata”, quali il suo comportamento umano verso i suoi parenti
Antonio Parisio e suo cugino Mazzei81. Le
autorità supreme, il Re e il Ministro della
Guerra, hanno già motivazioni sufficienti
per commutare la condanna, ma forse non
fu ininfluente l’effetto della battaglia per l’abolizione della pena di morte sostenuta, tra
gli altri, da Victor Hugo. Ma dovette contare
anche il fatto che, almeno per quanto concerne l’uccisione della sorella, la gente del
paese si era schierata dalla parte di Maria,
perché in lei vedeva la vittima e la vendicatrice di una tresca incestuosa. Pochi giorni
dopo la sentenza, l’8 maggio dello stesso
anno, il Re d’Italia commuta la condanna
alla pena capitale in quella dei lavori forzati
a vita82.
I paragrafi Il rito di iniziazione, La consegna del
cavallo e delle armi, Strategie e trasgressione sono stati
scritti in collaborazione con Domenico Scafoglio.
Fonti archivistiche
ACS: Archivio Centrale dello Stato, Roma.
ASCa: Archivio di Stato di Caserta.
ASFr Archivio di Staro di Frosinone.
ASI: Archivio di Stato di Isernia.
ASP: Archivio di Stato di Potenza.
ASS: Archivio di Stato di Salerno.
AUSSME: Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma.
Ibidem.
AUSSME, Roma, Fondo Brigantaggio, b. 63, fasc. 7, c. 81-92.
81
L’intera storia della grazia è stata diligentemente ricostruita in Curc: 249-60. Per le imprese di Maria Oliverio ved.
Sca-Del: 99-103. Nella stessa opera gli autori hanno riscritto e interpretato la vita, la personalità e il mito della
brigantessa (pp. 15-17; 99-103, 141-42, 148-51).
82
AUSSME, b. 63, fasc. 7, cc. 1-54.
79
80
76
antropologia e storia
Bibliografia
Bian = Q. Bianchi, Vita di Ninco Nanco, Manduria, Lacaita, 2001 (ed. or. 1903).
Boja = Bojano, La brigantessa del Matese nel verbale di interrogatorio del 1865, estratto s.n.t.
Bour = G. Bourelly, Il brigantaggio dal 1860 al 1864,
Venosa, Osanna Venosa, 2004 (ed. or. 1865).
Bourk = J. Bourke, Seduzioni della guerra, Roma,
Carocci, 2001 (ed. or. 1999.
Caia = Caiazza, La banda di Manzo tra i briganti
campani e lucani nel periodo postunitario, Napoli, Tempi Moderni, 1984.
Casc = F. Cascella, Il brigantaggio. Ricerche sociologiche e antropologiche, Aversa, Noviello,
1907.
Cesa = C. Cesari, Il brigantaggio e l’opera dell’esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma, Ausonia,
1928.
Chap = G. Chapman, Milocca. Un villaggio siciliano, tr. it., Milano, Franco Angeli, 1985.
Clem = G. Clemente, Introduzione a T. La Cecilia, Brano dell’istoria del brigantaggio di Capitanata e Basilicata dal 1861 al 1864, Foggia,
Edizioni del Rosone, 2008.
Curc = P. Curcio, Ciccilla, Cosenza, Pellegrini, 2010.
DeBl = De Blasio, Il brigante Michele Caruso, Napoli, Lubrano, 1910.
DeLu1 = S. De Luna (a cura di), Per forza o per
amore. Brigantesse dell’Italia postunitaria,
Cava de’ Tirreni, Marlin, 2008.
DeLu2 = S. De Luna, Ultima tellus (I ed.), Cava
de’ Tirreni, Marlin, 2008.
DeLu3 = S. De Luna, Le brigantesse crudeli. Analisi di uno stereotipo, in “Quaderni del Dipartimento”, Università di Salerno, Dip. Scienze
dell’Educazione, 2008-2009, pp. 319-334.
DeWi = A. De Witt, Storia politico-militare del
brigantaggio nelle provincie meridionali d’Italia, Firenze, Coppini, Coppini, 1884.
DiBi in Chie = F. Di Biase [Diario del sequestro]
in D. Chiefallo, Cilento, Contadini, galantuomini, briganti, Sarno, Edizioni dell’Ippogrifo,
2002.
/ 1 – donne in armi
DiCu = M. Di Cugno, Storia del brigantaggio in
Basilicata, Potenza, 2000.
DiTe = P. Di Terlizzi, I carabinieri e il brigantaggio
nell’Italia meridionale (1861-1870), Bari, Levante Editori, 1997.
Ferau = V. Feraudo, Briganti alla Caccìa, s.l., Legenda, 2007.
Ferr = O. Ferrara, Il brigante Santaniello e la brigantessa Padovella: una storia d’amore e di
guerra, in “L’alfiere”, settembre 2008.
Frie = Friedli, Quattro mesi fra i briganti del Sud
d’Italia, tr. it. in A. Caiazza, La banda Manzo
tra i briganti campani e lucani nel periodo postunitario, Napoli, Tempi Moderni, 1984, pp.
107-197.
“Gio” = “Giornale di Napoli”, 1865.
“GiOf ” = “Giornale Officiale”, Napoli, 1863.
Hob2 = E.I. HobsbawmI banditi, Il banditismo sociale nell’età moderna, tr. it., Torino, Einaudi,
1971 (ed. or. 1969).
“Jou” = “Journal Illustré”, 5/3/1886.
Lich = J.J. Lichternsteiger, Quattro mesi fra i briganti 1865/1866, tr. it., a cura di U. Di Pace,
Cava de’ Tirreni, Avagliano, 1984 (ed. or.
1894).
Lomb1 = C. Lombroso, L’uomo delinquente, Hoepli, Milano, 1876.
Lomb2 = C. Lombroso, Il brigantaggio, Aversa,
s.n.t., s.d.
Lomb-Fe = C. Lombroso-G. Ferrero, La donna
delinquente, Fratelli Bocca, Torino, 1915 (prima edizione 1892).
Luc1 = A. Lucarelli, Il Sergente Romano, Bari, Palomar, 2003 (ed. or. 1922).
Mach = A. Machado, Juan de Mairena, Editorial
dal Curdo 2010.
Ma-Fa = A. Manhés-R. Mc Farlan, Brigantaggio,
Lecce, Capone, 2001 (ed. pr. 1931).
Moe = W.J.C. Moens, Briganti italiani e viaggiatori inglesi, a cura di M. Merlini, tr. it., Milano,
TEA, 1997 (ed. or. 1866).
Monn = M. Monner, Notizie storiche documentate del brigantaggio nelle provincie napoletane,
Napoli, Berisio, 1965.
77
Q
uaderni
Nico = O. Nicosia, Brigantaggio postunitario: le
bande Colamattei e Fuoco, in “Latium”, 1988,
n. 5, pp. 82-145.
“Po” = “Il Popolo d’Italia”, 1866.
Padu = V. Padula, Cronache del brigantaggio in Calabria, a cura di D. Scafoglio, Napoli, Athena, 1974.
Palu = G. Palumbo, Cronologia del brigantaggio
sul Matese, in “Annuario” 1997, Associazione
Storica del Medio Volturno, Napoli, Laurenziana, 1997.
Poli = Polistina, Maria Rosa Martinelli. Causa
Masini. Difesa innanti il Tribunale di Guerra
di Potenza, Napoli, Tipografia Gargiulo, 1865.
“Pu” = “Il Pungolo”, 1862-1865.
Ri-L = G. Rizzo-A. La Rocca, La banda di Antonio Franco, Castrovillari, Il Coscile, 2002.
Roma = V. Romano, Brigantesse. Donne guerrigliere contro la conquista del Sud, Napoli,
Controcorente, 2007.
Sang = L. Sangiullo, Il brigantaggio nella provincia
di Benevento tra il 1860 e i1 1880, Benevento,
De Martini, 1975.
78
Sca = D. Scafoglio, Terre e briganti. Il brigantaggio
cantato dalle classi subalterne, Messina-Firenze, D’Anna, 1977.
Sca-Del. = D. Scafoglio-S. De Luna, Le donne col
fucile. Brigantesse dell’Italia postunitaria, Fisciano, Cues, 2008.
Serg1 = G. Sergi, Se vi sono donne di genio, in
«Atti della Società Romana di Antropologia»,
Roma 1893, pagg. 167-182.
Serg2 = G. Sergi, Sensibilità femminile, Lettera al
prof. Lombroso, in «Archivio di Psichiatria,
Antropologia criminale e Scienze penali per
servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente», gennaio 1892.
Tor = L. Torres, Tra i carabinieri a caccia di briganti nell’Abruzzo postunitario, Cerchio, Polla
Editore, 2001.
Tra = F. Trapani, Le brigantesse, Roma, Canesi,
1968.
Varu = P. Varuolo, Il volto del brigante. Avvenimenti briganteschi in Basilicata, Galatina,
Congedo, 1985.
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Mujeres en armas: la revolución
mexicana de 1910
Alicia Castellanos Guerrero - Francisco Pineda Gomez
D
esde tiempo atrás, las mujeres participan de múltiples formas en los procesos
de resistencia y transformación social de México. Su presencia en
las grandes gestas de la historia nacional ha
sido siempre fundamental desde la guerra de
independencia, que se inicia en 1810, las diversas resistencias patrióticas contra las invasiones extranjeras, la revolución de 1910,
hasta las luchas por sus derechos específicos
y los movimientos sociales contemporáneos.
Pero la invisibilidad y negación de las contribuciones de la mujer en la forja de una nación soberana y en los procesos emancipatorios de carácter democrático-popular será
una constante en el pensamiento patriarcal
que se expresa en la historiografía convencional y en una buena parte de la literatura
contemporánea, objetos del valioso trabajo
de la crítica feminista que ha emprendido,
con perspectiva de género, una nueva lectura de nuestra historia.
En la lucha por la independencia nacional, los sentimientos patrióticos expresados
1
2
por las mujeres no surgen exclusivamente
del “campo de las emociones”, como frecuentemente se puede leer en los libros de
la historia oficial, sino que éstos derivan de
una conciencia nacional que se fragua en las
múltiples formas de sujeción e injusticia colonial, desde el lugar subalterno de su condición femenina en la sociedad, que alienta su
compromiso con la nación que se va conformando desde el siglo XVIII. Los prejuicios
y el sexismo pesan a la hora de valorar, por
ejemplo, el papel que juega en momentos
cruciales de la lucha independentista, Josefa Ortiz de Domínguez, de origen mestizo
y mulato, “sensible a las experiencias de humillación, desprecio y segregación”1, fuentes
que alimentarán su conciencia2. La mujer
comunica a los líderes insurgentes los planes
de los realistas, ayuda a los soldados del ejército del pueblo y les provee alimentos, funciones que si bien corresponden al mundo
de lo “doméstico”, resultan acciones decisivas para el arranque de la rebelión anti-colonial y el triunfo posterior de la naciente
sociedad de ciudadanos libres.
Véase Gutiérrez Chong, 2004.
Ranero Castro, 2011; Natividad Gutiérrez, 2004: 34.
79
Q
uaderni
Las mujeres intervienen en estos procesos desde los distintos lugares que ocupan
en la sociedad y en sus colectividades de
pertenencia social, étnica, cultural, al igual
que en los proyectos contemporáneos para
refundar la nación y resistir los embates
de la devastación y el despojo neoliberales;
pero, aun así, las tareas que desempeña, aún
en el campo de la revolución y la lucha social, se consideran de poca trascendencia,
configurando una imagen estereotipada que
oculta convicciones políticas, conciencia social y amor a la patria.
En la revolución, las mujeres desempeñaron un papel estratégico en la guerra de
los ejércitos que lucharon por causas diametralmente opuestas: por una parte, las que
se unieron a la lucha del Ejército Libertador
del Sur y el Ejército villista, quienes combatieron por el fin de la explotación y la servidumbre de las haciendas, por Tierra y Libertad; mientras que, en la otra, las mujeres son
enroladas de diversas maneras en el Ejército
federal, luchando por la continuidad de viejos y nuevos privilegios de las elites políticas
y las clases dominantes3.
Las formas en que las mujeres participan
en la revolución fueron multifacéticas y refieren a su protagonismo en el campo de la
guerra y la política. En el escenario de una
profunda y cruenta revolución, ciertamente,
se encuentran mujeres que por su condición de clase, siguen vertientes de la lucha
social que se expresan en diversas corrientes
políticas. Encontramos mujeres en armas,
soldaderas, obreras que luchan por mejores
condiciones de trabajo, periodistas destaca
5
3
4
80
Véase Martha Eva Rocha Islas, 1991.
Véase Rocha Islas, 1991.
Ranero Castro, ob. cit: 19.
das en su labor informativa de denuncia y
difusión de los ideales de la revolución, sufragistas, etcétera.
Por ejemplo, estudiosas ubican figuras
como Margarita Ortega y su hija Rosaura
Cortari4, quienes fueron militantes magonistas que combatieron en el norte de la
República y contribuyen a reorganizar el
movimiento en Sonora y, junto con otras
mujeres, enfrentaron las tropas de Adolfo de
la Huerta, y en un tiempo estuvieron exiliadas en Estados Unidos. En esta lucha, el poder es implacable con las insurrectas, Margarita Ortega es llevada a prisión, torturada
por no revelar nombres de otros luchadores
y fusilada en noviembre de 1913. Acorde a
la misma autora, son mujeres con un sólido
compromiso político por sus convicciones
ideológicas.
Las mujeres en el maderismo, en cambio, son de clase media urbana y constituyen grupos anti-reeleccionistas, trabajan en
apoyo a la campaña para la presidencia de
Francisco I. Madero: sus nombres son, entre
muchos, Teresa Arteaga, Ma. Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar, Adela
Treviño y Carmen Serdán, mientras otras
mujeres participan en Ligas y Centros revolucionarios. Puntualizando, las mujeres “se
integran de formas distintas en lo doméstico, sindical, militar, político y feminista a las
distintas facciones revolucionarias: constitucionalistas, zapatistas y villistas.”5
No obstante, la imagen de la soldadera6
es la única que perdurará en el imaginario
social, ya que el poder la difunde y socializa encarnada en la figura de La Adelita, la
antropologia e storia
eterna acompañante del soldado, misma que
esencializa a la mujer revolucionaria en un
papel, marcado por la subalternidad, que
reitera la dominación masculina y niega su
protagonismo en la resistencia y lucha en
contra de un sistema de dominación y por
los ideales de la revolución. También, se
construye otro estereotipo, en el que se le
“dota de características tradicionalmente”
atribuidas solo a los hombres, como son “la
valentía, el aplomo y la bravura”, cualidades,
que en realidad, pueden ser intrínsecas a
todo ser humano.
Su inserción en este proceso estará sellada por el patriarcalismo, que inexorablemente asigna a la mujer un lugar dependiente y secundario. Cierto que en tiempos de
guerra, este orden de cosas sufre rupturas y
se abren espacios para campear con mayor
libertad y reconocimiento, e incluso ocultar
su condición de mujer, como es el caso, entre otras, de Amelia Robles. Esta mujer revolucionaria se hace pasar por hombre y por
sus méritos alcanza el grado de coronel en el
ejército zapatista; a ella acudían otras mujeres para “protegerse de la violencia sexual de
la guerra, o bien, con el fin de participar en
actividades militares y ser reconocidas como
soldados y no como soldaderas”7. También
ésta participación dependerá de la causa que
defienden y de los modos de su inscripción
en la sociedad.
Es verdad que muchas mujeres en este
período de la historia nacional cumplen el
papel de las llamadas “soldaderas”; esto es,
6
7
8
/ 1 – donne in armi
van a la lucha para abastecer a los hombres
combatientes, pero, a la vez, también es cierto que forman parte del esfuerzo bélico y, en
muchos casos, realizan tareas de informantes del Ejército Libertador, son transmisoras
de saberes y mensajes estratégicos para la
guerra. En tanto adherentes del ejército zapatista, en ocasiones, se defienden y vengan
a sus hombres caídos en combate; asimismo,
encontramos a maestras sindicalizadas que
apoyan al Ejército Libertador, mujeres organizadas en brigadas socialistas, y, desde
luego, mujeres en armas de heterogéneas
procedencias sociales, que alcanzan diversos
grados militares; fueron muchas las mujeres
en armas y combatientes en esta revolución
social, de todas maneras en la guerra revolucionaria no se lucha sólo con fusiles: hacen
falta las estructuras logísticas, médicas, de
alimentación; esto es, comunidad, familia,
relaciones de parentesco constituyen la base
de los ejércitos populares, en los que las mujeres son un pilar central.
Siguiendo las caracterizaciones que hacen estudiosos del zapatismo y del ejército
zapatista8, hay que señalar la base comunitaria del ejército zapatista, dando como resultado un ejército popular, lo que significa la
existencia de una fuerte relación entre ejército y pueblo, entre lo civil y lo militar. Así,
parece necesario pensar en las bases estructurales y culturales como condición para tener un mejor entendimiento de las formas de
participación de las mujeres en la revolución,
en particular en el zapatismo y en el villismo.
Rocha Islas recuerda que la mujer se incorpora en conflictos armados durante el siglo XIX, la compañera del soldado federal (“por extensión llamada “soldadera”), desempeña “tareas tradicionales” y “las que surgen como parte
de la guerra”.
Cano, citada en Ranero Castro, ob. cit.
Francisco Pineda, 2013, entre otros.
81
Q
uaderni
En la cultura agraria, el mundo de lo privado
y de lo público se funde en la guerra; así, el
hogar y la familia se encuentran en el terreno
de la guerra, y mujeres, niños y hombres se
desplazan y reproducen en los trenes y campamentos, esto es, en esta contienda las estructuras familiares son fundamentales.
Lo mismo ocurría en el villismo, que
también era un ejército popular y llevaba familias completas, aunque avanzada la lucha
intentó profesionalizar y disminuir la participación de las mujeres y niños. Aquí las
mujeres aportan a la causa de la revolución
“sus servicios educativos, de vinculación y
propaganda”9. Hay mujeres especialmente
valerosas, en tareas específicas y en el propio
combate, como Mariana Gómez Gutiérrez,
quien “escribió artículos a favor de la causa
revolucionaria en periódicos publicados en
español que circulaban en el sur de Estados
Unidos. Participó en la toma de Ojinaga
contra los orozquistas en diciembre de 1913;
durante el asalto a la ciudad ella iba con la
carga de caballería que atacó por el lado oeste. Al ver que las tropas desfallecían se puso
al frente de ellas para infundirles ánimo”10.
De mujeres valiosas está llena nuestra
historia, así como de muchos silencios y distorsiones que ocultan su participación, tanto
en la historia oficial como en la supuestamente alternativa. ¿Porque se les ha negado
su reconocimiento en los distintos procesos
que marcaron las grandes trasformaciones
que dan forma a la nación mexicana? Independientemente de ciertos imponderables
sociales que originan la separación de lo
público y lo privado en la sociedad, indiso
Ranero Castro, ob.cit.
Clee Woods, citado en Ranero Castro, 2008.
11
Véase Nira Yuval Davis, en Gutiérrez Chong, 2004.
9
10
82
ciables para la crítica feminista11, que contribuyen a explicar la necesidad de que las
mujeres permanezcan en el mundo de lo
privado; su exclusión de la esfera pública, de
la política, ha sido una estrategia del poder
patriarcal constante en muy diversos procesos de integración nacional. Lo cierto es
que la ideología patriarcal en sus diferentes
tradiciones nacionales y culturales, ha masculinizado el poder y determinado un lugar
subordinado para la mujer en la sociedad y
en la historia. No obstante, con el tiempo, la
historiografía feminista escrita por mujeres y
hombres estudiosos de la gesta revolucionaria, ha ido develando los diversos rostros de
las mujeres en la revolución, con base en la
documentación hemerográfica y la memoria
guardada por sus sobrevivientes, cuidadosamente recopilados. Así, la “soldadera”, no
es la única forma en que participa la mujer
en la revolución. Desde las fuentes históricas
y la crítica feminista, se va dando paso a la
imagen de una mujer multifacética en sus
acciones, de diversas procedencias sociales,
étnicas, educativas, generacionales, lo que se
va construyendo desde su lugar asignado en
la sociedad patriarcal y a partir de su intrínseca rebeldía de ser humano determinada
por su circunstancia y por su voluntad.
Mujeres y revolución.
Insurgencia y Plan de Ayala
No obstante, la historia, desde la perspectiva de los pueblos y contada por su protagonistas, es distinta, las mujeres son artífi-
antropologia e storia
ces de la misma; en la revolución de 1910 las
encontramos en la esfera de lo público, en
la guerra, comprometidas con los ideales de
tierra, libertad y democracia.
¿Por qué se levantó usted en armas?
Coronela Amelia Robles (zapatista): Por una
mera locura de muchacha, fue una aventura
como cualquier otra…
¿Y qué sensación experimentó usted al encontrarse
en plena aventura?
La de ser completamente libre.
Pero, ¿no sentía usted temores?
No. Yo nací en un rancho y desde pequeña me
acostumbré al caballo y a las armas.
Antes de ser revolucionaria, ¿a qué se dedicaba usted?
Estaba yo estudiando, quería ser médico. Pero,
qué quiere usted, vino la bola y me fui a la bola.
Al principio, mi decisión no dejó de ser una mera
locura; pero después supe lo que defiende un revolucionario y defendí el Plan de Ayala.
Coronela Amelia Robles, Ejército Libertador12.
A finales de 1910, sólo se disputaba la
presidencia de la república. Después del
fraude electoral, el movimiento anti-reeleccionista proclamó una rebelión armada para
llevar a Francisco I. Madero al gobierno.
Muy pronto, sin embargo, en el sur del
país irrumpió la multitud insurrecta y ésta
abrió la brecha de la revolución social. Las
acciones directas eran frecuentes por todos
los rumbos surianos, en especial, contra las
haciendas azucareras de los terratenientes,
fábricas textiles y grandes comercios de la
/ 1 – donne in armi
zona; los archivos municipales se incendiaban, las cárceles eran abiertas, los trabajadores presos fueron liberados y azotados
los caciques. Por donde quiera surgía la bola
zapatista: ¡Abajo haciendas! ¡Viva pueblos!
¡Muera el Supremo Gobierno!
En esos días, para apertrecharse de armas
y víveres, los campesinos tomaron el centro
industrial de Metepec, la fábrica textil más
importante de la república. Ahí, las mujeres
alentaron a los obreros a tomar por asalto los
almacenes, según informó El Diario13. Mientras que, en el exilio, el periódico ácrata Regeneración comentó que, luego de la ocupación
llevada a cabo por los zapatistas, “los obreros
de la fábrica – hombres y mujeres – no quedaron satisfechos, sino que acordándose de lo
mucho que les ha robado la Compañía, decidieron expropiar parte de lo que les ha sido
arrebatado bajo el reinado del ‘orden’ y la ‘ley’,
y así lo hicieron invadiendo los almacenes y
tomando todo lo que en ellos hallaron y que
sus propias manos habían producido”14.
La fábrica de Metepec llegó a contar con
más de 1 500 trabajadores en un solo turno;
mientras que, en la proximidad, en los caseríos fabriles de Atlixco, el 90% de los obreros
no eran originarios de ese municipio15. Estos
datos manifiestan las transformaciones estructurales de la época y, además, tuvieron
incidencia directa en la vida cotidiana. Considérese que, en aquel tiempo – como observó el destacado historiador en temas de
la vida cotidiana, José Pedro Barrán – en el
Coronela Amelia Robles, Ejército Libertador; entrevista realizada por Miguel Gil, en Iguala, Guerrero, abril de
1927. Citada por Edith Pérez Abarca en Amelia Robles. Revolucionaria zapatista del sur, Instituto Guerrerense de
la Cultura, Chilpancingo, 2007.
13
“3,000 atacaron la fábrica de Metepec. Eran 1,500 rebeldes y se les unieron 1,500 operarios de la fábrica que acababan de rayar”, El Diario, México, D. F., 9 de mayo de 1911.
14
“El movimiento avanza. La bandera roja es izada en Sasabe. Madero sigue pidiendo paz pero los rebeldes lo maldicen y lo están desconociendo”, Enrique Flores Magón, Regeneración, Los Ángeles, California, 20 de mayo de 1911.
12
83
Q
uaderni
Uruguay todos eran especialistas de la muerte. A la vuelta del siglo XIX, por el hecho de
que la mitad de los muertos eran menores de
diez años, todos habían tenido que asistir a
enfermos graves y ver morir a más de uno de
sus hijos16. Pero la muerte no sólo significaba
angustia personal; también, la costumbre y
la familiaridad con que se trataba la muerte
facilitaban las irreverencias hacia el poder:
allá, en la República Oriental del Uruguay, el
Entierro de Carnaval, la risa-poder popular;
acá, la revolución mexicana.
Estimado jefe
Hónrome en comunicar a usted que el enemigo está posesionado del cerro de Zempoala y las
avanzadas llegan hasta el portezuelo del panadero.
La señora coronela Rosa Bobadilla la sitiaron ayer
y casi toda la gente la avanzó [capturó] el enemigo. Todos los pacíficos [población civil] que se
encontraban en ese punto los mataron, y cuanto
ganado había y semillas, todo se lo llevaron.
Hoy salgo con el coronel Higinio Mendoza y la
misma coronela para dicho portezuelo. Les pondremos una emboscada. Haré todo lo que más
pueda, por no tener parque.
General Ignacio de la Fuente, Ejército Libertador17.
Rosa Bobadilla viuda de Albarrán, desde
el comienzo de la revolución fue zapatista.
En una ocasión que viajó a la ciudad de México, fue acusada de que ayudaba a los rebeldes; y en la prensa se dijo, incluso, que Emiliano Zapata con frecuencia pasaba varios
días de incógnito en la casa de Rosa. Ella,
que en su poblado era conocida “por su espíritu levantisco” y porque viajaba armada a
la ciudad de Toluca, se presentó a las oficinas
del periódico a protestar. Aseguró que había
ido a la capital de la república para tramitar
en Gobernación el ingreso de dos niños al
hospicio y que, también, podía demostrar
las gestiones que hizo en la Beneficencia Pública. Agregó que ella era revolucionaria y
que, en la lucha contra Porfirio Díaz, había
conocido a Zapata.
¿Y ustedes, llegaron a conocer al general Zapata en
persona?
Sí, yo lo llegué a conocer en persona.
¿Cuándo?
Cuando envió un escrito al general Valentín
[Reyes], para que mandara a un jefe, a que fuera
a recibir un lanzabombas18 que le mandaba… Sí,
nos recibió muy bien, fuimos como unos diez. Ahí
estaba él en una casa viviendo y todos sus soldados. Yo ahí vi muchos, pero yo fui con mi esposo…
Entonces, a nosotros nos dio el general [Zapata]
una comida, nos dio de comer ya para salir de allá
para el monte, con el cañón.
¿Qué impresión le causó a usted el general Zapata?
Entonces, me regaló a mí, el general Zapata me dijo:
– Señora, me hace el favor de que escoja dos cortes [de tela] de ahí, uno para usted y otro para su
esposo.
– Cómo no, general.
Me paré y escogí un corte para mí y otro para mi
esposo, para una camisa.
Un hombre muy decente, un hombre muy
atractivo, era un hombre que se veía un hombre
de conciencia…
Cfr. Coralia Gutiérrez Álvarez (Coord.), Movimientos Sociales en un ambiente revolucionario, BUAP, Puebla, 2013.
José Pedro Barrán, Historia de la sensibilidad en el Uruguay, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 2008.
17
General Ignacio de la Fuente al general Genovevo de la O, Ejército Libertador, Mexicapa, Estado de México, 15 de
marzo de 1916. Fondo Genovevo de la O (FGO) Caja 6, Expediente 3, Folio 38.
18
Los zapatistas llamaron lanzabombas a los cañones ligeros que ellos fabricaban. Existe una descripción detallada
de este cañón de 1.75 m de longitud en: “Hubo pruebas con un nuevo cañón, se fabrican granadas”, The Mexican
Herald, México, 15 de abril de 1915.
15
16
84
antropologia e storia
¿Usted no oía qué era lo que querían los zapatistas,
por qué peleaban?
El lema de Zapata era el que llevaban ellos.
¿Cuál era el lema?
El lema de Zapata era que dieran tierras para los que
las necesitaban. Porque antes los ricos les daban de
trabajar por 20 reales19. Todo el día arando la tierra,
ya sus pies ya les lloraban sangre, ya partidos. Unas
grietas así, de este tamaño, los inditos… Entonces,
estas pobres almas se cansaron naturalmente.
Que había revolución, ¡Vámonos a la revolución!
Y Zapata:
– Ya se acabó el tiempo de antes, despierten muchachos, abran los ojos. Ya se acabó que por 20
reales se mataban trabajando. Ahora no, dice.
Ahora, si dios nuestro señor nos ayuda, vamos
nosotros a tener tierras para que las trabajen ustedes, para que coman – decía Zapata – y que ningún gobierno se reelija. Por eso es la revolución,
que sea efectivo, dice.
Irene Copado viuda del general Valentín Reyes,
Ejército Libertador20.
Desde la primavera de 1911, con las acciones de la bola zapatista, inició un proceso que será decisivo en la historia de la revolución social de México: la convergencia
de mujeres y hombres rebeldes, campesinos
y obreros, así como de los zapatistas y magonistas. En el campo de batalla, otras cuestiones – distintas que las disputas electorales
– comenzaron a dirimirse como problemas
fundamentales de la república. En seguida,
Ricardo Flores Magón fue arrestado en Los
Ángeles, California. La sección italiana del
/ 1 – donne in armi
periódico magonista Regeneración denunció
el hecho, en Europa21. Al mismo tiempo, en
la ciudad de México, principió una campaña
de propaganda para exigir el “exterminio de
las hordas” jefaturadas por Emiliano Zapata, “El Atila del Sur”. Desde mucho antes, se
imaginaba al rebelde con el símbolo de Atila
porque éste representa una fuerza extremadamente amenazadora contra los privilegios
del poder. Atila – el más fuerte, flagellum Dei
– operó, en cierto modo, como un condensador de sentido para las preocupaciones racistas dominantes: el ‘sucio’, ‘mal oliente’, ‘estúpido’, ‘irresponsable’, ‘perezoso’, ‘chocarrero’
y ‘lascivo’, estaba en pie de guerra. Luego del
triunfo maderista, las tropas del gobierno
masacraron a zapatistas en la plaza de toros
de la ciudad de Puebla, donde se había improvisado un campamento revolucionario.
Esa noche, “niños, mujeres y ancianos, por
centenares, se encontraban, unos durmiendo
y otros entonando canciones populares… El
fuego de fusilería que vomitaban desde los
prados del cuartel de San Javier, las ametralladoras que colocaron en lugares estratégicos y los cañonazos que a 150 metros escasos
disparaban sobre la plaza de toros, hicieron
pronto una gran mortandad”22. Aquel año,
además, hubo tres intentos del gobierno para
asesinar a Emiliano Zapata, con emboscadas
en Puebla, Chinameca y Villa de Ayala.
En esas condiciones, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos proclamó el Plan
“20 reales”: expresión monetaria de origen colonial, los zapatistas la empleaban para designar un pago ínfimo.
Irene Copado viuda de Reyes, Ejército Libertador. Entrevista realizada por Alicia Olivera de Bonfil y Laura Espejel,
los días 14 y 28 de agosto de 1973, en Contreras, Distrito Federal. Programa de Historia Oral del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (PHO).
21
“Una nuova Scelleraggine. Ricardo Magón arrestado un’altra volta”, Regeneración, sezione italiana, n. 1, 15 de julio
de 1911. Disponible en Internet: archivomagon.net.
22
Testimonio escrito del doctor Guillermo Gaona Salazar y el ingeniero Gustavo Gaona, el 7 de noviembre de 1930, en Francisco Vázquez Gómez, Memorias Políticas (1909-1913), Universidad Iberoamericana-El Caballito, México, 1982, p. 326.
19
20
85
Q
uaderni
de Ayala (noviembre de 1911) y manifestó su
propósito de “acabar con la tiranía que nos
oprime y redimir a la Patria de las dictaduras
que nos imponen”. Llamó a todo el pueblo de
México, mujeres y hombres, a luchar con ese
fin. No convocó solamente a los campesinos
ni sólo a los habitantes del sur de la república.
El Plan de Ayala estableció tres tareas fundamentales sobre la propiedad: restitución de
las tierras usurpadas, confiscación y nacionalización. Estas acciones se aplicarían, respectivamente, en contra de los usurpadores,
los poderosos propietarios y los enemigos de
la revolución. A su vez, los beneficiarios de
estas medidas revolucionarias serían los pueblos y ciudadanos mexicanos, tanto los que
hayan sido despojados como los que sufran la
miseria debido a la monopolización; además,
las viudas y huérfanos de los combatientes
de la revolución. Los zapatistas proclamaron,
así, un código de justicia: la ley de los mexicanos desposeídos, diferente y opuesta a la ley
de los opresores. “Pueblo mexicano, apoyad
con las armas en la mano este plan y haréis la
prosperidad y bienestar de la patria”23.
Ciudadano general Emiliano Zapata
Mi general, estamos a las órdenes de usted. General, quiero que me haga usted favor de darme
el nombramiento [escrito] que usted dice darme,
anticipándole que por lo pronto necesito 50 carabinas y parque. Suplico a usted tenga la bondad
de decirme a quién me dirijo para los haberes de
mis soldados. Es cuanto le dice,
María Guadalupe Muñiz, Ejército Libertador.
Gracias de que nos haya usted concedido lo que
nuestros corazones deseaban: pelear por el Plan
de Ayala24.
La revolución social, que recién comenzaba en 1911, había asumido ya la forma de
una guerra civil y ésta se prolongará por diez
años, con intervenciones militares de Estados
Unidos (abiertas y encubiertas). Fue un proceso revolucionario muy difícil, agravado por el
hambre y las epidemias, sequías y migraciones,
así como por las estrategias de la contrarrevolución que tomaron a la población civil como
objetivo militar. Se ha calculado que en la zona
nuclear del zapatismo, el estado de Morelos, la
pérdida humana total excedió al 60% de mujeres y hombres nacidos antes de 1910. Asimismo se estima que, durante los peores años de
la ofensiva militar contra el zapatismo (1915,
1916 y 1918), en la república morían más de
la cuarta parte de los bebés, durante el primer
año de su vida. En 1914, la esperanza de vida
al nacer era de 17 años para las mujeres y, en
el caso de los hombres, 15 años25. El costo humano de la guerra de exterminio fue enorme.
Tales fueron las condiciones generales en
que se produjo la intervención de la mujer
revolucionaria, constituyente decisivo de la
gesta zapatista.
Al C. general Emiliano Zapata
Su Campamento
Me tomo la libertad de darle un detalle muy superficial sobre nuestra gira a Guanajuato [expedi-
Plan de Ayala, Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, en Emiliano Zapata. Antología, Laura Espejel, Alicia
Olivera y Salvador Rueda, INEHRM, México, 1988.
24
María Guadalupe Muñiz, Ejército Libertador, San Juan Ixtayopan, Distrito Federal, 10 de abril de 1915, Fondo
Emiliano Zapata (FEZ) 7, 4, 92 y 7, 6, 24-25 (dos fragmentos).
25
“Millones desaparecidos: el costo humano de la revolución mexicana”, Robert McCaa, http://www.hist.umn.
edu/~rmccaa/costo_humano_revolucion_mexicana.pdf.
23
86
antropologia e storia
ción de una columna guerrillera] y es como sigue:
Al hacer nuestra gira en julio del presente año
en compañía de mi esposo Cándido Navarro y
en unión del señor general Francisco Pacheco,
salimos por el rumbo de Salazar en donde tropezamos con tropas enemigas teniendo que tomar
el derrotero de Valle de Bravo, en cuyo trayecto
encontrando también tropas enemigas con las
cuáles se trabó un tiroteo como de cuatro horas.
Entonces el general Pacheco ordenó que nos regresáramos y nos internamos en el sierra por donde caminamos todo un día; pernoctando en ella
y al amanecer del día siguiente nos encontramos
solamente Cándido, Iparco mi hijo y yo. Tal vez en
la misma noche ordenó el señor Pacheco salieran
las fuerzas que eran a su mando con las cuales se
fue mi hijo Diascárides. Entonces nosotros tres
nos dirigimos a Coatepec de Harinas, en donde
encontramos al señor coronel Alarcón y su fuerza,
la que nos acompañó hasta Pilcaya, Guerrero, de
ahí le escribimos al señor general Pacheco suplicándole que nos mandara a nuestro hijo y demás
acompañantes y en espera de nuestra contestación
estuvimos dos días y entonces las fuerzas, no pudiendo permanecer por más tiempo, siguieron
rumbo a Guanajuato, quedándome yo en Pilcaya
en espera de mi hijo y los demás, los cuáles no llegaron a pesar de haber escrito cartas a varios jefes.
Permanecí allí dos meses en completa incomunicación, hasta que por casualidad fue el coronel
Vides Barona a una expedición y pude comunicarme con el general [Ángel] Barrios, quien en
otra expedición que mandó por allá y de acuerdo
con el general [Genovevo] de la O me trasladaron
a San Nicolás Malinalco, donde tengo el gusto de
ponerme a sus órdenes; donde sigo ignorando el
paradero de Cándido y mis hijos. Suplicándole
muy atentamente si usted ha sabido algo de ellos
se digne informarme, pues repito no he sabido
nada de ellos.
26
/ 1 – donne in armi
Me encuentro triste solamente por no poder
hacer algo en fruto de nuestra causa. Sin más y
deseándole todo bien y triunfos en la causa que
defendemos, quedo de usted como siempre su
afectísima segura servidora.
Reforma, Libertad, Justicia y Ley
Carlota Bravo de Navarro, Ejército Libertador26.
Cuando esta mujer revolucionaria escribió
esa carta a Zapata, ella no sabía que su esposo
ya había muerto en combate. Esa columna guerrillera tenía por meta irradiar la lucha zapatista en el norte del país y establecer su base de
operaciones en San Luis Potosí. Quizás, en su
soledad, Carlota Bravo recordó amargamente
aquella esperanza con la que ella, su esposo y
sus hijos, se incorporaron a la revolución zapatista, cuatro meses antes cuando hicieron una
colecta en Azcapotzalco, Distrito Federal, e hipotecaron su casa para comprar armas.
Liberación o muerte
La usurpación primordial de las tierras y
la configuración del poder se hizo, en México, por medio de la guerra colonial. El propio Hernán Cortés recibió de la monarquía
española el Marquesado del Valle, un título
de despojo que comprendía tierras, montes,
aguas y decenas de miles de vasallos en zonas
de los actuales estados de México, Veracruz,
Michoacán, Oaxaca, Morelos y el Distrito Federal. Al inicio del siglo XX, sin embargo, el
régimen agrario colonial de las haciendas no
había desaparecido. Por el contrario, continuamente potenció sus efectos destructores.
En Morelos, con la introducción del ferroca-
Carlota Bravo a Emiliano Zapata, Campamento Revolucionario en el Estado de México, 10 de noviembre de 1913,
FGO 13, 10, 66.
87
Q
uaderni
rril y la maquinaria moderna de los ingenios
azucareros, se intensificó la usurpación. Las
tierras destinadas a sembrar el maíz fueron
arrebatadas a los pueblos, para transformarlas
en cañaverales. Los pueblos también fueron
despojados de las principales fuentes de agua,
a fin de incrementar la capacidad de irrigar
las plantaciones y para generar fuerza motriz
en los ingenios azucareros. Asimismo, fueron
despojados de sus bosques, para facilitar otra
fuente energética a las haciendas: el carbón y la
leña. Ante los reclamos campesinos, un hacendado de Morelos respondió a gritos: si quieren
sembrar maíz, que lo siembren en macetas.
¿Cómo se hizo la conquista de México? Por medio de las armas.
¿Cómo se apoderaron de las grandes posesiones
de tierras los conquistadores, que es la inmensa
propiedad agraria que por más de cuatro siglos se
ha transmitido a diversas propiedades? Por medio de las armas.
Pues por medio de las armas debemos hacer porque vuelvan a sus legítimos dueños, víctimas de
la usurpación.
El general en jefe Emiliano Zapata27.
A diferencia de lo que sucedió en otras regiones azucareras del mundo, en Morelos, la
instalación de la tecnología moderna no produjo un dispositivo dominante con dos clases,
el terrateniente y el industrial. Aquí, la innovación técnica se aplicó sobre el régimen agrario
colonial28. Por eso se agudizó, simultáneamente, el monopolio de la tierra y la concentración
industrial en manos de los hacendados. Esto
es, en la zona nuclear del zapatismo la moderna hacienda unió la apropiación de una
renta absoluta, derivada del monopolio de la
tierra, con la apropiación de plusvalía, derivada de la explotación industrial del trabajo en
los ingenios azucareros. Esto engendró una
clase dominante combinada – terrateniente y
capitalista industrial a la vez – con métodos
exacerbados de explotación, despojo y humillaciones. Las infamias contra las mujeres, los
trabajadores y sus familias, para someterlos
al orden industrial-terrateniente, produjeron
una inmensa destrucción de la vida comunitaria. Pero el régimen de humillaciones que
impuso el capitalismo industrial, el agravio
moral, también fue uno de los factores que
potenciaron la gran rebelión de los oprimidos.
Tenían su costumbre de que ahí [en la hacienda]
entraban todas las muchachas, ¿verdad?, y la que
le gustaba al administrador la pedía y se la habían
de dar, pero no para siempre, nomás para una noche. Y cuando se casaba un operario, un trabajador,
tenía que depositar a la muchacha allá en el curato,
para que el cura, el administrador o el hacendado
le “enseñaran sus obligaciones” primero. Así se acostumbraba en aquel tiempo, [así] nos platicaban los
mismos viejos de aquella época. [El cura], ése vivía
en México, nomás venía a visitar. Ahí el administrador era el de todo. Sí, pero era español; no era indio,
eh. Por eso, cuando la revolución, los trabajadores
de la hacienda fueron los que más se sublevaron, de
allí salieron coroneles, generales, capitanes…
General Próspero García Aguirre, Ejército Libertador29
El General Emiliano Zapata a Gildardo Magaña, Ejército Libertador, Campamento Revolucionario, octubre de
1913. FGO, 17, 2, 34.
28
Cfr. Horacio Crespo, Historia del Azúcar en México, tomo I, Azúcar S.A. y Fondo de Cultura Económica, México,
1988.
29
General Próspero García Aguirre, Ejército Libertador, entrevista realizada por Laura Espejel y Salvador Rueda en
Tlatenchi, Morelos, el 16 de agosto de 1975 (PHO).
27
88
antropologia e storia
El dilema moderno estaba bien claro: el
sometimiento brutal o la muerte. Las masacres de obreros en Cananea y Río Blanco
(1906), en este sentido, fueron emblemáticas
de aquello que ocurría por todos lados. Pero,
en esas condiciones, sucedió lo extraordinario. La gente abrió un boquete a ese callejón
sin salida y emprendió una gran revolución.
Así, con el doble movimiento de la mirada –
sobre el contexto específico del capitalismo
industrial y sobre la historia larga de la colonialidad del poder – es posible apreciar la
articulación de las luchas del campo y la fábrica, la convergencia de mujeres y hombres,
en contra de aquel régimen de explotación,
humillaciones y despojo.
General Emiliano Zapata
Las alumnas del Colegio Guadalupano del Sagrado Corazón, al saber de su entrada triunfante a
México, llenas de júbilo nos reunimos en la casa
de la alumna Victoria Castro, y pasamos el día
muy feliz, honrando a los libertadores de la patria y gritando mueran los verdugos carrancistas
que nos dejaron aterrorizadas por los horrores
que cometieron y a cada rato saboreábamos estas
palabras: vivan los valientes héroes que lucharon
con valor hasta romper las cadenas de la esclavitud… Y nos enorgullecemos que nuestra patria
tenga hijos fieles que sienten inflamado su corazón con el sacrosanto fuego del patriotismo, y
su levantada actitud sirve de ejemplo.
Luz Aguilar, La Piedad, Michoacán30.
Ahí, en la multiplicidad de articulaciones, radica la potencia de impacto de aquella
experiencia revolucionaria y sus enseñanzas.
Si la dominación capitalista impone múltiples rupturas a la vida en común; entonces,
/ 1 – donne in armi
la posibilidad de comprender aquella gran
lucha popular radica en redescubrir las articulaciones dentro de la diversidad territorial
y de género, en el campo y en la fábrica, así
como a través de las duraciones distintas de
los procesos históricos de poder y resistencia.
En el pueblo de San Pablo Atlazalpan, reunidos
a petición de la señorita presidenta Adelaida del
Castillo, los señores jueces y todo el pueblo que
voluntariamente con ella están dispuestos a sacrificarse dando un paso al frente para defender los
derechos de nuestra patria, en unión de nuestro
jefe supremo de la revolución del sur y centro, el
ciudadano general Emiliano Zapata y del general
Everardo González; para demostrarles nuestra
unión y fidelidad firmamos todos de acuerdo lo
antes dicho con la expresada señorita, levantamos
esta acta en febrero 7 de 1915, con las firmas que
al calce se presentan31.
Que en esta lucha hubo grandes obstáculos, es cierto. Pero también es cierto que
hay que descubrir cómo los revolucionarios
trataron de enfrentar las dificultades y cómo,
en común, construyeron un horizonte de liberación social y liberación nacional. Hubo
experiencias, en muchos estados de la república, en que las mujeres tuvieron mando
revolucionario; los hombres, por su lado,
no sólo lo aceptaron sino que lo respetaron
y expresaron orgullo por el mando de una
mujer. Con esto también se manifestaba el
curso ascendente de la revolución social. La
subversión de los artificios que produjeron
jerarquías milenarias estaba en marcha.
– ¿Y ése que va [vestido] de charro?… Ay vale,
este coronel ha de ser muy valiente.
Luz Aguilar, La Piedad, Michoacán, 12 de enero de 1915. FEZ 4, 1, 43-44.
Adelaida del Castillo y 99 firmas, Atlazalpan, Estado de México, 7 de febrero de 1915. FEZ 5, 1, 60-61.
30
31
89
Q
uaderni
– ¡Qué, no te fijas! ¡Si es la China [pelo crespo], la
coronela China!
Y que le veo las orejas, pues las tenía agujereadas; y ella nos iba arriando a bajar al gobierno.
Y entonces conocí, verdaderamente, a la coronela
China…
¿Nos podría describir más, un poco más, a la coronela China?
Era trigueña de tez, media delgada, alta, muy delgada.
¿De dónde era ella?
No sé de dónde haya sido. Ella era costeña, pero no
sé de dónde… Era prieta costeña [origen africano]…
¿Ella también traía hombres bajo su mando?
Bastante gente. Pero, en la revoltura, allí, quién
iba a saber cuántos serían.
Joaquín Campos Rodríguez, Ejército Libertador32.
Por lo mismo, la contrarrevolución se
empeñó con saña en combatir a las mujeres,
a las familias y a las poblaciones del territorio zapatista. La suegra de Emiliano Zapata,
doña Guadalupe viuda de Espejo y tres de sus
hijas fueron secuestradas por el gobierno militar de Victoriano Huerta, a mediados de julio de 1913. En aquella ocasión, la secretaría
de Guerra dijo que, desde hacía tiempo, tenía
aviso de la existencia de una red de mujeres
que, con el pretexto de vender comida o fruta
en las estaciones del ferrocarril, eran hábiles
informantes de los zapatistas, a los que ponían al corriente de las fuerzas militares que
llegaban, así como de sus movimientos. Pero
ése no era el caso de la familia Espejo, que
vivía refugiada en Yautepec. “El objeto de la
detención de estas mujeres es el de tenerlas
como rehenes”, explicó el principal diario
de la ciudad de México, El Imparcial 33. Las
mujeres como rehenes: eso también fue un
elemento de la guerra de exterminio contra
los zapatistas. El Ejército Libertador redobló
sus esfuerzos militares. En aquel momento se
preparaba un ataque sobre la ciudad de México y, al mismo tiempo, un atentado dinamitero sobre el automóvil del dictador Victoriano Huerta. La policía secreta hizo una
batida en la capital y obtuvo evidencia de los
preparativos. El encabezado de la sensacional
noticia rezaba: “Una banda de anarquistas
pretendía dinamitar al señor presidente de la
república y otras personas”. Este episodio de
la revolución ofrece nuevos elementos de la
lucha olvidada que hicieron los zapatistas en
la capital de la república. En efecto, en aquellas acciones zapatistas participaban mujeres
y hombres que venían de las filas magonistas.
En esta ocasión, Susana Barrios, hermana
del general insurgente encargado de la preparación del ataque a la ciudad de México,
fue una de las mujeres aprehendidas por la
policía. “Agradezco a usted sinceramente – le
escribió Ángel Barrios a Emiliano Zapata –
la participación que toma con motivo de la
prisión de mi hermana y compañeras [Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez
de Mendoza], que tantos y tan buenos servicios han prestado y seguirán prestando en
provecho de la causa del pueblo; pero puede
usted estar seguro que desde su prisión estarán ayudándonos ya moral como intelectualmente en nuestros trabajos”34.
Emiliano Joaquín Campos Rodríguez, Ejército Libertador. Entrevista realizada por Laura Espejel en Miacatlán,
Morelos, el 12 de julio de 1975 (PHO).
33
El Imparcial, 7 de julio de 1913.
34
Ángel Barrios a Emiliano Zapata, Campamento Revolucionario en el Estado de México, 3 de agosto de 1913, FGO
13, 7, 18-19.
32
90
antropologia e storia
Los magonistas llevaron su experiencia
de lucha clandestina armada a la revolución
del sur. Ángel Barrios, por ejemplo, mencionó que usaba tinta especial en los mensajes
que enviaba a la red urbana zapatista, en la
capital de la república. Mientras que en su
campamento se elaboraban balas esféricas
de plomo para el cuerpo de escopeteros.
También fabricaban minas, bombas y demás
explosivos con que se dotó a un cuerpo especial de dinamiteros. El artefacto para el atentado contra de Victoriano Huerta debió ser
eléctrico; no sería lógico el empleo del sistema de mecha para atacar, en movimiento, el
automóvil del dictador. Jesús E. Hernández
(a) Trigueño, un minero que trabajaba en
tareas clandestinas de ese contingente, llevó
los implementos eléctricos hasta el campamento de Ángel Barrios.
El 24 de noviembre de 1914, tres años
después de la proclamación del Plan de
Ayala, el Ejército Libertador tomó la capital
de la república, cuya población era de más
de 400 mil habitantes. Poco después arribó
Emiliano Zapata y los periodistas se presentaron en su campamento. El jefe suriano se
hallaba en medio de un numeroso grupo de
hombres humildes que formaban semicírculo a su alrededor. Una banda amenizaba
con sus acordes y una débil luz alumbraba
la escena, en la estación de ferrocarril. Ahí
no había siervos opulentos, ni jueces beodos
de sangre, como antes dijera la prensa. No
había tumbas profanadas o danzas satánicas,
ni cuerpos mancillados o pudores inauditos. Nadie se complacía en extraer los ojos
/ 1 – donne in armi
y cortar los testículos. No había rastros de
chacales ni de turbas demoníacas, orgías
monstruosas, huesos calcinados, miembros
tumefactos y dios no era flagelado por Atila35. Sólo eran humildes rebeldes convencidos de su propia fuerza libertaria. Mujeres
y hombres, ancianos y niños, dispuestos a
vencer o morir, pero también dispuestos a
vencer y cumplir.
Había gente de a’i mesmo de México que a los zapatistas nos conceptaban como… se puede decir,
como gente que come gente, vaya. ¡Sí, de veras!
[ríe]
– Ustedes se comen a la gente, nos dijeron unas
que se sentaron con nosotros a’i en el zócalo.
Y me le quedo mirando yo, a una joven, le digo:
– Bueno, ¿por qué nos dices eso?
Dice: Porque ustedes son muy… ¡Quién sabe!,
como del cerro. Ustedes se comen a la gente…
Coronel Narciso Cuéllar Ramírez, Ejército Libertador36.
La revolución social en ciudad
Días después llegaron a México las fuerzas de Pancho Villa y se reunieron con las
zapatistas. Un reportero anticipó que por
mucho tiempo se conservaría en la memoria
la marcha de los 58 mil rebeldes del sur y del
norte que recorrieron la urbe resonante, el
domingo 6 de diciembre de 1914.
La vanguardia de la columna armada
había llegado a Palacio Nacional a las 12 y
diez minutos. Los metales tocaron a libertad mientras que Villa y Zapata entraban.
Acerca del discurso racista contra el zapatismo, cfr. Francisco Pineda, La revolución del sur, 1912-1914, Ediciones
Era, México, 2005, y primera reimpresión, 2013.
36
Coronel Narciso Cuéllar Ramírez, Ejército Libertador. Entrevista realizada por Laura Espejel en El Higuerón,
Jojutla, Morelos, el 19 de julio de 1975 (PHO).
35
91
Q
uaderni
Al salir al balcón central del Palacio, ambos
recibieron el saludo del gentío que llenaba
la plaza de armas y fervor. Se descubrieron
ante la multitud que los aclamaba, y permanecieron así hasta que la manifestación cesó.
No me consta pero me han asegurado que nací
en San Juan del Río, Durango, el nevado amanecer del día 27 de enero de 1875. Este dato debe
ser importantísimo, porque lo han anotado con
minuciosa escrupulosidad en los registros de la
cárcel, cada vez que he estado allí…
Cuando entro a alguna parte, o cuando me presentan a alguien, digo invariablemente: Juana B.
Gutiérrez de Mendoza, San Juan del Río, Durango, 27 de enero de 1875, etcétera, etcétera.
Estos etcéteras son la segunda parte del programa…
También me los sé de memoria y también me he
acostumbrado a repetirlos; parecen un sonoro repique de campanas a vuelo: sedición-rebelión, sedición-rebelión, sedición-rebelión… Eso dicen las
palabras que agregan a mi nombre en los registros.
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Ejército Libertador37.
Desde antes de la revolución, Juana Belén
destacó como directora del periódico rebelde
Vésper. Por su parte, Dolores Jiménez y Muro
– quien usaba el seudónimo de Espartaco
– dirigió dos periódicos zapatistas, El Ideal
Suriano y El Libertario, en Cuernavaca y la
ciudad de México, respectivamente. Asimismo, en la capital, Dolores Jiménez y Muro
fundó un Centro Feminista. Además, en su
condición de maestra, junto con el profesor
y general zapatista Otilio Montaño lograron
la adhesión del Sindicato de Maestros de Escuela a la causa del Plan de Ayala. Así, el 21
de marzo de 1915, por las calles de la capital
desfilaron las primeras milicias de las maestras adherentes a la revolución, armadas con
fusiles, uniformadas y con un estandarte que
decía: “1er. Regimiento de la Brigada Socialista de México.- Sexo Femenil”.
El 5 de mayo siguiente, desfilaron contingentes del mismo sindicato junto con tres
mil efectivos de infantería, caballería y artillería del Cuerpo Nicolás Bravo del Ejército
Libertador. Conmemoraban de ese modo la
victoria de las tropas republicanas de México sobre las tropas imperialistas de Francia
(Puebla, 5 de mayo de 1862). El desfile del 1°
de mayo lo hicieron los zapatistas con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Las fuerzas
villistas habían marchado al norte, desde diciembre, y sólo dejaron delegados y escoltas
en la capital.
Secretario General del Sindicato de Maestros
El general Otilio E. Montaño, en la entrevista que
tuvimos últimamente, me comunicó de una manera verbal los propósitos de ustedes, afiliándose
a los principios que sirven de lábaro a esta revolución, y estimaría infinito de su patriotismo y
entereza, que laboraran ahora, como siempre, en
pro de la buena causa que sostenemos con tezón
y sacrificio. Celebro infinito su actitud, y al encausarse en la vía que prosiguen, obtendrán, sin
duda, el aplauso de la Patria y la estimación de
sus conciudadanos.
Sírvase usted dar cuenta con la presente nota a la
H. Asamblea y aceptar mi nsideración y aprecio.
El general en jefe Emiliano Zapata38.
En el mes de junio, el Sindicato de Maestros de Escuela se reunió, en asamblea, para
Apuntes autobiográficos en Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, extraordinaria precursora de la Revolución mexicana, Ángeles Mendieta Alatorre, México, 1983, p. 18.
38
“Un telegrama del general Emiliano Zapata”, The Mexican Herald, 6 de mayo de 1915.
37
92
antropologia e storia
ratificar su apoyo al Ejército Libertador. Los
trabajadores de la educación comunicaron al general Otilio Montaño que estaban
dispuestos a empuñar las armas y, además,
formar brigadas sanitarias, organizar servicios de ambulancia, vigilancia y exploración,
así como “levantar el espíritu del pueblo,
por medio de mítines en los lugares públicos más concurridos de la ciudad”. Aquella
asamblea también acordó establecer, en la
línea de fuego, un servicio de información
para el sindicato39. Otilio Montaño – ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en
el gobierno de la Convención Revolucionaria y, a la vez, miembro del sindicato – les
respondió complacido. Dio instrucciones
para que todos los profesores que tuvieran
arma se alistaran, en ese ministerio, para
asignarles su brigada y pidió las nóminas
de las profesoras integrantes de las brigadas
sanitarias del sindicato. La comisión sindical estaba formada por las maestras Marina
Martínez y Clementina Barroso, así como
por los profesores Jesús Sánchez, Rodríguez
Arana y José Juan Barroso40.
¿Y usted conoció a algunas mujeres en la revolución?
El que jue coronela es de San Pablo Oztotepec
[Distrito Federal], que se llamaba Esperanza; parece que se llamaba Esperanza González.
¿Ella tenía grado?
Coronela.
¿Y qué tal era doña Esperanza González luchando?
/ 1 – donne in armi
Pues, era arrebatada, era arrebatada… una muchachona gorda y tenía su sombrero tejano y con sus
polainas y con su pantalón de caballería que tenía.
¡Ah!, usaba pantalón la señora.
Pantalón de caballería.
¿No usaba falda?
No, con un [sombrero] tejano y se parecía a muchacho. Con un caballo prieto y su pistola.
¿Y fue la única que usted conoció, mujer…?
Otra mujer de San Salvador [Cauhtenco, Distrito
Federal], pero nunca me acuerdo cómo se llamaba.
¿Y usted la conoció a doña Esperanza González,
habló con ella?
¡Cómo no!, nos encontramos allá en Yautepec,
en la hacienda de Atlihuayán, donde también
fue a pedir elemento de guerra y allí estuvimos
chanceando, allí en la hacienda [donde el Ejército
Libertador instaló la Fábrica Nacional de Cartuchos, acuñó moneda de plata y cobre, e instaló su
escuela militar41].
Juan Arellano Aguilar, Ejército Libertador42.
A su vez, el Centro Feminista marchó
por las calles de la capital junto con el Sindicato de Maestros de Escuela. “En esta
ocasión, ha manifestado más entusiasmo el
elemento femenino que el masculino”, observó un reportero43. Las mujeres de la ciudad estaban en la línea. Al mismo tiempo,
las reuniones de los trabajadores se multiplicaban. Luego de la primera conferencia para
obreros que asistían a escuela nocturna, en
el Museo Nacional, se proyectó una película
sobre la tragedia de la explotación y el ham-
“Están dispuestos a empuñar las armas.- Una comisión del Sindicato de Maestros se acercará a la Comandancia
Militar con el fin de ofrecer sus servicios para la defensa de la metrópoli”, The Mexican Herald, 20 de junio de 1915.
40
“Los profesores se aprestan a luchar. – El Sindicato de Maestros de Escuela pide defender a la Convención con las
armas en la mano”, The Mexican Herald, 20 de junio de 1915.
41
Cfr. Francisco Pineda, Ejército Libertador, 1915, Ediciones Era, México, 2013, pp. 382-384.
42
Juan Arellano Aguilar, Ejército Libertador. Entrevista realizada por Alicia Olivera de Bonfil en Milpa Alta, Distrito
Federal, el 7 de agosto de 1973 (PHO).
43
“Los maestros marcharon esta mañana”, El Combate, 24 de junio de 1915. “Se efectuó la manifestación convencionista”, The Mexican Herald, 25 de junio de 1915.
39
93
Q
uaderni
bre, Germinal 44. Otro periódico adherente
de la causa zapatista, El Combate, publicaba en esos días, por entregas, el folleto de
Kropotkin, “Los Tiempos Nuevos”45. Sergio
Pasuengo, villista, junto con Luis Méndez y
Antonio Díaz Soto y Gama celebraron un
mitin socialista en el Teatro Colón, participaron oradores del Sindicato Mexicano de
Electricistas46. Mientras tanto, el Sindicato
Mexicano de Electricistas, el Sindicato de
Empleados y Obreros de la Compañía de
Tranvías de México, el Sindicato de Empleados de Comercio y el Sindicato de Dependientes de Restaurant, fundaron la Confederación General del Trabajo47. En aquellos
días de junio, el Ejército Libertador defendía la ciudad de México del ataque masivo
carrancista y, simultáneamente, las mujeres
pobres de la ciudad se alzaron. Venustiano
Carranza había establecido el bloqueo económico, la burguesía en masa acaparaba los
principales víveres y los pobres de la ciudad
padecían hambre.
Para el lunes 21 de junio de 1915, cuando
triunfó la primera resistencia zapatista contra el ejército enemigo, las aglomeraciones
para conseguir maíz se volvieron avalancha
humana. Unas 30 mil mujeres batallaron
para conseguir algo qué comer, hubo dos
muertas y varias heridas. En ningún expendio o mercado se consiguió masa ni maíz. Y
se agotó la paciencia. En seguida, la gente en
tumulto se decidió a tomar por la fuerza los
víveres que negaban los acaparadores. La lu-
cha se generalizó en todos los rumbos de la
ciudad. El pueblo hambriento ha empezado
a castigar a sus infames verdugos, expresó
El Combate. Un contingente de la multitud
acudió al cuartel zapatista en la capital, para
reclamar la solución al problema del hambre. Ahí, el encargado directo del Cuartel
General zapatista, general Santiago Orozco
(antiguo magonista, hijo adoptivo de Juana
Belén Gutiérrez de Mendoza y desde el año
anterior, además, su yerno), hizo un discurso y luego envió una declaración escrita para
la prensa, que se publicó al día siguiente,
cuando la rebelión urbana escaló.
Un numeroso grupo de soldados y del pueblo ha
venido hoy a gritarme qué es lo que se hará en
situación tan desesperada si el problema sigue
complicándose, teniendo como único resultado
el hambre. Dicho grupo me pedía que le informara que si nosotros no tomaríamos medidas para
solucionar este problema. Yo les contesté que en
mi carácter de revolucionario defendería la causa
del pueblo en cualquiera circunstancia en que me
encuentre y la posición en que me pueda encontrar. El problema está en pie: el hambre, la miseria
y la angustia reinan ahora entre la clase humilde
del pueblo, y de prolongarse esta situación, el comercio sufrirá las consecuencias si no restringe
su actual comportamiento. El dilema es éste: o
el comercio vuelve sobre sus pasos o el pueblo y
las tropas tomarán lo que necesiten de donde lo
encuentren… Este es el dilema y los culpables deben de atenerse a las consecuencias.
General Santiago Orozco, Ejército Libertador48.
“La primera conferencia para obreros.- Se hizo propaganda de los ideales proclamados por la revolución”, The
Mexican Herald, 24 de junio de 1915. Germinal (Albert Capellani, 1913, 140 min.), basada en la novela de Émile
Zola sobre una huelga minera, en el norte de Francia.
45
Kropotkin, “Los tiempos nuevos”, traducción de Juan J. Rubio, El Combate, 18-29 de junio de 1915.
46
“Mitin socialista en el Teatro Colón”, El Combate, 26 de junio de 1915.
47
“La Confederación General del Trabajo”, The Mexican Herald, 25 y 26 de junio de 1915.
48
“Pueblo y soldados se dirigen al Cuartel General del Sur”, The Mexican Herald, 25 de junio de 1915.
44
94
antropologia e storia
El 22 de junio, grandes contingentes de
mujeres pobres acudieron a los mercados
y tomaron los víveres. La acción directa se
propagó por toda la ciudad, hubo graves
enfrentamientos de carácter insurreccional.
En las calles de Simón Bolívar, el guardián
de una tienda disparó “sobre la multitud,
habiendo causado la trágica muerte de una
infeliz mujer y lesionado a algunas otras personas que allí se encontraban”49. Otra mujer,
que encabezó la rebeldía en calles del centro, descargó rudos golpes de hacha contra
la tienda de abarrotes El Vapor, al tiempo
que insultaba a los propietarios del establecimiento. Las puertas estaban por ceder,
cuando se oyeron detonaciones de arma de
fuego que provenían del interior y se produjo la dispersión. Murió asesinada una mujer. La muchedumbre se rehízo pronto, los
disparos de la tienda continuaban; mujeres y
hombres arrancaron pedazos de asfalto para
defenderse y arremetieron de nuevo contra
la tienda.La columna insurrecta en la octava
demarcación fue encabezada por una joven
de 15 años, Carmen Macías. La policía fue
impotente para contener la acción y ‘alguna
persona’ hizo varios tiros al aire para tratar
de disolver el coraje. Carmen, en lugar de
intimidarse, arengaba a sus compañeras. En
la tienda Las Cumbres de Maltrata, esquina
de Bolívar y Mesones, el propietario Fernando Pérez Álvarez y uno de sus empleados
también hicieron fuego contra la gente, después fueron capturados. Sobre la calzada de
Nonoalco, Sabina García fue asesinada por
bala en el pecho, murió un niño de 40 días y
resultaron heridas por bala María Concep-
/ 1 – donne in armi
ción Panera, Dominga Romero, Manuela
Velázquez, Catarina Corona, así como Pedro Jiménez. Los zapatistas encargados del
Cuartel General y el ayuntamiento del Distrito Federal, Santiago Orozco y Gildardo
Magaña, ordenaron al Inspector de Policía
(villista) que pusiera en absoluta libertad a
las prisioneras de las jornadas de lucha50.
La combinación del levantamiento urbano y la defensa armada de la capital fue
el rasgo más peculiar de las jornadas de junio. En el mismo espacio y tiempo, los más
humildes y los más oprimidos, en combate:
las mujeres pobres contra la burguesía y el
ejército de los campesinos revolucionarios
contra el carrancismo. Con un añadido
importante, era la capital de la república y
tiempo de revolución. Aquellas columnas
multitudinarias de mujeres pobres pasaron
de la defensiva a la ofensiva. Ya no pidieron
maíz, lo tomaron por medio de la acción
directa. Si en 1911, la proclama del Plan de
Ayala para restituir, confiscar y nacionalizar
las tierras fue, abiertamente, un llamado a la
insurrección campesina; ahora, en la capital,
la confiscación masiva de los alimentos, en
los hechos, era un llamamiento a la insurrección urbana.
En junio de 1915, surgió una situación
insurreccional. Pero, no era la huelga política general de los obreros lo que generaba
condiciones para el levantamiento urbano
masivo, sino la fuerza de las mujeres y los
campesinos, en las calles de la capital y en
la línea de fuego. En esta coyuntura, el problema crucial de la insurrección urbana no
era cómo ganar para la causa a un sector del
Ídem.
“Los grupos no hacen frente a los bomberos”, “Más de 10 cuartillos de maíz se venden”, The Mexican Herald, 27 de
junio de 1915.
49
50
95
Q
uaderni
ejército represor – como ocurrió en otras experiencias históricas – sino cómo incorporar
a los hombres trabajadores al levantamiento. La huelga revolucionaria para ejecutar,
en la capital, masivamente el Plan de Ayala
y nacionalizar los bienes a los enemigos de
la revolución estaba a la orden del día, igual
que la defensa militar. Lo crucial no eran los
alegatos doctrinarios. Más bien, los acontecimientos señalaban una posible ruta: ligar
orgánicamente la fuerza de la insurgencia
campesina con la rebelión de las mujeres y
llamar a la huelga general como medio auxiliar para producir la insurrección.
El levantamiento general en la ciudad y
la confiscación a los enemigos de la revolución, no eran una utopía; más bien, fue la
acción masiva de las mujeres pobres en las
calles. En los hechos, fue el punto más alto
de la revolución social de México, un trayecto convergente en las luchas del campo y la
ciudad. La situación insurreccional que se
produjo era la condición necesaria para asumir los siguientes escalones revolucionarios:
aplicar masivamente el Plan de Ayala en la
ciudad y confiscar los bienes a los enemigos
de la revolución, acaparadores y especuladores, que era la burguesía en masa; en consecuencia, estructurar órganos populares para
el control de los alimentos y la producción.
Ese proceso revolucionario de los pobres
del campo y la ciudad, a pesar de grandes
dificultades que tuvo desde que inició en
el año de 1911, arribó a un punto en que se
avizoraba otro horizonte histórico: la posi-
ble unidad orgánica del Ejército Libertador
y el levantamiento urbano; la combinación
de trincheras y barricadas para asumir conjuntamente la resistencia armada al carrancismo y a la burguesía.
Semanas después, el ejército carrancista
sobrepasó a las líneas defensivas del Ejército
Libertador y tomó la capital de la república. El
New York Times anunció alegre: “es el principio del fin de la revolución”51. Por su parte, el
comandante carrancista proclamó que, con la
ocupación de la ciudad de México, “el gobierno constitucionalista domina casi la totalidad
de la república y con ello ha demostrado que
es un gobierno fuerte, porque cuenta con las
armas” – entregadas por Estados Unidos52 –
“para el restablecimiento del orden y la ley”53.
En seguida, González informó a Carranza
que sus topas habían hecho más de 3 mil
muertos zapatistas, sólo en uno de los sectores de combate, y decretó la anulación de la
moneda circulante en la ciudad. Los comerciantes se negaron a vender y de inmediato
reinició la rebelión de las mujeres pobres, en
toda la ciudad de México. El motín más grande ocurrió en La Merced, el mayor mercado
urbano del país. Llegó la tropa carrancista y
lanzó una carga de caballería contra la multitud, pero la avalancha humana de mujeres
y niños no se disolvió. “Minutos después, se
escucharon descargas de fusilería. En el pavimento ensangrentado quedaron yacentes”
los cuerpos del hambre. Bajo un titular que
rezaba: las autoridades militares emplearon la
fuerza para poner orden, el Mexican Herald
“Capture of Mexico city by the carrancista forces”, The New York Times, 12 de julio de 1915.
En nueve meses, enero-septiembre de 1915, el ejército carrancista recibió de Estados Unidos 25.3 millones de cartuchos y 53 749 fusiles y carabinas, según los registros del mismo ejército en el puerto de Veracruz. Cfr. Francisco
Pineda, Ejército Libertador, 1915, op. cit.
53
“Las operaciones del Ejército de Oriente”, The Mexican Herald, 12 de julio de 1915.
51
52
96
antropologia e storia
informó: “A los primeros disparos, el pánico
se posesionó de la multitud y, en desordenada
carrera, hembras y pequeñuelos empezaron a
guarecerse en cuanto punto se creían a salvo
de una bala… golpeaban fuertemente en las
puertas de las casas cercanas, pidiendo asilo
con angustiada voz. Todo era inútil”. La bestia
estaba lanzada y “las maderas de las puertas
se oponían al paso de los que buscaban refugio”. La tropa carrancista también disparó
contra la muchedumbre en La Lagunilla, San
Juan y el rumbo del casco de Santo Tomás.
Las mujeres heridas fueron amontonadas en
el Hospital Juárez, donde no había médicos,
medicinas, ni camas para atenderlas54. Las
muertas de La Merced y otros mercados no
fueron tomadas en cuenta, desaparecieron.
El orden del hambre se mezcló con la sangre,
eso ha sido de ley.Al día siguiente, en Washington, el secretario de Estado dio instrucciones al agente Silliman: “dígale a Carranza
que la actitud de Pablo González, al ocupar la
ciudad de México, ha causado una impresión
favorable”55.
La guerra de resistencia zapatista continuó por cinco años más, en condiciones
etraordinariamente difíciles. Fue una gesta
heroica de la revolución social y eso no lo
pudieron exterminar, quedó grabada con
fuego en la memoria histórica de México.
Pero si la historia de la revolución zapatista
puede ser entendida como un texto, otras revoluciones sociales aparecen ineludiblemen-
/ 1 – donne in armi
te como su contexto. Se multiplican así las
posibilidades de comprender la significación
histórica del Ejército Libertador.
Y la lucha sigue: de un lado, los acaparadores de
tierras, los ladrones de montes y aguas, los que
todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el
petróleo. Y del otro, los campesinos despojados
de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han
sido robados en su jornal o en sus intereses, los
que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor, y que quieren
recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra
que les permita trabajar y vivir como hombres libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y
sin miserias.
El general en jefe Emiliano Zapata56.
Mujeres participaron en todas las etapas
de la lucha revolucionaria, temprano en el
siglo XX, desde que surgió la bola zapatista y se iniciara la insurgencia, las cartas de
las coronelas y mujeres zapatistas dirigidas
al general del Ejército Libertador, Emiliano
Zapata revelan su lugar y sus ideales en esta
gesta heroica del pueblo mexicano, las mujeres escriben para comunicar sus planes de
lucha, refrendar su convicción con la revolución y solicitar armas; testimonian sobre la
figura del general y los ideales de la revolución que terminarían con la explotación de
los trabajadores de las haciendas y condiciones infrahumanas en las que vivían; en estas
“Se registraron en la metrópoli varios saqueos.- La cuestión de los billetes dio margen a serios desórdenes en La
Merced y en otros sitios. – Las autoridades militares emplearon de la fuerza para poner el orden”, The Mexican
Herald, 16 de julio de 1915.
55
Robert Lansing a John Silliman, Washington, D.C., 16 de julio de 1915. Foreign Relations of the United States
812.00/15454.
56
Manifiesto “Al pueblo mexicano”, Ejército Libertador de la República Mexicana, Cuartel General en Tlaltizapán, 29
de mayo de 1916. Fondo Gildardo Magaña 27, 5, 56.
54
97
Q
uaderni
cartas dejan testimonio de su conciencia mujeres que junto con sus familias brindaron
sus bienes para la causa de la revolución y
compra de armas, informando sobre los enfrentamientos con las tropas enemigas y en
condiciones extremadamente adversas de la
lucha, poniéndose a las órdenes del general;
jóvenes estudiantes de colegios religiosos en
la ciudad de México comunican su felicidad al honrar a los libertadores de la patria;
mujeres de diversas procedencias sociales
y étnico raciales con pantalón al mando de
tropas, quienes fueron respetadas y reconocidas, ganaron admiración, por su entrega
y capacidad y por su valentía. La revolución
social en la ciudad de México se caracterizó
por las acciones heroicas de mujeres y hombres y grupos organizados para la defensa de
la ciudad de México, fueron estratégicas para
la guerra. Pero la guerra de exterminio que el
mal gobierno emprendiera no tendría límites, los intereses extranjeros en juego, particularmente del gobierno de Estados Unidos,
contribuirían a la derrota de los revolucionarios. Muchos hombres y mujeres murieron
en esta revolución; lo que representó una
pérdida demográfica, entre muertos, desaparecidos y emigrados57. No obstante, fue un
tiempo de rupturas de relaciones asimétricas,
de convergencias y solidaridades de mujeres
y hombres y de muchas esperanzas. Queda
la memoria de esta gloriosa gesta, protagonizada por mujeres y hombres con los más
caros ideales, la profunda convicción de que
la lucha sigue, pues de un lado están los insaciables de poder y por el otro, millones de
pobres despojados de bienes y derechos que
quieren vivir como mujeres y hombres libres.
La lucha sigue
La lucha por una Patria con justicia y libertad, por tierra y territorio, en defensa de
los recursos de la nación, por los derechos de
los ciudadanos y los propios de las mujeres,
de los diferentes, no ha terminado. Vivimos
un momento de nuestra historia más complejo por la globalización del poder y de la
guerra, a poco más de un siglo de la revolución de 1910, nos encontramos nuevamente, como en los tiempos de la dictadura de
Porfirio Díaz, contra la cual se rebelaron los
zapatistas y los villistas y tantos otros mexicanos, ante la paulatina pérdida de la soberanía nacional, regional y local, y el despojo
de la nación, del trabajo y de las conquistas
laborales de los trabajadores, circunstancias
todas, que unen a los hombres y a las mujeres que aspiran otro mundo.Los ideales que
dieran lugar a la revolución siguen vigentes,
vivos, la patria, la patria de los pobres está en
peligro, desde hace tiempo los pueblos y las
comunidades indígenas están amenazados
por la expansión de las empresas transnacionales y nacionales, por las reformas constitucionales que privatizan y venden el patrimonio del pueblo mexicano, nuevas luchas han
sido emprendidas por mujeres y hombres en
contra del despojo de los bienes de la nación.
Luego de poco más de un siglo, en las tierras
de Zapata y cuna de la revolución del sur, el
gobierno del estado de Morelos promueve
un programa neoliberal de “modernización
e industrialización” a través del Plan Integral
de Morelos, para favorecer grandes empresas
nacionales y transnacionales; su desarrollo y
expansión afectarán tierras agrícolas, terri-
Véase a Robert McCaa, http://.hist.umn.edu/-rmccaa/costo_humano_revolucion_mexicana.pdf.
57
98
antropologia e storia
torios, salud de sus habitantes y patrimonio
cultural de la nación.
Por ejemplo, en la región del Oriente
de Morelos, las empresas españolas Elecnor y Abengoa, instalarán termoeléctricas,
empresas metal-mecánicas que habrán de
generar empleos para técnicos calificados
procedentes de otras regiones, originando
un desplazamiento de los pobladores originarios, señala Hersch58; además de los graves efectos en la vida de los pobladores por
el alto consumo de agua que exige su funcionamiento, pondrán en riesgo la vida de
sus habitantes, pues uno de los gasoductos
atraviesa una zona de alto riesgo que es el eje
neo volcánico del Popocatépetl. En la región
centro, la Esperanza Silver, es el nombre de
una de las empresas canadienses al que el
gobierno mexicano le ha concesionado un
proyecto de explotación minera a tajo abierto, significando despojo de tierras, uso del
agua en proporciones que afectaría el riego
de tierras de uso agrícola y el abastecimiento de los habitantes del sur de la ciudad de
Cuernavaca y vulneraría el centro ceremonial de Xochicalco, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. En este caso
particular, la movilización de la población,
/ 1 – donne in armi
de los investigadores del INAH Morelos, entre otros actores, impidió el avance del proyecto, pero lamentablemente la empresa está
buscando nuevos subterfugios para la explotación de los minerales y la depredación
indiscriminada del medio ambiente. Hoy la
empresa Álamo, otra firma canadiense reanuda el proyecto de extracción de metales
preciosos, una megaminería tóxica de alto
impacto para las comunidades de la región59
y el desarrollo y modo de vida de los campesinos, y de nuevo, hombres y mujeres se
organizan en defensa de sus tierras, salud y
patrimonio material y cultural. El Frente de
Pueblos en defensa por la Tierra y el Agua
conformado por habitantes de los estados de
Morelos, Puebla y Tlaxcala ha demandado la
cancelación del Proyecto Integral Morelos.
Desde fines del siglo pasado, las mujeres
zapatistas de Chiapas, han estado activas en
el proceso de formación de un ejército sui
generis, que es el EZLN, en el que son reconocidas como comandantas, mayores, entre
otros grados militares. Se cuenta que una
compañera llamada Susana, miembro del
EZLN en 1993, juntó las demandas de miles
de mujeres, darían contenido a la Ley Revolucionaria de Mujeres60, la que sintetiza y
Paul Hersch, De gasoducto y termoeléctricas: ¿el mejor modelo de desarrollo para el Oriente de Morelos?”, En el
Volcán, Revista virtual, 15 de noviembre de 2012: 3.
59
Editorial, “La Minería a tajo abierto en Morelos y la “Seguridad Hemisférica”, en El Volcán, Revista virtual: 2
60
Primero. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha
revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segundo. Las mujeres tienen derecho
a trabajar y recibir un salario justo. Tercero. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden
tener y cuidar. Cuarto. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son
elegidas libre y democráticamente. Quinta. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud
y alimentación. Sexta. Las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima. Las mujeres tienen derecho a elegir
su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava. Ninguna mujer podrá ser golpeada o
maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en
las fuerzas armadas revolucionarias. Décima. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan
las leyes y los reglamentos revolucionarios.
58
99
Q
uaderni
comprende un campo diverso de la vida social en 10 derechos históricamente negados,
varios de los cuales implican su presencia en
la esfera pública, históricamente de exclusividad masculina Algunos de estos derechos
han sido reconocidos desde hace tiempo en
la legislación internacional (la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, etc.).
No obstante, los estados capitalistas no han
respetado ni hecho respetar, incluso derechos que durante largo tiempo estuvieron
sujetos a leyes específicas: por ejemplo, el
derecho a votar de las mujeres, que sólo se
reconoce hasta mediados del siglo XX, luego
de larga lucha de las mujeres sufragistas.
El derecho a participar en la lucha revolucionaria “en lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen”, se ha ejercido
por la vía de los hechos en la revolución,
recuérdese que en la lucha armada, las mujeres acudieron a la indumentaria masculina
con osadía y por necesidad práctica. No hay
que olvidar que la guerra ha sido el campo
de lo masculino, símbolo de fuerza y poder,
con sus atributos y exclusividades; así, las
mujeres zapatistas de hoy reclaman el derecho a participar y merecer grados militares
y no han tenido que ocultar en este tiempo
su identidad de mujer; si acaso lo hicieron
algunas mujeres en la revolución. Participar
en los asuntos de la comunidad y ocupar
cargos en las Juntas de Buen Gobierno si son
elegidas democráticamente, son, sin duda,
derechos que plantean una transformación
de los roles tradicionales de mujeres y hombres, cambios en la política y en la toma de
decisiones, que se supone, históricamente
exclusivos de los hombres, no sólo en las comunidades indígenas, pero en la sociedad.
Estos derechos conducen a un cumplimiento distinto de deberes y compromisos con la
100
familia, cuya preservación como institución
es un asunto de todos sus miembros. Su espíritu es profundamente revolucionario, en
la medida que no sólo significa el derecho
de las mujeres de participar y de su desarrollo como personas, y como miembros de la
comunidad, a la que igualmente se quiere
contribuir en su continuidad y cambio, sino
que implica potenciar y sumar las capacidades de todos los miembros de la familia y de
la comunidad para alcanzar las aspiraciones
de una vida mejor. Trabajar y recibir un salario justo constituyen una demanda histórica,
aunque parece que está referido al trabajo
para la comunidad, que por tradición no ha
sido remunerado. Salud y alimentación son
derechos de todos y, muy específicamente
de las mujeres que requieren una atención
especializada relativa a la reproducción biológica. El derecho a la educación abre una
ruta para la incorporación más amplia de
la mujer a la vida social y política. El derecho a decidir el número de hijos que pueden
tener y cuidar, nos remiten a los derechos
reproductivos, que a la fecha no se han ejercido plenamente, el reconocimiento de este
derecho rompe con una concepción y una
práctica patriarcales que han confinado a la
mujer exclusivamente al mundo de lo privado, al hogar y al cuidado de los hijos, una
práctica de control del Estado, en particular, de los cuerpos femeninos, (dependiendo de las políticas demográficas que pone
en práctica en distintos contextos, relativas
al control de la natalidad, legalización o no
del aborto, etc.), de los hombres, condicionado por algunas religiones, un derecho que
corresponde primordialmente a la mujer,
como es decidir plenamente sobre su propio
cuerpo. La prevención de la violencia intra y
extra doméstica y la penalización del intento
antropologia e storia
de violación constituye un reconocimiento
fundamental en estos tiempos de violencia,
en los que la violencia de género se exacerba,
de feminicidios y conversión de la mujer en
una especie de botín de guerra.
A veinte años de autonomía zapatista en
Chiapas, las mujeres cuentan los avatares de
su participación. Esta ley revolucionaria ha
ido cambiando las relaciones de género, reconocen que se avanza, poco a poco, “que no
han cumplido totalmente”, aclaran que no
quieren mandar y dominar, lo mismo que los
hombres han hecho durante siglos, “pobrecitos”, lo que quieren las mujeres y hombres zapatistas es construir una nueva humanidad,
la lucha no es una lucha de mujeres o una lucha de hombres, es una revolución en la que
van juntos. Aquí es importante no perder de
vista los límites de lo jurídico a nivel nacional y local; así, si los derechos se quedan sólo
inscritos en la ley y no derivan en prácticas y
acciones y políticas para hacerlos vigentes, de
nada habría servido el esfuerzo para hacer las
leyes, es cierto, lo sabemos todas (os) es un
proceso largo y complejo, implica un cambio de mentalidades, de conciencias, como
lo constatan las mismas mujeres zapatistas,
a veinte años de su lucha. Ahora proponen
agregar nuevos derechos, que con los diez de
la Ley aprobada desde 1993 suman 33, pero
que todavía no son incorporados en esta Ley:
Estos se refieren al derecho al descanso;
piénsese en las interminables horas de trabajo y multiplicidad de tareas que la mayoría
de las mujeres cumplen, con las dobles o triples jornadas para las mujeres en la familia,
/ 1 – donne in armi
fuera de casa y en la política. Piden se prohíba el abandono de las mujeres sin razón;
“el derecho a tener, a heredar y a trabajar la
tierra”; a recibir crédito, a impulsar y dirigir
proyectos productivos”; a repartir los bienes
por partes iguales en caso de separación del
matrimonio; a ser apoyada cuando se hace
trabajo para la organización; a defenderse
verbalmente; piden sean castigados quienes
discriminan, se burlan y abusan de las mujeres en múltiples formas; exigen el derecho al
respeto y a la información, a ser respetadas e
informadas.
Todo este campo de formas de trabajo
no reconocido y valorado socialmente, de
subordinación, indefensión y de múltiples
formas de discriminación y exclusión son
asignaturas pendientes en el proceso de
construcción de la autonomía en toda su
complejidad, de una sociedad sin dominación masculina. Pese a que estos derechos
aún no se han incorporado a la Ley, en la
práctica los zapatistas de hoy desarrollan y
consolidan sus autogobiernos, la educación
intercultural, profundizan e instituyen el reconocimiento y participación de las mujeres
en la vida social y política, en el marco de los
múltiples procesos que causan la crisis económica mundial y la política de un Estado
neoliberal que avanza sobre los territorios,
los bienes de la nación.
Este es el legado de las zapatistas históricas y contemporáneas, de innumerables
mujeres indígenas y no indígenas, de las
mujeres de Cherán, Michoacán, que desde hace dos años, sacaron las fogatas61 a la
Las fogatas son los fuegos de las cocinas que las mujeres de Cherán sacaron a la calle, como puntos de reunión y
organización, para defender su bosque y la dignidad de su pueblo. Muchas fogatas se prendieron en las esquinas
de las calles de la ciudad, alrededor de las cuales se juntaron los vecinos, conviviendo pese a las diferencias políticas. Las mujeres preparan alimentos que son compartidos, las fogatas siguen prendidas. Las fogatas de Cherán se
61
101
Q
uaderni
calle para defender su patrimonio, que es
su bosque, su comunidad, sus familias, la
dignidad y la vida, y son ejemplo para que
otras fogatas se prendan en la República.
Etimológicamente y literalmente, patrimonio significa herencia recibida por la vía
paterna, esto es expresión de la dominación
masculina, pero también pasado, recuerdo,
memoria e identidad individual y colectiva:
“el patrimonio creado por la memoria y la
palabra que lo expresa, produce en el grupo el sentimiento de compartir una misma
herencia y de atar los lazos que la hacen posible. En ese sentido, herencia, memoria y
patrimonio son expresiones de un mismo
espacio mental y social”, escribe Urbano62.
La polisemia de esta palabra también obedece a la intervención de diversos actores en
su definición y defensa de intereses diversos
que intervienen en el uso y apropiación, en
la concepción y valoración, que se transforman en el tiempo y el espacio; su uso
depende, asimismo, de las estructuras familiares históricamente patriarcales, de los
intereses de las clases dominantes y grupos
sociales, del tipo de Estado, así como de las
tendencias mismas del capitalismo. Este patrimonio cultural puede ser igualmente entendido como “el conjunto de costumbres,
tradiciones, territorios, conocimientos, sistemas de significación; símbolos, danzas, ritos, formas de organización laboral, social y
política; técnicas, instrumentos, vestimenta,
lengua, educación, medicina, festividades,
religión, arte, arquitectura, mobiliario, espacios sagrados…”63. Pero, posiblemente,
con cierta certeza podemos plantear que
una de las especificidades de este patrimonio que particularmente los pueblos campesinos e indígenas han conservado, descansa
en un núcleo de elementos relacionados con
formas de organización y valores comunitarios y una relación protectora y sagrada con
la naturaleza; así como de una concepción
más humanista de la vida y de la conflictividad social inherente a todo sistema social,
constituyendo la base de una identidad colectiva que, indudablemente, cambia en el
tiempo y que, independientemente, de los
ejes que la pueden estructurar, es condición
para un proyecto común de futuro de cualquier colectividad.
convierten en un símbolo de lucha que las mujeres emprenden, entre otras formas en las que participan por la
autonomía de su comunidad. Cuenta una mujer de Cherán el inicio de la lucha en su comunidad: “Los primeros
meses del movimiento fueron muy difíciles. No teníamos agua para tomar porque nosotros mismos nos encerramos. El alimento empezó a escasear. No teníamos dinero. No podíamos salir porque nuestras cabezas tenían precio. El crimen organizado en las comunidades indígenas de alrededor ofrecía $10,000 pesos por hombres o mujer,
niño, joven o anciano de la comunidad de Cherán. Y nosotros no salíamos porque teníamos miedo. Nosotras nos
atrincheramos y comimos lo poco que teníamos y nos empezó a llegar la ayuda humanitaria. Durante 3 meses
estuvimos sin salir de nuestros pueblos. Los que trabajamos fuera de la comunidad estuvimos 3 meses sin trabajar.
La gente que se dedica al hasta el día de hoy no puede ir a cultivar la tierra, ni siquiera traer leña porque el crimen
organizado todavía está en nuestros bosques y nos cazan como si fuéramos venados, como si fuéramos coyotes.
(…) De esta naturaleza es el impacto del crimen organizado en los pueblos indígenas, compañeros. (…) Los
pueblos indígenas estamos siendo ferozmente azotados por el enemigo sin rostro. Y desgraciadamente en la actualizada nuestros gobiernos se han asociado con ellos.” “Mujeres cuentan sus luchas: Cherán, Atenco, DF/ Mujeres
y la Sexta. Abajo y a la izquierda. Con todo el corazón. https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2012/03/15/
mujeres-cuentan-sus-luchas-cheran-atenco-df/
62
Henrique Urbano, 2000: 15.
63
González Luis et al, 1994.
102
antropologia e storia
Compartimos la idea que expresa Luxen64
de la artificialidad de la distinción entre patrimonio físico y patrimonio intangible que se
reconoce en los documentos internacionales
y nacionales; impide ciertamente una visión
compleja de la cultura y antepone más bien una
fragmentada que no reconoce los valores subyacentes en lo material y la materialización de
la dimensión inmaterial.; además dar cuenta
de la diversidad y distintos modos en que el ser
humano despliega su capacidad de organizarse,
representar, apropiarse de su propia historia, etc.
La apropiación de la historia de la revolución de 1910 y particularmente de las
contribuciones mujeres zapatistas es un patrimonio de los mexicanos que en este momento de una profunda crisis económica y
civilizatoria que vive la humanidad, de una
gran crisis del estado nación en México, deviene en una memoria que vitaliza el presente en el que la incertidumbre forma parte de
la vida cotidiana y alienta las resistencias y
luchas del pueblo mexicano, las que habrán
de lograr una articulación nacional, para vislumbrar perspectivas de futuro. Retomando
la idea de Ernest Gellner con relación a las
diferencias entre nación y etnia, que es la
capacidad de comunicación, la defensa del
patrimonio local, regional y nacional y las
luchas democráticas deben lograr ser nacionales a partir de potenciar su convergencia.
El horizonte de la lucha se amplia y piensa
desde lo local, lo regional y nacional, niveles
64
/ 1 – donne in armi
en los que las mujeres y hombres convergen
y construyen autonomía y defienden el patrimonio de la comunidad, de los pueblos indígenas y afrodescendientes y, de la nación, esta
unidad mujeres y hombres es un potencial
inconmensurable, si la unidad se constituye
entre seres libres de la presión y de subordinaciones. Si uniéramos las memorias y testimonios de tantas luchas y, específicamente,
las de las mujeres, en los grandes momentos
de nuestra historia nacional, regional y local,
escribiríamos todas (os) una historia gigantesca y dejaríamos una hermosa herencia a las
generaciones venideras, con la transmisión
de tradiciones culturales, lenguas y costumbres. Pero este legado se puede dejar, si juntamos hoy todos nuestros esfuerzos, saberes
y corazones y nuestras luchas para defender
el patrimonio nacional, nuestros territorios,
nuestros bosques, y el patrimonio de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, para construir una patria por la que
lucharon las y los zapatistas históricos y todos
los mexicanos. Si prendemos y no dejamos
apagar las fogatas, y hacemos una grande, tal
como nos han enseñado las mujeres de la comunidad de Cherán.
Bibliografía
Barrán, José Pedro, Historia de la sensibilidad en
el Uruguay, Ediciones de la Banda Oriental,
Montevideo, Uruguay, 2008.
“En el curso de los últimos 30 años, la noción de “patrimonio cultural” no ha cesado de ampliarse (…).Un enfoque
global y antropológico del “patrimonio”, nos lleva hoy a considerarlo como un conjunto social de manifestaciones
diversas, complejas e interdependientes, reflejo de la cultura de una comunidad humana…La distinción entre patrimonio físico y patrimonio intangible, aparece hoy como algo artificial. El patrimonio físico no adquiere todo su
sentido si no salen a la luz sus valores subyacentes. Y recíprocamente, la dimensión inmaterial, para su conservación, debe encarnarse en las manifestaciones tangibles, en los signos visibles (…). Esta dialéctica puede mostrarse
particularmente fecunda, a la hora de asegurar una mejor representación de las culturas del mundo que privilegian
la forma oral frente a la escrita, y las artes y tradiciones populares frente a las expresiones artísticas eruditas…”.
103
Q
uaderni
Castellanos Guerrero Alicia, L’utopie novatrice et
mobilisatrice du zapatisme, en Zapatisme: la
rebéllion qui dure, Alternatives Sud, Centre
Tricontinental et Éditions Syllepse, Louvaine-la-Neuve, Bélgica, 2014.
Crespo, Horacio. Historia del Azúcar en México,
tomo I, Azúcar S.A. y Fondo de Cultura Eonómica,México, 1988.
Espejel, Laura, Alicia Olivera y Salvador Rueda.
Emiliano Zapata. Antología, INEHRM, México, 1988.
Gellner Ernest, Cultura, identidad y política. El
nacionalismo y los nuevos cambios sociales,
Gedisa, Barcelona, 1989.
González Luis et al, Derechos culturales y derechos indígenas en la Sierra Tarahumara,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Chihuahua, México, 1994.
Gutiérrez Álvarez, Coralia (Coord.), Movimientos Sociales en un ambiente revolucionario,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, 2013.
Gutiérrez Chong, Natividad (Coord.), Mujeres y
Nacionalismos en América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México, México,
2004.
Jaiven, Ana Lau, “Las mujeres en la revolución
mexicana. Un punto de vista historiográfico.”
Secuencia 33, Instituto de Investigaciones Dr.
Luis Mora, México, 1995.
Lever, M. Elsa “Mujeres periodistas durante la
época revolucionaria, el caso del universal” en
Razón y Palabra, Primera revista electrónica
en Iberoamérica, especializada en comunicación. Ponencia presentada el 30 de abril de
2010 en la Mesa redonda “Mujeres revolucionarias” dentro del Ciclo de Conferencias
“Entre mujeres insurgentes y revolucionarias”,
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
México, D.F. Véase Tesis de Maestría, “Pensar
en voz alta. La participación de mujeres articulistas de opinión en las páginas editoriales
del diario El Universal”, FCPYS-UNAM, México 2007.
104
McCaa, Robert. “Millones desaparecidos: el costo
humano de la revolución mexicana”, http://
www.hist.umn.edu/~rmccaa/costo_humano_revolucion_mexicana.pdf.
Martínez, Leticia Calvario. “Bibliohemerografía
sobre la participación política y social de las
mujeres en México.” Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, México, 1996.
Mendieta Alatorre, Ángeles. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, extraordinaria precursora
de la Revolución mexicana, Cuernavaca, Talleres Impresores de Morelos, Morelos, México, 1983.
Miller, Beth. “Concha Michel: revolucionaria
mexicana.” Revista, La Palabra y el Hombre,
no. 50, Universidad Veracruzana, Veracruz,
México, 1984.
Pérez Abarca, Edith. Amelia Robles. Revolucionaria zapatista del sur, Instituto Guerrerense de
la Cultura, Chilpancingo, 2007.
Participación de las Mujeres en el gobierno autónomo. Cuaderno de texto de primer grado
del curso de “La libertad según las zapatistas”,
2013Pineda, Francisco, La irrupción zapatista, 1911,
Ediciones Era, México, 2014, primera reimpresión.
— La revolución del sur, 1912-1914, Ediciones
Era, México, 2013, primera reimpresión.
— Ejército Libertador, 1915, Ediciones Era, México, 2013.
Ramos Escandón, Carmen. “Quinientos años de
olvido: historiografía e historia de la mujer en
México.” Secuencia 36, México, 1996.
Ranero Castro Mayabel, Benítez Juárez Mirna A
y Domínguez Pérez Olivia, “Mujeres en la Revolución Mexicana”, Cuadernos de Trabajo.”
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 2011.
Rocha Islas Martha Eva. “Presencia de las Mujeres en la Revolución Mexicana: Soldaderas y
Revolucionarias”, en Memoria del Congreso
Internacional sobre la Revolución Mexi-
antropologia e storia
cana. Tomo 1. Gobierno del Estado de San
Luis Potosí / Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana de la
Secretaría de Gobernación. San Luis Potosí,
México, 1991.
Ruiz Martínez Apen, “Nación y género en el México revolucionario: La India Bonita y Manuel
Gamio” Revista, Signos Históricos, núm. 5,
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, 2001.
Salgado, E., “Fragmentos de historia popular II. La
mujer en la revolución” Secuencia, 03. Vol. 0,
Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora,
México, 1985.
Turner, Frederick C. “Los efectos de la participación femenina en la Revolución de 1910.” Historia Mexicana, Vol.16 No. 4, Universidad de
Conecticut, 1967.
Urbano, Henrique, Patrimonio y Modernidad,
Turismo y Patrimonio, no. 1, Universidad
San Martín de Porres, Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería, Lima Perú, 2000: 15
Vázquez Gómez, Francisco, Memorias Políticas
(1909-1913), Universidad Iberoamericana-El
Caballito, México, 1982.
Vega Soria Harlen, “Obreras en el Porfiriato y en
la Revolución Mexicana, una bibliografía comentada”, Tesina de Licenciatura en Filosofía
y Letras, UNAM, México, 2009.
Páginas Web consultadas
http://biblat.unam.mx/es/revista/generos/4
http://biblioteca.colmex.mx/revistas/
/ 1 – donne in armi
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/2461
http://www.redalyc.org/pdf/344/34400502.pdf
http://hdl.handle.net/123456789/2461
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/14/cultura/a05n1cul
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/revistas_electronicas_delestudios_de_genero
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/2099/
1/198761P49.pdf)
www.razonypalabra.org.mx
www.mujeresnet.info
Hemerografía
El Combate, México, 1915.
El Diario. México, 1911.
El Imparcial. México, 1913.
The Mexican Herald, México, 1915.
The New York Times, Nueva York, 1915.
Regeneración, Los Ángeles, California, 1911.
Archivos consultados
Programa de Historia Oral, INAH.
Archivo Electrónico Ricardo Flores Magón,
INAH, http://archivomagon.net.
Fondo Emiliano Zapata y Fondo Genovevo de la
O, Archivo General de la Nación.
Fondo Gildardo Magaña, Archivo Histórico de la
UNAM.
Foreign Relations of the United States, Department
of State, Universidad de Wisconsin, http://
uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS.
105
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Le Amazzoni di Procopio.
Variazioni su un mito nella Bisanzio
del VI secolo
Claudio Azzara
N
ei Libri delle guerre (Ύπὲρ
τῶν πολέμων λόγοι) dello
storico bizantino Procopio di Cesarea (ca. 500-ca.
560/570), dedicati alle campagne militari condotte dall’imperatore Giustiniano in
Oriente, in Africa e in Italia, rispettivamente contro i Persiani, i Vandali e i Goti, e di
cui lo scrittore fu in buona misura testimone
diretto, non mancano frequenti ed estese digressioni dalla narrazione principale di carattere geografico ed etnografico, in ossequio
a una precisa e risalente tradizione letteraria.
In questo modo, il lettore veniva soddisfatto
nelle sue curiosità circa paesi e popoli, spesso per lui lontani e mal conosciuti, che erano
toccati dal racconto dei fatti bellici e che, per
così dire, costituivano lo sfondo degli stessi;
non senza l’inserzione occasionale da parte
1
dell’autore di aneddoti curiosi e di resoconti mitici o leggendari, desunti, così come la
massima parte delle informazioni geografiche ed etnografiche, da opere anteriori (anziché da una conoscenza diretta dei luoghi e
delle genti menzionate, che per lo più mancava). In particolare, all’inizio del IV libro dedicato al conflitto combattuto in Italia contro
i Goti (VIII del totale dei Libri delle guerre),
Procopio, nello spostare momentaneamente
l’attenzione dal teatro italico, dove stava per
andare in scena l’ultimo atto della lunghissima guerra (535-553) che si chiuse con la
definitiva rovina del regno dei Goti, a quello
persiano, in cui erano allora ripresi gli scontri dopo un periodo di tregua, forniva una
lunghissima descrizione (che occupa sette
dei trentacinque capitoli in cui è ordinato il
libro in sede di edizione critica moderna)1
Per l’edizione critica degli scritti di Procopio si rinvia a quella classica di Haury e Wirth in Procopii Caesariensis
De bello Gothico, in Eiusdem Opera omnia, II: De bellis libri V-VIII, edidit J. Haury, addenda et corrigenda adiecit
G. Wirth, Lipsiae 1963 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Nel presente contributo si citerà dalla versione italiana di Filippo Maria Pontani in Procopio di Cesarea, La guerra gotica, Roma 1974.
Per un’introduzione alla figura di Procopio e alla sua opera si rinvia, tra i lavori più recenti e significativi, almeno
a: A. Cameron, Procopius and the Sixth Century, London 1985; A. Kaldellis, Procopius of Caesarea. Tyranny,
History and Philosophy at the End of Antiquity, Philadelphia 2004; D. Brodka, Die Geschichtsphilosophie in der
spatantiken Historiographie. Studien zu Prokpios Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokattes,
Frankfurt am Main 2004.
107
Q
uaderni
delle popolazioni che abitavano i territori del
Ponto Eussino, cerniera fra il continente europeo e quello asiatico e linea di demarcazione fra i due grandi imperi antagonisti.
Lo storico di Cesarea ammetteva che in
passato molto era già stato scritto sull’ambito di cui egli ora intendeva occuparsi, ma
che ciò nonostante riteneva necessario insistere di nuovo sull’argomento dal momento
che nei libri antichi si trovavano, a suo dire,
numerose imprecisioni ed evidenti errori;
anche perché nel lasso di tempo trascorso
da allora il susseguirsi degli avvenimenti e
le ripetute migrazioni di genti che si erano
prodotte avevano inevitabilmente trasformato il quadro, rendendo obsolete le vecchie
descrizioni. La polemica sembrava diretta
soprattutto contro autori quali Senofonte e
Arriano, pure non menzionati in maniera
aperta, per deduzione dagli esempi di antiche inesattezze citati da Procopio: come
l’aver collocato in un’area litoranea gli Tzani
che abitavano invece una regione montuosa
dell’interno, o aver distinto i Colchi dai Lazi,
laddove questi erano solo due nomi differenti della stessa etnia. Insomma, Procopio
si preoccupava di precisare come fosse suo
scrupolo rendere un buon servizio ai propri lettori riportando in maniera accurata
«nomi e fatti secondo la realtà oggi vigente
in ciascuno di quei paesi» e trascurando di
riprendere «notizie leggendarie o comunque
antiquate»; per esempio evitando di dilungarsi sulle ipotesi d’identificazione del punto
esatto nel Ponto Eussino in cui «secondo i
poeti, fu incatenato Prometeo», nella piena
consapevolezza che c’è «una bella differenza
2
3
108
Procopio di Cesarea, La guerra gotica cit., IV, 1, p. 314.
Ivi, IV, 2, p. 315.
fra la mitografia e la storia»2. Avviatosi, dunque, finalmente a elencare le popolazioni del
Ponto partendo da Bisanzio e procedendo
verso oriente, dopo aver menzionato i Bitini, gli Onoriati, i Paflagoni e i Pontici «veri
e propri», e le città di Eraclea, Amastri, Trapezunte, Sinope e Amiso, Procopio citava il
fiume Termodonte rammentando che presso di esso «si racconta che fossero accampate
le Amazoni»3, sulle quali si riprometteva di
tornare più diffusamente in seguito. Infatti
egli riprendeva subito la propria carrellata
di toponimi e di stirpi, non facendo mancare qualche glossa curiosa, come, per esempio, quella relativa al fatto che nei dintorni
di Trapezunte, e solo lì, il miele prodotto
dalle api è amaro, cosa «estremamente strana» (ma che non ci si preoccupava affatto
di spiegare). L’esplicita, dichiarata, volontà
di attenersi al puro dato storico, scansando
ogni annotazione mitografica, trovava qualche contraddizione nei cenni qua e là presenti al fato di Apsirto, vittima delle trame
di Medea e Giasone, da cui traeva il proprio
nome l’antica città di Apsarunte, ubicata nel
luogo del suo assassinio; o alle imprese dello
stesso Giasone, con particolare riferimento
alla precisa collocazione del vello in un determinato punto, piuttosto che in un altro,
della Lazica.
Giunto a descrivere il Caucaso, Procopio sottolineava immediatamente non solo
l’imponenza di tale sistema montuoso, le cui
cime si spingevano al di là delle stesse nubi,
ma anche il suo rilievo in qualità di spartiacque fra genti diverse, tra cui spiccavano
gli Unni. E proprio da qui, secondo quanto
antropologia e storia
era tramandato («si dice»), provenivano le
Amazzoni, che, spintesi poi verso occidente,
«avrebbero posto il campo presso Temisciro
e il fiume Termodonte, dove ora c’è la città di
Amiso», cioè nell’Anatolia centro-settentrionale. Riferita la notizia, lo storico di Cesarea
annotava però subito come «oggi però in
nessuna delle località attorno al Caucaso si
conserva una qualche memoria delle Amazzoni o un nome che le riguardi», malgrado
Strabone e molti altri avessero scritto copiosamente su di loro4. Prendendo le distanze da
quanto trasmesso dal grosso della tradizione
letteraria, Procopio precisava con chiarezza la propria interpretazione del mito delle
Amazzoni. Secondo lui avevano certamente
ragione quanti in passato avevano negato che
costoro fossero «una razza di viragini», sorta
di deroga alla natura umana, ritenendo piuttosto che si trattasse delle donne di un’antica tribù sopravvissute alla strage dei propri
uomini e costrette perciò dalla necessità a
cavarsela da sole, dando vita a una forma di
organizzazione sociale del tutto particolare.
Infatti, egli reputava plausibile che in un’epoca remota una qualche etnia caucasica si fosse stanziata presso il Termodonte lasciando
al campo le donne mentre gli uomini conducevano scorrerie a scopo di razzia per l’intera Asia; i guerrieri maschi erano però tutti
caduti vittime della resistenza opposta dalle
popolazioni da loro aggredite, lasciando così
sole le proprie compagne. Queste ultime,
«costrette dalla paura dei vicini e dalla penuria di viveri», ben presto furono obbligate a
6
4
5
/ 1 – donne in armi
indossare le armi lasciate all’accampamento
dagli uomini e a dotarsi di «coraggio virile»,
compiendo «gesta di valore», ma solo perché
«spinte a ciò da necessità», «fino a che tutte
furono sterminate»5. Questa lettura, per così
dire “razionale”, del mito delle Amazzoni
appariva dunque a Procopio l’unica accettabile, anche perché suffragata da esempi a
lui contemporanei; egli annotava, infatti, che
allorquando in tempi recenti gli Unni si erano scontrati con i Romani era capitato che
tra i cadaveri lasciati dai barbari sul campo
di battaglia ne fossero stati rinvenuti anche
diversi di sesso femminile, mischiati ai guerrieri maschi. Se quindi tra gli Unni del suo
presente c’erano donne che combattevano
assieme agli uomini, perché non credere che
ciò potesse essere accaduto anche in passato,
presso una popolazione oltretutto ritenuta
progenitrice degli Unni non fosse altro che
per la medesima provenienza geografica? E
in questi termini, a suo parere, doveva risolversi l’intera questione.
Come s’è detto, Procopio citava esplicitamente soprattutto Strabone quale autore che
prima di lui si era diffuso nel fornire notizie
sulle Amazzoni. Il geografo greco nella sua
opera6 si era innanzitutto preoccupato di
vagliare le diverse ipotesi formulate da altri
scrittori antichi (come Teofane di Mitilene,
Ipsicrate, Metrodoro di Scepsi) sulla regione in cui sarebbero state stanziate le donne
guerriere, alternativamente poste ora nell’Albania caucasica, lungo il fiume Mermadalis,
che avrebbe separato il loro territorio da
Ivi, IV, 3, pp. 318-319.
Ibidem.
Edizione critica in Strabonis Geographica, edidit F. Sbordone, I-II, Roma 1963-1970 (Scriptores graeci et latini
consilio Academiae Lynceorum editi); cenni sulle Amazzoni in: XI, 5; XII, 3. Versione italiana in Strabone, Geografia, libri 11-12: Caucaso, Asia centrale e Anatolia, a cura di R. Nicolai e G. Traina, Milano 2000.
109
Q
uaderni
quello degli Sciti; ora in una valle fra i Monti
Cerauni, nell’Armenia. Comunque, esse erano sempre collocate in quell’Oriente remoto
e favoloso, compreso fra la Scizia, la Persia e
l’India, che per i greci era la sede di una gran
quantità di popoli esotici, reali o immaginari
che fossero. Secondo le multiformi tradizioni
che Strabone enumerava, le Amazzoni sarebbero originariamente vissute nella Scizia,
presso la palude Meotide, oppure in un’area
imprecisata delle montagne del Caucaso, e da
questa sede primitiva sarebbero migrate in
un secondo tempo in Anatolia, dove avrebbero fondato la città di Temiscira. Per altri
narratori, tuttavia, il senso del loro percorso
sarebbe stato esattamente inverso: avrebbero
abbandonato Temiscira e l’Anatolia dopo esser state sconfitte dai Greci, per riparare solo
allora nella palude Meotide. Le fonti antiche
le collocavano spesso in rapporto con altre
popolazioni, come i Sarmati, stirpe nomade
di etnia iranica le cui donne pare combattessero a cavallo assieme ai loro uomini e alla
quale veniva attribuita da alcuni una struttura sociale di tipo matriarcale; in alcuni casi
si sosteneva che la popolazione dei Sarmati
avrebbe avuto origine proprio dalla prole
nata dall’unione delle Amazzoni con gli Sciti.
Quindi, sempre attingendo a fonti anteriori, Strabone aveva tratteggiato per rapidi cenni la peculiarissima organizzazione
sociale delle Amazzoni, insistendo su alcuni aspetti destinati a solleticare in modo
particolare la curiosità dei suoi lettori. Le
Amazzoni provvedevano per ogni cosa da
sé, coltivando i campi, pascolando il bestiame e soprattutto allevando cavalli, la loro
specialità, mentre le più valide tra loro sapevano anche cacciare a cavallo e cimentarsi
nella guerra: insomma, erano perfettamente
in grado di svolgere tutte le attività riserva110
te di norma agli uomini, venendo dunque a
costituire una sorta di “società alla rovescia”.
Si diceva che da bambine si recidessero la
mammella destra per meglio maneggiare le
armi, specialmente per scagliare con maggior facilità ed efficacia il giavellotto, il quale
costituiva la loro arma principale assieme
all’arco e a uno scudo leggero, mentre il capo
e il corpo erano protetti solo dalle pelli di bestie feroci. La diceria sulla mutilazione mammaria era ampiamente riprodotta un po’ in
tutti i testi antichi, alcuni dei quali (come lo
pseudo-Ippocrate) la riferivano alle donne
dei Sarmati, identificando queste proprio
con le Amazzoni. Si può forse immaginare
che tale uso, reale o meno che fosse, oltre a
uno scopo “pratico” (come suggeriva, tra gli
altri, anche Strabone), implicasse pure una
certa valenza simbolica, insita nel fatto che
la cancellazione di un attributo femminile
finiva con il rendere in qualche modo più
simile a quello degli uomini il corpo delle
Amazzoni proprio nel momento in cui costoro si dedicavano a un’attività ritenuta peculiarmente maschile quale quella militare.
Il problema della riproduzione, e quindi
della continuità della stirpe, stante l’assenza
di uomini, veniva risolto, come molti raccontavano e Strabone stesso riportava, con
l’aiuto di una popolazione vicina, quella dei
Gargareni, costituita di soli maschi, che si
dicevano fossero in origine giunti nel Caucaso proprio con le Amazzoni, avessero
poi combattuto un lungo conflitto contro
di loro e avessero infine stipulato una pace
che prevedeva quale unico rapporto tra le
due etnie l’incontro reciproco una volta
l’anno proprio per generare dei figli. Infatti,
durante la primavera le Amazzoni salivano
con i Gargareni sulle montagne che costituivano il confine fra i rispettivi territori e si
antropologia e storia
univano con loro, al buio in modo da non
sapere chi giaceva con chi. Nove mesi dopo,
le bambine che nascevano erano trattenute
dalle Amazzoni, mentre i maschi venivano
rinviati ai Gargareni perché se li tenessero,
adottandoli in modo casuale dal momento
che non si poteva sapere chi fosse il padre di
ciascun infante.
Strabone sottolineava che nel caso delle Amazzoni la tradizione non aveva mai
saputo separare i resoconti leggendari dai
fatti storicamente accertati, tramandando
gli uni e gli altri in un flusso indifferenziato che aveva costantemente alimentato il
mito delle donne guerriere. Stupefacente, a
suo dire, era il fatto stesso che potesse essere
esistita una società di sole donne, oltretutto capaci di soggiogare i popoli circostanti
e di spingersi con fortunate spedizioni militari addirittura fino all’Attica. Molti erano i
centri urbani che si ritenevano da loro fondati (anche importanti come Efeso, Smirne,
Mirina), così come alle Amazzoni venivano
ascritte numerose sepolture e monumenti; a
loro veniva associata soprattutto la città di
Temisciro, con la vasta pianura stesa fra il
fiume Termodonte e le montagne, reputata
la loro sede principale. Alcune narrazioni a
suo parere apparivano palesemente infondate, sebbene fossero riportate da parecchi
autori, come quella relativa a un incontro
avvenuto fra la regina della Amazzoni Talestria e Alessandro Magno; mentre non
poteva del tutto escludersi una loro partecipazione alla guerra di Troia, da più parti
asserita. Insomma Strabone, nel dedicare
7
/ 1 – donne in armi
un discreto spazio all’interno della propria
opera all’affascinante, e sconcertante, realtà
delle donne guerriere, sempre così prossima
a confondersi con la pura leggenda, glossava
le singole asserzioni prodotte in merito delle
sue diverse fonti, ma evitava, in definitiva,
di formulare un proprio giudizio esplicito
complessivo sull’origine di una società tanto
singolare, come invece sceglieva di fare Procopio, riecheggiando pure quelle leggende e
dicerie che lo storico di Cesarea invece taceva o liquidava come mera fantasia.
All’incirca nello stesso periodo in cui
scriveva Procopio un altro noto autore, Jordanes (nato tra la fine del V e gli inizi del
VI secolo), nel suo De origine actibusque Getarum7 (largamente modellato sulla perduta
storia dei Goti di Cassiodoro) indugiava a
sua volta nel riferire quanto ancora al suo
tempo veniva tramandato circa le favolose
Amazzoni, fornendo però un racconto ben
diverso da quella dello storico di Cesarea
e, in sostanza, più vicino nei modi a quello
di Strabone. Per Jordanes gli uomini della
Amazzoni sarebbero stati proprio i Goti, i
protagonisti della sua opera. Alla morte del
re Taunasis, le donne dei Goti, rimaste sole,
sarebbero state attaccate dagli uomini di una
tribù vicina, che le volevano catturare e rapire, ma sarebbero riuscite a respingere gli aggressori, sbaragliandoli sul campo. Inebriate
dall’inopinata vittoria, si sarebbero date due
regine, una, Lampeto, incaricata di difendere
da ogni possibile invasore le sedi di stanziamento originarie, in Scizia; l’altra, Marpesia,
gravata del compito di guidare una schiera
Edizione critica in Iordanis De origine actibusque Getarum, a cura di F. Giunta-A. Grillone, Roma 1991 (Fonti
per la Storia d’Italia, 117); cenni sulle Amazzoni in: V; VII; VIII. Versione italiana di Elio Bartolini in I barbari. Testi dei secoli IV-XI scelti, tradotti e commentati, Milano 1982, pp. 429-577. Per una recente introduzione a Iordanes,
si veda A. Amici, Iordanes e la Storia gotica, Spoleto 2002.
111
Q
uaderni
di guerriere in scorribande attraverso tutta
l’Asia, fino ai contrafforti del Caucaso, allo
scopo di sottomettere quante più genti e
paesi fosse possibile. Questo esercito «mai
visto» avrebbe imperversato per l’Armenia,
la Siria, la Cilicia, la Galazia, la Pisidia, la
Jonia e l’Eolia, fondando città e castelli ed
erigendo a Efeso uno splendido tempio in
onore della dea Diana, cacciatrice e arciere
come erano loro stesse. Le Amazzoni avrebbero così dominato gran parte dell’Asia per
almeno cent’anni, prima di ritirarsi nel Caucaso. Anche Jordanes riprendeva la leggenda
dell’accoppiamento concordato una volta
all’anno con gli uomini delle popolazioni limitrofe per garantire la continuità della stirpe, con le femmine nate da tali unioni trattenute dalle madri e i maschi resi ai padri;
precisando, inoltre, che secondo una diversa
tradizione (sulla cui veridicità Jordanes non
si esprimeva) le Amazzoni avrebbero invece
ucciso i neonati di sesso maschile. Quest’ultima diceria contribuiva ad alimentare ulteriormente il terrore che l’asserita crudeltà
delle Amazzoni suscitava: quale nemico, infatti, poteva risultare più spietato in battaglia
di madri che erano solite non risparmiare
nemmeno i propri figli?
Lo storico dei Goti raccoglieva, infine, e
offriva al suo pubblico, ma senza vaglio, pure
un’ultima carrellata di resoconti leggendari
sulle Amazzoni: nemiche di Ercole e di Teseo (che aveva generato un figlio dalla regina
Ippolita, sua prigioniera), partecipanti alla
guerra di Troia sotto la guida della regina
Pentesilea, ancora attive e potenti al tempo
di Alessandro Magno. In particolare il loro
ruolo nell’assedio di Troia era stato amplifi-
112
cato in epoca antica dal poema di Arctino
di Mileto l’Etiopide, composto nel VII secolo
a. C. e assai diffuso in epoca classica, di cui
sopravvivono oggi solo un frammento e un
riassunto contenuto nella Crestomazia dello pseudo-Proclo, posteriore di due secoli.
Nell’Etiopide si narrava lo scontro fra Achille
e Pentesilea, intervenuta con le sue guerriere
al fianco dei troiani e uccisa dall’eroe greco;
da notare che nell’Iliade le Amazzoni erano
invece dipinte quali antiche nemiche dei
troiani, come raccontava lo stesso re Priamo
rievocando una spedizione contro di loro
avvenuta molti anni prima e alla quale egli
stesso aveva partecipato.
Insomma, nella propria evocazione delle favolose Amazzoni, Jordanes operava alla
stessa stregua degli autori antichi, recuperando ed elencando alcune tra le numerose e
variegate narrazioni loro relative, desumendole tanto da fonti di carattere storiografico,
geografico ed etnografico quanto da altre di
genere squisitamente letterario, senza esprimersi sull’attendibilità o meno di ciascuna
di esse; anzi, non rifuggendo nemmeno dal
richiamare gli aspetti più sinistramente suggestivi della loro leggenda, come quello delle
presunte pratiche di infanticidio. Ben diverso dunque appare, rispetto non solo alle fonti classiche ma anche al suo contemporaneo
Jordanes, lo scrupolo storiografico di Procopio, così dichiaratamente attento a discernere il vero storico dalla tradizione mitografica
e letteraria e a fornire una spiegazione logica
e verosimile dell’esistenza delle Amazzoni
(donne rimaste sole e perciò costrette a imparare l’uso delle armi per difendersi), sottraendole all’aura della leggenda.
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Interventi e contributi sul tema
Donne e armi nell’alto medioevo.
Il caso longobardo
Arianna Bonnini
Una legge emanata dal re dei longobardi
Liutprando nell’anno 734 si preoccupava di stabilire un criterio di risoluzione per un caso assai singolare, verificatosi da poco, che, come osservava lo
stesso monarca, non aveva precedenti, e per il quale non vi era quindi alcuna sanzione adatta nell’Editto che raccoglieva le leggi della sua stirpe. Com’era stato direttamente riferito al re, alcuni uomini
intenzionati ad assaltare un villaggio per razziarlo,
preoccupandosi di evitare in caso di cattura l’elevatissima composizione (cioè la pena pecuniaria a
carico del reo che puniva il reato) prevista per tale
fattispecie da una norma del predecessore Rotari
(titolo 19: il versamento dell’enorme somma di 900
solidi o in caso d’insolvenza la morte per il capobanda, di 80 solidi per gli altri membri), avevano
mandato al loro posto le proprie donne, incluse le
serve, le quali avevano portato a compimento la
spedizione armata infierendo sugli aggrediti «con
maggior crudeltà di quanto facciano gli uomini».
1
Le vittime, in assenza di una legge che contemplasse ciò che era successo, si erano appellate al monarca, il quale provvide subito a colmare la lacuna
legislativa garantendo loro giustizia, pur senza riuscire a celare il proprio disprezzo nei confronti di
costoro per essersi fatti battere da delle donne (due
volte nel testo si sottolinea che sono uomini con
«una forza inferiore», «più deboli»). Qualora un
fatto del genere si fosse ripetuto in futuro, stabiliva
Liutprando, in primo luogo le donne colpevoli, se
ferite o uccise nel corso dell’attacco, non avrebbero
avuto alcun diritto alle composizioni ordinariamente previste dall’Editto per le lesioni inflitte a
un soggetto di sesso femminile, mentre invece i loro
mundoaldi (cioè i detentori del mundio della donna) sarebbero stati tenuti a risarcire secondo legge
i danni provocati dalle assalitrici. Ma, soprattutto, l’autorità locale avrebbe dovuto applicare loro
la durissima pena della decalvatio (vale a dire lo
strappo violento dei capelli con asportazione di
parte della pelle del cranio, una sorta di “scalpo”)
e farle anche frustare trascinandole «per i villaggi
vicini a quel luogo», «in modo che in futuro le donne non osino commettere una simile malvagità»1.
Leges Langobardorum 643-866, hrsg. F. Beyerle, Weimar 1947, Liutprandi leges, 141: «Relatum est nobis, quod
aliqui hominis perfidi et in malitia astuti, dum per se non presumpsessent mano forti aut violento ordinem intrare
in vicum aut in casam alienam, timentes illam conpositionem, que in antiquo edicto posita est, fecerunt collegere
mulieres suas, quascumque habuerunt, liberas et ancillas, et miserunt eas super homines, qui minorem habebant
virtute, et adprehendentes hominis de ipso loco et plagas fecerunt, et reliqua mala violento ordine plus crudeliter
113
Q
uaderni
Non sfugge come all’evidente valenza afflittiva
della pena se ne accompagnasse un’ulteriore, consistente nello svergognare in pubblico le colpevoli
portandole in giro per tutto il territorio circostante e
castigandole in una maniera esemplare e infamante, allo scopo di diffondere un terribile monito per
quante avessero mai osato emularle. In un siffatto avvenimento il disonore per le colpevoli, che la
pena inferta pubblicamente amplificava e rendeva
perpetuo tramite le cicatrici conseguenti alla decalvatio e alle frustate, era generato dalla loro stessa
condotta inaudita, perché costoro nel compiere un
assalto armato erano fuoriuscite dai limiti di ruolo
e dai parametri di comportamento imposti al genere femminile, comportandosi piuttosto da uomini sì
da venir meno al decoro del proprio sesso. Il legislatore confessava, infatti, di aver dovuto produrre la
nuova legge in quanto il reato che era stato sottoposto al suo giudizio non poteva essere assimilato
a nessun altro di quelli già regolati da Rotari, dalla
rivolta di contadini all’harschild (cioè alla razzia
2
114
di un villaggio in banda armata)2, «dal momento
che queste cose le fanno gli uomini, non le donne»;
mentre ora si trattava per l’appunto di un «raduno
di donne» inammissibile e senza precedenti. Nei casi
di harschild o di riunione di contadini in bande la
punizione inflitta ai rei arrivava alla messa a morte
(riscattabile tramite composizione) per il capo, con
pagamento delle composizioni per tutti i danni arrecati a uomini e cose; ora, l’introduzione dell’ulteriore connotazione infamante oltre che afflittiva della
decalvatio e delle frustate in pubblico per i villaggi
vicini appare rispondere alla volontà di denunciare
e amplificare la vergogna specifica che si percepiva
insita nel comportamento di donne che avevano
osato condursi da uomini. Insomma, se la violenza
commessa da soggetti maschili veniva sanzionata in
ragione della natura del reato e dell’entità dei danni da esso prodotti; quando a farsene responsabili
erano individui di sesso femminile si aggiungeva
l’aggravante del peculiare disonore insito in una
condotta che implicava l’usurpazione di un ruolo ri-
quam viri exercuerunt. Dum autem hoc ad nos pervenissit, et ipsi homines pro sua violentia, qui minus potebant,
interpellabant: ita prospeximus in hoc edicto adfigere: ut si amodo mulieres hoc facere in qualecumque locum
presumpserit, primum omnium decernimus, ut si aliqua iniura aut obprobrium, aut plagas aut feritas, aut mortem
ibi acceperint, nihil ad ipsas mulieres aut ad viros aut ad mundoald earum conponant illi, qui se defendendum
eis aliqua fecerint lesionem aut internicionem. Insuper et publicus, in quo loco factum fuerit, conprehendat ipsas
mulieres, et faciat eas decalvare et frustare per vicos vicinantes ipsius loci, ut de cetero mulieres tale malitia facere
non presumant. Et si in ipsa causa feritas aut plagas fecerint ipsae mulieres cuicumque homini, mariti earum conponant ipsas plagas aut feritas, quas ipsae fecerunt, secundum edicti tinore. Hoc autem ideo prospeximus tam de
disciplina quam de conpositione, quia non potuimus mulierum collectionem ad harschild consimilare, neque ad
seditionem rusticanorum, quia istas causas viri faciunt, nam non mulieres: ideoque sic de ipsis mulieribus faciat,
sicut supra statuimus. Si quidem simpliciter in scandalum qualiscumque mulier cocurrerit, et mortem aut plagam
aut feritam ibi susceperit, sic ei faciat iustitiam, sicut decessor noster rothari rex instituit et iudicavit». Del corpus
edittale esiste una versione italiana commentata con testo latino a fronte in Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Roma 2005, da cui sono tratti i brani tradotti
inseriti nel testo. Per una primissima introduzione alle leggi dei longobardi si vedano almeno E. Besta, Fonti del
diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano sino ai tempi nostri, Padova 1938; F. Calasso, Medio Evo del diritto,
I: Le fonti, Milano 1954. Circa la decalvatio, è pena di particolare gravità e di applicazione assai rara (presente, oltre
che nel citato titolo 141 di Liutprando, nei titoli 80 dello stesso Liutprando e 4 delle leggi di Astolfo); su di essa si
vedano le annotazioni di S. Gasparri, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane,
Spoleto 1983 pp. 140-151. Sulla figura del mundoaldo e il valore del mundio si tornerà qui sotto.
Il riferimento è a Rotari 19 (attacco a un villaggio in banda organizzata); 279 (razzia di una banda di contadini);
280 (rivolta di contadini). Da notare che Liutprando 134 prendeva in considerazione il caso di uomini che si
fossero riuniti tra loro per aggredire vicini con cui avessero controversie di proprietà, stabilendo che anche quella
fattispecie non potesse essere equiparata all’harschild o alle bande di contadini, ma piuttosto al complotto per
realizzare un omicidio già sanzionato da Rotari 11 (tramite semplice pagamento di una composizione).
antropologia e storia
servato agli uomini, l’uso delle armi, meritando una
punizione dal carattere anche infamante.
Del resto, la medesima logica si trovava già
presente in qualche misura in un precedente titolo
di Rotari (il 378), il quale, considerando le possibili
ferite riportate da una donna che si fosse volontariamente immischiata in una zuffa tra uomini,
sanciva che il calcolo della composizione per tali
lesioni si dovesse formulare come se a rimanere
colpito fosse stato il fratello di lei, perché risultava
incongrua sul piano concettuale, quasi inimmaginabile, la partecipazione di donne a un tumulto,
«quod inhonestum est mulieribus facere»3.
Nella società longobarda la capacità giuridica
dell’individuo era strettamente legata alla sua capacità di portare le armi; pertanto, essa non solo
non veniva riconosciuta agli appartenenti al vasto
gruppo dei non liberi, suddiviso al proprio interno tra aldi (semiliberi) e servi, ma nemmeno alle
donne, le quali per tutta la loro vita erano obbligatoriamente sottoposte alla protezione (mundio) di
un uomo, fosse esso il padre, il marito, un fratello
oppure un altro parente maschio, e persino, in casi
estremi, il re in persona4. Il mundio era un concetto proprio dei diritti di area germanica, interpretabile nei termini di un “potere di protezione” in
qualche misura accostabile al concetto romano di
potestas del pater familias. La donna longobarda,
come confermava la legge codificata5, non poteva
vivere sui iuris (selpmundia), ma doveva rimanere
sempre sottoposta al mundio di un uomo. Pertanto,
ella non godeva di diritti nel senso di facoltà, ma
3
4
5
/ 1 – donne in armi
solo di diritti affievoliti, a lei concessi dalla legge
limitatamente a determinate situazioni giuridiche
e che potrebbero essere concepiti piuttosto come
una licencia. Un mundoaldo (cioè il detentore del
mundio) poteva perdere il mundio sulla donna in
caso di acclarata condotta indegna verso di lei o
di manifesta incapacità di difenderla; solo in una
circostanza del genere alla donna veniva permesso
di scegliere liberamente a chi riaffidare il proprio
mundio, se a un qualsiasi uomo di suo gradimento
oppure alla medesima corte regia. L’incapacità giuridica della donna si esprimeva anche in occasione del matrimonio, istituto nel quale ella figurava
come res tradita trasmessa dalla famiglia d’origine
all’uomo che la prendeva in moglie in seguito al
perfezionamento di due precisi negozi giuridici: la
desponsatio (cioè l’accordo allora stipulato tra il futuro marito e il padre di lei) e la traditio (vale a dire
la consegna materiale della donna al suo sposo). Il
marito, generalmente ma non necessariamente,
acquistava il mundio su di lei versando alla sua
famiglia d’origine una somma (meta) la cui disponibilità rimaneva poi alla donna; a quest’ultima il
consorte pagava anche un’ulteriore somma (morgingab, “dono del mattino”), in segno di onore e di
soddisfazione dopo la prima notte di nozze. Se il
marito non procedeva all’acquisto del mundio della
propria moglie, quest’ultimo restava a un membro
maschio della sua famiglia d’origine, il che implicava allora per la donna una doppia subordinazione,
al proprio mundoaldo e alla potestalis dominatura
del coniuge.
Rotari 378: «Si mulier libera in scandalum cocurrerit, ubi viri litigant, si plagam aut feritam factam habuerit aut
forsitan inpincta fuerit aut occisa, adpretietur secundum nobilitatem suam et sic conponatur, tamquam si in fratrem ipsius mulieris perpetratum fuisset; nam alia culpa pro iniuria sua, unde nongenti solidi iudicantur, non
requiratur, eo quod ipsa ad litem cocurrit, quod inhonestum est mulieribus facere».
Per un’introduzione all’organizzazione sociale dei longobardi e alla loro vicenda storica si vedano almeno P. Delogu, Il Regno Longobardo, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. I: P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli, Longobardi
e Bizantini, Torino, 1980, pp. 1-216; C. Azzara, L’Italia dei barbari, Bologna 2002; S. Gasparri (a cura di), Il regno
dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni, Spoleto 2004. Considerazioni sul ruolo della donna,
soprattutto con riguardo alla violenza, si trovano in A. Bonnini, Le donne violate. Lo stupro nell’Italia longobarda
(secoli VI-XI), in “Nuova Rivista Storica”, XCV, fascicolo I (2011), pp. 207-248.
Rotari 204.
115
Q
uaderni
Nell’arcaica struttura tribale dei longobardi il
godimento dei pieni diritti era quindi riservato ai
maschi, in quanto solo costoro erano in grado di
portare le armi e, pertanto, di partecipare al gairethinx, l’assemblea degli uomini liberi, autentica
sede del potere. Lo stesso re presso di loro era in
primo luogo un comandante militare. Nel testo
dell’Editto il vocabolo exercitus viene spesso a coincidere con la totalità della gens Langobardorum,
colta come l’insieme degli uomini liberi-guerrieri, e
ciò appare ben comprensibile in una società votata
alla guerra, principale fonte di sostentamento economico almeno nella fase originaria della propria
storia, e la cui cultura era fondata sui valori militari. In tale panorama di rigida separazione di ruoli
le donne, incapaci di usare le armi analogamente
a un uomo, finirono dunque per essere costrette
entro uno status di subordinazione giuridicamente
definita che rese l’occasionale ricorso alla violenza
armata da parte di alcune tra loro inammissibile e
innaturale sul piano concettuale prima ancora che
contra legem.
Dove porta la storia
Soldatesse crudeli
afroamericane e arabe
Anna Maria Musilli
Le soldaderas della rivoluzione messicana e le
brigantesse dell’Italia postunitarirano fino a pochi
anni fa due dei pochissimi casi conosciuti di donne soldato presenti come gruppo in organizzaoni
armate prevalentemente maschili: un fenomeno
che solo in questi ultimi anni si va diffondendo
all’interno di Stati diversi per struttura e cultura.
L’ultima guerra mondiale aveva registrato la presenza delle donne negli eserciti, soprattutto in quello sovietico, ma si trattava quasi sempre di ruoli
secondari. Se si eccettuano le ausiliarie di Salò e le
partigiane della Resistenza, alle soldatesse degli altri eserciti non era consentito l’uso delle armi. Non
dipese dalla marginalità del loro ruolo se queste
ultime, considerate utili in tempo di guerra, ven-
116
nero quasi nascoste nei momenti ufficiali del dopoguerra, perché un destino non diverso ebbero le
partigiane e le ausiliarie di Salò.
Tutto questo ci consente di concludere che, se il
fatto che gli uomini resistono ad accettare le donne soldato denuncia la persistenza di pregiudizi e
timori maschili nei confronti delle donne, l’accettazione che le donne possano fare la guerra non
implica necessariamente il superamento completo
delle discriminazioni. Solo recentemente si è cominciato a riflettere su questi aspetti, su cui per ragioni politiche e per resistenze culturali ha gravato
un lungo silenzio rotto soltanto dagli accertamenti
critici sulla storia delle brigantesse di Domenico
Scafoglio e Simona De Luna.
L’altro problema che le esperienze di donne in
armi sopra ricordate pongono è che esse presentano
indubbie somiglianze, ma al tempo stesso notevoli
differenze, che sembrano rendere difficile raccontarle come capitoli diversi di una medesima storia
delle donne nel loro rapporto con le armi. E le difficoltà crescono, quando di questi gruppi si analizza
il contesto e il rapporto con la politica, costringendoci a muoverci lungo un asse che va dal rivoluzionarismo populista delle soldaderas alla passione
fascista delle repubblichine.
Per quanto concerne il presente, le analisi si
sono focalizzate sulle forze armate statunitensi e
hanno fatto luce anche su situazioni nuove, determinate dall’arruolamento di massa delle donne
(circa quindicimila unità), dal loro accesso a nuovi
ruoli militari e dal raggiungimento della parità cogli uomini nell’esercito, ma hanno anche prodotto
un mutamento sostanziale del fenomeno delle soldatesse. Scomparse le motivazioni patriottiche e
ideologiche del secondo conflitto mondiale, la guerra americana nel Medio Oriente è diventata una
disperata risorsa dei ceti disagiati e marginali, che
attrae soprattutto le donne afroamericane. L’opera
Questioni globali concernenti il genere (Global
Gender Issues) di Spike V. Peterson e Anne Sisson
Runyan (Boulder, Westview Press, 1993) analizza
in chiave moderatamente femminista gli effetti della presenza delle donne nell’esercito americano, ar-
antropologia e storia
rivando alla conclusione che, a parte l’uguaglianza
tra i sessi, essa non ha contribuito a modificare i
sistemi simbolici e comportamentali della vita militare, che continuano ad essere plasmati dai valori
della mascolinità e dal culto della virilità, implicanti aggressività e durezza; valori che hanno finito
col risucchiare nella loro logica le stesse donne, con
risultati a volte sorprendenti e perfino sconcertanti. Né convince del tutto la giustificazione che
il contrasto all’aggressività e alla violenza non si
risolve soltanto all’interno di un’unica istituzione.
Intanto, anche se le troviamo impegnate in
prima linea, le soldatesse sono tutt’altro che eroine.
Secondo la rivista del centro ricerche del Congresso
Usa, CQ Researcher, la vita durissima e il rischio
altissimo di rimanere ferite o uccise durante le missioni in luoghi pericolosi come l’Iraq e l’Afganistan
induce sempre più frequentemente le soldatesse a
farsi congedare facendosi mettere incinte. Accadeva anche alle brigantesse, ma solo perché queste
ultime ignoravano l’uso dei contraccettivi (quelli
tradizionali funzionavano male), ma, dopo il parto, che solitamente avveniva in casa delle “mammane”, esse ritornavano spontaneamente nelle
bande. Le soldatesse americane violano invece le
leggi che proibiscono di avere rapporti sessuali durante le missioni, rischiando di finire davanti alla
corte marziale.
Ma il fenomeno delle soldatesse americane ha
un lato oscuro, che forse ci costringe a rivedere criticamente l’immagine del femminile, che per parecchi decenni, coincidenti con la storia del femminismo e oltre, abbiamo coltivato e condiviso. Alcuni
anni fa a Washington la CBS mandò in onda fotografie in cui nella Bagdad occupata dagli americani i soldati e le soldatesse statunitensi torturavano
i prigionieri nel carcere di Abu Ghraib, già luogo
di detenzione e di tortura nel regime abbattuto. Ne
sono protagonisti 17 americani, tra cui un generale
donna. Nelle fotografie scattate dagli stessi aguzzini
è possibile vedere prigionieri iracheni con elettrodi
sui genitali, mentre altri sono costretti a mimare
atti omosessuali per il divertimento dei militari
statunitensi. In un inquadramento che avrebbe
/ 1 – donne in armi
fatto la felicità di De Sade compare un mucchio di
corpi nudi di prigionieri accatastati, uno dei quali
mostra una frase ingiuriosa scritta sul corpo con la
vernice. In un’altra foto un cane attacca un irakeno
inerme e atterrito. In un’altra ancora compaiono
prigionieri incappucciati, con elettrodi collegati ai
polsi, costretti a stare in equilibrio su una cassetta,
sapendo che – gli hanno fatto credere –, cadendo,
morirebbero fulminati. Le torture avevano lo scopo di strappare informazioni ai prigionieri, ma gli
aguzzini e le aguzzine mettevano qualcos’altro nel
loro lavoro: risulta documentato che un prigioniero
minorenne è stato violentato da un americano in
presenza di soldatesse statunitensi che, divertite,
fotografavano lo stupro.
Il commento immediato che lo shock sollecita è
la pur banale verità che le donne sono come gli uomini in fatto di violenza e di sesso. È sopravvissuta
invece fino ai nostri giorni la convinzione, avallata
perfino da pensatori quali Adorno e Horkheimer,
che la violenza e la crudeltà del mondo, inestricabilmente associate all’ossessione del potere, e in
qualche modo da essa prodotte, avessero soltanto
un volto maschile, e che le donne le avessero subite,
ma non adoperate. Nella donna risiederebbe invece
l’ultima possibilità di un mondo pacificato e innocente. Il fatto che le donne in armi, sulle quali questa rivista ha iniziato le prime analisi approfondite
che si conoscano, non si sono dimostrate diverse
dagli uomini in guerra nell’uso della violenza e nel
rapporto col potere sembra ridurre questa convinzione a mendace mitologia. Il problema è emerso
da poco, con la scoperta dei fenomeni storici delle
soldaderas messicane e delle brigantesse italiane,
ma la vicenda contemporanea delle torturatrici
sadiche americane getta altra luce, più inattesa e
fosca, sul fenomeno delle donne in guerra.
Da qualche anno si è cominciato a scrivere che
“sul terreno dell’utopia si cominciano a contare dei
cadaveri. Il primo è l’illusione che le donne possano declinare al femminile certi ruoli storicamente
riservati ai maschi, l’idea che nelle loro mani il
comando si tramuti in un gesto giusto e gentile.
L’esperienza di questi anni ci dice, al contrario, che
117
Q
uaderni
quando una donna ha il potere, spesso lo usa come
i maschi, con in più una smania napoleonica di rivalsa. La parità su cui si batterono generazioni di
femministe non è mai diventata un’uguaglianza di
possibilità, ma si è rapidamente convertita in un’uguaglianza di comportamenti” (M.Gramellini, “La
Stampa”, 2004). Ma non si tratta, fatte le dovute
differenze, di “donne nuove” o di un problema solo
di oggi. Storicamente le donne hanno sempre “fatto
parte dei massacri e della mitologia che li circonda”
(J. Bourke, Le seduzioni della guerra, 2001): gli
occhi dell’oggi tuttavia ci consentono di guardare
da più prospettive e con un aggancio diretto con
la realtà il fenomeno della crudeltà e degli eccessi
delle donne combattenti, il cui significato non solo
illumina un aspetto della storia pregressa, ma va al
di là di essa, ponendo domande sui modi di essere
naturalmente e culturalmente donna nel rapporto
con le armi e il potere che ad esse le armi conferiscono.”La tortura eseguita da una donna sull’uomo, topos di romanzi neri e film gialli e fumetti
porno, era finora meno probabile nella realtà”; la
donna ambiziosa e spietata si considerava fuori
della norma, e come tale ha alimentato lo stereotipo letterario della donna fatale.
In un’ottica femminista si potrebbe pensare che
l’emancipazione delle donne in armi dalla cultura
tradizionale abbia trovato un limite nella loro forse
residuale soggezione all’uomo, soggezione che sarebbe responsabile della “permanenza del tratto
fallico della sessualità di donne. Ma questa lettura contrasta col fatto che le combattenti più dure e
spietate sono spesso quelle più libere e forti.La subordinazione all’uomo, soprattutto al capo, c’entra
piuttosto nella misura in cui produce il fenomeno
delle gregarie pronte, per ambizione o per amore o
per dovere, ad emulare anche la crudeltà dei capi
in tutto il suo orrore e a identificarsi col loro potere. Molte delle brigantesse studiate da Scafoglio e
De Luna erano totalmente devote ai capibanda, da
tollerare infedeltà e tradimenti.
Ma in altri casi potevano operare dinamiche
diverse. È possibile, anche, che la donna, improvvisamente liberata, non riesca a controllare la vio-
118
lenza che la libertà porta con sé, e si lasci attrarre
da essa. Va da sé che allora entra in gioco tutta la
precedente storia della donna, che rende ragione di
un istinto di vendetta, di rivalsa per la sottomissione e le violenze subite, trasferito astrattamente dai
propri aguzzini agli uomini in quanto tali e infine,
realisticamente, a quelli che la sorte ha messo di
traverso, nemici, prigionieri, persone comunque
ritenute o immaginate colpevoli. Sappiamo quanto
le donne umiliate o violate possano diventare aggressive e violente.
In molti casi tuttavia i condizionamenti e le
ragioni culturali e politiche sembrano prevalenti.
Una emancipazione parziale e limitata delle donne è stata ed è spesso una caratteristica degli stati totalitari e dei regimi autoritari dell’Occidente,
quando prendono la via di una modernizzazione,
che concerne soprattutto le trasformazioni tecnologiche, militari, economiche e meno quelle culturali. Valgano gli esempi storici del fascismo e del
nazismo, con cui quanto accade oggi alle donne
nel mondo arabo – escludendo alcune categorie,
come le combattenti curde degli ultimi anni e le
palestinesi – presenta alcune analogie. Nell’Iran
il processo di occidentalizzazione promosso dallo Scià aveva coinvolto anche la condizione delle
donne, alle quali per la prima volta fu consentito
di liberarsi del velo; la rivoluzione di Komeini ne
ripristinò l’uso, ma, al tempo stesso, concesse alle
donne alcune libertà e possibilità di accedere a ruoli e attività tradizionalmente maschili, compresa la
possibilità di formare una milizia femminile. Inizia così nel mondo islamico il singolare connubio
di una modernizzazione limitata ed eterodiretta
con la persistenza e il rafforzamento dei vincoli
tradizionali, con una chiara funzione di incentivo
e insieme di controllo. Questo implica che la modernizzazione ha percorsi diversificati, che ogni
cultura opera scelte e le innovazioni che considera compatibili con i propri valori e che la stessa
emancipazione femminile non si sottrae a questa
che sembra una regola fondamentale. Non si può
probabilmente parlare – come si fa, a volte a ragione – di lavaggio del cervello, perché la re-islamiz-
antropologia e storia
zazione è comunque condivisa dalle donne, che avvertono l’occidentalizzazione come una minaccia
perigliosamente sospesa sul loro mondo, o come un
progetto estraneo al loro modo di stare al mondo.
Se portare le armi è per la donna il simbolo vistoso
di una conquista e di un riconoscimento, portare il
velo, oltre a indicare emblematicamente la difesa
della propria identità attraverso fedeltà ai valori
tradizionali dell’Islam e a rafforzare la comune
fede religiosa, concilia questa vittoria delle donne
col mondo dei maschi. Nella sua concretezza, la
realtà salda principi in linea teorica incompatibili.
Almeno secondo la logica di una parte del mondo
occidentale tradizionale.
Come fossero viste le donne in armi nel mondo musulmano ce lo spiegano gli uomini del più
conservatore dei regimi arabi, col decreto saudita
che autorizzava le soldatesse americane a guidare,
sulla base della considerazione che “le soldatesse
Usa in uniforme non sono donne quando guidano
veicoli militari”. Il paradosso suggerisce più di una
possibile interpretazione, ma la più immediata
sembra essere quella che cancella, non solo la sessualità, ma anche l’identità di genere della donna
che fa il lavoro degli uomini. Fonte di preoccupazione, forse di angoscia, sembra essere proprio la
sessualità femminile. In Indonesia le donne recentemente diventano soldatesse senza portare il velo,
in un esercito, che è una istituzione aconfessionale
e multietnica, ma i musulmani integralisti propongono di introdurne l’uso. L’impiego delle donne per
operazioni militari come soldatesse col velo e perfino col burqa si diffonde sempre più nel mondo musulmano, soprattutto tra gli estremisti di ispirazione tradizionalista, compresi, oggi, i soldati dell’Isis.
È invece difficile parlare di emancipazione attraverso le armi e la guerra, quando si evoca la tragedia delle bambine-soldato africane. Il fenomeno
presenta qualche analogia con i lati più marginali e
oscuri della storia delle brigantesse dell’Italia meridionale, anch’esse spesso giovanissime, se non bambine. Sulle soldatesse africane esiste uno studio di
Susan MaKay e Dyan Mazurana (“Where are the
Girls?”), frutto di una ricerca condotta soprattut-
/ 1 – donne in armi
to in Monzambico, Uganda e Sierra Leone, da cui
risulta che le bambine presenti nelle forze armate
riguardano 55 paesi e nella maggior parte dei casi
esse partecipano ai combattimenti. Spesso sono sottratte con la forza alle famiglie: il rapimento, che il
più delle volte era una menzogna delle brigantesse
per difendersi in tribunale, in Africa è un fatto reale. Una volta arruolate, sono costrette a compiere
delitti anche contro i propri familiari, allo scopo di
impedire il loro ritorno al villaggio. Quando sono
esse stesse a scegliere la vita militare, lo fanno per
sopravvivere all’indigenza e alla fame, per un bisogno di sicurezza o come reazione a violenze subite.
Superato l’addestramento, combattono come i maschi, e, come non poche brigantesse, alcune di esse
sono abili e feroci nei combattimenti e nelle razzie.
Alcune di queste miliziane spietate sono le compagne degli ufficiali, sui quali esercitano una notevole
influenza, grazie alla quale godono di grande prestigio tra i soldati. Le soldatesse comuni però sono
più esposte alle violenze e agli stupri dei maschi.
Molte – circa un terzo – rimangono incinte, e quelle che non continuano a combattere durante la
maternità rimangono fuori dell’esercito, e sono al
tempo stesso rifiutate dalla loro comunità, a causa
del figlio illegittimo, o perché ammalate di malattie
a trasmissione sessuale.
Tutto questo succede con qualche variante anche nella Costa d’Avorio, insanguinata sin dal 2011
da una guerra civile ancora non del tutto spenta,
alimentata dagli interessi economici delle grandi
potenze. In tutti i gruppi armati militano alcune
decine di migliaia di bambine-soldato. Ad esse ha
dedicato un informatissimo articolo di Vauro Senesi (in “Il Fatto Quotidiano”, 20 luglio 2014). A
volte si arruolano volontariamente per sottrarsi a
una vita di stenti, ma spesso accade che vengano
rapite dai soldati, che le costringono a compiere
delitti contro la gente del villaggio o i loro stessi
parenti, le addestrano militarmente e le usano anche, volenti o nolenti, come il loro campo sessuale.
Prodotto della violenza, finiscono per essere esse
stesse catturate dal gioco maligno della guerra, e
diventano crudeli e spietate nei combattimenti. Fi-
119
Q
uaderni
nita la guerra, rifiutate dalla loro gente, finiscono
nella prostituzione. Allo scrittore che la interrogava Ashley dichiarava: “È il mio lavoro. So come si
smontano e si montano le armi. Ho già ucciso molte persone quindi non potrei più fare altro lavoro, a
parte essere militare. So maneggiare le armi, potrei
essere un malvivente, preferisco essere un soldato”.
Erano innamorate di Mussolini:
le ausiliarie di Salò
Annalisa Di Nuzzo
Il tema delle donne in armi, che è insieme antropologico e politico, e consente forse di guardare
da angolazioni nuove non solo la storia delle donne, ma l’intera storia civile, dovrebbe essere esteso
proficuamente – si spera che ci siano altre occasioni
per farlo, oltre la felice partenza rappresentata da
questo numero della rivista – alle Ausiliarie della
Repubblica di Salò: un fenomeno in larga misura
indotto dalla propaganda di regime, ma anche –
questo soprattutto sembra renderlo interessante –
frutto, come l’altro fenomeno parallelo ed opposto
delle donne della Resistenza, del nuovo sentimento
femminile di autosufficienza e di autostima, legato alle supplenze esercitate dalle donne durante
quattro anni di guerra e perfino alle loro precedenti esperienze nel Ventennio. La scarsa letteratura che le concerne si polarizza su due prospettive
interpretative: quello della agiografia nostalgica e
celebrativa e quello della decisa condanna, che è,
alla fine, una condanna politica. È rimasto fuori
dal coro il discorso alla Camera dei deputati tenuto
da Luciano Violante, che “da sinistra” rivendicò la
dignità delle tensioni ideali che avrebbero mosso le
giovani fasciste di Salò a cercare forme di eroismo e
sacrificio verso “una patria”. Bollato con l’accusa di
revisionismo e di superficialità storica, il discorso
fu relegato, nel dibattito che ne seguì, nella pura
dimensione accademica.
Istituito da Mussolini nell’aprile del 1944, il
Servizio Ausiliario Femminile riscosse un grande
successo, che sarebbe interessante cominciare a
120
spiegare: presentarono domanda di arruolamento
oltre seimila donne appartenenti ad ogni ceto sociale e provenienti da ogni parte dell’Italia, alcune
minorenni, parecchie madri e mogli. Le ausiliarie
normalmente non erano armate, ma durante i corsi erano addestrate all’uso delle armi e sia nella X
Flottiglia Mas che nelle brigate nere parteciparono
attivamente ad azioni militari, infiltrandosi perfino come spie nelle zone del paese liberate dagli
Alleati. Resta da chiarire perché Mussolini istituì
un corpo del genere e perché tante donne, prevalentemente giovali e giovanissime, vi aderirono. Già
prima della guerra lo stesso Mussolini aveva creato
un singolare legame donna-fascismo; la sua politica verso le donne aveva mirato alla formazione di
una “nuova italiana”, la donna fascista, attraverso
un cambiamento della sua dimensione quotidiana,
che coinvolgeva sia gli aspetti intimi e personali, quali la gestione del corpo, sia la formazione e
l’inserimento sociale. Il dittatore aveva tentato di
staccarsi dalla tradizione del primo fascismo, che
accentuava solo la prolificità delle madri, a favore
del rifiuto della riservatezza, il silenzio, la timidezza, il sentimentalismo e, pur restando la maternità
e la famiglia il perno della vita della donna fascista, tutto lo stile di vita doveva essere impregnato
di energia, coraggio, fierezza, decisioni rapide, voce
alta ed espressione schietta di sé (cfr. Franca Poli,
Fidanzate con la morte. Storia delle ragazze di
Salò, 2013). Le giovani donne aderirono per fedeltà
ad un regime che consideravano immutabile e per
un amore viscerale nei confronti di Mussolini, che
il culto della personalità aveva trasformato in una
specie di idolo, un padre-amante insostituibile. Si
pensi allo sguardo innamorato di una ragazza di
Salò, che così racconta il suo incontro con Mussolini: “Quello che mi colpì del Duce fu l’espressione dei
suoi occhi, che infatti non ho mai più dimenticato:
sembrava che ci guardasse a una a una e che il suo
stato d’animo, di fronte al nostro slancio, fosse di
una gioia pensosa. Ciò che direi, oggi, è che il suo
sguardo non aveva nulla del leader che insuperbisce alla vista di coloro che lo acclamano. Viceversa,
era quello di un padre che è sì orgoglioso dei propri
antropologia e storia
figli ma anche, in un suo modo segreto, preoccupato del loro avvenire; e preoccupato, anzi, assai più
del loro destino che del proprio”.
Spesso appena adolescenti, le donne fasciste si
lasciarono travolgere dalla tentazione di una nuova emancipazione ed abbracciarono la causa con
una passione a volte estrema. Rimasero affascinate
dal fascismo e dal dittatore, ma anche dalla novità
assoluta dell’esperienza, essendo le prime in Italia ad essere inquadrate in un corpo militare che
dava loro l’opportunità di uscire da quel ruolo tipicamente femminile che avevano sempre avuto. In
altre parole, esse mettevano in pratica quella voglia
di emancipazione che già altre generazioni avevano cominciato a vivere e che in altri paesi si era
già concretamente avviata. L’ educazione e la propagande del regime avevano poi fatto il loro corso;
una propaganda ed una pedagogia che già nei primi anni del Ventennio inculcava alle ragazze che il
bene della Patria faceva parte della sacra missione
della donna e che la Madre era insignita della gloria
di educare la prole a questo ideale. Teresa Labriola, una della più note intellettuali del tempo, aveva
abbracciato il programma dell’Associazione nazionalista, nonostante la sua formazione familiare.
Per certi aspetti la sua svolta politica dalla sinistra
alla destra richiamava quella dello stesso Mussolini
e di altri esponenti della “generazione del fronte”.
Il socialismo marxista era quasi una seconda natura per la Labriola, figlia del filosofo e attivista
politico napoletano. Teresa, il cui ingegno volubile
e salottiero aveva ben poco assimilato della filosofia marxista, aveva al pari di Mussolini una mentalità élitaria, imbevuta del volontarismo comune
a un’intera generazione di intellettuali. Ammirava
l’idealismo di Giovanni Gentile, col quale aveva
studiato, e preferiva l’iconoclastia di George Sorel e
Friedrich Nietzsche ai principi inesorabili del marxismo della Seconda Internazionale. Secondo Teresa solo nuove, fresche avanguardie, abbandonando
l’inetto riformismo del movimento socialista italiano, avrebbero costruito una nuova Italia, ripudiando I’agnosticismo liberale per infondere nel popolo
italiano una nuova “eticità”. Questa élite per la
/ 1 – donne in armi
Labriola era soprattutto al femminile: fin dal 1908
parlava della “capacità di sacrificio, peculiare della
donna”, che la rendeva l’unico soggetto capace di
ricomporre il “contrasto tra le esigenze dell’individuo e quelle della specie”. La sua visione delle donne italiane come campionesse di un nuovo ordine
sociale fondato sulla revisione dei concetti di razza,
nazione e Stato, risultò accattivante. La stessa figlia
prediletta del duce, Edda Ciano Mussolini, continuerà a sostenere negli ultimi anni della sua vita
che il fascismo aveva dato modo che si realizzasse
un femminismo di destra. In una situazione in cui
le donne quasi mai disponevano di informazioni
diverse e alternative, era stato facile al fascismo
costruire una nuova identità femminile mediante
un sistema formativo autoritario ed eterodiretto; le
voci delle ausiliarie, affidate a scritture autobiografiche che da non molto cominciano ad essere note,
risentono del lessico e della propaganda del tempo,
che poneva come principio fondante del riconoscimento del femminile il valore del sacrificio, e faceva
leva su un sentimento di maternità mediterranea
e su un desiderio di emancipazione e di partecipazione pubblica. La dilatazione del sentimento
materno oltre i confini familiari ispirò una cura corale dei soldati sbandati, dei prigionieri fuggiti, dei
bambini, che conviveva con una volontà forte di
protagonismo personale, di cittadinanza da vivere
accanto e analogamente a quella maschile. L’addestramento era duro: “niente rossetti, niente donne
fatali, niente amori conturbanti”, quindi controllo
affettivo e sessuale, spirito di sacrificio, sorretti da
una retorica che ripeteva gli stilemi e i temi della retorica fascista. Basta leggere giornalini come
“Sveglia” del 1944 per rendersene conto.
Questo clima spirituale era arroventato dal
riflesso delle passioni, che dividevano il paese. Le
lettere di alcune condannate a morte mostrano
drammaticamente la complessità di una formazione, in cui l’indottrinamento fascista era riuscito
a mettere radici nei vissuti delle persone, perché
aveva saputo subdolamente catturare i valori profondi, le domande di autenticità e di intransigenza
di donne giovani che, chiamate per la prima volta
121
Q
122
uaderni
ad assumere un ruolo da protagoniste, accettarono
pienamente il sacrificio per la “patria tradita”. È
quanto emerge da una lettera che una condannata
a morte scrive a sua madre:
la fede la portassi sempre tu per mio ricordo. Addio
per sempre (in “Lettere dei caduti della Repubblica
Sociale Italiana”, Associazione Nazionale Famiglie
Caduti e Dispersi della RSI, 1990).
Mamma mia adorata,
Purtroppo è giunta la mia ultima ora. È stata
decisa la mia fucilazione che sarà eseguita domani, 25 luglio. Sii calma e rassegnata a questa sorte
che non è certo quella che avevo sognato. Non mi è
neppure concesso di riabbracciarti ancora una volta. Questo è il mio unico, immenso dolore. Il mio
pensiero sarà fino all’ultimo rivolto a te e a Mirko.
Digli che compia sempre il suo dovere di soldato e
che si ricordi sempre di me. Io il mio dovere non ho
potuto compierlo ed ho fatto soltanto sciocchezze,
ma muoio per la nostra Causa e questo mi consola. È terribile pensare che domani non sarò più;
ancora non mi riesce di capacitarmi. Non chiedo
di essere vendicata, non ne vale la pena, ma vorrei
che la mia morte servisse di esempio a tutti quelli che si fanno chiamare fascisti e che alla nostra
Causa non sanno che sacrificare parole. Mi auguro
che papà possa ritornare presso di te e che anche
Mirko non ti venga a mancare. Vorrei dirti ancora
tante cose, ma tu puoi ben immaginare il mio stato
d’animo e come mi riesca difficile riunire i pensieri e le idee. Ricordami a tutti quanti mi sono stati
vicini. Scrivi anche ad Adolfo, che mi attendeva
proprio oggi da lui. La mia roba ti verrà recapitata
ad Aosta. Io sarò sepolta qui, perché neppure il mio
corpo vogliono restituire. Mamma, mia piccola
Mucci adorata, non ti vedrò più, mai più e neppure
il conforto di una tua ultima parola, né della tua
immagine. Ho presso di me una piccola fotografia
di Mirko: essa mi darà il coraggio di affrontare il
passo estremo, la terrò con me. Addio mamma
mia, cara povera Mucci; addio Mirko mio. Fa’
sempre innanzitutto il tuo dovere di soldato e di
italiano. Vivete felici quando la felicità sarà riconcessa agli uomini e non crucciatevi tanto per me; io
non ho sofferto in questa prigionia e domani sarà
tutto finito per sempre. Della mia roba lascio a te,
Mucci, arbitra di decidere. Vorrei che la mia picco-
Pur nel rispetto per la dignità di chi è capace
di scrivere lettere di questo tenore, la nostra consapevolezza che non c’era una patria tradita, e che
si trattava di un motivo della propaganda fascista,
specchio della falsa coscienza del regime, frena in
parte l’intensità della nostra umana partecipazione. Anche perché le vittime causarono anch’esse
altre vittime, e alcune, oltre a combattere dalla
parte sbagliata, uccisero e torturarono. Questi documenti vanno comunque sottratti all’oscurità cui
li condanna una parte politica, non tanto per una
generica volontà di restituire voce e dignità ai vinti,
e comprendere, pur in assenza di condivisione, l’entità della tragedia della guerra civile, quanto per
rappresentare le contraddizioni interne alla storia
dell’emancipazione delle donne, liberando questa
storia dai facili schematismi e dalle costruzioni
ideologiche. Certamente le adunate fasciste permisero alle donne di uscire dai luoghi privati e di
essere protagoniste di spazi pubblici, di conquistare
la piazza, di essere come i loro fratelli (“non eravamo libere di uscire da sole, di incontrare amici, di
andare a cinema, ma la divisa e le adunate ce ne
davano l’opportunità. Si percepiva di essere prese
in considerazione, di essere parte di un tutto, forse
per la maggioranza era la patria, non il fascismo,
anche se nessuna, o quasi, aveva l’idea di che cosa
fosse esattamente”), ma questo avveniva senza la
minima consapevolezza di quello che il fascismo
realmente era ed a costo di una militarizzazione
autoritaria che non era certo la forma ideale dell’emancipazione femminile.
La retorica funeraria di un regime che aveva
ormai i giorni contati provò a cavalcare fino in
fondo il motivo epico della “bella morte”, inondando le canzoni delle giovani donne votate al sacrificio: “O giovane ragazza / Che parti volontaria
/ Per fare l’ausiliaria / Ricorda che la vita / Non
sempre sarà bella ….”. E ancora: “Cara Mamma,
antropologia e storia
parto volontaria / Dammi un bacio senza lacrimar…./ …a noi la morte non ci fa paura, / ci si
fidanza e ci si fa l’amor”. Quando si studieranno
accuratamente questi testi, riuscirà facile forse far
emergere temi cari ad un languido e stucchevole
romanticismo tipico di una letteratura femminile
da romanzi d’appendice, che si declina nelle forme
del nuovo eroismo. E si potrà anche mostrare come
il vento di questa modernizzazione autoritaria dei
ruoli e dei compiti delle donne aveva investito anche il rapporto con la famiglia, in particolare con i
padri, che si opposero spesso alle decisioni dell’arruolamento, mentre le figlie si sentivano sacerdotesse e garanti del nuovo ordine. Si era realizzata
con successo una sorta di militarizzazione della
mente di ragazze molto giovani insieme all’elaborazione di una sacralità laica e pubblica, che sarà
/ 1 – donne in armi
ricorrente in molti regimi totalitari del secondo
Novecento, per esempio quelli del Vietnam o della
Cambogia. Questo fa pensare che questa militarizzazione della mente femminile non fosse soltanto
il prodotto di un regime disperato che avverte la
sua fine, ma sembra porsi come un modello attraverso il quale si procede alla ricostruzione di un
tessuto sociale e si elabora un rito collettivo, che,
comunque, passa attraverso la soppressione di libertà, atrocità, esposizione dei cadaveri. In ogni
caso è interessante osservare che le donne soldato
di questo periodo, ausiliare o partigiane, per motivi opposti sparirono dalla visibilità pubblica: le
prime, perché traditrici e da rinnegare, le seconde
perché probabilmente ingombranti e possibili concorrenti nel gestire lo spazio politico della ricostruzione di un paese.
123
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
“Facta ficta”
nella ricerca scientifica
e nel romanzo storico-antropologico
Domenico Scafoglio
Antropologia e storia: un incontro
da riconsiderare
I
l rapporto tra la ricerca antropologica e quella storica non può esaurirsi
in una rilettura della disciplina storica alla luce dell’antropologia e viceversa. L’incontro, peraltro in alcuni momenti e in parte già avvenuto, non può neppure
limitarsi al “trapianto” nella ricerca storica di
importanti concetti e temi antropologici, per
dare vita a una disciplina di confine, come
l’antropologia storica. Innanzitutto perché
esistono molte tendenze e scuole negli studi antropologici (evoluzioniste, storiciste,
diffusioniste, funzionaliste, funzional-strutturaliste, culturaliste, strutturaliste, cognitiviste ecc.), che alla fine hanno in comune
poche idee importanti, appena sufficienti
per formare una identità disciplinare ridotta
all’essenziale, e divergenti per tutto il resto.
I concetti antropologici estrapolati da diversi sistemi dovrebbero comunque risultare
coerenti, se non interattivi, tra di loro per
celebrare il loro incontro o fusione con la
storia e dovrebbero inoltre essere collocati
in un nuovo sistema storico-antropologico
in modo da creare una totalità coerente, di
segno nuovo e diverso, con gli altri elementi
di provenienza storica: una nuova disciplina
non è la somma di due precedenti discipline,
ma un sistema di pensiero e una modalità di
ricerca nuova e potenzialmente innovativa.
In secondo luogo, occorrerebbe liberare
i concetti antropologici dalle contaminazioni ideologiche che si sono accumulate nella storia di una disciplina che è convissuta,
restandone frequentemente contagiata, se
non coinvolta, con storie di conquiste, di
dominio e di violenza acculturatrice. È un
compito che spetterebbe anche alle discipline storiche, analogamente contaminate da
interessi di parte e da più o meno oscure o
palesi connessioni con i gruppi di potere.
Il peso delle differenze e delle affinità
A un primo approccio, le differenze tra la
ricerca storica e quella antropologica possono apparire macroscopiche, al punto da rendere comprensibile in parte diffidenza, che è
durata parecchi decenni, degli antropologi
nei confronti delle indagini storiche. L’antropologia, pur occupandosi, soprattutto nel
suo momento etnografico, non diversamente
125
Q
uaderni
dalla ricerca storica, di situazioni specifiche,
caratterizzate da un’ estrema concretezza,
non può fare a meno delle generalizzazioni
che le consentono la formulazione di leggi
del comportamento sociale; questo ha fatto
sì che soprattutto nella sua fase funzionalista e strutturalista essa si autorappresentasse come una disciplina nomotetica, opposta
alla ricerca storica, qualificata invece come
disciplina descrittiva, idiografica, proiettata verso la rappresentazione del particolare.
Non è una differenza da poco, perché, grazie
all’impiego scientifico e sistematico del metodo comparativo, il confronto tra le culture
può mettere in gioco il decentramento della
conoscenza, che costituisce un merito storico
della pratica e della riflessione antropologica.
Se è vero che, come sostiene Lévi-Strauss,
entrambe le discipline sono unificate dallo
scopo comune, che è “la migliore intelligenza
dell’uomo”, è anche vero – se guardiamo alla
differenza tra i loro territori e alle sue implicazioni teoriche – che, mentre gli storici per
lungo tempo non sono usciti quasi mai fuori
della storia dei loro popoli, e, quando si sono
imbattuti nelle altre storie, le hanno osservate e interpretate dal punto di vista della storia
propria, l’antropologia ha perseguito lo scopo indicato da Lévi-Strauss attraverso il confronto con la diversità culturale: le forme della conoscenza e l’intero sapere antropologico
sono fondamentalmente legati all’incontro
e al confronto tra due alterità, quella del ricercatore europeo e quella dei popoli lontani
(per lo più “primitivi”) o delle culture popolari del proprio paese e di tutto l’Occidente.
Le due spinte fondamentali del pensiero antropologico, quella universalista e l’altra, opposta e complementare, la spinta relativista,
presuppongono un campo d’osservazione
costituito da una varietà di popoli e culture
126
diverse, compresa quella del ricercatore. In
quanto disciplina anche applicata, l’antropologia studia le culture su larga scala per
pervenire a una teoria generale della società,
da utilizzare per comprendere casi specifici
e risolvere problemi concreti, oppure approfondisce la conoscenza di singole culture, per
rapportarsi ad esse nella maniera giusta e facilitare la loro interazione, nella prospettiva
di un mondo tollerante e dialogante.
Quanto al metodo, l’antropologia, dopo
una iniziale e solida esperienza storicista,
ha privilegiato per molto tempo l’approccio sincronico all’oggetto di studio, mentre
lo storico è stato visto come uno specialista
della diacronia. È la sincronia, che, fermando
strumentalmente il flusso degli eventi, consente di allargare lo sguardo su tutti i lati del
campo di ricerca e scoprire angoli ignorati o
occultati, mentre lo sguardo catturato dal divenire costringe ad appiattirsi sul dinamismo
storico e a privilegiare i tratti che determinano i mutamenti delle società in evoluzione,
trascurando tutti gli altri, escludendo o sottovalutando stati di coscienza e forme di vita.
Quando si schiaccia il presente sulla prospettiva del futuro, si impedisce di cogliere la vastità e complessità dell’hic et nunc, della storia
che è, a vantaggio della storia che deve essere.
Ma non sempre gli individui e i popoli vivono la storia nella prospettiva di un divenire
intravisto o sognato, e non per questo la loro
esistenza porta le stimmate dell’irrilevanza.
Ma forse il discrimine maggiore, più volte rilevato, tra l’antropologia e la storia è costituito dal fatto che gli studi antropologici
hanno indagato le trame di significati latenti
e le strutture profonde della cultura inconsapevole dei gruppi umani, mentre gli storici
si sono prevalentemente occupati – a parte
qualche proposta solitaria di psicoanalisi
antropologia e storia
della storia, avanzata negli anni sessanta del
secolo passato – delle espressioni coscienti
e delle logiche di superficie. Questo per gli
antropologi ha implicato l’approfondimento
di importanti problemi di ordine cognitivo
ed epistemologico, rimasti quasi estranei
alla riflessione degli storici. Vi hanno contribuito in maniera decisiva gli strumenti e
le tecniche stesse dell’antropologia, a cominciare dallo strumento principe della conoscenza antropologica, la ricerca sul terreno,
l’ osservazione, la conoscenza diretta e l’autosservazione, poco praticate o sconosciute
all’indagine storica.
È difficile che gli antropologi alle prese
con la storia rinuncino a queste che potrebbero essere le conquiste più alte della loro
disciplina: ove questo avvenisse, rappresenterebbe per essi una regressione dal piano propriamente antropologico a quello meramente
etnografico (che comunque continuerebbe a
costituire per tutti un fondamento e un punto
di partenza imprescindibile).
La storia dei rapporti tra le due discipline
dimostra comunque che l’ostilità o l’indifferenza per la storia non è congenita all’antropologia, ma inizia soltanto con i funzionalisti e si conclude con l’esaurirsi dell’esperienza
dello strutturalismo. Precedentemente gli
evoluzionisti e i comparativisti della seconda metà dell’Ottocento avevano conferito
una grande importanza alla ricerca storica:
in Cultura primitiva Tylor, citando Spencer,
dichiarava che i concetti si comprendono
solo se se ne sa fare la storia, e riteneva oltremodo rischioso cercare di spiegare un’usanza separandola dai fatti passati con i
quali è connessa. Il limite di questo interesse
per la storia era la teoria degli stadi, in cui
esso si risolveva, opportunamente liquidata
poi da Boas. Notoriamente i funzionalisti e
/ 1 – donne in armi
strutturalisti, nello sforzo di assimilare l’antropologia alle scienze naturali, andarono
oltre, rimproverando gli storici di lavorare
in maniera congetturale su un passato mal
conosciuto e mal documentato, perché di
solito anteriore alla invenzione della scrittura. In realtà il rifiuto della storia era inscritto
nell’epistemologia struttural-funzionalista,
secondo cui il presente ha in se stesso le condizioni che spiegano il suo funzionamento,
alla cui comprensione la storia è totalmente
estranea ed inutile.
Da alcuni decenni – sono cose note –
le prevenzioni degli antropologi nei confronti del lavoro degli storici sono cadute,
insieme all’illusione di adottare il modello
delle scienze naturali, mentre è cresciuta la
consapevolezza che l’indagine etnografica
e etnologica limitata alla ricerca sul campo
priva la rappresentazione delle culture della
necessaria profondità storica, già auspicata
dai padri fondatori dell’antropologia. Una
crisi pressoché parallela ha attraversato la
ricerca storica, facendo prendere coscienza
– sollecitata dal confronto con i risultati e i
metodi delle ricerche antropologiche – dei
limiti tematici e delle inadeguatezze teoriche
e metodologiche degli studi storici tradizionali. Crisi salutare, che ebbe come esito la
nascita della storia antropologica francese,
dalle “Annales” a Braudel e alla “nuova storia”, che per la prima volta ha forzato i limiti
della ricerca storica tradizionale, aprendosi
alla possibilità di pervenire a una lettura più
sottile e complessa dei documenti, transitare nuovi territori di ricerca, prima ignorati
o trascurati, arricchire la ricerca storica di
una nuova consapevolezza critica. Gli studi storici hanno cominciato a contaminarsi
con l’antropologia, in un momento in cui
quest’ultima metteva in discussione i suoi
127
Q
uaderni
stessi fondamenti, e iniziava a riconoscere
una “somiglianza di famiglia” cogli studi
storici.
Evento favorevole fu l’affermarsi, prima
in America e poi in Europa, delle correnti
di pensiero riflessivo, grazie al quale il riconoscimento della comune letterarietà ha
contribuito ad accelerare e rafforzare l’avvicinamento delle due discipline. Mentre il
campo antropologico fu presto e facilmente sconvolto dalla fortuna dell’antropologia
interpretativa e dialogica, fuori d’Italia la
riflessività ha contagiato anche il territorio
della ricerca storica, con l’idea che le costruzioni storiche si fondino su punti di vista,
che le rendono assimilabili in ultima analisi
alle creazioni artistiche, con le quali condividono le medesime strategie discorsive e persuasive, oltre una poetica più o meno implicita e un rapporto significativo col mito. Per
un altro verso la presunzione di oggettività
affidata alla creduta inconfutabilità dei dati
è stata messa in crisi dalla consapevolezza
che il passato è una costruzione che si riscrive ogni volta alla luce del presente, secondo
un ordine di idee in cui la storia sembra aver
trovato ispirazione e sostegno nella psicologia del profondo: le ricerche sulla memoria
individuale e collettiva insegnano che, se il
passato costituisce una “totalità ineffabile”,
che occorre decostruire per poterlo conoscere, la sua interpretazione diventa una operazione creativa e retrospettiva: in virtù del
“principio dell’appropriazione”, l’ elaborazione sia consapevole che inconscia del passato
“è resa possibile dalle nuove esperienze del
soggetto e attraverso di essa il passato assume una nuova qualità e può produrre effetti
psichici nuovi” (Peth 2002: 429).
L’avvicinamento ha portato, sul piano
epistemologico, a smussare il contrasto tra
128
l’osservazione diretta degli antropologi che
lavorano sul terreno e l’osservazione storica,
in cui il documento sostituisce la realtà, sulla
base della considerazione che in entrambi i
casi il ricercatore opera in maniera analoga
(ossia adoperando procedure di tipo induttivo-deduttivo, compiendo comparazioni, disegnando classificazioni e operando selezioni di dati sulla base di un modello teorico) e
lavora su testi o documenti, cui occorre incessantemente porre nuove domande e che
bisogna leggere ogni volta alla luce di nuovi
codici: testi e documenti che l’antropologo,
a differenza dello storico, si costruisce da sé,
con l’aiuto degli informatori. Nietzsche aveva già fatto importanti considerazioni sulla
inscindibilità di conoscenza diretta e storia,
a proposito dell’autosservazione: “L’autoconoscenza diretta non basta da sola a conoscersi: abbiamo bisogno di storia, perché
il passato continua a fluire dentro di noi in
cento onde; noi stessi non siamo altro che
quello che avvertiamo in ogni momento di
questo flusso. E anche qui, se vogliamo entrare nel flusso del nostro essere apparentemente più nostro e personale, vale il detto di
Eraclito: non si entra due volte nello stesso
fiume (Niet 1965, II, 223).
Si è andata, anche per questa via, sdrammatizzando l’opposizione sincronia/diacronia, quando si è compreso che l’oggetto
dell’osservazione diretta non nasce sotto gli
occhi dell’ osservatore, ma preesiste al suo
sguardo e ciò che egli osserva è soltanto
l’ultimo istante di un fenomeno che ha cominciato a dispiegarsi in un tempo a volte
recente, a volte lontano se non immemorabile: il presente è un racconto che viene da
lontano. In questo modo il cerchio si chiude,
e l’antropologia sembra ritornare, con altra
consapevolezza, alle origini tyloriane.
antropologia e storia
Antropologia storica?
Questi fatti recenti, che rappresentano
in sede antropologica un aspetto della più
generale crisi che attraversa l’organizzazione tradizionale dei saperi, hanno fatto pensare alla possibilità della generalizzazione
delle esperienze delle “Annales”, facendone
il fulcro di una disciplina autonoma, l’“antropologia storica”. Si è pensato cioè che
questa nuova disciplina esistesse già, e che
rimanesse soltanto da fissarne lo statuto,
definirne i confini, mettere a punto il quadro teorico-metodologico. In realtà, pur
essendo orientate da un proposito di sintesi onnicomprensiva, le varie definizioni
dell’antropologia storica risentono delle diverse sensibilità, storie culturali, estrazioni
disciplinari degli studiosi, rendendo difficile
il compito di unirle in una sola categoria,
sul fondamento di un comune denominatore. A titolo di esempio ricordiamo una sola
delle definizioni dell’antropologia storica,
che nel 1987 diede Peter Burke (Bur 1988:
5-10) individuandone cinque componenti
fondamentali: casi particolari concreti, invece delle tendenze generali indagate dalla
Storia sociale su basi quantitative; fatti di
modeste dimensioni, microstorie e storie di
piccole comunità; “descrizione densa”, intesa come interpretazione “dell’interazione
sociale in una data società nei termini delle norme e delle categorie di quella società
stessa”, contrapposta alla lettura dall’esterno,
“etica”, degli storici sociali; simbolismo nella vita quotidiana, ossia “usanze, abitudini
e rituali apparentemente banali”. È difficile
immaginare che tutti gli antropologi storici
si possano riconoscere in questa definizione
dell’antropologia storica. In definizioni di
questo tipo l’incontro tra le due discipline
/ 1 – donne in armi
si realizza a un livello modesto, come una
contaminazione en bass, che lascia fuori
della nuova disciplina alcuni aspetti dirompenti dell’esperienza storica ma soprattutto
di quella antropologica, quali la rappresentazione dei vissuti esperienziali individuali;
l’ utilizzazione complementare delle ricerche
quantitative e seriali; il recupero della presenza e del ruolo delle masse, come rimedio
alle lacune della ricerca macrostorica e alle
omissioni della storiografia tradizionale; l’attenzione alle marginalità sociali e culturali,
potenzialmente capace di mettere in discussione, nell’ottica, per esempio, di Khun, i paradigmi scientifici dominanti e di agevolare
il loro superamento; l’individuazione e l’uso
di nuove fonti, come quelle orali, folkloriche
e letterarie; la pratica del lavoro comparativo. Assenze significative, che riducono l’antropologia storica di Burke al ruolo di una
“disciplina del particolare”, classificabile
come etnografia storica connotata in senso
sociologico. Le carenze maggiori si collocano sul piano teorico, al quale rimangono
estranei i concetti, vecchi (per così dire) e
recenti, che hanno attraversato il campo antropologico nell’ultimo mezzo secolo, quali
il recupero della soggettività interpretante
nelle scienze umane e sociali, il carattere
dialogico della conoscenza nelle discipline
umanistiche, il problema della “forma” della
scrittura storica, il rapporto tra la psicologia
e la ricerca antropologica e storica, il ruolo
della storia e dell’antropologia nell’ organizzazione dei saperi.
“Facta ficta”: se la storia non è una scienza
Storici e antropologi, sia che collaborino
nella medesima indagine, sia che procedano
129
Q
uaderni
ognuno per conto proprio, hanno in comune
il problema che ha acceso un importante dibattito negli anni settanta del secolo passato
e non si è ancora risolto, quello dell’esistenza
o meno delle leggi generali che governano la
storia e della loro conoscibilità. Nell’ opinione di molti l’esistenza di queste leggi conferirebbe agli studi storici una veste scientifica,
laddove la loro inesistenza farebbe di essi
un’attività di più difficile definizione. Senza
andare troppo lontano, diciamo che della
loro esistenza si era detto convinto, in un articolo pubblicato nel 1979, l’argentino Carl
G. Hempel (Hem 1979), secondo cui esse
avrebbero oggettivamente una funzione analoga a quella che le leggi hanno nelle scienze
naturali, e si potrebbero conoscere mediante
il collegamento delle cause a dei fini, che conferirebbe ad esse una capacità di predizione.
La tesi ha trovato l’avallo in sede filosofica di
esponenti del positivismo logico e di filosofi
analitici, come Popper. Per tutti “spiegare un
avvenimento equivale a dimostrare che è effetto di una causa o, in altri termini, è un caso
di una legge” (Pop 1981: 111).
Nelle tradizioni di pensiero opposte non
esistono i fatti, ma soltanto le rappresentazioni, facta ficta, come aveva sostenuto
Nietzsche (Nie 1881: 307), che può essere
considerato il punto di partenza – o almeno quello di maggior prestigio – di quanti
considerano i fatti indissociabili dal loro
racconto e dalla soggettività di chi li evoca.
Con essa si raccorda Ricoeur, quando aggiunge che “un fatto fisico semplicemente
avviene, mentre un fatto umano ha già uno
statuto storico, perché è stato già raccontato
nelle cronache, nelle leggende ecc.”, per cui il
vero problema è semmai quello di capire “in
quale tipo di discorso questa struttura esplicativa funziona” (Ric 1983: 165). La critica
130
contro la “realtà” del dato storico era stata ripresa in sede antropologica da Lévi-Strauss,
in base alla considerazione che la ricostruzione storica è il risultato di una sintesi compiuta dal soggetto investigante, implicante
la selezione e perfino l’invenzione dei dati.
Pur non escludendo che in un futuro imprecisato la storia potesse divenire una scienza,
l’antropologo sosteneva che i miti delle società evolute “sono tutti riducibili alla storia”,
implicando che tutta la storia è riducibile al
mito (Lev-Ca 1969: 69-70); il mito compare
dove manca la conoscenza scientifica, tra i
“primitivi”, che, incapaci di analizzare scientificamente la natura, della natura fecero la
protagonista della loro mitologia; invece noi
civilizzati “abbiamo riassorbito, pulito, assimilato nell’analisi scientifica” il mondo naturale, mentre abbiamo mitologizzato il mondo della storia, perché esso è “impermeabile
alla scienza – perlomeno, allo stadio in cui si
trova attualmente – quanto lo è la natura per
i popoli primitivi” (Lev 1969: 68).
In realtà, quando nelle società evolute
gli uomini si impegnano a dare una struttura scientifica alla conoscenza della storia,
la loro immaginazione continua a esercitarsi
anch’essa sui fatti storici, i quali conservano
nella forma di miti un’esistenza parallela, riconoscibile – nei suoi esempi più importanti
– nell’epos e nel romanzo storico: le società
complesse hanno perciò una percezione
doppia dei fatti storici, contesi da una presunzione di scienza e al tempo stesso oggetto
di una rappresentazione immaginaria. Nelle
società moderne coscienza storica e rappresentazione immaginaria coesistono, forniscono risposte a bisogni diversi e producono
effetti diversi, ai quali la gente non vuole rinunciare. Questo sembra costituire un problema finora scarsamente approfondito.
antropologia e storia
Per Lévi-Strauss invece è possibile dare
dei fatti storici una rappresentazione mitologica e non scientifica, perché i fatti sono
imprevedibili nel loro svolgimento: “bisogna
inchinarsi di fronte alla contingenza irriducibile della storia” e prendere atto che “la
storia reale si sottrae alle leggi di sviluppo,
come quelle elaborate dai marxisti” (Lev-Di
1988: 177). Perché i fatti variano, non si ripetono, né si somigliano: “non esistono dunque leggi della storia, perché il numero delle
varianti è tale, che vi sono talmente tanti parametri, che forse soltanto un intelletto divino potrebbe conoscere, o sa già dall’eternità,
che cosa accade o accadrà. Quelli umani
ogni volta si ingannano; la storia lo dimostra. Si dice: ‘delle due l’una’, ed è sempre la
terza”. Anticipando per certi aspetti Benjamin, Lévi-Strauss riteneva che semmai “gli
eventi sono imprevedibili sin tanto che non
si sono verificati. Ma quando hanno avuto
luogo, si può cercare di capire e di spiegare.
Si possono legare gli avvenimenti gli uni agli
altri e cogliere retrospettivamente la logica
di tale contaminazione” (Lev-Di 1988: 177).
Almeno attualmente, il lavoro dello storico è
inevitabilmente parziale, e può portare solo
a risultati parziali: la logica con cui leghiamo
i singoli fatti non costituisce la struttura logica della totalità.
Fuori del “bordello dello storicismo”
Le tradizioni di pensiero storiciste tendono a collocarsi dalla parte delle leggi, per
via della tendenza a stabilire nessi di causalità fra momenti diversi della storia. Ad esse
Benjamin obiettava che “nessun fatto, perché causa, è perciò storico. Lo diventerà solo
dopo, postumamente, in seguito a fatti che
/ 1 – donne in armi
possono essere divisi da millenni”. Da questo
storicismo Benjamin sganciava le tradizioni
autentiche di materialismo storico, perché
“lo storicismo postula un’immagine ‘eterna’
del passato, il materialista storico un’esperienza unica con esso. Egli lascia che altri
sprechino le proprie forze con la meretrice
‘c’era una volta’ nel bordello dello storicismo.
Egli rimane signore delle sue forze: uomo
abbastanza per far saltare il continuum della storia” (Benj 1995: 84-86). Invece l’idea
benjaminiana dello “sviluppo a strappi” rivendica l’autonomia e la creatività dell’agire
umano contro il rischio delle strumentazioni ideologiche e le mitologie del continuazionismo e del casualismo storiografico.
La critica del continuazionismo storicistico e della presunzione di oggettività assoluta delle ricostruzioni storiche, insieme
alla presa di coscienza della loro natura di
narrazione di narrazioni e alla sua identificazione con le rappresentazioni mitiche,
hanno aperto la strada a riflessioni teoriche
coraggiose sulla storia negli ultimi decenni,
introducendo elementi di novità, che non
possono essere ignorati o non tenuti in conto nelle pratiche di ricerca.
Una storia dialogica?
Lo spazio che la soggettività ha guadagnato in sede antropologica potrebbe costituire un problema per gli storici che vanno
a incontrare l’antropologia. Eppure era stato
proprio uno storico, Alain Besançon, a sostenere la necessità dell’apertura delle analisi
storiche alla soggettività (la soggettività del
testo, ma anche dell’autore): nel proposito di fondare una psicoanalisi della storia,
Besançon negli anni 1968-1971 poneva, ac131
Q
uaderni
compagnati da lucide proposte di soluzione,
gli stessi problemi, che, al di là dei rapporti
tra la storia e la psicoanalisi, a breve avrebbero sconvolto il tradizionale assetto teorico-metodologico del settore antropologico
(Bes 1975): “oggetto e soggetto dell’indagine
storica (e psicoanalitica) non sono ontologicamente, qualitativamente diversi. Nella misura in cui l’oggetto è l’uomo (ovvero
documenti-che parlano-di uomini), quello
intrecciato tra il documento storico e il suo
interprete è un dialogo fra due pari, fra due
soggetti”, ed entrambi sono soggetti relativi.
Relativo il documento, che non enuncerà
mai tutto ciò che gli ‘sta-dietro’”; relativo
anche l’interprete, ricettacolo di sogni e
desideri, che inevitabilmente si riversano o
riverberano nell’analisi, togliendole purezza e trasparenza (Bes 1975: 69). Riflessioni
preziose, le cui radici sono state opportunamente individuate “in un humus teorico per
più versi prossimo a quello da cui sono nati
Heidegger, Gadamer, l’ermeneutica come
scuola filosofico-teologica” (Mor 1975: 17).
La soggettività profonda
e la mediazione della forma
La rivalutazione del ruolo della soggettività dell’interprete ha dato i suoi frutti assai
più in sede antropologica (in cui raramente
si è fatto il nome di Besançon) che storica.
Era già risaputo che l’intera storia intellettuale ed emotiva dell’interprete, passando
attraverso il suo lavoro di selezione e costruzione concettuale e formale, confluisce
nelle sue rappresentazioni, a dispetto della
sue presunzioni di oggettività e asetticità. E
si era in qualche modo già posta l’esigenza
di collocare lo stesso interprete all’interno
132
del campo della ricerca, come elemento da
indagare oltre che indagante. Ora, però, si va
oltre, alla ricerca dei condizionamenti che
provengono dalla soggettività più profonda
dell’autore. Besançon, se, per un verso, anticipava le istanze dell’antropologia dialogica
e interpretativa, per un altro le scavalcava
portando la stessa storia in un altro ambito di competenze, quello della psicologia,
in parte familiare all’area antropologica, ma
con a quella storica: l’interprete subisce non
soltanto i condizionamenti “dettati dalla
nostra situazione storica”, ma anche di “ciò
che in noi sfugge alla storia, della parte non
storica di noi stessi, ossia dell’inconscio”.
Dall’inconscio vengono le motivazioni segrete, quelle che ci consentono di dare risposte a domande come queste che Besançon si
pone: “Che cosa vogliamo di preciso quando facciamo della storia? A quale desiderio
primario questo desiderio di sapere può riferirsi? La mia scommessa è che le risposte
a questi due problemi (sull’inconscio nel
testo e in noi che l’esaminiamo) non possono essere cercate che insieme; che lo storico non può avanzare nella conoscenza del
testo senza condurre parallelamente questo
necessario esame di coscienza”. Il progresso
della conosenza scientifica è proprio prodotto dall’inquietante incontro del simile-esterno
a sé e dell’altro-interno a sé (Bes 1975: 23).
L’ elemento fondante dell’osservazione,
cosciente e inconscia, è proprio nell’interazione soggetto/oggetto: quando il sistema
dello storico incoscientemente o involontariamente si “mette in risonanza con il sistema
fantasmatico dell’oggetto studiato” (“fantasma”), ossia, quando l’inconscio dello storico si incontra o scontra con l’inconscio che
emerge dal documento, nell’osservatore si
produce una “perturbazione euristica” (Bes
antropologia e storia
1975: 72, 69) analoga a quella prodotta dal
“perturbante” freudiano, che genera immagini familiari e sinistre, terribili e accattivanti.
In altri termini, l’investigazione storica può
fare emergere dall’incontro/scontro dell’inconscio del testo e della personalità dell’interprete uno scenario fantasmatico, tramato
di desideri, affetti, pulsioni, ossessioni.
È una svolta radicale, perché finora gli
storici che hanno dato spazio al soggetto
“non hanno evidenziato nulla più dei modi
razionali-coscienti, categoriali dell’operare
storico” (Mor 1975: 19). Essa getta nuova
luce su tutta la strutturazione del testo scientifico: il “compimento di un desiderio”, che
fonda l’immaginario dello storico-antropologo, è inevitabilmente “più o meno deformato dai processi difensivi”, sicché nessun
interprete, come già pensava Freud, “va
più lontano di quanto gli permettano i suoi
complessi e le sue resistenze interne: ciò che
si reprime in sé impedisce di vedere ciò che
gli corrisponde, allo stato di rimozione, nella cultura che si studia” (Bes 1975: 65, 68).
La perturbazione euristica può però giovare a superare complessi e resistenze interne,
sbloccando almeno in parte il linguaggio e
aprendo a nuovi orizzonti la comunicazione.
È questo il momento creativo e innovativo della discesa agli inferi della soggettività
inconscia. Si tratta di ben altro che di concetti psicoanalitici trasformati in “figure di
stile”, come pensa Certeau (Cert 1975: 298).
Perché l’incontro dei vissuti soggettivi del
testo e dell’interprete può approdare a nuove
forme di decodifica, che restituiscono un’esperienza insospettatamente più ricca, più
intensa, frastagliata, meno convenzionale e
scontata: laddove – nell’opinione di Nietzsche, che in parte condividiamo – “i nostri
storici letterari sono noiosi, perché costrin-
/ 1 – donne in armi
gono a parlare di tutto e a giudicare anche là
dove non hanno vissuto niente” (Niet 1965:
30 (60).
L’ermeneuta, a nostro giudizio, al tempo
stesso dovrà tenere conto del fatto che già il
testo che egli analizza è assai più del “fantasma”, perché, nel suo nascere, al sistema
fantasmatico sono state conferite forme culturalmente approvate, differendo o promuovendo o plasmando pulsioni e istinti in conformità con le regole sociali, in modo che
i loro contenuti diventassero consapevoli
rimanendo inespressi, o sospesi tra l’inconscio e la coscienza, o manifesti ma non immediatamente percepibili. La perturbazione
euristica ed ermeneutica ha però la capacità
di farli emergere dalla loro liminarità o latenza, esplicitando il non detto, dando un
volto all’inespresso, ma anche l’ermeneuta
dovrà fare i conti, a un altro livello, con i
contenuti della coscienza, i codici culturali,
le convenzioni stilistiche e retoriche, dando vita a formazioni di compromesso tra la
pressione fantasmatica e il principio della
realtà. Se l’inconscio ha suggerito le scelte
“primarie”, è stato il lavorio culturale a fare il
resto. Questo lavorio è presente nella strutturazione del testo e fa parte della rappresentazione della realtà (Scaf 1996: 95-206).
Storia e letteratura
La forma della scrittura della storia come
dell’antropologia è insomma anche un problema letterario. Un elemento che ha accomunato storicamente l’antropologia e la storia è stata anche la comune avversione alla
letteratura, che concerne tre aspetti: il rifiuto
della cura formale, come vizio pernicioso
che attenta al rigore del linguaggio scientifi133
Q
uaderni
co; la condanna dei cedimenti all’immaginazione storica, che consegna la realtà dei fatti
e delle cose al mondo dell’invenzione e delle chimere; l’utilizzazione dei testi letterari
come fonti per la l’interpretazione di eventi
e di interi periodi storici.
In sede storiografica, tra quanti si sono
rivoltati contro l’“influenza cancerogena
della critica letteraria”, e tra quelli che li
hanno secondati in questa crociata troviamo, inaspettatamente, Hobsbawm. In realtà,
proprio il grande storico inglese aveva avuto il merito di utilizzare anche testi letterari
come fonti delle sue opere sul banditismo
sociale; ma aveva al tempo stesso commesso degli errori (da cui probabilmente fu
indotto a questo drastico ripensamento),
concernenti il trattamento dei materiali letterari, che sarebbe stato necessario, riconosciuta preliminarmente la loro natura di fonti speciali, analizzare con strumenti specifici,
chiedendosi, per esempio, se le convenzioni
e le regole dei generi letterari, gli archetipi
dell’epos brigantesco avessero potuto avere
qualche peso nella determinazione delle invarianze presenti nelle rappresentazioni del
brigantaggio, che lo storico analizza come
specchio ora della realtà, ora del modo di
pensare diffuso (Scaf 1994: 9-10).
Negli anni settanta, nel pieno boom del
riflessivismo antropologico, il problema del
rapporto della storia con la letteratura viene
posto in termini critici, grazie alla presa di
coscienza del carattere artistico delle opere
storiche. Si è trattato di una svolta di notevole qualità, ma assai più limitata nell’estensione e negli effetti di quanto di simile era
accaduto nell’area antropologica (Scaf 2013:
21-32). In Veyne (Vey: 1973) si è affacciata
l’idea che la storia si fondi sull’opinione e che
ai testi storici non siano estranee le strategie
134
di carattere discorsivo e persuasive e che essi
conservino rapporti significativi col mito,
celino una loro poetica e siano in qualche
modo assimilabili alle creazioni artistiche.
White (Whi 973) per primo si inventa “un
approccio formalista allo studio del pensiero
storico del secolo XIX secolo” (p. 12), facendo emergere dai testi “la struttura profonda
dell’immaginazione storica” e arrivando alla
conclusione che le opere storiche “presentano un contenuto profondo che è generalmente poetico, di natura specificamente
linguistica, e che serve da paradigma, acriticamente accettato, di ciò che dovrebbe essere una spiegazione caratteristicamente storica”. Per ottenere un “effetto di spiegazione”,
gli storici mettono in atto una delle seguenti
strategie o una loro combinazione: spiegare
secondo l’argomento formale; secondo l’intreccio; secondo l’implicazione ideologica.
Alla fine, l’opera storica si rivela come “una
struttura verbale in forma di discorso in prosa narrativo che tende ad essere un modello,
o icona, di strutture e di processi passati,
nell’interesse di spiegare ciò che erano rappresentandoli”. La conclusione ultima è che
“la storia è un’attività intellettuale insieme
poetica, scientifica e filosofica” (Whit 1973)
Collocate in una dimensione eccentrica della ricerca storica, queste riflessioni
non hanno modificato l’organizzazione del
lavoro storico né gli apparati teorici e strumentali della disciplina. Ma forse hanno
contribuito a incoraggiare alcune scelte coraggiose, come quella di un antropologo storico di prim’ ordine come Thompson (Thom
1981), che con sicurezza e sano senso critico
ha legittimato l’uso dei testi letterari come
fonti: perché le opere letterarie forniscono
rappresentazioni preziose della vita, dei costumi, delle istituzioni e degli eventi di una
antropologia e storia
società in un preciso momento storico, ma le
risorse conoscitive più interessanti che esse
possono offrire sono quelle che dischiudono la mente a mondi interiori storicamente
connotati, cogliendo in profondità la vita e
l’intera esperienza di una società: “in definitiva, gli uomini consumano le loro vite sotto
forma di esperienze; per le loro esperienze,
per le loro illusioni e la loro autocoscienza,
dobbiamo basarci su fonti letterarie; e se
gli storici smetteranno di cercare di capire
come le generazioni passate hanno condotto
le loro esperienze di vita, commetteranno un
grosso sbaglio. Forse a quello stadio reinventeranno l’arco e la freccia” (Thom 1981: 263).
Se poi si parte dall’idea della storia come
“teatro delle passioni”, l’esperienza più profonda di una società, di un gruppo umano
in un preciso momento storico è consegnata
ai testi letterari. La psicoanalisi e la critica
letteraria risulteranno allora indispensabili al lavoro ermeneutico, per via della loro
esperienza dei meccanismi linguistici, delle
pratiche espressive e dei linguaggi dell’inconscio. Infine, l’antropologia e la storia non
solo possono avvalersi degli approfondimenti cognitivi ed esperienziali della letteratura e della psicologia del profondo, ma – lo
ha dimostrato in parte White con le sue analisi della produzione storica dell’Ottocento
– possono mutuare dai prosatori e dai poeti
strumenti espressivi e tecniche di costruzione del testo, per restituire al linguaggio il suo
uso creativo e ridare alle rappresentazioni
scientifiche le emozioni del vissuto.
Come abbiamo in più occasioni sostenuto, l’antropologia va verso la letteratura, perché si è resa conto di poter avvalersi
proficuamente della conoscenza dell’uomo
approfondita dalle opere letterarie e per
sottrarsi al rischio di un impoverimento co-
/ 1 – donne in armi
gnitivo (Scaf 2014: 702). La medesima considerazione potrebbe valere per la storia, se
si eviterà che il connubio tra la letteratura e
le scienze storiche e sociali partorisca soltanto romanzi storici o storico-antropologici, in
cui spesso la storia è un pasticciato fantasma.
La storia è anche passione
Il successo del romanzo storico
Questi romanzi pongono questioni come
quella della loro legittimità a fornire elementi utili alla conoscenza della storia: problema non solo teorico, se si considera che il
romanzo storico è la prima fonte di informazioni storiche per il pubblico mediamente colto, interessato assai più alle narrazioni
storiche che alla saggistica storica. Si tratta
anche di capire se esistono criteri per una
valutazione, che non sia unicamente letteraria, di questa produzione, di comprendere
quali sono le ragioni della sua fortuna tra i
lettori, a quali domande fornisce risposte e
qual è il suo rapporto con la ricerca storico-antropologica.
Intanto bisogna resistere alla tentazione
di liquidare questi testi come lavori mendaci e inutili, che suggeriscono spesso l’idea
dei beni di consumo contraffatti e taroccati:
anche quando sono storiograficamente inattendibili, almeno i migliori di essi pongono
spesso dei problemi di scottante attualità,
azzardano intuizioni nuove ed entrano spesso nel vivo dei dibattiti culturali e politici del
loro tempo. Le responsabilità del romanziere
storico sono grandi, proprio per questa capacità di influenzare un pubblico enormemente più vasto dei lettori degli storici.
Una delle ragioni del successo dei romanzi storici e storico-antropologici va
135
Q
uaderni
cercata nella considerazione che gli studi
scientifici si lasciano attrarre dagli elementi
razionali, normativi delle vicende storiche
e dalla logiche che le attraversano, mentre
sfugge ad essi la loro complessità, che solo in
parte rientra nell’ordine intellettuale della realtà. Già nel secolo passato, davanti all’irrazionalità della storia, evidenziata dalla tragedia delle due guerre mondiali, storici dotati
di ricca sensibilità confessavano di trovarsi
impreparati a “intendere il termine ragione
diversamente da come l’avevamo appreso”,
mentre alcuni romanzi sembravano “andare
a fondo là dove noi storici restiamo in superficie”. Non molto diversamente la generazione presente, che fatica a dare un nuovo
senso alla ragione, dopo lo spegnimento di
certezze ritenute intoccabili e l’apparizione
inquietante di sintomi di un’apocalisse culturale a ridosso di quella economica, cerca
anch’essa narrazioni nuove che restituiscano
all’esistenza il suo significato, ed i romanzi di
qualità “ci ispirano il rispetto che spontaneamente viene attribuito a coloro che si sono
portati molto vicini ai luoghi infernali. Loro
la sanno più lunga di noi”. Dichiarazioni
importanti, che riconoscono al romanziere
il diritto di interpretare la storia, attribuendogli la sfera ampia e calda dell’esperienza,
senza peraltro intaccare la professionalità e
gli spazi degli storici di professione, perché
“noi dobbiamo far comprendere ciò che l’artista fa sentire, e spiegare ciò che lui mostra
con uno sguardo” (Bes 1975: p. 21). Dunque,
il romanziere deve “far sentire” quello che il
ricercatore deve “spiegare”. Nel romanzo, in
altri termini, lo scrittore riversa l’esperienza
umana nella sua pienezza, a differenza delle
investigazioni storiche e antropologiche, che
hanno un orientamento unidirezionale e
compiono scelte ed esclusioni di dati in vista
136
del loro scopo, che è quello dell’accumulo di
un sapere segmentario.
Sia lo scrittore che lo scienziato sociale
costruiscono modelli di relazioni e di interconnessioni, ma lo fanno in maniera diversa: il romanzo storico ha preso il posto
delle narrazioni mitiche ed è esso stesso una
narrazione sostanzialmente mitologica. La
gente legge romanzi perché cerca in essi il
senso dell’esistenza. La differenza tra la storia antropologica e il romanzo storico esiste
ma non è incommensurabile, perché anche
le ricostruzioni storico-scientifiche come
sappiamo non sono esenti da contaminazioni mitologiche, e alla fine tutto potrebbe
risolversi in una differenza di quantità e di
qualità, oltre che di procedure.
Le differenze decisive sono altre: le scienze sono dalla parte delle strutture e della funzione, laddove il romanzo è proiettato verso
una totalità ricca e intensa. Il saggio storico
non ignora la dimensione emotiva e la sfera
del simbolico, ma comunica emozioni e simboli concettualmente (ossia traducendo le
emozioni in concetti astratti e impoverendo
i simboli nelle loro spiegazioni); invece il romanziere possiede un linguaggio altamente
simbolico, quello della letteratura, in grado
di comunicare le emozioni che egli attribuisce ai personaggi mediante le proprie emozioni, che in qualche modo vicariamente le
rappresentano, e che il lettore accoglie per
autentiche, come in un magico affidamento.
Il problema, che stiamo cerando di focalizzare, non è tanto quello del diritto ad esistere dello specifico genere romanzesco, che
chiamiamo storico-antropologico, quanto
quello di capire la sua compatibilità con l’antropologia e la storia, ossia l’utilità o complementarità del romanzo per la conoscenza
degli eventi storici, tenendo conto che esso
antropologia e storia
è stato ed è ancora, a dispetto di quello che
pensiamo e crediamo, informatore (e formatore) di storia per un vasto pubblico di
lettori.
Nel trattamento delle fonti storiche, la
differenza tra il romanziere e lo storico-antropologo consiste nel fatto che quest’ultimo
deve rispettare una procedura rigorosa e
soggetta a verifiche, che pretende in primo
luogo la conoscenza e il rispetto dei fatti
documentati, laddove lo scrittore conserva
la sua libertà di inventare. Quanto ai limiti
dell’invenzione, è necessario che lo scrittore
restituisca una situazione storica individuale o collettiva con una certa verosimiglianza;
questo però non basta a fare del suo racconto un’ opera di qualche validità o utilità dal
punto di vista dello storico. La sua validità e
utilità per la conoscenza storica dipenderanno soprattutto dalla capacità di interpretare
intuitivamente (ma anche concettualmente)
lo spirito di una vicenda, di un’intera società
o di un’epoca, anche manipolando le fonti
in maniera funzionale a questo scopo. In altri termini, lo scrittore non può ignorare le
fonti né esimersi da una conoscenza approfondita delle forme di vita e degli eventi di
un momento storico, ma può subordinare il
loro trattamento, ricorrendo anche a invenzioni e manipolazioni, a quella “intuizione
dell’insieme”, al “colpo d’occhio” che restituisce l’anima profonda della storia. Se uno
scrittore si cimenta con la storia, deve saper
restituire di un periodo storico o di un’epoca
o di una presunta condizione universale (ma
concreta) dell’esistenza una immagine che
dovrebbe trovare innanzitutto un riscontro
concettuale nelle pagine dei professionisti
del lavoro storico-antropologico, il che potrà
avvenire – come dimostrano tutte le esperienze presenti e passate dei buoni romanzi
/ 1 – donne in armi
storici: si pensi a Balzac letto la Engels – se
lo scrittore possiede i mezzi per procurarsi
una serie così vasta e articolata di informazioni significative, da consentirgli di “entrare” nelle situazioni evocate, dando l’illusione
di “esserci stato”. Proprio come gli antropologi, che sono riconosciuti come tali solo se
danno la certezza di “esserci stati”. Con l’aggiunta delle risorse (quando ci sono) del suo
talento, della profondità delle sue intuizioni
e della forza della sua scrittura, che daranno
l’impressione di un ritorno felice dalla discesa agli inferi. Allora il romanzo storico-antropologico potrà integrare la storia evocata
dagli storici e dagli antropologi, a volte approfondirla e perfino porsi a volte come una
alternativa. Un romanzo che non si attiene a
queste condizioni può legittimamente aspirare – se i lettori e i critici glielo consentono
– a essere considerato, letterariamente parlando, un buon romanzo, ma non ha il diritto di definirsi un buon romanzo storico-antropologico. Perché non può pretendere di
fare luce sulla storia, se la storia non c’entra.
La storia trasformata
in mito dalla politica
Come abbiamo anticipato, i fatti storici
evocati dai romanzieri hanno l’aspetto prevalente del mito, per cui la nuova fioritura
del romanzo storico e storico-antropologico
ripropone in termini nuovi l’antica opposizione mito/storia, che nella vulgata corrispondeva all’opposizione realtà/invenzione
o, nel peggiore dei casi, verità/menzogna. Il
rifiuto di queste distinzioni era già stato auspicato all’interno di solide e importanti tradizioni europee di studio e di ricerca soprattutto nel settore dell’antichistica: Bachofen,
137
Q
uaderni
tra i tanti, aveva scritto che “la moderna ricerca storica ha indicato alle scienze dell’antichità una strada lungo la quale non si raggiungerà una comprensione più profonda né
più coerente”, perché “la distinzione tra mito
e storia non ha alcun senso e nessuna giustificazione nei confronti della continuità dello
sviluppo umano. Essa deve essere completamente abbandonata nell’ambito della nostra
ricerca” (Bach 1989: 12).
La convinzione che il mito fosse portatore di storia è implicita anche in opere come
Il ramo d’oro, la monumentale impresa di
James Frazer, ma è in ambito funzionalista
che troviamo per la prima volta la definizione scientifica di mito per merito di Malinowski: il mito “è un racconto, il cui significato è importante e decisivo nel contesto
pratico della sua narrazione. In generale
esso giustifica comportamenti nel presente:
giustificare il proprio presente con un mito
è un’esigenza di ogni società. In questo senso anche la storia può diventare mitologia”,
perciò, “non credo che ci sia una distinzione così netta tra mito e storia” (in Lea: 41).
In sostanza, il funzionalismo apre una strada, che Lévi-Strauss percorre con maggiore
decisione, interpretando – lo abbiamo già
visto – la storia tout court come mitologia:
“gli storici trasformano gli avvenimenti passati in schemi di efficacia permanente, che
permette di interpretare la struttura sociale
di una società e di intravedere i lineamenti dell’evoluzione futura” (Lev 1966: 234):
nel mito la comunità rappresenta se stessa
procedente nella direzione di un destino
salvifico, già segnato, analogamente nelle
scritture storiche dell’Occidente “la struttura della storia è orientata dal progresso,
dal presente se non dall’avvenire: il futuro è
presentificato, l’avvenire è dominato dall’im138
maginazione”. Già per i romani la storia
era esempio e preparazione dell’avvenire;
a questa rappresentazione storica di segno
epico si sovrappose poi il messianismo giudaico-cristiano e, successivamente, il rivoluzionarismo marxista. Leach invece parte
da Lévi-Strauss per ritornare a Malinowski,
di cui riprende quasi alla lettera il pensiero:
la storia può diventare mitologia. Dunque la
storia non è sempre mitologia, ma può diventarlo, quando viene utilizzata dai politici
per motivi di propaganda e per legittimare
il loro comportamento. Nietzsche aveva già
fatto considerazioni simili, concludendo che
“i tiranni di ogni genere (anche artisti e politici tirannici) fanno spesso violenza alla storia, affinché essa appaia come preparazione,
come scala che porta a loro” (Niet 1965: II,
307) Ad esse sembra ispirarsi Leach, aggiungendo un chiaro progetto di demistificazione: “Tutti i politici, moderni o primitivi che
siano, hanno bisogno di una mitologia di
fondazione: in definitiva il loro governo va
nella direzione di un destino salvifico prefigurato e scritto nel mito. Gli antropologi devono sottoporre questo tipo di storia ad una
critica distruttrice, perché è una storia fatta per diventare mito per finalità politiche”
(Lea 1985: 41). Per Lévi-Strauss non c’è altra
storia che quella mitologizzata. Per Leach
invece un’altra storia è possibile, se si rifiuta
la storia manipolata per ragioni politiche.
Esiste la storia senza mitologia?
Ma cosa rimane della storia, una volta
che se ne toglie la parte mitologica (in cui
si coagulano, mescolandosi e confondendosi, il punto di vista, il contenuto inconscio,
l’intenzione agiografica, la strategia politica,
antropologia e storia
il mito personale del soggetto o dell’oggetto);
esiste, una volta cancellate le incrostazioni
mitiche, un “resto” non ideologizzato, oggettivamente reale? O gli eventi entrano nella
storia solo a condizione di diventare leggenda? Esistono fatti del tutto indipendenti dal
racconto che li assume? Questo “resto” può
essere comunicato fuori del suo (o di qualunque) statuto retorico, che ad esso conferisce senso e direzione?
Indubbiamente, distruggendo, come
vuole Leach, le strumentalizzazioni e le falsificazioni politiche della storia, si compie
un’ opera degna sotto il profilo della verità
e dell’etica, ma non si cancella interamente
l’involucro mitologico delle narrazioni storiche, sia perché esso risponde a bisogni diffusi e irrinunciabili, al di là delle domande
della politica, sia perché i fatti diventano
comunicabili e comprensibili nei modi in
cui qualcuno li racconta, e quando vengono
narrati sono anche lo specchio deformante del narratore, individuale o collettivo (e,
attraverso lui, della sensibilità, dei bisogni,
anche oscuri, del suo tempo), per cui dovremmo forse ipotizzare l’esistenza di una
domanda di mito, emergente dalla totalità
profonda dell’esistenza e riversantesi anche
nel racconto storico. Il lavoro dello storico è
ovviamente diverso da chi costruisce o racconta miti, per via dell’uso di fonti certe, più
o meno scritte (con i limiti rappresentati dal
fatto che – come è stato chiarito – le fonti
non sono fatti, ma racconti di fatti), per la
verificabilità delle procedure di analisi e di
sintesi e, infine, per il carattere segmentario
delle sue conoscenze; ma per la scelta dei
dati e dei criteri, per l’orientamento complessivo e per l’uso che della storia si fa, e –
forse soprattutto – per i contenuti inconsci
che attraversano i fatti narrati, le ricostruzio-
/ 1 – donne in armi
ni celano effettivamente un impianto mitico,
che è compito dello studioso individuare e
portare alla luce. In questo impianto mitico
c’è e permane, ineliminabile, il particolare
punto di vista dell’osservatore, che fa parte
della strutturazione dei fatti operata dalla
narrazione e che deve essere esplicitato e
privato di ogni valore assoluto. Se perciò è
inevitabile fino a un certo punto che la storia
sia anche mitologia, si può almeno cercare
un nuovo equilibrio, che impedisca che le
ragioni del mito prevalgano su quelle della
critica.
Possiamo perciò ridurre la distanza tra il
mito e la storia, senza eliminarla interamente. Anche se non si spiega, in questo modo,
l’essenza ultima della storia, si circoscrive
almeno l’area del suo mistero. Non ci può essere una storia interamente scientifica, non
solo perché l’oggettività dei fatti è compromessa dalla soggettività del ricercatore ma
anche perché l’oggetto è costituito da fatti di
cui fatichiamo a capire le regole. Lévi-Strauss
è stato in questo il più chiaro ed esplicito di
tutti, distruggendo con la forza della sua dialettica l’illusione del progresso che alimenta
la rappresentazione occidentale della storia.
I fatti anteriori alla forma e alla struttura
che ad essi dà l’ermeneuta, partendo dal suo
angolo visuale, sono il resto neutro e irrelato,
al quale soltanto chi lo assume per raccontarlo potrà attribuire quello che considera
un valore o un disvalore. Nell’Italia postunitaria – è solo un esempio – la guerriglia
denominata brigantaggio da alcuni, riconosciuta come guerra civile da altri, ha ispirato diverse e opposte narrazioni, che tuttavia
avevano in comune la realtà di alcune decine
di migliaia di contadini passati per le armi:
il resto di un conflitto decennale, lo zoccolo
duro, che almeno in parte non poteva essere
139
Q
uaderni
da nessuno negato, se non a costo di porsi
fuori di ogni dialettica, come tutti i negazionismi mendaci, ma che può essere legittimamente raccontato in diversi modi da diverse
parti, salvo a lasciare il giudizio all’etica e alla
politica, consegnando al mistero le ragioni
del male.
(Continua)
Abbreviazioni
Bac 1989 = J.J. Bachofen, Introduzione a Das Mutterecht, in Eva Cantarella, Introduzione a Bachofen, Introduzione al Diritto materno, Roma.
Ben 1995 = W. Benjamin, Angelus Novus, Torino,
Einaudi.
Bes 1975 = A. Besançon, Storia e psicoanalisi, tr.
it., Napoli, Guida (or. 1968-1971).
Bur 1988 = P. Burke, Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna, tr. it., Bari, Laterza (ed. or. 1987).
Cert 2006 = M. de Certeau, Quello che Freud fa
della storia, in La scrittura della storia, tr. it.,
Milano, Jaka Book (ed. or. 1975).
Geh 1965 = A. Gehlen, Genese der Modernitād,
in Aspekte der Modernitād, Gōttingen, Hans
Steffen.
Hem 1979 = C.H. Hempel, La función de las leyes
generales de la historia, in La ezplicación scientífica, Buenos Aires, Paidos (or. 1942).
Jung 1965 = C.G. Jung, Contributo allo studio
psicologico della figura del Briccone, in P. Radim-C.G. Jung-K. Kerényi, Il Briccone Divino, tr. it., Milano, Bompiani (ed. or. 1954), pp.
175-201.
Lea 1985 = E.R. Leach, Uomini come formiche?,
intervista, in “Prometeo”, a. 3, n. 10, pp. 34-41.
140
Lev 1966 = C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, tr. It., Milano, Il Saggiatore, (or. 1958).
Lev-Ca 1969 = P. Caruso (a cura di), Lévi-Strauss
Foucault Lacan, Milano, Mursia.
Lev-Di 1988 = C. Lévi-Strauss-D. Eribon, Da
vicino e da lontano, intervista, tr. it., Milano,
Rizzoli (or. 1988).
Mor 1975 = S. Moravia, Presentazione di Bes
1975, pp. 5-18.
Niet 1965 = F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II
Scelta di Frammenti postumi, Milano, Adelphi.
Niet 1978 = F. Nietzsche, Aurora, Milano, Adelphi.
Peth 2002 = N. Pethes-J. Ruchatz, Dizionario della memoria e del ricordo, tr. it., Milano, Bruno
Mondadori (or. 2001).
Pop 1981 = K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi.
Ric 1987 = P. Ricoeur, Tempo e racconto, I, Milano, Jaca Book (or. 1983).
Scaf 1974 = D. Scafoglio, L’epos brigantesco popolare nell’Italia meridionale, Salerno.
Scaf 1996 = D. Scafoglio, La barca del cielo. Studio
sull’ altalena, Salerno, Gentile.
Scaf 2013 = D. Scafoglio, Quando uno diventa
due. Sugli antropologi che scrivono poesie, in
“Quaderni di Antropologia e scienze umane”,
I, 2.
Scaf 2014 = D. Scafoglio, Passé, présent et futur de
l’antropologie littéraire en Italie, in “Ethnologie française”, 4, ottobre.
Thom 1981 = E.P. Thompson, Società patrizia cultura plebea, tr. it., Torino, Einaudi (or. 19711978).
Whi 1973 = H. White, Retorica e storia, tr. it., Napoli, Guida (or. 1973).
Wri 1971 = G.H. Von Wright, Spiegazione e comprensione, Bologna, Il Mulino.
Vey 1973 = P. Veyne, Come si scrive la storia, Bari,
Laterza.
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Fare e dire la storia
raccontando storie
Giulio Angioni
N
on è raro dover dire del
rapporto tra il mestiere di
insegnante
universitario,
come nel mio caso di antropologia, e l’attività di narratore. Per cavarmela
a buon mercato spesso dico che oggi in Italia
quasi nessuno può vivere di scrittura letteraria,
a meno che non scriva per i Moloch televisivi.
Ma poi concedo che mi pare ci sia un rapporto
stretto tra il mio mestiere di saggista e il mio
hobby di narratore. E che, entrando nei particolari di un racconto, potrei trovare nessi più
o meno immediati tra i due modi di scrivere,
saggistico e narrativo, e nei temi trattati. Ci
troverei anche certe sensibilità di antropologo, ma usate diversamente. Con un pubblico
adatto, ne capto la benevolenza dicendo che
per me cercare di diventare antropologo e
cercare di diventare scrittore sono anche una
conseguenza del bisogno di fare i conti con le
mie origini, quindi con la mia terra e la mia
gente, e dunque con la nostra storia particolare, e in fondo con me stesso. Ma anche questo
è troppo ovvio, troppo detto, troppo indossato.
E sbandierato senza pudicizia.
Potrei forse dirlo meglio precisando che
sia da antropologo sia da scrittore cerco di
fare i conti col me stesso collettivo mediante
la ricerca e la riflessione, dedicandomi in particolare al mondo da cui provengo, in questi
due modi di cui sono un poco esperto: studiando con gli strumenti dell’antropologia,
descrivendo e trasfigurando alcuni aspetti
con lo strumento del racconto, reinventando
un mondo perché, paradossalmente, sia più
veritiero. Nessuno sa meglio di uno scrittore
sensato che la vita ha solo il senso che riusciamo a darle fin dalla prima volta che diciamo “Mamma, raccontami una storia!”.
E di che cosa scrivi? Questa domanda
sembra sciocca, in presenza di libri già scritti
e pubblicati. E chi te la fa finisce spesso che te
lo spiega lui di cosa scrivi. E consiglia o impone ciò di cui scrivere o non scrivere, di questi
tempi. Alla lunga, mi sono convinto che ne ha
diritto, se uno ha fatto la fatica di leggermi. Ed
è una domanda che merita riposta. La risposta
che mi do io è che scrivo del mondo e della
vita, sempre e tutti interi, il mondo e la vita, e
anche di tutto il resto, se c’è un resto. Ma mi dicono spesso che scrivo sempre della Sardegna.
Non è falso. Anche perché in luoghi come la
Sardegna abbondano i portavoce letterari della
propria gente. Ma pur essendo già velleitario
dire della Sardegna, cito Tolstoi e proclamo
la mia aspirazione, nel dir di Sardigna, a dire
141
Q
uaderni
dell’universo mondo e della vita tutta intera. A
parte che i luoghi come la Sardegna nel mondo
d’oggi sono molto numerosi, forse addirittura
maggioranza, per lo meno in quanto periferie, e periferie di periferie. Poi però mi do una
regolata. E ammetto che un mio tema importante, preminente, sempre attuale negli ultimi
decenni e ancora attualissimo, è quello del mutamento della mia isola: mutamento sia endogeno che esogeno, sia programmato (industria
chimica e Costa Smeralda, per esempio) e sia
endogeno e spontaneo, che mi pare anche più
interessante del riproporsi del Piano di Rinascita Economica e Sociale della Sardegna. Nei
miei racconti degli anni ’70 il mutamento incombe sempre in varie forme, compresa l’emigrazione massiccia di giovani uomini e donne. Oppure l’obsolescenza del vecchio mondo
agropastorale, la fine di un mondo durato millenni che scompare in due decenni. E la vertigine culturale che ne consegue. Credo che,
diversamente dalla maggioranza di chi allora
faceva e oggi ancora fa narrativa in Sardegna,
non mi colloco né tra i detrattori del nuovo e
i laudatori del vecchio, né tra i vergognosi del
vecchio e laudatori del nuovo. Spesso ci guadagno l’antipatia degli uni e degli altri, perché le
loro convinzioni sono, come dappertutto, pure
qui molto forti e pregiudiziali.
Anche a me pare di dovere e potere raccontare cose che a tutti gli altri sfuggono, si lasciano per strada, anche quando ne trattino, come
nel caso dell’emigrazione e del grande e rapido
mutamento del Novecento. Che a me pare proseguire troppo inavvertito, sebbene tanto invocato dal politicismo banale del cambiamento.
Potrei dire che per me diventare scrittore è
stata conseguenza della percezione del mutamento socio-culturale, della pluralità coeva dei
modi di vivere in questo luogo che si continua
a rappresentare e ad apprezzare come immo142
bile e primordiale. Mentre siamo già anche
qui nel postmoderno, ma quasi saltando a pie’
pari la modernità. È che sono anch’io un sardo
in bilico tra tradizione e modernità: continuo
a essere un contadino trexentese che studia e
vive in Europa, curioso di tutto, preoccupato di
molto. Studiarlo da antropologo, il mio mondo
d’origine in mutamento, a un certo punto non
mi è bastato, come anch’io devo dedurre a posteriori. E ho fatto ricorso a questo primordiale
mezzo del raccontare, potente e collaudato in
tempi storici soprattutto per iscritto.
Non credo però di avere aderito di proposito a dei generi. Ho la presunzione di averne
adattato delle possibilità, come nel caso del romanzo storico e della detective story. L’essere di
mestiere un antropologo mi fa vedere il mondo da certi punti di vista, mi ha abituato a certi
temi e problemi, come appunto il mutamento,
la pluralità e la mescolanza culturale, però non
mi pongo mai esplicitamente il problema di
essere un antropologo che racconta, o che scrive “gialli”. Lo sono, come sono parecchie altre
cose come tutti, problematicamente.
Essere sardi non è mai stato facile. Ho apprezzato altri modi di sentirsi al mondo più
a proprio agio. Nella geografia immaginaria
della modernità, quest’isola non si sa dove
collocarla. Nemmeno nella geografia immaginaria della modernità italiana, con la sua vecchia questione meridionale e con la sua nuova
questione settentrionale. I sardi, la Sardegna,
hanno sofferto a lungo di una specie di oblio
esterno, di inesistenza. Noi sardi al mondo e
per il mondo ci siamo troppo poco, i siciliani ci sono troppo, e i grandi popoli ci sono
e basta. Noi abbiamo il problema del nostro
posto nel mondo, come molti altri certo, ma
l’abbiamo eccome, a modo nostro. A me pare
che l’abbiamo di più. Ma nei già molti decenni
della mia vita ho vissuto la strana esperienza
antropologia e storia
di essere parte di una gente e di una terra che
è passata da un’immagine di diversità negativa a un’immagine di diversità positiva, da
isola isolata da poena insularis del Ti sbatto in
Sardegna! a uno dei paradisi delle vacanze. E
dunque di essere sardo continuo sia a vergognarmi che a essere orgoglioso, fortunato e
diminuito, qui a due passi dall’Africa simbolo
europeo moderno di ogni arretratezza.
Vivere in quest’isola è impegnativo. Ma
anche l’andarsene. O il restarci impigliato. Ho
imparato a vivere in una dimensione agropastorale paesana sarda degli anni di guerra e dopoguerra, in una dimensione già acutamente locale e globale, da guerra e dopoguerra mondiale,
appunto, ma in un’isola con modi di vita ancora
simili a quella dell’età dei nuraghi. Credo che
anche un sardo che si riconosce solo nei luoghi più comuni del sentirsi sardo mi riconosce
come sardo leggendo una mia pagina. Forse anche un lettore non sardo. Una mia lettrice piemontese ha scoperto in tutti i miei racconti un
personaggio piemontese negativo. Mai accorto.
Ma è che nella mia vita di insulare sardo c’è un
momento traumatico fondante. A dieci anni mi
hanno mandato a studiare dai preti in Piemonte
e lì mi hanno inculcato quella loro convinzione
che sono da meno in quanto sardo. Da questa
scoperta non guarirò più, temo. Non ero stato
preparato a questa brutta sorpresa. Me ne difendo ancora. Non ci farò mai abbastanza i conti.
Tanto più che certe protervie nordiche sono diventate delirio padano organizzato in lega.
Nei miei scritti narrativi, dicevo, è centrale
il tema del mutamento, e quindi anche il tema
del ritorno a qualcosa che non è più quel che si
vorrebbe, storia vissuta ma anche storia nel suo
senso di ricordo meditato del passato. Il mio
scrivere è anche percorso di conoscenza in andirivieni tra passato e presente, magari per non
avere troppa paura del futuro, spesso ridotto a
/ 1 – donne in armi
minaccia. E poi sono troppo convinto che ogni
identità individuale è anche il risultato particolare di identità collettiva a sua volta fatta di
varie identità l’una dentro l’altra a scatole cinesi. E dunque, come dico spesso, se siamo fatti
come le cipolle, le cipolle in tempi di normale
nutrimento sono buone come condimento,
non come il piatto unico dei tempi delle nostre
carestie secolari. Cioè, questa cosa che diciamo
identità forse in letteratura non è buona in tutte le salse e tanto meno come piatto forte. A me
pare che la forza nuova della letteratura sarda
di oggi sia sapere usare le cipolle identitarie
come condimento, spezia, spizzico, e non più
come piatto unico. Non ci insisto, anche perché mi pare abbia qualche ragione chi dice che
niente va prescritto o proibito in ciò che diciamo arte. Tutto può essere elaborato e apprezzato esteticamente, anche le cipolle identitarie
come piatto unico.
Come narratore a volte sono detto uno
dei padri del giallo sardo, mentre avrei forse
preferito, dovendo proprio essere classificato,
passare per un continuatore, magari per un
rifondatore del romanzo storico sardo rimpolpato di antropologia, come ho cercato di fare
nel raccontare, ne Le fiamme di Toledo, la storia vera di Sigismondo Arquer bruciato come
eretico nel 1571, qualche settimana prima
della battaglia storica di Lepanto. Non so che
dire della fortuna attuale del giallo, che non mi
pare nuova, nemmeno il giallo di tipo seriale.
Le unità di tempo e di luogo e le maschere-personaggi sono antichi e collaudati elementi di
serialità. Se il racconto ha bisogno di sorprese,
ha altrettanto bisogno del noto, del chi si rivede, del brivido del consueto. E il giallo sfrutta il
consueto più dell’insolito. E poi c’è giallo e giallo
tanto quanto c’è libro e libro. La letteratura di
genere non mi piace in quanto di genere. Non
capisco gli appassionati esclusivisti di gialli o di
143
Q
uaderni
fantascienza. Leggo Simenon, Asimov e Dick
mentre apprezzo molto il nostro Salvatore Satta, ma anche Le avventure di Pinocchio e Delitto
e castigo, non perché classificabili in un certo
genere e tutti quanti in un iper-genere che oggi
diciamo fiction, ma perché sono quel che sono
e mi prendono, m’interessano, mi edificano, mi
piacciono. Banale, ma così per tutti. Nessuno
ha mai spiegato le mode, inevitabili come le intemperie, a meno di attribuirle solo all’insipienza umana, dimentica del passato e cieca verso il
futuro. E nell’attuale domanda globale di offerte
locali, non poteva mancare una Sardegna in
giallo, come in altri tempi una Sardegna storica
o preistorica o più spesso fuori dalla storia.
Come lettore, ma anche come scrittore,
mi sento vicino a giallisti, da Duerrenmatt a
Chandler, da altri americani ad altri svizzeri,
francesi, italiani, dal milanese Scerbanenco ai
sardi Mannuzzu e Todde e ad altri sardi giovani
come De Roma e Mandreu, per ovvi motivi di
affinità. Ed è per affinità ereditate che mi sento
vicino a Sciascia. Come cerco di fare anch’io,
Sciascia scrive di individui che sono dei tipi
sociali, e di situazioni che sono molto umanamente elementari pur restando siciliane ben
radicati nella storia siciliana. I buoni scrittori
fanno sempre più o meno questo. Ma certuni
credono di fare altro, di essere e di rappresentare l’unico e l’irripetibile. Per Sciascia, come
voglio che sia per me, il giallo, l’inchiesta, la
rappresentazione dell’emergenza delittuosa,
sono espedienti per dire altro d’importante: soprattutto più importante del mero venire a capo
di una vicenda complicata di morti ammazzati.
Già, il giallo, racconto di morte sterilizzata con
un simulacro di spiegazione, di cui alcuni si accontentano. Verso uno come Sciascia, che non
accontenta, si sente debitore chiunque scriva
in Italia dopo di lui. Sciascia ormai sta nell’aria
che respira chiunque legga o scriva, in qualche
144
modo anche in negativo, nel suo incoercibile
scetticismo sulla possibilità che i siciliani possano cambiare, credendo nella possibilità che il
loro mondo cambi in meglio per progetto umano. Sciascia riesce a pensare e a rappresentare
il disagio di vivere da siciliano come metafora
di un disagio più generale, per lo meno italiano, dunque come disagio di una modernità
difficile, di un cattivo passato che non riesce a
passare, non si riesce o non si vuole far passare,
gattopardescamente non solo dalle sue parti.
Sciascia ha sempre raccontato il male, storicamente determinato alla siciliana e panumanamente aborrito e denunciato, senza sterilizzarlo o divertirsi a sezionarlo, bensì soffrendo,
anche perché mai si arriva a comprenderlo. Il
suo è certo un male siciliano. Il male alla sarda gli assomiglia, ma fino a un certo punto. Gli
assomiglia nel non essere né comprensibile né
accettabile. Il male sardo ha in più, per chi lo
rappresenta e per chi l’osserva, di essere anche
esotico, particolare pur restando generale e generico. Gli scrittori (e tutti gli altri tipi di artisti)
sardi e dei tanti luoghi simili a un luogo come la
Sardegna, che non cerchino di risolvere il problema eliminandolo oppure vestendo i panni
di una vaga quanto risaputa genuinità locale,
devono prendersi il compito supplementare di
fare i conti con la peculiarità del disagio (o della
fortuna, se uno è ottimista) di essere al mondo
da sardi, ma in compagnia ecumenica, glocali,
cioè globali e locali. Come il siciliano Sciascia,
appunto, ma anche diversamente. E non è che
il diversamente sia meno importante di ciò che
accomuna. Se non si scappa alle proprie origini
particolari, non si scappa nemmeno all’umano
elementare. E se è difficile vivere nell’umano
elementare, lo è anche, ogni tanto, anzi spesso,
per il tipo d’uomo storico che ti capita di essere
e di voler essere, per non dire dell’uomo che sei
e vuoi essere personalmente.
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Su alcuni effetti
della valutazione all’italiana
Stefano Semplici
L’
ANVUR, nella Premessa del
Rapporto finale sull’esercizio
di valutazione dei risultati della ricerca (VQR) per il periodo
2004-2010, datato 30 giugno 2013, ha indicato
in modo chiaro gli obiettivi e al tempo stesso i
limiti di questa ambiziosa impresa. L’Agenzia,
coerentemente con i compiti e le responsabilità che le erano stati assegnati dal DPR 76/2010,
ha messo a disposizione della comunità accademica e scientifica e dell’opinione pubblica
una ingente mole di dati, che corrispondono
a molteplici finalità: a) “presentare al paese
una valutazione imparziale e rigorosa della ricerca” nelle diverse istituzioni nelle quali essa
viene svolta, per facilitare e rendere più consapevoli le scelte degli organi di governo delle
diverse strutture, delle famiglie, dei giovani
ricercatori, delle industrie e degli enti pubblici; b) determinare una graduatoria per area
scientifica e per struttura “che costituisca uno
degli elementi su cui basare la distribuzione
della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università”; c) offrire
agli atenei e agli enti di ricerca informazioni
utili ad orientare “la distribuzione interna
1
delle risorse acquisite” fra i loro dipartimenti
e sottostrutture; d) “consentire un confronto
della qualità della ricerca nazionale con quella
dei principali paesi industrializzati”. Vengono
immediatamente aggiunti alcuni caveat. Il
primo riguarda l’esclusione della mission che
si accompagna da sempre, nelle università,
all’attività di ricerca: i risultati della valutazione presentati nel Rapporto “non riguardano
in alcun modo la qualità e quantità dell’attività
didattica”, anche se l’ANVUR “ritiene comunque che una buona didattica richieda, a ogni
livello, la presenza di un’attività di ricerca adeguata”. Si precisa poi, con la differenza fra questo esercizio e i ranking degli atenei pubblicati
periodicamente da organizzazioni, quotidiani
e università, la scelta di non proporre un confronto della qualità della ricerca fra aree scientifiche differenti, sconsigliato per l’impossibilità di incrociare criteri metodologici e culture
della valutazione profondamente diversi. E si
chiarisce infine – last but not least – “che i risultati della VQR non possono e non devono
essere utilizzati per valutare i singoli soggetti”,
anche in questo caso per ragioni ben note agli
addetti ai lavori1.
Vengono citate: “la scelta dell’associazione prodotti-soggetti valutati, dettata dall’ottimizzazione del risultato di
145
Q
uaderni
Gli effetti di questo tentativo di introdurre
finalmente anche in Italia la cultura e soprattutto la pratica della valutazione si misureranno ovviamente nel lungo periodo. È già
possibile, tuttavia, indicare alcune ricadute
immediate sull’attività di docenti e ricercatori
e sulla governance del sistema che suscitano
più di una perplessità e che dovrebbero suggerire rapidi interventi di correzione, muovendo dalla consapevolezza che non esiste valutazione dei professori che non presupponga
l’attività dei professori della valutazione. Nel
senso della circolarità che caratterizza, con
tutti i suoi rischi e le sue ambiguità, l’esercizio della peer review, che della valutazione
è lo strumento principale nelle aree non bibliometriche e uno strumento di supporto e
verifica comunque prezioso anche in quelle
bibliometriche. Ma anche nel senso che la
valutazione della produzione scientifica rinvia
per la sua legittimità e perfino doverosità alla
produzione della valutazione come scienza,
scivolando poi, grazie all’uso di questo vocabolario tutt’altro che ingenuo, verso il suo imporsi come industria. Ed è proprio qui che si
richiede una particolare attenzione. Le regole
della valutazione sono il risultato della stratificazione, della selezione e infine della vera
e propria istituzionalizzazione (perfino nella
forma di discipline accademiche) di procedure che, anche quando rimangono ancorate ad
aspetti essenzialmente quantitativi, non sono
2
3
146
mai neutrali. Per gli obiettivi che si propongono, per i comportamenti che incentivano o
sanzionano, per i rapporti di potere che disegnano. Su questi obiettivi, comportamenti e
rapporti è dunque necessario aprire e mantenere un serio confronto pubblico.
Un modello di darwinismo accademico?
Nel febbraio del 2012, in un’intervista
ad un quotidiano, Sergio Benedetto (membro del Consiglio direttivo dell’ANVUR e
coordinatore dell’esercizio della VQR 20042010) si esprimeva in termini perentori sugli obiettivi del gigantesco sforzo di valutazione in atto: “Tutte le università dovranno
ripartire da zero. E quando la valutazione
sarà conclusa, avremo la distinzione tra researching university e teaching university.
Ad alcune si potrà dire: tu fai solo il corso
di laurea triennale. E qualche sede dovrà essere chiusa. Ora rivedremo anche i corsi di
dottorato, con criteri che porteranno a una
diminuzione molto netta”2. Tagliare, chiudere, diminuire. Non stupisce che proprio
Valutare e punire sia il titolo di uno dei testi più critici nei confronti dei presupposti
teorici dell’intero meccanismo e dell’uso a
fini di controllo ed omologazione di termini quasi universalmente connotati in modo
positivo come qualità, eccellenza, efficienza,
merito3. L’idea della progressiva eliminazio-
struttura e non del singolo soggetto, la richiesta di conferire solo tre prodotti di ricerca pubblicati in sette anni,
che costituiscono in molti settori della scienza un’immagine della produzione complessiva dei singoli soggetti
molto parziale, la non considerazione del contributo individuale al prodotto nel caso di presenza di coautori, e,
infine, l’utilizzo di metodi di valutazione la cui validità dipende fortemente dalla dimensione del gruppo di ricerca
cui sono applicati”. Il Rapporto è disponibile su: http://www.anvur.org/rapporto/main.php?paragraph=premessa&cap=UFJFTUVTU0E=. Consultato il 13 novembre 2014.
Laurea DOC (intervista a cura di Simonetta Fiori). Il testo è disponibile su: ricerca.repubblica.it/repubblica/
archivio/repubblica/2012/02/04/laurea-doc.html. Consultato il 13 novembre 2014.
Cfr. V. Pinto, Valutare e punire, Napoli, Cronopio, 2012.
antropologia e storia
ne dei meno dotati, in effetti, non sottende
necessariamente una strategia di massimizzazione degli interessi del più forte a scapito
dello sviluppo di tutti gli altri. Fu Herbert
Spencer – guadagnandosi così la palma di
padre fondatore del darwinismo sociale – a
teorizzare con particolare crudezza questo
carattere competitivo fino alla lotta per la
sopravvivenza del passaggio dalla società
militare a quella industriale, interpretandolo
in linea con la tesi generale secondo la quale
nel corso del progresso umano alcune parti vengono sacrificate appunto “a beneficio
della società nel suo complesso”: mentre negli stadi più remoti questo sacrificio prende
la forma di mortalità nelle guerre, in quelli più progrediti esso “prende la forma di
mortalità prodotta dalla lotta commerciale,
e dalla viva concorrenza che ne consegue”4.
Il darwinismo accademico si potrebbe allora
interpretare come una nuova variante a fin
di bene di questa pratica della “viva concorrenza”, non diversamente dalla “distruzione
creatrice” teorizzata da Schumpeter. Non ci
si aspetta che i perdenti, che in quanto tali
sono destinati ad essere soppressi, gioiscano
del loro destino. In una società che voglia
essere equa, oltre che ricca, questo inevitabile prezzo da pagare al progresso sarà compensato dalle misure, tendenzialmente finanziate dalla fiscalità generale, che evitano
che questa ‘morte’ sui mercati si traduca in
marginalizzazione sociale ed esclusione dai
diritti fondamentali, garantendo così a tutti
non solo la massima uguaglianza possibile
delle opportunità ma anche le condizioni e
lo stimolo per ripartire dopo un fallimento,
magari con un’altra sfida.
4
/ 1 – donne in armi
Le finalità della VQR dichiarate dall’ANVUR orientano decisamente la valutazione
alla competizione. L’obiettivo è quello di stilare delle graduatorie e di fornire in questo
modo uno strumento utile a tutti i livelli per
decidere la distribuzione delle risorse, con
un esplicito riferimento, nel caso del Fondo
di Finanziamento Ordinario, alla sua quota
premiale. Collegando in modo così stretto
gli incentivi alla posizione in una classifica
(e anche assumendo quel che è in realtà controverso, cioè che la classifica sia stata determinata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e correttamente applicati, consentendo
così di riconoscere il merito e portare allo
scoperto le sacche di inefficienza e spreco)
non ci si può meravigliare nel constatare che
i soggetti interessati modificano i loro comportamenti con l’obiettivo prioritario di migliorare appunto il loro ranking: i criteri di
una valutazione competitiva non si limitano
a fotografare una realtà e in qualche modo la
creano. L’utilizzo del vocabolario della premialità al posto di quello punitivo di tagli e
chiusure non cambia la sostanza delle cose,
perché allargando la forbice delle risorse
disponibili – come si può facilmente comprendere – si rende sempre più difficile, anche potendo contare su buone idee, talenti e
impegno, chiudere il gap della qualità, che è
destinato a sua volta ad allargarsi. E alla fine
non c’è neppure bisogno di sopprimere i più
deboli, perché scompaiono da soli.
Le ragioni per le quali l’applicazione di
questo metodo alla produzione e trasmissione del sapere richiede una straordinaria cautela sono di almeno due ordini. C’è, in primo
luogo, la questione della compatibilità fra la
H. Spencer, Principi di sociologia, Torino, UTET, 1967, vol. II, p. 997.
147
Q
uaderni
natura e le finalità della ricerca scientifica e
un approccio che crea di fatto ostacoli alla
collaborazione anziché favorirla. E li crea
là dove in gioco c’è davvero uno dei pilastri
fondamentali della stessa competitività del
sistema-paese, che andrebbe costruito e consolidato secondo una prospettiva coerente
ed equilibrata anche quando, riconoscendo
le differenze fra i diversi atenei e i loro diversi territori e dunque il valore dell’autonomia,
si dovesse trattare di decidere chi fa che cosa.
Il fatto che questa competizione si accenda
per risorse sempre più limitate e dunque per
ridurre il loro taglio piuttosto che acquisirne
di nuove funziona da acceleratore di questa
contraddizione a tutti i livelli. Nei caveat
dell’ANVUR era nascosta una contraddizione latente rispetto all’obiettivo di offrire indicazioni utili alla distribuzione delle risorse
all’interno dei singoli atenei ed enti di ricerca. Una volta stabilita e applicata la finalità
premiale delle graduatorie, infatti, la strada
era aperta per la sua pervasiva estensione al
di là dei confini stabiliti dalla stessa Agenzia,
pena l’esposizione alla contestazione quasi
automatica di aver cercato di eludere i parametri dell’oggettività, della qualità e del merito in nome dell’arbitrio e del familismo accademici, tradizionale capo d’accusa contro
uno dei ceti dirigenti (i professori universitari) la cui immagine appare da tempo più
compromessa agli occhi dell’opinione pubblica. Sono così venuti rapidamente meno
i vincoli a non confrontare aree scientifiche
differenti e a non utilizzare i risultati della
VQR per valutare i singoli docenti e ricercatori, anche e soprattutto in vista di un loro
possibile avanzamento di carriera.
5
148
Il risultato, ampiamente prevedibile e
previsto, è un adattamento opportunistico
ai criteri utili a favorire lo scorrimento verso l’alto nelle graduatorie, che non sempre
corrispondono a quelli che davvero promuovono lo sviluppo del sapere. Basti citare
due atteggiamenti. La redditività nel breve
termine può diventare una scelta obbligata,
prosciugando quello sforzo di pensare lungo dal quale sono nate molte delle più importanti rivoluzioni scientifiche e culturali.
L’ossessione del publish or perish produce
esiti sconfortanti come il salami slicing, cioè
la tecnica dello spezzettamento dei risultati
della ricerca per avere più articoli da pubblicare e per non lasciare ‘buchi’ nella propria
attività produttiva, come fece Kant nei lunghi
anni di silenzio che precedettero l’uscita della Critica della ragion pura. È naturalmente
vero che proprio questo esempio può essere
facilmente utilizzato dai molti “inattivi” che
coprono in questo modo la loro debolezza o
semplicemente la loro scelta di dedicarsi ad
altro, ma ciò non giustifica la conclusione che
solo ciò che può essere finalizzato e calcolato vale. Ugualmente insidiosa è la tentazione
dell’omologazione al main stream, che riproduce lo stile accademico di quella “filosofia
delle università” che Schopenhauer liquidava
con disprezzo, perché attenta a promuovere
la devozione di coloro che “misurano le loro
dottrine alla volontà del Ministero e a quelle che di volta in volta sono le sue opinioni”
anziché trasmettere “al fiore della nuova generazione” una parola viva davvero capace di
“svegliare lo spirito di ricerca”5.
Il secondo ordine di perplessità rispetto
ad una curvatura della valutazione in senso
A. Schopenhauer, La filosofia delle università, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1992, p. 82.
antropologia e storia
esclusivamente competitivo è formulato in
modo chiaro ed efficace nel capitolo conclusivo del Rapporto con il quale si è concluso il
lavoro di un gruppo di esperti nominato nel
2008 dalla Direzione Generale per la Ricerca
della Commissione Europea con l’incarico
di approfondire proprio il tema della valutazione della ricerca scientifica all’interno
delle università6. Una volta definite le diverse graduatorie, si legge nel documento, la
scelta di premiare le università e gli studiosi
che hanno ottenuto i migliori risultati non è
l’unica possibile. Il decisore politico può anche (e in qualche caso probabilmente deve)
privilegiare nell’allocazione delle risorse
proprio le istituzioni che sono rimaste più
indietro e che vanno tuttavia aiutate a recuperare per non compromettere l’equilibrio
complessivo del sistema e la sua capacità di
supportare le punte di eccellenza con una
base solida e ampia di metodologie, buone
pratiche e capitale umano. Il DM 9 agosto
2013, n. 713 offre un buon esempio di una
scelta poco attenta a questa esigenza. In esso
venivano definiti i criteri per l’assegnazione
ai singoli atenei della quota del 20 per cento
della somma dei Punti Organico relativi alle
cessazioni del Personale a tempo indeterminato e del Personale ricercatore a tempo
determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell’anno 2012. Attraverso
una formula particolarmente complessa, che
avrebbe dovuto fotografare in modo oggettivo la qualità degli atenei dal punto di vista
amministrativo, si determinava una forbice
che garantiva all’istituzione giudicata più
virtuosa addirittura il 213 per cento del turn
6
7
/ 1 – donne in armi
over e agli ultimi il 7 per cento, cioè nulla.
Nella coda della graduatoria si affollavano
molti atenei del Sud e questa constatazione
imponeva e impone una domanda, che va
al di là delle divergenze, che pure non mancarono, sulla correttezza dei criteri utilizzati. Il compito dello Stato è semplicemente
quello di misurare e certificare i risultati di
una competizione e lasciare che si realizzi la
desertificazione universitaria di intere aree
del paese? È accettabile concentrare risorse
premiali sul merito di pochi anziché sullo
sforzo di far crescere – naturalmente senza
indulgenze per i responsabili dello spreco di
denaro pubblico – la qualità diffusa del sistema? Quella della lotta di tutti contro tutti per la sopravvivenza non può essere una
soluzione e l’esercizio della valutazione deve
necessariamente avere un orizzonte e obiettivi più vasti.
La mission dimezzata
È lo stesso Rapporto del gruppo di esperti della Direzione Generale per la Ricerca
della Commissione Europea che ho appena
citato a sottolineare come sia importante, per
coloro che hanno la responsabilità di prendere decisioni sul sistema della formazione
superiore, non solo considerare seriamente
i risultati della valutazione della ricerca, ma
anche “gettare un occhio sulle altre funzioni
delle loro istituzioni: l’insegnamento e l’apprendimento e il coinvolgimento della comunità”7. La cosiddetta “terza missione”, alla
quale questo coinvolgimento rinvia, ha gua-
Cfr. Aa.Vv., Assessing Europe’s University-Based Research, Brussels, European Commission: Directorate Generale
for Research, 2010, pp. 56-57.
Ivi, p. 59.
149
Q
uaderni
dagnato rapidamente terreno in questi ultimi anni come uno dei fondamentali fattori
di spinta dello sviluppo economico e sociale,
che trova nelle università il suo luogo naturale. L’ANVUR, partendo dalla distinzione fra la sua dimensione di “valorizzazione
economica della conoscenza” e quella “culturale e sociale”, ne propone una definizione
articolata e ampia. Nel primo caso, a tema
c’è “la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini
produttivi” e appartiene a questa logica, con
tutti i delicati problemi di regolazione che ne
derivano, anche il fatto che, “a qualche stadio del processo, la conoscenza prodotta dal
sistema pubblico di ricerca, per sua natura
pubblica e inappropriabile, assuma invece la natura di un bene privato”. Il secondo
vettore della terza missione è invece quello
della produzione di beni che “possono avere
contenuto culturale (eventi e beni culturali,
gestione di poli museali, scavi archeologici, divulgazione scientifica), sociale (salute
pubblica, attività a beneficio della comunità,
consulenze tecnico/professionali fornite in
equipe), educativo (educazione degli adulti, life long learning, formazione continua)
o di consapevolezza civile (dibattiti e controversie pubbliche, expertise scientifica)”.
A distinguere le due prospettive c’è anche il
fatto che per la fruizione di questi beni non è
previsto il pagamento di un prezzo o in ogni
caso non di un prezzo di mercato e che la
loro rilevazione e misurazione è più difficile,
in quanto tali attività vengono spesso svolte
dai singoli ricercatori e non dalle istituzioni. L’Agenzia, in questo documento di lavoro
dell’aprile del 2013, sottolinea anche come
gli indicatori di terza missione non possano
che essere differenti “da quelli che tracciano
i risultati delle missioni di insegnamento e
ricerca” e non possano “compensare gli altri”
(assumendo ad esempio che una forte presenza sui media possa bilanciare la debolezza nelle pubblicazioni scientifiche)8.
Con queste precisazioni, gli indicatori di
terza missione sono stati comunque inclusi
nell’esercizio della VQR 2004-2010 e nel relativo Rapporto. Il Green Paper su Fostering
and Measuring “Third Mission” in Higher
Education Institutions, realizzato attraverso
la collaborazione di una rete di università
finanziata dal Lifelong Learning Programme
della Commissione Europea, invitava ad una
grande cautela nell’avvicinare la terza missione a classifiche e logiche immediatamente premiali: gli autori del Paper dichiaravano
esplicitamente di aver evitato di proporre
una metodologia di ranking, perché ciò
avrebbe significato non rispettare “la straordinaria diversità e variabilità nella missione,
nel profilo e nella qualità che sono evidenti
fra le università del continente europeo, per
non parlare del resto del mondo. Le graduatorie generali possono spostare l’attenzione
dall’impatto che si sta ottenendo in quanto
istituzione alla competizione, forse superficialmente nella metrica piuttosto che nella
sostanza, con altre istituzioni”9. Nel Rapporto sulla VQR 2004-2010, in effetti, sono
Cfr. La terza missione nelle università e negli enti di ricerca italiani. Documento di lavoro sugli indicatori (Workshop
12 aprile 2013). Il testo è disponibile su: anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/documento/80. Consultato il 15
novembre 2014.
9
Fostering and Measuring “Third Mission” in Higher Education Institutions, p. 19. Il testo è disponibile su: http://
www.e3mproject.eu/docs/Green%20paper-p.pdf. Consultato il 15 novembre 2014.
8
150
antropologia e storia
stati utilizzati gli indicatori di attività conto
terzi, brevetti, spin-off, incubatori, consorzi,
siti archeologici e poli museali per assegnare
anche in questo caso ad ogni università, ente
di ricerca e consorzio una “posizione in graduatoria”, mentre solo per la voce “altre attività di terza missione” si specifica che “dall’esame delle risposte sono emerse differenze
tra le strutture nell’interpretazione dell’unità
di analisi che renderebbero la graduatoria
priva di significato”10. L’impianto fortemente
competitivo del modello italiano di valutazione trova così un’ulteriore conferma.
Che ne è invece della didattica, cioè della
mission to educate che è stata la prima missione delle università europee “sin dal medioevo”, per citare ancora il Green Paper? I
risultati della VQR – come ho ricordato –
“non riguardano in alcun modo la qualità e
quantità dell’attività didattica” e non potrebbe essere altrimenti. Questa limitazione è
del tutto ovvia e comprensibile e il fatto che
si cominci con la ricerca e la terza missione
non esclude evidentemente l’intenzione di
valutare successivamente anche la qualità
dell’insegnamento, con l’obiettivo magari di
stilare le relative classifiche. La storia della
politica universitaria di questi ultimi anni
orienta però ad una conclusione diversa: la
logica competitiva è stata sistematicamente e
deliberatamente agganciata alla sola valutazione della ricerca e dei suoi prodotti, marginalizzando l’attività didattica e facendo della
stessa proposta di differenziare researching e
teaching universities uno strumento di esplicita gerarchizzazione delle missioni. A sostegno di questa tesi è utile richiamare almeno
/ 1 – donne in armi
tre decisioni, che sono state e sono di grande
impatto disincentivante rispetto all’impegno
appunto didattico dei professori universitari.
La prima è stata la scelta di stabilire per
legge che la didattica non conta ai fini della
carriera accademica. La Legge 30 dicembre
2010, n. 240, meglio nota come Legge Gelmini, ha istituito come è noto una abilitazione scientifica nazionale come “requisito
necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori” (art. 16, comma
1). Questa abilitazione viene attribuita “con
motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del
contributo individuale alle attività di ricerca
e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni
e per area disciplinare, definiti con decreto
del Ministro” (art. 16, comma 3, lettera a).
Le polemiche non hanno risparmiato né i
criteri e i parametri definiti con il DM 76 del
7 giugno 2012 né i giudizi delle Commissioni nominate per le due tornate 2012-2013 e
che hanno prolungato i loro lavori ben oltre
il termine fissato dall’articolo 8, comma 6 del
DPR 14 settembre 2011, n. 222, richiedendo
per questo una defatigante sequela di proroghe. Ma non si sono mai infiltrati dubbi
sul fatto che la commissione debba semplicemente ignorare l’attività didattica svolta o
la propensione a svolgerla in modo efficace,
a seconda che il candidato abbia già lavorato
o no come professore. L’ampiezza dei criteri
indicati dal DM 76/2012 per la prima fascia
sottolinea anzi questa esclusione: a dover
essere accertata è semplicemente la piena
Cfr. http://www.anvur.org/rapporto/main.php?paragraph=7.2&cap=Ny4yLiBJIERBVEkgREkgQ09OVEVTVE8gREkgVEVSWkEgTUlTU0lPTkU=. Consultato il 15 novembre 2014.
10
151
Q
uaderni
maturità scientifica, “attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate
e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una
posizione riconosciuta nel panorama anche
internazionale della ricerca. Sono ulteriori
criteri di valutazione la capacità di dirigere
un gruppo di ricerca anche caratterizzato
da collaborazioni a livello internazionale,
l’esperienza maturata come supervisore di
dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre
finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito
internazionale e la capacità di promuovere
attività di trasferimento tecnologico” (articolo 4, comma 1). L’unico riferimento alla
prima missione dell’università, coerentemente con l’impianto della normativa, appare quello della supervisione dei dottorandi.
Per la Legge Gelmini, d’altronde, è solo al
momento della “chiamata” che può essere
valutata anche l’attività didattica dei professori. I relativi obblighi, di conseguenza, saranno assolti nella consapevolezza della loro
inutilità ai fini degli avanzamenti di carriera.
La seconda decisione, con la quale la didattica appare mortificata con una determinazione tanto implacabile da non arretrare
neppure di fronte ad un esito francamente
paradossale, è quella che ha fissato i criteri per
la valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei. Non solo insegnare bene è inutile prima. Lo è anche dopo. Il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, stabilisce infatti,
all’articolo 9, che le politiche di reclutamento
del personale sono valutate in relazione ad
una serie di criteri fra i quali non è indicata
in nessun modo la qualità dell’insegnamento,
mentre figura, in cima alla lista, “la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di
152
servizio presso l’ateneo ovvero al passaggio a
diverso ruolo o fascia nell’ateneo”. Anche per i
nuovi professori, insomma, il primo dovere –
o almeno quello che solo conta per evitare che
la propria università venga penalizzata – non
è quello di andare in aula ed insegnare bene,
ricevere gli studenti, seguire tesi, ma quello di
continuare a scrivere articoli, possibilmente
in riviste con un impact factor elevato. Ed è
davvero significativo constatare come deputati e senatori, in occasione della conversione
in legge del decreto 24 giugno 2014, n. 90, abbiano ritenuto indispensabile introdurre un
emendamento con il quale si ribadiva appunto che “la qualità della produzione scientifica
dei professori reclutati dagli atenei all’esito
dell’abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento”. Quasi un
richiamo ai pochi che si sono spesi in questi
anni per ricordare che una università senza
didattica o comunque con una didattica senza qualità è una contraddizione in termini. E
certamente non una sollecitazione ai Rettori a
considerare prioritario l’impegno a garantire
agli studenti le migliori risorse disponibili.
Il terzo e ultimo passo di questa strategia è la destinazione di tutti o quasi gli interventi premiali sulla base delle classifiche
della qualità della ricerca e dei suoi prodotti.
Il decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2014 (secondo
lo Schema disponibile al momento della
consegna di questo articolo) è una dimostrazione eloquente della sistematica pervasività
di questo atteggiamento. La “quota premiale”, che sale al 18 per cento del totale delle
risorse disponibili, viene assegnata per il 70
per cento in base ai risultati conseguiti nella
Valutazione della qualità della ricerca (VQR
2004-2010), per il 20 per cento in base alla
antropologia e storia
Valutazione delle politiche di reclutamento
(cioè, come abbiamo appena visto, in base
ad un criterio sostanzialmente identico al
primo) e per il restante 10 per cento in base
ai risultati della didattica, con specifico riferimento alla componente internazionale. La
didattica, dunque, vale al massimo il 10 per
cento, ammesso che si possano considerare
davvero come indicatori della sua qualità il
numero dei corsi offerti in lingua inglese e
quello degli studenti stranieri, quale che sia
la loro provenienza. È possibile che questa
situazione possa modificarsi con l’avvio delle procedure previste per l’accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio e
con le relative “visite” delle commissioni di
esperti che dovranno accertare la “qualità”
di questi ultimi, con il rischio concreto di
chiusura per quei corsi che non dovessero superare positivamente la verifica. Ma è
un’ipotesi, anche per il numero ridottissimo
di visite che la stessa ANVUR dichiara di
poter effettuare, che resta a sua volta tutta da
verificare. Molti, probabilmente, sono ancora pronti a riconoscere che una buona università è tale solo quando offre una buona
didattica e non solo un elenco di ricercatori
che, rimanendo chiusi nei loro laboratori e
nelle loro biblioteche, collezionano citazioni
e non si preoccupano minimamente di formare allievi capaci a loro volta di far crescere i diversi ambienti nei quali si troveranno
a lavorare. Si ha però talvolta l’impressione
che vi sia, in chi governa l’università italiana,
la convinzione che i ‘migliori’ debbano essere salvaguardati dal fastidio di insegnare o
che comunque una didattica di qualità venga
per così dire ‘da sola’, una volta garantita la
qualità della ricerca. La prima affermazione
ha almeno il merito di sollevare a viso aperto la questione della missione dell’universi-
/ 1 – donne in armi
tà. La seconda rischia di essere un modo per
realizzare alla chetichella lo stesso obiettivo.
Presidi di parole
La fredda oggettività degli algoritmi elaborati dagli ‘esperti’ è diventata la scialuppa
di salvataggio degli zelatori della qualità. Ha
fatto un passo indietro perfino la politica, il
cui prestigio agli occhi dell’opinione pubblica non è probabilmente superiore a quello
dei professori universitari, tuttora omologati nel linguaggio e nella sensibilità comuni
alla logica feudale dei ‘baroni’. Esemplare, da
questo punto di vista, è quanto previsto dal
Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19
sul rapporto fra l’ANVUR e il Ministero rispetto alla definizione dei criteri e parametri
che dovrebbero appunto garantire la qualità
del sistema: l’Agenzia “definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio universitari e
li comunica al Ministero. Gli indicatori sono
adottati con decreto del Ministro entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione”
(art. 6). Insomma: l’ANVUR decide e il Ministro, aggiungendo la sua firma, esegue. In
questo contesto, a dir poco insolito, gli aspetti
cruciali sui quali occorrerebbe portare l’attenzione del decisore politico sono la presunzione della neutrale purezza delle regole – della
quale ho già parlato – e la loro dilagante, soffocante, inutile ipertrofia, pendant patologico
della convinzione che non ci si possa fidare
dei professori universitari più che di un noto
borseggiatore su un autobus affollato. I Requisiti di Assicurazione della Qualità esposti
nell’Allegato C al Decreto Ministeriale 30
gennaio 2013, n. 47 su “Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi
153
Q
uaderni
e dei corsi di studio e Valutazione Periodica” (modificato dal Decreto Ministeriale 23
dicembre 2013, n. 1059) illustrano in modo
efficace questa duplice criticità.
I requisiti sono 7 e l’ultimo indica come
calcolare la “quantità massima di didattica
assistita” che può essere considerata “sostenibile” per le Università Statali (l’implicita
assunzione di un diverso parametro di sostenibilità per quelle non Statali è evidentemente già una scelta politica). La formula è
dunque la seguente: DID = (Yp x Nprof +
Ypdf X Npdf + Yr x Nric) x (1 + X). Ai fini
del calcolo di DID si deve tenere presente
che: Nprof = numero dei professori a tempo
pieno dell’Ateneo; Npdf = numero dei professori a tempo definito dell’Ateneo; Nric =
numero totale dei ricercatori a tempo pieno
e definito dell’Ateneo; Yp = numero di ore
“standard” individuali di didattica assistita
individuato dall’ateneo e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore); Ypdf = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito
ai professori a tempo definito (max = 90 ore);
Yr = numero di ore “standard” individuali
di didattica assistita individuato dall’ateneo
e riferito ai ricercatori (max = 60 ore); X =
percentuale di didattica assistita erogabile
per contratto di insegnamento o supplenza
(max = 30%). Completa la formula il fattore
k, calcolato sulla base dei risultati della VQR
e che consente alle università con una valutazione più alta della qualità della ricerca di
incrementare anche la quantità massima di
didattica erogabile. Il valore DID viene così
moltiplicato per k, il cui valore massimo è
indicato in 1,2, «corrispondente a una valutazione positiva di eccellenza della ricerca».
Il fattore k, come appare del tutto evidente, è un elemento che appartiene al confron154
to culturale e politico sulla missione dell’università e non cessa di essere tale per il fatto
di generare una formula con la quale calcolare un numero di ore di lezione (uso questo termine per evitare di addentrarmi nella
selva oscura dell’interpretazione del concetto di “didattica assistita”). In un sistema di
incentivi tutto sbilanciato sulla ricerca, può
anche essere visto come il tentativo di aprire un’alternativa alla separazione netta fra le
researching universities dove si insegna poco
(e tendenzialmente per pochi) e le teaching
universities dove si fa poca ricerca e per questo si insegna di più. Resta naturalmente il
problema che per le università (che nel contesto attuale hanno certamente un interesse
ad ampliare l’offerta formativa e accogliere
in questo modo un numero potenzialmente
maggiore di studenti) può non essere facile persuadere i propri docenti-ricercatori ad
insegnare di più, essendo questa attività sostanzialmente irrilevante dal punto di vista
degli interessi e delle ambizioni accademici
dei singoli. Peraltro, essendo il DID calcolato moltiplicando il numero totale dei professori su un numero di ore standard, non
è detto che siano poi i ricercatori giudicati
migliori ad andare davvero in aula ad insegnare. Ed è proprio l’indicazione di questo
standard individuale a fornire un’ulteriore
dimostrazione del fatto che queste formule incorporano sempre una storia e precise
scelte di modello, di priorità, di obiettivi.
Perché proprio 120 ore (che diventano 90
per i professori a tempo definito e 60 per i
ricercatori)? Perché non 150? O 192, come
in Francia? L’indicatore scelto dall’ANVUR,
come ho detto, ha alle spalle una storia. Era
stato l’articolo 16 della Legge 4 novembre
2005, n. 230 ad introdurre un preciso obbligo
di 120 ore di didattica frontale per i professo-
antropologia e storia
ri universitari a tempo pieno (80 per quelli
a tempo definito). L’obbligo evaporò nell’attesa dei Decreti Ministeriali che avrebbero
dovuto definire i parametri in base ai quali
“le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e
della specificità e della diversità dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti”. Il risultato è che ‘università che
vai, obbligo che trovi’, anche prescindendo
dalla considerazione della predisposizione e
dell’efficacia dei controlli sul rispetto da parte dei docenti dei loro doveri nei confronti
degli studenti. E il tentativo, annunciato dal
Ministro Profumo nel 2012, di ritornare su
questo punto per risolverlo in modo chiaro
e definitivo con l’indicazione di un minimo
di 100 ore l’anno di didattica frontale venne
stroncato ancor prima di raggiungere le aule
parlamentari. Poste queste premesse, l’indicatore sulla sostenibilità della didattica appare uno strumento tutt’altro che neutrale. Le
120 ore sono diventate un massimo e non più
un minimo. E, soprattutto, non corrispondono più ad un preciso obbligo individuale, che
viene lasciato indeterminato. I singoli docenti potranno anche collocarsi al di sotto dello
“standard”, purché il loro minore impegno sia
compensato da altri. E in assenza di concreti
incentivi a comportarsi altrimenti non ci sarà
da stupirsi se molti tenteranno di farlo.
L’ipertrofia burocratica è – come ho detto
– uno degli elementi che più hanno caratterizzato gli interventi regolatori di questi ultimi anni. I 6 requisiti di assicurazione della
qualità che precedono quello sulla sostenibilità della didattica appaiono in effetti ridondanti e contribuiscono a costruire un struttura farraginosa, con funzioni inutilmente
moltiplicate e sovrapposte, che impongono
un inutile carico di lavoro supplementare a
/ 1 – donne in armi
docenti già alle prese con le conseguenze del
blocco del turn over e del taglio delle risorse.
I primi 3 requisiti affermano solennemente
che ogni ateneo “stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte
a realizzare la propria visione della qualità
della formazione” (AQ 1), “sa in che misura
le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio” (AQ 2) e “chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando
verso risultati di sempre maggior valore”
(AQ 3). Porre come obiettivo di una università il raggiungimento di risultati di sempre
maggior valore non è meno ovvio di quanto
possa esserlo affermare che per una azienda
for profit è importante puntare ad aumentare i ricavi e ridurre i costi mantenendo alta
la soddisfazione dei consumatori. È dunque
sul modello di governance che da tutto ciò
risulta che occorre concentrarsi.
Il 3 ottobre 2014 è stata pubblicata sul
sito dell’ANVUR la Nuova Versione delle
Linee Guida per l’Accreditamento Periodico
delle sedi e dei corsi di studio, che espone
“criteri, metodi e procedure” da utilizzare
a tal fine e “contiene informazioni che gli
Atenei possono utilizzare per riflettere sul
livello di sviluppo raggiunto dal proprio sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)”.
Ecco come viene spiegato il contenuto del
Requisito AQ 1: “Politiche e procedure rendono evidenti i ruoli, le responsabilità e le
interazioni che si determinano tra Organi
di Governo, CdS, Dipartimenti, Strutture
di Raccordo o altre articolazioni interne
dell’Ateneo, strutture tecniche di supporto,
Presidio Qualità, Commissioni paritetiche
docenti-studenti, Nucleo di valutazione.
Tali elementi possono trovare formalizzazione, oltre che nello Statuto e nei regola155
Q
uaderni
menti degli Atenei, in documenti di programmazione approvati dagli Organi di
Governo e in delibere di Organi che, pur se
non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indirizzi rilevanti a
questo scopo”. Il Requisito AQ 4, che impegna gli atenei a possedere “un’effettiva
organizzazione con poteri di decisione e di
sorveglianza sulla qualità dei CdS”, ci aiuta a
comprendere in che modo, concretamente,
si debbano articolare tali ruoli, responsabilità ed interazioni. Le Linee Guida, dopo aver
integrato la lista con i Rapporti di Riesame
e i relativi Gruppi, puntualizzano come, per
soddisfare tale requisito, si dovrà osservare
fra l’altro se il Presidio Qualità “affianchi le
strutture coinvolte (Dipartimenti o Strutture di Raccordo, Commissioni paritetiche
docenti-studenti e CdS) in tutte le fasi della AQ […] se il Nucleo di Valutazione e le
Commissioni paritetiche docenti-studenti
svolgano un’adeguata e documentata attività
annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ,
da cui risultino pareri, raccomandazioni e
indicazioni indirizzate al Presidio Qualità e
agli Organi di Governo dell’Ateneo […] se
il Presidio Qualità e gli Organi di Governo
dell’Ateneo siano a conoscenza dei pareri,
delle raccomandazioni e delle indicazioni
che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti producono e sulla base di esse comunichino e mettano in atto adeguate misure migliorative”.
La relativa documentazione dovrà mettere
le Commissioni di Esperti della Valutazione
“nella condizione di comprendere agevol-
mente quale ripartizione di ruoli e responsabilità sia prevista tra i diversi soggetti”11.
È arduo immaginare che tutto ciò sia davvero indispensabile per migliorare la qualità
della vita e dei risultati scientifici e didattici
degli atenei italiani. Quel che è certo – come
ho scritto insieme al collega Giovanni Salmeri cercando volutamente il linguaggio della
provocazione – è che porta con sé una serie
di effetti collaterali sui quali varrebbe la pena
di riflettere: “occupazioni che tolgono spazio al nostro vero lavoro e ci trasformano in
passacarte che non hanno più tempo e voglia
neppure di parlare con gli studenti (e ancor
meno fra di noi); adempimenti che sono,
per ammissione universale, perfettamente
inutili e inducono a continui falsi ideologici,
consistendo, in buona parte, nelle redazione
di documenti in cui si parla di riunioni immaginarie con discussioni immaginarie su
argomenti immaginari; una mentalità che è
la filigrana di queste normative e che rivela
una sistematica sfiducia nei confronti delle
Università, presentate all’opinione pubblica
come istituzioni che devono continuamente
dimostrare di non essere associazioni a delinquere dedite alla circonvenzione di incapaci;
la mortificazione dell’autonomia universitaria tramite una regolamentazione nevrotico-ossessiva che rende sempre più difficile
l’invenzione, la sperimentazione, l’interdisciplinarità, non per ultimo per l’anticipo spropositato con cui ogni sia pur minima novità
va programmata”12. È importante che ci siano
nelle nostre università presidi di qualità. Non
è utile che siano presidi di parole.
Cfr. Nuova Versione Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio erogati in modalità convenzionale:
Finalità e procedure per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio, pp. 2, 5-6 e 7-8. Disponibile su http://www.
anvur.org/attachments/article/698/2_Finalita%CC%80%20e%20procedure%20DEF.pdf. Consultato il 16 novembre 2014.
12
G. Salmeri e S. Semplici, L’università che uccide se stessa, 29 aprile 2014. Consultabile su http://www.roars.it/online/
luniversita-che-uccide-se-stessa/
11
156
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Antropologia e letteratura
Ritorno ad Alvaro.
Tra richiamo antropologico e tensione letteraria
Luigi Reina
Nello scaffale dei debiti non pagati, tra la
ventina di monografie dedicate all’opera di Corrado Alvaro ho ritrovato, invitante, un volumetto
non trascurabile (Gennaro Mercogliano, Corrado
Alvaro, Rossano, Ferrari Editore) cui non avevo
prestato attenzione adeguata perché impegnato
nella redazione di un volume sul romanzo italiano degli ultimi due secoli (Percorsi del romanzo,
Roma, Lepisma, 2012). Merita attenzione per le
sollecitazioni che fornisce a una ulteriore riflessione sulla poetica dello scrittore calabrese di cui,
con manifesta passione, l’autore del volume rivendica l’ancoraggio solido all’antropologia della
comune regione, terra mitica nella memoria.
È una tesi in qualche modo contrastante, e
perciò stimolante, rispetto a quella a me più cara
applicata all’irrequietezza dello scrittore che si dispose a investigare (col rammarico di non trovare conforto) nei miti della civiltà contemporanea
(un «rimbarbarito ’600») trasferendoli in vicende
e occasioni da romanzo. In questo (forzando lo
spazio del pacifico idillismo naturale, che rimane
come memoria psicologica e luogo edenico d’attrazione, per il personaggio narrativo) entrano,
e cercano adeguata accoglienza, quali essenziali
fattori fondanti, materiali naturali, realistici, o fat-
tuali, e supporti magici, simbolici e allusivi che,
attraverso metaforiche aggregazioni di dati testimoniali e di supposizioni ideali, guidano nella
direzione di approdi letterari di sicura robustezza.
I tempi e i modi vi sono scanditi dalla rappresentazione contestuale delle tappe che evidenziano, in Alvaro, motivazioni e conseguenze del montante disagio dell’uomo nel processo di mutamento
della società che lo condiziona costringendolo a
subire riti e ritmi connessi all’epidemico fenomeno di omologazione culturale (politica, economica
e tecnologica), con il potenziarsi della capacità di
invadenza di modelli appartenenti ad altre civiltà,
che incoraggiano a ricercare possibili ancoraggi
nei disvalori della moda, del successo e del denaro. Con tutto quanto di contrastante e negativo si
riversa sul personaggio da romanzo che, non avendo saputo rinunciare alla sua identità (di meridionale, nel caso di quelli di Alvaro), non ha potuto
adeguarsi al sistema del nuovo, interiorizzandone
i modelli, e perciò è rimasto narrativamente come
irrealizzato (umanamente, spaesato), sempre tentato dalla rinuncia all’impegno, o dalla fuga verso
un altrove indefinibile, o da un improbabile ritorno all’antropologico Eden purtroppo smarrito.
Esattamente come il prototipo di Sebastiano Babe
colto nel suo più che problematico rapporto con il
labirinto metropolitano, e incapace di adeguarvisi.
C’è un punto su cui è facile concordare con
la tesi inseguita dal Mercogliano, nel desiderio
157
Q
uaderni
di ritrovare un possibile tracciato che faccia da
amalgama riportando ad organicità l’opera di
Corrado Alvaro. Riguarda l’ipotesi che induce
a registrarne la poetica bifronte ad essa sottesa:
come antropologico frutto, spontaneo quanto
genuino, di natura (mito delle origini), e come
espressione di un genetico bisogno di soddisfare l’esigenza avvertita di un progetto culturale di
elevato prestigio (cultura della modernità). Viene
opportunamento esplicitato, dal critico, attraverso una campionatura di assaggi testuali e proposizioni interpretative che, rapportandosi a personali, anche assai pregresse esperienze di fedele
investigatore, testimoniano a favore non soltanto
della propria amorevole frequentazione di lettore, ma anche di una tensione euristica mai paga.
Ed è questa che, alla fine, motiva e corregge a
un tempo, chiarificando, l’apparente simpatetico
coinvolgimento dello studioso e la disposizione
favorevole dell’uomo nei confronti dello scrittore.
Si tratta di condizioni entrambe di «natura»,
derivanti dalla comune origine calabrese (antropologia), e responsabili, per senso di appartenenza, di quella non raffrenata disposizione
compartecipativa, appena mitigata dall’esigenza
di collocare, poi, il dato empirico e personale su
un piano di oggettiva valenza, pur con i rischi
connessi al regressivo richiamo della confortante
ascendenza. Al fine di esorcizzare quei rischi, il
critico s’impegna a dimostrare che richiamo di
natura e sollecitazioni di cultura, in Alvaro, assolutamente s’integrano e tendono a esaltarsi all’insegna della calabresità. Una tesi che viene sviluppata con incursioni nelle opere e col recupero di
funzionali dati biografici.
Ma si dà il caso che proprio questo ancoraggio sembrò non soddisfare Alvaro che si adoperò
nel ricercare gli opportuni correttivi attraverso la
frequentazione, dimostratasi rigenerante, di sicuri campioni della cultura più attiva e avanzata del
resto d’Europa. Assunti a modelli o eletti a interlocutori privilegiati, furono questi a suggerirgli
quell’interrogativa disposizione che lo guidò lungo
i sentieri di una pratica sperimentale, tenuta come
158
in sospensione d’attesa, nell’intimo, entro una mai
smessa ricerca di aggiornamento, perdurando la
tensione creativa esposta alla riproposizione di
«storie» che fossero come «memorie» da un mondo sommerso, carico di «misteri», e «avventure»
che fossero prodotti di un’immaginazione allegorica esercitata su frantumi di realtà ipotetica («è
impossibile scrivere realisticamente… Scrivere di
qualcosa di più della realtà», annotava).
Contrastivamente si esibivano per lui due
mondi quasi inconciliabili, riaprendo il discorso
sulla natura e, dunque, sul modo di rappresentazione simbolica di essa, attraverso la letteratura,
che interessava il moralista Alvaro più di quanto non interessi il critico Mercogliano sollecito a
cogliere l’attenzione dello scrittore per «l’umana
dignità e per il decoro del mondo».
Di là delle vecchie questioni riaperte o riapribili (antico e moderno, paese e città, società ed
individuo, storia e politica, regola e caos, omologazione e identità, civiltà e barbarie, organicità e
labirinto….), quelli di Alvaro erano interessi gnoseologici e tensioni sperimentali che, rispolverando annose diatribe, mettevano sotto accusa i
vecchi moduli compositivi e sollecitavano definizioni di grammatiche nuove. Le quali, se producevano in lui risultati di arricchimento tematico,
obbligavano altresì ad un continuo apprendistato (ideologico e strumentale) chiunque volesse
mettere a frutto il nuovo tanto nella milizia giornalistica quanto nella produzione creativa. Il ritorno anche frequente ai moduli di un ripagante
e quasi automatico sistema di rappresentazioni
lirico-idilliche del reale era il rifugio, l’ancora di
salvezza, angelicamente riposante dei momenti
di maggiore tensione (affettiva o ideologica, che
fosse) in cui veniva prodotto il «qualcosa di più»
che era la letteratura, da féerie o da strumento di
conoscenza critica che dovesse apparire.
Su tale versante si collocano racconti e reportage dal sud del mondo (il Mezzogiorno d’Italia, la Turchia, la Russia Sovietica) che hanno
alle spalle l’esperienza dell’antropologia paesana
e rappresentano in modo più evidente una sorta
antropologia e storia
di perdurante difficoltà che lo scrittore avvertiva nel far lievitare diversamente una materia già
tutta letterariamente consumata. Un’eccezione
fortunata (Gente in Aspromonte) ne aveva esaltato
superbamente un modello, che tuttavia rimaneva
frutto spontaneo e unico di una scelta quasi istintiva, d’ascendenza antropologica, «emotiva» e non
coltivata, come Alvaro preferiva dire («Scrivere
per me nasce da un’emozione che voglio comunicare…»), qualcosa, insomma, «che si trova nell’animo e da cui provengono le azioni» sviluppate su
polverizzati fondali di vita mummificata che solo
la memoria dl gruppo conserva ed attesta.
È la parte che preferiscono, in genere, i lettori o critici meridionali di Alvaro, come Mercogliano il quale si ricostruisce anche un percorso
(parsimonioso e personalizzato) di funzionale
storiografia critica insieme ad un inventario di
riferimenti contestualizzanti l’attraversamento, da
parte dello scrittore, di vicende che segnarono in
parte la storia politica e civile del tempo. Naturalmente di quelle che lasciarono tracce evidenti
nelle opere in cui domina l’altra poetica: quella,
cioè, che sostituisce all’umanità paesana, fissata in
quasi assolute figurazioni antropologiche, il prototipo del meridionale inurbato costretto a vivere
l’avventura come sradicato o come pedina alienata di una controstoria da costruire, come altra
memoria, sulla storia che non può essere ormai
altro che metropolitanaed europea, soggetta a
tutte le incursioni interpretative e condizionanti.
Di questa diversa storia, narrativamente Alvaro si accinse a delineare alcuni tratti costitutivi,
rinunciando all’idillio e spingendosi sui sentieri
della sperimentazione più ardita, per uno come
lui che s’interrogava sull’applicazione di leggi partorite dalla filosofia politica a rischio di devianza
nella prassi (L’uomo è forte), dalle nuove convenzioni imposte al costume (Il nuovo giorno), o
dalla scienza (Belmoro), per servire al racconto
del sociale massificato (Tutto è accaduto), o per
sovraintendere alle complessive ragioni dell’omologazione (Il mare, Domani) che costringe all’accettazione del diverso come essenziale strumento
/ 1 – donne in armi
di inserimento nella modernità e non consente
nemmeno la coltivazione della nostalgia dell’identità. Un mondo, dunque, la cui diversa formalizzazione costringeva a una nuova narrazione,
presupponendo anche altre conoscenze.
Per letture «finalizzate» di questo tipo occorre ben scegliere i campioni di ordine testuale
o i dati testimoniali (biografici e relazionali) da
assemblare («Non si può separare lo scrittore
dalla sua biografia», suggeriva Alvaro). Mercogliano non trascura di mostrarne consapevolezza
e si impegna a esibirne campioni individuati con
puntigliosità analitica e procedimento selettivo
che una scrittura ricca di lucentezza contribuisce a aggregare in sistema logico. Sono assaggi
che non prefigurano, tuttavia, un itinerario diacronicamente disposto (e forse non lo vogliono
fare), ma si limitano a fornire un contributo di
illuminazione alla tempra dell’uomo impegnato
nella quotidiana milizia di cronista che racconta il proprio tempo. Insistono nel trascorrere,
selettivamente, su particolari caratterizzanti il
rapporto dell’uomo con la modernità, piuttosto
che quelli dello scrittore creativamente proteso
a testimoniare il cambiamento (o l’avventura)
nella pratica più intima dell’attività letteraria cui
sentiva dover fornire prove alternative di testimonianze efficaci quanto innovative, andando oltre
il proprio sentire, ma provando a collocarsi sulla
linea indicata dalla più moderna e innovativa letteratura europea.
Si è dato il caso che a questo impegno dell’uomo e dello scrittore non abbia corrisposto un’attenzione altrettanto disponibile della critica che
ha preferito seguire percorsi interpretativi più
tranquilli, come quelli cui appare particolarmente sensibile Mercogliano: la mitologia dei luoghi
e degli affetti, il ritratto rusticale, il realismo lirico
e la dipintura di atmosfere, l’idillismo naturale e
la tensione memoriale, le tinte locali e il radicamento regionale… Interpretazioni e valutazioni
conseguenti sono relazionate a quell’idea di calabresità, estensivamente intesa (come condizione
di natura e come dato di cultura), che dovrebbe
159
Q
uaderni
fornire il leitmotif di una supposta o possibile
esemplarità quasi monolitica dell’intera opera
(cosa che a me non pare). Talché tutto può ad
essa raccordarsi funzionalmente, anche quanto ne sembra più lontano: il ritratto dell’uomo/
personaggio posto di fronte all’eterno femminino
oppure alle prese con l’appuntamento fatale; il
tormento della sospensione tra bisogno di radicamento (il paese) e spinte integrative (la città);
l’ansia di coniugazione di antropologia e storia,
natura e cultura, realtà e utopia, identità e omologazione, ordine e caos; l’alienazione umana o il
dramma dei costumi…; o quant’altro è possibile
rinvenire pescando da vicende biografiche rilevanti (i viaggi e i soggiorni per inchieste o per
altro, tra capitali europee e Italia, da irrequietezze
intellettuali (letture della Bibbia e dei i classici), o
da notazioni aneddotiche. E, finalmente, dal cercato bagno nella contemporaneità attraverso lo
strumento delle inchieste e dei reportage, o con
racconti in forma di elzeviri o con saggi di costume e con indagini che approfondiscano consonanze (molte) o divergenze intellettuali (non
poche): Pavese, Papini, Albertini, Amendola,
Bontempelli, Pirandello…
Limitativa a me appare la rinuncia a individuare il positivo emergente dalla pratica della
modernità, all’inizio identificata nella tentacolare
rappresentazione della diversa civiltà metropolitana (alienante e regressiva) Perché proprio questa segna le tappe di un costante attraversamento
di altri modelli culturali e societari per i quali lo
scrittore si mantenne come in interrogativa attesa. Strumenti euristici ne erano non più quelli
forniti dagli approfondimento antropologici o
dai modelli del realismo regionale, bensì quelli
della rinata analisi sociologica che faceva buona
festa anche alle grammatiche narrative di riferimento sollecitando l’elezione di nuovi modelli e
una revisione degli impianti tematici e dei registri
compositivi.
Tutte cose che poco si raccordano con il richiamo alla genetica connotazione della calabresità che scorre in zone più permeabili alle
160
esigenze di genere, come sarebbe facile riscontrare se si volesse recuperare quella dimensione
monografica per l’interpretazione che a me tanto
interessa. Perché non bastano le parsimoniose
referenze assunte dalla bibliografia critica o qualche spunto di riflessione sulla concezione estetica
dello scrittore, anche se non caricate di eccessiva
responsabilità definitoria, se poi non si dà il giusto rilievo a dichiarazioni esplicite dello scrittore,
come quando lamenta: «In Italia non si arriva più,
e da un pezzo, a elaborare una cultura piena, una
letteratura che arrivi all’apice della cultura.».
In un contesto di storiografia critica, se non
ci si vuole arrestare alle soglie del complesso sistema compositivo, non si può non riconoscere
a tali espressioni la medesima valenza attribuita
nella cultura di Alvaro al dettato di quell’umanesimo moderno, capace di coniugare il vero con
il buono, su cui insiste Mercogliano. Si tratta di
qualcosa di manzoniano, in linea con l’utilizzo dell’antistoria applicata alle forme del sociale
(«lotta per la vita») che lo scrittore ritrovava compromesse col politico: quella «cabala» mai accettata o esplorata veramente, quindi mai capita e
perciò non spiegata (deriva moralistica?), se non
metaforizzando. Per tale ragione egli si affidava,
sperimentalmente, alla favola distopica o all’allegoria (cultura), su un proscenio che sollecitava
le tentazioni del ritorno e rimandava ritualmente
al mondo delle origini (natura), che diviene, nel
tempo, come un archetipo mitizzato ma ormai
sempre più imprendibile.
Cogliervi soltanto una quasi devozionale disposizione d’animo (cosa non sbagliata in sé) significherebbe sminuire un po’ il significato di un
impegno ben più forte di Alvaro nel ruolo di critico testimone del proprio tempo, assunto come
uomo e come intellettuale/scrittore, non certo
riconducibile al peso esercitato dall’idea di una
«Calabria dal robusto sentire, generosa e forte»,
la Calabria di natura, assai a lui cara e così ricca
di «orgogliosa pazienza…». Per difetto di azione,
il peso della connessa prevaricante «naturalezza
istintiva» ne farebbe davvero un campione as-
antropologia e storia
soluto di dipintore di atmosfere o di pittore del
tempo e dell’anima: scrittore, certo, ma non sicuramente mymethes, e in quanto tale, anche difficilmente collocabile in sede storiografica, tenendo conto dei modi in cui avvenne il trapasso tra
due epoche segnate dall’avvento della democrazia
repubblicana e dall’apertura di tutte le frontiere.
C’è da dire che, nonostante le professioni ripetute di fascinazione della compostezza classica, in realtà Alvaro era legato a una concezione
mimetica della narrativa che, applicata alla tradizione italiana, glela faceva apparire combattuta
tra due determinazioni: come espressione della
«lotta per la vita», e come frutto degli «impulsi
del sangue e degli appetiti». In qualche modo il
suo canone era tutto già definito alle origini: tra
contenuto ed espressione. Il sistema articolato
del Decameron, gli forniva l’archetipo (di scorta,
L’asino d’oro di Apuleio), con Manzoni/Verga a
segnare le tappe di avanzamento del primo motivo (realismo) e D’Annunzio quella del secondo
(idealismo/estetismo).
Più ricorrente e di più agevole e diffusa declinazione, per ragioni che non importa qui precisare, nella tradizione narrativa italiana è stato
più frequentato il motivo della lotta per la vita.
Ma Alvaro non se ne accontentava, tanto che tendeva a motivarlo liricamente. L’Europa chiamava
ad altre imprese che la contemporaneità sollecitava e gli scrittori proponevano nella pratica creativa: con il sempre eterno Dostoevskij, Mann,
Proust, Kafka, Joyce, Orwell, Huxley, Sologub,
Gončaròv…. La sua attenzione, forte dell’esperienza novecentista, si rivolse fiduciosa a questi
(anche quando s’introducevano chiare prese di
distanza, come per Proust) per arricchire il proprio mondo e trovare nuove espressioni.
La critica intravide subito la disposizione dicotomica già evidenziata, ma preferì concentrarsi sul
primo tracciato (accreditato anche dall’anagrafe).
Considerando il secondo come di scarto, si privilegiò la formula con cui si potevano evidenziare le
implicazioni regionalistiche e idilliche («scrittore
di atmosfere»), condite da un moralismo appro-
/ 1 – donne in armi
dante, fuori dalle strutture narrative, a forme varie
di scritture, dall’elzeviro al pamphlet sociopolitico
(L’Italia rinunzia?) e al saggio di costume…
Un esempio? Prendete i suoi personaggi:
sono tutti, in qualche modo, fuori di chiave, cioè
sradicati, non integrabili, sia che appartengano al
sistema antropologico dell’idillio paesano e sia
che si travaglino nella tentacolare babele cittadina, tra pulsioni del sangue e degli appetiti; tutti con nostalgia di ritorno o desiderio di fuga, e
quando appaiono diversi o non sono integrabili
(Dale), o appartengono a un altro mondo, o difettano di umanità per eccesso di fattori singolativi che li destina a un «altrove» (Belmoro). Un
dualismo non ancora risolto criticamente, che
rende problematica la collocazione storiografica
dello scrittore. Personalmente l’ho affiancato a
Moravia, nella sezione Viaggio intorno all’uomo
del volume ricordato all’inizio, ma per farne una
rappresentazione da doppio speculare, con il primo, Alvaro, destinato a incarnare la figura dello
scrittore e il secondo quello del narratore: moralista il primo, totale il secondo; geloso, amaro
elegiaco ed umbratile, Alvaro; prensile e rotto ad
ogni possibile aggiornamento pur di inseguire il
processo della storia, Moravia per il quale la critica ha risolto subito la dualità. Credo si tratti di
problemi che appartengono a sistemi di cultura
piuttosto che a natura. E questi dicono che qualcosa in Alvaro è allo stato d’incompiutezza, come
le opere pubblicate postume.
Se la sollecitazione di cultura, demonicamente maliosa, fu responsabile di fughe in avanti e di
volitive scommesse letterarie approdanti a esiti
(non sempre compiuti) che si nutrono di variegate mitologie metropolitane (da Misteri e avventure a Domani) trasudanti controverse esperienze
di mutazioni troppo rapide e distanti per poter
produrre effetti immediati (Belmoro), l’altra, angelicamente riposante, fornì in genere effetti di
liricità sublimante, con forme di ripiegamenti
compensativi verso aree tematiche letterariamente consolidate (realismo regionale) e personaggi
un po’ imbalsamati («mummie che si polveriz-
161
Q
uaderni
zano, secondo lo scrittore, con il mondo di cui
fanno parte») in una sorta di eroismo commotivo destinato a trascendere il dato naturale per
ricomporsi in atmosfera trascolorando la stessa
umanità (Gente in Aspromonte). Gli stessi tessuti
narrativi ne seguono le sorti, per la necessità di
trasformare i tratti di umanità, statisticamente assommati, in figure di personaggi che rimangono
sempre fuori misura, per deficienza antropologica, e perciò non più eroi, o per condizionamento
del ruolo, e perciò non più uomini (L’uomo nel
labirinto o L’uomo è forte).
Miraggio utopico sarebbe stato poter pervenire a una fissazione antropologica dell’uomo nella costrizione di un ruolo che lo scrittore
avrebbe voluto di sufficiente corrispondenza ideale, come i critici hanno percepito. Ma, alla verifica, il personaggio derivatone finisce col risultare,
con sempre maggiore evidenza, senza scampo
anche in un contesto eletto a malioso Eden che
va custodito gelosamente, fuori dalla contaminazione illusoriamente accarezzata di poterlo riconquistare (ricorrente motivo del ritorno dopo il
viaggio metropolitano, caratteristico di tanti personaggi di Alvaro). Qualche volta può essere assunto a schema o a puro fattore eletto a campione
di storia, ma sempre in linea, come chiarificazione di poetica, con quello che lo scrittore definiva
«un nucleo emotivo che si trova nell’animo e da
cui provengono le azioni».
Mercogliano risolve il contrasto (o la dualità), rimarcando questa illustrazione di poetica,
con una incisiva formula definitoria, a riassunto:
«Alvaro pittore del tempo e dell’anima». È ispirata
da una contrapposizione ossimorica della Campo che testimonia sulle ultime ore dello scrittore
trascorse nella casa di Trinità dei Monti, tra «tenebra» e «lume». Il critico, ripensando al dissidio tra cultura e natura, o modernità e classicità, riannoda i fili disponibili proponendone una
sintesi estrema: «l’anima stride di dolori antichi».
Quanto basta a farci capire che il suo è un attraversamento dell’opera di Corrado Alvaro all’insegna della ricerca di elementi in grado di favorire
162
la definizione di un profilo di intellettuale a tutto
tondo motivato da una concezione etica ed estetica del mondo nella quale convivono ascendenze arcaiche, mitiche, o forme dell’immaginario e
componenti empiriche del mondo contemporaneo che, per divenire oggetto da romanzo, devono potersi piegare al trattamento simbolico che
ne fa lo scrittore soprattutto quando ne ricerca remote connotazioni antropologico-ambientali o di
natura mitica con strumenti memoriali psicologicamente motivanti (Sebastiano Babe o Rinaldo
Diacono). Un intellettuale con la nostalgia della
naturalezza paesana e il bisogno di sublimazione delle genetiche connotazioni, ma che sente il
contrastivo richiamo della cultura della modernità metropolitana.
Il critico lo segue nei viaggi forzati e nei vagabondaggi conseguenti tra Berlino, Roma, Mosca,
Milano, Parigi, Napoli e quell’«altrove» spesso
dato come luogo d’origine del personaggio romanzesco liberatosi dal mito del ritorno (ormai
solo testimonianza di nostalgia) perché catapultato in un non-luogo rispetto a quello suo di
provenienza e cui è tolta la possibilità di pensare
a un credibile scampo edenico, la terza via corteggiata da Alvaro, sulla quale poteva incontrare
Gioacchino da Fiore, Mattia Preti, frate Barlamo,
Tommaso Campanella…Passava per utopia, e
si coniugava con sradicamento e alienazione e,
una volta approdata in territorio contemporaneo, diventava distopia (Belmoro), incrociando
la «cabala» politica (L’uomo è forte) o l’antistoria
(Memorie di un mondo sommerso). Per lo scrittore si trattava forse di dare soddisfazione all’esigenza di ritrovamento di quei frammenti di etica
da proporre ai propri lettori insinuandoli, come
postulati categorici, negli spazi commentativi o
illustrativi consentiti dallo sviluppo della narrazione, o incarnandoli in figure di personaggi che,
anche per questo, finiscono per somigliarsi spesso tra loro.
(Gennaro Mercogliano, Corrado Alvaro, Rossano, Ferrari Editore, p. 208, € 15,00).
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Scaffale antropologia / storia
G. Botti, Sulle vie della salute. Da speziale a farmacista-imprenditore nel lungo Ottocento a Napoli, Bologna,
Il Mulino, 2008
In un passo del suo Apologia della storia, riprendendo le posizioni di Michelet e di Fustel de Coulanges, M. Bloch ricorda come «l’oggetto della storia [sia]
per sua natura l’uomo. O meglio: gli uomini»1. L’uomo,
colto nella sua dimensione sociale, è il fine ultimo di
una scienza capace di mettere a fuoco tempi e contesti su grande scala, senza perdere di vista quanti in essi
si muovono. Più avanti, infatti, Bloch aggiunge che il
«buono storico somiglia all’orco della fiaba: là dove fiuta
carne umana, là sa che è la sua preda»2.
Proprio su queste premesse si muove Gabriella
Botti nel suo “Sulle vie della salute. Da speziale a farmacista-imprenditore nel lungo Ottocento a Napoli” (edito
per i tipi del Mulino). Attraverso un sofisticato gioco di
piani, la strategia di ricerca induce l’autrice a muoversi
nelle intricate trame della genesi della professione di
farmacista nella Napoli dell’Ottocento. L’analisi storiografica è condotta in frequente correlazione (di cui si
colgono spesso i tratti dissonanti) con altri casi italiani
che hanno anticipato il processo di verticalizzazione
capitalistica e di concentrazione che a Napoli si innescheranno soltanto a Novecento inoltrato. La ricerca,
per affermazione stessa dell’autrice, colma una lacuna:
quella relativa all’assenza, tra gli studi sulle professioni,
della categoria dei farmacisti. La ragione più probabile
rimanda ad una sorta di liminalità del gruppo rispetto
alle convenzionali e codificate strutture ermeneutiche
della categoria lavoro: artigiani, mercanti, professionisti, sono classificazioni diverse che, nel caso dei far
1
2
macisti, confluiscono in una medesima storia. Il lavoro
di ricerca ha consentito all’autrice di cogliere il peso di
un’assenza che si è tramutato in spinta per la ricerca, nel
tentativo riuscito di condurre a sintesi i molteplici contributi storiografici già disponibili (e di cui vi è ampia
traccia nel volume) per costruire, a partire da essi, analisi originali sui tratti evolutivi di una professione mai
compiutamente indagata per il contesto napoletano.
La struttura del volume, organizzata secondo il
duplice corrimano cronologico e argomentativo, si articola per piani ed individua i tratti di un processo di
per sé archetipico dell’ascesa (economica e sociale) della
borghesia napoletana di fine Ottocento. L’origine delle
professioni e il loro determinarsi nei diversi contesti
geografici è un argomento di rilevante interesse poiché
procede in stretta correlazione con le evoluzioni economiche, politiche e sociali, soprattutto tra diciannovesimo e ventesimo secolo, quando il profitto scalza la
rendita e la localizzazione lascia il posto alla dimensione nazionale e sovranazionale. Il mutamento storico tra
ancien régime ed età contemporanea in Italia procede
di pari passo con il lungo cammino dell’industrializzazione, di cui proprio l’avvento della figura del farmacista-imprenditore a Napoli, secondo le analisi della
Botti, diverrà un esempio nitido. In un’ottica di lungo
periodo, il fenomeno è condizionato da eventi epocali
che si muovono sullo sfondo: il passaggio dall’età borbonica all’Italia unita, le trasformazioni economiche
cui la Napoli capitale del Regno è soggetta nel corso
del diciannovesimo secolo, le evoluzioni urbanistiche
e sociali che inevitabilmente da quelle trasformazioni
scaturiscono, gli strati popolari e le élites i cui protagonisti si muovono anche in termini di mobilità sociale, le
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1969, p. 41.
Ibidem.
163
Q
uaderni
strategie familiari che vi sottendono, le storie personali,
tutti elementi di una trama robusta su cui è intessuta la
storia di un’evoluzione.
Su questi quadri di ampio respiro si innestano le
analisi di dettaglio della Botti, che muovono da argomenti apparentemente minori (come lo studio della
formazione di una categoria professionale in un contesto spaziale circoscritto) ma che si mostrano, invece,
profondamente utili per le estensioni concettuali che,
proprio in quelle analisi, trovano conferma o smentita.
In quest’ottica l’autrice articola una ricostruzione storica che radica in numerose fonti d’archivio per ramificare concetti e documentare dettagliatamente mutamenti
in grado di descrivere scenari più ampi.
L’evoluzione della figura del farmacista professionista è attraversata dalle nuove conoscenze in campo
medico; un ripensamento delle scienze sociali affianca
l’innovazione scientifica e così, dalle impellenze della
diagnostica l’asse operativo si sposta sulla terapeutica.
Il processo evolutivo marca il passo di un percorso
tutto culturale che procede dal problema al rimedio:
in questa non secondaria rivoluzione delle modalità di
approccio alla salute (tutta inscritta in un contesto ottocentesco figlio della rivoluzione francese e delle più tarde spinte positivistiche che dell’estrema fiducia nella capacità umana di individuare rimedi aveva nutrito le più
grandi scoperte scientifiche del secolo) allocano anche
le conquiste che in campo medico avevano riguardato
la fisiologia e l’anatomia. La ricerca dei rimedi procede
accanto a queste dinamiche, sospinta da diversi fattori
di cambiamento che hanno portato, già sulle prime, a
determinare la separazione tra la figura del medico e
quella dello speziale-farmacista: sullo sfondo si muovono le grandi conquiste della scienza, come i progressi
compiuti con l’affermazione del metodo anatomo-clinico nella diagnostica e la scoperta degli alcaloidi. A
sostenere il progresso vi è l’avanzare inarrestabile delle
conoscenze in campo chimico, fisico e biologico. Ma
lo studio condotto dalla Botti, nel ripercorrere le tappe evolutive della farmacopea dal periodo borbonico
fino al primo Novecento incrocia anche la storia della
malattia: nell’individuare i rimedi ci si imbatte necessariamente nelle patologie più diffuse o in quelle ritenute
più pericolose, una sorta di “storia nella storia” in cui
meglio si manifesta il lavoro per piani compiuto in questa ricerca.
Così le antiche spezie cedono il passo alle sostanze
chimiche e il farmacista professionista prende il posto
dello speziale: una proporzione matematica che svela il
senso di un’evoluzione emblematica dei grandi processi
economici tra Otto e Novecento.
Ma i filoni di studio che analizzano il lento formarsi
della professione a Napoli, le conquiste nel campo delle
conoscenze scientifiche, le trasformazioni culturali che
164
surrogano l’idea di malattia con quella di salute, aprono
progressivamente alle direttrici sociali ed economiche
del fenomeno. Una dettagliata ricostruzione compiuta
attraverso lo studio dei fondi archivistici notarili, di Stato civile, del Protomedicato e della Prefettura, definisce
i contorni di una storia che apre a risvolti socio culturali (come nel caso del ruolo esercitato dalle comunità
straniere a Napoli), di genere (è il caso della funzione
gregaria delle donne in questa storia, della loro istruzione come della loro inquieta e tarda emancipazione)
ed economici (relativi all’affermarsi dell’impresa farmaceutica).
Il farmacista diviene così il protagonista del quartiere e della città. La sua bottega raccoglie i bisognosi nel
corpo e diviene luogo di confronto politico: al riguardo
la Botti descrive i retrobottega delle farmacie come spazi all’interno dei quali si alimentava la cospirazione risorgimentale che si saldava alla rete liberale in funzione
antiborbonica. L’autrice ricostruisce fatti e vicende della
cospirazione e dei sospetti nei confronti della categoria:
denunce e “soffiate” rinfocolano il contrasto politico e
portano i tutori dell’ordine pubblico a monitorare da
vicino le botteghe di farmacia. Il centro antico della città di Napoli diventa il centro dell’attivismo liberale che
nelle farmacie trova il luogo più adatto per compattarsi.
Protagonisti e vicende legati al risorgimento meridionale svelano il volto nuovo di una capacità di azione che
si fa tutt’uno con la speranza di dare origine al mutamento. Le aspirazioni politiche si saldano a quelle del
riscatto sociale e il professionista che opererà nell’Italia
unita saprà gradualmente risalire i gradini di una gerarchia sociale apparentemente immobile.
La ricostruzione storica del riscatto professionale è
strettamente intrecciata ad un altro interessante filone
che attraversa, in maniera trasversale, tutto il volume:
quello della formazione e dell’istruzione. Gli speziali
prima e i farmacisti poi si formano attraverso un tirocinio pratico nelle botteghe e solo negli anni trenta
dell’Ottocento vedranno il primo tentativo di istituzione di un corso pubblico di studi, propedeutico al rilascio di cedole e privilegi per l’esercizio della professione.
Tuttavia, solo dopo l’Unità il corso di studi comincerà
ad essere organizzato in scuola universitaria di farmacia secondo i modelli europei. È dagli anni Settanta,
infatti, che prenderà il via quel progressivo cambio di
rotta che porterà al rilascio delle prime lauree in chimica e farmacia e al diploma in farmacia. L’excursus si
accompagna anche all’analisi di dettaglio che la Botti fa
per ricostruire, nel tempo, il dispiegarsi degli interventi
normativi su cui si è fondato lo sviluppo del settore e
l’affermazione della figura professionale del farmacista a
Napoli. Significativo, rispetto ad altri casi europei, sarà
il ritardo con cui si giungerà, solo nel 1910, all’istituzione dell’ordine professionale.
antropologia e storia
Il volume, inoltre, trascina il lettore nella Napoli
dell’Ottocento, con il dedalo di vie e di quartieri puntualmente descritti. Un viaggio nello spazio, oltre che
nel tempo, che rappresenta una delle chiavi più suggestive di questo volume: percorrere la Napoli del centro
antico o quella del Vomero è un’operazione felicemente
riuscita e che svela, lungo il suo dispiegarsi, vicende,
nomi, architetture. Un’operazione di puntuale ricostruzione topografica delle vie cittadine accompagna nella
percezione anche simbolica di un’ascesa professionale
replicata nello spostamento delle farmacie e delle famiglie che le possiedono. Il dislocamento verso la parte alta della città costituisce la metafora più eloquente
dell’affermazione di una professione, come quella del
farmacista, destinata a consolidare il proprio prestigio
proprio nel corso del Novecento.
In ultimo, le storie delle grandi famiglie di farmacisti a Napoli (locali e straniere) ricostruite attraverso i
documenti d’archivio e sulle fonti orali raccolte dall’autrice negli anni: Beneduce, Cutolo, Kernot, Berncastel,
/ 1 – donne in armi
Mangiapia diventano altrettante storie di legami e relazioni personali, capaci di rileggere e riconfigurare
spazi sociali come indicatori storici di più lungo periodo. L’evoluzione da speziale a farmacista-imprenditore
nella Napoli dell’Ottocento costituisce, pertanto, un
percorso che rimanda all’agire degli uomini, agli assetti
sociali ed economici, ai complessi mutamenti politici
a ridosso dei quali la storia ricostruita e narrata dalla
Botti si svolge. La nascita della professione di farmacista
nel lungo Ottocento a Napoli allunga però le sue propaggini anche nei primi decenni del secolo ventesimo,
quando la categoria si impone come élite finanziaria e
di potere proprio in virtù di un’egemonia economica e
politica che le opportunità offerte dalla concentrazioni
di matrice capitalistica consentono. Quelle del volume
pertanto, sono vicende di lungo corso che preludono a
fenomeni più ampi e consolidati che arrivano fin dentro
ai giorni nostri.
(D. Verrastro)
165
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Rassegna di studi
G. Gasparello-R. Stefani, Raíces de nuestra justicia, documentario
Il Messico sta vivendo una situazione di violenza
sociale generalizzata senza precedenti. Mentre lo Stato
ha intrapreso una vera e propria guerra contro alcuni
settori della delinquenza organizzata e del narcotraffico,
utilizzando a tal fine la militarizzazione e la sospensione
di diritti civili in tutto il paese, è fondamentale approfondire e diffondere esperienze che, partendo da contesti sociali e culturali diversi dal sistema dominante, cercano di modificare la trama della violenza e disattivarla
senza ricorrere ad una risposta che faccia uso della forza
o della violenza stessa. Questo è il proposito e l’obiettivo
del lungometraggio Raíces de nuestra justicia (Radici
della nostra giustizia, 2014), prodotto dal Centro di Diritti Umani Miguel Agustín Pro Juárez, alla cui realizzazione ho partecipato. Per piú di due anni un gruppo
di difensori di diritti umani ed antropologi abbiamo
documentato diversi percorsi e pratiche di giustizia in
comunitá indigene e non indigene di diverse regioni
del Messico: la zona Norte del Chiapas, la Montaña e
la Costa Chica del Guerrero, il sud di Durango e l’istmo
di Oaxaca.
Storicamente, i popoli indigeni hanno vissuto in
contesti di violenza: violenza di Stato e repressione politica, caciquismo, razzismo, violenza inter e intraetnica,
delinquenza comune, criminalità organizzata, violenza
politica e violenza strutturale. I processi di organizzazione e costruzione di autonomia, ed i sistemi di giustizia come un’espressione di tale autonomia, rappresentano una risposta positiva a queste diverse situazioni di
violenza.
Questo lavoro acquisisce una rilevanza particolare
nell’attuale dibattito sul fenomeno sociale delle autodefensas (“autodifese”, gruppi di civili armati), che nell’ultimo anno si è diffuso in tutto il territorio messicano di
fronte alla minaccia del narcotraffico e la delinquenza
organizzata. Sebbene questo fenomeno possa rappresentare – nel migliore dei casi- una risposta collettiva e
spontanea a fronte di situazioni di violenza insostenibili, ha innescato un meccanismo di cooptazione/criminalizzazione da parte del governo, e ha tolto legittimità
ad altri processi di organizzazione comunitaria. Mentre
le autodefensas sorgono in modo congiunturale per rispondere al problema specifico della sicurezza comunitaria, il quale non è altro che la punta dell’iceberg della
profonda costruzione della violenza attuale e storica, le
esperienze che si raccontano nel lungometraggio svelano le diverse forme in cui i popoli indigeni risolvono
alla radice le situazioni di violenza, prima che diventino
problemi di sicurezza comunitaria o pubblica. Così, se
risaliamo nella successione delle possibili risposte alla
violenza, troviamo la risoluzione dei conflitti e l’amministrazione della giustizia. La risoluzione dei conflitti è
fondamentale, poiché cerca di disattivarli in modo pacifico, per mezzo dell’accordo, la conciliazione e la coscientizzazione delle parti coinvolte. È una costante in
tutte le esperienze di giustizia indigena e interculturale,
di cui ne è il cuore. Ci sono esperienze dirette principalmente alla risoluzione dei conflitti comunitari, come
gli jmeltsa’anwanej-risolutori di conflitti- di Bachajón
(Chiapas), influenzati dal profondo lavoro svolto in tal
senso dalla Diocesi di San Cristóbal de Las Casas e da
organizzazioni civili come la Commissione per la Riconciliazione Comunitaria (CORECO). In altre esperienze,
la conciliazione è parte di un sistema di amministrazione della giustizia più complesso che include anche il
giudizio di coloro che hanno commesso qualche errore,
e la loro rieducazione per mezzo del lavoro comunitario
(socialmente utile), come nella Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias nello stato del Guerrero o
nelle Juntas de Buen Gobierno in Chiapas. In entrambe
queste esperienze si risolvono in maniera autonoma e si
167
Q
uaderni
sanzionano per mezzo della rieducazione anche problemi gravi come l’omicidio, la violenza sessuale o il traffico
di droga e migranti. Nelle società indigene, in termini
generali, non troviamo la pena carceraria come castigo,
se non per tempi brevi (8 o 12 ore, nei casi degli ubriachi
molesti). In molti paesi europei, i sistema giudiziari si
sono modificati in tempi recenti incorporando la mediazione e le pene alternative al carcere, recuperando
forme che sono sempre state predominanti nelle societá
indigene dell’America Latina.
Questi sistemi di giustizia o di risoluzione dei
conflitti, vigenti nelle regioni indigene e interculturali,
non presentano le caratteristiche congiunturali delle
autodefensas, al contrario: affondano le proprie radici
nelle strutture organizzative dei popoli, nei collettivi e
commissioni che articolano la vita comunitaria, come
viene spiegato dalle autorità ayuuk (o mixes), un popolo con una lunga tradizione autonoma e comunitaria. Le giustizie “autonome” non sono necessariamente
“ancestrali”, sono piuttosto molto innovatrici, ma sono
radicate nelle strutture assembleari e nei meccanismi
decisionali collettivi; la loro giustizia è poi esercitata da
autorità collegiate, mai da una sola persona, che devono
rispondere delle loro decisioni alla comunità che le ha
elette. Stiamo dunque parlando di una giustizia vicina
alla gente, che riflette valori e norme che le persone capiscono e condividono perché fanno parte della propria
cultura e sono e vigenti nella vita quotidiana. Questo
è il secondo elemento sottolineato da tutte le esperienze raccolte nel documentario, l’abissale differenza della
giustizia propria, basata sulla ricerca della conciliazione e su norme condivise, e la giustizia ufficiale o dello
Stato, che viene invariabilmente definita come corrotta,
ingiusta, inaccessibile e incomprensibile. La denuncia
della corruzione e della mancanza di attenzione verso
la popolazione indigena da parte delle autorità statali
incaricate di amministrare la giustizia è un dato importante che emerge dal lungometraggio. Pur mostrando
una situazione preoccupante, tale denuncia dimostra
anche una profonda conoscenza dei propri diritti ed
una forte determinazione a rivendicarli, lottare per ottenerli e costruirli nella pratica quotidiana.
In questi mesi si sta preparando, secondo le dichiarazioni del Commissario per il Dialogo con i Popoli
Indigeni Jaime Martínez Veloz, una “iniziativa di gran
profondità” che dovrebbe riprendere gli Accordi di San
Andrés ed armonizzare, in termini di diritti indigeni,
la legislazione messicana con i trattati internazionali.
Perché tale iniziativa non sia, come d’abitudine, solamente cosmetica, sarà fondamentale il riconoscimento
pieno del diritto e delle pratiche di autonomia. In tal
dibattito, ciò che si racconta e si denuncia in Raíces de
Nuestra Justicia dovrebbe occupare le autorità riguardo
all’urgenza non solamente di rispettare, finalmente, gli
168
Accordi di San Andrés ma anche di combattere la corruzione, l’ignoranza ed il razzismo che caratterizzano
il sistema giudiziario in tutto il Messico e che, senza
dubbio, rappresentano per i popoli indigeni il principale ostacolo all’esercizio del proprio diritto alla giustizia.
Il documentario completo è disponibile all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?=IZO7UW
uDT0M e la versione corta (8 min.) all’indirizzo: https://
www.youtube.com/watch?v=vCB1gpg-0C0.
(G. Gasparello)
Franco Cardini, In Terrasanta; pellegrini fra medioevo e
prima età moderna, Bologna, Società Editrice il Mulino,
2007, p. 544
Il testo di Cardini espone dettagliatamente il senso
del viaggio come percorso individuale e collettivo, interiore ed esteriore, che termina col raggiungimento di
una meta. I pellegrinaggi cristiani verso la Terrasanta,
in epoca medievale, vedono al centro la figura del pellegrino; colui che è caratterizzato dallo “status viatoris”, e
raccoglie le sue memorie di volta in volta per realizzarne una cronaca. I viaggi cristiani affondano le loro radici almeno in due tradizioni differenti; la aliyah ebraica
(la salita verso Gerusalemme) e il viaggio greco-romano al santuario. Durante gli spostamenti nella Terrasanta, il pellegrino poté servirsi di sostanze oniropoietiche per enfatizzare attraverso la percezione dei sensi
il contatto con gli elementi sacri. La prima spedizione
massiccia di pellegrini diretti in Terrasanta avvenne
sotto Costantino, periodo storico in cui fu consentito
praticare liberamente il culto cristiano. Tali viaggiatori,
che partivano ogni anno, erano spronati da una curiosità devozionale, lo stesso spirito con cui si muovevano
a caccia di reliquie nelle “cerche”. Tale periodo vide il
trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli;
quindi la dislocazione dell’interesse culturale collettivo
sulla zona delle coste asiatiche del Mediterraneo – che
congiuntamente all’area geografica orientale, all’epoca
dominata dall’impero romano –, era una zona ricca di
tradizioni. Sorse, così, un nuovo genere letterario detto
memorialistico, tecnicamente formato dalle cronache
sugli Itineraria in Terrasanta. Il “peregrino”, che al ritorno del viaggio recava con sé reliquie di ogni tipo,
diveniva incettatore di pignora sacra; costui si serviva
delle memorie di viaggio di altri pellegrini per ottenere
le indicazioni sulle distanze da percorrere e le città in
cui fermarsi. Il primo racconto di viaggio ci è pervenuto dall’anonimo di Bordeaux: si tratta dell’itinerario
burdigalense, e narra dei percorsi palestinesi, ripercorrendo le memorie del Cristo attraverso l’excursus nei
antropologia e storia
luoghi sacri. Cardini sottolinea come i pellegrinaggi
cristiani abbiano gettato le basi per la istituzione del
modello moderno di città-santuario diffusosi a Roma e
in Oriente. Tuttavia, a ridosso dei secoli VII e X Roma
e Gerusalemme sperimentarono una fase di crisi, e la
pratica del pellegrinaggio fu riformulata. Il primo pellegrinaggio di cui si hanno memorie è di Santo Brasca
(funzionario ducale di Milano, e ambasciatore di Ludovico il Moro) che s’imbarcò su una nave partita da
Venezia verso Gerusalemme. A questa spedizione parteciparono molti fra artigiani e mercanti. Sembra che il
Brasca fosse stato guidato nelle “cerche” dai francescani
del Sion, osservando da vicino i costumi dei valligiani
fra l’aprile e il novembre 1480. Con l’utilizzo da parte
dei viaggiatori di determinate vesti di viaggio, delle
quali il Brasca fa dettagliata descrizione ne Les Mémoires du Voyage, si rafforza l’idea del viaggio medievale
come esperienza umana mistico-liturgica, praticata anche nel contesto musulmano, che in quel periodo, aveva
dato avvio ad un processo di pacificazione col mondo
cristiano. Cardini evidenzia, inoltre, come la narrazione delle memorie di viaggio fosse dipesa soprattutto dal
livello di preparazione del pellegrino. Il periodo delle
partenze variava da aprile all’inizio dell’autunno, ma il
viaggio completo era suddiviso in fasi distinte, ognuna
relativa alla propria marcia, dal luogo di origine al luogo d’imbarco, o dalla marcia attraverso il mare verso la
Terrasanta, oppure dalla rotta del Mar di Levante alle
coste italiche. Le imbarcazioni, o più propriamente galee, di proprietà dei pirati erano alternate alla Pola, nave
dalla forma tondeggiante con capacità di trasporto di
sessanta uomini fra balestrieri e marinai. Mentre la galea, che aveva sostituito la trireme romana, era veloce e
di legno sottile, come si evince dal termine di derivazione greco-bizantina e significa pesce spada, per il richiamo al numero cospicuo di remi, e per la forma oblunga.
Santo Brasca rimase in Terrasanta per circa venti giorni,
e riuscì a rientrare in Italia nello stesso anno, poco prima che cominciasse l’autunno, facendo tappa a Giaffa
il venti luglio e dopo circa otto giorni a Gerusalemme,
infine a Betlemme verso il Giordano e la Betania. L’analisi di Cardini sul fenomeno dei viaggi mistici come
manifestazioni della realtà è rivolta anche agli aspetti
materiali, quindi, agli itineraria commerciali lungo la
Costa orientale del Sinai, del mercato indiano di per
sé florido, produttore ed esportatore di stoffe pregiate
e tessuti. Nei documenti del XIII secolo lasciatici dal
da Uzzano è evidente che dall’Italia del Nord partissero
continue esportazioni di tessuti. L’equipaggiamento e il
vestiario tardo trecentesco del pellegrino era costituito
dalla veste, il bordone, e la bisaccia come mostrano le
stampe sui documenti: “Ch’el porta due borse seco, una
/ 1 – donne in armi
ben piena de patientia, l’altra che habia ducento ducati
venetiani”. Nessun accenno da parte sua circa i periodi di pestilenza più frequenti e temuti dai viaggiatori a
causa delle condizioni precarie tipiche del viaggio. Gli
scritti sulle esperienze di viaggio erano tanto più dettagliati quanto maggiore era la cultura del viaggiatore, e
variavano in base alle disponibilità economiche, da cui
la possibilità di navigare su imbarcazioni più confortevoli e veloci, o fermarsi lungo il percorso su più tappe.
Le reliquie provenienti dall’Occidente erano associate
soltanto alle notizie che i viaggiatori diffondevano di
esse. La Santa Croce assieme alla corona di spine era ancora considerata fra le reliquie la principale, mentre ai
riti e alle icone sacre venivano conferiti poteri di operare miracoli, come la tradizione di immergersi nelle acque del Giordano per guarire dalle malattie. Dopo aver
percorso il libro a tappe, quasi come fosse un viaggio,
fra le pagine è possibile avere una visione d’insieme, tale
per cui l’autore ha inquadrato il pellegrinaggio non solo
come fenomeno di massa relativo ai credi religiosi, ma
come espressione individuale e trasversale di fede. In
particolar modo, come riportato dal San Severino nelle
sue memorie: “Tuti li mori turchi et che tengono la lege
di Machometo, hano prima per loro principale chiesa
il templio di Salomone che è in Ierusalem, et Sancto
Abram et La Mecha, tuti sono ubligati visitare ognuno
de questi predicti lochi almancho tre volte”. Nella visione prospettica della concezione medievale il credente
musulmano era visto come un cristiano capovolto, che
aveva abbandonato la fede cristiana, dalla quale si era
sentito rinnegato. La presenza musulmana in Spagna,
infatti, frenava l’identificazione occidentale con la Cristianità: nozione, questa, scomoda per i cristiani stessi.
Concludendo, dal saggio emerge che ai viaggi medievali di carattere sacro era propria un’ambivalenza di
fondo (collettiva e individuale); il senso del fenomeno
di massa era espresso in termini di spostamento pratico,
che portava, quindi, gli uomini a viaggiare sulle navi in
maniera collettiva, mentre, il senso dell’individualismo
era connesso alla descrizione dei luoghi sacri, che veniva affrontata in maniera soggettiva, in modo tale che
ciascun pellegrino potesse fotografare in funzione della
sua anima il luogo e trasmetterne l’immagine che sentiva propria. Questa modalità di approccio al culto ha
gettato le basi per il consolidamento del sapere cristiano
in Europa, un sapere che di lì a poco sarebbe divenuto
predominante, sebbene portasse ancora tracce di paganesimo. Di fatto, esso ha svolto una funzione essenziale
nella costruzione della sfera politica religiosa, economica, militare e amministrativa medievale.
(O. Paesano)
169
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Notiziario
Libri/Eventi
Un convegno e una iniziativa per la maschera di Pulcinella
A Laurino si è svolto il 19 settembre 2014 il Convegno “Il Burlone Divino”, organizzato dal Comitato promotore per
la valorizzazione della maschera di Pulcinella come bene immateriale dell’umanità. L’incontro è servito a illustrare le
motivazioni che hanno spinto gli ideatori dell’iniziativa a creare le condizioni per sostenere la candidatura della maschera
come bene immateriale dell’umanità riconosciuto e protetto dall’UNESCO. Il Convegno è stato curato da Domenico
Scafoglio, già ordinario di Antropologia all’Università di Salerno, la psicologa Sandra Maragno, Amministratore della
SeleFor, Simona De Luna, ordinaria di Antropologia, direttrice del Laboratorio antropologico dell’Università di Salerno.
Figura universale e al tempo stesso incarnazione etnica, campana ma anche italiana e perfino mediterranea ed europea,
di un grande archetipo culturale presente in analoghe forme su scala pnetaria, Pulcinella nella sua storia plurisecolare ha
trovato la sua comunità d’origine e d’elezione in Napoli e nella Campania, che per questa ragione – in sintonia con quanto
richiesto dal regolamento UNESCO per l’individuazione e il riconoscimento delle “comunità prototipo” abilitate a sostenere le candidature – hanno tutte le caratteristiche per diventare titolari dell’importante iniziativa.
Presente in quasi tutti i generi teatrali tradizionali popolari, semipopolari e colti – la Commedia dell’Arte, la Commedia “ridicolosa”, il teatro delle maschere, l’opera buffa, il teatro di figura, il balletto, il teatro di strada e così via – Pulcinella è stato ed è ancora una figura centrale del Carnevale, con straordinarie varianti locali, nelle quali si è espressa
per secoli la creatività e l’identità del genius loci; è diventato un tema letterario e musicale, attraverso cui la comunità
elettiva ha riflettuto sui grandi temi della vita, della morte, dell’amore, con ironia e filosofia, trasgressione e saggezza.
La maschera ha assunto nel tempo le caratteristica delle figure totemiche, radicandosi profondamente negli usi e nelle
tradizioni culturali, religiose e magiche del territorio, dove è tuttora presente come folklore vivente, dotato di una
vitalità tutt’altro che “residuale”.
Come si legge nel comunicato che presenta l’iniziativa, la comprensione di Pulcinella presenta tutte la complessità
dei fenomeni solo apparentemente semplici: alcuni dei personaggi più importanti della cultura occidentale, come Goethe, Kerenij, Jung, Lacan, a questa maschera hanno dedicato pagine che hanno fatto luce sullo spessore che la risata
pulcinellesca nasconde e rivela: con qualche esagerazione, Alessandro Fontana ha scritto che Cristo e Pulcinella, spesso
associati nelle rappresentazioni e nelle narrazioni, “appaiono come le figure costitutive della scena simbolica italiana,
allo stesso modo in cui Dioniso e Apollo, secondo Nietzsche, lo erano per la scena greca”.
Questi ed altri temi sono stati oggetto di discussione nel Convegno di Laurino con interventi di Scafoglio e De
Luna, insieme a Antonio Fava, uno dei protagonisti del revival della Commedia dell’Arte: temi che si sono intrecciati
con la discussione – avviata e approfondita da Annamaria Amitrano, ordinaria di antropologia all’Università di Palermo – sui risvolti economici e sugli effetti positivi che potrà avere la valorizzazione della maschera come bene culturale
sull’immagine e sulla promozione del territorio.
Congresso Internazionale a Morelia sulle Poéticas de la Oralidad
Dall’1 al 4 giugno 2014 nella sede dell’UNAM ENES di Morelia si è svolto il primo convegno internazionale su
Poéticas de la oralidad. Questo il vasto e ricco programma delle attività:
Inauguración, con Ken Oyama, Mariana Masera, Berenice Granados, Santiago Cortés y Lori Garner; Conferencia
inaugurale, Martin Lienhard (Universidad de Zurich) “La performance oral, los contextos y el cine”, presenta Ken Oyama
Prima sessione: Palabra y memoria, modera Santiago Cortés. Interventi di Carlos Huamán (Centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM) “Oralidad y memoria en la poesía cantada del mundo andino perua-
171
Q
uaderni
no contemporáneo”; Eliana Acosta (DEAS-INAH) “El lugar del tiempo. Apuntes desde la etnografía sobre el vínculo
entre palabra, voz y memoria”; María del Carmen Díaz Vázquez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
“Oralidad y memoria en el relato autobiográfico”; Daniel Gutiérrez Rojas (El Colegio de México) “Oralidad y transmisión de conocimientos”; Juan Manuel Mendoza (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) “Historia oral
y reflexividad. Tres testimonios de la historia agraria uruapense”; Andréa Betânia da Silva (Universidade Federal da
Bahia) “Entre acordes de viola e fios da memória: a cantoria de improviso brasileira e seu caráter”.
Seconda sessione: La palabra y su función social, modera Caterina Camastra. Interventi di Luciana Hartmann
(Universidad de Brasilia) “Miedo y encanto en narrativas orales contadas por niños”; Ana Zarina Palafox Méndez (Becaria del FONCA) “La mujer y la décima: introspección, autoconocimiento y sonoridad”; Miguel Nenevé y Simone de
Souza Lima (UFAC y UNIR) “Descolonizar a língua portuguesa – uma leitura da oralidade e da memoria em Mia Couto”; Martha Itzel Pineda Vázquez (Academia Mexicana de la Lengua) “Cantos de sanación de lo sagrado femenino”;
Olivier Le Guen (CIESAS) “La poética cotidiana del maaya t’aan. El uso de la morfología expresiva en maya yucateco”;
César Hernández Azuara (Universidad Iberoamericana) “La comida tradicional en las coplas del son huasteco como
parte de su identidad”.
Lezione magistrale: José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá de Henares) “Poéticas de la oralidad”; presenta
Claudia Carranza.
Terza sessione: Gesto e imagen, modera Olivier Le Guen. Interventi di Carolina Odone Correa (Pontificia Universidad Católica de Chile) “San Antonio, desde los retablos de las capillas de San Pedro Estación (Cuenca San Pedro-Inacaliri, II Región, Antofagasta, Chile)”; Mercedes Martínez González (ENES Morelia, UNAM) “Oigo y veo, luego
proyecto. La importancia de la etnografía en el proceso de diseño”; Martha Ribeiro (Universidade Federal Fluminense)
“Memória, experiência e ritual no trabalho do performer: o workcenter de Grotowski e Thomas Richards”; Edilene
Diaz Matos (Universidade Federal da Bahia) “Corpo e voz: teatralidade das poéticas orais”; José Alfredo López Jiménez
(CIESAS, Sureste) “Entre gestos y narraciones tzotziles de pistik”; Ilia Alvarado Sizzo (ENES Morelia, UNAM) “La hacienda y el ejido en el imaginario popular de Nueva Italia”; Proyección de video documental Unas mujeres que décimas
dicen Ana Zarina Palafox (FONCA).
Secondo giorno: Lezione magistrale Aurelio González (El Colegio de México) “La oralidad, conservación y variación poética en la tradición oral”, presenta Cecilia López Ridaura.
Prima sessione: Fiesta, música y danza, modera Claudia Carranza. Interventi di Jorge Amós Martínez Ayala (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) “Cuadros de castas en coplas cantadas. Los estereotipos raciales en la
lírica tradicional de la Tierra Caliente”; Grissel Gómez Estrada (Universidad de la Ciudad de México) “Tres versiones
de la chilena que se llama La malagueña curreña”; Miriam R. Torres Carrillo (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
“La oralidad en la obra de Jack Kerouac y su traslado a la música popular”; Agustín Rodríguez Hernández (ITESM
Campus León) “La controversia de este siglo: Yeray y Pimienta a ritmo de arribeño”; Leidys Estela Torres Samudio
(Universidad de Chiriquí, Panamá) “Tradición y presente de la décima cantada en Panamá”; Raúl Eduardo González
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) “Los estribillos en las canciones folclóricas”.
Seconda sessione: Artes verbales en medios masivos, modera Raúl Eduardo González. Interventi di Rodrigo Bazán
Bonfil (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) “Poeticantológica: lírica popular, medios masivos y mecanismos
de consagración”; Raúl Casamadrid (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) “Verosimilitud y variación
en los diálogos del cine de oro mexicano (1948-1954)”; Tania Espinales Correa (Universidad Nacional Autónoma de
México) “Las formas del humor en las canciones de Chava Flores Artes verbales en medios masivos de comunicación”;
Claudia Carranza Vera (El Colegio de San Luis) “La risa en la red. Reflexiones en torno a la narrativa oral que circula
en la web”; Martha Isabel Ramírez González (El Colegio de San Luis) “El motivo del baile con el diablo: su presencia en
un contexto multimediático de transmisión”.
Lezione magistrale: Gloria Chicote (Universidad de La Plata, Argentina) “La literatura popular en Iberoamérica:
de la tradición a la globalización”; presenta Mariana Masera.
Presentación de proyectos de investigación; modera Edith Negrín. Interventi di Proyecto Vanegas Arroyo (Instituto
de Investigaciones Filológicas, UNAM) Grecia Monroy (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM), “Impresos y poéticas
populares”; Mariana Masera, Briseida Castro (ENES Morelia / Facultad de Filosofía y Letras, UNAM), Crónica de un
hallazgo y sus viscisitudes”; Rafael Bolívar y Adrián Olvera Hernández (Facultad de filosofía y Letras, UNAM), “Base
de datos y portal electrónico”.
Terza sessione: Escritura y oralidad, modera Bernardo Pérez. Interventi di José Alejos García (Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM) “Estética de la literatura oral indígena”; Marcelo Alejandro Garrido Monroy (Universidad Católica de Temuco, Chile) “La historia de un caballo muerto bajo la lluvia que no interesó a nadie”: la oralidad
como memoria absoluta y precaria en El auriga Tristán Cardenilla de Alfonso Alcalde”; Luz María Lepe (Universidad
172
antropologia e storia
/ 1 – donne in armi
Autónoma de Querétaro) “Oralidad/Oralitura. Relaciones de la voz con la escritura en la literatura indígena”; Raquel
Iglesias Plaza (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) “Intertextos de canciones tradicionales infantiles
en la novela El circo que se perdió en el desierto de Sonora, de Miguel Méndez”; Anastasia Krutitskaya (ENES Morelia,
UNAM) “La Oración del Santo Sepulcro en la Nueva España del siglo XVII”; Lilia Álvarez (El Colegio de San Luis)
“La leyenda del juego de barras o la leyenda del juego de las varas: relaciones entre relatos populares inquisitoriales y
registros orales del Valle de San Francisco, S.L.P”.
Terzo giorno: lezione magistrale Alfredo López Austin (Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM) “El
género mítico en el contexto literario mesoamericano”, presenta Berenice Granados.
Prima sessione in Cosmovisiones: modera Sue Meneses Eternod. Interventi di Michela Craveri (Universidad Católica de Milán) “Cuenta la escritura de la cueva, la escritura de la barranca de Tulan: oralidad y poesía en los títulos de
tierra del área k’iche’”; Danieli dos Santos Pimentel (Pontificia Universidade Católica do Río Grande do Sul) “O mito
da Cabeça voadora no imaginário de povos indígenas da Amazônia”; Berenice Granados (ENES Morelia, UNAM),
“‘Nosotros lo sembramos de nuevo’: aproximación a las caras de la muerte en la tradición oral purépecha”; Víctor Hernández Vaca (Universidad de la Ciénega) “Kuatsokoro: el arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música
y la danza”; Ignacio Silva Cruz (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) “Huehuetlahtolli: la “palabra antigua” en Diego
Durán y Alvarado Tezozómoc”; Danira López Torres (El Colegio de San Luis) “Pecado y desorden: confesión o muerte
mediante rezos y velas negras”.
Seconda sessione: Formas rituales, modera Martin Lienhard. Interventi di Cecilia Jaime González (Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM) “El deseo de lanzarse al mar por amor… Un ritual que permanece”; Jahzeel Aguilera Lara
(ENES Morelia, UNAM) “El ciclo ritual y la narrativa tradicional en la comunidad nahua de Acatlán, Guerrero”; Gloria
de Jesús Rosas (UIIM), Sue Meneses Eternod (ENES Morelia, UNAM) “Discursos ceremoniales de la boda purépecha
en Cuanajo”; Alejandro Martínez de la Rosa (Universidad de Guanajuato, Campus León) “Los parabienes. Tradición,
palabra y música para despedir angelitos”; María del Carmen Orihuela Gallardo (Posgrado en Estudios Mesoamericanos, FFyL, UNAM) “La palabra como cuerpo de seres de viento. Discurso ritual de los mayas de Nunkiní, Campeche”;
Renzo Aroni Sulca (Universidad de Davis, CA) “Carnaval de Accomarca: música, canto y memoria de una masacre
en el Perú”.
Lezione magistrale: Gonzalo Espino Relucé (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) “Willlanakuy
willanakuy kasqan/ Cuento es cuento”, presenta Luz María Lepe Presentación de proyectos de investigación, modera
Víctor Hernández Vaca.
DARP: un prototipo digital para la presentación de poesía ritual (INAH) di Ernesto Miranda; Laboratorio de
Materiales Orales (ENES Morelia, UNAM) di Santiago Cortés y Berenice Granados; Oralidad y escritura. Experiencias
desde la literatura indígena (Universidad Autónoma de Querétaro) di Luz María Lepe.
Quarto giorno: Presentación de proyectos de investigación.
Prima sessione: modera Michela Craveri, Estudios del wixárika o huichol (Departamento de Estudios en Lenguas
Indígenas, Universidad de Guadalajara); Interventi di Paula Gómez López, “Intuiciones sobre oralidad y escrituralidad
de hablantes de wixárika”; Julio Ramírez de la Cruz, “La crónica histórica en la cultura huichola”; José Luis Iturrioz
Leza, “La escrituralidad antes de la escritura”; Corpus Michoacano del Español (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Universidad de Guadalajara); Bernardo Pérez Álvarez (UMSNH),“Aportes metodológicos de un
corpus oral en lingüística”; Susana León Ambriz (UMSNH), “Consideraciones lingüísticas para el análisis de narraciones orales: Conversaciones con ex braceros”; Gabriela Patiño Sánchez (U. de G.), “Gramática y oralidad: el uso de
quedar(se) en la oralidad”.
Lezione magistrale: Domenico Scafoglio (Università di Salerno) “Antropología y literatura escrita y oral: cuestiones teóricas y de método”; presenta Caterina Camastra.
Seconda sessione: Presentación etnopoética, modera Enrique Flores. Interventi di Dennis Tedlock (State University
of New York at Buffalo) “Sonidos y silencios en los cuentos orales”; Serge Pey (Poeta) “Performance etnopoética”.
“Ethnologie française” (ottobre 2014) sull’ “Ethnologie du littéraire”
La nota rivista francese pubblica negli atti del convegno di Metz dedicato ai rapporti tra l’antropologia e la letteratura gli interventi di J.-M. Privat, L.F. Fournier, D. Scafoglio, M. Chapdelaine, A. Lesne, G. Bois, A. Kéfa, S. Menard,
M.-C. Vinson, M. Scarpa, A.D. Alter, M.N. Craith, U. Hockel. Questo l’annonce, curata dalla redazione, dell’iniziativa:
“Entre l’ethnologie et la littérature les relations sont multiples: expressions littéraires dans la société, production, médiation et réception des textes, univers symboliques et rhétoriques propres aux cultures. Une ethnologie du littéraire,
173
Q
uaderni
c’est aussi l’étude des manifestations publiques définissant «la chose littéraire»
au sein de micro-univers sociaux et symboliques. Ce numéro traite du rôle des
oralités lettrées, exprimées à l’occasion de salons du livre, de soirées conteuses
et de réappropriations festives locales de héros littéraires.
Si Ethnologie française a publié de nombreux travaux sur la littérature,
c’était le plus souvent à propos de corpus à dominante de littérature orale. Cette livraison étend le champ à l’analyse ethnocritique de la modernité littéraire.
L’ethnocritique s’intéresse aux jeux incessants à l’œuvre dans le texte entre des
formes plus ou moins hétérogènes de cultures orale et écrite, folklorique et
officielle, religieuse et profane, féminine et masculine, légitime et illégitime,
endogène et exogène, attestée et inventée, etc. Il s’agit d’une démarche critique
en devenir et ce numéro s’aventure ainsi à explorer les systèmes ethno-sémiotiques de grands textes littéraires, la poésie de Baudelaire, le théâtre de Koltès,
le roman (Flaubert, Comtesse de Ségur, Hélène Cixous).
Enfin, le numéro propose une dimension comparative pour cartographier
les relations institutionnelles, scientifiques et symboliques que différents pays établissent entre études culturelles et
études littéraires, révélant l’image particulière que chaque pays (et chaque langue) conçoit de sa propre littérature.
174