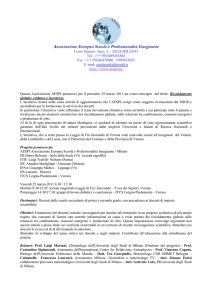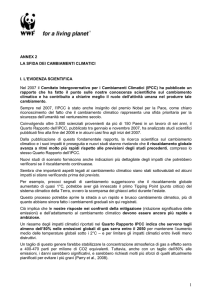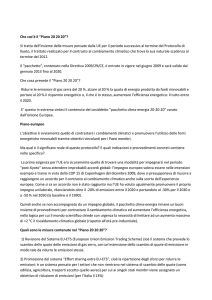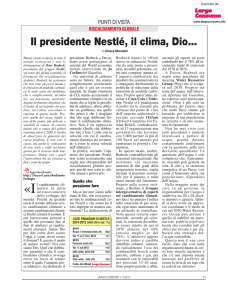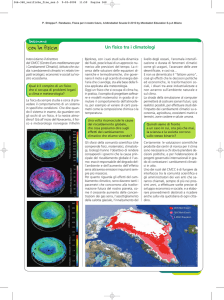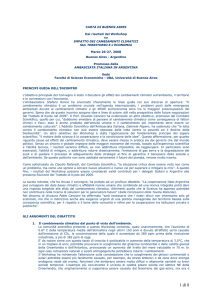donne in difesa dell'ambiente
Emergenza ambientale, crisi climatica e ruolo delle donne
nei processi di articolazione sociale e di difesa dei territori
DONNE IN DIFESA DELL'AMBIENTE
Emergenza ambientale, crisi climatica e ruolo delle donne
nei processi di articolazione sociale e di difesa dei territori
A cura del CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
www.cdca.it
Contributi di:
Miguel Angel de Porras Acuña
Maria Marano
Lucilla Salvia
per il focus tematico
Giulia Dakli
Isotta Carraro
per il focus di genere
Coordinamento e realizzazione editoriale a cura di:
Marica Di Pierri – presidente CDCA
Lucie Greyl – coordinatrice CDCA
Laura Greco – responsabile progettazione CDCA
2012, Edizioni CDCA
Largo Gassman Roma
tel/fax. 06.36003373
Si ringrazia Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle Elette del Comune di Roma per il
sostegno al lavoro del CDCA e il pluriennale impegno a difesa dei diritti delle donne e
dell'ambiente.
Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto “DIDA Donne in Difesa dell’AmbienteFormazione di giovani volontarie e realizzazione di una pubblicazione su difesa delle foreste,
cambiamento climatico e ottica di genere”, con il contributo della Commissione delle Elette del
Comune di Roma.
Opera riproducibile a fini divulgativi e didattici a patto di citarne correttamente la fonte.
SOMMARIO
PREFAZIONE
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
FOCUS TEMATICO
IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL CLIMA
1. DA RIO A DURBAN PASSANDO PER KYOTO. DOVE CI HA PORTATO LA GOVERNANCE GLOBALE
2. LE SOLUZIONI DELLA GOVERNANCE
3. IL FINANZIAMENTO INTERNAZIONALE DELLE MISURE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
4. REDD: FUOCO SULLE FORESTE
5. FORESTE E AGRICOLTURA: SOTTO LA MINACCIA DEI CDM?
6. LA SFIDA DELLE MIGRAZIONI
7. VERSO LA GIUSTIZIA CLIMATICA
FOCUS DI GENERE
RUOLO DELLE DONNE NELLA PREVENZIONE, L’ADATTAMENTO
E LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
1.GLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA CONDIZIONE DELLE DONNE
2.RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLE DONNE DA PARTE DELLA GOVERNANCE GLOBALE
3.DONNE COME AGENTI DEL CAMBIAMENTO
4.CASISTICA
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
1. Prefazione
Il fenomeno degli sconvolgimenti climatici rappresenta oggi la principale minaccia alla
sopravvivenza umana sulla Terra. Una minaccia seria, riconosciuta ormai dall’intera comunità
scientifica e che si sta già abbattendo sulla vita quotidiana di tutti noi.
Il mese di ottobre dello scorso 2011 è stato il più caldo dal 1880. Il National Climatic Data Center
del National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA), organo del Dipartimento di
Commercio degli Stati Uniti, ha registrato nel periodo tra gennaio e ottobre 2011 un aumento della
temperatura sulla superficie della Terra pari a +0.85° (+ 0,53° di aumento medio sulle temperature
medie del suolo e dei mari) rispetto alla temperatura media del secolo scorso. Secondo
l’Osservatorio di Mauna Lao del NOAA, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera oscilla
attualmente intorno a 390 parti per milione (ppm) e nelle ultime decadi si è registrato un aumento
continuo dei livelli di concentrazione di CO2, che sono passati da +0.88 ppm annuali nella decade
1961-1970, a +2.04 ppm annuali nella decade 2001-20101. Tenendo in considerazione che a 350
ppm corrisponde il livello massimo di concentrazione delle emissioni per limitare l’incremento
delle temperature a +1.5°, un aumento da considerare già molto pericoloso, la tendenza è realmente
preoccupante. Sappiamo ormai che un aumento di + 2° della temperatura significherebbe
incrementare del 50% l’irreversibilità dei danni provocati.
L’allarme è stato lanciato anche dall'ultimo rapporto dell’IPCC, l’Intergovernmental Panel
on Climate Change dell’ONU2, il quale conferma che i disastri meteorologici e climatici causati
dalle attività umane stanno aumentando. Sono infatti sempre più numerosi i casi di siccità e di
inondazioni; i ghiacciai si sciolgono rapidamente causando l’innalzamento del livello dei mari e il
dissesto idrogeologico; gli inquinamenti chimici provocano l’acidificazione degli oceani; le zone
forestali – in particolare quelle tropicali – si riducono; si modificano i cicli bio-geo-chimici
dell’azoto e del fosforo, l’insicurezza nella produzione alimentare e nell’accesso al cibo avanza, la
biodiversità si riduce con un 20-30% delle specie a rischio di estinzione e il fenomeno delle
migrazioni ambientali assume risvolti via via più drammatici. Entro la fine del secolo si prevedono
tra i 200 milioni e 1 miliardo di persone costrette a lasciare le loro terre di origini per cause
ambientali.
Eppure è evidente che, nonostante la gravità della situazione, non si è ancora sviluppata,
soprattutto da parte dei governi, una reale presa di coscienza sui rischi che corriamo. Dopo
diciasette anni di negoziazioni internazionali, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera continua ad
aumentare, gettando benzina sul fuoco del surriscaldamento del pianeta. In questa drammatica realtà
1
2
Tutte le statistiche del National Climatic Data Center del NOAA sono disponibili sul sito:
http://gis.ncdc.noaa.gov/map/ncs/?thm=themeTemp
IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4), disponibile sul sito:
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf
6
le responsabilità delle politiche economiche e di sviluppo dei governi nazionali e delle
organizzazioni
internazionali sono alte. I meccanismi di negoziazione classici, rispetto alle
soluzioni e alle proposte sviluppate e sostenute dal mondo della ricerca e dalla società civile, stanno
dimostrando una sostanziale inadeguatezza a far fronte alla sfida rappresentata dal clima. Una sfida
che ci impone un ripensamento profondo del modello di società e di economia, consapevoli della
responsabilità che il sistema attuale ha nell’esplosione della crisi ambientale e climatica.
Piuttosto che concentrarsi sull’analisi dei contenuti, dello sviluppo e dell’implementazione di
proposte valide, le potenze che hanno diretto sin qui le negoziazioni sul clima hanno impiegato i
loro sforzi nel disegnare possibili forme economiche e finanziarie delle misure di mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico, confermando ancora una volta il ruolo chiave del mercato
economico e finanziario nel guidare le politiche internazionali.
Conclusosi da poco il 2011, l’anno internazionale delle foreste, preme sottolineare la
preoccupante situazione delle aree forestali del pianeta e va sottolineato che la sola deforestazione
partecipa per un quinto alle emissioni globali di gas serra. Nel corso del secolo scorso abbiamo
assistito ad un inesorabile processo di degrado e distruzione delle foreste, accelerato negli ultimi
decenni dagli impatti della corsa all’accaparramento delle risorse e al consumo del territorio, che
hanno portato alla costruzione di megaprogetti, allo sviluppo di attività estrattive, all’avanzamento
dell’urbanizzazione, all’inquinamento e agli sconvolgimenti climatici prodotti dalle attività umane.
La velocità del processo di deforestazione del pianeta è marcata, da un lato, dalle debolezze e
dall’inadeguatezza delle politiche di riforestazione, di ripristino e di conservazione delle foreste
poco vincolanti, ma, allo stesso tempo, anche dagli stessi Meccanismi di Sviluppo Pulito (CDM).
Meccanismi pensati in origine per proteggere le foreste, ma che, utilizzati estensivamente, hanno
permesso il riconoscimento di molte colture forestali (e monocolture) altamente distruttive per
l’ambiente quali soluzioni al cambiamento climatico. Le foreste sono inoltre messe a rischio in
molte zone del mondo dall’incidenza dei cambiamenti climatici e dai fenomeni meteorologici
estremi. Sempre più frequenti, infine, sono i casi di aggressione da parte di insetti, malattie e
incendi. Il ruolo delle foreste, che ricoprono il 10% della superficie del pianeta e contengono il 60%
della biodiversità globale, è essenziale per la stabilità del clima globale e quindi per la nostra
sopravvivenza. Distruggere le foreste implica limitare il potenziale di cattura di CO 2 e di produzione
di ossigeno. Vuol dire distruggere la biodiversità e mettere in pericolo la vita di più di un miliardo
di persone la cui sopravvivenza dipende dalle foreste e condannare all’estinzione le culture
tradizionali.
Di fatto, i popoli indigeni, i “guardiani della Madre Terra”, giocano un ruolo fondamentale nella
conservazione delle foreste e della biodiversità. La stessa Banca Mondiale, fra i grandi promotori di
un modello di sviluppo che mette a repentaglio il clima e le foreste, lo riconosce: tra il 2000 e il
2008 le zone abitate dai popoli indigeni dimostravano livelli di deforestazione del 16% più bassi
7
che altrove3. La deforestazione avanza e sconvolge anche i sistemi idrogeologici di molte regioni
del mondo. Le foreste distrutte o degradate non permettono più all’acqua piovana di raggiungere i
bacini idrici sotterranei, causando il moltiplicarsi di tragici eventi di alluvioni, come abbiamo visto
in Liguria nei mesi di ottobre e settembre 2011. D’altro canto, la diminuzione delle precipitazioni
colpisce anche l’Amazzonia, il polmone della Terra, generando un aumento della mortalità degli
alberi, la degradazione della foresta e una conseguente diminuzione della capacità di assorbimento
di CO2. Questo fenomeno non deve essere percepito come lontano da noi. Anche in Italia, infatti, le
ricerche dimostrano la correlazione tra le temperature sempre più alte, l’inquinamento atmosferico e
la salute delle foreste. Un recente studio realizzato dal Corpo Forestale dello Stato nell’ambito del
progetto europeo FutMon, lancia l’allarme per un terzo degli ecosistemi forestali che, secondo la
ricerca, sarebbero a rischio.
In occasione di Rio+20, Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si
terrà a Rio de Janeiro il prossimo giugno, a vent’anni esatti di distanza dall’Earth Summit del 1992,
il CDCA vuole offrire con questa pubblicazione una chiave di lettura e di analisi sulle questioni
collegate al cambiamento climatico. Partendo dai negoziati internazionali sul clima, dalle misure e
dalle strategie attuate, si affronteranno i temi chiave di un dibattito ancora troppo marginale: la
finanziarizzazione della natura e dei cambiamenti climatici, le migrazioni ambientali e la giustizia
climatica, con un focus particolare sugli impatti che le donne, in particolare le donne rurali e
indigene, subiscono con l’incedere del cambiamento climatico e sul ruolo che esse ricoprono in
quest’ambito. A causa delle inique relazioni di potere all’interno della famiglia e della comunità,
delle barriere sociali, economiche, culturali e politiche, dei ruoli che esse ricoprono all’interno della
comunità e delle loro caratteristiche fisiche, le donne rappresentano infatti una delle categorie più
colpite dagli impatti negativi del cambiamento climatico. Quanto detto assume proporzioni
maggiori specialmente nel Sud globale, dove la popolazione è totalmente dipendente dalle risorse
naturali e dai servizi ambientali gratuiti e dove spesso è alle donne e alle ragazze che spetta il
compito di procacciare acqua e combustibili e di provvedere al fabbisogno della famiglia. D’altro
canto è innegabile che, proprio grazie al ruolo che rivestono all’interno della comunità e grazie alla
loro profonda conoscenza del territorio e delle risorse naturali, sono proprio le donne a rivestire
principalmente il ruolo di agenti di cambiamento nella lotta al cambiamento climatico, attraverso la
messa in pratica di opzioni di adattamento sostenibili. La pubblicazione vuole inoltre denunciare
come, nonostante ciò, le donne siano ancora oggi sistematicamente escluse dai processi decisionali
e dalle negoziazioni internazionali e contribuire al necessario dibattito affinché esse recuperino un
doveroso ruolo di centralità nello sviluppo delle politiche di adattamento e mitigazione del
cambiamento climatico.
3
Studio della Banca Mondiale: Nelson A., Chomitz K.M., “Effectiveness of Strict vs. Multiple Use Protected
Areas in Reducing Tropical Forest Fires: A Global Analysis Using Matching Methods”, 2011
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022722
8
Acronimi e Abbreviazioni
BM
Banca Mondiale
CDCA
Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
CDM
Meccanismi di Sviluppo Pulito
CE
Commissione Europea
CEDAW
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne
CER
Certificati di Emissioni Ridotte
COICA
Coordinamento delle Organizzazioni Indigene del Bacino Amazzonico
COP
Conferenze delle Parti
FAO
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
FMAM
Fondo Mondiale per l’Ambiente
FMI
Fondo Monetario Internazionale
GFCC
Fondo Verde per il Cambiamento Climatico
GGCA
Global Gender and Climate Alliance
IDP
Sfollati interni
IFAD
Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo
ILO
International Labour Organization
IOM
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
IPCC
Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico
IUCN
International Union fo Conservation of Nature
LULUCF
Land Use, Land-Use Change and Forestry
NOAA
National Oceanic and Atmosferic Administration
OGM
Organismo Geneticamente Modificato
ONU
Organizzazione delle Nazioni Unite
PPM
Parti Per Milione
PSIDS
Unione delle Piccole Isole del Pacifico
REDD+
Riduzioni delle Emissioni da Deforestazione e Degrado Forestale
SBSTTA
Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological Advise
UNCCD
Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione
UNDP
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
UNFCCC
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
UNHCR
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
UNICEF
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
WECF
Women in Europe for a Common Future
WEDO
Women’s Environment and Development Organization
Focus Tematico
Il conto alla rovescia del clima
10
1. Da Rio a Rio+20 passando per Kyoto.
Dove ci ha portato la Governance Globale
Venti anni fa, l’ONU convocava a Rio de Janeiro il Vertice della Terra per discutere della
necessità di sviluppare politiche capaci di mitigare i diversi impatti delle attività umane sul pianeta.
Al centro del dibattito internazionale emerse il tema della sostenibilità ambientale e vennero
individuate come prioritarie tre questioni: la desertificazione, la biodiversità e i cambiamenti
climatici. Nel corso del Vertice, i Paesi decisero di aprire alla firma la Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la quale, attraverso il suo organo di governo,
la Conferenza delle Parti (COP) – che si compone dei rappresentanti di tutti i governi membri – da
due decenni sta tentando di raggiungere accordi e di elaborare azioni specifiche volte a limitare e
combattere il cambiamento climatico.
Questo lungo periodo di negoziati ha implicato un costoso processo diplomatico, la
mobilitazione di migliaia di persone provenienti da diverse parti del mondo e l’organizzazione di 17
Conferenze internazionali, ognuna preceduta da numerose riunioni preparatorie. Uno sforzo
economico e diplomatico che purtroppo non ha ancora portato a nessun risultato concreto, se non ad
accordi volontari caratterizzati dalla vaghezza degli obiettivi e dall’assenza di misure coercitive atte
a garantirne il rispetto. Tale scenario è dovuto principalmente alla mancanza di volontà da parte dei
Paesi industrializzati, che sono poi quelli maggiormente inquinanti, di stipulare accordi che
prevedano limiti vincolanti per le emissioni e che contribuiscano a ridurre la quantità di gas
climalteranti rilasciati nell’atmosfera. Purtroppo, nel corso delle COP, ogni tentativo di
negoziazione in questa direzione è stato vano. E benché a livello mondiale, accademici e scienziati,
siano riusciti a rendere inconfutabile la minaccia costituita dal cambiamento climatico prodotto da
fattori antropici ed abbiano identificato il limite oltre il quale non sarebbe più possibile frenarne le
conseguenze, gli studi prodotti sono rimasti lettera morta di fronte al fallimento degli ultimi summit
internazionali, primo tra tutti la 15ª COP tenutasi a Copenhagen nel 2009.
In Danimarca,
l'attenzione dei media e della comunità internazionale era notevole quanto le aspettative serbate nel
raggiungimento di un accordo, ma ciò non ha impedito ai governi dei Paesi industrializzati di far
saltare qualunque pattuizione potesse metterne in discussione gli assetti.
Con la 16a COP, tenutasi a Cancún, in Messico, alla fine del 2010, emerge un altro dato:
non vi è, come era stato invece a Copenaghen, una polarizzazione tra Paesi emergenti e principali
potenze economiche nel processo decisionale tale da impedire il raggiungimento di un accordo. Nel
summit messicano emerge piuttosto il ruolo della Cina e delle nuove potenze asiatiche, determinanti
per la sigla di un accordo. Cancún si distingue quindi per una maggiore intesa tra i Paesi rispetto
alla Conferenza di Copenaghen; l’unica posizione controcorrente resta quella della Bolivia, il solo
11
Paese parte della COP ma non firmatario dell’accordo di Cancún. La Bolivia è stato, inoltre,
l’unico Stato a chiedere a livello internazionale l’adozione di politiche incisive per la riduzione
delle emissioni e una gestione della crisi climatica basata sui diritti dell’uomo e della natura. Ha
messo inoltre in atto un processo partecipativo e di dialogo che ha coinvolto i movimenti sociali
boliviani e internazionali, come avvenuto durante la Cumbre dei Popoli di Cochabamba nell’aprile
2010, convocata dal governo Morales dopo il fallimento della COP15 e animata da oltre 45.000
delegati provenienti da tutti i continenti. La posizione boliviana è fortemente contraria all’adozione
di meccanismi di mercato (come il carbon trade) nella lotta al cambiamento climatico ed è critica
nei confronti delle decisioni assunte durante i vertici, che si sono tutti conclusi senza l’adozione di
accordi formali sulla riduzione delle emissioni.
Le 193 Parti che hanno raggiunto un accordo a Cancún sono riuscite a dare un’immagine di
maggior coesione rispetto a Copenaghen, immagine tuttavia in contrasto col documento approvato,
che manca di efficacia poiché non esiste una definizione comune di molti punti dell’accordo,
mentre ci si riferisce a misure di finanziarizzazione della crisi climatica, come il carbon trade e i
Redd+, qualificandole come “soluzioni”. Questa confusione contribuisce a generare insicurezza
giuridica e può essere interpretata come un insuccesso in chiave legislativa. Per far fronte alla
necessità di presentare comunque risultati all’opinione pubblica, i governi dei Paesi industrializzati
hanno riproposto discorsi vaghi e proclamato impegni generici per nascondere in realtà il blocco
che le potenze industriali impongono alla sigla di accordi vincolanti sulle emissioni.
Non molto dissimile quanto avvenuto durante la 17° Cop, tenutasi alla fine del 2011 a
Durban, in Sudafrica. Il tema al centro delle discussioni era il futuro del protocollo di Kyoto, in
scadenza alla fine del 2012. Al momento Kyoto rappresenta l'unico documento vincolante sulla
riduzione delle emissioni, anche se si è dimostrato ampiamente insufficiente e la necessità di
rafforzarne obiettivi e misure di controllo è un'innegabile evidenza. Kyoto aveva come obiettivo da
raggiungere entro il 2012 la riduzione delle emissioni del 5,2% rispetto ai livelli del 1997. Ma
anziché ridursi, ad oggi il livello globale di emissioni è aumentato di circa il 30%. Ciononostante,
anche a Durban, l'unica innegabile evidenza è stata ancora una volta la mancanza di volontà politica
dei governi di agire conseguentemente alla gravità della minaccia climatica. Un atteggiamento che
ha tradotto anche questo vertice in un altro fallimento annunciato. Il documento finale della 17°
COP, battezzato Durban Package, non si discosta di una virgola dalle scarsissime aspettative della
vigilia: non vengono previsti obblighi di riduzioni per il post Kyoto mentre è previsto un generico
impegno per i 194 paesi della Cop a discutere entro il 2015 di un nuovo protocollo operativo dal
2020. Nulla è previsto neppur transitoriamente dal 2012, anno della cessazione del protocollo, al
2015, anno indicato per la stipula un nuovo accordo sulle emissioni di cui non viene neppure
sottolineato il carattere vincolante. Non prevedere alcun vincolo coercitivo per la riduzione delle
emissioni - vale la pena ricordarlo - significa ulteriore svuotamento del senso del protocollo, basato
12
sul principio di responsabilità storica e differenziata. Senza contare che la scienza continua a
ripetere che o si inizia a far calare concretamente le emissioni già a partire dal 2015 (anno massimo
per il picco emissivo) oppure di invertire la rotta non c'è speranza. E' perciò che secondo
organizzazioni sociali, sindacali, contadine, indigene, ecologiste, il Durban Package è l'ennesimo
fumo negli occhi: una timida intesa di facciata su un futuro accordo globale che entrerebbe in
validità addirittura tra 9 lunghissimi anni, condannando il pianeta ad un aumento di almeno 4°c. Un
aumento che va oltre le più nere previsioni, e che significherebbe condannare il pianeta a una
apocalisse senza precedenti.
Ironia della sorte ed altra risultanza del vertice sudafricano, la prossima Cop sul clima, la 18°, si
terrà a dicembre prossimo nel petrolifero Qatar, ovvero nel paese che ha il più alto tasso di
emissioni pro capite al mondo.
Prima di allora, tappa intermedia di enorme rilievo in cui in discussione sarà il concetto
stesso di sostenibilità - e le vicissitudini climatiche ci rientrano di diritto - sarà, nel giugno 2012,
l’appuntamento di Rio di Janeiro dove, a vent’anni dal Vertice della Terra del 1992, si celebrerà la
Conferenza delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile denominata Rio+20.
Box 1
Tabella cronologica dei vertici internazionali sulle questioni
ambientali e climatiche
2012
(prossimo dicembre) COP18 in Qatar
2012
Vertice Mondiale Rio+20 sullo sviluppo
2011
COP17 Durban
2010
COP16 Cancùn (Accordi di Cancùn)
2009
COP15 Copenhagen
2008
COP14 Poznan (introduzione REDD+)
2007
COP13 Bali (Bali Roadmap)
2006
COP12 Nairobi
2005
COP11 Montreal (REDD torna in Agenda)
2004
COP10 Buenos Aires
2003
COP9 Milano
2002
COP8 New Delhi
2001
COP7 Marrakech (accordi di Marrakech – REDD viene
rimosso)
2001
COP6 parte II (COP6b) Bonn (Accordi di Bonn)
2000
COP6 Hague (non c’è accordo decisionale sul Buenos Aires
Action Plan)
13
1999
COP5 Bonn (stabilisce un calendario aggressivo)
1998
COP4 Buenos Aires (Buenos Aires Action Plan)
1998
Protocollo di Kyoto aperto (84 firme)
1997
COP3 Kyoto (Protocollo di Kyoto, “seme” del REDD)
1996
COP2 Ginevra (Dichiarazione Ministeriale di Ginevra)
1995
COP1 Berlino – prima Conferenza delle Parti (Mandato di
Berlino)
1994
UNFCCC entra in vigore
1992
Vertice Mondiale di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo – nasce
la UNFCCC
1990
Nasce l’INC (Comitato Intergovernativo di Negoziazione)
1988
Nasce l’IPCC – Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico
1987
Rapporto della Commissione Brundtland
1979
1a Conferenza Mondiale sul Clima
Nelle discussioni preparatorie rispetto al vertice brasiliano, i Paesi in via di sviluppo del
G77, vicini alle posizioni del governo della Bolivia, denunciano la mancanza totale di trasparenza e
l'incoerenza di misure più adatte a rafforzare le emergenze che ad affrontarle. Secondo la loro
analisi, si è assistito negli ultimi anni ad una riorganizzazione dei grandi poteri economici e della
governance globale che in nome della crisi economica sacrificano ulteriormente diritti e ambiente,
riproponendo con più aggressività le stesse misure che hanno generato la crisi. I paesi del G77
denunciano con allarme che il quadro di fondo rimane inalterato e nessuna misura concreta viene
adottata per ridurre la febbre del pianeta: tutte le soluzioni proposte dalla governance, dalle grandi
compagnie e dalle forze politiche si concretizzano in decisioni che hanno come fine ultimo la
protezione di interessi particolari e la promozione di modelli produttivi ed energetici obsoleti ed non
sostenibili.
14
2.Le “soluzioni” della governance globale
Una prima considerazione si riferisce alle cosiddette “non soluzioni” in discussione nelle
negoziazioni internazionali. Il Protocollo di Kyoto, l’unico documento a carattere vincolante al
momento vigente, scade alla fine del 2012. Kyoto prevedeva una diminuzione del 5,2% delle
emissioni per il 2012 secondo i livelli del 1990. Ad oggi i livelli di emissioni di gas serra sono
invece aumentati, secondo le stime, di circa il 30% rispetto al 90: secondo CO2 Now, dai 6.149
milioni di tonnellate di CO 2 emesse nel 1990, si è raggiunta nel 2009 l’emissione di 8.398 milioni di
tonnellate di CO2 nell’atmosfera. I risultati, o non risultati, raggiunti, dimostrano i limiti del
Protocollo e dimostrano perché si sia rivelato insufficiente e sostanzialmente non vincolante. Allo
stesso modo, le Conferenze delle Parti sul Cambiamento Climatico sono risultate non concludenti:
non esiste un limite massimo di emissioni per i Paesi più inquinanti, né un piano prioritario e
vincolante di riduzione per questi Paesi.
Dal punto di vista della prosecuzione dell’accordo, dalla COP17 di Durban i paesi della
COP hanno sottoscritto un generico impegno a continuare le negoziazioni per arrivare entro il 2015
all’adozione di un accordo la cui entrata in vigore è prevista entro il 2020. È dunque prevedibile che
le negoziazioni possano proseguire in occasione di Rio+20.
Durante i 17 anni di vigenza, le COP hanno istituito organismi ad hoc come l’IPCC, Panel
Intergovernativo sul Cambiamento Climatico che ha definito due rami di azione principale: le
azioni di adattamento (dirette all’aggiustamento dei sistemi naturali o umani a fronte delle nuove
caratteristiche dell’ambiente) e le azioni di mitigazione (che incidono sulla produzione umana o
sulla capacità di assorbimento di gas ad effetto serra per ridurne la concentrazione nell’atmosfera tra
cui spiccano i Meccanismi di Sviluppo Pulito, CDM).
Attraverso i CDM, inclusi già dal Protocollo di Kyoto, i Paesi e le aziende possono “ridurre”
le loro quote di emissioni investendo in progetti “per ridurre emissioni” nei Paesi in via sviluppo.
Questi meccanismi hanno permesso di avallare progetti inquinanti sotto le etichette di CDM, che
hanno anche ispirato la filosofia del Programma delle Nazioni Unite sulla Riduzioni delle Emissioni
da Deforestazione e Degrado Forestale (REDD+), che applica questi meccanismi alla conservazione
delle foreste. Il programma REDD+ permette di qualificare le monocolture per biocarburanti e lo
sviluppo di agro-business forestali e del commercio di legname quali misure virtuose, anziché minacce per l’ambiente.
15
Box 2
Proposte delle “società in movimento” per l’attuazione di vere soluzioni
Numerose sono le proposte avanzate dalle comunità locali, dai movimenti sociali, dalle
associazioni, dai sindacati: una “società in movimento” altamente capace di pensare dal globale al
locale azioni concrete per far fronte ai cambiamenti climatici1:
- il trasferimento delle spese per le forze armate, la guerra e la sicurezza in spese per affrontare i
cambiamenti climatici, il trasferimento del 6% del PIL dei Paesi inquinanti verso misure di
mitigazione e adattamento e la tassazione delle emissioni per la riconversione;
- la creazione di un reale quadro negoziale vincolante, che possa garantire la riduzione delle
emissioni, basato sul concetto di responsabilità degli inquinatori nel fronteggiare i cambiamenti
climatici e sul sostegno ai Paesi con minori possibilità economiche;
- l’attuazione di piani di preservazione, recupero e gestione sostenibile delle foreste secondo le
necessità e non secondo il loro valore sul mercato;
- lo sviluppo di una nuova giurisdizione nazionale e internazionale che abbia come ispirazione la
giustizia ambientale e climatica, che tenga conto del debito ecologico maturato, che preveda la
costituzione di tribunali ambientali nazionali e di un tribunale internazionale per la giustizia
ambientale e climatica;
- il trasferimento di tecnologie ai Paesi con minori possibilità economiche;
- la salvaguardia e il supporto dell’agricoltura contadina locale – come quella famigliare – a scapito
di quella volta all’esportazione; lo sviluppo di una società “post carbon” declinata in un settore
industriale riconvertito e non estrattivista; il perseguimento dell’efficienza energetica e di
un’urbanizzazione sostenibile e a basso impatto, che permettano il raggiungimento di una riduzione
di oltre l’80% delle emissioni entro il 2050.
Quelle assunte dai governi in seno alle COP sono dunque considerate “false soluzioni”,
basate sulla finanziarizzazione del cambiamento climatico e sulla mercificazione della natura. Uno
degli esempi meglio esplicativi è fornito dal meccanismo del Cap and Trade, che permette a chi
inquina di più di comprare – sotto forma di credito o permessi – il proprio “diritto ad inquinare”
da chi inquina di meno. Crediti gratuiti vengono inoltre concessi a chi applica i “Meccanismi di
Sviluppo Pulito” e altre azioni di mitigazione e compensazione. Questo sistema corrisponde
innanzitutto ad una necessità del mercato finanziario, bisognoso di creare nuovi mercati mentre non
16
è utile a garantire la diminuzione delle emissioni. Non vi è alcuna regolamentazione in merito ai
tetti massimi di emissioni il che impedisce una reale efficacia di tali meccanismi nell’effettiva
diminuzione delle emissioni.
A questo ragionamento appartiene anche il gran dibattito nato negli ultimi anni attorno alla
“green economy”, che rappresenta secondo gran parte delle reti sociali per la giustizia ambientale,
una nuova frontiera di accumulazione di capitale – basata sugli stessi equilibri di potere e sui
medesimi meccanismi di produzione, distribuzione e consumo – piuttosto che una reale inversione
di tendenza del modello economico a favore della sua sostenibilità sociale ed ambientale. Sotto
l’etichetta glamour di “economia verde”, vengono inclusi progetti discutibili dal punto di vista
ambientale e climatico come inceneritori, monocolture, centrali nucleari, megaprogetti di
approvvigionamento energetico (come il fotovoltaico su terreni agricoli o le mega dighe), etc.
Alternative apparenti, che di fatto contribuiscono all’aggravarsi della crisi ambientale e sociale.
Box 3
Alternative per una Economia Solidale
A livello mondiale si moltiplicano oggi le reti di scambio e lo sviluppo di meccanismi economici che
obbediscono a logiche diverse da quelle di mercato. L’uscita dall’attuale crisi economica ed ecologica
mondiale non può che passare attraverso la costruzione di una nuova forma di economia che tenga
necessariamente conto dei limiti fisici del pianeta.
In questo senso è necessario rafforzare le reti di economia solidale esistenti; reti poco conosciute ma in
continua evoluzione che contribuiscono in larga misura a ridisegnare un paradigma di produzione e
consumo basato sul rispetto dei diritti e dell’ambiente: reti del commercio giusto, mercati contadini,
gruppi di acquisto solidale, piccole cooperative, spazi autogestiti che forniscono beni e servizi possono
essere vettori di un’economia ad alto livello occupazionale ma a basso consumo energetico.
Ovunque nel mondo si sono diffusi e sviluppati nell’ultimo decennio esempi di questo genere in cui
esperienze collettive, spesso ostacolate dalle istituzioni, sono divenute fondamenta per lo sviluppo di
un nuovo modello di economia sociale.
Sul piano europeo, la normativa relativa agli obiettivi di emissione è piuttosto avanzata
rispetto al quadro internazionale. Con la Strategia Europea 20-20-204, l’Unione Europea mira ad
una riduzione del 20% delle sue emissioni, ad un aumento del 20% dell’efficienza energetica e al
raggiungimento di un 20% della produzione energetica basata sulle energie rinnovabili entro il
4
Testo completo della Strategia 20-20-20 reperibile sul sito:
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28188_en.htm
17
2020. Nel corso della COP16, l’UE ha rivisto gli obiettivi di emissione proponendo una riduzione
interna del 30% delle emissioni entro il 2020, con l’impegno dei grandi inquinatori ad accettare e
rispettare l’impegno. Seguendo questo percorso, nel marzo del 2011, la Commissione Europea ha
presentato al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni un piano a lungo termine (vedi Box 4) incentrato su una prospettiva “low
carbon” per implementare la transizione verso un’“economia a basse emissioni” mirando ad una
riduzione delle emissioni interne dell’80% entro il 2050.
Box 4
Road Map della Commissione Europea5 verso un’economia competitiva
low carbon entro il 2050
La Road Map analizza le possibili piste di intervento per i settori più importanti dell’economia europea,
esaminando una serie di scenari basati su diversi tassi di innovazione tecnologica e sui prezzi dei
combustibili fossili.
-Settore energetico: Si stima che la quota delle tecnologie a bassa intensità di carbonio nel mix di
produzione elettrica passerà dall’attuale 45% al 60% nel 2020 e dal 75% all’80% nel 2030, per sfiorare
il 100% nel 2050. A tale scopo sarà necessario diversificare l’approvvigionamento elettrico europeo e
avvalersi delle più avanzate tecnologie nel campo delle rinnovabili. Importante sarà anche il sistema
ETS di scambio delle quote di emissione, che favorirà l’introduzione sul mercato di tecnologie low
carbon, così che il settore energetico stesso possa adeguare le proprie strategie operative all’evoluzione
delle tecnologie e ai prezzi dell’energia. Altri strumenti utili saranno la tassazione dell’energia, il
sostegno tecnologico e l’investimento nelle reti intelligenti delle rinnovabili.
-Trasporti: Si mira a ridurre le emissioni del settore del 54% entro il 2050 attraverso l’innovazione
tecnologica, agendo su: efficienza dei veicoli (nuovi motori e materiali); nuovi carburanti e sistemi di
propulsione; migliore utilizzo delle reti. Fino al 2025 una maggiore efficienza dei carburanti continuerà
ad essere lo strumento principale, ma dal 2030 le emissioni generate dal trasporto potrebbero scendere
sotto i livelli del ‘90 grazie a: sistemi di tariffazione destinati a far fronte alla congestione del traffico e
all’inquinamento atmosferico; tariffazione delle infrastrutture; pianificazione urbanistica intelligente;
potenziamento dei trasporti pubblici; sviluppo di tecnologie dei motori ibridi (veicoli ibridi ricaricabili e
veicoli elettrici). Fondamentale è la realizzazione su larga scala dell’elettrificazione, per evitare un uso
troppo massiccio dei biocarburanti e di altri carburanti alternativi.
-Edilizia: Grazie al miglioramento dell’efficienza energetica, le emissioni del settore potrebbero calare
del 90% entro il 2050. A questo scopo il consumo energetico dei nuovi edifici costruiti a partire dal
2021 dovrà essere prossimo allo zero, orientando il consumo verso l’elettricità low carbon (comprese le
pompe a calore e gli apparecchi per riscaldamento ad accumulazione) e l’energia rinnovabile (solare,
biogas, biomassa) anche per le reti di teleriscaldamento; gli Stati dovranno includere requisiti di
efficienza energetica negli appalti pubblici. La ristrutturazione del parco immobiliare esistente è più
complessa: nel prossimo decennio occorrerà aumentare di 200 miliardi di euro gli investimenti in
5
La Road Map è stata presentata dalla Commissione Europea nel marzo del 2011. Il testo completo è reperibile
sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:EN:NOT
18
componenti e attrezzature per l’edilizia a basso consumo energetico; bisogna predisporre meccanismi di
finanziamento intelligenti (tassi di interesse preferenziali per stimolare gli investimenti del settore
privato a favore di soluzioni edilizie più efficienti).
-Settore industriale: Le emissioni di gas serra del settore potrebbero essere ridotte del 83-87% nel
2050, attraverso l’utilizzo di impianti e processi industriali più efficienti sotto il profilo energetico e
delle risorse; un maggiore ricorso al riciclaggio; l’impiego di tecnologie di riduzione delle emissioni
diverse dal CO2 (ad esempio l’ossido d’azoto e il metano). Dopo il 2035 dovrebbe essere esteso su
ampia scala il ricorso alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, in particolare per le emissioni dei
processi industriali, comportando un investimento annuo di oltre 10 miliardi di euro. In parallelo con
l’elaborazione del quadro politico dell’UE in materia climatica, occorrerà però continuare a monitorare
e ad analizzare gli impatti di queste misure sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica.
-Agricoltura: Dopo il 2030 il ritmo di riduzione delle emissioni del settore agricolo potrebbe rallentare,
conseguentemente alla crescita demografica mondiale, e nel 2050 l’agricoltura rappresenterà un terzo
delle emissioni totali dell’UE. Tuttavia, entro il 2050 il settore può comunque puntare a una riduzione
delle emissioni diverse dal CO2 del 42-49% rispetto al ‘90. Le politiche agricole dovranno puntare a:
incrementi sostenibili dell’efficienza; uso efficiente dei fertilizzanti; biogassificazione e migliore
gestione del concime organico; foraggi di migliore qualità; diversificazione e commercializzazione della
produzione a livello locale; maggiore produttività del bestiame e ottimizzazione dei benefici
dell’agricoltura estensiva. Attraverso corrette pratiche agricole e forestali si può rafforzare la capacità
del settore di preservare e catturare il carbonio mediante misure per ridurre l’erosione e favorire il
rimboschimento (mantenimento dei terreni prativi, ripristino delle zone umide e delle torbiere e
non-lavorazione o lavorazione minima del suolo). È anche auspicabile invertire la tendenza allo spreco
dei prodotti alimentari e riorientare i consumi verso alimenti a bassa intensità di carbonio.
Per la realizzazione delle linee guida previste dalla Road Map, la Commissione sottolinea la
necessità di aumentare gli investimenti di capitale (con un
incremento medio annuo di 270
miliardi), per ridurre la fattura energetica e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e
creare nuovi posti di lavoro. Al fine di raggiungere l’obiettivo di una riduzione delle emissioni
dell’80% è dunque necessario predisporre una profonda riforma del sistema economico e del lavoro.
Nonostante la Road Map rappresenti ad oggi il documento con gli obiettivi più avanzati
sulla riduzione di emissioni, meno avanzato è il piano di azione che dovrebbe applicarne i dettami.
Le misure concrete previste restano generiche e non puntuali, ulteriormente indebolite dal poco
incisivo vincolo legislativo europeo. È esempio di ciò la scarsa implementazione della Strategia
dell’Unione Europea in Italia e in altri paesi europei.
19
3.Il finanziamento internazionale delle misure contro il cambiamento climatico
Nel contesto del dibattito internazionale sulla questione del cambiamento climatico, il
finanziamento delle diverse proposte politiche a livello internazionale è uno dei punti che genera
maggior conflitto tra le parti. Gli accordi stabiliti riconoscono la responsabilità dei Paesi sviluppati
per la maggior parte dell’attuale livello di emissioni a livello globale, ma non li penalizza, piuttosto
permette loro di continuare a contaminare prevedendo meccanismi di compensazione finanziaria. Di
contro, il sistema attraverso il quale i Paesi sviluppati mobiliteranno i mezzi finanziari necessari per
implementare concretamente i progetti di mitigazione e adattamento è molto controverso e al centro
di una accesa discussione.
T o t a le d e p o s it a t o n e i f o n d i c lim a t ic i ( U S D m n )
O th e rs
O th e r EU
N o rw ay
Fran ce
U n it e d S t a t e s
F in la n d
It a ly
Ir e la n d
Ja p a n
C ze c h R e p u b lic
A u st r a lia
U n it e d K in g d o m
C an ad a
S w it ze r la n d
Sw eden
Eu ro p e a n U n io n
S p a in
D e n m ark
G e rm an y
0
50
100
150
200
250
300
Grafico 1: Milioni di dollari depositati in vari fondi dedicati ai cambiamenti climatici per paese
donatore. Fonte: http://www.climatefundsupdate.org/ , Elaborazione propria.
La proposta presentata a Copenaghen, che proveniva dal G77+ Cina, prevedeva l’istituzione
di un fondo globale, il Fondo per il Settore Ambientale Mondiale (FMAM), che sotto la diretta
autorità della UNFCCC, fosse l’unico responsabile della gestione di tutte le risorse finanziarie
destinate alle misure di adattamento e mitigazione. Questa proposta, invisibile nella diffusione
mediatica e nel dibattito internazionale, ha trovato resistenze all’interno del meccanismo delle COP
soprattutto da parte dei paesi industrializzati. Diverso destino invece è toccato alla proposta, emersa
durante la COP16 di Cancùn, di creare un Fondo Verde per il Cambiamento Climatico (GFCC)
20
per finanziare misure nei Paesi meno sviluppati. La proposta, propagandata con grande risalto dai
media come misura della generosa solidarietà dei leader del “mondo sviluppato” nei confronti dei
paesi dei sud del mondo, rimane però a tutt’oggi un progetto indefinito. Né a Cancùn, né a Durban
sono state infatti definite l’origine o le forme di finanziamento del fondo, mentre rispetto
all’amministrazione l’unico suggerimento ha riguardato l’affidamento alla Banca Mondiale di un
ruolo centrale di gestione. Ciò ha causato dure critiche da parte dei Paesi in via di sviluppo che
considerano l’istituzione fortemente vincolata agli interessi dei Paesi sviluppati. In particolare si
teme che l’influenza dell’istituzione finanziaria possa condizionare prestiti, selezione dei progetti e
squilibri a favore dell’iniziativa privata, considerando che la Banca Mondiale è storicamente una
delle principali responsabili delle politiche di sviluppo e di aggiustamento strutturale colpevoli
dell’espansione del modello di sviluppo cui è imputabile lo stesso cambiamento climatico. Appare
in tal senso paradossale, nella critica dei Paesi del G77, che allo stesso istituto sia demandata la
gestione di un fondo di investimenti che ha come scopo quello di fronteggiare le cause e gli effetti
dello stravolgimento climatico.
Nello specifico, gli investimenti dei primi fondi del GFCC, gestiti dalla Banca Mondiale,
verrebbero destinati a progetti di mitigazione (80%), trascurando l’adattamento (20%), senza una
definizione della destinazione degli investimenti né un controllo oggettivo degli stessi da parte della
UNFCCC. In definitiva la BM si troverebbe dunque a prendere ogni decisione relativa all’utilizzo
dei fondi senza alcuna previa discussione nell’ambito di organizzazioni o conferenze a carattere
democratico. Le principali critiche mosse al Fondo Verde sostengono che, attraverso i meccanismi
di finanziamento – basati sulla condizionalità degli aiuti – possa aumentare la spirale del debito che
già affligge i Paesi del Sud globale.
Vale la pena ricordare una delle proposte più discusse, avanzata a Copenaghen dal noto
finanziere George Soros e sostenuta dall’ex-direttore generale del Fondo Monetario Internazionale
(FMI), Dominique Strauss-Kahn, che prevedeva di utilizzare le risorse del FMI per sbloccare i
finanziamenti sul clima. Secondo Soros le nazioni industrializzate potrebbero investire una parte
dei loro 283 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo in progetti per il taglio delle emissioni
nei paesi emergenti. In tal senso, nonostante l’imperativo di prevedere fondi “nuovi e aggiuntivi”
alla cooperazione tradizionale, il pericolo è che l’aiuto per la mitigazione e l’adattamento al
cambiamento climatico vada a sostituire gli abituali aiuti allo sviluppo invece di prevederne di
nuovi, come dimostra l’esempio della Gran Bretagna, che ha deciso il trasferimento del suo
contributo abituale per l’aiuto allo sviluppo, pari a 2.5 miliardi, interamente al GFCC. In questo
scenario il rischio è che i Paesi sviluppati, classicamente erogatori di aiuti, tentino di accumulare i
fondi necessari attraverso meccanismi finanziari, creando nuovi titoli e nuovi mercati del debito per
la partecipazione del capitale privato attraverso il FMI. Anche la strategia di tassazione di
quest’ultimo è impostata in modo tale da non prevedere alcuna progressività basata su criteri
21
ambientali: non sono previsti vantaggi impositivi per chi inquina meno, inoltre il FMI ha proposto
la fine dei sussidi al petrolio, che potrebbero apportare una grande quantità di fondi per il
finanziamento delle politiche di cambiamento climatico.
Queste proposte di fiscalità ambientale hanno un futuro incerto in tempo di crisi.
L’emergenza economica in cui versano molti paesi e la scarsa attenzione riservata a tematiche pur
centrali come la crisi ecologica e climatica lasciano supporre che si sceglierà come sin qui avvenuto
la via della finanziarizzazione, generando prevedibilmente ulteriori profitti per gli speculatori e
maggiori costi in capo ai contribuenti.
Dopo le tornate fallimentari di Copenaghen, Cancùn e Durban sembra alquanto nero il
futuro delle negoziazioni sul clima. I Paesi più vulnerabili rischiano di perdere gli aiuti allo
sviluppo o di non vedere partire un piano concreto di adattamento all’emergenza climatica.
Box 5
Proposta alternativa per il Fondo Globale sul clima
Una proposta equa potrebbe consistere nell’introduzione di tasse speciali per i prodotti maggiormente
inquinanti e l’imposizione del trasferimento di una percentuale del PIL dei Paesi con le industrie più
inquinanti da destinare alle politiche di adattamento e mitigazione. Un sistema fiscale basato
sull’imposizione diretta e sulla disincentivazione all’inquinamento permetterebbe, attraverso i fondi
generati, di finanziare adeguatamente un fondo globale per il clima. Per quanto riguarda la gestione di
quest’ultimo, la responsablità dovrebbe essere affidata ad un organismo dipendente dall’Assemblea
Generale dell’ONU, che garantisca un controllo democratico sottraendolo a istituzioni finanziarie come
BM e FMI. Questa proposta basata su sistemi di tassazione già applicati a livello nazionale in vari Paesi
come Danimarca o Finlandia è stata lanciata a livello globale tra gli altri dall’associazione ATTAC
International6, impegnata nella campagna per un sistema fiscale globale basato sulla giustizia
economica.
La questione della finanziarizzazione dei cambiamenti climatici e del finanziamento delle
misure di mitigazione e adattamento hanno aperto un dibattito anche a livello europeo. Nel 2005
l’UE ha creato il Sistema EU-ETS di Commercio di Emissioni7 (Emissions Trading System), uno
dei sistemi pionieri nell’ambito della commercializzazione dei diritti di emissione. Tuttavia questo
nuovo mercato è stato al centro di numerose critiche, poiché le imprese del settore dell’energia
6
7
Sito di ATTAC International - http://www.attac.org/en.
Per approfondire, la sezione del sito dell’UE sull’azione climatica:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.
22
sono state le uniche ad assumersi gli obblighi, essendo il settore energetico l’unico in deficit di
diritti di emissione, mentre gli altri settori hanno registrato un surplus tra le emissioni permesse e
quelle realizzate. Questo tetto delle emissioni è stato fissato ben al di sopra dei livelli di
inquinamento attuali da parte dei diversi settori economici europei, il che rappresenta un incentivo
per lo scenario “business as usual”, all’interno del quale le politiche sul cambiamento climatico non
hanno alcuna efficacia e non riducono le emissioni. Il Sistema europeo di Commercio di
Emissioni ha di fatto contribuito alla deregolamentazione del valore dei permessi di emissione,
dei prezzi delle energie fossili e, da ultimo, all’aumento delle emissioni in Europa.
L’UE inoltre è stata uno spazio sperimentale nel finanziamento dei CDM, in quanto questi
sono stati finanziati principalmente dalle imprese del settore energetico. Secondo la UNFCCC è
stato valutato che entro il 2012 le imprese private europee investiranno 12,5 miliardi di dollari nelle
compagnie energetiche cinesi sotto il quadro dei CDM. L’effetto distorto che ne discende è la
sovvenzione pubblica di un business privato già profittevole di per sé, come nel caso degli
investimenti europei nel settore delle rinnovabili in Cina, che ad esempio riceverà finanziamenti da
parte del Fondo Verde ma contemporaneamente genererà ricavi attraverso il proprio commercio. In
questo modo le imprese inquinanti hanno il lasciapassare sui loro attuali livelli di emissione e i loro
progetti sulle nuove tecnologie ricevono sovvenzioni.
La politica europea nell’ambito del cambiamento climatico, caratterizzata da questa doppia morale,
pare obbedire maggiormente ad obiettivi economici connessi alla necessità di diversificare le fonti
energetiche (a fronte del continuo aumento dei costi del petrolio) piuttosto che ad un reale
preoccupazione verso la riduzione dell’impatto ambientale che l’economia europea ha sul pianeta.
La crisi delle democrazia rappresentativa che vivono i paesi europei negli ultimi anni ha inoltre
portato ad una partecipazione diretta degli interessi delle maggiori imprese nelle negoziazioni
internazionali. Le voci dei governi nelle riunioni di negoziazione per la lotta al cambiamento
climatico si sono spesso limitate a portare avanti gli interessi dei maggiori gruppi economici
nazionali, spesso coincidenti con le industrie più inquinanti.
23
4.REDD: fuoco sulle foreste
Uno dei programmi più importanti dei CDM è la Riduzione delle emissioni legate alla
deforestazione e al degrado dei boschi (REDD)8, cui si è aggiunto alcuni anni dopo il programma
REDD+. Il programma fu approvato a Bali nell’ambito dei negoziati internazionali della COP13 e
modificato a Poznan nel 2008, dove furono incluse nel programma la conservazione e l’uso
sostenibile dello stock di carbonio dei boschi.
Il programma REDD nasce dall’esperienze del progetto “Noel Kempff Mercado”9, che nel
1997 vide diverse imprese internazionali, provenienti per lo più dal settore energetico e petrolifero,
finanziare la protezione e il rimboschimento di un parco naturale nel nord-est della Bolivia. Il
progetto creò un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito della lotta al
cambiamento climatico, che entrò nell’ambito delle negoziazioni Land Use, Land-Use Change
and Forestry (LULUCF).
Alla base del REDD c’è il principio di aumentare il sequestro di carbonio atmosferico
proteggendo le foreste, attraverso un sistema di incentivi che renda "conveniente" mantenere le
foreste intatte invece che abbatterle. Una volta accertata la quantità di carbonio che una data foresta
è capace di catturare, la fase finale del programma prevede che i Paesi cosiddetti “avanzati” paghino
ai Paesi in via di sviluppo delle compensazioni per preservare le loro foreste dalla deforestazione.
Le attività del Programma REDD sono condotte dai governi locali e nazionali, da grandi ONG e
dalle imprese del settore privato.
Il REDD è di fatto anch’esso uno schema di compensazioni per il mercato delle emissioni, e
va’ dunque a produrre crediti di emissioni. Questi crediti, generati dai progetti portati avanti nei
Paesi in via di sviluppo, possono essere sfruttati dai governi dei Paesi “avanzati” per raggiungere gli
obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto o possono essere rivenduti sul mercato del carbonio.
In pratica, essendo il REDD basato su processi finanziari, i Paesi sviluppati lo utilizzano di fatto
come sistema per continuare a emettere carbonio, pagando piccoli contributi, e senza investire in
tecnologie più efficienti. Anche le grandi multinazionali hanno fiutato l'affare, e stanno puntando a
impossessarsi dei terreni forestali che potranno godere di sussidi, togliendoli ai popoli indigeni e
alle comunità locali. Gli incentivi rischiano di creare dunque un nuovo assalto alla terra, ai danni
delle comunità indigene e rurali: il crescere del valore delle foreste che abitano attira nuove ondate
di investitori e avventurieri, e minaccia i diritti indigeni sulle proprio terre. Tra le critiche rivolte al
sistema dei REDD vi è anche il rischio di leakage, ovvero di una protezione selettiva delle zone boschive, producendo come effetto che in una regione le foreste vengano protette con successo, men-
8
9
Per maggiori informazioni sul programma REDD, il sito: http://www.un-redd.org/.
Noel Kempff Mercado Project - http://www.cbd.int/forest/doc/noel-kempff.pdf.
24
tre in un’altra la deforestazione aumenti, ad esempio perché le superfici delle foreste protette non
possono più esser trasformate in terreno da coltivare.
Il programma REDD+ va oltre la prevenzione della deforestazione e della degradazione delle foreste, ed include anche il ruolo della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste e la
valorizzazione degli stock di carbonio delle foreste nella riduzione delle emissioni. Il Programma
REDD+ è uno degli accordi più noti ma anche una delle principali fonti di conflitto all’interno dei
tavoli negoziali sul clima. I suoi limiti erano già emersi nel progetto del ‘97 , durante il quale ci si
rese conto che le compagnie incaricate del rimboschimento ostacolavano le pratiche agricole tradizionali di quella zona. Pur avendo avuto molto successo presso la UNFCCC, uno dei lati oscuri del
programma è che esso permette agli Stati di mantenere la loro indipendenza nell’identificare le aree
forestali nazionali e le aree forestali degradate dove sviluppare monocolture, considerate come attività di rimboschimento, nonostante i pesanti effetti i termini di contaminazione (massiccio utilizzo
di agro tossici) e di perdita di biodiversità e fertilità dei suoli che esse producono.
In pratica, le compagnie inquinanti possono acquisire crediti nel mercato del carbonio in
cambio della conservazione, del rimboschimento o della gestione sostenibile di un’area forestale nei
paesi del sud del mondo. È chiaro in tal modo che il Programma REDD+ utilizza in definitiva gli
stessi meccanismi che hanno causato i problemi ai quali si cerca di porre rimedio. Tali meccanismi
vengono teoricamente ascritti al campo della cosiddetta “green economy”, che concettualmente,
alla luce del rapporto Brundtland10, inserisce una valutazione di tipo ambientale nell’analisi
economica, pur mantenendo tale valutazione come fattore esterno. Questa corrente teorica non
abbandona il tradizionale paradigma della scienza economica ortodossa che separa natura ed
economia. Sulla base di questo paradigma accademico, il cui carattere realmente innovativo dal
punto di vista della sostenibilità è ampiamente dibattuto, si stanno sviluppando delle risposte al
cambiamento climatico fondate a ben guardare sugli stessi meccanismi di mercato che lo hanno
generato.
Il mercato dei diritti di emissione, fulcro delle odierne strategie contro il cambiamento
climatico, si fonda infatti sull’idea che l’incentivo del mercato possa orientare gli attori economici
ad assorbire i costi ambientali delle loro attività. L’incentivo consiste nella possibilità, per le
imprese inquinanti, di acquistare Certificati di Emissioni Ridotte (CER) attraverso l’investimento
in progetti CDM nei Paesi del Sud del mondo e, successivamente, di rivenderli sui mercati dei Paesi
del Nord globale ad altre imprese inquinanti. I CER sono stati introdotti partendo dall’assunto per
cui le attività produttive dei paesi sviluppati – alla base dei modelli di consumo che stanno
esacerbando lo sconvolgimento climatico – non possano essere modificate senza comportare una
sostanziale (e inaccettabile per il mercato) perdita di profitti. In quest’ottica, dunque, l’investimento
10
Il Rapporto Brundtland, noto come Our common future, è un documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione
Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene introdotto il concetto di sviluppo
sostenibile. Il Rapporto completo è reperibile sul sito: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
25
nei Paesi in via di sviluppo rappresenta l’unica strada da percorrere al fine di ridurre le emissioni a
livello globale. Un approccio questo che si basa sull’assunto per cui ogni processo produttivo ha
come unico scopo quello di massimizzare i profitti, non considerando come variabili nè la
distribuzione di ricchezza all’interno della società né le esternalità generate dall’economia, quali
inquinamento, ingiustizia sociale, ecc.
Box 6
Ruolo delle popolazioni indigene e rurali nel ripristino e nella conservazione delle foreste
A dispetto di quanto previsto da programmi come il REDD, per raggiungere concretamente l’obiettivo del
ripristino delle aree degradate è necessario principalmente interrompere il disboscamento, impedire lo
sfruttamento agro-industriale e fermare le riforestazioni con specie esotiche, limitando lo sviluppo delle
attività agro-forestali e delle monoculture in zone forestali. Inoltre nel prevedere politiche reali di tutela delle
aree boschive, non si può pensare di escludere le popolazioni indigene e contadine che le abitano e che sono
state capaci di tutelarle fino ad oggi.
In tal senso, le politiche forestali di conservazione possono essere davvero valide solo quando riconoscono e
considerano il ruolo svolto da queste popolazioni. In quest’ottica è necessario recuperare il concetto di bene
comune delle zone forestali, zone in cui le comunità e la natura arrivano a creare forme di coevoluzione eco e
socio-sostenibili. Tutte le azioni di ripristino delle foreste possono essere svolte dai popoli che le abitano
anziché date in gestione a imprese multinazionali, riconoscendo l’opportunità e anche la convenienza
economica del ripristino piuttosto che la distruzione delle foreste e lo sfruttamento agro-industriale della terra.
Per questo, i fondi destinati al cambiamento climatico dovrebbero essere condizionali all’instaurazione di
strategie di gestione forestale partecipative che considerino gli interessi degli abitanti dei territori in questione,
riconoscendo il valore della “deforestazione evitata” e del mantenimento dei servizi ambientali garantiti da
queste popolazioni a beneficio dell’umanità. Questo cambiamento di indirizzo nelle politiche di protezione
può essere compiuto solo promuovendo attività a basso impatto ecologico nel rispetto dei diversi stili di vita
dei popoli che vivono nelle aree forestali degradate. Tale posizione viene sostenuta da attori internazionali
come il World Rainforest Movement e innumerevoli comunità indigene, che per anni hanno difeso i loro
territori dallo sfruttamento non sostenibile. Anche la Via Campesina ha rifiutato il Programma REDD+,
sostenendo che si debba invece agire direttamente sulla prima causa della deforestazione: l’attuale sistema
agroalimentare mondiale.
Analogo ragionamento vale per le politiche di riforestazione. Secondo Friends of the Earth International –
impegnata attivamente nella denuncia dei crimini dell’industria dei biocarburanti – affinché possano essere
elaborate politiche di riforestazione adeguate è fondamentale l’esclusione da tali programmi delle piantagioni
di specie esotiche, ponendo così un freno all’attività delle grandi aziende internazionali che guidano
l’espansione delle monocolture di interesse commerciale nelle aree disboscate. Secondo l’organizzazione
un’efficace politica di riforestazione deve considerare in primis la salvaguardia delle specie autoctone e il
recupero delle foreste originarie fondandosi sulla partecipazione attiva delle popolazioni locali. In particolare,
sarebbe in tal senso auspicabile l’introduzione di incentivi tali da indurre gli agricoltori locali a piantare alberi
autoctoni sui loro terreni, al fine di migliorare l’agro-biodiversità della produzione agricola e, al contempo,
prevenire inondazioni, frane, erosione del suolo, ecc
A sollevare ulteriori critiche, è il fatto che i programmi REDD e REDD+ si basino sulla
definizione di “bosco” elaborata dalla FAO, una definizione a dir poco generica: “un bosco
26
corrisponde a terre che si estendono per più di 0,5 ettari dotate di alberi di un’altezza superiore ai
5m ed una copertura arborea superiore al 10%, o di alberi capaci di raggiungere questa altezza in
situ”11. Sulla base di questa definizione, che non fa alcun riferimento alla provenienza delle specie,
nel corso delle negoziazioni del programma REDD+ sono state presentate come misure di
protezione boschiva numerose proposte di impianto o estensione di monocolture nelle zone
degradate. È noto tuttavia che le monocolture hanno effetti dannosi sulla biodiversità, comportano
massicci utilizzi di composti agrochimici, contribuendo alla desertificazione e alla salinizzazione
del suolo. Con una definizione così vaga si corre dunque il rischio di sostituire i boschi originari del
pianeta con piantagioni e monocolture dannose per l’ambiente.
L’analisi di diversi progetti pilota internazionali, realizzati nell’ambito del programma
REDD+, dimostra come uno dei punti critici sia l’incapacità istituzionale di controllare le politiche
forestali. Con questo argomento si pretende di migliorare i sistemi di controllo attraverso la
partecipazione privata, autorizzando le coltivazioni per biocarburante o per il commercio di
legname nelle zone degradate garantendo in tal modo l’estensione delle attività economiche
piuttosto che la tutela delle aree boschive. In pratica, invece di incentivare il recupero della
biodiversità delle aree degradate attraverso, ad esempio, una gestione affidata alle popolazioni
locali, il Programma REDD+ aiuta le imprese che hanno innescato il processo di deforestazione a
guadagnare grazie al mercato CO2.
Ad esempio, nel caso di un Paese come l’Indonesia, nell’ambito del programma REDD+ si
prospetta che oltre il 25% dell’area complessiva da proteggere – e fino al 90% dell’area da
riforestare – sia destinato alla coltivazione di monocolture per i biocombustibili o per il commercio
di legname. Considerando le piantagioni alla stessa stregua delle foreste e dei boschi – come
generici “agenti in grado di catturare anidride carbonica” – non si tiene conto né della differenza
tra le varie specie (se siano cioè autoctone o meno) né della loro capacità di assorbimento di CO2.
Una piantagione, infatti, può catturare solo una quantità infinitesimale del carbonio trattenuto dai
boschi che, originariamente, occupavano le terre ora destinate alle monocolture. Inoltre, si utilizza
il concetto di “gestione delle risorse” causando l’effetto distorto di incentivare la produzione di
legname sotto l’ombrello del REDD+, introducendo per le imprese la possibilità di uno
sfruttamento forestale continuo con la contemporanea percezione di denaro da parte del GFCC.
Questo ha inevitabilmente conseguenze disastrose sulla conservazione dei boschi, considerato che
le industrie del legno sono inclini ad introdurre solo le specie caratterizzate da una crescita più
rapida e quindi più redditizie. In questo modo si determina il passaggio dai “boschi” alle “risorse
forestali”, disarticolando ecosistemi originari e confinando l’idea di un ripopolamento autoctono
delle aree degradate.
In definitiva, sotto l’egida del REDD, del REDD+ e di altre “false soluzioni” al
11
Fonte: FAO, http://www.cdmrulebook.org/497 e http://www.fao.org/docrep/009/j9345e/j9345e05.htm.
27
cambiamento climatico, l’industria forestale è riuscita a rafforzare la sua posizione a scapito delle
foreste primarie: pur prive di un supporto teorico, ma forti del lavoro di lobbying attuato in tutti i
summit internazionali, le grandi industrie vincolate al settore dei biocombustibili sono riuscite ad
introdurre le monoculture tra i meccanismi di assorbimento di CO 2, e questo suppone un
finanziamento diretto da parte del GFCC del processo di accaparramento delle terre – intensificatosi
in questi ultimi anni – per cui grandi corporazioni dell’agro-business acquistano la proprietà di
enormi terreni in diverse regioni del pianeta. Ciò ha trasformato il Programma REDD+ in una vera
e propria arma di espropriazione delle popolazioni indigene e rurali utilizzando l’argomento della
lotta al cambiamento climatico, disconoscendo il ruolo centrale di tali popolazioni nella
salvaguardia del patrimonio naturale nel corso dei secoli.
Già da alcuni anni i governi dei paesi industrializzati e delle economie emergenti hanno
conferito all’industria del biocombustibile il ruolo di attore chiave della “green economy”.
Particolarmente esemplificativa in questo senso è l’introduzione, da parte della Commissione
Europea nel 2007, dell’uso di miscele composte da un minimo del 10% di biocarburante per i
combustibili utilizzati all’interno dell’UE – pratica già introdotta negli Stati Uniti dal 2005.
Questa “risposta” al cambiamento climatico sembra tesa a diversificare le fonti energetiche
piuttosto che ad implementare una concreta strategia di riduzione delle emissioni, tanto che si è
concretizzata, ovunque nel mondo, in un’ondata di deforestazioni volte a creare lo spazio necessario
alla coltivazione delle monocolture per i biocarburanti. Ne sono esempi la diffusione della soia nel
continente sudamericano, il rinnovato slancio della canna da zucchero per la produzione di bioetanolo, la coltivazione massiccia della Jatropha Curcas – pianta velenosa che comincia a
diffondersi nelle monoculture di tutto il mondo per la produzione di biodiesel – l’uso del mais per la
produzione di etanolo. Tali varietà di monoculture sono tra le cause principali dell’attuale crisi
alimentare, in quanto queste forme di coltivazione concorrono all’accaparramento di terra fertile,
che si fa sempre più scarsa. Esse rappresentano, inoltre, la causa diretta o indiretta dell’aumento del
prezzo dei cereali e, mentre si premiano queste monoculture attraverso il Programma REDD+, gran
parte del mondo ne paga le conseguenze con la fame.
L’agro-business del biocarburante non solo è responsabile della deforestazione massiccia in
tutto il mondo ed è l’industria con maggiori responsabilità in termini di cambiamento climatico, ma
è anche dunque responsabile della distruzione della sovranità alimentare per molte popolazioni del
mondo. I principali Paesi produttori di biocombustibili sono infatti responsabili di disastrose
deforestazioni, come dimostra il caso già accennato dell’Indonesia. Questo Paese asiatico,
qualificato come uno dei “dragoni” economici della regione, ha raggiunto questo status grazie allo
sviluppo della coltivazione di palma africana, coltivazioni finanziate in parte dalla Banca Mondiale
sin dagli inizi degli anni ‘80. Inizialmente pensata per l’industria agro-alimentare, la coltivazione
della palma da olio ha determinato un costante aumento del livello delle esportazioni indonesiane e,
28
allo stesso tempo, ha prodotto una delle operazioni di deforestazione più selvagge mai registrate al
mondo, come pure l’essiccazione massiccia di torbiere, provocando incendi e l’emissione di una
grande quantità di gas a effetto serra. Nel corso di pochi anni di diffusione della palma africana,
l’Indonesia si è trasformata in uno dei maggiori inquinatori al mondo. La distruzione massiccia
delle selve tropicali in questo Paese è stata possibile grazie all’intervento dello Stato, col quale si è
giunti ad un’equiparazione dei boschi con le piantagioni di palma da olio. Negli ultimi anni si è
assistito alla riconversione del settore verso la lavorazione dell’olio per la produzione di biodiesel,
per rispondere al nuovo incremento della domanda mondiale di questo carburante e raggiungere gli
obiettivi della politica “verde” dei paesi del Nord globale. Sotto l’egida del Programma REDD+, il
governo indonesiano sta intensificando la coltivazione delle piantagioni di palma – con la
giustificazione di “controllare” le piantagioni illegali – procedendo attraverso l’espulsione delle
popolazioni indigene e rurali. Particolarmente esemplificativo, in questo senso, è il caso del
progetto Rimba Raya, nella provincia di Kalimantan12, dove, in nome dei CER, le imprese Shell,
Gazprom e la Fondazione Clinton hanno finanziato la “protezione” (cioè l’impianto di monocolture)
di oltre 100.000 ettari, impedendo alle comunità della zona l’uso delle foreste che rappresentavano
la loro principale fonte di sostentamento.
Questo non rimane però un esempio isolato. In moltissimi paesi e in vaste regioni,
soprattutto del Sud del mondo, le popolazioni rurali e indigene vedono quotidianamente violato il
loro diritto alla terra da parte delle imprese multinazionali e dei governi, spesso protetti da
programmi come REDD e REDD+.
12
Progetto REDD Rimba Raya: http://www.climatestandards.org/projects/files/rimba_raya/CCBA_PDD_Submission_for_Public_Comments_2010_06_05.pdf.
29
5. Foreste e agricoltura: sotto la minaccia dei CDM
La globalizzazione dell’attuale modello di sviluppo non ha fatto altro che accentuare e
inasprire gli effetti più deleteri che da sempre esso produce. Povertà, fame, crisi ecologica, crisi
energetica, ingiustizia sociale, sono le conseguenze ultime dell’espansione di un modello
economico che garantisce benessere solo ad una fetta della popolazione mondiale ma i cui effetti
negativi in termini ambientali, economici e sociali ricadono soprattutto su chi da quel benessere è
escluso.
Mentre le principali agenzie di sviluppo e le organizzazioni internazionali come Banca
Mondiale, FAO e IFAD si ostinano a definirli fenomeni residuali – risultato della mancanza o del
fallimento dell’incorporazione nel mercato mondiale – la povertà cronica, l’insicurezza alimentare e
la crisi ecologica devono essere letti non tanto come il risultato dell’esclusione, ma piuttosto come
conseguenza della stessa incorporazione nel mercato mondiale e nelle relazioni di produzione
che esso richiede, che, a loro volta, si basano su relazioni strutturali di disuguaglianza di diverso
tipo (di classe, di generazione, di genere, ecc.).
Il settore agro-alimentare è il settore che meglio esemplifica questo stato di cose. A
partire dalla riconfigurazione neo-liberista dei rapporti di produzione e distribuzione a livello
globale, avvenuta negli anni ‘80, il settore agro-alimentare è caratterizzato sempre più da un
evidente paradosso che lo rende il maggiore responsabile del cambiamento climatico in atto e,
allo stesso tempo, il principale generatore di fame e povertà. L’attività agricola è responsabile
della produzione di gas serra per una quota pari al 33% delle emissioni totali. Allo stesso
tempo, tuttavia, come in un vortice di causa ed effetto, il settore agro-alimentare è anche il
settore che subisce in misura maggiore gli impatti del cambiamento climatico.
Ma questo alto grado di vulnerabilità delle produzioni agricole di fronte agli
stravolgimenti del clima vale per tutti gli addetti coinvolti nel settore? Coinvolge tutte le forme
di agricoltura? Evidentemente no, ed è qui che si apre uno degli scenari più esplicativi dello
stretto rapporto tra giustizia ambientale e giustizia sociale. L’accelerazione del degrado
ambientale e del cambiamento climatico sta colpendo direttamente la produzione agricola e
la sicurezza alimentare di più di un miliardo di persone che vive già in condizioni di
povertà. Si tratta per la maggior parte di contadini poveri, qualcuno preferisce parlare di excontadini, visto che la doppia esposizione – al cambiamento climatico, così come all’attuale
sistema di produzione – ha innescato un profondo cambiamento sociale nelle zone rurali. Da
un lato si assiste ad una concentrazione del potere economico e politico nelle mani delle
multinazionali, dall’altra vi sono gli impatti distruttivi della crisi ecologica: i due fenomeni
insieme determinano una “stretta” sulla piccola attività agricola e innescano un processo di
differenziazione socio-economica. In questa situazione solo una piccolissima parte di contadini
30
riesce a garantirsi l’autosussistenza, mentre un esercito di contadini poveri non riesce più a
mantenere la propria attività ed ha pertanto cominciato a diversificare i propri mezzi di
sussistenza verso attività non-agricole. L’abbandono dell’attività agricola significa, a volte,
abbandonare anche la terra stessa, venderla o cederla in affitto agli agricoltori “benestanti” e,
successivamente, riversarsi in altre forme occupazionali, spesso informali o illegali, affollando
quelle cinture di povertà che circondano i principali centri urbani, in cerca della sopravvivenza
propria e delle proprie famiglie.
Box 7
L’agroecologia come alternativa all’agro-industria
L’Agroecologia è una disciplina scientifica relativamente nuova che, rispetto all’agronomia convenzionale, si
basa sui principi dell’ecologia per la progettazione e la gestione di sistemi agricoli sostenibili. L’agroecologia
osserva gli elementi di un ecosistema agricolo e le interazioni tra di essi proponendo principi e metodi di
lavoro che prendano in esame non solo l’aspetto produttivo ma anche la dimensione ecologica, tecnica,
socioeconomica e culturale del sistema agricolo. Gli obiettivi sono l’aumento della funzionalità e della
produttività, la preservazione della biodiversità, il riciclo dei nutrienti, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse
locali e l’autosufficienza economica delle aziende agricole locali. Questa tecnica agricola rivaluta le
conoscenze tradizionali dei popoli indigeni e dei contadini basate sull’armonia con i diversi ecosistemi della
Terra e le pratiche agricole ancestrali spezzate dall’espansione della rivoluzione verde durante il XX secolo.
L’agroecologia mette al centro del sistema il produttore e le sue conoscenze come fattore insostituibile, così
come lo sono le caratteristiche fisiche e biologiche di ogni unità di produzione. Enfatizza l’importanza della
partecipazione dei contadini per contrastare il processo di monopolizzazione della produzione agricola basato
sul profitto a breve termine. I contadini, insieme a studiosi e movimenti sociali di tutto il mondo, sono
consapevoli dell’inevitabilità di una transizione agricola.
Si stima che in America Latina circa un milione e mezzo di piccoli agricoltori adottino già tecniche agro
ecologiche. Ad esempio – secondo le stime di Miguel Altieri, professore di Agroecologia all’Università di
Berkeley – in Messico, la conversione dal sistema chimico a quello agro ecologico delle proprie coltivazioni di
caffè ha portato circa 100.000 produttori ad aumentare del 50% la produttività di quelle coltivazioni.
Nonostante l’agroecologia sia ancora un ambito in fase di sviluppo, il relatore speciale sul diritto
all’alimentazione dell’ONU, Olivier De Schutter, nel suo rapporto all’Assemblea Generale sul diritto
all’alimentazione13 del 20 dicembre 2010, ha identificato in essa la strada giusta per l’applicazione del diritto
all’alimentazione, a discapito dell’agricoltura industriale.
L’agroecologia combina dunque la rivalorizzazione dei metodi di coltivazione contadina tradizionali con
l’innovazione delle nuove politiche ecologiche e mira a:
- Migliorare il riciclaggio della biomassa, ottimizzare la disponibilità di nutrienti ed equilibrare il flusso di
sostanze nutritive;
- Assicurare che il suolo mantenga le condizioni favorevoli alla crescita delle piante, attraverso una corretta
gestione della sostanza organica e del sottobosco e migliorando l’attività biotica del suolo;
- Minimizzare le perdite dell’energia solare, dell’aria e dell’acqua attraverso la gestione del microclima, la
13
Fonte: http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1174-report-agroecologyand-the-right-to-food.
31
raccolta di acqua e la gestione del suolo attraverso una maggiore copertura del suolo;
- Garantire la diversificazione genetica e delle specie dell’agro-sistema nel tempo e nello spazio;
- Migliorare le interazioni biologiche vantaggiose e i sinergismi tra i componenti dell’agrobiodiversità per
promuovere i servizi e i processi ecologici chiave.
Nonostante la gravità della situazione, la UNFCCC non è stata capace di mettere in
discussione i modelli di consumo e di produzione attuali, fondati sull’idea illusoria che la crescita
economica possa essere illimitata. Anzi, come abbiamo visto, con l’introduzione dei CDM sono
stati creati nuovi mercati e nuove opportunità di accumulazione. Gli esempi sono molteplici: tra i
vari meccanismi di adattamento e mitigazione si distinguono la sostituzione di boschi con
piantagioni commerciali, lo sfruttamento della
biomassa come combustibile, progetti che
includono il commercio delle colture modificate geneticamente, la produzione di carbone
vegetale (il “biochar”) e lo sfruttamento dei territori comunitari, considerati terre improduttive
e marginali.
Sulla base di queste considerazioni sono molte le proposte avanzate da organizzazioni
sociali che lavorano sulle questioni legate alla sovranità alimentare e all’agricoltura organica come
soluzione alla crisi ecologica e climatica.
Box 8
Posizione di Via Campesina e di RIGAS sulla sovranità alimentare
Il movimento internazionale di Via Campesina raggruppa le organizzazioni contadine e di lavoratori
agricoli di tutto il mondo e ha come obiettivo principale l’adozione di politiche agricole e alimentari
solidali e sostenibili per far fronte a problemi inerenti alla sicurezza alimentare, la salute, l’impiego nel
mondo rurale, la crisi dei prezzi alimentari e i cambiamenti climatici. La Via Campesina individua
nella produzione alimentare agroecologica (vedi box 7) condotta dai piccoli agricoltori la miglior
risposta ai problemi dell’ambiente e della povertà.
Per la rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale - Rigas, promuovere e sostenere le economie
locali come base per la costruzione di un tessuto produttivo nuovo vuol dire anzitutto sostenere
l’agricoltura organica. In tal modo si otterrebbe, secondo le stime, il duplice risultato di supportare
l’occupazione con la stabilizzazione di 2 miliardi di posti di lavoro in tutto il mondo, e invertire la
rotta dei cambiamenti climatici di -2° centigradi, contribuendo a porre un freno al fenomeno dei nuovi
flussi migratori, tutelando allo stesso tempo la biodiversità (prima di tutto quella dei prodotti
agroalimentari) e valorizzando le conoscenze tradizionali che seguono i cicli naturali e non modificano
l’equilibrio ecologico del territorio. Rigas sottolinea che sono i contadini i veri “lavoratori verdi”, che
alimentano il 70% della popolazione, consumando poca acqua e petrolio a differenza dell’idroagrobusiness, grande produttore di emissioni.
32
Sappiamo perfettamente che le foreste possono e potranno rivestire un ruolo importante
nella lotta alla riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, la definizione di foresta proposta
dalla FAO e adottata dalla UNFCCC, come abbiamo visto in precedenza, si presta all’inclusione
delle piantagioni all’interno della definizione di foresta permettendo, attraverso i programmi
REDD, l’espansione delle piantagioni monocolturali come realtà sostitutiva delle foreste primarie.
I programmi REDD insomma invece di porre un argine al degrado delle foreste e alla
deforestazione, o di rappresentare una risposta reale ai problemi drammatici che ci apprestiamo a
vivere, si traducono in una nuova forma di “CO2lonialismo dei boschi”. Questa prassi rafforza vari
fenomeni: i conflitti per le risorse, l’esclusione dei senza terra, l’esclusione di forme di proprietà
collettiva della terra, la privazione di intere comunità della legittima aspirazione allo sviluppo delle
proprie terre e l’erosione dei valori culturali di conservazione senza fini di lucro
Abbiamo già spiegato perché la sostituzione delle foreste con le piantagioni
monocolturali, in termini ambientali, comporti un intervento drastico sulla biodiversità con gravi
effetti sulle comunità limitrofe. Vediamo ora meglio quali sono gli impatti di questo tipo di innesto
su territori agricoli.
La monocoltura è un paesaggio che non esiste in natura e non potrebbe esistere senza
l’intervento umano, ovvero senza dosi massicce di fertilizzati chimici e prodotti fitosanitari, oltre
che di ingenti quantità di acqua. Questo comporta dissesto delle risorse idriche, deterioramento
dei corsi d'acqua, inquinamento delle falde acquifere, erosione del suolo, perdita di
biodiversità, alterazione del clima locale e delle piogge, inquinamento dell’atmosfera
provocato da pesticidi e fertilizzanti, espulsione di intere comunità dalle proprie terre
ancestrali, violazione di diritti umani, ambientali e sociali, soprattutto ai danni delle donne,
deterioramento della diversità culturale, e di conseguenza diffusione della violenza sociale.
Alle comunità rurali limitrofe le foreste danno cibo e mezzi di sostentamento, attraverso
inputs fondamentali per l’agricoltura, quali la conservazione del suolo e dell’acqua. Le pratiche
agricole indigene si fondano tutte sul massimo rispetto delle diverse forme e funzioni delle foreste.
Si tratta di una cultura comunitaria che si basa sullo stretto legame tra foresta e agricoltura, che
l’attuale modello di sviluppo ha invece spezzato, considerando le foreste solo come risorse per
fini commerciali ed industriali e quindi in tal senso perfettamente sostituibili da piantagioni
monocolturali. La foresta naturale, nella sua diversità, rappresenta la ricchezza della biomassa, che
conserva l’acqua, difende i cicli nutritivi della natura e soddisfa i bisogni di cibo, combustibile,
foraggio, fertilizzante, fibre e medicamenti necessari alle comunità agricole. Al contrario le
foreste “artificiali”, come quelle di Eucalyptus, garantiscono elevati rendimenti nella produzione di
pasta per la carta, ma sono improduttive, oltre che dannose sotto il profilo ecologico relativo al ciclo
dell’acqua e alla sua conservazione, alla fertilità del suolo e ai bisogni umani di cibo e di produzione
alimentare. L’Eucalipto è persino incapace di produrre humus utile per la conservazione dell’acqua.
33
Un’altra importante produzione di biomassa da alberi forestali, trascurata da chi considera la foresta
solo dal punto di vista commerciale, è la resa in semi e frutta, come sostentamento per vaste
popolazioni tribali o rurali. Inoltre, la trasformazione delle foreste naturali diversificate in
monocolture uniformi permette il passaggio diretto dei raggi solari e delle piogge, che provocano,
rispettivamente, l’inaridimento del suolo a causa del sole e il suo impoverimento a causa delle
piogge.
Anche le piantagioni per la produzione di agro-combustibili o biocombustibili –
combustibili di origine vegetale invece che fossile – potranno ricevere crediti di carbonio attraverso
i CDM. Con questo tipo di monocolture, intere zone forestali o arabili verranno destinate alla
produzione di energia da biomasse, provocando più danni ambientali, sociali e alimentari di quanti
siano i benefici anche in termini di riduzione delle di emissioni. Di fatto abbiamo già spiegato che
le colture forestali non hanno la stessa capacità di assorbimento del CO 2 delle foreste.
Nei Sud del mondo l'espansione di coltivazioni per la produzione di biocombustibili, come
soia, mais, olio di palma, è spesso accompagnata da una politica di concentrazione della terra nelle
mani di pochi proprietari, con un effetto di esclusione dell'agricoltura su piccola scala e una
precarizzazione del mercato lavorativo. Le imprese che si approvvigionano di prodotti agricoli per
fini non alimentari rischiano di causare, con i loro investimenti, effetti disastrosi sulla sicurezza
alimentare delle popolazioni locali quando i prodotti agricoli destinati al mercato internazionale dei
biocarburanti entrano in diretta competizione con quelli destinati al consumo alimentare.
La crescita della domanda di biocarburanti, abbinata al meccanismo dei crediti di emissioni,
fornisce incentivi alle imprese produttrici e ai governi per spodestare i piccoli contadini delle loro
terre fertili e convertirle in terreni ad uso energetico, portando così ad un aumento delle persone che
soffrono la fame. La produzione di biocarburanti può causare indirettamente maggiore
deforestazione e conversione di terra. Quando i terreni agricoli esistenti si convertono alla
produzione di biocarburanti, l’agricoltura deve espandersi altrove per andare incontro alla domanda,
in continua crescita, di alimenti per cibo e spesso a spese di foreste, praterie, paludi e altri
ecosistemi ricchi di carbonio. Questo si traduce inevitabilmente in un’ulteriore diminuzione della
capacità di assorbimento delle emissioni di anidride carbonica.
Fra le altre false soluzioni contro il cambiamenti climatico che minacciano le foreste e la
sovranità alimentare, vi è il biochar, un carbone vegetale elaborato a partire dal riscaldamento
della biomassa, che viene utilizzato come fertilizzante. La produzione tradizionale di questo tipo di
carbone ha sempre fatto parte delle pratiche di fertilizzazione di molte comunità rurali. Tuttavia, le
proposte attuali sono per una produzione industriale su larga scale di questo tipo di carbone, il che
vuol dire piantare alberi che catturino anidride carbonica e bruciarli per produrre carbone vegetale
da mettere nel suolo. A parte le molte perplessità scientifiche sulla reale capacità di sequestro di
carbonio nel suolo, quello che più preoccupa dal punto di vista della giustizia sociale è che, affinché
34
questo processo abbia un reale impatto dal punto di vista climatico, immense distese di terra
vengono convertite in piantagioni dove far crescere alberi che verranno poi carbonizzati. Questo si
traduce inevitabilmente in un accaparramento massiccio di terre comuni e di foreste. Alcuni
sostengono che lo stesso processo può essere condotto su piccola scala o utilizzando i residui
agricoli piuttosto che coltivando nuove piantagioni di alberi. Tuttavia questa pratica, oltre a
permettere l’appropriazione di residui agricoli generalmente usati dai contadini come concime per
migliorare la resa delle loro terre, causa l’erosione e la degradazione del suolo, e quindi siccità.
Risulta emblematico che, se da un lato viene presentata l'immagine del biochar come adatto
all’implementazione da parte dei piccoli agricoltori, dall’altro per l’espansione di questa pratica
viene richiesta da più parti un’implementazione su larga scala di geo-ingegneria climatica.
In sintesi, l’argomento base su cui si fonda tutto l’impianto del CDM è lo sfruttamento
di territori comunitari, considerati terre improduttive e marginali. La corsa all’accaparramento di
ampi territori, presenti soprattutto nei paesi del Sud del mondo, è giustificata dalla convinzione che
questi vasti territori siano per la gran parte inutilizzati e in attesa di sviluppo. In realtà quando si
parla delle terre “marginali” dell’Africa, come dell’America Latina o dell’Asia, non si riconosce
che esiste già un’intensa pressione sulla terra e che solo pochissime aree, in realtà, possono essere
definite “marginali”. Queste terre infatti vengono già ampiamente utilizzate da piccoli agricoltori,
pastori, raccoglitori, cacciatori e da altre comunità indigene e rappresentano ecosistemi cruciali per
la biodiversità, per il ciclo dell’acqua e per la sopravvivenza di queste popolazioni. Lo
sfruttamento di territori “degradati o in degrado” per l’implementazione dei progetti CDM si
basa, inoltre, su un assunto falso: le piantagioni su larga scala non possono essere stabilite su terreni
degradati perché semplicemente non renderebbero. Probabilmente, quando si parla di “territori
degradati” si fa riferimento, in linea con la concezione sviluppista, alla sotto-utilizzazione, che non
equivale affatto a “degradazione” dal punto di vista delle comunità agricole limitrofe. Diversamente
da quanto riporta la vulgata prevalente, quelle stesse terre sono di vitale importanza per quelle
comunità, tanto che la crescente riduzione nell’accesso alle terre come pure alle altre risorse naturali
è sempre più annoverata tra le principali cause di violenti conflitti e atroci genocidi. Lo United
Nations Environment Programme (UNDP) ha, ad esempio, riscontrato nella scarsità d’acqua,
nell’impoverimento del suolo a causa della deforestazione e nella rapida perdita di significative
porzioni di terra coltivabile, i fondamentali fattori causali che hanno spinto il Darfur in quella
spirale di violenza che ha prodotto, dal 2003, 300.000 morti e più di due milioni di profughi 14.
14
Fonte: UNDP, http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?
ArticleID=5621&DocumentID=512&l=en
35
6. La sfida delle migrazioni
Dagli albori dell’umanità, lo spostamento di popolazioni indotto dai mutamenti climatici ha
tracciato la geografia e fatto la storia della specie umana. Lo scenario odierno mostra però elementi
nuovi. Le migrazioni ambientali di oggi sono infatti diverse, poiché differenti sono le dinamiche che
stanno alterando e distruggendo gli ecosistemi. In primis, i fattori antropici alla base dei
cambiamenti climatici, punta dell’iceberg del cambiamento ambientale globale, stanno
condizionando l’ambiente e la vita delle popolazioni a un ritmo impressionante. Come affermato dal
Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, l’epoca geologica attuale può essere definita
Antropocene, una vera e propria epoca dominata dall’uomo e dal suo impatto sull’ambiente.
Intere comunità, per lo più nel Sud globale, sono oggi costrette a lasciare le proprie terre a causa del
degrado ambientale accelerato dal riscaldamento planetario, conseguenza di un sistema di sviluppo
insaziabile ed iniquo che il Nord globale ha prodotto e sta portando avanti, non curandosi delle sue
conseguenze.
Mappa 1: Distribuzione dei punti maggiormente a rischio per il degrado ambientale e delle migrazioni di matrice
ambientale. Mappa del Progetto EACH-FOR, finanziato dalla Commissione Europea. Fonte: The Bridge, Rivista
trimestrale sull’integrazione europea.
36
Ragionando sui numeri vediamo che, fino al 2010, circa 50 milioni di persone sono state
costrette a migrare per cause ambientali, all’interno delle quali meritano una menzione quelle
direttamente connesse ai cambiamenti del clima. Lo scenario futuro è ancora più allarmante se
pensiamo che la comunità scientifica, diverse personalità del mondo accademico e alcune tra le
maggiori organizzazioni internazionali, quali l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati) e la IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), hanno dichiarato che
entro il 2050 si raggiungeranno i 200-250 milioni di rifugiati ambientali, con una media di 6
milioni di uomini e di donne costretti ogni anno ad abbandonare la propria terra. Altre stime
sostengono che la cifra sarà compresa tra i 400 milioni e un miliardo di profughi entro il 2100.
Milioni di persone sono attualmente in fuga spinte da cause di tipo ambientale ovvero
dall’inesorabile processo di deruralizzazione, dalla perdità di biodiversità e fertilità dei suoli,
dall’aumento della temperatura degli oceani, dallo scioglimento dei ghiacciai, dall’innalzamento del
livello del mare, dall’aumento delle precipitazioni intense e dalle fasi di siccità e – parallelamente –
dalla desertificazione e dalla deforestazione. Particolarmente interessante è la stretta relazione tra
cambiamento climatico, degrado delle foreste e migrazioni. L’aumento delle temperature e i sempre
più estremi eventi meteorologici stanno già provocando un forte impatto sulle foreste, il cui compito
principale, determinante nel mitigare i mutamenti del clima, è di trattenere ed assorbire il biossido
di carbonio. Distruggendo le foreste si impedisce loro di assolvere alla funzione di cattura di Co2
con un impatto negativo sul clima. La deforestazione ha anche altre implicazioni negative, in quanto
è causa di desertificazione, erosione del terreno, frane e smottamenti in aree piovose e collinari e del
progressivo peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che le abitano. Le cause della
distruzione delle foreste sono diverse ed interdipendenti tra loro: l’aumento dell’indice
demografico, la realizzazione di infrastrutture, la maggiore richiesta di terra, lo sfruttamento delle
risorse, le nuove tecnologie che permettono in tempi brevi di abbattere alberi secolari e disboscare
qualsiasi tipologia di terreno. Sono le popolazioni locali – i Pigmei in Africa, i popoli indigeni
amazzonici, i Penan in Malesia per fare alcuni esempi – le prime vittime della deforestazione e della
degradazione delle foreste, costrette a migrare per via della perdita dei mezzi di sussistenza e
vedendo minacciata è anche la loro identità culturale.
Il caso del popolo Penan in Malesia è particolarmente interessante. Oltre ad ospitare uno dei
più ricchi ecosistemi del mondo, le foreste tropicali che ricoprono il territorio della Malesia sono
riconosciute come le più antiche del nostro pianeta. Purtroppo, dagli anni ’70, i commercianti di
legname e i coltivatori di palma da olio – con l’autorizzazione del Primo Ministro Taib Mahmud (in
carica da 30 anni) – stanno distruggendo le foreste a un ritmo tre volte superiore che nel resto
dell’Asia. Le ricadute ambientali sono ovviamente enormi e di varia natura: viene distrutto un
grande polmone verde del pianeta e si riduce la biodiversità, la geomorfologia del territorio si
modifica e si immette nell’atmosfera una gran quantità di anidride carbonica. I terreni sono
37
convertiti in piantagioni di palma da olio e destinati alla costruzione di megaprogetti, con
ripercussioni devastanti sui popoli indigeni, che stanno cercando strenuamente di difendere la loro
foresta e di lottare per il proprio diritto alla terra e alla vita. Il governo continua ad affermare che il
taglio del legname viene effettuato in maniera sostenibile, ma da sempre, invece, a farne le spese
sono i numerosi gruppi etnici che abitano le foreste del Sarawak, regione situata nella parte malese
del Borneo. Primi fra tutti vi sono i cacciatori-raccoglitori Penan, che accusano il governo di
appoggiare le grandi compagnie del legno (Samling, Rimbunan Hijan, KTS, Shin Yang, Ta Ann),
che stanno letteralmente distruggendo le loro terre e violando ogni loro diritto. Il governo Sarawak
non riconosce i diritti dei Penan, sostenendo che questi non possono godere di diritti territoriali a
meno che non decidano di diventare sedentari o agricoltori. I Penan dipendono dalle loro foreste
per cacciare e raccogliere sago, frutti e rattan, utilizzato per intrecciare cesti e altri manufatti.
Particolarmente significativa è la dichiarazione di un uomo Penan all’organizzazione Survival
International: “Noi non siamo come gli altri popoli che possono vivere con il denaro. Senza la terra
non saremmo in grado di sopravvivere”.
Dagli anni ‘80 ha così avuto inizio la resistenza di questo popolo. Negli anni si è avuta
purtroppo un’escalation di violenza ai danni delle comunità che, oltre a vedere costantemente violati
i propri diritti civili, subiscono ogni tipo di violenza e abuso (compresa la violenza sessuale sulle
donne, come è stato dimostrato da un’inchiesta sullo stupro di alcune donne Penan 15). Malgrado la
pressione internazionale e i dettami della Convenzione Onu sui Diritti degli Indigeni, che
impongono ai governi di consultarsi e cooperare con le comunità indigene, la situazione non ha
subito modifiche. La questione del reinsediamento delle comunità Penan per far posto alla diga di
Murum esemplifica la grave vulnerazione di diritti e la scarsissima attenzione riservata dalle
istituzioni alle giuste istanze portate avanti da questo popolo. Più di 1000 cacciatori-raccoglitori
Penan sono stati costretti a lasciare la loro foresta con la promessa di reinsediarli in un territorio che
però nel frattempo era già stato venduto dal governo alla compagnia malese Shin Yang. Nel 2011,
un gruppo di Penan è riuscito ad ottenere un’importante vittoria sul gigante della palma da olio Shin
Yang, costretta a sospendere i lavori “in attesa che le autorità verifichino” se si tratti o meno di terra
destinata alla tribù.
I migranti ambientali sono obbligati a lasciare le proprie terre, per lo più aree rurali tra le più
povere al mondo. Il più delle volte, però, essi non sono nella condizione di affrontare viaggi oltre i
confini del proprio Paese e dunque si spingono “semplicemente” nelle città più vicine (parliamo
allora di Internal Displaced Persons – IDPs). Si innesca così un processo di urbanizzazione
selvaggia che, nelle realtà in via di sviluppo, assume contorni drammatici, con forti implicazioni di
natura ambientale e socio-economica. I miraggi dei centri urbani, per gli abitanti dei Paesi più
15
AA.VV., “A Wider Context of Sexual Exploitation of Penan Women and Girls in Middle and Ulu Baram,
Sarawak, Malaysia”, SUARAM Kommunikasi, Selangor (Malesia), 2010. Rapporto della missione d’inchiesta
condotta in Malesia dal Penan Support Group, il Forum-Asia e dall’Asian Indigenous Women’s Network (AIWN).
38
poveri come quelli dell’Africa sub-sahariana, si traducono in un crollo di tutte le aspettative, poiché
il viaggio termina nelle cinture periferiche delle megalopoli, gli slum. Aree dove si sopravvive
attraverso scambi tra poveri. Secondo il Rapporto “The Challenge of Slum” di UN-Habitat del
200316, sono oggi un miliardo le persone che vivono nelle periferie ed è già prevedibile che nei
prossimi 30 anni il numero raddoppi. Su questi dati Davis Mike, autore del libro Pianeta degli
Slum17, è riuscito a fornire una dettagliata fotografia della situazione globale di migliaia di persone
ai margini delle megalopoli (Lima, Manila, Nairobi e tante altre).
In generale, si possono distinguere, da un punto di vista concettuale, due tipi di migrazioni
di matrice ambientale: da un lato le migrazioni indotte da calamità naturali quali alluvioni,
terremoti, cicloni, incendi, ecc., dall’altro le migrazioni spinte dai cambiamenti ambientali:
deforestazione, desertificazione, innalzamento del livello del mare, perdita della biodiversità. A
livello globale, i flussi migratori arrivano principalmente dalle terre aride dell’area del Sahel – la
fascia di prateria semi-arida e della savana tra il Senegal e l’Etiopia – dal Corno d’Africa, da altre
zone dell’Africa sub-sahariana soggette a carestia, dalla Cina, dal Messico, da El Salvador e dal
Kenya. Non possiamo trascurare in questa mappatura le Piccole isole del Pacifico, a rischio per
l’innalzamento del livello del mare, così come il Bangladesh che rischia di perdere gran parte del
suo territorio costiero.
Box 9
Migrazioni ambientali e cambiamento climatico: la posizione dell’Unione delle Piccole Isole del
Pacifico in via di sviluppo (PSIDS)
Le piccole isole del Pacifico sono tra i Paesi maggiormente minacciati dall’innalzamento del livello del mare,
che potrebbe far scomparire buona parte delle loro terre mettendo in fuga migliaia di persone. I leader di questi
Paesi hanno indicato il cambiamento climatico come la più grande minaccia al sostentamento, alla sicurezza e
al benessere dei loro popoli. Consapevoli di questo pericolo si sono mobilitati per cercare una soluzione atta a
gestire l’emergenza dei profughi ambientali, muovendosi su due fronti: stipulando accordi con i governi dei
Paesi confinanti per l’accettazione dei profughi e presentando all’Assemblea Generale dell’ONU la risoluzione
“The threat of climate change to International peace and security” (settembre 2008). La risoluzione richiama
l’art.11 della Carta ONU, che prevede la possibilità, da parte dell’Assemblea Generale, di portare dinanzi al
Consiglio di Sicurezza tutte quelle situazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Tale risoluzione considera il cambiamento climatico come una minaccia alla sicurezza umana e propone tre
azioni concrete:
- portare la questione dei cambiamenti climatici dinanzi al Consiglio di Sicurezza;
16
17
UN-Habitat, “The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements”, Earthscan Publications Ltd.,
Londra, 2003
Davis Mike, Il pianeta degli slum, Feltrinelli editore, 2006.
39
- chiedere a quest’ultimo di attuare una serie di raccomandazioni relative ai cambiamenti climatici e alla pace e
alla sicurezza internazionale;
- invitare il Segretario Generale a discutere dinanzi all’Assemblea delle conseguenze del cambiamento
climatico, della sicurezza e delle azioni in merito intraprese dal Consiglio di Sicurezza.
Nel testo non si fa esplicito riferimento ai profughi ambientali, ma è chiaro che si stia parlando di loro e delle
possibili conseguenze che, a livello di conflitto, potrebbero innescare i flussi migratori, sia all’interno degli
Stati che oltre i confini, mettendo a rischio la sicurezza internazionale. Ciò che preoccupa maggiormente gli
Stati confinanti è che, con l’approvazione di questa risoluzione, il Consiglio di Sicurezza possa intervenire su
questioni di sovranità nazionale. Tale risoluzione rappresenta ad ogni modo un’importante base giuridica per
avviare il riconoscimento dello status giuridico di rifugiato ambientale.
Il fenomeno delle migrazioni ambientali è dunque molto complesso ed è stato, negli ultimi
decenni, amplificato dal notevole aumento dei disastri ambientali. Pensiamo che tra il 2005 e il
2007 l’UNICEF ha risposto a una media di 276 emergenze in 92 paesi, oltre la metà delle quali
causate da calamità naturali18. Altrettanto significativi sono i dati del Rapporto Mondiale sullo
Sviluppo Umano dell’UNDP19 del 2007-2008, che identifica ad oggi 344 milioni di persone a
rischio di cicloni tropicali, 521 milioni di persone a rischio inondazioni, 130 milioni esposte alla
siccità e 2,3 milioni esposte al pericolo di smottamenti di terreni e frane. Tuttavia, nonostante la
portata del fenomeno e la sua complessità, esiste ancora un vuoto normativo riguardo la tutela
giuridica internazionale di questi migranti. L’utilizzo dell’espressione “rifugiato ambientale”,
diventata oggi di uso comune, va a scontrarsi con il diritto, in quanto i migranti ambientali non
rientrano né nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951) né nel Protocollo
aggiuntivo del 1967, che considerano validi per il conseguimento dello status solo “motivi di razza,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le opinioni politiche” (art.1 della
Convenzione di Ginevra). È per questo che i rifugiati ambientali non godono a livello internazionale
di tutela specifica e non sono riconoscibili come richiedenti asilo, ma continuano piuttosto ad essere
inclusi nella categoria delle migrazioni indotte da fattori economici con tutti i limiti che tale
classificazione porta con sè.
18
19
Fonte: UNICEF, Humanitarian Action Report 2009, scaricabile per intero sul sito:
http://www.unicef.org/har09/index.html
Il Rapporto HDI dell’UNDP del 2007-2008 è scaricabile per intero sul sito:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/
40
Box 10
Necessità di un riconoscimento giuridico dello status di rifugiato ambientale
È evidente che il mutare delle tendenze globali della migrazione e l’aumento drammatico degli esodi di massa
per cause ambientali negli ultimi anni abbiano messo in dubbio l’attualità e l’efficacia della Convenzione di
Ginevra. Il vuoto normativo in relazione ai profughi ambientali si presenta pertanto lampante e l’assistenza
umanitaria da parte dell’UNHCR e degli Stati non è sufficiente a garantire un’esistenza sicura e dignitosa a
queste persone. Al fine di assicurare una protezione completa ai profughi ambientali si dimostra quanto mai
necessaria un’azione delle Nazioni Unite volta a garantire, in tempi brevi, una protezione giuridica specifica.
Ancora più urgente è, tuttavia, l’adozione di una definizione condivisa a livello internazionale di rifugiato
ambientale, definizione che, nonostante si parli di rifugiati ambientali già dal 1970, ancora non esiste.
Molti studiosi ed attivisti si stanno impegnando al fine di ottenere un riconoscimento legale dello status di
rifugiato ambientale. Dal 2002 un’apposita organizzazione, LISER – Living Spaces for Environmental
Refugees - si occupa di assistere queste persone con il fine di ottenerne il riconoscimento giuridico e quindi la
protezione a livello internazionale. Nel 2005, importanti sono state le parole provenienti dal mondo
accademico e pronunciate da Janos Bogardi, direttore dell’Università delle Nazioni Unite per l’Ambiente e la
Sicurezza Umana, il quale ha dichiarato, parlando di persone messe in fuga da fattori ambientali: “Questa
nuova categoria di rifugiato ha bisogno di trovare spazio negli accordi internazionali. E noi dobbiamo
anticipare le richieste di aiuti così come per tutte le altre categorie di persone”.
Altra questione importante riguarda le politiche migratorie attuate dai singoli stati e dall’UE che vanno spesso
nella direzione di chiudere le frontiere. Di fronte alle crescenti emergenze, le politiche di respingimento
dovrebbero lasciare il posto a delle politiche migratorie inclusive in grado di garantire diritti ai migranti, che
siano vittime di guerra, di disastri naturali o del deterioramento delle condizioni ambientali. In questa
direzione, uno degli aspetti fondamentali quando i migranti arrivano in un Paese straniero è quello di
assicurare loro la legalità del soggiorno, al fine di ricevere gli aiuti necessari per potersi integrare nella società.
Un altro aspetto importante sul quale lavorare, che però viene trascurato dai governi, è quello di prevedere
strumenti che rendano chiare le motivazioni che spingono i migranti a lasciare la propria patria.
Due buoni esempi in tal senso vengono dalla Svezia e dalla Finlandia, Paesi che hanno incluso i migranti
ambientali nelle loro politiche migratorie nazionali, riconoscendo lo status di migrante ambientale e
proteggendo giuridicamente coloro che fuggono dai disastri ambientali. Seguendo questa strada si potrebbe
avanzare verso il concreto riconoscimento giuridico dello stato di rifugiato ambientale a livello internazionale.
In ambito europeo la questione delle migrazioni ambientali fatica ad inserirsi nell’agenda
comunitaria. Spunti al dibattito sono stati avanzati dal gruppo dei Verdi Europei, senza che però ciò
si sia tradotto in avanzamenti concreti. Nel valutare tale situazione non possiamo non constatare le
difficoltà mostrate dall’Europa e dai singoli Stati membri, nel gestire i flussi migratori. La posizione
europea risulta alquanto ambigua rispetto ai flussi migratori, tanto che gli Stati UE tendono ormai a
prevenire gli arrivi dei migranti decentrando i controlli e affidando agli Stati della periferia europea
compiti costosi e delicati in materia di gestione delle migrazioni irregolari e di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati. Questi Stati però, il più delle volte non sono in grado di offrire
41
adeguate garanzie di rispetto dei diritti umani fondamentali e favoriscono politiche di controllo
scarsamente democratiche. Pensiamo semplicemente a quanto accade in Italia. Il nostro Paese, oltre
a caratterizzarsi per un ritardo delle leggi che regolamentano i flussi migratori, mostra un percorso
legislativo che, dagli anni ’90, con la legge Martelli, seguita dalla Turco-Napolitano (1998) fino ad
arrivare alla Bossi Fini (2002), è andato ad incidere sui migranti in senso vessatorio e punitivo fino
a culminare, nel 2009, nell’introduzione del reato di clandestinità.
I governi dunque propendono sempre di più verso politiche di respingimento, creando nella
società civile un atteggiamento schizofrenico che oscilla tra l’accoglienza e la psicosi. Si fa pertanto
sempre più impellente la necessità di garantire ai cittadini una visione realistica delle dinamiche che
muovono gli immigrati a lasciare le proprie terre e di descrivere la loro condizione di vita nel
momento in cui arrivano nei nostri Paesi. Tutto questo può contribuire a sviluppare una visione del
mondo multietnica dove la diversità possa diventare uno stimolo capace di arricchire la crescita di
tutti noi, in un rapporto di reciproco scambio e dove, a tutti gli esseri umani senza alcuna
discriminante, siano riconosciuti i diritti fondamentali.
Box 11
Strumenti necessari per creare una cultura dell’accoglienza:
formazione, informazione e sensibilizzazione
Per poter creare una cultura dell’accoglienza e della solidarietà gli strumenti di base sono innanzitutto la
formazione, l’informazione e la sensibilizzazione della società civile, delle istituzioni e dei decision makers.
Utilizzando appieno il potenziale offerto da questi strumenti, è possibile creare un terreno fertile per il
riconoscimento del fenomeno della migrazione per cause ambientali e dello status di rifugiato ambientale.
Nel riuscire a delineare dei percorsi coerenti alle specificità dei diversi flussi migratori, sono sempre
necessarie conoscenze, competenze, modelli di intervento, capaci di accogliere la dinamicità ma anche gli
elementi di continuità dei flussi migratori. È necessario andare oltre le superficiali descrizioni della realtà
migratoria fatta dai mass media che, attraverso immagini strumentalizzate e linguaggi “scorretti”, danno
un’immagine “naturalmente problematica” degli immigrati generando il più delle volte un sentimento di rifiuto
da parte della cittadinanza nell’accogliere questi migranti, raccontati come una minaccia e non come una
risorsa.
In Italia, nel 2009 l’Università “La Sapienza” di Roma ha condotto un’interessate ricerca 20 su immigrazione e
asilo nei media italiani. Dai risultati ottenuti è emerso chiaramente come l’immigrazione e la presenza
straniera in Italia siano appiatitti sulla dimensione dell’emergenza, della sicurezza e della visione problematica
del fenomeno. In questo ambito, molte organizzazioni, tra cui la Casa dei Diritti Sociali, stanno dando un
apporto concreto focalizzandosi su diverse iniziative nel campo sociale, culturale e ambientale, iniziative
incentrate su strategie di auto-aiuto e di promozione dei diritti di cittadinanza al fine di riaffermare il diritto di
20
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione, “Ricerca nazionale su
immigrazione e asilo nei media italiani”, Roma, 2009.
42
ognuno ad essere parte attiva della società.
43
7.Verso la giustizia climatica
Le migrazioni ambientali sono solo uno degli effetti dei cambiamenti climatici in termini di
generazione di ingiustizie. La grave portata degli impatti provocati dagli sconvolgimenti climatici
sull’ambiente, ma anche sulla società e sull’economia, produce nella realtà altrettanti profili di
vulnerabilità e di ingiustizia. L’accesso alle risorse naturali, alla terra e al cibo, il diritto a vivere in
un ambiente sano e sicuro, la sovranità dei popoli, sono fra i diritti fondamentali che la morsa dei
cambiamenti del clima riduce ogni giorno di più e che viene rafforzata dalle mancate decisioni e
dalle false soluzioni implementate dalla Governance globale.
Con il termine Giustizia Climatica si pone l’accento sulle conseguenze sociali, economiche
ed ambientali ineguali che il cambiamento climatico produce in capo alle popolazioni. Infatti sono
troppo spesso le popolazioni dei paesi del sud del mondo, che molto poco hanno contribuito alle
emissioni di Co2 che hanno causato tali stravolgimenti, a pagare il prezzo più alto in termini di vite
e distruzione del territorio. Ciò genera una ingiustizia contro la quale molte organizzazioni hanno
iniziato a lavorare reclamando giustizia ambientale e di seguito climatica (che ne è una
specificazione). Per capire che cos’è l’ingiustizia climatica basta partire da alcuni dati base del
cambiamento climatico: chi inquina e chi paga? Un cittadino statunitense produce annualmente
24 tonnellate di gas serra, sette volte di più di un cittadino dei Sud del mondo. Se i cambiamenti
climatici colpiscono tutti, il Sud globale è come abbiamo detto il primo però a subirne gli effetti. In
questo senso è fondamentale che i principali Paesi inquinatori assumano a pieno le loro
responsabilità. L’ultimo rapporto dell’IPCC del 2007 conferma che i cambiamenti climatici
colpiscono in misura maggiore i Sud del mondo non solo per via di fattori geomorfologici e
topografici, ma anche perché il grado di vulnerabilità di una popolazione – che dipende dalle
caratteristiche geografiche, politiche e istituzionali, dalla distribuzione delle risorse, dall’accesso
all’informazione e dalla disponibilità di tecnologie e fondi di un dato territorio – influisce
sull’intensità degli effetti dello sconvolgimento climatico.
Parlare di giustizia ambientale e climatica significa inevitabilmente parlare di giustizia
sociale e dunque di lotta contro la povertà, le prevaricazioni, le violazioni dei diritti e della loro
relazione con il degrado ambientale. Il cambiamento climatico in primis – classificato a livello
internazionale come moltiplicatore di minacce, in quanto accelera tendenze e instabilità esistenti e
rappresenta un pericolo per la sicurezza e lo sviluppo locale ed internazionale – sta avendo un
impatto drammatico sulla vita di decine di migliaia di comunità di tutto il mondo. Le popolazioni
più vulnerabili hanno meno capacità di intervenire per mitigare e adattarsi agli impatti del
cambiamento climatico, anche perché nella gran parte dei casi si tratta di popolazioni che vivono in
regioni collocate ai margini della divisione internazionale del lavoro e della distribuzione della
44
ricchezza mondiale, legate principalmente alla produzione agricola, settore che, più di altri, sta
risentendo dei cambiamenti del clima.
Box 12
Debito Ecologico e Debito Climatico
I Paesi industrializzati, dopo anni di sfruttamento e saccheggio delle risorse dei Sud del mondo, hanno
accumulato un debito sociale, storico ed ecologico, mentre le loro stesse attività economiche e produttive
contribuivano a far lievitare il debito estero dei Paesi del Sud globale, che ha costituito il maggiore ostacolo
allo sviluppo economico di tali paesi dagli anni ’70 ad oggi. Del debito ecologico fa parte anche il cosiddetto
debito climatico ovvero il debito contratto da paesi a forte industrializzazione per la gran quantità di
emissioni prodotte (che hanno contribuito al processo di cambiamento climatico) e per gli effetti devastanti
in tal modo prodotti nei paesi del sud.
Liberare i Paesi cosiddetti “in via di sviluppo” dal peso del debito estero significherebbe, in primis,
l’assunzione da parte del Nord globale della propria responsabilità economica, sociale ed ecologica
accumulata nella storia, e in secondo luogo permetterebbe ai Paesi del sud di svincolarsi dal legame di
sottomissione con il Nord e di raggiungere una maggiore sovranità e capacità di azione dal locale al globale.
Le proposte che vanno verso il riconoscimento del debito climatico trovano dunque la loro origine nelle analisi
e nelle rivendicazioni legate al debito estero dei Paesi del sud globale verso i Paesi del Nord globale.
Per i movimenti sociali riunitisi a Cochabamba, nell’aprile 2010 per la Conferenza dei popoli sui
cambiamenti climatici e per i diritti della Madre Terra, il primo passo da compiere verso la giustizia climatica
da parte dei Paesi detti “sviluppati” – principali responsabili dell’attuale stravolgimento climatico e del
degrado ambientale - è quello di assumersi la propria responsabilità storica e attuale, riconoscendo e onorando
il proprio debito climatico in tutte le sue dimensioni, come base per una soluzione giusta, effettiva e
scientifica al cambiamento climatico. Fra le misure raccomandate21:
-la restituzione ai Paesi dei Sud del mondo dello spazio atmosferico attualmente occupato dalle emissioni di
gas serra dei principali inquinatori. Questo implica la decolonizzazione dell’atmosfera attraverso la riduzione e
l’assorbimento delle loro emissioni;
-la compensazione per la perdita delle opportunità di sviluppo derivanti dal vivere in uno spazio atmosferico
ristretto e il trasferimento tecnologico da parte dei Paesi inquinatori verso i Paesi dei Sud del mondo;
-l’assunzione di responsabilità per i milioni di persone che dovranno migrare a causa del cambiamento
climatico da essi provocato e l’eliminazione delle proprie politiche restrittive in materia di migrazione,
offrendo ai migranti una vita dignitosa e diritti garantiti;
-l’assunzione del debito di adattamento legato agli impatti del cambiamento climatico nei Paesi dei Sud del
mondo, fornendo i mezzi per prevenire, minimizzare e facendo attenzione ai danni causati dalle loro eccessive
emissioni;
-il riconoscimento di questo debito come parte di un debito maggiore con la Madre Terra, adottando e
applicando la Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra nelle Nazioni Unite.
21
Tra le altre proposte emerse nel corso della Conferenza di Cochabamba: limitare l’incremento della
temperatura a 1° C; ridurre le emissioni di oltre il 50% entro il 2017; costituire un Tribunale Internazionale di
Giustizia Climatica; impedire la creazione di nuovi mercati del carbonio; destinare il 6% del PIL dei Paesi
sviluppati per finanziare le azioni contro il cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo.
45
Quanto sta accadendo a livello globale necessita di una profonda riflessione. È necessario
ripensare un modello di sviluppo capace di creare un equilibrio tra la sostenibilità ambientale e la
tutela dei diritti degli esseri umani.
Tentare di salvare il Pianeta Terra significa necessariamente mettere in discussione l’intero
sistema economico attuale, fondato sulla concorrenza, il profitto e la crescita illimitata a danno
dell’ambiente, dei diritti della natura e degli uomini stessi. Questo sistema ha generato una
profonda lacerazione nel rapporto tra uomo e natura, concepita come oggetto di dominio e non più
come “Madre Terra”, garante delle risorse essenziali per la sopravvivenza dell’uomo. Beni come
l’acqua, la biodiversità, la terra, i saperi ancestrali, ecc., vengono ridotti a mera merce. Continuando
a percorrere questa strada è inevitabile che si arrivi ad un punto di non ritorno, non solo nel
rapporto tra uomo e natura ma anche per quanto riguarda le relazioni fra i popoli.
Box 13
Buen vivir e Diritti della natura
Seguendo la prospettiva del Buen Vivir – del vivere bene in armonia con la natura e fra i popoli – si inverte la
percezione occidentale che l’uomo ha della natura: non siamo noi a dominarla, ma è lei ad offrirci la vita. In
questo senso, l’accordo di Cochabamba preme sul fatto che per affrontare il cambiamento climatico si debba
riconoscere la Madre Terra come fonte di vita e plasmare un nuovo sistema basato sui principi del Buen
Vivir:
-armonia ed equilibrio tra tutti e con tutti;
-complementarietà, solidarietà ed equità;
-benessere collettivo e soddisfazione delle necessità fondamentali di tutti in armonia con la Madre Terra;
-rispetto dei diritti della Madre Terra e dei diritti umani;
-riconoscimento dell’essere umano per quello che è e non per quello che possiede;
-eliminazione di ogni forma di colonialismo, imperialismo e interventismo;
-pace tra i popoli e con la Madre Terra.
Rafforzati dal protagonismo dei movimenti sociali, l’Ecuador e la Bolivia sono stati precursori nello sviluppo
un quadro politico e giuridico tale da permettere il riconoscimento della natura come soggetto di diritto, in
quanto garante del diritto alla vita. Dopo aver incluso i diritti della natura nelle loro rispettive nuove
costituzioni, entrambi i Paesi lo hanno sviluppato e integrato nei loro sistemi giuridici, rafforzando la capacità
di intervento per la protezione della natura e dei popoli di fronte alla distruzione ambientale in atto e ai suoi
impatti.
Fra le proposte del governo boliviano nelle istanze internazionali rientarno: la richiesta di riconoscimento, da
parte delle Nazioni Unite, dei diritti della Madre Terra e della risoluzione sull’acqua come diritto umano
universale, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel luglio del 2010.
46
La perdita dei mezzi di sussistenza per intere comunità rurali, la carenza dei beni
primari come acqua e cibo e la gestione non sostenibile delle risorse naturali stanno, infatti,
contribuendo ad aggravare situazioni di privazione ed ingiustizia sociale già esistenti. In
quest’ottica risultano significativi i dati del Rapporto dello United Nations Environment Programme
(UNEP) del 200922, che ha identificato almeno 18 conflitti violenti, a partire dal 1990, alimentati
dallo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, terreni fertili, minerali, boschi, petrolio, ecc.), e ha
evidenziato come, nel corso degli ultimi 60 anni, almeno il 40% dei conflitti intrastatali (guerre
civili come quelle in Angola, Congo, Darfur, Medio Oriente, ecc.) fosse legato alla gestione,
all’accesso e allo sfruttamento delle risorse naturali. La probabilità che le ostilità si
intensifichino è molto alta, sia per il crescente impatto che i cambiamenti climatici hanno
sull’ambiente, quindi su cibo, acqua e sulla diffusione di malattie, sia per l’aumento demografico
che implica una crescente richiesta di risorse.
Mappa 2: Distribuzione internazionale dei conflitti legati all’accesso e all’uso di risorse naturali, come la terra,
l’acqua, la popolazione ittica e la biodiversità. Fonte: “Cambiamenti climatici e governance della sicurezza: la
rilevanza politica della nuova agenda internazionale” – Rapporto Cespi maggio 201023.
22
23
UNEP (2009), From conflicts to Peacebuilding. The Role of Natural Resurces and the Environmental, Nairobi.
Fonte: http://www.cespi.it/OSSERVATORIO%20PI/PI0016App.pdf
47
Come si può allora frenare il cambiamento climatico? Inevitabilmente immaginando un
profondo ripensamento del modello di produzione, di distribuzione e di consumo, portando
proposte alternative all'attuale sistema economico che negli ultimi anni per salvare sé stesso
cerca di nascondere la propria voracità dietro una maschera chiamata “economia verde”, che non si
sta dimostrando efficace nel fermare il riscaldamento del globo né, tanto meno, nell’affermare
concretamente principi di equità e giustizia, sia essa sociale, ambientale o nello specifico climatica.
Box 14
Posizione dei popoli dell'Amazzonia:
centralità delle pratiche ancestrali e visione cosmocentrica
Le organizzazioni indigene appartenenti al Coordinamento delle Organizzazioni Indigene del Bacino
Amazzonico (COICA)24, oppongono alle proposte messe in campo dai governi sul clima proposte fondate sul
rispetto dei diritti umani, dei diritti collettivi e della Madre Terra e incentrate sulle conoscenze tradizionali e
delle pratiche ancestrali:
- consolidamento dei diritti territoriali indigeni e riconoscimento della loro sovranità sulle risorse naturali nella
giurisdizione internazionale e nazionale;
- riconoscimento della sapienza dei popoli indigeni sulla gestione dell’ecosistema della selva amazzonica,
delle tecniche locali e delle pratiche ancestrali;
- partecipazione effettiva e ampia dei popoli indigeni nei processi decisionali e nel disegno, implementazione e
monitoraggio delle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico sia nell’ambito delle
negoziazioni nazionali che in quelle internazionali;
- consegna della gestione e dell’amministrazione delle Aree Naturali Protette ai popoli indigeni contigui a
queste aree;
- applicazione vincolante del consenso libero e informato in tutti i processi di implementazione delle misure di
adattamento e mitigazione del cambiamento climatico nei territori indigeni;
- accesso dei popoli indigeni ai fondi di mitigazione, adattamento, per la costruzione di capacità e il
trasferimento di tecnologia;
- cancellazione dei meccanismi di mitigazione che prevedono la promozione delle monocolture e
l’introduzione di colture transgeniche ed esotiche che degradano la selva e i suoli dell’Amazzonia,
contribuendo al surriscaldamento globale;
- cancellazione dei megaprogetti energetici, anche se basati su fonti dette “pulite” come l’idroelettrico;
- fine del nucleare e reinvestimenti dei finanziamenti al nucleare verso programmi sviluppo per la sovranità
alimentare, l’educazione e la salute;
- ripristino del controllo statale della selva amazzonica in preda al narcotraffico, alle guerriglie e ai paramilitari
che impediscono l’implementazione di politiche di mitigazione;
- sviluppo di una politica congiunta di azione per la giustizia climatica tra gli Stati dell’area amazzonica,
attraverso la quale si implementino politiche sanzionatorie nei confronti dei Paesi che inquinano e politiche di
indennità ai Paesi che ne subiscono i danni.
24
Fonte: COICA, http://www.coica.org.ec/sp/ma_declaraciones/declaratoria_camb-climatico.htm
48
Un dato importante che non va trascurato quando parliamo di cambiamenti del clima è che,
se sono gli Stati fragili a pagare il prezzo più alto dell’ingiustizia ambientale, l’Occidente non deve
sentirsi immune dal pericolo. L’uragano Katrina, che ha colpito nel 2005 gli Stati Uniti,
classificandosi come uno dei cinque uragani più gravi della storia del Paese, ne è una testimonianza.
Ma non dobbiamo andare così lontano per cercare altri esempi. Purtroppo sono ancora più recenti le
tragiche immagini della “tempesta tropicale” (così classificata dalla statunitense National Oceanic
Atmospheric Administration) che ha colpito la provincia di Genova nell’autunno del 2011
squarciando il velo sull'annosa tendenza a sottovalutare la portata della crisi ambientale che sta
travolgendo, seppur con impatti differenti, l’intero globo.
Box 15
Crimini ambientali: necessità di una disciplina giuridica penale
Secondo i movimenti della società civile impegnati per la giustizia climatica, commettere un crimine contro
l’ambiente equivale a compiere un crimine contro la stessa umanità. È per questo che il riconoscimento del
crimine ambientale, previo il riconoscimento del diritto all’ambiente come diritto umano fondamentale, è
divenuto sempre più urgente e necessario.
Partendo dalla dizione giuridica di cui all’art.7 dello Statuto di Roma: “...per crimine contro l’umanità si
intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro
popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco: omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù,
deportazione o trasferimento forzato della popolazione, imprigionamento, tortura, stupro e violenza sessuale,
persecuzione, sparizione forzata di persone, apartheid […] altri atti inumani di analogo carattere diretti a
provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o
mentale”, si deve evidenziare come il reato contro l’Umanità sia ormai concepito quale figura criminosa più
ampia, e dunque non più necessariamente correlata ad eventi bellici. L’introduzione di questo reato
obbligerebbe i responsabili a rispondere dei reati commessi dinanzi ad un organo competente e farebbe sì
che vengano applicate sanzioni che stabiliscano le responsabilità e tutelino l’ambiente e le comunità
colpite.
Varie sono le proposte in campo, come ad esempio quella di estendere il mandato della Corte Penale
Internazionale dell’Aja anche ai crimini commessi contro la “Madre Terra” o di creare nuove istanze
giuridiche e penali a livello nazionale e internazionale, come ad esempio un tribunale di giustizia ambientale
e climatica. In Cile, nel novembre del 2010, la Commissione per le Risorse Naturali della Camera dei
Deputati ha approvato, all’unanimità, il progetto per la creazione di un Tribunale Ambientale. In Europa, tutte
le proposte in tal senso rimangono per ora solo sulla carta. L’Accademia Internazionale di Scienze Ambientali
di Venezia (IAES), presieduta da Adolfo Perez Esquivel – Premio Nobel per la Pace nel 1980 – ha lanciato nel
2006 la campagna mondiale per l’istituzione di una Corte Penale Internazionale ed Europea per i Crimini
contro l’Ambiente25. Alla base della proposta sta l’idea di ampliare le competenze della Corte Penale
Internazione includendo la nuova figura di reato relativa ai crimini ambientali. Per fare ciò è necessario
25
IAES – Carta per il riconoscimento del disastro ambientale intenzionale quale crimine contro l’umanità.
Disponibile sul sito dell’IAES: http://www.iaes.info/carta_crimini/Charter2006_it.pdf.
49
modificare lo statuto della corte internazionale con il consenso di almeno 2/3 degli Stati firmatari. Per
l’Europa, invece, si propone la creazione di una nuova corte ad hoc con sede a Venezia.
Ma l’ingiustizia climatica non è solo il prodotto degli effetti di un modello di sviluppo e dei
cambiamenti climatici prodotti. Essa è alimentata dalle mancate decisioni, dalle misure stesse
adottate nel corso delle conferenze internazionali sul clima e dalle negoziazioni dirette da chi
inquina di più, che non solo escludono le popolazioni più colpite dal processo decisionale, ma le
colpiscono ulteriormente, rafforzandone la vulnerabilità.
L’esempio della Cina, in questo quadro, è allarmante. Potenza economica emergente, è
ormai il primo produttore di gas clima alteranti al mondo, ma anche il precursore della green
economy. La Cina ad oggi porta avanti 1560 progetti CDM, quasi la metà dei progetti CDM
approvati nel mondo, che corrispondono al 63,84 % dei Certificati di Emissioni Ridotte in
circolazione a livello globale26. Questo Paese sta riconvertendo la sua produzione energetica
attraverso megaprogetti di energie dette “pulite” e non solo: megadighe, centrali nucleari e campi
estesi (spesso su terreni agricoli) di fotovoltaico e monocolture per biocarburanti. In questa maniera,
al di là del cambiamento della fonte di approvvigionamento, la Cina sta causando un’ulteriore
degradazione dell’ambiente e continuando a violare diritti individuali e collettivi. L’esempio
estremo estremo fornitoci dalla Cina mostra una deriva pericolosa generata da un modello
centralizzato che concentra potere e ricchezze e controlla una delle necessità principali della vita
umana, l’energia. Questo esempio ci aiuta a sgombrare il campo da equivoci attorno alla green
economy: se essa si traduce nella perpetrazione dello stesso modello centralizzato di
accumulazione, produzione e consumo, di devastazione ambientale, di mancata partecipazione dei
cittadini nelle scelte pubbliche, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento non ha di per
sé alcun ruolo di transizione verso altri modelli economici.
Box 16
Energia come bene comune
Per uscire dalla crisi ecologica e climatica, sono fondamentali la partecipazione dei cittadini e della società
civile da un lato, e la valorizzazione e il rafforzamento di strumenti come il Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors), promosso dall’Unione Europea, dall’altro. Tale Patto sostiene lo sviluppo in Europa di piani
energetici locali basati sull’energia rinnovabile e distribuita, sul risparmio e l’efficienza energetica come
misure per diminuire le emissioni di carbonio. Questo mutamento di modello si basa sul passaggio da un
26
Secondo i dati forniti dal governo cinese: http://www.gov.cn/english/official/201111/22/content_2000272_7.htm
50
sistema gerarchico di generazione e distribuzione dell’energia ad un sistema a rete intelligente, incentrato
sull’indipendenza energetica e sulla lotta ai cambiamenti climatici. L’energia prodotta in piccole quantità
tramite impianti diffusi sul territorio, viene accumulata localmente e ridistribuita in base alla necessità.
Come sostenuto dalla Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale – RIGAS, non solo tali percorsi
permettono di applicare misure reali per fronteggiare i cambiamenti climatici, ma rappresentano anche
l’opportunità di sostenere processi decisionali locali democratici, innovativi e di rilanciare l’occupazione e
la partecipazione in una prospettiva di riconversione del modello produttivo che tenda verso uno sviluppo
sociale e ambientale sostenibile. In particolare, la creazione di nuove istanze istituzionali partecipative che
dalle amministrazioni locali permettano l’attuazione di reali misure alternative, rappresenta un campo d’azione
da esplorare e implementare attraverso spazi di confronto tra governi locali e attori sociali.
Il concetto di energia come bene comune va’ sviluppato di pari passo con la sperimentazione di nuove forme
decisionali partecipative e di controllo sociale e con lo sviluppo e l’applicazione di piani di riconversione
energetica delle città.
La de-carbonizzazione della società e la sovranità energetica costituiscono un pilastro
fondamentale nella costruzione della giustizia climatica. Ripensare il modello di società implica
ripensare anche il modello energetico, quello economico, democratico e occupazionale. E se dai
livelli globali e nazionali si fatica ad implementare politiche forti ed incisive che garantiscano i
diritti della natura e dell’uomo, a livello locale numerose sono le iniziative e le proposte in campo.
Box 17
Moratoria delle estrazioni petrolifere: la proposta Yasunì
Dinanzi alla responsabilità dell’industria petrolifera nella crescita dei livelli di CO 2 in tutto il pianeta e
partendo dalla proposta ecuadoriana per il non sfruttamento del giacimento petrolifero del blocco ITT nel
parco dello Yasunì – riserva mondiale della biosfera27 – i movimenti non estrattivi appoggiano la proposta,
lanciata da Oilwatch, di una moratoria per l’industria petrolifera.
Insieme al progetto per il non sfruttamento dello Yasunì, i movimenti non estrattivi chiedono che venga
fermato ogni progetto di sfruttamento di nuovi giacimenti petroliferi e che l’industria del petrolio si assuma
i costi che le implicazioni ambientali dell’attività producono in tutto il mondo. Questa linea d’azione
potrebbe condurre ad una diminuzione del consumo di idrocarburi e ad un aumento del prezzo del
petrolio, contribuendo così al calo delle emissioni di gas climalteranti e allo sviluppo della ricerca e
dell’utilizzo di fonti e modelli energetici alternativi. L’implementazione di proposte simili permetterebbe
un’azione reale sull’origine dei gas a effetto serra. Iniziative di questo tipo sono molto importanti anche in
termini di conservazione delle foreste, considerando che molti giacimenti di idrocarburi si trovano proprio nel
sottosuolo delle foreste.
27
Per approfondire sul conflitto ambientale in corso in Ecuador per il progetto Yasunì, la Scheda del CDCA è
reperibile sul sito: http://www.cdca.it/spip.php?article606
51
In questa cornice, le risposte dei governi sono rimaste inconcludenti. Lo abbiamo visto in
diciasette anni di Conferenze delle Parti. Un arco di tempo nel quale poco o niente è stato risolto e
che non ha prodotto alcuna decisione vincolante allo scopo di tutelare il futuro dell’ambiente e
dell’umanità.
Significativa in tal senso è stata ancora una volta la Conferenza dei Popoli sul
Cambiamento Climatico e i Diritti della Madre Terra tenutasi a Cochabamba nel 2010 (vedi Box
13), il cui accordo finale individuava le cause della crisi sistemica proponendo misure concrete per
far fronte alla crisi climatica. Proposte che, dopo essere state incluse nelle negoziazioni preliminari,
sono rimaste lettera morta alla COP16 di Cancùn, decisione che ha portato la Bolivia a non aderire
all’accordo finale.
A pochi mesi dal Vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo di Rio de Janeiro, preme
sottolineare che ogni prospettiva di cambiamento del modello economico attuale non potrà
funzionare prescindendo da una seria analisi della crisi ecologica e dall'adozione di concrete
soluzioni per farvi fronte. Al contempo, ogni proposta ecologica senza un orientamento di rottura
con il nostro sistema non potrà che rivelarsi uno strumento al servizio delle politiche
dell’“economia verde”.
A fronte della crisi sistemica, epocale, che mina i fondamenti stessi su cui ha retto il progetto
della modernità, è necessario immaginare un’altra teoria economica e un modello di sviluppo
alternativo che mettano i diritti della natura e dell’uomo al centro dello sforzo cooperativo
sociale. Serve pertanto una conversione degli apparati produttivi e di consumo volta a decrescere
i flussi di materia e di energia impegnati nei cicli produttivi. Tale sfida può essere vinta solo se la
scienza, le tecnologie e la produttività che da esse derivano saranno indirizzate non solo ad
aumentare i rendimenti, ma anche a diminuire l’impatto umano sulla biosfera.
In questo cammino è fondamentale la partecipazione e il ruolo della società civile e delle
“società in movimento”, che per le loro proposte ed esperienze hanno dimostrato una maggiore
sensibilità e capacità nel definire politiche e misure concrete per affrontare il cambiamento
climatico rispetto alla governance globale.
52
Focus di genere
Donne in difesa dell'ambiente
Ruolo delle donne nell’adattamento
e nella mitigazione del cambiamento climatico
53
1.Gli impatti del cambiamento climatico sulla condizione delle donne
Il rapporto delle Nazioni Unite sullo Stato della Popolazione del 200928 (UNFPA - United
Nations Population Fund) ha evidenziato come nel Sud del mondo le donne tendano ad essere le
prime vittime dei cambiamenti climatici e come questi non solo mettano a rischio vite umane
minando la disponibilità dei mezzi di sostentamento, ma rendano più evidente il divario tra ricchi e
poveri ed amplifichino le disparità tra uomini e donne. Gli impatti sociali dei cambiamenti climatici
sono e saranno dunque di diversa portata, a seconda di fattori quali l’età, la classe sociale,
l’occupazione e il genere delle persone coinvolte.
Le donne del Sud del mondo rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo di opzioni di
adattamento sostenibili, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e delle risorse naturali e
grazie alle loro molteplici responsabilità all’interno della famiglia, della comunità e dei settori
produttivi. A livello globale, si stima che le donne rappresentino il 43% della forza lavoro impiegata
nel settore agricolo29. In Asia e Africa questa percentuale sale spesso a più del 50%, specialmente
nelle regioni di montagna, e nell’Africa subsahariana le donne sono responsabili addirittura del 7080% della produzione agricola di alimenti per il fabbisogno famigliare, della raccolta di legna da
ardere e nell’approvvigionamento di acqua potabile.
Al tempo stesso, tuttavia, le donne sono particolarmente vulnerabili all’impatto dei disastri
naturali e degli altri effetti del cambiamento climatico: in primo luogo perché costituiscono la maggioranza dei poveri del mondo e dunque sono le più dipendenti dalle risorse naturali minacciate dal
cambiamento climatico; in secondo luogo a causa delle impari relazioni di potere e delle barriere
sociali, economiche, culturali e politiche che le pongono in condizione di inferiorità rispetto agli uomini. Gli ostacoli che esse devono affrontare per adattarsi e reagire al cambiamento climatico sono
di varia natura: scarso accesso al sistema educativo e all’informazione, povertà, discriminazione
nella distribuzione del cibo, limitato accesso alle risorse, esclusione dalle istituzioni politiche e dagli organi decisionali. Raramente le donne godono di diritti proprietari sulle risorse che gestiscono e
da cui dipendono. Inoltre, ad esse è quasi sempre negata l’opportunità di gestire direttamente le risorse o di esercitare un’influenza politica sia a livello famigliare che, tanto più, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.
La crescente scarsità delle risorse naturali si traduce, per le donne, in un maggiore
investimento di tempo da destinare al loro reperimento e, di conseguenza, in una minore quantità di
tempo ed energie da dedicare alla propria istruzione e formazione. Questo porta ad un progressivo
aumento delle diseguaglianze sociali e dunque – in un circolo vizioso – ad un generale
28
29
Testo completo del rapporto disponibile sul sito dell’UNFPA:
http://www.unfpa.org/swp/2009/en/pdf/EN_SOWP09.pdf
FAO – “The state of food and agriculture 2010-2011”
54
peggioramento delle loro condizioni. In una prospettiva a lungo termine, ciò non potrà che causare
serie ripercussioni sulle relazioni di genere.
I più immediati impatti dei cambiamenti climatici incidono sui settori che tradizionalmente
sono di competenza delle donne: l’agricoltura di sussistenza, la raccolta di acqua, di legna da ardere
e dei prodotti delle foreste. E anche gli impatti indiretti, come i rischi sanitari e la spinta all’emigrazione, hanno effetti più gravi per le donne. Vediamo più nel dettaglio.
Impatti sulla sicurezza alimentare: Anche se, nei contesti rurali, donne e uomini rivestono ruoli
complementari nel garantire la sicurezza alimentare, le donne spesso hanno maggiori responsabilità
nella gestione delle risorse naturali e nel procacciamento degli alimenti: coltivano, lavorano e gestiscono i prodotti della terra destinati all’alimentazione della famiglia e sono responsabili di piccoli
allevamenti, della gestione degli orti e della raccolta di combustibili ed acqua. Gli uomini invece
traggono profitto dalle risorse attraverso il loro commercio. Il coinvolgimento delle donne in agricoltura è massimo proprio nelle regioni più colpite dagli impatti del cambiamento climatico. In questi contesti su di loro ricade la responsabilità di adattarsi, trovando strategie alternative per nutrire la
famiglia. Circa due terzi della forza lavoro femminile nei paesi in via di sviluppo – oltre il 90% nel
caso di molti paesi africani – sono impegnati nel lavoro agricolo. Nel sud-est asiatico le donne rappresentano il 90% della forza lavoro per la coltivazione del riso e nell’Africa sub-Sahariana l’80%
della produzione di prodotti alimentari è di loro responsabilità 30.
Il cambiamento climatico ha un impatto negativo su ogni aspetto legato alla sicurezza alimentare, dalla disponibilità dei prodotti alla loro accessibilità, dalla preparazione alla conservazione
degli alimenti, alla stabilità dei sistemi alimentari. Nel contesto del cambiamento climatico, la disponibilità dei tradizionali prodotti alimentari diventa scarsa e imprevedibile. Le donne devono affrontare la frequente perdita di raccolti – spesso le loro sole fonti di reddito e di sussistenza – mentre i relativi aumenti del prezzo dei prodotti alimentari rendono il cibo ancora meno accessibile alle
persone più povere e in particolare alle donne.
In Africa la percentuale di donne che devono far fronte a mutazioni dei raccolti dovute al cli ma varia dal 73% della Repubblica democratica del Congo al 48% del Burkina Faso31. Per le contadine, alle difficili condizioni ambientali si deve aggiungere la mancanza di risorse e di terra arabile
e, spesso, il negato diritto alla proprietà della loro stessa terra. Il sistema legale e consuetudinario
dei paesi in via di sviluppo spesso pone forti restrizioni ai diritti proprietari delle donne, ostacolando loro l’accesso al credito e ai servizi di estensione agricola e riducendo così l’incentivo ad adottare pratiche agricole eco-sostenibili e a sostenere investimenti a lungo termine destinati al risanamento dei terreni e al miglioramento della qualità dei suoli. A livello globale, le donne possiedono
30
31
FAO – “The state of food and agriculture 2010-2011”.
International Union for Conservation of Nature (IUCN), Gender and Climate Change Manual, 2009.
55
meno del 2% della proprietà complessiva e, in molti paesi, meno del 10% della popolazione femminile è in possesso ufficiale della propria terra 32.
Nonostante queste difficoltà, le donne rurali colpite dagli impatti del cambiamento climatico stanno sviluppando strategie di adattamento che includono la modifica e il miglioramento delle
loro pratiche agricole.
Carenza idrica: Si stima che attualmente 1,2 miliardi di persone soffrano di uno scarso accesso a
fonti sicure di acqua. Solo il 58% degli abitanti dell’Africa sub-sahariana vive entro una distanza di
trenta minuti a piedi da una sorgente di acqua sicura, e solo il 16% abita in una casa collegata alla
rete idrica33. Si stima che per il 2025 quasi due terzi della popolazione mondiale avranno difficoltà
ad accedere a fonti d’acqua sicura e che per un miliardo di persone la carenza idrica assumerà
proporzioni gravi. Il cambiamento climatico influirà anche sulla frequenza – sempre maggiore –
delle inondazioni e sulla qualità dell’acqua disponibile. Le popolazioni stanziate entro 90 km dalla
linea di costa saranno le più colpite dall’aumento di salinità delle falde d’acqua potabile. La raccolta
dell’acqua è dunque destinata a diventare un compito sempre più difficoltoso.
I diversi ruoli sociali rivestiti da uomini e donne implicano anche differenti bisogni e priorità
in riferimento all’utilizzo dell’acqua. Mentre gli uomini solitamente utilizzano l’acqua per l’irrigazione, l’allevamento e l’industria, le donne sono spesso le prime responsabili della raccolta di acqua
potabile e da usare per cucinare, lavare, igienizzare e nutrire piccoli allevamenti. Il fabbisogno di
acqua di una famiglia in una sola giornata può significare numerosi viaggi verso il pozzo più vicino.
Questi viaggi, nelle aree rurali, possono superare i 16 km al giorno e ad ogni viaggio le donne trasportano fino a 15 litri d’acqua34. L’acqua proveniente da sorgenti lontane raramente è sufficiente a
soddisfare il fabbisogno delle famiglie ed è spesso contaminata. Inoltre, l’aumento dei periodi di
siccità fa sì che ci si debba spesso accontentare di acqua proveniente da fonti più vulnerabili ad
agenti patogeni e batteri, aumentando il rischio di contrarre malattie. Nei casi in cui la contaminazione da arsenico della falda acquifera sia rilevante, tra i conseguenti problemi sanitari vi sono: lesioni e ispessimento della cute, macchie scure su mani e piedi, gonfiori e perdita di sensibilità. L’esposizione all’arsenico si manifesta anche in forma di lesioni alla pelle che possono portare a ripercussioni sociali. La situazione si aggrava per le donne, che possono essere respinte, escluse e stigmatizzate a causa del loro aspetto fisico.
Infine, il dover viaggiare per lunghi tragitti per raccogliere l’acqua espone donne e ragazze
al rischio di violenze, rischio che aumenta nelle aree di conflitto. Ad esempio, nel Darfur occidentale e meridionale, l’82% delle donne curate dopo uno stupro era stato attaccato durante lo svolgimen32
33
34
The Lancet and University College of London Institute for Global Health Commission, Managing the Health
Effects of Climate Change , 2009.
Fonte: http://www.unicef.org/wash/index_28268.html.
IUCN – WANI (Water and Nature Initiative); UNICEF; Gender and Water Alliance (GWA).
56
to di compiti quotidiani quali, appunto, la raccolta di acqua o legna da ardere 35. Nel caso in cui donne e bambine non riescano a riportare acqua sufficiente a casa esse sono spesso oggetto di violenza
fisica o verbale anche da parte degli stessi membri della famiglia.
Impatti sulla salute: Durante i periodi di carestia, e a causa anche del conseguente aumento dei
prezzi del cibo – circostanze che si aggraveranno con il cambiamento climatico – le condizioni di
salute di donne e bambine si aggravano prima e in misura maggiore rispetto agli uomini, per via di
costrizioni sociali e disuguaglianze di genere. Alcune malattie che colpiscono le donne più degli uomini, come malaria e dissenteria, aumenteranno con l’aumentare delle temperature. Le donne poi,
sono più soggette a carenze nutritive a causa del loro particolare fabbisogno nutrizionale, specialmente in caso di gravidanza o di allattamento al seno. Nel sud-est asiatico e nell’Asia meridionale,
il 45-60% delle donne in età riproduttiva è sottopeso e l’80% delle donne incinte ha carenza di ferro36. Nell’Africa sub-sahariana le donne devono trasportare carichi maggiori rispetto agli uomini ma
assumono una quantità minore di calorie, poiché è norma culturale che gli uomini debbano mangiare in quantità maggiore. Per le donne e per le bambine, un basso livello di nutrimento è associato all’aumento di anemia, problemi in gravidanza e durante il parto, basso peso del feto alla nascita e
mortalità perinatale. Inoltre, il livello nutrizionale di ognuno determina in parte anche la sua capacità di affrontare i disastri naturali. Altri rischi per la salute includono alti livelli di malnutrizione dovuti alla carenza di cibo, aumento della mortalità legata alle ondate di calore, alta incidenza delle
malattie legate all’acqua e maggiore diffusione di malattie respiratorie laddove vi è un peggioramento dell’inquinamento atmosferico.
Le differenze di genere nei rischi per la salute legati al cambiamento climatico riflettono
dunque un effetto combinato di influenze fisiologiche, comportamentali e socialmente costruite. In
qualità di responsabili della cura e dell’assistenza ai malati, le donne vedono aumentare il loro carico di lavoro man mano che i membri della loro famiglia si ammalano. La diminuzione del tempo da
esse dedicato al lavoro remunerato, unito alle crescenti spese mediche dovute alle malattie in famiglia, aumenta il loro livello di povertà. Anche l’accesso al servizio sanitario e alle cure mediche è
più difficoltoso per donne e bambine, a causa della mancanza di risorse economiche e alle restrizioni culturali che spesso impediscono loro di viaggiare da sole in cerca di assistenza medica.
I bambini sotto i 5 anni sono le maggiori vittime, specialmente delle ondate di calore. Le
bambine sono ancora più a rischio a causa della discriminazione di genere nell’allocazione delle risorse, comprese quelle alimentari e sanitarie. Anche le donne anziane sono particolarmente vulnerabili, specialmente nei paesi in via di sviluppo in cui le risorse sono insufficienti e le reti di sicurezza
sociale sono limitate o inesistenti. Queste donne non sempre comprendono appieno il loro diritto ad
35
36
Médecins sans Frontières, The Crushing Burden of Rape: Sexual Violence in Darfur, 2005.
Actionaid, “Non sono cose da donne”, 2009.
57
accedere al servizio sanitario pubblico e privato: anche se consapevoli dell’esistenza di questi servizi, è difficile che si possano permettere visite mediche e medicinali, oltre al fatto che spesso cliniche
e ospedali sono molto lontani dalle zone rurali dove queste risiedono.
Deforestazione e perdita di biodiversità: La perdita della biodiversità determina in modo diretto
un peggioramento delle condizioni di vita delle donne rurali, poiché molte di esse dipendono dai
prodotti forestali non legnosi per il loro sostentamento. Questi prodotti, infatti, oltre ad essere venduti, vengono utilizzati dalle donne nella medicina tradizionale e come elementi nutritivi nei periodi
di carestia. Le foreste, inoltre, fungono da banca dei semi per la conservazione delle diverse varietà
vegetali necessarie a coltivare raccolti alternativi che si adattino alle condizioni climatiche in continuo mutamento. La perdita della biodiversità rappresenta dunque una sfida alla salute e alla sussistenza delle donne rurali e delle loro comunità.
C’è poi un altro aspetto da considerare: la crescente deforestazione fa sì che la legna – il
combustibile solido più comune – si trovi in zone sempre più lontane dalle aree abitate. Nelle comu nità più povere e nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, la responsabilità della raccolta del la legna da ardere appartiene a donne e giovani ragazze, che devono impegnarsi in un lavoro fisicamente molto impegnativo che prende loro dalle 2 alle 20 ore settimanali. Di conseguenza, queste
donne hanno meno tempo per occuparsi dei lavori domestici, lavorare, partecipare alle attività pubbliche o politiche, studiare, formarsi e riposare. Spesso le ragazze non vengono mandate a scuola,
così che possano avere tempo per la raccolta del combustibile. Inoltre, quando costrette a percorrere
da sole grandi distanze in cerca di legna (così come avviene nel caso della raccolta di acqua) le donne sono maggiormente esposte al rischio di incidenti e di aggressioni sessuali.
Sfollamento e migrazioni: Al manifestarsi degli impatti negativi del cambiamento climatico
corrisponde un aumento della complessità dei movimenti migratori e degli insediamenti umani. Il
processo graduale di deterioramento ambientale produrrà, nei prossimi decenni, la crescita dei flussi
migratori interni e transnazionali. I disastri naturali legati al cambiamento climatico, quali
l’erosione delle linee di costa, le inondazioni, periodi di siccità e interruzioni della produzione
agricola, porteranno allo sfollamento e alla migrazione di un sempre maggior numero di persone.
Anche se la migrazione volontaria come reazione ai cambiamenti stagionali è una risposta
strategica a lungo utilizzata da molte comunità, la migrazione sta aumentando con l’incedere del
cambiamento climatico e include ormai anche popolazioni stanziali che si sono dovute spostare a
causa del deterioramento del loro ambiente. Se la migrazione coinvolge talvolta intere famiglie o
comunità, più spesso è solo un membro della famiglia – solitamente l’uomo – a migrare per trovare
nuove forme di sussistenza. In alcuni casi le rimesse provenienti dal lavoro migrante permettono
alle famiglie di dipendere in minor misura dalle attività agricole, permettendo loro di soddisfare il
58
loro fabbisogno alimentare anche in un contesto che vede diminuita la produttività della terra e ridu cendo così la pressione sulle risorse naturali nelle aree soggette a siccità. Nella gran parte dei contesti, la migrazione maschile dà tuttavia un contributo minimo alla sussistenza delle famiglie, lasciando a coloro che rimangono – le donne – un fardello di lavoro enorme. Le donne si devono quindi
occupare anche delle attività tradizionalmente maschili, in aggiunta alle loro tradizionali responsabilità domestiche e agricole.
Disastri naturali legati al cambiamento climatico: Lo Human Impact Report del Global
Humanitarian Forum37 stima che, attualmente, oltre 350.000 persone stiano morendo ogni anno a
causa del cambiamento climatico, di cui 14.500 direttamente a causa dei disastri ambientali ad esso
attribuibili. La grande maggioranza di queste vittime sono donne. Secondo un recente rapporto del
World Conservation Union e della Women’s Environment and Development Organization
(IUCN/WEDO)38, è 14 volte più probabile che muoia una donna o una ragazza che un uomo durante
un disastro naturale. Ad esempio, durante il ciclone che colpì il Bangladesh nel 1991, il tasso di
mortalità delle donne tra i 20 e i 44 anni era del 71 per mille, mentre quello degli uomini della
stessa fascia d’età era del 15; oppure, nel caso dello tsunami che colpì l’Indonesia nel 2004, il 70%
delle vittime erano donne, molte delle quali al momento dell’arrivo dello tsunami si trovavano in
casa e non avevano ricevuto alcun segnale di allarme.
In caso di disastri naturali, le donne devono affrontare rischi aggiuntivi rispetto agli uomini.
Questa particolare vulnerabilità è dovuta a una combinazione di fattori, tra i quali: differenze nella
socializzazione, per cui le ragazze non possiedono le abilità tecniche che hanno i loro fratelli, come
ad esempio la capacità di nuotare o di arrampicarsi sugli alberi; minore accesso alle informazioni e
dunque anche agli stati d’allerta meteorologici; ostacoli di natura culturale. Le norme culturali sulla
preservazione dell’onore femminile fanno sì che, in caso di pericolo, molte donne lascino
l’abitazione solo quando ormai è troppo tardi, in attesa di un uomo che le scorti. Diversi casi di
studio mostrano come il pudore, le inibizioni sociali e legate al vestiario e la mancanza di tecniche
di sopravvivenza contribuiscano ad un tasso di mortalità maggiore tra le donne a fronte di uragani e
inondazioni. Infine, dovendosi prendere cura di bambini, anziani e malati, le donne sono
maggiormente esposte.
Un’analisi della London School of Economics sui disastri naturali che hanno colpito 141
paesi ha mostrato che dove le donne hanno gli stessi diritti degli uomini c’è poca o nessuna
differenza tra il numero di vittime femminili o maschili, mentre dove si riscontra una maggiore
diseguaglianza di genere la mortalità femminile è molto più alta di quella maschile.
Inoltre, durante i disastri naturali, donne e bambine sono spesso soggette a intimidazioni, violenza
37
38
Global Humanitarian Forum, “Human Impact Report – Climate Change: The anatomy of a silent crisis”,
http://www.ghf-ge.org/human-impact-report.pdf.
UNFPA; WEDO, “Climate Change Connections”, 2009.
59
di genere, aggressioni sessuali, stupri e traffico di esseri umani. I disastri naturali, infatti,
distruggono le reti di sicurezza sociale, lasciando da soli bambini e donne. L’erosione delle norme
di controllo sociale rende le donne sole particolarmente vulnerabili.
Come sottolineato nello Human Development Report del 2007/8 39, non sono solo i disastri in
sé a colpire la popolazione, ma anche le loro conseguenze. A causa dei ruoli tradizionali che le donne rivestono nel contesto domestico, poiché esse sono le principali responsabili della ricostruzione
della casa e della cura dei familiari, nel periodo successivo ad un disastro naturale il loro carico di
lavoro quotidiano aumenta.
39
Testo integrale disponibile sul sito: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/.
60
2.Riconoscimento del ruolo delle donne da parte della governance globale
Le donne sono oggi quasi del tutto emarginate dai processi decisionali in materia di
cambiamenti climatici. Il dibattito internazionale sul clima non ha finora affrontato il problema
delle barriere di genere nell'elaborazione delle politiche ambientali né ha sottolineato a sufficienza
la necessità dell'integrazione delle donne in tali politiche. Neanche l'urgenza posta dal
riscaldamento globale o dai più recenti disastri ambientali ha indotto i decision-makers a porre le
donne al centro delle politiche di sviluppo sostenibile.
La Conferenza su Popolazione e Sviluppo delle Nazioni Unite ha riconosciuto il valore
potenziale delle donne nella gestione delle risorse naturali e la loro intrinseca importanza si riflette
nella documentazione di Agenda 21. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le donne restano sottorappresentate nei luoghi di formulazione delle politiche ambientali. Il dibattito climatico sta
perpetuando la sottovalutazione del contributo delle donne, nonostante si faccia un gran parlare
delle conoscenze che hanno le donne indigene nel campo della gestione ambientale e della
preservazione della biodiversità e dei terreni. Grazie all’interazione con la foresta e con altri
ecosistemi nel corso di molti anni, le donne indigene hanno sviluppato un sapere specifico sulle
piante e sul loro valore medicinale. Purtroppo questa componente della conoscenza locale non è
stata quasi mai sfruttata dai policy-makers, e se non usata potrebbe andare perduta in breve tempo.
Il settore dello sviluppo nel suo insieme – dal campo energetico a quello agricolo – sembra integrare
le questioni di genere solo sulla carta. Inoltre, l’integrazione avviene a piccole dosi e i diversi settori
di sviluppo adottano a distanza di tempo l’analisi di genere. Di conseguenza le politiche che si
sviluppano da una prospettiva di genere sono minime e deboli e mal collegate con quelle degli altri
settori chiave per lo sviluppo. Queste politiche offrono dunque poche opportunità per le donne
rurali di migliorare le loro conoscenze e di ottenere risultati significativi.
Allo stesso modo, le politiche di sviluppo non hanno ancora affrontato le strettoie che ostacolano
l’accesso delle donne al controllo e alla proprietà delle risorse.
Integrazione della prospettiva di genere nel quadro istituzionale internazionale
Da quando la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è
entrata in vigore nel 1994, e dalla prima Conferenza delle Parti (COP) nel 1995, le considerazioni e
la rappresentanza di genere sono state quasi del tutto assenti dai negoziati internazionali sul
cambiamento climatico, anche se, dopo il Vertice di Rio del 1992, era parso che la prospettiva di
genere dovesse essere presto integrata nei processi decisionali in materia ambientale. Già nel corso
61
del suo secondo incontro, nel 1996, il Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice (SBSTTA)40 aveva emesso la Raccomandazione II/7 sulla biodiversità in
agricoltura, nella quale si affermava che “la conoscenza attuale e potenziale sugli ecosistemi
agricoli locali generata dalle comunità di agricoltori è uno strumento importante al fine di
ottimizzare la gestione di quegli ecosistemi. Gran parte delle pratiche agricole e delle conoscenze
sono tramandate e gestite dalle donne nelle comunità locali di molte regioni del mondo. Il ruolo
delle donne nel mantenimento di queste conoscenze è di fondamentale importanza”. Il SBSTTA
raccomandava alla Conferenza delle Parti di incoraggiare lo sviluppo, il mantenimento e la
mobilitazione della conoscenza locale degli agricoltori e delle comunità agricole, con speciale
riferimento ai ruoli di genere nella produzione di cibo per lo sviluppo sostenibile.
Nonostante ciò non sono seguiti provvedimenti volti ad integrare questioni di genere legate
al cambiamento climatico fino alla COP7, nel 2001, quando la prima menzione ufficiale delle
donne apparve nella risoluzione di Marrakech41. In questa occasione, la delegazione di Samoa
chiese una rappresentazione più equa delle donne all’interno della struttura organizzativa e
decisionale dell’UNFCCC. Di conseguenza la COP7 espresse la necessità di incentivare la
rappresentanza femminile e la partecipazione delle donne negli organismi dell’UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto. Tuttavia, non è sufficiente assicurare la partecipazione delle donne a questi
dibattiti per garantire che i problemi che affliggono le donne nei paesi più poveri vengano realmente
affrontati. Dopo la COP11 di Montreal del 2005, gruppi di donne evidenziarono la necessità di
adottare un approccio di genere a tutte le questioni critiche e ai relativi meccanismi: mitigazione
GHG, adattamento al cambiamento climatico, trasferimento di tecnologia e finanziamento. Tra i
gruppi di pressione più attivi: la Global Gender and Climate Alliance (GGCA), che unisce gli sforzi
di 25 organismi tra agenzie dell’ONU, reti e ONG; la rete internazionale GenderCC-Women for
Climate Justice, Women in Europe for a Common Future (WECF) e Women's Environment and
Development Organisation (WEDO).
In occasione della COP15, tenutasi a Copenhagen nel 200942 si è potuto rilevare come,
nonostante la consapevolezza del cambiamento climatico e dei suoi impatti sia cresciuta
notevolmente dalla prima COP, la prospettiva di genere sia tuttora esclusa dal centro del dibattito.
Unico dato positivo: la leadership e la rappresentanza femminile tra i negoziatori chiave della
conferenza è stata più consistente rispetto agli anni precedenti, soprattutto tra le delegazioni della
società civile e delle organizzazioni non governative e inter-governative.
40
41
42
Il Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice è l’organo della Convenzione sulla Diversità
Biologica (CDB) incaricato di fornire un’opinione scientifica, tecnica e tecnologica. Raccomandazione II/7:
http://www.cbd.int/recommendation/sbstta/?id=6998.
Rapporto della 7a Conferenza delle Parti, tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 10 novembre 2001.
http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13.pdf.
Tutta la documentazione ufficiale relativa alla COP15 tenutasi a Copenhagen nel dicembre del 2009 è disponibile
nell’apposita sezione del sito dell’UNFCCC:
http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php.
62
Anche la COP1643, svoltasi a Cancun nel dicembre del 2010 non rappresenta di certo una
rivoluzione in materia di gender mainstreaming. Ancora una volta si riconosce che l’uguaglianza di
genere e la reale partecipazione delle donne e delle popolazioni indigene siano importanti al fine di
realizzare un’azione efficace su tutti gli aspetti del cambiamento climatico e che la prospettiva di
genere debba assolutamente essere integrata nei meccanismi di mitigazione, adattamento,
trasferimento delle tecnologie e finanziamento volti ad affrontare il cambiamento climatico.
Tuttavia oltre alle parole non si registrano ancora spinte concrete verso il raggiungimento di questi
obiettivi.
La COP17 di Durban, Sud Africa (2011)
È ancora presto per poter dire se, con l’ultima Conferenza delle Parti, tenutasi a Durban dal
28 novembre al 9 dicembre 201144, siano finalmente stati compiuti dei concreti passi avanti sulla via
dell’integrazione della dimensione di genere nel dibattito sul cambiamento climatico. Rispetto alle
precedenti COP le tematiche di genere sono state più visibili, anche se in misura maggiore nel corso
dei side events. In occasione del Gender Day, i delegati di alcune associazioni della società civile
(tra cui IUCN, CARE, WEDO, GenderCC, ecc.) hanno illustrato metodologie di genere innovative
adottate in sei paesi e regioni (Giordania, Mozambico, Egitto, Tanzania, Haiti e Centro America) e
hanno ricordato l’importanza di rafforzare la capacità delle donne all’interno delle delegazioni al
fine di accrescere la conoscenza e la divulgazione della dimensione di genere del cambiamento climatico. Nel corso del 5° Forest Day si è discusso dell’apporto dato dalla partecipazione femminile
alla protezione, conservazione e gestione delle foreste negli ultimi vent’anni, portando ad esempio
le esperienze dei paesi che hanno sviluppato politiche per il cambiamento climatico in un’ottica di
genere. Anche a livello di rappresentanza, la percentuale di donne presenti in qualità di negoziatori
o delegate è cresciuta, così come il numero di ministri dell’ambiente donna. Nonostante tutto però,
secondo il parere dei relatori intervenuti nel corso del Gender Day e delle reti della società civile
presenti a Durban si sarebbe potuto, e dovuto, fare di più per integrare la questione di genere nel dibattito generale sul cambiamento climatico. Anche da questo punto di vista i risultati non sarebbero
dunque, ancora una volta, all’altezza delle necessità imposte dalla crisi climatica. Eppure le sollecitazioni in questo senso, nel corso degli anni, sono state numerose e importanti. Ecco alcune delle
più importanti.
Il Capitolo 2445 di Agenda 21 – Global Action for Women towards Sustainable
43
44
45
La documentazione prodotta nel corso della COP16 è disponibile sul sito:
http://cc2010.mx/en/about/documents-of-conference/index.html.
Fonte: http://www.cop17-cmp7durban.com/.
Agenda 21, Chapter 24: “Global Action for Women towards Sustainable and Equitable Development”, Rio de
Janeiro, Brasile, 1992, scaricabile sul sito: http://habitat.igc.org/agenda21/a21-24.htm.
63
Development – fa appello ai governi affinché eliminino ogni ostacolo – costituzionale, giuridico,
amministrativo, culturale, sociale ed economico – al pieno coinvolgimento delle donne nelle
politiche di sviluppo sostenibile. Si raccomanda inoltre di rafforzare tutti quegli strumenti che
possono portare alla parità di genere, quali ad esempio gli elementi della CEDAW (Convenzione
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) riferiti all’ambiente e allo
sviluppo.
Anche il documento finale della 4° Conferenza Mondiale sulle Donne, la Piattaforma
d’Azione di Pechino (1995) si impegna, all’Obiettivo Strategico K su “Donne e ambiente”46, ad
assicurare la partecipazione attiva delle donne nei processi decisionali legati all’ambiente, ad
integrare la prospettiva di genere nelle politiche e nei programmi per lo sviluppo sostenibile e a
rafforzare i meccanismi volti a valutare l’impatto sulle donne delle politiche ambientali e di
sviluppo a livello nazionale, regionale e internazionale.
Il Johannesburg Plan of Implementation47 – documento finale del Vertice Mondiale del
2002 sullo Sviluppo Sostenibile – avvalora “il bisogno di integrare la prospettiva di genere in ogni
strategia e politica, di eliminare ogni forma di discriminazione di donne e bambine e di migliorare il
loro stato economico e di salute attraverso un pieno e pari accesso alla terra, alle opportunità
economiche, al credito, all’educazione e all’assistenza medica”. Nella sezione dedicata agli
strumenti di implementazione, si raccomandano la parità nell’educazione e l’avvio di gruppi di
ricerca sugli indicatori di genere48.
La Convenzione per Combattere la Desertificazione (UNCCD)49, entrata in vigore nel
dicembre del 1996, è un passo avanti nel gender mainstreaming, non solo perché riconosce il ruolo
delle donne nelle comunità rurali e nelle regioni più colpite dalla desertificazione e dalla siccità, ma
anche perché incoraggia esplicitamente l’uguale partecipazione di donne e uomini. All’art. 5 delle
sue Misure Generali, si impone ai paesi firmatari di promuovere la consapevolezza e facilitare la
partecipazione delle popolazioni locali e, nello specifico, di giovani e donne, col supporto delle
ONG, nel tentativo di combattere la desertificazione e mitigare gli effetti della siccità. Inoltre i
programmi educativi devono assicurare che tutti, e in particolare le donne e le bambine, abbiano
l’opportunità di partecipare all’identificazione, la conservazione, l’uso e la gestione sostenibili delle
risorse naturali nelle aree colpite.
In occasione del dibattito generale dell’Assemblea Generale dell’ONU e dell’High-Level
Event sul cambiamento climatico, convocato dal Segretariato Generale dell’ONU nel settembre del
46
47
48
49
Obiettivo K della Piattaforma d’Azione di Pechino del 1995, scaricabile sul sito:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm.
Testo completo del Plan of Implementation del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile del 2002:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf.
Tuttavia, fatta eccezione per l’introduzione del diritto alla proprietà della terra, la WEDO ha espresso la propria
insoddisfazione, definendo i riferimenti alle questioni di genere “solo ripetizioni di impegni presi precedentemente
in altri accordi, che non rappresentano alcun passo avanti”.
Testo integrale della Convenzione UNCCD: http://www.unccd.int/convention/text/convention.php.
64
2007, la WEDO e il Council of Women World Leaders hanno convocato una “Tavola Rotonda sul
Genere e il Cambiamento Climatico”, alla quale ha fatto seguito il riconoscimento – nel corso
dell’International Women Leaders Global Security Summit tenutosi a New York nel novembre del
2007 – dei rischi per le donne legati al cambiamento climatico e della necessità di includere le
donne ad ogni livello dei processi decisionali.
La Convenzione sull’Eliminazione di Ogni forma di Discriminazione contro le Donne
(CEDAW)50 del 1979 è considerata comunemente la carta mondiale dei diritti delle donne, oltre che
l’unico strumento giuridico internazionale che faccia riferimento direttamente ai diritti delle donne
rurali. La CEDAW stabilisce che gli Stati firmatari debbano garantire pari opportunità a donne e
uomini in materia di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. La convenzione obbliga le
parti a prendere tutte le misure necessarie per eliminare la discriminazione delle donne nei contesti
rurali al fine di poter così assicurare la loro partecipazione alle strategie di sviluppo rurale e a tutte
le attività della comunità. La Convenzione impone, inoltre, che alle donne rurali venga garantito
l'accesso al credito e ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione e alle risorse
tecnologiche.
Nel 2009, il Comitato CEDAW ha rilasciato una dichiarazione sulle questioni di genere e il
cambiamento climatico, esprimendo preoccupazione per l'assenza di una prospettiva di genere
nell’UNFCCC e nelle politiche regionali e nazionali sul cambiamento climatico e chiedendo agli
Stati firmatari di integrare l'uguaglianza di genere quale principio guida nella convenzione
UNFCCC. La crisi del cambiamento climatico potenzialmente apre nuove opportunità di
finanziamento e di occupazione alle donne, ma affinché queste possibilità possano essere realmente
sfruttate sarà necessario elaborare dati disaggregati per genere e integrare la dimensione di genere
nelle politiche e nelle linee guida programmatiche dei governi. Le politiche che sostengono la parità
tra i sessi in materia di accesso, utilizzo e controllo di scienza e tecnologia, di educazione formale e
informale e di formazione, possono rafforzare la capacità che una nazione ha di prevenire disastri
naturali e catastrofi e la possibilità di sviluppare strategie efficaci e inclusive di mitigazione e di
adattamento ai cambiamenti climatici.
La 52° sessione della Commissione sullo Stato delle Donne del 2008, ha identificato nella
prospettiva di genere applicata al cambiamento climatico una questione chiave. In base alla
Risoluzione 21 (jj) sul Finanziamento per la Parità di Genere e l’Empowerment delle Donne
(E/CN.6/2008/L.8)51, i governi sono chiamati a: “Integrare la prospettiva di genere
nell’elaborazione, l’implementazione, il monitoraggio, la valutazione e il reporting delle politiche
ambientali nazionali; rafforzare i meccanismi e fornire risorse adeguate ad assicurare la piena e pari
partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli legati alle questioni ambientali e
50
51
Testo completo della CEDAW: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.
Fonte: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/268/20/PDF/N0826820.pdf?OpenElement.
65
alle strategie volte a minimizzare l’impatto del cambiamento climatico sulle vite di donne e
bambine”.
Rappresentanza femminile nel quadro internazionale sul cambiamento climatico
Fino a poco tempo fa la percentuale di donne nel ruolo di scienziate e negoziatrici sul
cambiamento climatico negli istituti di ricerca, alle conferenze internazionali ecc., era ben al di
sotto del 25%. Questa percentuale è andata crescendo negli ultimi anni, grazie all’azione delle
organizzazioni femminili e/o ambientaliste in favore di un migliore equilibrio tra i generi nella lotta
al cambiamento climatico a livello nazionale e mondiale. Le donne sono poco rappresentate, a
livello internazionale, sia nelle delegazioni ufficiali che nei gruppi economici e della società civile.
Nella maggior parte dei paesi, sia avanzati che in via di sviluppo, le donne sono sotto-rappresentate
anche a livello nazionale, sia nelle istituzioni pubbliche che nel settore privato. Ciò nonostante esse
sono spesso più attive degli uomini nelle iniziative ambientali a livello comunitario, e in famiglia la
loro influenza può essere significativa.
Un’analisi di Ulrike Röhr – esperta in materia di genere, ambiente e sviluppo sostenibile,
fondatrice dell’organizzazione LIFE e V.– del 2006
52
ha mostrato come la rappresentanza
femminile in seno alle delegazioni COP fino al 2005 sia stata decisamente troppo bassa, variabile
da circa il 15% della COP3 (1997) al 28% della COP9 (2003). All’interno delle delegazioni delle
ONG e della società civile si ha la percentuale maggiore di rappresentanti donne, vista la loro forte
presenza nelle realtà associative locali. Eppure, le relativamente poche donne che erano presenti
hanno giocato un ruolo fondamentale nei negoziati, grazie al loro impegno e alle loro competenze
in ambito di networking, spesso anche grazie all’interazione con altri delegati al di fuori delle
sessioni ufficiali. Anche se nel 2008 all’interno di un certo numero di delegazioni ufficiali si
registrava una percentuale relativamente elevata di donne, sono stati ben 46 i paesi le cui
delegazioni non includevano neanche una sola donna. Data l'attuale sovra-rappresentanza maschile
in questo settore, è di vitale importanza che gli uomini siano consapevoli e attivamente coinvolti
nelle questioni di genere perché queste siano adeguatamente prese in considerazione al tavolo dei
negoziati.
52
AA.VV., Climate Change and Gender Justice, Cap. 13 – Minu Hemmati, Ulrike Rohr, “Engendering the climatechange negotiations: experiences, challenges, and steps forward”, OXFAM, GB, 2009.
66
3. Donne come agenti del cambiamento
“Noi donne indigene, in quanto responsabili della cura e della tutela della famiglia, della
trasmissione della nostra cultura e guardiane della Madre Terra, abbiamo la responsabilità morale e
spirituale di assicurare la salute e il benessere della Madre Terra e di aiutarla a sanare le ferite che l’essere
umano sta causando, attraverso un uso responsabile dei suoi doni.
Dobbiamo dedicare le nostre forze a rendere questo un mondo migliore, non solamente per i nostri
figli, ma per tutte le generazioni future. Noi donne sviluppiamo conoscenze specifiche sulla custodia della
Madre Terra che devono essere riconosciute e rispettate, anche per affrontare i cambiamenti climatici, di cui
siamo le prime vittime”.
Dichiarazione della Conferenza Mondiale delle Donne Indigene
presso il Foro Permanente sulle Questioni Indigene dell’ONU del 200853
È opportuno evidenziare come le donne indigene non siano solo le prime vittime del cambiamento climatico, ma come esse al tempo stesso rivestano un ruolo fondamentale in qualità di
agenti di cambiamento, in relazione sia alle misure di riduzione del danno che a quelle di adattamento alle mutate condizioni. Le donne possiedono infatti un vastissimo bagaglio di conoscenze ed
esperienze che possono essere utilizzate per mitigare i danni prodotti dai cambiamenti climatici, riducendo i rischi e l’impatto dei disastri naturali, e per sviluppare efficaci strategie di adattamento.
Le responsabilità che ricadono sulle donne all’interno della famiglia e della comunità, in qualità di
sovrintendenti alle risorse naturali e famigliari, consentono loro di contribuire al meglio allo sviluppo di strategie di sussistenza compatibili con il contesto ambientale in perpetuo cambiamento. Inoltre, è dato certo che le donne di fatto contribuiscono in misura minore degli uomini al cambiamento
climatico, grazie alle loro scelte ma soprattutto a causa del loro ruolo nella società e della povertà
che le affligge, che implica per forza di cose un minor consumo 54.
All’interno della comunità, le donne rivestono innanzitutto un ruolo riproduttivo, che porta
loro responsabilità legate alla crescita della prole e alla cura dei famigliari. Da ciò deriva una
particolare propensione alla cura dell’ambiente nel quale crescono i figli, nella speranza di poter
contribuire così a garantire loro un futuro. Le donne svolgono, però, anche un ruolo produttivo,
hanno cioè la responsabilità di garantire la sussistenza della famiglia, prestando mano d’opera
agricola, raccogliendo i prodotti delle foreste, allevando bestiame, ecc. Questo le rende direttamente
dipendenti dalla disponibilità e dall’accesso alle risorse naturali e fa sì che esse instaurino un
particolare legame e sviluppino una profonda conoscenza del territorio e delle risorse naturali
necessarie ai bisogni della famiglia e della comunità. Infine, le donne rivestono anche una posizione
chiave a livello comunitario, poiché è ad esse che spetta il compito di conservare e trasmettere la
cultura tradizionale e la memoria, di far convivere la comunità con la Madre Terra e di
53
54
Fonte: http://www.fimi-iiwf.org/en/noticia?idnoticia=415.
È meno probabile che prendano aerei per lavoro o che possiedano un veicolo di proprietà.
67
rappresentare in sostanza l’identità della comunità. Come risultato delle diverse funzioni da esse
svolte all’interno della società, le donne hanno sviluppato una radicata conoscenza e una capacità di
adattamento alle mutazioni climatiche e hanno messo in atto strategie per un uso razionale e
responsabile delle risorse disponibili, dando priorità ai bisogni della famiglia55. Inoltre, quali madri
ed educatrici, esse possono promuovere il cambiamento di abitudini e comportamenti negativi e
possono spingere i figli e gli altri membri della comunità ad adottare modelli comportamentali
sostenibili.
Nei paesi in via di sviluppo il bagaglio di conoscenza ambientale locale delle donne e le loro
tecniche gestionali sono di fondamentale importanza per l’adattamento al cambiamento climatico,
ma anche nei paesi avanzati sono le donne ad essere gli attori principali delle attività ambientali comunitarie e nell’educazione ambientale dei figli. Le donne prendono una vasta gamma di decisioni
sul consumo e la produzione in un’ottica di riduzione delle emissioni di gas serra, poiché esse sono
quasi sempre le prime responsabili dell’acquisto della maggior parte del cibo e dei beni di uso domestico. Esse sono anche più inclini ad adottare uno stile di vita pro-ambiente, che comporti il riciclaggio, il miglioramento dell’efficienza energetica, la partecipazione ad azioni della società civile.
Esse tendono, più degli uomini, a favorire politiche atte a ridurre le emissioni di gas serra, come la
limitazione dell’espansione aeroportuale o l’introduzione di tasse per le attività ad alto impatto ambientale. Attraverso approcci cooperativi e orientati al futuro, grazie anche alla naturale tendenza a
gestire il rischio in maniera più prudente rispetto agli uomini, le donne danno un potente contributo
alla resistenza sociale e possono guidare la società nell’adattamento al cambiamento climatico.
Sempre più spesso le donne stanno anche agendo in maniera diretta sul cambiamento climatico in
qualità di policy-makers e negoziatrici. Questi contributi possono crescere in maniera più veloce e
significativa man mano che le donne raggiungeranno la parità giuridica, economica e sociale in tutti
i paesi del mondo e a tutti i livelli.
Le donne indigene in particolare rivestono un ruolo vitale di resistenza volto alla creazione
di alternative. Esse trasmettono identità, cultura, memoria, spiritualità per il futuro della comunità.
Tramandando la cultura del proprio popolo, l’amore e il rispetto per la Madre Terra, le tradizioni
millenarie, l’uso dei frutti della natura, esse mettono in atto forme di resistenza quotidiana e
consuetudinaria, una resistenza che parte proprio dal loro modo di pensare, sentire e vivere come
donne indigene. Le donne delle comunità indigene hanno una solida consapevolezza delle cause
della distruzione dei loro territori e delle minacce per la sopravvivenza dei loro popoli e, attraverso i
coordinamenti e le organizzazioni intercontinentali sono all’avanguardia nelle lotte contro
megaprogetti, monocolture, privatizzazione delle risorse naturali che mettono in pericolo i loro
55
Es. in Africa subsahariana uno studio sui comportamenti di spesa di uomini e donne a fronte di aumenti del reddito
disponibile ha mostrato come le donne aumentino l’acquisto di beni di prima necessità per la famiglia, mentre gli
uomini si concentrino prevalentemente sui beni di lusso.
68
territori e le loro culture e quindi la sopravvivenza delle loro comunità.
È un fatto ormai che le donne di tutto il mondo – indigene e non – si stanno mobilitando.
Stanche di essere regolarmente escluse e non consultate nell’ambito del dibattito internazionale sui
processi decisionali finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici, esse hanno iniziato ad
organizzarsi non più solo a livello comunitario, come singole e virtuose esperienze di mitigazione e
adattamento, ma anche a livello nazionale, regionale e internazionale, come si vede dal numero
crescente di incontri, conferenze ed iniziative internazionali organizzate negli ultimi anni.
Il Foro “Mujeres Indígenas y sus Voces de Resistencia” – Bogotá, Colombia, 27
settembre 2006 – ha denunciato come i principali responsabili delle violazioni dei diritti delle donne
indigene e dei loro territori, nonché causa degli sfollamenti forzati, della perdita delle terre e della
sovranità alimentare, siano le attività delle imprese multinazionali e i progetti statali per lo sviluppo
economico (che spaziano dall’estrazione petrolifera e mineraria alle coltivazioni industriali come
quella di palma da olio) e la mancanza di politiche governative per la tutela della salute,
dell’educazione e del benessere delle comunità.
Di particolare rilievo è stato l’incontro dell’Alleanza delle Donne verso il Vertice sul
cambiamento climatico e i diritti della Madre Terra 56, tenutosi il 28 marzo 2010 a Cochabamba,
in Bolivia. Le partecipanti hanno effettuato una valutazione degli effetti negativi del cambiamento
climatico e identificato nel sistema capitalista la principale causa del riscaldamento globale. Come
si legge nel rapporto finale dell’incontro, il consumismo ha portato allo sfruttamento eccessivo delle
risorse naturali e all’uso sconsiderato dei combustibili fossili; le imprese petrolifere stanno
distruggendo interi ecosistemi; le guerre rappresentano il primo agente inquinante a causa dell’uso
di sostanze chimiche la cui combustione genera l'emissione di gas inquinanti. In questa situazione,
le donne sono colpite in maniera particolare e i paesi più poveri perdono la propria sovranità
alimentare, dipendendo sempre più dalle importazioni e contribuendo così alla distruzione della
produzione e dell’agricoltura locale – che si traduce nella scarsità di beni per il consumo domestico,
in una maggiore povertà, nel degrado ambientale.
Box 1
Proposte raccolte nel corso del Vertice di Cochabamba
Particolarmente esemplificativa degli argomenti trattati e delle proposte avanzate nel corso del Pre-Vertice di Cochabamba, è stata la pronuncia della Confederazione Nazionale delle donne contadine indigene originarie della Bolivia “Bartolina Sisa”, che raccoglie alcune proposte interessanti:
- che si recuperino e valorizzino gli usi e costumi degli avi, si impari a ringraziare e a chiedere per56
Fonte: http://pwccc.wordpress.com/category/working-groups/07-indigenous-peoples/.
69
messo alla Madre Terra per la semina e anche per il raccolto. Che si lasci riposare la terra per poter
continuare a produrre;
- che si recuperino e rivalorizzino le conoscenze ancestrali di cura e convivenza dei popoli indigeni
con la Madre Terra e che si instauri nel mondo il nuovo modello di sviluppo del “Buen Vivir” dei popoli indigeni;
- che si incentivi la partecipazione dei popoli indigeni agli spazi decisionali (partecipazione con la loro
voce e con il loro voto) nelle negoziazioni relative al cambiamento climatico;
- che vengano rispettati i diritti individuali e collettivi dei popoli indigeni inseriti nelle norme, nelle
convenzioni e nei trattati internazionali (Convenzione 169 della ILO, Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni, ecc);
- che i Paesi sviluppati paghino il debito climatico attraverso il trasferimento di tecnologie non inquinanti, che rispettino i diritti della Madre Terra e le risorse naturali e che le tecnologie trasferite siano
sviluppate o lavorate da persone del luogo in cui verranno utilizzate, al fine di creare posti di lavoro;
- che ci sia un ruolo molto più partecipativo delle donne nei negoziati mediante la socializzazione dell'informazione e che siano messi in atto meccanismi di finanziamento atti a rafforzare il ruolo delle
donne nel cambiamento climatico;
- che si promuova lo scambio di conoscenze per lo sviluppo di tecnologie pulite. Per questo è necessario eliminare i brevetti su tali conoscenze al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile;
- che si educhino e sensibilizzino le nuove generazioni (introduzione del tema della Madre Terra come
materia nei programmi educativi).
In occasione della conferenza “Women Participating to the Global Conference on Indigenous Women, Climate Change and REDD Plus”57, svoltasi il 19 novembre 2010 a Manila, nelle Filippine, si è ribadito l’enorme potenziale delle donne indigene legato alla loro conoscenza degli
ecosistemi e delle foreste e come esse siano sistematicamente escluse da ogni dibattito rilevante sul
cambiamento climatico. Per garantire che i loro diritti siano riconosciuti, così come il loro ruolo
nella mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, le donne indigene partecipanti hanno
chiesto che i diritti delle popolazioni e delle donne indigene siano riconosciuti, protetti e rispettati
come stipulato nella Dichiarazione dell’ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni e in altri strumenti giuridici internazionali quali la CEDAW e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Oltre a riconoscere che il cambiamento climatico ha i suoi effetti
peggiori sulle donne indigene, gli organismi internazionali preposti devono assicurare e appoggiare
la piena ed effettiva partecipazione delle donne indigene alle discussioni, consultazioni, processi decisionali sulle politiche, sui piani d’azione e sulle leggi a livello nazionale, regionale e mondiale e
fornire loro un più facile accesso ai meccanismi di finanziamento e di assistenza tecnica.
Particolarmente interessanti sono le proposte portate al pubblico dalle donne peruviane nel
corso del Raduno pubblico “Donne rurali contro i cambiamenti climatici”, tenutosi a Cuzco, in
Perù, nel novembre 2011. Il forum è stato organizzato dal Centro per i diritti umani delle donne Flora Tristán, nell’ambito dell’iniziativa dei Tribunali per le donne e il cambiamento climatico (Gender
and Climate Justice Tribunals), promossa dalla Feminist Task Force e dall’Appello Globale all’A57
Fonte:
http://www.indigenousportal.com/Gender/Securing-Rights-and-Enhancing-Capacities-of-IndigenousWomen-on-Climate-Change-Adaptation-and-Mitiga.html
70
zione contro la Povertà (GCAP) in quindici paesi in via di sviluppo del Sud del mondo 58. L’obiettivo: raccogliere le testimonianze e le proposte delle donne rurali per poi convogliarle alla XVII Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) a Durban, Sudafrica. Cinque donne, di cui tre indigene, hanno denunciato l’impatto dei
cambiamenti climatici sulla loro vita, l’economia, le relazioni familiari e la salute fisica e mentale.
Nel presentare le proprie proposte, le donne hanno rimarcato la loro intenzione di farcela con i propri mezzi e con le proprie capacità. Tra le richieste presentate dalle cinque donne: l’avvio di progetti
di formazione per le produttrici agricole finalizzati ad un efficiente utilizzo dell’acqua e al miglioramento del terreno e della produzione biologica; l’istituzione di assicurazioni agricole che tutelino le
piccole produttrici; il rimboschimento delle zone alto andine per favorire la generazione di microcli mi che attenuino le gelate e l’elaborazione di politiche sostenibili per promuovere la tutela della
biodiversità. Esse hanno poi fatto appello affinché i saperi ancestrali delle produttrici vengano finalmente riconosciuti e rafforzati con le tecnologie moderne
Nel loro messaggio ai partecipanti della COP17 di Durban59, le rappresentanti delle donne indigene africane di Camerun, Kenya, Uganda, Tanzania, Senegal, Mali, Ruanda e Sudan – riunite a
Nairobi, Kenya, nel novembre 2011 – hanno dichiarato: “Le donne indigene africane credono che
l’unico modo per affrontare alcune tra le sfide più critiche del cambiamento climatico sia quello di
integrare il cambiamento climatico in tutti i programmi di sviluppo a tutti i livelli. Le donne rurali e
indigene dovrebbero essere coinvolte nei processi decisionali e nella pianificazione, l’implementazione e la formulazione delle politiche e dei programmi di sviluppo concernenti il cambiamento climatico”. Esse raccomandano che sia data loro pari opportunità di prender parte agli organismi decisionali, di esser coinvolte nella formulazione delle politiche e che venga messa in atto una maggiore
diffusione delle informazioni sul cambiamento climatico sia a livello scolastico che all’interno della
società civile. Le rappresentanti hanno poi indicato le misure necessarie – per quanto riguarda finanziamenti, trasferimento di tecnologia, strategie di adattamento e preservazione delle foreste –
perché le donne indigene possano dare il loro contributo. Per quanto riguarda i finanziamenti, esse
chiedono maggiori informazioni sulle modalità di accesso delle donne indigene al Green Climate
Fund e maggiori stanziamenti di fondi alle comunità locali e alle organizzazioni della società civile.
Per quanto concerne le foreste, i governi devono incorporare i saperi tradizionali sulla gestione delle
foreste nelle politiche forestali; dividere equamente i benefici derivanti dai programmi REDD e
FCPF con le popolazioni indigene e avviare percorsi di ricerca specifici sulle specie indigene avvalendosi dell’apporto fondamentale della popolazione locale. Per quanto riguarda i programmi di
adattamento, alle donne dovrebbe essere facilitato l’accesso ai finanziamenti e alla tecnologia destinata al cambiamento climatico (soprattutto in agricoltura) e i governi e i donatori dovrebbero ap58
59
Fonte :
http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=408:mujerespropusieron-acciones-frente-al-cambio-climatico&catid=51:mujeres-frente-al-cambio-climatico&Itemid=73
Fonte : http://www.fimi-iiwf.org/es/alerta.php?idalerta=47
71
poggiare lo sviluppo di competenze delle donne indigene sulle nuove tecnologie e formarle sull’uso
di combustibili e carburanti alternativi, integrando al contempo il sapere indigeno con la nuova tecnologia.
Coinvolgimento delle donne nelle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
Esperienze pilota hanno dimostrato come le donne rurali ed indigene siano in possesso delle
conoscenze necessarie per sviluppare e diffondere innovativi metodi di coltivazione, in grado di
resistere o adattarsi alle mutate condizioni climatiche. Una valida strategia di adattamento comporta
l’adozione di metodi di coltivazione e di irrigazione che permettano la sicurezza delle colture anche
in caso di esaurimento delle risorse naturali o in situazioni meteorologiche impreviste. In Malawi,
ad esempio, alcune piccole proprietarie terriere sono state capaci di sviluppare tecniche di
coltivazione ecologica che hanno permesso loro di produrre una seconda coltura di mais e superare
così le carestie. In campo energetico, la produzione e l’utilizzo di bioenergia e di biocarburanti
porterebbe grandi benefici alle donne se combinato a politiche e pratiche volte a ridurre la povertà e
la disuguaglianza tra i sessi. La produzione del biocarburante jatropha, ad esempio, contribuisce a
ridurre l’erosione del suolo e ad aumentare la ritenzione idrica e allo stesso tempo porta nuove fonti
di reddito alle donne, poiché può essere utilizzato nella produzione di sapone e di burro di shea.
L’uso di stufe e forni ad alta efficienza energetica porterebbe ad una significativa riduzione delle
emissioni malsane e ridurrebbe la quantità di tempo che le donne devono destinare alla cucina,
permettendo loro di dedicarsi ad attività più produttive.
La biodiversità locale è mantenuta grazie alla conoscenza e alle competenze di donne e
uomini. A causa dei diversi ruoli che donne e uomini ricoprono nelle comunità rurali, essi
trasmettono conoscenze differenti e complementari: conoscono elementi diversi fra loro e
conoscono aspetti diversi dello stesso elemento; organizzano la loro conoscenza in modo differente
e la trasmettono con mezzi differenti. Questa conoscenza riguarda le risorse genetiche delle piante e
degli animali domestici, che rappresentano la base sia della produttività che dell’adattabilità dei
sistemi agricoli, ma riguarda anche le risorse selvatiche o semi-domestiche, che offrono una rete di
sicurezza in caso di carestia. In alcuni casi, come per il progetto Greenbelt Movement60 in Kenya, le
donne sono state attivamente coinvolte nelle attività di riforestazione, imboschimento e
rigenerazione degli ecosistemi e nelle attività di prevenzione della deforestazione. Nel caso del
Kenya le donne hanno ricevuto dei finanziamenti che hanno consentito loro di migliorare la propria
qualità di vita e allo stesso tempo di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. Nella
maggior parte dei casi, tuttavia, le donne raramente vengono retribuite per i loro “servizi
60
Fonte: http://greenbeltmovement.org/
72
ambientali”61.
Se alle donne fosse conferito un maggior potere decisionale all’interno delle famiglie e delle
comunità e se fosse garantito loro un pari accesso alle risorse naturali e alla proprietà della terra,
esse potrebbero produrre colture più resistenti garantendo una maggiore sicurezza alimentare e
possibili surplus ed entrate economiche.
61
OXFAM, “Responding to Climate Change in Vietnam: Opportunities for Improving Gender Equality”, maggio 2010.
73
4.Casistica
Nella sezione che segue sono enumerati esempi emblematici dell'importante ruolo svolto dalle
donne, con particolare riferimento alle donne indigene e contadine, in difesa dell'ambiente e del
territorio e in dinamiche di adattamento e mitigazioni degli effetti degli stravolgimenti climatici.
Riserva naturale di Popenguine – Senegal
Se non fosse per il lavoro di un gruppo di donne locali, la zona di Popenguine, sulla costa atlantica del
Senegal a 45 km a sud di Dakar, sarebbe oggi in totale degrado. L'ambiente di Popenguine è
caratterizzato, vicino alla costa, da foreste di mangrovie, mentre l'entroterra presenta un terreno molto
sassoso. All'inizio degli anni '80 i lunghi periodi di siccità e l'eccessivo sfruttamento da parte della
popolazione locale (per il pascolo e la raccolta di legna da ardere) avevano portato ad una considerevole
perdita di biodiversità. Molte delle specie locali tradizionali cominciavano a sparire. Nel 1986 il governo
senegalese dichiara il territorio riserva naturale e nel 1987, 116 donne del villaggio di Popenguine si
organizzano per proteggere e ripristinare l'ambiente del loro territorio, creando il Gruppo di Donne di
Popenguine (Regroupement des Femmes de Popenguine). Nel corso del successivo decennio, grazie al
lavoro di queste donne vengono piantati migliaia di alberi e cominciano a ricomparire alcune specie
animali e vegetali scomparse da tempo.
Forti del successo ottenuto a Popenguine, le donne decidono di espandere il progetto e nel 1995 si
uniscono alle donne della campagna vicina: otto villaggi si riuniscono nella cooperativa COPRONAT,
(Collectif des Groupements d'Intérêts Economiques des Femmes pour la Protection de la Nature), le cui
attività ricoprono oltre 100 km2 coinvolgendo oltre 1500 donne.
Le donne di Popenguine hanno sfruttato la conoscenza maturata grazie al loro quotidiano rapporto con
l'ambiente naturale per sviluppare delle soluzioni di adattamento efficaci, tra le quali pratiche di
rimboschimento delle mangrovie e di gestione energetica. Le loro attività contribuiscono a combattere la
desertificazione, a proteggere la biodiversità e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Ad esse
si sono gradualmente aggiunti anche gli uomini e i giovani dei villaggi. La protezione delle risorse
forestali ha contribuito a rigenerare il terreno, a ridurre la pressione sulla foresta e sulle risorse marine, ad
aumentare la quantità di combustibili disponibili per i villaggi e ad aumentare il reddito derivante dalla
vendita di legname e di altri prodotti della foresta, mentre l’adozione di nuove tecniche di gestione del
pascolo hanno permesso a molte specie animali di reinsediarsi nel territorio (sono ricomparse oltre 195
specie tra le quali: antilopi, sciacalli striati, manguste, ecc).
I fondi utilizzati per le attività del gruppo sono costituiti, prevalentemente, attraverso la formazione di
piccole tontine (forme di investimento primitive in cui ogni partecipante paga una quota di ingresso,
dopodiché il capitale raccolto viene investito e i partecipanti si distribuiscono gli utili derivanti dagli
investimenti).
Nella stessa regione alcuni gruppi di donne hanno messo in pratica alcune strategie agricole alternative.
La comunità rurale di Keur Moussa è composta da 37 villaggi, di cui 17 in aree soggette all'erosione e al
degrado del terreno. Tre di questi villaggi (Santhie Sérère, Kessoukhatte e Landou) sono stati selezionati
per condurre un progetto pilota nell'ambito del programma Agrobio Niayes dell'ENDA Pronat. Il progetto
74
è stato avviato dalla popolazione locale e soprattutto dalle donne, particolarmente attive all'interno del
comitato contro l'erosione. Per controllare il flusso d'acqua e limitare l'erosione del suolo e per riuscire ad
immagazzinare acqua durante la stagione delle piogge, esse hanno costruito dei piccoli muri frangiflutti. I
risultati sono stati subito visibili: aumento dell'acqua freatica, creazione di bacini idrici, stabilizzazione
del terreno, rigenerazione della vegetazione. Nel complesso la produzione agricola è migliorata e le
donne hanno ripreso a commerciare erbe tradizionali.
Oggi all'attività di rimboschimento, si sono aggiunti nuovi settori d'attività: le donne hanno piantato alberi
da frutto e piante ornamentali che possono essere vendute; è stato avviato un progetto volto ad introdurre
la raccolta differenziata nei villaggi e, quando possibile, a trasformare i rifiuti in compost; sono state
create banche cerealicole e piccoli orti famigliari; sono in corso diversi percorsi di formazione sul
riciclaggio, l'orticoltura e la gestione delle risorse naturali.
Ora che la riserva di Popenguine è nuovamente florida e ricca di specie animali e vegetali, le donne dei
villaggi stanno facendo di tutto per incentivare il turismo ecologico, che può portare ulteriori benefici alla
comunità e contribuire a creare nuovi posti di lavoro.
Stato federato di Orissa – India
Nel 1993 quindici gruppi femminili di mutuo aiuto operativi all'interno della regione costiera di Orissa,
nell'India orientale, si uniscono nella Samudram Women's Federation. Il gruppo nasce con l'obiettivo di
rafforzare i suoi membri economicamente svantaggiati attraverso l'introduzione di attività produttive
alternative e di proteggere le zone di nidificazione delle tartarughe Olive Ridley (ORT). Lo Stato costiero
di Orissa – in particolare le foci dei fiumi Devi e Rushikulya – è noto per la sua popolazione di tartarughe
Olive Ridley, riconosciute specie a rischio di estinzione dal governo indiano con l'Indian Wildlife
Protection Act del 1972. Questa regione ospita da sola più del 50% della popolazione mondiale di
tartarughe marine.
La Samudram Women's Federation lavora per la conservazione delle tartarughe attraverso il
monitoraggio, l'allevamento e la loro reintroduzione in natura, il ripristino del loro habitat naturale
attraverso il rimboschimento delle foreste di mangrovie e la protezione delle spiagge. Altre attività
importanti includono la costruzione di barriere coralline artificiali nelle zone costiere, allo scopo di
aumentare la popolazione marina e proteggere la biodiversità; l'organizzazione di campagne di
sensibilizzazione; l'avvio di progetti di formazione sulle tecniche di pesca sostenibile – in particolare sui
TED (Turtle Excluder Devices, dispositivi che impediscono alle tartarughe di rimanere impigliate) e sulle
no take zones, dove è proibita qualsiasi forma di pesca. La Federazione opera in rete con varie
federazioni locali e nazionali di pescatori, con l'università di Agricoltura e Tecnologia di Orissa, con
l'Orissa Marine Resource Conservation Council (OMRCC) e con l'Istituto di ricerca sulla pesca e sul
mare del governo indiano (CMFRI – Central Marine and Fisheries Research Institute).
Nel 2010 il progetto ha vinto l'Equator Prize dell'UNDP. Le attività della Federazione hanno dato, infatti,
ottimi risultati sia nel preservare la biodiversità sia nel migliorare la situazione socio-economica delle
donne membri e delle loro comunità. Per quanto riguarda la biodiversità, il programma ha consentito di
proteggere specie a rischio – oltre alle tartarughe anche delfini e altre specie marine dello stesso habitat;
le strategie di preservazione dell'ecosistema hanno contribuito a creare un habitat per oltre 130 specie
marine (coralli, spugne, ricci di mare, stelle marine, crostacei, molluschi, anemoni, cetrioli di mare,
alghe); la coltivazione delle alghe su zattere di bambù ha facilitato la ricolonizzazione di altri biocenosi
75
marini; il sapere tradizionale è stato sfruttato per lo sviluppo di tecniche di pesca sostenibile. A livello
socio-economico, invece, dal 2005 a oggi il reddito medio delle donne locali è salito da 25 rupie al giorno
(0.6 $) a 45 rupie al giorno (1 $); tra il 2006 e il 2008 la produzione di pesce di Samutram è aumentata di
quasi tre volte rispetto a quella di altri Stati indiani; le donne locali hanno ora un migliore accesso al
reddito, ai risparmi, al credito, alle forme assicurative. Al 2010 la Federazione operava in 44 villaggi in
quattro distretti costieri (su 21 totali) dello Stato di Orissa, coinvolgendo 308 gruppi femminili di mutuo
aiuto per un totale di oltre 4000 membri, e nel complesso più di 10.000 famiglie hanno tratto benefici –
diretti e indiretti – dal lavoro della Samudram Women's Federation.
Ondangwa – Namibia
Nel 2008 è nato, ad Ondangwa, nella Namibia settentrionale, dalla collaborazione di alcune donne, il
Creative Entrepreneur Solutions (CES), al fine di aiutare le donne più povere della comunità a rafforzare
le loro piccole imprese informali o ad aprirne di nuove. Per le donne rurali della Namibia – già affette
dalla povertà – le inondazioni, i periodi di siccità e le temperature in continua crescita rappresentano
un'ulteriore minaccia ai loro raccolti e alla sussistenza.
Nel 2009, l'UNDP insieme al CES ha elaborato un programma di adattamento comunitario (CBA –
Community Based Adaptation) in 20 comunità di 5 provincie della Namibia. Il programma è basato su un
approccio dal basso. IL CES ha contribuito alla formazione di gruppi femminili di mutuo aiuto sul
modello di gruppi già operativi in India. Le comunità si auto-organizzano in cooperative per affrontare
questioni legate al cambiamento climatico e per mettere insieme i fondi necessari ad avviare nuove
piccole attività imprenditoriali. Con questo approccio si cerca di garantire la sicurezza alimentare e al
tempo stesso di migliorare la condizione socio-economica delle comunità locali attraverso la creazione di
nuove attività imprenditoriali sostenibili. In questo modo si dà alle donne la possibilità di adottare
strategie di agricoltura conservativa e tecniche innovative di irrigazione per le loro aridocolture. Grazie al
programma, le donne coltivano ora diverse piante, più adatte alle nuove condizioni climatiche. Le
inondazioni – sempre più frequenti –hanno portato le comunità locali a dedicarsi all'itticoltura e ad
adottare sistemi di raccolta dell'acqua piovana.
Alla fine del 2011, sempre nell'ambito del programma CBA, il CES ha assemblato 150 stufe ad alta
efficienza energetica nel suo laboratorio di Ondangwa per poi donarle alle comunità che rientrano nel
programma. I forni sono facili da assemblare e adatti all’utilizzo domestico della famiglie rurali che
dipendono dalla raccolta di legna da ardere per cucinare e per il riscaldamento. L'utilizzo di questi forni
consente di risparmiare due terzi della legna da ardere e di produrre tra il 60 e l'80% delle emissioni in
meno. Inoltre la minore quantità di legna necessaria contribuisce a ridurre la deforestazione. Il costo di
produzione della stufa è ridotto, e l'obiettivo del CES è che le stufe vengano prodotte da piccole imprese
manifatturiere locali al fine di creare nuovi posti di lavoro ed incoraggiare la formazione di imprese e
cooperative.
76
Comunità andine di Apahua – Ecuador
I villaggi e le comunità andine di Apahua, in Ecuador – a 4000 m sul livello del mare – dipendono in
larga parte dal pàramo per la loro sussistenza. Il pàramo è un'area di prateria che ha la funzione di una
grande spugna, trattenendo l'acqua piovana e rilasciandola gradualmente nelle valli sottostanti.
Nonostante il suo ruolo fondamentale nell'assicurare acqua per centinaia di migliaia di persone, il delicato
ecosistema del pàramo è in pericolo. Negli ultimi anni più del 30% è andato distrutto, a causa delle
mutate condizioni climatiche ma soprattutto per l’eccessivo sfruttamento da parte dell’uomo, e con esso è
svanito il 30% delle risorse idriche utilizzate dalla popolazione locale di Apahua per il consumo
domestico e per l'agricoltura.
In queste comunità le donne sono le principali responsabili del lavoro agricolo e dell'approvvigionamento
idrico e alimentare delle comunità, poiché i mariti spesso migrano verso le città dell'entroterra e verso le
aree urbane costiere per lavorare. Gli uomini solitamente tornano nei villaggi solo in occasione delle
festività e durante la stagione del raccolto, perciò normalmente questi territori sono abitati e gestiti
prevalentemente dalle donne. Per questo motivo, le donne della comunità sono particolarmente
interessate alla protezione dell'ambiente in cui vivono e stanno mettendo in atto, grazie al sostegno di
Progressio, partner dell'Istituto degli Studi Ecuadoregni (IEE), strategie di mitigazione per impedire che il
pàramo sia totalmente distrutto da qui a pochi anni.
Nella comunità di Parahua, 17 donne stanno lavorando insieme per proteggere le sementi native e le
risorse idriche. Questa esperienza comincia a portare risultati positivi tangibili, tanto che le donne dei
villaggi vicini hanno deciso di dar vita ad una associazione di donne che comprende oggi oltre 150
membri. Grazie al loro lavoro, oggi gli abitanti dei villaggi non lasciano più pascolare i loro animali nel
pàramo e, gradualmente, stanno ricomparendo nel pàramo alcune varietà di erbe selvatiche, di arbusti e
alcune specie animali locali che erano da tempo scomparse. Le comunità locali ora vedono il pàramo
come una preziosa fonte di acqua e sono coscienti della sua importanza per la sopravvivenza
dell'ecosistema locale e per la loro sussistenza economica. Il miglioramento delle fonti d'acqua si traduce
in un generale miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti locali, della resa e della qualità dei
raccolti e della condizioni di salute della popolazione. Inoltre, proteggendo e migliorando le condizioni
ambientali del pàramo si dà la possibilità agli uomini della comunità di rimanere e di occuparsi dei
raccolti anziché dover migrare in città.
Regione di Kakamenga – Kenya
Nella regione di Kakamenga, nel Kenya occidentale, il maggiore problema legato al cambiamento
climatico è, da anni, l’erosione del suolo non fertile, che costringe le donne a raccogliere illegalmente la
legna da ardere nella vicina riserva nazionale della foresta di Kakamenga, contribuendo così al degrado
generale.
Nel 1994 è nato il Progetto Mama Watoto Group, che prevedeva un programma di rimboschimento della
regione ad opera di 28 donne e delle loro famiglie. Questo progetto ha consentito di ridurre l’eccessivo
sfruttamento delle risorse forestali, di creare una fonte alternativa di reddito per le comunità e di conferire
77
maggior potere alle donne rendendole responsabili del programma di rimboschimento. Inizialmente, una
donna del gruppo aveva comprato un appezzamento di terra a Kambiri per piantarvi degli alberi e
arricchire il sottobosco. Grazie al contributo del Kenya Wood Fuel and Agroforestry project questa donna
piantò diverse leguminose: grevillee, calliandre, e sesbanie e alcune mimose.
Le attività di rimboschimento e imboschimento cominciarono nel 1997, dopo la nascita del Mama Watoto
Group. Ad ogni membro vennero dati dei giovani alberi da piantare nei propri appezzamenti. Anche se
l'iniziativa era partita col solo scopo di dare alle donne una maggiore fonte di legna da ardere, le donne
capirono subito che la coltivazione di prodotti forestali avrebbe portato loro anche altri vantaggi. Quando
gli alberi raggiunsero la fioritura, infatti, le donne del gruppo cominciarono a dedicare parte delle loro
energie all’apicoltura.
Il progetto ha contribuito a conservare la biodiversità del territorio, a prevenire l'erosione del terreno e a
migliorarne la fertilità. Gli obiettivi del progetto inizialmente erano di ridurre l'eccessivo sfruttamento
delle risorse forestali e trovare una fonte alternativa di reddito per le comunità. Un obiettivo raggiunto,
insieme a quello di conferire maggior potere alle donne rendendole responsabili del programma di
rimboschimento, piantando alberi a crescita rapida sul proprio terreno. Ora il progetto si è evoluto e
prevede anche attività di formazione e iniziative di educazione ambientale. Il gruppo ha ampliato le
attività di produzione e lavorazione del miele, che contribuiscono ormai in misura consistente al reddito
delle famiglie. Lo stesso vale per la coltivazione della soia, l'itticoltura, la coltivazione di piante officinali
e di erbe tradizionali. Lo sfruttamento delle risorse forestali è diminuito in maniera significativa da
quando i membri della comunità hanno cominciato a diversificare la loro produzione. La struttura
dell'organizzazione incoraggia anche la partecipazione delle generazioni più giovani, contribuendo così
alla sostenibilità del progetto, che è già stato preso a modello da altri gruppi di donne nella regione.
Stato dell’Andhra Pradesh – India
Secondo il rapporto dello United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) del 2007, il
regime pluviale dell’India cambierà in maniera sproporzionata, con un’intensificazione dei periodi di
pioggia nei prossimi anni, che danneggerà l’attività agricola. Allo stesso tempo, le minori precipitazioni
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e i periodi di siccità sempre più frequenti porteranno a una
diminuzione delle scorte e a problemi nell’approvvigionamento idrico. Lo stesso rapporto cita, tra i
possibili impatti, un aumento di 0.5 gradi nella temperatura, che si tradurrà in un calo di 0.45 tonnellate
per ettaro nella produzione di grano indiana.
Per far fronte a questa situazione e come forma alternativa di lotta al riscaldamento globale, 5000 donne,
distribuite in 75 villaggi nello Stato federato dell’Andhra Pradesh, nell’India centro-orientale, si sono
unite in un collettivo e hanno abbracciato nuove tecniche di agricoltura organica, priva di agenti chimici e
non irrigata. A Zahirabad, le donne dalit (che costituiscono l’ultimo anello all’interno del sistema castale
indiano), hanno dimostrato di essere pronte ad adattarsi al cambiamento climatico adottando un sistema
di consociazione agricola che consiste nella coltivazione contemporanea di due o più specie di piante
sullo stesso terreno (determinate piante coltivate vicine le une alle altre si stimolano reciprocamente nella
propria crescita e si proteggono a vicenda contro malattie e parassiti) la cui produzione non richiede
acqua aggiuntiva, prodotti chimici o pesticidi. Queste donne coltivano diverse tipologie di colture
indigene su terre aride e degradate, che hanno saputo rigenerare con l’aiuto dell’organizzazione Deccan
78
Development Society (DDS). La DDS, operando in questa regione da oltre 25 anni, ha aiutato le donne
del collettivo ad acquistare appezzamenti di terra tramite gli schemi governativi previsti per i dalit e ha
contribuito alla formazione dei sangha, i gruppi locali di mutuo aiuto.
Le socie del collettivo hanno elaborato, e ora gestiscono, un sistema unico di “finanziamento delle
colture” e di distribuzione alimentare. L’iscrizione al sangha si ottiene in cambio di un pugno di grano.
Chi prende in prestito grano dalla banca del grano comunitaria deve in seguito restituire cinque volte
quello che ha preso. Il grano immagazzinato viene setacciato per conservare i semi migliori, mentre il
grano rimanente viene distribuito alle famiglie più povere, venduto ai membri in difficoltà a tassi
agevolati o sul mercato. Il denaro proveniente dalla vendita sul mercato viene depositato ogni anno in
banca e gli interessi che ne derivano vengono reinvestiti per finanziare prestiti ai membri. All’interno
della banca sono state finora raccolte fino a cinquanta varietà di sementi di cereali locali quali sorgo,
grano, caiano, semi di lino e miglio. Di recente le donne del collettivo hanno cominciato a trarre un
maggior profitto dalla vendita dei loro prodotti, certificati come biologici dal Partecipatory Guarantee
Scheme (PGS) Organic India Council, nelle vicine città di Zahirabad e Hyderabad.
79
Bibliografia
AA.VV., A Wider Context of Sexual Exploitation of Penan Women and Girls in Middle and Ulu Baram, Sarawak,
Malaysia, SUARAM Kommunikasi, Selangor (Malesia), 2010.
AA.VV., Responding to Climate Change in Vietnam: Opportunities for Improving Gender Equality, OXFAM GB,
2010.
AA.VV., Climate Change and Gender Justice, Cap. 13 – Minu Hemmati, Ulrike Rohr, “Engendering the climatechange negotiations: experiences, challenges, and steps forward”, OXFAM GB, 2009.
AA.VV., Managing the Health Effects of Climate Change, The Lancet and University College of London Institute
for Global Health Commission, Londra, 2009.
AA.VV., Tree Trouble: A Compilation of Testimonies on the Negative Impact of Large-scale Monoculture Tree
Plantations prepared for the sixth Conference of the Parties of the Framework Convention on Climate Change,
Friends of the Earth, Rainforest Movement, FERN, 2011.
Actionaid, Non sono cose da donne: Prospettive di genere al G8 del 2009, Milano, 2009.
ActionAid, Meals per gallon: the impact of industrial biofuels on people and global hunger, Milano, 2010.
Agenda 21, Chapter 24: “Global Action for Women towards Sustainable and Equitable Development”, Rio de
Janeiro, Brasile, 1992.
Aguilar L., Training Manual on Gender and Climate Change, International Union for Conservation of Nature
(IUCN);UNDP, San José (Costa Rica), 2009.
Altieri, A.M., Koohafkan, P., Enduring Farms: Climate Change, Smallholders and Traditional Farming
Communities, Third World Network, Penang (Malesia), 2008.
Bernstein, H., Class Dynamics of Agrarian Change, Fernwood Publishing, Halifax (Canada); Kumarian Books,
Willamsburg (MA, USA), 2010.
Bonham Carter R., “WASH initiative highlights African women’s needs for improved water and sanitation”,
UNICEF, New York, 15 settembre 2005.
Brown, O., Migration and Climate Change, IOM Migration Research Series n.31, Ginevra, 2008.
Bryceson, D.F., Kay, C., Mooij, J., Disappearing peasantries? Rural labor in Africa, Asia and Latin America,
Intermediate Technology Publications, Londra, 2000.
Calzolaio, V., Ecoprofughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani, NdA Press, Cerasolo Ausa di Coriano
(Rimini), 2010.
Carbon Trade Watch, Where the Trees are a desert: stories from the ground, FASE ES Transnational Institute,
Amsterdam, 2003.
Castels, S., Environmental Change and Forced Migration, Westmorland General Meeting ‘Preparing for Peace’
Initiative, Oxford, 2001.
CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, Conflitti ambientali: biodiversità e democrazia
della Terra, Edizioni Ambiente, Milano, 2011.
Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, Mudancas climaticas e refugiados ambientais, Resenha
“Migracoesna atualidade”, Anno 20, n.77, Brasilia, novembre 2009.
CESPI – Centro Studi di Politica Internazionale, Cambiamenti climatici e governance della sicurezza: la
80
rilevanza politica della nuova agenda internazionale, Osservatorio di Politica Internazionale, n. 16, Roma,
maggio 2010.
COICA, “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climàtico y los Derechos de la Madre Tierra :
Posicionamiento de la Coordinadora de las Organizaciones Indìgenas de la Cuenca Amazònica frente a Cambio
Climàtico”, Cochabamba, Bolivia, 17-18 aprile 2010
Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Sociale ed Economico Europeo e al Comitato delle Regioni; “Una tabella di marcia verso un’economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”, Bruxelles, 8 marzo 2011
Conclusiones Foro “Mujeres Indígenas y sus Voces de Resistencia”, Bogotá, 27 settembre 2006.
David, A., “50m Environmental Refugees by End of Decade, UN Warn”, The Guardian, Londra, 12 ottobre 2005.
Davis, M., Il pianeta degli slum, Feltrinelli, Milano, 2006.
De Marzo, G., Buen Vivir: Per una Nuova Democrazia della Terra, EDIESSE, Roma, 2009.
Del Testa, A., Gli esuli del clima – Analisi sui fenomeni dei rifugiati ambientali, A Sud Toscana, gennaio 2010.
Denton F., Climate change, vulnerability, impacts and adaptation: why does gender matter?, Gender and
Development, Vol.10 n.2, luglio 2002.
Dichiarazione Finale della Conferenza Mondiale dei Popoli a Cochabamba, Accordo dei Popoli, Cochabamba
(Bolivia), 22 aprile 2010.
Engelman R., Population, Climate Change and Women’s Lives, WorldWatch Report n.183, WorldWatch Institute,
Washington DC, 2010.
FAO, The state of food and agriculture 2010-2011: Women in Agriculture – closing the gender gap for
development, Roma, 2011.
FAO, State of the World's Forests, Roma, 2011.
IUCN, Indigenous Peoples and Climate Change/REDD. An overview of current discussions and main issues,
Washington DC, 2010.
Global Humanitarian Forum, Human Impact Report – Climate Change: The anatomy of a silent crisis, Ginevra,
2009.
Gubbiotti, M., Finelli, T., Falcone, F., Profughi ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate,
Dipartimento Internazionale di Legambiente (a cura di), Roma, 2011.
Hall, R., Lechón, D., Siakor, S., Yiah, J., Bessey, N., Lahn, B., Lovera, S., Diaz Peña, E., Baltodano, J., Surya, T.,
Redd: The realities in black and white, Friends of the Earth International Secretariat, Amsterdam, 2010.
IAES, Carta di Venezia 2006: “Carta per il riconoscimento del disastro ambientale intenzionale quale crimine
contro l’umanità”, Venezia, 13 settembre 2006
IFAD, Rural Poverty Report 2011, Roma, 2011.
IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change (AR4), 2007.
IPCC Working Group II Report, Summary for Policymakers: Impacts, adaptation and vulnerability, 2007.
Kelkar G., Adivasi Women Engaging with Climate Change, UNIFEM, IFAD, 2009.
81
Manila Declaration for Global Action on Gender in Climate Change and Disaster Risk Reduction, Manila (Filippine), 22 ottobre, 2008.
Mayer, N., Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena, Climate Institute, Sydney, 1995.
Mayer, N., Environmental Refugees: An Emergent Security Issue, GB, 2005.
McMichael, P., Contemporary Contradictions of the Global Development Project: geopolitics, glibal ecology and
the 'development climate, Third World Quarterly, 30: 1, pp. 247-262, GB, 2009.
Médecins sans Frontières, The Crushing Burden of Rape: Sexual Violence in Darfur, Amsterdam, 2005.
Nelson A., Chomitz K.M., Effectiveness of Strict vs. Multiple Use Protected Areas in Reducing Tropical Forest
Fires: A Global Analysis using Matching Methods, International Rice Research Institute, Manila (Filippine);
Independent Evaluation Group – World Bank, Washington DC (USA), 2011.
Nespor, S., I rifugiati ambientali, “Federalismi.it”, n.4, Roma, 2007.
O’Brien, K.L., Leichenko, R.M., 2000 Double exposure: assessing the impacts of climate change within the
context of economic globalization, Global Environmental Change n.10, 2000.
Obiettivo K della Piattaforma d’Azione di Pechino del 1995, disponibile sul sito:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm
OECD/FAO, Agricultural Outlook 2008-2017, Roma, 2008.
OXFAM, Responding to Climate Change in Vietnam: Opportunities for Improving Gender Equality, Oxford,
maggio 2010.
Plan of Implementation del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile del 2002.
Disponibile sul sito: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf
Rapporto della COP7 di Marrakech (29 ottobre -10 novembre 2001).
Disponibile sul sito: http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13.pdf
Schalatek, L., Bird, N., Brown, J., Were's the money? The status of climate finance post-Copenhagen, Climate
Finance Policy Brief n.1, 2010.
Shiva, V., Monocolture della mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura “scientifica”, Bollati
Boringhieri, Torino, 1995.
Smith, N., Nature as Accumulation Strategy, Socialist Register n.17, pp.16-36, GB, 2007.
Susana, A., Chai-Onn, T., de Sherbinin, A., Ehrhart, C., Warner, K., In search of a shelter. Mapping the effects of
climate change on human migration and displacement, CARE, UNHCR, CIESIN, UNU-EHS, 2009.
Tauli-Corpuz V., “Securing Rights and Enhancing Capacities of Indigenous Women on Climate Change
Adaptation and Mitigation”, Indigenous Portal, 20 novembre 2010
Testo integrale della Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne
(CEDAW). Disponibile sul sito: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
Testo integrale della Convenzione UNCCD.
Scaricabile sul sito: http://www.unccd.int/convention/text/convention.php
The Government Office for Science, Foresight: Migration and Global Environmental Change, Londra, 2011.
UNDP, Environmental Degradation Triggering Tensions and Conflict in Sudan, Ginevra/Nairobi, giugno 2007
82
UNDP, Human Development Report 2007/2008: “Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided
World ”, New York, 2007.
UNDP, GGCA, Resource Guide on Gender and Climate Change, 2009.
UNEP, From conflicts to Peacebuilding. The Role of Natural Resurces and the Environmental, Nairobi, 2009.
AA.VV., Women at the Frontline of Climate Change: Gender Risks and Hopes, UNEP, Norvegia, 2011.
UNFCCC, Investment and Financial Flows to adress Climate Change, an Update, Climate Change Secretariat,
Bonn, 2009.
UNFPA, State of World Population 2009. Facing a changing wolrd: women, population and climate, New York,
2009.
UNFPA, WEDO, Climate Change Connections: A Resource Kit on Climate, Population and Gender, New Yor,
2009.
UN-Habitat, The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, Earthscan Publications Ltd., Londra,
2003
UNHCR, The State of the World's Refugees: Human Displacement in the New Millennium, Roma, 2006.
UNICEF, Humanitarian Action Report 2009, New York, 2009.
United Nations General Assembly, “Report submitted by the Special Raporteur on the right to food, Olivier de
Schutter”, New York, 20 dicembre 2010.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione, “Ricerca nazionale su
immigrazione e asilo nei media italiani”, Roma, 2009.
Vargas-Lundius, R., Lanly, G., Villarreal, M., Osorio, M., International migration, remittances and rural
development, IFAD, Roma, 2008.
Via Campesina, Food Sovereignty for Africa: A Challenge at Fingertips, Via Campesina, Maputo, 2008.
Via Campesina, Sustainable Peasant and Family Farm Agriculture Can Feed the World, Via Campesina, Jakarta,
2010.
AA.VV., Gender and the Climate Change Agenda: The impacts of climate change on gender and public policy,
Women’s Environmental Network, 2010
World Bank, Tropical Forest Fires: A Global Analysis Using Matching Methods, Oxford University Press, New
York, 2011
World Bank, World Development Report 2008: Agriculture for Development, Oxford University Press, New York,
2008.
World Health Organization (WHO), Gender, Climate Change and Health, Ginevra, 2010.
World Watch Institute, State of the World 2009. In un mondo sempre più caldo, Annuari Edizione Ambiente,
Milano, 2009.
83
Links di approfondimento
A Sud - www.asud.net
ATTAC International – www.attac.org
Carbon Trade Watch - www.carbontradewatch.org/
Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA) - www.cdca.it
Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – www.csem.org.br.
Climate Funds Update - www.climatefundsupdate.org/
Coordinadora de las Organizaciones Indìgenas de la Cuenca Amazònica (COICA) - http://www.coica.org.ec/
CO2 Now - www.co2now.org
Friends of the Earth - www.foe.co.uk/
Global Gender and Climate Alliance (GGCA) - http://gender-climate.org/
International Organization for Migration (IOM) - www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) – Sezione Migration, Climate and Environment http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-climate-change-and-environment
Indigenous Portal – www.indigenousportal.com
International Union for Conservation of Nature (IUCN) – www.iucn.org
Lettera di World Rainforest Movement al SBSTA –
http://wrm.org.uy/actors/CCC/Letter_to_the_SBSTA.pdf
Living Space for Environmental Refugees (Liser) - www.liser.eu/
Movimiento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) - www.mst.org.br/
National Climatic Data Center del NOAA - http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html
Osservatorio Salva le Foreste - www.salvaleforeste.it/
Pulpmill Watch - www.pulpmillwatch.org/
REDD-Monitor - www.redd-monitor.org/
Rete italiana per la giustizia ambientale e sociale (RIGAS) - www.reteambientalesociale.org/
Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) – www.cbd.int/sbstta/
Survival – Il movimento per i popoli indigeni - www.survival.it/notizie/7873
UE – Azione Climatica - http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
UN-REDD – http://www.un-redd.org
UNWOMEN - http://www.unwomen.org/
Via Campesina - www.viacampesina.org/sp/
Women’s Environment and Development Organization (WEDO) – www.wedo.org
Women’s Environmental Network - http://www.wen.org.uk/
WomenWatch - http://www.un.org/womenwatch/
World Rainforest Movement - www.wrm.org.uy/
84
2012, Edizioni CDCA
Largo Gassman Roma
www.cdca.it
85
86