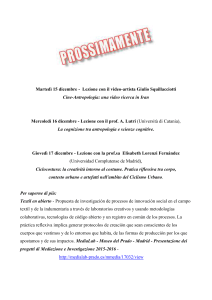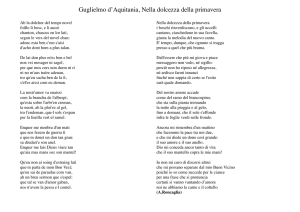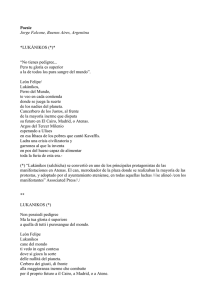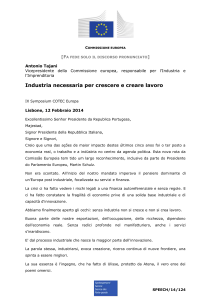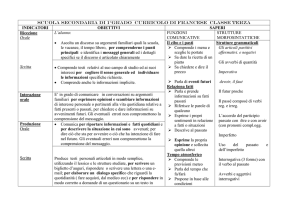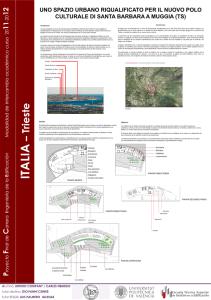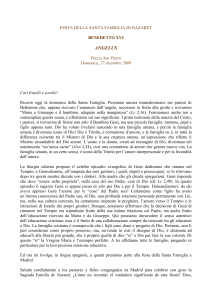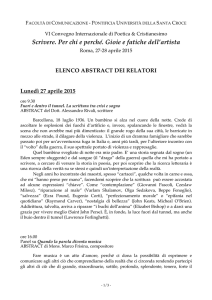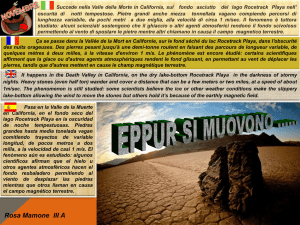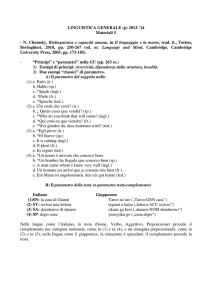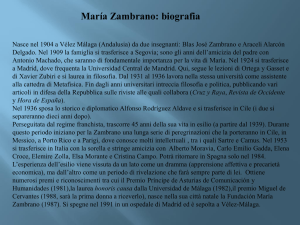BOLLETTINO
FILOSOFICO
Dipartimento di Studi Umanistici
Università della Calabria
Bollettino Filosofico
XXVII (2011-2012)
Ermeneutica
Natura/Cultura
Storicità
a cura di
Pio Colonnello, Roberto Bondì, Fortunato M. Cacciatore
BOLLETTINO FILOSOFICO
Dipartimento di Studi Umanistici
Università della Calabria
BOLLETTINO FILOSOFICO
Dipartimento di Studi Umanistici
Università della Calabria
Rivista diretta da
Pio COLONNELLO
Comitato scientifico
John ABBARNO (University of Buffalo – New York)
Mario ALCARO† (Università della Calabria)
Mauricio BEUCHOT PUENTE (IIFL-UNAM – México)
Roberto BONDÌ (Università della Calabria)
Romeo BUFALO (Università della Calabria)
Horacio CERUTTI GULDBERG (Cialc-UNAM – México)
Fortunato M. CACCIATORE (Università della Calabria)
Felice CIMATTI (Università della Calabria)
Ines CRISPINI (Università della Calabria)
Enrique DUSSEL (UNAM – México)
Raúl FORNET BETANCOURT (Bremen Universität)
Claudia STANCATI (Università della Calabria)
Silvia VIZZARDELLI (Università della Calabria)
Coordinamento di redazione
Vincenzo BOCHICCHIO (Caporedattore)
Stefano SANTASILIA (Segretario)
Segreteria di redazione
Donata CHIRICÒ
Daniele DOTTORINI
Luca LUPO
Emilio SERGIO
La rivista si avvale di una procedura anonima di peer review.
Bollettino Filosofico
XXVII (2011–2012)
Ermeneutica
Natura/Cultura
Storicità
a cura di
Pio Colonnello
Roberto Bondì
Fortunato M. Cacciatore
Copyright © MMXIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: giugno 2013
Indice
9 Premessa
Pio Colonnello, Roberto Bondì, Fortunato M. Cacciatore
SEZIONE I
Ermeneutica
15 Vincenzo Bochicchio
Temporalità plurali. Diacronia, sincronia e teleologia nel pensiero narrativo
33 Giuseppe Cacciatore
Interculturalità e riconfigurazione concettuale dell’ermeneutica
43 Giuseppe Cantillo
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
61 Horacio Cerutti Guldberg
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América
77 Pio Colonnello
La riscrittura del passato. Ancora sul nesso oblio perdono
95 Annabella D’Atri
Metafisica e leggi di natura in D.M. Armstrong
119 Maurizio Ferraris
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
127 Fabrizio Palombi
«La riproduzione interdetta»: ermeneutica e ripetizione in un confronto tra Lacan e Derrida
145 Sergio Sevilla Segura
La hermenéutica materialista
5
Indice
6
161 Giovambattista Vaccaro
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
179 Manuel E. Vázquez
Herencia y testamento (H. Arendt y J. Derrida)
195 Renata Viti Cavaliere
Croce e la storia del futuro (per un’ermeneutica del progresso)
SEZIONE II
Natura/Cultura
217 Ferdinando Abbri
Historia natural e cultura: aspetti del dibattito recente sul Nuovo Mondo
233 Andrés Galera
Questions about an anthropic nature
247 Dolores Martin Moruno
Feeling Nature: Emotions and Ecology
263 Vallori Rasini
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione di Arnold Gehlen
275 Sandra Rebok
Between Nature and Culture: Thomas Jefferson’s and Alexander von Humboldt’s interactions
with the Natural World
289 Giacomo Scarpelli
Mostri, giganti ed eroi. I fossili e le storie della storia del mondo
SEZIONE III
Storicità
301 Fortunato M. Cacciatore
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
Indice
315 Donata Chiricò
La voce: prima decisione politica
329 Deborah De Rosa
Michel Foucault: storia, scienze umane e finitudine
339 Rosario Diana
Con l’occhio al presente. Sollecitazioni crociane nella lettura dei classici
351 Fabio Frosini
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
369 Diego Fusaro
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
389 Saverio A. Matrangolo
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka
413 Vittorio Morfino
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Athusser
445 Sandra Plastina
Le figlie di Clio: storiche inglesi del XVIII secolo
7
Premessa
È giunto il tempo di fare un bilancio dell'intensa e feconda attività culturale
svolta dal "Bollettino Filosofico" nei suoi trentacinque anni di vita.
Fondato nel 1978 come annuario delle attività di ricerca condotte
nell'allora Dipartimento di Filosofia dell'Università della Calabria, il
"Bollettino Filosofico" ha sempre perseguito proprie ed originali linee di
investigazione, legate principalmente agli interessi scientifici dei docenti
del Dipartimento, ma anche dei non pochi studiosi italiani e stranieri
invitati a collaborare. Nella struttura tripartita della rivista - sezione
monografica, varia e recensioni - un posto di rilievo spetta indubbiamente
alla parte monografica, di cui ci piace ricordare, tra le tante tematiche
affrontate, almeno gli argomenti discussi nelle ultime annate: Forma e
immagine (2006); Rappresentazione dell'interiorità e dell'alterità nell'Europa
moderna (2007); Linguaggio ed emozioni (2008); Sensazione ed immaginazione
(2009); Pragmatismo e filosofia della biologia. Tra ontologia ed epistemologia
(2010).
Gli interessi scientifici dell'allora Dipartimento di Filosofia - la cui vita
istituzionale si è conclusa nel 2012, in quanto è confluito, insieme con altre
strutture, nel nuovo Dipartimento di Studi Umanistici - hanno compreso,
nel corso degli anni, una costellazione di ricerche, distinte e insieme
correlate tra loro: dall'ontologia all'epistemologia, dall'etica alle scienze
sociali, dall'estetica al pensiero religioso, alla fenomenologia
all'ermeneutica, al neoidealismo tedesco, alla tradizione della filosofia
italiana, al kantismo, al marxismo, alla storia del pensiero scientifico
moderno e contemporaneo, ai fondamenti del pensiero politico, alla
filosofia del linguaggio, alla semiotica, alla cultura e ai linguaggi del cinema
e dello spettacolo.
A partire dal fascicolo del 2010, la rivista è stata dotata, finalmente, di
una struttura organizzativa e redazionale. Accanto al direttore sono stati
costituiti, per la prima volta, un Comitato Scientifico, comprendente
studiosi italiani e stranieri, e un Comitato di Redazione. Certamente, la
scelta degli studiosi stranieri come componenti del Comitato Scientifico
non è avvenuta a caso. Si tratta di colleghi di varie Università estere, tra le
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 9-11
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606431
9
10
Pio Colonnello, Roberto Bondì, Fortunato M. Cacciatore
quali: University of Buffalo - New York, la Bremen Universität, la
Universidad Nacional Autónoma de México. Appunto in accordo con i
colleghi di queste e di altre Università, sono state stipulate tra l'Università
della Calabria e gli Atenei stranieri convenzioni culturali e scientifiche, che
prevedono scambi di docenti, di ricercatori e di dottorandi, seminari
comuni, convegni, pubblicazioni di Atti di congressi, ecc.
Questo numero del "Bollettino", che segna il passaggio dal vecchio al
nuovo Dipartimento, propone, nelle sue tre sezioni, l'approfondimento di
alcuni argomenti e problemi legati all'ermeneutica, al significativo tema
del nesso natura/cultura. nonché alle teorie della storia e alla riflessione
sulla storicità.
Il proposito è quello di sondare queste tre significative piste della
riflessione filosofica, che corrispondono ad alcune importanti direzioni
della ricerca dipartimentale, attraverso una ricognizione dei modelli e delle
attuali prospettive critiche.
Per quanto riguarda la prima sezione, i contributi qui raccolti
presentano sintomatici aspetti dei diversi indirizzi dell'ermeneutica
contemporanea, nella sua interrelazione con l'ontologia, l'epistemologia,
l'etica, la filosofia della storia, le scienze sociali, nonché la rilettura dei
rapporti tra individualità e alterità, io mondo, a partire dalla centralità
assunta dal tema del Verstehen.
Nell'impossibilità di fornire un resoconto dettagliato dei vari saggi che
riguardano la teoria dell'interpretazione, di essi possiamo qui fare cenno
solamente ad alcuni aspetti centrali. Da una parte risulta privilegiato
l'approfondimento di quei pensatori che, legati o meno alla tradizione
ermeneutica, hanno saputo indicare significative piste per lo sviluppo di
una teoria del comprendere. È questo il caso di Droysen, di Lukács, di
Croce, della Arendt, di Lacan, di Derrida, di D.M. Armstrong. D'altra
parte, l'investigazione del complesso territorio dell'ermeneutica
contemporanea riguarda alcuni concetti chiave, come il "nuovo realismo",
il tema della Wiederholung, la ricerca di senso delle "temporalità plurali", la
possibilità di una "riscrittura" del passato, il rapporto tra nichilismo ed
etica, la teoria del progresso, la particolare flessione latinoamericana
dell'ermeneutica filosofica, la possibile riconfigurazione concettuale
dell'ermeneutica stessa grazie al rapporto con la prospettiva interculturale.
Non meno interessanti sono le sezioni dedicate al rapporto
natura/cultura e alla storicità. Nella seconda sezione, tra gli autori di
riferimento spiccano i nomi di J. W. von Ritter, F. von Handerberg, A.
Premessa
11
von Humboldt, T. Jefferson, J. R. Frazer, D. Lewis, A. Gehlen. Questi i
principali temi affrontati: la visione dei fossili nella cultura greca, il
dibattito sul Nuovo Mondo, i rapporti tra indagine scientifica ed emozioni,
la dialettica tra dimensione naturale e dimensione artificiale, il principio
antropico applicato dall'uomo alla conoscenza della natura.
Infine, Foucault, Croce, Gramsci, Koselleck, Patočka, Marx, Bloch,
Althusser sono gli autori maggiormente discussi e approfonditi nella terza
sezione. Riguardo ai temi sui quali è diretta l'attenzione critica, vanno
segnalati importanti contributi che riguardano il rapporto tra storicismo e
storia, tra concezione naturale del mondo e storicità, nonché il significato
della rilettura dei classici, la relazione tra l’orizzonte d’aspettativa
dell'uomo e lo spazio dell’esperienza, la tensione problematica tra lo
husserliano “mondo della vita” e la dimensione della storicità, l'origine del
linguaggio come "prima decisione politica", l'apporto teorico delle
storiche inglesi del XVIII secolo.
Nel licenziare il numero del "Bollettino" alla stampa, desideriamo
infine ricordare il precedente direttore della Rivista, il compianto Mario
Alcaro, immaturamente scomparso nel luglio del 2012, nobile figura di
intellettuale, amico generoso, appassionato studioso del "pensiero
meridiano".
Desideriamo ringraziare, altresì, tutti coloro che hanno contribuito alla
revisione dei contributi e all'editing del volume, anzitutto i redattori
Vincenzo Bochicchio, Donata Chiricò, Daniele Dottorini, Luca Lupo,
Stefano Santasilia, Emilio Sergio.
Pio Colonnello
Roberto Bondì
Fortunato M. Cacciatore
Sezione I
Ermeneutica
VINCENZO BOCHICCHIO
Temporalità plurali. Diacronia, sincronia e teleologia nel
pensiero narrativo
Il racconto è «il custode del tempo»1: con questa affermazione si chiude
idealmente Temp et récit, l’opera in cui Ricoeur ricostruisce le complesse
dinamiche della temporalità narrativa. Il racconto – spiega Ricoeur – si
costituisce a custode del tempo perché quando ci disponiamo a raccontare
una storia, quando imbastiamo un intreccio di fatti ed eventi in una
narrazione, in realtà stiamo “rifigurando” il tempo in cui questi eventi si
svolgono come tempo di fini e di intenzioni, tempo di prassi e di progetti:
insomma, stiamo raccontando il tempo come “tempo umano”. Questo
tempo – insiste Ricoeur – è espressione di una temporalità sui generis. È un
tempo “terzo” rispetto al tempo cosmologico ed a quello fenomenologico,
e proprio questa sua terzietà consente alle narrazioni di “dire” la
temporalità dell’umano, con tutto il suo portato aporetico2.
Ma in cosa consiste questa temporalità? Quali sono le sue
caratteristiche? E in cosa si diversifica dal tempo dell’orologio, dal tempo
della diacronicità causale in cui un “prima” è sempre seguito da un “dopo”?
Rispondere a queste domande significa interrogarsi sulla forma del
racconto, sulla sua ontologia: se infatti intendiamo la narrazione come un
dispositivo creatore di senso3, allora i suoi caratteri ontologici si rendono
manifesti proprio nella sua struttura temporale perché, sostiene
Heidegger, è «nel fenomeno del tempo (…) [che] si radica la problematica
centrale di ogni ontologia»4. Ogni regione dell’essere, ogni dominio del
senso, ogni ontologia regionale, è anzitutto riflessione sulla natura
temporale di quel genere d’essere. E questo vale anche per la produzione di
P. RICOEUR, Temps et récit. III Le temps raconté, trad. it a cura di G. Grampa, Tempo e
racconto. III Il tempo raccontato, Jaca Book, Milano 1998, p. 369.
2 Cfr. ivi, pp. 369 ss.
3 Cfr. J. BRUNER, Acts of Meaning, trad. it a cura di E. Prodon, La ricerca del significato.
Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Torino 20032.
4 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, trad. it. a cura di P. Chiodi, Essere e tempo, Longanesi,
Milano 1976, p. 36.
1
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 15-31
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606432
15
16
Vincenzo Bochicchio
senso che procede dal pensiero narrativo.
Per analizzare lo specifico della temporalità narrativa, allora, è
opportuno ripercorrere brevemente i caratteri di altre due dinamiche
temporali intendendole come la forma di altri due domini della mente
umana – o se vogliamo di altre due ontologie regionali – e mi riferisco al
pensiero logico-paradigmatico e all’inconscio. E sebbene si tratti di
temporalità “inconciliabili” e dalle leggi talvolta antitetiche, nella
temporalità narrativa è possibile rinvenire le tracce tanto della temporalità
diacronico-paradigmatica, quanto della temporalità sincronico-inconscia.
Ma partiamo dalla forma del pensiero paradigmatico, e cioè il tempo
diacronico della causalità naturale.
La temporalità diacronico-paradigmatica
L’idea che l’essere umano si disponga a comprendere ed interpretare la
realtà utilizzando diversi “tipi di pensiero”, rappresenta per certi versi la
cifra del costruttivismo bruneriano. In Actual Minds, Possible Worlds, Bruner
espone una tesi che rimarrà un classico negli studi sul pensiero narrativo:
«ci sono due tipi di funzionamento cognitivo, due modi di pensare, ognuno
dei quali fornisce un proprio metodo particolare di ordinamento
dell’esperienza e di costruzione della realtà […] Ognuno di questi tipi di
pensiero, inoltre, possiede principi operativi propri e propri criteri di
validità»5. Questi due tipi di pensiero sono il pensiero paradigmatico e il
pensiero narrativo, ed i loro “principi operativi”, le loro leggi ed i loro
statuti, aggiunge Bruner, sono peculiari, eterogenei ed irriducibili. Ma
come si caratterizzano questi due “filtri ermeneutici” del reale?
Il pensiero paradigmatico «o logico-scientifico, persegue l’ideale di un
sistema descrittivo ed esplicativo formale o matematico»6: si tratta, in
buona sostanza, dello stile cognitivo “forte” tipico delle scienze naturali, in
cui i fenomeni sono descritti e rappresentati in termini causali e
nomotetici. Le sue leggi sono l’induzione (e correlativamente la
deduzione) e la causalità, e procede per categorizzazioni, classificazioni
gerarchiche, proporzioni: insomma, si tratta di un “pensare” che si dispone
a spiegare più che a comprendere, per utilizzare una nota distinzione proposta
5 J. BRUNER, Actual Minds, Possible Worlds, trad. it. a cura di R. Rini, La mente a più
dimensioni, Laterza, Roma-Bari 19975, p. 15.
6 Ivi, p. 17.
Temporalità plurali
17
da Dilthey e Gadamer7. Smorti, sulla scorta di Bruner, sostiene che il suo
ambito di applicazione sia “in prevalenza” il mondo fisico8, ma su questo ci
sarebbe da discutere a lungo: la dinamica del pensiero paradigmatico, in
effetti, è decisamente più economica dal punto di vista psichico, e
purtroppo quando si tratta di comprendere la complessità dei fenomeni
sociali e culturali non è raro imbattersi in schematici e lineari ragionamenti
di tipo logico e paradigmatico.
Ad ogni buon conto, la cifra del pensiero paradigmatico riposa nella
categoria di causalità e nei princìpi di identità e contraddizione. La prima,
soprattutto, ci interessa in questa sede, perché è l’esponente della
temporalità naturale in cui il prima (la causa) precede e induce il dopo
(l’effetto). La categoria di causalità crea una rigida asimmetria fra la causa e
l’effetto, un’asimmetria che dal punto di vista temporale istituisce il
“preciso rapporto” fenomenico fra il prima e il poi: la causalità, perciò, si
configura come la forma temporale propria del pensiero paradigmatico,
una temporalità che si può a pieno titolo indicare come paradigmaticodiacronica. Ora, il carattere asimmetrico della temporalità paradigmaticodiacronica e la natura formale della categoria di causalità sono due
questioni che si intrecciano fortemente nella Critica della ragion pura di
Kant, ed è proprio all’insegnamento kantiano che dobbiamo rivolgerci, se
vogliamo riflettere in profondità sulla natura formale di questo tempo.
Lo studioso della filosofia kantiana si sarà senz’altro accorto di
un’indiretta citazione della Ragion pura: i “precisi rapporti” che
caratterizzano l’asimmetria del tempo paradigmatico-diacronico. Scrive
infatti Kant nell’Estetica trascendentale che «la forma pura delle intuizioni
sensibili in generale si troverà a priori nell’animo, ed in essa verrà intuito,
in precisi rapporti, tutto il molteplice dei fenomeni»9, e con queste parole
introduce la questione della natura “formale” dello spazio e del tempo. Per
Kant, i “precisi rapporti” spazio-temporali che la nostra mente individua
intuitivamente nei fenomeni – il prima e il dopo, il sopra e il sotto, l’avanti
e il dietro, etc. – rappresentano l’unica forma possibile in cui questi
fenomeni sensibili possono darsi, la loro unica possibilità di accedere alla
7 Sulla questione della comprensione si veda soprattutto H.-G. GADAMER, Wahrheit und
Methode, trad. it. a cura di G. Vattimo, Verità e metodo, Bompiani, Milano 200414, pp. 305 ss.
8 Cfr. A. SMORTI, Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza
sociale, Giunti, Firenze 1994, pp. 93 ss.
9 I. KANT, Kritik der reinen Vernunft, trad. it a cura di P. Chiodi, Critica della ragion pura,
TEA, Milano 1996, p. 64.
18
Vincenzo Bochicchio
coscienza. In particolare il tempo, come forma del senso interno, è «la
condizione formale a priori di tutti i fenomeni in generale»10, e quindi
«tutti i fenomeni in generale, ossia tutti gli oggetti dei sensi, cadono nel
tempo e stanno necessariamente fra loro in rapporti di tempo [in
Verhältnissen der Zeit]»11.
Com’è noto, nell’Estetica trascendentale Kant non affronta la questione
della causalità fenomenica. Il tempo, in questa breve sezione della Critica, è
semplicemente descritto come la forma con cui l’animo – meglio, la mente
– struttura i dati sensibili, e l’interesse di Kant qui si concentra sulla natura
autoaffettiva di questa forma, e sulla asimmetria dei suoi rapporti. In
effetti, si tratta di due questioni che si intrecciano senza soluzione di
continuità, perché l’asimmetria dei precisi rapporti temporali è il modo
stesso in cui la mente si rende presente a se stessa. Il tempo, scrive Kant,
«poiché non rappresenta nulla se qualcosa non è posto nell’animo, non può
essere che il modo in cui l’animo è affetto dalla propria attività, ossia dal
porre la sua rappresentazione, quindi da se stesso»12. Il tempo in sé non
viene quindi percepito, perché non rappresenta nulla se qualcosa non viene
posto nell’animo: una formula molto evocativa per dire che il tempo si
esaurisce nel rapporto, che il tempo è il rapporto. E quando noi intuiamo
questo rapporto nei fenomeni, la nostra mente dispiega un intero dominio
ontologico, con le sue leggi e le sue regole. Il dominio del paradigmatico.
Il tempo dunque, come forma del senso interno, rappresenta i precisi
rapporti in cui si danno tutti i fenomeni. Nella mirata brevità dell’Estetica
trascendentale, Kant ne indica sostanzialmente tre: i «rapporti di
successione, di simultaneità, e di ciò che è simultaneo nella successione (il
permanente)»13, senza soffermarsi ulteriormente sulla natura di questi
rapporti temporali. Sarà compito dell’Analitica trascendentale approfondire
l’indagine sulla temporalità fenomenica, individuando e circoscrivendo lo
spessore intellettuale che queste determinazioni temporali sempre
comportano.
Nelle primissime pagine della Logica trascendentale si legge che «i pensieri
senza contenuto sono vuoti, e le intuizioni senza concetti sono cieche»14: si
tratta di un’affermazione rimasta celebre, perché indica con grande efficacia
Ivi, p. 75.
Ibid.
12 Ivi, p. 85.
13 Ibid.
14 Ivi, p. 92.
10
11
Temporalità plurali
19
l’interdipendenza esistente fra intuizioni e concetti. Le intuizioni sarebbero
inintelligibili se un concetto non le conferisse un certo significato, ed è
pertanto sempre «necessario rendere sensibili i propri concetti (ossia
aggiungere loro l’oggetto nell’intuizione), e rendere intelligibili le proprie
intuizioni (ossia sottoporle a concetti)»15. Ecco, mutatis mutandis si può
sostenere lo stesso argomento a proposito della forma dell’intuizione: questa
forma, il mero rapporto, diviene significativa solo se può essere pensata, se
assume uno spessore intellettuale, altrimenti resta anch’essa cieca.
Nell’esperienza propriamente detta i rapporti temporali non indicano mai un
accostamento casuale del prima e del poi, ma un ordine necessario, e questa
necessità non appartiene alla forma del senso interno16: la necessità è affare
dell’intelletto, e dei suoi concetti puri a priori. Così, inevitabilmente,
l’indagine sulla temporalità fenomenica ritorna prepotentemente in primo
piano proprio nell’Analitica trascendentale.
Qui, con grande efficacia, Kant individua la natura radicalmente
intellettuale della temporalità fenomenica, sostenendo che il tempo
dell’esperienza è sempre un tempo intellettualizzato, e quindi
paradigmatico:
ogni esperienza, e la sua stessa possibilità, richiede l’intelletto; […] esso
conferisce l’ordine temporale ai fenomeni e alla loro esistenza, assegnando
a ognuno di essi, nella sua qualità di conseguenza, una posizione nel
tempo, determinata a priori in relazione ai fenomeni precedenti; fuori di
questa posizione, i fenomeni non potrebbero collimare col tempo che
determina a priori la posizione di ciascuna delle sue parti17.
Questo vuol dire che i precisi rapporti istituiti nella forma del senso
interno divengono rapporti significativi solo in virtù di un principio
intellettuale, cioè di una regola necessaria. E Kant, che nell’Estetica
trascendentale aveva indicato nella permanenza, nella simultaneità e nella
Ibid.
«Il tempo come tale non può esser percepito e non è possibile, in rapporto ad esso,
determinare nell’oggetto, per così dire empiricamente, ciò che precede e ciò che segue.
[…] Ma un concetto che adduca la necessità dell’unità sintetica non può essere che un
concetto puro dell’intelletto, quale non si trova nella percezione; in questo caso si tratta
del concetto della relazione di causa ed effetto, in cui la prima determina il secondo nel
tempo come conseguenza e non come qualcosa che nella semplice immaginazione potrebbe
precedere» (Ivi, p. 192).
17 Ivi, 199.
15
16
20
Vincenzo Bochicchio
successione i Verhältnisse temporali, nelle Analogie dell’esperienza stabilisce
altrettanti princìpi intellettuali che danno senso a questi rapporti: il
«principio della permanenza della sostanza», il «principio della successione
temporale secondo la legge di causalità» ed il «principio della simultaneità
secondo la legge dell’azione reciproca o comunanza»18.
Il tempo dell’esperienza fenomenica, allora, è un tempo del
paradigmatico, nel criticismo kantiano: il senso del prima e del poi, il
senso della permanenza e della continuità, è stabilito da un principio
intellettuale, da una regola necessaria, paradigmatica. In altre parole, non
c’è rapporto temporale che non sia espressione di un principio
intellettuale, di una regola del pensare e del giudicare. E questa necessità
paradigmatica, ha sempre un andamento diacronico, persino nella
simultaneità.
Pensiamo infatti al rapporto di causa ed effetto: questo rapporto è
espressione di un principio logico, è una sorta di “diacronia logica”, che
sussiste anche quando lo scarto cronologico fra la causa e l’effetto è
inesistente. L’ordine intellettuale introdotto nel tempo, cioè, è più
importante del suo scorrimento, nella temporalità paradigmatica. Non a
caso, discutendo del principio di causalità nella seconda Analogia
dell’esperienza, Kant propone di distinguere accuratamente fra ordine e
scorrimento, quando si tratta di descrivere la struttura temporale
dell’esperienza fenomenica: «è importante tener presente come occorra
por mente all’ordine del tempo e non già al suo scorrimento; la relazione
permane anche nel caso in cui non si abbia scorrimento di tempo. Il tempo
fra la causalità della causa e il suo immediato effetto può anche dileguare (e
causa ed effetto sono allora simultanei) e tuttavia il rapporto intercorrente
fra di essi resta pur sempre determinabile in base al tempo»19. E
“determinare in base al tempo” significa determinare secondo un principio
logico.
In sostanza, se per Kant l’intelletto è il legislatore della natura20, allora
la prima legge che nella natura istituisce è proprio quella della temporalità
diacronico-paradigmatica. Si tratta di una temporalità rigidamente
asimmetrica (la causa è sempre causa, e viene logicamente prima
dell’effetto, che è sempre effetto), espressione di princìpi intellettuali
necessari che procedono dalle categorie. E, soprattutto, questa temporalità
Cfr. ivi, pp. 182-212.
Ivi, p. 201.
20 Cfr. ivi, p. 623.
18
19
Temporalità plurali
21
è espressione di un certo funzionamento della mente umana: un
funzionamento che istituisce un dominio ontologico ben preciso e
identificabile, quello della natura e della scienza. Forse, è proprio questo il
significato più profondo dell’intera filosofia kantiana: l’aver intuito che il
tempo come forma è anzitutto contenuto. La forma del senso interno (e
anche del senso esterno) non è una mera cornice o un mero contenitore in
cui si collocano le percezioni, ma è significato e senso, è la struttura stessa
dell’esperienza. Questa è la ragione per cui, nella prima Critica, la
diacronia logica si traduce in “determinazione temporale”.
Ed ecco perché Kant invoca spazio e tempo come «sorgenti
conoscitive»21: se si vuole veramente conoscere un certo dominio
ontologico, allora bisogna prendere in considerazione il suo contenuto più
significativo, ovvero la forma temporale che assume. E questa intuizione ci
consente di inoltrarci in un altro dominio ontologico, istituito da un’altra
forma temporale.
La temporalità sincronico-inconscia
La determinazione temporale della diacronia logica istituisce la
temporalità fenomenica, cioè la temporalità del paradigmatico e della
causalità. La vita della mente, tuttavia, non si esaurisce nel territorio della
logica e della coscienza, e il dominio del fenomenico rappresenta solo una
delle ontologie regionali che l’essere umano si trova quotidianamente a
percorrere. Fra gli altri generi d’essere con cui l’uomo ha a che fare, vi
sono senz’altro i processi e gli oggetti inconsci22: un territorio, quello
dell’inconscio, segnato da leggi e statuti suoi propri, molto diversi da
quelli della logica diacronica. Così come radicalmente diversa è la forma
temporale che ne caratterizza la struttura.
Non a caso Freud, quando si occupa di descrivere le caratteristiche
strutturali della vita psichica inconscia, si sofferma anche sulla particolare
forma temporale che la caratterizza:
non vi è nulla nell’Es che si possa paragonare alla negazione, e si osserva
Ivi, p. 78.
In questa sede con il termine “inconscio” farò riferimento all’idea psicoanalitica di
inconscio. Sulla differenza fra inconscio psicoanalitico e inconscio cognitivo si veda il
recente volume di G. PULLI, Note sull’inconscio, Moretti & Vitali, Bergamo 2011.
21
22
22
Vincenzo Bochicchio
pure con sorpresa un’eccezione all’assioma dei filosofi che spazio e tempo
sono forme necessarie dei nostri atti mentali. Nulla si trova nell’Es che
corrisponda all’idea di tempo, nessun riconoscimento di uno scorrere
temporale e – cosa notevolissima che attende un’esatta valutazione
filosofica – nessuna alterazione del processo psichico ad opera dello
scorrere del tempo23.
Non è questo l’unico luogo in cui Freud sostiene il carattere atemporale
dell’inconscio: il tema ricorre piuttosto frequentemente, ed è equamente
distribuito fra i testi della prima topica e quelli della seconda24. Quello che
caratterizza questo brano della seconda serie di Vorlesungen zur Einführung in
die Psychoanalyse è però il tenore filosofico che lo anima: Freud afferma che
i princìpi della logica e le forme spaziotemporali non siano affatto
universali e necessarie, come invece aveva sostenuto Kant, e con lui
numerosi altri filosofi occidentali. L’inconscio, con la sua relativa ontologia
regionale, sarebbe fuori dal tempo e al di là della logica. E il brano si
conclude con un significativo riferimento allo scorrere del tempo: per
Freud, nei processi psichici inconsci non si riscontrerebbe alcuna
alterazione dovuta allo scorrimento del tempo. L’inconscio, in definitiva,
non avrebbe una struttura temporale, e di conseguenza esisterebbero dei
processi psichici “atemporali”.
Si tratta di una tesi epistemologica forte, che merita di essere
approfondita. Per farlo, ancor prima di ripercorrere gli argomenti
freudiani, è necessario tornare alla nozione stessa di temporalità, facendo
nuovamente riferimento a Essere e tempo. Qui, introducendo la distinzione
fra Zeitlichkeit e Temporalität, Heidegger sostiene che «“temporale” non può
significare soltanto “essente nel tempo”. Anche il “non temporale” e
l’“ultra-temporale” sono temporali rispetto al proprio essere»25. La
temporalità non si riduce o non si manifesta semplicemente nello
scorrimento del tempo – come anche Kant aveva sostenuto – ma nella
forma che un certo genere d’essere assume, laddove forma indica sempre
un contenuto. Pertanto, se la temporalità rappresenta «la determinatezza
23 S. FREUD, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, trad. it. a cura
di M. Tonin Dogana e E. Sagittario, Introduzione alla psicoanalisi. Prima e seconda serie di
lezioni, Bollati Boringhieri, Torino 19959, p. 480.
24 A tal proposito si veda soprattutto la descrizione proposta in S. FREUD, Das
Unbewusste, ed. it. a cura di C. L. Musatti, L’inconscio, in Id. Opere di Sigmund Freud (OSF),
Bollati Boringhieri, Torino 2007, vol. VIII, pp. 70-71.
25 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, trad. it. cit., p. 36.
Temporalità plurali
23
originaria del senso dell’essere, dei suoi caratteri e dei suoi modi in base al
tempo»26, si comprende bene perché la temporalità del fenomenico sia
rappresentata dai “caratteri” e dai “modi” della logica diacronica: la
diacronia logica è l’ordine che dà senso a questi enti, è la loro forma, e
questo ordine è la temporalità.
Ora, è evidente che anche nell’inconscio freudiano deve esserci una
qualche forma, e correlativamente un ordine e una logica, per il semplice
fatto che senza forma e senza ordine i processi e gli oggetti psichici non
avrebbero alcun senso. Laddove, invece, i contenuti inconsci hanno
sempre un senso, e anche una logica, ben precisi e alternativi alla logica ed
al senso che orientano la vita cosciente. Ora, come nel caso kantiano
l’analisi della Logica trascendentale ci ha dato la cifra della temporalità
diacronico-paradigmatica, così adesso si tratta di indagare la logica dei
processi psichici inconsci, per arrivare a determinare la natura della
temporalità sincronico-inconscia. Una temporalità che è ordine, non
scorrimento, ed è radicalmente eterogenea rispetto alla temporalità del
paradigmatico.
Partiamo dal termine logica, che volutamente ho introdotto in questa
riflessione sull’inconscio freudiano. Nel Compendio di psicoanalisi, Freud
scrive che «le regole fondamentali della logica non hanno alcun valore
nell’inconscio, il quale, si può dire, è il regno dell’illogico»27, perché i
processi inconsci non obbediscono ai tradizionali princìpi della logicamatematica, come il principio di identità, il principio di contraddizione, il
principio del terzo escluso, né rispettano la legge di causalità e le più
elementari operazioni matematiche. Questo non vuol dire che i processi
inconsci non esprimano una loro logica, un loro ordinamento e delle loro
leggi: lo stesso Freud, quando ne descrive il funzionamento, ricostruisce
una logica che opera per condensazione, spostamento e sostituzione dei
contenuti psichici28. E certamente, questa logica “notturna” talvolta
contraddice gli assiomi della logica “diurna”, perché nei sogni i
contradditori coabitano, le alternative si congiungono, le parti sono
equivalenti al tutto, e così via. Insomma, per utilizzare un concetto caro a
Matte Blanco, la logica dell’inconscio è una logica ispirata al “principio di
Ibid.
S. FREUD, Abriss der Psychoanalyse, ed. it. a cura di C. L. Musatti, Compendio di
psicoanalisi, in OSF, cit., vol. XI, p. 595.
28 Cfr. S. FREUD, Das Unbewusste, cit., p. 71; ID., Die Traumdeutung, ed. it. a cura di C.
L. Musatti, L’interpretazione dei sogni, in OSF, cit., vol. III, pp. 287-295.
26
27
24
Vincenzo Bochicchio
simmetria”, perché «tratta come se fossero simmetriche delle relazioni che in
logica bivalente sono considerate asimmetriche. Esempio: se Giovanni è il padre
di Pietro, per l’inconscio profondo Pietro è anche il padre di Giovanni»29.
Non è qui il caso di ricostruire il complesso tessuto della metapsicologia
di Matte Blanco, che pure ha offerto e offre molti spunti di riflessione ai
filosofi che si occupano di spazio e tempo30: in questa sede, sarà necessario
solo soffermarsi brevemente sul principio di simmetria e sulla sua tipica
struttura temporale. Dunque, come abbiamo visto la logica “diurna” crea
una rigida e stabile asimmetria fra causa ed effetto, soggetto e predicato, A
e non-A, parte e tutto: asimmetria vuol dire che quando un concetto o un
oggetto vengono assegnati ad un certo “insieme” o classe, vengono anche
logicamente esclusi da un altro insieme. Causa ed effetto, ad esempio,
appartengono a due insieme ben definiti, non interscambiabili: “luce
solare” e “ombra” stanno in relazione di causa ed effetto, dove “luce solare”
si colloca nell’insieme “causa” e “ombra” nell’insieme “effetto”, ed in
questa relazione logica per nessuna ragione l’ombra può divenire la causa
della luce solare. Nei termini di Matte Blanco, si trovano in una relazione
logica asimmetrica. Questa asimmetria logica (la logica diacronica) si
determina come temporalità fenomenica, come ordine del prima e del poi.
In buona sostanza, il tempo della Ragion pura.
Nell’inconscio profondo vige invece il principio di simmetria, per cui le
relazioni fra gli insiemi comportano una estrema reversibilità: nei sogni la
causa può essere anche effetto, la parte può essere anche il tutto, il
maggiore può essere anche il minore e così via. Si tratta quindi di insiemi
infiniti, perché possono contenere potenzialmente tutto31. E che ne è del
tempo? L’ordine logico del prima e del poi, emblema della asimmetria
comportata dalla logica diacronica, viene annullato: più ci si inoltra nelle
profondità dell’inconscio, più si allenta la asimmetria delle relazioni
temporali diacroniche, e ogni “prima” e “poi” diventa un adesso32. In altre
29 I. MATTE BLANCO, Creatività e ortodossia, in La bi-logica fra mito e letteratura. Saggi sul
pensiero di Ignacio Matte Blanco, a cura di P. Bria e F. Oneroso, FrancoAngeli, Milano 2004,
p. 25.
30 Si veda soprattutto I. MATTE BLANCO, Thinking, Feeling and Being. Clinical Reflections
on the Fundamental Antinomy of Human Beings and World, trad. it. a cura di P. Bria, Pensare,
Sentire, Essere. Riflessioni cliniche sull’antinomia fondamentale dell‘uomo e del mondo, Fabbri,
Milano 2007, pp. 327 ss.
31 Cfr. I. MATTE BLANCO, The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic, trad. it. a
cura di P. Bria, L’inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica, Einaudi, Torino 1981.
32 In ciò si coglie il carattere “ricorsivo” dell’inconscio freudiano. Cfr. a tal proposito
Temporalità plurali
25
parole, poiché «il tempo comporta la consapevolezza di una successione
ordinata, con la simmetrizzazione l’ordine, che è per sua natura
asimmetrico, scompare e con esso la consapevolezza del tempo»33. La
logica inconscia ispirata al principio di simmetria, in buona sostanza, si
traduce in un ordinamento sincrono degli oggetti psichici.
La sincronia è l’esito dell’effetto omogeneizzante che il principio di
simmetria produce negli insiemi infiniti dell’inconscio. Un effetto che
scardina l’ordine lineare della temporalità diacronica, in virtù della quale il
tempo viene concepito come «una struttura ordinata […] in cui ogni
istante viene prima o dopo ogni altro istante». Questo ordine «può essere
rappresentato come una linea, uno spazio uni-dimensionale [...]. Esso
“fluisce” dal passato al presente al futuro», mentre nell’inconscio «tutti gli
oggetti sono catapultati l’uno dentro l’altro e lo stesso avviene per gli
istanti. […] In altri termini, tutte le relazioni spaziali e temporali sono
catapultate l’una nell’altra in modo tale che ogni cosa e ogni avvenimento […]
sono anche ogni altra cosa e ogni altro avvenimento»34.
Questo brano raccoglie in estrema sintesi le ragioni che inducono Matte
Blanco – e Freud, prima di lui – a dichiarare atemporali i processi inconsci.
Ma a ben vedere, il principio di simmetria identificato dallo psicoanalista
cileno, si limita ad affermare che l’ordine degli oggetti psichici inconsci
non sottostà alla determinazione temporale della diacronia logica. Questo
non vuol dire che l’inconscio non abbia una sua struttura temporale. Se
infatti concepiamo il tempo fenomenico come la determinazione della
diacronia logica, possiamo anche concepire la particolare sincronia che
ordina i fatti psichici inconsci come una determinazione temporale del
principio di simmetria.
In tutta evidenza, anche la sincronia è una forma temporale, proprio
come lo è la diacronia. Anche la sincronia ordina gli eventi psichici secondo
una forma che è contenuto: questo ordinamento temporale, infatti,
raccoglie nel presente del sogno avvenimenti, persone, oggetti e azioni che
assumono un senso solo in virtù della simmetria indotta dai processi
inconsci. In definitiva, si può dire che la sincronia è l’ordine logico che
assumono gli oggetti simmetrizzati nell’inconscio, proprio come la
diacronia è l’ordine logico degli oggetti che si presentano nel vissuto
P. COLONNELLO, “Freud, il perturbante e l’eterno ritorno”, Filosofia oggi 121 (2008) 1, pp.
133-147.
33 I. MATTE BLANCO, Thinking, Feeling and Being, trad. it. cit., p. 32.
34 Ivi, p. 301.
26
Vincenzo Bochicchio
fenomenico, e si tratta in entrambi i casi di forme temporali, di “ordini”
che danno senso a oggetti ed eventi. Scrive Matte Blanco che «in sé,
l’assenza di tempo è espressione di simmetria pura»35: ecco, parafrasando
quest’affermazione potremmo affermare che la simmetria pura si esprime
nella forma temporale della sincronia.
Ovviamente, la logica simmetrica e la logica classica si incontrano
molto spesso e Matte Blanco ha dedicato buona parte del suo lavoro a
ricostruire le forme in cui entrambe le logiche convivono, dando luogo a
strutture di senso che ritroviamo sia nella vita cosciente che nel sogno. E
dal punto di vista dell’ordine temporale, una struttura in cui è possibile
ritrovare elementi tanto della temporalità diacronico-paradigmatica,
quanto della temporalità sincronico-inconscia, è la temporalità teleologiconarrativa.
La temporalità teleologico-narrativa
Come si è già detto, Ricoeur sostiene che il racconto sia il custode del
tempo, sostanzialmente perché la narrazione configura – o meglio rifigura
– l’ordine temporale come “tempo umano”. Temp et récit si chiude infatti
con l’affermazione che la stessa identità umana – individuale e collettiva –
è un’identità narrativa, e che in quest’identità narrativa riposa il senso
ultimo della temporalità. Le ragioni per cui il tempo del racconto viene
interpretato come tempo autenticamente umano, Ricoeur le propone nel
primo libro di Tempo e racconto:
l’intersignificazione tra progetto, circostanze, caso è appunto proprio ciò
che viene ordinato mediante l’intrigo, così come noi l’abbiamo descritto
come sintesi dell’eterogeneo. L’opera narrativa è un invito a vedere la
nostra praxis come… è ordinata grazie a questo o quell’intrigo espresso
nella nostra letteratura. Quanto alla simbolizzazione interna all’azione, si
può dire che è proprio essa che viene ri-simbolizzata o de-simbolizzata
[…]. E infine, è il tempo dell’azione che, soprattutto, è rifigurato grazie
alla messa in azione36.
Ivi, p. 70.
P. RICOEUR, Temps et récit. I L’intrigue et le récit historique, trad. it. a cura di G.
Grampa, Tempo e racconto I, Jaca Book, Milano 1986, p. 133.
35
36
Temporalità plurali
27
Il tempo della narrazione, scrive Ricoeur, è un tempo rifigurato dalla
messa in azione, ed è un invito a risignificare teleologicamente
l’esperienza: per questo è tempo umano. In effetti, l’azione di cui si parla
in un certo racconto acquista il suo senso in virtù dell’“intrigo”, della fabula
e del suo esito, non ha mai senso in se stessa. Pensiamo a quello che
succede nell’esercizio quotidiano del pensiero narrativo: quando
raccontiamo una storia – effettivamente vissuta, o inventata – intrecciamo
fatti, episodi, individui in un intero che ha un inizio, uno svolgimento e un
finale. E poiché nella narrazione questi fatti ed episodi concorrono tutti a
determinare il finale, succede inevitabilmente che il finale concorra a
determinare il senso dei singoli episodi. Detto altrimenti, ogni episodio di
una narrazione ha senso in virtù del “tutto narrativo”, nel doppio significato
del ricevere senso e dare senso. E su questo delicato rapporto fra il tutto e
le parti, «l’oscura interdipendenza parti-tutto del racconto»37, si gioca la
tenuta e la resa del pensiero narrativo.
Nella peculiare “sintesi dell’eterogeneo” in cui si intrecciano gli episodi
del racconto, si coglie l’andamento schiettamente teleologico che struttura
il pensiero narrativo. Il parallelo con il funzionamento di un organismo
sembrerebbe quasi scontato: i singoli episodi svolgerebbero all’interno
della narrazione la stessa funzione che gli organi svolgono all’interno di un
organismo complesso. E non a caso, Ricoeur evocativamente scrive che il
racconto ci fa «vedere la nostra praxis come… è ordinata grazie a questo o
quell’intrigo»38, e cita più o meno direttamente la nota dottrina kantiana
del “come se”39, ovvero la ratio del giudizio teleologico. Rispetto alla
teleologia dell’organismo, però, la teleologia del racconto esprime una sua
peculiare dimensione temporale, e anzi si può dire che sia proprio la forma
temporale in cui si offrono gli episodi della storia a dare un ordinamento
teleologico alla narrazione. Concentriamoci, allora, sullo specifico di
questa forma temporale.
Un buon punto di partenza per indagare la natura teleologica della
temporalità narrativa è rappresentato dalla Poetica di Aristotele, il testo che
per secoli ha costituito il canone della produzione narrativa e recitativa.
Qui, Aristotele definisce le celebri forme dell’unità che dovrebbero
37 Cfr. J. BRUNER, La costruzione narrativa della “realtà”, in Rappresentazioni e narrazioni, a
cura di M. Ammanniti e D. N. Stern, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 24.
38 P. RICOEUR, Temps et récit. I, trad. it. cit., p. 133.
39 Cfr. I. KANT, Kritik der Urteilskraft, trad. it. a cura di A. Gargiulo e V. Verra, Critica
del Giudizio, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 27-31.
28
Vincenzo Bochicchio
caratterizzare i buoni racconti, insistendo soprattutto sull’unità di azione e
di tempo: «la tragedia è l’imitazione di un’azione compiuta e intera, dotata
di una certa grandezza; […] Intero è poi ciò che ha un principio, un mezzo
e una fine. […] Occorre dunque che i racconti ben composti non
incomincino a caso né finiscano a caso, ma usino delle forme dette»40.
L’unità di tempo è la forma che, più di ogni altra, compone in unità la
vicenda tragica. Una buona rappresentazione tragica, infatti, «cerca quanto
più può di essere compresa in una sola giornata o di eccederne poco»41, di
modo che la concentrazione del tempo possa tradursi nella concentrazione
del pubblico sulla vicenda narrata. E proprio in virtù della sua estrema
compattezza e unitarietà dal punto di vista temporale, la tragedia è
considerata da Aristotele superiore all’epopea perché riesce meglio nella
mimesis di una certa azione. In altri termini, poiché è più «indefinita per il
tempo»42, allora «l’imitazione epica è meno unitaria»43, e può risultare più
dispersiva. L’epica, in effetti, consente una certa variabilità nell’estensione
temporale, variabilità che in certi casi può arrivare ad insidiare i limiti
dell’“intero” e le forme dell’unità che ogni buon racconto deve
comportare, soprattutto quando l’intreccio narrativo è ricco di episodi più
o meno indipendenti.
Come esempio di epica ben riuscita, Aristotele cita i grandi capolavori
omerici: qui, in tutta evidenza, l’estrema dilatazione temporale e la
ricchezza degli episodi “collaterali” non insidia l’unità mimetica della
narrazione. Tutt’altro. Nella narrazione omerica prende forma un “intero”
ricco di episodi, e questa dinamica teleologica è espressione di una specifica
temporalità. Scrive infatti Aristotele che una buona epopea si deve
comporre
intorno a un’azione intera e compiuta, che abbia un principio, un mezzo e
una fine, perché procuri il piacere che le è proprio come un unico animale
intero; le composizioni non debbono essere simili alle trattazioni storiche,
nelle quali è inevitabile che venga fatta l’esposizione non di un’azione ma
di un periodo di tempo: tutti i fatti che in esso sono accaduti ad una o più
persone, ciascuno dei quali si trova con gli altri in un rapporto casuale.
Come negli stessi tempi si ebbero la battaglia navale di Salamina e in Sicilia
40 ARISTOTELE, Perì poietikès, trad. it. a cura di D. Lanza, Poetica, BUR, Milano 200417,
pp. 141-143.
41 Ivi, p. 133.
42 Ibid.
43 Ivi, p. 223.
Temporalità plurali
29
la battaglia contro i Cartaginesi, senza che esse tendessero allo stesso fine,
così anche nei tempi successivi talvolta accade un fatto dopo l’altro dai
quali non si produce alcun esito unitario44.
Una narrazione epica, sostiene Aristotele, è un “intero” che assomiglia
ad un animale vivente, e questa organicità è resa possibile dalla forma
temporale che assume: non è la stessa forma della trattazione storica, dove
episodi del tutto indipendenti vengono raccolti insieme unicamente perché
cadono nello stesso periodo di tempo. È l’azione del protagonista – o dei
protagonisti – che rende possibile l’intreccio narrativo, e organizza gli
eventi come se «tendessero allo stesso fine»45. Così, la dinamica teleologica
dell’azione umana – che è sempre orientata verso un fine – diviene la
forma temporale della narrazione epica: si passa dalla crono-logica della
storia alla teleo-logica del racconto46.
L’ordine temporale della narrazione, quindi, è la teleologia. Un
episodio non compare mai casualmente in una narrazione, ma ha un suo
preciso scopo, una ratio, un senso, e questo senso risulta dal finale verso
cui intende condurci. Insomma, è sempre un episodio orientato verso un
fine. La caratteristica di questa forma teleologica, poi, è che intreccia
elementi della temporalità diacronico-paradigmatica ad elementi della
temporalità sincronico-inconscia, senza però rispettare pedissequamente le
rispettive “logiche”. È infatti senz’altro necessario che in un racconto vi sia
una certa correlazione logica di causa ed effetto, perché altrimenti l’intrigo
mancherebbe di intelligibilità, ma questa «diacronicità narrativa»47 non è
espressione di una rigida causalità lineare. Come scrive Bruner, «il
carattere blando del legame tra stati intenzionali e azione successiva
rappresenta la ragione per cui i resoconti narrativi non possono darci
spiegazioni causali. Quello che essi ci danno è, invece, un fondamento per
interpretare perché un personaggio abbia agito come ha fatto»48. Lo spazio
ermeneutico che caratterizza il racconto, in buona sostanza, spezza la
diacronia logica opponendo alla spiegazione causale la comprensione
narrativa, e questa comprensione assume la forma temporale della
Ivi, p. 201. Corsivo mio.
Ibid.
46 Cfr. M. STERNBERG, “Raccontare nel tempo (I): Cronologia, Teleologia,
Narratività”, Enthymema I (2009), pp. 170 ss.
47 Cfr. J. BRUNER, La costruzione narrativa della “realtà”, cit., p. 22.
48 Ivi, p. 23
44
45
30
Vincenzo Bochicchio
teleologia, del come se… una certa azione fosse stata compiuta in vista di un
certo fine. In sostanza, questa causalità viene compresa nell’ottica del finefinale.
La temporalità narrativa, poi, assume anche i tratti della sincronia
inconscia. Si pensi, infatti, a come funziona il comune espediente narrativo
del flashback: ad un certo punto del racconto compare un episodio che
spezza la linearità cronologica, un episodio che da un lontano passato
immettiamo nel qui e ora della nostra narrazione. Questo episodio
concorre alla creazione di senso propria del racconto, e non importa
quanto sia lontano o vicino dal punto di vista cronologico. Succede, allora,
che la creazione di senso tipica del pensiero narrativo simmetrizzi il tempo,
ed il ruolo di un episodio lontano nel tempo risulti essenziale alla teleologia
narrativa quanto un episodio più recente. Per questa ragione gli episodi
narrati si collocano nell’intreccio narrativo secondo una logica che non
rispetta la linearità cronologica: la loro forma temporale, il loro
ordinamento logico, è schiettamente teleologico, perché i singoli episodi
fanno la loro comparsa nel racconto solo quando possono contribuire alla
creazione di senso che si compie nel fine-finale. In questo modo il tempo
lineare è simmetrizzato nella forma temporale della teleologia.
La temporalità diacronico-paradigmatica e la temporalità sincronicoinconscia sono così rifigurate in un nuovo ordine, una nuova forma
temporale che esprime un contenuto teleologico. Si tratta di un ordine per
certi versi «rassicurante»49, che crea uno spazio ermeneutico nel reale
vissuto o fantasticato ed organizza eventi ed azioni in una trama di senso
orientata alla comprensione, piuttosto che alla spiegazione. Prendendo a
prestito i contenuti della seconda Introduzione alla Critica del Giudizio, si
potrebbe affermare che il pensiero narrativo sia una forma del giudizio
riflettente: messo di fronte alla molteplicità degli eventi e dei vissuti, il
pensiero narrativo li riorganizza e li rifigura secondo il principio della
finalità. Questo “riflettere” non obbedisce alla dinamica determinante del
pensiero paradigmatico, ma nei singoli eventi si rappresenta la finalità,
istituendo un ordine che è rassicurante, è “piacevole” proprio come lo è la
rappresentazione estetica della finalità. Ecco perché le belle narrazioni –
anche quando rifigurano eventi drammatici – sono sempre “piacevoli”,
tanto per chi le racconta quanto per chi le ascolta e le legge: si tratta della
«capacità che noi abbiamo di trarre un piacere dalla riflessione sulla forma
49 G. VILLONE BETOCCHI, Ricordare e narrare, in Memoria e narrazione, a cura di M.
Sbandi, Idelson-Gnocchi, Napoli 1999, p. 31.
Temporalità plurali
31
della cose»50, una forma che istituisce la nostra mente, la finalità.
Così inteso, il pensiero narrativo si configura come la più comune e
ordinaria forma di giudizio estetico, una sorta di “ermeneutica del
quotidiano” che organizza vissuti e fantasie in una forma teleologica, e ci
restituisce così una temporalità che è autenticamente “tempo umano”.
Abstract
The paper aims to investigate the temporal structures that characterize
three different operating modes of the mind: the paradigmatic thought,
narrative thinking, the unconscious. While in paradigmatic thought,
following the Kantian reflection on time as a form of inner sense,
temporality is the order of succession and contiguity own scientific
knowledge, thought narrative temporality instead assumes a teleological
connotation: as shown by Bruner and Ricoeur, in fact, narrative thinking
interprets and negotiates events always orienting toward an end. Another
form of temporality, then, is that of the unconscious: a recursive
temporality, "simmetrizzante" (to use an apt expression of Matte Blanco),
which does not recognize any causal relationship (as indicated by Freud).
The paper aims to reconstruct the complex relationships that exist
between these structures and their temporal dimensions in mind, the
unconscious meaning, narrative thinking and paradigmatic thought, as
three different hermeneutical skills that the individual puts in place to
understand and interpret the world outer and inner world.
50
I. KANT, Kritik der Urteilskraft, trad. it. cit., p. 55
GIUSEPPE CACCIATORE
Interculturalità e riconfigurazione concettuale
dell’ermeneutica
1 - Il rinnovamento del paradigma filosofico, richiesto dalla riflessione sui
temi e sulle problematiche interculturali, si ripercuote anche sulla
riconfigurazione concettuale dell’ermeneutica. Fornet-Betancourt ha
affermato che la “filosofia interculturale” «preferisce entrare nel processo
di ricerca creativa che ha luogo proprio quando la “interpretazione” del
proprio e dell’altro si manifesta come risultato di una interpretazione
comune, mutua, per cui la voce di ognuno è percepita nello stesso tempo
come modello di interpretazione ugualmente possibile»1. Il problema,
dunque, appare chiaramente posto nella evidente sottolineatura del dato
interrelazionale, cosicché un atteggiamento critico-filosofico verso la
propria appartenenza/identità culturale, mentre permette la
desacralizzazione del punto di origine (e dunque il distacco da ogni
etnocentrismo), non annulla, al tempo stesso, il legame storicosituazionale, ampliandolo consapevolmente e contaminandolo nella
intercomunicazione e nel transito reciproco dei modelli culturali.
D’altronde, come è stato da più parti osservato, nella stessa pregnanza
semantica del termine interculturalità è insita la “progettualità”, cioè una
dimensione di analisi e comprensione delle culture che non si limita alla
registrazione delle tipologie. L’accento cade sul significato non puramente
verbale del prefisso inter, sulla sua esplicita designazione di una situazione
storica, di una attività etico-politica e di una pratica metodologica ed
epistemologica che si fonda sul concetto di relazione2.
Si potrebbe dire che la “filosofia interculturale” è una radicalizzazione
dei principali motivi teorici posti a base delle filosofie storicistiche ed
ermeneutiche.. Essa, infatti, ha di mira una vera e propria trasformazione
dei paradigmi filosofici, a partire dalla «necessità di pluralizzare i luoghi di
1 R. FORNET-BETANCOURT, Trasformazione interculturale della filosofia, a cura di G.
Coccolini, Dehoniana, Bologna 2006, p. 30.
2 F. PINTO-MINERVA, L’intercultura, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 13 e ss.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 33-41
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606433
33
34
Giuseppe Cacciatore
nascita della filosofia, di pluralizzare i suoi inizi, di pluralizzare e
diversificare i suoi metodi e le sue forme di articolazione». Tutto questo,
allora, riguarda gli stili teoretici, ma anche e forse soprattutto i profili
storici e narrativi, giacché si possono e devono ridiscutere le fonti e le
tradizioni, opere ed autori, anche classici.
La trasformazione interculturale della filosofia – scrive Fornet-Betancourt
– si impone, pertanto, come un programma di ricostruzione del passato e,
al contempo, di configurazione di un presente nel quale la filosofia si
riconosce come tale senza avere la necessità di installarsi preferenzialmente
in un sistema concettuale monoculturale, cioè, riconoscendo che
scaturisce e si articola a partire dalla comunicazione tra tradizioni distinte,
riconoscendo infine che non è monologica, ma polifonica3.
Per questo, allora, la “filosofia interculturale” aspira ad essere il
tentativo di superamento di ogni forma di monologo, ma intende proporsi
anche come qualcosa di più della pur auspicabile dialogicità “intraculturale”
che si può instaurare tra l’io e l’altro, tra l’identico e il diverso, tra il
proprio e l’estraneo. Essa, cioè, vuole andare oltre ciò che oggi si
manifesta in forme concettuali del tutto consumate dal modificarsi stesso
dei termini e dei contenuti con cui si definisce e si comprende una cultura.
«Il dialogo interculturale nel senso proprio del termine – scrive Pannikar –
ha luogo con lo straniero, che nel mondo moderno può essere il vicino
geografico, o spesso l’immigrante, il rifugiato o anche il lontano»4.
Si può, allora, certamente affermare che se la “filosofia interculturale” è
innanzitutto ricerca di nuovi paradigmi del pensiero, a partire dal
confronto e dal conflitto delle culture (se si tratti di dialogo/confronto o di
conflitto non è indubbiamente aspetto secondario, ma ciò tocca una sfera
pratico-politica e anche una opzione che pure appartiene, direi che è
consustanziale, al modello di “filosofia interculturale” di cui qui si sono
delineati i tratti5), allora anche l’ermeneutica deve essere ripensata. Anzi,
R. FORNET-BETANCOURT, Trasformazione interculturale della filosofia, cit., p. 9.
Cfr. R. PANIKKAR, Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica, Jaca Book, Milano
2002, p.23
5 Condivido il convincimento degli studiosi e dei teorici dell’interculturalità per i quali
essa favorisce lo sviluppo di tutte le dimensioni (conoscitive, etiche e ideologiche) del
pluralismo. Questo fa sì – come giustamente si è osservato – che l’interculturalità è
coerentemente chiamata a dare il suo «apporto alle logiche che sono alla base della
democrazia. Essa contribuisce in maniera determinante alla definizione di una convivenza
3
4
Interculturalità e riconfigurazione concettuale dell’ermeneutica
35
la prima osservazione che si può suggerire è che un’alleanza strategica fra
“filosofia dell’interculturalità” ed ermeneutica è resa oggi ancor più
auspicabile proprio alla luce delle oggettive difficoltà che si manifestano nel
processo di individuazione di convergenze solidaristiche dei popoli,
specialmente quando questo processo voglia caratterizzarsi per una aperta
dialettica tra le specifiche differenze storico-culturali dei popoli e
l’individuazione di elementi comuni di universalismo6, ad esempio dei
diritti e della dignità dell’uomo.
Se, inoltre, si riflette sul fatto che nelle sue origini moderne
l’ermeneutica si è costituita in stretto contatto con una idea di topica
fondata, più che sulla sua funzione retorica, su quella filosoficognoseologica dell’invenire, del ritrovamento delle cose e dei significati
(anche e soprattutto attivando l’immaginazione più che l’astratta
razionalità, la fantasia più che il calcolo, l’invenzione più che il rigore
geometrico), diventa possibile scorgere una analogia tra il procedere
topico-ermeneutico e la “filosofia dell’interculturalità”, intesa – così come
sostengono alcuni suoi teorici7 – come comprensione delle culture in
quanto luoghi in cui si pratica la filosofia. Vi è filosofia non perché si parte
da un modello paradigmatico che si espande e si globalizza, ma perché vi
costruttiva, il cui obiettivo è la costituzione di una società che stabilisca una interazione fra le
differenze e costruisca un tessuto di relazioni fra differenti identità. Questo implica, per
chiunque, relativizzare i propri riferimenti culturali e de-costruire quanto di totalizzante vi è
insito». G. GENNAI, Lessico interculturale, EMI, Bologna 2005, p. 92.
6 Ho creduto di poter individuare uno dei fondamenti teorici per un ripensamento
dell’universalismo in una chiave non ontologica o metafisico-trascendentale nella
tradizione dello storicismo critico che prende le mosse dalla convezione vichiana della
storicità. Mi permetto di rinviare, tra gli altri contributi, a G. CACCIATORE, “Giambattista
Vico: l’ordine della ‘comunità’ e il senso comune della “differenza"”, in F. RATTO (a cura
di), All’ombra di Vico. Testimonianze e saggi vichiani in ricordo di Giorgio Tagliacozzo, Edizioni
Sestante, Ripatransone, s.i.d. 1999, pp. 191-199. Per la storia e la teoria dello storicismo
critico e problematico rinvio ai miei libri: Storicismo problematico e metodo critico, Guida,
Napoli 1993; L’etica dello storicismo, Milella, Lecce 2000; e ai miei saggi “Etica e filosofia
della storia nello storicismo critico”, in G. CANTILLO - F.C. PAPPARO (a cura di), Genealogia
dell’umano. Saggi in onore di Aldo Masullo, Guida, Napoli 2000, tomo II, pp. 473-499;
“Storicismo ed ermeneutica”, in G. CACCIATORE - P. COLONNELLO - D. JERVOLINO,
Ermeneutica Fenomenologia Storia, Liguori, Napoli 2001, pp. 55-74; “Lo storicismo come
scienza etica e come ermeneutica dell’individualità”, in Magazzino di filosofia, 8 (2002), pp.
120-133.
7 Su questo punto specifico cfr. R. FORNET- BETANCOURT, «Filosofia intercultural», in
R. SALAS ASTRAIN (a cura di), Pensamiento critico latinoamericano, vol. II, Ediciones
Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile 2005, pp. 399 e ss.
36
Giuseppe Cacciatore
sono pratiche culturali della filosofia come esercizio concreto di pensare
che si fa carico della sua contestualità e storicità. Questo però significa che
ci può essere vera ermeneutica e autentica comprensione dell’altro solo
quando si abbia consapevolezza della pluralità dei luoghi possibili del
filosofare e, dunque, quando si attivi una radicale critica del pensiero
etnocentrico e occidentecentrico.
2 - Pluralità dei luoghi genetici del pensiero, relativizzazione (e non
relativismo) dei principi, sono compiti che assume su di sé chi riflette oggi
sull’interculturalità. Ma si tratta anche dei percorsi che deve attraversare
una ermeneutica che non voglia essere solo mera procedura metodica e
teoria gnoseologica, sia pur rinnovata, della filosofia. L’ermeneutica
contemporanea, da Schleiermacher a Dilthey, da Gadamer a Ricoeur, ci ha
mostrato il progressivo e necessario riorientamento del filosofare, il
ricollocarsi del suo centro dal mondo all’io, dalla cosmologia alla
umanologia, dall’universalità del cosmo all’individualità del Sé. Ma proprio
su questo punto la riflessione interculturale fa un decisivo passo in avanti
rispetto all’ermeneutica tradizionale, giacché non si tratta più del mero
processo di riconoscimento/comprensione del particolare costantemente
commisurato ad una presupposta universalità, ma della plausibilità di un
dialogo tra contesti parimenti comprensibili nel loro valore universale
proprio e sempre a partire dalla loro individualità. Una filosofia
ermeneutica preoccupata di definire e di comprendere il nesso tra le
individualità può, come si è detto, impegnarsi nell'opera di costituzione di
ambiti e finalità di una riflessione interculturale che non postula un astratto
dialogo con le culture, ma lo costruisce nella pratica di una interpretazione
e comprensione delle stratificazioni e delle articolazioni interculturali e
anche, e forse più, intraculturali, vista la composita fenomenologia
pluriculturale e plurirazziale delle metropoli contemporanee.
Per tale via, ermeneutica e interculturalità possono incontrarsi proprio
nell'assunzione del compito di oltrepassamento della situazione di mera
frammentazione degli universi culturali, per assolvere invece quello di
costruire (e non solo, dunque, trovare) nuove relazioni interidentitarie. Il
processo di traduzione da una cultura all'altra e viceversa sembra essere,
così, un reale e concreto terreno di comune lavoro teorico e di comune
pratica per l'ermeneutica e la riflessione interculturale. Una più
consapevole attenzione dell'ermeneutica contemporanea ai problemi della
traduzione - intesa non come meccanico trasferimento del testo da un
Interculturalità e riconfigurazione concettuale dell’ermeneutica
37
linguaggio all'altro, ma come individuazione di un possibile luogo di
incontro tra lingue, mentalità, pratiche sociali e culture diverse8 - si
intreccia con l'essenziale finalità di una comprensione della interculturalità
che persegua la prospettiva di fondare un nuovo universalismo che non
annulli o mortifichi le differenze. Entrambi i paradigmi, quello
ermeneutico e quello interculturale, com'è facile vedere, si basano su una
comune idea dell'universalismo che, in tanto può apparire aperto al
continuo processo del farsi, in quanto spinge ai margini sia la pretesa di una
filosofia assoluta e monistica, sia la pretesa di una trasmissione dei linguaggi
e degli atti comunicativi che voglia stemperare o cancellare le diversità. La
traducibilità dei linguaggi, intesi come veicoli/contenitori delle culture, si
converte nella possibilità della relazione e, dunque, nella “relativizzazione”,
da non intendersi come relativismo etico e culturale, ma come nesso di
reciprocità tra entità storicamente determinate.
Il rapporto qui istituito tra traduzione e interculturalità può servire
anche a definire la modalità di una pratica del comprendere che può farsi
realmente e produttivamente interculturale nella misura in cui il fatto
dell'interpretazione e della comprensione delle culture non si basi su un
atteggiamento di passiva registrazione (sia pur descrittivamente e
comparativamente rigorosa) delle differenze e delle analogie, ma assuma
piuttosto un carattere dinamico9. L'altro, l'estraneo, il diverso, non sono
da considerarsi entità immobili o semplicemente catalogabili da ricondurre
o, peggio, da assimilare al nostro linguaggio, alla nostra cultura, in una
8 «Ogni traduzione è al tempo stesso un’attività ermeneutica che indaga l’intenzione
presente alla base dei termini. Con uno sforzo sincero, dunque, si può raggiungere la
concettualità transculturale, tanto necessaria alla filosofia comparata.Comprendere è più
che tradurre, è una prestazione intenzionale, la cui riuscita o il cui fallimento ci sono
originariamente dati. Per tale motivo anche il fraintendimento è suscettibile di
comprensione autentica». Cfr. R. A. MALL, Interculturalità. Una nuova prospettiva filosofica,
Ecig, Genova 2002, p. 44.
9 Si è opportunamente osservato che il processo di interazione delle culture, almeno a
livello di studi antropologici (e non soltanto) mette in campo una serie di elementi
dinamici che costituiscono l’essenziale aspetto differenziale tra multicultura e intercultura.
La sottolineatura della dinamicità, come è facile capire, vale ancor più se dal sapere
antropologico si passa all’analisi dei fenomeni sociali e politici. «Mentre quindi il termine
intercultura indica reciprocità di scambi e conoscenze, con conseguente arricchimento della
società nel suo insieme sulla base di incontri (in cui le mutue identità si ridefiniscono nella
persistente ricerca di nuovi stili di interazione), multiculturalità disegna all’opposto una
situazione statica e sostanzialmente immutabile». Cfr. G. GENNAI, Lessico interculturale, cit.,
p. 81.
38
Giuseppe Cacciatore
parola, alla nostra radice identitaria. Esse vanno, innanzitutto, sottratte ad
una tradizionale dialettica soggetto/oggetto e immesse, piuttosto, in un
nuovo tipo di connessione che è quella paritaria soggetto/soggetto.
Insomma, l'altro non può essere considerato come oggetto passivo di
analisi e di una pratica, sia pur importante, di descrizione e classificazione
(e persino di condiscendevole e tollerante accettazione nel proprio
universo), e neanche può essere più sufficiente il solo procedimento della
traduzione. L'altro deve trasformarsi (anche e soprattutto grazie al
rapporto dialogante) in soggetto attivo di trasmissione di atti linguistici e di
fatti sociali, cioè di tutto quello che definisce una identità propria, che può
essere capita e condivisa in un comune processo di comprensione e
interpretazione.
A giusta ragione, allora, alcuni esponenti della “filosofia
interculturale”10, hanno sostenuto che uno dei più significativi contrassegni
10 Specialmente nelle aree filosofiche tedesca e latinoamericana è in corso, da un paio
di decenni, un interessante dibattito storico e filosofico sulla interculturalità. F. WIMMER,
Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, Junius, Wien 2004; ID., Interkulturelle Philosophie.
Geschichte und Theorie, Passagen Verlag, Wien 1990; R. PANNIKAR, Pace e interculturalità.
Una riflessione filosofica, cit.; ID., Sobre el diálogo intercultural, San Esteban, Salamanca 1990;
R. FORNET-BETANCOURT, Transformación intercultural de la filosofía, Desclée De Brouwer,
Bilbao 2001; tr. it. Trasformazione interculturale della filosofia, cit.; R. A. MALL,
Interculturalità. Una nuova prospettiva filosofica, cit.; ID., Philosophie im Vergleich der Kulturen.
Eine Einführung in die interkulturelle Philosophie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1992; R. MALL (a cura di), Philosophische Grundlagen der Interkulturalität, Rodopi,
Amsterdam 1993; W. WELSCH, “Transkulturalität. Lebensformen nach der Auflösung der
Kulturen”, Information Philosophie, 2 (1992), pp. 5-20 (in tr. it. anche in Paradigmi, 30
(1992), pp. 665-689); R. FORNET-BETANCOURT, “Supuestos filosóficos del diálogo
intercultural”, Cultura Latinoamericana, Annali Istituto di Studi latinoamericani, 3 (2001),
pp. 251-271; ID., Interculturalidad y filosofía en America latina, Aachen 2003; ID., Filosofar
para nuestro tempo en clave intercultural, Aachen 2004; ID., Zur interkulturellen Kritik der
neueren lateinamerikanischen Philosphie, Nordhausen 2005; A. ROIG, Caminos de la filosofía
latinoamericana (in part. il cap. VI, Filosofía latinoamericana e interculturalidad) Universidad
del Zulia, Maracaibo 2001; R. SALAS ASTRAIN, “Problemas y perspectivas de una ética
intercultural en el marco de la globalización cultural”, Revista de Filosofía, Universidad del
Zulia, Maracaibo, 41 (2002), pp. 7-29; H. KIMMERLE, Interkulturelle Philosophie. Zur
Einführung, Junius, Hamburg 2002; F. PINTO MINERVA, L'intercultura, Laterza, Roma-Bari
2002; V. MARTIN FIORINO, Dall’etica della liberazione all’etica interculturale latinoamericana,
in P. COLONNELLO (a cura di), Filosofia e politica in America latina, Armando, Roma 2005,
pp. 127-132; G. FAVARO - L.LUATTI, L'intercultura dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano
2004; G. GENNAI, Lessico interlturale, cit. Una serie di pubblicazioni degli ultimi anni, uscite
nell’ambito del gruppo di ricerca di rilevante interesse nazionale da me coordinato, hanno
affrontato la questione collegandola ai dibattiti internazionali sulla democrazia e i diritti
Interculturalità e riconfigurazione concettuale dell’ermeneutica
39
di essa consiste nell'idea che la comprensione di ciò che costituisce il
nucleo generativo e genealogico della identità di ciascuno si presenta come
un processo che esige la cosciente partecipazione interpretativa dell'altro.
Questo argomento della praticabilità di una ermeneutica che si faccia
filosofia e pratica della interculturalità, mi pare costituire oggi un aspetto
assai rilevante nella ricerca di una ricollocazione del pensiero filosofico nel
senso della capacità di offrire risposte ai problemi che, nelle società
contemporanee, sono sorti e sempre più sorgono e sorgeranno dalle
questioni aperte dal dibattito ormai ineludibile sull'assimilazione o sulla
integrazione dello straniero e dell'immigrato, dal confronto e, purtroppo,
anche dallo scontro tra differenti ordinamenti giuridici e differenti forme
di organizzazione politica, tra diverse identità culturali e religiose. Si può,
perciò, sostenere che i contenuti e le stesse modalità epistemiche
dell’interculturalità toccano saperi molteplici e singolari. Il che non solo fa
in modo che l’interculturalità possa costituirsi come una modalità che
investe la filosofia e l’etica, la storia e la sociologia, il diritto e la psicologia,
la letteratura e le arti, etc., ma possa anche favorire al massimo il
riconoscimento di una diversità che rivendica in prima istanza una uguale
dignità rispetto alle altre.
D’altronde, è proprio un corretto e riformulato uso del metodo
ermeneutico – inteso qui nel suo significato originario di comprensione dei
segni e dei testi che si depositano nella effettualità di una situazione storica
e culturale di individui, opere ed eventi – che può permettere l’attivazione
di un processo di analisi e di interpretazione delle esperienze di alterità ed
estraneità, liberate, per quanto possibile, da presupposti metafisici e da
principi onto-teologici, ma anche da pregiudizi ideologici. Cosicché,
l’ermeneutica che può fare, per così dire, da sponda alla filosofia
interculturale può essere solo quella che guarda a forme determinate di
diversità, storicamente e culturalmente legate alla situazione data, e non ad
astratti modelli di compatte e impenetrabili strutture culturali. Non è la
umani. Si veda: V.GESSA KUROTSCHKA, C. DE LUZENBERGER (a cura di), Immaginazione,
etica, interculturalità, Mimesis, Milano 2008; V. GESSA KUROTSCHKA (a cura di),
Interculturalità e questioni di genere, numero monografico di Filosofia e Questioni pubbliche,
1(2008); G. CACCIATORE - G. D’ANNA, Interculturalità. Tra etica e politica, Carocci, Roma
2010; G. CACCIATORE - R. DIANA, Interculturalità. Teologia politica e religione, Guida, Napoli
2010. Più in generale, per una bibliografia aggiornata sui temi dell'intercultturalità cfr. R.
CARBONE, “Una bibliografia ragionata sull'interculturalità”, in Appendice a G. CACCIATORE
- G. D'ANNA, Interculturalità. Tra etica e politica, cit., pp.155-198.
40
Giuseppe Cacciatore
figura astratta del turco, dell’arabo, del cinese, dello slavo, di coloro cioè
che esistono e che operano con me fianco a fianco in un medesimo mondo
vitale e in uno stesso luogo geografico, che può essere adeguatamente
compresa e, di conseguenza, immessa in una situazione di dialogo
interculturale. Insomma, non è né la teoria dello scontro fra civiltà né il
generico e retorico appello alla coesistenza multiculturale, che possono
attivare un efficace e concreto processo di reciproca accettazione, ma la
percezione e la comprensione di una diversità che si esprime nei prodotti
storici concreti della lingua, delle condotte e degli stili di vita, delle
tradizioni religiose, dei principi etici, in una parola, delle culture e dei
modi in cui queste si sono contestualizzate e autointerpretate.
3 - La “filosofia dell’interculturalità”, dunque, non rinuncia ad utilizzare
le classiche categorie definite e costruite dall’ermeneutica ottonovecentesca: l’ermeneutica filologico-linguistica come atto di
comprensione e relazione interindividuale (Schleiermacher); la
comprensione tipica dell’umano come oggetto della Istorica e come
fondamento di una autonoma metodologia e enciclopedia dei saperi
(Boeckh e Droysen); il Verstehen come comprensione dell’esperienza di vita
e delle sue oggettivazioni nel mondo storico (Dilthey); il ripensamento in
senso esistenziale ed ontologico dell’esperienza ermeneutica a fronte delle
epocali e radicali fenomenologie della tecnica e dei suoi esiti nichilistici
(Heidegger); la rinnovata storicità del comprendere e la ricerca di una
nuova “fusione di orizzonti” nella relazione tra forme e vita, tra il metodo
della ricerca storico-linguistica e la dimensione etico-valoriale dell’atto
ermeneutico (Gadamer); la rinnovata dimensione pragmatica del
comprendere tra pragmatismo, etica del discorso e sociologia critica (Apel,
Rorty, Habermas); l’elaborazione di un concetto ermeneutico del Sé nella
esperienza vitale del racconto e dell’autobiografia (Ricoeur). Né rinuncia a
una pratica, per così dire, interdisciplinare nella misura in cui la
comprensione dell’altro si rivela innanzitutto come interpretazione di
strutture psicologiche ed entità emotive, ma anche come interpretazione di
un’opera, di un atto linguistico, di un testo, di una costituzione, di un
codice, di un ordinamento, di un fenomeno politico, di un legamento
sociale.
Queste categorie e questi saperi hanno ora bisogno di essere radicalmente
ricontestualizzati in una dimensione storica fortemente segnata dai fenomeni
della globalizzazione, della ibridazione culturale, degli ormai massicci flussi
Interculturalità e riconfigurazione concettuale dell’ermeneutica
41
migratori, dei nuovi universalismi fondamentalistici e dei rinnovati progetti
neoimperialistici, ma anche, naturalmente, dagli effetti che questi fenomeni
hanno sulla politica, sull’antropologia, sugli assetti sociali e sulle dinamiche
economiche, sulle stesse mobili e conflittuali articolazioni geopolitiche del
mondo contemporaneo. Non a torto, allora, Mall – filosofo indiano di nascita
ma di formazione filosofica europea e tedesca e che ha dato alcuni dei
contributi teorici più importanti alla filosofia dell’interculturalità – individua
nel difficile nesso tra comprensione dell’altro e autocomprensione uno dei
passaggi cruciali di un rinnovato rapporto tra ermeneutica e interculturalità. Si
tratta di portare alle sue coerenti conseguenze i principi della ermeneutica
“umanistica” (ma sarebbe più chiaro e meno concettualmente compromesso
l’aggettivo “umanologica”) di Dilthey, sviluppare cioè in una direzione
relazionale il fondamento interno (il vissuto e la sua esperienza, l’Erlebnis) della
comprensione, volgerlo verso il mondo storico e le sue pratiche senza mai
recidere il legame genetico con la propria individualità.
Cogliere l’interno è un obiettivo ermeneutico, scrive Mall, che tuttavia
non deve essere fissato né secondo una logica duale, né in maniera
monoculturale, né attraverso l’idealizzazione. Occorre invece tenere
presente che anche l’interno ha il suo contesto culturale […] Una filosofia
ermeneutica mirante alla comprensione interculturale deve attenersi a una
teoria secondo la quale né il mondo con cui ci confrontiamo [l’esterno], né
i concetti, i metodi e i sistemi che nel far questo sviluppiamo [l’interno]
rappresentano grandezze aprioristiche e storicamente immutabili11.
Abstract
The paper aims to analyze the issue of reconfiguration of the
philosophical paradigm of interpretation in the light of the proposal of
intercultural philosophy. The intercultural perspective seems to set in
motion a radicalization of the question of understanding, specifically in the
relationship between self-understanding and understanding of others. This
node appears due to a necessary depth of understanding of the issue as it
was developed by Dilthey in his work.
11
R. A. Mall, Interculturalità. Una nuova prospettiva filosofica, cit., p. 42.
GIUSEPPE CANTILLO
La logica del comprendere.
Filologia e storia nella Istorica di Droysen
1. In un saggio del 1930, scritto in occasione della pubblicazione
dell’epistolario di Johann Gustav Droysen1, Friedrich Meinecke, che nel
semestre invernale 1882-83 aveva ascoltato le lezioni dell’ultimo corso di
Droysen su “metodologia ed enciclopedia della storia”, offre indicazioni
preziose sia per riconoscere la modernità della Historik come teoria della
storia sorta dal terreno stesso della storiografia, sia per ricostruirne la
genesi e gli obiettivi. Attraverso le testimonianze dell’epistolario, egli
ripercorre le tre fasi principali dell’attività storiografica di Droysen,
concentrate rispettivamente intorno alla storia dell’ Ellenismo, alla storia
dell’età delle riforme, e, infine, alla “gigantesca” storia della politica
prussiana. E proprio dall’interno dello stesso lavoro storiografico, e dalla
riflessione sui problemi del presente con cui tale lavoro è connesso,
Meinecke vede sorgere l’idea della Historik nelle sue successive delineazioni
e motivazioni, dapprima in margine alla pubblicazione del secondo volume
della Geschichte des Hellenismus (1843) e poi nel corso dei tormentati anni
cinquanta, in cui Droysen avverte con sempre più acuta consapevolezza la
crisi profonda che ha investito la società europea. Un aspetto inquietante di
questa crisi è agli occhi di Droysen il diffondersi anche in Germania di una
concezione del mondo naturalistica, fondata sull’affermazione esclusiva del
metodo scientifico-naturale. Di fronte a questa avanzata del naturalismo e
del positivismo, si pone con più forza l’esigenza di una riflessione sulla
storia al fine di rivendicare la specificità del metodo storico e il significato
della storia per la visione del mondo e l’orientamento etico-politico. In una
lettera a H. von Sybel del febbraio del 1852 Droysen scrive: «Ormai
nessuno più crede alle potenze ideali, e la politecnica napoleonica si insinua
nella scienza tedesca. Ad vocem. Per spuntarla contro questa tendenza che
guadagna terreno – i nostri uomini più sapienti a Jena insegnano che solo il
F. MEINECKE, J.G. Droysen, il suo epistolario e la sua storiografia (1929-1930), trad. it. in Id.,
Pagine di storiografia e filosofia della storia, a cura di G. DI COSTANZO, Esi, Napoli 1984, pp.
275 ss.; J.G.DROYSEN, Briefwechsel, hrsg. v. R. HÜBNER, Berlin 1929.
1
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 43-59
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606434
43
44
Giuseppe Cantillo
microscopio e la bilancia fanno la scienza, che il loro metodo materialistico
è il metodo in generale, proprio come facevano una volta con la filosofia di
Hegel i suoi allievi, finché la filosofia non è stata da ciò trascinata nel fango
— per spuntarla contro questa tendenza, nel semestre estivo terrò lezioni
su metodologia ed enciclopedia della scienza storica»2. Ma l’elaborazione
di una Historik è un compito estremamente complesso, e dalla decisione
comunicata a von Sybel passano alcuni anni prima che egli tenga
effettivamente un corso su di essa nel settembre del 1857.
Come si è accennato, l’avvertimento dell’esigenza di una “teoria della
scienza storica”, risale agli anni di Kiel e di Berlino, cioè alle radici
filologiche della formazione di Droysen, ed è stata espressa chiaramente
per la prima volta nella cosiddetta Privatvorrede, cioè nella prefazione scritta
nel maggio del 1843 per la seconda parte della Geschichte des Hellenismus, ma
fatta stampare soltanto in pochi esemplari, come ricorda lo stesso Droysen
nella Prefazione alla prima edizione del Sommario di Istorica3. Avvertendo il
bisogno di giustificare la sua concezione dell’ “ellenismo”, che si discostava
nettamente da quella tradizionale, quanto al significato di quest’epoca non
più valutata in termini di degenerazione e decadenza, Droysen è indotto ad
affrontare il problema della natura stessa della storia, svolgendo una serie
di “considerazioni” concernenti il metodo, le forme, l’oggetto e il soggetto
del conoscere storico. Ma queste considerazioni – osserva Droysen –
«potrebbero condurre ad un risultato soddisfacente ed acquistare piena
forza probante soltanto se potesse venir loro rivendicato un posto entro
una istorica, cioè entro una dottrina della scienza storica»4. Egli, infatti, è
convinto che al consistente sviluppo delle indagini storiografiche,
all’affinamento dei metodi, all’affermazione generale del pensiero storico
2 J.G. DROYSEN, Briefwechsel, cit., II, pp. 54-55. Sulla polemica antipositivistica e i
presupposti filosofici romantici di Droysen si veda G. COTRONEO, “Il ritorno di Droysen”,
in ID., Storicismo antico e nuovo, Roma 1972, in particolare le pp. 50-56.
3 Cfr. J. G. DROYSEN, Grundriss der Historik in Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und
Methodologie der Geschichte, hrsg. v. R. HÜBNER Oldenbourg, München 1937, p. 7.
unveränd. Aufl.,Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1972, pp. 319-320; trad.
it., Istorica. Lezioni sulla Enciclopedia e Metodologia della Storia, traduzione di L. EMERY,
Ricciardi Editore, Milano-Napoli 1966, p. 333). Nel corso dell’articolo il riferimento
all’edizione di Hübner verrà indicato con l’abbreviazione Historik.
4 J.G. DROYSEN, Theologie der Geschichte (Vorwort zur Geschichte des Hellenismus II, 1843), in
Historik, cit., p.377 (trad. it., cit., pp. 385-386). Un’analisi accurata di questo scritto in
relazione alla genesi della teoria della storia si trova in J. RÜSEN, Begriffene Geschichte.Genesis
und Begründung der Geschichtstheorie, Schöningh, Paderborn 1969, pp. 51-60.
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
45
non abbia corrisposto un’adeguata fondazione teoretica della storia
conseguita sulla base di una comprensione del processo storico. Tant’è che
egli afferma senza riserve: «Non vi è forse alcun campo scientifico che sia
così lontano dall’essere teoricamente fondato, delimitato e articolato come
la storia» e perciò «avremmo bisogno di un Kant, che esaminasse
criticamente non la materia storica, ma l’atteggiamento teorico e pratico di
fronte ed entro alla storia e che dimostrasse, ad esempio in qualche cosa di
analogo alla legge morale, in un imperativo categorico della storia, la viva
sorgente da cui sgorga la vita storica dell’umanità»5.
Questo qualcosa di analogo alla legge morale, questo imperativo
categorico della storia sembra delinearsi chiaramente già nelle pagine della
Privatvorrede, là dove Droysen – riflettendo sul rinnovamento della vita
religiosa nel protestantesimo contemporaneo – fissa nella fondazione del
Cristianesimo l’evento epocale che ha costituito «il grande spartiacque
nella vita complessiva dell’umanità, il cardine della sua storia» e ne scorge
l’essenziale nella comprensione ed espressione della “natura personale
dell’uomo”, considerato nella sua duplicità di “peccato e impotenza” e di
“elezione”, cioè nella sua intera natura di ente finito che però è chiamato a
innalzarsi all’infinito, di ente individuale che ha in sé la costante aspirazione
all’universale. Sicché per Droysen «ogni vero sviluppo ulteriore nella vita
dell’umanità» non può procedere che dalla «più profonda comprensione»
del «contenuto infinito» della fede cristiana e nella sua sempre più adeguata
espressione «in forma umana e finita, investendolo sempre più da presso,
nelle categorie del pensare e del comprendere». Questo significa, poi,
concepire la storia al di sopra delle storie (come Droysen dirà, più tardi, nella
Historik), come una connessione dinamica, come un intero che ha al suo
centro l’evento dell’incarnazione del Cristo, del λόγος έν αρχή, che è con
noi sino alla fine del mondo6 . In questa prospettiva di storia universale, dal
punto di vista, cioè, dell’io, del “germe del divino in noi”, sviluppato
“secondo la virtualità infinita” (così Droysen legge “la parola di Cristo, θεοί
εστε) – l’ellenismo appare a Droysen non più «come un punto morto nella
storia dell’umanità, […] deposito di ogni degenerazione», ma come un
«elemento vivo nella catena dello sviluppo dell’umanità»7, come “l’evo
Theologie der Geschichte, in Historik, cit., p. 378 (trad. it., cit, p. 386).
Ivi, pp. 371-373 (trad. it, cit., pp. 379-381).
7 Ivi, pp. 376, 371 (trad. it., cit., pp. 384, 378-379). Luciano Canfora ha giustamente
messo in rilievo come la Privatvorrede del ‘43 costituisca «il testo più esplicito e più
combattivo, di vera e propria rivendicazione, della novità della storia dell’Ellenismo» (Cfr.
5
6
46
Giuseppe Cantillo
moderno dell’antichità”8: quell’ epoca che «ha accolto l’eredità sia del
mondo greco, sia dell’antichità orientale, con tutte le loro attività e
passività» e da questa “mescolanza” ha prodotto “qualche cosa d’altro,
qualcosa di nuovo”9. Certo il moderno, il nuovo, il presente, afferma
spesso il suo diritto ad entrare nella storia attraverso la distruzione di
“splendidi fiori”, di “forme piene di vita”. Questo è certamente accaduto
anche per l’Ellenismo. Ma – si chiede Droysen – «non è ricca abbastanza la
storia, per risarcire a piene mani ogni perdita che reca?»10; e la sua
convinzione è che le perdite, che pur ci sono nell’età ellenistica, sono ben
risarcite dall’evento epocale della rivelazione di Dio nel Cristo – di quel
Dio che si è rivelato «anche nei pagani, la cui vita consistette nel
cercarlo»11. Ma per poter giungere a questa concezione, per poter
comprendere con giustizia ogni fenomeno storico – e ancor più come in
questo caso, un fenomeno finora frainteso – è necessaria una teoria della
storia che fondi il punto di vista della “concezione generale della storia
come svolgimento dell’umanità”, entro cui ogni fenomeno venga
riconosciuto nel suo significato e valore, e insieme nella situazionalità,
nella sua collocazione storica, in un hic et nunc; uno svolgimento, peraltro,
del quale è possibile “indovinare il termine della sua direzione” e che però
non è linearmente progressivo, ma conosce arresti, stagnazioni, fratture, e
soprattutto differenti, non contemporanei, ritmi di sviluppo tra le diverse
esistenze spirituali e forme di attività umana12 .
L. CANFORA, Ellenismo, Bari-Roma 1987, pp. 49-53).
8 J.G. DROYSEN, Theologie der Geschichte, in Historik, cit., p. 384; a p. 379 è definito invece
come “l’evo moderno del paganesimo” (trad. it., cit., pp. 387 e 392; nella traduzione di
Emery si trova in entrambi i casi: “evo moderno del paganesimo”).
9 Ivi, p. 370 (trad. it., cit., p. 378).
10 Ivi, p. 384 (trad. it., cit., pp. 392-393).
11 Ivi, p. 373 (trad. it., cit., p. 381).
12 Cfr. ivi, p. 355 (trad. it., cit., pp. 393-394). Sulla concezione della storia delineata nella
Privatvorrede si vedano le osservazioni di F. Tessitore nel saggio L’“istorica” di Droysen tra
Humboldt e Hegel (in F.TESSITORE, Storicismo e pensiero politico, Ricciardi Editore, MilanoNapoli 1974, pp. 87 e ss.). Egualmente sono da tenere presenti le pagine dedicate da F.
Gilbert alla concezione della storia che sta alla base delle ricerche su Alessandro Magno e
sull’ellenismo, di cui Gilbert giustamente mette in rilievo i fondamenti religiosi e filosofici,
riconoscendo l’importanza dell’influenza della filosofia della storia e della filosofia della
politica hegeliane specialmente nella prima fase delle ricerche droyseniane (cfr. F.GILBERT,
Johann Gustav Droysen und die preussisch-deutsche Frage. München u. Berlin 1931, si vedano in
particolare pp. 28 e ss.). Cfr. anche H. ASTHOLZ, Johann Gustav Droysen, Berlin 1931, pp.
15 e ss.
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
47
2. La Privatvorrede non solo pone esplicitamente l’esigenza di una
dottrina della scienza storica, ma ne delinea già alcuni principi
fondamentali, che, peraltro, rimandano ancora più indietro, alla originaria
formazione filologica di Droysen. Questo riandare al “filologo” dietro lo
“storico” non vuole, però, cadere nell’ “illusione” di cercare nelle origini
l’essenziale. Lo svolgimento storico, infatti, non è un naturale, tranquillo
“fluire che si fa quasi da sé” a partire da un nucleo iniziale, come lo stesso
Droysen ha chiarito criticando l’organologia della “scuola storica” nella
Privatvorrede13. Tuttavia, nei limiti di questa precisazione metodologica, è
innegabile che per la comprensione del pensiero storico di Droysen un
dato fondamentale è costituito dal riferimento al periodo della sua
formazione nell’Università di Berlino (1826-1829), in anni in cui –
secondo la suggestiva immagine che Dilthey ci dà in un Fragment del
Nachlass dedicato allo Hegels Berliner Periode – l’insegnamento del “filosofo
del mondo storico”, che «faceva penetrare il pensiero dello sviluppo in
tutte le sfere della cultura umana», si incontrava «con la tendenza storicocritica che aveva conosciuto uno splendido sviluppo nella filologia di
Schleiermacher, Boeckh e de Wette e nella “scuola storica” di Savigny» 14.
A questo riguardo restano illuminanti le osservazioni di Meinecke:
«Droysen aveva appreso a pensare, a indagare e a parlare ancora
nell’ultimo periodo dell’epoca goethiana». Di Hegel in particolare egli
«assimilò compiutamente la dialettica del moto storico nel suo inquieto
suscitare gli opposti per riunificarli in forme superiori», anche se,
ricollegandosi piuttosto all’“attivismo morale” di Fichte, scorgeva il
soggetto della dialettica storica non tanto nello “spirito universale che tutto
regge” quanto nell’ «individuo storico, che agisce liberamente per intimo
impulso della propria personalità al servizio di forze morali superiori»15.
«Per quanto elevati possano essere lo Stato, la Chiesa, il popolo, il diritto,
la proprietà e la famiglia» scrive Droysen «infinitamente più in alto di tutte
queste formazioni etiche si trova […] la personalità, con la sua libertà, la
sua responsabilità, la sua coscienza morale», grazie alla quale ogni
Cfr. Theologie der Geschichte, in Historik, cit., pp.379 ss.(trad. it., cit., pp. 387 ss.).
W. DILTHEY, Hegels Berliner Periode, in Gesammelte Schriften, Bd. IV (hrsg. v. H. NOHL),
Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1968, pp. 252-253.
15 F. MEINECKE, La concezione storica di Droysen, in Senso storico e significato della storia, trad.
it. di M.T. MANDALARI, ESI, Napoli 1948, pp. 38-39.
13
14
48
Giuseppe Cantillo
«soggetto individualissimo, questo singolo io, è a un tempo un io
assolutamente generale»16.
D’altra parte, quanto alla accentuazione del valore dell’individualità, se
è vero che Droysen tra il semestre estivo 1826 e quello invernale 18281829 ha frequentato con pari assiduità i corsi di Hegel e di Boeckh (che egli
considera entrambi come suoi maestri), è però indubitabile che la sua
formazione e i suoi orientamenti scientifici sono legati soprattutto
all’insegnamento di Boeckh e all’esperienza fatta nel suo Seminarium regium
philologicum, come lo stesso Droysen suggerisce nel Vitae curriculum
pubblicato nel secondo volume delle Kleine Schriften17. La sua vocazione
storiografica, la sua peculiare prospettiva filologica ed ermeneutica
nascono dall’interno della filologia di Boeckh – di una filologia, che
intendeva fondare una sua specifica scientificità e sistematicità, prevenendo
quella che sarà ancora la critica di Hegel alla filologia come mero aggregato
di conoscenze e discipline18. È questa, infatti, la critica che Boeckh muove
16 Cfr. J.G.DROYSEN, Historik. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. v. P. LEYH, Bd. 1,
Vorlesungen 1857 - Grundriss der Historik 1857-1858 und 1882, Fromman Verlag, StuttgartBad Cannstatt 1977, pp.363-366 (trad. it., Istorica. Lezioni di enciclopedia e metodologia della
storia (1857), a cura di S. CAIANIELLO, Guida Editori, Napoli 1994, pp. 499-503). Sulla
costruzione dell’ “io generale” come il punto di vista “eminentemente storico” si veda,
oltre il mio saggio “J. G. Droysen: storia universale e Kulturgeschichte” (in Archivio di storia
della cultura, I (1988), pp. 81 ss., in partcolare le pp. 89-94), la eccellente Introduzione di
Silvia Caianiello alla traduzione italiana della Historik 1857 [Istorica (1857), cit., pp. 9 e ss.,
in particolare le pp.26-29]. Il rapporto di Droysen con Hegel è stato curvato da Jörn
Rüsen nel senso di una “critica di Hegel” condotta proprio attraverso “l’accoglimento di
Hegel” (Begriffene Geschichte, cit., pp. 16-21), per cui la “storia concettualmente compresa”
non si chiude in se stessa, nel pensiero retrospettivo della razionalità del processo finora
attuato, ma porta allo scoperto la “ragione” operante “nell’oscurità del presente che lotta
per il proprio futuro” (quel che Hegel definisce “lo spirito nascosto che batte alle porte del
presente” o esprime con la metafora della “talpa”) e rende possibile la prassi del presente
lasciando vedere ad un tempo “la tendenza del futuro” (cfr. pp. 159-160).
17 «Frequentavi scholas Boeckhii, Hegelii, Lachmanni […] Bernhardii […] aliorum. In primis
Boeckhio, qui eximia me ut excepit ita prosecutus est humanitate, cum alia plurima accepta refero,
tum locum in Seminario regio philologico» (J.G. DROYSEN, Kleine Schriften zur alten Geschichte,
Bd. II, Verlag von Veit & Comp., Leipzig 1894, p. 432).
18 «Quando Hegel definisce la filologia come aggregato» osserva Boeckh «questo giudizio
sembra fondarsi proprio sulla Darstellung di Wolf» (A. BOECKH, Encyklopädie und
Methodologie der philologischen Wissenschaften, hrsg. v. E. BRATUSCHECK, Teubner, Leipzig
1877, p. 40; trad. it. di R. MASULLO, La filologia come scienza storica, a cura di A. GARZYA,
Guida, Napoli 1987, p. 76. La trad. it. riguarda solo la prima parte teorica della
Encyklopädie). Il giudizio di Hegel si trova accennato nel § 16 dell’Enciclopedia dove
nell’annotazione la filologia viene portata ad esempio di una disciplina, che “a un primo
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
49
agli altri filologi, finanche a F.A. Wolf, che pur si era posto il problema
dello statuto scientifico della “scienza dell’antichità”19. Come ha osservato
Silvia Caianiello, «il ritorno di Boeckh al termine “filologia” rappresenta un
polemico abbandono del progetto dell’Altertumswissenschaft di Wolf […]
basato sul filo conduttore inevitabilmente esteriore del rimando ad
un’epoca paradigmaticamente conchiusa in se stessa, cosmo di valori ideali
sottratti alla storia»20. E in effetti la concezione boeckhiana della filologia
ne slarga l’orizzonte sia oltre lo studio dell’antichità, sia oltre lo studio
delle lingue e delle letterature, fino a farla coincidere con la stessa
Geschichte nel senso più ampio del termine: come conoscenza organica delle
manifestazioni — “segni” [Zeichen] e “formazioni” [Gebilde] — dello spirito
umano in una sua storica individuazione, cioè come comprensione
dell’intera vita di un popolo, fondata sulla determinazione del concetto di
Volksgeist attraverso il riconoscimento delle sue espressioni21. Per
caratterizzare la natura della filologia Boeckh — che sul piano filosofico si
ricollega all’idealismo e in particolare a Schleiermacher e a Schelling22 —
prende le mosse dal concetto di scienza come “conoscenza concettuale
dell’universo”. Nella sua totalità ed unità la scienza è costituita dalla
filosofia, che Boeckh, alla maniera di Schelling, definisce come “scienza
delle idee”23, articolandola in due scienze fondamentali: fisica ed etica, «a
seconda del modo di porsi mentalmente, a seconda che il tutto, cioè, venga
inteso da un punto di vista materiale o ideale, come natura o come spirito,
come necessità o come libertà». Ora, però, la filologia, pur essendo
sguardo” appare essere costituita da “semplici aggregati di conoscenze” (G. W. F. HEGEL,
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. it. di B. CROCE, Bari 19513, p. 20).
19 A. BOECKH, Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, cit., pp. 40-43
(trad. it., cit., pp. 76-79). Proprio l’esigenza di dare una fondazione scientifica, vale a dire
una forma sistematica alla disciplina, spinge Boeckh a tenere lezioni su Encyclopaedia
antiquitatis litterarum a partire dal 1809, ripetendole per 26 semestri fino al 1865.
20 S. CAIANIELLO, Introduzione, cit., p.11.
21 Cfr. A. BOECKH, Encyklopädie, cit.. pp. 5-6, 8, 10-11, 21 (trad. it., cit., pp. 39-40, 42,
44-45, 55).
22 Cfr. J. WACH, Das Verstehen, Bd. I (1926), Nachdr., Olms, Hildesheim 1966, pp. 173177.
23 «L’intera scienza intesa come una totalità è filosofia, scienza delle idee» (A. BOECKH,
Encyklopädie, cit., p. 9); «La filosofia è, dunque, la scienza delle idee, ovvero la scienza dei
modelli eterni delle cose» (F. W. J. SCHELLING, Vorlesungen über die Methode des
akademischen Studiums, hrsg. v. M. SCHRÖTER, München 1927, Bd. III, p. 277 (trad. it.
Lezioni sul metodo dello studio accademico, a cura di C. TATASCIORE, Guida, Napoli 1989, p.
105).
50
Giuseppe Cantillo
intimamente legata con l’etica, non rientra in alcuna delle due scienze
fondamentali, ma, in un certo senso, al pari della filosofia le comprende
entrambe. Il suo compito essenziale, infatti, è l’Erkennen des Erkannten, la
“conoscenza del conosciuto” – un compito non “costruttivo”, ma
“puramente storico”: «come filologi non dobbiamo far filosofia come
Platone, ma comprendere (verstehen) gli scritti di Platone e invero non solo
come opere d’arte cioè rispetto alla forma, ma anche rispetto al contenuto.
Produrre la filosofia della natura non è compito del filologo, bensì suo
compito è conoscere o comprendere ciò che viene prodotto in questa
scienza, poiché la storia [Geschichte] della filosofia della natura deve essere
elaborata filologicamente. Lo stesso vale per l’intero campo dell’etica.
L’agire e il produrre di cui si occupano la teoria politica e la teoria dell’arte
non interessano come tali i filologi, i quali si interessano invece della
conoscenza di ciò che è prodotto da queste teorie. Perciò il compito vero e
proprio, specifico, della filologia sembra essere quello di conoscere ciò che è
prodotto dallo spirito umano, cioè il conosciuto»24.
Sotto il titolo Erkannten Boeckh comprende, quindi, tutte le
rappresentazioni, tutte le forme di simbolizzazione ed espressione dello
spirito, sicché nella filologia rientrano parimenti la storia dell’arte e della
religione. Non solo, ma, se «il logos» come egli scrive «è presente anche al
di fuori del discorso [Rede]», se «esso è in generale il prodotto spirituale
dell’uomo»25, allora «il concetto di filologia coincide con quello della
storia nel senso più ampio del termine»26. Senonché, di solito, la storia
viene intesa come storia politica, come narrazione di fatti, di eventi, per
cui sembra che si debbano separare storia e filologia. Accettando una tale
separazione, la filologia dovrebbe essere concepita soltanto come “la
riproduzione della tradizione relativa a ciò che è accaduto”, non come la
“presentazione [Darstellung] dell’accaduto”. Sicché «lo scopo della filologia
non sarebbe la storiografia, ma soltanto la storia della storiografia». «Ora
però» continua Boeckh – e qui vi è un preciso punto di contatto con idee
centrali anche nella Historik di Droysen – «una tale separazione non è
attuabile; anzi l’intera storiografia procede filologicamente, innanzitutto
perché si fonda sulle fonti, e poi perché gli stessi fatti storici sono un
conoscere, contengono, cioè, idee che lo storico deve appunto
A. BOECKH, Encyklopädie, cit., pp. 9-11 (trad. it., cit., pp. 43-45).
Ivi, p. 65 (trad. it., cit., p.103).
26 Ivi, p. 10 (trad. it., cit.. p. 44).
24
25
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
51
riconoscere»27, cioè “comprendere”, poiché, come Boeckh stesso precisa,
l’Erkennen des Erkannten è un Verstehen28. La distinzione tra filologia e storia,
in quanto storia politica, non è una distinzione tra scienze diverse, ma una
distinzione interna ad un’unica scienza, la distinzione, cioè, tra un intero
ed una sua parte29. Infatti, se la filologia ha “uno scopo puramente
storico”30, la storia politica è, a sua volta, una disciplina filologica che
rientra nell’ambito dell’Encyclopädie, nella sua seconda parte [Materiale
Disciplinen der Altertumslehre] e precisamente nella sezione dedicata alla “vita
pubblica dei greci e dei romani”. Proprio nel paragrafo dedicato alla storia
politica dell’antichità, cioè ai principî, ai compiti, al valore di questa storia
(§ 47), Boeckh chiarisce il concetto di Historik e ribadisce la sostanziale
identificazione di filologia e storia riconducendo la Historik alla parte
formale della filologia, vale a dire alla teoria dell’ermeneutica e alla critica:
«La teoria della storiografia, ovvero la Historik, deve chiarire l’idea e lo
scopo della storia e l’essenza dell’arte storiografica in relazione ai metodi e
all’esposizione. Se una tale teoria dev’essere l’organon della storia in senso
ampio, essa coincide con la parte formale della scienza filologica»31. Ci si
ricorda immediatamente del paragrafo 16 del Grundriss der Historik di
Droysen: «L’istorica deve porsi il compito di essere un organon del
pensiero e dell’indagine storica», e del paragrafo 18: «L’istorica
comprende la metodica dell’indagine storica, la sistematica di ciò che è
storicamente indagabile, la topica delle esposizioni di ciò che è stato
storicamente indagato».
Non rientra nell’obiettivo specifico di questo saggio un’analisi
dell’Encyklopädie di Boeckh – la quale, peraltro, richiederebbe in primo
luogo un lavoro critico di individuazione dei diversi strati di cui è costituita
a partire dall’originario Heft del 1809. Tuttavia, è opportuno soffermarsi
su qualche punto. È infatti incontestabile l’affermazione di Momigliano
Ivi, pp. 10-11 (trad. it., cit., pp. 44-45).
Ivi, p.52 (trad. it., cit., p. 91). Per una interpretazione della formula della “Erkenntnis des
Erkannten” come principio delle scienze ermeneutiche si veda il saggio dedicato a Boeckh da
F.RODI nel suo volume Erkenntnis des Erkannten. Zur Hermeneutik des 19. und 20. Jahrhunderts,
Frankfurt/Main 1990, pp. 70-88. Sulla teoria del comprendere in Boeckh si veda anche J.
WACH, Das Verstehen, cit., pp. 183 ss.
29 Cfr. J. WACH, Das Verstehen, cit., pp. 179-180. Su filologia e storia in Boeckh e in
Droysen cfr. il primo paragrafo della citata introduzione di S. Caianiello alla trad. it. della
Historik 1857 (pp. 9 e ss.).
30 A. BOECKH, Encyklopädie, cit., p. 18 (trad. it., cit., p. 52).
31 Ivi, p.338.
27
28
52
Giuseppe Cantillo
secondo cui “senza Boeckh non (si comprende) certo Droysen”32. E non
solo relativamente alla valutazione dell’Antike ma anche relativamente alla
Historik.
Un primo punto da considerare riguarda il rapporto filologia - filosofia.
È noto che da Heyne a Humboldt – per riprendere un’indicazione di
Momigliano – si è definita, nella riflessione sulla filologia e sulla storia, la
“incontestabile esigenza di una storia a posteriori” in opposizione alle
costruzioni speculative sia filosofiche che teologiche33. Anche Boeckh – sia
pure con una certa oscillazione nelle formulazioni – contrappone filologia
e filosofia, non riguardo all’oggetto, ma riguardo al metodo, al tipo di
concettualizzazione, alla natura dell’attività teoretica. La filosofia conosce:
γιγν ώσχει; la filologia riconosce: αναγ ι γν ώσχει. La filosofia procede a
partire dal concetto; la filologia a partire dal contingente, dal dato,
dall’esistente. Tuttavia l’opposizione non è assoluta. Anzi si rivela
piuttosto come una distinzione tra termini che necessariamente si
richiamano l’un l’altro. Infatti, «se la filosofia vuole costruire l’essenziale
di tutte le condizioni storiche date a partire dal concetto, essa deve
cogliere il contenuto interiore dei fenomeni storici, e per fare ciò ha
assolutamente bisogno della conoscenza di questi fenomeni, che sono,
appunto. l’espressione esteriore di quell’essenziale. Non può, per
esempio, costruire lo spirito del popolo greco, senza che le sia noto questo
popolo nella sua apparizione contingente». Reciprocamente anche la
filologia ha bisogno della filosofia. «Essa costruisce storicamente, non a
partire dal concetto; ma il suo scopo finale è quello di fare in modo che il
concetto appaia nell’elemento storico; non può quindi riprodurre la
totalità delle conoscenze di un popolo senza portare un’attività filosofica
nella costruzione. […] Se Aristotele ebbe bisogno delle Costituzioni e
dell’indagine filologica su di esse come base per la sua Politica, a sua volta il
filologo, come fili conduttori della sua indagine storica, ha bisogno dei
concetti politico-filosofici, come sono stati espressi nella Politica da
Aristotele. Se il materiale storico e quindi la stessa filologia non devono
essere un semplice aggregato, il materiale deve necessariamente essere
elaborato tramite concetti, come accade in ogni disciplina: di conseguenza,
anche la filologia presuppone a sua volta il concetto filosofico e nello stesso
tempo vuole generarlo». Vige quindi tra filologia e filosofia una circolarità,
32
33
A. MOMIGLIANO, Genesi storica e funzione attuale del concetto di ellenismo, cit., p. 155.
Ivi, p. 156
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
53
per cui “ha luogo una risoluzione dell’una nell’altra”. Questa convergenza
si riscontra in modo particolare nel rapporto tra filologia e storia della
filosofia e tra filologia e filosofia della storia. La filologia infatti nel suo
punto più alto si risolve nella filosofia della storia; la storia della filosofia, a
sua volta, è una scienza in cui la filosofia si risolve nella filologia 34.
Un secondo punto da considerare riguarda la logica del “comprendere”. Il
metodo filologico è un metodo induttivo; muove sempre dalla conoscenza
del particolare, dell’individuale dato. Tuttavia non consiste nella
riproduzione di una serie di singolarità disperse: “da ogni individuale si viene
ricondotti all’intero”. Nel Verstehen, tanto come comprendere ermeneutico,
cioè comprensione di un oggetto, di un intero individuale per sé preso,
quanto come comprendere critico, cioè comprensione del rapporto di un
oggetto con altri oggetti o con l’intero, è sempre in gioco la relazione interoparti, vale a dire il “circolo ermeneutico”, individuato già da Schleiermacher,
il maestro di Boeckh. Tale “circolo” rende infinito il lavoro filologico,
prolunga all’infinito l’arte del comprendere. La relazionalità di ciò che deve
essere compreso non si lascia, infatti, mai tradurre completamente e
compiutamente nel “discorso”. Sicché ciò che di volta in volta spezza il
“circolo” è un atto di comprensione immediato: una intuizione o una
divinazione, un sentimento [Gefühl]. È una intuizione, una divinazione, che
consente di cogliere l’intero nella parte, il macrocosmo nel microcosmo. È il
sentimento che consente “d’un colpo” di “riconoscere il pensiero di un
altro”: un sentimento che rinvia ad una originaria “congenialità”, la quale
soltanto può fondare, in ultima istanza, la possibilità di comprendere l’altro e
di comunicare con l’altro attraverso il medium dell’espressione. Appare qui il
principio classico-romantico dell’ομοιον γιγνώσχει, e nello stesso tempo si
presenta l’ineludibile circolo di intuizione e discorso che caratterizza la
moderna filosofia della coscienza. L’“immaginazione” integra l’analisi dell’
“intelletto”, il “discorso” si completa nell’“intuizione”. Il Verstehen
presuppone l’indagine accurata, ma si realizza in un atto di conoscenza
immediato in cui è coinvolta la totalità del soggetto comprendente, la sua
intera umanità35. È evidente che qui le posizioni di Boeckh mostrano marcate
A. BOECKH, Encyklopädie, cit., pp. 16-18 (trad. it., cit. pp. 50-52). Sul rapporto
filologia-filosofia cfr. J. WACH, Das Verstehen, cit., pp. 181 e ss.; F. RODI, Erkenntnis des
Erkannten, cit., pp. 82-83.
35 Cfr. A. BOECKH, Encyklopädie, cit., pp. 52-55, 75-78, 84-87 (trad. it., cit., pp. 91-94,
113-116, 123-127). Sul “circolo ermeneutico” cfr. F. RODI, Erkenntnis des Erkannten, cit.,
pp. 70-75.
34
54
Giuseppe Cantillo
affinità con quelle di Droysen e di Humboldt. Ci si ricorda immediatamente
di alcuni passi fondamentali del Grundriss der Historik: «l’essenza del metodo
storico è di comprendere indagando» (§ 8); «la possibilità del comprendere
consiste nel carattere a noi congeniale delle manifestazioni che abbiamo
davanti a noi come materiale storico» (§ 9); «il particolare viene inteso nel
tutto, e il tutto muovendo dal particolare» (§10); «dal meccanismo logico
dell’intendere si distingue l’atto dell’intendimento. Questo ha luogo, nelle
condizioni esposte, come intuizione immediata, quasi tuffandosi l’una anima
nell’altra» (§12)36. E nello stesso senso procedono le due “vie” del metodo
storico indicate da W. von Humboldt nel saggio su Il compito dello storico:
«Per raggiungere la verità storica si devono quindi percorrere
contemporaneamente due vie: esplorare l’accaduto in maniera rigorosa,
imparziale, critica, e collegare quanto è stato indagato, presagendo ciò che
quei mezzi non permettono di raggiungere»37. Come per Boeckh, al di là
dell’ermeneutica e della critica vi è l’arte della filologia che si esprime
nell’atto della comprensione, così anche in Humboldt, nonostante la
distinzione, vi è una profonda affinità tra l’attività dell’artista e quella dello
storico: «Come il poeta, anche se in modo diverso, lo storico deve elaborare
in sé quanto ha riunito in maniera confusa al fine di trasformarlo in un tutto
organico»38. E come, in ultima istanza, la comprensione filologica si fonda
sulla “umanità”39, sulla “comune intimità”40, che unisce l’interprete, il
filologo, e l’altro uomo, o gli altri uomini, di cui sono “espressioni” gli
oggetti della sua indagine, così anche per Humboldt quanto più a fondo, in
virtù del proprio genio e del proprio addestramento, lo storico comprende
l’umanità e il suo agire, o quanto più umanamente è ispirato dalla natura e
dalle circostanze, con quanta maggiore purezza lascia che si imponga la
Cfr. Grundriss der Historik, in Historik, cit., pp. 328 -330 (trad. it., cit., pp. 341-343).
W. von HUMBOLDT, Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers (1821), in Gesammelte Werke,
Berlin 1841, Bd. I, p. 4 (trad. it. di G. MORETTO, in W. von HUMBOLDT, Il compito dello
storico, a cura di F. TESSITORE, ESI, Napoli 1980, p. 121. Sul rapporto di Droysen con
Humboldt cfr. F.TESSITORE, “L’Istorica di Droysen tra Humboldt e Hegel”, in F.
Tessitore, Storicismo e pensiero politico, Riccardi Editore, Milano-Napoli 1974 e ID.,
Introduzione allo Storicismo, Laterza, Roma-Bari 2009, pp.78-98.
38 Ivi, pp. 2-3 (trad. it., p.120).
39 Cfr. A. BOECKH, Encyklopädie, cit., pp. 76-78,256-257 (trad. it., cit., pp.114-116, 302303).
40 Riprendo qui un concetto elaborato dal mio maestro Aldo Masullo (cfr. A. MASULLO, Il
senso del fondamento [1967], nuova edizione, a cura di G. CANTILLO e C. DE LUZENBERGER,
Editoriale Scientifica, Napoli 2007, pp.111-132.
36
37
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
55
propria umanità, tanto più compiuto risulta l’assolvimento del compito suo
proprio41.
3. La teoria della conoscenza abbozzata da Droysen nella introduzione
alla Historik e nei primi paragrafi del Grundriss42 – pur nella sua oscillazione
tra una impostazione psicologico-empirica e una impostazione criticotrascendentale – intende situarsi sul terreno della moderna filosofia della
coscienza e pone a suo fondamento il “fatto” originario del “cogito ergo
sum” e la dottrina kantiana della idealità dello spazio e del tempo. Tuttavia,
rispetto a questo abbozzo, quando si tratta di determinare tematicamente il
soggetto conoscente della storia, si insinua nella riflessione droyseniana un
movimento di storicizzazione dell’Io e di connessione del tempo non più
semplicemente con la coscienza rappresentante, ma con la soggettività
vivente.
Già nell’introduzione la distinzione tra natura e storia in base alle forme
o intuizioni pure della coscienza – spazio e tempo – mostra un’oscillazione
tra una distinzione puramente soggettivo-trascendentale di tipo
neokantiano e una distinzione, per così dire, fenomenologica, per cui i
fenomeni stessi nel loro presentarsi richiedono di essere “visti”
prevalentemente sotto la forma dell’intuizione spaziale o di quella
temporale, sotto la forma della permanenza, della ripetizione, da un lato, o
del divenire e dello sviluppo, dall’altro. Successivamente, nel capitolo
dedicato al metodo storico, l’esperienza esterna e quella interna, a cui
vengono riportati rispettivamente i fenomeni definiti come natura e quelli
definiti come storia, si divaricano più profondamente: l’esperienza interna
assume il carattere della vita e il tempo – nell’istante di vita – si fa reale;
mentre l’esperienza esterna assume il carattere dell’immagine, della
rappresentazione nella forma intuitiva dello spazio, ed è reale solo in
quanto entra in rapporto con la soggettività vivente. Scrive Droysen: «Il
nostro Io, che afferra e raffigura il mondo dei fenomeni distribuito secondo
lo spazio e il tempo vede spazialmente la natura in una estensione smisurata
intorno a lui; temporalmente gli appartiene solo l’istante, egli vive solo
nell’istante, avendo dietro di sé il vuoto senza fine di ciò che è passato,
dinanzi a sé il vuoto senza fine di ciò che verrà»: c’è qui chiaramente una
W.von HUMBOLDT, Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers cit., p. 4 (trad. it., cit., p.122).
Cfr. J.G. DROYSEN, Historik, cit., pp. 6 e ss., 11 e ss. (trad. it., cit., pp. 6 ss., 11 ss.);
Historik (Grundriss der Historik §§ 1, 2), pp. 325-326 (trad. it., cit., p. 339).
41
42
56
Giuseppe Cantillo
distinzione fenomenologica tra la natura come mondo di fenomeni “visto”
nello spazio, e la vita dell’Io nell’istante temporale, il quale diviene presente
in quanto «questo vuoto dentro di sé l’Io se lo riempie con le
rappresentazioni di ciò che fu, con ricordi in cui per lui il passato non è
tramontato; e il vuoto davanti a sé se lo riempie con le speranze e con i
disegni, con le rappresentazioni di ciò che vuole realizzare con la sua
volontà, e che si aspetta di vedere realizzato da altri». Attraverso il
riferimento alla struttura temporale l’Io appare nella sua interezza, non
solo come rappresentazione e memoria, ma insieme come sentire e volere;
inoltre, in quanto vive nel presente, nell’istante riempito di ricordi, è
essenzialmente storico: «il nostro contenuto in quanto quelle
rappresentazioni di ciò che è stato, ma è passato, noi le abbiamo anzitutto
per il fatto che noi stessi vi abbiamo partecipato in azione ed esperienza e
più addietro mediante i ricordi altrui, della nostra famiglia, del nostro
popolo; le abbiamo inoltre nelle copiose cose e forme che ci circondano,
nel nostro apprendere, nella lingua stessa, che col suo contenuto di parole
e rappresentazioni risale fino ad un passato remotissimo»43.Viene
riconosciuta così la formazione intersoggettiva dell’Io, la sua storicità.
Questo slittamento di Droysen dal soggetto intemporale, puramente
rappresentante e pensante, al soggetto storicamente condizionato,
empirico, è connesso con la sua formazione filologica e in particolare con il
suo legame con il pensiero di W. von Humboldt in cui si può scorgere già
un avvio a concepire il soggetto pensante non come puro pensare e
rappresentare, ma come soggetto pensante inserito essenzialmente nel
mondo storico-sociale : «Nell’uomo però» scrive Humboldt «il pensiero è
legato essenzialmente all’esistenza sociale»: la possibilità della sua
“oggettività” è fondata sul rapporto dell’Io e del Tu, sul comprendere
intersoggettivo44. Se Droysen non sviluppa una riflessione gnoseologica a
partire da questa intuizione del passaggio dal soggetto epistemico puro al
soggetto storico empirico, tale passaggio sorregge però la sua concezione
del conoscere storico come conoscere ermeneutico e la sua consapevolezza
della ineliminabile funzione della posizione storica del soggetto conoscente
Ivi, p.19 (trad. it., cit., p. 20).
W. VON HUMBOLDT, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, in Werke hrsg. v.
A FLITNER e K. GIEL, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1960 ss, Bd 3, p.
201.
43
44
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
57
nel processo della interpretazione storica, di cui è espressione la sua
peculiare concezione della “oggettività storica”45.
Proprio al “contenuto storico” dell’Io, alla storicità dell’uomo concreto
quale si manifesta nel volere, nell’agire, nell’operare, si ricollega il primo
principio della scienza storica indicato da Droysen nella Historik, che, con
espressione crociana, si potrebbe dire della “contemporaneità”: dalla
coscienza della storicità scaturisce l’interesse della storia, che è la
comprensione di sé e del proprio mondo, la comprensione cioè del
presente, che in quanto inserito nella continuità del processo storico, esige
di conoscere il proprio essere-divenuto: «Se ora lo spirito umano comincia
a riflettere che il suo hic et nunc, tutto ciò che lo anima e tutto quanta di
umano lo circonda, è cresciuto in tale continuità, e se egli cerca di rendersi
conto di ciò che così trovasi in lui e intorno a lui, e per esserne
consapevole e certo intraprende a indagare come ciò si sia fatto; allora a
tale scopo, non può rivolgersi alle realtà passate, perché queste sono
appunto passate. Ma solo ciò che, in lui e fuori di lui, non dileguato ne
resta ancora nell’hic et nunc e, per quanto in forma mutata, può ancora
essere afferrato empiricamente, questo solo dovrà e potrà dargli la risposta
cercata»46.
Ma com’è possibile risalire dai resti del passato agli uomini, alle
formazioni sociali, politiche, religiose del passato, alla loro vita che non è
più? Si inserisce qui, come elemento determinante della teoria del
conoscere storico, la teoria dell’espressione come carattere fondamentale
della vita umana e storica: su di essa si fonda anche la possibilità del
comprendere che è alla base della vita sociale e storica del presente, così
come della conoscenza storica. Il cogito ergo sum che Droysen ha indicato
come intima essenza dell’uomo si rivela, nella sua più profonda radice,
piuttosto come nisus formativus, secondo una trasformazione del cogito che
da Leibniz conduce soprattutto a Fichte. Alla radice della vita umana vi è
appunto una formgebende Kraft, una capacità di dar forma, di connettere le
parti nel tutto, di unificare il molteplice nell’unità di una forma, di una
figura. In virtù di tale “forza” o “energia formativa” l’interno dell’uomo si
esteriorizza, si comunica, si esprime. «L’uomo plasmando, foggiando,
configurando, in ogni manifestazione lascia un’espressione della sua più
intima essenza, del suo volere e del suo pensiero; è capace così di dare
45
46
Cfr. specialmente Historik, cit., p. 287 (trad. it., cit., pp. 300-301).
Ivi, p. 20 (trad. it., cit., p. 21).
58
Giuseppe Cantillo
espressione, durata e percepibilità a ciò che è stato solo pensato, solo
sentito, ad ogni moto dell’anima»47. Alla base del conoscere storico vi è
quello stesso comprendere che ha luogo nell’immediato mondo della vita e
prima di tutto nella comunicazione linguistica. Grazie alla congenialità
dell’espressione con l’esperienza interna di colui che comprende, questi
può proiettare su di essa quella relazione delle parti con l’intero che egli
esperisce direttamente nel proprio Io. «ll fatto singolo viene inteso nel
tutto da cui procede, e il tutto in base a questo singolo in cui si esprime»: il
circolo ermeneutico del costante arricchimento della comprensione delle parti
e del tutto nella loro reciproca rimandatività è messo in movimento dalla
trasposizione della totalità che l’Io comprendente esperisce nel proprio
vivere soggettivo all’altro Io di cui percepisce le espressioni; «colui che
comprende, essendo egli stesso un Io, una totalità in sé, come colui che ha
da comprendere, integra la totalità di questo in base alla singola
manifestazione e viceversa». Se questo è il “meccanismo logico” del
comprendere, «l’atto della comprensione» – osserva Droysen
richiamandosi al concetto schleiermacheriano di “divinazione” – «è come
una intuizione immediata», in cui «è totalmente all’opera tutta la natura
spiritual-sensitiva dell’uomo», ed è «il vincolo più intimo tra gli uomini e
la base di ogni esistenza morale»48. Il fatto della comprensione e, come sua
condizione, l’espressione sono perciò costitutivi del mondo storico; su di
essi si fonda quel processo di progressiva universalizzazione e liberazione
dal naturale e dal già-dato in cui consiste lo sviluppo della storia secondo le
diverse sfere delle “forze morali”, ovvero delle “comunanze morali”, in cui
soltanto l’uomo attua la sua “virtù creativa”49.
Il conoscere storico, che dalla linea del mondo etico del presente si
volge allo sviluppo attraverso il quale esso è divenuto, è essenzialmente un
comprendere; ma un comprendere che non è mai compiuto né può
esserlo, perché il suo oggetto è separato da esso «dalla mediazione infinita
della tradizione»50. In ciò si esprime un primo significato del metodo
storico come “comprendere indagando”: «non si tratta dunque di accertare
il passato né oggettivamente, né in tutta l’ampiezza di quello che fu il suo
presente, ma di ampliare, completare, rettificare la nostra
Ivi, p. 21 (trad. it., cit.,p. 22)
Ivi,pp. 25-26 (trad. it., cit., p. 27).
49 Ivi, p. 221 (trad. it., cit., p. 231).
50 H.G. GADAMER, Verità e metodo, trad. it. a cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano 19832,
p. 259.
47
48
La logica del comprendere. Filologia e storia nella Istorica di Droysen
59
rappresentazione ancora angusta, frammentaria, confusa del passato». È
questo il secondo principio fondamentale della scienza storica, che ne fissa
il compito: cercare di comprendere dai materiali, per quanto lacunosi, del
passato «che cosa vollero gli uomini che così hanno plasmato, agito,
lavorato, che cosa muoveva il loro Io e che cosa essi vollero in tali
espressioni e impronte del proprio essere»; cercar di comprendere le
ragioni e gli interessi delle azioni e delle produzioni degli uomini e delle
comunità e “il loro posto nel corso generale del passato del genere umano”,
il loro significato51. Il compito dell’interpretazione storica è quindi molto
più complesso della comprensione quotidiana: come si può risalire dalla
“periferia” delle espressioni al “centro” di ciò che vi si è espresso, quando
«non si discerne più alcuna volontà personale, ma parla a noi soltanto
qualche cosa di generale, il genio di un popolo, l’opinione di un’epoca,
l’indirizzo comune a innumerevoli credenti?». Di qui la necessità da un lato
della filologia (euristica, critica), dall’altro di un’arte dell’interpretazione
che fornisca «i punti di vista secondo i quali dobbiamo orientare la nostra
comprensione storica, la nostra interpretazione»: l’interpretazione
pragmatica, l’interpretazione delle condizioni, quella psicologica, quella
secondo le forze morali. Ed è soltanto nell’ultima forma di interpretazione
che la storia, secondo Droysen, si solleva effettivamente al punto di vista
della scienza, cioè al punto di vista dell’universalmente umano, dell’ “Io
generale” che è il soggetto della “storia della storia”, della “storia al di sopra
delle storie”, che è il telos di ogni indagine storica particolare o speciale52, e
ha ad oggetto il processo del progressivo divenire-se-stessa dell’umanità,
nel quale si viene manifestando, realizzando e conoscendo quel che August
Boeckh ha definito “il divino in terra” : l’idea di umanità, l’idea della libertà
che è l’essenza più propria dell’uomo e lo costituisce come personalità –
quella idea che per Droysen si è rivelata nell’evento storico epocale
[Epochemachen] della venuta del Cristo, ma verso cui già tendeva la Bildung
dell’Antike.
Historik, pp. 26-27 (trad. it., cit., p. 28).
Cfr. Ivi, pp. 149-156, 180-186, 202-204, 301-303, 307 (trad. it., cit., pp. 156-163,
188-194, 211-213, 315-317, 321); Historik (Grundriss der Historik), §§ 74-79, 84-86.
51
52
HORACIO CERUTTI GULDBERG
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica
filosófica de nuestra América*
En memoria del amigo fraterno
e inolvidable José Severino Croatto
(1930-2004), maestro en erudición
fecundante para la transformación
de la historia en pro de una vida digna.
Transformados en “amautas” consignistas,
tanto en la función de las ideas como
en la de la práctica, son incapaces
de crear una hermenéutica que supere
el trasvasije de importación1.
Calla, mi buen mochacho Grabielito,
hasta el que no cree es creyente,
y el que cree que cree muchas veces no cree.
Ellos nomás no lo saben y no importa
si lo saben o no.
El que cuenta, el importante es
cómo se vive, no cómo si reza.
Rezo sólo es canal2.
¿Será factible, de modo pertinente y con argumentación rigurosa,
sobrellevar esa dura crítica que el intelectual chileno Ariel Peralta Pizarro
* Agradezco la gentil invitación de Pio Colonnello a participar de esta publicación.
Aunque resulte reiterativo, he señalado en cada caso a quién debo el acceso a los textos
citados, porque sin esa trama generosa de colegas amigas y amigos, sería imposible acceder
a esos aportes tan sugestivos citados. Durante la elaboración de este trabajo se produjo el
lamentable fallecimiento de la querida amiga y colega María Alicia Puente Lutteroth
(Licha), cuya memoria y compromiso nos seguirán acompañando.
1 A. PERALTA PIZARRO, El mito de Chile, Santiago, Bogavante, segunda edición ampliada
1999 [1ª edición 1971], p. 126. Agradezco a Alex Ibarra el acceso al texto.
2 M. BARAONA COCKERELL, Sak’umesh, San José, Germinal, Costa Rica 2010, p. 194.
Tomado del diálogo entre Gabriel y el viejo Culebra. Este último es quien habla y la
redacción refleja el intento del autor de recuperar el lenguaje coloquial en la zona maya
veracruzana. Agradezco a Miguel su texto.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 61-76
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606435
61
62
Horacio Cerutti Guldberg
realizara justamente a la función “intelectual” tal como suele ser practicada
en la región, no sólo en Chile? Para ello, él mismo sugiere una vía, que
también conviene citar tal cual.
Pretender ser vanguardia, sin conocer el mínimo caudal de las
motivaciones esenciales, por muy alienadas que ellas estén, del pueblo a
que pertenece, es no sólo “arar en el mar” sino desconocer las leyes más
fundamentales de la humanidad y el mecanismo más profundo de la
Historia, entendida como un sistema forjador de ideas, pero en su espacio
temporal y en sus relaciones humanas indestructibles3.
En otras palabras, se trata de poner pie a tierra y no andar divagando en
las nubes. Tampoco refugiándose en generalizaciones supuestamente
universales, aplicables sin más a todo tiempo y lugar. Parece que siempre
es desde coyunturas, inmerso en ellas, que se filosofa y, sólo asumiendo
esta trama, se está en condiciones de aportar algo.
Si aceptamos que la hermenéutica bíblica ha tenido en esta
América nuestra un desarrollo muy creativo, jugando con los términos,
podríamos sugerir lo que intentamos en este artículo, cambiando el orden
de la expresión philosophia ancilla theologiae por theologia ancilla philosophiae.
No en un sentido peyorativo de hacer de la teología una “sierva” de la
filosofía, sino en cuanto al valioso servicio que la hermenéutica bíblica
puede aportar a la reflexión filosófica. E, incluso, detectando aspectos
convergentes durante múltiples intentos de escudriñar nuestros entornos y
procurar transformarlos en búsqueda de plenitud humana. Este juego
enfatiza ciertas idas y venidas, a sabiendas de que resulta prácticamente
imposible detectar orígenes “puros”, si queremos denominarlos así: sólo
filosóficos o sólo teológicos. Más bien, se advierte una larga serie de
dimensiones disciplinarias siempre en contactos, convergencias,
divergencias, complementación, derivaciones, traslapes, confusiones,
asimilaciones, etc.
Una muestra reciente, muy fecunda, muestra la convergencia, diríamos
ineludible, con el análisis social4. Quizá el punto neurálgico a recuperar
aquí de las valiosas reflexiones de ese trabajo, es el que refiere la necesidad
Ivi, p. 127.
J. HERNÁNDEZ PICO, “¿Qué aporta la espiritualidad cristiana o la reflexión teológica
al análisis social?”, ECA Estudios Centroamericanos (San Salvador, El Salvador, Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas”), 726 (2011), pp. 381-402.
3
4
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 63
de “organizar la esperanza” junto a la solidaridad. Y es que «La solidaridad
y la esperanza son hermanas gemelas. Las dos hacen posible la construcción
del reino de la tierra para que venga a nosotros el Reino de Dios»5.
Al mismo tiempo, debemos evitar cuidadosamente entrar en visiones
caricaturescas y deformantes de estos aportes regionales a la reflexión
mundial, a la vez que no debemos eludir las comparaciones y relaciones
con otras dimensiones, como por ejemplo, la literaria. Traslapes
terminológicos, presuntuosos “universalismos”, adjudicaciones simplistas,
ninguneo del pasado de pensamiento inmediato son algunos de los riesgos
ante los cuales cabe precaverse6. Por supuesto, es inviable detenernos aquí
en consignar antecedentes7.
Tampoco entraremos en el examen de propuestas muy relevantes,
como la de la hermenéutica analógica impulsada por el colega y amigo
Mauricio Beuchot8 ni en la recuperación del cuestionamiento de la
hermenéutica inspirado en la obra de Spinoza por parte de Deleuze9.
Interesantes debates sobre dimensiones hermenéuticas y filosofía tampoco
Ivi, p. 401 y también p. 397.
Cfr. A. R. ROLDÁN y J. L. GÓMEZ-MARTÍNEZ (Coordinador), Teología y pensamiento
de la liberación en la Literatura Iberoamericana, Milenio, Madrid 1996. A estos aspectos me
referí en la “Introducción” de este volumen, para la cual gentilmente José Luis me
convocó.
7 Uno, bastante relegado de la reflexión actual, es T. PAINE, La edad de la razón. Una
investigación sobre la verdadera y fabulosa teología, CONACULTA, México 2003 [1ª edición
1990]. Un trabajo muy cuidadoso permite reconstruir la trayectoria de un protagonista
clave, cfr. O. VILLANUEVA MARTÍNEZ, Camilo: pensamiento y proyecto político, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 2007. Agradezco al autor el acceso a su obra.
8 Cfr. una pequeña, pero sugerente, síntesis de su propuesta en M. BEUCHOT,
“Filosofía, hermenéutica y religión hoy” en O. WINGARTZ PLATA (Coordinador), Filosofía,
religión y sociedad en la globalización, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro
2011, pp. 13-26. Agradezco a Oscar el acceso al volumen.
9 Cfr. G. DELEUZE, Spinoza: filosofía práctica, Fábula, Barcelona 2009 [1ª en Francia
1970], entre otros textos relevantes. Agradezco a Manuel Santos su interlocución y sus
sugerencias de lecturas al respecto. Conviene retener esta afirmación del Rabino Daniel
Goldman de la Comunidad Bet-El: «... el texto bíblico es una creación humana al servicio
de la política económica, social y espiritual de los que la crearon y sigue siendo un factor
de composición para los que la interpretamos y nos inspiramos en ella, porque es parte de
una cultura que llevamos encantadoramente a cuesta, sea cual fuere nuestra idea de Dios o
nuestra incredulidad» (“De Bonn a Buenos Aires” Debates: “Se puede ser demócrata y
religioso?”, Página 12, Buenos Aires, 19.01.2012). Para contextualizar la situación judía
resulta indispensable el trabajo del colega de la Universidad de Montreal, Yakov Rabkin,
Contra el Estado de Israel. Historia de la oposición judía al sionismo, trad. Irene Selser, Martínez
Roca, Buenos Aires 2008 [1ª ed. en francés 2004]. Agradezco a Irene el acceso al texto.
5
6
64
Horacio Cerutti Guldberg
podremos recuperarlos en detalle, aunque no podemos dejar de
referirlos10.
Esa es tarea para futuros esfuerzos. Ahora me interesa concentrarme en
ciertos aportes de la hermenéutica bíblica a la filosofía, a sabiendas de que
no podré abordar todo el inmenso debate sobre la “deformación paulina” y
la “mixtificación de Jesús”11.
Dejando de lado, entre otros, estos aspectos y, por supuesto, sin
minimizarlos de ninguna manera, porque su estudio acucioso es
indispensable, veamos cómo ubicar esta dimensión hermenéutica para
poder atisbar algunos de sus aportes nodales.
Sólo el tópico de cómo entender la hermenéutica requiere de una labor
de reconstrucción inmensa. Por lo menos, conviene retener aquí un modo
de abordarla relacionada con la tradición diltheyana tan relevante en su
momento para la región. Al privilegiar la dimensión gráfica, se arriba a un
nuevo nivel de comprensión
una comprensión técnica. Dilthey lo llama interpretación. “Denominamos
interpretación la comprensión técnica de la vida fijada por escrito”. Y es
aquí donde se encuentra la parte medular del proceso de la comprensión
para las ciencias del espíritu y donde entramos de lleno al campo de la
hermenéutica […] estos esfuerzos han intentado organizar las reglas
descubiertas en una preceptiva que nos guíe y ayude a la correcta
interpretación. Este esfuerzo ha recibido el nombre de hermenéutica. Así,
la hermenéutica “constituye la técnica de la interpretación de testimonios
escritos12.
10 Cf. J. MUÑOZ Y Á. M. FAERNA (editores), Caminos de la hermenéutica, Editorial
Biblioteca Nueva, Madrid 2006. Para antecedentes y fuentes cfr. M. VELÁZQUEZ MEJÍA,
Hermenéutica Exégesis: uso y tradición. Vol. I, Segunda parte, Prolegómenos, UAEM, Toluca
2007, también de Manuel resulta un aporte sugerente su Hermenéutica Filosofía Genealogía,
UAEM, Toluca 2002. Agradezco a Manuel sus trabajos.
11 Cfr. G. CAMPIONI, Nietzsche y el espíritu latino, traducción y prólogo de Sergio
Sánchez, El Cuenco de Plata, Buenos Aires 2004 (particularmente el capítulo II –
agradezco a Sergio al acceso a esta valiosa obra); G. PUENTE OJEA, La existencia histórica de
Jesús en las fuentes cristianas y su contexto judío, Siglo XXI, Salamanca 2008; M. ONFRAY,
Tratado de ateología. Física de la metafísica, Anagrama, Barcelona 2006 [1ª en francés 2005,
en castellano 2006].
12 H. C. ARRIETA VALDIVIA, “La comprensión en Dilthey”, en Inter Alia Hermenéutica.
Memorias del Seminario de Hermenéutica y Ciencias del Espíritu, ENEP-Acatlán (UNAM),
México 1995.
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 65
Aquí la atención tiene que volverse a volcar sobre lo que aportan esos
escritos: contenido, forma, modalidades, supuestos, connotaciones,
referencias, lo dicho y lo no dicho. Lo cual conduce directamente a
dimensiones simbólicas y de sentido. Para lo cual, conviene recoger
algunos aspectos ya directamente relacionados con la hermenéutica bíblica.
El hombre es el animal capaz de simbolizar, y gracias a esa simbolización
encuentra un sentido en la realidad y en su propia vida. De ahí la
incongruencia de aquellos/as que pretenden desvalorizar lo simbólico por
temor a la alienación religiosa, o porque no quieren perderse en
construcciones puramente ideales. Se contrapone lo “real” a lo
“simbólico”, como si este último fuera pura ilusión. Pero este rechazo
(bastante frecuente en algunos sectores del mundo religioso
contemporáneo) ignora por completo lo que enseña cualquier
antropología: que el ser humano accede a su humanidad y existe en cuanto
tal por su facultad de distanciarse respecto de lo inmediato y de
representarlo simbólicamente13.
Si esto constituye al ser humano, aquí conviene traer a cuento también
la dimensión metafórica, tomando en consideración otra afirmación
decisiva de Levoratti: «Toda metáfora presupone de algún modo la
percepción intuitiva de una similitud entre cosas desemejantes»14.
Lo cual nos lleva de nuevo al símbolo y su definición, tal como lo
establece más delante de modo conciso y preciso a propósito de la cruz:
«El símbolo es y no es eso. De ahí que su formulación más apropiada sea el
dicho medieval: stat aliquid pro aliquo [“una cosa está en lugar de otra”]»15.
Finalmente, conviene no descuidar los ámbitos en que esta trama se
teje.
Y esto, porque «las cosas son elevadas a la dimensión simbólica por lo
que son y como lo son, pero la razón interpretativa es inseparable del
símbolo. Con mucha frecuencia, son el mito y la tradición religiosa los que
operan el nexo de simbolización»16.
13 A. J. LEVORATTI, “Metáforas y símbolos en el lenguaje de la Biblia”, en Búsquedas y
Señales. Estudios en Biblia, Teología, Historia y Ecumenismo, en homenaje a Ricardo Pietrantonio,
Lumen/ISEDET, Buenos Aires 2004, p. 117.
14 Ivi, p. 120.
15 Ivi, p. 126 y nota 13, cursivas en el original.
16 Ivi, p. 127.
66
Horacio Cerutti Guldberg
Los aportes de la Antropología de la Religión son también sugerentes
en este sentido y ayudan a relacionar dimensiones religiosas con
simbolismos y visiones del mundo, lo cual opera a la base de toda esfuerzo
de interpretación o búsqueda de sentido y lo hace posible. Elio Masferrer
ha señalado de modo sugerente:
Una consecuencia de la adopción de la categoría de sistema religioso es el
abandono de la noción de lealtad de los creyentes con la denominación
religiosa. Nuestra hipótesis plantea que la lealtad de los feligreses se debe
fundamentalmente a su modo de consumo de bienes simbólicos y que en la
medida que se produce un desfase del sistema con respecto a la
denominación de origen, los creyentes tienden a relacionarse con las
distintas denominaciones en la medida que les son útiles para configurar un
sistema religioso propio y en condiciones de operar. Desde esta
perspectiva, no reconocemos el concepto de deslealtad con las creencias
religiosas propias, sino que –por el contrario- la lealtad con su sistema de
visión del mundo lleva a los creyentes a retomar aquellos aspectos
pertinentes de las denominaciones religiosas para operar su sistema
religioso específico17.
Por cierto, demás está decir que aquí se juegan dimensiones fronterizas
entre laicismo y fideísmo (en los múltiples sentidos del término). Y Carlos
Mondragón se ha encargado de señalarlo con precisión:
La reproducción del espíritu laico no es cosa fácil. Y me atrevo a afirmar
que los distintos credos religiosos ortodoxos y sincréticos de la religiosidad
popular, están más presentes y juegan una función más importante en la
vida cotidiana de la población que cualquier ideología política o convicción
republicana. Es más fácil que el individuo común se autoconciba como
“creyente” que como “ciudadano”18.
O, también, las reflexiones agradecidas de Emmanuel Lévinas a
propósito de la solidaridad cuando la persecución nazi, recordando el caso
de Hanahh Arendt, quien contaba por radio lo que le había dicho al rabino
17 E. MASFERRER KAN, Religión, poder y cultura. Ensayos sobre la política y la diversidad de
creencias, Libros de la Araucaria, México 2009, p. 126. Agradezco a Elio el acceso a sus
trabajos.
18 C. MONDRAGÓN, “El laicismo y las minorías religiosas”, en VV. AA., El Estado laico
una conquista histórica, Instituto Nacional de Formación Política del PRD, México 2009,
pp. 30-31. Agradezco a Carlos el acceso a este volumen.
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 67
que le enseñaba religión: «… “he perdido la fe”. Y el rabino le contestó:
¿Quién te la pide? La respuesta es típica. Aquello que importa no es la fe
sino el “obrar” […] ¿Con qué creemos? ¡Con todo el cuerpo! […] El
rabino quería decir: “Hacer el bien es creer”. Esta es mi conclusión»19.
Así termina su reflexión agradecida Emmanuel Levinas y nos deja una
compleja trama inescindible como tarea de fondo en esta reflexión. Lo cual
nos reconduce, a las palabras del personaje campesino maya, el
protagonista Culebra en la novela de Miguel Baraona, citadas como
epígrafe. ¿Sabiduría analfabeta o sumamente (sobre)vivida?
Tenemos que seguir adelante, a pesar de la sensación de no haber
avanzado un milímetro. Porque el acoso al asunto va dando lentamente sus
frutos, como espero se vea a continuación. Examinemos, entonces
sucintamente, algunas dimensiones particularmente sugerentes para esta
reflexión.
La compleja relación inmanencia / trascendencia se hizo más accesible
en la reflexión de Severino Croatto, cuando indicaba con toda precisión,
que le aparecía como “evidente”: «que “trascendencia” es un vocablo
simbólico; no implica que el Misterio esté “en otro lado”; es también
inmanente en el hombre, por cuanto se le manifiesta de alguna manera.
Aquí se divisa ya la importancia del lenguaje simbólico, matriz de todo
lenguaje religioso»20.
Un poco más adelante insistirá en otro detalle, también decisivo para
estas reflexiones: «Las imágenes y los símbolos pueden decir más que las
palabras»21.
Aunque siempre sin poder eludir el enredo de las palabras. Su
enmarañada trama. En todo caso, supongo, Severino no descartaba que el
Misterio pudiera estar en otro lado. Lo que quería resaltar era su
adherencia o pertenencia al ser humano en tanto manifestación inmanente.
19 E. LÉVINAS, Lévinas: Gracias cristianos, Inédito. La confesión vibrante del gran filósofo:
durante el nazismo la Iglesia nos ayudó a los hebreos, in Anatéllei se levanta (CEFyT,
Córdoba, Argentina), 18 (2007), p. 37. Marta Palacio en la Editorial, “Otros textos para
Emmanuel Levinas” aclara: «… sincera y emotiva confidencia […] publicada post-mortem
por el periódico italiano Avvenire en septiembre de 2000 en un artículo en que agradece a
las religiosas de San Vicente de Paul el haber escondido a su esposa y su hija durante la
persecución nazi. En este número de Anatéllei hemos recogido y traducido este texto
inédito que tiene el encanto de la sencilla cercanía coloquial» (p. 9).
20 J. S. CROATTO, Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. Estudio de fenomenología
de la religión, Verbo Divino/Guadalupe, Navarra 2002, p. 59.
21 Ivi, p. 201.
68
Horacio Cerutti Guldberg
Lo cual no resuelve el problema, pero lo reubica de un modo sugerente,
sin duda.
Esto conduce, inexorablemente, a un complejo e irrenunciable
discernir, para quienes tienen fe y, por tanto, asumen el Misterio. Los
riesgos son claros y los asume explícitamente Gilberto da Silva Gorgulho,
cuando señala:
Además, en el plano del análisis hermenéutico, hay que destacar el
progreso y la madurez del uso de las mediaciones sociales de análisis. La
comprensión de la realidad del “fetiche” en el dinamismo de la sociedad,
marcó un nuevo inicio para la reflexión. La teología tiene la tarea de
discernir entre el “fetiche” y el “Espíritu” […] y remitiendo a
Hinkelammert añadirá] La hermenéutica es un discernimiento de las armas
ideológicas de la muerte y una búsqueda de las fuerzas del Espíritu de la
vida (cfr. 1 Jn 4)22.
La salvación es visualizada de este modo como un proceso y no como
una acción puntual efectuada por un deux ex machina. La trama es más
compleja y sólo desde ese proceso es factible avanzar hacia modalidades de
plenitud humana. A propósito de la teología de género, lo ha mostrado con
mucha perspicacia Violeta Rocha, partiendo de su propia experiencia de
vida en un contexto machista y patriarcal, como son la mayoría de nuestras
sociedades. Ello la lleva a apreciar que: «El proceso hermenéutico es
también un proceso de aprender para desaprender»23.
Lo cual requiere, como ella misma lo señala, cuestionar la ‘autoridad’
impuesta del canon. Conviene retener sus términos: «Desde el momento
en que aceptamos una autoridad de la Biblia que va por encima de la vida,
la justicia y la auto-afirmación humana, estamos hablando de una palabra
que mata, de una palabra que no es palabra, pues la verdadera palabra
crea»24.
La palabra creadora no está dada, sino que es aprehendida en medio del
proceso histórico. Un proceso que exige enfrentar desafíos, como el de la
22 G. DA SILVA GORGULHO, “Hermenéutica bíblica”, en I. ELLACURÍA Y J. SOBRINO
(coordinadores), Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación,
UCA, San Salvador-El Salvador 1993 [1ª 1991], p. 181.
23 V. ROCHA, “Género y Biblia. Una perspectiva latinoamericana”, en J.-J. TAMAYO Y
J. BOSCH (editores), Panorama de la Teología Latinoamericana, Verbo Divino, Estella-Navarra
2001, p. 503.
24 Ivi, p. 505, cursivas mías.
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 69
teología de género. Y nuevamente reitera Violeta Rocha: «La principal
estrategia es la educativa. El proceso de desaprender y aprender es una
dinámica de nunca acabar»25.
Y este proceso de aprendizaje y desaprendizaje interminable exige
replantear múltiples dimensiones de dominación, subordinación,
invisibilización y ninguneo, finalmente, denigrantes para quienes son. El
énfasis lo coloca en aspectos: sexuales, genéricos, identitarios, eróticos,
familiares, hogareños, cotidianos. Es en el día a día que se juega el logro,
reconocimiento y respeto a la dignidad humana en este mundo y en esta
historia. Fuera de mundo e historia no hay salvación, aunque las retóricas al
respecto abrumen.
No hay forma de evadirse del proceso histórico, tampoco de
interpretar esa salvación como un hecho aislado. Cabe enfatizar el sujeto de
este proceso: un pueblo en éxodo. Por cierto, una noción de pueblo que
en ningún momento homogeniza a sus integrantes y que no elude, al
contrario, destaca el conflicto social. No es un detalle menor que Jorge
Pixley reconociera la relevancia provocativa de las reflexiones de Porfirio
Miranda en Marx y la Biblia de 1971. Al punto de afirmar: «Para nosotros
los protestantes este libro fue el detonante decisivo para la teología de la
liberación» y más adelante añadirá: «Con Miranda, Buber y Mendenhall
pude encontrar una lectura de la Biblia»26.
En su cuidadosa y pertinente relectura del Éxodo, Jorge procuró
responder a «…la línea de lectura que el pueblo latinoamericano nos está
abriendo». Una relectura cuestionadora, justamente por estas
movilizaciones, de los reduccionismos “nacionalistas” de la interpretación
de este texto. Lo expresaba con toda precisión:
En América Latina estamos acostumbrados a teorías revolucionarias antireligiosas, o cuando menos arreligiosas […] Los creyentes tenemos una
dificultad inversa para leer este texto a la vez religioso y revolucionario. La
arraigada tradición liberal de separar religión y política, hace muy difícil
para los creyentes percibir que el éxodo [sic] es el texto guía de un pueblo
en revolución. Al contrario de los teóricos revolucionarios, para nosotros
la acción de Dios en la historia del pueblo de Israel no presenta ningún
problema. Pero nos resulta difícil leer la experiencia de Israel como una
Ivi, p. 509.
J. PIXLEY, “Una vida sorprendida por la Gracia”, en J.-J. TAMAYO y J. BOSCH
(editores), Panorama de la Teología Latinoamericana, cit., p. 455.
25
26
70
Horacio Cerutti Guldberg
auténtica revolución, una gesta donde el pueblo tomó en sus propias
manos su destino histórico que le había sido arrebatado por los reyes.
Siguiendo la interpretación nacionalista de la redacción yavista, se nos
había enseñado a leer el éxodo como el rescate por Dios de su pueblo,
después de la aberración de un periodo transitorio de esclavitud. En esta
lectura la nacionalidad es anterior al éxodo, que no sirve más que para
restaurarla. Al ubicar la producción del relato del éxodo dentro de las
luchas de los campesinos israelitas por lograr y defender sus condiciones de
vida frente a los reyes de Canaán, le devolvemos el carácter revolucionario
a la lucha contra el Faraón […] Experiencias históricas como las luchas
populares en América Central nos están abriendo los ojos al éxodo como
el texto guía de la revolución de un pueblo campesino profundamente
religioso27.
La cita ha sido muy extensa, pero muestra con toda claridad la
dimensión socio política ineludible de ese pueblo en marcha hacia su
liberación y las características de una liberación enfrentando sin rodeos el
conflicto social, siempre y cuando se aborde el esfuerzo de leerlo crítica y
problematizadoramente.
Un último tópico al que conviene hacer referencia nos remite a la
dimensión trinitaria. No podemos entrar aquí en los detalles de cómo esa
dimensión ha sido interpretada como trama dialéctica por otros autores,
con las indispensables referencias a Karl Rahner, Ignacio Ellacuría y Carlos
Cirne-Lima, por mencionar algunos de los más relevantes. Tampoco
detenernos en el prolijo e indispensable examen de la perijóresis. Aquí
quiero llamar la atención sobre la tesis presentada en Frankfurt por
Antonio González en 1991, en la cual procuró recuperar la articulación
trinitaria operando siempre al interior del proceso histórico. Para ello
requirió de aportes filosóficos y de las ciencias sociales, como él mismo
señaló. «Dios es trascendente en las cosas, no trascendente a las cosas»28.
La trinidad es pensada comunitariamente y no previamente como
‘personas’ que después se unen y esto cuestiona también la noción
J. PIXLEY, Éxodo, una lectura evangélica y popular, Casa Unida de Publicaciones,
México 1983, pp. 171-172. Así lo señalé oportunamente en mis comentarios a este texto
nodal, cfr. H. Cerutti Guldberg, "La dimensión utópica del Éxodo” en Presagio y tópica del
Descubrimiento (Ensayos de utopía IV), UNAM/Eón, México 1991, pp. 165-172. Le
agradezco por brindarme su texto y pedirme que lo comentara hace ya muchos años.
28 A. GONZÁLEZ, Trinidad y liberación. La teología trinitaria considerada desde la perspectiva
de la teología de la liberación, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El
Salvador-San Salvador 1994, p. 57. Agradezco a David Gómez el acceso al texto.
27
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 71
superficial de ‘sujeto’, para enfatizar la idea de agente plural realizador29.
Conviene retener algunas observaciones donde González deja sugerida su
línea argumental.
más que hablar en términos estáticos y duales de tres relaciones en Dios,
sería más adecuado decir, en términos dinámicos y más unitarios, que en la
Trinidad hay tres respectividades por haber tres personas que se
autoposeen entregándose absolutamente a las otras […] Dios se ha
manifestado también como Espíritu que resucita a Jesús y que continúa en
la historia del lado de los oprimidos y de todas las víctimas la obra de
deiformación hasta la consumación de los tiempos30.
En otro contexto, recuperó también esta dimensión trinitaria Pablo
Richard y retengo sus términos:
En esta situación caótica irrumpen desde lo más profundo del Pueblo de
Dios tres fuerzas positivas y trascendentales: la fuerza de la Solidaridad, de
la Palabra y del Espíritu. La raíz de estas fuerzas es la realidad misma de
Dios que es AGAPE (Amor, Misericordia, Justicia, Solidaridad), LOGOS
(Palabra de Dios) y PNEUMA (Espíritu o Poder de Dios). Agape, Logos y
Pneuma es la fuerza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en
nuestra historia. La fuerza del Dios-Agape se vive en los movimientos de
solidaridad. La fuerza del Dios-Logos se vive en el movimiento bíblico. La
fuerza del Dios-Espíritu se vive en la multifacética y variada espiritualidad
liberadora. Estas tres fuerzas irrumpen desde la profundidad misma del
pueblo de Dios […] El movimiento solidario, bíblico y espiritual es un
solo movimiento: el movimiento liberador de Dios Uno y Trino en
nuestra historia31.
En fin, nos toca recuperar, finalmente, uno de los trabajos de
referencia ineludible para la comprensión de la Teología de la Liberación.
Presentado como tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la
UNAM en 1978, el puertorriqueño Samuel Silva Gotay indicaba con toda
Cfr. Ivi, p. 171, nota 22.
Ivi, pp. 219-234.
31 P. RICHARD, “Hermenéutica: camino de encuentro con la Palabra de Dios (Diez
principios teóricos sobre la Lectura Comunitaria de la biblia)”, en G. HANSEN (editor), Los
caminos inexhauribles de la Palabra (Las relecturas creativas en la Biblia y de la Biblia). Homenaje de
colegas y discípulos a J. Severino Croatto en sus 70 años de vida, 40 de magisterio y 25 en el
ISEDET, Lumen / ISEDET, Buenos Aires 2000, p. 551.
29
30
72
Horacio Cerutti Guldberg
precisión el punto neurálgico que brinda la clave de esta reflexión. Sólo
recupero aquí unas líneas para dejar indicado cómo visualizaba en ese
momento el tópico.
La afirmación de la historia real como “única historia” y la historia como
única esfera de la realidad reconocida por la biblia lanzará la teología por
caminos no previstos por nadie y creará la posibilidad de un movimiento
ideológico capaz de acompañar y de justificar ideológicamente el modo de
producción socialista de la misma manera que la teología medieval
acompañó al feudalismo y de la misma manera que la teología protestante
acompañó al capitalismo liberal32.
En estas palabras y a pesar de identificar toda la producción teológica de
la liberación con el acompañamiento al socialismo, generalización muy
discutible y sobre la que se ha trabajado mucho posteriormente, lo decisivo
es la concepción de la historia, del proceso histórico como único y no
evadible. Este aspecto, en apariencia mínimo, resultó un disparador nodal
para la reflexión teológica y, sobre todo, para la hermenéutica bíblica.
¿Qué podríamos recuperar de este conciso y apretado recorrido
por algunas de las dimensiones nodales de la hermenéutica bíblica de la
liberación para nuestra reflexión filosófica? Saltan a la luz algunos aspectos
ineludibles. Dejando entre paréntesis – con todo respeto – nada menos
que la experiencia de la fe, resulta que las interpretaciones son construidas
desde disciplinas humanas donde la teología queda plenamente incluida. La
dimensión “ancilar” aparece como sumamente cuestionable, debido a que
la interpretación hace sus juegos asimilándose e, incluso, identificándose
con filosofía, teología, sociología, historiografía, antropología, psicología,
etc., según los casos. Con lo cual, no hay garantías ningunas de
interpretaciones presuntamente incuestionables. Siempre están las
dimensiones abiertas.
S. SILVA GOTAY, El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe.
Implicaciones de la teología de la liberación para la sociología de la religión, Cordillera/Sígueme,
Puerto Rico 1983 [1ª 1981], p. 96. Agradezco a Sammy el acceso a su texto. Una década
antes lo había puntualizado también Gustavo Gutiérrez en su texto decisivo para este
movimiento. Lo fundamental de este aspecto sería recuperado en una antología reciente
bajo el título “Una sola historia”, en G. GUTIÉRREZ, Textos esenciales. Acordarse de los pobres.
Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima 2003, pp. 210-211. Agradezco a Gustavo el
acceso a su texto.
32
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 73
Como suele suceder, las reflexiones de Gustavo Gutiérrez ayudan a
completar facetas de este rompecabezas interminable.
Al distinguir,
apoyándose en Gabriel Marcel, misterio de enigma y problema, lo
reconoce como no inefable, aunque no resulte fácil decirlo y comunicarlo.
Por ello: «La teología es un lenguaje. Intenta decir una palabra sobre esa
realidad misteriosa que los creyentes llamamos Dios. Es un logos sobre un
theos»33.
Ese lenguaje se traduce en la historia efectiva en lenguajes, con todas
sus dificultades de traspasar sus propias reglas y límites interpretativos.
Con todo, a Gustavo le parece a favor la diversidad de lenguas, a favor de
la dignidad humana, aunque dificulte en el paso a paso la interlocución
espontanea. ¿Será que nos fuerza al reconocimiento y al respeto mutuo,
mediante la referencia a reglas específicas en cada caso?
«En este telón de fondo [el “rechazo a la ficción de una comunidad humana
expresada en una lengua única”] la diversidad de lenguas, lejos de ser un
castigo para los pueblos dominados, es una protección de su libertad.
Impide que un poder despótico se imponga sin trabas»34.
No se trata, por tanto, de una mera visión instrumental o
instrumentalizadora del lenguaje, sino de vernos como seres de lenguaje,
donde las narrativas, la discursividad, el habla, el decir, la comunicación
resultan inherentes.
Debajo del vocablo logos empleado por Juan está el dabar hebreo, que
significa simultáneamente palabra y acontecimiento […] un
acontecimiento debe ser contado, dicho […] Se establece de este modo
una cadena narrativa, hecha a la par de memoria de sucesos pasados y de
factura de otros nuevos […] La narración incorpora dentro de ella al
oyente35.
Y, por si la evasión de lo histórico se hubiera filtrado por algún lado, no
queda más que re-volvernos, regresarnos a ella, de donde nunca podemos
salir. Por ello, se trata de abrir cauces nuevos en ese proceso
constituyente.
G. GUTIÉRREZ, “Lenguaje teológico, plenitud del silencio”, en ID., La densidad del
presente, Salamanca, Sígueme, 2003, p. 41.
34 Ivi, p. 57.
35 Ivi, pp. 64 y 67.
33
74
Horacio Cerutti Guldberg
«La teología es en verdad una hermenéutica de la esperanza» 36.
Y se llega así a un punto de culminación reflexivo y hasta normativo,
aunque sin pretensiones deterministas. Uno de los máximos sueños
diurnos, al que habrá que sumar, por cierto, otra dimensión en la que no
cabe abundar aquí: la resurrección de los cuerpos.
«Cada vez estamos más convencidos de que no es la muerte la última
palabra de la historia, sino la vida. Por eso la fiesta cristiana es siempre una
burla de la muerte: “Muerte, ¿dónde está tu victoria?”. Toda fiesta es una
pascua»37.
Lo cual nos devuelve a preocupaciones siempre presentes en esta
reflexión. ¿Cómo transformar de raíz esta realidad histórica intolerable?
Ignacio Ellacuría privilegió la dimensión revolucionaria sobre otras tareas
urgentes y dejó muy claro que no debe confundirse ni con reformismos, ni
con delegaciones de representatividad38. Otros autores añadirán elementos
para pensar la complejidad de las posiciones religiosas en medio de las
represiones, siempre con acento en lo político39.
Podríamos enfatizar lo que queda como saldo de este esfuerzo –
como juego lo referimos al comienzo- de relacionar filosofía y teología
para vislumbrar aportes de la hermenéutica bíblica al filosofar. Si
prescindimos – procedimentalmente – de la experiencia de la fe, no para
negarla o minusvalorarla, sino, reitero, por cuestiones metodológicas,
aparece con toda nitidez la identificación entre estos esfuerzos
interpretativos siempre en curso. Para decirlo de otro modo, es como si
resultara impracticable alejarse de la interpretación y, más bien, siempre se
Ivi, p. 67.
G. GUTIÉRREZ, “Juan de la Cruz desde América Latina”, en ID., La densidad del
presente, cit., p. 128.
38 Cfr. I. ELLACURÍA, “Utopía y profetismo”, en I. ELLACURÍA Y J. SOBRINO
(coordinadores), Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación.
cit., p. 435.
39 Cfr. M. QUIROGA GISMONDI, “El pensamiento de la Iglesia Católica durante las
dictaduras militares (1964-1978)”, en D. CAJÍAS, M. CAJÍAS, C. JOHNSON E I. VILLEGAS
(compiladoras), Visiones de fin de siglo Bolivia y América Latina en el siglo XX, Coordinadora de
Historia / IFEA / Embajada de España en Bolivia, La Paz 2001, pp. 599-615; L. RUANO
RUANO, “La experiencia colectiva e individual en el estudio de la identidad de la Acción
Católica Mexicana”, en L. LOEZA REYES Y M. PATRICIA CASTAÑEDA SALGADO
(coordinadoras), Identidades: teorías y métodos para su análisis, CEIICH-UNAM, México
2011, pp. 87-106; Y. ÁLVAREZ, “La Revolución argentina y los inicios de la radicalización:
juventud universitaria y catolicismo posconciliar en Mendoza (1966-1973)”, Latinoamérica
(CIALC-UNAM), 51 (2010/2), pp. 85-108.
36
37
Aportes de la hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica de nuestra América 75
está en un terreno interpretable, interpretado, por interpretar. El núcleo
central de estas ocupaciones y preocupaciones se ubica inevitablemente en
el proceso histórico. Allí estamos, allí somos, nosotros los constituimos y
es en esa trama donde pretendemos vivir en plenitud con toda la dignidad a
nosotros debida. Por lo tanto, aspiramos a cambiar y transformar todo
aquello que lo impida. Aquí no se puede eludir el paso heideggeriano del
círculo hermenéutico, donde del método se pasa a una dimensión
constituyente del ser humano; un ser hermenéutico. Con toda precisión se
lo ha señalado: «Surge una interrogante: ¿No es acaso la relación
perceptiva la primaria entre el hombre y los entes cosas?»40.
Lo cual nos coloca frente a la reiterada dificultad de esclarecer qué
significa precisamente percibir y sus relaciones con la conceptuación. Un
terreno en el cual se reabre la cuestión decisiva en nuestros tiempos del
poder de los medios de (‘des’) información para modelar percepciones o
producir un desangelado “analfabetismo medial”41.
Conviene concluir estas reflexiones abiertas recuperando las palabras de
Manuel Velázquez Mejía, cuando señalaba con toda precisión:
La hermenéutica alcanza su propia esencia sólo cuando se transforma de
disciplina que está al servicio de una tarea dogmática en disciplina que
reviste la función de órgano de la Historiografía […] Hermenéutica es
recuperación del significado por el sentido […] tocar las raíces que hacen
de la interpretación algo más que un mero instrumento gramaticalfilológico apto para escudriñar literalidades y textualidades, necesario,
sí, pero inacabado por la reducción técnica, práctica frecuente en la
búsqueda de sentido […] ¿no será que lo que llamamos a secas Historia
está fundada y configurada, explícita e implícitamente, y siempre y en
cada caso consciente o inconscientemente por un quehacer hermenéutico
cuyo ejercicio se constituye, se funda como valor y estructura
originantes de todo modelo histórico o historicidad interpretativa?42.-
W. NAVIA ROMERO, “Proyección en el siglo XXI de la hermenéutica del ser del
hombre, del ser y del lenguaje”, en L. TAPIA MEALLA (coordinador), Pluralismo
epistemológico, Muela del Diablo Editores, La Paz 2009, p. 155. Agradezco a Luis el acceso
al volumen.
41 Cfr. G. MICHEL, Una introducción a la Hermenéutica Arte de Espejos, Castellanos
Editores, México 1996, p. 47. Agradezco a Carlos Castellanos el acceso al texto.
42 M. VELÁZQUEZ MEJÍA, “Tres momentos de la hermenéutica” en ID., Hermenéutica,
Filosofía, Genealogía, cit., pp. 140-141, cursivas en el original.
40
76
Horacio Cerutti Guldberg
Abstract
One of the most creative areas in intellectual production in the region
has been the Biblical Hermeneutics, closely related to liberation theology,
though not as served as desirable. The purpose of this paper is to examine
some of these nodal contributions and consider their possible assimilation
of philosophical reflections for release. Dimensions as immanence or
historical significance, salvation as a process, people in exodus, Trinity
Convergence, among others, will be examined from a selection by
specifying criteria-it-works within the abundant available.
PIO COLONNELLO
La riscrittura del passato.
Ancora sul nesso memoria oblio perdono*
1. Il perdono come “redenzione” del passato
Perché il nesso memoria/oblio/perdono? In realtà, il perdono, è ben
noto, è una forma di dono intensivo, la capacità di cancellare l’offesa
ricevuta, di fare inabissare la colpa nelle oscure profondità dell’oblio. Nelle
pagine che seguono, cercherò di “ripetere” – nel senso di una “re-petitio”
come ricerca di ulteriori possibilità esegetiche – gli snodi fondamentali
della questione a partire da due significativi pensatori del nostro tempo,
Paul Ricoeur e Hannah Arendt, per giungere quindi ad alcune conclusioni.
Che il perdono sia quella facoltà umana dotata del potere di mutare il
passato, di convertire il «così fu» in «così volli che fosse», e che questa
facoltà sia una forma di azione, che consente all’uomo di sottrarsi
all'imprevedibile, all’incessante rottura del cambiamento, alla
destabilizzazione esistenziale come traumatico prodursi della differenza1 –
è certamente risaputo, per quanto riguarda il pensiero della Arendt.
Complementare al perdono è un'altra tipica capacità umana, quella di
fare e mantenere promesse. Se il perdono annienta l'irreversibilità del
*Il presente lavoro riprende e sviluppa alcuni temi del mio saggio apparso nel Bollettino
filosofico, XXVI (2010), dal titolo: L’ambiguo volto della dimenticanza. Una rilettura della
dimenticanza tra colpa e innocenza.
1 Cfr. H. ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958;
tr. it. Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1988, p. 174. Cfr. della stessa
autrice: “Truth and Politics”, The New Yorker (25.2.1967); poi in Between Past and
Future. Eight Exercises in Political Thought, New York 1968; la tr. it. Tra passato e futuro,
Garzanti, Milano 1991, è condotta sulla prima ediz. dell'opera Between Past and Future.
Six Exercises in Political Thought (1961), dove mancava il saggio Truth and Politics. Per la
tr. it. di quest'ultimo, cfr. Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino 1995, p. 29;
“Lying and Politics. Reflections on the Pentagon Papers”, The New Yorker Review of Books
8 (1971), pp. 30-9; ora in Wahrheit und Lüge in der Politik. Zwei Essays, München 1972;
tr. it. “La menzogna in politica. Riflessioni sui Pentagon Papers”, in Politica e menzogna,
SugarCo, Milano 1985.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 77-93
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606436
77
78
Pio Colonnello
passato, se esso serve ad inserire una falla – o un ventaglio di possibilità –
tra il continuum spazio-temporale fossilizzato nella necessità del già stato, la
promessa funge da rimedio all'imprevedibilità e all'incertezza del futuro; il
vincolarsi con promesse, così si esprime Hannah Arendt, «serve a gettare
nell'oceano dell'incertezza, quale è il futuro per definizione, isole di
sicurezza»2. Così, perdono e promessa appaiono come le due facce di
Giano bifronte: l'una rivolta al non-più e l'altra al non-ancora, ma
entrambe testimoniano la nostra capacità di agire, la nostra libertà umana,
cioè la capacità di svincolarsi dalle conseguenze di ciò che è stato, di ciò
che abbiamo fatto, a differenza dell'apprendista stregone – come suggerisce
suggestivamente la Arendt -, cioè di colui che finisce per restare egli stesso
vittima delle conseguenze del suo agire. In tal guisa, l'uomo, grazie alla
promessa e al perdono, finisce per rivelarsi ancora una volta il punto
archimedico – o il "tra" – da cui è possibile ripensare il rapporto tra la
gravità del passato e la consolazione del futuro, tra la cupa pesantezza del
già stato e la speranza del non ancora.
Entrambe le facoltà sono infine accomunate dalla relazione con la
presenza dell'altro o dall'apertura alla sua "trascendenza", risultando
impossibile sentirsi legato da una promessa fatta solo a se stesso o
perdonare nel completo isolamento dagli altri.
Ma lasciamo pure in ombra il tema della promessa, per rivolgere
l'attenzione peculiarmente alla questione del perdono. La Arendt riconosce
come solo a partire dal cristianesimo questa facoltà abbia acquistato
rilevanza nel dominio degli affari umani e come dal campo religioso il
perdono sia stato poi mutuato dalla sfera politica. D'altra parte, il fatto che
la scoperta del perdono abbia, alle sue origini, radici in un contesto
confessionale, non deve sminuire l'importanza di questa facoltà nelle
questioni politiche; vero è, sottolinea Hannah Arendt, che «la nostra
tradizione di pensiero politico è stata per sua natura altamente selettiva ed
ha escluso dalle sue articolazioni concettuali una grande varietà di
esperienze politiche autentiche, tra le quali non dovremmo sorprenderci di
trovarne alcune fondamentali»3. Prima dell'esperienza cristiana si possono
riscontrare tracce informi della consapevolezza del perdono, come rettifica
dei guasti derivanti dall'azione, solamente nel principio romano di
risparmiare i vinti (parcere subiectis), un principio del tutto sconosciuto al
mondo greco, o nel diritto di commutare la pena capitale.
2
3
H. ARENDT, Vita activa, cit., p. 175.
Ivi, p. 176.
La riscrittura del passato
79
Il perdono, come capacità tipicamente umana, è esattamente l'opposto
della vendetta, che è la naturale e quasi meccanica reazione contro
un'offesa e, pertanto, può essere prevista e in qualche modo calcolata
all'interno del processo dell'agire. Perdonare è “agire”, cancellare l'azione
dell'offensore, annullare il passato, cioè inaugurare l'assolutamente nuovo,
l'inimmaginabile, lo straordinario. In definitiva, tale facoltà mette in
questione la linearità seriale del tempo naturale, quel continuum spesso
raffigurato con l'immagine della freccia del divenire e pensato come
assolutamente irreversibile. Vero è che, di fronte alla scissione e alla
lacerazione che possono provocare i guasti dell'azione, non resta che agire
e superare le fratture esistenziali, proprio come fa chi perdona e "redime"
il passato. Restano comunque centrali, nel pensiero della Arendt, il
problema del tempo e quello del superamento della scissione, due
questioni in qualche modo tra loro connesse, che oggi sono fecondamente
ripercorse dalla riflessione ermeneutica. Si tratta allora di un cogitare che
non si affida più solo alla forza cogente del logo, ma a quella pietas del
pensiero, capace di fare esperienza fino in fondo della diversità e della
scissione e di conservare le ragioni della differenza.
Ebbene, la comprensione come sforzo di sfuggire alla protervia che tutto
– fenomeni e noumeni, situazioni affettive e modi dell'essere – possa
essere "afferrato" con le categorie dell'intelletto; la comprensione come
conato di superare la difettività del pensiero nel dire i nomi dell'essere, del
non essere o del fondamento trova la propria fonte sorgiva nella
dimensione della scissione e della lacerazione. In fondo, ogni
riconciliazione e giustificazione, e dunque ogni autentica comprensione,
muove dal dolore e dal tentativo di superare la scissione, di annullare la
rovina del negativo.
Si tratta insomma di una riconciliazione – o giustificazione – che non si
affida, come nel caso della fenomenologia hegeliana, alle strutture
"necessitanti" della ragione; affiora, piuttosto, la pietas di un pensiero che è
insieme giustificazione e perdono, epifania e innocenza, benedizione e
speranza. Bisogna, in ogni caso, fare attenzione, perché qui giustificare non
è semplicemente riabilitare il passato e valicare le differenze. Si ha qui da
fare con una giustificazione più "alta", cioè si tratta di "intervenire" sul
passato. È qui che le considerazioni arendtiane sul perdono come
"riscrittura" del passato risultano di grande interesse: in fondo,
interrompere o meglio "trasformare" il continuum temporale pietrificato
nella necessità del già stato, cioè mutare il passato svincolandoci dalle sue
80
Pio Colonnello
conseguenze, ha senso per aprire appunto nuove possibilità per il futuro.
Ed è proprio dell'uomo non semplicemente vivere "tra" le modalità del
tempo – tra ciò che non è più e ciò che non è ancora -, ma essere egli
stesso l'elemento che, mettendo in questione la linearità seriale del tempo,
inaugura il nuovo e l'impensabile.
2. Il perdono come “influenza” del passato sul futuro
Singolare appare l’intreccio tra memoria, oblio, colpa e perdono
nell’opera di Paul Ricoeur. A volere individuare un significativo punto di
partenza, possiamo fare riferimento anzitutto ad una caratteristica
fondamentale della memoria, il suo essere orientata verso il futuro. Essa si
contraddistingue non solo perché è un criterio di identità personale o
perché costituisce il legame originario della coscienza col passato: ciò che
qui interessa è che dalla memoria dipende l’orientazione del tempo: dal
passato verso il futuro4.
Nondimeno, l’influenza del passato sul futuro ha, come contropartita, il
movimento inverso, cioè l’influenza dello stesso futuro sul passato. A
riguardo, Ricoeur richiama esplicitamente il tema della colpa, «un fardello
che il passato fa pesare sul futuro». Che questo tema sia un Leitmotive
ricorrente nella letteratura esistenziale, in particolare nei paragrafi 58-60 di
Essere e tempo, è certamente risaputo. Non a caso, vi è un chiaro riferimento
proprio alla fenomenologia della colpa e alla tesi svolta nel famoso capitolo
III della seconda sezione dell’Hauptwerk heideggeriano: «La Cura porta in sé
cooriginariamente morte e colpa»5. Tuttavia, a Heidegger Ricoeur contesta
il convincimento che la colpa collochi saldamente, in una sorta di
4 Cfr. P. RICOEUR, Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen,
Wallstein, Göttingen 1998; tr. it. Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato,
Il Mulino, Bologna 2004, pp. 23 sgg. Cfr. dello stesso autore P. RICOEUR, La mémoire,
l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris 2000; tr. it. La memoria, la storia, l’oblio, Cortina, Milano
2003; Philosophie de la volonté. I. Le volontaire et l'involontaire, Paris 1950; tr. it., Genova
1990. Philosophie de la volonté. II. Finitude et culpabilité. I. L'homme faillible. II. La
symbolique du mal, Paris 1960; tr. it. Finitudine e colpa, Bologna 1970. Phénoménologie et
herméneutique, in AA.VV., Phänomenologie heute. Grundlagen – und Methodenprobleme
(Phänomenologischen Forschungen, Bd. I.), Freiburg-München 1975, pp. 31-75
5 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1957, p. 306 («Die Sorge birgt
Tod und Schuld gleichursprünglich in sich»); tr. it. Essere e tempo, a cura di P. Chiodi,
UTET, Torino 1986, p. 451.
La riscrittura del passato
81
ancoraggio, il poter-essere nel passato, in quanto la colpa rivestirebbe anche
un significato più profondo, se confrontata con un’attesa indeterminata. È
perciò necessario, «restituire al concetto di colpa l’ampiezza che nozioni
affini, come quella di eredità, “pre-acquisizione” (Vorhabe), “previsione
orientatrice» (leitende Vor-sich) contribuiscono a preservare»6.
Se il debito obbliga e se c’è un dovere di ricordare, argomenta ancora
Ricoeur, «esso è in virtù della colpa che, trasferendo la memoria al futuro,
letteralmente la declina al futuro: ti ricorderai! Non dimenticherai!»7. È
poi differente discorso che la colpa, in quanto argomento cardine
dell’analisi esistenziale, sia comunque altro rispetto allo status corruptionis in
senso teologico – come il medesimo pensatore ricorda –, sebbene, per
altro verso, si possano riscontrare significative analogie tra la “previsione
orientatrice”, che caratterizzerebbe ab intus la stessa colpevolezza e,
dunque, il trasferimento della memoria nella dimensione del non-ancora,
da una parte, e la protensione verso il futuro, sancita nel ristabilimento
dell’alleanza tra Jahvé e il suo popolo, dall’altra. Dopo la rottura del patto,
Cristo, nel ristabilire l’alleanza e cancellare la colpa, orienta, nell’ultima
cena, la memoria verso il futuro. Il pentimento, oltre che ricordo delle
colpe, è appello alla memoria di Dio. Affinché l’uomo potesse ricordare
per sempre l’alleanza con Dio, la religione cristiana si è convertita
prontamente, come già quella ebraica, in una religione della memoria. Al
centro di questo ricordo sta l’ultima cena con l’invito diretto al futuro
fatto agli apostoli. Il “comando del ripetere” si manifesta, così, come
antidoto ad una imperdonabile dimenticanza: ogni celebrazione eucaristica
avviene nell’esternare ciò che giace nella memoria, perché sia di nuovo
interiorizzato e consegnato alla memoria. Vero è che occorre ora
riconsiderare la questione, come vedremo più avanti, eminentemente nei
termini di un’ingiunzione morale, l’ingiunzione di “non dimenticare”:
«Zakhor, dice la Torah: divieto di oblio»8, sottolinea Ricoeur.
A questo punto occorre, però, fare i conti con un paradosso: è opinione
comune che il passato non possa essere cambiato, che esso è determinato in
P. RICOEUR, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 38.
Ibid., p. 37. Molto opportunamente Ricoeur osserva che «verrebbe allora da dire che
il passato che non è più, ma che è stato, reclama il dire del racconto dal fondo stesso
della propria assenza. Michel de Certeau suggerisce qualcosa di analogo in L’absent de
l’histoire: assente dal dire la storia, il passato essente-stato si fa domanda di un dire» (p.
40).
8 Ivi, p. 82.
6
7
82
Pio Colonnello
quanto affonda nella cieca notte della necessità; viceversa, il futuro è
generalmente considerato incerto, aperto, essendo il regno indeterminato
delle possibilità. Tuttavia il paradosso, commenta Ricoeur, è solo
apparente, perché se è vero che i fatti sono incancellabili, se essi appaiono
“pietrificati” nel loro essere-stato, in compenso il senso degli avvenimenti
non è fissato una volta per tutte: vero è che il carico morale legato al
rapporto di colpa verso il passato può essere di volta in volta alleggerito o
appesantito, «a seconda che l’accusa imprigioni il colpevole nel sentimento
doloroso dell’irreversibile, oppure che il perdono apra la prospettiva di
una liberazione dal debito», e ciò equivale a una conversione del senso
stesso del passato. «Si può considerare questo fenomeno di
reinterpretazione […] come un caso di azione retroattiva della mira del
futuro sull’apprensione del passato»9.
Naturalmente, nel porre in essere una tale operazione, occorre lasciarsi
guidare dall’imperativo di salvare le tracce, valorizzando al tempo stesso
l’elemento della “testimonianza”, il “vedere” “vicariato” dal dire e dal
credere. Ma salvare la veracità della memoria, salvare le tracce, implica
nondimeno preservare anche la memoria delle ferite e delle vittime della
violenza. Ecco la dimensione etica – o etico-politica – dell’ingiunzione di
“non-dimenticare”; tra le tracce vi sono, infatti, anche le ferite inflitte alle
vittime nel corso violento della storia. Per ciò appunto, rileva Ricoeur,
bisogna introdurre accanto a categorie epistemologiche, come fedeltà,
esattezza, che riguardano la veracità della memoria, categorie “patologiche”
o «quasi-patologiche e terapeutiche», come ferita e trauma, consentendo in
tal modo la riorganizzazione dei ricordi in livelli di senso, orientati
intenzionalmente nella direzione che dal passato conduce al futuro.
Si è osservato poc’anzi come il carico morale, legato al rapporto di
colpa verso il passato, possa essere appesantito se il colpevole resti
imprigionato nel sentimento dell’irreversibile o, viceversa, alleggerito se
sopravvenga il perdono come liberazione dal debito. Appare così centrale
il ruolo del perdono, che Ricoeur paragona a una forma di oblio. Ma sorge
prontamente la domanda: a quale forma di oblio?
Non è qui possibile ripercorrere, sia pure sinteticamente, la complessa
fenomenologia dell’oblio disegnata in Ricordare, dimenticare, perdonare,
unitamente all’elogio di ciò che non va inteso come il nemico o l’esatto
contrario della memoria, la minaccia dalla quale preservare il passato. Una
9
Ivi, pp. 92-93.
La riscrittura del passato
83
tale fenomenologia va dall’“oblio profondo”, che si manifesta nelle forme
complesse dell’oblio inesorabile – che non si limita a impedire il richiamo dei
ricordi, ma si adopera anche a cancellare la traccia dei vissuti – e dell’
“oblio immemorabile”, l’oblio dei fondamenti; fino ad una serie di figure
che si collocano tra l’oblio passivo e l’oblio attivo. Tra esse, interessante è
la figura “semi-passiva” dell’ “oblio di fuga”, «espressione della cattiva fede,
che consiste in una strategia di evitamento, essa stessa motivata da una
volontà oscura di non informarsi, di non indagare sul male commesso»10.
Tra le forme dell’oblio attivo, sintomatica è quella dell’ “oblio selettivo”,
che si rivela indubbiamente benefico, in quanto consente di filtrare la
massa dei ricordi del passato, che sarebbero altrimenti un peso
insopportabile, in senso nietzscheano: «il peso più grande».
Anche le riflessioni sul perdono si snodano nell’arco di un suggestivo
orizzonte fenomenologico. Esso, se da un lato risulta il contrario dell’oblio
passivo, tanto nella sua forma traumatica, quanto in «quella astratta
dell’oblio di fuga», dall’altro manifesta una certa affinità con l’oblio attivo,
ma «con molta cautela», avverte Ricoeur11. Oggetto del perdono, come
Ivi., p. 106.
Se il perdono, come forma di “oblio attivo”, verte direttamente sulla colpa, quel fondo
oscuro che sostituisce alla leggerezza della scalata la pesantezza che spinge verso il basso,
paralizzando così la memoria, e se occorre fare della colpa stessa il lavoro del lutto, allora
è forse opportuno ricordare le stesse analisi ricoeuriane sulla colpevolezza – come
contrappunto del perdono – a partire da quella dimensione originaria della coscienza, la
dimensione emozionale, che appare come il bagliore antelucano che precede il solare
splendore dei simboli del mito e della speculazione. A fronte della ripetuta insistenza di
alcuni filoni dell’ermeneutica contemporanea su concetti quali finitudine, fallibilità,
naufragio, a parere di Ricoeur, è possibile cogliere il passaggio dalla fallibilità alla colpa
nell’atto, cioè «“ripetendo” in noi stessi la confessione che ne fa la coscienza religiosa» (P.
RICOEUR, Finitudine e colpa, a cura di V. Melchiorre, Il Mulino, Bologna 1970, p. 249).
Al filosofo importa piuttosto la «ripetizione» della confessione, in quanto il linguaggio
della confessione rinvia ad un’esperienza che è la meno elaborata possibile: esso precede
il linguaggio mitico e quello speculativo. È interessante rilevare l’itinerario di Ricoeur
verso un territorio genuinamente originario: dalla speculazione sul peccato originale al
mito della caduta e da questo alla confessione dei peccati. In tanto è possibile guadagnare
la regione premitica e speculativa, in quanto al di sotto della gnosi e del mito vi è ancora
un linguaggio: quello della confessione, mentre il linguaggio del mito e della speculazione
sarebbero «riassunzioni di secondo e di terzo grado». L’esperienza della confessione,
tuttavia, al di là di una apparente semplicità, rivela una sua intrinseca stratificazione: il
sentimento di colpevolezza rinvia ad un’esperienza più radicale, l’esperienza del
“peccato”, che indica «la situazione reale dell’uomo dinanzi a Dio; a sua volta, il peccato
rimanda a una concezione più arcaica della colpa, quella della “impurità” concepita come
una macchia che contamina dall’esterno», come lo sfondo o il fondo oscuro dei
10
11
84
Pio Colonnello
forma dell’oblio attivo, sono non già gli avvenimenti in se stessi, gli eventi
passati, ma il loro senso, che riguarda il grado di colpevolezza assegnato ad
essi nella dialettica della coscienza storica. Tuttavia, a differenza dell’oblio
di fuga, il perdono non resta chiuso in «un rapporto narcisistico tra sé e sé,
poiché presuppone la mediazione di un’altra coscienza, quella della
vittima, la sola abilitata a perdonare»12.
Nella fenomenologia del perdono è descritta e analizzata tutta la vasta
gamma delle figure del perdonare: dal perdono di autocompiacimento, che
prolunga l’oblio di fuga, idealizzandolo, al perdono di benevolenza, che propende
ad accordare l’impunità, fino al perdono di indulgenza, figura cardine di gran
parte della nostra tradizione teologica, per la quale perdonare significa
concedere l’assoluzione, consentire la remissione dei debiti.
In ogni caso, occorre guardarsi dalla trappola del perdono facile, cioè dalla
pretesa di esercitare il perdono come un potere o una facoltà, «senza essere
passati attraverso la prova della richiesta di perdono e, peggio ancora, del
rifiuto del perdono». D’altra parte, occorre uscire dalla logica della
retribuzione, spesso chiamata in causa in occasione della problematica della
sofferenza ingiusta, come nel caso di Giobbe; tuttavia questa «cancellazione
magica» andrebbe nella stessa direzione dell’oblio profondo, che consiste
nell’usura delle impronte e nella stessa distruzione delle tracce.
Occorre a questo punto, argomenta Ricoeur, guadagnare un rapporto
nuovo con la colpa, con la perdita; la ricerca di questo nuovo rapporto
deve passare necessariamente attraverso l’idea di dono, che è alla base stessa
dell’idea di perdono. La critica alla logica della retribuzione è all’origine
della nostra tradizione teologica cristiana: amare e fare del bene ai propri
nemici, prestare senza chiedere nulla in cambio13, in quanto è appunto
sentimenti e dei comportamenti relativi alla colpa. Ancora una volta, il linguaggio deve
intervenire per delucidare un territorio emozionale ricco di polivalente significatività. Ad
ogni modo, con questo tentativo di risalire à rebours ai simboli primari del male attraverso
la ripetizione della confessione considerata ai suoi vari livelli di simbolizzazione, ci
avviciniamo propriamente alla soglia di una filosofia della colpa, che tuttavia deve essere
ancora indagata in una molteplicità di direzioni. È poi altro discorso se il lungo itinerario
ricoeuriano di risalire da una “mitica” della volontà malvagia ad una “simbolica” del male
– nella quale i simboli più densi teoreticamente come la materia o il peccato originale,
rimandano ai simboli mitici come l’esilio, l’accecamento divino o la caduta di Adamo, e
questi a loro volta ai simboli di impurità, del peccato e della colpevolezza – bene illustri il
tentativo di penetrare nella trama profonda o “segreta” del mito.
12 Ivi, p. 110.
13 Lc 6, 32-35
La riscrittura del passato
85
l’amore dei nemici la misura assoluta del dono, cui si associa l’idea del
prestito senza speranza di ritorno. È proprio il comandamento di amare i
nemici che inizia a spezzare la regola della reciprocità, esigendo un
perdono difficile, un perdono nelle situazioni estreme, puntando
direttamente alla radice dei conflitti e dei torti che richiedono il perdono.
È qui che si intrecciano storie “incommensurabili”, come quella di
Antigone; è qui che «si affrontano fedeltà al tempo stesso assolute e
limitate; la giustizia confina con la vendetta e il potere con la violenza; le
ferite sono curate come benedizioni»14.
Nondimeno, per illustrare in cosa consista il perdono nelle situazioni
estreme, Ricoeur ritiene opportuno fare riferimento, in conclusione, alla
hegeliana Fenomenologia dello spirito: alla fine della sezione dedicata allo spirito
certo di se stesso: la moralità, compare per la prima volta – ancora prima del
capitolo dedicato alla Religione – il termine perdono (Vergebung), inteso come
«equiparazione di entrambe le parti, mutuo perdono», “riconciliazione”.
3. Dal perdono come riconciliazione al perdono come “compensazione”
Nel tirare le fila di questa riflessione sul perdono, ricorderò brevemente
come questo luogo della Fenomenologia rappresenti davvero un momento di
fondamentale importanza nel lungo ed accidentato cammino della coscienza
che ha da riconoscersi come spirito assoluto. È mia intenzione fare riferimento
successivamente ad alcuni passi tratti dallo Zarathustra di Nietzsche, non per
individuare affinità o consonanze con il luogo hegeliano in questione, ma per
seguire un’ipotesi ermeneutica che possa scoprire, nelle stesse distanze
speculative, relazioni problematiche e piene di senso e, dunque, i luoghi di
passaggio che consentano l’attraversamento di ambiti teoretici differenti, tra
l’idea del perdono come riconciliazione e l’epifania di uno spirito innovatore,
capace di annullare un passato remoto inabissato nelle oscure gore di un oblio
colpevole.
Torniamo al passo della Fenomenologia. La vita infinita, scissa
nell'azione, aspira ora a una riconciliazione. Si fa strada l'idea di una riconciliazione vivente al posto di una opposizione morta. Il “fatto”, ciò che è
stato, l’elemento della singolarità sussiste ancora, ma come una ferita dello
spirito che attende il suo significato dal futuro, e perciò l’elemento della
14
P. RICOEUR, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 117.
86
Pio Colonnello
singolarità, presente nel fatto, è destinato a dileguare immediatamente:
«Le ferite dello spirito si rimarginano senza lasciar cicatrici»15.
Dallo spirito, divenuto spirito morale concreto (Gewissen), è nata una
nuova opposizione che riproduce la serie delle innumerevoli
opposizioni della coscienza. Lo spirito come universale affronta lo
spirito come individualità singola. Ora l'opposizione ha assunto una
forma concreta in due distinte figure della coscienza ciascuna delle quali
contiene, in maniera diversa, i due momenti dell'universale e del singolare. L'una è lo spirito agente, l'altra è l’anima bella. Ma il male è nella
separazione, perché il vero non è né nello spirito agente né nell’anima
bella, ma è nell’intero, anzi è l’intero: il Sé attuatore, che è «soltanto un
momento dell’intero», è il sapere che determina mediante il giudizio e
stabilisce la differenza del lato singolo e di quello universale dell’agire.
Quel male pone tale alienazione di sé o pone sé come momento,
attirato, mediante l’intuizione di se stesso, entro l’altro, nell’esserci
facente confessione di sé. Ma a questo altro deve infrangersi il suo
unilaterale e non riconosciuto giudizio; così come a quello il suo
unilaterale e non riconosciuto esserci dell’essere-per-sé particolare; e
come l’uno rappresenta la potenza dello spirito sopra la sua effettualità,
così l’altro rappresenta la potenza sopra il suo determinato concetto16.
L'unità si può attuare soltanto attraverso un continuo conflitto, un
incessante superamento. La vera vita dello spirito è appunto in questo
superamento, in una riconciliazione attraverso una opposizione.
Proprio come nella dialettica servo-signore, le figure della coscienza
nobile e della coscienza spregevole risultano rovesciate. La coscienza
universale giudicante si avvia a mostrare se stessa come cattiva e
particolare. Come ha opportunamente osservato Jean Hyppolite che
«proprio nel constatare in lei l'ipocrisia la coscienza agente giungerà alla
propria confessione. In tal modo essa si colloca non più sopra ma
accanto alla coscienza che essa giudica, ed è costituita “in tutto e per
tutto” come quella»17. Di conseguenza, il perdono che la coscienza
15 G. W. F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, in G.W.F. Hegel Werke in zwanzig Bänden, hrsg.
E. Moldenhauer – K.M. Michel, Bd. 3, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1970, p. 492;
Fenomenologia dello spirito, t. II, tr. it. di E. De Negri, La Nuova Italia. Firenze 1985, p. 193.
16 Ibidem
17 J. HYPPOLITE, Genèse et structure de la Phänomenologie des Geistes» de Hegel, Ed. Montaigne,
Paris 1946; Genesi e struttura della «Fenomenologia dello spirito» di Hegel, tr. it. di G. A. De
Toni, La Nuova Italia, Firenze 1977, p. 643.
La riscrittura del passato
87
agente concede all’altra è la rinunzia a sé: «La parola della conciliazione
è lo spirito esistente che intuisce il puro sapere di se stesso come
essenza universale nel suo contrario, nel puro sapere di sé come
singolarità che è assolutamente in se stessa, – reciproco riconoscimento
che è lo spirito assoluto»18.
Lo spirito assoluto come “reciproco riconoscimento” ci riporta al
tema di fondo della Fenomenologia: lo spirito che nella sua forma di sapere
più alto, cioè l’intuire il puro sapere di se stesso come essenza universale;
ma questo afferramento di sé è esattamente nel suo contrario, è l’«Io
esteso fino alla dualità». Dunque, la confessione della coscienza
impegnata nell’azione consiste nel riconoscere la continuità del suo Io
con l'altro Io; grazie alla medesima confessione da parte dell’altra
coscienza si restaura la loro identità: «Il sì della conciliazione, in cui i due
Io dimettono il loro opposto esserci, è l’esserci dell’Io esteso fino alla
dualità, Io che quivi resta uguale a sé e che nella sua completa alienazione
e nel suo completo contrario ha la certezza di se stesso; – è il Dio
apparente in mezzo a loro che si sanno come puro sapere»19.
Lo spirito assoluto, disvelato così dalla remissione dei peccati, non è
né l'astratto spirito infinito che si oppone allo spirito finito, né lo spirito
finito che persiste nella propria finitezza, ma propriamente l'unità e
l'opposizione dei due Io. In definitiva, il perdono è qui inteso come
«mutuo perdono», “riconciliazione”, che è ricostituzione dell’unità,
eguaglianza dell’Io con se stesso.
Se ci rivolgiamo ora allo Zarathustra di Nietzsche, notiamo che anche
qui – sia pure su un differente piano speculativo – abbiamo da fare con
un’unità scissa in una dualità e con una dualità che rappresenta, a suo
modo, un’unità. Secondo la stessa espressione poetica nietzscheana,
contenuta nelle Canzoni del principe Vogelfrei, in appendice alla Gaia
Scienza, Zarathustra è «l’Uno divenne Due» – («Da, plözlich, Freundin!
Wurde Eins zu Zwei – Und Zarathustra gieng an mir vorbei»)20. Intendo
ora ripercorrere alcuni significativi luoghi di Così parlò Zarathustra,
tenendo presente in particolare l’interpretazione che Carl Gustav Jung ha
svolto nei suoi Seminari su Nietzsche nella seconda metà degli anni
G.W.F. HEGEL, cit., 492; tr. it. cit., p. 194.
Ivi, p. 196.
20 F. NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft, in ID. Werke, Kritische Gesamtausgabe, hrsg.
von G. Colli-M. Montinari, Bd 5.2, de Gruyter & Co., Berlin 1973, p. 333; tr. it. La Gaia
Scienza, a c. di G. Colli-M. Montinari, Adelphi, Milano 1965, p. 274.
18
19
88
Pio Colonnello
Trenta21, sebbene, nella conclusione, io pervenga ad alcune riflessioni
che si discostano dalla finissima ermeneutica junghiana.
Jung ricollega opportunamente la figura di Zarathustra/Zoroastro
ad alcune divinità della mitologia persiana, anzitutto a Ahura Mazdā, il
dio in cui coabitavano originariamente due spiriti, Vohū Manah, lo
spirito della buona intenzione, e Angrā Mainyu, lo spirito maligno.
Questi due spiriti, uniti nello stesso dio, esprimevano al tempo stesso
l’unità e la divisione, l’Uno e il Due. Con la loro unione, essi
dimostravano come inizialmente non vi fosse alcuna separazione tra
bene e male; solo in seguito iniziarono a litigare e allora divenne
necessaria la creazione del mondo. Nondimeno, Jung riscontra alcune
affinità anche tra la predicazione di Zarathustra e la dottrina del
cristianesimo. L’insegnamento primitivo di Zarathustra era
caratterizzato infatti, egli osserva, da una vera pietas spirituale: «più che
le opere esteriori contava la Gesinnung, l’atteggiamento morale. La sua
dottrina insegnava che, come si commetteva peccato nella realtà
esterna, si può commettere peccato dentro di sé, e che si tratta di una
cosa altrettanto malvagia»22.
Interessante è, peraltro, tanto l’interpretazione archetipica della figura
di Zarathustra, che Jung identifica con l’esperienza primordiale del
Vecchio Saggio, quanto il parallelo che egli istituisce tra la dottrina
zoroastriana, in cui dopo un indeterminato periodo cosmico fa la propria
apparizione un Saošyant – un mietitore, un redentore – il quale dona
all’uomo l’insegnamento di una nuova rivelazione o rinnova verità antiche,
e la dottrina cristiana, dove la stessa idea riappare, sia pure mutata di
senso, nella forma dell’enantiodromia, nell’alternanza/oscillazione degli
opposti23: dallo stesso libro dell’Apocalisse si apprende che dopo che
l’insegnamento di Cristo ha raggiunto il suo effetto, allora viene concessa a
Satana, per un periodo indeterminato, l’opportunità di mettere in atto
malvagità di ogni genere; questi mostrerebbe, così, la sua natura di
21 C.G. JUNG, Nietzsche’s «Zarathustra». Notes of the Seminar given in 1934-1939, ed. by J.L.
Jarrett, Princeton University Press, Princeton 1988; Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario
tenuto nel 1934-39, tr. e c. di A. Croce, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino 2011.
22 C.G. JUNG, Lo Zarathustra di Nietzsche, cit., p. 11.
23 Jung utilizzava l’espressione eraclitea «enantiodromia» nel senso di «corsa nell’opposto»
– la tendenza a dar luogo al proprio opposto – già nei suoi scritti dei primi anni venti (cfr.
C.G. JUNG, Lo Zarathustra di Nietzsche, cit., p. 15, nota 25).
La riscrittura del passato
89
«Saošyant negativo che fa la propria comparsa nel momento in cui il regno
positivo di Cristo si approssima alla sua conclusione»24.
Zarathustra medesimo si manifesta, dunque, come un Saošyant che
apparirebbe in un determinato periodo cosmico, dando avvio alla propria
carriera, appunto come avevano fatto i Saošyant precedenti – Cristo o
l’Anticristo. Egli, infatti, entra in scena nel momento in cui si verifica un
evento epocale, che rende necessaria la sua presenza, la “morte di Dio”: se
Dio muore, occorre per l’uomo un nuovo orientamento, una nuova
rivelazione. Solo Zarathustra, come archetipo del Vecchio Saggio, può
donare all’uomo una nuova verità.
Cosa ha da dire Zarathustra all’umanità? Egli deve insegnare all’uomo
ciò di cui manca, ciò che l’uomo teme o disprezza. Il suo compito è
restituire ai poveri la loro ricchezza e ai saggi ciò che essi hanno perduto,
cioè la loro follia. La sua vera intenzione, sottolinea Jung, è quella di dare
avvio all’enantiodromia, offrendo la compensazione degli opposti.
Non è qui il caso di porre la questione se tale compensazione sia o
meno una forma di “redenzione”, dal momento che in Nietzsche, in fondo,
la redenzione non è quella che succede al peccato, ma quella che lo
anticipa, togliendo il peccato e la colpa prima ancora che essi siano. In
questo orizzonte redentivo non bisogna attendere il futuro, l’al di là del
tempo, non c’è alcuno iato temporale tra la caduta e il riscatto, la rovina e
la benedizione, proprio perché manca la separazione del bene dal male,
anzi siamo già «al di là del bene e del male».
Da parte sua, Jung ritiene di dovere considerare questo simbolismo in
riferimento al piano soggettivo, e ciò significherebbe che quando
Zarathustra, «nauseato dalla propria consapevolezza, sarà disceso fino ai
livelli più bassi dell’umanità nel suo complesso, sarà proprio lui quel saggio
che verrà ricompensato, per la propria saggezza, con la follia»25.
Proviamo invece a trasferirci dal piano soggettivo ad altro livello di
discorso. L’ipotesi che qui presento è che l’offerta della “compensazione” –
affinché «i saggi tra gli uomini tornino a rallegrarsi della loro follia e i
poveri della loro ricchezza»26 – consiste nel riconoscere la parzialità che
dimora nella saggezza – la hegeliana coscienza giudicante, lo spirito agente
Ivi, p. 15.
Ivi, p. 23.
26 F. NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, in Werke, cit., Bd. 6.1,
p. 5; Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, a c. di G. Colli-M. Montinari,
Adelphi, Milano 2011, p. 3.
24
25
90
Pio Colonnello
-, fino a quando non venga ricomposta l’unità. Solo che in questo caso,
l’unità non è la ricomposizione di ogni conflitto, il superamento delle
opposizioni e delle scissioni; si tratta, piuttosto, di un’unità che conserva
nel suo senso una tensione alla dualità, una “vocazione” enantiodromica.
Proviamo ora a rileggere un passo iniziale dello Zarathustra, lo stesso
che commenta Jung, partendo dall’ipotesi ermeneutica poc’anzi avanzata.
Il passo in questione è il seguente:
Zarathustra prese a discendere da solo la montagna, senza incontrare
alcuno. Ma giunto alle foreste, ecco si trovò dinanzi un vegliardo, che, in cerca
di radici per la foresta, aveva lasciato la sua pia capanna. E così parlò a
Zarathustra il vegliardo: «Questo viandante non mi è sconosciuto: alcuni anni
fa è passato di qui. Zarathustra era il suo nome; ma egli si è trasformato.
Portavi allora la tua cenere sul monte: oggi vuoi portare nelle valli il tuo fuoco?
Non temi i castighi contro gli incendiari? Sì, riconosco Zarathustra. Puro è il
suo occhio, né disgusto si cela sulle sua labbra. Non incede egli a passo di
danza? Trasformato è Zarathustra, un bambino è diventato Zarathustra.
Zarathustra è un risvegliato: che cerchi mai presso coloro che dormono?»27.
Si può essere senza dubbio d’accordo con Jung nel ritenere che il vegliardo
della foresta e Zarathustra si conoscono già, anzi sembra vi sia una segreta
identità tra i due – sebbene l’anacoreta rappresenti lo spirito cristiano delle
origini, ancora ignaro che il cristianesimo è giunto alla fine della propria
parabola. Il fatto stesso che si tratti di un eremita corrisponde agli ideali del
cristianesimo delle origini. Peraltro, l’annuncio della morte di Dio gli è dato
dallo stesso Zarathustra: «Questo santo vegliardo non ha ancora sentito dire
nella sua foresta che Dio è morto». L’anacoreta, lo spirito cristiano delle origini,
tuttavia ricorda che Zarathustra ha portato, in un tempo immemorabile, la
proprie ceneri sul monte, cioè ne ricorda la morte. Ora, invece, se lo trova
dinanzi trasfigurato: un bambino, un risvegliato, colui che è venuto a portare il
fuoco nelle valli per destare coloro che dormono ancora.
Zarathustra, l’archetipo del Vecchio Saggio, ora ne incontra un altro? O
incontra la sua vecchia identità, quella che egli si è lasciato alle spalle, nella sua
morte e trasfigurazione? Ovvero si tratta di due diverse rappresentazioni della
stessa figura archetipica?
Ora, è lo spirito ringiovanito che irrompe nel presente, dal momento che
lo spirito del cristianesimo ha dinanzi a sé solo il suo passato, senza potere
rivolgere il suo sguardo al futuro. Davvero singolare, a questo riguardo, è il
27
Ivi, 6; tr. it., cit., p. 4.
La riscrittura del passato
91
parallelo istituito da Jung tra l’archetipo del Vecchio Saggio e lo spirito
Paraclito, promesso da Cristo al momento della sua morte, come effetto
postumo della sua rivelazione: «Cristo lasciò tra noi o promise, secondo il
dogma, l’avvento del Paraclito, il consolatore, in altre parole lo spirito, come
nella discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste; si tratta dell’effetto
postumo della rivelazione cristiana, dello spirito che l’apparizione di Cristo
sulla terra ha lasciato dietro di sé. La sua apparizione fu come l’esplosione di
una granata, dopo la quale lo spirito continua ad aleggiare per un po’ e poi,
lentamente, si ritrae di nuovo sullo sfondo. A questo vegliardo potrebbe
dunque essere attribuito il nome di Paraclito: è lo spirito residuo del
cristianesimo, ed è sul punto di ritirarsi nella natura»28.
L’anacoreta dunque sa che è giunta la sua fine, la sua dissoluzione. E lo
sa anche l’altra grande figura emblematica che Zarathustra incontra più
avanti, l’«ultimo papa», il quale proclama la morte del «santo della foresta,
che cantando e mugolando lodava continuamente il suo Dio. Quando
trovai la sua capanna, non c’era già più, – c’erano invece due lupi che
ululavano per la sua morte – infatti tutte le bestie lo amavano. Allora
scappai via. Dunque ero venuto inutilmente in queste foreste e montagne?
Allora il mio cuore decise ch’io cercassi un altro, il più devoto di coloro
che non credono in Dio – ch’io cercassi Zarathustra!»29.
Zarathustra stesso, il più devoto tra gli atei, appare così il Consolatore,
il riconciliatore dell’uomo con il suo destino. Anche qui vi è l'idea di una
riconciliazione vivente, di sanare le «ferite dello spirito, senza lasciare
cicatrici», come abbiamo già visto nel testo della Fenomenologia hegeliana.
Anche qui si fronteggiano, di volta in volta, due figure: ora Zarathustra e il
vecchio anacoreta, ora Zarathustra e l’«ultimo papa», e così via. Tuttavia,
la riconciliazione che sancisce il perdono – che hegelianamente una
28 C.G. JUNG, Lo Zarathustra di Nietzsche, cit., p. 38. Non è qui il caso di interrogarsi
se il termine “Paraclito” (Paràkletos), “colui che è chiamato accanto” – appartenente alla
letteratura giovannea – abbia davvero il senso di “Consolatore” o se piuttosto questo
significato derivi da una dubbia etimologia e non sia attestato nel Nuovo Testamento.
Certo è che la venuta del Paraclito segna una nuova tappa nella storia della presenza di
Dio tra gli uomini. Al termine dell’ultima cena, Cristo annunzia che la sua venuta, al
momento delle apparizioni pasquali colmerà di gioia i discepoli (Gv 16, 22), ma la sua
presenza non sarà più di ordine sensibile, bensì “spirituale”. Il Padre donerà loro «un
altro Paraclito» (Gv 14, 16) che Gesù stesso manderà. Pur essendo “diverso” da Gesù,
il Paraclito, in quanto “Spirito di verità”, porta a perfezione la presenza di Cristo
stesso.
29 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, cit., p. 318; tr. it., cit., p. 301.
92
Pio Colonnello
coscienza concede all’altra coscienza – è di ben diversa natura. Ora non si
tratta dell’afferramento di sé esattamente nel suo contrario, dell’«Io esteso
fino alla dualità», dunque di restaurare l’identità, ovvero di ricostituire
l’eguaglianza dell’Io con se stesso.
Sanare le ferite dello spirito – secondo l’ipotesi ermeneutica che qui
presento – ha ora il senso di un “dono intensivo”, del per-dono, come una
forma di pietas (Frömmigkeit)30: è il dono della “compensazione”: restituire
ai poveri la loro ricchezza e ai saggi ciò che essi hanno perduto. Ma occorre
fare attenzione, perché pietas non indica, in questo contesto,
semplicemente la messa in mora delle strutture “necessitanti” della ragione
teoretica; la pietas, come forma di “dono intensivo” sta a indicare,
piuttosto, una sorta di restituito in integrum del passato remoto. Vero è che,
nella dottrina di Zarathustra, il passato dipende dal futuro e Zarathustra è
appunto l’uomo del futuro, colui che cancella la «menzogna» del passato e
ne riabilita la verità nell’orizzonte del futuro – mentre la figura del vecchio
anacoreta, che vive nell’oblio di verità profonde, all’oscuro della morte di
Dio, si inabissa nel gorgo senza fondo del passato: giustappunto nella messa
in questione della linearità seriale del tempo, nella trasformazione del “giàstato”, del «così-fu», nella forma del futuro anteriore («così-avrò-volutoche-fosse»), dunque nel singolare rapporto delle ekstasi temporali tra loro,
entra finalmente in gioco la riconciliazione, il rinnovato accordo dell’uomo
con il suo proprio destino.
Abstract
Why the nexus memory/oblivion/forgiveness? The paper thinks back
to the main themes linked to that conceptual constellation, beginning from
Hannah Arendt’s and Paul Ricoeur’s thinking, crossing through the
complex network of meanings the subject forgiveness takes on in Hegel’s
Phenomenology of Spirit, up to the problematic territory of Nietzsche’s
Zarathustra. Once again, one should deal with a paradox: it is common
belief that past cannot be changed, that it is given, since it sinks into the
blind night of necessity; on the contrary, future is mostly considered
uncertain, open, because it is the indefinite reign of possibilities. Now, is
the paradox actual or just illusory? In the face of reality, that is the notNon a caso, Zarathustra è definito Fromm, pio, devoto, anzi Frömmisten, “il più pio”. Cfr.
F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, cit., p. 318; tr. it., cit., p. 301.
30
La riscrittura del passato
93
erasable nature of the past, their being (or appearing) “petrified”, does the
sense of events result as fixed – or not-fixed – once for all, since the moral
responsibility, linked to the guilt-feeling towards the past, could be, from
time to time, made lighter or heavier? Is it possible, through the present
men reconciliation with their own past, to replace the covenant with
destiny? These are the questions the present paper is hinged on.
ANNABELLA D’ATRI
Metafisica e leggi di natura in D.M. Armstrong
Il filosofo australiano David Malet Armstrong, nato a Melbourne nel 1926
e attualmente professore emerito presso l’Università di Sydney, si è
conquistato un posto di primo piano nel panorama della filosofia analitica
contemporanea a partire in particolare dal testo del 1978 in due volumi,
Universali e Realismo Scientifico1. In precedenza, dopo essersi dedicato al
tema della visione in G. Berkeley2, filosofo del quale aveva curato anche
un’edizione delle opere, aveva comunque ottenuto una vasta notorietà
nelle discussioni filosofiche grazie alla netta posizione assunta nella
questione del rapporto mente/corpo, a favore di una teoria materialista
della mente3. Intendiamo qui di seguito analizzare le tesi principali
contenute nell’opera del 1978 e indicare quali di esse sono state da
Armstrong riprese e articolate nelle opere successive, in particolare in Cosa
è una legge di natura del 1983. Il nostro obiettivo principale è mostrare
quanto sia rilevante per il suo sistema filosofico la posizione di base che
Armstrong assume in difesa della metafisica: il filosofo australiano saluta
infatti con entusiasmo il fatto che essa, dopo la dichiarazione della sua fine
Si vedano D.M. ARMSTRONG (1978a) e (1978b).
Si veda D.M. ARMSTRONG (1960).
3 Si tratta di D.M. ARMSTRONG (1993). La prima edizione dell’opera risale al 1968 e
anche in questo primo sistematico lavoro si rivela l’efficacia del metodo, sia d’indagine che
espositivo, di Armstrong il quale presenta le proprie tesi in un serrato confronto critico
con le più accreditate teorie filosofiche, non limitandosi a quelle contemporanee. Ma,
come ha di recente riconosciuto lo stesso Armstrong, le sue tesi giovanili sulla mente non
sono riuscite del tutto a risolvere alcune delle questioni fondamentali che riguardano la
natura del mentale, in particolare le questioni che derivano dal riconoscimento del
carattere intenzionale della coscienza e dalla percezione delle qualità: «So in my philosophy
of mind I face difficulties from the alleged qualia and from the phenomenon of
intentionality that seem rather greater that anything I am aware of it in the rest of my
ontological scheme» (D.M. ARMSTRONG 2010 p. 115). Una discussione della filosofia della
mente di Armstrong, che non rientra comunque nelle finalità del pesente lavoro, richiede
necessariamente, in quanto la presuppone, l’analisi delle opzioni metafisiche di fondo dello
stessso Armstrong.
1
2
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 95-118
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606437
95
96
Annabella D’Atri
operata dal positivismo logico4, sia tornata a essere di nuovo rispettabile.
Non esita addirittura a caratterizzare questa fase del pensiero filosofico
come una vera e propria “svolta ontologica”5 che farebbe seguito alla nota
“svolta linguistica” del Novecento.
1. Predicati e proprietà. L’opera dedicata agli universali è divisa in due
parti, di cui la prima di carattere storico-critico, mentre la seconda è volta
a presentare una teoria sistematica degli universali, anche se lo stretto
intreccio fra le due parti è reso indispensabile dal metodo di Armstrong:
egli espone infatti il proprio realismo sugli universali come la teoria che
risulta preferibile in base a un mero calcolo razionale dei costi e dei
benefici dei sistemi esaminati, calcolo operato grazie all’analisi critica dei
vantaggi e degli svantaggi in termini di coerenza e completezza delle
diverse teorie in campo, analisi che egli compie appunto nel primo
volume.
Ma qual è la questione di fondo, l’oggetto principale dell’interesse di
Armstrong che lo conduce, a conclusione dell’argomentazione, ad
affermare l’esistenza degli universali in re? La questione è dichiaratamente
di tipo linguistico: riguarda la natura della proposizione e la sua struttura
minima, che corrisponde all’atto della predicazione, all’attribuzione di un
predicato a un soggetto.
Questo punto di partenza dell’analisi, al quale Armstrong resterà
sempre fedele, è fortemente condizionato dai suoi primi interessi in campo
filosofico, maturati, come più volte ricorda, quando, negli anni 1949-50
frequentava le lezioni di John Anderson il quale coniugava un rigido
naturalismo con la tesi, sorprendentemente analoga a quanto sostenuto in
4 È lo stesso Armstrong a indicare lo stato attuale della metafisica contemporanea
come la fase della sua riabilitazione, della riconquista della sua rispettabilità, dopo il
discredito su di essa gettato dal positivismo logico e dalla filosofia Oxoniense del
linguaggio ordinario: «The years when analytic philosophy was dominated first by the ideas
of the logical positivists and then by the ‘ordinary language’ approach that become
fashionable in Oxford were thankfully long done. Gone also were the objections that were
made to traditional metaphysics by these philosophers. Metaphysics is now respectable
again.» (D.M. ARMSTRONG 2010 p. VIII).
5 Armstrong (D.M. ARMSTRONG 1993b, p. 144) adopera quest’espressione nel
presentare J. Fales, allievo di G. Bergmann all’Università dell’Iowa, ricordando lo
splendido isolamento riservato dal mondo accademico e dalla tradizione analitica alle
riflessioni ontologiche avanzate in questa Università.
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
97
Europa da Russell e Wittgenstein6, che la realtà ha una struttura
proposizionale: «Io sono stato comunque influenzato molto
profondamente dalla teoria proposta dal mio docente a Sydney, il filosofo
scozzese John Anderson, secondo la quale la realtà, benché indipendente
dalla mente che la conosce, ha una struttura ‘proposizionale’».7
Anche se Armstrong aderisce pienamente a questa formidabile impresa
filosofica, definibile come una vera e propria «svolta fattualista» della
filosofia, che trova il suo principale motivo di ispirazione nelle prime
proposizioni del Tractatus di Wittgenstein8, ciò che caratterizza in maniera
6 In verità, come ricorda Armstrong (ARMSTRONG, 1993a, p. 96), in Australia, dopo la
seconda guerra mondiale, la filosofia era fortemente divisa fra i seguaci di Anderson
dell’Università di Sydney e quelli di Wittgenstein, in Melbourne. Armstrong ricorda anche
con orgoglio di essere stato l’unico caso di laureato di Sydney a essere chiamato a insegnare
a Melbourne.
7 D.M. ARMSTRONG (1999, p. 3). La stessa considerazione viene da Armstrong fatta
nel corso dei seminari tenuti alla City University di New York nel 2008: «Interestingly,
my own teacher in Sydney, John Anderson, used to argue that reality was ‘propositional’
and appeared to mean much the same thing as Russell and Wittgenstein» (ARMSTRONG
2010, p. 34).
8 Com’è noto, la proposizione 1.1 del Tractatus dice:«Il mondo è la totalità dei fatti,
non delle cose», e la 2: «Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose» (L.
WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, trad. it. A. G. Conte, Torino, Einaudi, 1964,
p. 5). Ci sembra opportuno, per i lettori di lingua italiana, richiamare un’importante
questione di traduzione. Questo è il testo tedesco della proposizione 1.1:«Die Welt is die
Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge», la cui traduzione italiana non crea eccessivi
problemi; ma la questione si complica se la mettiamo in relazione con la proposizione 2,
che definisce i fatti: «Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten».
Come si vede, in italiano non emerge bene la differenza sia fra i diversi sensi di “cosa”, sia
fra la semplice cosa e i rapporti fra cose, che naturalmente solo una successiva attenta
analisi dell’opera faranno emergere. Infatti “Sachverhalt” viene definito in 2.01 «eine
Verbindung von Gegenständen (Sachen, Dinge)», quindi come una combinazione di
oggetti, che possono essere o cose o altre entità. Veniamo invece alle traduzioni inglesi; la
prima, del 1922 è di C.K. OGDEN e F.P. RAMSEY, London, Routledge & Kegan Paul,
1922, con introduzione di Bertrand Russell. Così traduce la proposizione 1.1: «The World
is everything that is the case» e così la 2.:«What is the case, the fact, is the existence of
atomic facts». Qui c’è una lieve modifica del senso originario: definendo fatto come
l’insieme esistente di fatti atomici, si evidenzia l’esistenza di minime unità di senso, ma si
elimina l’esplicito riferimento ai rapporti fra cose (sache) ed al fatto che questi fatti atomici
siano a loro volta combinazione di “objects”. Invece la traduzione di D.F. PEARS e B.F.
MCGUINESS, New York, Humanities Press, 1961, alla quale fa riferimento Armstrong
traduce la 2 come: «What is the case (a fact) is the existence of state of affairs», traduzione
che appunto contiene il termine usato da Armstrong, ma che ha anche il vantaggio di
evidenziare il senso di ‘relazione’ rappresentato dal termine “affair”. Il lettore italiano,
98
Annabella D’Atri
peculiare il suo approccio alla questione è, da una parte, il rispetto per le
teorie classiche della predicazione, a partire innanzitutto dal Parmenide di
Platone, e, dall’altra, il rifiuto di un’impostazione meramente “semantica”.
Tale rifiuto si sintetizza nel negare che il riconoscimento delle proprietà
e del loro statuto ontologico dipenda essenzialmente dal bisogno di
assegnare un riferimento, un significato, ai predicati adoperati nei diversi
linguaggi. Armstrong intende operare un’«emancipazione della teoria degli
universali dalla teoria semantica»9 , il che significa che non dovremmo
aspettarci una corrispondenza biunivoca fra predicati (ovviamente qui
“predicato” va inteso nel senso di ‘tipo di predicati’, sorvolando sulle
differenze linguistiche negli enunciati di predicati che si riconosce abbiano
identico significato) e universali o proprietà. Potranno esserci predicati ai
quali non corrispondono universali, così come, viceversa, universali ai
quali non corrispondono predicati. Come esempi del primo tipo
Armstrong porta quelli di ‘unicorno’ (o ‘essere unicorno’) e di ‘essere più
veloce della luce’10. Ovviamente non è invece possibile fornire esempi di
casi del secondo tipo; per questo secondo caso sorge quindi la seguente
questione: cosa ci porta a sostenere che questi universali esistano? La
risposta appare fin troppo semplice, derivando da un’asserita analogia con
la teoria della percezione: così come è concepibile e ragionevole sostenere
che esistano oggetti che non sono percepiti né da noi né da altri,
similmente è concepibile e ragionevole sostenere che degli universali, non
espressi e non detti, esistano11.
Ed ancora, una volta che la questione è stata posta in termini così
semplici ed evidenti, non può non nascere un’ulteriore domanda: come
mai i filosofi del passato non hanno colto questa analogia? E soprattutto
come mai hanno condotto la discussione sugli universali per lo più
presupponendo che a ogni predicato corrispondesse un universale,
rendendo così oscuro e ‘sovraffollato’ il mondo degli universali?
Armstrong non ha dubbi: «È l’influenza dell’argomento che parte dal
Significato che ha così spesso falsato, e così fatalmente, il Problema degli
ormai avvezzo al termine “stati di cose” in Wittgenstein potrebbe non riconoscere
immediatamente, a differenza dal lettore di lingua inglese, la derivazione dal Tractatus del
termine “stato di fatto” con il quale si traduce “state of affairs”, termine che, come
vedremo, è centrale nella metafisica di Armstrong.
9 ARMSTRONG (1978a, p. 6).
10 ARMSTRONG (1978b, p. 10).
11 Ivi, p. 13.
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
99
Universali. Se si concepiscono gli Universali come significati, e se si accetta
il criterio semantico per l’identità dei predicati, ne segue immediatamente
che ciascun predicato-tipo è associato con il suo universale proprio. Di
questa situazione poi i Realisti hanno avanzato un’interpretazione
inflazionaria, i Nominalisti una deflazionaria.» 12
L’analisi della contrapposizione fra posizioni Nominaliste e Realiste,
che è il tema del primo volume sugli universali, trova così il suo filo
conduttore nell’individuazione di una comune distorsione semantica: i
Realisti moltiplicano i loro universali, ne deprezzano il loro valore (li
‘inflazionano’), mentre i Nominalisti, non riconoscendo una moltitudine di
entità non empiricamente date, finiscono per non riconoscere alcun valore
agli universali (li ‘deflazionano’): sostengono infatti che esistono solo i
particolari. Quanto al problema dell’identità del significato, per darne una
spiegazione, seguono strade diverse, possono infatti ricondurlo o a) all’
identità del predicato, o b) a quella del concetto, o c) a quella della classe
(o d) dell’aggregato) di appartenenza, o e) alla somiglianza con un modello
paradigmatico.
E proprio in base al diverso criterio scelto per giustificare l’identità del
significato Armstrong individua le diverse forme di Nominalismo,
etichettandole rispettivamente come Nominalismo: a) del Predicato, b)
del Concetto, c) della Classe d) delle parti, o «Mereologico»13, al quale
Armstrong dedica un’attenzione minima, e) della Somiglianza. Egli
sottopone poi ciascun tipo di Nominalismo a una critica serrata e passa
inoltre al vaglio dell’analisi razionale quella forma di Realismo che è
definibile come “Trascendente” o “Platonico” in quanto fa corrispondere ai
significati e ai predicati delle entità non spazio temporali. Al termine delle
diverse, accurate, analisi, emerge come ipotesi metafisica più plausibile e
meno problematica un’altra forma di Realismo, quello immanente che
Armstrong spesso identifica con un Realismo di tipo “aristotelico”14.
Fra le critiche specifiche alle quali Armstrong sottopone i diversi tipi di
analisi dell’identità del significato, ve ne è però una di tipo generale, valida
per tutte le teorie elencate: egli mostra, attraverso la riduzione analitica,
Ivi, p. 11.
Questa ne è la definizione:«La teoria che analizza l‘avere la stessa proprietà, o essere
nella stessa relazione da parte di particolari nei termini di essere parte dello stesso
aggregato di particolare» (ARMSTRONG 1978a ,138).
14 Per l’interpretazione delle tesi aristoteliche nelle opere di Armstrong si veda D'ATRI
(2010).
12
13
100
Annabella D’Atri
come tutte finiscano per cadere in un regresso vizioso all’infinito. Sia il
Nominalismo del Predicato che quello del Concetto, classificabili come
soluzioni soggettiviste del problema degli Universali, dal momento che
collocano gli universali o nelle parole degli uomini o nelle loro menti15,
sono costretti a mettere in relazione due tipi diversi di entità: gli oggetti,
da una parte, e il nome o il concetto, dall’altra, trovandosi quindi a dover
ammettere sempre ulteriori relazioni intermedie fra le singole cose, cioè
gli esemplari particolari delle cose, e il predicato o il concetto. In questi
casi si dovranno allora ammettere concetti di concetti e predicati di
predicati, concetti e predicati di livello sempre superiore fino all’infinito16.
Nel caso invece del Nominalismo della Classe, che sostiene che attribuire a
diversi oggetti un unico predicato o un’unica proprietà corrisponde a
rendere ciascun oggetto membro di una classe, a generare il regresso
all’infinito è la relazione di ‘essere membro di’, che, essendo un predicato,
è necessario che a sua volta venga analizzato in termini di appartenenza a
una classe.
Lo stesso tipo di regresso che vige nel caso del Nominalismo della
Classe è valido nel caso del Nominalismo della Somiglianza. A questo
proposito occorre sottolineare che Armstrong prende in esame una forma
sofisticata di teoria della somiglianza: quella forma che, di fronte al
problema che si origina dal fatto che, per lo più, le cose hanno fra loro
differenti gradi di somiglianza e non sempre uno stesso grado, risolve tale
problema facendo riferimento all’idea di paradigma: «Il Nominalismo della
Somiglianza è la teoria che analizza l’avere una stessa proprietà o una stessa
relazione da parte dei particolari in termini dell’avere una somiglianza
sufficiente con qualche paradigma particolare».17
Ebbene, anche in questo caso, si ricade nel regresso all’infinito in
quanto è la relazione di ‘essere somigliante al paradigma’ che, a sua volta,
ha bisogno di essere analizzata in termini di somiglianza a qualche
paradigma al quale assomiglia. Se, per esempio, abbiamo analizzato ‘essere
bianco’ in termini di somiglianza a un dato oggetto paradigmatico della
ARMSTRONG (1978a, p. 25).
In effetti Armstrong distingue due tipi di regresso, che chiama rispettivamente: a)
regresso dell’oggetto, quello al quale abbiamo fatto riferimento e b) regresso della
relazione, quello che riguarda il significato della stessa relazione di “cadere sotto un
concetto o un predicato” o, viceversa, di ‘applicarsi a un oggetto da parte di un predicato o
un concetto’, ma ai fini della nostra analisi, necessariamente sintetica, questa distinzione
può essere trascurata.
17 ARMSTRONG (1978a, p. 138).
15
16
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
101
bianchezza, ci rimane comunque da analizzare la relazione di somiglianza, e
così di seguito.
Quindi, onde evitare queste forme viziose di regresso, è opportuno
ammettere che i predicati, o meglio, le proprietà degli oggetti,
corrispondano a degli universali. A tal proposito Armstrong riconosce che
il primo ad avere con chiarezza difeso la teoria degli universali è stato
Bertrand Russell. Questi scrive in The Problems of Philosophy del 1912:
Se vogliamo evitare gli universali bianchezza e triangolarità noi sceglieremo
un particolare pezzo di cosa bianca o un particolare triangolo e diremo che
qualche cosa è bianca o è un triangolo se ha una rassomiglianza col
particolare che abbiamo scelto. Ma allora la rassomiglianza ricercata deve
essere un universale. Poiché vi sono molte cose bianche, la rassomiglianza
deve stare fra molte paia di particolari cose bianche; e questa è la
caratteristica di un universale. Sarà inutile dire che vi è una somiglianza
diversa per ciascuna coppia, in quanto dovremmo dire che queste
somiglianze si somigliano fra loro, e quindi in ultimo saremo costretti ad
ammettere come un universale la somiglianza. La relazione di somiglianza
quindi deve essere una verità universale ed essendo stati forzati ad
ammettere questo universale, noi troviamo che non vale la pena di
inventare difficoltà ed inammissibili teorie per evitare di ammettere degli
universali come bianchezza e triangolarità18.
Russell però, nello stesso capitolo del libro, introduce il suo famoso
“terzo mondo” o mondo degli universali e dell’universale dice: «non è
nello spazio né nel tempo, non è né materiale né mentale: eppure è
qualcosa»19 . Russell, così, riconoscendo che gli universali hanno una realtà
altra da quella dello spazio e del tempo, diviene il massimo rappresentante
nel Novecento di quello che Armstrong chiama “Realismo Platonico”.
E comunque, questa è ora la questione cruciale che Armstrong affronta,
può questa concezione trascendente degli universali dar conto del
problema delle proprietà, rispondere cioè alla solita questione: cosa
significa per una cosa avere una proprietà (o essere in relazione con
un’altra cosa o altre cose), sfuggendo al regresso vizioso all’infinito, del
tipo di quelli ai quali abbiamo precedentemente fatto cenno?
La risposta di Armstrong è assolutamente negativa, anzi, è proprio nelle
ontologie di ispirazione platonica che emergono le maggiori difficoltà
18
19
RUSSELL (1922, pp. 150-151).
Ivi, p. 114.
102
Annabella D’Atri
logiche di analisi del concetto di proprietà. Sono quelle stesse difficoltà che
lo stesso Platone ha ben riconosciuto nel Parmenide, e che si sintetizzano nel
problema, che ha attraversato tutta la storia del pensiero occidentale, del
rapporto dell’uno con i molti, o nel problema dell’uno oltre i molti. Nel
Parmenide la questione viene posta, fra l’altro, per quanto riguarda il
rapporto della Forma o Idea con le cose: il problema sorge in quanto è
necessario che le cose partecipino delle Idee, ma, contemporaneamente,
anche che ne siano separate.
Questo è uno dei passi cardine del dialogo platonico:
Ma allora ciascuna realtà che partecipa, partecipa di tutta la forma o di una
parte? Oppure esiste un altro tipo di partecipazione oltre a questi?» «E
come potrebbe esistere?- rispose» «Ti sembra, dunque, che la forma sia
presente nella sua interezza in ciascuno dei molti, rimanendo essa una, o
come?» «Perché, che cosa lo impedisce, Parmenide?- chiese Socrate» «Se
fosse una e identica, sarebbe presente contemporaneamente nella sua
interezza nei molti, che però sono separati, e in questo modo essa sarebbe
separata da sé20.
Strettamente connessa con questa aporia, propria della teoria delle
Idee, lo stesso Platone inoltre coglie l’aporia derivante dall’argomento
del regresso all’infinito: analizzando l’idea di grandezza21 sostiene che,
se chiediamo cosa sia comune alla cosa grande e all’idea di grandezza,
immediatamete fa il suo ingresso una terza idea di grandezza che le
accomuna e così di seguito fino a che le idee diventano una pluralità
infinita.
Armstrong riconosce a Platone il merito di aver colto le aporie della
relazione fra cose e proprietà, e quindi gli riconosce una superiorità
filosofica rispetto ai platonici novecenteschi che hanno sorvolato sulle
aporie proprie del concetto di partecipazione, ma, fatto significativo,
quando si riferisce all’aporia presentata nel Parmenide, lo fa attraverso
l’interpretazione datane da Aristotele. Armstrong la chiama infatti
questione del “terzo uomo”, che è così citata da Aristotele in Metafisica
990 b15-17; anche attraverso questi indizi si rivela l’ intenzione, da
parte del filosofo australiano, di assumere la questione per come la
presenta Aristotele, cioè come uno dei motivi fondamentali di critica e
20
21
Parmenide, 131 a4- b2 in PLATONE (2004, p. 213).
Parmenide 132a2-b2 in PLATONE (2004, p. 215).
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
103
rigetto della teoria platonica delle Idee o Forme trascendenti. Ma
Armstrong nota anche che l’argomento del terzo uomo è valido contro
la teoria delle Forme trascendenti solo in quanto si assuma anche
l’auto-predicazione delle forme, cioè, per esempio, il fatto che la
Forma del bianco, la bianchezza, sia essa stessa bianca, cosa che, per
esempio, non è, mentre, invece, è vero che la forma del bianco è essa
stessa una forma, quindi che essere forma è un predicato che si applica
anche a se stesso22.
Pur senza volere addentrarsi nelle questioni esegetiche della teoria
platonica delle Idee, Armstrong ricorda come sorprendentemente la sua
introduzione da parte di Platone in Fedone 95-96, sia congiunta alla
questione della ricerca delle cause del divenire23. Sorprendentemente
perché proprio la necessità che le Forme agiscano come cause del mondo,
nota opportunamente Armstrong, indebolisce fortemente la tesi di Platone
che le proprietà delle cose sono dipendenti da forme o entità trascendenti:
È naturale dire sia che i poteri causali di un particolare sono determinati
dalle sue proprietà, sia che questi poteri sono determinati dall’essere in sé
del particolare e da niente oltre a questo. Ma se si accetta la teoria degli
universali trascendenti, le proprietà di una cosa non sono determinate dal
suo essere in sé, ma piuttosto dalle relazioni che essa ha con le Forme oltre
se stessa24.
Il bisogno di riconoscere che le cose hanno un potere causale su altre
cose che non può derivare dal rapporto delle cose con le loro Forme,
accanto alla ragione di carattere logico derivante dalla separatezza delle
Idee, sopra ricordata, è una seconda, forte ragione, che Armstrong adduce
contro tutte le teorie esplicative delle proprietà che non riescano a dar
conto dei poteri causali delle cose. Aderendo, di fatto, alla definizione
aristotelica della conoscenza come conoscenza delle cause, Armstrong
avanza come alternativa ontologica più plausibile la propria dottrina, che
Si riconosce chiaramente in questa precisazione l’applicazione da parte di Armstrong
alla teoria platonica delle Idee della questione dell’autoreferenzialità delle classi, o
paradosso delle classi, che, com’è noto, si origina dalla domanda: la classe che contiene
tutte le classi che non contengono se stesse, contiene se stessa?
23 Si tratta dei notissimi brani in cui Platone parla della sua insoddisfazione per la le
cause individuate dai naturalisti, e del suo bisogno di rifugiarsi nei logoi (da tradursi come
discorsi, o concetti e idee). Sull’interpretazione del brano si veda REALE (1987, p. 157).
24 ARMSTRONG (1978a, p. 75).
22
104
Annabella D’Atri
ammette la realtà spazio-temporale degli universali, con ciò riattualizzando
la critica di Aristotele alla teoria platonica delle idee come critica neoaristotelica al platonismo novecentesco di Russell.
2. Universali e stati di fatto. Come riesce il Realismo immanente, quello
che sostiene che gli universali esistono non separati dalle cose,quella forma
di Realismo alla quale aderisce Armstrong, a sfuggire alle questioni logiche
legate al problema del rapporto fra oggetti e loro proprietà, fra individui e
universali? Se tutti i paradossi derivano dalla questione sul tipo di relazione
sussistente fra questi due generi di entità, la mossa di Armstrong consiste
nel rigettare l’idea che fra particolari e universali esista una vera e propria
forma di relazione: la questione del tipo di relazione sorge infatti se
partiamo dal presupposto che le due realtà siano distinte e separate. E
questo presupposto, fallace, è condiviso anche dalla tradizione empirista, a
partire da Locke, il quale, distinguendo fra l’essenza nominale delle cose,
cioè l’idea complessa data dalla collezione di tutte le loro proprietà, e la
loro essenza sconosciuta, non risolve il problema del rapporto fra questo
misterioso substrato e l’idea della cosa come un insieme di proprietà.
Seguendo le critiche di Berkeley all’idea di sostrato di Locke, Armstrong
nota il perfetto parallelismo, quanto al problema della relazione fra cosa e
suo concetto, delle tesi di Locke con quelle del Platonismo Trascendente:
Tutto ciò che possiamo dire sulla relazione è che è la relazione che sussiste
fra il substratum e le proprietà. Non possiamo dire nessuna cosa interessante
sul substratum. Locke lo descrisse come “qualcosa che non so cosa sia”, ma
questa di fatto è una descrizione troppo lusinghiera! Egli suppone che il
substratum abbia un qualcosa, una natura, sebbene noi in tale natura non
possiamo penetrare. Ma nei fatti può non avere alcuna natura. Essa è mera
particolarità, mera mancanza di natura che si trova in una relazione
indescrivibile con le proprietà. Non è chiaro se così abbiamo ottenuto
un’ipotesi intellegibile25.
Di conseguenza, quindi, Armstrong sostiene che quello che si richiede è
appunto una forma di Realismo Immanente che sia di tipo non-relazionale,
tale cioè da presupporre che fra particolarità e universalità dei particolari
sussista un’unione molto più intima che non una semplice relazione.
Anzicchè presupporre la loro separatezza ontologica, che costringe poi i
25
ARMSTRONG (1978a, p. 105).
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
105
filosofi a dover dar conto della loro unione, si presuppone la loro unità
ontologica e si fa appello al processo di astrazione razionale come
responsabile della loro separatezza: fra i particolari e le loro prorietà esiste
solo una distinzione di ragione, o, per dirla con Duns Scoto, al quale
Armstrong fa esplicito riferimento, fra la “haecceitas”, o l’essere un dato
questo, di una cosa e le sue “forme” vige una “distinzione formale”26.
Armstrong perviene così alla nozione centrale della sua ontologia,
quella di “stato di fatto” (state of affairs)27:«Uno stato di fatto è definito
come il possedere una proprietà da parte di un particolare o l’essere in
relazione da parte di due o più particolari»28. Come si può notare, quindi,
per Armstrong sono universali sia le proprietà (universali monadici, a un
termnine) che le relazioni (universali a più termini), ma sia le une che le
altre rispondono a quello che Armstrong chiama il Principio di
Istanziazione, che afferma che per ciascun universale a un numero di
termini n, esiste almeno un numero n di particolari che lo istanziano. Nel
caso più semplice, quello dell’universale monadico, o a un solo termine, ci
sarà almeno un particolare che possiede quella proprietà.
In maniera speculare, se guardiamo la cosa dal punto di vista dei
particolari, questi rispondono al Principio che, per ciascun particolare x,
deve esistere almeno un universale U, una proprietà o una relazione tale
che x sia U. I due principi insieme, chiamati da Armstrong di
“Istanziazione” e di “Rigetto dei particolari nudi”, contraddistinguono il
Realismo Immanente teorizzato da Armstrong. Sono essi sufficienti a
rappresentare la concezione ontologica di Armstrong, quell’ipotesi
generale sul mondo che fa degli stati di fatto le entità di base?
Su questa questione Armstrong è particolarmente preciso: egli parte
dalla distinzione, operata da D.C. Williams fra “ontologia analitica” e
Armstrong ritiene che il concetto di hacceitas di Scoto corrisponda alla nozione
aristotelica di τóδε-τι (un certo-questo), per come viene da Aristotele presentato in
Categorie, 3b 10-17 (in ARISTOTELE 1989, pp. 313-315), laddove in verità Aristotele
distingue fra un certo-questo, riferito appunto al mero esssere un particolare senza proprietà
alcuna, o sostanza prima, (come direbbe la metafisica contemporanea, un particolare
“nudo”, bare) e l’essere un certo-quale in quanto appartenente a una specie, o avente una
sostanza seconda. Armstrong, che non condivide la distinzione aristotelica fra predicazione
accidentale e sostanziale, e, di conseguenza, neanche il concetto di sostanza seconda, in
questo caso coerentemente si richiama ad Aristotele solo incidentalmente.
27 Come ricordato nella precedente nota 6, il termine corrisponde alla traduzione
inglese di Sachverhalt introdotto da Wittgenstein.
28 ARMSTRONG (1978a, p. 114).
26
106
Annabella D’Atri
“cosmologia speculativa”29, per affermare che la teoria degli stati di fatto
esaurisce la propria concezione ontologica più generale, quella che si
occupa appunto preliminarmente di decidere in generale sul tipo di realtà
costituita dai ‘mattoncini’ del nostro mondo che, come ebbe a dire lo
stesso Armstrong, corrispondono alle ‘pepite’ che lo compongono, ma
non sono sufficienti a descriverlo nella sua complessità. Tocca poi a
un’altra parte della conoscenza, quella che Williams chiama appunto
“cosmologia descrittiva”, ma che molti chiamano “metafisica”, indicare le
caratteristiche specifiche delle entità di base, individuarne gli universali che
le costituiscono, farne un ‘inventario’ preciso. La metafisica risulterebbe
così distinta dall’ontologia, che, quest’ultima, sarebbe dottrina a essa
preliminare, e che, individuando le caratteristiche necessarie degli enti, si
occuperebbe, per dirla alla maniera aristotelica, dell’essere in quanto
essere30. Orbene, per Armstrong, i due Principi sopra indicati, che
specficano le caratteristiche generali e necessarie di ciò che è, cioè degli
stati di fatto, appartengono appunto all’ontologia, o metafisica
preliminare. Ma per fare l’inventario del mondo devono intervenire gli
scienziati: sono loro che individuano gli universali, che ci dicono come è
fatto il mondo. Per questo Armstrong aggiunge agli attributi che
caratterizzano il proprio Realismo anche quello di “Scientifico”.
Nonostante il riconoscimento delle competenze specifiche degli
scienziati però il nostro filosofo può permetersi, proprio sulla scorta delle
dottrine predicate dagli scienziati, anche di avanzare delle ipotesi generali
su come sia fatto quel mondo che egli ritiene costituito da stati di fatto. La
prima ipotesi che Armstrong avanza è che esso corrisponda a un unico
sistema spazio-temporale, ipotesi che gli consente anche di identificare
ogni particolare con la sua posizione nello spazio-tempo: tale ipotesi è
propria della dottrina che egli definisce “Naturalismo”.
29 L’articolo di Williams, che contiene questa distinzione, “On the Elements of Being”,
The Review of Metaphysics 7 (1953), pp. 3-18, è ora tradotto in italiano con il titolo
“L’alfabeto dell’essere” in VARZI, (2008, pp. 340-356).
30 Si veda a questo proposito come viene presentata la questione da VARZI (2005, pp.
27-28): «nella sua dimensione formale l’ontologia si occuperebbe invece di ciò che esiste
non al fine di redigerne un inventario dettagliato né al fine di specificarne la natura, bensì
sotto il profilo generalissimo delle sue caratteristiche necessarie. […] Così concepita,
l’ontologia formale è dunque molto vicina a quella teoria dell’essere in quanto essere che per
Aristotele era l’ontologia tout court: si occupa dell’essere indipendentemente dalle sue
diverse manifestazioni.»
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
107
Così tutte le caratteristiche del Realismo di Armstrong, con le quali
egli di volta in volta lo designa, ci sono ormai note: si tratta di un Realismo
Immanente, Aristotelico, Scientifico, associato al Naturalismo. La
particolrità della metafisica di Armstrong, che ne fa la sua marca tipica, è
infatti la tesi che il realismo degli universali sia necessario per continuare a
credere nell’efficacia della conoscenza e nelle verità da essa predicate.
Senza un loro saldo ancoraggio nella realtà metafisica quindi anche le
leggi di natura, che sono ricercate dagli scienziati per dar conto dell’ordine
e della regolarità che il mondo manifesta, diventano facile bersaglio dello
scetticismo radicale: la loro necessità, a partire da Hume, risulta di fatto
derubricata in quanto viene ricondotta proprio a quella regolarità di cui le
leggi di natura dovrebbero essere il fondamento.
3. Critiche al Regolarismo. Nel testo del 1983, dedicato a definire le leggi
di natura, Armstrong sviluppa appunto la sua critica nei confronti della
cosiddetta teoria “Regolarista” delle leggi, quella che, richiamandosi a
Hume, sostiene che la necessità che attribuiamo alle leggi scientifiche
dipenda unicamente dall’associazione d’idee, in base a cui prevediamo
qualcosa di ancora non osservato a partire dalla collezione di fatti simili
osservati. La nostra idea di connessione necessaria, com’è noto, si fonda
secondo Hume unicamente sulla regolarità nel susseguirsi dei fenomeni.
Ma, come Armstrong sottolinea con forza, la capacità di poter inferire
qualcosa di nuovo dai fenomeni osservati non è solo compito specifico della
scienza, ma anche una delle capacità più importatnti per la vita stessa degli
esseri umani; quindi una spiegazione delle leggi che si limiti semplicemente
a identificarle con la regolarità della natura mina dalle fondamenta non solo
la conoscenza scientifica ma anche le credenze e le convinzioni del senso
comune, che sono alla base dei comportamenti umani e del vivere
quotidiano. Rimane inoltre la questione banale, ma assolutamete sensata:
come potrebbe essere possibile che gli uomini comuni riescano nel predire
fenomeni come, per esempio, un fatto scontato quanto vitale che il fuoco
brucerà, se nella realtà non ci fosse qualcosa che garantisca e fondi simili
previsioni e inferenze? La stessa obiezione è naturalmente valida a
proposito delle previsioni, certamente più complesse, della conoscenza
scientifica. Quindi, questo il ragionamento lineare di Armstrong, solo una
teoria Realista, quale quella da lui esposta in Universali e Realismo Scientifico,
è in grado di rispondere agli attacchi dello scetticismo e di fondare la
conoscenza sull’esistenza reale degli universali.
108
Annabella D’Atri
Inoltre, applicando anche in questo caso il metodo dialettico in senso
aristotelico, procedendo cioè attraverso la critica delle tesi contrapposte,
metodo che rimane fra le caratteristiche più notevoli della sua filosofia, il
pensatore australiano parte dall’esame della teoria humeana della
regolarità, per mostrare la necessaria presenza in essa di una dose minima
di realismo: la teoria infatti deve assumere come dato, base su cui fondarsi,
proprio la regolarità della natura, che quindi viene assunta come reale.
Ricordando come l’obiettivo polemico di Armstrong sia quello di
sconfiggere lo scetticismo derivante dalle teorie regolariste della causalità,
potremmo aggiungere che Armstrong intende sconfiggere il suo
avversario, lo scetticismo, sul suo stesso terreno; con ciò seguendo un
ragionamento analogo a quello messo in atto dal “realista” Cartesio, il
quale, per contrastare le tesi degli scettici del Cinquecento, aveva
l’obiettivo di rifondare, proprio a partire dal meccanismo del dubbio, una
nuova metafisica sistematica.
Armstrong sostiene a tal proposito che, se, come spesso si fa, si associa
la teoria della regolarità, o Humeana, con posizioni Nominaliste in
metafisica, non si riesce a spiegare come sia possibile individuare delle
regolarità in natura, non si comprende cioè come sia possibile riconoscere
che a cose identiche seguono cose identiche. Questa prima critica alla
teoria della Regolarità corrisponde infatti perfettamente alle critiche di
soggetivismo, che Armstrong ha già avanzato nei confronti delle teorie
Nominaliste: in base a quale criterio, fra le tante proprietà delle cose che
osserviamo, riusciamo a distinguere quelle che danno luogo a regolarità:
«la versione Realista della teoria delle leggi come Regolarità, per lo meno,
dovrà ammettere gli universali. Come altrimenti sarà possibile dire che
diverse istanze di una certa uniformità sono oggettivamente tutte istanze
dello stesso fenomeno?»31.
Comunque, anche concedendo che la teoria Regolarista si converta a
questo Realismo minimo, contro di essa resterebbero altre serie obiezioni
che Armstrong articola nelle seguenti argomentazioni:
I. La regolarità non è sufficiente: a) ci sono dei casi in cui è possibile
osservare regolarità alle quali non sono associate leggi alcune, o almeno
non siamo indotti a ritenere leggi tutte le regolarità che osserviamo in
natura: il fatto, per esempio, che in una stanza tutti portano un orologio da
polso non indica che via sia una legge di natura che lo sancisca.32 Ci
31
32
ARMSTRONG (1983, p. 16).
Ivi, p. 17.
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
109
potrebbero anche essere delle uniformità locali, valide solo in un certo
spazio, o tempo, ma non potrebbero essere considerate leggi in quanto a
queste ultime attribuiamo necessariamente l’universalità.
b) Esistono inoltre delle possibilità fisiche non realizzate, cioè dei
fenomeni derivabili da leggi che tuttavia, per una serie di circostanze, non
si sono mai realizzati. In questi casi i teorici della Regolarità non
vedrebbero la legge o la scambierebbero con qualcosa d’altro. Per
illustrare questa critica Armstrong sceglie il caso presentato da K. Popper
in Logica della scoperta scientifica: i moa sono uccelli della Nuova Zelanda
estinti, morti tutti prima dei loro cinquant’anni, ma essi sarebbero vissuti
più a lungo se dei virus non li avessero condotti alla morte. Non è quindi
una legge che i moa muoiano prima del raggiungimento del cinquantesimo
anno, ma si deve al caso. Un teorico della Regolarità direbbe invece che è
una legge, in quanto per tutti i moa è stato vero che essi sono morti prima
di quell’età33.
II. Mentre i casi precedenti mostrano che regolarità e legge possono
essere distinte, cioè che la regolarità non è sufficiente a identificare una
legge, per provare che la regolarità non è neanche necessaria all’esistenza
della legge, Armstrong si affida ai casi di leggi che riguardano oggetti non
esistenti, o, come preferisce dire, ai casi di leggi non istanziate: a) il caso
emblematico di leggi non realizzate, cioè di fenomeni retti da leggi di
natura, che di fatto non si verificano è quello della prima legge del moto di
Newton, che dice che, in assenza di forze, ogni corpo tende a conservare il
proprio stato di moto o di quiete34: «L’asserzione della legge ci dice cosa
accade a un corpo su cui non agisce una forza. Tuttavia può essere che
l’antecedente della legge non sia mai istanziato. Può essere che su ogni
corpo che c’è agisca una forza»35; b) analogamente la teoria della
Regolarità non potrà fornire alcuna spiegazione delle asserzioni
controfattuali, quelle che affermano che, se qualcosa, contrariamente al
fatto, si fosse realizzata, ne sarebbe discesa come conseguenza qualche altra
33 Così conclude POPPER (1970, pp. 483-484): «Quest’esempio mostra che possono
esserci asserzioni vere, rigorosamente universali, che hanno un carattere accidentale, e non il
carattere di vere e proprie leggi universali di natura. Di conseguenza, la caratterizzazione
delle leggi di natura come di asserzioni rigorosamente universali è logicamente
insufficiente e intuitivamente inadeguata».
34Questa la formulazione classica del principio di inerzia: «In assenza di forze, un
"corpo" in quiete resta in quiete, e un corpo che si muova a velocità rettilinea e uniforme
continua così indefinitamente».
35 ARMSTRONG (1983, p. 21).
110
Annabella D’Atri
cosa. È un controfattuale la proposizione “se non avessi frenato, la mia auto
sarebbe finita nel burrone”: cosa ci autorizza a ritenere vera una tale
affermazione se l’antecedente, il fatto di non avere frenato, non si è
realizzato?
III. Il terzo tipo di critica, secondo Armstrong decisivo, nei confronti
della teoria della Regolarità dipende poi dallo stato attuale della ricerca
scientifica: infatti «molte delle leggi della fisica contemporanea non si
manifestano nelle regolarità, quanto nelle distribuzioni statistiche»36. La
teoria della Regolarità non è in grado di dar conto delle leggi statistiche che
assegnano un preciso valore alla probabilità; in verità un tale valore
dipende in maniera stretta dalla casualità con la quale in natura si verificano
alcuni eventi: se un evento, molto raro in base alla legge, in un dato
periodo di osservazione si realizzasse più frequentemente, si assegnerebbe
un valore molto più alto alla sua probabilità.
Vedremo a breve come la teoria proposta da Armstrong intenda invece
superare queste critiche ancorando la teoria delle leggi di natura alla teoria
degli universali37. Così lo stesso autore riassume il nesso logico fra leggi di
natura e universali: «Dopo tutto le leggi sono le maniere fondamentali in
cui le cose si comportano, e le maniere di comportarsi dipendono dalle
proprietà delle cose. E, se le proprietà sono universali, le leggi verrebbero
a connettere gli universali che i particolari istanziano.»38
Se questa è l’ipotesi, se cioè le leggi sono considerate connessioni fra
universali, non può non sorgere conseguentemente la questione sullo
statuto ontologico di tali connessioni fra universali: essendo esse delle
relazioni, sono esse stesse degli universali? Questa è la domanda principale
che costringerà Armstrong a sviluppare ulteriormente la sua originaria
nozione di “stato di fatto”, in maniera tale da tenere conto anche di un
ulteriore problema, quello di distinguere la necessità della legge di natura
dalla necessità logica, cioè il tipo di relazioni necessarie studiate dalle
scienze della natura dal tipo di relazioni necessarie proprie delle leggi
logiche. A tal proposito già Popper39 aveva sostenuto che la necessità
“cosmica”, propria delle leggi di natura, che dipende da molteplici fattori,
Ivi, p. 29.
Come ha giustamente scritto D. MUMFORD (2007, p. 49), il realismo svolge una
funzione essenziale nella teoria della legge del nostro filosofo: «Realism about universals is
thus an essential part of Armstrong’s theory of laws» .
38 ARMSTRONG (2010, p. 35).
39 Vedi nota 16.
36
37
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
111
deve essere distinta dalla necessità di tipo logico, che è invece per sua
natura incondizionata. Armstrong, dal canto suo, come vedremo fra poco,
sostiene che, pur essendo necessario che in una legge di natura
l’antecedente venga seguito dal conseguente, la legge stessa non è
necessaria; egli intende così garantire al suo mondo di stati di fatto il
carattre della contingenza.
4. Le leggi di natura. Per meglio comprendere la teoria delle leggi è
opportuno ricordare che nell’opera sugli universali del 1978 Armstrong
ammette l’esistenza di universali di secondo livello, cioè di proprietà
predicabili di proprietà, quali, ad esempio, “essere complesso”, o “essere
strutturale”. L’esempio più semplice di proprietà strutturale è quello di
“composto di due elettroni”: «Consideriamo la proprietà strutturale di
essere (esattamente) due elettroni, una proprietà posseduta da tutti gli insiemi
di elettroni con due membri. Non possiamo dire che questa proprietà
implichi lo stesso universale, essere un elettrone, preso due volte, perché un
universale è uno e non molti»40.
Ciò che vale per gli universali monadici, cioè la possibilità che essi siano
di secondo livello, vale anche per gli universali a più termini, cioè le
relazioni, che possono anche essere di secondo livello quando collegano fra
loro universali di livello inferiore; e il capitolo finale di Teoria degli
Universali è appunto dedicato a definire la causalità e la legge naturale in
termini di relazioni fra universali. Cosa è una legge di natura può quindi
considerarsi il completamento della teoria degli universali di Armstrong.
Venendo ai dettagli, se una legge è una relazione necessaria fra due
universali, quali F e G, è corretto costruire una relazione di implicazione,
espressa dalla seguente formula: N(F,G) → (x) (Fx Gx), cioè il fatto che
esista una relazione necessaria fra F e G implica che, per tutti i particolari
x, se questi sono F, sono anche G. Si noterà che in tal modo Armstrong
intende restituire alla legge di natura il carattere di forte necessità che le
teorie Regolariste tendono a negarle. In altri termini Armstrong intende
andare oltre la mera regolarità del susseguirsi dei fenomeni naturali, per
individuare l’esistenza di un legame reale fra universali.
Ma la natura di questo legame fra universali doveva essere
ulteriormente analizzata: come lo stesso Armstrong ricorda, lo ha
inizialmente indotto a riflettere meglio sulla relazione di azione necessaria
40
ARMSTRONG (1978b, p. 138).
112
Annabella D’Atri
fra universali la seguente, acuta, domanda di un suo allievo: nella formula
N(F,G) la relazione N è essa stessa un universale?:
Ma, quanto più consideravo la questione, tanto più iniziavo a vedere il
fascino della tesi che N(F,G) sia due cose insieme, il sussistere di una
relazione fra universali e un universale (complesso) esso stesso.
Quest’idea, che lo stato di fatto costituito da N(F,G) sia esso stesso un
universale, non risolverà l’intero problema della comprensione
dell’implicazione. Alla fine, come vedremo, la relazione di azione
necessaria nomica, N, si dovrà accettare come originaria. Ma, se possiamo
accettare anche che N(F,G) sia un universale, istanziato nelle istanze
positive della legge, allora, penso, sarà molto più facile accettare la natura
originaria di N. Sarà possibile vedere chiaramente che, se N sussiste fra F e
G, questo implica un’uniformità a livello di particolari di primo livello41.
All’origine, cioè nella sua struttura ontologica, una legge di natura è un
universale che si realizza nelle sue diverse istanziazioni particolari: in
ciascun particolare che, per il fatto di essere F è G. Occorre infatti
ricordare che, essendo la legge un universale, anche a essa si applica il
principio di istanziazione che sostiene che gli universali non esistono se non
nei particolari42.
Ed è a questo momento dell’argomentazione che si colloca quella che
possiamo considerare la chiave di volta nella concezione della legge di
Armstrong: lui stesso ricorda di aver sostenuto, nel testo sugli universali,
che l’unione in uno stato di fatto di un particolare con un universale, o di
due particolari in una relazione, consiste in un particolare, e di avere
inoltre chiamato questo fenomeno “vittoria della particolarità” 43; aveva
anche aggiunto che questo fenomeno si verifica anche quando un universale
si unisce con un universale di livello superiore. La tesi generale era infatti
che gli stati di fatto sono comunque sempre particolari di primo livello.
Ora, approfondendo la teoria della legge, riconosce di essersi sbagliato:
«Nello stato di fatto N(F,G), i particolari di secondo livello, F e G, insieme
con l’universale di secondo livello, N, costituiscono uno stato di fatto che
considerazioni di simmetria inducono a pensare sia un particolare di secondo
ARMSTRONG (1983, p. 88).
È opportuno ricordare che proprio a questo principio Armstrong riconduce la
propria ispirazione generale di tipo “aristotelico”.
43 Si veda ARMSTRONG (1978a, p. 115).
41
42
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
113
livello. Ma un particolare di secondo livello è un universale di primo
livello.»44
In verità, come nota acutamente Mumford45, in seguito la concezione
subirà una modifica radicale: nel testo Un Mondo di Stati di Fatto Armstrong
parlerà delle leggi non più come universali ma come tipi di stati di fatto,
definendo i tipi come mere astrazioni tratte dagli esemplari particolari46,
con la dichiarata intenzione di non moltiplicare le entità della sua
ontologia, ma, di certo, rendendo più problematica la sua concezione:
come fa infatti una mera astrazione a rendere necessaria una connessione47?
Ma rimane da considerare ora se e come la concezione della legge come
relazione, universale, fra universali riesca a superare le difficoltà incontrate
dalla teoria della legge come regolarità, difficoltà che abbiamo elencato nel
terzo paragrafo:
I. Per quanto riguardo la necessità di distinguere fra legge e mera
regolarità, la teoria di Armstrong afferma semplicemete che basta
riconoscere che non tutte le regolarità corrispondono in natura a delle
leggi:
Non è necessario che le uniformità Humeane del singolo caso, le
uniformità connesse con le uniformità locali e le uniformità che sono
uniformità solo perché non si sono realizzate determinate possibilità, siano
considerate come manifestazioni di leggi. Infatti non può sussistere
nessuna relazione adeguata fra gli universali interessati. Essere un moa non
rende necessario morire prima dei cinquanta anni.48
II. Più complessa, ma anche più interessante, si rivela la risposta della
teoria di Armstrong alla questione delle leggi non istanziate, e a quella
della validità delle proposizioni controfattuali, dal momento che esse
sembrerebbero contraddire il principio di fondo della sua filosofia
naturalista, cioè il principio di istanziazione degli universali. Infatti, come
ARMSTRONG (1983, p. 89).
MUMFORD (2007, pp. 55-56).
46 ARMSTRONG (1999, pp. 225-227).
47 Si potrebbe uscire dalla difficoltà, e rispondere a Mumford, distinguendo fra un
livello epistemologico e uno ontologico: per astrazione perveniamo a conoscere come
indipendente l’universale che di fatto è sempre congiunto con un particolare. In questo
caso una legge generale è sempre presente in una particolare, che lascia intravedere in essa
la forma generale.
48 ARMSTRONG (1983, p. 99).
44
45
114
Annabella D’Atri
riconosce lo stesso Armstrong, proprio le leggi non istanziate, cioè le leggi
singole che hanno come antecedenti degli eventi non realizzati,
garantiscono in molti casi la capacità di prevenire sia danni per i singoli che
disastri per il genere umano tutto, quali, per esempio, degli incidenti
nucleari.
Per rispondere a tale questione Armstrong, che anche in tal caso guarda
ai risultati della ricerca scientifica contemporanea, fa ricorso al concetto di
legge funzionale. All’interno di questa cornice, le leggi non istanziate
corrisponderanno a casi di valori delle variabili non saturati, che la legge
funzionale mette in relazione. Le leggi non istanziate saranno così
interpretabili proprio come dei casi di controfattuali.
Per conciliare poi questa impostazione con il principio di istanziazione,
al quale non intende rinunciare, Armstrong propone di interpretare le
leggi funzionali come leggi di livello superiore, che regolano le leggi di
livello inferiore. Nel caso della prima legge di Newton, noi siamo in grado
di mostrare la presenza della forza di inerzia come agente in congiunzione
con altre forze e siamo in grado quindi di costruire la curva della funzione
che mette in relazione la quantità di queste altre forze, reali e misurabili,
con la quantità della forza di inerzia: in base all’andamento della curva,
siamo poi in grado di sapere che, se le altre forze fossero assenti, cosa che di
fatto non è, il corpo agirebbe solo in base alla forza di inerzia. Rendendo la
legge non istanziata, che mette in relazione un universale P con un
universale Q, con la formula P0→Q0, Armstrong avanza la seguente
interpretazione:
La concezione che desidero proporre è che l’asserzione di una legge non
istanziata dovrebbe essere costruita come un contro-fattuale. Istanze
dell’universale P0 non esistono. Dunque non esiste la legge P0→Q0. Ma,
se ci fossero dei P0, cioè se P0 esistesse, allora P0 sarebbe governata dalla
legge che tutti i P0 sono Q0. Asserzioni di leggi non istanziate sono in
realtà solo asserzioni su quali leggi sussisterebbero se, contrariamente ai
fatti, certi universali fossero istanziati, cioè, esistessero. In questo modo io
ammetto le leggi non istanziate, ma solo come casi delle leggi,
logicamente secondari.49
III. La questione finale, alla quale Armstrong dedica una più ampia
analisi, è quella legata all’importanza della statistica nell’ambito della
49
Ivi, p. 112.
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
115
scienza. A tal proposito occorre ricordare che proprio ad Armstrong si
deve una nuova interpretazione del concetto di probabilità, ricostruita,
grazie all’analisi combinatoria della possibilità, a partire da alcune
proposizioni del Tractatus di Wittgenstein.50
Limitandoici comunque alle leggi di natura, che sono a tema in questo
articolo, ciò che è interessante notare è come Armstrong intenda
affrontare la questione del rapporto fra necessità e contingenza alla luce di
un’interpretazione unitaria, che considera la necessità come il livello
massimo di probabilità del verificarsi di un evento, la probabilità come il
livello intermedio, probabilità che viene espressa appunto da una scala che
va da 1 a 0, e l’impossibilità come il livello minimo, cioè pari allo zero.
Il nostro mondo, l’unico reale, per Armstrong, il quale rifiuta il
realismo dei mondi possibili di David Lewis, è completamente pervaso
dalla contingenza. Non è assolutamente necessario che il mondo sia
proprio così come è, anzi, aggiunge, avrebbe potuto essere diverso da
come è. Ma, una volta che si realizzano determinati fatti o stati di fatto, si
realizzano anche alcune leggi che necessariamente conducono al
realizzarsene di altri: ribaltando una tradizione di pensiero che assegna la
contingenza solo ai particolari e la necessità agli universali, Armstrong
sostiene infatti che i suoi universali, quindi anche le leggi, in quanto
relazioni fra universali, sono contingenti.
Questa tesi è in assoluta coerenza con il naturalismo scientifico di
Armstrong, che sostiene che il filosofo, cioè il metafisico, ha il compito di
indicare i caratteri generali del mondo, nel nostro caso l’essere in quanto
insieme di stati di fatto, e che invece è compito dello scienziato scoprire
quali questi stati di fatto siano, quali siano gli universali che li compongono
e li mettono in relazione, quindi quali leggi di natura sussistano.
Quanto alla necessità di determinate leggi, essendo essa non di tipo
logico, anch’essa possiede un determinato grado di probabilità, cioè quello
massimo. Queste le conclusioni alle quali perviene Armstrong:
50 Non è possibile in questa sede soffermarsi su questa teoria, fra le più interessanti di
Armstrong, anche perché sarebbe necessario premettere, oltre a un’attenta analisi di
alcune proposizioni del Tractatus, anche una sintesi della “teoria dei mondi possibili” di
David Lewis, teoria alla cui critica è appunto dedicato il saggio di ARMSTRONG, A
Combinatorial Theory of Possibility, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
116
Annabella D’Atri
Le leggi irriducibilmente probabilistiche sono anche relazioni fra
universali. Queste relazioni danno (sono costituite da) una certa
probabilità oggettiva che istanziazioni individuali dell’universale
antecedente renderanno necessaria l’istanziazione dell’universale
conseguente. Esse forniscono la probabilità della necessitazione del caso
particolare. Come tutte le leggi, esse devono avere in qualche tempo
istanziazioni (positive). Le leggi deterministiche sono casi limite delle leggi
probabilistiche (dalla probabilità 1)51.
Quindi, nelle leggi di natura, l’inferenza necessaria da un antecedente a un
conseguente è essa stessa sottoposta a calcolo di probabilità, il che spiega il
carattere meno rigido, “sperimentale” e progressivo delle scienze della natura
rispetto alle scienze esatte: logica e matematica. Le scienze della natura sono
irriducibilmente a posteriori; e lo sono a tal punto che diventa una condizione di
esclusione dal novero delle leggi di natura il fatto che una determinata
inferenza possa derivare a priori dai due termini messi in relazione.
La stessa matematica, per eccellenza scienza di relazioni, non avrebbe a
che fare, per Armstrong, con relazioni autentiche, cioè con universali di
secondo livello che connettono universali di primo livello, bensì con quelle
che, a partire da Russell, si chiamano “relazioni interne”, che cioè non
hanno uno statuto ontologico separato dalla natura stessa degli universali
correlati. Per esemplificare, asserire la relazione di superiorità del due
rispetto all’uno non aggiunge nulla alla natura dei numeri coinvolti, ma
riguarda una relazione implicita (cioè interna) alla loro essenza:
Se si può mostrare a priori che due universali devono stare in una certa
relazione, allora fra essi non c’è una tale relazione. La connessione nomica
fra universali, in ogni caso, non può essere stabilita a priori. Deve essere
scoperta a posteriori. Così forse le leggi di natura possono essere trattate
come relazioni irriducibilmente di secondo livello, autentiche relazioni fra
universali. Invero, io suppongo che le leggi di natura costituiscano le sole
relazioni di secondo livello fra universali52.
Come si vede, la netta separazione delle leggi di natura dalle leggi logiche è
in Armstrong funzionale al riconoscimento del carattere provvisorio della
ricerca scientifica, che dipende inevitabilmente dalla sua natura storica, ma non
significa abdicare all’idea e al valore della verità. La questione della verità
51
52
ARMSTRONG (1983, pp. 172-173).
Ivi, p. 84
Metafisica e leggi natura in D.M. Armstrong
117
diventerà infatti quella centrale nella ricerca posteriore di Armstrong,
coniugandosi in indagini sui verificatori differenziate in base ai tipi di
proposizioni vere alle quali essi corrispondono. A costituire i verificatori degli
enunciati delle leggi scientifiche saranno appunto le relazioni universali, reali e
istanziate, fra universali.
Nel sistema metafisico di Armstrong la causalità, vero e proprio
“cemento dell’universo”, può essere definita quella «relazione di fondo che
unisce secondo legge le cose nel mondo»53; e in tal modo le leggi di natura
possono ri-diventare, dopo l’età dei relativismi e degli scetticismi,
manifestazioni di poteri reali e oggettivi corrispondenti a proprietà
universali delle cose.
Abstract
Aim of the paper is to sketch the theory of laws of nature and briefly
the metaphysical system of D. M. Armstrong, the most famous Australian
philosopher and one of the leading authorities in contemporary analytical
ontology. In his first work on universals describes his theory, defined
Immanent, Aristotelian and Naturalistic, due to the fact that in his view
universals are nothing without particulars, that are instantiations of the
formers. Armstrong’s ontology is therefore based on the concept of State
of Affairs, namely a particular having a property or two or more
particulars being related. Once he has in his ontology notions of universals
and state of affairs, Armstrong is able to analyse the laws of nature as
relations between universals, themselves universals, in order to overcome
Humean theory of Regularity and ensuing skepticism about scientific
knowledge.
BIBILIOGRAFIA
ARISTOTELE (1989), Categorie, a cura di M. ZANATTA, Milano, BUR, 1989.
D.M. ARMSTRONG (1960), Berkeley's Theory of Vision: A Critical Examination of Bishop Berkeley's
Essay Towards a New Theory of Vision, Melbourne University Press, Melbourne.
53
ARMSTRONG (2004, p. 144).
118
Annabella D’Atri
D.M. ARMSTRONG (1978a), Nominalism and Realism: Universals and Scientific Realism, Vol. I,
Cambridge University Press, Cambridge.
D.M. ARMSTRONG (1978b), A Theory of Universals: Universal and Scientific Realism, Vol. II.
Cambridge University Press, Cambridge..
D.M. ARMSTRONG (1983), What is a L aw of Nature?, Cambridge University Press,
Cambridge.
D.M. ARMSTRONG (1993a), "Reply to Bigelow" in K. CAMPBELL, L. REINHARDT, J. BACON
(eds.), Ontology, Causality and Mind. Essays in Honour of D. M. Armstrong, Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 96-100.
D. M. ARMSTRONG (1993b), "Reply to Fales" in K. CAMPBELL, L. REINHARDT, J. BACON
(eds), Ontology, Causality and Mind, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 144-152.
D.M. ARMSTRONG (1993C), A Materialist Theory of the Mind. Revised Edition (I ed. 1968),
Routledge, London.
D.M. ARMSTRONG (1999), A World of State of Affairs, Cambridge University Press,
Cambridge-New York.
D.M. ARMSTRONG (2010), Sketch for a Systematic Metaphysics, Oxford University Press,
Oxford-New York.
D.M. ARMSTRONG (2004),Truth and Truthmakers, Cambridge University Press, Cambridge,
A. D'ATRI (2010), "L'aristotelismo di D. M. Armstrong" in. M. ZANATTA ( a cura di), Studi
di filosofia aristotelica III, Pellegrini, Cosenza.
S. MUMFORD (2007), David Armstrong, McGill-Queen's University Press, Ithaca.
PLATONE (2004), Parmenide, a cura di F. Ferrari, BUR, Milano.
K. POPPER (1970), Logica della scoperta scientifica, trad. it. M. Trinchero, Einaudi, Torino.
G. REALE (1987) Per una nuova interpretazione di Platone, V ed., Vita e Pensiero, Milano.
B. RUSSELL (1922), I problemi della filosofia, trad. it. B. Ceva, Sonzogno, Milano.
A.VARZI (2008 a cura di), Metafisica: classici contemporanei. Testi di Armstrong, Black, Carnap et
alii, Laterza, Bari.
A.VARZI (2005),Ontologia, Laterza, Roma-Bari, 2005.
MAURIZIO FERRARIS
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
Qualcuno trova paradossale che io sia approdato al realismo dopo aver
partecipato al Pensiero debole. In primo luogo, si potrebbe osservare che non
c’è nulla di paradossale che nell’arco di un trentennio si possano cambiare
le proprie idee (non dimentichiamoci che il Pensiero debole è del 1983). In
secondo luogo, non si è trattato di un capovolgimento totale, ma piuttosto
di un modo di precisare una medesima istanza che personalmente ho
sempre avvertito come prioritaria: non ricevere le filosofie come dogmi,
ma confrontarle con la realtà, appunto. In terzo luogo, come sottolineo nel
Manifesto, ma come è stato notato da molti, nel Pensiero debole ci sono
contributi tutt’altro che “debolisti” (si pensi a Eco e a Marconi), e la stessa
idea di “pensiero debole” è qualcosa di talmente indeterminato che l’accusa
di averla abbandonata appare di una paradossalità ancora più squisita di
quella che mi viene imputata.
Ma, lasciando da parte le questioni privatissime, c’è un problema più
importante, e davvero rilevante dal punto di vista teorico, di cui vorrei
parlare in questo scritto. Ed è questo: non credo che nel passaggio dal
postmoderno al realismo ci sia davvero un cambio di prospettiva, che so,
dall’incendiario al pompiere. Le cose vanno diversamente: aderire al
postmoderno, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta,
significava seguire un progetto di emancipazione radicale. Rifiutare il
postmoderno in nome del realismo, negli anni Novanta e in seguito, ha
significato continuare a seguire un progetto di emancipazione radicale,
proprio nella misura in cui, per contro, il postmoderno si era trasformato
in populismo. Cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”? Solo questo: la
piena consapevolezza di venire dopo il postmoderno, ossia di avere
attraversato (e sperabilmente superato) l’antirealismo prevalente nella
seconda metà del secolo scorso, tanto in area analitica quanto in area
continentale. In questo senso, i suoi tratti fondamentali sono tre, e sono
accomunati, piuttosto che da una critica liquidatoria dell’antirealismo, dal
tentativo di conservarne le istanze emancipative evitando gli effetti
indesiderati, e in particolare la curva entropica che ha portato il
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 119-126
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606438
119
120
Maurizio Ferraris
postmoderno a dire addio alla verità e a dichiarare guerra alla realtà,
attuando in modo indiscriminato il principio secondo cui “non ci sono fatti,
solo interpretazioni”: un rilancio della decostruzione aggiornato ai tempi;
una collocazione dell’ermeneutica in una sede propria; e una prospettiva di
filosofia cosmopolitica.
Decostruzione
Ha scritto Primo Levi in I sommersi e i salvati: «L’intera storia del breve
“Reich Millenario” può essere riletta come guerra contro la memoria,
falsificazione orwelliana della memoria, falsificazione della realtà,
negazione della realtà, fino alla fuga definitiva dalla realtà medesima». La
realtà non è semplicemente una categoria psicologica, è anzitutto un
elemento imprescindibile per l’etica e la politica. E non si dimentichi che
anche i sospettosi eroi del postmoderno che hanno insistito sul carattere
costruito della realtà lo facevano in nome della realtà e della verità. In fin
dei conti, se Nietzsche, Freud, Marx hanno scritto quello che hanno
scritto, è stato in nome della verità. Ma sotto questo profilo esiste davvero
una incidenza della filosofia sulla politica?
Credo che convenga incominciare proprio da qui. Prendiamo il caso di
Nietzsche, un grande del pensiero e insieme un perenne inciampo per la
filosofia. Molto probabilmente Hitler ha letto Nietzsche molto meno di
quanto non lo abbia letto Thomas Mann, che non è affatto diventato nazista
e anzi ha dovuto abbandonare la Germania mentre gli bruciavano i libri in
piazza. Le teorie di Nietzsche sono anche la elaborazione concettualmente
e stilisticamente sofisticata di una angoscia piccoloborghese che aveva tante
manifestazioni ideologiche in una miriade di giornalisti, agitatori politici,
opinionisti di varia natura, con cui Hitler entrò invece in contatto, e che
del resto aveva un così ampio ascolto proprio perché esprimeva uno stato
d’animo diffuso. Poi Hitler salì al potere, e a questo punto in tutte le
università tedesche si tennero corsi su Nietzsche. Nel riuso di regime pezzi
importanti della teoria di Nietzsche vennero scartati perché non funzionali
(ad esempio, non era antisemita, era tendenzialmente antistato, e aveva
bizzarre teorie come l’eterno ritorno), ma altri (il nichilismo, la volontà di
potenza, l’istinto gerarchico) lo erano perfettamente, prestandosi a una
fruizione selettiva che approfittava del prestigio di un grande filosofo
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
121
proprio come Hitler si era avvalso del prestigio di grandi generali come
Ludendorff e Hindenburg.
Venendo ai postmoderni, il caso mi sembra più singolare, appunto
perché non abbiamo a che fare con una fruizione selettiva, bensì con una
realizzazione perversa. Né Lyotard né Derrida si sarebbero mai
riconosciuti in Bush e in Berlusconi. Anzi, li hanno criticati esattamente
come i loro colleghi realisti Chomsky o il Putnam degli ultimi vent’anni.
Come è successo? Credo che dipenda dal fatto che i postmoderni erano di
sinistra, ma buona parte dei loro autori no: erano (sino alla caduta del
Muro, che comportò lo sdoganamento di Marx, diventato inoffensivo)
impolitici come Freud o conservatori come Nietzsche, Heidegger e
Schmitt, e in effetti è molto più facile adoperare il teorico della volontà di
potenza, il rettore di Friburgo nel ’33 e il giurista del Führer per sostenere
posizioni di destra piuttosto che di sinistra. Si possono fare tutte le capriole
ermeneutiche del mondo, ma se questi tre pensatori, peraltro ricchissimi e
affascinanti, erano di destra, un motivo ci sarà stato. Quanto ai populisti,
certo Karl Rove, il consigliere di Bush, non aveva bisogno di Baudrillard
per sostenere che l’amministrazione USA creava la realtà. Forse non lo
aveva mai letto e ne ignorava persino il nome. Ma sicuramente un
giornalista o un commentatore minimamente acculturato avrebbe potuto
sostenere che la dottrina di Rove non era una insopportabile apologia della
menzogna, ma era anzi in linea con le più avanzate (e left-wing) teorie
sociologiche e filosofiche.
Insomma, di certo la teoria della causalità diretta è insostenibile, perché
postula un meccanismo di contagio e una importanza dell’ideologia che è
tipica del mondo visto con gli occhiali da miope di noi professori. Secondo
me, invece, è sostenibilissima la tesi della giustificazione retrospettiva, che
però non è una cosa da poco, perché ha almeno due conseguenze. Una,
diretta ma forse meno importante, è la legittimazione pubblica: faccio
queste cose non perché mi conviene, ma perché fior di filosofi, oltretutto
della parte politicamente avversa, hanno scritto che è giusto fare così.
L’altra, indiretta e secondo me più importante, è la delegittimazione degli
avversari: con che strumenti la sinistra può criticare la destra se
quest’ultima è giustificata proprio dagli ideologi della sinistra?
Lo scopo fondamentale del nuovo realismo, così, è la possibilità di
recuperare gli argomenti per la critica, dopo la delegittimazione
postmoderna. La parola “critica” dovrebbe mettere in chiaro che se ci si
appella alla realtà non è per Realpolitik, ma, proprio al contrario, perché si
122
Maurizio Ferraris
tratta di non abbandonare la critica e la decostruzione, sebbene sotto altre
forme, adatte al mutato momento storico e non ridotte a una pura
scolastica. È sacrosanto decostruire: in natura non esistono i granduchi, i
padri-padroni e gli angeli del focolare, loro sono socialmente costruiti. Qui
ritrovo la mia generazione, e proprio per questo trovo singolare che ci sia
chi osserva, come se fosse una obiezione, che io stesso ero un seguace del
pensiero debole. È indubbiamente così, e quello che facevo allora lo faccio
adesso, cercando di non ripetere gli errori di decenni fa.
Ermeneutica
Quanto
all’ermeneutica.
Nella
“pretesa
di
universalità
dell’ermeneutica” di cui si parlava nel secolo scorso c’erano due cose che
non andavano, a mio parere. La prima era, appunto, l’idea che ci fosse
ermeneutica in ogni momento dell’esistenza. La seconda era, invece, che
questa ermeneutica universale fosse qualcosa a cui avesse uno specifico
accesso soltanto il filosofo. Spesso i profani pensavano che gli ermeneutici
avessero speciali tecniche di interpretazione, ignote al resto del mondo.
Non era così. Di interpretazione ne sapevano come il resto del mondo,
magari anche meno, e il plus filosofico consisteva semplicemente nel dire
che dovunque, anche quando non ce lo si aspetta, c’è interpretazione.
Ciò detto, nessun realista nega l’importanza dell’ermeneutica nelle
pratiche sociali e conoscitive. Quello che appare inaccettabile è la
formulazione di Nietzsche “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”. Perché
anche qui, sulle prime appare come una grande promessa di
emancipazione, l’idea di una umanità che si libera dalle ombre della
caverna platonica, dai falsi idoli e dalle illusioni. Ma poi si rivela per quello
che è, un perfetto strumento reazionario, la traduzione filosofeggiante e
scettica del “La ragione del più forte è sempre la migliore”, l’idea che chi
ha il potere, per ingiusto e disumano che sia, può imporre le sue
interpretazioni, con la forza dei suoi avvocati o dei suoi eserciti o dei suoi
soldi. Ci si immagini in un tribunale in cui, invece che “La legge è uguale
per tutti”, si trovasse scritto “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”.
Come ci si sentirebbe? Molto peggio di Josef K, se si è onesti. Ma sono
sicuro che altri, i furbetti e i furfanti che popolano le cronache dei giornali,
o, soprattutto, i criminali di guerra di ogni tempo, si sentirebbero
sollevati.
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
123
Non dimentichiamolo: c’è un filo continuo che dal disprezzo dei fatti,
dal considerarli banali e modificabili, porta alla negazione dei fatti. “Non ci
sono fatti, solo interpretazioni” significa, se le parole hanno un senso, che
Auschwitz è solo una interpretazione. Anche senza giungere a posizioni
estreme, il costruzionismo comporta spesso delle estensioni indesiderate.
È per esempio molto facile che si confonda il “socialmente costruito” con il
“soggettivamente costruito”. Il che, ovviamente, è un errore. Non c’è
dubbio che l’economia e la politica siano costruzioni sociali, ma è
altrettanto indubbio che non dipende dalla volontà di un singolo soggetto
di trasformarle. Molto spesso la portata presuntamente rivoluzionaria
dell’ermeneutica è consistita proprio in questo: promettere una specie di
rivoluzione interiore, per cui un professore o un lettore o chicchessia,
interpretando, magari nella sua stanza e in totale sconnessione con
l’esterno, fosse un alfiere e un combattente dei tempi nuovi. Sartre aveva
detto che tra guidare un esercito e ubriacarsi in solitudine alla fine non c’è
differenza, e l’ermeneutica radicale sembra averlo preso in parola.
Ripeto: i realisti sanno bene che un pezzo importantissimo nel mondo,
e cioè la sfera sociale, non può darsi senza interpretazione, e che
l’interpretazione può essere ricerca della verità e non immaginazione al
potere. Il problema, semmai, e per restare all’endiadi della immaginazione
al potere, non è l’immaginazione, ma il potere, l’ossessione postmoderna
secondo cui non c’è verità, ma solo conflitto, interesse, prevalenza del più
forte, e che “interpretare” significhi essenzialmente scendere in guerra, o
quantomeno in campo. Ora, rifiutare questo uso aberrante della
interpretazione non vuol dire in alcun modo ridurla a immaginazione;
significa, al contrario, mostrare il nesso essenziale che l’interpretazione ha
con la verità e la realtà. L’argomento avanzato da qualcuno per cui il nuovo
realismo ridurrebbe l’interpretazione alla immaginazione, è, lui sì, un po’
troppo fantasioso, visto che gli oggetti sociali – un elemento centrale nella
ontologia realista – sono oggetti allo stesso titolo che gli oggetti naturali,
ma richiedono interpretazione.
E ovviamente realismo non è scientismo, una posizione in cui i realisti,
da Bilgrami a De Caro, da Gabriel a Bojanic, senza ovviamente dimenticare
Putnam o Eco, non si riconoscono affatto. Per quel che mi riguarda, la
prova macroscopica di questo è la differenza che ho proposto di tracciare
fra ontologia ed epistemologia, tra quello che c’è e quello che sappiamo a
proposito di quello che c’è. Il che non significa che la filosofia può rifiutare
le conquiste della scienza. Ma su questo i realisti vecchi e nuovi sono in
124
Maurizio Ferraris
buona compagnia: anche gli epistemologi anarchici cercano i migliori
medici. E, detto fra noi, fanno benissimo, non si vorrebbe mai che le loro
convinzioni filosofiche, se applicate con troppo scrupolo, li portassero a far
la fine di Don Ferrante, che dopo aver negato la peste perché non è né
sostanza né accidente si ammala e se ne va all’altro mondo maledicendo le
stelle come un eroe di Metastasio.
Globalizzazione
Un ultimo punto, al di là delle polemiche di retroguardia. Il nuovo
realismo è anche, guardando all’avvenire, la proposta di una filosofia
globalizzata. Mi spiego. A mio parere, la distinzione tra analitici e
continentali è essenzialmente una differenza tra pubblici della filosofia.
Difficilmente troverete un filosofo continentale intento a spaccare il
capello in quattro in un seminario di ricerca, e altrettanto difficilmente
troverete un filosofo analitico intento a parlare di grandi temi in un festival
filosofico, dove la stragrande maggioranza degli oratori è di formazione
continentale, più un certo numero di scienziati, psicoterapeuti e religiosi.
Questo, vorrei che fosse chiaro, non dice ancora nulla su una eventuale
superiorità degli analitici o dei continentali, non più di quanto la
constatazione della diversità dei pubblici di Boulez e dei Beatles possa
essere considerata un punto a favore dell’uno o degli altri. Abbiamo
semplicemente a che fare con delle circostanze storiche.
Perché gli analitici, espressione del sistema universitario angloamericano, di college raramente urbani e legati alla tradizione universitaria
medioevale, costituiscono una comunità coesa e un po’ monastica, dove le
persone dialogano tra loro con regole precise e a partire da un certo
numero di argomenti che cambiano col tempo ma sono quelli all’ordine
del giorno. Da questo punto di vista, la tradizione analitica non ha molto a
che fare con i media (sui giornali si parla pochissimo di filosofi, gli
americani sono sempre stupiti di come sono trattati da noi, per esempio),
ma è un media in se stesso, con una discreta rilevanza pubblica e
soprattutto con una netta predominanza rispetto ai continentali per quanto
riguarda il prestigio accademico. Anzi, questa rilevanza rischia di essere
crescente nel momento in cui le grandi università americane diffondono i
loro tutorial attraverso il mondo, trasformando di fatto le altre università
in Cepu più o meno grandi.
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
125
I continentali, invece, sono eredi piuttosto dei philosophes
dell’Illuminismo (quando sono chiari) e dei predicatori protestanti (quando
giocano sull’oscurità), ossia di intellettuali molto aperti allo spazio
pubblico, e i loro luoghi naturali di manifestazione sono i mass media. Da
questo punto di vista, vale la pena di osservare un punto. Dummett aveva
notato che Frege e Husserl, solitamente considerati come i capostipiti delle
due tradizioni di pensiero, non erano poi così distanti, un po’ come le
sorgenti del Reno e del Danubio. Certo, ma che cosa è cambiato, che cosa
ha approfondito il divario nei decenni successivi? Che cosa ha fatto sì che a
un certo punto le due tradizioni sembrassero lontane come le foci del Reno
e del Danubio? Essenzialmente, la crescente importanza dei media, che
hanno trovato un elemento di attrazione nella filosofia, e che hanno dato
spazio ai filosofi, con una ovvia preferenza per le formulazioni meno
esoteriche, e magari più provocatorie, d’accordo con il principio per cui la
notizia è sempre l’uomo che morde un cane, mai l’inverso. È qui che si è
creata la divaricazione tra i filosofi analitici (prevalentemente universitari)
e i filosofi continentali (prevalentemente mediatici).
Da tutto questo si possono imparare almeno due cose. La prima è che
non può esistere, da sola, una “filosofia pura”, iper-teoretica e astratta.
Non può esistere in una tradizione come quella italiana, che ha smantellato
per sempre i propri centri di eccellenza; ma non esiste nemmeno nel
mondo anglosassone, dove le esigenze di una filosofia più varia, facile,
provocatoria, politica e di immediata gratificazione sono state soddisfatte
giusto accanto alla filosofia, nei “cultural studies”, nei dipartimenti di
letteratura comparata, e simili. La seconda è che non può nemmeno
esistere, da sola, una “filosofia impura”, e non è nemmeno interessante.
Perché è vero che Aristotele se rinascesse oggi parlerebbe di soap operas;
ma parlerebbe anche di logica, di metafisica e di fisica quantistica. L’ideale
sarebbe quello di una filosofia capace di ricoprire tutti i ruoli, dalla filosofia
pura alla filosofia pop, senza dimenticare l’importanza della conoscenza
storica, e della cultura in generale. È possibile qualcosa del genere? E quali
sarebbero le condizioni perché ciò potesse avvenire?
Ecco perché la domanda che bisognerebbe porsi, a mio parere, è se la
tradizionale contrapposizione analitici/continentali possa ancora tenere, e
se non sia necessario piuttosto introdurre un terzo criterio, quello della
filosofia “globalizzata”. Di che cosa si tratta? Ai miei occhi questa filosofia
costitutivamente bilingue, cioè con produzioni in lingua nazionale e in
inglese, come tale oggettivamente più ricca del solo monolinguismo
126
Maurizio Ferraris
inglese, o della frammentazione delle sole lingue nazionali, potrebbe porsi
all’incrocio di tre elementi. 1. Una competenza scientifica, che nella
fattispecie di una disciplina con forte componente umanistica come la
filosofia, significa anche una competenza filologica e storica. A cui si dovrà
però aggiungere la competenza rispetto alle scienze (naturali e sociali) e a
temi di discussione quali il problema mente-corpo, l’ontologia del mondo
naturale, il problema dell’equa distribuzione dei beni materiali o la natura
dell’inconscio. 2. Una competenza teorica, dove l’elemento analitico (o più
propriamente accademico) fornisce la forma, mentre l’elemento
continentale (o più propriamente extra-accademico) fornisce i contenuti.
Se c’è un ambito in cui il detto “i concetti senza intuizione sono vuoti, le
intuizioni senza concetti sono cieche” si applica alla perfezione è proprio la
sfera dei rapporti analitico-continentali. 3. Una pertinenza pubblica. Le
persone sono disposte ad accettare un linguaggio tecnico o addirittura
incomprensibile se la contropartita è la cura del cancro. Ma questo non è
ciò che può offrire la filosofia. Dunque, fa intrinsecamente, e non
accidentalmente, parte della filosofia la capacità di rivolgersi a uno spazio
pubblico, consegnando a quello spazio risultati elaborati tecnicamente, ma
in forma linguisticamente accessibile.
Forse siamo in vista di una sintesi, dopo molti conflitti culturali e
scontri di civiltà che hanno caratterizzato l’incontro fra ambienti filosofici
diversi nel secolo scorso (su tutti, basterà considerare le vicende della
decostruzione in America). In una lingua che sarà l’inglese, o qualcosa del
genere, circoleranno dei contenuti fortemente ibridati (analitici,
continentali, di scienze cognitive, di storia della filosofia). Con ogni
probabilità ciò che chiamiamo, con quello che – ripeto – è una
terminologia radicalmente inadeguata, “filosofia analitica”, avrà una
prevalenza accademica (ossia tendenzialmente imporrà dei formati di
valutazione e di ranking, come in effetti sta già avvenendo), mentre la
“filosofia continentale” avrà una prevalenza pubblica. Ma non è affatto
detto che queste due anime non potranno convivere nelle stesse persone, o
quantomeno nella stessa università. Se questa circostanza dovesse
realizzarsi, come spero, si sarebbe forse superata l’incommensurabilità di
paradigmi, che ha spesso afflitto la filosofia. Non si darà più il caso del
filosofo X considerato un genio da certi e un imbecille da certi altri e –
apparendo improbabile che il filosofo X possa essere considerato un genio
da tutti – si perverrà almeno a un certo grado di consenso per cui il filosofo
X sarà considerato quasi universalmente un imbecille.
FABRIZIO PALOMBI
«La riproduzione interdetta»:
ermeneutica e ripetizione in un confronto tra Lacan e Derrida
Secondo una struttura abissale da determinarsi,
questo spazio è ecceduto da potenze di simulacro.
J. Derrida
1. Ai confini del senso
L’ermeneutica trova la sua antica origine nell’interpretazione dei
messaggi d’origine divina, considerati latori di un senso nascosto che
doveva essere rivelato. Progressivamente dilatata al fine di comprendere
l’intenzione dell’autore di un testo qualsiasi, l’ermeneutica ha subito una
estensione indefinita dei suoi confini, tesa a ricostruire un contesto di senso
entro il quale collocare anche la genesi della soggettività. Questa rapsodica
definizione dell’ermeneutica è funzionale all’esigenza d’evidenziare il
primato del senso per la sua pratica interpretativa.
In italiano il termine “senso” possiede un’interessante ambiguità che
merita d’essere valorizzata in quanto non è solo sinonimo di significato ma
anche di verso, orientamento, direzione. Il senso, doppio, unico o vietato,
dirige non solo il traffico caotico delle nostre città e delle arterie stradali
che le collegano ma anche quello dei nostri discorsi, delle nostre speranze
e delle nostre paure, come dimostrano locuzioni quali “senza senso” e
“insensato” che danno voce al timore di sprecare un lavoro, un progetto,
un’esistenza. Approfondendo questa metafora il senso potrebbe essere
pensato come una direzione che collega un oggetto, un evento o un
soggetto ad altri poli donando loro un valore. Il senso di un oggetto è
costituito dalla sua funzione: possiamo infatti immaginare dei vettori che lo
collegano ad altri connettendo contesti e risalendo di freccia in freccia.
Sino a dove? Questi fili che si incrociano, formando i nodi degli eventi e
delle cose, potranno essere fissati a quale telaio?
Se definiamo questa cornice come “vita” oppure “mondo” ci rendiamo
conto che la nostra esistenza non può essere valutata in termini di senso a
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 127-144
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606439
127
128
Fabrizio Palombi
costo di commettere una fallacia logica. Se la vita è la condizione di
possibilità del senso allora possiamo riflettere solo sulla “vita del senso” ma
non sul “senso della vita”. Si tratta, in estrema sintesi, della morte di dio
nietszchiana il cui valore non indica solo il dissolversi dell’orizzonte
religioso ma una più generale relativizzazione del senso che colpisce anche
la scienza contemporanea.
Sigmund Freud ha esaminato questo stesso tema in una diversa
prospettiva proponendo la fortunata definizione delle tre ferite
narcisistiche, rispettivamente attribuite a Copernico, Darwin e a se stesso.
Jacques Lacan si ispira alla riflessione freudiana per sottrarre e differenziare
la pratica psicoanalitica da quella ermeneutica individuando il limite del
senso in un significante fondamentale costituito dal fallo che, nella
prospettiva clinica, protegge il soggetto dai deliri interpretativi della
psicosi paranoica1.
Tra gli autori che hanno ispirato la riflessione di Jacques Derrida e la
sua critica alla ontoteoteleologia troviamo proprio Nietzsche, Freud e (in
forma complessa e spesso implicita) Lacan, che vengono usati in varie
occasioni per radicalizzare l’attacco alla metafisica teleologica. “Il fattore
della verità” si confronta con la tradizione psicoanalitica e, in particolare,
con quella lacaniana che viene considerata una lettura di Freud, per così
dire, troppo sensata, troppo vincolata a criteri di carattere ermeneutico2.
2. La lettera rubata
La disputa tra Derrida e Lacan è un complesso confronto giocato di
sponda per mezzo de La lettera rubata di Edgar Allan Poe (1845). Questo
celebre racconto ha contribuito a creare un genere narrativo, ed è stato
oggetto di numerose interpretazioni che hanno stratificato su esso un
imponente deposito esegetico.
La nostra attenzione si rivolgerà esclusivamente a due strati
cronologicamente successivi di questa tradizione di esegesi, costituiti
dall’interpretazione lacaniana del testo di Poe e da quella che definiamo
provvisoriamente la metainterpretazione o meglio la controinterpretazione
derridiana. Più precisamente, nel 1955 Lacan dedica una seduta del suo
Cfr. PALOMBI (2011).
Per un’interessante sintesi delle critiche alla tradizione ermeneutica cfr. DERRIDA (20022003, p. 93) e VERGANI (2000, pp. 169-178).
1
2
«La riproduzione interdetta»
129
secondo seminario, intitolato L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della
psicoanalisi3, a La lettera rubata. Il testo sarà in seguito pubblicato, sviluppato
e ripreso sino al 1966 quando viene proposto come brano inaugurale della
raccolta dei suoi Scritti. Vent’anni dopo il secondo seminario di Lacan e
quasi dieci anni dopo la pubblicazione degli Scritti, Derrida pubblica Il
fattore della verità (1975) con il dichiarato proposito di mettere in crisi
l’articolazione del commento lacaniano al fine di tentare un attacco
frontale alla sua interpretazione della psicoanalisi formulando la celebre
accusa di “fallogocentrismo”4.
“Abisso”, “abissale”, “abissato”, “inabissarsi”: sono i termini usati da
Derrida per definire la struttura narrativa de La lettera rubata che abbiamo
evidenziato nella prima citazione in esergo. Un elenco sufficiente a
scoraggiare ogni pretesa di esaustività nell’interpretare il testo di Poe che,
per quanto ci riguarda, useremo solo come fulcro teorico per proporre
alcune riflessioni in relazione alla ripetizione e ai limiti dell’ermeneutica.
In proposito non si deve dimenticare che le proposte teoriche di Lacan e
Derrida sono tra loro in competizione per stabilire chi sia il più distante dal
senso e dalla tradizione ermeneutica. La posta di questo complesso gioco è
costituita, per Lacan, dal primato del significante sul significato e, per
Derrida, della traccia sul senso.
Proporremo alcuni provvisori tentativi di catalogazione e
d’organizzazione dei diversi livelli del confronto per mostrare in seguito la
loro precarietà e insufficienza provocata proprio dalla struttura abissale
della narrazione di Poe. Inoltre avanzeremo qualche considerazione
strumentale su alcune opere d’arte che potrebbero essere efficaci dal punto
di vista esplicativo ma che necessitano di essere approfondite e
contestualizzate in un contesto più ampio. Uno di questi usi strumentali
legittimerà anche la seconda citazione in esergo estrapolata dalla Ricerca del
tempo perduto nella conclusione del nostro contributo.
La lettera rubata è un testo molto famoso del quale daremo per scontata
la conoscenza generalissima della sua trama e del suo baricentro narrativo
costituito dallo stratagemma di nascondere una lettera ostentandola in un
luogo inaspettato e visibilissimo. La lettera rubata, pubblicata per la prima
volta nel 1845 su “The Chamber's Journal”, è il terzo racconto di un ciclo
che ha come protagonista l’investigatore Auguste Dupin.
3
4
LACAN (1955-1956).
DERRIDA (1975, pp. 105-106).
130
Fabrizio Palombi
3. La struttura narrativa
Per dipanare, almeno parzialmente e provvisoriamente, l’intricata
struttura narrativa del racconto di Poe proponiamo il metodo analitico di
ricostruirla a posteriori, dalla sua fine. L’aggettivo “analitico” possiede la
duplice accezione di “scompositivo” e di “pertinente alla teoria freudiana”,
in particolare alla dinamica del Nachträglichkeit freudiano e dell’après-coup
lacaniano. Integriamo, inoltre, elementi del racconto che Poe non indica
esplicitamente ma propone al lettore in forma indiretta seppure
estremamente chiara. Secondo Derrida, questo metodo retrospettivo e
integrativo mostra una serie di cornici inserite l’una nell’altra sulle quali ci
soffermeremo in seguito; per ora ci limitiamo a segnalare le due maggiori,
individuate da un anno imprecisato del XIX secolo e da un intervallo
temporale di un mese che le separa, e una lunga e complessa serie di
minori che distinguono i diversi livelli narrativi.
In quella che potremmo considerare, approssimativamente e
temporaneamente, come l’inquadratura più piccola, la Regina di Francia
racconta al Prefetto di Polizia di Parigi del furto di una lettera di un suo
nobile spasimante, subito davanti ai suoi occhi ad opera del potente
ministro D. Del contenuto della lettera il lettore e i protagonisti del
racconto (con l’ovvia eccezione della regina) non saranno mai informati. Il
prefetto di Polizia s’impegna in lunghe, minuziosissime quanto inutili
ricerche della lettera nella casa del ministro dopo le quali chiede aiuto al
detective Dupin informandolo della vicenda in presenza di un suo amico
che, infine, lo narra al lettore. Interessante rilevare che l’amico del
detective, soggetto narrante della vicenda, resti anonimo, come voce senza
volto.
Dopo un mese il Prefetto ritorna da Dupin che, inaspettatamente, è in
grado di consegnargli la lettera dietro un lauto compenso. Il detective,
successivamente all’uscita di scena del Prefetto, racconta all’amico di
essersi recato due volte nella casa del Ministro: la prima per compiere una
ricognizione visiva della sua abitazione individuando il documento sottratto
in un portacarte appeso al centro di un camino. La seconda, dopo aver
distratto il Ministro grazie a un complice, ha sostituito la lettera con
un’altra sulla quale ha scritto con la sua grafia in modo che fosse
riconoscibile la seguente citazione «Una trama si funeste se non è degna
«La riproduzione interdetta»
131
d’Atreo è degna di Tieste» tratta da una delle più famose opere del
drammaturgo Prosper de Crébillon5.
4. Lacan, la lettera e la ripetizione
La rilevanza dell’analisi lacaniana del racconto di Poe per l’argomento
del nostro ciclo di seminari si evince sin dalle primissime righe dove lo
psicoanalista francese afferma che
La nostra ricerca ci ha condotti al punto di riconoscere che l'automatismo di
ripetizione (Wiederholungszwang) trae principio da ciò che abbiamo chiamato
insistenza della catena significante. Questa nozione l'abbiamo isolata come
correlativa dell'ex-sistenza (cioè: del posto eccentrico) in cui dobbiamo situare
il soggetto dell'inconscio, se si deve prendere sul serio la scoperta di Freud6.
Esaminiamo brevemente questa citazione e soprattutto alcune parole
chiave. Il termine tedesco Wiederholungszwang, più frequentemente
tradotto in italiano con la locuzione “coazione a ripetere”, “suole” indicare
la tendenza inconscia a ripetere modalità comportamento tipiche, passate o
stereotipate in contrasto con quello che Freud ha definito come il
«principio di piacere». La scelta di tradurre con l’automatisme de répétition il
termine freudiano ci pare interessante e ci riserviamo di studiarla in modo
approfondito in altre sedi, tuttavia sin d’ora ci sembra utile ipotizzare un
collegamento con uno dei più importanti riferimenti della formazione
giovanile dello psicoanalista francese costituito da Gaétan de Clerambault7.
La parola “ripetizione” ha, innanzitutto, nel lessico lacaniano,
un’accezione clinica e psicopatologica nella quale il soggetto cosciente si
scopre spettatore delle proprie azioni, agito da un automatismo del quale
vede i limiti, che può descrivere sino alla finezza fenomenologica, senza
essere tuttavia in grado di governare o controllare.
La “catena significante” viene costruita a partire dall’algoritmo
saussuriano rovesciato S/s (Significante su significato) che viene reiterato
in una successione di elementi costruita in modo tale che un elemento Sn
sia rispettivamente significato di Sn-1 e Significante di Sn+1. Questa
DE CREBILLON (1707).
LACAN (1955, p. 7).
7 PALOMBI (2009, pp. 17-18, 74).
5
6
132
Fabrizio Palombi
reiterazione è il “principio” della ripetizione nella sua duplice accezione di
fondamento e inizio.
Il riferimento alla ex-sistenza interpretata come “posto eccentrico” ha la
funzione di tenere insieme Freud e Heidegger e deve essere letta come una
critica al soggetto umanistico che trova nella coscienza il proprio centro. Al
contrario il baricentro della soggettività psicoanalitica è spostato verso la sua
periferia costituita dalle formazioni dell’inconscio ovvero sogno, motto di
spirito, lapsus e, come nel caso della coazione a ripetere, sintomo. Altri
aspetti ripetitivi sono l’iterazione delle narrazioni e delle narrazioni di
narrazioni, che incastrano il racconto di un personaggio dentro quello di un
altro, la ricerca ossessiva dei poliziotti nella casa del ministro.
Inoltre, secondo Lacan, nel testo di Poe viene riprodotta una struttura
triangolare che potremmo così riassumere in riferimento a tre personaggi
presenti nelle varie scene: a) Il Re, la Regina e il Ministro, b) la Regina, il
Ministro e il Prefetto, c) il Prefetto, Dupin e l’amico e d) Il Ministro,
Dupin e il complice.
Derrida rileva che le numerose occorrenze di termini quali “trio” e
“triangolo intersoggettivo” servirebbero a «descrivere le due scene del
“dramma reale” così decifrato» in relazione al complesso edipico freudiano8.
Questa è la verità ma (come direbbe Lacan) non tutta perché è
verosimile che l’insistenza dello psicoanalista sul tema del triangolo serva
per ricollegarsi non solo all’Edipo ma anche all’enigma dei tre prigionieri e
alla temporalità che caratterizza il suo setting analitico9. In una pagina del
seminario di Lacan si commenta la traduzione francese del titolo del
racconto di Poe affermando che
Baudelaire […] ha tradito Poe traducendo con «la lettre volée» il
suo titolo The Purloined Letter, che usa una parola rara […] to purloin,
[…], anglo-francese, composta […] dal prefisso pur […] e dalla
parola dell'antico francese: loing, loigner, longer. Nel primo elemento
riconosceremo il latino pro, in quanto si distingue da ante perché
suppone un dietro, davanti a cui esso si pone per eventualmente
garantirlo o per porsene come garante […]. Il secondo, vecchia parola
francese loigner […] vuol dire […] lungo: si tratta dunque di mettere
da parte, o, per ricorrere ad una locuzione familiare francese che
gioca sui due sensi, di mettre à gauche10.
DERRIDA (1975, pp. 41-42).
Cfr. PALOMBI (2009, pp. 44-47).
10 LACAN (1955-1966, p. 26).
8
9
«La riproduzione interdetta»
133
La glossa lacaniana evidenzia una lettera che non è propriamente
sottratta ma piuttosto posta di riserva, conservata in vista del futuro: una
traduzione che adombra gli obiettivi teorici della speculazione lacaniana sul
testo di Poe per mostrare il suo ineluttabile destino. Si tratta della tesi che
si trova alla conclusione del testo originario, successivamente integrato
negli Scritti da un’Ouverture e da una Suite, nel quale leggiamo «la formula
stessa […] della comunicazione intersoggettiva: in cui l'emittente […]
riceve dal ricevente il proprio messaggio in forma invertita. Così, ciò che
vuol dire “la lettera rubata”, cioè “giacente”, è che una lettera arriva sempre
a destinazione»11.
La lettera arriverebbe sempre perché essa non è tanto o solo un oggetto
materiale quanto una posizione, una relazione indipendente dal suo
contenuto, del quale, infatti, il racconto ci tiene all’oscuro. La sua
esistenza è determinata da una relazione tra soggetti e infatti, se il ministro
la distruggesse segretamente, renderebbe davvero invincibile il suo potere
di ricatto.
Lacan intende dimostrare «il potere del significante» in quanto «il vero
protagonista del racconto» sarebbe la lettera che dirige il traffico di tutti i
personaggi della storia12. In un'altra occasione commentando alcune pagine
del terzo seminario, dedicati alla «pace della sera», avevamo dato una
motivazione clinica del primato del significante come struttura soggettiva a
protezione dal delirio ermeneutico che caratterizza la paranoia13. In quei
brani del suo terzo seminario Lacan sostiene una simile tesi anche grazie a
una sorta di strana mereologia di sapore fenomenologico. Infatti, leggiamo
che la
materialità del significante […] è singolare in più di un punto, il primo
dei quali è di non supportare né sopportare punto la partizione. Fate
una lettera a pezzettini, resta la lettera che è, e in tutt'altro senso
da ciò di cui la Gestalttheorie può render conto con il larvato vitalismo
della sua nozione di tutto14.
LACAN (1966, p. 38, corsivo nostro).
CHEMAMA, VANDERMERSCH (1998, p. 187).
13 PALOMBI (2011).
14 LACAN (1966, p. 21 e n. 1).
11
12
134
Fabrizio Palombi
È importante ricordare in merito che Derrida, quasi vent’anni dopo,
richiamerà questa posizione interpretandola come una sorta di
radicalizzazione dell’interpretazione idealista della fenomenologia
husserliana15.
In questa sede, ispirandoci al tema derridiano della scrittura e al
tentativo deleuziano di interpretare il barocco alla luce dell’algoritmo della
piega16, vorremmo proporre una sorta d’interpretazione ologrammatica
della lettera.
Ricordiamo sommariamente che l’olografia è una nota tecnica di
registrazione realizzata con particolari tipi di laser in grado di riprodurre
illusoriamente la tridimensionalità di un oggetto della quale ci interessa
particolarmente la proprietà dell’invarianza di scala che motiva anche la sua
etimologia. La parola è un neologismo composto dai termini greci holos e
grafè e possiede un significato che si potrebbe rendere con la locuzione
“scrittura dell’intero” poiché, a differenza dalle tradizionali fotografie, ogni
porzione di un ologramma possiede tutte le informazioni dell’immagine
intera. Si potrebbe dire che in «un ologramma […] il tutto […] si
rispecchia nelle singole parti frammentarie» poiché il «tutto sta nella parte
che sta nel tutto»17.
A una prima ricerca non risulta che Lacan abbia mai manifestato
particolare interesse sull’argomento ma comunque pare coerente con la
sua interpretazione ottica della soggettività che in questa sede abbiamo già
avuto modo d’esaminare. Inoltre ricordiamo che lo psicoanalista francese si
è impegnato in alcune riflessioni sulla cosiddetta «olofrase» che possiede
alcune significative analogie con la proprietà dell’ologramma18.
Per comprendere il guadagno dal punto di vista psicoanalitico bisogna
integrare l’ologrammaticità della lettera con la natura immaginaria del
trauma.19 In questo modo potremmo immaginare ogni singolo atto
dell’automatismo di ripetizione, come qualcosa che riproduce un intero,
una scena primaria della vita del soggetto della quale non coglie
completamente il valore e che il soggetto è condannato a riprodurre.
Dobbiamo pensare tale scena originaria come qualcosa che non è mai
esistito, nel senso della semplice presenza, per porre la riproduzione come
DERRIDA (1991, p. 165), cfr. PALOMBI (2012).
DELEUZE (1988).
17 CARMAGNOLA (2007, p. 93).
18 Cfr. LACAN (1964, p. 233).
19 PALOMBI (2009, pp. 40-41).
15
16
«La riproduzione interdetta»
135
originaria e il soggetto come riproduttore di qualcosa di fondamentale di se
stesso che è destinata a sfuggirgli.
5. Criptoermeneutica lacaniana
La tesi di Derrida è diversa e, da alcuni punti di vista opposta, in quanto
sostiene «non che la lettera non arrivi mai a destinazione, ma [che] fa parte
della sua struttura il potervi anche non arrivare»20. Per dimostrare questa
tesi Derrida usa diverse argomentazioni tra le quali la più celebre è fondata
sull’analisi critica della cosiddetta “parola piena”. Si tratta di un concetto,
caratteristico della prima fase della riflessione lacaniana, usato per
distinguere la parola, pronunciata nel contesto analitico dal paziente per
liberarsi dalle identificazioni immaginarie, da quella vuota, sorta di
chiacchiera nel senso heideggeriano, che lascia il soggetto prigioniero dei
propri riflessi speculari.
La locuzione non compare mai in questa forma nel testo di Lacan
sebbene siano presenti espressioni semanticamente vicine quali «discorso
pieno di significazione»21 e riferimenti al cosiddetto “discorso di Roma”22.
La parola piena dovrebbe dimostrare l’incapacità lacaniana di liberarsi
del dominio del significato, dell’ermeneutica del senso e, di conseguenza,
della cosiddetta metafisica della presenza.
Queste considerazioni sostengono la critica radicale alla lettura
lacaniana del testo di Poe. Derrida ritiene che «nel determinare il posto della
mancanza» Lacan intenda proporre una sorta di “decifrazione ermeneutica”
nonostante i suoi tentativi di “denegazione” non sarebbero in grado
d’occultare il “significato ultimo” di questa criptoermeneutica lacaniana, il quale
sarebbe da individuare nel «legame tra Femminilità e Verità» che Lacan, a
quattordici anni di distanza, ripropone ancora.23 Derrida ritiene che
nel momento in cui il Seminario, come Dupin, trova la lettera […] fra
le gambe della donna, la decifrazione dell'enigma è ancorata alla verità.
Il senso della novella, […] “la lettera rubata”, cioè “giacente” […]
arriva sempre a destinazione […], è scoperto. In quanto scoperta di
DERRIDA (1975, p. 59); cfr. VERGANI (2000, p. 112).
LACAN (1966, pp. 15, 21).
22 LACAN (1956).
23 DERRIDA (1975, pp. 55-56).
20
21
136
Fabrizio Palombi
un voler-dire (la verità), in quanto ermeneutica, la decifrazione
[…] arriva anch'essa a destinazione24.
In questo modo si giunge a sostenere che «la verità della lettera rubata è
la verità, il suo senso è il senso e che la dinamica di “velamento” e di
“svelamento” consente di armonizzare «l'intero Seminario con il discorso
heideggeriano sulla verità»25. Derrida è consapevole che le sue obiezioni
potrebbero essere facilmente respinte ricordando che il testo citato
appartiene a una fase del pensiero di Lacan che data agli anni Cinquanta e
che non potrebbe valere per la successiva complessa evoluzione.
Infatti, Derrida fa riferimento al “discorso di Roma” (1956)
accoppiandolo con La direzione della cura (1961) come fulcro della sua
operazione di lettura filosofica e giustificando il proprio anacronismo nel
seguente modo:
un certo tipo di enunciazioni sulla verità si è presentato […] sotto
forma di sistema […]. Siccome il Seminario, insieme ad alcuni altri
saggi cui farò riferimento […] fa parte di tale sistema […] occorre
definirlo se si vuol capire la lettura della Lettera rubata. Si può e si
deve farlo anche se, dopo il 1966, in un campo teorico
trasformato, il discorso lacaniano sulla verità […] si prestasse a un
certo numero di aggiustamenti26.
Derrida sostiene un’interpretazione generale del pensiero di Lacan
come sistema, che verrà in seguito fatta propria anche dalla Roudinesco, e
che dovrebbe legittimare la propria lettura del Seminario su La lettera
rubata. In questo modo egli può usare un brano estrapolato da un altro
testo di Lacan, titolato appunto Parole vide et parole pleine dans la
realisation psychanalytique du sujet, nel quale si sostiene che «il discorso
rappresenta l'esistenza della comunicazione; anche se nega l'evidenza, afferma che
la parola costituisce la verità […] anche se è destinato ad ingannare, specula sulla
fede nella testimonianza»27. In questo modo Derrida intende svelare che nella
lettura lacaniana «la circolazione sarà sempre quella della verità: verso la verità.
DERRIDA (1975, pp. 59-60).
Ivi, pp. 51-52.
26 Ibidem (corsivo nostro).
27 LACAN (1966, p. 245) citato in D ERRIDA (1975, pp. 95-96).
24
25
«La riproduzione interdetta»
137
Causa ed effetto del circolo, causa sui, tragitto proprio e destino della
lettera»28.
Il filosofo francese evidenzia in particolare un passo del discorso
lacaniano nel quale «la parola piena» viene definita «per la sua identità con ciò di
cui parla»29 per sostenere che «la parola […] dell'esegeta si riempirebbe nel
momento in cui assume e si fa carico dei “principi di comprensione” del
messaggio dell'altro […] in quanto esso “veicola” una “parola piena”»30. Questo
sistema soddisferebbe una definizione rigorosa di «circolo ermeneutico» in
quanto «l’autenticità» diverrebbe il «polo di adeguazione e di riappropriazione
circolare per il processo ideale dell'analisi»31.
Giunto a questo punto Derrida ha gioco facile nel proporre una
compromettente citazione lacaniana nella quale un certo tipo di circolo viene
esplicitamente usato e invocato. Si tratta di un brano nel quale lo psicoanalista
francese sostiene che la lettera
può subire una deviazione, perché ha un tragitto che le è proprio
[…]. Il significante si mantiene unicamente in uno spostamento
paragonabile a quello delle pubblicità luminose […] in ragione del
suo funzionamento alternante […] che esige che esso lasci il suo
posto […] a patto di […] farvi ritorno circolarmente32.
Nella modernità e nella postmodernità anche i messaggi pubblicitari, le
luci e le regole gestaltiche che li animano, vengono interpretati da principi
ermeneutici che non devono più decifrare la volontà divina ma quella del
mercato che ne ha preso il posto. In questo modo la psicoanalisi
sembrerebbe perdere gran parte di quella sua funzione critica che Lacan
aveva rivendicato nella sua ambiziosa sfida nei confronti della psicologia
dell’Io. Inoltre, Derrida rileva che il Seminario di Lacan, pronunciato
nel 1955
ebbe nel 1966 il suo posto all'inizio degli Ecrits, secondo un
ordine, non […] cronologico, […]. Forse dovrebbe organizzare
una certa scena degli Ecrits. […]. A chi vorrà limitare la
portata degli interrogativi sollevati in questa sede, nulla
DERRIDA (1975, p. 133, n. 31).
LACAN (1966, p. 373).
30 DERRIDA (1975, p. 100).
31 Ivi, p. 101.
32 LACAN (1966, pp. 26-27) citato in D ERRIDA (1975, p. 49).
28
29
138
Fabrizio Palombi
impedisce di contenerli al posto attribuito a questo
Seminario dal suo autore: un posto d'ingresso33.
Il combinato disposto di queste due tesi è una sorta di attacco
frontale contro la psicoanalisi lacaniana che sembrerebbe da
alcuni punti di vista liquidata come espressione della tradizione
fallologocentrica 34 che in seguito sarà attenuato senza tuttavia
abbandonare mai completamente le sue riserve nei confronti di
Lacan 35.
Condividiamo se non la sistematicità del discorso lacaniano almeno una
caratteristica organicità, ma riteniamo che Derrida non valuti appieno la
portata della lettura retroattiva che lo psicoanalista francese applichi ai suoi
testi da lui stesso evidenziata nella sua seconda tesi. La lettura après-coup, di
origine freudiana e condivisa sia dallo psicoanalista sia dal filosofo francese,
modifica retroattivamente il valore del discorso e quindi anche della
funzione della “parola piena”. A questo proposito è importante
segnalare che Lacan propone un’efficace replica a queste accuse
già nel diciottesimo Seminario, intitolato Di un discorso che non sarebbe
quello del sembiante, che si può articolare nei seguenti tre punti: a)
distinzione del discorso filosofico da quello analitico già proposta nel
seminario precedente, b) inefficacia della riduzione della psicoanalisi
lacaniana al logocentrismo in opposizione a “una mitica archiscrittura” e c)
smarcamento «della nozione di ‘parola piena’ dalla formulazione
logocentrica» derridiana. Lacan sottolinea che la pienezza della parola non
riguarda la sua originarietà, in seguito decaduta, indebolita o svuotata, ma
che dipende dall’oggetto piccolo “a” quale «presentificazione impossibile
del mitico oggetto del primo soddisfacimento»36.
6. Cornici e abissi
Se questa nota critica di Derrida non ci sembra efficace, invece
riteniamo assai interessante un’altra sua argomentazione nella quale, con
effetto chiasmatico, viene messa in campo una sorta d’interpretazione
DERRIDA (1975, p. 126, n. 7, corsivi dell’autore).
DERRIDA (1975, p. 137, n. 39).
35 DERRIDA (1991) e (2003).
36 COSENZA (2008, pp. 276-277).
33
34
«La riproduzione interdetta»
139
ottica (almeno a noi piace pensarla così) de La lettera rubata nella quale
giocano un ruolo fondamentale i concetti di “cornice” e di “messa in
abisso”.
Derrida ritiene che vi sia «una cornice invisibile ma strutturalmente
irriducibile intorno alla narrazione» i cui limiti sono difficilmente individuabili37.
Il filosofo usa il termine francese cadre che, come sua consuetudine teoretica,
possiede un’interessante polisemia in quanto può significare “cornice” ma anche
«quadro […] nell'accezione cinematografica e fotografica».38 Lacan non si
accorgerebbe dell’importanza di tale cornice e la ritaglierebbe senza
preoccuparsi degli effetti della sua operazione per «ricostruire la scena del
significante in significato […], il testo in discorso».39
Nel primo capitolo del libro di Derrida, titolato «pretesti furtivi», viene
analizzato un brano de L’interpretazione dei sogni dove Freud commenta la celebre
favola di Andersen intitolata I vestiti nuovi dell’Imperatore40. Nelle ultime righe di
questo capitolo preliminare Derrida individua nel commento freudiano uno
strumento teorico fondamentale che sarà successivamente applicato sul
seminario di Lacan. Si tratta della
messa a nudo della messa a nudo, […] proposta da Freud, la messa a nudo
del motivo della nudità […] motivo […] travestito […] dalla fiaba di
Andersen […] in una scrittura che […] non appartiene più allo spazio della
verità decidibile. Secondo una struttura abissale5 […] la scena analitica,
messa a nudo […] viene prodotta […] in una scena di scrittura che denuda
[…] il senso dominante […] e la verità del re41.
Il baricentro di questa citazione si trova nell’aggettivo abissale che viene
precisamente esaminato dal traduttore italiano in relazione alla «mise en abîme,
l'inclusione in abisso […]. L'espressione è di origine araldica: si dice in abisso
o “in cuore” quando lo scudo, oltre alle altre figure principali, porta nel
suo centro un'altra figura o un piccolo scudo, che ha la caratteristica di
riprodurre il disegno dell'intero scudo, e quindi anche del piccolo scudo e così
via, ad infinitum».42 L’abissalità serve a Derrida per sostenere, contro
Lacan, che
DERRIDA (1975, pp. 38-39, corsivo nostro).
ZAMBON (1978, p. 127, n. 10).
39 DERRIDA (1975, p. 39).
40 Ivi, p. 18 e FREUD (1899, p. 227).
41 DERRIDA (1975, pp. 20-21, corsivo nostro).
42 ZAMBON (1978, p. 125, n. 5).
37
38
140
Fabrizio Palombi
La lettera rubata […] non comincia né con i drammi triangolari, né con
la narrazione che li mette in scena […]. Con essi perciò non termina
nemmeno. La lettera rubata mette in scena un narratore e un
regista […] il quale - finto dalla Lettera rubata - finge con La
lettera rubata di raccontare il “dramma reale” della lettera rubata,
ecc. Altrettanti supplementi che “abissano” […] il triangolo
narrato43.
Tale dinamica mette in crisi la possibilità di organizzare in modo stabile
la struttura del racconto, come abbiamo inizialmente proposto anche noi,
seguendo la reiterazione dell’algoritmo saussuriano rovesciato di Lacan.
Nello stesso modo diventa impossibile discretizzare le ripetizioni, i
passaggi di testimone da significante a significato, collocandole nella
successione che abbiamo presentato precedentemente. Le ripetizioni qui
sembrano, da un lato, inabissarsi in un regresso all’infinito e, dall’altro,
sovrapporsi, come fotogrammi di una pellicola sovraesposta sulla quale la
stessa immagine compare con i contorni moltiplicati e sfocati. In proposito
si deve anche tenere «presente, in rapporto ai molteplici giochi di Derrida, che il
verbo abîmer vuol dire [anche] guastare, rovinare»44.
Secondo Derrida tale «scena di scrittura» e i suoi «limiti […] abissati»
impongono una «interminabile deriva» alla «unità» de La lettera rubata di cui il
Seminario di Lacan non terrebbe «minimamente conto»45.
Per cercare di tematizzare le paradossali e inconfessate complicità teoriche tra i
due Jacques ci sembra interessante segnalare, come ricorda anche il
traduttore italiano, che il modo più semplice per realizzare la “messa in
abisso” è quella di prendere due specchi piani e di disporli parallelamente:
si crea così una scia di riflessi in cui gli oggetti sono riprodotti su scala
sempre inferiore che costituisce una fuga all'infinito, poiché l'oggetto si
rimpicciolisce fino ad assumere dimensioni impercettibili. Ci sembra sia
possibile vedere, in questo punto del testo di Derrida, un’autoapplicazione
della messa in abisso derridiana allo stesso testo derridiano perché con
malizia potremmo rintracciarvi la passione lacaniana per gli specchi
sviluppata nelle diverse varianti del dispositivo ottico.
DERRIDA (1975, p. 36).
ZAMBON (1978, p. 125, n. 5).
45 DERRIDA (1975, p. 107).
43
44
«La riproduzione interdetta»
141
7. Conclusione: la riproduzione interdetta
Siamo convinti che al di là delle vicende personali che hanno diviso i
due studiosi le loro ricerche si illuminano e chiariscono reciprocamente
con una struttura chiasmatica che lo stesso Derrida ha messo in luce
(1991). Come tenere insieme Lacan e Derrida allo scopo di approfondire e
chiarire il problema della ripetizione?
Nella coazione a ripetere il soggetto riproduce qualcosa che gli sfugge
perché è interdetto da una dinamica inconscia. Qualcosa che è invisibile
perché troppo evidente come accade ne Il perturbante46 ma soprattutto in
alcuni momenti della fase dello specchio lacaniana. Qualcosa che è, sotto
alcuni punti di vista, non completamente controllabile e definibile.
Sembrerebbe possibile individuare il cuore sfuggente della ripetizione in
una dialettica tra identità e differenza in quanto la ripetizione è il riprodursi
di un identico che non può essere tale: se lo fosse temporalmente,
spazialmente o logicamente, non sarebbe una riproduzione ma l’originale.
Questa argomentazione ossimorica indica che se qualcosa non fosse
identico a qualcosa d’altro non potremmo parlare di ripetizione, ma
nemmeno se lo fosse totalmente.
Per questo, seguendo anche Lacan e Derrida, proviamo a pensare la
ripetizione come originaria poiché risolve le aporie che nascono dal
pensare la ripetizione come una riproduzione dell’origine. In un modo
suggestivo vorremo concludere il contributo riferendoci a un celebre
quadro di René Magritte intitolato La riproduzione interdetta (1937) che pare
metta in scena con grande efficacia quanto abbiamo provato faticosamente
ad argomentare.
Questa famosa opera d’arte, conservata al Museo Boijmans Van
Beuningen di Rotterdam, sorprende lo spettatore mostrando un individuo
che contempla, riflessa in uno specchio surreale, le proprie spalle. Si tratta
di una sorta di specchio rovesciato, di anti-specchio, che, come nel celebre
quadro di Velasquez studiato da Foucault o nelle anamorfosi catottriche
valorizzate dai surrealisti e da Lacan, non si limita a duplicare la realtà in
modo neutrale ma produce un “quadro” diverso, nel quale soggetto e
oggetto, interno ed esterno producono un estimo47 cortocircuito.
46
47
FREUD (1919).
PALOMBI (2008)
142
Fabrizio Palombi
Nel quadro ritroviamo anche Poe perché il libro appoggiato sulla mensola,
riflesso correttamente, mostra la copertina di una sua opera, tradotta da
Baudelaire (1858) e intitolata The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838).
La riproduzione interdetta sembra possa essere applicata alla coazione a
ripetere dove un’intera scena viene riprodotta dettagliatamente perdendo
però alcuni elementi essenziali come quello del volto. Ponendo alle spalle
dell’individuo un altro specchio di questo tipo potremmo riprodurre una
messa in abisso oppure pensare che La riproduzione interdetta sia la cornice di
un’altra messa in abisso.
Abstract
Hermeneutic was considered as a koiné, a common language which
allows the communication between philosophy, science, religion and art
within the boundary of sense. My paper analyzes Jacques Derrida's attempt
to force this barrier of meaning examining one of his most famous books
titled The factor of truth.
Edgar Alan Poe, Sigmund Freud and Jacques Lacan are the main
theoretical references used by the French philosopher to face the challenge
that my paper will deal with and try to reconstruct from a historical and
logical point of view, underlining the importance of psychoanalytic
repetition. The focus of the paper's argumentation is represented by a
comparison between Lacanian and Derridian strategies of criticizing
hermeneutic and its circular dynamic.
Bibliografia
F. BONICALZI (2011, a cura di), Pensare la pace. Il legame imprendibile,
JacaBook, Milano.
M. CARDOT ET AL. (1991, a cura di), Lacan avec les philosophes, Albin
Michel, Paris.
F.CARMAGNOLA (2007), Il desiderio non è una cosa semplice. Figure di ágalma,
Mimesis, Milano.
R. CHEMAMA, B. VANDERMERSCH, (1998), Dictionnaire de la Psychanalyse,
Larousse-Bordas, Paris, trad. it. Dizionario di psicanalisi, Gremese, Roma,
2004.
«La riproduzione interdetta»
143
D. COSENZA (2008), Derrida e Lacan: un incontro mancato?, in
D’ALESSANDRO, POTESTIO, pp. 271-282.
P. D’ALESSANDRO, A. POTESTIO, (2008, a cura di), Su Jacques Derrida.
Scrittura filosofica e pratica di decostruzione, LED, Milano.
P. J. DE CRÉBILLON (1707), Atrée et Thyeste, trad. it. Atreo e Tieste, Bettoni,
Milano 1831.
G. DELEUZE (1988), Le pli. Leibniz et le Baroque, Minuit, Paris, trad. it. La
piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino, 2004.
J. DERRIDA (1975), Le facteur de la vérité, Flammarion, Paris, trad. it. Il
fattore della verità, Adelphi, Milano 1978.
J. DERRIDA (1991), “Pour l’amour de Lacan” in CARDOT, ET AL. (1991),
trad. it. “Per l’amore di Lacan”, aut aut, n. 260-261, 1994.
J. DERRIDA (2002-2003), Séminaire. La bête et le souverain. Volume 2, Galilée,
Paris, 2010, trad. it. La bestia e il sovrano. Volume 1, Jaca Book, Milano,
2010.
S. FACIONI, S. REGAZZONI, F. VITALE (2012) Derridario. Dizionario della
decostruzione, il nuovo melangolo, Genova.
S. FREUD (1976-1980), Opere di Sigmund Freud, Bollati Boringhieri, Torino,
12 voll.
S. FREUD (1899), Die Traumdeutung Franz-Deuticke, Wien, trad. it.
L'interpretazione dei sogni, in FREUD (1976-1980), vol. 3.
S. FREUD (1919), “Das Unheimliche”, Imago; trad. it. Il perturbante, in S.
FREUD (1976-1980), vol. 9, pp. 85 sgg.
J. LACAN (1956), "Fonction et champ de la parole et du langage en
psychanalyse", La Psychanalyse, I, pp. 81-166, trad. it. Funzione e campo della
parola e del linguaggio in psicoanalisi, in LACAN, J. (1966) pp. 231-316.
J. LACAN (1964), Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse
Seuil, Paris, 1973, trad. it. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della
psicoanalisi, Einaudi, Torino 1979.
J. LACAN (1966), Écrits, Seuil, Paris, trad. it. Scritti, Einaudi, Torino,
1974, ristampa 2002.
J. LACAN (1954-1955), Livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la
technique de la psychanalyse, Seuil, Paris, 1977, trad. it. Libro II. L'io nella
teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, Einaudi, Torino, 1991.
J. LACAN (1955-1966), “Le séminaire sur ‘La lettre volée’”, La
Psychanalyse, II, pp. 15-44 e in LACAN (1966), trad. it. Il seminario su ‘La
lettera rubata’ in LACAN (1966), pp. 7-58.
M. PASQUINO, S. PLASTINA (2008, a cura di), Fare e disfare. Otto saggi a
144
Fabrizio Palombi
partire da Judith Butler, Mimesis, Milano.
F.PALOMBI (2008), Un intermedio surreale. L’aporia di Antigone tra Judith
Butler e Jacques Lacan in PASQUINO, PLASTINA, pp. 123-138.
F.PALOMBI (2011), ‘La pace della sera’: considerazioni fenomenologiche sul terzo
seminario di Lacan in BONICALZI, pp. 279-296.
E. A. POE (1838), The Narrative of Arthur Gordon Pym, Harper, New York,
trad. it. Il racconto di Arthur Gordon Pym, Garzanti, Milano 1990.
E. A. POE, (1844) “The purloined letter”, in The Gift for 1845, trad. it. La
lettera rubata, Mursia, Milano 2009
M. VERGANI (2000), Jacques Derrida, Bruno Mondadori, Milano.
F.ZAMBON (1978), “Note del traduttore” in DERRIDA (1975), pp. 125-153
(aggiunte nell’edizione italiana a quelle originali di Derrida).
SERGIO SEVILLA SEGURA
La hermenéutica materialista
El viraje hacia la “escoria del mundo de los fenómenos”
que proclamara Freud tiene validez más allá
del ámbito del psicoanálisis, así como el giro de
la filosofía social más avanzada hacia la economía
proviene no sólo del predominio empírico de ésta,
sino asimismo de la exigencia inmanente
de interpretación filosófica
Th.W.Adorno, La actualidad de la filosofía
Se habla, en la filosofía de los últimos años, de que “la hermenéutica” – en
singular – se ha convertido en una nueva koiné en la que se habían en parte
traducido y en parte disuelto los perfiles nítidos de las formulaciones filosóficas
anteriores. Me propongo, sin embargo, repensar una de esas propuestas
filosóficas, la de Adorno, con un perfil fuerte, aunque mal interpretado, en
nuestro país y en el suyo, como propuesta de hermenéutica materialista que no
se deja disolver en otras – pienso en los intentos de aproximarla a Heidegger1, o
a Gadamer, e incluso a la deconstrucción. Dialogar con el perfil restablecido de
la hermenéutica materialista que Adorno propusiera en 1931 y mantuviera en
Dialéctica Negativa no es sólo un ejercicio para la historia de la filosofía del siglo
veinte; es también el intento de mantener, hasta donde sea posible, un programa
de filosofar que tiene mucho que decir al interrogar la situación presente.
Desarrollar lo que Adorno entendía por “interpretación” como tarea de la
filosofía, frente a la investigación, que caracteriza la actividad de las ciencias, es
un modo de empezar a responder a la pregunta central del pensamiento crítico,
a saber ¿Cómo se transforma lo que en Hegel fue el “punto de vista
fenomenológico”, que daba acceso a la teoría de la racionalidad en lo real, en un
punto de vista crítico sobre un mundo socialmente racionalizado?.
El punto de partida de esa crítica es la valoración de la situación
presente como el efecto de la modernidad: en ella, el mundo social está
1 Pienso en el influyente trabajo de H. MÖRCHEN, Adorno und Heidegger, Kett-Cotta,
Stuttgart 1981.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 145-160
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064310
145
146
Sergio Sevilla Segura
racionalmente controlado; y ese control produce experiencias nuevas de lo
intolerable. Decir de lo real que es racional no es ya un modo de
justificarlo; obliga, por el contrario, a preguntar por qué lo así
racionalizado produce formas nuevas de sufrimiento injustificable, sin dar
con ello pie a nuevos ataques a la razón. Esa es la tarea de la hermenéutica
materialista.
Realizar hoy la crítica de la filosofía implica aceptar la inoperancia, en la
situación presente, de dos de sus ambiciones más características: la crísis de
la pretensión filosófica de “totalidad”, y la crisis de la actividad de
“interpretación” como búsqueda de un sentido que, oculto tras lo que
aparece, da cuenta de ello. Ambos son rasgos de un cierto idealismo que ha
acompañado a toda filosofía como supuesto de su actividad.
En la crítica al cientifismo, descubrimos que la categoría de “sentido”
es más amplia que la de “saber”, y que nuestra comprensión de sentido es
configuradora de praxis. Pero la crítica a la metafísica que caracteriza el
comienzo del siglo veinte añade la advertencia contra una doble
objetivación ilusoria: la del “sentido” y la del “sujeto” que lo configura.
Sacar las consecuencias del abandono de esta doble ilusión no es tarea fácil
ni unívocamente formulable; los programas filosóficos se diferencian hoy
por el modo en que se posicionan conceptualmente ante la crítica de esa
doble objetivación.
La apelación a la racionalidad de algunas formulaciones de la Teoría
Crítica muestra hasta qué punto nuestra idea de una “razón crítica” sigue
anclada en algunos rasgos de los modelos que pusieron en circulación Kant
y Hegel. Ello es claro en el caso de Habermas, que acepta el falibilismo y
su propio estatuto post-metafísico, y, sin embargo, acepta dos rasgos
centrales de la tradición metafísica (el objetivismo de la hermenéutica y la
identidad del sujeto de la interpretación con el sujeto de la ciencia) que
conserva sin poner en cuestión.
El supuesto que se da como evidente es la necesidad de reconstruir una
teoría de “lo racional” como instancia crítica, que nos permita enjuiciar los
fenómenos sociales inaceptables como casos de “irracionalidad”, o bien de
racionalidad insuficiente; es la estrategia que se adopta cuando se aspira a
criticar la racionalidad instrumental en nombre de una racionalidad de fines
(Horkheimer), o la racionalidad funcional o sistémica en nombre de una
racionalidad comunicativa (Habermas). El supuesto de fondo es que una
racionalidad menguada sólo puede criticarse filosóficamente desde una
La hermenéutica materialista
147
racionalidad, si no total, que al menos complemente lo que se cree que le
falta a la razón instrumental.
Esa conexión entre teoría de la razón y crítica tiene momentos
culminantes en la obra de Kant, en los que, de algún modo, parece que
hemos quedado prisioneros. Su estrategia teórica pone de relieve la
conexión entre razón y justificación, tanto en el caso de la ciencia como en
el caso negativo de la metafísica: por eso la razón es el tribunal único ante el
que debe comparecer una teoría para recibir, o perder, cualquier forma de
justificación; construir un mapa de la razón es la única forma de establecer
una instancia crítica que legitime las teorías, lo que explica la fuerte
conexión existente entre validación epistémica y crítica de los discursos,
como formas, respectivamente, de conciencia verdadera y conciencia falsa.
A esa misma estrategia apela la teoría de la validez cognitiva, práctica y
estética de Habermas, al vincular significado y validez en la teoría de los
actos de habla. Sin embargo, una vez abandonada la perspectiva
trascendental, una teoría de la verdad, sin un mapa de las condiciones
trascendentales de posibilidad del juicio verdadero, o sin la postulación de
una norma incondicionada para todo ser racional posible, queda
sencillamente sin concreción y, por tanto, sin más base que la apelación
tácita en el lector a la vigencia de esa misma tradición kantiana que,
entretanto, hemos dejado de estar en condiciones de sostener.
Si aceptamos esa crisis de la estrategia trascendental, disponemos
todavía de “la otra” estrategia para elaborar una teoría de la razón; me
refiero a la que Hegel diseñó en la Fenomenología del Espíritu al describir la
razón como lo que descubre el fenomenólogo al describir las instituciones,
costumbres y formas de autoconciencia que encontramos como “Espíritu
objetivo” en las formaciones sociales creativas que fueron la polis griega, el
mundo del derecho romano o el mundo moderno de la alienación,
conceptualmente captadas por el sistema categorial de Aristóteles y de
Kant respectivamente. No se trata de analizar la razón presente en los
discursos científicos sino en sus formas de existencia en los vínculos
sociales efectivos: la familia, la ciudad, el derecho, la riqueza, el
estado,etc. La razón se autoproduce en todas esas formas de organización
de la vida social, en sus instituciones y en sus prácticas. Y una teoría de la
razón puede realizarse como reconstrucción conceptual de esas
instituciones y de las competencias de los sujetos que las crean y las hacen
funcionar. Significativamente la teoría crítica de Habermas apela también a
esa estrategia a través de las ciencias sociales recontructivas. Conocimiento e
148
Sergio Sevilla Segura
interés ya había planteado su posición ante la teoría de la racionalidad
hegeliana en términos de estatuto del discurso fenomenológicoespeculativo, pero es sugerente el hecho de que, en la obra posterior de
Habermas, las ciencias sociales empíricas ocupen el lugar de la descripción
fenomenológica hegeliana; la combinación de sociología de sistemas y
sociología de la acción en Teoría de la Acción Comunicativa nos da un modo
actualizado de acceso a lo que Hegel, sin ese instrumento, describía
fenomenológicamente, a saber, las formas sociales de existencia de las
figuras de la racionalidad. Lo mismo sucede con la gramática generativa de
Chomsky como ciencia reconstructiva de las competencias del hablante
normal, o con la psicología evolutiva de Piaget-Kohlberg cuando
reconstruye los estadios formativos de un agente moral competente.
Salta a la vista que, en Habermas como en Hegel, lo que se reconstruye
como racionalidad es lo que funciona como tal en la sociedad; pero si el
problema es criticar los efectos inaceptables de los procesos de
racionalización realmente existentes, una teoría de la racionalidad
reconstructiva no permitirá la crítica. Ciertamente podremos criticar
racionalizaciones insuficientes, o incompetentes, pero no plantear la crítica
de la razón en ejercicio por su propia teoría. Hegel jamás pretendió ese
tipo de uso de una teoría de la razón que, como el búho de Minerva, eleva
su vuelo al anochecer; y por eso Marx introdujo el punto de vista de la
praxis. Consecuente con esto, la perspectiva que Adorno introduce
comporta su propia ruptura con el idealismo, y una nueva articulación de
la filosofía crítica con la noción de praxis. Entremos en la primera
cuestión.
La posición que Adorno introduce como “materialismo” no es una tesis
ontológica, en sentido precrítico, sino la consecuencia rigurosa de la
ruptura de la filosofía con la aspiración a la totalidad y con la categoría de
sentido: “La crisis del idealismo equivale a una crisis de la pretensión
filosófica de totalidad. La ratio autónoma, tal fue la tesis de todo sistema
idealista, debía ser capaz de desplegar a partir de sí misma el concepto de la
realidad y toda realidad. Tal tesis se ha disuelto a si misma”2.
La “crisis del idealismo” ha de entenderse tanto como un factum
histórico-filosófico, cuanto como manifestación de nuestra imposibilidad
de justificar mediante la razón el mundo presente, convirtiéndonos así en
2 TH.W. ADORNO, Actualidad de la filosofía, Paidós, Barcelona 1991 p.74. Gesammelte
Schriften,1, Suhrkamp, Frankfurt1 1997, s.326 (En adelante abreviaré como G.S.1, con
mención de la página.)
La hermenéutica materialista
149
apologetas de lo inaceptable. En la historia filosófica, la gran ecuación
entre lo racional y lo real, que hacía de la filosofía de la historia la
verdadera teodicea, se hizo insostenible tras los embates de Kierkegaard,
Marx o Nietzsche. No se influyeron entre sí, ni sus pensamientos son
coordinables, pero muestran, por vías diferentes, la inviabilidad para la
filosofía de justificar el mundo tal como es. La hermenéutica, tal como la
concibe la crítica de Adorno, no puede prescindir de ninguna de sus
perspectivas.
Por otra parte, los procesos sociales de racionalización no han hecho
más que generalizarse y profundizarse en el tiempo que media entre Hegel
y nosotros; los designios de la Ilustración se han cumplido, y la propia
razón, convertida en fuerza autónoma, ha mostrado su capacidad de
producir esas formas nuevas de experiencia de lo injustificable que, años
después, Adorno categorizará recurriendo al concepto-topónimo
“Auschwitz”. Hay una experiencia de sufrimiento, vinculada a la realización
del concepto a expensas del particular, utilizado como materia prima
desechable y reemplazable, que obliga a realizar la crítica de la razón como
forma de opresión —no de emancipación. Si la filosofía ha de hacer la
crítica de los procesos de racionalización como conteniendo su propia
negatividad, debe romper con el supuesto de una razón totalizadora que
abarca lo real.
La categoría de totalidad desempeña una función vertebradora tanto del
idealismo como de un cierto tipo de materialismo que, desde la perspectiva
de Adorno, han periclitado. En el idealismo, la noción de totalidad expresa
y encierra el conjunto de significaciones posibles ya realizadas; de ese
modo predetermina la dialéctica hegeliana el contenido y los límites
lógicos y ónticos de lo real. Determinadas formas de comprender la
inversión materialista de la dialéctica no se dieron cuenta de que
incorporaban el idealismo al restablecer el punto de vista de la “totalidad
concreta” como lugar de la verdad y de la praxis, entendida como
aplicación política.
Esa ruptura con el idealismo, que para Adorno incluye también a la
noción heideggeriana de un sentido del ser, responde a nuestra necesidad
de pensar nuestro tiempo en conceptos, haciendo comparecer aquello
“otro que el concepto”, que éste tiende a eliminar en el pensamiento
idealista y en la realidad, introduciendo así su dialéctica negativa; criticar el
concepto es limitar el concepto, haciendo comparecer ese “afuera” que la
soberanía de la razón ignora. Anticipando esquemáticamente la propuesta
150
Sergio Sevilla Segura
de Adorno, podemos decir que señalar los límites a la razón desde un
particular inconceptualizable, pero no inefable, es lo que Adorno entiende
por materialismo; ello ubica a la interpretación en el contexto de la acción:
el “sentido” no pre-existe a la interpretación, que no es traducción, sino
elaboración; y la elaboración, que producimos al construir un modelo, se
consuma en la acción, y no en la mera reproducción especulativa. Una
hermenéutica así concebida pierde toda conexión posible con el esquema
de Habermas tanto como con el de Gadamer.
La categoría de totalidad arrastra en su caída a la categoría de “sentido”
como una especie de “doble” oculto tras lo que aparece, lo fenoménico, de
lo que daría cuenta y razón, justificándolo. «Después de Auschwitz, la
sensibilidad no puede menos de ver en toda afirmación de la positividad de
la existencia una charlatanería, una injusticia para con las víctimas, y tiene
que rebelarse contra la extracción de un sentido, por abstracto que sea, de
aquél trágico destino»3. Este texto, posterior en más de treinta años a la
primera formulación del programa de una hermenéutica materialista,
muestra la conexión profunda que señala Adorno entre la operación
filosófica de extraer el sentido que subyace a los fenómenos históricos y, de
algún modo, justificarlos. La “sensibilidad” ante determinadas
construcciones de la racionalización se rebela contra la operación
metafísica de la comprensión como donación de sentido; ahí muestra su
inactualidad el hilo que une la operación narrada en el mito platónico de la
caverna con la dialéctica hegeliana entre esencia y fenómeno. La filosofía, si
ha de ser “actual” y ha de interpretar el mundo racionalizado, sin por ello
justificarlo, debe crear un modo de hacer distinto al de esa tradición que es
injusta para con las víctimas. «La idea de interpretación no retrocede ante
esa liquidación de la filosofía que, me parece, señala el desplome de las
últimas pretensiones filosóficas de totalidad»4.
Dicho con la brevedad de una alusión, la ruptura con las categorías de
“sentido” y “totalidad” coloca la hermenéutica que Adorno nos propone en
las antípodas, por señalar otro ejemplo, de la “hermenéutica crítica” de
K.O.Apel, que asume el punto de vista de la totalidad cuando vincula
directamente la hermenéutica a las pretensiones de validez de una teoría
criterial de la racionalidad al afirmar: «Mediante la reflexión trascendental
sobre las condiciones de posibilidad y validez de la comprensión hemos
3 TH.W.ADORNO, Dialéctica Negativa, Madrid, Taurus 1975, p. 361. Gesammelte
Schriften, 6, Frankfurt, Suhrkamp, 1994, s.354.
4 TH.W.ADORNO, Actualidad de la filosofía, cit., p. 95; G.S.1, s. 339.
La hermenéutica materialista
151
alcanzado, a mi juicio, algo así como un punto cartesiano de
fundamentación última filosófica»5. La propuesta hermenéutica de Adorno
no es sólo post-idealista; es también una propuesta de Teoría Crítica que
elige una estrategia distinta a la de apoyar la crítica en una teoría del mapa
de la razón. Lo que durante el periodo posterior a la segunda guerra
mundial, y hasta 1989, pareció una actualización de la Teoría Crítica
vuelve a hacerse inactual, a mi modo de ver, en el momento presente que,
a muchos respectos, nos hace mirar de nuevo en dirección a la propuesta
hermenéutica de Adorno.
No es fácil determinar en qué sentido ve Adorno todavía practicable la
actividad filosófica tras la liquidación del idealismo hermenéutico, que
busca un sentido objetivado tras los fenómenos de que da cuenta. La
perspectiva de Habermas neutralizó la operatividad de la propuesta de
Adorno como Teoría Crítica, negando carácter filosófico al pensar
constelativo que es, según Habermas, una disolución de la filosofía en arte.
Habermas ignora deliberadamente la valoración positiva que Adorno
siempre realiza de la investigación social empírica en general, y de las
ciencias positivas en particular, como ingredientes insustituibles de la
Teoría Crítica; la diferencia entre ambos planteamientos reside, más bien,
en el progresivo “cientifismo filosófico” que va revistiendo la teoría de la
racionalidad habermasiana.
Pero, fácil o no, lo que Adorno propone es un cambio de posición para
la filosofía como crítica, si ésta ha de cumplir con su propósito de captar y
valorar la razón objetiva tal como funciona en nuestro mundo. Para ello
propone su tarea como una interpretación dialéctica que ha roto con la
búsqueda de sentido. El intento de caracterizar ese modo de hacer filosofía
no puede entenderse como una meta-teoría general, que no sería sino un
puro malentendido. Adorno se contenta con «sólo indicar la dirección en
que alcanzo a ver las tareas de la interpretación filosófica»6, y no por mera
modestia epistemológica, sino, a mi parecer, por coherencia con su crítica
a la voluntad de totalidad.
Ese “indicar la dirección” es ya señalar lo que es esencial en una
actividad; y la filosofía aquí es un modo de hacer que no oculta su conexión
con un ars inveniendi, cuyo organon es «una fantasía exacta»7.
K.O.APEL, La transformación de la filosofía, Vol. I, Taurus, Madrid 1985, p. 58.
Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt 1976, Band 1, s. 62.
6 TH.W.ADORNO, Actualidad de la filosofía, cit., p. 92; G.S.1, s. 337.
7 Ivi, p. 99; G.S.1, s. 342.
5
152
Sergio Sevilla Segura
Colocar la interpretación del lado de la acción supone asumir con todo
rigor los siguientes rasgos: (a) «La idea de interpretación no coincide en
absoluto con un problema del “sentido” con el que se le confunde la
mayoría de las veces»8.
(b) «La idea de interpretación no exige la aceptación de un segundo
mundo, un trasmundo que se haría accesible mediante el análisis del que
aparece»9.
El rechazo de la tradición platónica, kantiana, o, mas reciente,
husserliana da pie a un posible malentendido, que la literalidad del texto
puede favorecer cuando afirma: «La desconstrucción (“Auskonstruktion”)
en pequeños elementos carentes de toda intención se cuenta según esto
entre los presupuestos fundamentales de la interpretación filosófica»10. Ese
malentendido consistiría en aproximar la filosofía como interpretación,
que Adorno defiende, a alguna lectura de la hermenéutica o de la
deconstrucción en sentido heideggeriano. Sería, a mi juicio, una falsa
lectura de lo que Adorno propone, no sólo porque en el mismo texto haga
la crítica del horizonte del “sentido del ser”, o de la sacralización del
existente que, a su juicio, son elementos inaceptables de la estrategia
heideggeriana. Se trata, sobre todo, de que Adorno establece una
concepción distinta de la relación que existe entre la interpretación
filosófica, la verdad de las ciencias y la praxis histórica, en la dirección del
viraje, marcado por Freud, hacia la “escoria del mundo de los fenómenos”,
de la que tanto partido extrajo la deutung de los sueños, o de los actos
aparentemente insignificantes de la vida cotidiana.
Hay que dar todo su valor a las afirmaciones que realiza sobre las
ciencias, en el contexto de su crítica al cientifismo del Circulo de Viena;
junto a la tesis de la irreductibilidad de la interpretación filosófica a
cuestiones científicas, afirma la necesidad de articular ambos niveles de
actividad:
Plenitud material y concreción de los problemas es algo que la filosofía
sólo podría tomar del estado contemporáneo de las ciencias particulares.
Tampoco se podría permitir elevarse por encima de las ciencias
particulares tomando sus “resultados” como algo acabado y meditando
sobre ellos a una distancia prudencial, sino que los problemas filosóficos se
Ivi, p. 87. G.S.1, s.334.
Ivi, p. 88. G.S.1, s.335.
10 Ivi, p. 91. G.S.1, s.336.
8
9
La hermenéutica materialista
153
encuentran en todo momento, y en cierto sentido indisolublemente,
encerrados en las cuestiones más definidas de las ciencias particulares11.
Me interesa poner en claro, no sólo cuan diferente es la valoración del
conocimiento científico respecto a Heidegger, lo cual es muy obvio, sino
también respecto al Circulo de Viena, para clarificar cómo articula Adorno
filosofía y ciencia, sin que aquella se disuelva o se convierta en divulgación
de resultados que organiza una cosmovisión. Lo que resulta inaceptable del
neopositivismo es la concepción tradicional subyacente de un sujeto
trascendental y del “otro yo”, porque “con estas dos cuestiones, la escuela
de Viena ya se inserta precisamente en esa continuidad filosófica que
quisiera mantener apartada de sí”12. Al abandono del par conceptual
“sensible/inteligible”, presupuesto en la teoría tradicional del sentido, debe
acompañar la crítica de un sujeto trascendental, que realiza la síntesis entre
sujeto y predicado del juicio científico, garantizando de este modo su
validez general. La idea de sujeto puramente lógico del enunciado
científico, y la del “otro yo” supuesta en el carácter intersubjetivo del
principio de verificabilidad, deben ser criticadas «pues el sujeto de lo dado
no es algún sujeto trascendental, ahistóricamente idéntico, sino que toma
una figura cambiante e históricamente comprensible»13. Esa forma de
concebir al sujeto de la ciencia no puede trasladarse al sujeto de la
hermenéutica.
Resuena en su argumento la crítica hegeliana a Kant que introduce un
sujeto histórico concreto, no formal ni meramente lógico; pero, dada la
vinculación de la idea hegeliana del sujeto con la de totalidad, no puede
suponerse, sin más, una lectura hegeliana de lo que dice Adorno; ni
siquiera en la versión de una sociologización del sujeto que, mas próxima a
Marx, pudiera conducirle a una reducción de la epistemología a sociología
del conocimiento; precisamente, en discusión con la interpretación que
Lukács hace de la problemática de la cosa-en-sí niega frontalmente que el
problema se hubiera disuelto «si, por ejemplo, se hubieran señalado las
condiciones sociales en las que llega a producirse el problema de la cosaen-sí; algo que Lukács pensaba todavía como solución; pues el contenido
de verdad de un problema es diferente por principio de las condiciones
Ivi, p. 86; G.S.1, s. 333-334.
Ivi, p. 85; G.S.1, s. 333.
13 Ibidem.
11
12
154
Sergio Sevilla Segura
históricas y psicológicas a partir de las cuales se desarrolla»14. Tomar al
sujeto por una “figura cambiante e históricamente comprensible” no
significa reconducirlo a las condiciones históricas y psicológicas de su
génesis; y la especificidad del nivel epistemológico y la autonomía de la
validez de la verdad queda también suficientemente afirmada.
La formulación de una hermenéutica materialista contiene, como
momento esencial, el diálogo con Marx. Comencemos por el dificil tema
de la vinculación de la teoría con la praxis. Afirma Adorno: «Sólo
dialécticamente me parece posible la interpretación filosófica. Cuando
Marx reprochaba a los filósofos que sólo habían interpretado el mundo de
diferentes formas, y que se trataría de transformarlo, no legitimaba esa
frase tan sólo la praxis política, sino también la teoría filosófica»15. Adorno
está proponiendo su “hermenéutica materialista”, frente al programa
fenomenológico de Husserl y de Heidegger, y frente al Círculo de Viena,
como única forma de actualidad abierta a la filosofía, como interpretación
crítica de la sociedad, apoyada en las ciencias sociales; dejemos
simplemente dicho que ni “materialismo” ni “dialéctica”, utilizados por
Adorno tienen el mismo sentido que en un escrito de Lukács. La distancia
que separa a Adorno de un teórico del marxismo de la segunda o la tercera
internacional no consiste sólo en la pertenencia, o no, a un movimiento
político; para la Escuela de Frankfurt el marxismo “oficial” de los partidos,
socialdemócratas o comunistas, es una construcción ideológica – en el
sentido de “falsa conciencia” – en la medida en que se propone una
reconstrucción, en positivo, de la totalidad social; es esa “ilusión” de captar
la totalidad con el pensamiento la que dio complicidad ideológica con el
estado prusiano a la última filosofía de Hegel y, en mayor medida, al
marxismo soviético. Lo que una filosofía actual deja en el pasado es la
ilusión de que «sería posible aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del
pensamiento»16. El abandono de la falsa pretensión de ocupar el punto de
vista de la totalidad es lo que da pié a ciertos posicionamientos teóricos que
acompañan todo el desarrollo de la teoría crítica: «Ninguna razón
legitimadora sabría volver a dar consigo misma en una realidad cuyo orden
y configuración derrota cualquier pretensión de la razón»17. La razón
realizada en la sociedad como sistema no puede recibir legitimación de una
Ivi, pp. 91-92; G.S.1, s. 337.
Ivi, p. 94; G.S.1, s. 338.
16 Ivi, p. 73; G.S.1, s. 325.
17 Ibidem.
14
15
La hermenéutica materialista
155
teoría filosófica de la racionalidad como instancia de la libertad y la
autonomía de la especie humana; lo que despliega el funcionamiento
sistémico de la sociedad es justamente dominio y, por tanto, heteronomía.
Por eso sería “falsa conciencia” una representación filosófica de la totalidad,
como la que contiene una filosofía marxista “ortodoxa” de la historia, en su
versión reformista o revolucionaria. La concepción de la praxis que se
entiende a si misma como coherente con una tal teoría de la sociedad como
“totalidad” no puede ser sino la de la praxis como aplicación de una teoría
verdadera; pero la tesis XI sobre Feuerbach, como hemos visto, afecta,
según Adorno, también a la teoría filosófica; se trata, por tanto, de
construir otro tipo de teoría, cuya relación con la práctica no será la
aplicación técnica.
Por un lado, la teoría crítica no puede aceptar la forma política en que
el marxismo ortodoxo convierte la efectividad de la teoría en programa de
partido que aplica una supuesta comprensión científica de la totalidad, y de
sus posibilidades evolutivas científicamente determinadas, convirtiéndola
así en realización (ideológica) de la filosofía. El haber declarado ilusoria la
pretensión de totalidad se lo impide. Pero, por otro lado, la teoría crítica
se enfrenta a la teoría tradicional porque sus aplicaciones práxicas, la
racionalización tecnológica, reproduce el dominio sobre la naturaleza, y
también en el interior del vínculo social y a nivel intra-psíquico, al no
cuestionar su funcionamiento previo, y al potenciar su mera funcionalidad
sistémica. La pregunta por los efectos de realidad que tenga la teoría social
crítica, al ser ella misma una forma de praxis, dista mucho de ser
secundaria para su propia caracterización. La teoría crítica de la sociedad o
de la personalidad ha de inscribirse en una forma de praxis característica de
la hermenéutica materialista que Adorno propone como única forma de
actualidad de la filosofía. Hay en su escrito algunos esbozos claros: (a) La
praxis (emancipatoria) es distinta de la resolución técnica de problemas,
porque la interpretación, característica de la filosofía, es distinta de la
investigación propia de las ciencias particulares que formulan problemas y
los resuelven, y que «aceptan sus hallazgos, en todo caso sus hallazgos
últimos y más fundamentales, como algo ulteriormente insoluble que
descansa sobre sí mismo, en tanto la filosofía concibe ya el primer hallazgo
con el que tropieza como un signo que está obligada a descifrar»18. La
distinción entre praxis (emancipatoria) y aplicación (técnica) resolutoria de
18
Ivi, p. 87; G.S.1, s. 334.
156
Sergio Sevilla Segura
problemas depende de la demarcación entre ciencia y filosofía, entre
investigación e interpretación. El criterio de demarcación, apenas esbozado
en este escrito, contiene alusiones: (1) a que la ciencia resuelve problemas
que, así, son desterrados de la filosofía que, de otro modo, quedaría
“enturbiada” en sus planteamientos. (2) La filosofía no se distancia de la
ciencia, en un hipotético lugar superior, por lo general de sus
planteamientos o lo abstracto de sus categorías; al contrario, «los
problemas filosóficos se encuentran en todo momento, y en cierto sentido
indisolublemente, encerrados en las cuestiones más definidas de las ciencias
particulares»19. (3) Pero la actividad filosófica sobre esas cuestiones
definidas de las ciencias particulares no se dejan llevar por la dinámica
interna de esas ciencias que, presumiblemente, es la de la teoría
tradicional: «el reconocimiento de la sociología por parte de la
interpretación filosófica precisa de alguna restricción. Para la filosofía
interpretativa se trata de construir alguna clave que haga abrirse de golpe a
la realidad»20. Justamente ello reintroduce la cuestión por la teoría
filosófica como praxis: «Sólo en la aniquilación de la pregunta se llega a
verificar la autenticidad de la interpretación filosófica, y el puro
pensamiento no es capaz de llevarla a cabo partiendo de sí mismo. Por eso
trae consigo a la praxis forzosamente»21.
(4) Hay una cuarta indicación de Adorno sobre la conexión entre
interpretación y praxis, que nos devuelve al problema de delimitar entre lo
aceptable y lo rechazable en la racionalización social, y que pasa por la
distinción entre “problema” y “enigma”. Veamos un largo texto:
La respuesta al enigma no es el “sentido” del enigma de modo tal que
ambos pudiesen subsistir al mismo tiempo, que la respuesta estuviese
contenida en el enigma, que el enigma lo constituyera exclusivamente su
forma de aparición y que encerrara la respuesta en sí mismo como
intención. Más bien, la respuesta está en estricta antítesis con el enigma,
que no es algo lleno de sentido, sino insensato, y lo destruye tan pronto
como le sea dada la respuesta convincente. El movimiento que aquí se
lleva a cabo como juego lo lleva a cabo en serio el materialismo. “Serio”
significa ahí que la contestación no se queda en el ámbito cerrado del
conocimiento, sino que es la praxis quien la da. La interpretación de una
realidad con la que se tropieza y su superación se remiten la una a la otra.
Ivi, p. 86; G.S.1, s. 334.
Ivi, p. 97; G.S.1, s. 340.
21 Ivi, p. 94; G.S.1, s. 338-339.
19
20
La hermenéutica materialista
157
Desde luego, la realidad no queda superada en el concepto; pero de la
construcción de la figura de lo real se sigue al punto, en todos los casos, la
exigencia de su transformación real. El gesto transformador del juego del
enigma, y no la mera solución como tal, da el prototipo de las soluciones,
de las que sólo dispone la praxis materialista22.
El texto nos permite, aunque sea en forma de bosquejo, señalar las
líneas esenciales de una nueva concepción de la relación entre teoría y
práctica. La densidad histórico-filosófica de la cuestión, desde Aristóteles
hasta Marx es tal que hace superfluo cualquier intento de enfatizarla; y, por
tanto, cualquier intento de subrayar la importancia de la transformación
del planteamiento clásico que produce la intervención de Adorno, que
puede formularse así: 1.- Hay superación, pero no en el concepto. 2.- La
interpretación exige transformación real, impone un “gesto”, esto es, un
cambio de actitud del implicado encerrado en el enigma insensato; por eso
la constelación es una llave. El hallazgo de la falta del sentido restaura la
conciencia del sentido y de sus límites. Y lo inscribe en el orden de la
acción que transfinita, es decir que encuentra el límite y lo trasciende; por
eso Adorno habla de superación, no en el concepto, sino en la acción: en el
concepto no hay superación posible porque el enigma está fuera del ámbito
del sentido. 3.- Hay “juego transformador” y no “mera solución”: porque el
enigma que la constelación figura no es conceptualizable, ni es lugar
tolerable en el que vivir. El par “vivible/invivible” es más amplio que el par
“verdadero/falso”. El único criterio es la continuidad creativa de la acción,
y no la mera repetición.
El punto de partida del análisis de Adorno es la ruptura del supuesto
(de Platon a Hegel) de que lo que se presenta (fenómeno) expresa, de un
modo u otro, un sentido profundo (esencia), por así decirlo “prefijado”,
que el lenguaje cognitivo (de la filosofía) ha de lograr formular en términos
teóricos que permitan una solución. Si la actividad teórica de formular y
resolver problemas sucede es en determinados ámbitos que dan lugar a
ciencias particulares (y la prueba práctica de la solución del problema es la
aplicabilidad técnica de la ley teórica, o de sus consecuencias). Pero, “lo
que sucede” nos reta, con frecuencia, no como problema, sino como
enigma (Adorno ofrece como ejemplo político el análisis de la plusvalía, o
como ejemplo filosófico el de la cosa-en-sí); el enigma nos reta como lo
que no puede ser totalmente comprendido por remisión a un modelo
22
Ivi, pp. 93-94; G.S.1, s. 338.
158
Sergio Sevilla Segura
teórico; nos reta desde la situación vital en la que estamos comprometidos;
no se nos enfrenta como “objeto” disponible. El que interpreta lo hace en
actitud realizativa, es decir, en la actitud del ser activo que se encuentra
ante un obstáculo que ha de quitar de delante (disolviéndolo, dice Adorno)
para proseguir la acción propia. No es una cuestión de sentido, sino de
acción y, por eso, “la contestación no se queda en el ámbito cerrado del
conocimiento, sino que es la praxis quien la da”. En ese sentido se cumple
la tesis de Marx: no se trata de interpretar (ésto es, de extraer un sentido
profundo, que sea el duplicado en un segundo mundo – el de las
significaciones ideales – de lo que aparece en el ámbito fenoménico); se
trata de transformar el mundo, es decir, de disolver la configuración
fácticamente dada que impide que nuestra acción propia continúe adelante.
El enigma no tiene intención, ni remite a un segundo mundo, ni
desaparecerá por el mero hecho de llevarlo a concepto, como supone el
idealismo, caso de que la operación fuese posible. Pero tampoco cualquier
acción disolverá el enigma, si no se construye, por constelación de
elementos intelectivos (conceptuales y artísticos), “la figura de lo real”. La
interpretación puede prescindir del mundo del sentido, porque tiene
efectos en el mundo real fenoménico.
“Lo real” no consta sólo de lo necesario, sino también de lo
contingente; no sólo los elementos universales que el concepto puede
captar, sino también los particulares, de los que sólo puede dar cuenta un
lenguaje no conceptual, como, según Adorno, el que construye Beckett
para hacer comunicable el absurdo de la sociedad contemporánea;
trasladarlo a términos de sentido, aún si fuera posible, sería falsearlo. De
ahí, la primera formulación por Adorno del tema persistente de su
filosofía: el pensar por constelaciones, como modo de operar de la
hermenéutica materialista. La interpretación ha de estar abierta a lo
particular inconceptualizable y al sinsentido: es materialista porque se
opone a cancelar lo que sucede en el concepto.
Las constelaciones «son modelos con los cuales la razón (negrita mía) se
aproxima probando y comprobando (es decir, sin camino metódico prefijado, en un pensar que “tantea”) una realidad que rehúsa la ley, pero a la
que el esquema del modelo es capaz de imitar cada vez más en la medida
en que esté correctamente trazado»23. El modelo “imita” la realidad que
trata de captar, pero esa mímesis no comporta ningún regreso a la tesis de
23
Ivi, p. 99; G.S.1, s. 341.
La hermenéutica materialista
159
la “adequatio rei et intellectu”, puesto que es efecto de una actividad
inventiva, que va “probando y comprobando”. La actividad filosófica es
praxis, como pedía Marx, en un doble sentido. Invoca Adorno a Bacon y a
Leibniz para caracterizar la actividad filosófica como un “ars inveniendi”, y
afirma:
Cualquier otra forma de entender los modelos sería gnóstica e inadmisible.
Pero el organon de ese ars inveniendi es la fantasía. Una fantasía exacta;
fantasía que se atiene estrictamente al material que las ciencias le ofrecen,
y sólo va más allá en los rasgos mínimos de la estructura que ella establece:
rasgos que ciertamente ha de ofrecer de primera mano y a partir de sí
misma24.
En este primer sentido, en que el sujeto de la interpretación construye
un modelo por “fantasía exacta”, la interpretación es acción en ese primer
modo que Marx señalaba que el idealismo había comprendido mejor que el
materialismo, en la primera tesis sobre Feuerbach: el hombre que
comprende el mundo está realizando una acción, y su hermenéutica tiene
la lógica de una acción configuradora de materiales. Esta afirmación de que
la comprensión tiene la lógica de una acción introduce, como exigencia
propia, el segundo sentido de praxis, esto es, el de transformación del
mundo: «Para la filosofía interpretativa se trata de construir alguna clave
que haga abrirse de golpe a la realidad»25. Cuando Adorno analiza en
concreto esas claves se dirige a conceptos centrales de nuestra
comprensión de la sociedad —como “clase”, “ideología”— que intentan
captar fenómenos del mundo social, para los cuales el idealismo filosófico
construyó categorías “demasiado grandes”, y el sociologismo “demasiado
pequeñas”. Esos modelos para captar la configuración histórica en la que
vivimos y actuamos son imágenes históricas que no están ahí, previamente
disponibles para cualquier visión o intuición: «han de ser producidas por el
hombre, y sólo se justifican al demoler la realidad en torno suyo con una
evidencia fulminante»26. En este sentido también la filosofía es praxis:
destruye una configuración enigmática de la vida social al hacerla evidente
en su sinsentido. Adorno se resume a sí mismo en estos términos:
Ivi, p. 99; G.S.1, s. 342.
Ivi, p. 97; G.S.1, s. 340.
26 Ivi, p. 98; G.S.1, s. 341.
24
25
160
Sergio Sevilla Segura
Si es que la idea de interpretación filosófica que me había propuesto
exponer ante ustedes tiene alguna vigencia, se puede expresar como la
exigencia de dar cuenta en todo momento de las cuestiones de la realidad
con que tropieza, mediante una fantasía que reagrupe los elementos del
problema sin rebasar la extensión que cubren, y cuya exactitud se controla
por la desaparición de la pregunta27.
Es evidente la objeción inmediata que plantearía un pensamiento de la
acción política: constelaciones como la que expresa “la forma mercancía”
no es de esperar que desaparezcan simplemente al construir su modelo en
actitud realizativa. A ello cabe responder que no es cierto que la
hermenéutica materialista amplía la noción de “acción” como
transformación práxica de la filosofía; con ello, de algún modo, deja de
pensar las condiciones materiales de la acción política: ¿para quien lo es un
sinsentido?, ¿quien capta la constelación para disolver el enigma?, ¿quién
es, en definitiva, el sujeto político de esas operaciones? Lanzar el mensaje
del naufrago en la botella es confiar el mensaje al azar; pero un mensaje
tiene la forma que tiene y no otra porque está escrito, desde el comienzo,
para alguien, incluso para alguien imaginado a quien quiere configurar
como sujeto. Qué tipo de sujeto puede hacer frente con éxito a los
sinsentidos producidos por la racionalización opresiva, y cómo puede llevar
a cabo esa tarea son problemas pendientes para la teoría crítica de la
política, aún cuando rehúse determinar ese sujeto entre los ya existentes en
el mundo de la racionalización.
Abstract
Adorno formulates for the first time the program of the Critical Theory
as “materialistic hermeneutics”. After the “hermeneutical turn” of
philosophy in the second half of the twentieth century, this paper tries to
establish the profiles of Adorno’s hermeneutics. As a critique of semantic
idealism and of all idealisms, that hermeneutics fixes a new statute for
philosophy after Hegel, in a critical dialogue with the sciences, with
Nietzsche’s “genealogy”, with Freud’s “unconciousness”, and with an
important re-statement of Marx’s eleventh thesis on Feuerbach.
27
Ivi, p. 99; G.S.1, s. 342.
GIOVAMBATTISTA VACCARO
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
Nel 1912 il giovane filosofo ungherese György Lukács giunge a Heidelberg
insieme alla moglie e all’amico Ernst Bloch, conosciuto qualche tempo
prima nel circuito degli allievi di Simmel a Berlino. Lo accompagna una
discreta notorietà legata ad una storia del dramma moderno e ad un
volume di saggi di estetica e critica letteraria dal titolo L’anima e le forme,
oltre che a vari saggi minori. In questa opera Lukács aveva esibito uno
spiccato interesse per l’estetica, sullo sfondo del quale tuttavia egli aveva
cercato di dare una risposta alla concezione simmeliana del tragico
attraverso l’affermazione della priorità dell’etica1. A Heidelberg Lukács
stringerà amicizie importanti, come quelle con Weber e con Lask, e
troverà un ambiente cosmopolita, più vivace e dinamico di quello di
Berlino, con una nutrita ed attiva colonia di giovani studiosi russi che,
riuniti intorno a Fëdor Stepun, avevano già dato vita all’edizione russa
dell’organo dei neokantiani, la rivista Logos, e pubblicato un volume
collettivo in cui, rifacendosi alle correnti più originali della filosofia russa,
come gli slavofili e soprattutto Solovëv, si facevano promotori di un
misticismo dialettico aperto ad una speranza messianica nel rinnovamento
generale dell’umanità. Erano temi comuni sia a Bloch sia a certe tematiche
di Lukács, che si trovò così stretto tra questi filosofi, con cui egli era
entrato in contatto proprio attraverso la cerchia di Max Weber, e il suo
vecchio amico di Berlino, e subì l’influenza di entrambi2.
1 Su questi aspetti della produzione del primo Lukács cfr. il mio “Tra Simmel e
Heidegger. Ontologia e etica nel primo Lukács”, Fenomenologia e società XXVII (2004), pp.
23-38.
2 Su questo gruppo di intellettuali russi e sulla loro influenza su Lukács cfr. M.
COMETA, Postfazione a G. LUKÁCS, Dostoevskij, SE, Milano 2000, pp. 238 sgg., e A.
HOESCHEN, Das “Dostojewski”-Projekt. Lukács’ neokantisches Frühwerk in seinem
ideengeschichtlichen Kontext, Niemeyer, Tübingen 1999, pp. 250 sgg., che precisa è
consistita «in una prassi che si distingue per essere inaccessibile dal punto di vista della
filosofia della cultura nel senso della teoria dei valori neokantiana» (pp. 262-263). Per
quanto riguarda l’influenza di Bloch, lo stesso Lukács ne riconoscerà la portata nel suo
superamento del periodo saggistico e nel suo indirizzarsi verso la filosofia: cfr. G. LUKÁCS,
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 161-177
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064311
161
162
Giovambattista Vaccaro
A Heidelberg Lukács abbandona la forma del saggio, da lui teorizzata in
L’anima e le forme, e si impegna nell’elaborazione di un’estetica sistematica,
durante la quale egli prende coscienza delle aporie del neokantismo, ma
non abbandona la sua esigenza etica, poiché anzi , come è stato notato, la
riflessione estetica trova il suo sfondo proprio nel progetto di un’etica3.
Con l’inizio della prima guerra mondiale il progetto dell’estetica viene
abbandonato, e l’etica occupa tutto l’interesse di Lukács4. La cosa singolare
è che quest’opera di etica si costruisce ancora come un’opera di estetica, o
per lo meno di critica letteraria, cioè come un libro su Dostoevskij, a cui
Lukács comincia a lavorare nell’inverno del 1915 ed a cui attribuisce
appunto uno spessore che supera la semplice critica letteraria5. Di questo
lavoro, come è noto, resterà solo la parte introduttiva, che Lukács
pubblicherà nel 1916 nella Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft col titolo Teoria del romanzo: l’avanzare della guerra aveva
rivelato l’insufficienza anche di questo progetto ed aveva imposto altre
urgenze, ed il progettato libro su Dostoevskij rimase come una prova di
Lukács con se stesso.
Ma perché un’opera di etica si doveva configurare proprio come una
monografia su Dostoevskij? Lukács stesso in tarda età propone una
risposta: in quegli anni egli si trovava ancora impegnato in un confronto
con la situazione ungherese e nella battaglia contro i residui dell’ideologia
feudale, «e la letteratura russa (soprattutto Tolstoj e Dostoevskij) appariva
Pensiero vissuto. Autobiografia in forma di dialogo, Intervista di I. Éörsi, Ed. Riuniti, Roma
1983, p. 205.
3 Cfr. L. BOELLA, Il giovane Lukács, De Donato, Bari 1977, pp. 49 sgg.
4 Lo stesso Lukács molti anni dopo ricorderà che «La società poneva con la guerra
problemi radicalmente nuovi» (Pensiero vissuto, cit., 207), e di conseguenza «centro
dell’interesse dall’estetica all’etica» (ivi, p. 210): «cominciai a interessarmi di problemi
etici e non attribuivo più nessuna importanza alle questioni estetiche» (ivi, p. 60), e questo
interesse «mi ha portato alla rivoluzione» (ivi, p. 66).
5 Lo comunica lo stesso Lukács a Paul Ernst in una lettera del 1915: «Adesso
finalmente mi sono messo sul mio nuovo lavoro: su Dostoevskij (l’Estetica per il momento
riposa). Conterrà però molto più che Dostoevskij: grosse parti della mia etica metafisica,
della filosofia della storia ecc.» (G. LUKÁCS, Epistolario 1902-1917, a cura di É. Karádi e É.
Fekete, Ed. Riuniti, Roma 1984, p. 353). A. HOESCHEN, Das “Dostojewski”-Projekt, cit.,
preferisce infatti parlare di un Progetto Dostoevskij i cui due aspetti inscindibili sono
appunto questo libro sullo scrittore russo e l’Estetica, e che si sviluppa nell’ambito
dell’ontologia trascendentale che Emil Lask aveva cominciato a elaborare dal 1910 e della
rifondazione di una filosofia della cultura che essa implica.
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
163
sempre come l’indirizzo che più mostrava la strada»6, poiché «sono stati
[…] Tolstoj e Dostoevskij a farci vede come nella letteratura si possa
condannare in blocco tutto un sistema»7. Ma accanto a questa spiegazione,
che è quella del Lukács marxista della tarda maturità, può essercene
un’altra che trova le sue radici nel contesto della cultura europea della
giovinezza di Lukács, una cultura verso la quale proprio nell’intervallo tra
L’anima e la forme e il trasferimento a Heidelberg Lukács non si era
mostrato molto tenero, e che anzi aveva accusato di «impoverimento
interno», di «solitudine completa»8, di «fondamentale menzogna» e
«dilettantismo di fronte alla vita»9, trasformata «in una successione
ininterrotta di stati d’animo in perenne mutamento», privata di ogni
continuità, «perché lo stato d’animo non tollera continuità né ripetizioni»,
privata di valori e di oggetti «ridotti ad occasioni adatte ad evocare stati
d’animo»10, e per questo soprattutto privata di quell’autentica attività
dell’anima che plasma la vita attraverso la forma.
Questa cultura è accusata da Lukács di estetismo, ma sotto questo
termine non si fa fatica a intravedere i caratteri generali del nichilismo, di
un atteggiamento la cui «unica manifestazione di vita consiste nell’aderire
agli attimi con pieno abbandono» ed in cui «per il fatto stesso che tutto
proviene sempre dall’interno, nulla potrà mai scaturire veramente
dall’interno»11. L’opera etica a cui Lukács attende a Heidelberg deve essere
dunque una resa dei conti col nichilismo che permea la cultura
contemporanea, che diventa tanto più urgente di fronte all’evento che
sancisce questo nichilismo, la guerra, ed al quale, come lo stesso Lukács
aveva potuto constatare attraverso l’atteggiamento tenuto verso di essa da
tanti suoi amici e maestri, a cominciare da Max Weber, questa cultura
aveva mostrato di non sapere, o di non volere, opporsi. Ma questa resa dei
conti deve passare attraverso «il sacro nome di Dostoevskij»12, dello
G. LUKÁCS, Pensiero vissuto, cit., p. 206: «La ‘rivoluzione’ tolstojana-dostoevskijana –
dice Lukács più avanti – costituisce la prospettiva utopica e quindi il metro morale» (ivi, p.
209).
7 Ivi, p. 52.
8 G. LUKÁCS, La cultura estetica, in G. LUKÁCS, Cultura estetica, Newton Compton,
Roma 1977, pp. 14-15.
9 Ivi, p. 16.
10 Ivi, p. 15.
11 Ivi, p. 16.
12 Ivi, p. 30.
6
164
Giovambattista Vaccaro
scrittore in cui il giovane Lukács trova l’esempio più luminoso della lotta
più tenace contro il nichilismo in cui è finita la cultura europea.
Il confronto con lo scrittore russo e con la questione del nichilismo che
si pone attraverso di esso diventa quindi cruciale per la maturazione del
giovane Lukács consentendo il precisarsi di quell’esigenza etica che si era
posta nell’analisi esistenziale da lui condotta in L’anima e le forme, e
soprattutto prospettando un più ampio orizzonte entro il quale spingerla ad
un livello superiore.
Del resto lo stesso Lukács aveva tempestivamente avvertito l’esigenza
di spingere oltre la sua etica. Se infatti in L’anima e le forme egli era
approdato ad una concezione dell’etica come forma che si impone alla vita
attraverso il lavoro borghese, la professione come luogo di un rapporto
interumano regolato dal dovere, cioè dalla dedizione a qualcosa di
indipendente ma reale, già nel 1911 aveva accusato questa etica di
distanziare gli uomini13 e le aveva contrapposto un’«etica della virtù»14,
incentrata sulla bontà, che appunto per Lukács «non è una categoria
dell’etica» ma anzi «è lo staccarsi dall’etica»15. La riflessione su Dostoevskij
porterà Lukács a precisare l’insufficienza dell’etica formale, kantiana, che
egli chiama prima etica, proprio mettendola a confronto col nichilismo, al
quale essa ha ceduto nella cultura europea, e ad indicare nell’etica della
virtù, nella seconda etica, la via d’uscita non solo dal formalismo, ma anche
dal nichilismo16. L’idea del vivere associato non basta più a Lukács, in suo
problema diventa ora la qualità di questo vivere.
13 Cfr. G. LUKÁCS, Sulla povertà di spirito, Cappelli, Bologna 1981, pp. 102-103: «la
maggior parte degli uomini vive senza la vita e non se ne accorge. La loro vita è solo
sociale, solo infraumana; questi […] possono accontentarsi dei loro doveri […] perché
ogni etica è formale: il dovere è postulato, forma – e quanto più è perfetta una forma […]
tanto più cade lontano da ogni immediatezza. La forma è un ponte che ci distanzia; ponte
in cui andiamo e veniamo, e arriviamo sempre in noi stessi, senza incontrarci mai».
14 Ivi, p. 113.
15 Ivi, pp. 104-105.
16 L’importanza della seconda etica nello sviluppo intellettuale e soprattutto politico di
Lukács è stata sottolineata dai suoi allievi della cosiddetta Scuola di Budapest, soprattutto
da F. FÉHER (Al bivio dell’anticapitalismo romantico, in F. FÉHER, Á. HELLER, G. MÁRKUS, A.
RÁDNOTI, La Scuola di Budapest: sul giovane Lukács, La Nuova Italia, Firenze 1978, pp. 157246) e da Á. HELLER (Al di là del dovere. L’etica paradigmatica del classicismo tedesco nell’opera
di György Lukács, ivi, pp. 59-75; Quando la vita si schianta sulla forma, ivi, pp. 1-45, e Sulla
povertà di spirito. Un dialogo del giovane Lukács, ivi, pp. 47-58). Va reso merito alla Scuola di
Budapest di aver richiamato l’attenzione su alcune opere minori del giovane Lukács
tradizionalmente trascurate dalla critica, come Sulla povertà di spirito, di cui si sottolinea
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
165
Ma, anzitutto, in che senso la prima etica non regge la prova del
nichilismo? L’impianto di Teoria del romanzo ci mostra un Lukács che parte
da molto lontano, ed opera per mezzo di una strumentazione teorica in cui
si avverte la lezione dello Hegel della Fenomenologia dello spirito e in parte
anche di certi aspetti degli scritti teologici giovanili pubblicati da Nohl nel
1907. Lukács mette in campo infatti la categoria di totalità, intesa come
un’omogeneità in vigore prima ancora che le forme si applichino ad essa
come suo divenire cosciente e nella quale quindi sapere, virtù e felicità
coincidono17. La posizione dell’uomo in questa totalità è definita da un
rapporto con gli altri in cui il dovere è solo un problema pedagogico che ha
come referente le forme di questo rapporto, cioè le istituzioni, amore,
famiglia, stato. Questa definizione della totalità diventa lo strumento che
consente a Lukács di ricostruire la storia della cultura europea sulla base
della triade hegeliana quale si configura storicamente nella seconda parte
della Fenomenologia: l’immediatezza della totalità etica nel mondo greco, la
sua rottura nella pluralità degli individui del mondo moderno, l’aspirazione
alla sintesi di una comunità etica mediata in cui l’individuo sia in una libera
relazione con gli altri. Su questo sfondo si colloca sia l’emergenza del
nichilismo sia la crisi, ad essa connessa, della forme d’arte che Lukács sta
indagando fin dal Dramma moderno.
Questa totalità organica tipica del mondo greco appare quindi come
collettività, la sua forma storico-politica è la polis e la sua espressione
artistica è l’epos. Ma qui, come proprio l’epopea dimostra, l’individuo è
giustamente l’importante ruolo di cerniera tra la fase estetico-saggistica di L’anima e le forme
e lo sforzo di riflessione etica degli anni di Heidelberg nonché la funzione di incubatrice
della nuova concezione etica di Lukács. Va tuttavia notato anzitutto il disinteresse per il
lavoro su Dostoevskij da parte della Heller, che sembra invece piuttosto attratta
dall’incidenza della vicenda sentimentale di Lukács con Irma Seidler; in secondo luogo il
fatto che questi autori tendono a lasciare in ombra il confronto col nichilismo; infine una
riconduzione forse troppo diretta e immediata della seconda etica al comunismo, che
finisce con l’attribuire al giovane Lukács un’esigenza che nel ’15 sembra piuttosto ancora
mistico-espressionista, appunto, come dice Féher, solo un anticapitalismo romantico, e
che forse assume una coloritura decisamente e coscientemente comunista ancora solo in
Bloch. Sul periodo di Heidelberg cfr. R. ROCHLITZ, Le jeune Lukács: 1911-1916. Théorie de
la forme et philosophie de l’histoire, Payot, Paris 1983. Sull’evoluzione politica del giovane
Lukács cfr. M. LOWY, Per una sociologia degli intellettuali rivoluzionari: l’evoluzione politica di
Lukács, La salamandra, Milano 1978. Per una valutazione del lavoro intorno a Dostoevskij
in ordine all’evoluzione di Lukács dallo stile saggistico al pensiero dialettico cfr. E.
MATASSI, Il giovane Lukács. Saggio e sistema, Guida, Napoli 1979.
17 Cfr. G. LUKÁCS, Teoria del romanzo, Sugar, Milano 1962, p. 62.
166
Giovambattista Vaccaro
assente, o meglio è «conosciuto – definito sulla base dello spirito
oggettivo»18: «l’eroe dell’epopea – infatti – non è mai, a rigor di termini
un individuo. Fin dai tempi antichi, si è considerato carattere essenziale
dell’Epos che oggetto di questo non fosse un destino individuale, bensì il
destino di una collettività», poiché «la perfezione e la conclusione del
sistema di valori che determina il cosmo epico, dà luogo a un tutto troppo
organico perché in essa una parte possa a tal punto segregarsi in se stessa
[…] da divenire individualità», e per questo «la sequenza delle avventure,
in cui si allegorizza l’accadimento, ricava il proprio peso dall’importanza
che per essa hanno il bene e il male di un grande, organico complesso
vitale, di un popolo o di una stirpe»19.
In questo mondo spirituale «lo spirito assoluto si è risolto in quello
oggettivo; non vi è più alcun divario tra diritto e cerimonia […] nulla della
filosofia statale può divenire adiaforia: costrizione al voto» e c’è «unione di
organizzazione giuridica e politica»20, e corrispondenza di organizzazione
sociale e militare. Ma in questo mondo vige anche l’impossibilità di
compiere una vera azione e «l’impossibilità di realizzare il “conosci te
stesso” […] (perciò: importanza della filosofia dello stato, dello spirito
oggettivo per ogni filosofia “greca”)»21. Da questo punto di vista Lukács
può definire Socrate, «giacché qui interroga, non-greco»22. In pratica nel
mondo greco l’essenza è riferita alle istituzioni e non alla vita, e questo
marca per Lukács l’angustia di questo mondo. Questa centralità delle
istituzioni, o, per usare il termine hegeliano a cui Lukács fa ricorso, dello
spirito oggettivo, costituisce ciò che Lukács definisce con una espressione
di Ernst Bloch il geoviano. Lukács abbozza una ricostruzione storica delle
figure di questa nozione. Una di esse è il cristianesimo, che trasforma in
istituzione, soprattutto attraverso l’opera di San Paolo, il contenuto della
religione; un’altra è la filosofia tedesca, sia nella equivalenza hegeliana di
reale e razionale, sia nell’idea fichtiana della nazione.
Nell’analisi del geoviano Lukács fa poi rientrare anche figure
insospettabili, come Tolstoj, che fa dell’istituzione del matrimonio
qualcosa di naturale, o Kant, per l’equivalenza di buona volontà e volontà
libera, al punto da rilevare che «l’etica kantiano-fichtiana va paragonata
G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 37.
G. LUKÁCS, Teoria del romanzo, cit., pp. 102-103.
20 G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 68.
21 Ivi, p. 37.
22 Ibidem.
18
19
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
167
nella sua struttura logica con la prova ontologica di Dio»23, poiché ha come
presupposto la divina sostanzialità del diritto. Ma il richiamo a Kant rivela
come l’etica formale del dovere si esaurisce entro i confini dello stato, del
diritto, in pratica del geoviano, poiché essa, caratterizzata dalla veridicità,
dalla fedeltà, dal dovere come vissuto, è l’etica in cui il dovere si configura
come rapporto con l’istituzione e come ottemperanza della sua norma.
Ora, sulla base di quanto detto finora, cioè del destino a cui va incontro
l’individuo di fronte al geoviano, Lukács accusa questa etica di produrre un
«effetto non autentico»24 che la rende banale e suscita una lotta dell’anima
contro la convenzione. Perché? La risposta a questa domanda diventa
cruciale, perché apre alla questione del nichilismo25.
Hegelianamente, il mondo della polis e dell’epopea, il mondo della
collettività, si esaurisce a causa della sua angustia: gli dei diventano muti, il
mondo delle azioni si scinde dagli uomini e l’interiorità si separa
dall’avventura: sorge il mondo che Hegel aveva chiamato l’universo dei
molti dispersi26, il mondo borghese degli individui qualitativamente distinti
l’uno dall’altro. In questo mondo l’individuo si trova in una «solitudine
metafisica»27, in una «insanabile […], tragica solitudine» che «non è
soltanto l’ebbrezza dell’anima preda del fato, fattasi canto: è anche il
tormento della cultura condannata alla solitudine, che agogna alla
conoscenza», nel quale consiste il nuovo problema tragico, il problema del
soggetto che «non riuscirà mai ad afferrare che non è prescritto che sotto
lo stesso mantello vitale coabiti la stessa essenzialità», che «sa di
un’eguaglianza di tutti coloro che si son trovati e non riesce a capire che
questa loro nozione non rampolla da questo mondo» 28.
Questa solitudine si basa infatti su una scissione tra un’essenza che
rivendica la sua trascendenza, superiorità e indipendenza rispetto al mero
ente, la sua estensione oltre l’esistenza, e la vita, che invece esclude la
fissazione di una tale separatezza, che «rifiuta la determinazione, in essa, di
un punto focale e non tollera che una della sue cellule si attribuisca signoria
Ivi, p. 39.
Ivi, p. 37.
25 Lo stesso Lukács dà un’indicazione in tal senso quando nel frammento 102, dopo
aver accennato alla lotta contro la convenzione come problema interno alla prima etica,
inserisce tra parentesi l’appunto: «Inserire qui il nichilismo» (Ivi, pp. 59-60).
26 Cfr. G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze 1967,
vol. IV, p. 202.
27 G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 15.
28 G. LUKÁCS, Teoria del romanzo, cit., pp. 74-75.
23
24
168
Giovambattista Vaccaro
sul complesso», non tollera «un soggetto […] separato da ogni e qualsiasi
vita […] portatore della sintesi trascendentale»29, che, attraverso
l’umorismo, aspira a «una sostanzialità più genuina di quella che potrebbe
offrirgli la vita» e quindi «fa a pezzi tutte le forme e frontiere della fragile
totalità della vita allo scopo di pervenire […] all’Io dominatore del
mondo»30 di cartesiana memoria. Per questo Io il dovere diventa ora
insufficiente, poiché rappresenta appunto la forma della sua separatezza, il
rifugio dell’essenza fuggita dalla terra, e per questo è inautentico: «il
dovere uccide la vita» e il suo eroe «sarà sempre e soltanto un’ombra
dell’uomo vivente nella realtà storica […] , e il mondo che gli è offerto
come esperienza e avventura, null’altro che uno stemperato abbozzo del
reale»31. La critica della prima etica indica in Lukács una revisione del
giudizio sull’etica della professione da lui espresso in L’anima e le forme,
come emerge da altri indizi che affioreranno più avanti.
Il tragico della modernità consiste dunque per Lukács nella scissione
indicata dalla crisi del concetto classico di dovere, tra idea e vita, per cui
«in generale non si può dire che si viva. Per lo più si esiste soltanto»32, di
una esistenza che si sviluppa al livello minimo della vitalità, quello che
Lukács vede rappresentato nei romanzi di Dostoevskij da personaggi come
Rogožin o Dmitri Karamazov, che vivono un’esistenza vuota, ripiegata su
se stessa e priva di modelli o ideali. Oltre questo livello di vitalità Lukács
individua quello rappresentato dai nichilisti puri, come Raskolnikov o Ivan
Karamazov, e oltre ancora quello su cui vivono Myškin e Alëša, e ad essi fa
corrispondere tre livelli di ateismo, cioè di nichilismo. È soprattutto il
secondo livello a rivestire un’importanza strategica in questa articolazione
dell’analisi di Lukács, ed è di nuovo il versante estetico di essa, il
concretizzarsi del problema etico nella forma dell’arte tipico di questa fase
della riflessione lukácsiana, a dimostrarlo.
Il contrasto di reale e ideale si traduce infatti per Lukács nel degrado
del rapporto tra arte e vita, per cui «l’antico parallelismo tra la struttura
trascendentale nel soggetto raffigurante e le forme prodotte nel mondo
esteriorizzato, è infranto, e […] gli ultimi fondamenti della raffigurazione
non hanno più una patria»33, e la tragedia e l’epica si sono trasformate nei
Ivi, p. 86.
Ivi, p. 85.
31 Ivi, p. 79.
32 G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 26.
33 G. LUKÁCS, Teoria del romanzo, cit., p. 69.
29
30
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
169
due generi che esprimono la solitudine metafisica vista sopra: il dramma
non tragico e il romanzo. Quest’ultimo in particolare «è l’epopea del
mondo abbandonato dagli dei»34, il suo sentimento è quello di una virilità
matura che si trova in una condizione di frattura tra interiorità e avventura,
in cui «l’uomo […] può trovare il senso e la sostanza nella propria anima,
che in nessun luogo trova una patria» e «il mondo, sciolto dal suo
paradossale ancoramento nel mondo dell’al di là, sarà dato preda della
propria immanente mancanza di significato»35, per acquisire invece senso
dalla trascendenza del soggetto ad esso estraneo nella propria solitudine. La
contrapposizione di interiorità eretta a sostanza e mondo destituito di
senso qualificano il romanzo come il genere letterario nichilistico per
eccellenza, come «l’epopea di un’epoca, per la quale la totalità estensiva
della vita non è più data sensibilmente, per la quale l’immanenza vitale del
senso si è fatta problematica, e che tuttavia ha l’anelito alla totalità»36.
Ma poiché la discrepanza tra idea e realtà è espressa nel suo massimo
grado dall’idea di tempo, che appunto il romanzo introduce nella forma
della durata bergsoniana scissa dall’essenza di cui si va alla ricerca, «quasi si
potrebbe dire che l’intera azione del romanzo si riduca a null’altro che a
una lotta contro la potenza del tempo»37, nella quale «la soggettività non è
in grado di non perdere terreno nei confronti del fluire costante,
monotono del tempo», dal quale essa scivola fuori sperimentando così «la
più profonda e la più avvilente incapacità di avveramento della soggettività
stessa»38. Un appunto in cui Lukács connette “professione e durée” ci
indica che il tempo del romanzo è ancora il tempo dell’etica borghese e
delle istituzioni, il tempo della prima etica39. Ma lo scenario di questa etica
ora è quello della contrapposizione tra un mondo che viene avvertito come
Ivi, p. 130.
Ivi, p. 150.
36 Ivi, p. 89. «Il romanzo – dice altrove Lukács – è la forma dell’avventura, del valore
proprio dell’interiorità; il suo contenuto è la storia dell’anima, che qui imprende ad
autoconoscersi, che delle avventure va in cerca, per trovare, in esse verificandosi, la
propria essenzialità» (ivi, p. 132).
37 Ivi, p. 176.
38 Ivi, p. 174.
39 G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 16. È il frammento 94, dedicato a Romanzo e epos, che
si apre appunto con la domanda: «Che il romanzo nasca dall’isolamento?» (p. 15), e annota
più avanti: «Epos: natura; romanzo: società» (p. 16). Ma cfr. anche il frammento 21 (p.
19), dove Lukács sottolinea che nel romanzo «si produce un mondo della durée e delle
istituzioni oggettive», e ricorda come Dostoevskij non abbia mai dato forma a un
matrimonio, cioè a un’istituzione.
34
35
170
Giovambattista Vaccaro
contingente e incompiuto, diverso dalle categorie che fondano l’interiorità
del soggetto, e un individuo problematico in movimento verso
l’autocoscienza che si rapporta a quel mondo nella forma della
rassegnazione.
Questa articolazione del romanzo, questa sua forma e questa sua
conclusione, si ritrovano nei tre tipi di romanzo individuati da Lukács. Il
primo è il romanzo d’avventura, come evoluzione della concezione per cui
l’occupazione, la professione è il veicolo dell’azione per un soggetto che
avverte la centralità dell’azione ma ha come referente un mondo in cui la
separazione di realtà e ideale si porta dietro quella di azione e
contemplazione. Da questa scissione scaturisce poi il secondo tipo di
romanzo, che Lukács vede come tipico dell’arte della modernità: il
romanzo della disillusione. Questa Stimmung nasce dalla predeterminazione
del fallimento dell’azione da parte di un soggetto che enfatizza il suo dover
essere e la sua interiorità e si riduce ad un atteggiamento più contemplativo
che attivo, e rappresenta agli occhi di Lukács già un «programma
dell’ateismo»40, un modello d’arte nichilistico che esibisce una lotta contro
la convenzione.
Ma il pieno dispiegamento del nichilismo è trovato da Lukács nel tipo di
romanzo di cui Dostoevskij è maestro: il romanzo criminale. In esso è in
atto un “delitto necessario”, di cui Raskolnikov fornisce forse il modello
più compiuto, che, essendo rappresentato al di fuori di ogni tentazione di
ricostruzione psicologica, ma al contrario alla luce dell’interiorizzazione di
intricati nessi causali e dell’assunzione dei sentimenti come semplici dati di
fatto, elementi dell’azione, affida quest’ultima all’esperimento che il
soggetto compie su se stesso per conoscersi e la colloca in «una sfera del
destino»41, dove «il criminale […] si sente tale»42 e il problema morale si
pone come il problema della realtà. Ma ciò su cui Dostoevskij insiste
maggiormente è che questa azione, proprio per il suo carattere destinale, si
configura come quell’azione eroica di cui il soggetto della modernità era
andato in cerca inutilmente, come un’azione capace di «andare fino in
fondo (far saltare le istituzioni)»43, di produrre uno «sfondamento della
realtà»44, «un superamento dello spirito oggettivo»45.
Ivi, p. 16.
Ivi, pp. 18-19.
42 Ivi, p. 61.
43 Ivi, p. 18.
44 Ivi, p. 20.
40
41
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
171
Il soggetto del romanzo criminale è definito da Lukács con un altro
termine assunto da Ernst Bloch: luciferino, il soggetto ribelle al Dio che sta
in alto che si assume l’inevitabilità del peccato in un mondo in cui la prima
etica è entrata in crisi e attraverso la dannazione della propria anima
annuncia all’umanità la speranza in un futuro migliore. Tale è Ivan
Karamazov, ma non è un caso che nel terzo livello di nichilismo Lukács
colloca il terrorista russo Kalaev, in cui il sacrificio morale trapassa nella
lotta politica e la illumina. In questa figura è il presupposto dello scritto di
Lukács su Tattica e etica46, e la misura del percorso da lui compiuto, alla
luce della lezione di Dostoevskij, dalle vaghe esigenze di Sulla povertà di
spirito all’impegno politico concreto. Ma questo per Lukács non è l’unico
sbocco del luciferino e del nichilismo che esso rappresenta nella sua rivolta
contro le istituzioni: esso apre infatti anche al terzo livello della vitalità, di
cui il terzo nichilismo, quello del sacrificio rappresentato da Kalaev,
costituisce uno dei due versanti, e come tale esso è preliminare alla
seconda etica47, a quell’etica superiore rappresentata appunto da altre
forme di sacrificio come Myškin, o Sonja, o Alëša. La spiritualità del
terrorista e quella dell’apostolo laico trovano il loro terreno comune
secondo Lukács nello spirito russo.
Solo questo spirito infatti ha prodotto un nichilismo capace di avere una
potente carica etica che si rivolga contro lo stesso luciferino e lo superi, un
nichilismo autentico: «non vi è un ateismo europeo, solo uno russo»48. Se
infatti il primo, di cui Lukács indica il maggior rappresentante in
Nietzsche, e il modello russo nel Bazarov di Turgenev, si presenta come un
problema personale e morale, come una domanda su come si può morire
senza Dio, come una convinzione che non distingue in sostanza, si
potrebbe aggiungere esistenzialmente, chi la segue da ogni altro e non
coinvolge le conseguenze etiche della miscredenza, per i russi, per
Dostoevskij, il nichilismo è un’esperienza vissuta che riguarda la possibilità
di vivere senza Dio, non è il chiarimento di un errore, come in Feuerbach,
ma è l’esperienza della morte di Dio in forza della quale è realmente
successo qualcosa, non è un problema di scelte ideali, ma è direttamente
Ivi, p. 40.
Cfr. G. LUKÁCS, Tattica e etica, in G. LUKÁCS, Scritti politici giovanili 1919-1928,
Laterza, Bari 1972, pp. 10-11.
47 Nel frammento 88 Lukács appunta tra l’altro: «Nel libro: il capitolo sull’ateismo
prima della seconda etica» (G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 13).
48 Ivi, p. 31.
45
46
172
Giovambattista Vaccaro
connesso al problema della realtà. Per questo Lukács è colpito dal fatto che
in Dostoevskij gli atei non parlano mai di Dio e sono vicini a Dio al punto
che lo scrittore mette in bocca all’ateo Kirillov lo stesso apprezzamento
positivo dell’universo pronunciato dal santo starec Zosima.
Ma di fronte a Dostoevskij anche “il nichilismo buddista di Tolstoj”
appare a Lukács “europeo”49 e non russo. In Tolstoj infatti le idee appaiono
irrilevanti rispetto alla natura, e si ripresenta, ad es. in Anna Karenina,
quella lotta contro le convenzioni destinata a produrre il romanzo della
disillusione e il disprezzo del dialogo, mentre la posizione di Dostoevskij
appare a Lukács del tutto opposta: aperta al dialogo perché estranea alla
lotta contro la convenzione e per questo anche lontana dal romanzo della
disillusione50, ma anche al romanzo d’avventura, poiché «nell’anima si
trova l’avventura»51. Dunque quella seconda etica che nel romanticismo
tedesco era affiorata come idea, quindi nella frivolezza dell’ironia, e che in
Tolstoj si presenta, inautenticamente, come sentimento, si presenta in
Dostoevskij come la vera vita, come la vita da eroe a cui il soggetto della
modernità anela. Ma in cosa consiste questa seconda etica?
In diversi luoghi degli appunti per il volume su Dostoevskij Lukács
indica la vera vita, la vita da eroe, nello sforzo dell’anima di porsi come
sostanza52. La delucidazione della modalità di questo sforzo costituisce
dunque l’asse della definizione di un’etica autentica per un’esistenza
autentica. Il passaggio a questa etica, e quindi all’anima come sostanza,
Lukács lo trova esemplificato in Kierkegaard e nella sua «sospensione
teleologica dell’etico: sempre una sospensione del dovere della veridicità
(della rivelazione, dell’universalità)», cioè delle istituzioni della prima
etica, «che conduce alla solitudine, alla taciturnità»53, e, appunto, nello
spirito russo, dove questa sospensione e questo isolamento possono
spingersi, come si è visto, fino al crimine. Del resto questo isolamento, che
inaugura l’epoca che Fichte ha chiamato della compiuta peccaminosità,
appare a Lukács come necessario in quanto momento di passaggio, e come
Ivi, p. 16.
Lukács insiste su questo in molti frammenti: cfr. ad es. i frammenti 95 (ivi, p. 16),
22 e 23 (ivi, p. 19), 27 e 28 (ivi, p. 59). Per una critica a Tolstoj cfr. ivi, p. 21, e nel
frammento 19 aveva accusato Tolstoj e Turgenev di essere “non autentici” (ivi, p. 18).
51 Ivi, p. 15.
52 Cfr. ivi, pp. 29 e 59.
53 Ivi, p. 66. La figura kierkegaardiana a cui Lukács pensa è certamente l’Abramo di S.
KIERKEGAARD, Timore e tremore, in S. KIERKEGGARD, Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni,
Firenze 1972, pp. 48-100.
49
50
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
173
tale segna il tempo di Dostoevskij. Di fronte ad esso è improponibile il
modello del romanticismo tedesco, che vuole risolvere la seconda etica
nello stato, poiché anzi quest’ultimo dal punto di vista della seconda etica è
un non-essente-malvagio, come per il pensiero indiano e per Tolstoj, o il
sacrificio dell’anima, come per i rivoluzionari, o infine una realtà superata
ma essente, come appunto in Dostoevskij, che vede in esso il pericolo della
Bisanzio realizzata. E, analogamente, nella seconda etica «la giustizia non
compare»54, ma, come insegna il Discorso della montagna, è sostituita
dalla bontà, nella quale prende corpo la «nostalgia di un perdono
universale»55 che fa cadere il velo attraverso cui il mondo empirico ci
appare come il caos del solipsismo etico e costituisce l’ostacolo al
problema della redenzione che la sostanza dell’anima, o la seconda etica,
pone come problema della vita.
Alla luce di questa premessa allora l’azione eroica immediata, con la
quale in Dostoevskij coincide un pensiero che ormai non si identifica più
con la contemplazione, si configura come quell’atteggiamento tipicamente
russo per cui «il ritrovarsi dell’anima è il trovare gli altri»56, e di fronte a
cui i personaggi di Dostoevskij che cercano la solitudine, come Ivan
Karamazov o Versilov, non sono russi. La seconda etica, o la sostanzialità
dell’anima, o la stessa fede in Dio, consistono allora in questo
ritrovamento degli altri che passa attraverso la consapevolezza che «ognuno
di noi è colpevole per tutti e per tutto nel mondo […] e non solo per via di
un’universale colpa mondana, ma ogni singolo per tutti gli uomini della
terra»57, come Dmitri Karamazov che accetta la pena per il parricidio che
non ha commesso per scontare la colpa della sofferenza dei bambini.
Questo è il senso dell’apostolato laico proposto da Zosima ad Alëša a da
Tichon a Stavrogin, o assunto da Myškin: «il monaco e il saggio (indiano)
non sono nostre forme di vita»58.
Questo trovare gli altri costituisce una “democrazia etica” basata
sull’amore e sul rispetto nella quale ha luogo l’«eliminazione dei motivi
geoviani»59 e prende corpo invece una «volontaria comunità»60, di cui
G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 77.
Ivi, p. 29.
56 Ivi, p. 25.
57 Ivi, p. 24.
58 Ivi, p. 29.
59 Ivi, p. 75.
60 Ivi, p. 47.
54
55
174
Giovambattista Vaccaro
Lukács trova i modelli negli eretici medievali, come Wycliffe o,
soprattutto Franck e gli anabattisti, e nella quale è finalmente divenuta
possibile la «conciliazione dell’individuo problematico, guidato dal vissuto
ideale, con la realtà concreta, sociale»61, poiché essa «presuppone […] una
comprensione e una possibilità di collaborazione in rapporto a ciò che, tra
gli uomini, è considerato l’essenziale», e poiché essa «non è né il
radicamento ingenuo e spontaneo nei nessi sociali, con la conseguente
naturale solidarietà della mutua appartenenza (come accadeva nelle antiche
epopee), e neppure una mistica esperienza di comunione, la quale si lasci
alle spalle, dimenticandosene, l’isolata individualità», ma piuttosto «un
mutuo affinarsi e adattarsi di personalità» il cui contenuto «è un ideale di
libertà umana, la quale comprenda in sé e asseveri tutte le immagini della
vita consociata»62.
Ora al centro della seconda etica compare il genere umano che vive
concretamente in ciascun individuo, e lo stato diventa forma del genere,
cessando di essere istituzione coercitiva e realizzando un vero
«nominalismo delle istituzioni di contro allo spirito oggettivo»63 inteso «a
realizzare il minimo etico» in cui le istituzioni «hanno solo un puro valore
di sprone»64; ora il dovere si presenta come «dovere dell’amore»65 che
allontana dalla contemplazione e tenta «di superare l’eroico-luciferino sul
cammino verso la comunità»66; ora, infine, l’anima si raggiunge come
sostanza, oltre la scomparsa dell’anima individuale tipica del misticismo
indiano, ma anche oltre l’affermazione di essa nella sua solitudine di fronte
a Dio che caratterizza il mondo spirituale tedesco e che lo risospinge verso
una sterile nostalgia per la polis greca che costituisce la tragedia della
Germania. Dalla Russia invece Lukács vede giungere il messaggio
dell’affermazione della propria anima «nella comunità delle altre anime
voluta e creata da Dio»67, che Lukács denomina con un altro termine
ripreso da Bloch: paraclito.
Se dunque il luciferino, con la sua rivolta, col suo nichilismo, col suo
individualismo, era stato il passaggio necessario alla seconda etica, la
G. LUKÁCS, Teoria del romanzo, cit., p. 189.
Ivi, p. 191.
63 G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 53.
64 Ivi, p. 39.
65 Ivi, p. 73.
66 Ivi, p. 64.
67 Ibidem.
61
62
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
175
comunità fraterna paraclitea la realizza in pieno superando il luciferino e il
nichilismo. Ma se questo superamento fallisce, se falliscono Alëša e
Myškin, allora siamo condannati o a ricadere nel geoviano o a ripiegare
sulla rassegnazione di Lutero o di Franck, per il quale il mondo non può
fare a meno di un papa68. Su questo sfondo si colloca la problematicità della
rivoluzione, che in queste pagine di Lukács si spinge fino alla critica di
Marx, e che consiste nel rischio permanente dell’intellettualismo, del
cedimento della sostanza, della ricaduta della seconda etica nella prima nel
momento in cui le realizzazioni rivoluzionarie arrestano la lotta contro il
geoviano, le tappe di essa sono altrettanti ostacoli all’avvento del paraclito,
altrettante restaurazioni del geoviano, mentre su tutto stende la sua ombra
il problema della violenza rivoluzionaria, del crimine che fa perdere la
propria anima ma che è necessario come azione che si compie in nome
dell’amore per gli altri, e che per questo conferisce al sacrificio
rivoluzionario una doppia valenza. In fondo anche la rivoluzione, con la sua
duplice natura di trascendenza etica e di azione politica, è una sospensione
etica dell’etica, e per questo secondo Lukács non può essere giudicata dal
punto di vista real-politico69.
Ma se con la seconda etica ci troviamo di fronte ad un’etica comunitaria
e non più individualistica, restano da chiarire i tipi della solidarietà
interumana. Lukács ne indica tre: quello dell’Oriente, per cui l’io e il tu
sono un’illusione; la fratellanza astratta dell’Europa, in cui «l’altro è il mio
“concittadino”, il mio “compagno”, il mio “compatriota”»; e quella,
concreta, della Russia, in cui effettivamente «l’altro è mio fratello», e
«quando trovo me stesso, in quanto trovo me stesso, trovo l’altro»70. La
comunità che così si forma, e che a Lukács appare “utopica”, è appunto la
bontà, perché è fatta di soggetti «del tutto estranei (perché contano ancora
sulle anime isolate) ma nei rari e pochi momenti autentici vicinissimi»71. Su
questo sfondo si capisce l’importanza che Lukács attribuisce al dialogo, che
era al centro delle sue preoccupazioni già in Sulla povertà di spirito72, come
68 Cfr. ibidem. La fonte di Lukács qui è W. DILTHEY, L’analisi dell’uomo e l’intuizione
della natura. Dal Rinascimento al secolo XVIII, La Nuova Italia, Firenze 1974, vol. I, p. 115.
69 Cfr. G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., pp. 56-57.
70 Ivi, p. 81.
71 Ibidem, e più avanti Lukács ribadisce: «relazione con l’“amore” (tra gli uomini) e
Dio».
72 A. HOESCHEN, Das “Dostojewski”-Projekt, cit., pp. 11 sgg., ha indicato il primo
documento di quella che egli chiama il Progetto “Dostoevskij” proprio in questo scritto,
che ruota intorno al tema che ispira l’intero Progetto: la possibilità del dialogo come
176
Giovambattista Vaccaro
modalità dell’uscita dall’isolamento, dell’andata verso l’altro, della
comprensione reciproca. Chi, come Tolstoj, disprezza il dialogo, disprezza
l’interumano, di cui esso è condizione e realtà. Così la seconda etica può
essere davvero definita come «la prassi sociale dell’uomo concreto che è
interessato solo alla concretezza dell’altro», e «la sua forma ideale […] è la
“comprensione qualitativa delle persone”», che «rimane teoreticamente
indisponibile, dunque mistica […], cioè “nuda di senso e di valore”»73.
Ma se il problema di Lukács resta quello della forma d’arte che esprime
una determinata etica, il ritorno di una comunità ad un livello più alto e
complesso, l’avvento di una nuova polis, russa e non greca, si esprimerà in
una nuova epica74 che prenderà corpo in una scrittura non drammatica,
poiché il dramma cerca gli eroi e in esso si è eroi, ma non si vive da eroi. Il
modello di questa scrittura è ritrovato da Lukács naturalmente in
Dostoevskij, cioè in un autore a cui è estraneo il contrasto tra ideale e reale
e quindi la disillusione, e del quale perciò Lukács può affermare
paradossalmente che non ha mai scritto romanzi75, che si è collocato oltre
l’epoca della compiuta peccaminosità per alludere alla possibilità di un
nuovo mondo. In Dostoevskij, in sostanza, Lukács trova la conferma del
fatto che non si fa arte per l’arte, come vuole la cultura estetica del
nichilismo contemporaneo, ma, al contrario, «il problema estetico in
questione è […], nei suoi fondamenti ultimi, un problema etico […], è
«possibilità dell’accesso ermeneutico all’altro» (p. 13), di una «comprensione qualitativa
delle persone» (p. 3) opposta alla vita abituale e intesa non come accordo su contenuti
teoretici di pensiero, bensì compenetrazione delle anime attraverso il riconoscimento di
ciò che è voluto ed è sentito, secondo un modello che Lukács riprenderebbe da Simmel
(cfr. G. SIMMEL, I problemi della filosofia della storia, trad. it. Casale Monferrato, Marietti,
1982, pp. 29 sgg.). Hoeschen insiste molto sulla presenza di Simmel all’interno del
Progetto “Dostoevskij”, al punto di ritrovare lo stesso tema del ritorno dell’anima a se
stessa nello scritto Concetto e tragedia della cultura (cfr. G. SIMMEL, La moda e altri saggi di
cultura filosofica, Longanesi, Milano 1985, pp. 189-212), e da ricollocare il problema
centrale del Progetto “Dostoevskij” all’interno della problematica simmeliana della
tragedia della cultura come autoalienazione, pur precisando la differenza nel concetto di
cultura tra Simmel e Lukács, che consiste nel fatto che «mentre Simmel fissa la dialettica di
autosviluppo e autoprivazione che sta alla base dell’individualità, tutta l’attenzione di
Lukács si rivolge ad una sorta di aporetica dell’intersoggettività» (A. HOESCHEN, Das
“Dostojewski”-Projekt, cit., p. 22).
73 Ivi, p. 268.
74 Cfr. G. LUKÁCS, Dostoevskij, cit., p. 13, dove, nel frammento 87, Lukács annota:
«La seconda etica come apriori formale dell’epica».
75 Cfr. G. LUKÁCS, Teoria del romanzo, cit., p. 217.
Nichilismo, etica e filosofia della storia nel primo Lukács
177
tutt’uno col problema etico dell’utopia; il problema di stabilire fino a che
punto può essere giustificata, in senso etico, la possibilità di pensare un
mondo migliore»76. La soluzione di questo problema incarna ora per
Lukács il terzo momento della filosofia hegeliana della storia, il suo
compimento. E sarà il compito della rivoluzione.
Abstract
The paper aims to show, in the production of the early Lukács, the plot
and the value to considerations of nihilism, ethics, and compared to these,
the philosophy of history. Through the interpretations of the greatest
scholars and critics, to acknowledge the proximity and at the same time,
the originality of the thinker in question in relation to the work of Hegel.
76
Ivi, p. 166.
MANUEL E. VÁZQUEZ
Herencia y testamento
(H. Arendt y J. Derrida)
I – «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», escribió René Char. Al
pronto un enunciado imposible, una proposición sin sentido. Toda herencia, así lo
estipulan las leyes y el sentido común, viene precedida por la expresión de una
voluntad y encuentra su condición de posibilidad en la anterioridad de la decisión
que la constituye. Sin embargo, ese enunciado imposible encuentra su sentido en
la falta de sentido. Es decir, disolviendo y anulando el sentido. Una herencia
carente de testamento nunca es tal. Su falta de condición le impide ser algo
condicionado y, por tanto, presente, efectivo. Sin embargo, ese enunciado es un
aforismo, un fragmento, quizás un verso. Un verso no escrito en el interior de un
poema ausente, un fragmento sin totalidad, un aforismo sin sistema. En el poema,
lugar de lo imposible, se resuelve y disuelve el sentido de lo posible.
El sentido de lo posible no es algo posible, de la misma manera que el sentido
del sentido no es algo con sentido ni pertenece a la esfera del sentido. Ni lo tiene
ni carece de él. Es ese su peculiar régimen, su paradójica forma de relacionarse y
referirse al sentido. Por eso el sentido del enunciado, en tanto que sentido, ni es
un enunciado ni es enunciable. No puede ser dicho y sin embargo no remite a lo
inefable propio de una cierta comprensión de lo místico en la que el silencio acaba
siendo una mostración de lo que no cabe decir, es decir, el sinsentido a que aboca
la enunciación del sentido.
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», volvemos a leer. El verso
tampoco supera su condición imposible cuando invertimos sus términos:
«Nuestro testamento no está precedido por ninguna herencia». En ese caso nos
vemos remitidos a una “herencia”, una herencia anterior al hecho de ser tal, una
herencia sin herencia, una herencia previa a su constitución vía testamento. El
sinsentido se da a ver en este caso como la imposibilidad de un testamento que
nada transmite y que, por tanto, no permite identificar un conjunto de bienes
materiales o inmateriales como constitutivos de una herencia.
En cualquiera de sus dos posibles lecturas, el verso de René Char nos conduce
hasta la disolución del sentido. Sea cuando apunta al espacio donde encuentra su
posibilidad, sea cuando apunta a su propia desaparición. En un caso y en otro nos
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 179-194
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064312
179
180
Manuel E. Vàzquez
topamos con lo imposible que no puede ser dicho o aboca al vacío. Ni un camino
ni otro parecen transitables. La mística del silencio y la estética del vacío parecen
conducir a un más allá de la filosofía, un afuera, una exterioridad donde ella es
relevada por mor de sus limitaciones. Un llevar a la filosofía más allá de sí que
sitúa su verdad fuera de ella misma.
Las salidas que el vacío y el silencio habilitan así como el trayecto que conduce
a ellos, parten de un supuesto: es imposible lo estructural, lo lógicamente
imposible. Es decir, lo puramente intelectual cuya contradictoria constitución
impide su realización efectiva. Lo lógicamente imposible encuentra su correlato
en la inexistencia propia de lo que por ser fenoménicamente imposible nunca
podrá constituir el contenido efectivamente real de concepto alguno. Todo ello
podrá ser pensable pero no es cognoscible.
Sin embargo, es posible apuntar otra perspectiva. Cabe reconocer que
la imposibilidad no es simplemente negativa. Ello quiere decir que es preciso
hacer lo imposible. El acontecimiento, si lo hay, consiste en hacer lo imposible.
Pero cuando alguien hace lo imposible, si alguien hace lo imposible, nadie,
comenzando por el autor de esa acción, puede estar en condiciones de ajustar un
decir teórico, asegurado por sí mismo, a ese acontecimiento 1.
En ese caso lo imposible deja de ser el límite negativo de lo posible. Más
bien sería algo así como la reserva que hace posible el acontecer y, por ello, el
acontecimiento. Acontece, ocurre, tiene carácter de acontecimiento, lo que
se substrae a su imposibilidad y así se hace presente y posible. No hay llegar a
ser sin la sustracción, la retirada de lo imposible. En un mismo movimiento
queda anudada la presentación de lo posible y la retirada de lo imposible. No
hay una cosa sin la otra, una y otra son lo mismo. Sólo bajo tal condición es
posible el acontecimiento. Sólo bajo tal condición el acontecer no se confunde
con el suceder. Eso es justamente el acontecimiento: el tránsito de lo
imposible a lo posible donde lo imposible deviene algo efectivo y real y, por
tanto, deja de ser imposible. Nada de ello es ajustable a un “decir teórico”, es
decir, se deja encapsular en el concepto ni da lugar a un saber capaz de dar
razón de su propia validez.
No hay conocimiento de lo imposible, pero sí experiencia. La experiencia de
lo imposible no es una experiencia imposible2. Para decirlo con Derrida, «la
J. DERRIDA, G. SUSSANA, A. NOUSS, Decir el acontecimiento ¿es posible?, Arena, Madrid 2007, p. 92.
J. DERRIDA, J.L. MARION, R. KEARNEY, “On the Gift” en J. CAPUTO, D. JOHN, M. SCANLON
(Eds.). God, the Gift, and Postmodernism, Indiana University Press, Bloomington 1999, pp. 54-78.
1
2
Herencia y testamento
181
experiencia de lo imposible condiciona la acontecibilidad del acontecimiento. Lo
que ocurre como acontecimiento, no debe ocurrir sino allí donde es imposible. Si
fuera posible, si fuera previsible, es que aquello no ocurre»3. Ajeno a la previsión,
el cálculo o la anticipación, sólo hay acontecimiento allí donde lo imposible deja
de ser tal y deviene posible.
II – «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», repetimos, volvemos a
leer. En el verso parece resumirse nuestra condición de herederos. A ella no
podemos escapar, de ella no podemos huir. Incluso sin saberlo, sin poseer la
forma legal y jurídicamente establecida, nunca dejamos de serlo. En este caso
unos herederos que carecen de la carta de legitimidad que los convierte en tales.
Unos herederos no precedidos por la voluntad que expresa el testamento. Unos
herederos, pues, incapaces de valorar en qué medida cumplen el mandato de la
voluntad que expresa el testamento que es algo más – siempre es algo más – que
la simple cesión del disfrute y posesión de unos bienes.
La condición para que pueda haber herencia es que la cosa a heredar (…) no
dependa ya de mí, como si estuviese muerto al final de mi frase [antes incluso de
firmar un pensamiento]. Para decirlo de otra manera, la cuestión de la herencia
debe ser la cuestión dejada al otro; la respuesta es al otro4.
Se lega una propiedad, desaparece el que hasta entonces era su propietario, la
recibe el heredero. Una enumeración, una secuencia, sin duda, pero con una
precisión. Esa secuencia no es una sucesión. Más bien es algo instantáneo. Esa
complejidad queda anudada en el presente que sintetiza tres acciones. Para que la
donación sea efectiva, el donador debe desaparecer. Esa ausencia no es dejación
sino condición. Condición de la herencia. Persistiendo su agente, imponiéndose el
donador y su voluntad, la herencia se convierte en encargo: lo que tienen que
hacer los herederos. Sólo hay que deslizarse por el cumplimiento de las
instrucciones recibidas y las voluntades expresadas. El receptor, el heredero,
resulta así anulado, puesto en función de otro, deviene simple continuador que
cumple los dictados de quien lo precede.
La herencia tiene la forma del endeudamiento: el compromiso asumido con la
aceptación de la herencia. Una voluntad anula a la otra. La voluntad de quien
dona anula la voluntad de quien recibe. Una se prolonga más allá de ella, la otra
no llega a nacer. Una sobrevive a sí misma, la otra no llega a vivir. Esa herencia,
3
4
J. DERRIDA, Decir el acontecimiento ¿es posible?, cit., p. 94.
J. DERRIDA, Sur parole. Instantanés philosophiques, Editios de l’Aube, Paris 2005, p. 59.
182
Manuel E. Vàzquez
expresión de voluntad que exige cumplimiento, anula la libertad del receptor.
Por eso, «es necesario que renuncie a estar detrás de lo que digo, lo que hago o lo
que escribo para que quepa plantear la cuestión de la herencia»5. Una herencia sin
tutela, tal sería lo aquí nombrado. Una herencia en la que lo recibido, antes que
un deber u obligación, es una oportunidad, una posibilidad, un vínculo sin
imposición. Por eso nadie elige a sus herederos. Sin duda puede seleccionar a
quienes reciben, reproducen o repiten. Pero no elegirá a quienes harán de lo
recibido una oportunidad de ser ellos mismos, haciendo de lo recibido la materia
de la que está hecha su libertad.
Los herederos auténticos, aquellos que cabe desear, son herederos que han roto
suficientemente con el origen, el padre, el testador, el escritor o el filósofo para ir
con su propio movimiento a firmar (signer) o refrendar (contresigner) su herencia.
Refrendar (contre-signer), es firmar otra cosa, la misma cosa y otra cosa para que
ocurra otra cosa. La contrafirma supone en principio una libertad absoluta6.
Son los otros, los herederos, quienes deciden sobre lo recibido. Desde su
libertad. Son ellos quienes validan y refrendan. Son ellos, en suma, quienes en la
aceptación de la donación atribuyen legitimidad a lo recibido y le conceden la
oportunidad de seguir siendo. No para repetirlo sino para hacer de ello otra cosa.
Ahí hay creación, invención, novedad, pero también decisión. Una decisión
sobre el fondo de la fidelidad y la infidelidad, siempre que hagamos de cada una
de ellas algo más que la contraria de la otra:
a partir de la infidelidad posible uno se entrega a la herencia, se la asume, se la
retoma y se refrenda la herencia para hacerla ir más allá, hacerla respirar de otra
manera. Si la herencia consiste simplemente en mantener cosas muertas, archivos
y reproducir lo que fue, a eso no cabe llamarlo una herencia. No cabe desear un
heredero o una heredera que no invente la herencia, que no la lleve más allá, en la
fidelidad. Una fidelidad infiel. Nos volvemos a encontrar con este doble mandato
que no me abandona7.
La recepción no está al servicio de la reproducción o la repetición, sino de la
creación que añade e incrementa. La gestión de lo mismo es aquí sustituida por la
creación de lo nuevo. Un doble mandato, un doble imperativo (double bind): la
fidelidad que asegura las continuidades y la infidelidad que garantiza las
Ibid.
Ivi, p. 60.
7 Ibid.
5
6
Herencia y testamento
183
novedades. Sin regla que distribuya sus espacios u ordene sus relaciones. Su
contaminación abre el espacio de una negociación sin reglas dadas de antemano.
La herencia no es lo que se recibe, es lo que se inventa. Con el mismo sentido con
que decimos que cada texto inventa su lector y sus predecesores8.
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», leemos. En esta nueva
entonación hay que entender: nuestra herencia no está precedida de ninguna
prescripción. Carece de instrucciones de uso. En ella todo está por inventar. La
herencia acaba así identificada con lo que se recibe, aparece y se muestra: se
recibe, aparece y se muestra sin origen, sin autoridad, sin prescripción. Ahí está
incluida la posibilidad de la invención que incrementa, abre y concede
posibilidades a lo recibido. Pero sólo es objeto de invención en tanto lo
reconocemos como herencia, es decir, lo vinculamos a unos maestros, ancestros,
predecesores o un origen. Esa es la ficción fabulosa que inventa un origen, unos
predecesores, unos maestros o un padre que nunca hemos tenido para así
reconocernos como herederos, es decir, insertos en la cadena de sentido que es la
tradición.
Por eso la invención de la herencia inventa también a su receptor. Sólo así
adquiere el perfil propio con el que se destaca de lo precedente. Pero ahí también
se abre la posibilidad de quebrar la continuidad supuesta. En ese caso lo recibido
adquiere un sentido que lo proyecta más allá de su mera recepción. Esa es una
dinámica que no concluye. En ella estamos, en ella nos constituimos. Ahí se apela
a lo que de superación hay en la herencia. Añadir y heredar: eso es superar.
III – Ortega lo ha expresado con manifiesta claridad:
el espíritu, por su esencia misma, es, a la par, lo más cruel y lo más tierno o
generoso. El espíritu, para vivir, necesita asesinar su propio pasado, negarlo, pero
no puede hacer esto sin, al mismo tiempo, resucitar lo que mata, mantenerlo vivo
en su interior. Si lo mata de una vez para siempre, no podría seguir negándolo,
superándolo. Si nuestro pensamiento no repensase el de Descartes, y si Descartes
no repensase el de Aristóteles, nuestro pensamiento sería primitivo –tendríamos
que volver a empezar y no sería un heredero. Superar es heredar y añadir9.
Quizás lo más importante no sea esa oscilación de muerte y vida, su interna
relación y necesidad. Una y otra, al unísono, constituyen la sístole y la diástole
8 Sobre lo primero ha insistido J. DERRIDA, sobre lo segundo J.L. BORGES en “Kafka y sus
precursores”, en ID., Otras inquisiciones. Alianza, Madrid, 2002
9 J. ORTEGA Y GASSET, ¿Qué es filosofía?, Revista de Occidente, Madrid 2007, p. 193
184
Manuel E. Vàzquez
que anima el decurso histórico: una muerte lo suficientemente intensa que no
extingue la vida de lo negado y una vida lo suficientemente compleja como para
aceptar la negación que supone toda afirmación de sí.
Sin embargo, lo esencial quizás esté en otra parte. Más en concreto, en los dos
últimos renglones: «tendríamos que volver a empezar y no seríamos herederos.
Superar es heredar y añadir». «Volver a empezar»: esa es la amenaza a conjurar.
En ella el pasado no se torna experiencia y, carente de referencias, es el material
cada vez inédito que parece comenzar a cada instante. Pero hay una secreta
continuidad que nos convierte, en palabras de Ortega, en herederos. El pasado
recibido y legado debe ser mantenido con el rigor que exige la palabra tradición.
No se trata de comenzar, se trata de continuar. Sin embargo, continuar no es
repetir sino “añadir”. Es decir, sumar, incrementar el cómputo del más y lo
mejor, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo extensivo y lo intensivo.
Quizás haya alguna relación entre el “superar” orteguiano y la Aufhebung
hegeliana, elevación y supresión, “heredar y añadir”, dice Ortega10. Sin embargo,
todo podría ser de otra manera y quizás ya sea de esa otra manera. Y es que para
Ortega el pasado recibido como herencia no es ajeno al testamento legado a las
generaciones futuras en forma de prescripción normativa o afectiva. Esa visión
está asentada con la fuerza propia de lo evidente y de ella resulta difícil salir. Esa
visión estaría presente, por ejemplo, en H. G. Gadamer11 o en R. Koselleck12, en
la tradición como espacio de legitimidad y autoridad, en el pasado como espacio
de experiencias y reserva de enseñanzas.
Quizás todo pase por reconocer, como indica el verso de René Char, esa otra
posibilidad de la herencia sin testamento, la perplejidad que abre y la inquietud a
la que apunta: algo donado de lo que está ausente lo que lo convierte en tal. Algo
privado de la condición de posibilidad que lo convierte en lo que es. Es decir, un
comparecer del que se ausenta el sentido y en el que se entrega la perplejidad de
lo presente. Es decir, la perplejidad que suscita el presente que ya es un don13.
Ese don tiene aquí la forma de la herencia sin testamento.
10 D. HERNÁNDEZ, Estética de la limitación. La recepción de Hegel por Ortega y Gasset, Universidad
de Salamanca, Salamanca 2000; J. ORTEGA Y GASSET, Hegel. Notas de trabajo, Abada, Madrid 2007.
11 H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr,
Tübingen1960.
12 R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1979.
13 J. DERRIDA, Donner - le temps, Galilée, Paris 1991.
Herencia y testamento
185
IV – Una precisa comprensión del tiempo histórico exhibe así su colapso. La
comprensión basada en la asimetría entre el espacio de experiencia y el horizonte
de expectativas, la experiencia del pasado y el horizonte del futuro, que leemos
en Reinhart Koselleck.
El futuro temporalmente anticipado acaba espacialmente objetivado en el
pasado, haciendo del presente tanto el momento de transición entre el presente y
el pasado, como el instante donde el futuro deja de ser tal para convertirse en
pasado, es decir, futuro pasado. Ese futuro al que remite el horizonte de
expectativas sólo se torna anticipable a partir de la experiencia que acumula el
presente. El futuro reclama proyecto y anticipación. Oferta así un referente en el
que a modo de horizonte cabe elaborar el sentido, es decir, orientar la acción. El
futuro es en lo que cabe intervenir. En tanto por hacer, orienta el hacer. Un
imperativo habría que añadir a todo ello: conjurar la repetición, nunca hacer del
futuro la repetición del pasado. Novedad e innovación nombran la pulsión ajena a
la repetición.
Mucho de ello parece haberse alterado14. En particular lo que afecta al futuro.
Parece haber dejado de ser el espacio de proyectos orientados a lo mejor para
convertirse en piélago ignoto atestado de incertidumbres y temores. Antes que
encontrar en él la mejora del presente, aparece como su amenaza. Algo, en suma,
de lo que protegerse. Por eso se procede a su balización mediante el muro de
contención del pasado. El pasado queda así proyectado al porvenir y el futuro se
convierte en la repetición de lo que ya ha sido. En la vuelta del pasado se
neutralizan, vía repetición, las amenazas, temores y miserias asociadas al
porvenir. Lo mejor que puede pasar es que lo pasado vuelva a pasar. Y eso es,
quizás, lo que nos pasa.
Queda así nivelado el desequilibrio entre pasado y futuro, espacio de
experiencia y horizonte de expectativas, que constituía el supuesto del tiempo
histórico en la forma hasta aquí conocida. A la nivelación debe añadirse la
desaceleración. De esta manera el futuro plagado de amenazas es desplazado a una
mayor lejanía, conjurando así sus efectos sobre el presente, mientras ese mismo
presente es rellenado con el material que aporta un pasado cada vez más
ampliado, es decir, cada vez más presente.
El efecto que de ello se deriva es doble. Por una parte la sensación de
paralización, de desaceleración o crecimiento negativo; por otra, el presente
colonizado por el pasado con vistas a conjurar el futuro se dilata y extiende,
anulando el desnivel entre pasado y futuro propio del tiempo histórico. Se
14 H.U. GUMBRECHT, “Die Gegenwart wird (immer) breiter”, Merkur 629/630 (2001), pp.
769-784; ID., Production of Presence, Stanford University Press, Stanford 2004.
186
Manuel E. Vàzquez
interrumpe así el decurso, sustituido por la sucesión que regular y tediosamente
encadena lo igual a lo igual. De hecho parece como si ningún futuro hecho
presente fuera capaz de convertir al presente en pasado. Todo es actual,
generándose así el atasco, la obstrucción de lo que no acaba de pasar, convertido
en antídoto contra el futuro y sus amenazas.
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» puede ser leído, en ese
caso, de manera muy diferente a como hasta aquí hemos hecho. De entrada,
“nuestra herencia” remite bien a lo que recibimos de quienes nos han precedido,
bien a lo que donamos a quienes nos suceden. En un caso y en otro la ausencia de
testamento nombra la falta de instrucciones en la apropiación e integración del
pasado. Apropiación e integración tanto más intensa cuanto más evidente es su
finalidad: aplazar y neutralizar la llegada del futuro. En última instancia todo ello
deriva de la ausencia de un proyecto, bien en la forma de algo recibido, bien en la
forma de algo legado. Todo parece detenido en ese presente que crece a costa de
integrar un pasado llamado a contrarrestar un futuro reducido a simple plazo de
cumplimiento y amortización de la deuda recibida como herencia. El tiempo
histórico se ralentiza en la misma proporción con que pasado y futuro quedan
nivelados en el presente. En ese presente queda atascado el devenir histórico,
incapaz de alumbrar un futuro que siendo tal acabe por encontrar su espacio en el
pasado que lo objetiva. Tal es el resultado de la conjura del futuro y la ausencia de
anticipaciones capaces de proyectar más allá del propio presente un horizonte de
apertura, un espacio dispuesto a lo mejor.
V – El ángel de la historia de Benjamin, vuelto hacia el pasado, parece escrutar
el testamento de la herencia recibida. Quizás esa sea la clave de la redención del
presente en que se alumbra la posibilidad de un futuro que merezca el nombre de
tal. Vuelto hacia el pasado, su gesto no es ajeno a la memoria. En la memoria no
sólo se rescatan personas, sucesos y acontecimientos insertos en el pasado
cronológica e interesadamente ordenado que constituye la historia. Quizá más
importante que todo eso, la memoria redime lo orillado y condenado a la
insignificancia por el curso oficial de los acontecimientos. Esa memoria se cimenta
en ingentes cantidades de olvido. No solo por la dificultad de conservar en su
integridad el pasado; también y más importante, por el criterio que dictamina lo
que merece ser conservado y recordado. Por eso en el curso triunfal de la
historia, narración que redundantemente legitima la victoria de los vencedores –
en cualquiera de las formas en que esto ocurre –, queda poco espacio para todo
aquello que privado de la dignidad que le concede la memoria, acaba arrumbado
en el desván del olvido. Anónimo y ausente, ese denso material de indiferencia
Herencia y testamento
187
viene a recordarnos, a lo sumo, las muchas vías muertas que han quedado
aparcadas y apartadas a la espera de que otra mirada les conceda el porvenir que el
presente les niega15.
Conceder al pasado anulado por la historia el carácter de posibilidad equivale a
hacer de él algo más que un pesado fardo de engorrosa gestión y peor digestión.
Esa es una manera eficaz, sugiere Benjamin, tanto de resistirse al
empobrecimiento unilateral que el presente oferta, como de hacer del futuro algo
más que la prolongación mecánica del presente.
El pasado no retorna para legitimar o completar al presente, sino para
desestabilizar la penuria de sus expectativas. Es un asunto teórico, sin duda. Pero
en el caso de Walter Benjamin es también cuestión biográfica. Su historia personal
de fracaso, humillación y derrota lo trasciende haciéndolo llegar hasta nosotros.
Fracaso, humillación y derrota no son nunca asunto enteramente personal ni
cuestión estrictamente privada. Traducen la falta de un mundo y unas
circunstancias en las que esa vida derrotada hubiera sido una existencia digna de
tal nombre: una vida feliz.
La derrota o el fracaso personal traicionan la promesa de felicidad que nos es
entregada con la existencia. El tiempo de la existencia aloja la promesa que la vida
gestiona. Esa promesa de felicidad debe prolongarse en la construcción de una
sociedad donde sea posible cumplirla.
Nada debería truncar las expectativas que abre el horizonte de la promesa.
Cuando es incumplida, la redención del pasado de nuevo le concede la posibilidad
que en su momento le fue negada. La memoria del pasado deviene así memoria
del futuro y como si de una poderosa alquimia se tratara, Benjamin altera el lugar
que convencionalmente concedemos al pasado y al futuro. Ni la catástrofe
pertenece al pasado ni la esperanza remite al futuro. En rigor, el olvido y la
catástrofe pertenecen al futuro. Solo así se entiende que quepa hablar de una
memoria del futuro.
Si la catástrofe es la intensificación del presente que tediosamente se repite, en
ese caso lo catastrófico es el olvido del futuro: ese “extranjero invisible” para el
que cada vez parece haber menos espacio. No se trata del futuro que como plazo,
programa o anticipación prolonga al presente y sus miserias. Es más bien ese otro
futuro paradójico que llega para interrumpir la lógica del presente y abre el
espacio de la novedad. Eso solo puede tener la forma de la promesa que ilumina el
espacio de su cumplimiento por venir. Esa iluminación acontece cuando las
contradicciones nunca resueltas y las derrotas nunca reparadas, lejos de resolverse
15 M. E. VÁZQUEZ, “W. Benjamin, «memoria del futuro»”, in VV. AA., Pensadores judíos. Objeto
Perdido, Mallorca 2011, pp. 41-53.
188
Manuel E. Vàzquez
en una síntesis intelectual o una reconciliación aparente, estallan alumbrando el
espacio de su redención. Probablemente esa fue la manera en que Benjamin, a
caballo entre el materialismo histórico y la teología judía, fue capaz de deletrear
una palabra – revolución – de difícil sintaxis y realidad problemática.
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» remite ahora a la tarea de
hacer legible la derrota que el pasado nos ha legado como herencia. Lo donado no
es algo neutro o aséptico que sólo invita al trabajo de su recolección, incremento
y superación. Quizá lo más preciado es lo que oculta, la voz que silencia, las
posibilidades que encierra. Más allá de su clausura amparada en la repetición,
apunta a la tarea de descifrar su sentido en un pasado que así proyecta la fuerza de
su verdad en el futuro de su redención. Y nada de ello es ajeno a la revolución.
VI – Quizás sea este el momento, justo ahora que se apela a la revolución y el
sentido olvidado, de recordar nuevamente el verso de René Char: «Notre
héritage n’est précédé d’aucun testament». Ahora se trata de leerlo de otra
forma. Se trata de leerlo como lo que también es: una cita. Una cita que se
encuentra en Sobre la revolución de Hanna Arendt. Más en concreto, es el exergo
del capítulo titulado La tradición revolucionaria y su tesoro perdido.
Un libro todo él amparado en la memoria y el recuerdo, es decir, en lo
perdido «cuando el espíritu de la revolución – un espíritu nuevo y, a la vez, el
espíritu de dar origen a algo nuevo – no logró encontrar su institución adecuada.
No hay nada que pueda compensarnos de esta pérdida ni de evitar su carácter
irreparable, salvo la memoria y el recuerdo»16. La síntesis de lo nuevo y su
producción, el acto y la acción, es llamada aquí revolución, aunque amparada en
el espíritu. Es en este punto cuando se recurre al poeta “a fin de hallar la
articulación aproximada del contenido real de nuestro tesoro perdido”. René
Char fue, añade Arendt, «probablemente el más lúcido de cuantos escritores
franceses se unieron a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial». Su
libro, teñido de pesimismo, es un canto anticipadamente nostálgico por la vuelta a
la normalidad democrática tras la lucha por la democracia17. La Resistencia deja
paso a la votación y el ejercicio reglado de la democracia: «si sobrevivo, sé que
tendré que prescindir de la fragancia de estos años fundamentales, que tendré que
renunciar (no reprimir) a mi tesoro». Un proceso político, sin duda, pero en el
caso de Char también personal, pues «estas meditaciones son significativas por
cuanto son testimonio de un auto-descubrimiento involuntario, del gozo de
manifestarse en la palabra y en los hechos sin los equívocos ni las autocríticas que
16
17
H. ARENDT, On Revolution, Penguin, Londres 1990, p. 280.
R. CHAR, “Les Feuillets d'Hypnos”, in ID., Fureur et mystere. Gallimard, Paris 2003.
Herencia y testamento
189
son inherentes a la acción». Sin embargo, el hecho de ser demasiado “modernas” y
estar “demasiado centradas en su autor”, lastran su testimonio.
Se trata, por tanto, de otra cosa. Sin duda de recuerdo y memoria, pero
también de concepto: «si es cierto que todo pensamiento se inicia con el
recuerdo, también es cierto que ningún recuerdo está seguro a menos que se
condense y destile en un esquema conceptual del que depende para su
actualización»18. Cabe comprender aquí el “esquema conceptual” como esquema
“conceptual”, es decir, como apelación genérica a la manera en que los conceptos
formalizan la experiencia, una experiencia ciega sin su referente conceptual. Pero
también cabe comprenderlo como esquema conceptual, es decir, subrayando el
esquematismo de los conceptos que posibilita su aplicación. Sólo tal cosa
permitiría que el concepto “revolución” fuera algo más que una pura formalidad
intelectual y su realidad fuera más que una simple sucesión ciega de
acontecimientos privados de sentido.
En el primer caso se apela a la derrota de la teoría19 asociada al ocaso de la
revolución:
si es indiscutible que la erudición y un pensamiento conceptual de alto calibre
fueron las bases sobre las que se construyó la República americana, no es menos
cierto que este interés por la teoría y el pensamiento político desapareció casi
inmediatamente después que la empresa había sido realizada. Como ya he
indicado, creo que esta pérdida de interés, que se supone puramente teórico, por
los problemas políticos no ha constituido el “genio” de la historia americana, sino,
al contrario, la razón principal de que la Revolución americana haya sido estéril
para la política mundial20.
Es el olvido conceptual de la Revolución, sin duda, pero es también el olvido
del hecho revolucionario:
la enorme autoridad de la Constitución y de las experiencias derivadas de la
fundación de un nuevo cuerpo político determinó que el fracaso en incorporar los
municipios y las asambleas municipales como manantiales primigenios de donde
manaba toda la actividad política del país, significase su condena de muerte. Puede
parecer paradójico, pero lo cierto es que el espíritu revolucionario comenzó a
marchitarse en América bajo el impacto de la Revolución, siendo la propia
H. ARENDT, On Revolution, cit., p. 220.
Rechazo de la teoría que parece consustancial a los Estados Unidos y cuyo penúltimo
diagnóstico bien podría ser The Resistance to Theory de Paul de Man
20 H. ARENDT, On Revolution, cit., p. 220
18
19
190
Manuel E. Vàzquez
Constitución, la mayor hazaña del pueblo americano, la que terminó por
despojarlos de su bien más preciado21.
Ese conflicto percibido con rapidez por Jefferson entre Revolución y
Constitución, saldado a favor de esta última, es deudor de otra serie de
antagonismos. Por lo pronto el antagonismo entre revolución e
institucionalización:
si la fundación era el propósito y el fin de la revolución, entonces el espíritu
revolucionario no era simplemente el espíritu de dar origen a algo nuevo, sino de
poner en marcha algo permanente y duradero; una institución perdurable que
incorporara este espíritu y lo impulsase a nuevas empresas sería
contraproducente. De lo cual, desgraciadamente, parece deducirse que no hay
nada que amenace de modo más peligroso e intenso las adquisiciones de la
revolución que el espíritu que les ha dado vida22.
La revolución sin institucionalización condena a la revolución a la
desaparición, pero la revolución institucionalizada traiciona la revolución. No hay
forma eficaz de romper ese bucle. Toda revolución, parece apuntarse, está
llamada a desaparecer tras su institucionalización; es la revolución misma la que
acaba convertida en enemiga íntima de sí misma.
Cabe añadir a todo ello el antagonismo entre origen y principio que resuelve la
revolución. En ella lo absoluto se hace presente en la esfera relativa de los asuntos
humanos. Es la manera en que lo incondicionado se presenta en lo condicionado
constituyendo no sólo un punto de partida lógico sino también cronológico, es
decir, un momento en el interior de una secuencia temporal más amplia: “lo que
salva al acto del origen de su propia arbitrariedad es que conlleva consigo su
propio principio, o, para ser más precisos, que origen y principio, principium y
principio, no sólo son términos relacionados, sino que son coetáneos. El absoluto
del que va a derivar su validez el origen y que debe salvarlo, por así decirlo, de su
inherente arbitrariedad es el principio que, junto a él, hace su aparición en el
mundo. La forma en que el iniciador comienza cuanto intenta hacer, dicta la ley
que regirá los actos de todos aquellos que se le unen para participar en la empresa
y llevarla a término. En cuanto tal, el principio inspira los hechos que van a
seguirlo y continua siendo visible durante todo el tiempo que perdura la acción”23.
Ivi, p. 239.
Ivi, p. 232.
23 Ivi, p. 213.
21
22
Herencia y testamento
191
Quizás deba añadirse algo. El espíritu revolucionario, origen absoluto inserto en
el contexto relativo de los hombres, se objetiva como principio cuya
institucionalización convierte la arbitrariedad de lo incondicionado en necesidad
condicionante. Que dicha institucionalización acabe ocupando todo el espacio
anulando así el espíritu revolucionario, su compromiso con la novedad y el espíritu
de lo nuevo, es lo que ejemplifica el caso de la Revolución americana. Que en ello
está inscrito el destino de toda revolución es lo que quizás se insinúa. Que el
espíritu revolucionario anima la legitimación institucional que termina haciéndolo
desaparecer es quizás el círculo, la órbita, que describe toda revolución24. La
arbitrariedad que pone en marcha la acción es retroactivamente anulada dando lugar
a la necesidad legalmente objetivada en forma de instituciones25.
Quedémonos ahora en la apuesta de futuro ahí contenida. Es claro que la
arbitrariedad de la acción revolucionaria rompe con el orden vigente. Y es más
claro aún que ello se hace en atención a un orden por venir que hará presente un
futuro hasta entonces sólo proyectado. Un futuro no personal, un futuro
construido, en el que se toma posesión de sí. Tal es el índice de la secularización
propia de la Modernidad: «el mejor modo de medir la secularización del mundo y
la mundaneidad del hombre en una época dada es el grado en que la preocupación
por el futuro del mundo predomina en la mente del hombre sobre la
preocupación por su propio destino en un más allá»26. Es cuestión de perspectiva,
pero es también cuestión de matiz.
Quizás a nosotros nos llegue esa fórmula de la laicidad en una doble forma. En
la forma apuntada por Arendt donde la laicidad de los proyectos mundanos es
confrontada con la religiosidad de la vida personal tanto como el futuro de los
proyectos históricos es confrontado con la eternidad de la vida futura a alcanzar.
Eso explicaría, entre otras razones, el ascenso de la religión o las nuevas
espiritualidades en cualquiera de sus muchas manifestaciones. Pero todo eso
también llega hasta nosotros en la forma extrema en la que el individualismo ni
siquiera exige el rodeo por la espiritualidad o la religiosidad. Convertido en
instancia única, queda entregado a sí mismo con la misma intensidad con que
también gestiona personalmente su propio futuro. Sea lo que fuere, se presente
de una u otra forma, el olvido del futuro devenido extranjero al que apuntaba
Benjamin es proporcional a la ausencia de laicidad, la falta de proyectos y la
reintroducción siempre metamorfoseada de la religiosidad y el espiritualismo.
O. PAZ, “Revuelta, revolución, rebelión”, in ID., Corriente alterna. SigloXXI, México 1967.
J. DERRIDA, “Déclarations d’Indépendence”, in ID., Otobiographies. Galilée, Paris 1984.
26 H. ARENDT, On Revolution, cit., p. 230.
24
25
192
Manuel E. Vàzquez
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», traducido por Arendt,
apela a la «herencia que nos fue legada sin necesidad de testamento alguno
(inheritance which was left to us by no testament)»27. El sentido es ligeramente
diferente respecto de las variaciones, versiones y entonaciones que hasta aquí nos
han conducido. Todo parece bascular sobre la gratuidad de la herencia concedida
a una con la existencia cuya sobreabundancia no requiere la legitimación del
testamento. Es una herencia sin anterioridad constituyente que constituye a
quienes en ella se reconocen. Confundida con la naturaleza humana, en ella cabe
encontrar la síntesis entre «un espíritu nuevo y, a la vez, el espíritu de dar origen
a algo nuevo». Se nombra, pues, «lo que hacía posible que los hombres
corrientes, jóvenes y viejos, pudiesen soportar la carga de la vida: era la polis, el
espacio donde se manifiestan los actos libres y las palabras del hombre, la que
podía dar esplendor a la vida»28.
VIII - Pero nada es tan necesario a esa polis como el futuro. Olvidado para
Benjamin, amortizado para nosotros. La promesa del futuro ha sido absorbida por
el crédito. Para decirlo con Peter Sloterdijk:
la primacía del porvenir data de la época en que Occidente inventó este nuevo
arte de hacer promesas, a partir del Renacimiento, cuando el crédito ingresó en
las vidas de los europeos. Durante la Antigüedad y la Edad Media el crédito no
desempeñaba prácticamente ningún papel porque estaba en manos de los
usureros, condenados por la Iglesia. El crédito moderno, en cambio, abre un
porvenir. Por primera vez las promesas de reembolsos pueden ser cumplidas o
mantenidas. La crisis de civilización radica en lo siguiente: entramos en una época
en la cual la capacidad del crédito de inaugurar un porvenir sostenible está cada
vez más bloqueada porque hoy se toman créditos para reembolsar otros créditos.
En otras palabras, el “creditismo” ingresó en una crisis final. Hemos acumulado
tantas deudas que la promesa del reembolso en la cual se funda la seriedad de
nuestra construcción del mundo ya no puede sostenerse. Pregúntenle a un
estadounidense cómo imagina el pago de las deudas acumuladas por el gobierno
federal. Su respuesta seguramente será: “Nadie lo sabe” y creo que ese no saber es
el núcleo duro de nuestra crisis. Nadie en esta Tierra sabe cómo pagar la deuda
colectiva. El porvenir de nuestra civilización choca contra un muro de deudas29.
Ivi, p. 281.
Ibid.
29 P. SLOTERDIJK Y S. ZIZEK, “Comment sortir de la crise de la civilisation occidentale?”, Le
Monde, 28 de mayo, 2011.
27
28
Herencia y testamento
193
La cuestión ya no es, como en el caso de Arendt, la carencia de proyectos
comunes y mundanos y el recurso a la salvación individual. Ahora, más grave que
todo eso, hemos quebrado la confianza en la devolución del crédito sobre “la cual
se funda la seriedad de nuestra construcción del mundo”. “Vivimos a crédito”, nos
había advertido Nietzsche. Perdida la confianza, mermada nuestra capacidad de
devolución, la vida deja de ser tal y se convierte en supervivencia30. Es como si
hubiéramos comprado a crédito un futuro – un futuro que ha resultado ser de
desempleo, miseria y falta de expectativas – que, además, no podemos pagar. Tal
es la manera en que nos sido concedida la posibilidad de experimentar lo
imposible. Tal es nuestra experiencia de lo imposible cuando se presenta en la
forma del absurdo colosal, el sarcasmo monumental. Nos debatimos, azorados,
entre la fidelidad a un pasado y un proyecto en los que no nos reconocemos y para
los que carecemos de alternativas, y la ruptura, la infidelidad a algo no sabido ni
anticipable.
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», puede recibir así una
última entonación. Vendría a decir: hemos dilapidado nuestro crédito, la
confianza que merecíamos. Se esfuma así un futuro que sin embargo debemos
pagar y traumáticamente se ha hecho presente. Se comprende que la reacción sea
aferrarse a lo que hay, es decir, a lo que queda, e intentar que todo vuelva a ser
como antes y el pasado de nuevo se proyecte en un futuro que facilite su
actualización. Es posible que sea así. Es posible que a la cuestión del testamento
ausente se añada el problema de la herencia dilapidada. Sin herencia ni
testamento, todo parece sumido en la extrema nivelación donde la vida, al límite,
se confunde con la obtención de las condiciones de subsistencia. En ese caso, en el
mejor de los casos, podremos encontrar el testamento, rastrear nuestra propia
legitimidad, pero definitivamente hemos perdido la herencia.
«Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» podría leerse entonces
como: «el testamento que nos constituye no lleva aparejada ninguna herencia».
Ese testamento deviene así pura vacuidad, un simple flatus vocis del que sólo se
deriva su repetición indefinida. Si así la herencia acaba convertida en deuda
tangible y soberana, el testamento se torna discurso sonámbulo o teoría a la
búsqueda de su propio sentido. En el tránsito de uno a otro se cierra el círculo en
que queda comprendida nuestra actual circunstancia. Recordarlo quizás sea una
forma de empezar a salir de él e instalarse en otra circunstancia más afín a nuestras
más profundas aspiraciones.
30
J. DERRIDA, Apprendre à vivre enfin, Galilée-Le Monde, Paris 2005.
194
Manuel E. Vàzquez
Asbtract
The essay aims, through the continuous reference to the texts of Hannah
Arendt and Jacques Derrida, to highlight the problematic dimension of the future
intended as an inheritance without a will. In the unfolding of this analysis is in the
light, in a deep and compelling, our being called to the responsibility for the
present and that time, chiefly human, appears to be the place of expectations and
realizations.
RENATA VITI CAVALIERE
Croce e la storia del futuro
(per un’ermeneutica del progresso)
1. Preliminari
Croce redasse una vera e propria storia al futuro nelle pagine della sua
celebre Storia d’Europa del 1932. Non si trattò di previsioni a lungo
termine, in linea di principio vietate al filosofo il cui compito non voglia
essere, come non deve essere, quello di stabilizzare o di garantire un
determinato avvenire. Croce semmai indicava – come si legge nell’Epilogo
dell’opera – vie utili da seguire per la coscienza del presente sulla base
dell’interpretazione degli eventi in corso1. E tuttavia la prospettiva politica
di un’Europa nuova, enunciata nel contesto storico di quegli anni bui e
cruciali per il futuro dell’Occidente, appare ancor oggi, allo sguardo del
giovane lettore, un esercizio assai più impegnativo della pratica di ogni
corretta ermeneutica del presente. Il tema squisitamente teoretico che qui
si vuole porre riguarda il problema del tempo interno alla conoscenza
storica e la connessa idea di progresso sempre implicita nella riflessione sul
futuro, contro certe derive identitarie e i furori apocalittici che per lo più
attraversano ancora i nostri giorni.
Valgano in prima istanza alcune precisazioni terminologiche. La storia
futura non è la storia pensata al futuro. La prima è per dir così in mente dei,
affidata alla sequenza dei fatti con il sensibile contributo della fortuna, della
provvidenza anche solo laicamente intesa, del destino o del fato,
intrecciato con la virtù degli individui coinvolti o per lo più soltanto
travolti nelle circostanze. La storia pensata al futuro allude invece a ben
altro rispetto ai timori o agli auspici pur legittimi dei contemporanei, senza
peraltro incorrere nella discutibile “ideologia del presente”. Il futuro è a
tutti gli effetti un tempo della storia vissuta nel pensiero, benché a ragion
veduta neppure lo storico di professione si azzarderebbe a tracciare il
B. CROCE, Storia d’Europa nel secolo decimonono (1932), Laterza, Bari 1972; si veda
l’edizione Adelphi cura di G. Galasso, Milano 1991.
1
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 195-213
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064313
195
Renata Viti Cavaliere
196
profilo di tempi a venire. E tuttavia non potrebbe vietarsi di nutrire in cuor
suo speranze miste ad antiche paure non sempre suffragate dai fatti. Come
si ricorderà, l’entusiasmo (ma ciò vale anche per un sentimento avverso) al
cospetto di grandi eventi storici, rappresenta, nelle riflessioni kantiane
sulla rivoluzione francese, non tanto il sentire immediato di chi osserva a
distanza quanto l’espressione di un impegno morale a garanzia del futuro di
quel movimento straordinario di popolo che ebbe così ampia risonanza e
incidenza nelle vicende più prossime. E difatti il progresso – per insistere
sulla puntualizzazione terminologica – contiene nel prefisso “pro”
l’indicazione di un cammino “a favore” piuttosto che un andamento sempre
migliorativo nella successione dei tempi. Si deve perciò ancora insistere
sulle energie etico-politiche di coloro che saranno capaci di essere
veramente contemporanei, e cioè spettatori non inerti, capaci di cogliere
nel loro mondo “semplicemente” il preludio di un tempo non ancora
accaduto.
La distinzione di cui intendo servirmi va costruita in un certo senso a
tavolino, vale cioè in teoria, dal momento che non è possibile rinvenirla
nell’uso corrente (almeno nella nostra lingua) di parole come “futuro” e
“avvenire”. Si può scegliere, come ha proposto recentemente un valente
antropologo francese, di adottare il termine “futuro” per denominare il
tempo individuale della vita, quello realissimo, concreto, riempito di
desideri, affetti, aspettative, timori da ciascuno singolarmente percepiti.
Dell’“avvenire” si parlerà, invece, secondo una consolidata tradizione
politico-culturale, a proposito della collettività o del movimento
complessivo della storia. Si ritiene infatti che l’avvenire riservi in segreto
mète radiose oppure catastrofi imminenti, ma ciò accade per la verità solo
nelle assai vaghe previsioni di ipotesi ideologicamente fondate2. Si chiede
qui invece di tener distinto il tempo storico (della vita, della poesia, della
capacità d’inizio) dai cosiddetti tempi della storia, epoche o periodi a larghi
tratti descrivibili, quasi mai esenti dall’aggio che su di essi fanno le “grandi
narrazioni” (utopiche, ideologiche) che finiscono per inibire l’avvento pur
fortemente voluto di cambiamenti radicali3. Non stupisce inoltre che ancor
oggi sia in uso la compilazione di trattatelli rivolti a descrivere in astratto
2 M. AUGÉ, Futuro, Bollati Boringhieri, Milano 2012. Nella lingua francese l’avenir
richiama l’événement, l’evento storico.
3 Un personaggio del romanzo La condizione umana di André Malraux si chiedeva poco
prima di morire: «perché dover lottare e sacrificare la propria vita se la vittoria è garantita
in ogni caso dal movimento dialettico della storia?», vedi M. AUGÉ, Futuro, cit., p. 26.
197
Croce e la storia del futuro
gli elementi fondamentali e strutturanti delle società umane nel corso dei
tempi. Alla maniera delle antiche cosmogonie, essi stanno a garantire
l’avvenire, nella presunzione assai fondata che si rinnnovi l’identico:
all’ordine della pace seguirà il conflitto, all’ordine militare quello
mercantile, e poi di nuovo guerre e periodi di ricostruzione, mentre
rassicuranti miti magici o religiosi generosamente concedono, ma in via del
tutto eccezionale, pause significative per rigogliose riprese d’azione. È
innegabile che sbaglierà raramente la previsione dell’avvenire chi si diletta
a intrecciare nel loro succedersi le strutture invarianti della storia. Né
meraviglia che possano non di rado venir fuori, specie in età di crisi o di
grandi rivolgimenti, i teorici della salvezza con parole che risuonano però
stancamente pur nel doveroso appello alla civiltà, alla solidarietà,
all’educazione, nel dichiarato e spesso solo annunciato richiamo a un nuovo
umanesimo4.
Sta di fatto che il nuovo non emerge per reazione meccanica in
conseguenza di buoni discorsi o di prediche edificanti. Al tempo della vita
si connette non per caso quel tempo, considerato inaugurale per
definizione, che è il tempo della poesia. Mentre dunque l’avvenire resta
campo privilegiato delle filosofie della storia e delle religioni con i loro
miti dell’origine dei tempi in vista del tempo ultimo, il futuro, invece,
appartiene gelosamente all’umana capacità d’inizio che smentisce
positivamente, volta per volta, l’indifferenza per lo più dominante
all’interno di collaudate forme impersonali di vita in comune. L’esistenza
umana ha senza alcun dubbio bisogno di creazione, di cominciamenti, di
inauguralità. Nelle arti, che rappresentano l’esempio più alto di quella vera
e propria anticipazione del futuro in cui consiste la bellezza, accade che il
non ancora si presenti come possibilità aperta, che il nascosto si mostri pur
restando segreto, e che si realizzi puntualmente la trasfigurazione del reale
nella prospettiva di nuove metamorfosi. Si vuol dire che nella lettere e
4 Mi riferisco al volumetto di J. ATTALI, Breve storia del futuro, Fazi, Roma 2007 e al
recente libro di E. MORIN, La via. Per l’avvenire dell’umanità, Raffaello Cortina, Roma 2012.
Nel primo torna attuale l’analisi delle strutture della società umana nella sua storia; nel
secondo il sociologo si preoccupa di formulare una serie di buoni propositi perché si possa
immaginare un futuro migliore per la collettività. Quel che manca in queste indagini è il
riferimento esplicito alla capacità d’inizio che appartiene soltanto agli individui. Può essere
interessante, invece, la questione posta da P. SLOTERDIJK nel suo Devi cambiare la tua vita
(Raffaello Cortina, Roma 2010) a favore di una immunologia universale, la quale,
intersecando antropotecnica e filosofia della storia, induce a prendere misure di salvezza
per l’esistenza futura di ognuno di noi.
Renata Viti Cavaliere
198
nelle arti in generale prende valore il futuro perché nell’opera concreta
ciascun artista infutura la propria finitezza, esponendosi all’evento
dell’universale che così può riprendere nuova vita nel tratto di strada che
allontana ogni volta la civiltà dall’incombente barbarie. Torna utile, a
quanto pare, il pur rapido ricorso ad alcune note di estetica per rievocare il
senso autentico della temporalità vissuta, così ben radicato nel tempo della
poesia che è il tempo esemplare della vita nell’esperienza del bello
ontologicamente coniugato al futuro5. Nella storia dell’arte si osserva
infatti l’assenza di un progresso lineare e indefinito; e ciò è vero, perché il
progresso spiana il cammino verso l’ignoto, mentre per lo più nelle
moderne filosofie della storia si è preteso saldare il futuro al passato nella
convinzione di poterlo in ogni modo determinare. In conclusione, il futuro
escatologico, tipico delle grandi visioni della storia universale, benché sia
gravido di senso, di attesa, di speranze, di timori, manca della cosa più
importante, e cioè della fiducia necessaria nella possibilità di altri inizi che
è il principale movente di quel tempo della vita con il quale si costruisce
l’avvenire.
Sulla base delle brevi premesse ora elencate, che non intendono
riprodurre all’infinito il vecchio schema mentale del contraso tra idealismo
e realismo, suggerisco di rivedere nelle sue articolazioni teoretiche il
problema della conoscenza storica con l’attenzione rivolta al futuro. Tra
passato e futuro non insiste, come comunemente si crede, l’istante
inafferrabile del presente, in cui nostalgia e speranza tengono legati assieme
sentimento e volontà. Presente è il nunc stans in cui consiste piuttosto una
straordinaria potenza d’inizio (energheia che non è solo ergon, diceva
Croce6) che è principio di liberà in quanto libertà di cominciamento, il
tempo giusto (kairòs) in cui si interrompe il continuum temporale: qui ed
ora, infatti, comincia ogni volta il tempo della vita che interseca il tempo
della storia sino a consentire lunghi periodi di cristallizzazione dei
significati. Il fatto storico, già ovviamente raccolto nei documenti
d’archivio, non è semplicemente il risultato di un laborioso assemblaggio.
Il fatto storico è il farsi della memoria, l’interpretazione che riempie di
senso determinati contenuti, la letteralità vivificata dallo spirito di ricerca.
Il futuro è perciò oggetto di una nostra costruzione in quanto storia che si
fa, ma sempre nella convinzione che esso nasca nella frattura tra il già
5 Mi sono ispirata alle profonde analisi di R. ASSUNTO nel volume Filosofia del giardino e
filosofia nel giardino. Saggi di teoria e storia dell’estetica, Bulzoni, Roma 1981.
6 B. CROCE, Storia d’Europa, cit., p. 232.
199
Croce e la storia del futuro
compiuto e l’avvenire, in quanto emerge, senza alcun bisogno di roboanti
annunci, dal vuoto di schemi imperativi e sempre là dove esistano
condizioni favorevoli al nuovo che chiamiamo evento7. Ma su queste
suggestioni si tornerà in conclusione del discorso.
2. A partire da una noterella filologica
In aggiunta alle Considerazioni finali poste in chiusura della Storia come
pensiero e come azione (1938) Croce redasse una breve noterella filologica
ispirata a singolare prudenza nell’adozione del lessico sul tema della
conoscenza storica. L’uso promiscuo – diceva – in italiano e nelle altre
lingue della parola “storia” sia nel senso di “pensiero storico” sia nel senso
di “fatti” o “azioni” compiute, ha dato lugo a frequenti bisticci se non
addiruttura a sofismi dottrinali8. Il che si può evitare col distinguere
“storiografia” da “storia”, com’egli per lo più aveva fatto nel corso
dell’intera opera. E tuttavia sarebbe stato possibile stabilire quella
differenza adoperando nell’un caso il termine “istoria” (premettendo una
“i” per la verità soltanto fonica) e nell’altro, vale a dire per il riferimento al
fatto narrato, la parola “storia”. Croce dichiara infine di non aver avuto il
coraggio di assumersi la responsabilità di quella innovazione linguistica che
lasciava semmai ad altri patrocinatori, forse in un diverso contesto
disciplinare. Ci si chiede, allora, perché rievocare l’antica disputa, svoltasi
circa ottant’anni prima, sulla possibile (ma molto criticata) introduzione
del termine “istoria”, se poi bastò attenersi prudentemente alla distinzione
di storia e storiografia, che riprende la tradizionale distinzione di res gestae e
historia rerum gestarum. La questione dell’uso linguistico sembrò dunque
secondaria, o di scarso rilievo, rispetto al problema teorico già
diffusamente affrontato nelle dense pagine del volume del ’38. Segno,
tuttavia, della difficoltà di rendere senza equivoci terminologici
l’importante tema della conoscenza del fatto storico, narrato e compreso
7 Rinvio al mio saggio dal titolo “Natus sum. Il concetto di “nascita” in filosofia”, nel
volume Nascita e ri-nascita in filosofia, a cura di R. Viti Cavaliere e V. Sorge, La Scuola di
Pitagora, Napoli 2011.
8 Cfr. B. CROCE, La storia come pensiero e come azione (1938), Laterza, Bari 1966
(edizione critica a cura di M. Conforti, nota di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 2002), pp.
315-316. Per la discussione accesasi in Toscana alcuni decenni prima Croce rinviava alla
«Critica», XXXI (1939), p. 480.
Renata Viti Cavaliere
200
secondo la sua genesi. L’istoria o storiografia, che è narrazione pensata del
fatto, andava comunque distinta, nell’unità delle attività spirituali, dalla
storia che si rinnova in virtù dell’agire individuale, che va a costituire altri
intrecci per future narrazioni intelligenti delle situazioni storiche in
sviluppo.
Nell’Avvertenza alla prima edizione dell’opera qui esaminata Croce
rinviava alle precedenti analisi svolte in Teoria e storia della storiografia
(risalenti agli anni 1912-13) per sottolineare che altre considerazioni si
erano via via aggiunte anche in occasione di nuove esperienze di vita. Si
riferiva ovviamente all’esperienza storica dell’Italia e dell’Europa di quegli
anni in cui sostanziali cambiamenti politici avevano fortemente inciso nella
vita dei contemporanei. Insistere allora, com’egli volle fare, sulla
particolare connessione di storiografia e azione pratica, sarebbe servito sia
sul piano etico-politico sia sul piano logico-teoretico nel tentativo di
dipanare il complicato processo del pensiero storico. Problema difficile, ne
fu consapevole, al punto di aver provato per dir così un senso di vertigine,
quasi che si fosse affacciato sul misterioso “regno delle Madri”9. Croce si
servì di una splendida immagine faustiana per descrivere il compito della
storiogafia nella sua genesi, se è vero ch’essa nasce dal profondo di un
abisso, per un autentico bisogno di parlare ai contemporanei
indipendentemente dalle sterili lotte di scuola tra dottrine o sistemi di
pensiero. Dichiarava di non volere pertanto attaccare i nemici dello
storicismo, ma di fatto ne tracciava il profilo stigmatizzando l’assoluto
moralismo di chi colloca la vita etica fuori della storia allo scopo di poterne
agevolare «la riverenza da lontano e l’inosservanza da vicino». Croce non
dissimulava, pur con l’abile strategia retorica di chi nega per affermare, il
suo fiero proposito di smascherare il nemico: vale a dire quei “moralisti”
che in nome del passato soltanto, o del futuro astrattamente vagheggiato,
idoleggiano il tempo stabile della conservazione senza progresso o
dell’innovazione senza costrutto10. Sono loro, i moralisti in senso assoluto,
incapaci di collegare il conoscere al fare, inadeguati a pensare per concetti
nella spinta verso altri cambiamenti.
La teoria della storiografia di Croce è incardinata nella logica del
giudizio storico; nella logica della distinzione tra metodo classificatorio e
metodo dialettico-speculativo, nella convinzione che non esistano due
B. CROCE, “Avvertenza”, in Ivi, pp. 5-6.
Il celebre discorso oxoniense del 1930, “Antistoricismo”, si trova in B. CROCE,
Ultimi saggi, Laterza, Bari 1935, pp. 251-264.
9
10
201
Croce e la storia del futuro
metodi del conoscere ma uno solo, che non è quello naturalistico,
schematizzante e classificatorio, ma è quello che distingue affermando e
negando nell’atto teoretico del giudicare. La storiografia è momento
conoscitivo, un “fare teoretico”, contemplazione che però nasce dalle
passioni e dagli interessi legati alla vita pratica. Nelle conclusioni della
Storia come pensiero e come azione Croce si è espresso limpidamente con
parole che vanno riportare per intero:
…nella dottrina odierna non solo non si dà risalto all’importanza capitale,
ma quasi non si ha sentore, del principio che la verità della storiografia non
si fonda, secondo che ingenuamente credono i filologi, sul criterio del
probabile o delle testimonianze credibili, ma sull’altro, affatto diverso, del
suo generarsi dall’intimo dell’uomo, dell’uomo che è formazione storica,
e come tale è quella storia stessa che per opera della mente indagante sale a
storiografia11.
In precedenza, all’interno della stessa opera, Croce aveva con
altrettanta chiarezza escluso che si potesse tener separato il giudizio del
fatto dalla conoscenza della sua genesi:
Conoscere (giudicare) un fatto vale pensarlo nell’esser suo, e perciò nel
suo nascere e svolgersi tra condizioni che a lor volta variano e si svolgono,
non essendo altrove l’esser suo che nel suo corso e svolgimento di vita: e
invano si tenterebbe di pensarlo fuori di questa vita, perché, a capo dello
spasimo dell’impossibile sforzo, del fatto stesso non resterebbe neppure
l’ombra12.
Si negava, ricorrendo al contrasto tra possibile e impossibile, la
separazione del giudizio dal fatto, quasi che si potesse esercitare, senza
tema di arbitrio, una soggettività priva di riferimenti oggettivi, oppure una
storia (meramente oggettiva) senza storicità, priva cioè dell’intelligenza
della cosa stessa. Nelle considerazioni finali Croce traeva dall’insieme delle
annotazioni sparse nei vari saggi che compongono il volume del ’38 una
decisiva conclusione, sulla base anche dell’esperienza di storico già da
tempo acquisita:
11
12
B. CROCE, La storia come pensiero e come azione, cit., p. 299.
Ivi, p. 138.
Renata Viti Cavaliere
202
L’orrore lasciato dalla Filosofia della storia e dal suo astratto a priori ha
portato non solo gli storici ma i filosofi a stringersi paurosamente alle
testimonianze e ai documenti intesi come estrinseche testimonianze, e a
non avvedersi della realtà del processo storiografico che, se non è astratta
deduzione a priori, è certamente un’eduzione dal profondo, uno sbrogliare
e chiarificare e qualificare il nostro ricordo di quel che facemmo nell’atto
che lo facemmo, di quel che fece l’umanità che è in noi e di cui noi siamo
costituiti, nell’atto che lo fece; il che, quando non ha luogo, neppure la
storiografia ha luogo13.
Non sfugge il tono inedito di questa definizione della storiografia che
comunque torna a negare il valore di vecchie e nuove filosofie della storia,
mantenendo parimenti a distanza ogni altro tentativo di attestarsi sul piano
esclusivo della mera documentalità in ossequio al principio di antiquati
oggettivismi o realismi14. L’“eduzione dal profondo” è espressione
inconsueta nella scrittura crociana. Rievoca il passaggio dalla potenza
all’atto tipica della più classica delle filosofie come quella tomistica.
Rinnova, almeno in prima facie, un certo intimismo tipico della mentalità
moderna. Ripropone, indubbiamente, il vichiano convergere del vero col
fatto in cui consiste il conoscere storico che non è, e non può essere, un
“relata referre”, come se la storia fosse semplicemente una “fable
convenue” senza alcun fondamento di verità. Ora è ben chiaro che
l’essenza della storiografia non sta fuori dello svolgimento dei fatti,
neppure è tutt’uno con la necessità di procedere in una sola direzione: la
verità del fatto sta nell’atto di ricordare che a sua volta nasce dal
“profondo” a cui attinge il pensiero storico, che è sempre individuale, in
vista della chiarificazione di un problema o interesse pratico che prelude
all’azione. La conoscenza storica racconta paradossalmente un tempo a
venire nella prospettiva del già accaduto secondo la piena consistenza del
legame tra passato e futuro. Come la felicità è nell’attimo, così la verità
storica vive nella conoscenza del singolo, dove il tutto è presente,
diversamente dalla presunta ricomprensione del singolo nel tutto15. Ci si
riferisce all’autentico tempo della storia che è perciò interno al pensiero,
in quanto la storiografia è la storia dell’anima nostra, diceva Croce, che è
Ivi, p. 299.
Fu CARLO ANTONI nel suo Commento a Croce (Neri Pozza, Venezia, 1955) a parlare
della logica di Croce come di “un nuovo realismo”: si riferiva alla realtà vivente delle forme
spirituali che sono generatrici di nuove individualità, ossia di storia.
15 Cfr. B. CROCE, La storia come pensiero e come azione, cit., p. 248.
13
14
203
Croce e la storia del futuro
poi la storia stessa del mondo. L’atto dunque che temporalizza gli affetti e
la ragione, stabilendo il valore di ogni cosa nel futuro, è il giudizio storico
che legge caso per caso il possibile nel reale. Dal significato postumo
rispetto agli eventi prende forza il giudizio pre-vidente, che non cede al
dominio extratemporale del concetto. Accade così che un dramma morale
ed esistenziale venga ad animare il pensiero storico, dando vita all’eterna
genesi dell’attività giudicativa, vera e propria “eduzione del profondo” che
peraltro è possibile riscontrare nel criterio partecipativo-selettivo che
caratterizzò i saggi storiografici dello stesso Croce.
3. La “Storia d’Europa”, esempio di una storia del futuro
Contravvenendo alla lettera del dettato crociano penso che si possa
definire la Storia d’Europa una vera e propria storia del futuro. S’intende
che bisogna escludere quella “storia del futuro” che i vecchi trattatisti
definivano profezia e che offusca, piuttosto che schiarire, la luce di verità
necessaria per l’azione individuale. Il libro del ’32, dedicato a Thomas
Mann, ammirato dagli amici e sodali tedeschi, scritto nell’Italia fascista,
mentre in Germania si preparava l’ascesa al potere di Hitler, aveva preso le
mosse dal pathos profondamente vissuto dall’autore che lo indicò nella
“trepidazione per la vita della libertà” e per gli ideali liberali che in maniera
esangue sopravvivevano nell’intera Europa. Croce non volle ispirarsi alla
pura nostalgia per il secolo precedente al suo, ma certo tenne fermo il
legame “sentimentale” con quegli ideali di libertà da lui condivisi, che
molto lo sostennero nell’intelligenza del suo recente passato. La parte
narrativa del testo crociano, notevolmente ricca di dati e di annotazioni
storiografiche, è come racchiusa all’interno di riflessioni che ne
rappresentano corteccia e nocciolo, costituendo tipograficamente la
premessa e l’epilogo del libro. L’Europa, dai movimenti del ’30,
attraverso i progressi del moto liberale, fino al cambiamento dello spirito
pubblico soprattutto in Germania, e all’affievolirsi degli ideali liberali alla
vigilia della guerra mondiale (1914), viene concepita come un corpo solo,
unito nelle differenze locali e nazionali, emblema della federazione di stati
auspicata e immaginata contro ogni legittima previsione basata sulla vigente
realtà di quei tempi. Benché il confronto tra la geografia politica
dell’Europa prima e dopo la guerra mondiale del ’15-18 mostrasse
piuttosto l’aprirsi di una voragine tra mondi contrapposti, il filosofo si
Renata Viti Cavaliere
204
impegnò a stabilire la continuità tra le due Europe pur senza nascondersi le
gravi conseguenze della tragedia bellica che lasciava dietro di sé condizioni
spirituali degradate se non mai del tutto vinte dalla nuova barbarie. Cosa
restava degli antichi ideali liberali? Per la verità assai poco negli animi dei
contemporanei. E Croce elencava gli umori del presente attaversato da
moti di libertarismo attivistico o da rinnovati impeti irrazionalistici e
misticistici, mentre da più parti tornavano di moda le tesi sulla fine
dell’Occidente per l’imbestialirsi della natura umana nella previsione
coerente dei profeti di sventura. Tutto questo, diceva Croce, sarà oggetto
dello storico futuro quando matureranno i tempi e saranno portate ad
effetto le istanze in essi contenute. L’avvenire pensato da Croce tanto poco
fu foriero di effettualità storica, che proprio nulla dei suoi auspici
europeistici sarebbe comparso di lì a poco all’orizzonte della realtà dei
fatti. Neppure le grandi menti del tempo, pensatori e scienziati, previdero
ai primi anni trenta del ventesimo secolo il dispiegamento di un certo
futuro. Si dirà che nell’ottica crociana l’ideale della libertà aveva per sè in
serbo assai più dell’avvenire perché destinato a guadagnarsi l’eterno16. Ma
sarebbe un fraintendimento del pensiero di Croce voler scindere l’assoluto
dal relativo, il tempo umano dalla fissità di lumi perenni. La libertà è un
primum incondizionato che non ha nulla a che vedere con la trascendenza
oltremondana; essa è il motore interno al formarsi storico delle istituzioni
e dei processi politici. Sempre incarnata, la libertà ha operato come forza
viva e sorgiva nell’animo degli intelletti migliori che nel secolo
diciannovesimo costruirono i pilastri del movimento liberale. Nel Soliloquio
di un vecchio filosofo Croce così formulava il suo pensiero:
Così la libertà è andata e andrà ancora incontro a tempi di avversione, di
disconoscimento, di persecuzione; nondimeno essa vive in chi l’ama, vive
e opera nel raggio d’azione nel quale le è dato muoversi e che essa tende
ad ampliare, e di quanto accade fuori o contro di lei si rende chiaro noto,
perché accaduto” che sia, e da lei pensato e giudicato, è “caduto” tra i
presupposti della sua azione17.
Collocata tra i presupposti dell’agire politico la libertà è visibile anche
nell’eclissi che nasconde la luce di verità che in lei si esprime. Ma a quale
Celebre questo passaggio della Storia d’Europa, cit., p. 313 (Epilogo).
B. CROCE, “Soliloquio di un vecchio filosofo” (1942), in ID., Discorsi di varia filosofia
(1945), Laterza, Bari 1959, vol. II, p. 298.
16
17
205
Croce e la storia del futuro
verità si allude e come essa si mostra? L’ideale della libertà, colto ora nella
grande filosofia dell’Ottocento, romantica e idealistica, è lo stesso che fu
messo alla prova dalla filosofia sin dall’inizio della sua storia, come radice
ultima di un sentimento di provenienza comune che approdò sulle rive
della cultura greca, latina, araba, moderna. Croce pensava all’Europa come
ad una lingua originaria, parlata a lungo nelle filosofie di ogni tempo,
coltivata nella riflessione di chi impegna il presente nella prefigurazione di
altri mondi possibili. La verità della filosofia è infatti krinein, capacità di
distinzione e sforzo di discernimento, il rifiuto a seguire comandi o a
stabilire regole da imporre sulla vita o sulle menti in nome della più
rassicurante necessità. La filosofia tradizionalmente getta luce di verità sul
futuro:
Per intanto, già in ogni parte d’Europa si assiste al germinare di una nuova
coscienza, di una nuova nazionalità (perché […] le nazioni non sono dati
naturali, ma stati di coscienza e formazioni storiche); e a quel modo che,
or sono settant’anni, un napoletano dell’antico Regno o un piemontese del
regno subalpino si fecero italiani non rinnegando l’esser loro anteriore ma
innalzandolo e risolendolo in quel nuovo essere, così e francesi e tedeschi e
italiani e tutti gli altri s’innalzeranno a europei e i loro pensieri
indirizzeranno all’Europa e i loro cuori batteranno per lei come prima per
le patrie più piccole, non dimenticate già, ma meglio amate18.
Scritte nei primi anni Trenta, queste parole paiono intonate più al
sogno che alla profezia. Sono parole teoreticamente rilevanti benché
storicamente ineffettuali. Il processo di unione europea, in cui si confida,
contrastava palesemente con i nazionalismi in atto, mentre l’ideale
europeistico non parve allora, né sembra oggi, il progetto di un visionario.
Mai filosofo fu più realista e concreto nella previsione dell’impegno
politico che avrebbero assunto le future generazioni. I fatti di lì a poco
deflagrarono, sulla china di un vero baratro, pur conservando nel profondo
l’incentivo a superarli in virtù della eredità mantenuta. È perciò fuori
tema, sbilanciato e sbilenco rispetto all’opera crociana, il proposito di
mera restaurazione nel nuovo secolo degli ideali liberali dell’Ottocento,
frutto di esperienze diverse nate in altri contesti storici. Nuovi temi,
sociali, scientifici, pratici, avrebbero caratterizzato in seguito il confronto
delle idee, impedendo al filosofo di scandire i tempi come provvisori
18
B. CROCE, Storia d’Europa, cit., pp. 314-315.
Renata Viti Cavaliere
206
momenti di passaggio o dolorose parentesi culturali e politiche. Restavano
tuttavia a salvaguardia del sapere storico, che è narrazione intelligente degli
eventi, alcuni concetti di durata illimitata che avrebbero a lungo conferito
possibilità al senso delle cose passate. Valga ad esempio il concetto di
nazione che è “nascita” di nuove formazioni storiche e non già il dato
naturalistico di sangue e di suolo che contraddistingue le politiche
identitarie i nazionalismi di ogni epoca. Allo stesso modo diviene in qualità
di flusso dei significati l’universale della comunità umana composta di
esseri razionali che sono anch’essi dentro forme transeunti della realtà in
movimento. Ciò vale anche per il concetto di verità che cresce tra soggetti
pensanti, senzienti, agenti, rigettando la regola imposta per decreto divino.
Sbagliò chi credette di leggere nella Storia d’Europa il profilo astratto o
addirittura sovratemporale del mondo ottocentesco; si illuse chi intravide
nelle parole crociane l’ottimismo tipico di un certo storicismo metafisico.
L’Europa filosofica di cui parlava Croce era nata per meticciato da molte
culture e da notevoli differenze religiose e politiche. Era perciò divenuta il
simbolo dell’unita-distinzione che è il segno più proprio della filosofia
dello spirito vivente. Neppure sarebbe corretto collocare la filosofia di
Croce soltanto sotto la voce “storicismo”, senza il chiarimento necessario
del nesso temporale di storia e verità. Ritornano nelle pagine della Storia
d’Europa le stesse veementi invettive contro i nemici del pensiero storico
pronunciate nel discorso oxoniense di qualche anno addietro. Il sentimento
antistorico che allora circolava diffusamente in occidente era nato non per
caso dal venir meno del concetto stesso di storicità che per principio
esclude dogmi o principi assoluti. I nemici del pensiero storico sono essi i
veri miscredenti, irreligiosi e atei, rispetto al compito dell’Europa che
rappresenta in spirito la religione della libertà da Croce invocata nel
celebre primo capitolo del libro del ’32. Passatisti e progressisti sono
coloro che inneggiano a un passato mummificato per un verso, o, per
l’altro verso, si avviano con l’impeto di una totale impreparazione incontro
al nuovo più di moda. L’attacco era pur rivolto ai “futuristi” che nella
letteratura e nelle arti si qualificavano allegri distruttori, non solo
metaforicamente, di monumenti e archivi in nome della corsa all’inedito e
all’imprevisto. Sennonché, pur ventilando una storia futura, essi finivano
per rifiutare l’idea che la storicità fosse il regno del contingente mostrando
la tendenza a trarsi fuori del movimento, pur così decantato, stabilendo
regole che negano la concorrenza e la lotta. Una propensione al potere per
il potere unito alla ripresa di modelli e canoni accademici indusse molti dei
207
Croce e la storia del futuro
cosiddetti futuristi a chiudersi in pratica la via per la formazione del nuovo
e del diverso. Parimenti gli storicisti chiusi nelle catene del loro passato
riverivano la tradizione morta che non dà più spazio al futuro. Il pensiero
anti-storico, allora dilagante, parve a Croce il segno di un impoverimento
mentale, di debolezza morale, rinuncia all’abito dello spirito critico,
energia senza sostanza o, al contrario, principio di autorità senza capacità
d’inizio. Esso fu soprattutto un significativo allarme del regresso spirituale
dell’Europa tutta, che negava il più proprio della sua millenaria identità.
Scriveva Croce con estrema chiarezza:
È evidente che il sentimento storico coincide col sentimento europeo in
quanto nell’Europa si concentra la più ricca e nobile storia umana,
l’Europa ha prodotto l’ideale libertà e ha tolto su di sé la missione della
civiltà del mondo tutto, e non v’ha in Europa storia di singoli popoli e stati
che possa intendersi separatamente, fuori della vita generale
dell’organismo di cui sono membra […]. Sradicarsi dall’Europa dopo
essersi sradicati dalla storia è, di certo, proposito affatto coerente; ma di
quella coerenza che si ammira nei pazzi che a lor modo ragionano 19.
Per i filosofi dunque storicità vuol dire civiltà e cultura, e il sentimento
storico è il sentimento della libertà che è fonte di ogni progresso. Questa è
la sola e più alta religione che ci resti.
Nel corso del secolo decimonono era tornata viva, forse con più
frequenza che non prima, la memoria di sofferte battaglie per la liberazione
da vincoli e domini. Questo bisogno comparve ogni volta forte e
prepotente nella speranza di affrancarsi dallo straniero, nella decisione di
allargare il suffragio elettorale, nei nascenti costuzionalismi contro
l’assolutismo monarchico, nell’apertura a strati sociali prima trascurati,
nelle lettere e nella poesia come nelle scienze più moderne e innovative.
Non era stato forse lo spirito libero quella luce di verità che aveva spianato
l’avvenire e guidato alla costruzione del futuro? In termini filosofici ciò
aveva rappresentato la fine dei dualismi di cielo e terra, di cultura e natura,
di spirito e materia, mentre si affermava la convinzione che la storia non è
alla mercé di forze cieche o estranee allo spirito umano. Convinzione che
non avrebbe tradotto in idillio la tragedia della storia, che certo non
appronta nella sua immanenza vittorie definitive sul male e sull’ignoranza.
Croce raccoglieva così nell’ideale liberale che è ideale morale, e che aveva
19
Cfr. B. CROCE, “Antistoricismo”, cit., p. 260.
Renata Viti Cavaliere
208
trovato incremento nel secolo precedente, la possibilità di sostenere nel
pensiero il metodo consono all’esercizio della critica e della distinzione. La
storia del futuro prese infine forma non già di utopia vagheggiata in
difformità al mondo presente, ma di criterio efficace, propositivo, del
giudizo storico individuale, che alimenta con forza propulsiva la nuova
azione, indirizzandola a un bene più alto. Croce, per dir meglio, piantò nel
corpo spiritualizzato della storia umana il perno della sua sopravvivenza
che è tutt’uno con la civiltà, la cui fine, non auspicata né mai possibile,
costituirebbe il segno della conclusione dei tempi20. “Il secol che si
rinnova” con l’avvento della terza età dello Spirito, propugnata nel
dodicesimo secolo da Gioacchino da Fiore, compare per incidens nella
conclusione del capitolo sulla “religione della libertà”21. Ma è ben fondato il
sospetto che Croce volesse ironizzare per contrasto sul novus dux che taluni
cattolici vollero veder incarnato nel capo del fascismo italiano. All’idea
escatologica della fine del tempo Croce allora opponeva l’idea di un
cammino infinito, di un futuro che all’infinito chiede ai contemporanei di
essere messo in moto in virtù dell’idea di libertà che per definizione lascia
aperta la possibilità di numerosi cambiamenti. Il metodo liberale, che è
metodo di conoscenza, di comportamento politico e di relazioni
interpersonali, viene solitamente attribuito alla figura del “profeta
disarmato”, a sottolinearne il carattere mite, la disposizione all’ascolto, la
possibilità di imparare dagli avversari. E tuttavia in suo nome si sono
combattute le più aspre battaglie con lietezza e sacrificio. Quando
cominciò ad affievolirsi in Europa la fonte che ne aveva alimentato la
pratica, a partire dagli anni ’70 dell’Ottocento, in virtù di idee miranti a
screditare la natura umana (naturalismo, razzismo, un certo darwinismo,
determinismi storici e così via), assolutismi e dispotismi fecero il loro
ingresso nella cultura deprivata via via del sostegno dello spirito vivente.
Furono questi segnali di arresto o regresso, diceva Croce, che, se
indicarono il venir meno di un ergon, non potettero esaurire il potenziale di
quella energheia che è inscritta nella condizione umana22.
All’indomani della seconda guerra mondiale Croce volle esprimersi intorno alle
previsioni apocalittiche e all’inquietante prospettiva di una fine della civiltà europea. Può
accadere che un mondo finisca, diceva, ma non finirà la civiltà se sopravvive l’eterna forza
dello spirito immortale. Pensava al principio di vita che è attività, inauguralità, inizio. Cfr.
B. CROCE, La fine della civiltà, in ID., Filosofia e storiografia (1948), a cura di S. Maschietti,
Bibliopolis, Napoli 2005, pp. 283-291.
21 Cfr. B. CROCE, Storia d’Europa, cit., p. 21.
22 Ivi, p. 232.
20
209
Croce e la storia del futuro
A Thomas Mann Croce dedicò la Storia d’Europa e dovette sentire di lì a
poco affini al suo sentire i moniti del grande scrittore contro il fanatismo,
l’intolleranza, l’illibertà dei tempi23. Una nuova umanità si auspicava da più
parti che nascesse in quegli anni bui attraversati da impeti antiumanistici.
Croce per la verità non credeva nell’esistenza di un’umanità migliore, ma
ebbe chiara l’idea che alla radice della cultura europea dovesse essere
rinvenuto il principio dell’umanesimo che ha avuto una sua grande stagione
storica e che possiede per dir così un’anima immortale: la ragione
cosciente di sé (Hegel), la ragione (di ascendenza socratica) che discerne e
comprende senza astrattismi di maniera, la cultura che è confronto tra
diversi. Storia e verità si intrecciano allo stesso modo in cui le
appartenenze locali si intersecano tra loro e rifluiscono nella patria
universale dello spirito umano. Queste considerazioni ebbero voce assai
significativa negli ultimi scritti di Edmund Husserl, dove si descrive la
visione di una lotta senza quartiere tra lo spirito filosofico e la barbarie, tra
molte perdite reali e grandi vittorie ancora possibili:
Il maggior pericolo dell’Europa è la stanchezza. Combattiamo contro
questo pericolo estremo, da “buoni europei” con quella fortezza d’animo
che non teme nemmeno una lotta destinata a durare in eterno. Allora
dall’incendio che distruggerà la miscredenza […] dalla cenere della grande
stanchezza, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di vita e di una
nuova spiritualità, il primo annuncio di un grande e remoto futuro
dell’umanità: perché soltanto lo spirito è immortale24.
Si ha l’impressione che Croce e Husserl, in particolar modo negli anni
trenta del secolo scorso, abbiano scritto su questi temi muovendo già da un
remoto futuro, a cui non intesero però in alcun modo sovrapporre il piano
metastorico di immagini utopiche o apocalittiche.
4. Ermeneutica dell’idea di progresso
Il tema del progresso, tipico delle conversazioni che Croce definiva
“discorsi del tempo” intorno all’avvenire del mondo, acquista significato
TH. MANN, Scritti storici e politici, Mondadori, Milano 1957.
E. HUSSERL, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia” in ID., Crisi e rinascita della
cultura europea, a cura di R. Cristin, Marsilio, Venezia 1999, p. 92.
23
24
Renata Viti Cavaliere
210
nuovo e nuova energia sempre che, sottratto alle aspettative della
collettività, torna ad avere dimora nell’animo di chi procede a favore di un
ideale liberale di vita e di azione. In quest’ottica anche l’idea d’Europa,
così intrinsecamentre legata all’idea di libertà e alla storia nel suo libero
sviluppo, è stata e può essere ancora norma di comportamento politico ed
etico. Altra cosa sarebbe teorizzare astrattamente l’incidenza delle idee, o
dell’ideale europeistico, nella modificazione della realtà. Un’idea come
quella di progresso, sulla quale oramai pochi o nessuno punterebbero
l’attenzione tanto è andata screditandosi nel corso del Novecento (né oggi
può dirsi che goda di miglior fama), riprende vigore se ripensata insieme
con il tempo della vita che ha nel futuro il suo vero punto d’inizio. Al
futuro si pensa non soltanto in vista di una rassicurante previdenza degli
ostacoli o dei vantaggi possibili (lasciamo questo compito agli enti
assicurativi): il futuro è componente essenziale del pensare tra presente e
passato. In tal modo l’idea di progresso è indizio di capacità interpretativa
del già stato e sprone per possibilità di cambiamento rispetto al non ancora
accaduto. Essa non è dunque una categoria da applicare ai fatti storici, ma è
il farsi stesso dello sviluppo delle situazioni in cui è necessario prendere
posto, e ciò riguarda quell’andare avanti in favore di qualcosa, senza voler
soltanto percorrere strade tracciate in prosecuzione dell’esistente. Il
progresso è la molla dell’agire e la consapevolezza di poter cominciare un
processo mai prima iniziato, espressione della spontaneità e della causalità
libera in cui consiste il vivere secondo ragione.
Altra accezione ha avuto il progresso a partire dall’età moderna.
Rimasto a lungo fuori dell’esercizio conoscitivo e pratico del giudizio
storico, il progresso è stato per lo più collegato a fedi o a miti religiosi che
hanno scavalcato di molto la sequenza temporale per approdare al
raggiungimento finale di uno scopo potenzialmente molto circoscritto. Si è
così legato a realtà immaginarie piuttosto stabili, anzi stabilizzate per
ordine divino, ferme come motori immobili per secolari aspirazioni al
compimento ultimo. Previsioni storiche ne derivarono immancabilmente,
previsioni di tono apocalittico, perché rivelatrici del volere di un ente
supremo. Scriveva Croce nei paralipomeni alla storia degli anni Quaranta:
L’importanza di queste credenze sta in ciò: che la fede che le animava era
veramente sostanza di cose sperate, ipostasi immaginosa di aspirazioni
dell’anima umana alla pace, alla purità, alla giustizia, alla bontà: aspirazioni
le quali, non perché si presentavano in quella forma utopica non operavano
211
Croce e la storia del futuro
nel campo dei fatti, dove si può dire che sovente guadagnassero in efficacia
quanto avevano perduto nel campo del vero25.
Benché di scarso valore filosofico le utopie storico-religiose hanno
accompagnato intimamente intere generazioni che vissero e si nutrirono di
attese millenaristiche. Analogamente le previsioni basate sulla mera
empirìa, in conseguenza del progredire delle scienze e delle tecniche,
hanno suscitato iniziative feconde incrementando il cammino dei saperi. Va
perciò distinto il progresso come stato d’animo dal progresso come
concetto filosofico. Nei pensieri intorno al progresso, all’indomani dello
scoppio della prima guerra mondiale, la sconfessione della fede in un
garantito andamento verso il meglio non potette essere più radicale. Si
passò dalla fiducia negli avanzamenti della cultura al pessimismo più nero:
quasi che tutte le Furie si fossero abbattute sul mondo offrendo orrori
superiori a quelli delle età barbariche, anche per i mezzi tecnici messi ora a
disposizione. Alla speranza seguì la paura, il terrore, per un avvenire
neppure più intravedibile in seguito alla avvenuta “fine della civiltà”. La
delusione comportò un pessimismo morale ben più grave delle facili
illusioni dei fautori del progresso lineare e indefinito sostenuto da
illuministi e scientisti postmoderni. Croce traeva dallo spettacolo della
storia, che è sempre storia di progressi e regressi, mai definitivi, la
conclusione filosofica:
Il progresso non è altro che il ritmo dello spirito stesso, col quale soltanto
si può interpretare e intendere la storia, e verso il quale soltanto si può e si
deve indirizzare la vita morale26.
Il progresso suscita dunque opposti stati d’animo, entrambi efficaci per
la vita a seconda dei casi particolari: talvolta occorre che prevalga la
credenza nel meglio altre volte è opportuna la convinzione che si viva in un
clima di conclamata decadenza. E tuttavia sono proprio i moti del
sentimento che nella metodologia della conoscenza storica colorano il
tempo della vita intrecciato al tempo della storia. Perché ciò avvenga è
importante tradurre la nozione di progresso nell’ambito dell’analisi
B. CROCE, “Previsioni e apocalissi”, in ID., Il carattere della filosofia moderna (1940), a
cura di M. Mastrogregori, Bibliopolis, Napoli 1991, p. 189.
26 B. CROCE, “Il progresso come stato d’animo e il progresso come concetto
filosofico”, in ID., Filosofia e storiografia, cit., p. 302.
25
Renata Viti Cavaliere
212
soggettiva del futuro. Al timore e alla speranza, prima descritti, si
sostituirà allora la passione che accompagna il comprendere (il piacere
dell’imparare o del capire) tanto più profondo quanto più si sarà stati in
grado di inoltrare lo sguardo nella protensione verso il futuro, che è amore
(eros) nel senso di ricerca di possibili nuovi significati. Nella Filosofia della
pratica Croce aveva ben descritto il carattere esplorativo e meditativo della
percezione dei fatti in vista dell’agire “politico”. L’iniziativa che muove
all’azione e che ha ispirato la conoscenza stessa è volontà di cambiamento
prima di essere volizione particolare in collaborazione con altri soggenti
che vogliono, amano, agiscono. Ciò vuol dire che non si mettono in opera
astratti progetti lungamente disegnati dalla mente, ma si sceglie per una
decisione che è pro-gresso nella prospettiva volta per volta individuata.
[La decisione] cangia a ogni attimo; come cangia ad ogni attimo il
movimento del nuotatore o dell’atleta, secondo il moto del mare o
dell’atleta avversario e secondo la variante misura o qualità delle proprie
forze nel corso del processo volitivo27.
Quel problema storico che secondo Croce muove a conoscere il
passato, rendendo contemporanea ogni vera storiografia, è il giudizio del
futuro, la capacità di aggiungere pagine nuove che sono per definizione
avanzamenti anche se comportano qualche stasi o sensibili passi indietro.
Nella sua Teoria della previsione Raffaello Franchini così rappresentava il
progresso, che è l’essenza temporalizzatrice della condizione umana e
l’impegno etico-politico di ciascuno:
Ogni atto del vivere è un superare o tentare di superare il rischio del
futuro, contro il quale non esiste altra assicurazione che la nostra buona
volontà, l’impegno che noi siamo in grado di mettere all’opera, la bontà e
la tempestività delle nostre decisioni28.
In conclusione si può ipotizzare una storia del futuro solo a patto
ch’essa si attenga alla realtà di un antico compito filosofico: far accadere il
27 Cfr. B. CROCE, Filosofia della pratica (1909), edizione critica a cura di M. Tarantino,
nota di G. Sasso, 2 voll., Bibliopolis, Napoli 1996, p. 51.
28 Cfr. R. FRANCHINI, Teoria della previsione (1964), Giannini, Napoli, 19722, p. 116.
Se ne veda la ristampa a cura di G. Cotroneo e G. Gembillo, Armando Siciliano editore,
Messina 2001.
213
Croce e la storia del futuro
logos che non è semplicemente al principio di tutte le cose, ma è principio
in quanto “nascita” dell’essere che chiamiamo ragione29.
Abstract
Croce drew up a true "history of the future" in the pages of the famous
History of Europe in 1932. It was not long-term forecasts, which are
prohibited by the philosopher whose task is not to stabilize or to secure the
future. He gave rather - as we read in the Epilogue of the work - the
details useful way forward to present consciousness on the basis of the
interpretation of current events. And yet the political perspective of a
united Europe, stated in the historical context of the time crucial to the
future of the West, it is still the look of the new player much more
peaceful outcome of the exercise of proper hermeneutics. The purely
theoretical problem here that you want to put in their conception
"historicist" progress in thinking about the future, against the excesses of
identity and apocalyptic fury crossing our time.
Rinvio a tema trattato nel volume, già ricordato, su Nascita e ri-nascita in filosofia,
dove in un incontro a più voci si avvia l’analisi della categoria della natalità muovendo
dall’antico significato di “generatività” dell’essere, in una sorta di aggiornata ontologia del
cominciamento.
29
Sezione II
Natura/Cultura
FERDINANDO ABBRI
Historia natural e cultura: aspetti del dibattito recente
sul Nuovo Mondo
“siccome la virtù di questi [Romani]
venne finalmente corrotta dal lusso asiatico,
così la virtù di quegli Americani è guasta
in gran parte dalla intemperanza europea,
che è entrata fra loro”.
(F. ALGAROTTI, Saggio sopra l’impero degl’Incas, 1753)1
“… il Messico è felice. Frutto di quella libertà,
che unita alla prudenza, al solo fren soggiace
della legge, ch’io stesso sono il primo ad osservare”.
(FEDERICO II DI PRUSSIA – G. TAGLIAZUCCHI, Montezuma,
1755, Atto I, sc. I)2
Il 6 gennaio 1755 a Berlino, presso il Teatro Reale (Hofoper) voluto da
Federico II di Prussia, venne rappresentata l’opera Montezuma che aveva come
argomento la conquista e distruzione del Messico da parte degli spagnoli. La
musica era di Carl Heinrich Graun (1703/04-1759)3, il Kapellmeister di
Federico, e non solo l’argomento era stato scelto dal re ma lo stesso Federico
aveva scritto in francese il testo che il poeta di corte Giampiero Tagliazucchi
aveva tradotto e adattato in italiano in modo da poter essere intonato da
Graun. L’opera presentava Montezuma come la personificazione del sovrano
illuminato, pacifico, rispettoso delle leggi e dedito completamente al
benessere del proprio popolo mentre Hernan Cortés e gli spagnoli erano
l’espressione di un potere imperialistico e aggressivo. Nel finale dell’opera la
distruzione dell’impero messicano era la conseguenza inevitabile degli inganni
e dell’uso della forza da parte degli spagnoli: Montezuma e Cortés erano il
1 F. ALGAROTTI, Saggio sopra l’impero degl’Incas, a cura di A. Morino, Sellerio Editore,
Palermo 1987, p. 15.
2 C.H. GRAUN, Montezuma. Oper in drei Akten. Herausgegeben von A. Mayer-Reinach,
Verlag von Breitkopf und Härtel, Leipzig 1904, p. 11.
3 Graun Carl Heinrich, in S. SADIE (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
Macmillan, London 1980, 7, pp. 644-646.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 217-231
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064314
217
218
Ferdinando Abbri
simbolo di due modi opposti di esercitare il potere regale. L’opera costituiva
un nuovo capitolo della polemica antispagnola e anticattolica che alimentava
tanta cultura illuministica ma conteneva anche la rappresentazione esplicita di
un sovrano illuminato, e alcune caratteristiche prestate al sovrano messicano
rimandavano espressamente al Re di Prussia. A metà Settecento la scomparsa
Tenochtitlan veniva evocata sulle rive della Sprea in forma aspramente
polemica, e l’opera in musica si confermava uno strumento efficace di critica
filosofica e propaganda politica.
Due anni prima della rappresentazione del Montezuma Francesco
Algarotti (1712-1764), che era assai legato a Federico di Prussia e alla
corte di Berlino e molto attento alla struttura e al significato dell’opera in
musica4, aveva pubblicato un breve saggio sopra l’impero degli Incas,
ovvero sulla conquista del Perù nel quale aveva espresso una condanna
severa delle pratiche di conquista messe in atto dagli europei dopo la
scoperta dell’America5. Il saggio di Algarotti e l’opera di Graun
costituiscono due esempi significativi del permanere di quelle discussioni e
di quelle polemiche che, a causa della scoperta di una pluralità di mondi
sulla Terra, turbavano la coscienza europea sin dal Cinquecento.
Giova ricordare che nel corso del Settecento i viaggi intorno al mondo,
la presenza dei portoghesi e degli olandesi in Asia e i contatti di questi
ultimi con il Giappone, le scoperte geografiche, etnologiche e culturali nel
Pacifico avevano reso di nuovo attuale tutta quella serie di problemi
(filosofici, teologici, antropologici) che accompagnavano la scoperta di
civiltà altre, e da tre secoli questa scoperta assillava e tormentava l’Europa.
Nel 1778 il pastore e naturalista prussiano Johann Reinhold Forster (17291798) pubblicò a Londra le sue Observations made during a Voyage round the
World che costituivano un resoconto del secondo viaggio (1772-1775) di
James Cook intorno al mondo al quale Forster aveva preso parte col figlio
Georg6. Nel 1776 Georg Forster aveva infatti pubblicato il suo celebre
Voyage around the World, ossia una delle opere più fortunate di letteratura di
viaggio del tardo Settecento7.
Cfr. F. ALGAROTTI, Saggio sopra l’opera in musica, per Marco Coltellini, Livorno 1763
(ed. or. Venezia 1755).
5 F. ALGAROTTI, Saggio sopra l’Impero, cit.
6 J.R. FORSTER, Observations made during a Voyage round the World on Physical Geography,
Natural History and Ethic Philosophy, Printed for G. Robinson, London 1778. Cfr. M.E.
HOARE, The Tactless Philosopher. Johann Reinhold Forster (1729-1798), The Hawthorn Press,
Melbourne 1976.
7 J.R. FORSTER, A Voyage Round the World. Bearbeitet von R.L. Kahn, Akademie
4
Historia natural e cultura
219
Le Observations di Johann Reinhold non conobbero un grande successo
editoriale ma contengono una autentica miniera di informazioni riguardo alle
esplorazioni del Pacifico8. Quest’opera aveva come oggetto la geografia fisica,
la storia naturale ma anche la “ethic philosophy”, ossia gli usi e costumi dei
polinesiani e degli abitanti del Pacifico in genere. Forster elencava, con
prussiana precisione, i vari argomenti di storia naturale (la terra e i suoi strati,
l’acqua e l’oceano, l’atmosfera e i mutamenti del globo, i corpi organici e la
specie umana) che erano oggetto delle sue Observations e indicava le sue fonti
documentarie: il conte di Buffon e il naturalista svedese Torbern Olof
Bergman per la geografia fisica, Isaak Iselin per la storia filosofica del genere
umano, Johann Friedrich Blumenbach e John Hunter per l’anatomia.
L’oggetto della sua opera era «nature in its greatest extent», terra, mare, aria e
la creazione organica, con particolare attenzione alla classe «of Beings to which
we ourselves belong». Forster faceva altresì notare di essere stato in grado di
offrire un quadro dell’umanità nei diversi stadi perché aveva osservato «the
most wretched savages, removed but in first degree from absolute animality» e
i più civilizzati abitanti delle «Society Islands» (Tahiti)9.
Le Observations non si presentano come sola letteratura di viaggio, mostrano
una impostazione di carattere etnologico tipica dell’Età illuministica ma con
l’insistenza sulla storia naturale e sulla storia culturale richiamano anche quella
ampia letteratura “etnologica” (Oviedo, Acosta) che si era venuta affermando,
nel corso del Cinquecento, in relazione alla scoperta delle Indie occidentali. La
parte “etica” delle Observations risulta di particolare interesse perché svela come
un luterano dovette elaborare schemi interpretativi “nuovi” ma ortodossi per
poter inquadrare e definire le diversità umane che veniva osservando. Forster
aveva indicato nei fatti la base irrinunciabile della sua narrazione ma questi fatti
dovevano essere interpretati ed inseriti in uno schema teorico e ideologico
preciso. Ad esempio, egli nota la marcata diversità antropologica (fisica e
culturale) tra gli abitanti della “Tierra del Fuego” e quelli delle isole del
Pacifico e ipotizza che i primi discendano dai nativi dell’America del Sud,
quindi non sono appartenenti alle “races” degli uomini del “South Sea”, e
immagina molteplici percorsi migratori10.
Verlag, Berlin 1986 («Georg Fosters Werke, Band I»). Cfr. L. UHLIG, Georg Forster,
Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 2004, pp. 85-95.
8 Cfr. F. ABBRI, Un dialogo dimenticato, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 29-43.
9 J.R. FORSTER, Observations, cit., pp. I-II. Cfr. H. LIEBERSOHN, The Traveler’s World. Europe to
the Pacific, Harvard University Press, Cambridge (Mass) - London 2006, pp. 1-14.
10 Ivi, p. 244.
220
Ferdinando Abbri
Forster riconosce le numerose varietà della specie umana e segnala due
grandi varietà o razze nei mari del Sud: una più attraente, atletica, bianca e di
“benevolent temper”; una più scura, con i capelli che tendono a essere crespi,
il corpo più sottile e con un temperamento più “brisk”. La prima razza
contiene a sua volta delle varietà, quella più bella è a Tahiti, e in generale nelle
“Society Islands”, con uomini atletici, col corpo ben proporzionato, «but
always blended with a degree of effeminacy»: si tratta di popoli sensuali,
libidinosi, amanti del canto, delle danze, della teatralità («dramatic
performances») e nei loro balli «breathe a spirit of luxury»11. Gli abitanti delle
«Marquesas Islands» sono secondi per bellezza a ragione del carattere
proporzionato dei loro corpi e i giovani sono generalmente «most beautiful» e
«would afford many a fine model for a Ganymede»12. La seconda razza o tribù
è rintracciabile nella New Caledonia e nelle isole vicine e Forster fa notare le
differenze fisiche ragguardevoli tra la prestanza fisica dei «New-Caledonians» e
i nativi di altre isole che sono bassi, minuti, neri, simili ad una tribù di scimmie
e di sicuro un «ill-favoured set of beings»13. È ovvio che Forster mette in
stretto collegamento l’antropologia fisica con il carattere delle popolazioni per
cui alla prestanza fisica corrispondono temperamenti specifici (pacifici o
aggressivi) ma di grado elevato nella scala della civiltà mentre, ad esempio, i
poveri abitanti della Terra del Fuoco risultano amichevoli, di buona natura ma
anche «remarkably stupid», ovvero si tratta di inette e miserevoli creature in
una condizione disgraziata e degradata14.
Nel corso delle sue descrizioni Forster usa in maniera libera termini
come razze, varietà, tribù ma dopo la sezione descrittiva allorché deve
affrontare le cause delle differenze etniche tra gli abitanti dei mari del Sud
la premessa indiscutibile della spiegazione proposta è che tutta l’Umanità
deriva da un’unica coppia e le varietà sono accidentali. Forster nota che il
suo è un tempo, una «age of refinement and in fidelity» che vede gli
scrittori moderni usare tutti i mezzi possibili per invalidare l’autorità della
religione rivelata per cui anche le varietà umane sono utilizzate a tal scopo
ma il ricorso al buon senso e alla ragione dimostra che per quanto gli
uomini siano diversi nella «scale of beings» non formano razze separate15.
A menti prive di pregiudizi o di rancore contro la religione risulta sempre
Ivi, pp. 230-231.
Ivi, p. 233.
13 Ivi, pp. 238-243.
14 Ivi p. 251.
15 Ivi, pp. 252-253.
11
12
Historia natural e cultura
221
più evidente che «all mankind, though ever so much varied, are, however,
but of one species» e la discendenza da un’unica coppia è confermata16.
Forster ricorre ad una teoria climatica per spiegare le differenze tra le
due distinte razze o varietà di uomini da lui individuate nelle isole dei mari
del sud per cui le differenze di colore derivano dall’esposizione all’aria,
dall’influenza del sole – i Tahitiani sono quasi sempre vestiti e coperti
mentre gli abitanti della Nuova Caledonia sono sempre nudi, pertanto sono
più scuri – e da circostanze specifiche nel modo di vita.
Non intendo entrare qui nelle spiegazioni offerte da Forster perché
questo non è lo scopo del presente saggio ma voglio sottolineare elementi
di continuità e di discontinuità nella letteratura etnologica moderna.
Forster ci presenta una vera e propria storia naturale e morale delle Isole
dei mari del Sud nella quale la descrizione geografica dei luoghi, del
paesaggio naturale si unisce alla descrizione degli uomini e delle donne e
Forster utilizza considerazioni di antropologia fisica e di antropologia
culturale e, riguardo agli abitanti di queste isole, pone il fisico e il morale
in stretta connessione. A livello descrittivo Forster è assai attento a notare
le differenze, le diversità fisiche e culturali costruendo così un capitolo
della scoperta empirica di diversità impressionanti nell’Umanità come
genere. Le sue Observations sono un momento settecentesco, di innegabile
rilievo storico, filosofico e scientifico, della scoperta di una pluralità di
“mondi umani” nel nostro pianeta che formano insieme un affresco assai
composito. Il livello esplicativo si nutre invece di parametri tradizionali.
Come luterano Forster non ha la preoccupazione di conservare validità
all’idea tomistica di legge naturale, tornata di grande attualità con la
scoperta dell’America, ma è pienamente consapevole che le scoperte da lui
descritte possono costituire uno strumento di polemica antireligiosa, da
qui il suo ricorso ad una teoria climatica per mantenere validità al
monogenismo come spiegazione delle origini della Umanità17. Si può
affermare che Forster si ritrovò davanti i medesimi problemi che la
nascente etnologia rinascimentale si era trovata a affrontare dopo la
scoperta della Mesoamerica18.
Ivi, pp. 256-257.
Cfr. G. GLIOZZI, Le teorie della razza nell’età moderna, Loescher,Torino 1986; ID.,
Differenze e uguaglianza nella cultura europea moderna, Vivarium, Napoli 1993.
18 J.-P. RUBIÉS, “New Worlds and Renaissance Ethnology”, History and Anthropology 6
(1993), pp. 157-197, ora in ID., Travellers and Cosmographers. Studies in the History of Early
Modern Travel and Ethnology, Ashgate, Aldershot 2007.
16
17
222
Ferdinando Abbri
Forster racconta che gli abitanti di Mallicollo (nel gruppo di isole di
Vanuatu) sono fisicamente pelosi, instancabili, vivaci e alcuni di loro «illnatured and mischievous», tuttavia sembrano gioiosi e amanti del canto e
della danza. Nota che loro frecce avvelenate «had no effects on our dogs»,
anche se non è in grado di dire la ragione di ciò e non è convinto che le
frecce siano innocue, altrimenti non si spiegherebbe la cura dei nativi nel
proteggere le punte con una particolare resina19.
Il riferimento ai cani delle navi di Cook richiama altre specie canine
europee che due secoli e mezzo prima avevano fatto il loro ingresso in
un’altra terra da poco scoperta. Nel marzo del 1519 Hernán Cortés,
proveniente da Cuba, arrivò sulle spiagge del Messico e fece sbarcare i suoi
uomini, gli armamenti, schiavi africani e cubani come portatori ma anche
sedici cavalli spagnoli e un gruppo di cani da guerra, ossia mastini e cani
lupo. I cavalli e i cani di Cortés non solo erano specie naturali ignote nel
Nuovo Mondo ma erano anche prodotti di una definita civiltà guerriera
perché si trattava di animali addestrati alla guerra e alla lotta20. L’esempio dei
cani europei resistenti alle frecce avvelenate dei “selvaggi” di Vanuatu e dei
cani addestrati alla guerra degli Spagnoli intenti a scoprire, conquistare e
distruggere l’Impero di Moteuczoma Xocoyotl21 dimostrano che nello
scontro e nella conquista dei Nuovi mondi entrarono in gioco sia la cultura
intesa come insieme di modelli e di risorse (tecniche, scientifiche e di sapere)
sia la natura (specie animali, malattie) ma entrambe erano costruzioni sociali,
e uno scambio dialettico tra natura e civiltà era all’opera sia nei nuovi mondi
sia nei mondi vecchi che si appropriarono di quelli nuovi.
La globalizzazione attuale, i difficili rapporti a livello planetario tra le
varie civiltà hanno fatto assumere un’importanza cruciale al problema
dell’altro, soprattutto in Occidente. Gli storici si sono occupati da tempo
di questi temi che sono oggetto di ricostruzioni di rilievo ma gli eventi
contemporanei hanno proiettato alcune tematiche fuori da circoli scientifici
ed accademici. Ad esempio, la dissoluzione della Iugoslavia e la nascita di
una Repubblica di Macedonia con Skopje come capitale non solo ha
sollevato le dure proteste di Atene che rivendica nel suo territorio
J.R. FORSTER, Observations, cit., p. 243.
B. LEVY, Conquistador. Hernán Cortés, King Montezuma, and the Last Stand of the Aztecs,
Bantam Books, New York 2009, p. 1.
21 Questo è il nome più corretto, rispetto alla lingua Nahuatl, usato dagli storici
moderni di oggi per designare Montezuma.
19
20
Historia natural e cultura
223
l’esistenza dell’unica e autentica Macedonia22, ma ha anche reso di
un’attualità impensabile e di impatto pubblico, con manifestazioni talora
preoccupanti, la discussione tra storici, archeologi e storici dell’arte sul
carattere “greco” degli Antichi macedoni, cioè della dinastia dei Temenidi,
alla quale appartenevano Filippo II e Alessandro Magno. Fino a non molto
tempo fa se uno storico affrontava questo tema, sollevando interrogativi e
questioni del tutto legittime, rischiava subito di venir etichettato dai
nazionalisti greci come spia al soldo di Skopje23.
Nell’immagine collettiva le storiche e gli storici antichi sono percepiti
come una comunità a sé stante, un po’ appartata ma la nuova geografia
politica europea li ha proiettati sulla scena contemporanea e ha reso di
piena attualità la questione etnica nell’Antichità. Negli ultimi anni sono
infatti usciti pregevoli lavori storici che affrontano il problema etnico nel
mondo antico. Nel 1997 Jonathan M. Hall ha scritto un libro importante
su Ethnic Identity in Greek Antiquity24, nel 2001 Phiroze Vasunia ha
pubblicato una monografia sulla storia dell’Egitto ellenistico che indaga il
difficile rapporto tra cultura locale e cultura greca25 – il tema etnico è
diventato dominante in lavori recenti su Cleopatra VII Filopatore, ultimo
Faraone d’Egitto26 – mentre Erich S. Gruen, che è un celebre classicista,
ha dedicato le “Martin Classic Lectures” del 2006 al tema dell’alterità e ha
pubblicato queste lectures col titolo di Rethinking the Other in Antiquity27.
22 L.M. DANFORTH, Ancient Macedonia, Alexander the Great and the Star or Sun of Vergina:
National Symbols and the Conflict between Greece and the Republic of Macedonia, in J. Roisman,
I. Worthington (eds.), A Companion to Ancient Macedonia, Wiley-Blackwell, Malden –
Oxford 2010, pp. 572-598.
23 Daniel Ogden ha raccontato che nell’ottobre 2002, durante il settimo simposio
internazionale on Ancient Macedonia a Tessalonica, vi furono contestazioni e manifestazioni
pubbliche contro di lui, Ernst Badian (il decano degli studiosi di Macedonia antica) e Kate
Mortensen a ragione dei titoli dei loro interventi, ritenuti offensivi della reputazione degli
antichi macedoni. Cfr. D. OGDEN, Alexander the Great, University of Exeter Press, Exeter
2011, pp. 2-3. Sulla questione etnica: A. KARAKASIDOU, Fields of Wheat, Hills of Blood:
Passages to Nationhood in Greek Macedonia, University of Chicago Press, Chicago 2007.
24 J.M. HALL, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge
1997.
25 P. VAZUNIA, The Gift of the Nile. Hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander,
University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 2001.
26 F. ABBRI, Icona della Contemporaneità: Cleopatra VII d’Egitto, in M. Baioni, P. Gabrielli
(a cura di), Non solo storia, Società Editrice il Ponte Vecchio, Cesena 2012, pp. 9-18.
27 E.S. GRUEN, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton Oxford 2011.
224
Ferdinando Abbri
Filoni stabiliti, canonici di indagine storica e eventi contemporanei
contribuiscono alla fioritura degli studi sulla scoperta dei mondi altri, sul
viaggio in contesti diversi ed è del tutto logico che la tradizione degli studi
sul Nuovo Mondo continui a rappresentare un capitolo macroscopico delle
ricerche di storia moderna.
La Historia General de las Indias (1552) di Francisco López de Gómara è una
ricostruzione classica della conquista del Messico da parte degli spagnoli che si
ricorda anche per l’affermazione che «el descubrimiento de Indias» era
l’evento, fatta eccezione per l’Incarnazione di Gesù Cristo, più importante
dalla «creación del mundo» e per la definizione di Mundo Nuevo perché
grande come il vecchio (Europa, Africa, Asia) e «tanbién se puede llamar
nuevo por ser todas sus cosas diferentisimas de las del nuestro»28. Gómara, un
prete che non mise mai piede nel Nuovo Mondo, afferma che qui gli animali
sono di specie limitate e gli uomini, a parte il colore della pelle, sono
discendenti di Adamo, quindi né mostri né animali ma semplicemente uomini.
Gómara non sembra avere molto interesse per il mondo naturale anche se la
prima parte della sua opera è dedicata alla descrizione geografica delle varie
regioni americane insieme alla storia delle conquiste spagnole. La sua Historia è
in verità una celebrazione di Cortés come conquistatore del Messico.
Ho accennato sopra ai nomi di Oviedo e Acosta perché in questo caso si
tratta di autori di due storie delle Indie che mettono insieme l’aspetto della
storia naturale e quello della storia civile e culturale fornendo così un
fortunato modello letterario i cui echi si ritrovano in molte relazioni di viaggi
del Sei e del Settecento: l’unione tra la “descrizione” naturale e la
“descrizione” etnografica diventa centrale e rivela le modalità utilizzate dalla
cultura europea nella costruzione del mondo naturale e delle civiltà “nuove”.
Miguel de Asúa e Roger French hanno giustamente sottolineato che Oviedo
e Acosta inventarono un nuovo genere di scrittura storica: «storia naturale e
morale» o «storia naturale e generale»29. Nonostante l’esistenza di
precedenti classici l’idea di unificare queste due dimensioni grazie a un solo
sguardo è da mettere in relazione alla scoperta dell’America. Si trattò di
unificare la storia naturale (Aristotele e Plinio) e la storia “civile” nel senso
ciceroniano e delle res gestae di matrice medievale.
La Primera parte della Historia general y natural de las Indias di Francisco
Fernández de Oviedo (1478-1557) fu pubblicata nel 1535 e aveva come
F.L. DE GÓMARA, Historia General de Las Indias, Calpe, Madrid 1922, tomo I, p. 4.
M. DE ASÚA, R. FRENCH, A New World of Animals. Early Modern Europeans on the
Creatures of Iberian America, Ashgate, Aldershot 2005, pp. 53-54.
28
29
Historia natural e cultura
225
modello principale e dichiarato la Naturalis Historia di Plinio, anche se solo
una parte era dedicata alla storia naturale in senso stretto. Il senso forte
dell’importanza della natura del Nuovo Mondo è attestato dalle domande
retoriche che Oviedo si pone:
¿Quál ingenio mortal sabrá comprehender tanta diversidad de lenguas, de
hábito, de costumbres en los hombres destas Indias? Tanta variedad de
animales, assi domésticos como salvajes y fieros? Tánta multitud innarrable
de árboles, copiosos de diversos géneros de fructas, y otros estériles, assi
de aquellos que los indios cultivan, come delos que la natura de su proprio
ofiçio produçe, sin ayuda de manos mortales?30
Il rilievo della dimensione naturalistica nel lavoro di Oviedo è confermato
da una recente edizione inglese delle sezioni di storia naturale a cura di
Kathleen Ann Myers che conferma l’impatto storico-scientifico della
Historia31. In verità, il progetto di Oviedo era ambizioso perché cercava di
unire la storia naturale pliniana ad una storia generale e questa unificazione
tematica sfociava in un sostanziale contributo ideologico alla celebrazione
dell’Impero e delle conquiste spagnole.
A Siviglia nel 1590 il gesuita José de Acosta (1540-1600) pubblicò la
Historia natural y moral de las Indias che era destinata a grande fortuna,
popolarità e a costituire un vero e proprio modello. Il titolo completo
chiariva il contenuto perché nella Historia delle Indie «se tratan las cosas
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: y los
ritos, y cerimonias, leyes, y governo, y guerras de los Indios», dunque storia
della natura – i primi libri trattano del cielo (cosmologia), della temperatura
e del popolamento della terra – e storia culturale degli Indiani32. È evidente
che la prima parte del testo di Acosta ha per riferimento non il modello
pliniano ma la filosofia aristotelica perché si possono individuare
corrispondenze precise col De caelo e i Metereologica dello Stagirita.
Nella vasta e importante letteratura storica sul Nuovo Mondo e il suo
impatto sulla coscienza europea le opere di Oviedo e di Acosta, nelle loro
30 G.F. DE OVIEDO Y VALDÉS, Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme
del Mar Océano, Primera Parte, Imprenta de la Real Accademia de la Historia, Madrid
1851, p. 2.
31 K.A. MYERS, Fernández de Oviedo’s Chronicle of America. A New History for a New World,
University of Texas Press, Austin 2007.
32 J. DE ACOSTA, Historia Natural y Moral de las Indias, en casa de Iuan de Leon, Sevilla
1590.
226
Ferdinando Abbri
similitudini di genere letterario e nelle loro innegabili differenze filosofiche,
rappresentano fonti essenziali per le discussioni in merito alle origini
dell’Umanità. Non intendo ritornare su questi temi sui quali esistono libri di
assoluto valore sul piano storiografico ma il richiamo a Oviedo e Acosta mi
serviva per segnalare il ruolo che il loro modello di storia – naturale e
morale – ha svolto nella cultura moderna sino all’Illuminismo, ovvero esiste
un filo tematico che lega la Historia di Acosta e le Observations di Forster.
Nella parte restante di questo saggio voglio indicare due argomenti di
storia natural y moral che hanno richiamato di recente l’attenzione degli
storici e che dimostrano che la conquista del Nuovo Mondo è, nell’agenda
degli storici, un tema capace di catalizzare ricerche secondo le prospettive
più diverse. Si tratta, in questo caso, di una serie di semplici segnalazioni di
studi, non una rassegna sistematica, ma ritengo che possano rivestire un
qualche interesse dal punto di vista storico-filosofico.
La letteratura storica sulla scoperta del nuovo Mondo affronta le molteplici
dimensioni degli eventi che portarono alle conquiste spagnole in Mesoamerica
e spagnole e portoghesi in Sudamerica. Nel 1998 Grant D. Jones ha pubblicato
una magnifica storia della conquista, alla fine del Seicento, dell’ultimo regno
Maya che serve a confermare la costanza e la continuità plurisecolare
dell’espansionismo spagnolo nel Nuovo Mondo33. La questione della
cosmologia con i suoi risvolti religiosi, la sua influenza sulle pratiche cultuali,
ossia il tema dei sacrifici umani continua a produrre innumerevoli lavori. Nel
2008 Caroline Dodds Pennock ha pubblicato una monografia dal titolo Bonds of
Blood dedicata a argomenti relativi al gender, agli stili di vita e al sacrificio nella
cultura atzeca e si tratta di un buon contributo di storia sociale34. Nel 2001
Elizabeth P. Benson e Anita G. Cook avevano invece curato una raccolta di
saggi su Ritual Sacrifice in Ancient Peru, che confermava la centralità del tema
religioso nella storia delle civiltà precolombiane35.
Ross Hassig è un celebre storico antropologo della conquista spagnola
del Messico, autore di alcuni preziosi volumi sulla Mesoamerica antica e sul
Messico atzeco e coloniale. Nel 2006 è stata pubblicata la seconda edizione
del suo Mexico and the Spanish Conquest che contiene una eccellente
33 G.D. JONES, The Conquest of the Last Maya Kingdom, Stanford University Press,
Stanford 1998.
34 C. DODDS PENNOCK, Bonds of Blood. Gender, Lifecycle and Sacrifice in Aztec Culture,
Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008.
35 E.P. BENSON, A.G. COOK (eds.), Ritual Sacrifice in Ancient Peru, University of Texas
Press, Austin 2001.
Historia natural e cultura
227
ricostruzione delle vicende comprese tra il febbraio 1517 – l’inizio
dell’esplorazione dello Yucatan da parte di F.H. de Córdoba – e l’agosto
1521, data che segna la resa definitiva degli Aztechi36. In un bel saggio del
2007 Hassig ha chiarito il significato di pace, riconciliazione e alleanza nel
Messico azteco che consente in verità di definire l’importanza della guerra,
della conquista e delle modalità di costruzione dell’Impero da parte degli
aztechi. Hassig indica che gli aztechi non esercitavano forme di
imperialismo culturale e usavano strategie di integrazione fondate non
sull’imposizione della religione ma su quella del calendario. Nel Messico
venivano infatti utilizzati due calendari: uno solare di 365 giorni e di
diciotto mesi unito ad un calendario sacro di 260 giorni e questi due
calendari erano in uso contemporaneamente per calcolare un ciclo di 52
anni, al termine del quale con una cerimonia del fuoco si dava inizio ad un
nuovo ciclo di uguale durata37. Si può dedurre che la questione del
calendario rivestiva una grande importanza nella Valle del Messico.
In un volume del 2001 Hassig si era infatti occupato proprio del
problema della concezione della temporalità, quindi dei calendari in uso e
il suo libro, dal titolo Time, History and Belief in Aztec and Colonial Mexico, è
un contributo di indubbio valore da un punto di vista sia storico sia
metodologico38. La questione del calendario risulta essere al centro di una
serie di discorsi che hanno a che fare con la scienza, la religione, la politica,
l’idea di impero, e così via.
Tradizionalmente si ritiene che la civiltà azteca e le altre società
mesoamericane avessero una concezione ciclica del tempo e della storia
che fu in larga misura sostituita, dopo la conquista, dalla concezione lineare
tipica dell’Occidente, introdotta in America dagli spagnoli. Hassig cerca di
dimostrare che questa visione non è confermata dai dati, perché erano
all’opera nozioni diverse di tempo e di storia, non una sola e paradigmatica
nozione, e che gli aztechi erano abili manipolatori dei calendari.
Nel suo volume su Il passato, la memoria, l’oblio del 1991 Paolo Rossi ha
pubblicato un saggio dal titolo Vicissitudo rerum nel quale mostra in maniera
R. HASSIG, Mexico and the Spanish Conquest. Second Edition, University of Oklahoma
Press, Norman 2006.
37 ID., Peace, Reconciliation, and Alliance in Aztec Mexico, in K.A. Raaflaub (ed.), War and
Peace in Ancient World, Blackwell Publishing, Malden Mas. – Oxford 2007, pp. 312-328.
38 ID., Time, History, and Belief in Aztec and Colonial Mexico, University of Texas Press,
Austin 2001. Cfr. J. BRODA, Calendrics and Ritual Landscape at Teotihuacan. Themes of
continuity in Mesoamerican “Cosmovision”, in D. CARRASCO, L. JONES, S. SESSION (eds.),
Mesoamerica’s Classic Heritage, University Press of Colorado, Boulder 2000, pp. 397-432.
36
228
Ferdinando Abbri
indiscutibile il carattere mitico di una rigida contrapposizione tra il tempo
ciclico (visione antica, classica) e il tempo lineare e progressivo della
modernità. Scrive Rossi:
Non credo affatto che la modernità possa essere collocata sotto la categoria
del tempo lineare. Credo alla compresenza e alla difficile coesistenza, nella
nostra tradizione, di una concezione lineare e di una concezione ciclica del
tempo39.
Facendo ricorso a autori come Bruno, Bacone e Newton Rossi dava conto,
con precisi riferimenti a testi cruciali della modernità, di questa
compresenza. In Naufragi senza spettatore del 1995 Rossi confermava che
nella filosofia di Bacone, il filosofo del progresso scientifico, convivevano
una concezione ciclica della storia e del tempo e una salda fede nel
progresso40. Il concetto di una convivenza tra ciclo e freccia nell’Età
moderna si è ormai radicato tanto da indurre un musicologo come Karol
Berger a definire la modernità musicale in termini di contrasto tra ciclicità
bachiana e linearità mozartiana41. L’idea che la modernità europea fosse
portatrice esclusiva di una visione lineare del tempo appare del tutto
mitica, dunque è da ritenere che nella ideologia dei conquistatori spagnoli
convivessero concezioni diverse del tempo.
Hassig contesta la visione tradizionale – aztechi = ciclicità; spagnoli =
linearità – e dimostra che gli aztechi non sostenevano principalmente una
concezione ciclica del tempo e della storia, ma attuavano, a scopo politico,
una deliberata manipolazione del tempo attraverso il calendario42. L’uso
del calendario divenne uno strumento politico fondamentale nella pratica
di espansione dell’Impero azteco. Non è necessario riassumere qui le sottili
e puntuali ricostruzioni di Hassig ma è sufficiente sottolineare che la
questione del calendario nel Mexico pre e postcoloniale conferma che nei
rapporti tra nativi e conquistatori europei erano all’opera una serie di
parametri assai diversificati non riconducibili a dualismi rigidi.
Nel 2002 ho pubblicato un saggio su storia e antropologia nel quale
consideravo alcuni studi sui nativi americani con particolare attenzione alla
P. ROSSI, Il passato, la memoria, l’oblio, Il Mulino, Bologna 1991, p. 96.
ID., Naufragi senza spettatore. L’idea di progresso, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 35-38.
41 K. BERGER, Bach’s cycle, Mozart’s arrow: an essay on the origins of musical modernity,
University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 2008.
42 R. HASSIG, Time, cit., p. XIII.
39
40
Historia natural e cultura
229
questione dell’organizzazione della sessualità nel Nuovo Mondo, mettendo
in luce il dibattito intorno alla figura del cosiddetto “berdache” (un
individuo di sesso maschile che assumeva un ruolo di genere femminile)43.
Questo dibattito è tutt’ora in corso tra gli storici, non mancano polemiche
vivaci e talora aspre a riprova del rilievo, in ambito angloamericano, della
storia delle sessualità e delle relazioni di gender. Nel 2007 Thomas A.
Foster ha curato una raccolta di saggi dal titolo Long Before Stonewall.
Histories of Same-Sex Sexuality in Early America che si apre con un saggio di
Ramón A. Gutiérrez44, che è autore di un celebre libro sulla storia sociale
della sessualità nel New Mexico45. Gutiérrez riconsidera la questione del
berdache – termine derivato da bradaje, in origine un termine arabo per
designare un prostituto maschio – e sulla base delle fonti classiche per la
storia dell’America pre-colombiana giunge ad una conclusione netta:
quello del berdache non era un ruolo scelto ma un ruolo imposto. La
descrizione dei berdache come uomini “big and strong” conferma che si
trattava di prigionieri di guerra costretti a servire sessualmente il capo
guerriero che li aveva sconfitti, e potevano essere prestati dal capo ad altri
dignitari come segno della sua generosità o usati come prostituti da
chiunque potesse pagare, e per questo erano chiamati putos dagli spagnoli46.
Gutiérrez si schiera a favore dell’interpretazione proposta diversi anni
fa da Richard C. Trexler in merito alle relazioni di gender nelle civiltà
precolombiane, nelle civiltà europee e attive nello scontro tra nativi e
43 F. ABBRI, Il silenzio interrotto: antropologia e storia in alcuni studi recenti sui nativi
americani, in M.L. MEONI (a cura di), Culture e mutamento sociale, Le Balze, Montepulciano
2002, pp. 105-120.
44 R.A. GUTIÉRREZ, Warfare, Homosexuality, and Gender Status Among American Indian Men
in Southwest, in T.A. FOSTER (ed.), Long Before Stonewall. Histories of Same-Sex Sexuality in
Early America, New York University Press, New York - London 2007, pp. 19-31.
45 ID., When Jesus Came the Corn Mothers Went Away. Marriage, Sexuality and Power in New
Mexico, 1500-1846, Stanford University Press, Stanford 1991.
46 ID., Warfare, cit., pp. 28-29. Il racconto (1542) di Alvar Nuñez Cabeza de Vaca
(1488/90-1559) contiene molti riferimenti ai berdache e alle attitudini sessuali degli
indigeni della costa del nordest del Texas. Il celebre racconto di Cabeza de Vaca è relativo
agli eventi del 1528-1536, ossia al fallito tentativo spagnolo di conquistare la Florida, al
viaggio in Louisiana, Texas, New Mexico, Arizona e nordest del Messico. Si veda:
Naufragio de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, y Relacion de la jornarda que hizo a la Florida, in
Biblioteca de Autores Españoles desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias. Historiadores
primitivos de Indias, Tomo Primero, Atlas, Madrid 1946, pp. 517-548. A.D. KRIEGER, We
came naked and barefoot. The Journey of Cabeza de Vaca across North America, University of
Texas Press, Austin 2002.
230
Ferdinando Abbri
spagnoli, che è fondata sull’idea dell’esistenza di rapporti gerarchici di
potere47. Contro ogni visione romantica di terzo genere nelle società dei
nativi americani Trexler afferma che il berdache doveva servire
sessualmente capi e nobili di modo che i nobili non molestassero
sessualmente le donne, svolgeva quindi un ruolo obbligato di equilibrio
politico e sessuale48.
La rilevanza di questo tema e di temi ricompresi nelle questioni di
gender nel Vecchio e nel Nuovo Mondo è confermata da molti lavori. Nel
2003 Pete Sigal ha curato un’antologia dal titolo Infamous Desire. Male
Homosexuality in Colonial Latin America che contiene un ampio e
documentato saggio di Trexler sulla gerarchia di genere e sulla
subordinazione sessuale nell’America pre-ispanica nel quale ribadisce, con
una forte vena polemica, le sue tesi contro il canone interpretativo in
termini di un terzo genere49. Questa antologia contiene anche un saggio
sulla «same-sex sexuality and third-gender sexuality» nel mondo andino
pre-coloniale di Michael J. Horswell50. Nel 2005 Horswell ha pubblicato
un volume di indubbio rilievo dal titolo Decolonizing the Sodomite dedicato a
questioni di storia della sessualità nella «colonial Andean culture»51 e nel
quale sono proposte interpretazioni diverse rispetto alla dialettica di potere
individuata da Trexler come parametro fondamentale per comprendere le
sessualità nelle culture dei nativi americani.
Non posso entrare nel merito delle interpretazioni e delle controversie
tra storici sociali ma ritengo che questi sommari riferimenti siano
sufficienti a far comprendere che la storia sociale delle sessualità ha
conosciuto uno sviluppo ragguardevole e rappresenta un capitolo non
trascurabile delle vicende dell’America prima e dopo la colonizzazione.
Le prime grandi storie del Nuovo Mondo si sono strutturate nel duplice
aspetto di storia naturale e di storia generale o culturale e questo modello
47 R.C. TREXLER, Sex and Conquest. Gendered Violence, Political Order, and the European
Conquest of the Americas, Polity Press, Oxford 1995.
48 Ivi, pp. 166-167.
49 ID., Gender Subordination and Political Hierarchy in Pre-Hispanic America, in P. SIGAL
(ed.), Infamous Desire. Male Homosexuality in Colonial Latin America, The University of
Chicago Press, Chicago 2003, pp. 70-101.
50 M.J. HORSWELL, Toward and Andean Theory of Ritual Same-Sex Sexuality and ThirdGender Subjectivity, in Infamous Desire, cit., pp. 25-69.
51 ID., Decolonizing the Sodomite. Queer Tropes of Sexuality in Colonial Andean Culture,
University of Texas Press, Austin 2005.
Historia natural e cultura
231
rinascimentale è stato assai influente per tutta l’Età moderna. Le nuove
informazioni sui mondi altri si inserivano in questo modello che entrò
inevitabilmente in tensione a ragione della ricchezza e problematicità delle
scoperte realizzate grazie a viaggi su scala planetaria. Nella ricerca storica
attuale sulle scoperte geografiche i temi relativi alla natura, al paesaggio
sono indagati da una storia della scienza molto attenta alla dimensione
“coloniale” nelle vicende della scienza occidentale. In questa ricerca i temi
“etici”, di storia “morale” riguardo ai costumi si sono arricchiti grazie ad un
settore più nuovo che è quello della storia sociale delle sessualità che ha
consentito di guardare ad aspetti un tempo trascurati o ignorati. Sacrifici
umani, cannibalismo e sodomia erano visti dai conquistatori spagnoli come
pratiche comuni ai vari popoli del Nuovo Mondo, è pertanto essenziale
tentare di comprendere i contenuti di queste pratiche e i significati ad esse
attribuiti da nativi e da colonizzatori52.
52 P. SIGAL, (Homo) Sexual Desire and Masculine Power in Colonial Latin America: Notes
toward an Integrated Analysis, in ID (eds.), Infamous Desire, cit., pp. 1-24.
ANDRÉS GALERA
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
Ayudados por la física aristotélica, entender la naturaleza es un proceso
sencillo relacionado con la materia y su forma1. La natura es sustancia, el
sustrato primario componente de todos los objetos a considerar; y es
también la forma representativa de cada uno de ellos, la figura que los
identifica definiendo su existir antes y después de comprenderlos como
materia. Multitud de unidades diferentes compusieron el inventario
terráqueo tras la creación. Al inicio soledad, usurpada luego por un
hervidero de seres vivos pululando por el cielo, el mar y la tierra, tal y
como se narra en la Biblia2. Diversidad utilizada por Diderot para
caracterizar la naturaleza imaginando una mujer que ama disfrazarse3. Al
contemplarla, admirarla, surgen las preguntas sin respuesta, tantas como
las mil caras de su presencia, acompañadas de esos momentos absolutos,
existenciales, que Hegel nominó lo bello natural4; expresión del dialogo
interior de cada cual. Primero mirar, percibir los harmónicos rasgos,
entender por qué cada cosa ocupa su lugar. Ni los árboles enraízan en el
cielo ni las nubes transitan por el fondo del mar, escribe el romano Tito
Lucrecio Caro recordando el precepto5. La mecánica, aprender cómo
funciona el conjunto, viene después. Y, como razona Descartes6, la
naturaleza deja de ser una “diosa” reemplazada por el saber.
Inquisitivamente, los hombres conocen la tierra, la transforman generando
identidades que les pertenecen. Construyen un mundo propio, realidad
forjada en la sima de los sueños modelando la indeleble sustancia natural.
El tiempo da la razón a Francis Ponge: la terrenal natura es una
1 ARISTÓTELES,
Física, CSIC, Madrid 1996, p. 37.
Génesis, 1, 1-25.
3 D. DIDEROT, Sobre la interpretación de la naturaleza (edición bilingüe, introducción y notas
de Mauricio Jalón), Anthropos, Barcelona 1992, pp.26-27.
4 G. W. F. HEGEL, Introducción a la estética, Península, Barcelona 2001, p. 11.
5 LUCRECIO CARO, La naturaleza, Akal, Madrid 1990, libro I, p. 211.
6 R. DESCARTES, El mundo. Tratado de la luz, Anthropos, Barcelona 1989, p. 109.
2
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 233-245
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064315
233
234
Andrés Galera
«conmovedora mezcla del pasado de tres reinos»7. Piedras, plantas y
animales combinan sus esencias componiendo singulares momentos cronoespaciales. El presente surgió del ayer y el mañana será la consecuencia de
lo que ocurra hoy adaptándose a las eventualidades. Los errores hodiernos
guían la perfección relativa por venir. Trayectoria polifacética fruto de una
naturaleza constructiva, consumada mediante ese continuado despertar de
formas dormidas «en el sueño de lo inexistente» enunciado literariamente
por Luis Cernuda8. Por el camino, entre tanto ir y venir, nacer y morir,
renovarse, el hombre sueña con Dios. Le sirve, le imita, se identifica.
Andando el tiempo, dos acepciones conexas circulan por la mente de
George-Louis Leclerc, conde de Buffon, al pronunciar la palabra
naturaleza, ideas muy diferentes en su opinión9. La primera, escrita en
mayúsculas, representa el mito al que se vincula causalmente cualquier
fenómeno universal. La otra es su consecuencia: la naturaleza de las cosas,
reducida al limitado conjunto de cualidades propias de los objetos donde se
expresa la mayúscula. Mundo activo y pasivo, causa y efecto, potencia y
acto, en definitiva, de la materia que somos y vemos. Con diferente verso
y similar tono, la naturaleza, suscribe Jean Baptiste Lamarck, es el mayor
sujeto que el pensamiento humano puede abarcar. Da nombre al orden de
las cosas; fue el principio y no tiene fin10. Planteamiento global de uso
corriente para identificarla como un escenario ilimitado repleto de objetos
y fenómenos que interaccionan particularmente. Es el recinto contenedor
de todos los seres aludido por el barón Holbach en su Sistema natural11. El
mundo, relata Gayo Plinio Secundo, apodado el Viejo a diferencia de su
sobrino Plinio el Joven, «no sólo es la propia obra de la naturaleza física
sino también la misma naturaleza física»12. El todo es la suma de las partes
y algo más. La naturaleza simboliza una jerarquía omnipotente, todo lo
F. PONGE, “La tierra”, en ID., Piezas, Visor, Madrid 2006, p. 75.
L. CERNUDA, “La naturaleza”, en ID., Ocnos, El País, Madrid 2003, p. 16.
9 G. L. L. BUFFON, “Discours sur la nature des oiseaux”, in ID., Histoire naturelle des oiseaux,
Imprimerie Royale, París 1770, t. I, pp. 3-4.
10 J. B. LAMARCK, “Nature (la)”, in ID., Nouveau dictionnaire d’Histoire naturelle, J. F.
Deterville, París 1816-1819, 36 vols. Citamos por la recopilación J. B. LAMARCK, Articles
d’histoire naturelle, Belin, París 1991, p. 293.
11 P. H. THIRY barón de Holbach, Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde
moral, Londres 1871, 2ª ed., t. I, p. 2 (1ª ed. 1771. En ambas ediciones la autoría de la
obra se atribuye, falsamente, al fallecido Jean-Baptiste Mirabaud, secretario perpetuo de la
Academia francesa).
12 PLINO EL VIEJO, Historia Natural (lib. I-II), Gredos, Madrid 1995, lib. II, 1, p. 137.
7
8
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
235
abarca y todo lo puede, es una cosa y la contraria. Sus leyes son
inexorables. Hay que «aceptarla como es, con todas sus consecuencias»
escribe Dostoievski13. Lo explica Cicerón con mesura y pedagogía: «nunca
ocurrió lo que no pudo ocurrir, pero si pudo, uno no debe admirarse»14.
Lo corrobora Schopenhauer siguiendo a Plinio, preguntándose ¿cuántas
cosas no juzgamos imposibles antes de manifestarse?15 Receta mágica que la
sabiduría poética de Pessoa embellece escribiendo «Cada cosa a su tiempo
tiene su tiempo»16. Porque la naturaleza, como suscribe Stuart Mill, es un
“nombre colectivo” amplificado por la potencialidad de aquello que puede
sobrevenir. Representa el presente, el pasado y el futuro, da nombre, en
modo cronológico, a todo cuanto acontece17.
La naturaleza es el reino de lo imposible posible, el espacio y el tiempo
donde objetos y fenómenos se agolpan componiendo un coro polifónico
etnocéntricamente dividido en dos categorías ontológicas: lo artificial,
propio del hombre al ser la consecuencia de sus actos; y lo natural, todo lo
demás, incluido él por su condición de especie animal. Diferencia de clase
definida por la peculiar evolución cultural del género humano, que le ha
permitido alcanzar una posición dominante utilizando el conocimiento para
controlar el medio. Específica adaptación tecnológica. Tan particular
comportamiento contradice la actitud conservadora practicada por “los
otros”, quienes canalizan su actividad hacia la supervivencia del individuo y
del grupo mediante la alimentación y la reproducción. Simple adaptación
biológica. La diferencia atañe también al ser humano delimitando su estatus
natural: en armónica relación con una naturaleza, al mismo tiempo, madre
y madrastra – benefactora proveyéndole de los recursos y malvada por ser
la fuente de sus males –, el hombre salvaje se opone al irreverente “hombre
civilizado” capaz de proyectar el futuro utilizando el saber para componer
un mundo a medida, transformándolo en un espurio antropomorfismo de
necesidades y deseos. Un tiempo fuimos los elegidos de Dios para el uso y
disfrute de los bienes terrenales, más tarde, descubierta la indiferencia
F. DOSTOIESVSKI, Memorias del subsuelo, Barral, Barcelona 1978, p. 38.
M. T. CICERÓN, De Adivinatione, UNAM, México 1988, lib. II, XXII, p. 96.
15 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación, Mestas, Madrid 2001,
prólogo, p. 6. La referencia a Plinio corresponde a su Historia Natural, 7, 1.
16 F. PESSOA, Odas de Ricardo Reis, Unidad Editorial, Madrid 1999, p. 53, oda 21 (Odas de
publicación póstuma, 1935-1994).
17 J. STUART MILL, La naturaleza, Alianza, Madrid 1998, pp. 26-27.
13
14
236
Andrés Galera
divina, aceptamos la orfandad con el firme propósito de reedificar a
nuestra conveniencia el espacio terrestre.
El contrapunto a este absolutismo antropológico consiste en observar la
naturaleza como un proceso plural emergente en la relación que los
organismos establecen con el medio. Lo pensó el biólogo Jacob von
Uexküll iniciado el siglo XX18. Aplicando esta polivalente interpretación
habrá infinitas modulaciones relacionadas con igual número de especies, o
grupos, que habitan la Tierra. Modulaciones reguladas por la capacidad de
los individuos para generar y transmitir información. Extremando la idea,
obtendremos una explicación múltiple de la realidad compuesta por tantas
percepciones como organismos la conforman dado que su relación es
exclusiva. Es el mundo en multirepresentación, diríase aplicando
maximalistamente el concepto de Schopenhauer: la realidad como un
hecho que cada ser percibe en relación a sí mismo19. Fórmula individual
que manifiesta todo su potencial cuando se orienta hacia el colectivo
compartiendo información y generando memoria histórica. En caso
contrario se disipa con la muerte del sujeto. «Cada hombre es memoria»
concluye el filósofo Emilio Lledó enjuiciando el problema
informativamente. Desde el olvido, sin recuerdos, sin memoria, la vida
sería un vació, sería «un eterno presente, un comenzar cada día en la más
absoluta soledad y, por supuesto, en la más absoluta imposibilidad»20. En
este imaginado e interactivo escenario natural, teatro de la percepción y
del conocimiento, aunque sea sólo en la obligada y reducida esfera
biológica del sobrevivir, la idea de naturaleza adquiere un valor centrípeto:
gira alrededor de quien la define y representa.
Para la humanidad, la naturaleza es una colección de seres y aconteceres
sorprendentes tanto por lo que revelan como por lo que esconden.
Identidades ocultas cuya comprensión resulta aún más difícil.
Contemplándola, los interrogativos qué, cuál, cómo, dónde, cuándo,
porqué, pululan en la mente del hombre porque, como cualquier ser vivo,
es un descubridor, primero inducido por la necesidad – cuestión de
J. VON UEXKÜLL, Theoretische Biologie, Gebrüder Pastel, Berlín 1920; ID., Ideas para una
concepción biológica del mundo, Espasa Calpe, Madrid 1922. Cfr. también la reedición
francesa de J. VON UEXKÜLL, Mondes animaux et monde humain (suivi de La théorie de la
signification), Denoël, París 2004.
19 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación, Mestas ediciones, Madrid
2001, p. 13.
20 E. LLEDÓ, Elogio de la infelicidad, Cuatro ediciones, Valladolid 2005, p. 21.
18
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
237
supervivencia –, luego, además, atrapado por la curiosidad y la vanidad.
Así aparecen los creadores y pensadores protagonistas de la historiografía
escrita por Daniel J. Boorstin21. Un tropel de observadores, anuncia
Condorcet22 recuperando la utopía baconiana23 de una sociedad construida
por y para la ciencia, recorre sin cesar el globo terrestre para conocerlo.
Pretenden averiguar sus más íntimos secretos. Todos desenredan el mismo
ovillo. Tiran del hilo con la intención de desvelar los misterios del
universo. «Cada filósofo explica algún secreto de la naturaleza», leemos en
la Metafísica aristotélica. Hallazgos que aisladamente son poca cosa, pero es
el conjunto lo que cuenta24. El científico, intuye Francis Bacon, debe mirar
hacia adelante. Lo importante no es lo ya hecho sino lo que queda por
hacer25. Descartes, por su parte, lo tuvo claro. Sumando voluntades, su
Discurso del método explica que la comunicación es la mejor manera de
traspasar los límites cognitivos impuestos por la brevedad de la vida y los
errores experimentales. La clave consiste en comunicarse para compartir
objetivos, experiencias y resultados, convirtiendo la investigación en una
empresa conjunta de suerte «que los últimos comiencen donde terminaron
los anteriores, y así, uniendo las vidas y los trabajos de muchos, lleguemos
todos juntos bastante más lejos de lo que se lograría individualmente»26.
Esfuerzo común, lo califica Goethe, necesario para despejar el camino de
obstáculos y prejuicios27. Tiene razón el médico y filósofo francés Julien
Offroy de La Mettrie, otro cartesiano. No basta con escudriñar la
naturaleza, el conocimiento debe ser compartido en beneficio de quienes
pueden y quieran pensar28. Somos, como anuncia el verso contemporáneo
del poeta Caballero Bonald29, el tiempo que nos queda, individual y colectivo.
Durante la espera, el estudio de la naturaleza se formaliza como la tarea
D. J. BOORSTIN, Los descubridores, Crítica, Barcelona 1986; ID., Los creadores, Crítica,
Barcelona 1994; ID., Los pensadores, Crítica, Barcelona 1999.
22 M. CONDORCET, Fragmento sobre la Atlántida (edición de Mauricio Jalón), Silvio
Berlusconi Editore, Milán 2005, p. 3.
23 F. BACON, Nueva Atlántida, Silvio Berlusconi Editore, Milán 1996 (1ª ed. Nova Atlantis,
1627).
24 ARISTÓTELES, Metafísica, Espasa Calpe, Madrid 1988, lib. 2, I, p. 71.
25 F. BACON, Scritti filosofici (edición de Paolo Rossi), UTET, Turín 1975, p. 116.
26 R. DESCARTES, Discours de la Méthode. Citamos por la edición de Charles Adam & Paul
Tannery en Oeuvres de Descartes, Léopold Cerf, París 1902, vol. VI, p. 63.
27 J. W. VON GOETHE, Teoría de la naturaleza, Tecnos, Madrid 1997, p. 67.
28 J. OFFROY DE LA METTRIE, L’Homme-Machine (estudio introductorio de Paul-Laurent
Assoun), Denoël, París 1999, p. 143 (1ª ed. 1748).
29 J. M. CABALLERO BONALD, Somos el tiempo que nos queda, Seix Barral, Barcelona 2004.
21
238
Andrés Galera
común, y la indagación falla cuando incumplimos la norma impuesta por
Goethe: conocer plenamente sus fenómenos y sustraerlos con la
reflexión30. En su devenir social, paulatinamente el hombre es capaz de
inventar el universo, estudiarlo, imaginarlo, y representarlo en la mente
del animal simbólico idealizado por Ernst Cassirer31 como eje de una
civilización confundida y desdibujada por los intereses del animal racional
que queremos ser. Aprendemos construyendo un mundo virtual,
incompleto por el conocimiento parcial de unos sucesos atribuidos a causas
verdaderas mientras no se demuestre lo contrario. Causas ciertas en tanto
convengamos considerarlas incontestables, es decir, como sucesos que nadie
negaría aplicando el sentido común; y esto es lo más cercano a la verdad
que podemos aspirar a llegar. Lo explica Bertrand Russell32.
Usando el intelecto descubrimos una naturaleza inestable tanto por
nuestras carencias intelectuales como por su mutabilidad. Fenomenología y
composición varían durante la cronología terrestre caracterizándola como
un proceso histórico sin fin. Y no lo tiene porque, escribía Goethe, «ella
tiene, es, vida y sucesión desde un centro desconocido hacia un confín
incognoscible»33. Criterio de incertidumbre que no fue, ni es, ni será
compartido por todos. Por ejemplo, el reiterado Plinio, al redactar los
treinta y siete libros de su magna Historia natural, ufano y pretencioso,
sentencia: «Sólo yo entre los romanos he descrito completamente la
Naturaleza»34. En cierto modo, le acompaña la razón. Él cuenta lo que ha
visto, oído, leído, e imaginado. Verdades, mentiras, sueños, fantasías,
componen una memoria colectiva deficiente pero completa puesto que lo
desconocido no puede nombrarse, existe pero es invisible, permanecerá
oculto hasta que alguien lo vea, o se lo imagine, y comparta la información,
sólo entonces el objeto se hace visible, tendrá un sitio en los anales de la
historia natural. La cúpula de esta imaginada sala de espera es el universo
intuitivo idealizado por Platón en su Timeo. El reino de lo invisible-visible.
Principio de plenitud se denomina. Bajo esta ley cualquier objeto capaz de
existir lo hace realmente, aunque no lo veamos. Aristóteles fue comedido
J. W. VON GOETHE, Teoría de la naturaleza, Tecnos, Madrid 1997, p. 175.
E. CASSIRER, An Essay on Man. An Introduction to Philosophy of Human Culture, Yale
University Press, New Haven 1944.
32 B. Russell, “La filosofía del atomismo lógico”, en J. MUGUERZA (ed.), La concepción
analítica de la filosofía, Alianza, Madrid 1974, v. 1, pp. 140-1.
33 J. W. VON GOETHE, Teoría de la naturaleza, Tecnos, Madrid 1997, p. 207.
34 PLINO, Historia Natural, lib. XXXVII, 77, 3.
30
31
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
239
al aplicar esta función multiplicadora, puso límites a la imaginación porque
hay cosas imposibles: «suponer que lo que no existe, pero que es posible,
existe realmente o ha existido, es admitir que no hay nada imposible», y lo
hay35. Su teoría, es decir, lo que sus ojos vieron y su mente procesó,
relaciona los objetos formando una naturaleza secuencial, encadenada,
donde cada unidad comienza con la anterior: «Toda cosa intermedia es
precedida y seguida de otra, y la que precede es necesariamente causa de la
que sigue»36. Consecuentemente, la variabilidad queda restringida y
programada por esta conexión causal que delimita la expresión tipológica.
Es la voluntad de la naturaleza, concede el filósofo Schopenhauer en
tiempo y lugar diferentes para abordar el problema convirtiendo la forma
en una manifestación particular de la materia37. Voluntad que el sabio griego
concibe como un plan estructural continuo, relacionando los objetos
naturales por su creciente grado de complejidad. Desde las piedras hasta el
hombre, desde el átomo hasta Dios exclama el irreverente Voltaire38.
Como todas, la moneda natural aristotélica tiene dos caras39. Una, la
naturaleza necesaria, representa un esquema anatómico común, constante e
inalterable, fundamental para la vida. La otra, la naturaleza según la razón,
es la responsable de la diversidad tipológica adecuada a sus múltiples fines.
Juntas componen un modelo teleológico donde los seres vivos se suceden
cada vez más dotados de vida y movimiento. El invento tiene el nombre de
escala natural o cadena de los seres. Idea afortuna por los siglos, sintetizada
por Linneo bajo el lema la naturaleza no da saltos que Darwin utilizó al
formular su teoría evolutiva hilvanando la historia de la vida con el hilo
pétreo de la paleontología40.
Relata Ovidio en su Metamorfosis, escrita en la primera década de la era
cristiana, que antes de existir la tierra, el cielo y el mar, la naturaleza
estaba desnuda, era una masa informe, confusa amalgama de semillas de las
cosas futuras. Caos se llamaba41. Un texto mitológico donde los dioses
ARISTÓTELES, Metafísica, Espasa, Madrid 1988, lib. 9, IV, p. 234.
Ibidem, lib. 2º, II, p. 73.
37 A. SCHOPENHAUER, Sobre la voluntad de la naturaleza, Alianza, Madrid 1987, pp. 103104.
38 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, <<Chaine des êtres crées>>, t. II; en Oeuvres de
Voltaire, París, Werdet et Lequien, 1829, t. XXVII, p. 560.
39 Seguimos el análisis de Schopenhauer en Sobre la voluntad de la naturaleza, Alianza,
Madrid 1987, p. 100.
40 C. DARWIN, On the Origin of Species, Murray, Londres 1859, p. 206.
41 OVIDIO, Metamorfosis, I, 5-20.
35
36
240
Andrés Galera
ponen orden sobre la Tierra. Contrariamente, en De rerum natura, original
de Lucrecio Caro unos sesenta años antes, leemos que «cuando hayamos
comprobado que nada puede surgir de la nada, entonces descubriremos
más fácilmente lo que investigamos: de qué componentes puede cada cosa
formarse y cómo se producen todas sin la intervención de los dioses»42. El
ideario de Lucrecio se cobija en la arbórea sombra del materialismo
atomista confeccionado por Demócrito, quien imaginó descomponer la
naturaleza en invisibles partículas atómicas responsables de las propiedades
del universo. Al contrario de lo que parece, la propuesta no renuncia al
acto divino sólo lo anticipa, lo sitúa en el origen de la materia eliminando
del desarrollo posterior cualquier intervención ajena al sistema.
Transcurridos diecinueve siglos de la era cristiana Darwin – antes
Lamarck43 – utilizó similar fórmula conciliando evolución y religión. La
selección natural darwiniana es la mano alargada de Dios que mece la cuna
de la vida transformándola44. Creer en dioses o en el hombre, magia o
ciencia, fue, es, la alternativa para una civilización atrapada por la
incerteza. El hombre, como razonó Bacon45, teme más a la duda que al
error y se ilusiona con establecer principios infalibles, reales o no, que
salvaguarden, aparentemente, su frágil existencia legitimando los actos.
Preferimos equivocarnos a caminar por el tenebroso sendero de lo
desconocido. Indudablemente, magia y ciencia enfocan el problema desde
ángulos opuestos pero coinciden en la finalidad última: reparar la situación
de incertidumbre y desconocimiento implícito en nuestro convivir. Hay,
pues, comunión en los fines y, también, cierta unidad de origen dado que
ambas interpretaciones proceden de nuestro nexo con la naturaleza,
convertido en acontecimiento intelectual. Históricamente, la explicación
sobrenatural – mágica, religiosa – es el primer acto de nuestra
aproximación a la realidad. Durante el segundo, los científicos convierten
los sucesos que pueden en elementos conocidos y controlados por el
hombre. Entre estos episodios se establece un vínculo cronológico
LUCRECIO CARO, La naturaleza, Akal, Madrid 1990, lib. I, p. 106.
Cfr. A. GALERA, “Lamarck y la conservación adaptativa de la vida”, Asclepio, 2(2009), pp.
129-140.
44 Cfr. A. GALERA, “Creating evolution”, en M.A. PUIG-SAMPER, R. RUIZ, A. GALERA (eds.),
Evolución y cultura, Junta de Extremadura-UNAM-Doce Calles, Madrid 2002, pp. 13-20; ID.,
“Crear la evolución. El fundamento religioso del origen de las especies”, Atalaia-Intermundos
(Lisboa), 8-9(2003), pp. 141-147 (también en www.triplov.com/creatio/galera.htm).
45 Cfr. la presentación de Paolo Rossi a Francis Bacon, Dei principi e delle origini (edición de
Roberto Bondì), Bompiani, Milán 2005, p. 11.
42
43
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
241
representado por un paulatino y unidireccional goteo informativo, de
suerte que el conocimiento deja de ser mágico a medida que racionalmente
somos capaces de acercarnos a los hechos. Los milagros, explica Gian
Battista Porta, ya no lo son cuando averiguamos por qué ocurren46.
Gradualmente el conocimiento sustituye a la ignorancia pero somos
impacientes y durante el intervalo tenemos la necesidad, sentimos la
tentación, de justificar lo desconocido aplicando propiedades
extraordinarias que nos confortan eliminando el tenebroso vacío donde
mora la existencia. Bajo el prisma de este horizonte interminable, la
naturaleza se manifiesta como un intemporal escenario ocupado ad líbitum,
a voluntad, de Dios o de la ciencia, creándose una inmensidad estimulante
y aterradora: el infinito. El término abruma y reconforta, es, como intuye
Edgar Allan Poe, «un intento posible hacia una concepción imposible»47
que, ficticiamente, aproxima el inconmensurable universo que nos rodea a
la temporalidad de la vida que representamos. Paradoja que desazona
inevitablemente.
En su Historia Plinio propone limitar la actuación humana al finito
universo habitado. Es un argumento epistemológico necesario para
equilibrar nuestras pocas entendederas frente a la inmensidad del orbe. La
razón aconseja no ampliar el horizonte cognitivo sobrepasando nuestra
capacidad intelectual. Sería temerario, un desvarío vamos, creer en otros
mundos cuando ni tan siquiera alcanzamos a organizar el propio48.
Perdiendo el miedo al espacio y al tiempo, elevados en el firmamento
intelectual sobre un cúmulo de saberes suficientes para mirar al fantasma
de la infinitud sin perder el norte, hombres, como Nicolás Copérnico,
aplicaron su inteligencia al estudio de las «maravillosas revoluciones del
mundo y del curso de los astros, de las magnitudes, de las distancias, del
orto y del ocaso y de las causas de todo lo que aparece en el cielo»49.
Otros, como Leeuwenhoek, aprovechan el microscopio para cruzar la
frontera de lo infinitamente pequeño; y hubo quienes, como Fabio
Colonna, caminaron entre rocas identificando la vida fósil. El trasfondo
teórico de tan excéntrico comportamiento es, sencillamente, la eterna
cuestión de saber qué conocer y cómo hacerlo para explicar el porqué de
G. B. PORTA, Della magia naturale, Antonio Bulifon, Nápoles 1677, p.5.
E. A. POE, Eureka, Alianza, Madrid 1972, p. 29.
48 PLINO EL VIEJO, Historia Natural, Gredos, Madrid 1995, lib. II, 1, p. 138.
49 N. COPÉRNICO, Sobre las revoluciones, Altaya, Barcelona 1994, lib. I, p. 13 (De
revolutionibus orbium coelestium libri VI, 1543, lib. I, p. 7).
46
47
242
Andrés Galera
una naturaleza necesaria y huidiza a nuestro entendimiento. En su vertiente
filosófica, el oráculo de Delfos nos allana el camino: conócete a ti mismo
aconseja el famoso lema inscrito en el santuario de Apolo. A simple vista el
mensaje sugiere una actitud introspectiva, pero su significado va más allá
de la literalidad de las palabras. Conocerse es sinónimo de una
individualidad sujeta al colectivo. Podemos aislarnos pero,
inevitablemente, la sombra grupal alcanza al sujeto y, puesto que nunca
seremos otra cosa que una efímera pieza de un inmenso rompecabezas,
sólo conociendo el conjunto, la naturaleza, conoceremos al individuo. El
hombre, nos recuerda Jean Rostand, «es soluble en la naturaleza»50 y,
conscientes o no, al estudiar el universo buscamos una identidad. Tuvo
razón Jacques Monod afirmando que la aspiración última de la ciencia es
«dilucidar la relación del hombre con el universo»51. Conocemos para
conocernos y la travesía será larga, tanto como nuestra existencia grupal.
En su trasnochado y celebre tónico de la voluntad52, Santiago Ramón y
Cajal subraya la esterilidad de la metafísica para adivinar las leyes naturales.
Pitágoras, Platón, Descartes, Hegel, Bergson, todos perdieron el tiempo.
Sus esfuerzos son dignos de conmiseración y disgusto. Conmiseración «por
el talento consumido persiguiendo quimeras», disgusto «por el tiempo y
trabajo lastimosamente perdidos»53. El intelecto cajaliano es empírico por
activa y por pasiva, útil sólo cuando observa, describe, compara y clasifica
los hechos para conocerlos54. Afortunadamente, el celo positivista no es lo
único que cuenta a la hora de interactuar con la naturaleza. ¿Cómo hacerlo
pues? El dilema se resuelve actuando abiertamente, sin exclusiones,
rastreando opciones diferentes. Leer este inmenso libro requiere un
enfoque plural porque, siguiendo a Rostand, la dictadura de métodos e
ideologías «entorpece el desarrollo de la verdad»55. Cobijados bajo este
paraguas multicolor, la reacción antisistema de Feyerabend no parece
descabellada; y refutar la racionalidad única, excluyente, de una ciencia
J. ROSTAND, El hombre y la vida. Pensamientos de un biólogo, Fondo de Cultura Económica,
México 1960, p. 60.
51 J. MONOD, Le hasard et la nécessité, Seuil, París 1970, p. 11.
52 Citamos por S. RAMÓN Y CAJAL, Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de
la voluntad, CSIC, Madrid 2005.
53 Ivi, p. 21.
54 Ivi, p. 22.
55 J. ROSTAND, Science fausse et fausses sciences, Gallimard, París 1958, p. 73.
50
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
243
concebida y regida por reglas fijas56 resulta, incluso, conveniente. No
hacerlo sería ingenuo, irreal, pues la historia, como escribo en otro lugar57,
demuestra que saltarse las reglas es una regla utilizada por los sabios para
levantar el irregular templo de la ciencia. El principio de todo vale58 tiene valor
si aplicamos el sentido común. ¡El menos común de los sentidos! Aquí
radica el problema.
Atendiendo al sentido común de David Hume59, pensar la naturaleza es
una cuestión dual. La comprensión se cimenta sobre dos tipos de
operaciones: la elaboración de ideas y la información sonsacada a los
hechos60 – la razón y la observación aristotélica; las ideas y los objetos
sensibles de Platón; el sujeto y el objeto kantianos-. La razón custodia las
ideas, construidas como estructuras teóricas ciertas al margen de su
existencia real – la validez del teorema de Pitágoras es independiente de la
existencia del triángulo rectángulo –, y la experiencia da sentido a las
observaciones. Este sui géneris binomio intelectual gobierna el deseo de
saber presente, según Aristóteles61, en todos los hombres. Con su filosofar
escéptico Hume explica que, al percibir un hecho, el observador se
enfrenta a un mero acontecimiento descriptivo que no permite dilucidar ni
la causa ni el efecto. Pretender lo contrario sería errado.
Complementariamente, la reiterada observación del suceso confirma la
fenomenología y desencadena un proceso cognitivo automático e intuitivo
basado en el recuerdo, que anticipa el resultado en función de las
observaciones precedentes. La experiencia acumulada se convierte en un
conocimiento por costumbre al margen del raciocinio62. Funciona a modo de
un instinto natural «que ningún razonamiento o proceso de pensamiento y
comprensión puede producir o evitar»63. Con diferente manera de
discurrir, el fisiólogo Claude Bernard expone que, espontáneamente,
56 P. K. FEYERABEND, Contra el método, Folio, Barcelona 2002. Cfr., por ejemplo, pp. 23 y
122.
57 A. GALERA, Ciencia a la sombra del Vesubio. Ensayo sobre el conocimiento de la naturaleza,
CSIC, Madrid 2003, p. 216.
58 P. K. FEYERABEND, Contra el método, Folio, Barcelona 2002, p. 24.
59 D. HUME, Investigación sobre el conocimiento humano, Mestas, Madrid 2003 (An Enquiry
Concerning Human Understanding, Londres 1748).
60 Ivi, p. 39.
61 ARISTÓTELES, Metafísica, cit., lib. 1º, I, pp. 36.
62 D. HUME, Investigación sobre el conocimiento humano, Mestas, Madrid 2003, pp. 55-60.
63 Ibídem, p. 60.
244
Andrés Galera
nuestra primera opción es «interpretar los fenómenos de la naturaleza por
anticipación, antes de conocerlos por la experiencia»64. En la esfera
dialéctica de Adam Smith esta primaria conexión mental con el medio
prorrumpe como una asociación de ideas que, oportunamente consolidada
por la repetición, se conecta con la imaginación en grado de independizar
el pensamiento de la acción material. Todo sucede fluidamente, sin
pensar65. Con intención o sin ella, interaccionamos con la naturaleza y, con
la información obtenida, aproximamos el mundo interior a la realidad.
Seguimos a Pessoa afirmando que ser civilizado consiste en dar nombre a
las cosas y soñar sobre ellas inventando una realidad66. Al final, como
escribe Lledó, entre lo real y la mente quedan las palabras, los nombres de las
cosas, porque nombrarlas «es aprender a mirar, a contemplar lo real, para
tocarlo, para usarlo si es preciso, pero sobre todo para entenderlo»67.
Aprendemos equivocándonos, cometiendo errores. Confiamos en un saber
relativo donde lo verosímil constituye la mejor baza epistemológica.
Nuestra fe en las ciencias naturales, señalaba Condorcet, tiene su
fundamento en la «idea de que, conocidas o no, las leyes generales que
rigen los fenómenos del universo son necesarias y constantes»68. Otro
ejemplo, en su introducción a la estética Hegel vincula el término naturaleza
a la idea de necesidad y regularidad propias de la ciencia, contrapuesta a la
arbitrariedad y anarquía de la acientífica imaginación69. Confiando en
letanías similares emprendimos, y continuamos, la búsqueda del
reglamento universal: la versión laica del santo grial. Anhelamos descifrar
el códice para pilotar el barco con mano de hierro, transformando la
naturaleza en un laboratorio experimental donde poder actuar con
premeditación recreándola artificialmente a nuestra imagen y semejanza. «Al
averiguar las leyes de la naturaleza podemos esperar manipularla, y así la
C. BERNARD, Introduction a l’Étude de la Médicine expérimentale, J. B. Bailliére, París 1865,
p.48.
65 A. SMITH, “Los principios que presiden y dirigen las investigaciones filosóficas, ilustrados
por la historia de la astronomía”, en ID., Ensayos filosóficos, Pirámide, Madrid 1998, p. 52
(Essays on Philosophical Subjects, Londres 1795).
66 F. PESSOA, Libro del desasosiego, Seix Barral, Barcelona 1998, p. 54.
67 E. LLEDÓ, Elogio de la infelicidad, Cuatro ediciones, Valladolid 2005, p. 33.
68 M. CONDORCET, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, París 1795,
p. 327.
69 G.W.F. HEGEL, Introducción a la estética, Península, Barcelona 2001, p. 30.
64
Argumentos sobre una naturaleza antrópica
245
ciencia se hizo el origen del poder», aclara Bertrand Russell70 a quienes
permanezcan en la inopia. Atrapados en la red de una ciencia,
supuestamente, infalible, el hombre reemplaza la necesidad de conocer por
la ambición de saber. Anhelamos ser el dios en miniatura anunciado por
Pierre Grassé71 aunque sucumbamos en el empeño. El pequeño dios está
enfermo, subraya Grassé. Y lo está. La humildad no nos caracteriza. Hace
tiempo que la soberbia, el dislate científico, el arrogante estatus de su
práctica y de los practicantes, ofuscan el entendimiento. Embarcados en la
nave de la ciencia soñamos con la eternidad, contemplamos el universo
cautivos del deseo de perpetuarnos olvidando que somos un suceso
evolutivo con fecha de caducidad. Que lejos quedan, y pocos recuerdan,
las palabras iniciales de Holbach: «El hombre es obra de la naturaleza,
existe en la naturaleza, está sometido a sus leyes, no puede franquearla, ni
siquiera con el pensamiento»72.
Abstract
The human being knows the nature of necessity and curiosity. This
secular process is an act of identity that defines their existence and their
behavior within nature. This paper is a reflection on the anthropic
principle applied by man to know the nature, converted into intellectual
patrimony.
70 B. RUSSELL, La perspectiva científica, Planeta-De Agostini, Barcelona 1986, p. 78 (The
Scientific Outlook, G. Allen & Unwin, Londres 1949).
71 P. GRASSE, Toi ce petit dieu, Albin Michel, París 1971.
72 P. HENRI THIRY barón d’Holbach, Système de la nature ou des lois du monde physique et du
monde moral, cit., 2ª ed., t. I, p.1.
DOLORES MARTÍN MORUNO
Feeling Nature: Emotions and Ecology
Ecology in the History of Emotions
During the last three decades, an increasing number of books, articles
and conferences have proposed innovative perspectives in order to explore
to what extent emotions such as anger, fear, boredom, jealousy or
resentment are not merely universal feelings that are biologically based.
These works have also attempted to explain how these emotions have
evolved during different periods and in different cultures according to
gender, class and race differences. Although we all feel emotions such as
love, pain or hate, we cannot take their experience for granted and assume
that they have been considered in the same way throughout history and in
different social communities. This way of understanding the emotional life
of the past, which has been supported by scholars such as Barbara H.
Rosenwein, Peter Stearns and William Reddy, is typical of what has been
called “the History of Emotions”, a burgeoning field of research that cannot
be conceived as a specialized discipline, but rather as multidisciplinary
research that integrates social, cultural, political and scientific aspects of
the evolving conception of emotions1.
Drawing on these considerations, this essay aims to explore the
emergence of “ecology”, a term that was coined by the German biologist
Ernst von Haeckel (1834-1919), not merely as a scientific discipline to
describe the mutual relations of plants, animals, geography and the climate
1
The History of Emotions is deeply inspired by Friedrich Nietzsche’s idea of
elaborating a history of passions, Johan Huizinga’s cultural history and Lucien Febvre’s
history of sensibilities. The contributions, which have inaugurated the history of emotions
as a contemporary field of research, are those of Carol and Peter Stearns (STEARNS,
STEARNS, 1985), William Reddy (REDDY, 2001), Barbara Rosenwein (ROSENWEIN, 1998)
and Thomas Dixon (DIXON, 2003). Other relevant works focused on examining particular
affective states such as, fear, envy and pain are Joanna Bourke (BOURKE, 2006) Elena
Pulcini (PULCINI, 2011) and Javier Moscoso (MOSCOSO, 2011).
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 247-261
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064316
247
248
Dolores Martín Moruno
to each other and to their environment, but rather as an emotional
experience that has a history with multiple implications in the scientific
domain such as, the assessment of the ecological model as we understood it
today2. Therefore, I will argue in this essay how Romantic ecology
emerged in a concrete historical period, known as Romanticism, as a
complex emotional response that was aimed at protecting the natural
environment from its increasing exploitation at the hands of human
technology. Even though the intimate connections between Romantic
culture and ecology have been widely recognised in critical literature on
Romanticism, in some works belonging to the history of science and,
notably, in the tradition termed as “ecological criticism”, their relationship
remains problematic, as ecological concerns were expressed at that time
by means of a variety of terms and, even, poetical metaphors that need to
be carefully analysed3. With the aim of shedding light on the ways in which
Romantic culture provided a fertile ground for the development of
ecological concerns, I will analyse the origins of this sentiment of unity
with nature from the point of view of the history of emotions, in order to
demonstrate how this revolutionary way of feeling would only appear in
relation to the early 19th century Romantic cult of sensibility by means of
the exaltation of emotions such as pain, nostalgia, the sublime and love.
As I shall show, the history of ecology proposes an excellent example of
how emotions were considered as not only individual, but also cultural
phenomena, which are embedded in social communities that «define and
assess as valuable or harmful to them, the evaluations that they make about
others’ emotions; the nature of the affective bonds between people that
2
In this study, I will use the term “Romantic ecology” in order to refer to the
sentiment of unity with nature, which is different to the use of ecology as “ecological
science” proposed by Ernst Häeckel’s Generelle Morphologie der Organismen (HÄECKEL,
1866). However, my attempt here is to demonstrate that Romantic sensibility is at the
roots of further scientific developments such as Haeckel’s ecology, and how it can be
retraced from the point of view of the History of Emotions.
3
The works of Jonathan Bate (BATE, 2000), Karl Kroeber (KROEBER, 1994), Jim
McKusick (MCKUSICK, 2010), Timothy Morton (MORTON, 2007), Onno Oerlemans
(OERLEMANS, 2002) and Kate Rigby (RIGBY, 2004) are some examples of this academic
tradition that studies the relations between Romanticism and Ecology framed in the field
of Ecocriticism. Other works that propose fresh perspectives to interpret the Romantic
origins of ecology in the context of the History of Science are those of Robert J. Richards
(RICHARDS, 2008) Andrew Cunningham and Nicholas Jardine (CUNNINGHAM, JARDINE,
1990) and Stefano Poggi and Maurizio Bossi (POGGI, BOSSI, 1994).
Feeling Nature: Emotions and Ecology
249
they recognize; and the modes of emotional expression that they expect,
encourage, tolerate, and deplore»4. In this sense, ecology was a Romantic
invention that should be regarded as the implementation of a collective
project, which was conducted by a plethora of artists, scientists and
philosophers belonging to European Romantic circles such as British
Romanticism or German Naturphilosophie. In these late 18th and early 19th
intellectual milieu, a new sensibility emerged that was inspired by the
urgent necessity of developing a model to bring about reconciliation
between man and nature, a model that would, furthermore, assure the
well being of future generations on Earth.
Although the harmony of nature is a principle which has oriented
scientific works since Ancient Greece, such as those of Theophastrus (372286 B.D.) and Pliny the Elder (23-79 A.D.), this article states that ecology
is as a relatively modern way of feeling, that can only be traced back to late
18th and early 19th century Western societies. Its emergence can be
considered a reaction to the impact that the Industrial Revolution had on
human life. According to James C. McKusick, ecological concerns only
became urgent for people «who lived at the dawn of the Industrial era» and
saw the green world as «a remote, mysterious and magical place that
existed in sharp disjunction from the smoke, crowed streets and noisy
machinery of the city, where they lived»5. This is why emotions such as
melancholia and nostalgia toward the past times, which expressed a
particular yearning for the “good old days”, were fundamental forces in
constituting ecology as a common Romantic sensibility that marked the
desire to repair the physical and moral injury that man had inflicted on
nature by means of its demotion to a mere material resource6.
Following this approach, the Romantic invention of nature should be
understood as being intimately linked to the early 19th century process of
industrialisation that had not only transformed the natural environment
into an urbanised landscape, but one that was also threatening to turn
human life into a new type of artificial existence by means of introducing
technology in the most intimate areas of human experience7. In this
4
B. ROSENWEIN (2002, pp. 821-45).
MCKUSICK (2010, p. 70). See also BATE (BATE, 2000, p. 137) to explore how the
word “pollution” took its modern sense during the Romantic period.
6
To explore the meanings of Romantic nostalgia and its implications in our
contemporary societies, it is of special interest to consult Eva Illouz (ILLOUZ 1997, p. 94).
7
See OLSON (1991).
5
250
Dolores Martín Moruno
respect, the Industrial revolution represented not only a change of
awareness towards environmental problems, but also a broader cultural
transformation concerning the affective experience of one’s self in one’s
relation to nature, a new awareness that was aroused by the painful
separation of human being from its natural origins.
According to this Romantic mythology, the apparition of modern
science was interpreted as the culmination of the modern analytic
approach, which had its major exponents in René Descartes’ Principia
Philosophiae (1677) and in Isaac Newton’s Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (1686). In this sense, the first ecological contributions were
encouraged by the Romantic desire to restore the lost harmony between
men and nature by means of creating an alternative scientific model to the
mechanical understanding of the universe as an object, which was
controlled and manipulated in order to achieve social and economic
progress in Western countries. Therefore, Romantics understood that the
Enlightenment project had destroyed nature by promoting values such as
knowledge and power over all things, which had led to an increasingly
industrialised world, one that endangered the survival of animal species,
and even human existence itself in its overpopulated urban spaces. As
William Blake wrote about the apocalyptic vision of modern city:
And Building Arches high & Cities turrets & towers & domes
Whose smoke destroyed the pleasant gardens & whose running Kennels
Choked the bright rivers burdening with my Ships the angry Deep8.
It is for these reasons that the Romantic Movement has been considered
as the origins of the “Green movement” in ecological criticism. It
announced the arrival of a new sensibility towards nature that not only
contributed to the creation of ecology in the second half of the 19th century
as the «whole science of relations of the organism to the surrounding
environment, which includes in the broad sense all the conditions of
existence», but rather to the development of other social and political
contemporary movements, such as «environmental ethics and
environmental activism»9. As I shall demonstrate, by means of the analysis
of some selected writings of Jean Jacques Rousseau, Friedrich von
8
9
BLAKE (2008, p. 390).
HÄECKEL (1886, p. 286) and HUTCHINGS (2007, p. 176).
Feeling Nature: Emotions and Ecology
251
Hardenberg, Johann Wilhelm Ritter and Alexander von Humboldt,
Romantic concerns about nature’s vulnerability would lay the foundations
of our modern attitude of care for the physical world by means of the
celebration of emotions such as, nostalgia, love and the sublime, which
would become ways of seeing and experiencing how everything is
connected to everything else in the Universe.
Feeling Nature in Romantic Culture
We are still today very much in debt to the Romantic Era, when we
deal with emotions in the Western tradition. For instance, our
contemporary belief that life should be lived with intensity, with heart and
with style, almost as if every human life were a unique work of art, comes
from the Romantic period, a decisive moment in the History of Emotions
in which feelings were valued as the best way to express our subjectivity
becoming, furthermore, the source of creation in poetry, literature,
painting and, even, in science. As Robert Solomon, David Vallins and
Keith Oatley have pointed out, Romanticism should be interpreted as a
crucial period in Western cultural life, when passions became the most
powerful force of human behaviour and, moreover, the guarantee of our
authenticity10. As a culmination in the European cult of sensibility that can
be traced back to 18th century sentimentalism, the Romantic
understanding of emotions emphasized their status as natural and
spontaneous experiences, which are not easily separable from rational
thinking and, furthermore, that connected us with nature as the place
where one’s real identity is revealed11.
Nature was imagined in Romantic literature and art as the ultimate
force that gave free rein to our sentiments and feelings in the greatness of
mountains, glaciers or the ocean as is shown through paintings portraying
10
OATLEY, KELTNER, JENKINS (1996), SOLOMON (1993) and VALLINS (1999).
VALLINS (1999, p. 6). Thus, rational arguments were conceived as dependent on
sensation, emotion and intuition and, therefore, the process of articulating concepts and
arguments itself influenced these non-rational elements in the thinker resulting a
continuum of feelings and ideas. To understand the emergence of the category of
sensibility in the late 17th century as well as its relations with the 18th century “brain
nervous revolution” is necessary to consult, Georges S. Rousseau (G. S. ROUSSEAU 1963).
11
252
Dolores Martín Moruno
landscapes such as Caspar Friedrich’s Wanderer Above the Sea of Fog (1818)12.
This Romantic conception of nature as the place in which a human being
revealed his most intimate feelings was in stark contrast to the artificial
culture that was considered as a product of corrupted civilisation. This
view was first expressed by the philosopher Jean Jacques Rousseau (17121778). Rousseau’s famous claim of “return to the state of nature” was
pointing out the relevance of creating a vision of humanity in connection to
physical nature by means of the definition of the body as the medium,
which connected the human mind and the environment through the
experience of emotions13.
Furthermore, Rousseau suggested that our sensibility towards other
living creatures was the key to justify the belief that man must never harm
another man or even another sensitive being, as he is only a part of a higher
system, the natural realm, which should be respected in order to preserve
life as a whole. In his Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi
les hommes (1775), he expressed the need for humans to reconsider their
environmental thinking, as follows:
As they (sensitive beings) partake, however, in some measure of our
nature in consequence of the sensibility with which they are endowed,
they ought to partake of natural right, so that mankind is subjected to a
kind of obligation even toward the brutes. It appears in fact, that if I am
bound to do no injury to my fellow creatures, this is less because they are
rational than because they are sentient beings; and this quality, being
common to men and beasts, ought to entitle the latter at least to the
privilege of not being wantonly ill treated by the former14.
Rousseau’s affective attachment towards other living beings appeared
justified by means of the notion of sensibility, a concept, which had been
used in 18th century British moral philosophy as particular capacity that
revealed “a moral sense and a sense of beauty” that could be understood as
12
As the English definition of this term establishes “landscape is the appearance of a
land as we perceive it”, “the section of earth surface and sky that lies in our field of vision
as seen in perspective from a particular point”. In this way, Romantic landscapes included
the subjective experience as an active element in the construction of nature. For further
reading, see Claudia Mattos (MATTOS 2004, pp. 141-155).
13
OATLEY (2004, p. 13) RICHARDSON (2001, p. 3).
14
ROUSSEAU (2007, p. 14).
Feeling Nature: Emotions and Ecology
253
a response to the suffering of the others15. By appealing for sensibility
towards the natural environment, Rousseau was laying the roots of ecology
as an affective experience, which was based on the capacity of sympathy
toward the suffering of others. Indeed, this painful dimension of the
ecological experience would be further developed by early 19th century
Romantic poets such as Friedrich von Hardenberg (1772-1801), alias
Novalis, who interpreted this contemporary period in biblical terms
likening it to the Fall of Man from the Golden Age. This primordial state
was described as a time in which humankind and nature were as one, a
period of innocence where men lived in total harmony with other
creatures as they formed one physical body. Novalis wrote about this
idyllic period in the history of man and nature in the following way: «Still
earlier, instead of scientific explanations, we find fairy tales and poems full
of amazing picturesque traits in which men, gods and animals are described
as co-workers, and we hear the Origin of the world in the most natural
manner»16.
Therefore, in Novalis’ poetical work, the observation of the
complexity and diversity of the natural environment also implied
understanding ourselves, because man as a microcosm, reflects through his
body, the correspondences of the whole universe, i.e. the macrocosm.
Inspired by this analogy between nature and human being, Novalis stated
that knowledge of nature and man’s self-knowledge were intimately
interdependent as both were connected by means of a common sensibility:
Unknown and mysterious relations within our body cause us to surmise
unknown and mysterious states in nature; nature is a community of the
marvellous into which we are imitated by our body, and which we learn to
know in the measure of our body’s faculties and abilities […]. We touch
Heaven when we touch the human body17.
Romantic ecology was deeply rooted in the experience of the unity of
nature through the observation of the various mutual interactions that
15
See WICKBERG (2007) and MOSCOSO (2011, p. 85). Sensibility was not only the
matter of inquiry of moral philosophers such as Adam Smith and Hume, but also of
Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury, who proposed to understand the universe
by means of its interrelations in an Inquiry concerning Virtue and Merit (SHAFTESBURY, 1699).
16
NOVALIS (1903, p. 105).
17
NOVALIS (1903, p. 79).
254
Dolores Martín Moruno
linked geography, the climate, plants and animals and natural effects.
These interactions produced a sentiment close to wonder, melancholy and
beauty that Romantics usually called “the sublime”. Indeed, the German
naturalist Alexander von Humboldt (1769-1859) thought that to convey a
certain feeling towards nature such as the sublime was a prerequisite to the
development of his scientific research. In his writings, he introduced the
term Wechselwirkung to express a vivid description of the marvellous
interconnections of the flora and fauna that he had observed which
influenced his own moods and feelings18.
Thus, he explained in Ansichten der Natur (1807), in which he compiled
the experiences he acquired during his voyage to the American Continent,
how nature should be perceived as a type of painting in which the human
being was included as an active agent, because he is responsible for giving a
moral dimension to the landscape through his emotions19. Prior to the
invention of term “ecology” in the second half of the 19th century,
Humboldt was able to prefigure this moral attitude by describing the
mysterious communion between man and nature as follows:
The impression left on our minds by the aspect of nature is frequently
determined, less even by the peculiar character of the strictly terrestrial
portion of the scene than by the light thrown on mountain or plane, either
by a sky of azure purity or by one veiled by lowering clouds; and in the
same manner descriptions of nature act upon us more powerfully or more
feebly according as they are more or less in harmony with the
requirements of our feelings. For it is the inward mirror of the sensitive
mind which reflects the true and living image of the natural world. All that
determines the character of a landscape […] is in antecedent, mysterious
communion with the inner feelings and life of man20.
Humboldt believed that it was necessary to create a general natural
science, what he called physique générale, which would focus on nature as
the partner of mind and on science as an expression of culture. Following
this idea, he observed in his work Kosmos (1847), how the physical
18
MÜLLER (1994: 1-15).
It is interesting to note how Humboldt’s approach provides an excellent example of
Romantic objectivity as defined by Lorraine Daston and Peter Galison (DASTON, GALLISON
2007), an approach true-to-Nature.
20
HUMBOLDT (1849, p. 170).
19
Feeling Nature: Emotions and Ecology
255
description of the universe, which was understood as general natural
science, «does not constitute a distinct branch of physical science, it rather
embraces the whole domain of nature, the phenomena of both, the
celestial and terrestrial spheres, but embraces it only under the single point
of view of efforts made toward the knowledge of the universe as a
whole»21.
From this holistic point of view, the place of man was understood
within the most complex natural order of the universe as an insignificant
spectator, who can by no means control the processes that take place in it.
Thus, nature cannot be interpreted as a clockwork mechanism as René
Descartes and Isaac Newton’s vision had proposed, but rather as an
overwhelming force, which is in constant transformation and that we can
conceive by analogy to our bodies.
Moreover, according to Romantic cultural belief, biological bodies
were perceived as having many similarities to works of art. As Immanuel
Kant had pointed out in his Kritik der Urteilskraft (1790) both, biological
bodies and works of art could be regarded in teleological terms as a selforganised whole in which all parts were so united that each becomes
mutually cause and effect of the other22. Indeed, Kant’s reflections on
aesthetic judgement were just the philosophical foundations of the
Romantic experience of the sublime, «the strongest emotion which the
mind is capable of feeling» - as Edmund Burke observed - which connected
the individual with nature by means of the contemplation of the immensity
of the universe giving us the impression that we are one with the world 23.
The organic image of nature would become a popular Romantic
metaphor, notably in the German circle of Friedrich W. J. Schelling’s
Naturphilosophie, for understanding not only the transformation of different
electric, magnetic and chemical forces, but also to represent the moral
injury exerted by modern man against nature, a suffering that should be
repaired by means of developing a veritable ecological project. As I will
conclude, Romantic ecology was delineated as a revolutionary programme
through the writings of personalities linked to Schelling’s philosophy of
nature, such as the physicists Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), and the
poet Novalis. This new belief exalted love as the emotional force that
21
HUMBOLDT (1858, p. 105). See also WALLS (2009).
See also LENOIR (1982).
23
BURKE (1764, p. 59).
22
256
Dolores Martín Moruno
would finally crystallise the reconciliation between man and nature24.
Romantic love as the way of reconciliation
In 1810, the bizarre physician Johann Wilhelm Ritter, a personality
associated during his youth with the University of Jena, the centre of
Romantic ideas during the last decades of the 18th century, died, and his
autobiography the Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein
Taschenbuch für Freunde der Natur (1810) was published posthumously. In
this work, which was a chaotic compilation of aphorisms, results of his
experimental research in chemistry, galvanism and magnetism, were also
included some notes concerning the ecological project that German
Romantics demanded.
As Ritter wrote at the beginning of his autobiography, paraphrasing St.
Paul, only faith, hope and love could encourage the historical process
oriented towards the reconciliation between man and nature. In particular,
love was interpreted not only as the driving force of Ritter’s own scientific
project, but also a methodological tool that could unify what apparently
seemed disintegrated in nature, by establishing analogies among different
types of plants, animals and geographical formations 25.
Thus, Romantic love was not merely considered as an intimate feeling
experienced by the individual, which was symbolised in cultural terms
through the heart, but furthermore as the theoretical lens that served to
unite separated elements through the creation of union - a “we” -, which
becomes a new entity in the world26. However, to reach the utopian
reconciliation of man and nature was also a matter of hope, a revolutionary
emotion, which projected our memories of a past unity with nature in a
future (re)union. Thus, Novalis imagined this absolute reintegration of
man and nature in terms of physical attraction, as the sexual encounter of
two lovers, who desired to be fused together in one body, entwined in
24
BARSANTI (1993, p. 75). The German Romantic circle known as Naturphilosophie
understood the unity of nature by means of the interaction of diverse chemical, biological
and physical processes.
25
Johann Wilhelm Ritter (1810). Here I have used the recent English edition
published by Jocelyne Holland (HOLLAND, 2010, p. 23) in which we can find his allusion
to emotions such as love, hope and faith. «Now however remain faith, hope and love these three - but love is the greatest amongst them».
26
ALBERTI (2010, p.121).
Feeling Nature: Emotions and Ecology
257
eternal ecstasy:
One day all bodies shall be one Body, then the holy pair will float heavenly
blood. Oh! That the ocean were already reddening; that the rocks were
softening into fragrant flesh! The sweet repast never ends; love is never
satisfied. Never can it have the beloved near enough, close enough to its
inmost self […] More fiercely burns the passion of the soul; thirstier, ever
thirstier grows the heart, and so the feast of Love endures from
everlasting27.
Through Romantic writings, an ecological project can be retraced; a
complex emotional experience that was born out of suffering, but one
which is definitely oriented toward hope and love.28 Therefore, Romantic
ecology should be understood as the dynamic relationship established
between man and nature, a relationship that was manifested throughout
history. Furthermore, history was understood as a kind of mythology,
which went back to the innocence of the Golden Age, to describe the
aftermath of the painful separation of man from nature, and how finally
this suffering was turned into a positive affective mood that transformed
our past memories into a magical present, one in which man would be able
to rediscover the sublime in nature, in its diversity and complexity. At the
final point, only love and hope remained in order to achieve the Romantic
Utopia on the final reconciliation between man and nature.
As Novalis pointed out, only our feelings could help us to transform the
world into a magic place, in which we would be able to see «the ordinary
as extraordinary, the familiar as strange, the mundane as sacred, and the
finite as infinite»29. This new sensibility based on a common sympathy
between man and other natural beings was aimed at restoring the mannature relationship by means of (re)enchanting reality. This means that
emotions, which I have considered here not as psychological, but rather as
cultural objects, have evolved throughout history. They can be also
27
NOVALIS (1903, p. 127).
See also the following assertion of Ritter (see HOLLAND 2010, p. 531): «Man
himself begins to be the ideal, which may become his final one for all time […]. Nature
only permits him to linger by this ideal for a fleeting instant, however; she leads him away
even as he ceases to be it. And henceforth, the dawn of a unique life breaks for man, and
he awakens. Remembrance is his awakener, self-separation is his first pain, and its removal
his first hope».
29
NOVALIS in BEISER (2003, p. 101).
28
258
Dolores Martín Moruno
analysed as ways of observing and experiencing nature because they are the
veritable relationship that guide the connections between the biosphere
and humanity. Indeed, Romantic ecology could be understood as a kind of
healing art, which like poetry and medicine, attempted to alleviate the
suffering of damaged bodies by means of expressions of care such as love.
As I shall show throughout this essay, ecology provides an exciting
subject to be explored from the point of view of the history of emotions,
as this affective experience was based on a particular sensibility, which
emerged in a concrete historical period related to the social and cultural
transformations of the Western world resulting from the Industrial
Revolution. The relevance of this Romantic sensibility towards the natural
environment is not only that it encouraged the production of new scientific
models that studied the mutual relations among all organisms, processes
and objects in a given environment such as Häeckel’s ecology, but also
that it lays nature's fragility at the heart of our contemporary way of
feeling. It is no wonder that recent ecological studies such as Kay Milton’s
Loving Nature claimed one’s caring for the physical world as an expression
of emotions and in particular, of love, revealing to what extent the
Romantic invention of nature is still present in our manner of approaching
the environmental problems derived from the ever increasing
industrialisation of our world30.
Abstract
This article seeks to explore the historical ways in which emotions have
shaped our modern concerns about nature by examining the emergence of a
new sensibility inspired by the urgent necessity of protecting the natural
environment from the increasing industrialisation that took place in late 18th
and early 19th century Western societies. Even though Ernst von Haeckel
coined the term “ecology” in 1866, following on from Charles Darwin’s
evolutionism as a new science, which focuses on the study of the mutual
relations of plants, animals, geography and the climate to each other and to
their environment; we need to go back to Romantic culture in order to trace
the origins of this new way of appreciating the complexity and diversity of
nature. Drawing on these considerations, this article examines the constitution
30
MILTON (2002, pp. 2-3).
Feeling Nature: Emotions and Ecology
259
of a modern way of loving nature through the writings of some Romantic
poets and scientists such as Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Joseph
Schelling, Johann Wilhelm von Ritter, Friedrich von Hardenberg and
Alexander von Humboldt, who demonstrated a common desire to restore the
lost harmony between man and the environment. In a broader sense, this
article aims at demonstrating how ecology is a complex human experience that
also has a history, which is intimately linked to the Romantic cult of emotions
such as nostalgia, love and hope.
Works referenced
F.B. ALBERTI (2010), Matters of the Heart: Locating Emotions in Medical and
Cultural History, Oxford University Press, Oxford.
G. BARSANTI (1994), “On the origin of romantic biology and its further
development at the University of Jena between 1790 and 1850” in POGGI,
BOSSI (1994, eds.), pp.47-75.
J. BATE (1991), Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental
Tradition, Routledge, London-New York.
J. BATE (2000), The Song of the Earth, Harvard University Press
Cambridge (Mass.).
F.C. BEISER (2003), The romantic imperative: the concept of early German
romanticism, , Harvard University Press Cambridge (Mass.).
W. BLAKE (2008), The Complete Poetry and Prose of William Blake,
University of California Press, Berkley.
J. BOURKE (2005), Fear: A Cultural History, Virago, London.
E. BURKE (1767), A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the
Sublime and the Beautiful, J. Dodsley, London.
A. CUNNIGHAM, N. JARDINE (1990, eds.), Romanticism and the Science,
Cambridge University Press, Cambridge (UK).
L. DASTON, P. GALISON (2007), Objectivity, Zone Books, New York.
T. DIXON (2003), From Passions to Emotions, the creation of a secular
psychological category, Cambridge University Press, Cambridge (UK).
R. ERICKSON, M. A. FONT, B. SCHWARTZ (2004, eds.), Alexander von
Humboldt From America to the Cosmos, Bildner Center for Western
Hemisphere Studies, New York.
E. HAECKEL (1866), Generelle Morphologie der Organismen, Reimer,
Berlin.
260
Dolores Martín Moruno
F. VON HARDENBERG (NOVALIS) (1903), The Disciples at Saïs and Other
Fragments, Methuen, London.
Y. HOLLAND (2010), Key Texts of Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) on
the Science and Art of Nature, Brill, Leiden - Boston.
A. VON HUMBOLDT (1848) Kosmos: a Sketch of a Physical Description of the
Universe, H.G. Bohn, London.
A. VON HUMBOLDT (1849), Aspects of Nature: in Different Lands and
Different Climates, with Scientific Elucidations, Lea and Blanchard,
Philadelphia.
K. HUTCHINGS (2007), “Ecocriticism in British Romantic Studies” in
Literature Compass 4:1, pp. 172-202.
E. ILLOUZ (1997), Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural
Contradictions of Capitalism, University of California Press, Berkeley - Los
Angeles.
K. KROEBER (1994), Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and
the Biology of Mind, Columbia UP, New York.
T. LENOIR (1982), The Strategy of Life: teleology and mechanics in
nineteenth century German biology, Dordrecht, Springer.
C. MATTOS (2004), “Landscape painting: Between Art and Science” in
R. ERICKSON, M.A. FONT, B. SCHWARTZ (2004, eds.), pp. 141-155.
R. P. MCINTOSH (1986), The Background of Ecology: Concept and Theory,
Cambridge University Press, Cambridge.
J.C. MCKUSICK (2010), Green Writing: Romanticism and Ecology, Palgrave
Macmillan, New York.
K. MILTON (2002), Loving Nature: Towards an Ecology of Emotion,
Routledge, London-New York.
T. MORTON (2007), Ecology Without Nature: Rethinking Environmental
Aesthetics, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
J. MOSCOSO (2011), Historia cultural del dolor, Taurus, Madrid.
G. MÜLLER (1994), “Wechselwirkung in the Life and Other Sciences”, in
POGGI, BOSSI (1994, eds.), pp.1-15.
K. OATLEY (2004), Emotion: A Brief History, Blackwell Publishing,
Oxford, 2004.
K. OATLEY, D. KELTNER, J. M. JENKINS (1996), Understanding Emotions.
Blackwell Publishing, Oxford.
O. OERLEMANS (2002) Romanticism and the Materiality of Nature,
University of Toronto Press, Toronto.
R. OLSON (1991), Science Deified and Science Defied: The Historic
Feeling Nature: Emotions and Ecology
261
Significance of Science in Western Culture. Volume 2: From the Early Modern Age
through the Early Romantic Era ca. 1640 to ca. 1820, University of California
Press, Berkeley.
S. POGGI, M. BOSSI (1994,eds.), Romanticism in the Science: Science in
Europe 1790-1840, Kluver Academic, Dordrecht.
E. PULCINI (2011), Invidia: La passione triste, Il Mulino, Bologna.
W. REDDY (2001), The Navigation of Feeling. A Framework for the History
of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge.
R.J. RICHARDS (2008), The Tragic Sense of Life: Ernst Häeckel and the
Struggle over Evolutionary Thought, University of Chicago Press, Chicago.
A. RICHARDSON (2007), “Romanticism and the Body”, Literature
Compass, 1, pp. 1-14.
K. RIGBY (2004), Topographies of the Sacred: The Poetics of Place in
European Romanticism, UP of Virginia, Charlottesville.
B. ROSENWEIN (1998), Anger’s Past: The Social Uses of an Emotion in the
Middle Ages, Cornell University Press, Ithaca (NY, Usa).
B. ROSENWEIN (2002), “Worrying about Emotions in History”, American
Historical Review 107:3, pp. 821–45.
J.J. ROUSSEAU (2007), Discourse on the Origin of Inequality, Filiquarian
Publishing, Minneapolis.
G. S. ROUSSEAU (2004), Nervous Acts: Essays on Literature and Sensibility,
Palgrave, Basingstoke-New York.
A. ASHLEY COOPER, EARL OF SHAFTESBURY (1699), An Inquiry Concerning
Virtue, or Merit, Manchester, Manchester University Press, 1977.
R.C. SOLOMON (1993), The Passions, the Emotions and the Meaning of Life,
Hackett Publishing, Indianapolis.
P.N. STEARNS (1994), American Cool: Constructing a Twentieth-Century
Emotional Style, New York University Press, New York.
P.N. STEARNS, C. STEARNS (1985), “Emotionology: Clarifying the
History of Emotions and Emotional Standards”, The American Historical
Review Vol. 90, No. 4 (Oct.), pp. 813-836.
D. VALLINS (1999), Coleridge and the psychology of Romanticism, Feeling
and Thought, Palgrave, London.
L.D. WALLS (2009), The Passage to Cosmos: Alexander von Humboldt and
the Shaping of America, University of Chicago Press, Chicago (Ill.).
D. WICKBERG (2007), “What is the History of Sensibilities? On Cultural
Histories, Old and New”, in American Historical Society vol. 112, n°3.
VALLORI RASINI
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione
di Arnold Gehlen
1. Natura e cultura: una diade marcata
Nel corso dei primi decenni del Novecento il concetto di “natura” ha
avuto ampio spazio e differenti accezioni, declinate, per lo più, a partire
dall’imponente presenza di un variegato e polifonico dibattito scientifico.
Darwiniani e non, meccanicisti e vitalisti, riduzionisti e scettici fornivano
una ricca rete di riferimenti concettuali che non poteva essere ignorata dal
mondo dell’arte come (e soprattutto) da quello della filosofia. Agli
antipodi della sfera della natura, quasi a rappresentarne l’opposto
ontologico, figura l’ambito della cultura, il mondo dei prodotti spirituali e
dell’artificio. Complice del persistere di una diade così marcata è
certamente una svolta significativa che ha coinvolto l’ambito degli studi
antropologici, una svolta dovuta all’esigenza, sempre più sentita, di un
confronto diretto e profondo dell’uomo con gli altri enti biologici.
Nel delineare le specificità di un’autentica “antropologia filosofica”, il
filosofo e sociologo tedesco Arnold Gehlen si sofferma sull’importanza di
un momento di rottura nella storia del pensiero occidentale – per il quale
ringrazia principalmente Cartesio – che ha visto la filosofia emanciparsi
dalla teologia e un nuovo atteggiamento di ricerca, meno dogmatico e
favorevole all’osservazione empirica, sostituirsi gradualmente al
precedente. «Nel momento in cui la filosofia inizia a emanciparsi dalla
teologia», sostiene Gehlen, «si comincia a porre – cercando una risposta
all’interno di nuove categorie – la domanda: che cos’è l’uomo?»1. Non ci si
accontenta più di considerare l’essere umano come la creatura principale
della terra, plasmata a immagine e somiglianza di Dio e correlandone
l’essenza al suo creatore, ma si avverte l’esigenza – genuinamente filosofica
– di inquadrare l’uomo “per quello che è”, di indagare l’essere umano in
1 A. GEHLEN, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des
Menschen (1961); trad. it. di S. Cremaschi, Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta si
sé, a cura di V. Rasini, il Mulino, Bologna 2005, p. 30.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 263-274
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064317
263
264
Vallori Rasini
quanto tale, facendo uso di categorie “sue proprie”, concernenti cioè la sua
sola realtà2. Ovviamente, dal punto di vista di Gehlen, questi primi passi
verso la scoperta dell’ente umano hanno avuto i loro difetti; in primo
luogo – e di nuovo è Cartesio a essere chiamato in causa, questa volta però
per un rimprovero – la giustapposizione di una sostanza materiale e di un
elemento spirituale non rende giustizia all’unità della natura umana,
mantiene la ricerca antropologica nel solco del dualismo e, almeno in
parte, favorisce la sopravvivenza del pensiero metafisico.
In questa trappola – la trappola della speculazione metafisica –,
nonostante i suoi apprezzabili sforzi, era finito anche Max Scheler che, pur
duramente criticato, è considerato da Gehlen un vero “maestro”. Scheler
aveva cercato di superare il dualismo cartesiano concependo un principio
biopsichico che, a seconda del grado di evoluzione, manifestasse facoltà via
via più complesse tra i viventi e desse così conto della differenza specifica
tra forme viventi. La vita – sostiene – è sempre, in se stessa, anche
psichica, originariamente materia esteriore e interiorità;
è un dato di fatto che oltre a possedere il movimento, la formazione, la
differenziazione, la delimitazione spontanei rispetto allo spazio e al tempo
[…], le cose che noi chiamiamo ‘viventi’ non sono solamente oggetto di
una osservazione esterna, ma posseggono, come loro caratteristica
essenziale, un modo di essere per se stesse e interiore onde riconoscono se
stesse. […] Si tratta dell’aspetto psichico dell’autonomia, del movimento
spontaneo, ecc. dell’essere vivente in generale: dell’originario fenomeno
psichico della vita3.
Stabilito questo, Scheler si trova a fare i conti con la “diversità umana”,
con la specifica (e speciale) posizione dell’uomo nel cosmo. I vari livelli del
principio biopsichico sono tra loro differenti solo per grado, non per
qualità; e all’animale, non meno che all’uomo, sono riconosciute notevoli
capacità intellettive4. Cosa distingue, allora, l’essere umano dal più
intelligente degli animali? La risposta di Scheler è semplice (e prevedibile):
la presenza di uno spirito, di un “in più” che rende l’uomo capace di
2 A. GEHLEN, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940); trad. it di C.
Mainoldi, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, a cura di V. Rasini, Mimesis, Milano
2010, p. 46.
3 M. SCHELER, Die Stellung des Menschen im Cosmos (1928); trad. it. di R. Padellaro, La
posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di M.T. Pansera, Armando, Roma 1997, p. 119.
4 Ivi, p. 139.
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione di Arnold Gehlen
265
cogliere le essenze (un principio “eidetico” o “di ideazione”) e di
comportamento morale.
Sorvoliamo sul fatto che in questo modo Scheler ricade in una forma di
dualismo (Spirito/Principio biopsichico) e concentriamoci sul significato
che ottiene la “spiritualità” umana. Come ogni altro organismo, l’uomo
partecipa del principio vitale, cioè di quell’elemento naturale che pone in
atto l’esistenza organica. Ma, oltre a questo, l’uomo avrebbe a che fare con
un principio grazie al quale si determina una differenza qualitativa ed
essenziale rispetto ad ogni altro organismo vivente: solo lui è in grado di
assumere un punto di vista esistenziale completamente estraneo alla rosa
delle necessità biologiche; solo lui può prendere distanza dalle esigenze
naturali per seguire un percorso “culturale”. L’uomo, tra gli animali, è il
solo che sappia porsi “oltre” un’esistenza semplicemente fisiologica, fatta di
soddisfazione di bisogni vitali immediati. Egli può dunque emanciparsi
dalle leggi della natura e rifiutarsi di seguire ciecamente i dettami della vita
biologica, preferendo – consapevolmente – la via di un nobile
comportamento spirituale. La natura, con le sue regole improntate alla
sopravvivenza organica, può essere via via allontanata, quasi annullata da
chi sia in grado di seguire lo sprone della spiritualità. L’uomo trova così la
propria specificità in una dimensione extranaturale e la misura dell’umanità
diviene la capacità di sublimazione di certi bisogni. «L’uomo – chiarisce
Scheler – è perciò l’essere vivente che, in virtù del suo spirito, è in grado
di comportarsi in maniera essenzialmente ascetica nei confronti della sua
vita, che lo soggioga con la violenza dell’angoscia; può soffocare e
reprimere i propri impulsi tendenziali, vale a dire rifiutare loro il
nutrimento delle rappresentazioni percettive e delle immagini»5. Qui si
rende manifesta anche la differenza esistenziale con gli altri viventi:
«paragonato all’animale che dice sempre ‘sì’ alla realtà effettiva – anche
quando l’aborrisce e la fugge – l’uomo è ‘colui che sa dir di no’, l’’asceta
della vita’, l’eterno protestatore contro quanto è soltanto realtà»6. Questo
eterno protestatore è in grado di allontanarsi dalla sfera biologica tanto
quanto serve per entrare a pieno titolo in una dimensione esistenziale
diametralmente opposta, negando quanto più possibile la pressione della
natura. L’opposizione tra natura e cultura marca dunque la lontananza
dell’uomo dall’animalità e la sua speciale “posizione nel cosmo”.
Da questo punto di vista, Gehlen segue Scheler; condivide con lui la
5
6
Ivi, pp. 158-159.
Ivi, p. 159.
266
Vallori Rasini
necessità di individuare un punto di rottura tra l’uomo e l’animale. Tanto è
vero che una delle principali critiche che rivolge a Scheler è di sbagliare nel
mantenere un principio di continuità biologica tra i viventi, lasciando che la
natura umana “provenga” da quella animale (e ritrovandosi costretto a
ricorrere alla metafisica per stabilire una frattura tra esse). Criticando lo
“schema graduale” di Scheler7, Gehlen colloca lo iato tra natura e cultura in
seno alla struttura biologica del vivente. Il “pregiudizio” – così lo apostrofa
Gehlen – di una differenza solo graduale tra uomo e animale va rifiutato
con la stessa determinazione con cui va respinta l’ipotesi metafisica di uno
spirito extrabiologico. A suo parere, la specificità dell’essere umano
prende forma dalla costituzione concreta ed è scientificamente
constatabile. A causa di un’evidente carenza biologica (strutturale e
fisiologica), l’uomo è costretto a rinunciare alla dimensione naturale e a
inoltrarsi in un universo completamente diverso, quello culturale. È
convinto che l’uomo, provvisto del suo solo apparato “naturale” (la
dotazione biologica), non sarebbe in grado di resistere in vita più di
qualche giorno8. Le sue deficienze sono infatti molteplici: non ha
protezioni naturali dagli attacchi esterni; non possiede organi che possano
metterlo in una condizione di superiorità dinanzi alle minacce; non è
adatto alla fuga e non possiede un apparato sensoriale e istintuale
paragonabile a quello di molti animali. E come se ciò non bastasse, il
cucciolo umano, per rendersi autosufficiente, ha bisogno di un periodo di
assistenza incomparabilmente protratto, rimanendo per lungo tempo in
una situazione di forte dipendenza. Così mal dotato, in mezzo ad animali
assai più abili di lui nella difesa e nell’attacco, l’uomo ha dovuto
procacciarsi mezzi alternativi – vale a dire “non naturali” – per la
sopravvivenza. L’ingresso nella dimensione culturale appare dunque
inevitabile: «in conseguenza del suo primitivismo organico e della sua
carenza strumentale – afferma Gehlen – l’uomo è incapace di introdursi
nella natura. Per sopravvivere deve surrogare i mezzi di cui organicamente
difetta: trasformando il mondo a sua disposizione in qualcosa di utile alla
sua vita9. In questa continua trasformazione consiste, sostanzialmente,
l’agire umano: esso traspone in un universo extranaturale e retto da regole
autonome, l’esistenza di un ente solo biologicamente “naturale”.
All’opposto dell’animale, che continua a essere il prototipo dell’ente
A. GEHLEN, L’uomo, cit., pp. 57 sgg.
Ivi, pp. 52-53.
9 Ivi, p. 75.
7
8
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione di Arnold Gehlen
267
naturale, pienamente assistito da madre natura nelle sue funzioni vitali,
l’uomo deve affidarsi alla propria attività, alla progettazione,
all’invenzione. Quanto più, dunque, egli riesce a “proteggersi” dalla natura
dietro le mura dell’artificio, tanto più alte saranno le sue probabilità di
sopravvivenza; e quanto più si allontana dalla condizione animale, tanto più
manifesta sarà la sua specificità umana.
In questo modo, natura e cultura si divaricano drasticamente e senza
possibilità di ricongiungimento: l’una cresce – progressivamente –
sull’annichilimento dell’altra. D’altronde, è proprio ora, all’inizio del
Novecento, che si avverte particolarmente il bisogno di precisare la
diversità dei settori del sapere valutando la differenza specifica dei loro
oggetti: si sostiene che le “scienze della natura” si servono di metodi e
strumenti inadeguati nell’indagine delle “scienze dello spirito” (o “scienze
della cultura”), appunto perché le dimensioni alle quali si applicano sono
tra loro incommensurabili10.
2. L’ambiente intorno al vivente
Parte delle motivazioni addotte a giustificazione di questo divorzio,
rimanda al concetto di “ambiente”. In altre parole, idee diverse di
“ambiente” conducono verso idee di “natura” appartenenti a dimensioni
diverse. A permettere il discrimine è – in certo senso suo malgrado – il
pensiero del barone Jakob von Uexküll. Affermato biologo di origine
estone, animato da interessi fortemente filosofici, von Uexküll aveva
proposto una concezione del rapporto tra l’organismo e il suo esterno che,
muovendosi tra suggestioni neoplatoniche e motivi naturalistici, venne
recepita dagli ambienti intellettuali come innovativa e in certo senso
rivoluzionaria, facendo scuola tra i rappresentanti dell’antropologia
filosofica, ma ottenendo credito anche in ambito neokantiano ed
esistenzialista11.
Dal suo punto di vista, il compito della biologia è quello di studiare la
connessione tra il “mondo interno” dell’organismo, definito da una serie di
10 Si pensi al lavoro dello Storicismo tedesco e alle molte fatiche tese a precisare la
differenza specifica sussistente tra “oggetti naturali” e “oggetti spirituali” e le relative
metodologie di studio.
11 Fuori dallo stretto circuito dell’antropologia filosofica, si vedano almeno le posizioni
di E. Cassirer, M. Heidegger, M. Merleau-Ponty.
268
Vallori Rasini
“eccitazioni dinamiche”, e il “mondo esterno”, con cui il vivente interagisce
grazie a specifici “ricettori” ed “effettori”. Diversamente da altre scienze
della natura, la biologia non si occupa di un oggetto qualunque, valutabile
appunto “oggettivamente”, ma di un “centro organico soggettivo”,
strettamente correlato con ciò che lo circonda. Di fronte agli stimoli
provenienti dall’esterno, il soggetto biologico è in grado di percepire e di
agire, e la prestazione complessiva che ne risulta si riferisce sempre a
precisi fattori che compongono il suo ambiente. Il termine “ambiente”
indica l’insieme del mondo percettivo e del mondo “effettuale” del vivente:
«ogni animale – dice von Uexküll – è un soggetto che, grazie al suo
peculiare tipo di costituzione, dall’azione generale del mondo esterno
seleziona determinati stimoli, ai quali risponde in un certo modo. Queste
risposte consistono a loro volta in determinate azioni sul mondo esterno,
che influenzano gli stimoli»12.
Ne risulta una serie di “circuiti funzionali” (ad esempio, quello del
nutrimento, quello dell’accoppiamento ecc.), per ciascun sistema vitale;
essi sono reciprocamente connessi a formare un “mondo funzionale” il
quale, nella sua chiusura, costituisce qualcosa di simile a una struttura
monadica: ogni organismo – secondo la propria morfologia, le proprie
capacità e necessità – è, in tal modo, come incastonato in un ambiente a lui
perfettamente corrispondente. Per questo, occorre evitare non solo di
considerare l’ambiente come un unico luogo, oggettivamente osservabile
(come lo è lo spazio geometrico), ma anche di caratterizzarlo
antropomorficamente, attribuendogli proprietà che si accordano con la
natura umana, ma non con quella degli altri viventi. In relazione alla
diversità biologica degli organismi, occorre insomma riconoscere la
singolarità di ciascun ambiente, caratterizzato dalla presenza di “cose”
percepibili e utilizzabili all’interno di un particolare sistema funzionale. Al
termine “ambienti” – rigorosamente al plurale – corrisponde l’idea di
“mondi individuali”, universi tra loro incommensurabili, prodotto di una
determinata interazione; per questo avremo tanti ambienti quanti sono gli
animali13. Ogni animale è perfettamente adattato al proprio ambiente; in
esso trova ciò che riflette la sua gamma di bisogni e il suo livello di
12
J.
VON
UEXKÜLL, Teoretische Biologie (1928), Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973, p.
150.
13 Si veda in particolare J. VON UEXKÜLL, Streifzüge durch die Umweltwn. Ein Bilderbuch
unsichtbarer Welten (1934); trad. it., Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in
mondi sconosciuti e invisibili, a cura di M. Mazzeo, Quodlibet, Macerata 2010.
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione di Arnold Gehlen
269
complessità: ad animali semplici corrisponde un ambiente elementare; ad
animali più complessi un ambiente più ricco e complicato. In questo
ambiente “calibrato”, l’organismo svolge un processo vitale dalle
caratteristiche uniche, determinate da un “piano naturale”, a sua volta
unico. Lo si può facilmente constatare – sostiene von Uexküll –
osservando le manifestazioni percettive ed effettuali caratteristiche di
circuiti funzionali semplici, dove l’oggetto che entra in relazione con il
soggetto organico manifesta esattamente e solo quelle peculiarità che gli
consentono di appartenere al ciclo vitale di quel soggetto: «ogni soggetto
vive in un mondo in cui esistono solamente realtà soggettive»14 e nessun
“oggetto”; non esistono cioè elementi ambientali “uguali” – vale a dire:
aventi lo stesso valore e lo stesso significato – per ogni vivente.
Uno dei più celebri esempi di von Uexküll concerne la metamorfica
funzione di un albero del bosco per soggetti differenti: una quercia – dice –
se già per l’uomo, a seconda della sua condizione e dei suoi interessi appare
di volta in volta diversa (per un boscaiolo rappresenterà una determinata
cubatura di legname; per un bimbo impressionato dalla strane venature
della corteccia un mostro misterioso), per una volpe, ad esempio, sarà
importante solo per le grosse radici tra le quali avrà scavato il proprio
riparo; mentre per un uccello saranno i suoi rami ad avere il valore di un
utile sostegno: «in base alle diverse tonalità operative, le immagini
percettive dei numerosi abitanti della quercia stanno strutturate in modo
differente. Ogni ambiente ritaglia una zona dell’albero le cui proprietà
sono adatte a farsi portatrici delle marche percettive e operative dei vari
circuiti funzionali»15.
3. Ambiente chiuso e mondo aperto
La concezione dell’ambiente soggettivo del barone von Uexküll – come
dicevamo – ebbe notorietà e buona accoglienza negli ambienti che
trovavano eccessivamente riduttiva una impostazione meccanicistica delle
scienze biologiche. La ricerca di una dimensione non semplicemente
quantitativa della vita, in cui avessero un ruolo l’elemento temporale e la
relazione con l’altro, impegnava scienziati e intellettuali di varia estrazione
ideologica, specie nei primi decenni del secolo, quando anche in seno alle
14
15
Ivi, p. 150.
Ivi, p. 155.
270
Vallori Rasini
scienze fisico-chimiche si rendeva necessario cominciare a introdurre nuovi
parametri. La teoria di von Uexküll aveva il vantaggio di esaltare la
singolarità e l’unicità del legame tra organismo e ambiente partendo “dal
basso”, cioè dall’osservazione del comportamento del vivente, sempre
specifico, sempre biunivoco. La parola tedesca “Umwelt” porta in chiaro la
questione: composta da “um” (intorno) e da “Welt” (mondo), indica “ciò che
sta intorno” solo se c’è “qualcosa a cui” stare intorno, e precisamente una
“Innenwelt”, un “mondo interiore”. Il “mondo circostante” o “ambiente” 16
deve corrispondere (a doppio filo) all’organismo in quanto suo ambito
esistenziale: non c’è un semplice stare l’uno accanto all’altro, ma un essere
strettamente correlati, quasi a costituire un insieme monadico. La
corrispondenza funzionale della struttura morfologica e fisiologica del
vivente con il suo esterno produce una chiusura; l’ambiente è infatti ben
“racchiuso”, “circoscritto” intorno alle caratteristiche e alle possibilità
dell’organismo di volta in volta considerato. Ma occorre specificare:
dell’organismo animale (o non umano).
Qui infatti, sul limite della differenza tra animale e umano, si attenua
l’entusiasmo per la concezione di von Uexküll, quanto meno da parte degli
esponenti dell’antropologia filosofica tedesca17. Sì, perché di
corrispondenza o di adattamento reciproco tra organismo e ambiente è
difficile parlare in relazione all’uomo. L’animale ha una sua
specializzazione, è provvisto di istinti e in generale ha una dotazione
strutturale che gli garantisce la sopravvivenza nella congruenza con il
proprio milieu; ciò che non gli serve, per lui non esiste, e la sua
sopravvivenza è garantita proprio da questa limitazione e dalla sicurezza
che essa comporta. Ma per l’uomo le cose non stanno così. L’uomo –
come sostiene Gehlen – non è specializzato, è quasi privo di istinti e
sprovvisto degli organi più elementari per la difesa e l’attacco; l’uomo non
ha un ambiente. Non ha un ambiente perché gli manca quella particolare
aderenza – possiamo chiamarla adeguatezza o adattamento – a un circuito
naturale specifico; gli manca l’inserimento in un “mondo funzionale”. Von
Uexküll – scopritore di una nuova idea di “mondo individuale”e fautore
della deantropomorfizzazione dell’ambiente – ha troppo precipitosamente
16 “Umwelt” si può dire l’equivalente letterale del latino “ambito” o “ambiente”
(derivante, come “ambire”, da “andare intorno”).
17 Sulle osservazioni critiche a von Uexküll mi permetto di rimandare al mio Ambiente e
organismo. Plessner, Gehlen e il pensiero biologico di von Uexküll, "B@belonline. Rivista di
filosofia" 5 (2008), pp. 147-158.
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione di Arnold Gehlen
271
trasferito all’uomo le caratteristiche dell’universo animale – dice Gehlen –
e, ad esempio, «fece leva sulla nota idea per cui il bosco, per il poeta, il
cacciatore, il boscaiolo, una persona che vi sia sperduta, è un bosco ogni
volta diverso». E in questo modo commise un errore decisivo: prese «le
strutture comportamentali originarie, autenticamente istintive, degli
animali, che si rapportano a ambienti naturali e a loro coordinati, per le
specializzazioni acquisite del comportamento, che nell’uomo rispondono a
una ricca e articolata sfera culturale»18. Uno scambio, a quanto pare, del
tutto illecito: l’uomo non è adattato a un sistema funzionale più o meno
complesso; e non è neppure – propriamente – un “ente naturale”. È
“aperto al mondo” anziché chiuso nell’angusto circuito delle soddisfazioni
organiche e, lungi dal potersi ritenere un “animale superiore”,
semplicemente più evoluto o quantitativamente più intelligente, ha
piuttosto rotto i ponti con la catena graduata degli altri viventi e imboccato
una via di sviluppo “culturale”.
Il concetto di Umwelt – spiega Gehlen –, se definito a dovere nei suoi esatti
termini biologici, non è […] applicabile all’uomo, giacché nel punto
preciso in cui, nel caso dell’animale, si trova appunto la ‘Umwelt’ in
quello dell’uomo c’è la ‘seconda natura’, ossia la sfera culturale, con i suoi
peculiari, particolarissimi problemi e formazioni concettuali, che la
nozione di ‘ambiente’, di ‘Umwelt’ non inquadra, bensì, all’opposto, solo
riesce a occultare19.
Privo di un rapporto armonico con una costellazione “naturale” di
condizioni, l’essere umano deve modificare la struttura del proprio intorno
così da renderlo vivibile; questo è il motivo per cui anche geograficamente,
può vivere ovunque, al Polo come all’Equatore, sulle montagne come in
riva al mare, nelle steppe come nelle città. Progettazione e intervento gli
procurano quella dimensione «la quale dunque, nel suo caso, sta in luogo
dell’ambiente»20. In questo senso, l’uomo è “per natura” artificiale,
estraneo alla natura (a causa delle sue condizioni biologiche), e dunque
culturale “allo stato di natura”. «Cultura – precisa Gehlen – è dunque, in
prima approssimazione, l’insieme dei mezzi materiali e dei mezzi di
rappresentazione, delle tecniche materiali e di pensiero, istituzioni incluse,
A. GEHLEN, L’uomo, cit., p. 119.
Ivi, p. 120.
20 Ivi, p. 121.
18
19
272
Vallori Rasini
tramite i quali una data società ‘si regge’; in seconda approssimazione, è
l’insieme di tutte le istituzioni successive che si fondano su quanto
precede»21. La cultura non comincia “a un certo punto” dello sviluppo
umano; costituisce invece la precondizione della resistenza in vita
dell’uomo e la sua sola possibilità di esserci; per questo non importa
“quale” o “quanta”: qualunque uomo (o comunità), sin dal principio e
necessariamente, congedandosi dalla natura, si avventura in una
trasformazione prometeica22.
4. L’inevitabile insicurezza prometeica
La figura di Prometeo è certamente la più indicata allo scopo di
descrivere il “dovere” dell’essere umano: prevedere e provvedere. La
progettazione e, ovviamente, la realizzazione danno seguito alle scelte di
cambiamento concepite come importanti per la vita, sia del singolo sia
della specie. Mentre però l’intrepido titano mitologico sfodera tutto il suo
coraggio senza temere ritorsioni (che pure arrivano, inevitabilmente);
mentre cioè l’immagine di Prometeo è quella di un eroe, deciso e
infallibile, Gehlen ci presenta piuttosto un essere insicuro e bisognoso di
assistenza (nonché di guida). L’apertura al mondo rappresenta
un’incognita: l’uomo si trova esposto a una quantità indefinita di
stimolazioni, a un flusso continuo di impressioni percettive dinanzi a cui la
sua dotazione organica è quasi impotente. Giacché gli mancano i filtri per
selezionare gli impulsi, affrontare il mondo è un onere immenso. L’uomo
è dunque affaticato, per un verso, e costantemente in pericolo, per l’altro.
La ricerca dello sgravio, l’esonero da grandi, impegnative fatiche, che al
contempo gli procuri maggiore sicurezza e stabilità, diviene il suo destino;
l’ingresso nella cultura il suo percorso obbligato.
Questo passaggio gli è consentito dallo sfruttamento della tecnica (ma
forse dovremmo dire “delle tecniche”), che traduce la sua azione in fatti
convenienti assicurandogli il necessario sollievo. La tecnica è data
dall’insieme delle abilità di manipolazione delle cose e di applicazione dei
risultati di questo processo; essa è in grado di trovare una sostituzione degli
Ibid.
Ivi, p. 76: «La distinzione tra ‘uomo civile’ e ‘uomo allo stato di natura’ è una
distinzione equivoca. Nessuna popolazione umana, nei luoghi selvaggi, vive dei luoghi
selvaggi semplicemente, ognuna possiede tecniche venatorie, armi, il fuoco e utensili».
21
22
Natura, cultura e ambiguità umana nella posizione di Arnold Gehlen
273
organi mancanti, di potenziare facoltà esistenti e di liberare l’organismo da
oneri insopportabili. Per questo è l’indispensabile alleata dell’essere
umano; così indispensabile da dover essere considerata «vecchia quanto
l’uomo»23. Trasformando le condizioni naturali, essa per un verso elabora
materialmente la realtà circostante; per l’altro traspone simbolicamente –
soprattutto attraverso il linguaggio mimico e parlato – l’esperienza
percettiva, liberando progressivamente l’uomo da un impegno massiccio in
attività vitali elementari e favorendo lo sviluppo di energie che possono
essere utilizzate in applicazioni di livello superiore (come l’attività
razionale). Questa possibilità di ampliare e potenziare progressivamente il
proprio ambito d’azione “apre” – appunto – a un mondo, a una dimensione
che va ampliandosi proporzionalmente alle “elaborazioni efficaci” della
natura. Ecco perché là dove per l’animale c’è un ambiente, cioè un luogo
naturale in cui soddisfa i propri bisogni in relazione alla costituzione
soggettiva, l’uomo scopre un “mondo”, un habitat speciale, da lui stesso
prodotto e tuttavia ancora sempre da produrre.
«L’insieme della natura da lui trasformata con il proprio lavoro in tutto
ciò che riesca utile alla propria vita – chiarisce Gehlen – dicesi cultura, e il
mondo della cultura è il mondo umano»24. È inequivocabile che il mondo
della cultura sia l’alternativa “salvifica” (per quanto coatta) alla vita
naturale. Così come non c’è l’uomo senza una distanza dall’animale25, non
c’è neppure un’esistenza umana senza la distanza dalla natura; espletare il
dovere vitale di questo allontanamento è precisamente il compito
esistenziale di un “essere tecnico”, che appare sempre di più non solo –
come lo abbiamo già definito – “innaturale” ma persino “anti-naturale”.
Soprattutto quando si consideri il processo di emancipazione dall’organico
rinvenibile nella sua storia (il che equivale a dire: il processo di
allontanamento dal suo primordiale legame con la vita). A questo conduce
l’artificialità: a un affrancamento nobilitante dai bisogni più elementari, alla
libertà da pressioni di carattere puramente biologico e alla liberazione dal
rapporto con un ambiente predefinito. Questo è ciò che ci suggerisce
Gehlen.
Grazie soprattutto all’ingegneria tecnica e all’intervento diretto nella
23 A. GEHLEN, Die Seele im technischen Zeitalter (1969); trad. it., L’uomo nell’era della
tecnica, a cura di M.T. Pansera, Armando, Roma 2003, p. 32.
24 A. GEHLEN, L’uomo, cit., p. 64.
25 Ivi, p. 64, Gehlen dice espressamente: «non ci si deve lasciare indurre alla
supposizione che l’uomo sia solo gradualmente diverso dall’animale».
274
Vallori Rasini
struttura biologica umana, è difficile stabilire come si delinei oggi il futuro
dell’uomo: sempre più esposto alla manipolazione biologico-genetica e
sempre più bisognoso di manipolazione. Se si parte da una prospettiva
come quella gehleniana (peraltro largamente condivisa dal pensiero
contemporaneo), c’è da chiedersi quale statuto spetti davvero all’essere
umano. È un animale tra animali o qualcosa di diverso? Va considerato un
essere “naturale” o “artificiale”? O meglio: come si innesta l’artificialità
sulla sua naturalità originaria? La domanda, tuttavia, è forse mal posta; e
magari il problema va spostato all’indietro, fino a investire il significato
stesso dell’essere dell’uomo (e del vivente). Siamo certi che il divorzio di
natura e cultura rappresenti una premessa corretta o indispensabile?
Questa dicotomia costituisce un paradigma realmente fecondo
nell’interpretazione della realtà e del ruolo dell’uomo nel mondo?
Intanto, un dato certo pare che – qualunque sia la “verità” su di lui –
l’uomo riesce a immaginare la propria identità soltanto attraversando
l’ambiguità: il doppio, l’ambivalente, l’indefinito descrivono le sue
potenzialità meglio di qualunque precisa, univoca determinazione.
Abstract
This article analyses the themes of nature, culture and human ambiguity in
the thought of Arnold Gehele. After taking into account the dyad constituted
by nature and culture, showing the influence of Scheler’s thought, the author
turns his attention to the issue of the environment and the world in relation to
man as living being.
SANDRA REBOK
Between Nature and Culture
Thomas Jefferson’s and Alexander von Humboldt’s interactions
with the Natural World1
The eighteenth century was not only characterized by a questioning of
the old social order and the search for alternatives to the traditional
structures in society and politics. Different approaches to nature, a more
profound understanding of the natural environment and the interaction of
Mankind with the Natural World was also a much debated issue. The
European encounter with America had led to an intellectual confrontation
within the field of the natural history as well as the ethnography of the New
World. Thus new scenarios had appeared on the other side of the Atlantic,
adding interesting impulses to the philosophical and scientific study of the
relationship between nature and culture. Talking about these areas of
knowledge, we have to be aware that in the early eighteenth century natural
history had a different meaning from today: it was divided into Natural
Philosophy – containing a more scientific approach to understanding,
looking for the definition and description of nature and the physical universe
– and Moral Philosophy, focusing more on the content of morality, and
meta-ethical discussion of the nature of moral judgments and values.
This was the period of time when the Virginian politician, architect and
naturalist Thomas Jefferson (1743-1826) as well as the Prussian traveller
and scientist Alexander von Humboldt (1769-1859) grew up. These two
personalities both participated actively in the exploration of the Natural
World, as well as in the scientific debates of their time. Furthermore, they
were two of many intermediaries participating in the transfer of
knowledge between the Old and the New World, and demonstrated the
importance of transatlantic communication in the open exchange of
1 This work has been undertaken under the framework and with financial aid of the
research project HAR2010-21333-C03-02, financed by the Ministerio de Ciencia e
Innovación and within the activities aimed at the dissemination of science carried out at
the Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica at the Spanish National
Research Council in Madrid..
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 275-288
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064318
275
276
Sandra Rebok
political as well as scientific ideas and information. After their personal
encounter in 1804, during Humboldt’s visit to the United States at the end
of his famous American expedition, for the next twenty years they
maintained a personal correspondence in which they exchanged specific
information as well as their opinions about the important events of their
time. Due to their authority and position in their respective societies, their
ideas had a particularly far-reaching historical impact, and were thus also of
much interest to each other.
This text examines the interaction of Humboldt and Jefferson with the
Natural World, to which both, conditioned by their personal interests as
well as their respective historical backgrounds, showed a different approach.
Furthermore, their contribution to the debate on the Nature-Culture
relationship will be discussed, particularly those aspects concerning the
impact of culture on nature and their early approach to questions which
today are understood as environmental concerns and theories.
An approach from the Old World
From the beginning of his scientific activities, the Prussian clearly stated
how he defined the aim of his research: to study, analyse and describe the
Natural World. His concept of science envisaged the Earth as an indivisible
organic whole, all parts of which were mutually interdependent.
Humboldt regarded this synthesis as a harmonious unity and put his focus
on the scientific analysis of the ways in which things and phenomena on
Earth depend upon each other, in order to understand how the earth’s
natural systems are woven together. According to this holistic view and his
understanding of human society and nature as an interdependent system,
Humboldt also looked for the interconnection of human and physical
nature, an idea which later on inspired the term “ecology” 2.
Already in his work Geography of Plants, published in 1805, he expresses
the idea which he develops in a much more detailed way in his final and
synthesizing opus Kosmos, by stating that «[…] in the great chain of causes
2 O. FRÄNZLE, “Alexander von Humboldt’s holistic world view and modern interand transdisciplinary ecological research”. Proceedings: “Alexander von Humboldt’s
Natural History Legacy and its Relevance for Today”, Northeastern Naturalist, 2001,
Special Issue 1, pp. 57-90.
Between Nature and Culture
277
and effects no material, no activity can be considered in isolation»3. Thus
to Humboldt plant geography was a crucial link between the natural
sciences and the human sciences, which constituted a distinctive tradition
of inquiry; it «persisted, developed and diversified throughout the
nineteenth century»4. As he wrote in his Personal Narrative of Travels, he was
more concerned with the distribution of vegetation and its relationship to
climatic zones as well as other factors that affected the way it spread, and
less with the mere description of individual plants or species:
I was passionately devoted to botany, and certain parts of zoology, and
I flattered myself that our investigations might add some new species to
those which have been already described; but preferring the connection of
facts which have been long observed to the knowledge of insulated facts,
although they be new, the discovery of an unknown genus seemed to me
far less interesting than an observation on the geographical relations of the
vegetable world, or the migration of social plants, and the limit of the
height which their different tribes attain on the flanks of the Cordilleras 5.
In his later years, in his magnum opus Kosmos – his scientific testimony,
which articulated a grand theory of natural history – this concept was
extended through the unification of all creation on earth, as well as
everything in the universe, in order to present what he calls a “physical
description of the world”. In the foreword to this publication he describes
in detail his goal in relation to his holistic idea:
The principal impulse by which I was directed was the earnest
endeavour to comprehend the phenomena of physical objects in their
general connection, and to represent nature as one great whole, moved
and animated by internal forces. My intercourse with highly-gifted men
early led me to discover that, without an earnest striving to attain to
knowledge of special branches of study, all attempts to give a grand and
general view of the universe would be nothing more than a vain illusion.
3 A. VON HUMBOLDT, Essay on the Geography of Plants (ed. by S. T. JACKSON).
University of Chicago Press, Chicago 2009, p. 79.
4 M. NICOLSON, “Humboldtian Plant Geography after Humboldt: The Link to
Ecology”, The British Journal for the History of Science, vol. 29, n. 3 (Sep., 1996), pp. 290.
5 A. VON HUMBOLDT and A. BONPLAND, Personal Narrative of Travels to the Equinoctial
Regions of the New Continent, during the Years 1799-1804, 7 vols., Longman, London
1814-1829, here: 1822, vol. 1, p. iii.
278
Sandra Rebok
Humboldt not only applied his concept to different academic disciplines
and their interdependency, but also in a geographical sense to the
connections between certain regions. It was the comparison between
geographical territories he was interested in, including the connection
between the political and social movements he was able to observe. He
envisioned a program of comparative studies between America and Asia, a
goal he had from the beginning, although finally he was not able to carry it
out in the way he had planned, since for several reasons his Asian
expedition had to be limited to his journey through Russia in 1829. Thus
his view was always directed rather towards the relationship between
Europe and America. As a consequence, although for him our modern
term “Atlantic World” did not exist as such, he was fully aware of the
interconnection of the different regions that form part of this world.
We also have to bear in mind that as far as both his period and his
working methods are concerned, Humboldt has to be situated between
two different eras: the Enlightenment and the Age of Romanticism. On the
one hand, his scientific concept can be characterized as marked by the
Enlightenment, which was evident in his use of measuring instruments in
order to explore and understand the unknown world, or his method of
establishing separate measurements in order to be able to compare them.
In this sense, the methodology applied by Humboldt is considered
pioneering and modern: he kept field notebooks, numbered and classified
the specimens he found; together with his team he produced numerous
scientific illustrations, and his research results were published with strict
attention to procedure and detail. His integrative and global vision of the
American reality, on the other hand, leading him to more general
considerations, should be understood as an anticipation of the practices of
perception of the Romantic period. In particular Humboldt’s approach to
nature reveals how he moved between these two concepts: he put into
practice the concerns of the Enlightenment – to organize and measure
Nature to understand how each part functions – and included the focus of
the Romantic Movement on the subjective element of perception in the
description of nature6.
6 For more information on this issue, see: M. DETTELBACH, “Alexander von
Humboldt zwischen Aufklärung und Romantik”, in O. ETTE, U. HERMANNS, B. M.
SCHERER and C. SUCKOW (eds.), Alexander von Humboldt – Aufbruch in die Moderne, Berlin,
2001, pp. 137-149; M. M. SANZ and L. A. FALCÓN, “Del racionalismo ilustrado a la
sensibilidad romántica: La concepción singular del cambio de paradigma en la ciencia de
Between Nature and Culture
279
Another characteristic of Humboldt’s approach to nature can be seen in
his position between these two periods: he did not separate science and
art, but used them in connection and as complements to each other7. Thus
the result of his American expedition is not only presented to us in written
form, but also in the form of beautiful illustrations of different types of
landscapes or specific parts of nature, for instance of particular animals or
plants. With these artistic and visual presentations of scientific information
he sought to show in a more obvious way the links between the different
phenomena. Among his famous illustrations, for instance, are two crosssections of mountains, one representing the Teide, the highest mountain in
Spain, situated on the Canary island of Tenerife, and the other Mount
Chimborazo in Ecuador, where he showed the different “zones of
habitation”, i.e. the different kind of plants which grow at a particular
altitude and in specific climatic conditions.
With his fundamental assumption that neither humans nor nature can
be understood in isolation, that the human being is interconnected with its
natural environment, Humboldt inspired what we now call an
environmental discourse8. In his writings nature plays an essential role,
but not only in those publications dedicated to the representation of
natural phenomena. A fundamental experience for all his theories and
scientific convictions was his exploration of the different areas, landscapes
and environments of the American continent. As a consequence of what he
had seen and analysed during a very early stage of his expedition, in his
work Geography of Plants, Humboldt was able to argue that cutting down
forests causes climate change. In addition, the way in which he shows the
consequences of deforestation, of exposing bare soil to heat and wind, or
Alexander von Humboldt”, in M. A. LIRES et AL. (eds.), Estudios de Historia das Ciencias e
das Técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas,
vol. I, Pontevedra, 2001, pp. 349-357.
7 S. REBOK, “El arte al servicio de la ciencia: Alexander von Humboldt y la
representación iconográfica de América.” in: Publication on CD, 51º Congreso
Internacional de Americanistas, celebrated in Santiago de Chile, July 2003.
8 See L. D. WALLS, “Rediscovering Humboldt's Environmental Revolution”,
Environmental History, pp. 758-760; L. D. WALLS, The Passage to Cosmos. Alexander von
Humboldt and the Shaping of America, University of Chicago Press, Chicago and London
2009, pp. 8-9; A. SACHS, “The Ultimate ‘Other’: Post-Colonialism and Alexander Von
Humboldt's Ecological Relationship with Nature”, History and Theory, vol. 42, n. 4,
Dec., 2003, pp. 111-135; F. N. EGERTON, “A history of the ecological sciences, part 32:
Humboldt, Nature’s Geographer”, Bulletin of the Ecological Society of America, July 2009,
pp. 253-282.
280
Sandra Rebok
the ecological damage caused by the European exploitation of their tropical
colonies, through water shortage or mono-agriculture – an idea he
develops further in his Political Essay on the Kingdom of New Spain – can be
considered as important early steps into the field of environmental studies.
Talking about the aridity of the central Mexican plains and the lack of trees
in his work on New Spain, for instance, he states that: «These
disadvantages have augmented since the arrival of Europeans in Mexico,
who have not only destroyed without planting, but in draining great
extents of ground have occasioned another more important evil»9. In the
same line of thinking he had also observed and criticized the poor irrigation
system established by the Spanish in Mexico, which according to him was
going to make New Spain as dry as the metropolis:
This diminution of water experienced before the arrival of the
Spaniards, would no doubt have been very slow and very insensible, if the
hand of man, since the period of the conquest, had not contributed to
reverse the order of nature. Those who have travelled in the peninsula
know how much, even in Europe, the Spaniards hate all plantations, which
yield a shade round towns or villages. It would appear that the first
conquerors wished the beautiful valley of Tenochtitlan to resemble the
Castilian soil, which is dry and destitute of vegetation. Since the sixteenth
century they have inconsiderately cut, not only the trees of the plain in
which the capital is situated, but those on the mountains which surround
it10.
Also in his Personal Narrative he mentions how «the first colonists very
imprudently destroyed the forests» and as causes for the diminution of the
lake of Valencia he again enumerates the destruction of the forests, the
clearing of the plains, and the cultivation of indigo, among other factors11.
It is interesting, moreover, that although he normally tended to limit
his specific criticism of the Spanish government in its colonies, in the
context of these environmental concerns he made his views very clear
about his rejection of the colonial exploitation of other countries. Here he
finds the opportunity to express his first warnings that in remaking the
landscape the delicate natural balance would be affected, and that this
9 A. VON HUMBOLDT, Political Essay on the Kingdom of New Spain, 2 vols., I. Riley,
New York 1811, here: vol. 1, pp. 59-60.
10 Ibid., p. 22.
11 A. VON HUMBOLDT (1814 -29), vol. 4, pp. 63-64, 142.
Between Nature and Culture
281
would lead to a destruction of nature and also to an impact on mankind,
which formed part of the natural system. With his attempt to predict the
consequences of human activities on the natural environment, Humboldt
was thinking in a way that today we would call “global”. This way of
thinking, and the subsequent analysis and understanding of facts, added
much information to the study of nature and laid the groundwork for new
fields of knowledge that are now known as climatology or ecology. Thus,
inspired by this Prussian explorer, more than 100 years before the idea of
an ecosystem caught on in the popular imagination, many of America’s
first naturalists and scientists continued to explore this field of
interdisciplinary knowledge12.
An approach from the New World
Jefferson’s approach to the natural world was a different one from
Humboldt’s, since he was born and raised on the edge of the Virginian
frontier; thus from early childhood he was surrounded by the world of
nature, unaltered by mankind. He loved Virginia, the richly varied
landscapes, its flora and fauna, and yearned to be at home when he was
away. His first home was Shadwell, the farm of his father Peter Jefferson,
and it was there where he very early became a collector of minerals,
plants, animal bones, insects and fossil shells. The young Jefferson was
very much interested in the cycles of nature and became a close observer
of nature; he learned directly from nature the rhythm of planting and
harvesting, and lived in a balance with his natural surroundings13. For his
entire life he always tried to maintain this strong connection to nature,
which provided him his personal tranquillity and balanced character, as
shown in this famous quotation taken from a letter to Nemours: «Nature
intended me for the tranquil pursuits of science by rendering them my
supreme delight. But the enormities of the times in which I have lived,
have forced me to take a part in resisting them, and to commit myself on
12 Aaron SACHS fully develops his thesis of Humboldt's defining influence on
modern environmentalism in The Humboldt Current, Nineteenth-Century Exploration and the
roots of American Environmentalism, Viking Penguin, London 2006; see also L. D. WALLS,
“The Search for Humboldt”, Geographical Review, 96 (2006), pp. 473-477.
13 K. THOMSON, A Passion for Nature. Thomas Jefferson and Natural History, Monticello
Monograph Series, Thomas Jefferson Foundation, Monticello 2008, p. 15.
282
Sandra Rebok
the boisterous ocean of political passions»14. It was in his years in Europe,
when he represented the young American nation in Paris, that his interest
in natural science received a new impulse through contact with the leading
scientists there15.
Generally speaking, there were two sides of Jefferson’s attitude
towards the Natural World: many aspects of wild nature appealed to his
aesthetic side, to his heart: he always associated his greatest contentment
with closeness to nature. In some of his letters, especially in those directed
to women, and among them particularly his close friend Maria Cosway,
Jefferson could also become very passionate about landscapes. His passion
for nature can also be seen in the fact that in 1774 he purchased the 157
acres surrounding the Natural Bridge near Lynchburg, one of his favourite
places in Virginia, which he called the “most sublime of Nature’s works”16.
When he visited this place for the first time in 1767 he sketched the bridge
and made annotations in his Memorandum Book, which served as the basis
for his famous descriptions in his work Notes on the State of Virginia, the first
publication on the Natural History of Virginia. In this description he not
only contributed information about its size and geological formation, but
also the very passionate impressions made on him by this natural wonder:
«It is impossible for the emotions, arising from the sublime, to be felt
beyond what they are here: so beautiful an arch, so elevated, so light, and
springing, as it were, up to heaven, the rapture of the Spectator is really
indescribable!»17. Nevertheless, on the other hand he was also an intensely
practical man. For him the nature he lived in was something to control,
shape and change, since taming nature meant requiring detailed knowledge
to understand its mechanisms18. For Jefferson and his fellows nature had an
14 Jefferson to Nemours, 2 March 1809, Thomas Jefferson Papers, Library of
Congress.
15 Regarding Jefferson and science, see M. CLAGETT, Scientific Jefferson Revealed,
University of Virginia Press, Charlottesville 2009; E. T. MARTIN, T. Jefferson: scientist,
Collier Books, New York 1961; S. A. BEDINI, Thomas Jefferson, Statesman of Science,
Macmillan Publishing Company, New York 1990; S. A. BEDINI, Jefferson and Science,
Monticello Monograph Series. Charlottesville, Virginia: Thomas Jefferson Foundation;
Chapel Hill, North Carolina, Distributed by the University of North Carolina Press,
2002.
16 W. PEDEN (ed.), Thomas Jefferson: Notes on the State of Virginia, University of
North Carolina Press, Chapel Hill 1982, p. 24.
17 Ibid., p. 25.
18 K. THOMSON, A Passion for Nature, cit., p. 17.
Between Nature and Culture
283
active presence in their world; nature was what they encountered by
working with it day by day, it was what they had to master and make work
for them.
In his personal library the bibliography on the Natural World was quite
intensive. Jefferson had publications of the best known natural historians
of his time – Buffon, Linnaeus, Barton, Cuvier, Peale, as well as Humboldt
– and was inspired by their works19. Also in his own writings the word
nature appears very frequently and in different meanings: he refers to
nature in its basic principles, in a broader sense: natural law, natural right,
American nature, natural reason, natural means etc20. While for Jefferson
knowledge was everything, it was best when applied directly for a useful
purpose, since in early America practical matters had to be solved and he
had to find solutions for imminent problems. As he confirmed in a letter to
John Adams: «I am not fond of reading what is merely abstract, and
unapplied immediately to some useful science»21. It is important to bear in
mind that for Jefferson the study of Natural History was not just a hobby,
but was a crucial tool for his understanding of and his interaction with
nature: «out of his passion for natural history, Jefferson developed the
belief that nature is the guide to all that is good and pure and thus must be
the basis of a person’s education and subsequently their general
philosophy»22. This idea thus contrasted with the European approach to
nature common during the Enlightenment, or the idea of nature prevailing
afterwards during the Romantic Epoch. Finally, his idea of nature and the
use of the word can even be understood as his form of nationalism: against
Europe’s rich history and civilization, Jefferson puts America’s grand
nature, which was essential for the country, providing the base which
allowed it to prosper23. Also, in his last years, when he was defining the
19 E. MILLICENT SOWERBY (ed.), Catalogue of the Library of Thomas Jefferson,
Charlottesville 1983, vol. I, “History - Natural”, p. 297-545. 7. See also the large lists of
books and pamphlets on agriculture, gardening and botany in Jefferson’s library,
included in the annex in E. MORRIS BETTS (ed.), Thomas Jefferson´s Garden Book 17661824, Thomas Jefferson Memorial Foundation, Charlottesville 1999, with relevant
extracts from other writings.
20 C. MILLER, Jefferson and Nature. An Interpretation, John Hopkins University Press,
London 1988, p.1-4.
21 Jefferson to Adams, 14 October 1816, Thomas Jefferson Papers, Library of
Congress.
22 K. THOMSON, A Passion for Nature, cit., p. 20.
23 C. MILLER, Jefferson and Nature, cit., p. 9.
284
Sandra Rebok
classes to be taught in the University of Virginia, he still championed the
cause of nature: out of eight schools one was Natural History and another
Natural Philosophy.
Like his Prussian counterpart, and according to the methods of the
Enlightenment, Jefferson wanted to understand the world through his
precise scientific measuring instruments. Despite a lifelong career in public
service, Jefferson always remained a practicing and practical farmer; he
was also a horticulturist, experimenting with many varieties of plants and
vegetables, and converted Monticello and his other estates into progressive
experimental farms, where new plants were introduced and nurtured24.
His interest in his gardens was connected to the agricultural and
horticultural needs of the United States, but it was also a means to express
in practical terms his knowledge as well as his love for nature. He was
convinced that the introduction of new plant species would direct nature
for man’s benefit; so Monticello was his observatory and laboratory, where
he put his ideas into practise. Trying to find out what kinds of plants grow
in Virginia and under what conditions was for Jefferson another level of
devotion or contribution to his country and the American idea in general:
«The greatest service which can be rendered any country is, to add a useful
plant to its culture»25. His interest in the application of the practical
sciences can for instance be seen in his aspirations to produce wine in
Virginia26. As well as several other types of plants that he tried to make
grow in the United States with varying success, his efforts in this sense can
also be appreciated in his attempts to introduce livestock to his country,
importing animals such as the merino sheep and sheep dogs.
Jefferson’s pragmatic interest in the sciences has to be understood in
conjunction with his political mission. As a naturalist, he was personally
fascinated by all kinds of scientific studies, simply because he was curious
about the operations of nature. Nevertheless, he was always aware that he
24 P.J. HATCH, The Gardens of Monticello, Thomas Jefferson Memorial Foundation,
Charlottesville 1992, p. 5. See also: P. J. HATCH, The Fruits and Fruit Trees of Monticello.
University Press of Virginia, Charlottesville - London 1998; PETER J. HATCH, “A rich spot
of earth”: Thomas Jefferson’s Revolutionary Garden at Monticello, Yale University Press, New
Haven (Conn.) 2012.
25 P. L. FORD, The Writings of Thomas Jefferson, G. P. Putnam’s Sons, New York London: 1904 -5, vol. 7, p. 477.
26 J. HAILMAN, Thomas Jefferson on Wine, University Press of Mississippi, Jackson
(Miss.) 2009; R. DE TREVILLE LAWRENCE (ed.), Jefferson and Wine. Model of Moderation,
The Vinifera Wine Growers Association, The Plains (Virginia) 1989.
Between Nature and Culture
285
had two roles which he had to combine, as he mentioned in a letter to
Harry Innes talking about Natural History and Politics: «The first is my
passion, and the last my duty, and therefore both desirable»27.
Jefferson was not only interested in Natural History, but also in the
different aspects of the present natural world surrounding him. In
particular the Indian population had always been an important issue for
him; his personal encounters with the native population began during his
boyhood in Virginia and extended throughout his public career and into his
retirement28. Thus the particular situation of the Indians and all the
connected debates had accompanied him during his entire life in different
contexts: being among white farmers trying to obtain land from the native
population; later with his political rhetoric towards native Americans
during the Revolution; his proposals for scholarly studies of the indigenous
languages, cultures and ancient origins; his political program regarding the
Indians while serving as President of the U.S., in his effort to establish
peace with the tribes of the Louisiana Territory; or encountering
opposition to the civilization program from Native American religious and
political reformers29.
On numerous occasions he defended the Indians, in his Notes on the State
of Virginia as well as in letters to his correspondents on both sides of the
Atlantic. This defence of the native population can also been seen in the
context of the debate on the assumed inferiority of the New Continent –
his defence of American animals and plants as well as people.
Jefferson showed a rather scientific and political approach to Indians: he
was not interested in them in a philosophical or romantic sense, common
in Europe at that time, nor did he see them as objects of curiosity, or limit
his interest to the fact that they presented an obstacle to the westward
27 Jefferson to Harry Innes, 7 March 1791, in B. B. OBERG, J. JEFFERSON LOONEY
(eds.), The Papers of Thomas Jefferson, Retirement Series, vol. 19, 2008, p. 521.
28 More information about Jefferson’s attitude towards Indians can be found in A.
F.C. WALLACE, Jefferson and the Indians: the Tragic Fate of the First Americans, Cambridge
(Mass.) 1999; B. E. JOHANSEN, Franklin, Jefferson and American Indians: a Study in the Crosscultural Communication of Ideas, Ph.D. dissertation, University of Washington, Seattle
(WA - Usa) 1979; R. G. KENNEDY, “Jefferson and the Indians”, Winterthur Portfolio, vol.
27, 2/3 (1992): pp.105-21; S. G. BRAGAW, “Thomas Jefferson and the American Indian
Nations: Native American Sovereignty and the Marshall Court”, Journal of Supreme Court
History, vol. 31, 2 (2006), pp. 155-80; B. W. SHEEHAN, Seeds of Extinction: Jeffersonian
Philanthropy and the American Indian, Norton, New York 1974.
29 F.C. WALLACE, Jefferson and the Indians, cit., pp. viii-ix.
286
Sandra Rebok
expansion of the Whites. He wanted to acquire more knowledge about
them and asked basically the same questions as did the European scholars:
where did the Native Americans come from? What were the differences
between the tribes and their languages? What were the real differences
between Indians, Europeans and Asians beyond those that resulted from
dissimilar circumstances? And what, therefore were the underlying
similarities30?
The Lewis and Clark expedition, organized and dispatched by Thomas
Jefferson in order to explore the American West (1804-1806), was also
very much focused on obtaining detailed information about the native
inhabitants of the regions they crossed, particularly concerning their
languages and their customs. This interest becomes clear in the long
instructions Jefferson handed over to Meriwether Lewis, revealing his
convictions regarding the Indians: he told them to treat the native
inhabitants with respect, to meet all native groups on an equal footing and
to negotiate with them; and then to come back with information about
their language, traditions, monuments, their laws, customs, or their
relations with other Indian tribes31.
As a scholar he was also interested in understanding the native
American population in their original conditions, before being changed by
the influence of Europeans. It was a genuine interest he never lost and
which contributed in a considerable way to develop the nascent disciplines
of anthropology and ethnology, as well as comparative linguistics in the
United States. By the end of his presidency, Jefferson had collected lists of
vocabularies of some fifty different Indian languages, many from the efforts
of the Lewis and Clark expedition; some others he had collected himself
during his “northern Journey” with James Madison in 1791. As a politician,
however, he held the hard-headed view that there were only two choices
for the Indians: assimilate or to be destroyed. This led to the bizarre
situation that on one hand there was Jefferson, the naturalist, who
collected Indian vocabularies, the excavator of ancient burial mounds,
chronicler of the eloquence of America’s native peoples, and the mourner
of their tragic fate; and on the other, Jefferson the imperialist and architect
of Indian removal. Nevertheless, these are the two sides we encounter in
many different situations or contexts of his life and which are characteristic
30 THOMSON, A Passion for Nature, cit., p. 102.
31 Thomas Jefferson to Meriwether Lewis, 20 June 1803, Instructions, Thomas
Jefferson papers, Library of Congress.
Between Nature and Culture
287
of the context he lived in: Jefferson, the scholarly scientist, in his role as
president of the American Philosophical Society, expressed himself and acted
differently from Jefferson the politician, engaged in the making of a new
nation.
As we can see, Humboldt’s and Jefferson’s approaches to the Natural
World have several coincidences or aspects in common, in spite of the
obvious differences in their upbringing and the context they lived in –
Jefferson as a Virginian countryman and Humboldt as a cosmopolitan
person. No doubt this can be partially explained by the enlightened spirit
of their times. But beyond that it also shows a similarity in their minds and
personal interests, which became the basis for the lifelong lasting
friendship and interest in each other’s actions and thoughts.
In both cases their approach to and understanding of nature was
basically marked by the postulates of the Enlightenment – they measured
all different aspects with their beloved scientific instruments.
Nevertheless, years before the Romantic era started, with its particular
understanding of nature, in their letters as well as their writings they also
expressed a Romantic approach to nature and showed themselves
impressed by the majesty of certain landscapes.
Furthermore, both were involved in the philosophical and scientific
debates of their time, such as for instance the assumed inferiority of
America, and aimed to acquire new knowledge in different fields, through
bibliographical research, through the application of information resulting
from their own experiments, as well as from the exchange and comparison
of data, theories or ideas with other learned men of their time. The
transatlantic perspective in this context in particular is an aspect that
characterized their methodology in the Natural Sciences. They also had in
common that none of them specialized in one particular scientific field, but
both were aware of the importance of understanding the
interconnectedness of natural phenomena. Even in their view of mankind
as closely linked to nature, their studies were developed independently
from each other, but in the same direction: It was not only Humboldt who
pointed out the connection of climate and soil formations with the
distribution of plant and animal life, as well as the importance of the
relation of the geographical environment to the development of mankind,
particularly in the context of colonization, commerce and industry.
Jefferson, too, touched on all phases of the natural history of a region in his
Notes on the state of Virginia, and did not confine himself to a mere
288
Sandra Rebok
enumeration of towns, boundaries, inhabitants, industries, products and
the form of government in Virginia. Thus for instance he describes not
only its rivers, but also their relationship to commerce and especially to
their possible utility in trade; he furthermore classifies the plants and trees
as to their value for ornamental, medicinal and esculent purposes and
includes comparative views of America’s native birds and animals with
those of Europe32. Jefferson also correlated the data he found with
different phenomena, and studied the impact of the elimination of the
forests on the change of climate or the impact weather had on mankind.
The difference is that Humboldt was basically a scientist and was therefore
not only able to deepen his ideas and develop his theories based on them,
but also to expand his scientific ideas in a much broader way. As a
consequence, today Humboldt is considered to be an important forefather
of modern environmental thinking, whereas Jefferson’s early contribution
to the fundamentals of ecological concerns remains rather neglected.
Abstract
This contribution defines the approaches taken by the Prussian explorer and
scientist Alexander von Humboldt (1769-1859) and the Virginia statesman and
naturalist Thomas Jefferson (1743-1826) to nature and examines their respective
understanding of and interaction with the Natural World. Though conditioned
by their personal interests as well as their respective historical backgrounds, they
showed a different concept of nature, both took a global perspective and shared a
marked interest in the advance of science and the scientific exploration of the
New Continent: Humboldt through his own American expedition (1799-1804)
and Jefferson through the Lewis and Clark Expedition (1804-1806) he organized
and supervised during his presidency. Furthermore, both formulated a clear
response to the ideas of Buffon and de Pauw with respect to the assumed
inferiority of America—one from a European, the other from an American,
point of view. Finally, particular attention will be paid to those aspects
concerning the impact of culture on nature and their early approach to questions
regarding the relationship between man and nature, which today are understood
as environmental concerns and theories.
32 P. L. FORD, The Writings of Thomas Jefferson, cit., vol. XIII, 1907, p. iii.
GIACOMO SCARPELLI
MOSTRI, GIGANTI ED EROI
I fossili e le storie della storia del mondo
Paolo Rossi, maestro compianto, nei Segni del tempo indagò con
acutezza e rigore su come la scienza moderna ai suoi albori tentasse
d’interpretare la storia del mondo in seguito al ritrovamento sui picchi
montani di pietre con l’aspetto ora di conchiglie, ora di chiocciole, ora di
pesci1. Si trattava di fossili del Cambriano, del Devoniano e del Triassico,
ma ancora lunga era la strada da compiere prima di giungere a questa
spiegazione.
Il perdurare della credenza nella Creazione divina e l’ignoranza delle
trasformazione geologiche e biologiche costrinsero pertanto studiosi e
filosofi secenteschi, tra cui John Ray, Robert Hooke, Athanasius Kircher, a
ricorrere a soluzioni alquanto fantasiose: resti di crostacei, molluschi e
pesci sarebbero stati trasportati dalle rive del mare o dalle sue profondità
fin sulle vette dei monti da bufere di vento o da sconvolgimenti tellurici.
Oppure da intraprendenti pescatori, che dopo essersi cibati avevano
gettato via lische e gusci, i quali erano stati calcinati dal clima. Altre ipotesi
contemplavano la possibilità che i “corpi marini” fossero giunti in alta quota
a causa del Diluvio e del successivo ritiro delle acque. O, ancora, che la
“terra, gareggiando in fecondità col mare”, avesse prodotto animali simili a
quelli dei fondali oceanici. In qualche diverso caso si riteneva che ci si
trovasse di fronte a veri e propri scherzi di natura: i bizzarri reperti
avevano per puro accidente forme di esseri viventi ed erano stati prodotti
da una vis lapidifica del suolo stesso2.
1 P. ROSSI, I segni del tempo. Storia della Terra e storia delle nazioni da Hooke a Vico,
Feltrinelli, Milano 1979, pp. 21-149.
2 Ivi, pp. 22-25.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 289-298
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064319
289
290
Giacomo Scarpelli
Trascorrerà un secolo, sino al momento in cui si comincerà a
riconoscere le particolari pietre per quel che erano, testimonianze
organiche mineralizzate dell’immane vecchiezza del pianeta e delle
trasformazioni delle specie. Noi, tuttavia, prenderemo le mosse dai gusci
paleontologici alpini per prolungare lo sguardo storico a ritroso, alle spalle
delle dotte personalità che cercarono di conciliare le esigenze della ragione
con i dogmi della fede, spingendoci sulle sponde dell’antica Grecia e delle
sue colonie egee e ioniche. Per scoprire che la Grecia era stata anche la
prima civiltà che, imbattutasi nei resti fossili, li aveva percepiti e decifrati
al lume del suo peculiare pensiero creativo. In altre parole, investigheremo
su come gli ellenici lessero la documentazione del passato della natura con
lo strumento del mito.
Già James George Frazer, fondatore dell’antropologia novecentesca,
nel suo sforzo d’illustrare l’ascesa dell’Homo sapiens dalla magia alla
religione, alla scienza, aveva intuito che le reliquie paleontologiche
avevano avuto una funzione nei culti greci generati dall’atavico rapporto
dell’uomo con la natura, le sue forze segrete, i suoi cicli eterni3.
Lungo le coste della Cilicia occidentale, il panorama di pini, olivi e
piante di zafferano è punteggiato di bianche rovine elleniche e bizantine.
Tra cui, narra Frazer, quelle del tempio di Corico, consacrato a Zeus. Il
quale però, secondo la leggenda, qui pare avesse dovuto difendere il suo
regno da un temibile rivale, un terrificante essere acquattato in una vicina
caverna, profondissima e resa impenetrabile da una foresta di stalattiti. Era
il gigante Tifone, partorito dalla madre terra, fornito di torso umano e
corpo di rettile, munito di ali e grinfie di rapace e – nella descrizione di
Eschilo - dagli occhi che lampeggiavano di luce selvaggia e dal respiro di
fiamma4. Come già i Titani, anche Tifone assalì l’Olimpo, gettando
scompiglio tra gli dèi. Con una falce tagliò i tendini delle mani e dei piedi
di Zeus e l’imprigionò nell’antro coricio. Sarebbe finita così per il re dei
numi, se il fedele Hermes non l’avesse liberato e curato, con l’aiuto del
silvestre Pan. Tremenda la vendetta di Zeus, tornato sul trono: schiantò
con la sua folgore Tifone e lo scaraventò lontano, oltre l’Egeo, nelle
viscere dell’Etna.
G.J. FRAZER, Adonis Attis Osiris. Studies in the History of Oriental Religion. Part IV of the
Golden Bough, 2 voll., Macmillan, London 1914, I, pp. 152-161 (1a ediz. in un vol.,
1906).
4 ESCHILO, Prometeo incatenato, 351-372.
3
Mostri, giganti ed eroi
291
Questo il mito. Non era difficile individuarne la matrice tellurica e
vulcanica. Ma ciò non bastava a Frazer per delucidare la primordiale figura
del gigante e la localizzazione della sua tana di Corico. Lo studioso
britannico suppose che entrambe potessero essere messe in qualche
relazione con la scoperta di mammiferi estinti. Prendendo spunto dalla
constatazione del maestro di Darwin, il geologo Charles Lyell, secondo cui
le reliquie fossili di quadrupedi avevano diffusione in tutti i paesi affacciati
sul Mediterraneo, Frazer dimostrò che la Cilicia, e in particolare le sue
gole e caverne calcaree, erano ricche di conchiglie, ma anche di ossa di
mammut dell’èra Cenozoica5. La vera immaginazione creativa si distingue
dalla fantasia fine a stessa proprio perché parte dall’osservazione del reale e
la trasforma in narrazione seducente. Per tale motivo, l’autore del Ramo
d’Oro dedusse che la presenza di ossa pietrificate di grandi dimensioni,
associata alla fenomenologia vulcanica, avessero incendiato la vivida mente
dell’uomo antico, dando origine alla favola dei giganti dalle fauci
fiammeggianti che tentarono di assalire l’Olimpo e però furono sgominati
da Zeus.
Dal momento che anche in Trinacria – l’attuale Sicilia – i suoi abitanti
dovevano essersi imbattuti in resti di mammut, elefanti e ippopotami colà
estinti, era legittimo reputare che le spaventevoli spoglie che riemergevano
da un tempo immemorabile avessero contribuito, insieme alla lava etnea,
alla nascita del mito sia di colossali antenati degli isolani stessi, sia del
riottoso Tifone. Il quale, finito imprigionato sotto la montagna, per furiosa
frustrazione avrebbe periodicamente vomitato fuoco6.
A convalida di tali congetture, Frazer, che aveva solida formazione di
classicista e in passato aveva curato l’edizione della Periegesi della Grecia di
Pausania, menzionava anche il caso di Megalopoli, nell’Arcadia. La piana
di questa città, caratterizzata da eruzioni e vampe sulfuree, si tramandava
fosse stata teatro di una grandiosa battaglia tra Titani e dèi7. E qui erano
altresì venerate ossa di taglia sovrumana, appartenenti, si diceva, al colosso
Opladamo, che aveva protetto Rea, la madre di Zeus, dal vorace Crono.
Verosimilmente si trattava invece proprio di parti dello scheletro di
5 J.G. FRAZER, Adonis Attis Osiris cit., I, pp. 153 e 157. Cfr. C. LYELL, Principles of
Geology, 2 voll., Murray, London 187512, II, pp. 518 e segg. (1a ediz. in 3 voll. 18301833).
6 J.G. FRAZER, Adonis Attis Osiris cit., I, p. 157; A. HOLM, Geschichte Siciliens im
Alterthum, 2 voll., Engelmann, Leipzig 1870-1874, I, pp. 57-356.
7 PAUSANIA, Periegesi della Grecia, VIII, 29.1
292
Giacomo Scarpelli
mammut – l’antenato dell’elefante, dal pelame bruno e dalle lunghe zanne
ricurve – che oggi sono conservati in un museo locale8. Le conclusioni del
precorritore Frazer furono quindi che si dovessero riconoscere quali parti
integranti della mitologia i racconti di giganti e di mostri scaturiti in
connessione con i ritrovamenti di grandi ossa fossili9.
Pertanto, non sarebbe azzardato affermare che il mito, espressione di
quell’estro poetico che Vico definì “corpolentissimo”10, generatore di
infinite “storie della storia del mondo”, discendesse anche dalla
paleontologia, molto tempo prima che essa diventasse una scienza11.
Le leggende sui Ciclopi – su Polifemo fra tutte – ebbero
presumibilmente origini analoghe. Non si trattò però solamente di giganti
e di titani. Il ritrovamento di denti appartenuti ad animali preistorici è da
ritenere fosse di per sé occasione per partorire ulteriori vicende favolose.
Come quella di Cadmo.
Figlio del re fenicio Agenore, Cadmo errò alla ricerca della sorella
Europa, rapita dall’insaziabile Zeus. Nel suo vagare il prode principe fondò
la città di Tebe e dovette affrontare il drago che divorava chiunque si
avvicinasse alla vicina fonte Diria. Sconfitto il drago, la protettiva Atena gli
consigliò di cavargli i denti e di seminarli. Cadmo ubbidì e da quei denti
germogliarono e s’incarnarono animosi guerrieri; Cadmo li confuse
scagliando in mezzo a loro pesanti pietre, e quelli, non sapendo da chi
fossero colpiti, presero a massacrarsi a vicenda. Ne sopravvissero
solamente cinque, gli Sparti (letteralmente “i seminati”), che divennero i
capostipiti delle famiglie tebane. Cadmo non riuscirà mai a ritrovare la
sorella (che d’altronde diverrà felice madre di Minosse, sovrano cretese),
ma sarà il primo re di Tebe e sposerà Armonia, figlia di Ares e Afrodite, e
8 Ivi, VIII, 32.5. Frazer tradusse e curò quest’opera: Pausanias’s Description of Greece, 6
voll., London, Macmillan 1898; vedi in particolare il commentario, IV, p. 352. Mi
permetto di rinviare anche al mio “Frazer e il bosco sacro”, in Bollettino Filosofico
(Università della Calabria), XVII, 2001, pp. 419-428.
9 J.G. FRAZER, Adonis Attis Osiris cit., I, p. 158. In seguito il tema dei fossili e della loro
interpretazione nel mondo antico fu affrontata da W.R. HALLIDAY: The Greek Questions
of Plutarch, Clarendon Press, Oxford 1928.
10 Vedi di G.B. VICO, La Scienza Nuova, a cura di Paolo Rossi, Rizzoli, Milano 1977
(ediz. originale in 2 tomi, Stamperia Muziana, Napoli 1744).
11 Il richiamo a Storie della storia del mondo, che abbiamo apposto anche a sottotitolo del
presente testo, vuole essere un omaggio all’opera di Laura Orvieto (pubblicata per la
prima volta a Firenze da Bemporad, nel 1911, corredata delle splendide illustrazioni di
Ezio Anichini), che ha iniziato alle meraviglie della mitologia generazioni di bambini.
Mostri, giganti ed eroi
293
da lei avrà Semele, futura mamma di Dioniso12. Significativo che di questo
mito fosse tentata un’interpretazione storica fin dal IV secolo a.C., da
parte di Palefato, erudito e grammatico, autore del trattato Sulle cose
incredibili, che proponeva appunto una lettura razionale delle più
conosciute leggende greche. Cadmo avrebbe quindi combattuto non con
un drago, ma con un re dal nome Draco, possessore di una collezione di
denti di elefante più unica che rara; alcuni guerrieri si sollevarono per
impadronirsi di essa, e dopo aver deposto Draco si eliminarono l’un
l’altro. Al di là del risultato prosaico dell’esegesi di Palefato, non è da
escludere che gli antichi denti (o zanne?) di pachiderma da cui nacque la
leggenda fossero proprio di Mammuthus meridionalis pleistocenico.
Mille fili percorrono, intrecciano e inesauribilmente ricollegano la
mitologia, rinnovandone l’incanto. Uno sviluppo delle gesta di Cadmo è
ravvisabile in un episodio delle Argonautiche di Apollonio Rodio (III secolo
a.C.): Giasone, alla conquista del Vello d’Oro, si trova a dover sostenere
una prova al cospetto di Eeta, crudele monarca della Colchide (e fratello
della maga Circe). All’eroe tocca domare due tori infuriati, aggiogarli,
arare un campo e seminare manciate di quei denti strappati proprio dalle
mascelle del drago che Cadmo ha ucciso. Dai solchi dissodati subito spunta
una schiera di giganti dagli elmi lucenti. E Giasone, che ha ricevuto gli
accorti suggerimenti di Medea – la figlia di Eeta che spasima per lui – getta
fra costoro una grossa pietra rotonda, che li disorienta e li aizza, replicando
una scena più arcaica. Come cani voraci attorno a un osso, e levando alte
grida, i giganti si accoppano reciprocamente: “sopra la terra / madre
cadevano colpiti dalle proprie lance / come i pini e le querce travolti
dall’infuriare dei venti”13.
Dalla tenebra del passato riemergono dunque terrificanti creature.
Come ognuno sa, la mitologia è popolata anche di mostri veri e propri, che
diversamente da quelli fin qui esaminati non hanno il benché minimo
sembiante umano; è probabile che in qualche caso essi fossero concepiti
dalla mente greca sull’onda dello sgomento di fronte ai resti di specie più
ancestrali del mammut, vissute quando il genere Homo non era ancora
apparso, o muoveva barcollando i suoi primi passi da bipede.
Il destino di Dioniso sarà di finire fatto a pezzi e divorato da quegli stessi Titani che
avrebbero tentato l’assalto all’Olimpo.
13 APOLLONIO RODIO, Argonautiche, III, 1374-1376. Per l’intero episodio si vedano i
versi 1025-1405.
12
294
Giacomo Scarpelli
Lasciando da parte, con buona pace di Palefato, la questione se il drago
sconfitto da Cadmo fosse ispirato a qualche rettile del Giurassico, appare
accettabile l’ipotesi avanzata dalla studiosa americana Adrienne Mayor sulla
figura del Grifone14. L’essere alato, becco e artigli d’aquila, corpo di leone,
chiamato dagli elleni Gryps (da grypós, “adunco”), si immaginava giungesse
dalle steppe della Scizia, dove era stato custode di enormi ricchezze, che
aveva strenuamente difeso dalle razzie degli Arimaspi, avida popolazione
munita di un solo occhio. Effigiato su brocche, tazze, crateri, calderoni e
pissidi di Eubea, Samo e Olimpia, il Grifone, con la sua sagoma rostrata
rammenta la struttura di un dinosauro, il Protoceratops, o meglio del suo
scheletro15. Specie erbivora del Cretacico, il Protoceratops possedeva un
cranio massiccio e un muso prominente da rapace. Diffuso in Asia e
presumibilmente in illo tempore rinvenuto da genti locali durante gli scavi di
miniere d’oro, le ossa confuse nello strato geologico insieme a quelle di
altri animali, del grande rettile i greci avrebbero visto le raffigurazioni,
assorbendone nel proprio patrimonio culturale l’idea fiabesca
dell’irriducibile guardiano di tesori.
Analogo ragionamento potrebbe valere per il mostro emerso dalle onde
del mare cui viene offerta in sacrificio Esione dal padre Laomedonte, re di
Troia, allo scopo di placare l’ira di Poseidone e di Apollo. L’orrida
creatura è scatenata dai due numi per vendicarsi del mancato impegno del
sovrano di elargire loro doni per aver eretto le mura della città.
Provvidenzialmente Eracle trae in salvo l’innocente principessa, e trapassa
con i suoi dardi il mostro. Il volubile Laomedonte, benché abbia promesso
di regalargli i propri magnifici cavalli, si rimangerà nuovamente la parola,
attirandosi anche la ritorsione dell’eroe, che saccheggerà Troia.
Ebbene, l’iconografia greca (in particolare un vaso corinzio del 560
a.C.) rappresenta, nella scena cruciale dell’intervento di Eracle,
l’abominevole belva che sbuca da una grotta marina, la testa che ha
l’aspetto più che altro di un teschio di mammifero terrestre. Il modello è
stato individuato nel cranio fossile del Samotherium, una giraffa del Miocene
scoperta nell’isola egea di Samo16. Sorge però il dubbio che una scatola
A. MAYOR, The First Fossil Hunters, Paleontology in Greek and Roman Times, Princeton
University Press, Princeton and Oxford 2000.
15 Ivi, capitolo 1.
16 Ivi, pp. 15-21, 91-93, 151-161. Vedi J. BOARDMAN, Early Greek Vase Painting. 11th to
6th Centuries B.C., Thames & Hudson, London 1998, fig. 402. A riguardo, un lavoro
pionieristico fu svolto dal padovano Carlo De Stefani, direttore del Museo Geologico
14
Mostri, giganti ed eroi
295
cranica di giraffa, per quanto antidiluviana, non apparisse di per sé tanto
impressionante né per aspetto né per dimensioni. Non è quindi da
escludere che l’archetipo del predatore di Esione sia stata un’altra specie
estinta, di cui forse non sapremo mai nemmeno l’esistenza17.
Come che fosse, l’indagine potrebbe proseguire. Qui sarà sufficiente
osservare che svariate orme nel terreno solidificato, attribuite dai greci ai
portentosi piedi di qualche eroe o semidio, a prodigiosi cavalli o ad
ulteriori creature mitologiche, sono state in epoca recente riconosciute
quali impronte di conchiglie bivalvi e di voluminosi molluschi scomparsi18.
Tali considerazioni ci riconducono così alla decrittazione dei “corpi marini
che su’ monti si trovano” da cui abbiamo iniziato il nostro viaggio19. E
c’inducono a identificare nell’uomo ellenico uno stupore fertile,
inesauribile, quasi infantile nei confronti della natura primigenia, che
veniva evocata con colori ora vividi, ora foschi. Ne scaturiva il racconto, la
favola, che ricreava allegoricamente l’essenza della vita, della psiche, del
mondo e, per un processo d’inversione, si proponeva di darne riprova
tangibile nella realtà.
E così, non solo le mura di Troia erano state erette con l’ausilio degli
dèi, ma quelle della Micene degli Atridi erano state costruite macigno su
macigno dai Ciclopi. In un anfratto di Itaca era stata poi individuata la
grotta delle Ninfe cui Odisseo era devoto20. La grande rupe sul monte
Sipilo, in Lidia, che rammentava un profilo femminile, le vestigia
di Firenze dal 1885 al 1924: “Les terrains tertiaires supérieurs du Bassin de la
Méditerranée”, in Annales de la Societé Géologique de Belgique, XVIII, 1891, pp. 201-419;
“Viaggio nella penisola balcanica”, in Bollettino della Società Geologica Italiana, XIV,
1895, pp. 283-284; e (insieme a C.J. FORSYTH MAYOR e W. BARBEY) Samos. Étude
géologique, paléontologique et botanique, Bridel, Lausanne 1891. Vedi anche A.B. COOK,
Zeus. A Study in Ancient Religion, 3 voll., Cambridge University Press, Cambridge 19141940, III, p. 3.
17 In ogni caso, più inquietante il teschio del Giraffokeryx punjabensis, giraffide più
antico, fornito di una testa con due paia di corna coniche, che i greci reputavano quella
pietrificata di un drago.
18 J. BOARDMAN, The Archaeology of Nostalgia. How Greeks Re-created Their Mythical Past,
Thames & Hudson, London 2002; trad. it. di M.C. Coldagelli, Archeologia della
nostalgia, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 32-33.
19 Impiego qui il titolo di una celebre opera di ANTONIO VALLISNERI, medico e
naturalista, allievo di Malpighi: De corpi marini che su’ monti si trovano, Venezia, Lovisa,
Venezia 1721.
20 Sull’argomento vedi J.V. LUCE, Celebrating Homer’s Landscapes. Troy and Ithaca
Revisited, Yale University Press, New Haven 1998.
296
Giacomo Scarpelli
pietrificate di Niobe, la nuova regina di Tebe, che orgogliosa della propria
numerosa figliolanza si era vantata di essere superiore alla dea Latona,
madre solo due volte: di Apollo e di Artemide. Questi ultimi, offesi e
adirati, avevano sterminato la prole della superba sovrana. Annientata dal
dolore, Niobe era fuggita lontano e non aveva mai cessato di versar
lacrime, che erano diventate ruscelli, e lei stessa era stata tramutata in
roccia21. E ancora, quel tumulo che si stagliava su un promontorio
dell’Ellesponto (l’attuale Yasse Tepe) era di certo la tomba di Achille,
l’eroe degli eroi, caduto durante l’assedio di Ilio22. Del resto, Schliemann
quando un giorno s’intestardirà a ritrovare le rovine di quella guerra fatale,
non farà forse suo il medesimo principio di riconoscimento, affidandosi alle
indicazioni disseminate nei poemi omerici?
Nel mondo classico si trasformavano in esseri mitici sia gli animali
estinti – come s’è visto – sia quelli viventi che popolavano terre lontane e
incognite. Le scimmie che s’intravedevano lungo le coste africane, con le
loro “membra scarne” e la coda “sull’osso delle natiche”, erano credute
Satiri, personificazioni della natura silvana, perennemente intenti a
inseguire ninfe leggiadre e riottose, ma anche sprovvedute comuni
mortali23. Un particolare genere di primati, i babbuini, passava poi per la
razza delle Sfingi, imparentata con le Arpie e con le Sirene e come loro
predatrici in gruppo. Era infine di una scimmia catarrina la pelle che veniva
esposta come reliquia di Marsia24, il suonatore di flauto che incautamente
aveva sfidato Apollo in una tenzone musicale e aveva perso; per punirlo
della sua boria il nume lo aveva legato a un albero e scuoiato vivo.
Dell’arco in verità il nome è vita, ma l’opera è morte.
Lo affermava inesorabile Eraclito, facendo forza sulla quasi identità dei
vocaboli biós (arco) e bíos (vita)25. Quest’illuminante metafora dell’Oscuro
G.E. BEAN, Aegean Turkey: an Archaeological Guide, London, Benn 1966, pp. 53-55.
Vedi anche P.M.C. FORBES IRVING, Metamorphosis in Greek Myths, Clarendon Press,
Oxford 1990.
22 J.V. LUCE, Celebrating Homer’s Landscapes cit., pp. 134-141.
23 PAUSANIA, Periegesi della Grecia, I, 23.5 e 6.
24 Cfr. J. BOARDMAN, The Archaeology of Nostalgia cit., trad. it., pp. 158-159.
25 ERACLITO, fr. 22B48 DK (H. DIELS-W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker,
Weidmann, Berlin 19526).
21
Mostri, giganti ed eroi
297
di Efeso richiamava proprio la figura di Apollo, solare arciere oltre che
insuperabile citaredo. Uno studioso attentissimo alle risonanze del sapere
greco quale Giorgio Colli, ha osservato che sia l’arco sia la cetra (o meglio
la lira), si ottenevano curvando con inclinazioni differenti le corna di un
capro, l’animale sacro a Dioniso, e innestandovi la corda per scoccare o
quelle da accordare26. La vita si realizza perciò nei frutti di entrambi gli
strumenti, emblemi di morte e di bellezza, che appaiono in contraddizione
all’occhio umano, ma sono pura armonia per quello olimpico.
Appare evidente che i greci effettivamente ricostituirono l’immagine
del cosmo e dell’esistere riproducendola sotto forma d’intensa e
ammaliante rappresentazione tanto simbolica quanto concreta. La
mitologia seppe raggiungere con l’intuizione poetica l’anima della natura
anche nelle sue intrinseche affinità e potenzialità. La sagoma o la pelle di
una scimmia poteva passare per quella di un uomo, in quanto, appunto,
antropomorfa. Non diversamente, l’immensa gabbia toracica e le lunghe ossa
degli arti di un mammut era credibile appartenessero a un gigante, così
come il profilo di un Protoceratops suggeriva un uccello colossale. Poiché il
progetto biologico dei vertebrati era il medesimo, poteva essere applicato
anche agli esseri d’invenzione, rendendoli verosimili. La poesia precede la
storiografia e, talvolta, la scienza. In questo senso parrebbe lecito parlare
del primo affacciarsi dell’idea di omologia strutturale che un giorno diverrà
elemento portante dell’evoluzionismo darwiniano. Basti pensare a colui
che ne sarà il massimo diffusore, Thomas H. Huxley, il quale individuerà
precisamente l’affinità tra dinosauri e uccelli27.
Scriverà Freud nel 1907 che il poeta «è sempre stato il precursore della
scienza e anche della psicologia scientifica»28. Toccherà proprio al
fondatore della psicoanalisi (appassionato lettore di Frazer) combinare i
principi evoluzionistici con le rappresentazioni della mitologia, per
penetrare nei tenebrali della mente e rivelarla con la lanterna della ragione.
Ma questa, come si dice, è un’altra storia.
G. COLLI, La sapienza greca, Adelphi, Milano 1980, pp. 25, 194-195. Dello stesso
cfr. Dopo Nietzsche, ivi 1974, pp. 44-45 e La nascita della filosofia, ivi 1985 [1a ediz.
1975], pp. 40-42.
27 T.H. HUXLEY, “On the Animals Which Are Most Nearly Intermediate between Birds
and Reptiles”, in Geological Magazine, V, 1868, pp. 357-365.
28 S. FREUD, Der Wahn und die Traüme in Wilhelm Jensens ‘Gradiva’, Heller, Leipzig und Wien
1907; trad. it. di C. Musatti, Il delirio e i sogni nella ‘Gradiva’ di Wilhelm Jensen, in Opere,
Bollati Boringhieri , Torino 1989, V, p. 293.
26
298
Giacomo Scarpelli
Abstract
Ancient Greece was the first civilisation that discovered fossils and
perceived and explained them with its creative thought. The present essay
is an investigation on the way in which Hellenes read the documentation of
the past of Nature and Heart with the instrument of Myth. Frazer (on the
basis of the studies by Lyell) guessed that fossils had a function in Greek
cults and identified in Typhon myth a telluric matrix, but also the
consequence of the discovery of extinct mammals bones. In the same way,
we can establish that legends regarding Titans, Cyclops, Gryphon,
Cadmus, Jason and sea-monsters awaked by Poseidon and Apollo, were
born in connection with the astonishment of Greek man in front of the
relics of Mammuthus meridionalis, Protoceratops and Samotherium. Similarly,
the myths of Satyrs, Sphinxes and the Marsyas’s skin were produced by a
mental and cultural process inspired by the figures and remains of apes and
monkeys. Such Greek poetical and philosophical creativity
(“corpolentissima”, as said by Vico), was involved with the unconscious
recognition of structural homology. Structural homology will become a
fundamental instrument for Darwinian evolutionism. Later, it will be
Freud’s duty to arrange the evolution (of psyche) with mythological
representations.
Sezione III
Storicità
FORTUNATO M. CACCIATORE
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
La dignità di quella scienza umana che è chiamata la storia sta, fra l’altro, nel
privilegio che le compete di interessarsi, negli atti e nelle istituzioni dell’uomo,
dell’immensa regione del sonnambulismo, di quel quasi-tutto che non è il puro
stato di veglia, l’acidità sterile e silenziosa dell’interrogazione stessa, il quasi
niente1.
Soffriamo a causa non soltanto dei vivi, ma dei morti.
Le mort saisit le vif!2.
Che cosa fabbrica lo storico, quando “fa della storia”? A che cosa lavora? Che
cosa produce? Interrompendo il suo girovagare erudito nelle sale degli Archivi,
egli si distacca per un momento dallo studio monumentale che lo situerà tra i suoi
pari e, una volta in strada, si chiede: che cos’è questo mestiere? M’interrogo
sull’enigmatica relazione che mantengo (intrattengo) con la società presente e con
la morte, attraverso la mediazione di attività tecniche3.
1. Nessuna «diserzione» verso un «altrove filosofico», in nome o al
servizio di verità preformate, separate da ogni «luogo» sociale, economico,
istituzionale, culturale4. Non si tratta di ricercare principi, categorie,
dottrine, allo scopo di ridestare le scienze umane dal «sonnambulismo
teorico»5, solo per ricadere nel sonnambulismo della teoria o del modello,
puri e immuni da ritorni e sopravvivenze ideologiche. Non per questo lo
storico interrompe, ancora una volta, il girovagare negli archivi e tra i
monumenti.
1 J. DERRIDA, “Forza e significazione”, in ID., La scrittura e la differenza, tr. it. a cura di
G. Pozzi, Torino 2002, p. 5.
2 K. MARX, Il Capitale, vol. I, tr. a cura di A. Macchioro e B. Maffi, UTET, Torino
2009, p. 75.
3 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, tr. a cura di S. Facioni, Jaca Book, Milano
2006, p. 62.
4 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 63.
5 Ibid.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 301-313
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064320
301
302
Fortunato M. Cacciatore
Posto che (questi) sia Certeau stesso (o anche lui, come
lascerebbe pensare lo slittamento, nel primo esergo, dalla terza
persona, egli, lo storico, alla prima persona riflessiva, m’interrogo), il
«fare (del)la storia» reca, in (e oltre) sé, le tracce di un «marchio
indelebile»: quello del suo luogo di produzione e della singolarità delle
sue pratiche6. E se c’è - un altrove (o un fuori) spazio-temporale della
storiografia - già lavora al suo interno: non perché essa sia
un’operazione compiuta, ma perché è già sempre esposta ai prestiti,
dunque alle alterazioni di sé, degli altri7. Il luogo proprio dello
storico è già sempre espropriato dalle istituzioni (politiche,
economiche, sociali, accademiche), nelle quali trova dimora la sua
attività. E, al tempo stesso, dal passato, ovvero dalla morte, di cui
mira, per vocazione, ad appropriarsi.
Duplice relazione dello storico con l’alterità in forma di
«frattura» o «cesura».
Coupure non semplicemente tra due alterità, ma di un’alterità
nell’altra:
Fondata così sulla frattura tra un passato, il suo oggetto, e un presente, il
luogo della sua pratica, la storia non cessa di ritrovare il presente nel suo
oggetto, e il passato nelle sue pratiche. E’ abitata dall’estraneità che essa
cerca, e impone la sua legge alle regioni lontane che conquista credendo di
render loro la vita8.
Una frattura, o un «limite originario», necessario e denegato9, rende
possibili, e impossibili nella loro purezza, due «posizioni» rispetto al
Ivi, p. 26.
Ivi, pp. 92 ss. Tale esposizione costitutiva della pratica storica è ciò che può
innescarne il potenziale critico. Proprio perché i suoi metodi «non consistono più nel
procurare oggetti “autentici” alla conoscenza» e il suo ruolo non risiede più nella pretesa di
«fornire alla società rappresentazioni globali della sua genesi», la storia può intervenire
come «sperimentazione critica di modelli sociologici, economici, psicologici o culturali».
Essa usa, dunque, un’«attrezzatura presa a prestito» (Certeau cita P. Vilar), ma, al tempo
stesso, la «collauda [...] trasferendola su terreni diversi, così come si collauda una vettura
da turismo facendola funzionare su piste da corsa, a velocità e in condizioni che eccedono il
suo uso normale».
8 Ivi, p. 47.
9 Ibid.: «Lo statuto di questo limite, necessario e denegato, caratterizza la storia come
scienza umana». «Umana» non solo e semplicemente in quanto ha per oggetto «l’uomo»,
6
7
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
303
«reale»: il reale «in quanto è il conosciuto» («quel che lo storico studia,
comprende o “risuscita” di una società passata) e il reale «in quanto è
implicato dall’operazione scientifica» («la società attuale, cui si riferiscono
la problematica dello storico, le sue procedure, le sue forme di
comprensione e infine una pratica del senso»). E due «tipi di storia»:
quella che pretende di raggiungere il vissuto, riesumato tramite una
conoscenza del passato e quella che s’interroga sul pensabile, cioè sulle
condizioni di possibilità della comprensione storica10.
Certeau pensa il rapporto tra queste «due forme» non come una
semplice «opposizione», ma come una «tensione». Ciò perché la
«posizione» stessa dello storico è «instabile»:
Se dà la priorità a un risultato “oggettivo”, se tende a porre nel suo
discorso la realtà di una società passata o a restituire alla vita uno
scomparso, egli riconosce tuttavia in questa ricostruzione l’ordine e
l’effetto del proprio lavoro. Il discorso destinato a dire l’altro resta il suo
discorso e lo specchio della sua operazione. Inversamente, quando torna
alle sue pratiche e ne esamina i postulati per rinnovarli, egli vi scopre
condizionamenti che hanno origine molto al di qua del suo presente, e che
risalgono ad organizzazioni anteriori di cui il suo lavoro è il sintomo e non
la fonte11.
L’«operazione storiografica» e il suo «lavoro di differenziazione» (tra
avvenimenti, dati, serie...) si fondano sulla cesura «tra un presente e un
passato»: suppongono «l’atto che stabilisce una novità, distaccandosi da una
tradizione, per considerarla come un oggetto di conoscenza». Tuttavia, il
passato non cessa di ritornare, incorporandosi nella pratica storiografica e
dislocando la «cesura» che rende possibile l’operatività di quest’ultima. «Il
morto risorge all’interno del lavoro che postulava la sua sparizione e la
possibilità di analizzarlo come un oggetto»12.
Prassi presente e oggetto passato «si alterano reciprocamente»: proprio
perché posta (tracciata dalla «decisione» che instaura il «lavoro
scientifico»), la frontiera tra i due poli «comincia a muoversi», s’inverte, si
ma «perché la sua pratica reintroduce nel “soggetto” della scienza quello che era stato
distinto come suo oggetto».
10 Ivi, p. 46.
11 Ivi, pp. 46-47.
12 Ivi, p. 47.
304
Fortunato M. Cacciatore
sposta13. Lo storico non sfugge alle «latenze», alla «pesantezza di un passato
ancora presente», né può astrarre dalle procedure critiche di distanza ed
esclusione implicate dal «luogo» (spazio-temporale) in cui opera. Nel suo
lavoro, permanenze e rotture «si amalgamano», mentre si delimitano14.
Come nella pittura di Mirò, dove il tratto che disegna delle differenze con
dei contorni e rende possibile una scrittura (un discorso e una
“storicizzazione”) è attraversato da un movimento che gli è contrario; è
vibrazione di limiti. La relazione che organizza la storia è un rapporto
cangiante, di cui nessuno dei due termini è il referente stabile15.
2. Lo storico, produce? Sì, pare rispondere Certau, almeno
implicitamente e in forma interrogativa16. La riflessione sulla storiografia
(nel XIX e nel XX secolo) avrebbe riscoperto e rinominato (si vedrà fra un
istante attraverso chi), nella produzione, il suo «principio di spiegazione
quasi universale», già operante, all’inizio della modernità occidentale, nel
riconfigurare dimensioni e contorni del clivaggio tra res gestae e historia rerum
gestarum, simplex historia e ornamentum, Geschichte e Historie17.
Ma come evitare di ridurre la produzione all’evocazione indeterminata di
un rapporto necessario, solo postulato e, ciononostante (o proprio perciò),
rimosso? «Ritorno al fondamentale» - risponde Certeau.
Vale a dire: ritorno a Marx, o, quanto meno, ad alcuni suoi testi, citati in
sequenza come per fornire una sorta di palinsesto18.
Le Tesi su Feuerbach (la prima), anzitutto:
Il difetto principale di ogni materialismo fino a oggi, compreso quello di
Feuerbach, è che l'oggetto, il reale, il sensibile è concepito solo sotto la
forma di oggetto o di intuizione; ma non come attività umana sensibile, come
attività pratica, non soggettivamente [...]19.
Ivi, p. 48.
Ibid.
15 Ivi, pp. 48-49.
16 Mi riferisco a uno degli interrogativi posti da Certeau nel secondo esergo: «Che cosa
produce [lo storico]?»
17 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 17.
18 Ivi, pp. 18ss.
19 K. MARX, Tesi su Feuerbach, tr. di Palmiro Togliatti, in appendice a F. Engels, Ludwig
Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca, Editori Riuniti, Roma 1950, pp.
77-80.
13
14
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
305
E poi l’Ideologia tedesca:
il vivere implica prima di tutto il mangiare e bere, l’abitazione, il
vestire e altro ancora. La prima azione storica [die erste geschichtliche Tat] è
dunque la creazione dei mezzi per soddisfare questi bisogni, la produzione
[die Produktion] della vita materiale stessa [...] condizione fondamentale
[Grundbestimmung] di qualsiasi storia [aller Geschichte], che, ancora oggi,
come millenni addietro, deve essere compiuta ogni giorno e ogni ora
[...]20.
Tuttavia, postulare la «base» della storia (o l’invariante condizione di
possibilità materiale dell’azione storica) non è sufficiente. La produzione in
generale «è un’astrazione»: occorre rimarcarne le determinazioni storiche,
riconoscendovi l’articolarsi di bisogni, organizzazioni tecniche, istituzioni
sociali.
Ecco allora Per la critica dell’economia politica:
Quando si parla di produzione, si parla sempre di produzione a un
determinato stadio dello sviluppo sociale, si parla della produzione di
individui sociali [...] ad esempio [...] nessuna produzione è possibile senza
uno strumento di produzione [...]; né senza lavoro passato e accumulato
[...]; la produzione è sempre un particolare ramo della produzione21.
E ancora:
[...] è sempre un determinato organismo sociale, un soggetto sociale che
agisce entro una totalità, più o meno considerevole, di rami di
produzione22.
In breve, attraverso questi «testi classici», Certeau imposta il problema
della relazione tra «luoghi determinati» e «discorsi che vi si producono»23.
Più precisamente:
20 K. MARX – F. ENGELS, L’ideologia tedesca, tr. di Cesare Luporini, Ed. Riuniti, Roma
1991 (X ed.), p. 18.
21 K. MARX, Per la critica dell’economia politica, tr. di E. Cantimori Mezzomonti, E.
Riuniti, Roma 1969, pp. 172 ss.
22 Ibid.
23 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 19: «Ho creduto possibile – scrive
Certeau – trasporre qui quello che Marx chiama “il lavoro produttivo nel senso economico
306
Fortunato M. Cacciatore
Considerare la storia come un’operazione significherà tentare [...] di
comprenderla come rapporto tra un posto (un reclutamento, un ambiente,
un mestiere, ecc.), delle procedure di analisi (una disciplina), e la
costruzione di un testo (una letteratura)24.
3. I passi di Marx riportati da Certeau si leggono in conclusione di
uno scritto 25, che precede i saggi raccolti ne La scrittura della storia e
sembra mimare la forma delle Prefazioni (storiche e/o filosofiche). Ma
come se, in esso, entrassero in contatto, facendo cortocircuito, le
prefazioni filosofiche all’opera storiografica (anticipazione in forma
concettuale, teorica, o epistemologica della narrazione o esposizione
storica)26 e quelle storiche all’opera filosofica (anticipazione in forma
narrativa o rappresentativa dello sviluppo concettuale)27. In questo
del termine”: “il lavoro è produttivo solo se produce il suo contrario”». Sarebbe necessario
soffermarsi a lungo su questa trasposizione. Qui, ricordo solo che quest’ultima citazione del
palinsesto marxiano è tratta da un passaggio dei Grundrisse che vale la pena citare più in
esteso: «Lavoro produttivo è soltanto quello che produce capitale. Non è insensato, chiede
ad esempio (per lo meno in termini analoghi) il signor Senior, che il costruttore di
pianoforti debba essere un lavoratore produttivo e il pianista no, sebbene senza il pianista il
pianoforte sarebbe un’assurdità? Ma è esattamente così. Il costruttore di pianoforti
riproduce capitale; il pianista non fa che scambiare il suo lavoro con un reddito. Ma il
pianista produce musica e soddisfa il nostro senso musicale, e in un certo senso lo produce
addirittura. Non è così? Effettivamente sì: il suo lavoro produce qualcosa; ma non per
questo esso è lavoro produttivo in senso economico; così non è produttivo il lavoro del
buffone che produce chimere». Ora, dove collocare lo storico e la sua produzione, la
storiografia? Dal lato del pianista che produce solo musica, soddisfacendo il senso musicale? O
accanto al buffone che produce chimere? O, invece, dal lato del lavoro produttivo in senso
economico: produzione di capitale? O entre-deux? Per i Grundrisse, cfr. K. MARX, Lineamenti
fondamentali della critica dell’economia politica, tr. di E. Grillo, La Nuova Italia, Firenze
2000, vol I, pp. 234 ss.
24 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 63.
25 Il testo s’intitola Scritture e storia.
26 Mi riferisco, come si sarà forse inteso, alle riflessioni hegeliane sulle Vorreden (e sulle
Einleitungen), in particolare, a ciò che si può leggere nella Prefazione alla Fenomenologia dello
spirito.
27 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 49. In relazione alla nota
precedente, occorre puntualizzare che Certeau tocca il problema delle Prefazioni solo a
proposito della storiografia. «Ad esempio: l’analisi di un periodo socio-economico o
culturale di breve o lunga durata, è preceduta, nell’opera di storia, da Prefazioni in cui lo
storico racconta il percorso di una ricerca. Il libro, fatto di due metà ineguali ma
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
307
testo, stampato in corsivo28, le citazioni marxiane indicherebbero un
programma, ma anche (forse) la fedeltà a un’esigenza critica, o la
confessione di un «luogo» (anche nel senso di «posizione», quando si
dice «prendere posizione», il che non significa necessariamente
schierarsi per un «partito», per questo o quel «programma politico»).
Mi limito qui a indicare qualche traccia di (ri)lettura possibile di Marx
in Certeau (e viceversa), per rimarcare, più in generale, quali effetti
possano segnalarsi nella riflessione sull’operazione storiografica in rapporto
al concetto di «produzione».
Ma, prima, è il caso di ricordare rapidamente in che modo, a partire
dalla «produzione», si presentano i fondamenti (ontologici e
antropologici) della materialistische Geschichtsauffassung («concezione
materialista», come si traduce solitamente, o «apprensione materialista
della storia», come pure si potrebbe tradurre, per indicare un modo di
afferrare le condizioni/azioni storiche, che non è più semplicemente
empirico, perché già richiede un certo grado di astrazione, ma non è
ancora concettuale, e nemmeno rappresentativo nel senso della
Vorstellung)29. I «presupposti reali» della storia (e, di conseguenza,
l’oggetto della storiografia, Geschichtsschreibung) non consiste nei «fatti
morti» (toter Fakta) raccolti e inventariati dagli «empiristi che sono
anch’essi astratti», né si risolve in azioni immaginarie di «soggetti
immaginari», come per gli «idealisti»30. La «scienza reale e positiva»
comincia là dove cessa (o ancora deve aver luogo) la «speculazione»,
ovvero quando (e se) può emergere la «presentazione» (Darstellung) del
«processo della vita» (tätige Lebensprozeß), o del suo f/atto 31.
Tuttavia, la produzione è, fin dall’inizio, riproduzione (o implica già
una storicizzazione, dunque un rapporto con l’alterità del passato e delle
condizioni che la determinano). Scrivono Marx e Engels:
simboliche, congiunge alla storia di un passato l’itinerario di un procedimento».
Precisazione d’obbligo: Certeau reca come esempio la presentazione del Lutero (1928) di
Lucien Febvre, storico per eccellenza. Resta, tuttavia, l’interesse, a mio avviso, di un
confronto tra la funzione che questo genere di testi svolge nella scrittura della storia e in
quella filosofica, soprattutto quando divengono il pretesto per una critica dell’una nei
confronti dell’altra e viceversa.
28 Ne ho già citato qualche passaggio, in tondo, per esigenze tipografiche.
29 In questa sede, la mia lettura delle citazioni di Certeau si concentra solo sull’Ideologia
tedesca, escludendo, evidentemente, altri possibili ritagli in questo e in altri scritti di Marx.
30 K. MARX– F. ENGELS, L’ideologia tedesca, cit., p. 14.
31 Ibid.
308
Fortunato M. Cacciatore
a ogni generazione è stata tramandata dalla precedente una massa di forze
produttive, capitali e circostanze, che da una parte può senza dubbio
essere modificata dalla nuova generazione, ma che d’altra parte impone a
essa le sue proprie condizioni di vita e le dà uno sviluppo determinato, uno
speciale carattere; che dunque le circostanze fanno gli uomini non meno di
quanto gli uomini facciano le circostanze 32.
Ecco perché si può parlare di un’ontologia della (ri)produzione della
vita, in cui condizione e prima azione della storia coinciderebbero. Su
questa «base» (Basis), ciò che prenderà solo ex post il nome di «materialismo
storico» si elabora come un programma critico di «analisi del processo di
formazione, produzione reale delle rappresentazioni idealistiche della
storia e della politica», in breve: del «processo di idealizzazione»33.
Ma in tanto è storico in quanto (se) «può dimostrare che l’idealizzazione della
storia è essa stessa il risultato necessario di una storia determinata»34. La critica
materialista e storica dell’ideologia non si riduce alla denuncia dell’«errore»,
dell’«illusione», dell’«inganno» o della «manipolazione» (una critica la cui
ingenuità era stata già rimarcata da Hegel nella Fenomenologia dello spirito), ma è
il correlato di un’apprensione (Auffassung) del «reale» come «rapporto»
(Verhältnis), o «struttura di rapporti pratici», ogni volta determinato
storicamente. Il «reale», se è «rapporto» - o l’«essere», se è «attività pratica» implica già un’astrazione determinata, che gli individui possono cogliere solo
attraverso un’astrazione di secondo grado, o speculativa. Il materialismo storico
può definirsi scientifico, positivo e reale, solo se può discriminare, «in atto», tra
l’una e l’altra astrazione (o fra l’uno e l’altro «linguaggio»: quello della «vita
reale» e quello della rappresentazione ideologica)35.
Tuttavia, la produzione ideologica non si risolve nel movimento di
inversione/distorsione e autonomizzazione di prodotti spirituali che,
nell’Ideologia tedesca, si manifestano ovunque, in una serie che non si chiude
(«nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della religione,
Ivi, p. 30.
É. BALIBAR, La vacillazione dell’ideologia nel marxismo, in ID., La paura delle masse.
Politica e filosofia prima e dopo Marx, tr. di A. Catone, Mimesis, Milano 2001, p. 98.
34 Ibid.
35 Ivi, p. 99.
32
33
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
309
della metafisica, ecc., di un popolo»), sicché il concetto di ideologia
sembra perdere pertinenza e specificità non per difetto, ma per eccesso36.
I prodotti ideologici e la loro «parvenza di autonomia» divengono
efficaci solo in quel processo «spettrogeno», che Derrida, in Spettri di Marx,
pensa come una «incorporazione paradossale»:
[...] l’ideologico, così come mutatis mutandis il feticcio, sarebbe il corpo
donato, o piuttosto prestato, dato in prestito, l’incarnazione seconda
conferita a una idealizzazione iniziale, l’incorporazione di un corpo che
certamente non è né percepibile né invisibile, ma che resta una carne, in
un corpo senza natura, in un corpo a-fisico che si potrebbe dire, se ci si
fidasse di queste opposizioni, un corpo tecnico o istituzionale37.
Ora, chi può (ha il potere) di distinguere (giudicare, criticare, opporre)
tra la prassi vitale, il suo spirito e la sua incorporazione spettrale (o ideologica),
e da quale posizione?
A una questione così posta, è possibile rispondere solo postulando un
luogo immune da investimenti ideali, occupato «profeticamente»38 da una
soggettività capace di parlare solo attraverso la sua prassi, senza altre
mediazioni, installata in sorta di «grado zero» dell’«ideologico»39. Solo
ritraendosi, a sua volta, in questo «luogo», la critica materialista
dell’ideologia può cogliere «l’equivalenza delle differenti modalità di
idealizzazione che costituiscono l’ideologico»40. E può stabilire tutte le
antitesi dello «speculativo» (predicato dell’equivalenza): la vita,
36 K. MARX – F. ENGELS, L’ideologia tedesca, cit., p. 13. La «teoria dell’ideologia»
rischia di perdere la sua forza proprio in conseguenza della sua forza onnicomprensiva.
37 J. DERRIDA, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e la nuova Internazionale, tr.
di G. Chiurazzi, Cortina, Milano 1994, p. 161.
38 É. BALIBAR, La vacillazione dell’ideologia nel marxismo, cit., p. 99.
39 E. LACLAU, Muerte y resurrección de la teoría de la ideología, in ID., Misticismo, retórica y
política, Fondo de cultura económica de Argentina, Buenos Aires 2000, p 10 e p. 13. La
«critica dell’ideologia» tradizionale – spiega Laclau - esige «un punto a partire da cui –
almeno tendenzialmente – la realtà parlerebbe senza mediazioni discorsive». Mettere in
gioco il presupposto di tale «livello metalinguistico» - e indicare in esso la «illusione
ideologica per eccellenza» (l’ideologia della fine delle ideologie) - non significa dichiarare
inutile ogni «critica», ma rimarcare le condizioni di (im)possibilità di una «critica
dell’ideologia in quanto tale», immune dagli incroci e dai conflitti «intra-ideologici».
40 É. BALIBAR, La vacillazione dell’ideologia nel marxismo, cit., p. 99.
310
Fortunato M. Cacciatore
l’individualità, la pratica, la produzione… ovvero le condizioni positive
che rendono possibile il «Geschichte machen»41.
In tale formula che, nell’Ideologia tedesca, appare come una citazione, è
possibile leggere l’indicazione e la denegazione di una «difficoltà» (ostacolo
o problema, Schwierigkeit): il continuo riaprirsi e dislocarsi dello scarto tra
produzione della vita e storiografia materialista (Darstellung che si vuole senza
incorporazione spettrale)42.
5. Come, nel testo di Marx e Engels, «Geschichte machen», così, ne La
scrittura della storia, «faire de l’histoire»43 - l’espressione in cui si abbrevia la
complessità dell’operazione storiografica – si trova scritta tra virgolette.
Forse, una citazione (di una citazione). O una traduzione che tenta di
registrare, in quella citazione, la memoria dello «speculativo» inscritto nel
termine storia, complicando la relazione tra la prassi che ne riceve il nome e
il concetto di «produzione». Qui, in particolare, lo «speculativo» assume la
forma (senza forma stabile) di un’«ambiguità» costitutiva, in cui sembra
arrestarsi, come in un’«immagine dialettica»44, il continuo movimento
della storia «sul confine» tra due «riduzioni» (nient’altro che «finzione» o
nient’altro che «riflessione epistemologica») senza potersi stabilire in
nessuno dei due «luoghi».
Scrive Certeau:
[...] il termine storia nell’uso corrente connota, di volta in volta, la scienza
e il suo oggetto – la spiegazione che si dice e la realtà di ciò che è avvenuto o
avviene. Altri campi non presentano la stessa ambiguità [...]45.
41 K. MARX – F. ENGELS, L’ideologia tedesca, cit., p. 19: «per poter “fare storia” gli
uomini devono essere in grado di vivere». E’ la frase che precede immediatamente il passo
dell’Ideologia tedesca citato da Certeau (cfr. infra, nota 13).
42 Ivi, p. 14: «La difficoltà comincia [...] quando ci si dà allo studio e all’ordinamento
del materiale, sia di un’epoca passata che del presente, a esporlo realmente [...]».
43 Cfr., ad esempio, M. D E CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 26 (là dove
Certeau invita a «prendere sul serio espressioni cariche di senso – “fare della storia”, “fare
della teologia” [...]»).
44 W. BENJAMIN, Parigi. La capitale del XX secolo, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, tr.
a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 2006, p. 161. Scrive Benjamin: «Ambiguità è
l’apparizione immaginale della dialettica, la legge della dialettica in condizione di arresto.
Questo arresto è utopia e l’immagine dialettica è quindi immagine di sogno».
45 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 27.
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
311
Così, lo storico, «respinto verso il suo presente e verso un passato»,
esperisce una prassi che è «inestricabilmente la sua e quella dell’altro
(un’altra epoca o la società che oggi lo determina)».
Il suo lavoro verte sull’ambiguità stessa che il nome della sua disciplina
indica. Histoire e Geschichte: ambiguità in ultima istanza, ricca di senso. La
scienza storica non può infatti disgiungere completamente la propria
pratica da quello che essa coglie come oggetto, e deve incessantemente
precisare le forme successive di tale articolazione46.
Tale ambiguità, in cui Certeau disloca l’«ultima istanza» (la
«produzione»), privandola di appoggio, non arresta il lavoro storiografico
che «consiste nel creare degli assenti»47 – incorporazioni spettrali – proprio
per riattivare l’«atto produttore»48, restituire vita e parola al «corpo che
tace»49. Alla duplice ingiunzione (dell’altro passato e dell’altro istituzionalepolitico-sociale-economico…) lo storico non può rispondere se non con una
procedura auto-contraddittoria: «pone la morte» ovunque, mentre «nega
la perdita, attribuendo al presente il privilegio di ricapitolare il passato in
un sapere»50.
Per lo storico, la «redenzione» (Rettung) del passato è possibile solo «nei
confronti di qualcosa che, nell’attimo successivo, è già irrimediabilmente
perduto»51. Ma il suo discorso non può nemmeno fare affidamento su ciò che
sarebbe solo un’ulteriore modificazione della presenza: l’assenza di
qualcosa/qualcuno, una volta pienamente presente, poi perduto. E ultimo
46 Ivi, p. 57. In questo, come nel passo precedente, è impossibile non riconoscere
un’eredità hegeliana. Si legge nell’Introduzione alle Lezioni sulla filosofia della storia, volume
I: La razionalità della storia, La Nuova Italia, Firenze 1941, p. 167: «Il termine storia
possiede, nella nostra lingua, tanto il valore oggettivo quanto quello soggettivo e significa
sia historia rerum gestarum sia le stesse res gestae, così la vera e propria narrazione storica come
l’accaduto, gli stessi atti ed eventi. In questa riunione dei due significati in un solo termine
noi dobbiamo vedere qualcosa di più e di meglio che un risultato estrinseco del caso:
dobbiamo scorgervi la verità che la narrazione della storia appare contemporaneamente
alle azioni e agli eventi storici».
47 M. DE CERTEAU, La scrittura della storia, cit., p. 59.
48 Ivi, p. 27.
49 Ivi, p. 7.
50 Ivi, p. 10.
51 La citazione è tratta dai già citati materiali preparatori alle Tesi di filosofia della
storia di W. BENJAMIN, Parigi. La capitale del XX secolo, in Angelus Novus. Saggi e frammenti,
cit., p. 79.
312
Fortunato M. Cacciatore
rifugio del «prestigio» («impudico e osceno»)52, spesso accreditato alla
storiografia (e/o alla filosofia della storia), di testimoniare ancora in nome
del presente (dato ormai per assente, o messo a tacere).
Questi spettri vengono accolti nella scrittura a condizione di tacere per
sempre.[...] L’altro è il fantasma della storiografia. E’ l’oggetto che essa
cerca, che onora e sotterra53.
Forse, occorre rintracciare, nell’«antinomia» stessa, l’esigenza critica
che attraversa La scrittura della storia in nome di un (problematico) ritorno a
Marx. L’operazione storiografica che «ritaglia» un posto per il passato, o
per l’altro, può essere anche intesa come «un modo per far posto a un
avvenire»54. Ma non si dà alcun «luogo» extra-ideologico (o extraspettrale), presente, passato o futuro, stabilito in anticipo, per accoglierlo
e/o respingerlo.
52 M. D E C ERTEAU , Fabula mistica. XVI-XVII secolo, tr.it. a cura di S. Facioni,
Jaca Book, Milano 2008, p. 1. Traspongo e leggo (a mio modo) nei termini del
problema storiografico riflessioni che Certeau dedica alla mistica: «Un assente fa
scrivere. Non smette di scriversi, lungo il viaggio in un paese dal quale sono
allontanato. A voler precisare il luogo della sua produzione, vorrei anzitutto evitare
a questo racconto di viaggio il “prestigio” (in questo caso impudico e osceno) di
essere preso come un discorso accreditato da una presenza, autorizzato a parlare in
suo nome un discorso, insomma, supposto sapere cosa ne è. Ciò che dovrebbe
esserci non c’è: senza rumore, quasi senza dolore, tale constatazione è al lavoro.
Raggiunge un luogo che non sappiamo localizzare, come fossimo stati colpiti dalla
separazione assai prima di saperlo. (…) Si è malati di assenza perché si è malati
dell’unico». Una volta localizzato, a limite deposto, l’unico «cambia scena». Ma,
nonostante (o proprio attraverso) i suoi vari spostamenti, «non smette di
organizzare con la sua assenza una produzione “occidentale”», in due direzioni:
«quella che moltiplica le conquiste destinate a colmare una mancanza originaria» e
«quella che ritorna sul postulato di tali conquiste, e s’interroga sulla “vacanza” della
quale sono gli effetti» (ivi, p. 4). (Anche qui generalizzo una lettura che Certeau
dedica, in particolare, all’emergenza di un’«erotica», nello stesso tempo in cui «si
sviluppa e poi declina», nell’Europa moderna, la «mistica» – l’una distinta
dall’altra, eppure accomunate dalla «nostalgia» che «risponde al progressivo
cancellarsi di Dio come Unico oggetto d’amore», Ibid).
53 Ivi, p. 6.
54 Ivi, pp. 100-101. Lo storico può fare conto solo sulla sua «pratica più rigorosa», che
«consiste nel simbolizzare il limite e di conseguenza nel rendere possibile un superamento» scrive Certeau, con inflessioni ancora una volta hegeliane.
“Incorporazione spettrale” e produzione storiografica
313
Abstract
Following the thread of the reflections of De Certeau, the essay is
basically interested in the production of the historian and of his report, in
the same production, with the otherness of the object of his search. In this
way you can let the issue come to light the condition of historical research
and the understanding of that which is the basis of his knowledge.
DONATA CHIRICÒ
La voce: prima decisione politica
Perché ci sia pratica bisogna che la trasformazione del corpo
del soggetto che provoca a sua volta la trasformazione dell’oggetto
che svolgerebbe nell’eventuale pratica il ruolo di mezzo
sia una decisione, ossia una trasformazione non naturale. (…)
Il corpo del soggetto, grazie alla facoltà di decisione di cui è provvisto,
possiede una particolarità fondamentale: esso può essere causa
– causa, ad esempio, della messa in moto del mezzo di una pratica –
senza essere stato a sua volta un effetto
L. Prieto, Saggi di Semiotica I
1. Una secolare tradizione ha indicato nella capacità di parlare il fatto
grazie al quale sancire la “specialità” degli umani. Tuttavia, il carattere
specificamente fonatorio che ha assunto la facoltà linguistica nella nostra
storia filogenetica, non è mai diventato un argomento rilevante delle
scienze del linguaggio, salvo poi, in alcuni momenti, essere letteralmente
brandito per rafforzare antiche egemonie e crearne di nuove. È questo il
caso del secolare dibattito sulla sordità nel corso del quale il tema della
superiorità della voce articolata e della presunta inevitabilità per i sordi
della «rieducazione orale»1 contribuisce a scrivere una delle pagine più
cupe della storia della riflessione medico-filosofica sulle patologie sensoriali
del linguaggio2. Allo stesso tempo, il punto di vista a cui abbiamo appena
fatto riferimento, ha concorso ad alimentare mitologie più o meno
teologiche circa la questione dell’origine del linguaggio ed ha fatto sì che
quest’ultima giungesse sino a noi mantenendo intatto il suo carattere
profondamente enigmatico. Anche Cartesio, nel suo tentativo di affrancare
il metodo scientifico (la condanna di Galileo e la conseguente mancata
pubblicazione del suo Trattato sull’Uomo risale al 1633) dall’autorità della
Scolastica e della teologia, ha finito per svalutare la filosofia attribuendole
1
2
DESCHAMPS (1779).
CHIRICÒ (2001).
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 315-327
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064321
315
316
Donata Chiricò
«fondamenta molto poco solide»3 e rendere ancora più misteriosa e
inafferrabile la questione linguistica.
Come è noto, la sua è una posizione innatista e dualista che di fatto
risolve il problema dei fondamenti biologici e dell’origine del linguaggio
rimuovendolo e collocando quest’ultimo fuori dalla natura e dalla storia. Il
linguaggio è presupposto quale tratto consustanziale dell’essere uomo
(unico ad essere res cogitans) e come ciò per cui è del tutto superfluo
fornire spiegazioni. Non è necessario andare a cercare da dove provenga o
come e grazie a cosa venga concretamente prodotto e padroneggiato. Esso
è attributo distintivo di un io che è specificamente mente (âme raissonable),
la cui forma di vita di fatto non è vita ma artificio o pura astrazione.
Considerata immortale, questa mente non dipende dal corpo, non ha
tempo, non occupa nessun luogo. La sua natura propria (toute l’essence) è
l’attività di pensiero4. In questo contesto, l’assenza di linguaggio presso gli
animali e, in particolare, presso quelli morfologicamente più simili agli
esseri umani, rappresenterebbe la prova del carattere ontologicamente
eterogeneo della natura animale rispetto a quella umana la quale viene
concepita come intrinsecamente linguistica e totalmente indipendente dalla
specifica corporeità in cui normalmente si incarna.
In effetti, è una cosa estremamente significativa che non ci siano uomini
che, per quanto ebeti e stupidi possano essere, senza escludere i folli
(insensés), siano incapaci di combinare (arranger) insieme parole diverse e
produrre un discorso attraverso cui far comprendere i loro pensieri e che,
al contrario non ci sono altri animali che per quanto perfetti e felici
possano essere, possa fare la stessa cosa. La qual cosa non si verifica per
mancanza di organi, in quanto sappiamo bene che le gazze e i pappagalli
possono produrre parole come noi e, tuttavia, non possono parlare come
noi, ovvero testimoniando che pensano ciò che dicono. Di contro, i sordi,
che sono privi degli organi che servono per parlare tanto o più che gli
animali, hanno l’abitudine di inventare da soli qualche segno attraverso cui
si fanno capire da coloro che frequentandoli costantemente, hanno il
piacere di apprendere la loro lingua. La qual cosa dimostra non solo che gli
animali hanno meno intelligenza (raison) degli uomini, ma piuttosto che
non ne hanno affatto. È infatti evidente che ne è necessaria molto poca per
poter parlare e, per quanto si possa constatare che ci siano tra le specie
animali altrettante differenze che tra gli uomini, e che i primi sono più
3
4
DESCARTES (1637, p. 14).
DESCARTES (1637, pp. 35-37).
La voce: prima decisione politica
317
facili da addestrare di questi ultimi, non è credibile che la più perfetta delle
scimmie o il più perfetto dei pappagalli non sia in grado di eguagliare in
questo anche il bambino più limitato, o almeno un bambino che avesse il
cervello ritardato (troublé), se la loro anima non fosse totalmente differente
dalla nostra. (…) È su questa base che avevo descritto la mente (âme
raissonable) e dimostrato che essa non può derivare (être tirée) dalle
proprietà (puissance) della materia5.
Con l’avvento dell’empirismo di matrice lockiana, i “fatti” oggetto di
interesse della filosofia cambiano. Che si tratti di colori piuttosto che di
suoni o forme, di sapori piuttosto che di mere sensazioni, comincia a farsi
strada il convincimento che il mondo delle cose, il mondo nelle sue
manifestazioni concrete e materiali, prima o poi finisce per irrompere sulla
scena del pensiero. L’insieme di “lezioni di limite” che provengono dalla
relazione effettiva che l’uomo ha con il mondo, si impone e genera
domande. E quando le domande sopraggiungono affermano,
implicitamente, che fino a quel momento, probabilmente, si sono fornite
risposte insoddisfacenti, si sono attribuite alla mente poteri che di volta in
volta avrebbero dovuto essere verificati e comunque riletti alla luce, ad
esempio, dell’organizzazione dei sensi, del loro reciproco sostenersi,
differenziarsi o, addirittura, escludersi. Dopo l’uomo di Cartesio, ideale e
idealizzato,”naturalmente” linguistico e pensante in quanto sostanzialmente
innaturale, la filosofia moderna accoglie nelle sue auree sfere il corpo e la
sua caducità. Temi insoliti quali la cecità e il suo impatto sull’esperienza
“complessa” delle forme e dei corpi, e su quella “semplice” dei colori,
vengono discussi nel Saggio sull’Intelletto Umano in quanto banco di prova
fondamentale per qualsiasi teoria della conoscenza. Essi obbligano a
confrontarsi con il fatto che, immortale o meno che sia, la mente conosce
il mondo in quanto vi accede attraverso le mortalissime porte della
fisiologia umana, “fonte rilevante della maggior parte delle idee che
abbiamo” (Locke, Saggio sull’Intelletto Umano: II, I, § 3).
Il sentire, il “come l’uomo sente”, espunto da Cartesio dalla vita della
mente e, quindi, ridotto ad una processo meccanico, ricomincia ad essere
tematizzato almeno come problema con cui confrontarsi. La questione
dell’io, dell’’io sono’ ridiventa una questione che non ha solo a che fare
con l’io penso, ma altresì con l’’io osservo’, io provo qualcosa che ha a che
fare con il mondo. Il “cogito” ridiventa un tema da discutere anche a
5
DESCARTES (1637, pp. 54-57).
318
Donata Chiricò
partire dal fatto che l’uomo è, letteralmente, un’entità che ‘fa’ esperienza,
vale a dire che impatta con gli oggetti sensibili e li trasforma con il
desiderio piuttosto che con la credenza piuttosto che con la volontà (ivi, II,
I, §§ 2-4). Questo fa sì che in quella “camera oscura” (ivi, II, XI, § 17) che
è l’intelletto umano giungano due tipi fondamentali di conoscenze: quelle
del mondo che non ha bisogno di noi per esistere e quelle del mondo che
esiste in quanto noi facciamo qualcosa con quello che siamo.
2. A seguito dell’evoluzione teorica che l’empirismo raggiunge negli
scritti di Etienne Bonnot de Condillac la nozione stessa di esperienza, che
già Locke aveva problematizzato e arricchito, viene ulteriormente precisata
ed approfondita. In questo contesto subentra una nuova consapevolezza
che cambia profondamente il concetto di natura umana. Quest’ultima non
è considerata un equipaggiamento fisso e predeterminato, ma una
condizione di partenza trasformabile e da trasformare. La stessa sensorialità
viene spiegata alla luce di un’idea evolutiva dell’ontogenesi che fa del
corpo un utensile governabile ed educabile, un dispositivo di autogoverno,
di azione piuttosto che di esecuzione. Il dualismo cartesiano viene così
superato grazie ad un’idea di soggetto che si realizza come tale non in
quanto dubita e pensa, ma in quanto “lavora” ad una trasformazione della
sua naturalità prima di tutto corporea la quale, appunto, non rappresenta
(e non deve rappresentare) né un destino né una garanzia. È la fine di
qualsiasi verità di natura.
È difficile per noi ricordare l’ignoranza nella quale siamo nati: è uno stato
che non lascia tracce (….) Dire che abbiamo imparato a vedere, ad
ascoltare, a gustare, a sentire, sembra un paradosso. Siamo, infatti, inclini
a credere che la natura ci abbia dato l’uso completo dei nostri sensi nello
stesso istante in cui ha dato loro una forma e che noi ce ne siamo sempre
serviti senza doverli sottoporre ad una educazione (sans étude). Ero preda
di questo pregiudizio quando ho pubblicato il Trattato sull’origine delle
conoscenze umane. (….) Al contrario, la natura ci dota di organi per
metterci nelle condizioni, attraverso il piacere, di saper cosa dobbiamo
cercare e, attraverso il dolore, ciò che dobbiamo fuggire. Ma il suo lavoro
si ferma qua; essa lascia all’esperienza il compito di farci acquisire
comportamenti (habitudes) e di completare così il lavoro cominciato6.
6
CONDILLAC (1754, pp. 10-12).
La voce: prima decisione politica
319
Questo vuol dire che per comprendere la specifica mente incarnata
nell’umano è necessario tenere conto non tanto di una presunta specialità
rispetto, ad esempio, agli animali, ma del fatto che la storia degli uomini
non coincide con la loro storia naturale. Le prestazioni che si possono
considerare derivate da quest’ultima, spiegano, al massimo, la fisiologia,
ma non sono in grado di rendere conto dell’utilizzo libero e liberato che di
questa può essere fatto. È importante mettere qui in evidenza che
dall’interno di un’epoca nella quale nasce la biopolitica7, proprio il
fondatore del sensismo individua nel corpo l’ontologica ribellione al già
dato (fosse anche il corpo stesso) e indica la strada che fornisce un antidoto
alla possibilità stessa del corpo-macchina.
In effetti, nel Trattato sulle sensazioni (1754) un astratto uomo-statua è
protagonista di una singolare ontogenesi delle “facultés de l’ame”. Animato
da una mente (esprit) priva di qualsiasi conoscenza o principio innato (privé
de toute espèce d’idée), interiormente costituito “comme nous” ed
esteriormente fatto di marmo8, esso accede al mondo solo in quanto viene
ripetutamente esposto alla realtà nelle sue diverse e, inizialmente slegate,
espressioni materiali: odori, suoni, sapori, colori e forme, corpi e
superfici. Trattandosi di esperienze che per loro natura sono sempre
sgradevoli o gradevoli, esse si guadagnano così l’interesse della statua. In
ogni momento governata dal dolore o dal piacere9, senza i quali sarebbe
esposta ad ogni sorta di pericolo e resterebbe immobile10, essa fugge le une
e viene attirata dalle altre. Da questo processo emerge nel tempo il suo
intelletto (entendement), la sua volontà e tutte le operazioni che ne
derivano: giudizio, riflessione, desideri, passioni, bisogni, azioni.
Bisogna dire che fino a quando la statua gioca il ruolo di un sistema
capace di recepire e elaborare informazioni sensibili ed essa passa da una
sensazione all’altra moltiplicando e diversificando le sue idee e, quindi, gli
oggetti della sua attenzione, dei suoi desideri e del suo diletto (jouissance),
la sua condizione obiettiva rispetto al mondo ed a se stessa resta
estremamente artificiale. In effetti, potremmo dire che la statua è una
macchina in senso proprio. Funziona ma non sa. In fondo non vive. Vede
senza sapere di vedere, ascolta senza sapere di ascoltare, usa i sensi
ignorando di averli. A questo stadio non si rende nemmeno conto di avere
FOUCAULT (1976).
CONDILLAC (1754, p. 11).
9 CONDILLAC (1754, p. 58).
10 CONDILLAC (1754, p. 119).
7
8
320
Donata Chiricò
un corpo11. Il dato interessante è che questa ignoranza comincia a diradarsi
solo quando quel corpo – organizzato per muoversi sotto la spinta della
desiderabilità o indesiderabilità delle sensazioni – comincia, in senso
proprio, a fare qualcosa, ovvero smette di essere esecuzione, mera
reazione ad uno stimolo, e diventa azione.
Specificamente, nella statua di Condillac il corpo appare solo quando si
manifesta un movimento, vale a dire l’utilizzo originariamente
involontario, successivamente finalizzato, degli arti, in particolare della
mano, scandaglio della propria superficie corporea e del mondo. Toccarsi,
toccare, muovere ed usare le mani, distinguere le diverse parti di cui è
composta quell’entità a cui la mano che si muove pure appartiene.
Riconoscere tutto questo come un insieme riconducibile ad una sola
origine e finalmente comprendere che essa è un unico sistema da cui
dipendono la mano e la sua azione, le sensazioni che ne derivano e le
molteplici esperienze sensibili che gradualmente si presentano12.
Finalmente protagonista di un movimento nello spazio, la statua comincia a
sperimentare, anche solo grazie ad un urto, ad una giustapposizione, ad un
incontro casuale con le cose, che ciò che modifica il suo stato esiste ed è
fuori di lei. Si manifesta così, grazie a quel particolare tipo di esperienza
che deriva dal tatto (che è un sentire e un fare allo stesso tempo), l’uso
consapevole della propria sensibilità e la conseguente scoperta di una realtà
altra da sé. È uno scarto importantissimo, una prima certezza fondata sul
corpo o, meglio, sull’azione del corpo.
Bisogna dire che grazie al tatto si realizza altresì un salto cognitivo che
gli altri sensi non sono in grado di produrre: fa il suo ingresso un livello di
complessità dell’esperienza in conseguenza della quale la statua impara a
sviluppare quella forma di “attention qui combine les sensations” e “les
compares sous différens rapports”13. Altrimenti detto, diventa capace di
“riflessione”14. Questo vuol dire che ogni oggetto diventa una molteplicità
di relazioni: l’informazione sensoriale più immediata (il colore, ad
esempio) e la sua materialità più tangibile: il corpo da cui proviene, la sua
consistenza, la sua temperatura, la sua forma. Dall’interno di una forma di
vita caratterizzata fino a quel momento da informazioni sensibili processate
CONDILLAC (1754, p. 87).
CONDILLAC (1754, pp. 101-103).
13 CONDILLAC (1754, p. 126).
14 Ibidem.
11
12
La voce: prima decisione politica
321
e mai poste nelle condizioni di essere problematizzate, la mano che si
muove dal corpo al mondo è come se, letteralmente, plasmasse la materia
di cui quest’ultimo è fatto. Da questo punto di vista essa instaura una
primitiva forma di narrazione del mondo stesso. È una narrazione per così
dire plastica, performativa. Ma è pur sempre una narrazione.
3. È importante mettere in evidenza che a questo stadio della sua
evoluzione, la statua è e resta muta. L’acquisita capacità di manipolare le
proprie esperienze componendole e ricomponendole alla luce della
molteplicità di rapporti da cui sono intrinsecamente caratterizzate a partire
dal momento in cui il tatto fa emergere capacità nuove rispetto all’uso
degli altri sensi, non sembra aver bisogno di un fondamento linguistico. Il
che vuol dire, di conseguenza, che nessuna delle esperienze sensibili a cui
l’uomo-statua gradualmente accede, è concepita per generare linguaggio,
fosse anche in una forma primitiva. Quel corpo proprio, che pure è
presentato come capace di evolvere e modificare la sua natura,
evidentemente accede ad un grado di trasformazione che di fatto coincide
con lo stato di natura laddove quest’ultimo può essere inteso come la
condizione in cui gli uomini (esattamente come gli animali) sono capaci di
occuparsi della loro sopravvivenza e conservazione15, affidandosi alla
ripetizione degli atti che il loro istinto suggerisce.
Quando mi riferisco alle idee che la statua acquisisce, non pretendo
certo che essa acceda a conoscenze di cui possa rendersi conto con
precisione: essa non ha altro che conoscenze pratiche. La sua lungimiranza
(lumière) coincide con il suo istinto, vale a dire con l’abitudine ad agire in
base a una forma di conoscenza (d’après des idées) di cui non è in grado di
rendersi conto, abitudine che, una volta acquisita, la guida con certezza
senza che essa abbia bisogno di ricordarsi la successione di decisioni che gli
e la fanno acquisire. In una sola parola, essa ha acquisito delle conoscenze.
Ma, una volta che queste idee gli hanno insegnato a comportarsi, essa non
ci pensa più, agisce per abitudine. Per acquisire conoscenze simboliche
(connaissances de théorie) è necessario avere un linguaggio16.
Bisogna dire che la statua senza parole che ereditiamo da Condillac è
tale senza dramma. Egli la lascia muta e, almeno apparentemente, questo
non sembra rappresentare un problema. La domanda sul perché questa
15
16
CONDILLAC (1754, p. 11).
CONDILLAC (1754, p. 136).
322
Donata Chiricò
creatura, che pure è dotata di udito, non parli, non sembra preoccupare il
suo ideatore. Certo è singolare che, in un testo il cui progetto è quello di
dimostrare che dai sensi nascono tutte le facoltà dell’intelligenza, non
venga suggerito, nemmeno vagamente, in che modo questo possa
riguardare il linguaggio. Ed è ancora più singolare che questo accada tra le
mani di un filosofo che ha dedicato alla questione linguistica una
significativa parte delle sue riflessioni. Il che vuol dire che non è un caso.
Del resto, il sensismo di Condillac non ha nessuna velleità di essere una
forma di continuismo. È estremamente sofferto ed aporetico. Il “dono”
della parola resta tale. La natura della mente umana (esprit) rappresenta
un’espressione speciale dell’organizzazione della materia la quale, perché
ci sia la parola (interprete dei sentimenti dell’anima) deve poter mettere in
campo una serie di mezzi estremamente peculiari ed è questo che spiega
perché gli animali non sono in grado di apprendere una lingua17.
In effetti, se osserviamo attentamente le caratteristiche della forma di
vita in cui viene inserita la statua protagonista del Trattato sulle sensazioni, è
facile comprendere che l’esito di quel tipo di esperimento non poteva
essere che un mondo di silenzio, un mondo afasico. La statua, in effetti, è
confinata nel suo mutismo poiché in qualche modo sconta un difetto di
progettazione, un peccato originale: è troppo autosufficiente per essere
anche solo minimamente umana. In effetti è sola, troppo sola. Fronteggia il
mondo. Diventa il mondo, forse. Ma non riesce a diventare un sé
emancipato da questo mondo. Non riesce a diventare essere umano. La
statua è sola ed è adulta. Non ha bisogno di nessuno e da nessuno dipende.
È l’esploratrice solitaria di un ambiente che non contempla nemmeno la
presenza di un’altra statua e, in quanto tale, espunge l’alterità e, quindi, la
questione del linguaggio in quanto quest’ultimo è, prima di tutto,
relazione.
Così sola e solitaria, così silenziosa, paradossalmente rappresenta l’altra
faccia dell’artificio caratterizzato dall’uomo di Cartesio. Quest’ultimo è
tutto immortale pensiero a cui il linguaggio viene attribuito d’ufficio in
quanto prova della sua ontologica distinzione da un mondo animale
concepito come popolato da marchingegni che incarnano ed esprimono i
principi d’ordine del meccanismo. Privi di qualsiasi forma di intelligenza,
gli animali sono propriamente muti perché regolati dalla ripetizione. Come
17
CONDILLAC (1755, pp. 370-373).
La voce: prima decisione politica
323
dire che non c’è nulla nel linguaggio e nell’intelligenza che possa essere
ricondotto ad elementi di ‘animalità’. La statua, al contrario, è tutta calata
nella sua fisicità e proprio per questo sviluppa una sua forma di
intelligenza. Ma è innegabilmente un’intelligenza non linguistica. È,
propriamente, un’intelligenza animale. La “sensazione che si trasforma”,
accattivante metafora architettata per mostrare che, se marchio di
specialità bisogna attribuire agli umani, questo deve essere guadagnato e
ereditato, non ha tra le sue forme possibili qualcosa che somiglia al
linguaggio.
Altrimenti detto, il tentativo di Condillac di sfatare l’innatismo e i
pericoli filosofici e no che ne potevano derivare (la nozione di innato
doveva ripugnare un filosofo ‘rivoluzionario’ come lui) rappresentato
dall’epopea della sua statua che coraggiosamente comincia a muoversi in
un mondo di cui non sa nulla, cozza contro il test dei test: quello
linguistico. Insomma, qual è il vero problema? Il vero problema è che
nessuno meglio di Condillac sapeva che cercare il linguaggio nella fera del
sentire, sarebbe stata un’operazione estremamente difficile. Una cosa è
dire che il modo in cui siamo fatti, la morfologia dei nostri organi, i bisogni
di cui sono depositari, ha a che fare con il modo in cui conosciamo ed
interpretiamo il mondo e, quindi, stabilire che le scienze empiriche
possano contribuire a fornire metodi e categorie anche alla filosofia,
un’altra cosa è riuscire a spiegare, proprio sulla base dell’unità del vivente,
perché e come ad un certo punto presso gli uomini appare il linguaggio e
presso animali anche dotati di capacità di articolare i suoni, questa capacità
resti inaccessibile.
Bisogna ricordare che a Condillac mancavano dati circa il rapporto tra il
cervello e il linguaggio, dati che cominciamo ad avere una loro consistenza
scientifica a partire dal 1865, anno in cui Paul Broca pubblica il testo (Sur le
siège de la Faculté du langage articulé) che di fatto fonda la neuropsicologia e
dimostra il rapporto tra strutture cerebrali e produzione delle parole e
che, quindi, difficilmente avrebbe potuto essere confortato da una
prospettiva neurobiologica. Bisogna dire altresì che Condillac recupera una
spiegazione in termini materiali del linguaggio in chiave filogenetica
(Grammaire, 1775) ma alla tradizione successiva lascia irrisolta la domanda
circa il mutismo della statua. Insomma, in che modo questo corpo fatto di
sensi e sensazioni origine di tutte le facoltà umane ha a che fare con quel
324
Donata Chiricò
“noi” che si chiama linguaggio? Condillac non lo ammette ma lo lascia
intendere: in nessun modo. Cerchiamo di capire perché.
4. In effetti, un’interessante risposta la troviamo nel più originale degli
eredi di Condillac: Marie-François-Pierre Maine de Biran. Mai rinnegando
l’impostazione materialista data alla «science de l’entendement humain»18
dalla tradizione ideologista ed enciclopedista a cui sente di appartenere19,
Maine de Biran rimette in discussione il sensismo proprio in quanto
quest’ultimo elude una domanda fondamentale: “comprendere fino a che
punto l’anima è attiva, fino a che punto essa può modificare le impressioni
esterne, aumentarne o diminuirne l’intensità grazie all’attenzione che può
dedicare loro; esaminare fino a che punto essa può essere padrona di questa
attenzione” (Autobiografie : 59). Bisogna dire che quando Maine de Biran
invoca “l’attività dell’anima” non intende resuscitare un dualismo alla
Cartesio e ristabilire il potere assoluto della res cogitans a spese della res
extensa. Egli vuole, al contrario, potentemente radicare nella materialità
più corporea la sua filosofia della mente e fare di questa una filosofia della
prassi. Questo vuol dire che il pensiero viene qui concepito non come il
prodotto finale dell’attività reiterata dei sensi (habitude), ma come ciò che è
costitutivamente azione, «sforzo originario indipendente» (effort primitif
indépendent)20.
Contrariamente a quanto era accaduto a Condillac, il linguaggio non
rappresenta un problema da eludere o rimandare ma piuttosto l’elemento
che getta luce sulla natura della natura umana, sull’’artificio’ che la rende
tale e ne definisce la sua aspirazione e destinazione. In effetti, quella
specifica forma di prassi caratterizzata dall’uso della voce articolata ed
attraverso la quale gli esseri umani esercitano quotidianamente la loro
facoltà di linguaggio, riveste caratteristiche tali da obbligare ad una messa
in discussione di tutte quelle dottrine, più o meno teologiche, che
identificano la parola con un dono e il suo destinatario con un eletto.
Se troviamo una lingua pronta nella società in cui nasciamo, la
padronanza (l’intelligence) di questa lingua, vale a dire la lingua
propriamente detta, piuttosto di essere un dono è, per ciascuno di noi,
MAINE DE BIRAN (1800, p. 230).
MAINE DE BIRAN (1800, pp. 22-23).
20 MAINE DE BIRAN (1820, p. 31).
18
19
La voce: prima decisione politica
325
un’acquisizione lunga e difficile, un impegno (étude) di tutta la vita che
esige quasi lo stesso sforzo, la stessa concentrazione e lo stesso lavoro
mentale (activité d’esprit) che la sua stessa invenzione21.
Primo ed interessante elemento su cui Maine de Biran concentra la sua
attenzione è il fatto che l’imprinting uditivo indispensabile alla produzione
di suoni articolati inizia nel corso della vita fetale22. Anche volendo, per il
momento, passare in subordine il fatto che l’esistenza di una vita psichica
del feto fosse all’epoca totalmente ignorata e che di quest’ultimo fossero
praticamente inesistenti vere e proprie descrizioni anatomiche23, pensiamo
di poter a ragione sostenere che ciò che rende speciale il punto di vista di
Maine de Biran, risieda proprio nel fatto di essere stato in grado di intuire
che una dottrina che spieghi il linguaggio da un punto di vista anche
biologico, debba tenere conto della sua ontogenesi e della sua
embriogenesi.
Partire dal feto significa partire da un’esperienza caratterizzata da
specifici requisiti: lo stretto contatto con un corpo altro da noi, l’ascolto di
suoni provenienti dall’esterno24. Vivere in un ambiente così caratterizzato
significa, dunque, sperimentare la resistenza e, malgrado tutto, riuscire a
vincerla muovendosi; stare a contatto con i suoni e non poter ancora
riprodurli. Varcata la soglia della vita uterina, ogni neonato viene accolto
in una dimensione linguistica rispetto alla quale egli è uno spettatore
necessariamente impotente e tuttavia profondamente implicato. Ormai
gettato nel mare dei suoni, non può che mettere in atto la sua prima vera
“azione” e esigere dalla sua voce (ovvero da se stesso) di mettersi in ascolto
e finalmente provare a diventare umano. Si tratta propriamente di quella
specifica forma di “sforzo intenzionale” (effort volontarie) che, una volta
concretizzata, consegna ad ogni essere umano più che un dono, un
compito: convertire il silenzio in dialogo, il grido in parola, l’animale
adatto alla sopravvivenza in un essere capace di convivenza.
È un artificio solo umano, tutto umano. A ognuno di noi, a ognuna
delle società in cui viviamo, spetterebbe quotidianamente rispettare questo
straordinario atto di evoluzione creatrice rappresentato dalla parola. Essa
MAINE DE BIRAN (1818, p. 188).
MAINE DE BIRAN (1802, p. 158).
23 SÖMMERRING (1799).
24 MAINE DE BIRAN (1800, p. 40).
21
22
326
Donata Chiricò
appartiene alla vita e solo della vita resta debitrice. La storia della specie
umana ha tristemente dimostrato che manchiamo spesso la nostra
destinazione barattandola con imposture. La più recente si chiama
comunicazione globale.
Abstract
The existence of language has been rightly considered the fact that it
makes specific humans compared to other non-human animals. This is
essentially the position that our culture inherited from Cartesianism
according to which men speak because they have a mind that is
"essentially" separate from the body. Animals do not speak because, not
having a mind are "matter in motion," an embodiment governed by
mechanical principles. The perspective changes, in particular, thanks to
materialism biologistic defended and conveyed by tradition encyclopedist.
You can not and you should not talk tract more specific man and man, as if
the language were not part of this world (continuity with animals, with
nature). Definitely think humans, but just as surely feel, have a relationship
with the world, with the smells, the colors. But this, of course, so do the
animals. Of course, the question now becomes: but if the materials (ie,
experiences) are the same for everyone, because humans produce effects
different from those produced by animals? The answer to this question is,
but we do it with organs, with a body very different from that animal.
Once there, there is the impasse of continuism. It 'clear that the
philosophers of the 700 missing Darwin. Lacking, for example, an idea of
the relationship between the body and brain development, the idea of the
evolution of the species, the co-evolution nature-culture.
But if the philosophers of the 700 missing Darwin, this is not what
happens to us. However, the contemporary cognitivism expunges, once
again, biology. Yet Darwin was clear that this is some kind of biology that
makes "historically" as a society-solidarity that had made the difference.
Now, if we reflect on this simple indicator, that is, that our survival or our
statement is explained by how we are, how we think and how we live with
others, is likely to get the urgent question of how did we create, by alone,
the conditions of our extinction. Since these are the data on the health of
the earth and humans.
La voce: prima decisione politica
327
Bibliografia
P. BROCA (1865), “Sur le siège de la Faculté du langage articulé”, in
HECAEN-DUBOIS, La naissance de la neuropsychologie du langage. 1825-1865,
Flammarion, Paris 1969, pp. 108-121.
E. B. (de) CONDILLAC (1754), Traité des sensations, Fayard, Paris 1984,
pp. 311-429.
E. B. (de) CONDILLAC (1755), Traité des animaux, Fayard, Paris 1984,
pp. 9-307.
E. B. (de) CONDILLAC (1775), Grammaire, Slatkine Reprint, Genève
1970, t. VI, pp. 263-625.
D. CHIRICÒ (1999), “Condillac: il linguaggio tra sensibilità e società”,
Bollettino Filosofico Dipartimento di Filosofia Università della Calabria, 15
(1999), pp. 75-87.
D. CHIRICÒ (2001), Sordità: storia e problemi, in Patologie del linguaggio e
scienze cognitive (A. Pennisi e R. Cavalieri edd.), il Mulino, Bologna, pp.
15-49.
C.F. DESCHAMPS (1779), Cours Élémentaire des sourds et muets, chez les
Frères Debures, Paris.
R. DESCARTES (1637), Discours de la méthode, Bordas, Paris 1988.
M. FOUCAULT (1976), La volonté de savoir, Gallimard, Paris.
J. LOCKE (1690), An essay concerning Human Understanding (P. H.
Nidditch ed.), Oxford University Press, Oxford 1991.
M.-F.-P. MAINE DE BIRAN (1800), I Mémoire sur l’influence de l’habitude
sur la faculté de penser, Vrin, Paris (F. Azouvi éd.), t. II, pp. 30-123.
M.-F.-P. MAINE DE BIRAN (1802), Mémoire sur l’influence de l’habitude sur
la faculté de penser, Alcan, Paris (P. Tisserand éd.), t. II.
M.-F.-P. MAINE DE BIRAN (1818), Origine du langage, Alcan, Paris (P.
Tisserand éd.), t. XII, pp. 167-213.
M.-F.-P. MAINE DE BIRAN (1820), Nouvelles considérations sur les rapports
du physique et du moral de l’homme, Alcan, Paris (P. Tisserand éd.), t. XIII.
M.-F.-P. MAINE DE BIRAN (s.d.), Autobiographie, Alcan, Paris (P.
Tisserand éd.), t. XIII, pp. 48-9.
S.T. SÖMMERRING (1799), Icones embryonum humanorum, Varrentrapp et
Wenner, Francofurti ad Moenum.
DEBORAH DE ROSA
Michel Foucault: storia, scienze umane e finitudine.
1. Storia totale e sua distruzione
C’era una volta una grande Storia liscia, uniforme in ognuno dei suoi
punti. Così, secondo Foucault, veniva concepito il divenire di uomini,
cose, animali: tutto compreso in uno stesso, unico ciclo. Dalla più remota
antichità greca fino a tempi molto recenti nella cultura occidentale, la
Storia univa in uno stesso continuo le cose tutte, svolgendo, oltre alla
funzione di memoria, anche altre funzioni essenziali come quelle di mito,
veicolo della tradizione, coscienza critica del presente; finanche
decifrazione del destino dell’umanità, tra anticipazione di futuro o
promesse di ritorno. Che ordinasse il tempo degli umani al divenire del
mondo come una grande cronologia cosmica, o che estendesse il principio
e il moto del destino umano alla natura, la grande storia liscia funzionava in
base ad un tempo che trascinava tutte le cose, esso stesso compreso, in un
unico ciclo comune.
Ma esattamente come le altre sfere dei saperi, anche la storia ha
risentito della grande discontinuità epistemica con la quale, all’inizio del
XIX secolo, si apre l’età moderna: la continuità viene fratturata, entra in
scena la discontinuità, e anche la storia dell’uomo e delle cose viene
costretta ad ospitare ciò che prima sembrava rifiutare per definizione:
l’evento. Foucault dedica, in Le parole e le cose, poche ma dense pagine a
questo problema, cercando di chiarire quale sia il ruolo della storia rispetto
alle scienze umane, perché «forse il suo posto non è tra le scienze umane o
a fianco di queste: è probabile che il rapporto che la lega ad esse sia […]
più fondamentale di quanto non potrebbe esserlo un rapporto di prossimità
in uno spazio comune»1.
Accade, in maniera relativamente improvvisa rispetto ai tempi lunghi
della storia del sapere, che ogni cosa si scopra avere una storicità propria.
1 M. FOUCAULT, Les mots et les choses, Éditions Gallimard, Parigi 19 66; trad. it. Le
parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, p. 393
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 329-338
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064322
329
330
Deborah De Rosa
Nello spazio del sapere si impongono tante sezioni per quante sono le cose;
vita, lavoro e linguaggio trovano le loro proprie leggi, rispettivamente di
evoluzione, sviluppo e cambiamento, funzionamento interno. Le cose,
anche le cose più singolarmente umane come il lavoro, il linguaggio o la
natura come voce di creazione o fine del mondo, si liberano dallo spazio
continuo che imponeva loro la medesima cronologia degli uomini, e
l’uomo si trova diseredato di tutto ciò che costituiva i contenuti più
manifesti della sua storia.
L’uomo come lo conosciamo oggi, soggetto e oggetto di studio delle
scienze umane, l’uomo che subentra all’essere umano con la rottura
dell’episteme della rappresentazione, fa la sua comparsa “destoricizzato”.
Già, perché l’uomo come tale prima non c’era, ci avvisa Foucault. In
quella che il filosofo francese definisce età classica (da metà del XVII secolo
a inizio del XIX), l’uomo coincideva con la coscienza del proprio potere di
contemplare e produrre idee su sé e sugli altri esseri2. La domanda “che
cos’è l’uomo?” è relativamente recente, e sorge avendo come condizione
di possibilità la nascita di scienze empiriche di nature aventi storicità
specifiche, nature al cui incrocio l’uomo si scopre naturato, cioè sostenuto
e contenuto ad un tempo: è nella misura in cui esistono una biologia,
un’economia e una linguistica che è possibile chiedersi chi è che parla,
lavora e vive, ed è nella misura in cui parla, lavora e vive che l’uomo si dà
al sapere positivo. Si scopre dunque una storia delle cose, di quelle stesse
cose che fornivano prima le dimensioni di una storia dell’uomo insieme ad
esso in un unico ciclo. Si scopre una storia di cose primariamente umane,
di campi d’esperienza agiti dall’uomo, nascono scienze come la psicologia,
la sociologia, la filologia: si inaugura l’era delle scienze umane. Che
rapporto hanno con esse la Storia?
Per rispondere, è necessario prima inquadrare il ruolo del tempo in
questo tipo di studi. Nessuno dei contenuti che le scienze umane hanno per
oggetto può restare fermo in se stesso: ogni sapere dell’uomo sull’uomo è
soggetto al movimento incessante della Storia, il quale determina di volta
in volta una nuova sezione sincronica da analizzare. Così come i contenuti
dei singoli campi di sapere, anche la scelta a monte dei campi stessi,
nonché strumenti e metodi da utilizzare, sono forniti e modificati
incessantemente da una storicità che li sostiene e li attraversa. Il rapporto
2 G. CANGUILHEM, “Mort de l’homme ou épousement du cogito”, Critique (luglio
1967), 242, pp.599-618; trad. it. “Morte dell’uomo o estinzione del cogito?”, in M.
FOUCAULT, Le parole e le cose, cit., pp.417-436, p. 432.
Michel Foucault: storia, scienze umane e finitudine
331
che la Storia ha con le scienze umane è bivalente, positivo e limitativo al
tempo stesso. Positivamente, la Storia fornisce ad ogni scienza dell’uomo
lo sfondo entro il quale stagliarsi validamente, in termini di area culturale,
episodio cronologico e persino inserzione geografica; ma la necessità
imprescindibile di tali definizioni a monte, se letta secondo diversa
prospettiva, significa anche la distruzione di ogni pretesa di validità
universale. L’uomo non appare mai nella propria positività senza che
questa venga immediatamente limitata, poiché a ben vedere, ci dice
Foucault, le scienze umane non fanno altro che mettere in rapporto gli
episodi culturali in cui si radicano su metodi, concetti ed esistenza stessa,
con episodi culturali che fanno da oggetto; se invece si applicano alla
propria sincronia, mettono in rapporto con se stesso l’episodio culturale
dal quale sono emerse.
Tra le scienze dell’uomo è compresa a buon titolo anche la Storia
stessa. In egual misura essa è intrinsecamente relativa, e un movimento
incessante la accomuna a ciò che essa stessa narra. Così come le scienze
dell’uomo sono attraversate da un’oscillazione tra le positività dell’uomo
preso come oggetto (e manifestato empiricamente da lavoro, vita e
linguaggio) e i limiti radicali del suo essere, la Storia oscilla ed agisce nello
spazio tra i limiti temporali che definiscono le forme singole di lavoro, vita
e linguaggio, e la positività storica del soggetto che, attraverso la
conoscenza, accede ad esse. Non c’è soluzione di continuità al perpetuo
arretramento della finitudine rispetto a se stessa, che la pone nella
condizione imprescindibile di avere da ripensare tutto il già pensato.
L’uomo non conosce altro se non ciò che il tempo storico ritaglia nei modi
e con gli strumenti che la storicità seleziona, avendo a disposizione sempre
e solo uno sguardo prospettico e mai uno sguardo sull’intero a tre
dimensioni; la prospettiva consente un certo possesso positivo, sul tipo
della percezione e della comprensione, che abita ed indaga società e
significati. L’intellezione universale e definitiva è vietata.
2. Lo spazio dell’evento
Prima della frattura epistemologica del XIX secolo, il legame tra
soggetto e oggetto era problematizzato tutto all’interno di una conoscenza
positiva che disvelava progressivamente parti di un intero ancora ignoto.
332
Deborah De Rosa
L’età moderna ospita sistemi di sapere in cui i rapporti tra soggetto e
oggetto sono inquadrati e giocati nell’erosione cui entrambi sono
assoggettati. Tutto ciò che è stato già pensato a livello manifesto sarà
pensato di nuovo e continuamente ad opera di un pensiero non ancora
manifesto: tale diventa la legge del tempo in quanto limite esterno alle
scienze umane. Oggetto fondamentale dei saperi sull’uomo diventa
l’inconscio.3
La parola detta ha sempre un inconscio dietro di sé, che abita nella
dimensione del perennemente sottinteso dell’episteme. Profondamente
depositate nella vita collettiva, le epistemi agiscono da griglie concettuali
per la determinazione attiva delle forme di sapere di ciascuna epoca:
l’irriflesso è quella regione la cui emergenza storica dentro il pensiero
giustifica un progetto come quello archeologico4. Il concetto-funzione che
funge da strumento per la ricerca ha il nome un po’ provocatorio5 di “a
priori storico”: un a priori che non sfugge alla storicità costituendo una
struttura intemporale al di sopra degli avvenimenti, ma che si definisce
come l’insieme delle regole che caratterizzano una pratica discorsiva, come
legge di coesistenza degli enunciati tra loro per spiegarli nella loro
dispersione. In questa concezione non c’è spazio per una storia come nome
felice da dare ad una memoria secolare e collettiva; per Foucault, Storia è
l’insieme dei materiali buoni da raccogliere per esplicitare come tutti
quegli insiemi, al tempo stesso familiari ed enigmatici che si presentano
attraverso il tempo come la medicina, la politica o l’economia,
costituiscano altrettanti campi autonomi, anonimi e senza soggetto.
Foucault adotta una strategia volta a reintrodurre quella diversità che si
credeva la Storia dovesse respingere quasi per definizione. Si sarebbero
rivelati per lui fondamentali gli studi sulle riflessioni bachelardiane relative
alla discontinuità nella teoria delle scienze, e «l’idea di un lavoro della
3 M. FOUCAULT, Le
parole e le cose, cit., p. 398.
O. MARZOCCA, Moltiplicare Foucault. Vent’anni dopo, Mimesis, Milano 2004, p. 30.
5 Piaget avanza il dubbio che Foucault non abbia fatto altro che «raccontare a cose fatte
l’accaduto, come se avesse potuto essere dedotto a priori dalla conoscenza della sua
episteme» (J. PIAGET, Le structuralisme, P.U.F., Paris 1968; trad. it. Lo strutturalismo, Il
Saggiatore, Milano 1971, p. 165). Canguilhem stesso, largamente favorevole a Foucault,
giunge a chiedersi se l’episteme foucaultiana sia «davvero o no qualcosa di più di un essere di
ragione», e se possa garantire di avere «a che fare con qualche cosa che non sia una parola
(G. CANGUILHEM, “Mort de l’homme ou épousement du cogito”, Critique (luglio 1967),
242, pp.599-618; trad. it. “Morte dell’uomo o estinzione del cogito?”, in M. FOUCAULT,
Le parole e le cose, cit., pp.417-43, p. 427).
4
Michel Foucault: storia, scienze umane e finitudine
333
ragione su se stessa nel momento in cui si costituisce degli oggetti di
analisi».6 Il quadro teorico che così si forma è quello di un movimento
storico discontinuo, segato da rotture epistemologiche che tagliano
l’ordine del sapere e comportano, di volta in volta, nuove sistemazioni dei
paradigmi conoscitivi. Ciò da cui Foucault si discosta è l’unico elemento di
continuità rimasto nel quadro teorico bachelardiano, ossia il progresso, il
presupposto di un sempre maggiore incremento dei valori di verità e di
razionalità del sapere. La prima preoccupazione di Foucault, già da anni
prima della stesura di Le parole e le cose, era quella di liberare «le cronologie
e le successioni storiche da ogni prospettiva di progresso, restituendo alla
storia dell’esperienza un movimento che non prende niente a prestito dalla
finalità della conoscenza o dall’ortogenesi del sapere»7
Oltre a Bachelard, Foucault deve molto a Canguilhem e al suo studio su
contesto culturale e condizioni storico-istituzionali – discorsive e non – in
cui le scienze mediche e biologiche erano prodotte, aspetto trascurato dalla
‘storia cronachistica’. Per Canguilhem la storia di un concetto ha una sua
specifica temporalità, rivelatrice non tanto di un processo epistemologico
di auto-correzione, come accade con le scienze esatte, quanto della
persistenza del fenomeno problematico nel complesso di soluzioni
contraddittorie e valori ideologici che vengono via via ad esso associati, e
che nel loro insieme ne compongono la storia. Questa tensione è
l’inevitabile risultato di discipline che non hanno diritto alle procedure di
convalida delle scienze esatte: la storia di tali scienze non consiste nella
graduale insorgenza e manifestazione di verità scientifiche, quanto
piuttosto in una storia di discorsi veridici. La verità, come la storicità,
deriva da particolari pratiche discorsive; opera internamente come forma
di regolamentazione, oltre a essere il prodotto storico della lotta fra diversi
regimi discorsivi8. Infatti
Ciò che passa per la testa di qualcuno, ivi compresi i filosofi, fa
effettivamente parte della storia: dire qualcosa è un evento. Tenere un
D. TROMBADORI, Colloqui con Foucault. Pensieri, opere, omissioni dell’ultimo maître-àpenser, Alberto Castelvecchi Editore, Roma 1999, p. 52.
7 M. FOUCAULT, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Plon 1972; trad. it. in Storia
della follia nell'età classica, Rizzoli, Milano 2010, p. 126. Cfr. anche G. BACHELARD, La
Philosophie du non : Essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique, P.U.F., Paris 1940;
trad. it. La filosofia del non. Saggio di una filosofia del nuovo spirito scientifico, Armando
Editore, Roma 1998.
8 Cfr. G. CANGUILHEM, Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, Vrin, Parigi 1968.
6
334
Deborah De Rosa
discorso scientifico non è qualcosa che si colloca al di sopra o a lato della
Storia: fa parte di essa tanto quanto una battaglia o l’invenzione della
macchina a vapore, o un’epidemia9.
Così, dalla storia pensata attraverso la filigrana dell’evento, si tratterà
di recuperare delle regolarità differenziali, aperte e disperse, delle soglie di
differenziazione, e non delle figure destinate a ritrovarsi nel Tutto.
Oltre a respirare il clima di cambiamento dell’epistemologia francese
del Novecento, Foucault aveva recepito le grandi trasformazioni apportate
alla ricerca storica dal lavoro degli storici delle École des Annales. La nouvelle
historie, introducendo lo studio della longue durée e dunque delle serie,
aveva consentito di spostare l’attenzione degli storici dagli eventi politici e
dalle loro repentine successioni a processi più complessi, meno nobili e più
duraturi, riguardanti gli aspetti della vita materiale. Dunque ai problemi
tradizionali della storia, come l’interpretazione dei legami di casualità tra
gli avvenimenti, l’attribuzione di significato agli stessi, l’introduzione dei
periodi lunghi, si erano sostituiti altri tipi di problemi: la modalità di
periodizzazione, l’individuazione delle tipologie di serie possibili, il
riconoscimento di elementi di rottura tra le serie e al loro interno. Si
teorizzava già di fornire resoconti di mutamenti, e per venire a patti con il
passato bisognava innanzitutto fare i conti con la sua estraneità, invece di
ricercare le somiglianze e le continuità che consentivano di equipararlo al
presente e dunque, in pratica, di destoricizzarlo.
3. La finitudine infinita
L’inconscio, oggetto fondamentale delle scienze umane,10 e la legge del
tempo in quanto loro limite esterno, sono i due volti della finitudine.
Essere finito vuol dire essere contenuto entro le leggi di una prospettiva
conoscitiva, la quale vieta una intellezione universale e conoscitiva.
Quando la storia naturale diviene biologia, quando l’analisi delle ricchezze
diviene economia, quando la riflessione sul linguaggio si fa filologia e viene
meno il discorso classico in cui l’essere e la rappresentazione trovavano il
proprio luogo comune, allora l’uomo appare con la sua posizione ambigua
9
D. TROMBADORI, Colloqui con Foucault, cit., p. 84.
M. FOUCAULT, Le parole e le cose, cit., p 398.
10
Michel Foucault: storia, scienze umane e finitudine
335
di oggetto nei riguardi di un sapere e di soggetto che conosce; e non
potendosi sottrarre al gioco della natura, non può che fondare la propria
conoscenza se non limitandola.
In qualche misura l’uomo è dominato da lavoro, vita e linguaggio. La
sua esistenza concreta trova in essi le proprie determinazioni: si può
accedere all’uomo solo attraverso le sue parole, il suo organismo, gli
oggetti che fabbrica, come se questi inizialmente (questi soli, forse)
detenessero la verità; e l’uomo medesimo non appena pensa «si svela ai
propri occhi soltanto nella forma di un essere che è già, in uno spessore
necessariamente sottostante, entro un’irriducibile anteriorità; un vivente,
uno strumento di produzione, un veicolo per parole che gli preesistono».
Tutti questi contenuti non si offrono al compito di una conoscenza
possibile se non legati da cima a fondo alla finitudine; essi infatti non
sarebbero là, nella luce che li rischiara in parte, se l’uomo, che per loro
tramite si scopre, fosse imprigionato nell’apertura muta, notturna,
immediata e felice della vita animale; ma d’altro canto non si darebbero
nemmeno sotto l’angolatura che li dissimula in se stessi se l’uomo potesse
percorrerli senza più nel lampo di un intelletto infinito.11 Il sapere
dell’uomo è finito, in quanto esso è imprigionato, senza liberazione
possibile, nei contenuti positivi del linguaggio, del lavoro e della vita;
inversamente, la vita, il lavoro e il linguaggio si danno nella loro positività
perché la conoscenza ha forme finite.
L’intento essenziale dell’archeologia è quello di liberare la storia dal
pensiero della “soggezione trascendentale”, espressione con la quale
Foucault intende la dipendenza del pensiero e della sua storia dalle
strutture mentali dell’uomo, dalle sue esperienze vissute, dalla sua
soggettività o dalla sua coscienza in generale. Non appena l’uomo cominciò
a percepirsi nei suoi militi come “naturato”, si produsse uno squilibrio:
mentre si imponeva la necessità di interrogare l’essere dell’uomo in quanto
fondamento di tutte le positività, l’uomo divenne invece ciò a partire da
cui ogni conoscenza poteva essere costituita nella sua evidenza immediata e
non problematizzata. Il soggetto divenne fondamento di conoscenza, in
esso venne trovata l’origine.
L’uomo, in quanto allotropo empirico-trascendentale, non è affatto natura
e sostrato inalterabile; egli è ‘solo’ figura dell’episteme moderna. Affinché
il pensiero dell’uomo abbandoni questo sonno antropologico, ossia «la
11
M. FOUCAULT, Le parole e le cose, cit., p 338.
336
Deborah De Rosa
sicurezza disinvolta con cui i promotori attuali delle scienze umane
considerano concesso come oggetto, dato lì anticipatamente ai loro studi
progressivi, ciò che in partenza era solo un loro progetto di
costituzione»12, l’antropologia deve svegliarsi al suono delle trasformazioni
epistemiche; in una parola, deve storicizzarsi.
Il primo sforzo in vista di questo sradicamento dell’antropologia è
dovuto a Nietzsche, il quale, più che la morte di Dio, annunciò la fine del
suo uccisore, ossia l’esplosione del volto dell’uomo nel riso e nel ritorno
delle maschere poiché «l’ultimo uomo è, a un tempo, più vecchio e più
giovane della morte di Dio; avendo ucciso Dio, è lui stesso che deve
rispondere della propria finitudine; ma dal momento che parla, pensa ed
esiste entro la morte di Dio, il suo crimine stesso è destinato a morire;
[…] l’uomo scomparirà».13 Se la scoperta del Ritorno segna la fine della
filosofia, la fine dell’uomo invece segna il ritorno dell’inizio della filosofia.
Infatti la morte dell’uomo non lascia una lacuna da colmare, bensì uno
spazio entro cui finalmente è di nuovo possibile pensare.
Ma è Kant quel maestro d’equilibrio che, dopo aver composto un’opera
sui limiti della conoscenza, predispone il contrappeso inscrivendo il
coraggio di sapere nel bagaglio morale dell’uomo moderno.14 Sapere
aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!
Foucault conosce il Kant dell’Antropologia da giovanissimo, dedica a
questa opera la tesi secondaria di dottorato, e si accompagna della presenza
kantiana così a lungo da giungere, nel 1983, a dichiarare di considerare il
testo kantiano sull’Illuminismo come testo ‘blasone’ della propria
filosofia.15 La contestazione dell’antropologia che sta alla radice della stessa
ricerca archeologica è radicata nell’ appartenenza alla tradizione critica.
Critica è quella che dice al sapere: sai bene fin dove sei in grado di
sapere? Ragiona finché vuoi, ma sai bene fin dove puoi ragionare senza
pericolo? La critica è il fondamento su cui Foucault ha costruito una
metodologia per la storia della cultura: il mattone di base è il fatto che
l’uomo è finito, che il sapere si dà in prospettiva, che quanto più la Storia
G. CANGUILHEM, “Morte dell’uomo o estinzione del cogito?”, cit., p. 436.
M. FOUCAULT, Le parole e le cose, cit., p. 412.
14 M. FOUCAULT, “Qu’est-ceque la critique? (Critique et Aufklärung)”, Bulletin de la
Société française de philosophie, 2, (aprile-giugno 1990), pp. 35-63; trad. it. Illuminismo e
critica, Donzelli Edizioni, Roma 1997, p. 15.
15 M. FOUCAULT, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (19821983, Gallimard), Parigi 2008; trad. it. Il governo di sè e degli altri. Corso al Collège de France
(1982-1983, Feltrinelli), Milano 2009, lezione del 12/01/1983.
12
13
Michel Foucault: storia, scienze umane e finitudine
337
stessa tenta di superare il proprio radicamento storico e di raggiungere,
oltre la relatività storica della sua origine e delle sue posizioni, la sfera
dell’universalità, tanto più chiaramente porta le stigmate della sua nascita
storica e tanto più pone in risalto la storia cui essa stessa appartiene. Fare
della critica – e dell’Aufklärung inteso come attitudine a misurare la
possibilità di autonomia di conoscenza – la questione centrale, significa
impegnarsi in una pratica storico-filosofica che non ha nulla a che vedere
con la filosofia della storia né con la storia della filosofia. «Si tratta […] di
farsi la propria storia, di fabbricare, come per finzione, la storia che
sarebbe attraversata dal tema dei rapporti tra le strutture razionali che
articolano il discorso vero e i correlati meccanismi di assoggettamento.
Evidentemente, posta in questi termini, la questione sposta gli oggetti
familiari agli storici sul terreno del soggetto e della verità, temi ad essi
tradizionalmente estranei.16
Le parole e le cose si aprono con la citazione della tassonomia fantastica di
Borges, che diviene emblema di come i limiti di ciò che è ritenuto vero o
falso, di ciò che riteniamo credibile o incredibile non siano oggettivi, ma
siano tracciati dalle configurazioni epistemologiche dalle quali emergono e
si relazionano tra loro gli enunciati, fino a produrre oggetti e criteri in base
ai quali includere o escludere gli oggetti stessi. Successivamente a Le parole
e le cose Foucault legherà in misura sempre maggiore la circolazione degli
enunciati agli effetti di potere che la verità è in grado di trasmettere. In
fondo, il terreno per gli sviluppi dell’ultimo Foucault sull’etica come cura
di sé è già pronto da questi primi studi: da un lato, Kant è il filosofo
dell’analitica della verità che ha risvegliato il pensiero occidentale dal
sonno dogmatico della metafisica, volendo indagare i limiti e le condizioni
di possibilità della conoscenza; dall’altro, Kant è il filosofo della ontologia
del presente che con la domanda sull’Illuminismo ha inaugurato
l’interrogazione critica sul presente. La minorità dell’uomo è da imputare
a lui stesso, e non dipende da difetto di intelletto, ma dalla mancanza di
decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere
guidati da un altro. L’uscita dallo stato di minorità è strettamente connessa
al fare del presente il tempo della filosofia, esercitando un pensiero che si
sa essere finito su una conoscenza che non si pretende poter essere
universale, per analizzare una Storia che è archivio di eventi e mutamenti.
L’uscita dallo stato di minorità viene presentato come un evento che ha
16
M. FOUCAULT, Illuminismo e critica, cit., pp. 49-50.
338
Deborah De Rosa
dischiuso prospettive di emancipazione politica e culturale e che, proprio
in virtù delle possibilità aperte, richiede a tutti e a ciascuno una decisione
che le renda attuali. Prendere le mosse dall’imminente cancellazione
dell’uomo «come sull’orlo del mare un volto di sabbia»17 è per Foucault il
primo fondamentale passo, che deve venir fuori insieme all’emergere della
storicità come modalità dell’intelletto. La Storia è essa stessa un fenomeno
storico, come tutto ciò che ha per contenuto; come sempre, ciò che a
Foucault interessa è mettere in discussione i presupposti.
Abstract
What does it mean, for man, to be finite? In which way does finitude
reconcile itself with the inevitable advance of history? In The Order of Things
(1964) Michel Foucault writes a few pages concerning the possible role of
history as one of the human sciences, born at the moment of the birth of
Man as a subject and object of knowledge.
This article will trace some of the most important philosophical and
cultural conditions that allowed the epistemological turn from the
historical discourse of the continuous to the discourse of the discontinuous.
Reflections will be put forward to clarify why Foucault doesn’t categorize
history as a human science but gives it a foundational role, and why the
analytic of finitude is important to build up that critical anthropology that
will lead to his last theory of subject.
17
M. FOUCAULT, Le parole e le cose, cit., p. 414.
ROSARIO DIANA
Con l’occhio al presente.
Sollecitazioni crociane nella lettura dei classici
1. Questo breve saggio è il risultato di una serie di lezioni che tenni dal
16 al 19 novembre 2009 nella sede napoletana dell’Istituto per la Storia del
Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno (Ispf) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Titolo del seminario era: Filosofia del passato e riflessione sul
presente. “Contemporaneità della storia” e “contemporaneità della filosofia” in
Croce. Una proposta teoretica. La “proposta teoretica”, formulata e discussa
allora con gli studenti, consisteva nell’assumere le posizioni teoriche
crociane, indicate nel titolo dell’incontro di studio, non tanto come
documenti storico-filosofici relativi ad alcune parti rilevanti di una delle
riflessioni più ricche, complesse e controverse del Novecento europeo, ma
piuttosto come esortazioni (e non è detto che tali non fossero anche per
Croce) a sperimentare la possibilità di intraprendere la lettura dei ‘classici’
filosofici – a cui sono consegnati i dilemmi e le soluzioni dei grandi
pensatori del passato – con una più pronunciata esigenza (non certo priva
di attenzione alle diverse ambientazioni storico-culturali in cui i testi
furono concepiti e scritti) di ricercare (ove possibile, naturalmente) nella
meditazione del passato strumenti metodologici, strutture concettuali,
apparati teorici che possano costituire una risorsa preziosa per sostenere e
meglio articolare le domande filosofiche suscitate dal nostro presente e
magari offrire buone basi per formulare ipotesi di risposta. Si tratta,
naturalmente, di una fra le altre possibili modalità di approccio alla lettura
di un testo filosofico; una modalità che pone un problema molto complesso
– non possiamo affrontarlo ora – e che provoca contaminazioni trasversali
fra le tradizionali aree disciplinari in cui si dipana il sapere filosofico.
Rimandando la questione ad altra sede e a un diverso momento, ci si
accontenterà qui di fornire una traccia delle lezioni, conservando
l’impianto generale del lavoro, che fa perno sul confronto diretto con la
pagina crociana. A tale scopo, si è quasi escluso del tutto il riferimento alla
vastissima letteratura secondaria.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 339-349
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064323
339
340
Rosario Diana
Nel paragrafo che segue si rimedita la teoria del giudizio, così come
viene esposta nella Logica crociana del 19091, e si mostra come in essa si
annunci un’idea di ‘contemporaneità della filosofia’. Nel terzo paragrafo si
ripropone sinteticamente la nota tesi che afferma la contemporaneità della
storia. Infine, nel quarto si traggono le conclusioni del nostro discorso.
2. Centrale nella Logica di Croce è la teoria del giudizio. Giudicare
significa unire un soggetto a un predicato per mezzo di una copula.
Condizione necessaria affinché si dia un giudizio, è che soggetto e predicato
siano distinti nella loro natura. Per il filosofo abruzzese, la condizione
appena indicata si realizza pienamente nel giudizio individuale, ossia quello
in cui: a) il soggetto si distingue dal predicato sia dal punto di vista formale
(dal momento che il soggetto è individuale, ossia è una rappresentazione,
mentre il predicato è universale, ovvero è un concetto) sia, di conseguenza,
dal punto di vista del contenuto; b) posta la distinzione fra soggetto e
predicato, la copula esercita la sua funzione più autentica, che è appunto
quella di unire due elementi eterogenei (rappresentazione e concetto). Il
giudizio individuale (rappresentazione/individuale + concetto/universale) è il
giudizio vero e proprio, anzi l’unico vero giudizio. Nella Logica Croce
chiarisce in maniera esemplare:
Soggetto e predicato possono essere con ragione e giustificazione distinti
solamente in quanto l’uno non è universale e l’altro sì, l’uno non è concetto e
l’altro sì: vale a dire, solamente in quanto l’uno è rappresentazione e l’altro
concetto. Un concetto […] è sempre […] concetto universale, e disadatto
dunque a fungere da soggetto cui si applichi un predicato […]. Solo la
rappresentazione può essere veramente soggetto, e solo il concetto veramente
predicato, come si osserva nel giudizio individuale, che congiunge i due
elementi. Il giudizio individuale: «Pietro è buono» pone e media, ossia
congiunge, il soggetto «Pietro», e il predicato «buono», l’uno
inconfondibile con l’altro2.
Dal momento che il giudizio individuale è unione di rappresentazione e
concetto, di intuizione e intelletto, esso, a tutti gli effetti, può essere
definito «intuizione intellettuale ossia intellezione intuita»3. Non solo,
1 B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, ed. crit. di C. Farnetti, con una Nota al
testo di G. Sasso, 2 voll., Bibliopolis, Napoli 1996 (le citazioni seguenti si riferiscono
esclusivamente al vol. I, d’ora in poi indicato con la sigla: Log).
2 Log, p. 123 (corsivi miei).
3 Log, p. 125.
Con l’occhio al presente
341
proprio in virtù di tali caratteri, esso è anche un giudizio percettivo, ossia
una percezione. A questo proposito bisogna ricordare che per Croce la
percezione è cosa ben diversa dall’intuizione in senso stretto. Se
l’intuizione è rappresentazione pura e semplice che prescinde dai requisiti
di realtà o irrealtà, la percezione non è abbandono al sentire e all’intuire,
ma è «apprendere una cosa come avente tale o tal’altra qualità, e perciò
pensarla e giudicarla»4.
Non basta. Croce aggiunge anche che il giudizio storico, quello cioè per il
quale noi stabiliamo che un fatto è accaduto nel passato, è un giudizio
percettivo, così come il giudizio percettivo stesso è giudizio storico. Ma
leggiamo le parole vive del filosofo:
Il giudizio individuale può prendere anche nome assai più noto e familiare,
quello di percezione; come la percezione dovrebbe essere detta
sinonimicamente giudizio individuale o almeno giudizio percettivo. […]
Donde la dignità suprema del giudizio individuale, che effettua tutta la
conoscenza da noi in ogni istante prodotta, e pel quale solamente
possediamo il mondo, anzi pel quale solamente un mondo è. Nei giudizi
percettivi sono compresi anche i giudizi che da taluni si denominano
memorativi o storici: quelli cioè pei quali si afferma che un fatto è accaduto
nel passato. […] Tutti i giudizi percettivi sono in qualche modo memorativi e
storici, perché il presente, nell’atto medesimo in cui lo fermiamo innanzi al
nostro spirito, diventa un passato: oggetto, come si suol dire, di memoria
e di storia5.
Nel giudizio individuale (o percettivo o storico) il soggetto, ossia la
rappresentazione dell’individuale, è l’elemento che urge e spinge lo spirito
a darsi un mondo nel giudizio storico. Senza l’insorgere di un’intuizione che
si fa percezione, ossia affermazione di realtà, non ci sarebbe ragione e
motivo di giudicare, ossia di costituire quel mondo storico contemporaneo al
giudicante, che è l’orizzonte entro cui emergono per lui sempre nuovi
problemi e, dunque, sempre nuove occasioni per formulare giudizi e con
essi riconsiderare e ristrutturare quel mondo storico stesso6. Da questo punto
Ibid.
Log, pp. 125-126 (corsivi miei).
6 «Tutta la filosofia che andiamo svolgendo – osserva Croce – comprova che nulla vi ha
di esterno allo spirito, e perciò non vi sono di fronte a esso “posizioni” di sorta; e che i
concetti stessi di mondo esterno, meccanico o naturale non sono già posizioni dall’esterno,
4
5
342
Rosario Diana
di vista si coglie la centralità – seppure incardinata nell’indissolubilità del
rapporto con il predicato (concetto universale) – della componente
rappresentativa (ossia individuale) nel giudizio storico: essa attesta che il
giudicare è di volta in volta risposta comprendente (preparante non
determinante dell’agire7) alle sollecitazioni problematiche sollevate o
imposte al pensatore-storico dalla realtà a lui contemporanea, che egli
stesso costituisce, riempie di senso, e nella quale vive svolgendo il proprio
compito intellettuale.
Quest’ultimo punto si comprende ancora meglio, se spostiamo la
nostra attenzione sul giudizio definitorio. A prima vista quello definitorio
sembra non essere un vero e proprio giudizio, dal momento che i tre
elementi costitutivi del giudicare – soggetto, copula e predicato – non
sono reciprocamente distinti. Infatti, nel giudizio definitorio: «la volontà è
la forma pratica dello spirito»8, noi individuiamo un soggetto («la volontà»)
e un predicato («la forma pratica dello spirito») che sono entrambi
universali. Pertanto nel giudizio definitorio: a) un universale si predica di
un altro universale (manca, dunque, la distinzione fra soggetto/individuale
e predicato/universale); b) l’universale che fa da predicato in realtà non
aggiunge nulla al concetto del soggetto (non vi è, quindi, differenza di
contenuto fra i due), ma semplicemente esplicita il concetto del soggetto
(come nei giudizi analitici kantiani). Dunque «la differenza di soggetto e
predicato è qui illusoria, perché predicato significa l’universale che si predica di
un individuale, e qui tanto il preteso soggetto quanto il preteso predicato sono due
universali, e il secondo, non che essere più ampio del primo, è il primo
stesso»9; c) la copula in realtà non è più tale, dal momento che essa non
connette due elementi distinti. Essi sono già uniti, poiché il predicato dice
semplicemente il soggetto, senza estendere la cognizione che già ne
abbiamo. «L’“è”, nel caso della definizione – scrive Croce –, non esprime
altro se non l’atto stesso del pensiero che pensa, perché quel che si pensa è,
in quanto si pensa: se non fosse non si penserebbe, e, se non si pensasse,
non sarebbe»10. Dunque nel giudizio definitorio in realtà il pensiero non
ma posizioni dello spirito stesso, che foggia quel cosiddetto “esterno”, perché gli giova
foggiarlo, salvo a riannullarlo quando non gli giova più» (Log, p. 136).
7 Cfr. B. CROCE, Il carattere preparante e indeterminante della storiografia rispetto all’azione,
in ID., La storia come pensiero e come azione (1938), ed. crit. a cura di M. Conforti, con una
Nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 2002, pp. 183 sgg.
8 Log, p. 100.
9 Ibid (corsivi miei).
10 Ibid.
Con l’occhio al presente
343
predica qualcosa di qualcosa, ma semplicemente pensa, definisce il
contenuto del pensare. Ciò detto, possiamo perciò concludere con Croce
che, «rispetto al concetto, la definizione non è da ritenere da esso
distinguibile»11; ovvero: concetto e definizione si identificano. Non solo.
Poiché sappiamo che per Croce non vi può essere concetto senza
espressione del concetto e che, anzi, concetto ed espressione si
identificano, dobbiamo concludere che concetto, espressione e definizione
si identificano: la definizione è l’espressione del concetto e dunque il
concetto stesso. «Definire – scrive Croce –, sotto l’aspetto verbale, vuol
dire esprimere il concetto; e tutte le espressioni del concetto sono
definizioni»12.
A questo punto si impongono, però, due domande reciprocamente
connesse: 1) se quello definitorio non è un vero e proprio giudizio, in
quanto è privo della componente rappresentativo-percettivo-individuale,
allora perché se ne parla nella Logica?; 2) dal momento che se ne parla,
vuol dire che questo giudizio – malgrado tutto – esercita una qualche
funzione, quale? Il dilemma posto dai due quesiti si chiarisce, se con Croce
proviamo a rispondere innanzitutto alla seconda delle due domande. Se,
sulla base all’indicazione stessa del filosofo abruzzese, formuliamo il
seguente giudizio storico: Pietro è esistente, dobbiamo dare per acquisiti i
concetti di “uomo” (Pietro, appunto) e di “esistenza”, altrimenti quella
proposizione non significherà nulla per noi. Questo dovrebbe bastare a
farci concludere – con Croce – che il giudizio storico presuppone il giudizio
definitorio. Si legge nella Logica:
Il giudizio definitorio non è giudizio individuale, ma il giudizio individuale
implica un precedente giudizio definitorio. Che si pensi il concetto di uomo,
non vuol dire che l’uomo Pietro esista; ma per affermare che l’uomo
Pietro esiste, si deve prima aver affermato che esiste l’uomo, ossia aver prima
pensato quel concetto13.
Dunque, se così stanno le cose, non possiamo rinunciare al giudizio
definitorio, se vogliamo continuare a concepire ed esprimere (i due atti per
Croce si identificano, come abbiamo visto) giudizi individuali e storici.
Con ciò abbiamo chiarito la funzione (imprescindibile) del giudizio
Log, p. 101.
Log, p. 102.
13 Log, p. 154 (corsivi miei).
11
12
344
Rosario Diana
definitorio: resta però il fatto che esso – a voler essere conseguenti rispetto
all’argomentazione crociana – non è un vero e proprio giudizio, poiché è
privo della dimensione rappresentativa e individuale. E se questa mancanza
fosse solo apparente? Il procedimento crociano è chiaro: per poter
sussumere a pieno diritto il giudizio definitorio sotto il titolo generale del
“giudizio”, dobbiamo ricercare (e trovare) anche in questa forma
particolare del giudicare quella componente percettivo-rappresentativa che
denota il giudizio in quanto tale. Le vie che conducono al conseguimento
dell’obiettivo sono due. La prima prende in considerazione – per così dire
– il bisogno storico del giudizio definitorio. Una definizione è sempre la
risposta ad una domanda emergente da un problema sorto storicamente e,
come tale, condizionato e contestualizzato. Ciò significa, ad esempio, che
la definizione di uomo come “animale razionale” corrisponde a quella che
dell’essere umano poteva dare la filosofia greca del IV secolo a.C. con
Aristotele. Non solo, ma la definizione, nascendo dalla posizione di un
problema filosofico che è storicamente condizionato e di volta in volta
diverso, si riferisce a questo problema filosofico stesso, in quanto
contribuisce a chiarirne gli aspetti ed eventualmente a darne una soluzione.
Dunque – lo ripetiamo – una definizione è storicamente situata in quanto è
la risposta ad un problema circoscritto che si pone in un determinato
momento della storia del pensiero. Eccolo dunque l’elemento
rappresentativo ed individuale che entra nel giudizio definitorio: è appunto
il problema storicamente dato, è la situazione storica che genera quella
domanda filosofica a cui il giudizio definitorio cerca di dare risposta. Ci
conviene, a tal proposito, leggere un lungo brano del filosofo, che saprà
ripagarci dello sforzo compiuto.
Ogni definizione è la risposta a una domanda, la soluzione di un problema; e
non vi sarebbe luogo a pronunciarla se noi non facessimo domande e non
ci proponessimo problemi. Perché ci daremmo quell’incomodo? quale
bisogno ci costringerebbe? Come ogni atto dello spirito, la definizione sorge
da un contrasto, da un travaglio, da una guerra che invoca pace, da una
oscurità che cerca luce, ossia, come abbiamo detto, è una domanda che
chiede risposta. Né solamente la risposta suppone la domanda, ma tale
risposta, tale domanda. La risposta deve essere intonata alla domanda,
perché altrimenti non sarebbe risposta, ma elusione di risposta. Il che
torna a dire che la natura della domanda colora di sé la risposta, e che una
definizione, considerata nella sua concretezza, appare determinata dal
problema che la fa sorgere. Variando il problema, varia l’atto definitorio.
Con l’occhio al presente
345
Ma la domanda, il problema, il dubbio è sempre individualmente
condizionato: il dubbio del bambino non è quello dell’adulto, il dubbio dell’uomo
incolto non è quello dell’uomo colto, il dubbio del novizio non è quello
dell’addottrinato, il dubbio di un italiano non è quello di un tedesco, e il dubbio di
un tedesco dell’anno 1800 non è quello di un tedesco dell’anno 1900; anzi, il
dubbio formolato da un individuo in un determinato momento non è quello che lo
stesso individuo formola un momento dopo. Semplificando, si suole affermare
che una stessa domanda è stata mossa tal quale da molti uomini in varî
paesi e in varî tempi; ma, col dire ciò, si fa per l’appunto, una
semplificazione, ossia un’astrazione. In realtà ogni domanda è diversa
dall’altra, e ogni definizione, per costante che suoni è circoscritta da certe
determinate parole, in realtà è diversa dall’altra, perché le parole, anche
quando sembrino materialmente le stesse, sono effettivamente diverse
secondo la diversità spirituale di coloro che le pronunciano, i quali sono
individui e si trovano perciò sempre in circostanze individuali e nuove. […]
Ammessa la condizionalità individuale e storica di ogni pensamento del
concetto ossia di ogni definizione […], si deve ammettere altresì che la
definizione, la quale contiene la risposta e afferma il concetto, nel fare ciò
illumini quella condizionalità individuale e storica, quel gruppo di fatti da cui essa
sorge. Lo illumina, ossia lo qualifica per quel che è, lo apprende come soggetto
dandogli un predicato, lo giudica; e, poiché il fatto è sempre individuale, forma
un giudizio individuale; ossia ogni definizione è insieme giudizio individuale14.
Come si vede, la conclusione più conseguente è la riconduzione del
giudizio definitorio al giudizio individuale e storico. «L’atto logico –
aggiunge inequivocabilmente il filosofo – […] è unico, ed è identità di
definizione e giudizio individuale»15.
La seconda via percorsa da Croce si riferisce alla natura del concetto:
una forma di conoscenza teoretica di secondo grado che presuppone
l’intuizione come suo fondamento. Nella Logica leggiamo:
Il pensamento del concetto è un grado superiore alla pura rappresentazione,
e nei gradi dello spirito il superiore contiene in sé l’inferiore, nel concetto si deve
ritrovare di necessità non solo l’elemento concettuale ma anche quello
rappresentativo, e congiunti e fusi in guisa tale che non sia dato distinguerli
14
15
Log, p. 159-161 (corsivi miei).
Log, p. 161 (corsivi miei).
346
Rosario Diana
se non per astrazione. […] Il concetto non si applica all’intuizione, perché
non esiste nemmeno per un attimo fuori dell’intuizione16.
3. La tesi sulla contemporaneità della storia non ci impone tutti i
passaggi che sono stati necessari per illustrare e argomentare quella che
abbiamo denominato ‘contemporaneità della filosofia’. La sua enunciazione
è, infatti, molto più diretta ed esplicita, e si trova nel primo capitolo di
Teoria e storia della storiografia, intitolato: “Storia e cronaca”. «“Ogni vera
storia – vi si legge – è storia contemporanea”»17. Cosa intende dire il
filosofo con questo aforisma? Vuole, da un lato, affermare la stretta
connessione fra i problemi attuali e urgenti in cui il pensatore-storico si
imbatte, vivendo entro l’orizzonte ampio della propria epoca, e la
direzione nonché l’oggetto della sua ricerca; dall’altro, vuole mettere fuori
gioco ogni tentazione di concepire il lavoro dello storiografo come
esercizio di pura erudizione. Secondo la proposta teorica crociana,
contenuta in quel famoso assunto, il nostro rapporto con il passato è
mediato e governato dalle circostanze e dalle questioni che si agitano, sono
vive e fortemente sentite entro l’alveo del nostro mondo storico
contemporaneo: è, infatti, «evidente che solo un interesse della vita
presente ci può muovere a indagare un fatto passato»18. Ancora una volta
vale la pena di ricorrere alle parole stesse del filosofo, che sono – come
sempre, del resto – un modello di chiarezza e di concisione:
Quale l’interesse presente della storia che narra la guerra peloponnesiaca o
la mitridatica, le vicende dell’arte messicana o della filosofia arabica? Per
Log, pp. 162-163 (corsivi miei). «Senza le intuizioni non sono possibili i concetti –
scrive Croce nell’Estetica – […]. Le intuizioni sono: questo fiume, questo lago, questo
rigagnolo, questa pioggia, questo bicchier d’acqua; il concetto è: l’acqua, non questa o
quella apparizione e caso particolare, ma l’acqua in genere» (B. CROCE, Estetica come scienza
dell’espressione e linguistica generale – 1902 –, a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1990, p.
29).
17 B. CROCE, Teoria e storia della storiografia (1917), ed. crit. a cura di E. Massimilla e
T. Tagliaferri, con una Nota al testo di F. Tessitore, 2 voll., Bibliopolis, Napoli 2007, vol.
I (d’ora in poi: Tss), p. 12. Per un esame dell’articolata costituzione testuale di quest’opera
crociana cfr. E. MASSIMILLA, T. TAGLIAFERRI, “L’edizione critica di Teoria e storia della
storiografia”, in I percorsi dello storicismo italiano nel secondo Novecento, a cura di M. Martirano
ed E. Massimilla, Liguori, Napoli 2002, pp. 371-378; E. MASSIMILLA, T. TAGLIAFERRI,
“Ancora sull’edizione critica di Teoria e storia della storiografia”, Archivio di storia della cultura
XVII (2004), pp. 185-203.
18 Tss, p. 12.
16
Con l’occhio al presente
347
me, in questo momento, nessuno; e quindi, per me, in questo momento,
quelle storie non sono storie, ma, tutt’al più, semplici titoli di libri storici
[…]. Quando le penserò, rielaborandole secondo il mio bisogno spirituale
[…], quando lo svolgimento della cultura del mio momento storico (e
sarebbe superfluo, e forse anche inesatto, aggiungere: di me come
individuo) apre innanzi a me il problema della civiltà ellenica, della
filosofia platonica, o di un particolare atteggiamento del costume antico,
quel problema è così legato al mio essere come la storia di un negozio che
sto trattando, o di un amore che sto coltivando, o di un pericolo che
m’incombe; ed io lo indago con la medesima ansia, sono travagliato dalla
medesima coscienza d’infelicità, finché non riesco a risolverlo. La vita
ellenica è, in quel caso, presente in me; e mi sollecita e mi attrae o mi
tormenta, come il sembiante dell’avversario, della donna amata, o del
figlio diletto pel quale si trepida19.
4. Giudizio individuale, giudizio definitorio, tesi sulla contemporaneità
della storia, pur nella differenza delle rispettive articolazioni logicostrutturali e dei contesti teoretici di riferimento e di applicazione, attestano
la centralità della vita storica effettuale quale punto di origine per la
costruzione e la direzione del sapere. Meno impetuose di quelle enunciate
nella II inattuale di Nietzsche20; pensate e maturate in un quadro teorico
profondamente diverso rispetto a quello nietzscheano e con una maggiore
e più dettagliata attenzione ai processi effettivi con cui si costituiscono gli
strumenti concettuali necessari alla conoscenza – soprattutto di tipo
umanistico –, le posizioni crociane, che abbiamo appena esaminato,
possono essere naturalmente criticabili a vario titolo e da diverse
prospettive filosofiche ed epistemologiche. Qualcuno potrà giudicarle
antiquate, e forse avrà buon gioco e ragione a farlo: al momento la
questione non è di grande importanza. Quello che mi sembra interessante
nel Croce della contemporaneità della filosofia e della storia – che qui si è
cercato insufficientemente di delineare – è il deciso e incisivo accento
posto sulla chiara direzionalità dello sguardo di chi riflette e indaga, cui si
collega l’altrettanto chiara stigmatizzazione di ogni ingenua, per quanto
appassionata, concessione alla (vuota) amenità e alla (talvolta circense)
erudizione filosofica e storica.
Tss, pp. 12-13.
Cfr. F. NIETZSCHE, Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874), a cura di G.
Colli e M. Montinari, trad. it. di S. Giametta, Adelphi, Milano 19814.
19
20
348
Rosario Diana
Si formulano sempre nuovi giudizi storici e si forniscono sempre nuove
definizioni perché il nostro tempo – come quello che per i grandi pensatori
del passato fu il loro tempo – ci mette di fronte a individualità sempre nuove
che vogliamo comprendere e a problemi sempre nuovi che richiedono spesso
nuovi o rinnovati strumentari concettuali. Si può guardare al passato con gli
occhi del presente, perché nell’oggi una questione cruciale ci attanaglia e
pensiamo di poterne illuminare alcuni aspetti riandando a situazioni
analoghe più antiche o recenti: e ciò non perché la storia è
(improponibilmente) magistra vitae, ma perché rapporti di filiazione teorica
che riteniamo di ravvisare, linee di tendenza, vecchie e nuove
corrispondenze fra la condizione odierna e quella di ieri o dell’altro ieri
possono offrire un contributo alla comprensione della nostra vita attuale21.
Tutto ciò, su cui – lo si ribadisce – si può convenire o meno, indica,
però (ed è questo che ora interessa), una posizionalità e una direzionalità del
lavoro di ricerca – e segnatamente di ricerca filosofica, quella che qui mi
sta più a cuore –, che possono essere rifiutate, certo, ma anche scelte da un
indagatore, come alcune possibilità fra tante altre. Se con Croce – ossia
coperti dall’autorevolezza di un pensatore ‘grande’, ma anche controverso,
contrastato e da contrastare in molti aspetti del suo pensiero – si opterà
per la posizionalità e direzionalità dello sguardo filosofico che dal presente
muove verso il concetto e verso la parola del passato, allora anche la
riflessione proveniente da un’altra costellazione storico-teorica, oggettivata
in quel testo comunemente chiamato ‘classico’ (che, come il tempo per
Agostino22, tutti noi sappiamo cos’è, se nessuno ci chiede di definirlo) ne
avrà un beneficio. Sospesa quell’auralità e quella venerazione sacrale che il
riconoscimento di un’esemplarità d’eccezione legittimamente gli tributa, il
‘classico’ filosofico sarà ‘riscoperto’ nella sua funzione originaria di strumento
per pensare e (sia detto con scandalo dei benpensanti) ‘saccheggiato’ nelle
parti che – opportunamente rimeditate – ci consentiranno di dare qualche
21 «L’oggetto della storia della filosofia – osserva Croce a questo proposito in un altro
luogo e in un diverso tempo – […] è […] un problema critico e la soluzione che se n’è
data; e suo motivo non è la disposizione a rivivere i vari problemi in estetica contemplazione,
sì invece un determinato nuovo problema che travaglia il pensatore, una nuova domanda alla
quale esso dà risposta e per la quale risale alle precedenti domande e risposte a cui la sua si
annoda come un discorso coi suoi precedenti, e che, nell’atto stesso che rischiarano il nuovo
problema, ne vengono rischiarate» (B. CROCE, Intorno alle condizioni presenti della storiografia in
Italia, in ID., Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono – 1921 –, 2 voll., Laterza,
Bari 19302, vol. II, p. 176).
22 Cfr. A. AGOSTINO, Confessioni (400), lb. XI, 14, 17.
Con l’occhio al presente
349
risposta al nostro presente e di obbedire all’antico imperativo delfico che
impone l’autoconoscenza.
Per condurre correttamente un’operazione siffatta – e in qualche caso
riguadagnare così un senso per il proprio lavoro filosofico –, c’è bisogno,
ovviamente, di consapevolezza storica e raffinatezza ermeneutica, che
saranno il frutto di un lungo esercizio del mestiere; e non è detto che il
faticoso itinerario di ricerca che si percorrerà con questi intenti sarà
fruttuoso. Ma, nell’eventualità di una riuscita, la ricompensa potrà essere
grande: conoscere un po’ meglio se stessi e il proprio mondo, e farlo in
compagnia di qualche illustre, buon amico…
Abstract
After reviewing and discussing the theory of Croce's contemporary
history – exposed, as is well known, in Theory and History of
Historiography (1917) –, the author proposes to transfer from history to
philosophy. With this shift, and discounting the question, He interprets the
relationship between theoretical elaboration and the history of philosophy
in the light of the relationship between past and present in the above
mentioned thesis statement of Croce, thus indicating a possible mode of
philosophical work.
FABIO FROSINI
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere
di Antonio Gramsci
1. Una difesa dello storicismo
In un importante contributo sul marxismo di Gramsci, risalente al
1975, Nicola Badaloni ha distinto due sensi dello «storicismo» sviluppato
nei Quaderni del carcere: il primo di essi, che è anche quello «primario e
decisivo», «equivale all’emergenza politica di una nuova civiltà (il
socialismo)», mentre il secondo, «dipendente dal primo», «sta a designare
lo spostamento lineare dei termini costituenti il suddetto significato
principale ed il ripresentarsi in condizioni sempre trasformate del
problema principale e fondamentale». Pertanto, «se nel primo senso lo
storicismo è il prender forma concreta del problema della rivoluzione, nel
secondo esso è lo spostamento lineare che segue al modificarsi delle
condizioni»1. Il senso principale dello storicismo gramsciano equivale
dunque ‒ secondo questa interpretazione ‒ a un progetto politico
inquadrato in un’analisi storica precisa, determinata; mentre il secondo è la
presa in carico dello slittamento dei significati, conseguente al successo, o
anche all’insuccesso, di quel progetto. Ciò che abitualmente si definisce
storicismo ‒ l’affermazione dell’esserci una “storia” (comunque la si voglia
definire), in conseguenza della quale le categorie e i concetti sono destinati
a variare continuamente, e in questa variazione a presentarsi come una
continuità (la continuità del variare) ‒ viene confinato da Badaloni a un
rango secondario; mentre il nucleo fondante dello storicismo gramsciano
consisterebbe piuttosto nell’organizzazione e sistemazione teorica del
complesso di questioni che si presentano a una forza rivoluzionaria.
È a partire da questa distinzione, che Badaloni può definire lo
«storicismo assoluto» come un sinonimo di «filosofia della transizione»2,
1 N. BADALONI, Il marxismo di Gramsci. Dal mito alla ricomposizione politica, Einaudi,
Torino 1975, pp. 159-160.
2 Ivi, p. 145.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 351-367
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064324
351
352
Fabio Frosini
precisando che il contenuto di esso è il modo in cui «le forme del dominio»
si trasformano politicamente «in quelle del controllo su se stessi e della
autoregolazione della vita». Rimane invece fuori da questo orizzonte,
strutturalmente, «la piena e libera esplicazione ed espansione delle
facoltà»3. Lo “storicismo assoluto” consiste dunque nella re-interpretazione
di massa (dunque come fatto politico) di ciò che nel presente si presenta
come “necessità”, in termini di “libertà”. Tale re-interpretazione verrebbe
resa possibile da un duplice passaggio: la dimostrazione scientifica del
carattere non eterno, ma appunto storico-transeunte, di tali vincoli; e
l’assunzione soggettiva (cioè nella sfera della coscienza e in quella della scelta
morale) di essi in vista del mutamento dell’etero-direzione in autoregolazione4.
Badaloni è tornato più volte, in seguito, su questa interpretazione5,
sostanzialmente mantenendola, anche se ha gradualmente indebolito
l’alone umanistico dal quale era inizialmente circondata6. Nel suo
impianto, questa lettura dello storicismo di Gramsci come «filosofia della
transizione» era presente già in precedenza7, ma la definitiva messa in
secondo piano della riduzione del lato logico, o universale, alle condizioni
Ibidem.
L’accentuazione unilaterale sul versante soggettivo, della volontà, e la correlativa
riduzione della necessità alla transitorietà, sono stati giustamente fatti rilevare da E.
MORERA, Gramsci’s Historicism. A Realist Interpretation, Routledge, London and New York
1990, pp. 56-58.
5 Cfr. N. BADALONI, “Antonio Gramsci. La filosofia della prassi come previsione”, in
E. HOBSBAWM (a cura di), Storia del marxismo, Vol. III, Tomo 2, Einaudi, Torino 1981, pp.
251-340; ID., Il problema dell’immanenza nella filosofia politica di Antonio Gramsci, Arsenale
Editrice, Venezia 1988. Un esercizio ermeneutico sui temi della cibernetica, ma
mediatamente riferito a Gramsci e a Marx, è in N. BADALONI, “Ragione e mutamento”, in
A. GARGANI (a cura di), Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività
umane, Einaudi, Torino 1979, pp. 241-277.
6 Cfr. p. es. N. BADALONI, Il problema dell’immanenza nella filosofia politica di Antonio
Gramsci, cit., p. 36: «[...] la soggettività è qualcosa di diverso da quella dell’idealismo
perché l’uomo è traversato dai problemi, reagisce su di essi, ma non li fonda in modo
immediato».
7 Cfr. N. BADALONI, Marxismo come storicismo, Feltrinelli, Milano 1962, in partic. p.
179 («Lo storicismo senza miti corrisponde da una parte alla consapevolezza del divenire
storico, dall’altra alla convinzione che anche il relativamente permanente all’interno del
blocco storico (struttura), è attaccabile a tutti i livelli, e modificabile attraverso la prassi
cosciente umana») e p. 208 (il contributo di Gramsci sta nell’enfasi posta sulla «urgenza
della prassi cosciente come elemento della contraddizione»). Cfr. inoltre ivi, pp. 29-32,
37-39.
3
4
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
353
genetiche, o del divenire, trae origine dalla necessità di rispondere
all’attacco mosso allo storicismo da Cesare Luporini. Come Badaloni
esplicitamente ricorda8, nell’“Introduzione” a Dialettica e materialismo è
contenuta una durissima liquidazione, che in qualche modo suggella il
percorso avviato da Luporini ‒ all’inizio in modo solo implicito ‒ con la
«discussione tra filosofi marxisti» svoltasi nel 1962 su “Rinascita”, e
apertamente dichiarato nel dicembre 1965 con la pubblicazione, su
“Rinascita – Il Contemporaneo”, dell’articolo “Una visione critica
dell’uomo”9, che segna anche la definitiva rottura del fronte “storicistico”
interno ai filosofi comunisti10.
In Dialettica e materialismo, Luporini definisce lo storicismo come
un’entificazione della storia, che identifica la realtà con questo ens rationis,
al quale attribuisce, in quanto «soggetto», la responsabilità dell’accadere11.
Grazie a questa premessa, egli può agevolmente dichiarare che «quasi
sempre gli effetti ideologici storicisti sono reazionari», in ragione del
«contributo pratico ideologico che viene dato al dominio del passato sul
sistema del presente, indirizzato a bloccarne determinate alternative e
possibilità reali rispetto al futuro, o a trattenerle»12. Vi è dunque
un’urgenza pratica, politica, che induce ad abbandonare lo storicismo, per
il quale vi è un «continuum di un mutamento graduale e progressivo di
qualità, in cui di fatto il salto di qualità si muta[...] in un focus ideale»13.
Ma esistono anche delle ragioni di ordine teorico, che hanno a che fare
con l’incapacità, secondo Luporini, della «coscienza storica» di «dominare
conoscitivamente» la complessità strutturale della realtà14; e all’altro
estremo con l’autonomia della teoria sia rispetto alla dimensione
strategica15, sia a quella ideologica16: con l’esistenza insomma di un piano
N. BADALONI, Il marxismo di Gramsci, cit., p. 161 (nota 26).
Ripreso in C. LUPORINI, Dialettica e materialismo, Editori Riuniti, Roma 1974, con il
titolo “Marxismo e scienze umane” (pp. 362-372).
10 Su tutto ciò cfr. F. Cassano (a cura di), Marxismo e filosofia in Italia (1958-1971). I
dibattiti e le inchieste su “Rinascita” e il “Contemporaneo”, De Donato, Bari 1973.
11 Cfr. C. LUPORINI, Dialettica e materialismo, cit., pp. XXVIII-XL, in partic. p.
XXXVI.
12 Ivi, p. XL.
13 Ivi, p . XXX.
14 Ivi, p. XXXIV (qui Luporini cita da un proprio articolo pubblicato in “l’Unità” del
19 gennaio 1966, in preparazione dell’XI Congresso del Pci).
15 Cfr. ivi, p. XXX.
16 Cfr. ivi, p. XXXIX.
8
9
354
Fabio Frosini
propriamente «sistematico», di una «autonomia della concettualizzazione
come sede del sapere scientifico»17, che sfugge alla storia, ai suoi
condizionamenti e, insomma, al divenire18.
Entro questi limiti e a queste condizioni, anche Luporini è disposto a
concedere a Gramsci esattamente ciò che gli concede anche Badaloni: per
lui, lo «storicismo assoluto» elaborato nei Quaderni del carcere esprime lo
sforzo di liberare la teoria dagli «ideologismi astratti»: ma questo sforzo a
sua volta
si presenta [...] sempre come possibilità storicamente data nella prassi
sociale. Sorge cioè come giudizio storico inserito e operante nell’azione
storico-sociale-politica consapevole. [...] Il metodo di Gramsci è il metodo
di tale giudicare storico connesso all’azione, quindi alla lotta, che richiede
sempre di porsi in condizioni di comprendere (storicamente) le ragioni
d’essere, le radici nella realtà (passato-presente), delle posizioni
combattute (e in ciò manifesta la propria superiorità)19.
Anche per Luporini, lo storicismo proposto da Gramsci è accettabile
solamente se inteso come una sorta di filosofia della necessità: un’arma di
combattimento rivolta a mettere in luce le possibilità concrete di strappare
all’avversario posizioni sul terreno della lotta per l’affermarsi una nuova
civiltà. I suoi limiti sono, sul piano propriamente teorico o della “verità”,
nettamente segnati, e coincidono con la sua stessa transitorietà. Dello
storicismo si elimina perciò anzitutto lo sfondo generalissimo, che equipara
la realtà a storia, e successivamente si riduce quanto ne residua a un
ragionamento circostanziale, a cui, a sua volta, è riconducibile «la complessa,
articolata, identificazione gramsciana [...] di filosofia e politica»20.
2. Morte e rinascita dello storicismo
Se mi sono soffermato così a lungo sulle posizioni di Badaloni e
Luporini, è perché in esse ‒ e proprio in riferimento allo storicismo
Ivi, p. XXIV.
«A questo punto devo però confessare che credo nella meta-fisica» (ivi, p.
XXXVIII).
19 Ivi, p. 49 (il passo è tratto dal saggio “Appunti su alcuni nessi interni del pensiero di
Gramsci”, del 1958).
20 Ibidem.
17
18
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
355
gramsciano ‒ viene a condensarsi in maniera esemplare una problematica
che ha attraversato tutto il marxismo italiano fino alla soglia degli anni
Settanta. Intendo quella sorta di alternativa, che grazie all’esistenza del Pci
e alla sapiente opera di sintesi realizzata da Togliatti si era venuta a
configurare, tra Gramsci e Marx, ovvero tra uno storicismo concepito
come una sorta di philosophia realis (questo punto viene da Luporini
riconosciuto senza remore21), e un approccio a Marx che, per rimbalzo,
non poteva che nascere dalla crisi dello storicismo (cioè dalla crisi della
società italiana del dopoguerra e quindi del progetto strategico a essa
corrispondente)22, e presentarsi pertanto o con caratteri di immediatezza
“attualistica” rispetto al presente ‒ come accadde con la linea inaugurata da
Raniero Panzieri e Mario Tronti23 ‒ o viceversa come rifiuto dello
“storicistico” nesso tra teoria e attualità ‒ come fu il caso appunto di
Luporini.
In entrambi i casi, era difficile “salvare” Gramsci dopo la metà degli anni
Sessanta24, e si dovette attendere la metà del decennio successivo, per
avere un nuovo tentativo di sintesi: ma non più condotto, a quel punto,
all’insegna dello storicismo e della filosofia, ma dell’“egemonia” come
teoria delle dislocazioni del potere sul piano materiale e su quello dei
saperi (rivoluzione passiva)25. In questa luce, le prese di posizione di
Badaloni e Luporini qui discusse, rispettivamente del 1975 e 1974,
Cfr. ivi, p. XXIX.
Il passaggio è ben sintetizzato da N. BADALONI, Il marxismo italiano degli anni Sessanta,
Editori Riuniti, Roma 1971, pp. 9-25. Cfr. anche C. CORRADI, Storia dei marxismi in Italia,
manifestolibri, Roma 2005, pp. 149-153.
23 Cfr. R. PANZIERI, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, a cura di S. MANCINI,
Einaudi, Torino 1976 (raccoglie testi risalenti al periodo 1961-1964), M. TRONTI, “Lenin
in Inghilterra”, Classe operaia. Mensile politico degli operai in lotta, gennaio 1964, pp. 1 e 1820; ID., Operai e capitale. Nuova edizione accresciuta, Einaudi, Torino 1971 (la prima
edizione è del 1966). Cfr. C. CORRADI, Storia dei marxismi in Italia, cit., pp. 138-142, 167173.
24 Cfr. la ricostruzione della crisi dello storicismo, in relazione alle letture di Gramsci,
in G. LIGUORI, Gramsci conteso. Storia di un dibattito 1922-1996, Editori Riuniti, Roma
1996, pp. 132-138, 147-152.
25 Mi riferisco al convegno organizzato dall’Istituto Gramsci nel 1977. Cfr. F. FERRI (a
cura di), Politica e storia in Gramsci. Atti del convegno internazionale di studi gramsciani,
Firenze 9-11 dicembre 1977, 2 Voll., Istituto Gramsci-Editori Riuniti, Roma 1977-1979.
Cfr. C. CORRADI, Storia dei marxismi in Italia, cit., pp. 234-245. Un tardo, anche se
straordinariamente efficace, frutto di questa stagione, è L. PAGGI, Le strategie del potere in
Gramsci. Tra fascismo e socialismo in un solo paese. 1923-1926, Editori Riuniti, Roma 1984.
21
22
356
Fabio Frosini
assumono un significato retrospettivo e per certi aspetti “autobiografico”;
ma sono esemplari nel mostrare la quasi-obbligatorietà di certe secche
interpretative; la quasi-impossibilità di attingere la nozione di storicismo,
se non filtrata attraverso l’investimento reale che essa aveva subìto nel
corso degli anni Cinquanta; la difficoltà, infine, di individuare una via di
accesso al tema, che fosse in grado di confrontarsi realmente con il grande
nodo degli anni Sessanta e Settanta in Italia: il confronto tra la filosofia e le
scienze umane come riflesso del nuovo industrialismo tecnocratico.
In questo nuovo quadro, paradossalmente, deprivato della sua
credibilità filosofica, lo storicismo gramsciano può ricomparire, anche se
nella forma dimidiata di «solvente della tradizione e del “folklore”» e di
espediente utile «a disincagliare grandi masse dalle secche di un
naturalismo metastorico e a mostrar loro come ogni situazione sia
complessa, mutevole, dunque da mutarsi»26. Paradossalmente: perché qui
finisce per essere in gioco ‒ ma solo come stampella strategica ‒
esattamente quella seconda accezione dello storicismo gramsciano, che
Badaloni aveva finito per considerare inessenziale a intenderne il concetto.
Ma ciò accade, precisamente perché, una volta isolato dalla sua base
filosofica, lo storicismo è destinato a ri-precipitare verso una mera
considerazione della storia come transitorietà delle forme, che non ne
mette in discussione lo statuto, ma solo le rende meno insensibili al tempo
e quindi alla politica.
Questa traiettoria appare pertanto destinata a esaurirsi, arrivando qui lo
storicismo a essere accettabile esclusivamente nella sua forma più generica,
e solo una volta che essa sia stata privata di ogni aggressività teorica. Altre
sono perciò le strade che conducono ‒ o possono condurre ‒ a una
riconsiderazione attuale di questo tema in Gramsci. Da questo punto di
vista, un riferimento è contenuto in un passaggio marginale presente in un
libro che, pubblicato per la prima volta nel 1985, ha avuto un crescente e
perdurante effetto nella storia delle interpretazioni di Gramsci nel mondo
anglosassone e anglofono. In Hegemony and Socialist Strategy, Ernesto Laclau
e Chantal Mouffe definiscono lo «storicismo assoluto» come «il radicale
rifiuto di qualsiasi essenzialismo e di qualsiasi teleologia aprioristica»27. La
26 R. BODEI, “Comprendere, modificarsi. Modelli e prospettive di razionalità
trasformatrice”, in A. GARGANI (a cura di), Crisi della ragione, cit., pp. 197-240: 223.
27 E. LACLAU, C. MOUFFE, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic
Politics, Verso, London 20012, p. 90. Il libro è ora tradotto in italiano: Egemonia e strategia
socialista, a cura di F. M. CACCIATORE e M. FILIPPINI, Il melangolo, Genova 2011.
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
357
sua assolutezza è qui riconosciuta come l’esatto contrario delle pretese
universalistiche dello storicismo rifiutato da Luporini, ovvero come
un’istanza di critica di ogni metafisica dell’oggettività e di ogni filosofia
della storia; come la matrice, dunque, di una concezione aperta, ma non
priva di una precisa struttura, del tempo storico e del nesso tra oggettività,
verità e politica.
È su questa base, che si può parlare oggi di una ripresa ‒ nelle letture di
Gramsci ‒ di tematiche in senso lato definibili “storicistiche”, come avviene
negli studi culturali ‒ con la loro enfasi sull’“articolazione” come
costruzione attiva, sulla messa tra parentesi delle classi sociali, sulla
dislocazione come forma irriducibile dell’identità28. Questo ambiente
intellettuale è però, dal punto di vista di uno sviluppo coerente del
progetto contenuto nei Quaderni del carcere, estremamente scivoloso. Se ‒
come ha acutamente notato Badaloni ‒ «la crisi dello strutturalismo forte
degli anni sessanta ha riproposto il tema dello storicismo», questo passa
necessariamente attraverso la critica mossa da Derrida alla «metafisica della
“presenza”», restandone condizionato proprio nella difficoltà a convogliare
politicamente la storicità come «mero fluire» grazie all’intervento di «un
principio egemonico»29. A questa accezione di storicismo come «mero
fluire» si oppone oggi del resto un nuovo trascendentalismo30,
riproponendosi così un’oscillazione vecchia di secoli; ovvero si tenta, in
modo anch’esso regressivo, di recuperare una posizione in qualche modo
“realistica”31.
Cfr. S. HALL, Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi culturali e
postcoloniali, a cura di M. MELLINO, Meltemi, Roma 2006, pp. 81-82 (anti-essenzialismo),
90-91, 324 n. 6 (articolazione), 106, 112, 303 sgg., 318 (dislocazione), 201-202, 217218, 220, 222, 225 (classi), 205-206 (egemonia), 216 (soggetto), 251-253 (contingenza
del significato, in riferimento a Derrida), 290, 311, 317 (esterno costitutivo), 315, 317,
320 (identità), 317-318 (universale, sutura).
29 N. BADALONI, Il problema dell’immanenza nella filosofia politica di Antonio Gramsci, cit.,
nota 48, a pp. 67-68.
30 Per reagire allo “hegelismo” di Žižek, Laclau è giunto a ribaltare la propria
posizione, recuperando il “trascendentale” e definendo «lo storicismo radicale» come
«un’impresa auto-contraddittoria». Cfr. E. LACLAU, “Identity and Hegemony: The Role of
Universality in the Constitution of Political Logics”, in J. BUTLER, E. LACLAU, S. ŽIŽEK,
Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left, Verso, London-New
York 2000, pp. 44-89: 58.
31 Cfr. E. MORERA, Gramsci’s Historicism, cit., pp. 34 sgg.
28
358
Fabio Frosini
3. Verità e politica
Nelle posizioni qui sopra schizzate, una componente irrinunciabile
dello storicismo assoluto risulta assente. Quando tenta di darne una
definizione, Gramsci lo caratterizza infatti come assolutizzazione di due tesi:
quella del carattere ideologico della conoscenza ‒ storicismo come
«liberazione totale da ogni “ideologismo”, [...] reale conquista del mondo
storico»32 ‒ e quella dell’immanenza ‒ storicismo come
«mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero»33. All’antiessenzialismo occorre unire il materialismo riformulato in termini di
immanenza34. Ciò però non è ancora sufficiente, perché questa sintesi
rischia di ridursi all’ennesimo shibbolet teorico. Occorre aggiungere la tesi,
secondo la quale queste due posizioni filosofiche possono trovare la loro
compiuta, non contraddittoria formulazione teorica, solo perché per la prima
volta vengono spostate, o più precisamente “tradotte”, nei termini della
pratica.
Torniamo così alla discussione tra Badaloni e Luporini. In essa, sebbene
in modo riduttivo, questa nozione di storicismo assoluto già appariva. Qui
infatti il rapporto con la politica reale veniva indicato come il punto
qualificante la posizione elaborata da Gramsci, ma esso non veniva spinto
fino a ridefinire lo statuto della “teoria”. È invece esattamente questo il
nocciolo del progetto di Gramsci, che non intende “accostare” ciò che
tradizionalmente si è chiamato filosofia a ciò che tradizionalmente ha preso
il nome di scienza politica, facendo una semplice somma di due cose che,
per il resto, sono lasciate sussistere indisturbate. Gramsci ha inteso fare
ben altro: riformulando lo statuto della filosofia e, al di qua di essa, il
rapporto tra il pensiero e la verità come – in accordo con la seconda tesi Su
Feuerbach – un fatto pratico e non teorico35, egli ha compiuto dentro il campo
della filosofia un duplice spostamento, il cui risultato è la ridefinizione
completa di questo stesso ambito: in primo luogo, ha riconosciuto la
32 Quaderno 4, § 24 (A. GRAMSCI, Quaderni del carcere. Edizione critica dell’Istituto
Gramsci a cura di V. GERRATANA, Einaudi, Torino 1975, p. 443: d’ora in avanti, citato
con QC seguito dal numero della pagina).
33 Quaderno 11, § 27: QC, 1437.
34 Cfr. P. IVES, Gramsci’s Politics of Language. Engaging the Bakhtin Circle and the Frankfurt
School, University of Toronto Press, Toronto etc. 2004, pp. 3-15.
35 Cfr. P. D. THOMAS, The Gramscian Moment. Philosophy, Hegemony, and Marxism, Brill,
Leiden 2009, pp. 308 e 448.
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
359
filosofia in generale come una potenza politica, il rappresentante nella teoria
di una forza sociale organizzata, essa stessa un’istanza attiva di aggregazione
egemonica. In secondo luogo, ha assegnato al marxismo il compito di
portare fino alla sua conseguenza estrema e coerente la vocazione
totalizzante della filosofia, vale a dire il suo proporsi sempre come un
sapere che non può essere contenuto nello spazio di nessuna disciplina
particolare, perché in realtà non riguarda la scienza ma la vita stessa, e in
quanto tale aspira a “cambiare” il mondo, anche quando si proponga
solamente di “interpretarlo”.
Nella riformulazione a cui Gramsci sottopone il marxismo nei Quaderni
del carcere, come “filosofia della praxis”, questa è la filosofia che ha iscritto
dentro il proprio statuto, in modo coerente, la vocazione pratica della
filosofia, e che pertanto si pone apertamente come istanza di
un’universalizzazione reale, politica, e cioè come un centro di
organizzazione dei saperi, della cultura, dell’intero senso comune, che
mira a rivoluzionare «da cima a fondo»36 la vita e il modo di intenderla.
Questa è la filosofia, in breve, che conduce «al capovolgimento della
posizione tradizionale del problema filosofico e alla morte della filosofia
intesa nel modo tradizionale»37.
L’identità originale dello storicismo assoluto la si coglie, pertanto, solo
collocandosi all’altezza del rapporto tra verità e politica, intendendo con
ciò, però, non una questione strategica, temporanea (come accade in
Badaloni e Luporini), ma costitutivo di una nuova concezione della verità,
una concezione che nasce dallo spostamento reale del punto di vista della
filosofia, dallo spazio del potere a quello delle classi subalterne. Momento
dell’esercizio concreto della critica storica (nel tentativo di opporre alla
storiografia ufficiale un diverso e opposto angolo visuale) e momento della
ridefinizione teorica di nozioni come verità, oggettività, realtà, non
possono essere scisse38, ed è proprio in questa unità che trova corpo la
novità dello storicismo assoluto: nell’impossibilità di contenerlo in una
posizione “filosofica” e, insieme, nel cambiamento che il campo della
Quaderno 4, § 11: QC, 433.
Quaderno 1, § 132: QC, 119.
38 Per l’affermazione di questa unità cfr. G. CACCIATORE, “Storicismo”, in G. LIGUORI,
P. VOZA (a cura di), Dizionario gramsciano 1926-1937, Carocci, Roma 2009, pp. 814-818:
817. Cfr. anche ID., “Storicismo speculativo e storicismo critico”, in G. POLIZZI (a cura
di), Tornare a Gramsci. Una cultura per l’Italia, Avverbi, Grottaferrata 2010, pp. 197-212.
36
37
360
Fabio Frosini
filosofia subisce ad opera di questa non solo affermata, ma praticata
continuità tra storia, politica e teoria39.
4. Dallo storicismo all’«unità della teoria e della pratica»
Che l’obiettivo di Gramsci fosse l’elaborazione di questo complesso
“gioco” tra filosofia, storia e politica, risulta in pieno da una considerazione
diacronica dei Quaderni del carcere, alla luce della quale appare in chiara luce
anche il carattere nient’affatto scontato o da subito acquisito di tale
posizione. Essa è anzi l’esito di una lunga ricerca, che giunge solo nel 1932
a una formulazione piena, cioè alla messa in relazione strutturale con la
storia, nella duplice accezione di historia rerum e di res gestae.
Nel Quaderno 1 lo storicismo compare in accezione generica, dilatata:
lo «storicismo moderno» è un «ambiente culturale» del «secolo XIX»40.
Addirittura, «il materialismo storico, così com’è» attualmente, viene
giudicato «l’aspetto popolare dello storicismo moderno»41, e la «filosofia
moderna» in generale è definita «filosofia dello storicismo»42. Viene in
questo modo istituita una relazione di derivazione del marxismo da un
grande filone, che ha alimentato anche varie scienze particolari, come la
linguistica, con Graziadio I. Ascoli e Matteo G. Bartoli43, e la teoria della
storiografia, con Ernst Bernheim44.
Si ha qui la ripresa, a grandi linee, di un modo estremamente ampio di
concepire lo “storicismo” che risale al primo periodo torinese di Gramsci:
esso è un sinonimo di concretezza, di realismo politico, di concezione
dialettica della storia, di capacità di considerare la realtà come,
39 Sul rapporto, in Gramsci, della storiografia con lo storicismo, cfr. F. FROSINI,
“Storia”, in G. LIGUORI, P. VOZA (a cura di), Dizionario gramsciano 1926-1937, cit., pp.
807-811.
40 QC, 18.
41 Quaderno 4, § 3: QC, 424.
42 Quaderno 4, § 5: QC, 425.
43 Cfr. rispettivamente Quaderno 1, § 73: QC, 82, e Quaderno 3, § 74: QC, 352 («A
me pare che tra il metodo del Bartoli e il crocismo non ci sia nessun rapporto di
dipendenza immediata: il rapporto è con lo storicismo in generale, non con una particolare
forma di storicismo»).
44 Cfr. Quaderno 4, § 5: QC, 425.
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
361
essenzialmente, libertà, spontaneità e lotta di contrapposte energie45.
Gramsci lo fa discendere da Hegel, così come, in continuità con Hegel,
dalla lezione morale e intellettuale rappresentata in Italia e in Europa dalla
filosofia di Benedetto Croce46. Più in generale, lo identifica con una
concezione della realtà in cui non esistono «meccanizzazioni» né «forme
irrigidite di vita»47. E non è un caso che questa antica accezione riemerga
all’inizio del lavoro teorico del carcere, in un momento in cui Gramsci
tenta di riordinare le idee e di raccogliere gli spunti fecondi di tutta la
propria biografia.
Ma già a questa altezza, nel 1930, il lemma compare in un’accezione
diversa. Nei §§ 28 e 29 del Quaderno 1, due testi dedicati alla discussione
su “Storia e antistoria”48 in corso allora in Italia (vi prese parte anche
Croce), Gramsci osserva che in gioco c’è molto più di una controversia
accademica. La polemica di matrice storicistica contro il «diritto naturale»
mira a «distruggere certi stati d’animo molto diffusi e che sono ritenuti
pericolosi»49, e assolve pertanto una funzione politica di un certo rilievo. Le
implicazioni a cui Gramsci pensa ‒ in questa stesura lasciate nell’ombra ‒
vengono da lui rese esplicite nella seconda, nel Quaderno 27:
La polemica in realtà mira ad infrenare l’influsso che specialmente sui
giovani intellettuali potrebbero avere (e hanno realmente) le correnti
popolari del «diritto naturale», cioè quell’insieme di opinioni e di
credenze sui «proprii» diritti che circolano ininterrottamente nelle masse
popolari, che si rinnovano di continuo sotto la spinta delle condizioni reali
45 Cfr. L. PAGGI, Antonio Gramsci e il moderno principe. I. Nella crisi del socialismo italiano,
Editori Riuniti, Roma 1970, cap. I (pp. 3-42); L. BASILE, “Gramsci e la costellazione
idealistica tra il 1914 ed il 1917”, in A. DI BELLO (a cura di), Marx e Gramsci. Filologia,
filosofia e politica allo specchio, Liguori, Napoli 2011, pp. 117-128; L. RAPONE, Cinque anni
che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo (1914-1919), Carocci, Roma
2011, pp. 259-293.
46 Cfr. Alfa Gamma, “Il Sillabo ed Hegel”, Il Grido del Popolo, n. 599, 15 gennaio 1916;
e la ripubblicazione dello scritto crociano “Religione e serenità”, del 1915, nel numero
unico La città futura, del 1917.
47 A. Gramsci a L. Galetto, febbraio 1918, in A. GRAMSCI, Epistolario, Vol. 1, gennaio
1906-dicembre 1922, a cura di D. BIDUSSA, F. GIASI, G. LUZZATTO VOGHERA, M. L.
RIGHI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2009, p. 173.
48 Cfr. M. CILIBERTO, “‘Contraddizioni’ dello storicismo”, in C. RICCHINI, E. MANCA,
L. MELOGRANI (a cura di), Gramsci. Le sue idee nel nostro tempo, editrice l’Unità, Roma 1987,
pp. 82-84.
49 Quaderno 1, § 28: QC, 23.
362
Fabio Frosini
di vita e dello spontaneo confronto tra il modo di essere dei diversi ceti. La
religione ha molto influsso su queste correnti, la religione in tutti i sensi,
da quella come è realmente sentita e attuata a quella quale è organizzata e
sistematizzata dalla gerarchia, che non può rinunziare al concetto di diritto
popolare. Ma su queste correnti influiscono, per meati intellettuali
incontrollabili e capillari, anche una serie di concetti diffusi dalle correnti
laiche del diritto naturale e ancora diventano «diritto naturale», per
contaminazioni le più svariate e bizzarre, anche certi programmi e
proposizioni affermati dallo «storicismo». Esiste dunque una massa di
opinioni «giuridiche» popolari, che assumono la forma del «diritto
naturale» e sono il «folclore» giuridico50.
In questa seconda versione, scritta a Formia al principio del 193551, si
riversa e accumula tutta una serie di analisi e riflessioni svolte nel
frattempo, che hanno dissolto l’opposizione tra diritto naturale storicismo
in un continuum caratterizzato, a ogni altezza, dall’interazione (spesso
casuale, ma talvolta organica) tra intellettuali e ceti popolari, come anche
tra cultura moderna e «folclore». Il diritto naturale diventa di conseguenza
‒ come Gramsci scrive in un testo del gennaio 1933 ‒ anch’esso a pieno
titolo «un elemento della storia, indica un “senso comune politico e
sociale” e come tale è un “fermento” di operosità»52. Ma nella nota del
Quaderno 1 è già chiaramente annotato il ruolo tutto politico del tema
dello “storicismo”, che funziona come un segnalatore dei tentativi
intrapresi in Italia per ricostruire un’egemonia borghese.
Ma c’è dell’altro. Nello stesso paragrafo 28 e nel successivo, Gramsci
equipara l’antitesi tra storicismo e diritto naturale, a quella tra critica e
passione, spostando l’intera questione sul terreno della ricerca di unità tra
teoria e pratica. Marx offre «l’espressione più alta anche esteticamente, del
“sarcasmo appassionato”»53, di un sarcasmo cioè che critica le illusioni
popolari senza distruggerle, ma con compartecipazione costruttiva, per
Quaderno 27, § 2: QC, 2316.
Traggo le datazioni dei testi dei Quaderni del carcere dalla tavola cronologica
riassuntiva pubblicata da G. COSPITO in “Appendice” al suo “Verso l’edizione critica e
integrale dei ‘Quaderni del carcere’”, Studi storici 52 (2011) 4, pp. 881-904: 896-904.
52 Quaderno 15, § 8 (Q, 1761). Si noti che questo paragrafo è scritto in polemica con
le tesi nazionalistiche, avverse al diritto naturale, di Maurizio Maraviglia, alle quali
Gramsci già alludeva, in termini assai simili, nel Quaderno 1, § 4 («Gli attuali polemisti
contro il diritto naturale...»): QC, 7, e nel § 28 («Nella polemica presente contro il diritto
naturale...») QC, 22.
53 Quaderno 1, § 29: QC, 23.
50
51
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
363
favorire non tanto il loro passaggio alla mentalità storicistica, quanto la
formazione di un’unità ideologica organica, su basi completamente nuove,
tra alta cultura e cultura popolare. È qui insomma già in gioco il tema, in
seguito ampiamente sviluppato, dell’«unità della teoria e della pratica»
come questione da che va «impostata storicamente, e cioè come un aspetto
della quistione politica degli intellettuali»54.
Se mi sono soffermato così a lungo sulla coppia di paragrafi 28 e 29 del
Quaderno 1, scritti nell’ottobre del 1929, rischiando anche qualche
eccesso di lettura teleologica, è perché già poco dopo, tra maggio e agosto
del 1930, l’accenno, in essi contenuto, a collegare la funzione politica del
concetto di storicismo a una ridefinizione complessiva dello statuto del
concetto e del sapere, trova una prima espressione esplicita nella qualifica
di Marx come «essenzialmente uno “storicista”»55 in collegamento immediato
con la categoria di «immanenza» alla quale Marx, precisa Gramsci, «dà [...]
un significato proprio»56. A questa altezza, lo storicismo non è già più
un’intuizione dinamica della realtà: esso è una funzione politico-egemonica
nella teoria, che in Marx si precisa come problematica dell’immanenza,
ovvero come ciò che più avanti diventerà la già ricordata impostazione
storica dell’unità di teoria e pratica nella «quistione politica degli
intellettuali».
E infatti, subito dopo, nel § 24 del Quaderno 4, anch’esso scritto tra
maggio e agosto 1930, Gramsci avvia una differenziazione interna al
concetto di storicismo, trascrivendo in questi termini l’antitesi tra
«sarcasmo appassionato» e «sarcasmo di “destra”» abbozzata nel Quaderno
157: lo «storicismo» viene ora individuato compiutamente nella sua
specificità di prodotto pratico e ideologico del periodo della
Restaurazione, cioè, rispettivamente, come salvaguardia in forma “passiva”
delle rivendicazioni rivoluzionarie sotto la guida della grande borghesia e
dell’aristocrazia, e come «filosofia politica» che critica l’astrattismo
piccolo-borghese dei giacobini. Dinnanzi a questo storicismo qualificato
nella sua origine e funzione ideologica, il marxismo si presenta come «uno
storicismo “popolare” che critica e l’ideologia piccolo-borghese e
l’ideologia “aristocratica”, spiegando ambedue e spiegando “se stesso” ciò
che rappresenta il massimo “storicismo”, la liberazione totale da ogni
Quaderno 11, § 12 QC, 1386.
Quaderno 4, § 11: QC, 433.
56 Ibid.
57 QC, 23.
54
55
364
Fabio Frosini
“ideologismo”, la reale conquista del mondo storico, cioè l’inizio di una
nuova civiltà originale»58.
Come si vede, la presa di distanza dalla natura di classe, dunque
ideologica dello storicismo liberale, non si esaurisce in una critica politica,
in una scissione reale; essa investe anche la dimensione metodologica del
concetto di “storia” posto alla base della filosofia: è grazie al fatto che sa
praticare la critica anche di «se stesso», che il marxismo può dirsi «la reale
conquista del mondo storico», e a sua volta, questa conquista è un fatto
teorico e pratico allo stesso tempo. Qui è il nesso con la tematica
dell’assorbimento critico della filosofia dell’immanenza: se quest’ultima
pensa la compenetrazione di soggetto e oggetto, di storia e verità, si tratta
di pensare a sua volta la funzionalità politica di questa posizione in
relazione ai dislivelli di potere/sapere, portando a unità i due momenti,
vale a dire la questione di un’analitica del potere e quella di un’analitica del
sapere, come aspetti inseparabili di un’unica questione.
5. Storia come immanenza
Non è un caso, se da qui in avanti la riflessione sul tema dello
storicismo si investe tutta nel duplice tentativo, da una parte, di elaborare
un concetto appropriato dello «storicismo dei moderati»59, come
aprioristico «contemperamento di conservazione e innovazione», in
evidente vicinanza al concetto di «rivoluzione passiva» (sviluppato subito
prima60); dall’altra, di mettere a fuoco la specificità dello storicismo
marxista in quanto storicismo.
Sul primo versante, Gramsci ipotizza dapprima, ala fine del 1930, che
Croce e Gentile abbiano «reso più “astratto” lo Hegel» tagliandone via «la
parte più realistica, più storicistica» dalla quale invece «è nato
essenzialmente il marxismo»61; e giunge infine, nella primavera del 1932, a
definire lo storicismo idealistico, e in specie crociano, come «speculativo»,
dove questo aggettivo implica un concetto astratto di storia (esito della sua
arbitraria costrizione entro i termini pregiudiziali della dialettica
rivoluzione-restaurazione), dunque un legame ancora forte con la
QC, 443.
Cfr. Quaderno 8, § 27: QC, 958, gennaio-febbraio 1932.
60 In Quaderno 8, § 25: QC, 957.
61 Quaderno 4, § 56: QC, 504, novembre 1930.
58
59
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
365
«teologia» nonostante tutte le proclamazioni in contrario. Su questo
terreno la svolta avviene con il § 224 del Quaderno 8:
Teologia – metafisica – speculazione. Il Croce cerca sempre di mettere in
rilievo come egli, nella sua attività di pensatore, abbia cercato di
«espellere» dal campo della filosofia ogni residuo di teologia e di
metafisica, fino a negare ogni «sistema» filosofico, presentando la filosofia
come la soluzione dei problemi filosofici che lo sviluppo storico presenta e
impone nel suo svolgimento. Ma ogni filosofia «speculativa» non è essa
stessa una teologia e una metafisica? Questo «residuo» non è un residuo, è
un «tutto», è tutto il metodo del filosofare, e per esso ogni affermazione di
«storicismo» è vana, perché si tratta di «storicismo» speculativo, del
«concetto» di storia e non della storia62.
Proprio quel Croce, da cui Gramsci aveva a Torino preso le mosse63, e
che ancora nei Quaderni compare, con la sua teoria delle «distinzioni»,
come un argine posto alla «degradazione della filosofia tradizionale»
perpetrata dall’attualismo64, grazie all’individuazione, che si è mostrata, di
una doppia implicazione tra storicismo e immanenza, viene qui spinto al
margine opposto, quello di un «metodo del filosofare» che rimane debitore
della teologia.
La tesi è ribadita in un gruppo di testi scritti nello stesso giro di
settimane65. In uno di essi fa anche la sua comparsa il riferimento alla
necessità di un Anti-Croce66, lemma ripreso altre due volte: nella seconda
stesura di questo paragrafo67 e in una nota di stesura unica del Quaderno
1068. L’Anti-Croce ‒ spesso indebitamente generalizzato, con riflessi di
profonda ambiguità, a marca teorica dell’intero progetto dei Quaderni del
carcere ‒ va invece letto alla luce di questa congiuntura, nella primavera del
1932, quando Gramsci ritiene di aver formulato la nozione di immanenza
62 QC, 1081-1082. Si noti che il testo si conclude con l’annotazione: «Tuttavia la
critica del Croce ai residui di teologia e di metafisica deve essere riassunta e studiata
attentamente», che non viene ripresa nella seconda stesura (Quaderno 10 I, § 8).
63 Cfr. sopratutto L. BASILE, “Gramsci e la costellazione idealistica tra il 1914 ed il
1917”, cit.
64 Quaderno 1, § 132: QC, 119.
65 Cfr. Quaderno 8, §§ 235 e 237, e Quaderno 10 I, § 7, tutti stesi tra aprile e maggio
del 1932.
66 Quaderno 8, § 235: QC, 1088.
67 Quaderno 11, § 51: QC, 1477.
68 Quaderno 10 I, § 11: QC, 1234.
366
Fabio Frosini
storicistica e realistica, e procede quindi a prendere le distanze da Croce e,
insieme, dall’accezione generica di storicismo, ora ridotta alla sintesi di
speculazione e conservazione69.
La congiuntura dell’aprile-maggio 1932 coincide con la ridefinizione
complessiva del lavoro ai Quaderni: la stesura dei «Raggruppamenti di
materia» nel Quaderno 8, in marzo-aprile, e l’avvio di almeno alcuni degli
“speciali”. In questo contesto, quello marxista viene definito «storicismo
assoluto»70 o «realistico»71, e posto sistematicamente in connessione con la
problematica della nuova immanenza. Ciò risulta evidente in testo del
maggio 1932 intitolato Immanenza speculativa e immanenza storicistica o
realistica. Qui la filosofia della praxis viene equiparata «a Hegel + Davide
Ricardo», dove il ruolo di Ricardo sta nella «scoperta del principio logico
formale della “legge di tendenza”» come matrice di una «nuova
“immanenza”, una nuova concezione della “necessità” e della libertà
ecc.»72. È tutta una nuova prospettiva che qui si apre, definitivamente
emancipata dalla fascinazione crociana: la filosofia dei distinti può ora
essere recuperata grazie alla sua «traduzione in termini di storicismo
realistico»73, e cioè stabilendo «con esattezza il significato storico e politico
dello storicismo crociano», riducendolo «alla sua reale portata»74. In questa
luce ‒ e solo in questa ‒ va letta l’affermazione, che è un po’ il suggello a
questo percorso: «La filosofia della praxis è lo “storicismo” assoluto, la
mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero, un umanesimo
assoluto della storia. In questa linea è da scavare il filone della nuova
concezione del mondo»75 (e si notino le virgolette apposte a “storicismo”, a
indicare l’assunzione del termine in accezione del tutto nuova) 76.
69 Gramsci registra la propria presa di distanza rispetto alla posizione giovanile proprio
nel testo del Quaderno 10 (I, § 11) in cui nomina l’Anti-Croce: «[...] in quel tempo il
concetto di unità di teoria e pratica, di filosofia e politica non era chiaro in me ed io ero
tendenzialmente piuttosto crociano» (QC, 1233).
70 Quaderno 8, § 204: QC, 1064, febbraio-marzo 1932; Quaderno 15, § 61: QC, 1826,
giugno-luglio 1933.
71 Nel sommario del Quaderno 10, aprile-maggio 1932.
72 Quaderno 10 II, § 9: QC, 1247.
73 Quaderno 10 II, § 6: QC, 1244.
74 Quaderno 8, § 39: QC, 966, febbraio 1932.
75 Quaderno 11, § 27: QC, 1437, luglio-agosto 1932.
76 Un’ulteriore presenza del lemma si registra nel Quaderno 26, § 5: QC, 2298, fine
1934-primi mesi del 1935. Si noti che questa è la seconda stesura di due testi commentati
supra (Quaderno 1, § 29 e parte del § 28). Qui compare la lezione «storicismo integrale»,
Storicismo e storia nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
367
Abstract
A brief snippet of the debate on Gramsci’s “historicism”, held by Nicola
Badaloni and Cesare Luporini between 1962 and 1975, introduces us to
the focal point of this contribution, namely the profound and
groundbreaking redefinition of “historicism” carried out by Antonio
Gramsci in his Prison Notebooks. Starting from the reactivation of the
meaning of “historicism” as a synonym for modern philosophy in general, a
meaning he was familiar with between 1914 and 1919, Gramsci gradually
deconstructs this notion, integrating it into the question of the unification
of theory and praxis and of the search for a “realistic” approach to
“immanence”. Consequently, historicism not only splits into two opposite
notions ‒ “idealistic” and “absolute” or “integral” historicism ‒, but it also
incorporates the tension between history, politics and truth, that is at the
core of the “philosophy of praxis”.
opposto a «storicismo idealistico», come esito dello sdoppiamento di ciò che nella prima
stesura era «storicismo» tout court.
DIEGO FUSARO
L’importanza di Reinhart Koselleck
per una storia critica delle idee
1. Premessa
Se è vero che la riflessione e l’opera di Reinhart Koselleck (1923-2006)
si stanno affermando, in tempi piuttosto recenti, come un imprescindibile
punto di riferimento per studiosi provenienti dalle discipline più
eterogenee, dalla storia agli studi politici alla sociologia1, non deve passare
inosservato come i contributi del Begriffshistoriker tedesco più raramente, e
indubbiamente con minore entusiasmo, siano stati recepiti, o anche solo
adeguatamente presi in considerazione, dai filosofi e, più in generale, dagli
storici della filosofia.
Questo è vero soprattutto se si presta attenzione all’orizzonte italiano,
in cui, come è noto, la Begriffsgeschichte è andata incontro a una ricezione
davvero sui generis2, secondo tre differenti approcci metodologici che ne
restituiscono immagini a tal punto differenziate da far sorgere
legittimamente il dubbio che non si tratti di riferimenti alla stessa
esperienza culturale: a Trento, la Begriffsgeschichte koselleckiana si è
1
Sulla fortuna della Begriffsgeschichte koselleckiana, nonché sulle “avventure”
della sua ricezione internazionale, si veda P.P. PORTINARO, “ “Begriffsgeschichte”
e filosofia politica: acquisizioni e malintesi”, in Filosofia politica, n. 1 (aprile 2007),
pp. 53-64. Cfr. inoltre (in riferimento alla ricezione italiana) S. CHIGNOLA, “Tra
storia delle dottrine e filosofia politica. Di alcune modalità della ricezione italiana
della Begriffsgeschichte”, in Il Pensiero politico, n. 33 (2000), pp. 242-264. Ci
permettiamo, infine, di rinviare anche al nostro studio L’orizzonte in movimento.
Modernità e futuro in Reinhart Koselleck, Il Mulino, Bologna 2012 (con presentazione
di P.P. Portinaro).
2
Si veda Cfr. M. SCATTOLA, “Storia dei concetti e storia delle discipline
politiche”, in Storia della storiografia, n. 49 (2006), pp. 95-124.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 369-388
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064325
369
370
Diego Fusaro
affermata soprattutto grazie all’opera di Pierangelo Schiera3, il quale –
studioso di Otto Brunner e curatore di svariate opere di Koselleck – ha
insistito, da un punto di vista schiettamente storiografico e politologico,
sulla necessità di porre i due autori in relazione tra loro; in questo caso,
l’interesse metodologico per la storia concettuale koselleckiana si inserisce
nel quadro di quella che Schiera chiama, sulle orme di Brunner, “storia
costituzionale”4 (Verfassungsgeschichte). A Bologna, invece, la riflessione
koselleckiana – soprattutto nel suo versante politico – è stata introdotta
specialmente dalla rivista “Filosofia politica”, che, fondata da Nicola
Matteucci e ora diretta da Carlo Galli5, si è dotata di una sezione di
“Materiali per un lessico politico europeo” e propone numeri monografici
dedicati ciascuno a uno specifico concetto politico. Infine, a Padova alla
diffusione del pensiero di Koselleck ha contribuito soprattutto Giuseppe
Duso con il “Centro Interuniversitario di Ricerca sul Lessico Politico e
Giuridico Europeo”6; Duso, inoltre, ha riscritto in modo originale – anche
3
Cfr. soprattutto P. SCHIERA, “Considerazioni sulla Begriffsgeschichte, a
partire dai Geschichtlichen Grundbegriffe di Brunner, Conze e Koselleck”, in
Società e storia, n. 19 (1996), pp. 403-411, soprattutto p. 408, dove si allude a una
“storia ‘concettuale’ (non ‘dei concetti’, come sarebbe meglio tradurre in italiano
l’espressione tedesca Begriffsgeschichte)” che «però, non è più quella direttamente
trattata nei Geschichtliche Grundbegriffe. È semmai una Begriffsgeschichte che da
quest’ultimi è resa possibile, in virtù del metodo che essi propongono e della
straordinaria apertura storiografica a cui […] essi hanno dato luogo».
4
Cfr. P. SCHIERA, Premessa alla seconda edizione, in O. BRUNNER, Per una nuova
storia costituzionale e sociale, Vita e Pensiero, Milano 1970, pp. X-XI.
5
Cfr. ad esempio Filosofia politica, 4, 1990, num. 1 (“Pensiero politico e storia
dei concetti”, pp. 5-73) e Filosofia politica, 11, 1997, num. 3 (“Storia dei concetti”,
pp. 357-424).
6
Cfr. G. DUSO, Storia concettuale come filosofia politica, in “Filosofia politica”, n.
11 (1997), pp. 393-424; S. CHIGNOLA, “Tra storia delle dottrine e filosofia
politica. Di alcune modalità della ricezione italiana della Begriffsgeschichte”, in Il
Pensiero politico, n. 33 (2000), pp. 255-263; Id. – G. DUSO, Introduzione, in Idd.,
Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell’Europa, Franco Angeli, Milano
2005, pp. 7-12.
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
371
se non esente da ambiguità7 – la storia della filosofia politica occidentale
impiegando l’impianto categoriale koselleckiano8.
Ad accomunare queste tre prospettive sideralmente distanti tra loro è il
fatto che tutte metabolizzano l’insegnamento koselleckiano della
Begriffsgeschichte all’interno di orizzonti disciplinari che, in ogni caso,
esulano da quello della storia della filosofia. Si tratta, peraltro, di un
fenomeno alquanto curioso, se si considera che, come è stato da più parti
sottolineato9, l’impianto teorico di Koselleck costituisce un indispensabile
strumento di lavoro non soltanto per lo storico in senso stretto, ma anche
7
Cfr. P.P. PORTINARO, “Begriffsgeschichte” e filosofia politica: acquisizioni e
malintesi, cit., pp. 58 ss.
8
Cfr. G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica,
Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 21-27. Duso individua con precisione l’errore di
Koselleck – l’aver trascurato la svolta operata in campo politico dal paradigma
artificialista hobbesiano – ma commette, a mio avviso, l’errore opposto: finisce
per retrodatare la Sattelzeit al XVII secolo, alla “nuova scienza politica” inaugurata
da Hobbes, come se il mutamento dei concetti proprio della Neuzeit fosse già
avvenuto, nell’essenziale, nel XVII secolo. In particolare, Duso (e la scuola che, a
Padova, a lui si richiama) assume come cuore della propria lettura della
Begriffsgeschichte (usata in verità come scudo per la propria autonoma posizione
teorica, assai distante per intenti e per esiti da quella di Koselleck) la discontinuità
radicale tra un cosmo politico incardinato sul governo e uno basato invece sul
potere sovrano. Scrive Duso: «Koselleck ha ragione a porre la Sattelzeit per
l’epoca moderna nella seconda metà del Settecento […], se egli si riferisce ai
concetti in relazione alla loro diffusione nella vita sociale, culturale e politica.
Tuttavia, se si porta l’attenzione sulla genesi di quei concetti, tenendo conto della
relativa autonomia propria della storia concettuale e del fatto che ci può essere
sfasatura tra nascita dei concetti e immediata realtà storica, bisogna concludere
che la Trennung nei confronti di un millenario modo di intendere il mondo,
l’uomo e la politica nasce prima della seconda metà del XVIII secolo. Tutti i
concetti che alla fine di questo secolo si diffondono e diventano comuni sono già
elaborati e determinati nella nuova scienza politica che nasce con Hobbes a partire
dalla metà del Seicento» (Ivi, p. 21). Del resto, Duso ha anche tentato di mostrare
come lo stesso Koselleck si sia visto costretto, in più occasioni, a risalire
all’indietro fino allo spartiacque hobbesiano per poter dare ragione della
specificità dei concetti moderni: cfr. ID., “Historisches Lexikon e storia dei
concetti”, in Filosofia politica, VIII (1994), pp. 116-117.
9
Cfr. ad esempio J. FERES JÚNIOR e S. CHIGNOLA, “The Expanding Horizons
of Conceptual History: a New Forum”, in Contributions to the History of Concepts,
1.1 (marzo 2005), p. 4; K. PALONEN, The Politics of Conceptual History, ivi, p. 39.
372
Diego Fusaro
per chi, con intenti più specificamente filosofici, miri a elaborare una
diagnosi generale della modernità in quanto tale, riconducendola ad alcuni
princìpi fondamentali, con i quali rendere ragione delle singole
determinazioni empiriche che hanno costellato l’avventura moderna: e
questo, peraltro, in coerenza con l’intento dell’opera del Begriffshistoriker
tedesco, che mai ha celato la propria vocazione di “storico generale” à la
Droysen10, né il proprio obiettivo teorico primario, la comprensione delle
strutture generali – analizzate a partire dal piano della temporalità e delle
Zeitstrukturen11 – di quel processo “sfaccettato e pluridimensionale”12 che è
10
«Preferisco essere un incompetente nella storia generale piuttosto che uno
specialista in un unico settore»: R. Koselleck, “Begriffsgeschichte,
Sozialgeschichte, begriffene Geschichte. Reinhart Koselleck im Gespräch mit
Christof Dipper”, in Neue politische Literatur, n. 43 (1998), p. 202. Koselleck, con
il suo rifiuto di ogni specialismo disciplinare, è stato uno degli ultimi grandi storici
in grado di mantenere uno sguardo aperto e olistico, tale da permettergli di
conoscere ogni settore provenendo da studi esterni alla storia. L’attenzione di
Koselleck non è rivolta a un settore particolare della storia, ma, piuttosto, a
un’indagine generale, di marca filosofica, sulle condizioni generali di possibilità
della storia, sulle categorie metastoriche trascendentali che permettono la
storicizzazione e la genesi stessa di ciò che, dal XVIII secolo in poi, l’Occidente ha
chiamato “storia”. Cfr. S. CHIGNOLA, “Nel laboratorio della storia possibile”, Il
Manifesto, 7 febbraio 2006. Cfr. anche K. PALONEN, Die Entzauberung der Begriffe.
Das Umschreiben der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck, cit.,
pp. 206 ss.
11
Per inciso, è questo, al di là delle trasformazioni e dei ripensamenti,
l’orizzonte comune di lavori koselleckiani anche assai diversi tra loro come
Vergangene Zukunft e Zeitschichten. Su questo, si rimanda al lavoro monografico di
M. RICHTER, The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction,
Oxford University Press, Oxford 1995.
12
R. KOSELLECK, Einleitung, in Id. (a cura di), Studien zum Beginn der modernen
Welt, 1977; tr. it. a cura di A. Furlanetto, Gli inizi del mondo moderno, Vita e
Pensiero, Milano 1997, p. XI. Fin dalle prime pagine del suo saggio introduttivo,
Koselleck pone le questioni decisive, che rivelano il vero obiettivo della sua
Begriffsgeschichte, la comprensione dell’enigma della modernità: «da quando esiste
in effetti la percezione di un tempo nuovo? All’interno di unità confrontabili dove
si possono comprovare quelle accelerazioni che furono in grado di suscitare un
cambiamento di percezione? E dove si possono rilevare ritardi e ostacoli che già
dai contemporanei furono sentiti come tali? Come si trasformò l’orizzonte delle
attese per il futuro; si spalancò a pianificazioni di più lungo periodo?» (Ivi, pp. IXX).
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
373
stata la Neuzeit. La cifra stessa del progetto begriffsgeschichtlich di Koselleck
presenta dunque – anche al di là delle ammissioni del suo stesso teorico –
una sua chiara impronta filosofica.
La scarsa attenzione dei filosofi e degli storici della filosofia per la
riflessione koselleckiana può naturalmente essere compresa se si considera
il fatto che il monumentale Lexikon – l’esito più maturo, sistematico e
metologicamente articolato della Begriffsgeschichte13 –, per un verso,
presenta una sua ineludibile curvatura politologica, configurandosi come
un lessico specializzato soprattutto nel campo politico e, dunque,
prestandosi a letture orientate in questo senso, e, per un altro verso, trova
in Italia una già collaudatissima tradizione storico-filosofica, dotata di un
suo preciso programma di ricerca e di un suo chiaro orientamento e,
dunque, tale da determinare una certa difficoltà di assimilazione.
Alla luce di quanto sostenuto, nelle pagine che seguono tenterò di
mostrare – brevemente e senza alcuna pretesa di esaustività – in che senso
e secondo quali modalità la riflessione begriffsgeschichtlich di Koselleck possa
essere fecondamente assunta come punto di riferimento per l’elaborazione
e la pratica di una storia critica delle idee e, dunque, per gli storici della
filosofia. Quelli che propongo sono semplici spunti per l’elaborazione di
una storia critica delle idee che resta ancora da scrivere e da impostare, ma
per la cui elaborazione sono convinto che la riflessione koselleckiana possa
costituire un importante stimolo.
2. Lineamenti di una storia critica delle idee
Anzitutto, occorrerà prospettare una definizione della storia delle idee
che, per quanto approssimativa e provvisoria, renda possibile chiarire
come il metodo di Koselleck possa essere reso in essa operativo. In prima
approssimazione, ritengo che il compito di una storia critica delle idee
possa essere delineato su due fronti, che solo astrattamente e in funzione
espositiva possono essere distinti, perché nella pratica concreta della
disciplina costituiscono un’unità inscindibile. Per un verso, secondo le
13
Cfr. M. RICHTER, The History of Political and Social Concepts. A Critical
Introduction, cit., pp. 64 ss.
374
Diego Fusaro
coordinate della foucaultiana Archéologie du savoir14, essa è chiamata a
soffermare la sua attenzione, diacronicamente, sulle faglie e sulle
discontinuità che si generano nella trasmissione delle forme culturali e
simboliche e che vanno immancabilmente a scuotere la continuità narrativa
inerziale di una data cultura, intessuta di schemi identitari e di tetragone
permanenze. La storia delle idee, dunque, come attenzione più per le
fratture e i riorientamenti che non per le continuità e le persistenze (ché,
altrimenti, la storia finirebbe per essere indebitamente intesa come lo
sfondo cangiante nonostante il quale permangono le identità).
Per un altro verso, penso che la storia critica delle idee sia chiamata a
occuparsi del nesso inscindibile che viene a instaurarsi in ogni momento
storico, lungo l’asse della sincronia, tra il pensiero e i codici culturali, da
una parte, e le condizioni materiali della produzione e del potere,
dall’altra, mostrandone la fitta rete di coimplicazione e assumendo come
proprio privilegiato oggetto d’analisi la “zona di scambio” tra idee e realtà,
tra costellazioni concettuali e costellazioni sociopolitiche. In questo senso,
la storia critica delle idee deve operare secondo una deduzione sociale15 e
non trascendentale delle categorie del pensiero, mostrando geneticamente
il loro sorgere a partire da contesti socialmente, politicamente e
storicamente condizionati.
Si potrebbe anche dire, da un certo punto di vista, che la storia critica
delle idee si regge sul tentativo di coniugare Foucault e Marx, facendo
interagire il programma di ricerca del primo – con la sua attenzione per le
discontinuità storica e per l’ordre du discours16 – con la “concezione
materialistica”17 e con lo smascheramento delle formazioni ideologiche
14
Cfr. M. FOUCAULT, L’Archéologie du savoir, 1969; tr. it. a cura di G.
Bogliolo, L’Archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Rizzoli,
Milano 20095, pp. 34 ss.
15
Si veda C. PREVE, Storia dell’etica, Petite Plaisance, Pistoia 2007, pp. 110
ss.; mi permetto inoltre di rimandare al mio Minima mercatalia. Filosofia e
capitalismo, Bompiani, Milano 2012 (con saggio introduttivo di A. Tagliapietra),
pp. 63 ss.
16
Cfr. Id., L’ordre du discours, 1971; tr. it. a cura di A. Fontana, L’ordine del
discorso, Einaudi, Torino 1972.
17
Il testo marxiano da cui ripartire per elaborare una piattaforma teorica per
la storia critica delle idee può essere soprattutto la Deutsche Ideologie, al cui centro
vi è una riflessione sul nesso tra le forme di strutturazione sociale, economica e
politica di una data epoca e le sue produzioni simbolico-ideologiche: cfr. K. MARX
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
375
tematizzati dal secondo, epurati però dal riduzionismo che potenzialmente
li caratterizza fin dal loro atto genetico e che storicamente li ha
caratterizzati lungo gli snodi in cui sono venute articolandosi le “avventure
della dialettica” del marxismo novecentesco.
Del resto, nella stessa figura concettuale posta in essere dalla storia
critica delle idee vi è un fecondo rimando reciproco – foucaultiano e,
insieme, marxiano18 – tra la componente critica e quella storica centrato
sul presupposto per cui, da un lato, la critica, per essere tale, deve
assumere come costante riferimento il divenire storico come luogo delle
rotture e delle faglie che ritmano il succedersi di quelle che Foucault
chiamava le epistème19 e, dall’altro, la storia, per non essere
surrettiziamente e ideologicamente intesa come immutabile sfondo di
permanenza illimitata delle figure concettuali e dei codici culturali, deve
instaurare un’alleanza strategica con la critica demistificante. In maniera
diametralmente opposta rispetto all’ideologia20, che tende ad annullare la
dimensione storica naturalizzando ciò che è socialmente e storicamente
determinato (in modo da neutralizzare la critica, la quale non si rivolge mai
alla natura ma sempre e solo alla società), la storia presenta una sua
naturale vocazione critica, mostrando la genesi delle costellazioni sociopolitiche, il loro divenire, nonché il loro trapassare in nuove forme (e,
dunque, denaturalizzando e, insieme, defatalizzando l’esistente).
– F. ENGELS, Die deutsche Ideologie, 1845-1846 (1932); tr. it. a cura di D. Fusaro,
Ideologia tedesca, Bompiani, Milano 2011, con presentazione di A. Tagliapietra.
18
Sul nesso Foucaul-Marx ha recentemente scritto Toni Negri: «Foucault fa
buon uso di alcune intuizioni che il giovane Marx non fu in grado di tradurre in un
dislocamento della critica della proprietà, lungo le strutture trascendentali del
capitalismo, fino alla fenomenologia della corporeità. Nonostante Foucault abbia
adottato diversi travestimenti nel suo rapporto con Marx – larvatus prodeo – questo
rapporto resta estremamente profondo» (M. HARDT – A. NEGRI, Commonwealth,
2009; tr. it. a cura di A. Pandolfi, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli,
Milano 2010, p. 42). Cfr. R. M. LEONELLI (a curadi), Foucault-Marx. Paralleli e
paradossi, Bulzoni, Roma 2010; M. BARRETT, The Politics of Truth. From Marx to
Foucault, Polity Press, Cambridge 1991.
19
Si veda M. FOUCAULT, Les mots et les choses, 1966; tr. it. a cura di E.
Panaitescu, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 19703, pp. 124 ss.
20
Sul concetto di ideologia, cfr. T. EAGLETON, Ideology. An Introduction, 1991;
tr. it. a cura di S. Negrini, Che cos’è l’ideologia, Il Saggiatore, Milano 1993; F.
ROSSI-LANDI, Ideologia. Per l’interpretazione di un operare sociale e la ricostruzione di un
concetto, Meltemi, Roma 2005.
376
Diego Fusaro
Da una diversa angolatura, riprendendo quanto appena sostenuto, la
storia presenta una sua naturale vocazione critica, nella misura in cui
disgrega la pretesa solidità delle forme di sapere che si pretendono valide
sub specie aeternitatis, e la critica ha una sua inaggirabile propensione a
rintracciare nel fluire della storia i punti di rottura e di metamorfosi
tramite i quali smascherare (storicizzandoli) i giochi di potere e di dominio
che vengono a instaurarsi entro la società di volta in volta presa in esame.
Operando secondo una deduzione sociale e non trascendentale delle
categorie del pensiero dalla strutturazione storica della società, la storia
critica delle idee permette di decifrare il nesso dinamico tra i concetti
filosofici apparentemente più astratti e il concreto tessuto sociale, politico
e storico di una data epoca, mostrando come tra le due dimensioni sussista
sempre un’inscindibile unità21. In particolare, il contenuto sociale e
storicamente determinato può sempre essere decriptato entro il guscio
apparentemente impenetrabile della presunta neutralità delle categorie
filosofiche astratte e gnoseologiche: le idee filosofiche sorgono sempre in
un preciso contesto sociale e rispondono a esigenze conoscitive e di
orientamento che sono esse stesse sociali22. Il nesso tra società e idee è
immancabilmente quello di una reciproca coimplicazione.
Per la storia critica delle idee centrata sulla deduzione sociale delle
categorie, le questioni anche più astrattamente filosofiche o teologiche (dal
concetto di “causa” in Hume a quello di “critica” in Kant, dalla nozione di
Trinità in Agostino a quella di Dio in Tommaso23) devono sempre essere
intese come una modalità essenziale, sia pure mediata, obliqua e criptica,
con cui – come ho provato a mostrare altrove24 – gli uomini cercano di
rappresentarsi simbolicamente i loro rapporti sociali, in una dinamica con
cui l’essere sociale si riflette nell’autocoscienza umana secondo modalità via
via più consapevoli e mature25.
21
Su questo tema, mi permetto di rimandare ancora al primo capitolo di
Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo, cit., pp. 53 ss.
22
Cfr. C. PREVE, Storia dell’etica, cit., pp. 23 ss.
23
Cfr. Ivi., pp. 56 ss.
24
Mi sia consentito di rinviare ancora una volta a Minima mercatalia. Filosofia e
capitalismo, cit., pp. 63 ss.
25
Occorre dunque, come ha scritto Lukács, “mostrare come questo essere
sociale e la sua apprensione non meno socialmente necessaria si riflette, in forma
chiara e riconoscibile, nelle categorie filosofiche più complesse e apparentemente
più astratte e lontane dalla vita sociale”: G. LUKÁCS, Der junge Hegel und die
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
377
3. Il contributo di Koselleck
Alla luce di questo pur rapido e impressionistico inquadramento della
storia critica delle idee, credo che la riflessione di Koselleck possa costiture
un importante punto di riferimento soprattutto per due suoi presupposti
teorici, al centro di Vergangene Zukunft (1979), ma poi ampiamente
codificati anche nella Einleitung al Lexikon nonché nelle voci che lo
compongono. Mi limito qui a enunciarli, per poi prenderli in esame
singolarmente in maniera più estesa: si tratta del nesso tra sincronia e
diacronia e del legame tra i concetti e la realtà socio-politica. Sono due punti
particolarmente importanti, a mio giudizio, perché imprescindibili per
delineare una storia critica delle idee nel senso sopra chiarito, che faccia da
piattaforma programmatica per una storia della filosofia vocazionalmente
critica.
Prendo le mosse dal primo punto. Soprattutto nella Einleitung al Lexikon,
Koselleck ha insistito su come il principio fondamentale su cui si regge la
Begriffsgeschichte da lui praticata debba essere identificato nell’intreccio del
piano diacronico con quello sincronico26: per un verso, infatti, la storia dei
concetti studia che cosa significhi, sul piano “orizzontale” della sincronia,
per i singoli attori all’interno di una data società – storicamente collocata –
un dato concetto, analizzandolo nella sua portata politica e sociale,
mostrando cioè come quel dato concetto sia politicamente attivo in un
dato contesto storico e sociale; e, nello stesso movimento
begriffsgeschichtlich, essa mette in luce gli “strati del tempo”27 (Zeitschichten)
che sono andati a depositarsi in ogni singolo concetto, esaminato sul piano
“verticale” della diacronia tramite l’attenta ricostruzione storica delle
avventure del Begriff, ossia dei diversi significati che, lungo l’asse mobile
della storia, sono andati depositandosi in esso. Secondo quanto
programmaticamente chiarito dalla Einleitung al Lexikon, nello studio dei
Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, 1948; tr. it. a cura di R. Solmi, Il giovane
Hegel e i problemi della società capitalistica, Einaudi, Torino 1960, 2 voll., II, p. 553.
26
Cfr. Cfr. L. SCUCCIMARRA, “La Begriffsgeschichte e le sue radici
intellettuali”, in Storica. Rivista quadrimestrale, n. 4 (1998), pp. 7-99.
27
Si veda soprattutto R. KOSELLECK, Zeitschichten. Studien zur Historik,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000.
378
Diego Fusaro
concetti “la diacronia e la sincronia verranno intrecciate tramite la storia
concettuale”28.
Seguendo Koselleck, la Begriffsgeschichte scatta una “fotografia generale”
della società di un certo periodo storico, fornendone uno spaccato
sincronico, ossia mostrando la fitta rete di concetti storici, politici e sociali
con cui essa si esprime e fa la propria storia in una tensione tra piano
linguistico e piano socio-politico: proprio perché – e su questo tema
tornerò più estesamente in seguito – tra concetti e realtà politica concreta
sussiste un nesso alchemico di reciproca influenza, la Begriffsgeschichte,
studiando il lessico socio-politico di un dato contesto, esplora eo ipso la
situazione sociale e politica di un mondo storico, nonché la precisa
relazione che in quest’ultimo gli attori sociali instaurano tra il loro agire e
la concettualità di riferimento (storicamente variabile).
È quanto Koselleck – in larga parte sulla scia di Schmitt29 – fa in modo
magistrale fin dal suo pionieristico lavoro Kritik und Krise30, composto nel
28
ID., “Einleitung” (1967), in Id. – O. BRUNNER – W. CONZE, Geschichtliche
Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, KlettCotta, Stuttgart 1972-1997, 9 voll., I, p. XXI.
29
Sul nesso tra Koselleck e Schmitt, cfr. J.-F. MISSFELDER, “Die Gegenkraft
und ihre Geschichte: Carl Schmitt, Reinhart Koselleck und der Bürgerkrieg”, in
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, volume 58, n. 4 (2006), pp. 310-336;
N. OLSEN, “Af alle mine lærere har Schmitt været den vigtigste: Reinhart
Koselleck’s intellektuelle og personlige relationer til Carl Schmitt”, in Historisk
Tidsskrift, n. 104 (2004), pp. 30-60. Scrive Koselleck a proposito del proprio
debito nei confronti di Schmitt: «Carl Schmitt ha fortemente ispirato la
Begriffsgeschichte, sviluppandola ulteriormente rispetto a Brunner. Nei suoi scritti
storico-politici, egli indaga sulla parola collocandola nel giusto tempo e nel giusto
luogo. A questo proposito, Carl Schmitt propugnava una posizione di base
radicalmente storica (eine radikal historische Grundposition), che si regge sull’unicità,
propria dell’epoca, di un concreto uso delle parole. Questo non gli impediva di
condurre liberamente anche una Begriffsgeschichte diacronica. Mi ricordo del suo
libro sulla dittatura, in cui egli ha indagato con la storia dei concetti
(begriffsgeschichtlich untersucht) la transizione dalla dittatura interinale a quella
KOSELLECK,
“Begriffsgeschichtliche
Probleme
der
sovrana»
(R.
Verfassungsgeschichtsschreibung”, in Id., Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik der
politischen und sozialen Sprache, a cura di U. SPREE – W. STEINMETZ, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 2006, p. 382). Il riferimento koselleckiano al “libro sulla
dittatura” è, naturalmente, un riferimento a: C. SCHMITT, Die Diktatur. Von den
Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf,
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
379
1954 e poi pubblicato nel 1959: in quest’opera, come è noto, l’attenzione
del Begriffshistoriker si concentra non già sulle idee disincarnate e sospese nei
cieli rarefatti della pura teoria, ma sulla funzione politica e storica svolta
dal pensiero e dalla mentalità illuministica all’interno del concreto quadro
politico corrispondente, ossia dell’assolutismo31. L’interesse della storia
1921; tr. it. a cura di B. LIVERANI, La dittatura: dalle origini dell’idea moderna di
sovranità alla lotta di classe proletaria, Laterza, Roma-Bari 1975. Per una
ricostruzione della semantica politica in area tedesca (con particolare attenzione
per gli anni della progettazione del Lexikon), cfr. W. Dieckmann, Sprache in der
Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache, Winter,
Heidelberg 1969.
30
Cfr. R. KOSELLECK, Kritik und Krise. Pathogenese der Bürgerlichen Welt, 1959;
tr. it. a cura di P. SCHIERA, Critica illuministica e crisi della società borghese, Il
Mulino, Bologna 1972.
31
Su Kritik und Krise e, in particolare, sul modo koselleckiano di intendere la
relazione tra Illuminismo e assolutismo, cfr. K. M. BAKER, Inventing the French
Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century, Cambridge
University Press, Cambridge 1990; K. VON BEYME, “Partei”, in R. KOSELLECK,
O. BRUNNER, W. CONZE, Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, cit., IV, pp. 681-733; R. VON BIEBERSTEIN,
Die These von der Verschwörung 1776-1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberalen
und Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung, Lang, Bern 1976; F. FURET,
Penser la Révolution française, 1978-1988; tr. it. a cura di S. Brilli Cattarini, Critica
della Rivoluzione francese, Laterza, Roma-Bari 1980; H.U. GUMBRECHT, R.
REICHARDT, T. SCHLEICH, Für eine Sozialgeschichte der Französischen Aufklärung, in
IDD. (a cura di), Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich. Zwölf Original-Beiträge,
München, Wien 1981, 2 voll., I, pp. 3-51; N. HINSKE, “Einleitung”, in ID. (a cura
di), Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 19813, pp. XIII-LXIX; H. KUHN, Kritik und
Krise...von Koselleck, in “Historische Zeitschrift”, Bd. 192, 1961, pp. 666-668; A.J.
LA VOPA, “Conceiving a Public: Ideas and Society in Eighteenth-Century Europa”,
in Journal of Modern History, n. 64 (marzo 1992), pp. 79-116; M. MAURER,
Aufklärung und Anglophilie in Deutschland, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1987; H. MÖLLER, Vernunft und Kritik. Deutsche Aufklärung im 17. und 18.
Jahrhundert, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986; J. POPKIN, “The Concept of
Public Opinion in the Historiography of the French Revolution: a Critique”, in
Storia della Storiografia, n. 20 (1991), pp. 77-92; V. SELLIN, “Politik”, in R.
KOSELLECK, O. BRUNNER, W. CONZE, Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, cit., IV, pp. 789-874; G.S.
WOOD, “Conspiracy and the Paranoid Style: Causality and Deceit in the
380
Diego Fusaro
critica delle idee non è per le idee in quanto tali, ma per la loro espressività
politica, ossia per il modo in cui esse operano nell’orizzonte di un preciso
quadro storico, condensando sul piano simbolico le trasformazioni della
realtà socio-politica e, insieme, promuovendole attivamente.
Trascendendo i confini della storia delle idee nella sua forma canonica e
aprendo un cantiere di riflessione metodologica e di problematizzazione
della relazione tra idee e storia, tra linguaggio e politica, tra concetti e
società, l’indagine al centro di Kritik und Krise converge sul duplice nodo
teorico della critica illuministica e della crisi della società borghese e viene
condotto evitando le secche dell’attenzione esclusiva per le grandi
personalità storiche: secondo il rilievo di Schmitt, il fuoco prospettico
dell’analisi koselleckiana converge sulla “zona di scambio” tra i processi
sociali alimentati e tenuti in tensione dal vocabolario illuminista e il modo
in cui quest’ultimo va modellandosi proprio sul terreno concreto dei
conflitti, dei compromessi e degli equilibri dinamici dell’azione e del
pensiero politico: il tutto in una trama di fitte interrelazioni tra realtà storica
e idee politiche che, nella loro biunivocità, si connettono le une alle altre in
maniera niente affatto coerente, né si offrono in maniera piana e cristallina
alla funzione rappresentativa dello storico. In uno snodo cruciale di Kritik
und Krise, anticipando i più maturi esiti del Lexikon, Koselleck ha così
compendiato la tematizzazione del nesso sincronico operata dalla
Begriffsgeschichte:
Il metodo impiegato fonde le analisi storico-concettuali con le analisi sociologiche
delle situazioni. Le correnti di pensiero verranno studiate soltanto per rendere
evidente il loro accento politico; verranno chiarite le situazioni nelle quali le idee
furono concepite e sulle quali a loro volta hanno influito, ma soltanto per
ricavarne l’evidenza politica delle idee32.
Eighteenth Century”, in The William and Mary Quarterly, n. 39 (1982), pp. 401441.
32
R. KOSELLECK, Critica illuministica e crisi della società borghese, cit., p. 10.
Cfr. anche S. HAIKALA, “Criticism in the Einlightenment. Perspectives on
Koselleck’s Kritik und Krise”, in Finnish Yearbook of Political Thought, n. 1 (1997),
pp. 70-85. Il limite dell’analisi koselleckiana viene individuato nella «scarsa
attenzione rivolta al fatto che anche le reazioni anti-illuministiche influenzarono i
problemi dell’Illuminismo e i suoi fallimenti» (ivi, p. 80). In altri termini,
Koselleck si concentra esclusivamente sulla forza propulsiva dell’Illuminismo,
senza tenere conto della “forza contrastante” del polo opposto, inteso staticamente
come forza passiva. Oltre che nei confronti della riflessione di Schmitt, l’analisi
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
381
È negli scritti successivi, soprattutto in quelli raccolti in Vergangene
Zukunft, che Koselleck ha intrecciato il metodo dell’indagine sincronica –
già attivo in Kritik und Krise – con quello dell’analisi diacronica, secondo
una linea che accompagnerà tutti i suoi successivi lavori e che può con
diritto essere assunta come architrave della Begriffsgeschichte. Quest’ultima,
come si è detto, sottopone ad attenzione il nesso di coimplicazione e
tensione tra il lessico socio-politico e la realtà concreta all’interno di un
determinato quadro storico, operando sincronicamente: in questo senso,
“storia dei concetti” significa anche “storia tramite i concetti”, ossia analisi
di una data società, in un suo specifico momento storico, attraverso i
concetti in cui essa ha articolato linguisticamente le proprie esperienze e le
proprie aspettative e ha agito richiamandosi ad esse.
Accanto a questa prima istanza, la Begriffsgeschichte koselleckiana esplora
diacronicamente i singoli concetti nel loro sviluppo storico, mostrando come
il singolo Begriff alberghi al proprio interno una ricca ed eterogenea
stratificazione semantica corrispondente agli slittamenti di significato a cui
è andato storicamente incontro e che, a loro volta, rivelano le
trasformazioni e i riorientamenti nel modo di concepire la temporalità e il
rapporto con la politica (è in questa prospettiva che si colloca la teoria
koselleckiana si rivela qui debitrice, sia metodologicamente sia
contenutisticamente, nei confronti della Verfassungsgeschichte di Otto Brunner,
ossia dello studio, nei differenti contesti storici, degli elementi “sostanziali” che
caratterizzano l’organizzazione del potere corrispondente a ciascuno di quei
contesti. Non deve del resto essere trascurata nemmeno l’incidenza di quella che
Conze chiamava Strukturgeschichte: essa si regge sull’idea che esistano, in una data
situazione, elementi permanenti, combinati tra loro in maniera tale da costituire
nello stesso tempo l’asse portante della manifestazione storica di un qualsiasi
accadimento o gruppo di accadimenti e, insieme, la chiave per decifrarne il
significato e il funzionamento interno. Sulla genesi, la teoria e gli sviluppi della
Strukturgeschichte, cfr. J. KOCKA: Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 19862, ID., Sozialgeschichte in Deutschland
seit 1945. Aufstieg, Krise und Perspektiven, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2002; W.
SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, Oldenbourg, München 1989,
pp. 281-301; R. LUTZ (a cura di), Von der Volksgeschichte zur Strukturgeschichte. Die
Anfänge der westdeutschen Sozialgeschichte 1945-1968, Leipziger Univ.-Verl., Leipzig
2002.
382
Diego Fusaro
koselleckiana della “soglia epocale”33, Sattelzeit, come frattura radicale tra
mondo premoderno e mondo moderno). Così, per portare un solo
esempio, il concetto di “democrazia” verrà studiato nel Lexikon sia
sincronicamente, sul piano “orizzontale” della relazione che esso presenta
con il concreto quadro storico, politico e sociale del periodo preso in
esame, sia diacronicamente, sul piano “verticale” dei mutamenti storici a
cui è andato incontro nell’arco temporale che unisce virtualmente il
mondo greco e quello contemporaneo.
È anche alla luce di queste considerazioni che Koselleck tiene aperta, e
anzi elegge a proprio ambito di indagine, la dimensione storica della lingua,
con l’obiettivo di far emergere come si sia storicamente giunti a un dato
concetto nel suo senso moderno, quali avventure storiche abbiano
attraversato le singole parole di cui si serve la politica non meno della
sociologia, la filosofia non meno della storia. Scrive Koselleck nella
Einleitung al Lexikon: «la somma delle concrete analisi dei concetti si
trasforma da un inventario storico in storia concettuale tramite il principio
diacronico (das diachronische Prinzip)»34. E ancora: «solo una prospettica
articolazione diacronica del concetto permette di conoscere trasformazioni
strutturali di lungo periodo”»35, che sfuggirebbero se ci si limitasse a uno
studio sincronico.
Per quel che riguarda il secondo aspetto dell’analisi begriffsgeschichtlich
di Koselleck che ho proposto di individuare come punto di riferimento per
una storia critica delle idee, esso riguarda, come si è detto, l’originale
modo di concepire il rapporto tra i concetti, le idee e, più in generale, la
dimensione simbolica, da una parte, e le concrete configurazioni storiche,
sociali e politiche, dall’altra. L’interesse della Begriffsgeschichte non coincide
33
Si veda soprattutto R. KOSELLECK, Über die Theoriebedürftigkeit der
Geschichtswissenschaft (1972), in Id., Zeitschichten. Studien zur Historik, cit., p. 302.
Si veda inoltre E.J. Palti, “Koselleck y la idea de Sattelzeit. Un debate sobre
modernidad y temporalidad”, in Revista de Historia Contempóranea, n. 53 (2004),
pp. 63-74.
34
R. KOSELLECK, “Einleitung” (1967), in ID., O. BRUNNER, W. CONZE,
Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, cit., I, p. XXI.
35
R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 1979;
tr. it. a cura di A.M. Solmi, Futuro passato: per una semantica dei tempi storici,
Marietti, Genova 1986, p. 99 (esiste anche una recente riedizione del testo per i
tipi della Clueb, Bologna 2007).
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
383
mai con lo spazio operativo di una mera ricostruzione linguistica, né con
una storia delle idee disincarnata dal concreto quadro storico o – come
invece accade con alcune esperienze dell’intellectual history36 – tale da
considerare la dimensione simbolica come una costante che si mantiene
sempre identica nonostante la storia. Al contrario, come precisa la
Einleitung al Lexikon, «il nostro baricentro rimane nell’area della struttura
storica sociale»37, e sarebbe pertanto fuorviante cercarlo nell’area della
«moderna scienza del linguaggio»38 nelle sue molteplici declinazioni.
Il concetto – e, per estensione, la dimensione simbolica – non viene
concepito come un inerte rispecchiamento della realtà socio-politica, né
come una produzione dello spirito indipendente dal concreto mondo
storico, ma, al contrario, è inteso come una forza, come un’intensità
espressiva, come un’energia pratica che pone in essere una relazione
biunivoca tra piano storico concreto e piano simbolico, secondo un nesso
sinergico per cui ciascuno dei due è determinato dall’altro e, insieme, lo
determina39. Per la Begriffsgeschichte di marca koselleckiana, i concetti non
36
Paradigmatica resta, in questo senso, l’esperienza della storia intellettuale di
Arthur Lovejoy: cfr. soprattutto A. LOVEJOY, The Great Chain of Being. A Study of
the History of an Idea, 1936; tr. it. a cura di A. Formigari, La grande catena
dell’essere, Feltrinelli, Milano 1966. Cfr. anche ID., Essays in the History of Ideas,
1948; tr. it. a cura di D.V. Pardini, L’albero della conoscenza. Saggi di storia delle
idee, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 29-41. Nella prospettiva di Lovejoy, il
procedimento della storia delle idee potrebbe dirsi «in qualche modo analogo a
quello della chimica analitica [...]. Essa seziona i monolitici sistemi individuali e li
risolve [...] nei loro elementi compositivi, fino a quelle che si potrebbero
chiamare le loro idee-unità”» (ID., La grande catena dell’essere, cit., pp. 11-12). Tali
idee-unità sarebbero in numero relativamente limitato (la varietà dei sistemi e
delle dottrine dipende piuttosto dai differenti modi di combinarle) ed è «ai
comuni ingredienti logici o pseudo-logici o affettivi che si celano sotto le
differenze superficiali che lo storico delle singole idee deve cercare di arrivare»
(ivi, p.12). Cfr. F. CRISPINI, “L’esperienza “temporalizzata” della “storia delle
idee”, epistemologia e storiografia in Arthur O. Lovejoy», Atti dell’Accademia di
scienze morali e politiche, Officine grafiche, Napoli 1984.
37
R. KOSELLECK, “Einleitung” (1967), in ID., O. BRUNNER, W. CONZE,
Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, cit., I, p. XXI.
38
Ibid.
39
«La politica è mediazione, ovvero concetto, nel senso tecnico di ‘oggetto
categorizzato’: che la politica non sia nulla di più immediato, di più ‘semplice’ o
384
Diego Fusaro
sono mai mere cristallizzazioni passive delle vicende storiche: la
convergenza tra concetto e storia tematizzata dalla Begriffsgeschichte deve
piuttosto essere interpretata come una “tensione”40 (Spannung) in atto, e
non certo come “identità di concetto e storia”41 (Identität von Begriff und
Geschichte), nel senso di una conciliazione già avvenuta e tale da dover
essere semplicemente registrata.
Tra i due poli del linguaggio e della storia sussiste sempre una tensione
irrisolta: tra i concetti e la storia non si dà mai piena corrispondenza, né
nel senso marxista, secondo cui i concetti sono storia che si fa pensiero
(l’essere che determina la coscienza), né in quello gadameriano42, in
anteriore ai concetti, significa che ‘politica’ è in realtà un linguaggio, un’intensità
espressiva, un orizzonte di senso, un ‘livello energetico’ nel quale non si
incontrano ‘cose’, ma appunto concetti […], e che lo ‘strumento’ adeguato per
interpretarla è la storia dei concetti»: C. GALLI, “Politica: un’ipotesi di
interpretazione”, in Filosofia politica, n. 3 (1989), pp. 23-24.
40
R. KOSELLECK, “Einleitung” (1967), in ID. – O. BRUNNER – W. CONZE,
Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, cit., I, p. XXIII.
41
Ibidem.
42
In particolare, è come se Koselleck radicalizzasse le posizioni gadameriane
fino a renderle caricaturali, sostenendo che per Gadamer sussisterebbe una sorta
di identità tra linguaggio e realtà tale per cui la seconda si risolverebbe
interamente nel primo, e al di fuori del linguaggio non esisterebbe alcunché. È
vero che in Verità e metodo sono presenti argomenti che sembrerebbero suffragare
questa posizione, come ad esempio quando Gadamer fa riferimento a una
«struttura ontologica fondamentale per la quale l’essere è linguaggio, cioè
autorappresentazione, struttura che ci si è rivelata in base all’esperienza ermeneutica
dell’essere» (H.-G. GADAMER, Wahrheit und Methode, 1960; tr. it. a cura di G.
Vattimo, Verità e metodo, Bompiani, Milano 20018, p. 554), ma accanto a questi
passaggi ve ne sono molti altri in cui egli chiarisce come l’esperienza ermeneutica
della verità si dia nel linguaggio, senza che questo implichi che l’essere sia, toutcourt, linguaggio. Da questo punto di vista, si potrebbe sostenere che la posizione
di Gadamer è di marca ermeneutica più che ontologica: il linguaggio è il luogo nel
quale l’uomo si rapporta con i significati del mondo, il luogo entro il quale
l’esperienza della comprensione e dell’eventuale verità può giocare ed essere
portata alla luce. L’ermeneutica di Gadamer si configura, sotto questo profilo,
come comprensione che si produce per mezzo del linguaggio, e per questo motivo
il linguaggio diviene un elemento avvolgente che si identifica con la comprensione
e la vita stessa degli uomini, i quali vivono come uomini solamente perché sono
immersi in quel linguaggio. Per un’interpretazione del problema del nesso
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
385
accordo con il quale il linguaggio determina la realtà. A giusta distanza dai
due poli della riduzione del concetto a emanazione sovrastrutturale e della
realtà a determinazione del concetto, la Begriffsgeschichte sceglia una via
mediana: equidistante da entrambi i poli, essa si propone di farli entrare in
una feconda relazione biunivoca, mantenendo la dimensione linguistica e
quella storica in un rapporto tensionale insopprimibile. Secondo quanto
chiarito in Vergangene Zukunft:
Il metodo della storia concettuale spezza l’ingenuo circolo vizioso
che va dalla parola alla cosa, e viceversa. Sarebbe un cortocircuito
teoricamente irrimediabile intendere la storia solo a partire dai suoi
propri concetti, per esempio come identità tra lo spirito del tempo
linguisticamente articolato e i complessi di eventi. Invece esiste per
l’appunto una tensione (Spannung) tra il concetto e lo stato di fatto,
tensione che ora è soppressa (aufgehoben), ora ricompare (wieder
aufbricht), ora sembra insuperabile (unlösbar). Si può continuare a
constatare uno iato fra le situazioni sociali e l’uso linguistico che si
propone di esprimere o che le supera. Cambiamento del significato
della parola e cambiamento della cosa, mutamento di situazione e
necessità di nuove denominazioni si corrispondono in modi ogni
volta diversi43.
In una simile prospettiva, il compito della Begriffsgeschichte viene a
coincidere con una delicata operazione di comprensione del modo in cui la
storia si cristallizza nei concetti e, insieme, del modo in cui i concetti agiscono
sulla storia44. Ed è per rendere conto di questa strutturale ambiguità che
Koselleck codifica la duplice funzione dei “concetti storici fondamentali”
(geschichtliche Grundbegriffe): ciascun concetto storico, da un lato, si
configura come un “indicatore” (Indikator) che registra e riflette sul piano
linguaggio-essere in Gadamer, cfr. R. RORTY, La filosofia di Gadamer. “L’essere che
può venir compreso è il linguaggio”, in “Iride”, n. 2 (2000), pp. 313-322; D. DI
CESARE (a cura di), L’essere, che può essere compreso, è linguaggio. Omaggio a HansGeorg Gadamer, Il Melangolo, Genova 2001; G. MARTINI, La sfida
dell’irrappresentabile, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 77 ss.
43
R. KOSELLECK, Futuro passato, cit., p. 103.
44
Cfr. C. DIPPER, Die “Geschichtlichen Grundbegriffe”. Von der Begriffsgeschichte zur
Theorie der historischen Zeiten, in “Historische Zeitschrift”, n. 270 (2001), p. 281.
Cfr. inoltre M. RICHTER, Understanding Begriffsgeschichte. A Rejoinder, in “Political
Theory”, n. 17 (1989), pp. 296-301.
386
Diego Fusaro
delle idee il mutamento storico a cui va incontro la realtà; dall’altro, si
presenta come “fattore” (Faktor) del mutamento storico, ossia come
potenza attiva e, almeno in parte, autonoma in grado di orientare l’agire
degli uomini, sospingendone le azioni in vista di determinati fini. Come
sottolinea Koselleck, «un concetto non è solo un indicatore dei complessi
di relazioni che comprende: è anche un loro fattore. Con ogni concetto
vengono posti determinati orizzonti, ma anche i limiti di un’esperienza
possibile e di una teoria pensabile»45.
Rivelando un’incidenza profonda della linguistic turn e
dell’urbanizzazione heideggeriana operata da Gadamer, Koselleck
attribuisce al linguaggio un ruolo che non sarebbe eccessivo definire
“demiurgico” e che, in ogni caso, non va a contraddire il nesso biunivoco
tra realtà e concetti: «le parole possono guidare le forme del
comportamento e provocare gli eventi, ma sono anche condizionate da
interessi e sono dipendenti dagli attori politici e dalle parti politiche.
Parole e fatti agiscono le une sugli altri, e viceversa, e si stimolano a
vicenda»46. E questa interazione non si risolve mai – né sul piano storico,
né su quello della singola esperienza concreta – in un’egemonia di uno dei
due poli. Scrive Koselleck:
Ogni linguaggio ha sempre una duplice funzione: da un lato, esso
registra passivamente ciò che accade all’esterno, e fissa ciò che gli
si impone senza essere a sua volta linguaggio – il mondo, quindi,
come si dà dal punto di vista pre-linguistico e non-linguistico.
Dall’altro lato, il linguaggio modifica attivamente tutti gli stati di
cose e i dati di fatto extralinguistici. Ciò che è extralinguistico e
deve essere saputo, conosciuto e capito, deve essere
concettualizzato47.
Tra i fatti storici e gli uomini che li compiono si frappone sempre il
medium del linguaggio. La realtà non si lascia mai del tutto
“concettualizzare” e i concetti, dal canto loro, non si esauriscono mai
45
R. KOSELLECK, Futuro passato, cit., p. 102.
ID., “Die Geschichte der Begriffe und Begriffe der Geschichte”, 1979; tr. it.
a cura di L. Fonnesu, “Storia dei concetti e concetti della storia”, in Contemporanea,
n. 1 (1998), p. 11. Su questi punti, cfr. B. MAY, “Koselleck. Tempo storico e
memoria linguistica”, in Il Mulino, n. 2 (1987), pp. 328-333.
47
R. KOSELLECK, Storia dei concetti e concetti della storia, cit., p. 13.
46
L’importanza di Reinhart Koselleck per una storia critica delle idee
387
completamente nella realtà: in certi casi, la prima racchiude più di quanto
sia contenuto nei secondi; e in altri casi, al contrario, vi è maggiore
ricchezza nei secondi. In una simile prospettiva, si può ragionevolmente
sostenere che i concetti e la realtà storica si intrecciano in uno spazio a
geometrie variabili: la loro relazione “elastica” fa sì che tra loro non vi sia
mai piena corrispondenza. Scrive Koselleck: «La storia è sempre di più o di
meno rispetto a ciò che si può concettualmente dire su di essa – proprio
come il linguaggio rende sempre di più o di meno rispetto a quanto sia
contenuto nella storia reale»48.
Secondo questo intreccio a geometrie variabili tra il ruolo di indicatori
e quello di fattori proprio dei concetti, la storia determina la sfera
concettuale e, insieme, i concetti determinano la trama storica, in un nesso
aperto tra le due dimensioni che spetta allo storico indagare di volta in
volta, senza mai far valere la pretesa riduzionistica di annullare o anche
solo di marginalizzare una delle due valenze a favore dell’altra.
Sarebbe eccessivo liquidare il problema, come pure è stato fatto, nei
termini di un’“indecisione teorica di fondo”49: Koselleck opta
consapevolmente per questa soluzione, e dunque la tensione irrisolta tra
concetti e realtà storica è tutto fuorché il frutto di un’indecisione teorica.
Essa risponde, piuttosto, alla volontà di sottrarsi all’unilaterale riduzione
dei concetti a emanazioni del reale o, in modo opposto, di concepire il
reale come prodotto dei concetti. Ed è proprio in questa feconda ambiguità
che può indubbiamente essere ravvisato uno dei più originali contributi del
Begriffshistoriker tedesco per una storia critica delle idee così come ho
cursoriamente provato a delinearla per tratti generalissimi: nella riflessione
koselleckiana, come si è visto, accanto all’attenzione per le discontinuità
storiche, troviamo quella tematizzazione del nesso tra piano sincronico e
piano diacronico e della relazione biunivoca tra concetti e realtà che, lungi
dall’essere un fondamentale strumento metodologico per i soli storici o
per i soli studiosi della storia delle dottrine politiche, potrebbe costituire
un’imprescindibile piattaforma teorica per gli storici della filosofia e, più in
generale, per gli storici delle idee.
48
ID., “Stichwort: Begriffsgeschichte” (2002), in ID., Begriffsgeschichten, cit., p.
102.
49
N. AUCIELLO, Vortici e forze (storiografia e riflessione), in ID., R. RACINARO (a
cura di), Storia dei concetti e semantica storica, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma
1990, p. 34.
388
Diego Fusaro
Abstract
This article aims to underline the philosophical and methodological
originality of Reinhart Koselleck’s theory. According to his philosophy of
history, history emerges only when temporalization becomes part of the
experience of the world, thereby causing a shift in men’s horizon of
expectation in relation to the space of experience such that they no longer
coincide. Political concepts become historicized as indicators of change.
The article reflects also on the concept of “new time” (neue Zeit) in
Koselleck’s work and on its relationship to the historical concept of “the
modern age” or “modernity” (Neuzeit).
SAVERIO A. MATRANGOLO
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
Per una fenomenologia del sacrificio
Il tentativo di percorrere un sentiero filosofico impervio che proponga
l’inconsueto accostamento fra ambiti concettuali dissonanti come
“fenomenologia” e “sacrificio”, presuppone un chiarimento preliminare
circa il senso di questa giustapposizione. L’orizzonte entro cui trova
riscontro siffatta intenzione teorica sarà qui rintracciato nel percorso
conoscitivo del filosofo ceco Jan Patočka all’interno della tradizione
fenomenologica1. Le motivazioni del taglio teoretico utilizzato verranno
difatti esplicitandosi attraverso l’incursione nelle riflessioni patočkiane sulla
categoria di “mondo naturale”, che riprende l’idea di “mondo-della-vita”
(Lebenswelt) della intensa, seppur tarda, riflessione husserliana, e sul senso
storico-genetico del metodo fenomenologico, tematica che, viceversa,
poco spazio ha trovato nella tradizione fenomenologica già a partire dal suo
capostipite, ma i cui germi è possibile rinvenire attraverso uno scavo nella
filosofia heideggeriana del periodo di Sein und Zeit2.
L’intera opera di Patočka reinterroga di continuo la tensione
problematica fra mondo e storicità nel tentativo di offrire una rilettura
feconda e originale del metodo fenomenologico che allo stesso tempo ne
riscopra le intenzioni originarie dissolte, a volte, nei tecnicismi e negli
scadimenti teoreticizzanti che, a partire da alcune zone concettuali marcate
dallo stesso Husserl, ne hanno disinnescato la carica conoscitiva e il
carattere costitutivo più autentico. E proprio a partire dal corto circuito fra
mondo e storicità, la lettura patočkiana istituisce quel doppio confronto
1 Sembra ormai acquisita nel dibattito filosofico odierno la specificità della posizione di
Patočka nel contesto della tradizione fenomenologica, sia in riferimento alla proposta
originale da cui essa pende avvio con Edmund Husserl, ma anche rispetto a quella variante
interpretativa suggestiva che ne ha offerto Martin Heidegger.
2 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Halle 1927; trad. it. di A. Marini, Essere e
tempo, Mondadori, Milano 2006.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 389-412
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064326
389
390
Saverio A. Matrangolo
con Husserl e Heidegger aprendo a un dialogo e a una mediazione mai
avvenuti a causa dell’irrigidimento reciproco sulle rispettive posizioni che
ha di fatto precluso la possibilità di un incontro su uno sfondo teorico più
comprensivo entro il quale la radicalizzazione dei rispettivi presupposti
speculativi avrebbe dovuto inevitabilmente condurre, in una variante
inesplorata del metodo fenomenologico le cui potenzialità sono da
scorgere in una nuova apertura di questo orizzonte di pensiero al senso
della storicità autentica del mondo e dell’esistenza come “essere-nelmondo”. Il pensiero del filosofo ceco muoverà successivamente sempre più
verso una storicità radicale che traspare da ultimo nel sacrificio. In ciò che,
oltre ad individuare un ambito di indagine storico-antropologica, racconta
anche l’esperienza testimoniale che investe la sua stessa vicenda personale3.
1.
La concezione naturale di mondo come problema fenomenologico
Nel febbraio del 1929 il giovane studioso Jan Patočka, recatosi a Parigi
nell’ambito del percorso formativo che da dottorando di ricerca gli
consente di trascorrere un anno nella città francese, incontra per la prima
volta Edmund Husserl. L’incontro è occasionato dall’invito, da parte di
Alexandre Koyré al “padre della fenomenologia”, a leggere i Discorsi
Parigini, che costituiranno la cellula originaria a fianco della quale Husserl
pubblicherà quel testo fondamentale che sono le Meditazioni Cartesiane4.
Il valore più che altro simbolico della vicenda racconta comunque un
momento decisivo della biografia del filosofo ceco che, proprio a partire da
quell’incontro, riconoscerà nelle profonde questioni poste dal metodo
fenomenologico la propria missione teorica, al punto che già la sua tesi di
dottorato sarà dedicata a un tema di sicura ascendenza husserliana quale Il
concetto di evidenza e il suo significato per l’epistemologia. Successivamente, nel
3 Il termine sacrificio si riferisce innanzitutto alla fase tarda dell’opera di Patočka
nonché al suo impegno etico-politico nei confronti della situazione storica contingente che
dal fallimento della “Primavera di Praga”, passando attraverso il periodo di
“normalizzazione”, che significa anche censura e marginalizzazione subite in prima persona
dal filosofo ceco, conduce infine all’esperienza di “Charta 77” e al conseguente
“interrogatorio” che ne provoca la morte nel 1977.
4 E. HUSSERL, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Husserliana, I, S. Strasser
(a cura), Nijhoff, Den Haag 1950; trad. it. di F. Costa, Meditazioni cartesiane e i Discorsi
Parigini, Bompiani, Milano 2002. Sulle notizie concernenti la biografia di Patočka si è fatto
riferimento a E. KOHÁK, Jan Patočka. Philosophy and selected writings, The University of
Chicago Press, Chicago 1989.
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
391
1933, Patočka si recherà a Friburgo dove avrà modo di incontrare
assiduamente Husserl e di conoscere i suo assistente privato Eugen Fink, il
quale avrà non poca parte nel suo cammino di pensiero, introducendolo
innanzitutto a quella torsione ermeneutica della fenomenologia che stava
prendendo piede sulle orme dell’ormai “ex allievo” Heidegger. La
stimolante frequentazione di siffatto ambiente culturale costituisce
l’occasione da cui prende avvio la gestazione della tesi di abilitazione con
cui Patočka si presenterà ufficialmente al panorama filosofico dell’epoca, Il
mondo naturale come problema filosofico, pubblicata nel 19365. In questo testo,
seppur fedele alla lezione husserliana e ai presupposti di base che
costituiscono l’“ortodossia” del metodo fenomenologico, è già possibile
intravedere lo stigma dei primi tentativi di ripensamento di suddette
strutture, seppur nei limiti di una riflessione che sembra ancora esigere da
se stessa chiarimenti decisivi. Ma aldilà della piena o meno conformità del
testo alla proposta husserliana convenzionale, ciò che è da sottolineare è
l’orizzonte preliminare che fa da sfondo al momento concettuale decisivo
da cui si diparte l’intera riflessione patočkiana. Stiamo parlando di uno di
quei problemi fondamentali della fenomenologia che Husserl rimarca spesso
sebbene quasi mai in modo sistematico nel corso della sua produzione
filosofica, ma che nondimeno rimane uno snodo teorico centrale intorno al
quale si raccoglie il dibattito fenomenologico successivo: la concezione
naturale di mondo.
Ora, non è limitatamente a questa opera d’esordio che Patočka
circoscrive lo spazio per comprendere la portata della questione per la
fenomenologia, ma è tutta la sua produzione a recare il marchio distintivo
del concetto naturale di mondo. Fino a qualche tempo fa si era soliti
anteporre, nel suo cammino di pensiero, una prima fase “fenomenologica”,
di cui l’opera d’esordio costituiva in qualche modo il manifesto, a una
successiva fase “storica”, coincidente con un nuovo interesse di tipo etico e
con le conseguenti riflessioni sulla politica. Questo tipo di lettura è ormai
superato, e la questione del “mondo naturale” costituisce da questo punto
di vista una delle conferme più lampanti della continuità fra impianto
teoretico e riflessione storico-politica nel filosofo ceco. Ad ogni passo,
difatti, è possibile riscontrare la presenza e la portata teorica di questo
ambito concettuale decisivo in cui si gioca proprio il nesso, mai districato
esplicitamente da Husserl, fra fenomenologia e storicità.
5 J. PATOČKA, Přirozený svet jaco filosoficky problem, Praha 1936, trad. fr. di J. DANEK –
H. DECLEVE, Le monde naturel comme problème philosophique, Nijhoff, Den Haag 1976.
392
Saverio A. Matrangolo
Non sarà poi così sorprendente, allora, scorrendo i Saggi eretici sulla
filosofia della storia6, l’opera più matura e rappresentativa del filosofo ceco
dedicata a questioni più vicine al versante storico ed etico-politico del suo
cammino di pensiero, scoprire che anche nell’incipit di questo testo
fondamentale è possibile riscontrare un esplicito riferimento al «problema
di una “concezione naturale del mondo” […] sollevato dal filosofo
positivista Richard Avenarius»7, attraverso il quale lo stesso Patočka, sulla
scia di Husserl, risale a siffatto luogo speculativo. Si dovrà allora valutare
innanzitutto la portata della questione per coglierne l’incidenza sul metodo
fenomenologico e tentare di comprenderne alcune strutture decisive che,
da un certo momento in poi, ne hanno ridefinito l’impianto conoscitivo.
Negli stessi anni in cui Patočka pubblica la sua opera d’esordio, Husserl
discuterà a Vienna e a Praga, alla presenza dello stesso giovane “allievo”
ceco, i temi fondamentali che andranno a comporre i paragrafi della sua
ultima opera su La crisi delle scienze europee8. Nelle intenzioni dell’autore
questa opera era da intendersi come una ulteriore introduzione alla
filosofia fenomenologica e come l’ultima grande occasione di esplicitare il
senso di una fenomenologia trascendentale. Ma la Crisi costituisce anche uno
dei pochi testi husserliani in cui il tema della storia gioca un ruolo decisivo.
Nondimeno, il quadro teorico che sottende alla stesura di questo testo fa
innanzitutto riferimento, com’è noto, alla questione della nascita della
“moderna scienza della natura”, all’esigenza di un ripensamento dei suoi
presupposti epistemologici e alla meditazione sul senso della scientificità in
generale. Elemento, quest’ultimo, che sottolinea l’istanza, mai rinnegata e
sempre viva sullo sfondo della riflessione husserliana, di una filosofia come
scienza rigorosa9. Si tratta di un’esigenza teorica che si manifesta
innanzitutto a partire dall’ideale di universalità che pure costituisce lo
specifico di un cambiamento di paradigma epistemologico decisivo che
avviene proprio a partire dall’epoca moderna, allorché si assegna
all’umanità quel compito infinito di ricerca di un fondamento assoluto. Ma
6 ID., Kacířské eseie o filosopii dĕjin, Praha 1975; trad. it. di D. Stimilli, Saggi eretici sulla
filosofia della storia, M. Carbone (a cura), Einaudi, Torino 2008.
7 Ivi, p. 3.
8 E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften un die transzendentale
Phänomenologie, Husserliana, VI, W. Biemel (a cura), Nijhoff, Den Haag 1959; trad. it. di
E. FILIPPINI, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano
2008.
9 ID., La filosofia come scienza rigorosa, trad. it. di C. Sinigaglia, Laterza, Roma-Bari
2005.
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
393
perché, allora, si parla di crisi? La tradizione scientifica e filosofica, da
Cartesio in poi, aspirerà all’ideale di una conoscenza “chiara e distinta”
sulla cui onda proficua si realizzeranno mirabili successi e scoperte nel
campo delle scienze “esatte”. Ma in questo contesto si assisterà anche alla
progressiva scissione di filosofia e scienza e alla conseguente dicotomia fra
soggetto e oggetto. Dal momento che «la crisi di una scienza comporta
nientemeno che la sua peculiare scientificità, il modo in cui si è proposta i
suoi compiti e perciò in cui ha elaborato la propria metodica, siano
diventati dubbi»10, la questione sarà allora quella di comprendere in che
senso l’ideale di scientificità inaugurato in epoca moderna è divenuto
dubbio. Tale motivo richiama il cosiddetto problema dell’oggettivazione.
Nei primi passi del testo Husserl critica le tendenze, di stampo
positivistico, di riduzione della scienza a fattualità obiettivamente
constatabile. Oggettivazione significa innanzitutto fare astrazione da
qualsiasi elemento soggettivo e considerare la scienza come mera scienza di
fatti da cui gli interrogativi specificamente umani sono stati completamente
espunti11. In secondo luogo significa attribuire al mondo intuitivo,
all’ambito della natura, il carattere di universo di meri fatti legati assieme da
relazioni di tipo causale e spiegabili da una razionalità depurata da ogni
sostrato “metafisico”, senza più alcun legame, dunque, con quella “filosofia
prima” da cui originariamente proveniva ogni forma di teoresi e che ora
invece travalica il senso della missione conoscitiva inesauribile che le scienze
rivendicano unicamente per sé. Così, «si incomincia ad intravedere una
scienza universale infinita: l’infinito appare razionale e quindi dominabile
attraverso una idealizzazione preliminare […] a priori»12. Idealizzazione
preliminare, indagine conoscitiva aprioristica per cui la verità consiste nella
sua oggettivazione e investe innanzitutto le possibilità intrinseche a una
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, cit., p. 33.
Cfr. Ivi, p. 35 e ss. È proprio in queste pagine che Husserl riporta la famosa
affermazione secondo cui «le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto» (ivi, p. 35).
Su tali questioni si veda anche ciò che scrive Enzo Paci, uno dei primi interpreti della Crisi
nel panorama filosofico italiano, in Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Il Saggiatore,
Milano 1964, pp. 19-23. Riportiamo di seguito un breve passo che sintetizza tutta la
questione nei termini in cui viene posta da Husserl: «La crisi delle scienze è dovuta alla
rinuncia, da parte delle scienze stesse, alla propria scientificità intesa come orizzonte della
vita, come senso e scopo della vita. Vero non è soltanto il fattuale, obiettivamente
constatabile: vera è l’idea della razionalità di cui vive ogni scienza e che dà un senso alla
vita» (ivi, p. 20).
12 Ivi, p. 26.
10
11
394
Saverio A. Matrangolo
disciplina fondamentale come la matematica, nella quale si esaurisce il
senso della forma empirica di quell’ambito di ovvietà costituito dalla natura.
È questo il senso del progetto galileiano: una scienza matematica della
natura, una indagine condotta more geometrico per cui la natura perde ogni
vitalità intrinseca e si pone come semplice oggetto (ob-iectum) di
osservazione e misurazione13.
L’origine di questa idealizzazione rimane nondimeno oscura, e il senso
della matematizzazione dei plena, da cui muove la nuova concezione
meccanicistica della natura, diventa quello di un movimento che conduce
dalla misurazione all’idealizzazione, conformandosi sempre più alla forma
conoscitiva di una tecnica. Si perde ogni riferimento al mondo
dell’esperienza (Erfharungwelt) e al “mondo-della-vita” (Lebenswelt), a quella
dimensione pre-scientifica costituita dall’evidenza intuitiva della natura da
cui in realtà ogni esercizio tecnico di misurazione, e relativa idealizzazione,
ha origine. Vi è cioè uno strato empirico originario sul fondamento del quale
vengono a costituirsi le sustruzioni logico-matematiche14 e le leggi universali
che pretendono di spiegare tutto. Questo strato preliminare è costituito
proprio dal mondo dell’esperienza in generale, da una concezione naturale di
mondo che Husserl caratterizza come sfera pre-teoretica e pre-scientifica. Si
è visto d’altronde come la questione venga introdotta già nell’ambito del
positivismo logico da Avenarius, capostipite della corrente filosofica di fine
‘800 nota come Empiriocriticismo e autore del testo intitolato
inequivocabilmente Il concetto umano di mondo15. Husserl d’altronde riflette
sulla concezione naturale di mondo e sullo stesso pensiero di Avenarius già
a partire dai primi anni del ‘900, in particolare nel contesto di un corso
universitario tenuto nel 1910 a Gottinga su I problemi fondamentali della
fenomenologia16. In questo testo la categoria di mondo individua l’ambito
preliminare in cui si raccolgono i vissuti a partire da cui si costituisce la
soggettività. Il problema riguarda cioè il darsi del mondo nell’atteggiamento
13 Cfr. il fondamentale § 9 della Crisi, dedicato a “La matematizzazione galileiana della
natura”, in cui Husserl offre una ricostruzione storica dettagliata delle questioni
epistemologiche cui si sta facendo riferimento.
14 Cfr. E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, cit., pp. 61 e ss.
15 R. AVENARIUS, Der menschliche Weltbegriff, Reisland, Leipzig 1891.
16 E. HUSSERL, I problemi fondamentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di
mondo. Da quanto scrive il curatore dell’edizione italiana di queste lezioni, sembra che
Husserl lesse il testo di Avenarius sul “concetto umano” di mondo nel 1902 e vi meditò
sopra a lungo (cfr. V. COSTA, Il concetto naturale di mondo e la fenomenologia, introduzione a
E. HUSSERL, I problemi fondamentali della fenomenologia, cit., p. XXVIII).
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
395
naturale e il suo modo di costituirsi nella coscienza; questioni
evidentemente decisive nell’ambito della riflessione husserliana che
rimandano da ultimo al momento della riduzione fenomenologica su cui si
concentrerà anche Patočka. Ma bisognerà dapprima entrare nel merito
della proposta empirio-critica, in cui sia Husserl che Patočka riconoscono il
luogo di una prima e autorevole formulazione del problema.
Nella speculazione di Avenarius è possibile riscontrare la stessa esigenza
husserliana di garantire uno statuto epistemologico e un rigore scientifico
indubitabile alla riflessione filosofica. Ciò è possibile attraverso una critica
dell’esperienza pura, questo l’impegno teorico e anche il titolo dell’opera più
importante di Avenarius17 in cui si condensa il senso dell’originalità del
modello empirio-critico e la sua irriducibilità alle strutture obsolete del
positivismo classico. Il problema è quello di ridefinire il rapporto tra uomo
e mondo non più come realtà disgiunte, ma come poli di una medesima
esperienza: come anche successivamente in Husserl, la questione investe
direttamente la relazione tra fattore fisico e fattore psichico all’interno
dell’esperire. L’esperienza pura non è un analogo dell’apriori kantiano, ma
emerge proprio nel ripensamento del concetto di mondo depurato dalle
attribuzioni categoriali e dai valori che nel corso della storia del pensiero
gli sono stati conferiti dalle diverse teorie scientifiche e filosofiche, da
quelli che egli chiama i prodotti storici della introiezione. Il concetto umano
di mondo risulterà, dunque, caratterizzato storicamente, ma potrà
assumere un valore assoluto allorché rinvierà al punto di partenza naturale
da cui è possibile ricavare l’esperienza immediata del darsi delle cose stesse
prescindendo da mediazioni teoriche, sistemi di pensiero o attribuzioni
“metafisiche” di qualsiasi tipo18. È questo il senso del primo dei due assiomi
fondamentali del metodo empirio-critico: «ogni individuo umano assume
originariamente di fronte a sé un ambiente con molteplici costituenti;
17 R. AVENARIUS, Kritik der reinen Erfharung, Reisland, Leipzig 1890; trad. it. di A.
Verdino, Critica dell’esperienza pura, Laterza, Bari 1972.
18 A. Verdino, nella sua “Introduzione”, riporta la traduzione di alcuni brevi passi
presenti a p. XXIV del Vorwort originale della Critica che non compaiono, viceversa, nella
traduzione parziale dell’edizione italiana. Li riportiamo di seguito, insieme al commento
dello stesso curatore dell’edizione italiana, per l’evidente interesse che rivestono in
riferimento alla proposta di Husserl e soprattutto per l’assonanza che mostrano con il
motto fondamentale della fenomenologia: «Avenarius, dopo aver detto che ha cercato di
“far parlare solo le cose stesse” fa una precisazione di capitale importanza ai fini
dell’interpretazione globale delle sue concezioni: “e per cose qui intendo anche le
concezioni del mondo e le teorie della conoscenza degli uomini”» (ivi, p. XXIII).
396
Saverio A. Matrangolo
assume altri individui umani con molteplici asserti; e assume che ciò che
viene asserito è in qualche modo dipendente dall’ambiente. Tutti i
contenuti di conoscenza delle Weltanschauungen filosofiche […] sono
modificazioni (Abänderungen) di quell’assunzione originaria»19. Questo
ambiente originario è proprio il mondo umano, il mondo-della-vita, il
piano preliminare dell’esperienza da cui anche le scienze esatte traggono
contenuto e forma, come conseguentemente recita il secondo degli
assiomi: «la conoscenza scientifica non ha forme o metodi essenzialmente
diverse dalle forme e dai metodi della conoscenza non scientifica: tutte le
forme e tutti i metodi della conoscenza scientifica sono sviluppi
(Ausbildungen) delle forme e dei metodi della conoscenza prescientifica»20.
Il compito della critica dell’esperienza pura sarà dunque quello di
rinvenire, al di sotto delle stratificazioni e delle aggiunte che storicamente
hanno modificato l’assunzione originaria pre-scientifica, un nucleo
essenziale, un fondo comune agli individui nel tempo e nello spazio, una
concezione universale e assoluta di mondo che Avenarius chiamerà proprio
il concetto naturale di mondo21. Lo stesso Husserl, si è visto, individua uno
strato dell’esperienza dato prima di ogni possibile teorizzazione o di
qualsivoglia pratica scientifica di oggettivazione che stravolga il senso di un
sapere ormai disgiunto dal polo soggettivo, bandendo l’elemento
propriamente umano dalle prerogative scientifiche di una conoscenza in
grado di cogliere il “mondo vero”. Sin dalle lezioni del 1910, nondimeno,
per Husserl «la scienza della natura [è sempre] la scienza sorta sulla base
del concetto naturale di mondo»22. La pretesa della scienza di cogliere il
mondo vero, cioè, può essere accolta unicamente se essa resta fedele
all’orizzonte naturale preliminare da cui proviene.
Sono motivi evidentemente decisivi per comprendere il tentativo di
riorientare la fenomenologia da cui muove la riflessione di Patočka già a
partire da Il mondo naturale come problema filosofico. I luoghi finora
attraversati, d’altronde, diventano chiarificanti rispetto a diversi aspetti
ambigui per cui si caratterizza l’opera husserliana relativamente, ad
esempio, alla forma dell’“idealismo trascendentale” per cui si è potuto
parlare di “atteggiamento teoreticizzante” e solipsismo in cui scadrebbe la
R. AVENARIUS, Critica dell’esperienza pura, cit., p. 3.
Ivi, p. 4.
21 Cfr. R. AVENARIUS, Das Menschliche Weltbegriff, cit.; A. VERDINO, “Introduzione”,
cit., p. XVII-XVIII.
22 E. HUSSERL, I problemi fondamentali della fenomenologia, cit., p. 28.
19
20
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
397
proposta fenomenologica originaria. Le lezioni sul concetto naturale di
mondo sembrano offrire, viceversa, «un modello per molti versi
alternativo a quello che si era imposto in Idee I, una via diversa da quella
cartesiana […] poiché in queste lezioni la riduzione fenomenologica e il
senso stesso della ricerca fenomenologica in quanto tale emergono più
limpidamente, evitando, sin dall’inizio, quell’equivoco che indurrà molti
pensare alla fenomenologia come a una sorta di solipsismo
trascendentale»23. Sebbene nella sua opera d’esordio Patočka riprenda il
concetto husserliano di “mondo-della-vita” così come viene presentato nel
contesto delle analisi della Crisi, egli ne ridefinisce il campo semantico
riportandolo all’originaria caratterizzazione che ne aveva dato Avenarius
ma anche, inizialmente, lo stesso Husserl. Patočka, difatti, parla
propriamente di “mondo naturale” quale ambito da riguadagnare attraverso
una analisi fenomenologico-trascendentale che restituisca all’uomo una
concezione unitaria del mondo24. È questa la difficoltà presentata, ma in
definitiva non risolta, dal positivismo contemporaneo: l’uomo moderno
vive un mondo duplice. Da un lato il mondo circostante dato
“naturalmente” e dall’altro il mondo considerato da un punto di vista
scientifico. In questo senso «il problema della filosofia è il mondo come
totalità»25. Ma il pensiero della totalità appartiene all’ontologia classica, per
la quale il mondo costituisce il suolo saldo su cui si erge ogni concezione
filosofica, scientifica o religiosa. La critica dell’epoca moderna a questa
dimensione ingenua, naturale, per certi versi anche antropomorfica, rende
impossibile ormai scorgere la totalità, non siamo più in grado, cioè, di
vedere il problema del mondo come totalità, di rivolgere lo sguardo in ciò
che è e di stupirci26. Si assiste a un crollo spirituale per il quale qualsivoglia
tentativo di filosofare assume la forma del nichilismo. Ma, come già visto in
23 V. COSTA, Il concetto naturale di mondo e la fenomenologia, cit., p. XIV. Si fa
riferimento qui alla cosiddetta svolta “cartesiana” che giunge a compimento con la
pubblicazione del primo volume delle Idee. Cfr. E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die
reine Phänomenologie, Husserliana, III/1, K. Schuhmann, Nijhoff, Den Haag 1976; trad. it.
di V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro primo:
Introduzione generale alla fenomenologia pura, Einaudi, Torino 2002.
24 Cfr. J. PATOCKA, Le monde naturel, cit., p. 1.
25 Ivi, p. 5.
26 Cfr. ivi, p. 6. Su questi motivi si veda pure ID., Platón a Evropa, Praha 1973; trad. it.
di M. CAJTHAML – G. GIRGENTI, Platone e l’Europa, G. Reale (a cura), Vita e Pensiero,
Milano 1997.
398
Saverio A. Matrangolo
Husserl e Avenarius, prima ancora di ogni attività teorica l’uomo esperisce
ingenuamente il mondo che gli è dato naturalmente. Prima di qualsiasi
obiettivazione, l’oggettività inerisce all’esperienza preliminare del mondo
intuitivo. «Il punto di vista naturale è quello di questa esperienza semplice
e ingenua, di ciò che la tradizione chiama “senso comune”, “opinione
corrente” o conoscenza naturale del mondo»27. È questo il fondo obliato da
cui pure deriva la concezione scientifica del mondo in cui l’uomo moderno
si riconosce. Le scienze della natura non costituiscono però il mero
prolungamento del mondo ingenuo, ma attuano una ricostruzione radicale
sottomettendo l’universo alle leggi fisico-matematiche, disconoscendone
così il carattere naturale originario. Di conseguenza «il mondo naturale
non è altro che l’apparenza soggettiva di ciò che è oggettivo»28; l’elemento
soggettivo con i suoi vissuti, «noi stessi in quanto vissuto, tutto, in una
parola, porta le stigmate della non originalità e dell’apparenza pura»29. Per
l’oggettivismo moderno il conflitto fra mondo scientifico e mondo naturale
non esiste, poiché la vita ingenua non ha alcun valore noetico. In questa
prospettiva l’uomo sperimenta l’alienazione dal sentimento naturale della
vita rimettendosi a un complesso di forze oggettive, «si irrigidisce
nell’appercezione fondamentale della sua non-libertà; si sperimenta come
ente agente delle forze oggettive; percepisce se stesso non come persona
ma come cosa»30. Nondimeno, vi è pure una presa di coscienza di tale
abdicazione e reificazione di sé che si manifesta nell’angoscia dell’uomo
contemporaneo di fronte alla sua finitezza. L’unica possibilità di
riconciliazione fra mondo scientifico e mondo ingenuo, contemplata nel
contesto dell’oggettivismo moderno, implica la resa e l’obliterazione del
secondo a favore del primo. Soluzione quest’ultima che però non esaurisce
mai completamente il bisogno di unità, quel «postulato pratico»31
rivendicato sempre di nuovo da un’esigenza filosofica ineluttabile.
La critica del positivismo alla “visione scientifica del mondo” riguarda lo
statuto epistemologico della fisica meccanicista moderna e la sua pretesa di
scientificità che in realtà si sarebbe rivelata illusoria. Il meccanicismo cioè
non sarebbe altro che una nuova concezione “metafisica” che costruisce un
mondo delle cose in sé, in realtà “artificiale”, del quale il mondo che ci è
ID., Le monde naturel, cit., p. 8.
Ivi, p. 9.
29 Ivi, p. 8.
30 Ivi, p. 11.
31 Ivi, p. 6.
27
28
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
399
dato intuitivamente diventerebbe un pallido riflesso soggettivo. «Il
positivismo si propone di eliminare la dicotomia per cui il mondo si
presenta diviso in causa fisica da una parte e conseguenza soggettiva
dall’altra»32. Tuttavia, anche questo fondamentale tentativo di recupero
della concezione naturale di mondo nella sua unicità, rimane limitato al
proposito di conciliare siffatto ambito soggettivo e relativo alle strutture
fondamentali della scienza naturale-matematica. Il positivismo logico cioè
non farebbe altro che sostituire ai concetti “metafisici” di sostanza e
causalità quelli di relazione e funzione, nel tentativo di superare la metafisica
attraverso la logica e la matematica33. La stessa prospettiva di Avenarius,
come già emerge dalle analisi della tesi di abilitazione, rimane circoscritta a
questo orizzonte teorico di riferimento, precludendosi, dunque, la
possibilità di cogliere la questione nella sua profondità 34.
Se è vero, come scriverà il filosofo ceco qualche decennio dopo, che «la
moderna fenomenologia ha sviluppato l’affascinante problema
dell’oggettivazione»35, è anche vero che essa ha mostrato come la scienza
della natura e la metafisica meccanicistica moderna non hanno in nessun
caso raggiunto, ma neanche avvicinato, il terreno dell’assoluta oggettività.
In un contesto teorico siffatto vige la legge della causalità. Ma il mondo
dell’esperienza intuitiva si costituisce anche di esseri reali, di soggetti
umani che certo sono sottoposti anch’essi alla relazione causale allorché si
sperimentano non come persone ma come cose tra le cose. Nella
prospettiva meccanicista, difatti, non c’è spazio alcuno per un soggetto
agente36. È in questo senso che nella concezione scientifica moderna viene
obliato l’ambito della possibilità e della scelta, e quindi anche della libertà;
il luogo, cioè, in cui vige anche la legge della motivazione. La legge della
motivazione individua un movimento vitale indifferente alla causalità
naturale, un movimento di apertura a quella totalità del mondo in cui si
inscrive propriamente l’essere dell’uomo. In definitiva «la scienza
sostituisce l’idea della conoscenza della totalità con quella della conoscenza
del tutto, di tutte le cose e relazioni esistenti, sostituisce l’idea della
32
ID., Il mondo naturale e la fenomenologia, A. Pantano (a cura), Mimesis, Milano 2003,
p. 79.
Cfr. ivi, pp. 74-83.
Cfr. ID., Le monde naturel, cit., pp. 20-21.
35 ID., Per la preistoria della scienza del movimento: il mondo, la terra, il cielo e il movimento
della vita umana, in ID., Il mondo naturale e la fenomenologia, cit., p. 57.
36 Cfr. V. COSTA, Mondo, azione e storia in Jan Patočka, in V. Melchiorre (a cura), Forme
di mondo, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 260.
33
34
400
Saverio A. Matrangolo
conoscenza del mondo con quello della conoscenza del contenuto del
mondo, l’idea della conoscenza dell’essenza delle cose con quella di
sistema formale di pensiero sulle cose, l’idea della conoscenza stessa con
quella di una ricerca che ignora l’opposizione tra architettura e dettaglio,
tra concezione e tecnica»37.
2.
Esistenza e fenomenicità. Il senso della storia e del sacrificio.
Nel ripensare la questione dell’oggettivazione, il metodo
fenomenologico husserliano ha riguadagnato innanzitutto l’accesso a
quell’ambito preliminare in cui ogni esperienza intuitiva prende corpo, in
cui le cose si danno nella loro evidenza originaria. Recuperando poi le
istanze più feconde del positivismo logico, la fenomenologia si concepisce
come filosofia critica poiché «vuole tracciare un solco tra ciò che è evidente
e ciò che ha la mera pretesa di esserlo. […] L’oggetto originariamente
intuibile, proprio del mondo esterno, alla cui esperienza diretta ogni
sapere della natura ed ogni oggetto naturale deve far ritorno, è l’oggetto
della percezione»38 che affiora in un contesto di senso soggettivo e relativo,
in quella sfera pre-categoriale che pure per Husserl non costituisce il
“mondo vero” in sostituzione di quello costruito dalle scienze esatte. Il
proposito è invece quello di conferire un nuovo fondamento filosofico alla
razionalità europea, di delineare una scienza del mondo-della-vita la cui
verità è sì «pratica, imprecisa, relativa in rapporto alla situazione, ma non
fantastica né “relativa” nel senso dell’arbitrio individuale»39. Il mondo, in
questo senso, è un’evidenza primaria, ma anche un contesto pratico e una
dimensione relazionale in cui gli esseri umani si ritrovano a vivere nella
loro fatticità, è una idea trascendentale ma anche il fondo insondabile da cui
emerge la domanda fondamentale sull’essere dell’uomo. In tal senso il
mondo costituisce una categoria imprescindibile per un ripensamento in
37 J. PATOČKA, Osservazioni sulla posizione della filosofia all’interno e al di fuori del mondo,
in ID., Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, G. Di Salvatore (a cura), Centro
Studi Campostrini, Verona 2009, p. 36.
38 ID., La razionalità europea e il segreto del mondo, in ID., La superciviltà e il suo conflitto
interno, F. Tava (a cura), Unicopli, Milano 2012, pp. 128-129. Si veda inoltre quanto
scriveva Patočka già in Le monde naturel, cit., p. 97: «la percezione è l’esperienza originaria:
ci dà direttamente gli oggetti in sé all’interno del nostro circostante».
39 ID., La filosofia della crisi delle scienze secondo Edmund Husserl e la sua concezione di una
fenomenologia del mondo della vita, in ID., Il mondo naturale e la fenomenologia, cit., p. 132.
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
401
chiave antropologica del fondamento fenomenologico40. Non ci si potrà
dunque esimere dal compito di indagare il senso della vita frammentaria e le
vicende contingenti dei singoli individui; il metodo fenomenologico dovrà
cioè muovere sempre più verso una analisi di tipo storico-genetico41 che
renda conto di ogni dato intuitivo nella totalità preliminare costituita dal
mondo. «In un certo senso, la totalità preliminare è presente come lo sono
le cose singole»42. Con totalità, difatti, è possibile intendere sia l’insieme di
tutte le cose che si danno sensibilmente già sempre qui, sia il campo
impercettibile di una presenza non materiale che si rivela nella sua assenza,
l’orizzonte che consente alle cose stesse di uscire allo scoperto, di
manifestarsi. L’analisi fenomenologica mostra come nell’atteggiamento
naturale la vita umana si ponga sempre nell’orizzonte di questa totalità
preliminare43, come l’esistenza sia da intendersi sempre come essere-nelmondo.
Ora, se la diagnosi della scienza moderna e dei suoi fondamenti rivela le
sedimentazioni di senso e le falsificazioni ideologiche che in essa
occorrono, è anche vero che vi è una direttrice del cammino di pensiero di
Husserl in cui di fatto la luce del mondo rimane oscurata44. Stiamo parlando
della via cartesiana, di quell’“idealismo trascendentale” i cui semi, già sparsi
nelle lezioni su L’idea della fenomenologia45, giungono infine a maturazione
nel primo tomo delle Idee, laddove si parla ormai distintamente di
“sospensione” dell’atteggiamento naturale e di pre-giudizio circa l’esistenza
di ogni cosa, di una “messa fuori circuito” del mondo stesso rispetto alla
struttura conoscitiva di una soggettività assoluta. Volendo motivare
l’accesso della coscienza al reale, Husserl riabilita l’attitudine dello
scetticismo metodologico nei confronti dell’atteggiamento naturale
ingenuo e della credenza che sta saldamente alla sua base: il mondo esiste.
Cfr. V. MELCHIORRE, Il mondo come idea trascendentale, in ID., Forme di mondo, cit.,
pp. 4-13.
41 È possibile rinvenire un primo richiamo programmatico di siffatta esigenza, che
affiora piuttosto tardi in Husserl, già in J. PATOČKA, Le monde naturel, cit., p. 90.
42 Cfr. ID., Per la preistoria della scienza del movimento, cit., p. 59.
43 Cfr. ivi, p. 60; Id., Le monde naturel, cit., p. 57.
44 Patočka utilizza spesso questo gioco di parole fra “luce” (svĕtlo) e “mondo” (svĕt) che
è possibile rendere unicamente in ceco, laddove i lemmi hanno la stessa radice
etimologica.
45 Cfr. E. HUSSERL, Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen, W. Biemel (a cura),
Nijhoff, Den Haag, 1950; trad. it. di E. Franzini, L’idea della fenomenologia: cinque lezioni,
Bruno Mondadori, Milano 1998.
40
402
Saverio A. Matrangolo
La questione è nota: nell’atteggiamento naturale ogni cosa mi viene
restituita nella sua datità immediata, la percepisco nella forma di un
“realismo ingenuo” per il quale il mondo e le cose che in esso si
manifestano sono esistenti in sé e continuerebbero ad esistere
indipendentemente da me. Questa “ovvietà” viene scossa
dall’atteggiamento scettico che mi fa dubitare dell’esistenza stessa del
mondo. Ora, sebbene questo ragionamento segua evidentemente la logica
del dubbio metodico di Cartesio, Husserl tuttavia non ha intenzione di
scoprire il fondamento evidente e assoluto da cui dedurre tutto l’edificio
del sapere. La sua indagine conoscitiva mira, viceversa, a liberare la sfera
fenomenica, vuole lasciar apparire quell’unica certezza indubitabile
rappresentata dal fenomeno. Può darsi che io mi inganni nel credere che
esista qualcosa ma è indubitabile che, allorché percepisco, qualcosa si
manifesta a me. Può darsi che questo apparente non esista, ma non posso
dubitare del fatto che qualcosa appaia a me. In tal senso l’apparenza del
mondo è indubitabile, il fenomeno del mondo mi si manifesta
effettivamente. Le cose stanno diversamente quando invece si presume di
dedurre l’esistenza in sé del mondo dalla mera apparenza. Ciò rispetto a
cui si deve praticare l’epoché fenomenologica è proprio questa presunzione
di esistenza. A dover essere messo “fuori circuito” non è il fenomeno del
mondo, ma la tesi circa la sua esistenza, la convinzione che ciò che vediamo
esiste realmente. L’epoché costituisce nondimeno una “sospensione del
giudizio”, una “messa tra parentesi”, che non vuol dire annullamento della
tesi di esistenza, non significa rifiutare la credenza che il mondo esiste, ma
accettare l’invito a rendere ragione di ciò che ci appare46.
Patočka riconosce il merito e la radicalità di un atto teorico che possa
restituire legittimità ai fenomeni, egli tuttavia non può non ravvisare
l’insufficienza della tematizzazione husserliana dell’epoché in quanto
limitata all’atteggiamento naturale e immediatamente scavalcata dal
momento concettuale successivo di riduzione che, di fatto, ne disinnesca la
portata conoscitiva47. «Husserl ha scoperto la sfera fenomenale, la sfera di
Cfr. E. HUSSERL, Idee, cit., p. 66-73. Sulla questione si veda anche V. Costa, Husserl,
Carocci, Roma 2009, pp. 23-37.
47 Sulla distinzione dei due momenti concettuali cfr. J. PATOČKA, Epoché et reduction, in
ID., Qu’est-ce que la phénomenologie, trad. fr. di E. Abrams, Millon, Grenoble 1988, pp.
248-261, saggio espressamente dedicato alla questione che qui non è possibile seguire nella
sua complessità. Sulla questione si veda anche il capitolo all’interno del recente studio di
A. PANTANO, Dislocazione. Introduzione alla fenomenologia asoggettiva di Jan Patočka, Mimesis,
Milano 2011, intitolato: “La costellazione dell’epoché” (pp. 33-67).
46
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
403
ciò che si mostra nel suo apparire […] Adesso egli cerca, con un
procedimento analogo a quello dello scetticismo di Cartesio, di mettere in
evidenza questa sfera e assicurarla metodologicamente»48. Il mondo non
esiste in quanto trascendente, ma si dà senza ombra di dubbio come vissuto
interno alla mia coscienza. Il senso della riduzione fenomenologica è quello
di rinvenire un terreno completamente sottratto alla sfera del dubbio, e
questo terreno Husserl lo individua unicamente nell’immanenza di una
coscienza pura. Ogni realtà assume senso per me unicamente in quanto si dà
al mio io, in quanto vissuto riferito ad un polo soggettivo. «L’intenzione è
quindi diretta verso l’apparire come tale, verso la sfera fenomenale. Ma
questa intenzione è circoscritta attraverso termini che provengono dalla
sfera del soggettivo: non si parla di una messa in evidenza del campo
fenomenale come tale, ma di una riduzione all’immanenza pura»49. Solo
riconducendo lo sguardo dagli oggetti alla soggettività a cui si manifestano,
le cose si danno in quanto vissuti indubitabili. È questo il “primato
trascendentale” della coscienza: il mondo esiste unicamente in quanto si dà
ad essa50.
Il quadro teorico e la terminologia presentati nel contesto di Idee I,
giustificano in qualche modo le accuse di coscienzialismo e solipsismo
rivolte alla proposta fenomenologico-trascendentale di Husserl, ma
soprattutto rendono conto delle critiche che lo stesso Patočka rivolge al
maestro. Il filosofo ceco certo non nega la validità del tentativo husserliano
nel tentare di conferire autonomia a un “centro di vissuti”, ma allo stesso
tempo vuole mostrare come il compito originario della fenomenologia non
sia quello di stabilire il fundamentum inconcussum della coscienza, il “chi”
assoluto a cui si manifesta il mondo. La struttura dell’apparire non si limita
cioè a indagare il “chi”, “a chi” appare qualcosa, ma si costituisce
contemporaneamente ad altri due momenti fondamentali che sono il “che
cosa” appare e il “come” dell’apparire. Questi tre poli sono cooriginari in
ogni donazione che realizzi la percezione, e la fenomenologia deve rivelare
il movimento stesso di manifestazione, l’apparire dell’apparente che non
appare esso stesso. Il senso della proposta patočkiana di una fenomenologia
asoggettiva è proprio questo. Ovviamente non si può mettere da parte la
soggettività, in quanto se qualcosa appare, appare sempre a qualcuno. La
J. PATOČKA, Il soggettivismo della fenomenologia husserliana e la possibilità di una
fenomenologia “asoggettiva”, in ID., Che cos’è la fenomenologia?, cit., p. 275.
49 Ivi, p. 276.
50 Cfr. V. COSTA, Husserl, cit., pp. 33-35.
48
404
Saverio A. Matrangolo
fenomenologia asoggettiva non vuole essere, cioè, una fenomenologia
senza soggetto51, ma un tentativo di restituire la fenomenologia al campo
d’indagine che le appartiene in modo originario, dunque a quella sfera
autonoma dell’apparire dell’ente che non può essere ridotta a nessuna cosa
particolare che in essa appare. «Husserl è dunque penetrato fin nel cuore
della situazione (critica) della fenomenologia soggettiva, per quanto
evidentemente non ha avuto poi il coraggio di sacrificare la metafisica
idealista della coscienza che fino all’epoca della Krisis continua a difendere e
che proviene interamente da una operazione artificiale di
soggettivizzazione del fenomenale»52. Patočka vuole invece ricondurre il
metodo fenomenologico alla sua missione originaria, e crede di farlo
innanzitutto rilanciando la posta in gioco teorica istituitasi nel solco che
separa/unisce il momento dell’epoché e quello di riduzione.
Quando Husserl introduce, nelle pagine di Idee I, quello straordinario
atto di sospensione del giudizio che libera la sfera dei fenomeni mostrando
la radicalità del metodo fenomenologico, egli si preoccupa
immediatamente di ridurne la portata universale53. L’epoché, difatti, deve
limitarsi al mondo naturale, non può abbracciare la sfera indubitabile e
necessaria della coscienza, l’unico residuo fenomenologico che rimane dopo
la riduzione eidetica. Patočka rompe la connessione fra i due momenti
concettuali teorizzando una epoché “senza riduzione”, e ne estende la
portata per riguadagnarle l’universalità che Husserl le aveva sottratto.
L’epoché deve cioè essere attuata anche nei confronti della sfera immanente
dei vissuti soggettivi, così da restituire al metodo fenomenologico il campo
che gli è proprio: la sfera di ciò che appare, il campo dei fenomeni.
«L’esempio stesso di Husserl mostra che una fenomenologia come scienza
dell’apparire in quanto tale […] è impossibile senza una certa ontologia.
Una teoria dell’apparire come tale non è possibile che alla condizione che
l’a priori del mondo sia sganciato dal suo funzionamento inizialmente
anonimo e che sia reso fenomeno»54. D’altronde lo stesso Husserl nella
Crisi sembra in qualche modo aver rimeditato la questione ed essersi reso
conto delle confusioni che l’utilizzo di termini quali “coscienza assoluta” e
51 Cfr. R. BARBARAS, L’ouverture du monde. Lecture de Jan Patočka, Éditions de La
Transparence, Chatou 2011, p. 203.
52 J. PATOČKA, Il soggettivismo della fenomenologia husserliana, cit., p. 279 (corsivo
nostro).
53 Cfr. E. HUSSERL, Idee, cit., p. 71.
54 J. PATOCKA, Epoché et reduction, cit., p. 260.
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
405
“messa fuori circuito del mondo” avrebbero potuto generare. La
fenomenologia può riconquistare la propria specificità, tuttavia, ponendo
sempre di nuovo la questione di fondo del mondo naturale in quanto ambito
dell’apparire. Ancor più rilevante in questo contesto sarà infine la presa
d’atto del carattere specificamente storico del mondo-della-vita.
Il problema della storia nel pensiero di Husserl ha sempre assunto un
carattere ambiguo e controverso. Basti pensare alla polemica nei confronti
dello storicismo inteso come mero relativismo in La filosofia come scienza
rigorosa. All’interno della Crisi la questione assume un diverso spessore
poiché la storicità viene tematizzata innanzitutto in quanto strato
percettivo. Il mondo-della-vita costituisce la totalità preliminare,
l’orizzonte esperienziale che si dà anche nelle sue varianti storiche. Il
mondo circostante è l’esito delle contingenze storiche e noi stessi, in
quanto esseri viventi, siamo caratterizzati dall’orizzonte culturale in cui la
nostra stessa vita è compresa. Ciò che chiamiamo “io” non è altro che il
risultato di sedimentazioni storiche di senso. L’essere umano è posto
sempre all’interno di una determinata concezione del mondo
(Weltanschauung) che gli proviene da una tradizione55. Da questo punto di
vista ogni percezione del mondo risulta caratterizzata da assunzioni
storiche particolari. Così, ad esempio, la luna potrà essere allo stesso
tempo un satellite del pianeta terra per me che ho una concezione del
mondo “scientifica”, e una dea per un uomo “primitivo” che ha una
concezione “mitica” del mondo. Il mondo dovrà individuare invece uno
strato della percezione omogeneo per tutti gli esseri umani di tutte le
epoche storiche. «Il compito di cogliere il “mondo naturale” coincide con il
problema di cogliere nell’uomo ciò che non dipende dalle casualità
storiche della sua evoluzione, dunque ciò che di comune può essere
mantenuto mediante variazione in tutte le modalità della vita umana. […]
Ma cogliere ciò che è comune mediante variazione non significa ancora
necessariamente aver colto un’essenza dell’uomo data una volta per
tutte»56. Quello che cerca Husserl è dunque un a priori storico, uno strato
percettivo “invariante” e comune, sulla base del quale chiunque può fare
55 «Comprendere se stessi significa interrogare quegli strati che mi costituiscono, e
dunque esplicitare la storia stessa, la tradizione che si è sedimentata in me in quanto
soggetto trascendentale» (V. COSTA, Husserl, cit., p. 165). Su ciò si vedano inoltre le
analisi contenute in R. TERZI, Il tempo del mondo. Husserl, Heidegger, Patočka, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2009, pp. 87-108.
56 J. PATOČKA, Il mondo naturale e la fenomenologia, cit., p. 89.
406
Saverio A. Matrangolo
esperienza delle cose stesse affrancate dalle determinazioni storiche e
culturali. Ma questo non significa rilanciare una dinamica di obiettivazione
simile a quella operata dalle moderne scienze della natura? Lo stesso
Husserl si rende conto delle difficoltà cui si va incontro nel limitare il
problema della storia alla ricerca di uno strato invariante57, e nondimeno
egli rimarrà fedele a questa impostazione anche nella sua ultima opera.
Patočka, invece, individua nella questione della storicità stessa il senso del
fondamento antropologico di una indagine fenomenologica in grado di
riproporre il rapporto tra uomo e mondo evitando di assolutizzare l’uno o
l’altro dei termini in questione, partendo piuttosto da quella che egli
definisce, sulla scia del supporto concettuale che gli viene offerto da
Heidegger, l’altro grande interprete della tradizione fenomenologica,
l’apertura storica legata ai fenomeni. Il mondo per Heidegger si costituisce
in quanto totalità di rimandi, non fa riferimento cioè alla totalità intesa
come somma di tutti gli enti, ma ad una apertura che fa sì che ogni ente
possa apparire all’interno di una totalità di senso. Il mondo non è un ente,
ma la condizione di possibilità di ogni ente.
In definitiva Husserl ha visto il problema dell’apparire ma è rimasto
ancorato al suo idealismo trascendentale, alla ricerca di uno strato
invariante, di una coscienza “pura” a cui il mondo si manifesti. Heidegger,
nella sua originale rilettura, attribuisce all’io astratto husserliano il
carattere dell’esistenza e della fatticità facendone un “Esserci” (Dasein)
storico, l’unico tra gli enti a cui è consentita l’apertura all’Essere. «Se
liberiamo la “sfera noematica” di Husserl dal significato di trascendenza
immanente (se ci asteniamo dall’orientamento unilaterale verso gli oggetti),
otteniamo pressappoco ciò che Heidegger chiama la regione dell’aperto»58.
L’esistenza è sempre esistenza in un mondo, essere-nel-mondo,
consapevolezza della propria finitezza. L’esistenza umana è il modo
d’essere dell’unico ente che non è indifferente al proprio essere e che è
inserito perciò in un contesto di senso per cui il mondo circostante diviene
57 «Se noi ci poniamo il fine di una verità concernente gli oggetti che sia valida per tutti
i soggetti […] noi veniamo a trovarci sulla via che porta alla scienza obiettiva. Ponendo
come fine questa obiettività (una “verità in sé”) assumiamo una specie di ipotesi che
travalica il puro mondo-della-vita. Ma noi abbiamo prevenuto questa possibilità di
“travalicamento” del mondo-della-vita attraverso la prima epoché (l’epoché delle scienze
obiettive) e ora siamo in imbarazzo riguardo a ciò che può essere preso in considerazione
scientificamente come un che di constatabile una volta per tutte e da parte di tutti». (E.
HUSSERL, La crisi delle scienze europee, cit., pag. 167).
58 ID., Saggi eretici, cit., p. 10.
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
407
l’“in-quanto-che-cosa” della manifestazione. E il fenomeno del mondo si
rivela proprio allorché tale struttura, pur costituendo la condizione di
possibilità dell’apparire, diviene impercettibile. In tal senso «bisogna
interpretare ogni fenomeno come un trapelare, un uscire dal
nascondimento»59. Nondimeno, l’apertura legata ai fenomeni è sempre
un’apertura di tipo “storico” e implica un movimento dell’esistenza umana in
un “mondo”, in un orizzonte temporale determinato. Così, mentre per
Husserl il mondo rimane un ambito concettuale “pre-teoretico”, per
Patočka e per lo stesso Heidegger il mondo naturale individua al contrario
il luogo che consente l’apparire dei fenomeni, l’ambito del “disvelamento”, ma anche la condizione di possibilità di ogni prassi umana.
Tuttavia, anche in Heidegger la tematizzazione della storicità si rivela
insufficiente, non essendo egli interessato al fenomeno dell’apertura, ma
unicamente alla questione del senso dell’essere60.
Lungo tutta la sua opera Patočka non smetterà mai di rivendicare al
fenomeno la sua storicità intrinseca. Se l’esistenza si muove all’interno del
mondo naturale, questo movimento va inteso come motilità fondamentale
di un ente che vive storicamente, all’interno di una situazione. Il senso della
storicità emerge, cioè, contemporaneamente alla presa di coscienza della
dinamica di occultamento e dis-velamento dell’essere degli enti61. La
manifestazione si dà già laddove questa dinamica di apertura non viene
tematizzata, e fin quando il senso della storicità rimane impensato,
l’esistenza umana vive in una modalità che potremmo definire “a-storica”.
Il mondo naturale sarebbe allora il luogo da cui ha origine della storicità,
l’orizzonte a-storico, o come dirà Patočka: “pre-istorico”, in cui l’esistenza
si dà in modo irriflesso, in una modalità che non comprende la dimensione
della storicità. Il mondo naturale sarebbe il tutto primigenio,
Ibidem.
Cfr. ivi, pp. 5-13, e ID., Platone e l’Europa, cit., pp. 45-47. Secondo Patočka la
proposta heideggeriana risulta manchevole nella tematizzazione di una “differenza
antropologica” che non può prescindere da elementi decisivi come quello della corporeità
e dell’alterità, i quali vengono relegati dello stesso Heidegger nell’ambito dell’ontico
poiché non risultano funzionali ad un interesse dichiaratamente ontologico. Per un
approfondimento della questione si veda almeno ID., Per la preistoria della scienza del
movimento, cit., pp. 59-66; si veda poi la seconda sezione di ID., Che cos’è la Fenomenologia,
cit., pp. 131-236, in cui sono raccolti i saggi sulla questione del corpo, e R. Terzi, Il tempo
del mondo, cit., pp. 178-188.
61 Cfr. J. PATOČKA, Saggi eretici, cit., p. 14. «In ogni disvelamento umano,
storicamente prodotto, dell’essere, si manifestano sempre nuovi mondi storici» (ibidem).
59
60
408
Saverio A. Matrangolo
l’indifferenziato da cui la storia ha origine differenziandosi e ponendo
l’uomo nell’apertura, nella lacerazione che si istituisce fra natura e cultura.
Precedentemente a questa rottura l’uomo vive in una ingenuità originaria,
in una concezione del mondo pre-istorica, nella mera accettazione e
ripetizione di una esistenza che potremmo definire “primitiva”.
L’esistenza umana si svolge secondo quei “tre movimenti
fondamentali”62 esposti a più riprese da Patočka nel corso del suo cammino
di pensiero per cui dapprima io devo essere generato e accettato da altri
uomini (primo movimento di radicamento) nel mondo. Dovrò in seguito
difendere quella vita che mi è stata data. Questo secondo movimento di
difesa avviene principalmente attraverso il lavoro, per mezzo di cui posso
provvedere alla vita. Nel contesto di questi primi due momenti l’esistenza
ha un senso ben definito e non riconosce il movimento di manifestazione
degli enti nell’aperto. L’apparire dell’apparente non viene cioè posto in
questione e l’uomo rimane avvolto nell’oscurità del “totalmente altro” e
del mistero. Ma anche nel mondo pre-istorico è presente la possibilità di una
rottura con l’esistenza ingenua. Il senso accettato fino a quel momento può
diventare, cioè, improvvisamente inadeguato e problematico poiché non
comprende quella oscurità misteriosa che l’uomo non si azzarda a indagare.
Se l’uomo si spinge oltre l’esistenza quotidiana e la mera ripetizione di sé, il
senso ingenuo e dato dell’esistenza pre-istorica non sarà più in grado di
garantire le risposte, che nell’ambito del mythos precedono sempre le
domande. L’uomo si apre allo stupore solo se rivolge lo sguardo in ciò che
è e si rende in grado di accedere ad un terzo movimento, quello di
apertura, che lo espone alla problematicità e allo scotimento del senso
precedentemente accettato63. È questa rottura con l’ingenuità del passato
che origina il pensiero filosofico e di conseguenza l’esistenza storica e
politica. L’uomo diviene ora un essere “capace di verità”, l’unico essere
consapevole di un senso ulteriore, problematico, che ha a che fare
direttamente con l’apparire degli enti nella chiarezza. Tuttavia egli in un
primo momento considera questa consapevolezza una maledizione64. Ma
sebbene l’abisso della notte e dell’oscurità mostri all’uomo la sua finitezza,
egli riuscirà nondimeno a concepire un progetto di vita assumendosi la
62 Cfr. almeno ID., Saggi eretici, cit., pp. 39-55; Per la preistoria della scienza del
movimento, cit., pp. 62-71; ID., Il mondo naturale e la fenomenologia, cit., pp. 106-124; ID.,
Che cos’è la Fenomenologia, cit., pp. 45-129.
63 Cfr. ID., Saggi eretici, cit., pp. 45-46.
64 Su ciò si veda ID., Platone e l’Europa, cit., pp. 45-66.
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
409
responsabilità di questa vita insensata, realizzando cioè la propria esistenza
e prendendosi “cura dell’anima”65. La grandezza del mondo greco è stata,
appunto, quella di delineare un progetto responsabile dalla presa d’atto
della propria finitezza. L’uomo che vive nella polis è il primo in grado di
riconoscere la propria storicità e di farne un ideale che si trasformerà nel
motore stesso della storia dell’Europa: la cura dell’anima. Nondimeno
questa storia ha pure gettato le basi su cui si costituirà quel progetto
moderno e quell’ideale scientifico di obiettivazione per cui il mondo
naturale sarà respinto nell’oscurità e l’uomo perderà la consapevolezza
della propria storicità. La modernità vivrà difatti nella pretesa di una
chiarezza assoluta, cercherà di strappare al mondo «l’ultimo velo di
mistero»66 e la razionalità ad essa intrinseca si risolverà da ultimo nel
progetto di una civiltà “tecno-scientifica”, nella cui essenza può realizzarsi lo
svelamento totale dell’esistente67. Così, l’oscurità, da cui pure sorge il
movimento di manifestazione degli enti, sarà rimossa insieme alla domanda
fondamentale sul senso di ciò che è.
Nel penultimo dei Saggi eretici, dedicato proprio all’analisi della “civiltà
tecnica”, Patočka esplora l’esistenza umana nei termini di autenticità e
inautenticità. L’uomo pre-istorico vive nell’inautenticità, caratterizzata
dalla dicotomia sacrum-profanum. Il profanum pertiene alla sfera del lavoro e
della vita abietta68, laddove il sacrum individua, invece, l’ambito dei
misteri, la dimensione dell’orgiastico e del demonico che successivamente
sarà subordinata alla responsabilità. Bisogna cioè affrancarsi dalla cattiva
ripetizione di una dinamica perversa che incatena l’esistenza, e «la polis,
l’epica, la tragedia e la filosofia greche sono diversi aspetti dello stesso
slancio vitale che rappresenta il risollevarsi da uno stato di decadenza»69. Il
mondo pre-istorico è attraversato dalla dimensione misterica del culto che
però sarà progressivamente disciplinato e superato nella cura dell’anima,
nell’accesso al regno della responsabilità e della libertà70. Il mondo tecno65 Cfr. ivi, pp. 64-66; ID., Saggi eretici, cit., p. 116. «Le due possibilità fondamentali
dell’uomo, esistere “storicamente” […] ed esistere “non-storicamente” […], sono
entrambe possibilità di un essere storico, se si assume qui la parola “storico” nel senso
ontologico, e non in quello della storia come insieme di fatti». (ID., Il mondo naturale e la
fenomenologia, cit., p. 90).
66 ID., Per la preistoria della scienza del movimento, cit., p. 69.
67 ID., Saggi eretici, cit., p. 128.
68 Ivi, p. 109.
69 Ivi, p. 113.
70 Cfr. ivi, pp. 116-117.
410
Saverio A. Matrangolo
scientifico segna invece l’occultamento del segreto del mondo,
l’obliterazione dell’apparire in quanto tale, ma in esso nondimeno si
realizza una nuova caduta nell’orgiastico. L’ideologia del progetto tecnoscientifico, difatti, domina l’uomo incatenandolo alla vita e indicandogli un
cammino escatologico verso una “salvezza” che lo garantirà da ciò che
appartiene costitutivamente al regno dell’oscurità: la morte, la minaccia di
quella perdita assoluta che un’esistenza inautentica rigetta con orrore. Ma
proprio da questo abisso notturno emerge anche una esperienza
impensabile allorché ci si trova sommamente esposti alla morte. Coloro
che fanno, ad esempio, l’esperienza abissale del fronte, della guerra e della
morte nel XX secolo per «assicurare ad altri il giorno futuro sotto
l’immagine del progresso», avvertono «oscuramente che la vita non è tutto
e che essa può rinunciare a se stessa»71. Se la “Forza” accumulata dal
meccanismo produttivo innescato dalla civiltà tecnica deve sfogarsi nello
scontro bellico e nel sacrificio di una moltitudine di “senza nome”72 esposti
al fronte e al niente della morte, in questa esperienza, tuttavia, è possibile
giungere ad una nuova consapevolezza e attraverso la completa
destituzione di sé accedere paradossalmente alla libertà da tutto. Il sacrificio
compiuto al fronte cessa cioè di essere relativo e diventa una esperienza
sovrana di “scotimento”. L’esistenza raggiunge una vetta, una
consapevolezza sinora obliterata che è in grado di andare oltre l’alienazione
del processo di oggettivazione affrancandosi della quotidianità e dalle sue
aspettative inautentiche. L’uomo è in grado di farsi carico della morte a cui
il fronte lo espone poiché adesso la sua vita «inciampa nel niente, in un
confine invalicabile oltre il quale tutto cambia»73. Solo laddove l’esistenza
giunge all’annichilimento di sé, cresce anche ciò che salva (das Rettende);
Patočka, sulla scia delle riflessioni heideggeriane sulla tecnica, indica
nell’estrema esposizione al pericolo, nell’accettazione della perdita assoluta
e nel rimettersi all’irriducibilità del sacrificio di sé, l’unica possibilità per
l’uomo di riacquistare la sua umanità74. Il sacrificio rimanda a una esperienza
Ivi, pp. 144-145.
ID., Les périls de l’orentation de la science vers la technique, in ID., Liberté et sacrifice. Ecrits
politiques, trad. fr. di E. Abrams, Millon, Grenoble 1990, p. 271.
73 Ivi, p. 147.
74 Cfr. ivi, cit., pp. 263-270; Id., Séminaire sur l’ère technique, in ID., Liberté et sacrifice,
cit., pp. 277-285. Nelle ultime pagine dei Saggi eretici Patočka parla di una “solidarietà fra
gli scampati”, fra coloro che hanno fatto questa esperienza di scotimento e sono ora «in
grado di comprendere che cos’è in gioco nella vita e nella morte, quindi nella storia» (p.
151).
71
72
Concezione naturale del mondo e storicità in Jan Patočka.
411
obliterata e incomprensibile nell’era tecnica75 ma nondimeno ineludibile,
perché l’uomo stesso è sacrificio. Il sacrificio autentico è quello compiuto
nella consapevolezza di una perdita irrecuperabile, nella finitezza che
caratterizza l’Esserci umano e lo rende capace di un “sacrificio per niente”,
di sacrificarsi per ciò che non è un ente. «Essere significa essere
nell’assoluta singolarità, nell’esposizione al pericolo assoluto […] offrirsi in
sacrificio affinché qualcosa d’altro possa “essere”»76.
La tematizzazione propriamente “storica” del sacrificio nell’opera di
Patočka rimarrà tuttavia limitata. Pur rimandando spesso all’orizzonte
sacrificale arcaico, da cui pure emerge il logos, e al rivolgimento di senso
offertone dalla prospettiva cristiana, la questione non diventerà mai
direttamente oggetto di una indagine conoscitiva che renda conto del
carattere distruttivo e generativo del sacrificio stesso. Ma la specificità del
percorso intellettuale ed esperienziale del filosofo ceco ci indica
nondimeno un compito autenticamente fenomenologico, una direzione di
senso che egli non ha avuto modo di descrivere in un linguaggio
speculativo per via dell’urgenza storica che lo ha interpellato radicalmente,
una “fenomenologia del sacrificio” che ha potuto unicamente esibire
nell’insondabile finitezza di una esistenza dedicata alla teoresi, nel porre
«un interrogativo davanti alla terra e al cielo […] affinché terra e cielo non
manifestino soltanto se stessi, bensì siano la manifestazione di “qualcosa di
superiore”»77.
Abstract
Talk about a phenomenology of sacrifice means to deal with the
cognitive path along which unravels the work of the Czech philosopher Jan
Patočka and his attempt to redirect in a historical sense-the genetic
phenomenology of Husserl. From the reflection on the category of
"natural world" Patočka repeats the problematic tension between
Cfr. ID., Les périls de l’orentation de la science vers la technique, cit., p. 272.
ID., Il mondo naturale e la fenomenologia, cit., p. 118. Sulla questione del conflitto e
del sacrificio in Patočka ci permettiamo di rimandare a S. A. MATRANGOLO, Jan Patočka e la
ripresa del πόλεμος eracliteo: una prospettiva impolitica contro l’«ideologia del giorno», in F.
BONICALZI (a cura), Pensare la pace. Il legame imprendibile, Jaka Book, Milano 2010, pp. 261282.
77 Ibidem.
75
76
412
Saverio A. Matrangolo
Lebenswelt (the "life-world" of the late Husserl's reflection) and size of
historicity, and reinterroga these basic structures in an attempt to return to
the phenomenological method that fertility dissolved attitude
teoreticizzante which the same Husserl gives life. The sacrifice, in this
context, is the completion of the process of thought patočkiano, not only
as a historical-anthropological investigation of the structures that define it
and which seem to be at odds with the intent of the original theoretical
phenomenology, but also as a witness experience investing his personal
story. Perhaps in this regard will not have to then ask whether a
phenomenology of sacrifice does not mean always, in some way, a sacrifice
of phenomenology?
VITTORIO MORFINO
Sul non contemporaneo:
Marx, Bloch, Althusser
1.
Non contemporaneo e inattualità
La questione della temporalità plurale o della non contemporaneità è
emersa a più riprese nella storia della tradizione marxista. Intendo con
questo intervento mettere a fuoco la questione prendendo come
paradigmatico il differente utilizzo del concetto di ‘non contemporaneo’
fatto da Marx nell’«Introduzione alla Critica del diritto statuale hegeliano»,
nel Bloch di Eredità del nostro tempo prima e di Differenziazioni nel concetto di
progresso (tradotto in italiano semplicemente con il titolo Sul progresso) poi,
ed infine nell’«Oggetto del Capitale» di Althusser, provando a trarre da
queste differenze delle indicazioni e delle cautele sull’utilizzo del concetto.
Prima di affrontare questi testi, mi sembra tuttavia di una qualche
utilità tracciare una linea di demarcazione rispetto al concetto nicciano di
“inattuale” (unzeitgemässe), per evitare confusioni e sovrapposizioni non
estranee al nostro tempo. Ora, l’utilizzo che Nietzsche fa di questo
concetto nelle Considerazioni inattuali e della conseguente contrapposizioni
tra attualità e inattualità è tutto dominato da una istanza dualistica: ciò che
è inattuale è non contemporaneo rispetto ad una contemporaneità
inautentica (la contemporaneità degli ‘spiriti deboli’, dei ‘filistei’), e
dunque nell’inattualità risiede in realtà una contemporaneità più profonda,
una autenticità , quei cento uomini dallo ‘spirito forte’ capaci di agire «nel
nostro tempo, [ma] in modo inattuale – ossia contro il tempo, e in tal
modo sul tempo e, speriamolo, a favore di un tempo venturo»1.
Questo schema, segnato da un profondo dualismo tra vita e scienza, è
usato da Nietzsche per leggere il proprio tempo, proiettandovi la sua
lettura della grecità della Nascita della tragedia dominata dal tradimento
1 F. NIETZSCHE, Unzeitgemässe Betrachtungen, in Nietzsche Werke, hrsg. von G. Colli e
M. Montinari, Ab., Bd. 1, De Gruyter, Berlin - New York 1972, 243, tr. it. di S.
Giammetta e M. Montinari, Einaudi, Torino 1972, p. 82.
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 413-443
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/978885486064327
413
414
Vittorio Morfino
socratico dell’equilibrio di apollineo e dionisiaco: la scienza viene separata
dalla vita e diviene tradimento della vita. Si deve allora
cercare, con sguardo coraggioso i nostri modelli nel primitivo mondo
greco antico, del grande, del naturale e dell’umano. Ma là troviamo anche la
realtà di una cultura essenzialmente antistorica [wesentlich unhistorichen Bildung]
e di una cultura nonostante ciò o piuttosto a causa di ciò indicibilmente ricca e
piena di vita. Anche se noi tedeschi non fossimo nient’altro che discendenti
– non potremmo, per il fatto di guardare a una tale cultura come a
un’eredità da appropriarci, essere niente di più grande e superbo2.
È in questo senso che nelle Considerazioni inattuali all’attualità di uno
Strauss, «filisteo della cultura», o di un von Hartmann, viene contrapposta
l’inattualità di Schopenhauer e di Wagner. Da un punto di vista teoretico è
di estremo interesse il fatto che in Essere e tempo Heidegger, prendendo in
considerazione la ‘seconda inattuale’ proietti sulla coppia nicciana
attuale/inattuale, la coppia autenticità/inautenticità:
La possibilità che il sapere storiografico possa essere o ‘di vantaggio’ o ‘di
svantaggio per la vita’ si fonda nel fatto che la vita è storica nelle radici
stesse del suo essere e che, di conseguenza, in quanto effettivamente
esistente, si è già sempre decisa o per la storicità autentica o per
l’inautentica. Nella seconda delle sue Considerazioni inattuali (1874),
Nietzsche si è reso conto dell’essenziale circa «i vantaggi e gli svantaggi del
sapere storiografico per la vita» e lo ha esposto in modo chiaro e
persuasivo. Egli distingue tre specie di storiografia: la monumentale, la
antiquaria e la critica, senza però giustificare esplicitamente la necessità di
questa triplicità e il fondamento della sua unità. La triplicità della storiografia
è implicita nella storicità stessa dell’Esserci. Questa fa anche comprendere in
qual modo la storiografia autentica debba costituire l’unità concreta ed
effettiva di queste tre possibilità. La suddivisione di Nietzsche non è
casuale. L’inizio della sua considerazione fa supporre che egli
comprendesse molto di più di quanto abbia detto3.
La lettura heideggeriana ci permette di porre l’accento su un carattere
fondamentale dell’uso della coppia attuale/inattuale: essa non solo è
Ivi, p. 303, tr. it. cit., p. 136.
M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, in Gesamtausgabe, Bd. 2, Klostermann, Frankfurt 1976,
p. 523, tr. it. di Chiodi, Longanesi, Milano 1970, p. 473.
2
3
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
415
dominata dall’opposizione di vita e scienza, di volontà e rappresentazione,
in ultima istanza, cioè, da un profondo vitalismo, ma da un radicale
individualismo (ornato qua e là da un patetico aristocraticismo). Si veda
questo passaggio della seconda inattuale come specimen:
Si continui pure a […] scrivere la storia dal punto di vista delle masse [die
Geschichte vom Standpunkte der Massen zu schreiben] e a cercare in essa quelle
leggi che possono essere dedotte dai bisogni di queste masse, ossia le leggi
del movimento degli strati inferiori di creta e di argilla della società. Solo
per tre rispetti mi sembra che le masse meritino uno sguardo: innanzitutto
come copie evanescenti [verschwimmende Copien] dei grandi uomini, fatte su
carta cattiva e con lastre logore, poi come ostacolo [Widerstand] contro i
grandi, e infine come strumenti [Werkzeuge] dei grandi; per il resto che se
le prenda il diavolo e la statistica4.
Il tempo della massa è l’attualità, solo l’individuo grande, dallo spirito
forte può sopportare l’inattualità. In questo senso la linea di demarcazione
rispetto a Nietzsche è tracciata: ciò che vuole essere messo a fuoco in
questo saggio è precisamente la non contemporaneità delle masse.
2.
Il non contemporaneo nell’«Introduzione alla Critica»
Una genealogia all’interno della tradizione marxista del concetto di ‘non
contemporaneo’ non può prescindere dall’uso che il giovane Marx ne fa in
uno dei testi famosi del cosidetto ‘passaggio al comunismo’,
l’«Introduzione» a Per la critica della filosofia del diritto di Hegel scritto a cavallo
tra il ’43 e il ’44 e pubblicato nei «Deutsch-Französische Jahrbücher» nel
1844. In esso Marx indica alla filosofia il compito di portare a compimento il
lavoro iniziato da Feuerbach attraverso la critica della religione: si tratta, una
volta mostrato che la religione è un prodotto dell’uomo, di criticare quella
realtà che ha prodotto l’illusione religiosa. Ecco un celebre passaggio
marxiano aperto da un celebre chiasma sulla verità:
È dunque compito della storia, una volta scomparso l’al di là della verità,
quello di ristabilire la verità dell’al di qua. E innanzi tutto è compito della
filosofia, la quale sta al servizio della storia, una volta smascherata la figura
sacra dell’autoestraneazione umana, smascherare l’autoestraneazione nelle
sue figure profane. La critica del cielo si trasforma così nella critica della
4
F. NIETZSCHE, Unzeitgemässe Betrachtungen, cit., pp. 315-316, tr. it. cit., p. 148.
416
Vittorio Morfino
terra, la critica della religione nella critica del diritto, la critica della teologia
nella critica della politica5.
Tuttavia l’introduzione marxiana si rifersice ad un testo scritto
nell’anno precedente a Kreuznach, La critica del diritto statuale hegeliano, che
non prende in considerazione la realtà tedesca, cioè lo Stato prussiano, ma
la filosofia tedesca del diritto e dello Stato nella sua più alta espressione, i
Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel. E questo per la precisa ragione che
la realtà tedesca è non contemporanea:
La seguente trattazione [Marx si riferisce alla Kritik] – un contributo a tale
lavoro – si rifà inizialmente non già all’originale ma ad una copia, alla
filosofia tedesca del diritto e dello Stato, e ciò per nessun’altra ragione se
non quella che essa si rifà alla Germania. Se ci si volesse ricollegare
direttamente allo status quo tedesco, sia pure nell’unico modo adeguato,
cioè negativamente, il risultato rimarrebbe sempre un anacronismo
[Anachronismus]. Persino la negazione del nostro presente politico [unsern
politischen Gegenwart] si trova già, come un fatto polveroso, nella soffitta
storica dei popoli moderni. Se nego i codini incipriati, mi rimangono pur
sempre i codini non incipriati. Se nego le condizioni del 1843, mi trovo,
secondo il calendario francese, appena nell’anno 1789, ben lungi dunque
dal punto focale del presente. Anzi, la storia tedesca si vanta di avere un
corso che nessun popolo dell’olimpo storico le ha mostrato e che nessuno
imiterà. Noi abbiamo infatti condiviso le restaurazioni dei popoli moderni
senza condividere le loro rivoluzioni. Abbiamo subito le restaurazioni, in
primo luogo, perché altri popoli osarono una rivoluzione, in secondo
luogo, perché altri popoli subirono una controrivoluzione, una volta
perché i nostri signori avevano paura e un’altra perché i nostri signori non
avevano paura. Noi, coi nostri pastori alla testa, ci trovammo sempre una
sola volta in compagnia della libertà, nel giorno della sua sepoltura6.
È la storia stessa, attraverso il suo corso nei popoli moderni, che si è
occupata di condurre una critica della realtà tedesca: il presente tedesco è
il passato dei popoli moderni, «le condizioni tedesche stanno sotto il livello
della storia»7, tuttavia una critica della realtà tedesca non è priva di
5 K. M ARX, “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung”, in MEW,
Bd. 1, 1956, p. 379, tr. it. in K. MARX – F. ENGELS Opere, vol. III, Editori Riuniti,
Roma 1976, p. 191.
6 Ivi, pp. 379-380, tr. it. cit., pp. 191-192
7 Ivi, p. 380, tr. it. cit., p. 192.
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
417
significato anche per gli altri popoli nella misura in cui «lo status quo
tedesco costituisce l’aperto compimento dell’ancien régime, e l’ancien régime è
la tara occulta dello Stato moderno»:
La lotta contro il presente politico tedesco è la lotta contro il passato dei
popoli moderni, che continuano tuttora ad essere molestati dalle
reminiscenze [Reminiszenzen] di questo passato. È per essi istruttivo vedere
l’ancien régime che visse da loro la sua tragedia, recitare ora la sua commedia
come replica tedesca. Tragica fu la sua storia fino a quando esso era il
vecchio potere preesistente del mondo mentre la libertà era un capriccio
personale, in una parola, fino a quando esso credeva e doveva credere
nella propria legittimità. Fino a che l’ancien régime, in quanto ordine
mondiale vigente, lottò contro un mondo ancora in formazione dalla sua
parte stava un errore storico universale, non personale. Perciò il suo
tramonto fu tragico. Invece l’attuale [jetzige] regime tedesco, un
anacronismo [ein Anachronismus], una flagrante contraddizione con assiomi
universalmente riconosciuti, la nullità dell’ancien régime esposta alla vista
del mondo, si immagina ancora di credere in se stesso e pretende dal
mondo la stessa immaginazione [dieselbe Einbildung]8.
Presente e reminiscenza in Inghilterra e Francia, passato, anacronismo e
immaginazione in Germania: la lotta si iscrive in questo tessuto di
temporalità.
Tuttavia vi è un aspetto riguardo a cui la Germania è contemporanea
del presente: la filosofia. I tedeschi vivono il presente degli altri popoli
attraverso la filosofia:
Come i popoli antichi vivevano la loro preistoria nell’immaginazione,
nella mitologia, così noi tedeschi abbiamo vissuto la nostra storia futura
nel pensiero, nella filosofia. Noi siamo i contemporanei [Zeitgenossen]
filosofi del presente [Gegenwart], senza esserne i contemporanei storici. La
filosofia tedesca è il prolungamento ideale della storia tedesca. Se dunque
noi critichiamo anziché les oeuvres incomplètes della nostra storia le oeuvres
postumes della nostra storia ideale, la filosofia, la nostra critica si trova
invero in mezzo ai problemi dei quali il presente dice: that is the question.
Ciò che presso i popoli progrediti è rottura pratica con le moderne
condizioni dello Stato, in Germania, dove tali condizioni ancora non
esistono neppure, è innanzi tutto rottura critica con il riflesso filosofico
di tali condizioni. La filosofia tedesca del diritto e dello Stato è l’unica storia
8
Ivi,pp. 381-382, tr. it. cit., pp. 193-194.
418
Vittorio Morfino
tedesca che stia al pari col moderno presente ufficiale.Il popolo tedesco,
perciò deve annoverare questa sua storia sognata fra le proprie attuali
condizioni, e sottoporre alla critica non soltanto queste attuali condizioni
ma insieme anche la loro astratta prosecuzione9.
In questo senso si rivela necessaria la critica marxiana della filosofia
hegeliana del diritto, in quanto essa, unita al sorgere del proletariato
tedesco, permetterebbe alla Germania di «pervenire ad una prassi à la
hauteur de ses principes, cioè ad una rivoluzione che la innalzi non soltanto al
livello ufficiale dei popoli moderni, ma all’altezza umana che sarà il prossimo
futuro [die nächste Zukunft] di questi popoli»10.
La non contemporaneità, l’anacronismo, della Germania rispetto agli
altri popoli, dove per ‘altri’ si intende naturalmente Francia e Inghilterra,
unita alla contemporaneità della filosofia tedesca pone le condizioni di un
salto nel futuro degli altri popoli:
Come la filosofia trova nel proletariato le sue armi materiali, così il
proletariato trova nella filosofia le sue armi spirituali e non appena il
lampo del pensiero sarà penetrato profondamente in questo ingenuo
terreno popolare, si compirà l’emancipazione dei tedeschi a uomini11.
Potremmo riassumere con uno schema di questo genere:
t
Presente
politico
Passato
dei
Ancien régime
tedesco
popoli moderni
t
Filosofia tedesca dello
Presente
dei
Stato
2
Stato
popoli moderni
moderno
t
Critica della filosofia
Futuro
dei
Rivoluzione
3
tedesca dello Stato
popoli moderni
sociale
1
In questo gioco retorico di anticipi e ritardi, di contemporaneità e non
contemporaneità, di reminiscenze e prefigurazioni, di immaginazione e
Ivi, p. 383, tr. it. cit., pp. 195-196.
Ivi, p. 385, tr. it. cit., p. 197.
11 Ivi, p. 391, tr. it. cit., p. 203.
9
10
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
419
realtà, tutto ambientato peraltro nella vecchia Europa settentrionale, Marx
non rinuncia tuttavia, come risulta evidente dallo schema, all’idea di un
tempo fondamantale, rispetto al quale si danno appunto contemporaneità e
non contemporaneità, anticipi e ritardi, fasi prefissate attraverso cui è
necessario passare: ancien régime, Stato moderno, umanità liberata.
3.
Il non contemporaneo nell’Eredità del nostro tempo
Prendiamo ora un secondo modello di ‘non contemporaneo’, quello
presente in Eredità del nostro tempo di Ernst Bloch, una raccolta di articoli,
scritti tra il 1924 e il 1934, pubblicata nel 1935. Si tratta del tentativo di
riformulare il concetto marxiano ed engelsiano di ‘sopravvivenze’ al fine di
comprendere la formazione del nazismo ed allo stesso tempo di pensare
una strategia politica in quella congiuntura. Il cuore del testo è costituito,
come lo stesso Bloch dichiara nella prefazione del 1935, dall’articolo dal
titolo «Non-contemporaneità e il dovere di renderla dialettica».
Prendiamo l'incipit:
Non tutti esistono nello stesso presente [Nicht alles sind im selben Jetzt da].
Alcuni vivono il presente solo esteriormente, per il semplice fatto che li si
può vedere oggi. Ma ciò non vuol dire che essi vivano
contemporaneamente agli altri [Damit aber leben sie noch nicht mit den
Anderen zugleich]. Essi portano in sé invece qualcosa di anteriore che viene a
mescolarsi con il presente12.
Questa anteriorità, questa inattualità è al centro dell'analisi blochiana
della società tedesca e dell'ascesa al potere di Hitler: «Anche le masse sono
affluite verso l'inattualità, perché l'insopportabile presente [unerträgliche
12 E. BLOCH, Erbschaft dieser Zeit, in Werkausgabe, Bd. 4, Suhrkamp, Frankfurt, 1962, p.
104, tr. it. modificata, a cura di L. Boella, Milano, Il Saggiatore, 1992, p. 82. Boella
traduce così l'attacco: «L'esperienza dell'attualità non è la stessa per tutti», spostando la
non contemporaneità dal piano oggettivo a quello soggettivo, a quello del vissuto; meglio
Jean Lacoste che traduce «tous ne sont pas présents dans le même temps présent» (Héritage
de ce temps, Payot, Paris, 1978, p. 90) e Mark Ritter che traduce «not all people exist in the
same Now» (Nonsynchronism and the Obligation to Its Dialectics, «New German Critic», 11,
1977, p. 22. Su questo testo vedi R. BODEI, Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch,
Bibliopolis, Napoli 1979, che oltre ad un perspicuo commento di Bloch offre un
ricchissimo inventario storico-filosofico a proposito della temporalità plurale, per
utilizzare il quale è tuttavia necessario tracciare precise linee di demarcazione teoretiche.
420
Vittorio Morfino
Jetzt] sembra almeno diverso con Hitler, perché Hitler propone a ognuno
l'immagine delle vecchie e buone cose. Quasi a nient'altro è stata tributata
una attenzione così scarsa, niente è più pericoloso di questa capacità di
essere ad un tempo ardente e miserabile, contestatario e noncontemporaneo. Gli operai non sono più soli con gli imprenditori.
Numerose forze provenienti dal passato, da una base del tutto diversa,
cominciano a mettersi in mezzo»13. Il tempo dei giovani di estrazione
borghese deprivati di prospettive borghesi di vita14, il tempo dei
contadini15 e il tempo del ceto medio impoverito16 sono altrettanti tempi
E. BLOCH, Erbschaft dieser Zeit, cit., p. 104, tr. it. cit., p. 82.
«L'aria fresca della gioventù fa bruciare ancora più forte il fuoco a sinistra, quando
brucia, ma se questo viene 'riacceso' a destra, è ancora più facile il compito di sedurre i
giovani dei circoli borghesi: la giovinezza del sangue, la giovinezza organica è un terreno
favorevole ai nazisti» (ivi, p. 105, tr. it. cit., p. 83).
15 I contadini hanno secondo Bloch un duplice tratto non-contemporaneo, il primo
legato alla proprietà dei mezzi di produzione, il secondo al «tenace radicamento che deriva
dalla materia che essi lavorano, che li mantiene e li nutre in forma immediata». Essi «sono
attaccati all'antico suolo e al ciclo delle stagioni» (ivi, p. 107, tr. it. cit., p. 85). «Non è
dunque – continua Bloch – soltanto la crisi agraria che spinge i contadini verso destra,
dove si sentono protetti dalle dogane e viene promesso loro il ritorno in tutto e per tutto
dei bei tempi andati. La loro esistenza legata da vincoli, la forma relativamente arcaica dei
loro rapporti di produzione, dei loro costumi, della loro vita, che segue il calendario e il
ciclo di una natura immutabile, si oppongono all'urbanizzazione e cementano la loro
alleanza con la reazione, esperta di non-contemporaneità. Anche il loro buon senso terra
terra, come il senso della proprietà e l'individualismo contadino […] provengono da
epoche precapitalistiche, da rapporti di produzione che avevano già rivendicato la
distribuzione della terra in un'epoca in cui non c'era ancora un borghese a svolgere il ruolo
di imprenditore individuale» (ibid.).
16 «[…] è caduto in miseria, quindi è sensibile ai germi rivoluzionari, ma il suo lavoro
avviene lontano dal fronte e i suoi ricordi lo rendono totalmente estraneo all'epoca.
L'insicurezza, che si limita a generare nostalgia per il passato in forma di impulso
rivoluzionario, fa sorgere nel bel mezzo della grande città figure che non si vedevano più
da secoli. Tuttavia anche qui la miseria non inventa niente o non inventa tutto, bensì non fa
che portare alla luce la non contemporaneità che per molto tempo è sembrata latente o
appartenente al passato [Ungleichzeitigkeit, die lange latent oder höchstens eine vom gestern
schien], ma che ora riprende forza ben oltre il passato in un ballo di San Vito quasi
inspiegabile. Anche in città dunque risorgono modi d'essere antichi, insieme ad antichi
modi di pensare e capri espiatori come l'usuraio ebreo, simbolo dello sfruttamento in
generale. Si crede alla fine della ‘schiavitù dell’interesse’, come se l’economia fosse ancora
al 1500, sovrastrutture che sembravano da tempo capovolte si rimettono in piedi, veri e
propri passaggi urbani del Medioevo stanno immobili nell’oggi. Qui la taverna ‘Al sangue
nordico’, là il castello del conte Hitler, là la chiesa del Reich tedesco, una chiesa terrestre
in cui il popolo della città ha anch'esso la sensazione di essere il frutto del suolo tedesco e
13
14
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
421
non contemporanei che innervano il potere di Hitler: «con il cedimento di
Hitler, può darsi che ciò che è non-contemporaneo apparirà più debole: in
ogni caso esso resta il germe e il fondamento della sorpresa
nazionalsocialista così come di ogni futura sorpresa eterogenea»17.
Ciò che Bloch sottolinea con forza nella sua analisi della società tedesca
è che questa non contemporaneità (Ungleichzeitigkeit) non è solo una non
contemporaneità soggettiva:
Ad ogni modo, non tutto qui si riassume nel piccolo uomo che si fa delle
illusioni [der sich täuscht]. La miseria porta anche, oltre all'alba che viene
dall'odore di chiuso, un'alba autentica con cui bisogna fare i conti [Die Not
bringt neben Frühe aus Muff auch echte, mit der zu rechnen ist]. Oggi ci sono
stivali della miseria che, come gli stivali della felicità della fiaba, portano
nei tempi passati. Se la miseria non toccasse che uomini contemporanei
[gleichzeitige], anche nel caso che avesse posizioni, origini e coscienza
differenti, non li farebbe andare in una direzione tanto diversa e in
particolare tanto lontano all'indietro; né essi sarebbero così poco capaci di
‘comprendere’ la lingua comunista, che è appunto del tutto
contemporanea [völlig gleichzeitig] e orientata esattamente verso l'economia
più avanzata. Uomini contemporanei, malgrado una collocazione
intermedia che li rende economicamente gabbati, malgrado le apparenze
[trotz allen Scheins], non si lascerebbero prendere al laccio così
massicciamente da una barbarie e da un romanticismo tanto arcaici
[archaisch verwildern und romantisieren]. È altrettanto certo che i membri del
ceto medio non si ribellano contro la mercificazione allo stesso modo del
proletario, in quanto non partecipano che indirettamente alla produzione,
e inoltre l'impiegato, perlomeno fino a poco tempo fa, non era così
annientato, alienato nel suo lavoro e incerto rispetto alla sua situazione
come il proletario. A ciò si aggiunge il fatto che, a differenza del
proletario, l'impiegato aveva qualche possibilità di promozione
individuale. Ma se nemmeno ora dopo la proletarizzazione e l'insicurezza
totali, una volta scomparso il tenore di vita superiore e qualsiasi
prospettiva di carriera, le masse di impiegati non si precipitano verso i
comunisti o perlomeno verso i socialdemocratici, ma dalla parte opposta,
ciò significa che manifestamente sono all'opera forze che dissimulano la
mercificazione non solo ideologicamente e soggettivamente (questo fu
comunque il caso solo fino al dopoguerra, in un ceto medio non ancora
venera il suolo sacro, la Confessio dell'eroe tedesco e della storia tedesca» (ivi, pp. 108-109,
tr. it. cit., p. 86).
17 Ivi, p. 111, tr. it. cit., p. 88.
422
Vittorio Morfino
radicalizzato), ma anche realmente, ossia in seguito a una noncontemporaneità reale [realer Ungleichzeitigkeit]. Sono dunque all'opera
impulsi e riserve provenienti da epoche e sovrastrutture precapitalistiche,
non contemporaneità autentiche [echte Ungleichzeitigkeiten] che una classe in
declino riattualizza nella propria coscienza e fa riattualizzare. Ma qui non
soltanto i contadini e la piccola gente si sono conservati intatti, ossia
antichi, bensì anche i signori che stanno più in alto. La strada che il capitale
si è aperta attraverso il paese che gli è stato ‘organicamente’ trasmesso,
mostra nella sua versione tedesca sentieri laterali e punti di rottura
particolarmente numerosi. [...] La Germania non [è] solo un paese del
grande capitalismo e […] la casta degli Junker non [è] solo apparenza18.
Una società non è dunque uno spazio omogeneo permeato da un unico
tempo che costituirebbe il campo di gioco della contraddizione semplice. La
Germania in particolare è secondo Bloch il «paese classico della non
contemporaneità [klassische Land der Ungleichzeitigkeit], ossia dei residui non
superati di un'esistenza e una coscienza economica più antiche. […]
‘L'ineguaglianza di sviluppo’ che Marx attribuisce, per esempio
nell'«Introduzione» del ’57, alla produzione materiale rispetto a quella
artistica, persistette qui abbastanza a lungo anche sul piano materiale,
impedendo di conseguenza che nella gerarchia economica delle forze si
imponesse in modo univoco il pensiero del capitale, della contemporaneità.
Con il feudalesimo a est dell'Elba si mantenne in ogni caso tutto un museo di
interazioni tedesche, una sovrastruttura anacronistica [deutsche
Wechselwirkungen und anachronistischer Überbau] che, per quanto invecchiata e
fragile dal punto di vista economico, continua pertanto a dominare»19.
Dunque la rivoluzione marxista non trova solo l'opposizione della
contemporaneità capitalistica, ma anche quella di questa non
contemporaneità che trova le sue radici nella struttura materiale della
società: «Accanto e all'interno di molta falsa non-contemporaneità [viel
falscher Ungleichzeitigkeit] si trova di conseguenza questa non contemporaneità
certa [diese gewisse]: in Germania, presso il contadino, il disperato, il piccolo
borghese fallito, la natura e, a maggior ragione, i fantasmi [Spuk] della storia
risorgono con particolare facilità. La crisi economica che libera i fantasmi, si
sviluppa in un paese che ha una quantità eccezionalmente rilevante di
materiali precapitalistici»20. Quelli che Bloch chiama i fantasmi della storia,
Ivi, pp. 112-113, tr. it. cit., pp. 89-90.
Ivi, pp. 113-114, tr. it. cit., p. 91.
20 Ivi, p. 114, tr. it. cit., p. 91.
18
19
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
423
le ideologie di epoche passate, si ripresentano con tanta più facilità poiché in
Germania sono presenti le strutture materiali di quelle epoche passate.
Sulla base di questa analisi Bloch distingue tra contraddizione
soggettivamente e oggettivamente non contemporanea:
Questa contraddizione, finché è un rifiuto semplicemente sordo del tempo
attuale è soggettivamente non contemporanea, quando si manifesta come un
residuo di epoche precedenti che si è mantenuto nell'epoca attuale, è
oggettivamente non contemporanea. […] La contraddizione non
contemporanea è dunque il contrario di una contraddizione motrice ed
esplosiva, non sta dalla parte del proletariato, la classe oggi decisiva, non
sta sul campo di battaglia tra il proletariato e il grande capitale in cui si
gioca la lotta decisiva. La contraddizione non contemporanea e il suo
contenuto non sono apparsi, in effetti, che alla periferia degli antagonismi
capitalistici, rappresentandone quasi una diversione fortuita, perlomeno
messa di traverso; di modo che, tra la contraddizione non-contemporanea
e il capitalismo c'è uno iato, una frattura che si riempie in forma
consolatoria o si copre con un velo di nebbia21.
Per padroneggiare questa concezione della contraddizione Bloch
sviluppa una teoria della «dialettica a molteplici livelli»: lo sviluppo sociale
non è spiegabile attraverso la celebre dialettica proposta da Marx nella
«Prefazione» del 1859 tra forze produttive e rapporti di produzione,
dialettica semplice e che suppone la contemporaneità della società a se
stessa ed uno sviluppo lineare del tempo storico (nel senso che il presente è
gravido del futuro ossia il futuro esiste già in seno al presente22), ma
necessiterebbe di una dialettica che «renda più ampio il tempo attuale»:
La contraddizione soggettivamente non contemporanea è la collera repressa, la
contraddizione oggettivamente non contemporanea è il passato non ancora esaurito;
la contraddizione soggettivamente contemporanea è l'atto rivoluzionario libero del
Ivi, pp.116-118, tr. it. cit., pp. 93-95.
«A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società
entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di
proprietà (che ne sono soltanto l’espressione giuridica) dentro i quali tali forze per
l’innanzi si erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si
convertono in loro catene. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Con il
cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la
gigantesca sovrastruttura» (K. MARX, «Prefazione» a Per la critica dell’economia politica, in
K. MARX – F. ENGELS, Opere, vol. 30, Editori Riuniti, Roma 1986, pp. 298-299).
21
22
424
Vittorio Morfino
proletariato, la contraddizione oggettivamente contemporanea è il futuro impedito
contenuto nel presente, i benefici della tecnica bloccati, la società nuova bloccata di
cui quella vecchia è gravida nelle sue forze produttive23.
Contro il modello della dialettica fondata sulla contraddizione
semplice, Bloch propone una «dialettica pluritemporale e plurispaziale»,
che tenga conto di poliritmia e contrappunto. E tuttavia non spinge sino in
fondo questa istanza nel momento in cui sembra concepire questa
complessità come temporanea e non strutturale. Anche in Bloch, come nel
giovane Marx, seppure con una complicazione del quadro, la pluralità dei
ritmi è solo apparente, vi è comunque un tempo fondamentale rispetto a
cui contemporaneità e non contemporaneità sono definiti, e questo tempo
fondamentale scorre inesorabilmente nella direzione del comunismo, per
quanto frammenti di passato possano metterglisi di traverso impedendone
temporaneamente il regolare fluire. La pluralità di ritmi sembra essere una
condizione momentanea, in attesa che il praesens – come dice il Bloch di
Experimentum mundi – si faccia praesentia e che finalmente ci sia dato di dire
all'attimo: «fermati, quanto sei bello!»24.
4.
Non contemporaneità e progresso
Bloch ritorna ad usare il concetto di ‘non contemporaneo’ in una
conferenza tenuta nel 1955 alla Akademie der Wissenschaft della DDR, di
cui era stato nominato membro, dal titolo Differenziazioni nel concetto di
progresso; in una congiuntura politica completamente differente Bloch si
serve del concetto di non contemporaneo per complicare il quadro di una
ideologia del progresso il cui obiettivo polemico è manifestamente il
marxismo ortodosso del regime.
La mossa d’apertura consiste nel rimarcare le ombre inerenti ad ogni
progredire, rifiutando l’idolatria della successione del tempo in sé:
Non v’è a questo riguardo nessun indice sicuro dell’evoluzione
temporale [keinen sicheren Zeit-Reihen-index] del progresso, secondo il
quale nella storia, in ogni caso o anche soltanto nel complesso, il
Ivi, p. 122, tr. it. cit., p. 98.
E. BLOCH, Experimentum mundi, in E. BLOCH, Werkausgabe, Bd. 15, Frankfurt,
Suhrkamp, 1975, pp.81-114, tr. it. a cura di G. Cunico, Roma, Queriniana 1980, pp.
117-150.
23
24
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
425
successivo significhi proprio un di più rispetto a ciò che precede. Questo
sembra ovvio. A Hegel comunque non parve tale: la guerra del
Peloponneso dopo l’età di Pericle, la guerra dei Trent’anni dopo il
Rinascimento posero serie difficoltà al suo concetto di negazione,
altrimenti generale, ausiliario del progresso25.
La seconda mossa consiste nel mettere in luce il fondamentale
eurocentrismo del concetto di progresso, che pone l’Europa come fine
naturale del processo storico in ultima istanza al servizio dell’ideologia
dell’imperialismo coloniale. Bloch denuncia la sopravvalutazione del
concetto di ‘classico’ configurato dall’Europa. Bloch usa il Partenone come
esempio di classicità elevata a modello normativo che finisce per porre in
ombra non solo altre forme d’arte extraeuropee come la plastica dei negri,
i templi indiani o le pagode cinesi, ma anche ad altre forme giunte a
maturazione in Europa come il Gotico o il Barocco. Questo classicismo è al
servizio del dominio dell’uomo bianco.
Questa la ragione, secondo Bloch, di complicare questo quadro al
servizio del dominio dell’uomo bianco, mettendo l’accento sulle non
contemporaneità interne alla storia europea. A questo proposito Bloch
evoca nuovamente il passaggio marxiano dell’«Introduzione» del ’57 in cui
si sottolinea l’ineguaglianza di sviluppo tra l’arte greca e la tecnica greca,
per sottolineare la condizione inversa presente nella società capitalistica:
non c’è, cioè, sincronia tra il progresso nella struttura e quello nella
sovrastruttura. Anzi, l’uno può essere nemico dell’altro:
Bach e Leibniz – scrive – non corrispondono affatto alla miseria della
Germania di allora. I loro piedi ne sono stati appena sfiorati, mentre
d’altro lato uno sviluppato capitalismo avrebbe potuto essere anche
avverso alle Muse. «La produzione capitalistica molto pronunciata», dice
Marx nelle Teorie sul plusvalore, «è nemica di certi settori spirituali della
produzione come l’arte e la poesia». Senza questa visione, senza questa
separazione di una prosperità economica e sociale da un’epica non
altrettanto fiorente, si arriverebbe alla «illusione dei francesi del
diciottesimo secolo, di cui Lessing si faceva beffe con tanta grazia». Il che
significa a sua volta: politica e arte nei riguardi dell’elevazione borghese
non furono sempre vasi comunicanti. Per quanto sia stretta la connessione
25 E. BLOCH, Differenzierungen im Begriff Fortschritt, in Werkausgabe, Bd. 13, Frankfurt,
Suhrkamp, 1975, p. 119, tr. it. Sul progresso, a cura di L. Sichirollo, Guerini e Associati,
Milano 1990, p. 23.
426
Vittorio Morfino
materiale fra la base determinante e ciò che essa determina, la
sovrastruttura, sulla prima a sua volta operante, il progresso in ambedue
non avviene necessariamente nello stesso modo, nello stesso tempo e
soprattutto al medesimo livello [in gleiche Art, in gleicher Tempo und vor allem
mit gleiche Rang]26.
Tuttavia la complicazione del concetto di progresso non mette in gioco
solo la ‘non contemporaneità’ di struttura e sovrastruttura; si tratta secondo
Bloch di mettere in rilievo anche la discontinuità del progresso tra presunti
stadi della sovrastruttura. In questo senso possono essere considerate delle
aporie del progresso le nuove valutazioni di forme a lungo considerate come
dei semplici stadi di forme più perfette, per esempio la valutazione delle
«sculture egiziane [come] rigidi archetipi [steife Vorgänger] di quelle greche»27,
valutazione che deriva da un ideale classico di bellezza che pone la grecità
come telos. In realtà l’Egitto e la Cina costituiscono delle aporie rispetto al
concetto di progresso, proprio perché resistono ad una loro riduzione ad una
fase pre-greca dello sviluppo dell’umanità:
Le aporie del concetto di progresso seguito finora, troppo rigidamente
indirizzato [allzu geradlinig] all’Europa, hanno per sé una vasta storia
dell’arte insieme a proprie valutazioni estetiche assolutamente
sostenibili, per lo meno serenamente discutibili, dell’arte non greca
[aussergriechischer] e soprattutto non europea [aussereuropäischer]28.
Tuttavia Bloch ritiene reazionaria tanto la manipolazione coloniale del
progresso quanto un’astorica negazione di esso. Il progresso va pensato
invece come un cocchio dai molti cavalli: non solo sostituire all’Oriente
come preistoria l’attualità della Cina, dell’India, dell’Africa, permette di
evitare di pensare queste culture attraverso il telos dell’incivilimento
dell’uomo e restituire ad esse il «concetto di orgoglio degli uomini di
colore per le culture nazionali non mediate dall’Europa». In questo senso
lo stesso Partenone, nella misura in cui si presenta fondato «in forme
stilistiche antichissime e preasiatiche, appare nella sua vera grande umanità,
non classicistico».
Ivi, p. 122, tr. it. cit., pp. 31-32.
Ivi, p. 123, tr. it. cit., p. 33.
28 Ivi, p. 125, tr. it. cit., p. 35.
26
27
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
427
Il problema è come sistemare l’immenso materiale storico. In questo
senso Babilonia ed Egitto possono costituire il passato dell’Europa; ma non
altrettanto si può dire di India e Cina. Una risposta potrebbe essere fornita
dal geografismo frammentario dei cicli di cultura, per cui Egitto, India e
Cina sarebbero dei mondi per sé stanti con delle fasi di infanzia, gioventù,
virilità e vecchiaia (il riferimento maggiore è evidentemente Spengler). In
questo modo si evita l’aporia costituita dal materiale storico extraeuropeo,
ma si finisce per concepire la storia come costituita da isole, come una
sorta di «circo americano». Tuttavia, aggiunge Bloch,
Se in certi casi le manchevoli o interrotte comunicazioni tra i popoli e i
diversi livelli sociali introducono separazioni, ciò non turba affatto
l’unitarietà del corso: anche una sinfonia, per citare questo esempio
particolarmente adatto, non si svolge con un continuo di tutte le voci. [...]
Rappresentare la storia universale come successione di periodi è senza
dubbio molto più facile che rappresentarlo nella contemporaneità dei
luoghi e nella pluralità delle sue voci [Zweifellos ist eine derart vielstimmig
zusammengehaltene Topisierung in universalhistorischer Darstellung viel
schwieriger als die Periodisierung]; questo concetto topografico esige infatti,
per lo meno quando si presenta come storico universale, un multiversum
anche nel tempo29.
Al di là tanto dello schema della linea continua che di quello delle epoche
intese come isole (al cui interno si riproduce tuttavia lo schema della linea
sotto forma delle fasi della vita di una civiltà) si tratta di pensare dunque la
storia attraverso il concetto di una temporalità plurale, rappresentata dalla
metafora del multiversum, espressione che Bloch riprende da William James
che tuttavia la utilizzava per pensare la molteplicità delle sfere di esperienza
della psiche.
L’idea blochiana è tutt’altra. Il multiversum non è relativo all’esperienza,
è, per così dire, ontologico. A questo scopo Bloch propone una riflessione
sul tempo: «il tempo – scrive Bloch – esiste solo perché qualcosa accade
[Zeit ist nur dadurch, dass etwass geschieht]»30. Certo, ciò appare chiaro
riguardo al tempo vissuto e tuttavia Bloch aggiunge immediatamente che il
«mero tempo vissuto [der bloss erlebten Zeit] non dice molto del
29
30
Ivi, pp. 128-129, tr. it. cit., p. 43.
Ivi, p. 129, tr. it. cit., Ibid.
428
Vittorio Morfino
problema»31, prendendo chiaramente le distanze da un’impostazione della
questione della temporalità plurale in termini di filosofia dell’esperienza.
D’altro canto il tempo cronologico è un progredire simmetricamente
suddiviso in spazi eguali e in quanto tale può essere riconodotto alla serie
numerica restando indifferente ai contenuti. È dunque una mera astrazione
dal vissuto, ad esso non si addice i concetti di vuoto o pieno, poiché in esso
tutto è ugualmente pieno e vuoto:
[...] se è vero che la ruota della storia, quanto meno alla lunga, non si può
far girare all’indietro, anche se deriva dall’orologio, ed è ancora una cosa
sola con l’innegabile procedere in avanti della lancetta, con quella ruota si
indica il tempo-tendenza e quindi qualcosa di qualitativo e non il tempo in sé
neutro dell’orologio32.
Il mero scorrere del tempo cronologico è dunque privo di contenuto e di
valore. Tuttavia non si tratta di istituire una mera opposizione tra il tempo
della fisica e quello della storia (alla maniera hegeliana), poiché se è vero che
rispetto alla materia inanimata il tempo è uniforme (Galileo e Newton), cioè
manca del tutto nel tempo della fisica uno dei contrassegni del tempo
storico, l’irreversibilità, tuttavia proprio la nuova fisica, caratterizzata dalla
teoria della relatività e dei quanti, modifica la concezione newtoniana del
tempo «come variabile quantitativamente ‘scorrente’ e indipendente per
poter stabilire relazioni numericamente esatte»:
la critica di Einstein a Newton che rifiuta l’ipotesi di Newton dell’isocronia
di tutti gli eventi molto lontani [an der Newtonschen Voraussetzung einer
Gleichzeitigkeit aller noch so entfernten Ereignisse]. Com’è noto, esiste
sincronismo [Gleichzeitigkeit] (con differenze così esigue da essere trascurate)
solo per luoghi vicini [...]. Luoghi molto lontani non hanno attimi eguali
[gleiche Augenblick], non soltanto perché manca la possibilità di misurarli (ciò
che in fondo sarebbe una precisazione di carattere idealistico e non reale
sperimentale), ma perché ogni luogo, secondo Einstein ha il proprio tempo,
almeno per quanto concerne l’attimo33.
Ibid.
Ivi, p. 130, tr. it. cit., p. 45.
33 Ivi, 132, tr. it. cit., p. 46.
31
32
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
429
In questo senso Bloch ritiene che dall’idea di spazio di Riemann inteso
elasticamente potrebbe derivare una riflessione su «un non rigido concetto di
tempo [unstarren Zeitbegriff]»34:
[...] il campo [...] appartiene alla forma [...] del mutevolissimo accadere della
materia [wechselvollen materiellen Geschehens] [...], proprio per questo lo
spazio fisico può insegnare qualcosa al tempo, e cioè che, nel suo
succedersi storico, questo deve essere concepito come non costante e, se
non proprio curvo, per lo meno a suo modo ricco di curve. Una
‘pluridimensionalità’ della linea del tempo [eine Mehrdimensionales der
Zeitlinie], come è necessario alla ricchezza geografica del materiale
storico, è alla fisica assolutamente estranea35.
Ora, proprio in questa prospettiva del multiversum e della
pluridimensionalità appare a Bloch tutta l’insufficienza della partizione in
epoche della storia umana: antichità, medioevo etc. Queste partizione
sembrerebbero contenere nei nomi ciò che di diverso accade e tuttavia la
colorazione che essi danno alla temporalità dell’epoca rimane puramente
esteriore, una tinta scolorita. Il tempo che scorre attraverso di esse viene
reificato, permane come invariabile sostrato, nonostante le suddivisioni
cronologiche, «tutt’al più gli viene attribuito figurativamente qualcosa come
l’età dell’uomo, ‘periodo greco, giovinezza del genere umano’ e così via»,
mentre «si trova sempre ripetuta un’espressione di scarso valore, arieggiante
a un’aurora: ‘sorgere del secolo’, per tacere poi delle antiche misticonumeriche accentuazioni (anno 1000 o anche 1524)»36 .
Si tratta invece di porre l’accento sulla specificità:
Le discipline particolari dell’essere e della coscienza storici, che tutte
insieme appartengono alla storia, ci hanno fatto conoscere strutture del
tempo proprie e legittime. Prima di tutto troviamo il concetto, sul piano
economico tanto importante, del tempo lavorativo: in esso la stessa ora
ha un coefficiente, cioè viene diversamente calcolata secondo il lavoro
qualitativo esplicato. Si trovano inoltre i concetti del tempo
assolutamente particolari nella sovrastruttura; basta solo accennare ai
ritmi musicali e poetici e prima di tutto ai costruttori della frase. V’è un
tempo tranquillo nella forma della fuga, un tempo teso e pieno di ansietà
Ivi, p. 132, tr. it. cit., p. p. 47.
Ivi, pp. 133-134, tr. it. cit., p. 49.
36 Ivi, p. 134, tr. it. cit., Ibid.
34
35
430
Vittorio Morfino
nella sonata. V’è un tempo che si svolge copioso nell’ampio spazio
dell’epica, a differenza di quello del dramma, non artisticamente ma
materialmente complesso e raccorciato o pieno di omissioni o anche di
salti cronologici. Nella costruzione della sonata come del dramma
appare, inoltre, una relazione tonica-dominante propria del loro tempo
specifico: la forma dell’andamento non è più per così dire cronica, ma
acuta, propria dell’incalzante, imminente e finalmente verificantesi
fausto o infausto accadere37.
Ma non solo si dà una molteplicità, una pluridimensionalità dei tempi
su un piano ontologico, vi è una molteplicità di modi di immaginare il
tempo. Bloch sottolinea come non solo intere civiltà esistano nel tempo,
ma come queste contengano, nella mitologia e nella religione un proprio
modo di immaginare il tempo (per esempio, il tempo greco è quasi privo
di futuro, mentre il tempo cristiano ne è ricco):
Varietà di strutture temporali [Zeitstrukturen] non si trovano nella semplice
cronologia di un susseguirsi storico [...] non proprio nel problema della
colorazione del tempo dei singoli periodi storici, e soprattutto con pieno
diritto nelle singole sovrastrutture. Tali differenziate strutture del tempo
non sono però [...] quelle che permettono di ridurre a un minimo comun
denominatore il progresso nell’organizzazione economica, nella tecnica e
nell’arte. Di qui risulta che fra il molteplice materiale che modifica il
concetto di tempo storico (per forma e contenuto), e lo rende adatto di
volta in volta ai vari contenuti, si trova alla fin fine il multiforme materiale
dello scopo, al quale come elemento valorizzante, il succedersi delle forme
temporali è talvolta riferito. Appunto questi riferimenti finalistici non
ancora del tutto omogeneizzati tra loro, variano, oltre alle forme del
progresso, anche le strutture del tempo nelle quali avvengono quelle
differenti e spesso disuguali forme (organizzazione sociale, tecnica, arte e
così via). Di volta in volta l’insieme delle tendenze sociali si sovrappone
certo, anche come generale tendenza, ai movimenti temporalmente
stratificati della tendenza stessa; tuttavia le diverse correnti della
stratificazione rimangono in questo insieme. Ed esse esigono particolari
concezioni temporali-contenutistiche non più di forma omogenea –
esigono una specie di tempo riemanniano: un concetto di tempo
variamente misurabile, secondo la partizione, e soprattutto secondo i
contenuti finalistici – ancora vari e molto nascosti del materiale storico38.
37
38
Ivi, pp. 134-135, tr. it. cit., p. 50.
Ivi, pp. 135-136, tr. it. cit., p. 51.
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
431
In questa direzione Bloch ritiene che possa essere evocata la teoria
leibniziana del tempo secondo cui questo sarebbe, come lo spazio, una
forma attiva delle forze e del loro movimento, un modo del movimento:
questa concezione dinamica del tempo che nelle sue conseguenze non
considera le serie temporali della storia umana come immutabili e
ovunque egualmente costituite. E in primo luogo essa vede una differenza
fra i milioni di anni della preistoria (per non parlare dei miliardi di anni
geologici e persino cosmologici) e il paio di millenni di storia della cultura a
partire dal periodo neolitico. Qui si manifesta non soltanto una differenza
cronometrica, ma in particolare una distinzione inerente alla densità
dell’esser tempo, specie nella sua struttura qualitativa, in breve, una
oggettiva variabilità anche nella successione: con tutta l’insopprimibile unità
di connessione dello sviluppo storico, connessione non lineare-temporale, bensì
anche cronologicamente differenziata e federativa, e solo così utilmente
centripeta [fruchtbar zentrierten]39.
Certo contro Leibniz è possibile una presa di posizione che Bloch
definisce come «formalismo e statica categoriale», di cui il perfetto modello
sarebbe Hartmann e la sua affermazione che il tempo scorre indifferente
verso tutto, «sempre lo stesso, assolutamente eguale, qualunque cosa
accada»40. In realtà non ci sono forme di tempo in sé:
Al di fuori della vita sociale del proprio ‘tempo’ non c’è metrica diversa,
discutibile, come se una struttura temporale come tale vivesse e si
muovesse. Ma non c’è neppure nella storia mero tempo cronologico
oppure, il che è lo stesso, il tempo come contenente neutro astratto41.
Certo, se il tempo è solo dove accade qualcosa, ci si deve chiedere se il
ritmo di questo accadere influisca sul tempo, cioè se il frangersi sempre
uguale dell’onda sulla roccia per centinaia di migliai di anni sia ugualmente
lungo e ugualmente denso come il breve anno del ’17 russo, domanda che
Bloch precisa sia da intendersi in senso oggettivo e non in riferimento al
tempo vissuto, cioè in una direzione bergsoniana:
Ivi, p. 136, tr. it. cit., p. p. 52.
Ivi, 137, tr. it. cit., p. 53.
41 Ivi, 136, tr. it. cit., p. p. 52.
39
40
432
Vittorio Morfino
Tutte le successioni di tempo, non soltanto quella storica, devono essere
comprese in connessione con le suddivisioni variamente dense
dell’accadere storico materiale, delle sue tendenze e dei suoi contenuti.
Esiste una differenza intensiva e qualitativa del tempo storico stesso di
fronte al tempo-natura come si presenta nella ‘storia naturale’, diverso
inoltre dall’altro indicato dalla componente t della fisica. Ora si
comprende [...] che il tempo della natura offre una minore densità nella
sua estensione, formalmente molto più ampia di quella storico-culturale.
Confrontato con questo, è un meno, dilatato all’infinito, in tempo
intensivo qualitativo; come anche la natura preistorica contiene un meno
nello sviluppo del proprio essere. E i suoi milioni e miliardi di anni, che
sono (o sembrano) disposti in serie apparentemente omogenea prima del
paio di migliaia d’anni della storia umana, sono perciò da usare per un
confronto non troppo stringente ma illustrativo, una specie di tempo
inflazionato a confronto con l’ ‘età dell’oro’ storico-culturale42.
Tuttavia non si deve cadere nell’errore, reso in un certo senso
paradigmatico da Hegel, di considerare il tempo della natura come il
passato del tempo storico, come una sorta di «preterito assoluto»:
[...] in una vera ‘topologia’ storico-universale dei tempi non può non
essere preso in considerazione il problema di una vera e propria serie di
tempi naturali che non dappertutto sbocca nella presente serie storica. Lo
svolgersi lineare, in fila indiana, del prima e del dopo non può
assolutamente sostenersi ad un prima naturale considerato come trascorso,
ad un dopo della storia della cultura considerato soltanto come
determinante. Parimenti, l’immensa costruzione della natura si presenta
più come uno scenario, sul quale il dramma che a esso corrisponde per
dimensione non è ancora stato rappresentato nella storia dell’uomo, più di
quanto l’essere e la coscienza storico umani appaiono l’occhio già aperto di
tutta l’essenza della natura. Un’essenza della natura che non solo si trova
prima della nostra storia e la sostiene, ma in gran parte l’avvolge, a lungo,
come storia per forme e contenuto ancora in via di mediazione con il
tempo della storia43.
42
43
Ivi, pp. 138-139, tr. it. cit., p. 55.
Ivi, p. 141, tr. it. cit., p. 59.
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
433
In conclusione non è pensabile secondo Bloch una nuova antropologia
marxista senza una nuova cosmologia marxista, che neghi la freccia del
tempo che dalla natura conduce alla storia. E proprio la costruzione di
questa cosmologia ci darebbe gli strumenti per negare anche il progresso
unilineare che si svolgerebbe attraverso la storia:
Quanto più fallisce la tradizionale accentuazione meramente occidentale –
per non parlare poi del discredito che le è proprio in quanto imperialista –
tanto più può essere d’aiuto una visione utopisticamente aperta, essa stessa
ancora sperimentale. Solo in tal modo centinaia di culture possono
confluire nell’unità del genere umano che così viene a formarsi, secondo
un tempo storico non lineare, secondo un tempo della storia non
uggiosamente monocorde. Proprio per amor dell’unità del genere umano,
l’Africa e l’Asia segnano all’unisono un percorso sia poliritmico che
polifonico del progresso verso questa unità, sebbene sotto un sole sorto,
sia dal punto di vista pratico che teoretico, in Europa, e che vorrebbe
illuminare una comunità davvero senza schiavitù. Dopotutto il concetto
occidentale di progresso non ha implicato nelle sue rivoluzioni vertici
europei (e neppure africani o asiatici), bensì una terra sola, nel suo insieme
migliore44.
Rispetto a Erbaschaft dieser Zeit, in cui il modello esplicativo della
temporalità plurale era utilizzato per spiegare la formazione del nazismo
nella società e nella storia tedesca, in Differenziazioni nel concetto di progresso il
modello della temporalità plurale è applicato alla Weltgeschichte con il preciso
scopo di sovvertire la concezione lineare della storia, tipica dell’hegelismo e
di certa scolastica marxista, scandita da fasi ad un tempo temporali e
geografiche guidate da un telos eurocentrico. In questo testo Bloch sembra
abbandonare l’idea di un tempo fondamentale misura degli altri, a favore di
un multiversum temporale che troverebbe una ricomposizione nell’orizzonte
escatologico del comunismo.
5.
Althusser e la non contemporaneità strutturale
Veniamo infine ad Althusser che propone la sua teoria del tempo
storico a metà degli anni Sessanta. Per comprendere lo specifico uso
althusseriano del concetto di ‘non contemporaneo, è fondamentale
44
Ivi, p. 145, tr. it. cit., p. 64
434
Vittorio Morfino
ritornare sull'introduzione del concetto di ‘surdeterminazione’ nel Per Marx
che Althusser utilizza per tracciare una linea di demarcazione tra la
contraddizione hegeliana e quella marxista: mentre la contraddizione
hegeliana è lo sviluppo di un'unità semplice in cui è iscritto ab origine il suo
telos, la contraddizione marxista è sempre ‘surdeterminata’ in quanto si
sviluppa all'interno di un tutto sociale complesso strutturato a dominante.
Riprendendo il saggio di Mao sulla contraddizione45, Althusser afferma che
è necessario distinguere in un processo storico tra la contraddizione
principale e quelle secondarie, tra l'aspetto principale e quello secondario
della contraddizione e cogliere il suo diseguale sviluppo. Ma Althusser
propone un passo ulteriore:
Se ogni contraddizione lo è di un tutto complesso strutturato a dominante,
non si può pensare il tutto complesso fuori dalle sue contraddizioni, fuori
dal loro rapporto fondamentale di disuguaglianza. In altre parole, ogni
contraddizione, ogni articolazione fondamentale della struttura e il
rapporto generale delle articolazioni nella struttura a dominante,
costituiscono altrettante condizioni di esistenza del tutto complesso.
Questa affermazione è di primissima importanza. Essa infatti significa che
Mao scrive: «In ogni caso, è assolutamente certo che in ciascuna delle diverse fasi di
sviluppo del processo esiste solo una contraddizione principale che svolge la funzione
determinante. Da ciò consegue che in ogni processo, se in esso esistono numerose
contraddizioni, ve ne è necessariamente una principale, che ha una funzione determinante,
decisiva, mentre le altre hanno una posizione secondaria e subordinata. È quindi
necessario, nello studio di ogni processo, che sia complesso e contenga più di due
contraddizioni, fare ogni sforzo per trovare la contraddizione principale. Una volta trovata
questa contraddizione principale, è facile risolvere tutti i problemi. […] Abbiamo già detto
prima che non bisogna trattare tutte le contraddizioni di un processo come fossero uguali,
che occorre distinguere la contraddizione principale e quelle secondarie, e stare attenti
soprattutto ad afferrare la contraddizione principale. Ma in ogni contraddizione, sia essa
principale o secondaria, i due aspetti contraddittori si possono trattare come fossero
uguali? No, neanche questo è possibile. In qualsiasi contraddizione, gli aspetti
contraddittori si sviluppano in modo ineguale. Sembra talvolta che vi sia equilibrio delle
forze ma non si tratta che di una situazione temporanea e relativa; stato fondamentale è lo
sviluppo ineguale. Dei due aspetti contraddittori, uno è necessariamente principale, l'altro
secondario. Principale è quello che svolge la funzione determinante nella contraddizione. Il
carattere di una cosa è determinata soprattutto dall'aspetto principale della contraddizione,
il quale occupa la posizione dominante. Ma questa situazione non è statica: gli aspetti di
una contraddizione, quello principale e quello secondario, si trasformano l'uno nell'altro e
il carattere della cosa cambia di conseguenza» (MAO TSE-TUNG, “Sulla contraddizione”, in
ID.Opere scelte, vol. I, Casa editrice in lingue estere, Pechino 1969, pp. 350-351).
45
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
435
la struttura del tutto, dunque la ‘differenza’ tra le contraddizioni essenziali
e la loro struttura a dominante, è l'esistenza stessa del tutto; che la
‘differenza’ tra le contraddizioni (che vi sia contraddizione principale,
ecc.; e che in ogni contraddizione vi sia un aspetto principale) fa tutt'uno
con le condizioni di esistenza del tutto complesso. Per parlare chiaramente
questa proposizione implica che le contraddizioni ‘secondarie’ non sono il
puro fenomeno della contraddizione ‘principale’, che la principale non
rappresenta l'essenza di cui le secondarie sarebbero i fenomeni […]. Essa
implica invece che le contraddizioni secondarie sono essenziali all'esistenza
stessa della contraddizione principale, che ne costituiscono realmente le
condizioni di esistenza, così come la contraddizione principale costituisce
la loro condizione di esistenza46.
Le condizioni di esistenza, di cui parlano i classici del marxismo, non
sono dunque secondo Althusser il contesto dello svilupparsi della
contraddizione, ma il modo stesso in cui il tutto sociale esiste, che a sua
volta non è nulla di differente dalle sue contraddizioni:
Se dunque le condizioni non sono nient'altro che l'esistenza attuale del
tutto complesso, esse sono le sue stesse contraddizioni, ciascuna delle
quali riflette in sé il rapporto organico che la lega alle altre nella struttura a
dominante del tutto complesso47.
La contraddizione è dunque sempre, conclude Althusser,
«complessamente-strutturalmente-inegualitariamente-determinata – se mi
si vuole passare questa parola spaventosa!… Ho preferito, lo confesso, una
parola più corta: surdeterminata»48. In un orizzonte teorico di questo tipo
non si offre una semplice contemporaneità al gioco degli opposti nemmeno
nella prospettiva escatologica di una praesentia che risolva infine la
complessità dei piani temporali sbrogliando la matassa in un tempo pieno.
La questione viene esplicitamente affrontata sul versante di una teoria
della temporalità in un paragrafo di Leggere il Capitale, l'«Abbozzo di una
teoria del tempo storico», dove come in Bloch (seppur in modo più netto)
è ancora una volta Hegel ad essere utilizzato come «contro esempio
L. ALTHUSSER, Pour Marx, La Découverte, Paris 19963, pp. 210-211, tr. it. a cura di
F. Madonia, Editori Riuniti, Roma 1967, pp. 181-182.
47 Ivi, p. 213, tr. it. cit., p. 184.
48 Ivi, p. 215, tr. it. cit., p. 64.
46
436
Vittorio Morfino
pertinente», un Hegel nella cui filosofia della storia è all’opera una
concezione del tempo marcato da due caratteristiche fondamentali:
1) la continuità omogenea del tempo;
2) la contemporaneità o categoria del presente storico.
Queste due caratteristiche non sono altro che le due coordinate
dell’idea, successione e simultaneità, nel suo darsi sensibile. Delle due
quella di gran lunga più importante è, secondo Althusser, la seconda,
quella in cui «si manifesta il pensiero più profondo di Hegel». Infatti la
categoria di contemporaneità dice precisamente qual è la struttura
dell’esistenza storica della totalità sociale:
La struttura dell’esistenza storica è tale che tutti gli elementi della
totalità coesistono sempre nello stesso tempo, nello stesso presente, e
sono dunque contemporanei gli uni agli altri nello stesso presente. Ciò
vuol dire che la struttura dell’esistenza storica della totalità sociale
hegeliana permette ciò che io propongo di chiamare una ‘sezione di
essenza’ [coupe d’essence], cioè l’operazione intellettuale con la quale si
opera una sezione verticale [coupure verticale] in un momento qualunque
del tempo storico, una sezione del presente tale che tutti gli elementi
della totalità rivelati da questa sezione siano tra loro in un rapporto
immediato che esprime immediatamente la loro essenza interna49.
Althusser ritiene che sia la natura specifica di questa totalità a
permettere la sezione d’essenza, la sua natura spirituale, che fa sì che ogni
parte sia pars totalis in senso leibniziano. La continuità del tempo si fonda
precisamente sul succedersi continuo di questi orizzonti contemporanei la
cui unità è garantita dall’omnipervasività del concetto. Da qui il duplice
senso del momento dello sviluppo dell’idea in Hegel:
1) momento come momento dello sviluppo che deve ricevere una
periodizzazione
2) momento come momento del tempo, come presente.
Questo dunque lo sfondo della celebre affermazione hegeliana della
Filosofia del diritto: «Comprendere ciò che è, è il compito della filosofia,
poiché ciò che è, è la ragione. Per quel che concerne l’individuo, del resto,
ciascuno è un figlio del suo tempo; così anche la filosofia, è il tempo di essa
appreso in pensieri [so ist auch die Philosophie, ihre Zeit in Gedanken erfasst]. È
49 L. Althusser, «L’objet du Capital», in AA.VV., Lire Le Capital, PUF, Paris 19963, pp.
276-277, tr. it. a a cura di R. Rinaldi e V. Oskian, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 100-101.
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
437
altrettanto insensato figurarsi che una qualsiasi filosofia vada al di là del suo
mondo presente, quanto che un individuo salti il suo tempo, salta al di là di
Rodi»50. Il presente è per Hegel l’orizzonte assoluto di ogni conoscenza,
perché ogni conoscenza non è altro che l’esistenza, nella conoscenza, del
principio interiore del tutto. In questo orizzonte una conoscenza del futuro
è impossibile ed è dunque altrettanto impossibile una scienza della politica
in quanto «sapere riguardante gli effetti futuri dei fenomeni presenti»51: gli
individui Weltgeschichtliche (cosmico-storici) non conoscono infatti il futuro
ma lo «indovinano come presentimento»52.
In questa teoria hegeliana del tempo storico che «è tratta
dall’empirismo più comune, dalle false evidenze della pratica quotidiana,
che ritroviamo nella sua forma ingenua presso la maggior parte degli storici
(per lo meno in tutti quelli conosciuti da Hegel)»53, Althusser vede il
modello di una concezione della storia estremamente diffusa anche nello
strutturalismo in cui la coppia omogeneità/contemporaneità è tradotta
nella coppia diacronico/sincronico: «Alla base di questa distinzione sta la
concezione di un tempo storico continuo e omogeneo, contemporaneo a
sé»54. Il sincronico è la contemporaneità intesa in senso hegeliano, mentre
il diacronico non è altro che il divenire di questa presenza nella
«successione di una continuità temporale». E, al contrario di quello che si
potrebbe pensare, questa rappresentazione ingenua del tempo storico è
presente persino nella storiografia delle «Annales». Certo, gli storici di
questa scuola constatano che vi sono tempi differenti (corti, medi e lunghi)
e osservano le loro interferenze come risultati del loro incontro, ma non
pongono la questione in termini concettuali sulla struttura del tutto che
determina queste variazioni. Essi ritengono di poter misurare queste
varianti riferendole al tempo continuo e omogeneo55.
50 G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Sämtliche Werke, Band VI,
herausgegeben von G. Lasson, Leipzig, Meiner 1930, p. 15; tr. it. a cura di G. Marini,
Laterza, Roma-Bari 1987, p. 15.
51 L. ALTHUSSER, «L’objet du Capital», cit., p. 278; tr. it. cit., p. 102.
52 Ibid.
53 Ivi, p. 279, tr. it. cit., p. 203.
54 Ibid.
55 Sul rapporto tra la teoria del tempo storico althusseriano e la storiografia delle
«Annales» cfr. P. SCHÖTTLER, Althusser and Annales historiography. An impossible dialogue?, in
E.A. KAPLAN AND M. SPRINKER (edited by), The Althusserian Legacy, Verso, London - New
York 1993, pp. 81-98.
438
Vittorio Morfino
Si tratta allora secondo Althusser di pensare per differenza rispetto ad
Hegel la temporalità del tutto complesso sempre-già-dato presente nel
pensiero di Marx. Qual è la temporalità del tutto sociale? Non la
contemporaneità, il presente storico hegeliano, poiché esso ha un centro
espressivo che si irraggia uniformemente in ogni punto della circonferenza.
Non il sincronico che si occupa, secondo la definizione di Saussure «di uno
spazio di tempo più o meno lungo durante il quale la somma delle
modificazioni sopravvenute è minimo»56: l’ontologizzazione della
linguistica saussuriana nello strutturalismo fa sì che nella sincronia sia
rintracciabile una sorta di «grammatica generale» di un'epoca di cui il
paradigma è forse il concetto foucaltiano di episteme di Le parole e le cose.
Non la molteplicità dei tempi della storiografia delle «Annales», poiché
questa molteplicità conserva una relazione fondamentale con lo scorrere
omogeneo di un tempo che è misura degli altri. Si tratta di comprendere
quale forma di temporalità pertenga al momento attuale, alla situazione
concreta nel suo darsi alla conoscenza. E per far ciò è necessario «costruire
il concetto marxista di tempo storico a partire dalla concezione marxista
della totalità sociale»57. Il tutto sociale marxiano
è un tutto la cui unità, lungi dall’essere l’unità espressiva o ‘spirituale’ del
tutto di Leibniz e Hegel, è costituita da un certo tipo di complessità, l’unità di
un tutto strutturato, che comporta dei livelli o istanze distinti e ‘relativamente
autonomi’, che coesistono in questa unità strutturale complessa articolandosi
gli uni con gli altri a seconda dei modi di determinazione specifici, fissati in
ultima istanza dal livello o istanza dell'economia58.
La concezione marxista della totalità sociale è fatta emergere da
Althusser nel commento ad un passaggio della «Introduzione» del 1857 in
cui Marx afferma che «in tutte le forme di società vi è una determinata
produzione che decide del rango e dell’influenza di tutte le altre e i cui
rapporti decidono perciò del rango e dell’influenza [Rang und Einfluß] di
56 F. SAUSSURE, Cours de linguistique générale, édition critique par R. Engler, Tome 1,
Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1968, p. 227, tr. it. a cura di T. De Mauro, Laterza, Bari
1967, p. 123.
57 L. ALTHUSSER, «L’objet du Capital», cit., p. 280, tr. it. cit., p. 104.
58 Ivi, pp. 280-281, tr. it. cit., p. 104.
Sul non contemporaneo: Marx, Bloch, Althusser
439
tutti gli altri»59. Il tutto per Marx è «un tutto organico gerarchizzato»,
tutto che decide appunto della gerarchia, del grado e dell’indice di efficacia
tra i diversi livelli della società.
Qual è la temporalità di questo tutto gerarchizzato? Non la
contemporaneità hegeliana:
La coesistenza dei differenti livelli strutturati: l’economico, il politico e
l’ideologico ecc., e quindi dell’infrastruttura economica, della sovrastruttura
giuridica e politica, delle ideologie e delle formazioni teoriche (filosofia,
scienze), non può più essere pensata nei termini della coesistenza del presente
hegeliano, di quel presente ideologico in cui coincidono la presenza
temporale e la presenza dell’essenza nei suoi fenomeni60.
Un tempo continuo e omogeneo «non può essere ritenuto il tempo
della storia»; non solo, non è possibile nemmeno pensare «nello stesso tempo
storico il processo dello sviluppo dei differenti livelli del tutto»: ogni livello
ha infatti «un tempo proprio relativamente autonomo dagli altri livelli»61.
A ogni formazione sociale corrisponde il tempo e la storia dello
sviluppo delle forze produttive, dei rapporti di produzione, della
sovrastruttura politica, della filosofia, delle produzioni estetiche: «ciascuna
di queste storie è scandita secondo ritmi propri» e può essere conosciuta
solo se si determina il concetto della specificità della sua temporalità, con il
suo sviluppo continuo, le sue rivoluzioni, le sue rotture. Non si tratta di
settori indipendenti, ma relativamente autonomi, autonomia relativa che è
appunto fondata su una certo tipo di articolazione del tutto, su un certo
tipo di dipendenza: «[la] specificità di questi tempi e di queste storie è
differenzia